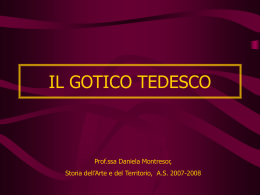Isabella Rosoni (Università di Macerata) Ordinamento amministrativo coloniale e mobilità degli individui. Il caso della Colonia Eritrea [Paper presentato al convegno Vecchie e nuove migrazioni nell’area mediterranea, Tripoli come un miraggio, Convegno internazionale di studi promosso dall’Università di Macerata e la Provincia di Ascoli Piceno a Porto Sant’Elpidio, 2425 Novembre 2006] da non citare senza l'autorizzazione dell'autore Abstract Da sempre le migrazioni fanno parte del modo di vita africano. Il nomadismo carovaniero, le migrazioni pastorali, la coltivazione ciclica della terra, hanno costituito per molto tempo il tratto culturale delle popolazioni africane che abitano le regioni aride o semiaride del continente. Nonostante la popolazione della colonia eritrea presentasse ben spiccate queste caratteristiche, la sensibilità del nostro colonialismo verso quel fenomeno che oggi definiamo “mobilità degli individui” fu scarsa. L’attenzione antropologica alle strutture sociali, alle attività economiche, alle pratiche religiose, e ovviamente alla mobilità territoriale della regione eritrea fu determinata soprattutto dalla necessità della amministrazione italiana di suddividere i territori in aree (regioni) il più possibile omogenee. Per il resto l’amministrazione coloniale si interessò al tema della mobilità in modo sostanzialmente marginale, spinta soprattutto da urgenze esterne quali, ad esempio, la redazione dei censimenti, la regolamentazione del lavoro indigeno, la riscossione di tributi, l’adesione alla lotta antischiavista. 1 1. Alcune questioni di lessico Un aspetto che colpisce, nel dibattito contemporaneo, è il carattere problematico che ha assunto il termine migrante. Il suo senso moderno, in quella che viene definita “era della globalizzazione”, è quello di outsider, fuorilegge, non rispetto a questa o quella legge del paese di provenienza o di arrivo, ma della legge in quanto tale. I migranti (spesso rifugiati) sono fuori dal nomos, sono relegati in una deriva liminare che può essere transitoria o permanente. Sono condannati a una transitorietà, instabilità e provvisorietà che può essere eterna o temporale, e questo perché i migranti perdono la propria identità politica che è costituita di due elementi essenziali: appartenere a una nazione ed essere cittadini. Ma l’incremento esponenziale dei flussi migratori verificatosi negli ultimi 50 anni ha comportato una modifica, e ha attribuito un significato nuovo, anche a due concetti che alla migrazione sono indissolubilmente legati, quello di cittadinanza e quello di nazione. Oggi la nazione può essere definita, in termini molto generali come quel “noi” collettivo a cui appartiene un certo Stato. La nazione non è tanto un fatto “naturale”, uno spazio, per intenderci, definito da confini, quanto l’esito di un processo sociale di identificazione, collocato nel tempo e nello spazio. Una identità collettiva, quindi, che si realizza attraverso tutta una serie di pratiche culturali e rituali, che possono essere la celebrazione delle festività nazionali, l’elaborazione di una lingua comune, la creazione di un dibattito pubblico attraverso un sistema di comunicazione esteso su tutto il territorio nazionale (Cfr. E. Caniglia 2005, p. 29). La nazione, può essere etnica e cioè avere una origine socio-biologico-culturale, discendere da una storia collettiva fondata più o meno simbolicamente da un nucleo di tipo etnico che precede il costituirsi di uno stato territoriale (modello tedesco, inglese, italiano); oppure può essere nazione civica e cioè essere fondata solo politicamente (modello francese e americano). I due modelli corrispondono, come è fin troppo noto, a due tipi di differenti trattamenti per gli individui che siano cittadini o stranieri. La nazione etnica funziona come un potente meccanismo di esclusione dalla cittadinanza. Se il criterio è quello dello jus sanguinis, bisogna essere figli o discendenti di cittadini per essere cittadini di uno Stato. Viceversa la nazione civica ha carattere inclusivo. Per entrare a farvi parte non hanno importanza le caratteristiche ascrittive (etniche, culturali, razziali) dell’individuo, basta essere nati nel 2 territorio dello Stato (jus soli), o scegliere di dimorarvi e di essere leali verso le sue istituzioni statuali e i suoi valori fondamentali. (cfr. J.Habermas 1982).. Mi preme qui fare un accenno brevissimo a quanto questi due modelli corrispondano ai modelli di politica coloniale elaborati fra fine Ottocento e primi Novecento, il modello anglosassone della autonomia e quello francese della assimilazione (cfr. I. Rosoni 2006 pp. 47 ss.). Mentre in passato i termini nazione e cittadinanza indicavano fenomeni politici tutto sommato aproblematici e tendenzialmente sovrapponibili, oggi, le peculiari caratteristiche della nuova migrazione si scontrano necessariamente con il principio classico della territorializzazione dei popoli che sta alla base del concetto, tutto europeo, di StatoNazione (sia che si parli di nazione etica che di nazione civica): e cioè del concetto secondo il quale ogni popolo deve avere un suo Stato e risiedere in un territorio specifico. Di conseguenza oggi, per gli immigrati, la trasformazione della tradizionale cittadinanza nazionale si orienta verso un modello che potremmo definire di cittadinanza flessibile. La cittadinanza è flessibile quando non è più necessario sviluppare un senso di appartenenza nazionale verso il paese ospitante, e neanche cancellare i caratteri etnoculturali specifici dell’immigrato. Non si richiede più, come un tempo, l’assimilazione come condizione per l’incorporazione legale dell’immigrato; la sua naturalizzazione che comportava la perdita del suo vecchio status. Il cittadino flessibile è incorporato legalmente in un territorio ma può sviluppare legami e interessi con più di un paese alla volta. Risiedere in uno, lavorare in un altro, provenire da un terzo (cfr. E. Caniglia 2005, pp. 45 ss.). Sarebbe ingenuo pretendere di ritrovare la stessa ricchezza del dibattito e le stesse figure giuridiche e politiche nella storia dei rapporti tra Europa e Africa di cento anni fa. Innanzitutto perché i termini presi in esame: migrazione/cittadinanza/nazionalità avevano un significato diverso e aproblematico. Secondariamente perché la grande migrazione dai paesi del Sud del mondo verso i paesi a capitalismo avanzato non c’era. Infine perché i flussi migratori, presenti sicuramente anche allora, non avevano però la stessa portata, lo stesso significato politico, e non coinvolgevano le stesse aspettative individuali. Inoltre, a ben guardare, tutto il dibattito sulla civilizzazione, che è la giustificazione nobile del colonialismo, era in realtà un dibattito sulla estensione del concetto di nazione, e quindi sulla estensione della cittadinanza, sulla esportazione delle varie nazionalità e cittadinanze nei territori nullius che essendo appunto territori politicamente di nessuno, quelle identità avrebbero potuto e dovuto assorbire. 3 Allora il problema era, evidentemente, che l’essere quei territori di nessuno era una finzione giuridica costruita ad arte dal diritto internazionale. Infatti, se non erano degli Stati, intesi nel senso ottocentesco del termine, essi erano di proprietà, perlomeno, di chi ci viveva. Il diritto internazionale di fine 800 era però molto chiaro al riguardo. Un territorio abitato da una popolazione “numerosissima ma barbara”, dal punto di vista del diritto privato appartiene a quella popolazione, ma dal punto di vista del diritto internazionale appartiene allo Stato (europeo) che lo occupa e vi estende il proprio dominio. In questo quadro una opinione autorevole fu quella di Catellani che ricondusse lucidamente la questione entro i termini del diritto coloniale: «Può esistere in un territorio una popolazione numerosissima che sia però così barbara e così disgregata da non poter dirsi che costituisca verun ordinamento politico né sia soggetta alla sovranità di qualche capo… quel territorio sarà bensì, nei riguardi del diritto privato, posseduto nella parte abitata dalla popolazione collettivamente considerata o dai singoli individui che la compongano, ma dal punto di vista della sovranità quel paese dovrà essere considerato res nullius. Le persone fisiche individuali vi esistono e perciò la proprietà del suolo non è disponibile se non in quanto quella popolazione lo abbia fino allora lasciato in abbandono o successivamente e spontaneamente lo abbandoni; ma la persona giuridica rappresentante politicamente il paese e la collettività che lo abita non vi esiste, e le sovranità costituite degli Stati civili vi trovano il campo così sgombro alla loro influenza politica e all’estensione del loro dominio, come nelle parti deserte di quel territorio, i singoli individui trovano il campo sgombro alla loro attività d’ordine privato e all’estensione della loro proprietà. Mentre il diritto d’occupazione privata degli individui deve arrestarsi davanti ad un altro individuo fornito di diritti preesistenti, il diritto di occupazione politica degli Stati deve arrestarsi non già davanti a qualunque moltitudine di individui, ma soltanto davanti ad un altro Stato» ( E. L. Catellani 1885, pp. 579-580). Un simile atteggiamento non poteva che avere conseguenze negative quanto al riconoscimento dei diritti di cittadinanza degli abitanti dei territori conquistati. Questi, non godendo già da prima della conquista coloniale dei diritti politici, non ne avrebbero goduto appieno neppure in futuro o, perlomeno, fino a che non avessero dimostrato di aver raggiunto un grado accettabile di civilizzazione. 4 2. La migrazione è una caratteristica costante della società africana Da sempre le migrazioni fanno parte del modo di vita africano. Si tratta di differenti tipi di migrazione che hanno un tratto comune: si decidono e si realizzano a livello di gruppo e di conseguenza sfuggono a ogni forma di calcolo individuale. Quando non sono imposti dalle catastrofi naturali o politiche, si segnalano come caratteristica della coutume o della cultura di quel gruppo. Il nomadismo carovaniero, le migrazioni pastorali, la coltivazione ciclica della terra, hanno costituito per molto tempo il tratto culturale delle popolazioni africane che abitano le regioni aride o semiaride del continente. Questa forma di movimento della popolazione, imposto dai bisogni di trovare acqua e pascoli, è quello che viene in mente quando parliamo di migrazioni tradizionali. Ma non è il solo. Anche le popolazioni che praticavano l’agricoltura rudimentale avevano bisogno di spostarsi per trovare terre fertili; gli scambi e i commerci che molti popoli adottarono come attività principale provocarono migrazioni di carattere ciclico o temporaneo; così come le guerre di conquista che comportarono lo spostamento dei vincitori sui territori dei vinti. Infine la tratta degli schiavi, che costituì per più di tre secoli la forma più massiccia e brutale di migrazione. Si stima a 15 milioni il numero degli individui che, dal 1550 al 1850 lasciarono l’Africa. E un numero più o meno uguale fu quello delle vittime delle guerre interne e degli spostamenti forzati che la tratta provocò all’interno del continente. Riassumendo, nel corso dei secoli le migrazioni rappresentarono la risposta abituale delle popolazioni africane alle calamità naturali: carestie, siccità, inondazioni, malattie degli uomini e degli animali; ma anche alle calamità che potremmo definire “storiche”, come le guerre e le occupazioni che spesso provocarono considerevoli flussi di popolazione da un territorio a un altro. Poi, a partire dal periodo coloniale, in gradi diversi, le migrazioni tradizionali subirono l’influenza dei colonizzatori e, in un gran numero di casi, le sono sopravvissute. Ma è fuor di dubbio che la presenza europea produsse un tale sconvolgimento nella organizzazione dell’economia e della società che i movimenti della popolazione che seguirono finirono e per eclissare le migrazioni tradizionali e per modificarne radicalmente la natura. La conquista coloniale ebbe per effetto principale quello di spostare il centro di gravità dell’attività economica sulle zone costiere, ma anche di creare degli spazi di sviluppo all’interno del paese, lì dove venivano scoperti i giacimenti minerari o dove veniva collocato il centro delle attività economiche. I bisogni delle economie europee ridisegnarono la mappa dell’Africa e alla redistribuzione dell’attività economica si 5 accompagnò una redistribuzione della popolazione: Per esempio l’utilizzo delle vie marittime per il trasporto delle merci produsse insediamenti nelle zone costiere che invece, in epoca precoloniale, quando il commercio seguiva le vie delle carovane, erano poco popolate perché considerate insalubri. Poi l’elezione delle zone interne più fertili per lo sviluppo della coltura di prodotti per la esportazione: caffè, olio di palma, cacao, banane, caucciù ecc. incentivò l’esodo verso l’interno. Infine la costruzione di ferrovie, di strade, di infrastrutture, determinò lo spostamento della manodopera indigena verso i centri del nuovo mercato del lavoro. Per il periodo in cui si mantennero le pratiche della schiavitù e del lavoro forzato questa redistribuzione di lavoratori verso le zone economiche bisognose di manodopera sollevò soltanto un problema di tipo logistico. La manodopera andava recuperata là dove era abbondante senza preoccupazione per le conseguenze umane, sociali ed economiche che questo prelevamento e trasferimento di uomini comportava. Dopo l’abolizione della schiavitù e del lavoro forzato, l’imposizione alle popolazioni di un tributo da pagare in denaro determinò in queste la ricerca di un lavoro salariato e, di conseguenza, il loro spostamento verso le attività considerate come economicamente più redditizie dal potere coloniale. In questo modo la tassazione degli indigeni ottenne un duplice risultato: da un lato quello di assicurare alle amministrazioni coloniali un budget che garantisse la quasi autosufficienza delle spese amministrative, dall’altro, dopo l’abolizione del lavoro forzato, la possibilità di pilotare i flussi migratori interni verso le attività considerate economicamente più redditizie (cfr. S. Ricca 1990, pp. 26 ss.). 3. L’emigrazione non segue la bandiera. Colonialismo ed emigrazione italiana Ma la storia del colonialismo, lo sappiamo, è, se mai, quella di una migrazione a senso inverso. Quando un paese è nello stadio di esuberanza demografica, se non dispone di territori capaci di assorbire la popolazione sovrabbondante, dirotta le correnti migratorie verso le colonie. L’Italia di fine Ottocento vedeva la sua popolazione in esubero migrare verso l’America: Stati Uniti e Argentina erano i Paesi che accoglievano gli italiani in cerca di fortuna. La preoccupazione politica del nostro Paese era per la perdita della italianità e nasceva sostanzialmente dalla osservazione che l’emigrazione non seguiva la bandiera. Solo per fare un esempio, sicuramente diacronico ma significativo per il quadro che sto tracciando, 6 nel 1931 il numero degli italiani in Libia è meno della metà di quello degli italiani in Tunisia: 45.000 contro 91.000. ( cfr. N. Federici 1938, p. 42). Quella della italianità era una vera e propria ossessione per l’epoca; anche perché, se vogliamo, si trattava di una conquista recente. Le date della unificazione: 1860 e 1870 precedono infatti di poco quelle delle prime conquiste coloniali. L’Italia appena unificata temeva di perdere la propria identità nazionale. Nel triennio 1887-1900 Crispi aveva riformato il Ministero degli Affari Esteri imponendo che i nostri rappresentanti all’estero usassero come lingua ufficiale la lingua italiana, che non si sposassero con straniere, che i loro figli seguissero dei corsi di studio uguali a quelli dei loro coetanei rimasti in Italia ( cfr. G. Melis 1996, p. 171). Le prime conquiste coloniali, tra le tante motivazioni di carattere politico, economico, culturale, ebbero anche quella di poter trasferire l’esubero di popolazione in una colonia che fosse italiana, una realtà territoriale alla quale la madrepatria potesse trasmettere i caratteri di una seconda Italia. In questo modo non sarebbero andate perse le tradizioni, le pratiche rituali e culturali, la lingua nazionale, insomma tutto quello che contribuisce a costruire la identità nazionale. Quindi un problema di identità, ma anche un problema economico. Alcuni anni dopo, siamo attorno agli anni Trenta del Novecento, quando arrivò in colonia il secondo grande flusso migratorio dall’Italia, l’attenzione principale si rivolse alla ricchezza che gli immigrati portavano nel paese di immigrazione, sia perché più produttivi degli indigeni, sia per la promessa demografica che rappresentavano. Gli italiani arrivati in colonia portavano nuove risorse, lavoro, ricchezza, energie produttive e riproduttive (cfr. N. Federici 1938). Ecco che viene in luce l’importanza dell’elemento demografico. Il riferimento, per tutta la letteratura dell’epoca fino ai primi decenni del Novecento, è il caso degli Stati Uniti d’America, dove la popolazione europea si sostituì, letteralmente, a quella locale e relegò i pochi indigeni sopravvissuti nelle riserve; ma per il colonialismo africano la storia era certamente diversa, perché gli europei erano pochi, gli indigeni molti e rappresentavano pur sempre una riserva di manodopera a basso costo. Sappiamo poi come finì la storia del progetto di popolamento e come l’Italia perse, malamente, le sue colonie. Tuttavia il tema della identità culturale rimase in quegli anni un problema centrale, e per tutta la durata del nostro colonialismo e anche oltre, nelle colonie si continuò a respirare l’atmosfera della madrepatria. 7 4. Amministrazione coloniale e migrazioni Comunque sia, visto in questa prospettiva storica, il tema delle migrazioni degli eritrei all’interno della colonia non sembra interessare granché i colonizzatori italiani. Il problema della migrazione era soltanto, ai loro occhi, un problema di diritti, dal momento che riguardava unicamente lo spostamento di risorse umane dall’Italia verso la colonia, un problema di nazionalità quindi, di cittadinanza. I cittadini italiani erano se mai interessati a sapere se, emigrando in colonia, avrebbero perduto qualcosa dei loro diritti, del loro status di cittadini (cives optimo jure). Non era questa una preoccupazione per i sudditi coloniali indigeni che, non godendo delle qualità politiche della cittadinanza, e non appartenendo a una nazione, non creavano, dal punto di vista giuridico, alcun problema con i loro spostamenti e le loro migrazioni. La circolazione della manodopera indigena all’interno degli spazi coloniali era tuttavia un fenomeno rilevante. Tali movimenti assumevano spesso i caratteri della coercizione perché avevano per protagonisti, nella nuova veste di lavoratori salariati, quanti erano stati costretti a lasciare i propri territori in seguito alla penetrazione italiana (cfr. P. Corti 2003, p. 40). Nella Colonia Eritrea, solo agli inizi del XX secolo, come illustrerò più avanti, l’utilizzazione di questa manodopera a contratto sarà disciplinata dal decreto governatoriale del 25 marzo 1903, n. 181. In Eritrea la conquista coloniale spostò il centro della attività economica: spesso dall’interno verso la costa (Massaua), a volte invece le popolazioni si spostarono verso l’interno, quando vennero creati, quasi dal nulla, i centri del potere politico ed economico (penso ad Asmara). In generale la redistribuzione della popolazione seguì le scelte economiche dei colonizzatori. Là dove c’era bisogno di manodopera si trasferirono, in modo più o meno forzato, gli eritrei. Anche le scelte di politica fondiaria furono determinanti per le migrazioni interne: la politica demaniale di Baratieri comportò, come è noto, forti flussi migratori all’interno del paese. Tuttavia, nonostante il fenomeno fosse di assoluta evidenza, sia la politica coloniale, sia il diritto coloniale, lo relegarono a pratica amministrativa. Di esso si occupò l’amministrazione coloniale quando divise la colonia in regioni il più possibile omogenee, per territorio, ma soprattutto per popolazione (cfr. I. Rosoni 2006). Anche i funzionari coloniali (Commissari Regionali) lo presero in esame quando stilarono, come prevedevano gli ordinamenti amministrativi della colonia, i censimenti biennali delle popolazioni. Ancora, divenne oggetto di studio da parte degli antropologi e degli etnografi. L’etiopista Carlo 8 Conti Rossini, definì l’Abissinia «un museo di popoli» (C. Conti Rossini 1913, p. 61 ss, e Id., 1929, p. 20). E certamente se ne occuparono i geografi quando stesero le loro relazioni sulle popolazioni delle terre conquistate (cfr. O. Marinelli 1913, pp. 45 ss.). L’amministrazione coloniale, con l’ art. 293 del Regolamento per i Commissari regionali e Residenti (Decreto governatoriale del 30 maggio 1903, n. 213), disciplinò in qualche modo la migrazione interna, quando stabilì che, previo nullaosta dei commissari regionali, l’autorità di P.S. avrebbe dovuto accordare agli eritrei i fogli di via per gli spostamenti all’interno della colonia. Lo stesso articolo prescriveva che agli indigeni non potessero essere rilasciati passaporti. (Il passaporto garantiva una possibilità di spostamento permanente, il foglio di via una possibilità di spostamento temporaneo e contingente). L’amministrazione coloniale si occupò delle migrazioni anche quando affrontò il problema della tratta degli schiavi. La Colona Eritrea, dove evidentemente non esisteva la schiavitù, era però attraversata dalle carovane di merci e schiavi dirette ai mercati del Darfur. Ma anche dalle coste, soprattutto quelle della Dancalia, i mercanti di schiavi imbarcavano la loro merce per l’Arabia. La diffusione del fenomeno, ancora nella seconda metà dell’800, è testimoniata dal famoso viaggiatore svizzero Werner Munzinger che negli Studi sull’Africa Orientale, resoconto del suo viaggio in Africa al seguito della spedizione Vogel del 1861, scriveva: «Nel mio viaggio di ritorno da Gedda a Suez [gennaio 1863], il vapore che mi portava, e che apparteneva al governo egiziano, era carico di 200 schiavi, pei quali s’era pagato soltanto la metà del nolo, e che furono sbarcati a Suez senza la minima difficoltà. Alcuni egiziani ai quali io ne feci le meraviglie, mi risposero che non si poteva far loro rimprovero di questo commercio, perché, dal momento che i lavori per l’istmo di Suez toglievano gli agricoltori all’aratro, era d’uopo introdurre schiavi per sostituire le forze perdute. Neppure nel Sudan il divieto di siffatto commercio viene severamente mantenuto. Noi incontrammo sulla strada da Kartum a El Obeid molte carovane di schiavi. In El Obeid stesso se ne sarebbero potuti comprare centinaia; solamente non erano più esposti sul mercato» (cfr. W. Munzinger 1890, pp.15-16). Anche Ferdinando Martini, governatore dell’Eritrea dal 1897 al 1907, e futuro Ministro delle Colonie, ne parla il 15 febbraio del 1908, alla Camera dei deputati, poco dopo il suo rientro definitivo dall’Africa. Martini si lamentava del fatto che l’Italia, avendo aderito all’atto generale di Bruxelles per la repressione della schiavitù, atto che la obbligava e a liberare gli schiavi presenti in Eritrea e a combattere ogni forma di schiavismo, perdesse il dazio per l’attraversamento della colonia pagato dalle molte carovane che, ora, visto il pericolo di 9 perdere le merci, si guardavano bene dall’attraversare le sue frontiere: «... Della schiavitù ... orbene anche noi aboliamo la schiavitù quando si tratta di sudditi nostri, questo è giusto: ciò si può fare senza pericolo, e si fa, è stato sempre fatto. Ma io mi domando perché dobbiamo esser noi obbligati ad abolire la schiavitù anche per i sudditi degli altri, per quelli di Menelik ad esempio? Perché questo accade: un carovaniere viene da Jeggiu, dai Vollo Galla, da Goggiam, porta con sé pelli, zibetto, miele ed altre mercanzie e naturalmente vengono con lui tre, quattro, cinque schiavi: questi arrivati in Colonia, domandano di essere liberati; naturalmente si liberano per essere fedeli all’atto di Bruxelles, ed anche perché se non si liberassero, della negata liberazione giungerebbe notizia in Italia, e alcuni giornali non tarderebbero a dar taccia al Governatore di barbaro e di negriero. Gli schiavi dunque si liberano, ma il carovaniere, che, in questo modo, perde più di quello che non ha guadagnato con le sue merci, in Colonia non torna più, e prende altre vie, va in altri mercati dove l’osservanza dell’atto di Bruxelles è molto meno rigida; perché in sostanza questo è il vero: questa abolizione della schiavitù, a cui si dà il pomposo nome di vanto umanitario, non è che una insidia internazionale» (cfr. F. Martini 1908, pp. 320-321). Anche nella Relazione sulla Colonia Eritrea per gli anni 1902-7, troviamo testimonianza, per gli anni che vanno dal 1903 al 1906, di 235 casi di schiavi fuggiti dalle regioni circostanti, dal Darfur, dall’Amara, dal Mar Rosso, che si sono messi sotto la protezione del governo coloniale e sono stati quindi liberati (cfr. F. Martini 1913b, pp. 1576 ss). Molti schiavi si rifugiavano in Eritrea ancora nel 1940. In un numero monografico degli «Annali dell’Africa Italiana» del 1940, si scrive del villaggio di Ducambia (Residenza di Barentù), nato per accogliere gli schiavi liberati fuggiti dalle regioni confinanti (cfr., Il lavoro e l’assistenza sociale, l’assistenza agli schiavi liberati, 1940, pp. 1095 ss). Infine si occuparono di migrazione i funzionari coloniali quando dovettero regolamentare il lavoro indigeno. In Eritrea, il fenomeno dei flussi migratori che da oltre Mareb e dal Mar Rosso arrivavano in colonia in cerca di lavoro è ben illustrato da Dante Odorizzi che, in un allegato alla Relazione sulla colonia Eritrea (anni 1902-1907), riferisce di circa 1.000 operai indigeni provenienti dalla costa arabica e di circa 2.400 dall’Impero etiopico (cfr. D. Odorizzi 1913 pp. 880 ss.). Tale flusso migratorio, non straordinario per le cifre messe in campo, ma sicuramente significativo per la piccola colonia italiana, indusse il governo coloniale a disciplinare il mercato del lavoro indigeno. La prima legge sulla regolamentazione della manodopera indigena è il Decreto governatoriale del 25 marzo 1903, n. 181, che regola i rapporti tra la mano d’opera 10 indigena e gli imprenditori italiani. Questa legge è solo un esempio di una legislazione che prendeva piede in tutti i paesi africani occupati dalle potenze europee. Agli inizi del secolo i governi coloniali realizzarono di dover tutelare i sudditi coloniali da una forma di lavoro che, se pur salariato e libero, ricordava molto il lavoro perpetuo degli schiavi. Regolando e disciplinando il lavoro indigeno si sarebbe contrastato lo spostamento forzato della popolazione operato dagli imprenditori europei, sia all’interno della colonia, sia all’interno dell’impero coloniale. Il compito venne assunto dalle amministrazioni coloniali che incaricarono i loro funzionari di controfirmare di volta in volta tutti i contratti di lavoro e di assicurarsi che i termini contrattuali venissero rispettati. In questo modo l’amministrazione coloniale assumeva il ruolo di arbitro, di mediatore, tra la domanda e l’offerta di lavoro. Per cultura, e per ovvi motivi politici, l’amministrazione stava dalla parte degli imprenditori ai quali era legata da vincoli non solo di “vicinanza” ma anche di forte interesse economico (basti soltanto pensare alle procedure per l’assegnazione delle concessioni e degli appalti), ma si trovava anche costretta a tutelare il lavoro degli indigeni che erano, a tutti gli effetti, sudditi delle potenze coloniali. Un esempio illuminante che riguarda le colonie portoghesi è contenuto nel romanzo dello scrittore portoghese Miguel Sousa Tavares, intitolato Equatore. Siamo a S. Tomè, agli inizi del Novecento. Nell’isola lavorava una manodopera importata dall’Angola. Si trattava di un caso di emigrazione, più o meno forzata, da una colonia all’altra dello stesso impero, e il fenomeno assomigliava molto al traffico di schiavi che fino a pochi anni prima aveva spostato la manodopera indigena dalla provincia che ne possedeva in abbondanza a quella che ne era priva. Quindi, nonostante la legge del 29 aprile 1875 avesse abolito la schiavitù in tutti i domini dell’impero, di fatto il traffico degli schiavi continuava, per opera degli imprenditori che imbarcavano lavoratori dalle coste dell’Angola e li sbarcavano sulle coste di S. Tomè. Ai lavoratori veniva sì riconosciuto un salario (spesso solo sulla carta), ma poi non li si metteva nelle condizioni di ritornare alle proprie case. Per i commentatori dell’epoca soprattutto questo ultimo dato rendeva la loro condizione di lavoro molto simile a quella dell’antica schiavitù. A tutela dei sudditi africani del Portogallo intervenne la legge del 29 gennaio 1893 che stabiliva che il contratto di lavoro durasse al massimo 5 anni, e imponeva agli imprenditori portoghesi la creazione di un fondo di rimpatrio, destinato a sopportare i costi del loro rientro nelle terre d’origine, costituito con il versamento della metà del salario dei lavoratori delle piantagioni. Per tornare al caso italiano, la legge che regolava i rapporti tra la mano d’opera indigena e gli imprenditori italiani era un decreto governatoriale e aveva quindi, a tutti gli effetti, e 11 all’interno del territorio coloniale, il valore di una legge. Tuttavia, come gran parte della legislazione italiana relativa alle colonie, era stata concepita dalla macchina amministrativa eritrea e non dal parlamento italiano. La legge non istituiva, come invece la legge portoghese, un fondo per il rimpatrio, perché l’unica altra colonia italiana, la Somalia, non esportava lavoratori in Eritrea, tuttavia dava conto di una notevole sensibilità verso la tutela del lavoro indigeno. Ne illustro brevemente il contenuto. L’art. 1 prevedeva che «Tutti gli indigeni che intendano impiegarsi come giornalieri in aziende, industrie od imprese condotte da europei od assimilati, devono munirsi di un libretto personale, che sarà rilasciato dall’autorità di pubblica sicurezza del luogo». Sul libretto, contenente i dati generali del lavoratore, le assunzioni e le cessazioni dal servizio, dovevano essere apposte dal datore di lavoro, in presenza di un’autorità italiana, tutte le annotazioni relative alla paga, ai patti del contratto di lavoro, al genere di lavoro. Il salario doveva essere determinato in misura fissa e corrisposto a periodi non maggiori di 15 giorni. A richiesta del lavoratore, la paga poteva essere parzialmente corrisposta anche in derrate, subordinando il prezzo di queste al controllo dell’autorità (art. 2). L’art. 3 prevedeva che le giornate di lavoro, i pagamenti, le somministrazioni eseguite in corso d’opera fossero chiaramente registrate sul libretto, a cura del datore di lavoro, e da lui controfirmate. L’operaio doveva esibire giornalmente il libretto. Le false annotazioni erano punite a norma del titolo VI, libro 2° del Codice Penale (Delitti contro la fede pubblica). L’imprenditore che ometteva di eseguire le annotazioni prescritte era punito a norma dell’art. 434 del Codice Penale (Contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico: rifiuto di obbedienza all’autorità) e cioè con l’arresto sino a un mese oppure un’ammenda da 20 a 300 lire. L’operaio poteva presentare reclamo all’autorità coloniale solo se munito di regolare libretto di lavoro. Poi l’art. 5 vietava ai giornalieri indigeni, salvo gravi motivi, di abbandonare il lavoro senza darne preavviso di almeno una settimana. I giornalieri potevano però abbandonare in qualunque momento il lavoro se l’imprenditore si fosse rifiutato di eseguire le annotazioni sul libretto. Seguivano altri articoli, tutti più o meno conformi alla normativa del diritto del lavoro dell’epoca, infine, di una certa rilevanza, l’art. 8 che prevedeva che «gli imprenditori europei o assimilati i quali nei loro rapporti con operai indigeni diano prova di malafede o si rendano colpevoli di maltrattamenti od abusi, saranno esclusi dagli appalti e dai cottimi per opere e forniture pubbliche, e nei casi più gravi, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi, saranno espulsi dalla Colonia, a sensi dell’art. 39 del regio decreto 8 dicembre 1892 12 sull’ordinamento della pubblica sicurezza in Eritrea» ( cfr. Decreto governatoriale 25 marzo 1903, n. 181). Complessivamente si trattò di una buona legge, lo possiamo affermare con certezza se non altro perché non ebbe una buona accoglienza da parte degli imprenditori italiani che la trovarono vessatoria per la dignità e i diritti dei coloni. Tuttavia, nel panorama europeo, la legislazione inglese, peraltro di tre anni più tarda, risultava molto più favorevole nei confronti dei lavoratori, e di conseguenza più severa nei confronti dei datori di lavoro. Infatti l’Ordinanza del Governo dell’Africa orientale britannica del 1906, oltre a creare apposite sanzioni penali (la legge italiana faceva invece riferimento alle leggi comuni del Regno), si attardava a regolare, in favore dei lavoratori, alcune condizioni contrattuali quali l’alloggio, la coperta della notte, la razione giornaliera di cibo, gli orari del vitto, i turni di lavoro ecc. Per concludere voglio riportare una nota di colore che tradisce la ambigua sensibilità politica di molti degli italiani emigrati in colonia, che passavano con una certa disinvoltura ideologica dalla condizione di sindacalisti a quella di imprenditori. Si tratta della testimonianza di un funzionario coloniale, Dante Odorizzi, che fu commissario regionale a Massaua e poi Residente della Dancalia settentrionale. Odorizzi sottolineava in un suo scritto, le difficoltà degli imprenditori italiani a riconoscere ai lavoratori eritrei gli stessi diritti riconosciuti in patria ai lavoratori italiani: «Nei lunghi anni da che io disimpegno funzioni giudiziarie in Eritrea, non ho mai trovato che il breve e concettoso testo del decreto del 1903 sulla mano d’opera degli indigeni fosse suscettibile di lasciare al giudicante incertezze o dubbi: pur troppo le difficoltà per amministrare la giustizia in simile materia vengono spesso, più che dalla incertezza della legge coloniale, dalla riluttanza in molti assuntori di lavori ad impegnarsi dando il libretto agli indigeni, dal loro sdegno di esser chiamati da indigeni a rispondere in giudizio delle eventuali inadempienze, dalla loro pretesa di volere assoggettare l’indigeno a qualsiasi mutamento di patti contrattuali loro piaccia escogitare. E’ facile per tal modo che il Commissario giudicante noti stupore o indignazione nell’assuntore europeo nell’atto di sentirsi condannare a restituire multe indebitamente applicate o a reintegrare l’indigeno di danni per intempestivi e non giustificati licenziamenti: lo stupito o indignato sarà qualche volta uno di coloro che, nelle regioni italiane ove il lavoro ha imposto le sue leggi al capitale, hanno condotto gli operai o i contadini in tumulto a imporre la disdetta o la rinnovazione dei patti, magari già liberamente conclusi ed accettati. Come se la dignità del lavoro fosse meno considerevole 13 se invocato da uomini di una razza di pelle diversamente colorata!» (cfr. D. Odorizzi, 1913, pp. 883-4). BIBLIOGRAFIA Caniglia E. (2005), Cittadinanza e immigrazione. Europa e USA a confronto, in «Queste istituzioni», n. 136/137, pp. 28-49. Catellani E.L., (1885), Le colonie e la conferenza di Berlino, Torino, UTET. Conti Rossini C., (1913), Schizzo etnico e storico delle popolazioni eritree, in Martini F.(a cura di), L’Eritrea economica: prima serie di conferenze tenute in Firenze sotto gli auspici della società di Studi Geografici e Coloniali, Novara, De Agostini. Conti Rossini C., (1929), L’Abissinia, P. Cremonese ed., Roma. Corti P., (2003), Storia delle migrazioni internazionali, Bari, Laterza. Decreto governatoriale (25 marzo 1903, n. 181), che regola i rapporti tra la mano d’opera indigena e gli imprenditori, in Mori A. (1914-1915), Manuale di legislazione della Colonia Eritrea, (Pubblicato a cura del Ministero delle colonie), 8 voll. Roma, L’Universale imprimerie polyglotte, 1914-1915, vol. IV, pp. 1062 ss. Decreto governatoriale (30 maggio 1903, n. 213), Regolamento per i Commissari regionali e Residenti, in Mori A., Manuale di legislazione della Colonia Eritrea, (Pubblicato a cura del Ministero delle colonie), 8 voll. Roma, L’Universale imprimerie polyglotte, 1914-1915, vol. V, pp. 14 ss. Federici N., (1938), Le correnti migratorie e le correnti commerciali tra Colonie e MadrePatria, in Annali dell’Africa Italiana, anno I, vol. I, 9 maggio 1938, pp. 37-51. Habermas J., (1982), Stato, diritto, cittadinanza, Torino, Einaudi. Il lavoro e l’assistenza sociale, l’assistenza agli schiavi liberati, (1940), in «Annali dell’Africa Italiana», anno III, vol. II, pp. 1095 ss. Marinelli O., (1913), Uno sguardo geografico all’Eritrea, in Martini F. (a cura di), L’Eritrea economica: prima serie di conferenze tenute in Firenze sotto gli auspici della società di Studi Geografici e Coloniali, Novara, De Agostini, 1913. 14 Martini F., (1908), Discorso tenuto alla Camera dei Deputati il 15 febbraio 1908, in Paoli R., Nella Colonia Eritrea, studi e viaggi. Con in fine il discorso di Ferdinando Martini tenuto alla Camera dei Deputati il 15 febbraio 1908, Milano, Fratelli Treves, 1908. Martini F. (a cura di) (1913a), L’Eritrea economica: prima serie di conferenze tenute in Firenze sotto gli auspici della società di Studi Geografici e Coloniali, Novara, De Agostini. Martini F., (1913b), Relazione sulla Colonia Eritrea del Regio Commissario civile Ferdinando Martini per gli esercizi 1902-907 presentata dal ministro delle colonie (Bertolini) nella seduta del 14 giugno 1913, in A.P., Camera, legislatura XXIII, sessione 1909-13, 4 voll., Roma, Tip. della Camera dei deputati, Vol III, Allegato 101 intitolato Azione antischiavista, pp. 1576 ss. Melis G., (1996), Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993), Bologna, Il Mulino. Mori A. (1914-1915), Manuale di legislazione della Colonia Eritrea, (Pubblicato a cura del Ministero delle colonie), 8 voll. Roma, L’Universale imprimerie polyglotte. Munzinger W., (1890), Studi sull’Africa Orientale, Voghera Carlo ed., Roma. Odorizzi D., (1913), Mano d’opera indigena, in Martini F., Relazione sulla Colonia Eritrea del Regio Commissario civile Ferdinando Martini per gli esercizi 1902-907, presentata dal ministro delle colonie (Bertolini) nella seduta del 14 giugno 1913, in A.P., Camera, legislatura XXIII, sessione 1909-13, 4 voll., Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1913. Vol II, allegato n. 43, pp. 880 ss. Ordinanza del Governo dell’Africa orientale britannica (1906), in Odorizzi D., (1913), Mano d’opera indigena, in Martini F., Relazione sulla Colonia Eritrea del Regio Commissario civile Ferdinando Martini per gli esercizi 1902-907, presentata dal ministro delle colonie (Bertolini) nella seduta del 14 giugno 1913, in A.P., Camera, legislatura XXIII, sessione 1909-13, 4 voll., Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1913. Vol II, allegato n. 43, pp. 884 ss. Ricca S., (1990), Migrations internationales en Afrique: Aspects légaux et administratifs, Paris, L’Harmattan. Rosoni I., (2006), La Colonia Eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana (18801912), Macerata, EUM. Sousa Tavares M., (2006), Equatore, Roma, Il cavallo di ferro. 15
Scarica