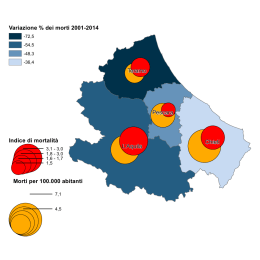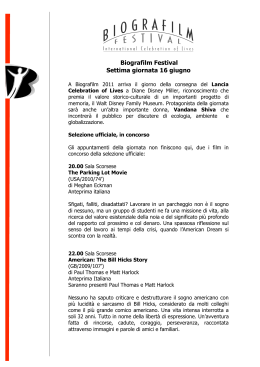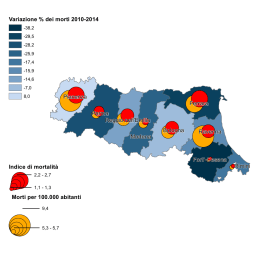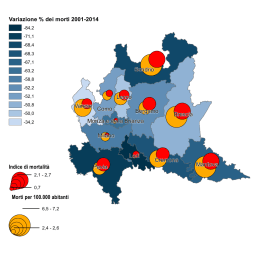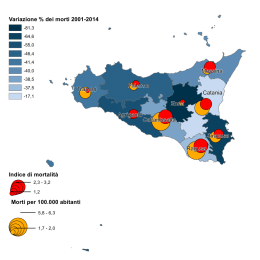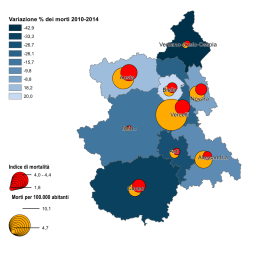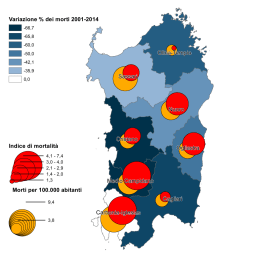23 Febbraio 2003 n. 7 10 Domenica SPETTACOLI il nostro tempo CINEMA/1 Il kolossal di Scorsese sulle radici violente della città «Gangs of New York» capolavoro a metà A sinistra, Leonardo Di Caprio e Cameron Diaz in «Gangs of New York» di Martin Scorsese. Sotto, una scena di battaglia fra le due fazioni rivali che si spartiscono il territorio e, a destra, Daniel Day-Lewis. In alto, ancora Di Caprio in «Prova a prendermi» CINEMA/2 «Prova a prendermi» truffa all’America PAOLO PERRONE Scomposto. Disequilibrato. Violento. Eccessivo. Ipertrofico. Eppure, anche se solo a tratti, memorabile. Sono i primi aggettivi che vengono in mente al termine della proiezione di «Gangs of New York», il film di Martin Scorsese interpretato da Leonardo Di Caprio, Daniel Day-Lewis e Cameron Diaz, costato 100 milioni di dollari, girato interamente a Cinecittà in sei mesi di riprese, più volte annunciato sugli schermi e più volte rimandato, per via di presunti contrasti fra il regista americano e la Miramax, la casa di produzione dei fratelli Weinstein, e per la ferita ancora aperta dell’attentato alle Twin Towers dell’11 settembre 2001. Una ferita, per nulla rimarginata, sulla quale non sembrava davvero opportuno gettarci subito sopra il sale urticante di una pellicola aspra, cruenta, accusatoria, intenzionata a scoprire le luride radici di una città dai mille volti e dalle mille zone d’ombra. La vera anima di New York, per Scorsese, non nasce solo dal sangue e dal sudore di razze diverse, approdate nel Nuovo Mondo dal Vecchio continente, ma anche e soprattutto dalla corruzione, dal predominio della legge del più forte sulla legge della democrazia ancora traballante e traditrice di metà Ottocento. A Manhattan, infatti, nel 1846 le bande rivali dei Nativi (protestanti, sbar- LIBRI Franco Montini (a cura di) IL CINEMA ITALIANO DEL TERZO MILLENNIO Torino, 2002, Lindau pp. 287, 19,50 euro Eppur si muove. E negli ultimi due anni, anche velocemente. La conferma arriva dal successo di «Ricordati di me», il nuovo film di Gabriele Muccino fresco campione d’incassi. Così come, in precedenza, da «La stanza del figlio», «I cento passi», «Le fate ignoranti», «L’ultimo bacio», «Casomai» e, ancora prima, «Pane e tulipani». Il nuovo cinema italiano, dopo anni di diffidenza reciproca, è riuscito a ricreare un rapporto privilegiato con il proprio pubblico. Alla sua “rinascita” e al ritorno d’interesse nei suoi confronti è dedicato questo accurato volume, che, articolato nei capitoli «I registi», «Gli attori», «Gli sceneggiatori», «I produttori», «I tecnici», «La critica», «Gli esordi» (con le schede di una quarantina di opere prime), mette efficacemente a fuoco gli elementi di novità e di ricambio generazionale avvenuti un po’ in tutti i comparti produttivi della settima arte made in Italy. a cura di Paolo Perrone cati nel XVII secolo) e degli immigrati irlandesi (i Conigli morti, comunità cattolica che vive sottoterra) si scontrano al Five Points, la piazza in cui convergono le cinque principali strade della città. A trascinare le due opposte fazioni, da una parte c’è William Cutting (DayLewis), detto Bill il Macellaio, dall’altra c’è padre Vallon (Liam Neeson). La lotta per il predominio territoriale è corpo a corpo, spada contro spada. Asce, bastoni, pugni. Senza pistole. Senza fucili. Padre Vallon viene ucciso dal Macellaio sotto gli occhi del figlio, Amsterdam (Di Caprio). Il bimbo trascorre sedici anni nel riformatorio di Hellgate, e quando esce giura a se stesso di vendicare la morte del padre. Incontra tramite amici irlandesi il Macellaio, che nel frattempo è diventato il leader indiscusso del quartiere con la complicità della polizia e del capo del partito democratico, ne conquista la fiducia, camuffando la sua vera identità, e ne diviene il bracco destro, innamorandosi a sua volta di una delle sue donne, la ladra e prostituta Jenny (Cameron Diaz). «Gangs of New York», pur raccontando una storia individuale, è un film corale sulla nascita di una nazione. «L’America è nata nelle strade», recita lo slogan scelto per lanciare il film. E infatti «Gangs of New York» è un ritratto dal basso, una discesa negli inferi delle classi sociali più umili, un romanzo epico, un affresco storico, una pagina bianca su cui motivi religiosi, profili etnici, risvolti politici e rimandi culturali si compenetrano senza sosta. Tratto dal libro omonimo del giornalista Herbert Asbury, pubblicato per la prima volta nel 1927, ambientato durante la Guerra di secessione fra Nord e Sud, nell’epoca in cui il governo federale del presidente Lincoln promulgò la legge di coscrizione obbligatoria, scatenando la rivolta dei diseredati e degli immigrati, non solo irlandesi ma anche olandesi, FICTION tedeschi, polacchi, russi, il kolossal nasce da un’idea che Scorsese aveva cullato fin dal 1970 e tenuto in un cassetto, pazientemente, per trent’anni. Ricondotta, una volta approdata nelle sale, dalle quattro ore originarie di durata alle due ore e quarantacinque minuti conclusive, imposte, a quanto pare, dalla produzione, la pellicola del regista di «Taxi Driver», «Toro scatenato» e «Casinò» vive di momenti di splendido cinema ma manca, nel complesso, di coesione, scioltezza narrativa e autentico fascino. Ogni inquadratura, in «Gangs of New York», è densa di folla, tumulti, arredi, oggetti, ogni immagine odora di legno, sigari e stoffe, ogni sequenza trasuda umidità balorda, odio insaziabile, astuzie fatali, vendette implacabili. Questa ricchezza di messa in scena, che trova nella straordinaria ricostruzione scenografica di Dante Ferretti il vero polmone di tutto il film, si rivela, però, paradossalmente, il suo stesso limite. Anziché limitarsi ad avvolgere le vicende narrate, l’imponente predominanza scenografica si erge, in effetti, ad assoluta protagonista, collocandosi in primo piano, abbagliando lo sguardo, invadendo ogni fotogramma. E così, se la cornice in cui si muovono i personaggi è strabordante di suggestioni, l’approccio vicendevole fra gli stessi protagonisti non ne possiede affatto l’identica pregnanza, con Di Caprio, scialbo snodo nevralgico della vicenda, surclassato da un Day-Lewis dall’energia folgorante. Cappello a cilindro sulla testa, un occhio di vetro, un paio di baffoni neri all’insù, un vasto repertorio di coltelli pronti ad essere scagliati a raffica e a conficcarsi ovunque, nelle carni del proprio nemico o sul legno di una parete: proprio la contradditoria figura di Bill il Macellaio, criminale generoso e assassino fraterno, impersonata dall’attore inglese con stupefacente determinazione e inusitata ferocia, prende il sopravvento su tutti e si trasforma nel polo d’identifica- ANNA ABBATE E’ zione obbligatorio per il pubblico in sala. La veemenza magnetica davvero rara con cui Day-Lewis affronta il ruolo del padre-padrone del Five Points impoverisce, di riflesso, l’ambigua relazione che il giovane Amsterdan intrattiene con lui. Una relazione tutta giocata, in sede di sceneggiatura, sull’attrazione carismatica del Macellaio (e fin lì ci siamo) ma sostenuta, sottotraccia, da una carica vendicativa altrettanto indomabile (che qui, invece, non riesce ad affiorare). A parte una splendida sequenza in cui il Macellaio si confessa, quasi in punta di lacrime, al suo allievo, il rapporto fra i due, su cui dovrebbe articolarsi tutto «Gangs of New York», resta sostanzialmente inerte e inespresso. Il padre che non è mai stato e il figlio che non sarebbe mai voluto essere, dunque, ci sono solo a intermittenza, e il loro rapporto, che dovrebbe grondare attrazione e repulsione, senso di protezione e impulso omicida, raggiunge una certa familiarità ma non riesce a sfondare il muro dell’estraneità, restando a galleggiare in superficie. Un peccato. Non solo perché sminuisce la ben nota abilità di Scorsese nel contrapporre magistralmente ogni polarità umana, ma anche perché sciupa, così, un sontuoso décor da kolossal d’altri tempi e alcune scelte registiche come al solito di prim’ordine. Certo, l’ingresso nella New York del 1846 attraverso una porta presa a calci, che immette subito nel cuore della storia partendo dai bassifondi catacombali in cui vivono i Conigli morti, resterà a lungo nella memoria. Così come l’effervescente sequenza del lancio di coltelli alla Pagoda cinese, con Jenny vittima sacrificale della perizia balistica del Macellaio, è orchestrata da Scorsese con perfetta progressione emotiva, al pari della mezz’ora finale del film, con il calco- «Mai morti» e la Decima Mas grande affermazione di civiltà ERIKA MONFORTE In certi momenti si ha la sensazione che un film, un libro o uno spettacolo giungano assolutamente necessari, che rappresentino una precisa risposta al preoccupante diffondersi di sentimenti, movimenti, atteggiamenti culturali che esaltano le pulsioni più violente della natura umana. È il caso del monologo teatrale «Mai morti», scritto e diretto da Renato Sarti, in scena dal 12 al 15 febbraio al Teatro Garybaldi di Settimo Torinese. Destato da immagini di folla (i funerali per i morti di Piazza Fontana), in una notte contemporanea, un uomo rievoca con fanatico rimpianto la sua storia di militante della formazione fascista tristemente nota come Decima Mas. Le parole che seguono, i dati (soprattutto numeri di morti, elenchi di sevi- Protagonista Sergio Castellitto Quasi sette milioni e mezzo di spettatori hanno seguito la fiction «Ferrari» andata in onda su Canale5. Un risultato ottimo, tenendo conto delle scelte coraggiose degli sceneggiatori Carlo Carlei (che ha firmato anche la regia), Mario Falcone e Massimo De Rita. Il film, infatti, non si è limitato a una ricostruzione agiografica del più celebre costruttore d’auto del mondo, anzi sovente ha fatto passare in secondo piano le vicende professionali per mettere in luce l’uomo e la sua sfera privata. Proprio questo punto di vista, assai raro in analoghe produzioni televisive, aveva convinto la famiglia del costruttore a dare il beneplacito alle riprese, dopo aver rifiutato per anni le proposte dei più svariati registi (tra i quali Sidney Pollack). Una decisione, quella degli eredi, che deve essere stata assai sofferta: se la vita “sportiva” di Enzo Ferrari appare trionfale, la vicenda umana è segnata da una serie di lutti precoci (il padre, il fratello durante la Grande guerra e il figlio Dino affetto da distrofia muscolare) e dalle tormentate vicende matrimoniali che sfociano nella relazione extraconiugale con Lina Lardi e la conseguente nascita del figlio Piero. Il film non ha cercato di nascondere questi aspetti intimi e complessi. Anzi, ognuno di essi compare come controcanto, quasi a sottolineare il sacrificio che ogni tappa della fortunata carriera dell’eroe (tale fu in effetti nel suo campo) ha richiesto all’uomo e chi gli stava attorno. Sergio Castellitto, dietro gli occhiali scuri di Enzo Ferrari, si è rivelato ancora una volta l’attore più versatile e completo della fiction nostrana, superando con abilità la difficile interpretazione di un personaggio assai riservato che difficilmente lasciava trasparire le proprie emozioni («se un uomo non esprime emozioni, non significa che non ne ha», diceva Ferrari-Castellitto). Un uomo combattuto, che solo alla fine del film, incalzato da un misterioso cambiata la metropoli, fino alle due Torri Gemelle svettanti nella skyline più famosa del mondo, «Gangs of New York» risente di brusche compattazioni temporali, inevitabile residuo dei tanti metri di pellicola finiti nel cestino in sala di montaggio. E pur nel suo sguardo impietoso, temerario e solenne, resta un capolavoro mancato. C’era una volta in America, ci dice Scorsese. Ma quel che c’era, a metà Ottocento, puzzava pestilenzialmente di marcio e colorava, tragicamente, di rosso. Lo spettacolo interpretato da un ottimo Bebo Storti TEATRO Enzo Ferrari e la sua vita: l’uomo al posto del mito STEFANO FRASSETTO lato spostamento d’interesse dal duello fra il cattivo maestro e il giovane rampollo alla guerriglia civile che insanguina la città (con le aggressioni razziste, gli incendi in tutti i quartieri e l’intervento dell’esercito). Ma al di là delle lame fatte vibrare in aria o sferrate a un millimetro dalla gola, dell’emblematica dissolvenza che stringe in un pugno dalle cinque dita le cinque arterie del Five Points, o dell’immagine conclusiva che in rapida sequenza mostra, nei decenni successivi, come è TUTTO VERO. Frank W. Abagnale Jr. è realmente esistito, anzi vive tuttora felicemente nella sua patria, gli Stati Uniti. La sua storia rocambolesca è raccontata in «Prova a prendermi», l’ultimo film di Steven Spielberg, interpretato dal divo hollywoodiano del momento, Leonardo Di Caprio, protagonista anche di «Gangs of New York» di Martin Scorsese. Tratto dall’omonima autobiografia (il best-seller americano è edito in Italia da Piemme col titolo «Prendimi… se puoi!»), il film, campione di incassi in queste settimane, racconta come un ragazzino di soli sedici anni abbia potuto diventare, nel giro di pochissimi anni, il più gio- Sergio Castellitto in «Ferrari» e inquietante intervistatore (quasi un fantasma del passato dickensiano) confesserà che «il più grande trionfo non vale un unghia di un uomo». Un’affermazione tesa più a convincere se stesso che l’interlocutore. Oltre agli interpreti, «Ferrari» si è dimostrata una fiction di qualità nella regia e nella fotografia. Alcune riprese “a volo d’uccello” delle campagne emiliane al tramonto, tagliate in due dal bolide rosso, sono piccoli gioielli che meriterebbero uno schermo più grande del ventun pollici. zie) procedono lungo un filo di memoria che parte dall’occasione mancata di rendere l’Italia, attraverso la strategia della tensione e il “Golpe Borghese” (il capo indiscusso di quella X Mas), un regime di colonnelli come la Grecia; il filo viene poi srotolato per tornare alle “gloriose” imprese d’Etiopia (il vergognoso uso di gas tossici sulle popolazioni civili e i massacri spaventosi, come l’eccidio della comunità copta di Debrà Libanos) per giungere a sciorinare, come in un rosario di morte e di violenza, le gesta degli “eroi” della Decima Mas (di cui «Mai morti» era il nome di uno dei più spietati battaglioni). Il tutto reso ancor più inquietante dalla convinzione della possibilità di una rinascita, di un ritorno all’attività, certificato da piccoli e grandi eventi: dal “passaggio” in televisione, in un pomeriggio di inizio 2002, dell’inno della “banda”, con tanto di pubblico stolidamente plaudente, agli episodi di violenza e repressione del G8 di Genova, in un clima di revisionismo generale, la cui diffusa superficialità fa perdere le coordinate della storia e della memoria. Quella che si alza dal letto in cui dorme il carnefice “mai morto”, interpretato da un ottimo Bebo Storti, non è allora solo la figura di un uomo spietato e inseguito dai suoi fantasmi, ma è la vera e propria immagine di una memoria nuda, che cerca di rivestirsi. Ma la memoria nuda si riveste in due modi: quello ideologico, simboleggiato in scena dalla lenta vestizione di un’uniforme fascista, e quello storico, che ricopre di dati certi, sconvolgenti, indiscutibili, il corpo del passato, e lo erge in tutta la sua fisicità contro l’odierna e diffusa voglia di liquidare con un’assoluzione totale (simile a quella accordata dai tribunali subito dopo la guerra) una parte pesante della nostra Bebo Storti, protagonista del monologo teatrale «Mai morti» storia recente. Tra le altre peculiarità di questo testo di Renato Sarti, già autore di un importante monologo ispirato alle vicende della Risiera di San Sabba, lager nazifascista tutto italiano, vi è la capacità di porre in evidenza, con ironia non forzata, alcune gravi contraddizioni di una certa ideologia oggi sempre più tollerata. «Patriota», si definisce il carnefice, mentre tortura, al servizio dei tedeschi, i partigiani italiani; «Dio, Patria e Famiglia» sono i punti cardinali del suo agire, salvo poi vantarsi di un numero impressionante di preti seviziati e massacrati e affermare con tracotanza: «Siamo pronti ad uccidere la nostra stessa madre e ad inchiodare Cristo ad una seconda croce». Il nostalgico, e per certi versi patetico reduce di Salò, non farebbe più di tanta paura se non sapessimo quanti adolescenti, in ogni parte d’Europa, esaltando i fasti del Ventennio, sostengono con invasata convinzione idee xenofobe, maschiliste, e nazionaliste, e se non avessimo visto i diari di tanti studenti, anche liceali, decorati da svastiche, fiamme tricolori e “santini” di Hitler e Mussolini. Ecco allora perché il lavoro di Sarti, che ha su- scitato ovvie polemiche e contestazioni di neofascisti, va lodato non tanto come atto politico, ma soprattutto come vibrante affermazione di civiltà. MILANO Una mostra di fumetti e dischi Per tutti gli appassionati torna a Milano «Fumettopoli». L’1 e 2 marzo, presso l’Hotel Executive (viale Sturzo 45) si svolgerà dalle 10 alle 20 la nona edizione della mostra mercato dedicata a fumetti, libri, film, colonne sonore, Cd, Dvd e gadgets, tutti di argomento fumettistico, oltre ai dischi di vinile, non solo riguardanti gli eroi di carta ma anche di idoli pop e rock dagli anni Cinquanta a oggi. Saranno allestiti un centinaio di stand per un’autentica full immersion nel mondo della fantasia. I visitatori riceveranno in omaggio un albo speciale inedito, creato appositamente per la manifestazione. Per informazioni: www.fumettopoli.com. vane e astuto truffatore d’America: sembra incredibile, ma a diciannove anni Frank aveva già rubato ben quattro milioni di dollari. Siamo negli anni Sessanta. Frank fugge di casa il giorno del divorzio dei suoi genitori. In tasca ha solo un libretto di assegni scoperto. Nient’altro. Molto in fretta scopre che riesce a sopravvivere usando il suo fascino, la sua intelligenza e le sue qualità camaleontiche: inizia la sua carriera di truffatore falsificando assegni che incassa distraendo l’attenzione di giovani e ingenue cassiere con imprevisti e svariati inviti a cena. In più non lascia tracce evidenti dietro di sé perché, appena ottenuti i contanti, se ne va in un altro stato, possibilmente sulla costa opposta: travestito da pilota della Pan Am attraversa più volte l’America da Est a Ovest e viceversa: difficile stargli dietro. Ma i travestimenti di Frank/Leonardo non finiscono qui: si finge, e sempre con successo, professore, agente segreto, medico, avvocato, senza destare mai alcun sospetto. Come fa? Da chi impara? Guarda la televisione: la sua facoltà di medicina sono i telefilm del «Dr. Kildare», quella di giurisprudenza le imprese forensi a puntate di «Perry Mason»… Tutto fila liscio, finché sulle sue tracce si mette un ostinato agente dell’Fbi addetto alle frodi fiscali e alle falsificazioni, che lo insegue con accidiosa ossessione da un capo all’altro del continente: è Carl Hanratty, interpretato con grande padronanza dal sempre più bravo Tom Hanks, che, vestito alla «Blues Brother», presta la sua faccia qualsiasi a un personaggio più sfaccettato e complesso delle apparenze. Il poliziotto è il contrario di Frank: onesto e niente affatto disinvolto, anzi molto impacciato, ma dotato di una ferrea volontà e di una rigorosa intelligenza. Si metterà sulle sue tracce senza dargli tregua. Tra i due nascerà, come spesso accade, un profondo senso di rispetto e ammirazione reciproca (e forse anche ciascuno per l’altro finirà per rappresentare una specie di famiglia), che li condurrà verso il lieto fine, che si impegna a dare concretezza alle speranze dello spettatore, che in un empito di simpatia per entrambi non vuole né vincitori né vinti. Dopo il dittico “futuribile” di «A.I.» e «Minority Report», con «Prova a prendermi» Spielberg mette in scena uno dei film minori della sua vasta filmografia: tutto ciò non toglie nulla al film, che peraltro è una commedia godibilissima, sostenuta da un buon ritmo dall’inizio alla fine, interpretata alla perfezione da due superstar come Leonardo Di Caprio e Tom Hanks, che si confermano fra gli attori più ispirati ed eclettici del panorama internazionale. Infine, una menzione speciale va anche a Christopher Walken, nella parte del padre di Frank: un personaggio di evasore fiscale spiritoso e malinconico, un eterno perdente sfortunato vittima dei suoi stessi imbrogli, che l’attore interpreta con grande profondità.
Scaricare