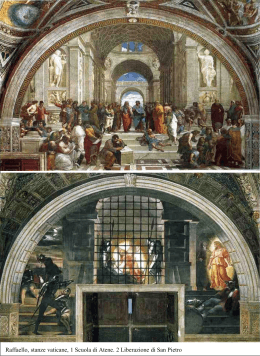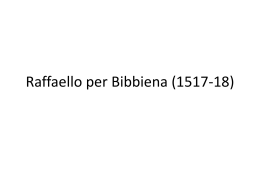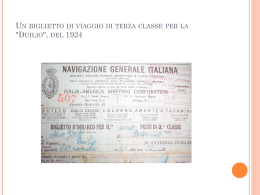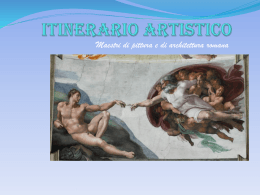Raffaello Baldini Giovanni Giovannetti / Effigie Lo sguardo nell’infinito di Franco Loi E ra il settembre del 1977, quando a casa di Dante Isella a Casciago, subito dopo il pranzo, Vittorio Sereni disse al nostro ospite: “Prendi un po’ quel libro che ti ho dato da leggere, sai, di quel poeta romagnolo…”. Dante Isella poco dopo tornò con E’ solitèri, un libretto di Raffaello Baldini, fatto stampare da Galeati di Imola. Non ricordo se subito l’indomani o due giorni dopo telefonai e lo invitai a casa mia, in via Sambuco. C’era con me anche il pittore friulano Francesco Bierti. Così come mi avevano colpito le sue poesie, provai subito una forte simpatia per quell’uomo dagli occhi intelligenti, che sembrava sempre schermirsi, tuttavia per niente remissivo, mentre sul suo volto d’avorio passavano lampi d’ironia. Pochi mesi dopo, nell’agosto del ’78, scrissi per il “Corriere d’Informazione” un articolo sul suo libro. Diventammo grandi amici. Raffaello era uno di quegli uomini per i qua- li la conversazione è quasi un rito. Credo che soltanto nei racconti di Maupassant o di Čechov si possa leggere di gente che attorno a un tavolo si scambia idee, impressioni, racconta. Di solito in Italia si parla tutti assieme o si discute. Raffaello era un amabile conversatore. Due erano gli argomenti preferiti: l’arte e la musica. E la musica riempiva le sue giornate solitarie o lo vedeva assiduo frequentatore della Scala. Non si parlava mai di poesia. Soltanto una volta, quando nell’82 andai a passare le vacanze in Romagna, mi portò da leggere delle nuove poesie inedite e passammo un pomeriggio a leggere e commentare. Eppure non ho conosciuto nessuno che come lui sapesse trasformare la chiacchiera in poesia. Memorabili sono i suoi interminabili monologhi in cui tutte le contorsioni, i rigiri, il rimuginare, tutte le sfumature psicologiche dell’animo umano sono espresse in una ragnatela sonora che suscita nell’ascoltatore attenzione e sconcerto, drammatiche intuizioni e riso, emozioni e riflessioni. Specialmente quando lui si presentava davanti a un pubblico a leggere l’effetto di quella sequenza di parole, dette in fretta, affannate e ironiche, era travolgente. Sin dalla prima volta che ebbi l’occasione di ascoltarlo in una lettura pubblica, e penso fosse a Pavia, due cose mi sembrarono essenziali alla sua dizione: la teatralità monologante e l’arguzia. Nel suo dire, Lello, proprio mentre sembrava perdersi nel groviglio senza uscite dei suoi personaggi, nel momento in cui sembrava esibirsi sulla scena con le loro miserie, le loro meticolose, cavillose proposizioni, si allontanava e sembrava guardarci con ironia: ci si rendeva conto che lui non era travolto, ma ci guardava come per dire, con la sua usuale bonomia, che sì, si può ridere, ma non proprio del tutto. Del resto, Lello, quasi a porre un distacco tra sé e i suoi personaggi, accennava spesso alla fonte di quel profluvio di parole: il bar di suo padre sulla piazza di Santarcangelo, do13 Raffaello Baldini / Lo sguardo nell’infinito ve lui, bambino o ragazzino, si nascondeva sotto i tavoli e ascoltava le chiacchiere dei clienti, i loro racconti, le confessioni sussurrate o gridate tra una briscola e un bicchiere di vino. Ci andai con lui a vederlo quel bar, e lui ne era orgoglioso come quando mi portò a visitare la casa in campagna del Pascoli, o il Castello da cui si vede tutto il paese, le campagne vicine e le montagne verso San Marino e verso il Montefeltro. Non era solo il bar il luogo del suo ascolto. Nella poesia “Lói”, luglio, siamo “a Ciola, proprio in cima, / alla casa di Baròus, / ma di dietro, nell’ombra” e quattro paesani giocano a tressette, e a uno viene “la cricca di coppe / e tre tre senza danari” (“a Zula, própia in zéima, / ma la chèsa ad Baròus, / mo di dri, tl’òmbra”, “la crécca ad còppi / e tri tré fal denèri”). Certo, come questa, molte altre saranno state le occasioni di ascolto, i contatti con i compaesani, il rapporto intimo con la lingua. “Chiacchiere in piazza, scaracchi, sbadigli, bestemmie […] / […] le imprecazioni che ha detto Ruggero della Zoppa / quando ha perso il furgone a cocincina […] / […] / e su su fino al Poggio, era un rosario”, scrive nella Nàiva : è un paesaggio e una storia, il canzoniere di un paese e della sua gente (“zchéurs in piaza, saràc, sbadài, biastéimi […] / […] / i santéssum ch’ l’à détt Gero dla Zòpa / quant l’à pérs e’ furgòun a cocincina, / […] / e sò sò fina e’ Pózz, l’era un rusèri”). Come scrissi tanti anni fa sulla rivista “Lengua”: “Se Tonino Guerra era stato il cantore della vicenda corporea della poesia romagnola, Baldini, pur parlando ancora di corpi, entra nell’anima del suo paese: la memoria, la paura, il chiacchiericcio interiore, le stesse vicende corporee divengono soprassalti della coscienza, meditazione, panico; ciò che in Guerra si fa aforisma e traslazione, in Baldini tende al monologo, al travaglio interiore, all’attrito tra pensiero e realtà, tra bisogni di luce, e sicurezza esistenziale, e l’opacità e l’oscurità della materia”. La poesia “I nóttal”, i pipistrelli, mi 14 sembrò sin da allora simbolica, rappresentativa di tutta la poesia di Lello: c’è il timore di vivere, l’indecisione nel prendere una qualsiasi decisione, la disperata solitudine del protagonista, il senso della violenza che è nell’aria, la paura, e persino l’incomunicabilità, i problemi del linguaggio. Già l’inizio introduce nei patemi d’animo del protagonista e crea un’atmosfera di paura: “Non dovevo lasciar aperta la finestra, / adesso mi sono entrati i pipistrelli. / Volano dappertutto, fanno dei sibili, / vengono bassi, mi sfiorano la faccia” (“A n’éva da lasè vért’ la finestra, / adès u m’è éintar i nóttal. / I vòula dimpartótt, i fa di céul, / i vén da bas, i m stréssa ma la faza”). Poi è tutto un elucubrare nevrotico sulla natura dei pipistrelli, sull’impossibilità di capirli, sulla diversità del linguaggio: “Io da vicino non li ho neanche mai visti, / mi hanno sempre fatto schifo, / ma magari sbaglio io” (“Me da davséin a n gn’ò gnénca mai vést, / i m’à sémpra fat schiv, / mo magari a sbai mè”). Nemmeno la considerazione che “non sono cattivi”, “niente becco, e nemmeno le unghie”, lo tranquillizza. Come somiglia alla paura dell’uomo per gli altri uomini! L’altro visto come un nemico, un pericolo. E nella considerazione finale c’è tutta l’amara solitudine e il desiderio di farsi amare, di tentare un colloquio con gli altri uomini, eppure arrendersi alla paura: “E se gli dessi voce io? / […] / Adesso provo. / Se davvero qualcuno mi rispondesse?” (“E s’a i déss vòusa mè? / […] / Adès a próv. / Se dabón qualchedéun u m’arspundéss?”). Chi ha l’avventura di leggere le poesie di Baldini viene condotto in un mondo oggettivo, riconoscibile, gremito di personaggi come uno di quei romanzi di Balzac, le cui storie s’intersecano e ci conducono una nell’altra. Ma qui è anche come entrare nel contraddittorio e intrecciato animo d’un uomo. Non si sa mai dove comincia la storia di un personaggio e quella del suo autore, quanto davvero sia oggettivo quello scenario e quel fluire di pensieri. La verità è che l’oggettività è data da una simbiosi, identità di lingua, di luoghi, di vicende, identità di sentire. Chi ha conosciuto Raffaello sa che, come nei suoi personaggi, l’atto del parlare e del fare provocavano in lui un tergiversare, un soffermarsi sulla soglia del dire o del fare, un vero panico dell’azione. Quanto poco veniva detto di quel rumore di dubbi, di pensieri, di ritrosie e movimenti! Quasi sempre, sia che si trattasse di parlare di una malattia o di un cruccio famigliare o di una proposta o, che so, di un invito a cena o del recarsi insieme in qualche luogo, anche solo trattandosi di proferire una parola, Lello finiva spesso col dire: “Ne parleremo… Ti dirò… ti dirò…”, e questo dopo aver tergiversato, accennato, sottaciuto. Ecco perché i suoi personaggi sono così loquaci e, in fondo, così monocordi, incapaci di sintetizzare. Ogni volta si perdono nelle sfaccettature di un solo argomento. Sembra quasi che l’autore faccia dire ai suoi personaggi tutto quello che non osa o trova superfluo dire nella realtà. A me viene sempre in mente, più che per qualsiasi altro, quel che Flaubert ha detto di Madame Bovary. Questo parlarsi addosso, questo perdersi e quasi annullarsi nell’analisi delle piccole cose però nasconde qualcosa. C’è sempre l’allusione a un suo cruccio interiore, a qualcosa di profondo che sta dietro o al fondo di ogni suo monologare: si potrebbe parlare del “male di vivere” come di una indicibile speranza, di un confronto con qualcos’altro o Qualcun altro. Non si tratta di qualcosa di esplicito. La finzione, la trasposizione di persona, il gioco degli specchi è sempre attivo nelle poesie di Lello. Ma una metafora sicura la troviamo in “La sparzéina”, il refe, dove i lavoranti alludono a qualcuno, il padrone, che sta sopra di loro, che non si vede mai ma che poi giudicherà il loro fare. Si lavora male in quel laboratorio, anche perché “è un buio qui di sotto”, e ogni cosa sentiamo che si riferisce a qualcos’altro: “quel finestrino lassù in alto, / ma gli si son rotti tutti i vetri e ci hanno messo / dei gran pez- Raffaello Baldini / Lo sguardo nell’infinito lo su questo argomento. In “E’ divèri”, in “A n’e’ so” e “Mètt” e molte altre. Ma è da ogni personaggio e da ogni chiacchierata che viene un senso di sgomento, nascono delle domande. Del resto il punto di domanda è ricorrente. Sembra che i personaggi di Lello si avvolgano nei punti di domanda, e non sappiano più districarsene. In una poesia come “Scegliere”, che è corta – 27 righe – ne ho contati 18. Mi ricordo che una volta, parlando con lui, abbiamo accennato bròi piò ca nè préima”): non è così anche nella vita? Ti sembra di aver risolto un problema, e te lo ritrovi più complicato di prima. E poi la sedia che “non c’è mica da fidarsi”, e ancora quel finestrino col cartone, ma “non rimedi niente” e, soprattutto, “io penso anche a quell’altro di sopra, / che quello, vallo a capire” (“mè a péns ènca ma cl’èlt ad sòura, / che quèll, val a capéi”). Sì, non è solo, il lavorante; sta chino sui suoi gomitoli, ma sopra di lui c’è chi lo giudicherà, controllerà e darà il suo giudizio sull’operato. Il lavorante, il gomitolo, il filo, il padrone: non siamo forse noi, la nostra vita, il nostro fare, l’assillo, come scrive la Cvetaeva, di “qualcosa o Qualcuno” che chiama, che dentro di noi “vuole essere”. Ritorna molte volte la poesia di Lel- al punto interrogativo, e lui mi ha detto che il punto di domanda è come uno sguardo nell’infinito: “Guardi guardi, e non c’è mai risposta”. Teatro, ho detto fin dal principio. Lo scenario è quello di Santarcangelo. Ma può essere quello della città o paese di ciascuno di noi. Eppure i riferimenti sono precisi, i nomi delle strade, i nomi delle persone, dei fiumi, delle case, direi persino dei fiori e delle pietre. Tuttavia anche noi ci siamo aggirati in quelle contrade, conosciamo quei personaggi, sentiamo dentro di noi quello scorrere di pensieri e di dubbi, sentiamo sorgere in noi quelle domande. Siamo noi che recitiamo su quel palcoscenico, siamo noi che percorriamo le scene di quel teatro. C’è quindi una triplice mimesi: i personaggi sono, essi stes- Giovanni Giovannetti / Effigie zi di cartone” (“che finistréin, ’lasò d’in èlt, / mo u s’i è ròtt tótt i véidar e i i à mèss / di gran pézz ad cartòun”); il lavoro – “stai per sciogliere tutto un groviglio, il filo / senti che cede […] / […] / vai avanti, ma non badi a dove metti i piedi, / trascini un capo che avevi già districato, / l’ammucchi, l’imbrogli più di prima” (“t sté par sciòi tótt un patòun, e’ féil / t sint ch’e’ zéd […] / […] / t vé ’vènti, mo ta n bèd dò t mètt i pi, / t strascéin un chèv ch’ ta l’évi za svrucé, / ta l’amócc, ta l’im- si, l’autore, e siamo noi; il teatro è la loro, la sua, la nostra esistenza. Io amo in modo particolare due poesie di Lello: “E’ bagn ad nòta” e “Lói”. Forse perché mi piace il canto, e mi affascina la lirica. Ma non è questo. Io stesso sono stato teatrante e narratore. Forse perché penso siano tra le poche poesie in cui non è evidente la mimesi dell’autore, in cui le vicende e le persone le senti davvero autonome dall’autore. Una volta sono andato con Lello, sua moglie Lina, Gianni e Mafalda Fucci, a casa di Tolmino Baldassari. Forse c’erano anche Franco Brevini e il poeta Bellosi. Abbiamo parlato di tante cose al tavolo del giardino di Tolmino, e poi siamo andati a fare una passeggiata verso i ciliegi. Ho detto a Lello della mia predilezione per quelle due poesie, e lui mi ha detto che non le leggeva quasi mai. “Forse le senti più oggettive delle altre, troppo descrittive…”, ho suggerito. “Forse…”, mi ha detto, “… forse le leggo con più difficoltà…”. Era un uomo molto conviviale e nello stesso tempo l’uomo più solo che abbia frequentato. Era un piacere sedersi a mangiare con lui: mangiava di tutto, con gran gusto, ed era ghiotto di dolci. Un tempo arrivava sempre con una bottiglia di trebbiano delle sue parti. “Porca masola”, diceva, “è più buono dell’anno passato”. Una volta ero in vacanza a Sirolo, sul Conero, e lo portai nella gelateria in piazza. Lo ammiravo, io che allora pativo di stomaco, mentre gustava una grande coppa al cioccolato – di gran lunga il gusto che preferiva – ricoperta di panna. Mi viene in mente “La fira”: “Novario, dàlle un cono / a questa bambina, crema e cioccolato, / o vuoi la stracciatella?” (“Novario, dài un cono / ma sta burdèla, crema e cecolèta, / o t vu la straciatella?”). “Il gelato è di crema e cioccolato”, diceva, “se no, non è gelato”. “Come, non si può andare al Grand Hotel, io ci vado / quando mi pare, verso mezzogiorno / a prendere un aperitivo, cosa vuol dire? / è anche un bar, ottomila lire, paghi, mangi, / olive, patatine, bevi, vai in giro / col 15 Raffaello Baldini / Lo sguardo nell’infinito tuo bicchiere…”. Eppure, forse, nel Grand Hotel di Rimini Lello non c’è mai entrato. Ero andato a Rimini con Lina. Non ricordo perché, eravamo soli. Forse Lello e Silvana erano andati a far delle compere in centro. Non ricordo. So che siamo passati davanti al Grand Hotel e Lina ha detto: “Come mi piacerebbe entrare… Sai, Lello si vergogna… non mi ha mai voluto portare… Me lo faresti questo favore? Da sola non mi sono mai tentata…”. E così siamo entrati nella grande hall. Abbiamo girato un po’, fino allo scalone e nelle altre stanze, e poi siamo andati verso la spiaggia. “Credi che possa sedermi qui…?”. “Perché no… Ma figurati, possiamo fare quello che vogliamo…”. E Lina si è seduta sull’orlo di un lettino. In quel momento è passato un inserviente e le ha detto: “Ma signora, si accomodi… Aspetti che le porto dei cuscini…”. E poco dopo Lina era sdraiata e l’inserviente le ha chiesto se voleva qualcosa da bere e le ha offerto un bicchiere di champagne. Mi sono seduto vicino a lei, e per circa un quarto d’ora siamo rimasti a guardare il mare lontano. Proprio come i suoi personaggi, Lello doveva lasciar scorrere la sequenza di pensieri, di paure, di pudori, prima di decidersi a parlare o ad agire. Quella volta che venne a Sirolo, io ero andato alla spiaggia di San Michele con i ragazzi e Silvana – San Michele era allora una spiaggia proprio sotto il Conero, poco frequentata. Ci si arrivava da un sentiero scosceso, attraversando prima una boscaglia e poi tra gli arbusti e le pietre. Soltanto la sera, quando decidemmo di tornare, alla fine della salita, ci accorgemmo di Lello che ci aspettava da qualche ora. “Sai, non sapevo decidermi… poteva essere pericoloso… per via del cuore… e poi non sono pratico… poteva capitarmi qualcosa… incespicare… spinarmi… e poi il tempo poteva cambiare… io non ho nemmeno il costume… e nemmeno Lina…”. Scrive in “Un pezzo di carta”: “… ho dei momenti che mi prendono 16 delle paure, / di che? non lo so, / ho paura di tutto”. La poesia di Baldini consiste proprio nella capacità di guardarsi e non tralasciare niente, penetrare fino in fondo alla propria, che è anche l’altrui, miseria e rappresentarla nel suo esprimersi, nel suo stesso formarsi. Due poesie, a mio parere, sono riassuntive della genialità di Lello e della sua capacità di farsi interprete dell’uomo contemporaneo, “Cut”, nascondino, e “La chéursa”. In “Cut”, nel paradigma del gioco tra bambini, è tutto il significato della solitudine: “loro, / poveracci, cercano sempre, ma non mi trovano, / e li voglio vedere a trovarmi in questo buco. / Può darsi anche che abbiano perso la voglia, / che il gioco si sia smagliato, che siano andati a casa. / Peggio per loro, io sto buono fra tutte queste assi, / qui sotto non mi trova più nessuno” (“lòu, / puràz, i zirca sémpra, mo i n mu n tróva, / e a i ví vdai a truvèm dréinta sté béus. / E’ pò ès ènca ch’i apa pérs la vòia, / che e’ zugh u s séa smanè, ch’i séa ’ndè chèsa. / Pézz par lòu, mè a stagh bón tra tótt stagli asi, / aquè sòtta u n mu n tróva piò niseun”). Come si potrebbe dire meglio la volontà di nascondimento dell’uomo, la sua finzione, nei confronti di se stesso e degli altri? e, nello stesso tempo, l’intima soddisfazione del proprio star nascosto, l’orgoglio della solitudine? Nella “Chéursa”, la corsa, il paradosso della paura reciproca, il senso della violenza che passa tra gli uomini, da cui nessuno è esente: una paura e una violenza che sono dentro di noi, quanto più noi l’attribuiamo agli altri. “Mi sono corsi dietro urlando, e io non capivo, / non so se avessero il fucile, ma i coltelli, / ho visto le lame luccicare sotto i lampioni. / Andavo come un bracco e loro tutti dietro” (“I m’è chéurs dri rugénd, e mè a n capéva, / a n so s’i avéss la s-ciòpa, mo i curtéll, / ò vést al lèmi léus sòtta i lampiéun. / Andéva cmè un chèn brach e lòu tótt dri”). Ma poi: “ho visto / davanti a me tre o quattro che correvano / e guardavano indietro, mi guardavano a me. / Sul momento non ho capito, volevo dire qualcosa, / ma non mi sono trovato la voce […] / […] / Però a me mi pare che siano / quelli di prima, quelli che inseguivano me / […] / pare che abbiano paura, e io li inseguo, / ho paura anch’io, ma come devo fare? / potrei fermarmi, e se poi mi sbaglio? / se mi fermo e quelli dietro mi sono addosso?” (“ò vést / davènti mè tri quatar ch’i curéva / e i s guardéva di dri, i m guardéa mu mè. / Te préim a n’ò capéi, a i vléa dí quèl, / mo a n mu n so tróv la vòusa […] / […] / Però mè u m pèr ch’i séa / quéi ’d préima, quéi ch’i m déva dri mu mè / […] / e’ pèr ch’i apa paéura, e mè a i dagh dri, / ò paéura ènca mè, mo cm’òi da fè? / a m putrébb farmè què, e se pu a m sbai? / s’a m férm e quéi di dri i m’è madòs?”). Non potrebbe essere detta meglio l’angoscia del nostro tempo. L’uomo senza Dio è in balia degli eventi. Come diceva Ivan Karamazov, “tutto è lecito” ma tutto diviene anche paura, di sé e dell’altro, incapacità di affrontare con coraggio la vita. Il gioco del nascondimento introduce alla fuga da sé e dall’altro. Ora Raffaello ha finito la sua corsa, ha sconfitto le sue paure. Ci ha lasciati inermi come i suoi personaggi. Quando martedì pomeriggio, con Silvana e il poeta Stefano Marino, siamo andati nella camera ardente della clinica Santa Rita di Milano, ho provato quasi un conforto: non c’era più il Lello sofferente degli ultimi tempi, erano scomparse le paure, i dubbi, la maschera del dolore: davanti a me c’era un uomo sereno, finalmente acquietato, composto. L’ho guardato a lungo. Mia moglie gli ha fatto una lieve carezza, l’amico Stefano l’ha salutato. Ma io mi sono soffermato ancora. Non riuscivo a trattenere un sorriso amoroso, stavo per parlargli. Come ho già scritto altrove, e come Lello ha espresso stupendamente tante e tante volte, quando tutto sembra finito, forse, si ricomincia. C’è sempre qualcosa da dire. Anche in me affiorava la domanda. Ma questa volta la mia risposta sarebbe stata sicura. Franco Loi Raffaello Baldini / Lo sguardo nell’infinito Un susórr A n dégg e’ paradéis, ch’e’ sarébb tròp, t mór e t vé drétt in paradéis, dài, zò, u n s pò, l’è una pretàisa, e’ purgatóri, ècco, mè la m’andrébb da sgnòur, che e’ purgatóri, e’ pèr acsè, mo u n’è mégga, la zénta i cràid ch’e’ séa una sèla d’aspèt, e’ purgatóri, ta t péurgh dabón, la è gnara, u n’è l’inféran, zért, che l’inféran, burdéll, quant a i péns, s’u n’i fóss e’ purgatóri, sno paradéis e inféran, catéiv cmè ch’a sémm tótt, s’na cativeria instècca, mè dal vólti ch’a sint a déi: a l’inféran i è póch, e in paradéis, u m vén da déi, quant’èi? ancòura minch, mo pu u i è e’ paradéis? se tanto mi dà tanto, l’è mèi sté zétt, va là, ch’ s’u m sint don Primo, cumè, u n gn’è e’ paradéis? mo a géva acsè, u s fa par déi, l’è un mònd, quèst, u s vàid ad cal robi, ènca se pu u n’è, dài, a n sémm tótt di slabazír, u i è ’nch’ dla bóna zénta, ci sono anche le persone oneste, no, mè, la mi paéura, che la paéura, in fònd, l’è un pó ch’a i péns, s’ t’é paéura ad qualquèl, la paéura e’ vó déi ch’u i è qualquèl, fóss ènch’ l’inferan, l’è qualquèl, o no? ch’e’ fa paéura, mo l’è una paéura, cma s pòl déi? ècco, sè, ch’ la à un fundamént, l’è un segnèl, l’è cmè quant ma la staziòun e’ sòuna e’ campanèl, cs’èll ch’e’ vó déi e’ campanèl? che sta par arivé e’ treno, ch’u i è un treno, invíci, parchè adès la nòta a m svégg, pu a m’indurmént, pu a m svégg, e ò di mumént, mo l’è un’èlta paéura, l’è cmè quant t’un insógni t casch e ta n’aréiv mai, o ch’i t dà dri, che s’i t’aciapa, e tè, córr córr, t si sémpra alè, cl’èlta l’è una paéura ch’ t’un zért séns, la t fa ènca cumpagnéa, quèsta no, quèsta, t si da par tè, che pu l’è tentaziòun, al vén ma tótt, e l’è ’nca zchéurs ch’ ta i é sintí méll vólti, ch’i n vó di gnént, l’è tótt buséi, sno che, al tre dla nòta, che ad nòta al robi al dvénta, pu al tentaziòun, e’ dièval e’ sa fè, l’è cmè t fóss tè, cmè ch’al t’avnéss da dréinta, amo, se no che tentaziòun sarébbal? ch’u t vén in mént cla vólta, quant t’é vést l’usèri, te campsènt, un camaròun pin d’òsi, òsi purséa, una muntagna d’òsi, e alè te lèt, che ta l sé ch’u n’è vèrra, che la matéina dòp ta n’i pens piò, parchè e’ dè l’è un èlt mònd, u i è e’ sòul, l’è frèdd, capòt, capèl, scialètta, capucino sla s-ciómma, t’é d’andè ad tènt ’d chi póst, t’incòuntar un sgraziéd, ta i fé la carità, mo ad che mumént, quèll l’è un mumént, te schéur, ta i si sno tè, e u t pèr d’ sintéi ’na vòusa, éun ch’u t déi pièn, t’un susórr: u n gn’è gnénca l’inféran, u n gn’è gnént. Un sussurro. Non dico il paradiso, che sarebbe troppo, | muori e vai dritto in paradiso, dài, su, | non si può, è una pretesa, | il purgatorio, ecco, | a me mi andrebbe da signore, che il purgatorio, | pare così, | ma non è mica, la gente crede che sia | una sala d’aspetto, il purgatorio, | ti purghi davvero, è dura, || non è l’inferno, certo, | che l’inferno, ragazzi, | quando ci penso, se non ci fosse il purgatorio, | solo paradiso e inferno, | cattivi come siamo tutti, | con una cattiveria di fondo, io delle volte | che sento dire: all’inferno sono in pochi, | e in paradiso, mi viene da dire, quanti sono? | ancora meno, ma poi c’è il paradiso? | se tanto mi dà tanto, | è meglio star zitti, va’ là, che se mi sente don Primo, | come, non c’è il paradiso? ma dicevo così, | si fa per dire, è un mondo, | questo, si vedono di quelle cose, – anche se poi | non sono, dài, non siamo tutti dei delinquenti, | c’è anche della buona gente, | ci sono anche le persone oneste, | no, io, la mia paura, | che la paura, in fondo, è un po’ che ci penso, | se hai paura di qualcosa, | la paura vuol dire che c’è qualcosa, | fosse anche l’inferno, è qualcosa, o no? | che fa paura, ma è una paura, | come si può dire? ecco, sì, che ha un fondamento, | è un segnale, è come quando alla stazione | suona il campanello, cosa vuol dire | il campanello? che sta per arrivare | il treno, che c’è un treno, || invece, perché adesso la notte mi sveglio, | poi mi addormento, poi mi sveglio, e ho dei momenti, | ma è un’altra paura, è come quando | in sogno cadi e non arrivi mai, | o che t’inseguono, che se ti prendono, e tu, | corri, corri, sei sempre lì, | l’altra è una paura che, in un certo senso, | ti fa anche compagnia, questa no, | questa, sei solo, | che poi sono tentazioni, vengono a tutti, | e sono anche discorsi che li hai sentiti mille volte, | che non vogliono dir niente, sono tutte bugie, solo che, | alle tre di notte, | che di notte tutte le cose diventano, | poi le tentazioni, il diavolo ci sa fare, | è come fossi tu, come ti venissero da dentro, | e beh, se no che tentazioni sarebbero? || che ti viene in mente quella volta, quando hai visto | l’ossario, al cimitero, | un camerone pieno d’ossa, | ossa alla rinfusa, una montagna d’ossa, | e lì nel letto, che lo sai che non è vero, | che la mattina dopo non ci pensi più, | perché di giorno è un altro mondo, | c’è il sole, è freddo, cappotto, cappello, sciarpa, | cappuccino con la schiuma, devi andare, | in tanti di quei posti, incontri un disgraziato, | gli fai la carità, – ma in quel momento, | quello è un momento, al buio, ci sei solo tu, | e ti pare di sentire una voce, uno che ti dice | piano, in un sussurro: | non c’è neanche l’inferno, non c’è niente. 17 Raffaello Baldini / Lo sguardo nell’infinito Cut La chéursa A zughé a cut bsògna avài òc, ès féurb. Mè a cnòss di póst, di béus ch’a i so sno mè. Stavólta a m so masè tramèza agli asi de magazéin de lègn ad Bigudòun. A i sint ch’i zcòrr, ch’i cèma, a sbarlòc dal fiséuri, a i vèggh ch’i zéira, ch’i s’inségna se daid dò ch’i à d’andé. Mè aspétt aquè, a n mu n móv, a téngh e’ fiè. Adès u m pèr ch’i s séa un pó sluntanè, mè a stagh sémpra masèd, l’è bèla un’òura, a m’inféil t’un budèl piò strètt, acsè, fra do cadasi, a i ví fè dvantè mat. Mo dò ch’i è? a n’i sint piò, i n capéss mégga gnént, i va purséa. E’ sarà piò ’d do òuri ch’a so què, l’è da òz dopmezdè, u s fa nòta, e lòu, puràz, i zirca sémpra, mo i n mu n tróva, e a i ví vdai a truvèm dréinta sté béus. E’ pò ès ènca ch’i apa pérs la vòia, che e’ zugh u s séa smanè, ch’i séa ’ndè chèsa. Pézz par lòu, mè a stagh bón tra tótt’ stagli asi, aquè sòtta u n mu n tróva piò niseun. I m’è chéurs dri rugénd, e mè a n capéva, a n so s’i avéss la s-ciòpa, mo i curtéll, ò vést al lèmi léus sòtta i lampiéun. Andéva cmè un chèn brach e lòu tótt dri, ò travarsè la piaza, pu a m so bótt te Baròun, mo dop la pòumpa a so tòuran pr’e’ Ciód e a m so infilé ti pórtich fina Tiglio dal smanzài, ò imbòcch e’ lavadéur, ò pas la Méura, da la Zóppa a so vnú sò ma la Costa, pu tla Bósca, a so sèlt dréinta un curtéil, ò fat du rèm ad schèli, a so vnú fura vsina la Massèni, a so chéurs vérs la Roca, me crusèri ò ciap d’inzò vérs e’ Pòzz Lòngh, e ò vést davènti mè tri quatar ch’i curéva e i s guardéva di dri, i m guardéa mu mè. Te préim a n’ò capéi, a i vléa dí quèl, mo a n mu n so tróv la vòusa, a n’arivéva a ’rscód e’ fiè. Però mè u m pèr ch’i séa quéi ’d préima, quéi ch’i m déva dri mu mè, éun e’ va un puchìn zòp, un èlt l’à un brètt ch’a m l’arcórd, mo i córr véa, i n sta a sintéi, e’ pèr ch’i apa paéura, e mè a i dagh dri, ò paéura ènca mè, mo cm’òi da fè? a m putrébb farmè què, e se pu a m sbai? s’a m férm e quéi di dri i m’è madòs? Nascondino. Per giocare a nascondino bisogna avere occhio, essere furbi. | Io conosco dei posti, dei buchi, che so solo io. | Stavolta mi sono nascosto fra le assi | del magazzino del legno di Bigudòun. | Li sento che parlano, che chiamano, | sbircio dalle fessure, li vedo che girano, | che si indicano col dito dove devono andare. | Io aspetto qui, non mi muovo, trattengo il fiato. | Adesso mi pare che si siano un po’ allontanati, | io sto sempre nascosto, è ormai un’ora, | m’infilo in un budello più stretto, così, | fra due cataste, li voglio far diventare matti. | Ma dove sono? non li sento più, | non capiscono mica niente, vanno purchessia. | Saranno più di due ore che sono qui, | è da oggi pomeriggio, si fa notte, e loro, | poveracci, cercano sempre, ma non mi trovano, | e li voglio vedere a trovarmi in questo buco. | Può darsi anche che abbiano perso la voglia, | che il gioco si sia smagliato, che siano andati a casa. | Peggio per loro, io sto buono fra tutte queste assi, | qui sotto non mi trova più nessuno. La corsa. Mi sono corsi dietro urlando, e io non capivo, | non so se avessero il fucile, ma i coltelli, | ho visto le lame luccicare sotto i lampioni. | Andavo come un bracco e loro tutti dietro, | ho attraversato la piazza, | poi mi sono buttato nel Baròun, ma dopo la fontanella | sono tornato per il Ciód e mi sono infilato | sotto i portici fino ad Attilio delle granaglie, | ho imboccato il lavatoio, ho passato la Mura, | dalla Zóppa sono venuto giù alla Costa, | poi nella Bosca, sono saltato dentro un cortile, | ho fatto due rami di scale, | sono venuto fuori vicino alla Massani, | sono corso verso la Rocca, all’incrocio | ho preso in giù verso il Pozzo Lungo, e ho visto | davanti a me tre o quattro che correvano | e guardavano indietro, mi guardavano a me. | Sul momento non ho capito, volevo dire qualcosa, | ma non mi sono trovato la voce, non arrivavo | a tirare il fiato. – Però a me mi pare che siano | quelli di prima, quelli che inseguivano me, | uno va un pochino zoppo, un altro ha un berretto | che me lo ricordo, ma corrono via, non stanno a sentire, | pare che abbiano paura, e io li inseguo, | ho paura anch’io, ma come devo fare? | potrei fermarmi, e se poi mi sbaglio? | se mi fermo e quelli dietro mi sono addosso? La poesia “Un susórr” è tratta da Intercity, Einaudi 2003. “Cut” e “La chéursa” sono tratte da La nàiva Furistír Ciacri, Einaudi 2000. 18
Scarica