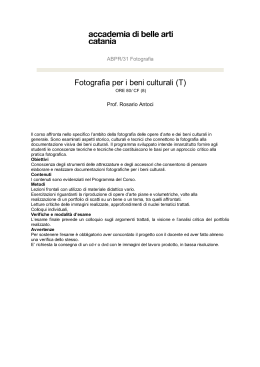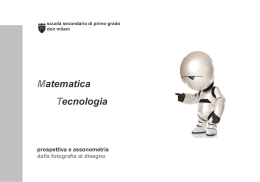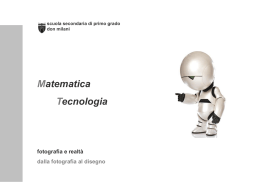GRUPPO FOTOGRAFICO ANTENORE, BFi RASSEGNA STAMPA Anno 7o, n.7 - Luglio 2014 Sommario: Srittori e fotografia: un viaggio tra parola e immagine.………………………………………pag. 2 Fotografie da Arles…………………………………………………………………………………………………pag. 3 Quando Marte si fa selfie……………………………………………………………………….………………pag. 5 Fotografia: la favola ruvida di Anders Petersen (ma si, rubategli il mestiere)……pag.10 Non vedo la notizia. Fotobanner e giornalismo.……………………………………………………pag.13 Nature vive: la fotografia secondo Sam Abell………………………………………………………pag.16 L'intervista che non ho mai fatti a HCB…………………………………………………………………pag.18 Fotografia che muove, che si muove, che ci smuove……………………………………………pag.20 Foto girevoli, viris e patologie Web.………………………………………………………………………pag.23 I vagabondaggi di Sergio Lorrain, il fotografo degli invisibili.………………………………pag.25 Cesare e la "sorellina disabile"………………………………………………………………………………pag.27 Spilimbergo Fotografia.Ventotto anni tra passato e presente..……………………………pag.31 Cortona On the Move………………………………………………………………………………………………pag.34 Ghirri in Italy, reloaded..………..……………………………………………………………………………..pag.37 Giorgio Appendino 1928-2014.………………………………………………………………………………pag.39 La famiglia dell'uomo. Una religione in bianco e nero..…………………………………………pag.40 Museo di Fotografia Contemporanea………………………………………………………………………pag.45 Gianni Berengo Gardin…………………………………..………………………….……………………………pag.48 Gordon Parks, il narratore multiforme……………………………………………………………………pag.49 C'è della fotografia in quella follia………………….………………………………………………………pag.52 Storie dal Sud dell'Italia.…………………………………………………………………………………………pag.57 Ma noi non ci saremo. Una giornata nella caverna delle immagini.……………………..pag.59 A occhi aperti, quando la storia si è fermata in una foto………………………………………pag.65 Scarpe al sole, foto in tasca……………………………………………………………………………………pag.69 1 Scrittori e fotografia: un viaggio tra parola e immagine di Anna Toscano da http://www.ilsole24ore.com/ Esce con sottotitolo "Un magnifico inizio 1840-1870" il primo volume dedicato a «Scrittori e fotografia» di Diego Mormorio. Il progetto prevede l'uscita di dieci volumi dedicati al rapporto tra due forme d'arte che a volte sembrano così distanti ma che in realtà si compenetrano a vicenda dacché l'immagine fotografica esiste. In questo primo volume Mormorio narra la reazione di scrittori e poeti agli affascinanti inizi della fotografia: una fitta documentazione storica di come i grandi artisti della penna si siano approcciati alla nuova arte del dagherrotipo. Non tutti, infatti, si lasciarono convincere dall'artificio nuovo, come Gustave Flaubert che non rintracciava nessun segno artistico nella riproduzione dell'immagine nella dagherrotipia. Altri invece non si fecero trascinare dalla vanità della moda del ritratto ma iniziarono a studiare la novità da un punto di vista scientifico, come Edgar Allan Poe che si fece ritrarre nel 1842 e nel 1840 scrisse in un articolo intitolato «The Daguerreotype»: «Lo strumento deve essere indubbiamente considerato il più grande trionfo della scienza moderna, se non il più straordinario», per poi addentrarsi sull'importanza della riproduzione prospettica degli oggetti. Fino a Baudelaire che per tutta la vita restò uno dei più accaniti denigratori della fotografia, nonostante ciò si fece ritrarre più volte da Nadar, uno dei più grandi fotografi a lui contemporanei. Una parte del volume presenta una preziosissima antologia che raccoglie testi sulla fotografia da Poe a Whitman, dando così la possibilità al lettore vorace di assaporare le parole stesse dei grandi autori. L'ultima parte del libro è dedicata alle immagini di altri scrittori corredate da un testo di approfondimento: qui incontriamo il celeberrimo «Ritratto di Emily Dickinson» del 1945 di autore non identificato, George San, Alessandro Manzoni e altri. Un volume prezioso, curato ed elegante, che indaga e sviscera passioni e ostilità, presiti e rifiuti, tra immagine e parola. Diego Mormorio, «Scrittori e fotografia», Postcart 2013, pagine 324, euro 20 2 Fotografie da Arles da http://www.ilpost.it/ Dal 7 luglio al 21 settembre si terrà ad Arles, in Francia, la 45esima edizione di Les Rencontres d’Arles, il più importante festival europeo dedicato alla fotografia. Il festival – fondato nel 1970 dal fotografo di Arles Lucien Clergue, dallo scrittore Michel Tournier e dallo storico Jean-Maurice Rouquette – comprende oltre 50 mostre di artisti affermati ed emergenti, esposte in molti luoghi della città, alcuni straordinariamente aperti per l’occasione . Questa edizione si intitola Parade e sarà l’ultima curata da François Hebel, ex direttore della prestigiosa agenzia fotografica Magnum Photos di Parigi, che in passato si era già occupato delle edizioni dei Rencontres del 1986, del 1987 e poi dal 2002 al 2014. Hebel spiega che l’evento è pensato come «un’ultima parata per alcuni dei tanti amici che hanno dato forma alla recente storia del festival: Raymond Depardon, Christian Lacroix, Martin Parr, Lucien Clergue, Erik Kessels, Bill Hunt, Joan Fontcuberta, Luce Lebart. Dato che la nostalgia non è nel nostro stile, hanno offerto tutti nuove ed entusiasmanti proposte». A loro si aggiungono comunque molti altri artisti per la prima volta al festival, come Vik Muniz, Daile Kaplan e il regista svizzero Vincent Perez. 3 Tra le molte cose interessanti da vedere c’è una retrospettiva dedicata al fondatore dei RencontresLucien Clergue; una mostra di libri di fotografia cinesi, alcuni risalenti ai primi del Novecento, curata da Martin Parr; una raccolta di autocromie (una tecnica inventata dai fratelli Lumière nel 1903 per scattare immagini a colori) del fotografo francese Léon Gimpel, in cui bambini travestiti da soldati impersonano scene della Prima guerra mondiale. La collezione dello scrittore WM Hunt è dedicata soprattutto a immagini di gruppi e folle: squadre, parate, manifestazioni, assemblee, cerimonie; mentre Pop Photographica: Images and Objects di Daile Kaplan, direttrice del dipartimento di fotografia delle Auction Galleries a New York, comprende esclusivamente fotografie utilizzate per decorare oggetti: scatole, vestiti, cuscini. Oltre ai lavori più famosi come Stardust di David Bailey eMen and Women di Lucien Clergue, ci 4 sono quelli dei tanti fotografi emergenti: Will Steacy, che racconta la vita dei giornalisti al Philadelphia Inquirer, e il sudcoreano Youngsoo Han, per i suoi reportage dopo la Guerra di Corea. Durante la settimana di inaugurazione, che quest’anno si è tenuta dal 7 al 13 luglio, il festival organizza numerosissimi eventi e spettacoli. Per tutta la durata dei Rencontres è poi possibile partecipare a workshop e lezioni, prendere parte a visite guidate gratuite e sottoporre i propri lavori al parere di fotografi professionisti. TAG: ARLES, FOTOGRAFIA, LES RENCONTRES D'ARLES Quando Marte si fa il selfie di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it «Mi avete fato piangere. Vi ringrazio», così ha scritto Kristen di Portland, Oregon, sul libro dei visitatori. Dovrebbero consegnare un pacchetto di kleenex alla cassa, assieme al biglietto. Occhi lucidi brillano nella fresca penombra del War Photo Ltd., primo e per ora unico museo al mondo dedicato interamente alla fotografia di guerra. Illuminate una per una, le immagini galleggiano nell’oscurità come sogni. O incubi. Perché nessuno, qui, sterilizza l’orrore delle immagini. Quando è troppo, ti puoi sedere: in un angolo c’è decompressione emotiva, sedie tavolini e qualcosa da leggere. un’area di Qualcuno invece preferisce arrabbiarsi. Di fronte alla testa mozza di un soldato liberiano portata in trionfo per le vie di un mercato, una foto celebre e terribile di Noel Quidu, un visitatore indignato corse ad apostrofare Wade Goddard, il direttore del museo: «Lei come osa mostrare cose del genere?». La risposta: «E lei come osa ignorarle?». 5 Se proprio non ti va, puoi rimanere a pascolare assieme alle mandrie gelatofaghe deipackage tour sui marmi tirati a lucido dello Stradun, il corso elegante della città vecchia di Dubrovnik, Croazia, regina dell’Adriatico, splendido gioiello veneziano incastonato nelle sue antiche mura. Puoi evitare di svoltare nell’ombroso vicolo Antuninska, puoi ignorare quel portone quadrato che quasi non si vede, tra una boutique e un baretto, puoi rifiutarti di salire le scale della vecchia casa e di scoprire questi due piani ben arredati e sconvolgenti. Puoi non farlo. Vedere non è un obbligo. Sapere non è un obbligo. Però, da quattro anni, ventimila turisti ogni estate fanno come Kristen. Salgono. Piangono. Meditano. «Dovreste chiudere a chiave Bush e Cheney tre giorni qui dentro», ha lasciato scritto Zahn da Austin, Texas. Wade non è un militante pacifista. «O forse sì, in qualche modo, ma non mi piace dirlo». Wade Goddard è un fotografo, o meglio lo è stato, benché lo abbia fatto quasi per caso. Ventenne, stufo di allacciare cavi dell’alta tensione «nel bel mezzo del nulla», cioè nella sua Nuova Zelanda, nel ‘90 trasmigrò a Londra a sciacquare bicchieri di birra nei pub, di sera; e a giocare con la sua Canon, di giorno. René, un amico freelance già esperto, lo convinse a partire assieme per la Jugoslavia in fiamme. «Volevo capire perché un uomo uccide un uomo. L’ho capito: per paura. Perché ha il terrore che l’altro lo faccia per primo». Era il 1992: si disintegrava l’eredità di Tito. I media erano assetati di immagini e Wade non smise più di scattarne, per le agenzie, per Newsweek, per il New York Times, a Pec, a Pristina, a Mostar, A Sarajevo, in tutti i gironi dell’inferno balcanico. Poi, improvvisamente, dopo dieci anni di pallottole schivate e di corse tra le macerie, smise. «Mi sono balcanizzato», ride. Pacificato, anche. Sposato con una parrucchiera di Zagabria. «Per coprire la guerra in Kosovo avevo perso i primi sei mesi di mia figlia, non volevo perdere gli anni successivi». Rifiutò un incarico in Afghanistan: «Non mi andava di mangiare tutti i giorni pollo e riso, riso e pollo, pollo e riso», ride, elude la curiosità. Forse è un altro genere di carne che ha stomacato Wade? No. Non ancora. «La guerra è nauseabonda, sporca, insensata. Ma se vuoi fermarla la devi vedere e far vedere». Il museo è la continuazione della fotografia di guerra con altri mezzi. Ai tavolini di un caffè di Dubrovnik, Wade aveva conosciuto un imprenditore belga appassionato di fotografia, Freredic Hanrez. Un’affinità elettiva fulminante. Fu lui a mettere i soldi per comprare, restaurare e arredare una casa di pietra, bombardata come tante. 6 Così War Photo Ltd. aprì nell’estate 2004 coraggiosamente lontano dalle grandi capitali della fotografia ma pronta a conquistarle («Vorrei aprirne un altro a New York e uno a Parigi»), nacque volutamente qui, sulla soglia di marmo dell’ultima devastante guerra europea. Il 6 dicembre del 1991 la perla dell’Adriatico veniva travolta e bruciata da un tornado di 14 mila bombe, da terra, dal cielo, dal mare. Non fu l’evento più cruento del lungo conflitto etnico nell’ex Jugoslavia (meno di cento le vittime civili), ma fu tra i più carichi di simbolica ferocia: la vecchia Ragusa dalle possenti, inutili mura strategicamente non serviva a nulla, era solo una bandiera da bruciare con rabbia e disprezzo. Chi lo ricorda, oggi, tra le migliaia che intasano le vecchie calli in un vapore di calamari fritti? Boutique, negozi di souvenir e ristorantini sotto i tetti di tegole rosse restaurati in modo impeccabile. Le cicatrici del bombardamento, le “rose di cemento” nei lastricati, devi cercarle, nulla e nessuno te le indica. Al piano terra del palazzo Ploce il comune ha allestito la Stanza della memoria, venti metri quadri con le foto tessera degli «eroici difensori» del ’91, qualche filmato, bandiere, una rosa con la scritta «Grazie». È un monumento, non un documento. E i monumenti, si sa, servono soprattutto per dimenticare. Nella libreria sullo Stradun non trovi neanche un volume sulla guerra in città. «Provi nei negozi di souvenir», suggerisce il commesso un po’ a disagio. Ha ragione, eccoli proprio lì, tra t-shirt e collanine, i libri e i dvd con le immagini della devastazione: in inglese, per i turisti. «Al museo entrano pochissimi visitatori locali», ammette Wade, «pochi perfino quando esponemmo le foto del conflitto balcanico. La guerra per loro non esiste più». War Photo Ltd. non ha ottenuto lo status di museo dal governo croato. Giuridicamente è una galleria privata, vive di biglietti, cataloghi e stampe numerate e firmate, in vendita tra gli 800 e i 1800 euro. Non è speculare sull’orrore, Wade? Quasi s’offende: «Vendo una dozzina di stampe all’anno, è un contributo degli appassionati di fotografia al lavoro dei fotografi. I nostri conti del resto sono in perdita. Se volessi fare tanti soldi e in fretta con la guerra, mi metterei a vendere dei fucking mitragliatori». Insomma nessun aiuto dallo stato, e tasse come se fosse una pizzeria. «I croati non ce l’hanno con noi, semplicemente ci ignorano, che è peggio». È tutto il resto del mondo, però, a passare per Dubrovnik. Visitatori e immagini. Sui muri ogni due o tre mesi cambiano le mostre, gli argomenti, gli autori. Goddard li seleziona personalmente. Alexandra Boulat, Christopher Morris, Ron Haviv, Darko Brandic, Yuri Kozyrev, Heidi Levine Jan Grarup tra quelli già passati su queste pareti, gli italiani Paolo Pellegrin e Alex Majoli tra quelli che Wade vorrebbe invitare. Sudan, Iraq, Rwanda, Palestina: solo foto di guerre contemporanee, attuali, in corso. «È troppo comodo commuoversi sulle guerre del passato, sulle foto di 7 Capa o della Bourke-White. Questo è un museo pedagogico, non storico. Voglio che la gente reagisca, più che farsi una cultura». Sul libro dei visitatori sono due le parole più ripetute, quasi sempre assieme: bellezza e sofferenza. Stridente, scandalosa, sospetta coppia: Marte e Venere, gli amanti del “terribile amore per la guerra” di cui ragiona il filosofo James Hillman. Foto troppo belle addormentano le coscienze, l’estetica diventa anestetica: questo sostiene un’intera schiera di pensatori critici, Susan Sontag in testa. Lana Šlezic, esilissima fotografa croato-canadese, se ne tira fuori: «La bellezza è la porta del senso», dice facendo da cicerone al cronista tra le sue splendide, compostissime, dolorosissime immagini di donne afgane, «mentre lo shock chiude quella porta. Il dovere del reporter è capire capire dove passa il confine». Veramente, non è proprio la fama di esteti che da un secolo e mezzo accompagna i fotografi sui campi di battaglia. Piuttosto quella di spoliatori di cadaveri. Sciacalli, avvoltoi.Voyeur, se va bene. Mitizzati ma in fondo disprezzati, adrenalinici, sempre in odor d’ambiguità verso il loro oggetto: in fondo, è stato detto, il fotografo di guerra è la miglior approssimazione a un soldato che sia accettabile per un pacifista. Però qualcosa è cambiato. Da poco, da molto poco. Diciamo da Abu Ghraib in poi. Quelle foto-ricordo maldestre e compiaciute, arma da guerra e trofeo insieme, prese con le macchinette digitali dagli aguzzini sorridenti dei carcerati iracheni fecero tremare il Pentagono nel 2004, proprio quando War Photo Ltd. apriva i battenti. Ma erano davvero così pericolose quelle foto per l’establishment militare? Forse solo un po’ eccessive. I generali assorbirono il colpo e schivarono le conseguenze. Ma in realtà quelle immagini così diverse dalle foto di guerra che tutti conoscevamo svelavano una strada nuova nella manipolazione dell’informazione. Estetismi, zero. Mediazioni, zero. Erano l’autoritratto della guerra, puro e semplice. L’immagine della guerra come la vede chi la fa: e un autoritratto, si sa, difficilmente danneggia il proprio soggetto. È dalla prima guerra del Golfo che l’establishment militare prova a diffondere un’unica immagine dei conflitti, quella vista dalla canna del fucile. Telecamere montate sulla punta dei missili, sull’elmetto dei marine. Spettacolare. Chirurgica e pulita. Soprattutto: capace di togliere di mezzo la mediazione di quei rompicoglioni dei fotografi. Marte, dio della guerra, licenzia il collega Hermes, dio messaggero, e fa da solo. Il mondo vuole immagini della guerra? Benissimo, gliele forniamo noi militari, direttamente, gratis e in abbondanza. Perchè, vedete, la prima soluzione, quella del black-out, non funzionò. I corpi bruciati dei soldati di Saddam sulla «strada della morte», 8 scovati dai professionisti dell’immagine, bucarono le prime pagine. Non funzionò, ma solo perché la guerra-Nintendo, nitida e asettica come un videogame, la guerra delle scie di missili in un cielo verde-monitori, una guerra senza cadaveri, non era credibile. Devono averci pensato su, i generali, sotto i loro firmamenti di stellette. Volete proprio vedere il sangue? Bene, non c’è problema, possiamo darvi anche quello, sempre senza giornalisti di mezzo. Magari indirettamente, tollerando che siano i redneck diciottenni texani in divisa a diffondere via Internet le loro disgustose istantanee traboccanti raw meat, carne cruda. Fioriscono i siti di immagini raccapriccianti “direttamente dal fronte”. Alcuni sollecitano contributi promettendo in cambio l’accesso gratuito a siti porno: Marte incontra di nuovo Venere, questa volta però in un bordello indecente. E questa volta i media cominciano ad abboccare. Del resto, un marine vede ben di più di quanto è concesso vedere a un fotografoembedded. È lì quando la guerra accade, e “più vicino possibile”, avrebbe detto Capa. Potentissimo, l’autoritratto della guerra potrebbe presto invadere tutto il nostro immaginario. Sarebbe una catastrofe. L’eccesso di pathos interpretativo del fotografo, scriveva Barthes, ammutolisce le immagini: ma la sua assenza? Wade ricorda, ancora a disagio: «Entrando in una casa kosovara abbandonata in fretta dagli occupanti serbi, trovai sparse sul pavimento delle fotografie tremende. I miliziani si erano fotografati l’un l’altro, ridendo, mentre torturavano i musulmani. Ecco cosa succede quando la guerra si fa l’autoritratto». Ci accorgeremmo, allora, di quanto ci mancano i vecchi calunniati voyeur, i presunti “avvoltoi”, i fotografi di mestiere. Di quanto ci serva, per affrontare l’incomprensibile, la mediazione di un occhio esterno e pensante. «Noi non siamo marine brufolosi che godono a fotografare il sangue», Wade sfoglia ilportfolio delle foto di un amico e collega celebre, Ron Haviv, «guarda, in questa foto c’è un cadavere, ma vedi? C’è anche lo sguardo terrorizzato del suo compagno d’armi che ha paura di fare la stessa fine, c’è la casa distrutta, c’è la donna che scappa: c’è una storia». Un bambino sanguinante, un altro coperto di vomito. Una testa mozzata. Niente autocensure, perché «non potrei mai disinfettare la realtà. Però posso raccontarla. Devo raccontarla. Devo farti vedere in faccia cos’è davvero un fucking “danno collaterale”, com’è una famiglia massacrata per sbaglio al check-point, il cervello del bambino sparso sui sedili di un’auto identica a quella che tu hai nel garage. La guerra è una grande bugia: ma la fotografia di guerra è la verità di una bugia». Ha ragione David Hockney, serve la sensibilità di un artista per immaginare la guerra e non restare schiavi delle sue immagini brute. Il pennello di Botero è riuscito a riscattare i tremendi souvenir di Abu Ghraib. 9 Ma i veri, i grandi fotografi sono artisti. Da Bob Capa a James Nachtwey («Un dio!», esclama Goddard senza la minima ironia) sono pittori in trincea. Hanno negli occhi la storia delle immagini, la cultura e l’etica della visione. Solo da quando abbiamo visto le impudenti cartoline del caporale Lyndde England e dei suoi camerati ci siamo resi conto che i fotografi di guerra professionisti sono più vicini al Goya dei Disastri della guerra o al Picasso di Guernica che a meccanici fotocopiatori dell’orrore. «La guerra non si può fotografare», scriveva John Steinbeck di Capa, «lui ha fotografato le sue emozioni». Lo spettacolo della guerra, quello rimane, col rischio di fascinazione e seduzione che ogni spettacolo si porta dietro. Ma c’è spettacolo e spettacolo. Le istantanee dei marine sono il circo massimo dei gladiatori: puro piacere della macelleria, in confezione senza filtro. I racconti visuali dei fotoreporter sono la tragedia greca: ricerca di senso nell’insensato, guidati da un pensiero. Però, lo sappiamo tutti, Sofocle riesce a condannare il tiranno Creonte solo sulla carta della sua scrittura, non nel mondo reale. Le fotografie di guerra hanno mai fermato una guerra? «Il Vietnam è la prima guerra vinta dai fotografi. La Bosnia, la prima che abbiano perso», scrisse con qualche ragione la vecchia volpe Kissinger davanti all’assedio di Sarajevo. Wade sospira: «È la gente che cambia la storia. Se le foto non funzionano più, vuol dire che è cambiata la gente, non la fotografia. Forse siamo più deboli. Ma cosa succederebbe se non ci fossimo più?». Resterebbe sul campo di battaglia solo Marte. La spada in una mano, la gigapixel con quintuplo zoom nell’altra. Sorridente, col dito sull’autoscatto. [Una versione di questo articolo uscì su La Domenica di Repubblica il 5 agosto 2007] Tag: Abu Ghraib, Alex Majoli, Alexandra Boulat, Christopher Morris, Creonte, Darko Brandic, David Hockney, Dubrovnik, Freredic Hanrez, Goya, Heidi Levine, Henry Kissinger, James Hillman, Jan Grarup, John Steinbeck, Lana Šlezic, Lyndde England, Margaret BourkeWhite, Noel Quidu, Pablo Picasso, Paolo Pellegrin, Ragusa, Robert Capa, Roland Barthes, Ron Haviv, Sofocle, Susan Sontag,Wade Goddard, War Photo Ltd., Yuri Kozyrev Scritto in etica, fotogiornalismo, guerra | 2 Commenti » 10 Fotografia: la favola ruvida (ma sì, rubategli il mestiere) di Anders Petersen di Cristina d'Antonio da http://www.gqitalia.it/ Volete imparare qualcosa da un fotografo che ha fatto un pezzetto di storia? Andate in Toscana: a fine luglio Petersen terrà uno dei laboratori del Tpw. Con lui, la sua gigantesca famiglia adottiva: i randagi della vita che ha ritratto in questi anni, rigorosamente in bianco e nero. L’invito a chi vorrà seguirlo? Non siate spaventati dalle vostre paure La prima volta che ha messo piede al Café Lehmitz, qualcuno gli ha soffiato la sua Nikon F. La vedeva volare sopra le teste e passare di mano di mano, di clic in clic. «Fate una foto anche a me? Quella è la mia macchina». Clic. È il 1967. Anders Petersen ha 23 anni e quello sguardo disarmato che gli permetterà, da allora in poi, di avvicinare le persone a una distanza voluta. Sufficiente per mantenere il proprio punto di vista, ridotta per permettere il contatto con il soggetto. In quel bar di Amburgo Petersen lo svedese ha passato tre anni. Ha fotografato puttane, alcolizzati, ladri. La prima delle sue tante famiglie adottive. «Direi al giovane che ero: non temere le tue paure» Oggi ha 70 anni. È entrato nei manicomi, nelle carceri, nei ricoveri per anziani. Ha fatto mille incontri. È testimone di vite in un contrastato bianco e nero. Ha ricevuto tanti premi (uno: autore dell’anno a Les Rencontres d’Arles nel 2003), insegna, tiene dei workshop (il prossimo è in Toscana, dal 27 luglio al 2 agosto, in occasione del Tpw). Ma ha ancora quello sguardo: tondo, mite, incuriosito. «Non saprei dire come sono cambiato dal Lehmitz, ma so che c’è un filo rosso che mi tiene legato a quei giorni. Lo stesso bisogno di fratellanza. E se potessi dire qualcosa al giovane che ero, sarebbe che non bisogna essere spaventati dalle proprie paure». E come si sente oggi? «Come uno che gira con una piccola macchina fotografica e che ama la gente. Molte delle mie foto sono frutto di incontri capitati nei bar o per le strade. Ho un approccio quasi primitivo: cerco persone nelle quali riconoscermi, disposte a passare del tempo con me e a condividere delle esperienze. Si tratta di diventare intimi quel tanto che serve a potersi fare delle domande a vicenda». Stiamo parlando della sua visione di distanza? «Sì. Non mi interessa la fotografia che se ne sta lontano, al sicuro, al riparo dai fatti. Non sono tipo da nascondersi dietro gli angoli. Voglio stare in mezzo, dove capitano le cose, sentire di appartenere alle persone davanti alla mia lente. È un’assunzione di responsabilità: innanzitutto verso me stesso». Mette a nudo la gente. Di quale verità è alla ricerca? «Non sono interessato a spogliare la gente. Sono poche le immagini in cui appare un nudo, e se così è, avviene in modo naturale, in armonia con il contesto. Scelgo di rappresentare quello con cui mi sento emotivamente connesso e non mi basta mostrare la superficie: ho bisogno di andare a fondo, di entrare in una sfera di vulnerabilità. Non mi interessa la verità, voglio farne parte». Uscire dalla zona di confort è la sua priorità… «Ci viene insegnato a muoverci in una griglia di sicurezze, perché è così che si dà ordine alla società. Ma se vuoi essere creativo, non puoi restare ingabbiato. 11 Devi essere fluido. Disposto a scioglierti come un pupazzo di neve al sole». Cosa la fa sentire al sicuro? «Credere che non esistono sicurezze». Forza contro fragilità: insiste ancora con l’importanza di sentirsi deboli nella vita? «Sì, cerco ancora di essere abbastanza fragile invece che abbastanza forte. Mi permette di aver bisogno degli altri, di creare un’osmosi, di sentire tutto con maggiore intensità». Dice: ogni mia foto è un autoritratto. Di cosa è alla ricerca? «Di una mia famiglia, e di mettermici in mezzo». Non ce l’ha, una famiglia? «Ho un figlio e vivo con Julia, il mio amore». Si è mai innamorato di uno dei suoi soggetti? «Può ben dirlo!». Randagi. Tossici. Si muove spesso in contesti spinosi. «Per me non esistono luoghi sgradevoli, da evitare. Ovunque ci sia una traccia umana, c’è vita. E confesso di trovare più energia per terra, nella polvere, che non in cielo, tra gli angeli». Perché i suoi racconti sono solo in bianco e nero? «Perché sono abituato a usare la Tri-x, e quindi continuo con quello che conosco bene… (è la pellicola più usata in assoluto per fotografare in condizioni di luce ridotta, ndr). E perché credo di avere più scelta: non essere condizionato da un colore che prevale su altri mi permette di usare la fantasia, di crearne di personali». I suoi progetti durano due, tre anni. Come li sceglie? «Mostrando il mio interesse. Se sei abbastanza curioso, un macchina fotografica può essere una formidabile chiave di accesso all’esistenza della gente. Altrimenti non sarei mai potuto entrare in una prigione di massima sicurezza». Come capisce che è il momento di chiudere e di passare oltre? «Non lo so mai. In realtà è un processo che non si interrompe. Semplicemente, a un certo punto, compare un passaggio che mi porta in altre stanze. Verso un nuovo progetto». Cosa pensa quando vede il risultato dei suoi sforzi? «Anni fa mi deludevano, ed era orribile. Pensavo di aver incontrato persone meravigliose, alle quali non rendevo giustizia. Mi sentivo totalmente perso, non mantenevo la distanza. Il risultato erano delle foto confuse, fuori fuoco. Ho cercato di cambiare, di allenarmi a tenere un piede dentro e uno fuori dalla situazione. Ora uso un approccio ravvicinato, ma mantenendo il controllo». Cambia mai idea su come raccontare una storia? «Di continuo». Chi decide? La testa? Lo stomaco? «Il cervello è il primo a prendere delle decisioni, ma nel bel mezzo dello shooting è lo stomaco che prende il comando». Insegna fotografia: qual è la prima cosa che cerca di passare a chi l’ascolta? «Che non esistono foto belle o brutte. Si tratta di essere credibili in quello che facciamo. Il mio compito è di indicare a ognuno una direzione. E poi, assieme al gruppo, di esplorare i possibili percorsi. Vedere dove ti porta tutto questo è già di per sé un’avventura». Come riconosciamo il nostro punto di vista? 12 «Sfidando i nostri sogni. Individuando cosa ci muove un’emozione. È così che possiamo riconoscere quell’abilità che ci rende unici. È un semplice trampolino. Poi, non resta che lanciarci. E provarci». Ha mai l’impressione di perdersi qualcosa? «Non è mia abitudine lamentarmi. Non sento la mancanza di niente, non ho rimpianti. Il tempo che resta serve ad altro: ci sono così tante sorprese, e alcune terribili contraddizioni, con cui fare i conti. E io sono ben contento di potermici confrontare: chi pensa di sapere, che l’età porti saggezza, non ha capito nulla». Gira sempre con una Contax T3 in mano? «Magari non in mano. Ma dove posso agguantarla al volo per una foto, questo sì». Non vedo la notizia. Fotobanner e fotogiornalismo di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it Un giorno qualsiasi dell’ultima settimana, apro la homepage di Buzzfeed. Notizia d’apertura: “Ventisette inconvenienti che ogni commesso di negozio ha affrontato”. La terza notizia è già sponsorizzata da Vodafone. La notizia più letta del momento riguarda la forma da dare alle sopracciglia. Il mondo sembra un posto spensierato per viverci, visto da Buzzfeed. Molti di voi sanno già cos’è Buzzfeed: un giornale nativo Web, fondato otto anni fa da Jonathan Peretti, che fu anche tra gli ideatori dell’Huffington Post, è uno dei portali di informazione più frequentati della Rete. Vanta di avere 85 milioni di lettori unici. Qualcuno sostiene che sia la formula vincente per l’informazione sul Web. Io non credo, le formule sono ancora molte e nessuno onestamente può dire di sapere come sarà fatta l’informazione sul Web anche solo fra cinque anni. Ma certo molti lo pensano e si adeguano: anche in Italia c’è chi ha cercato di imitarne il modello, con esisti per la verità non troppo entusiasmanti di popolarità. Forse sul Web si nasce, non si diventa. Comunque, non è di questo che voglio parlarvi, ma dell’uso che Buzzfeed, che prendo a modello esemplare di una tendenza, fa delle fotografie. Che sembrano essere la materia prima del contenuto. 13 Nella versione raggiungibile via browser, ma ancora di più in quella raggiungibile via app, la prima pagina di Buzzfeed si presenta come una griglia di fotografie. Sono le foto i veri titoli delle notizie, attirano l’occhio prima del titolo scritto a parole. In alcuni casi, il titolo della notizia appare solo quando il lettore sfiora col mouse la fotografia. La scelta è chiarissima: l’accesso ai contenuti, nell’informazione in Rete di questo tipo, avviene prioritariamente attraverso le immagini. Le fotografie non sembrano essere mai state così importanti, necessarie, indispensabili all’informazione, o almeno alla presentazione dell’informazione. Il Web celebra il trionfo delle fotografie. Non solo: su Buzzfeed le foto sono quasi tutte correttamente creditate e firmate. Potrebbero essere perfino pagate… Dovremmo essere tutti contenti, no? Ma che fotografie sono? Un certo numero di fotografie sono d’agenzia, delle agenzie maggiori, per le notizie d’attualità. Una quantità di fotografie sembrano recuperate dal Web, da Flickr, e ovviamente ci sono molte fotografie di stock. Nella sezione esteri, è vero, trovo quel giorno un buon fotoreportage sull’inquinamento in Cina, una ventina di buone immagini firmate Souvid Datta, offerte in grande formato e ben didascalizzate. E mi accorgo improvvisamente che queste fotografie non appartengono alla stessa famiglia delle altre. Non svolgono la stessa funzione, anche se appaiono sullo stesso organo di informazione. Queste sono contenuto giornalistico. Le altre invece sono elementi strumentali, funzionali, elementi meta-informativi alla pari dei titoli, le testatine, i pallini gialli che etichettano le notizie (Quiz! Win! Lol!), elementi capta-sguardo e tira-clic. Ecco, credo che il futuro del fotogiornalismo, e scusate se l’ho presa così alla larga, dipenda dalla bilancia sempre più squilibrata fra queste due famiglie di fotografie: quelle che definirei foto-banner, e quelle che ancora sono fotogiornalismo. Molto dipende dalla capacità che avrà il lettore di distinguerle. Il fotogiornalismo come lo conosciamo non è scomparso dall’informazione online. Ma il suo ruolo retrocede a quello di uno fra i tanti possibili contenuti, un contenuto di uso occasionale, di nicchia, destinato a lettori sofisticati che amano il genere. La fotografia che più si intreccia operativamente con l’informazione, quotidianamente, di default, ormai, è decisamente un’altra. Lo dico a quegli amici fotografi che si ostinano a pensare che il passaggio dalla carta al Web sia solo un cambio di supporto materiale, e si attendono dall’informazione Web la stessa considerazione per il giornalismo visuale che avevano, almeno alcuni, i media tradizionali da edicola. Non ricevendola, e vedendo invece pubblicate una gran quantità di fotografie che giudicano pessime, non sanno darsi altra spiegazione che questa: i capiredattori sono diventati improvvisamente ignoranti, tirchi e cattivi. E non si tratta neppure, come a volte siamo tentati di dire per risolvere la questione, di un problema di crisi e di spending review degli editori. Ogni ristrutturazione della spesa comporta scelte e priorità, e se il fotogiornalismo finisce in fondo alla lista delle priorità dobbiamo comunque chiederci perché e siamo daccapo. La vera difficoltà è fare i conti con l’idea che lo scenario dell’informazione, nel processo di trapasso sul Web, stia subendo una mutazione genetica che ovviamente non ci piace, e che quindi rifiutiamo di vedere. 14 E così ci rifiutiamo di risalire alle sue radici, che affondano nella battaglia titanica ormai ingaggiata da tempo, non ancora risolta, fra editoria tradizionale editata e redazionale da una parte, e colossi delle piattaforme, dei software e degli hardware dall’altra, per stabilire quali saranno alla fine i veri padroni dell’informazione. E quindi, come sarà fatta quella informazione. Se questo è lo scenario, anche farsi domande sull’etica del fotogiornalismo rischia di diventare un esercizio tutto rivolto al passato. Quando la maggioranza delle fotografie che l’informazione Web utilizza sono quello che ho detto prima, l’etica del fotografo come professionista cosciente e responsabile è una cosa nobile ma che riguarda quasi solo la sua coscienza. Al sistema dell’informazione importa assai poco. Se la maggioranza delle fotografie che arrivano al lettore non sono più altro che materia semilavorata, e assumono senso e funzione solo a seconda dei contesti in cui sono utilizzati come elementi grezzi da plasmare, allora l’etica non riguarda più i fotografi, ma le fotografie stesse. Come si comportano, le fotobanner, nella nuova informazione online? Sono illustrazioni, ma non decorative o riempitive, come capitava a volte anche nei media tradizionali. Sono illustrazioni operative, che hanno un compito da svolgere. Devono dare il la al lettore, imporgli in modo inconscio il mood (spensierato, divertito, indignato, incuriosito) con cui affrontare la lettura dell’articolo. Devono impostare e sostenere la funzione dell’articolo, anche quando si tratta di quella nuova razza di giornalismo ibridato con la pubblicità che va sotto il nome di branded journalism. Buzzfeed, avrete notato, ha pochi banner, poca pubblicità tabellare. Ha però molti contenuti giornalistici apertamente sponsorizzati e altri forse copertamente tali. Un articolo sulla “dipendenza da Nutella” cosa sarà? Bene, in questo caso le fotografie sono chiamate a favorire quella serie di accostamenti di idee che portano il lettore a immaginare un prodotto anche quando non gli è direttamente nominato. Nulla di nuovo: per decenni la Coca-Cola, con un relativo successo, si è impegnata a far scattare l’associazione di idee tra la situazione “ragazzi allegri che si divertono insieme” e la sua bevanda. Così come, con deciso successo, la Kodak identificò la situazione “domenica di felice gita familiare” con la necessità di scattare un rullino di Kodachrome. Se il branded journalism è un caso estremo di compromissione, resta vero che anche le fotografie non implicate in strani traffici fra pubblicità e informazione ricevono dai nuovi mediail compito di definire un clima emotivo riconoscibile per il lettore: in questi casi sono la promozione di un brand che è la stessa testata, il sito stesso. Il Web chiama prepotentemente al suo servizio la fotografia, come non mai, ma il ruolo che temo le spetterà sempre più spesso è questo: materia prima semilavorata, plasmabile, emotiva e non informativa, servizievole e subliminale. A questo punto, lo so, dovrei passare alla pars construens, dire cosa possono fare i fotogiornalisti per reagire a questa tendenza e riaffermare il ruolo, la dignità, l’utilità del giornalismo visuale In cui in molti ancora crediamo. Francamente, confesso di non saperlo. Ho visto e apprezzato e tifato per molti esperimenti di resilienza fotogiornalistica: i gruppi e le cooperative, le piattaforme indipendenti, il crowfunding, la ricerca di una relazione diretta con i lettori utilizzando tutte le 15 opportunità della Rete. Alcune di queste imprese generose sono fallite, altre lottano ancora. Non so quali possano avere successo, lo auguro a tutte. Per parte mia, una convinzione ce l’ho. Che la sopravvivenza della democrazia dell’informazione sia legata indissolubilmente alla difesa del giornalismo redazionale, editato, al giornalismo che svolge per la comunità quel lavoro che nessun cittadino può svolgere da solo, di ricerca, verifica, validazione, selezione, gerarchizzazione, messa in ralazione causale e contestuale delle notizie e assunzione di responsabilià piena di tutto questo. Contro ogni illusione di felice “disintermediazione” (utopia sapientemente indotta, che si risolve immancabilmente nel suo contrario: cadere nelle mani di mediatori occulti, non identificati, non responsabili, interessati), credo che giornalisti di parola e di immagine dovrebbero avere ben chiaro che c’è un destino comune che ci lega, non un fossato che ci separa. [Testo dell'intervento che avrei voluto pronunciare all'incontro su etica e fotogiornalismo di Corigliano Fotografia 2014, al quale purtroppo non ho potuto partecipare] Tag: Buzzfeed, Coca-cola, Corigliano Fotografia, fotogiornalismo, Huffington Post, Jonathan Peretti,Souvid Datta Scritto in fotogiornalismo, Immagine e Internet | 25 Commenti Nature vive: la fotografia secondo Sam Abell di Janna Dotschkal da http://www.nationalgeographic.it/ FOTOGALLERIA "Componi l'immagine e poi attendi che qualcosa la animi": uno dei grandi nomi di National Geographic racconta la sua carriera, il lavoro per il magazine, la sua concezione dell'arte fotografica. Dal blog PROOF fotografie di Sam Abell « PRECEDENTE - Foto 1 di 9 - SUCCESSIVO » 16 Quando frugo nei nostri archivi e mi capita sott'occhio una foto di Sam Abell, capisco subito che è sua. Sam ha uno stile davvero caratteristico, con una composizione sempre pulita e uno splendido uso delle tonalità di colore. Mesi fa, frugando tra i nostri archivi online per il sito Found su Tumblr, ho trovato questa incredibile immagine di un acquario con un paesaggio riflesso sul vetro. Ma per quanto cercassi, non sono riuscita a trovare la data di scatto della foto, così sono stata costretta a lasciarla nell'archivio. Di recente però ho deciso di intervistare Sam, e ho scoperto la data di quella fotografia, che è stata scattata nel 1980. Ne ho approfittato per pubblicare la foto e fare una chiacchierata con questo fotografo che produce immaigni dal fascino sommesso e che tanto ha dato aNational Geographic nel corso della sua lunga carriera. Nota: Molte delle immagini in questa galleria sono state scattate per National Geographic ma non sono mai state pubblicate sulla rivista. JANNA DOTSCHKAL: Raccontami di questa fotografia. SAM ABELL: Si trattava di un commissionato su Hagi, in Giappone, una cittadina della costa sudoccidentale di Honshu che non era stata bombardata durante la Seconda guerra mondiale e manteneva quindi la sua architettura storica nonché la sua storica personalità. Il tema del servizio era proprio questo. Il commissionato era dela durata di un mese, nel corso del quale ho soggiornato in una piccola locanda tradizionale, una ryokan, nel centro storico del paesino. Non avevo automobile, ma il posto era - come dire - piccolo, limitato; la cittadina era piccola, perciò in quelle quattro o cinque settimane ho potuto immergermi nella storia in maniera intima e continuativa come non ho forse mai fatto in tutta la mia carriera. Ogni giorno camminavo per le vie, e un giorno sono capitato in un grande parcheggio ce era stato trasformato in un mercato agricolo. Al centro di questo mercato c'era un grande acquario con pesci vivi in vendita. Mi piace molto l'idea di unire natura morta e paesaggio, perciò ho scattato attraverso il vetro, riuscendo a unire nell'immagine l'acqua, il cielo e il paesaggio. E ho cercato anche di unire il pesce affinché entrasse nella composizione. Si tratta quindi di una composizione cercata attraversata da pesci; la diffìcoltà è stata tutta nel tempismo, ma è bastato scattare un certo numero di foto. Speravo che almeno uno scatto risultasse ben composto, con un'armonia perfetta tra il soggetto in primo piano e lo sfondo. Io la vedo come una fotografia paesaggistica con pesce, visto che è cominciata come paesaggio, una cosiddetta "natura morta" che in verità non è affatto morta. Le nuvole erano importanti, l'albero era molto importante e la prospettiva della foto era anche importante. Il pesce doveva essere nella giusta posizione. Ma il motivo per cui ho scelto questa particolare immagine nel corso dell'editing non è solo la posizione del pesce, bensì la riflettività dei tre elementi. JANNA: Hai parlato di osservare, aspettare e scattare un certo numero di foto molto simili. Trovi che questo approccio rappresenti la tua visione generaledella fotografia? 17 SAM: Assolutamente si. La scuola del "componi e attendi”. Io sono membro onorario di quella scuola. È uno dei tanti modi di scattare fotografie, ma è quello che funziona meglio per me. Negli anni mi sono appassionato alla pratica di osservare una scena, comporla in maniera rigorosa e poi attendere che qualcosa la animi. In questo caso, era l'acquario. Ho scelto lo scatto che aveva più vita, perché quello che mi interessa è la "vita di una fotografia". In questa immagine la vita viene infusa dal pesce, dalle bolle, e dalla iridescente proprietà riflessiva di questi particolari elementi. L’intervista che non ho mai fatto a HCB di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it No, tranquilli, non scrivo un altro articolo su Henri Cartier-Bresson. I classici non finiscono mai di dire cose nuove… Ma io non sono un classico. Mi dispiace però lasciar correre questaantologia di interviste, dodici, sparse nel corso della sua carriera, che dimostrano, mi pare, che l’uomo non era poi così ostico, laconico e irraggiungibile come la sua fama vorrebbe. E allora vi propongo un gioco. Ho ritagliato un po’ di risposte, autentiche, di HCB. E ho inventato a posteriori le domande, soprattutto quelle anacronistiche, che allora nessuno avrebbe potuto fargli. Peccato mortale del giornalista! Ma qui lo confesso. Sappiatelo. È solo un gioco, un po’ divertente un po’ tendenzioso. Ovviamente il senso appropriato delle risposte lo troverete nel libro. Eccovi dunque le riposte che HCB non ha mai dato alle domande che non gli ho mai fatto… 18 —— Signor Cartier-Bresson, ha mai fatto un’edizione delle sue fotografie a tiratura limitata? “Penso che le fotografie vengano scattate per essere riprodotte per le masse, non per i collezionisti. [...] L’arte risiede esclusivamente nell’umanità della propria riflessione”. Cosa pensa del World Press Photo? “Tutta questa competizione per stabilire chi sia il migliore è stupida. Distrugge qualcosa. Come si può mantenere una freschezza di sguardo e al tempo stesso partecipare a questa corsa?”. Lei è rimasto sempre fedele alla sua Leica. Quanto contano ora le capacità dell’autore, con le macchine iper-programmate? “Chiunque può scattare fotografie. Sull’Herald Tribune ho visto quelle di una scimmia che si destreggiava con una Polaroid, con la stessa abilità di molti proprietari di quella macchina”. Si fida della critica fotografica attuale? “Le persone capaci di vedere sono rare quanto quelle capaci di ascoltare”. Che futuro intravvede per i professionisti della fotografia? “Il nostro è un mestiere molto umile. [...] Veniamo accolti come il signore che viene a riparare lo sciacquone e quasi si deve portare dietro il posacenere”. Quali dei molti workshop in giro consiglia a un principiante? “Tutte queste scuole di fotografia non sono una cosa seria. Cosa insegnano? Lei potrebbe insegnarmi a camminare? Le scuole sono una fregatura”. Il futuro del fotogiornalismo in quest’era digitale? “Non ci sono quasi più riviste e nessuna vi manderà in qualche paese straniero perché ormai ci sono già andati tutti. Il mondo è cambiato”. Cosa pensa dei software di post-produzione? “Non ho niente a che vedere con quella roba. Non è il mio mestiere. Per me sta tutto nel momento dello scatto”. Ammette almeno la correzione dei toni, dei contrasti, dei colori? “L’unico modo di correggere una fotografia è azzeccare la successiva, se la realtà lo consente”. Come se la cava con le liberatorie? “Siamo tutti dei marginali e non dovremmo essere costretti a conformarci come tentano di fare queste leggi assurde: Signore, posso uscire? Signore, posso fotografare? Signore posso guardare con un occhio, con due occhi, con un occhio meccanico, un occhio di vetro?”. 19 La fotografia nell’era digitale ha smesso di essere documento di qualcosa? “Non si è mai tanto scadenti come quando si cerca di documentare. [...] La fotografia non dimostra niente [...] Non dobbiamo fare altro che stabilire rapporti”. Il libro, nell’era del Web, è ancora la meta nobile del fotografo? “Non ho mai scelto i titoli dei miei libri. Così come non ne ho mai curato l’impaginazione”. Molti professionisti dell’obiettivo sono gelosi del titolo di fotografo, lei cosa ne pensa? “Essere conosciuto come fotografo è una forma di potere, e io non ne voglio sapere”. Cosa pensa della nuova fotografia d’arte? “Oggi gli artisti guardano poco e pensano troppo. Ne risulta un accademismo sedicente di avanguardia”. Cartier-Bresson è ancora un modello da imitare? “Oh! Potrei dirvi delle cose bruttissime su di lui, mi raccomando, non parlateci mai, è insopportabile”. Tag: fotogiornalismo, Henri Cartier-Bresson, postproduzione Scritto in fotogiornalismo, Venerati maestri | 27 Commenti » Fotografia che muove, che si muove, che ci smuove di Leonello Bertolucci da http://www.ilfattoquotidiano.it/ Theater of Life - foto di Tomasz Lazar 20 Anche in fotografia, oggi più che mai, la questione è vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Chi lo vede mezzo vuoto, e ha le sue ragioni, si focalizza prevalentemente sul mercato asfittico dell’editoria in crisi, sulla bulimia superficiale da social, sull’incuria visuale dilagante. Chi lo vede mezzo pieno, anch’egli con le sue “pezze d’appoggio”, si concentra piuttosto sul dato che – sembra un paradosso – mai come oggi è stato vivo e vivace l’interesse verso le proposte culturali legate alla fotografia, che si moltiplicano e hanno una crescita costante nella partecipazione del pubblico. Dunque? Fotografia agonizzante o vitale? Una possibile risposta è: fotografia schizofrenica. Essa viene contemporaneamente “annacquata” dall’attuale uso mordi e fuggi dei grandi numeri ma anche promossa dai grandi numeri stessi: se ogni mille giovani che fotografano con lo smartphone feste di compleanno da postare sui social anche uno solo s’incuriosisce e vuole approfondire, allora siamo salvi. Questa tendenza positiva, questo “bicchiere mezzo pieno”, si può leggere per esempio nella crescita numerica e qualitativa dei festival di fotografia, sia in Italia che all’estero. Queste manifestazioni, queste kermesse che si svolgono in ogni dove, hanno al centro la fotografia come cultura ma anche come passione, curiosità e divertimento. Uniscono mostre, workshop, letture portfolio, intrattenimento e pure turismo, visto che ci si sposta e si soggiorna nei luoghi di svolgimento. Ovviamente ce ne sono di ottimi e ce ne sono di mediocri. Mentre in questi giorni si aprono Les Rencontres ad Arles, una delle manifestazioni più importanti del mondo, qui in Italia il 17 luglio s’inaugura uno dei festival più interessanti e meglio organizzati: Cortona on the move. Il festival ha vari ingredienti vincenti: il tema forte del viaggio, inteso on solo come esplorazione dello spazio fisico ma anche come viaggio interiore (infatti il sottotilo del festival è “Fotografia in viaggio” e non “di viaggo”); poi una selezione ragionata e attenta alla qualità degli autori proposti, dovuta alla grande competenza della curatrice Arianna Rinaldo. E ancora, un’organizzazione superefficiente con l’appoggio di partner istituzionali e privati. Non da ultimo la cornice, ovvero la magia di un luogo come Cortona, contenitore ideale per un fuori-dentro in tensione estetica ed emotiva senza soluzione di continuità. Nello scrivere di un festival di fotografia, di solito si accompagna il testo con una serie di foto tratte dalle varie mostre monografiche, col risultato di creare una sorta di “collettiva” che sposta il senso di ogni cosa, e dove ogni autore viene mortificato e reso incomprensibile estrapolando una o due foto dal suo intero progetto, a cui magari ha dedicato anni. Dunque evito questo tipo di “rassegna stampa”, ma piuttosto scelgo arbitrariamente un solo autore invitandovi a scoprire di persona gli altri (tutte le mostre sono visibili fino al 28 settembre). Io devo avere avuto una vita precedente in Polonia: andando a Paris Photo (ne scrissi qui) venni folgorato dal fotografo polacco Pankieviz e ora, tra gli autori – tutti interessanti – presentati a Cortona, mi intriga intensamente, quasi per le stesse ragioni, un altro fotografo polacco. 21 Si tratta di Tomasz Lazar, che presenta la mostra Theater of Life (realizzata in collaborazione con l’ente del turismo della Regione Podlaskie). Difficile razionalizzare e dunque descrivere quel qualcosa che è la cifra narrativa di Lazar; è un misto di poesia, ironia, grottesco, incanto, stupore, equilibrio, sogno e pure incubo. Il risultato è uno stile personalissimo non urlato ma penetrante, con uno speciale “imprinting” sottotraccia. Se il lavoro di Lazar che viene presentato a Cortona è un viaggio – e deve in qualche modo esserlo, se è stato selezionato – che tipo di viaggio è, dove ci porta? Cosa ha visto il fotografo lungo il suo percorso? Ed è stato, il suo, più viaggio di chilometri o viaggio immaginario della mente? Anche se già letta e riletta mille volte, mai come in questo caso sembra davvero appropriata la famosa frase di Proust: “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”. E il nostro Tomasz lo sa. 22 (seguitemi su Twitter) Commenti (2) Più informazioni su: Fotografi, Fotografia, Mostre, Smartphone, Social Network, Viaggi. Foto girevoli, virus e patologie Web di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it Centrifuga per asciugare il significato delle fotografie “Ecco la foto che fa impazzire / commuovere / indignare il Web”. Internet sembra una persona, nei nuovi luoghi comuni. Ma quando si personalizza uno strumento, non è più un semplice luogo comune, né una metafora. Si è mosso qualcosa nel nostro rapporto con quello strumento. Quando poi sento dire, o leggo: “C’è una foto che gira sul Web…”, allora mi preoccupo. Gira? Come una trottola? E chi ha dato il primo colpo di manovella? Sul Web? Ma dove, di preciso? Su quale pagina, portale, sito, profilo se ne va in giro…? Quali sono le tue fonti? Sei in grado di citarle? Sono attendibili? “Gira sul Web” non è un modo di dire. È un modo di pensare, anzi di acquisire le informazioni che servono per pensare e per prendere decisioni importanti nella nostra vita. Ed è un modo pericoloso . E se chi dice “gira una foto sul Web” è addirittura un pubblico decisore, prendendo per giunta una solenne cantonata, mi preoccupo ancora di più, dieci volte di più, mi spavento proprio. 23 Quell’espressione, “gira sul Web“, somiglia molto a una riedizione della frase da tinello dei nostri genitori: “l’ha detto il telegiornale”. Ma è una falsa analogia. L’ingenuità e la creduloneria sono le stesse, ma i nostri genitori avevano alcune scusanti: di tigì, all’epoca loro, ce n’era uno solo, o due ma in fotocopia. La capacità critica stentava, ma almeno la fonte dell’informazione era chiara. “Gira sul Web” non indica una fonte. Il Web non è una fonte, è un canale. Un enorme canale. Riferirsi al Web come fosse una fonte di informazione strutturata, editata, è altrettanto insensato che dare un valore di diagnosi medica alla frase “c’è in giro un virus…”. Il vero problema è che non basta essere consapevoli di questo, cioè che il Web è solo un canale. Perchè, scusate, è un mio pallino, non esistono strumenti neutri, e ogni canale, passatemi la metafora, colora a modo suo l’acqua che lo attraversa. Ma l’ideologia interessata del Web è fatta apposta per incoraggiare quel modo di dire e di pensare, per confondere le acque: è utile ai suoi aspiranti dominatori presentare la Rete come un unico grande serbatoio da cui siamo “liberi di attingere” gran parte delle informazioni e di quant’altro ci serve per vivere. L’evoluzione delle interfacce conferma e rafforza questa ideologia monopolista. Ho appena letto che l’accesso a Internet via mobile ha superato in Italia quello via schermo fisso.Ora, dunque, quel flusso di informazioni ci arriva direttamente in tasca. Quasi tutte le nozioni che acquisiamo quotidianamente ci arrivano sulo stessodisplay. Conversazioni con gli amici, informazioni editate, informazioni “dirette”, intrattenimento, servizi… Come un gigantesco imbuto, tutto passa in quei pochi pollici di vetro retroilluminato. Lasciamo stare la questione, cruciale per il futuro dell’informazione, della colossale lotta in corso fra multinazionali per conquistare quote di temposchermo. Pensiamo ora solo agli effetti di questa concentrazione “spaziale” sull’apprendimento e sullo spirito critico. Bene, alcuni effetti sono come quelli che mi ha raccontato, perplesso, un autorevolissimo collega. “A volte mi capita questo: so benissimo di avere già letto una certa notizia, ma non ricordo dove l’ho letta. Quando leggevo solo giornali di carta non mi capitava mai”. Proprio così. Il salto dalla carta al Web – lo ha scritto tempo fa anche lo Scientific American - fa guadagnare un sacco di opportunità, ma ne fa perdere alcune, tra le quali quelle molto preziose che ci dà la memoria visualespaziale, capace di distinguere tra loro le informazioni assunte in luoghi fisicamente diversi. 24 Quando tutto quel che sappiamo del mondo, compresa gran parte delle relazioni umane, ci arriva nella stessa modalità e nello stesso spazio fisico, quella mappa geografica interiore collassa. La nostra mente conserva solo la memoria di aver letto una certa cosa “su Internet” cioè sul display, e questo mette in ombra la fonte reale di quell’informazione (sito, testata, social). Questa commistione pericolosa, questo indebolimento critico (sapere chi ci ha dato un’informazione è essenziale per gestire quell’informazione) non è solo un effetto collaterale spiacevole: fa parte di un’ideologia dell’informazione che, se prevarrà, farà pendere la bilancia dei poteri globali che lottano per il controllo dell’informazione dalla parte dei gestori di piattaforme, di aggregatori, di portali che pescano e rilanciano marmellata di informazioni non verificate, non gerarchizzate, non collegate, a danno dell’informazione editata, verificata e responsabile. Quel che scriviamo noi giornalisti, se ci riusciremo ancora; quel che fotografate voi fotogiornalisti, se ci riuscirete ancora, non sarà più nostro, neanche se riusciremo ancora a firmarlo e perfino a farci pagare il lavoro. Sarà della Rete. “Gira sul Web” vuol dire questo. Pensiamoci ogni volta che pronunciamo questa espressione, ogni volta che rilanciamo una notizia “carina” magari già rilanciata da un amico su Facebook, presa da chissà dove. Questa pista da ballo virtuale, piena di revolving photos, dove ogni informazione giracome un derviscio imbambolato, ci farà perdere l’equilibrio, se non stiamo un po’ più attenti. Tag: Facebook, fotografia, Internet, Scientific American, Web Scritto in condivisione, fotografia e società, Immagine e Internet | 6 Commenti I Vagabondaggi di Sergio Larrain, il fotografo degli invisibili da http://www.libreriamo.it/ 25 In mostra per la prima volta in Italia al Forte di Bard fino al 9 novembre la grande retrospettiva dedicata a Sergio Larrain, il cileno che girò il mondo per fotografare gli ultimi, gli orfanelli, le prostitute. La mostra è curata da Agnès Sire, amica di penna di Sergio al quale l'artista ha consegnato idealmente il suo patrimonio di immagini MILANO – Insieme alla mostra su Picasso, il Forte di Bard (AO) si dedica anche alla fotografia, e lo fa con uno dei personaggi più schivi e al contempo più interessanti del panorama della fotografia mondiale: Sergio Larrain con ''Vagabondages''. Come molti dei grandi fotografi, anche Larrain fa parte dell'agenzia Magnum Photos, chiamato personalmente da Henri CartierBresson nel 1959. LA MOSTRA – La mostra, coprodotta da Magnum Photos e curata da Agnès Sire, direttore della Fondation Henri Cartier-Bresson, sotto l’alto patrocinio dell’Ambasciata del Cile in Italia, rappresenta al Forte di Bard la prima grande retrospettiva italiana dedicata a Sergio Larrain. 127 scatti, quasi tutti compresi tra il 1950 e il 1964, il maggior periodo di produzione del fotografo, 4 disegni e 4 scritti originali di Larrain, 5 riviste accompagnate da 6 scatti vintage, 4 libri, oltre a due filmati sono esposti nelle sale delle Cantine del Forte. Agnès Sire, direttrice della Fondazione Henri Cartier-Bresson e amica epistolare di Larrain per circa 30anni lo ha definito un meteorite che ha attraversato l’universo della fotografia e che ha avuto la saggezza di fermarsi perché non riusciva più a trovare la sua libertà fotografando, ma solo alienazione. Fermamente contrario all’idea di una mostra sulle sue fotografie, perché l’attenzione mediatica lo avrebbe allontanato dal suo isolamento duramente conquistato, Sergio accettò solo alla fine della sua vita che Agnès Sire curasse una retrospettiva del suo lavoro. Il catalogo dell’esposizione, “Sergio Larrain: Vagabond Photographer” a cura di Agnès Sire e Gonzalo Leiva Quijada ha da poco la medaglia d’oro come Best Photography Book Award dalla Kraszna-Krausz Foundation, il più prestigioso premio anglosassone sull’editoria fotografica. BIOGRAFIA D’ARTISTA – Sergio Larrain nato nel 1931 da una famiglia aristocratica cilena (il padre era infatti un celebre architetto) mal sopportava il lusso e la bella vita e così decise presto di allontanarsene. Dopo 3 anni di insoddisfacenti studi in ingegneria forestale negli Stati Uniti, dal '50 inizia a fotografare con una Leica IIIC e, tornato in Cile, sviluppa le foto in un piccolo laboratorio allestito in casa. I bambini orfani e abbandonati, la vita degli umili e dei dimenticati di Santiago sono i soggetti del primo lavoro di Larrain e rappresentano, al tempo stesso, lo specchio della sua personalità e l’espressione del suo desiderio di una società migliore. Fotografa gli ultimi e, con il suo sguardo di compassione, riesce ad essere tutt’uno con loro, divenendo loro amico. Questo nucleo di fotografie diventerà un riferimento imprescindibile per tutta la fotografia cilena e segnerà l’inizio della notorietà di Larrain e della sua attività di fotografo: prima free lance, poi foto reporter della rivista brasiliana O Cruizero Internacional, sino alla collaborazione con l’agenzia Magnum negli anni ’60, su diretto invito del fondatore Cartier-Bresson. Sergio Larrain ha lavorato anche con il Premio Nobel per la Letteratura Pablo Neruda, scattando le foto per “Una casa en la arena” e collaborando con lui per il suo primo libro, Valparaiso. 26 Nel 1978, non riuscendo più a trovare nella fotografia la propria libertà, decise di abbandonarla, e di ritirarsi a vita privata, iniziando un percorso di introspezione mistica in un paesino sulla cordigliera cilena, nel silenzio delle Ande, lontano dal mondo e dalla società. Lì avrebbe insegnato yoga e disegno, scritto libri e poesie, e vissuto in maniera autosufficiente fino alla morte. Oggi le sue opere fanno parte delle collezioni di musei e collezioni prestigiose, tra cui quella del MOMA di New York. Tags: Sergio Larrain, Vagabondages, Magnum Photos, Henri CartierBresson, Agnès Sire Cesare e la “sorellina disabile” di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it Cesare Colombo, foto © Lorenzo Ceva Valla, g.c. «Sono sicuro di aver visto giusto? E soprattutto: che cosa ho visto?». Un “libretto rosso” non dovrebbe concludersi così, con un dubbio esistenziale. Ma Cesare Colombo è stato, per oltre mezzo secolo di cultura visuale italiana, un rivoluzionario senza dogmi e senza diktat, e non si pentirà adesso, a un anno dagli ottanta tondi. Almeno alla seconda domanda, comunque, è facile rispondere per lui: ha visto tutto quel che c’era da vedere attorno a lui, e non ha soltanto visto, ha fatto, e ha fatto vedere. Fotografo, grafico, critico, storico, giornalista, editor, docente, archivista, curatore: il secolo dell’immagine lo ha attraversato come un prisma, lo ha scomposto in tutti i suoi mestieri. Chiunque si è occupato di fotografia, negli ultimi decenni, ha incrociato le molte strade di Cesare Colombo, pivot schivo, non esibizionista, di una generazione di “vedenti”. 27 Il riassunto di tutto sta adesso in un libro dalla copertina rossa, La camera del tempo, edito da Contrasto e scritto assieme a Simona Guerra, qualcosa tra un’autobiografia intellettuale, un album, un’antologia. Ma prima ancora sta sugli scaffali di questo studiolo bianco soppalcato, in moderato produttivo disordine, che dà su un cortile “di ringhiera”, che dà su una sponda del Naviglio Grande, un distillato di Milano, la città delle immagini, «la città che butta via le immagini… Guardi cos’hanno fatto di questo tratto di Naviglio…».Zatteroni da cocktail, pedane con erba finta, megaschermi per i Mondiali, lame di pubblicità che squartano la prospettiva più pittoresca della città. «È la logica conclusione di un percorso… Un paese che non crede nel vedere». Immagine, nel Novecento, è stata un sinonimo di fotografia, la mamma di tutte le immagini meccaniche. Figlio e nipote di artisti, svezzato fin da piccolo ai traumi dell’arte per via di quelle modelle nude nello studio di papà, in posa «vicino alla stufetta elettrica, mi immunizzarono da turbamenti psicologici vari». Cesare Colombo, 1957. Milano, via Montenapoleone, gli ultimi fattorini. © Cesare Colombo, g.c. Usava la fotocamera di papà, la sua camera oscura, approdò al curioso turbolento mondo dei «sacri weekend estetici», l’accanito clan dei fotoamatori delle gite domenicali e dei concorsi con le medaglie di vermeil, che a Milano aveva, ed ha ancora, una casa nobile, il Circolo Fotografico Milanese, dove Cesare ragazzino assisteva agli epici scontri fra il formalismo crociano di Giuseppe Cavalli e l’umanesimo impegnato di Pietro Donzelli, battaglia fra titani che non lasciava scampo, o di qua o di là. E Cesare andò di là, con gli impegnati, e con la penna in mano, sempre stato bravino a scrivere, incrociò le spade con gli “esteti”, ma adesso un po’ è pentito: «Vedendo come è andata poi la vicenda fotografica italiana, be’, in fondo loro, con tutte le loro geometrie levigate e sfumate, rivendicavano quella dignità e autonomia al linguaggio della fotografia, che la cultura di questo paese non ha mai riconosciute». Assunto per qualche anno all’Agfa, la sfidante tedesca dell’industria fotografica italiana, ma sospetto di intelligenza col nemico (scriveva anche per la rivista della concorrenteFerrania, bibbia mensile del fotoamatorismo anni 28 Cinquanta), poi grafico pubblicitario in proprio, specialità fotografia industriale, oggi diremmo immagine corporate. E intanto però fotografo “sociale”, di strada, engagé, nella Milano della Vita Agra, dove incrociava i Mulas, i Dondero, i De Biasi, i Nicolini, i Lucas. «Ho vissuto senza troppi problemi una doppia esistenza, durante la settimana costruttore d’immagine dell’impresa, nel tempo libero contestatore visuale col movimento studentesco…». Lo dice con un’ombra di ironia. «Vedo le cose in prospettiva. Avevamo molta fiducia in lei, ma la fotografia è un medium gracile. Riesce splendidamente a creare relazioni di senso nello spazio, ma non sa andare oltre la cornice. Guardi: una celebre foto di calcio, una magnifica rovesciata. Ma poi, avrà fatto gol? Vedo la tensione dei muscoli, l’espressione del viso, nessuno saprebbe descriverli in parole. Ma non so com’è andata a finire. La fotografia ha bisogno delle parole». Quando arrivò il ’68, sembrava facile. «C’era un corteo ogni giorno, o quasi. Le immagini andavano sui giornali, quelli della sinistra soprattutto. Ma ci siamo chiesti se era proprio quella, la fotografia impegnata. Capimmo abbastanza presto che una foto di lotta non era buona solo perché era giusto lo slogan dello striscione che avevi inquadrato. Che bisognava risalire la corrente, andare alle radici dei conflitti, magari avvistare quelli nuovi». Cesare Colombo, 1968. Milano, il grattacielo per uffici Galfa visto dal grattacielo Pirelli. © Cesare Colombo, g.c. In una sua foto del ’69, la parete trasparente del grattacielo Galfa, presa di sera, col buio ma con gli uffici ancora attivi e illuminati, un alveare dove ogni impiegato abita da solo la sua celletta, è un simbolo potente dell’alienazione post-industriale. Aveva «visto giusto», quindi?Sorride: «Posso dire di essermi occupato per cinquant’anni di un medium che in Italia non è mai interessato a nessuno, 29 meno che mai alla nostra classe intellettuale. L’espressione “fotografia italiana” è una contraddizione in termini. Questo non era un paese destinato alla fotografia. Tutto lo spazio era già occupato dalla massa imponente della nostra tradizione d’arte. Gli intellettuali italiani non hanno mai degnato di uno sguardo questa parente povera, questa sorella disabile dell’arte che si fa a macchina. Il posto per lei è rimasto quello che le assegnò Baudelaire: umile servetta, senza autonomia espressiva. Quando le imprese mi chiamavano per un lavoro su commissione, mi dicevano “fammi questo, e fammelo così e così”: persone che magari non sapevano neppure cos’era un esposimetro. I grandi giornalisti inviati dicevano “il mio fotografo”, come un esploratore direbbe “il mio sherpa”… In America, paese visualmente vergine, il fotografo Walker Evans e lo scrittore James Agee lavorarono alla pari un libro celebre, da noi invece Vittorini strapazzò Luigi Crocenzi per Conversazione in Sicilia». Il cinema ce l’ha fatta, però, a bucare quel muro supponente e dorato. «Fino a un certo punto. Il neorealismo è stato una versione del melodramma. La fotografia invece non aveva madri nobili a cui rifarsi». Ma Il Mondo di Pannunzio, lei ci ha collaborato, valorizzò la fotografia… «Purché genuflessa alla parola. Non erano foto, erano elzeviri visuali scelti e ”orientati” dallo scrittore. Il Mondo era pieno di foto, ma nella sua storia ha dedicato due soli articoli alla fotografia, tutti e due per la mostra romana di Cartier-Bresson». Eppure, o forse per questo, per una missione di salvataggio, per uno spirito di rivincita, Colombo aggiunse un giorno alle sue mostre celebri, come L’occhio di Milano, ai suoi reportage, alle collaborazioni con le riviste d’architettura, insomma ai suoi mestieri, anche quello dell’archivista. Salvatore di foto altrui, altrimenti destinate all’oblio o alla pattumiera. Studioso di fondi considerati poco più che scatoloni di cartacce. Gli archivi delle grandi aziende, quelli delle istituzioni, quelli degli studi fotografici dell’Ottocento, dei fotografifreelance del Novecento, fino a quelli del Mozambico post-rivoluzionario che lo chiamò a Maputo a rimettere in ordine la memoria visiva orgogliosa di un paese intero. Troppo tardi ormai per salvare la “sorella disabile”? La fotografia oggi è ovunque, quindi non è più nulla in sé. Dissolta nell’ambiente, inavvertita come il respiro. “Siamo tutti fotografi”, ha certificato perfino Paris Match. Con qualche anno di ritardo, si chiude il Novecento della fotografia? «Apparentemente nulla scuote più l’osservatore. La missione fotografica originaria, far conoscere il visibile, sembra esaurita per ridondanza. In effetti, il fotografo del futuro prossimo potrebbe essere solo un super-editor che deve solo rimescolare il già visto». Ma lei non crede che finirà così, dico bene? «Ho una fiducia, diciamo, statistica. Milioni di persone incontrano la fotografia. Nel mare della fotografia preterintenzionale, gestuale, della fotografia che vale come un “ciao come stai?”, sarà comunque più facile che a qualcuno venga voglia di andare oltre. Una buona reflex costa poco più di uno smartphone…». 30 La fotografia è morta? «Non lo dirò mai. Certo, non sta molto bene. Ma io sono in attesa». [Una versione di questo articolo è apparsa su La Domenica di Repubblica il 5 luglio 2014] Tag: Agfa, Cesare Colombo, Circolo fotografico milanese, Elio Vittorini, Ferrania, Giuseppe Cavalli,Henri Cartier-Bresson, Il Mondo, James Agee, Luigi Crocenzi, Mario De Biasi, Mario Dondero, Mario Pannunzio, neorealismo, Paris Match, Pietro Donzelli, Simona Guerra, Toni Nicolini, Ugo Mulas, Uliano Lucas, Walker Evans Scritto in fotogiornalismo, fotografia e società, Venerati maestri | 13 Commenti Spilimbergo Fotografia. Ventotto anni tra passato e presente di Terry Peterle da http://www.artribune.com/ Spilimbergo Fotografia 2014, promossa dal CRAF - Centro di Ricerca per l'Archiviazione della Fotografia, ha inaugurato la sua 28esima edizione lo scorso sabato. La meravigliosa cornice è quella di Palazzo Tadea, con mostre, eventi, incontri e corsi. Bruno Cattani, Memorie 31 Spilimbergo Fotografia si è aperta con gli interventi di Guido Cecere, professore, critico e curatore, che ha aperto le mostre dirette da lui stesso, da Massimo Vitali con Sempre più pallide, Towards Achrome, fotografie in grande formato che descrivono con apparente leggerezza come il turismo di massa abbia invaso le più belle spiagge d’Italia, e di Monika Bulaj, fotogiornalista, scrittrice e antropologa polacca che, in Genti di Dio. Viaggio nell’altra Europa, cerca in viaggio nelle minoranze etniche e religiose le vicende più profonde dell’animo umano. A questi due artisti e fotogiornalisti il Craf ha attribuito il Premio Friuli Venezia Giulia Fotografia 2014. Da citare l’emozionale ricordo del fotografo ritrattista udinese Francesco Krivec da parte del collega Franco Martelli Rossi. Con un delicato racconto viene reso omaggio all’immensa eredità fotografica lasciato da Krivec con il premio Amici del CRAF – X Edizione. Più di 60mila negativi donati al CRAF, tra ritratti di gente comune e personalità di interesse storico-culturale come Pier Paolo Pasolini, e le molteplici situazioni importanti della città di Udine, come le vie stravolte dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale o la visita di personalità politiche nel dopoguerra come De Gasperi e Berlinguer. La sua memoria non è solo fonte di informazioni, ma rappresenta soprattutto una coscienza dell’epoca. Massimo Vitali Tra le altre mostre presenti in varie città della Regione, Franco Fontana alla Galleria Tina Modotti di Udine: una celebrazione del colore e della luce sovraesposta, surreale, sospesa e a prima vista impossibile su paesaggi, edifici e corpi. A Villa Ciani, Lestans, a cura di Sandro Parmiggiani, Bruno Cattani con Memorie racconta di paesaggi rubati dal progresso, sembianze del secolo passato, la continua ricerca di tracce da mettere in salvo dall’oblio. Appuntamento domani 18 luglio, presso le Sale Espositive della Provincia a Pordenone, per l’inaugurazione di Capolavori di Storia della Fotografia. 32 Dall’archivio di Charles Henri Favrod, a cura di Charles Henri Favrod e Walter Liva. Una rappresentativa di autori, patrimonio del CRAF e donati dallo stesso autore, che hanno marcato la storia della fotografia sin dalle sue origini, tra i quali anche Edward Weston. Maria Mulas, Andy Warhol, 1987 #2 Tra le mostre più attese, quella che inaugura venerdì 25 luglio: Maria Mulas e i suoiRitratti: un sessantesimo di secondo, con fotografie di grandi artisti e personaggi, da Andy Warhol a Joseph Beuys, da Henry Moore a Keith Haring; mentre sabato 26 si apre la mostra di Robert Doisneau, La Fotografia Umanista, a cura di Walter Liva: protagonista una romantica Parigi, un legame inscindibile di bianco e neri tra donne, uomini, bambini, innamorati, animali e la quotidianità della città. Accanto alla serieDevant la Joconde, da collezioni 33 private e dall’archivio di Roberto Salbitani sono tratte altre venti immagini, a completare l’omaggio del CRAF a Doisneau e all’impegno delle figlie Annette e Francine, che conservano e valorizzano il suo archivio fotografico. A loro – all’Atelier Doisneau – verrà assegnato l’International Award of Photography 2014. Tra le altre mostre, da segnalare quelle di Michele Mattiello e Uma Kinoshita dal titoloConseguenze. Vajont – Fukushima, nello spazio di Mulino di Ampiano, presso Pinzano al Tagliamento; e quella di Burkhardt Kiegeland e Willie Osterman, Salzstrasse, nel Centro Civico di Lignano Sabbiadoro. Uma Kinoschita, Lost 02 Una rassegna, quella di Spilimbergo Fotografia, che non vuole solo divulgare la cultura della fotografia come mero piacere visivo, ma che intende rendere consapevoli gli spettatori, amanti e non della fotografia, come questa arte stia prendendo un posto sempre più preponderante nella vita di tutti i giorni, non solo nel panorama culturale, ma soprattutto nella sfera educativa della socialità. Cortona On The Move da http://undo.net/it DIVERSE SEDI, CORTON A (AR) Quarta edizione del Festival internazionale fotografia in viaggio. Tra i grandi autori di quest'anno Rob Hornstra, Jacob Aue Sobol, William Albert Allard ma anche una mostra sulla smart photography. Inoltre dibattiti, proiezioni, workshop e letture portfolio. 34 COMUNICATO STAMPA L’appuntamento per appassionati e operatori è fissato per il 17 luglio 2014, giorno di apertura dell’edizione 2014 del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move – fotografia in viaggio. Il festival è giunto alla sua quarta edizione ed è orm ai consacrato come uno degli eventi più importanti della scena fotografica internazionale. Anche quest’anno, fino al 28 settembre, Cortona sarà al centro di storie, viaggi e avventure raccontate da alcuni dei più importanti fotografi della scena internazi onale. Nella prima settimana del festival, quella tradizionalmente più ricca di eventi, nei vicoli della città toscana si incontreranno grandi fotografi, i migliori esperti di fotografia a livello nazionale ed internazionale, giovani talenti e semplici appassionati. Arianna Rinaldo sarà per il terzo anno consecutivo il direttore artistico del festival organizzato dall’Associazione Culturale ONTHEMOVE. Le sue scelte per l’edizione 2014 riprendono il percorso di innovazione, sperimentazione e altissima quali tà tracciato fin dal 35 2012. Tra i grandi fotografi di quest’anno Rob Hornstra, Jacob Aue Sobol e William Albert Allard, ma anche un’imperdibile mostra sulla smart photography curata da Kathy Ryan e Scott Thode. Nei primi giorni del festival (dal 17 al 20 d i luglio) si concentreranno gli eventi quali inaugurazioni, dibattiti, proiezioni, workshop e letture portfolio dei migliori photo editor nazionali ed internazionali. Mostre: WILLIAM ALBERT ALLARD Portraits of America JACOB AUE SOBOL Arrivals and departures ALBERT BONSFILLS Lina and Mengchun BRASCHLER & FISCHER The China Project ROB HORNSTRA The Sochi Project ALVARO LAIZ Transmongolian: the secret history of the Mongols TOMASZ LAZAR Theater of Life - Focus on POLONIA CARLO LOVARI Viaggio in Famigli a ALESSANDRO PENSO European Dream, Road to Bruxelles KATHY RYAN & SCOTT THODE Goin’ Mobile, curated by Kathy Ryan and Scott Thode ANASTASIA TAYLOR -LIND Negative Zero Chapter 1: Birth TERRA PROJECT Land Inc. TOMASZ TOMASZEWSKI Overwhelmed by the atmosphere of kindness - Focus on POLONIA MARTIN WEBER A map of Latin American Dreams Letture portfolio : Manila Camarini - D di Repubblica; Lucy Conticello - M, le magazine du Monde; Renata Ferri - Io donna, Amica; Olivier Laurent – Editor at Lightbox Time; Emanuel a Mirabelli - Marie Claire Italia; Andrey Polikanov - Russian Reporter Magazine; Fiona Rogers – Magnum Photos; Kathy Ryan – The New York Times Magazine; Maarten Schilt, Marie Louise Schilt - Schilt Publishing & Gallery; Scott Thode – Fortune Magazine; Giulia Ticozzi – Linkiesta; Erik Vroons – Gup Magazine; Donald R. Winslow - News Photographer magazine for NPPA. Per prenotare una lettura portfolio e i workshop con grandi fotografi e professionisti della fotografia info sul sito. Immagine: Anastasia Taylor -Lind Ufficio Stampa: Luca Faenzi tel. 328 6438076 - 347 3300362 - 328 8414658 [email protected] Associazione Culturale On the Move, Località Vallone, 39/A/4 - Cortona, 52044 (AR) 36 Ghirri in Italy, reloaded di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it Claudia Corrent: Isola di Burano (VE), ©2014 Claudia Corrent, g.c. “La cosa più difficile è scavalcare Ghirri”, avrebbe detto un bravo e noto fotografo della semiultima generazione di paesaggisti italiani, e non ho dubbi che volesse esprimere con questo un grande messaggio di affetto, di stima e di rimpianto. C’è Luigi Ghirri in mezzo alla strada di tutti coloro che guardano questa Italia attraverso una lente. Lo si può aggirare, lo si deve superare, ma è lì. Nei nostri occhi e dentro di noi. Forse qualcuno ha trovato un modo giusto, intelligente, di farci i conti. Viaggio in Italia, forse la piùambiziosa impresa intellettuale collettiva della nostra fotografia, compie trent’anni. La distanza di una generazione. La distanza giusta. L’idea è nata, l’ho vista nascere anch’io, alla fine dell’anno scorso sulla pagina FacebookWe Do the Rest. Dove Fulvio Bortolozzo, testa lucida sotto più punti di vista, forse all’inizio per gioco, poi per ipotesi, poi sul serio, ha cominciato a raccogliere materiale fotografico per una rivisitazione di quell’esperienza. Il risultato è Questo paese, opera collettiva di venticinque fotografi sparsi irregolarmente lungo lo Stivale (una mappa che rifà il verso alla copertina del Viaggio li colloca nello spazio), presentata recentemente a Corigliano Fotografia. Fatevi spiegare meglio dalla voce di Fulvio. Rivisitazione e non riedizione, e non rifacimento. Per fortuna. Semmai, verifica. Verifica di distanze diverse. Fra i fotografi d’oggi e il team Ghirri. Fra la sua Italia e la nostra. Fra le diverse sensibilità di oggi. Ma anche una verifica, diciamo così, di diffrazione. 37 Sapete, come quando un raggio di sole passa per un prisma di vetro. Ho avuto questa impressione. La imponente, ingombrante poetica ghirriana allargata come in uno spettro, scomposta nei suoi colori fondamentali per poterla analizzare meglio, per capire quanto le onde luminose si possono allontanare dalla loro sorgente originaria. Giancarlo Rado: Diego Rizza, la moglie Anna Zurek , il figlio Tomek e Savanna ritratti in Malga Fossernica di Dentro , Caoria, Trentino, prima della chiusura dell’alpeggio estivo. ©2013 Giancarlo Rado. g.c. Non fatevi l’idea sbagliata: da quel che ho visto, e mi riservo di vedere meglio, nel lavoro collettivo ci sono vicinanze ma anche lontananze estreme, ci sono tracce di quel che è accaduto nel frattempo (Guido Guidi hic fuit…). Ciascuno dei venticinque, in ogni caso va per la sua strada. Non per caso, la selezione ha incluso anche un lavoro su ritratti. Ma quel che ho trovato interessante nel concetto, è che nessuno ha sentito il bisogno di uccidere nessuno, neanche simbolicamente. Si può andare oltre senza ammazzare i padri: guardandoli in faccia. Mettendo alla prova il loro insegnamento. Staccandosi come i figli fanno. Il passo avanti mi sembra questo: si può fare a meno del genere paesaggio? Si può cominciare a passare, intravedendo una terza stagione dopo quella Alinari e quella Ghirri, dalla fotografia dei luoghi alla fotografia nei luoghi, per dirla con le parole del curatore? La condizione di base per l’inclusione nel progetto era che il fotografo avesse un legame speciale, intenso, biografico con i luoghi in cui fotografa. E questo è già un passaggio importante. 38 Ghirri e i suoi partivano alla scoperta di un paese troppo guardato e poco visto. Ce n’era bisogno: solo uno sguardo non preparato, carico di sorpresa, poteva riuscire a rinnovare lo sguardo codificato da un secolo di cliché, cartoline, instamatic del papà. L’Italia che dobbiamo ri-guardare oggi (cioè per la quale dobbiamo avere ri-guardo, rispetto: anche questa è lezione di Ghirri) è un’altra Italia, fotograficamente ricodificata dalla neofotografia di massa. Dalla fotografia che si disinteressa ai luoghi, o viceversa li “pompa” entfaticamente di filtri preimpostati. Ora dunque è lo sguardo di prossimità, quello della quotidianità, quello della fotografia tascabile e preterintenzionale, che rischia di ricodificare a modo suo quello sguardo che la generazione Ghirri aveva provato, in parte riuscendoci, a decongestionare dai luoghi comuni visuali della sua epoca. Ed è quindi una rinnovata fotografia della prossimità quella che può e deve tornare al lavoro, proprio come si riprende la manutenzione di un monumento, anche lì più o meno a cadenza di trent’anni, con lo stesso scopo di allora: restituire alla visione fotografica il suo compito, che è scambiare visioni significative del mondo fra le persone. Può essere che abbia visto male. Forse è solo quel che spero che accada, contando che l’esperimento continui. Tag: fotografia, Fulvio Bortolozzo, Luigi Ghirri, paesaggio, Viaggio in Italia Scritto in paesaggio, Venerati maestri | 24 Com Giorgio Appendino 1928-2014 di Michele Ghigo, Presidente d'Onore della FIAF da [email protected] Nella notte tra il 23 ed il 24 Luglio, nella propria abitazione di Collegno (TO), è mancato dopo lunga malattia, GIORGIO APPENDINO HonEFIAP, uno dei protagonisti della crescita della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Era nato ad Alba(CN) nel 1928 ed era socio del Gruppo Fotografico dell’Azienda Tramviaria Municipale di Torino , nella quale ricoprì diversi incarichi di responsabilità. Entrò nella struttura organizzativa della FIAF nel 1977 come vicesegretario e ricoprì l’incarico di segretario dal 1978 al 1991, dedicando alla Federazione profusione di lavoro e di idee non comuni, e moltissime ore di presenza in sede 39 nello svolgimento di tutte le mansioni di segreteria in periodi in cui il volontariato imperava, anche perché la nostra struttura non poteva permettersi la collaborazione di personale retribuito. Dobbiamo a Lui l’uscita dal ventre materno della Società Fotografica Subalpina e sopra tutto la ricerca di una sede autonoma dotata di spazio espositivo oltre che di archivio, prima in via Sacchi 28bis e poi in corso San Martino 8. Era uomo dotato di una grande carica di umanità, che manifestava sopra tutto in occasione di congressi e raduni, conquistando la stima e la simpatia di soci di ogni parte d’Italia, ed anche dei primi nuclei di socie oltre che della mogli e fidanzate dei soci. Di gradevole aspetto, nel tempo si era dotato di una barba ben curata che aveva fatto malignare molti, che vedevano in tal segno delle mire presidenziali…Questo, se pur ci fu, egli mai lo manifestò, anche se talvolta si lasciò andare ad atteggiamenti un tantino autoritari. Cosa ben rappresentata dal ritratto ufficiale che gli fece Filiberto Gorgerino quando era all’apice della carriera Lasciato l’incarico si ritirò nell’ombra, seguendo la tradizione di tanti altri piemontesi benemeriti della patria. Raccolse testimonianze scritte e fotografiche degli anni in cui la FIAF lo vide protagonista. Non so se ci sarà dato di prenderne conoscenza, e non so quali disposizioni abbia lasciato alla vedova ed ai figli. Ad essi voglio far giungere tutta la nostra riconoscenza per quanto Lui ha fatto per noi e per la fotografia amatoriale italiana. Con fraterno affetto e ricordando il Congresso di Courmayeur da Lui voluto ed organizzato, tra le cime più belle d’Italia, canterò anch’io al Signore “lascialo andare a fotografare tra le tue montagne!” La famiglia dell’uomo. Una religione in bianco e nero di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it Il ritiro dell’anziano predicatore, l’eremo dove ha voluto rifugiarsi mezzo secolo dopo l’epoca del successo travolgente e delle folle adoranti, ma anche delle accuse feroci e delle condanne politiche, è un piccolo castello candido coi tetti spioventi d’ardesia che domina l’ansa di un torrente, appoggiato sulle spalle di un gruzzolo di case, nel cuore del cuore dell’Europa più antica. 40 Il maniero medievale di Clervaux, nel nord del Lussemburgo, un’ora di treno dalla capitale, è un edificio bianco e nero, come lo sguardo con cui il profeta umanista scrutava il mondo. Non l’hanno dimenticato. Nel fresco del mattino, stretti nelle sciarpe, piccoli gruppi pellegrini arrancano lungo la stradina ciottolata, entrano nel cortile sghembo e vanno a rendere omaggio al gran vecchio. È un flusso esile ma costante. Nei tredici anni da che è qui, sono venuti a trovarlo trecentomila persone. Tanti, ma pochi rispetto ai nove milioni che lo attesero, lo osannarono, si commossero davanti a lui nei soli cinque anni che trascorse in predicazione, missionario itinerante in decine di paesi del mondo. Il profeta esiliato nel santuario di Clervaux, a questo punto è bene chiarire, non è un uomo. È una lunga sequenza di pannelli fotografici. Insomma è una mostra. Però è la mostra piùfamosa della storia della fotografia, una grande opera collettiva, firmata da un’intera generazione di fotografi, apice e bibbia dell’umanesimo in bianco e nero, fonte e ispiratrice di infinite successive vocazioni: The Family of Man, si chiamava e si chiama ancora, titolo rubato a un discorso di Abraham Lincoln: ossia, la famiglia dell’uomo. Dietro l’antica mostra c’è comunque una persona in carne ed ossa, o meglio c’era: Edward Steichen aveva già 76 anni quando la concepì, nel 1955, per il MoMa di New York di cui dirigeva la sezione fotografica. A trentacinque anni dalla sua scomparsa arrivano in Italia l’affascinante retrospettiva che al Jeu de Paume di Parigi ha già visto sfilare 65 mila visitatori e il corposo volume dell’editore Skira che hanno riscoperto quest’uomo dalle mille vite: fotografo d’arte, di moda, di pubblicità, ufficiale dell’esercito Usa, pittore, esteta, designer, curatore, manager, perfino floricultore. Ma per capire davvero chi fu, è qui nella sua patria mitteleuropea, nel suo paese natale, che bisogna venire, qui dove lui stesso volle fosse ospitata per sempre la grande opera della sua vita, il suo capolavoro, anche se comprende solo tre o quattro foto fatte da lui. Un oggetto storico che definire solo “mostra” è poco. Fu piuttosto un trattato di etica per immagini, un’utopia, forse una fede. Probabilmente una fede. Il catalogo del ’55, che il MoMa continua a ristampare da cinquant’anni e finora ha venduto cinque milioni di copie, forse il livro di fotografia più venduto al mondo, fu collocato dalla libreria Scribner, sulla Quinta Strada, nello scaffale “religioni”. Eccoci. Siamo venuti a capire cosa sopravviva di quell’utopia, oltre alle cartoline e a qualche gadget in vendita nel minuscolo museum shop; cosa aleggi ancora del suo spirito originario nel silenzio di queste sale, nella luce fioca, certo per non danneggiare le immagini d’epoca, ma così propizia al raccoglimento. Una religione, certo. Ma con un solo semplice dogma, scolpito sul pannello iniziale in due versi del poeta Carl Sandburg, che di Steichen era il 41 cognato e l’ispiratore: «C’è un solo uomo al mondo / il suo nome è Tutti Gli Uomini». Il resto, le 502 fotografie di 273 fotografi di 68 nazioni, si limita a svolgere in modo naturale, semplice, didascalico, quel laconico vangelo. Scorrono le immagini di bambini che nascono, giocano, si nutrono, crescono, diventano adulti che amano, piangono, restano soli, lavorano, pregano, discutono, soffrono, muoiono, lasciando nel mondo altri bambini che crescono e così via, in un’eterna catena, identica a se stessa nei modi, nei gesti, in ogni tempo e in ogni luogo, abbiano quegli esseri umani facce scure di africani, occhi stretti di orientali, o volti lentigginosi di americani. Universalismo come necessità di specie, fraternità antropologica come destino obbligato dell’umanità, inscritto nei suoi cromosomi, oltre tutte le etnie, le ideologie, le fedi. «Negli anni della guerra fredda, del maccartismo, ci voleva coraggio per affermare una verità come questa», sostiene Jean Back, direttore del Centre National de l’Audiovisuel. L’istituzione governativa del granducato ha in cura la mostra dal ’93, quando finalmente le ultime volontà dell’illustre connazionale furono esaudite, e l’unica superstite delle cinque copie originali, scovata negli scantinati del MoMa, fu restaurata amorevolmente (ci lavorò una specialista italiana, Silvia Berselli) e richiamata in servizio in dodici sale del castello di Clervaux. Un luogo che Steichen stesso aveva scelto, benché non fosse proprio il suo villaggio natale, perché lì attorno s’era combattuta la battaglia delle Ardenne, una delle più sanguinose della seconda guerra mondiale. Un carro armato Sherman, issato su un podio davanti al castello, ancora oggi ricorda ai passanti che la grande famiglia dell’uomo include anche fratelli come Caino e Abele. «The Family è una magica fiammella di speranza e di pace ancora accesa», insiste Back. Ma tanti, a a paetire da Roland Barthes, non la pensavano così. La sua stroncatura, quando la mostra passò per Parigi, fu spietata, e dettò il rigetto definitivo della Family, quasi una dannazione, nell’opinione pubblica di sinistra. Mistificatorio «adamismo», scrisse il gran semiologo: mito ambiguo, questa filosofia dell’universale natura umana cancella la storia e nasconde le ingiustizie sociali. Imperialismo mascherato da paternalismo, infierirono altri pensatori radical, perfino negli Usa: questa mostra e solo una ipocrita e interessata assolutizzazione della famiglia nucleare patriarcale borghese americana. Che dire? I sospetti di strumentalità non erano del tutto immotivati. Costata ben 111 mila dollari d’allora a uno sponsor come Rockefeller, dal ’57 al ’61 The Family mandata in tournée mondiale a cura dell’Usia, l’agenzia di propaganda del governo americano, il cui scopo era proclamare in tutto il pianeta, ma soprattutto oltrecortina, la superiorità dell’american way of life. 42 L’ideale della famiglia felice, più che l’obiettivo di una politica di welfare, era in quegli anni un’arma della guerra fredda. Quando la mostra sbarcò a Mosca, nel ’59, affiancava un’expodi beni di consumo made in Usa: fu proprio in quell’occasione, davanti alle stufe e ai frigoriferi di Macy’s, che Nixon puntò il dito al petto di Kruscev gridandogli: «Voi comunisti mangiate cavoli, noi carne!». La Pravda infatti subodorò l’offensiva consumerista e sparse a piene mani sarcasmo sulla mostra. Ma negli stessi giorni, in controtendenza, il rosso poeta Evtushenko s’entusiasmava perché «la musa della fotografia ha reso visibili i fili che legano i popoli». The Family aveva fatto centro. Eppure Edward Steichen era tutto tranne un imperialista e un maccartista: frequentava la lyrical left newyorkese anteguerra, portava chiaro nel cuore il marchio della sua cultura europea, pacifista e vagamente socialista, la sua ambizione era, e lo diceva esplicitamente, fondare la coscienza transnazionale di una nuova umanità sulla base di un solo, esile, tautologico dogma: «ogni uomo è un uomo». Messaggio semplice e immediato. Le masse infatti risposero molto più degli intellettuali. Lunghe code, entusiasmi, commozione. The Family toccava i cuori. Ma non sempre le risposte emotive furono quelle attese. A Beirut nel ’58 una copia della mostra fu distrutta da una sollevazione palestinese. Una seconda fu danneggiata da uno studente nigeriano infuriato contro la rappresentazione dei neri «come selvaggi primitivi». La famiglia dell’uomo non fu sempre fraterna davanti a The Family of Man. Oggi, nella penombra del castello di Clervaux, tra pannelli che nonostante le amorevoli cure di una restauratrice italiana, Silvia Berselli, mostrano qua e là l’usura del tempo negli spigoli ammaccati, nelle didascalie logorate, l’eco di quelle asprezze è quasi spento. Sul libro dei visitatori, commenti pieni di emozione ma un po’ poveri di contenuto. Molti copiano semplicemente le citazioni letterarie che sono le uniche didascalie del percorso; soprattutto quella di Anna Frank: «Continuo a pensare che la gente sia buona nel fondo del cuore». Del resto, chi sale quassù non viene a vedere una mostra di fotografia: perché in effetti non lo è. È una mostra per mezzo di fotografie. Ci la concepì si prese il diritto e la libertà di ridurre il medium a contenuto «che dà forma alle idee», maltrattando l’ego dei grandi autori, alcuni dei quali se ne risentirono. Eppure, quando nel ’53 Steichen e il suo collaboratore Wayne Miller lanciarono un appello ai fotografi di tutto il mondo, ricevettero in risposta una valanga di oltre due milioni di immagini. La selezione, durata due anni, fu radicale: contarono la carica emozionale dell’immagine, la coerenza al progetto. La firma illustre, no (l’unico autore apparentemente italiano, ad esempio, è un Vito Fiorenza che i nostri storici della fotografia sembrano ignorare, forse un italoamericano). 43 Certo, nel gruppo ci sono Cartier-Bresson, Capa, Lange, Brandt, Doisneau, Erwitt, ma non sempre con le loro foto memorabili; spuntano una Arbus tutt’altro che arbusiana, un irriconoscibile Frank, ma ci sono soprattutto decine di foto anonime, d’agenzia, ritagliate dai rotocalchi. Non la singola immagine, ma la mostra in sé è il medium. Steichen ne commissionò ildesign a un architetto di scuola Bauhaus, Paul Rudolph: grandi pannelli che si staccavano dalle pareti e galleggiavano nel vuoto lasciando intravedere dietro altre immagini, come nell’altare centrale dove famiglie africane, italiane, americane in posa volutamente si sovrappongono e si confondono. Più che spettatori ci si sente, proprio come voleva Steichen, partecipanti a qualcosa. Un rito? Di certo una narrazione, nel senso che alla parola darebbe Lyotard: un’interpretazione finalistica della vicenda umana. Barthes aveva ragione, qui la Storia non c’è: tutte le utopie sono per definizione astoriche. Vediamo persone ridere, piangere, amare, soffrire, morire: ma non sappiamo perché. Le immagini sconvolgenti dei lager nazisti, allora così fresche nella memoria, mancano, la Shoah è citata solo in due scatti del rastrellamento del Ghetto di Varsavia. La lacuna sconcerta. Ma un’irruzione più cruda del “male assoluto” avrebbe probabilmente corroso in modo insanabile la tesi della fondamentale bontà umana. La morte in guerra invece c’è, ma eternizzata come la nascita, come l’amore: il marinesenza vita ai piedi di una collina birmana è un’icona epica, un Ettore insepolto sotto le mura di Troia. E il fungo atomico che esplode in faccia al visitatore nella penultima sala, unica immagine a godere di uno spazio tutto suo (ma in Giappone fu rimossa), resta fuori dalla storia, è un simbolo ammonitore, è la visione mitica dell’Apocalisse che attende l’umanità se non riconoscerà la sua naturale vocazione fraterna. Se la storia è assente, del resto, non c’è neppure la geografia: di ogni foto, un’etichetta ci dice il nome dell’autore ma non il luogo; la molteplicità apparente da cui Steichen intendeva estrarre l’unità fondamentale della razza umana, dobbiamo dedurla dagli abiti, dai tratti somatici; insomma, lo volesse o no l’autore, da stereotipi di razza e di nazionalità. Gli africani sono quasi sempre seminudi. I francesi hanno il cappello floscio. Una delle pochissime fotografie prese in Italia è il ritratto di un suonatore di mandolino. Dunque, il vecchio profeta era un uomo del suo tempo, le sue utopie erano sincere ma datate e collocate, per questo si prestarono ad essere politicamente indirizzate: vero, tutto vero. Anche l’Unesco, quattro anni fa, ha inserito quest’album di famiglia a dimensione planetaria nel Registro della Memoria del Mondo (unica mostra a farne parte) in quanto «memoria di un’epoca intera», quasi a volerne storicizzare le pretese di validità universale. 44 Eppure, nell’ultima sala della mostra, tonda, ricavata nella torre angolare del castello, i ritratti di bambini che galleggiano nell’aria, appesi a spirale su sottili aste, inseguendosi come un vortice di volti nel vento, non ispirano ragionamenti storico-culturali: stringono il cuore. Due bimbi, nella famosa immagine di Eugene Smith che chiude l’esposizione, sembrano sbucare dal buio verso la luce di una promessa felicità. Il ciclo della vita torna sempre al suo inizio, questo suggeriva Steichen, che viveva in un mondo appena uscito da uno spaventoso macello mondiale, e sperava con tutto il cuore fosse l’ultimo. Noi invece, che viviamo nel macello a bassa intensità della guerra permanente, in quei bambini vediamo possibili vittime di martiri kamikaze o di bombardamenti umanitari (eccola, la parola tanto cara a Steichen, umanità, trascinata nel sangue) Ma la musa della storia si diverte a rovesciare le frittate. Il tempo gioca con le intenzioni e ribalta i fini. Cinquant’anni fa il progetto egemonico americano aveva bisogno di nascondersi dietro la finzione paternalista di un’umanità omogenea; oggi, al contrario, qualsiasi progetto di sopraffazione globale ha bisogno di teorizzare grandi distinzioni tra le genti e le culture; espellere dal recinto umano intere nazioni o intere religioni è la condizione per poterle bombardare senza scrupoli morali. Davanti a una tazza di caffè fumante, nella taverna del castello, ancora preso dalle emozioni intatte del frande rito delle fotografie dell’uomo, cerco di convincere monsieur Back che il suo eroe e compatriota Steichen ha più ragione adesso che allora; che oggi, molto più che mezzo secolo fa, è necessario sbattere in faccia a chi tiene il dito sul grilletto quella eccezionale banalità: che un uomo è un uomo in tutto il mondo. Tag: Abraham Lincoln, Anna Frank, Bill Brandt, Carl Sandburg, Clervaux, Cna, Diane Arbus, Dorothea Lange, Edward Steichen, Elliott Erwitt, Evgenij Evtusenko, Henri CartierBresson, Jean Back, Jean-François Lyotard, Lussemburgo, Macy's, MoMa, Nikita Kruscev, Paul Rudolph, Richard Nixon, Robert Frank, Rockefeller, Roland Barthes, Silvia Berselli, The Family of Man, Usia, Vito Fiorenza, W. Eugene Smith, Wayne Miller Scritto in archivi, Classici, icone, musei | 3 Commenti » Museo di Fotografia Contemporanea da http://undo.net/it TRIENNALE DI MILANO, MILANO - FINO AL 10.09.2014 2004-2014. Opere e progetti. Un allestimento che valorizza 100 opere acquisite dal Museo e 15 progetti realizzati nel decennio. Le due parti della mostra sono intrecciate: i temi presenti sono il paesaggio urbano e naturale, la figura umana, la societa' in trasformazione e la sperimentazione artistica. 45 COMUNICATO STAMPA Nel cuore dei festeggiamenti per i 10 anni di attività, il Museo di Fotografia Contemporanea trasferisce l'attività espositiva estiva alla Triennale di Milano e mette in mostra i propri capolavori, con un grande allestimento che valorizza 100 importanti opere acquisite nel decennio e 15 progetti. Inaugurato nel 2004 nella sede di Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo-Milano dopo una fase prep aratoria durata dal 1996 al 2003, il Museo di Fotografia Contemporanea compie dieci anni. Unico museo di fotografia finanziato pubblicamente esistente in Italia dedicato alla fotografia contemporanea, è un centro di cultura del terzo millennio e fin dalla sua nascita ha lavorato sulla trasformazione, a un tempo, dell’idea di fotografia e dell’idea di museo. Il museo è nato e cresce nella contemporaneità e lavora sulla complessità e sulla frammentazione che caratterizzano l’arte e la comunicazione del nuovo secolo. Porta dunque avanti i suoi programmi su più livelli: conservazione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio fotografico e bibliotecario; realizzazione di mostre dalle collezioni e su progetti specifici; pubblicazione di cataloghi e testi di studio sulla fotografia e l’arte; promozione della cultura visiva verso pubblici diversi attraverso una fitta attività di mediazione culturale; ideazione di progetti di committenza ad artisti contemporanei e di progetti di arte pubblica con la partecipazione dei cittadini. Con le sue collezioni fotografiche di 2 milioni di immagini e una biblioteca specializzata con 20 mila volumi e riviste, è un centro di studio, ricerca e produzione culturale imprescindibile nel mondo della fotografia italiana che go de di ampio riconoscimento a livello 46 internazionale. Per festeggiare i suoi primi 10 anni di attività il Museo di Fotografia Contemporanea presenta una grande mostra alla Triennale di Milano, una istituzione con la quale ha già realizzato in anni recenti diversi importanti progetti espositivi. Obiettivo della mostra è offrire al pubblico un “affresco” delle più significative opere acquisite tra il 2004 e il 2014 e dei numerosi progetti realizzati durante questo periodo. Le due parti della mostra (opere e progetti) sono strettamente intrecciate tra loro: i temi presenti sono il paesaggio urbano e naturale, la figura umana, la società in trasformazione, la sperimentazione artistica, in una fitta e articolata narrazione visiva nella quale il visitatore può cogliere il rapporto dialettico tra il patrimonio, la committenza agli artisti, il rapporto con i cittadini spesso coinvolti nelle attività del Museo. La mostra comprende, oltre alle opere fotografiche, anche numerosi video e filmati di documentazione dei progetti ed è accompagnata da una pubblicazione edita da Silvana Editoriale a cura di Roberta Valtorta, che racconta l’identità, le attività, il patrimonio del museo. Realizzata in collaborazione con Regione Lombardia e La Triennale di Milano, grazie al contributo delle aziende RS Components, Banca Popolare Commercio e Industria, Epson Italia, Associazione Amici del Mufoco, con l'apporto tecnico di Tino Sana, MaMà Design Italia e Philips. Gli artisti in mostra: Andrea Abati, Giampietro Agostini, Mari na Ballo Charmet, Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Peter Bialobrszeski, Günter Brus, Vincenzo Castella, Mario Cattaneo, Cesare Colombo, Mario Cresci, Paola Dallavalle e Fulvio Guerrieri, Marco Dapino, Paola De Pietri, Joan Fontcube rta, Vittore Fossati, Luigi Gariglio, Jean-Louis Garnell, Carlo Garzia, Moreno Gentili, Jochen Gerz, Bepi Ghiotti, Luigi Ghirri, Paolo Gioli, William Guerrieri, Guido Guidi, Jeroen Huisman, Arno Hammacher, Jitka Hanzlovà, Roni Horn, Karen Knorr, Francesco Jodice, Mimmo Jodice, Gianni Leone, Uliano Lucas, Fulvio Magurno, Martino Marangoni, Roberto Masotti, Paola Mattioli, Giuseppe Morandi, Toni Nicolini, Cristina Nunez, Cristina Omenetto, Federico Patellani, Bernard Plossu, Francesco Radino, Paolo Riolzi, Ac hille Sacconi, Roberto Salbitani, Marco Signorini, Alessandra Spranzi, Antonio Strati, Beat Streuli, Pio Tarantini, George Tatge, Hans van der Meer, Fulvio Ventura, Cuchi White, Silvio Wolf. Info: [email protected], http://www.mufoco.org, 02 6605661 Triennale di Milano - viale Alemagna, 6 Milano Orari: mar-dom 10.30-20.30, giov 10.30 -23, Ingresso libero 47 Gianni Berengo Gardin da http://undo.net/it VILLA NECCHI CAMPIGLIO, MILANO La mostra, organizzata dal FAI - Fondo Ambiente Italiano, ospita 27 fotografie scattate tra il 2012 e 2014 che ritraggono il quotidiano passaggio di mastodontiche navi da crociera nel Canale della Giudecca di Venezia. COMUNICATO STAMPA Il FAI - Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Fondazione Forma per la Fotografia e Contrasto mette in mostra dall’11 luglio al 28 settembre 2014, negli ambienti del piano terra diVilla Necchi Campiglio, bene del FAI nel cuore di Milano,ventisette fotografie di Gianni Berengo Gardin scattate tra il 2012 e il 2014, che ritraggono il quotidiano usurpante passaggio di mastodontiche navi da crocieranel Canale della Giudecca di Venezia. Una mostra di grande impatto che intende far riflettere su questi mostri che quotidianamente minacciano Venezia, che con i loro “inchini” fanno tremare più volte al giorno i suoi preziosi monumenti, che con i loro volumi producono onde e correnti sottomarine che logorano le delicate fondamenta della città, e che con i l oro motori inquinano l’aria. Le fotografie costituiscono un reportage duro, severo, rigoroso: un lavoro di testimonianza, ma soprattutto di denuncia da parte di uno 48 dei più grandi fotografi italiani, Gianni Berengo Gardin che ha vissuto a lungo a Venezia , città di suo padre.Un lavoro che equivale a una presa di posizione netta, che il fotografo sente come un dovere civile. Ufficio Stampa FAI - stampa: Simonetta Biagioni– tel. 02 67615219; [email protected] Novella Mirri – radio e tv – tel. 06 68308756; [email protected] Ufficio Stampa Fondazione Forma per la Fotografia Laura Bianconi – tel. 335 7854609 [email protected] Villa Necchi Campiglio, via Mozart 12, Milano. Orario: a mercoledì a domenica dalle 10 alle 18. Ingresso: Adulti: € 9,00; Bambini (4 -14 anni): € 4,00; Studenti universitari fino ai 26 anni: € 5,00; Iscritti FAI: g ratuito. Gordon Parks, il narratore multiforme di Lodovico Lindemann da http://www.artribune.com/ Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri, Verona - fino al 28 settembre 2014. Nel suggestivo percorso tra modernità e antichità romane, realizzato da Libero Cecchini nei primi Anni Ottanta, è allestita la mostra “Gordon Parks. Una storia americana”. Gordon Parks, Grandi magazzini, Birmingham, Alabama, 1956 © the Gordon Parks Foundation 49 La mostra – realizzata dalla Fondazione Forma per la Fotografia in collaborazione con Gordon Parks Foundation e Contrasto – si propone di presentare l’opera di un artista quanto più eclettico. Nacque fotografo, Gordon Parks (Fort Scott, 1912 – New York, 2006), anche se prima di farne una professione svolse ogni genere di lavoro per sopravvivere, poi divenne regista, compositore e scrittore. In ogni arte che affrontò lasciò qualcosa di sé, perché, nonostante il mezzo cambiasse, il suo linguaggio rimase coerente ed estremamente riconoscibile. Autore di varie autobiografie, la sua arte è davvero un caso in cui opera e persona vengono a coincidere, in cui l’esperienza individuale e l’immersione in prima persona nelle proprie storie si fanno portatrici di messaggi universali. Gordon Parks in mostra a Verona Eppure la sua carriera non attraversò in una sequenza cronologica le varie attività, ma lo vide impegnato in più forme d’espressione contemporaneamente, negli stessi anni e addirittura negli stessi giorni. Proprio per questo la mostra è suddivisa in sezioni tematiche, per facilitare una comprensione dell’opera che, esposta cronologicamente, risulterebbe troppo multiforme. Ne dimostra dunque l’eclettismo: dopo una serie di crude immagini tratte dalle raccolte sulla violenza delle gang di Harlem, sulla povertà della famiglia Fontanelle nello stesso quartiere e sulla miseria della famiglia sudamericana di Flavio, vengono presentate le raffinate foto di moda. Gordon Parks in mostra a Verona 50 La sua formazione è quella della Farm Security Adiministration, dove poté incontrare Dorothea Lange o Walker Evans. Il modello teorico è quindi Lewis Hine, uno dei padri della fotografia documentaria: usare l’immagine come la più efficace delle armi contro le ingiustizie sociali. Se Hine la usò per battersi per le riforme sul lavoro minorile e i fotografi della FSA per raccontare la povertà della Depressione, Gordon Parks la mise al servizio della battaglia contro la segregazione razziale. Eppure non imboccò la via della denuncia diretta, ma preferì quella del racconto. Gordon Parks in mostra a Verona Immerso nella letteratura afroamericana, il suo modello è in realtà da ricercare più nello scrittore Richard Wright, che usò la forza delle parole allo stesso scopo, e in tutti gli altri leader americani neri fra cui si inserì con il suo lavoro (fu, per esempio, il primo afroamericano a penetrare nello star system hollywoodiano) e di cui realizzò potenti ritratti: da Malcolm X a Muhammed Ali, da Martin Luther King a Duke Ellington. Visitare una mostra degli scatti di Gordon Parks è per molti versi assistere alla storia del movimento per i diritti civili. Verona // fino al 28 settembre 2014 Gordon Parks – Una storia americana - a cura di Alessandra Mauro Catalogo Contrasto CENTRO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA SCAVI SCALIGERI Piazza Francesco Viviani - 045 8007490 [email protected] 51 C’è della fotografia in quella follia di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it “Pazzo melanconico” lo avevano classificato i medici del Manicomio di Reggio Emilia. Una delle molte fantasiose etichette della pignola nomenclatura positivista della malattia mentale. Pazzo, chissà: di certo non era tanto stupido, dal momento che si ribellò con tutte le sue forze, imprecando, all’obbligo di farsi fare il ritratto fotografico, rito d’ingresso a cui era sottoposto per decreto ogni degente. Gridava, il “melanconico”, protestava che «col ritratto si avrà il modo di perseguitarlo di più». Di lui, ricoverato attorno al 1870, sappiamo troppo poco (un vago accenno nel resoconto di un noto clinico in visita, Arrigo Tamassia) per capire quanto consapevole fosse la sua impavida ribellione. Di sicuro era fondata più delle risate dei medici che lo compativano. Magari sragionava, ma aveva ragione, il “melanconico”: la fotografia perseguitò i matti. Peggiorò la loro segregazione. A lungo, e con metodica pervicacia. Come tutti gli oggetti e i saperi coinvolti nel funzionamento di un’istituzione totale, anche la fotografia della follia fu uno strumento totalizzante, oppressivo, usurpatore di diritti. 52 Arma tagliente, qualche medico se ne rendeva conto: Henri Legrand du Saulle, in quegli stessi anni, vietava la circolazione delle foto dei suoi pazienti di Rouen, e faceva distruggere le negative. Dovette trascorrere più di un secolo perché la fotografia dei matti riuscisse a liberarsi da quel marchio d’infamia mutandosi nel suo contrario: uno strumento di liberazione. Una mostra, proprio a Reggio Emilia, dove l’ospedale psichiatrico San Lazzaro fu una città nella città (duemila ricoverati) fino agli anni Settanta, racconta ora tutta la sofferta, contraddittoria parabola della fotografia psichiatrica, dalle immagini che legano a quelle che sciolgono, dagli ordinatissimi “gabinetti fotografici” dei manicomi ottocenteschi all’irruzione dei reporter basagliani oltre «il muro dell’indifferenza». Fino alla terza stagione, la più sconosciuta e recente, e anche la meno sicura di sé: la fotografia del dopo-riforma, la fotografia dei “matti tra noi”, che paradossalmente ribalta tutte le certezze, rimette in causa le precedenti, facendoci apparire un po’ meno arrogante la prima, un po’ meno trionfale la seconda. Al San Lazzaro, uno dei più antichi manicomiitaliani (lo volle il duca Francesco III d’Este nel 1755), la fotografia era stata ammessa precocissimamente, nel 1878, da un direttore, Augusto Tamburini, che aveva l’occhio attento alle novità terapeutiche europee. Il pioniere britannico Hugh Welch Diamond aveva sperimentato l’uso della fotografia come ausilio frenologico appena un ventennio prima, nel suo ospedale del Surrey. Ma la moda aveva fatto breccia un po’ ovunque, quasi che la scienza della mente deviata non aspettasse altro che il suo strumento mancante: l’unico in grado di offrire ai medici della psiche, ancora incerti sulla consistenza e i metodi della propria disciplina, qualcosa di paragonabile a ciò che per i colleghi del corpo era l’anatomia: un corpo da osservare, un oggetto fisico da misurare. La fotografia inverava il sogno, anticipato dalla fisognomica di Lavater e Lombroso (anch’essa in attesa del Grande Strumento), di dedurre scientificamente la psiche dal soma, insomma l’anima dal volto. Inoltre, se al medico la fotografia offriva la possibilità di astrarre la malattia universale dal malato particolare (solo grazie alla fotografia JeanMartin Charcot riuscì a “inventare” l’isteria alla Salpetrière), per il medico psichiatra funzionava come salutare distanziamento rispetto ad un malato tra i più imbarazzanti, pericolosi, squilibranti, «poveri esseri che vegetano» e tuttavia sempre «guardati con misterioso terrore». Dolore assoluto, senza freni, la sofferenza del malato mentale rischiava (rischia ancora) in ogni momento di coinvolgere e di travolgere chi la osserva: dolore pietrificante come lo sguardo di Medusa. E come lo specchio di Perseo, la fotografia fece da schermo, prelevando la pazzia dal pazzo e mettendola a disposizione, spettro ormai inoffensivo, sulla 53 scrivania del professore; mentre il suo originario possessore, ormai inutile, poteva “dar di matto” quanto voleva, ben legato al letto di contenzione. Perché potesse accadere, il fotografo dei matti doveva essere più artista che burocrate. Emilio Poli, semplice responsabile del guardaroba a cui Tamburini affidò il gabinetto fotografico del San Lazzaro, si rivelò tale. Il cortile del severo palazzo alla periferia della città si mutò in teatro di posa, sul cui palco, a credere al Tamassia, «accorrevano i poveri malati colla massima docilità», recitando senza copione la loro demenza, inscenando in un libero canovaccio di gesti ora patetici, ora drammatici, ora violenti, il loro misterioso, surreale squilibrio. Dovrebbero parlarci, queste immaginisopravvissute, nascoste e ora riscoperte, di un dramma del contenimento e della sorveglianza; riescono piuttosto a calarci in una scena magica di pietà sublimata. C’è da dire che il pazzo è il cliente ideale del fotografo. Le «bugie diplomatiche» del ritratto borghese, le sue finzioni identitarie, i petti rigonfi, gli sguardi artatamente fieri, i «poveri dementi» non li conoscevano. Affrontavano l’occhio di vetro del Poli «senza contraffare l’espressione del loro viso», senza cercare «quelle posizioni buffonesche, o tragiche, in cui vediamo drappeggiate la maggior parte delle fotografie dei sani». Bugiarda per vocazione, convenzionale per obbligo, la fotografia per assurdo guadagnò la sua libertà nel luogo dell’assoluta illibertà. Il paradosso si riallineò presto. All’alba del Novecento, con l’affermarsi della moderna psichiatria, la fiducia nella diagnosi visuale della malattia 54 mentale andò rapidamente in crisi. impressionano le lastre ai sali d’argento L’inconscio, il subconscio, non Ma la fotografia non uscì per questo dalle mura dei manicomi, cambiò semplicemente mestiere: da aiuto medico a sorvegliante. Traslocò dall’ambulatorio alla portineria. I degenti venivano fotografati non più nella libera, perfino anarchica espressione della loro follia, ma nella razionalità panottica della posa frontale, che omologava ogni individualità nel tipo universale del Pazzo, icona della nostra cattiva coscienza. Spillata sulla cartella clinica, la fotografia del malato non era più la sua radiografia mentale, ma un attrezzo tecnico per il riconoscimento rapido. Aprì la strada, assieme alla cugina fotografia poliziesca, al moderno documento d’identità. Può essere spiacevole saperlo, ma la foto che ci guarda dalla nostra patente è la foto di un pazzo: quantomeno, la sua nipote. Morte della nosografia creativa, inizio della fotografia poliziotta: al San Lazzaro l’operazione diventò così standardizzata e ripetitiva che la si poté affidare addirittura ad un degente. Resurrezione della fotografia anti-psichiatrica: negli anni Sessanta furono a volte gli stessi ricoverati a far entrare i fotografi oltre il portone proibito, spacciandoli per pazienti in visita. Quei reporter che avevano letto Laing e Goffman si chiamavano Carla Cerati, Gianni Berengo Gardin, Luciano D’Alessandro, Gian Butturini, Uliano Lucas, tutti a vario titolo e misura affascinati dallo “slegamatti” Franco Basaglia. Le immagini che si susseguirono in quegli anni sui libri e sui rotocalchi, terribili e affettuose, strazianti e tenere assieme, volutamente spogliate da ogni estetismo per puntare al cuore dell’emozione, furono il colpo d’ariete su cui lo psichiatra triestino contava per «usare l’istituzione contro se stessa» e aprire quelle porte inchiodate. Morire di classe, il pamphlet progettato da Franco e Franca Basaglia per la celebre «serie politica» Einaudi, con le foto di Cerati e Berengo, divenne il “libretto viola” della battaglia contro i manicomi: ma era fatto solo di immagini, intercalate a evocatrici citazioni da Brecht, Swift, naturalmente Foucault. La legge 180 è forse l’unica riforma sociale ad avere contratto un debito di gratitudine con la cultura visuale. Eppure anche su quelle immagini è giunto il monento di ragionare criticamente. Senza nulla togliere al coraggio, alla generosità, alla passione dei fotografi che el realizzarono, la mostra di Reggio (in particolare il saggio dello psichiatra Cosimo Schinaia, nel volume che è molto più di un catalogo di mostra) ne coglie, per la prima volta, forse grazie alla distanza storica, un rischio paradossale: la conferma dello stereotipo del pazzo. Un “matto da slegare”, beninteso: ma per mostrare a “quelli di fuori” l’ingiustizia delle sue sofferenze era necessario semplificarne l’immagine, uniformarla, mettere in ombra le facoltà “sane” ed esporre solo quelle “malate” e sofferenti alla pubblica e politicamente impegnata indignazione. Crani rasati, 55 teste fra le mani ossute: il più celebre scatto di Carla Cerati è diventato icona dlela follia: non della liberazione. Ma è possibile fotografare la malattia mentale senza ingabbiarla di nuovo, seppure in una griglia di compassione? Ci si è provato. Ma è stato necessario mettere da parte ogni retorica, anche liberatoria, abbasasare il tono e lo sguardo. “Fotografia debole” è forse quella del dopo-Basaglia, priva della sicurezza che le davano le teorie più o meno scientifiche prima, le battaglie politiche e umanitarie dopo. Incerto è l’occhio che ha seguito le tortuose strade di una riforma che ha rivelato i suoi affanni e incontrato molti avversari ben felici di amplificarli. I “matti tra noi”, terza categoria storica dell’iconografia della follia, non appaiono più come una classe omogenea da segregare o da liberare in blocco, ma come uno sciame di naufraghi dispersi nel mondo in cui si confondono, si mescolano, svaniscono. Seguirli uno per uno, raccontare storie sempre più uniche e divergenti è stata la scelta dei fotografi del “dopo” . Qualcuno (Giovanni Sesia) ha sentito il bisogno di ripartire da capo, di andare a cercare i ritratti seriali degli antichi malati del San Lazzaro, per risarcirli della perduta soggettività, quasi raschiando via a colpi di pennello la patina fotosensibile che li imprigionava. Altri hanno raccontato, semplicemente, i percorsi di vita dei “liberati”. Individui dispersi nel mondo. Sempre appesi a un filo sottile, assediati dal frastuono di un mondo ostile: stringe la testa fra le mani l’ex degente sorpresa da Butturini nell’attimo di terrore che sembra, che è, l’Urlo di Munch. Ma anche appesi alla mano amica di un’infermiera, come in una dolcissima immagine di Alex Majoli: cordone ombelicale, carezza rassicurante di chi non abbandona; e allora si può anche, finalmente, riposare, e allora il sole che illumina il mondo dei sani scalda e basta, non brucia più. [Una versione di questo articolo uscì su La Repubblica il 30 ottobre 2005] Tag: Alex Majoli, Arrigo Tamassia, Augusto Tamburini, Carla Cerati, Cesare Lombroso, Cosimo Schinaia, Edvard Munch, Emilio Poli, Erving Goffman, Francesco III d'Este, Franco Basaglia, Gian Butturini, Gianni Berengo Gardin, Giovanni Sesia, Henri Legrand du Saulle, Hugh Welch Diamond,Jean-Martin Charcot, Johann Kaspar Lavater, Luciano D'Alessandro, manicomi, Reggio Emilia,Ronald Laing, Salpetrière, San Lazzaro, Uliano Lucas Scritto in fotogiornalismo, fotografia e società, politica | Un Commento » 56 Storie dal sud dell'Italia da http://www.mufoco.org/ In occasione dei 10 anni di attività, il Museo di Fotografia Contemporanea propone fino al 12 ottobre 2014 una grande mostra dedicata al Sud dell’Italia con opere dalle sue collezioni attraverso le immagini di importanti e noti autori che hanno costruito la storia della fotografia italiana. La mostra, a cura di Arianna Bianchi e Roberta Valtorta, comprende 120 fotografie di Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna organizzate in 16 nuclei tematici. Questi gli autori rappresentati: Letizia Battaglia, Antonio Biasiucci, Carmelo Bongiorno, Mario Cattaneo, Mario Cresci, Luciano D’Alessandro, Mimmo Jodice, Uliano Lucas, Lello Mazzacane, Carmelo Nicosia, Federico Patellani, Tino Petrelli, Francesco Radino, Marialba Russo, Ferdinando Scianna. Le immagini sono tratte dai fondi fotografici Mario Cattaneo, Grazia Neri (di pertinenza del Museo), Lanfranco Colombo e Federico Patellani (deposito di Regione Lombardia). Le fotografie in mostra coprono un arco storico di cinquant’anni, dal secondo dopoguerra ai primi anni Novanta, e toccano questioni profondamente legate all’identità economica e culturale delle aree meridionali: la vita rurale descritta nel rapporto con la terra e con gli animali, la tradizione religiosa, la antica ritualità del culto dei morti, il Carnevale, l’emarginazione sociale e il degrado urbano, il lavoro in miniera, il problema della disoccupazione e le lotte per combatterla, le figure dei bambini, vere icone del Sud, i sapienti oggetti della 57 cultura popolare, il tema della mafia, doloroso e offensivo per queste genti, il paesaggio del mare e quello della campagna, richiami alla bellezza di terre straordinarie e a lungo sfortunate. Si tratta di una mostra intensa e ricca di spunti non solo sul piano informativo ma anche su quello emotivo, composta di immagini di forte impatto sociale e di alto valore estetico, che restituisce un problematico spaccato dell’ambiente sociale ed etno-antropologico di una parte importante dell’Italia. Al bianco e nero delle ricerche di questi grandi fotografi fanno da contrappunto gruppi di immagini a colori scelte dal fondo Grazia Neri che “illustrano” l’immaginario turistico del Meridione: spiagge, barche, piatti di cibi tipici, frutti, fiori, artigianato, costumi tradizionali, luoghi divacanza, natura rigogliosa, le meravigliose cartoline quasi pop che ci fanno amare il Sud. Oltre che per l’importanza degli autori e della “questione meridionale” stessa, di grande peso nel passato e ancora di scottante attualità per il nostro paese, la scelta di questo tema è stata anche pensata in relazione alla città di Cinisello Balsamo, che da 10 anni ospita il Museo di Fotografia Contemporanea. Come è noto, Cinisello Balsamo, città dell’hinterland milanese fortemente investito dal grande processo di industrializzazione durante il “boom” economico, è città di immigrazione: la sua popolazione, che contava soli 15 mila abitanti nei primi anni Cinquanta, arriva a più di 80 mila negli anni Settanta per l’arrivo massiccio di immigrati che, provenienti soprattutto dalle regioni meridionali, diventano i lavoratori delle grandi fabbriche del nord Milano, dunque gli attori fondamentali dell’economia di questa vasta area, e dell’economia italiana stessa. Accompagna le fotografie una serie di video-interviste a cittadini di Cinisello Balsamo, che tra ricordi, pensieri, saperi, raccontano le loro radici, i loro sogni, la loro attuale esistenza in un territorio diverso da quello che hanno lasciato. Partecipa al video “Storie dal Sud dell’Italia”: Vieni a raccontarci il tuo Sud ed entra a far parte del video in mostra. Il set è aperto: domenica 27 aprile e 18 maggio dalle ore 14 alle 16. 58 Ma noi non ci saremo. Una giornata nella caverna delle immagini di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it Nella nuova caverna di Platone il tempo è due volte immobile: al minuto e all’ingrosso. Non scorrono i giorni in questo perenne crepuscolo di luci al neon, non cambiano le stagioni nel suo eterno autunno a temperatura costante, senza pioggia e senza vento. Ma anche la grande Storia qui è ferma: letteralmente congelata in venti milioni di fotografie ibernate sotto zero, sepolte sotto settanta metri di roccia calcarea, pronte a sfidare i secoli. Nel mito più celebre della filosofia greca le immagini del mondo reale si riflettono nelle viscere della montagna, dove schiavi incatenati le credono vere. Anche in fondo alla penombra di queste chilometriche gallerie troverò le immagini speculari del mondo esterno. Ma non mi aspetto che a custodirle siano uomini semiselvaggi ingenui e abbruttiti. Infatti, «Benvenuto sottoterra!», quando il portone blindato rosso si apre, è un’elegante signora bionda ad accogliermi con un sorriso. Si presenta: Ann Hartman, manager del FilmPreservation Facility di Corbis, l’agenzia fondata da Bill Gates nel 1989. È la vestale della memoria visiva degli ultimi centocinquant’anni. La sacerdotessa del più ambizioso e fantascientifico progetto di conservazione iconografica mai tentato: mettere in salvo il fragile specchio del pianeta, tenerlo al riparo da uragani, terremoti, attentati terroristici e guerre nucleari, per centinaia, forse migliaia di anni, in fondo a una vecchia miniera di minerali ferrosi, sessanta miglia a nord della capitale americana dell’acciaio: Pittsburgh, Pennsylvania. 59 Arrivarci non è facile. Anche Luca e Silvia di Corbis Italia, filiale aperta da pochi mesi, miei compagni speleologi delle immagini, hanno un’idea vaga di dove si trovi il cuore del loro patrimonio aziendale. Scivoliamo, cartine alla mano, in auto dentro una cartolinadella provincia americana, fra colline boscose, laghetti e casette di legno col dondolo sotto il portico E la bandiera sull’asta. Il villaggio rustico di Boyers è l’ultimo riferimento civile, poi si va a intuito. Niente segnali, solo un parcheggio e una stradina chiusa da una sbarra presidiata da uomini armati suggeriscono che siamo arrivati. «Stop please», sorridenti, ma col mitra ben in vista, perquisiscono l’auto con cortese efficienza. Chiedono due documenti per ogni visitatore. Verificano via radio: sì, siamo attesi. Otteniamo un pass a testa e un piccolo estintore rosso: «tenetelo sempre con voi», questo non è rassicurante. La sbarra si alza, la strada si tuffa all’ingiù, s’infila sotto la collina. Scendiamo sotto terra. Sembra un tunnel come un altro, ma appena dentro ti trovi in un dedalo di grandi gallerie asfaltate, scolpite nella roccia grezza, trenta chilometri di incroci, curve, corsie che sfumano nella foschia biancastra dei neon. Se non ci facessero strada, sarebbe impossibile arrivare a destinazione. Dietro una curva un incongruo pupazzo di Babbo Natale, ma non i segnali che t’aspetteresti, neppure quelli per l’uscita di emergenza. Motivi di sicurezza: «Chiunque riesca a ingannare i controlli, è meglio che non sappia orientarsi». Bagliori di fari: nella penombra incrociamo altre automobili. C’è traffico, nel labirinto sotterraneo. Corbis non è il solo abitatore del luogo: oltre i finestrini scorrono decine di portoni blindati rossi, la maggior parte anonimi, identificati da un codice, alcuni invece con insegne vistose: US Security Service, Universal Studios, National Archives. Oltre duemilacinquecento tra uffici governativi e aziende private hanno affittato pezzi di galleria per i loro archivi più preziosi. È un caveau grande come una città. Una multinazionale della conservazione, la Iron Mountain, fondata da un ex coltivatore di funghi, comprò questa miniera dismessa nel 1950. Anni di guerra fredda: l’America pareva ossessionata dall’olocausto nucleare, e qui doveva sorgere un enorme bunker per la sopravvivenza dei più previdenti, o più importanti, o più ricchi. Curioso: non funzionò. Gli americani preferirono mettere al sicuto i loro ricordi, più che i loro corpi. La città dei rifugiati fu presto riconvertita in condominio di scantinati di lusso, una enorme cassaforte supertecnologica, un super-caveau. 60 Ma anche così brulica di vita come un termitaio. Nella città senza tempo lavorano millesettecento persone. «Abbiamo un corpo di vigili del fuoco con sei automezzi, squadre di tecnici, impiegati, archivisti. In caso di necessità abbiamo viveri per trenta giorni, ed energia per una settimana», elenca Charles J. Doughty, vicepresidente di Iron Mountain, al volante del carrello elettrico, di quelli che girano sui campi da golf, con cui ci ha prelevato da uno dei parcheggi interni. Guida e intanto fa da cicerone, girato all’indietro, tanto lui il labirinto lo sa a memoria: «Una volta mi lasciarono dentro a luci spente. Trovai l’uscita a tentoni. Lavoro quaggiù da trentaquattro anni…». Un’esperienza davvero underground. «Non è poi molto diverso che lavorare al sessantesimo piano di un grattacielo. Col vantaggio che gli impiegati non escono a farsi una passeggiata», ride. Ci fermiamo davanti ad un portone con lo scudo della Warner Bros: dietro, centinaia di pile ben ordinate di «pizze» in scatole tonde d’alluminio. Sono i master dei film. Comprese le scene che il pubblico non ha mai visto. È incredibile quante cose l’umanità pensa debbano essere conservate in eterno. I brevetti di tutte le invenzioni americane. I registri matrimoniali della contea di Somerset. I prototipi dei gioielli Cartier. I biglietti depositati dalla pietà popolare sul luogo (non lontano da qui) dove si schiantò l’UA93, l’«aereo degli eroi» dell’11 settembre. «Carta, microfilm, bytes, in qualsiasi modo l’umanità voglia lasciare traccia di sé, noi la aiutiamo a farlo», commenta Mr. Dougthy con orgoglio aziendale. L’ingresso di Corbis è il più elegante di tutti. Luce bianca, tappeto, piante in vaso, uno schermo al plasma su cui scorrono le più celebri immagini dell’archivio. E d’improvviso, varcato il portone, svanisce la claustrofobia. L’ambiente è ampio, luminoso, ben arredato, fiori, poster, pavimenti scintillanti, computer, reticoli di tubature gialle, blu, rosse. Altre due archiviste di Corbis e tre stagisti s’aggirano nel ronzio dell’aria condizionata, come in qualsiasi ufficio di città, tranne il rumore del traffico. C’è una piccola mensa con dispensa, microonde e bollitore del caffè. «Vuole favorire? Qui non è comodo fare un salto al bar all’angolo…». Ma solo le pareti scalpellate al grezzo, però laccate di bianco, ricordano che l’aria aperta è lontana come il tetto di un palazzo di venti piani. Ann C. Hartman dirige il Fpf dal 2002, poco dopo il gran trasloco. Fu un’operazione quasi militare, efficiente e riservata, degna di una missione della Cia. Una colonna di diciotto camion frigoriferi partì da New York, precisamente dal palazzone sulla 44ª strada che per mezzo secolo era stato il regno di Otto Bettmann, il più straordinario mercante d’immagini che la storia ricordi. Fino a pochi mesi prima gli undici milioni e mezzo di fotografie dell’archivio Bettmann, cuore di questa che è verosimilmente la più grande raccolta di immagini del secolo dell’immagine, stavano malinconicamente marcendo sugli scaffali di un deposito di Manhattan, dove la scomparsa del loro raccoglitore le aveva lasciate orfane. 61 Bibliotecario a Lipsia, fuggiasco nel ’35 dalla Germania nazista, Bettmann era sbarcato a Manhattan con pochi vestiti, ma con due bauli pieni di fotografie. Portava con sé, in esilio, le immagini di un’Europa minacciata dalla barbarie. S’inventò un mestiere, quello di venditore di fotografie, e fondò quella che oggi si chiamerebbe una stock image agency, ma che allora era poco più di un mestiere da trovarobe. Lungimirante: la civiltà dell’immagine era in pieno boom. I giornali cominciavano ad aver fame di immagini, soprattutto di quelle generiche, passepartout, da mettere in pagina quando mancano le foto fresche d’attualità. E il germanico Otto, meticoloso come un tedesco, aveva inventato un sistema di archiviazione che nell’era pre-Google gli consentiva di rintracciare in pochi minuti, tra le migliaia presto divenute milioni, l’immagine giusta per il cliente di turno. Comprati a prezzo di carta straccia, interi archivi di giornali, agenzie, fotografi venivano rimessi in circolo. Il valore aggiunto era l’intuizione che il Novecento bruciava dal desiderio di vedersi e soprattutto rivedersi, ma che senza una guida, uno scout, sarebbe affogato nello sterminato oceano di immagini che quello stesso desiderio aveva prodotto; urgeva un trovatore. Quel che Bettmann in realtà si faceva pagare non erano le immagini, ma il genio della sua mente di metodico archivista borgesiano. E non sbagliava mai. I giornali e gli editori pagavano volentieri. Tanto da permettergli, nell’81, di ritirarsi comodamente in pensione in Florida. Senza bauli, questa volta. Le sue foto, undici milioni, restarono orfane a Manhattan. E s’ammalarono. Contrassero la tremenda lebbra dei negativi. Scattate quasi tutte su pellicole di deperibile acetato, andavano letteralmente in pappa. La puzza di aceto, nelle stanze dell’archivio, era soffocante quando Bill Gates andò a visitarlo, nel ’95, con l’idea di comprarsi tutto. Al signor Microsoft era venuta un’idea curiosa: diventare il proprietario, e il rivenditore, di quante più immagini possibile. Aveva appena fondato Corbis, che in latino vuol dire cesto, e un cesto aspetta di essere riempito. L’archivio Bettmann (assieme ad altri archivi di agenzie e giornali nel frattempo acquisiti da Gates, per un totale di venti milioni di reperti) era un ottimo inizio. Ma rischiava di veder subito la fine. Gates seguì il consiglio di un esperto, Henry Wilhlem, guru della conservazione: «Scegli il freddo. Congela le foto e dureranno in eterno». E lui così fece. A dispetto di tutti i requiem cantati in questi anni digitali, l’immagine fotografica deve avere ancora un valore enorme, perché il signor Microsoft non fa niente per niente, altrimenti non sarebbe diventato l’uomo più ricco del mondo; e se lui, re dei bit e deibyte, ha deciso di diventare anche il più grande proprietario al mondo di vecchie fotografie di carta, fragili negative di celluloide, delicate lastre di vetro al collodio, vuol dire che quelle immagini sono un patrimonio. 62 Ed eccoci qui, nella ghiacciaia dell’immaginario mondiale. «Questa è la sezione Vip, very important photos», Ann apre lo sportello zincato di un congelatore: sui ripiani, in buste numerate di plastica sottovuoto, scatole di cartone senza acidi color beige ospitano a venti gradi sotto zero gli originali delle immagini più note dell’archivio Bettmann, ovvero le più vendute: la vertiginosa merenda sulla trave dei muratori del Rockefeller Center, Einstein che fa la linguaccia, Rosa Parks che viaggia orgogliosa sul bus non più riservato ai bianchi, eccetera. Dal loro gelido letargo, le foto da hit parade escono solo in casi eccezionali: «riportarle a temperatura ambiente è un’operazione rischiosa». In giro vanno i loro duplicati digitali ad alta definizione. Ma l’emozione vera deve ancora arrivare. Sta in fondo al primo tunnel, dietro un portello bianco con oblò e maniglia d’acciaio, tipo cella del macellaio. «Si metta il giaccone», fa Ann, «andiamo in miniera». Uno stanzino di acclimatazione. I piedi s’appiccicano al pavimento: un tappeto adesivo preleva la polvere dalla suola delle nostre scarpe. Si apre il secondo portellone. Il salto di temperatura è brusco: siamo a sette gradi centigradi, umidità 35% costante. Nel biancore polare, il colpo d’occhio è straordinario: centinaia di scaffali, migliaia di cassetti, allineati in corridoi lunghi come due campi di calcio. Vecchi schedari di metallo grigio, classificatori di lamiera, casse di legno: è il mobilio di Bettmann, portato qui tale e quale, contenitori e contenuto, perché era più urgente salvare che riordinare. Eccole, dunque. Abitano qui le icone della memoria ottica collettiva. Le immagini che abbiamo scolpite nella mente, senza le quali non sapremmo più pensare la storia. Sono qui i fragili originali di carta, celluloide o vetro, di alcune delle foto più famose del mondo. L’Hindenburg che brucia, Hitler che passeggia al Trocadéro, Mao che sguazza nello Yangtze, Neil Armstrong che saltella sulla Luna, papa Wojtyla che s’accascia ferito in piazza San Pietro, l’ignoto eroe di piazza Tian An Men davanti al carro armato, Stalin Roosevelt e Churchill sulla panchina di Yalta, lo sguardo livido dei gerarchi nazisti a Norimberga. Sono qui, accanto alle loro sorelle, le immagini dimenticate o inedite, ma altrettanto preziose. La guerra civile americana, il fondo più antico. L’impagabile archivio della Uniter Press sul Vietnam. I reportage della seconda guerra mondiale. Archivi interi di grandi fotografi: Riis, Weegee. I ritratti glamour dei divi di Hollywood. Da grandi poster sui muri, Malcom X e Martin Luther King che si stringono la mano, Audrey Hepburn, Babe Ruth sembrano i santi patroni della gelida cattedrale silenziosa. Ci infiliamo guanti bianchi di cotone, apriamo con trepidazione uno, due, tre cassetti a caso. Ecco le immagini lebbrose, corrugate come pelli di coccodrillo o sollevate come pasta sfoglia: «Ma il degrado è bloccato. Le recupereremo col restauro elettronico». 63 Per ora riposano nell’ordine che stabilì lui, il tedesco geniale. La sua calligrafia inclinata spunta a tratti dal dorso di una foto, su una scheda. Un oceano di scatti che nessuno guarda da decenni. Solo il venti per cento degli originali è stato scannerizzato e digitalizzato. Ancora meno, poche centinaia di migliaia, sono le foto che chiunque può sfogliare online sul sito di Corbis. Tutto il resto, parliamo di milioni di immagini, è un deposito archeologico ancora da scavare. Per quanto ne sappiamo, capolavori ignoti della fotografia mondiale potrebbero essere sepolti in questo enorme freezer. Ogni apertura di cartella dà il brivido della scoperta. Peschiamo a caso: Italia, fascismo, dopoguerra. Spuntano, tra veline dattiloscritte, ingiallite e fragili come ostie, le eccezionali immagini dei reporter dell’International News Photos, grandi professionisti anonimi. Personaggi, eventi pubblici, ma anche scene di strada, vita quotidiana: le scarpe fuori misura degli scugnizzi, lo sberleffo di un Balilla tra i piccoli camerati, sciuscià che giocano alla morra nelle strade di Roma liberata, «ecco questa è inedita», conferma Ann dando un’occhiata al retro. Una busta ha un titolo particolare: «Mussolini, esecuzione». Ci vuole stomaco forte: ecco la tristemente nota impiccagione di piazzale Loreto, ma anche una serie di scatti anche più terrificanti, il volto del Duce tumefatto, l’autopsia, la ricomposizione dentro una cassa di legno grezzo, tra un frate benedicente e donne che ridono. Ann distoglie lo sguardo, «È orribile, ma è storia. E la storia va conservata tutta quanta». Certo. Ma per chi? Quando Corbis annunciò l’operazione grande freddo, la stampa si scatenò. Gates seppellisce in una tomba la memoria visiva del mondo, accusarono editorialisti del New York Times e del New Statesman. «Da allora ci sforziamo di smentire quel pregiudizio», dice Ann. L’archivio è accessibile, su appuntamento, a storici e ricercatori, ma pochi ne approfittano. «Abbiamo cinquanta richieste a settimana, ma quasi tutte via email. Troviamo noi le immagini che cercano. Fisicamente vengono qui solo cinque ricercatori all’anno». Certo, il viaggio è scomodo. «Ma un posto come questo non c’era alla periferia di New York». Be’, un edificio refrigerato forse si trovava. Ma la caverna delle immagini è molto di più di un magazzino commerciale coscienziosamente gestito. È una fantasia post-human, è il sogno di scavalcare almeno in effigie la fine della nostra specie. Sotto fresche e asciutte coperte di calcare, anche quando finirà l’elettricità le fotografie continueranno a mantenersi, forse per migliaia di anni. È un monumento all’homo photographicus, l’unico animale creatore e consumatore d’immagini, ad uso degli archeologi, forse dei paleontologi, di chissà quale futura epoca o razza. I bauli di Bettmann, un po’ più gonfi di quando fuggirono dall’Europa in fiamme, sono partiti per un altro viaggio, temendo forse un’altra apocalissi. I 64 viventi che abiteranno la Terra dopo di noi decifreranno questi geroglifici di carta dissepolti dalla piramide di Pittsburgh. Se avranno occhi, vedranno come eravamo. Ma noi non ci saremo. [Pubblicato nel luglio 2007] Tag: Adolf Hitler, Ann C. Hartman, Benito Mussolini, Bill Gates, Boyers, Charles J. Doughty, Corbis,Film Preservation Facility, Franklin D. Roosevelt, Henry Wilhlem, International News Photos, Iron Mountain, Karol Wojtyla, Malcom X, Mao, Martin Luther King, Otto Bettmann, Pittsburgh, Stalin, Tian An Men, Winston Churchill Scritto in archivi, Letture d'estate | Un Commento » A occhi aperti, quando la Storia si è fermata in una foto da http://www.libreriamo.it/ E' stata inaugurata alla Reggia di Venaria a Torino il 26 luglio la grande mostra A occhi aperti, tratta dall'omonimo libro di Mario Calabresi. La rassegna, in collaborazione con Contrasto e Magnum Photos rimarrà aperta fino all’8 febbraio prossimo MILANO – Mario Calabresi, scrittore e giornalista, direttore del quotidiano La Stampa dal 2009 spiega così l'inedita mostra presso la Reggia di Venaria ''A occhi aperti. Quando la Storia si è fermata in una foto'', che trae ispirazione dal suo libro, dall’omonimo titolo: «Queste foto, che hanno plasmato il nostro immaginario collettivo, mi hanno spinto ad andare a cercare i loro autori per farmi raccontare il momento in cui hanno incontrato la Storia e hanno saputo riconoscerla.» La mostra è stata realizzata in collaborazione con Contrasto e Magnum Photos. 65 IL CONCEPT - Mario Calabresi, appassionato di fotografia, ma anche e soprattutto di giornalismo e realtà, ha intrapreso un viaggio molto speciale: un viaggio profondo ed affascinante nella storia recente, cercando alcuni dei “testimoni oculari” che con il loro lavoro, e la voglia di scavare tra le pieghe della cronaca, hanno raccontato alcuni momenti straordinari del nostro presente in una serie di immagini (un centinaio circa) realizzate con gli occhi ben aperti sul mondo. Ne è nato un libro, A occhi aperti, appunto, che ha raccolto le interviste, vibranti e palpabili, a dieci grandi fotografi, dieci testimoni del nostro tempo: Abbas, Gabriele Basilico, Elliott Erwitt, Paul Fusco, Don McCullin, Steve McCurry, Josef Koudelka, Paolo Pellegrin, Sebastião Salgado e Alex Webb. INTERVISTA A – Abbas. Se incontri la Storia da bambino, sei capace di riconoscerla per tutta la vita, sviluppi un istinto speciale che ti fa capire prima degli altri quando le situazioni stanno per raggiungere il punto di rottura. La sua carriera comincia alla fine degli anni Sessanta con la guerra del Biafra. E poi Vietnam, Bangladesh, Cile, fino al Medio Oriente con il racconto della rivoluzione iraniana. Gabriele Basilico. Basilico è un’eccezione. Ho sempre seguito fotografi che fossero tormentati dall’attualità, dalla malattia di esserci quando le notizie si fanno Storia, e di certo nessuno di loro lavora con il cavalletto, una macchina fotografica 10x12 e scatta con il flessibile. Ma il risultato può essere sorprendentemente giornalistico: l’approccio più lontano può raccontarti il dramma della guerra civile libanese, la deindustrializzazione di Milano o il cambiamento del paesaggio francese. Passaggi epocali che spesso la cronaca non è in grado di cogliere. Elliott Erwitt. Erwitt ha fotografato tutto e tutti. Nelle sue foto non c’è mai pesantezza, mai retorica, ma una costante dose di ironia. E proprio dall’ironia, da una foto grottesca, comincia simbolicamente l’inizio del viaggio di Erwitt nelle tensioni razziali americane, che sfoceranno nella segregazione del Sud degli Stati Uniti nel 1950, con tutto il suo carico di violenza e insensatezza. Paul Fusco. «Ero pieno d’ansia ma mi bastò guardare fuori dal finestrino per capire: vidi la folla e tutto fu chiaro. Abbassai il finestrino, allora si poteva fare, e cominciai a scattare. Fui investito da un’onda emotiva immensa, c’era tutta l’America che era venuta a piangere Bobby, a rendergli omaggio. I Kennedy avevano dato speranza alla gente e ora quella gente vedeva tramontare il sogno. Se ne andava con quel treno. Quel treno è stato il vero funerale, quello dell’America. È durato un’intera giornata, era fatto per il popolo. Era il Funeral Train». Don McCullin. Più di ogni altro Don McCullin ha mescolato drammaticamente il lavoro con la sua storia personale: ogni scatto parla delle tragedie del mondo e dei fantasmi della sua infanzia di miseria e violenza. Il suo linguaggio è crudo e detesta il politicamente corretto, ma sentendo raccontare la sua vita si capisce come abbia potuto viaggiare e testimoniare gli orrori del mondo senza perdere la ragione. La sua storia lo ha vaccinato e gli ha permesso di resistere, ma la sua storia lo ha anche condannato a continuare a cercare il dolore, creando quasi una dipendenza. 66 Steve McCurry. Le foto di McCurry appaiono levigate, armoniose, serene, anche se raccontano di fame o inondazioni. Si potrebbe credere che il suo tocco magico sia quello di cogliere l’attimo senza sporcarsi. Poi lo incontri, e capisci che invece è dovuto scendere fino in fondo, nella fatica e nella sofferenza. A cavallo tra il 1983 e il 1984 realizza i suoi lavori più importanti, quello sui monsoni, il viaggio in treno in India e il famoso ritratto della Ragazza afghana: «L’incrocio di storie e situazioni del 1984 è stato, in senso positivo, la mia tempesta perfetta». Josef Koudelka. La foto della macchina in corsa, che percorre Stalin Avenue, è la prima che Josef Koudelka, trenta anni, scatta quel 21 agosto 1968. La prima di uno dei più grandi reportage della storia della fotografia: la testimonianza della repressione della Primavera di Praga nel sangue. Duecento pellicole che costeranno al suo autore vent’anni di esilio. Koudelka avrebbe rivisto Praga soltanto nel 1991, quando i genitori erano già morti. A loro va infatti la dedica del suo libro Invasione Praga 68. Paolo Pellegrin. “Se le tue foto non sono abbastanza buone significa che non sei abbastanza vicino”, diceva Robert Capa. Ho seguito il lavoro di Pellegrin in Palestina, in Libano, a Guantanamo, in Iraq, nelle periferie USA o nel Giappone dello tsunami, leggendo le sue immagini con quella frase di Capa che significa una sola cosa: esserci, essere in prima linea, aderire al soggetto, mostrarlo senza remore. Quando guardi una foto di Pellegrin non puoi restare distante, vieni trascinato dentro, nella guerra, nel dolore, nella desolazione. Ogni scatto non è solo, fa sempre parte di una storia, di un percorso. Sebastião Salgado. «Avevo il sogno di andare in Africa perché molti brasiliani vengono da lì e perché milioni di anni fa eravamo un solo continente. Così nel 1973 ho lasciato il mio lavoro di economista a Londra per un viaggio di tre anni in Africa, con una nuova professione: fotografo. La mia fotografia consiste nel rispettare le persone, mostrando una storia. Dopo aver raccontato tutto questo dolore del mondo mi sono ammalato e per salvarmi mi sono imposto di testimoniare il bello, di mostrare a tutti l’incanto della natura». Alex Webb. Per capire il confine tra il Messico e gli USA – “the Border” – e il suo fascino bisogna guardare le foto di Webb o leggere Cormac McCarthy, per scoprire luoghi di silenzio, di attesa, che sembrano non appartenere a nessuno. Quello che colpisce di più nei suoi racconti e nel suo approccio al mondo è la totale assenza di tesi da dimostrare, a guidarlo è l’atteggiamento del cercatore, con due soli strumenti sempre con sé: la curiosità e la pazienza. Per questo si definisce un fotografo di strada e non un fotoreporter. 67 Tags: A occhi aperti, Mario Calabresi, Reggia di Venaria, Contrasto, Contrasto books,Magnum Photos, Abbas, Gabriele Basilico, Elliott Erwitt, Paul Fusco, Don McCullin, Steve McCurry, Josef Koudelka, Paolo Pellegrin, Sebastião Salgado, Alex Webb Scarpe al sole, foto in tasca di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it Appena dieci anni dopo, il rimbombo dell’«inutile strage» era diventato una cartolina sorda. Nel 1928, ripubblicando Le scarpe al sole, il suo libro più celebre, Paolo Monelli s’accorse che il ricordo memoria s’era già mutato in fotografia: «Mentre ho ancora ben nette nella memoria le linee del terreno, e i sassi, i mughi, i soldati, i feriti, i morti, le masse tedesche avanzanti, il sangue colante dalla 68 fronte del caporalmaggiore De Boni, gli occhi sbarrati di Altin, nulla mi è rimasto delle voci, degli urli, dei rumori, degli scoppi, come se la scena l’avessi vissuta, immagine vana tra altre immagini vane, sullo schermo d’una pellicola muta». E sullo schermo di un muto computer oggi la riviviamo noi. Con i suoi stessi occhi. Vediamo i suoi «buoni alpini», i veci e i bocia, come li vide lui, che finita la guerra li avrebbe trasfigurati, con le parole, da burbere macchiette militaresche a eroi di un’epica; ma che allora, col ta-pum degli obici nelle orecchie, guardava solo con curiosità, simpatia e ruvida tenerezza. E li fotografava con lo stesso sguardo. Dieci, cento volte li fotografò: quasi settecento, per la precisione. Tante sono le foto di guerra prese da Monelli, scrittore e giornalista di successo, ma fotografo privatissimo, così privato che quasi nessuno in novant’anni le ha viste, quelle sue immagini. Non che si fossero perse, o sepolte chissà dove: erano rimaste, semplicemente, appartate. Assieme ad altre centinaia di scatti, a pacchi di lettere, ritagli e manoscritti, a migliaia di libri, dal 1983 sono affidate alle cure della Biblioteca statale Baldini di Roma, a cui le consegnò pochi mesi prima di morire la vedova dello scrittore, Palma Bucarelli, bella figura di intellettuale, energica e colta direttrice della Galleria nazionale d’arte moderna di Roma. Un tesoro taciturno, al limite dell’afasico. Profili di montagne, luoghi, volti: tutti senza nome, rari e imprecisi gli scarabocchi sul retro. Davvero «immagini vane tra immagini vane». Forse anche Pino Ielen sente disagio per l’inquietante silenzio di queste immagini, e cerca di esorcizzarlo versandoci sopra un diluvio di spiegazioni minuziose, nomi di montagne, di alpini, date, quote, cifre, che può sapere a memoria solo un appassionato di Grande Guerra come lui: «Ecco, qui tre alpini del terzo plotone stanno leggendo un giornale, si legge anche il titolo, Si lotta oltre il monte Cimone, dunque siamo attorno al 15 luglio 1916…». Vorresti dirgli, a costo di offenderlo, zitto un momento Pino, guardiamocele in silenzio; ma poi capisci che è il suo modo di salvare quei ricordi, richiamarli a vita, e lo lasci fare. Del resto, se non ci fossero stati lui e i suoi cinque o sei amici dell’Associazione storico-culturale Valsugana orientale e Tesino, tutti volontari, questo tesoro non sarebbe mai stato utilizzabile. Quando hanno saputo della sua esistenza, hanno chiesto all’archivio che le conserva di poterci lavorare. Volontariamente. Appassionatamente. Hanno avuto le copie elettroniche di tutte le immagini. Hanno cominciato a riconoscerle una per una, a ri-battezzare le cime e le facce, ce l’hanno fatta quasi sempre. In tempo per farne una grande mostra per il novantesimo anniversario della fine della Prima guerra mondiale, qui a Borgo Valsugana, che è un po’ il baricentro dell’avventura di Monelli, in questo piccolo e curioso museo della Grande guerra dove dietro le vetrine convivono spallina a spallina le divise degli alpini e quelle dei Kaiserjäger, perché questa fino al 1915 era Austria. 69 Quasi ogni casa qui ha appesa al muro la foto di un nonno in divisa asburgica; in questa valle la storia orizzontale, quella dei confini e delle guerre, è volubile, «solo il rapporto con la verticalità è stabile», dice l’assessore Emanuele Montibeller indicando col dito le cime eterne. In «questa benedetta valle Sugana che ha le cantine piene di vino e i granai colmi di mele odorose» Monelli era arrivato, ventunenne volontario negli alpini, lui borghese di pianura; nato nel modenese, già pronto a fare «malinconicamente l’avvocato nella curialesca Bologna», rinnegò il dandy annoiato che era, cercando il bagno rigeneratore tra «uomini nuovi, che hanno veduto il confine della vita e ne sono ritornati». Suona un po’ dannunziano, ma era l’aria del tempo. Il commilitone Angelo Manaresi, che sarà sottosegretario alla guerra nel Ventennio ma finirà badogliano, lo descrisse «freddo e incaramellato, sottile come un giunco, caustico, mordace, freddurista impenitente, gran conquistatore di donne». Un signorino della città fra gli ispidi guerrieri dalla penna nera: eccolo proprio così, sbarbatello in divisa, aria un po’ saputa, in una fotografia che evidentemente gli ha fatto qualcun altro. Ha una macchina fotografica al guinzaglio, una macchina a soffietto. Forse una Vest Pocket, la folding camera di cui «ogni ufficiale e soldato dovrebbe provvedersi», come recita lo slogan che proprio nel 1915 la Kodak pubblica sui giornali accanto al disegno di un alpino. E quanti soldati infatti fotografarono. Forse più di quanti già sappiamo: altri tesori probabilmente giacciono nascosti nei bauli dei nonni. Ufficiali, più che altro, perché la fotografia negli anni Dieci era ancora un po’ costosa. Ma anche fantaccini, cappellani, medici. Fu la prima guerra fotografata da dentro. Dicevamo: quel damerino incaramellato,una volta assegnato al terzo plotone della 265ª compagnia del battaglione Val Cismon del 7° Reggimento alpini, ricevette subito un perentorio consiglio: «Si tagli i capelli, si lasci crescere la barba e cominci a bere vino». Eseguì. Dopo poche settimane: pizzetto, fiasco, pipa. Mimesi esteriore, metamorfosi interiore. Quel che ha di prezioso questo finora ignoto 70 fotoromanzo di Monelli, è la sua evoluzione nel tempo e nello spirito, una mosaico di tessere che Ielen e i suoi amici con pazienza da trincea stanno rimettendo in ordine come fossero le illustrazioni mancanti di Le scarpe al sole. Quel che ci si vedrà alla fine sarà forse in grado di dare un’altra vita a un libro quasi sparito dalla circolazione, di cui sembra sopravvissuto solo il titoloproverbio. I suoi personaggi ora hanno un volto. Ecco la «vecia Vendramin», locandiera-mamma di Feltre; ecco alle falde del Setole il De Lazzer con addosso quell’inverosimile frac rosso trovato nel baule di una casa devastata che s’ostinava a indossare per servire a mensa gli ufficiali; ecco Zanella, l’attendente del tenente Monelli, con cui «avrò scambiato duecento parole in tre anni», muto anche in foto mentre guarda il lago di Costabrunella, ecco il sottotenente Marni che non si stanca mai (lui no, i commilitoni sì) di strimpellare alla chitarra in sperticate canzoni napoletane. «Ci sono tutti», s’intenerisce Ielen, «come ce li aspettavamo». Eroi senza Omero, nelle Termopili ghiacciate di un fronte che «non era neppure il più importante», tiene a spiegarti Luca Girotto, medico e storico della guerra sul Lagorai, «non decise le sorti del conflitto», ma non per questo fu un minore massacro di popoli. Nell’album Monelli, però, battaglie nessuna: in battaglia si spara, non si scatta. C’è invece il diario visivo della guerra dei tempi morti, della noia nervosa dietro i ripari, del barbiere di trincea, del bicchiere di vino identitario, della messa da campo, dei muli fedeli, di una guerra che ha anche spazio per le risate, le battute sconce, le sfide a palle di neve. Anche la «cronaca di gaie e tristi avventure» di Monelli fu comunque arruolata nel tronfio reducismo del regime fascista, ma francamente non ci stava. Non perché Monelli fosse un pacifista, anzi era stato interventista e non si pentì; tantomeno un dissidente politico: la sua carriera di giornalista, dal Carlino alCorriere, fiorì tra le due guerre . Ma l’ironica e commossa epopea alpina che Monelli scolpisce ha ben poco di imperial-romano, è un’epica barbuta e ruvida di bestemmie e di bevute che passa sotto la retorica, forse ne fonda un’altra tutta sua, comunque diversa da 71 quella che gli «imboscati», i borghesi, i politici, gli alti ufficiali cercavano di costruire addosso agli alpini già allora, mentre quelli ammazzavano e si facevano ammazzare per cento metri di pietraia chiamata «patria». Nel libro, Monelli racconta di una licenza spesa andando al cinematografo, a Castelfranco Veneto. A vedere cosa? Un film sulla guerra, «che era qualchecosa di buffo, una concezione quarantottesca, truppe al Savoia! per quattro sullo stradone, piume di bersaglieri e trombe che suonavano l’attacco», roba da ridere, e Monelli infatti ci ride forte in sala, e grida: «Io che faccio la guerra vi dico che la guerra non è così!». Lo zittisce seccato un borghese: «E cosa me ne importa? Lasciate che me la goda riprodotta come me la figuro io». Grandissimo, preveggente apologo mediatico, questo. La guerra vista a casa non è mai la guerra vera: vale per l’Ortigara come per l’Iraq. Come se la «godevano» la guerra, dunque, i civili? Nelle tavole acquerellate di Beltrame, dove gli alpini sembravano una baldanzosa squadra sportiva. O nelle fotografie ben scelte dell’Illustrazione italiana, dove la guerra somigliava a una passeggiata naturalistica tra le dentate scintillanti vette. A Monelli, roba così faceva venire l’itterizia. Lui che pure fu accusato, all’opposto, di aver messo in pagina «poco odore di morte e di piedi», si sarebbe vendicato di quella retorica con un libro di sorprendente sarcasmo, La guerra è bella ma è scomoda, che sembra scritto per liberare la memoria dei «suoi» alpini dalla morsa degli «utopisti della pace perpetua» come da quella degli «eroi da retrovie». È un libro illustrato con le feroci vignette satiriche di Novello, chiaramente suggerite dallo scrittore. Monelli dunque sentì il bisogno di contrapporre immagini “autentiche” a immagini “fantasiose”. Perché allora non usò le sue fotografie? I suoi bozzetti di vita e di umanità, ma anche le foto più simboliche e astratte, come le croci di legno nella neve, il tunnel scavato nel ghiaccio alla cui imboccatura s’affaccia un sogno di montagne assolate e senza sangue? Per la verità, Monelli non scrive mai di aver fotografato al fronte. Se nel fondo familiare non ci fossero anche i negativi, se la scia di immagini non corrispondesse passo passo ai suoi trasferimenti, se la serie non s’interrompesse bruscamente quando Monelli fu catturato dagli austriaci, si potrebbe perfino dubitare che le abbia scattate lui. Pensava forse che le fotografie fossero penosamente incapaci di reggere il peso della memoria? Di trasmettere l’emozione? Eppure lasciò che si ricavasse un film, dal suo libro, nel ‘35: andò pure a fotografare il set. Eppure qualche descrizione di fotografia spunta, proprio nelle pagine delle Scarpe al sole. Ma sono altre fotografie, sono quelle che i soldati portavano nel portafogli, sul cuore. Il ritratto che gli arriva dalla «perfetta bambina diciannovenne lontana», per sognarci su. Un’altra fidanzata, trovata nel portafogli di un commilitone falciato dalla mitraglia. 72 E un’altra foto ancora, «cinque ragazze floride», forse le sorelle, «nel mezzo la madre con così accorata mestizia negli occhi», questa volta uscite di tasca al cadavere di un much, un soldato asburgico, ungherese per la precisione; a gridare che anche il nemico ha mamme fidanzate e sorelle come tutti i Ceschin, gli Zanella, i Rossetto di questa parte della barricata. Forse, vuol dirci Monelli, sono le fotografie della pace perduta le uniche davvero capaci di smontare la guerra: non le «immagini vane» che la replicano. Mute come sono, le foto degli affetti fanno esplodere le parole che hanno dentro, aprono la porta a certe «zaffate di dubbio» rarissime ma feroci, come quella che prende di sorpresa autore e lettore a pagina 128 delle Scarpe: «se valga, dunque, questo tradizionale concetto di Patria, tanto stento, tanta rovina». [Una versione di questo articolo uscì su La Domenica di Repubblica il 19 ottobre 2008] Tag: Achille Beltrame, alpini, Biblioteca Baldini, Illustrazione Italiana, Lagorai, le scarpe al sole, Luca Girotto, Novello, Ortigara, Palma Bucarelli, Paolo Monelli, Pino Ielen, Prima guerra mondiale, Tesino,Valsugana Scritto in Autori, guerra, Letture | Nessun Commento » ------------------------ Rassegna Stampa del Gruppo Fotografico Antenore www.fotoantenore.org [email protected] a cura di G.Millozzi www.gustavomillozzi.it [email protected] 73
Scarica