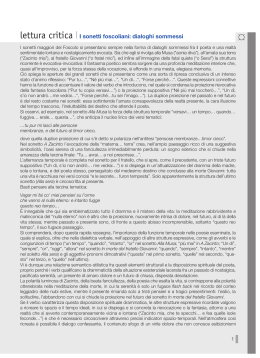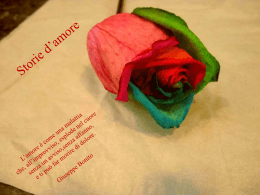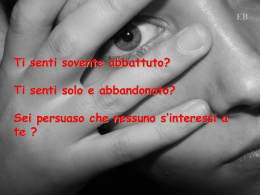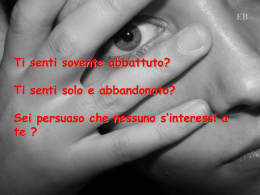Riccardo Becheri I SONETTI DI SHAKESPEARE Prato 2004 ©Tutti i diritti riservati all’autore [email protected] Prato 2004 2 INDICE INTRODUZIONE Pag. 5 1Questo è il mio mondo 2Erano anni 3E se 4Ho una famiglia 5Data una scorsa 6Non devo 7LINGUA INGLESE 8SONETTO E ENDECASILLABO 9RIMA E STROFE 10I grandi letterati 11Qui alla fine SONETTI Pag. 45 3 4 INTRODUZIONE 5 6 1 - Questo è il mio mondo, non quello di Shakespeare. Anzi, per completare con frasi che suonano orgogliose e sono invece disincantate se non disperate, aggiungo che quando, mai e per sempre, questi miei sonetti dovessero essere stampati, non devono essere stampati nello stesso volume col testo inglese originale. Di più: il mio nome deve comparire bene in alto come nome dell’autore e il titolo dell’opera deve restare I sonetti di Shakespeare. Chi fosse tentato di fare riscontri, si procuri una delle molte edizioni dei Sonetti di Shakespeare. Aggiungo ancora che ritengo questi miei sonetti un acquisto imperituro della poesia italiana, degni di diventare un classico nella nostra tradizione. Ammesso che una tradizione continui. E ammesso che la poesia, italiana o straniera, non sia già morta da tempo. Questo è il disincanto, o la disperazione. In verità fra questi due termini c’è una contraddizione profonda e come tale la vivo. Se penso a un mondo senza Dante e senza Shakespeare sono preso dallo sconforto. Se invece penso a un mondo senza storie letterarie, senza tradizioni accademiche e senza poeti per forza, mi sento come disincantato, libero e leggero. Ma di questo voglio parlare alla fine, come conclusione naturale delle mie riflessioni. Ora dirò perché e come mi sono deciso a tradurre i sonetti di Shakespeare e subito dopo stenderò qualche considerazione sulle traduzioni di poesia dall’inglese. 2 - Erano anni, decenni, che non mi occupavo di poesia. Non la leggevo, non la criticavo e tanto meno la scrivevo. La trascuravo: come si deve fare con i vuoti e fantasiosi riti di mummificazione. 7 Un giorno, esattamente un anno fa, più che altro perché non avevo di meglio da fare, mi sono riletto, fra le altre mie cose, anche Roberto ed Elvira che non leggevo da anni. Giacché c’ero rilessi anche l’introduzione su La metrica della mia poesia. Non avevo riletto questo piccolo saggio da forse trent’anni e lo trovai ancora valido, nonostante qualche ingenuità e qualche mancanza di approfondimenti su alcuni punti. Sarà stato perché la lettura di Roberto ed Elvira mi aveva commosso (sì, commosso: è bella e grande poesia quasi sempre. Ma cosa significa? La poesia non significa niente e non vale niente.) sarà stato dunque perché ero commosso che ritenni ancora fattibile un discorso tecnico sulla poesia, almeno come stimolo intellettuale e curiosità storica. Ciò mi spinse a comprare La metrica italiana – Teoria e storia di Francesco Bausi e Mario Martelli. E’ questo uno dei rari libri che ti riconciliano col mondo universitario, altrimenti odioso e inutile in campo letterario. Una frase, alla fine del libro, mi colpì in maniera particolare: “Scrivere un sonetto… significa compiere un estremo atto di fiducia nelle capacità conoscitive della Ragione”. Questa frase mi colpì in misura persino eccessiva; mi tornava in mente di continuo e la sentivo vera. Eppure sapevo benissimo che da simili teorie estetiche la poesia era stata sopravvalutata almeno dalla fine del Settecento: era stata gonfiata finché non era scoppiata per la forza stessa del suo nulla. E se Dio vuole era morta, anche se tanti non se ne sono proprio accorti, o peggio, fanno finta per interesse di non accorgersene. Di tutto questo avevo pure scritto tanti anni prima in conclusione della mia stroncatura d’Ungaretti. Me lo 8 ricordavo benissimo ed ero ( un anno fa, come lo sono oggi) convinto della giustezza del mio pensiero. Purtuttavia quelle parole continuavano a tornarmi in mente: “ Sonetto… estremo atto di fiducia… capacità conoscitive della Ragione”. 3 - E se mi fossi sbagliato prima? Perché negare l’estremo atto di fiducia? Si noti che non mi avrebbe minimamente colpito un collegamento del sonetto alle confessioni sentimentali. Nemmeno m’avrebbe colpito la rimasticatura del sonetto come forma poetica per eccellenza. Su questa strada sarebbe bastato a fermarmi il mio disgusto per la poesia. Quello che mi stuzzicava era l’idea del sonetto come strumento conoscitivo, personificazione concreta della “Ragione” manifestata in una pagina: il tutto è lì e lo vedo tutto insieme. Devo confessare che in questo mio stato d’animo non confluiva solo il mio vecchio rifiuto della poesia, ma anche un più recente, ma ormai solidificato, sentimento di stanchezza profonda verso la filosofia, la psicologia, la sociologia, la critica, la storia e tutte le cosiddette scienze costruite con le chiacchiere. Se il mondo è conoscibile, lo deve essere senza bisogno di bibliografie. E con poche parole: il sonetto, appunto. Era la fine di luglio. Il primo d’agosto partivo per il mare con tutta la famiglia. Fu così che presi con me, fra gli altri, un vecchio volumetto dei Sonetti di Shakespeare edito nel 1965 dall’Universale Economica Feltrinelli, che allora avevo comprato e che mai prima mi era preso voglia di leggere. Dopo quasi quarant’anni mi sono accorto che le ultime pagine di quel volume sono rilegate a testa in giù. Se lo 9 avessi sfogliato quando lo comprai, di sicuro lo avrei riportato indietro reclamando un esemplare perfetto. Ma ora sono contento di non averlo fatto. Se questo libro fosse un francobollo da collezione, sarebbe una rarità e varrebbe di più. E’ un’edizione integrale curata da Gabriele Baldini, col testo inglese e la traduzione a fronte, in prosa, di Lucifero Darchini apparsa per la prima volta nel 1908. Portai con me questo libro, a preferenza di altri libri di poesia che pure posseggo anche se non li leggo, forse perché era l’unico intitolato Sonetti ed era di piccole dimensioni. Pregherei il gentile lettore che prima o poi anch’io avrò di non credere che io sia talmente ignorante da non sapere cosa sia il sonetto, e che è una gloria italiana, e che la sua severa forma e stringatezza lo hanno sempre eletto a palestra di forza e d’intelligenza, e che l’esempio del Petrarca si era diffuso in tutta Europa e da ultimo in Inghilterra, e che di sonetti all’estero prima e dopo Shakespeare se ne sono scritti migliaia in tutte le lingue, e che Carducci in un sonetto si dichiara scrittore di sonetti postremo e non sesto, e che D’Annunzio ne ha scritti molti, tutti notevolmente vuoti compresi i quattordici dedicati alla mia città, Prato, dov’egli studiò da liceale. E così via. Se faccio sfoggio d’ignoranza è per distinguermi da chi sa tutto. Mi portai dunque al mare il volumetto dei Sonetti di Shakespeare solo per verificare se quei sonetti, che conoscevo gravati di fama ma che non avevo mai letto, avrebbero potuto passare l’esame dell’estremo atto di fiducia nella Ragione, meglio di altri sonetti italiani che già conoscevo. 10 4 - Ho una famiglia numerosa. L’anno scorso al mare i commensali oscillavano da dodici a venti e la casa che avevamo affittato non aveva la lavastoviglie. Lo dico perché noi adulti ci eravamo divisi i compiti ed io mi ero riservato quello di rigovernare almeno una volta al giorno, più spesso due. Rigovernare piatti, bicchieri, pentole e tegami, e sedere d’estate all’ombra d’un albero di fico senza far nulla, sono le attività più spirituali dell’uomo, le uniche all’altezza della nostra storia e del nostro futuro, e le uniche degne di essere perseguite con ogni sforzo. Non sono però intercambiabili fra loro. Sedere sotto un fico è un’esperienza contemplativa che arriva spesso all’estasi del sentimento panico, o della mistica pura, o dell’illuminazione buddista. Anche ai livelli più bassi e nelle nature meno dotate, è un’attività altamente filosofica. Queste cose le so perché ho tre fratelli che sono alberi di fico. Ho anche tre sorelle, donne in carne ed ossa, debitamente registrate all’anagrafe. Ma non avevo fratelli. Un bel giorno, non so se io loro o loro me, ci siamo scelti come fratelli: sono tre begli alberi di fico lungo l’argine del Bisenzio. Rigovernare, invece, è un’attività più scientifica e razionale. C’è da stabilire l’ordine logico in cui vanno lavate e poi sciacquate le stoviglie ( l’ordine è: i biberon dei piccini, i bicchieri, le posate, i piatti e infine le pentole e i tegami; da ultimo i fornelli); c’è da scegliere lo strumento più adatto per ogni oggetto, se la spugna, o la spazzola, o la retina di metallo; c’è da decidere qualità e quantità del detersivo. Dopo un po’ ci si eleva a un livello veramente rarefatto di astrazione, che non ha però il sentimento panico d’unità con l’intero creato che si ottiene sedendo sotto un fico. 11 Rigovernare, ai livelli più alti di astrazione, genera invece supremi interrogativi. L’acqua che vien giù dal rubinetto non cade perché attratta dalla forza di gravità verso il centro della Terra, ma perché spinta dalla pressione dell’acquedotto. Non è tirata davanti, ma spinta da dietro. Certo, anche l’acqua dei piatti sciacquati gocciola verso il basso e non sembra che ci sia qualcosa che la spinga. D’altra parte non vedo nemmeno niente che la tiri in giù. E se la legge della gravitazione universale fosse falsa? o almeno insufficiente e parziale? Che vuol dire che due corpi si attirano reciprocamente in proporzione della loro massa? Newton fece un impercettibile salto, e sotto di lui la Terra, incontro alla mela? No, mi pare molto più logico ipotizzare che tutte le cose aborrono il vuoto e cercano di allontanarsi il più possibile dallo spazio siderale. Non so se questa ipotesi possa spiegare tutti i fatti dell’universo e se sia la spiegazione più semplice. Io adoro il principio d’economia, il cosiddetto Rasoio di Ockham: Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Ma c’è quella solenne sciocchezza della Terra che girerebbe non solo intorno al sole, ma anche su se stessa. E molti ci vorrebbero gabellare che questa sciocca teoria spiega tutto in maniera più semplice rispetto alla solare evidenza ( sottolineo solare ) che è il Sole che tramonta da una parte e sorge dall’altra, mentre la Terra se ne sta bella, pacifica e ferma al centro dell’universo. Dicono che la loro teoria spiega anche certi fatterelli del tutto trascurabili, mettiamo tre miliardesimi dei fatti della mia vita. Domando: dove finisce il principio d’economia se per spiegare tre miliardesimi si devono sconvolgere tutti gli altri miliardesimi? Dopo cinque o sei giorni che ero immerso in simili esperienze intellettuali presi a mano i Sonetti di Shakespeare. 12 5 - Data una scorsa veloce all’introduzione di Gabriele Baldini, affrontai il primo sonetto. Non avevo affatto l’intenzione di tradurlo. Volevo soltanto verificare se quei quattordici versi potevano reggere insieme il peso della “Poesia” e della “Ragione”, o almeno di una delle due anche se scritta con l’iniziale minuscola. Leggevo e rileggevo il testo inglese; leggevo e rileggevo la traduzione a fronte. Non capivo. Presi a scorrere i cinque o sei sonetti successivi. Mi fermai perché capivo ancora meno. Mi dissi che, se non risolvevo il primo sonetto, era inutile che continuassi; potevo rimetter via il libretto scespiriano e seppellire anche la metrica insieme alla poesia. La ragione avrei dovuto seppellirla in un altro riquadro del cimitero, ma avrei dovuto comunque seppellire anche lei, almeno come aspirazione a una razionalità esprimibile in poche ed essenziali parole. Il testo inglese mi era estraneo. La traduzione del Darchini era anche troppo esplicativa del senso letterale, ma talmente sillogistica da risultare banale: una prosaica concatenazione di sovrabbondanti parole che indebolivano il pensiero anziché rafforzarlo. Per trovare un senso che mi soddisfacesse, decisi di tradurre il sonetto in endecasillabi italiani, raccolti secondo la nostra tradizione in due quartine e due terzine, la cui compiutezza strofica non fosse affidata alla rima, ma alla compiutezza del discorso che doveva chiudere ogni strofa con un punto fermo. Ritrovare l’endecasillabo mi divertì come ritrovare un vecchio amico con cui ci si può abbandonare a discorrere dei bei tempi andati. Ci presi gusto e continuai a tradurre i sonetti di Shakespeare seguendo strettamente l’ordine del libro che ricalca l’ordine canonico dell’edizione del Thorpe. 13 Alla fine del mio mese di vacanza avevo tradotto i primi quarantacinque sonetti con nessun altro supporto oltre al mio libretto. Ne traducevo sino a tre o quattro al giorno; la mattina dopo li rileggevo; li paragonavo ad altre traduzioni se c’erano (il volumetto contiene anche una piccola antologia di altri traduttori) ed apportavo qualche correzione se mi sembrava utile. Dopodiché passavo al sonetto successivo. Quasi mai ho riletto i sonetti dei giorni precedenti. Se fossi un letterato che deve tener alto il prestigio della poesia, a questo punto direi che passai una feconda vacanza d’intensa attività spirituale, in comunione costante con uno dei più grandi geni dell’umanità, scoprendo di ora in ora sempre nuovi tesori artistici e milioni di significati testuali più profondi della fossa delle Marianne. Siccome invece il mio scopo è, più modestamente, quello di dire la verità, confesserò che, mentre i miei vicini d’ombrellone si dilettavano con le parole crociate e con altri giochi enigmistici, io mi divertivo a scoprire il rebus d’ogni sonetto scespiriano e a renderlo non con parole crociate, ma con parole italiane ritmate in endecasillabi raccolti in quartine e terzine. Tutto qui. Tornato a Prato, mantenni la stessa assiduità di lavoro, salvo un intervallo di quattro o cinque mesi per tirar giù un altro scritto. Anche il metodo rimase uguale. Avevo bensì aggiunto altri due testi che ho poi consultato regolarmente sino alla fine: l’edizione dei Sonetti negli Oscar Classici Mondatori con introduzione di Anna Luisa Zazo e traduzione di Giovanni Cecchin , diciamo in prosa versificata; e soprattutto l’edizione Rizzoli curata e tradotta da Alessandro Serpieri. Quest’ultimo libro è il testo definitivo per un lettore italiano che voglia affrontare i sonetti di Shakespeare. 14 Dal cinquantesimo sonetto in avanti, mi leggevo e rileggevo il testo originale, leggevo le tre traduzioni dai libri citati, leggevo il commento del Serpieri a ciascun sonetto e poi, quasi rigo per rigo, costruivo i miei bravi e begli endecasillabi. Alla fine, com’era successo fin dal primo sonetto, emergeva nell’estrema chiarezza il senso di quei quattordici versi. Il testo inglese non mi era più estraneo; e capivo. Volutamente non ho consultato altre traduzioni che ho in seguito cercato e comprato. Già possedevo il volumetto con i quaranta sonetti tradotti da Ungaretti. Mi ero riservato di consultare eventualmente le altre traduzioni solo dopo che avessi finito l’ultimo sonetto. 6 - Non devo tener alto il prestigio della poesia, però non vorrei nemmeno spregiarla. Purtroppo il dire pari pari cos’è suona spesso come uno spregio, ma non è colpa mia. Ugualmente, non posso vantarmi di nessuna comunione spirituale con nessun grande genio. Ma certo mi sentivo vicino Shakespeare mentre traducevo. Lo vedevo quasi farmi cenno di lasciar perdere i suoi esegeti e sfidarmi a rintracciare la chiave che avrebbe potuto aprirmi un suo sonetto. E lo vedevo ridere di gusto quando svelavo un rebus particolarmente malizioso, come all’inizio con la cosiddetta “sequenza matrimoniale”. Tutti quei contrasti tra ciò che cresce e ciò che muore, tra fame e ingordigia, tra usura e ricchezza, tra morte e discendenza, giravano intorno all’immagine del bel giovane dedito alla masturbazione anche più volte al giorno, con grande spreco di ricchissimo sperma. Shakespeare rideva alla grande: “Voi, oggi, riducete tutto al sesso nudo e crudo!” 15 E io a ribattere: “Proprio tu dici questo? Tu, coi tuoi sonetti sulla lussuria e sulla voglia? A proposito, che ci fu fra te e il bel giovane, quando lui smise di masturbarsi?” Vedo ancora Shakespeare che saltava dalle risate e m’indicava col dito: “Anche tu! Sei anche tu fra gl’ipocriti censori! Ma non avete altro da fare che dedicarvi a queste curiosità?” E rideva: “Gli ho strinto la mano tre volte, nient’altro. E voi ci avete costruito sopra un castello di arzigogoli. Oh, come siete buffi!” Poi si fece quasi serio e disse: “Se vuoi ti svelo chi era il bel giovane.” “No, per carità,” lo fermai subito. “Se tu me lo dicessi, dovrei penare chissà quanto per convincere i tuoi biografi. E a che scopo? Queste curiosità non sono più nemmeno di moda. Ora tutti gl’interpreti dei tuoi sonetti son lì a dire che, nell’insieme, sono un grande dramma con tre o quattro personaggi. Qualcuno è arrivato a dire che i sonetti sono il tuo teatro concentrato.” “Lo so , lo so. Anch’io mi diverto ogni tanto a controllare le pensate degli esperti nelle mie opere. Non ti dico quanto rido fra me, quando leggo certe cose. A volte mi dico ‘Questi sì che sono geni! Su un piedistallo di tre centimetri son capaci di costruire un castello di trecento pagine.’” “Grande poeta, grande drammaturgo e anche grande vanesio, vedo,” lo punzecchiai . “Nemmeno in paradiso diventano noiose le tiritere libresche?” “Ma noi non ci perdiamo mica tempo. Basta un’occhiata e diciamo ‘Oh, che imbecille!’” “Piuttosto” ripresi io, “dimmi se l’idea di pubblicare i sonetti fu tua o di Thorpe.” “Mia?” Esclamò Shakespeare, tra lo sdegnato e il divertito. “Se m’è toccato un posticino in paradiso è proprio perché non ho mai pubblicato le mie opere, a parte due cosucce che 16 mi sono costate cent’anni di purgatorio. No, no: è colpa di quel delinquente di Thorpe. Se lo piglio… Del resto, se non l’ho incontrato in quattrocent’anni di eternità, vuol dire che è all’inferno e gli sta bene.” “Non hai tutti i torti a volerlo all’inferno” aggiunsi io. “Che si fa la dedica d’un libro a chiunque sia, indicandolo con le iniziali! Però” continuai, “allora Thorpe era più appassionato di te per la poesia italiana. Forse era più istruito.” “Cosa intendi dire?” si alterò Shakespeare. “La raccolta pubblicata da Thorpe comprende 154 sonetti: sono uno per ogni sillaba metrica del sonetto italiano. Un suo omaggio alla patria del sonetto” aggiunsi, “è evidente.” “O codesta?” fece Shakespeare. E dopo un attimo di sbalordimento prese a ridere forte: “Codesta è più bella della storia della masturbazione. Thorpe era un caprone molto più ignorante di me. Io non ho mai saputo una parola d’italiano, ma Thorpe non sapeva nemmeno che fosse esistito un poeta di nome Petrarca. No, fu un caso.” “Quale caso? Per arrivare a 154 Thorpe ( o sei stato tu? Comincio a dubitare che tu continui a recitare anche in paradiso), o tu o Thorpe avete messo insieme i sonetti dedicati al bel giovane, quelli per la dama bruna (era una civetta o soltanto una gran puttana?), altri sonetti sparsi e infine avete tirato fuori da chissà dove gli ultimi due, che fanno piangere, solo per completare l’omaggio di 154.” Shakespeare continuava a ridere e a dire: “No, fu un caso.” Poi aggiunse: “Ho scritto centinaia di sonetti. Per fortuna la maggioranza sono andati persi. Voi non capite: allora, per noi, scrivere un sonetto era come per voi, oggi, fare una telefonata: ‘Ciao, come stai? Dove sei?’ e giù quattordici versi in rima.” 17 “Se ti sentissero, chissà cosa direbbero i critici strutturalisti e i semiotici che si sono tanto sbizzarriti sui tuoi sonetti!” “Mah! Forse nel loro mondo pedante hanno ragione. Certo, se per scrivere un sonetto avessi dovuto tener presente tutto quello che loro dicono di scoprirci, non avrei scritto nemmeno il primo verso del primo sonetto.” “Su questo son d’accordo con te. Quando uno è insicuro, si preoccupa della teoria e della critica. Quando matura, se matura, si abbandona alla spontaneità: se c’è qualcosa emergerà; sennò, pace.” “Vedo che anche tu credi al genio innato” mi canzonò lui. “Mi fa molto piacere: tutti dicono che io sono uno dei più grandi geni dell’umanità.” “ Ma no! Anzi è il contrario. Si diventa spontanei dopo che per anni si è accumulato cose altrui e per altrettanti anni, e di più, le abbiamo buttate via e dimenticate.” “E lo dici a me? Io tiravo giù i miei drammi, in fretta e come venivano, su dei fogliacci già divisi per le parti da distribuire agli attori. E dopo dugent’anni vengo a scoprire che sono un genio universale! Tu, piuttosto, ti attacchi al mio nome e invece di scrivere qualcosa di tuo, ti metti a rifriggere i miei sonetti.” “Rifriggere?” saltai sù io, punto sul vivo. “Innanzi tutto, tanti miei sonetti tradotti sono migliori dei tuoi originali; e poi… e poi…” Smisi perché vedevo Shakespeare ridere e battere le mani e indicarmi come uno zimbello: “Signore e signori, ecco a voi uno che crede ancora alle gare letterarie, a chi è migliore e peggiore, e alle classifiche dei poeti . Se metti Dante prima di me, ti ricuso per legittima suspicione di nazionalismo.” “Va bene” convenni sorridendo. “Ma dimmi almeno una cosa importante: si può esprimere in un sonetto una piccola 18 verità particolare che, non si sa come, racchiuda tutta intera la verità?” Shakespeare si fece serio, mi guardò e disse: “Ti svelerò un segreto ben più interessante dell’identità del bel giovane o della dama bruna. Quando voi viventi guardate un sasso, o un fiore, o anche un topo, e specialmente un grande albero secolare, voi vedete la verità tutta intera. Ora lasciami andare. Noi che disgraziatamente abbiamo un nome conosciuto dai posteri siamo solo anime in pena continuamente evocate da tutti. Dobbiamo correre come ossessi a ogni richiamo e non troviamo mai pace. Oh, come vorrei essere un albero anonimo in mezzo a una foresta!” 7 –LINGUA INGLESE. Se fossi in vena di scherzi, e ci fosse qualcosa su cui scherzare, direi che ho una buona conoscenza scolastica della lingua inglese scritta. Potrei addurre la prova dell’unico trenta e lode guadagnato nella mia carriera di studente universitario, appunto in lingua e letteratura inglese. La verità è che se un inglese parla non capisco una parola e io, in inglese, incespico su ogni vocabolo e sono incerto sulla pronuncia. Che gusto potrei avere della lingua inglese? Nessuno, infatti. Sono nato e ho sempre abitato nel centro della Toscana. Ho il gusto della lingua italiana per queste origini e per gli studi, le letture, le frequentazioni, la pratica che ne faccio da decenni cercando di adattarla al mio pensiero e di adattare il mio pensiero alla mia lingua. Con tutto questo, ne scopro sempre nuove possibilità e il mio gusto per l’italiano aumenta ogni giorno, quel gusto che è insieme istinto e amore coltivato. 19 Per chi è di madrelingua inglese e per la sua lingua percorre il mio stesso sentiero, ho comprensione e amore fraterno. La lingua inglese è una lingua capace di grande poesia, grande prosa e grande scienza. Quello che non comprendo è come possa uno nato in una lingua avere per un’altra lingua il gusto che ho io per l’italiano. Questo non lo comprendo in generale. Per l’inglese, in particolare, non riesco a capire come uno nato in una lingua neolatina possa averne amore: semplicemente; non dico un gusto elevato. E mi limito alle lingue neolatine perché non conosco abbastanza bene lingue di altri ceppi per dirne qualcosa. A un orecchio neolatino l’inglese suonerà sempre come un borbottio monosillabico, una lingua infantile piena di omofoni, priva dell’ossatura di un verbo, incapace di sintassi e che perciò si rimette al non detto, ai modi di dire e ai molti significati di una parola altresì detti polisemia. Mi piace citare Julia Alvarez nata di lingua spagnola, emigrata da bambina negli Stati Uniti e diventata scrittrice di lingua inglese. E’ sua madre sotto pseudonimo che parla in Yolanda la bugiarda: “Per molto tempo ho pensato che gli americani fossero più intelligenti di noi latini, altrimenti come potrebbero parlare una lingua tanto difficile? In seguito mi sono convinta del contrario. Dato che si può scegliere in che lingua esprimersi, solo un idiota può decidere volontariamente di parlare in inglese.” Tante volte s’intuiscono i grandi rivolgimenti storici da fenomeni che a tutta prima sembrano trascurabili. Il cambiamento riportato da Julia Alvarez, del giudizio su chi decide di parlare in inglese, rivela che il fascino dell’impero statunitense è crollato nelle coscienze; e come sempre avviene, non tarderà a manifestarsi un crollo anche 20 nell’economia e nella politica. Potrei azzardare un’altra previsione: che da questo crollo inizierà anche la fine del predominio internazionale della lingua inglese durato duecento anni al seguito, prima, dell’impero britannico e poi di quello statunitense. Certo, se non la smetteremo di farci imporre la lingua dell’impero di turno, corriamo tutti il rischio di dover imparare migliaia d’ideogrammi cinesi. Non rimpiangeremo mai abbastanza l’uso del latino come lingua dei rapporti internazionali, della filosofia e della scienza. Era sì la lingua di un impero, ma di un impero ormai scomparso. Ed è una lingua che non solo si legge come si scrive e si scrive come si parla, ma è soprattutto una lingua esatta in cui, quando si parla, si dice. Ma queste sono solo sparate in aria che in fondo non ci interessano. Quello che voglio sottolineare è che troppo spesso chi affronta la letteratura inglese e la traduzione da un autore inglese parte, senza rendersene conto, facendo prima di tutto un inchino e rimanendo per tutto il tempo a bocca aperta: “Dato che lui scrive in una lingua tanto difficile, una lingua che ha consentito a chi la parla di dominare il mondo, non sarà più intelligente di noi latini?” E’ proprio una riserva mentale di questo genere che traspare dall’atteggiamento di tanti interpreti della letteratura inglese. Non voglio certo riesumare le polemiche ormai bicentenarie fra poesia germanica e poesia neolatina, di cui dette un riassunto Benedetto Croce già nel 1918-19 nel suo saggio su Shakespeare. Notava Croce che alle vanterie tedesche, fatte proprie con ritardo dagl’inglesi, “dettero fede anche critici francesi e italiani” che “si chinarono riverenti alla superiorità” della poesia germanica e del suo campione, Shakespeare appunto. 21 Io, ora, non sto parlando di poesia, sto parlando della differenza della lingua inglese dalle lingue neolatine e in particolare dall’italiano. Mi soffermerò un minuto a esaminare il monosillabismo e la polisemia di tante parole inglesi. Il fatto che in inglese moltissime parole siano costituite da una sola sillaba e che una sola sillaba, scritta ma ancor più pronunciata, assuma quindi moltissimi significati differenti a seconda del contesto, questo fatto viene pregiudizialmente considerato una ricchezza che le altre lingue non potranno mai raggiungere. Ecco allora Elio Chinol che, commentando le sue traduzioni dei sonetti scespiriani, fra l’altro quasi sempre buone anche se in versi liberi, esce a dire: “E’ ben noto, ed è stato ripetutamente sottolineato come gli agili monosillabi di tante parole inglesi debordino e straripino negli equivalenti, pesantissimi, polisillabi italiani.” Ed ecco che il fatto dei molti significati che ha un monosillabo inglese invece di essere qualificato per quello che è, cioè una povertà di vocabolario, viene rovesciato in una ricchezza che deborda e straripa (è il caso di ripeterlo) nel magnificarne i tanti significati. Sotto quest’ultimo aspetto è notevole l’effetto che fanno i commenti del Serpieri ai singoli sonetti. Sono commenti precisi e ricchissimi, frutto d’alta filologia e d’una profonda conoscenza dell’inglese elisabettiano, nonché naturalmente dell’inglese moderno. Invidiabile: io lo invidio. Pure, l’effetto globale che fanno le sue note alle parole dei sonetti, con la ricchezza di campi semantici continuamente richiamati e illustrati, ti porta a esclamare, se uno non sta attento: “Accidenti a me che sono nato in una lingua povera!” 22 Si veda, per fare un esempio, già la nota al primo sonetto: “la parola increase copre un ampio campo semantico… sta sia per ‘procreazione’ e per il suo effetto, la ‘progenie’, che per ricca ‘riproduzione’ di un modello, nella specie, e per generoso ‘allargamento’, ‘crescita’, ‘perpetuazione’ del soggetto.” E continua: “questa prima parola in rima ha la forza di un intero campo semantico generativo.” Infatti si evidenzia una “opposizione di campi semantici, l’uno all’insegna dell’increase e l’altro del decease (la prima rima che si ha ai vv. 1 e 3): al primo appartengono i termini della bellezza, dell’abbondanza e della vita (fairest, beauty, heir, abundance, ornament, gaudy spring, bud), al secondo quelli della fame, della sottrazione e della morte (die, decease, contracted, foe, cruel, buriest, churl, waste, niggarding, grave).” E naturalmente conclude: “Qualsiasi parola italiana che appartenga al campo semantico di increase… risulta pertanto inadeguata a renderne la piena estensione.” Tutto ciò mi porterebbe allo sberleffo e a trovare su due piedi una parola, di due sillabe come increase, che ne rende la piena estensione anche in italiano. Proporrei “pene”, o anche “cazzo” se vogliamo andare sul pesante, che sboccia come una rosa all’inizio e alla fine muore e sparisce nella tomba. Ma mi trattengo per rispetto e riconoscenza verso il Serpieri che le merita. Chi merita invece d’esser detto un trombone che soffia trombonate è Ungaretti. Sarà la mia antica antipatia verso di lui che illustrai anni fa nel mio libretto, ma per me le sue traduzioni fanno pena. Qui voglio soltanto segnalare la sua nota alla traduzione di record con “ricordo” nel sonetto 59: per illustrare questa difficilissima (ed errata) traduzione gli ci sono volute 14 pagine a stampa. Vi riporta due versioni integrali del sonetto 59, una francese di Charles-Marie 23 Garnier e l’altra italiana di Piero Rebora; vi cita Les Belles Lettres, Péguy, i Cahiers de la Quinzaine, il Simbolismo, il Barocco, Amyot, Valéry-Larbaud, i collaboratori di Mesures e di Commerce, André Gide, Mallarmé, Poe, Caro, Monti, Leopardi, Sainte-Beuve, Petrarca, Ronsard, Scève, Colombo, Flaubert, Hugo, Madame Roger des Genettes, Cavalcanti, Dante, Tasso, Manzoni, Bossuet, Pascal, Racine, il Quattrocento, il Petrarchismo, Meleagro, il Neoplatonismo, il Manicheismo, Filone Ebreo, Platone e, per finire, Cristo. Naturalmente non manca l’affondo sulle “omonimie e sinonimie che con tanta liberalità i lessici inglesi offrono all’espressione lirica, dandole la flessibilità fonetica impareggiabile ch’essa possiede.” Allora diciamola tutta e chiara: le omonimie, cioè i molti significati che può assumere una parola, esistono in tutte le lingue e sono una ricchezza per chi parla. Ma quando le omonimie, in una lingua tendenzialmente monosillabica, sono inevitabili, non sono più una ricchezza, ma una maledizione che rivela l’intrinseca povertà di vocabolario di quella lingua, come ho già detto. E infatti l’inglese ha cercato rimedio alla povertà originaria del suo anglo-sassone, prima, scrivendo in maniera differente lo stesso suono, e poi, appropriandosi di migliaia di termini latini, direttamente o tramite il francese dopo la conquista normanna. E andando per questa via aldilà del segno. Si sono infatti creati anche migliaia di sinonimi, che sono una dubbia ricchezza e una sicura confusione. Tanto è vero che qualcuno ha scherzosamente proposto che gli uomini di lingua inglese usino solo monosillabi d’origine anglo-sassone e le donne solo polisillabi d’origine latina. Inoltre l’inglese è una lingua incredibilmente prolissa, nonostante tutti i suoi monosillabi. Ha una costruzione pedante del periodo e del discorso con 24 tutti quei pronomi personali necessari per dare un senso ai suoi verbi monchi e col balletto ossessivo degli aggettivi possessivi. E’ stato calcolato, e ce ne dà conto Giorgio Melchiori in L’uomo e il potere – Indagine sulle strutture profonde dei Sonetti di Shakespeare, che Shakespeare adopra I, me, my, thou, thee, thy, messi insieme, la bellezza di 10,19 occorrenze in media per ogni sonetto: quasi un’apparizione per ogni verso. Anche nella resa grafica d’un suono (vedi il nome Shakespeare), nessun’altra lingua adopra così tante lettere alfabetiche come l’inglese; in maniera cervellotica e in forme cangianti perdipiù. Vero è che per le tante parole monosillabiche una pagina di buona prosa inglese tradotta in buon italiano, o viceversa, richiede un minor numero di battute sulla tastiera. Ma è vero anche che molti hanno scambiato il minor numero di battute per agilità, flessibilità, concisione e ricchezza di significati. Ma in queste qualità l’inglese non ha nulla da insegnare all’italiano. Con questo non voglio essere frainteso. Ho già detto che l’inglese è una lingua capace di grande poesia, grande prosa e grande scienza. Ha naturalmente le sue caratteristiche, differenti da quelle dell’italiano e da quelle delle lingue neolatine. E’ una lingua che, quando parla, non sempre dice, ma più volentieri accenna e rimanda a qualcos’altro. Non è un caso che il predominio dell’inglese coincida con l’epoca romantica. Ammiro la letteratura inglese e americana. L’ammiro molto, ma non la amo; come non amo il romanticismo in genere, con tutto quel puzzo di disfacimento, di suicidi, di morte e di pazzia, già presente alla fine del Settecento e che poi ha ammorbato tutto l’ambiente spirituale, specialmente dalla fine dell’Ottocento e per tutto il Novecento. 25 Per ciò che qui m’interessa, il romanticismo si riassume nella sopravvalutazione della poesia, nell’osannare la lingua inglese come la vera lingua adatta ai tempi e nello sforzare Shakespeare come precursore e campione insuperabile del nuovo sentire poetico. Doveva essere evidente da subito che la poesia non avrebbe potuto reggere quel carico di responsabilità e quel rango che le attribuirono i filosofi e i critici, soprattutto tedeschi, fra Settecento e Ottocento. Ma tant’è: poeti e letterati si abbandonarono con entusiasmo alla mitologia dell’arte e ne fecero una religione. Quando si accorsero che la gente era stufa delle loro pose, invece di prender coscienza onestamente che la poesia non era quella gran cosa che dicevano i teorici, cominciarono a maledire il pubblico ignorante e profano, che non capiva. E per rendere chiaro a tutti che i profani non capivano la poesia, cominciarono a non voler farsi capire a bella posta. Da qui nasce, dopo una prima stagione interessante, il disfacimento della letteratura romantica, da Mallarmé e Rimbaud, fino al dadà, al futurismo, all’ermetismo, e fino al nulla del secondo Novecento. E da qui deriva l’assurda conseguenza che i mitomani della poesia diventarono i più fieri detrattori della loro lingua a favore dell’inglese e poi, dato che più sù dell’inglese non si poteva andare, di ogni lingua in generale. La chiacchierata senza senso sui limiti del linguaggio, d’età anche questa bicentenaria, è tutta un annaspare intorno alla poesia concreta, fatta di parole versi e strofe, messa a confronto col mito romantico della poesia. Invece di riconoscere onestamente che quel mito era un’invenzione cervellotica, molti hanno continuato per l’arco di due secoli a disquisire sui limiti del linguaggio e a tentare di superare quei limiti 26 immaginari per attingere la Poesia, l’Arte, lo Spirito e qualunque astrattezza scritta con la maiuscola. E sono finiti a spregiare la chiarezza comunicativa fra la comunità dei parlanti; e quelle lingue che nonostante tutto la preservano più di altre. 8 - SONETTO E ENDECASILLABO. E’ pacifico e ammesso da tutti che il sonetto elisabettiano, e quindi scespiriano, composto da tre quartine e un distico, deriva dal sonetto italiano composto da due quartine e due terzine, o da un’ottava e una sestina come altri preferiscono dire. E’ altrettanto pacifico che il verso decasillabo usato da tutti i poeti elisabettiani, e anche da Shakespeare, deriva dall’endecasillabo italiano. Che poi alcuni chiamino il decasillabo inglese “pentametro giambico”, per dargli un lustro classicheggiante, e che la prosodia inglese sia differente da quella italiana, non significano nulla a questo riguardo: è pacifico che il sonetto scespiriano, come metro e come verso, deriva dall’italiano. Ci sono state sicuramente ragioni profonde che hanno indotto i poeti elisabettiani a quelle modifiche per adattare all’inglese il modello italiano. Sono state ampiamente studiate e le accetto in blocco. Mi sembrerebbe pacifico, però, che un traduttore italiano di sonetti elisabettiani fosse cosciente che sta tentando di riportare alla forma originale una copia. E che le solite ragioni profonde che consigliarono le modifiche in un senso, valgono a maggior ragione, ora, nel senso opposto. Ciò non riguarda, evidentemente, chi si contenta di una versione in prosa. Inoltre ognuno è libero di scrivere le sue traduzioni come meglio crede, anche una parola per ogni rigo, e può spargere quindi un sonetto in tre o quattro pagine. 27 Tuttavia una discussione su questo punto sarebbe stata gradita. Niente, nessuno dei traduttori italiani s’è posto il problema: tutti lì a inchinarsi alle tre quartine e al distico e a maledire l’italiano perché richiederebbe 16 o 17 sillabe in media per le 10 inglesi. Perciò ne farò io una piccola discussione. Non intendo raffazzonare l’ennesima teoria della traduzione, non mi interessano né le brutte fedeli né le belle infedeli, non voglio citare nomi di teorici, voglio soltanto parlare della traduzione dei sonetti elisabettiani in italiano. Il mio discorso vale pertanto solo per la loro traduzione in italiano, perché dall’italiano derivano. Certo, devo premettere un discorso generale: quello della coerenza. Preferisco “coerenza” a “fedeltà”, ma non ne faccio una guerra di religione; anche “fedeltà” può andar bene. Se uno è profondo conoscitore di Shakespeare e del linguaggio elisabettiano e vuol avvicinare il lettore italiano agli originali, dovrebbe essere coerente col proprio assunto: stampare la sua traduzione a fronte o in calce all’originale; una traduzione completa e precisa, in prosa, che non disdegni di esplicitare in un intero discorso il senso completo anche di una sola parola originale; una traduzione accompagnata, sonetto per sonetto, da un commento e da una serie di note testuali. Diciamo, per i sonetti di Shakespeare, la traduzione di Lucifero Darchini rivista e aggiornata, e i commenti e le note di Alesssandro Serpieri. Si avrebbe così la perfetta coerenza e la perfetta traduzione intesa come ausilio per la lettura dell’originale. Se uno invece intende tradurre quei testi in poesie italiane, anche in versi liberi, persino in prosa artistica, cambia con ciò stesso il suo dovere di coerenza, che non è più verso l’inglese, ma verso l’italiano. Non è necessario che sia un 28 profondo conoscitore dell’originale e può sfruttare tranquillamente il lavoro dei traduttori dell’altro tipo che proprio a questo servono. Deve però essere un profondo conoscitore della lingua in cui traduce, delle sue forme e delle sue tradizioni; e solo verso di essa essere coerente. Voler tradurre i sonetti scespiriani in poesia italiana significa voler dare preminenza alla traduzione sull’originale e accettarne coerentemente tutte le conseguenze. Non si può esser fedeli a due padroni. Per questo ritengo ipocrita e incoerente la stampa dell’originale accanto alla traduzione e per me non la voglio. Ipocrita e incoerente, perché si fa una scelta ardita e poi, per paura di tanto ardire, ci si appoggia agli originali reclamando comprensione dal lettore per le proprie insufficienze di stile, accampando la necessità di non tradire il testo. E per la medesima incoerenza si mettono le mani avanti, con l’ingigantire le difficoltà della traduzione da una lingua così ricca e profonda in un piccolo idioma primitivo come sarebbe l’italiano. Detto questo, veniamo alla questione delle famose 16 o 17 sillabe italiane che sarebbero necessarie per rendere, in media, le 10 sillabe del decasillabo inglese. Queste cifre angustiavano molto Ungaretti, ma anche Alberto Rossi e altri che, pur senza dare numeri, hanno commentato le loro traduzioni. Bene, l’endecasillabo italiano ha quasi sempre undici sillabe, ma può averne anche dodici o tredici. Per cui, se proprio vogliamo fare i contabili, la differenza con l’inglese si ridurrebbe. Ma ancor più si riduce con la sinalefe, cioè la contrazione di due o più vocali successive di parole differenti in un’unica sillaba metrica, o con la sineresi, che è lo stesso fenomeno nell’ambito di una parola. Di più: oltre a quanto 29 ho detto circa i pronomi personali necessari per dare un senso ai verbi inglesi e alla pletora degli aggettivi possessivi inglesi (pronomi e aggettivi che quasi sempre si possono tranquillamente trascurare), voglio aggiungere che gli asciutti sostantivi italiani, uniti a verbi altrettanto precisi, danno spesso alla frase un significato più vicino al senso degli originali sostantivi, accompagnati da aggettivi che è meglio trascurare. Ma l’essenziale è la maggior concisione del pensare in italiano rispetto al tradurre dall’inglese. E questa, se leviamo “italiano” e “inglese”, è forse l’unica, vera, teoria della traduzione. Leggo nella Nota sulla traduzione di Alberto Rossi che nei sonetti di Shakespeare circa il dieci per cento dei versi è costituito da dieci monosillabi. Chi resta affascinato da questi numeri (dieci per cento, dieci monosillabi, sedici sillabe italiane), tradisce inevitabilmente l’italiano: l’esempio pessimo è Ungaretti che si adagia a fare versi di sedici sillabe, veri tortelloni ripieni di parole senza babbo. A questo punto della mia scrittura, in piena notte, sono stato preso dalla tentazione di strafare a proposito del numero di sillabe. Ho fatto una cosa che uno studioso per bene non farebbe mai, ma che io, che non devo rispondere a nessuno, mi posso permettere. Ho compiuto lo sberleffo che mi frullava in mente da giorni e ho tradotto il primo sonetto di Shakespeare in un sonetto italiano composto da quattordici quinari.Eccolo: Fiore è il tuo pene che cresce e muore. Ma la bellezza lasci un erede! 30 Tu, primavera, tu, gioia al mondo, dolce spilorcio, sprecone avaro, nel boccio tuo riversi il seme e solo te ami. Pietà del mondo! Non divorare ciò che gli spetta. Sono settanta sillabe, la metà esatta delle centoquaranta di Shakespeare. E traducono perfettamente il suo sonetto in una bella e divertente poesia italiana che ha una sua unità di timbro e di vocaboli. Questa è la coerenza verso l’italiano unita alla fedeltà verso l’originale inglese. Stiamo perciò attenti a contare le sillabe: non si parla con la bocca ma col cervello. Questa è la terza versione che do del primo sonetto; ne ho già scritta una quarta, pornografica, che evito di pubblicare per decenza. Prima di morire voglio vedere se mi riesce fare 154 versioni differenti del primo sonetto, o almeno 140, come omaggio a Shakespeare. Ho già detto come nacque la prima traduzione del primo sonetto. La seconda mi parve necessaria come riscontro, dopo che avevo tradotto tutti i sonetti, per vedere come era cambiato il mio modo d’interpretare l’originale e di renderlo 31 in italiano. Devo dire che l’esperienza mi ha fatto più guardingo: la seconda versione è più fedele all’originale, ma forse la prima è migliore. Non l’avevo letta da mesi e non la rilessi che dopo aver scritto la seconda versione. Ho fatto altri due esperimenti. Ho tradotto il sonetto 66 con quattordici endecasillabi intervallati da quattordici quinari, rispettando anche la divisione in tre quartine e un distico, se così si può dire. Forse mi condizionò la sequela di dieci versi che cominciavano con and. O forse non ebbi la pazienza di cercare una versione di soli endecasillabi; ma quando mi ritrovai la poesia come poi è rimasta, mi sembrò perfetta e non l’ho più cambiata. Il sonetto 145 è già anomalo di suo perché ha i versi non di dieci sillabe come tutti gli altri, ma di otto: è composto da tetrapodie giambiche, come dicono. Nel tradurlo non volli interrompere la mia serie di sonetti italiani in endecasillabi; ma poi, lo stesso giorno, mi prese lo scrupolo che anch’io avrei dovuto renderlo con versi più brevi. Il novenario avrebbe rispettato le proporzioni dell’originale, ma non so perché usai il decasillabo, che fra l’altro è un verso che non mi è mai piaciuto con quel suo ritmo taratà taratà taratà. Forse rispetta meglio l’insulsaggine dell’originale. Conservai anche le tre quartine e il distico, con la coda “Non te”, che è la cosa più bellina delle due versioni, insulse però anche loro. Ci sono poi nel testo originale altri due sonetti irregolari: il 99 che ha un verso in più e il 126 che ha due versi in meno o, per meglio dire, è una poesia composta da sei distici a rima baciata. Anch’io li ho tradotti come sono: con un verso in più e con sei distici, senza rima naturalmente. 32 9 – RIMA E STROFE. A che serve infatti la rima? Ha una funzione eufonica che vuol dire musicale; ha una funzione semantica perché svela o crea un rapporto fra due parole differenti; ha una funzione strutturante perché i suoi schemi determinano la forma metrica dell’intero componimento e delle strofe in cui si divide. Se non me lo ricordassi, ho ancora a portata di mano il libro sulla metrica italiana di Bausi e Martelli. Ma io continuo a chiedermi: a che serve la rima? Mi ha colpito il fatto che quest’ultima frase inizi e finisca con la sillaba “ma”, come “Martelli” subito prima e, sù sù fino all’inizio del paragrafo, “mano”, “forma”, “semantica”, “rima”. Il suono “ma” è abbastanza eufonico o devo per forza abbinare “rima” con “cima” per dare musicalità al mio discorso? E se basta “ma”, non potrebbero essere eufonici anche gli altri suoni della emme? Avremmo allora, dall’inizio: “rima”, “musicale”, “semantica”, “schemi”, “determinano”, “forma”, “metrica”, “Martelli”, “ma”, “chiedermi”, “rima”. Vedo che mancano il suono “mo” e diversi suoni composti di emme con altre consonanti, ma diamo per scontato che ci siano. E se sono eufonici i suoni della emme, come sono quelli della bi, della ci e di tutte le consonanti, per tacere delle vocali? Diciamo allora meglio che la musicalità di una poesia italiana dipende dall’insieme dei suoni delle parole italiane; distribuiti in sequenze ordinate di sillabe accentate e atone. E dunque: a che serve la rima? Ha una funzione semantica, dicono, ma che significa? Non mi pare che la rima sveli arcane rispondenze fra le parole. La rima prima era in cima e ora è ima: cosa ho svelato? O quali inauditi rapporti ho creato? 33 Il mio cognome è Becheri; si pronuncia sdrucciolo con due e chiuse. Nessuna parola italiana fa rima in -écheri. Una volta un mio professore d’italiano su un compito in classe mi dette il giudizio: “Becheri, becero” che è un’assonanza, una quasi consonanza e una rima imperfetta. E creò una rispondenza semantica di cui vado fiero. Riconosco che se avesse scritto “Becheri, troppo scurrile” oggi non me lo ricorderei. Se è questa la funzione semantica, può esserlo di tutte le parole, non solo di quelle in rima: di tutte le parole che siano unite fra loro da un legame significativo, anche se non formale: come ci insegnano le metafore. Finalmente: la rima avrà la funzione strutturante, per cui essa, sola, crea fra i versi quei legami detti strofe e quei legami fra le strofe detti metri, come il sonetto? Ebbene, la rima di per sé non ha nemmeno questa funzione strutturante, né da sola né insieme ad altri accorgimenti tecnici. E non ha nemmeno le 18 (diciotto!) funzioni che vi rintraccia Alvaro Valentini in un suo libro su La rima, la forma e la struttura. Tutte queste funzioni sono invenzioni distillate da teorici e professori. La rima tra “funzioni” e “invenzioni” è voluta. La rima in –ioni, come quella in –ente degli avverbi, è una di quelle che ricorre più spesso nella prosa d’oggi, e delle più fastidiose. Sicuramente nemmeno io personalmente le sfuggo. Nei sonetti che seguono ho cercato di evitare le rime. In alcuni casi di rime spontanee che sono capitate, ho usato degli artifici per evitarle; in altri casi, quando proprio mi sembrava che non significassero nulla, le ho lasciate. La rima ha avuto una grande importanza nella poesia italiana dei primi secoli. Ma già dal Quattrocento ha cominciato a scendere di tono. Per ancora un secolo se ne è potuto fare un uso tra l’ironico e il distaccato, come nei 34 poemi cavallereschi. Poi è diventata sempre più una nenia cantabile che assai di rado riusciva a raggiungere e a mantenere per più di tre o quattro versi un livello serio di espressione. Nell’ultimo secolo è diventata dominio dei parolieri delle canzonette e dei pubblicitari scadenti. Ed oggi, nella poesia, la rima ha una quarta o diciannovesima funzione che è la più frequente di tutte: rende volgare un componimento. Tutto questo non lo dico per giustificarmi per non aver usato le rime nei miei sonetti. Mi sarebbe bastato dichiarare che le trovo ridicole. E se proprio avessi dovuto, potevo portare la giustificazione del Leopardi che riteneva rima e traduzione incompatibili. Io mi chiedo invece: se togliamo le rime, cosa resta di un sonetto? E che differenza c’è tra il sonetto italiano, il sonetto elisabettiano e un qualsiasi componimento di quattordici versi sciolti? Per rispondere a queste domande si deve avere ben chiaro cosa forma davvero una strofa e cosa distingue una strofa dall’altra, pur mantenendo fra di loro un’unità che nel nostro caso si dice “sonetto”. La risposta non è affatto difficile: il sonetto ideale è un discorso compiuto, diviso in quattro periodi, ciascuno dei quali si emana in quattro o tre respiri detti “versi”, che acquistano il loro intero valore dall’unione del significato e del suono delle parole con l’alternarsi di tempi forti e deboli. Il valore del singolo verso trae forza dal respiro e la rende aumentata alla sequenza dei respiri stessi, sì che ogni periodo afferma una realtà. E le quattro affermazioni di realtà, compiutamente armonizzate fra loro, svelano una verità certa e indiscutibile. Questo è il sonetto ideale dove la rima non è necessaria nemmeno per definirne la struttura; e se la rima c’è, deve giustificarsi di per se stessa e non pregiudicare il risultato. Nemmeno è 35 richiesto che il verso sia endecasillabo; già prima ho proposto un sonetto in quinari e uno in decasillabi. A rigor di logica non è richiesto neanche che i versi abbiano tutti la stessa misura, ma certo il sonetto in endecasillabi è il modello che chi scrive cerca di imitare e chi legge o ascolta tiene come termine di paragone. Le deviazioni dalla sua norma acquistano un significato per il fatto stesso di non rispettare il modello. Il periodo può debordare dalla strofa e concludersi nella successiva; il respiro può non combaciare col verso canonico e spezzare il successivo. O la strofa contenere due o più periodi; o il verso due o tre affannosi respiri; o i versi possono non essere endecasillabi. Tutto questo acquista un significato per il fatto stesso di deviare; così come acquista un significato, oltre al senso delle parole, al valore dei versi, alla forza dei periodi, alla realtà e verità del sonetto, il pieno rispetto del modello. Modello che non è un’idea platonica , ma una poesia che da secoli tutti possono leggere: Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand’ella altrui saluta, ch’ogne lingua deven tremando muta, e li occhi no l’ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d’umiltà vestuta; e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per li occhi una dolcezza al core, che ‘ntender no la può chi no la prova; 36 e par che de la sua labbia si mova un spirito soave pien d’amore, che va dicendo all’anima: Sospira. “Questo sonetto è sì piano ad intendere… che non abbisogna d’alcuna divisione” ci conferma Dante. E nonostante il passare dei secoli e il parere contrario di Gianfranco Contini (Varianti e altra linguistica, pag. 166) me ne sto ben stretto all’affermazione di Dante. La traduzione in concetti moderni che ne dà il Contini è una di quelle esibizioni professorali che, se esistesse un Dio, ci sarebbero risparmiate. Quale sia allora la differenza fra un sonetto nostro e un sonetto in italiano di tre quartine e un distico è presto detto: deviando dalla norma, l’autore dichiara d’esser succube d’una predominanza straniera, perdipiù d’altri tempi. Le due quartine e le due terzine sono uno svolgimento che si affretta alla fine con equilibrio, gravità ed eleganza. La terza quartina invece pesa con un dipiù che è quasi sempre un riempitivo inutile; e scoppia nel distico con la smania di dire alla fine tante cose che meraviglino il lettore; concettini, preziosaggini, e “maraviglia”: il barocco. Niente mi pare più lontano dal sentire moderno, e di sicuro dal mio, dell’esteriorità barocca. Ed anche Shakespeare, quando vi soggiace, non è più Shakespeare. Sarebbe bene cercare d’esser fedeli a Shakespeare nella sua grandezza, non nelle sue cadute. Per un italiano, tradurlo in tre quartine e un distico, quando non sia occasionale e comunque attenuato dalla scrittura in due quartine e due terzine, significa confinarlo nella sua isola e nel suo secolo e perdere in 37 partenza quello che di eterno e universale Shakespeare ci ha lasciato con i sonetti. 10 – I grandi letterati non rigovernano e quindi non si pongono i supremi interrogativi che poi, per una censura da loro imposta, vien fatto credere al popolo che siano domande che uno studioso serio non può e non deve porsi. Io invece rigoverno e mi chiedo: che valore avrebbero i sonetti di Shakespeare se lui avesse scritto solo questi e nient’altro? E inoltre: che valore avrebbero, se sapessimo tutto di lui e del bel giovane e della dama bruna, e di quante volte hanno fatto all’amore, in due o in tre e in quale motel? O anche: che giudizio ne daremmo se l’in-quarto edito dal Thorpe riemergesse intonso dal fondo d’una biblioteca dopo quattro secoli, senza nessuna indicazione dell’autore? Queste domande non sono soltanto ingenue trasposizioni dei precetti di Benedetto Croce, che raccomandava ai critici di distinguere fra persona pratica e persona poetica e di tenere la mente ben stretta all’opera da esaminare, trascurando tutto ciò che è indifferente all’arte che in quella opera si manifesta, salvo poi fare una disamina di tutta la critica scespiriana. La domanda potrebbe essere messa in questa forma: parlando dei sonetti di Shakespeare, parliamo di 154 poesie di 14 versi, o parliamo di queste poesie più una mole sterminata di libri, memorie, tesi e confutazioni che le riguardano? Per parlare solo delle poesie si è tentata la strada dell’analisi strutturalista e semiotica. Ma è apparso quasi subito chiaro che l’indagine, per questa strada, diventava “autopsia di un cadavere; anzi, è lecito sospettare che, per agevolare l’esame, siano gli stessi analisti a provocare la 38 morte del soggetto”, come notava argutamente Giorgio Melchiori nel già citato L’uomo e il potere. Devo dire, però, che anche lui non ci risparmia le sue brave dissezioni anatomiche. Sembrerebbe allora che l’unica strada percorribile sia quella tradizionale e letteraria che ho esemplificato col nome di Benedetto Croce. E in effetti ritengo il suo saggio su Shakespeare perfetto e insuperabile, premettendo naturalmente che ne ho letti pochi di altri critici. Ma chi mi potrebbe dare le mille vite necessarie per leggerli tutti? Da una ricerca su internet Google mi dice che Shakespeare ha 3.880.000 segnalazioni e i suoi sonetti 96.000, di cui 55 in cinese, 200 in giapponese e 53 in coreano. Quando imparerò il coreano? Il punto debole della critica letteraria tradizionale è l’ipocrisia ammantata di sicumera professorale. Ne va salvo Croce, naturalmente, che si muove su un altro piano. Ma che dire di tanti altri? Rimanendo ai sonetti di Shakespeare, ho comprato negli ultimi mesi tutte le traduzioni che sono riuscito a trovare; per ora sono a undici. Quasi tutte riportano una bibliografia più o meno estesa: dando per scontato che la maggioranza siano segnalazioni di studiosi inglesi, perché non vi compare una, dico almeno una, segnalazione di un critico tedesco, francese, spagnolo, per non dire coreano? Ci sono alcune segnalazioni di autori italiani, che completano il sottinteso ipocrita e lo esplicitano: noi che ci occupiamo dei sonetti di Shakespeare siamo il ponte che unisce il mondo anglosassone all’Italia; quello che passa sotto il ponte non riguarda le cattedre di Lingua e Letteratura Inglese delle università italiane. L’assunto della critica letteraria tradizionale, ma dovrei dire di tutte le cosiddette scienze basate sulle chiacchiere, è 39 che sia doveroso affrontare un argomento o un autore impadronendosi anche della letteratura che lo riguarda, prima di apportare il proprio sassolino alla grande muraglia della bibliografia relativa. Il compito è impossibile e il tacerlo è ipocrita. Spacciare poi la favola che gli esperti della materia, debitamente riconosciuti dai loro simili, sanno come muoversi in quella letteratura e sanno estrarne l’essenziale senza doversi sobbarcare davvero l’intera bibliografia, questa è la sicumera professorale. Ma tutto ciò, a parte il segnalarlo, non m’interessa granché. Quello che mi preme evidenziare, invece, è che per questa via si perde di vista l’opera, l’autore o l’argomento che ci aveva fatto muovere all’inizio. Anche l’altra strada, quella dell’analisi strutturalistica e semiotica, conduce allo stesso punto. All’inizio, la novità del metodo sembrava che potesse liberare l’opera dalle incrostazioni secolari e attingere direttamente il significato, per esempio, del sonetto 146 di Shakespeare. Ma subito è diluviato anche con questo metodo e ora si può fare, e di sicuro qualcuno l’avrà già fatta, una ricca bibliografia delle analisi strutturalistiche dei sonetti scespiriani debitamente ordinata per numero. E se là ci si perde dietro alla biografia romanzata dell’autore e dei personaggi, o alle vicende del periodo elisabettiano , o alla pronta dimenticanza di Shakespeare e alla sua riscoperta agli albori del romanticismo, o al successivo gonfiare come un unico pallone dell’importanza dell’arte, dell’importanza di Shakespeare e del subentro dell’inglese al francese quale lingua di riferimento internazionale, qui ci si perde dietro ai diagrammi a clessidra, agli schemi fonici, alle statistiche di frequenza dei vocaboli e alle indagini elettroniche, il tutto naturalmente con le poesie ridotte a cadaveri. 40 Il metodo giusto non può che essere quello di negare in partenza qualunque valore alla letteratura che vortica intorno ai sonetti di Shakespeare, come a qualunque altro argomento che ci venisse desiderio di conoscere direttamente. Se fossi di madrelingua inglese, mi sarei limitato ad additare il volume William Shakespeare – Sonnets, senza aprir bocca; ma siccome per fortuna sono di madrelingua italiana, li posso trasportare nel mio mondo, tradurre secondo l’etimologia. E qui giunto, mi guardo bene dal commentarli; mi limito ad additare i miei sonetti. Se per me c’è un senso nei sonetti di Shakespeare, aldiquà delle migliaia di libri che li commentano, lo si deve ritrovare nelle mie traduzioni. 11 – Qui alla fine devo dare una risposta all’interrogativo che all’inizio mi aveva spinto verso i sonetti di Shakespeare: scrivere un sonetto significa davvero compiere un estremo atto di fiducia nelle capacità conoscitive della Ragione? Spero che la definizione del sonetto che ho dato prima faccia sospettare a chi legge quanto sarei felice di rispondere sì e come sarei pronto a innalzare lodi alla poesia. Disgraziatamente la realtà non obbedisce ai miei desideri e ha la protervia di stare per virtù propria. E la realtà è che nessuno sa più cosa farsene della poesia. * * * BABELE Gigantesco nella radura un faggio gli alberi intorno domina e presenta a ciascuno del sole quanto deve, perché ciascuno viva della terra. 41 Hanno radici gli alberi e non parlano; linfa profonda scavano e la vita insieme dalla terra, senza muoversi, larga protendono al cielo, sicuri. Pensano insieme gli alberi all’eterno che in eterno ritorna, ed ogni volta sempre più il cielo con la vita scalano. Vaga invece, terribile, ogni uomo; ferocemente parla e non capisce: da solo ognuno al cielo innalza tombe. New York 11 settembre 2001 Non ho voglia di continuare. E’ duro fare profezie e vederle subito dopo cominciare a realizzarsi nella maniera più tragica. Per chiudere il mio discorso in qualche modo, elencherò alcune asserzioni senza argomentarle e senza armonizzarle. La poesia non ha più nessuna funzione sociale. Nessuno la vive e nessuno la legge. Chi si ostina ad atteggiarsi a poeta è un illuso. Solo pochi accademici, per motivi di cattedra, fanno finta di dare importanza alla poesia moderna e così finiscono di ucciderla. La poesia, e il sonetto che ne è la forma paradigmatica, non hanno nessuna capacità conoscitiva e non sono mai momenti o strumenti della “Ragione”. I frutti delle capacità conoscitive e della ragione, qualunque cosa significhino, sono beni sociali duraturi e presuppongono che chi li riceve 42 se ne arricchisca come chi li crea e li trasmette. Questo la poesia non è mai stata, forse; di sicuro non lo è oggi. Un sonetto, per chi lo scrive, può al massimo essere paragonato alla preghiera intima o a un momento di illuminazione interiore. Chi scrive un sonetto confida nella illuminazione mistica, cioè nella sua capacità di chiarire a se stesso un momento, un fatto, un sentimento e di inviarlo come una preghiera verso l’assoluto. Senza mai ricevere una risposta diretta, come sempre avviene con le preghiere rivolte a Dio. Per chi lo legge, ammesso che qualcuno lo legga, ha lo statuto di un’esperienza altrui in un ambito per sua natura ineffabile; o, il che è lo stesso, dicibile solo con le parole, i versi, le strofe con cui è stato scritto quel sonetto. Spiegazioni, analisi, commenti, critiche e teorie estetiche non hanno nulla a che fare con la poesia alla quale pretendono di riferirsi. In genere la uccidono ed estirpano i germogli. Per questo la poesia non significa niente: è, ma non può essere significata, cioè messa in altri segni, spiegata, tradotta. Se nel migliore dei casi c’è, è lì e basta; non significa nient’altro. E non vale niente perché i prodotti dell’uomo, per acquistare valore, devono avere una funzione e un commercio sociale. Manipolare un organismo che non fa più parte della società degli uomini vivi sperando di traghettarlo nell’eternità, è un rito di mummificazione, come dicevo all’inizio. I rapporti con l’assoluto, voluti e cercati dall’individuo, sono in genere autoesaltazioni, droghe psicologiche che non portano a niente. O a distruzioni. Che Dio, se ce n’è almeno uno, abbia davvero misericordia di noi tutti e specialmente degli ultimi e dei più deboli. 16 settembre 2001 43 44 SONETTI 45 1. Dalle più belle creature vorremmo figli sì che la bellezza si eterni. E se appassisce ogni singola rosa possa tramandarla un tenero erede. Ma tu, sposato ai tuoi occhi lucenti, sol la tua luce fecondi d’eterno; troppo crudele al tuo dolce te stesso, la tua abbondanza riduci in penuria. Avaro principe di primavera, fresco ornamento del mondo, tu sperperi su te stesso la tua ricca energia. Pietà del mondo! Perché la tua morte non privi ciò che è dovuto al futuro: la bellezza che nessun altro incarna. 8-8-2000 46 1. Dalle creature più belle vogliamo figli sì che non muoia mai la rosa. E se col tempo dovrà pur morire, un erede ne trasmetta memoria. Ma tu, sposato al lume dei tuoi occhi, quella luce alimenti per te stesso, facendo carestia con la ricchezza, a te stesso nemico e a te crudele. Tu, della primavera unico araldo, nel tuo stesso bocciolo ti riversi. Tenero avaro, fai spreco di te! Abbi pietà del mondo, tu del mondo fresco ornamento! Ciò che gli è dovuto non tenere per te, e per la tomba. 24-6-2001 47 2. Quando quaranta inverni solcheranno di profonde trincee la tua fronte, la veste giovanile di bellezza che ora ti lodano sarà scomparsa. Allora sarà vana lode dire, e vergogna, e un niente, che permane dei tuoi giorni fiorenti la bellezza nel profondo dei tuoi occhi infossati. Quanta gloria maggiore ti sarebbe mostrar tuo figlio con la tua bellezza, che salda il conto e la vecchiaia sfugge. Il legittimo erede del tuo corpo, riscattando l’orgoglio dei tuoi giorni, giovane e caldo il tuo sangue farebbe. 48 3. Lo specchio guarda ed a te stesso imponi: “Ora è il tempo che un’altra faccia crei.” Del tuo volto non derubare il mondo né maledire d’ogni madre il ventre. Dov’è la donna che vergine e bella, sdegnerebbe l’abbondante tuo seme? E chi è quello sì amante di sé che neghi agli altri la sua discendenza? Come lo specchio del suo primo Aprile tu sei a tua madre, così tu vedrai in quella faccia il tuo tempo dorato. Ma se infecondo ti arrendi alle rughe, senza curarti della tua memoria, solo morrai e con te la tua immagine. 49 4. Amore prodigo, perché riversi sopra te stesso il tuo bel patrimonio? E’ un prestito il retaggio di natura e per ridarlo ai generosi è dato. Perché abusi dei munifici doni e bello e avaro per te li trattieni? Perché, usuraio ma senza profitto, usi tanta ricchezza per non vivere? In solitudine amando te stesso te stesso frodi del tuo dolce io. E quando il conto chiuderà natura quale bilancio lascerai, sciogliendo nella tomba con te la tua bellezza, che, usata, a noi eredi parlerebbe? 50 5. Le ore che lievi l’aspetto formarono, amabile a ogni sguardo che v’indugia, con protervia costante disfaranno la bellezza che bella ora vi eccelle. Travolge il tempo nell’odioso inverno la linfa dell’estate: gela, cade l’ultima foglia e il rigido squallore copre ogni cosa e regna anche sul bello. Se intanto dell’estate il distillato liquore in vasi di vetro raccolto non fosse, la bellezza e la memoria rapite ci sarebbero. E se i fiori, pur distillati, perdono l’aspetto, ne vive ancora dolce la sostanza. 51 6. Non lasciar dunque sfiorire l’estate senz’aver distillato il seme tuo. Rendi preziosa la fiala che accoglie la tua bellezza prima che si estingua. Uso felice, e non usura, paga chi il dovuto concede: dieci volte più felice saresti se, per uno, dieci te stesso ispiri, e ancora dieci. Quale potere avrebbe allora morte sopra di te, se alla tua ora trova nella tua discendenza te vivente? Non ostinarti ad amare te solo: sei troppo bello per cadere preda della morte e dei vermi, tuoi eredi. 52 7. Guarda ad oriente quando il sole spunta con la benigna fiammeggiante testa: quaggiù ogni occhio alla sua maestà l’omaggio rende e segue il suo apparire. Ed anche quando del cielo ha scalato la cima, gli occhi mortali lo adorano, seguendo la bellezza nel suo culmine, come giovane e forte in piena luce. Ma quando come in tarda età saluta pesante il giorno, dal tragitto basso si distolgono gli occhi e s’allontanano. Così tu nel tramonto del tuo giorno lontano da ogni sguardo morirai: ammenoché tu non procrei un figlio. 53 8. Perché ascolti tristemente la musica, tu che sei musica per chi ti ascolta? Perché ami ciò che non lieto accogli? Forse hai piacere di ciò che ti annoia? Se i giusti accordi di sposati suoni offendono il tuo orecchio, è perché sciupi in una voce sola i molti suoni che, insieme fusi, tu dovresti reggere. Gioie e dolcezze non si fanno guerre: guarda come ogni corda maritata vibri con l’altra in un dolce accordo. Così un padre e una madre, tutti in uno col figlio, cantano lo stesso suono. Ma tu, da solo, resterai nessuno. 54 9. Per timore del pianto d’una vedova forse te stesso da solo consumi? Se morrai senza figli il mondo intero sarà come tua sposa inconsolabile, come una vedova che sempre piange l’immagine di te che ormai non ha: ogni altra vedova in mente rivede negli occhi di suo figlio il volto amato. Ciò che il prodigo spende resta al mondo, ma scade e si consuma la bellezza che, non usata, si distrugge invano. Nessun amore per gli altri in quel cuore risiede, che su se stesso commette il vergognoso assassinio d’amore. 55 10. Nega se puoi di non amar nessuna. Vergogna, ché a te stesso non provvedi. D’essere amato da molte puoi dire, ma è evidente che nessuna ami, poiché si preso sei d’odio omicida che mai non cessi a danneggiar te stesso, l’edificio bellissimo cercando di rovinar che riparar dovresti. Cambia, ch’io possa cambiare giudizio! Potrà più l’odio che il gentile amore? Come il tuo aspetto, sii grazioso e dolce ed a te stesso mostrati pietoso. Per amor mio procrea, come te, altri; e la bellezza viva in te o nei tuoi. 56 11. Quanto declini d’altrettanto cresce in un dei tuoi quel che tu stai perdendo; e il nuovo sangue, che giovane infondi, tuo puoi chiamare quando invecchierai. Da ciò, saggezza e il bello e lo sviluppo. Sennò, follia, vecchiaia e decadenza. Se tutto al mondo come pensi fosse cesserebbero i tempi e il mondo e tutto. Chi la Natura non vuole che duri, bruti e senza bellezza, che si estingua; guarda invece a chi lei tutto concesse: tu, quale dono munifico sei. Ti scolpì suo sigillo e tu, munifico, devi imprimerti in altri e non morire. 57 12. Quando conto il passaggio delle ore che muta il giorno nell’orrida notte, quando sfiorita la violetta guardo, e dei riccioli il nero farsi argento, quando alberi orgogliosi vedo nudi della chioma che i greggi proteggeva, e il verde dell’estate nei covoni restrinto e con le barbe ispide e bianche, allora penso alla bellezza tua: come anche tu rovinerai nel tempo, perché tutte le cose dolci e belle di per sé vanno ed altre ne ricrescono; e niente contro il tempo ci difende se non la prole con cui tu lo vinci. 58 13. O amor mio, se tu ben riflettessi! Tu ti appartieni fino a che tu vivi. Contro la fine che verrà prepàrati, e il tuo sembiante a qualche altro cedi. Così quella bellezza che hai in prestito non cesserebbe, perché tu saresti, dopo la morte, di nuovo te stesso con le tue forme nella bella prole. Chi lascerebbe cadere sì bella casa, che la saggezza salverebbe dai tempestosi giorni dell’inverno e dallo sterile freddo di morte? Solo un dissipatore. Amor mio, tu avesti un padre, lo abbia anche tuo figlio. 59 14. Non dalle stelle traggo i miei giudizi, eppur mi sembra di leggere gli astri, ma non per dire la buona fortuna, o la cattiva, malattie o morti; né l’avvenire raccontare posso a ciascuno coi suoi venti ed i tuoni; o che d’un principe il regno predica con frequenti letture delle stelle. Ma nei tuoi occhi traggo il mio sapere da stelle fisse dov’io leggo questo: virtù e bellezza sempre insieme andranno, se cambierai per far di te un vivaio . Altrimenti di te questo predico: virtù e bellezza con te finiranno. 60 15. Quando vedo che tutto ciò che cresce solo un momento risplende perfetto, che sulla scena del mondo ombre s’agitano su cui arcane imperano le stelle, quando comprendo che uomini e piante, mantenuti dai medesimi influssi, si vantano della lor fioritura ma giunti al sommo nell’oblio si perdono, allora penso allo stato fugace in cui m’appare la tua gioventù, trionfante mentre il tempo distruttore disfà ogni giorno nella sconcia notte. Per amor tuo muoverò guerra al tempo: ciò che disfà, di nuovo io t’innesto. 61 16. Perché non fai una guerra più potente contro il tempo, sanguinoso tiranno, e ti rinforzi per la tua vecchiaia con veri mezzi anziché le mie rime? Ora sei dei felici giorni al culmine e molte vergini serre vorrebbero, con desideri virtuosi, portare i tuoi fiori, tuoi viventi ritratti. Così vivrebbe per linee di vita, nel suo valore e nella sua bellezza, ciò che un pennello o la mia penna incerta mai potranno di te rappresentare. Dando te stesso, te stesso conservi: vivrai ritratto dal tuo dolce seme. 62 17. In futuro chi crederà ai miei versi anche se descrivessi ogni tuo merito? Come una tomba finora nascondono la tua vita e solo in parte ti mostrano. Se la bellezza potessi descrivere dei tuoi occhi, o elencare le tue grazie, l’età futura direbbe ch’io mento, ché sì celesti sembianze mai furono. E queste carte ingiallite dal tempo, non più che un vecchio ciarliero apprezzate, nessuno crederebbe che di te diano il giusto ritratto e non la favola. Ma se qualche tuo erede allor vivesse, in lui e nei miei versi, allor vivresti. 63 18. Paragonarti a un bel giorno d’estate? Più dolce sei e amabile: le gemme di maggio strappano i venti improvvisi dell’estate, che troppo breve resta. Talvolta il sole in cielo troppo brucia e poi offusca la sua luce d’oro. Dalla bellezza ogni bellezza scade per il cambio di sorte o di natura. Ma la tua estate eterna non tramonta: nessuno ruberà la tua bellezza né vagherai fra l’ombre della morte. Perché tu sempre in versi eterni vivi. Finché l’uomo respira o l’occhio vede, finché vive il mio verso, tu vivrai. 64 19. Strappa gli artigli al leone e la terra fa’ che divori le sue stesse dolci creature; e la Fenice imperitura, tempo divoratore, fa’ che bruci. Come tu vuoi, stagioni tristi o liete alterna, e ciò che vuoi al vasto mondo e alle caduche sue dolcezze imponi, tempo troppo veloce: tutto fa’. Ma di solcare ti vieto con rughe la bella fronte del mio amore: lascia questo modello inviolato al futuro. Oppure no, puoi fare anche il tuo peggio, tempo e vecchiaia: il mio amore diletto vivrà giovane sempre nei miei versi. 65 20. Volto di donna dipinto di mano stessa della natura hai, signore e anche signora della mia passione; ed hai un cuore gentile di donna, ma non volubile com’è costume di infide donne; ed hai l’occhio più terso, che non inganna nel suo guardare e fa d’oro l’oggetto su cui posa. Sei perfezione d’ogni umanità: rubi gli occhi degli uomini e alle donne l’anima avvinci. E se donna Natura ti concepì, s’innamorò di te e perciò aggiunse cosa, per me inutile, delizia per le donne. A me il tuo amore. 66 21. Non scrivo versi come quella Musa che in un dipinto vien sforzata all’opera e s’ingegna d’usare ogni artificio e si compara a ogni bellezza e al cielo. Doppi confronti orgogliosi facendo, la luna e il sole, le gemme del mare e della terra, nei suoi versi usa, e le più rare piante che fioriscono. Lasciate che io scriva nei miei versi, io che sono sincero nel mio amore, semplicemente che il mio amore è bello, come ogni figlio agli occhi di sua madre. Altri esageri con frasi retoriche: ciò che non voglio vendere non lodo. 67 22. Niente potrà persuadermi che vecchio io sia, finché tu e gioventù tutt’uno siete: invecchierò anch’io quando vedrò su te segni del tempo. Perché quella bellezza che ti copre è solo rivestita dal mio cuore che nel tuo petto vive e il tuo nel mio. Come allora potrei esser più vecchio? Abbi amore, così, cura di te com’io per te, e non per me, farò, custodendo il tuo cuore ch’è sì caro. Da tutti i mali lo terrò lontano; ma se io muoio non riavrai il tuo cuore: tu me lo desti per mai più riaverlo. 68 23. Come inesperto attore sulla scena che per paura oltrepassa la parte, e come chi per ira incontrollata indebolisce la sua stessa forza, così son io che, per paura, il rito di perfette cerimonie d’amore dimentico; e la forza del mio amore sembra andar oltre per la troppa forza. Oh, lascia allora che i miei libri siano l’eloquenza che, muta, amore implora e ricompensa cerca al mio parlare che più e più, e forse troppo, ha detto. Ciò che l’amore silenzioso ha scritto a udir con gli occhi impara, per amore. 69 24. Il mio occhio è il pittore che ha ritratto la tua immagine bella sulla tela del mio cuore; il mio corpo la incornicia e il tutto è fatto dal miglior pittore. Solo tramite gli occhi dell’artista si può cercare la tua vera immagine, appesa nel negozio del mio cuore che per finestre ha i vetri dei tuoi occhi. Gli occhi per gli occhi come bene rendono! I miei hanno dipinto le tue forme; i tuoi sono finestre sul mio petto da cui il sole si gloria di mirarti. Eppure gli occhi non tutto dipingono: di ciò che sente il cuore niente sanno. 70 25. Chi è favorito dalle stelle vanti pubblici onori e titoli orgogliosi. Io che son privo di questi trionfi solo gioisco di chi più onoro. I favoriti dei principi roteano a girasole le altezzose foglie, ma il loro orgoglio che uno sguardo uccide in una tomba spenge il suo splendore. Ed al guerriero di mille vittorie una sconfitta cancella l’onore, e delle sue fatiche anche il ricordo. Felice io che amo e sono amato e che nessuno potrà mai spostare da quest’amore; né io mai potrei. 71 26. Padrone del mio amore che m’hai stretto in vassallaggio pei tuoi grandi meriti, questi devoti versi io te li invio non per mostrare ingegno ma omaggio. Povera cosa a causa del mio ingegno questa sì grande devozione appare; ma in un benigno tuo favore spero che tu nuda l’accolga nel tuo animo. O tu stella che guidi il mio cammino, finché non vesti con grazioso aspetto ciò che d’amore, disadorno, invio, di come t’amo non oso vantarmi: solo se mostri la benigna faccia, alla tua prova metterò l’ingegno. 72 27. Rotto dalla fatica, cerco il letto per riposar le membra dal viaggio; ma subito mi inizia nella testa l’altro lavoro, come di un ritorno. Per quant’io sia lontano, a te i pensieri devoti corrono e le stanche palpebre tengono aperte: nel buio riguardo, come un cieco, cercando la tua immagine. Finché la vista della mente vede un gioiello sospeso: la tua ombra che rende bella la notte spettrale. Così di giorno le mie membra e poi di notte la mia mente, a causa tua, a causa mia, non trovano riposo. 73 28. Come recupero la mia salute, del beneficio del riposo privo? Quando la notte non ristora il giorno e m’opprimono insieme e notte e giorno? Sebben di regni fra loro nemici fra lor s’alleano per torturarmi, con la fatica il giorno e col rimpianto d’esser, la notte, sempre più lontano. Lusingo il giorno e la notte dicendo che tu sei l’oro splendente del sole e delle stelle la grazia vibrante. Ma ogni giorno prolunga il mio tormento ed ogni notte sembra che più forte renda la forza di questo tormento. 74 29. Quando, in disgrazia con la sorte e gli uomini, piango da solo il mio stato infelice e con vani lamenti accuso il cielo e da me maledico il mio destino augurando a me stesso d’esser altro, simile a chi è ricco di speranza, simile a lui d’aspetto e come lui ricco d’amici e d’arte e di sapienza, e quasi arrivo a disprezzar me stesso, felicemente ti penso, il mio stato, come allodola risvegliata, canta inni di gioia alle porte del cielo: perché il ricordo del tuo amore dolce non cambierei con lo stato di re. 75 30. Quando richiamo con malinconia dolci ricordi di cose passate, lamento il vuoto di ciò che bramai e del mio tempo migliore la perdita. E allora l’occhio mi s’empie di pianto, al ricordo degli amici diletti rapiti nella notte senza fine; e di pene d’amore cancellate; e di sì tante immagini svanite. Allor mi dolgo dei dolori andati e di ciascuno il già pianto ripiango. Ma se in quel mentre, amico mio diletto, a te io penso, ogni perdita resa mi viene e termina tutto il dolore. 76 31. Il tuo petto m’è caro per i cuori tutti che, assenti, io ho creduto morti; là con tutti i suoi pregi regna Amore, e con gli amici che credei sepolti. Quanto tributo alla morte han versato i miei occhi di religiose lacrime e sante per gli amori a me rapiti che, ormai lontani, in te celati giacciono. Tu sei la tomba dove sempre vivono i trofei dei miei amori sepolti, che a te rendono ciò che a loro diedi. Quel che di tanti fu è tuo soltanto: io vedo in te le immagini che amai e tu, che tutte sei, hai di me tutto. 77 32. Se tu vivrai oltre il mio giorno ultimo, quando morte mi coprirà di polvere, e per fortuna rileggessi ancora questi poveri versi del tuo amante, coi migliori del tuo tempo comparali; e pur se ogni altra penna superasse di ben altri poeti questi versi, per amor mio, e non per loro, serbali. Concedimi amorevole un pensiero: “Se innalzata si fosse del mio amico la poesia fino a quella d’oggi, rime migliori avrebbe scritto Amore; ma poiché lui è morto, gli altri versi per lo stile, i suoi per amore leggo.” 78 33. Ho visto spesso un glorioso mattino accarezzare la cima dei monti e indorare con celeste alchimia i verdi prati e i pallidi torrenti. Ma poco dopo la sua faccia ho visto oscurarsi di densissime nubi e correre sul mondo, derelitta, a occidente, per la disgrazia in fuga. Così da prima ha brillato il mio sole su me trionfante; ma, ahimè! Fu mio un’ora e poi fu coperto da nubi. Ma non per questo disdegno il mio sole: ben può il sole dell’amore oscurarsi se anche il sole del cielo vien coperto. 79 34. Perché sì bella giornata promettere e far che viaggi senza il mio mantello, per poi sorprendermi con basse nuvole che sporcano di pioggia il tuo splendore? Non basta che tu rompa fra le nuvole ad asciugare il mio viso sbattuto: nessuno reputa buona la cura che la ferita allevia e lascia il male. La tua vergogna non sana la perdita, né il dispiacere solleva la croce di chi sopporta un’offesa sì dura. Ma le lacrime che il tuo amore versa sono perle preziose che guariscono ed ogni mala vicenda riscattano. 80 35. Non ti angustiare più per ciò che hai fatto. Anche le rose hanno spine, la luna e il sole sono oscurati da nubi e i bruchi vivono in dolci boccioli. Tutti sbagliano; ed anch’io: che i tuoi falli autorizzo scusandoli nei versi e i tuoi peccati giustifico troppo, abbassando il mio essere per te. Poiché alla colpa dei tuoi sensi un senso trovo, contro di me faccio il processo: la parte avversa si fa tuo avvocato. Tra l’amore e il rancore è in me una guerra che mi trasforma in complice del ladro, che dolcemente, e atroce, mi deruba. 81 36. Noi due dobbiamo essere due sebbene uno sia il nostro amore: così la macchia che a me è rimasta senza il tuo aiuto dovrò sopportare. I nostri due amori hanno una sola dignità, che crudelmente separa e dolci ore d’amore sottrae, ma non cambia quell’uno che è l’amore. Non potrò più riconoscerti sempre, perché la mia vergogna non ti macchi. Né tu mi onorerai pubblicamente, perché il tuo onore non ti venga tolto. Non farlo! T’amo talmente che mio sei e così mio è anche il tuo amore. 82 37. Come d’un figlio giovane e vivace si compiace orgoglioso un vecchio padre, così io, dalla fortuna abbattuto, dei tuoi pregi e valori mi consolo. Perché se nascita, bellezza e ingegno e tutto questo e altro e altro ancora è di diritto tuo in sommo grado, a questo tronco innesto anche il mio amore. E allora, né abbattuto, o disprezzato, o povero, mi sento: la tua immagine è sì ricolma di pregi che vivo anche di ciò che la tua gloria emana. Se avrai del meglio il meglio che a te auguro, dieci, e dieci volte me felice! 83 38. Come può la mia Musa ricercare altri argomenti finché tu respiri, troppo eccellente per carte volgari, ma che ti versi dolce in questi versi? Rendi grazie a te stesso se di mio qualcosa degno alla tua vista appare: chi sarebbe di scrivere incapace quando tu stesso poesia accendi? Sii la decima Musa, dieci volte più degna che le nove d’eternare con accenti immortali chi ti invoca. Se a questi strani giorni mai piacesse la mia esile Musa, sarà mia la fatica, ma certa è a te la lode. 84 39. Come posso cantarti degnamente quando di me sei la parte migliore? Perché lodare io stesso il mio me stesso? E quando te lodo, cos’altro lodo? Anche per questo viviamo divisi e il nostro amore cessa d’esser unico; perché, lontano, ciò che t’è dovuto io possa darti. E che tu solo meriti. Oh, assenza, qual tormento mai saresti se nel tuo ozio ore dolci non dessi per impiegarle in pensieri d’amore che dolci ingannano ore e pensieri; e come insegni a dividere l’unico, qui lui lodando che da qui è lontano. 85 40. Prenditi tutti i miei amori, amor mio, prendili tutti, e cosa avrai di più? Nessun amore che chiamare amore tu possa, amore, perché il mio è tuo. Se allor per amor mio usi il mio amore, non posso biasimarti; eppur ti biasimo se, ingannando te stesso, assaggerai gustando ciò che tu stesso rifiuti. Ma ti perdono il furto, dolce ladro; eppur l’amore sa che più dell’odio brucia il torto inatteso dell’amore. Grazia lasciva in cui bene si mostra tutto il male, coi tuoi dispetti uccidimi: non dobbiamo per questo esser nemici. 86 41. Questi torti leggeri che commetti, assente io talvolta dal tuo cuore, alla bellezza tua ed ai tuoi anni, che in te tentano sempre, ben s’addicono. Tu sei gentile e quindi da esser vinto; bello tu sei e quindi da assalire. Chi potrà mai, quando una donna chiama, lasciarla austero senza che prevalga? Ahimè! Ma almeno potresti non prendere il mio posto; e sgridare la bellezza e gli anni tuoi, che proprio là ti portano a infrangere una doppia fedeltà: di lei, che tenti con la tua bellezza; di te, che la bellezza rende falso. 87 42. Che tu l’abbia, non è tutta la pena. Eppur l’amavo! Ma che essa abbia te è il colmo del mio soffrire, la perdita d’amore che più profondo mi tocca. Ma io vi scuso, amanti traditori: tu ami lei perché sai che io l’amo; e similmente lei, per amor mio, soffre, ingannandomi, che tu la provi. Se perdo te, del mio amor sei il guadagno; se perdo lei, tu trovi quella perdita: voi vi trovate ed io entrambi perdo. Per amor mio la croce m’imponete. Ma, lusinghiera dolcezza! se uno tu ed io siamo, me solo lei ama. 88 43. Quanto più chiudo gli occhi e più essi vedono: di giorno solo cose indifferenti, ma in sogno essi te scorgono brillante e luminosi nel buio s’accendono. Se la tua ombra fa brillare l’ombre ad occhi senza vista,dimmi allora quale sostanza lieta mostrerebbe la tua ombra di giorno in chiara luce! Benedetti sarebbero i miei occhi posando su di te nel giorno vivo, non tra il sonno sull’ombra tua imperfetta. Finché non ti vedrò, son notti morte i giorni e giorni vivi quelle notti, quando brillante in sogno a me ti portano. 89 44. Fosse pensiero la pesante carne, a dispetto delle avverse distanze, da lontanissimi limiti a te, dove ora stai, mi porterebbe subito. Potrei anche la terra più remota calpestare, ché l’agile pensiero e terre e mari per te varcherebbe e là sarebbe dove sta pensando. Però il pensiero che non son pensiero, ma d’acqua e molta terra son composto e non posso annullare lunghe miglia, m’uccide. E riempio di lamenti il tempo; e lacrime dai grevi miei elementi solo ricavo, del dolore emblema. 90 45. Ovunque io sia gli altri due son con te: l’aria sottile che è il mio pensiero e del mio desiderio il fuoco puro, presenti assenti, instancabili corrono. Quando a te in dolce ambasceria d’amore questi elementi più veloci vengono, io che da quattro a due sono ridotto, fino a morir di tristezza m’abbatto. Quando essi, della tua buona salute assicurati, a me veloci tornano, gli elementi di vita si reintegrano. E godo alla notizia; ma per poco. Non più felice, li rimando indietro di nuovo ancora e aumenta la tristezza. 91 46. Si fanno guerra mortale il mio occhio e il mio cuore per la visione tua: l’occhio vorrebbe proibire al cuore, mentre il cuore la vuole, la tua immagine. Il cuore afferma che in lui tu stai là dove nessun occhio è penetrato; nega l’assunto l’altra parte e dice che in lui è riflessa la tua bella immagine. Per decider la causa è convocata una giuria di pensieri, schiavi del cuore, che con verdetto dividono: al mio occhio è dovuta la bellezza tua esteriore, e al diritto del cuore tutto l’intimo amore del tuo cuore. 92 47. Un’alleanza di mutui servigi ora s’è stretta fra il mio cuore e l’occhio, quando il mio occhio ha fame d’un tuo sguardo o il cuore soffoca pei suoi sospiri. Si sfama l’occhio allor col tuo ritratto e al banchetto dipinto invita il cuore; l’occhio altra volta è ospite del cuore per aver parte ai pensieri amorosi. Così col tuo ritratto e col mio amore, benché lontano, sei sempre con me: dai miei pensieri tu mai t’allontani. E quando dormono, in me la tua immagine risveglia il cuore e la visione tua è diletto al mio occhio ed al mio cuore. 93 48. Quante sciocchezze misi sotto chiave, quando partii, in sicura custodia, sì che nessuna mano falsamente le adoprasse al mio posto! E quanta cura! Ma tu, al cui confronto i miei gioielli sono sciocchezze, tu degno conforto ed ora grande affanno, caro e unico cruccio, di ladri infidi sarai preda. Nella dolce prigione del mio petto, dove non sei ma pur ti sento chiuso, e non in un forziere ti lasciai. Ma anche là sarai rubato, temo, perché diventa ladra la virtù per ottenere un premio così caro. 94 49. In previsione del tempo, se mai verrà quel tempo, quando i miei difetti tu noterai, e trarrai l’ultima somma del tuo amore dietro saggi consigli, In previsione del tempo, in cui tu, passando, mi guarderai indifferente col sole dei tuoi occhi e convertito avrai il tuo amore in ragione austera, In previsione di quel tempo, io mi rinsaldo cosciente dei miei meriti; e questo affermo contro il mio interesse: per lasciarmi, me misero, hai ragioni legali e forza di legge, mentre io per amare non allego motivi. 95 50. Come procedo gravoso nel viaggio quando la fine del triste percorso farà dire al mio ristoro e riposo: “Tanto più sei lontano dal tuo amico.” Procede l’animale che mi porta, e con me porta il mio dolore, stanco come sapesse che il suo cavaliere non vuol fretta che da te lo allontani. Quando talora nell’ira lo sprono fino al sangue, non si scuote e risponde con un lamento greve, a me più acuto che a lui lo sprone, perché quel lamento mi ricorda che a me davanti giace il mio dolore e dietro la mia gioia. 96 51. Così il mio amore la lentezza pigra scusa dell’animale che da te m’allontana: perché dovrei affrettarmi? Fino al ritorno, non serve che corra. Che scusa, allora, la povera bestia mai troverà, se anche l’andar veloce sembrerà tardo? Darò sprone al vento; ma anche il volo scoprirei immobile. Nessun destriero, allora, sarà pari al desiderio del perfetto amore, in fiera corsa senza pigra carne lanciato. E amore scuserà il ronzino che per amore volle esser lento: io correrò, e lui potrà andar piano. 97 52. Così son io: come il ricco al tesoro, dolce, nascosto, con chiave beata non tutte l’ore accede, per acuire la fine punta del piacere raro. Per questo così solenni le feste e così rare lungo l’anno sono, come pietre di valore e gioielli messi a intervalli lungo una collana. Così ti tiene il tempo come scrigno o forziere che cela vesti rare, per rendere beato qualche istante quando di nuovo schiude il suo splendore. Beato sei, perché dai modo, avendoti, di trionfare e, assente, di sperare. 98 53. Di che sostanza, di cosa sei fatto che milioni di ombre ti corteggiano? Ciascuno ha, ognuno, un’ombra sola e tu, solo, tutte l’ombre proietti. Si può descrivere Adone, e l’immagine sarà una povera tua imitazione; o sulle guance d’Elena porre ogni artificio di bellezza, e tu sarai dipinto allora in vesti greche; la primavera e il raccolto dell’anno per noi sono ombre della tua bellezza. D’ogni grazia esteriore hai qualche parte. Ma tu a nessuno somigli e nessuno ti somiglia per costanza di cuore. 99 54. Quanto più la bellezza sembra bella quando adorna l’essenza di dolcezza! Sembra bella la rosa, ma più bella la teniamo per quell’odore dolce che in essa vive. Le rose canine hanno lo stesso profondo colore; su uguali spine pendono e lascive aprono i bocci al soffio dell’estate. Ma il loro pregio è solo nel mostrarsi: vivono ed appassiscono neglette; da sole muoiono. Le dolci rose, morte, ancor danno profumi dolcissimi. Quando tu svanirai, gioventù bella, la tua essenza diffonderà il mio verso. 100 55. Né marmo, né monumenti dorati di re sopravvivranno a questi versi. E tu in essi brillerai più che pietre neglette, lorde di lurido tempo. Guerre e rivolte abbatteranno statue, case, fortezze; ma né spade o fuoco mai potranno bruciare la vivente testimonianza della tua memoria. Contro la morte ed il nemico oblio, tu durerai; la tua lode avrà spazio anche negli occhi dell’ultima gente. Finché il mondo si porterà alla fine, tu vivi in questi versi ed hai dimora, sempre viva, negli occhi di chi ama. 101 56. Dolce amore, rinnova la tua forza: la tua punta non sia meno affilata dell’appetito che oggi il cibo sazia ma domani ritorna come prima. Così amore sii tu. Sebbene oggi tu riempia gli occhi affamati e li sazi, domani guarda ancora e non uccidere con sazietà perpetua questo amore. Come un oceano è il triste intervallo che separa le coste, ma agli amanti promette il beato ritorno d’amore. E come è pieno d’affanni l’inverno! Ma benvenuta fa aspettar l’estate, tre e tre volte più desiderata. 102 57. Sono tuo schiavo: cosa posso fare se non attendere per ore e giorni ai desideri tuoi? Non ho servizio più prezioso finché tu non mi chiami. Né oso recriminare sull’ora senza fine in cui guardo l’orologio in tua attesa, mio sovrano; o pensare all’amara tua assenza quando esci. Né oso domandare al mio pensiero, con gelosia, dove e a far cosa vai, ma come schiavo rattristato resto. Certo, là dove vai sono felici. L’amore ch’è sì pazzo alle tue voglie, d’ogni cosa che fai non pensa male. 103 58. Quel dio che m’ha fatto tuo schiavo eviti ch’io pensi ai tuoi momenti di piacere o chieda il conto insistente delle ore, poiché, vassallo, son stretto ai tuoi comodi. Lascia che soffra, se sono al tuo cenno, della tua libertà l’imprigionata assenza, e docile e paziente aspetti, senza accusarti, e sopporti i tuoi colpi. Stai dove vuoi: tu hai sì tanti diritti per far ciò che ti aggrada del tuo tempo. E a te compete il perdonar te stesso delle colpe che contro te commetti. Devo aspettare, pur se è un inferno, non biasimare, giusto o ingiusto sia. 104 59. Se niente è nuovo, ma ciò che è fu, come s’ingannano le nostre menti che il nuovo cercano e invece abortiscono la placenta d’un bambino già nato. Oh, potesse la memoria all’indietro cercare anche di cinquecento anni, per mostrarmi in antichissimi libri, dacché l’uomo li scrive, il tuo modello. Vedrei cosa diceva il mondo antico della meravigliosa tua figura: se noi, o loro, o nessuno migliora. Oh, ma sono sicuro che gl’ingegni delle ere passate han tributato lodi a soggetti di te meno degni. 105 60. Come le onde incalzano alla riva, così i nostri minuti; che s’affrettano alla fine, rubando ognuno il posto al precedente. E innanzi tutti spingono. La nascita, appena entrata nel mare di luce, in maturità si trascina: è incoronata, ma eclissi contorte contro la gloria combattono. E il tempo i doni che già dette ora distrugge: strappa alla giovinezza la ghirlanda; divora alla natura ogni virtù; e sotto la sua falce niente sta. Ma tuttavia contro il tempo crudele i miei versi staranno in lode tua. 106 61. Sei tu che vuoi che le mie stanche palpebre sulla tua immagine di notte s’aprano? Desìderi che i miei sonni si rompano sull’ombre, simili a te, che m’ingannano? E’ il tuo spirito che tu fuori mandi così lontano a spiare i miei atti, per scoprire vergogne e ore inutili come alimento alla tua gelosia? No! Se anche è tanto, non è così grande il tuo amore. E’ il mio che mi tien sveglio; il vero mio amore che per te ruba il riposo e sta di sentinella. Per te veglio, mentre tu vegli altrove, da me lontano e sì vicino ad altri. 107 62. Interamente possiede i miei occhi e la mia anima ed ogni mia parte questo peccato d’amare me stesso, che tanto m’è infiltrato dentro il cuore. Nessun volto è grazioso come il mio, nessuna forma perfetta e nessuna perfezione, come la mia, vera. E da me dico che tutti sovrasto. Ma quando questo specchio come sono, sbattuto, svela, e avvizzito dagli anni, l’amor di me allor leggo al contrario: se così è, l’amare me è iniquo. Sei tu, il me stesso, che per me dipingo, col fiore dei tuoi giorni, la mia età. 108 63. Come son io ora, anche il mio amore sarà consunto dal tempo oltraggioso; quando l’ore seccheranno il suo sangue e la fronte gli empiranno di linee; quando il mattino suo di gioventù sarà corso nella scoscesa notte e le bellezze di cui ora è re spariranno con la sua primavera. Per quel tempo mi fortifico ora contro il coltello crudele degli anni, sì che non tagli mai, oltre alla vita, anche il ricordo della sua bellezza, che in queste linee nere sarà vista. Esse vivranno, e lui con loro, giovane. 109 64. Quando ho visto sfigurata dal tempo la superbia di età ormai sepolte, e torri altere vedo rase a terra, e il bronzo eterno schiavo della morte, quando ho visto l’oceano guadagnare famelico sul regno delle terre, e il fermo suolo emergere dall’acqua, e ognuno perdere, e acquistare, e perdere, quando ho visto tali scambi di stato, e lo sfacelo delle cose stesse, dalla rovina ho imparato a pensare. Verrà quel tempo e ruberà il mio amore. E al pensiero di morte senza scelta piango d’avere, ché temo di perdere. 110 65. Se né pietra né bronzo o terra o mare contrastano il potere della morte, come potrà a questa rabbia opporsi la bellezza non più forte d’un fiore? E l’alito di miele dell’estate reggerà i colpi di molte tempeste, se anche rocche dalle porte d’acciaio non resistono all’assedio del tempo? Come, allora, la più preziosa opera del tempo al tempo celare, e fermarlo, e impedire il saccheggio di bellezza? In nessun modo, se non ha potere questo miracolo: nel nero inchiostro possa il mio amore luminoso splendere. 111 66. Stanco di tutte queste cose invoco morte e riposo: quando vedo che il merito già nasce come un pezzente; e nullità bisognose di tutto, ricche di fronzoli; e la fede più pura rinnegata miseramente; e grandi onori concessi a persone degne d’infamia; e la virtù verginale con forza prostituita; e la retta perfezione negata malignamente; e la forza da poteri deformi debilitata; e tutte le arti dalle autorità imbavagliate; e la stoltezza che usurpa le cattedre negare il genio; e la nuda verità dileggiata di scherni astuti; e il bene schiavo che ubbidisce al male suo superiore. Stanco di tutte queste cose, andarmene vorrei dal mondo, se morire non fosse anche lasciare solo il mio amore. 112 67. Perché dovrebbe egli vivere in mezzo all’infezione, e l’empietà graziare, sì che il peccato di lui s’avvantaggi e si adorni della sua compagnia? Perché dovrebbe una morta cosmesi rubare alle sue guance il colorito? Perché dovrebbe una triste bellezza imitare l’ombra delle sue rose? Perché dovrebbe egli vivere, adesso che la natura ha fallito ed implora sangue vivo da infondere, giacché, fiera di molti, di lui solo vive? Lo preserva per mostrar quanto ricca, prima di questi tempi orrendi, fosse. 113 68. La sua guancia è così il vero modello dei tempi quando viveva e moriva la bellezza, come ora fanno i fiori e invano tentano i falsi ornamenti; prima che bionde trecce tolte ai morti, anziché prede di tombe, vivessero su un’altra testa una seconda vita: morto vello per chi osa lo sfarzo. In lui si vedono le sante e antiche età, vere in se stesse e senza orpelli, che non chiamano estate il verde altrui. Lui, vera mappa e modello, preserva la natura contro l’arte falsata, per mostrare com’era la bellezza. 114 69. Ciò che di te si vede non necessita altro di più che il cuore possa aggiungere: la nuda verità che ti è dovuta, come lode al nemico, ognuno dice. Il tuo aspetto esteriore di esteriori lodi è sovrano; ma le stesse lingue, con altri accenti, le lodi confondono guardando quello che gli occhi non mostrano. Scrutando infatti dentro la tua mente che dai tuoi atti traspare, il pensiero, anche se l’occhio fu appagato, scopre che il tuo bel fiore ha fetore d’erbacce. Se con la tua apparenza ciò contrasta, così si spiega: diventi volgare. 115 70. Che tu sia biasimato, non significa che tu n’abbia la colpa: la calunnia colpì sempre la bellezza e il sospetto vola nell’aria più dolce del cielo. Se agisci bene, la calunnia è lode, segno dei tempi che ai migliori tocca, perché il vizio dei vermi ama il più dolce frutto e tu gli offri la pura primizia. Gli agguati della giovinezza hai vinto o non ti hanno assalito; eppur l’invidia non frena ma dilaga, pei tuoi meriti. Se un sospetto di male non macchiasse la tua apparenza, allora re, tu solo, di tutti i regni dei cuori saresti. 116 71. Finché delle campane udrai i rintocchi, lugubri e mesti, annunziar che passai dal vile mondo ai vilissimi vermi, tu potrai piangermi; ma non più a lungo. Anzi, se leggi questi versi, ignora chi li scrisse, perché ti amo talmente che se pensarmi ti reca dolore non voglio avere i tuoi dolci pensieri. E non ridire il mio povero nome quando sarò mescolato all’argilla. Con la mia vita spengi anche il tuo amore: non abbia il saggio mondo alcun motivo di curiosare dentro ai tuoi lamenti e di schernirti, insieme a me assente. 117 72. Non abbia il mondo a costringerti a dire per quali meriti, anche dopo morto, mio dolce amore, tu mi ami: dimenticami! Niente in me potrai mostrare di buono. Non devi escogitare oltre il mio merito virtuose menzogne, o lodi appendere sulla mia tomba, maggiori di quelle che la severa verità vorrebbe. Non abbia a sembrar falso quel tuo amore che per amore il non vero riporta, sia sepolto il mio nome col mio corpo. Esso non viva a mia o tua vergogna, perché a mia vergogna è ciò che faccio e così a te, se ami cose non degne. 118 73. Quella stagione in me puoi osservare dell’anno, quando poche foglie gialle pendono scosse dal freddo sui rami, nudi cori dove uccelli cantarono. In me tu vedi del giorno il crepuscolo, quando la luce sparisce a occidente a poco a poco nella nera notte, come altra morte che il riposo afferra. In me tu vedi del fuoco l’ardore che giace come sul letto di morte, sulle ceneri di ciò che ha bruciato. Questo rende il tuo amore ancor più forte, come ben sai, perché appieno si ama solo colui che tra non molto lasci. 119 74. Ma sii sicuro: quando più riscatti mi salveranno dall’ultimo arresto, sempre il diritto la mia vita avrà di restare con te in questi versi. Rileggendoli, rivedrai di me quella parte che ti fu consacrata: la polvere sarà polvere, a te il mio spirito, la mia vera parte. Allora avrai di me perduto solo le scorie, un corpo morto, vile preda dei vermi, indegno che tu lo ricordi. Quello che esso contiene è ciò che vale. E questa essenza è la mia poesia; e questa sempre con te resterà. 120 75. Per me sei come il cibo per la vita, o per la terra in estate le piogge. E per la pace che mi dai io lotto come l’avaro con le sue ricchezze, ora esultante d’avere e poi, subito, sospettoso che il mondo lo derubi. Ed io, ora voglio star solo con te e poi, che tutti il mio piacere vedano. Or sazio di godere la tua vista, poco dopo, affamato d’uno sguardo; ora e dopo, da te la gioia prendo. E così giorno dopo giorno anelo, o sono sazio; divorando tutto, o di tutto mancante ti desidero. 121 76. Perché il mio verso di nuovi ornamenti è così spoglio? e senza variazioni? Perché non guardo, come oggi tutti, ai metodi stranieri ed agli effetti? Perché scrivo tranquillo nel mio modo e l’invenzione vesto in noti panni, sì che mostra ogni parola l’origine e il suo studio, e quasi dice il mio nome? Oh, sappi, dolce amore, che di te sempre io scrivo e dell’amore tuo, perciò il mio meglio è vestire di nuovo le parole già spese. Come il sole che un giorno dopo l’altro è nuovo e vecchio, quel che fu detto, il mio amore ridice. 122 77. Lo specchio, come fu la tua bellezza; la meridiana, che l’ore preziose svaniscono; e questo libro, t’insegni che i vuoti fogli la tua impronta attendono. Le rughe che di te lo specchio mostra son memoria di tombe spalancate; la meridiana furtiva ammonisce che il tempo scivola verso l’eterno. E allora affida a questi bianchi spazi ciò che la tua memoria non contiene, e i tuoi pensieri ti parranno nuovi. Queste abitudini, se tanto spesso guardi e rifletti, gioveranno molto; e te ed il tuo libro arricchiranno. 123 78. Tanto spesso t’invocai per mia musa e al mio verso ho trovato tale aiuto, che ogni altra penna ha copiato il mio modo e al tuo servizio sparpaglia poesie. I tuoi occhi che insegnarono a un muto il canto e il volo alla bassa ignoranza, penne aggiungono all’ala di quei dotti e una doppia maestà alla grazia loro. Ma sii fiero di ciò che io compilo, la cui influenza è tua e da te nasce: negli altri emendi soltanto lo stile. Della mia arte invece tutta l’arte sei ed innalzi la goffa ignoranza che già fu mia come alto sapere. 124 79. Finché fui solo a invocare il tuo aiuto solo il mio verso aveva ogni tua grazia; ma ora son decaduti i miei metri e la mia musa lascia il posto a un altro. Ammetto che il tuo amabile argomento, dolce amore, ben altra penna merita; ma il tuo poeta di te quel che inventa a te rubò ed ora ti rimborsa. Virtù ti presta e rubò la parola al tuo contegno; ti dà la bellezza e la trovò sulla tua guancia: solo di ciò che in te già vive può lodarti. Non ringraziarlo dunque degli omaggi: te li deve perché già ti appartengono. 125 80. Oh, come tremo quando di te scrivo, sapendo che uno spirito migliore loda il tuo nome, usando ogni potere per farmi muto sulla tua grandezza. Ma poiché è un oceano, il tuo merito regge l’umile vela e la superba; così la barca mia, tanto inferiore, naviga audace l’ampia tua distesa. Anche se poco profondo il tuo appoggio mi tiene a galla, mentre egli cavalca con l’alto scafo i tuoi insondati abissi. Se naufrago come misera barca mentr’egli avrà fortuna, questo è il peggio: perché il mio amore fu la mia rovina. 126 81. Ch’io viva per dettare il tuo epitaffio, o che tu viva quando sarò sciolto, da qui la morte non potrà slegarti pur se di me sarà tutto sparito. Da qui il tuo nome avrà vita immortale anche se io a tutto il mondo muoia. Io avrò in terra una tomba comune, ma il tuo sepolcro è negli occhi degli uomini. Il mio verso sarà il tuo monumento letto da occhi non ancora nati e recitato da bocche future. Così, quando quel che ora respira sarà morto, tu vivrai pei miei versi dove più spira la vita degli uomini. 127 82. Lo so, non sei sposato alla mia musa e puoi scorrere perciò senza biasimo le devote parole che scrittori, con libri che tu benedici, dedicano. Nella coscienza e nell’aspetto sei tanto bello che trovi oltre il mio elogio i tuoi confini, e sei costretto a prendere lodi più fresche di più freschi giorni. Fa’ pur così; ma quando la retorica t’avrà dipinto coi suoi strani tocchi, vedrai davvero, tu vera bellezza, le piane lodi del tuo vero amico. Su guance esangui grossolani adoprano tinte e pennelli, ma su te è un crimine. 128 83. Che tu avessi bisogno di belletto mai me n’accorsi e perciò non lo misi sul tuo bel volto. Trovavo, o mi parve, che tu eccedessi ogni lode poetica. Perciò fui parco nel cantarti i pregi, ché tu stesso, presente, ben mostravi come una penna comune non renda, parlando di valore, il tuo valore. Questo silenzio m’imputasti a colpa: per me è più gloria assai restare muto che creare una tomba di parole. Altri pretendono di darti vita, ma c’è più vita in uno dei tuoi occhi di quanto entrambi i tuoi poeti inventino. 129 84. Cosa dirà di più, chi parla al massimo, che questa lode: tu solo sei tu, nei cui confini è chiusa la ricchezza ch’è limite ed esempio per chi cresce? Penuria estrema in quella penna abita che non dà qualche gloria al suo soggetto; ma chi scrive di te, se riesce a dire che tu sei tu, degna opera ha fatto. Basta copiare ciò che in te è scritto; non fare peggio di quel che sì chiaro fece natura: questo il vero stile. Tu però aggiungi alle tue belle doti una maledizione, che le lodi vuoi cumulare e con ciò le svilisci. 130 85. Tace impacciata la mia musa mentre dissertazioni in tua lode, da tutte le altre muse, son limate in preziosi fraseggi, impressi in caratteri d’oro. Io penso bei pensieri, mentre belle parole un altro scrive; e come un chierico analfabeta “Amen” sempre grido al suo inno in sì bella forma sciolto. Ti lodano e io penso: “Sì, è così”, ed altre lodi aggiungo col pensiero che in amore più che parola vale. Dunque gli altri rispetta per il soffio delle parole loro; me, pei muti miei pensieri che veramente parlano. 131 86. Fu la superba vela del suo verso, salpata per far preda del tesoro, te, più prezioso di tutti, che uccise e chiuse i miei pensieri dove nacquero? Fu il suo spirito, istruito da spiriti a scrivere altamente, che mi uccise? No; né lui, né i compari che di notte l’aiutano, hanno bloccato il mio verso. Né lui, né il suo domestico fantasma che di notte gli svela altri segreti, mi piegano al silenzio: non li temo. Ma quando i tuoi favori le sue righe riempiono superbe, allora manca la materia al mio verso ed esso langue. 132 87. Addio. Troppo prezioso tu sei, lo sai bene, perché io ti possegga. La carta dei tuoi diritti t’affranca e su te scadono quindi i miei titoli. Solo per tua concessione ti tengo: dov’è il mio merito in tale ricchezza? Manca la causa in me di sì bel dono e perciò si disperde il mio diritto. Desti te stesso ignorando i tuoi meriti, oppur sbagliando a chi ti desti, a me. Il dono malinteso, ora che sai, riprendi. Come un sogno che lusinga t’ho avuto re nel mio sonno; ma ora, svegliandomi, ti vedo in altro modo. 133 88. Quando ti aggraderà di disprezzare ogni mio merito agli occhi di chiunque, contro di me combatterò al tuo fianco per dimostrare che tu sei virtuoso. (E sei spergiuro!) Ogni mia debolezza ben conoscendo, inventerò una storia, riprovevole a me e a tuo favore, per cui lasciandomi otterrai più gloria. Anch’io però riceverò un guadagno, perché amandoti in ogni mio pensiero, facendo il tuo vantaggio, io n’avrò il doppio. Tale è il mio amore e a te così appartengo, che per darti ragione, volentieri sopporterò calunnie ed ogni torto. 134 89. Di’ che m’abbandonasti per mia colpa, e aggiungerò ragioni alla tua accusa. Se racconti che son zoppo, all’istante zoppicherò senza oppormi al tuo dire. Non potrai, amor mio, screditarmi, per dare forma al cambio che vagheggi, più di quanto io farò, perché lo vuoi. Strangolerò l’amicizia, estraneo mi mostrerò, evitandoti e tacendo il tuo nome, affinché non lo profani coi racconti d’una vecchia amicizia. Per te contro me stesso faccio voto di combattere, perché mai dovrò amar colui che sì tanto hai in odio. 135 90. E allora odiami quando vorrai; e se è così, ora; ora che il mondo mi è contro, piegami; unisci i tuoi colpi alla sfortuna e finiscimi subito. Non fare che, scampato ad un dolore ch’io abbia già sconfitto, tu m’assalga con un tempo peggiore. Non protrarre la mia disfatta se l’hai già decisa. Se vuoi lasciarmi, io non sia alla fine già fiaccato da piccole ferite, ma vieni in prima linea, sicché il peggio della sfortuna dall’inizio assaggi: altri dolori che sembran dolori altro parranno, contro la tua perdita. 136 91. Chi della nascita, chi dell’ingegno, chi della forza, chi della ricchezza, chi delle vesti, anche alla moda e brutte, chi di falchi e levrieri e di cavalli, ognuno ha il suo piacere a lui affine, superiore per lui a tutti gli altri. Ma questi aspetti non sono all’altezza della gioia che tutti in me li aduna. Il tuo amore più che nobile nascita vale per me, più che ricchezza o vesti o cavalli o levrieri o falchi vale. E avendo te, mi vanto d’ogni orgoglio. Solo di ciò son misero, che puoi togliermi tutto e il più misero farmi. 137 92. Ma per sottrarti a me fa’ pure il peggio, perché io vivo finché tu sei mio: non durerà la vita oltre il tuo amore, perché da quest’amore essa dipende. Così non temo il peggiore dei torti quando al minore la mia vita ha fine. Vedo per me un migliore destino che dipendere dalla tua incostanza. Sta la mia vita in te, se vuoi cambiare: oh, quale titolo felice trovo, felice del tuo amore e di morire! Ma c’è felicità senza una macchia? Tu potresti, o già puoi, essere falso ed io, né ora né giammai, saperlo. 138 93. Così vivrò, credendoti fedele, come un marito illuso, finché il volto d’amor, pur se non è, tale m’appaia: con me il tuo sguardo, ed il tuo cuore altrove. Nei tuoi occhi non può vivere l’odio, così da quelli non saprò se cambi. Nel sembiante di molti il falso appare in umori e cipigli e strane rughe. Ma tu fosti creato sì che sempre sul tuo volto apparisse il dolce amore, qual che fosse il tuo segreto pensiero. Oh, quanto simile alla mela d’Eva diventerebbe quella tua bellezza se la virtù non rispondesse al volto. 139 94. Chi può ferire e non usa il potere, chi non fa ciò che più fare potrebbe, chi muove gli altri e lui sta come pietra, lento alla tentazione, freddo, immobile, grazie celesti giustamente eredita e dagli sprechi le ricchezze salva: solo per sé padrone del suo volto e servi gli altri della sua eccellenza. Quel fiore che d’estate sa d’estate ma per sé vive e muore, se infettato, anche l’erba più vile lo sovrasta; perché le cose più dolci diventano, coi loro stessi atti, le più aspre: i gigli marci più che erbaccia puzzano. 140 95. Come amabile e dolce la vergogna rendi, che simile ad un verme rode la rosa e intacca il tuo bel nome in boccio: di dolcezze rivesti i tuoi peccati. Chi racconta la storia dei tuoi giorni con lascivi commenti sui tuoi svaghi, nominando il tuo nome benedice la maldicenza che diventa lode. Oh, quale bella dimora hanno scelto i vizi in te, che li veli ed ogni cosa che l’occhio può vedere rendi bella! Ma a questo privilegio così grande sta’ attento, dolce cuore: anche il più duro coltello, male usato, perde il taglio. 141 96. Chi dice giovinezza o esuberanza, chi giovinezza o gentile capriccio, siano tue colpe o grazie, essi le amano: per tutti volgi in grazie le tue colpe. Come al dito d’una regina in trono un brutto anello sarà ben lodato, così gli errori che in te tutti vedono son trasformati in oneste virtù. Oh, quanti agnelli ingannerebbe un lupo travestito da agnello! Così tu: oh, quanti ammiratori traviare potresti con la forza del tuo rango. Non farlo! T’amo talmente che mio sei e così mio è anche il tuo nome. 142 97. Quanto simile all’inverno l’assenza da te, tu gioia dell’anno fugace! Che gelo e quanti giorni bui ho visto! Ovunque intorno era un nudo dicembre. Eppur la lontananza fu d’estate e in quel primo fecondo autunno, pregno della lascivia della primavera, come parto di vedova nel lutto. Sembravano quelle messi abbondanti solo speranze e frutti senza padri, perché tu solo dai gioia all’estate. Ma tu lontano, anche gli uccelli tacciono, o danno un canto tetro che le foglie ingiallisce come se fosse inverno. 143 98. Fui lontano da te in primavera, quando l’aprile con superbe tinte di giovinezza ogni cosa vestiva e anche il greve Saturno a lui rideva. Ma né canto d’uccelli né profumo di fiori, vari d’odore e d’aspetto, seppero indurmi ai dolci canti estivi o a coglier fiori dal superbo grembo. Né mi stupii al candore del giglio né del profondo rosso della rosa: solo dolci figure da te tratte, tu che di tutto questo sei il modello. Sembrava invece inverno e, tu lontano, come tue ombre queste cose vidi. 144 99. Così sgridai la violetta precoce: “Dolce ladra, dove se non dall’alito del mio amore rubasti il tuo profumo? Dalle sue vene attingesti impudica il colore del tuo dolce incarnato.” E il giglio condannai perché rubò la tua mano; e i boccioli i tuoi capelli; e le rose i tuoi colori più puri: una bianca, una rossa; e un’altra, ladra che derubò entrambe, al furto aggiunse il tuo alito, ma nel suo splendore un bruco ti vendicò e l’uccise. Osservai molti fiori, ma nessuno mai ho visto in cui dolcezza, o colori, o profumo a te rubato non fosse. 145 100. Dove sei, Musa, che da tanto tempo dimentichi di parlare di lui che la potenza ti dona? Il tuo fuoco forse avvilisci su soggetti indegni? Ritorna, Musa immemore, e riscatta coi tuoi bei versi il tempo così vano. Al cuore canta di chi sa ascoltarti ed è per te lo stile e l’argomento. Levati e guarda se sul dolce viso del mio amore abbia il tempo inciso un segno. E ovunque sprezza del tempo il passaggio. Dona gloria al mio amore sì che il tempo non giunga prima a guastare la vita: ferma e previeni la sua falce curva. 146 101. O oziosa Musa, perché non affermi che verità e bellezza insieme stanno? Esse, entrambe, dal mio amore dipendono; e così in te: in questo è il tuo destino. Rispondi, Musa, vorrai forse dire: “La verità non richiede colori, né la bellezza verità applicate: il meglio è meglio se a niente è mischiato.” Lui non richiede lodi e tu stai muta? Vane scuse! Se a una tomba dorata sopravvivrà, dal tuo canto dipende. Fa’ la tua opera e fra molto tempo fallo sembrare come ora appare, ché le future età possan lodarlo. 147 102. Il mio amore, anche se appare più debole, si è rafforzato pur se non lo mostro. L’amore invece che viene esibito diventa merce per chi lo possiede. Quand’era nuovo il nostro amore (ed era appena primavera!), lo cantavo come usignolo sul far dell’estate, che poi tace nei giorni più maturi. L’estate è sempre amabile, ma gl’inni che ora gravano dai rami son musica assordante che toglie ogni diletto. Perciò talvolta, come l’usignolo, mi trattengo in silenzio e non m’abbasso, per non tediarti, in un comune canto. 148 103. Quali misere opere produce la mia Musa se il suo argomento è tale che, tutto spoglio, è di maggior valore di quante lodi io possa mai aggiungere! Non biasimarmi allor se più non scrivo: guarda il tuo specchio e lì vedrai il tuo volto che di tanto sovrasta ogni invenzione e, offuscando i miei versi, mi discredita. Coi miei versi vorrei solo cantare le tue grazie e i tuoi pregi. Perché allora emendare ciò che per sé è bello? Così, più che in un verso possa stare, molto di più, ti mostrerà lo specchio quando te stesso guarderai riflesso. 149 104. Mai per me sarai vecchio, dolce amico: com’eri quando per primo il mio occhio nel tuo si pose, ancora sei. Tre freddi inverni il vanto all’estate hanno tolto; tre splendide primavere cambiate in gialli autunni ho visto; e per tre volte bruciò nel giugno il profumo d’aprile, da quando te, come ora sei, ti vidi. Tuttavia la bellezza impercettibile scorre come le ore, ed il mio occhio sulla tua dolce forma può ingannarsi. Per questo dubbio, ascolta tu che ancora non sei nato: prima che tu nascessi della bellezza era morta l’estate. 150 105. Non chiamate idolatria il mio amore, né il mio diletto appaia come un idolo, se le mie lodi e i canti, tutti uguali, sono per uno, d’uno e di lui sempre. Costante è oggi il mio amore e costante domani in meravigliosa eccellenza; così il mio verso, servo alla costanza, solo una cosa esprime e mai non cambia. “Bello, gentile e vero”, questo canto. “Bello, gentile e vero” sono i temi, tre in uno, che meravigliosi vario. Bello, gentile e vero: separati finora furono, ma ora i tre in uno solo si sono incarnati. 151 106. Quando vedo descritte in vecchie cronache le persone più belle, che più belle rendevano l’antiche rime in lode di dame e cavalieri ormai spariti, allora, quella più dolce bellezza, di mano o piede o labbra o occhio o fronte, lodata dall’antica penna, vedo che è la bellezza che tu ora hai. Perciò son profezie di questo tempo le antiche lodi che te prefigurano, anche se il canto è inferiore al tuo merito. Ma anche noi, che il presente vediamo, abbiamo occhi bensì per stupirci, ma fallisce la lingua nel lodarti. 152 107. Né i miei timori, o l’anima profetica del grande mondo che sogna le cose, possono più limitare il destino del mio amore nella sua durata. Or che la luna superò l’eclissi, ride anche chi predisse sventure: le incertezze s’incoronano certe e la pace esibisce ulivi eterni. Come gocce di balsamo del tempo, queste rime mantengono il mio amore sempre vivo. E la morte a me s’inchina, lei che divora genti ottuse e mute. Tu in questi versi avrai il tuo monumento, quando anche il bronzo si sarà disfatto. 153 108. Cosa ancora può vergare l’inchiostro ch’io non abbia di te già raccontato? Cosa dire, o registrare di nuovo, tal che il mio amore esprima od il tuo merito? Niente, dolce ragazzo; devo solo ripetere, come preghiera a Dio da che primo santificai il tuo nome, la stessa cosa: tu mio, io tuo. L’eterno amore che in ognuno è nuovo non si cura del tempo o della polvere; ed anche la vecchiaia fa sua serva, mostrando il primo germe dell’amore che là si genera, dove più il tempo e l’aspetto lo vorrebbero morto. 154 109. Oh, non dir mai che il mio cuore era falso! Neanche l’assenza smorzò la mia fiamma. Come potrei strapparmi da me stesso o dall’anima mia che in te vive? Quella è la casa del mio amore; e là, sempre in tempo, mai cambiato dal tempo, come un viandante di nuovo ritorno, della mia assenza lavando la macchia. Se tutte le debolezze che assediano il sangue umano anche me travolgessero, non dubitare ch’io possa lasciarti. Io chiamo nulla l’intero universo eccetto te, ogni bene, mia rosa. E niente lascio perché tu sei tutto. 155 110. Come un buffone mi sono mostrato qua e là errando: è vero. I miei pensieri ho trafitto; ciò che è caro, svenduto; rinnovato vecchie offese agli affetti. Ed è vero che verità e costanza guardai con sdegno. Eppure quegli errori un’altra gioventù m’hanno arrecato, provando al peggio che il tuo amore è il meglio. Senza più fine, or che tutto è passato, accogli il mio desiderio. Mai più con nuove prove tenterò l’amico, un dio d’amore a cui sono devoto. Dammi il tuo benvenuto, come in cielo, dentro al tuo puro ed amoroso petto. 156 111. Oh, sgrida per amor mio la fortuna, vera colpevole delle mie azioni, perché provvide alla mia vita mezzi volgari che volgari modi creano. Da lì il mio nome ha ricevuto un marchio. Da lì, come la mano del tintore, la mia natura quasi porta il segno. Compatiscimi e fa’ ch’io mi rinnovi: come docile paziente berrò le più amare pozioni per curare questo grave contagio, anche più volte. Compatiscimi allora, caro amico, e sii sicuro che da sola basta la tua dolce pietà per farmi sano. 157 112. La tua pietà e il tuo amore mi cancellano il solco inciso da volgari scandali. Chi dice bene o male non m’importa, se tu copri il mio male e il bene approvi. Per me sei tutto: i miei pregi, e vergogne, solo da te mi sforzo d’ascoltare. Nessuno esiste, e per nessuno esisto, che, giusta o no, la mia natura cambi. In un abisso le altre voci getto, di critica o di lode. E resto sordo come un serpente ai richiami e agl’incanti. Sappi perché degli altri non mi curo: sei tanto radicato nel mio animo che tutto il mondo, altro, è per me morto. 158 113. Lasciato te, solo attraverso l’animo vede il mio occhio, e nell’andar mi guida soltanto in parte e in parte resta cieco; sembra che veda, ma in effetti è spento. Nessuna forma più consegna al cuore, d’uccello o fiore o d’altro ch’egli afferri; dei suoi fugaci oggetti non ha l’animo nessun riscontro e non può trattenerli. Perché ogni cosa nelle tue sembianze ritraccia l’animo, bella o deforme che sia, cigno o corvo, giorno o notte. Di te ricolma, né d’altro capace, la più profonda verità dell’animo rende falso il mio occhio e ciò che vede. 159 114. Forse il mio animo di cui sei re l’adulazione, peste dei potenti, beve? Oppure il mio occhio dice il vero, ma dal tuo amore imparò la magia di trasformare mostri e cose informi in cherubini dal dolce sembiante simile al tuo, creando perfezione d’ogni oggetto caotico che aggrega? E’ il primo caso: il mio animo beve, come un re, la lusinga del mio sguardo che al suo palato sa cosa prepara. L’occhio sa bene cosa gli è gradito; e se è veleno non farà peccato, perché lo ama e per primo lo beve. 160 115. Quei versi che finora ho scritto mentono, proprio nel dire che di più amarti non potevo; ma non sapevo allora perché più ardente poi bruci la fiamma. Ero conscio del tempo, i cui accidenti rompono voti e decreti di re, scoloriscono il bello e il forte piegano secondo il corso di cose mutevoli. Questo allora temendo, e di me certo, trascurai il resto e incoronai il presente proprio dicendo: “Il mio amore è massimo”. L’amore è un bimbo: questo non sapevo. Non dovevo cantare la pienezza di ciò che va crescendo e ancora cresce. 161 116. Non porrò impedimenti al matrimonio di due anime fedeli. L’amore, quando muta o recede, ancorché muti o receda il compagno, non è amore. Oh, no! E’ un faro saldo che sovrasta tempeste e non ne è scosso; è come stella per una barca errante che l’altezza ne prende senza saperne il valore. Non è l’amore zimbello del tempo; per la sua falce non cade; né muta; e impavido resiste fino all’ultimo. Se questo fosse errore, e su di me provato fosse, io non ho mai scritto e nessun uomo mai avrà amato. 162 117. D’essermi tutto risparmiato accusami: nel ripagarti dei tuoi grandi meriti; nell’aver trascurato quell’amore a cui giorno per giorno più mi stringo; che ho frequentato gente sconosciuta; che al mondo prodigai il tuo diritto; che a tutti i venti innalzai la mia vela perché da te lontano mi rapisse. E colpe e dolo a mio debito segna, e a giuste prove i tuoi sospetti cumula, esponendomi all’ira del tuo sguardo. Ma non colpirmi col tuo odio vivo! Io mi sforzai soltanto di provare la costanza e la forza del tuo amore. 163 118. Come per render l’appetito acuto stuzzichiamo il palato con le spezie, e per curare malanni mai visti ci ammaliamo curandoci con purghe, così, mai sazio della tua dolcezza, con salse amare ho condito il mio cibo e, malato di star bene, ho cercato la malattia prima che arrivasse. Così talmente ho anticipato i mali, per astuzia d’amore, che ho peccato; e sano e in forze mi curai col male. Ma da ciò ho imparato, e la lezione sento vera, che le droghe avvelenano me che di te così caddi malato. 164 119. Quali lacrime di sirena bevvi distillate da alambicchi infernali, mescolando paure alle speranze fino a perdere, credendo di vincere? Che gravi errori commise il mio cuore pensando d’esser più che mai beato? Come i miei occhi dall’orbita uscirono nel delirio di questa pazza febbre? Oh, beneficio del male! Ora so che ancor meglio dal male è reso il meglio; e che l’amore infranto, quando nuovo rinasce, è assai più bello e grande e forte. Così istruito, al mio bene ritorno e tre volte guadagno ciò che spesi. 165 120. Che tu una volta a me fosti infedele, ora m’aiuta: il dolor che provai ora mi piega a forza nel rimorso, perché d’acciaio altrimenti sarei. Se della mia infedeltà hai sofferto com’io soffrii, hai passato un inferno. Ed io, crudele, non mi sono detto quanto una volta ho sofferto per te! Quella notte di miseria potesse avermi ricordato quel dolore! E offerto a te, e tu a me allora, l’umile balsamo che ai cuori è caro. Ma quella colpa tua è ora un pegno: la tua la mia, la mia la tua, riscatta. 166 121. E’ meglio essere abietto, se il non esserlo riceve la condanna d’abiezione: così stimato dalle altrui vedute, anche il giusto piacere viene perso. Perché mai gli occhi altrui, corrotti, falsi, accennano al mio sangue sensuale? O spie di me più deboli, cattivo fra sé contano quel ch’io penso buono? No, io sono quel che sono. Chi conta le mie colpe si basa sulle proprie: posso essere dritto e loro storti. Costoro, marci, ai miei fatti non pensino. O il male universale essi propugnano che nella cattiveria l’uomo regni? 167 122. Ho nella mente il tuo dono, il taccuino, tutto scritto per memoria costante che rimarrà, sopra vani caratteri, aldilà d’ogni data, nell’eterno; o almeno, quanto alla mia mente e al cuore la natura concederà d’esistere. Così tanto vivrà il tuo ricordo e non prima ti ruberà l’oblio. Non mi serve un registro per sommare il tuo amore, e mi arrischiai a lasciarlo, perché la mente mia più ti conserva. Tenermi un povero accessorio aggiunto per ricordarti, sarebbe lo stesso che ammettere che mai io ti dimentichi. 168 123. No, Tempo, non vantarti che io cambi! Con sempre nuova potenza elevate, le tue piramidi per me son nulla, rivestimenti di cose già viste. Son brevi i nostri giorni; e ciò che vendi, per questo come nuovo lo ammiriamo, e fatto nascere apposta per noi, piuttosto che pensare che son cose già dette. E te e i tuoi annali sfido: non mi stupisce il presente; o il passato; mentono le vestigia che vediamo, frutto soltanto del continuo spingere. Questo fo voto e questo io sarò: costante resto contro te e la morte. 169 124. Se il mio amore fosse dovuto al rango, da bastardo potrebbe la fortuna trattarlo; all’odio o all’amore del tempo soggetto; erbaccia fra le erbe; o fiore. No! Lontano dal caso esso fu eretto. Non si guasta nello sfarzo gioioso, né cade nel servile malcontento a cui inviterebbe questo tempo. Non lo scuote la cattiva politica, quell’eresia meschina sulle ore, ma tutto solo sta, grande politico che domina ogni volgere del tempo. Ne chiamo a testimoni quei buffoni che criminali vissero e ben muoiono. 170 125. Io, perché reggerei un baldacchino per onorare di fuori l’esterno, o getterei eterne fondamenta che poi caduche e in rovina si svelano? Non ho visto che tutto, e più, perdeva chi pagò troppo di forme ed ossequi, gli arrivisti consunti nel guardare, che al sale preferiscono il dolciastro? No! Sia il mio omaggio al tuo cuore, sincero: povera offerta senza scorie, libera, senza arte alcuna; ma da me a te. Tu, delatore prezzolato, vattene! L’animo onesto, tanto è più accusato e tanto meno in tuo potere resta. 171 126. O tu, caro ragazzo, che hai potere sul volubile tempo e la sua falce, tu che calando, dolcemente cresci e a chi ti ama mostri il suo appassire, se Natura, sovrana su rovine, mentre innanzi procedi, ti trattiene, al suo scopo ti lega: contro il tempo essa si afferma e il vile istante uccide. Ma temila, o tu, suo favorito: lei trattiene ma non serba il tesoro. Alla resa dei conti, anche protratta, dovrà saldare consegnando te. 172 127. Da sempre il nero non è come il biondo, bello. Oppur bello non fu mai lodato. Ma ora è il nero di bellezza erede e il biondo da bastardo si svergogna: quando chiunque usurpa la natura e impresta al brutto una bionda cosmesi, allora il nome e la sacra dimora della dolce bellezza è profanata. Perciò nero di corvo sono gli occhi della mia donna e per quelle, né bionde né belle, che il creato falso rendono, vestiti a lutto quei suoi occhi sembrano. E il loro lutto per l’altrui infamia, a ognuno dice che così è il bello. 173 128. Quanto spesso, tu mia musica, suoni la musica su quei legni beati, dove le dolci tue dita governano l’armonia delle corde che m’incanta! Quei tasti invidio che agili saltano per baciarti l’incavo della mano, mentre le labbra mie, che ciò vorrebbero, all’ardire arrossiscon di quei legni. Vanno, con passo gentile, le dita che tu muovi facendo più beato, delle mie labbra vive, il morto legno. Se in questo son felici quei legnetti, da’ pure a loro le tenere dita: alle mie labbra, le tue da baciare. 174 129. Spreco di spirito e d’infamia scempio è la lussuria finché è lussuria: falsa, assassina, sanguinaria, immonda; selvaggia, estrema, infida e crudele. Goduta, subito vien disprezzata. Fuor di ragione rincorsa e inghiottita, fuor di ragione è odiata come un’esca apposta tesa per far impazzire. Pazza nel perseguire e nel possesso. Avuta, avendo, e per avere, estrema. Alla prova, beata, e poi sventura. Davanti gioia, e dopo solo un sogno. Nessuno sa come sfuggire il cielo che a questo inferno gli uomini conduce. 175 130. Occhi di sole non ha la mia donna, né di corallo sono le sue labbra. Bianca è la neve? Lei ha il petto grigio. Fili d’oro i capelli? Sono neri. Ho visto rose, insieme, rosse e bianche, ma tali rose non ha sulle guance. C’è più delizia in diversi profumi che nel respiro che da lei si parte. Amo udirla parlare benché sappia che la musica ha suoni più piacevoli. Non ho mai visto una dea che incedeva: so che calca la terra la mia donna. Eppure la mia amata è così rara come qualunque lei dei falsi canti. 176 131. Pur come sei, tu sei tiranna al pari di quelle orgogliosamente crudeli per la loro bellezza, perché sai che il mio gioiello sei più caro e chiaro. Ma in verità c’è chi dice, guardandoti, che il tuo volto non può far sospirare. Non oso dire che costoro sbaglino, lo giuro tuttavia tra me e me. Per secondare che non giuro il falso, mille sospiri uno sull’altro partono, al pensier del tuo volto, a testimoni che a mio giudizio il nero tuo è bello. Certo: anche i tuoi atti sono neri; da lì, io credo, nasce la calunnia. 177 132. Amo i tuoi occhi ed essi, conoscendo che il tuo cuor mi tormenta con disdegno, in amoroso lutto si son messi, neri, compassionando il mio dolore. E in verità, né il sole mattutino dona alle grige guance dell’oriente, né la fulgida stella della sera dà tanta gloria al placido occidente, come i tuoi occhi donano al tuo volto. Fa’ così che s’addica anche al tuo cuore quell’amoroso lutto che ti dona. Se ogni tua parte di pietà rivesti, giurerò nera la bellezza stessa e laide quelle che hanno altro colore. 178 133. Maledetto sia il cuore che fa gemere il mio cuore, per le ferite inferte al mio amico oltre a me! Io non bastavo? Schiavo anche lui della mia schiavitù! Me da me stesso il tuo occhio m’ha tolto; e, più crudele, anche l’altro me stesso. Di lui, di me, di te, son ora privo: tormento triplice da attraversare! Nel tuo cuore d’acciaio il mio imprigiona, ma guardiano esso resti del mio amico: dentro di me, non potrai più ferirlo. E tuttavia tu lo farai perché, essendo in te rinchiuso, sono tuo e così tuo è ciò che è chiuso in me. 179 134. Così ho ammesso che lui ora è tuo e che io stesso a te sono asservito. Io m’abbandono, ma l’altro me stesso rendimi a mio conforto, ancora e sempre. Ma tu non lo vorrai, e lui nemmeno: tu sei bramosa e lui è compiacente. Solo doveva garantir per me quel contratto che invece ora lo lega. Tu, usuraia che tutto dai in uso, vuoi la penale per la tua bellezza e lui persegui, per me debitore. Così lo perdo, ché cercai un garante! Entrambi, e lui e me, tu hai: intero egli ti paga ed io mai non m’affranco. 180 135. Mi chiamo Voglia e tu hai già un Voglia, e Voglia ancora e Voglia in sovrappiù. Sono d’avanzo io che ti molesto volendo penetrare la tua voglia? Vorrai concedermi mai di nascondere la mia voglia nella tua così larga? L’altrui voglia sembrerà sempre grazia ed alla mia non brillerà accoglienza? Il mare, tutto d’acqua, in abbondanza la pioggia aggiunge ancora alle sue scorte. Così tu, che hai il tuo Voglia e le tue voglie, allàrgati con me che sono Voglia. Non sdegnare gentili pretendenti; pensali tutti in uno, e tutti in Voglia. 181 136. Se l’anima ti frena quando incalzo, giura all’anima tua ch’io sono Voglia: l’anima sa che lì voglia è ammessa e fino in fondo per amore accoglila. Voglia vorrà il forziere del tuo amore, pieno di voglie e la mia voglia in quelle. Nelle grandi accoglienze entra un gran numero e uno è nulla: inosservato io passi. Uno conto nel conto dei tuoi beni: per nulla prendimi, purché ti piaccia prendere un nulla, come dolce in te. Fa’ che sempre il mio nome sia il tuo amore, amalo sempre e così me vorrai. Ma tu lo sai, perché il mio nome è Voglia. 182 137. O cieco Amore, cosa fai agli occhi, ché guardo ma non vedo ciò che vedo? Cosa sia la bellezza, e dove, sanno; ma il peggio come il meglio fanno essere. Se i miei occhi con sguardi generosi si fermano dove tutti veleggiano, perché di questi occhi hai fatto uncini a cui legasti il giudizio del cuore? Perché il mio cuore pensa, quel che pubblico vedono gli occhi, un pascolo privato, facendo onesta quella faccia impura? Su cose giuste e vere hanno sbagliato il cuore mio e gli occhi; ed ora essi son condannati a questa falsa piaga. 183 138. Quando il mio amor mi giura fedeltà, benché sappia che mente, io le credo, sì che mi pensi giovane e inesperto delle sottili falsità del mondo. E vanamente pensando che giovane mi pensi, e tutti invece sa i miei giorni, semplicemente credo alla sua lingua: così entrambi il vero cancelliamo. Perché non dice che mi è infedele? Ed io perché non dico d’esser vecchio? Oh, la fiducia in amore è un sembrare! Perciò io mento a lei e lei a me: giacendo insieme con le nostre colpe, veniamo lusingati da menzogne. 184 139. Non chiedermi ch’io giustifichi il torto che la tua crudeltà m’infligge al cuore! Non con l’occhio, ma di lingua feriscimi; ad armi pari, senza inganni, uccidimi. Dimmi che il cuore ti trascina altrove, ma il tuo occhio si astenga in mia presenza di pascersi dattorno. Che bisogno hai dell’astuzia se con forza vinci? Ti scuserò così: “Ah, la mia amata sa che i suoi sguardi nemici mi furono, ed ora altrove con gli occhi ferisce e da me li distoglie.” Ma non farlo! Poiché quasi son morto, con gli sguardi uccidimi e questa pena abbia fine. 185 140. Sii saggia quanto sei crudele: evita di sdegnare la mia muta pazienza e il dolore non mi dia le parole per narrare la sconsolata pena. Se potessi insegnarti la saggezza, ti direi di chiamarmi sempre amore anche se non mi ami: ai moribondi la salute pronosticano i medici. Se disperassi, ne potrei impazzire e dire cose su di te cattive, tali che il pazzo mondo crederebbe. Perché non sia così, né diffamata tu resti, gli occhi tuoi sappi dirigere, anche se il cuore fai girar lontano. 186 141. In verità, non ti amo con gli occhi, essi notano in te mille difetti; ma è il mio cuore che ama e si compiace d’amare ciò che la vista disprezza. Né delizia l’udito, la tua voce; né il tatto inclina a certi toccamenti; né gusto né odorato da te sola inviteresti alla festa dei sensi. Ma facoltà o sensi un cuore folle non posson dissuadere dal servirti; e come schiava del tuo cuore altero lasciano ingovernata un’ombra d’uomo. Ma in questa peste conto anche un guadagno: lei che mi fa peccare, mi punisce. 187 142. L’amore è il mio peccato, e la tua cara virtù è l’odio, odio per l’amore mio che è peccato; ma compara il mio col tuo stato: non merito rimprovero. Comunque, non dalle tue rosse labbra che falsi patti d’amore suggellano per profanarli (come anch’io ho fatto), e il dovuto rubando ai letti altrui. Sia legittimo, dunque, che ti ami come tu ami quelli che con gli occhi corteggi, mentre a te i miei son gravi. Radica in cuore la pietà sì che tu la meriti, quando la vorrai: col tuo esempio non ti sia negata. 188 143. Guarda una brava massaia che insegue qualche pennuto che le sfugge avanti, come posa il suo bimbo per star dietro a quell’essere che lei vuol fermare; e intanto il bimbo dà a lei la caccia, e piange e grida a lei, tutta affannata a seguire chi davanti le vola, del bambino non curando il dolore. Così tu corri dietro a chi ti sfugge ed io, il tuo bimbo, lontano t’inseguo. Se mai raggiungi chi speri, a me volgiti. Come una madre sii gentile: baciami. Pregherò che tu abbia ciò che vuoi, se torni indietro e il mio pianto consoli. 189 144. Ho due amori, di speranza e sconforto, che al pari di due spiriti mi tentano: l’angelo buono è un uomo biondo e bello, l’altro è una donna coi capelli neri. Per condurmi all’inferno, il male femmina l’angelo buono tenta dal mio fianco; e cerca di corromperlo in demonio, coprendo la purezza di lussuria. Che il mio angelo si sia volto in diavolo, sospetto ma non so: lontani sono e amici fra di loro. E vivo e dubito che un angelo si trovi in quell’inferno. Mai lo saprò, finché il cattivo spirito rigetterà marchiato quello buono. 190 145. Quelle sue labbra che l’Amore fece sibilarono un suono che diceva “Io l’odio”, a me che per lei anelavo. Ma quando vide il mio pietoso stato la compassione le addolcì il suo cuore, rimproverando la lingua che sempre era solita a parole gentili; e le insegnò a parlare di nuovo. “Io l’odio” essa alterò con un finale, simile a giorno gentile che segue una notte infernale di demoni. Ogni odio essa tolse a quell’ “Io l’odio” che le sfuggì di bocca; e mi salvò la vita, subito “Non te” aggiungendo. 191 145. Le sue labbra che l’Amore fece in un soffio mi dissero: “Odio” proprio a me che per lei mi languivo. Quando vide il pietoso mio stato, la pietà nel suo cuore discese, riprendendo la lingua che sempre era solita a un fare gentile, e diversa la fece parlare. Alterò quella frase: “Io odio” con la fine che seguì, gentile come giorno che succede a notte, infernale demonio caduto. Affrancò quell’ “Io odio” dall’odio e la vita mi rese dicendo: “Non te”. 192 146. Povera anima, della mia terra peccaminosa centro di potenze ribelli, dentro inaridisci e soffri e il muro esterno decori: perché? Perché sì tanto spendi nell’affitto d’una dimora che ogni giorno scade? L’eredità di quanto a te è affidato non spetta ai vermi? Non finisce il corpo? Che il tuo corpo languisca, anima mia. Lascia che soffra e aumenterai i tuoi meriti; compra ore divine e cedi polvere. Nutrita dentro e non più ricca fuori: così farai la morte della morte, e lei morta, non sarà più il morire. 193 147. Il mio amore, come una febbre, anela ciò che più a lungo ne alimenti il morbo e che il male, nutrendosi, rinnovi l’incessante appetito da appagare. La ragione m’abbandonò con sdegno, medico del mio amore le cui cure lasciai cadere; ed ora disperato con lei concordo: il desiderio è morte. Incurabile, delirante e pazzo, or che più la ragione non m’assiste, a caso penso e senza posa parlo. Perché lontano dal vero ho giurato che bella sei e luminosa appari: tu, come inferno nera e notte buia. 194 148. Povero me, che occhi in fronte Amore mi ha messo che la realtà non vedono? O se la vedono, dov’è fuggito il mio giudizio che falsa la vista? Se è bello ciò che gli occhi bello notano, perché dice la gente che non è? Se non lo è, il mio amore dimostra che l’occhio innamorato il falso dice. Come potrebbe esser vero quell’occhio così turbato da veglie e da lacrime? Finché non s’apre il cielo, il sole stesso non vede niente. Di lacrime cieco mi tieni, o amore, perché, se vedessi, tutti i tuoi immondi difetti vedrei. 195 149. Puoi dire tu, crudele, che non t’amo, quando contro me stesso te difendo? Non penso a te, quando per te dimentico me stesso e sono a me stesso tiranno? C’è chi tu odi e che io chiami amico? C’è chi tu guardi male ed io lusinghi? Quando ti vedo irritata, non corro alla vendetta su di me, gemendo? Che ho rispettato del mio orgoglio, quando ti basta un cenno degli occhi per farmi adorare persino i tuoi difetti? Ma continua ad odiarmi, amore. Adesso conosco la tua mente: quello ami che come sei ti vede, ed io son cieco. 196 150. Da quale mai potenza hai tu il potere per dominarmi proprio coi difetti? Per farmi dire che i miei occhi mentono e giurare che il giorno non ha luce? Da che discende che il brutto ti doni, e che dal fondo dei tuoi atti affiori tale una forza e prova di bravura, che di te il peggio tutto il meglio eccede? Chi t’insegnò a farti amar di più, tanto più vedo e sento cause d’odio? Se amo quella che altri detesta, non dovresti con altri detestarmi. Se la tua indegnità mi fece amarti, tanto più sono degno che tu m’ami. 197 151. Troppo giovane è Amore per sapere quale coscienza dall’amore nasca? Non incolparmi, o dolce ingannatrice, se non vuoi che il mio fallo a te s’incolpi. L’anima mia ripete che l’amore sul corpo trionfi, ma non sente il corpo altre ragioni e al tuo richiamo induce la più nobile parte al tradimento. Ergendosi al tuo nome, la sua preda ti elegge. Ed orgoglioso del suo orgoglio, d’esser tuo schiavo si contenta, al fine di star nelle tue cose, e lì cadere. Manca coscienza, se io chiamo amore lei, per il cui amore mi ergo e cado? 198 152. Tu sai che amandoti sono spergiuro, ma tu, giurando amore a me, due volte spergiura sei: nel primo letto ed ora, giurando odio a me dopo l’amore. Ma di doppio spergiuro accuso te, quand’io venti e più volte ho infranto voti, travisando coi voti quel che eri? La mia fiducia in me per te ho perso. Ho giurato del tuo profondo affetto, del tuo amore, sincerità e costanza. Per darti luce ho accecato i miei occhi, li ho costretti a giurare che eri bella: spergiuro è proprio quell’occhio che giura, contro il vero, una sì turpe menzogna. 199 153. Posò la torcia, Cupido, e dormì. Colse il momento una ninfa di Diana e quel fuoco, che amore accende, immerse in una fredda fonte della valle. La fonte da quel sacro fuoco trasse un calore sempre vivo che sana, bagno bollente che tuttora gli uomini scoprono cura sovrana ai malanni. Ma Cupido, riaccesa la sua torcia dagli occhi della mia donna, il mio petto toccò e, malato, ricercai quel bagno. Ma non trovai la cura in quella fonte: mi possono sanare solo gli occhi dove Cupido prese nuovo fuoco. 200 154. Giacendo addormentato il dio d’Amore posò la torcia che ogni cuore infiamma. Molte ninfe votate a vita casta là intorno vennero danzando; e il fuoco, che molti cuori aveva riscaldato, a lui prese la devota più bella: così il sovrano di calde passioni fu disarmato da vergine mano. Quella torcia lei spense in una fonte, che, preso il fuoco d’Amore, divenne calde terme e rimedio ai mali umani. Io, schiavo della mia donna, dico che se il fuoco d’Amore scalda l’acqua, l’acqua giammai raffredderà l’amore. 201
Scaricare