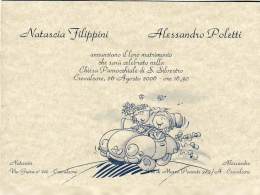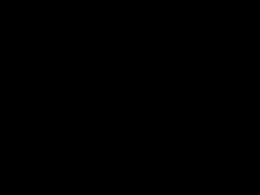leggi, scrivi e condividi le tue 10 righe dai libri http://www.10righedailibri.it Marsilio X 1 02/03/12 18.01 Gianni Solla Il fiuto dello Squalo Marsilio 3 02/03/12 18.01 ESTRATTO PROMOZIONALE NON IN VENDITA © 2012 by Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia Pubblicato in accordo con l’agenzia letteraria Vicolo Cannery Prima edizione: marzo 2012 ISBN 978-88-317-1180 www.marsilioeditori.it 4 02/03/12 18.01 IL FIUTO DELLO SQUALO a Dario 5 02/03/12 18.02 Cerchiamo di capirci, se hai una pinna da squalo sulla faccia allora diventi un carnivoro La prima volta che mio padre mi ha chiamato Squalo avevo tre settimane. Mi teneva avvolto in un plaid mar rone a pochi centimetri dalla stufa a cherosene che ac cendeva bruciando un foglio di giornale infilato nel buco del serbatoio. Aveva paura: adesso che ero nato, era dav vero costretto a tornare nel letto di mia madre tutte le notti? Continuava a guardarmi attraverso gli occhiali a goccia e non si spiegava quella cosa misteriosa che avevo sulla faccia. Mi chiamò Squalo perché gli piaceva che avessi il nome di una pianta carnivora o di un predatore. Doveva farlo sentire meno responsabile. Se ero nato con quella pinna al posto del naso, c’era da aspettarsi che mi sarebbero com parse le branchie e in bocca un centinaio di denti triango lari. Era convinto che per ognuno di noi esistesse un solo nome possibile, e lui aveva trovato il mio. Quarant’anni dopo, sul mio biglietto da visita c’è scritto LO SQUALO. Tutti quelli a cui devo dei soldi mi conoscono con que sto nome. Quando avevo una casa sul mio citofono c’era scritto Squalo. La “S” è il tasto più consumato del mio computer. Mi chiamano così per la forma del mio naso, ma se a 7 7 02/03/12 18.02 chiedermelo sono i miei clienti, allora dico che è per il mio fiuto negli affari. Sono stato io a mettere in mezzo questa storia. Nel mio ambiente, alcuni dicono che sento il sangue a chilometri di distanza, altri che sono più innocuo di un pesce gatto. In tutti e due i casi, il mio destino è scritto nella forma del mio naso. Chi conosce la stanza dove vivo alla pensione Nuova Li bia e sa quanto valgono i vestiti che indosso, capisce perché lo Squalo ha deciso di cambiare acque. Sono fuori di cen totrentaduemila euro con i Santamaria. Hanno in mano il rione Terzo mondo, Secondigliano e Miano. È il clan più potente della città. Cominciamo per gradi. Prima di conoscere le circostan ze che mi hanno portato al fallimento, mi toccherà raccon tare di come si siano conosciuti i miei genitori, perché la verità è sempre contenuta nell’inizio di ogni storia. 8 8 02/03/12 18.02 L’inizio dell’inizio Mio padre ha scritto per la prima volta il nome di mia madre con il sangue di un pollo. Nemmeno era sicuro di come si scrivesse. Nella prima versione della storia ha riempito un secchio con il sangue del pollo e mentre gli altri operai della chicken farm fanno il tifo per lui, immerge la mano nel secchio e scrive la frase sulla parete bianca. Nella seconda versione utilizza direttamente il pollo tenendolo per il collo mentre gli altri operai urlano il suo nome e battono le mani. In tutte e due le versioni gli operai tifano per lui e in tutte e due mia madre gli dice di sì. Partì per la Svizzera con quattordici sigarette e una coperta con un ricamo arabo fatto a mano. Prese quattro treni e camminò due giorni a piedi. Alla stazione di Mi lano vendette la coperta a una guardia e comprò una stecca di sigarette. La guardia lo fregò sui soldi, lui, sul ricamo arabo. Fu dopo la vendita della coperta che si fece spiegare la strada per la Svizzera e che camminò i due giorni a piedi per non spendere i soldi che adesso aveva in tasca. Era contento, i posti freddi gli erano sem pre piaciuti. In Svizzera si sistemò a casa di Cristiano, un suo amico partito quattro mesi prima. Si presentò all’indirizzo che la 9 9 02/03/12 18.02 madre di Cristiano usava per spedire le lettere alle quali lui non aveva mai risposto. Perciò mio padre sapeva che quello era l’indirizzo giusto. Quando gli aprì la porta, mio padre restò a guardarlo e pensò che non basta cambiare posto per essere un’altra persona e che la miseria è un de stino capace di prendere il treno e di seguirti per migliaia di chilometri. Cristiano lo sistemò in una stanza completamente vuo ta. Non aveva il materasso, ma una pila di cartoni per le uova. Mio padre aveva paura delle galline. La parola esatta era: alectorofobia. Gliela scrisse il medico in stampatello sul bordo di un foglio di giornale dopo che accompagnò sua madre a comprare le uova e gli vennero le convulsioni. Gli ritornò in mente quella parola strana. Si stese sui car toni per sentire se erano comodi, doveva averci dormito qualcuno perché si erano ammorbiditi e avevano preso una forma capace di contenere una spina dorsale. Il giorno seguente andò all’ufficio di collocamento. Arrivò presto, l’ufficio era chiuso, rimase fuori alla porta a vetri senza fare niente. La gente lo guardava. Poi apri rono dall’interno e lui entrò. Restò un’ora su una sedia di plastica, poi un uomo senza capelli gli disse di entrare. L’uomo gli fece cenno di non sedersi, era una questione di pochi minuti. Esaminò la fedina penale e il libretto sanitario. Gli fece scrivere il suo nome ventisette volte per controllare come lo scriveva e se sapeva contare, poi si infilò dei guanti sottili che sembravano una pellicola. Con una pinza di plastica trasparente si avvicinò per al zargli le labbra e verificare lo stato dei denti. Fece due passi nella sua direzione, mio padre lo fermò e se le tirò su da solo. 10 10 02/03/12 18.02 «Muoviti» gli disse, con il labbro superiore alzato. Dopo l’ispezione l’uomo ritornò alla scrivania, infilò gli occhiali bifocali, se li sistemò sul naso e riempì un modu lo. Scriveva veloce, conosceva a memoria la posizione di ogni casella da riempire. Respirava male, doveva avere il naso chiuso e ogni cinque secondi sbuffava aria dalla boc ca. Mio padre restò tutto il tempo senza parlare, ascoltava quel respiro, poi l’uomo gli disse che per come stavano le cose, lui poteva lavorare solo all’altoforno. Colpa dei den ti pensò mio padre, che da quando era partito non li aveva più lavati. «Va bene» disse. Proprio a lui che piacevano i posti freddi. Gli consegnarono una tuta e delle scarpe protettive di una misura più grande. Ogni volta che appoggiava la pun ta del piede, il tallone si staccava. Con una barra meccanica doveva infilare dei blocchi di metallo in un carrello mobile agganciato a una rotaia. Il carrello sostava alla sua postazione per quaranta secondi e poi ripartiva. Prima di cominciare a muoversi, emetteva per cinque secondi un fischio, fisso nei primi tre secondi, intermittente negli ultimi due. Una volta ripartito, trasci nava nel cuore dell’altoforno i blocchi di metallo e dopo quattordici secondi ne arrivava un altro. Quel lavoro non gli piaceva: detestava il caldo e il fi schio del carrello. Il nono giorno svenne. Cadde senza piegarsi sulle gam be, come sarebbe caduto un palo della luce. Solo quando il terzo carrello entrò nel forno senza i blocchi all’interno, si resero conto che qualcosa non andava. Fermarono l’in tera linea aspettando che si riprendesse. 11 11 02/03/12 18.02 C’era un magazzino che faceva da infermeria. Lo por tarono là i due russi che lavoravano al reparto con lui. I russi sapevano cosa fare coi blocchi di metallo, ma non con un uomo svenuto. Inoltre era svenuto in una lingua che ignoravano. Il responsabile venne fuori dal suo ufficio e si mise a sbraitare qualcosa con il caposervizio. Il caposervizio era un polacco immigrato dieci anni prima, aveva la faccia bianca, i capelli nerissimi e una macchia a forma di stella sulla fron te. Alzò il braccio e puntò mio padre che intanto si stava riprendendo. Non seppe mai cosa si dissero quei due, però capì che le cose si stavano mettendo male. Terminato il tur no gli dissero di lasciare le scarpe protettive di proprietà dell’acciaieria e di non presentarsi il giorno seguente. Ci pensò tutta la notte. Era steso sui cartoni delle uova appoggiati sul pavimento. Gli piaceva stare vicino alle mat tonelle perché questo lo faceva sentire una pianta e ogni tanto allungava le mani sperando di trovare del terreno umido. Era la prima volta in vita sua che veniva licenziato. Buttò giù mezza bottiglia di vodka che gli avevano regala to i due russi e il mattino seguente, con lo stomaco in fiam me e una bottiglina di Maalox nel taschino della giacca, si presentò al collocamento spiegando quello che era succes so. L’uomo senza capelli lo ascoltò con attenzione, poi gli chiese in che genere di posto avrebbe voluto lavorare: un posto freddo, rispose lui. Compilò un altro modulo e gli trovò lavoro alla chicken farm, una fabbrica che confezio nava polli nelle vaschette. «È l’ultimo lavoro che ti do» disse l’uomo. 12 12 02/03/12 18.02 L’intero stabilimento era un’enorme cella frigo. Bastava un solo grado in più e quintali di pollo in vaschetta sareb bero marciti. C’erano pezzi di carne e macchie di sangue ovunque, la puzza prendeva alla gola. Bisognava indossare un camice bianco e le cuffiette. Gli venne di nuovo in mente quella parola strana: alectorofobia. Ma queste galli ne erano morte e a lui la morte non gli aveva mai fatto impressione. Inoltre c’era una cosa buona, il freddo. Lo faceva ragionare e lavorare forte, in sole due settimane, dopo che gli ebbero dato un paio di scarpe protettive del la misura giusta, divenne il caporeparto alla trinciatura. Andava piano. Aspettava che tutti quelli che erano alla catena con lui avessero staccato il pollo dal gancio, tagliato il collo e buttato via la testa nel circuito centrale, tagliato in orizzontale il corpo all’altezza delle cosce, tagliato quindi in due sezioni il petto e in due sezioni le cosce e riposto tutto in una vaschetta di plastica. Solo a questo punto, an che se aveva finito mezzo minuto prima degli altri, schiac ciava il pulsante rosso e la catena alta scorreva consegnan do a ogni postazione un nuovo pollo. Sembrava che nella vita non avesse fatto altro che squartare polli al freddo e premere un pulsante rosso. Alla fine della terza settimana di lavoro, mio padre ave va messo assieme abbastanza soldi per comprarsi un mate rasso. Non aveva la macchina né poteva pagare il traspor to, allora se lo caricò sulle spalle e attraversò la piccola cittadina. È stata la prima cosa che ha posseduto. Per que sto tutte le volte che si sentiva perduto andava a stendersi sull’unica cosa al mondo veramente sua. Il venerdì mio padre e Cristiano andavano a puttane. At torno all’area industriale c’erano dei bordelli, erano case 13 13 02/03/12 18.02 piccole, su due livelli, con poche stanze da letto al piano superiore e un divano su cui aspettare in quello inferiore. Bisognava attendere con discrezione senza dare fastidio alle ragazze. La tariffa era calcolata sui salari della fabbrica dei polli, dell’acciaieria, della fabbrica di plastica e della fabbrica dei frigoriferi. Se si voleva sapere quale era la media di un salario svizzero, bastava entrare in un bordello e chiedere a quanto mettevano un pompino. Mio padre aspettava il suo turno sul divano recitando tra i denti un Atto di dolore per farsi perdonare, e quando una delle ragazze si liberava, lo faceva salire al piano di sopra. Lui a metà della scala si faceva il segno della croce senza farsi vedere e pregava l’anima di suo padre che per primo l’aveva accompagnato in un bordello alla ferrovia. La ragazza allora prendeva il pollo, lo tagliava in orizzon tale e poi in verticale. Poi premeva il pulsante e ne arrivava un altro. La vita priva di sensazioni era piacevole. Lavorava in un frigorifero gigante, non capiva la lingua delle persone che lo circondavano, andava con una puttana diversa ogni venerdì per dieci minuti sperando che non avessero au mentato lo stipendio alla fabbrica della plastica. Il mondo delle relazioni e delle passioni non era indispensabile. Era una massa schiumosa sullo strettamente indispensabile e se c’era una sola cosa a cui non avrebbe mai rinunciato, era il bottone rosso della catena alta dei polli. Ogni volta che lo schiacciava la sua sopravvivenza era garantita per altri venti minuti. Se lo avesse premuto un milione di vol te era fatta. La Svizzera era in espansione, i suoi abitanti potevano permettersi di non mangiare soltanto pollo e il costo di un pompino era aumentato del cinque percento nei due mesi 14 14 02/03/12 18.02 successivi. Così alla chicken farm fu introdotto un altro prodotto: lo stoccafisso. Lo stabilimento aveva assorbito una piccola azienda a conduzione familiare che si occupava di importazione di stoccafisso dalla Svezia. L’ambizione era quella di piazzare sul mercato vaschette con porzioni di stoccafisso. Dopo poche ore di formazione, il personale della chicken farm, trovò sui ganci della catena, oltre ai polli, pezzi di stocca fisso da tagliare in forma quadrata e infilare nella vaschetta secondo le istruzioni che ognuno aveva ricevuto. L’unica figlia del proprietario dell’azienda di stoccafisso divenne la responsabile della sezione trinciatura dove lavorava mio padre, si chiamava Fabienne, e mio padre diceva che la vedeva meglio in un bordello. Lo diceva con convinzione, uno, perché aveva una certa pratica, due, perché Fabienne si era messa con un cronometro in mano a misurare quan to tempo impiegasse ogni operaio a sezionare, tagliare e confezionare sia il pollo che lo stoccafisso. Fabienne indossava il camice bianco e girava senza cuf fietta igienica. Non aveva le scarpe protettive e portava gli stivaletti di gomma antiscivolo. Aveva un quaderno con i fogli a quadretti sul quale appuntava i tempi di ogni ope raio. Aveva disegnato con il righello una tabella, nella co lonna di sinistra c’era il nome dell’operaio, in quella di destra il tempo impiegato per la trinciatura. Nel freddo dello stabilimento, il fiato di ognuno aveva una consistenza vaporosa, ma quello di Fabienne era più denso di quello di chiunque altro. Si affiancava all’ope raio, salutava, schiacciava il pulsante sull’orologio e face va partire la lancetta dei secondi. Tutti cominciarono a chiamare la Puttana, quella che poi sarebbe diventata 15 15 02/03/12 18.02 mia madre. Ognuno nella sua lingua. Quando tutte le ca selle dello schedario di Fabienne contennero un nome e un numero, venne fuori che mio padre era la causa del mancato innalzamento della produttività del suo reparto. In pratica il vecchio premeva il bottone rosso troppo len tamente: per la seconda volta avevano puntato il dito contro di lui. Lo tolsero dalla sua postazione e misero uno svizzero che tutti nel reparto dicevano fosse stato concepito e cre sciuto in un bordello. Mio padre passò tutta la notte sul materasso a fissare il soffitto e finirsi una bottiglia di rum che aveva comprato in un supermercato. Vomitò due volte, non era abituato, per un po’ pensò che gli stava venendo la febbre, poi si addormentò. La mattina fece la doccia e la barba e ritornò allo stabilimento. Lo svizzero lavorava a testa bassa, andava veloce e non appena aveva finito, contava a voce alta fino a otto e poi premeva il pulsante. «Conta fino a dieci» gli dissero gli altri operai. «Otto» rispose lui. In questo consisteva la bravura dello svizzero, nell’urla re agli altri di sbrigarsi a finire. Sganciava il pezzo, lo sbat teva sulla postazione, lo tagliava tenendolo fermo con una mano, respirava velocemente, non alzava mai la testa, più veloce andava più l’azienda gli voleva bene, allora non ave va altra scelta, doveva tagliare il doppio degli altri, metterli in difficoltà, aveva sentito le voci che giravano su di lui, teneva la testa bassa, non voleva amici alla catena di trin ciatura, lui li schifava i rumeni, i polacchi, gli egiziani, gli italiani, i filippini, i marocchini, i napoletani, e quando co 16 16 02/03/12 18.02 minciava a contare, alcune donne stavano ancora taglian do la parte esterna del pezzo. Non tutti riuscivano a tenere il ritmo dello svizzero e bisognava fermare la catena per aspettare che gli altri avessero tagliato il pollo. Una mattina la catena di mon taggio venne fermata per quattro volte. Fabienne uscì dal suo ufficio, aveva i capelli biondi, il collo bianchissi mo e gli zigomi alti. Il rumore dell’impianto di aerazione era tremendo, la catena era ferma, i ganci vuoti, lo svizze ro alzò il braccio e indicò mio padre, disse che gli operai erano abituati male, la colpa era la sua se tutti andavano così lenti. Mio padre tolse la cuffietta esibendo il principio di cal vizie che gli avrebbe portato via i capelli dal centro della testa, prese lo svizzero per il collo e gli infilò la testa in un secchio pieno di sangue di pollo. Gli altri operai restarono immobili, uno di loro comin ciò a contare ad alta voce, uno, due, tre, quattro, corsero due uomini delle pulizie a fargli mollare la presa. Fabienne restò bloccata a guardare la scena. Quando gli tirarono fuori la testa, lo svizzero aveva il sangue dei polli in bocca, nel naso, nelle orecchie, nei capelli. Il sangue era rosso, intenso, lucido sotto i neon del corridoio trinciatura. Il ca mice di mio padre aveva una strisciata di rosso all’altezza del petto e lui, come ultimo gesto, cercò di appendere lo svizzero alla catena alta assieme ai polli e agli stoccafissi ma i ganci erano troppo piccoli. Il giorno seguente nella fabbrica e per tutti i bordelli del vicinato non si parlava che dell’episodio di questo italiano che aveva quasi ammazzato uno svizzero tenendogli la te sta in un secchio pieno di sangue di pollo. Continua in libreria e in ebook 17 02/03/12 18.02
Scarica