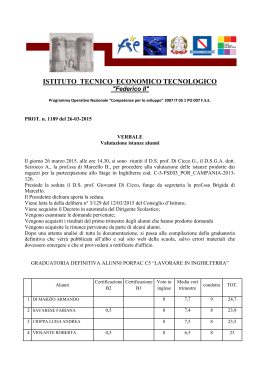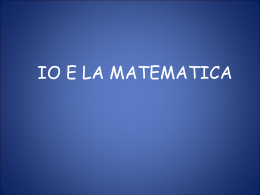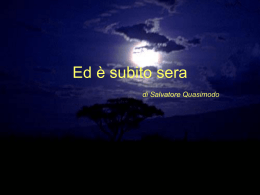0 PREFAZIONE Il mio ricordo d’infanzia più lontano si adagia sopra un pavimento di legno, in casa della nonna, scaldato da un raggio di sole passato tra le imposte. Un gatto piccolo e magro, mai visto prima, è rannicchiato, in posizione fetale, in un semicerchio di luce. Si lamenta piano, senza muoversi. Mi avvicino e mi accorgo che in quella piccola ribalta il micetto dà la sua ultima rappresentazione… Per tantissimi anni quella scena è rimasta chiusa in fondo alla memoria. Eppure si concepivano, forse, in quel momento, i germi della vita e della morte che avrebbero maturato la mia coscienza. E mi pare abbia avuto inizio, da allora, il mio sentire tragico, pur tra gli spasimi di luce gioiosa che la vita a tutti sa elargire. Non avrei mai immaginato che degli ombrelli da me smarriti potessero, loro, recuperarmi e rivelarmi quanto segue in queste pagine. E temo, lettore, la tua prevedibile insofferenza al contrasto, che non ho saputo appianare, tra la bizzarria del caso e certo tono di disperata monocromia nella quale i fatti evocati si vedono costretti. Ma tu, rispetto a me che ho veduto aprirsi questi ombrelli per una notte intera, hai almeno il vantaggio di poterli chiudere in un solo istante. 1 OMBRELLI Non di tutto un uomo deve lasciare testimonianza. Di molte cose è già tanto che conservi memoria per sé. Lo sciabordare dell’onda, che nella distesa della solitudine riporta e riprende i ricordi allegri o dolorosi, non è che il sintomo eterno della nostra irreversibile mediocrità. Ma se lo spirito rassegnato delle cose venisse, una volta, lacerato da una forza imprevedibile, che, capace di animare le cose stesse, da non so che stagione della nostra vita ce le ponesse di fronte, come ineludibile sangue del nostro sangue … Quella sera (mia moglie era in ospedale con una gamba ingessata e mio figlio svolgeva il suo master a Londra) avevo deciso di togliere l’audio al televisore perché, nel caso mi fossi lasciato vincere dal sonno, almeno non ci fosse alcun danno per i vicini. Ma non erano ancora le ventitré che ho sentito bussare. Due colpi discreti, quasi lontani. Quando non suonava il campanello, di solito a bussare era un vicino che aveva bisogno di qualcosa. Ma, aperta la porta, nessuno compariva sull’uscio. Forse mi ero deciso tardi ad aprire e il vicino non aveva osato insistere, al pensiero che fossi già a letto. Riaffondai nella poltrona per seguire distrattamente le immagini mute del video. Ma non si fecero attendere due colpi più decisi alla porta. Questa volta mi precipitai ad aprire. Ancora nessuno sull’uscio. Incominciai a preoccuparmi. Sapevo che l’impressione falsa di sentire o di vedere alcune cose poteva costituire un indizio di incipiente demenza senile. Ma se si fosse trattato di questo non sarei meno folle adesso, nel pretendere di riferire ad altri le assurdità di una sera della mia vita. Invece, credetemi, a bussare erano stati dei semplici …. ombrelli! Ombrelli da me dimenticati in giro, qui e là, nel corso degli anni. 2 Ora avevano ritrovato la strada di me smemorato. Erano tornati. Avevano da dirmi cose delle quali erano stati testimoni durante la mia assenza da loro. Cose, come seppi, che mi riguardavano. Si disposero nella stanza, poggiati al tavolo, in ordine di età (mi parve). Dopo essersi consultati diedero inizio al mio viaggio nel passato. Parlò Ombrello-Uno: “Avvicinati, sentirai un ronzio, come di mare in una conchiglia. Sono le voci lamentose di una litania, di una sera lontana della tua vita. E’ un compianto, ma senza il morto in casa. E’ il lamento di una partenza, della partenza di allora, per l’America. E’ l’addio a una donna. Se vale la pena pagarle tanto viaggio è perché lì troverà una sicura sistemazione; vuol dire che qualche compaesano emigrato l’ha chiesta in moglie. Una donna non può tornare. Parte per sé. Solo gli uomini partivano per ritornare (se ritornavano) col gruzzolo necessario a sistemare la casa e la famiglia lasciate al paese. Allora Giuseppina di zio Stefano non la vedremo più. Baci, abbracci, che si ripetono e, per la stanza, un odore di fazzoletti bagnati di lacrime. A turno le amiche le si siedono accanto sulla cassa che faceva da divano e le tengono la mano. Nel dondolio doloroso e lungo di quella nenia le parole “soru mia!” dovevano essere tenute e sostenute con vibrante intonazione. Tu non capivi e non piangevi. Il tuo giro di pena era ancora lontano. La nonna, un’ora dopo, ti riportò a casa. Non le ricordasti di prendermi, come ti aveva raccomandato. Io, dal mio cantuccio, nel povero e buio corridoio, non potevo fare altro che accogliere, nel mio scheletrico ricettacolo di pipistrello, ogni voce, ogni rumore, ogni respiro. E, soprattutto, quel lamento, mentre le amiche tutte si passavano la “morta” chiamata a nozze in America. Sapevo che un giorno ci saremmo incontrati e che avrei dovuto raccontarti ogni cosa. Essere dimenticati non ci sottrae al nostro destino, ma a voi la dimenticanza non risparmia, nel tempo, il dolore struggente del ricordo. 3 Dopo la partenza di Giuseppina, rimasi non so quanto tra quelle mura, dimenticato da tutti. La casa al buio, per mesi. Una mattina mi svegliai nelle mani di Cicco. Mi aveva ripulito del calcinaccio che mi nascondeva tra i mattoni di una parete abbattuta. Mi dovette solo sistemare una stecca che si era contorta. Per il resto ero nuovo. Cicco era contento di avere un ombrello tutto per sé. Lo desiderava da quando aveva visto le facce dei vicini ridere dietro i vetri delle finestre, quella volta che era rimasto chiuso fuori nel balcone e sacramentava mentre la pioggia e la grandine lo bersagliavano. Per questo, nella brutta come nella bella stagione mi sistemava sulla sua groppa, col manico assicurato a uncino al colletto della giacca. Le mani erano impegnate a mettere in moto le grucce corte e robuste e che sembravano avvitate a un cuscinetto sotto le ascelle. Procedeva in ginocchio, strisciando su due coppe di copertone di camion, povero e pietoso abitacolo per i suoi arti inferiori, lesi dalla poliomielite, che lo aveva strappato ai giochi all’età di sette anni. Quello strisciare era il suo annuncio per le vie del quartiere. Avevate fatto l’orecchio al suo passaggio e quando per un po’ dalla via non si sentiva quel cadenzato stropiccio, vi chiedevate l’un l’altro se Cicco era malato. Cicco era rimasto orfano di padre durante la campagna di Russia e la povera Concetta, che aveva partorito quella creatura in mezzo agli ulivi quando era giornaliera, gli aveva dato tutta la tenerezza di cui poteva essere capace. Ai primi segni della malattia del figlio aveva fatto i lavori più umili perché non gli mancassero le cure necessarie. Anche la pietà dei vicini era stata utile, prima che il sussidio di invalidità gli consentisse di avere il necessario per vivere. Mancata anche Concetta, Cicco poté conservare solo una delle stanze che don Pasqualino aveva ceduto loro in affitto. Ma si arrangiava a vivere, perché era un abile intagliatore. Con un semplice coltellino era in grado di fornire i cucchiai di legno a mezzo paese, al punto che i bancarellisti del fiera di San Gregorio si dicevano stizziti per la concorrenza. Prendeva venticinque 4 lire a cucchiaio e cinquanta a mortaio. Soltanto da Nunziatina non prendeva niente, perché era stata la sua catechista e lo faceva andare come chiudifila, dietro ragazzi e ragazze, durante le processioni religiose. Era poi insuperabile nell’allestimento degli altarini, con papaveri, margherite e rose lungo le vie del paese che ogni anno venivano percorse dal Corpus Domini. E Nunziatina, per via di quelle artistiche prestazioni, gli faceva acquistare prestigio e importanza anche nella congrega che eleggeva il comitato della festa patronale. Ma Cicco era, soprattutto, l’eroico difensore dell’oro di San Rocco. Lo stesso don Biagio, ogni anno, durante la novena, quando la folla dei fedeli era in ginocchio e occupava persino la piazza antistante la chiesa, ricordava dall’altare l’azione compiuta da Cicco. E Nunziatina, baciandolo sulla guancia, a nome della congrega e di tutto il paese gli offriva le nuove figurine del santo pellegrino che indicava le proprie ferite, accompagnato dal cane devoto e guaritore. I ladri (balordi, come si seppe poi, venuti da paesi vicini) erano riusciti a forzare la cassetta contenente gli ori che durante la processione di agosto, come ogni anno, erano stati offerti al santo. Tutto il paese dormiva. Stavamo rientrando dalla passeggiata notturna. Cicco era solito portarsi fino allo spiazzo del frantoio e da lì aspettava che si spegnesse la luce della stanza di Nunziatina. Era la sua maniera di darle e di darsi la buona notte. Arrivati davanti alla chiesa di san Rocco, sentì dei rumori sospetti. Poi persino un bisbiglio. Si accostò piano alla casa di Carmelo, che proprio in quei giorni veniva ristrutturata, e si nascose tra i sacchi di cemento e di sabbia. Ebbe modo di sbirciare una figura col volto coperto da un fazzoletto sistemare in un borsone gli oggetti che un altro gli porgeva dal buco di un muro della sacrestia. Cicco intuì il misfatto sacrilego e incominciò a fremere per l’indignazione e, soprattutto, per le proprie condizioni che lo rendevano impotente di fronte a quel pericolo. 5 Improvvisamente i due malviventi si sentirono gelare il sangue da una voce cavernosa che fendeva l’aria dicendo: “Santu Roccu cu lu vestuni veni mu pigghia a dui latruni! …” I due guardarono verso il luogo di provenienza della voce ma non videro che sacchi, e Cicco, che si era calata la coppola sugli occhi, non poteva essere che un sacco. Intanto si erano illuminate delle finestre e si sentivano le voci delle famiglie svegliate dal tormentone di quella filastrocca ossessiva, come da un vecchio settantotto giri dal solco rigato. I ladri si diedero alla fuga. Ma Cicco fece in tempo a dare un colpo di stampella in uno stinco di quello col borsone. Saltato il solco, la puntina del grammofono ora emetteva urla di dolore e bestemmie e parolacce. Il ladro venne catturato e l’oro restituito a san Rocco, che aveva ispirato l’ugola e il bordone di Cicco. Cicco sollevato e portato in trionfo fino a casa. Ma nessuno, neppure Nunziatina, era mai riuscito a convincerlo a lasciarmi a casa, almeno quando era certo che non ci fossero temporali in arrivo. Mi teneva stretto e mi accarezzava, dicendo che non mi avrebbe mai lasciato. Purtroppo, senza gambe, non avrebbe potuto cavalcarmi e volare some su una scopa, ma, un giorno, mi avrebbe usato come un pallone e, dopo un lungo giro, saremmo atterrati, infine, dietro il mondo. A quel pensiero, adagiate a terra le stampelle, mi apriva e si metteva a cantare: “Dietro il mondo – ho un bel fondo – dove faccio il girotondo!” . Nessuno lo prendeva sul serio, ma tutti compativano quella fissazione del posto “dietro il mondo”, dove Cicco immaginava che un giorno sarebbe stato meno solo e meno infelice. 6 Poi avevano messo in giro la voce che Nunziatina era stata vista uscire, di notte, dalla casa del prete. Addirittura, che Nunziatina fosse rimasta incinta. Ma siccome non bastava, si disse che era quasi certo che fosse andata da una “mammana” di Pizzo, che teneva nascosti gli aborti dietro pagamento. E che non ci andava per la prima volta. Cicco non voleva crederci e diceva, agitando una stampella, che con quella avrebbe schiacciato volentieri quelle malelingue. Ma intanto Nunziatina al paese non ci tornava per davvero. E Cicco smise di difenderla. Divenne taciturno e rancoroso con la propria sorte, che gli aveva tolto, ancora una volta, la gioia di vivere. Lo vidi, specie di sera, bere a dismisura e mi pianse il cuore, ma non potevo farci nulla. E così, la cirrosi epatica finì di martoriare quel corpo che da sempre aveva dovuto trascinarsi per le strade della vita. Cicco non si fece più vedere in piazza né alle processioni. Nessuno sapeva come passava il giorno e la notte. Una sera, sul tardi, mi sorprese, perché lo udii cantare ancora, dopo tanto, la sua filastrocca del “mondo”. Ci avviammo verso la chiesa di Santa Maria e una chiave, che Cicco conservava dai bei tempi in cui partecipava ai lavori della congrega, ci fece passare furtivamente, per il cancello dell’orto, nella sacrestia. Fu un aprire e chiudere di stipetti e non ne compresi la ragione. Ma quello che non potrò dimenticare è la salita, in groppa a uno nelle condizioni di Cicco, dei quaranta scalini di legno che portavano al campanile. Sentivo il suo respiro affannoso e il ticchettio delle grucce, che Cicco puntava per guadagnare, ogni volta, sollevandosi nel copertone, i gradini della scala. All’alba, sfiniti, conquistammo la cima e ci addormentammo, con il complice silenzio delle campane… Era il secondo giorno della festa ed era appena finita la gara dei pignattelli pieni di soldi, da rompere con un bastone e a occhi bendati. Ora tutti si erano spostati verso il centro della piazza, per assistere alla gara dell’albero della cuccagna. La cima del 7 palo cosparso di sego stava per essere conquistata da Pasquale Quaranta, che aveva già messo mano sulla treccia di salsiccia che gli ballava sugli occhi. Improvvisamente, però, si udirono dei rintocchi di campana, e tutti rivolsero lo sguardo in direzione della Chiesa–madre. Nessuno era in grado di capire il perché di quei rintocchi, visto che non figuravano nell’itinerario della festa. Ma lo scampanio continuava e una voce disse che le pareva di scorgere qualche strano movimento sulla torre campanaria. Ecco che Cicco, infatti, si sporgeva dalla cella del campanile. Dalla coppola rovesciata cominciò ad estrarre e lanciare delle ostie che aveva preso in sacrestia. Eseguiva quella operazione con garbo, come aveva sempre fatto coi papaveri per il percorso del Corpus Domini. E cantava “Oh, che giorno beato – il ciel ci ha dato! … T’adoriamo, ostia divina – t’adoriamo, ostia d’amor!”. Quando l’ultima manciata di quei petali non aveva ancora toccato il suolo, sentii che intonava il suo vecchio ritornello: “Dietro il mondo – ho un bel fondo – dove faccio il girotondo!” Allora mi sfilò dal colletto, mi aprì e giù, entrambi, a inseguire le ostie. Ma fu solo un lungo urlo della folla a spaventarmi. Io e Cicco scendevamo leggeri, sfioravamo le tegole dei tetti e andammo, infine, ad atterrare dietro il muro del campanile, proprio dove iniziava l’orto di Belmonte. La folla si precipitò in quel punto, dove doveva essere avvenuto lo schianto. Ma solo io fui trovato, aperto e adagiato sul terreno degli ulivi, come sul pavimento di casa per asciugarmi dalla pioggia. Di Cicco nessuna traccia. Solo io lo vidi affacciarsi da dietro il mondo, per un attimo, farmi l’occhiolino e indicarmi, prima di scomparire, in una nube rosa un girotondo di bambini. “Io – fece Ombrello-Due – ti porto il ricordo di una festa del paese in cui sei nato. Mi hai trascinato a malincuore, per il pericolo, paventato dalla mamma, che l’acquazzone di agosto non riprendesse col suo gusto di rovinare la festa. Divenni inutile fardello nel vostro gioco preferito, quando era allestito, in mezzo alla piazza, il palco dei musicanti: recuperare tavolette e tasselli che sostenevano la cassa armonica, 8 per rinforzare le carrette su cui facevate le gare, nello spiazzo davanti alla chiesa di Santa Maria. Quella volta, però, qualcosa non doveva funzionare. Avanzando accovacciato ti parve improvvisamente che una morsa tenesse inchiodata la mia punta e che qualcuno emettesse dei rantoli. Fuggisti insieme ai tuoi compagni e non ti desti più pensiero del mio destino. “Pasticcia”, come ogni anno in occasione della festa di San Rocco, si era riempito di pasta e carne e polpette e si era ubriacato, per poi andare a russare sotto il palco, tra il vomito suo e i cani randagi che gli leccavano il naso. Già si sapeva che la notte dormiva seduto su una sedia impagliata, perché l’enormità della sua pancia gli impediva di riposare in un normale letto. Adesso sai perché, tastando al buio con la mia punta quella trippa, avevi suscitato la reazione dell’ospite strano che ormai da un pezzo navigava alla deriva di quel golfo mistico. Rimasi per tutta la durata della festa sotto il palco e da lì mi è toccato udire delle cose che vale la pena riferirti. La prima è che durante le prove di una “fantasia” della Norma udii il direttore raccomandare alla seconda cornetta di entrare a tempo sul sibemolle acuto della “casta diva”, altrimenti qualcuno del comitato della festa avrebbe potuto accorgersi del duetto nascosto. Nessuno vi aveva mai fatto caso, ma la parte di Norma, nella stessa aria assolo, veniva ripartita da due solisti. Il primo, quello che avviava l’aria, non aveva abbastanza fiato per la parte più acuta e allora, in quel punto cruciale, ci voleva un cavallo fresco a sostenere l’impervia scalata. Tanto nessuno, tra i rumori di sottofondo della festa, di ruminazione di fave e ceci secchi e spari di minipetardi, poteva far caso al geniale espediente della banda. 9 L’altra rivelazione che ti voglio fare è commovente. L’ho udita da un anziano bandista, al quale spettava il compito di segnalare, con due colpi di timpano, l’inizio del “pezzo” da eseguire. E’ la storia degli “orfani” della banda. Dalle famiglie poverissime dei paesi dove c’era una banda si prelevava, per carità, qualche bocca da sfamare e veniva accolta, con tanto di divisa, nell’organico dei musicanti. Non era necessario che suonassero, bastava che nelle marce lungo le viuzze del paese soffiassero, con moderazione e credibile distribuzione di fiato, negli strumenti loro assegnati. I batuffoli di cotone opportunamente sistemati nei clarinetti e nei tromboni facevano da complice sordina alle eventuali stonature provocate dal terreno accidentato. I comitati delle feste pagavano. E così, all’età di dieci, quindici anni, gli “orfani” potevano portare qualche soldo a casa e aiutare la famiglia. L’anno in cui piansero anche le pietre, gli “orfani” fecero la loro parte più bella. La figlia di Filomena, Palmira, stava morendo di cancro e una sera, con un filo di voce, aveva chiesto il favore di farla accompagnare fino alla chiesa con la banda. Quando venne il momento, prima che mastr’Angelo desse l’attacco della marcia funebre, quattro “orfani”, per il pudore di quella morte, si tolsero il berretto; non portarono gli strumenti alle labbra e, per tutto il percorso, li tennero abbassati. La banda suonò, naturalmente, senza di loro. Ma, proprio grazie a quella tenerezza, eseguì con più commovente partecipazione la marcia in si bemolle minore di Chopin. Filomena stava, svenuta, tra le braccia di altre madri e forse, a quelle note, sognò che la figlia scendeva dalla scaletta di un giardino e, tra le palme benedette, raggiungeva la piazza dove l’aspettavano un coro di amiche e i quattro orfani della banda. Palmira si metteva in testa il berretto di uno di questi e dai loro strumenti estraeva dello zucchero filato e lo porgeva ai bambini e ai vecchi del paese. E poi iniziava la gara con un gran premio per chi indovinava in quale zucchero filato si nascondeva la bacchetta del direttore, e tanti palloncini colorati salivano al cielo … 10 So che il tuo ricordo della festa era fatto delle luminarie di tuo zio Bartolo e dei fuochi di artificio; della pistola a tamburo coi colpi a salve che spaventavano la nonna, dei mostaccioli di mandorle e miele. Ma cosa può venire a sapere un ombrello dimenticato non lo avresti sospettato. Il destino di una cosa non passa con la festa, se questa cosa è stata contaminata dalla presenza umana. Anche noi siamo “orfani” in sordina. Anche noi, nei meandri accidentati del tempo, spesso ci dimentichiamo di tacere. Stavo per congedarmi da te, ma ecco che mi assale un altro ricordo doloroso, che non avrei voluto riferirti. E’ inutile …. è ormai dentro di me e mi stira, di una fitta dolorosa, il mio abito nero e liso dal tempo. Qualcuno mi avrebbe recuperato, dopo il terzo giorno di festa, insieme alle altre cose da portare nel camion della ditta. Invece dovevo rimanere ancora altri due giorni al mio posto, con sulla pedana una cassa di zinco e la folla attorno che piangeva la sventurata sorte di Gerardo … Era un arcangelo, con le cosce da soldato tedesco, l’unico della squadra operaia che valesse la pena vedere in pantaloncini corti. Le ragazze lo sbirciavano dalle finestre socchiuse, quando, sotto il sole di agosto, sistemava i pali degli archi coi tiranti o li assicurava ai balconi delle case. In alto, poi, sulla scala grande con le ruote di ferro, ficcando i polpacci tra i pioli, non gli mancava mai l’aria e, sospeso nel vuoto, svitava le lampadine o staccava con le pinze i legacci di fil di ferro. Si vantava di navigare a quelle altezze come una barca e diceva che il capogiro lo faceva venire lui alle ragazze, con le evoluzioni del suo corpo atletico. Correva voce che la mattina, nel capannone che ospitava gli operai, prima di pisciare, il suo membro fosse così eretto e duro da sorreggere la latta dei chiodi e dei bulloni, che gli altri sollevavano appena con entrambe le mani. 11 Carmela era stata sempre orgogliosa di quel figlio. Era nato grosso e sano e benché il padre se ne fosse lavato le mani, in paese sapevano tutti di chi era figlio. Persino nell’andatura, ora che s’era fatto uomo, tutti riconoscevano il passo di don Elia. Solo gli mancavano la divisa di brigadiere e la pistola d’ordinanza con cui era stato ucciso Vincenzo, un operaio socialista, durante la manifestazione del primo maggio. La provocazione era iniziata di prima mattina. Alla banda chiamata dal sindacato e che suonava l’Internazionale e Bandiera rossa, i capi del latifondo locale avevano contrapposto un manipolo di poveracci che, ben pagati, eseguivano Faccetta nera e Bianco fiore. Si cominciò con gli insulti e si venne alle mani, all’ammaccatura di ottoni e ossa, ai coltelli, al sangue di Vincenzo cane rabbioso, alla bomba a mano lanciata da Colicchio dal balcone del Municipio per vendicare Vincenzo, alla piazza vuota, cosparsa di ferite e pianti senza testimoni. Carmela diceva sempre che al suo Gerardo mancavano solo gli studi, altrimenti sarebbe diventato un attore più famoso e più amato di Amedeo Nazzari e di Rossano Brazzi. Ma intanto poteva, senza gli studi, fare l’operaio delle luminarie, montare archi e palchi per le feste dei santi patronali della Calabria. Ed erano le feste che gli consentivano di mostrarsi alle belle ragazze. E così, in un primo pomeriggio, quando sapeva che le giovani e anche le donne maritate lo stavano ammirando furtivamente, per una fatale vanità volle esibirsi, col coltello tra i denti, all’altezza di due fili scoperti … che lo tennero, in un estremo gesto di pietà, appeso e dondolante, tra l’orrore e i pianti disperati dei suoi compagni e della gente. Staccata la corrente, in quattro dovettero portare giù quel corpo martoriato, come in una “deposizione” delle icone. 12 Tutti, per due giorni e due notti, mi ferirono col dolore dei loro lamenti, invocando il povero Gerardo.” Toccò a Ombrello-Tre: “Vengo dal paese e dal tempo dei tuoi studi liceali. Mi hai lasciato nel bar di Piazza Dante. Un tuo compagno di scuola, al quale Pippo il barista mi aveva affidato, dimenticò, a sua volta, la consegna. Mi tenne in casa sua, fino a quando, resi i miei servigi o passato di moda, finii in un solaio. Da lì, per anni, ho potuto ascoltare e raccogliere le cose di cui sto per dirti. Ma l’affaccio “Belvedere”, ventilato di azzurro e della tiepida luce che saliva dalla marina, e che tu inevitabilmente associ al ricordo di quegli anni, rimarrà una quinta disanimata della mia rappresentazione. Non ti ricorderò Pino, il gestore miope dei bigliardini, che vi guardava dai due vetri spessi come culi di bottiglia; che un padre avvinazzato picchiava quando vi faceva troppo credito. E chi ha mai più pagato le centinaia di partite fatte nei giorni di pioggia, quando “tagliavate” e non sapevate come trascorrere la mattinata? O Giacomo, il povero sacrestano che sapevate terrorizzare con quella storia dei “garibaldini”. Appena spuntava incominciavate a dire, ad alta voce, che i garibaldini erano stati visti sbarcare all’alba e che dalla marina si stavano inerpicando sulle vie petrose del “purgatorio”. E allora si metteva a tremare e a correre, per non so che antica paura, alimentata dalla parrocchia locale contro l’arrivo di non so che camicie rosse … O Agostino, il tuo compagno di classe che rompeva i vetri con le potenti vibrazioni della sua risata e dei rutti cavernosi. 13 O l’equivoco tragicomico di Antonella, la figlia di Ciccillo “gagliardetto”. Il padre ce l’aveva con la malapianta della democrazia, che aveva consegnato l’Italia ai comunisti e a scuola non si parlava che di sesso e di politica. Tra la nostalgia per i bei tempi del ventennio e il puritanesimo ad oltranza delle pareti domestiche, la figlia si era trovata a frequentare la quarta ginnasiale senza sapere cosa fossero le mestruazioni. Una mattina, nei bagni del liceo, s’era vista le mutande sporche di sangue, che colava per le gambe. Presa dal panico si era messa a strillare uscendo sulla strada e invocando aiuto, come una povera ragazzina appena sfuggita a uno o più violentatori. La solidarietà per lei e l’indignazione per il fatto avevano, in pochi minuti, sollevato l’intero paese. Il medico del prontosoccorso e i carabinieri non poterono che prendere atto dell’equivoco e riconsegnare la spaventata e illibata Antonella alla comunità e ai suoi compagni di classe. O il castello (‘u casteju), dietro il quale andavate a fare a pugni, quando avveniva qualche disfida. Vuoi che ti riporti quei giorni di maggio, passati tra gli scogli della marina, quando i tuoi compagni erano ancora in classe per le ultime interrogazioni? E la sabbia che papà, a casa, rovesciava in mezzo alla stanza dalla tua cartella, per dimostrarti che non eri stato a scuola? No, non sono qua, almeno io, per rievocare atmosfere e figure su cui adagiare comodamente la tua nostalgia. C’è un volto che invoca la tua memoria tarda. Un volto pallido e smorto, levigato dai venti di salsedine ancora dopo quegli anni e quei luoghi. Alta figura e spalle curve, come se dovessero farsi perdonare lo slancio insolito della persona. Una cornice di 14 capelli neri, a spazzola, delimitava quella fronte timida e dimessa che si faceva dondolare dal tronco durante le interrogazioni alla cattedra. Ferma la mente su quel volto: non è più tra i banchi della tua classe. E’ nella sala di attesa di un ospedale. Da dieci giorni vi è ricoverato Nino, il suo bambino di sette anni, forse affetto da male incurabile. Vedi i suoi occhi, che ricordi timidi e sfuggenti, ora fissi nel vuoto, come se non si fosse ripreso da un trauma antico. Viene chiamato dal dottore, che gli parla di linfoma e di qualche speranza nella chemioterapia … Pasquino non si dava pace. Non mangiava, non dormiva. Quelle ore stressanti, tra ospedale e ufficio, lo avevano ridotto una larva di uomo. Si portava il Valium in tasca e, per un po’, ne sentì l’effetto consolatorio. Ma i dissapori con alcuni colleghi aumentarono, nell’amaro lievito di quei giorni, la sua angosciata solitudine. E pesò come mai il clima di astio e di diffidenza che i più solerti nell’infame esercizio del mobing gli avevano creato, in ufficio, in quegli ultimi mesi. Uno in particolare lo odiava, uno dal cognome inglese e dall’accento napoletano, che lo conosceva da quindici anni e che lo aveva messo in cattiva luce col direttore. Lo odiava dal giorno in cui Pasquino aveva offerto una bottiglia di champagne da bere coi colleghi mentre annunciava la nascita del suo bambino. L’altro non riusciva a mettere incinta la moglie. Tutte le volte che Pasquino parlava del piccolo Nino, era una scossa di odio verso il giovane padre. E tra sorrisi e ipocrisie crebbe, strisciante fino allo scranno del potere, la serpe dell’invidia. Proprio nel momento più bello della sua vita Pasquino si trovò a dover dare spiegazioni, convocato più volte negli uffici della direzione, di alcuni libri scritti dalla sorella filocastrista e dei quali lui avrebbe fatto omaggio ai colleghi. E, cosa più grave, al crescente interesse per la propaganda politica risultava corrispondere uno scarso e lento disbrigo di alcune pratiche assicurative. Il delatore tranquillizzava Pasquino, dicendogli che, per quanto era in grado di poter capire, nulla era mai trapelato di negativo nei suoi confronti. Il clima di ostilità che 15 avvertiva era una sua impressione gratuita, dovuta a semplice depressione, che tutti possono provare. Ma intanto gli era stato notificato, al ritorno dalle ferie, di essere stato assegnato ad altro ufficio, con minori responsabilità. Nessuno gli chiese il perché di quella dislocazione. Non era il mondo che lo schiacciava e, forse, non era il destino che lo aveva preso di mira. Ma se è vero che da qualche parte qualcuno culla pietosamente il nostro dolore nella luce del giorno, ognuno dovrebbe potervisi scaldare. Invece le stesse sofferenze di Nino parvero al padre inflitte come atroce e beffarda variante di quella persecuzione. Maria, anche lei distrutta, non poteva aiutarlo, perché nessuno sapeva staccarla dal lettino del figlio. Quella creatura che si lamentava, tra la febbre altissima e i continui sudori, era lo stesso bimbetto che, al ritorno dal lavoro, gli saltava tra le braccia e gli dava i baci col pizzicotto? Chiese, più volte, a Dio che passasse a lui tutte le tribolazioni del figlio. E lo visitò il pensiero che tutto fosse soltanto un incubo. E l’incubo venne. Una notte sognò che Nino era caduto in una buca e che occorreva una corda per raggiungerlo e salvarlo. Ma la sola corda che si vedesse nei dintorni era quella che pendeva da una trave, con un uomo impiccato. Allora si arrampicava per sciogliere quel cappio ma, arrivato a quel corpo, si accorse di essere proprio lui stesso l’impiccato. Si portò per istinto le mani al collo e si svegliò. Tra i singhiozzi invocava il nome del figlio. Era solo. Vide che non erano ancora le sei, ma si alzò dal divano su cui si era addormentato vestito, rimise il cappotto e si avviò con la macchina alla periferia del paese, dalla parte dei mulini. Aveva nevicato tutta la notte. Pasquino pensò di scendere e sedersi in mezzo a quel silenzio. Da tanto tempo non guardava il cielo e ora che lo vedeva buio gli parve più vicino, più alla portata della sua disperazione; 16 come il saio nero di una madre, sulle cui stratte filiali si sarebbe calata, prima o poi, la consolazione di un sorriso. Fece un sospiro profondo e accarezzò la neve. Volle prenderne una manciata ma si accorse che qualcosa gli impediva di sollevarla: un filo di ferro aggrovigliato gli pungeva la mano. Allora gli venne in mente il cappio del sogno; capì il senso di quella buca da cui Nino non sarebbe più uscito e del proprio desiderio di morire piuttosto che vivere senza il figlio. Ora si sentiva più leggero e camminava per la campagna imbiancata. Dopo circa due ore volle ritornare, riprendere la macchina e dirigersi in ospedale. Ma, avviato il motore, non si decideva a partire. Gli era venuto in mente il viso del cognato Luigi. Ma il viso di tanti anni prima, davanti a un tavolo, che lo prendeva in giro perché lo aveva vinto al gioco delle carte. E anche scomparso quel tavolo, quel viso continuava a ridere col cinico sarcasmo che si riserva ai vinti, ai vinti dalla vita. E anche scomparso quel volto, rimaneva un profondo rancore per quella figura, perché aveva riferito alla suocera che Pasquino si stava imbottendo di Valium e di altro ancora, per non pensare alla disgrazia del figlio. Era vero che il Valium, somministrato in larghe dosi, aveva innestato su quei poveri nervi l’assuefazione. Ma forse che avrebbe potuto meglio trascorrere le notti e i giorni, pure al pensiero delle lacrime versate dalla mamma? E non era lo stesso cognato che, come altri parenti e colleghi di lavoro, gli aveva negato il prestito necessario per portare il figlio in una clinica svizzera, dove forse glielo avrebbero salvato? Cambiò itinerario. Trovò solo Luigi, il quale non ebbe il tempo di dirgli “ciao!” che una pallottola lo stese a terra. Pasquino riaccese il motore e sgommò verso la campagna innevata. La sventura stava per toccare il fondo di quei giorni avari di speranza. Doveva essere un incontro col nipotino di sei anni, forse perché in lui avrebbe sentito ancora, sano e felice, il figlio che non sapeva più riconoscerlo. Chiese che per l’arrivo dei cugini dal 17 Belgio il bambino potesse uscire in anticipo dalla scuola, e lo portò con sé in macchina. Giulio mangiò una caramella e ne tenne alcune, durante il viaggio, nei pugni chiusi, nelle tasche. E chiedeva allo zio, durante quel percorso insolito, perché non lo portava a casa. Ma l’altro non rispondeva e non lo guardava. Si fermò, di colpo, entrò in una radura e strinse con forza lo sterzo, come se cercasse di aggrapparsi a una nuvola incontaminata. In quella distesa di neve la detonazione fece un breve giro tra i rami, per poi adagiarsi, come Giulio, su quel prato di luce deturpata, dove il piccolo sarebbe stato trovato bocconi, ancora con le manine nelle tasche del cappotto. Giulio e Nino, gli allegri cuginetti, potevano, finalmente, riprendere i loro giochi innocenti. Ma neppure le loro voci gioiose seppero placare, restituendola al giorno, la lacerante angoscia di quella coscienza smarrita. E così, un collega di lavoro doveva cadere stramazzato, nella propria cucina, per un proiettile che ne aveva devastato la schiena, proprio mentre si piegava sull’olio bollente, vi immergeva la forchetta e ne cavava delle frittelle per l’ospite. I vicini avevano visto con terrore Pasquino allontanarsi con la pistola in mano. Rifugiatosi in una casa di campagna abbandonata, era stato circondato dai carabinieri e solo nel tardo pomeriggio, in un barlume di coscienza, aveva accolto le parole della sorella Lucia, che col megafono, tra il pianto, lo scongiurava di arrendersi. Puoi immaginare il dolore di quelle tre famiglie coinvolte nella tragedia. Dal manicomio giudiziario in cui è stato rinchiuso, Pasquino continua a dire di non meritare nessuna pietà. Forse per questo non è ancora morto”. 18 “A me – disse Ombrello-Quattro – è toccato riportarti agli anni dell’università, a Messina, inizio anni settanta. E’ una sera di pioggia (mi pare ovvio!) in una parallela di viale San Martino. Facciamo le scale di uno di quei palazzoni umidi e freddi, per raggiungere il secondo (o terzo?) piano, dove si trova la pensione del “Ragno d’oro”. Alla fine della prima rampa una bambina ci si piazza davanti aprendo le braccia, in un gesto che voleva essere di gioco innocente, ma che per noi, a giudicare dal tuo improvviso rossore, aveva del rimprovero, quasi della disapprovazione. Facciamo la seconda rampa. Di solito venivano ad aprirci un rumore di tacchi alti e una vestaglia discinta. Invece ci accolsero un passo claudicante e un viso disfatto di donna sessantina. Furono il secondo segno sinistro della serata. Ma tu non badasti ad altro che collocarmi nell’angolo del corridoio, per scomparire in una camera che conoscevi bene. Non passarono cinque minuti che sentii uno squillo di telefono e un rapido via vai dalle stanze lungo il corridoio verso l’uscita. Una soffiata. La claudicante dirigeva la ritirata e si apprestava a convincere i poliziotti che quella pensione onorata ospitava regolarmente studenti e lavoratori del messinese e delle coste calabre. Fu in quel trambusto che mi dimenticasti e io uscii, ma non ancora per molto, dalla tua vita. Intanto, dal mio cantuccio, seminascosto da un vecchio cappotto appeso al muro, e non ancora scoperto per l’imperversare del bel tempo, ebbi modo di capire che era ripreso il giro normale delle cose, tra quelle mura, e il “Ragno d’oro” ritesseva tranquillamente le sue giornate. Prima di uscire da quella monotonia per rientrare, seppure indirettamente, nella tua vita, voglio ricordare la farsa tragica di una mattina che Sina (o Rosetta?) si era messa 19 a sbraitare, nel pianto, contro le magare che dovevano sicuramente averle preparato la “fattura”. Ben sette clienti avevano maledetto le tremila lire sbattute sul comodino, perché si erano dovuti ritirare a bocca asciutta. Ci voleva, in giornata, la visita di un parrino per la benedizione di quella stanza, altrimenti la poveretta sarebbe stata cacciata via con l’umiliante marchio di non saper fare neanche quel mestiere. Fu chiamato, non ricordo con quale pretesto, il parrino, che liberò quella stanza, quel letto, dalla “fattura”. Ora (è proprio vero che tutto il mondo è paese!) una mano mi afferrò per portarmi, senza saperlo, ancora una volta da te, nella pensione “Emilia”, vicina all’università. Un filo, certamente tessuto dal “Ragno d’oro”, legava le due pensioni. Don Franco faceva la spola di quel giro e così, una sera di temporale, dopo aver raccolto, in qualità di “esattore”, le quote delle zone affidategli, mi collocò nel portaombrelli dell’appartamento dove tu occupavi, per finire il lavoro di tesi, una cameretta. Ma tu non mi hai riconosciuto. Ti vedevo io entrare e uscire o intrattenerti nel corridoio coi ragazzi greci tuoi coinquilini, che il numero chiuso delle accademie greche e le idee politiche (mi pareva di capire) avevano riversato sulle facoltà universitarie siciliane. Dionisio Bombaris, in particolare, nonostante le spie del regime dei colonnelli, si fidava con tanta tenerezza della tua amicizia. Ti aveva raccontato della madre vedova che faceva la cameriera e gli mandava i soldi per farlo studiare e diventare chimico. Ma qualche volta i soldi, spediti puntualmente, non giungevano a destinazione. Era il modo vile che si usava per scoraggiare i dissidenti che sparlavano del governo della madrepatria. Ma la pensione doveva essere pagata e la padrona dell’”Emilia” non voleva sapere di colonnelli e di capitani. Si trattava sicuramente di scuse che quei figli di puttana si inventavano per non pagare. Il povero Dionisio non faceva eccezione. 20 Già alla padrona avevate dato il soprannome di “Picca”, perché vi diceva sempre che l’affitto era picca e che era necessario aumentare la quota. Era sempre la stessa musica. E il giorno minacciato dell’aumento di affitto era solita bussare alle nostre porte facendosi accompagnare da un baffuto energumeno che non parlava, lo stesso alla cui cortese mano (nera, stavo per dire) dovevo il mio trasloco, cioè le nuove correnti d’aria del nuovo corridoio. Eri rimasto addolorato della cacciata dell’amico greco e maturava la tua intenzione di andare via alla chetichella dalla pensione, senza pagare l’ultima mensilità. Come studente potevi non essere in grado di pagare l’affitto di Dionisio, ma potevi, almeno quella volta, non pagare il tuo. Ma alla strozzina della Picca bisognava dare una lezione memorabile, anche per il divieto vigliacco di farvi usare un vostro fornellino elettrico, in quelle camere prive di riscaldamento. Appena inserito lo spinotto nella presa, saltava la corrente, perché il contatore, predisposto dal taccagno angelo della casa, non voleva sapere del freddo cane che, specie la sera, vi costringeva a stare a letto col cappotto per studiare. E così una notte, rigirandoti nel letto e non potendo chiudere occhio, ti venne l’idea (che io continuo a disapprovare: il sangue degli innocenti …) di rapire Santina, ben sapendo la morbosa predilezione che la padrona di casa nutriva per la sua piccola. La incontravi spesso, perché dal pianerottolo che portava alla mansarda Santina aveva il libero accesso a tutte le stanze della casa. Non c’era modo più efficace di punire la Picca, che solo per voi studenti figli di cane non aveva riguardo. Una volta rapita, avreste potuto portarla da Rocco e altri due compaesani che avevano affittato un modesto appartamento, lontano, dalle parti del cimitero. La complicità sarebbe stata ripagata con una serata di godimento per il branco. Così, ti vidi l’ultima volta uscire furtivamente con una pesante valigia. Il piano era che Rocco telefonasse in pensione alle diciotto, fingendosi uno studente in cerca di una camera. Avrebbe tenuto impegnata la padrona e tu, senza essere veduto, avresti 21 imboccato rapidamente le scale. Sotto avresti recuperato la preziosa refurtiva, l’eccezionale ostaggio assicurato al laccio. L’indomani mattina la sorpresa: la tua stanza era vuota, erano scomparsi libri e indumenti. La Picca sbraitava contro di te, con intonazioni isteriche specie quando vide un filo pendere dalla finestra, penne e nastro adesivo sparsi per terra e, qui e là, i segni di una lotta violenta, come se qualcuno fosse stato costretto a lasciare quell’amorevole casa. La sera, poi, mentre la Picca sperava ancora di poter riabbracciare la sua cocca, l’anima innocente di Santina, deposto il proprio corpo nella casseruola di un’allegra brigata, già sorvolava lo stretto, tra candidi gabbiani che le segnavano la via di un mondo migliore. Adesso, dopo tutti questi particolari, ti sarai dato una ragione del tuo incubo ricorrente: sei a Messina, ma con gli anni di adesso, e corri trafelato verso il porto, perché un uomo piccolo e curvo, con gli occhiali sul naso e un registro aperto sul petto, ti rincorre e urla che la tua laurea deve essere revocata, perché proprio lui si è accorto che dai voti del tuo libretto manca ancora quello di storia greca. Se fossi un ombrello dotto ti direi, per metterti vergogna, che Socrate morente ha ricordato a un suo discepolo di essere debitore di un gallo ad Asclepio. Ma Socrate non rubava i polli della polis. Tu, pure debitore di una gallina, non hai santi ai quali sciogliere il voto e, per punizione, sarai sempre rincorso dal segretario della facoltà di lettere di Messina, signor Gallino, per via di un esame mai registrato”. Ed ecco Ombrello - Cinque. 22 Vengo dalla piana di Gioia Tauro. Sono fatto della stessa tela che un giorno si distese sotto il sole della tua terra e ne spense luce e calore. Perché un giorno, quel giorno, non una ma le mille e mille madri della Piana si calarono sulle labbra amare il manto bruno del pianto…. Rimasi assorto nella penombra del corridoio, mentre sul lettino di Giuseppe ti eri appisolato per smaltire il buon vino fatto da suo padre. Sarebbe passato Mimmo, verso le quindici, e vi avrebbe dato un passaggio fino al liceo di Palmi, dove frequentavate il corso abilitante, E chi pensò più a me, passato il temporale? Né ti curasti, dopo, di recuperarmi in qualche modo. Né vi udii più scandire solennemente i versi sugli eroi greci che bevono, combattono e muoiono, avvolti dalla nera Moira… Dovevo rimanere, per tanto tempo, chiuso tra un vecchio baule e la parete del sottoscala. Proprio dove mi raggiunsero, una sera, e mi straziarono, le laceranti urla di un padre e di una madre. Il brigadiere, erano appena passate le ventidue, li aveva dolorosamente informati dell’uccisione di Giuseppe; prelevati e portati in una camionetta perché identificassero il corpo martoriato del figlio. Sotto il pergolato della trattoria, dove coi compagni di partito aveva festeggiato la vittoria elettorale, Giuseppe guardava il cielo con gli occhi sbarrati, in una contrazione dolente e interrogativa. Ancora sorpreso, nella morte, di quella morte …. Eri tornato dal servizio militare. Ti aspettava, ormai, qualche sporadica supplenza e il corso abilitante e poi, forse, ancora una supplenza, fino alla definitiva sistemazione come insegnante. 23 Ma i mesi passarono e di lavoro neanche l’ombra. E trovasti intorno a te il crescente disamore, che ti fa sentire più triste e più solo, quando non hai i soldi per le sigarette, e neppure per riparare un vecchio ombrello. Il paese dove eri tornato non era affatto cambiato: era amministrato dagli arroganti di sempre. Bisognava procurare al più presto l’abilitazione e allontanarsi ancora, alla ricerca del pane. Ma la tua generazione aveva avuto il dono dell’utopia. Trovasti amici e compagni coi quali immaginare ancora un futuro di giustizia sociale e di fratellanza universale. La Cina, Cuba, L’Unione Sovietica e i Paesi dell’Est sarebbero stati sempre modelli sospirati e lontani, se non si aveva il coraggio di restare e incominciare a vincere, sul proprio territorio, il cancro della rassegnazione e dell’immobilismo sociale. In quegli anni, lo so, nulla poteva gratificare un giovane comunista quanto il sorriso fiducioso e l’affetto di un bracciante, di un contadino, di uno studente. Era la tua rivoluzione… E accanto alla politica, in quella tarda primavera della tua vita, conoscesti momenti di passione tenera e struggente, come tutto quello che si deve lasciare. E venne l’amicizia generosa e allegra di Giuseppe, Luciana, Lelia, Carmela, Fulvio. Così aveva rivelato la sua fatalità il corso abilitante, a Palmi… E fu dopo la tua partenza che una sera sentii l’allegra comitiva, a cena in casa di Giuseppe, rievocare alcuni momenti della vostra amicizia. Giuseppe, come era solito fare, con sardonica ironia e ammiccando a una malinconica presenza, ricordò che a più di un galante convegno, lungo la strada che portava alla pineta, ti eri presentato claudicante, per via di un chiodo in una scarpa, che rispuntava caparbio e doloroso. Dovevi ogni tanto abbassarlo con un sasso, per poter riprendere il cammino. E diceva, tra le risa, che proprio tu che eri solito levarti i sassolini dalla scarpa non eri stato in grado di far sloggiare un chiodino. E Luciana aggiungeva di non essere sicura se in quel piccolo martirio non ci fosse la nemesi pateticamente 24 invocata da lei e dalle altre colleghe, alle quali durante una festa, a casa sua, avevi pestato i piedi nel goffo tentativo di ballare. Poi si decantarono le tue doti di imitatore e il divertimento che eri quando, nell’aula del corso abilitante, in attesa che arrivassero i professori, ne imitavi voce e mimica. Ti riusciva, soprattutto, di contraffare la voce e i gesti del presidente del corso. Riproducevi l’espressione del suo volto contratto, con gli occhiali scivolati sulla punta del naso, e la persona tesa in avanti, come nella spasmodica attesa di infilarsi una supposta. Fulvio ricordò che quell’aula aveva dovuto ospitare, spesso, anche la tua voce (la meno convincente) di cantante lirico. Qualche applauso e molte risate. Ma non una sola richiesta di bis. E si finì per ricordare il tuo impegno politico di comunista che aveva sperato di cambiare il destino del mondo e, con esso, della Piana. Giuseppe ti rivedeva ancora con l’Unità e il Popolo sotto il braccio, emblematici organi di stampa che salmodiavano quel “compromesso storico” respinto con diffidenza dai vecchi compagni della base del partito. Eppure, ora che anch’egli si era iscritto al PCI, si rendeva conto di quanto amaro fosse sentirsi costretto ad andarsene, e giocarsi l’identità di piccolo intellettuale organico al movimento operaio e contadino. E qui Giuseppe chiuse con un pittoresco suo “eh, quei cani!” Apostrofe con cui aveva sigillato anche i saluti in una cartolina che ti aveva inviato a Torino… E anche quella volta ero stato con voi, a Palmi. Era giorno di mercato, ricordo, e volevate farvi un panino, perché a stomaco vuoto sarebbe stato ancora più indigesto il pur dietetico commento alle terzine dantesche che vi attendeva al corso, nelle ore pomeridiane. Un uomo paffuto e rubicondo affettò dal banco la mortadella, ma disse, con rammarico, di avere già venduto tutto il pane. Una donna, certamente una madre, già sull’uscio del negozio, tornò indietro e tirò fuori dalla borsa di vimini un pane, che 25 spezzò e volle dividere con voi (“dui giuvani”). E fu vano il tentativo di farle prendere dei soldi. Poi, mentre seduti su una panchina dell’affaccio sulla piana mangiavate il pane, Giuseppe disse che alla scena della generosità di quella donna, al mercato, avrebbe dovuto essere presente anche il professore del corso di letteratura italiana. Si era detto scandalizzato perché una donna del popolo aveva bestemmiato al “fegato della Madonna”. E al fegato dei poveracci aveva mai pensato? Forse, per una contaminazione inconsapevole di credenze religiose, l’aruspicina divinazione spingeva ancora quella donna a sollecitare con le imprecazioni il fegato della Madonna, e chiedere così, a suo modo, alla Madre delle madri quando la miseria avrebbe smesso di angustiare i diseredati. Era una forzatura, una stronzata – Giuseppe lo ammetteva – ma l’illustre professore che non smetteva mai di esaltare i modi civili del Nord, specie di quella Trieste dove vivevano i suoi cognati, non sapeva che nel Sud erano più frequenti le occasioni di bestemmiare, per la povera gente? Forse che Ecuba, per Euripide, era stata sacrilega a chiedersi se fosse il vuoto etere o il Padre degli dei a guardare con cinica indifferenza la sventura dei vinti? E così, tra un boccone e l’altro, citando e scagionando dal cipiglio filisteo non so quante materne viscere nobilitate dalla poesia, passaste in rassegna le bestemmie più strambe che avreste potuto inviare al professore. E davanti a quella ringhiera passarono allora, in processione, le tante madri dolorose del Sud, come circonfuse di nebbia, evocate , e subito spente, da un limbo, tra il mito e la storia. Tra le tante spiccava Elisabetta, la madre dei fratelli Vinci, che col braciere in testa, poggiato sulla corona di un grosso fazzoletto inumidito, percorreva a piedi, all’alba di almeno tre giorni alla settimana, chilometri e chilometri, mentre nella pignatta, tra la cenere calda, finivano di cuocere, piano, i ceci o i fagioli. Era il piatto caldo per i due figli che studiavano a Vibo e non potevano, oltre all’affitto, 26 pagarsi da mangiare. E la seguiva, a non molta distanza, lungo quell’asfalto senza fine, Concetta, che voleva raggiungere un uomo morto sul Golgota e portargli, stringendosela sul petto, la piccola veste bianca e azzurra della bambina che un killer della mafia le aveva straziato a pallettoni, perché involontaria testimone dell’assassinio del vicino di casa… Poi non ti vidi più. Fui dimenticato ospite di Giuseppe e dei suoi genitori. Egli si gettò a capofitto nella politica. A nulla servivano il greco e il latino se non cambiava la vita civile del Sud. Se una raccoglitrice, negli anni settanta, poteva marcire, con la schiena curva sulla terra in mezzo agli ulivi, dall’alba al tramonto per il compenso irrisorio di mille lire al giorno. Se per ottenere un lavoro un uomo doveva bussare alla casa di don Cristiano, dopo l’inutile attesa di chiamata dall’ufficio di collocamento. Dall’anatomia di quel sottosalario, del discredito e della sudditanza dei poteri istituzionali Giuseppe capì che occorreva una lotta senza quartiere alle prepotenze dei mafiosi e dei politici che li proteggevano. Fino a quando non gli venne la generosa stravaganza di provocare don Cristiano, passando colla macchina della propaganda sotto i balconi della sua villa e alludendo, con l’altoparlante, ai galantuomini amici dei mafiosi che, sotto la maschera istituzionale, nascondevano i giochi di potere per arricchirsi e fare arricchire le cosche che li avevano fatti eleggere. Anche alcuni amici d’infanzia, lo sapeva bene, erano stati irretiti come manovalanza dalla mafia. “Qualcuno” aveva sulla coscienza anche quel povero ragazzo che era stato vittima di lupara bianca perché, usato come killer di uno dei delitti più indagati, era divenuto un testimone scomodo. Tutti sapevano a chi si riferiva Giuseppe: ragazzi, assunti come corrieri della droga, venivano poi “battezzati” e avviati alla perdizione. Non era quella la via per il lavoro dei giovani disoccupati della Piana. E avvenne, proprio in quel periodo, lo scandalo della Cooperativa delle arance. 27 Quando i corrotti dalla mafia vennero arrestati, confessarono che erano stati avvicinati e invitati in una cascina di don Cristiano. Dovevano solo chiudere un occhio sulla pesatura delle arance e sul numero dei “viaggi” compiuti effettivamente dai camions. Fu la prima volta che il nome del sindaco passava dalle labbra socchiuse della gente ai caratteri stampati dei fascicoli delle preture e a quelli dei volantini diffusi da Giuseppe e dai suoi compagni, davanti al Comune. Davanti al cancello della villa del primo cittadino altri compagni lasciarono un cestino con delle arance marce. Ora che il ferro era caldo bisognava batterlo. L’opposizione faceva il suo lavoro, in Consiglio. Ma Giuseppe volle subito sollevare l’illegittimità del progetto della Giunta di far passare come edificabile un territorio che lui riteneva, invece, di interesse storico archeologico. Ne erano testimonianza i recenti ritrovamenti di resti di un tempio arcaico, risalente alla colonizzazione locrese. La Sovrintendenza archeologica aveva dato ragione all’opposizione. Il CO.RE.CO. avrebbe bloccato l’iter di approvazione della delibera. Durante una seduta del Consiglio incominciò ad essere condivisa, anche da parte di alcuni consiglieri della maggioranza, la tesi dell’illegittimità. La seduta fu aggiornata almeno nove volte e, ormai, si parlava di crisi dell’amministrazione comunale. Fu allora che una notte, saranno state le due, sentii una macchina avvicinarsi nella via e improvvisamente partire delle scariche di mitraglietta contro la porta. I proiettili impazziti nelle carambole andarono a conficcarsi nel muro del sottoscala. Alcuni, deposta la loro furia, si fermarono presso il mio puntale, non senza avermi prima colpito qui, dove, a ricordo di quella festa, mi sono rimaste due stecche spezzate. Giuseppe dal letto si era precipitato alla finestra della sua camera, senza fare in tempo a scorgere la macchina che si allontanava. La madre e il padre erano rimasti terrorizzati nel loro letto. Urlarono più volte il nome di Giuseppe, finché non furono da lui rassicurati che tutto era passato. 28 Sicuramente si trattava di bande di ubriachi che si divertivano a spaventare la gente, a quell’ora di notte. Ma il silenzio in cui ricaddero la via e quella casa accompagnò, ancora per buona parte della notte, i pensieri di Giuseppe. E ci fu un altro episodio. Meno equivoco e , questa volta, nella luce più solare: un pacco postale, consegnato sulla tavola imbandita di un mezzogiorno. Conteneva un vaso. Uno strano vaso nero, nella cui parte centrale spiccavano figure bianche di corpi umani stilizzati, capovolti. Ancora più singolari le didascalie riportate sul cartellino che accompagnava il vaso: Reperto: 240 Tipologia: vaso per ceneri rosse Epoca: XX secolo d.c. Scuola: Pirabalos Provenienza: ignota. Giuseppe disse ai genitori che si trattava di un regalo che un amico archeologo di Nicotera gli aveva promesso da tempo. Ma in cuor suo sapeva di quale significato sinistro quel regalo era portatore. La scuola di Pirabalos (“lanciatore di fuochi”, alias “lupara”) altro non era che l’onorata società che stava preparando l’urna funeraria per lui comunista. Né gli sfuggì il cinico e beffardo sarcasmo di quel “XX secolo dopo Cristo”. Rimaneva l’enigma di quel numero 240. Ma almeno a quello non volle subito pensare. Fu all’indomani, alla fine di un direttivo della sezione, che, tornando a casa, gli venne in mente che quel numero poteva essere una sorta di requisitoria per le lotte di giovani che aveva guidato vittorioso contro l’esproprio privato di quel terreno di interesse archeologico. Doveva trattarsi del numero della delibera che la Giunta si era vista invalidare, e con la quale avrebbe potuto contentare tanti amici degli amici che ancora non si erano ingrassati abbastanza con la speculazione edilizia. La conferma gli venne dal segretario comunale. Era ormai tutto chiaro. 29 Perché era pur sempre lui, Giuseppe, quel figlio di cane che qualche anno prima se lo ammazzavi nemmeno lo pagavi, tanto era povero e solo. Adesso era rimasto povero, ma non più solo. E la baldanza non gli veniva dal suo partito, grande e lontano, di “lotta e di governo”. Erano i poveracci che aveva saputo scuotere, andando nelle loro case a misurarne la disperata e rassegnata sudditanza alla mafia. Potevano toccare la sua carne di contadino che non tremava davanti a nessuno, perché la cultura e la coscienza politica gli scaldavano il desiderio temerario della sfida e del riscatto. Avvenne così che fu il primo comunista eletto, con più voti dei candidati democristiani e socialisti sostenuti dalle potenti cosche mafiose. Quella ostinata e vittoriosa denuncia delle losche pretese del sindaco sulla cooperativa e su quel sito archeologico aveva messo in crisi l’amministrazione, con le conseguenti dimissioni del primo cittadino e della giunta. Era seguita la gestione commissariale, che aveva bloccato tutti i progetti ambiziosi della maggioranza. Una nuova stagione di battaglie, e più efficaci, sarebbe venuta dai banchi del Consiglio comunale… Il resto lo sai. Ho compilato questi grumi di storia come li ho colti, a volte sfumati dagli spifferi frequenti che visitavano il mio angolo; altre volte ancora tiepidi dei sospiri amari, risaliti dal profondo di un pozzo senza luce. Ho impiegato quasi vent’anni per trovarti. Prima di darci convegno per questa notte, ho tentato, più volte, la strada del rimorso per il Sud, fatta dei viottoli che ti portarono, un tempo, al fiume, tra gli aranci e gli ulivi. Ma l’ho trovata arsa di salsedine e di asfalto. Ora vengo a ricordarti quello che, lasciando i compagni, hai finito per dimenticare: a ogni stagione il Sud è zolla rivoltata, a scaldarsi di luce senza pane… Eh, quei cani!…” 30 “Eri soddisfatto – disse Ombrello-Sei – dello schizzo di quel paesaggio. Avevi sempre desiderato cogliere la luce spettrale che dalle nubi, dopo il temporale, si specchia nelle acque del Po. Quel tratto di curva grigio-verde, tra il cimitero di Sassi e San Mauro, si era più volte sottratto alla tua matita. Ma quella volta era fatta. Con quegli appunti e le impressioni luminose ancora fresche sarebbe stato più facile il trasporto su cartoncino coi pastelli a olio. Ti avviasti di passo nel viottolo verso casa, dimenticandomi poggiato ad un platano del sentiero che per un’ora e più era stato il tuo punto prospettico. Passai lì la notte e il giorno dopo, senza che tu venissi a recuperarmi. Poi, più che la solitudine mi vinse il sonno. Quando mi svegliai avevo ripreso il mio viaggio. Penzolavo dalla mano di un immigrato di colore, al quale non dispiacque farsi padrone di un ombrello ancora nuovo, e gratis. Rimasi con lui quasi tutto l’inverno. Mi ci volle un po’ per imparare a capire la lingua in cui Lamin si esprimeva quando era da solo o comunicava coi suoi compaesani. E allora mi resi conto di essere un ignaro complice di un clandestino senegalese, arrivato in Italia da Dakar e ingaggiato nella raccolta dei pomodori nelle campagne del casertano. Insieme ad altri extracomunitari dormiva nei loculi vuoti del camposanto, mangiava e vestiva alla meglio, nella speranza di una condizione più umana. Durante una rissa con due compagni di lavoro asserviti alla camorra locale aveva ricevuto delle coltellate e aveva deciso, ancora una volta, di cambiare aria. E così aveva raggiunto la sorella Zoe, che viveva a Torino già da cinque anni. Si prostituiva nei pressi della stazione di Porta Nuova. Così viveva e ospitava il fratello. 31 Li udii parlare sommessi, con tenerezza, alcune sere, e capivo che dovevano parlare della loro infanzia e della famiglia numerosa che il padre non aveva potuto sfamare. Qualche volta intonavano una cantilena, che persino io trovai dolce e solare. Ma li ho uditi anche litigare e insultarsi e picchiarsi, quando il danaro non bastava o, negli ultimi tempi, perché lui, dopo aver fatto lo scaricatore di cassette a Porta Palazzo, si era fatto incastrare in una rete di spacciatori. Era stato Hassan, l’amico algerino, a convincerlo. Una sera lo aveva portato nella zona di san Salvario e presentato ad alcuni del giro. Avevano macchine, orologi, cellulari, vestiario a non finire. Valeva la pena scaricare cassette o marcire dietro un banco del pesce, alle dipendenze di un pugliese o di un calabrese, magari più razzista di quelli della Lega? Baciando la povera madre le aveva promesso di percorrere la strada dell’onestà. Ma l’aveva trovata desolata e amara. Nel paese del benessere, raggiunto con tanto sacrificio, aveva vissuto mesi di stenti e umiliazioni, e riabbracciato la sorella divenuta prostituta. Non sarebbero stati lui e Hassan a rovinare il mondo. Nei momenti di rabbia più disperata anche lui avrebbe desiderato il sollievo della droga. Procurarla a chi ne aveva bisogno non era cosa spregevole. Era naturale anche quella, se era stato naturale farsi strozzare dagli scafisti, essere sfruttato dai negrieri delle campagne di Caserta, dormire nei loculi dei cimiteri. Hassan aveva ragione. Ma Zoe, se mai, portava l’esempio di loro connazionali laureati che si guadagnavano da vivere pulendo, di sera, fino a tarda notte, i locali dei supermercati. Avrebbero trovato, pian piano, qualcosa di meglio. Col senso materno che ispira le donne di ogni parte del mondo, era convinta che fosse sufficiente il prezzo del proprio degrado. Non era esaltante il suo lavoro e, per tutte, bastava ricordare l’infamante ripresa con le telecamere delle retate delle prostitute, l’attacco di sorpresa di giovani poliziotti divertiti e il fuggi fuggi delle ragazze che si coprivano il volto. Amaramente 32 terrorizzate dal pensiero di essere riconosciute, per televisione, in patria, dai propri familiari, per i quali avevano ancora un’identità. Lamin, vedendola piangere, le prometteva che avrebbe trovato un lavoro onesto e regolarizzato il proprio soggiorno. Ci aveva provato davvero e una volta anch’io feci la fila con lui, dall’alba alle tredici, davanti all’ufficio “stranieri”. Ma aveva riconosciuto, in quella fila, uno dei due fratelli che lo avevano accoltellato nel bar della periferia di Caserta, e che lui aveva denunciato. Ebbe paura e si dileguò. D’altra parte, dalla rete, ormai, era difficile uscire. Una mattina Lamin s’era visto rientrare Zoe con una guancia coperta di cerotti. L’avevano sfregiata perché il fratello non aveva consegnato a tempo una partita di droga e nessuno sapeva dove si fosse cacciato. Così aveva dovuto ingoiare l’infamia di quel pane senza pace. Fu in una sera di marzo che dovevo, almeno io, uscire da quel giro. Aveva piovuto tutto il giorno e Lamin mi portò con sé. Bisognava incontrare qualcuno ai Murazzi. Dal modo in cui l’uomo mi stringeva, doveva trattarsi di un’operazione molto importante e rischiosa. Sul ponte della “Gran Madre”, a un certo punto, Lamin accelerò il passo. Si era accorto che qualcuno ci pedinava. Dall’altra parte del ponte, dei poliziotti, armati di mitra e coi cani che a malapena riuscivano a trattenere, sembravano attendere proprio noi. Allora, dopo avermi cacciato qualcosa dentro, Lamin mi lanciò con forza contro i rami di un albero che lambivano il ponte, alla base del parapetto. Di rimbalzo andai a ficcarmi nell’intercapedine di assi di cemento, rifugio senza pretese di gabbiani inurbati e colombi residenti. Per fortuna potevo sporgere la testa e, data la posizione nella quale mi ero cacciato, non era poco. Non mi accorsi subito che tra il frastuono del via vai delle macchine sul ponte e lo scorrere del fiume, sotto, non avrei più potuto ascoltare le voci degli uomini. Proprio ora che avevo imparato a gustarne i toni e i linguaggi diversi. Ma tu non temere, non ti annoierò con un resoconto etnico sugli extracomunitari che Lamin e Zoe mi hanno fatto conoscere. Non intendo parlarti del couscous o del 33 Corano, o del modo diverso in cui gli africani suonano il violino, poggiandolo sulla gamba e non sulla spalla e tenuto col mento. Non per questo dovevo compiere il mio inquieto percorso e poi ritrovarti. Piuttosto, prima che il tuo piccolo mondo venisse contaminato dai destini dei fratelli africani, albanesi, romeni, non avresti ascoltato che con malcelata insofferenza questa mia testimonianza. Ti portavi dentro l’antico rancore di un sonoro schiaffo subito, all’età di dieci anni, da Reno, quando ti cacciò dal suo grande giardino. Era lì che abitava anche sua cugina, tua compagna di classe, della quale eri disperatamente innamorato. Rivederla fuori dalle ore di lezione sarebbe stata la tua felicità. Fu lei, invece, a vedere la scena di schiaffo e spintone quando Reno ti aveva escluso dal numero dei compagni degni di entrare in quel giardino. Su quella cacciata hai costruito, poi, episodi determinanti della tua vita. Ogni piccolo sgarbo, ogni umiliazione li vivevi con l’angoscia e il dispetto per quell’esclusione, mai perdonata, mai dimenticata. E ogni volta era il bruciore del tuo volto di allora. Persino nella tua apparizione politica doveva acquattarsi, pur tra le appassionate lotte per il Socialismo, quella antica e nuda ragione privata. In più di un comizio hai attaccato Reno, ormai anche tuo nemico di partito, perché da latifondista reazionario non voleva cedere un suo terreno per costruirvi l’asilo per i bambini. Era, in verità, sempre il tuo rancore ad ispirarti. Attraverso quei bambini, volevi far rientrare nella proprietà di Reno il bambino che ne era stato cacciato tanti anni prima. Così nobilitavi la tua piccola caduta, rivivendo la caduta dell’uomo e la sua cacciata dall’Eden. Eppure tanti, oggi, da contrade sperdute del mondo conoscono il quotidiano esodo alla ricerca di pane e dignità. E non pensano di essere stati cacciati da un giardino per averne alleggerito l’albero dei frutti proibiti. La spada infuocata dell’angelo guardiano non brucerebbe la loro fronte come il dolore e l’umiliazione dello sputo fraterno. 34 Ho visto, da quel mio nuovo punto d’osservazione, a un semaforo, un uomo inchiodare alla gogna il fratello africano. Si è fatto lavare il vetro anteriore e posteriore e non gli ha dato nulla. E’ ripartito sgommando e sghignazzando. L’altro morde lo strofinaccio che usa per asciugarsi il sudore e spegne l’atroce smorfia nel pensiero della moglie e dei figli che aspettano, in un povero quartiere di Rabat, i suoi risparmi. Ma fui anche testimone di un’altra cacciata: la morte di Abdul. Vidi, una sera, un gruppo di ragazzi prendere di mira un extracomunitario, ai Murazzi. Gli avevano rivolto degli insulti e lui aveva reagito. Arrivavano, già eccitati, da una festa per due di loro che avevano conseguito la maturità. Il giovane si rifiutava di rimanere in ginocchio davanti al gruppo. Allora in tre lo tennero per le mani e per i piedi, a terra, come un crocifisso, e gli versarono addosso i residui di birra e coca cola. Ma la preda non si arrendeva e urlava disperati improperi contro il branco, imbestialito perché sul volto di Abdul non comparivano lacrime. L’ultimo divertimento fu trascinarlo fino al bordo del muretto, sollevarlo e gettarlo in acqua. Ma l’infamia doveva ancora essere consumata. Il ragazzo, risalito in superficie, dimenava le braccia cercando di guadagnare i bordi di cemento ai quali aggrapparsi. Peggio per lui se non sapeva nuotare. Abdul finalmente piangeva e invocava aiuto. Ma per fiaccare l’istinto di sopravvivenza gli lanciarono contro sassi e lattine. Infine, gli calarono sulla testa un aspirapolvere che giaceva accanto al bidone della spazzatura. Fu la fine. I festaioli lo videro scomparire. Si guardarono e si avviarono, in silenzio, verso la BMW, regalo della maturità. Fu quella l’unica volta, da quando sono al mondo, che, solo per soffrire di quella morte, ho desiderato una coscienza d’uomo. 35 Ma non ero che una cosa. Se al passaggio del male bastasse opporre la nostra condanna, la terra sarebbe sprofondata da un pezzo. E’ per l’innocenza delle cose che dura il vostro mondo. Pure, gridai con tutte le mie forze, ma quel grido era destinato a ricadermi dentro. Desiderai morire. Poi svenni, non so per quanto tempo. Mi risvegliai nel consueto frastuono, ma l’atmosfera era mite e per me si preannunciava il lungo ozio della stagione che voi chiamate bella”. Con l’animo profondamente rattristato, specie da quest’ultima testimonianza, vedo che gli ombrelli, in silenzio, si avviano a uscire. Con loro anche due ombrelli che erano rimasti zitti. Sembravano tristi. Non ho mai visto delle teste così ripiegate sul tronco. Perché loro non mi hanno detto nulla? Hanno forse timore che qualcosa possa profondamente turbarmi? “Noi – disse uno di loro voltandosi – siamo ombrelli in grado di prevedere il futuro. Siamo quelli dimenticati nei camposanti. Abbiamo rivelato ai primi smemorati cosa li avrebbe attesi nel corso degli anni. Ma la vanità di sapere, senza la fatica di vivere, aveva eccitato i più. E nei cimiteri venivano lasciati più ombrelli che fiori. Abbiamo deciso di tacere e restare, muti, accanto ai compagni che riportano il tempo andato, soltanto per controllare la loro memoria, che una volta era il nostro futuro. Non chiederci altro!” Richiusi la porta lentamente. Rimasi, non so per quanto, in piedi, con l’animo turbato. Si erano fatte le sette. Vidi dal televisore, che era rimasto acceso e muto, scorrere le immagini del servizio meteorologico. 36 Sul tram per l’ospedale pensavo ai miei strani ospiti. Mi chiedevo se avessi fatto bene ad ascoltarli in silenzio e se non sarebbe stato meglio chiedere altri particolari su Cicco, Pasquino, Dionisio, Giuseppe, Lamin, Abdul … Perché, poi, avevano scelto questo momento della mia vita? Forse non mi rimaneva ancora molto da vivere? Ebbi, allora, la stravagante idea di dove e quando mi sarebbe piaciuto avere smarrito altri ombrelli, orchestrando compiacenti ritorni, eludendo vigili e dolenti sensi di colpa. Ma provai subito vergogna. Riascoltai nella mente il portavoce degli ombrelli taciturni: “Non chiederci altro!”. Scesi alla fermata dell’ospedale. Mia moglie mi aspettava. Inevitabilmente ognuno avrebbe rassicurato l’altro sulla tranquillità della notte trascorsa. 37 GRAFFITI Ho ancora nelle orecchie lo scroscio dell’acqua rotta dai residui frantumi di cemento intorno al ponte, cosparsi di detriti. Mi ero accostato con la bicicletta a studiare dei graffiti che mi avevano incuriosito. Vidi che, come in altri punti del percorso, essi intrecciavano sogni, maledizioni, orgasmi, nel babelico e furtivo plurilinguismo metropolitano. Dal bisonte rupestre di Altamira ai risorti manifesti elettorali di Pompei, ai “puttana Davide è mio!” o “al punto gioco tutti al rogo” di corso Casale, sul muro adiacente a una pensilina del 30 per Chieri, un’instancabile mano continuava a lasciare il suo ieratico segno. Viterale (Giovanni?) in quella seconda “A”, al corso di pittura, non doveva insegnarmi i segreti del graffito? Per una miseria di tecnica a olio o per uno scarabocchio di sanguigna, quanta preziosa rivelazione di quell’arte trasgressiva, che con quattro lettere in rilievo, segnava l’esproprio innocuo e stravagante di grosse porzioni di demanio! Finivo di leggere una scritta che terminava nella parte posteriore del muro, quando, sfiorando l’angolo, l’occhio fu catturato da una strana visione. Sotto l’ultima arcata del lato opposto del ponte, al sommo di larghi strati di cemento, al riparo dal sole, un uomo, forse un ragazzo, piegato in avanti, mi pareva che soffiasse in un sassofono e che stesse eseguendo una musica di fogli svolazzanti, trattenuti alla meglio sul leggio di un treppiede. Non mi giungeva una sola nota di tanto sforzo, a causa del via vai delle macchine sul ponte e dello scroscio dell’acqua. Associai subito il movimento dondolante dell’afono solista all’altro, altrettanto sfiatato e liturgico, delle donne che, sfinite e senza voce, avevo visto un tempo, nel Sud, piegarsi sulle tombe, invocare nomi e volti scomparsi, il giorno dei morti. Mi recai, risalito il ponte Regina, sul luogo del suonatore solitario. Ma se ne era già andato. Sul posto solo qualche traccia di pentagramma ingiallito e senza note. La 38 raccolsi e mi guardai intorno. Pensai a quella strana performance che avevo visto. Era possibile studiare uno strumento in mezzo a quel frastuono? Forse nella mansarda del palazzo doveva viveva non gli era consentito suonare? Era un “matto” che simulava un’occupazione così divertente e misteriosa, ma consumata in così saggia solitudine? Decisi, infine, che la mattina successiva mi sarei presentato prima al mio posto di osservazione, per saperne di più. Ma la mia attesa fu delusa. Fino alle dieci e mezza non era comparso nessuno sotto quel ponte. Forse il mio strano personaggio aveva scelto un’altra nicchia dove starsene tranquillo. Inforcai la bici fino al ponte Sassi e, di ritorno, fino a quello Isabella. Nulla. Mi ricordai che non avevo preparato da mangiare per me e per mia moglie (lei lavorava ancora, part-time, nel suo ufficio). Ritornai a casa. Passò una settimana. Avevo ormai rimosso quell’episodio. Ma, una mattina, rividi il solista solitario, mentre percorrevo la pista ciclabile appena ricavata dalla sponda adiacente al vecchio zoo. Era lui, stava suonando il suo sassofono, con la stessa tuta grigia e il copricapo rosso. Pedalai con forza per non farmelo scappare ancora e decisi di raggiungere quella volta del ponte per la strada che, al momento di andarsene, avrebbe dovuto percorrere. Non impiegai più di sei minuti. Anche questa volta, però, l’uomo era scomparso. Ma per poco, pensai, perché aveva lasciato il leggio del treppiede, con su dei fogli e una matita. Attesi più di un’ora, inutilmente. Vidi, seduti sul margine, due uomini che pescavano. Mi avvicinai al primo e gli chiesi se per caso poteva indicarmi in che direzione era andato il giovane che suonava il sassofono. L’uomo non si voltò neppure. Portava degli occhiali neri e sembrava troppo intento a osservare il punto in cui aveva affondato l’amo. Feci dieci passi e rivolsi la domanda al secondo. Ma neppure questo mi rispose. Vidi che aveva un auricolare da walkman e che non mi ascoltava. Altre canne si sporgevano lungo il Po, ma così lontane che non potevano essere inutilmente scomodate. Intanto, con mia grande meraviglia, era scomparso persino il leggio. Allora pensai che qualcuno, forse, si stava divertendo alle mie spalle. Mi guardai intorno, cercando qualche volto sornione che spiava divertito la mia inquietudine. Ma ogni cosa mi 39 appariva immersa nella normale indifferenza di una normale giornata di maggio. Una giornata che non varrebbe la pena ripercorrere se non mi avesse toccato là dove, da sempre, l’uomo crede che possa essere agitato qualche fondo di luce. Perché, forse, non per caso quella figura mi aveva richiamato le immagini di un cimitero del Sud. Forse nella memoria giacciono grumi di antichi lutti, che solerti prefiche hanno cura di risvegliare. Ricordai allora che una diecina di anni prima era morto Enzo Porretta, bravo sassofonista, pittore di talento, curioso di lingue e filosofie orientali. Già corroso dalla cocaina e dalla cirrosi epatica, era caduto, una sera, spinto da un marocchino ubriaco, nei pressi di piazza Vittorio e aveva battuto la testa, con forte emorragia. La disgrazia aveva troncato il nostro dialogo, che si preannunciava, per insistente desiderio di Enzo, fitto di appassionate discussioni sull’arte e sulla lingua greca antica. Non aver fatto in tempo a regalargli una copia dei “Canti” di Leopardi, che avrebbe voluto approfondire nel nostro dialogo, era cosa che mi addolorava ancora. Mi aveva prestato un trentatré giri con alcune incisioni di Billie Holiday. La voce di Billie era più struggente di tutte le Isotte, Violette e Mimì morenti. Lo diceva con una punta di rimprovero per quella che giudicava la mia caparbia melomania. Quando sul suo pianoforte strimpellavo qualche romanza d’opera, mi diceva che era possibile abbellirla con le variazioni del suo sassofono. E con disinvoltura farciva di un pathos tutto suo alcuni passaggi di quelle melodie che mi erano parse, per anni, intoccabili e perfette. Vedeva nell’opera la complice codificazione di quel gusto e di quelle convenzioni da cui era escluso il mondo di sofferenze e di talenti ribelli che egli amava e di cui si sentiva parte. Ma mi vennero in mente anche la madre e il padre di Enzo… Lei, da mesi, faceva le ore presso le madame della collina, perché il figlio le chiedeva soldi per pagare dei debiti ad alcuni “amici”. Luigi, già in pensione e malato di asma, scolpiva il legno. Nello scantinato di via Santa Giulia, delle arboree forme levigate 40 sembravano snodarsi in ammiccanti capriole; altre si contorcevano e si protendevano, in un ultimo anelito, a sfiorare il proprio ombelico: moderne, audaci icone di “pietà”. Ma, dopo la morte del figlio, ormai monolitico silenzio, al buio. Scivolosi trampolini per i topi. La madre mi aveva fatto vedere alcuni graffiti che Enzo, con un chiodo, aveva inciso sui bordi di alluminio del letto e su un muro coperto dall’armadio. Parole “straniere”, che riconobbi come greco antico: le tradussi con commozione “cerco la pace” e allora Santina pianse a dirotto e, sedutasi sul letto, mi teneva la mano. Mi raccontò di quando era arrivata a Torino, con Luigi e il piccolo Enzo. Aveva trovato lavoro in una fonderia ed era stato il primo “chiodo” del suo lungo calvario. Le avevano assegnato il compito di fissare con dei chiodini mani e piedi di un crocifisso di lega su una croce di legno laccato. Era una produzione in serie per le canoniche e per alcune scuole private. Doveva crocifiggere una settantina di Cristi al giorno, e ogni volta che il martelletto affondava i chiodi, quella madre dolorosa si sentiva lacerare le viscere colpevoli e piangeva. Ma non aveva scelta e tenne quel lavoro per un anno e mezzo. Passarono gli anni e, con l’occupazione in fabbrica di Luigi, sembrava che la famiglia potesse vivere tranquilla e serena. Quand’ecco la “sorti” bussare alla sua porta! La figlia Luisa, più piccola di Enzo di tre anni, senza una ragione apparente, si era precipitata dalla finestra della cucina, dopo una delirante corsa sugli zoccoli di legno e un aprire e chiudere di tutte le porte della casa. Il rumore ossessivo di quegli zoccoli ora lo udiva ogni sera, prima di addormentarsi, ed era come l’accelerare del tic tac di un orologio che, di colpo, si schianta e sprofonda nel tonfo di un silenzio mortale… Perché mi assalivano questi ricordi? Non era questo che mi ero proposto in quella passeggiata lungo il Po. 41 Ritornai allora ai graffiti che avevo lasciato. Come se mi aspettassi di cogliervi una ragione di quanto mi accadeva. Si stagliavano, sul fondo umido e grigio del muro, lettere blu contornate di giallo, in un rilievo bizzarro e vibrante e, quasi a sfidare ogni criterio di verosimiglianza, lettere serpeggianti che attraversavano le altre e formavano un nome: Nazzareno. Forse il graffitista si era firmato. Un altro graffito era rosso su fondo nero, con rilievi in bianco e azzurro. L’intreccio di parole sembrava alludere alla parola songs. Seguivano le lettere che non avevo potuto finire di leggere la prima volta, quella mattina in cui mi era apparso il sassofonista. Si trattava di lettere più piccole e tutte attaccate: Ladyday. Pensai a una seconda firma. Ma perché mai delle lettere scritte sui muri di un ponte avrebbero dovuto contenere un messaggio misterioso per me? Quanti segni rivelatori conterrebbero i graffiti sparsi per tutta la città, e per tutte le altre città? Ripresi la bici e me ne tornai a casa. Eppure, la notte mi parve di rivedere, in sogno, Enzo Porretta che mi urlava, sempre dall’altra sponda del fiume, la parola “songs”. Nello sforzo di farsi sentire gli si era sfilato il sassofono che, scivolando lungo il pendio dell’argine, veniva portato via dalla corrente. L’indomani mattina ritornai sul punto dove avevo scorto, la prima volta, il leggio del solista. Avevo portato con me un pacchetto regalo che deposi piano sopra un sasso, coprendolo di erbe e fiori. Nessuno mi notò. Finalmente avevo donato a Enzo i “Canti” di Leopardi che gli avevo promesso e che, nel sogno, aveva voluto ricordarmi a gran voce. Seppi, molto tempo dopo, quando ebbi il coraggio di raccontare quel mio segreto, che Ladyday era un soprannome di Billie Holliday. Come se non bastasse, dal tram, una mattina, vidi sulla locandina di un’edicola, a grosse lettere, un titolo di cronaca: “Clochard viene ucciso nel sonno, a sassate”. E allora mi venne in mente il giorno in cui avevo assistito alla rivolta dei barboni. 42 Saranno stati una decina, arrampicati sul grande cancello che era stato posto a bloccare l’accesso dei vagabondi, di notte, al portico della Gran Madre. Dicevano che la casa della Madre di Dio doveva rimanere aperta ai poveri. Che loro su quei gradini ci dormivano soltanto e non avevano mai fatto nulla di male. Forse qualche cartoccio di vino e qualche lattina di birra dimenticati, ma nient’altro! Il fatto è che si avvicinava il grande giorno dell’arrivo del Papa a Torino e bisognava, per tempo, ripulire ogni cosa. E poi, in una struttura che ospitava l’Ossario dei caduti per la Patria, cosa ci facevano dei vagabondi pieni di zecche? La polizia aveva disperso il gruppo degli assalitori. Ancora uno, forse il più giovane, si ostinava a rimanere aggrappato al cancello. Soltanto dopo una serie di strattoni e di pugni si resero conto che il corpo del barbone era pieno di sangue. Si era infilzato i braccio su una stecca di ferro acuminata della grata. Dovettero chiamare l’ambulanza per non farlo morire dissanguato. Seppi, poi, che lo chiamavano Nazzareno… Sempre scalzo, estate e inverno. Oppure calzato, ma con le stesse scarpe, estate e inverno. Giacca jeans, pantaloni pure, estate e inverno, di notte e di giorno. Era passato anche lui, chissà da quanto. Un altro di cui non avevo mai sentito la voce. Lo avevo visto, qualche volta, col suo cane. Ma la mente ne aveva esorcizzato la presenza, col relegarlo tra le cose: strano, bisbetico accessorio del mio sentire quotidiano, nel quotidiano scenario. Viveva delle miserie che riusciva a racimolare per sé e per Barone (generosa invenzione di quadrupede, che non poteva, forse non voleva, non soffrire l’uomo che gli parlava da quando era cucciolo). Un giorno avevano visto Nazzareno correre verso piazza Borromini. Sembrava terrorizzato. Era inseguito dai camerieri romeni di un bar, perché la padrona, mentre stava sul water, si era accorta che Nazzareno la spiava dalla finestra che dava sul cortile interno. Due fratelli proprietari di un’edicola avevano finto di dargli ricovero dietro il banco. Invece lo tempestarono di calci, perché avevano saputo che, di notte, 43 quello si divertiva a pisciare dal tetto dell’edicola dei giornali, perché così poteva pisciare sul mondo. E il cane di quel cane, per finire l’opera, segnava il territorio dove avevano deciso di passare la notte. Senza dire che da un piano alto di piazza Vittorio, Nazzareno era stato visto sbracarsi e cacare in mezzo alle macchine parcheggiate, per poi tirarsi su i pantaloni e riprendere il proprio vagabondaggio lungo le sponde del Po. Quando si sedeva al sole davanti a Palazzo Nuovo, le ragazze lo salutavano da lontano chiamandolo per nome. Si avvicinavano e si degnavano di intrecciargli i crespi e biondi capelli con acconciature stravaganti e originali. Poi, un giorno, era bastato un po’ di frittata, condivisa col fedele Barone, a liberare la zona da quella vergogna... I morti, quelli che non abbiamo seppellito in un sacro recinto della memoria, gemono, di tanto in tanto, dagli interstizi di penombra, dove si vedono ricacciati senza pietas. Non vale chiuderne le palpebre. Ci guardano. E se solo per caso ne cogliamo con tenerezza il ricordo, non per questo ci assolvono. Una mattina che passavo per il ponte Regina, pensai a quante voci non si ascoltano, che si spengono e muoiono. Come quelle degli uomini soli che, lungo il Po, piangono e pescano e pensano al poco e amaro della loro vita. Ore trascorse a pescare un pesce che vale quanto un ratto, pescato e gettato e ripescato, fino a farlo morire di vecchiaia: quando più non abbocca a rivedere le facce dolorose degli uomini e preferisce struggersi nell’acqua fetida, ma che è pur sempre il principio di tutte le cose. E anche per me, mi dicevo, sarebbe venuto il momento del silenzio, in cui nessuno avrebbe più ascoltato la mia voce di giorno, né quella di notte; nel tiepido e sterile risveglio che precede il buio. Ma intanto, intorno a me, gemeva, pur basso, il canto 44 della vita e , ricucita di biancospino, l’anima della terra sanguinava ancora. Ebbi un sussulto. Cercavo di convincermi, poiché vorace è il coito della vita, che quell’azzurro nel cielo e quel sole che scaldava le alghe e le anatre del Po segnavano la vittoria sui morti che mi avevano visitato. Quando, improvvisamente, una forza mi risospinge sotto il ponte. Si è fatto buio. Sprofondo….. Forse in una metropolitana, sulla ripida infinita scala mobile della King’s Cross di Londra?… Dove, all’incrocio di cunicoli, senza un filo di luce a risalire, malinconici minotauri accordano strumenti… Ma, al primo luccicante tintinnio di moneta, un chiaro di luna mi riporta sui Murazzi. Un sassofono brilla, portato alla deriva. Un vecchio, sulla ghiaia, a cavallo di un piccolo tronco, lo pialla e piange e ripete piano: Pinocchio è morto di overdose! Sulle sponde del fiume i pescatori si sono addormentati. Paiono vinti sul punto di intonare un coro a bocca chiusa. Di lontano, con l’amo ritirato e la canna tra le braccia, sono povere teste appese ai loro sogni. Intanto, un gruppo di ragazze cerca di consolare Maddalena. Le hanno detto che nel tardo pomeriggio, proprio cinque minuti dopo che era montata sulla macchina di un cliente, era passato Nazzareno, steso su una barella, che dormiva abbracciato al suo cane, anch’egli addormentato. Un’ambulanza li aveva portati via. E Maddalena piange a forti singhiozzi. Per non aver potuto lavare, asciugare coi propri capelli e ungere d’unguento il corpo del barbone. Nella città della Sindone. Graffiti deturpano rivoli di lacrime e di sangue. 45 TSUNÀMI “Fond-li-re ab-rof a-pe-iu-ro-fu….” sillaba il moncone osco-umbro delle Tavole di Gubbio, riportato nel testo di glottologia su cui sto preparando un esame sempre rimandato. Sono a Messina, in una gelida giornata dei miei anni di studente universitario. Il freddo della stanza mi fa battere i denti; strofino con forza le mani sulle ginocchia; ogni tanto risistemo la coperta che non riesce a scaldarmi le spalle. Se aggiungo altre calze alle tre paia che ho già infilate ho paura che il piede non entri più nella scarpa. Cerco di concentrarmi nello studio, ma non ci riesco. Ho persino le lacrime agli occhi, mi sento avvilito. Devo per forza superare questo esame. Sono al secondo anno fuori corso. La mia e la famiglia della fidanzata reclamano e sollecitano la laurea. E mi attende, subito dopo, il servizio militare. Ma, per ora, sento solo il desiderio di un po’ di fuoco, per scaldarmi. Ed ecco, improvvisamente, sul muro del palazzo di fronte vedo adagiarsi un fascio di luce. Il rosa consueto di quella facciata, come per effetto di una velatura, assume un tono giallo rossastro di Napoli. Una lama di calda luce discende giù, giù (i balconi più in alto ne sono esclusi). Mi avvicino alla finestra e seguo quella festa fin dove arriva la vista, ma ne indovino il prosieguo fino ai tetti più bassi, e ancora giù, forse sul muretto adiacente l’ingresso del palazzo, forse ad altezza d’uomo. Vorrei chiudere il libro e precipitarmi giù in cortile, dove mi attende tanta grazia. Ma non è senza pudore che uno si accorge di essere una misera cosa; scoprirsi, all’occorrenza, bisognosi di una manciata di sole, al pari di un gatto o di una lucertola. Così, misuro ogni mio movimento. Mi tiro su il bavero del cappotto, che già indossavo in casa. Mi avvicino alla porta e, piano, apro. Piano richiudo. Per le scale non incontro nessuno, ma su ogni pianerottolo mi sento come spiato nel mio imbarazzante segreto. Sono ormai in cortile. Mi appoggio con le spalle, la schiena, i polpacci al muro imbiancato di luce. Ora non saprei dire per quanto, ma sono una 46 cosa attaccata a una cosa. Una cosa che si scalda. Ma che … pensa. Per questo, il passaggio di una signora con un cane lupo mi richiama alla mente il lupo di Gubbio ammansito dalle carezze di Francesco. Ma il grande santo posto a giacere sulla “terra sola” mi fa ritornare i brividi. Lo sterile e noioso esercizio delle Tavale di Gubbio si stempera appena nella più opportuna e benefica associazione al “Fratello sole”. Ritorno su, nella mia stanza, ai miei libri. Ma l’aria fresca e quella sferzata di sole mi hanno lasciato la voglia di fare due passi per il viale che fiancheggia il quartiere. Rieccomi per le scale. Sto finendo la prima rampa, quando vedo salire una persona che me ne ricorda in modo impressionante un’altra. Anzi, è proprio l’altra… Ma non può essere lei! Cosa ci fa per le scale di quella casa, di quel giorno, di quel mio giorno, un volto che non avrei conosciuto se non cinque o sei anni dopo? Spengo la mente per vedere se le cose si rimettano nei loro abitacoli spazio temporali assegnati dalla vita. Ma Giulia è sempre lì ferma, con un sorriso amaro, che ostenta indifferenza. Tento allora io di passare oltre quelle maledette scale. Mi sento afferrare per un lembo del cappotto, ma non da lei (che ha le mani occupate dalle borse della spesa). A trattenermi è una bambina dallo sguardo tenero e ostinato, sbucata da non so dove, per accrescere la mia angoscia. Forse mi hanno scambiato per una persona che conoscono: forse è proprio questo che devo dire, se voglio liberarmi. Ma so che non è così. Rimango immobile e aspetto che sia Giulia a dirmi qualcosa. Ma, proprio in quel momento, si apre e richiude una porta di quel piano. Rimango solo e libero. Libero di ricordarmi così come da tempo mi sono lasciato in fondo alla memoria: senza Giulia, senza debiti, senza rimorsi, senza l’univoco destino del dopo, che umilia e deturpa “l’aurora dalle dita rosate”. Libero e salvo; libero di aggirarmi nel regno di ombre che non si lacerarono il volto, allora, per il mio esodo. E che non hanno, oggi, il diritto di inchiodarmi con lo sguardo. Ma non mi accorgo di fare le scale interne dal lato sbagliato del palazzo. Così ripercorro la strada di un destino che non era stato il mio. 47 Mi trovo ormai per l’interminabile Viale San Martino. Evito la Casa dello studente, che mi porterebbe diritto all’ateneo. Giungo al porto. La “Caronte” sta per salpare e mi unisco alla folla per varcare la passerella. E’ stata una magnifica idea andare al porto. Confondersi, ora che ho imboccato un altro destino, con la gente più diversa. Si parte. Mi lascio andare, seduto su una panchina tiepida, accanto a scialuppe coperte da un telo. Il profumo del mare e l’andirivieni, sul ponte, dei passeggeri, mi cullano estatico. Immagino che tra poco mi dirigerò verso il bar (è anche la prova che sei un passeggero regolare) e che prenderò un arancino, fingendo di avere fame. Ma qualcuno, davanti alla cassa, si piega per raccogliere da terra una moneta e allora rinuncio al mio posto nella fila, perché mi rammento di non avere soldi. Mi avvio fuori per riprendere il posto sulla panchina di prima. La trovo occupata. Per una scaletta di ferro imbiancata raggiungo il ponte più alto. E’ tutto quieto e tranquillo. Mi appoggio al parapetto e osservo il mare. Ora mi giungono delle voci confuse dalla cabina di comando. Si tratta di un coro sommesso, di tanto in tanto interrotto dal dialogo tra il comandante e la capitaneria del porto. Mi colpisce una parola, soprattutto, che viene ripetuta più volte: tsunàmi. Dove devo aver sentito questa parola? Non ricordo. Le acque scorrono in liscia ritirata mentre la nave traghetto avanza. La schiuma è una nitida e ritmata moviola per il mio ricordo… Ecco emergere da quelle acque il viso della mia insegnante di scienze del liceo e pronunciare quella parola. Con l’ampio gesto delle minute braccia ne mima la traduzione dal giapponese: “o-o-onda su-u-ul porto!”. Il tre che regolarmente riportavo sulla pagella, nella sua disciplina, mi fa perdere di vista la professoressa … Al suo posto, tra schiamazzi e risate, ecco il volto di Sergio! Sergio, il figlio del benefattore Lacquaniti che, in memoria del suo bambino perso nel terremoto di Messina, aveva fatto costruire un asilo. Lo avevo frequentato anch’io. Lo riconosco, è lui! Quante volte i suoi occhi tristi mi avevano rincorso dal ritratto e mi avevano scovato dietro un banco, da cui intrecciavo con lui colloqui che non ricordo più! 48 Ora lo vedo portato in salvo, tra fiumane di annegati, dalla folla dei bambini, me compreso, del suo asilo. Rifugiatici in un’aula che la acque non possono raggiungere, suor Maria ci ordina il silenzio e, testa sul banco, ci addormentiamo. Ma mi risveglia, di soprassalto, la lugubre sirena della “Caronte”. Raduno sul ponte, di tutti i passeggeri. Ci viene consegnato un salvagente. Si preparano le scialuppe. Tra poco la nave, in preda ad un impazzito orgasmo del fondale marino, sarà sollevata e rovesciata, per finire come una vecchia carcassa che si abbatte sulle coste sopra un’onda dai trampoli di morte!… Ma io non voglio raggiungere Villa San Giovanni. Devo assolutamente tornare a Messina. Lì c’è Mimmo. Non posso lasciare che l’amico fraterno perisca insieme agli altri. Quando è stato colpito dall’ictus, in Polonia, gli dissi che avrei dato non so quanti anni della mia vita, purché si salvasse. In questo momento deve essere nella sua stanzetta, alla Casa dello studente, piegato su quei volumacci di medicina, che tante ore hanno già sottratto al nostro dialogo. Devo avvertirlo al più presto e, al più presto, fuggire insieme su per i monti Peloritani. Un dio marino mi ascolta. Ed ecco che improvvisamente, in una scialuppa, mi vedo risalire la via che porta proprio alla Casa dello studente. Sono già sotto le finestre dell’edificio. Chiamo Mimmo a gran voce. Ma vedo, all’altezza della sua finestra, al suo posto, una strana figura, vestita dei paramenti da sacerdote, sopra l’impalcatura di un ponteggio, avanzare con passo claudicante. E’ il sacerdote che, in un lontano pomeriggio di maggio del 1973, avevo visto in processione, sotto il baldacchino, rivolgere lo sguardo verso le finestre di noi studenti e farci, attraverso un megafono, gli auguri per gli esami imminenti. Ma ora, da quell’altura, stringe delle borse di plastica, dalle quali rovescia acqua e acqua a non finire, in quella via che ne è già sommersa. Ricordo che un divertimento infame di alcuni studenti consisteva nel lanciare sui passanti (meglio se vecchi asmatici) buste di plastica piene di acqua che, all’urto, esplodevano addosso alla persona. Nel giorno dell’ira, ora, il sacerdote vendica l’affronto che i più sacrileghi gli avevano fatto nell’annaffiargli i fedeli in 49 processione e col fargli calare dai quattro angoli del baldacchino, come da uno sciacquone, acqua sui sacri paramenti. La Questura aveva aperto un’inchiesta. Le stanze dello studentato perquisite. Erano stati trovati armi e documenti falsi. Avvertiti per tempo, anche io e Mimmo avevamo dovuto prelevare, per una diversa provvisoria ricettazione, la nostra batteria: le pentole e la pignatta dei nostri pasti frugali e sostanziosi (chi può dimenticare quella pasta e fagioli?) e il fornello, che non era lecito tenere in camera. Ora mi arrampico su per i tubi del ponteggio. Dalla stanza, vuota, di Mimmo passo, per una scala, alla terrazza dell’edificio. Alla calca di studenti che straripa dai parapetti si offre uno spettacolo apocalittico: sono scomparse le coste di Reggio, Lazzaro, Gallico da un lato dello Stretto; dall’altro quelle di Messina, Riposto, Sant’Alessio. Le fauci di Scilla e Cariddi vomitano i quarantamila morti di Reggio e i novantamila di Messina del 1908. Cavalloni di tredici metri si abbattono sulle case che hanno resistito al primo risucchio. Poi, risospinti da bollori e fiati di rovina, con lugubre ghigno di ritorno raschiano case e bastioni di miseria: come beffarde carezze in contro pelo sulla carcassa di un gatto spento. L’abisso del mare e quello del tempo mi frullano nella mente. Disperato, cerco in quella ressa di volti una risposta alla ricerca dolorosa di Mimmo. Ma mi accorgo, con orrore, che quelle facce appartengono a corpi pietrificati. Sono salvo io solo, forse, per il triste ufficio di fare la conta dei morti? Devo fuggire. Con una corda mi calo nella scialuppa. La corda si spezza e, precipitato nel fondo della barca, perdo i sensi. Quando mi riprendo, mi scopro in una immensa pianura. In ginocchio, poggiato sul bordo della scialuppa, spingo lo sguardo nella vasta distesa, ma non vedo nulla. Tutto tace, seppure di un silenzio sospetto. Qualcosa ancora sussulta nel profondo e il vento di morte, che ha appena scatenato quel finimondo, sta solo riprendendo fiato. Tsunami ritorna. … Devo proprio adesso, a una distanza di pochi metri, vedere mio figlio? E’ lui, ragazzo di non più di dieci anni. Suona un pianoforte dalla tastiera muta, noncurante di quel flagello (come può rimanere così inerte?). Urlo il suo nome. Non può sentirmi. Allora mi piazzo alle sue 50 spalle, pronto a deviare e tenere lontana da lui quella furia che ormai ci lambisce. Con le mani e tutta la persona trattengo e respingo quel ciclone infernale. Mi pare di non potere più respirare. Sto per cedere e allora mi giro per vedere e invocare ancora una volta, forse l’ultima, mio figlio. Ma da lui ora mi separa un nuovo ostacolo, alle spalle, e mi opprime: un muro. Un muro che si ostina a rimanere, nonostante i miei sforzi a rimuoverlo… E’ il muro soleggiato dove, da un pezzo, mi sto scaldando. Da quel muro non mi sono mai mosso. Solo l’anima, errabonda, ha varcato le lande possibili della grazia e dell’orrore. E’ quasi mezzogiorno: tra poco, dall’orologio sul campanile del Duomo, la bronzea morte, nel suo rituale affaccio dalla torre campanaria, con la falce reciderà un’altra mezzora del nostro tempo. Rifaccio le scale lentamente, come un clown che si è appena esibito in un circo al buio, senza fischi e senza applausi. Rientro nella stanza. Sono stanco. Mi stendo sul lettino e guardo a lungo il soffitto. Sto per addormentarmi. Ma, prima, sento ritornare nella mente suoni da un pezzo familiari: “Fond-li-re ab--rof a-pe-iu-ro-fu….” 51 LOVARO Una sera di novembre mi scopro in un letto d’ospedale. Ho avuto un’emorragia cerebrale, forse dovuta a un’interferenza di farmaci. Nel mio ricordo “emorragia cerebrale” è legata alla morte del nonno materno, che non ho fatto in tempo a conoscere. Non si può escludere che la familiarità, nel mio caso, sia stata determinante per la patologia. A ogni modo, per questa volta, mi è andata bene. Passa un mese, e posso finalmente seguire le mie terapie senza la carrozzella. Per sicurezza, mi appoggio a un bastone. Tra non molto potrò lasciare il reparto e continuare la riabilitazione in day-hospital… La mattina, dopo colazione, passiamo qualche ora nelle stanze-palestra con le fisioterapiste alle quali siamo stati assegnati. La riabilitazione viene affidata alla loro grazia e al loro rigore professionale. Seguono gli incontri con le psicologhe, che ci propongono dei test di graduale difficoltà, da risolvere seduta stante o come compito per l’indomani. Alcuni test sono di notevole facilità e, all’inizio, possono creare un imbarazzo logico-emotivo. Ma alla seconda, terza seduta si può vivere qualche momento di smarrimento, di panico, di frustrazione. Giuro a me stesso, se mai potrò tornare al mio lavoro e alla mia vita di prima, di trovare un’ora al giorno nella quale esercitare la mente sui casi più imprevisti; a ricavare, anche con varianti piacevoli, schemi di percorsi almeno vagamente simili alle formule proposte nelle aule di psicologia: Che animale è quello che vedo raffigurato? Chi è il presidente della Repubblica italiana? Se togliamo sei punti al numero proposto dalla schermo del computer cosa ci rimane? E se ne togliamo altri sei? E ancora sei? Quanti anni assegnerei alle persone delle quali sul video si vedono solo i volti? Riprodurre con una matita, nel minor tempo possibile, alcune figure geometriche comparse per pochi minuto sul video. Chi è il presidente della Repubblica italiana? (ancora!) 52 Bisogna concentrarsi sui quesiti proposti, senza associazioni o divagazioni, tipiche di una mente in stato morboso, se non di un paziente cerebro leso. Scopro, così, di non avere saputo (da quanti anni?) pensare a una cosa, senza richiamarne, per possibili associazioni, altre. La figura del coniglio (uno dei test!) non potevo vederla senza richiamare alla mente il coniglio che fugge davanti alla vaporiera nel dipinto di Turner; un episodio dell’infanzia: due zampate ricevute sulla faccia dal coniglio che una mia zia, tenendolo per le orecchie, porgeva a una troppo ravvicinata e incauta carezza. Senza dire dei quattro conigli necrofori per Pinocchio che non vuole bere la purga. Alla fine di queste sedute, mi sento stanco e mortificato. E, giorno dopo giorno, cresce una nuova preoccupazione: quanto può durare quel trattamento? Le deduzioni e le valutazioni delle psicologhe potranno determinare il mio destino umano e professionale? La giovane psicologa che mi accoglie e mi congeda con un gentile sorriso potrebbe classificarmi e archiviarmi come un essere ormai socialmente inutile? Non avrebbe più alcun valore il mio spirito ancora pieno di ricordi e di curiosità, capace di sentire la gioia, la pietà e il dolore? E’ possibile che questa sacerdotessa custode della mia mente, che mi ha detto di non aver mai sentito il nome di Antonio Gramsci, appartenga ad un universo migliore del mio? Quante volte penso di comunicare al mondo esterno queste paure, durante i colloqui con i miei familiari, amici, allievi. Ma sento che è meglio tacere, cedendo all’idea dolorosa ma ineluttabile che tutto questo deve pur essere la mia nuova vita. Ma proprio la vita è troppo furba per mostrarci la desolata disperazione, che ci spingerebbe ad odiarla e rifiutarla. Una nuova psicologa entra nella mia vita e ne 53 spazza, come la fata dai capelli turchini, tutti gli incubi. Si parla di musica, di cinema, di arte, di letteratura. Bando alle terrificanti operazioni matematiche! Per intercessione della salvifica mi viene concesso di dipingere e disegnare nell’aula della terapia occupazionale. Realizzo dei ritratti che sono ammirati. La riabilitazione comincia per davvero. Pure, mi capita, da alcune notti, di lasciare il mio letto e fare delle lunghe passeggiate per i diversi piani dell’ospedale… Una pallida luce mi guida nella discesa di due rampe di scale, Sono chiuse le porte delle aule di psicologia. E’ invece aperta, sebbene poco illuminata, la stanza della terapia occupazionale. Per raggiungerla devo attraversare il lungo corridoio. Disposti in fila, a rasentare il muro, ci sono, addormentati e come dimenticati sulle loro carrozzelle, i pazienti più vecchi. Riconosco il signor Sandro, che avevo incontrato nella terapia di gruppo. Ce l’aveva a morte con la nuora, con la quale sarebbe finita certamente male! Ma ora dorme, se sono vere quelle figure silenti e dolenti, nella paziente e inconsapevole attesa. La signora Matilde tiene il polso rovesciato sul ventre e le foto della nipotina occupano, sparse a terra nella fioca luce, alcune mattonelle del pavimento. Intere sedute a decantare gli occhi e i labbruzzi di Donatella! Non è da escludere che, tra una settantina d’anni, la nipotina di quella nipotina non venga, a sua volta, a trovarsi, dietro quella porta, ad attendere di essere ricevuta da un camice bianco con gli occhiali. C’è anche il signor Daniele, che nelle ore di musicaterapia rideva e faceva ridere. Tra i possibili esiti comportamentali di un ictus è la risata prolungata e senza motivo. I suoni che dovevamo emettere a bocca chiusa erano, per lui, una risata contenuta e repressa da tanto tempo. Noi altri pure ridevamo, indicando in lui il capro espiatorio ai rimproveri del maestro. 54 Poi veniva il sesso, sognato e protestato da Daniele in modo maniacale e civettuolo. Faceva segni sguaiati alla ragazza senegalese dirimpettaia, e l’attendeva tutta la notte, sicuro, ogni volta, di averla convinta a dare, negra com’era, il proprio corpo per una manciata di euro. Siccome non la dava, non rimaneva che ridere, ridere, ridere… tanto, quella lì non valeva la pena di avvicinarla, perché puzzava e doveva avere (un infermiere gli aveva fatto questa confidenza) l’a.i.d.s.. Con le infermiere, le dottoresse, le fisioterapiste (perché con le bianche non era classista) sfoderava tutte le tenerezze di cui era capace. Vi lasciava, nel mezzo di una conversazione, per inseguire una bella fisioterapista che gli aveva sorriso. Ma si voltava a inseguire un’infermiera nella direzione opposta, perché gli aveva fatto un segno inequivocabile. Ora dorme, con la bocca spalancata in un’afona risata, e tiene con gelosia, tra le gambe, un’ostentata protesi fallica. Ma non è che lo strumento africano della pioggia, sottratto furtivamente all’aula di musicaterapia. Sono davanti all’aula di terapia occupazionale. Entro piano, ma non vedo nulla di quegli strumenti fantastico ricreativi che ci facevano sembrare tanti bambini vigilati dalle tate dai grembiuli bianchi. E’ scomparso il pavimento di mattonelle lucide, in cambio di un piano a base di cemento e di terra distribuiti in modo poco uniforme. Tra le cose che piano prendono forma mi appare un volto con una barba bianca e con palpebre come appesantite da malinconica attesa. La coppola è agganciata a una margherita delle botti situate in fila dietro il trespolo su cui il vecchio è seduto. Forse sto sognando. Quello non può essere Lovaro, già vecchio quando io ero bambino e in un paesino calabrese. E non può una sala dell’ospedale trasformarsi in una cantina, in quella cantina di allora. Eppure egli era seduto su uno sgabello di legno, levigato e liscio come il manico di una zappa. Lo scranno che un’anonima schiera di assetati viandanti aveva occupato, alla fine di faticose giornate. Anche la cassa con la merce di ritorno, deposta sul battuto di terra, si godeva il tiepido della cantina, temperato, di 55 tanto in tanto, da qualche spruzzo di vino chiamato, per antico vizio, a rigenerare la terra. Ma cosa ci faceva lì Lovaro? Ed era Lovaro o l’ovaro, come il padre? Si trattava di strani patronimici, suggeriti non dai nomi ma dai mestieri. Lovaro ormai non vendeva uova ma elastici, lamette da barba, pettini e almanacchi di Barbanera. Lo vedevo così, quando con la sua cassetta sulla schiena, assicurata da una grossa cinghia, attraversava la piazza del paese. Mi si accostava mentre facevo la guardia ai due sassi che segnavano la mia porta. Mi piaceva giocare in porta, ma non avevo il benché minimo senso della squadra. Lovaro si fermava e sottoponeva alla mia vista le sue gote carminio-paonazzo. Secondo me, la moglie si sarebbe accorta che egli aveva bevuto? Con volto e tono atteggiati a rispettosa e garbata compassione gli rispondevo di sì. E allora egli sfoderava una sorta di confiteor che balbettava allontanandosi. Lo indispettiva quella rituale, impietosa riprova che in questo mondo non esiste un briciolo di solidarietà o di complicità. Ma ora egli si trova vicino alla botte ristoratrice. Nella mia mente egli si è fermato, non gira più per le fiere. Col volto carminio-paonazzo di sempre, ma ormai dimentico della terribile visita di controllo della moglie, chissà da quanto scomparsa dal mondo… Era la vigilia dell’Epifania. La nonna mi aveva mandato col fiaschetto da riempire. Nella cantina aspettavo il mio turno. Lovaro dal suo scranno mi chiedeva cosa mi avrebbe portato la Befana. A lui vecchio la vecchia aveva anticipato quella bella sorpresa: in una mano palleggiava una patata bollita; nell’altra, con una presa che l’allenamento aveva reso più sicura, teneva un bicchiere di vino… 56 Archetipo o essenza del mio spirito povero e assorto, Lovaro mi riportava la sua unica ricchezza. Coronato di una frasca di cantina, mi spruzzava la soglia della vita. Ora cerco di ritornare nella mia stanza. Ma, risalito nell’atrio, mi colpisce una luce accecante, che si diffonde per le invetriate e le fessure delle imposte. Mi viene in mente che nella stanza – deposito delle carrozzelle da riparare una finestra non veniva mai chiusa. Per via dei fumatori clandestini, diurni e notturni. Allora mi affaccio a respirare il luminoso biancore della neve. I sentieri, tiepidi di luna, lasciavano al paesaggio in discesa, tra grovigli di acacia e decorose villette, una inquieta e maestosa sonnolenza. Solo qua e là, come contraltare dell’ostinato riflesso lunare, piccoli sprazzi d’ombra, o di colore, versati da mani invisibili. Forse è meglio rientrare, attendere nella stanza la fine di quelle visioni febbrili. Ma ecco che quelle piccole macchie si allargano e allungano, fino a coprire di bluastro tutto il dorso della collina. Una piccola radura si salva; il sua manto di neve si stacca da terra e sale verso l’ospedale, come un aquilone. Si posa sui rami di una rubinia, sotto la finestra. Ma ora è divenuta una camicia bianca con macchie d’inchiostro blu… Ne avevo indossata una simile, la mattina della prova d’italiano, all’esame di licenza media. A casa avevano deciso che sarebbe stato più elegante usare la stilografica di papà. Non mi sono mai piaciute le stilografiche, ed ecco il bel risultato! Siccome l’inchiostro non mi pareva abbastanza scorrevole, mi ero messo a schiacciare lo stantuffo che, esplodendo, mi aveva schizzato tutta la camicia. Ricordo le mie lacrime di vergogna e di paura per il compito andato a male; il preside che batteva i denti senza dire nulla; la bidella Venturina che, nello sgabuzzino pieno di ramazze e pantofole, mi aiutava a infilare una sua maglietta da lavoro, per riaccompagnarmi al mio banco a svolgere il compito. Il compito era “sul giorno più bello della vostra vita” (!). Scegliemmo tutti il giorno della prima comunione, con camicia bianca e guanti bianchi… 57 Ritornato a letto, mi sento stanco ma sereno, ormai rientrato nel mio corpo che, forse, dura ancora. Pure, quella camicia e quella neve si adagiano soffici e incontaminate, a chiudere il giro del mio giorno. Proiettata su quel sudario, forse la vita mi sta passando davanti. Ho sentito dire che è una cosa che succede a chi sta per lasciare questo mondo. Alcune sequenze del cortometraggio si ripetono, fino a quando una si fissa e, nel sussulto di un lampo, brucia. Ora è la pace di un lontano, tenero sentiero, dove le cicale scavano il cuore dell’ulivo. Poi, improvvisamente, il silenzio. Con la cassetta a tracolla, Lovaro riprende il suo cammino. Si apre una vasta distesa litoranea su cui, muti, discendono gabbiani. 58
Scaricare