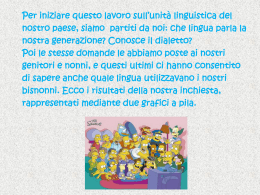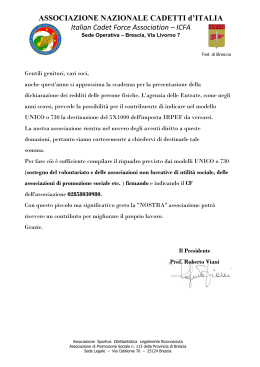Provincia di Brescia Vice Presidenza Assessorato alle Attività e Beni Culturali e alla valorizzazione delle Identità, Culture e Lingue Locali Cöntem sö töt dall’A alla Z Pensieri parole opere e … omissioni della lingua bresciana Giacomo Danesi Giacomo Danesi ® [email protected] Tutti i diritti riservati E’ vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo (internet compreso), senza il consenso scritto dell’autore I quadri riprodotti sono di Eugenio Busi, al quale va il mio più vivo ringraziamento Progetto grafico: Alessandra Raineri Finito di stampare nel mese di dicembre del 2005 Presso l’azienda grafica della Società Editrice Vannini – Gussago (BS) 2 Ai miei genitori Angelo e Rosina Scorza 3 Provincia di Brescia Vice Presidenza Assessorato alle Attività e Beni Culturali e alla valorizzazione delle Identità, Culture e Lingue Locali “Mi rattrista sempre che vada persa una lingua, perché le lingue sono il pedigree delle nazioni.” Samuel Johnson: da Boswel, Giro delle Ebridi Secondo le statistiche ogni giorno sulla Terra spariscono una cinquantina tra dialetti e lingue. Un patrimonio di cultura, immenso e incommensurabile, va così giornalmente perduto sia per le attuali generazioni sia per quelle future. La tendenza pare inarrestabile anche nella nostra Italia. Nella nostra provincia, soprattutto nei paesi e nelle valli, fortunatamente molti parlano ancora il dialetto della propria zona. Sarà bene ricordare che il dialetto bresciano, anzi, la lingua bresciana, non è uniforme. Il modo di esprimersi del camuno è ben diverso da quello della bassa bresciana. Dunque, un patrimonio ancora più vasto da valorizzare e proteggere. Se fino ad oggi il nostro dialetto ha mantenuto una certa valenza, lo dobbiamo ai poeti e autori di commedie. E’ grazie a loro se oggi certe espressioni, modi di dire e di fare, sono ancora insiti nel nostro linguaggio, nel nostro modo di essere. Loro non si vergognano di parlare, di pensare, di agire in dialetto. 5 Vorrei anche sfatare l’accusa che il nostro modo di esprimerci è brutto e volgare. Ci sono parole e modi di dire che portano con sé una melodia che lascia stupiti. Parliamoci chiaro, ogni linguaggio è bello. Mi è di conforto un sonetto di un poeta dialettale milanese e famosissimo: Carlo Porta. Nel suo “I paroll d’on lenguagg”, davanti all’obiezione che non sempre il dialetto è piacevole, così si espresse in un suo sonetto: “Le parole d’una lingua, caro signor Gorelli, sono una tavolozza di colori che possono fare il quadro brutto e possono farlo bello, secondo la maestria del pittore”. Ho affidato al giornalista Giacomo Danesi di raccogliere e commentare da par suo, e nella massima libertà, un piccolo vocabolario di espressioni, tra le più o meno curiose, della nostra lingua dialettale. “Cöntem sö töt dall’A alla Z - Pensieri, parole, opere e… omissioni della lingua bresciana”, mi pare abbia colpito nel segno. Confesso che molte delle espressioni commentate da Danesi non le conoscevo. A conferma della necessità che occorre da parte di tutti fare un ulteriore sforzo per raccogliere, custodire e far conoscere sempre più la nostra lingua. Occorre farlo, in primis, nelle scuole d’ogni ordine e grado, favorendo anche gli autori di commedie dialettali e poeti. Ma, soprattutto, stimolare nelle nostre famiglie l’uso del dialetto insegnando ai bambini fin dalla primissima età, a parlare la lingua dei nostri nonni. Senza remore, senza timori, senza pudori. Il Vice Presidente Massimo Gelmini Brescia, 13 dicembre 2005, Santa Lucia 6 INTRODUZIONE Se la lingua muore, / se s’impesta / se perde le parole / e prende il lutto, / se nelle case cieche / nel cuore dei vecchi / s’imprigiona, /allora il paese è finito, / è senza storia. Ignazio Buttitta Bagheria 1899-1997 (poeta siciliano) “La parola è tutto. Il resto sono solo chiacchiere.” Così un noto umorista italiano. Quando il vice presidente della Provincia di Brescia Massimo Gelmini mi ha chiesto di raccogliere e commentare in una pubblicazione pensieri, proverbi, modi di dire e quant’altro della lingua bresciana, ho accettato con entusiasmo. Con entusiasmo perché quando nel dicembre del 2004 pubblicai una raccolta di Detti Dialettali nell’Industria Bresciana per conto dell’Aib (Associazione Industriale Bresciana), le reazioni furono molto positive. Dopo aver scritto alcuni capitoli del nuovo libro, sono stato preso dal panico. Il pensiero che la parola è tutto mi angosciava. Il pericolo, immanente, di sconfinare nelle chiacchiere era palese. Quando si parla si corre il rischio di pestare i piedi alla propria anima. Quando si scrive si rischia di pestare i piedi dell’anima altrui. Se ciò avvenisse non me lo potrei perdonare. Scrivere, commentare e pensare nella lingua madre, il dialetto, è impresa ardua. Molto più difficile che scrivere in italiano, lingua ormai imbastardita da neologismi e ferita da frasi e modi di dire importati da culture a noi lontane e quasi sconosciute. Il rischio, gravissimo, è che nel giro di pochi lustri l’inquinamento sia talmente avanzato da rischiare l’estinzione di gran parte della nostra cultura. Il tutto a favore di 7 una lingua globale senza anima e riferimenti. Il dialetto, un tempo il solo modo di comunicare, a sua volta rischia di sparire (o forse è già sparito?), perché chi ha il dovere di custodirlo non ha ancora capito il pericolo mortale che l’oblio e il disinteresse porta con sé. Il dialetto? Una lingua per i bifolchi, ci raccontavano a scuola. Oggi, salvo nelle Valli, in Franciacorta e qualche paese della bassa bresciana, parlare la lingua madre suscita pietose ironie, per non dire di peggio. Il risultato? I nostri giovani non conoscono nulla o quasi delle nostre tradizioni, del nostro modo di parlare, quindi, di pensare. E’ il linguaggio che tiene legato un nucleo familiare, una comunità, una nazione. Un patrimonio immenso di storie, riti, modi di dire, di fare, di pensare, di agire, rischia la totale estinzione. Un gravissimo danno non solo per i bresciani se muore il suo dialetto, ma per l’intera umanità. Lo stesso vale per qualsiasi altro paese, provincia, regione d’Italia. Molti rimarranno delusi da questa mia fatica. I bagolinesi non troveranno in questo libro nessuna espressione dialettale a loro cara. Così anche per i gardesani, i bassaioli, i camuni, ecc. Ho privilegiato il dialetto che si parla in Franciacorta perché lì sono le mie radici. Non me ne vogliano. Sono certo che in queste zone molti sono i cultori del dialetto locale. Sta a loro adesso aprire la porta della memoria e mettere su carta ricordi, modi dire, pensieri e, perché no, opere e … omissioni. Vorrei che questo mio modesto lavoro fosse anche di stimolo per chi ha il dovere di mantenere vive le nostre tradizioni. Soprattutto con il linguaggio. Questo dovere è affidato alla famiglia, alla scuola, alle istituzioni. Le future generazioni hanno il diritto di sapere, conoscere e mantenere a loro volta l’immenso patrimonio che sarà loro trasmesso. Solo così possiamo sperare che la nostra cultura non abbia a morire. Se così non fosse prepariamoci ad un lento ma inesorabile colpevole declino dell’intera nostra civiltà. 8 A La tensione del filo affari amicizia amore 9 Affari Nòta nòta che tè troaré notàt! Nota nota che troverai annotato 10 Lo ricordo bene quel libretto con il quale la mamma andava a fare la spesa da Neve e Stelli, titolari di un piccolo negozio d’alimentari in Via Pezzotti al numero 5 ad Adro, in Franciacorta. Lo ricordo perché ogni tanto sbirciavo per conoscerne il contenuto: un arido elenco di cifre che, sommate, a fine mese determinavano il debito da saldare con la busta del papà Angelo, operaio alla Falck a Sesto San Giovanni, il solo a portare avanti la famiglia allietata da 5 bambini. Ghet ciapàt la busta? Hai preso i soldi, la paga, sì insomma, il salario? Sì la paga, perché lo stipendio lo prendevano solo gli impiegati. Sottile distinzione, vero? Ma aveva la sua valenza. Certo, per il bottegaio, ma questa valeva anche per il panettiere, il negoziante di tessuti e altri commercianti, era un rischio annotare il tuo debito sul libretto. Il rischio, appunto, di trovarsi con un libretto zeppo di numeri e poi non riscuotere nulla. Ma, in quei tempi, l’onestà faceva parte del Dna dei poveri. Cercate di immaginare la stessa scena ai giorni nostri. Non sarebbe più possibile, anche perché i piccoli negozi stanno scomparendo. Fate una prova. Presentatevi alla cassa di un supermercato e chiedete di pagare con il libretto. Vi chiederanno il libretto degli assegni, naturalmente! Chiameranno anche la vostra banca per un controllo, statene certi. Per la verità in qualche bar ancor oggi qualche titolare accetta di segnare il vostro debito su un notes. Piccole cifre, fino ad un massimo di 20-30 euro. Incredibile a dirsi. Di solito perde i soldi e anche il cliente! Nòta, nòta che tè troaré notàt… 11 Amicizia A dì dè sé tè fé amici a dì la verità tè è nemici Dicendo di sì ti fai amici dicendo la verità ti fai nemici 12 Verità sacrosanta! E’ la vita, come sempre maestra, ad insegnarti che questo proverbio è tristemente vero. “E’ terribile per un uomo scoprire improvvisamente che per tutta la vita non ha detto altro che la verità”. Così Oscar Fingal O’Flaherthe Wills Wilde nel suo romanzo: “L’importanza di chiamarsi Ernesto”. Facile immaginare che quell’uomo avrà sicuramente pochi amici. Dove sta, a questo punto, il paradosso? Nel fatto che puoi chiedere la verità solo ai nemici. Con il disagio che ne consegue. Cerco conforto nei sacri testi. Nell’Ecclesiaste ecco la famosa frase: “Qui inveni illum (amicum) inveni thesaurum”. Ma la vita, per l’ennesima volta maestra, insegna il contrario. Se trovi un tesoro, infatti, trovi tanti amici. Allora puoi anche permetterti di dire verità scomode senza pericolo di perderli. Nel dubbio non mi resta che fare mia un’altra massima di Oscar Wilde: “La verità? Per cortesia, risparmiamocela.” Rileggendo “Tenera è la notte” di Francis Scott Fitzgerald, forse ho trovato la chiave di volta del problema in una frase bellissima e terribile. Eccola: “Fra i trent’anni e i quaranta sentiamo il bisogno di amici. Dopo i quaranta sappiamo che non ci salveranno più di quanto ci abbia salvati l’amore.” Ho superato da quattro lustri i fatidici quarant’anni, dunque… 13 Amore E’l n’ha mangiàt dè carne dè còll Ne ha mangiato di carne di collo 14 Aprite un libro di detti dialettali e cercate la parola Amore. Li troverete tutti datati. Con tanti saluti alla convinzione che l’amore non ha tempo. Ho scelto questo proverbio perché sembra scritto secoli fa. Lo immaginate un ragazzo dei nostri tempi che passa ore e ore sotto la finestra o il balcone dell’amata, con il capo rivolto verso l’alto, nella speranza di vederla apparire? Perché poi un ragazzo dovrebbe perdere tempo quando, è notorio, sono ormai le ragazze a prendere l’iniziativa? No, la carne di collo, se permette, oggigiorno se la possono permettere (forse) solo le ragazze che aspettano il principe azzurro. Poi arriva il principe. Solo che, spesso, è di tutti i colori meno che azzurro. “Sono innamorato? – Sì, poiché sto aspettando.” Così Roland Barthes nel suo fondamentale saggio “Frammenti di un discorso amoroso”. Splendido Barthes quando racconta la storia d’amore tra il mandarino e la cortigiana. “Un mandarino era innamorato di una cortigiana. “Sarò vostra – disse lei, - solo quando voi avrete passato cento notti ad aspettarmi seduto su uno sgabello, nel mio giardino, sotto la mia finestra”. Ma, alla novantanovesima notte, il mandarino si alzo, prese il suo sgabello sotto il braccio e se n’andò”. Se vi capita di trovare un ragazzo con il collo taurino, non fatevi illusioni. Nessuna ora passata sotto il balcone o finestra in attesa dell’amata. Quasi sicuramente sta frequentando una palestra. 15 B Neve su Brescia beghe 17 Beghe En casa ghè sèmper piaghe Se ’l-òm èl gha ‘l bigaröl E la fòmna braghe In casa ci son sempre piaghe se l’uomo porta il grembiule e la donna le brache 18 Il mondo è cambiato! Aveva ragione mia nonna Lucrezia quando sul letto di morte mi confidava che non voleva morire. Il motivo? “Giacomino – mi sussurrava con un fil di voce – come vorrei continuare a vivere per sapere quante cose cambieranno in futuro. Invece…” Cara nonna Lucrezia, è vero. Ne avresti viste delle belle! Meglio che certe cose tu non le abbia ne vissute ne intuite. Sapessi, nonna Lucrezia, quanti uomini con ‘l bigaröl ci sono in giro oggigiorno! Tu sei sempre stata convinta che ci si sposa tra uomini e donne. Questo per far nascere i bambini. Altri tempi! Oggi non è più così. Il mondo è cambiato, s’è evoluto. Non è più necessario per fare i bambini che i genitori siano un maschio e una femmina. Oggi una coppia di sposi può essere formata da due uomini o da due donne. No, non chiedermi come fa una coppia così assortita a fare i bambini, perché è troppo complicato spiegartelo. In virtù di questi epocali cambiamenti si modificano anche i proverbi. In teoria quello sopra citato vale fino ad un certo punto. In casa ora ‘l bigaröl lo possono portare entrambi gli uomini, e le braghe ambedue le donne. Non mi è noto se le piaghe in casa siano sparite per via di questo nuovo modo di concepire la coppia. Starò a vedere. In fondo chi vivrà vedrà. Una domanda. Henri Bergons riscriverebbe, come ha fatto in L’evoluzione creatrice, che: “La vita non procede per associazione e addizione di elementi, ma per dissociazione e divisione”? Ne dubito fortemente. 19 C Canti all’osteria carità cimitero comandare 21 Carità Per tenere su la carica del nostro corpo e del morale la regola più simpatica è questa senza eguale: il bene e il buono segnalarlo e il brutto dimenticarlo Per tègner sö la sosta del còrp e dèl moràl, la regola piö giösta l-è chèsta sensa fàll: èl bé e ‘l bù notàl ‘l brot desmentegàl 22 Esattamente il contrario di quanto avviene oggigiorno. Basta accendere la televisione o sfogliare i giornali per capire come gira il mondo. Splendido questo pensiero del più grande e conclamato poeta della lingua bresciana: Angelo Canossi. Sembrano frasi scritte sulla sabbia quelle di San Paolo, quando nella sua lettera ai Corinzi (12, 4-5) affermava: “La carità è paziente, la carità è benevola, non ha invidia, la carità non si vanta, non si gonfia, non agisce disonestamente, non cerca il proprio interesse, non si adira.” Ribadiva Sant’Agostino, nei suoi sermoni, che la carità equivale all’insieme di tutti i precetti. Perché allora nella nostra società sembra prevalere il male? Che abbia ragione la Genesi la dove si legge che l’istinto del cuore umano è incline al male fin dall’adolescenza (8, 21)? 23 Cimitero Nà al nomer disissèt Andare al numero 17 di Via Milano 24 Quando si dice il caso! Il celebre cimitero “Vantiniano” di Via Milano in Brescia è ubicato al numero civico 17. Per i superstiziosi non è proprio un numero simpatico. Il motivo? Semplice. Scrivete il numero 17 in cifre romane. Eccolo: XVII. Ora dimenticate che è un numero e usatelo come fossero lettere dell’alfabeto. Fatto? Bene. Ora anagrammate il tutto. Il risultato? VIXI. Il suo significato in latino? Da brivido: “Ho vissuto”! In tema d’anagrammi non è da meno il famigerato numero 13. Infatti, se anagrammate la frase: “Al numero tredici”, il risultato non è certo meno inquietante: “I creduli tremano”! Può bastare, grazie. Perché “Vantiniano” e quando fu costruito il “Camposanto”? Da una piccola pubblicazione editata il 1° novembre 1877: “Tra le fabriche di Brescia recenti la più cospicua è il Camposanto, un chilometro circa discosto dalla porta a sera, costrutto sui disegni dell’architetto Rodolfo Vantini. Vietata con decreto 5 settembre 1806 la sepoltura nelle chiese e negli annessi sagrati (nelle chiese di Brescia numeravansi 1087 avelli), fu nel 1808 comperato il terreno, benedetto ai 19 gennaio 1810 da mons. Gabrio Maria Nava di santa memoria, e si cominciò a sepelirvi il giorno dopo, continuando a portar al Fopone, fuori porta S. Alessandro, i morti degli spedali. Al comune di Brescia erano allora uniti Fiumicello e Urago con porzione de’ comuni di S.Nazaro Mella, S.Alessandro, Mompiano e S.Bartolomeo; che per ciò usano ancora il cimitero della città. Era un quadrato cinto di muro, col lato di 150 metri: sorgea nel mezzo una gran groce di ferro; e una croce di ferro o di legno, col nome e qualche altra parola, si ponea sulla fossa di ogni sepolto. Ma già queste croci, dipinte, dorate, variamente adorne, faceano manifesta la pietà de’ congiunti: e quale per suo defunto sortiva la fossa appie’ del muro di cinta, v’incanstrava una pietra con epigrafe. Ne rammento alcuni cui mi fermava a rilegger fanciullo: e a canto un’aiuola seminata di fiori, su cui pioveva un salice i pallidi rami. Ugo Foscolo avea nel 1807 in Brescia pubblicato il suo carme, e di Verona rispostogli Pindemonte; e Federigo Borgno, maestro nelle nostre scuole, voltato que’ versi in esametri latini. Cantano i due poeti la religione de’ sepolcri naturale e antica quanto la civiltà: scoppiava or essa da tutti i cuori”. 25 Comandare E ché l’è la me cà ché, e ché cümande me ché e höi sai chi chè a ché e chi chè e ché Questa è la mia casa e qui comando io e voglio sapere chi va e chi viene in questo posto 26 Dubito che le ultime generazioni di bresciani abbiano mai cantato (o sentito cantare) questa canzone. Il sabato e la domenica sera, poco prima di far ritorno a baita, gli uomini (per farsi coraggio…) cantavano nei licinsì o nelle osterie questa canzone. Volevano affermare, a parole, che a casa propria erano loro a comandare. Beata ingenuità. Lo sapevano tutti che erano le mogli a comandare! Comandare. E’ evidente a tutti che questo desiderio è proprio insito nella natura umana. Scriveva John K. Galbraith, nel suo saggio Il nuovo stato industriale, che entrando in qualunque forma d’attività organizzata, una chiesa, una banda, un ufficio governativo, una commissione parlamentare, una casa di piacere, il nostro primo istinto è di chiedere chi comanda. Preferisco pensare come Goethe che, nel suo Götz von Berlichingen, affermava convinto: “Colui solo è felice e grande che per essere qualcosa non ha bisogno né di comandare nè di ubbidire”. 27 D Lo spaventapassere debiti dio donna 29 Debiti Va pör lènt a pagà i pöl desmentegà Va pure adagio a pagare si possono dimenticare 30 Chi si dimentica? Lo Stato? Le banche? Ma mi faccia il piacere! “Paga le tasse e imposte con un sorriso”, affermava ammiccante, tempo fa, una campagna pubblicitaria del Governo per indurre i contribuenti a pagare il dovuto. Io sono andato all’Esatri per fare il mio dovere e pagare, appunto, il dovuto. Con un sorriso, naturalmente! Ma loro volevano i soldi! Così me ne sono andato. Lasciamo perdere, per carità di patria, le banche. Con quei maledetti computer che nel giro di pochi secondi sanno tutto, o quasi, di te, non ci sono più scorciatoie. “La vita sarebbe impossibile se ricordassimo. Tutto sta a scegliere quello che si deve dimenticare”, affermava Maurice Martin du Gard nel suo Petite suite de maximes et caractères. In verità, io da tempo ho scelto cosa dimenticare. Ma lor signori evidentemente no. Non mi resta che sperare che s’avveri quanto scritto da Jacques Bainville in Lectures: “La facoltà di dimenticare, fortissima negli individui, lo è ancora di più nelle società umane”. Splendido pensiero! Speriamo che sia valido anche per le società di capitale, per azioni, Srl, Sas, e l’Esatri… 31 Dio Signùr, vò ‘l si che mé sö ‘n tabalòre. Tignìm la mà söl cò, che nò ‘l mè sòre. Signore, voi sapete che io non sono intelligente. Tenetemi la mano sulla testa che non esca di senno. 32 Che bellissimo atto di fede! Chiedere a Dio di rimanere umili per non insuperbirsi, perdere il contatto con la realtà di tutti i giorni e aspettarsi un aiuto per non uscire di senno. Che nò ‘l mè sòre! Stupenda espressione figurata che vuol rimarcare l’auspicio che la testa, esposta all’aria, non gli evapori. Sorare, dunque, sciorare, che deriva dal latino volgare (e)xaurare, esporre all’aria, appunto. C’è un altro termine in dialetto bresciano con il quale si vuol identificare un tabalore, un fessacchiotto, ecco. È la parola Tananai. Secondo il Dizionario della Lingua Italiana di Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli, significa: “Confusione prodotta da gente che parla ad alta voce, con concitazione”. Invece, nella lingua bresciana, Tananai, significa essere ingenuo, timido, imbranato. Chi non ricorda la storiella della pettoruta e provocante signora che, davanti al giovanotto timido e goffo, stanca di aspettare una sua avance mentre si trovavano sulla pista da ballo, non trovò di meglio che attirarlo a sè sussurrandogli in un orecchio, sulle note di una vecchia canzone di Frank Sinatra: Strensem tananai… 33 Donna “L’immaginazione delle donne è molto rapida; balza in un attimo dall’ammirazione all’amore, dall’amore al matrimonio”. Così Jane Austen in Orgoglio e pregiudizio (Darcy). Scegliere una frase dialettale per identificare nel bene e nel male la donna è impresa assai ardua. Sono tantissimi, e tutti con un fondo di verità, i proverbi e modi di dire inventati negli anni dai nostri nonni. Per questo il lettore mi perdonerà se all’inizio di questo capitolo ho messo un pensiero sulla donna non in dialetto ma in lingua italiana. Tra le tante frasi dialettali ne ho scelte alcune che, sono certo, attireranno la curiosità del lettore. 34 La belèssa dè le fòmme la düra tré dé: fresca sbiadida e lassomela lé La bellezza delle donne dura tre giorni: fresca sbiadita e lasciamola perdere Spietata analisi della breve giovinezza delle donne che abitavano in campagna, dedite ai lavori nei campi. Splendide nella loro giovinezza prima del matrimonio; sbiadite poi per le numerose maternità e per il duro lavoro nei campi. Quasi dimenticate quando il corpo precocemente sfioriva sotto il sole cocente, per il lavoro nella stalla e in casa. Io le ricordo bene queste donne franciacortine. Le ricordo quando venivano ad aiutare a bater. Ho ancora negli occhi quella curiosa macchina che provvedeva a trebbiare il grano. Quell’aggeggio infernale che pareva le fauci di un misterioso animale che, nel suo movimento dall’alto in basso, serviva per imballare i gambi del frumento in balle di paglia. Ma ricordo ancor di più le belle ragazze che arrivavano dal vicinato per aiutare la mamma e la nonna nel preparare il cibo per i contadini. Non mi sfuggiva certo la loro malizia e il loro nascondersi nel fienile, con alcuni contadini del luogo, durante qualche breve pausa dal duro lavoro. Poi si sposavano. Qualche anno dopo erano quasi irriconoscibili. È la vita, bellezza! 35 Quando la fòmna la mèt le braghe prega ‘l Signür che bé la tè aghe Quando la donna indossa i pantaloni prega il Signore che te la mandi buona Un pensiero da far rabbrividire le femministe! Sicuramente datato questo modo di pensare, oggi quasi superato anche nel più retrogrado dei cervelli umani. Eppure non era così un tempo. Chi porta le braghe en chè la cà ché? urlavano i nostri nonni! Gli uomini, solo gli uomini. Ma il mondo cambia, le persone modificano il loro modo di essere, di pensare. Oggi, a ben guardare, le donne portano quasi niente… 36 Grassessa fa belèssa Grassezza fa bellezza Raccontala alle donne d’oggi! Almeno sotto le nostre latitudini. Non la pensano così, invece, nei paesi arabi dove una donna in carne è il massimo della libidine. Da noi la moda impone la quasi magrezza. Il risultato non può che essere l’aumento dell’anoressia. I terribili effetti di questa patologia li abbiamo sotto gli occhi. Donne italiane grasse, non disperate. Stiamo marciando a grandi falcate verso una società multietnica. A prevalenza islamica. Dunque… 37 La fòmna che gha nissü udùr la sènt dè bù La donna che non si profuma sente di buon odore L’odore della pelle! Unico e inconfondibile in ognuno di noi. Grande la sua valenza erotica in ogni corpo. Semmai il problema sta nel riconoscerlo questo profumo. Ahinoi! Tutto questo diventa ogni giorno più difficile, con grande gioia dei creatori di profumi. Di chi la colpa? Dell’inquinamento certamente. Ma anche dell’uso e abuso dei profumi, saponi, bagnoschiuma e quant’altro. Uso e abuso che non permettono più al nostro odorato di percepire quei feromoni che il nostro corpo, splendido mediatore e messaggero di sensazioni, emana in ogni momento della giornata. Molti, penso, conosceranno l’aneddoto che riguarda Napoleone Bonaparte quando, tornando vincitore da una battaglia, mandò in avanscoperta un suo fido messaggero per informare la moglie che stava tornando a casa. Non senza ricordagli d’informare la consorte di non lavarsi! Certamente. Perché il corpo pulito e profumato avrebbe perso gran parte degli odori, gli umori e le percezioni che fanno inconfondibile e unica ogni pelle, ogni sentore. 38 E Autoritratto eredità 39 Eredità El pianzer dè l’erede, sotà la maschera ‘l-è ‘n rider Il pianto dell’erede sotto la maschera è un riso 40 Accidenti! Adesso mi è chiara la scritta che spesso trovo sulle lapidi nei vari cimiteri che settimanalmente visito in città e dintorni. “Signore, non ti chiediamo perché ce l’hai tolto, ma ti ringraziamo per avercelo dato”. Giusto, anzi, giustissimo. Se ben ricordo più il morto è ricco e più le lacrime sono copiose. Bella forza, risponderebbe Teognide di Megara. Non era, infatti, lui che nelle Sentenze affermava convinto che non si piange un morto che non ha lasciato ricchezze? Avete notato queste vedove inconsolabili, piangenti sulla bara del marito, come nel giro di pochi mesi rifioriscono a nuova vita? Dubito che al mio funerale ci saranno lacrime e stridor di denti. Infatti, da tempo ho fatto mia la massima bresciana che dice: “Té a ma, tè a ma / che èrgu i maierà. / La ròba la resta, / e té tè tòca ‘ndà”. Vale a dire: risparmia, risparmia, vedrai che qualcuno godrà di questo. Le cose terrene restano, ma tu te ne dovrai andare. Me ne guardo bene di fare il risparmioso! Dicevano i nostri nonni che quando Maria magra la öl troàt, töte le porte la gha spalancàt. Bellissimo il nome dato alla morte: Maria magra. Curiosa anche la frase Tirà i sgarlècc, per significare la morte di una persona. Tutto questo per non pronunciare la parola morte! Per pudore, probabilmente. Come per pudore s’indica con la frase Chèl de süra per indicare Iddio. 41 F La sigaretta con le cartine filastrocca furbizia 43 Filastrocca Sere le che andae a Nae, go encuntràt el cüràt de Nae El ma dumandàt endo che nae Go dit che nae a Nae a truà el pret de Nae Stavo andando a Nave quando ho incontrato il curato di Nave. Mi ha chiesto dove andavo. Gli ho detto che stavo andando a Nave a far visita al prete di Nave. 44 Bellissima questa filastrocca-scioglilingua per la verità poco conosciuta. Tutta giocata sul termine “Nae”, inteso come comune di Nave, e “nae” come voce del verbo andare, è la dimostrazione che il dialetto bresciano non è per niente truce come molti pensano. Sembra perfino melodioso! Con tanti saluti a chi denigra il nostro modo “barbaro” di esprimerci. Certo se appari in televisione, e ogni tre parole esclami “pota”, le cose cambiano. Di sicuro fai ridere. Purtoppo per il popolo bue è tutto ciò che conta. 45 Furbizia Chi prèst galèl èl sé farà prèst i la capunérà Chi si fa presto galletto verrà altrettanto presto incapponato 46 Oggi si fa un gran parlare del bullismo come fosse una conseguenza dell’attuale modo di vivere. Da che mondo è mondo nella comunità umana la presenza del bullo, del furbo, dell’astuto di turno è sempre stata presente. Sono numerosi i detti dialettali sulla furbizia, astuzia e superbia. Il detto proposto mi è piaciuto perché contiene un termine che pochi conoscono. A meno che non abbia fatto il contadino: capunèra. La capunéra è ancor’oggi la gabbia dove si racchiudono i polli. O, meglio ancora, i capponi per portarli all’ingrasso. Deriva dal termine capunà, ovvero castrare, evirare i galli. Un intervento chirurgico, quello di evirare i galli, dove l’esperienza e la perizia erano fondamentali. Il termine capunà ha anche un’altro significato, sicuramente più volgare. Chi? Che la gnàra là? Me lo zabèla capunado. Sì, insomma, me la sono già “fatta”. Oggi è una frase in disuso, e solo pochissimi, penso, ricorderanno questa espressione triviale. 47 G Innamorati gioventù giustizia 49 Gioventù Un buon giovane (da sposare): che abbia pane che sia sano che venga da lontano sia buon cristiano En bù zuenòt: che ‘l g’habe pà che ‘l sie sà che ‘l vègne dè lontà che l’sie ‘n bù cristià 50 Accidenti, peggio che sottoporsi alla visita di leva! Avete notato come non era indispensabile che la ragazza fosse o meno innamorata del giovanotto? Abbia pane, ovvero che abbia un lavoro, ma soprattutto che abbia voglia di lavorare… Lo confesso. Questo concetto mi era terribilmente ostico. Ma tant’è. Che sia sano. Ah sì? Per i rachitici, mi sembra di capire, nisba. Che venga da lontano. Per cortesia, non mettiamola giù dura. Bastava che fosse del paese vicino. Pochi chilometri di distanza, ecco. Ma non c’era il detto: “Moglie e buoi dei paesi tuoi?” Oggi, comunque, nessun problema per le ragazze. I giovanotti non arrivano solo dai monti e dal piano, ma da mille città lontane. Di tutti i colori, perfino! E sia un buon cristiano. Immediato il ricordo va a un pensiero di Don Lorenzo Milani tratto da Esperienze pastorali. Eccolo. “Dopo tutto l’istruzione religiosa che occorre per vivere da buon cristiano è in fondo poca cosa”. Care ragazze e ragazzi d’oggi. Che (s)fortuna essere nati ai giorni nostri! 51 Giustizia La talomora la tè le mosche ma la mòla le vespe La ragnatela trattiene le mosche ma lascia andare le vespe 52 Bellissima questa similitudine, molto simile ad un altro proverbio della nostra lingua. Eccolo: “Le leggi je come le talamore, le mosche le resta ‘n trappola e i muscù le j-a sfondà”. Vale a dire: “Le leggi sono come le ragnatele, le mosche restano in trappola, ma i mosconi le sfondano”. Qualcuno se la sente di smentire queste due perle di saggezza? Affermare che la verità, alla fine, si fa sempre strada, suona ai giorni nostri terribilmente ironico. Prima o poi? Purtroppo poi! Quasi sempre si parla di lustri. A questo proposito faccio mio il pensiero di Louis Antoine Lion Saint-Just quanto nei suoi Frammenti sulle istituzioni repubblicane scrisse: “Finché vedrete qualcuno nell’anticamera dei giudici e dei tribunali, il governo non val nulla. E’ un orrore che si sia costretti a chiedere giustizia”. La storia delle talamore, ragni, mosche, moscerini, vespe e via dicendo? Non mi resta che chiedere aiuto a Carlo Porta, poeta milanese d’altri tempi, con un sonetto tratto da La giustizia de sto mond. Ecco il suo pensiero in proposito: “La giustizia de sto mond / la someja a quij ragner /ordii in longh, tessuu in redond, / che se troeuva in di tiner. / Dininguarda a mosch, moschitt / che barzega on poo arent; / purghe subet el delitt / malappena ghe dan dent. / All’incontra i galavron /sbusen, passen senza dagn, / e la gionta del scarpon / la ghe tocca tutta al ragn.” La traduzione? “La giustizia di questo mondo somiglia a quelle ragnatele ordite in lungo, tessute in tondo, che si trovano nelle tinaie. Dio guardi mosche e moscerini che vi bazzicano un po’ vicino; purgano subito il delitto non appena vi si impigliano. Invece i calabroni bucano, passano senza danno, e la giunta dello scarpone tocca tutta al ragno”. E’ poi vero che c’è in tutti noi quest’ansia di giustizia? E se avesse ragione Henry Louis Mencken quando, nel suo Prejudices, The Series affermò che l’ingiustizia è relativamente facile da sopportare; quella che proprio brucia è la giustizia? 53 H Il torrente hòi (in lumezzanese: soldi) 55 Hòi Piöcc fa piöcc e hòi fa hòi I pidocchi fanno pidocchi i soldi fanno soldi 56 Bello questo detto lumezzanese. Oh Dio, da tempo avevo il sospetto che fosse proprio così. La vita, come sempre maestra, s’è incaricata di dimostrarmelo anno dopo anno. Parlo dei soldi, naturalmente! Per i pidocchi basta salire su un treno. Invidio il mio collega e amico Egidio Bonomi che da buon lumezzanese saprà sicuramente l’origine del termine hòi. Non vado da anni allo stadio “Mario Rigamonti” in Brescia, dove incontravo il buon Egidio intento a preparare il suo articolo di colore sulla partita. Ora non saprei come rintracciarlo per chiedere lumi. Caro Egidio, ricordi quante discussioni sul termine L’èn giànde? Incredibile la parlata dialettale lumezzanese! Senza alcun dubbio uno dei dialetti più interessanti in assoluto al mondo. Ho detto interessante, non bello. Straordinariamente difficile poi comprenderlo. Chi volesse approfondire questa tematica, consiglio la lettura del volume: “Proèrbe e modi di dì che ghe ree a hcomparì”, di Enzo Saleri e edito dal Comune di Lumezzane – Assessorato alla Cultura – “Felice Saleri” – 2003. Numerosi sono i proverbi lumezzanesi che esaltano sì il guadagno, ma soprattutto i soldi accantonati. Eccone tre. “Ol prom rehparmiat, l’è òl prom guadagnat”, il primo risparmiato è il primo guadagno; “Palanca rehpmarmiada, palanca guadagnada”, soldo risparmiato, soldo guadagnato; “Vàl de piò òna palanca rehpmarmiada che hènto guadagnade”, vale di più un soldo risparmiato che cento guadagnati. 57 I Transumanza sotto la pioggia invidia 59 Invidia Se l’invidia la fos féer tot èl mònt èl scòtarès Se l’invidia fosse febbre tutto il mondo scotterebbe 60 Vuoi vedere che l’aumento della temperatura del nostro bello ma malato pianeta è colpa dell’invidia e non dell’effetto serra o della corrente del golfo? L’invidia. Forse il più odioso dei vizi capitali. Non so se ringraziare Dio per avermi preservato da questo vizio. Faccio quest’affermazione dopo aver letto che per Bertrand Russel l’invidia è la base della democrazia. Adesso capisco perché sir Wiston Leonard Spencer Churchill affermava che la democrazia è il peggior modo di governare una nazione! Sono invece convinto che avesse ragione Miguel de Cervantes y Saavedra quando, nel Don Chisciotte (parte II, cap. VIII), affermava: “O invidia, radice di mali infiniti, verme roditore di tutte le virtù!” Per quella legge non scritta per la quale molte volte è vero esattamente il contrario, vuoi vedere che aveva ragione Jules Renard quando nel suo Diario scriveva che l’invidia è il sentimento più fortificante e più puro? Io però sto con Virgilio quando nelle sue Bucoliche (I. 11) affermava: “Non equidem invideo; minor magis”, ovvero: “Non ti invidio; mi meraviglio, piuttosto.” Nonostante tutte queste dotte citazioni, che bella è la frase dialettale summenzionata con la quale i nostri nonni definivano l’invidia! 61 L La battitura della falce lavorare 63 Lavorare L-è riàt còl mal dè la milza E’ arrivato col male alla milza 64 Vale a dire era già stanco e distrutto ancor prima di cominciare a lavorare. Parliamoci chiaro. Vero che l’articolo 1 della nostra Costituzione afferma perentorio che: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Non posso nemmeno dimenticare però quanto voleva significare Cesare Pavese affibbiando ad un suo capolavoro il titolo di: Lavorare stanca! Ho sempre guardato con simpatia, fin dai tempi del mio duro lavoro sulla catena di montaggio alla Fratelli Onofri di Renate Brianza, in provincia di Milano, chi batteva la fiacca e prendeva il tutto con sana filosofia. Mi dava sui nervi, invece, chi pontificava con frasi tipo: L’òio dè gombèt l’-è sant e benedèt, ovvero è santo e benedetto colui che ha volontà di lavorare; oppure: laurà dè spala, intendendo lavorare sodo. Laurà e unùr j-è nassìc ensèma, lavoro e onore sono nati assieme, mi faceva capire come certe nascite siamesi fossero assolutamente inopportune e dolorose! Ero, invece, più propenso ad amare detti come questo: Ai pultrù passa mai l’ùra, la passa svelta ‘nvece a chi laura. Accidenti a voi! Perché voler velocizzare il tempo quando già di per sé trascorre velocissimo senza possibilità di fermarlo? Mistero. El laurà dè la festa, èl va föra dè la finestra, cioè il lavoro festivo va fuori dalla finestra, ovvero non rende. Devono sapere i lettori più giovani che nei tempi andati, quando il lavoro nei campi urgeva e non si poteva procrastinare, per poterlo svolgere in un giorno festivo occorreva il permesso del parroco, pena un peccato in più da confessare. Sia benedetto il nome di papa Giovanni Paolo II che durante il suo pontificato ha più volte esortato i cristiani ad onorare la domenica, giorno del Signore, astenendosi dal lavoro. Vi posso assicurare che nessun parroco dell’italico suolo potrà mai dire di essere stato da me interpellato per ottenere il permesso di lavorare la domenica. Mai. E così sia. 65 M Bucato al torrente mestieri modi di dire morire 67 Mestieri Ghè riàt él peroloto È arrivato lo stagnino 68 Inconfondibile la sua voce quando, con una pentola appoggiata ad una spalla, arrivava gridando: “Fomne, ghe riàt el peroloto”. Le donne accorrevano portando le pentole bisognose di riparazione. Lui, el peroloto, le portava via e poche ore dopo riappariva con le pentole tirate a lucido. Incuriosito un giorno lo seguii. Scoprii così che poco lontano aveva attizzato un fuoco alimentato da carbone. Seduto per terra, con la pentola tra le gambe, lavorava di pinza e stagno per tappare i buchi. Poi compiva il percorso all’inverso per consegnare le pentole lustre. Il tutto per poche lire. Qualcuno ricorda cos’è el perol? Era, anzi è, una grandissima pentola, riempita d’acqua, che i nostri nonni attaccavano ad una pesante catena, di buon mattino, quando era stata presa la decisione di uccidere il maiale. L’acqua, portata ad ebollizione, serviva per pulire il maiale appena ucciso dal massadur che, a quei tempi, si serviva di uno scanil per uccidere la povera bestia con un colpo al cuore. Il tutto tra orribili grida di dolore del maiale. Oggi, grazie a Dio, è obbligatorio ucciderlo con un colpo di pistola alla testa per impedire che abbia a soffrire. Il mestiere del peroloto è scomparso, come tanti altri: Penso al ‘l moleta, alla facia töta ströta de ‘l spasacamì, ‘l frèr per ferà i cavalli e i muli. Dove sono finiti i scarpulì ? Oggi per riparare le scarpe devi andare al supermercato da Mister Mint. Ma per favore! Dove sono i contadini che batt la ransa? E la signora Giuseppina perché non va più al fiume a laá i panisèi èn cül büsu? No, non vedrò più la copia di coniugi di Adro che abitavano in Via Roma al numero 56. Io li ricordo bene. In bicicletta, trainando un curioso trabiccolo andavano famiglia per famiglia a cardare la lana degli stremàss e delle prepònte. La loro professione? Sgarsì. Inutile dire che i stremàss sono i materassi e le prepònte sono i piumoni. Sono passati pochi decenni ma sembra un secolo. Per ricordarli non ci resta che ammirarli nei quadri di Ottorino Garosio ed Eugenio Busi e tanti altri bravi artisti bresciani. 69 Modi di dire Ma va a Pifiù a ferà gli òch col martilì de pàja! Ma vai a Piffione a ferrare le oche con il martello di paglia! Bellissima ed elegante espressione inventata dai bresciani per mandare un seccatore a quel paese. Il paese, anzi una frazione di Borgosatollo, è ed era, appunto, Piffione. Nell’immaginario comune Piffione, in verità posto nell’immediata periferia sud di Brescia, era un luogo lontano, privo d’interesse, anonimo. Talmente privo d’interesse e di attrazioni che nel 1996 il sindaco di Borgosatollo Giorgio Zanardini, alla richiesta dell’Istituto Geografico De Agostini di illustrare sotto l’aspetto paesaggistico, culturale e quant’altro il suo comune, scrisse testualmente “…Il paese non offre spunti panoramici o attrazioni meritevoli di attenzione…”; “…Non vi sono fiere o mercati…”; “…Non si ricordano nomi di persone illustri nate nel paese…”; “…Bibliografia locale: non esiste nulla…”. E via dicendo. Figuratevi la frazione Piffione! La storia di ferrare le oche con il martello di paglia? E’ un rafforzativo. Andare a Piffione, dunque un luogo lontano e disagiato, e per di più essere costretti a ferrare le oche con un martello di paglia, penso sia il peggio del peggio. In verità non si trattava di mettere a ferro le palme dei piedi delle oche, ma inchiodarle al suolo affinché non si muovessero. Il mancato movimento, come logico, impedisce ai poveri animali di disperdere energie, favorendo così un più veloce aumento del peso corporeo. Attenzione! Se per sbaglio pronunciate la fatidica frase in presenza di un borgosatollese, o di un abitante di Piffione, la risposta, immediata, sarà sicuramente questa: “Vero, però ferriamo solo gli òch di passaggio…”. Cioè voi! 70 Gnurànt come le bòbe Ignorante come l’upupa Povero uccello! Sto parlando, naturalmente, dell’Upupa (Upupa epops), della famiglia degli Upupidi, appartenente all’ordine dei coraciformi. Diffuso in Europa, Asia e Africa settentrionale, d’inverno migra verso i tropici. Considerato nella mitologia come presagio di sventura, per colpa del suo verso (un basso “pu-pu-pu”), a tutt’oggi nel sentire comune è identificato come “uccello del malaugurio”. Non la pensava così il grande Aristofane quando nella sua commedia “Gli Uccelli” affidò all’Upupa (secondo il mito in origine era un uomo - il re di Tracia Tereo - trasformato poi in un uccello), il ruolo di mediatore tra Pistetero, Evelpide e i volatili. Per la cronaca Aristofane portò in scena la commedia, ancor oggi attualissima, nel 414 a.C. Splendido uccello l’Upupa! Tanto è vero che la L.i.p.u. (Lega Italiana Protezione Uccelli) l’ha inserito nel suo logo. Nel vocabolario camuno-italiano di Mauro Fiora (1997), alla parola bòbe la traduzione è: sempliciotto. Nella lingua bresciana è fuor di dubbio che si usa il nome dialettale dell’Upupa (Bòba) per identificare una persona ignorante. Già mi sembra una forzatura considerarlo un uccello del malaugurio per via del suo canto notturno, figuriamoci portarlo a simbolo della stupidità! Un mio amico di Gussago di nome Cesare Paletti, cacciatore, mi ha dato questa chiave di lettura per tentare di dare un’ interpretazione al detto dialettale. L’Upupa ha questa particolarità: scesa dall’albero, si posa sul terreno e può rimanere nel breve spazio di qualche metro, anche per ore, senza un’apparente motivazione se non quella di muoversi su se stessa compiendo piccoli passi, e nient’altro. Può bastare questo per essere etichettati come ignoranti? Aspetto lumi dagli specialisti della nostra lingua bresciana per nuove interpretazioni. 71 Daghela mia a lüle che l’è ‘n magütt Non concedere le tue grazie a quel manovale Penso che il significato sia comprensibile a tutti. Una breve precisazione è necessaria. Prima di tutto occorre rimarcare che magütt non fa parte del dialetto bresciano, ma milanese. Nel dialetto bresciano è el manöàl, il manovale, l’aiutante del muratore. Ma, visto che moradùr e manöàl, che hanno costruito le varie Milano Uno, Due, Tre, San Felice, Rodano e via di seguito, era e sono maestranze bresciane, logico e scontato che il termine milanese di magütt fosse successivamente fagocitato dal nostro e dagli altri dialetti lombardi. L’etimologia di magütt? Franco Ogliari nel suo interessante volume: Questa nostra Milano, edito da Mursia nel 1972, racconta che questo termine nasce dal vizio dei milanesi di usare parole abbreviate. Infatti, durante la costruzione del Duomo di Milano, il monsignore addetto alla registrazione delle maestranze, stanco di scrivere in latino i nomi di una delle figure più importanti impiegate nell’edificazione del Duomo milanese, ovvero il magister carpentarius, identificando con questo nome il carpentiere, invece di scrivere ogni volta accanto al nome del carpentiere la parola latina, l’abbreviava scrivendo mag. (gister) ut (come sopra), ovvero magut. Aggiungere un’altra T finale, dunque magütt, e identificare in questo termine (errando) l’aiuto muratore, fu una normale evoluzione del linguaggio comune. 72 Inutile dire che la frase dialettale sopra citata era indirizzata dai giovanotti alle ragazze che si accompagnavano con qualche manovale del paese o dintorni. Convinti di una loro supposta superiorità, dovuta al fatto di svolgere una professione come l’impiegato, geometra, ragioniere e via dicendo, cercavano di far desistere l’oggetto delle loro attenzioni dal continuare a frequentare un semplice magütt. Il maldestro epiteto quasi mai raggiungeva il suo scopo. Non avevano ancora capito quei ragazzotti che il muratore, il manovale, l’idraulico, lo scaricatore di porto o il camionista erano (e sono) ancor oggi gli uomini più concupiti dalle donne (di qualsiasi estrazione sociale) per via dei feromoni che, sembra, riescono a produrre grazie al lavoro manuale, attirando di conseguenza il sesso femminile. Chiedete all’endocrinologo. O, meglio ancora, alle vostre amiche più intime… 73 Va a fat encülà Va a farti inc… Classico modo di dire (o di fare?) in lingua bresciana per mandare a quel paese un seccatore o un amico. D’accordo. Molto meno elegante che mandare qualcuno a Piffiù a ferà gli òch, ma certamente più incisivo ed immediato. Ho un ricordo personale di questo curioso modo di mandare al diavolo qualcuno. Torbiato di Adro, in Franciacorta. Periodo estivo. Dalla città arriva il classico ragazzino per bene, ben vestito, faccia da fighetto. Noi ragazzi eravamo vestiti poveramente. Ai piedi noi aveamo i tròcoi, sì insomma, gli zoccoli. Anche d’inverno. Questo ragazzino ai piedi aveva i pattini a rotelle! Mai visto una cosa simile. Ci pensò l’amico Alberto Nembrini ad “interrogarlo” a dovere. “Ehi gnaro, da che band egnet te?” Risposta: “Me sö de Brèsa”. Di rimando il bravo Alberto: “Caso ciaàt, le de Brèsa encülàt!”. Un modo di dire volgare? Quasi certamente sì. Anche se, a mio giudizio, volgare è quasi sempre la persona che la pronuncia; quasi mai il detto in se stesso. Thomas Edward Lawrence, nelle sue Lettere, affermava che un tocco di volgarità – nel senso migliore della parola – era indispensabile alla grande arte. Convinto della bontà di quest’asserzione era anche il grande direttore d’orchestra rumeno, scomparso alcuni anni fa in Italia, Sergiu Celibidache. Memorabili le sue direzioni d’orchestra con la Rai di Torino, accompagnato al pianoforte da Arturo Benedetti Michelangeli. 74 Un giorno il maestro stava provando con la Filarmonica di Monaco il primo movimento della Sinfonia n. 1 in do maggiore, opera 25, di Sergej Seergevič Prokofev, sinfonia nota con il nome di “Classica”. I giovani orchestrali la stavano eseguendo in maniera troppo “pulita”, corretta, quasi perfetta. La cosa, come logico, non piacque al maestro. Con un gesto perentorio fermò l’orchestra e rivolgendosi loro ricordò che nella lingua italiana c’è un termine curioso: cafone, che significa uomo volgare nei gesti, nel modo di fare. “Ecco – continuò Celibidache – ci vuole un po’ di volgarità anche nella musica, soprattutto in questo movimento”. I suoi ragazzi sorrisero alla battuta, capirono cosa voleva da loro il maestro, e la prova finì in gloria. Qualcuno mi potrà obbiettare che una lingua, un dialetto non ha nulla a che vedere con l’arte. Io non ne sarei così convinto. Non posso dimenticare quanto affermava Karl Kraus nei suoi Detti e contraddetti, quando affermava che il linguaggio è la madre, non l’ancella del pensiero. Cosa c’è di più artistico del linguaggio, quando lo stesso suo rifiuto equivale a una morte? Mi sembra fosse Roland Barthes nelle sue Mitologie ad esprimere questo concetto. Se però fossi costretto a scegliere se essere mandato a quel paese da un bresciano o da un veneto, non avrei dubbi: sceglierei il veneto. “Ma va in mona” è, infatti, il loro beneaugurante epiteto. Fatti salvi gli inalienabili diritti e gusti personali, non ci possono essere dubbi: va in mona è tutt’altra cosa. Se non altro per questione di centimetri. O no? 75 Morire Le nàt a sta bià Ha cambiato residenza 76 Devo all’amico e collega carissimo Tonino Zana questo pensiero, che ha il potere di rendermi triste non appena affiora nella mia mente. Chi abita nella bassa bresciana, e soprattutto nella zona d’Orzinuovi, comprende benissimo il suo terribile significato: ” E’ andato a star via e ora riposa in pace (almeno si spera) al cimitero.” A Borgosatollo, invece, non aspettano nemmeno che siano gli altri a chiedere che fine hai fatto. In prima persona ecco la terribile frase: “Nò ai pi”, per indicare, appunto, la propria morte. Il perché di questa espressione è presto detto. Come tutti sanno fin dall’inizio del XIX secolo, il cimitero era sempre ubicato vicino alla chiesa. Ci pensò Napoleone, con il famoso editto di Saint-Cloud del 5 settembre 1806 a vietare la sepoltura nelle chiese e vicinanze. L’amministrazione di Borgosatollo individuò la nuova area cimiteriale ai confini del centro abitato. Si provvide anche all’alberazione del viale d’entrata del cimitero piantumando numerosi esemplari di Cedro Deodara, comunemente chiamati in dialetto: “Pi”. La storia racconta della puntuale moria dei cedri durante il periodo estivo. Convinti che fosse un problema di clima, ogni anno con tenacia provvedevano a ripiantumarli. Fu un concittadino di nome Guidetti a capire e risolvere il problema. La colpa non era del clima ma della mancanza di terreno vegetale, essendo il sottosuolo costituito da sabbia e ghiaione. Il problema fu risolto, a spese del Guidetti, creando due profonde trincee riempite da terreno fertile e profondo. “Nò ai pi” o “Le nàt a sta bià”, purtroppo bisogna morire. Non mi conforta nemmeno Foscolo con i suoi Sepolcri! Che assurdità chiedersi se all’ombra dei cipressi e dentro l’urne, anche se confortate di pianto, il sonno della morte fosse men duro. Il Foscolo, sempre lui, si permetteva di urlare:“Morte, tu mi darai fama e riposo”. Non m’importa nulla della fama. Mi basta il riposo, finalmente eterno, spero! Il pensiero di dover fare un giorno San Martì mi angoscia però ogni giorno di più. 77 N L’arrotino con la “Lambretta” noi 79 Nòtèr - Noàltèr Noi 80 Ho vissuto quasi quarant’anni in Franciacorta. In dialetto franciacortino Noi si traduce con la parola Nòtèr. Ho sempre sorriso al modo con il quale i cittadini lo traducono: Noàltèr! Questo plurale majestatis lo identificavo, e continuo ad identificarlo, come un rafforzativo quasi voluto per comunicare una loro supposta superiorità. Per questo mi ha sempre dato fastidio. Ma tant’è. Però che strano. Il Noàltèr e il Nòtèr mi fanno ricordare Luigi Pirandello quando nel “Sei personaggi in cerca d’autore” fa dire al padre: “Ciascuno di noi (…) si crede “uno” ma non è vero: è “tanti,” signore, “tanti,” secondo tutte le possibilità d’essere che sono in noi: “uno” con questo, “uno” con quello – diversissimi! E con l’illusione, intanto, d’esser sempre “uno per tutti,” e sempre “quest’uno” che ci crediamo, in ogni nostro atto. Non è vero! Non è vero!” Lo sospettavo. Che bello pensare che tutte le persone come noi sono Noi, mentre tutti gli altri sono Loro… 81 82 O Il maglio odio 83 Odio L’odio e l’invidia i fa orbi i òm L’odio e l’invidia rendono ciechi gli uomini 84 Dell’invidia ho già detto. Strano che questo terribile vizio non lo si trovi segnalato nei sette peccati capitali. Sarà anche vero che l’odio molte volte appare come un difetto dell’immaginazione, ma io lo ritengo un peccato “odioso”. Di sicuro subdolo se è vero che Georges Bernanos, nel suo Diario d’un curato di campagna, scriveva: “E’ più facile di quanto si creda odiarsi. La grazia è dimenticare.” Che strano. Molti pensano che l’odio assomigli in maniera sputata all’amore. Ma per amare bisogna conoscersi. Mentre si può odiare e odiarsi senza conoscersi affatto! Questo concetto appare ancor più fondato nelle nostra società, dove i rapporti con gli altri sono sempre più labili e distanti. Esiste però un’altra corrente di pensiero che ha dell’odio una concezione diversa, quasi sublimale. E’ il caso di Forster M. Edwuard, che nel suo libro Il viaggio più lungo, scriveva: “Tu pensi che sia bello non odiare nessuno. Io ti dico che è da criminali. Tu vuoi amare tutti allo stesso modo, e questo è peggio che impossibile, è sbagliato”. Sulla stessa lunghezza d’onda Samuel Butler nei suoi Taccuini: “Poco importa cosa odiamo, purché odiamo qualcosa”. Charles Baudelaire si spinge oltre. “L’odio è un liquore prezioso, un veleno più caro di quello dei Borgia; perché è fatto con il nostro sangue, la nostra salute, il nostro sonno e due terzi del nostro amore. Bisogna esserne avari”. Così nel lavoro: L’arte romantica. Eppure qualcosa di vero ci dev’essere se Svetonio nel suo Tiberius scrive che lo stesso imperatore, nei suoi commenti contro la sua persona, amava ripetere: “Oderint dum probent”, ovvero: “Odino, purché approvino”. Sbaglio se affermo che questo pensiero di Tiberio potrebbe essere un efficace slogan per qualche personaggio politico alle prese con la prossima campagna elettorale? Che poi, come afferma il proverbio bresciano, l’odio insieme all’invidia renda ciechi gli uomini, questo è un altro paio di maniche. Non è forse vero che il cieco attira compassione? Strano però che la cecità dello spirito provochi quasi sempre l’odio. 85 P Preghiera in stalla povertà pregare 87 Povertà Àrdel bè àrdel töt, ‘l-òm senza sòlcc come ‘l-è bröt Guardalo bene guardalo tutto l’uomo senza denari come è brutto 88 Essere poveri. Una dura condizione non solo fisica ma soprattutto morale. “Vi saranno sempre dei poveri in mezzo a voi, per la ragione che vi saranno sempre dei ricchi, cioè degli uomini avidi e duri che cercano non tanto il possesso quanto il potere.” Così Georges Bernanos nel suo memorabile Diario d’un curato di campagna. E’ proprio vero che l’uomo senza denari è anche brutto fisicamente? Temo che avessero ragione Edmond e Jules de Goncuourt quando nel loro trattato Idee e sensazioni affermarono convinti che: “La miseria ha i suoi gesti. Il corpo stesso alla lunga prende abitudini da povero”. Badate a quelle affascinanti, e nel contempo terribili, fotografie di gruppo di scolaresche e feste della classe degli anni del primo e secondo dopoguerra del secolo scorso, e vi convincerete quanto siano vere le parole di Edmond e Jules de Goncourt. Oggi la nostra società è colpita da un’altra terribile miseria e povertà, apparentemente meno visibile di quella economica ma sicuramente più subdola: quella culturale. Se è vero, come è vero, che solo l’uomo colto è libero, ben si comprende l’attuale scarsità di uomini liberi. 89 Pregare Anime sante, anime purganti voi eravate come noi noi diventeremo come voi. Pregate il Signore per noi noi pregheremo per voi affinché tutti possiamo andare in paradiso. Anime sante, anime purganti vòter séref come nòter nòter deenteròm come vòter. Preghì ‘l Signür pèr nòter nòter pregheròm pèr vòter chè podome na töcc en paradis 90 Bellissima questa preghiera insegnatami da nonna Lucrezia, donna piissima. Accanto alle preghiere ufficiali della Chiesa, quasi sempre in latino, c’era anche una devozione spicciola, quasi spontanea, composta da filastrocche e preghiere che erano insegnate a noi bambini, tramandate da padre in figlio. Questa preghiera sulle Anime purganti mi aveva sempre spaventato. Ogni volta che la nonna recitava questa orazione, ne rimanevo terrorizzato. Perché? E’ presto detto. Colpa di due parole: Anime purganti. Mi ricordavano, infatti, l’olio di ricino, il famigerato purgante che in quei tempi era propinato a noi bambini come antidoto a tutti i mali. 91 Un’altra preghiera-filastrocca che mi metteva in agitazione era questa: Vi saluto anime sante non vi chiamo per nome perché siete numerose. voi eravate come me e un giorno diventerò come voi. Signore vi ringrazio che mi avete dato la grazia di trascorrere una buona giornata. Vi prego di farmi la grazia di poter trascorrere una buona notte. a me e a tutti i miei familiari e anche a tutti gli altri. Va salüde anime sante no va fo ‘l nome perché sif tròp èn tante. Voàltre séref come mè e mè deentarò come voaltre. Signür va ringrasie chè mif dünat la grasia de fa un bù dè. Va preghe dè fam la grasia de fa una bunö not a mé e a töcc i mé e a töcc j-àlter. D’accordo. La preghiera si rivolge alle Anime Sante e non a quelle purganti, ma scoprire che un giorno sarei diventato come loro mi ha condizionato l’intera vita. 92 Q Trasporto del letame quaranta 93 Quaranta A quaranta èl tira ma èl stanta A quarant’anni funziona ancora ma con difficoltà 94 Un modo triviale di manifestare il proprio disagio per l’età che avanza, con tutti i suoi crucci. Charles Pégy, nella sua Victor – Marie, comte Hugo, lo faceva con una certa eleganza scrivendo che: “Quarant’anni è un’età terribile. Perché è l’età in cui diventiamo quello che siamo”. Curioso il modo con il quale Edmond e Jules de Goncourt, nel loro Journal, descrivono una donna a quarant’anni. “La donna di quarant’anni cerca furiosamente e disperatamente nell’amore il riconoscimento del fatto che non è ancora vecchia. Un amante le sembra una protesta contro il suo atto di nascita.” Salvo le solite eccezioni, ancor oggi per la donna i quarant’anni sono un traguardo che ha il potere di mandarla in paranoia, terrorizzata di non contare più nulla se non per quelli che l’hanno amata da giovani. Incredibile errore! Mai età è generosa con il mondo femminile come quello della maturità. Ma, stranamente, loro le donne, sembrano non accorgersene! “Töcc i fröcc a là sö stagiù”, afferma un proverbio bresciano. Basta saperli cogliere e non lasciarli marcire sul terreno. A quarant’anni i frutti sono copiosi. Ma anche a sessanta, ottanta… Non c’è un altro proverbio che dice: “Col tép madüra pò i nespoi!” Basta saper aspettare. 95 R A messa prima religione ricco 97 Religione Dè ché a domà Dio proederà Da oggi a domani Dio provvederà 98 Credere nella Provvidenza. Che grande dono! Quando giovanissimo, con pochissima voglia di lavorare, anzi, con nessuna voglia, ai miei denigratori ricordavo la Provvidenza e, soprattutto, quel passo del Vangelo di Matteo (6, 28) laddove Gesù ammoniva gli apostoli con questo splendido pensiero: ”Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale di più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, nè ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un’ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?” Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena”. Forte di questa massima evangelica, m’incamminai per le vie del mondo seminando guai in quasi tutti i continenti. In occasione dei miei, sempre più rari, ritorni a casa, ricordo ancora i sorrisi di scherno e la terribile frase: “Và a laurà lasarù”. Tenni duro fino a quarant’anni, quando ritenni che la Provvidenza avesse già fatto fin troppo per me. La massima evangelica e dialettale, in ogni caso, rimangono valide. Davanti a questa perla di saggezza bresciana, immediato il ricordo a Charles Dickens quando nel suo: Il Circolo di Pickwick scrive: “In tutto questo c’è una Provvidenza.” Disse Sam. “Certo”.” rispose suo padre, approvando gravemente col capo. “Senza una Provvidenza, che ne sarebbe degli impresari di pompe funebri, Sammy?” 99 Ricco El fa ‘l mestér dèl Michelàs mangià béer e nà a spas Fa il mestiere del Michelaccio mangiare bere e andare a spasso 100 Il sogno di tutti noi umani. O meglio, di noi poveracci. Perché, occorre dirlo, chi è ricco sfondato non sempre trova il tempo, o la voglia, di fare el Michelàs. Mangiare, bere e viaggiare (mi auguro che andare a spasso voglia dire questo) non è da tutti. Costa sacrificio, soldi, tempo. Dio sa quanto è prezioso il tempo! Senza contare i soldi… Ebbi modo di notare, in passato, che el mestér dèl Michelàs spesso era prerogativa non del ricco sfondato ma del piccolo arricchito che, trovandosi improvvisamente con qualche palanca in tasca, intuiva la fortuna che gli era capitata tra capo e collo. Con una certa faciloneria spesso metteva a repentaglio la pace familiare e la stessa piccola impresa che gli era costata tanti sacrifici. No, non ho mai invidiato le prime due prerogative dèl Michelàs, ovvero mangiare e bere. Troppo banale. Mi basta ancor oggi un pezzo di salame, formaggio o stracchino, e un bicchiere di vino rosso nella scodella bianca per sentirmi un re. Ma quel nà a spas sicuramente si. Per questo motivo quando mio papà Angelo, al mio ritorno dal servizio militare nell’ 8^ Reggimento Alpini “Brigata Julia” a l’Aquila, nel lontano 25 luglio 1965, mi informò a muso duro che la vita consisteva nel lavorare, sposarsi e andare in pensione (in attesa della morte, mi è sembrato di capire), presi la valigia e scappai nomade per le vie del mondo! A modo mio per oltre 20 anni ho fatto la vita dèl Michelas. Ovvero, ho viaggiato, ero ricco. Guido Piovene, affermava che viaggiare dovrebbe essere sempre un atto di umiltà. Ahinoi! non sempre è stato così. Purtroppo. 101 S La benedizione salute santi soprannome studiare 103 Salute L’èn giànde In malora. Si è ridotto a mangiar ghiande 104 Questa curiosa espressione, tanto cara ai nostri nonni e nonne, è tradotta da Angelo Albrici nel suo volume: Giöna piö dè Bertoldo con la frase: “In malora. Si è ridotto a mangiar ghiande”. In verità, almeno in Franciacorta, ma anche in altre parti della nostra vasta provincia, ha un significato più ampio. Oserei dire quasi diverso. Con quest’espressione, infatti, è di solito identificata una persona che sta molto male fisicamente. Solo in senso traslato identifica ai giorni nostri, invece, una persona mal messa sul piano economico. Nella maggior parte dei casi ancor oggi l’èn giànde vuol significare una persona gravemente ammalata, sofferente, quasi sempre fisicamente emaciata, magra, quasi incapace di stare in piedi e di svolgere le normali attività quotidiane. Le ghiande, frutto della pianta di Farnia, meglio conosciuta come quercia sotto il nostro cielo della Pianura Padana, cosa c’entrano? C’entrano perché le ghiande, in illo tempore, erano raccolte, tostate e macinate per preparare un surrogato del caffè. Una brodaglia che Antonio Griffo Flavio Dicas Commeno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio, Altezza Imperiale, Conte Palatino, Cavaliere del Sacro Romano Impero, Esarca di Ravenna, Duca di Macedonia e di Illiria, Principe di Costantinopoli, di Cilicia, di Tessaglia, di Ponte di Moldavia, di Dardania, del Peloponneso, Conte di Cipro e di Epiro, Conte e Duca di Drivasto e Durazzo, sì insomma, il mitico Totò, chiamava ciofeca, il caffè dei poveri. Dire che una persona l’èn giànde, dunque, vuol significare sì che sta male ed è malmessa; ma indirettamente vuol ricordare quei tempi lontani quando il contadino era costretto a sottrarre ai suini il prezioso frutto della quercia, tostarlo e macinarlo nel famoso macinino, che si trova ancora al mercatino delle pulci, per illudersi bevendo quella schifosa brodaglia di “sentire” il sapore del caffè, allora prezioso ed introvabile. 105 Santi Acqua dè rane acqua dè bés Sant’Antone ‘l la benedés Acqua delle rane acqua delle serpi Sant’Antonio la benedice 106 Era la preghiera che mio nonno Giacomo recitava quando mi accompagnava in campagna, al Cinquino di Torbiato, una frazione del comune di Adro, prima di bere acqua dal fosso. Caro nonno Giacomo, penso che se tu ora fossi in vita, nemmeno l’invocazione a Sant’Antonio potrebbe salvarti da morte certa se ti azzardassi a bere l’acqua che scorre nei fossi della nostra bella Franciacorta. Ma tant’è. Invocare l’aiuto dei santi era un tempo una delle prerogative di chi abitava in campagna e lavorava i campi. Il pane ed il companatico dipendevano esclusivamente dal raccolto che il buon Dio concedeva in ogni stagione. Chi ha la mia età ricorda sicuramente le Rogazioni, preghiere recitate dal sacerdote, dai chierichetti e dalle pie donne che accompagnavano il corteo attraverso le strade di campagna, soffermandosi a pregare davanti alle santelle. Ero particolarmente colpito dalle frasi in latino che il sacerdote e le pie donne recitavano. “A fulgore et tempestate” cantava il sacerdote. “Libera nos Domine” rispondevamo con le donne. E fin qui tutto bene, nel senso che capivo il significato. Il problema era l’invocazione successiva: “A peste, fame et bello”. Bello? Perché mai un uomo bello doveva considerarsi un pericolo per la campagna, tanto da chiedere aiuto all’Essere Supremo? Un mistero fino a quando, più tardi, mi fu spiegato che bello voleva dire guerra! Il dramma era l’invocazione: “A morte perpetua”. Da noi chierichetti tradotta con: “A morte la perpetua”, il mio pensiero andava immediatamente alla signora Maddalena, la perpetua di don Giuseppe Ferrari, parroco di Torbiato, una signorina tanto cara. Perché mai invocare la sua morte? Assurdo! Intuì che questa strana lingua aveva spesso significati ben diversi da quelli apparenti. A tal punto che… Ma questa è un’altra storia. La tradizione delle rogazioni è ormai quasi del tutto scomparsa. Come sta scomparendo la campagna, purtroppo! 107 Chi öl bèla galèta per san Zè ‘l la mèta Chi vuole bozzoli belli porti il seme dei bachi all’incubatrice per San Zeno 108 Ho il terribile sospetto che se chiede a qualche giovane bresciano cosa sono le galète, vi risponderanno che sono le arachidi. Coltivare i bachi da seta era in quel tempo fonte di guadagno. Tutta la casa era messa a disposizione dei bachi da seta stesi su dei grandi telai. Incredibile il rumore dei bachi che mangiavano le foglie di gelso. Un rumore inconfondibile che non dimenticherò mai più. Che spettacolo ammirare il baco che spariva lentamente avvolto nel bozzolo color oro! I bozzoli erano poi venduti. Meno le falopè, i bozzoli andati a male, che nonna Lucrezia faceva bollire per poi, con grande perizia, recuperare da essi del prezioso filo usato per fare qualche indumento. Falopo. Pochi ricordano questa curiosa espressione che era quasi sempre affibbiata a una persona di poco pregio, che aveva fatto cilecca…, ad un fallito nella vita. Ho il fondato sospetto che fosse in uso solo in Franciacorta. 109 Soprannome Schitöm Veramente curiosa quest’espressione dialettale inventata dai nostri nonni per determinare il soprannome di una persona. In passato ogni famiglia era identificata con un soprannome. I componenti della mia famiglia da parte di padre erano originari di Vigolo, in provincia di Bergamo. Curiosamente però ci fu affibbiato il soprannome di Parsanech, ovvero provenienti da Parzanica, paese contiguo a Vigolo, dove la quasi totalità degli abitanti portavano, e portano, il cognome di Danesi. I miei fratelli ed io eravamo, invece, identificati come i preturì, ovvero i nipotini del pretur (il pretore). Mio nonno Giacomo, in verità, non era pretore, ma un semplice giudice di pace, o qualcosa di simile. Ergo eccoci identificati con un soprannome ad hoc. Alle Fornaci di Torbiato famoso era il soprannome affibbiato ad un ragazzo smilzo: Carnera! Erano i tempi d’oro del campione di pugilato Primo Carnera. Un armadio alto quasi 2 metri. Logico e scontato che uno magro e piccolo fosse immediatamente bollato con il soprannome di Carnera. Sempre alle Fornaci altro soprannome famoso era quel di Cül néghèr. Il signore in oggetto conduceva una piccola osteria dove, come logico, si beveva vino rosso, anzi, nero. Ergo… Attenzione! Da non confondere con Cül bianch, schitöm con il quale si identificava chi frequentava in modo assiduo la parrocchia. 110 A proposito di parrocchia. Chi non ricorda a Torbiato Rusinä del prét? Era la nipote di don Giuseppe Ferrari, compianto parroco in illo tempore. Era Rusinä il nostro punto di riferimento in parrocchia. Fu lei ad informarci che il matrimonio di Cia Longa, una vedova che si apprestava a seconde nozze con un cittadino d’Erbusco, si sarebbe svolto alle 3 di notte! Un tempo per le vedove risposarsi voleva dire sottoporsi ad incredibili ironie, che si concretizzavano nel suonare incudine e martello, davanti alla chiesa, in segno di scherno. Oltre naturalmente al suono delle tole, ovvero scatole di latta che fungevano da gran cassa. Inutile dire che gli abitanti della piccola frazione di Adro a quell’ora mattutina erano tutti, nessun escluso, strategicamente sistemati in piazza armati di tole, incudine e martello. Il malcapitato don Ferrari fu costretto a chiudere il portone della chiesa perché il fracasso impediva di celebrare il sacro rito. Cia Longa e il novello sposo “fuggirono” poi a bordo di una vecchia utilitaria, impreziosita dalle tole e quant’altro, in direzione della Bellavista, con destinazione Erbusco. Altri tempi! 111 Studiare La àca la gha maiàt i lìber La mucca gli ha mangiato i libri 112 Con quest’epiteto era bollato chi abbandonava gli studi per incapacità o malavoglia. Ma non è solo questa l’interpretazione data alla summenzionata frase dialettale. Angelo Albrici, nel suo citato libro Giöna Piò de Bertoldo, afferma che: ”S’intende anche che giunto alla lettera acca, che non vale niente ed in bresciano equivale a mucca, non ha proseguito a studiare”. Sono molte le ironie coniate in passato per bollare gli studenti per niente inclini allo studio. Eccone alcune. Chi tròp èl studia, mat èl deentarà, chi poc èl studia fachì èl resterà. Ovvero: chi studia troppo diventerà matto; chi studia poco, resterà facchino. Davanti alla prospettiva di diventare matto, logica la scelta per una sterminata moltitudine di giovani decidere di studiare poco. Se poi restava facchino, pazienza… El ghè ‘n sa ‘na pagina dè piö dèl lìber. Ne sa una pagina più del libro. Un saccente o solamente sapeva più di quanto occorreva per vivere in quei tempi? Mistero. Non la passava liscia nemmeno il laureato ignorante. I nostri nonni avevano coniato per questo dottore un detto veramente irridente. Eccolo: Istruìt come ‘l Dutùr dè …gnaga, che al cüràa ‘l cül per ‘na piaga! Dotto come il medico di un paese che curava il deretano come una piaga. Può bastare? 113 T Le cesene tempo 115 Tempo Alba rossa: o vènt o gòssa Alba rossa: o vento o pioggia 116 Il tempo in senso meteorologico, naturalmente! Sì, insomma, le previsioni del tempo che hanno avuto nel colonnello Bernacca la pietra miliare. Datemi una nuvola, un uragano e vi costruirò un impero. Di chiacchiere. Oggigiorno non c’è stazione radiofonica, televisiva, giornali, riviste che non abbiano la loro rubrica sul tempo che farà. Sarà anche vero che le previsioni degli esperti sono sempre esatte. In verità il tempo metereologico risulterà poi quasi sempre sbagliato! Anche nel cazzeggio giornaliero il tempo occupa grande spazio. Ma i nostri nonni come si comportavano in tema di previsioni? Quali gli strumenti a disposizione? Nessuno strumento, ma osservando la natura e scrutando il proprio corpo. Metodi empirici che, quasi sempre, si rivelavano più azzeccati di quelli emessi oggi con l’ausilio di palloni sonda o satelliti. In primis il dolore ai calli! Non c’erano dubbi che il dolore ai calli era sintomo sicuro di cambiamento meteorologico. Sal mìssa e mal dè cai, l’acqua la manca mai. Idem i dolori muscolari o localizzati in prossimità di vecchie fratture ossee. Poi bastava guardare la natura. Come appunto, il proverbio dell’alba rossa. Simile a quello: rosso di sera buontempo si spera. Quando mercordé èl bagna gioedè, stì sicür che piöf ‘a venerdé, dicevano i nostri nonni. Il vento aveva una sua valenza particolare. Quando i gài i canta fora d’ura, se l’aria l’è ciara la sé fa scura. I cacciatori asserivano convinti che Gardéna sola bròca, ‘l-è ‘l-invèren che ciòca; ovvero cesena sul ramo, inverno alla porta. La cesena inteso come uccello migratore, naturalmente, che ha la particolarità d’appoggiarsi sui rami secchi più alti. Non dimentichiamoci del vento, altro segnale di cambiamento meteorologico. Chi abita in prossimità di una linea ferroviaria conosce bene il linguaggio del vento. Il suono della littorina, forte o flebile, è una sicura previsione meteorologica. A proposito della littorina della linea BresciaEdolo, gestita un tempo SNFT, ora dalle Ferrovie Nord. Sapete come era tradotta quella sigla? Senza Nessuna Fretta Trasportiamo! O, meglio ancora: “Signorine Non Fatevela Toccare”! 117 U Natura morta ungere 119 Ungere I cadenàs perché nò i scàine bösogna òntai I catenacci perché non stridano bisogna ungerli 120 Bello il termine òntà, per significare oliare. Inutile dire che la frase menzionata vuol significare che per ottenere qualcosa occorre “ungere”. In caso contrario e difficile ottenere qualcosa. Così i nostri nonni identificavano le bustarelle. Nei tempi andati le palanche erano contate. Allora si ricorreva al cibo. Bòca piena nò la dis dè nò. Un buon banchetto serviva sicuramente alla bisogna. Ancor più curiosa la frase Ontàga i àer, ovvero ungergli le labbra. Vale a dire gratificarlo con una mancia. Da non confondere con la frase Cicem i gos, ovvero succhiami sul collo, che quasi sempre aveva un significato spregiativo. Meno usata, invece, la frase Töcc i gha la bòca tajada per traèrs. Vale a dire che tutti hanno la bocca tagliata per traverso, vale a dire a forma di salvadanaio. 121 V Le storielle del nonno vecchiaia 123 Vecchiaia Nemo est tam senex qui se annum non putet posse vivere Nessuno è tanto vecchio che non creda di poter vivere ancora un anno Cicerone, Cato Maior de senectute 124 D’accordo, non è in dialetto bresciano questo straordinario pensiero, ma il latino è la lingua dei nostri antenati. Non penso che in questa pubblicazione la bellissima espressione latina possa stonare. Anzi! Curiosi di sapere come la pensavano i nostri nonni sulla vecchiaia? Come i vecchi di oggi, anche se l’aspettativa di vita attuale è ben diversa da quella di allora: con il terrore. Soprattutto per la paura di finire all’ospizio. E per manifestarlo usavano una frase truce per indicare quel luogo: “‘L –è zò èn dei macù”, ovvero: “E’ ricoverato nell’ospizio dei vecchi”. Curioso e malinconico il termine macù che, giustamente, Giovanni Scaramella nel Dizionario Vocabolario Ortografico Bresciano traduce con: sciocco, macaco. Un’altra frase dialettale per indicare l’attuale casa di riposo era questa: “ ’Nda a casa bigolèra”. Per il semplice motivo che a tavola servivano sempre i bigöi, gli spaghetti nostrani. Quante volte da parte dei giovani ho ascoltato questa espressione: “La dis la Sacra Scritüra: Laurà tè ècio, che tè ghé la pèl düra”! Écio era anche il nome bonario con il quale s'identificava sia il nonno che il papà. I tempi cambiano, anche se il risultato finale mi sembra atrocemente uguale, e anche i detti dialettali perdono un po’ della loro verità. Come questo, per esempio: “Fina ai sinquanta, sé söbia e sé canta, dai sinquanto ‘n sö, poc sé söbia e se canta piö”, ovvero: “Fino ai cinquanta si zufola e si canta, dai cinquanta in su poco si zufola e non si canta più”. Fortunatamente non è così ai giorni nostri. Anche il prossimo è datato: “Quant sé gha ‘na certa età piö de béer e mangià no sé pöl fa”. Non è vero, non è vero. Chiedetelo agli anziani di Milano che hanno chiesto nei giorni scorsi al Comune di fornir loro il Viagra a prezzo ridotto! Ma l’attuale vecchiaia non è triste? Si, perché finiscono le speranze. Ci restano però le gioie. Poche ma importanti. 125 Z “Non esiste nel dialetto bresciano (come suono n.d.r.); ha lo stesso suono della S intervocalica (s) e viene usata nelle parole corrispondenti italiane che hanno la Z, per non mettere in difficoltà il lettore. Inoltre può sostituire: cc, gg, zz,; c,g; ce, ci; gi; sg. Esempio: Uccello ozèl, Loggia Lòza, … camicetta camizèta…. In finale di parola prende il suono di S aspra. Esempio: vérz, vérs….” Da: “Nuovo Vocabolario Ortografico Bresciano” di Giovanni Scaramella, Com&Print Editore – Brescia 2003 – pag. IX . Per onorare il sottotitolo di questa pubblicazione, mi astengo dal commentare questa consonante. Perché dovrei farlo? Manca perfino il suono… 126 BIBLIOGRAFIA ANGELO ALBRICI Giona piö dè Bertoldo - Stamperia Fratelli Geroldi (Brescia) - Ed. 30.11.1969 MONICA DEL SOLDATO - MARGHERITA SCHIARETTA Modi di dire di Brescia Edizioni La Libreria di Demetra - Colognola ai Colli (VR) 2000 ENZO SALERI Proèrbe e modi de dì che ghe ree a hcomparì - Comune di Lumezzane Assessorato alla Cultura - “Felice Saleri” 2003 GIOVANNI SCARAMELLA Nuovo Vocabolario Ortografico Bresciano - Com&Print Editore - Brescia 2003 127 Prefazione pag. 5 Introduzione “ 7 A B C D E F G H I L “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 9 17 21 29 39 43 49 55 59 63 Affari - Amicizia - Amore Beghe Carità – Cimitero – Comandare Debiti – Dio – Donna Eredità Filastrocca – Furbizia Gioventù – Giustizia Hòi Invidia Lavorare M N O P Q R S T U V Z Mestieri – Modi di dire – Morire Noi Odio Povertà Quaranta Religione – Ricco Salute – Santi – Soprannome – Studiare Tempo Ungere Vecchiaia Omissis Bibliografia Indice 128 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 67 79 83 87 93 97 103 115 119 123 126 “ 127 “ 128
Scaricare