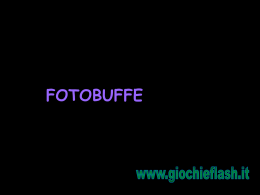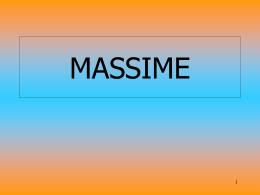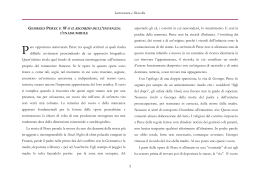n.8 2 The Godfather Nathaniel Hawthorne di FILIPPO PENACCHIO A ssieme a Herman Melville e a Mark Twain, Nathaniel Hawthorne è solitamente considerato il padre fondatore della moderna letteratura americana. Come i suoi colleghi, anch’egli diede alle stampe per lo meno un libro «infernale», stando alle sue parole: idealmente riponiamo La lettera scarlatta a fianco di Moby Dick, un romanzo “formativo” che oltre al «sacro vincolo matrimoniale tra maschi» e agli effetti deleteri di una dieta a base di fagioli celebra la vita come dannazione eterna, e a Le Avventure di Huckleberry Finn, altro romanzetto “divertente” il cui protagonista ammette candidamente che sì, andrà all’inferno. Hawthorne non era certo il tipo dello scrittore virile, né tantomeno bohémien, ci mancherebbe: visse fino a quarant’anni morbosamente coccolato da madre e sorelle, si sposò in età adulta con una pallida zitella ipocondriaca, tentò con scarsissimi risultati di vivere in una comunità trascendentalista – roba di hippies ante-litteram (vedi Il romanzo di Valgioiosa) – costringendosi infine a trascorrere una «penosa schiavitù» presso la dogana di Salem, MA, pesando sale e carbone. Era però, questo poco ma sicuro, un uomo tormentato ed esacerbato (e magari pure impotente e predestinato), che concepiva la scrittura come ossessivo atto di espiazione, che ritraeva se stesso in un certo personaggio (Oberon) triste e malinconico, che esordì ricomprando tutte le copie del suo primo romanzo e dando loro fuoco nella convinzione che «gli scrittori sono poveri diavoli e perciò Satana li uncina a suo piacere». Il fatto che i suoi antenati perseguitarono e mandarono al rogo una buona quota di streghe deve aver pesato non poco sulla sua coscienza e anzitutto deve avergli instillato un paio di idee quantomeno malsane: che la dannazione eterna sia un destino plausibile (La casa dei sette abbaini) e che l’(oscena) essenza del reale risieda nell’indicibile o nell’inattingibile (Il velo nero del pastore o Il giovane buon Brown). Oggi lo ricordiamo soprattutto per quel «testamento di un uomo spiritualmente suicida» che è La lettera scarlatta, in cui si racconta di una giovane donzella che per avere avuto un figlio al di fuori del matrimonio (e da un prete, per giunta) viene fisicamente taggata con la A di “adultera”, ritenuta demoniaca e per questo condannata a morire da peccatrice. Ovviamente Hawthorne è troppo pavido per raccontarci nel dettaglio la morbosità del suddetto patto faustiano: e infatti questo romanzo che ci insegna che l’inferno, in fin dei conti, esiste per davvero, oggi lo leggiamo superficialmente, senza prestare fede alle parole di biasimo per il genere umano – e per il sesso femminile in particolare – spese dal suo autore. Indi per cui mi prenderò io l’onere di esplicitare alle donne adultere che stessero leggendo queste righe le parole con cui Hawthorne condannò la sua corrotta eroina: «Io vi battezzo non nel nome del Padre, ma nel nome del Demonio». Amen. 3 Sommario La citazione del mese Le vite ortogonali Libri (quasi) mai letti Letterature Involontarie Nobel minori Punizioni! Biografie Edulcorate Me lo copre il prezzo? Le città letterarie Oh, Scena! 5 6 7 8 10 11 12 13 13 14 Viaggi La lettera che muore Mattoni L'angolo del cinematografo Pillole di Scienza I ferri del mestiere La posta dei lettori Metaletterari di carta Ghost World Iperboloser 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 Editoriale Benvenuti a Finzioni numero otto. Si avvicina il primo compleanno del progetto di lettura creativa e, per festeggiarlo, abbiamo preparato un numero bellissimo e un’offerta da far impallidire la renna di Babbo Natale, quella col naso rosso. massimi livelli. Noi, infatti, pensiamo anche ai problemi di tutti i giorni come “cosa regalare per Natale a chi voglio bene?” Semplice, regala Finzioni! Sei mesi di abbonamento da gennaio a giugno al costo di una stecca di carbone. Tutti quelli che aderiranno all’offerta, per non rimanere a mani vuote il 25, riceveranno via mail un pdf da stampare con la conferma del regalo, giusto giusto per metterla nella busta dove di solito la nonna mette i soldi, così la sorpresa sarà doppia! Torna il grande cinema su Finzioni, con Amici Miei (fonte inesauribile di idee e supercazzole) e Where the wild things are, tratto dal libro illustrato di Maurice Sendak e sceneggiato da Dave Eggers. Inizia poi una rubrica, curata da Licia Ambu, dove finalmente ci si mette nei panni del povero libraio che vende una copia di Benni a fronte di centociquanta Dan Brown e che, troppo spesso, si sente rivolgere richieste come Cercavo un libro ma non ricordo né il titolo né l’autore. Tutti i dettagli su finzionimagazine.it e finzioni.bigcartel.com. Finzioni però non è solo intrattenimento culturale ai La Redazione 4 C os'è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione. Philippe Noiret alias Giorgio Perozzi, Amici miei. La citazione del mese Il genio & Opera struggente di un formidabile genio di JACOPO CIRILLO P remessa: chi non ha mai visto Amici miei lo guardi, per carità di Dio, lo guardi! Il Perozzi, ammirato dalla fantasia dell’amico Necchi e dalla sua - diciamolo - cacca, si interroga su cosa sia il genio. Non a caso proprio a lui viene affidato questo ragionamento, visto che il personaggio del goliardico giornalista rappresenta l’inizio e la fine del film, il suo nume tutelare. Il genio stesso, insomma. Ma allora, cos’è il genio. Molti hanno provato a spiegarlo. Iniziamo da quel nume tutelare di Harlod Bloom che, nel suo didascalico libro Il genio, ne parla come senso d’eccellenza. E parla dell’eccellere come l’aspirazione allo straordinario e al trascendente. Mmmm, trascendente. Dunque al di là di se stessi, fuori da sé. Ma Orazio, il poeta, diceva che il genio “è il dio della natura umana, il dio che abbiamo dentro di noi”. Allora il genio è qualcosa che abbiamo dentro e che per esprimersi ci trascende, cioè diventa oltre noi e, per questo, ci resiste nel tempo e nello spazio. L’opera di Leonardo da Vinci in effetti lo ha di certo superato in longevità. Per un tal Censorino poi (nato nel 238 d.C.) è anche l’angelo custode che protegge e mette sulla retta via. Adesso la cosa si fa interessante: nella cultura araba, ove noi infedeli tendiamo sempre ad associare il genio alla lampada, il jinn deriva dalla lingua aramaica e significa “nascondersi, occultarsi”. Dentro di noi evidentemente. E quando il jinn esce di solito è cattivo e dunque, uccidendoci, ci sopravvive. Romani, arabi, supercazzole e vecchi critici letterari ricalcano più o meno la stessa dinamica: il genio, qualunque cosa sia, è nascosto dentro di noi ma esce fuori (trascende) e, buono o cattivo che sia, vive anche dopo di noi. Non a caso Philip- 5 pe Noiret è morto tre anni fa ma la sua idea ci fa ancora da spunto. Ed ecco che arriva il personaggione: Dave Eggers. Nella sua Opera struggente di un formidabile genio ci sono due brani incredibili, uno da pagina 166 e l’altro a pagina 271, in cui Eggers, che si trova a essere, per tutto il libro, autore, narratore e personaggio, entra letteralmente con la sua voce fuori campo nei discorsi che i protagonisti, lui compreso, stanno facendo nella narrazione, redarguendoli - addirittura dice al suo fratellino che sta uscendo troppo dal personaggio (!) - e quindi rimettendoli sulla retta via. Ecco il genio dei romani, degli arabi e di Monicelli. E’ dentro, nascosto, poi esce, trascende, è cattivo, redarguisce e mette sulla retta via. Dave Eggers è letteralmente il genio del suo libro e il libro è la sua lampada. Ecco, l’ho detto. Le vite ortogonali Kugelmass vs Alexei Ivanovich di JACOPO DONATI P lutarco scrisse una serie di 24 biografie che prese il nome di Vite parallele. Per ognuna prese una figura greca ed una romana, le mise una affianco all’altra e ne cercò le similitudini. Ma qui si parla di finzione, mica di realtà!, e così i miei grandi saranno i personaggi d’inchiostro dei libri. Lavoro ben più umile il mio che, oltre a esaminare solo una parte della vita di questi personaggi, ne sottolineerà le differenze. amore. Bastano poche settimane perché la lezione imparata svanisca. Kugelmass ci riprova ma qualcosa va storto. Una volta entrato nel libro il marchingegno prende fuoco e Persky muore. Kugelmass non si ritrova nel romanzo che credeva ma in un manuale di spagnolo in cui finirà i suoi giorni inseguito dal verbo irregolare tener. Kugelmass Alexei Ivanovich Alexei è una pedina nelle mani delle donne. È proprio una donna che gli fa assaporare il suo errore: il gioco d’azzardo. Una dama francese lo distruggerà quando sarà ricco e una vecchia sarà lì ad assillarlo con le giocate, ma Polina, la donna di cui si innamora, sarà la sua rovina dall’inizio alla fine. Dostoevskij metterà Alexei in mezzo a ricconi senza scrupoli, dove finirà per credere che l’unico modo per ottenere il cuore di Polina sia diventare ricco. E ci riesce!, ma è tutto inutile, e Polina parte disprezzandolo più di prima. Alexei e Polina non si vedranno per molto tempo. Un giorno Alexei riceverà dei soldi da un amico perché possa farsi una carriera. Questo amico gli rivelerà che Polina lo ama e i sogni del giocatore, subito andranno a lei e al gioco d’azzardo. Ancora convinto di poterla raggiungere con i soldi, andrà fantasticando grandi vincite e altrettanto Kugelmass è professore di lettere universitario. Ha due figli, una moglie-balenottera e una montagna di alimenti da pagare alla prima moglie. La vita ristagna monotona nel suo petto peloso e ha bisogno dir provare emozioni nuove. Cosa fareste se vi fosse data la possibilità di entrare in un romanzo a vostra scelta? Woody Allen, che dirige Kugelmass da dietro la pagina, sceglie la tresca con Emma Bovary. Quale miglior opzione di una storia letteraria per non essere colti in flagrante? Grazie a un tale di nome Persky, Kugelmass entra nel libro e si abbandona all’amore. Commette però commette l’errore di portare Emma fuori dal romanzo in cui non riuscirà a rientrare. “O mi riporti nel romanzo o mi sposi!” e quella che era una semplice scappatella si tramuta in incubo. Un collega di Kugelmass lo riconosce e minaccia di dire tutto alla moglie, ma tutto si rimette a posto e il professore di lettere impara la lezione: non tradirà più. 6 Cosa c’è di ortogonale tra la vita di Kugelmass e quella di Ivanovich? Una cosa li distingue nei loro errori: Alexei sogna di recuperare le perdite alla roulette per essere accettato da Polina, mentre Kugelmass è guidato più dagli ormoni che dal cuore. Per Alexei l’errore, il gioco d’azzardo, è solo un mezzo, per l’altro è il fine. Meglio tenerlo a mente se non si vuole finire i propri giorni inseguiti da mostri ben peggiori di un verbo irregolare. Fëdor Michajlovič Dostoevskij Il giocatore. Woody Allen - Il caso Kugelmass in Effetti collaterali. Libri (quasi) mai letti Fenomenologia dei libri quasi mai letti di Maria Giovanna Ziccardi M i permetto, questa volta, una variazione sul tema: la fenomenologia dei libri quasi mai letti. Il dove e il come stanno nel mondo. Perché capita, sapete, di iniziarli e non finirli, ma anche di incontrarli. E vederli lì, proprio come libri quasi mai letti, in molti casi, mi mette una grandissima tristezza. Uno di questi casi capita qualche giorno fa, quando ho avuto modo di soffermarmi sull’elegante libreria di una laureatissima famiglia benestante. Mi piace osservare le librerie di tutte le case, curiosarci dentro, rapirne idee. Ma sono le suddette scansie che meritano tutto il mio spazio, questo mese. Ebbene, davanti al design ultra moderno di questi discreti scaffali borghesi, la prima cosa che penso è: questa libreria è falsa. Nulla che sia fuori posto, nulla che non ci si aspetti, nulla che non si conosca già. L’insieme dei libri sta lì davanti a te a dirti: “ecco! Guardami e giudica”. Ogni volume è ordinato per casa editrice: ma non trapela l’amore fisico per il libro quanto piuttosto una mania estetica fine a se stessa. O all’armonia del salotto. didi soli, Paula, Via col vento, vari titoli di Grisham, molti cataloghi illustrati di Raffaello o Leonardo, la serie completa dell’enciclopedia della filosofia, una dozzina di libri della collana della Repubblica (libro+giornale, di qualche anno fa). Nessuna edizione economica, nemmeno di Feltrinelli. Nessun libro più vecchio di 10 anni. Nessun mattone, nessuna stramberia, nessuna biografia astrusa, nessun guizzo imprevisto. Nessun autore che non avesse venduto almeno un best seller. Niente che assomigliasse al singhiozzante, naturale, accumulo di una famiglia che studia, che guarda, che sceglie cosa leggere perché il piacere di leggere comincia proprio da questa scelta (economica, personale, intellettuale, stupida, morale, irrazionale, pregiudicata, impregiudicata, spregiudicata). Una libreria, invece, senza aggettivi. Orfana di imprecisione. Una messa in scena, dove la scena è la perfezione che più si cerca e più sfugge. E stona. Possibile che anche i libri possano diventare artificio? E poi si capisce, la bella libreria è anche una brava libreria. Ed ecco sciorinati e mescolati tutti i titoli della migliore o peggiore (non so), ma comunque più ovvia, tradizione letteraria: Il nome della rosa, Io uccido, Il giardino dei Finzi Contini, La mia Africa, Il codice da Vinci, La metamorfosi, Mille splen- 7 Libri quasi mai letti. Perché meritavano di non essere letti e non lo sono stati o perché meritavano di essere letti ma sono stati trasformati in oggetti di arredo. Chiamati, in qualche modo, a fare status. E in effetti lo fanno: sterilizzati di qualsiasi fascino, non chiamano, non vibrano, ma veicolano un’idea assolutamente precisa. Quella appunto di un’esposizione che cerca approvazione, e non della tua biblioteca che sfogli e sfoggi anche, sì, ma con commozione, con entusiasmo, o magari rammaricandoti che “è tutta lì”. Una libreria per gli invitati. L’abbandono dei libri quasi mai letti è anche questo. E vorrei sottolineare il quasi. Perché una libreria congegnata in quel modo non segnala tanto un’assenza, quanto piuttosto un disinteresse. Un interesse che arriva fino a “lì”, perché comunque ha gli strumenti per arrivarci, ma non si spreca oltre. E a quel punto i libri vanno benissimo per fare bello (e bravo) il salotto. Letterature involontarie La memoria fra il cretto e la palude. Cose non false da dire in coda. di EDOARDO LUCATTI L e memorie si danno alle carte, se si ha tempo e penna per scriverne. Diventano best seller e in qualche modo si maiuscolano, scaffalano, scontrinano. Altre volte rimangono semplici diari e altre volte ancora - molte per la verità - finiscono nella spazzatura, scambiate per qualcos’altro da tua madre o da una domestica d’improvvida latitudine. Ma sono sempre memorie, memorie che sanno di banana, di sangue mestruale, di marcio, di niente, di tutto, di quello che finisce nei cassonetti, insomma. Ci sono anche altre memorie, certo. Memorie date alle fiamme, arse su pire, fuochi, roghi, memorie di popoli che hanno voglia e fretta di essere altro, senza sapere – per altro - che non ce la faranno mai. C’è memoria da confidare, memoria da falsare, memoria da nascondere, memoria da esaltare. C’è memoria e, più spesso, non ce n’è. Non ce n’è, punto. Non c’è traccia di traccia né orma di orma, niente. Peti senza metano. E per come la vedo io, anche se svariati e saggi maestri in velluto a coste sono soliti dire il contrario, non è detto che sia sempre un male. Perché si può anche ricordare alla René Ferretti, cioè – fuor di metafora – ricordare ‘a caz- zo di cane’ e a quel punto, quando il passato proprio e altrui è reso alla caricatura di se stesso, incancrenito nella sintassi ebete di un pensiero sconcio e meschino, a quel punto – voglio dire – anche l’Alzheimer fa la sua porca figura nel carnet delle possibili alternative. Ora: non serviva la quantistica per spiegarci che non si può mai dire il Vero, perché IL vero è sempre UN vero ed è l’osservatore che decide e bla bla bla. Serve però l’esperienza di uomini con le palle ancorate al mondo per spiegarci che si può, e si può davvero, dire cose non false. La verità è inattingibile (grazie e Graziella) ma non per questo è d’obbligo la menzogna. Quando parlate del vostro passato, quando lo raccontate all’orecchio del povero stronzo che nella fila vi sta davanti (perché le generazioni, se non lo sapeste, sono ferme in coda aspettando che un impiegato dica loro chi sono), quando fate questo, insomma, nulla vi vieta di essere onesti. Mi sono informato, ho fatto una coda e un impiegato me l’ha detto: si può! E mi piace pensare che quel medico chirurgo di nome Alberto Burri, avendo visto i resti di Gibellina dopo il terremoto del 8 Belice, abbia pensato qualcosa di simile. Gibellina è un paese siciliano in provincia di Trapani, che il noto sisma del 1968 rase completamente al suolo, senza risparmiare nemmeno ciò che il caso, a volte, mantiene in piedi. Il terremoto, a Gibellina, è stato piuttosto preciso. Ed è proprio di quella lutulenta precisione che Burri ha recato, onestamente, memoria. Non l’ha fatto scrivendo un carme, scolpendo una stele, o innalzando un monumento, con cui un po’ – per forza – avrebbe mentito. No. Ha preso tonnellate, tonnellate e tonnellate di cemento e le ha colate sopra l’intera pianta del Paese, un unico blocco omogeneo spezzato solo dall’impianto viario originale, conservato e tutt’ora percorribile. Forse il Cretto di Burri non dice il vero, ma certamente dice cose non false. Visto dall’alto, fornisce la prospettiva che un osservato- re irreale avrebbe avuto se durante il terremoto fosse stato sottoterra e avesse visto la stessa aprirsi. Vedi strade come faglie, spaccature, e le vedi dall’alto anche se sono il panorama impossibile di un uomo irreale che sottoterra, quando il sisma colpì Gibellina, non c’è mai stato. Non è la verità. Sono solo cose non false. Memorie oneste adese a opere d’arte il cui genio, nella grandezza che sconti se ci passi davanti, è annichilente. Ai traumi che furono si aggiungono poi i traumi che potrebbero. La pianura bolognese, con i suoi 1.600 canali ormai incapaci di far defluire i carichi attuali di pioggia, potrebbe tornare a essere la palude che era. Così, da un momento all’altro. Basterebbe solo che si verificasse una certa congiuntura metereologica, per altro in tendenziale avvicina- mento, e nel giro di sei mesi chi vi scrive continuerebbe a farlo da una zattera o da una palafitta, punzecchiando con un remo il cadavere galleggiante di Gianni Morandi. La memoria dell’acqua è un po’ diversa da quella del cemento. Ricordare con la testa sott’acqua, se mai vi fosse capitato, non è poi così male: ti senti nuovo, inedito, suscettibile di infinite nascite, sul punto di lanciare la palla del secolo nella più clamorosa delle partite di baseball, quando tutto il casino dello stadio si rapprende in un boato indistinto e ti fodera le orecchie di ovatta. E allora sei solo sblub e sbloab. O crack, ma allora sei tornato sulla terra che trema, a Gibellina. Sblub. Sblub e crack. Verboso metro 20 Cose non false. 15 10 5 0 Ritaglia il verbosometro e attaccalo sulla schiena del tuo amico verboso 9 Nobel minori Verboso metro L’eloquio deloquia: lo si parametri, dunque, in funzione di soglie di verbosità che ne dipanino l’evolvere, l’involvere e l’avvolvere. Da 0 a 5 espressioni verbose. Latenza del verboso. Il singolare riluce nel pauperismo dei villici, ramingo dinoterio prosodico scampato all’impudente glaciarsi del dire. Da 5 a 10 espressioni verbose. Brezza verbosa. Distendesi l’eloquio lungo plaghe d’orpelli musabili, muscovite di senso che rattiene la voce in gibigiana. Da 10 a 15 espressioni verbose. Telluria verbosa. Ciacchero clivo del sema che incerona l’abisso a meta, liberando legioni d’una lutulenza che ‘l pudore tenea per ascosa. Da 15 a 20 espressioni verbose. Verbocrazia. Tripudio fulgente della lingua: di fuètto s’agguizzano i nervi palatali; ne promana un sentire che mal s’addice al fucato anelito del frasaio e ben si predica, invece, d’un dire-miele la cui voce per ovunque - si dissipa. Più di 20 espressioni verbose. Verborrimìa. Il nulla s’attarda nel discorso e ne fa vano asfodelo. "Le amanti" di E. Jelinek di VIVIANA LISANTI C i si immagina i membri dell’ Accademia Svedese come una commissione composta da vecchi professori austeri, dai rigorosi gusti letterari, cultori del purismo linguistico e un po’ propensi al politically correct, soprattutto se si tratta di assegnare l’onorificenza più ambita al mondo. Poi si scopre che la Jelinek ha vinto il Nobel per la letteratura nel 2004 e ci si deve ricredere: i vegliardi hanno decisamente il gusto della provocazione . Innanzitutto Elfriede Jelinek è la donna più odiata dal governo austriaco, e anche nel resto dell’Europa non se la cava niente male: sarà perché non perde occasione di criticare politica e società viennese sostenendo che l’unico lato innocente che l’Austria mostra al mondo di sé è quello turistico, quello delle cartoline con Alpi innevate e piste da sci, dietro al quale però si nasconderebbe una realtà fatta di autoritarismo, “monocultura dei pareri”, disprezzo per arte e artisti; sarà perché inquina quelle immagini idilliache di verdi boschi e placide vacche al pascolo, che tutti noi abbiamo in mente, ambientandoci sconcerie di ogni tipo. L’arte della Jelinek, però, è lontana dall’essere pornografia, oscenità fine a se stessa. Semplicemente la scrittrice non si risparmia né sul piano linguistico, né su quello del contenuto quando si tratta di scavare nella quotidianità per metterne a nudo i meccanismi sociali più profondi: svelare ipocrisie, false convenzioni, smascherare la strut- 10 tura patriarcale e maschilista della società viennese. Il sesso quindi diventa una sorta di indicatore dello stato della società: se è onnipresente nelle forme più violente e malate, beh, evidentemente “c’è del marcio in Austria”… Ne Le amanti (Sperling&Kupfer, 178 p., € 10,50) Jelinek ci racconta degli “oggetti Brigitte e Paula”, alternando capitoli che, per strade divise ma parallele, seguono la vita di due donne diverse ma uguali nel loro percorso: entrambe trascorrono un’esistenza priva di prospettive per il futuro; entrambe affidano la propria felicità ad un uomo, ambiscono al matrimonio per ragioni economiche e per realizzarsi socialmente in un ambiente, quello piccolo-borghese austriaco, che le vuole imprigionate nel ruolo di mogli-madri-casalinghe. Il sesso violento, brutale, sia dal punto di vista fisico che psicologico, che ci viene raccontato nel romanzo, è vissuto come strumento nel rapporto di forza che si crea tra le due coppie di amanti: le donne lo usano per legare l’uomo a sé e assicurarsi un futuro; gli uomini per soggiogare la donna. In ogni caso che si presenti, è sempre quest’ultima a risultare vittima, prima dell’amante e poi, ancor peggio, di se stessa, non avendo la forza interiore, tanto meno l’appoggio esterno, per reagire all’abuso di potere perpetrato ai suoi danni. “Se qualcuno ha un destino, è un uomo. Se qualcuno riceve un destino, è una donna” Punizioni! “Chi ha spostato il mio formaggio?” di Spencer Johnson di MICHELE MARCON Q uesta punizione mi fu inflitta molto tempo fa, quando mio padre, forse accortosi della mia irriducibile esitazione nell’affrontare la vita, o, molto più probabilmente, cominciando ad abbracciare la prospettiva che il proprio primogenito fosse lanciato verso una luminosa carriera manageriale, mi diede da leggere un piccolo libro che avrebbe dovuto, a parer suo, rappresentare lo strumento per prepararmi a diventare un “leader di me stesso” (cit.). Spesso negli anni a seguire mi sono chiesto come mai non mi avesse dato da leggere i grandi romanzi di formazione come il Wilhelm Meister, Il rosso e il nero o I turbamenti del giovane Törless, piuttosto che una favoletta costruita attorno ad una metafora alquanto sempliciotta tirata avanti a fatica da quattro personaggi che sembrano usciti direttamente dal mondo lobotomizzato e lobotomizzante de L’Albero Azzurro: Nasofino, Trottolino, Tentenna e Ridolino. Ah, quasi dimenticavo, questo piccolo libro si chiama Chi ha spostato il mio formaggio?, ed è stato scritto dallo stesso autore del leggendario (l’aggettivo non è mio) One Minute Manager. L’edizione italiana presenta un sottotitolo quanto mai edificante: cambiare se stessi in un mondo che cambia, in azienda, a casa, nella vita di tutti i giorni. E così ho recuperato dalla libreria impolverata l’odiato libercolo, in primis per scrivere questo pezzo per Punizioni!, ma anche per scoprire se col passare degli anni qualcosa è cambiato. La quarta di copertina recita: “Questo è un libro scritto per tutte le età, la storia si legge in un’ora, ma il suo messaggio dura tutta la vita”, perciò mi sono voluto fidare (… e per fortuna che si legge in un’ora, perché io, dopo quasi dieci anni, mi ero dimenticato sia la storia che il messaggio e me lo sono riletto tutto!). L’idea è, come detto, semplicissima. All’interno di un Labirinto vivono 2 Topolini e 2 Gnomi che passano le giornate alla ricerca del Formaggio. Il Formaggio è ovviamente quello che gli psicologi chiamano oggetto del desiderio, mentre i 4 personaggi, mi duole dirlo, siamo noi, o meglio, sono quattro attitudini comportamentali aberranti. Fortunatamente già nelle prime pagine mi sono imbattuto in una chicca sfiziosa che ha stimolato la mia curiosità: la narrazione si fa metanarrazione nel momento stesso in cui il narratore confida che la storia che sta per narrare non è altro che una storiella ovvia e banale, ma che può nascondere un significato profondo. Mi son detto: “Stai a vedere che ci trovo qualcosa di profondo”. A dire il vero non ho trovato molto 11 di più. Il vero problema è che per proseguire la lettura è necessario sorpassare uno scoglio quasi insormontabile: il libro è scritto male. Ma male forte. È imbalsamato, epidittico, posticcio e straziante. E se me n’ero accorto già a 16 anni, figuratevi ora! Nonostante ciò ho tenuto duro e ho finito di leggerlo in meno di un’ora. Devo dire che, in fin dei conti, Chi ha rubato il mio formaggio? avrebbe pure una lezione molto importante da insegnare, che potremmo riassumere così: se vuoi mangiare il tuo Formaggio devi imparare a cambiare. Bello, sì, ma… se solo non fosse scritto così male! Insomma, ho letto libri che avevano molto meno da dire, ma, dicendolo meglio, mi sono rimasti impressi più a lungo. Le più grandi lezioni della mia vita (tralasciando gli scappellotti) le ho sempre apprese dai libri che ho amato, i libri scritti bene. L’adolescente, Dedalus, Il giovane Holden, e potrei citarne molti altri. Ma ciò non toglie che un’oretta gliela possiamo dedicare. Non si sa mai che se ne esca qualcosa di buono. In fondo, in questi 10 anni qualcosa è cambiato. Sono cambiato io. Magari anche perché ho cominciato a mangiare il formaggio, che fino a qualche tempo fa proprio non potevo sopportare. Biografie Edulcorate Henry Charles Bukowski di ANDREA MEREGALLI “P resi la bottiglia e andai in camera mia. Mi spogliai, tenni le mutande e andai a letto. Era un gran casino. La gente si aggrappava ciecamente a tutto quello che trovava: comunismo, macrobiotica, zen, surf, ballo, ipnotismo, terapie di gruppo, orge, ciclismo, erbe aromatiche, cattolicesimo, sollevamento pesi, viaggi, solitudine, dieta vegetariana, India, pittura, scrittura, scultura, composizione, direzione d'orchestra, campeggio, yoga, copula, gioco d'azzardo, alcool, ozio, gelato di yogurt, Beethoven, Bach, Budda, Cristo, meditazione trascendentale, succo di carota, suicidio, vestiti fatti a mano, viaggi aerei, New York City, e poi tutte queste cose sfumavano e non restava niente. La gente doveva trovare qualcosa da fare mentre aspettava di morire. Era bello avere una scelta. Io l'avevo fatta da un pezzo, la mia scelta. Alzai la bottiglia di vodka e la bevvi liscia. I russi sapevano il fatto loro”. Questo è un sunto, amico. Io non è che ho 10.000 battute. Proprio no. Diciamo che veleggio, ti piace la parola veleggio?, tra le 2.000 e le 3.000 battute. Spazi inclusi. Questo è quanto. Quindi. Non mi metterò a elencare i tuoi titoli. I tuoi libri. Che noia, perdiana. Ma, facciamo, tipo, che improvvisiamo. Sì, lo so. Lo so Henry Charles Bukowski che sei morto. Ma, come ho già specificato, potremmo fare finta che. Ok? Io, a te, mi sono avvicinato grazie al mentore. A John. Grazie a John “idolo” Fante. Pare che sulla cresta dell’onda, e, dimmi, cos’è che si vede dalla cresta, Hank?, ne hai curato delle prefazioni o delle postfazioni e via dicendo. E insomma, che diventi Bukowski. Insomma che la tua vita da sfigato-folle-alcolizzato che, ti dirò, ha un po’ rotto il cazzo, diventa, d’un tratto, affascinante. scritto migliaia di poesie. Cazzo, ho pensato, questo mi garba. Questo ha stile. E, in effetti. Cioè, originalità zero. Da James Dean a Fabrizio Corona, sempre la stessa solfa. Sigarette, vino, donne. Nel 1994, quando te ne sei andato, 74 anni ma ci pensi Hank?, io avevo dieci anni. Maledetto e inesorabile e ineluttabile tempo. Quante cose, quante, avrei voluto sapere. Sull’urgenza in particolare. Su quella cosa che tu hai definito “urgenza”. L’urgenza di scrivere che, per dirla Sì, certo, tu ci hai messo del tuo. Le parole. Le poesie. I racconti. I romanzi. Hai scritto come un dannato. Roba che io ho letto. Roba che mi ha indotto a pensare. Roba che si avvicina alla mia incapacità cronica di concentrazione. Roba corta, roba breve, roba buona. come te, se non ce l’hai è inutile, è inutile battere sui tasti, è inutile sforzarsi. Meglio andare a lavorare. A lavorare, come hai fatto tu. E il postino e il manovale e l’operaio e l’impiegato, tutti quei lavori che ti capitano tra capo e collo, con centinaia di domande annesse. Sì. Il fatto che hai pubblicato con case editrici minuscole. Il fatto che sei figlio di immigrati. Il fatto che hai avuto un acne che neanche un nerd di quindici anni. Il fatto che hai bevuto un paio di oceani di vino. Il fatto che hai schiacciato con gusto donne obese. Il fatto che hai Cioè, questo concetto del poeta finalmente, dico io, non filosofo. Che tu con una poesia ci hai raccontato della scopata della sera prima. E con un’altra della giornata alle corse. E con un’altra del licenziamento alle pompe funebri. E con un’altra ci hai chiarito tuo padre. E con 12 bondantemente citato. Ma a me citare piace di brutto, mi pare elegante ma, in realtà, è una pacchianata mastodontica. Cosa riportare, ora, Hank? un’altra ci hai illuminato sull’amore, che è un cane che viene dall’inferno. E che queste poesie, di fuoco, forse, appunto, infernale, ne avanzano. E così i racconti. E così i romanzi. L’imbarazzo della scelta. L’inutilità, pure, probabilmente. O forse no. Beh, oltre sessanta (60) libri. Io li tengo in camera e la sezione “Bukowski”, mi viene caldo solo a guardarla. “Agli scrittori piace soltanto la puzza dei propri stronzi”. Fantastico. Anche qui, come faccio a citare. Lo so che ti ho già ab- Me lo copre il prezzo? Sociologia del libraio di LICIA AMBU L avorare in una libreria significa passare l’intera giornata tra scaffali. Topos fascinoso, non c’è che dire, avvolto da quell’aura semantica per cui il libraio non può che essere un individuo felice. Una questione sociologica in pratica. In effetti è così per buona parte del tempo. Chi lavora in una libreria, con passione, crede nei comandamenti della cultura per osmosi, sniffa l’odore delle pagine nuove e/o vecchie e ha tutte le nevrosi da comprovato o provetto biblio tossico. Il must è che si legge gratis e per lavoro. Ma è più complesso di così. Verrebbe quasi da dire che la mappatura strategica del mestiere include una sinergia ben più ampia di fattori: un mix tra prossemica, qualche nozione di carattere generale e molto spirito d’avventura, tra le altre cose. In effetti si va a braccio, non si sa mai cosa aspettarsi, dalla richiesta di un libro nascono un sacco di considerazioni barra conversazioni interessanti, anche quando si parte da basi apparentemente disastrose: - Buongiorno, cercavo un libro, dice E fino qui, pensi - Però non mi ricordo né il titolo né l’autore Classico Innegabile, a volte capitano anche situazioni imbarazzanti, buffe o terribilmente infauste per la pazienza, ma sono in minoranza, va detto, il più delle volte è divertente, non sai mai cosa ne viene fuori e finisce sempre che impari un sacco di cose. Un altro aspetto molto interessante è che i libri dicono tanto su chi li acquista. Certo la scelta di un titolo dipende da molti fattori: il momento storico (macro e micro), l’autore, il titolo, la copertina (come l’hanno capito gli editori…), la pubblicità, il passaparola (la pubblicità micro in sostanza) e cose così. Proprio per questo forse, la cosa interessante è capire quale aspetto prevale sull’altro. Poi, con il tempo, nascono un sacco di legami letterari, pettegolezzi culturali e confronti a prova di club del libro o neofiti te- 13 ste per ultime fatiche di penne più o meno eccelse. Alle spalle di tutto ciò, lo sporco lavoro dietro le quinte: il rifornimento, la vetrina con scenari da apriti cielo, l’organizzazione, i conti da far quadrare, gli scaffali da rimettere in ordine, il Natale, dover spiegare perché un libro prenotato da giorni non è ancora arrivato, che il fuori catalogo è una dura realtà ma esiste e che se un autore non ha ancora pubblicato un nuovo libro noi non sappiamo il perché esattamente come tutti gli altri adepti del suddetto. Dulcis in fundo qualche richiesta seriamente interessante, se non altro per l’eventuale possibilità di esaudirla: - Buongiorno signorina. - Buongiorno a lei, mi dica - Oh, che bei libri. Devo fare un regalo per un anniversario di matrimonio… avete dei tovaglioli con scritto sopra 25 anni? - Perfetto Oh, Scena! Oh, Reading! di SIMONE ROSSI Testi che tra l'altro vorrebbero essere incitamenti a resistere spudoratamente e invece porcaputtana fanno venire da piangere. V asco Brondi scrive così: “e il nostro senno è in una bottiglia di moretti accatastata sulla luna, l'anello resterà per poco sulla spiaggia. quando a forza di ferirci siamo diventati cosanguinei. e tu risparmi sul riscaldamento e sulle arance. e mi distraggo mentre mi parli delle tue giornate perché non compaio più tra i titoli di coda. e mettevamo i capelli tagliati male sul davanzale perché alle rondini potevano tornare utili. rassicurare le madri, che se ne fregano che se ne fregano. Mi sa che troveremo una strada mi sa sara, come quando davanti al muro del pianto siamo caduti per terra dal ridere sommesso. come quando dentro piove e alla stazione di Mestre sembra sempre di essere in un film che devono ancora fare”. La prima botta sono le lettere minuscole, e sara che ci spunta in mezzo come un fiore, o come un brufolo. La seconda è il citazionismo e il respiro stretto delle frasi: direi che sembra un po' il jump cut di Godard, ma mi sa che non c'entra niente. Passano i cavi della tensione tra un punto e il punto successivo, il senso appare dall'alto come una specie di tempesta elettrostatica, non c'è bisogno di capire tutto, ci sono solo dei luoghi poco comuni, luoghi scomunicati da andare a illuminare a petrolio finché non muoiono i canarini segnaletici. La terza botta è la più forte, e la fanno solo certi libri con certi lettori: io, io lettore, quando leggo la distrazione di chi si sente scomparire dai titoli di coda o i capelli tagliati male sul davanzale o le madri “che se ne fregano che se ne fregano”, io capisco. Non mi identifico in Vasco Brondi. Lo ripeto: non mi identifico in Vasco Brondi, come non mi identifico in Salinger né in Sheldon né in Shiva. Lo scrittore è una figura mitologica inventata dai critici, non ci interessa lo scrittore: ci interessa lo scritto. Capisco questo scritto, mi arriva la tempesta, capisco perché ci sono scritte quelle cose lì e capisco perché sono scritte in quel modo lì, con le ripetizioni ripetute e la citazione di A rose is a rose is a rose di Gertrute Stein (era Gertrude Stein, vero?). Sento che funziona. Gli credo. “Secondo me, gli autori del nuovo cinema non muoiono abbastanza dentro le loro opere: vi si agitano, vi si contorcono, o meglio vi agonizzano, ma non vi muoiono: perciò le loro opere restano testimonianze di una sofferenza del fenomeno assurdo del tempo". Ah, il fenomeno assurdo del tempo, aveva ragione Pasolini, come al solito, avete ragione tutti, e noi non siamo riusciti nemmeno a sederci dalla parte del torto: i posti erano tutti occupati, anche lì. Cellacci e ciellini ci scrivono lettere aperte per incoraggiarci a scoraggiarci, ad andarcene, a essere felici altrove: ce lo meritiamo, con tutti i soldi che hanno speso per mandarci a scuola. E noi chissà quando troveremo un vero lavoro, e 14 quando la finiremo di giustificarci con il solito Jeff Buckley: maybe I'm just too young / to keep good love from going wrong. Ci siamo passati tutti, ci stiamo passando tutti. Poi ogni tanto succede che qualcuno trovi il modo di raccontarla, di raccontarci, e subito ci smarchiamo e diciamo che no, quelli non siamo noi, le etichette non ci piacciono, nemmeno quelle discografiche, e meno male che stanno finendo, questi cazzo di anni zero. Si può accusare Vasco Brondi di non morire abbastanza dentro le sue opere, di fare il bello con le nostre disgrazie, ma poi lo guardi e non è bello, e non siamo belli nemmeno noi, è bella solo sara, e accusiamo il colpo, e basta. Vasco Brondi l'ho visto a teatro e questa rubrica parla di testi teatrali: il libro si chiama Cosa racconteremo di questi cazzo di anni zero, il reading pure. Ho pensato che un libro con la parola “cazzo” nel titolo potesse andare bene per Oh, Scena!, solo che Oh, Scena! parla di testi teatrali. Poi quel libro è diventato uno spettacolo teatrale, cioè un reading, in realtà fondamentalmente è un reading, c'è lui che legge mentre suona, e ogni tanto canta. Allora questa puntata s'intitola Oh, reading!, che probabilmente sarà il nuovo titolo di Oh, Scena!, o la seconda serie, o che ne so. Oh, reading! si legge òrriding. A pro Wikipedia e cerco snob. Dal latino sine nobilitate, designa «una categoria di persone che imitano i modi ed il modo di vivere di classi sociali superiori, atteggiandosi in maniera raffinata e altezzosa». Aspirare ad essere altro, come Firmino. Nel libro da ombrellone di Sam Savage il topo che sopravvive cibandosi di libri si sente un pervertito desiderando sessualmente le donne che vede sugli schermi del cinema. Guarda il proprio corpo di ratto e sogna di essere umano. La corsa all’oro, la lotteria milionaria, la gente che conta, i prestigiosi club di filantropi. Una cieca corsa al potere che evidenzia solo la pochezza di chi non si accorge di essere un pesce nell’acquario, perso in una estenuante ed infruttuosa corsa di topi. Sarebbe bastato ascoltare Rat race di Bob Marley o leggere Charles Baudelaire, secondo il quale «questa vita è un ospedale dove ogni malato è ossessionato dalla brama di cambiar letto», magari accanto ad uno che conta, un letto sì da malato, ma da malato prestigioso. Ho pranzato accanto a snob filantropi o presunti tali. Io fuggivo peripatetico in cerca di sole, loro patetici e soli si studiavano a vicenda. In tre ore di conversazione non ho mai sentito nominare un libro, un disco, un film, un quadro, un viaggio. Solo commenti su chi era in sala e su come abbinare camicia e gioielli. Questa cosa mi ha turbato tanto da farmi riprendere in mano I vagabondi del Dharma per rileggere il pensiero semplice e netto di Japhy: «hanno tutti gabinetti a mattonelle bianche e fanno sporchi stronzi grossi come quelli degli orsi di montagna, ma tutto vien spazzato via in razionali fogne supercontrollate e nessuno pensa più agli stronzi né si rende conto che la sua origine è merda e fetore e rifiuto del mare. Passano tutta la giornata a lavarsi le mani con saponi cremosi che sognano in segreto di mangiare nel bagno». Meglio José Saramago: «come tutti i figli degli uomini, il figlio di Giuseppe e Maria nacque sporco del sangue di sua madre, vischioso delle sue mucosità e soffrendo in silenzio». «Che cosa vieta di dire la verità ridendo?» si domanda Orazio nelle Satire. Viccavdo, ricco bambino di otto anni immaginato da Pulsatilla, con fare snob chiede a Babbo Natale di non ricevere più gli innumerevoli regali e, se possibile, Viaggi Snob di ALESSANDRO POLLINI di accettare i resi dei regali inutili. Gli si rivolge con una lettera dove scrive: «il pvoblema non é solo di natuva logistica; il dvamma é che con questi affavini, poi, sono in doveve di giocavci pev non dave un dolove a chi me li ha vegalati. Visto che il tempo è quello che è, ho cominciato a impovmi degli ovavi. La mattina mi costvingo a mezz’ova di pista. Tovnato da scuola ho due ove di puzzle» e così elencando il programma di giochi cui si sottopone quotidianamente con lo stacanovismo degno di un precario. Problema che non tange il bambino povero de Il giocattolo del povero, citando nuovamente Lo Spleen di Parigi di Charles Baudelaire, che si diverte, invidiato da un bambino ricco che ignora un giocattolo nuovo e costoso, con un topo vivo chiuso in una scatola. Come dicevo prima, pesci in un acquario, giacché «i due ragazzi se la ridevano 15 fraternamente tra loro con i denti di una uguale bianchezza». Insegna Epicuro che «l’avvezzarsi a un regime di vita semplice e non ricercato sia è assolutamente salutare, sia rende l’uomo sollecito verso le necessarie occupazioni del vivere quotidiano, sia ci dispone meglio alle raffinatezze che di tanto in tanto ci toccano e ci rende impavidi di fronte alla sorte». Alla faccia dello snobismo e degli atteggiamenti di finta raffinatezza, e pure scritto in latino! Certo, gli snob di cui sopra guarderanno il dito mentre gli si indica la luna, ma in fin dei conti se i denti brillano di una uguale bianchezza, mi dico sia meglio leggere un buon libro dimentichi della necessità di sembrare ciò che non si è. In fondo, citando ancora Epicuro, «non bisogna fingere di filosofare, ma filosofare davvero; infatti non abbiamo bisogno di sembrare star bene, ma di stare bene per davvero». Mi sono venuti in mente in questo articolo: Sam Savage - Firmino (Einaudi, 179 pp. 14,00 euro); Charles Baudelaire - Lo Spleen di Parigi (Mondadori, 216 pp. 8 euro); Jack Kerouac - I vagabondi del Dharma (Mondadori, 272 pp. 8,50 euro); José Saramago - Il vangelo secondo Gesù Cristo (Einaudi, 410 pp. 12,50 euro); Orazio Quinto Flacco - Satire (Garzanti, 290 pp. 9,90 euro); Pulsatilla - Quest'anno ti ha detto male. Lettere a Babbo Natale cestinate da lui medesimo e casualmente ritrovate. (Bompiani, 120 pp. 8,90 euro); Epicuro - La felicità e il piacere (Barbera, 59 pp. 6,90 euro) La lettera che muore Verso la twitteratura? di MICHELE MARCON B entornati a La lettera che muore, la rubrica di Finzioni che ha tante domande e nemmeno una risposta, e che, proprio per questo motivo, è sempre al passo coi tempi. La storia dell’umanità è segnata da invenzioni che hanno cambiato radicalmente i nostri rapporti col mondo e con gli altri. Pensate alla ruota, un mondo post-industriale senza di essa sarebbe oggi inconcepibile. Pensate al preservativo, fino al 1960 era fatto col budello animale (bleah), ma ha sempre permesso di avere rapporti sessuali con frequenza e sicurezza. Oppure pensate alla carta, senza la quale per voi sarebbe impossibile leggere Finzioni. Nonostante ciò, all’epoca c’era molto scetticismo di fronte a questi oggetti geniali. Ve lo immaginate? “Infilare il mio pene nel budello di un maiale?! Non sia mai!” Oppure: “Scrivere su questi straccetti bianchi? Meglio la pietra che è più solida e duratura”. In fin dei conti è prerogativa dell’uomo essere diffidente di fronte alle novità. Poi, come sempre, è la storia a mettere l’ultima parola. Oggi ci troviamo di fronte ad un altro di questi momenti epocali. C’è un’invenzione che potrebbe nuovamente cambiare il nostro modo di vedere le cose. E, vista la portata dell’avvenimento, l’argomento è più o meno sulla bocca di tutti. Sto parlando dalla nuova alfabetizzazione veicolata dal web in generale, e, in particolare, vorrei fare riferimento a Twitter, social network che per- mette di postare segmenti testuali non più lunghi di 140 caratteri. Ultimamente si sente parlare spesso della sua applicazione alla “letteratura” (con gli ormai famosi, per chi segue questa rubrica, empi diacritici). È convinzione comune che si possano scrivere romanzi in 140 caratteri. Certo, dicono gli integrati, bisogna andarci coi piedi di piombo, ma il futuro della letteratura è la brevità. Non c’è più tempo per spararsi dei pistolotti come la Recherche o come L’uomo senza qualità. E se non c’è tempo per leggerli, figuriamoci per scriverli! Perciò proliferano concorsi per scrivere mini-romanzi su Twitter; se ne possono contare a decine, centinaia, e l’entusiasmo è alle stelle, perché diventare romanziere sembra finalmente essere alla portata di tutti. Ma a me piace soffermarmi a riflettere su come cambiano le cose e credo che piaccia anche a voi. Allora è giusto dire che questa cosa della brevità non è mica nuova. Un certo Hemingway agli inizi del ‘900 scrisse quello che fu definito il romanzo più breve del mondo: “Vendesi: scarpine per neonato, mai indossate”. A parte l’amarezza celata nelle poche parole dello scrittore americano, possiamo ritrovare la stessa brevità in contesti più vicini alla nostra cultura: i proverbi e i detti popolari. Questo ritorno al passato vuole forse dire che la letteratura sta 16 diventando una cosa più popolare, quindi più aperta a tutti, quindi più giusta? Ben venga, ma io questo proprio non ve lo so dire. Però posso fare un’altra domanda. Dove andremo a finire? Forse il romanzo diventerà una forma letteraria polisintetica, un po’ come la lingua eschimese, per cui una sola parola esprime una moltitudine di relazioni, sia grammaticali che semantiche? Ve lo potete immaginare? Una parola, un romanzo. Insomma, uno scrive “casa”, e ha praticamente scritto un libro, magari pure un best seller. Se l’opera è così aperta come si dice, poi spetterà al lettore ricostruire la storia sulla base delle proprie connessioni inferenziali. Casa: 5 milioni di copie vendute. Sarebbe incredibile, no? Non ci credete? Forse non ci credo più di tanto nemmeno io. Ma chi avrebbe mai pensato che l’uomo avrebbe messo piede sulla luna? E chi, quindici anni fa, si sarebbe potuto aspettare tutti i cambiamenti degli ultimi cinque anni? Staremo a vedere. Io per sicurezza mi tengo in serbo un bel po’ di parole pronte a diventare best seller. Mattoni "Pierre o delle ambiguità" di Herman Melville Peso: 4,05 kg di FILIPPO PENNACCHIO I l lettore addentro, come il sottoscritto, alla programmazione pomeridiana di Canale 5, saprà bene che appena dopo Beautiful, ma subito prima di Uomini e Donne, va in onda Centovetrine, soap opera che racconta delle sorti – tragiche – di una dinastia imprenditoriale torinese, funestata da continue lotte intestine per la successione al vertice della holding, turbata da rivolgimenti amorosi tra i suoi vari membri, devastata da una sorte infausta e – esattamente come nei grandi cicli romanzeschi del XIX secolo – da un determinismo sociale dilagante. Tra i suoi protagonisti, Centovetrine annovera un giovane e bell’avvocato – interpretato da un attore a suo modo grandioso, una sorta di genio tragico letteralmente incapace di plasmare il proprio volto se non in un’unica, abbacchiatissima espressione – le cui giornate sono scandite da ritmi lavorativi pazzeschi e da ripetute simulazioni di trasporto amoroso per la frigidissima e perennemente incazzata figlia del defunto patriarca-ex-presidente della holding di cui sopra. È però, invero, profondamente innamorato di una giovane collega avvocatessa: una bionda acqua-e-sapone sessualmente inservibile, irreprensibile in quanto a etica professionale, inconsapevole (fino a un mesetto fa) sorellastra della summenzionata, mestruatissima figlia-del-papi. Come un po’ a tutti noi, anche a questo personaggio cui, suo malgrado, spetta anzitutto il compito di ritrarre l’impoverimento sessuale dell’uomo italiano, capita talvolta di giocare sporco sul lavoro, di mentire alla propria donna – per altro confinata (sempre fino a un mesetto fa) su una sedia a rotelle: allegria! –, di confessare all’amata avvocatessa la propria viscerale passione. Eppure, puntualmente, succede che chiunque – persino la domestica – ne biasimi le scelte, gli paventi un destino disgraziato, lo ponga di fronte a terribili decisioni. Addirittura la polizia, sospettandolo a capo di una per altro innocua truffa, si mette a rompere i coglioni. Bella merda, insomma. E infatti questo personaggio la cui vita è diventata nient’altro che un’estenuante sequela di ricatti morali, decide – come biasimarlo? – di fuggire (a Cuba, per altro). Nell’ultima puntata, poco prima del definitivo addio, un bel primo piano del suo volto ci mostra un uomo distrutto – una «decalcomania attanziale», diciamo –, il cui sguardo arreso sembra dirci: «perché tutto questo? Sono solo un uomo». Pierre, il protagonista di Pierre o delle ambiguità di Herman Melville, è in fondo assai simile a un 17 attore di Centovetrine – ma anche, suvvia, a un provincialotto come il sottoscritto la cui Bildung, ahimè, si svolge in quel di Milano, a contatto con coglioni micidiali che, dato che scrivono su Vice / frequentano presunte gallerie d’arte / conoscono un sacco di “persone giuste”, quindi ridicole, si autoeleggono a crema intellettual-sarcazzo della città. Anche per Pierre, difatti, la vita è un’estenuante sequela di delusioni: si innamora di una donna che poi scopre essere sua sorella, viene cacciato di casa in tenera età, cerca inutilmente fortuna nel mercato editoriale, uccide, perché vi è costretto, un poveretto, in ultimo viene condotto alle «Tombe», un carcere nel cui nome non c’è alcuna facile ironia. Manco a dirlo, la sua fine sarà tragica. Come per l’eroico avvocato di Centovetrine, il consorzio umano si rivela infine la più grossa delle delusioni esperibili su terra ferma: già il buon Ismaele (ma pure il capitano Achab), d’altronde, lo aveva intuito, comprendendo come il mare aperto fornisse il rimedio più sicuro per gli umori malinconici e un rifugio dalle delusioni terrestri, ritrovandosi a sentenziare bene: «I quietly take to the ship». Certo per noi lettori il problema risiede, ancora una volta, nelle dimensioni (o, come sempre, nel peso): certi dialoghi grotteschi con i redattori di Zero durano al massimo il tempo di una sigaretta e la visione di una puntata di Centovetrine, con pubblicità annessa, non richiede più di venti minuti, mentre i “mattoni”, per raccontarci quanto l’umanità, in genere, faccia cacare, impiegano un numero spropositato di pagine, richiedono pomeriggi interi di fedele dedizione, annoiano, alle volte, tantissimo: in due parole, a volerne dire meglio, somigliano più alla vita vissuta, la quale d’altra parte, si sa, è ben peggiore di una soap opera. Che tragedia. L'angolo del cinematografo “Where The Wild Things Are” di Spike Jonze di MARINA PIERRI D a noi è arrivato con il titolo Nel paese delle creature selvagge e, a meno che non foste estremamente determinati a vederlo e dunque l’abbiate fatto, la programmazione nelle sale è stata così pressappochista da farlo passare del tutto inosservato. Esatto: dalla seconda settimana, è stato spostato al pomeriggio perché creduto un film per bambini; dalla terza, visto che neanche presso il pubblico giovanissimo tirava granché, l’hanno levato proprio di mezzo. Adesso vi state chiedendo come sia possibile. Ma come, il film di Spike Jonze basato sul bestseller di Maurice Sendak Where The Wild Things Are, sceneggiato niente meno che da Dave Eggers, realizzato interamente in analogico con veri pupazzi di pelo e stoffa? Quello attesissimo che aveva pure Wake Up degli Arcade Fire nel trailer? Proprio quello. E adesso vi spiego perché è successo, o, almeno, vi do la mia versione. WTWTA non è un film per adulti e non è un film per ragazzini. È un film destinato a chi conosce il libro, lo sceneggiatore, il regista, gli attori, la gente che ne ha creato la colonna sonora (Karen O degli Yeah Yeah Yeahs con un coretto stile Antoniano) e, dulcis in fundo, ha voglia di cooperare nella costruzione della storia. In una parola: è un film di nicchia. Molto di nicchia. E pure per quella nicchia, il primo tempo è una palla mai vista. Giuro: quando l’ho visto io, alle cinque del pomeriggio, i genitori che accompagnavano i pargoli (muti) non hanno fatto che parlare ad alta voce tutto il tempo e almeno tre o quattro dopo i primi trenta minuti se ne sono andati. Non so dargli torto: Jonze, in effetti, commette una scorrettezza fondamentale. Per tutta la prima parte della pellicola, non scatena nessun sentimento per il piccolo protagonista che non sia antipatia o, peggio, incomprensione (insomma “buca” l’identificazione). Non si capisce chi sia questo piccolo scassamaroni, perché se la prenda con la madre e pianga tanto, perché guardi uno strano plastico con dedica – quella del padre – con il muso lungo e, poi, per quale ragione si sposti nella terra dei mostri, questi strani, strani mostri, che non sono teneri, anzi, sono violenti, brutti, quasi spaventosi, mentre dicono e fanno cose senza senso. Eppure, come si dice, la pazienza premia: nella seconda parte di WTWTA tutto va al suo posto e quello che era un film noioso e scucito diventa un lavoro meraviglioso sul dolore e la solitudine di un bambino che da poco ha perso il padre. Jonze ed Eggers, che hanno 18 trasformato un classico di fantasia in una specie di bizzarro lavoro sull’autismo infantile o almeno in un’esegesi della separazione, riescono – non senza difficoltà – a fare intuire, solo intuire l’antefatto grazie al potere dell’allegoria. Così, lentamente, emerge l’assiologia, il mondo di valori del piccolo Max. Il mostro Carol "è" suo padre: un padre che, immaginiamo, è stato violento e incontrollato, che ha scosso le fondamenta della famiglia con la sua impulsività e, in ultima analisi, per colpa della sua stessa insicurezza. E una madre, KW, che custodisce il piccolo nella sua pancia e lo nasconde alle ire del maschio, ire che nascono dall’allontanamento, dalla sensazione di mancanza di controllo. Il percorso di Max, che avviene tutto nella fantasia, è un percorso di crescita che è superamento dell’identificazione sghemba con il padre. O qualcosa del genere. Fatto sta che, al suo ritorno, “la cena era ancora calda” e lui può finalmente essere sé stesso, un bambino, un semplice bambino che veglia sulla mamma e su cui la mamma veglia. Q ualche anno fa una importante rivista scientifica di fisica chiese ai lettori di giudicare l’esperimento più bello di tutti i tempi. Con italica soddisfazione l’esperimento più bello fu giudicato “interferenza dell’elettrone singolo”. Già il titolo spacca! Questo esperimento, pensato nel 1920, fu realizzato dopo aver superato difficoltà pratiche enormi per la prima volta nel 1976 nei laboratori del CNR di Bologna. Olé! Brevemente: prendiamo uno schermo con un paio di fori vicini rettangolari, stretti e lunghi (doppia fenditura) e pensiamo di avere dietro una pellicola in grado di registrare cosa succede dietro allo schermo stesso. Se noi tiriamo tante palline sullo schermo solo quelle Tipici comportamenti di onde e particelle, due categorie distinte e contrapposte. Però la meccanica quantistica ci dice che nell’infinitamente piccolo queste due categorie si fondono, per dare vita a quello che viene definito un dualismo onda-particella. Ovvero: le particelle subatomiche (es: elettroni) sono nel contempo onde e particelle. Un concetto non tanto più semplice da comprendere della natura contemporaneamente umana e divina di Gesù, giusto per fare un esempio triviale. Bene, se noi prendiamo una fenditura piccolissima (di dimensioni paragonabili a quelle degli atomi) e ci facciamo passare un elettrone alla volta otteniamo una figura sbalorditiva (lo sbalordimento compare dopo averla guardata per un po’). Gli elettroni sono par- per la prima volta fu possibile vedere il dualismo onda-particella. È un po’ complicato, lo so. Ecco quindi un bell’invito a guardarvi un sito che spiega per bene l’esperimento (http://l-esperimento-piubello-della-fisica.bo.imm.cnr.it/). Ma perché è stato giudicato il più bello? Dov’è l’estetica nella scienza? Cominciamo con l’estetica di questo esperimento: la possibilità di vedere, sensorialmente, un concetto incredibilmente astratto, esprimibile chiaramente con complicate formule matematiche ma che, per sua natura, trascende l’esperienza sensoriale. E con questo esperimento è possibile tenere in mano una fotografia che contiene l’essenza della meccanica quan- Pillole di scienza L’esperimento più bello (ed è italiano!) di FABIO PARIS con la giusta direzione potranno attraversare i buchi e, colpendo la pellicola, andranno a formare una coppia di strisce dietro alla fenditura stessa. Una pallina (particella) può passare a sinistra o a destra. Punto. Se invece è un’onda a colpire la fenditura avremo un fenomeno detto interferenza (pensiamo alle barriere di scogli al mare con le onde che le attravesano e tutte le figure geometriche che disegnano sull’acqua, ecco a voi l’interferenza): le onde aggirano gli ostacoli, attraverseranno la fenditura e andranno a formare tantissime righe parallele dietro alla fenditura stessa colpendo lo schermo non solo dietro alle due fenditure, ma anche altrove. ticelle, vengono fatte passare uno alla volta attraverso la fenditura, e all’inizio si concentrano dietro alle due strisce, disengando dei punti nella nostra pellicola come delle palline nell’esperimento di sopra. Ma ben presto si vede che le palline non si concentrano solo dietro alle fenditure, ma si distribuiscono a formare una figura di diffrazione, come le onde. Un elettrone passa a destra o a sinistra della fenditura! E con cosa interferirebbe poi? Con se stesso!!! Onde o particelle? Entrambe le cose, che strippo! E 19 tistica. E anche abbastanza semplice da capire, nonostante i suoi risultati siano rivoluzionari. Eccone la bellezza, un po’ come tenere in mano, per un credente, la prova della trinità. E non è poco. I ferri del mestiere …a che fare con i libri? di AGNESE GUALDRINI M otivo di prestigio per molti dei nostri autori è essere tradotti all’estero. Non appena vengono informati che un editore straniero è interessato al loro libro e che ci sono buone probabilità che venga tradotto una patina di orgoglio inizia ad avvolgere le loro voci. Lì per lì è una cosa che in effetti dà una certa soddisfazione: io sono contenta perché ho fatto bene il mio lavoro (sono riuscita a vendere il libro all’estero), la casa editrice è contenta perché guadagnerà un utile, l’autore è contento perché la sua opera sarà divulgata al di fuori dell’Italia. Si preparano i contratti, si mandano le reading copies agli editori, si monitora che i 18 mesi che devono decorrere dalla data di stipula del contratto all’effettiva pubblicazione non diventino 4 anni e via discorrendo. Fin qui, con tutti che sono felici e contenti, sembra tutto chiaro e semplice. In realtà, come in tutte le cose, l’idillio dura poco e improvvisamente iniziano a spuntare mille insidie. Una delle prime trappole (e una delle più irritanti) consiste nella preparazione dei moduli delle tasse. Uno pensa di lavorare in una casa editrice e di avere a che fare tutto il giorno con i libri (e tutti quando dici che lavori in una casa editrice ti ammirano e pensano a quanto sei fortunato, sì proprio tu, che tutto il giorno hai a che fare con i libri). In realtà il più delle volte finisce che i libri te li porti a casa la sera perché la maggior parte del tempo in casa editrice la passi a fare altro. Oltre alle e-mail, alle schede libro, e a rispondere al telefono, in questo altro rientrano gli odiosi moduli delle tasse. Non che ci voglia la scala per farli, ma sono di una noia mortale e in più c’è sempre qualcosa che non va bene. La Corea li vuole fronte/retro, la Polonia ha solo le voci in polacco senza traduzioni in inglese, la Grecia invece di un foglio a4 normale usa delle specie di lenzuoli, la Francia ha dei moduli tutti suoi (figuriamoci, sono francesi), gli USA richiedono password e username, codici PIN PUK (e io francamente non ho ancora ben capito a cosa corrispondano tutti questi codici. Li inserisco e basta sperando ogni volta che sia tutto corretto perché il sol pensiero di vedermi recapitare lo stesso tax form da rifare perché errato mi provoca un certo malessere …e certe volte è accaduto). Può poi capitare che gli editori che si dicono interessati e che sono lì, pronti a firmare, per una qualche ragione cambino idea: il libro non lo vogliono più tradurre. Ora, la cosa in sé non ha nulla di drammatico. Certo dispiace, ma ce ne facciamo presto una ragione. La situazione diventa però una vera tragedia agli occhi dell’autore che, ormai con la voce canterina e gli occhi illuminati, vede la sua gioia sbriciolarsi improvvisamente. Non si capacita del rifiuto, in alcuni casi si offre di occuparsi lui della traduzione, che ha giusto un amico croato che tradurrebbe molto volentieri il libro a costo zero. In questi casi si rassicura l’autore, spiegandogli che sono cose che succedono, che 20 ci saranno altri editori interessati (e mentre lo dici sai già che hai parlato troppo presto e che da quel momento in poi non avrai pace…finché un altro editore non si convincerà davvero a comprare i diritti del libro in questione). Anche quando arrivano finalmente le copie tradotte in casa editrice (e la trafila pare conclusa) le insidie sono ancora in agguato. A parte il fatto che a volte il copyright è sbagliato (e se uno volesse potrebbe montare una querelle burocratica di non poco conto), in alcuni casi arrivano davvero dei libri assurdi: tipo l’edizione portoghese della storia del diritto con una copertina rosa big babol, o un’edizione francese di un libro divertente seminarrativo che pare l’agenda della banca. Un po’ stupita, un po’ divertita, già ti prepari al commento dell’autore. Ascolti e prendi nota. Nel migliore dei casi riesci a dire la tua. Sai che fa parte del gioco. La Posta dei Lettori di Matteo Bettoli di MATTEO BETTOLI C aro Bettoli, le scrivo da Wanegooga, Hawaii. Ebbene sì, pure qua in mezzo al Pacifico leggiamo Finzioni. Leggiamo... insomma, io lo leggo. Ogni tanto. Perché ci scrive pure il nipote di un mio caro amico d'infanzia, che mi ha detto “dai fagli sto piacere, che sennò Jacopo mi si scoraggia”. Non è malaccio. Abito alle Hawaii dagli anni 60: a chi mi diceva “don't give up on your dreams, buddy” ho replicato “ci mancherebbe” e sono venuto a trafficare gemme preziose in questo paradiso. Chi me lo faceva fare di stare nella bassa padana? Ma veniamo al motivo della lettera. E' uscita da poco una biografia di J.F.Kroninger sulla vita di Markessen, consigliere di una buona metà del presidentame democratico post-kennedista. Ed un capitolo è interamente dedicato a Morandi, Gianni Morandi. SpiritoLibero68, Wanegooga M arkessen, una vita a cento all'ora (13 euri su edizioni Jerry P Roman) è l'incendiario volume voluto da William Clinton alla fine del suo secondo mandato presidenziale per celebrare l'amico e collaboratore Markessen, il cui nome di battesimo -come per i calciatori brasiliani- è sempre passato in secondo piano. Lei accennava a Markessen e Gianni Morandi, un connubio improbabile nato per caso quando, durante una visita diplomatica nel belpaese del Presidente Lyndon B. Johnson nel 1965, il consigliere venne a contatto con la Morandi-mania italiana. Fu amore. Ciò che sbalordisce è che da quel viaggio in poi Markessen cominciò zitto-zitto ad inserire versi delle canzoni del Gianni nazionale in numerosi discorsi presidenziali, slogan elettorali ed interventi nelle università. Un pazzo, o un burlone. Se Johnson nel 1968 davanti al Congresso dichiarava qualcosa che in inglese assomigliava pericolosamente a “il soldato americano non suona la chitarra ma uno strumento che sempre fa la stessa nota rattatatà” (cfr. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, 1966), appare ancora più inquietante che Jimmy Carter nel 1977, parlando della questione petroldollari, dichiarasse davanti ad una platea di accademici assopita “fatevi mandare dalla mamma a prendere un gallone di benza”. Corrispondenze morandiane di questo tipo, nelle partecipazioni di Markessen, sono frequentissime. Neanche William Clinton fu risparmiato: in un suo discorso seguente alla bufera causata dalla Monicona Lewinsky, dichiarò “non ho barato né bluffato mai, e questa sera ho messo a nudo la mia anima. ho perso tutto ma ho ritrovato me... uno su mille ce la fa”. • A rrivare alla bellezza interiore è più facile in presenza di una decenza esteriore. Questo il titolo che il celebre professore di Estetica Ludwig Roiterski ha dato alla sua opera manifesto dell'idratantismo estone. Ludwig Roiterski ha aperto la diga e spianato la 21 strada per un botto di correnti che mettono i puntini sulle “i” e frenano gli entusiasmi degli aspettononcontisti. L'aspetto conta, dice Roiterski, e “deve saper contare almeno fino a 5” (cit.) pena la marginalizzazione in un mondo di idratati. Ed è qui la caratteristica forse più interessante dell'idratantismo roiterskiano: chi non si idrata è destinato a perdere dal punto di vista sociale, lavorativo e spirituale. “Poche storie” dice Roiterski “in ascensore, quando sono faccia a faccia con sconosciuti, voglio vedere visi idratati”. Tangente al discorso spirituale, l'idea che l'idratazione innalzi. Che ne pensa? Gastone Fortunato, Costantinopoli N on disprezzo chi consiglia una buona crema idratante. Roiterski quando dice che Arrivare alla bellezza interiore è più facile in presenza di una decenza esteriore scoperchia il vaso del Pandoro proprio ora che è Natale. E lo fa in coscienza. Perchè l'aspettononcontismo non riscalda più i cuori di chi è sempre in cerca di nuove baggianate a cui dedicarsi? Scelte sbagliate della dirigenza, per così dire. Lisandra Rosk, celebre autrice di Trasandatezza e di Tutti si ricordano solo dell'Elvis grasso, ha scatenato l'ira di molti perbenisti mangiando -prima del ballo delle debuttanti di Toronto- il pollo con le mani, mani che ha successivamente strisciato sulla tovaglia e con cui ha infine stretto affettuosamente il faccione della première dame canadese Liza Alcindor. Resta il dubbio che dietro l'idratantismo ci siano le industrie cosmetiche e che Roiterski non sia altro che un burattino di glicerina. Mi sembra *un po' una forzatura* dire poi che l'idratantismo innalzi verso più alte forme di conoscenza: a una storia del genere ci può credere giusto quel fritto di Tom Cruise e quella sciroccata di sua moglie. • C aro Bettoli, ho appena finito di leggere Non posso credere che pure lei avesse uno strippo talmente consistente da risultare fatalmente non ignorabile, volume agreste che rispolvera la fascinazione per i titoli lunghi di Lina Wertmüller per proporci una sag(r)a sui lupi mannari con fattezze da adolescenti che ci stanno dentro un casino. Con questa sag(r)a le edizioni Maringa hanno fatto il botto e hanno scoperto un nervo già scoperto di suo: i vampiri hanno rotto i coglioni, ARIDATECE i lupi mannari pelosoni. Magari in una location contadina, perchè no. L'intuizione di Caspare Mas- simo Caselli, guardiano di museo con la passione per la scrittura, ha colto nel segno e oramai l'Italia è celebre in tutto il mondo per le sue novelle sui lupi mannari contadini. Io mi sento partecipe di questo evento e ne sono entusiasta, era ora che all'impero Romano e al Rinascimento facessimo seguire un po' di popolarità fondata sui lupi mannari con le fattezze di adolescenti bellocci. Danilo Mannaro, Bellinzona Non so, effettivamente è difficile rimanere impassibili e tenere a bada l'eccitazione mentre l'Italia sale sul tetto del mondo grazie ai lupi mannari. Caspare Massimo Caselli ha capito che una combinazione tra lupi mannari e adolescenti poteva funzionare ed ha deciso di provare, costruendo una storia improbabile su un diciottenne sfigato, Luciano, che scopre che la diciottenne che sembra finalmente starci in realtà è una lupa mannara. Diversamente da quanto si potrebbe pensare, la storia non si incanala sui binari del racconto fantastico alla Salgari o alla Verne (averne di scrittori come 22 Verne) quindi qua niente tesori, cacce al lupo o buchi nei vulcani che arrivi fino al centro del mondo. Come al solito si svolta nel moccismo esasperato di un diciottenne già sfigato di suo che si scontra con l'irsutismo mannaro della diciottenne di cui si è innamorato. La location contadina sembra messa lì apposta per vendere casolari lucani agli americani post-reaganiani e le battute crasse si sprecano (“è vero che tira più un pelo di +-+- che un carro di buoi, ma la mia vita è sempre stata guidata dai carri di buoi”, dice Luciano sconfortato ma anche un po' orgoglioso). Insomma: gli ingredienti ci sono tutti e sarebbero di ottima qualità (i lupi mannari, i carri di buoi, le turbe tardoadolescenziali, l'irsutismo) ma la storia è esile e non ci convince. Però tutto il mondo ci guarda, grazie ai lupi mannari. E non è poco. scrivete a: [email protected] Metaletterari di carta I sessanta centimetri di Perec di LICIA AMBU C ’è il sole. Fanno trentacinque gradi e vogliamo, all’unanimità, andare in vacanza. A livello spirituale in modo prepotente, tra l’altro. Ovvero, non ci va di fare niente. Possiamo andare al mare. O al fiume. Insomma, da qualche parte, in qualche spazio. Appunto. Lo spazio. Entità. Luogo. Uno spazio vicino, che so, il litorale o il lago a un’ora da casa. Spazi che esistono in quanto abitati. (Esisterebbero lo stesso, ma questo è un altro discorso…) Per esempio, dice Perec (Specie di spazi, Bollati boringhieri 1989, pp.111): le città, le campagne o un giardino pubblico, sono spazi vicini. E vivere è passare da uno spazio all’altro, continua. Sopravvivere al caldo è passare dalla città ad altro spazio, dico. E mi porto un libro: uno spazio occupato da parole. Spazio scritto. In sé e per sé nulla di sconosciuto. Lo spazio, diamine, che si può dire? Invece no! Metti che per caso ti porti proprio il libro di Perec, ad esempio. Un soggetto che per una quisquilia del genere è capace che ti genera l’universo. In quella specie di superlativo attimo che compone la sua creazione: ti prende, ti sbatte davanti ad una pagina e tira fuori lo scibile. role e arrivano deserti, isole, anche l’arcipelago, perdinci! Diamoci il tempo di coordinare le riflessioni metafisiche, perché poi è l’ora di Borges. Poteva mai mancare in un momento così Borges? Quell’Aleph (Feltrinelli 2003, pp.188), che è tutti i luoghi? E full optional anche: da ogni prospettiva! Metaluogo per la memoria ciclica e cumulativa, un alfabeto con dentro tutto, dice Perec, scrive Perec, quindi è un po’ come se dicesse (no?). L’abc del mondo. Il mondo in un abc. In 60 cm quadrati (vedi sopra). Guida sempre Perec e tu, nel mentre, L o spazio inventario e quello inventato, dice, comincia sulla carta. Eccolo a rispolverare vecchie letture come il Petit Larousse Illustré, una roba che in 60 cm quadrati ci racchiudeva 65 termini geografici, ricorda. Cioè, tu apri la pagina di questo volume e strabordano oasi, ruscelli, sorgenti, foce estuario. Bastano semplici pa- 23 puoi scrivere le tue annotazioni a margine del suddetto libro, occupandone spazio libero, (ulteriori specifiche in merito, alcune pagine dopo) o leggere Perec che scrive di Borges mentre guardi un fiume che è disegnato, solcato, scritto nel Petit Larousse, che Perec ha letto e poi citato appena vicino Borges. Rovine circolari. Un’infinità a portata potenziale. Borges e Perec… senza parole. Horror vacui, dannazione! Graphic Novel “Exit Wounds” di Rutu Modan di MARINA PIERRI Se leggete questa paginetta almeno di tanto in tanto, saprete che mi piace cominciare la rubrica con una riflessione sul titolo della graphic novel che ho appena letto. Beh, non ci vuole un genio per capire che l’inglese è una lingua speciale, misteriosa, capace di mantenere il suo fascino discreto nonostante tutto il mondo ormai la usi, la maltratti e la spiattelli. Personalmente, sono attratta dalle locuzioni: a volte mi sembra che all’italiano manchi la stessa forza di catacresi, lo stesso slancio nel congelare i concetti in una, o due sole, semplici parole. sua morte è la meno dolorosa delle molte altre che seguiranno e che, pure, verranno tanto inseguite. Il romanzo, non a caso, è un romanzo di viaggio: Numi cerca Koby, figlio dell’uomo che ha amato e che potrebbe essere defunto in un attentato, nonostante sia coetanea dell’uno e inevitabilmente molto più giovane dell’altro; i due finiscono per È ovviamente il caso di Exit Wounds, che designa un avvenimento preciso e piuttosto prolisso a spiegarsi: è la maniera inglese di descrivere la ferita provocata dall’uscita del proiettile, che è molto più ampia di quella in cui entra; la pallottola, infatti, si deforma nella carne e, attraversandola, crea uno squarcio più ampio di quello da cui è penetrata. Complicato, no? Eppure quando lo si vede scritto sulla copertina del libro d’esordio dell’israeliana Rutu Modan (tradotto in italiano Unknown/ Sconosciuto ed edito dalla mitica Coconino, come la maggior parte delle graphic novel di cui leggete qui) sembra semplicissimo. Il titolo, così come deve essere, riassume il racconto: un uomo muore – forse - ma la notizia della 24 conoscersi, in maniera complessa e ritrosa, con rabbia e nostalgia da entrambe le parti, mentre scoprono un’intimità casuale e scomoda. I protagonisti hanno in comune un fantasma che resta sempre tale: il padre, Gabriel, non lo vedremo mai e non sapremo mai cos’avrebbe voluto da dire, se mai qualcosa ci fosse stato. Ma come succede nei film di Hitchcock, o in certi court drama in cui non si sa mai cos’è successo veramente, a rincorrersi sono le assenze e le mancanze. Solo queste, in Exit Wounds contano e solo da queste la storia si sviluppa. Nel loro percorso alla ricerca dell’introvabile, Numi e Koby sono impegnati in una caccia al tesoro speciale: quella dei ricordi reciproci. E dai loro ricordi – ancora, assenze – il lettore indovina la fisionomia morale di un uomo che non c’è, mai, per nessuno. C i sono due modi per raccontare storie: la noiosa verità e la mirabolante esagerazione dei fatti. L’esagerazione dei fatti, o iperbole, è bella perché è una caricatura. Wittgenstein (yawn) diceva che fare una caricatura non è altro che privilegiare e mettere l’accento su una parte in rapporto con il tutto, creando dunque, dico io, una sproporzione. O meglio, un’assimmetria. L’asimmetria fa ridere e fa pensare, perché non è regolare, dunque buffa, e va messa a posto gestalticamente con la propria testa. L’iperbole, la storia esagerata, segue esattamente questa dinamica: è divertente e fa lavorare il cervello. Fa ridere e fa pensare. Ci sono poi due ruoli che si al- ternano nelle storie: la banalità dei vincitori e il sorprendente spessore dei perdenti. Le storie dei vincitori sono retroattivamente incastrate nel rasoio di Occam: la soluzione è spesso la più semplice e ovvia. Quando le leggi, sembra che tutto sia andato liscio, che sia successo quello che doveva succedere e niente altro. L’eroe ha vinto perché è buono, la soluzione più semplice è che vinca. Non si scappa. non fuori, come Karate Kid. Solo che loro perdono per costituzione. Le storie dei perdenti invece sono più belle perché i perdenti, per tirare acqua al loro mulino, si raccontano in modo più personale, più soggettivo, si guardano dentro non potendo ovviamente aggrapparsi alla rassicurazione dei fatti oggettivi. Trovano la verità dentro di sé, In questa rubrica accoppieremo felicemente questi due fenomeni, raccontando storie esagerate di grandi perdenti. Quel ganzo di Walter Benjiamin ha detto che la storia è il bottino dei vincitori. L’iperbole, allora, è la risorsa, forse l’ultima, dei perdenti. E la verità soggettiva è infinitamente più interessante: come diceva qualcuno (quel qualcuno era Kierkegaard ma avevo paura di annoiarvi ancora di più), con soggettivo non si intende un attributo relativistico ma una appropriazione della verità in termini esistenziali. La verità per me. Iperboloser William Henry Harrison di JACOPO CIRILLO W illiam Henry Harrison, nono presidente degli Stati Uniti d’America, un predestinato. Suo padre era uno dei firmatari della Dichiarazione d’Indipendenza, lui, arruolatosi nell’esercito a soli 18 anni per le guerre contro gli indiani, diventò generale a 24 anni, poi Segretario per i Territori del Nord Ovest a 25 e Vice Governatore poco dopo. A questo punto, il giovane Will comincia a montarsi un po’ la testa: senatore, ambasciatore in Colombia, cancelliere. E poi, nel 1840, decide di concorrere alle elezioni presidenziali, inventando il “populismo”. Si presentò come il rappresentante degli uomini duri, schernen- do durante i comizi il rivale Martin Van Buren e dandogli dell’effemminato perché si lavava in una vasca da bagno, cosa che, notoriamente, gli uomini duri aborrono. Fu un successo stratosferico, Harrison vinse in scioltezza, ma qui cominciarono i problemi. Infatti, nonostante le sue promesse, lui non era più da tempo un uomo duro: viveva in un villone, si faceva il bagno in vasche grandi come barche, fonti attendibili dicono che fu lui a inventare la manicure maschile. Il giorno dell’insediamento alla Casa Bianca, il 4 marzo 1841, il cielo era leggermente rannuvolato e spirava un’antipatica brezzolina da ponente. Tutti i suoi assistenti gli 25 dicevano: ma presidente su, si copra un po’, è così cagionevole e qua mi sa che viene a piovere. Ma Bill, altero, si proclamò "l'uomo della capanna di tronchi e del sidro forte" ("Log cabin and hard cider candidate") e tenne il discorso – diventato famoso come il più lungo discorso di insediamento della storia americana – in camicetta e basta. Le nuvolette si trasformarono in nuvoloni, la brezzolina in uragano e, com’è come non è, William Hanry Harrison si beccò una polmonite fulminante che se lo portò via nel giro di un mese. Insegnando a tutti una lezione importante: se vuoi fare lo sburo e non lo sei, lascia stare che tanto alla fine ti sgamano. Contributi da: Jacopo Cirillo non è mai riuscito a spiegare a sua nonna cosa fa nella vita. Prima per colpa della semiotica, adesso per colpa di una casa editrice. Ha cofondato questa rivista solo per poterle dire: faccio il co-fondatore di una rivista. E anche, ma secondariamente, per poter dire quello che gli pare sui libri che legge. leggere e a inseguire innumerevoli passioni che, per lo più, svaniscono nel giro di pochi giorni lasciando il posto a nuove manie. Agnese Gualdrini, 27 anni, laureata in Filosofia nel lontano 2005. Da ormai un anno vive e lavora a Roma in una casa editrice con un non ben definito ruolo di giano bifronte (saltella tra l’ufficio diritti esteri e la valutazione degli innumerevoli dattiloscritti che ogni giorno invadono la posta). Adora il caffè amaro, il lungotevere, i libri di Natalia Ginzburg e cantare anche se violentemente stonata. Carlo Zuffa nelle ultime due decadi non ha raggiunto traguardi degni di nota e ritiene che la sua infanzia sia stata traviata dal finale di “Marcellino Pane e Vino”. Ora, di notte nel buio della sua cameretta, studia piani segreti per i COBRA, i quali gentilmente gli hanno concesso un pò di tempo libero per co-fondare Finzioni. Viviana Lisanti è laureata in scienze storiche e studia cultura editoriale all’Università Statale di Milano. Momentaneamente si guadagna da vivere spacciandosi per grafica nonostante non possa vantare alcuna conoscenza in merito. Nessuno fin’ora se ne è ancora accorto, quando verrà smascherata sarà costretta a far fruttare una laurea a detta di molti “inutile”. Licia Ambu pensa che avere una sola personalità sia uno spreco di spazio. In fase di definizione a ciclo continuo, ama in ordine sparso (e intercambiabile) un sacco di cose. Attualmente la posizione più quotata per guardare il mondo le sembra a testa in giù. Matteo Bettoli nasce in epoca reaganiana su un carro di bovini, dal quale eredita la passione per la dinamicità. Scostante, ombroso e pretenzioso - questo dicono di lui gli amici - a 21 anni controlla i principali media di casa: 3 televisioni, 2 computer, l’abbonamento all’Espresso e la radio ricevuta in regalo per la cresima. Decide allora di trasferirsi. Passa un po’ di tempo a zonzo occupandosi di robe politiche. Ultimamente lavora a Bruxelles dove viene spesso bollato con l’espressione *lobbista*. Edoardo Lucatti. Edo. Ode. Deo. Un essere flesso nell’edibile, nella lirica e in un soprannaturale deodorante. Performer di incauta protervia, aruspice della significazione e calciapalle di poca morale. Semiònte per alcuni, semiòta per altri, è una piccola fucina di omaggi al vostro personale sconcerto teoretico. Michele Marcon ama così irrazionalmente le lettere da aver avuto la leggerezza di confessare in famiglia una certa velleità letteraria. Il giorno dopo il padre si presenta a casa con una maglietta del Milan autografa: “Allo scrittore Michele, Kakà”. Nonostante incertezze sull’autenticità, Michele si sente fregato: gli tocca diventare Jacopo Donati studia Filosofia estetica a Bologna. La sua carriera universitaria gli permetterà, al massimo, di suonare l’organetto per strada: conscio di ciò, per non pensarci, passa buona parte del suo tempo a scrivere, a n. 8 / Dicembre 2009 [email protected] www.finzionimagazine.it 26 tale musicale Vitaminic.it ma scrive anche su Rolling Stone, PIG Magazine e Blow Up. Ascolta una media di tre nuovi dischi al giorno, legge, guarda un sacco di film e serie televisive americane. uno scrittore, non è più un affare privato. Per ora è un abile lettore, ma la cosa triste è che tifa Juve praticamente dalla nascita. Andrea Meregalli è un pensatore di quasi venticinque anni. In questo istante medesimo si arrovella su quesiti del tipo: “Cosa farò da grande?”. Assiduo frequentatore di autostrade nonché massimo esperto in campo internazionale di prodotti quali friggitrici, scalda patate, piastre per panini e salamandre, ama molto abbinare correttamente i boxer con le calze. Passa buona parte della sua giornata a leggere le scritte oscene sulle porte dei cessi nei centri commerciali. Simone Rossi vive alla Casa del Cuculo, “un posto dove ci piove dentro” (cit.). Di giorno scrive, di sera suona, di notte dorme. Tutti e tre troppo poco. Una volta è stato in Etiopia: il viaggetto è diventato un libretto, La luna è girata strana (Zandegù, 2008). Sta volentieri senza scarpe e fa un po’ fatica ad arrivare a fine mese. Tende a scrivere sui muri palindromi intellettualoidi tipo in girum imus nocte et consumimur igni. Il suo gatto si chiama Chomsky, ma non si vedono da un po’. Fabio Paris nasce impagliato, e così finirà, per evitare che gli amici ballino sulla sua tomba. Zingaro, in accezione monicelliana, ha studiato chimica, seguendo la sua passione per la geopolitica. Ora vive facendo l’inviato da Pittsburgh per Finzioni e spacciandosi per esperto di nanotecnologie. Greta Travagliati, semiotica appassionata di arte, Proust e culturalizzazione della merce. Si interessa di tendenze e chincaglierie del contemporaneo anche se avrebbe preferito vivere nell’800. Attualmente vive a Milano dove lavora in un centro ricerche e dove spera aprano presto Starbucks colorati, una pasticceria turca ed un centro di gravità permanente a forma di pera. Filippo Pennacchio, già in tenera età plagiato dalla figura di Lee Harvey Oswald, a tutt’oggi suo eroe personale, vive a Milano, dove studia, fa la spesa alla Pam, frequenta concerti di dubbio gusto e beve dei gran birroni. Quando non sa che fare, ammortizza i propri desideri nel sapere, manco fosse un personaggio delilliano, leggendo libri dalle cinquecento pagine e oltre. Di conseguenza, alle volte si annoia tantissimo. Matteo Treleani è dottorando in semiotica a Paris Diderot e ha una curiosa passione per i campi non affini. Amante dei miti greci e della musica barocca, è un sommo sostenitore dell’arte dell’insignificanza, ovvero del non voler dire nulla. Maria Giovanna Ziccardi, laureata in giurisprudenza a Trento nel lontano 2008, sotto una nevicata epocale, ha una spiccata vocazione per i lavori non pagati. Si barcamena tra case editrici, udienze e cronaca locale. Pensa che la matematica sia alla base del declino della civiltà moderna e crede che chi è capace di fare la conversione euro-lira sia dotato di capacità divinatorie. Ama leggere e scrivere, ma non leggere quello che ha scritto. Alessandro Pollini é laureato in Psicologia ma non legge nella mente delle persone. Da quando ha iniziato a seguire Voyager é convinto che l’uomo non sia mai andato sulla luna, ma i Templari si. Ha ventotto anni ed é bellissimo. Marina Pierri ha 28 anni e vive a Milano, dopo dieci gloriosi anni passati a studiare/lavorare/fare radio/ fare la dj in quel di Bologna. Si occupa a tempo pieno del por- Finzioni è disponibile solo su abbonamento. Abbonati o richiedi gli arretrati su http://finzioni.bigcartel.com 27 www.finzionimagazine.it
Scaricare