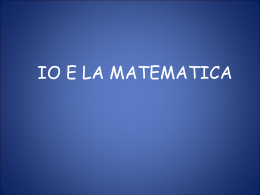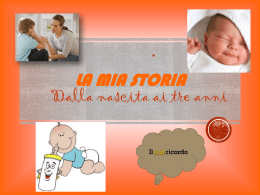XIII Edizione I Colloqui Fiorentini – Nihil Alienum Gabriele D’Annunzio: “Ah perché non è infinito come il desiderio, il potere umano” 27 febbraio – 1 marzo 2014, Firenze Fiera I CLASSIFICATO SEZIONE NARRATIVA “E TU RISPONDI, SE PUOI…” Studente: Sidney Fontana della classe III BSU del Liceo Scientifico Albert Einstein Docente referente: Cristina Vallebona di Piove di Sacco (Padova) L’autobus traballa, fa di ogni buca un’onda ed ogni onda va al ritmo della canzone che mi suona nelle orecchie. Frank Sinatra riempie i polmoni. Per lui solo poche pause, per noi, per me, nemmeno una. Pensieri di questo tipo ti fanno credere che la vita sia destinata a non avere un ritmo, un libretto d’istruzioni con le regole per ogni occasione. Sinatra allunga le vocali, le fa durare quanto piccoli “per sempre” privati, come quelli che si scambiano gli innamorati quando sono felici, concede alle ultime sillabe delle parole una minuscola infinità di tempo, precisa, composta, che fa apparire il limite inesistente. Io chiudo gli occhi. Sento la luce verde dei neon carezzarmi le palpebre e le ciglia. Mi lascio condurre dalle note in posti meravigliosi, tra i miei ricordi perfetti e le mie invenzioni laboriose: esse sono il mio lavoro sartoriale su misura, un taglia, cuci, attacca, stacca, certosino, paziente. Ora sono in quei posti, quelli in cui si sta quando ci si lascia andare abbastanza da arrivarci. A volte non ci si arriva, a volte si riesce a malapena a raggiungere metà percorso, poi si aprono gli occhi e tutto finisce, tutto s’infrange. Ma oggi no. Oggi, ora, proprio qui, voglio stare aggrappata al palo di ferro, voglio lasciare che le buche mi cullino fino a casa, voglio che questa canzone mi assorba, voglio che mi lasci il tempo di sognare ciò che sono, che sono stata e che vorrei essere. “Ho programmato ogni percorso, ogni passo attento lungo la strada. Ma più, molto più di questo, l’ho fatto alla mia maniera.” Non ricordo la prima volta che vidi Giovanni, né la prima volta che ci parlai, né la prima volta in cui mi sorrise. In fondo, io e lui non siamo mai stati quelli delle prime volte. Eravamo solo persone che si passavano accanto senza sfiorarsi, che non si osservavano, che a volte si sorridevano educatamente senza farci nemmeno caso. Non ricordo il modo in cui diventò per me come una seconda pelle, come lo strato in più che d’inverno ti protegge dal freddo e d’estate dai raggi del sole. Una cosa che ricordo, però, è la volta in cui capii che non ci sarebbero stati altri occhi in cui mi sarei voluta perdere, né altre labbra che avrei voluto osservare discorrere di questo e di quello. Ricordo il momento in cui la sua importanza iniziò a fare del mio cuore il macigno più piacevole da sostenere. Ricordo la mia voce al citofono (‘Ciao, sono Allegra. C’è Giovanni?’), i passi di sua madre correre sui gradini per venirmi ad aprire (‘Giovanni arriva subito’, aveva detto), il colore sgargiante della maglia di lui, la brevissima pausa che fece per osservarmi prima di venirmi incontro. Ricordo il mio respiro incerto, stupito dal palpitare esagerato del mio cuore, da quel pompare vita velocemente, come se ci fosse stata un’altra “me sottocutanea”, come se la normalità all’improvviso non bastasse più, come se il titolo di “amico” non gli andasse più bene. Troppo stretto o troppo largo o troppo vecchio o troppo poco. Ricordo l’ombra del suo abbraccio, la carica d’imbarazzo che ci mise prendendomi tra le braccia, e quel ‘ciao’ strascicato tra le labbra. Ricordo il pensiero che aderiva completamente a quel momento: un ‘mi sei mancato’ lungo dieci pagine, profumato da mille fragranze, descritto da mille lingue diverse. Ero lontana da casa, ma lì, in quell’istante mi sentii confusa e fui certa che non era ‘casa’ quella da cui venivo, bensì, lo era quella che mi aveva accolta timidamente, per un istante. Lui era casa mia. Io ero a casa. Quanto ci si può sentire persi senza un amore come quello? Feci dei miei occhi appena una fessura. Il bus blu era fermo al semaforo, fermo tra le auto, tra anime, persone, cose accomunate da una meta. In quel dettaglio di tempo mi chiesi quante di quelle persone stessero correndo incontro alle braccia del proprio posto nel mondo, tra le braccia di madri, padri, figli, mariti, mogli, conoscenti, amici, cugini, fratelli e sorelle, che in quel momento sarebbero state le presenze adeguate, i simboli giusti da accostare alle note, lo stacco impercettibile tra un accordo di mi e la minore sulla tastiera di una chitarra. Mi chiesi quanto tempo, ognuno di loro, ci aveva messo a prepararsi il cuore per quell’incontro, se erano bastati i cinque minuti dopo la sveglia, o la pausa caffè tra un turno e l’altro, se c’era voluta l’intera ricreazione a scuola o quaranta minuti spesi ad ascoltare la stessa canzone, ore e ore occupate a guardare lo stesso film. Poi richiusi gli occhi, abbandonai sul pavimento appiccicoso dell’autobus le mie domande, proprio come avevano fatto con me quando era stato il tempo, quando la decisione da prendere era ‘andare o restare’. A casa mia, lui, non c’era mai stato. Io invece avevo visto la sua tante di quelle volte da aver racchiuso nella mia memoria ogni particolare, ogni stridio di porta e ogni movimento della tenda blu nella sua stanza. Ero stata in quel posto tante di quelle volte da permettermi di abbandonare il mio sguardo negli angoli polverosi, di tanto in tanto. Avevo vissuto il suo vivere, e gli avevo raccontato innumerevoli volte del mio, avevo imparato da quella casa, dalla disposizione dei quadri sul muro arancione, e avrei voluto che lui facesse lo stesso, che operasse nella mia vita con la stessa attenzione ai dettagli, con la propensione al saper riconoscere nelle cose dubbie qualcosa di certo, che io non riuscivo a capire. Avrei voluto tanto mostrargli la costellazione delle cinquantuno foto attaccate ai muri della mia stanza, avrei voluto spiegargli le luci dell’alba proiettate sul piumone il lunedì mattina, avrei voluto fargli leggere le mie poesie da dodicenne sconfitta nascoste nei quaderni di musica. Avrei voluto illustrargli i quattro anni antecedenti ai fastidiosi dodici, in cui mi ero evoluta con le mie parole ed ero diventata ciò che sono. Desideravo che lui vivesse la mia realtà, desideravo decodificare le pianure e dimostrare che oltre le colline gialle dei suoi luoghi era bello imparare ad amare anche le distese verdi in primavera di paesi sconosciuti. Forse sarei riuscita a fargli capire la nebbia fitta, o la pioggia che batte forte sulla finestra. Credo che non potrà accadere. La signora dal giubbotto giallo dietro di me prenota la fermata. Di spalle sembra un raggio di sole, ma io l’ho visto, il suo volto, ho visto quanto in realtà sia ghiaccio e gelo, quanto desideri la libertà. Eppure non la conosco, eppure tra qualche giorno mi sarò dimenticata di lei, dei capelli bianchi, delle rughe marcate. Tra un po’ non m’importerà più di lei. Ma per ora non posso non osservarla. Per lei ho messo in pausa le mie fantasie, ho ritardato i ricordi. Volevo darle l’ultima occhiata prima di vedere il suo corpo uscire da qui, verso il mondo, prima che il suo odore mi impregni per l’ultima volta. Il bus si ferma, e lei, agile, si muove, cammina verso l’uscita come un bimbo affamato verso la soglia della cucina. Spero che lei possa stare bene, anche se mi ha lasciata. Ora qui ci sono il bimbo con la mamma islamica e il barbone dal cappello rosso. Posso sentire i loro odori, posso immaginare le loro storie, le loro vite, il rumore della farina di semolino che cade nella ciotola prima di fare il couscous, le macerie di una vita che ha svestito l’uomo lasciandolo solo con il suo cappello rosso e i suoi rimorsi. Scuoto la testa, cerco dentro di essa la mia storia sospesa a cui dovrò dare una fine, o un seguito almeno. La mia canzone è giunta al primo ritornello. Ricordo che, una volta, molto tempo prima che avvenisse la magia del pianerottolo, gli parlai delle mie paturnie, della mia vita che sapeva di desolazione, senza più stimoli, senza più nulla per cui valesse la pena tentare. Ricordo di avergli scritto uno di quei messaggi lunghi che mi facevano sentire a mio agio. Tra quelle parole io sparivo, evaporavo, lasciando solo la forma stilizzata delle lettere. ‘Sono uno di quegli alberelli minuti con i rami troppo lunghi’, gli avevo scritto, e lui aveva risposto che non ci sarebbe stato motivo di vergognarsi: i rami troppo lunghi sono il segno che alla vita si è sempre dato tutto, aveva detto. Ricordo che tirai fuori quella storia qualche tempo dopo averlo rivisto, in una sera d’estate, vedendo il fuoco bruciare i rami tra il vociare allegro degli amici, i nostri amici. ‘Hai visto che fine fanno, i rami troppo lunghi?’, gli avevo chiesto, ma lui, quella volta, non aveva fatto altro che guardarmi duramente e scalare di un posto, lontano da me. Quella fu la prima volta che non mi salvò, che mi lasciò impigliata tra i relitti, come un’alga destinata a decomporsi nel fondo dell’oceano. Quella sera ricordo di essermi fiondata sul cellulare, alla ricerca del numero adatto, facendo una patetica roulette con i pollici sullo schermo e gli occhi colmi di amarezza opaca, alla ricerca di una voce che mi avrebbe consolata nonostante mezzanotte fosse passata da un pezzo. Ciò di cui, però, mi rendevo conto, era che la voce che avrei voluto davvero sentire era lì accanto a me e mi aveva imposto il silenzio. La mia guancia si posa sul palo. Se ci fosse mia madre mi direbbe di non appoggiarmi, mi direbbe ‘chissà quanta gente si è appoggiata, magari con le mani sporche e ora ti ci appoggi tu, ma non ti fa schifo?’. Mi chiedo se davvero ci si sia mai appoggiato qualcuno, mi chiedo quale sia il volto dello sconosciuto di cui parlano sempre le madri per spaventare i figli, lo spaventoso ‘uomo nero’ che rapisce i bambini e che non si lava mai. Il freddo del palo è piacevole. Se apro gli occhi posso vedere il colore della mia pelle troppo chiara. Le vacanze sono finite da poco, io sono lontana mille e mille miglia da lui e la mia pelle è ancora chiara come all’inizio dell’estate. Questo palo di metallo ghiacciato mi fa pensare al mio gatto, a tutte le volte che mi ha fatto capire che aveva fame limitandosi a sfregare le guancie pelose sui piedi del tavolo, in cucina. Chissà se qualcuno se ne accorge, chissà se qualcuno è indeciso se venire o meno a dirmi ‘Ho capito, il tuo cuore è affamato. Aspetta un minuto, ti porto subito un po’ d’amore.’. Basterebbe anche un abbraccio, anche uno solo di quegli sguardi che ti dicono ‘So come vanno le cose’ senza aprire bocca. Basterebbe anche il messaggio di un cartellone pubblicitario. Ma qui, non ci sono cartelloni, né sguardi, né abbracci, qui, per me, non c’è nient’altro che tre sconosciuti su un autobus blu. Come si finisce ad essere così soli? Per un attimo la mia memoria tocca i giorni vicini, quelli come oggi, come ieri, fatti in serie come fossero appena usciti da una catena di montaggio. Tutte quelle ore di antropologia trascorse cercando di seguire il filo logico di un discorso astratto, campato in aria, con la mano sinistra a sorreggere il mento e tutto il peso della mia mente, delle fantasie che fanno opachi i miei occhi, che interrompono il disperato tentativo di concentrarmi. Cosa vedono quegli occhi opachi è semplice: la bidella bionda che entra, che dice il mio nome e chiede se posso uscire, che mi mette la mano al centro della schiena accompagnandomi fuori dalla classe. Dice il mio nome, dice che c’è qualcuno per me, e io già lo so, già so che dietro l’angolo, appena giù dalle scale, mi aspettano i suoi occhi verdi pieni di cose da dire, quei suoi capelli ricci, quel suo odore semplice, e già lo sento. O almeno immagino di sentirlo, e la parola chiave è proprio questa: ‘immagino’. Cosa sento ora che mi sono smascherata? Che mi sono tolta la benda opaca dagli occhi e riesco a vedere chiaramente che la porta cigolante è ancora chiusa? Cosa provo ora che riprendo atto del fatto che la bidella bionda mi odia e che anche la minima cosa di quel sognare ad occhi aperti è falsa? Non provo niente. Questa sensazione mi assale così spesso che non riesco nemmeno più a darle un nome. Cos’è? Umiliazione? Rabbia? L’ombra di una di quelle illusioni che fanno sospirare, che ti lasciano così vuota da toglierti ogni scusa di bocca? Da farti ammettere a denti stretti che sai bene che non accadrà e che se è già successo non ritornerà? No. Ci sono. È una domanda: Perché? Perché alcuni di noi sono destinati ad essere impotenti di fronte a certe situazioni, certi amori, certe notti insonni alla ricerca di un motivo per far andare avanti quell’esistenza? Perché persone come me sono destinate ad essere solo un piccolo granello di sabbia destinato al silenzio caotico di una massa, la società, che non ti apprezzerà mai, che non ti vede nemmeno? Non ti vede la società e non ti vede lui. Sei invisibile, non esisti. Perché? Aspetta, ce l’ho sulla punta della lingua … è la domanda giusta … Il bus inchioda. Una cuffietta bianca mi scivola dall’orecchio sinistro. Ho gli occhi sgranati, sono sul pavimento colloso, grigio per mascherare lo sporco. L’autista chiede scusa come se fosse solo una congettura, come se non gli dispiacesse affatto. Il barbone si precipita a vedere come sto. Ha fatto male, il naso mi sanguina, la canzone va avanti, ho sbattuto sul seggiolino di plastica davanti a me. Perché va tutto così lentamente? La signora islamica cerca nella borsetta un fazzolettino e il bambino inizia a piangere. Velata di viola, aiuta l’uomo dal cappello rosso a mettermi a sedere sul seggiolino. Sembra una di quelle scene da apocalisse, da rapina in banca, in cui un tizio viene ferito e tutto inizia a girare intorno a lui. Ora scopro che gira davvero, non l’attenzione ma la testa. Sento l’autista sbuffare e accostare. È grasso e flaccido. Viene verso di me e mi da una pacca sulla spalla. È a disagio. ‘Questi genitori che lasciano andare i figli in giro da soli’, dice. La donna mi chiede se sto bene e all’improvviso mi sono dimenticata come si parla. Penso e basta. L’autista mi chiede se ho un numero di emergenza da chiamare. Io chiudo gli occhi e dimentico di riaprirli. Un giorno vorrei poter ricordare di avergli dato il tuo. Vorrei poter pensare a quando l’autista ha composto il numero e a quanto tu fossi sorpreso del fatto che chiamassero proprio te nonostante tu fossi così lontano. Vorrei poter raccontare la storia della volta in cui sono svenuta in autobus dicendo ‘E non ci crederete mai, ma avevo messo proprio il giorno prima il suo numero tra le preferenze delle chiamate rapide!’. Peccato per la password d’accesso, peccato che odio i numeri d’emergenza che mi intasano lo schermo, peccato che non è successo, che non ti hanno chiamato, che tu non sai nulla, e forse non lo saprai mai. Io non sono arrabbiata con l’autista. In fondo è normale: quando ti tagliano la strada freni. E lui ha frenato. Più che altro è colpa mia, la ragazzina attaccata al palo quando tutti i posti erano liberi. Ma in fondo una scusa ce l’ho: la visuale. Da lì mi sembrava di poter vedere tutto, di poter origliare alle conversazioni nelle macchine al semaforo anche se non riuscivo a vedere nessun passeggero. Lì vedevo me stessa. Non so perché. È una parola familiare: perché. Cosa stavo dicendo prima? Cos’avevo trovato che ora ho perso? Non ricordo. Eppure era importante. Apro gli occhi. Mia madre è qui, mi accarezza i capelli. Sono in un ambulatorio colorato. Perché i dottori non riescono a capire che non si può mettere un adolescente in pediatria? A sedici anni a che mi servono i coniglietti, i prati verdi e i fiori colorati dipinti sui muri? A sedici anni servono delle frasi piene di speranza scritte in rosso sulle pareti, graffiti che ci mostrano che non è tutto perduto, che c’è sempre qualcosa da salvare. A sedici anni serve un po’ d’amore, serve un’amica che ti ascolti, un treno sempre pronto a partire verso albe chiare sconosciute, un sole sempre pronto a tramontare, quei pomeriggi pieni di musica che ti si incidono dentro, che ti fanno respirare davvero, che ti dicono ‘starai bene’. Invece qui di speranza non ce n’è. Bambini che urlano, altri che vanno avanti e indietro per i corridoi nei loro pigiami chiari, come fossero fantasmi, come fossero brutte copie di sogni infranti. Vorrei poter cancellare questi disegni stupidi, vorrei poter far bianche le pareti e disegnare schiene nude, come quelle incise lentamente, senza far rumore, nelle ultime pagine del mio quaderno di matematica. Vorrei poter disegnare le mie occhiaie di velluto, e a chiunque mi chiederà spiegazioni, dirò che è semplice natura morta. Non sento più niente di vivo in me. Sono persa. Qualche mese fa avevo l’abitudine di disegnare nudi, scapole urlanti, colonne vertebrali piegate su se stesse. Una cosa che amavo fare era tracciare con la matita, la rotondità dei seni pallidi, che erano di una perfezione anatomica, quasi impossibile da percepire in un corpo vero, un’intimità cancellabile, ideale. Disegnavo donne magrissime sperando di poter diventare come loro, un giorno. Dopo un po’ mi resi conto che ero destinata ad essere fragile dentro e non fuori. Mentre il mio cuore portava il peso dei miei errori, le mie ginocchia sorreggevano settantacinque chili e mezzo di infelicità. Ma almeno Giovanni era con me … aveva detto che ero come un tramonto … non aveva detto che se ne sarebbe andato. Ricordo ancora il giorno in cui i suoi occhi mi dissero che sarebbe andato tutto storto, le mie mani che tremavano, i miei occhi che si chiudevano in fretta per evitare di lacrimare. Nello stomaco non c’erano più farfalle, ma uccelli rapaci che a furia di beccare strappavano i tessuti e le interiora, rompevano le costole e mi facevano sentire quanto poco fossi per lui. In fondo lo ero sempre stata, il punto è che lui se n’è accorto dopo aver costruito una di quelle relazioni che non potresti sopportare di perdere. La dottoressa entra nell’ambulatorio. Ha il camice sbottonato, la targhetta rivolta in giù. ‘Tutto bene?’, mi chiede. Di solito, quando qualcuno me lo chiede, rispondo solo ‘Definisci ‘bene’.’, ma questa volta non è il caso. ‘Sì, grazie’, le dico. ‘Strano.’, dice, e io non capisco. Lei mi fissa, poi si china su uno di quel carrellini d’acciaio. Mi dice ‘Apri’ e mi punta una luce negli occhi. Il bianco, per un attimo, mi assorbe, e io non esisto. La dottoressa chiede a mia madre come mi chiamo. ‘Allora, Allegra, cosa ricordi?’ ‘Sono caduta, in autobus. Cioè, l’autista ha frenato e io sono caduta. Ho sbattuto la testa.’. La dottoressa guarda mia madre, poi abbassa gli occhi. Sospira piano, tanto lentamente da darmi il tempo di osservarla. Ha gli occhi marroni, i capelli di un biondo spento, del colore di un lampione in lontananza, un faro acceso nella nebbia di Novembre. ‘Bene, starai qui per una notte. Se domani stai meglio torni a casa, okay?’. Annuisco, poi dico ‘Ma io sto bene’. Lei ride, la stessa risata che per anni mi è stata sbattuta in faccia da parenti, professori, compagni di classe, persone che non facevano altro che ridere, come a dire che capirò col tempo. ‘Chiedo all’infermiera quale stanza è libera.’, dice. A volte mi chiedo se davvero non conto niente o se è solo una mia impressione. Me lo sono chiesta molte volte, diciamo tutte quelle volte in cui lui mi è passato accanto e mi ha ignorata. A volte mi sono persino chiesta se davvero esisto. Quante domande, quanta scarsità di risposte! Eppure, alcune risposte le ho trovate, ne ho preso atto senza chiedermi quale fatto miracoloso me le abbia fatte scoprire. Come una gazza ladra di primavera ho fatto tesoro di tutto ciò che scintilla, ho corso il rischio di tagliarmi, e il più delle volte è successo, ma non me ne sono mai pentita. Trovare alcune risposte è come leggere di fretta un bel libro: si accetta la possibilità di tagliarsi i polpastrelli scorrendo le pagine. Altre ricerche sono come le notti in bianco, quelle che ti ispirano e che il giorno dopo ti fanno sentire sottosopra. Le mie migliori scoperte le ho fatte scrivendo, e col tempo mi hanno fatto capire quante cose avevo da dire, da offrire, a volte agli altri, altre volte a me. Questa volta, invece, manca la domanda. Stanza numero 247. Il neon mi fa sentire incapace, come una pazza nel suo manicomio personale. Più che una stanza sembra una cella. È colpa del cielo cupo fuori dalla finestra, o forse della pioggia battente dentro la mia testa. Porto una mano alla nuca, e scopro la garza. Mia madre mi tiene per mano. Ho sempre saputo che in quello spazio tra le nostre dita c’è tutto l’amore del mondo, un amore taciuto ma ovvio. Mi chiedo a che punto sia la mia canzone. Dov’è Frank? Dov’è la sua indipendenza? Se potessi gliene strapperei un po’ e la terrei per me. ‘Ti gira la testa?’ ‘No, mamma, sto bene.’. In quelle due parole, c’è qualcosa di erroneo. Vorrei conoscere l’uomo che sta bene, bene veramente, l’uomo a cui piace il suo lavoro, a cui va bene il luogo in cui vive, che è felice della sua relazione. In vita mia non ne ho mai incontrato uno. Forse, se avessi la certezza che uomini del genere possano esistere mi lascerei andare. Forse non darei peso alle parole, non mi farei tutte queste paranoie. Forse troverei più in fretta le risposte, forse mi andrebbe bene qualsiasi cosa, persino la mia faccia dentro lo specchio la mattina. Forse … In fondo io ho sempre odiato le condizioni, tutti quei ‘se’, quei ‘forse’, quei ‘ma’, quei ‘nonostante’. Le condizioni impediscono alle persone di fare progetti, toglie loro il potere di decidere e di agire per il loro bene. Io sarei stata felice, se solo lui non mi avesse scaricata come il sacchetto dell’umido sul marciapiede il mercoledì sera. Se fossi in grado di decidere chi amare, forse il sole alle otto di mattina brillerebbe di più. Sono parole che non riesco a decifrare, o, magari, sono solo paranoie, scarti di paure che emergono dal calderone neuronale dei miei pensieri. Quante volte mi sono chiesta come sarebbe se fossi più magra, o più bella, se avessi un’altra faccia. Perché vedo un futuro migliore in ciò che non sono? Perché non riesco ad essere la persona che la società richiede? Mi sento come una goccia di pioggia informe, diversa, caduta troppo in fretta sul vetro gelido di una realtà che non piace a nessuno, neanche ai grandi, neanche ai dottori, ai professori, alla bidella bionda che mi odia, a mia madre, a Giovanni. Ma ho come l’impressione che per me sia un po’ più difficile. Sono alla finestra. Questa camera puzza di vecchio, di polveroso, di dolore. Questa camera puzza di desiderio, il desiderio di essere in un altro posto, con altra gente attorno, o nessuno. Mi volto. Mia madre è seduta sul letto con le gambe a penzoloni, sembra una bambina. Alza il viso. ‘Cosa ti avevo detto? Se hai un punto d’appoggio devi tenerlo stretto, se no rischi di romperti il naso! È così che ho sempre fatto con tuo padre, e credi che io non voglia sentirmi più libera? Ma certo che voglio, ma se mi rompo il naso poi come faccio? Bisogna fare attenzione alle conseguenze, capito? È da quando eri piccola che cerco di insegnarti queste …’. Smetto di ascoltarla. Le sue regole per raggiungere la tanto agognata stabilità non sono mai servite a nessuno, nemmeno a lei, che quando papà è via per lavoro piange sul cuscino sognando di essere una persona diversa con una vita diversa, sognando la felicità che il giorno del loro matrimonio ha barattato con quel senso di equilibrio che in realtà non c’è mai stato. In fondo siamo tutti simili, abbiamo tutti la stessa espressione alle cinque del mattino, abbiamo le stesse mete, le stesse ambizioni, solo che alcuni si sono stufati di aspettare gli effetti o di consumare piaceri che durano al massimo venti minuti. Io mi sono stufata, forse più di tutti gli altri. Mi sento come intrappolata, lì per lì per affogare in un bicchiere di buon vino rosso, rosso come il sangue secco vicino le mie labbra. Mi piace pensare che se ci fossi stato tu non avresti permesso tutto questo. Mi avresti strappata via da questo stupido posto, da questa stupida gente, da questa stupida madre, da queste stupide questioni irrisolte e domande formulate a metà. Se ci fossi stato tu avrei trovato la mia stupida stabilità nei tuoi stupidi occhi. Quegli stupidi occhi dai colori incerti. Oh, ma, se io potessi, tu saresti qui, il tuo mestiere sarebbe la tua passione e la tua passione sarei io. Se tu fossi qui mi terresti la mano, forte, come fossimo bambini affidati l’uno alle cure meticolose dell’altro. E ti amerei, sì, se potessi ti amerei e tu saresti tutto il mio mondo, esattamente come adesso, ma io, io e nessun altro, sarei il tuo asse, il punto più vicino al tuo cuore, l’osservatorio dei tuoi battiti. E ora ci rimane solo una cosa, solo una domanda, e mi è lecito dopo tutto questo doloroso viaggio, dopo l’autobus tempestato di pioggia, dopo la tempesta dentro me medesima, mi è lecito forse più di qualsiasi altra cosa, e tu rispondi, se puoi: perché non è infinito come il desiderio, il potere umano? Postfazione Vi ho presentato Allegra, un’adolescente di oggi travolta dall’amore (anche se non ricambiato) per Giovanni, che vive tra i ricordi in cerca di un suo posto in cui trovare calore umano. Allegra è sincera nei suoi desideri e nei suoi pensieri, non è come sua madre, che la riempie di regole per raggiungere la tanto ambita serenità e di paure per le quali non potrebbe nemmeno appoggiarsi su un corrimano. Allegra, come Gabriele D’Annunzio, è creatrice di bellezza, e vede nella semplicità delle cose, come delle persone, dei fondamenti per ciò che è bello, ciò che è da ricercare. Come l’autore abruzzese, ella vuole fare alla sua maniera, vuole trovare le sue risposte e formulare altre domande, e come lui, si chiede come mai il potere umano non è infinito quanto il desiderio (nel suo caso quello travolgente di aver accanto la persona che ama). Al contrario di D’Annunzio, però, Allegra non ha paura del dolore, lo vive nei suoi pensieri ogni secondo di ogni minuto dandosi lo spazio per affrontarlo, o, forse, per riaprire ferite cicatrizzate malamente, e non parla di gioia, non ne è ossessionata, come la madre. Allegra è un personaggio comune a tutti gli adolescenti, è ogni adolescente alla ricerca di un benessere sano, basato sulla vita in sé, una vita che non ha spazio per i piaceri effimeri.
Scaricare