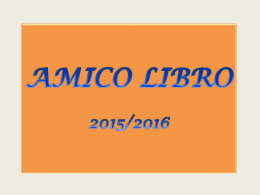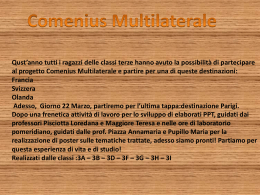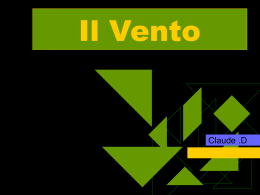2 Paolo Scottini L’ultima orchidea 3 Iniziativa personale edita nel: ottobre 2011. Questo libro è opera di fantasia. Nomi, personaggi, luoghi e avvenimenti sono il prodotto dell’immaginazione dell’Autore o sono usati in modo fittizio. Ogni riferimento a fatti, luoghi o persone reali, viventi o scomparse, è puramente casuale. [email protected] 4 A Martina, il mio fiore più bello 5 6 Premessa dell’autore Rovereto, ottobre 2011 Era stato quel caldo pomeriggio d’estate che sentii la chiamata. L’estate del 2008. Era successo in biblioteca, dopo aver restituito all’addetta alcuni libri presi in prestito qualche settimana prima e che, dopo averli letteralmente divorati, stavano da alcuni giorni scompostamente girovagando da un sedile all’altro della macchina. Li raccolsi e li adagiai come reliquie sul bancone delle rese, consegnai alla responsabile la tessera con i miei dati e, mentre aspettavo la confermata restituzione, con il mio solito sorriso da ebete stampato sulla bocca notai la locandina. La signora mi chiese qualcosa che naturalmente non afferrai; quella che mi catturò da quel momento in poi, era stata una stupida carta stampata appesa alla parete. Ulisse era stato avvisato dalla maga Circe della presenza delle Sirene, per cui ai marinai aveva fatto tappare i timpani con la cera e lui si 7 era fatto legare all’albero maestro per non soccombere ai melodiosi canti delle marinaresche creature, tanto attraenti quanto pericolose. Purtroppo io non ero stato avvisato da nessuno, quindi fui immediatamente rapito dall’ armonia di quel suono e, come uno stolto, cedetti alla prima lusinga. Ecco che qualcosa mi afferrava e con violenza mi attirava a sé, e la forza che interagiva tra due enti fisici come il mio corpo e quel manifesto, annullava in pochi secondi la breve distanza che ci separava. Lessi, e fu amore a prima vista. Lo stampato appuntato alla bacheca informava il cittadino di un concorso letterario che si sarebbe svolto di lì a qualche mese presso la sede della biblioteca civica di Raossi, e incoraggiava la partecipazione a chiunque avesse qualcosa da raccontare in merito alla valle, la sua gente, la sua cultura o la sua storia. Non mi era mai passato per la mente di scrivere neanche il più semplice biglietto d’auguri indirizzato alla Vallarsa, figurarsi un racconto! Eppure, in quel preciso istante, mi balenò l’idea che forse qualcosa da buttar giù ce l’avevo anch’io. Mi stavo sempre più convincendo che la storia esisteva, stava sepolta da qualche parte, da sempre smaniosa di saltar fuori; bastava semplicemente riuscirla 8 ad individuare ed estrarre. Cominciai a pensare ed ecco affiorare i primi scogli: come trovare qualcosa di originale, qualcosa che non sia stato ancora trattato? Certo, la Vallarsa è una terra ricca di storia e sappiamo bene tutti quanto, durante il Grande Conflitto, sia stata brutalmente oltraggiata, facendole quella guerra dono di tutto ciò che comporta essere terra di confine. Una valle così orribilmente stuprata dall’uomo può non aver niente da reclamare? A quello, ringraziando Dio, hanno pensato egregiamente gli innumerevoli autori di testi memorabili, tutti molto bravi e informati e, visto che il sottoscritto non è uno storico, mi sono convinto che sarebbe molto più intelligente cambiare argomento per non affondare nel banale o peggio ancora incappare in vergognosi sbagli. Però non sono neanche un letterato, o uno scrittore capace di osannarne le ineguagliabili vette o esaltarne le verdeggianti vallate. Che non sia forse il caso di lasciar perdere? Salutai scoraggiato la signora e con in testa una miriade di progetti confusi, salii in macchina dirigendomi verso Staineri, il paese che mi ospita da oltre un quarto di secolo. Raggiunto il bivio di Anghébeni, imboccai la strada provinciale che sfocia a Rovereto 9 passando dalla sponda destra a quella sinistra del Leno. Il paesino di Staineri dal punto in cui mi trovavo dista circa un chilometro e mezzo e, se fatto in automobile, per arrivarci non ci si impiega più di tre minuti. Quel pomeriggio mi ci volle quasi un’ora. Non perché ci fosse traffico o perché mi fossi accidentalmente trovato con l’auto in panne, ma perché appena oltrepassato il menzionato abitato, il mio sguardo fu attirato nella direzione del sottostante cimitero di guerra. E lì sentii il fulmine conficcarsi nella carne. Le Sirene mi stavano divorando. Accostai raggiante sul selciato: sapevo finalmente da dove cominciare. Osservai il territorio, studiai il paesaggio e la fantasia fece il resto. Dopo circa un’ora di meditazione mi fiondai in macchina, ingranai la prima e due minuti dopo stavo parcheggiando sotto casa. Salii di corsa i quarantatre scalini che portano alla mia residenza, veloce come un capriolo selvatico, solamente che l’animale, alla fine della rampa, non avrebbe avuto il fiatone che tenevo io dopo l’impegnativa performance. “Dove corri?” mi chiese stupita mia moglie. “Impegni inderogabili” risposi. “Carpe diem, amore.” 10 Quel pomeriggio avevo gettato le basi di L’ORCHIDEA (ampiamente romanzato e rititolato solo in un secondo tempo con l’epiteto più specifico di L’ULTIMA ORCHIDEA) ma mi ci vollero tutti e tre i mesi concessi dalla commissione d’esame per poterlo rendere presentabile. Lo consegnai l’ultimo giorno ammesso, proprio sul filo di lana. Quando ricevetti la raccomandata che mi informava del primo premio assegnatomi nella categoria adulti, non credetti ai miei occhi. Come era possibile tutto ciò? Eppure era proprio il mio nome quello che stava in neretto al centro dell’epistola. LA STANZA IN CIMA ALLA TORRE, altro racconto ambientato in Vallarsa, l’ho partorito un anno e mezzo dopo il primo ed è stata proprio questa sua collocazione geografica a darmi lo spunto di inserirlo in questo volume. Malgrado il titolo ingannevole, questa è una storia d’amore; amore nel vero senso della parola. E’ una storia di cuore antica come il mondo, e proprio perché appartiene al mondo credo che ci sia sempre qualcuno ispirato a parlarne, cantarne; scriverla o descriverla in tutte le forme d’arte conosciute. Mi auguro di 11 riuscire a smuovere i sentimenti e a donarvi qualche minuto di piacevole distrazione. Se il risultato non fosse quello auspicato, siate magnanimi. Ho incluso anche una terza scrittura PERCEZIONE. E’ il minimo omaggio che potessi fare ai miei amati genitori. La poesia con cui apro FINO AL TUO RISVEGLIO è un po’ il sunto del libro. Mi è piaciuto giocarci inserendola all’inizio. Non vogliatemene. A cerchio ho narrato la capacità che ciascun individuo dispone per combattere la propria solitudine. Che poi non è detto sia la deficienza dei rapporti sociali tra esseri viventi, che io reputo alquanto superficiale, ma qualcosa di più profondo: il vuoto dell’anima piuttosto che quello del corpo. Lungi da me la presunzione di ricalcare le righe del colosso Màrquez e dei suoi Cent’anni di solitudine, romanzo ineguagliabile. Anche se mi rivoltassi da capo a piedi non ne uscirebbero le capacità. Tutto quel che posso fare è mostrarvi quello che possiedo, che messi a confronto sono sciocchi granelli di sabbia. Per quel che mi riguarda devo dire che scrivere, se pur mi comporti un esborso considerevole in termini di fatica, mi diverte 12 parecchio; provo emozioni e vivo in prima persona la storia che di volta in volta narro e quella dei miei personaggi. Lo scopo è di riuscire a infondere in voi ciò che nello scrivere io stesso percepisco perché, credetemi, è un gran bel percepire. Dopo aver battuto il punto che decreta il termine di ogni racconto, mi concedo qualche giorno di tregua, un utile recupero di energie che mi serviranno in seguito per rileggere e correggere la stesura. Ed ecco che mi si aggroviglia in testa il solito, singolare pensiero: la storia, o meglio, le storie che m’accingo a raccontarvi probabilmente non sono andato io a cercarle, ma credo siano state loro a servirsi di me per poter essere lette. Buona lettura amici, e… scusatemi ma vorrei aggiungere ancora una cosa, poi finisco, lo giuro. E’ una citazione del filosofo tedesco Nietzsche il quale enuncia: Tutto ciò che ruota attorno agli eroi si trasforma in tragedia. 13 Tutto ciò che ruota attorno ai semidei si converte in satira. E tutto ciò che ruota attorno a Dio cosa diventa: mondo? P. S. 14 Ora girate pagina. Si comincia. 15 16 Il mio amore è come la luce del sole nascente Ma la luce del suo volto m’ ha lasciato E sembra che anche il mondo si sia oscurato Come nel giorno del Giudizio Hamida Ghafour 17 Fino al tuo risveglio Lo capirò la notte che districherai il garbuglio dei miei sogni, variandoli in sottili filati di raso basilari per tessere drappi di sonno pregiato. Sì, lo capirò la notte in cui l’occhio di Sirio accecante nel suo lustro, non più infrangerà specchi di finestre, e mai vi giungerà a plasmare quel corpo che vibra, a fronde di pomeriggi ventosi. 18 Me lo esporrà l’insonnia dei passi al frutteto, sacche d’inchiostro squarciate al contatto col morso, e giù, stille fluenti e labbra grondanti del sangue delle more. Soltanto allora comprenderò quanto lo sciame della libertà impollini stimmi di solitudine, e il silenzio in cui orbita il mio mondo aspetti solo il tuo risveglio. 19 20 L’ultima orchidea 21 22 oggi C’è un mondo fatto di paesi. Ci sono paesi fatti di case. Ci sono case fatte di storie. Tra le tante una è da raccontare. Questa. Terminò così. Con un’alba aggrappata alle vette più alte e un vento agitato il quale, inesorabile, butta da Sud. E’ brezza marina che sfiora la crosta e tutto scompiglia. Animi e cose. Come adesso, terminerà. Come adesso. Con il timido albeggio che scavalca i rilievi, in sella a un vento il quale, guarda caso, malgrado sia solito scorrazzare da Sud, contrariamente ad ogni logica nonché equilibrata aspettativa, quest’oggi infierisce da Nord. E trascina 23 polvere, dissemina lustro, abbranca paesi, striglia la terra, supera le case. Fruscia sui muri, sbircia nelle stanze, stormisce infilando le soglie, i tagli delle imposte, le imperfezioni delle commessure. Imbatte in scuri socchiusi che, come niente fosse, li scansa e li scavalca. Incappa in finestre ermetiche. Nessun problema: oltrepassa il vetro. Penetra. Oh, perfide ante di legno, mute e accostate, non statevene lì a guardare. Apritevi! Spalancatevi! Annullate per sempre il patto stipulato con l’uomo mille anni or sono, voi che un regno siete tenute a proteggere, allontanando le combattive notti e i giorni invasori, entrambi usurpatori di un diritto sovrano: il vostro. Tutto ciò non ha più senso ormai. Oh, degne scudiere dell’oscurità. Dismettete le logore vesti e indossatene di nuove, assai confacenti. Disgregate il caparbio, il puntiglio: mutate! Proponetevi! Apritevi al mondo, voi, inesorabili ancelle solitarie, negoziate una tregua! Suvvia, almeno momentanea. Sospendete il conflitto subìto, prostratevi al giorno e accogliete a mani ferme e spirito saldo l’esercito della luce che avanza. Scardinate una volta per tutte l’ombelico ferroso che v’unisce: ribellatevi! Osservate il chiarore che vi si infrange addosso, vedete in quanti pezzi si 24 divide? Bene, abbrancatene un frammento e raschiate il lembo su cui si trova scolpito quel non più legittimo accordo. Prima o poi il suggello sarà depennato e allora, vedrete, non si troveranno appoggi a far d’appiglio e il palco intero crollerà, assicurato. Ma c’è pegno da pagare. Purificarsi costa: ci sono preghiere da recitare, implorazioni da barattare. Suppliche vendute a caro prezzo che qualcuno, la notte, al mercato divino spaccia. Notte infame, infame notte! Notte sciagurata, che rifila promesse non in grado di mantenere, alimenta speranze incerte, si ciba di sfiduciata disperazione. Eh sì, speranze, speranze, e ancora speranze: quelle che poi si frangono al suolo dell’alba, precipitando nell’inconsistente coerenza di una frivola e inconcepibile realtà. Luce che avanza, lenta. Vento che bisbiglia. Persiane che osteggiano in un legno di tarme e di ruggine. A volte fremono. E allora avanti, perdio! Ancora un’altra, una di quelle notti… e un’altra ancora… e poi ancora. E allora ogni sera, alla solita ora, ligi al dovere di un’ordinaria adunanza voi stesse vi ritrovate, vecchie e sciagurate scuracce di legno, vi scontrate, flettete e riflettete, v’intendete e… saldate – saldate, assestate, 25 unite – affari rimasti in sospeso, rapporti dissacrati, vite scollegate, pensieri confusi. Ma non chiudete, no! No! No! Quello mai, non vi potete chiudere. Sbattere forse. Oh, se sbattete alle volte, ma non chiudervi. Giammai! Se vi serraste compromettereste lo scopo di quell’eccelso, serafico e immolato sacrificio. Allora v’accostate, appena a sfiorarvi, lasciando intravvedere un piccolo spiraglio – non troppo in realtà, ma neanche troppo largo se è per quello – una media fessura, un insignificante spazio triangolare di vuoto cosmico, un parallelepipedo d’aria del tutto incapace, ovviamente, di contrastare la fresca e avvolgente luce del giorno. Un abito chiaro che, poco per volta, veste la nudità della notte, inondando la stanza con sprizzi d’argento. Ecco che l’invadenza di un avido ma implicito barlume s’impossessa del nulla, sfuggevole e silente come un fantasma. Una stanza. Poca luce, un’inezia. L’arredo scarno. Parecchio disordine. Al centro un letto, occupato. Un corpo che respira, debole. Abbraccia il cuscino quel corpo assopito. Dorme ma non dorme, contemporaneamente. 26 Bentornata dolce e sottile schiarita! E’ l’inarrestabile che avanza. Scrollatosi di dosso l’accecata notte, il nuovo giorno riporta alla realtà un mondo che fino a pochi minuti prima celava nel buio ogni cosa; l’ottenebrato ricomponimento di un’esistenza sminuzzata, con mille sfocati tasselli che pezzo dopo pezzo riacquistano la giusta forma, l’equa dimensione, intercalando la propria immagine nello stesso posto e con la medesima cura con cui una mano avvizzita, la sera addietro, li aveva collocati. Un gioco di maestria e prestigio, quello: come tessere di un mosaico nel patio del palazzo, dove il tempo avvenuto, associato ad uno scalpiccio eccessivo, inevitabilmente sgualcisce. E come queste, anche lo sporco per terra e le profonde crepe alle pareti affermano con voce impostata come quella casa sia del tutto dimentica delle giornate di prodigo vissute. Su un lato l’antiquato sofà – dalla stoffa strappata: a tratti; sciupata: per l’intera superficie – sommesso ma fiducioso affida i suoi lamenti alla clemenza di un mai più avvenuto rinnovamento. Il semivuoto cassettone funge da tempo immemorabile più come pista d’atterraggio per mosche e coleotteri vari piuttosto che contenitore della 27 biancheria di casa. Il ripiano di supporto è la rampa di lancio di uno stormo di storie il cui volo, vincolato a una sottile lastra di vetro, è sottoposto all’immobilità di un attimo resosi eterno. Nature vive e facce in primo piano occupano lo spazio contenuto da una cornice spartana. Fotografie. Nient’altro che banali, consumate fotografie. Vecchie, fottutissime fotografie. Alcune, quelle più recenti, sono stampe su carta a colori, altre invece esaltano la particolarità di un ritratto in bianco e nero. Dietro a tutti, indubbiamente la più vetusta, regalando alla vista la dorata sfumatura di un antico viraggio fa capolino la foto di un uomo, ancora fresco di vita, riservato e, forse, anche timoroso. Vicino a lui, una donna. In basso, in corsivo, una data a sancirne il periodo: estate 1914. Un uomo e una donna. La sua, di donna? Probabile di sì, probabile di no. Più facile di no, visto che a studiarla minuziosamente spunta fuori il suo essere di fanciulla. Fortunato lui se fosse stata una sua fidanzata, quella: da complimentarsi. Porcoboia! Questo avrebbe pensato chiunque si fosse trovato davanti a quella foto: proprio da complimentarsi. Lui, l’uomo della foto, che nella sua esistenza terrena detenga una personalità riservata e timorosa lo si intuisce 28 chiaramente dalla piega dell’occhio che punta l’orizzonte, traccia una strana traiettoria obliqua, sfugge all’obiettivo; come pure da quella sua espressione straniata e il sorriso sforzato, probabilmente eroso da qualche sorta di dubbio vago. Sorride sì, ma è un sorriso sporco quello, tanto per intendersi. Niente a che vedere con la purezza di un sorriso schietto, quello autentico, quello credibile, quello che in mezzo allo scompiglio della vita ti prende per mano e ti fa volare. Un sentimento strozzato, tenuto evidentemente ingabbiato nella voliera della sua stessa anima. Viceversa, lei è raggiante. Dall’atteggiamento si evince che è una ragazza a dir poco felice. Va pur chiarito che ci si possa sbagliare, ovviamente, ma, a differenza del primo, il suo sguardo è scintilla gioiosa. Diverso è quello dell’uomo. Assolutamente. Non ci fosse la piega dell’occhio a inquinare la scena chiunque c’arriverebbe; giacché, impeccabile nel suo apparire, non lascia che trasparire solo un debole indizio della sua pena, un refuso inavvertibile, impercettibile, ma abbastanza da non poter essere ignorato. Sembra incredibile quante osservazioni possano filtrare da una minuscola scalfittura. Dietro il paravento del suo sguardo si svela 29 qualcosa di molto simile ad arida terra di deserto, podere asciutto, disseccato – gemma sradicata e gettata al vento, sperduta nel vento – landa desolata e incolta. Miseria bell’e buona insomma. Logicamente è solo la merce mostrata quella che si vende – o almeno, che ci si augura di vendere – non quella accatastata in magazzino; al massimo la si può immaginare tutta quella roba lì. E la verità celata è quasi sempre diversa dalla verità detta. Ottima copertura l’eleganza del suo viso. Nonché complimenti per la vegetazione tutta che esso accoglie. Lodi per l’inqualificabile e rigogliosa peluria detenuta! Difatti sul volto dell’uomo spiccano ovunque cespugli di pelo. Baffi e sopracciglia talmente folti da svergognare la foresta amazzonica se messa a confronto, e una lanugine irsuta che spunta ribelle dall’orecchio inquadrato, manco occultasse floridi campi di granoturco. Malgrado ciò, altra cosa in cui si distingue è la garbata raffinatezza. Porta il cappello quell’uomo, grigio a tese larghe, ed è talmente arrembante che dall’alto del suo pulpito sembra declami un editto; senza nulla togliere all’accurato vestito della domenica, di squisito cotone color antracite rigorosamente abbinato al cappello, garofoletto rosso all’occhiello, foulard di seta al collo, giradito 30 d’oro all’anulare sinistro. Un vestito coi controfiocchi non c’è che dire – forse il più bello tra i posseduti – robe che per decidere d’indossarlo c’avrà pensato delle ore. Doveva essere stato proprio un giorno importante, quel giorno, per riuscire a trasformare un individuo sperduto nell’anonimato in una persona di così tanto rilievo. Come se da modesto tugurio uno si trasformasse in reggia. Guardatelo lì, tutto impettito il signore, davvero un bell’uomo. Peccato per quell’unico, marginale, fin quasi trascurabile particolare descritto… Tuttavia, di una cosa si poteva esser certi, quella sì! L’altra metà del suo sguardo. La parte sincera, quella in chiaro, quella ben visibile nella foto e contro cui l’occhio non trova il minimo inciampo. Lo si capisce chiaramente quanta fierezza ostentasse per la ragazza che gli si staglia accanto. Lei è giovane, molto più di lui; ed è bella, parecchio bella. Oltretutto veste da Dio, e il suo corpo scivola sinuoso dentro quei tessuti, pettinati dall’ambrata luce del tramonto. E poi i suoi capelli: miele di castagno liquido. Catturano, le due figure, non c’è che dire. Prendono l’immaginazione e se la portano a spasso, pur restando immobili in quel loro attimo di visibilio sincero. Una posa cercata, costruita, foss’anche non voluta comunque ben 31 riuscita. Belli, l’uno di fianco all’altra, ravvolti da una circospetta estasi ammaliatrice. Un lampo. Fragore e puzza di magnesio. Una tendina che prima si apre, poi si chiude. Neanche tanto velocemente. Carta sensibile che reagisce alla luce. Una foto: porzione di tempo compresso in un istante. Riassunto di storia. Riassunti di storie diverse. Varie foto: vari episodi. Vicende di vita trattenute lì sotto vetro. Concentrati di eventi incarcerati dentro una teca. La mummificazione dei ricordi. Attimi rubati e impacchettati che soffrono muti un perpetuo rapimento. L’unico modo perché si salvino. Codardi voi, baleni di vita. Avanti, offrite pure le spalle allo specchio, vigliacchi! Paratevi il culo come avete sempre fatto. Vigliacchi! Giratevi una volta tanto e osservate il mondo che sta in lui riflesso. Giratevi stolti! Guardate, e noterete voi stessi quanto sia tutto fittizio e alterato. Uno specchio con dentro un pianeta. Una guarnigione di cornici allineate e inclinate. Uguale il numero dei piedini a sostegno. Invalidi appoggiati a una stampella. Fittizio e alterato, il mondo riflesso. Conforme ci si sposta esso rivela: una porta, un 32 rinsecchito rametto d’ulivo appeso al crocifisso, tre pendule che partono a raggiera dal lampadario d’ottone ossidato, di cui solamente su due ci stanno avvitate le lampadine. Un vaso di fiori che reclama le ingiustificazioni dei soggetti assenti. E un armadio. Solo la facciata davanti. Le ante richiuse, come braccia conserte a volersi eclissare. Sudicio e malmesso si direbbe, ma in fondo gran narratore, testimone oculare di una vita modesta, giullare di corte al palazzo dei folli. Gran narratore lui, guardiano del giorno e della notte, da sempre custode di un letto riflesso, il quale – valoroso vascello – veleggia negli oceani della mente assistendo il naufragio dei sogni della donna su di esso coricata. Il riflesso di una donna su di esso coricata. Non dorme la donna. Non è sveglia la donna. A mezza via. Un trasferimento in atto. In procinto di lasciare il luogo in cui s’accatastano gli agitati sonni dei fanciulli per raggiungere due sbadigli più avanti il soporoso risveglio degli adulti. Lei, giovane donna. Splendida adolescente dai capelli color del miele. Quello di castagno. Liquido. 33 Il vento borbotta una lingua che non gli è stata insegnata. Ha un accento diverso la lingua del Nord. Le imposte accolgono, e vibrano. Così… Così… …Così sta per terminare. Un giorno qualunque. L’arrivare di un giorno qualunque. E come ogni buon arrivare di giorno qualunque, esso è preceduto da un mattino qualunque; che a sua volta succede a una notte qualunque. Il finire di una notte qualunque. Quindi, se il giorno non è ancora arrivato e la notte se la sta già squagliando, vuol dire che questo, toltoci di dosso ogni ragionevole dubbio, resta sicuramente e inequivocabilmente un mattino. Un mattino qualunque s’intende. E c’è pure un mistero in questo mattino qualunque. Un segreto che insedia il volume di una stanza: il corporeo rimpatrio delle forme. Gli stipiti richiusi e le tende tirate filtrano uniformi il nebuloso, affralito albedine, restituendo ai mobili, libri e suppellettili l’amena veemenza di un vago disordine generale. Il comodino col piano di vetro. Un bicchiere riverso, gocce d’acqua che picchiano 34 a terra; una seggiola storpia stracarica di vesti; abiti spiegazzati sulla pediera del letto, gettati alla rinfusa; una ciabatta qua e l’altra chissà dove; boccette di profumo sigillate e velate di polvere; forcine per capelli, libri, una sveglia che segna le sei e quarantadue. Qualcosa di prepotentemente distorto disegna lo spazio affidato a una prospettiva dettata sì dagli anni ma pur anche contrassegnata da un lassismo spregiudicato e una consuetudine ottusa. Un modo assai caotico di vivere la camera da letto. A dettarne la differenza, se di differenza possiamo parlare, è l’impressionante pulviscolo accumulatosi. Difatti, se prima questi oggetti venivano in qualche modo adoperati, adesso giacciono ripudiati nei meandri di un polveroso mondo dimenticato. Inoltre, gli stessi infissi creano una valvola indispensabile per suddividere l’area a metà; un trasparente diaframma tra una vita vissuta quietamente tra le mura domestiche e un’altra contrapposta al di fuori di queste, più gravosa e complicata. Troppo complicata. Il vento scuote una tela. Tranello bestiale. Zampette frenetiche la tessono. Su e giù… giù e su. Su e giù… giù e su. Mai fermo. Non è concessa sosta al costruttore di un tale calappio: salterebbe la cena. Discende il bordo 35 esterno dello stipite, il ragno, opportunamente ancorato al suo bolo; incrocia il filo disteso e ci passa sopra. Assicura la bava al filato con estremo rigore, poi ne risale la cima. Su e giù, giù e su. Su e giù, giù e… …oscilla la rete, il dispetto di un vento che strappa le corde e arpeggia imperioso – cetra fra le sue dita – e l’argentea, tremula rete fluttua come naufraga in balia di corrente. Talvolta sbatte e sventola a bandiera. Talvolta danza su una musica sorda. Tarantella ampollosa. Ogni tanto frena, s’acquieta, quasi si ferma, il vento… ma lui… …su e giù. Giù e su… giù e su. Su e giù… Se ne frega l’aracnide delle pretese del soffio. Non si impensierisce. Inchiodato alla ragione di uno scopo ben delineato lui tesse imperterrito, con scrupolosità maniacale, tutelato dall’assoluta convinzione che l’opera resisti a folate ben più impegnative. Fin da bambina era stato un affascinante diversivo quello di trincerare il suo apparire oltre la trasparenza di un vetro. Unire le due ante fino a saldarne le balze e far scorrere un doveroso chiavistello. Puntellare i gomiti al davanzale, prendersi il mento fra le dita intrecciate e starsene lì, col naso talmente unito 36 al vetro che l’alito si condensava attorno formando un alone chiaro e vaporoso; e allora spostarsi perché più non ci si vede, dando così il tempo all’alone di ritirarsi, risucchiato nei depositi segreti di una eterea barriera cristallina. Starsene così, un po’ appiccicata al vetro un po’ no, passare le ore a guardare, immaginare, sviluppare le sorti della storia che vi scorre dentro. Il contenuto di una finestra è simile ad acquavite: l’alcoolico distillato di una fermentazione. Verde lievitazione, concentrato di pianeta, inebriante attrazione e profumo intenso. Roba per intenditori. Irrilevante proliferazione di un mondo in costante sviluppo e crescita disumana. Da rimanere storditi per l’eternità, sicuro. Due spazi, due mondi diversi: quello di fuori e quello di dentro. Lei aveva scelto di vivere quello di dentro e stare a vedere quello che sarebbe accaduto in quello di fuori. Uno spasso analizzarne l’impercettibile movimento delle masse: forze contrapposte che in qualsiasi momento si sarebbero scontrate, frantumando i sogni e le speranze di chiunque in quella circostanza si fosse trovato in traiettoria. Doveva assolutamente prendere per mano la situazione finché il tempo glielo concedeva e assumere lei stessa il ruolo di arbitro per 37 dirigere la partita che si apprestava a cominciare: una di quelle senza regole e schemi logici, delle quali che tu stia dentro o fuori è assolutamente irrilevante. La cosa più bella consiste proprio nel fatto di non farne parte. Se potesse dipendere da lei, rimarrebbe rannicchiata per sempre oltre quel vetro, rinnegando la sua stessa vita, per poi magari ritrovarsi catapultata in qualche remoto punto dell’universo. Anzi, è forse l’universo intero a vorticare lì, adesso. Tutto in quella stanza. Terre di Vallarsa. Terra improba, difficile. Da allontanare se possibile. Ma abitata. E persino amata. Mattino presto. Interi paesi avvolti nella sopita quiete di un incerto e crudo albeggio invernale. Un Generale avvinto, lui, l’inverno, e il suo gelido pugno d’acciaio disamora gli intenti umani, costretti ognuno per il suo verso ad abbandonare il sacro tepore dei loro letti. Come in tutte le case della valle, anche in quella della ragazza arrivata al capolinea dei suoi sogni regna la stessa, identica percezione. La cadenza regolare del respiro viene sovrastato dal ritmico ticchettare della sveglia che, per quanto vetusta, con solerzia da di carica ogni sera prima di mettersi a letto. Lo 38 snervante bubbolare del meccanismo mai l’ha infastidita, anzi, quel suono meccanico lo ha sempre parificato ad una sorta di compagno di viaggio; una sgraziato ma simpatico carillon: Clic… Clac, Clic… Clac, Clic… Clac. Ma quanto sarebbe durato questo accordo tedioso?... Sicuramente finché la molla non si sarà scaricata, scema!... Ma per quanto ancora? E’ questo il suo primordiale pensiero. Strano concetto, inconcludente. Intanto di fuori il vento asserisce. Percepisce la sua voce in sottofondo e vorrebbe rispondergli. Non lo fa. Ode dei rumori. Un leggero subbuglio. I fantasmi del luogo ogni tanto si fanno avanti. Frusciano, scuotono. Talvolta pure lei. Ma sta sognando o… riflettendo? Lo stato di coscienza non è stato ancora totalmente acquisito e solo nel successivo dormiveglia si accorge come il torpore la stia lentamente abbandonando, riportando la mente e il corpo ad una realtà più vivida che mai. Tutto si risveglia. Tutto tranne una cosa. Cavolo, non mi sento più le dita… Il formicolio che da qualche secondo le rende insensibile una mano le fa intuire di aver dormito con il braccio in posizione anomala, magari tenuto schiacciato da qualche parte sotto il suo stesso peso. Cercando un po’ di sollievo si gira sul lato 39 opposto, sfregandosi intanto l’arto addormentato. La riattivata circolazione sanguigna rende tutto più semplice. Clic… Clac, Clic… Clac, Tum-Tum, Tum-Tum. Concentrata e con gli occhi socchiusi percepisce pure il cuore martellarle in petto nella gola e sulle tempie, forte e sonante come colpi di grancassa che scandiscono un ipotetico ritmo. Prova a confrontarne la regolarità con quello marcato dallo scorrere dei secondi. Ottimo pensa, galoppano in perfetta sincronia. Un altro sottile scricchiolio. Proviene dai travi del ballatoio. Un rumore che ben conosce. La frenetica marcia degli inquilini di sopra, quelli che vanno e vengono a loro piacimento, che attraversano gli spazi in un lampo e un secondo dopo già più non senti. Possono passare minuti, anche ore magari, o giorni interi perfino, robe che tu dici sarà la volta buona? Dio, fa’ che sia la volta buona. Ma, come quando il brusco risveglio distrugge una dormita straordinaria, improvvisamente, senti le travi che: giù di nuovo a mietere quelle corse febbrili. I ghiri. Porcadiquellaeva! Stramaledette bestiacce! Devo inventarmi qualcosa prima che mi si frulli il cervello. Gli scalpiccii e gli scricchiolii del ballatoio avrebbero potuto destare a chiunque un pizzico 40 di allarmismo, ma questa mattina non sono sufficientemente bruschi da far impensierire la ragazza o, perlomeno, non più del dovuto. E’ troppo assorta ad ascoltare la musica del proprio corpo: una tale composizione di note da assimilarla a una melodia. C’è sempre un momento in cui capisci con minima probabilità d’errore di essere più sveglio di prima. Quel baleno improvviso è arrivato. E si porta sotto braccio una considerazione. Spalanca gli occhi. “Ma è una melodia!” C’è musica in sottofondo. Vera musica. Proviene sicuramente dalla cucina, al piano terra, la prima stanza in cui ci si imbatte entrando in casa, una di quelle musiche ascoltate nei salotti della vecchia borghesia, tirate fuori un po’ stonate dal megafono di un annoso grammofono a manovella. Nonostante le note impresse nel vinile vengano catturate dal congegno meccanico e poi trasmesse all’altoparlante in maniera alquanto distorta, riconosce chiaramente la melodia di quel brano: senz’ombra di dubbio i suoi timpani sono stimolati dall’orchestrale interpretazione di Il bel Danubio blu, celebre valzer viennese. 41 Un pezzo speciale, uno dei tanto ascoltati da suo padre. Ma chi può aver acceso il giradischi dato che l’unica persona ad essere in casa sono io? Che qualcuno si sia intrufolato in cucina mentre stavo dormendo? Ricorda benissimo che gli zii avevano caricato, un paio di giorni addietro, alcune vettovaglie sul loro carretto e si erano diretti a Rovereto per dipanare certe importanti commissioni. Era intenta a rassettare la casa quando, la settimana precedente, in modo del tutto involontario captò le loro voci provenire dalla strada. “Con questo possiamo tirare a cinquantadue… Anche cinquantatrè.” “Come minimo… Non un centesimo di meno… Cinquantacinque mi sembra ancora un prezzo ragionevole… Parti alto che poi per calare le braghe siamo sempre in tempo… In più ci stanno i trenta che ci restano i Galvagni… Cerca di farteli dare tutti stavolta.” “Se non si fanno vivi anche questo mese vado fin sotto casa e… gli faccio vedere io con chi hanno a che fare…” “Non sei capace di ciò, Alfredo.” “Tu non mi conosci…” “…” “Quel che è giusto è giusto.” 42 “…” “Perché non dici niente, Luigia? Non credi alle mie parole?” “Staremo a vedere. Intanto a noi ci mancano… e loro la legna se la sono goduta, però.” Parlavano di soldi, di una riscossione rimasta insoluta nella precedente vendita autunnale di svariati quintali di laste di faggio, e che i cittadini moderni sono sempre più indigenti, oltre modo sfacciati e prepotenti. Allo stesso tempo avrebbero arrotondato vendendo ai mercati di fondovalle i salumi di propria produzione. Durante il periodo natalizio era stato sacrificato il lardoso verro, allevato nella porcilaia del Casaro con la sacrosanta intenzione di trasformarlo in eccellenti salami caserecci. La sua carne tritata, resa ancor più gustosa da una saggia mistura di spezie e erbe aromatiche dosate ad arte, era servita a riempire decine di sacche intestinali tutte rigorosamente annodate alle estremità con il robusto spago di canapa. Per la prima volta in vita sua aveva voluto essere lei stessa lì presente per tutto il tempo occorso alla macellazione, e nel suo inconscio rivedeva ora la sgradita scena della mattanza: tutto quel sangue, gli animaleschi urli e… la povera 43 bestia in preda al demonio. Quando lo zio Alfredo e i vicini di casa Umberto e Giovanni Raoss afferrarono il maiale per la coda, le orecchie e le zampe e lo rovesciarono sopra lo scotennatolo, l’animale emise un urlo da far saltare i timpani. Allora si sentì montare dentro una specie di ribollimento, e il nauseabondo fetore della morte in attesa le diede il voltastomaco. Si sarebbe messa pure lei a strillare come quel corpo che strattonava in ogni dove, pur essendo trattenuto da robuste ganasce di legno. Avrebbe voluto scappare dal mattatoio e dissociarsi alla disumana esecuzione di quel grasso suino, ma qualcosa la faceva desistere alle proprie istintive intenzioni. Anche se non ce la faceva a reggere davanti a quella tribolazione non doveva darlo a vedere, non era più una ragazzina, e la vita da adulta comporta momenti poco piacevoli, spregevoli ma necessari. Meglio cercare di dare una mano e, piuttosto, se proprio non avesse sopportato, voltare la faccia dall’altra parte e far finta di niente. Umberto, che sapeva fare il suo mestiere come nessun altro, impiegò un istante ad affondare il coltello nella giugulare della bestia che, con strazianti grugniti, schizzava sangue come acqua pompata a pieno getto. Immediatamente Giovanni si munì del 44 paiolo preposto ai piedi del tavolo e raccolse tutto quello che sgorgava dal pingue collo roseo. Lo avrebbe usato in seguito per fare i sanguinacci che solo a lui riuscivano così buoni. Intanto, le pupille della ragazza erano braccate da quella scena orripilante, e cercavano una via di fuga come prede rincorse da una muta di cani ringhiosi. Ma non trovavano scappatoie: il territorio era troppo ristretto e, senza saperlo, erano finite in trappola. Avrebbe preferito piangere, ribellarsi e fermare le intenzioni criminali degli aguzzini, ma era a conoscenza di quanto tutto quello che stavano realizzando fosse necessario. Lo zio e gli altri sapevano il fatto loro, e sicuramente il dover sacrificare un animale che avevano cresciuto in casa con amorevole dedizione era imposto unicamente dalla sacrosanta necessità di sostentamento. Era stato proprio il senso di impotenza che le aveva dato la forza di rimanere irremovibile all’interno di quel locale e, attonita, si prodigò in un silenzio distaccato, che era tutto dire in mezzo a quel trambusto. Condivise minuto per minuto le ragioni di una morte procurata e voluta perché così è deciso, regole dettate dal codice della sopravvivenza e controfirmate con schizzi di sangue sul muro che scendevano verticali come stigmati fluenti 45 dal corpo di un santo. Scelse allora di puntare un’angolazione diversa ma, nel girarsi, i suoi occhi incrociarono lo sguardo atterrito del maiale. Da lì non fu più capace di staccarsi. Avrebbe giurato che la bestia la stesse implorando e tra quei grugniti si celasse la supplica un soccorso, di un aiuto, una minima speranza di salvezza; e lei invece che cosa aveva fatto? Col groppo in gola, aveva chiesto a Giovanni se poteva lei stessa raccogliere il sangue nel paiolo. Ecco che cosa era riuscita a fare la gran dama: una vigliaccata, una pugnalata alla schiena. Fredda e spietata, esattamente come può esserlo certe volte la vita. E lo tenne ben saldo quel paiolo, premurosamente contro la mesa dove il sangue fiottava a fontana, malgrado avesse perso il vigore iniziale, sforzandosi di ben osservare l’apatico grifo dell’animale morente. Il bestiale sacrificio affidato all’uomo e alla sua discendenza. Carne che in futuro avrebbe nutrito intere famiglie; non era lei che aveva deciso tutto questo ma la natura stessa, quindi, perchè farsi pigliare dai sensi di colpa? Gli urli si fecero sempre più deboli e anche le scosse di quella massa rosa si affievolirono fino a che, cessata la scolatura dal collo, il tutto s’accasciò sul tavolato. Sembrava una sacca 46 svuotata del contenuto, la bestia, una vescica flaccida e livida. Appoggiò il contenitore sopra il tavolo. Era colmo di sangue fino all’orlo. Lo adagiò preoccupandosi di non spanderne troppo. Si sedette stremata per la fatica e la tensione del momento. Anche se vacui, gli occhi del cadavere le stavano sempre addosso. Ancora adesso di tanto in tanto la notte si ritrovava sveglia per le palpitazioni. Le si profilavano immagini riproposte. Le partiture erano sempre le stesse. Zampe che scalciano, grugni contratti in smorfie diaboliche, fili di bava che insudiciano il pavimento, e tutto intorno un lago di sangue. Quante volte in sogno rivedeva lo stesso sguardo cieco e le stesse disciolte pupille mostrate quel giorno dall’animale agonizzante, e le rimbombavano in testa i grugniti supplichevoli che lei stessa aveva contribuito a placare definitivamente. Non coglieva odio in quello sguardo, ma solo pietà verso il genere umano. Giunti a quel punto, gli uomini s’erano preparati per la raschiatura della cotenna e per il vero e proprio rito della macellazione; un’arte imparata con l’esperienza e la costanza di chi ci mette il cuore nel fare il proprio lavoro. La giusta stagionatura avrebbe fatto il 47 resto, trasformando il macinato in prelibatezze d’alto rango. Con questo risultato, sarebbe stato difficile trovare nelle piazze cittadine acquirenti immuni ai peccati di gola. Col ricavato si sarebbero riforniti di generi di prima necessità come pasta, olio, farina e zucchero. Viveri difficili da recuperare malgrado la ridente cittadina si offrisse al commercio e al consumo; addirittura introvabili nella più disagiata e impoverita valle trentina. Se tutto scorreva via liscio e senza intoppi, non sarebbero ritornati prima di venerdì pomeriggio. Venerdì mattina a mettercela tutta. Ed oggi, se non ricorda male, è appena mercoledì. Sente il cuore portarsi in temperatura e il respiro a darci dentro. Ventilare, ventilare, ventilare. E giù a soffiare, inalare e soffiare, inalare e soffiare… mantice inefficace, del tutto incapace di mitigare l’agitazione che le attizza lo stomaco. Ventilare, ventilare, ventil… Sì, sono sicuramente gli zii che per qualche motivo sono stati costretti a fare rientro a casa. Doveva trovare una motivazione plausibile. … are, ventilare,ventilare, ventil… C’è stato un imprevisto e durante la notte hanno dovuto rincasare. Ma che stupida, stavo dormendo e non potevo certo essermi accorta 48 di nulla. Risposte sempre meno convincenti. Ma sì, non poteva che essersi svolta così la faccenda. Ma c’è sempre qualcosa che le sfugge, non capisce cosa. …are, ventilare. Temperatura in aumento! Ventilare per Dio!… Forza!... Il disco suona… suona… suona… non smette mai. Sono felice che si siano ravveduti. Dover rimanere in casa da sola per tutta la settimana sotto un certo aspetto le aveva incusso un po’ d’angoscia. Però adesso sono tornati e stanno qua con me… vero? Maledizione, sono loro di sotto. E chi altro? In quel momento, come il Verbo fece con Mosè, tutto le si rivela. Non servono scene da baraccone o giochi di puro illusionismo, con lei basta e avanza una semplice constatazione, una cosa da nulla ma sufficientemente efficace per bloccarle respiro, circolo arterioso e parte di quello venoso: Ma il nostro grammofono sono anni che non funziona! Se non lo si arrestasse, l’evoluzione naturale di quel sentimento che fino a qualche istante prima si poteva classificare come ‘avvertita ma misurata curiosità’, sarebbe quella di gonfiarsi, allargarsi, incrementarsi, ingigantirsi, una di quelle cose lì insomma, ma non piano piano, 49 magari prima chiedendo: “Compermesso”. Eh no! Sarebbe bello poter dire ‘ecco che arriva: prepariamoci!’ no, lo fa tutto di colpo lui il botto, BOONG! ed è fatta. Una specie di implosione interiore tanto per capirsi. E allora lo senti che ti prende la gola, il mostro, e l’orrenda creatura diventa indomabile come irrefrenabile diviene lei stessa, sotto le lenzuola – di un letto – in una stanza – strappata alla notte – raccolta dall’alba – di un freddo – arioso – mattino – d’inverno. Non lo sente approdare, lo sente e basta. E quello che prova è qualcosa di molto agitato, più vicino alla paura che alla sola apprensione. “Zia Luigia, zio Alfredo…siete voi?” sibila con voce asprigna, pungente, ma minima. Non ode risposta. Stesso tono: “Chi c’è di sotto?” Niente. Nessun rumore inconsueto, da casa momentaneamente disabitata. Soltanto quella musica storpia; pazzesco. E’ bastato il muto responso a un quesito inconsiderato per spremere dalla sua mente ancora acerba mille azzardate ipotesi. Alcune probabili, altre assolutamente assurde. Alla stessa maniera, il fiume di note che sgorga deliberatamente dalla fonte di un qualche diabolico marchingegno oltrepassa le porte ed esonda nelle stanze, livellando ogni 50 spazio occupato con una sfacciata, insolente musica austriaca. Oltretutto anacronistica e fuori moda. Avrebbe voluto una volta per tutte alzarsi e capire cosa cavolo sta succedendo giù al piano terra, ma la sua testa tutto confonde e il suo animo perde coraggio. Qualcosa di misterioso la trattiene dentro quel letto, pervicacemente, forse perché per il momento lo trova il posto più sicuro al mondo. Cerca il lembo del lenzuolo e lo tira su, fin sopra gli occhi, poi istintivamente rannicchia le gambe stringendosele con le mani. Quel letto, grembo materno portatore di feto. Tiepida impronta di fossile incastonato nel sasso. Solido guscio che protegge, fa da clipeo e salvifica. Chiude gli occhi, si tappa le orecchie. Non vuole vedere e non vuole sentire. Ma tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo quella maledetta melica. Ho capito, è tutto un sogno! Io sto dormendo e quello che mi sta capitando non è altro che un semplice, stupido incubo. Sono andata a letto troppo presto ieri sera e la cena mi è rimasta sullo stomaco…ma certo, che idiota… non potrebbe essere stato altro che questo. Si rigira, strabuzza gli occhi, sospira. Sarà veramente soltanto un sogno? E come per incanto la musica cessa. Il silenzio si sarebbe impadronito del luogo se 51 non ci fosse lo screziato graffiare della puntina sul disco. Sopraggiunto alla fine del brano il piatto gira a vuoto, esalando una ruvida monodia. Emette solo un flebile gemito, ripetitivo. Strano quel verso, ipnotico singhiozzo. Dopodiché anche la molla perde di carica e, dopo un mezzo giro del vinile, tutto il meccanismo si ferma, stabilizzando un silenzio quasi innaturale. Finalmente, pensa lei. Per meglio sincerarsi solleva la testa dal cuscino, allargando notevolmente il campo visivo. Quanto le piace la lentezza del suo mondo, la falsa immobilità di quell’universo. La ritrovata quiete la mette a suo agio. Ave a te Madonna benedetta invoca mentalmente. Ma è sola parvenza. Sì perché le osservazioni si spezzano in un attimo, producendo lo schiocco pulito e nitido di un ciocco di legno che esplode tra le vampe. I suoi occhi vagano per la stanza semibuia e si fermano, istantaneamente, bloccati nell’angolo più lontano, dove le ombre dei faggi scosse dalla brezza mattutina danzano scomposte nella luce madreperlacea che entra dalla finestra. E lì vi restano, come presi in ostaggio. 52 Le ombre formano una figura, laggiù. Laggiù c’è un uomo. La invade un terrore grande come mai ne aveva conosciuto. Il panico, che le aveva temporaneamente svuotato la capoccia, sta ora rimbalzando sulle pareti di una teca cranica bersagliata dagli input più assurdi. Dal glottide non le sfugge alcun lamento, nemmeno il gemito più debole. Si ritrova incapace di produrre suoni non meno di quanto sia in grado di formulare pensieri. I muscoli del collo, delle braccia e delle spalle, le si sciolgono in qualcosa di molto simile ad olio di paraffina. Scivola sotto la testata del letto, lentamente, cercando la protezione del cuscino e rannicchiando le gambe, consapevole che il vuoto mentale e l’assoluta incapacità fisica potrebbero produrre danni peggiori di un blackout. La figura resta immobile, nascosta nell’ombra della stanza. Sembra non abbia un viso, un’espressione, è solamente un’entità astratta che gioca con le movimentate luminescenze provenienti dall’esterno e forma obliqui disegni sui muri. Chi sei?, avrebbe voluto gridare, che vuoi da me? Cosa ci fai qua? Ma non riesce a formulare alcuna frase. 53 Continua a fissare quell’essere, incapace di togliergli lo sguardo di dosso, ed è come se guardasse il nulla. Solo una cosa nota chiaramente: la forma dell’oggetto che lui impugna. Un filetto bianco, lucente. Forse un coltello. A quel punto le mascelle del terrore si schiudono, lasciando intravvedere la cavità orripilante da cui viene inghiottita. Il fiato s’inspessisce. Mille puntini argentati le annebbiano la vista. Blackout! Non sa per quanto tempo sia rimasta priva di sensi, sicuramente solo qualche minuto. Questo glielo riferisce la ragione, quando al suo risveglio scopre che il liquido caldo che le bagna la coscia è conseguenza del liberarsi della sua vescica. Il tramestio del vento che sbatte sul muro non aiuta. Scricchiolii di cardini, spifferi gelati, brividi sulla pelle. Sulle ciarle di Eolo rammenta la situazione in cui si trova. Si ridesta in lei un esile tentativo di pensiero subito ostacolato da una muraglia di paura nera e informe. Un uomo. C’è un uomo in camera mia. 54 ieri A mezza valle sorge un paese. Uno dei tanti. Una pennellata di tetti ocra sopra una tela verde di pascoli e cortili. Una manata di case. Confini definiti. Muri contro muri, grondaie sopra grondaie, un susseguirsi d’ingressi. A tratti uno slargo, qualche fontana, animali da cortile, un garbuglio di lingue acciottolate che si districano e s’allontanano. Il perfetto svolgimento della sinfonia che il tempo dirige e l’umanità intera esegue. La storia che si prosegue da una vita. Ininterrottamente. Agli occhi di Dio quell’insieme rurale potrebbe sembrare un monile, un infilato di minuzzole perline bianche, ma a Lui che tutto vede e tutto sa, non si può certo nascondere che esse sono umili case, nate dalla pietra dei monti limitrofi e cresciute col sudore di chi vi abita. Fustigato per gran parte dell’anno dal vento del Sud, non 55 ha mai fatto cenno di resa, anzi, la tempra del suo spirito è resa solida grazie alla mano vergata di una natura severa, intollerante. Più batte più rafforza, più si rafforza meno sente che batte, solidificando in quel modo lo strato calloso posseduto delle sue trecento anime. Nonostante ciò, questo lo rende piuttosto simile a centinaia di altri piccoli agglomerati montani che popolano i declivi alpini, ma solamente a chi lo conosce veramente – e vi risiede da tempo – esso si rivela per quello che è, mostrando una bellezza che al distratto rimarrà per sempre occultata. Tante, troppe persone sono state costrette per i motivi più disparati ad attraversare in lungo e in largo le sue anguste vie, ma quasi sempre in maniera frivola, affrettata. Solo poche di loro hanno avuto la possibilità di goderselo pienamente. Poterlo contemplare nel suo intimo è un’impresa faraonica. Riuscire a stanarne l’animo lindo, gentile e ordinato: un progetto ambizioso. Non parliamo poi di compiacersi al conseguimento di uno sguardo rivolto al sole; questo voleva dire dedicare un bel po’ del prezioso tempo proprio che, spendendolo per star lì ad aspettare, scrutare, osservare, estrapolare, non per tutti è considerato investimento. Peccato, perché nei giorni di primavera è una giovane 56 donna affacciata al balcone, e il balcone un’esplosione di fiori dai mille profumi e colori a ridosso di svettanti monti rupestri. D’inverno è un’anziana signora coi bianchi capelli brinati e lo scialle innevato che le avvolge le spalle, tutta raccolta nel suo piglio e piuttosto introversa. E dinanzi a ciò, lo sguardo svanisce nella distesa di una valle lenta, solenne, la quale soddisfa i capricci di un burbero torrente che sconquassa con la sua esuberanza il tedioso romitaggio del bosco. Anghébeni è proprio così: ha una sua bellezza segreta, una sua vita. Eppure non è altro che un piccolo paesino d’altura, con pochi abitanti, testardi e scontrosi com’è solita la popolazione alpina. Il carattere della gente rispecchia le gelide e interminabili serate invernali, dove si sopporta l’insopportabile e il conforto lo si riceve dal silenzio ovattato che ricopre le sue strade. Intanto l’aspettare corrode. Eh sì, l’aspettativa è una delle sfide più dure da affrontare, lassù. Aspettano i campi il disgelo. Aspetta il bosco il sole più mite. Aspetta l’uomo che transiti la notte. La notte. Ma prima che tutto questo avvenga le antropiche ombre si susseguono, incalzano, si trascinano, smorzano il rumore dei loro passi 57 dentro un unico e candido ammanto nevoso. Si muovono frettolose con i sacchi neri in spalla. Spallacci e corde di canapa a vincolarne il carico. Vestono di panno pesante e sputano aliti vaporosi che condensano al freddo polare dell’inverno trentino. Fuori tutto tace ma le finestre, quelle finestre, svelano. Le cornici illuminate dalle lampade a petrolio riferiscono un lieto brusio. Il sommesso vociare casalingo tiene desta la famiglia e ravviva quel senso di fratellanza e di amicizia che brucia e schiocca e arde e brilla sotto ogni tetto, e tutto quel tripudio che sale, investe, pigia, avvampando e scintillando come uno sprizzare di faville nel caminetto. Ebbene sì, è lì dentro che la magia s’avvera. Le case si svestono, cambiano d’abito e tutte, ma proprio tutte, sia le vecchie che le nuove abitazioni si ricoprono di dignità e di pudore. E’ semplicemente mondo. In cui si nasce. In cui si muore. “Dell’acqua tiepida, fate presto.” “Qualcosa di pulito, cristosanto. Muoviamoci!” “Ho bisogno di un catino, signor Cobbe. Un catino.” 58 “…” “E non stia lì impalato. Veda di rendersi utile, si sbrighi. Un catino e acqua tiepida, subito!” “Ma…” “Mhmmm! Ahaaa!” “Forza… non abbiamo tempo da perdere. Anche lenzuola e coperte pulite.” “Certo… arrivo.” “Le forbici nel bollitore sono pronte?” “Un attimo… non so’ neanche cosa sia io un bollitore!” “SIGNOR COBBE! la prego, forse è meglio che rimanga di là. Lasci fare a noi.” “Va bene, va bene, purché non si arrabbi, signora Ester.” “Dov’eravamo rimaste? Ah… ecco…” “Mhmm…” “Ecco la testa… la vedi, la testa?” “Preparati, Armida, siamo arrivati al nocciolo.” “Io sono pronta, Ester. E lo deve essere anche ’sta poveretta. Ancora una spinta, Francesca. Dài, da brava, ancora una spinta.” Era stremata, Francesca. Ma l’esasperata voglia di separarsi da quel supplizio infervorava in lei la volontà di impegnarsi in una nuova prova di forza. La contrazione la 59 sentì arrivare, ed era forse peggiore delle altre, come stesse per essere infilzata su un gigantesco arpione usato per la pesca alla balena, un’artica punta ricurva infilata nell’addome e poi fatta girare e rigirare perché meglio possa penetrare. Partendo da dietro, si capisce, dalla parte rettale. Spinge e contrae il suo ventre, Francesca, in quella notte di pioggia incessante. Come melo maturo pronto a cedere il suo frutto, ormai. Un salto a capofitto nell’abisso profondo. Sì, perché è così che ci si propone al mondo: un tuffo di testa nell’oceano della vita. “Cristo quanto sangue.” “Benissimo, Francesca, brava, così. Ancora dài, su.” “Ahaaa! Mhmmm!” “Dell’acqua fredda, subito! Ghiacciata!” “Ma… è normale tutto questo sangue?” “Arriva l’acqua fredda? Veloce. E le forbici.” “Mettimi meglio il lenzuolo… più sotto… PIU’ SOTTO HO DETTO!” “Ci siamo Francesca. Così… così… Prendi da lì, Armida. Così… Perfetto. Ecco… bene, la testa è uscita.” Con la faccina fra le mani fece un leggero movimento rotatorio. 60 “Ancora una, Francesca. Dài. L’ultima, te lo prometto. Respira e spingi.” “Ahaaaiii!” Urla di dolore di una donna distrutta, sul quale tavolo di quercia allineava i suoi lamenti per poi rilanciarli, tutti insieme, contro a un anonimo soffitto di calce e paglia. Urla di sfogo di donne in movimento, sudate, agitate, impegnate in un lavoro sporco ma, se ben sviluppato, pure gratificante. Lacrime di gioia di un futuro padre, seduto nella stanza adiacente, con le mani impegnate a torturare il solo bottone rimasto attaccato alla giacca. L’unica persona al mondo, in quella piovosa sera d’estate, a non essere in grado di combinare nulla. “Femmina. E’ UNA FEMMINA!” “Una bambina, bene. Dio sia lodato, sembra tutto a posto. Ma guarda che carin…” “Tagliamo e tamponiamo. Facciamo presto. Non abbiamo poi tutto ’sto tempo.” Non ci pensarono su troppo. Furono svelte, affidatarie di una sveltezza che solo anni di esperienza può impartire. Tagliare e annodare fu quasi un tutt’uno. “Ora piangi, bella. Piangi… piangi… PIANGI!” 61 Il primo respiro trova porte serrate. Le apre e corre via come un matto; attraversa corridoi e stanze sigillate, svergina trachee e violenta bronchi immacolati: un reticolo di canali messi lì per essere inondati. Alimenta cellule alveolari che prima erano branchie, e adesso sono alveoli: scambiatori di gas respiratorio. E fa male tutto questo, la prima volta. Fa un male cane. Allora pianse. Furono musica i suoi vagiti. Musica emessa da uno strumento appena improntato, musica mai suonata prima, musica nuova. S’abbracciarono, le levatrici. Si congratularono. Si felicitarono prima tra loro, poi con i neogenitori. Infagottarono la bambina e la presentarono al padre, che ormai, a furia di tirare, se l’era già bel che staccato quell’ultimo, benedetto bottone. Incredulo, sostenne qualche istante quel corpicino semi raggomitolato. Se lo tenne in braccio una piccola, intensa, gradevolissima frazione di tempo, eppure gli parve di sorreggere l’eternità intera. Non si riesce a capire quale sia la formula esatta, quella la cui interpretazione lessicale viene descritta come insieme di parole imposte da una consuetudine legale o rituale che si pronunciano nel corso di determinate 62 circostanze. Si sa soltanto che, arrivati a un certo punto, bastano quattro parole, quattro precise parole e le certezze radicate vengono spiantate, divelte, estirpate. Il futuro prefissato siede sulla parte iniziale dell’asse ed ha un suo peso. All’estremità opposta c’è il presente che, guarda caso, ha lo stesso peso del futuro prestabilito. Il fulcro è il destino. Al centro dell’asse c’è una biglia di vetro: la nostra vita. Così come descritto tutto sembra perfetto. L’equilibrio dell’esistere. La risolutezza della vita con uno sguardo al presente e uno al futuro. Il passato è passato, ramazzato, tirato su e portato nella discarica dei concetti: se non nei ricordi non ci si preoccupa più. Però ogni tanto il destino fa il bischero ed emette la formula. Una maledettissima espressione rituale che, non trovando niente di meglio da fare, va a sedersi su una delle due estremità dell’asse, indifferentemente a fianco del presente o del futuro che sia. A quel punto non serve che venga spiegato cosa succede: dovuto ad uno squilibrio di peso l’asse si inclina. Le strade percorse, strade per un certo qual verso ritenevamo sicure, assimilate con l’educazione, l’età, la scuola, tutte quelle robe lì insomma, l’assoluto equilibrio del nostro essere per chiarire la questione, in quel preciso istante 63 divergono pigliando le direzioni più assurde; le più comode sicuramente, ma che per la maggior parte dei casi non sono le più azzeccate, e prendono una velocità tale che a fermarle sono cazzi. Ed ecco la nostra biglia lanciarsi lungo quel piano inclinato, a rotta di collo e allora, a quel punto tutto diventa un’incognita. E’ angosciante certo, ma alle volte capita. Ed è strano quando arriva. Quello in cui si è fortemente creduto, quello a cui ci si attacca, è completamente messo in discussione. Una formula. Quattro insiemi di lettere messe lì a costruire una frase, neanche poi tanto articolata per giunta, e tutto barcolla. Non è più cosa certa un valore. Non è più cosa certa un merito, una qualità. Dopo un idioma del genere ci si riversa dentro uno scombussolamento devastante, come un maremoto che fa crollare le palafitte del prestabilito. Fatto sta che il valore di una certezza venne a mancare tutto di colpo quando dalla bocca di una delle levatrici fu emessa una semplice frase. Una stupida, inaspettata, malaugurata frase: “Ci serve un dottore.” Un interrogativo si piantò dritto nel cervello di Pietro. “Un dottore?.. A cosa serve un dottore?.. La piccola mi sembra stia bene. Guardate e ditemi 64 voi se non sta bene… forza, guardate!.. E’ sana come un pesce, la piccina, sentite come strilla… Ha fiato da vendere, lei… Osservate che nervo!.. tutto un movimento… No, no, sta benissimo… io non me ne intendo di certe cose ma immagino si capisca quando uno necessiti di terapia.” Lo sguardo delle donne non proclamava un concetto schietto. Bisognava arrivarci. “Ma… scusate tanto… ma, io… credo di aver frainteso… vi chiedo di perdonare la mia ingiustificabile pedanteria nell’afferrare la questione, ma… non vi sentite bene? Avete bisogno di cure?” Le donne non capivano cosa stesse farneticando. “Sua moglie, signor Cobbe. E’ urgente!” Eccola la stonatura. La steccata. La nota sbagliata nell’esattezza di una musicalità estiva. Assomigliava a una sorta di zirlo, quel suono, una fattispecie di sibilo estromesso dal dentro devastato della puerpera, come scaturito da un congegno grippato. E tutto quel plasma a sporcare la purezza immacolata di un lenzuolo e a decolorarle il volto. Tutto un travaso di materia solida prima, e liquida a seguire. E lo 65 spirito bendato a farsi un giro sull’orlo del canyon. Picchiata dal temporale la casa vedeva, elaborava e riferiva. Le altre case seppero e a loro volta raccontavano. Ben presto le contrade tutte conobbero, ma non si intromisero. Rimanendo così, osservatrici e conservatrici di una preghiera mai recitata. E’ stato tra i muri di quella casa che Donata Cobbe, un po’ per costrizione un po’ per scelta, da oltre ottant’anni aveva intrapreso il trascorrere della sua vita. Sembrava scatenatosi il secondo diluvio universale quando le pareti della camera da letto l’avevano vista nascere e irrompere con temperamento su questo pianeta. Malgrado non potesse ricordarlo, sicuramente di quella notte come di mille altre senza memoria conserva tuttora una fragrante sensazione: l’avvolgente profumo dei fiori di gelsomino. Ha sempre associato casa sua al gelsomino. In giardino un’agguerrita siepe formava una barriera naturale che ogni anno combatteva conquistando territori sempre più ampi. E poi c’era il fieno, di certo il primo odore percepito dato che costituì il suo 66 primitivo giaciglio. Un profumo amaro e sporco di sangue. Il sangue di sua madre. L’emorragia massiva conseguente al parto se la portò via senza esserle stato concesso il ricordo del suo viso, il colore dei suoi occhi, la forma delle sue labbra, l’imprimersi della sua voce. Sopra il letto imbrattato di liquido organico e placenta, qualcuno spegneva la tremula fiamma che alimentava la vita di una mamma la quale aveva appena donato la luce alla sua primogenita. La gioia del parto non era bastata a restituirle la forza necessaria per contrastare una complicanza succeduta in un’epoca in cui la medicina stava ancora percorrendo sconfinati campi inesplorati. Era stato un travaglio terribile durato una giornata intera, poi, subito dopo aver figliato, le cose si aggravarono irrimediabilmente. Nessuno sapeva più cosa fare. Le levatrici si superarono mettendo in atto ogni soluzione plausibile raschiando anche il fondo del barile della loro competenza, ma purtroppo non possedevano la formazione sanitaria che l’intervento in quanto tale richiedeva. Arrivata a un certo punto Francesca crollò, e come una foglia al vento si lasciò trasportare al suo destino. Le sue ultime parole furono rivolte al marito. 67 “Donata” sussurrò. “Come hai detto, tesoro?” “Donata. Voglio chiamare così la bambina.” “Ma non era stato deciso per Anna come la madre della Madonna? Credevo ti piacesse.” “Penso che Donata sia il nome giusto, perché questa piccolina è il dono che il Signore ha voluto affidarci quest’oggi”. “Donata: molto bello. Sarà sicuramente questo il suo nome.” “Voglio vedere la mia bambina, voglio toccarla… non credo di aver tantissimo tempo per farlo.” “Di tempo ne troverai a sufficienza quando starai meglio. Adesso arriva il dottore e vedrai: ti rimetterà in sesto in un batter d’occhio. Avrai un mucchio di cose da fare quando riacquisterai le forze!” “Sto male, Pietro. Mi sento debole… sfinita… Perdonami, Pietro, se non ce la faccio perdonami.” “Eh no che ti perdono!, le sconterai tutte al momento opportuno, lo giuro. Intanto cerca di guarire che qua siamo in due adesso ad aspettarti.” “In tre.” “...?” 68 “In tre. C’è anche la donna vestita di nero, lì tra voi, che se la ride di gusto.” “Vaneggi. Lo capisci che vaneggi? Cristo santo: stai delirando. Ti ho detto che non puoi lasciarci ora! Sant’iddìo! Promettimelo. Promettimi che non ci abbandoni qui sul più bello. Lo so che a volte sono una persona difficile, spesso insopportabile, e ti capisco: per questo sei autorizzata ad andartene. Ma non ora. Abbiamo il fieno da portare a riparo, le patate da sterrare, le vacche da riprendere, il tetto da sistemare, e adesso una bambina da far crescere. Non puoi andartene ora. Dopo sarai libera di farlo, ma non ora.” “Lo vuoi un consiglio, caro il mio signor Cobbe? Sbrigati a fare tutte ’ste cose.” “Con calma, tesoro. Non c’è fretta.” “Ora fammi stringere il mio angioletto, che ogni minuto andato è perso.” Teneva gli occhi velati di commozione, la donna, e nonostante una serie di lacrime le ostacolassero la messa a fuoco riuscì in qualche modo a scorgere sua figlia: non era forse una creatura celeste? Faticò non poco ad allungare il braccio e col movimento della mano a cercare il corpicino della bambina. Quella piccina che tanto si dimenava, e strillava così forte che sembrava 69 nei polmoni le si fossero liberati tutti i venti del mondo. Malgrado ciò, lo sforzo sostenuto ebbe un successo insperato. La donna afferrò sua figlia e la trascinò a sé. Se la strinse al petto con la delicatezza che soltanto una madre certe volte possiede; e la sentiva così vulnerabile, così attaccabile, così tanto disarmata. Eppure ardentemente viva. Nel frattempo, le donne che l’avevano svincolata dalla madre, pulita, avvolta in una calda coperta di lana e affidata al padre, si stavano più che mai preoccupando per lo stato di salute della donna. Una situazione gravemente compromessa dato che a causa delle incessanti piogge di quei giorni, l’arrivo del medico, distante in occasioni ordinarie soltanto mezz’ora di cavallo, era stato seriamente ostacolato per via delle inondazioni derivate dallo straripamento del torrente Leno, giù a fondovalle. Lui, il padre, rimaneva seduto a bordo letto, cercando di dare il suo appoggio come meglio poteva; non s’era fidato a lasciarla sola nemmeno un istante. Neanche quando Luigia, la moglie di suo fratello, vista la situazione critica venuta a creatasi, si era offerta per dargli il cambio. 70 “Cerca di riposare, cara” disse il marito. “Sei ancora troppo debole.” “Ma… è la mia bambina. La nostra bambina. Ha bisogno di noi, adesso.” “Lei ha bisogno di te non meno di quanto ne possa avere tu ora” disse. E su quelle parole l’ormai stremato cuore della donna si ritrovò un ulteriore carico da supportare: su di esso gravava ora anche il peso dell’afflizione. Per lei quel muscolo aveva fatto l’impossibile: vissuto momenti gioiosi, altri disperati, aveva corso e s’era riposato, aveva succhiato e spremuto plasma fin dal primissimo battito; s’era perfino diviso in due segnando l’inizio di una nuova vita, cosa di cui comunque andasse era riuscito a portare a termine. Adesso però la battaglia stava assumendo dimensioni abnormi e la sua forza si stava notevolmente affievolendo. Fu nel preciso istante in cui il dottore varcò la soglia di casa che gettò le armi sventolando lo stendardo della resa. Fatto rimane che, dopo sette ore dalla nascita di Donata, agli occhi di quella donna tutto cessò di esistere. Di lì a un mese avrebbe compiuto ventitré anni. 71 Era l’inizio del ventesimo secolo e la drammaticità di simili eventi rappresentava cosa comune. La sopravvivenza vincolava la gente al baratto: una vita in cambio di un’altra. Donata era nata orfana di madre e all’inizio sembrava, sotto tutti i punti di vista, anche orfana di padre. Sì perché suo padre Pietro Cobbe, assalito dallo sconforto si barricò in cantina, da solo, rifiutandosi categoricamente di uscire se non per espletare i fabbisogni corporali. Suo fratello Alfredo e sua cognata Luigia valutarono questo esaurimento improvviso come un atto esagerato, inconcludente ed eccessivo; ma evidentemente quattro anni di matrimonio non erano stati sufficienti a sbollire l’affetto coniugale che ancora lo legava alla sua povera sposa. Lui l’amava. Amava il suo respiro, il suo profumo, le sue gesta, perfino quei piccoli difetti, minimi ma assai differenti dai propri. Amava la sua freschezza e il suo disordine immaturo, amava l’aurea che l’accerchiava. Le voleva bene più del suo fucile, perfino più del suo cavallo. Ah, se il cielo avesse concordato una tregua e il dottore fosse arrivato in tempo per sanarla! Ammutolito dal dispiacere e accecato dal dolore, passava le giornate assorbendo l’umidità di una cantina buia, insalubre, dove 72 soltanto un rettangolo di pino traforato lo interferiva col tramestio del giorno e la magnanimità della notte. E le notti che ci passava erano nottate contrassegnate dal bruciore di occhi arrossati puntati alla luna. Deperiva a vista d’occhio. Le sue guance sbiancavano giorno dopo giorno come un animale al salasso. Non voleva più mangiare, non gradiva parlare con nessuno. Smise perfino di usare le latrine esterne, pisciando e defecando all’interno del medesimo perimetro in cui vegetava. Preoccupato, il fratello interpellò lo stesso dottore che poche settimane prima aveva ritardato il soccorso alla povera partoriente. Questa volta il medico arrivò solerte, e se ne andò ancor più velocemente facendosi consegnare dei soldi in cambio di una lunga lista di medicine. “Avrebbe bisogno di consistenti cure ospedaliere piuttosto che artificiosi intrugli d’erbe” suggerì la cognata al marito mentre visionava la ricetta con aria basita. In quei giorni la bambina dormiva e piangeva come tutti i neonati del mondo e, in braccio alla zia, poppava da un succhiotto ricavato con budello di maiale il latte di capra allungato con acqua e fiori di camomilla. Andò avanti così per sei settimane e mezza. Chi a badare all’uno, chi all’altra. 73 Finché, alla fine della sesta settimana, la donna non ne ebbe abbastanza. Riscaldò il latte avanzato, prese la piccola Donata dalla culla in cucina, qualcosa di solido dal cassettone e si diresse al seminterrato. Scese le scale sfilando con passo deciso davanti al marito che la guardava esterrefatto. Espresse alcune rimostranze, l’uomo, che però rimasero ignorate. Furente, Luigia s’era lanciata dritta alla porta dello scantinato, scalciando e ragliando come un’asina isterica. Raggiunse l’obiettivo e diede inizio all’assalto. Impugnò e armeggiò contro la serratura bloccata, colpendo più volte le specchiature della porta col mattarello procuratosi di sopra. Al culmine di quel trambusto la porta si aprì. Quando la donna si trovò di fronte lo scheletro ammorbante in cui s’era trasformato il cognato Pietro, si bloccò lì su due piedi, non sapendo bene se quello che stava facendo fosse la cosa giusta. Fu solo un attimo, poi scacciò all'istante quel pur savio pensiero facendo spazio alla decisione filata al culmine di una lunga serie di settimane estenuanti. Senza emettere sentenze consegnò bruscamente il fagotto contenente Donata e la ciuccia del latte alle ossute braccia di Pietro, il padre legittimo. Gli scaraventò 74 l’involto in braccio avvalendosi della garbata delicatezza adoperata da un boaro coi suoi tori. Quando Pietro, aperta la porta, si ritrovò tra le braccia sua figlia e di fronte quella donna indemoniata, l’unica cosa che fu in grado di formulare era stato un semplice interrogativo: “Che c’è Luigia, sei ammattita?” La donna lanciò un grugnito di sfogo prima di sbattergli la porta in faccia, girare i tacchi e andarsene, con l’eco dei passi furiosi che dal seminterrato rimbalzava fin sotto le travature del tetto. Tornata in cucina s’accasciò su una sedia pagliata incrociando le braccia e tirando un sospiro di sollievo. Alfredo non era neanche arrivato alle scale che udì la voce della moglie ammonirgli: “Provaci e ti uccido.” Sembrò interminabile quel pomeriggio. Ad ogni rintocco della pendola s’alternarono nell’origliare con la tempia appoggiata alla soglia, oppure nello sbirciare dal buco della serratura. Il seminterrato sembrava ostaggio del silenzio. Quel poco che lasciava filtrare la toppa non era altro che un’ombra figurata mossa da fili di luce sempre più languidi. Nessun suono di voce. Nessun pianto di neonato. Nulla. 75 Il silenzio infondeva un rumore sgradevole, quasi un fastidio. Il puzzo ne condiva il concetto. I pensieri sul peggio si affastellarono. Luigia s’era quasi pentita del piano escogitato. “Non le avrà mica fatto del male, quel pazzo!” si dissero. Discesero e risalirono le scale una decina di volte, anche con l’intenzione, poi repressa, di scardinare quella maledetta porta e riprendersi la piccina, se non era troppo tardi. Si trovavano in cucina pronti a intraprendere la spedizione di salvataggio quando, alle venti in punto, udirono un vagito. Ebbero un sussulto. Si guardarono con felicitata incredulità. La linea dei loro visi demarcava la soglia dello stupore, un inizio di compiacimento. Dopodiché, preannunciato dal trambusto della molla a scatto e dal cigolio dei cardini, la porta si aprì. Per la seconda volta quel giorno. “Esce, benedetto Iddio” riferì Luigia al marito incredulo. “Tuo fratello è uscito.” Sì, adesso si sentiva chiaramente il pianto di un bambino. E quel vagito era più di un vagito. Due vagiti, o anche tre. Tre in uno. La bimba strillava come mai lo aveva fatto in quasi sette settimane di vita. Tutta la casa accoglieva quegli urli con scricchiolii di benvenuto e quell’uomo con fruscii di 76 bentornato. L’effluvio che si respirava era quello della ripartenza, la voce udita quella di una bambina affamata e da strigliare; ma questo il padre incompetente non poteva ancora saperlo. La tromba delle scale portò con sé soltanto una richiesta, un’istanza che arpeggiò i timpani degli zii con suoni di cetre celtiche. “Ehi, voi due, se non lo avete capito c’è una bambina da cambiare qua sotto. Cristo santo, non ho mai visto tanta merda in vita mia!” La ripartenza concedeva spunti di qualsiasi argomento, anche i più inappropriati. Da quel giorno l’uscio della cantina non venne più richiuso. Il primo anno di vedovato non fu facile da superare. Pietro ne soffrì molto, ma riuscì a contrapporre al dolore per la perdita prematura della giovane sposa la gioia di poter accudire la nuova arrivata, riversando su di lei l’amore in avanzo e ritrovando così la felicità che pensava di aver perduto nel baratro del lutto. Passato il tempo necessario per ripulirsi, ristabilirsi e schiarirsi le idee, si rese conto che la morte non significava solo dolore ma anche piacere, non implicava solo una perdita ma anche un’aggiunta. Il dolore e la morte non si configuravano soltanto come sottrazione, 77 abbandono e disperazione, ma contenevano il sapore di un risarcimento emozionale, di un bilanciamento affettivo. E più il tempo passava più il panorama appariva opposto. Tanto prima maledisse Dio al punto da rinnegargli la fede quanto ora lodava e benediceva la sua sacra immagine e l’immensa magnificenza. Capì che non era rimasto solo ma che Francesca le aveva lasciato una figlia a cui badare e per la quale sarebbe stato disposto ad accettare qualsiasi compromesso. Divenne mentore indefesso sia come padre che, per quel che poteva, come madre, riuscendo ad onorare appieno l’impegno assegnatogli da un destino maledettamente beffardo. Intanto Donata – la sua piccolina – cresceva sana e coccolata, e per tutto il periodo preadolescenziale la mancanza di una madre era un affare circoscritto al tempo che ci si impiega a scaldare un piatto di minestra o a rifare un letto. La ragazza percepiva ancora adesso i mille sapori della sua giovinezza: la falciata del prato obliquo, difficoltoso, impuntato; il profumo della casa cordiale, munifica, larga quanto il cuore di un’eletta; il fumo corpulento che spreme gli occhi; il ribollio di una polenta selvatica e irrequieta, inavvicinabile alla sua 78 versata, raccolta sopra un cencio pulito e poi tagliata e ingoiata in palmo di mano. Inoltre ci stavano i fiori. Non s’era mai visto in quella casa un vaso oziare disoccupato. Se ne trovavano dappertutto, tanto fuori quanto all’interno. Per suo padre era una specie di fissazione, diceva che il profumo di un fiore assorbe l’odore della morte e il suo colore snoda anche l’animo più incaponito. Sebbene lei su questo nutrisse dubbi profondi, i balconi di casa, i davanzali delle finestre e il tavolo della cucina, erano sempre immischiati in qualcosa di variopinto, profumato e possibilmente appena reciso. Per fare fronte a ciò, nel triangolo di terra dietro casa, oltre allo straordinario gelsomino, s’era riservato un piccolo appezzamento coltivato a giardino. Le sue mani sapevano di terra in qualunque stagione dell’anno. Iniziava quando il sole di primavera svegliava rettili, richiamava uccelli, svestiva persone, e terminava quando il gelo serrava portoni e terreni, rassodandoli. Lo spossamento del giorno veniva rinvigorito dalle ore serali trascorse in giardino, a badare agli alberi, ai fiori, col silenzio dipinto in molti modi, immerso in pensieri passeggeri, anche attorno a una canzone magari, uno stornello allegro, beatificando la pausa di una nuvola che 79 trattiene un po’ di sole e un po’ di sale sulla fronte. Seminare, curare e invasare ogni genere di pianta, da semplice sollazzo si trasformò in passione. Morbosa passione. Gerani dai colori più svariati, dalie, astri alpini e quantità industriali di gigli martagone corredavano il paesaggio; tra il pietrisco brillavano a fiaccola alcune piante di stelle alpine e svariate di belladonna. Sotto i pini cresceva il rododendro, il ciclamino e l’erica; a lato rose canine e margherite di campo deponevano nell’erba la loro semenza. “Un fiore ha bisogno di due cose” diceva, “sotto: parecchia sostanza, sopra: tanta luce. Il risultato di tale mistura genera bellezza. La sostanza è formata da elementi naturali come la terra, l’acqua, i minerali. La luce è l’operaio che li seduce, li miscela, e con una formula che attrae li punta in alto, in faccia al sole. Il variopinto dei petali è richiamo, interesse, avvicinamento, fascino, seduzione, perché solo in natura esiste l’attrazione, che è l’opposto della gravità. Attrazione è bellezza pura, slancio vitale. Senza bellezza la pianta declina, gravita e muore.” Spesso parlava alle piante che curava. Non si aspettava risposte, gli bastava credere che queste lo ascoltassero. Perché la pianta si sa che ascolta. Cercava il punto esatto per la 80 parola e lo strapianto, un orizzonte ampio e un solco accogliente, dimodoché potessero prestare orecchio ai placidi pascoli, alle frastagliate creste, alle volatili meteoriti, agli immutabili pianeti, alle galassie tutte: all’universo intero insomma. Che potessero urlare sotto le tempeste e boccheggiassero nell’afosità di canicole incandescenti; comprendessero sia la smisurata vastità dell’ignoto che la prossimità di un ronzio che fa incetta del polline fabbricato. Una pianta è coalizione tra il presente di necessità e il futuro di eccedenza, completo ma lontano. Un futuro perfetto, che è appunto la lontananza a conservare tale. Trovato il posto la pianta deve attecchire. E non sempre è compito facile. Specie se il soggetto non fa parte di ceppo indigeno. Il forestiero è spesso mal accolto. Il foresto di quel tempo trovò alloggio dentro un fatiscente tugurio di vetro e paglia impastata all’incrocio tra i due cateti di un giardino gremito di corolle e petali variopinti, al riparo dal vento e da sguardi denigratori. Certi occhi non meritano il dono di vedere, come certe bocche quello di parlare. “Tempo buttato” proclamavano gli scettici. “Non ce la farà mai” scommettevano i dubbiosi. Lo straniero teneva 81 un nome comune: orchidea; ma era di una razza speciale: Galearis. L’azzardo e la lepidezza infervoravano le perseveranze dell’uomo. Il volersi superare occupava il centro del mirino. La soddisfazione è il risultato di innumerevoli tentativi e altrettante delusioni, di ostinazione, fermezza, ma pure di un paraocchi e una buona dose di cera nei timpani. E tanta, tanta fortuna. Sembrava una sfida impossibile far fiorire in un ambiente montano una pianta mediterranea, dove l’ardore del sole del mezzogiorno e il soffio del vento di mare sviluppano linfa e concime. Le Galearis: piante da terrazzi caldi e salmastri, non certo da crudi appezzamenti alpestri. Le prealpi trentine non tengono tale prodigio, il loro vento e il loro sole sono schiaffi che rianimano piuttosto che carezze che risvegliano. E la Galearis s’era soltanto appisolata. Usò lo stratagemma dei vetri per creare calore. La terra giusta per le fondamenta, l’alcalinità dosata per il nutrimento. Passarono mesi, ed ecco che il tralcio della tenacia sviluppò germoglio. “Vedi piccolina” le disse una domenica mattina il padre, al passeggio dopo messa, “l’orchidea è sinonimo di affetto e raffinatezza, oltre ad essere una pianta prodigiosa. Da 82 sempre è considerata capace di allontanare le influenze nefaste tantoché, nel Medioevo, si usava per realizzare filtri d’amore. Quindi dovresti considerarlo un privilegio avercele in giardino.” Montò in spalle la bambina e si avvicinò alle menzionate infiorescenze. “Non mi piace, papà” abbozzò puntandogli i talloni al costato, “è scolorita, più bianca di un lenzuolo, mi fa paura! I suoi petali assomigliano ad una bocca spalancata… sembra quasi mi voglia sbranare.” Effettivamente, agli occhi fantasiosi dei bambini, quei lunghi peduncoli verdi come cervici affusolati, quelle nivee bocche smascellate da cui s’ergono labelli rilucenti simili a scimitarre ottomane, non potevano che destare un certo nervosismo; e di tale peculiarità era succube anche Donata. “Amore mio, cosa stai dicendo. E’ solamente un fiore: un semplicissimo fiore, tutto qui. Non un mostro che mangia i bambini.” Spallò la figlia. Si sedettero a cavalcioni del muretto, le sistemò i capelli e il colletto della camicia. Osservò l’orizzonte e poi puntò a lei, dritta sul mento, evitando il contatto degli occhi. Voleva svelarle qualcosa e le parlò, usando il tono pacato riservato alle confidenze. “Ti ho mai raccontato di Orchide?” disse. 83 “No, non mi ricordo.” “Un’antica leggenda parla di un fanciullo bellissimo che si chiamava Orchide il quale, poveretto, oltre che dalla bellezza era posseduto anche dalla diversità. Sì perché chiunque, al suo maturare, si poteva accorgere che gli spuntavano due seni femminili.” Lei ascoltava a palpebre allargate: due carboni accesi incastonati dentro una faccina sveglia. Le piacevano le storie, soprattutto quelle raccontate così, con enfasi. Lui era la voce dell’albero e lei il fico che pendeva dalle sue labbra ramose. Continuò. “Orchide, a mano a mano che cresceva, pur essendo un maschio assumeva sembianze femminili, formando un corpo sinuoso e delicato. Per questo motivo era evitato sia dalle femmine che dai maschi che lo trovavano entrambi diverso da loro. La sua ambiguità fisica si ripercuoteva anche nel carattere, alle volte timido e schivo altre volte aggressivo e lussurioso. La derisione popolare lo rese introverso con la gente e riluttante con se stesso, fintantoché un giorno più amaro del solito si gettò dalla rupe e morì. Improvvisamente sul luogo della sua morte fu tutto un germoglio, fiori assai diversi ma nello stesso tempo simili nella loro esternante 84 sensualità. Queste fioriture vennero chiamate orchidee evocando appunto il nome alla memoria dello sventurato Orchide. Per questo motivo gli efébi, cioè i giovani ateniesi in procinto di diventare uomini, si vestivano di bianco e cantavano lodi agli dei con in testa una corona di orchidee.” “Quanto è brutta, papà. E’ triste. E’ una storia infelice, fa piangere.” “Lo so, è decisamente malinconica, ma serve a farti capire che questo è un fiore che trasmette amore e purezza. E noi poveri cristi ne abbiamo costantemente un bisogno esagerato.” La piccola deglutì, inaspettatamente, e sussurrò con la mezza voce che non le era rimasta strozzata in gola: “Ce ne stanno orchidee in Paradiso? Vorrei che le vedesse anche la mamma”. L’innocente richiesta lo prese alla sprovvista, privandolo della dizione. Rimase sgomento. Riuscì solo in un secondo momento a parare il tiro e lo fece con un colpo da maestro. “Ne avrà a mazzi! Credo le stia raccogliendo tutti i santi giorni, a cosa pensi che servano le nuvole lassù se non ad annaffiare i giardini del cielo?” Scivolò fuori sgomitando quella risposta, superando impacci e lasciandosi alle 85 spalle un cuore spezzettato. “Anzi, sono convinto ci sia stata la sua assistenza nel farcele germogliare.” Concluso quel discorso notò un luccichio tra le palpebre della figlia: un’unica goccia salata che scendeva silenziosa rigandole la guancia paffuta e arginatasi sul dorso di una manina arrivata prontamente a spazzar via quell’umida ambasciatrice di pena. “Dove sarà adesso la mamma? Vorrei tanto che fosse qui con noi…” E la tenerezza della frase lo catapultò in un vortice struggente, tramoggia di sentimenti, mistura d’amore e compassione. Pietro avrebbe dato qualsiasi cosa per vivere all’interno di quella lacrima; uscire da due grandi occhi scuri, neri come bacche di fitolacca, scivolare lungo un viso liscio e modellabile dal tempo, baciare fugacemente una bocca semiacerba e dissolversi in un pugno di dita innocenti. Ma la cosa da far sparire in quel momento erano innanzitutto i piagnistei. Un gran sorriso gli si incuneò tra le labbra. Guardò ammiccando la bambina e mentre con una mano le scarmigliava i capelli biondicci la sfidò con acume: “L’ultimo che arriva è un babbeo.” Se la vide scappare di mano come se la ragazzina possedesse la viscida duttilità di 86 un’anguilla. Cominciò a rincorrerla lungo tutto il sentiero, fin davanti all’uscio di casa, che a quell’ora era tagliato di mezzo dalla linea d’ombra della sera – guardandosi bene dal farla arrivare per prima – dimodoché poi, fingendo di essere a debito di fiato, si gettò a terra come sfiancato dalla fatica. Di fronte alla ridicola messinscena la bambina scoppiò a ridere di gusto, delle sganasciate che traboccavano allegria, spensierate, limpide come propositi, contagiose come sbadigli; fortunatamente dimentica di un qualcosa di inspiegabile, difficile da accettare per un adulto, figurarsi per una bambina di sette anni appena compiuti. Non riuscendo ancora a trovare le giuste parole per affrontare un argomento tanto delicato, decise che la scelta più opportuna sarebbe stata quella di rimandare. Così facendo, anche quella sera come cento altre a venire, oltrepassarono forzatamente felici la soglia di quel giorno, seguita da quella dei mesi, delle stagioni, degli anni, consolidando un rapporto costruttivo basato sulla fiducia e sul dialogo, pervenendo sempre a ripiegare nell’ironia tutti i piccoli disaccordi che inevitabilmente sorgono nei discorsi affrontati da persone come loro, liberi esponenti di generazioni diverse. Fra i due tuttavia ha sempre prevalso una sana 87 complicità rincalzata dall’affetto familiare e da un inattaccabile rispetto reciproco. Aveva da poco festeggiato il suo diciassettesimo compleanno quando ad Anghébeni arrivò un eccentrico viaggiatore; un tipo alquanto bizzarro che si portava appresso un cane e una strana attrezzatura sulle spalle. Diceva di essere un artista del ritratto stampato, e si guadagnava da vivere scattando fotografie alle persone incuriosite da quella nuova diavoleria della chimica. L’idea di tramandare ai posteri la propria immagine era stata altamente apprezzata dalla comunità vallarsese, oltretutto fattibile in tempi brevi e spendendo cifre modeste. “Gente, il tempo è denaro!” diceva. “Pensate io sia un pittore?” Pausa calcolata. “Sbagliato: il mio lavoro è diverso. Loro disegnano con le matite, io con la luce. E’ la luce che genera l’immagine… e la luce non perde tempo in chiacchiere.” Non succedeva tutti i giorni di trovare qualcuno che sapesse maneggiare materiale sensibile su carta alla nitrocellulosa, miscelare acidi di arresto e fissaggio, armeggiare con scatole stagne alla luce, obbiettivi anastigmatici e cavalletti di tenuta. Al principio la gente era 88 incuriosita più per tutto quel marchingegno che per il lavoro in sé. Si fecero avanti. Taluno di più coraggioso si avvicinò maggiormente e capì. Quei pochi a cui venne spiegato il procedimento fotografico potevano vantare un bagaglio di conoscenze che mai si sarebbero sognati prima di allora. Così successe che loro stessi relazionarono salmodiche conferenze sull’uscio di casa davanti agli amici, osannando i miracoli del progresso e facendo pubblicità a tutto spiano, e, soprattutto, a costo zero. Furbo l’artista! Avvenne che la disciplinata curiosità popolare si tramutò in un vero e proprio assalto di massa. Per tutta la settimana che il fotografo si trattenne in paese, egli non ebbe un minuto libero da impegni. L’assiduo lavoro nel ritrarre le famiglie residenti nella zona lo costringeva a fare gli straordinari, e riceveva richieste anche da molti abitanti dei paesi vicini. S’intravvedevano intere famiglie raccolte attorno ai rispettivi camini, o tutti seduti in improvvisati salotti, espressioni austere, teste brillantinate e vestizioni adornate a festa. Restavano interminabili minuti fermi, immobili, concentrati in pose statiche e… quasi naturali, a parte la paura nell’attesa del fragoroso lampo al magnesio, sempre poco gradito. 89 La strana malattia contagiò anche Pietro e Donata i quali, dopo aver constatato l’ottimo lavoro consegnato ai vicini, si prestarono anch’essi ad essere immortalati. Prima di farsi ritrarre lui si pettinò – forse per la prima volta in vita sua – i baffoni arruffati, indossò il vestito grigio sopra la camicia bianca e impiegò parecchio tempo prima di riuscire a farsi un nodo poco più che modesto alla cravatta. Lei aveva i capelli tirati sulle spalle e indossava l’abito regalatole dalla zia Luigia per il suo compleanno, dritto e sciolto, a vita alta, che scendeva verticale ma aderiva dove necessario a tutte le forme del suo corpo, disegnando archi tanto belli da spezzare i cuori. Sembrava una gara a chi sfoggiava di più. “Caspita! Lo sai che messo così sei proprio un bell’uomo!” disse Donata appena s’imbatté in suo padre tirato a lucido. “Se non fossi il mio papà quasi quasi ci proverei…” “Quanto sei scema, smettila di prendermi in giro e andiamo che quello ci sta aspettando.” Ammirarono la loro foto per giorni interi, osservarono il loro atteggiamento, risero per lo strano taglio dei capelli e i singolari lineamenti del viso. Indubbiamente si vedevano belli, prestanti, ma in quel frangente mancava qualcosa che completasse la magica armonia 90 della posa. Non tardò poi molto a scoprire cosa durante quel flash non avesse funzionato a dovere. Fu tutta colpa di un particolare che lui già sapeva e non si era ancora deciso di riferirle. Comprese solo adesso perché in quella foto lo sguardo di suo padre fosse così… assente. Perché, nel profondo dei suoi occhi, si nascondesse un uomo che piangeva. Glielo fece capire una lettera arrivata una mattina di settembre del 1914, una missiva dell’Impero Austro Ungarico che comunicava a tutti i maschi abili di età compresa tra i 18 e i 45 anni l’arruolamento di massa e ordinava a Pietro Cobbe l’imminente partenza per il fronte russo. Nel decorso dell’anno ci sono date i cui avvenimenti rimangono impressi più di altri. Quei giorni sono simboli, e vengono contrassegnati nella memoria della gente proprio perché è alla gente che appartengono: Natale, Capodanno, Pasqua e via dicendo. Poi ci sono le date che spettano al singolo individuo, come potrebbe essere l’inizio di un amore, il primo o l’ultimo giorno di scuola, un matrimonio, un compleanno. E non è detto che si debba associare esclusivamente a un episodio felice. La ricorrenza personale di 91 Donata è datata 14 settembre. Il giorno più doloroso della sua vita. “Non preoccuparti, tornerò presto” le disse suo padre mentre se la stringeva stretta fra le braccia. E più lui l’abbracciava più in lei montava il cruccio, la disperazione: una preoccupazione scomoda e pressante. La valanga in cui era incappata le dava le vertigini e la sensazione era quella di essere travolta sempre più nell’abisso dell’abbandono. Non era assolutamente certa, ma avvertiva il netto presentimento che sarebbe stata l’ultima volta che alle sue orecchie arrivava il timbro di quella voce. “Sii prudente papà, io sarò qui ad aspettarti, dovesse cadere il mondo.” “Oramai sei una donna, quindi sei in grado di gestirti. Comunque sappi che gli zii saranno sempre disponibili per ogni tuo fabbisogno e su di loro puoi fare affidamento. Abiteranno in questa casa finché io non sarò tornato. Tu preoccupati dei campi e degli animali, e ricordati di dare l’acqua ai fiori. Soprattutto alle orchidee.” Lei annuiva silenziosa. Intanto lo guardava, anche se a dirla tutta il suo bulbo oculare focalizzava una forma dai tratti imprecisi, sconfusionati. Sì, perché tra la stretta della 92 palpebra s’intercalavano scene violente, foschie di distruzioni, canali di sangue, omicidi comandati, fumo, devastazioni. E poi sguardi di figlioletti soli e spaventati, di ragazzini come lei, legati a una preghiera che forse mai verrà esaudita. Nel loro guardarsi si materializzavano immagini da macello, involucri di uomini simili a carcasse d’animali accatastate le une sulle altre, svuotate del contenuto e della vita. Un putrido scotennatoio. Il riverso di un maiale sgozzato e gettato in un pozzo di sangue, un fiume di sangue, da riempirvi un bacile all’occorrenza; una fatica a lei stessa serbata, da quando le era stata aperta la ragione, perché nulla andasse perso, nulla venisse sprecato. In fin dei conti anche nelle atrocità trovi scorie di buona sostanza. L’occhio vacuo che la fissava. La bocca contratta che lasciava intravedere zanne giallastre. La ferita prosciugata che disegnava una piega, come l’arricciatura di un lenzuolo stropicciato. Ridicola quella smorfia stampata sul muso. Lo sberleffo di una bestia alla donna e al mondo che l’hanno tradita. Serrò le palpebre: sapeva che tutto ciò non rispecchiava la realtà ma la delirante ironia di un visione malvagia. Un’allucinazione. Solo la disgiunzione da suo padre non rientrava in quei canoni. 93 Quando si lasciarono lui le baciò la fronte. Un bacio che significava partenza. Partenza: comunque il primo passo verso il ritorno. E da quel minimo movimento si scatenò il cataclisma. Sentì quelle labbra cedevoli, rosee, frastagliate come onde che frangono contro gli scogli urtare indelicatamente la sua fronte, e accusò una sensazione orribile ricevendo quel bacio. Percepì la sconfitta padrona delle aspettative divincolarsi fra il contatto delle epidermidi e le esalazioni del dopobarba. Tremava accostata alle sue labbra e il profumo di acqua di colonia le devastava lo stomaco, ma, sia ben chiaro, in quel preciso momento non li avrebbe sostituiti con nessun altra cosa al mondo. Chiuse gli occhi e inspirò a polmoni stipati. Quell’istante le rimase impresso un’eternità. Un breve attimo lungo una vita intera. Il ricordo di un odore e di un gesto. L’ultimo regalo di suo padre. Non seppe mai se fosse stato catturato, ferito o caduto sul campo. Lo diedero per disperso e, se pur le speranze fossero sempre rimaste accese, lui mai più fece ritorno. Il faro della fiducia si spegneva gradatamente sull’oceano dell’inconsapevolezza. 94 Questa fu la cosa più angosciante: il non sapere. Se le avessero comunicato che suo padre era stato colpito, oppure deceduto, ebbene sì, avrebbe comunque sofferto, ma forse dopo, poco alla volta il dolore sarebbe passato e con esso attenuato anche il tormento. Almeno se ne sarebbe fatta una ragione. Invece così era una punizione illegittima, una sevizia interminabile. Prima di partire, le aveva assicurato che sarebbe rimasta ad aspettarlo, e così fece. Malgrado la responsabilità che gli zii assunsero nei suoi confronti, e nonostante le molteplici mozioni affettive ricevute dei ragazzotti della valle, lei difendette a spada tratta il ruolo conferitole dall’uomo che le stava accanto su quella foto, con lo spirito forte e deciso che a suo tempo aveva guidato anche Penelope. Per i primi anni i suoi pensieri erano rivolti solo ed esclusivamente al genitore. Considerava quella situazione come la causa di un banalissimo errore di percorso, un semplice ma fastidioso intoppo sulla carreggiata della vita, una momentanea interruzione del cammino che avrebbero dovuto condividere insieme. Poi cominciò a prendere in considerazione la probabilità che la guerra se lo fosse effettivamente portato via, rendendolo 95 servibile soltanto per alimentare i vermi e il ricordo. Ecco che la morte ancora una volta la sfiorava, entrava nella sua vita confrontandola con un nuovo dolore. Ma perchè? Lei che non aveva avuto la gioia di conoscere sua madre, perché adesso era stata privata anche dell’altro genitore? Perché questo accanimento contro la sua persona? Si faceva spesso queste domande, ma non riusciva a concretizzare risposte. A mano a mano che passava il tempo cambiavano pure le interpellanze formulandone di nuove, continuamente. Pensava a tante cose. Troppe. Per esempio che lei sarebbe invecchiata e i suoi capelli avrebbero perso il colore evidente, biondo mielato, invece suo padre sarebbe rimasto sempre lo stesso, verosimilmente uguale a com’era nella foto sul comò. Quante volte le sarebbe piaciuto riaverlo vicino, dialogare con lui, uscire in giardino e farsi ripetere il significato dei fiori; sbeffeggiare la sua voce, scimmiottare i suoi gesti, odorare il suo odore. Magari annaffiare le piante e provare a far germogliare le orchidee, le quali nel frattempo si erano tutte seccate. Sarebbe magnifico pozzare ancora una volta i piedi nelle artiche acque del Leno, per poi scongelarseli davanti agli alari incandescenti, 96 stirargli la camicia della domenica, vedergli comparire in volto le prime rughe. Perché ci si impoverisce quando una persona cara viene a mancare, ci viene sottratto parte di quel tesoro che non sapevamo di possedere, di un valore che mai avremmo immaginato quanto fosse quotato. Ci viene a mancare la sua forma, il suo contenuto, in un certo qual modo il suo modello di vita, che è molto di più di quello vissuto, di quello succeduto. C’erano troppe esperienze che doveva ancora realizzare. Che dovevano ancora realizzare. Ma perché? Perché rischiava ogni giorno di sragionare? Fu sempre più convinta di quanto legittimo fosse il presupposto in cui, dal momento che una persona non c’è più, questa continua comunque a viverci addosso. Quindi bisogna ospitarla nella propria intimità costringendosi quasi ad offrirle un’altra chance, una nuova rinascita. E farlo nel modo più dolce e indolore possibile. Adesso, quando pensa a suo padre, quel dispiacere è sempre accompagnato da un sorriso, il sorriso che lui aveva sempre. Sono passati quasi sessantacinque anni da quando le loro vite si erano separate e in tutto quel tempo non ha fatto altro che cercare di trasformare il male provato in una forza 97 dirompente. Il rapporto che prima s’era creato tra padre e figlia non è cambiato, si è solamente perfezionato. Papà non mi abbandonare. Non abbandonarmi mai, si ripeteva Donata in continuazione. E lui non l’ha mai fatto. Ancora adesso che la chioma dorata aveva lasciato il posto ad una argentea acconciatura e il corpo raggrinzito stava giorno dopo giorno percorrendo faticosamente l’ultimo tratto di una longeva vita, ecco che lo ritrovava sempre lì, accovacciato nel suo angolo personale ma pur sempre libero di gironzolare tra i meandri del suo cuore e quelli della sua mente. Garbato, silenzioso, pronto a intervenire nelle situazioni di emergenza, preparato a rispondere a tutte le evenienze, quelle alle quali nei lunghi periodi di crisi spesso e volentieri veniva richiesto un suo aiuto. Il dignitoso viaggio che Donata scelse di percorrere per riuscire campare, e che comunque fino a qualche anno prima riusciva a impugnare saldamente, si stava ora lentamente sgretolando, sfarinandosi come una franata ghiaiosa dopo l’inverno. Lei, che nella casa del fornaio era stata un pilastro di granito. 98 Crescendo aveva imparato a cavarsela. Sapeva cucire, fare di maglia e cucinare; tanto lavorava nei campi quanto rassettava la casa, conservandola sempre linda e profumata. Era stata proprio questa sua dote a fugare i dubbi su una scelta non particolarmente così scontata. La famiglia Arlanch discendeva da una lunga generazione di fornai. Padre, madre, sette figli immancabilmente maschi più una, l’ultima, la meno attesa, uno sbaglio di calcolo espulsivo, un semplice errore di valutazione, la quale a dispetto di tutti – ma pure per la gioia di tutti – se n’era uscita femmina; un nonno paterno, tre gatti, sei galline, otto conigli, un fagiano adottato e un cane. Oltre alle pulci che quel figlio di un cane si portava a spasso ogni santo giorno. Indivisi dentro la stessa casa, sotto lo stesso tetto; tutto un mondo che ruotava attorno a una panetteria mai ferma. Fornai loro stessi. Di notte a impastare, di giorno a vendere: pagnotte croccanti e profumate, sfilatini, biscotti secchi, prodotti di alta pasticceria. Vendere il pane per comprare il frumento. Comprare il frumento per ricavarne farina e con quella infornare il pane, che immancabilmente poi si vendeva, per comprare il frumento e tutto il seguito. Una gigantesca ruota che gira, come quella sul canale che col 99 suo roteare rendeva fluido il pesante movimento delle macine. “Osserva, non sarà l’industria della seta” diceva il nonno al nipote più grande quando scendevano giù, al reparto macinazione, “ma è pur sempre una gran bella industria. E’ stato mio nonno a iniziarla, in seguito mio padre ci fece dei lavori di ammodernamento che io conclusi. Successivamente l’ha presa in mano tuo padre che, come puoi constatare tu stesso, ora ne trae profitto. Tuo sarà il dovere di mantenerla.” Il nipote suddivideva la sua prospettiva lavorativa tra gli assordanti ingranaggi di quella diavoleria produttiva e i silenziosi nonché desolanti pascoli alpini. “Che giramento di pale” replicava cercando di non farsi sentire. I due genitori lavoravano giorno e notte, dentro quel forno. Assiduamente. Sembravano fatti di piombo invece che di carne e ossa. Come fecero a sfornare otto figli questo rimase un mistero. Un giorno la madre, stremata per l’ennesima fatica, formulò al marito una propria richiesta. “Mi serve aiuto.” “Provvederò io stesso a trovare ciò di cui abbisogni” le rispose convinto. 100 Un rango familiare oberato di lavoro come quello del fornaio non poteva farsi mancare una collaboratrice. Una donna che si occupasse di una parte dei lavori domestici era diventata una necessità e, a maggior ragione, presso una famiglia che deteneva un conto economico tale da non accorgersi minimamente di quella spesa extra giacché, se il dieci per cento delle chiacchiere che circolavano per strada corrispondeva a verità, in quella casa la pecunia occupava in toto il volume assegnatole nel doppiofondo del comò. Il profumo di un lavoro decoroso attirò le femmine della valle come orsi appresso un alveare. Le aspiranti furono parecchie ma chi per un verso chi per l’altro vennero tutte scartate. Tutte tranne Donata, vagliata per le referenti doti. Fu assunta in pianta stante e, nel giro di pochi giorni, venne nominata contemporaneamente: – Caposquadra igiene domestica; – Prima educatrice per l’infanzia; – Chef de rang nonché de cuisine; – Addetta al servizio di lavaggio, stiraggio e stoccaggio di un sempre più elevato massiccio di biancheria per l’uomo la donna il bambino, nonché per la casa e, inoltre – Pronto Intervento Veterinario. Insomma, da sola o affiancata alla padrona di casa doveva saper far fronte a tutte queste 101 incombenze. Il compito principale era quello di tenere pulita sia l’abitazione domestica che il forno stesso. Poi doveva accudire i figli, in particolar modo i più giovani, preparare da mangiare – per tutti naturalmente –, rifare i letti, rifocillare gli animali, e alla fine, se avanzava tempo, poteva badare al nonno. Sei giorni la settimana. Cinquantadue settimane l’anno. Di fronte a tale richiesta non disperò, anzi, tutto quel darsi da fare le erogò una carica inaspettata. Così puliva, ramazzava, spolverava, e al tempo stesso si guardava attorno. Stava spesso giù, nel laboratorio. Anelava il desiderio di imparare. Quelle che prima erano soltanto occhiate sporadiche, col tempo e la confidenza ottenuta si trasformavano in osservazioni dettagliate e domande sempre più mirate. Apprese cose nuove. Assimilò. Alla fine ci mise le mani, era inevitabile. Si sa che l’indiscrezione è femmina e se per di più, oltre che curiosa quella femmina è anche a dir poco intuitiva e perspicace, allora la frittata è fatta. Non ci fu da meravigliarsi se a soli pochi mesi dall’assunzione al nuovo incarico, modellare e infornare panetti di farina cruda, salata, impastata e lievitata divenne una delle sue 102 specialità. Assorbì in fretta i trucchi del mestiere. Ora ambiva soltanto alla perfezione. Furono anni sudati ma ricchi di soddisfazione. Venne accolta in casa come una zia, o meglio ancora come una figlia, e lei con la stessa moneta ricambiava. Lavorava sodo, quello è vero, ma veniva trattata bene. E poi essere costantemente a contatto con un mare di gente era certamente meglio che starsene tutto il giorno da sola a vedersi fuggire via gli anni e le vita; per di più il compenso ricevuto, sommato a qualche piccolo extra, faceva passare anche il mal di schiena più acuto. Scorreva veloce lo sgambettare delle stagioni. Il cuore della valle pulsava. Ogni tanto una cellula sgarrava come una sorta di extrasistole, saltava un battito, sacrificato a una sorte certa, ma poi ripartiva, immediatamente, ristabilendo il ritmo che s’era smarrito. Assistette al trapasso del patriarca, all’invecchiamento del padrone e della sua consorte, e fu testimone della crescita dei ragazzi. Giovanotti cresciuti un po’ così, con una madre e un padre che non erano propriamente dei genitori autoritari, sottoposti alla pedagogia di una donna che non era per l'appunto un’educatrice scrupolosa, e venuti su come puledri allo stato brado, forgiando il 103 carattere irascibile, burbero e litigioso degli irascibili, burberi e litigiosi uomini di montagna. L’unica cosa che non assorbirono affatto era la sacrosanta voglia di lavorare di cui gli irascibili, burberi e litigiosi uomini di montagna per qualche oscura ragione si ritrovano intrinseca; forse perché l’ultimo sfilaccio se l’erano spazzolato via i due infaticabili genitori. Due di quei figli, quelli che a incrociarli venivano additati come i più mansueti, trovarono moglie; gli altri cinque no. Forse perché in giro non c’erano così tante femmine bendisposte a sopportarli, oppure perché avevano gusti difficili quei cinque scavezzacollo, chi lo sa. In ordine ti tempo la sorella fu la terza ad accasarsi. Capì che sarebbe stato amore vero fin dal primo istante che Egli si mostrò: un autentico colpo di fulmine. Testualmente parlando si potrebbe dire che galeotto fu il tocco di quel Dio capace di depredarle il cuore. Terribile e misericordioso allo stesso tempo. S’infatuò del Signore in maniera quasi morbosa, d’altronde si sa che Lui è maestro nel farsi amare; come nel farsi odiare se è per quello, mettiamoceli pure i puntini dove ci vanno... I due anni di fidanzamento furono un postulato di dubbi e interrogativi che alla fine 104 convennero nel sacramento del matrimonio. Il rito nuziale venne celebrato alla fine del noviziato, nel preciso momento che le furono consegnati i voti, a Fabriano, dentro il monastero benedettino intitolato a S. Luca, dopo una pomposa cerimonia durata quasi quattro ore. Alla cerimonia assistettero anche i genitori, che sedevano ai primi posti della seconda fila di banchi, davanti a una numerosa folla di credenti e di fronte a un Abate e una Abbadessa che da quel momento si fecero garanti che l’obbedienza, la povertà e la castità suffragate non venissero mai perse di vista ma preservate dalle aggressioni della vita e custodite inalterate e inattaccabili all’interno di un monastero, non a caso cintato da spesse grate di ferro e alte mura di pietra. La clausura era una prova d’amore più imposta che scelta. Da quel giorno oltre al domicilio cambiò anche il nome. Ora si chiamava Agata. Suor Agata, per la precisione. Perseguì il suo cammino di fede con la consegna dell’anello, il velo nero, la cocolla per i canti e il libro delle preghiere. L’auto sostentamento e la Lectio Divina – la lettura approfondita delle Sacre Scritture – cominciarono ad occupare gran parte del suo tempo. Il resto lo spendeva nella partecipazione attiva alle messe e ai canti liturgici. Suo padre 105 non era mai stato completamente d’accordo riguardo questa sua scelta. “A cosa serve una monaca?” le aveva chiesto uno di quei giorni duri da digerire. “Praticamente a nulla” le rispose soave la figlia. “Come a niente servono i fiori, la poesia, le arti come la musica, il canto e tutte le cose che non ‘servono a’ produrre immediatamente qualcosa. Ma perché tutto ciò che non ‘frutta’ viene ritenuto inutile? Viviamo una cultura del simbolo, il servizio di noi monache è nell’ordine del segno. Il Gaudium et spes cita che alcuni di noi sono chiamati a dare testimonianza manifesta della dimora che attende ogni uomo nel cielo e a conservare vivo nella famiglia umana il desiderio di questa futura residenza.” Di fronte a tale risposta suo padre desistette, levò volta agli ormeggi e lasciò andare la chiatta della risoluzione, ritrovandosi su una banchina deserta senza addii e senza rimpianti. Dal giorno dell’internazione di sua figlia non seppe più nulla. I fratelli celibi, intanto, salvaguardavano l’anima e il corpo dalle fatiche della vita: non studiavano, non lavoravano; per farla breve non facevano nulla di utile. Frequentavano un bar dopo l’altro, tutto il giorno con le mani in 106 mano. Il loro passatempo preferito era scannarsi per chi riusciva a sudare di meno, litigando in continuazione. Su una cosa però ci fu comune accordo, una decisione che al momento conclusivo aveva sicuramente smosso il basamento di alcuni tumuli e incrinato di brutto le sovrastrutturate lapidi in marmo: ad un certo punto della loro vita d’adulti – più o meno responsabili e raziocinanti, molto meno che più… – convennero nel vendere in blocco il mulino, il laboratorio e il forno: l’attività intera insomma. Nessuno dei presenti aveva la più pallida intenzione di proseguirne le orme tracciate dai bisavoli lungimiranti: alla facciaccia loro e dei parenti tutti! Si tennero la casa padronale, quella sì, e lo fecero solamente per non far morire di crepacuore gli anziani genitori, e perché poteva offrire ancora un riparo agli scapoli nullafacenti. All’indomani della stipula del contratto Donata si trovò obbligata a recuperare i suoi effetti personali e andarsene. La sua presenza era diventata scomoda. Un oggetto che non serviva più. I suoi servigi da imprescindibili divennero eccedenti. 107 “Ce la possiamo sbrigare da soli” le dissero. Ma la verità era un’altra: le risorse economiche si stavano assottigliando spaventosamente. E questo era un grosso guaio per tutti. Il vino e l’ozio formano la miscela perfetta per dilapidare un patrimonio, specialmente quando un mucchio di soldi finisce nelle mani di chi, quelle stesse mani, non le usa se non per calarle addosso al prossimo o per serrarle attorno a un bicchiere. Oltretutto di chi non le usa come non usa il cervello, e lì, di scervellati, ce ne stavano parecchi. Di fatto successe che Donata era stata sollevata dall’incarico, esonerata, licenziata: mandata via insomma. Ma quello che maggiormente a lei dispiaceva era il fatto di doversi distaccare da quella che per anni aveva ritenuto la sua riacquistata famiglia. Per una donna di una certa età, che riesce ad affezionarsi anche al più insignificante filugello di gelso, be’, affrontare il commiato è un ulteriore stringimento a un cuore già stretto di suo; un patetico lasso di tempo difficile da affrontare, svenevole, da risolvere il più in fretta possibile se si vuol sopravvivere. Fin quasi da mettersi a letto e alzarsi l’indomani, a fatto compiuto. Ma, siccome il sonno non s’adatta al giorno, si ritrovò costretta a 108 raggrumare le ultime scorie di coraggio per affrontare con determinazione ogni singolo esponente di quella nuova ma ormai scemata famiglia. Erano tutti là, schierati sul ciglio della strada come un viale alberato. I sette figli maschi e le due nuore. Ambedue gravide, le nuore. Nove linee stagliate all’orizzonte, conservatorie della solenne immobilità di un plotone d’esecuzione. Uno di fianco all’altro come giorni stampati su un calendario. Ne mancavano tre: la monaca e i due vecchi. La religiosa si capisce, ma i padroni? Come mai di loro non c’era traccia? Erano forse deceduti quella notte stessa? Poco plausibile. Forse si sentivano peggio di Donata, incapacitati d’affrontare un addio? O forse era il boicottaggio della vergogna a preponderare? Lì, in mezzo alla strada, dove si consumava l’ultimo sacrificio umano si stavano immolando le aspettative genitoriali e quelle di una sguattera al Nume della follia. La brezza convogliava raffiche a mulinello. Il sole bruciava. Le linee tiravano un’esile filo d’ombra. Poggiò la valigia, Donata, squadrando l’insieme. Serbò l’irremovibilità di un generale in rassegna quando s’avvicinò ad ognuno di loro. Li salutò ad uno ad uno. Li abbracciò. 109 “Statemi bene, figli miei” disse. Riscosse solo un cenno con la mano, freddo e distaccato. Poi, con un pizzico di malincuore, diede un’ultima occhiata al mulino e alla gigantesca ruota che adesso stava ferma come mai lo era stata negli ultimi ventisette anni quattro mesi dodici giorni e una triste manciata di ore. All’estremità di un paletto s’era imbrigliato un canovaccio. Sbatteva gioioso il tessuto al vento. L’addio del mulino alla donna che l’aveva accudito. L’unico grazie ricevuto. Si girò senza enunciare lemmi, anche perché qualsivoglia cosa ne fosse uscita sarebbe stata blasfema, e nel girarsi i suoi occhi sfiorarono le finestre padronali. Un’ombra ondeggiava dietro la tenda tirata. Riconobbe la sagoma, che però come un lampo s’era già dileguata. Restò un istante a cercarla, quell’ombra ingarbugliata, nell’esile speranza di un ravvedimento, che tuttavia rimase a venire. Allora svincolò lo sguardo, afferrò la valigia e riprese a camminare. “In bocca al lupo, Donata” sentì augurarsi alle spalle. “Crepa” rispose affagottata in una clamide di stizzita. Lui, il vecchio, colui che l’aveva anni addietro assunta, spostò il lembo della tenda. 110 Era un cotone a maglia larga, sottile, dalla trasparenza confusa, enigmatica. Nel senso che chi stava dentro poteva benissimo osservare chi stava fuori, ma non viceversa. Scostò quell’orlo e guardò. Anche lui stava lì sotto, al suo fianco e, se non fisicamente, stava comunque redarguendo i ragazzi che erano i figli suoi purtroppo, ma che mai come adesso avrebbe voluto non lo fossero, perché non era in quel modo che si lascia andare una di casa. Mascalzoni irriconoscenti! Ma la sciatteria contratta con l’avanzar dell’età non lo aiutava per niente anzi, lo autorizzava a non fare nulla per imporsi. E non c’entrava il rimorso, neanche l’insonnia conosciuta in quegli ultimi anni. C’entravano un pugno di ragazzi, sedie vuote che gli stavano intorno, passi che cambiavano direzione quando lo incontravano, pezzetti di un pane duro che si sbriciola invece di affettarsi. Questo lasciava a intendere lo sguardo di quell’uomo barricato dentro casa, e se avesse avuto vent’anni di meno avrebbe fatto vedere loro di quale impasto egli fosse composto. Morso da un’odiata vergogna piuttosto che sopprimerla la foraggiava, cercando di scomparire dietro il cortinaggio di una finestra anonima. Ma ormai cosa importava? Lui era lo stesso giù ad 111 abbracciarla, a dirle quanto mai fosse dispiaciuto nel vederla partire, sapendo perfettamente che stavolta mai più si sarebbero rivisti, dentro quella casa. Picchiettò le scarne dita sul vetro, debolmente. Troppo fragili quei colpi. Un mai arrivato addio telegrafico. Riabbassò la tendina, prese una seggiola e si sedette. Cercò il cesto della frutta secca. Lo trovò poco distante. Era vuoto, se non considerava l’unica noce che si perdeva al suo interno. Ripulì il cesto sopprimendo anche quella. Spaccò facilmente il guscio con le sue dita nodose ma ancora possenti come querce. Ne estrasse il gheriglio e se lo cacciò in bocca, dando morsi feroci come spremiture; ma nemmeno un po’ assaporò il gusto amarognolo e astringente del tannino e di olio vegetale che si liberavano a compromettere un palato aspro. Chinando lo sguardo scoprì il buco nel calzino: almeno quello si poteva rammendare. Vicino a lui sua moglie lavorava di maglia. Gli occhiali sul naso. I capelli raccolti a cruccolo sotto un pizzo di cotone agganciato con le forcine. Faceva e disfava, disfava e faceva, dando strappi rabbiosi alla lana che quel giorno non c’era verso di far stare annodata su quei maledetti ferri. 112 “Sai una cosa?” le disse il marito. “Dio c’ha punito donandoci la fertilità, fossimo stati sterili non avremmo picchiato il culo tanto in basso.” “Parole sante” rispose la donna. Trentasette minuti dopo Donata calpestava il lastricato del suo paese natio. Lo stesso passo mantenuto per tutti quegli anni quando le notti del sabato rientrava per il sacrosanto riposo domenicale. Quaranta minuti dopo intravvedeva lo sterpeto ricoperto da cumuli di calcinacci e sporcizia ammucchiata. Erano i rimasugli spinosi della rinsecchita barriera naturale quale era stato il suo rigoglioso gelsomino. Sempre una botta al cuore quello scompiglio, uno choc elettrico erogato al centro del muscolo cardiaco. Che bastardi! pensò mentre apriva la porta di casa, quarantuno minuti dopo. Ritornò ad abitare casa sua come un tempo, e come un tempo per tutto il tempo concessole, che adesso era proprio tanto, il tempo a disposizione. “Ben ritrovata cara vecchia casupola. Eccomi di nuovo tra le tue solide mura. Ancora qui ad aspettarti, papà.” E quello fece. Per il resto dei suoi giorni. 113 Lì dentro ritrovò i ricordi perduti. Riaffiorarono memorie che avrebbe gradito fossero dissolte nell’oblio, scadute di validità. Rinvenne in lei una personalità misantropa e scontrosa, forse più selvatica di come l’aveva accantonata cinque lustri e mezzo prima. L’eredità di una famiglia che alla fine s’era dimostrata piuttosto irriconoscente. Ma lo stesso non si diede per vinta. Quella che scalpitava sotto il suo sedere, la cavalla della sua esistenza, estremamente convinta di aver saldamente imbracciato, trattenuta per le briglie, tutto a un tratto si era rivelata per quello che era. Il completamento di un’esistenza che rimpallava al contraccolpo di un pensiero. Inaspettatamente le redini si erano sciolte e la bestia liberata. Cominciò così un galoppo fatto di analisi e riflessioni. Le introspezioni furono all’ordine del giorno. Dedusse, confrontò, capì. Deliberatamente scossa da non pochi turbamenti, si accorse quanto la situazione era stata abile nello sfuggirgli di mano. Un prodigioso numero da circo. Uno strabiliante gioco di carte. Rimase allibita nel notare il rimbalzo avvenuto nel corso degli anni. I giorni acceleravano il passo, sempre di più, sempre più veloci, mettendosi persino a correre come 114 ladri smascherati, o come puledri spronati all’impazzata, ultimando quel moto in un susseguirsi convulso, incontrollato, perpetuo; e alla fine mostrandosi soltanto come un attimo, un movimento, un battito di ciglia. Il tempo aveva la facoltà di trasportare le persone con la potenza cosmica di un buco nero, capace di risucchiare al suo interno le altrui esistenze e trasferirle in un’altra dimensione. Era questa la dimensione di un mondo visto con gli occhi stanchi di una donna ritrovatasi anziana, costruito con giornate tutte uguali, talmente affini da scorgere in ognuna una sua diversità. Come i tramonti che a guardarli sembrano tutti uguali ma ogni volta regalano emozioni differenti. E le lunghe notti passate ad ascoltare la voce del buio, sperando nell’indulgenza di un sonno non più amico. Infine ancora il mattino, smaniosa di assaporare in silenzio le meraviglie dell’alba novizia, sentirsela scivolare sulla pelle come la morbida carezza di un fanciullo. Un tocco delicato che acquieta e rasserena. Era questo il momento in cui quotidianamente faceva visita al cimitero militare ubicato sul terrapieno sottoposto al paese, il luogo ideale per parlare con qualcuno 115 che, come suo padre, non ha mai più fatto ritorno a casa. Quando se ne ricordava si portava appresso un mazzolino di fiori di campo e li depositava nel bicchiere collocato ai piedi dell’eccentrico crocifisso ferrato sovrastante il camposanto. Dalla fontana situata sul tornante della strada provinciale attingeva un po’ d’acqua e la versava nel calice arrugginito. Sempre. Tutti i giorni. Poi parlava ai suoi ragazzi, più di settanta croci in legno assolutamente uguali, anonime, supplichevoli. Pregava per quei giovani senza nome e senza patria, pregava per suo padre. Pregava per se stessa. Dopo alcuni minuti di solitaria conversazione terminava il discorso segnandosi con la mano come la fede cristiana precetta e, benedicendo le tombe degli sfortunati combattenti, riprendeva mestamente la strada di casa. Risaliva con fatica la massicciata, con il sampietrino sempre più dissestato se non, per diversi tratti, addirittura divelto. Strascicava i piedi, la donna, desiderando il respiro che ogni volta le si invischiava in gola. I polmoni reclamavano ossigeno, e l’energia dei muscoli disertava. Arrivata a casa si sarebbe preparata qualcosa da mangiare, poche e semplici 116 pietanze sufficienti a nutrire una donna debilitata dall’età e dalla malattia. Poi, con occhi provati, avrebbe letto le rime di qualche annoso e rovinato testo di poesie; poche a dire il vero, ma che risultavano perfino eccessive rispetto a ciò che riusciva a distinguere sopra quelle pagine decisamente consunte o addirittura mancanti. “Fatevi sotto che vi scucio l’anima!” pronunciava. Si rivolgeva ai libri come fossero individui. E da questi – come questi – il più delle volte veniva accantonata. Gli impedimenti alla leggibilità la costringevano a procedere con lentezza, a sormontare le difficoltà, a usare tutta l’esperienza, il sapere e l’immaginazione per dare corpo alle parole ombra, ma quegli ostacoli non la intralciavano. Anzi, le parole coi contorni sbiaditi, le liriche illeggibili plasmate in versi sfocati, oscillanti, sembravano pulsare di significato, palpitare di vita; al contrario di lei che si sentiva spenta di malinconia. L’orologio a colonna avrebbe contrassegnato il passo del tempo clemente con rintocchi a scadenza programmata, finché in un punto ben preciso del mandato, seduta davanti alla vetrata del balcone avrebbe finalmente incontrato la sera, rimirando ancora una volta il tramonto 117 che si stava delineando. Un tramonto analogamente diverso da tutti gli altri, ovviamente. Pertanto, il giorno dopo, ogni cosa sarebbe ricominciata. 118 oggi Un uomo, pensa terrorizzata. C’è un uomo in camera mia. “Chi…” All’inizio riesce solo ad emettere quel fragile sussurro che nessuno che si trovasse dall’altra parte della stanza avrebbe mai potuto udire. Prova ad inumidirsi le labbra con la lingua e riformula la domanda. Tiene le mani così strette da non sentirsi più le dita. “Chi sei?” Ancora un sussurro, ma questa volta con un po’ più di vigore. La figura non risponde, rimane ferma dov’è, come priva di vita. La troica formata da ombre, luna e vento, contribuisce a rendere il momento terribilmente ambiguo e, per la prima volta, la ragazza dubita della concretezza del suo visitatore. Prova quindi ad osservare meglio la 119 scena, mettendo in discussione il suo risveglio con la possibilità di essere rimasta incatenata al suo stesso incubo. Ed è proprio in quel momento che l’ombra si muove, staccandosi dalla parete di fondo. L’incubo non è finito. Quell’individuo s’avvicina minaccioso. Semiparalizzata dalla paura intravede nell’ombra i suoi occhi. Due circonferenze incandescenti che la fissano ma, inspiegabilmente, si sorprende nel constatare che non sembrano intenzionati a farle del male. Tutt’altro, l’oscura figura possiede qualcosa di affabile, di familiare e il suo silenzio non trasmette apprensione ma accende fiaccole di fiducia, lumi che effondono sicurezza. E sarà proprio l’enunciazione di alcune parole a coordinare la sua mente. Abbozzando un tiepido sorriso quell’essere inizia a parlare. Con tutta la dolcezza di questo mondo, dalle labbra screpolate dell’uomo esce una semplicissima frase; ed è solo in questo preciso istante, nel riconoscere quella voce, che il suo cuore quasi s’incricca. “Dai piccolina, alzati che è tardi.” “Papà?” chiede la ragazza alzandosi di scatto. “Forza, alzati, senza tirare fuori scuse come fai sempre.” 120 Sgrana gli occhi sbalordita, strabocchevoli d’incredulità. “Sei tu, papà?” Si guarda attorno cercando la materialità della sua stanza, la conferma che tutto questo sia reale. “Si amore, sono io, sono tornato.” L’uomo appoggia le mani alla pediera, sedendosi a bordo letto. Non è possibile, suo padre si trova davanti a lei, vivo e vegeto, tutto intero e… sorridente. Pazzesco, da non crederci. Forse sta ancora sognando, malgrado avverta una sensazione di tangibile risveglio. Chiude gli occhi per un attimo e li riapre. Lui è ancora lì, seduto sulla falda del letto. “Oh papà, finalmente… da quanto tempo ti attendevo. Hai visto che ti ho aspettato! Ma dov’eri finito… Che bello papà… sono stata brava? Gli zii non ci sono, sono andati a Rovereto… però… mi avevi spaventata, prima… Oh papà…” “Ssss! Calmati tesoro, cosa ti succede che sei tutta agitata? Lo so che gli zii non ci sono, per questo sono venuto io a svegliarti, personalmente.” “Ma papà. Sei stato via così tanto tempo. Non abbiamo più ricevuto tue notizie e…” 121 “Esagerata! E’ stato solo per un breve periodo, cosa vuoi che sia. Ti avevo promesso che appena potuto mi sarei fatto vivo: le mantengo io le promesse. Devi sapere che la guerra è una brutta bestia, non sai mai quello che ti serba, quanto possa essere dura, e spietata, e cinica. Comunque adesso sono di nuovo con te e ti posso assicurare che stavolta non ci separeranno mai più.” “Ti voglio bene papà…” Ad un tratto il suo sorriso viene a scemare e l’espressione è un accorato taglio degli occhi. Continua: “I fiori papà… i fiori… sono…” “Li ho visti amore, sono stupendi. Grazie per il tuo aiuto.” “Ma…” “Sì, anche le orchidee, meravigliose.” Alza il braccio, ma diversamente da quello che si era immaginata, nota con stupore che l’aggeggio impugnato da suo padre non è un coltello ma, per l’appunto, un rigoglioso esemplare delle sue Galearis. L’uomo porta il fiore alle narici aperte. Socchiude gli occhi. Riempie i polmoni. Annusa il fiore assaporandone lo straordinario effluvio e lo porge a Donata. Lei osserva con straordinaria ammirazione. E’ la 122 seconda volta in pochi minuti che non crede ai suoi occhi. “Adesso alzati che ti devo far vedere una cosa” dice Pietro mentre le accarezza i capelli arruffati. Incuriosita, con un balzo felino salta dal letto, lascia la stanza e scende a rotta di collo le scale, saltando due gradini alla volta. Era tornato suo padre e non voleva perdersi nemmeno un minuto della sua compagnia. Aveva talmente tante cose da chiedergli che ogni secondo sprecato sembrava irrimediabilmente perso. Entra nel tinello, dove si espone ancorato alla parete un capiente lavello in pietra. Più alto ci sta lo stipetto, a fianco lo specchio perlato e, sotto, un ossuto sgabello sopra il quale s’appoggia la grolla colma d’acqua. Ne prende un po’, versandola nel lavamano. Poi afferra il sapone di lavanda, lo mette a contatto con l’acque e se lo passa sul viso, sulle braccia, in centro alle gambe. Voleva farsi bella per cui era spinta dall’urgente bisogno di detergersi. Doveva far piazza pulita dei ricordi, lavar via il dolore che le si era accumulato dentro durante tutto questo tempo. Desiderava strapparsi di dosso il senso di vuoto, procacciatore di sofferenza e di solitudine. Soprattutto doveva levarsi di dosso 123 l’insopportabile traccia lasciata dalla sua urina. Alza gli occhi ed ammira l’immagine rimandata dallo specchio. La donna che vede, malgrado sia fortemente stralunata e spettinata, riflette un aspetto a dir poco raggiante. Ricorda il fastidioso formicolio che al momento del risveglio le indolenziva l’avambraccio. Se lo era sentito intorpidito, assente nei movimenti e insensibile al tatto. Tuttavia era bastato un lieve massaggio per far allontanare il torpore e a restituirgli la giusta vitalità. La stimolazione manuale aveva fatto al braccio quello che suo padre stava facendo alla sua vita: con la sua presenza le stava iniettando nuova linfa vitale. Una sconosciuta medicina più forte e più potente di qualunque antibiotico in circolazione: il vero mistero della vita. Nella sua mente percepisce che qualcosa di inspiegabile stava succedendo. Sente delle fitte che non scaturiscono dal corpo ma dalla testa. Forse è proprio così, dopo un lungo e penoso travaglio Donata avverte le contrazioni del parto. Lo sviluppo illogico della cellula ha prodotto effetto. Una massa biologica dalle sembianze umane. La sua psiche sta concependo una nuova se stessa. E’ lava incandescente quella che le circola in vena, si sente viva, euforica, felice come un 124 usignolo. Come sono carina, si dice osservandosi, e come mi sento bene. Dalla cucina: un sordo gorgoglio. Acqua che bolle e aroma. Sbuffi di vapore. Il borbottio del caffè riconduce la ragazza al presente. Quanto le era mancato quel piacere mattutino; una delle tante cose che solo suo padre poteva ridarle. E lo respira come respirasse la vita, quella che le era stata negata, così delicata, fragile. E intanto si sente rinvigorire, prendendosi a carico nuova energia. Capisce di essere più forte. Potente e appagata come Dio. La voce di suo padre dall’altra stanza: “Vieni, o il caffè si raffredda. Sbrigati che poi dobbiamo uscire.” In quel momento il grammofono riprende a suonare, e la musica e l’aroma del caffè si avvinghiavano nell’aria, mischiando il sapore alla melodia. E danzano assieme, solo e unicamente per lei. “Arrivo!” le grida Donata. Grazie papà, grazie davvero. Prima di uscire sbircia dalla finestra. Vuole accaparrarsi lo schiarire promesso da un sole non ancora sorto; ma rimane impressionata nel notare un fatto straordinario. A tutto era preparata, tranne a questo. Lì fuori, sotto lo 125 spannare di un bosco ombroso, l’orto tripudia con una fioritura e un tramestio di colori straordinario. E la luce che irradia non è opera di scenografia. “Non ci credo” fiata. Indugia nell’esprimersi, interdetta e allo stesso tempo sbalordita. Per la terza volta quel giorno. “Dove mi porti, papà?” declama. “In un posto bellissimo, qui a due passi.” “Arrivo subito, concedimi un minuto per cambiarmi.” “No!” risponde perentorio. Intuisce d’aver usato un tono brusco nel formulare quel dissenso, quindi, notando l’attimo di smarrimento impressosi sul viso della figlia, cerca di riparare al danno assumendo un atteggiamento più conveniente: “Non serve amore mio, sei semplicemente bellissima e così vestita stai che è una meraviglia.” “Ma sono un disastro! Guardami, sono tutta spettinata, indosso ancora le ciabatte. E poi non posso mica uscire in camicia da notte!” “Rilassati, te l’ho già detto, andiamo solo qui sotto casa, e fuori, credimi, non fa affatto freddo. Non ti fidi più di me?” Con la gentilezza marcata sulle labbra e raffrontata nei movimenti le accarezza il viso, e nota che le si sgancia la corazza delle palpebre e si spiana un 126 minimo di sorriso. Le prende una mano. Si annodano le dita, si saldano i palmi, le allunga lo scialle e insieme raggiungono la porta d’entrata che, per quell’occasione, combina con quella di uscita. Come gran parte delle giornate invernali anche questa, protesa all’aspro cielo di gennaio, elargisce la sua giusta dose di freddo canino. Cristalli di brina sbiancano il terreno indurito, ammantando la superficie arida e liscia come un lenzuolo steso a protezione. C’è qualcosa da salvaguardare lì sotto, qualcosa da tutelare nel tempo e preservare al conseguente degrado. Il mondo scivola sul manto ghiacciato che unisce il cielo alla terra e dissolve in un grigio scarabocchio il frastagliato contorno delle montagne. La valle perde i confini e il fiacco silenzio aleggia come un sogno leggero sulle giogaie. Ogni suono ed ogni rumore si ode in lontananza, fin sull’altro lato del declivio. Il triste richiamo dei corvi e i primi passi di uomini e animali, unici segnali di vita, attraversando il paesaggio invernale preannunciano il risveglio di un nuovo giorno. Emerse da nuvole di fiato e condensa e congedate da una querimonia di foglie morte, due ombre indistinte affrontano la gelata 127 mattutina, barattando la calda protezione di una dimora con l’insensatezza di un percorso. Un tratto di direzione che fiancheggia lo stazionamento di un parallelepipedo cavo usato a fontana, il quale ora butta soltanto un rivoletto d’acqua ma che è assai sufficiente per alimentare l’iceberg formatosi attorno. La raggiungono. La oltrepassano, la fontana. Quella sulla curva, proprio sotto il paese. “Dove siamo diretti?” chiede ancor più incuriosita Donata. “In un posto che tu conosci bene. Ci stanno aspettando tutti. Ci sono anche gli amici tuoi.” “Quali amici?... Io non ho più amici.” Intanto s’apre la valle in scenari teatrali. Le luci dell’alba tinteggiano i passeri di un blu diluito. Le creste sono assorbenza per l’inchiostro della notte. I campanili evocano preghiere, penitenze, residenze eterne. La semi oscurità è avvolgente e penetrante, affine al vento polare che raschia per tutta la sua lunghezza i brumati terrazzi della Vallarsa: un gelido zefiro trascinato fin lì dalla mordace schiarita notturna. La ragazza avverte sulla pelle la lama pungente del ghiaccio, ma non lamenta alcun fastidio; non è il momento di soffermarsi su certe sottigliezze. Anche se il suo corpo esternamente è scosso da brividi 128 improvvisi, dentro spadroneggia un ardore dirompente. Riavere suo padre è quanto basta per riscaldarle il cammino. Raggiungono il noce dormiente. Lo oltrepassano. Raggiungono il tiglio sfiorito. Lo oltrepassano. Rasentano il diradato pendio. Misurano con lo sguardo il dislivello tra due future terrazze erbose. Ne constatano la pendenza. Non le oltrepassano ma le raggirano. Poco più avanti intravedono un bagliore. Alcune luminarie a petrolio appese ai meli e ai ciliegi di cinta colorano di luce un normale pianoro sterrato. Un vociare confuso, tanta musica. E’ quella di una vera e propria ganzega l’euforia che si eleva dal campetto sottostante la strada. Aria di festa. Di brindisi. Di ovazioni. Sicuramente lì sotto si celebra qualcosa. “E chi sarebbe il matto che festeggia a quest’insolita ora del mattino?” chiede Donata sbigottita. “Quei matti siamo noi” risponde lui, “e questa è la nostra commemorazione: quella per il mio ritorno e il proseguo di una futura vita insieme.” “No, non è possibile…” La prende per i fianchi. La fa avvicinare perché capisse. 129 Il prato è invaso dalle persone. Gran parte di loro giovani, più o meno dell’età di Donata, altri leggermente più anziani, anche se tra i quali, ad occhio, nessuno raggiunge l’età di suo padre. I maschi indossano una divisa militare, le femmine sfoggiavano un vestito lungo e sgargiante, da cerimonia. Parlano lingue diverse ma incredibilmente riescono a dialogare senza nessuna difficoltà. Scherzano e ridono, si divertono. Sembra, da come si comportano, che si conoscano da tempo. Quando scorgono Pietro e Donata, s’azzittiscono, uno dopo l’altro, come per riflesso, indugiando allibiti e allo stesso tempo incantati. Vi si profila uno scenario nuovo, diverso, mai interpretato. Un tipo alto, dinoccolato, con un viso scarno e gli occhi tristi di chi nella vita ha più subìto che ricevuto, s’avvicina alla coppia. Una spremitura di brillantina mette in mostra la riga perfetta dei suoi capelli, che luccicano non meno delle stellette di metallo sugli alamari e la collezione di medaglie che tiene spillate al petto. Saluta militarmente, portando di scatto la mano destra alla fronte e posizionandosi impettito sull’attenti. “Benvenuta signorina, la stavamo aspettando” dice l’ufficiale. Una ragazza da 130 dietro sperimenta un timido battito delle mani, che immediatamente viene plagiato dagli altri. Dopo pochi secondi l’intera guarnigione si unisce in un applauso scrosciante. Lei non capisce, ma non le importa. Si accosta al fianco di suo padre, quasi a volerci entrare. Lo percepisce un posto sicuro. “Quanta gente papà, ma io… io non conosco nessuno.” “Non è vero piccolina, tu li conosci tutti, e molto bene anche. Solo che prima d’ora non li avevi mai visti.” “Ma…” All’estremità opposta del prato, a ridosso della siepe che ne delimita il confine, un’improvvisata orchestrina da campo esegue musica da ballo. E’ il solito, inequivocabile repertorio viennese. Ognuno dei presenti, rapito dalla melodia del brano, cerca una propria compagna per offrirle un festoso giro di valzer. Donata è confusa, emozionata, le sembra di vivere un sogno sconnesso. Uno di quelli con le principesse e i cavalli bianchi, fatto di zucche e scarpette di cristallo, perse sulle infinite scalinate di austeri manieri. L’eterno sogno di una ragazzina smarrita nei meandri del proprio destino. 131 All’udir quelle note, l’uomo afferra Donata, la trattiene per il polso, se la tira delicatamente contro e, mentre la guarda negli occhi, sfila l’orchidea conservata fin da prima nell’occhiello della giacca e la intrappola con l’aiuto di una forcina tra i suoi capelli disciolti. “Adesso sei splendida” pronuncia Pietro sistemandogli l’acconciatura. Alla fine ci riesce. Erano secoli che non succedeva; anche se si impegnava o si sforzava, non arrivava al dunque. Solo adesso, svincolata dalle ganasce che per anni tenevano compresso quel sentimento, lui riesce a farla piangere. Non è il pianto di dolore quello, ma il pianto liberatorio, prodigo. Le si intorpidiscono gli occhi, allora le passa una falange sulle ciglia e le dice: “Ehi, cos’è tutta questa mescalina?” La goccia salata non conosce da troppo tempo la forma delle sue guance, la linea del suo viso, l’abbaglio che la colloca tra le palpebre socchiuse. Silenziosa per natura, da canali interni scivola giù, sobbalzando tra le pieghe di una smorfia, e a scavalcarla, e ancora più giù, fin sotto al collo. Viene cacciata dal pozzo di un cuore fiacco che sempre di più fatica a galleggiare. Dovrebbe considerarla una vittoria, questa. Una conquista inaspettata. E’ il 132 ricongiungimento alla sua gioia più pura, finalmente. “Vuole questa dolcezza degnarmi di un ballo?” “Certamente mio sire.” E si tuffano in quel delirio di suoni, a cavallo di una giostra fatta di gente in festa, assieme a persone alle quali era stata promessa una patria, un futuro, ma che in cambio avevano dovuto sacrificare le loro stesse vite. Eroi senza nome e senza gloria, figli di un paese che li aveva in parte dimenticati. Adesso finalmente una casa se la sono conquistata, e sta tutta dentro il cuore di quella donna. Più di settanta ragazzi uniti in una virtuosa danza collettiva. Più di settanta croci piantate nell’arido e gelido sottosuolo di un camposanto, ritrovando forse in quel posto la pace per cui avevano combattuto. La ragazza è in estasi, affascinata, come quando da bambina rimaneva ore ad ammirare mamma gatta che giocava coi suoi cuccioli, o quando stava assorta a valutare le innumerabili sfumature di un arcobaleno. Le gira la testa. Le salterellate circonferenze di pista danneggiano l’equilibrio. Allora si ferma, si toglie lo scialle e lo usa per cingere il collo a suo padre. Lo tira verso di sé, gli 133 sussurra: “Ti voglio bene papà. Promettimi che adesso la vizierai per benino questa tua figlia.” Così facendo gli recapita un bacio d’affetto e, con un gesto che lambisce la malizia, gli morsica lo zigomo sbarbato ma pizzicante. “Se è questa la tua richiesta, vedremo di soddisfarla. A meno che tu non mi voglia mangiare prima!” Ridono felici, come da tanto non succedeva. Riprendono a ballare. Alla fine di quell’orbita si sente stremata, il fiato s’è fatto grosso, la stanchezza e l’emozione per tutte quelle sorprese hanno preso il sopravvento. Sente le palpebre pesanti come macigni e il sonno che bussa incallito alla sua porta. Abbracciando suo padre le appoggia delicatamente il mento sul petto, abbassa lo sguardo. La riga degli occhi si salda. Un vuoto d’ombra l’avvolge. Si addormenta senza sognare. 134 domani Mario chiuse con un colpo energico il portellone posteriore del suo Fiat Ducato. Era da più di un mese che doveva far sistemare quella maledetta serratura, e se alla portiera non dava una spinta vigorosa e con la dovuta cattiveria, avrebbe corso il rischio che durante il viaggio si aprisse da sé, inavvertitamente, perdendo per strada parte del carico. La Famiglia Cooperativa di S. Anna occupava quasi tutto il pianterreno di un edificio di recente costruzione, l’istituto bancario insediava solo una piccola parte del fabbricato, il lato ad ovest. Sul pianoro di fronte si stendeva il piazzale adibito a parcheggio e ai lati si ergevano il teatro comunale, la scuola materna e il bar del paese. Un valido punto nevralgico per quel che riguarda l’economia 135 locale, non c’è che dire. Arrivò che lo spiazzo era immerso nella semioscurità e faceva freddo; un freddo foriero di neve, che però, se pur il terreno sotto i piedi fosse duro come il ghiaccio, il vuoto del cielo sopra la testa sbugiardava tale sensazione. Nel parcheggio regnava il deserto, nessun rumore inconsueto. Soltanto lo spasmodico abbaiare di un cane, proveniente dalle case giù a valle, dotato indubbiamente di gran voce e temperamento furente; e l’acuto sferragliare delle sue ceste metalliche che strisciava estraendole dal vano di carico e le accatastava sull’asfalto. In un paio di abitazioni si intravedeva una luce, qualcuno che stava sveglio. Nelle altre, cupe, probabilmente dormivano ancora. Finito di scaricare incastrò nella cesta dei prodotti la copia siglata della bolla di accompagnamento. Come sempre aveva sistemato tutto davanti alla griglia basculante, pronto per essere allineato più tardi sulle scaffalature espositive. Un rumore poco distante. Il fascio luminoso di due fanali in movimento. Una macchina che si avvicinava. A tutto gas. Arrivò lì in un baleno. Guadagnato il tornante liberò la sterzata, predisposta a inseguire una retta fatta d’asfalto e segmenti verniciati di bianco: a tratti continui, a tratti no. Trovatosi in 136 traiettoria puntò gli abbaglianti in fronte a Mario che, bestemmiando e portatosi una mano a visiera, si scostò di qualche passo, semi accecato. Il motore dell’auto rombava e gli pneumatici stridevano ad ogni curva impegnata. Quasi certamente un ritardatario che si dirigeva sul luogo di lavoro in tutta fretta. Qualunque fosse stata la sua meta era indubbiamente ancora distante, perché in un attimo arrivò e in un attimo se ne andò, portandosi dietro il frastuono del motore tirato per il collo e lasciandosi alle spalle centimetri di battistrada e puzzo d’olio bruciato. O quello è Niki Lauda o è pazzo, pensò il consegnatario. Sì, perché bisogna essere pazzi a correre in quel modo per andare a lavorare. In scia a quel concetto Mario si sistemò alla guida del Ducato. Accese una sigaretta e, scrollando il capo, avviò il motore. Partì nello stesso istante in cui con le dita pigiava lo start dell’autoradio. Di tanto in tanto lungo il tragitto buttava un occhio agli specchietti retrovisori. Meglio non fidarsi. Percorreva tutti i giorni quella strada, fin da quando aveva assunto l’incarico di smistare i prodotti caseari della Centrale del Latte di Trento ai vari spacci alimentari della zona. E giocoforza doveva farlo alle prime ore del 137 mattino, prima che i negozi alzassero le serrande. Abbassò leggermente il finestrino laterale per far sì che il fumo uscisse liberamente. L’autoradio cantava musica italiana. Anni sessanta. Oltrepassò il ponte di Arlanch che stava albeggiando. Leggera salita. Il motore diede una stizza di disappunto. Allora scalò una marcia. Fumo nero dalla marmitta e rumore di ingranaggi; ma fu una terapia azzeccata perché in un attimo il furgone riprese a respirare. Rinvigorito puntò l’erto che agguanta il paese di Anghébeni. Sopraggiunta l’ultima curva, poco prima delle case, girò istintivamente lo sguardo verso il declivio. L’aprirsi della valle era scenografico. Al punto focale: la Vallagarina. Sui fianchi: boschi vigorosi, vitigni e coltivazioni ortofrutticole. Appena sotto: il sepolcreto militare. Fu su quello scorcio che venne attratto da qualcosa di insolito, qualcosa che spiccava nella penombra, come se una strana configurazione alterasse la rigorosa linearità del camposanto. Parcheggiò sulla banchina, scese gettando il mozzicone sull’asfalto. Ci pestò sopra e, con un espiro liberatorio, esalò l’ultima boccata di fumo. Poi, a piedi, scese il sentiero. 138 L’avvicinarsi a quella forma confermò l’ipotesi formulata: accasciato ai piedi di una malmessa, visibilmente sghemba croce lignea, giaceva il corpo di un essere umano. Braccia protese. Mani increspate come mare in burrasca. Mani ferme, quindi passata è la tempesta: maltempo in evidente attenuazione. Ma il fatto strano era che, malgrado la rigida temperatura del mattino e l’inadeguata collocazione del soggetto, esso profanava la sacralità del luogo ricoprendo la sua nudità con una semplice, lisa, consunta camicia da notte. Tratteneva un infeltrito scialle di lana, l’inerte figura, probabilmente confezionato anni addietro dalle stesse mani che lo stavano afferrando. Con esso avvolgeva l’incrocio dei legni. Oltremodo allarmato si precipitò. Con l’avvicinarsi l’intuizione si fece certezza: quell’essere è donna. Anziana a vedersi. Ma chi? Con estremo tatto rollò il corpo, ed era come ribaltare un secolare tronco di pino appena segato. Il braccio contratto cadde sotto il fianco. Il dorso della mano toccò il pietrisco che risuonò come pacciame calpestato. Occhi, naso e bocca rivolti svelarono un nome. Donata?... Ma cosa ci sei venuta a fare qui sotto benedetta donna. 139 Mario, abitando a Foxi, conosceva fin da piccolo Donata. Sua madre, nel susseguirsi degli anni, lo aveva messo al corrente delle traversie subite. “Quella donna è stramba” diceva Mario. “E’ la vita che è stramba” rispondeva sua madre. Era a conoscenza del lavoro nei campi, degli anni passati al servizio di un fornaio. E ora, a sviluppo compiuto, pur biasimandola comprendeva quel suo mondo solitario che s’era proposta di ricalcare. L’aveva conosciuta che stava sola, la vedeva in giro da sola, e adesso se la ritrovava lì, incondizionatamente sola. Nel suo cerchio s’era creata la reputazione di una donna mesta, ostinatamente triste; non del tutto scoraggiata o remissiva, ma infelice sì, su quello i dubbi filavano via che era una meraviglia. Dava a chiunque l’impressione che dovesse rincorrere l’eterna ricerca di qualcosa, ma non s’era capito bene se di qualcuno o di se stessa. La prima impressione che uno si faceva, comunque, era quella di trovarsi di fronte una signora a modo, certamente strana, ma proba. L’onestà di chiunque si trascini dietro quella fievole luce. Il nebuloso vagabondare di chi ignora la via. La lucente traccia di una lunga aspettativa che forse, adesso, s’era compiuta. 140 Una faccia senza volto sembrava quella, opaca, senz’occhi, bocca, spoglia di parole. Sprovvista di suono. Ora teneva in grembo il suo non viso. Non emetteva nessun tipo di rifrazione quel non volto, non un barlume, non un respiro; si compiacque nello scoprire in esso l’espressione di chi non sembri avesse patito sofferenza, anzi, lo trovava avvolto in un’aurea di autentica beatitudine. Uno stato di pacata quiete interiore. Cosparse da un fragrante effluvio di lavanda, sembrava addirittura che le sue labbra stessero sorridendo. Istintivamente le accarezzò la guancia raggrinzita. Rimase esterrefatto nell’appurare l’indeformabilità della morte. Il congelamento della vita. Un raggio di sole – il primo quel giorno – cascò traversale, sparpagliando lame di luce novella. Il fascio si profuse anche al ceppo metallico – base d’appoggio ai cardini di ferro zincato del cancelletto all’entrata del cimitero – che sperperò abbagli a destra e a manca. Accecatosi, Mario fu costretto a deviare lo sguardo su un particolare diverso. I capelli per esempio, o le spalle. Una singola parte alla volta: a vederlo interamente, quel corpo, 141 sarebbe stato eccessivo. Nuovamente il suo olfatto fu colpito da un intenso, mellifluo profumo. Più dolce della lavanda. Impiegò un po’ di tempo nel capire che l’aria era cosparsa dalla fragranza di un candido fiore. Labelli prominenti e petali immacolati che la donna esibiva tra i suoi lunghi e soffici capelli d’argento. 142 epilogo Terminò così questa storia. In un mattino come un mattino qualunque, con il fastidio di un vento sfacciato che fino a quel momento, contrariamente ad ogni logica nonché equilibrata aspettativa, buttava da Nord. E così, come la brezza mattutina con l’avanzar dell’aurora s’ammorbidiva, anche la veemenza delle raffiche degradava, e l’ultima folata bastò appena per raccogliere da terra una manciata di foglie sparse e immolarle al volo, destinando ognuna di queste a posti lontani. Curiosamente due di loro stavano ancora attorcigliate, un intreccio così solido che l’estrema forza di una ventata non sarebbe mai riuscita a dividere. Rimasero a mezz’aria, vibrando e piroettando in un vortice festoso, pronte a scomparire nel blu di quel cielo che sconfinava sopra le loro ombre. Doveva aver 143 risalito l’arcobaleno, quella saldata foglia, che la consegnerà alle nuvole e al sole. E se incontrerà il fulmine della tempesta o un vento assai violento non avrà nessunissima paura perché è facoltà sua – loro – discernere la retta via e quindi saprà orientarsi e riprendere la direzione opportuna per tornare dove la valle e le montagne hanno scelto di esistere, per fare in modo che il bosco rinvigorisca i pendii, il torrente attraversi i campi e, più in alto, le giovani aquile ritrovino il loro nido. Insieme stavolta. Stavolta per un mai più addio. Comincerà un’altra storia. Così. Con un’alba aggrappata alle cime più alte e un vento leggero e tiepido il quale, debitore di ogni logica nonché equilibrata aspettativa, inesorabilmente butta da... 144 145 146 La stanza in cima alla torre 147 148 Al tempo in cui il filosofo tedesco Fredrich Nietzsche istruiva a cogliere l’essenza della vita che si nasconde dietro il dato apparente; lo scrittore irlandese Oscar Wilde si riavvicinava all’amato Lord Alfred Douglas detto Bosie, suscitando non pochi dissensi sulle bocche della buona società; e il poeta pescarese Gabriele D’Annunzio si trasferiva a Firenze per vivere la sua più intensa storia d’amore con l’attrice Eleonora Duse, in un piccolo paese della Vallarsa trentina io, maniscalco Serafino Matassoni, figlio illegittimo di Geremia Matassoni, che per non destare pubblico scandalo sposò mia madre malgrado fosse a conoscenza della sua gravidanza clandestina, ebbene, dopo tutto questo popò di cose che v’ho detto, a quel tempo io non tenevo ancora una fidanzata. 149 Be’, forse ce l’avrei anche avuta una ragazza, solamente che la mia prescelta non era mai stata messa al corrente dell’impegno che io stesso, in maniera del tutto arbitraria, le avevo assegnato. Ero talmente innamorato di quella donna che avrei schiodato Cristo dalla croce se me lo avesse chiesto, ma la tremenda timidezza che da sempre m’attanaglia il fegato, mi teneva recluso in una diffidenza tale da non avere mai avuto il coraggio di proclamarmi. Ardeva dentro di me quel tipo di innamoramento che si potrebbe catastroficamente classificare apocalittico, non so se mi spiego. Silvia era la ragazza più bella del mondo. Del mondo che avevo visto e, quasi sicuramente nonostante la mia accresciuta età, di quello che non avevo ancora avuto modo di scoprire. Mancava qualche giorno al milleottocentosettantaquattresimo Natale della storia quando, tra sventolii di bandiere e squilli di trombe, sgattaiolai su questo mondo. Dopo aver fatto urlare mia madre e sudare le comari, abbozzai la prima poppata, quindi fui avvolto in una coperta pulita e adagiato sulla balla di fieno ai piedi della mangiatoia delle vacche, come Gesù, e come Lui mi ritrovai un padre adottivo che giocoforza dovette accollarsi un’altra bocca da sfamare. Una minima 150 differenza denotava il fatto che il mio, di padre, non lavorava il legno ma coltivava la terra e, all’epoca, chi coltivava la terra viveva una condizione di assoluta povertà. Ma credo che anche in questo un po’ ci somigliavamo. Nella nostra casa di Foppiano di bello c’era poco. La ricordo senza troppa nostalgia, con muri neri di fumo, pavimenti unti e stanze assediate dalle mosche. Come una latrina attraverso il tempo, tuttora mi ritrovo la memoria satura dai miasmi del letame e dell’acetilene. Tutto, a cominciare dalle lenzuola di flanella, dalla calce passata sui muri o dai pochi vestiti posseduti, era ricoperto da una patina simile al burro, quello rancido però. Un colore giallo nerastro che si insediava negli occhi e alterava la vista. Al mattino, quando di malavoglia portavo le capre al pascolo, vedevo ogni cosa di quel colore così sudicio e disorientante, come se guardassi il mondo attraverso un culo di bottiglia. Persino la vallata e i verdi prati del dosso Oveche li percepivo così: depressi e malandati. Ma c’erano due cose in quella casa che consideravo ricchezze. Una era la cavalla Beatrisa Felisa Dia de Consuelo, una raffica di nomi che mio padre gli affibbiò avvalorando la sua fissazione 151 per gli sfarzosi lignaggi di derivazione iberica. “Detengono un fascino tutto loro…”, sciorinava vantando una cultura piuttosto discutibile; e terminava la frase con: “…Cosa che tu non potrai mai comprendere, considerate le tue origini.” Pertanto, siccome non lo avrei mai capito quel nome, pensai bene di storpiarlo sul nascere chiamandola semplicemente Bea. Bea era un favoloso Haflinger nato dall’accoppiamento di una cavalla indigena con uno stallone arabo El Bedavi. Ancora non lo sapevamo, ma era stato grazie ad un incrocio simile che non troppo distante da noi, nella zona sudtirolese di Avelengo, si diede inizio alla tutt’oggi titolata razza Avelignese. Già al suo primo anno, il ronzino sfoggiava uno splendido mantello sauro-dorato, il ciuffo e la criniera color del grano maturo e la coda dai crini abbondanti, sottili e lisci come la seta. Inoltre si contrassegnò di un particolare che la rese unica: claudicava vistosamente. La causa era da imputarsi allo sfilacciamento dei tendini debito di una caduta dal muretto di sponda alla strada; cosa che a me non interessava un accidente, tanto era intenso il rapporto con il quadrupede. Ancorato ai finimenti e brandendo un paletto appuntito mi proclamavo il principe della foresta. Sfidavo i mostri e combattevo i 152 mulini a vento attinti dalla fantasia che la striminzita letteratura di cui disponevo mi evocava. Giocavo da solo, e da solo dialogavo: “Seguimi, Sancho Panza, e ti farò governatore dell’isola promessa.” Poi, cambiando il tono della voce: “Ma io ho sempre fatto il barbiere!” “Be’, direi che il barbiere non fa per te”, mi rispondevo cercando di rispettare le trame che sapevo a menadito. Andavo altezzoso affermandomi imbattibile in groppa al mio destriero. Quante battaglie avevo affrontato in compagnia dell’equino! Quelle che da grande avrei combattuto ogni giorno, modellando zoccoli e pareggiando scatole cornee asportandone l’eccessiva crescita e bloccando su queste ferri sagomati forgiati al momento, su misura e ognuno a seconda delle rispettive necessità. Credo sia stato grazie a Bea e alla sua tendinopatia che ho iniziato ad avvicinarmi ai cavalli, finendo poi per esercitarla come professione l’arte della mascalcia… …l’altra, era un vecchio baule di legno che i miei tenevano in soffitta. Non era tanto grande, e forse per ciò lo ricordo zeppo di ninnoli e cianfrusaglie. Straripava di roba inutilizzabile ma non per questo da buttare in chippa. 153 “Potrebbero sempre tornare utili!” ribadiva premurosa mia madre. M’incuriosiva più d’ogni altra cosa rovistare dentro quel ben di Dio. Quando s’accendeva la smania mi fiondavo in soffitta e, inginocchiato come un credente di fronte all’effige del Santo patrono, suffragavo le mie pene al cospetto del mistico sarcofago. La mia, però, era una penitenza calcolata; già, perché mi sollevava sapere che al suo interno c’avrei trovato di tutto: dall’armonica a bocca di mio padre – che tra l’altro non ho mai sentito suonare una sola volta – alle sgalmere consunte dello zio Arturo. Dai pantaloni di lana strappati sulle cuciture che indossavano i miei cugini andando alle sagre di paese, alle boccette di china con le colature seccate sui bordi. C’erano persino alcune corde di violino arrotolate e fissate con lo spago; una scatolina contenente diversi bottoni di metallo, di pelle o in madreperla, e l’unica lettera d’amore che mio padre scrisse – diversi anni prima – a quella donna che in futuro sarebbe diventata sua moglie: ovverosia mia madre. Ma il bello stava all’inizio, la prima cosa che balzava agli occhi quando il baule veniva disserrato. Appena sollevavo il coperchio, al di sopra di tutto, come avessimo siglato un patto di comune accordo o 154 controfirmato un appuntamento senza termine, trovavo lei, come sempre lì ad aspettarmi, irremovibile. Era una consunta ma per nulla indecorosa scatola dei biscotti Dessler in cui mia madre conservava i suoi preziosi. Un paio di orecchini di ambra nera, un rosario di madreperla, una medaglietta d’oro colombiano fine come un’ostia, il manifesto del circo Barneby ripiegato in cinque parti e alcuni fermacapelli argentati. C’era pure un libretto per le messe, dove dei piccoli quadrifogli essiccati distendevano i loro petali tra le note dei canti eucaristici e, dentro una busta di carta, il mio primo taglio di capelli. Arruffavo la ciocca sul palmo della mano sorridendo, mi sembrava un minuscolo nido di quaglia. Ma la cosa più strabiliante era la magia che emanava il manifesto circense. Lo ritenevo un documento dai profluvi sacrali, con i bordi frastagliati e le immagini colorate. Sullo sfondo ci stavano disegnati gli animali esotici, tra cui rettili indescrivibili e rapaci uncinati. Mangiafuoco e donne barbute a sfidarsi su un letto di chiodi; l’ammaestratore panciuto dotato di frusta a intimorire i leoni. In primo piano lei: la mia ragazza. Detiene il viso di un angelo quella donna che volteggia leggiadra sul trapezio, impegnata in un salto a mezz’aria. 155 Indossa una tutina infittita di sottili righe turchesi su sfondo bianco e la luce del sole si sbriciola contro le mille paillettes del bustino. Lo porta talmente attillato da rendersi impreziosita di una grazia affilata. A completamento un nastro rosso le si annoda fra i capelli. Calza ballerine di lacca chiuse con le stringhe. Avrei giurato che volasse. Quando incontrai per la prima volta Silvia, m’era sembrato come se la ragazza si fosse materializzata dal poster del circo Barneby per mettersi a scalpicciare in lungo e in largo l’acciottolato della piazza assediata dai banchetti e barroccini. Avevo suppergiù dodic’anni, e per la prima volta non mi sembrava vero quello che stavo vedendo. Una percezione impossibile. Al grande mercato di Rovereto c’eravamo andati per vendere i tacchini e gli asparagi selvatici. Aveva piovuto tutta la settimana, perciò dalla casa di Foppiano ci separavano otto chilometri di sentieri fangosi. Mio padre stava davanti al gruppo col cappello di feltro in testa, la bottiglia del vino in mano e mia sorella sulle spalle; una brunetta dagli occhi cerulei, sempre raffreddata e con il moccolo verde al naso. Dietro, mia madre con l’artrite che quel giorno la faceva ammattire più del solito, e i corbelli degli asparagi come cespi 156 di rose contro ai quali, sballottando ad ogni suo passo, si fustigava le gambe. Ogni tanto accennava una smorfia di sofferenza, socchiudendo le palpebre e corrugando la fronte; un fiume di afflizione che le sfociava grinzoso attorno agli occhi. A ben pensarci, non le avevo mai notato delle rughe così profonde. In mezzo ci stavo io che m’affidarono il compito di trasportare i tacchini. Li avevamo rinchiusi in gabbie di legno e filo di ferro intrecciato a rete, uno ridosso all’altro come stracci dentro un secchio bucato. Cinque cellette poco più grandi di un’urna, stipate sopra un misero carretto di salice. Spingevo il carretto e i goglottii mi trafiggevano i timpani. Impietosito dall’incivile costrizione, a turno li liberai per far loro prendere respiro. Tuttavia, siccome non dovevano scappare, a quel genio di mio padre venne l’idea del secolo. Legò una corda passandola dal collo fin sotto le ali dei volatili e fissandone l’estremità al timone di traino, quindi ogni tre passi inciampavano e sbraitavano come forsennati. Per mia disperazione, gli animali cercavano continuamente di razzolare nel fango e, una volta arrivati a Rovereto, più che tacchini 157 sembravano dei grossi corvi sporchi e spennacchiati. Mi venne da sorridere nel vedere come si erano conciati, ma la risata non fece in tempo a smuovermi le labbra che un sonoro manrovescio mi girò la faccia dall’altra parte. “Disgraziato!” sentii urlare mio padre. Mi voltai e mi scontrai contro il suo sguardo truce, due occhi avvampati e un braccio ancora alzato. “Guarda cos’hai combinato!” E giù un altro sganascione. Teneva la mano pesante, lui, la mano di chi è costretto a trascinarsi in vetta per riuscire a sopravvivere; di chi sa che più la corrente è forte più bisogna vogare per guadare il fiume ma, ahimè, il controllo del mezzo non è mai stato il suo forte. Trattenni le lacrime solo per non dargliela vinta. Ero furioso e ostinato. Dovevo essere ostinato. Tentai di contrastare il suo sguardo contrapponendo la mia rabbia alla sua tracotanza, mentre col bordo degli incisivi mi procuravo una ferita alla base del labbro. Ma erano i suoi di occhi a ferire di più; percepivo quelle minuscole fessure dalle pupille come capocchie di spilli infilzati nella carne. Mi sentii disprezzato e trafitto, come se dai denti di una serpe defluisse tanto odio 158 quanto veleno. Mi stava sfidando, e io in qualche modo resistevo. Con tutto me stesso. Non sapevo per quanto ancora, ma immaginavo che prima o poi sarebbe successo. Non ero portato per la lotta dura. La collera cominciava ad offuscarmi la vista e il mio colorito doveva essere paonazzo. La guancia arroventava come carne alla griglia. Alla fine cedetti, e nel bel mezzo del mercato fui costretto ad abbassare il capo, preso in ostaggio dal rimorso e dall’imbarazzo. Fu proprio su quel ripiego che, infervorato dalla situazione, dalla sua bocca uscì la frase che nessun figlio vorrebbe mai sentirsi dire: “Allora sei proprio scemo! Chi vuoi che compri un’animale ridotto così? Sei un buono a nulla. Su questo, non ti smentisci mai.” Mia sorella osservava la scena con un mezzo sorrisetto divertito, da ebete. Allora cercai mia madre. Anch’essa mi guardava, ma con penosa rassegnazione, senza dire nulla. Quanto odiai quel suo atteggiamento patetico. Riuscì a far passare solo una manciata di secondi, attimi che per me equivalsero a un’eternità, quando provò a intervenire in mia difesa. Ma come ben immaginavo, l’unica cosa 159 che fu in grado di ribadire era stato: “Dài Geremia, è solo un ragazzo.” “Ragazzo un corno!” urlò mio padre. “Alla sua età mi stavo già spaccando la schiena su e giù per i boschi, mentre la sera mi scoppiavo le vesciche ai piedi! E’ un fannullone buono a nulla, ecco cos’è il bastardo. Sappi che mi vergogno di averlo riconosciuto come figlio. Mangiapane a tradimento!” apostrofò portando la bottiglia alle labbra. Quelle parole mi percossero più del ceffone. Ma il colpo di grazia me lo dettero i taciti giudizi dei passanti, quando li sentii depositarsi sulla mia persona, freddi e pesanti come lastre di marmo. Maledissi mia madre e la sua remissività. A quel tempo, anche un suo piccolo aiuto m’avrebbe dato la forza di sostenerli. Ebbi un brivido. Mi sentii smarrito. Avrei voluto fuggire, scappare lontano, nascondermi e non farmi più vedere. In pochi minuti ero diventato lo zimbello dell’intera piazza; l’ingenuo spaventapasseri bersagliato dal puntiglioso stormo di corvi. Cosa avevano tutti da guardare? Cosa avevo fatto di così terribile? O era stata tutta quella sceneggiata a incuriosirli? Questo non lo potevo sapere ma, su quella difesa negata, compresi chiaramente 160 quanto il pensiero di mia madre, di fronte alla testardaggine del marito, fosse considerato vano e insignificante. Proprio su quel fatto codificai la sua vita. La trovai angosciata, fragile, perennemente in bilico, come un filo d’erba che vortica sull’orlo fatale nel mulinello di una fontana. Così, con gli occhi lucidi e la testa dolorante, nel bel mezzo della fiera mi misi a ripulire i tacchini, togliendoli le croste di fango con un pugno di paglia. Fu in quel momento che, alzando la testa, la vidi passare. Sembrava una dea discesa dall’Olimpo. Appariva e spariva in mezzo alle sue amiche, come il brillio di una stella tra le nubi di un fosco cielo notturno. Chiara breccia tra nuvole temporalesche. Stella polare dei miei pensieri. La farinosa e lucente scia di una cometa che io inseguivo con lo sguardo, mentre mio padre bestemmiava perché nessuno avrebbe mai comprato dei tacchini così sporchi, evidenziando più che mai la mia colpa. Ma ormai ero altrove. Non le sentivo neanche più le sue ingiurie. Vedevo in controluce un torrione sulla cui sommità s’apriva una fessura stretta e sprangata. Non riusciva una solida grata di ferro a impedire alla luce di uscire, come non riusciva a trattenere quelle candide 161 mani principesche protese nel vuoto e una voce supplice a invocare il mio aiuto. E immaginavo che lui fosse l’Orco e i pennuti, trasformatisi in draghi, ostacolavassero la mia avanzata, con quella loro coda serpentina e le trucide fauci esalanti zolforee alitate di fuoco; allora io, il valoroso salvatore dal cuore impavido, li avrei sfidati alla morte, tutti quanti, anche l’Orco, in modo da procurarmi il libero accesso alla scala che portava nella stanza dov’ero certo lei m’attendesse. Lassù, in cima alla torre. “Dovrei vendere te, altro che i tacchini!” sgolava mio padre al di fuori del vaneggiato campo di battaglia. “Ammesso che qualcuno ti voglia” aggiunse svuotando la bottiglia. Lui era così. Se cominciava la giornata imprecando avrebbe continuato fino a notte inoltrata, capacissimo di demolire a testa bassa ogni trascurabile iniziativa intrapresa. Ragionare con mio padre sarebbe stato come scavare un pozzo nel mare: puoi metterci tutto l’impegno possibile, ma buche non se ne formano. Soltanto un enorme quantitativo di vino lo avrebbe steso la sera, riportandolo da un’alcolica, momentanea e rissosa loquacità alla sobria insicurezza di sempre. Allora pensavo che sì, magari si fosse fatto avanti qualcuno per comprarmi e portarmi via, 162 discostandomi una volta per tutte da quell’essere così meschino. Alla fine avevamo venduto i tacchini e gli asparagi di bosco. Con quei soldi mia madre comprò l’olio, lo zucchero e la farina, ma quella sera stessa la sua fronte accolse una ruga nuova. Tornammo molte altre volte al grande mercato di Rovereto. L’umore di mio padre non mi importava più granché. Per me, quelle erano giornate di festa, le uniche che avessero un senso su tutte le altre dell’anno. Facendo pascolare le capre e specializzandomi nel ferrare i cavalli, aspettavo con impazienza il giorno di fiera. Per incontrare Silvia che non sapevo ancora si chiamasse così. Per rivedere il suo volto, sentirla dialogare con le amiche e imparare a distinguerne il timbro della voce. Così giorno dopo giorno, senza che mai mi adocchiasse veramente, malgrado gli sporadici tentativi che escogitavo per attirare le sue attenzioni la vedevo crescere, fiorire e modellare il suo corpo con linee morbide e voluttuose. Diventare sempre più bella. Ogni volta di più. E ogni volta di più mi sembrava irraggiungibile, sempre più rinchiusa nel suo castello. 163 Finché, dopo anni di tentennamenti, scoprii il suo nome. Lo sentii pronunciare dalla signora al banco del pesce, di sfuggita: “Ecco Silvia, due meravigliose trote di lago appena pescate. Te le tengo segnate e… porta i miei saluti ai tuoi cari genitori.” “Grazie, Milena. Già me le immagino con le patate!” Udendolo scandito nell’aria il suo nome, mi si gonfiò il cuore. Ricordai immediatamente quel Leopardi che avevo letto da poco e i suoi versi dedicati a una donna dalla curiosa omonimia: Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi? Eccola là, Silvia, coi suoi occhi gioiosi e lo sguardo sfuggente. Una ragazza generata col mio stesso stampo: entrambi timidamente incapaci di estrapolare dal profondo dell’anima i sentimenti e gli affetti provati. Quanto avrei voluto rincorrerla, afferrarla e finalmente 164 pronunciarmi: “Aspetta, non fuggirmi, mi chiamo Serafino…”, per poi confessarmi: “…e sono profondamente innamorato di te”, oppure: “…e tu mi piaci da impazzire”, ma non sono mai riuscito a trovarne il coraggio. Rimasi lì, fisso come un baccalà sotto sale, per vedermela anche quel giorno sparire, inabissatasi tra la folla in movimento. Notai solo allora, quando di Silvia m’era rimasta solo un’ombra impressa nella mente, l’imponenza del caseggiato di fianco al torrente. Svettava dinanzi, adombrando la piazza con le sue pareti bianche, e dentro quelle pareti le cornici lignee delle finestre, e su quelle finestre le vetrate trasparenti. E dentro ai vetri, quel giorno, io ci vedevo il cielo. Ora sapevo altre due cose sul suo conto: che Silvia era il suo nome, e non disdegnava il pesce. Quella sera, rivivendo la scena del mercato avvolto nella pesantissima coperta che copriva quasi tutto il paglione, mi sovvenne un’idea. Fu come una dardo che colpì la ragione, mentre con le dita accarezzavo i contorni della ragazza raffigurata sul poster, la quale speravo si separasse una buona volta dallo stato di 165 segregazione impostole dentro quella maledetta scatola di latta: una mano me l’avrebbe data di sicuro lo zio Arturo. Il mio ‘intercessore’, nei periodi di ferma dai campi, si dedicava alla pesca di frodo. Provai a interpellarlo. “Non se ne parla nemmeno”, mi rispose perentorio. “Troppo pericoloso per un ragazzino come te.” Insistetti, finché il giorno antecedente il mercato riuscii a convincerlo a portami con sé, promettendogli di tenermi la bocca ben cucita con mia madre – nonché sua sorella – e a sobbarcarmi per l’intero tragitto tutto l’armamentario. Era sufficiente che alla fine mi cedesse un po’ del pescato, da elargire a lei naturalmente, dimodoché, approfittando della generosa offerta, avrei avuto la tanto agognata opportunità di conoscerla. In quel posto non c’ero mai stato, laggiù, tra le anse percorse dal Leno. Discendemmo la val delle Fontanelle inoltrandoci nell’ombra di un fitto faggeto. Un tiepido sole mattiniero sonnecchiava tra le chiome, adagiando i suoi raggi sopra un letto di fronde. Bruscoli di luce s’intercalavano nello spazio lasciato tra le foglie, come tele di ragno vincolate ai bordi, ma la gravità le faceva precipitare, e cozzando 166 al suolo lo imbrattavano di un chiarore tenue. All’interno di quel bosco ci imbattemmo nel torrente che schiaffeggiava fragoroso le fenditure della roccia. Con l’audacia adolescenziale e lo zaino in spalla ne risalimmo il corso, saltellando sulle pietre di un arzigogolato ciglione ghiaioso, e ci inerpicammo ai fianchi di litigiose cascatelle che contribuivano a rendere il tragitto umido e assordante. Più sopra, verso la Brazzavalle, l’acqua zampillava dalla selce brillando come piombo fuso il quale, defluendo indispettito dentro l’argine breccioso, s’infrangeva formando elaborati pizzi lattescenti. Presa sul piano, tutta quell’acqua, formava delle pozze così ampie e feconde che non era difficile trovarci al loro interno notevoli quantitativi di pesce. Lo zio Arturo stava perfezionando uno stratagemma che sarcasticamente amava definire: “A prova di bomba.” Invece della solita attrezzatura da pesca, usava dei cilindri contenenti una specie di prodotto plastico altamente esplosivo. Era una varietà di dinamite procuratagli dal suo amico Gidio, uomo dalle spalle grosse e il naso rubizzo del robusto bevitore; di quella che sgraffignava nelle miniere dell’alta Savoia cui saltuariamente lavorava. Il compito di 167 trasportare tutta ’sta roba era stato affidato a me, ovviamente. Accettai quella proposta con gioia e senza esitazioni. Era un lavoro da duri, quello. Da veri uomini. Pertanto, siccome da questi involucri era facile fuoriuscissero gocce di nitroglicerina, dovevo stare attento a non scuoterli esageratamente e, soprattutto, a non inciampare. Se fossi caduto con quella roba in mano sarebbe stata la catastrofe. Ma quando si è giovani chi riesce a fermarti? Chi va a pensare che qualcosa non debba funzionare come la si programma? Quelle sono considerazioni che insorgono a maturazione avvenuta, almeno così si dice. Un processo di mediazione simbolica di cui lo zio Arturo non era ancora riuscito portare a termine. Dentro la bisaccia tenevo l’esplosivo, nella tasca della giubba i detonatori. Dovevamo calcolare bene il momento del lancio. La bravura stava nel fatto che la deflagrazione avvenisse in un punto ben preciso della sua traiettoria: a pelo d’acqua. Se si fosse verificata prima, ora non sarei qui a raccontarlo; ma neanche troppo sotto la superficie poiché avrebbe causato lo squarciamento dei corpi. Bisognava essere precisi e calcolatori. L’onda d’urto procurava una voragine assassina che, a opera conclusa, c’avrebbe portato a galla il 168 pesce stordito o già belle che morto. A quel punto sarebbe stata una baggianata per noi recuperarlo. Nel momento del botto sentivo il terreno vibrare. Tenevo gli occhi socchiusi e con gl’indici mi tappavo le orecchie. Quei colpi assurdi m’avrebbero scosso per parecchio tempo negli anni a venire, e il progresso evolutivo del composto chimico si sarebbe conquistato la piazza d’onore nell’eterna disputa tra i popoli. Io, invece, avrei continuato irremovibile a interpretare la parte della comparsa, in un frangente storico poco gradevole da ricordare. Quella sera portammo a casa un cospicuo bottino. Lo zio me ne cedette una quota generosa che, giustificatomi in qualche modo, consegnai a mia madre. Escogitando un sotterfugio, avvolsi nella cartapaglia i tre esemplari più belli i quali, a loro volta, nascosi dentro un vaso di vetro, perché la notte il gatto non facesse festa. Fu una notte interminabile, quella notte di maggio. Non chiusi occhio. Tutto il mio corpo era in preda a un’eccitazione dirompente. Ero emozionato e il cuore lo sentivo martellare in gola. Non riuscivo a trovare la posizione adatta 169 per addormentarmi, così mi rigiravo in continuazione, aggrovigliando la coperta fradicia di sudore attorno alle caviglie. Nel buio vedevo lei… anzi noi due… cioè io che le porto le trote e lei che mi guarda, mi sorride e dice: Ho sempre sperato mi notassi. E la sua apparenza mi trapassava la mente, togliendomelo quasi del tutto, il sonno. Dopo ore di agitati ripensamenti stavo per assopirmi quando cominciò a piovere, e il rumore degli scrosci mi ridestarono, ancora. Udivo la pioggia alternare la sua caduta, prima lieve, poi più intensa, poi di nuovo leggera, e sentivo ogni singola goccia frantumarsi al contatto coi coppi. Colpi secchi, ritmici, a scandire il trascorrere del tempo. L’istante che scappa. Inesorabile. Quel suono omofono contribuì ad appisolarmi e sognai un prato, le capre al pascolo. C’erano anche dei frassini lì vicino. Da uno di questi il becchettare di un picchio cinereo. Gli stessi colpi, secchi e ritmici. E il mio sguardo bambino fissava il picide che, simile alla pioggia di una notte insonne, tambureggiava lo scivolare del tempo sulla verticale di una corteccia traforata. Poi un colpo più forte, sordo. Il boato del tuono mi riportò al mio letto. Fuori schiariva. 170 La giornata che seguì era grigia e cupa, percorsa da continue sfuriate di fredda pioggia. A metà mattina, quando raggiunsi Rovereto, una pesante nebbia scacciò le nuvole appiccicandosi agli alberi ricurvi e calando sulle case. C’ero venuto da solo questa volta, tenendomi stretta come una reliquia la sacca del pesce. Non vedevo l’ora di rivederla, Silvia, inconscio che sarebbe stata anche l’ultima. Quel giorno di maggio mi imbattei in lei per strada. Nel momento esatto in cui la intravidi stava passeggiando spalle alla chiesa, mentre un piccione scuro e svirgolato come un zitto musicale si librò nell’aria, sbatacchiando le ali e tubando a festa. Abbandonò il sagrato, il timido uccello, per poggiarsi più in alto, sul frontone curvilineo coronante il portale, anch’egli desideroso di raggiungere qualcuno evidentemente. Ammirai la mia amata e… ebbi un sussulto. Come al solito non era sola. Soltanto che al momento non stava in compagnia delle sue amiche, ma di una persona a me sconosciuta. Aveva un bel profilo, alto e biondiccio. Un ragazzo. Si stringevano la mano, si abbracciavano. Quella vista mi immobilizzò lì su due piedi. Per qualche minuto contrassi l’agilità di un putto di marmo. Anche la mente stagnava su quelle onde. Non 171 sapevo più cosa fare, il mio corpo non reagiva agli impulsi della ragione, anche perché non riuscivo a formulare alcun ragionamento. L’immagine di lei avvinghiata a quel ragazzo era pari a un pugno nello stomaco. Mi caddero le braccia, non soltanto in senso metaforico, e la sacca del pesce mi scivolò giù dalla spalla andando a cozzare per terra. L’impatto col terreno lo percepii con un rumore sordo, di ceramica frantumata. Un’acidità di stomaco mi salì dall’esofago. Fu come se il dolce domenicale fosse andato a male e dopo alcuni morsi l’avessi rigurgitato; non prima di subissarmisi in gola un indefinito retrogusto amaro. Loro non mi stavano minimamente considerando, così, con subdola disaffezione, m’addossai al blocco di case che rasentava la piazza. Continuai a guardarla con circospezione cercando di non farmi notare. La storia di sempre. Adesso stavano vicini, troppo per non farmi certi ripensamenti. Si parlavano e ridevano, l’uno di fronte all’altra, con le bocche che si sfioravano appena. Occhi negli occhi, naso contro naso, respiro dentro respiro. Fatto sta che, dando atto alle predette supposizioni, misero fine al mio sviscerato rimuginare 172 attuando un semplice ma inevitabile gesto: si baciarono. Non era come uno di quei baci che mi dava mia madre, fatto sulla guancia, preciso e veloce, ma di quelli in cui si uniscono le labbra formando un tutt’uno, addolciti con la passione che s’addice a due innamorati. Io li osservavo grondando sangue, mentre fissavo la mano di lei accarezzargli la zazzera riccioluta. La lisciava, delicata, quasi avesse tra le dita soffici riccioli di lana. Fu a quella vista che il cuore mi si spezzò, riversando i suoi cocci nel profondo dello stomaco. Non ebbi una reazione immediata, almeno credo, ma una serie di reazioni contrastanti che ridussero il mio pensiero ad un'unica considerazione: Ha ragione mio padre, sono proprio un coglione. Improvvisamente uno strale di sole fece breccia nel cataclisma nuvoloso e ricadde sui due amanti, illuminandoli nel loro momento di gloria. Solo allora, per una frazione di secondo, il suo sguardo si congiunse al mio. Era stata la prima e unica volta che ci guardavamo veramente e in quell’istante mettemmo a nudo i nostri pensieri. Non avrei mai voluto succedesse ma, anche se solo per un attimo, capii quanto lei fosse felice. I suoi occhi emanavano tutta la gioia che provava, a differenza dei miei, che da poco l’avevano 173 perduta. Fu solamente in quel modo che riuscii a pronunciarmi ma, di tutto quel che ne uscì, non rimase altro che un’inespressa dichiarazione. Rimossi le idee all’imponente caseggiato di fronte. Il cielo, dentro quelle finestre, era adesso un’opprimente lastra d’ardesia. Mi era stato detto che la vita, al contrario di come potremmo supporre, è sostanzialmente incoerente e la prevedibilità dei fatti un’illusoria consolazione. Così s’era dimostrata. Raccolsi la sacca e ritornai sui miei passi. Una volta raggiunto il ponte di Santa Maria gettai il pescato al torrente. Mi soffermai ad osservarlo mentre si disperdeva tra i flutti come ormai lo era il mio destino. Non tornai mai più al grande mercato di Rovereto, arrivati a questo punto non c’era più scopo di andarci. Provai persino a dimenticarla, interpellando il tempo del quale si dice: cancelli ogni macchia. Ma del suo, di segno, non riuscii mai a sbarazzarmi completamente. Ogni tanto, quando salgo in mansarda e rivedo il vecchio baule, be’, in quei momenti mi prude il desiderio di aprirlo. E vi giuro che il più delle volte non resisto alla tentazione di farlo. Così, rassicurato dalla sua debita presenza, raccolgo 174 la scatola di latta che ritrovo lì in prima fila, sempre al suo posto. La scoperchio. Recupero il poster e lo distendo. E la ragazza sul trapezio con le ballerine ai piedi e i capelli nastrati pare mi inviti a volare, come se nel tempo, il desiderio di poterla abbracciare, non si fosse mai estinto. Solamente che io, adesso… io non posso. C’andrei di corsa, con tutte le mie forze, ma… non posso. Sarebbe una cosa fantastica, ma proprio per ciò impossibile da concretizzare: un banchetto a cui mi è stata revocata la condivisione. Allora accarezzo il suo viso e un pizzichìo amaro mi brucia il contorno degli occhi; una specie di irritazione cutanea che si insinua tra le palpebre, in modo particolare nel punto in cui una lacrima sciagurata col suo trabocco inconsapevolmente m’annebbia la vista. Malgrado tutto, ancora adesso che sono vecchio, solo e brontolone, e gli assordanti cavalli vapore stanno progressivamente rimpiazzando quelli che in carne e ossa m’hanno dato da vivere per oltre sessant’anni, ogni volta che ripenso a Silvia, alla Silvia di allora, il cuore comincia ad accelerare il suo battito, e ci devo stare attento perché potrebbe farmi brutti scherzi, alla mia età. 175 Forse è stato meglio così, dopotutto di lei non conoscevo nulla. Magari col passare del tempo e giocando a carte scoperte, si sarebbe rivelata una donna sciocca e puerile; e poi assieme a quel ragazzo la scorsi assolutamente raggiante. Beata lei. Solamente di una cosa tutt’oggi mi rammarico, una sola: di non aver mai avuto, nei giorni della mia giovinezza, il coraggio di scardinare la porta e ascendere quella scala. La scala che portava alla sua stanza, lassù, in cima alla torre. 176 177 178 Percezione 179 180 Oggi è martedì: un giorno speciale. Non perché il martedì sia più speciale del mercoledì, del giovedì o che so io… del venerdì; ma perché oggi, per la prima volta da oltre due anni, ho sentito mia madre. La prima volta da quando è diventata un vaso di cenere. Di vederla mi succede spesso. Ogni tanto entra garbata nei miei sogni e vi si permea in tutta la sua robusta e amabile forma, si lascia guardare, sorride, mi premia anche di un suo gesto, ogni tanto, ed io penso che è meglio di starsene lì ad osservare l’immutabile e sigillata sterilità di una foto attaccata con lo scotch sulla parete del frigo. Mai più l’avevo sentita. Mai sino ad oggi. Martedì, giorno di mercato. A Rovereto gli affari economici ambulanti si svolgono il martedì. Da sempre credo. Quindi 181 se in strada fermi qualcuno per chiedergli il giorno e lui ti risponde: “Dì de mercà”, sai già in che frangente settimanale ti trovi. Nella mia famiglia i giorni sono tutti contrassegnati da delle frasi, dei mini proverbi. Trovi il mèrquer de la paura, il zòbia vignùa stimana perdùa, il vendro sgnocolà de patate e bacalà, il sabo senza sol l’è na dòna senza amor… e avanti così, ognuno una sua locuzione. Era stata mia madre ad insegnarmeli, quando alla fine delle lezioni la maestra mi dette come compito a casa la trascrizione sul quaderno nonché l’apprendimento mnemonico di una massima popolare relativa al giorno in questione. Ogni giornata una citazione diversa, per tutta la settimana corrente. Frequentavo la seconda elementare a quel tempo, sapevo scrivere a malapena e gli errori d’ortografia spiccavano feroci col rosso delle correzioni. Ma quel compito m’era piaciuto e c’avevo dato dentro a penna tratta. Il venerdì successivo chiusi il quaderno con espressione compiuta, soddisfatto dell’operato, anche se credo che qualche stornello se lo sia inventato di sana pianta, perché in vita mia certe asserzioni non le ho mai sentite snocciolare da bocche diverse dalle nostre. Che forza era mia madre! 182 Il mese scorso stavo nella casa dei miei genitori: la stessa mia di un tempo. Ora ci vive soltanto mio padre e la caparbia autosufficienza che l’ha sempre contraddistinto. Fin da subito i telefilm del tenente Colombo, le spaccatine del forno all’angolo o il giro dei negozi al centro si fecero echi della parte felice della sua memoria. Il sentiero del recesso gli si schierò davanti come un invito pieno di bar dove i caffè si servono generosi e i bicchieri di vino fanno da stampella a un’anima zoppicante. In questi anni di vita in solitudine ha scoperto dentro di sé la tristezza, che non è una sensazione deprimente anzi, è addirittura piacevole, se si accetta di condividerne la compagnia. Almeno non dovrà più cenare da solo. La cucina è un perfetto ordine casalingo. Il gas e le stoviglie ora le lava mio padre, col grembiule allacciato sul davanti e il detersivo per i piatti che lei preferiva. Non è facile separarsi dalle abitudini di una vita. Mi capita di vederlo in piedi, accanto al lavandino, mentre guarda le bolle d’acqua insaponata che scoppiano quando la tensione superficiale si spezza. Credo di sapere a cosa pensa. Girovagando per le stanze mi imbattei in un taccuino per gli appunti. Lo identificai. Era 183 l’agenda personale di mia madre ma che, piuttosto che agenda, definirei un tabernacolo di ricette. La sfogliai con religioso rispetto. Quante cose mi stavano tornando in mente. Nella goffa rotondità di quella calligrafia i ricordi si manifestavano come ombre in un turbine nevoso, una bufera che mi trascinava nel passato più bello che avessi mai vissuto. Le pietanze mi prendevano la mano. Gli stufati e le minestre ribollivano la mia immaginazione. Le verdure gratinavano, le salse arricchivano i sapori. E poi le torte, sì proprio quelle dei compleanni, delle ricorrenze. Come le ricordo belle le mie feste di compleanno! Gli amici attorno alla tavola, il pandispagna con le fragole e la panna montata, i tiramisù. E poi tutte quelle candeline accese, e il suo fiato complice che sempre mi facilitava lo spegnimento. Lei che non poteva neanche assaggiarli i dolci per colpa dell’insulina. Era quello il periodo dei calzoncini corti, il periodo delle ginocchia sbucciate, degli ammonimenti, delle raccomandazioni, delle corse in bicicletta giù a scavezzacollo, del mio cipiglio impuntato e delle trasgressioni. Del mio io ruffiano, imbevuto nella viscosa irruenza di un virgulto testardo e risoluto, ancora troppo inverdito per fruttare. 184 Era il periodo della sua calma di madre, del suo faccione bonario, lo sganascio balordo, sincero, delle prediche infinite, del premuroso palmo di una mano che saggia la mia fronte rovente, di quei suoi capelli ingarbugliati gli uni negli altri come le sequenze indistricabili di un fotoromanzo da Grand Hotel. Una serie di riviste all’angolo della panca. Eccoli. Sono proprio i Grand Hotel che torreggiano accatastati gli uni sugli altri, mischiandosi i titoli e le illustrazioni a colori. Il solo settimanale a non aver subìto tradimenti, come sposo di una moglie giusta e fedele, amato dal tempo della giovinezza fino ai suoi ultimi istanti, ad occhi quasi del tutto perduti. Una copia m’osservava dal divano, a fauci spalancate. Non capii perché ma la richiusi, così, senza un motivo preciso. Non mi capita sovente di mettere a posto le cose degli altri: quel giorno lo feci. Notai che la copertina portava una data recente. Come immaginavo lo compera ancora. Non so cosa sia che gli manca di più, se la spumeggiante allegria in cui lei alloggiava o la sua irrefrenabile voglia di andare, viaggiare, assieme a lui naturalmente, inopinabilmente in due; anche brevi itinerari magari, stile ‘gita domenicale’ tanto per intenderci. “Andiamo” 185 diceva e partivano, malgrado l’instabilità sulle gambe e il fiato sempre più corto. La sera si vedeva che erano stati bene, la pelle schiaffeggiata dal sole e lo spirito sollevato. Quell’autunno era stato un autunno di funghi. Me ne portarono un cesto ricolmo. Me lo ricordo come fosse adesso. Non posso dimenticare l’ultimo abbraccio di mia madre. “Forza, andiamo” e partivano. La macchina teneva sempre il pieno e il motore gorgogliava sereno, scaramantico. Ma quella notte non lo avvisò. Quel viaggio lo intraprese da sola, a cuore appena fermo. “Aspettami che mi preparo” gli disse in gran confusione mio padre, mentre le baciava la fronte livida e fredda. Lei non rispose ma sono sicuro si siano capiti. Adesso una fila di cipressi ombreggiano il suo abitacolo. Il piccolo spazio di una cella in un alveare di cemento. E’ l’ultimo in fondo alla fila, dietro una moltitudine di facce appiccicate a sacrali parallelepipedi di pietra. Fiori recisi ornano il rialzo di marmo, succhiando acqua dai sottovasi in policarbonato. Quando arrivo ne aggiungo un po’, anche se a quest’incombenza avrà sicuramente provveduto mio padre durante le sue visite quotidiane. Non vado mai via dal cimitero senza prima dare 186 acqua ai fiori. E’ più forte di me. Lo faccio anche se poi marciscono, e allora verranno buttati e sostituiti da altri che a loro volta marciranno. Probabilmente è il loro destino. All’interno di certi cancelli ogni cosa va a male. Martedì di mercato. Decido di farci un giro. I banchetti sfoggiano mercanzia spicciola. Orpelli e vestimenti giustiziati oscillano agganciati all’ossatura metallica degli ombrelloni. Alla bancarella dei fiori spicca il rosso dei garofoletti, il bianco delle calle, il variopinto delle rose. Ma ciò che mi colpisce maggiormente è il rubino cupo dei fiori di amaranto. L’amaranto, dal tempo dei tempi simbolo di immortalità; dalle recondite reminiscenze classiche m’esce di assoggettarlo al termine greco ‘amàrantos’ ovvero ‘che non appassisce.’ Credo di non trovare nulla di più appropriato. Cerco lo spazio sul rialzo di marmo, il giusto necessario per farci stare comodo il mio acquisto floreale senza invadere quello degli altri. Anche se poi lo spazio occupato da un mazzo di fiori non lo reputo affatto una sottrazione di territorio. Do l’acqua ai nuovi arrivati, cominciando così a sacrificarli fin da subito. Appoggio una mano contro il frontale 187 del loculo. E’ strano il calore che emette. Tra un gesto dissetante e una sensazione di bollore percepisco delicati strappetti al braccio, come se qualcuno provocasse la mia attenzione. Mi giro. Intorno non vedo nessuno. Improvvisamente una raffica di vento m’avvolge. Il sole che prima brillava a diamante ora s’accascia. Odo appena, filtrate dalla distanza, le voci e le risate della gente per strada. Anche il rumore della ferrovia arriva con una risonanza fantastica, come se non fosse lo sferragliare di un convoglio ma il suono stesso della mia esistenza. Ho la sensazione di esserne così avviluppato da non capire nemmeno più da che parte arrivi la corrente, se da un posto lontanissimo o a un passo da me. Un turbine fastidioso che scapiglia i ciuffi e scompiglia i pensieri. Una pressione inquietante. E lì mi ritrovo, immobilizzato al centro di un vortice surreale, nel qual mentre il mondo mi vortica intorno. L’imbuto ventoso si trascina appresso delle forme, delle parvenze. Scorgo immagini familiari. Vedo una casa, persone che la abitano, una culla, una donna che accarezza un bambino dall’estro soporoso. Riconosco la donna: mia madre. Riconosco il bambino: quello sono io. Gli arruffa i capelli a quel figlio pregno delle mie sembianze. Ci 188 soffia contro. Un alito strano che smorza le fiammelle dei lumini come candele sulla torta. L’intuizione si concretizza in vacillante realtà. Aspramente sussurro: “Sei tu, mamma?” Il vento s’irrobustisce, il caldo si fa intenso. La pietra scotta. Pulsa. Le raffiche sembrano onde gigantesche, una corpulenta versione di tsunami dell’aria. Il vortice impetuoso un gorgo abissale. Il rumore della strada un’unica nota incessante, rintronante. I cipressi s’inchinano a terra fin quasi a spezzarsi, i vasi volteggiano spargendo petali ovunque, foglie strapazzate e idee confuse sul disco di una trottola impazzita. Tutto un inseguirsi di materia e di pensiero. “Sei tu, mamma?” quasi grido. “Rispondi, ti prego!” Solo allora lei mi guarda in faccia, seria, con labbra leggermente schiuse: l’antico modo suo di chiedere. E proprio a me, suo figlio, imbalsamato e vuoto di risposte. Nel rivelarmi quell’espressione l’uragano raggiunge l’apice del furore. I vestiti si sbrindellano. Mi si sfuoca la vista, la mano è fusa alla pietra. La luce languisce e il mondo diventa ombroso. Qualcosa di liquido mi comprime, non riesco a muovermi liberamente. Sento una mano ma non la riesco a vedere. Un battito sordo e 189 regolare mi trafora le meningi. So che apre la bocca perché odo la sua voce. E’ lei che mi chiama. Che mi parla… che mi vuole… Allora grido. A squarciagola. E’ un urlo derivato da una sensazione mista di felicità e spavento, di godimento e angoscia mescolati insieme, di qualcosa che vorrei ma di cui non sono ancora preparato; di qualcosa che sono preparato ma che per il momento non vorrei. Poi, inverosimilmente tutto si placa. La pressione del vento demorde, cessa. Il mio corpo s’alleggerisce, sembro galleggiare, esattamente come una pagliuzza che fluttua sullo specchio catramoso e paco di uno stagno. Non provo gravità, non soffro vertigini, fame, sete, gioia, dolore; i sensi sembrano svaniti, le emozioni pure. Mi sento come foglia sul ramo ottobrino, basterebbe un niente per farmi precipitare. Però sto bene; un benessere che non ho mai provato. E’ come… come fossi… strano, ma credo di essere tornato nel suo ventre. Certo, cosa c’è di più grandioso che riappropriarsi della sacca materna e sguazzare beati nel succo amniotico della gestazione? E’ lei che mi cresce e mi nutre, uno spago invisibile che combina il cielo alla terra, lo sento. La sento. Sento il suo corpo formarsi nel mio, sento i suoi spasmi espellettivi, il suo donarsi di madre, le sue 190 prime carezze, gli abbracci, il calore delle parole. Sento alcune piccole rughe avanzare, il suo invecchiare sempre più avanti del mio, com’è nel giusto delle cose; ma più che altro coi polpastrelli traccio la linea morbida del suo sorriso. La sento. E capisco che non sarà per sempre. Non credo sia durato molto. Mi riavei solo quando staccai la mano. Tutto stava come prima. Il ghiaietto scricchiolava sotto il peso delle suole, il sole irradiava il giusto bollore stagionale, i cipressi immobili come guardie papali, i vasi allineati al loro posto; solo l’annaffiatoio s’era svuotato e i fiori pisciavano a terra la troppa acqua versata. Tutto quel casino non aveva lasciato la ben che minima impronta. Fissai l’effige. Mia madre sorrideva frontale, spendendo l’eterno sorriso prodigato a chiunque. Riappoggiai la mano al davanti, freddo e liscio come lo era sempre stato. Eppure io l’ho sentita. Il sole s’è fatto basso, adesso. Anche se obliquo l’astro ancora emette un taglio lucente, divisorio. Soltanto al di là qualcosa sarà cambiato. I furgoncini del mercato si saranno 191 richiusi, pronti per l’indomani. Il vociare delle persone e l’odore di fritto svaporati. Gli operai della nettezza urbana avranno ripulito ogni angolo di marciapiede e il traffico si sarà ripreso la strada. In un attimo tutto quanto si riporterà allo scorrere quotidiano, dimentichi di un presente che, purtroppo, si è già perduto. E’ quasi sera, mi sento frizzante, sereno, come quel cielo aperto in cui m’immedesimo. Guardo alto mentre passeggio. Come scintillano nel blu cobalto vespertino le luminarie della mia città. 192 193 Ringraziamenti In primis ringrazio tutti quanti voi che mi avete letto, perché se siete arrivati fin qui il mio intento è stato raggiunto. Ho un debito immenso verso la mia affettuosa e paziente moglie, Tiziana, e mia figlia Martina, per avermi concesso senza troppi lamenti il tempo necessario per sviluppare le mie storie; inoltre è stato osservando i loro Kleenex usati che ho capito di avere imboccato la giusta direzione. Ragazze, è inutile che ripeta quanto vi ami! Un sentito grazie alla mia affezionata nipote Ilaria, che ogni tanto le rubo del tempo prezioso, quello che ultimamente non ha, soprattutto adesso che s’è fatta mamma. 194 Sono infinitamente grato alle mie sorelle Luisa e Michela, che riescono sempre a spingermi prima che mi fermi. Grazie davvero, sorelline! A mio padre Valerio, saggio e combattivo. Con tristezza ricordo e onoro colei che ora sarebbe la più agguerrita delle mie fan, mamma Riccarda, venuta a mancare prima che pubblicassi questo libro. Non ha avuto l’opportunità di leggerlo, ma credo non sia un grosso guaio. Ogni volta che scrivo ho la sua mano sul cuore. Ringrazio anche il Gruppo Editoriale L’Espresso perché mi ha dato l’opportunità di rendere pubblica questa mia fatica. E siccome avrete capito benissimo che sono un autodidatta, un plauso particolare lo rivolgo a tutti i libri che ho letto, da loro ho imparato cose che nessun altro mi avrebbe mai insegnato. Ricordo inoltre che questi racconti sono opere di fantasia, e come tutte le storie fantastiche vanno presi per quello che sono. I riferimenti a fatti realmente accaduti sono il concatenamento di fortuite casualità. Nomi e luoghi, in parte, appartengono alla mia immaginazione. 195 Un consiglio a tutti: se per puro caso doveste passare nei pressi di Anghebeni o di Foppiano, non sperate di incontrare i miei personaggi che passeggiano per le vie dei rispettivi paesi, piuttosto fermatevi prima a casa mia, nella frazione di Staineri, che magari, dopo aver ingollato un buon bicchiere di vino, una storia potreste raccontarmela voi. 196 197 198 INDICE Fino al tuo risveglio pag. 18 L’ultima orchidea pag. 21 La stanza in cima alla torre pag. 147 Percezione pag. 179 199 200 201
Scarica