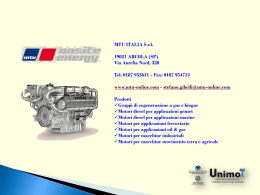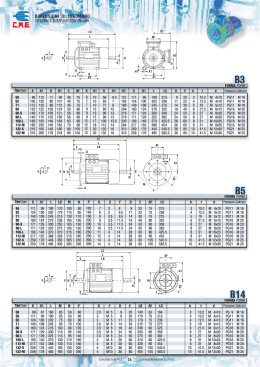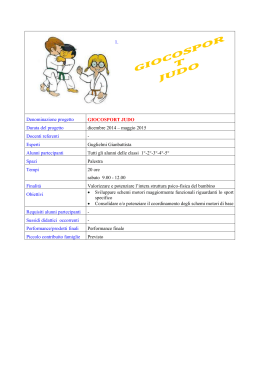Consorzio Venezia Ricerche SEZIONE 3 ESIGENZE DI TUTELA AMBIENTALE, NORMATIVA ESISTENTE O DI FUTURA APPLICAZIONE, E PROPOSTE DI COMPATIBILITÀ PER L’AMBITO LAGUNARE. Le esigenze di tutela ambientale, che tanta attenzione ricevono da parte dell’opinione pubblica, non ne trovano però solitamente altrettanta da parte degli stessi utenti quando questi sono coinvolti con impegno economico o di comportamentale individuale. E’ il caso anche della nautica sia ricreativa che professionale in laguna, e che coinvolge almeno quattro aspetti di rilevanza ambientale profondamente diversi fra loro: 1. la necessità di contenimento e riduzione delle emissioni gassose, di fumosità e del particolato dovuto alla combustione dei motori diesel ed a benzina, particolarmente sentito ai bassi regimi tipici dell’ambito urbano e anche conseguenti alle limitazioni di velocità sulle motorizzazioni più esuberanti. E’ un aspetto che riguarda principalmente i produttori dei motori, ed in seconda istanza il mercato, ma assai poco i comportamenti dei singoli; 2. gli spandimenti nell’acqua lagunare di materiali poco o per nulla biodegradabili, o velenosi o comunque inquinanti, come conseguenza della navigazione di per sé, o d’impianti e comportamenti inadeguati. E’ un aspetto che nuovamente coinvolge in modo significativo il mercato, motoristico e delle vernici, e pariteticamente i comportamenti dell’utenza; 3. la limitazione delle emissioni rumorose, problema particolarmente sentito in ambito urbano ma da considerare anche sotto l’aspetto di tutela del lavoratore professionale. E’ prevalente il comportamento e la sensibilità del singolo utente rispetto al coinvolgimento dei produttori; 4. l’organizzazione e l'ordinamento delle operazioni a carattere industriale che coinvolgono la gestione delle acque e del territorio, e riguardano specificatamente i battelli lagunari: in questa vasta area d’attenzione sono comprese una quantità eterogenea di attività, dallo smaltimento dei reflui di sentina dei battelli alla costruzione degli scafi e conseguente impatto sul territorio, alle operazioni di trasporto acqueo e rifornimento di sostanze pericolose od inquinanti nei canali lagunari, alla necessità di smaltimento di battelli costruiti in materiali non biodegradabili da parte di un’utenza disseminata e non controllabile. L’aspetto organizzativo è fondamentale, e scarsa la necessità d’interazione con i produttori. Saranno esaminati nel seguito con adeguato dettaglio questi aspetti, concentrando l’attenzione sui primi tre, che sono di specifica pertinenza dello scopo dello studio. Sezione 3 Pagina 1 Consorzio Venezia Ricerche Modi ed opportunità d’intervento sugli aspetti ambientali: il quadro di riferimento. Le quattro ‘aree d’attenzione ambientale’ che interessano la navigazione lagunare sono considerate in modo differente dall’opinione pubblica, e con priorità diverse da quelle derivanti dalle valutazioni logiche e tecniche: ad esempio, le emissioni di rumore in ambito urbano sono assai più presenti all’attenzione pubblica del problema, assai specialistico, di una norma efficace per il rifornimento sicuro dei distributori di carburante sulle isole, o quello assai fastidioso dell’eleiminazione dei motori a due tempi. Quattro pesi, insomma, e quattro misure. Le possibilità di intervento del decisore pubblico sono molto diverse nei quattro casi: elevata possibilità di intervento efficace dove sono coinvolti i comportamenti e l’organizzazione, limitata possibilità dove prevalgono i fattori tecnologici e macroeconomici, come nel caso delle prestazioni dei motori e della loro disponibilità sul mercato. Malauguratamente, a questa considerazione si aggiunge che ogni intervento che implica il coinvolgimento attivo e personale del singolo utente ha minore probabilità di successo e d’accettazione che non modifiche assai più ampie ed impegnative, ma che operino su contesti in partenza più organizzati. Il contenimento delle emissioni acustiche, gassose e degli spandimenti è già da qualche tempo oggetto dell’attenzione del legislatore europeo. Per forti resistenze lobbistiche dei produttori – non esclusivamente italiani, anche se la componente resistente nazionale è forte a causa della prevalenza commerciale italiana nel settore nautico minore – la norma europea stenta ad affermarsi, e per aspetti rilevanti non ha mai superato lo stato di proposta 1. Per identico motivo, in ambito nazionale è completamente assente ogni riferimento normativo al riguardo, se si eccettua una breve menzione del 1994 del Ministero della Sanità che mirava a segnalare la pericolosità dell’uso di pitture marine a base venefica nell’ambito lagunare. 2 1 Cfr Direttiva EU94/25/EC sulla omogeneizzazione della normativa sulla nautica da diporto. La modifica pendente, documento COM (2000) 639, è fermo da oltre tre anni all’approvazione del Parlamento europeo. Entrambi i documenti sono riportati in appendice. 2 Decreto Minsanità 29.7.94, in esecuzione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/339/CEE e 91/339/CEE Sezione 3 Pagina 2 Consorzio Venezia Ricerche Questi due argomenti esorbitano dalle possibilità di normazione su base locale (provinciale o regionale) per semplici ragioni tecniche ed economiche: il mercato d’area lagunare è troppo piccolo perché desti l’interesse dei produttori per soluzioni produttive dedicate. In altre parole, le vendite in laguna, i tassi di rinnovo attesi e lo sviluppo futuro del mercato escludono ogni convenienza per i grossi produttori a seguire eventuali norme locali in fatto di specifici limiti d’emissione inquinante dei motori. Ben diverso è stato il posizionamento dell’amministrazione dello Stato della California – che non va dimenticato, ha un prodotto interno lordo confrontabile con quello nazionale italiano – o del congiunto interesse di Svizzera, Germania ed Austria, nazioni che hanno dovuto comunque coalizzarsi per affermarsi nei confronti dei produttori. Pensare che su scala regionale italiana si possano stabilire limiti normativi in modo indipendente è velleitario. Gli esempi precedenti sono stati menzionati perché si tratta degli esempi più rilevanti di normazione in campo ambientale-nautico, che, si ribadisce, in sede europea ancora non è riuscita. In assenza di norme europee molti produttori di motoristica nautica stranieri, europei e giapponesi in particolare, si sono già adeguati alle norme californiane (travasate poi nella norma federale US EPA, Environmental Protection Agency) e svizzero tedesche (BSO, Bodensee-Schifffahrtsordung). Vale quindi la pena di esaminarle criticamente, essendo anche la base dichiarata di un’eventuale normativa ambientale europea al riguardo. Sezione 3 Pagina 3 Consorzio Venezia Ricerche Normative esistenti per le emissioni gassose ed acustiche e loro diffusione sul mercato motoristico. Va innanzitutto osservato che le norme, tanto americane che d’estrazione europea riguardano esclusivamente la nautica da diporto (recreational crafts). La nautica professionale è per ora esclusa da ogni normativa, con ovvie quanto ingiustificate proteste dei produttori del diporto: il motivo sta nella difficoltà di elaborare un criterio unico e generale per i motori professionali, tenuto conto delle diversità d’impiego, ma anche nella ben differente prevalenza numerica di quel settore sull’altro. L’eccezione sfortunatamente è proprio a Venezia, dove la nautica professionale in ambito urbano ha invece un ruolo preponderante. 3 L’accordo trilaterale svizzero-austro-tedesco BSO risale alla fine degli anni ’80, è entrato in vigore nel 1992 ed è stato rivisto nel 1996 (BSO2 4). I motori da diporto delle ultime generazioni più diffusi in campo internazionale (solo per citarne alcuni diffusi in laguna, i DEUTZ MWM, gli MTU, i VOLVO Penta, i Mercury) rispettano già i limiti BSO. I limiti BSO d’emissioni gassose sono di fatto sovrapponibili agli analoghi statunitensi EPA 5, che hanno un’applicazione graduata nell’arco temporale di circa 8 anni a partire dal 2000. Curiosamente, le norme BSO sono in questi anni più stringenti che quelle statunitensi, che saranno a regime ed allineate con BSO solo nel 2005-2006. I maggiori produttori europei e giapponesi hanno quindi una produzione attualmente rispondente alle prescrizioni di entrambi, e si stanno orientando verso uno standard comune. L’IVECO AIFO, unico produttore nazionale rilevante di motori diesel entrobordo, non rispetta né BSO né EPA per la sua produzione da diporto (almeno nelle gamme in commercio attualmente) e non è chiaro se le nuove produzioni saranno rese compatibili, partendo da specifiche automobilistiche per ora non comparabili. I motori diesel più recenti IVECO AIFO della produzione degli anni ’90, per la loro estrazione camionistica seguono le norme automobilistiche EURO2 ed EURO3 in particolare. La nuova produzione IVECO, commercializzata nella primavera del 2003, rispetterà all’origine le norme stradali EURO4. 3 A partire dal 2004 però negli Stati Uniti potrebbe entrare in vigore la EPA 40 CFR Part 94, che riguarderà i commercial diesel marine engines. La norma è molto avversata dagli stessi produttori statunitensi. 4 Il testo dell’accordo BSO2 del 1996, attualmente in vigore, è riportato in appendice. 5 Il testo della norma EPA Recreational crafts, del 2000, è riportato in appendice. Sezione 3 Pagina 4 Consorzio Venezia Ricerche La situazione d’analogia auto—barca può essere tollerata in ambito locale – su base d’equivalenza, ed in assenza di norme diverse 6 – e solo per l’impiego professionale, per l’impiego diportistico questo sicuramente è un ostacolo commerciale di non poco conto evidentemente trascurato da IVECO in considerazione della sua scarsa presenza nazionale ed internazionale nel settore dei recreational crafts. Gli altri motori di produzione italiana per specifico impiego marino sono di disegno spesso obsoleto, e frequentemente non rispettano alcuna particolare norma a carattere ambientale. Il riferimento è in particolare ai fuoribordo di produzione nazionale, ma anche ai motori entrobordo installati da più di una decina d’anni, ancora in commercio, sia a benzina che diesel. Le norme EPA e BSO coprono i quattro segmenti motoristici tipici del diporto • motori fuoribordo (80% del mercato europeo in termini numerici, nel 1998) • motori entrobordo a benzina (2.0 % del mercato) • motori entrobordo diesel (10 % del mercato) • moto d’acqua (8 % del mercato) e limitano le percentuali di monossido di carbonio, idrocarburi incombusti, ossidi d’azoto e particolato emessi dai differenti tipi di motore, accertati secondo cicli di lavoro standard per impiego marino. Non esiste la possibilità di semplice verifica ‘sul campo’ del rispetto dei limiti d’inquinante nel corso d’esercizio, ed occorre far pieno affidamento sulla certificazione all’origine del fabbricante. La normativa europea proposta è altrettanto stringente per i motori fuoribordo quanto la BSO2, ma è meno esigente per i motori entrobordo ed entrofuoribordo. Particolare attenzione è stata posta da tutti i legislatori agli aspetti inquinanti dei motori a due tempi , che sono molto diffusi 7 per i loro pregi (semplicità, affidabilità, basso costo e buon rapporto potenza/peso) ma hanno elevato impatto ambientale, a causa del loro in- 6 L’equivalenza è d’altra parte esplicitamente ricordata nel ‘Regolamento regionale’. Il problema sta semmai nella effettiva applicabilità, per i motori venduti che non fossero di estrazione stradale. 7 In particolare però in Mediterraneo, dove la nautica ha connotazioni di nautica più povera. Assai meno che in Mediterraneo sono diffusi nel Nordeuropa e negli Stati Uniti; assai di più che nel Mediterraneo, sono presenti nel Terzo Mondo. Sezione 3 Pagina 5 Consorzio Venezia Ricerche trinseco funzionamento con lubrificazione ‘ad olio perduto’. Infatti, un motore a due tempi emette una percentuale rilevante d’olio lubrificante incombusto insieme ai gas di scarico, e nelle applicazioni fuoribordo marine l’olio è direttamente scaricato in acqua. Oltre a questo le emissioni gassose sono rilevanti, a causa della combustione poco efficiente. In Sud Europa e nella laguna i fuoribordo a due tempi sono l’80 % dei motori naviganti nel diporto: la loro affidabilità, il basso costo ed il basso tasso d’impiego esclude che siano rinnovati a ritmi accelerati 8. A partire dal 1996, gli standard EPA e BSO proposti per i motori a 2 tempi sono così bassi da impedirne di fatto l’uso, ed obbligare inoltre all’adozione di marmitte catalitiche sugli entrobordo a benzina. Sia gli uni che gli altri, quindi, non saranno esplicitamente vietati 9, è semplicemente impossibile costruirne d’adeguati. I motori entrobordo a benzina sono ormai relativamente rari anche nel diporto, a causa del costo del carburante, ma sono i motori endotermici con minori emissioni: difficilmente raggiungono il 5-10% delle emissioni d’ossidi di carbonio di un motore a due tempi. Sono ancora semi-sperimentali e poco diffuse in campo marino le marmitte catalitiche ormai comuni nell’uso terrestre, rese anche poco interessanti dalla scarsa diffusione percentuale dei motori ad accensione comandata fra i motori marini: nessun motore a benzina esistente, ancorché catalizzato, soddisfa i requisiti BSO2; invece almeno i motori catalizzati rientrebbero nella futura norma europea. I motori diesel entrobordo sono soggetti a norma principalmente sotto l’aspetto delle emissioni di particolato in sospensione nei gas, polveri sottili e ossidi d’azoto. Il rispetto dei limiti regolamentari è di fatto possibile solo con l’impiego di regolazione elettronica della combustione, con tecniche d’iniezione common rail e controllo delle portate d’aria alle turbine tramite waste gates. 8 Un fuoribordo può durare dai venti ai venticinque anni, se ben tenuto. Purtroppo un modo di prolungarne la vita è aumentare ulteriormente la percentuale d’olio nella miscela. Credenza vuole che questo sia anche un rimedio alla scarsità d’ottano delle benzine ‘verdi’, così è invalso l’uso di aumentare in ogni modo la percentuale d’olio, che quindi sempre più finisce incombusto in acqua. 9 Potrebbe costituire una strada parallela di messa al bando dei 2 tempi: non esplicitamente, ma richiedendo una documentazione di conformità agli standard BSO2 impossibile da ottenersi. Sezione 3 Pagina 6 Consorzio Venezia Ricerche I limiti di rumorosità sono stati fissati originariamente nella BSO in modo alquanto generico, come semplici limiti di pressione acustica da non superare ma senza specificare se riferiti al solo motore, al battello allestito ed in che condizioni. Nella norma europea proposta si fa invece riferimento a specifiche norme di prova standard (ISO 14509), che accomunano lo scafo ed il motore. In genere la rumorosità non è un problema, data la diffusione dello scarico raffreddato ad acqua e relativo forte abbattimento del rumore aereo. Un particolare applicativo della norma statunitense è significativo e degno di valutazione: invece di architettare complesse verifiche sul campo a carico dell’Amministrazione il legislatore richiede che il fabbricante garantisca il permanere della corrispondenza agli standard, per i motori che vende, nel corso di una vita utile stimata in 480 ore (!) , ma non oltre 10 anni d’età. Oppure che includa nella garanzia i pezzi necessari al mantenimento dello standard. Se l’utente, od il controllore hanno ragionevole sospetto di non-conformità,10 solo in quel caso allora sarà avviata la ri-misurazione dei parametri, a carico del fabbricante se risultasse fuori norma. 11 E’ un criterio interessante che può ispirare un meccanismo analogo in ambito lagunare riguardo la de-taratura delle pompe combustibile sui diesel entrobordo sovrapotenziati, che spinga l’officina a prendere le migliori precauzioni del caso per evitare frodi, adattandole dinamicamente alla risposta del mercato in modo assai più rapido di quanto possibile per l’Amministrazione, a cui dovrebbe essere direttamente chiamata a rispondere. 10 L’acquirente, sapendosi tutelato e per evitare sanzioni, si fa di sicuro parte diligente. 11 Va da sé, con conseguenze anche economiche pesanti sul fabbricante, che non ha così interesse alcuno ad alleggerirsi di precauzioni al riguardo cautelandosi anche nelle condizioni di vendita . Sezione 3 Pagina 7 Consorzio Venezia Ricerche Il controllo di fumosità allo scarico dei diesel entrobordo in impiego lagunare L’adozione di controlli su limiti di fumosità in particolare dei motori diesel, prassi automobilistica comune, sembrava inizialmente fosse tecnicamente difficile da concepire sui battelli, almeno allo stato attuale e come generalità dei casi. Il raffreddamento ad acqua dei motori marini infatti è usato anche per diluire e raffreddare i gas di scarico, e falsa di conseguenza anche l’eccesso di fumosità. La differente miscelazione d’acqua di raffreddamento (proporzionale alla mandata della pompa di raffreddamento, cioè legata al numero di giri del motore) e gas di scarico (massima fumosità a bassi regimi) avrebbe complicato ulteriormente la generazione di un criterio attendibile. In sostanza, un motore diesel marino avrebbe fornito valori d’opacità di difficile accertamento e, per di più, variabili istante per istante a seconda del suo raffreddamento, se non fosse stato possibile accedere direttamente alla colonna di gas prima della miscelazione in acqua. E’ stato invece chiarito con l’officina IVECO AIFO, e da colloqui avuti con diversi motoristi manutentori che la modifica non presenta particolari difficoltà, dovendosi solo sistemare un punto di prelievo dei gas forando ad es. il manicotto dell’acqua di raffreddamento (riser), oppure inserire un manicotto flangiato predisposto per la sonda, fra l’uscita della turbina e l’ingresso del riser. Anche sui motori più recenti, che sono dotati di waste gate e riser in ghisa pressofusa, non sembra che l’operazione sia eccessivamente complicata, e comunque possibile. Una verifica operativa può comunque essere avviata sulla base dei modelli d’opacimetri omologati dalla Motorizzazione, e delle relative prescrizioni d’installazione, in particolare per quanto riguarda gli attacchi e le temperature ammesse dalla sonda. Sezione 3 Pagina 8 Consorzio Venezia Ricerche Si apre quindi una possibilità interessante per il controllo sul campo dei livelli di fumosità dei motori professionali, ed in ultimo dello stato del motore: tutti i motori diesel entrobordo marini possono essere disaccoppiati dal carico ed accelerati a vuoto, e quindi non solo le procedure, ma anche le scale d’accettabilità sono immutate rispetto ai motori stradali. I limiti d’accettabilità della fumosità allo scarico12 sono regolati dalla Direttiva 77/143/CEE relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e delle emissioni dei gas di scarico, e prevedono che il valore limite dell'opacità delle emissione di scarico in libera accelerazione (motore in folle e accelerato gradualmente con dolcezza dal regime minimo al regime massimo) debba essere: • • • motori diesel ad aspirazione naturale: 2,5 m-1 (63,5%) motori diesel turbocompressi: 3,0 m-1 (70%) motori diesel immatricolati prima del 1980: 3,0 m-1 (70%) Nel diporto esistono invece numerosi motori (tipicamente, i fuoribordo) che non hanno parti accessibili del sistema di scarico o di raffreddamento per posizionare una sonda, o che scaricano sott’acqua direttamente attraverso il mozzo dell’elica: su questi, ovviamente, non è possibile nessun controllo in esercizio, come d’altra parte ammette anche la norma EPA americana. L’unica possibilità di limitarne le emissioni è di richiedere la conformità al ciclo d’omologazione al banco, da nuovo, secondo canoni fissati da un protocollo internazionale esistente od alla direttiva europea, quando sarà implementata. E’ possibile fare riferimento all’analogia con la normativa EURO stradale (come d’altra parte esplicitamente fa la legge speciale per Venezia) anche se va considerato che i motori marini di derivazione stradale si adeguano molto lentamente, e che i motori ‘realmente marini’ non seguono le norme EURO. Utilizzare le medesime scadenze previste per le norme stradali potrebbe essere quindi velleitario, per mancanza di modelli sul mercato. Poche garanzie esistono poi, purtroppo, che il mantenimento delle caratteristiche sia verificabile durante la vita del motore, mancando in Europa un meccanismo all’origine simile a quello statunitense. 12 In base alla c.d. ‘Legge speciale per Venezia’ l’indice d’opacità si deve applicare tanto ai motori automobilistici che a quelli marini. Sezione 3 Pagina 9 Consorzio Venezia Ricerche I limiti di rumorosità Esistono due aspetti rilevanti nel fissare i limiti di rumorosità dei motori marini, professionali e da diporto: l’emissione verso l’esterno, e quindi il fastidio arrecato più o meno occasionalmente a terzi ad una data distanza, e l’esposizione acustica del lavoratore professionale per prolungati periodi di tempo. La norma europea proposta, sostanzialmente concorde con le altre normative, prevede limiti differenziati di rumore per scafo + motore in base alla potenza installata a bordo, e misurati alla distanza di 15 metri trasversalmente al battello al massimo della velocità Potenza motore in kW Livello di pressione sonora in dB(A) Smax PN <= 10 67 10 < PN < = 40 72 PN > 40 75 Per installazioni con due o più motori è consentita una tolleranza di 3 dB.13 Incidentalmente si nota che questo implica anche far poca onda, quantomeno non frangente e rumorosa. Penalizza insomma di più le barche tozze e dislocanti, che le snelle e plananti. Il Regolamento provinciale indica in 72 dB(A) misurati a 25m il limite di rumorosità, quindi un valore forse più basso di quanto verrà fissato nella norma europea prossima, almeno per motori più grossi. Si porrebbe allora il problema pratico di ri-misurare eventualmente le barche omologate dal fabbricante in base alla norma europea, e quindi si suggerisce di mantenere il valore di 72 dB(A) citato nel testo del Regolamento, ma prevedendo modalità di misura analoghe a quelle della eventuale direttiva EU ed attenuandolo leggermente, se fosse più restrittiva. Per ragioni pratiche e di realizzazione, non appare insomma opportuno discostarsi dalla norma europea, tenuto anche conto che, essendo riferito alla piena potenza spesso irrag- 13 Lo standard completo della misurazione secondo norme europee è riportato in appendice, nella bozza di direttiva comunitaria non ancora approvata in sede CE. Sezione 3 Pagina 10 Consorzio Venezia Ricerche giungibile in ambito lagunare, in effetti i livelli di rumorosità attesa saranno in pratica inferiori. Esiste un problema d’armonizzazione della rumorosità in condizioni di certificazione con le eventuali prescrizioni a livello municipale urbano, ma si è preferito in questa sede limitarsi ad indicare quali sono i limiti massimi ammissibili di rumorosità dei battelli a piena potenza e velocità, e non quali debbano essere i criteri di rumorosità tollerabile localmente in ambito urbano, che risentono di riflessi, smorzamenti, echi. Questo, in completa analogia con quanto si fa abitualmente ad es. sulle caratteristiche d’attenuazione delle marmitte o sugli avvisatori acustici delle automobili, dove future limitazioni del disturbo applicabili in aree delimitate non sono oggetto d’esame in sede d’omologazione, ma esclusiva responsabilità del conduttore. Il limite proposto di 72 dB(A) massimo non esclude quindi che, in particolari condizioni e zone, il conduttore debba esser obbligato a limitare ulteriormente il rumore per seguire requisiti più stringenti. Le esposizioni dei lavoratori professionali sono invece regolamentate, in campo marittimo, da una norma IMO 14 , che prevede l’uso di protezioni acustiche individuali per esposizioni prolungate a livelli superiori a 85 dB, e raccomanda un limite di 75 dB negli spazi per passeggeri e di lavoro. 15 E’ stato verificato con alcune prove dirette che il livello d’insonorizzazione interna d’alcuni battelli professionali (mototopi, motobette in acciaio e mototrasporti per attività edilizie, in particolare) sono largamente insoddisfacenti, ed i limiti IMO superati. Non solo un problema “verso l’esterno”, dunque, ma anche per la tutela della salute degli addetti. Questo aspetto è particolarmente sentito nei topi, dove il ‘topista’ può rimanere esposto per lungo tempo al sibilo delle turbine che sempre più di frequente sono presenti sui motori professionali, posto che nella configurazione standard l’aspirazione delle stesse avviene direttamente dal vano di guida ad una distanza inferiore al metro dalle orecchie del conducente. 14 IMO res. 468(XII), convertito in decreto legge DL 271/99, riportato in appendice. 15 Benché la ‘sanzione’ del DL 271 nel primo caso sia solo l’obbligo di indossare le cuffie, non è chiaro quale invece sia nel secondo caso: è certo che la qualità del trasporto in caso di superamento del limite è alquanto scadente. Questo aspetto potrebbe essere oggetto di indagine sui mezzi di trasporto publlico di linea. Sezione 3 Pagina 11 Consorzio Venezia Ricerche Premere per una migliore insonorizzazione del vano ed imporre un limite massimo tollerabile (con motore alla massima potenza) non superiore a 80 dB almeno sui battelli di nuova immatricolazione sembra un suggerimento normativo in linea con quanto in vigore in casi analoghi anche terrestri. Per le imbarcazioni esistenti, l’adozione dei riferimenti riportati nel DL 271/99 anche per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 24m è poi del tutto praticabile, con costi anche relativamente contenuti. Sezione 3 Pagina 12 Consorzio Venezia Ricerche Spandimenti funzionali e volontari in acqua: il caso dei motori fuoribordo a 2 tempi L’uso dei motori a due tempi in laguna, o meglio la loro proibizione, è già stata oggetto d’animate discussioni in sede di Commissione per il moto ondoso. I motori a due tempi sono funzionalmente molto inquinanti, ma anche molto numerosi. La diffusione ne impedisce anche l’eliminazione immediata. Rispetto al tempo delle discussioni precedenti, durante le quali non esistevano alternative praticabili alla propulsione a due tempi 16, adesso esistono sul mercato numerosi modelli di motori a quattro tempi fuoribordo, forse solo meno assortiti nella gamma sotto i 25 Hp. Non sono ancora pienamente accettati dall’utenza (costano e pesano assai di più, benché consumino meno) ciononostante il futuro ne vedrà una diffusione sempre più ampia. Nel frattempo, sembra opportuno intervenire almeno sulla motorizzazione più vecchia, imponendo o favorendo la dismissione dei motori a due tempi d’età superiore a 12-15 anni, età risultante dal libretto del motore. L’età di 15 anni non è casuale; la durata media di un fuoribordo indicata dalla proposta di direttiva europea per il controllo d’emissioni nella nautica è di 10 anni. Paradossalmente, lo stesso documento indica in sole 350 ore la vita in termini di funzionamento continuo, confermando così i bassissimi impieghi annui effettivi di questi motori. D’altra parte, non va sottovalutato che il parco di natanti, ed a maggior ragione dei motori, ha già almeno dieci anni di vita, in media. I cinque anni aggiuntivi d’età graziata servirebbero ad escludere per il momento almeno metà del parco, e probabilmente a limitare le rimostranze dei proprietari (...un motore il mio che è come se fosse nuovo, ha dieci anni e va benissimo...). E’ poco sostenibile in buona fede che un motore vecchio di quindici anni in effetti sia “un motore nuovo”, anche se usato molto poco. La natura del problema, d’altra parte, è del tipo ON-OFF: non è possibile pensare ad un motore a due tempi “che inquina poco”. O è consentito usare i due tempi, o non lo è. La massima tolleranza può essere esercitata nella progressione temporale del divieto, nel diluire nel tempo l’obbligo di sostituzione, nel prolungare la vita dei motori esistenti, ma sapendo bene che l’eliminazione dei due tempi dalla navigazione lagunare non richiederà, 16 Ad esclusione della propulsione elettrica, il cui obbligo all’epoca fu proposto per il diportismo minore, e vige in ambito molto limitati come il lago di S. Croce od il Titisee. Sezione 3 Pagina 13 Consorzio Venezia Ricerche senza interventi draconiani, non meno di una decina d’anni. Un segnale d’attenzione al problema, anche se di difficile controllo, è poi di prescrivere un limite massimo d’olio nella miscela, il 2-3% al massimo: i motori più vecchi, anche per consolidata credenza lagunare che attribuisce all’olio lubrificante inesistenti capacità antidetonanti, sono alimentati invece con miscela anche all’8-10%. Una possibile proposta di graduazione della sostituzione potrebbe quindi articolarsi in • proibizione della vendita di motori nuovi a due tempi di potenza superiore a 20-25 hp immatricolati dal gennaio 2004 per uso su natanti LV in ambito lagunare. La dilazione di un anno ha lo scopo di annullare le scorte dei commercianti; • nessuna limitazione al commercio dell’usato ed utilizzo di motori a due tempi esistenti di potenza superiore a 20-25 hp immatricolati negli ultimi 12-15 anni, ma progressivo divieto d’utilizzo di quelli più antichi, a far data dalla prima commercializzazione segnata sul libretto del motore. La grazia ai motori più piccoli avrebbe lo scopo di escludere le micro-potenze, numerose ma meno inquinanti di quelle grandi, e non imporre eccessivi oneri di sostituzione su un’utenza presumibilmente anziana, di ridotte possibilità economiche e che utilizza i motori in modo limitatissimo. Oltre a ciò, è dubbio che esistano in commercio alternative a quattro tempi in misura adeguata e di peso relativamente contenuto per le potenze sotto i 25 Hp. E’ prevedibile che in questo modo escano dal circuito dell’utenza circa 1.000-1.500 motori/anno, ma anche che in parte saranno sostituiti da usato equivalente più recente, e con le inevitabili proteste iniziali dei fabbricanti, dei rivenditori e degli utenti 17 . Infatti la scelta del- le versioni a quattro tempi è limitata ai maggiori fabbricanti mondiali (americani e giapponesi, in particolare) ed esclude i piccoli fabbricanti europei ed italiani, specialmente a carattere semiartigianale e con un’offerta tecnologicamente obsoleta. 17 Forse i rivenditori capteranno però il potenziale interesse a vendere motori nuovi, lasciando la protesta ad una parte dell’utenza ed ai fabbricanti nazionali. L’utenza ad impiego elevato si sta già convertendo al 4 tempi. Sezione 3 Pagina 14 Consorzio Venezia Ricerche Spandimenti funzionali e volontari in acqua: le pitture antivegetative. 18 Le pitture antivegetative che con cui sono trattate le carene delle navi e dei battelli contengono componenti biocìdi, il cui scopo è di contrastare la crescita di organismi sulla superficie immersa ed diminuire così la resistenza d’attrito all’avanzamento, che tenderebbe a crescere col passare del tempo e del rigoglio. I biocidi sono cioè componenti venefici lentamente solubili in acqua che, aggiunti alle pitture da scafo, servono ad uccidere la vegetazione che va a stratificarsi sulle imbarcazioni in acqua, specialmente se questa è stagnante e relativamente calda com’è il caso della laguna veneta. I biocidi sono stati progressivamente sostituiti, passando da miscele a base di composti a base d’arsenico (molto efficaci perché molto velenosi) fino ai composti rameici di qualche anno fa ed organostannici attuali fino a pochi mesi fa 19 . La veneficità era ovviamente mantenuta dalle elevate concentrazioni e dalla elevata velocità del rilascio, il che andava a discapito della vegetazione ma anche della biosfera in generale, particolarmente per le alte concentrazioni d’imbarcazioni in ambito ristretti. La dimostrata teratogeneticità delle pitture antivegetative ha suggerito, senza troppa pubblicità, di sostituire i prodotti più efficaci con altri di minor impatto ambientale. Questo anche tenendo conto che le imbarcazioni da diporto si concentrano in zone limitate, spesso pregevoli da punto di vista ambientale, e stazionano a lungo senza muoversi dagli ormeggi. Di conseguenza nel diporto si usano pitture ad alta solubilità, e rilascio garantito anche a barca ferma. Contrariamente a quanto può sembrare ovvio, le navi d’alto mare inquinano meno, perché hanno invece pitture con tassi di rilascio inferiori (una nave è costantemente in movimento, e con alti rilasci la pittura sarebbe dilavata troppo rapidamente, mentre intercorrono anche tre anni fra ogni ‘riverniciatura’ ). Non solo, ma i biocidi sono ben ampiamente dispersi nel volume degli oceani. La situazione attuale è che le pitture antivegetative, in vendita in Europa dal prossimo 31 dicembre 2002, categoricamente non possono più contenere composti organostannici, e le 18 Si ringrazia il sig. A. Baseggio, del colorificio Baseggio srl di Spinea, per le informazioni relative alle formulazioni e vincoli normativi delle pitture marine antivegetative attuali. 19 Un rischio dei biocidi è non solo la veneficità (letalità sui microrganismi marini) ma anche quello della teratogeneticità (alterazione genetica di specie non direttamente coinvolte nel processo di stratificazione). Sono particolarmente soggetti alterazioni teratogenetiche organismi pluricellulari, come molluschi e pesci. Sezione 3 Pagina 15 Consorzio Venezia Ricerche pitture sono già in vendita da oltre un anno e mezzo esclusivamente in questa composizione modificata (organostannici sostituiti da un tinfree component). Gli effetti per l’utenza questa estate sono apparsi evidenti: le pitture non funzionano più come l’anno passato, per intendersi, e la voce comune della laguna addebita la maggior sporcizia delle carene alla più fiorente ed aggressiva flora lagunare 20 , non alla minor effi- cacia delle pitture. Abbinata, fra l’altro, a maggior costo rispetto all’anno passato. La dimensione e la complessità del problema, unita alla difficoltà di controllo ed alla specificità dell’argomento, suggerisce anche in questo caso che la normativa provinciale si adatti semplicemente alla norma europea in vigore, senza introdurre varianti e maggiori vincoli 21 22. Risulta fra l’altro che gli studi commissionati in tempi recenti all’ARPAV, sulla concentrazione di biocidi nella laguna di Venezia, non hanno evidenziato concentrazioni né pericolose, né rilevanti di veleni disciolti nelle acque ed originati dalla pitture, questo anche con le composizioni precedenti ora vietate, ed inoltre l’utenza non è al corrente di queste modi20 21 22 I taxi quest’estate sono stati sollevati e spazzolati in carena in media ogni dieci giorni, come dire che l’antivegetativa è tale solo per nome, non certo per l’effetto sulla flora lagunare. Lo scarso effetto è ben evidente nella foto di taxi sollevato nella sezione 4. I composti del mercurio ed i composti dell’arsenico non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: 1) carene d’imbarcazioni; 2) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura. I composti organostannici non possono essere immessi nel mercato per essere utilizzati come sostanze e costituenti di preparati a formulazione libera da utilizzare con funzioni di biocidi in vernici antivegetative e non possono essere utilizzati come sostanze e costituenti di preparati con funzione di biocidi per impedire la formazione d’incrostazioni di microrganismi, piante o animali su carene d’imbarcazioni di lunghezza fuori tutto, quale definita dalla norma ISO 8666, inferiore a 25 metri; imbarcazioni di qualsiasi lunghezza utilizzate prevalentemente nelle vie di navigazione interna e nei laghi; gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura; qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso. Tali sostanze e preparati non possono essere immessi nel mercato se non in imballaggi di capacità pari o superiore a 20 litri; venduti al dettaglio al pubblico, ma esclusivamente agli utilizzatori professionali. Salva l'applicazione d’altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull'imballaggio di tali preparati devono figurare in maniera leggibile e indelebile le seguenti diciture: “Non utilizzare sui battelli di lunghezza inferiore a 25 metri fuori tutto, sulle imbarcazioni di qualsiasi lunghezza utilizzate prevalentemente nelle vie di navigazione interna e nei laghi e su qualsiasi apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura. Riservato ad utilizzatori professionali”. Le disposizioni di cui alla sezione 2, lettera a), e le disposizioni specifiche in materia d’etichettatura di cui alla sezione 2 si applicano ad Austria e Svezia o a decorrere dal 1 gennaio 2003 e saranno riesaminate dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate prima di tale data. La direttiva europea è in verità antica, 76/769 CEE del luglio 1976, ma è stata modificata in via definitiva solo dalla 1999/51/CE del 26.5.99. L’entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2002. Sezione 3 Pagina 16 Consorzio Venezia Ricerche fiche alla composizione delle pitture. Il divieteo ad ogni buon conto andrebbe esteso alle imbarcazioni di lunghezza superiore a 24m, con impiego lagunare, nel dubbio che fosse possibile ancora per qualche anno approvvigionarsi di pitture escluse dal mercto ufficiale. Esistono pertanto i presupposti per un divieto generalizzato in ambito lagunare, da pubblicizzare come iniziativa di tutela dell’ambiente locale, di sicuro successo e senza che esistano particolari problemi d’implementazione pratica. Sezione 3 Pagina 17 Consorzio Venezia Ricerche Spandimenti funzionali e volontari in acqua: le acque reflue di sentina e rifiuti umani Lo sversamento volontario delle acque oleose di sentina, che sono inevitabili nella navigazione a motore 23, il getto a mare di rifiuti e la discarica di liquami sono vietate da una convenzione internazionale 24 in prossimità della costa, e comunque entro le c.d. ‘aree speciali’, una delle quali è l’intero Mediterraneo. Tutti questi reflui vanno raccolti in appositi contenitori, e smaltiti a terra in idonei punti di raccolta che ogni Amministrazione marittima ha dovere di predisporre, a costi ragionevoli. 25 La laguna veneta, nella sua natura ambigua d’acque interne e marittime, potrebbe non essere esplicitamente considerata come compresa nella MARPOL e quindi potrebbe dover essere tutelata con particolare ordinamento nazionale o locale per quanto riguarda le discariche di materie contaminate da idrocarburi, rifiuti e reflui. Un articolo del Regolamento provinciale al riguardo è stato cancellato da una sentenza del TAR, né è noto se sia stato surrogato in qualche modo, o ripristinato. Sui battelli professionali e nel diporto esistono difficoltà pratiche, per le dimensioni, i costi e la complessità, ad ospitare impianti di raccolta dedicati. Negli Stati Uniti, sistematicamente, le imbarcazioni da diporto sono attrezzate con serbatoi di raccolta dei reflui umani e petroliferi, con pompe dedicate: è vietato tassativamente scaricare in mare, mentre le marine sono attrezzate con collegamenti appositi per lo svuotamento dei serbatoi. In Italia non è nota la situazione delle possibilità di smaltimento nelle marine da diporto, però sono opportunità che eventualmente riguardano le imbarcazioni, per certo non i battelli ed i natanti che si appoggiano per ricovero e stazionamento a semplici approdi e che non dispongono d’alternative allo smaltimento clandestino in mare. Allo stesso modo, si ignora con precisione ma si intuisce che gli impianti sanitari di molte imbarcazioni da diporto dotate di possibilità di permanenza a bordo scarichino, specie sulle più anziane, direttamente in acqua. 23 I reflui di sentina derivano dall’inevitabile raccolta d’acqua piovana, da infiltrazioni, da stillicidi nella sentina, insieme con ogni colaggio di nafta, olio e morchia proveniente dall’apparato motore. 24 Convenzione MARPOL 73/78 e successivi emendamenti, ratificata dall’Italia nel 1981. 25 Per le navi gli attacchi fognari per la discarica a terra sono comunemente sostituiti da impianti di depurazione e trattamento biologico a bordo, e sono in ogni modo obbligatori solo sopra una data dimensione. Sezione 3 Pagina 18 Consorzio Venezia Ricerche Analogamente si richiederebbe un controllo individuale, caso per caso, che i lancioni GT e grandi battelli per trasporto passeggeri, dotati di servizi igienici e magari anche di bar/ristoranti, siano attrezzati per il mantenimento a bordo dei rifiuti fino ad uno smaltimento congruo, e come questo in realtà avvenga. Allo scopo di coprire un possibile vuoto normativo, si propone l’allargamento della disciplina MARPOL, od equivalente, di divieto assoluto di discarica in laguna d’ogni sorta di refluo alle imbarcazioni lagunari di qualunque dimensione, quale che sia il servizio da loro svolto. E’ da valutare se non sia proponibile, sulle imbarcazioni professionali più piccole come mototopi e taxi, richiedere l’installazione di un piccolo serbatoio da 10-20 litri, anche amovibile, con pompetta aspirante dedicata, flessibile e pigna d’aspirazione per la raccolta dei reflui oleosi di sentina e smaltimento gratuito presso serbatoi più grandi posti, ad esempio, presso i distributori di carburante. Obbligo che sarebbe comunque da estendere con effetto immediato a tutti i battelli di dimensione superiore a 12m di lunghezza, se già non sono attrezzati in altro modo. Sezione 3 Pagina 19 Consorzio Venezia Ricerche L’organizzazione e l'ordinamento delle operazioni complementari alla navigazione lagunare A semplice titolo di completezza, si illustrano alcune possibili iniziative di tutela ambientale collegate alla navigazione lagunare, relative ad alcuni aspetti che sono stati limitatamente considerati fino ad ora. Il trasporto di merci pericolose in laguna, per mezzo di battelli per impiego professionale, è un aspetto che sembra a tutt’oggi privo d’ogni ordinamento specifico. Sono da comprendere in questa voce i movimenti ed i rifornimenti d’idrocarburi, di materiale radiologico e tossico per gli ospedali e centri sanitari, di prodotti tossici solubili, di gas compressi, infiammabili e materiali esplosivi o reattivi, che per forza di cose si svolgono spesso in ambito urbano, aree densamente popolate e trafficate. Più che al pericolo intrinseco 26 , l’assenza di norma espone al rischio politico di condanna da parte dell’opinione pubblica in caso d’evento anche minimo che coinvolga questi trasporti (anche solo per collisione od incendio fortuito) ed ad inevitabili ricadute polemiche sull’intero assetto della sicurezza dei trasporti lagunari. Effettivamente uno spargimento di gasolio nei canali interni per falla di una bettolina da 500 t 27 potrebbe portare all’infausto primato di massima superficie urbana inquinata a seguito di un singolo incidente 28. Anche se è poco probabile che si verifichi un evento così catastrofico, qualunque avvenimento meno tragico ma sufficientemente amplificato dai massmedia porterebbe con sé, in assenza di ogni precauzione normativa preliminare, uno strascico polemico molto spiacevole per qualunque amministrazione. Parallelamente a questo aspetto, andrebbe ordinata ed armonizzata la disciplina dei rifornimenti delle navi e delle aree industriali, che sono competenza sì dell’Autorità marittima (svolgendosi in acque definite marittime e portuali) ma sono svolti con mezzi non soggetti 26 Obbiettivamente piuttosto basso, non essendosi registrato alcun incidente di rilievo nella storia del traffico motorizzato della laguna. Va considerato però l’incremento inarrestabile dell’età media dei natanti dedicati. 27 N’esistono di vecchie di 35 anni, a semplice scafo, in pieno servizio sotto sorveglianza ogni cinque anni da parte della Motorizzazione civile e dell’Ispettorato di Porto. 28 Un conto approssimativo, trascurando la compartimentazione interna, mostra che uno strato di 1 mm di gasolio – che scorre terribilmente veloce - ricoprirebbe mezzo milione di metri quadrati di canali cittadini. In una città ‘terrestre’ lo spandimento è certamente più ostacolato, e difficilmente di quest’entità. I trasporti urbani, sono unitariamente più piccoli, 30 t al massimo. Sezione 3 Pagina 20 Consorzio Venezia Ricerche alla sorveglianza tecnica dell’Autorità marittima, bensì della Motorizzazione o dell’Ispettorato di Porto. Attività che riguarda anche impianti – come i distributori di carburante sulle isole, ed altri impianti industriali del genere – che non sono soggetti al controllo dell’Autorità marittima. Lo smaltimento delle imbarcazioni in materiale non-biodegradabile è un altro versante finora poco considerato dell’impatto del traffico lagunare. Il problema ancora non si è posto con tutta evidenza, come si è visto in altra sezione di questo rapporto, ma esistono forti segnali che inducono alla dovuta attenzione. Non è assolutamente da escludere, anzi, è probabile, che nel breve giro di pochi anni ci si debba preoccupare di come individuare, recuperare, e smaltire migliaia di tonnellate di VTR ed ABS ogni anno, che sarebbero altrimenti abbandonate senza criterio e senza possibilità d’individuazione del proprietario. E’ questo un altro esempio della esteriorizzazione dei costi che la produzione della VTR ha indotto a carico della comunità, e che andrebbero compensati con qualche forma di riequilibrio monetario a carico del proprietario che si è avvantaggiato di un più basso prezzo d’acquisto iniziale, e di manutenzione nel corso della vita del manufatto. Esiste tempo sufficiente per impostare un’operazione articolata di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, ma anche per prevedere e provvedere a modalità di raccolta e trattamento di questi manufatti, di valorizzazione dei costi e di finanziamento. Non va dimenticato che un battello inutilizzabile e destinato all’abbandono spesso non è in grado di galleggiare, è difficile da rimuovere e da trasportare, e quindi occorrerebbe un’attrezzatura dedicata simile a quanto VESTA ha predisposto per la rimozione dei rifiuti ingombranti in terraferma, oltre che punti di raccolta ed idee precise sul modo di smaltire o riciclare questi relitti. Un costo di svariate migliaia di € per unità, a prima superficiale impressione. Un’organizzazione di questo tipo, per quanto inizialmente possa essere snella, va in ogni caso pensata anche per l’ambito urbano e per la pulizia degli stazi dai relitti semiaffondati, sempre più frequenti, che diminuiscono il decoro cittadino ed impediscono lo sfruttamento appropriato degli spazi acquei. Sezione 3 Pagina 21
Scarica