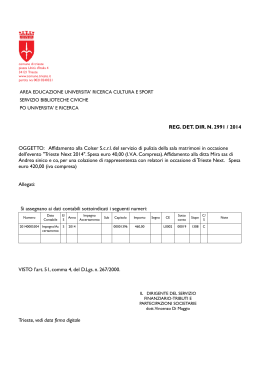Giorgio Weiss PRIME RIFLESSIONI CON TRIESTE NEL CUORE 1 2 PRESENTAZIONE Intervento critico di Maria Pia Somma Giorgio Weiss non è un letterato di professione, ma in questa sua opera prima palesa una naturale capacità a comunicare, capacità che da un lato ci autorizza a definirlo scrittore e dall’altro ci fa sperare che a questa, seguiranno altre opere. Qua e là scorrendo questo libro ho provato curiosità, desiderio di sfogliare avanti, piacere nel constatare fin dalle prime battute che chi ha scritto è una persona felice. Mi sono sentita, però, in alcuni momenti, indiscreta, intrusa in casa d’altri, e ho faticato un po’ a rendermi conto di essere stata invitata, di avere avuto la gioia di essere ospite in una vita che pur non essendo mia, ho sentito tale: l’autore mi ha permesso di entrare, di guardare, di condividere squarci della sua esistenza. In Pensieri ho letto due frasi che subito mi hanno fatto riflettere e mi piace di ricordarle. La prima ironicamente recita: “Chissà quanti nemici mi sarò fatto con queste affermazioni!” e si riferisce al fatto che Weiss pensa, in buona fede, che parole assemblate senza l’uso di metrica e rime non possano essere definite poesia. Nell’esternare ciò teme addirittura di offendere i suoi amici poeti dilettanti. Spiace contraddirlo, ma la poesia, quella che rimane nel cuore e nella mente, che prende l’anima, spesso è proprio quella che non ha rime e non è rispettosa della metrica. È la poesia che esce dai canoni consueti, li travalica, con la capacità di far pensare, di commuovere e di farsi specchio, quasi fosse stata scritta solo e confidenzialmente per chi vi si accosta. Io traggo poesia, non prosa dalle righe di questo scritto, anche da quei puntini di sospensione che precedono il nome Nory, la moglie dell’autore. Quanta emozione, sincerità, amore che ha saputo intendere e far intendere 3 in maniera così semplice. È poesia, raccontare di sé e far sì che chi legge si trovi all’interno di ciò che viene raccontato, dentro il sentire di chi scrive, far provare o riprovare sensazioni che sono dello scrittore, ma che il lettore scopre appartenere anche a se stesso. E non è poesia da poco. Sono Pensieri di Weiss ai quali riesce facile dar credito proprio perché anche noi li abbiamo pensati, vissuti. E chi come me, non poteva fisicamente esserci in alcuni giorni di Infanzia, legge con sincera partecipazione di quei momenti, non certo tutti sereni, ma ricordati con tanto realismo, con sì grande efficacia da suscitare il desiderio di esserci stati. E prova rabbia nel rendersi conto di tanto dolore e di tante vessazioni subite: proponendoci brani della sua vita Giorgio Weiss, in punta di penna e di passione, ci aiuta a comprendere meglio la nostra storia. E poi c’è la seconda frase. Dimora nel capitolo Prosecco in Pensieri: “Nella vita per riuscire bisogna trovarsi al posto giusto nel momento giusto” Credo sia un’affermazione incompleta. Nella vita per riuscire bisogna trovarsi al posto giusto nel momento giusto, ma non basta, se manca il coraggio si perdono comunque tutte le occasioni che la sorte ci offre. È importante fare le scelte giuste e ritengo che Giorgio Weiss ci sia riuscito. Ha scritto, per esempio, e ha scelto di pubblicare un libro bellissimo, pieno di sincerità e di amori per la sua famiglia, per i suoi amici, per la sua terra, per la vita. Grazie per il regalo, Giorgio, fatto a me e a quanti, mi auguro in molti, ti leggeranno. Maria Pia Somma gennaio 2004 4 PENSIERI Febbraio 2000 5 6 PENSIERI 1999, ultimo anno di questo secolo e di questo millennio, siamo alle soglie del duemila ed ho sentito il desiderio di scrivere alcuni miei pensieri, impressioni, fugaci lampi che mi passano per la testa, quasi un’agenda di appunti da rivedere nel tempo, senza sequenza logica, aperta a tutti coloro che avessero piacere di leggerla. Dedicata ai miei nipoti che, quando saranno grandi e, se, avranno piacere di sapere, potranno trovare in quest’agenda scorci di vita, usanze e costumi dei tempi passati e della nostra famiglia. 7 8 POETI Oggi ci sono tanti poeti. Molte persone, uomini o donne, adulti, per fortuna pochi ragazzi, scrivono versi. Ma di versi si tratta? In tanti casi penso proprio di no. Mi vengono in mente....... O cavallina, cavallina storna che portavi colui che non ritorna....... I cipressi che a Bolgheri alti e schietti van da S.Guido in duplice filar quasi in corsa giganti giovinetti mi vennero incontro e mi guardar....... Metrica, rima, sentimenti intensi.....poesia insomma! Prendo in mano alcuni libretti di poeti contemporanei, scorro le pagine, si sente l’intensità del desiderio di esprimere emozioni interne, scriverle, quasi inciderle e scolpirle, per rafforzare le sensazioni che salgono dall’animo e dal cuore. Commoventi, alle volte, altre scherzose e piene di brio, ma sono frasi, senza rima e molto spesso senza metrica. Frasi, e non versi messe lì, riga sotto riga quasi a segnare gli intervalli di lettura che una normale interpunzione avrebbero espresso, forse, meglio. Quanti nemici mi sarò fatto con queste affermazioni!!! Non lo so ma io la penso così. 9 INFANZIA Sono ormai vecchio, anzi no, oggi si dice anziano ed il mio pensiero vola indietro alla fanciullezza. I più begli anni dell’infanzia quando tutti i bimbi giocano........ per me, guerra! Corse con la mamma nei rifugi antiaerei, freddo, umidità, buio, tristezza, pianti, fame.... piatti di minestra lasciati sul tavolo della cucina ed, al rientro, inevitabilmente freddi e rappresi. Ma si mangiavano lo stesso. Come giocattoli certamente no “Lego”, automobiline radiocomandate, biciclette, pupazzi, bambole, soldatini, carri armati, fortini, castelli, cannoni, pistole, fucili, video games...... ecc. ma solo tanta fantasia, due o tre mollette su di un bastone e si aveva un fucile. Un pezzo di cotone di un vecchio lenzuolo oramai inservibile legato intorno alla vita e una tavoletta di legno più o meno sagomata e si aveva il cinturone con la Colt. Eppure non rimpiango quei tempi, mi hanno forgiato, affrontare la vita è stato più facile. Superare le difficoltà è stato quasi un gioco. Oggi i bambini hanno tutto. Domani sapranno superare le asperità della vita? 10 18 ANNI Una volta si diventava maggiorenni a 21 anni, ma a 18, comunque, si aveva più libertà. Si andava al cinema e la domenica pomeriggio a ballare. Una volta non c’erano discoteche assordanti con luci psichedeliche, lampi, 200 decibel per centimetro cubo, ma c’erano tante sale dove la gioventù poteva ballare, stare in allegria e fare conoscenze, senza uscirne rintronati e con la testa in pallone. L’orchestrina in un angolo suonava serie di quattro o cinque ballabili e poi c’erano alcuni minuti di intervallo. Le ragazze sedevano ai tavoli ed i ragazzi stavano pronti a scattare alla prima nota musicale per avvicinarsi alla ragazza adocchiata nell’intervallo..... “Signorina permette questo ballo?”... alle volte “Sì”, alle volte.... “No grazie, sono stanca”, oppure, “Grazie sono già impegnata”. Quasi sempre frasi fatte.... “Studia?, che scuola? che anno fa?..... Lavora? dove?... ah sì, mi sembrava di averla già vista...” Rigorosamente del “Lei”. Quanti balli, quante ragazze, quanti posti.. Ginnastica Triestina, Chimici e Petrolieri, Inter, Edera,...... D.I.M.! Poter accedere al Dopolavoro Interaziendale Marittimi, più noto come Circolo Marina Mercantile, non era facile, bisognava ci fossero due soci effettivi che garantissero per poter divenire “socio aggregato”. Ci riuscii! È stata la svolta decisiva della mia vita. A 19 anni compiuti, una domenica, vedo seduta ad un tavolo una splendida ragazza. Mi avvicino per invitarla a ballare.... un altro mi precede.... ed io guardo, non ne cerco un’altra. Invidio quel fortunato che riesce a fare una serie di balli. Intervallo. Lei si siede al tavolo. Io con fare indifferente mi avvicino, scruto l’orchestra.... fumano. Divento nervoso, spengono le sigarette, stanno prendendo gli stru11 menti in mano. - Signorina, permette questo ballo? – Sì grazie - ma non suonano... Dio ti ringrazio i primi accordi.... lei si alza mi sorride ed io non capisco più nulla. Le gambe si muovono da sole, la tengo dolcemente per paura di farle male. Poche parole, io impacciato, lei timida. Mi sento bene, man mano che passano i secondi riprendo forza, la stringo un pochino, lei non rifiuta. Il cuore batte forte, ho paura che lei lo senta, mi distanzio leggermente. Il tempo passa troppo in fretta. C’è l’intervallo. Nel salutarla chiedo: - Posso avere il piacere di avere anche il prossimo ballo? Sì! Sono passati 42 anni..... NORY! 12 SONO CONTENTO Sì, sono proprio contento di aver vissuto in questa epoca. Quante cose sono cambiate velocemente, freneticamente. Da bambino, appena finita la guerra, si giocava per la strada, sui marciapiedi eravamo i re. Con il gesso si segnavano i percorsi del Giro d’Italia e con i tappi della birra riempiti con la cera della candela si gareggiava. Rettilinei, salite, curve, discese, attenti nel dosare il colpo con il dito, perchè se il “piattino” usciva dalla riga segnata con il gesso, si ritornava indietro. Gli avversari scappavano via... bisognava rischiare nei tratti diritti di fare un tiro forte e raggiungerli prima della serie di curve. Automobili? Boh! I marciapiedi erano nostri e basta! Si facevano i “carretti”: due assi di legno fissati a un traversino fisso dietro ed uno mobile impernato al centro e posto anteriormente con quattro ruote.... rigorosamente cuscinetti a sfera, una corda legata ai lati del traversino mobile anteriore per dare la direzione al veicolo lanciato giù per le discese in mezzo alla strada. Freni?.... i tacchi delle scarpe.... quanti tacchi! A scuola: asta e filetto, bordurine, bella calligrafia, incollare figurine, fare mosaici.... ah sì... qualche volta pensierini, forse grammatica, qualche poesia. Il primo giorno sul posto di lavoro ti trovo alcuni colleghi con le “mezze maniche di satin”, penna con il pennino, calamaio, su grossi libri, registrazioni, contabilità, brogliacci di cassa, prima nota...... Operazioni su conti correnti e libretti a risparmio, rigorosamente a mano in bella calligrafia. Calcolo degli interessi! Quanti giorni mancano al 31 Dicembre?.... Capitale, volte tasso, volte tempo, fratto 36.000....... Chiusure contabili di fine anno: tre mesi di tempo, tutto deve essere pronto per il “bilancio” da presentare il 31 Marzo. 13 Rigorosamente camicia bianca maniche lunghe, giacca e cravatta, anche d’estate. Oggi, marciapiedi non esistono, automobili fino sul gradino del portone di casa, bambini rinchiusi dentro le quattro mura domestiche, tanti giocattoli sì! piste elettriche per gare automobilistiche, giochi d’abilità al computer, giocattoli spaziali, pistole laser, ....ma l’aria aperta? Ah! già è inquinata anche quella e allora.... Scuola, il primo giorno, calcolatrici, computer, accessori di lusso firmati da noti designers.... Lavoro in banca: tutto elettronico, nano secondi, 1000 giga, internet, banche dati, piazza affari, BOT, CCT, fondi d’investimento....... Camicie sgargianti, sbottonate, petti villosi, scollature generose per le ragazze, minigonne, jeans...... Sono passati 50 anni ..... sembra un millennio. Sono fortunato di aver visto in così poco tempo....tanto. 14 NONNO OCCHIALI Nonno occhiali, così soprannominai da bambino il nonno paterno. Nonno Cesare avrei dovuto chiamarlo, ma dato che portava un bel paio d’occhiali cerchiati con una sottilissima montatura d’oro che gli incorniciava il viso magro, serio, sul quale stavano formandosi le prime rughe, furono gli occhiali a colpirmi per primi e pertanto divenne “nonno occhiali”. Proveniva da una famiglia benestante dell’alta borghesia di Trieste. La famiglia aveva una grande villa in via Crispi alta, proprio dietro al teatro Rossetti; la domenica andavano al “liston” in contrada del Corso con la carrozza con 4 cavalli, il palco all’opera, vita di società. Il nonno era sempre elegante, ben vestito, un vero signore che all’inizio della guerra, ceduta la villa che cominciava ad avere dei costi di regia non più sostenibili, andò ad abitare in un bell’appartamento in via Kandler, e comunque sempre ristoranti di lusso, casinò di Portorose, ippodromo di Montebello...... Era tempo di guerra, il nonno lavorava come direttore in una fabbrica di casseforti prima e in una fabbrica che produceva olio dopo. Lo vedevo poco, ogni tanto veniva a trovarci, ma sempre di fretta. Poco prima della fine della guerra l’oleificio, venne bombardato e distrutto e nonno perse il posto di lavoro. Ne cercò un altro, ma i tempi erano duri, la guerra era finita e si cominciava pian piano a ricostruire; i reduci tornati dalla guerra, cercavano pure loro un lavoro per ricominciare a vivere. La disoccupazione era alta, ma nonno, data la sua esperienza, riuscì a trovare un posto da impiegato. Non più direttore. Un appartamento piccolo in via Sette Fontane; vestiti più modesti, mangiare a casa, Sisal..... Poi venne la pensione. I dirigenti, un tempo, non versavano contributi alla Previdenza Sociale, pertanto la pensione fu quella minima. Misera! Il nonno venne a vivere con noi. Si ammalò, gli venne una cattarata agli occhi e fu necessario farlo operare. La vista si indebolì ulteriormente, altra operazione. La cecità quasi totale. Gli ultimi anni, li ha passati in casa o tutt’al più, con l’aiuto del bastone, riusciva ad andare fino al bar sotto casa. 15 Sembra una storia come tante altre. Ma non lo è! Sembra piuttosto la storia della cicala della ben nota “La cicala e la formica”. La storia del “nonno occhiali” ci insegna non ad essere avari, ma quando si hanno tanti soldi, spendere si, ma non tutto, e salvare qualche cosa per il futuro o per i momenti più difficili. 16 NONNO “CIUPO” Come l’altro nonno aveva la caratteristica degli occhiali, il nonno materno aveva un ciuffo ribelle di capelli, che scendeva inanellato sulla fronte e come tutti i bimbi, che dicono strambotti, per me il ciuffo era diventato “ciupo” Il suo lavoro è sempre stato di operaio specializzato presso i cantieri navali. Dapprima al Cantiere Navale di Monfalcone, poi al Cantiere Navale San Marco a Trieste ed infine gli ultimi anni presso il Cantiere Navale Felszegi di Muggia, quale fiduciario per l’organizzazione del lavoro. Era un tipo mattacchione, sempre con il sorriso sulle labbra e pronto a prendersi burla dei nipoti con piccoli scherzi, che alla fine, finita la sorpresa, faceva scoppiare di gioia e si correva ad abbracciarlo e baciarlo. Per lui questa era la sua più grande ricompensa e soddisfazione. Lui faceva “impazzire” tutti compreso Roky, il mio cane lupo. Quando veniva a trovarci portava sempre con sè due o tre biscotti di quelli economici, Osvego si chiamavano, e prendendone uno dalla tasca, lo faceva vedere al cane, il quale festante, correva per afferrarlo. Troppo facile! Nonno buttava il biscotto sotto la credenza della cucina ed allora il povero cane, che era di stazza grossa, con le zampe cercava disperatamente di prenderlo, guaendo e piagnucolando. Alla fine quando, dopo parecchi tentativi, riusciva a prendere il biscotto, scappava in salotto a mangiarselo in santa pace, mentre il nonno rideva contento di aver fatto il dispetto. Più che un nonno sembrava un monello. A dieci anni ho fatto la Cresima. Eravamo nel 1947, la guerra era finita da due anni appena. Soldi ce n’erano pochini. Quando si fa la Cresima è uso che il “santolo” regali l’orologio. Mamma mia, complice, mi preparò dicendomi che il nonno, purtroppo, non avrebbe avuto i soldi per comprarmi l’orologio; mi avrebbe fatto senz’altro un regaletto per festeggiare, ma l’orologio proprio no. Pazienza! Come tutti i ragazzi di allora, avevo un carretto per correre lungo le discese delle strade adiacenti la mia casa, tanto di automobili ce n’erano un 17 paio all’ora, sì e no, pericoli quasi inesistenti. Purtroppo un giorno, battendo contro un marciapiede, una ruota, che era di legno e non un cuscinetto a sfera, si spezzò. - Diamola a nonno “Ciupo”, il mago, la riparerà in men che non si dica. Il tempo passava e della ruota c’era solo un vago ricordo. Arrivò il sospirato ed atteso giorno della Cresima. Il vestitino nuovo, la camicetta bianca candida, la cravattina grigia, i sandali nuovi con le calzette bianche. Tutto era pronto eravamo tutti in trepida attesa di nonno Ciupo che mi avrebbe fatto da santolo. Ma ancora non arrivava. Eravamo sul poggiolo, guardavamo l’angolo da dove avrebbe dovuto sbucare. - Mamma, mamma, corri, vieni a vedere! C’è un auto che arriva, si ferma davanti al nostro portone! Da dietro scende il “santolo”, c’è l’autista. Nonno dal basso ci saluta, ha un pacchetto in mano, sale le scale. - Olà, come va?, tutto bene? Siamo in festa eh? La Cresima è una festa importante, indimenticabile, specialmente per il cresimando... Ah, sì, caro Giorgio, non sono riuscito a comperarti l’orologio da polso, però ti ho costruito un orologio a sole! Sì, lo appendi in poggiolo e, quando c’è il sole, vai a vedere l’ombra che fa sul muro e saprai l’ora. E mi consegna il pacco, ben incartato, tutto infiocchettato. Sono emozionato, tolgo il nastro, apro la carta colorata, sotto c’è ancora carta di giornale, la tolgo, ancora una e così via 10, 15 carte, non so quante! Il cuore batte, finalmente c’è una scatola di cartone, l’apro e sotto la paglia c’è.......... la ruota del carretto riparata!!! Gioia da una parte, delusione dall’altra, neanche l’orologio a sole. Pazienza, la mamma mi aveva avvertito che il nonno non aveva soldini! Ma, un momento! Come si spiega la macchina..., l’autista... e allora? Ovviamente non dico nulla. - Andiamo, su! se no si farà tardi - dice nonno “Ciupo” - cosa volete, la macchina va a carburo, non corre tanto e non è detto che arrivi fino alla chiesa. Ci prepariamo per uscire, sono contento, ma anche un po’ triste. - Su, non pensiamoci è andata così! Siamo sulla porta e nonno “Ciupo” mi dice: - Giorgio non vorrai mica 18 uscire con quei sandali sporchi? Li guardo, erano lucidi come uno specchio! - No, no, così non va bene, prendi uno straccio e qui c’è la “patina” (il lucido da scarpe in dialetto) - e mi porge una scatola di “Crema Emulsio”. Mi levo un sandalo, prendo lo straccio da intingere nel lucido da scarpe, apro il vasetto e per poco non svengo. Divento rosso, le lacrime mi scendono copiose sulle guance, vorrei urlare, ma la gola è stretta da un nodo che me lo impedisce. Nel vasetto c’era un meraviglioso orologio da polso, lucente, con il cinturino in pelle marrone, il più bell’ orologio del mondo, nessuno poteva avere un orologio così bello!!! Ecco questo era nonno “Ciupo”, sempre pronto allo scherzo, alla battuta. È mancato troppo presto, un brutto male ce l’ha portato via troppo presto e anche lì, mi hanno detto anni dopo, ha chiuso la sua vita con una battuta: - Ciao a tutti, vado in viaggio, non so se tornerò. Addio! 19 MIO PADRE E MIA MADRE Descrivere mio padre, non è una cosa semplice, anche perchè nella sua vita non ha fatto cose che possano rimanere scolpite nella memoria come fatti eccezionali. Era un uomo semplice, tutto casa e lavoro, non aveva vizi, non aveva amicizie vere, per lui il suo lavoro e la sua casa erano tutto. Un mondo piccolo, chiuso, dovuto anche al fatto che è vissuto in un periodo storico non dei più felici. Nato nel 1910, orfano di madre in tenera età, già a cinque anni si è trovato coinvolto in un periodo bellico enorme, spaventoso, in una città per la quale sono morti un milione di persone tra le due fazioni in guerra, per strapparla dal dominio Austro-ungarico e ricongiungerla alla madre patria, l’Italia. Fame, stenti, tutti gli uomini validi in guerra, in una guerra che non sentivano, anche perchè combattuta a fianco degli Austriaci e contro i fratelli italiani. A casa solo donne, la mamma di mio padre era morta da poco, dando alla luce una bimba, morta anche lei, papà allevato dalle zie che, per quanto amorevoli, erano pur sempre zie. Bambino senza mamma e senza papà, desideroso di un affetto che non c’era, che non poteva esserci. Gli anni passano, bene o male va a scuola, lasciato senza guida a se stesso, termina le scuole dell’obbligo e va subito a lavorare presso un’agenzia assicurativa a fare le prime esperienze. 1930, riesce a farsi assumere alla Riunione Adriatica di Sicurtà, e lì pian piano comincia a cambiare la sua vita. Conosce Marcella, una ragazza semplice, con quattro fratelli, figlia di un operaio specializzato, che lavorava presso i cantieri navali, si innamora, e riversa in lei tutto l’amore che da più di vent’anni portava in cuore e non riusciva ad esternare. Marcella, mamma mia, lavorava, quale commessa, in un rinomato negozio di calzature, e dopo breve sposa l’impiegato assicurativo Cesare, smette di lavorare, come si usava a quei tempi, per dedicarsi totalmente alla sua casa. Anche a lei sembrava di aver toccato il cielo, non più otto persone in due stanze e cucina. Affittano un bell’appartamentino in via Vergerio e vi costruiscono il loro nido d’amore. Sì, d’amore, perchè, finalmente, mio padre aveva qualcuno d’amare. 20 Dopo il primo anno sarebbe dovuta nascere una bella bambina, mia sorella, ma con l’assistenza sanitaria inesistente dell’epoca, mia sorella venne alla luce morta, soffocata dal cordone ombelicale, che le cingeva la gola. Altro dolore da sopportare ed inghiottire. Nel 1937, nacqui io, prematuro, in sette mesi, un chilo e novecento grammi, incubatrici non esistevano, o forse solo per i ricchi in certe cliniche private. Allora, tanta bambagia, bottiglie d’acqua calda da sostituire continuamente, coperte, ma soprattutto tanto amore per questo bimbo, sono riusciti a farmi sopravvivere. Papà e mamma al settimo cielo, bisognava cambiare appartamento, più bello, più luminoso, più nuovo, doveva esserci la stanzetta per il bambino e soprattutto il riscaldamento e il bagno! Agli inizi del 1940 ci trasferimmo in via Padovan, stanza, stanzetta, salotto, cucina, bagno, W.C., atrio, due poggioli, cantina, soffitta, riscaldamento, una reggia per quell’epoca. Scoppia la seconda guerra mondiale, papà riesce a non fare il militare ed andare al fronte, continua a lavorare alla R.A.S., ma la miseria comincia a farsi sentire nuovamente. Non c’erano generi di prima necessità, scarseggiavano gli alimenti ed io essendo gracile per natura, creavo ulteriori preoccupazioni ai miei genitori che si disperavano non potendo trovare soluzioni alternative. Anche questo periodo passò, venne il dopo guerra, e pian piano le cose si ristabilirono. Papà aveva fatto un po’ di carriera e poterono tirare un piccolo sospiro di sollievo. Erano già quarantenni però, quarant’anni che hanno pesato come macigni sulla schiena. Cominciare a respirare a quarant’anni non è certo il massimo. Da questo punto in poi, finalmente, le cose cominciarono ad andare meglio, papà divenne procuratore dell’Agenzia Generale, lo stipendio aumentò e cominciarono a vivere più serenamente. Io ho sposato la mia adorata Nory, sono nate due splendide bambine e i miei genitori sono tornati indietro di almeno vent’anni. Ci hanno coccolato, viziato, stravedevano per le nipotine, ci hanno portato in villeggiatura tutti gli anni, in gita o, comunque, a pranzo fuori tutti i fine settimana. Non avevano amici, quelli si fanno in gioventù, conoscenti pochi, hobby non ne avevano, vizi nemmeno, avevano solo la famiglia e finalmente la gioia di vivere, papà non sapeva fare nulla di manuale in casa ed è forse per 21 questo che io mi arrangio a fare un po’ di tutto; la mamma, invece, aveva il dono di saper cucinare e sapeva cimentarsi al meglio sia nelle cose semplici che nei manicaretti complicati, faceva a maglia perfettamente e sapeva anche tagliare e cucire. Quanti vestitini per le nipotine! Ma cominciare a vivere dopo i quarant’anni è dura, dura da pensare, ma sopra tutto dura da vivere. Papà e mamma, grazie di aver saputo stringere i denti e tener duro, io vivo anche di questo vostro sacrificio. 22 MIO SUOCERO E MIA SUOCERA Due persone, ovviamente, totalmente differenti dai miei genitori, ma non per questo meno cari al mio cuore. Erano di poco più giovani dei miei genitori, originari di Buie d’Istria dove hanno serenamente vissuto fino al 1945. Quel poco che so della loro infanzia, è per sentito dire da racconti e ricordi di Nory e sua sorella Ucci, mia cognata. So di certo che era una sana famiglia patriarcale, unita e totalmente dedita alla cura delle numerose vigne dalle quali, con la produzione del vino, riuscivano a vivere bene ed essere una delle famiglie benestanti della cittadina. In casa, ampia per la verità, viveva il nonno patriarca con la nonna, i due figli con le rispettive mogli e i nipotini. La vita di lavoro era dura: gli uomini, alzarsi presto la mattina, andare nei campi a lavorare fino a sera; le donne, riordinare la casa, accudire ai figli, curare l’orto, preparare il pranzo da portare in fretta agli uomini lavoratori, preparare la cena, pronta al rientro dei mariti. Un bicchiere di vino, due chiacchiere e a nanna, pronti per il giorno seguente. I bambini a giocare all’aria aperta in una sana vita agreste. Anche lì, la guerra è stata brutta, ma vissuta con meno paure e meno disagi, soprattutto rispetto al cibo. Anche lì i tempi cambiavano e Guido, mio suocero, decise, visto che non aveva un figlio maschio che potesse continuare il lavoro dei campi, pensò bene di andare dal padre a chiedergli di lasciare le terre al fratello e per lui di acquistare una trattoria a Trieste. Così fu deciso, fu fatto, era il 1943 e questa fu la svolta decisiva nella vita di mio suocero e, per dire il vero, di tutta la famiglia. 1945, fine della guerra, arrivo in paese dei partigiani titini, abolizioni di tutti i diritti, confische, soprusi e mio suocero, insofferente, decise di raccogliere la sua famiglia e venirsene a Trieste per ricominciare una nuova vita. Non più produttore di vino con vendita all’ingrosso, ma più semplicemente venditore al minuto. Tempi duri, post bellici, rimettere in attività una trattoria che era decaduta fortemente mancando l’occhio del padrone, 23 riselezionare la clientela, dare un volto nuovo all’ambiente fino a farlo diventare un ritrovo di gente modesta, ma gente per bene, un ritrovo familiare dove, sia sua moglie che le due figlie piccole potessero vivere in serenità. Sul retro della trattoria c’era una specie di magazzino, una stanza comunque, e quello fu il primo alloggio per la famiglia. Da una casa decorosa, calda e ospitale ad una stanza fredda e poco ospitale. Anche su di loro la guerra aveva lasciato il segno. La forza di volontà di mio suocero era enorme, per lui il passato era passato ed ora c’era solo l’avvenire, lottare per ricominciare e stare meglio. Nessun rimpianto per ciò che aveva lasciato, nostalgia poca, tanto desiderio, assieme alla sua Gigetta, di rifarsi una vita, stringendo i denti e....avanti tutta. I fatti gli hanno dato ragione, pian piano “l’osteria del nonzolo” si fece un nome in tutto il popoloso rione di S.Giacomo ed anche oltre. Infatti, avendo egli, un “buon bicchiere di vino”, il passa parola l’ha fatto conoscere in breve tempo e la trattoria era sempre affollata di avventori, che oltre a consumare il vino in loco, si facevano riempire bottiglie per asporto in modo da portarselo anche a casa. Per le trattorie e per chi sapeva lavorare bene ed onestamente era il momento d’oro. Il nonzolo, la nonzola e le nonzolete erano sulla bocca di tutta la gente che faceva a gara per essere dei “buoni clienti”. Gli affari andavano bene tanto che, Guido, pensò di acquistare un’altra trattoria in via della Madonnina. Sarebbe stata un’altra fonte di reddito dandola in gestione a qualche oste capace e volonteroso. Ma, eravamo nel 1954 e Giovanni, il fratello di Guido, non potendone più di vivere sotto quel regime, spaccarsi la schiena a produrre il vino per poi vederselo “rubare” dall’ammasso, decise di abbandonare, pure lui, la casa natia e venire, da profugo, a Trieste. Il suo destino sarebbe stato di finire in un campo allestito per i profughi, cercare un lavoro, non si sa quale, con la prospettiva di vivere con la sua famiglia quasi di stenti. Qui salta fuori il cuore generoso di Guido che, checchè se ne dica degli Istriani, non ha mai cessato di esserlo. Offre al fratello la possibilità di lavo24 rare anche lui, ancora, con il vino, e gli cede la trattoria di via della Madonnina acquistata da poco togliendolo così da un futuro incerto e buio. Guido mette di nuovo sotto le spalle e lavorando 365 giorni all’anno, non c’erano giornate di chiusura settimanale degli esercizi, e per 14 ore al giorno, può permettersi di acquistare un’altra trattoria, in via del Solitario, e tre appartamenti. Uno di questi l’ha acquistato perchè io e Nory ci sposassimo e avessimo un tetto dove abitare. Per dire il vero, nelle sue decisioni, tanto ha pesato la parola di Gigetta che, nei momenti giusti e con le parole giuste, aveva saputo convincerlo. Anche il primo appartamento che io e Nory abbiamo abitato, in via dell’Istria, lo dobbiamo alle “spinte” della “nonzola” Guido e Gigetta hanno lavorato con questo ritmo per 15 anni, fino al 1960, anno in cui io e Nory abbiamo sposato. Mi ricordo che nei momenti di relax, parlando tra di noi, dicevo a Guido: - Avete fatto tanto e avete guadagnato bene, ma avete fatto quindici anni di “galera” e i quindici più bei anni della vostra vita. Quello che ora Nory ed io abbiamo, tanto lo dobbiamo anche ai loro sacrifici. 25 LE MIE “BAMBINE” Paola, Elena.....le mie bambine. Sono sposate entrambe, Paola ha pure 3 figli, i miei nipoti, sono nonno, sono vecchio, pardon, oggi si dice anziano, ma loro sono sempre le mie bambine. Sarà anche perchè io le chiamo “topolino”, sarà perchè loro mi abbracciano forte e mi baciano come quando erano piccole, sarà perchè io le vedevo solo alla sera quando tornavo dal lavoro, all’ora di cena e pertanto il tempo sembrava fermarsi e non le vedevo, o non volevo vederle crescere. Ora torno alla sera a casa dal lavoro e non le trovo. Sono a casa loro, con i loro meravigliosi mariti, e di ciò sono felice. Il desiderio è di chiamarle al telefono per sentire la loro voce, ma no Giorgio, lascia stare, avranno da fare, preparare la cena, lavare, stirare, rassettare la casa, tutti quei lavori che durante il giorno, essendo occupate, non possono fare. E poi non si può, sembrerebbe quasi che volessi controllarle, cosa fanno, dove sono o dove vanno. Sono donne, hanno i loro doveri e i loro problemi, hanno la loro intimità, il loro nido. È giusto così, anche io e Nory quando ci siamo sposati avevamo la casa nostra, ma spesso e volentieri, anzi troppo spesso, avevamo i miei genitori “tra i piedi”. Alle volte era comodo che badassero alle bambine, mentre io lavoravo e Nory aveva la possibilità di accudire alla casa. Però avremmo voluto anche stare soli qualche volta, con le bambine. È tutto giusto, è tutto vero, è l’eterno ciclo della vita, saranno luoghi comuni e frasi fatte, ma ciò non toglie che le mie bambine non sono più a casa e mi mancano. Sicuramente non sarò stato un padre perfetto, avrò dato loro dei dispiaceri e, forse, qualche severità in più del necessario, però ho due bambine meravigliose, affettuose, sincere, leali, buone, disponibili, sensibili, perseveranti, tenaci, brave......ecc. ecc. e ne sono orgoglioso perchè solo una persona fortunata può avere due bambine così. Ed è questo il migliore augurio che posso fare loro di essere ripagate dai loro figli come io sono stato ripagato da loro. Le mie bambine. 26 ...........mettiamo da parte, per il momento, i “pensieri” di famiglia e provo invece a focalizzarli su fatti, aneddoti, episodi o storielle alle volte più allegre, altre un po’ meno ma comunque inerenti il mondo che mi circonda........... 27 MONELLERIE DEL DOPO GUERRA 1947, io avevo dieci anni, pertanto, come detto, giocavo assieme agli amici coetanei in strada di giorno. La sera, anche se non c’erano pericoli di sorta, i miei genitori non mi lasciavano uscire, neanche sotto casa dove avrebbero potuto tenermi d’occhio. Dopo cenato, d’estate, andavo sul terrazzo che si affacciava sulla strada a vedere i ragazzi più grandi che seduti in crocchio sul cordolo del marciapiede, confabulavano per inventare scherzi da fare ai rari passanti. Abitando al secondo piano, tiravo l’orecchio per cercare di capire cosa stessero per escogitare. Niente da fare, nel pur totale silenzio, parlavano così a bassa voce, che non riuscivo a capire una parola. Ed ecco che alcuni ragazzi si alzano prendono una scatola da scarpe con il coperchio ben chiuso e la appoggiano a circa un metro dal muro della casa che fa angolo tra il viale D’Annunzio e la via Padovan. Poi di corsa si risiedono con il gruppo. Erano ormai le 20.30 o le 21.00 ed i passanti erano rari e frettolosi. Passa uno e tira oltre, passa il secondo, idem e così via, nessuno nota la scatola a un metro dal muro. Ecco uno finalmente nota la scatola, un po’ sgualcita per la verità, con fare indifferente si avvicina gli dà un bel calcione e lancia un urlo di dolore. I ragazzi, ridendo, scappano in tutte le direzioni. Nella scatola c’erano due mattoni! Altra serata, stessa scena, cambia il soggetto. Sull’angolo del marciapiede c’è un’aiuola con dentro piantato un grosso ippocastano. Tutto il viale D’Annunzio è alberato. I soliti ragazzi stanno pensando ad un altro tiro mancino. Ecco che vedo all’improvviso uno di loro alzarsi, correre verso il margine dell’aiuola e depositare a terra un portafoglio usato. La gente passa e, nella scarsa illuminazione stradale, non lo nota. Ma ecco che arriva “occhio di falco”, vede il portafoglio, si ferma, guarda in giro stando distante circa due metri dall’oggetto, guarda in alto, guarda a destra, guarda a sinistra, vede il gruppo di ragazzi seduto ad una ventina di metri di distanza, ma chiacchierano tra di loro. Fischiettando, indifferente, lentamente si avvicina alla preda, fa un passo avanti, uno indietro, si riguarda in giro, lenta28 mente si china facendo finta di allacciarsi una scarpa, e poi con fare lesto allunga la mano per prendere il sospirato portafoglio....e zacchete il portafoglio vola via come una scheggia. Era legato con un filo di nylon ed uno dei ragazzi, con l’altro capo in mano, al momento giusto, aveva dato uno strattone. Occhio di falco, indignato, si alza e borbottando chissà quali improperi, con passo spedito, prosegue il suo cammino giù per viale D’Annunzio. Passati alcuni anni, ero già sedicenne, e incominciavo anch’io a prendere parte in prima persona a degli scherzi. Erano scherzi innocenti, fanciulleschi, che però ci divertivano tanto. A quei tempi si pagava solo il canone di abbonamento al telefono, non c’erano scatti, non c’era il T.U.T. si poteva telefonare quanto si voleva ed ecco allora uno scherzo abbastanza ricorrente. Si sceglieva un numero a caso, se all’altro capo del filo rispondeva una voce giovanile e scattante, si diceva: “Scusi ho sbagliato numero” se, al contrario, si sentiva la voce di una persona anziana, specialmente se femminile, si diceva: “Scusi signora c’è Mario?” La vecchietta rispondeva: “Qua no ghe xe nissun Mario”. ”Scusi, buona sera”. Il secondo di noi nuovamente: “C’è Mario?” – “Qua, nissun Mario!” – “Scusi” Così il terzo, il quarto, il quinto..... La vecchietta cominciava a balbettare, non capiva cosa stesse succedendo, arrivava ad essere un poco seccata dopo la ventesima telefonata. Era allora che l’ultimo della “banda” chiamava per l’ultima volta la vecchietta dicendo: “Buona sera signora, son Mario, me zercava forsi qualche d’un????” e giù a ridere tutti come matti. 1954, domenica, pomeriggio, rigorosamente a ballare alla Ginnastica Triestina; ore venti il ballo finiva ed era allora che “Manubrio” si scatenava. Manubrio, al secolo Fabio Z., era così soprannominato in quanto portava i basettoni molto lunghi ed arcuati a punta verso il viso. Sembrava di vedere il manubrio di una bicicletta da corsa. Una domenica sera, ricordo, avevano inaugurato la torrefazione “La Portizza” ed era uso in quei tempi, il giorno dell’inaugurazione offrire una tazzina di caffè a tutti quelli che entravano. 29 Eravamo una trentina di amici sul marciapiede di fianco alla torrefazione in modo che i baristi non potessero vederci. Per primo entra “Manubrio”. - Buona sera – Buona sera Signore, possiamo offrirle un caffè? – No grazie, è tardi e dopo non dormo, permettono solamente che mi pesi? – Prego faccia pure. La scena, il barista con la mano protesa verso la macchina del caffè per preparare un ottimo espresso, il collega con il piattino in una mano ed il cucchiaino nell’altra, fermi a mezz’aria in quanto non utilizzabili. “Manubrio si avvicina alla classica bilancia che tutte le torrefazioni avevano vicino alla porta d’ingresso, sale, controlla il peso, scende, riverente ringrazia, saluta ed esce dal locale. Un minuto dopo la scena si ripete con il secondo ragazzo, poi il terzo e così via finchè l’ultimo ad entrare vede i baristi con la bocca aperta, con i capelli irti, gli occhi spalancati, incapaci di proferire parola. Penso che a tanti anni di distanza quei baristi, si ricordino ancora quell’inaugurazione. Altra domenica, altro scherzo. Piazza Goldoni era un po’ differente da quella d’adesso, infatti, in mezzo alla carreggiata, al vertice della via Mazzini era sistemato il “gabbiotto” in cui il vigile urbano di turno regolava il traffico, comandando manualmente i semafori. Il traffico, un po’ perchè era domenica sera, un po’ perchè, a quei tempi, non c’erano tante automobili in circolazione, era scarso ed i semafori cambiavano, in alternanza, i loro colori: verde, giallo, rosso, rosso, giallo, verde, in un’alternanza non sincrona, ma a seconda delle necessità e gestite dal vigile. Ed ecco l’organizzatore “Manubrio” dividere il folto gruppo in due: una ventina nei pressi della Scala dei Giganti e l’altra ventina all’altezza dei portici di piazza Goldoni. Ad un cenno convenuto i venti “indiani” di Scala dei Giganti, urlando con gridi di guerra Sioux, scesero nella pianura di piazza Goldoni per attaccare i venti cow boys che bivaccavano al riparo. Sentendo le urla di guerra dei Sioux, i cow boys, prese le armi, partirono per respingere l’attacco. Lo scontro avvenne al centro della prateria, nelle vicinanze del “gabbiotto” del vigile, con degli assordanti “bang bang” delle inesistenti colt simboleggiate dalla mano chiusa, con il pollice alto e l’indice puntato, mischiati alle urla di 30 guerra degli indiani. Il povero vigile, uscito dal “gabbiotto” con il fischietto in bocca, cominciò a lanciare dei trilli che non riuscivano a coprire le grida dei contendenti e, semmai, per mancanza di fiato, si affievolivano sempre più. La scena era seguita con ilarità e qualche timido applauso da coloro che aspettavano, in quel punto nevralgico, il tram, l’autobus o la filovia. Prima che il vigile rimanesse senza fiato o a sua volta chiamasse il “decimo cavalleria” i cow boys e gli indiani, finita la battaglia, ritornarono, in gran fretta, ai rispettivi “alloggiamenti”. 31 SCENETTE IN BANCA Come già detto ho lavorato per 35 anni alla Cassa di Risparmio di Trieste ed essendo stato sempre in “prima linea” cioè a contatto diretto con il pubblico, durante la mia carriera ne ho visti di episodi, alle volte comici e alle volte tragici. Ma io qui voglio ricordare solo quelli che sembrano barzellette ma sono, al contrario, fatti realmente accaduti. Mi ricordo che, un tempo, per fare delle operazioni sul libretto a risparmio si doveva andare allo sportello, dire che tipo di operazione si desiderava fare, dopo di che l’impiegato ti dava un talloncino giallo o verde a seconda se si versava o se si prelevava. Si vede che già quella volta esisteva la legge sulla privacy, infatti, il cassiere per non chiamare per nome le persone, chiamava il numero che era stampigliato sul talloncino ed il cliente chiamato si presentava alla cassa. Il cassiere chiama con voce normale: Novecentottantasette....e nessuno si presenta; alza un poco la voce e ripete: Novecentottantasette..... e niente, la terza volta ripete il numero quasi urlando....non c’è nessuno. Mette il libretto a risparmio in parte e continua il suo lavoro. Passa ben più di mezz’ora e una vecchietta affannata si accosta allo sportello e gli dice: - Scusi signor cassiere, prima ha chiamato novecentottantasette???? - Sì signora, ma dove era finita? - Sa, cosa vuole, io avevo portato i soldi giusti per il versamento e pertanto sono dovuta ritornare a casa a prendere questi.... e porgendogli mille lire, candida gli dice: - Tenga pure il resto per il disturbo. Questa è capitata proprio a me. Ero alla cassa presso l’Agenzia di Opicina. Mi si presenta una signora con un modulo di versamento in conto corrente debitamente compilato. Era, cosa rara, perfetto numero di conto corrente, agenzia di appartenenza, nome cognome e indirizzo completi, l’importo in cifre e l’importo in lettere e c’era pure la distinta di versamento con i vari tagli delle banconote, i pezzi e il totale. Perfetto!!! Peccato che negli spazi riservati all’ufficio dove bisogna scrivere con delle sigle se sono contanti, 32 assegni su piazza o fuori piazza, se sono assegni circolari o di conto corrente o postali ecc. nella casella dove si indica la valuta, cioè la decorrenza per il conteggio degli interessi del versamento, e lì la signora ha pensato bene di scrivere nella casella della valuta.....italiana!!! Sempre a Opicina, anni sessanta, entra un cliente “primario”, di quelli buoni insomma, che hanno soldi. Il direttore lo vede, si alza, gli va incontro e ossequioso lo saluta: - Buon giorno signor Mario, in che cosa posso esserle utile? - Nulla di importante, dovrei fare un piccolo versamento. - Ma certo, a sua completa disposizione....Weiss, per favore, vieni qui ad aiutare il signor Mario. Il signor Mario, titolare di un buon ristorante sull’altipiano, mi consegna il solito cartoccio del pane pieno di soldi da sistemare e contare. Il direttore lo intrattiene mentre io sistemo i soldi, preparo il versamento, registro l’importo sul suo conto corrente, timbro e firmo la ricevuta e gliela consegno. Lui si alza, mette la ricevuta in tasca e ringraziando saluta e va verso l’uscita, al che, riverente come sempre, il direttore dice al signor Mario: - Grazie signor Mario, torni presto a trovarci e mi ricordi alla sua signora. Il signor Mario fa ancora quattro o cinque passi, si avvicina all’uscita, prende la maniglia in mano e pensoso si gira e guardando serio il direttore dice........Perchè???? Altra scenetta ad Opicina. Eh, ma sempre Opicina!!! Cosa volete quindici dei miei trentacinque anni di servizio li ho trascorsi lì. A metà mattina veniva la ragazza del bar a portarci i cappuccini e posava sul banco il vassoio con le tazzine. Un giorno, il collega Danilo correndo a prendere il vassoio per portarlo sul retro dell’ufficio, si rivolge alla ragazza del bar, giovanissima e molto bella, dicendole: “Beata ti che te ga tuto davanti. - Ma sior Danilo cosa la disi, no’ la se vergogna?! - Ma cosa te ga capì?? Te son maliziosa!! Mi intendevo dir che te son giovine, che te ga tuto davanti, la vita te sorridi e che el tuo futuro sarà felice, te lo auguro”. Sarà vero che intendesse questo?? 33 Opicina, inverno freddo, c’era la neve che veniva giù abbondante, sembrava di essere in un’agenzia di montagna. Entra il signor Luciano, un cliente simpaticone, sempre pronto alla battuta e con la barzelletta pronta. Dice: “Mama che fredo, xe i lupi fora. Qua ghe volessi butar zo in stomigo qualche cossa de caldo. Muli, i ga verto, qua de Micel, un buffet che fa luganighe, crodeghini, porzina e tuto el resto. Volè che ve ofro un bon panin caldo de porzina col cren??? - Orca sì, magari sior Luciano! - ghe disemo in coro. Guardandoci tutti dietro il banco esclama: Porzina per ti, porzina per ti...e, quando arriva a Paolo, un neo assunto che ora è vice direttore generale della banca, e che, poverino, aveva i due denti incisivi superiori molto sporgenti dice: - E ti un piato de carote?? - No, no, no porsina anca par mi, grasie! Cambiamo agenzia, ci troviamo all’agenzia numero quattro di via della ginnastica. Sempre affollatissima di clienti frettolosi ed impazienti. C’era il cassiere Aldo che con flemma olimpica svolgeva le sue mansioni: lentamente prendeva il documento, sia esso un libretto a risparmio, un assegno da pagare, un versamento in conto corrente, l’avviso di una cambiale o che si voglia e alzandolo all’altezza giusta, con voce stentorea, chiamava: - Mario Rossi, Giuseppe Verdi, Francesco Bianchi ecc. Era un tipo fatto così, molto bravo, preciso ed esatto, ma sempre con movimenti lenti e chiamando ad alta voce il cliente frettoloso che aspettava. Il vicecapo agenzia, il signor Tullio, era un tipo allegro, socievole, ma insofferente al modo di fare del cassiere, gli diceva sempre: - Cosa occorre che gridi così forte, e poi basta il cognome, cosa serve chiamare nome e cognome. Al che Aldo rispondeva: - E se ci sono due Rossi, due Verdi, due Bianchi posso sbagliare ed io non sbaglio mai!!! E Tullio si rodeva il fegato e meditava il tiro mancino aspettando il momento propizio per farglielo. Ed il momento venne, era un giorno che il salone era particolarmente affollato, ci saranno state almeno trenta o quaranta persone in attesa. Aldo sempre con la sua flemma chiama “Mario Rossi, Giuseppe Verdi.......” e poi prende in mano un libretto a risparmio 34 che Tullio aveva appena acceso con cinquemila lire, lo apre lentamente e con la sua classica voce roboante chiama: - LOGO DURO......... 1958, agenzia due, una delle più importanti allora, ma anche adesso per dire il vero, già all’epoca eravamo circa quindici dipendenti, dal funzionario ai commessi. Il capo era il signor Marcello, persona squisita, sempre elegantemente vestito con capi fatti su misura dal sarto. Capita un giorno che entra una persona vestita con giubbotto e pantaloni di velluto con un voluminoso involucro sotto il braccio. Mi si avvicina e chiede: - Il direttore per favore. Lo prego di attendere un attimo.... sarei andato a vedere se era libero. Busso alla porta del signor Marcello e annuncio questa strana persona che chiede di lui. Lui acconsente, ma mi prega di rimanere con lui presente alla conversazione ....non si sa mai. Faccio accomodare la persona che entra e dice queste testuali parole: Dottore buongiorno, sono un camionista che recapita capi di abbigliamento e pezze di stoffa per conto della ditta Zegna. Ho appena consegnato parecchia roba alla ditta Godina, qui di fronte, ma si vede che nella fretta il magazziniere ha caricato una pezza in più di stoffa di pura lana inglese di misura per fare un bel vestito gessato completo di panciotto e forse anche due paia di pantaloni, se permette gliela faccio vedere. Toglie la carta che avvolge la pezza, l’apre e la fa toccare a Marcello che, da intenditore, la stropiccia, la maltratta, prende un filo di stoffa e con l’accendino lo brucia per sentire, dalla puzza, se è veramente lana e non sintetico. Tutto bene. Per sicurezza però prende il telefono e chiama il suo sarto di fiducia che ha il laboratorio proprio in via Carducci di fronte alla nostra Agenzia. Dieci minuti dopo arriva il sarto, controlla la stoffa, la trova ottima e per il prezzo richiesto è un vero affarone, a parte il rischio dell’acquisto non del tutto corretto. Sta di fatto che il signor Marcello rischia, si fa fare ancora uno sconto sul già basso prezzo e tutto felice consegna la “pezza” al sarto che, avendo già le sue misure, confezioni il bel gessato in pura lana pettinata inglese!! Passano alcuni giorni e il sarto chiama il signor Marcello dicendogli che 35 vada subito nel suo laboratorio perchè deve fargli vedere una cosa non molto piacevole. Il signor Marcello mette il cappotto ed esce. Ritorna mezz’ora dopo e quando lo rivedo mi sembra un cane bastonato. Lui sempre ritto ed impettito che camminava a passo spedito, era affranto, curvo, e stascicava i piedi. Cosa è successo signor Marcello?, - gli chiedo. E lui di rimando: Lasci stare. Se sapesse, si ricorda la stoffa inglese? - Certo che sì, - gli rispondo, - bellissima! - Bellissima sì, ma poca! Infatti srotolata la pezza, il primo metro e venti centimetri era di pura stoffa di lana inglese, il resto......garza!!!! Forse il solo panciotto!!! 1962 sono stato trasferito all’agenzia di Opicina. L’Agenzia si trova in piazzale Monte Re. Un poco più avanti c’è pure la farmacia, con la cui titolare e tutti i collaboratori eravamo in rapporti di amicizia più che di lavoro. Un giorno, il dottor Dario, un farmacista che lavorava presso la farmacia, entra in agenzia ridendo con le lacrime agli occhi. - Dario cosa succede?? – Vi prego lasciatemi stare, mi è successa una cosa che ha dell’inverosimile. Sono dietro il banco, entra un signore di una trentina d’anni, ben vestito, che si avvicina e mi dice: - Govorite slovensko?, - No, guardi parliamo solamente italiano, ma cosa le serve? ha la ricetta? – No, mi no ga riceta. - Le fa male qualche cosa? ha febbre? le dolgono i denti? - No, no, mi no sta mal, mi ga bisogno, come se disi, me servi......ah sì!! Ti ga coverceti per klinc??? Filiale di Muggia. La signora Maria, madre di un noto personaggio della cittadina, anche in campo politico. A quei tempi la signora aveva oltre novant’anni, ma non li dimostrava minimamente, non l’ho mai vista camminare, sempre con passo lesto quasi di corsa. Ho saputo la sua storia da alcuni colleghi nativi del posto; proveniva da famiglia modesta e già da ragazza aveva cominciato a lavorare portando, per poche lire, i pranzi caldi, che le mogli preparavano, agli operai del cantiere navale. E perché i pranzi arrivassero caldi agli operai, doveva correre altrimenti non prendeva neanche quei quattro soldini. Con tutto ciò, la signora Maria, sacrificando la 36 sua giovinezza prima, e la sua vita di donna sposata dopo, era riuscita, assieme al marito, a far studiare il figlio e farlo laureare. Bisogna dire la verità che il figlio non si è mai dimenticato dei sacrifici della madre e se la coccolava con vero amore filiale. Ora la signora Maria era ben vestita, non lavorava più, ma ciò non ostante era sempre in movimento, aveva tanto da fare. Tutto questo per fare un quadro della situazione. Ribadisco, aveva più di novant’anni. Un giorno viene in filiale, mi si avvicina e mi dice: - Giorgio, picio, qua dentro solo de ti me fido, sa, cosa te vol, go in parte quatro petenei; cossa te me consigli de far, come posso farli render per assicurarme la veciaia?? No comment! Verso la fine del 1969, assieme al collega Piero abbiamo inaugurato l’agenzia di Prosecco. Bellissimo!! Preparare il posto di lavoro a misura propria e non doversi adattare a quello che si trova, tutto ordinato....pronti a cominciare. Primo giorno, ore otto e venti minuti apriamo la porta....nessuno. Passano i minuti e vediamo la gente passare davanti all’agenzia, si ferma, cerca di curiosare dentro ma i vetri fanno da specchio e non vedono nulla. Qualcuno si avvicina, facendo scudo con le mani vicino agli occhi e appoggiandosi sul vetro guarda dentro, guarda noi che senza clienti, sbrigavamo pratiche inesistenti e rispondevamo al telefono che non squillava. A mezza mattina entra il primo cliente, vestito da lavoro, barba lunga, sporco di terra, ha lavorato nei campi o nella vigna, mi si avvicina e mi chiede incuriosito: - Go quatro soldi de parte, cossa la me consiglia? - Sa, oggi come oggi è molto interessante investire il danaro risparmiato, perchè in base alla legge 1228 ci sono tre forme di investimento a 12, 18 o 24 mesi. È ovvio che il maggior tasso di interesse si percepisce vincolando il danaro per 24 mesi. Ma attenzione in quanto per nessun motivo si può estinguere anticipatamente il deposito neanche pagando una penale. Il danaro deve rimanere fisso per tutto il periodo prescelto. Io le consiglio di investire una cifra a lungo termine per avere maggior interesse, un’altra a medio termine e un’altra ancora senza vincoli per necessità immediate. -Si, la ga proprio ragion, parlo co’la baba a casa e po’ torno. Dopo di lui, 37 per fortuna, arrivano tanti altri clienti che aprono conti correnti, libretti a risparmio, comperano titoli di stato, azioni ecc.. L’agenzia funziona che è un piacere, vinta la prima diffidenza e col passa parola i clienti, che in molti casi diventano amici, si moltiplicano a vista d’occhio. Il lavoro aumenta e, per dire la verità, alle volte, essere solamente in due è un po’ stressante. Siamo ormai alla soglia del mese di apertura, ed ecco che entra un cliente “nuovo”, tirato a lucido, con il vestito nero, quello dei matrimoni, cresime, funerali e feste comandate, con un pacchetto racchiuso in carta di giornale sotto il braccio, mi si avvicina e mi fa: - Alora femo come che gameno dito! Mi prende un tremore, faccio finta di niente, ma cosa ho mai detto a questo signore che non ricordo di aver mai visto e, tirando un bel sospiro dico: - Ah sì, sono contento, allora ha deciso per il meglio?? - Sì! la ga ragion lei, xe meio far cussì e no corer ris’ci. Bisogna indagare e dico: - Lei sì che è una persona che ragiona e sa quello che fa! Ha parlato in casa? Cosa hanno detto? - Sì, femo novanta milioni a ventiquattro mesi, sesanta a dodici mesi e el resto li lasemo liberi perchè forsi compro un teren. - Ottimo, bella scelta e quanti lasciamo liberi? - No so esatamente, la conti lei che la ga più pratica. E mi consegna il pacco avvolto nella carta di giornale. Diligentemente apro il pacco e mi trovo davanti ad un “mattone” di banconote da centomila lire ben stretto da una miriade di elastici. Li conto e sono esattamente trecentocinquanta milioni. Duecento milioni liberi. Si trattava di quella persona in vestito da lavoro, barba lunga e sporco di terra che un mese prima era venuto a chiedere informazioni. Sempre a Prosecco siamo giunti ai primi di settembre del 1970. Quella volta l’intervallo di pranzo era molto lungo andava dalle tredici e trenta alle quindici e trenta. Io e Piero mangiavamo qualche cosa e poi facevamo belle passeggiate nel bosco che portava verso la locanda da Martin, sul sentiero che va fino al villaggio di S.Croce. La mamma di Piero, per la verità anziana, era ricoverata all’ospedale per l’ennesimo attacco di cuore. Era un mar38 tedì e Piero alle tredici e trenta mi dice: - Giorgio oggi non vengo a pranzo, vado a trovare la mamma per vedere come sta, sono un po’ preoccupato. Erano ormai le quindici e trenta e Piero non era ancora arrivato. Finalmente un minuto dopo arriva, stravolto, entriamo in agenzia con due o tre clienti che stavano aspettando, corre al telefono, chiama il direttore, nostro superiore, in sede centrale e quando risponde dice: - Direttore, mandi subito, magari da Opicina, qualcuno a sostituirmi perchè devo correre nuovamente all’opedale, mia madre sta morendo e non so nemmeno, se quando arriverò là, sarà ancora viva. Dall’altro capo del filo la risposta: Eh cossa, al ultimo momento la me avisa! Questa è stata la risposta del direttore. Piero sbatte il telefono, esce di corsa, sale in macchina e via. Arriva all’ospedale, la mamma era morta da dieci minuti. Ritorniamo a Muggia. Anno 1968. La filiale è come una piccola sede centrale, si fa di tutto, dalle normali operazioni che si fanno nelle agenzie, alla stipula di mutui, alla concessione di fidi, al servizio di esattoria e di tesoreria, al pagamento delle pensioni, ecc. In quel tempo ero addetto, tra l’altro, al pagamento delle pensioni. Giovanni fu per anni il “nostromo” del vaporetto che collegava Muggia a Trieste e viceversa. Ma ormai il vaporetto non c’era più, sostituito dalla filovia, ed Giovanni era andato in pensione. Una buona pensione dato che aveva navigato per quarant’anni arrivando al grado di “nostromo”. Il giorno cinque di ogni mese pari Giovanni , puntuale, si presentava al mio sportello con il suo libretto pensionistico, firmava il certificato e se ne andava col suo bel malloppo. Verso il venti del mese pari, e così di seguito ogni otto o dieci giorni veniva da me e mi diceva: - No go più un petenel, quando te me da la pension? - Giovanni, la pensione l’ha incassata quindici giorni fa. Ci vuole ancora un mese e mezzo prima che arrivi la prossima pensione. 39 - E mi cossa fazo senza petenei? cossa magno intanto? no posso sempre andar de mia sorela a scoderghe soldi. Mi gavevo una bona pension, una volta. - Ma Giovanni lei ha una buona pensione, prende più lei di pensione che io di stipendio, come può aver già speso tutti i soldi? -Cossa te vol, una volta ciapavo de più, adesso soldi xe pochi, xe solo scartofie, xe solo documenti. Questo ritornello, ormai, durava da mesi e mesi. Sempre a dirmi che non aveva “petenei” ma solo “documenti”. Allora mi venne un sospetto, sembrava impossibile ma non si sa mai, e dissi: - Giovanni, faccia una cosa, vada a casa, prenda tutti i documenti che ha ricevuto e me li porti che così controlliamo a cosa servono, va bene? - Sì, sì ‘deso vado e forsi torno anche ogi se rivo, ‘dio Giorgio, se vedemo! Verso le ore undici vedo Giovanni che ritorna, aspetta il suo turno, e mi si avvicina: - Eco qua, ciapa, i soldi xe finidi e me resta solo ‘sti documenti che te me ga dado. - Guardo i “documenti”, erano tanti e tanti biglietti da lire centomila. Le centomila lire erano uscite da poco ed Giovanni non le conosceva, pensava fossero documenti. Conto i “documenti” erano trentasette milioni. A questo punto, vista l’incapacità di Giovanni, lo faccio accomodare dal direttore al quale spiego tutta la storia ed anche lui fa una faccia tra lo stupito, l’incredulo e abbozzando un sorriso misto tra lo scherno e la compassione decide di chiamare telefonicamente la sorella. Giovanni era vedovo. Accese un libretto a risparmio a nome di Giovanni con la firma per delega alla sorella in modo che con quei “documenti” potesse curare il fratello e dargli ogni tanto un pochi “de petenei” per i capricci. La riconoscenza e gli occhi commossi di quella donna non li dimenticherò mai. Ancora Muggia. C’erano due fratelli: Franco e Paolo “picio”. Bisogna che faccia un preambolo per descrivere questi due personaggi. 40 Erano, appunto, due di quattro fratelli, nativi di Isola d’Istria, italianissimi, che come tante altre migliaia, avevano lasciato la terra natia, per rifarsi una vita in terra italiana. Sono sempre stati, come il novanta per cento degli Isolani, del resto, dei pescatori, mentre gli altri due fratelli avevano lavorato nell’industria conserviera del pesce che, un tempo, fioriva a Isola d’Istria. Franco, un pezzo d’uomo alto più di un metro e ottanta, con un paio di spalle robuste e due manone che sembravano delle clave. A vederlo sembrava un orco, invece era di una bontà infinita, teneva sempre con sè e aiutava lo sfortunato fratello: Paolo “picio”. Era così soprannominato perchè, per sua sfortuna, era nano, avrà raggiunto sì e no il metro e trenta. Cercate di immaginare questi due inseparabili fratelli che camminando per le calli di Muggia, uno accanto all’altro, con andatura dondolante, in silenzio, sbrigavano i loro affari. Un metro ottanta con a fianco un metro e trenta. Avevano impiantato un grosso allevamento di mitili lungo la costa muggesana, da Muggia appunto fino a Punta Sottile. Con le loro barche, quotidianamente, seguivano il tratto di mare, controllando lo svilupparsi dei mitili. Quando erano pronti per essere “strappati” dalle corde con la loro “pedocera” raccoglievano i grappoli di mitili, li insaccavano e d’urgenza li mandavano a “depurare” o ai filtri del Villaggio del Pescatore, nei pressi di Duino, oppure fino a Bari dove c’è il più grande depuratore d’Italia. Gli affari andavano bene e settimanalmente venivano, inseparabili, a portare i proventi del loro lavoro, quasi sempre assegni, e li versavano nel conto corrente della “Ditta”. Sempre di poche parole, come la gente di mare, ma con tanta gentilezza ed educazione, facevano i versamenti e se ne andavano. La cosa era durata un anno circa, qualche piccolo prelievo per le necessità del loro lavoro e per la loro sopravvivenza, ma il grosso rimaneva nel conto che, per la verità, si gonfiava sempre più, tanto da divenire uno dei “conti primari” della Filiale. Capita un brutto giorno, Franco e Paolo “picio” entrano in banca, con il loro incedere lento e dondolante, mi si avvicinano e mi dicono: 41 - Portemo via tuti i soldi del conto dela Dita. Mi viene un accidente, erano quasi duecento milioni, più di un miliardo di oggi. Accenno con difficoltà due parole confuse: - Tutto? ma non abbiamo tanti soldi in contanti. - Come no li gavè, xe soldi nostri che gavemo portadi qua! - Sì, ma siccome erano troppi, li abbiamo mandati alla nostra sede centrale in quanto hanno una cassaforte più grande. - Bon, no fa gnente, vinimo a ciorli doman! - Un momento per favore, vi faccio parlare col direttore, così vi mettete d’accordo su modalità e tempi. Vado dal signor Mario, il direttore, e gli riferisco la richiesta. Il signor Mario, sbianca in volto e mi fa cenno di farli passare nel suo ufficio. Chiamo Franco e Paolo “picio” e li faccio accomodare. Il signor Mario incalza: Egregi signori, buon giorno, accomodatevi, prego. No, stemo in pie che gavemo furia. - Mi diceva qui, il collega, che volete prendere tutti i soldi del conto della Ditta, cosa è successo? Perchè? Vi è stato fatto qualche sgarbo? Qualche altra banca vi offre più interesse?, parliamone non è il caso di prosciugare un così bel conto corrente. - No gnente, i ne servi e basta, tuto in soldi, no asegni, per domani matina presto. Salutano, si girano e se ne vanno. Al signor Mario non resta altro che telefonare alla cassa principale in sede e ordinare per l’indomani centottanta milioni in contanti. Duro colpo per la Filiale, ma soprattutto la delusione del non capire il perchè di questo improvviso prelievo. Il mattino seguente Franco e Paolo “picio” arrivano con un sacco di quelli che si usano per gli indumenti da ginnastica, mi si avvicinano e io dico loro: - Andiamo dentro dal direttore perchè non è il caso che la gente veda tanti soldi in contanti. - Entrano, stipano le mazzette nella sacca, fanno un nodo alle corde e 42 salutando se ne vanno. Pazienza, giornata buca per la filiale, speriamo in tempi migliori! Passano due giorni e Franco e Paolo “picio” entrano con due pacchi sotto il braccio, mi si avvicinano e mi dicono: - Novanta milioni sul mio conto e novanta su quel de Paolo. Prendo i soldi, sono gli stessi di due giorni prima. Li conto sono esattamente cento e ottanta milioni. Guardo Franco e dico: - Ma perchè questo? Non potevamo l’altro ieri fare due giroconti di novanta milioni l’uno, dal conto della Ditta ai vostri conti personali? - E no sior mio, numeri xe numeri, ma soldi xe soldi. 43 PROSECCO Una delle cose che Nory ed io siamo riusciti a realizzare ha un nome: Prosecco. La storia è iniziata alcuni anni prima; a me era venuto il desiderio di “evadere” nei fine settimana e parte delle ferie. Ed ecco che nella mia mente si insinuò la possibilità di acquistare una barca, usata s’intende, per poter uscire al largo nel golfo o fare mini crocierette lungo la costa sia nostra che istriana. Una pilotina insomma, che avesse un paio di cuccette per dormire, una cucinetta per preparare i pasti e un WC marino con servizi igienici, oltre s’intende, un piccolo pezzo di tolda dove Nory e le bambine potessero abbronzarsi. Io mi sarei messo a pescare e se qualche pesce avesse abboccato avremmo mangiato quello, altrimenti pasta al pomodoro o scatolette. Spirito d’avventura insomma. Sogni.... Nory era preoccupata: le bimbe sono piccole e se cadono in acqua?....., se ci sono le onde e non si riesce dormire?....., se le bambine stanno poco bene in mezzo al mare?..., neanche fossimo in mezzo al Pacifico.....Io non starei tranquilla e pertanto non sarebbe un divertimento. Chiuso il capitolo “barca” che, forse, a posteriori, pensandoci bene, è stato meglio così in quanto il mantenere in efficienza una barca costa molto, sia finanziariamente che in questione di tempo. Tirala fuori dall’acqua, togli le incrostazioni e la vegetazione dalla chiglia, dagli due o tre mani di antivegetativo, controlla tutte le parti metalliche che non abbiano la ruggine, rimettila in acqua...ogni anno! Il chiodo fisso non molla: niente barca....allora roulotte! Avendo lavorato all’Agenzia di Opicina, conobbi un noto rivenditore di una prestigiosa marca nazionale di roulotte che mi, anzi ci, convinse ad acquistarne una di cinque metri, usata, ma ben tenuta. La facemmo portare al Campeggio Europa di Fernetti e così cominciò la nostra vita di campeggiatori, all’aria aperta, lontano dai rumori in un ambiente sano con tanti amici tutt’intorno. Ma come in tutte le cose belle c’è anche il rovescio della medaglia. 44 La roulotte era sempre la stessa, ma lo spazio a disposizione tutt’intorno si riduceva sempre più. Era infatti il boom del campeggio e sempre più roulotte dovevano venir sistemate. È una mia teoria che, comunque, i fatti tante volte hanno avvalorato, e cioè che nella vita, per riuscire, bisogna trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Così è stato anche questa volta. Era il 1970 e assieme al collega ed amico Piero Atti, avevamo inaugurato la nuova Agenzia della Cassa di Risparmio a Prosecco. Un giorno entrò in banca una vecchietta triste quasi piangente, prelevò dal libretto a risparmio una piccola cifra ed io, non per curiosità, ma per capire quella sua tristezza, le chiesi cosa fosse successo. Lei allora aprì il suo animo in uno sfogo misto tra rabbia e tristezza e mi raccontò che abitava in località Baita di Sgonico e che essendo la località troppo isolata, alcuni anni prima aveva acquistato un piccolo terreno a Prosecco per potersi costruire una casetta. Lei vedova, con una piccola pensione, ed il figlio panettiere in città, risparmiava soldino su soldino per poter cominciare, in economia, a costruire la tanto desiderata casetta. Evidentemente non aveva ancora nessun progetto elaborato e tanto meno presentato, per l’approvazione, all’Ufficio Tecnico comunale, sta di fatto che il nuovo piano regolatore aveva pensato bene di trasformare il terreno da “area costruibile” e “area di zona verde”. Il sogno si era frantumato e doveva rimanere a “Baita”. Ascoltai in silenzio il suo racconto, dopo di che le chiesi cosa avesse intenzione di fare di quel terreno a lei inservibile; mi rispose che per forza doveva cercare di venderlo e purtroppo anche ad un prezzo inferiore di quello che lo aveva pagato, essendo stato declassato. Mi feci dare il nome e l’indirizzo. Rientrato a casa, la sera, ne parlai con Nory.... bello, anzi bellissimo.... ma con quali soldi?? Sempre, facendo capo alla mia teoria prima esposta, fu il momento giusto. Infatti mio padre era andato da poco in pensione e quando io gli prospettai la possibilità di avere un “campeggio” tutto nostro privato, si offrì con molto entusiasmo di acquistarlo lui per donarlo alle nipotine. 45 La mia, la nostra gioia, fu immensa anche se il lavoro che mi aspettava era enorme. Disboscare, recintare, scavare, livellare, costruire, portare all’interno acqua e corrente elettrica, ore, giorni, settimane, mesi di lavoro....ma cos’era questo di fronte alla gioia di avere un pezzo di terra proprio, con quasi tutte le comodità ed il pensiero che la bambine sarebbero vissute all’aria aperta, senza pericoli? Niente! Anzi una gioia, quanti week-end a lavorare con Nory, nonno Guido e qualche operaio preso alla giornata per i lavori più pesanti. Alla fine l’entrata trionfale della roulotte nel nostro “campeggio”. Prosecco. Il nostro “pezzo di terra” misurava poco meno di mille metri quadri. A fianco c’era ancora un terreno libero di circa mille e quattrocento metri quadri. E se qualcuno, visto quello che avevamo fatto noi, l’avesse acquistato per fare altrettanto? Magari gente confusionaria che avesse fatto “sagre” con amici, con canti, balli e suonate di fisarmonica? Che fare? Ed ecco a Nory viene una brillante idea! Dei suoi amici-conoscenti accaniti campeggiatori con un figlio piccolo come le nostre bambine, tenevano la roulotte al campeggio Obelisco, li contattò e propose loro di venire a vedere la nostra soluzione e di fare altrettanto nel terreno ancora libero. Detto fatto, videro il terreno, si accordarono con un loro amico, che aveva pure due figli piccoli, ed i nonni, pure campeggiatori, in modo da dividere le spese in tre, fecero esattamente quello che avevo fatto io, ed incominciò un periodo meraviglioso che durò parecchi anni, finchè i figli divennero grandi. In un angolo facemmo l’orto: insalatina, radicchio, prezzemolo, carote, pomodori, piselli ecc. controllando ogni giorno, aspettando quando, finalmente, avremmo potuto gustare i nostri prodotti. Ogni tanto Paola ed Elena tiravano fuori una carota, anzi una carotina, perchè non c’era tempo d’aspettare che crescessero, la lavavano sotto il rubinetto e via come Fratel Coniglietto a rosicchiare quella bontà. Spesso venivano da noi, a giocare, i bambini dei vicini Alberto, Gabriella e Gianni, altre volte erano Paola ed Elena ad andare da loro e così le giornate passavano in allegria con ‘sto vociare di bimbi allegri. Quando poi un pomeriggio arrivai, con una novità, ebbi tutti i bambini intorno ansiosi di vedere cosa avessi portato. Aprii il grande pacco ed uscì un ammasso di 46 tela-plastica senza forma e colorata. Cos’è questo “telone”? mi chiesero, ed Alberto, il veterano dei campeggiatori bambini, sentenziò: è una veranda! No, dissi io - ce l’abbiamo già, andate a prendere la pompa a pedale che vediamo. A turno tutti cominciarono a premere con il piede sul mantice della pompa. Quando si stancava uno, continuava l’altro. Ci volle una buona ora perchè la cosa cominciasse ad avere un aspetto tale da essere riconosciuta. Paola gridò: - Papà è una piscina!? Sì! diametro due metri e mezzo circa, altezza sessanta centimetri....una vita per riempirla d’acqua. I cinque bambini, impazziti dalla gioia, il mattino dopo di buon ora erano già ai bordi pronti ad entrare. L’acqua era fredda e le mamme a dire loro: - Più tardi quando il sole sarà alto e l’avrà scaldata un pochettino potrete entrare. Tutti e cinque, in costumino da bagno, zoccoli ed asciugamano, ogni dieci minuti mettevano il dito dentro e dicevano: “mamma si è scaldata....” Un bel da fare a trattenerli, poi verso le undici del mattino dopo il furioso assedio dei bambini, le difese delle mamme cedettero e fu l’assalto dei Marines a Guadalcanal. Tuffi, “nuotate”, spruzzi tutt’intorno, grida, gioia, sorrisi compiaciuti sul viso dei genitori che stavano a guardare quello che quei cinque marmocchi riuscivano ad inventare per giocare in quel “catino” d’acqua. Poi veniva l’ora di pranzo e, nei giorni festivi, si accendeva il fuoco e si faceva la grigliata, bistecche, costine, braciole, salsicce, pollo, bruschette, ecc. da consumare al tavolo posto all’ombra sotto gli alberi e nel silenzio si sentivano solo i rumori delle mandibole che dialogavano con il cinguettio degli uccellini ed il cri-cri dei grilli. Sembrava di essere fuori dal mondo. Poi, i bambini andavano a fare il riposino pomeridiano, mentre gli adulti, seduti sulle poltrone a sdraio, facevano finta di leggere il giornale o un libro per darsi un contegno fino a quando, come bambini, chiudevano gli occhi per la “pennichella” ristoratrice. Poi c’erano le “seratine”. Dopo cena, tutti i gruppi familiari si riunivano, 47 alternativamente, sotto la tenda/veranda di uno di noi. Una sera da Alfio e Maria, un’altra da Pino e Lorenza, un’altra dai nonni Da Pisin ed infine una sera da noi. Ognuno portava una piccolezza, un dolcetto, una bottiglietta di vino di quello buono, un liquorino e si passavano alcune ore in allegria e spensieratezza, chiacchierando, accennando qualche piccolo coretto, magari accompagnato dalla chitarra di Alberto. La domenica pomeriggio, verso la fine di Settembre, tutti e cinque i bambini mi venivano a chiamare, armati di borse in nylon riciclate dal supermercato dove le mamme erano andate a fare le compere, perchè dovevamo andare in “gita a Modena, Udine, Firenze, Siracusa, Pisa, Catania, ecc.” Era il nostro piccolo segreto, il nostro codice d’azione. Allora armati delle borse, guanti, bastoni si decideva: Oggi andiamo a Modena! OK via si parte. Ci si avviava per i sentieri in cerca dei rovi dove crescevano le...more; infatti “M” di Modena corrispondeva alla “m” di more, “U”-uva, “F”-fichi, “S”-susine, ecc. Alla fine della “gita” si tornava con le borse piene di frutta che sarebbe servita per la “seratina” in allegria e, come spesso accadeva, se la frutta era in eccedenza, le mamme, ora una ora l’altra, avrebbero fatto la marmellata. Nelle serate più calde d’Agosto, la sera, ci si riuniva intorno al tavolo grande, sotto gli alberi, all’aperto anzichè sotto la tenda/veranda. Una sera successe che sentimmo un rumore strano provenire poco distante, sembrava un fruscio, sommesso e continuo; qualcuno disse: - Oh Dio sarà una vipera!. - Ma no, non può essere - disse un altro - perchè i rettili sono animali a sangue freddo, pertanto di notte stanno fermi e si chiudono a ciambella per avere minor dispersione termica. Dovevamo svelare il mistero, prendemmo una potente torcia per illuminare la zona del rumore e, col fascio di luce, illuminammo un grosso esemplare di istrice. - Bellissimo! Presi un paio di guanti, di quelli grossi da lavoro, lo prendemmo e lo appoggiammo sul tavolo. L’istrice si racchiuse in una “palla” alzò gli aculei e, per spaventarci, cominciò ad agitarli sbattendoli uno contro l’altro con un rumore quasi assordante. Sapendo che dove c’è 48 l’istrice non ci sono vipere, pensammo bene di metterlo in un angolo con alcune foglie di insalata fresca e un piatto d’acqua, sperando che si fermasse. Niente da fare, il mattino dopo se n’era andato, insalutato ospite. Altra serata, stiamo chiacchierando tra di noi, mangiando un dolcetto, quando arriva sul tavolo una ghianda, poi un’altra e un’altra ancora. Evidentemente non cadono da sole, qualcuno ce le sta tirando addosso, ma chi? Ci guardiamo in giro, non c’è nessuno, è tardi ed i bambini sono già a dormire. Si sente un rumore provenire dai rami sopra di noi, alziamo gli occhi e vediamo un ghiro che ci osserva e fa di tutto per attirare la nostra attenzione. Alfio allora dice: - Volete vedere che il golosone ha visto che mangiamo il dolce e ne vuole un pezzetto anche lui? Noi ci stringiamo sulla panca verso un’estremità ed Alfio all’estremità opposta mette un pezzettino di dolce. Stiamo in silenzio per vedere la scena. Il ghiro comincia a scendere lungo il tronco, cerca di avvicinarsi al dolce, ma ha paura, torna indietro, torna giù, scappa di nuovo e così di seguito per parecchie volte. Ogni discesa era sempre più vicina alla “preda”, finchè, in un attimo di coraggio estremo, prende il pezzo di dolce e veloce se ne scappa tra i rami. Altro pezzetto di dolce, posizionato da Alfio un po’ più vicino a noi, altre timorose discese e altre fughe tra i rami. Alla fine con nostra immensa gioia, dopo un oretta, il ghiro fermo sul tavolo mangiava pezzetti e briciole di dolce. Un mattino di primavera, faceva ancora freddino, andai a controllare se tutto fosse in ordine nel nostro campo. Aprii il cancello, entrai, lo richiusi e mi diressi verso la roulotte e vidi una “cosa” velocissima che attraversava la campagna e spariva verso il fondo della stessa mentre sentii un tonfo. Altro rumore di qualcosa che, correndo, attraversava il prato. Era un leprottino che spaventato cercava di scappare e uscire ma inesorabilmente sbatteva contro la rete di recinzione. Allora ritornai sui miei passi e spalancai il cancello che dava sulla strada, proprio di fronte al bosco. Mi spostai verso il fondo del prato in modo che il leprotto corresse nella direzione opposta, cioè verso l’uscita. Dopo alcuni tentativi con relativi cozzi contro la rete, finalmente vide il varco, indugiò un attimo e alla fine spiccò un salto che in 49 un solo balzo attraversò la stradina e si posò sul muretto a secco al limitare del bosco. Si fermò un attimo si girò verso di me, mi guardò per alcuni istanti e poi sparì all’interno della boscaglia. Ancora oggi ricordo quegli occhietti, sembrava quasi mi ringraziassero per la libertà avuta. Una sera di primavera avanzata, saranno state le diciannove, stavo rientrando verso casa dopo una controllatina che tutto fosse in ordine all’interno del nostro campo. Avevo lasciato, in macchina, la provinciale ed imboccata la camionale all’altezza del mobilificio Lanza. Fatti un centinaio di metri passai sotto un ponte con a destra e a sinistra la roccia alta circa due o tre metri in cui era stata scavata la strada. In senso opposto c’era una macchina ferma che mi lampeggiava; rallentai, doveva essere successo qualche cosa.....Guardai meglio e vidi fermo, verso il margine sinistro, un meraviglioso esemplare di capriolo maschio fermo in mezzo alla strada. Volsi lo sguardo verso destra e vidi scendere dalla roccia, molto lentamente, un capriolo femmina, gravida, che con incedere malsicuro, dato il suo stato, attraversava la strada. Ci saranno voluti almeno due minuti perchè riuscisse a risalire sulla roccia opposta. Quando la femmina giunse al sicuro, il maschio si guardò a destra e a sinistra, quasi a controllare che tutto fosse a posto o, forse, a ringraziare perchè ci eravamo fermati, e con un agilissimo balzo salì sulla roccia per seguire e continuare a proteggere la sua femmina, che gli avrebbe dato, di lì a poco il suo Bamby. Tutto questo e tante cose ancora sono PROSECCO Continua...... 50 don P.G. Leggendo il nostro quotidiano locale, “Il Piccolo” di domenica 16 Gennaio 2000, a pagina 23 vedo una foto che, per iniziare la giornata, mi porta un senso di pace e di gioia allo stesso tempo. Il titolo: Consegnato il “premio Barcola ‘99”. Nella foto sono immortalati Monsignor Ragazzoni, il vice sindaco Damiani e il presidente del “premio” Franco Giorgini. Il sottotitolo e la descrizione recitano così: Mons.Ragazzoni, una lezione d’impegno civile “Un uomo di chiesa che ha dato uno straordinario contributo alla crescita e allo sviluppo della coscienza civile della città”. Così il vicesindaco Roberto Damiani ha sintetizzato le motivazioni che hanno portato ad attribuire al vicario della diocesi e presidente dell’Opera del Villaggio del Fanciullo, monsignor Pier Giorgio Ragazzoni, il “Premio Barcola ‘99”, manifestazione giunta ormai alla sua 7.a edizione. Nella foto Lasorte, mons. Ragazzoni mentre riceve dal vicesindaco Damiani e dal presidente e animatore del premio Franco Giorgini l’ambito riconoscimento, opera dello scultore Pino Callea. Quanti ricordi mi si affollano nella mente, vorticosi, veloci, con un susseguirsi di immagini, situazioni, scenette, frasi....... cerco di fare ordine e cominciare dall’inizio. Io conobbi don Pier Giorgio nel 1961 quando, per motivi di lavoro, mi trasferii con la famiglia ad Opicina. Don P.G., così era chiamato, soprattutto dai “suoi” ragazzi, don Pier Giorgio Ragazzoni, un prete all’avanguardia, per i tempi, in cui era istruttore, educatore, ma innanzi tutto amico dei piccoli ospiti del “Villaggio del Fanciullo”. Il Villaggio era stato creato immediatamente dopo la seconda 51 guerra mondiale per accogliere, sul modello della “Città dei ragazzi” creata in America da padre Brown, gli orfani di guerra che senza famiglia stavano crescendo come piccoli delinquenti nelle strade delle città. Io ebbi l’occasione di vedere il Villaggio alla sua apertura, quando con mio padre e mia madre, una domenica, avemmo la fortuna di poter “visitare”, su invito, il comprensorio. Era proprio una città. C’era tutto: si accedeva dalla via di Conconello attraverso un ampio cancello, sorvegliato da 2 “ragazzi guardiani” che, dopo aver controllato l’invito, ci fecero entrare accompagnati da un “ragazzo cicerone” che ci fece da guida. Visitammo i tre laboratori di formazione al lavoro, per i ragazzi più grandi che avevano già terminato la scuola dell’obbligo, e che erano, una stupenda e moderna tipografia, un’attrezzatissima falegnameria e una bella officina meccanica per carpentieri in ferro. C’era poi il complesso scolastico con parecchie e ben tenute aule sia per la scuola elementare che media. C’era una piccola banca, infatti tutti i ragazzi che “lavoravano” nei laboratori, ricevevano uno stipendio in valuta coniata e stampata per il Villaggio, spendibile, ovviamente, solamente all’interno dello stesso. Nella Banca potevano depositare i loro guadagni e prelevare, man mano che servivano, piccole somme per acquistare nel “General Store” quanto poteva loro essere utile. Il General Store è il termine americano di quello che noi oggi chiamiamo il “Grande Magazzino” dove si poteva trovare dalla caramella alla.....bicicletta. Bisogna ricordare che in quell’epoca noi non si aveva ancora il concetto del grande magazzino, ma eravamo ancora al singolo negozio specializzato. C’era il bar/ristorante dove i ragazzi si ritrovavano al mattino per la colazione e poi a pranzo e a cena. C’erano gli edifici con le stanze da letto a due o tre posti, al cui piano terreno c’era la ricreazione con tavolini, calcetti, tavoli da ping pong, ecc. Per finire, c’era l’infermeria e la chiesetta. Una vera città gestita e curata dai ragazzi, sotto l’occhio vigile di istruttori sia ecclesiastici che laici. Quando nel 1961, come detto, ritornai ad Opicina, il Villaggio c’era ancora, come pure oggi, ma non aveva più quelle caratteristiche. Infatti gli orfani di guerra erano diventati adulti e avevano intrapreso il cammino 52 della vita. Le finalità del Villaggio erano cambiate, al posto degli orfani di guerra si potevano trovare “ragazzi difficili” vittime di separazioni coniugali, abbandonati da parte di ragazze madri, figli di genitori carcerati, ecc. Il compito di don P.G. non era facile; infatti succedeva spesso che venisse, sempre di corsa, da me in banca, alla Cassa di Risparmio, per qualche veloce operazione. Mi ricordo di averlo visto spesso in camicia di flanella a quadroni con le maniche rimboccate, in blue jeans, impolverato di segatura di legno. Veniva spontanea la battuta: “Reverendo è in missione segreta con opportuno travestimento?”. Lui con il suo aperto sorriso e la voce calda e suadente una volta mi disse: - Non è con la tonaca che si può cercare di “recuperare” i ragazzi difficili, ma vestendosi come loro, stare in mezzo a loro, lavorando con loro. Soffrire e gioire con loro, cercare di entrare nei loro ragionamenti e tentare di riportarli a giuste decisioni dettate, queste sì, da ciò che la ”tonaca” mi ha insegnato, ma senza farla pesare a poco a poco......come una missione a casa nostra e non in terre lontane. Don Pier Giorgio Ragazzoni, ha avuto parecchi incarichi, negli anni a venire, presso la Diocesi di Trieste, fino ad arrivare oggi ad essere monsignor Pier Giorgio Ragazzoni, Vicario del Vescovo di Trieste. Non ha mai però dimenticato o abbandonato il “suo” Villaggio tant’è che ne è il presidente. Sono passati oltre cinquant’anni dalla fondazione del Villaggio del Fanciullo, ragazzi ospiti, per fortuna, oramai ce ne sono pochi. Rimane in funzione la tipografia, con dipendenti qualificati, padri e madri di famiglia con una scuola di specializzazione per ragazzi che vogliono imparare “l’arte” della composizione tipografica. La scuola di un tempo è stata trasformata nella “International School”, una scuola privata a tempo pieno, che va dall’asilo alla scuola media e dove la lingua d’insegnamento è l’inglese con insegnanti di madrelingua. L’officina di carpenteria meccanica funziona ancora ed è considerata una scuola di specializzazione con esami ed attestati finali che qualificano i frequentatori indirizzandoli al mondo del lavoro. Negli enormi spazi della proprietà sono stati creati dei nuovi sodalizi, quali l’Associazione Tennis Opicina, che può contare su quattro campi da tennis oltre la sede sociale con bar e ristorante. Il Centro Sportivo Internazionale, con una 53 attrezzatissima palestra sia per la ginnastica soft, sia ginnastica aerobica che body building, ecc. È stato creato pure un campo sia per il calcio che per il foot-ball americano. Del “vecchio” Villaggio del Fanciullo – Città dei ragazzi- oggi è rimasto poco o niente ma don P.G. è sempre là a custodire, vegliare ed amare il “suo” Villaggio e ad essere amato da generazioni di ex suoi “ragazzi” grati e riconoscenti di quello che lui ha donato loro............la strada retta della vita. 54 AMORE FRATERNO Si parla tanto di amore fraterno, ma quello che sto per narrare ha qualche cosa che travalica la normalità per arrivare ad un alcunchè di sublime e mistico. Come già in un altro “pensiero” avevo ricordato, quando ero ragazzo, essendo i marciapiedi sgombri da auto in sosta, si poteva giocare al “Giro d’Italia” con i tappi di birra riempiti di cera di candela per renderli più pesanti; il più bravo di tutti noi era un ragazzo che abitava in viale D’Annuzio, che allora si chiamava viale Sidney Sonnino. Era Mario Vatta, un coetaneo, che aveva un’abilità incredibile nel dosare i tiri in modo da non uscire dal tracciato. Aveva anche una grande passione, suonare il saxofono, e gli riusciva bene, le sue agili dita correvano sui tasti traendo dallo strumento delle note dolci e forti allo stesso tempo, il suo repertorio preferito, quando non doveva studiare musica classica, era il jazz. Mario aveva un fratello maggiore il quale, avendo la vocazione, frequentava il Seminario Vescovile di Trieste ed era quasi arrivato alla fine, pronto a prendere i voti. Essendo un ragazzo giovane e pieno di vita, il fratello di Mario, aveva l’hobby delle scalate in montagna. Era un buon rocciatore e nei pochi momenti liberi che il seminario gli concedeva, prendeva scarponi, corde, chiodi, piccozza e quant’altro potesse servire per fare una scappata in Val Rosandra e scalare le pareti del Monte Carso, del Cippo Comici, ecc. Ma il destino della sua breve esistenza era segnato, un brutto giorno pagò con la vita quello che era uno dei pochi diversivi che concedeva allo studio e alla Fede. Quel chiodo, forse mal fissato, forse la roccia più friabile, forse le dita hanno perso l’appiglio ed il suo corpo è volato in fondo al burrone, vicino al torrente sotto gli occhi inorriditi dei suoi compagni di cordata. Mario rimase particolarmente scosso, non venne più a giocare al Giro d’Italia, si isolò, lo vedevamo saltuariamente, un saluto, un “come va?”, “ci vediamo.......” Il tempo passava, le abitudini cambiavano, le amicizie variavano e di Mario rimase solo un vago ricordo sempre più pallido fino a svanire. Divenuti “adulti” ognuno andò per la sua strada, lavori diversi, chi si fece una 55 famiglia, chi rimase scapolo, ognuno per la sua strada. Una ventina di anni fa mi capitò di leggere sul nostro quotidiano locale che un certo don Mario Vatta aveva fondato la “Comunità di S.Martino al Campo”, una comunità per il recupero dei tossico dipendenti, basata su metodi nuovi fondati più sulla convinzione psicologica e sull’alternativa che sul vietare tassativamente l’uso della droga. Incuriosito dal nome, peraltro molto comune e che mi ricordava il compagno di giochi d’infanzia, feci delle ricerche e venni a scoprire che era proprio lui: il campione del “Giro d’Italia” nonchè saxofonista jazz. Correva l’anno in cui il Circolo dei Dipendenti della Cassa di Risparmio di Trieste, festeggiava il suo venticinquesimo anno dalla costituzione. Il Consiglio Direttivo decise di festeggiare tale data offrendo alla Cittadinanza tutta un concerto vocale e strumentale presso la chiesa Luterana di Largo Panfili. Il maestro Nossal diresse egregiamente il coro dei Madrigalisti Triestini e il complesso dei Cameristi Triestini. Essendo l’ingresso libero a tutti, il direttivo del Circolo pensò che gli intervenuti, se lo credevano, avrebbero potuto deporre in un’urna all’ingresso, una libera offerta a favore della “Comunità di S.Martino al Campo. A tale scopo fissai un appuntamento con don Mario Vatta con il duplice scopo: chiedere l’autorizzazione per la raccolta di offerte per la sua Comunità e il piacere di rivedere l’amico d’infanzia. L’incontro, per me, fu molto toccante, se ci fossimo incrociati per la strada nessuno dei due avrebbe riconosciuto l’altro, tanto eravamo cambiati fisicamente ed....invecchiati. Dopo le prime frasi di circostanza: “son passati gli anni, ma possiamo darci del tu?....certo...anzi! ...così ritorniamo giovani...ti trovo bene... Come stai??...” Mario mi chiese: - Ti sei sposato?... hai figli?. - Sì certo, ho due bellissime bambine...ma dimmi tu piuttosto non era il tuo povero fratello che aveva l’intenzione di diventare prete??? - Sì! Ma, come sai, il Signore lo ha chiamato a sè prima che divenisse un Suo Ministro. Io ho passato dei momenti terribili, avevo sempre davanti 56 agli occhi quel povero corpo martoriato, mia madre non dormiva la notte, entravo nella mia camera da letto e vedevo, appesa, la tonaca che mamma aveva confezionato per lui e che non avrebbe mai potuto indossare. Eravamo così felici della sua decisione che, allora, con la sua morte il mondo ci crollò addosso, ci mancava qualcosa, c’era un vuoto incolmabile. Probabilmente altre persone avrebbero imprecato, avrebbero detto che non era giusto e che se ci fosse stato un Dio non avrebbe potuto permettere una tragedia simile. Io no! Ho visto in tutto questo, anche se doloroso, un disegno divino del quale non potevo capire il significato, ma che dentro di me diceva: “Mario, quella che tuo fratello ha lasciato, quella è la tua strada, percorrila e siine degno”. Ed eccomi qua, l’unica cosa che mi è rimasta dall’infanzia è la passione per il saxofono e per il jazz. Suono ancora sai? E sempre di più! Uso questa mia passione nella cura ai miei assistiti. La “terapia” musicale ha sortito effetti insperati, i poveretti provano una gioia nuova e se qualcuno tenta di suonare qualche strumento, anche gli altri trovano stimolo ad emulare. Hanno la mente occupata e non pensano, per un po’, alla droga. A qualcuno sono riuscito ad insegnare a leggere uno spartito e sono riuscito a creare un piccolo gruppo, una band e un paio di sere la settimana, facciamo dei concertini jazz, seguiti anche da non appartenenti alla comunità, quali membri del volontariato, loro familiari, amici. Questo è il mio metodo per cercare di recuperare questi infelici ed inserirli nella Società e fare in modo che non siano degli emarginati. Se tutti riuscissero ad aiutarli in qualche modo, dando loro degli stimoli, degli interessi, dei diversivi alla quotidianità piatta e grigia, sarebbe, forse, il primo passo per debellare il mondo della droga. Questa, in sintesi, è la storia di un amico d’infanzia che, per i casi della vita, ho perso, ritrovato e riperso nuovamente, quest’ultima volta quasi esclusivamente per colpa mia. Infatti mi ero ripromesso di invitarlo presso il nostro Circolo per una serie di conferenze sulla sua “missione” e per illustrare gli scopi della sua “Comunità”, magari presentando anche un piccolo concerto di musica jazz. Lui sempre indaffarato, io altrettanto, ho provato a rintracciarlo telefonicamente un paio di volte, sempre senza successo. Il tempo è passato e, come cinquant’anni fa, ci siamo “persi” nuovamente. Ci 57 saranno altre occasioni? - chissà... forse... vedremo. Don Mario Vatta, comunque, è stato, è e sarà un faro di speranza per tanti emarginati, e per me un grande Amico. 58 3 DICEMBRE 1988 - 3 OTTOBRE 1998 Due date, due momenti importanti nella vita della nostra famiglia. Paola ed Elena hanno sposato, sono diventate “signora Rotella” e “Signora Salvador”. Due giornate memorabili, climaticamente opposte: Paola, una giornata piovosa, ma resa luminosa dalla gioia e dall’Amore; Elena, una giornata di sole, che incorniciava la stessa gioia e lo stesso Amore. Ricordo il mattino del 3 Dicembre, l’emozione, la frenesia dei preparativi, il rincorrersi per la casa, i vestiti, la parrucchiera, il fotografo, l’ombrello. Sì, il grande ombrello bianco che mamma Nory, con difficoltà, era riuscita a trovare in previsione di una giornata di pioggia. Ero io il protagonista, il padre della sposa, colui il quale doveva portare all’altare la figlia e consegnarla al futuro marito. Quale emozione, quale responsabilità, vigilare che tutto procedesse come da cerimoniale, l’entrata in macchina sotto casa tenendo ben protetta la sposa sotto l’ombrello bianco. Il tragitto fino alla chiesetta di Cologna, nella parte alta di via Commerciale. Il cuore andava a mille, trattenere la lacrima era un problema, finalmente la macchina lentamente arriva alla base della scalinata che conduce alla chiesa. Scendo veloce, apro l’ombrello, e vado dalla parte opposta per aiutare Paola ad uscire dalla macchina. Paola ha un bel daffare a tenere raccolto l’ampio vestito bianco in modo che non tocchi terra per non farlo inzaccherare. Le porgo il braccio e, sotto l’ombrello, saliamo la scalinata, sembra enorme, ogni gradino sembrano dieci, non finisce mai. Finalmente arriviamo sulla soglia della chiesa, qualcuno mi prende l’ombrello, Paola può, finalmente, lasciare l’abito che si rimodelli. La musica ci accoglie, gli invitati hanno tutti uno sguardo strano, sorridono e piangono contemporaneamente, le mani serrate intorno ai fazzoletti che vogliono nascondere, ma non ci riescono. Passo lento, sul tappeto rosso, ci avviciniamo all’altare dove un ragazzo giovane, emozionato attende la sua sposa: Gianni che con gesto dolce, quasi temendo di farle male, la prende tra le braccia e l’accompagna all’altare. Io do un bacio alla figlia che se ne va e uno al “figlio” che arriva. Mi giro e vado vicino alla mia Nory, 59 anche lei emozionatissima, lo sguardo di entrambi alla nuova coppia, alla nuova famiglia. Elena è vicino a noi, lei pure ha gli occhi lucidi. Don Pippo celebra un rito bellissimo, con belle parole e sinceri apprezzamenti. Foto, riso, confetti, gioia, allegria, finalmente si ride solamente. Gli sposi se ne vanno con il fotografo che, data la giornata, sceglie posti particolari per il “servizio”: museo ferroviario, le calli di Muggia, scorci bellissimi. Infine il pranzo, all’hotel Lido, con la musica di “Esteban”, l’amico Mario conosciuto a Bibione dove intratteneva i turisti in una nota gelateria del centro balneare. Paola e Gianni erano entrati in amicizia, anche perchè Mario era nato e vissuto in Argentina, come Gianni era nato in Cile, e pertanto parlavano tra di loro la lingua madre: il “castigliano” che per lo spagnolo è come il toscano per gli Italiani. Alla sera ritorniamo a casa, con Elena, l’altra protagonista di questo racconto, felici al pensiero della gioia di Paola, ma un po’ tristi per quel letto vuoto. Passano gli anni, la storia si ripete, siamo al 3 Ottobre 1998, stesso caos in casa, tutti che corrono, parrucchiera, fotografo, eccetera. La macchina davanti al portone, niente ombrello! Sembra più semplice, macchè, il cuore batte a mille di nuovo, e la lacrima è difficile da trattenere, anche se Elena, conoscendomi, fa di tutto per distrarmi. Siamo un poco in anticipo, quindi la macchina procede lentamente, di tanto in tanto, lungo il tragitto, la gente sui marciapiedi si china, curiosa, a guardare la sposa. Elena per distrarmi, parla, parla, ma anche a lei l’emozione tira un brutto scherzo; giunti a Barcola non ce la fa più a deglutire tanto secca ha la bocca. Accostiamo al marciapiede, scendo dalla macchina e mi reco presso una rivendita di tabacchi a comperare della gomma da masticare al gusto di menta per alleviare il disagio di Elena. Giunti a Grignano, stessa scena, altra “lunghissima” scalinata, stesse emozioni. Niente ombrello da consegnare. La musica, ma non come l’altra volta, stavolta il giovane non sta fermo, emozionato, ad aspettare la sposa, anzi, per farla avanzare, le canta: “Vien diletta, vieni o sposa....”. Anche 60 stavolta la gente ha lo sguardo strano, tra il sorriso ed il pianto, stringono anche loro dei fazzoletti, ma sono tanti che non tentano neanche di nascondere......la causa è Fausto, è la sua canzone. Elena ha un cedimento, si aggrappa al mio braccio, piange di gioia, di emozione, di sorpresa. La musica finisce, sul tappeto rosso, a passo lento, andiamo all’altare e, anche stavolta, la figlia se ne va ed il figlio arriva. Li bacio e vado dalla mia Nory che piange, stavolta siamo proprio soli. Don Andrea, ex compagno di scuola di Fausto, ha voluto celebrare le nozze del suo amico, trovando delle parole e rievocando episodi di gioventù in comune che, di nuovo, fa piangere i presenti, ma sopra tutto i genitori e la sorella di Fausto che con Don Andrea hanno vissuto lunghi periodi ospitandolo pure in casa. Alla fine di nuovo foto, riso, confetti, gioia, allegria, risate. Gli sposi, con alcuni amici, se ne vanno con il fotografo per il servizio. Il fotografo è lo stesso che ha avuto Paola, gli scenari sono cambiati perchè il sole favorisce le foto all’aperto. Poi il pranzo al ristorante “Le Maschere” con la musica del “Duo euforia” che ci rallegra e ci fa ballare fino a tardi. Alla sera ritorniamo a casa, questa volta Nory ed io soli, i letti vuoti sono due. Una momentanea stretta al cuore, un po’ di sconforto, per fortuna subito fugati da un senso di gioia, gioia vera, immensa: esserci trasformati in tre famiglie, distanti ed unite. Prima in due, Nory ed io, poi tre, poi quattro, cinque, sei e con i nipoti nove........per il momento: Nory, Giorgio, Paola, Elena, Gianni, Fausto, Michele, Stefano, Elisa, ?,?,? 61 QUARANT’ANNI... Quarant’anni.....una vita! ...ideali....passioni....vocazioni Quarant’anni.....entusiasmi.......dinamismo........espressività. ....Quarant’anni......incisività......vigore.......dispiaceri..afflizioni.. .......Quarant’anni......contrarietà.....pene...dolori......tormenti......... .......Quarant’anni.....gioie..felicità..giubilo..estasi.....allegria..amore .....Quarant’anni.........un batter d’ali ....... un attimo..... ieri...... Sembra quasi impossibile che siano passati quarant’anni da quel 23 aprile 1960 quando, giovanissimi, emozionati, quasi tremanti abbiamo detto “SI’” sull’altare di Montuzza. Il pensiero va indietro a quella data, mi sembra così lontana, batto le palpebre e mi ritrovo adesso, in questo lasso di tempo ho rivisto tutto. Tutta la nostra vita assieme, fatta di tantissime cose. Tantissime belle, per fortuna, altre dolorose, poche per fortuna. Il tempo è un metro che diamo noi allo scorrere della vita. Se ci ripenso, avvenimento per avvenimento, dovrebbero passare altri quarant’anni per rivederli tutti. Invece no! Il pensiero ha un’altra dimensione e scorre via veloce facendoti rivedere i punti salienti e le tappe che segnano il cammino lungo quarant’anni. È bello e consolante ripensare a quello che si è riusciti a costruire assieme, sia materialmente, ma soprattutto moralmente. Avere una certa sicurezza economica che ti permetta di guardare al domani senza troppe apprensioni, sapendo che, ove necessiti, hai la possibilità anche di intervenire a favore dei tuoi cari per aiutarli a superare i momenti difficili, come noi siamo stati aiutati dai nostri genitori in base alle loro possibilità. Avere delle figlie cresciute nel rispetto della vita propria ed altrui, seguendo sempre quella via, che noi abbiamo loro indicato e che, per grazia del cielo, non hanno mai abbandonato e che le ha portate ad essere delle 62 mogli esemplari come la loro mamma. Valori questi che scaldano il cuore e fanno salire la lacrimuccia all’angolo dell’occhio, lacrima di gioia, di serenità, di appagamento, di distensione e tranquillità. I pensieri corrono, i ricordi affiorano in un balenio di lampi, di immagini, di situazioni vicine e lontane nel tempo come fossero successe contemporaneamente, quasi a voler riconfermare che il tempo, come già detto, sia un metro di misura che nel ciclo della vita non ha senso, perchè la situazione ricordata, che in realtà è durata un lasso di tempo, nel ricordo è un attimo. Ho piacere di ricordare un episodio che ha lasciato un solco profondo nei miei pensieri e nei miei ricordi, gioia e dolore, purtroppo, a breve distanza, ore... . Era il giorno di Pasqua del 1990, eravamo seduti a tavola ed avevamo appena finito di consumare il pranzo. Era il momento in cui ognuno di noi avrebbe aperto le uova per cercare la sorpresa. In quel momento non conta l’età, si è tutti bambini e si sogna di trovare chissà che cosa dentro l’uovo. Eravamo tutti in piedi indaffarati con nastri, nastrini e fogli variopinti di carta celophane, quando vedo Gianni che tenendo un bel nastro con tanto di fiocco intorno alla fronte di Paola esclama: “Anche Paola ha una sorpresa per tutti e, indicando la pancia, la tiene nascosta qui dentro”. Bocche aperte, fiato sospeso, lacrime, piccoli gridolini....ma è vero... abbiamo capito bene.... - Sì, sì è tutto vero - conferma Gianni. E Paola emozionata con gli occhi bassi annuisce. La “paralisi” che ha colpito tutti è finita, abbracci, baci, coccole, complimenti, congratulazioni, auguri......siamo tutti al settimo cielo. Paola e Gianni saranno genitori, Nory ed io nonni, Elena sarà zia...nonno Cesare bisnonno, quante cose cambieranno con l’arrivo di un bebè. Bisogna festeggiare, brindare, Paola no, perchè l’alcool......chi si ricorda più delle uova di Pasqua, lì sul tavolo, mezze aperte. Gioia indescrivibile! Passano un paio d’ore, Paola si accorge di avere una serie di puntini rossi attorno la vita che si estendono anche verso il torace. Apprensione, trepidazione, corsa al Burlo, sentenza, varicella. Il castello crolla, gli occhi si bagna63 no di nuovo di lacrime, ma questa volta sono di dolore. Sempre lacrime sono, ma quale diverso significato! Ebbene in poche ore sono successi avvenimenti che potevano durare mesi. Per fortuna io, nei miei pensieri, ricordo solamente un nastro con il fiocco tenuto da Gianni attorno la fronte di Paola. La festa era solo rimandata... Paola e Gianni ci hanno dato la gioia di tre bei bambini che sono la felicità loro e.... anche nostra. Tanti episodi si affollano contemporaneamente nella mia mente, vedo il giorno delle nozze assieme alla trepidazione in clinica per la nascita di Paola e quella di Elena – non riesco, con il pensiero, a quantificare il tempo che separa gli eventi -, il trasloco ad Opicina con le feste in giardino, l’appartamento di via dell’Istria con quello di piazza dei Foraggi, i quattro giorni tristi in cui sono venuti a mancare i quattro genitori, e tanti altri tra nonni, zii, parenti ed amici, ma per fortuna tante date felici, che segnano tappe miliari sul cammino della vita. Anche qui mi piace ricordare un fatto che, per me, ha dell’incredibile: la forza di volontà, la tenacia, la fermezza, la testardaggine, la costanza, la perseveranza della mia Nory nel voler ottenere l’abilitazione all’insegnamento. Erano trascorsi ormai tanti anni dall’ottenimento del diploma magistrale anche se, per la verità, per brevi periodi, quale insegnante supplente, è stata a contatto con la realtà della scuola. Si trattava, comunque, di fare dei corsi di preparazione agli esami, studiare come se dovesse rifare l’esame di maturità o forse anche di più, il tutto avendo una famiglia a cui badare. Si trattava di conciliare le due cose, non era facile, ed allora studiava la sera, che diventava notte ed ancora notte inoltrata, tutti i giorni, per mesi. Quante volte mi svegliavo alle tre del mattino, allungavo la mano, il letto era vuoto; mi alzavo, c’era la luce in cucina, trovavo Nory con la testa reclinata sui libri vinta dalla stanchezza e dal sonno. La svegliavo piano per accompagnarla a letto dicendo: Nory lascia perdere, non puoi andare avanti così, ti ammalerai, pensa alle bambine...... 64 Queste mie parole erano come una sferzata, invece di abbatterla la rafforzava, stringeva i denti e tirava avanti per la sua strada, testarda, con la voglia di farcela, per lei e per gli altri. Di nuovo notti insonni, brevi riposi sui libri, e via fino al giorno degli esami. La paura di non riuscire cominciava a fare capolino in lei, ed allora a sorreggerla dicendole che non è niente, che con tutto quello che aveva studiato sarà un gioco da ragazzi.....speranze. E così è stato, ce l’ha fatta, e bene anche, tant’è che è stata messa a ruolo immediatamente senza attendere in parcheggio che un posto si liberasse. Lei, modesta, ha sempre negato ma per me, è ovvio, è arrivata tra le prime in quanto grossi punteggi di preruolo non ne aveva, avendo insegnato saltuariamente come supplente. - È vero che il tutto ha dell’incredibile? Ma ormai ci aveva abituato e parecchi anni dopo eccola di nuovo sui libri a studiare di notte per ottenere la specializzazione per l’insegnamento ai bambini handicappati. Insegnante di sostegno, la chiamano, ma che sostegno e sostegno, insegnate missionaria dovrebbero chiamarla, lei e, ovviamente, tutte le sue colleghe che hanno la stessa specializzazione, in quanto riesce a far apprendere a dei bambini che hanno gravi problemi mentali, i primi rudimenti dell’alfabeto e dei numeri. Viene a casa felice e sorridente dicendo: - Pensa, la bambina ha saputo bene la tabellina del 2 – oppure - ha saputo leggere due lettere unite, una sillaba.... La bambina, purtroppo, ha magari dieci anni ed è in quarta elementare; per lei è una vittoria contro le disgrazie della natura essere riuscita a far capire un qualche cosa che umanamente, altrimenti, non sarebbe stato possibile. Tutto questo è durato anni ed io nella mia mente salvo come un flash la scena di Nory assopita sui libri sul tavolo di cucina. Lavoro, carriera, vita di tutti i giorni equivale a: soddisfazioni e amarezze, felicità e contrasti, serenità e momenti difficili, benessere e ristrettezze, salute e piccoli acciacchi, certezze e tentativi, scelte oculate e scelte avventate, successi ed insuccessi, questo e tante altre cose ancora sono quarant’anni insieme. Quarant’anni che non cambierei per nessuna ragione al mondo e che, se si potesse, rifarei volentieri anche sapendo che rivivrei i momenti 65 tristi che abbattono moralmente e fisicamente, ma che, alla fin fine, sono compensati ampiamente dai momenti felici che si ricordano volentieri ed aiutano a cacciare i ricordi tristi. Quarant’anni, una vita, un attimo, ieri, oggi e speriamo tanti altri domani sempre così. 66 INFANZIA Dicembre 2000 67 68 Dedicato alle mie figlie, Paola ed Elena, per significare loro il periodo, i fatti, gli avvenimenti che si sono succeduti incalzanti, turbinosi, pressanti alle volte insidiosi, alle volte lusinghieri e che, alla fine, per volontà del Signore, hanno fatto sì che, nascesse quella cosa meravigliosa che è la nostra famiglia. Oggi è suddivisa in tre nuclei familiari, che continuano ad essere meravigliosi grazie anche all’affetto dei generi ed a quello dei nipoti che per ora sono tre... e un domani... ???? papà 69 ....INFANZIA.... ma poi, la puoi chiamare infanzia? Alle volte la vita riserva delle sorprese, delle situazioni, degli episodi, che poi, a distanza di tempo, ripensandoci, sembrano quasi irreali, come fossero dei sogni, degli incubi, dei tormenti o aspirazioni, desideri, speranze che hanno le sembianze di fantasie, ma sono invece delle solide realtà. Questo è quello che mi passa per la testa quando, sforzandomi, ripenso alla mia gioventù, all’ambiente in cui vivevo, al periodo storico, alle situazioni a volte anche drammatiche che hanno caratterizzato e condizionato la prima parte della mia vita. L’anno scorso ho scritto i miei “Pensieri” che erano un flash di memorie, di situazioni, per lo più piacevoli, che hanno condizionato il periodo della mia vita che andava dai venti ai sessant’anni. Ora che ne ho sessantatré, sento il desiderio di rievocare i primi anni di vita, quelli, purtroppo, che sono stati i più difficili e che spero, mai più, altri bambini e ragazzi debbano rivivere. Mio padre e mia madre vivevano in un appartamento al quinto piano di via Vergerio 4 dove io sono nato il 19 Giugno 1937, al settimo mese di gravidanza, e, per mia fortuna, anche se piccolino, sano e pieno di voglia di vivere. I miei genitori mi raccontavano che ero vivacissimo, di buon appetito e che ben presto recuperai la mia nascita prematura. Come si usava allora, sono nato in casa, mia madre assistita dall’ostetrica, che in gergo si chiamava “levatrice”, ed evidentemente senza quelle assistenze che un parto prematuro avrebbero richiesto. Oggi, in analoghe situazioni, precauzionalmente, il bambino verrebbe messo nell’incubatrice almeno per un certo periodo. Allora solamente coperte di lana e bottiglie d’acqua calda. In quell’appartamento vissi i primi tre anni della mia vita circondato, 70 così mi dissero, dall’affetto dei genitori e dalla processione di zie e cugine che volevano tenere in braccio e viziare questo nuovo “fagottino”. Zia Wanda, una delle sorelle della mamma, per farmi addormentare correva attorno al tavolo della cucina cantando la marcia dei bersaglieri, zia Anita preparava le pappette e i biberon calcolando esattamente la temperatura degli alimenti in modo che fossero di mio “gradimento”. La mamma, presa un po’ in contropiede dall’anticipo della mia nascita, preparava gli abitini coadiuvata dalla zia Aristea che era sarta di professione, mentre Etta, sua figlia e mia cugina, di sei anni più “vecchia”, mi intratteneva con dei giochini per dar modo alla mamma e alla zia di lavorare. Quando compii i tre anni, nel 1940, all’inizio della guerra, papà decise di cambiare casa e prenderne una più grande, in modo che io potessi avere la mia cameretta. Rimanemmo nello stesso rione, ma ci trasferimmo in via Padovan, 12 al secondo piano. Da questo punto, anche se velati, cominciano i miei ricordi personali con l’apporto di episodi che mi furono raccontati in seguito, e che io ho allineato ai tempi reali. A papà, come a quasi tutti gli uomini allora trentenni, giunse la cartolina per presentarsi alla visita medica per l’idoneità al servizio militare ed essere mandato al fronte a combattere. Mamma si sentì scossa e disperata, sia per la paura di non rivedere più papà, sia per il fatto di semplice sopravvivenza in mancanza dell’unica fonte di reddito. Lei infatti, non avendo più né la mamma né la suocera, non avrebbe potuto ritornare al suo lavoro, abbandonato poco prima che io nascessi, non avendo dove e a chi lasciarmi. A questo punto, il buon Dio ci aiutò davvero, papà, causa insufficienza toracica e una leggera extra sistole, venne destinato ad eventuale servizio civile di assistenza territoriale e non dovette lasciare il suo lavoro di assicuratore. Da questo momento, io, pur giocando con quei quasi inesistenti giocattoli che il periodo offriva, ebbi modo di seguire gli avvenimenti bellici tra71 smessi da notiziari radio e commentati dagli adulti. Il bisogno di stare assieme di confortarsi e consolarsi l’un l’altro, fece in modo che quattro famiglie, che abitavano lo stesso palazzo di via Padovan, si frequentassero quasi giornalmente. La mia famiglia, quella delle due famiglie, al terzo piano, sopra di noi, i signori Vesselizza e Contento e quella del quarto piano prof. Bidussi, quasi quotidianamente ci si vedeva, si scambiavano opinioni, idee, valutazioni e considerazioni sull’andamento della guerra, sull’economia che precipitava e sulle difficoltà di approvvigionamento alimentare. La solidarietà di queste quattro famiglie, tutte con figli piccoli, fu una cosa che, ancor oggi, mi tocca il cuore nel pensare quanta fraternità, nel momento del bisogno, possa scaturire dagli animi al contrario di oggi dove l’egoismo ed il menefreghismo imperano. Pur nelle ristrettezze, mi piace ricordare, le serate natalizie o quelle del Capodanno che si passava, a turno, ora a casa di uno, ora a casa dell’altro. Si faceva una tavolata unica, ognuno portava le sue seggiole, ed ognuno portava quello che era riuscito a mettere insieme per creare un pasto, un dolce, un qualcosa che potesse far felici soprattutto i bambini e far sentir loro, almeno in quelle occasioni, il calore della Festa. Devo premettere che papà lavorava alla R.A.S. e che la direzione, nel limite delle sue possibilità, cercò di aiutare le famiglie dei dipendenti, fornendo ogni quindici giorni dei pacchi viveri che contenevano sempre le stesse cose, farina di polenta, marmellata, fagioli, riso e di tanto in tanto un po’ di zucchero e di surrogato di caffè, orzo torrefatto, per intenderci. Mamma era affetta da ulcera duodenale-gastrica e pertanto, con la tessera annonaria, aveva diritto ad avere un uovo e mezzo litro di latte al giorno. Festa grande!! La mamma, sacrificando la sua ulcera, con la farina di polenta, l’uovo, un po’ di latte e un po’ di zucchero faceva un impasto che stendeva con il mattarello, come fosse l’odierna pasta sfoglia, spalmava un po’ di marmellata, arrotolava il tutto come fosse uno strudel, lo infornava quel tanto che fosse necessario per cucinare la “pasta”, dopo di che faceva le porzioncine per noi ragazzi che divoravamo quella leccornia, quella ghiottoneria come il più grande dono piovuto dal cielo. 72 Il signor Contento, gestiva, allora, uno spaccio rionale delle Cooperative Operaie e ogni tanto riusciva ad avere un pezzo di lardo o di pancetta in più dal quale trattenere duecento o al massimo duecentocinquanta grammi da portare a casa. Altra festa grande!! La domenica seguente avremmo avuto a pranzo un “minestrone condito”, pensate, nientemeno che duecento grammi di pancetta per fare il minestrone per dodici persone: otto adulti e quattro bambini. Poi una o due “napoletane”, per gli adulti, che bevevano il famoso “caffè” del pacco viveri di papà. La signora Vesselizza ogni tanto riusciva a procurare un fiasco di vino che, parenti dal Carso, portavano a lei di nascosto. Ma il vino lo si salvava per feste veramente importanti! Infine il prof. Bidussi, quando era il suo turno per ospitare le altre famiglie, assieme alla figlia Lauretta, che era la più grande di noi bambini, ci deliziava suonando il pianoforte con pezzi di musica classica e con semplici marcette e canzonette per noi bambini che, a tempo di musica, marciavamo in fila indiana in corridoio. Ma anche questo “paradiso” – per noi la guerra a Trieste era lontana - era destinato a finire. Arrivammo al 1943, otto settembre, armistizio, soldati italiani che cercando di abbandonare la divisa, scappavano nel disperato tentativo di ritornare a casa sani e salvi. Le truppe tedesche avanzarono inesorabili, occupando paesi, villaggi e città. Questo ricordo è vivo nella mia memoria, era sera, buio, chiusi in casa con le tapparelle abbassate, si udivano colpi di fucile, di pistola, qualche raffica di mitra. Non era il fronte, ma per noi che della guerra, ancora, non avevamo avuto riscontro diretto, sembrò il finimondo. Durò un paio d’ore, almeno per noi, nella nostra zona, tra via Padovan, dove abitavamo, la zona dell’ippodromo, via Rossetti, via Cumano, vicino alle caserme. Il mattino dopo, sollevate le tapparelle, sembrò tutto tranquillo, però non si vedeva nessuno che camminasse per le strade, i negozi avevano le serrande chiuse, era presto magari, ma no! nemmeno la panetteria né la latteria erano aperte. Papà chiamò il suo ufficio per sentire come andava in centro città. Il portiere di turno rispose: - Signor Weiss resti a casa, qui non c’è nessuno, il mio turno finiva alle sei, siamo alle sette e trenta e non ho 73 avuto ancora il cambio, io sono chiuso dentro e non mi fido di uscire per andare a casa. Papà allora aprì la radio, si sentì una voce imperiosa e gutturale che stava, quasi urlando, dicendo cose, per me incomprensibili, in una lingua che non avevo mai sentito, seguita quasi subito da una seconda voce che, parlando male l’italiano, traduceva quello che “l’urlante” aveva appena detto. Ero troppo piccolo per capire esattamente cosa stesse succedendo, però ricordo che papà sbiancò in volto e, abbracciando la mamma e me, disse: Io non sono un cattolico praticante, ma questa volta bisogna pregare il Signore con tutto il cuore. Pian piano, i giorni seguenti, le strade si rianimarono, la vita bene o male, ricominciò. Per strada non si videro più divise militari grigio verdi con il moschetto, in cambio si videro divise scure con elmi lucidi, con il “para orecchie”, mitra a tracolla, passo marziale e sguardo truce. Cominciarono pure le incursioni aeree da parte degli alleati. Dapprima gli allarmi aerei suonarono a vuoto. Noi comunque, per precauzione si correva nei rifugi antiaerei che, al principio, erano costituiti dagli scantinati degli edifici il cui soffitto era puntellato con delle travi in legno, fino a tanto che non suonava la sirena del cessato allarme. Ricordo, un giorno, era inverno ed io ebbi la febbre dovuta ad una probabile infreddatura, suonò l’allarme e scendemmo in cantina, al freddo, giunse il medico e disse: - Donete, cossa fe qua? Andé a casa in caldo, no vedé che sti travi zinzola come i denti de mia nona. (Signore cosa fate qui? Rientrate in casa al caldo, non vedete che questa travatura dondola come i denti di mia nonna?) Erano infatti aerei che sorvolavano la nostra città, ma erano diretti su obbiettivi ben più a nord, verso la Germania. Memori dei consiglio che ci dette il medico, ed essendo sempre più frequenti gli allarmi aerei, sintomo che il pericolo si stava avvicinando, le mamme, in casa, scelsero di andare in un luogo più sicuro, anche se più scomodo, la galleria che si apriva in “piazza del fien”. 74 Caso voleva che l’allarme aereo suonasse spesso ad ora di pranzo, quando la minestra di risi e fagioli era in piatto. Molla tutto, corri nel rifugio che si trovava nell’allora su citata e non completata galleria di piazza Foraggi, e pazientemente si aspettava il cessato allarme che suonava dopo un’oretta circa. Lentamente si tornava a casa e, quel giorno a pranzo, “crostata” fredda di risi e fagioli, ma era buona lo stesso. In ottobre del 1943 sarei dovuto andare a scuola, alle elementari in via Donadoni, ma come fare, pochi genitori infatti mandarono i loro bambini alle scuole elementari, infatti se mentre si era a scuola fosse suonato l’allarme aereo, come avrebbero fatto i genitori a prelevare i loro bambini? Ecco che, la signora Contento, essendo lei maestra anche se non esercitava la professione, si offrì di farci fare la prima classe elementare in casa sua a me, a Sergio Vesselizza, che aveva un anno meno di me e a Lauretta Bidussi che ne aveva quasi uno di più. Ricordo, tante “bordurine” tante “aste e filetto”, un po’ l’alfabeto, qualche numero, scrivere poco, leggere meno. E così anche l’anno dopo, sempre in casa, quella che doveva essere la seconda classe. Alla fine della guerra, finalmente andai ad una scuola vera e, dopo un esame sommario che teneva conto più dell’età che del sapere, mi fecero frequentare direttamente la terza elementare. Questa carenza dei primi rudimenti, della grammatica, dei “conti”, del leggere e scrivere, condizionarono tutto il prosieguo dei miei studi, facendo penare me e soprattutto i miei genitori. In casa, l’inverno, si stava vestiti con maglioni di lana e pantaloni pesanti, infatti l’impianto di riscaldamento lo si faceva andare al minimo e solamente quando era proprio necessario. Il combustibile da bruciare nella stufa era il più disparato, carbone ce n’era poco in quanto esso serviva prettamente per la “macchina bellica”. I rifornimenti si facevano d’estate e gelosamente si dosavano nel periodo invernale. Ricordo che mamma metteva a mollo nella vasca da bagno vecchi giornali, quando erano ben impregnati d’acqua, li strizzava forte forte dando ad essi la forma di una palla delle dimensioni di un pugno. Dopo aver compresso ben bene la carta e 75 tolta più acqua possibile, le palle venivano messe ad asciugare al sole, girandole più volte al giorno. Asciugando, esse si compattavano e diventavano pesanti, pronte per essere salvate in cantina o in soffitta per essere bruciate l’inverno successivo. Infatti la carta così compressa ed asciutta bruciava lentamente, quasi fosse carbone, e sprigionava tanto calore. Altra fonte di calore era la legna. Anche quella non era facile procurarsela e ricordo che di sabato o di domenica, con capaci sacchi di iuta, io, mamma e papà, come molti altri triestini, ci si recava al “Boschetto” a raccogliere rami, pigne e tutto quello che era in grado di bruciare. Allora avevo sette anni, ma la scena a cui ho assistito domenica 4 giugno 1944, penso che non la dimenticherò mai e rimarrà impressa nella mia memoria quasi fosse un film da cineteca. Eravamo intenti, come al solito, a raccogliere legna, quando in lontananza sentimmo come un sordo boato, continuo, insistente, fastidioso che fece girare la testa a noi e a tutti i presenti, verso il mare, verso Monfalcone. Vedemmo, alti nel cielo, un nuvolo di aerei che, lentamente, si disposero in cerchio e dei grappoli di “punti neri” scesero verso la cittadina. Quando i “punti neri” vennero a contatto con il suolo, enormi palle di fuoco seguite da dense colonne di fumo nero salirono verso il cielo, quasi a voler ritornare al punto da cui erano partite. Stavano bombardando i cantieri navali di Monfalcone ma, come ben si sa, parecchie bombe colpirono anche case di civile abitazione, provocando gravi danni e vittime. Questo era il preludio a quello che sarebbe successo, pochi giorni dopo, a Trieste. Infatti era la sera del 9 giugno 1944, ci si accingeva ad andare a letto quando, improvvisamente, suonò l’allarme aereo, a lungo, più a lungo del solito, le sirene laceravano l’aria, con un fischio assordante, e sembravano non smettere mai. Ci vestimmo velocemente e, di corsa, scendemmo le scale, ci trovammo in strada con un chiarore tale che sembrava ci fosse il sole a mezzogiorno. Cosa stava succedendo? La gente gridava: -“Stanno buttando le bombe al fosforo.... Sono bombe incendiarie con il paracadute per colpire meglio i bersagli.....Ci vogliono bruciare vivi.... Intanto papà, tenendo stretti per mano la mamma e me, ci faceva correre, addossati ai muri delle case, verso la galleria antiaerea. Una persona, anzia76 na, uscita da un portone dell’allora viale Sonnino, vedendo tutto questo chiarore, si fermò, lanciò un urlo portandosi le mani al petto, e cadde riversa a terra. Un infarto provocato, probabilmente, dalla paura. Pianti, grida, disperazione di due donne, forse la moglie e la figlia......e tutti, a frotte, correre verso la galleria. In aria si sentivano, assordanti, i rombi degli aerei, sicuramente a bassa quota. I soliti, quelli “che sanno”, gridavano: - Correte, ora scendono e ci mitragliano....No, no, lanceranno i gas....macché gas e gas ci sono già le bombe al fosforo....Finalmente entrammo in galleria. Anche all’interno si sentiva fortissimo il rombo degli aerei, sembrava fossero, anche loro, dentro la galleria. Tutte le famiglie riunite, abbracciate strette, oserei dire tremanti, in silenzio, in un chiarore surreale creato da quelle strane luci che scendevano dal cielo, in attesa di sentire il rumore lacerante degli scoppi delle bombe....niente! Dopo una quindicina di minuti, il chiarore si affievolì gradatamente fino a rimanere buio pesto. In qua e in là si accese qualche torcia elettrica, la gente cominciò a sussurrare qualche cosa mentre si sentiva il rombo begli aerei che si allontanava e diventava sempre più debole fino a sparire del tutto. Ma cosa era successo? Cosa avranno fatto? È mai possibile tanto rumore per nulla? La gente si interrogò, le prime frasi, dopo la paura, salirono alle labbra. Qualcuno azzardò che fossero dei razzi illuminanti, dei bengala lanciati con il paracadute per poter fotografare la città. Intanto era tornata la luce elettrica, e la gente cominciò da defluire per tornarsene a casa, lentamente, quasi rassegnati, con la paura che questo fosse l’inizio di ben più tragiche situazioni. I presagi, quasi sempre, in situazioni del genere sono facili da formulare. La notte passò tranquilla, il mattino seguente la città riprese la solita routine quotidiana, ma la mente era rimasta a quella inspiegabile nottata. A mezza mattina, del 10 giugno 1944, nuovamente laceranti e prolungate le sirene dell’allarme aereo suonarono. Papà era al lavoro, in piazza Mazzini, ora p.zza della Repubblica, in città, la mamma e io, corremmo nuovamente verso la galleria, però questa volta l’allarme aereo fu suonato in 77 ritardo, infatti già quando giungemmo nell’allora “piazza del fien” si sentì il rombo assordante degli aerei. La mamma accelerò il passo, tirandomi con forza per mano, io correvo e di tanto in tanto mi giravo per vedere cosa stesse succedendo. Imboccammo la galleria e fatti, forse, dieci metri si sentì il primo fortissimo scoppio: io mi girai e vidi la casa all’angolo con la via Vergerio, sgretolarsi, lentamente, come fosse un film al rallentatore, la facciata intera abbattersi sulla piazza in un nuvolo di polvere e pietre e mattoni, rimbalzando, schizzare in tutte le direzioni. Una di queste pietre entrò anche in galleria e mi passò a qualche metro di distanza prima di cadere a terra rotolando. Gli scoppi si susseguirono in un incredibile sequenza, preceduti dall’inconfondibile sibilo che faceva la bomba cadendo. La galleria fu invasa da una polvere sottile provocata dagli intonaci che cadendo si sgretolavano, e da un acre odore di zolfo unito ad una puzza di bruciato che prendeva il fiato. La gente urlava, agli anziani mancava il respiro, chiedevano aiuto. Tutti tenevano un fazzoletto bagnato d’acqua tra la bocca ed il naso, il caos era indescrivibile. Il tutto durò circa una mezz’ora, ma per noi sembrò un’eternità. Le sirene del cessato allarme suonarono, sembravano sommesse, quasi, anche loro, spaventate ed incredule di quello che era successo. Uscimmo con calma, quasi a non voler vedere la scena che ci si sarebbe presentata. Questa volta il timore, la paura, l’angoscia furono più che fondate. Giunti all’aperto sembrò di essere giunti al primo girone dell’inferno. Edifici crollati, edifici lesionati, edifici che stavano bruciando, ma quella che fu la scena più desolante e spaventosa era alla destra uscendo, di fronte all’ippodromo. Infatti tutta l’area oggi occupata dai grattacieli di viale Ippodromo, piazza dei Foraggi, via del Ghirlandaio e l’area dell’odierna Saul & Sadoch fino alla via Veruda era occupata dal “Pastificio Triestino”. Ed ecco spiegata la ricognizione notturna del nove giugno, servì a localizzare appunto il pastificio, nel cui cortile erano pronti a partire per la Germania quaranta vagoni di pasta alimentare che non giunsero mai a destinazione ma che, al contrario, bruciarono per quattro o cinque giorni, formando una coltre di fumo nero che rese ancora più spettrale la scena. Scossasi di dosso la prima impressionante visione, la mamma lanciò un urlo: - Oh Dio! la nostra casa!! – Con il passo sempre più accelerato scen78 demmo il tratto di viale Sonnino, in mezzo a gente che gridava, piangeva, si disperava, lamentandosi dei danni subiti o perfino di aver perso tutto. Girato l’angolo con la via Padovan, per fortuna, vedemmo la nostra casa almeno “in piedi”. Salimmo i gradini che portavano al secondo piano, aperta la porta, la scena che ci si presentò non fu piacevole però nemmeno tanto tragica. Tutti i vetri delle finestre rotti, tende lacerate, calcinacci e polvere portati dentro dallo spostamento d’aria provocato dalle deflagrazioni delle bombe, un po’ dappertutto, un ombrello nero, chiuso, da uomo, in mezzo al corridoio........ non era di papà. Papà, al cessato allarme, uscì dai sotterranei, molto profondi, che fungevano da rifugio antiaereo, della Riunione Adriatica di Sicurtà, dove lavorava, le strade erano piene di gente che correva in tutte le direzioni. L’atmosfera era pesante, ma non tragica, infatti il centro cittadino fu abbastanza “risparmiato” dalle bombe a parte qualche singolo caso. Le voci dicevano che le zone più colpite erano S.Giacomo/Ponziana, a causa dei cantieri navali bombardati insistentemente e la parte alta di viale Sonnino e la zona di Montebello per il bombardamento subito dal Pastificio Triestino. Le linee telefoniche erano interrotte, così le linee elettriche, il gas e l’acqua. Papà non poté pertanto né telefonare né prendere il tram o la filovia per correre a casa; giunto a piedi in piazza Goldoni, incrociò un conoscente che abitava in piazza del Perugino, e chiese: - Pino, com’è su da noi?? – Cesare, un disastro, tutto raso al suolo, corro a vedere se si è salvato qualche cosa, ciao! Comprensibilmente, mio padre, che non era certamente un “coraggioso” si sentì venir meno, le gambe divennero improvvisamente pesanti e come un automa si diresse verso corso Garibaldi... piazza Impero....piazza Garibaldi....viale Sonnino. Il suo pensiero era rivolto a noi e non certamente alla casa; se era tutto raso al suolo, eravamo riusciti a rifugiarci in galleria? eravamo vivi? ci avrebbe rivisti? Con questi pensieri turbinanti nel cervello arrivò all’altezza della via 79 della Raffineria, guardò in su e vide sì tante macerie, ma per fortuna non tutto era raso al suolo. Il sangue tornò ad affluire nelle vene, il passo si accelerò, il respiro cominciò a divenire pesante perché il passo svelto divenne passo di corsa. Il viale Sonnino, che ha ottocento metri, sembrò avesse ottocento chilometri, angolo dopo angolo giunse alla via Padovan, girò lo sguardo a sinistra e vide la casa....si mise a piangere. Strana reazione fa la paura, le lacrime furono uno sfogo, una liberazione, lacrime di gioia insomma, di corsa giunse al portone, salì i due piani di scale e ci saltò addosso, ci abbracciò, tremava tutto! La città era in ginocchio, ci vollero parecchi giorni perché i servizi essenziali fossero di nuovo disponibili. Nel frattempo illuminammo gli ambienti con le candele, per cuocere accendemmo il focolare a legna che era in cucina, l’acqua prelevata dalle autobotti doveva essere bollita prima di essere usata. Per fortuna era Giugno e non faceva tanto freddo perché stare in casa senza vetri alle finestre non era certamente piacevole e trovarne da sostituire era un’impresa disperata. Mamma mise, nelle stanze, delle vecchie coperte sulle finestre con le tapparelle abbassate per proteggerci, durante la notte, dal freddo. Ci vollero mesi, quasi fino all’inizio dell’autunno, per ridare all’appartamento un aspetto vivibile. Non tutto era finito così, purtroppo, i generi alimentari di prima necessità scarseggiarono sempre di più, pane poco, latte un miraggio, i negozi di alimentari, desolatamente vuoti. Quando un alimentarista veniva rifornito, la notizia dilagava a macchia d’olio e le massaie si mettevano in fila, anche per ore, nella speranza di riuscire a prendere qualcosa, ancorché con la tessera annonaria. Non sempre l’attesa era coronata da successo, quando giungeva il proprio turno non era rimasto niente o quasi. I bombardamenti continuarono, con minor intensità, ma continuarono. Obiettivi illogici, in zone dove non c’erano né fabbriche, né caserme, né insediamenti militari, si diceva che gli aerei, ritornando dalla Germania, scaricassero le bombe residue per alleggerire il peso degli aerei e che i piloti “giocassero” al tiro al bersaglio scommettendo se avessero colpito questa o quella casa scelta a 80 caso da lassù. Forse fu soltanto propaganda messa in giro dalla “voce” del regime contro quelli, che allora, erano i nemici e che poi sarebbero divenuti i liberatori......o no? Non lo sapremo mai! L’inverno ritornò, più freddo che mai. I raduni serali delle quattro famiglie continuarono, anche perché, a turno, si riscaldava un appartamento solo, la sera, prima di andare a dormire risparmiando così parecchio combustibile. Pur essendo piccolo, sentii nell’aria che qualche cosa stesse cambiando. Le quattro mamme si riunivano in cucina, a chiacchierare, assieme a noi bambini che, in un angolo giocavamo. Gli uomini si ritiravano in salotto, si chiudevano dentro, e, stando in silenzio al buio per mezz’ora erano assenti, come se non ci fossero. Io non riuscii a capire questo atteggiamento, neanche quando usciti, bisbigliavano mezze parole alle mogli, per me, frasi senza senso. Ogni sera la stessa cosa e poi tutto ritornava “normale”. Le donne chiacchieravano, i bambini giocavano, gli uomini, talvolta, facevano una partita a carte. Una cosa notai, quasi per certo, che gli animi erano un po’ più sereni, distesi, i volti abbozzavano, di tanto in tanto, un mezzo sorriso. Cosa c’era mai da sorridere in quella desolazione, in quella miseria, in quella mancanza di tutto, dove la sera ci si vedeva e basta, raramente un caffè d’orzo, saltuariamente mezzo litro di vino in otto adulti o un cucchiaino di marmellata su di una fettina di polenta fredda per i bambini. Cosa c’era da sorridere? Dovetti aspettare la fine della guerra per saperlo. Quelle “sparizioni” serali di mezz’ora degli uomini erano dovute ad un fatto ben preciso, si chiudevano dentro al salotto con una coperta sulla testa, uno accanto all’altro, coprivano la radio per ascoltare “Radio Londra” che per bocca del colonnello Stevens, in uno stentato italiano, mandava messaggi di speranza alle popolazioni italiane ancora da “liberare”. Infatti, fine 1944 - inizi 1945 gran parte dell’Italia, cominciando dall’Italia meridionale, aveva già scacciato i Tedeschi e le truppe alleate, lentamente e, vincendo le sacche di resistenza, si avvicinarono al nord Italia. 81 La zona orientale, come sempre, ed ancor oggi, fu lasciata per ultima. Ma qui entrarono in gioco grossi accordi internazionali, infatti le truppe alleate si fermarono alle “porte” di Trieste per permettere alle truppe jugoslave del maresciallo Josip Broz, detto Tito, di entrare “vittorioso” in Trieste. Infatti tra il 30 aprile ed il 1 maggio 1945 un migliaio di “soldati” del IX corpus entrarono in una Trieste deserta. La popolazione barricata dentro le case, porte e finestre sbarrate, in silenzio, accettò, anzi subì e non accolse, questi “liberatori”. Loro pensarono di aver conquistato la città, ma si resero ben presto conto che la guarnigione tedesca, ancor rimasta sulla piazza di Trieste, si barricò dentro il castello di S.Giusto e dichiarò che si sarebbe arresa solamente alle truppe anglo-americane. Per tutti i quaranta giorni di occupazione jugoslava, il castello fu assediato, ma gli occupanti non si arresero ed anzi respinsero qualsiasi tentativo di conquista da parte dei militari jugoslavi, che erano dotati di scarsissimi mezzi bellici. Infatti più che un’occupazione militare, fu un’occupazione di bande partigiane, che si abbandonarono a veri e propri saccheggi e deportazioni. L’essere italiano, istriano ed aver occupato un posto pubblico di una certa rilevanza o, più semplicemente, accettando semplici denunce verbali che avessero detto: “Quello era simpatizzante fascista”, era già motivo sufficiente per essere arrestato, sommariamente processato e condannato a morte mediante infoibamento. Purtroppo vissi questa terribile esperienza, che non auguro a nessuno, verso il 20 maggio 1945. Le pattuglie dei miliziani che percorrevano le vie cittadine con passo poco militaresco e con un andamento oscillante, erano chiamate dalla popolazione: “le rughe”. Esse percorrevano le vie cittadine e si sentivano arrivare parecchio tempo prima, vuoi per le scarpe chiodate, vuoi per il tintinnare dei nastri di pallottole che portavano, copiosi, intorno al collo. Purtroppo, un giorno, una di queste “rughe” imboccò la via Padovan, lentamente e con i mitra in mano, scrutando i numeri civici su portoni delle case. Papà, mamma ed io eravamo in casa e sbirciavamo attraverso le griglie semiaperte delle tapparelle cosa stesse succedendo. Si fermarono davanti al portone con il numero dispari di fronte a noi, si girarono, attraversarono la strada e si diressero davanti al portone del n° 14, neanche lì anda82 va bene, si avvicinarono al nostro portone, si fermarono, era chiuso. Con il calcio del mitra cominciarono a battere gridando, in una lingua sconosciuta, frasi incomprensibili, sembrava volessero buttare giù il portone. Non so come o da chi il portone venne aperto. Noi tre, in silenzio, abbracciati stretti stretti, trattenendo il respiro e tirando l’orecchio seguimmo la sequenza dei movimenti della pattuglia. Fermata al piano terreno, probabilmente a leggere i nomi sul campanello, passo pesante li sentimmo salire al primo piano, prima davanti ad una porta poi davanti all’altra. Niente, altro rumore di passi su per le scale, papà tremava, mamma pure, mani strette nelle mani fino a farsi male, io mi morsi la lingua per non gridare, le lacrime scesero dagli occhi. Momenti interminabili, silenzio davanti alla nostra porta: paura, angoscia, panico, spavento, terrore, batticuore, trepidazione, turbamento.... tutto quello che si poteva provare in quel momento insomma. Probabilmente un attimo, un’eternità, una vita, il tempo non ebbe più senso, credo che allora capii cosa significhi “infinito”. Ritornò il rumore di passi, la porta di fronte, di nuovo i passi salirono le scale, si fermarono sopra di noi, ancora niente, altro rumore, la porta di fronte, attimi di silenzio. Come un colpo di cannone nel silenzio di una notte infinita sentimmo, nuovamente, il calcio del mitra battere insistentemente sulla porta, venne sfondata.....il signor Contento.....non lo vedemmo più . Il signor Contento, quella persona mite e gentile, gerente di un negozio di alimentari che, se poteva, aiutava la gente, quello del pezzo di pancetta da due etti per fare il minestrone per dodici persone, quello che con papà, Vesselizza e Bidussi ascoltava il colonnello Stevens da radio Londra, e pertanto, ascoltando la voce degli alleati, doveva essere per forza o fascista o filo nazista perciò doveva venir arrestato ed ucciso in nome della “libertà dei popoli”. I giorni passarono, il terrore rimase, la vita sembrava scorrere per inerzia, gran parte della gente era come un automa, quello che faceva, lo faceva automaticamente, con l’apatia di cose consuete, di cose scontate. Non c’era entusiasmo, calore, passione, fervore, alacrità, gioia di vivere insomma; si viveva perché si respirava ed il cuore, anche se pieno di pena, batteva ancora. 83 Papà andava in ufficio, come al solito, però non c’era nulla da fare. La direzione di Milano chiedeva notizie, aveva bisogno di pratiche, ma i collegamenti tramite corriere postale erano impensabili. Fu così che un alto dirigente, qui di Trieste, accompagnato da mio padre, si recò al comando delle truppe di occupazione jugoslave nella speranza di ottenere il permesso di poter portare un plico di documenti presso l’agenzia di Monfalcone perché, a sua volta, mandasse, per vie ordinarie, il plico a Milano. Scortati da soldati armati fino ai denti, furono ammessi al cospetto del “comandante” circondato da altri “ufficiali”. Facendo finta di capire quello che il dirigente disse loro, il comandante, in un italiano stentato ed approssimativo sentenziò:- Nema problema, mi ti dago permesso per confin con Italija per tuo omo. Il dirigente disse: - Molto gentile, grazie, ci sarebbe proprio necessario far pervenire alla direzione di Milano un pacco di documenti e così il signor Weiss, qui presente, accompagnato da un nostro autista potrebbe andare alla nostra filiale di Monfalcone per consegnare il pacco. Il comandante, sentendosi assai importante, gonfiò il petto e replicò:- Mi ti ga dito, nema problema, e preso un pezzo di carta ed una penna scrisse, brevemente, qualche cosa, appose una diecina di timbri vari, piegò il foglio e lo consegnò al dirigente. Questi, ringraziando, porse la mano al “comandante”, questi si alzò, si mise sull’attenti, alzò il braccio con il pugno chiuso e disse:- Zivel Tito!, e si rimise a sedere lasciando il dirigente, imbarazzato con la mano tesa. Riavutisi, il dirigente, stringendo in mano il biglietto scritto dal comandante, e mio padre si voltarono ed uscirono, sempre scortati, fino in strada. Senza voltarsi si allontanarono il più velocemente possibile ritornando, ben presto, in piazza Mazzini, all’interno del palazzo. - Caro Weiss - disse il dirigente - abbiamo finalmente il lasciapassare intestato a lei per portare i tanto sospirati documenti a Monfalcone. Prese lentamente il foglio, per consegnarlo a papà, lo aprì, lesse, sgranò gli occhi, la bocca si aperse, il mento cadde, non una parola uscì dalla bocca. Porse lentamente il foglio a mio padre che lo prese svelto, con curiosità, lo girò a sé e lesse ad alta voce:- Omo pol ndar su e zo per Monfalcon. Penso che questa frase finale possa sintetizzare il periodo dei quaranta 84 giorni che dovemmo vivere. Quaranta giorni, infatti, finalmente, il 9 giugno 1945 le truppe angloamericane, che furono attestate tra Monfalcone e Trieste, iniziarono la marcia di avvicinamento e, in breve tempo, senza trovare resistenza alcuna entrarono a Trieste, accolti da gente finalmente festante, che agitava bandiere italiane, abbracciando dei veri soldati, puliti, sorridenti e cordiali che sfilavano su camion, carri armati, jeep, motociclette e non straccioni sporchi, a piedi o su carri trainati da buoi. L’incubo era finito. Lo stesso 9 Giugno il ponte levatoio del castello di San Giusto, si abbassò e un centinaio di soldati tedeschi uscirono con le mani alte in segno di resa a veri soldati. La vita cominciò a migliorare, i viveri cominciarono a giungere, dieci giorni dopo, il 19 Giugno io avrei festeggiato i miei otto anni e per la prima volta in vita mia, anche se breve, potei vedere, toccare, assaggiare una tavoletta di cioccolata, caramelle e veri dolci. Trieste, comunque, era destinata ad essere contesa, strumento politico in mano ai “grandi” della storia, di quelli che, in quel momento, facevano il bello ed il cattivo tempo. Un confine provvisorio di occupazione, chiamato linea Morgan dal nome del generale inglese da cui fu negoziato, lasciò così la città in possesso degli Anglo-Americani e la maggior parte della penisola istriana sotto controllo jugoslavo. Dopo lunghi contrasti si decise poi, il 3 luglio 1946, che tutti i territori ad est di una nuova linea passassero alla Jugoslavia mente quelli a ovest avrebbero dovuto formare il Territorio Libero di Trieste. Il trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947 confermò l’esistenza di questo Territorio Libero, diviso in Zona A, sotto occupazione anglo-americana e una Zona B sotto occupazione jugoslava. L’occupazione avrebbe dovuto essere solo temporanea, finché il Consiglio di Sicurezza dell’O.N.U. avesse nominato un governatore neutrale con giurisdizione su tutto il territorio, ma poiché non si raggiunse mai un accordo sulla persona da designare si protrasse in realtà per anni. Ne conseguì che l’occupazione anglo-americana continuò “provvisoria85 mente” per nove anni. Le truppe americane tennero l’occupazione militare, mentre gli Inglesi ressero la parte amministrativa, civile e d’ordine pubblico. Infatti istituirono il corpo della Polizia Civile, che era formato da cittadini italiani per i ranghi “bassi” mentre gli ufficiali erano tutti inglesi. Le divise furono copiate dai “bobbies” inglesi, tant’è vero che, noi, non essendo abituati a quel genere di divise chiamammo scherzosamente gli agenti della Polizia Civile: “cerini” per la loro somiglianza estetica con gli omonimi fiammiferi. Durante il periodo di amministrazione alleata l’economia della città rifiorì, crearono molti posti di lavoro e la disoccupazione era quasi del tutto scomparsa. I militari, specialmente gli Americani, avevano una certa disponibilità finanziaria e, non avendo altro da fare, durante le ore di libertà dal servizio si riversavano nei bar, trattorie, ristoranti e in tutti quei locali pubblici che dessero loro un po’ di svago. Non c’era bar, caffè o ristorantino, che non avesse un angolino libero e non si attrezzasse con piccoli complessini musicali per allietare le ore libere dei militari. In viale XX Settembre, quasi tutti i bar, le gelaterie o le pizzerie che avessero il posteggio esterno di tavolini, avevano pure la musica dal vivo, magari solo il pianista, così a Barcola, lungo le rive, e fin anche in locali rionali e dell’altipiano, per non parlare della famosa taverna Dreher, meta per lo più di triestini che trascorrevano interminabili serate, in allegria, cantando in coro le allegre canzoni triestine tra un “piatto caldo Dreher” “gnocchi de pan con le luganighe o con il goulash” e tanti altri piatti della tradizione triestina, il tutto innaffiato da boccali di spumeggiante birra.. Molti musicisti triestini divennero famosi grazie a questa attività, infatti così hanno iniziato il maestro Guido Cergolj, Lellio Lutazzi, Ferruccio Ricordi (divenuto poi in arte Teddy Reno), Uccio Augustini, il maestro Manzetti e tanti e tanti altri dei quali ora mi sfuggono i nomi. Intorno a questa grossa fetta di mercato, ruotava una fonte di lavoro indotto quasi inesauribile. Allora avevamo, qui a Trieste, la famosa fabbrica di birra Dreher ed, essendo gli Americani fortissimi consumatori di birra, fu necessario programmare la fabbricazione di birra a ciclo continuo, 24 86 ore su 24. Venne creata, in località Prosecco, sull’altipiano, uno stabilimento, unico in Italia, che produceva la famosa Coca-Cola. C’era anche chi, approfittando della situazione, si procurava degli introiti illeciti. Per tutti, amo ricordarne uno che, pur essendo il massimo della truffa, lo considero anche il massimo dell’ingegno nell’arte dell’arrangiarsi a spese degli altri. Era abitudine dei soldati americani di sedersi a gruppi nei bar, mettere sul tavolo una banconota di grosso taglio, cinque o diecimila lire, ed ordinare birra per tutti. Bisogna tener presente che, a quell’epoca, una birra costava cinquanta o al massimo cento lire. Arrivava il cameriere con il vassoio, serviva le birre, prendeva la banconota di grosso taglio e metteva il resto in banconote, una sopra l’altra, al posto della banconota tolta. Gli spiccioli li metteva al centro del tavolo che, quasi sempre, costituivano la mancia e se li riprendeva. Passava un po’ di tempo e gli avventori chiedevano un altro “giro” di birre, il cameriere arrivava, poggiava il vassoio sul tavolo, serviva le birre, alzava il vassoio e prendeva dal “pacchetto” la banconota per pagare le consumazioni, gli spiccioli al centro che venivano immancabilmente ripresi quale mancia. A questo punto chi, non conoscendo l’episodio, direbbe: - Beh, e dove sta la truffa? E qui salta fuori l’ingegno dell’inventore che, se non fosse stato fatto da un triestino, si potrebbe pensare alle famose truffe alla napolatana. La cosa era semplice, il vassoio appoggiato sul tavolo, sopra il pacchetto di banconote, aveva il fondo bagnato d’acqua e, quando il cameriere lo sollevava, immancabilmente rimanevano “attaccate” una o due banconote. Pensate questa cosa ripetuta ogni sera, moltiplicata per il numero di tavoli assegnati a quel cameriere e, per gli anni di servizio, a quanto potrebbe ammontare il maltolto! Tutto questo era destinato a finire, non solo i guadagni illeciti, ma anche il “benessere” della città. Con il memorandum d’intesa del 5 ottobre 1954 la zona A passò sotto 87 l’amministrazione civile italiana e la zona B, leggermente ampliata, sotto l’amministrazione jugoslava. Con la dissoluzione della Jugoslavia del 1991, è subentrata la Slovenia nel controllo della zona B. Nell’ottobre del 1954 ci fu l’ultimo grande esodo dei cittadini italiani residenti nei territori annessi alla Jugoslavia, vista ormai l’impossibilità di una, in qual si voglia modo, ricongiunzione al territorio di Trieste e all’Italia pertanto. Il lavoro cominciò a scarseggiare, non servivano più tanti camerieri, cuochi, baristi, ecc......la fabbrica di birra Dreher riprese il ciclo di lavorazione in due turni soltanto, la “fabbrica” di Coca-Cola divenne solamente stabilimento di imbottigliamento e non più di produzione. Tutti i civili, polizia compresa, che lavorarono per l’Amministrazione alleata persero il posto di lavoro e pertanto migliaia di persone, Triestini specialmente, presero la via dell’emigrazione: l’Australia, qualcuno Stati Uniti, qualcuno Canada. Vennero incrementati i centri di raccolta, detti “campi profughi”, baracche in legno e, anche se ben attrezzate sempre baracche erano, in attesa che venissero costruite delle case per alloggiare questi nostri connazionali che, fuggendo, avevano abbandonato tutto. Ottennero dei punteggi, in base alla legge 336, che dava loro la possibilità di accedere ai posti di lavoro con diritto di priorità rispetto agli altri cittadini italiani. Essendo, come detto, di molto calata la richiesta di manodopera, ed essendo preferenziati i profughi dall’Istria, molti Triestini, non trovando lavoro, scelsero di partire appunto per cercare la fortuna in terre lontane. Qui, politicamente, sorsero le prime incomprensioni, infatti la stragrande maggioranza dei Triestini affermavano: - È sacrosantamente giusto aiutare questi nostri fratelli dell’Istria e della Dalmazia a rifarsi una vita in patria, ma non solo qui a Trieste, bensì su tutto il territorio nazionale, in modo da non penalizzare, nel mondo del lavoro, solamente i cittadini di Trieste. Il Governo di allora fece orecchie da mercante e se ne lavò le mani. Non tutti gli esuli lasciarono beni consistenti nelle mani dell’occupante popolazione jugoslava, ma sicuramente avevano una casa che, anche se piccola, era in muratura ed era la calda casa della famiglia e, non certamente, la 88 fredda baracca in legno assegnata come alloggio di fortuna che durò, al contrario, parecchi anni. Una grande dote degli Istriani, come dei Friulani del resto e di tutta la popolazione rurale o montana, è la tenacia, il non rassegnarsi alle avversità ma, al contrario, stringere i denti, tirarsi su le maniche e con sacrifici, ricominciare da capo. Questo gli esuli fecero, si adattarono a fare tutti i lavori, purché onesti. Provenivano dalle fabbriche conserviere del pesce di Isola d’Istria, dagli uffici, banche, cantieri e fabbriche di Pola e Fiume, ma soprattutto dalla campagna ed in special modo dai vigneti che, numerosi, ricoprivano le belle colline dell’Istria. Ma a Trieste non rifiutarono nessun tipo di lavoro, fecero un po’ di tutto, i muratori, gli imbianchini, i netturbini, gli osti, qualsiasi cosa pur di raggranellare i soldi per mantenere decorosamente la famiglia, non concedendosi lussi o svaghi per accantonare i soldi per realizzare il loro sogno, che è poi il sogno di tutti, di poter riavere una casa propria e non una assegnata, ancorché con affitti modesti, ma sempre assegnata e non sua. Gli esuli istriani, anche se con difficoltà, ebbero la “fortuna” di vivere in una nazione che, bene o male, era la loro. Non così i Triestini, emigrati in terre lontane, in climi tanto differenti, con lingua, mentalità, usi, costumi, consuetudini, tradizioni, sistemi politici e modo di vivere diametralmente opposti a quelli che furono costretti, non per colpa loro, ad abbandonare. Molti ebbero la fortuna o la capacità di integrarsi nel nuovo tessuto sociale, molti altri, invece, non riuscirono ad entrare, mentalmente, in questa nuova realtà. Parecchi, lavorando alacremente con perizia e professionalità, riuscirono a “bruciare le tappe” e crearsi uno spazio di una certa preminenza nella società che, dapprima, probabilmente, li aveva accolti con una certa diffidenza. Ebbi modo di conoscere alcuni emigranti che, parecchi anni dopo l’esodo, vollero ritornare a Trieste, quali turisti, o per nostalgia o per rivedere 89 parenti e amici o per far vedere la città natia ai loro figli nati e cresciuti nella nazione che li ospitava. Tutti, o quasi, avevano ormai ottenuto la cittadinanza australiana o statunitense o canadese, pochi vollero tenere la doppia cittadinanza. Dal punto di vista affettivo la nostalgia dei luoghi natii, ovviamente, restò nei loro cuori, ma nessuno dico nessuno avrebbe voluto rientrare in patria, considerando la nazione che li stava ospitando, la nuova patria, quella che riuscì a farli ritornare ad essere delle persone vive, che diede loro un lavoro e una nuova dignità di vita. Così ci stiamo avvicinando verso la fine di questo racconto, siamo ormai nel 1957, per me anno determinante, anno che segnerà una svolta, decisiva, nella mia vita. Un anno prima conobbi Nory, una splendida ragazza della quale mi innamorai subito, il classico colpo di fulmine, anche a lei non fui del tutto indifferente, tant’è che ne parlò a casa sia alla mamma che al papà. Suo padre guardingo, come tutti i padri del resto, volle sapere com’era la situazione e visto che sarebbero dovuti passare ancora degli anni per finire la scuola, trovare lavoro con tutto quello che ne consegue, consigliò la figlia di andare calma e non precipitare le cose. Se fossero state rose sarebbero fiorite e nel frattempo era bene che non ci vedessimo. Per fortuna erano rose! Mentre ancora frequentavo la seconda classe della sezione ragioneria dell’Istituto tecnico L. Da Vinci, una domenica, lessi sul quotidiano locale un bando di concorso presentato dalla Cassa di Risparmio di Trieste per l’assunzione di ventiquattro commessi. Sapevo che non era il massimo dell’aspirazione per chi avrebbe voluto diventare ragioniere, ma non potevo rinunciare assolutamente a Nory e l’unico sistema per ricominciare a far progetti era avere un lavoro sicuro. Ai primi di febbraio presentai tutta la documentazione necessaria per poter partecipare alla selezione mentre continuavo a “studiare”. Alla fine di marzo dovetti sostenere la prova scritta, alla stazione marittima, eravamo in 1200 candidati. Da quando presentai la domanda al giorno della prova 90 scritta mi preparai, per quello che era possibile, su argomenti di attualità, di economia, di politica, di storia, di cronaca recente e passata, leggendo giornali e rotocalchi, sfogliando libri, ascoltando giornali radio, tutto quello che sentivo cercavo di immagazzinare. Arrivò il fatidico giorno dell’esame scritto, tremavo tutto sia dalla paura che dall’emozione, il mattino la mamma mi diede una doppia camomilla al posto del caffellatte, ma non è che fosse servita molto. Pensai: Su che argomento verterà l’esame, chissà? Ma è inutile arrovellarsi il cervello, serve solo ad aumentare la tensione. Quel che sarà, sarà!! Una marea di gente seduta su tavolini singoli abbastanza distanti l’uno dall’altro in modo da non poter sbirciare sul foglio del vicino. Ogni tavolo una busta chiusa ed una biro accanto. Una ventina di persone, in piedi e in silenzio, passeggiavano tra i banchi ancorché prima che cominciassimo. Alle nove in punto una persona chiese l’attenzione di tutti i presenti e disse: - Signori, per la prima volta abbiamo deciso di effettuare la prova scritta con un nuovo sistema. Il sistema si chiama “Test attitudinale” ed è formulato con una serie di quiz da risolvere di volta in volta con dei tempi prestabiliti. Troverete una serie di foglietti e al mio comando cercherete di risolvere il primo, dopo il tempo designato per questo quiz suonerò un campanello e voi dovrete, anche se non ultimato, girarlo e porlo alla vostra destra e così via per tutta la serie. Buon lavoro ed auguri signori! Noi candidati ci guardammo sbigottiti, mah! Cosa sarà di noi? Al trillo del campanello aprimmo le buste togliendo il pacchetto di foglietti che ponemmo sul banco. Secondo scampanellio, iniziammo ad interpretare i foglietti. Sembravano i quiz della Settimana Enigmistica, domanda: Mettete una crocetta su quale di questi oggetti che secondo voi non è pertinente con gli altri. C’erano disegnati, un coltello, un’accetta, una forbice, una sciabola, un temperino aperto, un coltellaccio per battere la carne e una mezzaluna per il trito. Dieci secondi di tempo! E così di seguito fino a finire i trenta foglietti che facevano parte del pacchetto di quiz. - Ho fatto tutto giusto, in parte o niente? 91 Questo era il dilemma che mi assalì tutto il pomeriggio e i giorni seguenti. Gli altri saranno stati capaci più, come o meno di me, chissà? Dei 1200 sarebbero stati ammessi agli orali i primi 200 che avessero ottenuto il maggior numero di risposte esatte. Ripresi gli studi, che avevo un po’ trascurato per prepararmi all’esame e, per il rotto della cuffia, venni promosso. Ai primi di giugno ricevetti una raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Cassa di Risparmio che, aperta con trepidazione, mi comunicava di essere stato ammesso al colloquio, che si sarebbe tenuto il venerdì successivo alle ore 15 in una saletta al secondo piano della Sede Centrale. Il venerdì, già alle 14.30, passeggiavo dinanzi al palazzo di via Cassa di Risparmio, 10, i minuti non passavano mai e l’ansia aumentava, mi sudavano le mani e la gola era secca. Alle 14.45 entrai e chiesi al portinaio dove dovevo recarmi esattamente. Disse: - Prenda l’ascensore, vada al secondo piano, dall’ascensore a sinistra, la terza porta a destra, bussi ed entri. Così feci, bussai, entrai, c’era una specie di salottino dove, su delle seggiole, altri due ragazzi erano seduti. Buon giorno - dissi e loro risposero: - Buon giorno. Entrambi con la voce stentata e fioca, la cosa non mi aiutò di certo, l’emozione e la tensione era comune, la si sentiva nell’aria, nel silenzio sembrava quasi vibrasse. Nessuno apriva bocca, tutti e tre tendemmo l’orecchio verso la porta dove, probabilmente, era riunita la commissione d’esame che stava interrogando qualche altro candidato, nella speranza di sentire una voce, qualche parola, capire insomma cosa ci stesse aspettando. Nulla! Dei 200 rimasti, come detto, solo una ventina, appena il 10 per cento, sarebbero stati assunti. Gli esami orali venivano fatti a gruppi di quattro, io ero l’ultimo del gruppo di quel giorno. Improvvisamente, nel silenzio, sembrò di sentire un’esplosione che ci fece trasalire, era solo la maniglia della porta che si abbassava, la porta si aprì ed un ragazzo uscì, richiudendola dietro a sé, lentamente, bianco in viso, tremante. Noi subito a chiedere: Come è andata, era difficile, cosa ti hanno chiesto, quali erano gli argo92 menti, hai saputo tutto, sono severi, come ti hanno trattato...? La porta si aprì di nuovo, un signore giovane apparve e disse: Chi di voi è Giovanni Maestripieri? - Io, signore. - Venga, entri! - e la porta si richiuse. Il ragazzo uscito era Lucio Fabbretti il quale, ripresosi un po’, disse: - È stata dura, ma penso di avercela fatta, mi hanno chiesto un po’ di tutto, nozioni geografiche, qualche cenno storico, mi hanno fatto tradurre due frasette in tedesco, lingua che avevo studiato a scuola; ho dovuto risolvere un semplice problema matematico, ma soprattutto mi hanno chiesto come la pensassi e cosa ne pensassi dell’attuale situazione economica e politica della città e della nazione. Facendo domande e commentando tra di noi, a voce bassa per non essere sentiti, il tempo volò. La porta si riaprì, ne uscì Maestripieri, anche lui visibilmente scosso, il signore giovane riapparve e disse: - Per favore, signori, chi ha finito è pregato di andarsene, grazie. Amedeo Scordilli, prego, entri! I due già esaminati dovettero uscire, il terzo entrò ed io rimasi solo, nuovamente nel silenzio dell’ambiente, ma con il trambusto dei miei pensieri vorticosi, incontrollabili. Ebbi paura di sentirmi male, tirai un profondo respiro ripetendomi di rimanere calmo e cercando di autoconvincermi che, se ero riuscito ad entrare nei primi 200, ed era la cosa più difficile, avrei potuto farcela anche a passare il secondo turno. Quello che mi avrebbero chiesto di nozionistico o lo avrei saputo o no e questo era un normale esame, quasi come a scuola, dove chi sa, viene promosso e chi non sa viene bocciato. Quello che mi preoccupò di più fu, sempre se l’avessero chiesto a anche a me, era il mio pensiero sull’economia e sulla politica. - Di che ideologie politiche erano, di sinistra, di centro, di destra? Tutte le risposte sono esatte, basta sapere da che punto di vista si devono vedere gli argomenti trattati per compiacere l’esaminatore. Arrivò il mio turno, entrai, c’era un grande tavolo ovale pieno di libri, fogli, buste, però gli esaminatori, quattro persone in tutto, erano seduti a 93 fianco, su delle poltroncine disposte a semicerchio oltre a quella, di fronte, predisposta per l’esaminando. Devo dire che fecero di tutto per mettermi a mio agio, mi sorrisero, mi fecero accomodare, mi offrirono una sigaretta, che rifiutai cortesemente, mi chiesero se ero a mio agio e, alla mia timida affermazione un esaminatore prese una busta togliendo dei foglietti: era la prova scritta! - Dunque, lei si chiama Giorgio Weiss.....parente, forse, di quel Cesare Weiss che lavora alla R.A.S.? - Si signore, è mio padre. - Ah! Cara persona il Cesare, io ho parecchio da fare con lui per le polizze a garanzia dei mutui che stipuliamo con la Compagnia di Assicurazioni dove lavora. Bene...bene... ma veniamo a noi. Vedo che il test attitudinale non è stato completato, mancano parecchie risposte, però devo dire, che nel contesto delle domande solo una diecina sono quelle importanti, le altre sono state inserite per sviare l’attenzione su quelle che a noi maggiormente interessava. Delle dieci importanti, mi compiaccio con lei, perché ha risposto esattamente ad otto di esse. Vogliamo ora vedere e commentare quelle sbagliate ed il perché lei pensava che la risposta data fosse quella giusta? La prima domanda era una domanda di carattere bancario che, io ora, cercherò di riproporre ricordando i termini essenziali e non nell’esatta grafia. Una grande impresa di costruzioni, usa acquisire importanti appalti di opere pubbliche, da eseguirsi anche all’estero, doveva assumerne uno molto rilevante. Diede perciò incarico ad una banca di accreditare una somma di diversi milioni di dollari su un conto intestato ad un’altra Società, con sede a Londra. La banca eseguì prontamente l’operazione, purtroppo, in una giornata in cui si verificò un anomalo rialzo della quotazione del dollaro. In un paio di giorni però la quotazione rientrò nella normalità. Questa circostanza produsse quindi un notevolissimo danno economico all’impresa, che non esitò a promuovere un giudizio contro l’istituto di credito. I legali dell’impresa sostennero che avendo conferito un regolare man94 dato alla banca per l’acquisto della valuta estera per il successivo accredito a favore della Società di Londra ed essendosi quel giorno verificato l’anomalo rialzo della quotazione, la banca da mandataria diligente, avrebbe dovuto rimandare di qualche giorno l’operazione ben sapendo che dopo poco tempo la quotazione si sarebbe ristabilita ai valori normali. I legali pertanto chiesero la condanna al risarcimento del danno subito. I legali, difensori della banca, opposero il fatto che l’incarico conferito all’Istituto consisteva nell’acquisto di valuta estera in Borsa. Perciò non si trattava di un mandato, ma di un semplice ordine di Borsa e nemmeno indicava il prezzo d’acquisto. Espletando prontamente l’ordine, la banca si era comportata con la massima diligenza e non poteva ricevere alcun addebito per aver effettuato l’operazione in un giorno sfortunato! Oltretutto bisogna tener presente che le banche sono intermediarie necessarie nelle operazioni di valuta estera ed agiscono in regime di monopolio, questo pertanto rende non ipotizzabile il mandato basato su di un rapporto personale e fiduciario. Avendo, per questa risposta, durante l’esame. tre minuti di tempo per ragionarci e scrivere, non le deduzioni, ma solamente chi dei due avesse ragione, io come risposta diedi: - Ha ragione la banca! Il dirigente che voleva discutere con me le mie due risposte errate mi disse: Avendo dato lei ragione alla banca, ed essendo la risposta errata, cosa le ha fatto pensare che la banca avesse ragione? Dissi: - Ho dato ragione alla banca in quanto, se io fossi stato l’Impresa ordinate, conoscendo il valore, all’atto dell’ordine del dollaro, mi sarei premunito ordinando che l’operazione fosse eseguita solamente entro una certa oscillazione della valuta estera. Non avendolo fatto, ma avendo solamente dato l’incarico alla banca di acquistare dollari per mio conto, nulla avrei potuto chiedere di risarcimento. Avrei solamente potuto recriminare contro la sfortuna e fare ricadere la perdita in un normale rischio d’impresa. - Il suo ragionamento non fa una grinza e, posso confortarlo dicendo che tutti coloro i quali hanno risposto, e sono stati pochi, hanno dato ragione alla banca, però la giurisprudenza non la pensa così. Infatti il giudice 95 della Corte di Cassazione diede ragione all’Impresa sentenziando che la banca era responsabile perché aveva eseguito l’operazione con un cambio esageratamente alto rispetto l’andamento normale del mercato senza attendere il ritorno delle quotazioni a valori normali o in subordine senza chiedere conferma all’Impresa dell’esecuzione dell’operazione a valori anomali. - Ora vorrei sapere, nel quiz delle “lame”, perché ha messo la crocetta sulla mezzaluna come oggetto da scartare nella serie. - Il mio ragionamento è stato che era l’unica lama ricurva in mezzo a tutte le altre diritte. - Sì, effettivamente il ragionamento non fa una grinza, però la soluzione esatta era che la crocetta doveva essere messa sulle forbici in quanto l’utensile era composto da due lame, mentre gli altri avevano una lama sola. Rimasi per un istante perplesso, meditai sulla risposta ed ebbi il coraggio di replicare: Scusate, ma non condivido la soluzione perché le forbici, per essere tali, devono necessariamente avere due lame, altrimenti sarebbero dei coltelli. Io giudico che la non linearità del filo della lama sia da considerare una difformità, non il numero di lame che formano l’oggetto. I giudicanti si guardarono tra di loro senza proferire parola. Mi fecero ancora alcune domande di cultura generale e di cronaca, dopo di che mi congedarono dicendo: - A breve le faremo sapere qualche cosa, buon giorno. Mi alzai e, salutando con un accenno d’inchino, uscii nell’anticamera. Ero solo, gli altri se n’erano già andati, non potevo sapere nulla di quello che era successo, mi restava solo da sperare che l’esame orale non li avesse indispettiti per quella mia, forse non dovuta, replica. Mah. oramai era fatta! Incominciarono le vacanze estive della scuola, Nory la sentivo qualche volta, senza vederci. Il tempo passava e notizie niente! Avendo perso tutte le speranze di essere assunto, dato il tanto tempo passato, mi iscrissi alla classe terza, deciso a darci dentro per finire gli studi e cercare un altro lavoro. Il non poter stare con Nory mi faceva star male, non avevo voglia neanche di vedere gli amici, non avevo voglia di divertirmi. L’estate passò, stava per cominciare l’anno scolastico, mi decisi di cominciare a cercare d’acquistare i libri di testo per poter frequentare la scuola. 96 I primi giorni del mese di ottobre, arrivato a casa ad ora di pranzo, mia madre mi disse: È arrivata una lettera raccomandata per te dalla Cassa di Risparmio, leggila.... svelto! - Cosa vuoi, mamma, mi diranno che sono spiacenti per questa volta, ma che comunque terranno in considerazione il mio nominativo per il futuro, sono passati quattro mesi dall’esame orale, ormai non ci spero più. Aprii la lettera e lessi queste due righe in mezzo al foglio: “La preghiamo di presentarsi, quanto prima, all’Ufficio del Personale per comunicazioni che La riguardano”. Un tumulto interno mi assalì, la gola stretta dall’emozione non riusciva ad emettere alcun suono mentre le lacrime calde, cocenti, copiose scendevano sulle guance, le mani mi tremavano tenendo stretta la lettera, che portai al petto, riuscii ad emettere un gemito, che voleva essere un urlo, e dissi: - Nory, mamma.......!!! Il mattino seguente, alle otto, mi presentai nell’atrio della Sede Centrale della Cassa di Risparmio di Trieste chiedendo dell’ufficio del personale. Il portinaio, gentilissimo, mi disse che si poteva accedere agli uffici dopo le otto e mezzo ma, vedendomi così spaesato e imbarazzato, mi chiese: Lei è uno dei nuovi assunti? - Non lo so, spero – risposi - ho ricevuto solo una lettera di convocazione. - Stia tranquillo allora, la lettera la mandano solo a quelli che vengono assunti, agli altri niente, congratulazioni e.... auguri. Alle otto e un quarto, il portiere mi disse: - Può salire, ora è passato il signor Derossi che è il capo dell’ufficio personale, ed è a lui che deve rivolgersi. Prenda l’ascensore, vada al secondo piano, giri a sinistra, la terza porta ed è arrivato, bussi ed entri. Non so perché, ma questa frase, questa indicazione, mi era familiare, come l’avessi già sentita. Feci esattamente come il portinaio mi disse e....mi ritrovai precisamente dove, quattro mesi prima, avevo sostenuto l’esame orale. Bussai.... avanti.... entrai. Buon giorno – dissi - ho ricevuto una lettera per presentarmi qui oggi. 97 Il signor Derossi, era la persona con la quale avevo sostenuto l’esame orale, mi guardò e disse: - Mi ricordo di lei e del colloquio su quei due punti controversi. Dopo che lei era uscito da questa stanza, ne discutemmo a lungo e ci fece molta impressione la sua decisione, la sua risolutezza nel difendere le sue opinioni, sintomi di un carattere deciso che porta, in questo caso con successo, avanti con forza i propri convincimenti. Posso comunicarle che la commissione l’ha posto al dodicesimo posto in graduatoria delle venti assunzioni previste, pertanto dovrà farci avere nel più breve tempo possibile tutti i documenti necessari, specificati in questa lista, e con il ventun ottobre potrà cominciare a prendere servizio. Ci sarà un periodo di prova di tre mesi che, una volta superato favorevolmente, comporterà l’assunzione definitiva in pianta stabile. Dovetti fare uno sforzo per non mettermi a saltare dalla gioia, non so se in viso ero rosso fuoco o pallido cereo, le mani erano sudate e così pure la fronte, sentivo una sensazione di caldo, come una fascia, che saliva alla testa per poi scendere fino ai piedi e viceversa. Mi sembrò di vivere in un altro mondo, sentivo la voce del signor Derossi come si stesse allontanando sempre più fioca, quasi ovattata. Cosa mi stava succedendo, oh Dio stavo per svenire. Sentii il signor Derossi che diceva: - Weiss, si sente bene? Questo mi diede una sferzata, mi ripresi subito e dissi: - Mi scusi, l’emozione, la gioia, il batticuore, la felicità tutto insieme mi hanno frastornato, io ero venuto qui con delle tenui speranze, mai avrei immaginato una cosa così meravigliosa, grazie, grazie di cuore, spero sinceramente di non deludere mai le vostre aspettative. Diedi immediatamente comunicazione a Nory di quanto era accaduto e da quel momento, finalmente, i nostri sogni, le nostre speranze, le nostre aspettative, i desideri più reconditi potevano avverarsi, realizzarsi, materializzarsi, la strada sarebbe stata ancora lunga ed impervia, ma avevamo rimosso il primo e più duro ostacolo per iniziare il cammino della vita insieme. 98 I giorni seguenti furono dedicati alle pratiche burocratiche: libretto del lavoro, visite mediche, stato di famiglia, cittadinanza, fedina penale, certificati scolastici e tante altre cose che non ricordo. Arrivò il fatidico 21 ottobre 1957 e varcando la soglia del portone di via Cassa di Risparmio n° 10, voltai la pagina più importante della mia vita. Cominciò la vita da adulto, era necessario ragionare in un altro modo, le responsabilità arrivarono, i pensieri pure, era finita la gioventù, la fanciullezza, l’infanzia.... ripensandoci si potrebbe dire....”ma poi, la puoi chiamare infanzia?” 99 100 NATO A TRIESTE Febbraio 2001 101 102 PREFAZIONE Perché questo titolo? Mi sono chiesto, cosa ne so della mia Città natale? Niente, poco forse, comunque vorrei saperne di più. In fondo la mia famiglia, anche se di origini austriache, può considerarsi triestina al cento per cento. Infatti possiedo un documento attestante che un mio avo, tale Gaspare Weiss, nel 1799 ottenne la concessione di aprire una “pubblica stamperia” in Trieste. Io credo che per essere considerati “triestini”, basta che uno sia nato a Trieste e che la famiglia vi risieda magari da due o tre generazioni. In realtà un ceppo originario, autoctono non esiste. Trieste è sempre stata, dalle sue origini, luogo di transito dei più svariati popoli, data la sua collocazione geografica, crocevia tra l’est e l’ovest, tra nord e sud, punto d’arrivo dei commerci via mare e via terra. Ogni tanto qualcuno si fermava onde poter coordinare questi traffici ed ecco formarsi un piccolo nucleo familiare che, durante i secoli, aumentava e si sviluppava oppure diminuiva e spariva. È mio fermo intendimento, sviluppare ed approfondire questa ricerca, consultando testi antichi e moderni, annotazioni e pensieri ricavati dalla consultazione di libri specifici che la nostra Biblioteca Civica e il museo di Storia Patria di via Imbriani possiedono. Oggi, anche grazie ad internet, si può accedere e consultare anche testi di proprietà delle Facoltà di Storia Antica e Storia Moderna della nostra ed altre Università, entrare in siti specifici presso le Amministrazioni Comunali, Provinciali o Statali di quasi tutte le parti del mondo. Concludendo non so, se questa mia ricerca andrà a buon fine, se potrò citare la bibliografia e/o i siti che mi avranno fornito il materiale necessario a sviluppare questo studio che, è mia viva speranza, sia il più attendibile e coerente possibile e spero di non incorrere in facili e possibili errori di interpretazione, data la vastità dell’analisi da verificare. Giorgio Weiss 103 CAPITOLO 1 Molte persone amano viaggiare, visitare città e paesi nuovi, la sete di conoscenza è uno dei principali stimoli, la gioia di poter vedere le meraviglie della natura e tutte le cose che l’uomo ha creato nel corso dei secoli e dei millenni è uno sprone. Anch’io, limitatamente ai problemi di tempo e di “finanze”, ho fatto qualche viaggetto. Parecchio tempo, prima di partire, mi sono documentato, cercando libri, depliants, testi scritti che guidino ad una corretta visita dei luoghi prescelti sia in Italia che all’estero. Un paio di settimane fa, al ritorno da una visita a Roma, mi sono accinto ad assemblare il filmetto che ho fatto in ricordo degli stupendi luoghi visitati, come pure quello fatto alcuni mesi addietro a seguito della visita alle Langhe e al Monferrato in Piemonte. Mentre rivedevo il resoconto di questi ultimi due viaggi, mi sono chiesto: - Giorgio vedi tante cose stupende ma della tua Trieste cosa ne sai? Poco, niente - fu la risposta che dovetti darmi. Conosco San Giusto, il Castello di Miramare, il Teatro romano, il Carso........ Ma cosa sono, perché sono lì, chi li ha costruiti, quando, per quali motivi...... risposte poche, frammentarie, quasi sicuramente inesatte! Eh no! caro Giorgio, tempo ne hai poco, è vero, ma quello che hai devi usarlo per cercare di conoscere, capire, apprendere, sapere, rilevare, ma soprattutto discernere ed interpretare la tua città dalle sue origini. Adesso che mi sono deciso, bisogna trovare un punto di partenza da cui iniziare le ricerche; sì! ho deciso e credo che sia la cosa più ovvia. La prima cosa da fare è cercare di interpretare l’etimologia della parola Trieste. Già qui cominciano le prime diversità di versione, decodificazione ed esplicazione del termine. Alcuni storici, molto semplicisticamente, attribuiscono al nome di 104 Tergeste il significato romano di “costruita tre volte”. Secondo altri queste sono solamente delle “dicerie” in quanto il termine non è romano, bensì molto più antico. Esso deriverebbe da terg, termine tratto da un antica lingua indoeuropea, o forse dialetto, che aveva il significato di mercato e dal suffisso este, tratto dal linguaggio dei Veneti, che voleva dire città. Sarebbe prova di questo suffisso il nome di alcune città, quali Ateste e Segeste, fondate dagli antichi Veneti tanti secoli prima. Per quantificare l’epoca bisogna pensare che ciò avvenne prima che i Romani, scendendo dai loro colli, si espandessero nella pianura sottostante dove, dopo aver bonificato le paludi, eressero quella che è oggi chiamata la “città eterna”. Secondo questa interpretazione il nome della città di Tergeste significherebbe luogo di mercato o meglio ancora città-mercato. Sono riuscito ad identificare ancora una versione, che io ritengo leggendaria e poco probabile, in cui il nome di Tergeste deriverebbe dal nome di un guerriero, tale Tergesto o Tergesteo, che seguendo Antenore o Diomede e il popolo dei Veneti, una volta caduta Troia, si fosse fermato in questi luoghi da lui ritenuti splendidi, fondando una città a cui sarebbe stato dato il suo nome. Io sono propenso che la seconda versione, quella di città-mercato, sia la più realistica, però mi assale il dubbio che, se anche la terza versione sembri leggendaria, potrebbe avere qualche fondamento di verità. Bisogna pensare che ad un certo momento, le popolazioni indoeuropee cominciarono ad espandersi e dilagare, diffondendosi in tutta l’Europa, ma soprattutto nel bacino del Mediterraneo. Uno di questi gruppi, sicuramente, giunse in queste regioni. Chi li guidava non sarà stato il leggendario Tergeste o, comunque, un altrettanto aitante condottiero, con spalle robuste, alto e biondo che era a capo di questa tribù di Veneti?? E qui la storia vera si mescola con la leggenda, tanto da disorientare un poco. Proseguiamo nell’analisi tenendo in sospeso questa decisione sulle origini del nome di Trieste. Siamo agli inizi dell’età del ferro, circa mille anni prima della nascita di 105 Cristo. Da questo momento cominciamo ad avere i primi dati certi dell’insediamento umano nei nostri territori. I gruppi di persone, le tribù dei popoli che confluirono nella nostra zona, si attestarono sulla cima delle colline che circondano il golfo, costruendo villaggi e recintandoli con dei grossi e poderosi muri in pietra, a secco, cioè appoggiando e adattando le pietre una sull’altra senza l’uso della malta. Nacquero così quelle costruzioni che noi oggi chiamiamo castellieri. Il più ben conservato e grande castelliere che è stato ritrovato nella nostra regione è quello di Slivia, altri vennero portati alla luce in diverse zone del Carso. Sicuramente altri castellieri furono eretti anche sui colli più vicini alla costa ed essendo questi più prossimi al livello del mare erano pertanto climaticamente più confortevoli. Dati i successivi e più recenti insediamenti, gran parte di questi castellieri scomparve. Comunque furono ritrovate rare, ma sicure testimonianze sul colle di San Vito ed esse fanno pensare che anche i colli di San Giusto, Servola, San Pantaleone, Scorcola, ecc. abbiano avuto il loro castelliere. Il colle di San Giusto, in modo particolare, essendo il più vicino al mare, è il più probabile insediamento di qualche gruppo indoeuropeo. Resti in zona non ne sono stati trovati ma ciò, sicuramente, è dovuto al fatto che già all’epoca romana la cima del colle fu livellata per permettere la costruzione di templi e basiliche eliminando ogni traccia precedente. L’attuale via San Michele, quasi sicuramente, si snoda su di una strada aperta dalle genti preistoriche, che la usavano per scendere dai villaggi e raggiungere il mare, dove avrebbero trovato dei navigli provenienti dall’Oriente o dal Mediterraneo per poter barattare le loro mercanzie con i prodotti locali. È probabile pure che, dalle zone baltiche, giungessero delle carovane di mercanti al punto di mare più vicino dove poter vendere l’ambra, prodotta in gran quantità nelle loro regioni, ai mercanti dell’Oriente che ne facevano grande richiesta. Tutte queste sono congetture, supposizioni, ipotesi, teorie e non certezze documentate; infatti i primi scritti che provino l’esistenza di Tergeste risalgono al primo secolo avanti Cristo. 106 Risulta infatti che Roma, avendo consolidato il suo potere e dominio sulla penisola e in gran parte del Mediterraneo, decise di espandersi verso nord onde rafforzare le difese per arginare le calate dei barbari che, periodicamente, valicando le Alpi, cercavano sbocchi in territori più fertili e temperati. Partendo dal presupposto, come detto, che qui, esistesse un piccolo villaggio veneto, più ad est nella penisola istriana, certamente, erano insediati gli Istri che erano degli abilissimi marinai e quindi pirati, nonché dei formidabili guerrieri. Ad ovest, poco distante dalle nostre terre, sorse Aquileia fondata, si presume, nel 183 avanti Cristo, che fu una città e un porto di grossa importanza per i Romani. Come dicevamo, essendo gli Istri dediti anche alla pirateria, continuamente attaccavano le navi romane, che andavano e venivano dal porto di Aquileia. I traffici erano in costante aumento e specialmente da questo porto partivano navi cariche, tra l’altro, di anfore vinarie contenenti il famosissimo vino “Pucinum”, i cui vigneti si estendevano sul fianco del ciglione carsico che va da Sistiana a Prosecco. Fu considerato un vino terapeutico e tanto caro, poi, all’imperatrice Livia, moglie dell’imperatore Augusto. Al contrario, provenienti da Roma, giungevano merci di tutti i generi, necessarie ai legionari che ivi risiedevano. Fu in quel periodo che, via terra, i Romani si spinsero e si insediarono, cacciando i Veneti, in queste nostre terre e precisamente dal colle di San Giusto fino al mare. Tra il 178 e il 177 avanti Cristo, tale Console Manlio Vulsone partì da Aquileia con le sue legioni per portare guerra e distruzione in Istria e punire così gli Istri per le loro azioni di pirateria e dissuaderli da future incursioni. La spedizione punitiva si stava per trasformare in una disfatta, sta di fatto che la prima battaglia contro gli Istri fu quasi perduta. Dove si svolse la prima battaglia non è del tutto stabilito, ma sembrerebbe che le località più probabili fossero Sistiana o la piana di Bagnoli o forse anche quella di Zaule; alcuni studiosi identificano la zona nella gola 107 Cattinara-Montebello, ma ciò, strategicamente, è poco probabile. Qualche notizia su questa battaglia si può trovare in uno scritto dello storico romano Tito Livio, il quale narra che l’esercito romano, comandato appunto da Manlio Vulsone, era formato da due legioni, una coorte di Piacentini e più di tremila Carni. Lungo la costa era affiancata da una non meglio definita flotta che trasportava i viveri, le probabili armi e macchine belliche. La flotta si ancorò, quasi sicuramente o al largo della vallata di Zaule o nel golfo di Muggia ed è perciò che il luogo più probabile dell’accampamento fosse la piana di Zaule. Anche qui solo congetture in quanto reperti archeologici non furono mai stati ritrovati. Da quanto è stato modo di capire dagli scritti di Tito Livio, si presume che da quell’accampamento una legione si fosse allontanata per far provvista di legna, probabilmente di acqua e fieno per i cavalli. La coorte si accampò in una zona intermedia tra la flotta ed il campo base. I Romani non potevano sapere che un numeroso esercito di Istri fosse nelle vicinanze e, probabilmente nascosto in qualche castelliere, aspettava il momento migliore per attaccare. Gi Istri, al comando di un certo re Epulo, piombarono a sorpresa sull’accampamento, devastandolo, nel momento in cui i legionari meno se l’aspettavano. I legionari romani, colti di sorpresa, fuggirono disordinatamente per raggiungere le navi e mettersi in salvo. A sua volta le navi, vista la mala parata, salparono le ancore per allontanarsi dal pericolo. Sembrava tutto finito, ma il genio bellico romano e l’inesperienza degli Istri volsero le sorti di quella che sembrava una battaglia persa. Infatti gli Istri non inseguirono i Romani in fuga e si diedero, al contrario, ad azioni di saccheggio dell’accampamento abbandonandosi a laute libagioni con il pregevole vino dei Romani e rimpinzandosi di cibi trovati in abbondanza. Il Console Manlio Vulsone riuscì a rincuorare i suoi soldati e riunirli alla legione, che ignara dell’accaduto, stava ritornando con la legna, il fieno e l’acqua. 108 Chiamò in rinforzo i tremila Carni che erano accampati a cinquemila passi di distanza corrispondenti a circa sette chilometri e mezzo. Gli Istri, convinti di aver messo in fuga i Romani, dopo aver mangiato e bevuto a sazietà, si addormentarono all’interno dell’accampamento conquistato. L’attacco romano fu portato tanto di sorpresa che colse gli Istri impreparati e, sembra che oltre ottomila di essi rimasero uccisi. Gli altri si dispersero fuggendo nel territorio. La stagione era avanzata e, dopo questa vittoria, il Console stabilì di rientrare per svernare ad Aquileia. Decise, comunque, di lasciare un presidio nella zona formata da una o due coorti e probabilmente i tremila Carni più abituati al rigore dell’inverno. Potrebbe essere che questo presidio si fosse installato proprio sul colle di San Giusto facendo nascere così la Tergeste romana, o comunque su di un colle, ma vicino al mare, dove, eventualmente, le navi romane avrebbero potuto portare aiuto e, lontano dai colli carsici dove, nei castellieri, potevano annidarsi dei gruppi di Istri. L’anno dopo, passato l’inverno, il Console Vulsone ritornò in forze ed invase l’Istria intera distruggendo tutti i castellieri che si opponevano alla sua avanzata fino a giungere a quell’enorme castelliere che era la roccaforte di re Epulo. Il castelliere sorgeva a Nasezio, una località in prossimità dell’attuale Pola. Esso fu cinto d’assedio dai Romani, che fecero di tutto per conquistarlo deviando, persino, il corso del fiume che lo approvvigionava d’acqua fresca. Visto che era vano resistere, gli Istri prima uccisero le loro donne e i loro bambini, poi in molti, re Epulo compreso, si tolsero la vita per non cadere prigionieri dei Romani. Finì così la potenza degli Istri, pirati, predoni e grandi guerrieri. A questo, seguì un periodo alquanto movimentato per la piccola colonia romana. Il grosso delle truppe se ne ritornò ad Aquileia, mentre nel 166 a.C. i Carni si ribellarono e così pure nel 129 a.C. i Giapidi, abitanti della zona del Monte Nevoso. Il confine stava diventando poco tranquillo ed è per questo che, quasi sicuramente, Tergeste si trasformò in una colonia militare romana. Nel 53 a.C. i Giapidi scesero nuovamente su Tergeste e la 109 saccheggiarono. Fu allora che Giulio Cesare inviò in questa zona le sue legioni per fermare le invasioni. Fu necessario arrivare al 34 a.C. perché Ottaviano Augusto debellasse definitivamente i Carni, i Giapidi ed altre popolazioni montane, portando la pace in questa zona di frontiera. Nel 30 a.C. Tergeste divenne territorio di Roma, che una volta finiva al Rubicone ed ora arrivava al Formione, l’attuale Risano, ed infine al fiume Arsa. Fu così che l’Istria intera, Tergeste insieme a Venezia ed Aquileia, formarono la decima regione di quello che era l’ordinamento dello stato romano. Tergeste assurse a sempre maggiori onori in seno all’ordinamento romano in quanto era sede di un municipio romano retto da due alti magistrati, ebbe due senatori ed il consiglio dei decurioni, che era un gruppo di cento cittadini scelto con voto popolare. I cittadini, obbligati al servizio militare vennero assegnati alla XV legione detta Apollinare. Il municipio di Tergeste estendeva la sua influenza ed il suo potere ai Carni ed ai Catali. La città si espanse talmente che fu necessario abbattere le mura esistenti, tant’è che la zona era ormai pacifica. Si pensa che, pur mantenendo la forma “a scacchiera” tipica degli insediamenti romani, la città si estendesse giù per il colle fino al mare. Delle mura romane abbattute, attualmente rimane solamente un piccolissimo accenno nelle vicinanze dell’Arco di Riccardo. La parola “Arco di Riccardo”, nome coniato dal popolino, farebbe pensare ad un arco di trionfo, come tanti ce ne sono a Roma, invece altro non è che una porta della città lasciata lì per abbellire la zona. La prova che trattasi di una porta e non di un arco è data appunto dagli scavi eseguiti, tempo fa, dagli archeologi che trovarono sotto di essa la parte del muro di cinta rimasto. Tergeste, tanto si era espansa ed aveva assunto un ruolo importante nell’ordinamento romano, che si sentì la necessità di approvvigionare direttamente d’acqua la città, ed è così che fu costruita quell’opera grandiosa che era l’acquedotto. Esso partiva dalla Val Rosandra, dove ancora oggi ci sono ben visibili i resti, per giungere, attraversando la piana di Zaule, fino alla città. 110 Dobbiamo arrivare agli inizi del primo secolo dopo Cristo per avere altre testimonianze romane in Tergeste. Bisogna pensare che, in quell’epoca, la vita era breve ed il tempo passava monotono e che per creare cose imponenti ci volevano parecchi decenni se non proprio secoli. Il cuore e la vita dell’insediamento romano era il colle di San Giusto dove abbiamo le maggiori testimonianze. L’attuale Cattedrale fu eretta sopra i resti del tempio capitolino. Si stima che il tempio fosse lungo oltre venti metri e largo quasi diciotto. Due avancorpi laterali formavano i pronai sorretti rispettivamente da quattro colonne ciascuno. Ne è testimonianza più certa la nicchia scavata sotto la torre campanaria dove si possono notare i fusti anneriti delle colonne. Ad esso, che era il maggior tempio della città, si accedeva dall’attuale via della Cattedrale che è di sicura epoca romana. Si pensa che il tempio fosse dedicato alla triade capitolina, cioè Giove, Minerva e Giunone. Bisogna arrivare agli inizi del secondo secolo dopo Cristo per vedere un’altra imponente opera e cioè la basilica forense che fu eretta sullo spiazzo di San Giusto. Di essa rimangono parte delle colonne che formavano l’edificio, anch’esse ricostruite dalla Sovraintendenza, dove la parte in pietra è originale dell’epoca, mentre i mattoni sono stati aggiunti per ridare la rotondità ed il diametro delle colonne stesse. Bisogna tener presente che a differenza del “tempio” capitolino, che era un luogo di culto, la “basilica” forense era un luogo pubblico dove veniva amministrata la giustizia e serviva a tenere riunioni, anche pubbliche. La basilica era molto grande infatti, guardando i resti, si può calcolare che essa avesse almeno una lunghezza di ottantotto metri ed una larghezza di ventiquattro. Si può notare la scala d’accesso alla basilica e la “vasca” il cui contorno è visibilissimo a terra e dove, probabilmente, sedevano i giudici. Sul perimetro si può notare un canale, il quale certamente raccoglieva l’acqua piovana, che veniva scaricata dalle gronde della basilica e poi convogliata in un grande pozzo, ora non visibile perché coperto dal manto stradale. Da questa imponente opera si presume che in quell’epoca la città di Tergeste avesse assunto un importante ruolo nell’amministrazione romana. 111 Infatti fu un grosso nodo di comunicazione, anche perché l’importantissima città di Aquileia commerciava intensamente con l’Europa centrale ed orientale. Dato che il nome di Quintus Baienus Blassianus è stato rilevato su parecchie lapidi rinvenute tra i resti della basilica, si ipotizza che lo stesso fosse o il costruttore o un cittadino benemerito o più semplicemente una persona che avesse ricoperto importanti cariche civili o militari e quindi degno di essere ricordato ai posteri. Altra testimonianza, datata tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo, è il bellissimo teatro romano, probabilmente fatto erigere dal famoso ed insigne cittadino di Tergeste, che fu Quinto Petronio Modesto, e del quale teatro oggi è ben conservata la parte interna, manca infatti la facciata, che era adorna di numerosissime statue, come dimostrano i numerosi frammenti architettonici e i gruppi di statue che furono rinvenuti. Il teatro romano sarebbe stato il più bel monumento romano che avremmo potuto avere se, nel Medioevo, come è successo un po’ dappertutto, ma specialmente a Roma, i signorotti ed i prelati di allora non avessero saccheggiato le parti migliori dei templi pagani per erigere chiese, palazzi e castelli. Più che un teatro esso era considerato un’Arena, anche se non aveva la classica forma ellittica, in quanto venivano proposti anche spettacoli con i gladiatori. Del resto il nome del rione oggi conosciuto come “Rena Vecia” deriva appunto da Arena Vecchia o vecchio teatro che vogliasi dire. Era il periodo “aureo” della Tergeste di allora, lo dimostrano i numerosi tempietti, che furono eretti. Ad esempio quello dedicato alla dea delle messi, Cibele, i cui pochi resti sono stati rinvenuti presso l’arco di Riccardo; quello in onore di Bona Dea ritrovato scavando le fondazioni della Riunione Adriatica di Sicurtà sul lato della via S.Caterina oppure quello dedicato al dio Beleno nei pressi della via Bramante. Data l’importanza che aveva assunto Tergeste, anch’essa avrà avuto il suo Foro, situato probabilmente sempre sul colle di San Giusto, ma non avendone ritrovati i resti, nemmeno sotto la Cattedrale, si presume che potesse trovarsi, da qualche parte, sotto l’attuale castello. Fu ritrovata solamente una grande base sulla quale era eretta una statua equestre in bron112 zo aureo del più insigne dei Tergestini, Fabio Severo. Probabilmente, la statua fu predata dai barbari che la credevano d’oro o per essere fusa onde poter forgiare nuove armi. Sul basamento rinvenuto c’è inciso il più antico documento tergestino che magnifica i meriti di questo personaggio. Egli fu dapprima un magistrato a Tergete e poi senatore a Roma durante l’impero di Antonino Pio. In seguito si adoperò sempre per rendere grande Roma capitale e la sua città natale. I nobili, i ricchi mercanti, nonché i notabili della città fecero costruire delle splendide ville con pavimenti in mosaico, fontane e giardini a Barcola a Sistiana e Santa Croce, mentre sui colli soprastanti sorsero ville agricole e molte fattorie. I commerci nel porto fiorivano tanto che si pensa a parecchi piccoli porticcioli disseminati lungo la costa: uno lungo la riva Grumula, uno a Barcola – il cui nome latino era Vallicula che significa appunto porticciolo, e quello principale alle spalle dell’attuale piazza dell’Unità d’Italia. Ciò a dimostrare appunto che il teatro romano si affacciava sul mare. La romana Tergeste doveva essere, certamente, una gran bella, ricca e fiorente città e visse a lungo un periodo felice di pace, serenità e prosperità. Purtroppo le cose belle sono destinate a finire, infatti Trieste dovette subire, ad ondate successive, invasioni di barbari di ogni genere finché nel 568 i Longobardi la rasero completamente al suolo e tutti gli abitanti, che non riuscirono a mettersi in salvo, vennero trucidati. Nel 571, i Triestini superstiti, portando con sé, gelosamente, le reliquie dei santi e le poche e povere cose che erano riusciti a salvare, faticosamente, ricostruirono le loro case cinte con nuove mura di difesa. Ma la pace era finita e per molti secoli i Triestini dovettero solamente combattere. Nel periodo romano anche a Tergeste, come nel resto dell’impero, sorsero le prime comunità cristiane e pertanto anche qui ci furono le persecuzioni ed i martiri. Una delle più significative testimonianze fu casualmente scoperta nel 1963 durante l’esecuzione dei lavori in una scuola e scavando il manto 113 stradale davanti ad essa, in via Madonna del Mare. Nel sottosuolo viene conservata l’antica basilica della Madonna del Mare, che non ha niente a che vedere con la moderna chiesa in piazzale Rosmini. Si trova in uno spazio angusto, anche perché per ripristinare la strada soprastante si è dovuto fare una copertura in cemento armato poggiante su grosse travature portanti. Questa basilica aveva una pianta a forma di croce. Per quanto è dato sapere, potrebbe essere la prima chiesa di Trieste. Poter stabilire l’epoca della prima costruzione è quasi impossibile. Si può notare un mosaico ricco di motivi ornamentali, decorativi e ricchi di colori, che però sovrasta uno più modesto, formato da tessere bianche e nere. È quasi certo che, per abbellire la chiesa, fu posto sopra l’originale pavimento uno più ricco e decorativo e che si può far risalire al quinto o sesto secolo. Si può supporre che il pavimento sottostante sia stato costruito per erigere un tempio in conseguenza della liberalizzazione del culto cristiano decretato da Costantino nel 313. Potrebbe, ma non se ne è sicuri, che la prima chiesa sia stata eretta sopra, allargandolo, un sacello cristiano, magari risalente al duecento, dove erano sepolti i martiri cristiani. Di martiri cristiani Tergeste ne ha avuti molti. Di quelli di cui si hanno notizie, i primi risalgono all’epoca dell’imperatore Antonino Pio, tra gli anni 140 e 150 e sono Giacinto, Marco, Galliano e Giasone seguiti, pochi anni dopo, da Lazzaro e Apollinare. Il secolo seguente, sotto l’imperatore Valeriano, furono martirizzati Zenone e Giustina ed alla fine del secolo abbiamo i santi più famosi, che sono San Servolo, San Sergio ed infine San Giusto, giustiziato nel 303. Tanti altri, meno noti, furono sepolti in questo sacello. La vicina via Santi Martiri è la testimonianza del ritrovamento dei resti di questi santi nella basilica paleocristiana della Madonna del Mare. Chiusa questa parentesi, eravamo rimasti all’anno 568 e all’invasione dei Longobardi ed all’inizio del periodo più buio e più difficile da capire per la città di Trieste. Mancano notizie riferenti a questo periodo e non ci sono testimonianze scritte dirette anche a causa dei saccheggi e delle distruzioni che avvenivano ad ogni passata barbarica. 114 Si sa che i Bizantini liberarono questa regione annettendola al loro impero, però successive invasioni barbariche tra le quali, per la prima volta, quella di torme di Slavi agli inizi del settimo secolo, fecero ripiombare la regione in uno stato di prostrazione. I Bizantini, nel frattempo, avevano fondato l’esarcato di Ravenna, che avrebbe avuto la giurisdizione sulla regione veneta e sull’Istria, che divennero “province militari” create sulla falsariga delle “province di frontiera” dei Romani. Ogni uomo di Trieste e del territorio doveva essere pronto a difendere e vigilare le frontiere orientali, lungo le Alpi Giulie, dai Germani e dagli Slavi e lungo l’Isonzo dai Longobardi, che avevano Cividale come capitale. Con questo consolidamento, per centocinquanta anni, Trieste non subì invasioni di sorta e poté, grazie al porto, sviluppare traffici con l’oriente smerciando il sale, prodotto nelle numerose saline, e i suoi pregiati vini. Nel 752 i Longobardi, oramai civilizzati, rovesciarono l’esarcato bizantino di Ravenna, impadronendosi pure dell’Istria. Ai Bizantini rimase solamente la costa veneta con l’isola di Grado. Nel frattempo i Carolingi stavano sviluppando il Regno d’Italia e, liberando il Veneto dai Longobardi, lo annessero al regno della Chiesa. Fu il periodo delle guerre religiose tra Sacro Romano Impero e quello orientale dei Bizantini e con alterne vicende i territori passarono da un blocco all’altro finché non nacque quella grande potenza, che fu Venezia e che dominò per quasi mille anni. Trieste, al di fuori di queste vicende, rimase un feudo carolingio di stampo tedesco, agli ordini del duca Giovanni, che impose nuove tasse, servizi obbligatori, la leva militare ed infine chiamò in Istria gruppi di Slavi ai quali donò terre e pascoli appartenenti agli Istriani. Quest’ultimo episodio ricorda fatti, a noi, più recenti e tristemente noti. Nell’ottocentoquattro gli Istriani si appellarono all’imperatore Carlo Magno, che nella piana del Risano convocò un’assemblea cui parteciparono tutti i comuni istriani e così pure Trieste, nella quale fu deciso che il 115 duca Giovanni ridesse i privilegi tolti ai comuni. Ecco che, pur facendo parte del regno dei Carolingi, i comuni e così pure Trieste, si amministrarono da soli. La flotta del Ducato di Venezia, in Adriatico, arginò le scorrerie di Saraceni e Slavi delineando così la sua potenza sul mare riconosciuta anche dai comuni istriani che vissero una sorta di vassallaggio relativamente ai traffici marittimi. Le cose si stavano mettendo male, perché il Regno d’Italia non aveva più né la capacità né la forza di difendere i confini. Trieste e le città istriane furono praticamente abbandonate e dovettero difendersi da sole quando, tra la fine dell’800 e gli inizi del 900, ci furono le invasioni di Ungari e Slavi. Con l’aiuto dei vescovi, che nel frattempo avevano ottenuto maggiori poteri, resistettero a quella bufera. Trieste non fu mai vassalla a nessuno, però dovette versare i tributi e le tasse non più al re, ma al Vescovo Giovanni e ai suoi successori, in quanto lo stesso re aveva ceduto tutti i suoi diritti sulla città. Un balzello annuo doveva infine essere versato pure a Venezia per riconoscere la sua supremazia sul mare. In realtà Trieste, pur essendo un libero comune e governandosi con i suoi magistrati, doveva pagare tasse a Venezia ed al Vescovo riconoscendo così l’autorità del Sacro Romano Impero. 116 CAPITOLO 2 Siamo arrivati appena intorno all’anno mille e già quante cose sono successe in questa nostra terra. Ho dovuto rintracciare notizie su vari libri, testi, volumi e manuali, talvolta discordanti tra loro per le personali interpretazione date dagli autori. Anch’io, evidentemente, ho dovuto scegliere, ragionare e dare quella interpretazioni che ho ritenuto più possibile aderente alla realtà. Adesso passiamo al millennio seguente, altri libri, altre notizie da vagliare, altre fatiche. Non avrei mai pensato che queste “fatiche” potessero essere così piacevoli, perché scopro notizie e nozioni che, per uno storico possono sembrare ovvie, ma per me sono cose nuove e inaspettate....e pensare che a scuola la “storia” la digerivo male. Praticamente passiamo al “medioevo” che letteralmente significa l’età di mezzo, tra quella antica e quella moderna. Il termine “medioevo” fu usato per la prima volta dal tedesco Cristoforo Keller nella sua “Historia medii aevi” dai tempi di Costantino alla caduta di Costantinopoli del 1453. Convenzionalmente però, la fine del medioevo e l’inizio dell’era moderna si fa coincidere con la scoperta dell’America, nel 1492. La valutazione, comunque, di questo periodo è del tutto simbolico in quanto è stato variamente modificato dagli studiosi, secondo che, da un lato la decadenza, dall’altro il rinnovamento, siano stati valutati da un punto di vista artistico, culturale, religioso, politico, economico, sociale, ecc. Ma ritorniamo alla nostra Trieste e riprendiamo lo studio da dove l’avevamo lasciato. Come punto fisso prendiamo il 948, anno in cui il debole re Lotario, erede ormai di un regno d’Italia sempre più allo sfacelo e in balia dei feudatari, consegnò la città di Trieste ed il suo territorio, che si estendeva per un raggio di tre miglia oltre le mura, al vescovo Giovanni concedendo la completa immunità a lui ed ai suoi successori. 117 La parola immunità, all’epoca, e nel particolare periodo storico-politico in cui fu concessa, aveva un significato particolare e cioè che tutte la cariche pubbliche e l’amministrazione della città passavano, in pratica, dalle mani dei funzionari governativi a quelle del vescovo. Trieste, pertanto, divenne una città autonoma, non più legata al resto del territorio formato dall’Istria da una parte e dal Friuli dall’altra, e governata dal suo vescovo. La città, all’epoca, non era densamente popolate, il Caprin, nelle sue ricerche stima che Trieste avesse forse seimila abitanti ma, probabilmente, anche meno. Fu un periodo “buio” per tutta la regione. Il Friuli, a causa delle invasione dei Magiari, non aveva quasi più abitanti, sembrava di essere ritornati alla preistoria, la gente viveva in tuguri fatti di paglia impastata col fango, si vestivano con le pelli e si nutrivano con quel poco che riuscivano a cacciare o coltivare in miseri e piccoli orti. Anche a Trieste la situazione non era certamente migliore. A questo punto ho dovuto alzare gli occhi dai libri, dagli elaborati, dallo schermo del mio computer e fare una riflessione e farmi una domanda: Ma gli sfarzi che Roma aveva portato in questi lidi dov’erano andati a finire? Cenere, polvere, oblio, letargo, oscurità, periodo “buio” infatti. Invece di progredire la vita, la civiltà, gli usi, i costumi regredivano in modo tale, come detto, che sembrava di riessere alla preistoria. C’era tutto un fermento di eventi, il Regno Italico passò in mano ai re germanici, infatti Ottone I° aggregò parte dell’Italia settentrionale al ducato di Carinzia. Ma anche questa situazione era destinata a durare poco tempo in quanto, essendo in piena epoca feudale, il re abbandonò i territori nelle mani di conti, marchesi e nobili in genere che erano e diventavano suoi feudatari, che reggevano ed amministravano città, castelli ed interi territori restando del tutto autonomi e dovendo al re solamente portare aiuto e armati nelle guerre tra regnanti. È per questo che a Trieste, dopo il mille, cominciammo ad avere vescovi con nomi teutonici, mentre in Istria e nel Friuli avemmo i nobili di origine germanica. 118 Ne è esempio che ad Aquileia il patriarca Popone ricostituì la sua diocesi ricostruendo pure la grande basilica poi consacrata nel 1301. È così che Aquileia divenne sempre più grande fino a diventare una vera e propria potenza sia economica che militare. I vescovi di allora avevano ben altro ruolo di quelli dei giorni nostri, erano difatti dei veri e propri guerrieri e, tra l’altro, fedeli vassalli del re. Non solo non erano degli ecclesiastici e non dicevano messa, ma il più delle volte erano anche analfabeti. Questi vescovi venivano nominati dal re e non più, come un tempo, dal popolo e dal clero ed erano vestiti di armature in ferro anziché di paramenti sacri. Questo andamento di cose non lasciò insensibili i papi, che cominciarono a seccarsi di questo caos imperante e dichiararono, per intanto, decaduti tutti i vescovi di nomina reale o che avevano, magari con l’oro, comperato la loro nomina e che erano più dediti a riscuotere tasse e gabelle dai loro vassalli che curare le anime dei fedeli. Cosa successe nel resto d’Italia non ci è dato di sapere, però sappiamo che, per quanto riguarda Trieste, nel 1082 l’imperatore Enrico IV°, vista la situazione della città, spogliata e impoverita dalla politica vescovile, la consegnò al patriarca di Aquileia in modo che avesse un protettore più sicuro. Anche questa situazione era destinata ad essere transitoria, infatti nei primi anni dopo il 1100, la città fu di nuovo in mano ai vescovi estendendo il loro territorio ed esigendo decime e tasse anche da Umago, Capodistria ed altre cittadine istriane. Essendo il territorio notevolmente allargato ed ingrandito ci volle un gran numero di “servi fedeli” che svolgessero i lavori amministrativi ed erariali per conto del vescovo. Ecco che, in embrione, cominciò a formarsi una sorta di ceto medio, di borghesia che in seno ai vari agglomerati urbani cominciavano ad avere una certa importanza e considerazione da parte del popolino. La classe contadina, con l’espandersi dell’agricoltura, cominciò ad avere il suo peso nella società d’allora ed appaiono anche le prime forme di attività artigianali autonome. 119 La difesa delle coste dai pirati del mare era a carico del potere vescovile, che per far fronte a queste spese, “inventò” e cominciò ad avvalersi delle dogane. Iniziamo così il dodicesimo secolo, ricco di fermenti, e stiamo avviandoci a grandi passi al periodo comunale. Dopo centocinquant’anni che la città fu in mano dei vescovi, cominciò lentamente a liberarsi e togliersi di dosso questo giogo, questo dominio che ormai le stava stretto. Capodistria nel 1177 ebbe il suo vescovado, i vassalli più lontani erano passati ad altri signori, pertanto il vescovo di Trieste si ritrovò con un territorio ristretto e soffocato da alcune grandi potenze, quali il patriarcato di Aquileia, la contea di Gorizia, ma soprattutto da Venezia. Venezia infatti si stava sviluppando nell’Adriatico estendendo il suo dominio o perlomeno la sua influenza su tutta la costa istriana e dalmata. Tutte le cittadine costiere di Istria e Dalmazia dovettero sostenere una sorta di vassallaggio, in quanto la flotta veneta teneva sgombri i mari dai pirati. Trieste non fu dammeno versando tributi a Venezia in orne* di vino. Nel 1202, la flotta veneziana, al comando del doge Enrico Dandolo, e con al seguito migliaia di soldati a cavallo francesi, prima di recarsi in Oriente per la crociata promossa da papa Innocente III°, veleggiò sulle nostre coste per rintuzzare eventuali velleità di protesta. Anche Trieste accolse con grandi fasti il doge con il suo seguito. In quell’occasione trecentrentasei Triestini firmarono un patto in cui si sarebbero rispettati i beni dei Veneziani, che nel territorio triestino essi non avrebbero mai pagato tasse di alcun genere e che avrebbero aiutato i Veneziani a combattere la pirateria sul mare ed infine avrebbe “offerto” a Venezia un tributo annuo di cinquanta orne di vino. La cosa importante di questo accordo fu che esso fu firmato dai Triestini *orna= recipiente a forma di cono tronco nel quale le donne facevano il bucato e aveva una capacità variante dai settanta ai cento litri. 120 e non dal vescovo, che era il signore della città, il che fa supporre che essi godessero di una certa libertà amministrativa anche se il primo in testa dei firmatari era il gastaldo, sorta di capo amministrativo nominato dal vescovo e comunque rappresentante del re. Pochi anni dopo appare, per la prima volta, nominato il podestà. Il vescovado, oberato di debiti , andò sempre più in miseria, mentre i cittadini ed il comune videro aumentare considerevolmente le proprie ricchezze perché il porto di Trieste era punto di partenza e di arrivo per i pellegrini, che si recavano in Terra Santa facendovi accorrere numerosi mercanti. Nel 1253 per sanare, almeno in parte, i propri debiti concesse molti privilegi, ad esso riservati, al Comune e contemporaneamente nel 1283 non riconobbe più la sua appartenenza all’Impero, ma divenne vassallo diretto del patriarca di Aquileia. Trieste fu quindi praticamente alle dirette dipendenze di Aquilieia. La città era formata da cittadini che emergevano dall’età feudale, con una coscienza nuova, desiderosi di riscattarsi e governarsi da soli, ma, come oggi del resto, la città aveva un retroterra ostile ed il mare, suo sfogo naturale, impedito da Venezia, che nei commerci non ammetteva concorrenza alcuna. Sostenendo perciò la causa di Aquileia che vantava diritti pure sulle cittadine istriane, assieme al potente conte di Gorizia, Trieste si trovò coinvolta nel primo grosso conflitto con Venezia. Correva l’anno 1289 e un grosso esercito veneziano venne qui, deciso a distruggere o almeno a punire in modo esemplare Trieste. I Veneziani costruirono una cittadella fortificata sul pendio dell’attuale colle di Romagna e che arrivava, per intenderci, fino all’attuale tribunale. Il patriarca di Aquileia ed il conte di Gorizia guidarono un poderoso esercito per soccorrere Trieste. I Veneziani, dopo alcune piccole scaramucce, diedero una somma di danaro al conte di Gorizia perché se ne ritornasse a casa. Il patriarca di Aquileia, visto l’esercito dimezzato, se ne ritornò anche lui nei suoi territori. I Triestini, da soli, resistettero tenacemente alla superiorità di Venezia, 121 tanto da indurre il patriarca a ricostituire l’esercito, tornare indietro e mettere in fuga le truppe veneziane dalla cittadella di Romagna che i Triestini poi distrussero. Nel 1291 fu firmata la pace tra Venezia e il patriarca di Aquileia e fu così che Trieste dovette abbattere le mura sul lato mare consegnando le navi a Venezia. Sembrerebbe che il secolo finisse male per la città invece, al contrario, esso si chiuse in modo più che positivo. Nel 1295, pagando un grosso debito del vescovo, Trieste acquistò tutti i diritti civili che esso aveva, facendo terminare il potere che i vescovi avevano esercitato per quattrocento anni. La città era finalmente padrona di se stessa terminando, con ciò, il periodo feudale ed iniziando quello comunale che vide la città padrona del proprio destino. Quanti intrighi, quanti grovigli, quante macchinazioni, quante complicanze, tutto vortica nella mia testa, devo fermarmi un po’ per cercare di mettere a fuoco la situazione. Non è facile! Contemporaneamente vedo Istri, Romani, barbari invasori, vescovi, Veneziani, Longobardi, tutto in una ridda di lampi contrapposti che mi fanno vacillare, vedo mura, castellieri, fortificazioni, battaglie, distruzioni, saccheggi, anche un po’ di pace per fortuna. Credo che sia ora di smettere per un poco, rileggere tutto, riordinare le idee, metterle in sequenza e capire. Io che all’inizio pensavo fosse una cosa da poco, dissi: - Cosa vuoi, Trieste è piccola non ci sarà tanto da scoprire nella sua storia! Invece mi sono ritrovato in una cosa più grande di me e delle mia capacità. Ma io sono testardo e non desisto, per niente non ho un cognome tedesco, adesso mi concedo un attimo di respiro, una pausa di riflessione e poi via di nuovo alla ricerca di notizie che mi facciano continuare in questa mia analisi, anche se non è facile capire la storia né tantomeno leggerla, perché ognuno interpreta un fatto storico, un episodio, come meglio crede, come a lui conviene capire e credere e, certamente, io non posso fare eccezione. 122 CAPITOLO 3 Siamo giunti al Trecento e vediamo un quadro generale per farci un’idea della situazione. L’Europa trecentesca fu colpita da gravi calamità naturali, carestie ed epidemie ricorrenti vi portarono la fame e ne decimarono la popolazione. Il secolo XIV° fu anche quello della guerra dei cent’anni, dell’avanzata dei Turchi Ottomani in Asia e in Europa (1354), del papato avignonese, dello scisma d’Occidente. Gli ideali universalistici naufragarono col venir meno della forza delle istituzioni, papato e Impero, che li sostenevano e di cui Dante fu l’ultimo assertore, testimone della misera fine di Enrico VII° di Lussemburgo (1313). Ma alla caduta di quegli ideali, alla luce dei quali s’era svolta tutta la vita civile del medioevo, corrispondeva l’affermazione nella realtà e nel pensiero dell’idea di Stato nazionale, maturata nelle grandi monarchie occidentali di Francia, d’Inghilterra, di Castiglia, d’Aragona nel corso di conflitti secolari, mentre nell’area imperiale si consolidava la pluralità degli Stati regionali o cittadini di Germania e d’Italia (formata da signorie e città-stato del nord e del centro, repubbliche marinare, domini della Chiesa, regno angioino di Napoli) e, a Oriente, i regni di Boemia e d’Ungheria andavano acquistando posizioni rilevanti. L’impero bizantino sommerso dalle colonie veneziane, genovesi, catalane e ridotto a proporzioni sempre più esigue dai Turchi, ormai insediati nei Balcani, andava perdendo ogni ruolo politico. Da questa visione europea della situazione, restringiamo il punto focale per tornare alla situazione di casa nostra. Ricercando nelle biblioteche notizie e nozioni inerenti il trecento triestino si possono trovare moltissimi libri e pertanto moltissime idee, il più delle volte in contrasto tra di loro. La vera verità non la sapremo mai! Anche qui, soggettivamente, bisogna interpretare e analizzare e dare una propria risultanza. 123 Prendiamo in considerazione un episodio nostrano, tra tanti, noto come la congiura dei Ranfi. La prima domanda spontanea che ci si pone è: - Chi erano i Ranfi? Anche qui proviamo ad inquadrare storicamente la situazione. In questo periodo, nel trecento, si svilupparono molte signorie che non erano altro che città o territori guidati da un’unica famiglia. In molti casi si trattava di veri e propri feudatari, che non dipendevano più da nessuno. Successe pure che molte famiglie nobili e molto ricche, che possedevano piccoli castelli e magari molte terre coltivate, con il danaro conquistarono il potere. In giro c’erano molte e maggiori ricchezze, si svilupparono molte attività ed arti. I signori, infatti, vollero costruirsi case lussuose, palazzi e chiese, e quindi potenziarono e protessero le arti e gli artisti. Trieste cominciò a svilupparsi anche grazie a soldi provenienti dalla Toscana, perché in quell’epoca i grandi usurai, cioè quelli che prestavano soldi o, come si diceva allora, tenevano banco (termine dal quale è derivato l’attuale “banca” e “banchiere”) erano tutti toscani e principalmente fiorentini. Con la loro politica di astuti commercianti, sicuramente, contribuirono ad arricchire il Comune. Chiarito un po’ quello che era il periodo, la vita, la situazione di e a Trieste, ritorniamo appunto ai Ranfi. Si trattava di una famiglia di nobili, con molta probabilità di origine tedesca, vassalli del vescovo. Il nome di Marco Ranfo risulta spesso citato e scritto in documenti diplomatici, si desume da ciò che doveva trattarsi, senza dubbio, di un personaggio altamente importante nella vita politica della città. Si sa che possedeva una casa in Cavana eretta, si presume, su di un fondo che oggi si configura con il sito di via del Cavazzeni 1 e, molto probabilmente, era sua anche la torre Tigor, oltre a terre e vigne varie. Sembrerebbe che la famiglia fosse formata dal padre e da cinque figli, due maschi e tre femmine. Ci sono vari documenti, tra il 1318 e il 1350, che riportano testi, frasi, nozioni sulla famiglia dei Ranfi. C’era il divieto assoluto di costruirsi la casa su terreni di quella famiglia e, anzi, chiunque incontrasse un Ranfo poteva ucciderlo, anzi ne avrebbe ricevuto anche un premio. Nessuno poteva sposare una donna dei Ranfi e uno che avesse ucciso un Ranfo non poteva e 124 non doveva essere ingiuriato. Queste sono le notizie certe, ma il perché di tanto accanimento contro la famiglia non è dato di sapere; nessun scritto in merito è stato mai rinvenuto. Supposizioni, illazioni, pensieri ce ne sono tanti, dati dal fatto che potrebbero aver creato dei torbidi in città o forse, cosa più grave, aver minato la sicurezza del Comune. Potrebbero addirittura aver tentato di impadronirsene per farne una propria signoria oppure, non ultimo, potrebbero essersi macchiati di un tradimento filoveneziano. Indipendentemente da fatti leggendari, romanzati, storicizzati, frutto di realtà accaduta o fantasie del popolo sta di fatto che nel 1313 il potere della città fu saldamente in mano al Comune e che tra il 1315 e 1318 emanò i primi “statuti” che furono la prima codificazione delle leggi riguardanti la città. Venne così creato il famoso “sigillo trecentesco” della città tuttora riconosciuto. Si tratta di una torre con ai lati due alabarde e la scritta: “Sistilanu publica Castilir mare certos dat michi fines” con sotto il nome Tergestum. Il significato della frase che circonda il nostro sigillo è: “Sistiana, la via pubblica, Castellier e il mare mi danno confini certi – Tergeste”. Così era praticamente descritto il territorio del Comune di Trieste che andava, appunto, da Sistiana lungo i monti della Vena fino alla Val Rosandra e si chiudeva al mare. Un territorio piccolissimo, come oggi del resto, ma che a Trieste quella volta, bastava, circondata com’era da grandi potenze. Tutto il trecento, per la nostra città, è un continuo barcamenarsi tra le potenze di terraferma e Venezia che aveva a se tutte le cittadine istriane della costa che facevano concorrenza a Trieste nei commerci via mare. Unico cuscinetto, ad est, era la cittadina di Muggia che rimase ancora nelle mani del patriarca di Aquileia divenendo così la più terribile avversaria di Trieste al punto che erano impossibili, se non proprio proibiti, i matrimoni tra Triestine e Muggesane e viceversa. 125 Si arriva al 1553 quando i Triestini andarono a devastare il territorio di Muggia ma, vennero richiamati all’ordine da Venezia che ancora aveva ingerenza nelle nostre faccende, tant’è che il più dei podestà di Trieste erano veneziani. Il podestà veniva eletto dal popolo ed essendo quasi sempre lui veneziano e non friulano o triestino, significava che il partito che prevaleva in città era un partito che sosteneva ed era sostenuto da Venezia. L’Austria cominciava ad espandersi a danno del Patriarcato di Aquileia, prendendone alcune terre ed insidiando i signorotti ad essa fedeli. Un caso a noi vicino è quello del conte di Duino. Quello che Venezia non ammetteva assolutamente era la concorrenza sul mare avendo il monopolio dei traffici marittimi. Avvenne però che nel 1368 un vascello veneziano, adibito al pattugliamento del nostro golfo, intercettasse una barca piena di sale il cui proprietario era un certo Panfili. All’intimazione dell’alt da parte veneziana, il Panfili girò la prua della sua barca puntando decisamente sul porto di Trieste. I Veneziani, anch’essi, entrarono nel porto e pretesero di poter confiscare la barca contrabbandiera ed arrestare il suo comandante. Successe, invece, che i Veneziani ricevessero un sacco di botte e sembrerebbe che il comandante venisse addirittura ucciso. Per la paura di una ritorsione da parte veneziana, Trieste mandò immediatamente a Venezia una delegazione per chiedere scusa. Venezia ne approfittò per imporre ai Triestini di esporre il gonfalone di Venezia per Pasqua e per Natale, cosa che non avevano mai fatto prima, ma che questa volta, per il quieto vivere, accettarono. Ma si vede che tutto ciò non fu ritenuto sufficiente, tant’è vero che i Veneziani prepararono un grosso esercito per fare la guerra a Trieste. La flotta veneziana, con l’esercito comandato da Domenico Michiel, cominciò l’assedio di Trieste. Tutto ciò accadde alla fine del 1368. La città era ben munita e i Triestini si difesero strenuamente tanto che le truppe veneziane si trovarono in notevole disagio. L’assedio però si fece sempre più duro e i Triestini dovettero chiedere aiuti che furono rifiutati, 126 dapprima dal patriarca di Aquileia e poi dal conte di Gorizia. I Triestini provarono allora a chiedere sostegno a Francesco di Carrara ed anche al Visconti, signore di Milano, ma ottennero uguale rifiuto, anche perché nessun principe italiano voleva aver beghe, liti e contrasti con la potente Venezia. Quando ormai le armate di Venezia cominciarono ad aprire le prime brecce nella resistenza della città, i Triestini si offrirono in sudditanza al duca Leopoldo d’Austria, che accettò subito essendo egli già in possesso di gran parte del territorio alle spalle di Trieste, ma gli mancava lo sbocco al mare. Il duca Leopoldo delegò il conte di Duino a rappresentarlo per la firma dell’atto di dedizione da parte dei Triestini, dove riconoscevano di essere stati, fin dal passato, in signoria ai duchi d’Austria. Ottenuta la firma dell’atto di dedizione, il duca Leopoldo, inviò un potente esercito in soccorso di una città oramai stremata, dopo un anno di stretto assedio, attaccando il potente campo veneziano. In un primo momento, anche perché i Veneziani furono colti di sorpresa, sembrò che gli Austriaci dovessero facilmente prevalere, ma con abile mossa i due comandanti veneziani accerchiarono gli Austriaci facendoli fuggire a precipizio. Per i Triestini, caduta ogni speranza, non restò altro che arrendersi. Tutti temettero una vendetta spietata di Venezia, ma così non fu. Venezia pretese solamente l’esilio di quelli che erano stati gli avversi e, rispettando la città, chiesero un atto di dedizione al Doge. Per cautelarsi da ogni evenienza esterna, Venezia fece costruire a difesa un castello sul colle di San Giusto, che loro chiamarono Caboro, e il “castello a marina” dove oggi c’è il palazzo della Regione, già palazzo del Lloyd. Trieste fu, era ed è sempre stata una città tormentata, infatti neanche i Veneziani durarono a lungo. Nel 1378 iniziò quella che fu chiamata la “guerra di Chioggia” che vide da una parte Venezia e dall’altra Genova, il potente re d’Ungheria, il patriarca di Grado, il signore di Padova e il duca d’Austria. A quel punto, con tante gatte da pelare, i Veneziani non seppero 127 dove correre per difendersi. Genova riuscì ad espugnare Chioggia, mentre gli alleati occuparono tutte le città istriane che erano suddite di Venezia. Dobbiamo arrivare al 1380 perché il patriarca di Aquileia, con un grosso esercito, venisse, diceva lui, a liberarla dai Veneziani saccheggiandola, assieme ai Genovesi. Fu così che Trieste dovette firmare l’ennesimo atto di dedizione, questa volta al patriarca aquileiese consegnandogli, simbolicamente, le chiavi della città. Anche questa appartenenza fu di breve durata. Il 9 agosto del 1382, Trieste, con l’aiuto del conte di Duino che si impossessò della città con la violenza, finì nelle mani del duca d’Austria e dovette sottoscrivere quell’atto che poi fu detto di “dedizione all’Austria”. Le turbolenze cittadine che ne seguirono, fanno capire quanti contrasti ci fossero in città contro quell’atto che, però, fece in modo che i Triestini salvassero tutti i loro liberi statuti e rimanessero liberi di agire nei riguardi dei potenti vicini. Se fosse stato meglio rimanere fedeli a Venezia piuttosto che all’Austria, nessuno può azzardare una risposta, sta di fatto che, ragionando, allora Venezia non aveva alcun interesse di avere una potenziale concorrente portuale, mentre l’Austria necessitava di uno sbocco al mare. Trieste, bisogna dire il vero, non è mai stata austriaca perché, anche se era “dedita” all’Austria, serbò sempre la sua indipendenza interna sia di fronte ai duchi prima, arciduchi poi e imperatori d’Austria che la ressero fino al 1918. Trieste mantenne sempre la sua libertà che le permise di conservare e sviluppare la sua cultura italiana, anche nei secoli seguenti. Con questo atto di dedizione all’Austria finì il trecento triestino e sancì pure la fine del Libero Comune che era stato il sogno di moltissimi triestini. A questo punto della storia si può fare una considerazione che ritengo profonda: - Trieste e i Triestini hanno sempre avuto troppi nemici, troppi avversari, troppi interessi, troppi tornaconti, troppe invidie, troppi rancori 128 che si sono riversati contro questa splendida e viva città. Stiamo parlando della fine del 1300, oggi siamo nel 2001, siamo addirittura in un altro millennio, ma pensandoci bene anche se senza guerre, distruzioni e saccheggi, le lotte per il potere, sia politico che economico, continuano, forse più subdole, più in silenzio, chi non sta attento, forse, non se n’accorge nemmeno, ma per la città fanno altrettanto male. In economia, il porto e il suo punto franco contesi da Fiume, Capodistria, Monfalcone, Porto Nogaro, Venezia; in politica, pur essendo Trieste il capoluogo regionale, il Friuli, e Udine in particolare, vuole togliere, se possibile, molte istituzioni politico-amministrative proprie del capoluogo in modo che esso diventi Udine. Fatto con metodi moderni, che differenza c’è tra questo stato di cose e quello che c’era dalle origini di Trieste fino alla fine del trecento?? Non voglio andare oltre, anche perché, credo, che tutto questo sarà materia di chiusura di questa ricerca, che mi sta appassionando sempre più man mano che procedo, infatti ci vogliono ancora 700 anni per arrivare ai giorni nostri. Forza e coraggio! Gli Austriaci imposero alla città solamente la nomina del capitano, che era preposto all’osservanza delle leggi e il controllo dei tributi finanziari. Egli dovette semplicemente tutelare gli interessi della cittadinanza e far rispettare gli Statuti, che rimasero sempre in vigore. Praticamente i Triestini continuarono a governarsi da sé, anche nelle relazioni con i vicini. Il duca d’Austria pretese per sé solo la metà delle tasse, ma alcuni anni dopo cedette alla città anche questo privilegio, per cui potremmo dire che Trieste continuò, praticamente, ad essere un comune libero, sempre con un territorio limitato, ma in pace. Nel vicino Friuli, invece, ogni castello era in guerra con il vicino finché Venezia, stanca, non conquistò tutto il territorio annettendolo a sé. Del quattrocento ci sono tanti documenti conservati, che lo storico Jacopo Cavalli poté scrivere un libro sulla vita triestina del 1400. Sappiamo così che i commerci cominciarono a riprendere fiorenti, spe129 cialmente con l’entroterra e pure l’artigianato, per molto tempo da pochi esercitato, riprese vigore e si sviluppò notevolmente. Il maggior benessere della città fu dato dalla vendita del sale ricavato dalle numerose saline disseminate lungo la costa; dall’olio dei suoi pregiati e numerosi oliveti situati nella valle delle Noghere e nella zona di San Dorligo e dal buon vino delle sue colline prodotto, come all’epoca dei Romani, nella zona che va da Sistiana a Barcola. Sul Carso, al contrario, si sviluppò e fiorì la pastorizia. Sul Carso, oltre ai già noti villaggi di epoca romana, distrutti dai barbari e poi ricostruiti, quali Santa Croce, Sistiana, Aurisina e Slivia, si aggiunsero dei nuovi, come Opicina, Trebiciano, Contovello e Basovizza. Sempre dagli scritti si può rilevare che i Triestini già nel ‘400, nei giorni festivi, usavano andare a Opicina in una storica trattoria dove si mangiava molto bene e veniva servito un ottimo vino del Carso. Gli allevatori di Basovizza e di Trebiciano affidavano ai “mandrieri”, pastori di origine slava e croata, le loro mandrie per essere portate al pascolo estivo fino al Monte Re. Sempre su questi scritti si può leggere che Trieste era punto di raccolta e di partenza di pellegrini, che si imbarcavano su navi che li portavano nelle Marche e precisamente al santuario di Loreto per proseguire poi per Roma. A Trieste si eressero molti ospizi atti ad ospitare questi pellegrini che, spesso, erano poveri e bisognosi d’aiuto. Ci furono, in quel periodo, gravi epidemie di peste che provocarono la morte di molti abitanti. Il Comune, per alzare il livello e il tenore di vita da tanta miseria, favorì la venuta di commercianti ed artigiani italiani, per lo più veneti e friulani. In seguito a questa liberalizzazione all’immigrazione, giunsero anche i primi Ebrei ai quali si ricorreva per prestiti in danaro. Contrariamente a quello che sarebbe adito a pensare, gli Ebrei furono molto meno esosi negli interessi di quello che, nel secolo precedente, furono i Toscani. Fu così che i Triestini li ben tollerarono, anche perché disponevano di molta moneta liquida cosa che, in quei tempi, non era facile trovare. Nacque così la prima comunità ebrea in Trieste. 130 L’economia non fu proprio florida al principio del quattrocento, però fu l’inizio di una certa agiatezza. Infatti nei primi decenni di questo secolo si costruì la loggia comunale dove i componenti delle tredici casate si radunavano per decidere i provvedimenti da assumere per il buon andamento della città. Le tredici casate erano: Leo, Pellegrini, Bonomo, Belli, Burlo, Giuliani, Baseggio, Argento, Cigotti, Toffani, Stella, Padovino e Petazzi. Sembra quasi di leggere lo stradario di Trieste. Per quanto le tredici famiglie maggiorenti si dessero da fare, l’economia stentava a decollare anche perché i Carniolici, che allora erano gli abitanti dell’attuale Slovenia, per i loro traffici e commerci, preferirono appoggiarsi alle cittadine istriane piuttosto che a Trieste. Fu allora che i Triestini decisero di acquistare un castello, quello di Castelnuovo (oggi Podgrad) sulla strada di Fiume, da dove, assieme agli altri due castelli di Moccò e di San Servolo, poterono bloccare la strada ai Carniolici, che venivano con lunghe file di asini, deviandoli ed obbligandoli ad andare a Trieste. Nella città di Trieste, un po’ scherzosamente e un po’ anche per dileggio, i Carniolici furono chiamati “cici”. Capodistria e Muggia protestarono per questa situazione, ma Venezia, aveva altre gatte da pelare. Era in corso una guerra tra il re d‘Ungheria e il re d’Austria ed essendo, in un certo qual modo, Venezia alleata dell’Austria, non ebbe tempo per pensare alle piccole beghe delle città istriane con Trieste. Scoppiarono allora, tra i signorotti della regione, che parteggiavano alcuni per l’Austria ed altri per l’Ungheria, delle piccole guerricciole alle quali partecipò pure la nostra città. Per porre fine a questa situazione che si era venuta a creare, nel 1443 l’imperatore d’Austria Federico III° inviò a Trieste uno dei suoi più capaci uomini, cioè il toscano Enea Silvio Piccolomini. Essendo anche periodo di grandi scismi, all’imperatore d’Austria venne conferita l’autorità di nominare alcuni vescovi. Fu allora che nel 1447 ven131 ne nominato vescovo di Trieste Enea Silvio Piccolomini, persona che si rivelò illuminata. Ma proprio per questa sua peculiarità, era destinato a rimanere per poco tempo a Trieste, tant’è che nel 1450 divenne vescovo di Siena e pochi anni dopo ancora divenne Papa con il nome di Pio II°. Gli ingegni, in quell’epoca, erano rari pertanto quei pochi che ci furono, riuscirono ad emergere anche grazie all’appoggio dei potenti e degli imperatori. Dove non arrivava l’ingegno, arrivava la potenza del denaro. Federico III° fu un imperatore particolarmente povero, anche perché dovette indebitarsi per sostenere tutte le guerre con il re d’Ungheria. Decise allora, per procurarsi denaro fresco, di “affittare” al comune di Trieste l’esercizio del capitano e delle altre cariche governative. In parole povere il Comune di Trieste tornò ad essere completamente padrone di se stesso perché, pagando, veniva a mancare anche il Capitano, che era l’unico rappresentante imperiale. Tutto farebbe pensare che, finalmente, fosse arrivata un po’ di pace. Macché! Venezia, tra una pausa e l’altra delle sue guerre, pensò bene di sistemare la “questione triestina” chiedendo la liberazione delle strade del Carso in modo che tutti quelli, che avessero voluto andare a commerciare, potessero passare. Chiesero pertanto la cessione del castello di Castelnuovo. Venezia, allora, deteneva il monopolio del sale, che per i tempi era fonte di grande ricchezza, e non voleva concorrenza da parte di Trieste che pure possedeva le sue saline e aveva il suo commercio del sale. Fu così che nel 1463, per la terza volta, assediarono Trieste costruendo dei bastioni per metterci le loro bocche da fuoco. I Triestini lavorarono come dei matti. Di notte ripristinavano le brecce che le bombarde veneziane, durante il giorno, avevano aperto, opponendo una resistenza che fece meravigliare gli stessi Veneziani. La strapotenza di Venezia era indiscussa e nessuno, tantomeno Trieste, avrebbe potuto sconfiggere. Fu Papa Pio II°, che non dimenticò mai i Triestini, a intercedere e con i suoi uffici, firmò la pace. 132 Trieste dovette, purtroppo, cedere i suoi tre castelli di Castelnuovo, Moccò e San Servolo, dovette impegnarsi a non portare per mare il suo sale ne tantomeno cederlo ai mercanti veneziani però, in cambio, fu salvata dal saccheggio e dalla distruzione. Seguì un periodo piuttosto brutto e confuso per la città. La cronaca, e quindi non la storia, di quel periodo è piuttosto mutilata. Fu infatti scritta e poi tagliata diverse volte a seconda del colore politico, dell’appartenenza partitica dei copisti che, intenzionalmente, vi fecero delle omissioni ed inserirono degli errori. Nel 1467 una piccola minoranza di nobili, venne cacciata in esilio per non aver rispettato gli Statuti. Il 31 dicembre dello stesso anno, assieme al losco figuro che fu il capitano di Duino, tale Nicolò Luogar, rientrarono in città gridando al tradimento. Il Luogar tentò di annullare gli Statuti e le libere elezioni, di far firmare al Comune un atto solenne di abdicazione dei diritti a favore dell’imperatore. A questo punto, toccati nelle loro libertà, i Triestini si opposero in armi facendo prigioniero il capitano di Duino. Il Luogar ottenne la libertà in cambio del rilascio dei prigionieri triestini che si trovavano nelle carceri di Duino. I Triestini, che a lui si erano rivolti e lo avevano sostenuto, furono tutti impiccati tra gli archi della loggia municipale. L’imperatore, constatata la ribellione della città, decise di punirla esemplarmente ordinando al capitano Nicolò Luogar di raccogliere un esercito nella Carniola, e facendolo marciare contro i rivoltosi. Lo scontro avvenne nei paraggi di Ponziana e fu uno scontro epico nel quale, i Triestini guidati da Cristoforo Cancellieri si batterono eroicamente fino alla morte. Vinta ogni resistenza, si narra che il vincitore diede la città ai suoi uomini che la saccheggiarono, la bruciarono e sembrerebbe che la città fu rasa al suolo. Per tenere doma la città, l’imperatore fece costruire il castello di San Giusto. 133 CAPITOLO 4 Trieste, pian piano, cominciò a riprendersi, ma certamente il periodo non era dei più tranquilli. Nel 1469 quelli che furono il terrore della Cristianità, i Turchi, fecero la loro comparsa da queste parti spingendosi fino a Castelnuovo. L’impero turco stava sviluppandosi verso l’Europa e lungo i Balcani. Conquistarono la Grecia, la Macedonia, gli altri stati balcanici e su su fino ad arrivare alle porte di Vienna che venne stretta d’assedio. Dalle nostre parti, però quelli che vennero non erano veri e propri Turchi, ma bande di predoni che comprendevano elementi di razze diverse, ma tutti avidi di bottino. Passarono come una meteora, infatti come una furia giunsero, razziarono, bruciarono, uccisero e rapirono donne e bambini per venderli come schiavi, poi sparirono, scomparvero velocemente come velocemente erano giunti. Il punto più vicino dove furono viste le truppe regolari Turche, fu la piana di Zaule. Negli anni seguenti i Turchi, sempre evitando la città di Trieste, attraverso l’altipiano carsico, passarono nel Friuli dove i Veneziani per arginarli eressero la fortezza di Palmanova. Morto l’imperatore Federico d’Austria, amico dei Veneziani, gli successe Massimiliano che trovò subito modo di litigare. Ecco che nel 1508 Venezia mosse guerra all’Austria. Lo scontro avvenne a Pieve di Cadore dove l’esercito veneziano, guidato da Barlotomeo d’Alviano, mise in fuga gli Austriaci. Per l’ennesima volta Venezia, con le sue galere, bombardò Trieste, unica città imperiale sul mare rimasta. Essendo caduta pure Gorizia, ai Triestini non rimase altro che arrendersi per evitare un’altra distruzione. Trieste passò, nuovamente, sotto il dominio di Venezia i cui possedimenti giunsero sino alla Alpi Giulie. I Veneziani dotarono il castello di San Giusto, che era ancora in costruzione, del bel bastione rotondo dove, oggi, è ben visibile la lapide con il leone di Venezia. 134 I Triestini, per liberarsi dai Veneziani, cercarono di convincere la Corte di Vienna quanto fosse per loro utile avere uno sbocco sul mare Adriatico. La corte asburgica, allora, non capì tale importanza anche perché aveva altre cose a cui pensare che erano rappresentate dalle beghe con l’Ungheria. Venezia non ammetteva concorrenze sul mare, così che per buona parte del cinquecento fu un periodo molto duro per Trieste e la sua economia marittima, tanto da arrivare addirittura alla fame. Il diciassettesimo secolo fu anche peggiore del precedente. La città, a causa delle pestilenze, fu ridotta ad avere circa tre mila abitanti, quasi come nel medio evo e rischiò, quasi, di finire la sua esistenza di città. Trieste fu sfiorata dalla guerra tra Austria e Venezia che durò dal 1615 al 1618 e si concluse con la battaglia di Gradisca. In quel periodo gli Austriaci completarono la costruzione del castello di San Giusto. Si narra che la città fosse in un tale stato di miseria che quando, nel 1660, giunse a Trieste l’imperatore Leopoldo I°, i reggenti la città non poterono nemmeno offrire una cena a base di pesce all’augusto ospite, e si che Trieste era una città di mare. Si calcola che la miseria fosse dovuta al fatto che la città non corresse con i tempi e che rimanesse legata ai frutti ed ai proventi della terra che i vari signorotti possedevano. Ci ritroviamo agli inizi del 1700 e Trieste sembrava ancora una città medioevale, cinta dalle mura e arroccata al colle di San Giusto sul quale spiccano tuttora il castello e la basilica di san Giusto. Scendendo verso il mare c’erano tante piccole case in mezzo alle quali si erigeva la chiesa di Santa Maria Maggiore, costruita dai Gesuiti nel corso del XVII secolo, ed era la più grande chiesa di Trieste. In basso, verso il mare con le mura che fino a lì arrivavano, c’era la Piazza Grande con il Palazzo comunale e la sua loggia, la torre del Mandracchio, il Teatro e la chiesa di San Pietro, nonché la Locanda Grande che era l’albergo della città. Tutti questi palazzi oggi non ci sono più, almeno nella loro forma originale. Al di fuori delle mura c’erano i campi coltivati, le saline e lo squero dove si riparavano e costruivano le barche. La città con il circondario poteva 135 contare su di una popolazione di circa cinquemila abitanti. Ma ecco che, nel ‘700, sta per capitare l’evento più importante per la storia della città e che decise il suo futuro. Il 18 marzo 1719, l’imperatore Carlo VI° dichiarò e proclamò lo stato di “porto franco” per la città di Trieste. In pochi anni, grazie a questa sua nuova situazione economica, la città si trovò ad avere oltre trentamila abitanti. Grati, i Triestini, nel 1728 eressero una statua all’imperatore Carlo VI° in occasione della sua visita alla città, riconoscenti anche per essere stati scelti tra altri porti concorrenti che ambivano a divenire porti franchi, tra i quali Fiume, Buccari e San Giovanni di Duino. La statua a Carlo VI°, ancor oggi, è posizionata sul lato sinistro in alto della Piazza dell’Unità d’Italia. Pur essendo già tangibile un certo benessere, la sola dichiarazione di porto franco non fu sufficiente a far progredire Trieste. Ci vollero altre strategie e misure più energiche che solo Maria Teresa d’Austria, aiutata dal figlio, il futuro Giuseppe II°, seppe proporre ed imporre alla città a scapito dell’antico municipio patrizio e privilegiato che dovette inchinarsi e cedere al nuovo corso voluto dal governo centrale di Vienna. Furono queste misure che fecero mutare il piccolo centro in una città moderna, fresca, operosa, attiva e laboriosa. Tanto laboriosa da sentire, nel 1751, la necessità di incaricare l’architetto bergamasco Mazzoleni di proporre e far realizzare la “fontana dei continenti”. Il Mazzoleni, avvalendosi di tre “scalpellini di fino”, quali Giovanni Venturini, Giuseppe Grassi e Giambattista Pozzo, fece eseguire questa fontana da erigere nella Piazza Grande. Pregò, nel contempo, l’abate Gian Domenico Bertoli di Aquileia, di dettare le epigrafi da apporsi alla base della fontana stessa. In questa fontana, il Mazzoleni, volle contenere una raffigurazione simbolica del commercio, con le sue statue rappresentanti le quattro parti del mondo, la quinta allora si ignorava. Vi fu rappresentata la fama che gridava al mondo l’Emporio Triestino rappresentando colli di merci, botti ed altri emblemi del traffico accatastati sopra una piramide di blocchi di calcare, con ai lati le deità pagane appoggiate in conchiglie marine, 136 nelle quali sgorgava l’acqua per poi precipitare nel bacino. La statua dell’Africa la si volle in marmo nero, alle altre diedero costumi caratteristici. La lapide dettata dall’abate Bertoli fu tutta una celebrazione a questa città simbolo di un periodo storico, essa recita così: MEDIO HOC SECULO (alla metà di questo secolo) FRANCISCO I ET MARIA THERESIA REGNATIBUS (regnando Francesco I e Maria Teresa) CURA RUDOLPHI S.R.I. COMITIS A CHOTEK (a cura di Rodolfo conte del S.R.I. Chotek) AERARI PUBLICI REGENDORUMQUE COMMERCIORUM PRAESIDIS (reggente del pubblico erario e presidente del commercio) SUB PREFECTURA (sotto la prefettura) COMITIS NICOLAI AB HAMILTON (del conte Nicola de Hamilton) URBIS TERGESTI INCREMENTA (fu dato incremento alla città di Trieste) AB IPSIS IN CHOATA SUNT RERUM OMNIUM CLEMENTIS (con gli elementi di tutte le cose) IGNIS CULTO VICINAE SYLVAE COPIOSIOR (copioso il fuoco della vicina selva) AER EXPLETIONE SALINARUM PURIOR FACTUS (l’aria purificata col prosciugamento delle saline) TERRA FUNDO SANCTORUM MARTHIRYUM AUCTA ( ampliata la terra col fondo dei S.Martiri) AQUA A SCATURIGINE MONTIUM AD HUNC FONTEM DUCTA FUIT (l’acqua adotta a questa fonte dalla scaturigine dei monti). Sulla lapide posta sull’altro lato, verso il mare, ha un’intenzione altezzosa e recita così: SENATUS TERGESTINUS CIVIUM ADVENARUMQUE COMMODO HUNC FONTEM PERENNIS AQUAE AUGUSTAE MUNIFICENTIA DEDUCTAE PUBLICO AERE POSUIT – A.S. MDCCLI. Tradotto ed interpretato così: - Il Senato Triestino a comodo dei cittadini e dei forestieri questa fonte, d’acqua perenne, per augusta munificenza adotta, su area pubblica fu posta – Anno di nostra salute 1751. Maria Teresa decretò pure la libertà di culto a Trieste che permise alle varie comunità religiose, che qui risiedevano, di costruire le proprie chiese. 137 Unica condizione che Maria Teresa pose fu che tutte le chiese non cattoliche fossero addossate, almeno su di un lato, ad un edificio civile. Le mura furono abbattute, interrate le saline, e su questa bonifica fu costruita una nuova zona di Trieste che in onore della sovrana fu chiamata Borgo Teresiano. La “nuova città” fu costruita con belle strade dritte e bei casamenti, dove c’erano i magazzini, gli uffici come pure le case dei commercianti. Due tratti erano stati scavati in profondità in modo da per mettere al mare di penetrare. Furono creati così il Canal Grande e il Canal Piccolo, dove i navigli poterono entrare ed essere più comodi per le operazione di sbarco ed imbarco dei prodotti e dei passeggeri. Ingrandendosi la città, successero anche fatti di cronaca che, per l’epoca, fecero molto scalpore. Prendendone uno a caso, anche perché uno dei protagonisti ha un nome ancora noto a Trieste, è quello in cui Giovanni Gioachino Winckelmann, un prussiano, fondatore dell’arte moderna e padre dell’archeologia, nel 1768, di passaggio per Trieste, prese alloggio alla già citata Locanda Grande, dove venne accoltellato e ucciso a scopo di rapina, da tale Arcangeli. L’assassino venne preso e giustiziato, mediante “ruotazione” in piazza davanti alla locanda dove aveva commesso il delitto. Il corpo del defunto Winckelmann non si sa che fine abbia fatto, pertanto a ricordo di questo fatto, ma soprattutto per rendere omaggio all’illustre personaggio, nel 1833 venne costruito un cenotafio, sarcofago senza cadavere, ora custodito nell’Orto lapidario di San Giusto. Nel secolo XVIII, con l’evolversi della città e con l’aumento conseguente dei suoi traffici, vi giungevano sempre più nuovi immigrati, molti dei quali furono i veri e propri autori dello sviluppo della città. Essi erano provenienti da parecchi e diversi paesi come per esempio il greco Ciriaco Catraro, abilissimo negli affari che divenne molto ricco e fu il primo ad insistere perché a Trieste fosse costruita la Borsa. Possiamo ricordare il livornese Matteo Giovanni Tommasini, commerciante e finanziere di grosso spessore che progettò la costruzione di un nuovo teatro, ma che 138 venne ripreso, più tardi, dal siriano Antonio Pharaon detto Cassìs, altro ricco commerciante, che ne ultimò la costruzione. In città, data la continua immigrazione in cerca di fortune o per sfuggire nei paesi di origine a persecuzioni politiche, giunsero greci, svizzeri, tedeschi del nord, spagnoli, francesi e italiani appartenenti ai vari Stati ed infine molti orientali. Con tutte queste razze, questi popoli, e di conseguenza tante lingue, la città avrebbe potuto divenire una Babilonia. Invece così non fu perché i nuovi arrivati si uniformarono allo spirito della città e in brevissimo tempo ne acquisirono sia la cultura, gli usi e costumi, che la parlata italiana. Agli inizi qualche leggero screzio ed incomprensione ci fu tra le vecchie famiglie patrizie che abitavano la case della città vecchia e la nuova aristocrazia commerciale e straniera che abitava la città nuova, dove amava farsi erigere dei sontuosi palazzi come, ad esempio, il ricco commerciante greco Demetrio Carciotti che si fece costruire quella meraviglia architettonica che è appunto il “palazzo Carciotti”. Contrariamente a quanto tutti credono, il palazzo Carciotti non si limitava a quella che fino all’anno scorso fu la Capitaneria di Porto, bensì si estendeva a tutto quell’edificio già occupato, fino a poco fa, dall’A.C.E.G.A.T., per intenderci tutto l’isolato compreso tra riva Tre Novembre, via Genova, via Cassa di Risparmio e via Bellini. Altro personaggio di spicco della Trieste che contava, fu il conte Domenico Rossetti de Scander, nobile, commerciante, letterato, giurista e storico. Nel 1810 egli fondò la Società di Minerva che come scopo si prefiggeva di promuovere gli studi sulla storia di Trieste ed elevare la vita culturale della città. Trieste, in quell’epoca sentì la necessità di avere un mezzo di informazione che non fosse il solito passaparola e il sentito dire. Così nel 1784, un toscano, iniziò a stampare il primo giornale edito a Trieste. “Osservatore Triestino” fu chiamato ed iniziò con lo stampare poche copie, ma agli inizi dell’800 già aveva una tiratura di tutto rispetto. Trieste cominciò ad essere “osservata” da parecchie potenze, tant’è che il 139 29 aprile del 1797 anche Napoleone Bonaparte, con due generali e cento ussari entrò in città. Pernottò una sola notte presso il Palazzo Brigido, sulla cui facciata in via Pozzo del Mare esiste una lapide in ricordo dell’avvenimento, si fece consegnare tre milioni di contributo e se ne andò con la cassa del Comune. I Francesi comunque ritornarono e vi rimasero dal 1805 al 1814. La loro dominazione non fu delle più felici e l’economia della città ne risentì, tanto da far rimpiangere gli Austriaci. Furono create, dai Francesi, le famose “Province Illiriche” nel cui territorio era compresa pure Trieste. Gerolamo Buonaparte, fratello dell’imperatore, già re di Westfalia e col titolo di principe di Montfort, soggiornò a Trieste parecchie volte tanto che acquistò la palazzina, che oggi è la sede del Presidio militare dove, nel 1822 nacque suo figlio che, vent’anni dopo, sposò Clotilde di Savoia. Si narra che, in punto di morte, il marito di Clotilde raccomandasse la sua città natale a Vittorio Emanuele II. La villa oggi si chiama “Villa Principe Napoleone” dal nome del figlio di Gerolamo. Il 14 maggio 1850, l’imperatore Francesco Giuseppe I pose la prima pietra per la costruzione della “ferrovia meridionale” detta così perché, partendo da Trieste attraverso Aurisina, che era il meridione dell’Austria saliva al settentrione, cioè nella capitale Vienna. La città aveva raggiunto, ormai, i centocinquantamila abitanti ed il vecchio Acquedotto Teresiano risultò insufficiente per gli sviluppi della città tanto che nel 1859 venne costruita la centrale dell’acquedotto di Aurisina. Nel 1864 fu introdotta pure l’illuminazione pubblica alimentata a gas. Trieste fu sede di numerose compagnie di navigazione e scalo marittimo, si sentì perciò la necessita che sorgessero le prime compagnie di assicurazione le quali fiorirono in breve tempo. Ci sono parecchi documenti che attestano l’esistenza a Trieste di molte fabbriche, dalle carte da gioco ai pallini da caccia. Esiste ancora oggi, in via San Francesco vicino al nuovo palazzo della Regione, la “torre dei pallini” dove appunto il piombo fuso veniva colato dall’alto in una vasca d’acqua 140 gelida dove solidificavano. A seconda dell’altezza da cui veniva colato il piombo esso prendeva la forma e il calibro desiderati. C’erano pure parecchi cantieri navali di cui il più famoso di tutti fu il “Cantiere Panfili”, fondato nel 1780 e dove nel 1818 venne costruita la prima nave a vapore, varata con il nome di “Carolina”. Nel 1829 presso i Cantieri Panfili si apprestò la prima nave ad elica del mondo su progetto di Giuseppe Ressel. Nel 1860 venne inaugurato il Cantiere San Marco che era destinato a divenire uno dei più grandi ed importanti cantieri navali d’Italia e del mondo. Mi fermo un solo momento a pensare che in tutto questo ben di Dio di iniziative c’era già, da parecchi anni, anche il mio avo Gaspare che aprì, nel 1799, “pubblica stamperia” in Trieste. Risale al 29 dicembre del 1881 l’inaugurazione e l’uscita della prima copia del giornale “Il Piccolo” che fu così chiamato per il suo ridottissimo formato. Nella zona tra l’attuale p.zza Oberdan, foro Ulpiano e via Fabio Severo c’erano le caserme austriache nelle quali avevano sede anche le prigioni. Non si trattava di prigioni per detenere delinquenti comuni, bensì prigioni militari. Infatti stiamo entrando nel periodo detto dell’irredentismo e della redenzione. Di quelle costruzioni militari, oggi, rimane solamente la cella di rigore in cui fu rinchiuso Guglielmo Oberdan e che è diventata monumento nazionale e sede del museo del Risorgimento. Guglielmo Oberdan nel 1878 venne chiamato al servizio militare per prendere parte all’occupazione della Bosnia–Erzegovina, ma egli disertò, fuggì in Italia per unirsi ai patrioti triestini e istriani. Oberdan, perciò, era un patriota e voleva fermamente che Trieste venisse annessa all’Italia. Ma la terza guerra d’indipendenza era da poco finita e l’Italia firmò un patto d’alleanza con l’Austria. Questo patto a Oberdan e ai suoi amici patrioti proprio non andava giù e pensò bene che ci volesse 141 un’azione dimostrativa per esprimere il malcontento della città di Trieste e scuotesse così i suoi cittadini. Nel 1882, in occasione del quinto centenario della “dedizione” di Trieste all’Austria ci furono svariati festeggiamenti tra i quali anche un’esposizione che avrebbe dovuto essere inaugurata da Francesco Giuseppe I° in persona. Oberdan pensò bene di tornare a Trieste per tentare, con una bomba, di uccidere l’imperatore. Egli sapeva che l’impresa fosse quasi impossibile per la protezione che l’imperatore avrebbe avuto e la difficoltà, quindi, di avvicinarlo per lanciare la bomba. Così fu infatti, tanto che egli non giunse nemmeno a Trieste, anche perché tra i patrioti si era infiltrata una spia austriaca che lo denunciò, facendolo arrestare in una casa, a Ronchi, dove era in attesa del momento propizio per andare a Trieste. Trovato in possesso di due bombe, venne tradotto a Trieste e portato prima alle carceri, che si trovavano presso S.Maria Maggiore e quasi immediatamente segregato nella caserma, in quella cella buia e senza finestre che oggi, come detto, è l’unica testimonianza della caserma austriaca. Originariamente l’edificio, costruito per volere di Maria Teresa nel 1769, fu destinato a ospizio per i poveri e ospedale. Nel 1786 fu convertito in caserma e carcere da Giuseppe II. Venne apprestata la forca e con ciò gli Austriaci pensavano di spaventarlo e fare in modo che rivelasse tutti i segreti a sua conoscenza, sui motti dei patrioti. Ma lui rifiutò perfino di chiedere la grazia all’imperatore, perché voleva morire per attirare, col suo sacrificio, l’attenzione di tutti gli Italiani sulle tristi condizioni politiche dei Triestini. Per questi motivi, Oberdan venne ricordato come il primo volontario e il primo martire della guerra di redenzione. Alle sette del mattino del 20 dicembre 1882, all’età di 24 anni, venne giustiziato ed il suo corpo non fu mai più ritrovato. A riunificazione avvenuta tutte le città d’Italia, il cui stemma è posto sopra la cella, si tassarono in ragione di un centesimo per abitante in modo 142 da raccogliere la somma necessaria ad abbattere, nel 1925, la vecchia caserma austriaca e a costruire, nel 1927, il sacello dedicato a Guglielmo Oberdan, nonché la casa del Combattente, dove hanno sede, appunto, tutte le associazioni combattentistiche e pure il Museo del Risorgimento. Nel vicino museo sono ricordati tanti altri patrioti che si sono distinti, per ardimento, per unire la città di Trieste all’Italia. Tra i tanti ricordiamo il generale Petitti di Roreto, per primo sbarcato a Trieste il 3 novembre 1918. Ma non dobbiamo dimenticare il capodistriano Gian Rinaldo Carli, che ancora nel 1700 auspicava l’unione di tutti gli Italiani in uno stato sovrano. Poi tanti nomi, allora sconosciuti, che nel 1848 si radunavano all’interno del Caffè Tommaseo, covo di irredentisti e patrioti che, alimentati dagli articoli del giornale “La Favilla” svilupparono sempre più la coscienza nazionale. Fu così che tanti giovani giuliani e dalmati parteciparono alle guerre del nostro Risorgimento tra le fila dell’esercito italiano e dei garibaldini. Di quelli sconosciuti che si radunavano al caffè, spiccano alcuni nomi che, per le loro attività, partecipazione armata o semplice sostegno all’irredentismo, divennero famosi e sono oggi ricordati quali Giusto Muratti - bersagliere garibaldino, Lorenzo Gatteri – pittore che su tela riproduceva epiche battaglie, Giuseppe Caprin – che partecipò nel 1866 alla battaglia di Bezzecca nel Trentino, Domenico Lovisato – nato a Isola d’istria che seguì Garibaldi nella III guerra del Risorgimento, Gabriele Foschiatti, Leone Veronese....ecc. Questo fu il prologo della grande guerra, come venne chiamata la guerra che l’Italia combatté contro l’Austria per annettere a sé le provincie di Trento e di Trieste, capisaldi austriaci. Il 28 Giugno 1914 scoccò la scintilla che diede il pretesto per lo scoppio della prima guerra mondiale. Uno studente serbo attentò ed uccise a Sarajevo, l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo, nipote dell’imperatore Francesco Giuseppe e pretendente al trono di Austria e Ungheria. Fu così che l’Italia entrò nel conflitto, il quale iniziò il 24 Maggio 1915 e terminò il 4 novembre 1918, anche se, per la verità Trieste si liberò da sola 143 insorgendo con ribellione generale il 30 ottobre 1918 e si offerse con delirio d’amore all’Italia chiamando le truppe, ferme a Venezia. Il 3 novembre 1918 esse giunsero con il cacciatorpedinere Audace, il quale attraccò a quel molo che ancor oggi porta il suo nome e con un reggimento di bersaglieri che sbarcarono alla stazione marittima. Davanti a tutti, fieri di giungere in una città che si era liberata da sola, marciarono il generale Petitti di Roreto a fianco del duca d’Aosta. Nel periodo che precedette questo storico evento è doveroso ricordare i nomi dei Triestini che presero parte attiva alla guerra e furono moltissimi. Ne citeremo solo alcuni in rappresentanza di tutti che eroicamente combatterono quella guerra e che in parecchi caddero per l’ideale di proclamare e difendere l’italianità di Trieste: Scipio Slataper, Ruggero Timeus, Pio Riego Gambini, Giuseppe Vidali, Emo Tarabocchia, i gemelli Aurelio e Fabio Nordio, Ruggero Fausto Timeus, Antonio Bergamas, Gabriele D’Annunzio......fino a giungere alle medaglie d’oro concesse a Ugo Polonio, Carlo e Giani Stuparich, Giacomo Venezian, Francesco Rismondo, Nazario Sauro, Guido Brunner, Guido Slataper, Spiro Xidias, Fabio Filzi e Guido Corsi, nomi che, giustamente, furono ricordati dedicando loro altrettante vie cittadine. 144 CONCLUDENDO... A questo punto posso dire, perché lo penso, che Trieste abbia assunto quella che è la sua vera identità: essere italiana. A grosse linee cerchiamo di riassumere la lunga, ma breve storia di Trieste e dei Triestini. Trieste fu dapprima un castelliere, un piccolo scalo per scambi e/o baratti con navi provenienti da oriente, poi divenne dominio romano, seguirono invasioni e distruzioni alle quali seguì il dominio bizantino. Nel medioevo fu un po’ ai margini di eventi che sconvolsero, più il Friuli e le Venezie e pur passando, alternativamente, sotto domini dei Veneziani, degli Austriaci, dei vari Patriarchi fino all’ottocento dove giunsero Tedeschi del nord attratti da una cultura che amavano e che ritenevano superiore; i Greci provenienti da zone povere spesso oppresse dai Turchi, per non parlare degli Slavi che giungendo, per lo più, dal contado trovarono a Trieste un ambiente culturalmente molto evoluto. Trieste fu sempre un po’ autonoma anche grazie alla testardaggine dei Triestini, che volevano essere liberi di amministrarsi come meglio credevano. Anche se, probabilmente, in città agli inizi c’erano dei partiti politici filo-austriaci, filo-veneziani e filo- patriarchini, la più grande preoccupazione, che in ciò li univa, era salvaguardare e difendere la libertà del comune e dei suoi statuti che davano facoltà alla città di amministrarsi da sola tramite il Consiglio Maggiore e il Consiglio Minore, che si possono paragonare alle attuali Camera dei Deputati e del Senato. Nemmeno il dominio di 500 anni da parte dell’Austria riuscì ad eliminare tutti questi privilegi. Solamente gli ultimi 150 anni di dominio austriaco furono un po’ più pesanti anche perché, i Triestini, decisero di togliersi di dosso il giogo austriaco e ciò comportò una maggiore pressione e repressione sulla popolazione. Trieste è sempre stata piccola, chiusa in se stessa a difendere il suo esistere e soprattutto la sua lingua che nessun dominatore o semplice immigrato, riuscì mai a cancellare, anzi furono loro che dovettero adattarsi, con vero piacere però, ad imparare non solo la lingua italiana ma anche costumi, usi 145 e tradizioni esistenti tanto che, dopo pochi anni di permanenza, come succede tuttora, tutti si sentono e vogliono essere considerati triestini. Questo è quello che la Storia destinò ai Triestini cioè di restare italiani attraverso le innumerevoli vicende durante i secoli in questo estremo lembo orientale della penisola. È storia recente quella in cui i Triestini dovettero nuovamente essere soggiogati da dominazioni straniere e cioè dal 1943 al 1945 dai Tedeschi, nel 1945, per soli 40 giorni fortunatamente, dai partigiani slavi ed infine per ulteriori nove anni, fino al 1954, dall’amministrazione militare angloamericana. Avrebbe dovuto essere creato il Territorio Libero di Trieste, quale cuscinetto tra oriente e occidente ma, per fortuna, la decisione dei quattro “Grandi” rimase solamente sulla carta e alla fine del 1954 Trieste, con la sua ridottissima provincia, ritornò all’amministrazione italiana. Anche la situazione economica della città è cambiata. Da città cantieristica si è passati a città di studi e di cultura. Le grandi industrie sono emigrate o non sono state create a parte la Grandi Motori Trieste. Le raffinerie petrolifere hanno cessato la loro attività e la zona è divenuta deposito di greggio che tramite l’oleodotto transalpino viene mandato fino nell’alta Germania. In cambio Trieste si è dotata di uno dei più importanti centri mondiali di fisica nucleare, a Miramare, intitolato al premio Nobel Abdul Salam che, per decenni, lo resse e lo diresse fino a farlo diventare il più ambito punto di studio e di ricerca, meta dei migliori ricercatori mondiali. L’Area di Ricerca di Padriciano, altro complesso scientifico che l’Europa, se non il mondo, c’invidia. Esso doveva sorgere a Vienna, ma fu scelta invece la località carsica per la sua collocazione geografica e orografica, pur rimanendo a Vienna la direzione logistica e amministrativa. Ultimo nato in ordine di tempo, ma forse anche l’opera più importante è il Protosincrotrone, o come più comunemente viene detto “anello di luce”. Infatti in esso vengono studiate le risultanze dell’accelerazione delle molecole in questo anello. Trieste così è diventata un polo della scienza, un centro di convegni 146 mondiali e, sembra, si stia studiando la creazione di un nucleo alberghiero di dimensioni tali da poter diventare sede mondiale scientifica permanente. A questo proposito, sembra che un gruppo americano abbia intenzione di rilevare e bonificare dall’amianto l’hotel Europa, lungo la Riviera triestina, e adibirlo, appunto, esclusivamente a insediamento di studiosi e scienziati di tutto il mondo. Non è come agli inizi di questa ricerca dove gli scritti, le notizie, i documenti erano rari e frammentari, ora non è più possibile spaziare a largo raggio, ogni argomento, ogni avvenimento, ogni situazione ha bisogno di un intero libro per essere descritto. Tante persone, molto più qualificate, hanno già adoperato fiumi d’inchiostro per descrivere un solo palazzo o un solo castello o un solo museo. Io posso solamente leggere, imparare e recepire qualche cosa perché la mia Trieste, anche se piccola, ha tante cose da offrire e da far vedere a chi volesse scoprirle. Una città come Trieste, penso, sia unica al mondo, sia per la sua conformazione orografica, per la sua collocazione geografica, per la sua storia, per la sua cultura, per la sua multietnicità, per il suo spirito, per la sua mentalità che, alle volte, risulta un po’ troppo chiusa o poco aperta alle novità, allo sviluppo, alla modernità. I Triestini si rifugiano nel loro passato, che fu splendido, ma non vogliono capire che non potrà mai più ritornare se non con innovazioni sia tecnologiche che culturali, con la mentalità aperta che il nuovo millennio deve e potrà portare. Solo rimboccandoci le maniche, stringendo i denti e lavorando intensamente potremo essere nuovamente una grossa e importante città nel mondo e non certamente cullandoci in nostalgici ricordi che nulla producono e a nulla servono. In un’Europa che cerca di unificarsi in una sola grande nazione, in un’Europa dove popoli che europei non sono, vogliono entrare e farne parte a qualunque costo, dove si cerca di creare un’economia comune per il bene di tutti, dove perfino la moneta di scambio sarà unica, a Trieste esistono ancora delle persone ottuse e retrograde. Esse vorrebbero isolarsi e isolare la città quasi desiderassero ritornare all’epoca dei liberi comuni, con le piccole bot147 teghe artigiane, gli usurai toscani o ebrei, con un’economia basata sulla quotidianità senza sviluppo, senza domani, senza progetti, senza futuro certo o almeno programmato, senza quella imprenditorialità che, al giorno d’oggi, necessita per poter guardare con una certa serenità al futuro nostro ma soprattutto al futuro dei nostri figli e dei figli dei nostri figli. Trieste svegliati, scuotiti, sii la Trieste che mai si è piegata a nessuno, ma che sempre ha collaborato e ha accolto tutti in seno a sé per poter cooperare ed essere accolta nel mondo intero! Comunque sia, Trieste io t’amo perché sei Trieste ed io sono fiero di essere Triestino. Finito febbraio 2001 Dati storici e notizie tratti da bibliografie varie di: Lorenza Rescinati, Giulia Paola Ruaro, Laura Loseri Ruaro, Fiorenza de Vecchi, Marzia Vidulli Torlo, Ettore Campailla, Dante Cannarella, Adriano Verani Enciclopedia multimediale GEDEA, De Agostini Enciclopedia UNIVERSO, De Agostini Consultazione testi esposti e/o archiviati di: Biblioteca civica Civico museo di storia patria Civico Museo del Risorgimento Archivio storico de “Il Piccolo” 148 GITE Maggio 2001 149 150 INTRODUZIONE Mia moglie ed io non siamo mai stati dei grandi camminatori, di quelli che la domenica mattina si trovano in piccoli gruppi e che con lo zaino strapieno sulla schiena, pantaloni comodi, possibilmente di velluto, scarponcini alti che stringano bene le caviglie, rigorosamente camicia di flanella pesante a quadri più o meno colorata, giubbotto con la zip, leggero d’estate, pesante d’inverno, cappello in testa e bastone nodoso con la punta di metallo per aiutarsi sugli impervi sentieri, prendono le macchine per avvicinarsi alla montagna prescelta per quel fine settimana. Ce ne sono tante nel nostro circondario, sia in Italia che in Slovenia fino ad arrivare alle prime montagne della Carinzia. Rocce, flora e fauna abbastanza simili, ma comunque sempre paesaggi ed accostamenti differenti, che fanno di ogni gita una storia a sé sia per l’impegno che per l’appagamento delle vedute e degli scorci. Gente di poche parole che si avventura in lunghe ed estenuanti arrampicate e discese su sentierini di media ed alta montagna, magari che abbiano anche dei tratti in “ferrata”, equipaggiati con il cinturone in vita ed il moschettone da agganciare al cavo d’acciaio quale sicurezza sull’impervia e impegnativa salita. Se non si fanno almeno 30 chilometri, loro la chiamano una “passeggiatina in montagna” e non gita od escursione. Questa si può definire una vera e propria passione sportiva oltre che amore per la montagna. Avendo il fisico adatto, allenato fin da giovani, questa è una sana vocazione che ritempra oltre che il fisico anche lo spirito, che ti fa sentire libero al contatto con la natura, svincolato in un mondo quasi irreale. Alla sera ti ritrovi stanco fisicamente, ma con la mente sgombra, libera e leggera; una serenità idilliaca ti fa dimenticare e sopportare i doloretti muscolari che, con il passare degli anni, inevitabilmente si fanno sentire e non vorresti che il tempo passasse per poter assaporare ancora il piacere di quella gioia, magari davanti ad un buon bicchiere di vino in qualche rifugio montano davanti ad un caminetto scoppiettante. 151 Un quadro del tutto opposto e così lontano dalla realtà quotidiana della città, che con la frenesia, le ansie, la lotta con il tempo per raggiungere non si sa cosa, il cercare di acchiappare un’ipotetica e teorica meta che, beffarda, corre più di te e raramente si fa raggiungere. Anche qui alla sera ti ritrovi stanco fisicamente, ma anche mentalmente, magari con un ”cerchio alla testa” che ti attanaglia e non vedi l’ora di andare a dormire per riposare, ma soprattutto per liberare la mente dai mille problemi accumulati. Mia moglie Nory ed io, saltuariamente e non con regolarità settimanale come i veri appassionati, qualche volta accompagnati da coppie di amici, ci avventuriamo in “passeggiate” che per noi sono gite anche impegnative, rimanendo in provincia o tutt’al più in regione. Il nostro scopo non è quello di fare i famosi trenta chilometri o più, ma è quello di trascorrere una giornata o anche solo un pomeriggio all’aria aperta con un altro intendimento: quello di scoprire, vedere, osservare, riscontrare o trovare degli indizi, dei cenni o nozioni, dei referti, delle notizie su quanto che ci circonda sia riguardo alla flora, alla fauna, alla mineralogia che all’orografia e al paesaggio che ci attornia. Cercherò di ricordare alcune delle nostre escursioni che, muniti di libretti, opuscoli o semplici annotazioni, abbiamo fatto negli anni cercando di “vedere” le cose, che con tanta dovizia di particolari, eminenti studiosi del Carso hanno descritto per far sì che non di una semplice passeggiata nei boschi, nei prati o sulle rocce si tratti, ma che la passeggiata diventi anche fonte di informazione e di cultura in modo di farci apprezzare e capire quello che ci circonda 152 COS’È IL CARSO Innanzi tutto dobbiamo capire il Carso, sia geograficamente che geologicamente e pertanto avvalendoci di un’enciclopedia e libri vari scritti sull’argomento, cerchiamo di capire questo fenomeno. Il Carso è una regione a cavallo del confine tra Italia del nord est e la Slovenia nord-occidentale ed è delimitata dai corsi del Vipacco e del Timavo a nord est, e da una linea che unisce idealmente Punta Grossa con la città di Pinguente, in Istria, a sud ovest. Si tratta di un esteso altopiano calcareo che, con forma allungata in direzione da nord ovest a sud est, si spinge dal basso corso dell’Isonzo sino al golfo del Quarnaro formando il Carso propriamente detto. Nel suo ambito però si suole distinguere delle subregioni e precisamente: il Carso Monfalconese, situato a nord di Monfalcone e comprende il laghetto di Doberdò e culmina nel monte S. Michele a quota 274 metri sul livello del mare; il Carso Triestino, formato dall’altopiano a nord di Trieste e che ha un’altezza sul livello del mare, variante dai 200 ai 400 metri sul quale svetta il monte Lanaro che raggiunge i 545 metri di altezza; il Carso di Villa Opicina, che è quel vasto altopiano cosparso di doline, a sud del monte Lanaro; il Carso della Cicceria, esteso nella zona nord orientale dell’Istria, tra l’alto corso del Timavo e la depressione di Pinguente; il Carso di Castua, altipiano degradante a sud est sul golfo del Quarnaro. Nel Carso furono studiati e descritti i fenomeni provocati dall’erosione chimica delle acque nella roccia calcarea, oggi noti come fenomeni carsici o, carsimo come più comunemente chiamato. Un noto studioso di questi fenomeni, Fabio Forti, così sintetizza il concetto di carsismo: “....l’insieme dei fenomeni superficiali e sotterranei che interessano nel tempo e nello spazio un determinato complesso di rocce carsificabili....” 153 Egli dice che perché questo fenomeno avvenga gli elementi base sono tre: la roccia, l’acqua ed il tempo. Le rocce che permettono il fenomeno sono calcaree e pertanto solubili. L’acqua piovana esercita il potere solvente di questo tipo di rocce. Il tempo è quello necessario perché l’acqua pura, che eserciterebbe da sola un’azione pressoché trascurabile, venga additivata dal progressivo scioglimento dell’anidride carbinica che fa aumentare considerevolmente la solubilità soprattutto nel caso di un carbonato di calcio puro. Per analogia del paesaggio del Carso con quelli delle regioni vicine, il termine “Carso” è stato poi esteso ad altre regioni finitime. Si distingue così un Carso Istriano, esteso a sud ovest del Carso propriamente detto, mentre a nord est si usa distinguere l’Alto Carso nella zona compresa tra l’Isonzo, il Vipacco e l’Idria, e il Carso Carniolino che a loro volta continuano verso sud est nel Carso Liburnico, nel Carso Dalmato e nel Carso Bosniaco. Il nome italiano di Carso viene tradotto in sloveno e serbo-croato con il nome di Kras mentre in tedesco viene chiamato Karst. Il termine di carsismo comprende tutta quella gamma dei fenomeni connessi all’azione solvente, o corrosione che vogliasi dire, dell’acqua esercitata a danno delle rocce calcaree. Dal punto di vista chimico, il fenomeno sul quale si basa consiste nella trasformazione che subisce il carbonato di calcio, per prolungato contatto con acqua ricca di anidride carbonica e per reazione il carbonato di calcio, praticamente insolubile, passa a bicarbonato molto più solubile e come tale viene asportato, in soluzione, dalle acque di circolazione superficiali e sotterranee. Alla luce di ciò, appare evidente come i fenomeni carsici possano verificarsi esclusivamente in quelle regioni caratterizzate dall’esistenza di potenti ed estesi affioramenti di rocce calcaree fessurate e da una conformazione superficiale, nell’insieme, subpianeggiante o comunque priva di marcati rilievi. Dette regioni devono inoltre presentare un clima caldo umido o temperato umido poiché la trasformazione del carbonato di calcio in bicarbonato è ostacolata dalla diminuzione della temperatura. 154 L’evolversi del fenomeno carsico può essere così schematizzato: l’originaria circolazione idrica superficiale perde via via di consistenza per il progressivo aumento delle infiltrazioni nel sottosuolo, a seguito dell’ampliamento delle fessure presenti nella roccia sotto gli effetti della dissoluzione. Si realizza, in tal modo, una graduale sostituzione dell’idrografia superficiale con una sotterranea; si intensificano nel contempo i processi di corrosione all’interno delle rocce, processi che si spingono via via a livelli più profondi, fino a raggiungere il basamento della serie calcarea o, se non altro, fino al limite di massima profondità oltre il quale non è più possibile un’attiva circolazione in senso verticale. Detto limite è regolato dal cosiddetto livello di base del fenomeno carsico e può essere rappresentato dal livello più basso al quale sono poste le sorgenti carsiche di scarico, oppure dal contatto fra la pila di rocce calcaree e il loro substrato costituito da altre rocce impermeabili o, caso più generale e probabile, dal livello del mare. Potremo dire in definitiva che le fasi del fenomeno sono tre, come schematizzato nella tavola illustrata proposta e cioè: FASE 1 (dissoluzione) – Nell’aria troviamo presente l’anidride carbonica che viene prodotta sia dalla respirazione degli esseri viventi, sia dalla combustione, oltre che dalla decomposizione, di resti organici. L’acqua piovana, cadendo verso il suolo, scioglie l’anidride carbonica originando l’acido carbonico aumentando la sua acidità (quella che più o meno propriamente chiamiamo “durezza”) e scioglie così il carbonato di calcio contenuto nelle rocce calcaree, facendolo divenire bicarbonato di calcio solubile. FASE 2 (equilibrio) - Il carbonato di calcio non scioglie poiché il bicarbonato di calcio ha raggiunto il valore della sua maturazione FASE 3 (concrezionamento) – La parziale pressione dell’anidride carbonica contenuta nell’aria diminuisce notevolmente ed aumenta la temperatura, L’anidride carbonica si libera dell’acqua diminuendone così l’acidità per cui scomparendo il bicarbonato di calcio, per evaporazione, fa ridepositare il carbonato di calcio. Le principali forme che accompagnano l’evolversi del fenomeno carsico 155 sono rappresentate , per ciò che concerne la superficie, dai campi solcati, dalle doline, dalle valli morte, dalle valli cieche, ecc. I campi solcati corrispondono a profonde e strettissime solcature, ad andamento subparallelo, dirette secondo linea di massima pendenza, ossia secondo il senso di scorrimento delle acque dilavanti che le hanno originate. Le doline sono depressioni a pianta rotondeggiante e relativamente piccole con diametro generalmente inferiore ai 150 metri e una profondità che varia da qualche metro agli oltre 200 metri. Le doline presentano spesso sul fondo un inghiottitoio che smaltisce le acque meteoritiche e possono, alle volte, essere temporaneamente sede di piccoli bacini lacustri. Le valli morte rappresentano le tracce lasciate dall’originario reticolo idrografico subaereo, ormai scomparso o solo parzialmente presente lungo le cosiddette valli cieche, ossia valli o spezzoni di valle ancora occupati da corsi d’acqua attivi, ma privi di sbocchi superficiali. Il fondo delle depressioni carsiche menzionate è quasi normalmente ricoperto da depositi colluviali, detti terre rosse, costituiti da sostanze argillose e da impurità detritiche ossidate, originariamente presenti nelle rocce calcaree e di cui rappresentano i residui della dissoluzione. Inghiottitoi, pozzi, condotti forzati, gallerie, tutti variamente ramificati e dall’andamento irregolare, caverne, ecc., sono invece le forme più vistose del paesaggio carsico sotterraneo. La differenza tra inghiottitoi e pozzi è basata sulla loro percorribilità da parte dell’uomo. I pozzi, noti anche come abissi o voragini, sono certamente i più accessibili, mentre gli inghiottitoi, ubicati sul fondo di valli cieche, sono detti anche foibe. Forme costruttive del carsismo sono, invece, quelle risultanti dalla rideposizione di carbonato di calcio da parte delle acque di circolazione sotterranea e di quella sorgiva per perdita dell’anidride carbonica. Fra le più comuni vanno ricordate le numerose incrostazioni e, in particolare, le stalattiti e le stalagmiti, che ornano, rendendoli ancora più attraenti e talvolta assai pittoreschi, i complessi di cunicoli, gallerie, caverne, saloni, nicchie, 156 corsi d’acqua, cascate e laghetti sotterranei e che, saldandosi, portano alla formazione di vere e proprie colonne naturali. Adesso, dopo aver cercato di capire, per grosse linee, il fenomeno del nostro Carso, ci accingiamo a fare le nostre passeggiate “superficiali” dove solo marginalmente potremo vedere il fenomeno in quanto, né io né mia moglie siamo degli speleologi. 157 DA MIRAMARE A PROSECCO Un bel percorso, per incominciare, è il primo tratto di quello che è chiamato il “sentiero natura” e che da Miramare porta su per il pendio fino all’”Hostatia ai Pini” di Devincina nei pressi di Prosecco. Tra le due gallerie di Miramare/Grignano, c’è il cancello d’ingresso al parco del castello di Miramare. Già entrando nel parco rimaniamo ammirati della splendida flora che ci circonda, anche se non tutta è flora spontanea, ma parecchia è stata importata per abbellire il parco. Ci dirigiamo a sinistra per prendere un vialetto all’inizio del quale un cartello indica che ci troviamo sul viale che porta alla stazione ferroviaria di Miramare. Usciamo nuovamente dal parco e costeggiando un muraglione troviamo un sottopassaggio vicino ad una scala che, salendo, ci porterà alla stazione. Recentemente la stazione è stata totalmente restaurata e riportata agli antichi splendori di quando duchi e principi la usavano per raggiungere o lasciare il castello di Miramare, dimora di Massimiliano d’Asburgo, ma quando abbiamo fatto per la prima volta il percorso, essa era desolatamente abbandonata, cadente e in disuso, spento monumento di passate glorie. L’unica cosa che aveva resistito al passare del tempo e all’incuria dell’uomo erano, ma per fortuna ci sono ancor oggi, alcuni lecci in schiena alla stazione. I lecci sono le uniche querce sempreverdi presenti nella nostra zona e sono un’essenza caratteristica della flora mediterranea. Facciamo alcuni passi ed arriviamo in via Plinio dove, al finire della via stessa inizia la scalinata che ci farà salire fino a Prosecco. La scalinata, in gran parte lignea, si dice sia il tracciato che gli antichi pescatori facevano quotidianamente dalle loro case, costruite nei pressi di Contovello a difesa di incursioni piratesche, fino giù al mare ed alle loro barche, unica fonte di sostentamento per se e le loro famiglie. Ci ritroviamo in una zona molto tranquilla, amena ed, essendo esposta ad ovest, soleggiata e con una vista totale sul golfo. La sua conformazione, a “pastini” e la sua esposizione la rendono ottima per la coltivazione della vite. 158 A questo punto devo spendere una parola di spiegazione sul termine “pastino” usato in loco, ma che non esiste nella lingua italiana. Infatti quello che noi chiamiamo “pastino” in realtà è un gradonamento o meglio ancora un terrazzo. In geomorfologia si individua un ripiano intagliato dall’erosione marina, lungo i fianchi di una collina o di un monte, quando il livello del mare era superiore a quello attuale. I terrazzi con scarpata diretta parallelamente alla linea di costa, tipico delle fasce costiere, sono interessate da abbassamenti ciclici del livello del mare o da innalzamenti della terraferma. I terrazzi marini rappresentano lembi di precedenti piattaforme marine di abrasione o di sedimentazione preservati dai successivi cicli di erosione e costituiscono quindi le più classiche testimonianze degli abbassamenti relativi del livello marino. Per semplificare il tutto noi d’ora in poi useremo il termine locale di “pastino”. Non è un caso che una via vicina alla via Plinio, dalla quale noi abbiamo iniziato la salita, si chiami “via del Pucino”. Il Pucino infatti è un vitigno, ormai estinto, che aveva la sua collocazione da ove ora sorge il Centro di Fisica di Miramare, fino oltre Duino quasi fino alle foci del Timavo e produceva il famoso vino che già ai tempi dei Romani era coltivato nella zona e veniva inviato agli imperatori, come fosse un nettare, in speciali anfore che, partendo dal porto di Aquileia, via mare, giungevano fino a Roma. L’imperatrice Livia, moglie di Augusto, magnificava le doti di questo vino dicendo che, lui e solo lui, l’aveva fatta arrivare all’età di 82 anni, meta impensabile per l’epoca. Del vino scrisse Plinio: “....nasce nel seno del mare Adriatico non lontano dalla sorgente del Timavo, su un colle sassoso, il soffio del mare ne profuma poche anfore, medicamento che è superiore ad ogni altro, i vini del Pucino cuociono nel sasso....” Oggi, purtroppo, pochi sono i pastini ancora coltivati, perchè i viticultori sono rari ed il sacrificio è grande. Per accudire alle viti bisogna scendere a piedi lungo il ripido pendio e per vendemmiare bisogna farlo esclusivamente manualmente confidando, nel contempo, che le piogge innaffino i 159 vigneti in quanto non ci sono condotte idriche per l’irrigazione artificiale. Questo evidentemente non solo per le viti, ma anche per tutte le altre culture una volta presenti in zona. Le erbacce e l’incuria, ora, regnano sovrane. I costone carsico, in questo punto, è morfologicamente costituito da una parte marno-arenacea, detta flysch, termine probabilmente tratto dal tedesco flyssen che significa scorrere. Il flysch è formato prettamente da sabbia e fango ed ecco perché esso si presta ad essere utilizzato per terreni agricoli a differenza del terreno calcareo che non trattiene l’acqua in superficie. La parte calcarea del Carso è costituita da enormi depositi di organismi marini. Questi organismi vivevano sul fondo di un mare molto caldo, in tempi lontanissimi, e i loro gusci, accumulandosi gli uni sugli altri, formarono strati alti anche centinaia di metri. Nel corso dei millenni, processi chimici e fisici fecero trasformare i gusci in rocce, perlopiù bianche, che attualmente formano la superficie del nostro altopiano carsico. Tutto questo non è stato così semplice come sembrerebbe, anzi, si parla di millenni, di piogge torrenziali che portarono al mare detriti formati da sabbie e fango, che coprirono i resti dei molluschi marini. Immani cataclismi, spinte orografiche poderose e stravolgimenti apocalittici alzarono fuori dall’acqua conchiglie e sabbie, divenute ormai rocce, in modo da far divenire la base delle rocce calcaree nella posizione che oggi noi possiamo vedere. La città di Trieste e tutta la sua costiera fino a S.Croce, poggiano sul flysch mentre le rocce calcaree, che sono più resistenti all’erosione, fanno corona dall’alto. Questa zona è molto fertile anche perché un ruolo importante viene giocato dalla temperatura favorevolmente e sensibilmente influenzata dalla vicinanza del mare. Ma ricominciamo a salire il nostro sentiero dove potremo osservare una flora molto varia formata da vegetazione spontanea e resti di vegetazione domestica. Mia moglie mi fa notare l’alloro, le cui foglie, per il loro aroma, vengono 160 usate in cucina. Poco distante abbiamo modo di vedere degli arbusti di ligustro che vengono usati, trapiantati, per formare siepi di recinzione alle aiuole nei giardini. Alzando lo sguardo, una rigogliosa rosa canina accanto ad un abbandonato ciliegio domestico e ad un susino, si fanno ammirare per la loro bellezza. Su di un muretto a secco si è sviluppata, coprendolo quasi interamente, un’edera che allunga i suoi serpeggianti “rami” nel tentativo di invadere anche il sentiero e la vegetazione vicina. Sempre salendo, nel prossimo pastino, ci imbattiamo in un unico fico che, solitario, troneggia sulle erbacce tentando di resistere all’abbandono cui è stato destinato. In questo punto dovremmo vedere anche degli ailanti ma, non conoscendo noi le caratteristiche della pianta, non ci è possibile individuarli pur essendo informati che l’ailanto è un albero asiatico che attecchisce con profonde radici, si riproduce facilmente e viene usato per rinsaldare terreni franosi. Cominciamo a vedere i primi vigneti con disseminati qua e là dei ciliegi domestici alternati a ciliegi selvatici nati spontaneamente dai semi caduti e che aspetterebbero di essere innestati dall’uomo per dare anche loro i frutti, ma purtroppo l’uomo ha altro a cui pensare e si allontana sempre più dalla natura. Salendo ritroviamo sempre più numerose le rose canine. Ogni tanto la scalinata si interrompe in un breve tratto di sentiero fino a giungere al prossimo pastino ed ai prossimi gradini. A questo punto è doveroso fare una piccola sosta e ci giriamo verso il mare per poter ammirare il bellissimo golfo splendente al sole, che ormai in fase calante, lo fa sembrare adornato da fili d’oro e lingue di fuoco rossastre, le campagne ci circondano ed il sottostante parco del castello di Miramare ci scruta e sembra controllare il nostro cammino. Con gli occhi pieni e l’animo rinvigoriti da questa splendida visione ci riavviamo lungo il percorso notando i primi cespugli di emero, che è uno 161 dei primi arbusti annuncianti la primavera con i suoi piccoli fiori gialli. Questa è una pianta tanto desiderata da mia moglie Nory e che io avrei dovuto procurare e piantare in un nostro piccolo pezzo di terreno che abbiamo a Prosecco. Ma un po’ la pigrizia, un po’ la difficoltà di trovarla nei negozi di agraria, hanno fatto sì che sia rimasto un desiderio e non una realtà. Cominciamo a intravedere le prime “roverelle”, che sono una sorta di querce molto comuni sul Carso: per riconoscerle facilmente si osservano i rametti giovani, ricoperti da una patina vellutata che sembra una peluria. Ma perché questa “meraviglia” nel nominare degli esempi di flora che in definitiva non sono un’esclusiva del Carso. Se di meraviglia si può parlare, sta nel fatto che per uno degli strani fenomeni, detti appunto carsismi, queste piante si trovano ad altitudini inusuali. Infatti il loro habitat naturale è molto più alto. Per spiegare la presenza di tante specie ad altezze così basse bisogna tener presente una cosa e cioè che l’altezza del punto preso in considerazione sul livello del mare, deve essere triplicato. Se ci troviamo a 200 metri sul livello del mare, è come se fossimo a 600 metri. Ciò è riscontrato non solo nella flora ma anche nella fauna. Il nostro ciglione carsico, e la piana retrostante fino a giungere alle prime montagne, non supera mai i 350 metri sul livello del mare, eppure, da un ultimo censimento, si riscontra che esso è popolato da una colonia di oltre 2.000 caprioli. Dalla nostra guida illustrata cerchiamo, con molta fatica e non sempre con successo per quelle meno note, di individuare le tante specie di piante che, salendo il sentiero, ci si presentano per la prima volta. Oltre il querceto dovremmo individuare l’acero minore dalle caratteristiche foglie e tre lobi, aceri campestri, ornielli, carpinelle, carpino bianco, olmi campestri, acacie, sambuchi, salici, castagni e alcune grosse querce, il tutto accompagnato purtroppo da rovi, ortiche e dalla vitalba che sono i testimoni dell’abbandono e dell’incuria. 162 Qui vorrei fare un piccolo inciso per precisare una cosa. Io, e non vorrei che altri come me cadessero nel medesimo errore, credevo che il nome “vitalba” fosse il nome corretto di quella che si usa chiamare “vite americana” cioè quel rampicante che a volte, come l’edera, avvolge le piante fino a farle soffocare. In realtà la vitalba, il cui nome scientifico è Clematis vitalba, appartiene alla famiglia delle Ranuncolacee ed è propria dei boschi delle zone temperate. Ha un aspetto sarmentoso (simile all’aspetto del ramo secco della vite) con fusto legnoso e volubile, con foglie opposte e divise in 5 foglioline ovate. I suoi fiori sono biancastri, con numerosi stami sporgenti e sono raggruppati in pannocchie. Un po’ a lato del sentiero notiamo tre castagni secolari che in autunno, si dice, siano meta di “pellegrinaggio” di numerosi escursionisti per raccogliere le prelibate castagne cadute a terra. A lato del sentiero scorre un solco profondo invaso da ortiche e rovi che, ora, è un torrentello occasionale, ma che sicuramente, a suo tempo, deve essere stato un grosso corso d’acqua continuo tanto da essere riuscito ad incidere nel flysch il profondo solco ancora visibile. La vegetazione si manterrà così varia fino a giungere allo stagno di Contovello. Ora le campagne sono più curate ed i vigneti sono tenuti perfettamente con il terreno privo di erbacce ed i solchi lungo i filari perfettamente arati . I salici qui sono più numerosi, data anche la vicinanza dell’acqua, perché agli agricoltori ed ai viticultori i loro rami servono per fare legature a scopo agricolo. Il sottobosco del vicino boschetto di acacie è costituito da grossi cespugli di biancospino. È in questo punto del percorso che cominciamo ad osservare la fine del flysch e le prime formazioni di calcare. Come detto precedentemente, le torrenziali piogge, hanno portato verso il mare il flysch lasciando ben pulito e levigato il calcare. Siamo arrivati a quello che è denominato lo stagno di Contovello, che viene definito uno stagno carsico, ma il suo bacino è ancora in parte poggiante sul flysch oltre che sul calcare. Esso non dovrebbe pertanto essere chiamato “carsico” perché, per essere tale, dovrebbe essere completamente 163 calcareo. Il laghetto di Contovello ha una profondità massima di 2,50 metri e si calcola che abbia un volume di circa mille metri cubi d’acqua. La vita animale di questo specchio d’acqua ai più, come a noi del resto prima di approfondire la visita, è del tutto o quasi sconosciuta. Esso può sembrare un banale laghetto d’acqua stagnante, in realtà, anche a causa dell’acqua non troppo limpida, che non permette una visione del suo fondale, non si può notare che in esso vivono molte specie di pesci. Aguzzando la vista e con molta pazienza, mia moglie ed io, siamo riusciti ad intravedere ed individuare molti tipi di pesci rossi, qualche pesce gatto, tritoni comuni, molti insetti acquatici ed infine le anatre; queste ultime sicuramente discendono dai germani reali, dei quali però non conservano più i caratteristici colori del piumaggio, dovuto probabilmente, anche ai numerosi incroci con razze domestiche ivi residenti. Chinandoci verso l’acqua possiamo intravedere anche delle piccole tartarughe, comunemente dette della Florida, e che sono reperibili in qualsiasi negozio di animali. È facile intuire che questi animali non siano giunti da soli nello stagno ma bensì “scaricati” da qualcuno, che stanco di tenere in casa le bestiole, magari regalo natalizio o pasquale di bimbi viziati, le ha depositate nel laghetto alterando così l’ecologia del luogo. Intorno allo stagno, come già detto, notiamo il salice piangente ed i pioppi neri italici che crescono sulla sua riva erbosa. A questo punto ci allontaniamo da questo splendido angolo, non prima di aver scattato un’altra fotografia a ricordo e proseguiamo, sulla strada asfaltata, verso l’abitato di Prosecco. Ai margini di questa strada oltre alle specie già incontrate troviamo il primo grande abete mentre sulla piazzetta di Contovello, dinanzi alla chiesetta, svettano verso il cielo parecchi ippocastani. Ci addentriamo nell’abitato, dove nei giardini delle case osserviamo svariati tipi di piante la collocate dai proprietari; ci è dato di vedere pertanto piante di molti tipi: arbusti ornamentali, rose canine, abeti, lillà, pini neri, cipressi, noci, mandorli, ciliegi, ecc. 164 Arrivati al monumento alla Resistenza ci inoltriamo, lasciandolo sulla destra, attraversiamo un boschetto di cedri e, passando nuovamente tra le case, ci avviciniamo al bosco. Ci accorgiamo di essere alle ultime propaggini del paese perché negli spazi liberi, ai lati della strada, la vegetazione si fa sempre più spontanea e caratteristica: aceri, ciliegi canini, qualche prugnolo, aceri minori, rovi, ciliegi selvatici, rose canine, ornielli, carpinelle, roverelle....... Oltrepassiamo l’ultima casa a destra termina così anche l’asfalto e ci troviamo ad un bivio. Noi continueremo diritti e ci inoltreremo sul sentiero n° 6, girando a sinistra, scendendo, ritorneremmo a Grignano e Miramare. Ed è proprio in questo punto che noi abbiamo un piccolo pezzo di terreno dove avrei dovuto piantare l’emero per mia moglie. Entriamo sul sentiero n° 6, il quale porta fino a S.Croce e alla Vedetta Italia, e sulla sinistra possiamo ammirare una bella pineta di pino nero che fu importato dall’Austria e pertanto chiamato anche pino austriaco. Esso fu piantato dall’amministrazione asburgica per il rimboschimento della pietraia carsica. Questa è forse una delle più significative dimostrazioni di quanto prima asserito sul fenomeno del carsismo relativo all’altezza sul livello del mare, infatti in nessun altra parte, il pino nero è potuto attecchire a quote così basse. L’attuale politica di rimboschimento, non si sa bene perché, non usi più il pino nero, che pur radicando molto bene sui terreni sassosi e abbisognando di poca acqua per crescere, venga sostituito da altre piante. Per fortuna la natura fa il suo corso indipendentemente dai voleri politici dell’uomo e, più avanti, il sottobosco si è intanto arricchito di pini neri giovani di seconda e spontanea generazione. Proseguendo nel cammino arriviamo ad una radura che sulla destra ci fa ritrovare un’altra pineta e sulla sinistra possiamo notare delle grosse piante di rovere e delle roverelle. Sulla destra, dobbiamo prestare molta attenzione per notare, che nel muretto a secco di tipo carsico, c’è una breccia alla quale segue una “traccia calpestata” più che un vero e proprio sentiero. Questo è appunto il prosieguo 165 della nostra passeggiata che si inoltra nella pineta. Non essendo un sentiero “segnato” dal C.A.I. dobbiamo stare molto attenti a seguire il calpestio dei precedenti escursionisti per non perdere la strada. Poco male, direte voi, non siamo di certo in una boscaglia sudamericana e tutt’al più si dovrebbe fare qualche centinaio di metri in più, poco importa, già la meta è vicina. Il sottobosco di questa zona è molto vario infatti incontriamo, alternati, dei cespugli bassi di rovi e di vitalba, qua e là troneggiano dei biancospini, dei frassini, aceri e lecci. Le roverelle, molto sottili, svettano alte verso il cielo in cerca della vitale luce che le folte chiome del pino nero nega loro. La vegetazione, alle volte più fitta e alle volte più rada ci accompagna lungo il cammino; le piante sono quelle già incontrate lungo il percorso fatto. Ma ecco, all’improvviso, abbiamo la conferma del fenomeno di flora inusuale all’altezza orografica del posto. Dopo una leggera discesa troviamo una piccola pietraia i cui sassi presentano evidenti i fenomeni di erosione combinata di muschi e licheni con gli agenti atmosferici. I muschi infatti hanno intaccato la superficie permettendo alla successiva acqua piovana di insinuarsi ed allargare i solchi e le fessure dopo di che i licheni hanno trovato facilità di adattamento. Muschi e licheni....ci fanno pensare alle steppe russe o, comunque, a desolate lande nordiche..... Il sentiero a questo punto si allarga in quanto il Corpo Forestale dello Stato ed i volontari dell’antincendio hanno, parecchi anni fa, creato una delle tante linee tagliafuoco per preservare le nostre pinete dal propagarsi delle fiamme in caso d’incendio, circoscrivendo così il focolaio a più ridotte dimensioni. Ricordo quel periodo perché, facendo parte io pure del servizio di protezione civile nel gruppo della Sezione di Trieste dell’A.R.I., Associazione Radioamatori Italiani, proprio sul terreno di nostra proprietà fu installata la base operativa che coordinava, via radio, il lavoro delle squadre. Come appoggio logistico a questa operazione ci furono pure i volontari del Gruppo Fuoristrada Trieste che con i loro mezzi facevano la spola lungo le linee 166 tagliafuoco per il trasporto in punti di raccolta dei cespugli, rami, arbusti e quant’altro veniva tolto per creare queste linee. Sono felice, nel mio piccolo, di aver contribuito, seppur minimamente, a preservare e mantenere quell’immenso patrimonio che è il nostro Carso. Nel frattempo siamo giunti ad un trivio, a sinistra si ritorna al sentiero n° 6, quello che porta a S.Croce, a destra si ritorna, attraversando il cimitero di guerra autro-ungarico, verso Prosecco e diritti a poche diecine di metri si arriva all’Hostaria al Pini dove ci concediamo una sosta per gustare due buone fette di strudel di mele, un generoso bicchiere di vino bianco ed un’aranciata, prima di prendere l’autobus 44, che si ferma proprio li davanti, per ritornare a casa. 167 AURISINA Oggi ci accingiamo ad un altro tipo di gita. Visiteremo una località dell’altipiano carsico, non tanto per fare una lunga passeggiata in mezzo ai boschi, per sentieri o per prati, ma per vedere con occhio attento quello che i testi ci forniscono sulla caratteristica di questo particolare villaggio carsico. Normalmente l’uomo ama vedere stupendi paesaggi mozzafiato, infuocati tramonti magari ai tropici, cieli infiniti, azzurri e sereni o, talvolta, variegati da piccole nubi alle quali cerca, con la fantasia, di dare sembianze conosciute, lunghe spiagge incontaminate di sabbia fine e bianca con ai margini delle ombrose palme dalle quali raccogliere succose noci di cocco, o più semplicemente catene montuose, massicci, pareti rocciose a picco o pendii ricoperti di abeti lussureggianti d’estate e bianchi di neve d’inverno a noi più vicini.. Queste montagne sono rocce, pietre, sassi. Il Carso è un sasso infinitamente bello ed Aurisina è l’esempio lampante della sua bellezza, di un villaggio nato e cresciuto dal e sul sasso. Aurisina fu, un tempo, un nodo ferroviario, un bivio importantissimo della strada ferrata in uscita da Trieste nelle direttrici che portavano all’allora capitale Vienna e verso l’Italia. Se prendiamo Aurisina come luogo di residenza essa è un enorme cantiere di buche profonde, dove da secoli, prima eserciti di cavatori che manualmente, ed ora meccanicamente estraevano ed estraggono degli enormi massi di pietra per costruire palazzi, monumenti o semplici case. È un’immensa ricchezza che l’uomo ha saputo sfruttare tagliando, sapientemente e con arte, banchi di roccia compatta fino dai tempi dei Romani. Con queste rocce i Romani edificarono Aquileia ed il suo porto nonché palazzi e templi persino a Roma. La pietra di Aurisina è considerata la migliore del mondo, superiore ad ogni altra, dura come una gemma ed è il cuore del Carso. Durante i secoli di lavorazione della pietra ad Aurisina si sono creati degli immensi spazi ricoperti da brecciami, bianco testimone della trasformazione della roccia informe, staccata dal monte in blocchi cubiformi da 168 venire successivamente lavorati. Quasi a nascondere questa desolazione, la natura ha fatto nascere una selva di pini, di carpini e di frassini, delle macchie di sommaco e profumati cespi di timo e di salvia. Lungo le bianche strade del villaggio di Aurisina, oggi non si sentono più i ritmici colpi di mazza e di scalpello dei cavatori ed il muggire dei ruminanti buoi accasciati ai lati della cava che aspettano il loro turno per tirare il carro con i blocchi del marmoreo prodotto. Rumori tenui, dolci, quasi accattivanti, che creavano un atmosfera di operosità, di un sereno e faticoso vivere, testimoniato dal sudore della fronte che bagnava un lavoro pesante e spesso ingrato. Oggi il paesaggio è diverso, al posto dei buoi troviamo grossi autotreni dai chiassosi colori, udiamo, assordanti, i martelli pneumatici che hanno sostituito le mazze e gli scalpelli. Ci ledono i timpani i cigolii dei cavi d’acciaio che corrono su mobili gru che, quasi fossero dei leggeri fardelli, spostano i grossi blocchi cubiformi che pesano parecchie tonnellate. Abbiamo modo di vedere profonde voragini sulle cui pareti notiamo tagli freschi con il brecciame bianco alla loro base. Sembrano ferite fresche con le gocce di sangue che testimoniano la sofferenza del Carso. Un grande scrittore ed estimatore del Carso, Scipio Slataper amava, in modo particolare, questo punto del Carso al quale ha dedicato innumerevoli scritti. Amo ricordare, in modo particolare, un passo che così recita: “....attraverso le mille fessure della pietra, senti arrivare al cuore il grande lamento dell’acqua che corre nelle profondità della terra e beato sorridi al pispillare roteante delle rondini, alle nuvole che si trastullano nella luce, rabbrividenti pudiche sotto le fredde dita curiose del vento, alle stelle germoglianti nel cielo quando nel vespro si diffonde sul mondo un tepore leggero come fiato primaverile....” Ci sembra quasi che non si tratti di un villaggio carsico ma di trovarci al cospetto di una creatura di Dio, messa li per far gioire ed innamorare chi, come noi, si sofferma e si immedesima nella realtà della natura che lo circonda. 169 Dalla zona delle cave di Aurisina, partono parecchi sentieri in tutte le direzioni. Noi prendiamo uno in particolare, quello che attraverso giovani boschi, sull’orlo di strapiombi e sassi a picco, corre verso l’abbraccio del mare. Sui nostri passi incontriamo la maestosa stazione ferroviaria, monumento, oggi inutile, di quello che era il nodo ferroviario di una delle più importanti linee ferroviarie d’Europa e ci soffermiamo alla fresca ombra dei suoi grandi e secolari ippocastani. Usciti dal sottopassaggio ci sono quattro larghi sentieri, prendiamo quello di mezzo, seminato di minuto brecciame, e dopo aver oltrepassato alcune case puntiamo diritto verso la Torre dell’acqua costruita sull’orlo del ciglione. Vicino alla torre, vediamo affiorare dalle pietre, le ricostruite fondamenta di una casa contadina dell’epoca romana. Alla fine del sentiero puntiamo diritto verso il mare di Sistiana, la cui baia occhieggia radiosa e l’ammiriamo dallo slargo ai piedi delle torre piezometrica. La vista sul mare è aperta, immensa, lo sguardo non riesce ad abbracciare tutto il paesaggio. Bisogna girare la testa e scegliere, come fosse una macchina fotografica, gli scorci ed imprimerli nella memoria come su di una pellicola. Uno, dieci, cinquanta fotogrammi che si assommano nella mente, fotogrammi lontani della costa istriana, di Monfalcone, Grado, Lignano, Trieste, Muggia e quelli vicini della sottostante scogliera con i porticcioli di Sistiana, Santa Croce, Barcola..... A sinistra dello slargo della torre piezometrica, quasi per caso notiamo un segno sulla pietra, che sta ad indicare un vecchio sentiero, ora in disuso e non riportato su recenti guide, che scendendo, presumiamo porti verso la strada costiera. Essendo il sentierino ancora percorribile in quanto non molto sommerso dalla vegetazione, decidiamo di provare a perlustrarlo, sotto il sole, alla vista del verde grande mare, tra i pini, i lecci, l’odore del timo e della salvia ed il sommesso rumore che proviene dalle onde che si infrangono sulla scogliera. Nory ed io istintivamente ci guardiamo negli occhi ed abbiamo la sensazione di trovarci in un paradiso terrestre. 170 Purtroppo, non si sa perché, le cose belle sono destinate a durare poco infatti, dopo qualche centinaio di metri, il sentiero diventa più ampio e ci imbattiamo in una grande dimora, bella in verità, ma che stona inserita nel paesaggio carsico. Si sa, l’uomo è una strana creatura che tutto dissacra e cancella. Il sentiero diventa un’agevole strada, di facile percorrenza e poco dopo ci imbattiamo in un’altra moderna, bella e grande villa, seguita da un’altra e un’altra ancora. Aurisina, un mondo dai due volti, quello duro, compatto, granitico, severo, fiero e solenne della parte a monte, mentre quello che si affaccia sul golfo, verso il mare, risulta essere ameno, gaio, giocondo, ridente, mite e piacevole. Due volti, due mondi, due sentimenti nei quali giocano, contrastandosi tra di loro, le sensazioni provate in questo breve itinerario. Le immagini ed i profumi che il Carso hanno saputo infonderci, radicandoli nella mente e nell’animo, qualcosa di tangibile, sentimenti di ammirazione, di sorpresa e di stupore per quella meraviglia del Creato che è il nostro Carso. Sempre che sappiamo e vogliamo sentirli. Siamo giunti alla strada costiera, all’altezza di Canovella dÈZoppoli. La gita è finita, aspettiamo il pullman della SAITA per rientrare, felici, a Trieste. 171 VAL ROSANDRA Val Rosandra.... quanti ricordi! Ogni triestino, che possa definirsi tale, deve essere andato almeno una volta in “valle” come in dialetto viene semplicemente chiamata. Palestra di roccia per i più esperti, semplice passeggiata per la maggior parte dei suoi frequentatori. Mia moglie ed io ci siamo stati parecchie volte, ed ogni volta sembra la prima, perché l’atmosfera, la luce, la stagione, la temperatura e tante altre cose la fanno cambiare agli occhi di chi la vuol vedere non solo come una passeggiata. Questa volta incomincerò a raccontare di quando mio padre e mia madre mi hanno portato in Val Rosandra per la prima volta. Sarà stato il 1948 o 1949, non ricordo bene, era da poco finita la guerra, ed io avevo 11 o 12 anni. Non c’erano autobus o corriere che portassero in zona, pertanto la gita era veramente una gita e bisognava, da casa, fare il tragitto andata e ritorno a piedi. Partimmo molto presto, il mattino, eravamo in cinque....anzi in sei. Papà, mamma, io, due miei cugini valtellinesi, Gianni e Dario, ospiti a casa mia per le vacanze estive e Rocky. Rocky era il mio cane, un cane lupo non di razza, ma forte ed agile come un toro. Zaino in spalla, papà e borsa a tracolla, la mamma, pieni di panini imbottiti per sfamarci e di bibite per dissetarci. Noi ragazzi solo la borraccia con l’acqua fresca legata alla cintura dei pantaloni. La galleria di piazza Foraggi non era ancora finita e pertanto non si poteva attraversarla. Il percorso d’obbligo era salire a Cattinara e da lì scendere verso Bagnoli della Rosandra. Chi non ha i miei anni, non può nemmeno immaginare come si presentasse la zona allora. Partimmo da viale Ippodromo, subito dopo piazza dei 172 Foraggi, a sinistra c’era quello che rimaneva del Pastificio Triestino bombardato e incendiato nel 1944 a seguito di un’incursione aerea da parte degli Alleati. Sulla destra del viale c’era l’Ippodromo di Montebello dove, come adesso, i pomeriggi dei giorni festivi gruppi di scommettitori assiepavano le gradinate incitando i loro beniamini nella speranza di ricavarne una buona vincita. Dopo, solo campi coltivati, qualche stretta strada di campagna e casette contadine disseminate in qua ed in là. Dietro l’attuale sede dell’A.C.I. iniziava la via Francesco Veruda, la cui larghezza, sicuramente, non superava i due metri. Dopo aver attraversato la via Scomparini e abbandonato il selciato in porfido, iniziammo a percorrere la vecchia strada di Rozzol, in terra battuta, che oggi la chiameremmo “sentiero”. In mezzo a campi ed orti ben coltivati, l’allegra compagnia procedeva di buon passo con il cane che, andando avanti e indietro, faceva almeno tre volte il percorso. Il sentiero, in leggera salita, si dirigeva verso il colle di Melara che allora era cosparso di gigantesche querce e che in primavera diventava di un giallo incandescente, dovuto alle innumerevoli ginestre in fiore. Il nostro cammino si faceva più lento perché il sentiero, che correva lungo il fianco del colle, diventava più impervio, ma non per Rocky che continuava imperterrito a correre, quasi volesse spronarci ad andare anche noi più veloci. Il sentiero costeggiava un enorme vigneto che si perdeva lungo il fianco del colle fino a giungere a Cattinara. Al termine di questa coltivazione una casa rossa e bianca di stile coloniale troneggiava dall’alto in faccia al sole e dalla quale si poteva vedere tutto il golfo. Non ho dati certi, ma mi è stato riferito che l’intera proprietà, di parecchie decine di ettari, fosse di un noto gioielliere di allora. Si dà il caso che, a quei tempi, non ci fossero i frastuoni delle automobili, motociclette, motorini, autobus, camion che dobbiamo sopportare oggi, ma il silenzio, la pace, il verde dato dai querceti che coprivano Melara e 173 Montebello sono ancora vivi nella mia memoria. La grande casa coloniale oggi non c’è più, non ci sono più i vigneti, i boschi, le ginestre, il verde, il viottolo che noi percorremmo, ma in cambio abbiamo tanto cemento, larghe strade asfaltate, tanti pali di cemento e di ferro che sorreggono le illuminazioni stradali ai vapori di mercurio e sostituiscono gli alberi. I boschi sono stati rimpiazzati da selve di antenne televisive e per la telefonia mobile. Bisognerebbe chiedersi, a questo punto, se tutto ciò è progresso tecnologico, necessità di spazi vitali, esigenze per un miglioramento della vita, oppure pura follia distruttrice, interessi economici e commerciali di pochi a discapito di molti, o più semplicemente che nessuno può o vuole fermare la corsa del tempo. Non sta a me giudicare, ognuno è libero di trarre le sue conclusioni. Ma ritorniamo alla nostra gita; eravamo nel frattempo giunti a Cattinara, l’antica Gattinara, presidio romano che difendeva la strada che da Tergeste portava al Carso. Tra le poche case e una trattoria vedemmo la chiesa con accanto il cimitero. Il sentiero proseguiva verso la Chiusa, antico confine doganale del libero comune triestino, che si trovava nei pressi dell’attuale ospedale che, oggi, ha coperto i verdi prati. Lì in primavera, sbocciavano i bucaneve precoci, e le gialle primule formavano una distesa che sembrava un mare le cui onde altro non erano che l’ondeggiare dei fiori alla leggera brezza. Da lì, per fortuna, iniziava la discesa e sulla nostra destra, in basso, scorgemmo il villaggio di S.Giuseppe che si affacciava sulla piana di Zaule. L’attuale nome di S.Giuseppe della Chiusa è una contrazione del modo con cui veniva identificato l’antico villaggio e cioè, S.Giuseppe oltre la Chiusa. Saranno state le dieci del mattino e noi ragazzi cominciavamo a sentire un certo languorino ed allora papà e mamma decisero che era il caso di fare una breve sosta . I miei cuginetti, Gianni e Dario, pur essendo contenti di 174 fermarsi per la merenda, ci presero in giro dicendo che in montagna non ci si ferma dopo neanche due ore di camminata. Come dice la canzone, dopo aver mangiato, mangiato e ben bevuto, ci rimettemmo in cammino sul sentiero che correva ai margini della strada asfaltata, che da Cattinara scendeva verso Bagnoli e San Dorligo. Dopo aver percorso in allegria la discesa, canticchiando, ci ritrovammo nella piazza di Bagnoli e da lì imboccammo la stradina che, tra le case, ci avrebbe portato all’inizio dell’escursione vera e propria in Val Rosandra. Lungo il sentiero, sulla sinistra, scorgemmo il rifugio Premuda del C.A.I. ma, avendo già fatto sosta per la merenda, tirammo avanti diritti con passo regolare e spedito in quanto ci rimaneva da fare la parte più impegnativa del percorso. Il nostro cane correva sempre avanti e indietro, abbaiando felice, con la bocca aperta e la lingua penzoloni ma ecco, all’improvviso, visto il torrentello d’acqua vi ci si buttò dentro sguazzando nelle sue gelide acque. Mamma lo richiamò immediatamente perché aveva paura che, accaldato com’era, potesse prendere qualche malanno. A malincuore Rocky uscì dall’acqua e, come fanno tutti i cani, cominciò a scuotersi violentemente per togliersi l’acqua di dosso in un fuggi fuggi da parte nostra per non essere investiti dalla “doccia” indesiderata e fuori programma. Per me fu la prima esperienza di passeggiate “in montagna” e mi sembrò di una difficoltà immensa. Seguendo il sentiero alle volte vicino al torrente e alle volte più in quota in un’oretta circa giungemmo al paesino di Botazzo e lì facemmo la seconda sosta. Ricordo che per arrivare al paese attraversammo un ponticello sul torrente all’inizio del quale, sulla destra, c’era la sbarra di confine che divideva Trieste dall’allora Jugoslavia. Un soldato e un carabiniere in armi vigilavano il punto, dall’interno di una piccola garitta, mentre dall’altra parte, al limitare del bosco, un’intera pattuglia di miliziani, armati fino ai denti, erano accampati vicino ad una grande tenda militare. 175 Ci fermammo poco dopo il paese, su di un prato verde, e dopo esserci dissetati, iniziammo a consumare il nostro pranzo fatto di vitello impanato messo tra il pane, uova sode, un po’ di prosciutto e una fettina di torta di mele fatta dalla mamma. Noi bambini avremmo dovuto giocare e saltare sul prato, ma la stanchezza iniziava a farsi sentire ed essendo esattamente a metà percorso, altrettanta strada ci aspettava ed era meglio risparmiarsi. Anche Rocky, che comunque non stava mai fermo, camminava lentamente sul prato senza correre come prima. A quel punto a papà venne una buona idea e ci propose, invece di fare a ritroso il percorso già fatto, avremmo potuto salire verso Draga S. Elia e da lì a Basovizza dove avremmo trovato la corriera che ci avrebbe portato giù fino in città. Da Botazzo fino a Draga S.Elia la strada era molto ripida e faticosa e ci volle una buona oretta per arrivarci, ma da lì a Basovizza la strada era abbastanza pianeggiante e verso le sei di sera, giungemmo davanti alla chiesa di Basovizza dove c’era la fermata delle corriere. Avevamo avuto abbastanza fortuna in quanto la partenza della corriera era prevista per le 18.50 e rimaneva “solamente” tre quarti d’ora da aspettare. Tutti seduti sul muretto che circondava il sagrato della chiesa, stanchi, ma felici di quella bella esperienza, ricordavamo i punti della gita che c’erano piaciuti di più. Commenti favorevoli anche dai cugini, che abituati a montagne ben più impegnative, dissero che sentieri così suggestivi, chiusi tra le rocce e con tanta vegetazione, da loro in Valtellina non ce n’erano. Rocky era accovacciato ai piedi del muretto, anche lui distrutto dalla fatica, che si leccava le zampe e potemmo constatare che erano abbastanza gonfie. La corriera arrivò quasi in orario e ci portò in città. Erano le 20 e rientrammo nella casa che avevamo lasciato 12 ore prima..........una veloce risciacquata sotto la doccia e tutti a nanna. 176 In tempi più recenti, con mia moglie, la Val Rosandra l’abbiamo visitata con uno spirito meno avventuroso e con un altro intento. Lasciata la macchina sul piazzale di Bagnoli, anche noi ci siamo inoltrati lungo il sentiero. Le case oggi sono belle, molte sono restaurate in modo coerente, lasciandone tutte le caratteristiche carsiche antiche della costruzione e adattandone gli interni alle moderne esigenze di vita. Il rifugio Premuda oggi è un accogliente locale, che pur conservando i requisiti di rifugio montano, è dotato di una cucina che può servire dei buoni pasti a tutti i frequentatori della valle ed anche a chi si ferma lì solamente per gustare un buon panino di prosciutto crudo carsolino ed un generoso bicchiere dei vino terrano. Sembra quasi impossibile, ma ogni volta che ci siamo inoltrati nella valle, ci è sembrato di vedere un nuovo ambiente. Sicuramente è dovuto dalle differenze climatiche o di orario, se il sole è a picco oppure obliquo, se il torrente ha più o meno portata idrica con conseguente più o meno fragore dello scorrere dell’acqua tumultuosa. Sta di fatto che è un vero piacere entrare lungo i sentieri alzando gli occhi per ammirare le rocce a picco, palestra di roccia per tanti scalatori, le guglie e i lastroni che formano il Monte Stena, il San Michele e il Monte Carso. La valle è stata scavata dall’acqua nei millenni e porta scritto nella sua pietra tutto il lungo e difficile cammino compiuto, ma è anche un miracolo di luci e di ombre, di aridità e di rigogliosità, di durezza e di dolcezza. Un lembo di terra dove, in ogni stagione, abbiamo la possibilità di trovare tracce di un silenzioso incanto e di una bellezza che ci dà la gioia e la voglia di vivere. Procedendo, sembra quasi di sentirci circondati dalla dolce leggenda della sfortunata principessa Rosandra alla quale la fata dei fiumi ha dato la pace, ma non ha potuto fermare il copioso pianto per il suo perduto amore, pianto che ancora oggi alimenta le chiare, limpide e fredde acque del torrente. La Val Rosandra è uno dei pochi e rari esempi di luoghi dove l’uomo non è riuscito a provocare danni con il suo insaziabile desiderio di distru177 zione, di modificazione e di stravolgimento della natura, dove si può ancora respirare aria pura e sentire, nel silenzio, il cinguettio degli uccellini, restare deliziati da piccoli fiorellini bianchi, gialli, rossi o blu che timidamente si lasciano ammirare in mezzo ai fili d’erba che sembrano quasi essere stati messi lì per proteggerli. Volgiamo lo sguardo in alto, a sinistra, per scorgere quello che è rimasto del vecchio tracciato della ferrovia che collegava Campo Marzio a Divaccia e all’interno dell’Istria, ora sede di una comoda passeggiata per turisti. Guardiamo la vicina galleria e nuovamente la leggenda si impadronisce dei nostri pensieri. Uno scoglio alto, slanciato e sporgente, si dice sia quello che è rimasto dell’antico castello di Draga, tra le quali mura viveva, taglieggiando i viandanti e mercanti di allora, un perfido mago. Lungo il crinale ammiriamo il belvedere di Moccò e un’altra leggenda affiora. Il belvedere è stato eretto sui resti di un grande castello costruito dai Barbamoccolo a difesa e guardia della Valle da incursioni di tribù nomadi dedite al saccheggio. Più realistico e ancora oggi visibile nei suoi ruderi, il dirimpettaio castello di San Servolo, che conobbe e sopportò tutte le furie delle guerre che Trieste dovette sostenere con Venezia. Continuiamo la nostra passeggiata e, dopo passata una piccola salitina, alziamo nuovamente gli occhi per vedere un contrafforte roccioso sulla cui cima è stato posto un cippo a perenne memoria di Emilio Comici, uno dei più grandi, se non il più grande alpinista nato a Trieste. Ai piedi del cippo, non visibile dal sentiero, c’è pure una lastra di pietra sulla quale sono incisi altri nomi, tutti di nostri alpinisti che in una soleggiata giornata di gioventù lasciarono i loro inizi di vita sulle pareti della valle o in vicine montagne. Tante volte mi sono chiesto, senza darmi però una logica risposta, cosa spinge questi giovani a mettere a repentaglio la loro vita per sfidare una parete di roccia ed arrivare in cima alla montagna. Si dice che il salire una parete sia una palestra di vita, che la gioia della scalata sia qualche cosa di incommensurabile, che, giunti in cima, l’animo si apre in una serenità celestiale e che si è più vicini a Dio. Sarà vero, vuol dire che il mio amore per la natura e la montagna non è 178 così grande come io credevo fosse, ma sono contento così. Preferisco guardare, osservare, studiare e poterlo fare ogni volta che ne ho voglia pur rimanendo un anonimo, che non poterlo più fare ed avere un cippo a ricordo. A questo punto decidiamo di salire su quel minuscolo pianoro dove sorge la chiesetta di Santa Maria in Siaris. Dopo un’arrampicata, per l’erta salita, giungiamo dinanzi alla piccola costruzione per ammirare da lassù un paesaggio stupendo che ci riempie gli occhi di giochi di luci, di chiaroscuri poiché il sole gioca, alternandoli, sulla parete rocciosa di fronte. Vorremmo entrare nella chiesetta per una breve preghiera al Signore e un ringraziamento per tutte le bellezze che la natura, in quella valle, ci offre, ma la chiesetta è chiusa e di essa poco si sa, sembrerebbe che sia stata costruita ancor prima del XIV secolo. Il 3 maggio, è il giorno in cui tutti quelli che amano e frequentano la Val Rosandra, si ritrovano, a migliaia, per rendere omaggio a Santa Maria e rendere grazie a Dio. Viene celebrata la messa, ma all’interno riescono a trovar posto solamente quelle poche decine di persone che di buon mattino sono giunti sul piccolo sagrato antistante, mentre gli altri sostano in preghiera e seguono la messa diffusa dagli altoparlanti, giù giù per il sentiero fino in fondo alla valle. Seduti sulle pietre, mia moglie ed io, mangiamo mezzo panino ciascuno, più per riposarci un po’, che per necessità di far merenda, dopodiché riprendiamo la discesa verso la valle per uno stretto sentiero che porta giù fino al letto del torrente, alla Fonte Oppia e ai piedi della stupenda cascata. A questo punto decidiamo di ritornare indietro seguendo il sentiero che costeggia il torrente, che si trova a destra, mentre sulla sinistra, a tratti, ammiriamo i resti dell’acquedotto romano, che prendendo l’acqua dalla Fonte Oppia, la portava attraversando la piana di Zaule e Servola, fino all’antica Tergeste. Il pomeriggio è passato, stiamo per uscire dalla valle e dirigerci alla piazza di Bagnoli dove ci attende l’automobile per rientrare a casa. Ci giriamo un’ultima volta, quasi a voler fotografare, per ricordo, l’immagine della Val 179 Rosandra ripromettendoci di ritornare quanto prima e prendere il viottolo che porta alla Grotta delle Gallerie e ai terrazzoni che si stendono al sole o all’ombra degli alberi ai bordi del torrente, meta di famiglie con i bambini, che chiassosi e gioiosi, giocano a palla con il costante pericolo che finisca nelle gelide acque del Rosandra. 180 DUINO Oggi abbiamo deciso di fare una passeggiata nei pressi di Duino, dico nei pressi perché il territorio Duinate geograficamente si estende oltre a quello che è il suo castello e le case che lo circondano. Duino è come un enorme sasso che il Signore, per mano della natura, ha posto a picco sul mare per cantare e magnificarne l’azzurro intenso, quasi a contrastare le pietre e i colori del territorio retrostante. All’estremità di questo sasso sorgeva il vecchio castello di Duino, distrutto nel Quattrocento, di cui oggi possiamo vedere solo i ruderi. Nel medioevo era chiamato Tybein, che era il signore di questo lembo del Carso, ma si ignora l’epoca esatta della sua costruzione, che sembra però antecedente all’anno 1000. Comunque fu eretto in quella precisa posizione in quanto dominava a sud la scogliera di Sistiana e padroneggiava a nord le boscaglie degradanti verso il Timavo. La sua grande sovranità, però, era sul mare e sul porto di Duino. Il nuovo ed attuale castello fu eretto intorno ad un torrione romano e più volte ampliato da parte dei signori di Walsee investiti dall’Austria a reggere il ducato di Duino dopo la morte dell’ultimo dei discendenti, Ugo di Duino, e che fu anche il primo capitano austriaco di Trieste. Il nuovo castello fu già in piena efficienza agli inizi del XV secolo e serviva pure a proteggere il villaggio sorto ai suoi piedi, sulla strada chiamata Gèmina Timavi e che provenendo da Aquileia portava a Trieste. Estinta la famiglia dei Walsee, l’Austria affidò, per un breve periodo, la contea agli Hoffer e cioè fino alla morte del suo capostipite in battaglia contro i Turchi. Dal 1587 la signoria passò ai Torriani, che eseguirono importanti lavori nel castello nuovo badando non solo a crearsi un punto di difesa inespugnabile, ma provvidero ad attrezzarlo a tutte le più moderne comodità per la vita quotidiana convertendo la dimora del castello in un vero soggiorno principesco. Il castello divenne poi patrimonio dei principi della Torre e Tasso, ma durante la guerra del 1915-1918 venne quasi totalmente distrutto. 181 Nel 1920 i principi ricostruirono il castello restituendolo agli antichi splendori ed oggi le sue porte si aprono solamente per accogliere mostre di famosi artisti o congressi internazionali. Sulla torre sventola la bandiera che vuole essere anche un invito a tutti i popoli dell’Europa e del mondo ad unirsi in un comune destino. All’uopo è stato creato, in tempi recenti, entro i possedimenti dei principi, il Collegio del Mondo Unito che accoglie studenti di tutto il mondo accomunati in uno spirito di fratellanza e che assieme, indipendentemente dal colore della pelle e della fede religiosa, studiano e si avviano, dopo un difficile esame finale, all’arduo cammino della vita, in una società che loro stessi dovranno modificare onde cercare di evitare future guerre e incomprensioni nel desiderio di creare un mondo migliore. Lasciamo il paese e ci avviamo verso Sistiana. Proprio all’incrocio con la trafficatissima strada statale 14, sulla destra, inizia un sentiero che costeggiando il crinale carsico porta fino a Sistiana. Recentemente questo sentiero è stato ripristinato ed è stato intitolato a Rainer Maria Rilke, il poeta tedesco, nato a Praga nel 1886 ma che visse la sua giovinezza tra Monaco e Berlino. Egli viaggiò moltissimo alla ricerca di un’identità che rafforzasse il suo misticismo. Si recò in Russia da Tolstoj, a Parigi dove fu segretario di Rodin, celebre scultore francese, andò in Scandinavia, in Nordafrica e Spagna. Dal 1911 al 1912 soggiornò al castello di Duino, ospite della principessa Maria von Thurn und Taxis. Cosciente di una vocazione poetica, che egli chiamava religiosa, viveva al tempo stesso una lotta per affermare ciò che è più prossimo a noi, scorgendo nella propria poesia non un prodotto della volontà, ma il segno di una sottomissione a qualcosa di più grande, che ha fatto collocare Rilke vicino alla fenomenologia. Ed è con questo spirito, che nel 1912 iniziò a scrivere quell’opera immortale che sono le Duineser Elegien (Elegie di Duino) terminate nel 1922 a Muzot in un castello valdese della Svizzera. In una rigida mattina di gennaio, Rilke camminando a stento sulla sco182 gliera, mentre la bora con violenti raffiche sconvolgeva il mare e traeva dalle rocce, come da arpe Eoliche, un lamentoso suono, ad un tratto egli avvertì una misteriosa voce interiore dettargli, in due versi, l’attacco della sua prima Elegia: “chi mai, se io gridassi, mi udrebbe dalle schiere degli Angeli?” che fa ricordare la potenza della prima frase della quinta sinfonia di Beethoven. Quella stessa sera, Rilke aveva riempito tutti i fogli della sua prima Elegia. In tutte le Elegie difficilmente si cerca un cenno dell’ambiente duinese. Solamente fugaci gli accenni al castello di Duino, dove viveva: “Fuori il mare, fuori il Carso, fuori la pioggia; forse domani la bufera” Rilke, nell’approfondimento progressivo del suo pensiero, si astraeva dal mondo, e astratte dal mondo erano le sue liriche. Nel 1926 morì di leucemia e fu sepolto a Raron nei pressi di Montreux. Colà un violino, di una grande artista, diede al poeta delle “Elegie Duinesi”, l’estremo saluto con musiche di Sebastian Bach. Ritorniamo alla nostra passeggiata, la prima parte del sentiero si snoda all’interno di una pineta, poi il percorso prosegue con un gioco meraviglioso di luci e di spazi, negli anfratti del sasso, sale per specchiarsi nel mare che sotto strapiomba fra cespi profumati di timo e di salvia, scende per perdersi in mezzo all’ombra dei pini, nel verde delle siepi di sommacco, di frassini, sbuca improvviso su terrazze di pietra, si infila in dedali di bianca roccia, attraversa pietraie candide come nubi nel cielo d’estate. Nei punti in cui più alta si alza la roccia, troviamo delle diramazioni che portano a vecchie posizioni di artiglieria contraerea. Quelle postazioni, oggi, sono altrettanti belvederi. Tutto il sentiero offre ininterrottamente stupendi sguardi sulla barriera rocciosa e sul mare. Sembrerebbe, ma non lo è, una natura morta magistralmente impressa su tela da qualche noto pittore impressionista; piante e cespugli si arrampicano sui pilastri più esposti, sulle rocce strapiombanti. Nei punti più inaccessibili, sporgono canestri di ginestre, olivi, pruni e l’edera che danno vita alla roccia. Sotto, in basso, il verde, azzurro e pigro mare disegna e sussurra l’antica canzone dell’onda. 183 Ci fermiamo un momento per sederci su di una grande pietra per deliziarci di questa visione. Sembra quasi di sentire il canto del sasso del Carso che si affaccia e si specchia nel mare: una nenia dolcissima che stempera il cuore simile al sussurro del mare che, da bambino, udivo poggiando l’orecchio alla conchiglia raccolta sulla spiaggia. Riprendiamo la poca strada che ancora ci manca per giungere allo slargo di Sistiana, dove sorge il punto d’informazioni dell’Azienda di Promozione Turistica e dove termina il sentiero Rilke. Il castello di Duino è oramai lontano, il miracolo di sasso sposato alla terra e al mare ci saluta e ci sorride, ci invita a non dimenticarlo e a ritornare presto a trovarlo. Ci fermiamo un istante per un ultimo sguardo, ed io sento il desiderio di ringraziarlo per la gioia che mi ha dato pregando, nel contempo, data l’intenzione dell’attuale principe di vendere la proprietà, che non cada in mano di qualche speculatore che lo trasformi in residenza di lusso per ricchi viziati. Decidiamo, prendendo la macchina per spostarci, di vedere un’altra zona del comune di Duino e cioè la zona alle foci del Timavo. Pur essendo a pochi chilometri di distanza il paesaggio è del tutto diverso, il terreno è pianeggiante, rigoglioso di vegetazione ed il verde la fa da padrone. Non si tratta certamente del delta del Po, ma la foce del Timavo è abbastanza ampia e piacevole, meta di passeggiate domenicali di gruppi familiari in una zona pedonale dove non ci sono pericoli di automobili per i bambini. Il Timavo è un fiume che nasce dal Monte Nevoso, in Slovenia, e percorre col nome di Timavo Superiore un tratto iniziale di 47 chilometri su terreni arenacei ed impermeabili. Giunto però a 15 chilometri dalla costa, là dove hanno inizio le formazioni calcaree del Carso vero e proprio, del tutto permeabili, esso precipita nelle Grotte di San Canziano e prosegue quindi il suo corso sotterraneo per circa 40 chilometri in direzione da sud/ est a nord/ovest per tornare alla luce subito dopo a San Giovanni al Timavo 184 sotto forma di ricche sorgenti, le cui acque danno origine a un unico corso d’acqua, lungo appena 2 chilometri, e frettolosamente corre verso il mare nel golfo di Trieste a poca distanza di Monfalcone. Il suo corso sotterraneo è alimentato da numerose sorgenti carsiche e da altri corsi d’acqua ipogei ed è conosciuto solamente per grandi linee, in quanto sono ancora molto poche le voragini carsiche conosciute ed esplorate. Nory ed io sediamo su di una panchina per leggere uno dei libretti che portiamo con noi. È un libro che racconta un’altra leggenda, ma dato il suggestivo posto, il rumore dell’acqua ed il vociare della gente che, passeggiando, ci si avvicina per poi allontanarsi ci fa immedesimare e, quasi in un sogno ad occhi aperti, crediamo di vedere quello che in realtà non c’è. La terra allora era divinamente bella, era nella sua piena stagione, e gli argonauti dopo aver percorso il mondo, risalite le azzurre acque del’Istro, avevano trovato riposo presso le foci del Quieto. Giasone e Medea si erano saziati d’amore nei boschi che dalla Punta del Dente corrono verso la baia di Pirano, i colli di Trieste e le dolci acque del Timavo. Medea, nelle sue ore di esaltante felicità terrena, aveva piantato sul Carso, in quelle terre che il mare lambisce con infinita dolcezza e la pioggia di marzo rende leggere, l’amato lauro di Venere e beata aveva giocato con le spume bianche del Timavo godendo del sole e dell’acqua. Anche i Dioscuri, figli di Leda e di Giove, avevano conosciuto la gioia di correre sulla terra del Carso e quando i loro cavalli si abbeverarono nelle acque del Timavo e, nitrendo, riconobbero la divinità del fiume, essi innalzarono sul sasso, lambito dall’acqua, là dove oggi sorge, sommersa nell’ombra, la bella chiesa di San Giovanni in Tuba, un tempio al sole ed insegnarono alle genti del luogo ad allevare con arte i cavalli, che popolarono questa terra e crebbero con forti garretti portando dentro al petto il furore del vento. Genti forti vennero ad abitare queste nostre contrade e cavalcarono i cavalli duinati nelle lotte sostenute per fermare il passo delle legioni romane e che qui conobbero una sanguinosa sconfitta. 185 Stiamo fantasticando con queste notizie apprese dal nostro fascicolo, vivendo in un altro tempo, vedendo non quello che vediamo realmente, ma quello che crediamo di vedere quando, all’improvviso, colpiti da un pallone lanciato sbadatamente da un bambino, ci ritroviamo nella realtà, su di un bel prato verde con il Timavo, che imperterrito continua scorrere verso il mare. Si è fatto tardi, è ora di raccogliere le nostre cose, avviarci alla macchina e rientrare a casa sereni e felici di aver passato una bella giornata all’aria aperta, un po’ con la realtà, un po’ con la fantasia. 186 DA PROSECCO A SANTA CROCE Come già prima accennato, noi possediamo un piccolo pezzo di terra a Prosecco nel quale abbiamo sistemato due roulottes ed una piccola costruzione in muratura. Quando le nostre figlie erano piccole, d’estate, passavamo lunghi periodi in questa specie di camping privato concedendoci spesso delle passeggiate lungo i sentieri che da Prosecco vanno nelle varie direzioni. Una domenica, ricordo, avevamo deciso di fare i “turisti” e vedere che cosa i due paesini di Prosecco e Santa Croce offrivano. Prosecco ha due aspetti, quello antico e quello moderno: la parte antica con costruzioni prettamente carsiche con muri in pietra, piccole finestre, tetti regolari con uno o due comignoli, addossate le une alle altre in viuzze strette quasi a volersi proteggere vicendevolmente, qualche piccolo cortile e forse qualche piccolo terrazzo in pietra al primo piano; la parte nuova e moderna composta da belle ville con ampi finestroni e tetti più o meno movimentati in modo da dare un’impronta architettonica alla costruzione, circondate da ampi giardini recintati, portici, terrazze, vialetti e belle aiuole curate. Turisticamente parlando, l’unica cosa che il paese ci offre è la sua più antica costruzione, la chiesa. Essa fu eretta, come risulta da un’iscrizione posta sopra il portale, nel 1637. L’interno non presenta affreschi e arredi di particolare rilievo, ad eccezione del suo organo che ha ben 1.500 registri. Il campanile è alto 37 metri ed è visibile da molte parti dell’altipiano ed è dotato di tre campane, i cui suoni sono in mi bemolle, fa e sol, dando ad esse la possibilità di formare degli accordi particolarmente piacevoli. La chiesa è dedicata e consacrata a San Martino e l’undici Novembre, infatti, in paese c’è festa grande per onorare il Patrono. Viene allestito un piccolo parco dei divertimenti, c’è pure una fiera con bancarelle di tutti i tipi ed in tutte le trattorie viene servita la “gelatina”: un brodo concentrato di carne di maiale che, a freddo, posto nei piatti di portata si rapprende dando alla pietanza un aspetto trasparente nel quale si intravedono i pezzetti 187 di carne ed il tutto viene accompagnato da generose bottiglie di vino Terrano. Dopo aver girato per le viuzze e visitata la chiesa iniziamo la passeggiata verso Santa Croce prendendo quel sentiero numero 6 che passa davanti al nostro campo e che, in piccola parte, avevamo già percorso durante l’escursione da Miramare all’Hostaria ai Pini. Entriamo nel bosco di bellissime conifere d’alto fusto il cui sottobosco, in alcuni punti, è veramente rigoglioso e nel silenzio riposante del luogo sentiamo solamente il rumore dei nostri passi sul sentiero e sugli aghi di pino che lo ricoprono. Dopo circa quaranta minuti di passeggiata arriviamo ad un bivio che a destra porta verso il paese di Santa Croce, mentre a sinistra conduce verso il monte S. Primo. Noi decidiamo, come programmato, di andare verso Santa Croce e passiamo accanto a verdi doline e a formazioni rocciose caratteristiche. Il sentiero piega leggermente a sinistra ed ecco che ci troviamo di fronte il paese e la tipica cappella di San Rocco, piccola e rustica costruzione di stile gotico. Una bizzarra caratteristica di questa cappella è data dalla statua esterna che raffigura un pellegrino questuante. All’interno della cappella si legge un’iscrizione del 1646, data in cui si presume sia stata edificata. All’origine il paese era abitato prettamente da pescatori che, per un ripido sentiero, scendevano al sottostante piccolo porto ed era arroccato sul ciglione carsico prospiciente il mare, ora invece è diventato un centro densamente popolato che si estende fino alla provinciale Prosecco-Aurisina e dove, in armonia, convivono sia il ceppo italiano che quello sloveno. La chiesa, dedicata all’Invenzione della Croce (3 maggio) sembra sia stata costruita in epoca antecedente il 1500, anche se sulla facciata un’iscrizione porta la data del 1570 che potrebbe significare, però, una sua parziale ricostruzione. Altre date sono incise come quella, con iscrizione latina, sulla porta della chiesa e che porta il nome di Reinaldo Scarlicchio, datata 1613. Sul campanile, alto 30 metri, troviamo incisa la data dell’anno 1543. Dati certi di queste chiesette carsiche non se ne trovano, anche perché sono frutto della devozione degli abitanti del luogo che da soli, con i pochi mezzi a disposizione, erigevano in tempi diversi il loro punto di ritrovo spirituale. 188 Vicino alla chiesa parrocchiale scorgiamo un edificio che gli abitanti di Santa Croce chiamano “Vecchia Scuola” e sulla quale cerchiamo di leggere, ma con scarso risultato, un’iscrizione latina datata 1499. Altre cose Santa Croce non offre per quanto riguarda costruzioni antiche o monumenti, però ci regala uno spettacolo unico che solamente lei può offrirci. Ci affacciamo sul piazzale costruito a fianco della chiesa e della strada che scende alla stazione ferroviaria e ci si presenta d’un tratto una visione di straordinaria ampiezza: la costa istriana, dalla lanterna di Salvore a Pirano, Isola, Capodistria e Muggia, Trieste con i suoi due porti, la scogliera da Barcola a Miramare e Grignano, la costiera dal porto di Santa Croce a Sistiana, Duino e Monfalcone. In fondo notiamo la foce dell’Isonzo e la laguna fino a Grado. Nel centro il mare, un quadro esteticamente perfetto, con una ideale fusione di colori e coronato, in questa giornata particolarmente limpida, dall’incantevole visione delle Alpi Carniche e Giulie. Anche questa passeggiata è terminata, pian piano rientriamo nel paese per avvicinarci alla strada provinciale ed attendere l’autobus che ci riporterà a Prosecco. 189 DA SANTA CROCE AL BIVIO D’AURISINA Un giorno, ricordo, avremmo voluto rifare il “sentiero 21” a noi molto caro, quello che, attraverso vie campestri e cavalcavia ferroviari, va, anzi scusate, andava da Rupingrande ad Opicina. È da tanto tempo ormai che il sentiero 21 non esiste più, due manufatti della moderna civiltà lo hanno tagliato in due tronconi rendendolo inagibile, l’oleodotto transalpino, ma soprattutto l’autostrada che corre lungo l’altipiano. Era una passeggiata semplice, pianeggiante, ma tanto suggestiva tra boschetti deliziosi e ombreggiati d’estate, e prati fioriti. Era un sentiero poco frequentato e la vegetazione era intatta, tanto che per seguire il sentiero, era necessario scorgere i segnavia bianchi e rossi con il numero 21 apposti sugli alberi per non perdersi. Decidiamo allora, in alternativa, di fare il percorso che da Santa Croce va al Bivio di Aurisina. Saliti in piazza Oberdan sull’autobus 44 in mezz’ora circa scendiamo al centro di S.Caroce. Proprio in quel punto, il sentiero si infila tra case vecchie e rustiche per passare poi in una pietraia cespugliata a sinistra del nuovo villaggio creato per ospitare i profughi istriani. Il sentiero diventa una carraia, e lo si nota dai solchi paralleli lasciati dai carri o dai trattori che di là transitano, si dirige verso dei boschetti dapprima radi poi sempre più fitti fino a giungere in una rigogliosa pineta carsica. Nella pineta la carraia ritorna ad essere un sentierino che costeggia delle piccole doline coperte di cespugli e dei lunghi banchi rocciosi. Passando da uno scorcio all’altro, sempre piacevoli e differenti, ad un tratto vediamo una torre circolare che supera la vetta dei pini. Ci fermiamo per consultare il nostro immancabile libretto che ci darà notizie certe su questa struttura. Si tratta della torre costruita tra il 1854 ed il 1856 dalla Società delle Ferrovie Meridionali, quella che collegava Vienna a Trieste, per sollevare l’acqua delle polle di Aurisina, sorgenti al livello del mare. Questa torre oggi viene denominata “Torre vecchia” per distinguerla 190 dalla torre, molto più grande e più recentemente costruita situata poco sopra la strada costiera. La storia di questo acquedotto delle Ferrovie è strettamente connessa con la storia dell’approvvigionamento idrico della città di Trieste. Gli ingegneri, incaricati dei rilievi per la costruzione della ferrovia, avevano notato che gli operai che lavoravano sul tronco sotto il villaggio di Santa Croce, si rifornivano di ottima acqua potabile scendendo sulla spiaggia, dove avevano trovato parecchie sorgenti al livello del mare. Una volta accertata la potabilità e genuinità dell’acqua, venne fatta una minuziosa relazione alla direzione centrale dei lavori denominando il sito come “polle di Aurisina”. Trieste, da anni, abbisognava di un acquedotto che le assicurasse acqua sana e abbondante ed è per questo che la direzione accolse con grande interesse la relazione inviata dai loro ingegneri. Intercorsero fitte corrispondenze tra Vienna e Trieste e venne costituita, anche con molti azionisti locali, una società per azioni per la costruzione di un acquedotto. La presidenza della neo costituita società venne affidata al barone von Buck di Vienna. Le sorgenti, situate a circa tre chilometri dal piccolo porto di Santa Croce, vennero circondate da un muro e rinserrate in un fabbricato e un serbatoio venne scavato nella roccia per raccogliere l’acqua sgorgata dalle polle. Dal serbatoio, alcune pompe a vapore progettate ed eseguite dalla Fabbrica Macchine Sigl, facevano salire l’acqua alla torre di elevazione posta a 182 metri sul livello del mare e da lì una condotta in tubi di ghisa portava l’acqua alla stazione ferroviaria di Aurisina ed un’altra condotta portava l’acqua a Miramare e a Trieste. L’imponente opera di costruzione dell’acquedotto fu affidata ad un tecnico, l’ingegner Carlo Junker, lo stesso che, più tardi, fu incaricato dall’Arciduca Massimiliano a costruire il Castello di Miramare. L’entrata in funzione e l’inaugurazione dell’acquedotto che riforniva la città di Trieste avvenne il 27 luglio 1857. Dopo aver appreso queste interessanti informazioni, riprendiamo la nostra 191 passeggiata lungo il sentiero che scende tra i gradoni coltivati con una bellissima vista sul mare e sulla costiera. Volgendo lo sguardo a sinistra ammiriamo Grignano, Miramare ed in fondo, come una perla incastonata, la città di Trieste. Sempre con l’ausilio del nostro libretto, cerchiamo di scoprire, nella zona di Santa Croce a mare, delle sporgenze rocciose che altro non erano che delle “vedette” usate dai pescatori come punti di osservazione per la pesca al tonno, una volta molto sviluppata. Notiamo uno o due punti che potrebbero essere le citate vedette, ma non avendo dati certi, teniamo per buona la nozione appresa senza la conferma naturale. Odorose piante di timo e di salvia costeggiano il sentiero e ci accompagnano, con il loro profumo, nella nostra passeggiata tra lecci, pini e ginepri che nascono dal brecciame e incorniciano deliziose visioni. Sotto di noi, in trincea, passa la linea ferroviaria per Trieste e ancora più sotto corre il nastro d’asfalto della trafficatissima strada costiera. Il sentiero riprende a salire e, giunti quasi sul crinale, ci si apre un vastissimo panorama. La giornata è limpidissima e possiamo scorgere sullo sfondo le Alpi, ancora parzialmente innevate, dal monte Cavallo, sopra Pordenone, alle Dolomiti e dal Canin al monte Tricorno. Abbassando lo sguardo, verso il mare, notiamo le baie di Sistiana e di Duino con le rocce che le avvolgono, più in la Monfalcone e la foce dell’Isonzo con le sue “basse” di Punta Sdobba e Grado. Proseguendo, con impresso questo vasto panorama, giungiamo ad una piccola centrale elettrica dalla quale un sentiero ci porta verso il centro della borgata di Aurisina ed alla sua moderna piazza dove sorge il nuovo edificio del Comune. Di là, in cinque minuti, raggiungiamo la stazione ferroviaria di Bivio Aurisina, dove pazientemente attendiamo l’arrivo del treno che ci riporterà alla Stazione Centrale di Trieste, non prima, però, di aver ancora una volta ammirata la Cava Romana, i cui blocchi di magnifica pietra bianca si accumulano sullo scalo. Quella pietra è il prodotto più mirabile del Carso Triestino. 192 Anche per oggi la gita è terminata, un po’ stanchi, ma felici di aver visto ed imparato qualche cosa di nuovo, per noi. 193 LA COSTA DA SISTIANA AL TIMAVO Poiché nostra figlia Paola abita, con la sua famiglia, a Duino, decidiamo di fare una gita da quelle parti per poter, al rientro verso fine giornata, andare a trovare i nostri nipotini e, perché no, anche a riposarci un po’ prima del rientro a casa. Decidiamo di fare questa gita per cercare di scoprire ed imparare un po’ la “storia” di questa parte della nostra regione, zona terminale del Carso verso il mare. Ammiriamo la baia di Sistiana mare racchiusa da alte pareti rocciose, da pendii boscosi e le due lunghe scogliere che la proteggono dalle insidie del mare. Mi affiorano alla memoria ricordi di gioventù e racconto a Nory, che da bambino nel 1947, io avevo dieci anni, con i miei genitori ci recavamo abbastanza spesso in quei luoghi, perché mia zia Wanda , la sorella di mia madre assieme al marito Franco ed ai due figli Gianni e Dario era venuta, per un mese, a villeggiare a Sistiana. La zia, triestina di nascita, aveva sposato lo zio Franco che era valtellinese e pertanto, né lui né i figli nati a Sondrio, avevano mai visto il mare. La baia era del tutto differente, si scendeva per una stretta stradina e si arrivava su di una spiaggia sabbiosa deserta, solamente alcuni casoni di pescatori e tante reti da pesca stese ad asciugare. Ricordo che lo zio Franco al mattino presto si faceva accompagnare sulla spiaggia in attesa del rientro dei pescatori per poter acquistare e gustare, appena pescate, le ostriche vive. Erano la sua colazione. Sempre grazie al nostro inseparabile libretto, leggiamo che sulla spiaggia della baia furono rinvenuti mosaici appartenenti a edifici della stazione romana di Sistillianum che comprendeva ville e bagni. Il nome di Sistillianum venne impresso sul sigillo trecentesco della città di Trieste e stava ad indicare il limite occidentale del territorio della città. 194 La baia di Sistiana ha avuto un andamento ciclico, dallo splendore dei tempi romani alla semplice spiaggetta del dopoguerra. Il tempo passava e la baia cambiava volto di stagione in stagione. Pian piano la spiaggia venne coperta e resa agibile alle automobili, l’edilizia privata e commerciale sostituì i casoni. La parte occidentale della baia fu trasformata in un ampio e lussuoso campeggio che comprendeva oltre le piazzole di sosta per le tende e le roulottes, un bellissimo albergo, un ottimo ristorante e una sala da ballo all’aperto. Il complesso si chiamava “La Caravella” ed ebbe fama di essere uno dei più attraenti e ricercati campeggi d’Italia. Sul lato orientale, molto vicino alla cava che negli anni ’20 lavorava a pieno ritmo per procurare i materiali necessari per la costruzione del porto nuovo di Trieste, si erigeva il bagno ristorante “ da Castelreggio” il cui titolare, Carlo Castelreggio, era un abilissimo cuoco e un perfetto anfitrione. Memorabili le scorpacciate di semplici fritti misti di pesce freschissimo accompagnati da un delizioso vino bianco prodotto dallo stesso Carletto, così era affettuosamente chiamato dagli amici, e tratto dalla vendemmia delle sue vigne. Anni splendidi seguiti, purtroppo, dal ciclico andamento della baia che ha fatto sparire la Caravella lasciando una landa desolata e, dopo la morte di Carletto e di sua moglie Mariuccia, anche “da Castelreggio, le varie gestioni più o meno fortunate hanno fatto decadere il luogo. Speriamo in un rilancio del sito e, se il ciclo, come insegna la storia, ora è destinato a risalire, avremo, forse, la possibilità di riavere rivitalizzato un angolo splendido della nostra costa. A mezza costa, in mezzo a delle casette disseminate, sorge un vecchio palazzo in stile italico del XVII secolo, munito di feritoie per la sua difesa contro le scorrerie che allora infestavano l’alto Adriatico. All’epoca era la sede amministrativa per i poderi di Sistiana appartenenti alla Contea di Duino. Dopo la baia di Sistiana, verso Duino, vediamo un muro di roccia, alto circa ottanta metri, che cade a picco sul mare, molto profondo in quel 195 punto della costa e che conferisce un colore azzurro carico alle acque. La barriera di sasso si estende per oltre due chilometri e termina al Castello di Duino. La roccia è talmente compatta e poco fessurata che rende impossibile l’accesso anche dal mare non presentando nè insenature o grotte nè, tantomeno, spiaggette per l’attracco. Sopra questa barriera di rocce corre il sentiero che ho già descritto e percorso con mia moglie denominato “passeggiata Duinese” ed ora intestato a Rainer Maria Rilke. A questo punto scendiamo al porticciolo di Duino per ammirare quella, che non a torto, è considerata una delle più eleganti insenature dell’alto Adriatico con le sue rive ben curate sulle quali campeggiano alcune buone trattorie. Arrivando dal mare il colpo d’occhio è veramente splendido e questa piccola baia nulla può invidiare a ben più note consorelle della costa tirrenica. Da Duino la scogliera si abbassa lentamente di livello fino a giungere al Timavo. Tutta questa zona, in epoche remotissime, fu abitata. Infatti scavi effettuati in caverne in mezzo al bosco al di là del porto hanno fornito dei reperti interessantissimi di armi in pietra attribuibili ad abitatori trogloditi sicuramente di epoche anteriori a quelle che la leggenda degli Argonauti e di Diomede si riferiscono. La distruzione totale dei boschi tra Duino e il Timavo e la conseguente trasformazione della fertile zona in sterile landa hanno causato lo spopolamento di quelle terre per lungo tempo. Qui decidiamo di fermarci e non proseguire verso la foce del Timavo che in altra occasione abbiamo visitato e piegando a destra, ci avviamo verso la strada statale per sbucare di fronte alla moderna chiesa di S.Giovanni, disegnata dall’architetto Angelo Mazzoni con il suo bel portichetto ed il suo svettante campanile. A poca distanza vediamo ergersi l’erma del Comando della III armata con il monito: “Rispettate il campo della morte e della gloria” proprio di fronte al gruppo di lupi in bronzo che ricordano le gesta dei due reggimenti di fanteria della Brigata “Lupi di Toscana”. 196 Proprio in quel punto attendiamo pazientemente l’arrivo del pullman di linea proveniente da Monfalcone che ci porterà fino a Duino da Paola, Gianni e dai tre nipotini, anche questa volta soddisfatti della passeggiata “culturale” effettuata. 197 SUL SAN LEONARDO Una gita, Nory ed io, abbiamo voluto riservarla per salire sul monte San Leonardo. A casa, consultando i famosi nostri libretti, abbiamo scoperto che il San Leonardo ha un’intensa storia tutta sua e, questa volta, abbiamo deciso di fare la gita dopo esserci ben documentati su cosa andare a vedere. Il San Leonado, dai Triestini pomposamente chiamato monte, è una piccola altura verso il margine nord del Carso Triestino. In quei luoghi sia la storia che la preistoria, hanno lasciato profonde tracce e radici. La vista dalla cima è qualcosa di entusiasmante, infatti lo sguardo corre ad abbracciare la rada di Sistiana, la baia di Panzano, le varie lagune di Grado, si vede chiaramente il monte Cavallo, sopra Pordenone, le Dolomiti, le Alpi Carniche, le Alpi Giulie, la Selva di Tarnova e quella di Piro, il Monte Re e i monti della Vena, nonché, più vicini, l’altipiano di Duttogliano e di Comeno ed infine il Carso Triestino disseminato di villaggi più o meno grandi. Da lassù si spazia l’orizzonte per 360° e solamente questo è già un appagamento che, se muniti di un buon binocolo, un’oretta se ne va solamente per soddisfare il desiderio di ammirare il panorama. Nella lontanissima preistoria l’uomo che abitava le numerose caverne disseminate sul territorio, usava la cima del “monte” per scrutare i vicini clivi boschivi e la selvosa piana carsica a caccia di prede per soddisfare i suoi bisogni alimentari. Foreste immense ricoprivano tutto l’altipiano carsico, torrenti raccoglievano le acque dei colli circostanti per finire nel grande fiume, che nella profonda depressione, scendeva fino ad Jamiano. Il Timavo non aveva ancora scavato il suo quasi fantastico letto sotterraneo che da San Canziano va fino a San Giovanni di Tuba, ma scorreva tutto in superficie. Più tardi alcune comunità si stabilirono sulla vetta del San Leonardo per avere più possibilità di difesa da attacchi sia delle belve feroci che dell’uomo. Essi cinsero la collina con un triplice muro circolare, costituito da un alto vallo sopra una fossa profonda e divenne quello che è chiamato il “villaggio murato”. Nacque così il celebre Castelliere di San Lorenzo che è uno di quelli che ci hanno lasciato meravigliose testimonianze della loro esistenza. 198 È probabile che i torrenti, affluenti del Timavo, ed il Timavo stesso, abbiano tanto inciso il terreno, in modo da filtrare negli strati inferiori, tanto da costringere l’uomo a ritornare nelle numerose caverne dove l’acqua spesso ristagnava. Sempre a causa dell’erosione e l’assottigliarsi dei corsi d’acqua, le volte di queste caverne crollarono trasformandosi, con stupenda metamorfosi, in valloni circolari nel cui centro affluirono acque e terriccio. Si formarono così i caratteristici valloncelli carsici oggi scientificamente chiamati doline dall’omonimo vocabolo sloveno che significa valle, avvallamento. Castellieri e caverne vennero abbandonate in tempi assai più recenti quando, per probabile estinzione o abbandono dei territori da parte degli animali feroci, l’uomo decise di scendere nelle piane sottostanti costruendosi i primi focolai ai piedi delle rocce di Ternova e Samatorza. L’uomo cominciò allora una dura battaglia con la foresta per poter dissodare terreni e farne campi da semina. In breve le foreste si diradarono e riapparvero le sterili rocce che, flagellate da terribili venti, a malapena riuscivano, nelle doline, a trattenere la terra necessaria per le colture. La vetta del San Leonardo restò, comunque, per gli antichi abitatori del luogo un ricovero di salvezza tanto che eressero un sacello pagano nel quale l’uomo volle fissare la dimora del suo nume tutelare che, la credenza diceva, vagasse sulla cima del monte alla ricerca di un suo domicilio. Quando la popolazione carsica accettò la religione cristiana il sacello del monte San Leonardo venne prima abbattuto per poi erigere, al suo posto, un santuario cristiano. Per costruirlo furono usati tutti i materiali trovati sul posto e cioè i ciottoli e i sassi del vallo del vecchio castelliere nonché le pietre del sacello pagano. Non si sa a chi fu originariamente consacrato il tempio; solo in tempi più recenti esso fu dedicato a San Leonardo. La scelta di questo santo cui dedicare il tempio fu data dal fatto che egli è considerato il protettore dei deboli e del tempo, nel senso atmosferico. Leonardo era un nobile francese alla corte di Clodoveo I° che si convertì al cristianesimo, fu battezzato e divenne un missionario in Aquitania dove subì il martirio che lo beatificò. Egli veniva invocato dai villici duran199 te i temporali ed i fortunali ed esso placava la tempesta e salvava i campi ed i loro raccolti. Questa funzione di patrono dei campi e del tempo era una concezione di antiche ideologie germaniche, ma che la Chiesa, nel tardo medioevo, riconobbe a San Leonardo confermando questa dedizione popolare. Nessun altro nome di Santo protettore sarebbe stato più appropriato per il luogo, data la sua prerogativa di avere una visibilità circolare di oltre cento miglia, che permetteva di avvistare in tempo l’arrivo dei fortunali e correre ai ripari. Per moltissimi anni, la vetta ed il Santuario, furono meta di pellegrinaggi, il 6 di novembre festa dedicata a San Leonardo, lungo i ripidi sentieri da parte di devoti cristiani che celebravano le funzioni religiose ed i conseguenti festeggiamenti. Ma le popolazioni erano in continua evoluzione e pertanto vollero erigere, intorno l’anno 1500, pure un oratorio fuori dell’abitato di Samatorza e congiunto ad essa con una stradina solitaria. Intorno il 1600, l’oratorio, divenne la chiesa di S. Ulrico, suggestiva per il suo romitaggio e per l’austerità della costruzione. Il santuario di San Lorenzo venne abbandonato e pur essendo in assoluto decadimento, resistette alle incurie fino ad un centinaio di anni fa, quando crollò definitivamente e ne rimasero solo le mura perimetrali. In tempi più recenti, prelevati dagli abitanti i pietrami e quant’altro poteva necessitare per nuove costruzioni, rimasero visibili solo le fondamenta. Salendo ora il San Leonardo, in vetta, si trovano antiche vestigia che fanno affiorare alla memoria epoche remotissime, lontane e recenti che suggestionando ed impressionando profondamente ci fanno capire l’importanza di questo osservatorio naturale del Carso. Avendo appreso cose nuove, oltre a quelle poche che già sapevamo, decidemmo che la prima domenica di sole e cielo terso, ci saremmo recati sul posto per cercare di “vedere” tutto quello che avevamo letto. La domenica venne, mettemmo in macchina le pedule con i calzettoni, 200 la merenda e una borraccia d’acqua e ci avviammo verso la meta della nostra gita: il San Leonardo.................. mi venne improvvisamente da ridere e dal tanto ridere seguirono le lacrime, tanto che dovetti fermare la macchina ai bordi della strada. Mia moglie, preoccupata, mi chiese cosa fosse successo, ed io, dopo essermi un po’ calmato ed asciugati gli occhi dalle lacrime, le spiegai che mentre leggevamo le notizie sul San Leonardo, io con la mente cercavo di “vedere” tutto quello che in escursioni precedenti, fatte con l’amico Piero, non avevo visto e tutto ciò mi sembrò impossibile in quanto Piero era un cultore del Carso. Era tutto molto semplice, leggevamo del San Leonardo, ma io con la mente vedevo il Lanaro.............ecco perché non capivo!!!! Rimisi in moto la macchina e andammo a fare una bellissima gita sul San Leonardo, felici, perché avrei e avremmo visto una località nella quale non c’eravamo mai stati. Fu una gita ed un’esperienza indimenticabile. 201 LA ROCCA DI MONRUPINO Termino questo mio breve racconto sulle “gite” fatte con Nory, parlando della rocca di Monrupino. Non è stata lasciata per ultima perché meno importante, anzi, per me è forse il posto più bello e suggestivo del Carso. Monrupino è un sito che, tutti gli amici, parenti e conoscenti che ho fatto visitare, sono rimasti a bocca aperta per la suggestiva atmosfera che infondeva all’animo. L’aspra rocca sulla quale sorge la chiesa di Monrupino è una consueta formazione rocciosa calcarea che appare parecchio fratturata e parecchi inghiottitoi naturali si aprono sulle pareti. La cima della rocca si può raggiungere da 2 versanti, il primo e più comodo, attraverso una ripida rotabile, che girando a spirale, raggiunge il grande portone ligneo posto a levante. Il secondo è un’erta pedonale che, verso la fine, diventa una scalinata e raggiunge una pittoresca posterla* sul lato di ponente. Dalla posterla, con alcuni gradini in parte incisi nella roccia, si esce sul piazzale. Il vasto piazzale, che fa da corona alla vetta della rocca, è stato ricavato dalla sommità di un Castelliere. Le pareti a picco che circondano la rocca da ogni lato, la rendevano inespugnabile e inaccessibile dalle belve. La rocca di Monrupino, per queste caratteristiche, viene considerato uno dei principali centri, se non addirittura il primo, del Carso. La punta di una lancia di bronzo è considerata uno dei più importanti reperti trovati sul posto. 2000 anni fa, sui resti del Castelliere, i Romani costruirono una base fortificata per poter controllare, dall’alto, il transito attraverso il valico di Zolla delle merci e degli uomini che dal mare raggiungevano la valle del Vipacco. La fortificata rocca di Monrupino divenne nuovamente rifugio per la popolazione intorno la metà del 1500 quando, in quelle zone, continue * POSTERLA = piccola porta d’accesso in una fortezza o nelle mura d’una città 202 scorrerie dei Turchi rendevano pericolosa la vita nei villaggi delle vallate. I Turchi avevano mire di conquista dell’Europa orientale, tant’è che nel 1529 arrivarono sotto Vienna, cingendola d’assedio per parecchie settimane. La prima cappella, all’interno della rocca, fu costruita nel 1316 e che nel 1512 divenne una chiesa, press’a poco della forma di quella attuale. Nel 1559, di fronte alla chiesa, all’altro lato del piazzale, fu eretta la canonica. La chiesa fu danneggiata e riattata parecchie volte e nel 1856 fu elevata al rango di parrocchia. Quell’antichissima costruzione a ridosso del portone d’ingresso, a levante, è la parte più importante del complesso in quanto era l’antica casa del Comune. La chiesa che, solidissima da lassù, sfida da secoli le bufere del Carso, al suo interno possiamo vedere una pregevole pala, su lastra di rame, datata 1794, a firma di “Candidus”, e che rappresenta la Mater Salvatoris. Di notevole e pregevole fattura c’è pure un crocefisso eseguito da ignota mano artigiana. Fuori dalla chiesa possiamo ammirare una ben lavorata pila dell’acqua santa. Circa trent’anni fa il vecchio organo, irrimediabilmente guastatosi, è stato sostituito da uno nuovo e più moderno con ben 21 frontali e 12 registri. Il campanile, alto una ventina di metri, è stato costruito nel 1802 ed è visibile da tutto il Carso. Esso contiene 3 campane, la prima porta la data del 1798 le altre due, recenti, del 1952. Gli archivi della chiesa sono molto antichi, vi si possono trovare alcuni documenti del 1512. La vista è apertissima e si può vedere a nord la Selva di Tarnova, l’imponente massa del Nanos, gli altipiani di San Daniele e di Comeno. A Ovest possiamo vedere il monte Lanaro, mentre ad est notiamo il monte Orsario. Infine a sud c’è tutto il Carso Triestino da Duino a Basovizza. Il raggio d’orizzonte, da lassù, è veramente eccezionale essendo stato calcolato in 78 chilometri. È questo un ambiente suggestivo, silenzioso, lontano dai rumori del 203 traffico e della caotica civiltà moderna. Quando ci si siede sulle mura che circondano il piazzale non è difficile, con la mente, correre indietro nei secoli e rivivere le epoche rurali e pastorizie dove la vita era sicuramente più breve, ma anche il tempo scorreva lentamente senza la frenesia che oggi ci accompagna. Chiudere gli occhi ed ascoltare il leggero fruscio delle foglie degli alberi appena mosse da una leggera brezza, il cinguettio degli uccellini, lo stridere delle cicale che succhiano la linfa dei frassini, ci danno un dolce senso di benessere che non vorremmo finisse mai. Come tutte le cose belle, anche questo è destinato a finire presto, l’ora serale incalza e bisogna riprendere la macchina per rientrare a casa. Brevemente ho cercato di esprimere le nostre esperienze tentando di spiegare le nostre impressioni provate durante queste fugaci escursioni di poche ore al massimo. Nella mia mente sono rimasti tanti quadri, scorci, situazioni, immagini, che, di tanto in tanto, in una rapida carrellata mi fanno rivedere, esaminare e ricordare le nostre GITE IN CARSO 204 CONCLUDENDO... Carso. Penso che solo chi ci è nato e lo vive possa capirlo. Com’è possibile amare una landa piena di mistero su di un pianoro di sasso a malapena coperto da un sottile stato di terra dove l’uomo, testardo, cerca di coltivare le sue piante, lottando e rubando spazio alle pietre. L’inverno, con la sua gelida Bora che tutto spazza e nulla risparmia, solo il ginepro che si piega alle raffiche resiste con le sue radici aggrappate a quella poca terra ed alle pietre. I pini, serrati l’un l’altro, intrecciano le chiome quasi a fare barriera e, flettendosi, fanno da scudo all’irruento vorticare del vento tipico del Carso. Anche l’uomo, come il ginepro, resta attaccato alla sua terra, soffre ma non si lamenta, potrebbe migrare in lidi più temperati e confortevoli ma no, resta lì testardo, cocciuto, ostinato, e tutto questo perché? Perché chi ama il Carso lo accetta così com’è, nel bene e nel male, come una sposa alla quale bisogna restare fedeli nella buona e nella cattiva sorte, finché morte non ci divida. Ma ecco arrivare la primavera dove, dai detriti, fra le rocce, negli anfratti e dalla poca terra esplode d’un tratto la flora carsica, che sembra più una flora montana che d’altipiano, dove l’erba, le piante, gli arbusti, gli alberelli spuntano da ogni zolla e perfino dalle crepe della pietra e, in pochi giorni, i prati verdeggiano nascondendo le pietre, dando un aspetto rigoglioso al territorio. Non ci si ricorda più dell’inverno che aveva spogliato il Carso, sembra solamente un brutto sogno. Anche questo è il miracolo del Carso, come l’autunno, che ancora una volta fa cambiare aspetto al paesaggio. Il Carso si veste dei colori più meravigliosi, dilagano le foglie di tinta rosseggiante per arrivare fino al rosso fiamma viva, alternate a foglie color giallo intenso, e tutti questi colori parzialmente coprono il verde dei prati. Gli scorci che si possono vedere sembrano dei quadri di pittori famosi che con sapienti pennellate coprono la tela in un susseguirsi di toni chiaroscuri. 205 Noi questi quadri, non occorre che andiamo a vederli in pinacoteche famose, li abbiamo qui, sotto gli occhi, vivi splendenti, a centinaia, ma che dico a migliaia, basta avere occhi, animo e cuore per saperli guardare. È veramente difficile spiegare il Carso, perché per chi non lo conosce, non ci sono parole che possano bastare a descriverlo, non ci sono scrittori o poeti che possano farlo entrare nell’animo della gente e nel loro cuore. Per chi il Carso lo conosce, non occorrono parole, sa già tutto. Ma allora questo mio scritto è del tutto inutile? Credo di sì, ma a me fa piacere lo stesso di averlo scritto. Finito di scrivere Maggio 2001 Ringrazio tutti coloro che con i loro scritti, dai quali ho tratto nozioni e spunti, hanno permesso questa mia esposizione: Carlo Chersi, Mario Coloni, Giorgio Cusma, Fiorenza De Vecchi, Livio Grassi, Giuseppe Pittàno, Lorenza Resciniti, Laura Losei Ruaro, Pino Sfregola, Maria Vidulli Torlo Enciclopedia Multimediale Gedea, De Agostini 206 207 INDICE PRESENTAZIONE ............................................................................................. 3 PENSIERI .......................................................................................................... 5 PENSIERI ............................................................................................................ 7 POETI ................................................................................................................. 9 INFANZIA ......................................................................................................... 10 18 ANNI ............................................................................................................ 11 SONO CONTENTO ........................................................................................ 13 NONNO OCCHIALI ....................................................................................... 15 NONNO “CIUPO” ........................................................................................... 17 MIO PADRE E MIA MADRE .......................................................................... 20 MIO SUOCERO E MIA SUOCERA ................................................................ 23 LE MIE “BAMBINE” ........................................................................................ 26 MONELLERIE DEL DOPO GUERRA ........................................................... 28 SCENETTE IN BANCA ................................................................................... 32 PROSECCO ...................................................................................................... 44 don P.G. .............................................................................................................. 51 AMORE FRATERNO ....................................................................................... 55 3 DICEMBRE 1988 - 3 OTTOBRE 1998 ........................................................ 59 QUARANT’ANNI... .......................................................................................... 62 INFANZIA ....................................................................................................... 67 INFANZIA ......................................................................................................... 70 NATO A TRIESTE ........................................................................................ 101 PREFAZIONE ................................................................................................. 103 CAPITOLO 1 .................................................................................................. 104 CAPITOLO 2 .................................................................................................. 117 CAPITOLO 3 .................................................................................................. 123 CAPITOLO 4 .................................................................................................. 134 CONCLUDENDO... ...................................................................................... 145 GITE .............................................................................................................. 149 INTRODUZIONE .......................................................................................... 151 COS’È IL CARSO ........................................................................................... 153 DA MIRAMARE A PROSECCO .................................................................... 158 208 AURISINA ....................................................................................................... 168 VAL ROSANDRA ............................................................................................ 172 DUINO ........................................................................................................... 181 DA PROSECCO A SANTA CROCE ............................................................. 187 DA SANTA CROCE AL BIVIO D’AURISINA .............................................. 190 LA COSTA DA SISTIANA AL TIMAVO ....................................................... 194 SUL SAN LEONARDO .................................................................................. 198 LA ROCCA DI MONRUPINO ...................................................................... 202 CONCLUDENDO ......................................................................................... 205 209 Questo volume è stato fotocomposto da F&G Prontostampa sas - Trieste e impresso da Global Print s.r.l. Gorgonzola (MI) nel mese di marzo 2004 210
Scarica