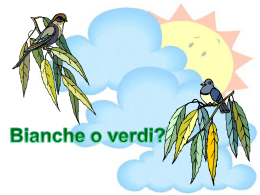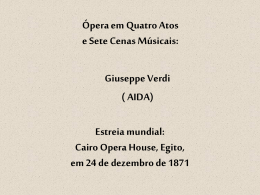Acquarello di Leopoldo Metlicovitz «Giuseppe Mazzini aveva il vizio, tra congiure, esili e liaisons con dame altolocate, di tuonare di tanto in tanto qualche profezia. Nel 1836 aveva dato alle stampe la Filosofia della musica: libello gonfio di sacro ardore, più che di crome e di biscrome. Pagine su pagine erano dedicate (sempre un po' tra le righe) alla necessità che il melodramma, genere d'intrattenimento all'epoca diffusissimo, divenisse il mezzo per infiammare d'amor di patria nobiluomini e popolani. E siccome mancava un compositore che si prestasse alla bisogna, occorreva immaginarselo. Il dedicatario dell'operina era dunque un "giovane ignoto, che forse in qualche angolo del nostro terreno s'agita". Mentre Mazzini, dall'esilio svizzero, profetizzava, a Busseto il Messia invocato e ancora ignoto si arrabattava per ottenere l'umile posto di Maestro di Musica del piccolo borgo rurale nel Ducato di Parma e poter così impalmare la fidanzata Margherita Barezzi». A Beatrice, donna d'incanti e d'incantesimi Prologo Scusatemi, sono il Prologo. E, come tale, chiamato a dar brevemente conto del come e del perché delle scelte dell'autore. Il quale ha avuto l'idea un po' pazza di offrire all'altare del centenario verdiano e alla propria passione per il Bussetano e il melodramma un centinaio di paginette di profilo, così, senza pretese accademiche, ma con la voglia di avvicinare Peppino (quello vero, non quello sponsorizzato dalle grancasse) al più vasto pubblico possibile. Preciso, ha tentato di esserlo. Divertente, o almeno leggero e garbato, anche. Lo spazio ridotto lo ha costretto a tagliare alcuni aspetti e ampliarne altri, secondo i suoi gusti e le sue (magari scriteriate) preferenze. Come d'uso, l'autore m'invita poi a qualche ringraziamento, sentito e non di prammatica: a Beppe Benvenuto che ha creduto nel libro e a Elvira Sellerio che ha deciso di dirgli di sì; a Paolo Paolini che ha risciacquato in Arno qualche intemperanza linguistica di troppo e lo ha indotto ad alcuni necessari ampliamenti; ai prodigiosi biscottini «Butter Cookies» e alle sigarette Merit i oo's che lo hanno sorretto di pagina in pagina. E alla dedicataria dell'operina, senza la quale essa non sarebbe mai nata. M.B. I Giuseppe Mazzini aveva il vizio, tra congiure, esili e liaisons con dame altolocate, di tuonare di tanto in tanto qualche profezia. Ne imbroccò, a memoria di storico, solo una. Nel 1836 aveva dato alle stampe la Filosofia della musica: libello gonfio di sacro ardore, più che di crome e di biscrome. Pagine su pagine erano dedicate (sempre un po' tra le righe) alla necessità che il melodramma, genere d'intrattenimento all'epoca diffusissimo, divenisse il mezzo per infiammare d'amor di patria nobiluomini e popolani. E siccome mancava un compositore che si prestasse alla bisogna, occorreva immaginarselo. Il dedicatario dell'operina era dunque un «giovane ignoto, che forse in qualche angolo del nostro terreno s'agita». Mentre Mazzini, dall'esilio svizzero, profetizzava, a Busseto il Messia invocato e ancora ignoto (che, ironia della sorte, si chiamava anche lui Giuseppe) si arrabattava per ottenere l'umile posto di Maestro di Musica del piccolo borgo rurale nel Ducato di Parma e poter così impalmare la fidanzata Margherita Barezzi. Di essere il Predestinato, ancora non lo sapeva, anche se i suoi sogni di gloria e quattrini lo portavano a Milano, lontano dal puzzo di stallatico e dai detestati compaesani. Di nome faceva Giuseppe Fortunio Francesco Verdi ed era nato in una piccola casa di Roncole, frazione di Busseto, la sera del i o ottobre 1813. Per uno strano scherzo del destino, solo pochi mesi prima, il 22 di maggio, Richard Wagner aveva visto la luce a Lipsia. Cominciò così, pressoché simultaneamente, il derby tra i due protagonisti del teatro d'opera ottocentesco. Da un lato, Verdi. Adorato dal pubblico, impersonava l'Italia provinciale e contadina, di scarpe grosse e cervello fino, facile alla lacrima e all'entusiasmo. Dall'altro, Wagner. Campione della Germania borghese e sgobbona, dotta e tormentata, e dunque osannato dalla critica. Tanto che, quando divampò la polemica tra i partiti verdiano e wagneriano, gli intellettuali italiani più à la page si schierarono compatti col Cigno di Lipsia. Quasi nessuno aveva sentito una nota delle sue opere, ma si sapeva che erano infarcite di armonie ardite e difficili. E tanto bastava. Verdi piaceva agli incolti e ai plebei, addirittura divertiva, dunque era triviale e scontato. Inoltre, era diventato una sorta di monumento nazionale, poco simpatico alle élites «radical chic». Il bussetano aveva subito la stessa sorte di Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Camillo Benso conte di Cavour e Vittorio Emanuele H. I suoi cori, dal «Va pensiero» a «O Signore, dal tetto natio» a «Si ridesti il leon di Castiglia», avevano infiammato i cuori sulle barricate e il suo stesso nome era stato utilizzato per inneggiare a «Vittorio Emanuele Re d'Italia». Fu dunque accolto tra i santini dell'epopea Risorgimentale e dato in pasto agli agiografi, da Raffaello Barbiera, a Michele Lessona, ad Arthur Pougin, e ai giornalisti, che non esitavano a ravvisare nei lineamenti del Maestro i tratti somatici di Dante, Leonardo e Michelangelo, topos poi ripreso dal solito Gabriele D'Annunzio al momento di verseggiarne la morte. La casa delle Roncole, con la sua facciata in pietra e il tetto spiovente, fu trasformata in un Presepe; per metterne meglio in luce il genio, si volle che i genitori di Verdi fossero dei bifolchi ignoranti. Il che non era del tutto vero. Papà Carlo, «probabilmente analfabeta», come raccontò anche il reputatissimo critico Massimo Mila, sapeva invece leggere, scrivere e far di conto, tanto da essere tesoriere della Fabbrica della Chiesa di san Michele. Non era mai stato contadino, né tanto meno lo era stato il nonno del compositore, che anzi aveva avviato l'attività di oste e droghiere. Anche mamma Luigia Uttini proveniva da una famigliola di piccoli commercianti e proprietari di locande nel piacentino. Erano piccoli piccoli, dunque, ma pur sempre borghesi. Nella casa-bottega delle Roncole, più che le sane virtù agresti, Peppino apprese le utili arti del «negozio» e contrasse il fatale morbo della «roba». Oltre a maturare, a contatto con i ruvidi birocciai e i bifolchi che la frequentavano, il caratteraccio che lo doveva rendere celebre come «l'Orso di Busseto» e che sin dall'infanzia doveva attirargli i pettegolezzi dei ciarlieri compaesani. Il piccolo Verdi serviva messa nella Chiesa della Madonna dei Prati come chierichetto, per contraccambiare i rudimenti musicali impartitigli da don Paolo Costa e garantirsi il diritto a usare l'armonium. Si narra che un giorno, rapito dalla musica emessa dall'organo, dimenticasse di allungare al parroco le ampolline. Il celebrante don Jacopo Masini gli sferrò un calcio e lo fece ruzzolare, tra le risate dei parrocchiani, ai piedi dell'altare. «Ch'at vena na saièta!», «Che tu venga fulminato», fu la blasfema reazione del ragazzo. E la «saièta», recitano le cronache, arrivò davvero. La sera del 14 settembre 1828 un temporale si abbatté sul paese. Durante il Vespro un fulmine penetrò nel santuario uccidendo don Masini e facendo strage di sacerdoti e cantori. II La Bassa padana è, a detta del critico e scrittore Bruno Barilli, «il paese del melodramma». Una sorta d'affinità elettiva lega, infatti, i parmigiani alla musica e in particolare all'opera. Inclinazione testimoniata dalle falangi di cantanti e professori d'orchestra coll'esse strascicata sparsi in tutta Italia, dai profluvi di spartiti mai pubblicati che si scoprono a ogni smontar di soffitta e dalla fama nefasta del Teatro Regio, fossa dei leoni per soprani e tenori. La genetica musicofilia emiliana sbocciò ben prima che Giuseppe Verdi inanellasse i primi successi. Oggi, a veder Busseto, può stupire che fosse sede di un prestigioso teatro, incendiatosi la sera del 27 ottobre del 1813: per i superstiziosi, 17 giorni dopo la nascita di Verdi. In scena si rappresentava la Proserpina di Giovanni Paisiello con protagonista la mitica Rosamunda Pisaroni, contralto prediletto da Gioachino Rossini. Sulle origini del rogo, si potrebbe malignare e pensare che sin dalla culla Verdi volesse vendicarsi delle future, acidule battute del pesarese, delle accuse d'aver ucciso il belcanto, dei fischi che di quando in quando gli avrebbero tributato i napoletani, fans sfegatati di Paisiello che aveva studiato e colto i suoi allori proprio nella capitale partenopea. Più che dai trilli e dai salti d'ottava della Pisaroni, l'infanzia di Peppino fu bombardata (e segnata) da suoni di fattura più plebea. Magari un po' grevi, come i cori dei clienti di papà Carlo nell'osteria delle Roncole, i canti degli artisti girovaghi e le tiritere dei loro organetti, il baccano della banda durante le festività; o frutto dell'artigianato dei molti dilettanti, come le accademie della locale Società Filarmonica, onore e vanto del paesotto sin dal Cinquecento, di cui era presidente il colto vinattiere Antonio Barezzi. Peppino prendeva gusto a tutto, ma prediligeva l'organo che ancor oggi fa mostra di sé nella chiesa posta proprio di fronte all'osteria. Una passione tale da convincere il parroco don Pietro Baistrocchi a impartirgli i primi rudimenti musicali e da indurre il padre a comprargli una malandata spinetta. Un rudere i cui bei dì erano passati da un pezzo, presto ridotta a malpartito dal piccolo pestatasti e riparata dal cembalaro Stefano Cavalletti. In spregio alle ragioni di bottega e in onore alle lacrime preoccupate di Peppino, l'artigiano eseguì il lavoro gratis, aggiungendo addirittura una pedaliera al cimelio, e appose all'interno dello strumento un cartiglio che reca l'anno del precoce trionfo «commerciale» del compositore: «A.D. 1821». Un po' frastornati dal bombardamento sonoro, alla fine, papà Carlo e mamma Luigia si convinsero a far studiare il rampollo. Dietro le insistenze e le palanche del Barezzi, beninteso: uomo di buon cuore e sentimenti liberali (aveva fatto della Filarmonica un covo di «sovversivi» coccardini), musicofilo e dilettante di pianoforte, clarinetto, flauto, corno e oficleide. Soprattutto, un benestante disposto a far da mecenate a Peppino. Fu un tirocinio artigianale: allo studio musicale con Fernando Provesi, organista del duomo e direttore della Filarmonica, e a un'infarinatura di buone lettere somministrata con qualche scapaccione da don Pietro Seletti, si univa la pratica. Un po' per finanziarsi le lezioni, un po' per dare gloria al paese e ripagare le attenzioni del Barezzi (del quale aveva cominciato a frequentare la casa e la figlia Margherita). «Dagli anni 13 fino ai 18 », narrò più tardi il Maestro, «ho scritto una farragine di pezzi: Marcie per banda a centinaja; forse altrettante piccole sinfonie che servivano per Chiesa, pel Teatro, e per accademie; cinque o sei tra concerti e variazioni per pianoforte che io stesso suonava nelle accademie; molte serenate: cantate (arie, duetti, moltissimi terzetti) e diversi pezzi da chiesa di cui non ricordo che uno Stabat Mater». L'esordio, quindicenne, fu nel 1828: la banda della Filarmonica eseguì una sua sinfonia scritta per il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini e otto pezzi per baritono e orchestra su testi poetici di Vittorio Alfieri, I deliri di Saul. Ma agli applausi entusiasti dei compaesani facevano riscontro le prime, sonore trombature. I biografi ricamarono il solito feuilleton sul genio incompreso. In realtà, i motivi delle bocciature erano più terra terra. Nel 1829, fu il «campanile» a far scegliere ai fabbricieri del Duomo di Soragna un organista autoctono anziché il bussetano. Giuseppe, successivamente approdato a Milano nel 1832, si vide rinviare al mittente la richiesta d'ammissione al Conservatorio. Era troppo vecchio, era cittadino di uno stato straniero (il Ducato di Parma) e la sua esecuzione casereccia del «Capriccio in la maggiore» di Heinrich Herze aveva urtato i delicati timpani dell'insegnante di pianoforte, il dotto Antonio Angeleri. Verdi se la legò, tanto per cambiare, al dito e conservò sempre tra le sue carte il faldone della domanda respinta. Quando, molti anni dopo, gli sarà chiesto di legare il suo nome all'istituzione meneghina, la risposta sarà poco diplomatica: «Non mi voleste quand'ero giovane, non mi avrete da vecchio». III Conservatorio o non Conservatorio, proclamò Antonio Barezzi ai delusi coniugi Verdi, Peppino a Milano doveva restare. Carlo e Luigia avrebbero preferito per il loro rampollo un tranquillo avvenire da maestro ginnasiale, fidando poco nell'incerto futuro rappresentato dal palcoscenico. Ma, in fondo, i danari li mettevano il sor Antonio e il Monte di Pietà di Busseto, dunque... E Milano fu. La città ambrosiana contendeva a Napoli il titolo di capitale musicale d'Italia, era il centro intellettuale più vivace della penisola e stava sperimentando forme moderne d'industria culturale, come già constatava, testimone diretto e attento, Carlo Cattaneo. Il mondo degli impresari, alla Domenico Barbaja o alla Bartolomeo Merelli, era affiancato dai colossi editoriali di Giovanni Ricordi e di Francesco e Giovannina Lucca: non solo stampavano spartiti e libretti, ma facevano sentire il peso della loro influenza e imponevano i loro autori, anche grazie a riviste e pubblicazioni specializzate sponsorizzate più o meno sottobanco. Il circuito dei teatri, a parte la Scala, comprendeva un buon numero di sale (i Filodrammatici, la Canobbiana, il Fiando, il Carcano...); circoli, associazioni, società benefiche allestivano accademie e opere liriche ed erano a caccia di nuovi talenti. Per un giovane compositore, Milano era una Mecca di opportunità. Peppino, nel 1832, fu dunque sistemato in via Santa Maria, presso Giuseppe Seletti, nipote del suo antico insegnante ginnasiale (dove restò poco, aveva cominciato a insidiarne la figliola Norina) e affidato all'anziano e arcigno maestro Vincenzo Lavigna affinché si perfezionasse. Lavigna apparteneva alla vecchia scuola. Nato nel 1777, si era formato a Napoli con Fedele Fenaroli (insegnante di Domenico Cimarosa e Nicola Zingarelli) e poi con Giovanni Paisiello, il quale nel 1802 lo aveva piazzato alla Scala come compositore di opere e balletti e «maestro concertatore». In una lettera del 9 gennaio 1871 a Francesco Florimo, Verdi ricorderà i limiti del suo apprendistato presso il Lavigna: «Nei tre anni passati con Lui non ho fatto altro che Canoni e Fughe, e Fughe e Canoni in tutte le salse. Nissuno m'ha insegnato l'istromentazione, ed il modo di trattare la musica drammatica». Lavigna non era il mentore rimbambito e démodé descritto, sia pure con affetto, da Verdi. Adorava il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, ancora considerato un'opera sperimentale, e lo faceva compulsare al riottoso allievo fino alla nausea. Soprattutto, invitò il Barezzi a provvedere Peppino d'un abbonamento alla Scala inducendolo a scucire ben 75 lire austriache. Verdi poté conoscere le opere di Saverio Mercadante (Donna Caritea, il cui coro «Chi per la patria muor vissuto è assai» fu intonato dodici anni dopo dai fratelli Bandiera sulla via della fucilazione), Gioachino Rossini (Otello), Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti (la celebre Lucrezia Borgia del 26 dicembre 1833), Luigi e Federico Ricci, Lauro Rossi, Carlo Coccia, Luigi Pacini. Compositori grandi e minimi, autori di capolavori o artigiani cui era demandato il compito di fabbricare roba «di cassetta». Frequentazioni tali da irritare gli intellettuali più raffinés, pronti a vedere in quei suoni plebei i germi del deprecato edonismo verdiano. All'anglista Gabriele Baldini non parve vero di sottolineare come «la messe di emozioni musicali che può raccogliere Verdi alla soglia dei vent'anni non include neppure Weber»; al critico Carlo Casini di contrapporre l'ambiente sofisticato che negli stessi anni praticava Richard Wagner a Dresda. Eppure, fu proprio appollaiato nel loggione che Peppino s'impossessò dei ferri del mestiere. Nel frattempo, occorreva tutelarsi con un buon posto fisso. A Busseto, morto nel 1833 Fernando Provesi, maestro di cappella del comune e organista del duomo, si scatenò la guerra di successione. Da una parte, i coccardini liberali della Società Filarmonica capitanati da Barezzi sostenevano Verdi; dall'altra, i codini clericali guidati dal prevosto don Gian Bernardo Ballarini non volevano saperne dell'ennesimo laicone. Il conflitto fu aspro e meschino come solo possono esserlo le baruffe di paese e coinvolse addirittura il ministro dell'Interno di Parma, Francesco Cocchi. Tra tumulti, poesie satiriche (la vicenda ispirò il poema in nove canti Gli uccelli accademici) e colpi di mano (i filarmonici rubarono gli spartiti dalla chiesa, per evitare che potesse usarli Giovanni Ferrari, l'organista nominato con un golpe da Ballarini), la batracomiomachia si concluse solo nel 1836. Salomonicamente. Le funzioni di organista (assolte dal Ferrari) furono scisse da quelle di maestro di cappella, affidate a Verdi per tre anni. Peppino poté così, il 4 maggio del 1836, sposare Margherita, la quale, sempre più allergica alle piccolezze bussetane, spingeva il marito alla conquista del bel mondo milanese. IV «Io passo la mia più bella gioventù nel nulla». Poco lieto del posto a Busseto, Giuseppe Verdi tambureggiava di epistole lamentose il maestro Pietro Massini. Massini, ben introdotto nei salotti, presidente della Società Filarmonica milanese, rappresentava il Caronte in grado di traghettare Peppino dalla bruma della Bassa ai palcoscenici meneghini. I due si erano incontrati nel 1834 alle prove della Filarmonica, dove Vincenzo Lavigna aveva accompagnato l'allievo. Alcuni membri della buona società si erano riuniti per formare un coro e mettere in scena la Creazione di Joseph Haydn: nessuno dei tre maestri accompagnatori si era presentato e, senza troppi complimenti, il malvestito Verdi fu schiaffato sul podio. Se la cavò talmente bene che i conti Pompeo Belgiojoso e Renato Borromeo gli fecero dirigere l'oratorio al Teatro dei Filodrammatici e, a seguire, al Casino dei Nobili, presenti l'arciduca Ranieri d'Asburgo e tutti i magnanimi lombi del circondario, frenetici di applausi per il campagnolo con le pezze sul sedere e l'aspetto spiritato. Ovvio che Verdi iniziasse a confrontare le sete e i merletti appena intravisti con le scarpe grosse dei tredici allievi cui giornalmente doveva far subire le sue sfuriate. E ancor più i paragoni li faceva l'ambiziosa Margherita. Dunque, Milano era la meta. Massini la strada. Un bell'operone la carrozza. E così, tra una lezione di solfeggio e una scarica di scappellotti alla studentaglia, Giuseppe trafficava intorno al Rochester, dramma verseggiato da un tal Tasca, di cui non è rimasta né una riga né una nota, e un altrettanto misterioso Lord Hamilton, su libretto di Antonio Piazza. Sul rapporto tra Rochester, Hamilton e Oberto, conte di San Bonifacio (la prima opera di Verdi a essere rappresentata), gli studiosi si sono sbizzarriti, ipotizzando trasformazioni, travasi o, addirittura, che i due primi spartiti venissero rifiutati e che Peppino facesse poi sparire le tracce dell'insuccesso. Il 16 settembre 1836 il compositore annuncia a Massini di aver completato 1' Oberto, conte di San Bonifacio, su libretto del Piazza modificato da Temistocle Solera. Lo stesso giorno a Milano si tengono i funerali di Lavigna. Peppino non partecipa, ingolfato dal lavoro. Massini intanto decade dall'incarico di direttore del Teatro dei Filodrammatici. Tocca dunque scovare un altro promotore. Su e giù da Milano, finanziati da Antonio Barezzi, Peppino e Ghitta ricercano uno sponsor. Verdi prova a piazzare l'opera al Regio di Parma, ma l'impresario risponde picche. Poi chiede a Massini di intervenire addirittura presso Bartolomeo Merelli, patron del Teatro alla Scala. Nel frattempo, briga e forca anche il conte Belgiojoso. La famiglia Verdi intanto cresce: il 26 marzo 1837 nasce la primogenita Virginia; l'i i luglio del 1838 un maschietto, Icilio Romano. Dài e dài, l'Oberto sembra destinato ad andare in scena alla Scala di Milano la sera di Carnevale del 1839, rappresentazione di beneficenza a sostegno del Pio Istituto Teatrale fondato dal duca Carlo Visconti di Modrone. Eccellente il cast: il soprano Giuseppina Strepponi, il tenore Napoleone Moriani e il baritono Giorgio Ronconi. Ma, a parti già assegnate, Moriani si ammala gravemente. L'opera viene annullata, poi Merelli decide di rinviarla al 17 novembre su insistenza di Ronconi e della Strepponi. Non c'è però tempo di gioire. Il 12 agosto muore infatti Virginia. I Verdi lasciano Busseto per seguire gli interessi di Giuseppe (che si dimette 28 ottobre dall'incarico di maestro di cappella) a Milano, si trovano a corto di quattrini e devono ricorrere al Barezzi o addirittura al Monte di Pietà, dove Margherita impegna i pochi gioielli per pagare in tempo l'affitto di due squallide stanzette. Le sciagure sembrano non aver fine: il 22 ottobre muore anche il piccolo Icilio. L'Oberto va finalmente in scena con il basso Ignazio Mariani, sua moglie Antonietta Ranieri e Lorenzo Salvi, uno tra i tenori preferiti da Gaetano Donizetti (fu, nel 1839, il primo Gianni di Parigi). Buona l'accoglienza del pubblico che, come ricorda il «Figaro», «parco d'applausi al primo atto, esuberò in acclamazioni al secondo». Tiepida invece la stampa, con l'eccezione del critico della «Moda», un tal Bermani, che dichiara essersi fatto il maestro «uno stile interamente suo». E infatti l'Oberto è già opera tutta verdiana: nella musica, dove tra risciacquature donizettiane e belliniane, mercadantesche e rossiniane, fanno capolino il tipico piglio teatrale e l'energia; nei personaggi che soffrono e agiscono, senza piegare elegiacamente il capo; per non parlare poi del protagonista Oberto, il primo della sterminata serie di padri-padroni della drammaturgia del bussetano. Al quale arriva finalmente qualche tallero. L'editore Giovanni Ricordi acquista la partitura per I.000 lire. Il Merelli gli offre un buon contratto: tre opere, da consegnare una ogni otto mesi, pagate 4.000 lire austriache cadauna, da rappresentarsi alla Scala o al Krtnerhortheater di Vienna. Che sia la volta buona ? V Neanche cessati gli applausi dell'Oberto, Verdi si dà da fare per onorare il contratto e si mette al lavoro sul Proscritto, un vecchio libretto di Gaetano Rossi, che però non lo soddisfa. Passarlo i mesi, il Proscritto non nasce e Bartolomeo Merelli sembra rassegnarsi a una ripresa dell'Oberto. Poi il maestro Nini, che avrebbe dovuto musicare un'opera buffa, rinuncia. L'impresario si rivolge dunque al giovane (e debitore) Verdi appioppandogli l'onere di far ridere il pubblico scaligero. Con parsimonia meneghina, anziché un testo nuovo, offre al suo pupillo una massa di roba decrepita, di scartafacci mai musicati o di opere cadute. Il meno peggio sembra essere Il finto Stanislao, scritto oltre vent'anni prima dal celebre Felice Romani (perbacco, il librettista di Bellini, Donizetti e Rossini), ma con la mano sinistra, prendendo spunto da una farsa francese del i 8o8, Le faux Stanislas di Alexandre Pineux Duval, e per un compositorucolo boemo in visita a Milano, tale Adalbert Gyrowetz: una dozzina di riprese, poi giù a prender polvere negli archivi. La trama è il solito miscuglio di travestimenti, matrimoni ed equivoci, il testo esilino e zeppo di luoghi comuni, ma Verdi non ha neanche il tempo di ponzarvi troppo. Un attacco di angina lo costringe a letto, poi Margherita comincia ad accusare strani dolori e febbri. Giuseppe si rimette in piedi giusto in tempo per assistere all'agonia della sposa: il 18 giugno Ghitta muore, stroncata da una sospetta meningite. Il compositore corre da Merelli, supplicandolo di rescindere il contratto, ma l'impresario è irremovibile: «the show must go on», e non può certo permettersi, dopo la rinuncia del Nini, di annunciare ai poco teneri funzionari asburgici l'ennesimo cambiamento del cartellone. Non è senza cuore, il buon Bartolomeo, ha passato le sue traversie (furtarelli vari in gioventù) e, raggiunto il benessere, non vuole intralci. Dunque, Un giorno di regno sia, e sia in fretta, visto che la prima è fissata per settembre. Sullo scombinato libretto di Romani, mette le sue mani non proprio leggere il buon Temistocle Solera, tagliuzzando a destra e a manca con tanto criterio da rendere la trama incomprensibile. Verdi non protesta, scrive come viene viene, pescando negli orticelli di Bellini, Donizetti, Rossini e, soprattutto, di Domenico Cimarosa e Daniel Auber. Il 5 settembre 184o, per l'apertura della nuova stagione, Un giorno di regno, ossia il finto Stanislao, «melodramma giocoso» di Giuseppe Verdi, va in scena alla Scala di Milano. Di tutto rispetto il cast: il soprano Antonietta Ranieri Marini impersona la Marchesa del Poggio; il mezzosoprano Luigia Abbadia, Giulietta di Kelbar; il tenore Lorenzo Salvi, Edoardo di Sanval; il baritono Raffaele Ferlotti, il Cavaliere di Belfiore. Il pubblico è ben disposto nei confronti del ventiseienne Verdi, già soprannominato «il maestrino», che giusto un anno prima aveva debuttato con successo sul palcoscenico milanese con l'Oberto, conte di San Bonifacio. Stavolta però l'opera è un fiasco. Bordate compatte di fischi accompagnano la fine degli atti, tanto da costringere la direzione dell'Imperial Regio Teatro ad annullare le repliche previste. Pollice verso del pubblico, pollice verso della stampa. Per il «Figaro», addirittura, la trama sconnessa e «la poca attitudine dei cantanti al genere giocoso» sono attenuanti rispetto alla cruda verità: «L'ispirazione ha quasi interamente abbandonato il Verdi»; per «La Moda», i cantanti «perdettero la bussola a tal segno da cessar di cantare, o muover soltanto le labbra»; per «Glissons, n'appuyons pas», «ad ogni passo v'incontrate un motivo che già sapete a memoria»; per l'autorevole «Corriere delle Dame», «lo spartito di Verdi ha dato in complesso una mentita alle belle speranze che si erano di lui concepite dopo il suo primo esperimento». Un bello spirito comincia a far circolare un distico atroce dedicato alla débdcle del bussetano: «Solo regnò dei suoi nemici a scorno / Ma il regno, si può dir, fu di un sol giorno». La tradizione voleva che i compositori assistessero alla «prima» dei loro lavori seduti in orchestra, pronti a ricevere il responso degli ascoltatori. Verdi affronta l'onta, ingurgita fino all'ultimo buuu, poi corre a casa, nelle stanzette di via San Simone 3072 (oggi via Cesare Correnti), imballa i mobili e li rispedisce a Busseto, dall'affranto suocero; rotto il contratto con l'impresario della Scala, Bartolomeo Merelli («Non scriverò più una nota! ») - che però, da vecchia volpe del palcoscenico, gli conferma la stima («La mia fiducia in te non è diminuita: chi sa che un giorno non ti decidi a riprendere la penna! Basta avvertirmi due mesi prima di una stagione, e ti prometto che la tua opera sarà rappresentata») - il «maestrino» si ritira nella stanzuccia misera d'una pensioncina in via Durini e sopravvive dando lezioni di musica. VI Orso sì, ma in anni maturi accorto promoter della propria immagine, Verdi rivela alle volte un genio per le pubbliche relazioni degno del diabolico Gabriele D'Annunzio: ad amici e critici musicali, come Camille Bellaigue e Filippo Filippi, dispensava granelli d'aneddoti e ricordi, coll'impegno, naturalmente, che li riportassero in articolesse e volumi. Vero, quando gli si chiese di redigere un'autobiografia, bollò la proposta come «indecente». Se invece si trattava di glossare lavori altrui, non si tirava certo indietro. E così, quando nel i 881 Ricordi pubblicò in italiano la Vita aneddotica di Giuseppe Verdi del francese Arthur Pougin, colse l'opportunità di dare, qua e là, un'aggiustatina dettando rettifiche e annotazioni al curatore e traduttore Folchetto (Jacopo Caponi). A Michele Lessona, occupato a scrivere le «vite d'italiani illustri» di Volere e potere, pubblicato nel 1869, rifilò durante una conversazione alle terme di Tabiano, prima di scriverne a Ricordi, un piccolo capolavoro di letteratura drammatica larmoyant relativo alla nascita del Nabucodonosor, poi scorciato in Nabucco, l'opera della consacrazione. Dunque, Verdi, ridotto a far l'insegnante di musica dopo il fiasco di Un giorno di regno, avrebbe incontrato Bartolomeo Merelli in Galleria de' Cristoforis. Strada facendo, sotto la neve di prammatica, l'impresario gli avrebbe infilato sotto braccio il libretto del Nabucco, «bellissimo» (nonostante l'avessero scritto le manone di Temistocle Solera) pregando che il «maestrino» ci desse almeno un'occhiata. Verdi accetta per sfinimento. Giunto a casa, getta con stizza il manoscritto sul tavolo che, oh meraviglia, si ferma «ritto in piedi», aperto sui versi «Va, pensiero, sull'ali dorate». Il compositore comincia a piluccare il melodrammone biblico. Si fa forza, va a letto, macché, il Nabucco gli «trotta pel capo» e impone d'esser messo in musica. Sia vera oppure no, la storia, come si sa a lieto fine, è bellina. Il genio, in qualche modo, doveva prorompere, risorgere dopo il tonfo. In realtà, se non per un breve periodo di sconforto, trascorso a legger «romanzacci», Verdi il teatro musicale non aveva pensato di abbandonarlo, come un giorno confessò di sfuggita al Filippi: «Se ho continuato in questa mal'augurata carriera si è perché a ventisei anni era troppo tardi per fare altra cosa, e perché non avevo fisico abbastanza robusto per tornare ai miei campi». I quali campi giacevano poi in quel di Busseto, l'«infelicissimo» e pettegolo paese pronto ad accogliere con tutti i disonori l'illustre compaesano tornato alla biolca e alla drogheria con le pive nel sacco. E così, già il gennaio del 1841 vede Verdi impegnato a raccomodare l'Oberto per l'Opera di Genova: «Il pezzo che piacque più di tutti» registra Peppino in una lettera a Luigi Balestra, «fu l'aria d'introduzione: vi ho aggiunto la Banda e fa un chiasso diabolico». Nel frattempo, tutte le energie erano concentrate su Nabucodonosor, pronto per l'autunno del 1841. Cosciente che si trattava dell'ultima chance, il «maestrino» sfoderò gli artigli. Intanto, col povero Temistocle Solera. Il poeta, con tutta la sua imponenza, i suoi mustacchi e la sua fama, si vide costretto a mutar scene e buttar giù nuovi versi. Verdi, infatti, macchinava qualcosa in più di un rifacimento del Mosè rossiniano. Quindi, dopo il coro del «Va, pensiero», via il duetto d'amore e giù una bella profezia per Zaccaria: «A posare sui crani, sull'ossa / qui verranno le jene, i serpenti, / fra la polve dall'aure commossa / un silenzio fatal regnerà! // Solo il gufo i suoi tristi lamenti / spiegherà quando viene la sera / niuna pietra ove sorse l'altera / Babilonia allo stranio dirà». Il tutto, sorretto dal lampeggiamento di quaranta biscrome d'archi e dall'acciaccatura di oboi e corno (il gufo, perbacco!). Il secondo a finir graffiato dal leoncello fu Bartolomeo Merelli. Verdi pretende che l'opera sia rappresentata per il carnevale del 1842, in modo da poter disporre del baritono Giorgio Ronconi e del soprano Giuseppina Strepponi, per le cui voci aveva composto le parti di Nabucco e Abigaille. Merelli nicchia, son previste altre opere in prima assoluta, il cartellone è già stampato... nulla da fare, Verdi si impunta e la spunta, pare grazie ai buoni uffici della Strepponi, cui aveva fatto leggere la partitura. Insoddisfatto poi dei cori scaligeri, che la meneghina parsimonia di Merelli non vuol saperne di ampliare, provvede di tasca propria. Si dovette solo accontentare di vecchi costumi e, a quanto pare, della stessa Strepponi, come riporta in una lettera Gaetano Donizetti. Pinin, infatti, è in pessime condizioni fisiche e vocali, sfiancata dal superlavoro. Il 4 ottobre del 1841, ha sfornato l'ennesimo marmocchio; le ultime petformances hanno mostrato una preoccupante usura. Per di più, secondo la commissione medica della Scala, «è affetta di tanta flogosi laringo-tracheale, che la conduce all'etisia, se subito non cessa d'esercitare la sua professione». Il referto data 3 marzo 1842. Il 9, Giuseppina doveva affrontare la terrificante tessitura di Abigaille. Durante una serata da "o la va o la spacca". VII E andare, doveva andare per forza. «Il successo della nuova opera», racconta Arthur Pougin, «cominciò alle prove... il carattere dello spartito era talmente nuovo, talmente sconosciuto, lo stile così rapido, così insolito che lo stupore era generale», tanto che le maestranze, ad ogni pezzo, non mancavano di proclamare, in dialetto, «chef.. a noeuva!». Secondo Massimo Mila, invece, «il Nabucco parlava un linguaggio musicale di cui non aveva motivo di sorprendersi chi fosse abituato alle opere serie di Rossini, a quelle di Bellini, di Donizetti, di Mercadante. La foutta noeuva consisteva... nell'energia morale di cui si sentiva ora caricato quel linguaggio». Il raffinato musicologo sembra così cedere al fascino del «Verdi patriottico», del popolo pronto a scattare in armi alle note d'un Vate consapevole che lo scontro tra Ebrèi oppressi e oppressori Babilonesi ricalca le vicende italiane. E così la vulgata tramanda milanesi con il fazzoletto in mano al «Va, pensiero», bissato a furor di pubblico contravvenendo alle severe e imperial regie regole. La notizia, riportata per la prima volta da Franco Abbiati, non trova però alcun riscontro nelle critiche dell'epoca, che non avrebbero mancato di segnalare un fatto tanto clamoroso. Né i recensori si soffermarono troppo, pur lodandolo, sul coro, che musicalmente non costituisce un momento isolato, ma fa tutt'uno con la profezia di Zaccaria (e in effetti «Coro e profezia» è intitolato il numero nella partitura autografa). Sullo spirito risorgimentale del Nostro, poi, basterebbe dare un'occhiata alla prima pagina dello spartito subito acquistato e pubblicato da Ricordi: «Posto in musica e umilmente dedicato alla S.A.R.I. la serenissima Arciduchessa Adelaide d'Austria il 31 marzo 1842 da Giuseppe Verdi »... Il segreto del successo di Nabucco è, forse, un altro. E sta nei duecentosei colpi di grancassa della sinfonia, aggiunta all'ultimo momento per far contento Antonio Barezzi. Reminiscenza degli exploit bandistici bussetani ? Forse, ma anche sintomo dell'energia che pervade la partitura, e che sorreggerà anche le più trucide opere degli anni giovanili. Il pubblico doveva rimanere incatenato alla sedia. Bisognava trovare qualcosa di nuovo. In grado di superare le amorose elegie belliniane e donizettiane e capace di far suonare, in maniera diversa, persino i calchi rossiniani che qua e là fanno capolino nell'opera. È l'aria truculenta e gotica di Francesco Domenico Guerrazzi (L'assedio di Firenze è del 1838), delle ballate di Giovanni Berchet. Insomma, Verdi percepisce la voglia di cappa e spada, traduce in musica i «romanzacci» letti durante il periodo di stasi creativa e spande il nuovo stile a piene mani, creando un modello di opera epicheggiante che perde i coturni neoclassici e indossa il giustacuore victorhughiano. Non è un caso che la struttura del libretto, diviso in quattro parti (Gerusalemme - L'empio - La profezia - L'idolo infranto), arieggi il feuilleton e la stampa popolare. Su uno sfondo al calor bianco, «corale», si stagliano le passioni dei personaggi. Non tutto è, ovviamente, attentamente calibrato. In particolare, gli «amorosi» Fenena e Ismaele risultano sfocati. Ma se si ha la ventura di ascoltare le parti di Nabucco e Abigaille cantate come Verdi avrebbe voluto, i due personaggi escono dalla consueta routine. Nabucco, innanzitutto. Verdi mette alla frusta le capacità di Ronconi. Volta a volta re e padre afflitto, superbo e generoso, costretto a cantare su tessiture altissime, spinto a una dinamica sonora sfumata, che passa dal pianissimo alla grandiosità delle apostrofi, Nabucco è la prima grande parte per baritono scritta da Verdi. Il baritono non è più solo l'antagonista del tenore, ma il vero motore della vicenda: e tale rimarrà da ora in avanti, almeno fino a Otello e Falstaff. Corda simile alla normale voce maschile (e dunque non molto amata dalle stilizzate regole melodrammatiche), proprio per questo diventa in Verdi la «voce dell'uomo» per antonomasia. Su un altro versante, Abigaille: come donna innamorata e respinta, resta sullo sfondo. Sbalza invece la principessa ambiziosa, immagine che si traduce in un canto pronto a passare dalle delicate fiorettature dell'andante «Anch'io dischiuso un giorno» alla bruciante cabaletta «Salgo già del trono aurato». Il successo alla Scala fu strepitoso. E, col successo, arrivò la caccia dei salotti milanesi al maestrino (per di più fresco vedovo), le tresche garbate con marchesine e duchessine, e magari con le più attempate ma sempre piacenti mamme. «Perfino la moda, perfino la cucina gli toglievano ad imprestito il nome, facendosi i cappelli alla Verdi, gli scialli alla Verdi, gli intingoli alla Verdi» scrive Lessona. Un periodo mondano destinato a durare poco. La fama andava consolidata, come il peculio. Richiesto di sparare una cifra per scrivere un'opera per l'apertura della nuova stagione, Verdi si rivolge alla Strepponi. Il soprano è irremovibile. Peppino deve chiedere al Merelli la stessa cifra pretesa da Bellini per Norma: 8.000 lire austriache. Verdi, per non sbagliare, rettifica a 9.000. VIII «Se non avessi conosciuto il nome del compositore, avrei scommesso che era un colonnello d'artiglieria», sentenziò Gioachino Rossini, dopo aver letto una partitura verdiana, secondo quanto riporta Edmond Michotte nei suoi Souvenirs. Il pungente giudizio del pesarese fu poi abbreviato nella definizione «compositore col casco» con cui fu a lungo etichettato Giuseppe Verdi. Il quale, da parte sua, col casco o senza, schiccherò dieci opere in circa sei anni, dai Lombardi alla prima Crociata (alla Scala di Milano, l'i r febbraio 1843) fino a La Battaglia di Legnano (al Teatro Argentina di Roma, il 27 gennaio 1849). Dieci melodrammi, cui va aggiunto il Jérusalem, rifacimento dei Lombardi per l'Opéra di Parigi, e una messe di aggiustamenti e arie aggiuntive composte per i divi del palcoscenico. Un lavoraccio, svolto in condizioni di salute spesso precarie, con l'alito degli impresari sul collo, si chiamassero Vincenzo Flauto o Benjamin Lumley, e le pretese degli editori Ricordi e Lucca da onorare. All'amico napoletano Masi, il 5 novembre 1845, quasi a giustificare lo spregio in cui gli studiosi più raffinati terranno poi questi lavori, Verdi si confessa «imprigionato continuamente a scarabocchiare note, dalle quali Iddio scampi le orecchie d'ogni buon Cristiano». A Clarina Maffei, il 12 maggio 1858, dichiara d'aver subìto, dal Nabucco in poi, «sedici anni di galera». Eppure, non c'era nulla da fare. La fama, dopo averla toccata, bisognava consolidarla. Era indispensabile, a caldo, confermare il successo scaligero e conquistare con nuove composizioni le «piazze» più importanti, dal San Carlo di Napoli a La Fenice di Venezia, dall'Opéra di Parigi al Teatro di Sua Maestà a Londra. A parte Emani e Macbeth, la produzione degli «anni di galera» non ha mai riscosso, salvo sporadici casi, l'entusiasmo della critica: le accuse di «cabalettismo», «edonismo» e di «prava volontà estetica» (così il pedantissimo Eduard Hanslick) hanno pesato a lungo come macigni. Certo, in questi melodrammi scritti a ritmo forsennato il «mestiere» spadroneggia. Verdi si barcamena tra partiture, librètti, cantanti. Per il genere epicheggiante, «Nabucco style», si rivolge per lo più al maltrattabile Solera. Quando vuole osare qualcosa di più, con i Due Foscari, è il turno del malleabile Francesco Maria Piave. Per Napoli, si affida all'idolo locale Salvatore Cammarano (e sarà Alzira); per Londra al colto Andrea Maffei, chiamato a libretteggiare i Masnadieri di Friedrich Schiller: due esempi di come ottimi letterati si rivelassero legati a schemi ormai démodé o privi di senso del teatro. Verdi assaggia una pluralità di fonti (da Tommaso Grossi a George Byron), di argomenti, di personaggi. Si assicura i migliori cantanti e cerca di compiacere gli ascoltatori. Nei Lombardi e nell'Attila titilla il municipalismo di milanesi e veneziani: i Lombardi si aprono su piazza Sant'Ambrogio; l'Attila celebra l'edificazione della città lagunare da parte dei profughi della distrutta Aquileja. La Battaglia di Legnano, commissionata dai triumviri dell'effimera Repubblica Romana, è tutta un inno alle virtù italiche e alla lotta al tedesco. Dove l'ispirazione manca, soccorrono le cabalette, le bande, i colpi di grancassa e gli ottoni, gli unisoni e i raddoppi orchestrali oppure gli estenuanti pianissimi: amore e morte, padri fratelli amanti l'un contro l'altro armati in passioni al fulmicotone. Se proprio il dramma non viene fuori, s'accende la pirotecnia dei cantanti, si chiamino Jenny Lind o Gaetano Fraschini, Erminia Frezzolini o Carlo Guasco. E tutto, o quasi, miracolosamente regge. Perché Verdi è, soprattutto, uomo di teatro, che ostenta l'abitudine di concertare le opere in palcoscenico per adattarle ai cast e garantirne la migliore resa. La roba leccata non fa per lui. La sperimentazione, sì, purché «giudiziosa». I personaggi acquistano rilievo, l'elemento amoroso pure, e tra fulgore di spade e cozzi virili anche il lirismo prende corpo, come nei Lombardi (e basterebbero l'aria di Oronte «La mia letizia infondere» o il terzetto «Qual voluttà trascorrere»). I pezzi chiusi, arie cabalette duetti e quant'altro, sono progressivamente montati in scene complesse (fin nella brutta Alzira), blocchi narrativi che regneranno da Rigoletto in poi. All'interno dei recitativi, comincia a meglio delinearsi il concetto di «parola scenica». Alcune frasi assumono un particolare rilievo: nell'Attila, la clamorosa entrata della vergine guerriera Odabella, «Santo di patria indefinito amor» che fa precipitare il soprano, a freddo e in otto battute, dal do sopracuto al si sotto il rigo, due ottave sotto; nella stessa opera l'inciso di Ezio ad Attila «Avrai tu l'Universo, resti l'Italia a me!» provocava scrosci inarrestabili d'applausi. Certo, non sempre le cose funzionano. Trionfano i Lombardi e cade l'Alzira, l'Attila ha successo, i Masnadieri si salvano per un pelo e il Corsaro crolla... Ma Verdi incassa applausi, fischi e svanziche senza batter ciglio. Dal Giorno di regno sembrano passati secoli. IX Ottenuta la definitiva consacrazione alla Scala di Milano con i Lombardi alla prima Crociata l' i i febbraio del 1843, a Verdi, per partire alla conquista del mondo, occorreva mettere il naso con opere nuove fuori dalle brume meneghine. Prima tappa: Venezia. Nell'estate del 1843, inizia così una fitta corrispondenza con il presidente della Fenice, conte Nani Mocenigo e col segretario del teatro, Guglielmo Brenna. Verdi impone onorario (salato: 12.000 lire austriache, ma Peppino non transige, e soggiunge «somma della quale non mi contenterei l'anno venturo») e termini contrattuali, ma la scelta del soggetto e del librettista si tramuta in un tormentone. Si parla di una Caterina Howard, poi di una Caduta de' Longobardi, di un Cola di Rienzi, a un tratto sbuca un Due Foscari, «fatto veneziano e musicabilissimo». Già, veneziano fin troppo, con tutti i Mocenigo, Foscari, Contarini e Loredan ancora in giro per calli e certo non felici di veder sbattuti sul palcoscenico gli aviti panni (più o meno puliti). Verdi vuole comunque staccarsi dalla maniera di Nabucco e Lombardi e battere strade diverse. Per di più, ma glielo impongono a Venezia, con un nuovo librettista. Sulle prime, Peppino non pare entusiasta. «Io non conosco il Sig. Piave, ma se la S.V. me lo assicura per buon poeta conoscente dell'effetto teatrale, e delle forme musicali... », scrive guardingo da Senigallia. Seminarista fallito, figlio d'un vetraio di Murano andato in rovina, Francesco Maria Piave era, melodrammaticamente, una «musa vergine». Sbarcava il lunario alternando correzioni di bozze e traduzioni, poesie d'occasione per nozze e battesimi e collaborazioni giornalistiche. Tre anni più anziano di Verdi, bistrattatissimo dai critici, fu però un ottimo librettista. Aveva umiltà, senso del teatro, funzionalità, doti che, nel pazzo universo dell'opera romantica, valevano molto di più dei futuri giochetti intellettualistici d'un Arrigo Boito. Ed era prono ai voleri di Peppino: «El maestro vuol cussì e basta» pare usasse intercalare quando l'incontentabile bussetano gli imponeva di accorciare o allungare, mutar scene e metro a seconda crel proprio estro e della drammaticità richiesta dal momento. E dire che, sulle prime, i rapporti non furono idillici. Dopo che Piave ebbe proposto a Verdi un Cromwello già bello e fatto, a Peppino balenò un'altra idea: «Oh se si potesse fare 1'Hernani sarebbe una gran bella cosa... Domani scriverò a lungo al Sig. Piave e stenderò tutte le scene del1'Hernani che mi sembrano adatte». Era un argomento incandescente: la prima rappresentazione del dramma di Victor Hugo aveva visto, a Parigi, gli avanguardisti romantici occupare la platea con Théophile Gautier e il suo gilet rosso in testa. L'argomento aveva subito tentato Felice Romani e Vincenzo Bellini, che avevano dovuto rinculare per il niet della censura. Piave era poco entusiasta, recalcitrava e per di più bussava a quattrini, il che non poteva ben disporre il parsimonioso bussetano. Galeotto fu l'incontro tra i due, a Venezia, e qualche marachella che il viveur Piave non avrà mancato di offrire al suo ospite. Poco a poco passarono dal lei al voi al tu. Ed Emani fu. Non senza problemi. Verdi strapazzava continuamente il povero Francesco Maria; il Mocenigo non voleva saperne del corno, pegno del patto tra Silva e il protagonista, ritenuto sconveniente in una disputa fra tre corteggiatori d'una donzella. Ingoiato il corno, la direzione provò a imporre a Verdi un contralto, Carolina Vietti, come protagonista en travesti, quasi si fosse ancora ai tempi di Rossini. Poi, si litigò sul finale dell'opera. Verdi voleva un terzetto, Piave si ostinava a proporre un'aria per tenore, di quelle belle romanze «di morte» che avevano reso celebre Napoleone Moriani; la stella del cast, la fenomenale Sophia Lòwe, pretendeva invece un funambolico rondò. Ma Verdi tenne duro. Con i cantanti fu sempre di manica piuttosto larga (per una ripresa di Ernani scrisse su invito di Rossini un'aria per il tenore Nicola Ivanov, «Odi il voto», facendosi ovviamente pagare), ma non quando ne andava di mezzo la teatralità: e lì ci voleva un terzetto. L'Ernani va in scena il 9 marzo del 1844. Un anno dopo il Nabucco. Ma non ne bissa il trionfo. Amaro il commento del Maestro alla contessa Appiani: «Se avessi avuto dei cantanti, non dico sublimi, ma almeno tali da intonare, l'Emani avrebbe avuto l'esito che ebbero a Milano il Nabucco e i Lombardi». La LCiwe, che aveva sul gozzo il rondò, andò in scena svogliata, il protagonista Carlo Guasco era fuori forma, basso e baritono non erano un granché. E senza cantanti, Emani non si fa: opera a caratteri, che mette in primo piano la lotta tra il bandito Ernani, re Carlo e Silva per la bella Elvira, rappresenta un autentico tour de force vocale. Arie estatiche o frementi, duetti terzetti e concertati dove le ugole si scatenano l'una contro l'altra in un duello all'ultimo acuto, Emani è un flusso melodico ininterrotto. Che, di lì a poco, entusiasmerà le platee nelle repliche e nelle riprese: entro l'anno toccherà quindici città italiane. X Dopo il successo dell' Attila al Teatro La Fenice di Venezia, il 17 marzo 1846, anche grazie a un'interpretazione maiuscola di Sofia Liiwe (stavolta mattatrice, dopo le bizze dell'Emani), i malanni di Verdi degenerano in «febbre gastrica». I certificati medici lo mettono per cinque mesi al riparo da Francesco Lucca, Benjamin Lumley e Antonio Lanari, tutti alla caccia di una nuova opera. Parte della convalescenza è trascorsa a Recoaro, dove Peppino alterna alle cure termali le conversazioni col dotto Andrea Maffei, il «simpatico sfarfallino» appena separatosi dalla contessa Clarina, traduttore dal tedesco e dall'inglese e librettista in pectore dei Masnadieri per Londra. Oltre a rimettersi in salute, Verdi ponza. Per il colto pubblico fiorentina, occorre mutare ancora maniera. Ristabilitosi, mette addirittura fretta all'impresario Lanari. Il 19 agosto 1846, Peppino ha già innestato la quarta: «Il tempo stringe... per fare un lavoro di qualche importanza i mesi che restano sono appena sufficienti». Se l'impresario non riesce a scritturare il tenore Gaetano Fraschini, poco male. Bisogna accaparrarsi il baritono Felice Varesi «il solo artista attuale in Italia che possa fare la parte che medito, e per il suo genere di Canto, e per il suo sentire, ed anche per la sua stessa figura... Il soggetto non è né politico né religioso: è fantastico». Quale sia, il compositore lo comunica a Piave: «Questa tragedia è una delle più grandi creazioni umane! » annuncia, e gli allega «lo schizzo del Macbet... Non vi deve essere una parola inutile: tutto deve dire qualche cosa... Brevità e sublimità», si raccomanda. Verdi aveva letto la tragedia di William Shakespeare nella traduzione di Carlo Rusconi, che riportava brani delle Lezioni sull'arte e sulla letteratura drammatica di August Wilhelm von Schlegel. Secondo Schlegel, Shakespeare crea per le streghe «un linguaggio particolare» che ricorda «l'idea della sorda musica che accompagna le danze notturne di quegli esseri tenebrosi»; Macbeth è «un eroe.'.. che conserva il segno della primitiva nobiltà del suo animo in tutti gli eccessi a cui è trascinato»; le scene capitali del dramma sono «l'uccisione di Duncano, il simulacro del pugnale che volteggia innanzi agli occhi di Macbeth, l'apparizione di Banco nel convito, l'arrivo notturno di Lady Macbeth addormentata». Sembra un riassunto dell'opera verdiana e delle epistole con cui il Maestro tempesterà librettista, impresario, cantanti. Il librettista, innanzitutto: «Come sei sempre prolisso», «troppe parole» sono i premi alle fatiche di Piave. Verdi è incontentabile, Francesco non gli sta dietro e ottiene il benservito: «Oh certamente tu non hai nissun torto salvo quello d'avermi trascurato in modo incredibile questi due ultimi atti. Pazienza! S. Andrea ha aiutato te e me». Già, Sant'Andrea Maffei ritocca, dà una leccatina qua e là e ottiene il favore del Maestro (che poi dovrà pentirsene nei Masnadieri e tornare di corsa a Piave). La seconda vittima è il portafoglio dell'impresario, cui viene richiesto di investire in «Coro» e «Macchinismo». Verdi pretende una «fantasmagoria» (un apparecchio ottico da proiezioni), tormenta lo scenografo della Scala, Alessandro Sanquirico, e il pittore Francesco Hayez, corregge costumi e fondali. Ma i più vessati sono i cantanti. Verdi ha in mente uno studio d'anime. Monta i pezzi chiusi in scene complesse. Farcisce lo spartito di indicazioni. Nelle lettere a Varesi si scatena in annotazioni interpretative. Fa provare il celebre duetto «Fatai mia donna» più di centocinquanta volte. La critica asserì che Verdi perseguiva una sorta di Sprechgesang wagneriano, blaterò e blatera di «declamato drammatico». Fu citata la lettera che Peppino scrisse a Cammarano in occasione della ripresa del Macbeth al San Carlo nel 1848, contestando la scelta della troppo angelica Eugenia Tadolini. Lady Macbeth ha da essere «brutta e cattiva», con «una voce aspra, soffocata, cupa... che avesse del diabolico». Viene però il dubbio che i tedeschizzanti musicologi non abbiano letto bene lo spartito, dedicato da Verdi a Barezzi, «padre, benefattore e amico». Macbeth e la Lady cantano su tessiture scomode, eseguono pianissimi a tutte le altezze. Macbeth deve padroneggiare anche il canto fiorito. La satanica Lady deve affrontare l'aria «Vieni, t'affretta», la veemente cabaletta «Or tutti sorgete», il brindisi «Si colmi il calice»: altro che declamato drammatico. E infatti, i due interpreti scelti da Verdi erano fuoriclasse. Varesi, di ottima tecnica, era cantante vigoroso e buon attore. Marianna Barbieri-Nini (ma Peppino avrebbe voluto addirittura la pirotecnica Lówe) brutta, era brutta, ma aveva una voce raggiante per timbro, ampiezza, estensione e agilità, oltre a un temperamento aggressivo. L'opera va in scena il 14 marzo 1847 con un successo tiepido, che si tramuterà in trionfo alle repliche. Verdi è soddisfatto e anela al riposo. Il 23 maggio 1847 scrive a Léon Escudier: «Voglio proprio provare una volta in vita mia se è bella la vita del signore». Prova rimandata. Lo attendono Londra, Parigi e una certa Giuseppina. XI La sera del 27 gennaio 1849 La Battaglia di Legnano di Giuseppe Verdi trionfa al Teatro Argentina, nella Roma repubblicana che ha appena defenestrato il Papa. Il pubblico al delirio obbliga il bis dell'intero ultimo atto. L'opera, programmata per Napoli, era stata progettata per aiutare Salvatore Cammarano, a corto di quattrini e con sei figli sulle spalle, mentre era rimasto solo vagheggiato un Assedio di Firenze che Piave avrebbe dovuto trarre dal romanzo di Francesco Domenico Guerrazzi. La lotta dei Comuni contro il Barbarossa è però il congedo di Peppino dagli operoni storicorisorgimentali. Dopo il '49, non è più tempo di Franceschi Ferrucci. La distratta censura che ha passato i cori patriottardi di Nabucco e dei Lombardi si fa arcigna. Verdi del resto ha sempre più in mente opere «a caratteri» tipo Macbeth ed Emani. Il clima è mutato. Verdi pure. Lo spiantato «maestrino» è ora un ricco possidente: a Busseto, ha acquistato nel 1845 il palazzo Cavalli, già dei conti Dordoni; nel 1848, la villa e il fondo agricolo di Sant'Agata. La morte di Gaetano Donizetti gli ha tragicamente sgombrato il campo. Famoso anche all'estero, accoglie fiaschi e trionfi con una nonchalance pari ai cospicui cachet. Ha composto i Masnadieri per Londra e adattato come Jérusalem i Lombardi per Parigi, facendo per la prima volta i conti con le necessità del grand-opéra. Dal 13 aprile 1844 ha un fedelissimo allievo e collaboratore, Emanuele Muzio, figlio del calzolaio di Busseto, affidatogli da Barezzi. Le lettere del pettegolo «Rossetto» sono una miniera di squarci sulla vita di Peppino e dell'ambiente teatrale, descritti con puntiglio e senza veli (della seconda moglie di Rossini, Olimpia Pélissier, Muzio scrive a Barezzi che «essa ha una rendita di 3o mila franchi accumulati col menar le coscie»). A un certo punto, però, Verdi fa a meno del suo appiccicoso famulus. In viaggio verso Londra, a un tratto Peppino lo scarica: deve volare a Parigi, Jenny Lind pare non voglia più cantare opere nuove e lui la vuolè per i Masnadieri... Ma a Parigi, si può arguire, c'è ben altro. C'è Giuseppina Strepponi che, dopo aver dato l'addio alle scene, vi ha aperto una scuola di canto. È stato lo stesso Verdi ad aiutarla. «Vi ringrazio di quanto avete fatto e di tutto quello che farete pella mia raccomandata», scrive il 26 ottobre del 1846 agli Escudier, il cui giornale, «La France Musicale», si era dato da fare per pubblicizzare i corsi del soprano. Quando poi l'amicizia nata ai tempi del Nabucco si tramutasse in liaison è incerto. Probabile che l'idillio sbocci nel 1847: il compositore è a Parigi alle prese con Jérusalem, ma il soggiorno si prolunga ben oltre la prima dell'opera. Verdi torna in Italia solleticato dal fragore del 1848. Tocca Milano, fa una scappata a Busseto. Ma il 31 maggio riparte già per la capitale francese e in estate affitta per sé e Peppina un quartierino a Passy. La restaurazione lo coglie nei panni di un ricco farmer, famoso, sentimentalmente impegnato, obbligato a mutar maniera, e in fretta. Ma come? Scartati gli impegnativi Amleto e Re Lear, Verdi chiede a Cammarano un «dramnìa breve di molto interesse, di molto movimento, di moltissima passione onde mi riesca più facile musicarlo». Sarà Luisa Miller, tratto da Kabale und Liebe di Schiller, in scena al San Carlo di Napoli 1'8 dicembre 1849. Verdi, dopo le quarantottate, ripiega sull'efficace coppia amore e morte. Come nell'Emani e nei Masnadieri, affronta una passione che divide adulti e giovani, deboli e potenti. E torna a sbozzare la figura del padre, il buon Miller, strumento della rovina della figlia Luisa, come già lo era stato lo stolto Giacomo nella Giovanna d'Arco. Incassati gli applausi di Napoli, arrivano le perplessità di Trieste. Stiffelio, al Teatro Grande, il 16 novembre 185o lascia dubbiosi pubblico e critica. Il soggetto era stato proposto da Piave. Il dramma francese Le Pasteur, ou l'Evangile et le Foyer, di Emile Souvestre ed Eugène Bourgeois, da cui il libretto è tratto, rappresentato a Parigi nel 1848, subito tradotto in italiano da Gaetano Vestri, correva per la penisola nonostante i paterni della censura: era la storia di un pastore evangelico sposato e debitamente cornificato. E infatti il censore Giuseppe De Lugnani, a due giorni dalla «prima», impose cambiamenti a libretto già stampato (si risolse con delle pecette), e alla scenografia: via altare e croce, la chiesa non doveva somigliare a una chiesa. Francesco Hermet, sulla «Favilla» del 20 novembre, rilevò l'assenza di <<cavatine od arioni a coro obbligato», la rinuncia al «ricamo sovrabbondante dell'istrumentazione a gran colpi di cassa» e al «clangore assordante degli ottoni». In Stiffelio, per la prima volta, Verdi affronta una vicenda contemporanea e borghese. Crea un protagonista lacerato tra due doveri e due morali: il cristiano che deve perdonare e il marito che vorrebbe vendicarsi. È il germe di Rigoletto, padre e buffone, di Azucena, madre e figlia... XII Il 28 aprile 185o Giuseppe Verdi comunica a Piave di aver scelto l'argomento per l'opera commissionatagli dalla Fenice di Venezia. Unico dubbio, la censura, ma «se la polizia volesse permettere sarebbe una delle più grandi creazioni del teatro moderno... Il soggetto è grande, immenso, ed avvi un carattere che è una delle più grandi creazioni che vanti il teatro di tutti i paesi e di tutte le epoche. Il soggetto è Le Roi s'amuse, ed il carattere di cui ti parlo sarebbe Tribolet che se Varese è scritturato nulla di meglio per Lui e per noi». Il dramma di Victor Hugo era stato rappresentato a Parigi il 2 2 novembre 1832 e subito proibito. A vent'anni di distanza, la materia non si era certo raffreddata: un re libertino seduce la figlia del suo buffone di corte; il buffone, deforme ma ricco di sentimenti paterni, decide di vendicarsi; in scena sicari, prostitute e una fanciulla che sacrifica verginità e vita per un amore mal riposto... Il presidente della Fenice, Carlo Marzari, scrive terrorizzato a Verdi per farsi spedire il libretto, preoccupato della «sfavorevole accoglienza» ricevuta da Le Roi s'amuse «tanto a Parigi che in Germania per la dissolutezza di cui va gonfio». Peppino, fiducioso, si mette intanto al lavoro e ricerca i cantanti. La risposta della censura si fa attendere. Poi arriva. Come un fulmine. Il 21 novembre 185o l'Imperial Regio Direttore Centrale Carlo Martello comunica alla Presidenza del Gran Teatro La Fenice: «Sua Eccellenza il Signor Governatore Militare Cavalier de Gorzkovski... deplora che il poeta Piave ed il celebre Maestro Verdi non abbiano saputo scegliere per far emergere i loro talenti, che quelli di una ributtante immoralità ed oscena trivialità, qual è l'argomento del libretto intitolato La Maledizione». La relazione giunge a Busseto e scatena le ire di Peppino: «O mi coprissero d'oro, o mi gettassero in prigione, io sarei sempre nell'impossibilità di scrivere un altro libretto». Comincia una spietata trattativa fra mene della censura e appelli alla ragione di Verdi: «Non capisco perché siasi tolto il sacco!... Tolto quel sacco non è probabile che Triboletto parli una mezz'ora al cadavere prima che un lampo venga a scoprirlo per quello di sua figlia... Osservo infine che s'è evitato di fare Triboletto brutto e gobbo!! Io trovo appunto bellissimo rappresentare questo personaggio estremamente difforme e ridicolo, ed internamente appassionato e pieno d'amore... le mie note, belle o brutte che siano non le scrivo mai a caso e che procuro sempre di darvi un carattere». Piave, in mezzo alla bufera, ha ordini precisi: «Non lasciarti indurre a fare trattamenti che portassero alterazioni ai caratteri, al sogetto, alle posizioni: se si tratta di parole lo puoi fare». Tira e molla, molla e tira, si raggiunge un compromesso: l'azione è spostata nel '500 a Mantova, il re è trasformato in un Duca senza nome (per evitare le ire dei Gonzaga), Triboletto diventa Rigoletto, Bianca si trasforma in Gilda. Verdi, febbrilmente al lavoro, invita Piave a stringere, gli detta i testi da versificare, gli impone la posizione dei pezzi. E Piave, in stato di grazia, gli sforna un bel libretto, magari rozzo nel linguaggio eppure teatralissimo. Verdi ci mette, di suo, le melodie. E innova, soprattutto la parte del protagonista, privo delle arie tradizionali ma con ariosi e duetti fatti apposta per spremere le capacità espressive del baritono Felice Varesi. La coloratura di Gilda è chiamata a simulare i palpiti del cuore; del Duca viene evidenziata la protervia libertina, di Sparafucile l'aplomb professionale, di Maddalena il carattere da puttana innamorata. Peppino raggruppa arie, duetti, pezzi d'insieme, articola i tre atti rispettivamente in sole 6, 3 e 4 scene, tanto da affermare ad Antonio Borsi di aver ideato l'opera «senz'arie, senza finali, con una filza interminabile di duetti». Al Borsi, marito del soprano Teresa De Giuli, che chiedeva al Maestro un'aria supplementare per la moglie, Verdi risponde che dei versi e delle note se ne sarebbero potuti anche fare, ma sarebbe mancata la «posizione». A meno di non voler mostrare Gilda a letto col Duca. Su questa lettera si imbastì la falsa leggenda di un Verdi nemico delle arie. In realtà, il bussetano non vi rinuncia mai, purché funzionali al dramma, inserendole, sia pur miniaturizzate o destrutturate, sino in Otello e,Falstaff. In Rigo-letto, studia per Varesi una «cabaletta sfarzosa, d'effetto», aggiunge un'aria per il tenore Raffaele Mirate, La donna è mobile, ed è talmente sicuro del suo effetto che lo obbliga a non cantarla mai prima della rappresentazione. In occasione di una ripresa parigina, inserisce un gradevole valzerino per Maddalena, Prends pitié de sa jeunesse, in onore del contralto Marietta Alboni. L'I i marzo 1851 Rigoletto trionfa alla Fenice, poi comincia a correre per tutta Italia e all'estero con i titoli più disparati. La critica, tanto per cambiare, ci capisce poco. E magari spara a zero. Per il «Times», Rigoletto è «l'opera più debole del signor Verdi, la più sfornita d'ispirazione... Entrare in un'analisi sarebbe perdita di tempo e di spazio». XIII Di ritorno a Sant'Agata dopo i trionfi veneziani, Verdi ha sul tavolo i pasticci amministrativi combinati dal padre Carlo, che con mamma Luigia è ospitato nella tenuta. Articolo quattrini, Peppino non ci sente: «Io intendo esser diviso da mio padre e di casa e di affari... presso il mondo Carlo Verdi dev'essere una cosa, e Giuseppe Verdi un'altra», comunica al notaio Balestra il 21 gennaio del 1851. Dopo aver provato il suo amor filiale, si rigetta sul lavoro. Da Vienna, gli propongono di rimpiazzare Gaetano Donizetti, con la prospettiva di diventare maestro di corte e far tintinnare nel già pasciuto forziere ben 12.000 lire all'anno; da Parigi, di musicare il Don Carlos per l'Opéra: prospettiva ghiotta, ma Peppino si proclama offeso d'esser stato contattato non dal direttore Nestor Roqueplan, ma dai librettisti Alphonse Royer e Gustave Vàez. In attesa che Oltralpe imparirio la buona creanza, c'è l'impegno con il San Carlo da onorare. Per Napoli, sceglie un testo di Antonio García Gutíerrez, El Trobador. Il drammone aveva furoreggiato in Spagna, tanto che al suo diciassettenne autore era stato conferito l'onore di sfangare, nel 1832, il servizio militare. Verdi, cui cappa, spada e truculenze assortite garbavano moltissimo, è entusiasta: «A me sembra bellissimo, immaginoso e con situazioni potenti», scrive a Salvatore Cammarano, invitandolo a prestare attenzione al personaggio di Azucena, cui inizialmente vuole intitolare l'opera. E si raccomanda: «In quanto alla distribuzione dei pezzi vi dirò che per me quanto mi si presenta della poesia da potersi mettere in musica, ogni forma, ogni distribuzione è buona, anzi più queste sono nuove e bizzarre io ne sono più contento. Se nelle opere non vi fossero né Cavatine, né Duetti, né Terzetti, né Cori né Finali etc. etc., e che l'opera intera non fosse (sarei per dire) che un solo pezzo, troverei più ragionevole e giusto». Il paradosso non era una sbandata wagneriana, ma il tentativo di smuovere dalla routine Cammarano, il tradizionalista autore della Lucia di Lammermoor, avviticchiato ai modi impolverati che Verdi aveva dovuto digerire in occasione di Alzira. Il canovaccio del buon Salvatore arriva, ma manca «tutta la novità e la bizzarria del dramma spagnuolo», e Azucena ha perso per strada il suo «carattere strano e nuovo». Verdi allega una sua proposta alternativa, anche perché il poeta dà l'impressione di batter la fiacca. Non è però la calma partenopea a rallentare Cammarano, che muore il 17 luglio 1852. Cesare De Sanctis, un ricco commerciante melomane amico di Peppino sin dai tempi di Alzira, raccomanda il giovanissimo Leone Emanuele Bardare, che «non cape in sé per la gioia» di lavorar per Verdi. Con gioia più o meno ricambiata dal compositore, non c'è tempo di trovar di meglio. Il 14 dicembre, lo spartito per canto e pianoforte è pronto. Non il San Carlo. L'opera è dirottata al Teatro Apollo di Roma retto da Vincenzo Jacovacci, che suggerisce alcuni ritocchi per evitare noie con la censura, e va in scena il 19 gennaio 1853. Fu un tripudio. Verdi non aveva abolito cabalette e pezzi chiusi, anzi li aveva portati all'iperbole in un ritmo formidabile. Il Trovatore è la summa del melodramma romantico. Leonora e Manrico sono simboli dell'ardore giovanile, come già lo erano stati Elvira ed Ernani; il Conte di Luna è un degno terzo incomodo; Azucena, divisa tra amor filiale e amor materno, tra affetto per il bimbo che ha cresciuto e desiderio di vendetta, è il motore del dramma. L'opera divenne il vessillo dei verdiani puri. Per Bruno Barilli, Verdi in Trovatore «ignora le parafrasi, s'intromette furiosamente, taglia i nodi con la roncola, e fa scorrere lacrime e sangue esilaranti, piomba sul pubblico, lo mette in un sacco, se lo carica sulle spalle e lo porta a gran passi entro i rossi vulcanici dominii della sua arte». Per Eduard Hanslick, invece, «la musica del Trovatore è ad un tempo la piena espressione della rozzezza artistica di Verdi e dell'intensità del suo talento», impegnato in una «voluta, dolorosa ricerca del triviale». In effetti, l'opera (a parte Azucena) mette in scena personaggi dalla psicologia sommaria, così come sommaria è l'ambientazione. È una corrente ininterrotta di energia il segreto di Trovatore. Un'energia tale da esser fraintesa. Della partitura si impossessarono gli urlatori, che trascurarono le mille sfumature per darci dentro a pieni polmoni. Tipico il caso di Azucena: il suo «Stride la vampa» andrebbe cantato pianissimo, sbalzando i trilli qua e là disseminati a simulare il crepitio delle fiamme. A parte Marilyn Horne, i mezzosoprani spianano e tirano dritto più becere che si può. Sul versante opposto, impregnati di filologia, i direttori d'orchestra si fanno un vanto nell'eliminare il do di petto nella cabaletta di Manrico «Di quella pira». Verdi mai lo scrisse: fu la trovata di un tenore, forse del primo interprete Carlo Baucardé. E fu un colpo di genio, che seguiva le prassi esecutive (la cabaletta andava variata nel «da capo» a gusto dell'interprete) e, soprattutto, coglieva lo spirito gagliardo di Manrico. XIV Solo a Parigi, lontana dai pettegolezzi, a braccetto col suo «Mago», Giuseppina Strepponi è pienamente se stessa. Non deve stare tappata in albergo, può darsi a un po' di mondanità e frequentare i teatri senza udire il sottofondo di brusii. E così, una sera d'estate del 1851, Peppina e Peppino assistono alla Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio. Verdi è folgorato dal soggetto contemporaneo, ancor più scabroso di Rigoletto. Inoltre, non può essere insensibile a una vicenda che gli rammenta la sua scandalosa liaison. La puttana che si redime per amore... Anzi. In fondo, Margherita Gautier non è che una cocotte, un'educanda al confronto della Strepponi, donna di palcoscenico (!) che ha scodellato due figli non si sa bene se da Bartolòmeo Merelli, da Raffaele Moriani o da chi altri. E poi, l'aria benpensante e codina che condanna l'amore della femmina perduta per il giovanebene Armando Duval, pur senza sentore di stallatico, è la stessa che ammorba Busseto. Né si va lontano dal vedere in Antonio Barezzi una sorte di Duval padre, imprigionato dai pregiudizi e timoroso della «gente». Da Parigi, il 21 gennaio del 1852, Verdi apostrofa il suo secondo padre: «Ella vive in un paese che ha il mal vezzo d'intricarsi spesso negli affari altrui, e disapprovare tutto quello che non è conforme alle sue idee... Da ciò provengono i pettegolezzi, le mormorazioni, le disapprovazioni... Io non ho nulla da nascondere. In casa mia vive una Signora libera indipendente... Chi sa se ciò sia bene o male ? ... Bensì io dirò che a lei, in mia casa, si deve pari anzi maggior rispetto che non si deve a me, e che a nessuno è permesso mancarvi sotto qualsiasi titolo». Anche il pudibondo vinattiere, che dopo la sciacquata epistolare tratterà Peppina come si deve, darà poi da ciarlare ai benpensanti quando, rimasto vedovo, impalmerà la domestica trentenne. In Traviata intenti artistici e vita reale vanno a braccetto. Peppino è ansioso di lavorare sull'opera nata quasi a un parto con Trovatore eppure così diversa. Uno sferragliare d'armi e colpi di teatro l'epopea di Manrico; intima e raccolta, a volte salottiera, la tenera e drammatica parabola di Violetta. Il che si riverbera nella partitura. Verdi mette a frutto il lirismo di Stiffelio e Luisa Miller e le conquiste di Rigoletto. Come nella tragedia del gobbo, i pezzi sono montati in ampie scene e le melodie si innestano l'una all'altra e l'una diversa dall'altra, dallo scintillio del primo atto, tutto un nevrotico vocalizzo, ai repentini trapassi dei tre grandi duetti, sino agli estenuati pianissimi dell'«Addio del passato» e della morte. La composizione del libretto non ha lasciato grandi testimonianze epistolari. Verdi riceve Piave (che aveva provato invano a riproporgli il Cromwel) direttamente a Sant'Agata, poi lo rispedisce a Venezia per limare le «lungaggini che farebbero dormire il pubblico» e sistemare con il solito Guglielmo Brenna gli eventuali problemi con la censura. Le melodie ribollono nonostante la strumentazione del Trovatore ancora da fare. E così allo scultore Vincenzo Luccardi, che lo attende a Roma, Verdi ordina: «Va da Jacovàcci che ti darà un pianoforte e fallo mettere nella mia stanza da studio, onde, appena arrivato, possa scrivere l'opera per Venezia senza perdere un minuto di tempo». Peppino giunge in laguna il 21 febbraio 1853. Ovviamente senza Peppina, un po' preoccupata dalla vicinanza del suo «Mago» col goliardico Francesco Maria. «Digli che non ti dimostri la sua amicizia battendo l'acciarino... Addio, ti bacio quel cuore d'angelo, che spero mio per sempre, quanto al resto non giurerei neppure nel momento che scrivo, specialmente con Piave vicino», scrive l'apprensiva Strepponi, cui son giunte all'orecchio certe precedenti marachelle veneziane. Venti giorni prima della rappresentazione Verdi preannuncia a Piave il prevedibile tonfo: «Ricevo da Venezia una lettera anonima in cui mi si dice che se non faccio cambiare donna e basso farò un fiasco completo. Lo so, lo so». E così fu, il 6 marzo del 1853: «La Traviata, ieri sera, fiasco. La colpa è mia o dei cantanti?... Il tempo giudicherà», comunica Peppino a Emanuele Muzio. I veneziani si erano smascellati quando, all'ultimo atto, avevano sentito «quel medico da farsa decretare che la tisi non accordava che poche ore a quel po' po' di matrona che era la Donatelli». La quale Fanny Salvini-Donatelli, ingaggiata perché era l'unica disponibile, aveva ricevuto consensi nel I atto e sibili in tutto il resto. Il tenore Lodovico Graziani era svociato. E aveva pasticciato anche Varesi, fuori parte e zufolato nell'aria «Di Provenza», della quale ebbe poi a lamentarsi. «Vorrei potervi far sentire da uno che sapesse cantare l'andante Di Provenza per farvi capire che è il miglior cantabile che m'abbia scritto per Baritono», scrisse poi Verdi al De Sanctis. Un gruppo di fans, tra i quali Antonio Somma, Cesare Vigna e lo stesso Piave, organizzarono la resurrezione al Teatro San Benedetto, con un cast rinnovato: nei panni della protagonista l'esile Maria Spezia, Filippo Coletti quale Giorgio Germont. Il 6 maggio 1854 La Traviata ebbe «un successo senza esempio». XV Chissà se, a cose fatte, Verdi avrebbe rifirmato quel contratto che lo portava ancora una volta fuori dalla quiete di Sant'Agata. Eppure l'occasione era ghiotta. Scrivere una partitura per l'Opéra di Parigi, da mettere in scena addirittura in occasione dell'Esposizione Universale del 1855! L'evento offriva l'opportunità di dimostrare ai cugini d'Oltralpe di che mirabilia fosse capace un compositore italiano alle prese con un genere tipicamente francese come il grand-opéra. L'Esposizione avrebbe celebrato il nuovo assetto urbanistico della capitale voluto da Napoleone iii ed eseguito dal prefetto Georges Eugène Haussmann. La trasformazione di maggior rilievo era costituita dai grandi boulevards, ottenuti sventrando alcuni dei quartieri storici e voluti per favorire le cariche di cavalleria in caso di sollevazioni popolari. Ironia della sorte, proprio a un sanguinoso tumulto si ispirava il soggetto: Les Vépres Siciliennes, libretto del celeberrimo Eugène Scribe e di Charles Duveyrier, dedicato alla rivolta dei palermitani contro gli angioini del 31 marzo 1232. Scribe, in realtà, aveva ricicciato un vecchio testo versificato per Gaetano Donizetti, musicato col titolo Le Duc d'Alba ma mai rappresentato (lo fu nel 1882, e solo allora Verdi si accorse della truffa). L'operone era quello che ci voleva: rispondeva appieno alle leggi che sovrintendevano al grand-opéra: cinque atti infarciti di sommosse, balletti (il primo, rigorosamente un'ora dopo l'inizio dello spettacolo, per dar modo agli ufficiali di sollazzarsi con le grisettes), feste, colpi (e cambi) di scena. Chissà la faccia di Peppino a leggere il libretto! Francesi e italiani ci facevano una magra figura; l'organizzazione dei pezzi era banale. Al secondo, al terzo e quarto atto era prevista la stessa scansione: un'aria, un duetto, un finale. Ma il compositore si dà comunque da fare per soddisfare la «grande boutique». Ribobola a più non posso l'orchestrazione (vero pallino dei parigini), sfrutta al meglio le doti dei cantanti e cura la scenografia. Verdi e la Strepponi, partiti alla volta di Parigi a metà ottobre del 1853, vi si fermarono fino agli inizi del 1855. Unico svago del lungo soggiorno le serate a casa di Rossini e le continue lettere di protesta indirizzate al direttore dell'Opéra Louis Crosnier, vuoi per il libretto, vuoi per la messa in scena, vuoi per il cast. A un certo punto, il soprano Sophie Cruvelli, stella del teatro, pensa bene di rendersi irreperibile a prove iniziate e concedersi una vacanza d'amore col suo spasimante, il barone Vigier. Fu uno scandalo mondiale, tanto che a Londra fu messa in scena una pièce intitolata Where is Cruvelli? Figuriamoci Verdi. All'Appiani, il 21 ottobre, scrisse d'essere impegnato a fare i bauli e pronto a rescindere il contratto. Non aveva fatto i conti con la Cruvelli, che si ripresentò bel bella a metà novembre all'Opéra, come se nulla fosse successo, tuffando la testa nello spartito. Sia come sia, messa in scena il 13 giugno 1855, l'opera fu applaudita entusiasticamente per ben cinquanta repliche. Anche oggi, qualche critico va in deliquio di fronte alla strumentazione raffinata, e si lamenta solo delle arie «banali». In realtà, proprio in alcuni cantabili («O tu Palermo» di Procida, «Giorno di pianto» di Arrigo, il bolero di Elena, «Mercé dilette amiche», l'aria di Monforte, «In braccio alle dovizie») Verdi riesce ad astrarsi dal farraginoso meccanismo che il sussiegoso Scribe (cui certo non si potevan chiedere modifiche) gli aveva messo in mano. Per il resto, la trama è contorta e i personaggi stereotipati: Elena è una virago, il patriota Procida un terrorista, Arrigo un tonto e l'unico a riscattarsi è il tiranno Monforte, diviso tanto per cambiare tra dovere di patria e amor paterno... Un po' poco, per chi aveva appena musicato La Traviata. Quasi per rifarsi la bocca, Verdi si dedica agli ozii di Sant'Agata: «Da mattina a sera sono sempre fra campi, boschi, in mezzo a paesani, a bestie... alle migliori però, alle quadrupedi». E scontenta la povera Peppina che avrebbe volentieri svernato a Parigi o, tutt'al più, a Genova. Nel frattempo, Peppino prova, convocato Piave, a risistemare Stiffelio. Per aggirare la censura, muta il titolo in Aroldo, il protagonista in crociato e trasferisce il tutto nella contea di Kent del xii secolo: a beneficio della trama, basata su un divorzio. A seguire, adatta il T;ovatore per Parigi. Gira a destra e a sinistra per tutelare i suoi interessi, impedire rappresentazioni clandestine e farsi pagare il giusto onorario dai Ricordi. E, tanto per impinguare le casse, cede il 12 maggio del 1856 alle profferte di Gio Batta Tornielli e dei conti Mocenigo per una nuova opera alla Fenice, dietro il congruo compenso di 12.000 lire austriache. Il soggetto sarà comunicato al fido Piave il 12 settembre: Simon Boccanegra, dal drammone di Antonio García Gutíerrez. Contemporaneamente, Peppino assume un impegno anche con il San Carlo di Napoli per Un Ballo in maschera. Ma stavolta i napoletani riusciranno a fare arrabbiare Verdi sul serio. XVI Tanto per amor di novità, Verdi pensò addirittura di far fare il Simon Boccanegra in prosa. Rinsavito, ammonì il buon Piave: «Come tu hai osservato benissimo, questo Simone ha qualche cosa di originale. Così bisogna che il taglio del libretto, dei pezzi ecc. ecc. sia più originale che si può». Nonostante gli sforzi, l'originalità latitava: insoddisfatto, si affidò ad Antonio Somma per rifinire un soggetto ostico, sulla linea dei Due Foscari, già protagonisti di un «mezzo fiasco». La passione politica, la lotta del doge plebeo Simon Boccanegra per conservare il suo potere e le trame di Paolo Albani e del patrizio Jacopo Fiesco per strapparglielo, era in primo piano a scapito di amore e colpi di scena. In un'atmosfera tenebrosa, i personaggi sono dilaniati da contrapposte passioni e i piani pubblico e privato si intrecciano. Verdi ce la mette tutta, sbalza da par suo i caratteri di Boccanegra e di Fiesco, ma l'opera manca irrimediabilmente di teatralità. Inevitabile il risultato. La «Gazzetta privilegiata di Venezia» la disse lugubre, ma indorò la pillola definendola «assai elaborata, condotta col più squisito artifizio e si vuole studiarla nei suoi dettagli». Più drastico il pubblico: «Ho fatto a Venezia un fiasco quasi altrettanto grande di quello della Traviata. Credevo di aver fatto qualche cosa di possibile, ma pare che mi sia ingannato», scrisse addolorato alla contessa Maffei. A differenza di Traviata, poi, Simone non accennava a risollevarsi. «Gli ho voluto bene come si vuol bene al figlio gobbo!» confiderà in tarda età al nipote Angelo Carrara. Un gobbo che finirà raddrizzato, ma, per il momento, non c'è tempo. Bisogna sfornare qualcosa per Napoli. Verdi ritiene di aver trovato in Somma il librettista adatto per Re Lear. Ma anche stavolta non se ne farà niente: è indisponibile il soprano Maria Piccolomini, «indispensabile» a detta del Maestro per il ruolo di Cordelia. Peppino sceglie il soggetto di un'opera di Daniel Auber su libretto di Scribe: Gustave III ou le bal masqué, andata in scena con successo a Parigi il 27 febbraio 1833; nel 1841 Vincenzo Gabussi ne fece trarre un libretto da Gaetano Rossi per la Fenice (Clemenza di Valois); nel 1843 toccò saccheggiarlo a Saverio Mercadante e a Cammarano, col titolo Il Reggente, al Regio di Torino. La storia di Gustavo m di Svezia, assassinato da uno psicopatico durante un ballo, solleticava. Malgrado le modifiche che si imponevano per tacere l'omosessualità del monarca. La sceneggiatura fu inviata a Napoli nel 1857, col titolo Una vendetta in dominò, ambientata non più in Svezia, ma in Pomerania. Somma, però, non ne volle sapere di apparire come autore del libretto. Perché ? Prudenza partenopea. A novembre Verdi ha in mano i versi. In dicembre ha completato lo spartito per canto e pianoforte. I14 gennaio s'imbarca a Genova per Napoli in compagnia di Peppina (che però viene fatta sbarcare a Livorno). Il 14, Verdi approda alle falde del Vesuvio e si accinge a provvedere come suo solito, nel corso delle prove, alla strumentazione. Ma la censura ha respinto fin dall'ottobre 1857 la sceneggiatura. Un soldato aveva aggredito con la baionetta il re di Napoli. Lo stesso 14 gennaio Felice Orsini attenta alla vita di Napoleone III. E Verdi pretende di mettere un regicidio in scena! C'è invece pronta una bellissima Adelia degli Adimari, scritta sulla falsariga del testo di Somma da un censore con manie letterarie... Imbufalito, Verdi rompe il contratto e si busca una denuncia per danni «da liquidarsi in via specifica, coll'arresto personale». Il bussetano non si lascia intimidire. Invia all'avvocato Arpino un memoriale, Difesa del Maestro Cavalier Giuseppe Verdi, nel Tribunale di Commercio di Napoli, dove espone le gravi alterazioni del libretto, l'assurdità di spostare epoca e luogo e conclude che «alla bestemmia in arte non va risposto». Finisce a tarallucci e vino. Verdi può ritirare l'opera e si impegna a presenziare a una ripresa del Simone. Il melodramma cade in grembo all'impresario del Teatro Apollo di Roma, Vincenzo Jacovacci, ormai abituato agli «scarti» di Napoli. Ammanicato col clero e disposto a far carte false (e magari a oliare la macchina) pur di avere una nuova opera di Verdi, ottiene il nulla osta. Noriostante la censura avesse approntato anch'essa un libretto sostitutivo (il Conte di Gothemberg), due sole furono infine le modifiche: Gustavo di Svezia diventa il governatore Riccardo e il luogo dell'azione è spostato al di là dell'oceano, a Boston. Così ritoccata la partitura va in scena il 17 febbraio 1859 e trionfa. Il Ballo in maschera è un capolavoro: finita l'epoca delle marionette, ogni personaggio è percorso da sentimenti contrastanti ed evolve nel corso degli avvenimenti; la partitura è splendida e offre pagine memorabili. Verdi ebbe però da ridire sul cast. Ottimi gli uomini (il tenore Gaetano Fraschini, Riccardo, e il baritono Leone Giraldoni, Renato), pessime le donne. Jacovacci, soprannominato «sor Cencio» per la sua tirchieria, aveva giocato al risparmio. Alle recriminazioni di Peppino, l'impresario rispose imperturbabile che avrebbe ripreso l'opera nella stagione successiva, curando le parti femminili e accontentandosi sui maschietti, perché tanto quelli buoni li avevano già sentiti. XVII In una lettera del 23 giugno 1859, il giorno prima della battaglia di Solferino, Verdi si dispera con Clarina Maffei di non poter correre in prima linea. L'ardore patriottico c'è, non la salute: «Che potrei io fare che non son capace di fare una marcia di tre miglia, che la testa non regge a cinque minuti di sole, e che un po' di vento, od un po' di umidità mi produce dei mali di gola da cacciarmi in letto qualche volta per settimane?! Meschina la natura mia! Buono a nulla! ». A malincuore, Peppino assunse un ruolo più prestigioso. Rappresentante di Busseto all'assemblea delle province parmensi in occasione del plebiscito, a Torino conosce Vittorio Emanuele ii e soprattutto Cavour, il «Prometeo della nostra nazionalità» che, il io gennaio 1861, gli offre la candidatura alla Camera. Eletto, Verdi seguì la linea del premier e si adoperò a favore di leggi per sovvenzionare orchestre e cori stabili nei teatri di Milano, Roma e Napoli, nonché scuole di canto gratuite per gli allievi promettenti e bisognosi. Dopo la scomparsa di Cavour, si eclissa anche l'entusiasmo e, nel 1865, confessa a Piave che i 45o deputati sono 449, «perché Verdi deputato non esiste». Nel frattempo, in gran segreto, aveva sposato Giuseppina il 29 agosto del 1859, nella chiesetta di Collonges-sous-Salève, in Svizzera, con testimoni il sagrestano e il vetturino. Nuove commesse bussano intanto alla porta di Sant'Agata. Mario Corticelli, segretario dell'attrice Adelaide Ristori a San Pietroburgo, fa pervenire nel 1861 a Verdi una lettera del celebre tenore Enrico Tamberlick, che gli commissiona un'opera per il Teatro Imperiale, dietro il sontuoso compenso di 6o.000 franchi. Il Maestro accetta e propone il Ruy Blas di Victor Hugo, ma la censura pronuncia il suo niet alla storia dell'ascesa di un lacchè amante d'una regina. Quando il figlio di Tamberlick, Achille, fa sapere che la censura ha cambiato parere, è troppo tardi. Giuseppe si è ormai orientato su Don Alvaro o la fuerza del sino, opera intricata come il nome del suo autore, Angel de Saavedra Ramirez de Banquadano, duca di Rivas. Lima che ti lima, Piave riesce a cavarne fuori una roba macchinosa, truculenta ma credibile, adatta a Verdi che ormai ha fatto la bocca alle opere a grandi quadri. Il 2 2 novembre La Forza del Destino è finita, salvo, come al solito, la strumentazione. I coniugi Verdi e il loro cagnolino Loulou partono per Pietroburgo con codazzo di servitori, bottiglie di Bordeaux e Champagne. Viaggio inutile. Un'indisposizione del soprano Emma La Grua (primo della serie di episodi che daranno alla Forza una fama jettatoria) impedisce a Verdi di concertare l'opera durante le prove. Lo farà in tutta quiete a Busseto. Nei ritagli, musica l'Inno delle nazioni su un pomposo testo del giovane Arrigo Boito per rappresentare l'Italia all'Esposizione internazionale di Londra. L'inno viene però respinto dall'invidioso direttore musicale dell'Esposizione, Michele Costa: aveva chiesto una marcia, non un brano vocale! James Mapleson, direttore dell'Her Majesty's Theatre, coglie l'occasione e fa eseguire l'Inno il 24 maggio, per il compleanno della regina Vittoria, sotto la direzione di Luigi Arditi. . Il i o novembre 1862 finalmente La Forza del Destino va in scena a San Pietroburgo con un cast di all stars (Caroline Barbot, Leonora; Enrico Tamberlick, Alvaro; Francesco Graziani, Don Carlos; Achille De Bassini, Melitone; Costance NantierDidiée, Preziosilla) e la partecipazione del celeberrimo clarinettista Ernesto Cavallini, che Verdi benefica d'un assolo prima dell'aria di Alvaro. Tutta la famiglia imperiale, zar Alessandro il in testa, assiste alla prima. Si fa rumorosamente notare alle repliche una pattuglia di giovani compositori, seguaci di Mikhail Glinka, destinati poi a formare il «Gruppo dei 5», che protesta contro il compositore straniero, contro il melodramma aristocratico e fa i conti in tasca al Maestro. 20.000 rubli si era preso, a loro ne toccavano 5oo! Scemati gli applausi, la critica si divide. Entusiasta il «Journal de St. Pétersbourg», perplessi il «Russkij Mir» e il «Cyn otecestva», tutti pronti a riconoscere però l'esistenza di una «nuova maniera verdiana» e la «coerenza e integrità» della strumentazione. L'opera toccò Madrid, Roma, Nizza, Torino e Reggio Emilia prima di apprpdare alla Scala nel 1869, ampiamente rivista. Neanche Verdi era totalmente convinto di un melodramma macchinoso e troppo cruento. Nei ritocchi aggiunse nuovi pezzi e sistemò il finale: Don Alvaro non si sarebbe più gettato da una rupe dando dell'imbecille al Padre Guardiano, ma avrebbe ricevuto la luce della conversione. Ciononostante, qualcuno arricciò il naso, parlò a sproposito di meyerbeerismo e addirittura di wagnerismo. In realtà, Verdi aveva stabilizzato la costruzione drammatica acquisita nella «trilogia popolare»: i pezzi chiusi sono inseriti in grandi quadri drammatici dove pullulano scene di massa (fioccano le citazioni dal Wallenstein di Schiller) e parti di fianco. Fa inoltre irruzione l'elemento umoristico, con la presenza di Frate Melitone. XVIII «Sono accusati di essere caldissimi ammiratori di Vagner... un uomo di molto ingegno che si piace delle vie scabrose, perché non sa trovare le più facili e le più diritte». Così nel 1862 scrive Verdi a Clarina Maffei a proposito dei due giovani frequentatori del celebre salotto, Arrigo Boito e Franco Faccio. Giovani, e malfamati. Scalmanati «novatori» lo erano di certo, ma poco attratti dal Cigno di Lipsia che, anzi, Boito aveva definito un falso profeta. Loro guardavano a Meyerbeer, a Weber, a Mendelssohn e Beethoven, in una babele che spaziava dal grand-opéra al sinfonismo nordico. In Italia, però, i pregiudizi sono duri a morire. Di Wagner non si era ascoltata una nota, dei suoi ponderosi scritti si avevano notizie di quinta mano. L'autorevole critico Filippo Filippi, l'unico a saperne qualcosa in più, l'avéva dichiarato estraneo allo spirito italiano. Ma nulla. Bastava qualche raffinatezza nell'orchestrazione, bastava proclamarsi innovatori ed ecco il termine wagneriano (sottinteso: antiverdiano) correva di bocca in bocca. Il 20 novembre 1862 il «Museo di Famiglia» pubblica l'ode All'arte italiana declamata da Boito durante una cena in onore di Faccio, i cui Profughi fiamminghi avevano colto un certo successo, l'i i novembre, alla Scala. Permaloso come al solito o imbeccato dalle malelingue, Verdi non ha dubbi: a lui sono rivolte le accuse di essere «vecchio e cretino» e di aver «bruttato» l'altare dell'arte come un «muro di lupanare». In realtà Boito ce l'ha con i compositori alla Cagnoni e i critici alla Mistrali (per i quali già Trovatore era sovversivo), ma Peppino non ascolta ragioni e se la segna: Faccio e Boito, prima di essere accolti a corte e diventare l'uno il direttore d'orchestra preferito, l'altro il librettista delle ultime opere, dovranno passare in purgatorio anni di contrizione. Il brindisi scapigliato, del resto, era stato l'incipit di un decennio di amarezze,. Muoiono nel 1866 Carlo Verdi e nel 1867 Antonio Barezzi; Piave è paralizzato su un lettino d'ospedale; a Sant'Agata e Busseto, la quiete è interrotta da baruffe paesane e liti con amministratori trascurati e ladruncoli, da Mario Corti-celi a Giovannino Barezzi, soprannominato dal Maestro «zampa di velluto». I detestati bussetani pretendono di dedicare al loro emerito compaesano l'erigendo nuovo teatro e danno per scontato che a fronte di tanto onore l'Eccellentissimo allenti i cordoni della borsa e componga una nuova opera. Verdi dapprima risponde a calci, poi accetta la dedica (non senza aver vergato presso il notaio un atto dove elenca i torti subiti) e paga i o.000 franchi l'abbonamento a un palco dove, annuncia, mai si recherà. Anche il ménage domestico è turbato. Dal soprano boemo Teresa Stolz che, a partire dal 1868, Verdi comincia a frequentare troppo da vicino, suscitando il garbato risentimento della Peppina. Per la Penisola si diffondono le Società del Quartetto al fine di propagare la musica strumentale; Meyerbeer e Gounod sono nomi sulla bocca di tutti. Nel 1868, l'idea di Verdi per una Messa di requiem in commemorazione di Rossini, che avrebbe dovuto raccogliere i migliori compositori italiani dell'epoca, è respinta. Il primo novembre 1871 approda in Italia, a Bologna, il Lohengrin di Wagner, diretto da Angelo Mariani, ex bacchetta verdiana (ed ex fidanzato della Stolz). L'impressione di Verdi dopo aver ascoltato l'ouverture del Tannhiiuser, comunicata a Opprandino Arrivabene i131 dicembre 1865, era stata sintetica: Wagner «è matto». Verdi assiste anche al Lohengrin e postilla la partitura, riassumendo così le sue valutazioni: «Impressione mediocre. Musica bella, quando è chiara e vi è il pensiero. L'azione corre lenta come la parola. Quindi noia. Effetti belli d'istromenti. Abuso di note tenute e riesce pesante». Ma a Ricordi, più semplicemente, si dichiara stomacato da quel che ha visto e sentito. Pubblico e critica la pensano diversamente, e iniziano a inneggiare al tedesco. Né le autorità si mostrano grate al «bardo» dell'unità nazionale. Il 29 marzo 1868, Emilio Broglio, ministro dell'Istruzione, scrive a Rossini per ottenere consigli sulla riforma dei Conservatori e rivitalizzare la musica italiana: «Dopo Rossini, che vuol dire da quarant'anni, cosa abbiamo ? quattro opere di Meyerbeer... Come si può rimediare a una sì grave sterilità?» si chiede l'incauto. La lettera è resa pubblica: Verdi ha appena ricevuto la Commenda della Corona d'Italia. La restituisce al mittente: «Quest'ordine è stato istituito per onorare coloro che giovarono sia con le armi, sia con le lettere scienze ed arti all'Italia. Una lettera a Rossini dell'E.V. ... sentenzia che da quarant'anni non si è più fatta un'opera in Italia. Perché allora si manda a me questa decorazione ? Vi è certamente un equivoco nell'indirizzo e la rimando». Unica consolazione in tanto sfacelo, l'incontro con l'idolatrato Alessandro Manzoni, il 3o giugno del 1868. Per il resto, amarezze e polemiche. Alle quali Verdi risponde in due modi. Interpellato, ostenta il più assoluto conservatorismo: no alla musica sinfonica, lontana dallo spirito italiano, no all'innovazione, no alle teorie estetiche... «Torniamo all'antico: sarà un progresso», proclama a Francesco Florimo. Quanto ai Conservatori, si studino Benedetto Marcello e Giovanni da Palestrina... Nella pratica, invece, Peppino tira dritto. XIX In Spagna per seguire una rappresentazione della Forza del Destino, il 21 febbraio 1863 Verdi visita l'Escorial, «severo, terribile come il feroce sovrano che l'ha costruito». È il germe del futuro Don Carlos. Nel frattempo, commesse e rifacimenti si susseguono. La strada, ormai, appare tracciata. Organizzazione per grandi scene, nessuna rinuncia alla melodia, ma sempre maggior importanza alla «parola scenica» e al recitativo, orchestrazione più accurata. I frutti maturati nella trilogia popolare e nella Forza del Destino si vedono già nel 1865, quando per una ripresa al ThatreLyrique Verdi si dedica a Macbeth: ritocca la partitura e compone alcuni pezzi nuovi, tra cui l'aria per la Lady, «La luce langue », al posto della cabaletta «Trionfai! Sicuro al fine». Il successo è inizialmente fiacco, anche se la nuova versione si impone sulla precedente: Peppino non procede più a balzi e tentoni, è sicuro dei suoi mezzi e sa quello che vuole, checché ne dicano la critica e lo stesso pubblico. Perlopiù parigino. Il rapporto tra il compositore e i palcoscenici francesi è ambiguo e sarà destinato a sciogliersi solo il I 2 ottobre 1894, quando in occasione di una trionfale ripresa di Otello il presidente Casimir Perrier conferirà a Verdi la Legion d'onore. Per il momento, il bussetano si lamenta del grand-opéra, dei cantanti, dei direttori d'orchestra, delle maestranze, fa il ritroso, si nega: «Scherzate!!» comunica a Leon Escudier dopo l'ennesima profferta: «Scrivere all'Opéra!!! Credete voi che non vi possa essere proprio nissun pericolo per i miei occhi dopo quanto è successo due anni fa alle prove dei Vépres ?». Cosa era successo ? Verdi si era dedicato anima e corpo alla ripresa dell'opera, addirittura aveva scritto una nuova aria per far meglio figurare il tenore Villaret. E come l'aveva ringraziato la «grande bottega»? Alle prove, Peppino fa notare al direttore un movimento troppo rapido. Si ripete, ma l'orchestra per ripicca lo rallenta ostentatamente. «È un cattivo scherzo, non è vero?», sbotta Peppino con la sfrontata bacchetta. «Buon Dio, no. Questi signori pensano di aver provato a sufficienza». «Ah, proprio ?». «Capirà, hanno i loro affari... ». «Ah, essi hanno i loro affari, che non sono quelli dell'Opéra ? Bene», chiude, fa i bagagli e torna in Italia. Come s'osava tormentarlo dopo un tal precedente ? Ma dài e dài... Anche stavolta l'occasione è succulenta per soldi e prestigio: va celebrata l'Esposizione Universale del 1867. Dapprima Verdi si balocca tra Re Lear, Cleopatra, Salammbò, poi si orienta su Don Carlos, dall'omonima tragedia di Schiller, e affida il libretto a Joseph Perry, cui subentrerà, dopo la morte, Camille Du Locle. L'opera debutta l'I i marzo 1867, cinque atti con i consueti ballabili e grandi scene di massa. Il successo è moderato. Il Don Carlos era lungo (nonostante i tagli effettuati durante le prove) e complicato: ancora una volta, la riflessione sulla politica e sul rapporto tra potere, amore, amicizia, risulta ostica per il pubblico e per una parte della critica. Verdi, pur aderendo formalmente allo stile del grand-opéra, lo modifica sostanzialmente. Il canto è raccolto ed espressivo, limitate le girandole vocali (il protagonista ha una sola aria, per di più dimessa, al I atto) per dar spazio a duetti e ampi ariosi (celeberrimi l'andante sostenuto di Rodrigo, «Per me giunto è il dì supremo», con l'anomala cabaletta «Io morrò», e il monologo di Filippo II, «Ella giammai m'amò»). I critici, a parte Teophile Gautier e Ernest Reyer, parlano di wagnerismo, meyerbeerismo, monotonia. La bigotta imperatrice Eugenia abbandona il palco, indignata per l'apostrofe scagliata da Filippo il contro l'Inquisitore: «Taistoi, prétre». Passano tre anni ed è la volta di Aida. Ismail Pascià, dopo l'inaugurazione del Canale di Suez, ha fatto erigere un teatro d'opera e offre a Verdi, preferito a Gounod e Wagner, 150.000 irresistibili franchi d'oro per avere una sua composizione. Al lavoro si mettono Antonio Ghislanzoni, Camille Du Lode e l'archeologo Auguste MaHette, che fornisce il soggetto (una leggenda, a suo dire, trascritta da un papiro). Ma a salire in cattedra è lo stesso Verdi, tornato più incontentabile sceneggiatore di prima. In novembre l'opera è fatta, ma la scenografia, costruita a Parigi sotto la supervisione di Mariette, rimane bloccata per il drammatico evolversi della guerra francoprussiana del 187o. Aida va trionfalmente in scena al Cairo il 24 dicembre 1871 e alla Scala, 1'8 febbraio 1872. Spettacolare centone del falso esotico e dell'erotismo da cartolina allora di gran moda (Verdi stesso chiamava il finale atto ii, con la marcia trionfale e conseguenti elefanti, il «bataclan»), oggi scempiata da modi vocali veristicheggianti, rivela sotto i fronzoli la forza di concezione drammatica, l'acquisita sapienza armonica e la consueta capacità di scolpire i personaggi attraverso la melodia. Fa capolino, come già nel Ballo in maschera, il leit motiv. La critica cita Wagner, a sproposito. E Verdi si arrabbia. XX «Sentirmi da capo dirmi che non ho saputo scrivere e che son diventato imitatore di Wagner. Bella gloria! Dopo quasi quarant'anni di carriera finire imitatore! »: Clarina Maffei insiste, vuole che il Maestro riprenda a comporre, ma Verdi, picche. Dopo Aida, si è chiuso in uno sdegnoso silenzio artistico. Di tanto in tanto interrotto da qualche chicca, tanto per far sapere che il vecchio leone è in grado di tirar zampate e respingere chi insidia la sua supremazia. Il primo aprile del 1873 Verdi fa ascoltare a un gruppo di amici, all'albergo delle Crocelle a Chiatamonte, addirittura un Quartetto per archi. A lungo respinge le offerte per una rappresentazione pubblica: ci mancherebbe solo d'essere accusato d'inseguire la pestilenziale moda «strumentale»! Il 9 giugno Verdi scrive al sindaco di Milano, Giulio Bellinzaghi: onorerà Alessandro Manzoni, morto il 2 2 maggio, con una Messa di requiem. Particolare. Lo spartito sa ben poco di cattolico e di manzoniano, e molto del laicismo di Verdi, in odore di massoneria. La Messa è la testimonianza di un lottatore, che di fronte alla morte né si piega, né si spezza, né si rasserena. Il direttore d'orchestra tedesco Hans von Billow, così infatuato di Wagner da cedergli persino la moglie, si rifiutò addirittura d'assistere alla prima: «Un'occhiata di contrabbando a questa nuova emanazione del Trovatore e della Traviata ci ha tolto ogni volontà di assistere a questo Festival»; Verdi, l'«onnipotente corruttore del gusto artistico italiano», anziché una Messa, ha scritto un melodramma. Il Requiem è diretto dall'autore, nella Chiesa di San Marco, il 22 maggio 1874. Un trionfo, destinato a ripetersi di lì a poco alla Scala e in tutto il mondo. Verdi è attivissimo. Gira in lungo e in largo per curare le messe in scena delle ultime composizioni, ritocca nel 1881 Simon Boccanegra e nel 1884 Don Carlos, dice la sua sulla riforma dei Conservatori, intenta nel 1875 una causa ai Ricordi, accusandoli di avergli sottratto parte dei diritti d'autore. , Soprattutto, difende il melodramma italiano, minacciato dai «goti» e dai «novatori». «Noi tutti, Maestri, Critici, Pubblico, abbiamo fatto il possibile per rinunciare alla nostra nazionalità musicale. Ora siamo a buon punto; ancora un passo e saremo germanizzati in questo come in altre cose», scrive il 3o marzo 1879 al conte Opprandino Arrivabene. Ma di nuove opere neanche a parlarne. Il 29 giugno 1879 dirige alla Scala il Requiem in favore degli alluvionati del Po. Giulio Ricordi, poco rassegnato al silenzio della sua maggior fonte di entrate, approfitta della successiva cena di gala. Piazza, vicino a Peppino, Arrigo Boito, tra un risotto e un bicchier di vino salta fuori l'idea per un Otello da trarre dalla tragedia di Shakespeare e... lo sventurato risponde. Le tresche per riavvicinare Verdi a Boito dopo lo sciagurato brindisi erano state lunghe e laboriose, ma coronate da successo. Boito, dopo gli esordi scapigliati e il fiasco del Mefistofele (l'opera d'arte dell'« avvenire »!) caduto alla Scala il 5 marzo del 1868, si era lentamente costruito una fama di intellettuale colto e raffinato, ben inserito nell'establishment, e la nomea di librettista principe. Ancor oggi certa critica cade in deliquio soprattutto per i libretti approntati per Verdi, che invece non solo non brillano per decoro linguistico (la «Notte densa» dell' Otello fa concorrenza alle «Foreste imbalsamate» dell'Aida), ma spesso spiccano per macchinosità e lungaggini. Al solito soggiogato dagli uomini di cultura, Verdi gli appalta non solo i versi, ma anche la sceneggiatura, sovente cervellotica. Dopo una tormentata gestazione, supportato da un mastodontico battage pubblicitario (Bianche Roosevelt, nell' instant-book Verdi: Milan and Otello, arriva a ribattezzare «Otellopolis» la capitale ambrosiana), Otello debutta alla Scala, diretto da Franco Faccio, il 5 febbraio 1887. Un trionfo, nonostante gli svarioni del tenore Francesco Tamagno e soprattutto del soprano Romilda Pantaleoni, che Verdi aveva dovuto trangugiare per compiacere Faccio (compiaciuto a sua volta dalla Romilda). Breve pausa, e poi di nuovo in pista: se un'opera buffa aveva rischiato di troncare la carriera di Verdi, una «commedia lirica», tratta dalle Allegre comari di Windsor e dall'Enrico iv di Shakespeare, doveva esserne il suggello. «Amen e così sia! Facciamo adunque il Falstaff», scrive a Boito nel 1889, dopo aver maturato la faccenda per una decina d'anni. Il 9 febbraio del 1893, l'opera va in scena alla Scala. Successo caldo ma non entusiasmante, qualche perplessità da parte della critica. Di Otello e Falstaff si può lodare la sapienza nell'orchestrazione, il flusso melodico ininterrotto, alcuni squarci dove pulsa il miglior Peppino (l'intero i atto e parte del iv di Otello, il «Credo» e il «Sogno» di Jago, il suo duetto col protagonista «Tu ?! Indietro! Fuggi!» del finale atto ii di Otello; di Falstaff, la caratterizzazione del «pancione» e il III atto), ma questo Verdi che tiene dietro alle lungaggini di Boito, che manca di sintesi teatrale, non è più lui. E sembra quasi rendersene conto. Si favoleggiano infatti nuovi lavori, ma stavolta il Maestro ha detto stop. Il 14 novembre 1897, Peppina muore. Il 2I gennaio 1901, a Milano, Verdi è colpito da paralisi cerebrale fulminante. Alle 2.5o del 27 gennaio 1901 spira. Il 12 ottobre 1902, i primi ospiti, quattro donne e cinque uomini, entrano nella Casa di riposo fatta costruire a Milano «per accogliervi i vecchi artisti di canto non favoriti dalla fortuna, o che non possedettero da giovani la virtù del risparmio». Fu l'ultima opera di Verdi e, a sua detta, «la più bella». Da inaugurarsi post mortem. I beneficati non avrebbero così potuto ringraziarlo. Max Bruschi (Milano, 1969) l'autore di questo ritratto biografico di Verdi com'era, tracciato con divertimento e molto amore - ha curato edizioni di testi del Settecento e dell'Ottocento (Verri, Da Ponte, Leopardi) e collabora come critico letterario e musicale con rotocalchi e quotidiani italiani.
Scarica