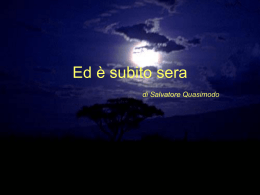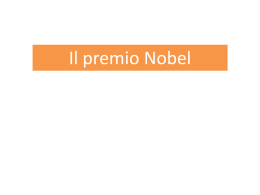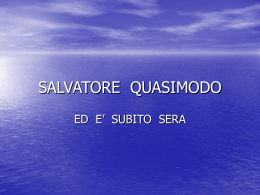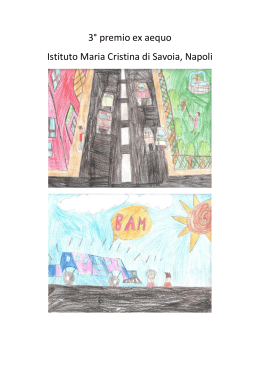no anche un po’ di fastidio ma grazie a Luciano fui accolto benissimo e voglio ricordare che ad almeno uno di quegli incontri redazionali conobbi Barthes, Roland Barthes, di cui allora ero entusiasta ammiratore, avendo letto un suo brevissimo acutissimo saggio su Brecht. Venti o trent’anni dopo venne a Roma il teatro giapponese delle Ombre, presentato in prima europea alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna a Valle Giulia: quello spettacolo mi entusiasmò e ne scrissi su «Paese Sera» due cartelle vibranti – almeno secondo me; alcune settimane dopo lo stesso spettacolo fu rappresentato a Parigi, anche lì con grande successo e Roland Barthes gli dedicò un libro intero: L’impero dei segni, 1970, sulle singolarità del Giappone. Franco Fortini era sicuramente il più autorevole del gruppo e apparentemente tra i più aperti. Ho detto apparentemente perché a me capitò ciò che adesso racconto: metà degli anni Cinquanta, cominciavo a essere stanco delle scuole private, soprattutto perché mi rendevano quattrocento lire all’ora, il che significa che per arrivare a quarantamila lire al mese dovevo fare cento ore di lezioni al mese, più di venti ore alla settimana ma, tenendo conto dei numerosi giorni di vacanza in un anno scolastico, voleva dire che in parecchie settimane sfioravo le quaranta ore settimanali: certo non avevo ancora trent’anni. Ero appunto tra inquietudine e stanchezza quando Luciano mi disse che Fortini cercava qualcuno che gli facesse delle ricerche in biblioteca, e Luciano aveva pensato a me e glielo aveva detto, che ne pensavo io? Io gli dissi che ero molto contento, che mi faceva molto piacere lavorare per/con Franco Fortini. Luciano fissò per me un appuntamento a casa Fortini dove mi recai alla data stabilita, e dove mi pare di esservi già stato con Luciano e altri. Ricordo però che ci andai vestito in maniera meno scapigliata del mio solito. Appena arrivato, Fortini mi accolse con calore, dirò così, aveva appena ricevuto una lettera-cartolina da Pasolini che gli annunciava la nascita di «Officina» a Bologna, con Leonetti e Roversi, e lo invitava a collaborarvi. Erano usciti con successo i Ragazzi di vita e Pasolini cominciava già a porsi come figura centrale delle nuove generazioni letterarie. Anch’io provavo interesse e ammirazione per la sua opera. Poi si passò a discutere a lungo delle posizioni di «Ragionamenti» e, a un ritorno del nome di Pasolini e dell’uscita di «Officina», mi disse che non solo lui era stato invitato ma era stato anche pregato di suggerire qualche nome di nuovi collaboratori, preferibilmente giovani e aggiunse precisamente: «Mettiti in contatto anche tu: aspetta che ti do l’indirizzo» e si mise a ricercare la cartolina postale ricevuta da Pasolini. Non gli fu semplice ritrovarla ma a un certo punto, aperto cassetto dopo cassetto, la ritrovò «Eccola. Aspetta che ti do l’indirizzo» e si mise a fissare molto attentamente, troppo attentamente, troppo lungamente quella cartolina: «Va bene, ti darò l’indirizzo un’altra volta» e rificcò la cartolina in un cassetto. Io glielo avevo letto preciso sulla fronte: «Ma perché aprire una porta gratis a un eventuale concorrente?» L’illustre, poetico inquisitore non sapeva che la cartolina postale con l’annuncio della prossima uscita di «Officina» Pasolini l’aveva mandata anche a me. Solo che non lo sapevo nemmeno io perché Pasolini non aveva il mio indirizzo e me l’aveva spedita da Schwarz, l’editore della mia prima raccolta di versi. Eravamo nell’autunno del ’54, come credo di avere già scritto; quella pubblicazione mi era costata ottantottomila lire, ottantamila per l’acquisto di duecento copie del libretto e ottomila lire per il costo della stampa dei tre disegni di Migneco: ed ero ancora debitore di quelle ottomila lire, anche perciò suppongo non bazzicavo Schwarz: saldai il conto l’estate del ’55 e Schwarz mi consegnò la lettera-cartolina postale di Pasolini indirizzata a me. Nessun accenno, in quell’incontro con Fortini, a quel progetto di collaborazione di cui mi aveva accennato Luciano, e per cui era avvenuto l’incontro. Quindi, da quell’in- 228 229 203_10_MARSILIO_Promemoria.indd 228-229 11/02/11 17.38 Più complicati e ipocriti, soprattutto da parte di lui, i rapporti con Sereni che per fortuna esplosero pubblicamente a un certo punto. Nel ’54 pubblicai le Cronache, delle quali era apparsa allora solo una recensione su «l’Unità», di un omonimo, un Pagliarani che non conoscevo, Gino, che faceva la corte a Giulia Niccolai e una volta che in casa Niccolai le faceva vedere il libretto delle mie Cronache, come mi raccontò lui stesso, arrivato il papà di Giulia, un ingegnere notoriamente di destra, sposato con un’americana, ingegnere molto interessato a sapere chi fosse e cosa facesse il ragazzo che andava dietro a sua figlia, gli mostrò le Cronache che aveva in mano e disse che era lui l’autore: l’ingegnere, uomo di mondo, sapendo che i poeti non sono pericolosi, ne fu soddisfatto, d’altra parte Gino non poteva dire che era uno dei redattori più prestigiosi de «l’Unità». In realtà di recensioni ce ne furono altre due e di prestigio culturale maggiore, una di Luciano Erba e una di Renzo Modesti, ma io ne venni a conoscenza parecchio tempo dopo. Avevo cominciato a dire dei rapporti con Sereni: un giorno per strada a Milano mi ferma e mi attacca bottone Salvatore Quasimodo, con non poca mia sorpresa, perché non lo conoscevo e non l’avevo mai incontrato, ma ero redattore all’«Avanti!» ormai da parecchi mesi, e quindi senza che me ne rendessi conto ero anch’io a Milano ormai ufficialmente diventato un poeta. Non ero un ammiratore specifico di Quasimodo ma ricordavo, come ricordo ora, la dolcezza di quel «Tindari mite ti so», il fuoco di quella «Cavalleria degli sbarchi» a Messina, subito dopo il terremoto (ho appreso invece solo pochissimi anni fa che aveva fatto in tempo, giovanissimo, a figurare in qualche raccolta di poeti futuristi). Ho piuttosto nitido il ricordo di quel primo incontro: per esempio la tintura dei suoi capelli che scendeva verso il collo e la sua soddisfazione nel raccontare una verità come pettegolezzo; il pettegolezzo che mi riguardava era il seguente: che nell’ultima riunione ufficiale della giuria del premio Soave (un premio voluto e organizzato da Sereni con tutti i nomi più illustri della cultura letteraria facente capo alla Lombardia, cioè Montale, Vittorini, Anceschi, lo stesso Sereni e altri che non ricordo, premio che in pochi anni raggiunse rapidamente un notevole prestigio ma che altrettanto rapidamente finì) era stato indicato vincitore il mio libretto Le Cronache, ma poi quando i giurati si ritrovarono a Soave per la proclamazione del premio, Sereni chiese e ottenne un’ultima riunione di giudici, nella quale riunione attaccò violentemente le Cronache dicendo che il linguaggio era volgare (come risulta anche dalla pubblicazione einaudiana della corrispondenza di Pasolini; Sereni si difese dicendo, suppongo, che 230 231 contro nessuna novità, da più punti di vista. Però quando La ragazza Carla uscì sul «Menabò» e Vittorini invitò Fortini a un panorama della poesia più recente, il pezzo che Fortini ne scrisse risultò di grande impegno e valorizzazione anche del mio lavoro, perciò i buoni rapporti con lui non li interruppi e indirizzai a lui uno dei primi componimenti della Lezione di fisica, «Proseguendo un finale» cioè il finale de La ragazza Carla che è finale d’amore mentre «Proseguendo» tira in ballo «la forza. Senza forza / amore e intelletto nemmeno servono / a definire se stessi, ma per quant’altro poco sappia della vita / quanto attrito che brucia, assieme come sono stridenti!» Mandai a Fortini quel componimento, lui deve essersi sentito in dovere di rispondermi nello stesso modo come fu di usanza qualche tempo dopo ma non dev’essere rimasto contento della sua prova e mi scrisse (io stavo già a Roma, mi pare) pressappoco «Ci ho provato ma non credo in quelle cose lì» e così finirono i miei rapporti con Fortini. Sereni. Il premio Soave scippato 203_10_MARSILIO_Promemoria.indd 230-231 11/02/11 17.38 Quasimodo in prosieguo di tempo, frequentandolo, imparai ad amarlo, se posso dire così, o almeno ad essere compartecipe dei suoi difetti donchisciotteschi, puerili e generosi: in casa di amici comuni una volta qualcuno raccontò come Quasimodo avesse ospitato nel suo appartamento in affitto tre mogli (presente, passata, futura) durante gli anni di guerra; alle risate di parecchi una signora riservatissima osservò «Bisogna avere una grande capacità d’amore» nello stupore di qualcuno. Un altro ricordo di Quasimodo, a un premio Viareggio dove io ero come cronista dell’«Avanti!» nell’estate del ’59: lo vidi incontrare e abbracciare il suo amico Marotta che a un certo punto gli chiese pressappoco: «E per quella cosa, hai delle novità?» Risposta, pressappoco: «Sì, buone, è sicuro, sicurissimo...» Ma a me che credevo di sapere di che cosa stessero parlando, mi parve che non ci fosse poi così tanta convinzione, in quella sicurezza. Ma, a Dio piacendo, in quello stesso ottobre ebbe il premio Nobel. A me era stata raccontata così, e forse dallo stesso Quasimodo: che in un’estate precedente, ’57 o ’58, era capitato a Milano l’anziano segretario generale del premio Nobel, che aveva intenzione di tastare il polso all’Italia incontrando i maggiori scrittori italiani: però in piena estate non trovò nessuno, erano tutti in vacanza, tranne Quasimodo che diventò immediatamente lo chaperon e l’animatore del soggiorno del segretario del Nobel il quale dovette sbilanciarsi in promesse, che mantenne. Il quinto premio Nobel per un italiano (primo Carducci, secondo il pacifista Teodoro Moneta, terza Grazia Deledda, quarto Pirandello), il quinto premio Nobel a Quasimodo fu salutato in Italia così: Emilio Cecchi sul «Corriere della Sera» in un elzeviro su due colonne scrisse un articolo il cui concetto base è questo: «A caval donato non si guarda in bocca» (come commentò allora qualcuno). E in un pamphlet Beniamino Dal Fabbro allora volle ricordare (o inventare) che Eugenio Montale nel «Corriere della Sera» gridava: «Una colonna, una colonna» intendendo dire che la notizia del Nobel a Quasimodo non meritava di più. Ma anche Montale secondo me beneficiò di quella svista del segretario generale perché si convinse anche lui segretario di aver fatto un torto alla letteratura italiana e non si diede pace finché non gli riuscì di ripararlo, quel presunto torto, sedici anni dopo, nel ’75, col premio Nobel a Montale. Lo scandalo per il Nobel a Quasimodo fu assolutamente vergognoso, perché, se si osservano i premi dal punto di vista della giuria del Nobel, si vede che quelli letterari seguono spesso indicazioni in qualche modo politiche, e/o geografiche, e/o neoclassicheggianti, e/o il grande successo di pubblico, e con Quasimodo si premiava la Sicilia, il traduttore 232 233 col suo volgare non intendeva definire una volgarità ma piuttosto una colloquialità) e fu proclamato vincitore Angelo Romanò. A me furono spedite tre o sei bottiglie di vino Soave come premio per l’opera prima ma io non lo sapevo, la radio aveva dato la sola notizia della vittoria di Romanò e in quei giorni ero in Romagna, sapevo però che Schwarz aveva mandato le Cronache, di cui era editore, a quel premio di cui forse non sapevo nemmeno l’esistenza, così mi arrivarono a metà inverno tre bottiglie gravate di un dazio (c’era ancora il dazio che sui vini era piuttosto pesante), me le tenni, me le bevetti ma soltanto due o tre anni dopo, e grazie all’incontro con quel linguacciuto di Quasimodo capii che venivano dal premio Soave. Penso adesso che l’attenzione e la simpatia continua che ebbero Vittorini ed Anceschi per il mio lavoro abbia avuto origine appunto dalle Cronache e da quel premio Soave che mi fu sottratto all’ultimo momento. Quasimodo. Le tre mogli. Premio Nobel e reazioni della stampa. Premio Taormina, gare di veglia con Ungaretti. L’arrivo della Achmatova 203_10_MARSILIO_Promemoria.indd 232-233 11/02/11 17.38 dei lirici greci e l’antifascista di qualche sinistra. Nessuno scandalo invece o molto, molto meno quando l’ultimo Nobel a un italiano fu attribuito a un guitto, un grande guitto, cioè un grande attore comico, indubbiamente, ma sul piano della letteratura i suoi testi mi sembrano piuttosto penosi. L’ultimo ricordo che ho di Quasimodo è del ’64: in parecchie centinaia fummo invitati da Giancarlo Vigorelli nella sua qualità di segretario della Comunità Europea degli Scrittori a Taormina, in occasione del premio Taormina assegnato quell’anno alla Achmatova, Anna Achmatova, pseudonimo di Anna Andreevna Gorenko. La grande poetessa tardò parecchio ad arrivare, probabilmente per difficoltà di passaporto, o insomma di uscita dall’Urss, così noi invitati ce la spassammo nel magnifico albergo San Domenico per almeno una settimana; Pasolini, per esempio, dopo due o tre giorni non potè più attendere perché aveva le riprese di un film che lo richiamarono a Roma, Montale non c’era non so perché ma c’erano Ungaretti e Quasimodo, i quali si sentivano in gara fra loro due a chi andasse a letto più tardi: vinceva quasi sempre Ungaretti perché aveva la risorsa, mi pare, di potersi addormentare e risvegliare sempre, seduto in poltrona ascoltando o non ascoltando le chiacchiere degli altri o a tavola (si può anche semplicemente dire che s’abbioccava molto spesso). Quasimodo non aveva quella risorsa e rischiava molto perché era handicappato dal grave attacco al cuore subito pochi anni prima e che non gli lasciò, rispetto a quel ’64, che altri quattro anni di vita. E il sempre sorridente Ungaretti riusciva a ritirarsi in camera sua più tardi, molto più tardi di lui. Ungaretti in quell’occasione fece una serrata corte a Ingeborg Bachmann, la quale cercò di liberarsene facendo a sua volta qualche sorrisetto di compiacimento e/o di incitamento a qualchedun altro di noi, ma con scarso successo anche lei. Un simpatico, forse simpaticissimo poeta irlandese di cui non ricordo il nome lasciò solo lui un conto liquori al San Domenico di 390.000 lire (me lo disse lui stesso l’ultima volta che lo incontrai una decina d’anni fa a Bracciano mentre stava dietro a un’anzianotta nobildonna romana). Finalmente la Achmatova arrivò: arrivata in gran segreto una sera, fu previsto l’incontro ufficiale di quanti erano stati invitati lì per renderle omaggio per le dieci del mattino. Aspettammo non più di tre/quattro ore: prima di farsi vedere da noi voleva farsi bella come Dio comanda: e bella e dolcissima ci apparve quando fummo ammessi nel salotto della sua suite: solo che c’era troppa folla, i fotografi specialmente con tutte quelle loro macchinone che costrinsero la grande poetessa a dire che non intendeva assolutamente farsi fotografare e quindi invitò, anzi ordinò ai fotografi di andarsene immediatamente dal salotto e quelli se ne andarono scocciati e scornati, ma tra gli ultimi fotografi a uscire l’Achmatova ne scorse uno, proprio un bel giovane, e gli disse qualcosa in russo che significava: «No, tu no, non devi uscire, tu che sei un bel giovane.» E durante l’incontro se lo coccolò più volte con lo sguardo. E c’erano Ungaretti, Quasimodo e Vigorelli, come sappiamo, e poeti e letterati da tutto il mondo, francesi e americani in abbondanza e a metà pomeriggio ci furono una o due ore circa di letture dei poeti presenti, in onore della grande poetessa. 234 235 203_10_MARSILIO_Promemoria.indd 234-235 Luciano Amodio. Rosa Luxemburg. Lelio Basso. Riunioni di «Ragionamenti». I Guiducci. Tullier. L’editore Schwarz. Le due collane di poesia. Incontro con Schwarz a Cuba. Casarotti, i disegni per Inventario privato e la sua abbuffata di bicchieri. L’incidente. Migneco e le Cronache. Milli Bortolotti Luciano si laureò in filosofia con Banfi, tesi, credo la prima in assoluto, su Gramsci, il primo suo libro su Rosa Luxemburg. Si capisce subito che odiava ogni ortodossia, era un marxista un po’ o tanto nicciano, dicevamo, e gran- 11/02/11 17.38 de interesse per la letteratura senza esagerare però né con Proust né con Mann (sui quali esagerava allora Renato Solmi). Però non molto tempo dopo il suo libro, edito dalle socialiste edizioni del Gallo, uscì una Luxemburg di Lelio Basso, da Einaudi, che mise in ombra nella sinistra il lavoro di Luciano, esclusivamente per ragioni tecniche, cioè l’abbinata Einaudi-Basso, il quale Basso era già fra i più brillanti rivali di Nenni nel partito socialista. In casa di Basso si tennero per un certo periodo riunioni di giovani intellettuali; almeno una volta, ma forse due ci andai anch’io; purtroppo forse per mia cattiveria, ne ho soltanto questo ricordo: a un certo punto su questa tavolata di una dozzina di persone compare una bottiglia di grappa e bicchierini minimi da rosolio per tutti quanti, qualcuno non beve super alcolici, ma Sergio Capriolo è propenso a un bis, e fa per versarselo quando come un fulmine gli arriva sul suo braccio la mano del padrone di casa che dice pressappoco: «No, non voglio che si dica che si fanno orge in casa mia.» Alle riunioni di «Ragionamenti» cui partecipai grazie a Luciano con la massima assiduità possibile non figurarono mai, invece, né bottiglie di liquori né di vino; lì si stava abbastanza tutti quanti su un piede di parità; certo Fortini era ovviamente per prestigio ed età il primus inter pares ma Luciano, Roberto Guiducci e sua moglie Armanda non si facevano certo intimidire da nessuno, e così l’Enrica Pischel e così Gianni Scalia quando capitava da Bologna. Il mio saggetto Ragione e funzione dei generi del ’57 ci mise almeno un mese, mi pare, a passare l’esame del comitato di redazione: due o tre redattori tra i quali sicuramente Fortini e Armanda Guiducci non erano convinti del mio uso del termine “semantico” che allora non era ancora di moda. Grazie sempre a Luciano conobbi quel simpatico impiegato comunale che era il più surrealista poeta italiano di allora, Antonino Tullier e tramite lui, che lo diede a Luciano per me, ebbi il consiglio di rivolgermi a Schwarz per la pubblicazione delle Cronache. Schwarz allora si occupava, come sempre, soprattutto di arti visive, ma aveva già pubblicato Quasimodo in una bellissima edizione e aveva iniziato una collana di giovani poeti di cui aveva già scritto Arrigo Cajumi sul «Corriere della Sera». Schwarz mi accolse molto tranquillamente, senza nessun particolare sussiego e si creò in poco tempo una qualche forma specifica di amicizia con sua moglie, una giovane signora acuta e dolcissima che se n’è andata molto presto, troppo presto, dalla vita. Io non sapevo nemmeno che quei giovani poeti pubblicati da Schwarz erano divisi in due gruppi: quelli facenti parte della collana “Dialogo col poeta” e quelli fuori collana, semplicemente “Schwarz editore”; probabilmente gli uni e gli altri parteciparono alle spese editoriali. L’ultimo ricordo personale che ho di Schwarz (e spero che non rimanga proprio l’ultimo) è a Cuba, al convegno culturale de L’Avana indetto da Fidel Castro: inneggiava eccitatissimo e convintissimo al semplice prolungatissimo grido «Ho-Chi-Min, Ho-Chi-Min!» In un primo momento avevo chiesto qualche disegno da mettere assieme alle Cronache ad Alberto Casarotti che illustrò, quattro o cinque anni dopo, l’Inventario privato: Casarotti era un ragazzone grande e grosso di bellissima anarchia, deceduto parecchi anni fa ormai, ma per fortuna il lavoro e il suo ricordo sono mantenuti vivi dalla sua compagna Germana e successe che una sera fui invitato a cena dal Casarotti in un ristorantino di corso Torino, a Milano: in quella occasione Casarotti si divertì a stupirmi mangiando, fra pasta e quant’altro, cinque o sei o sette portate e anche almeno una mezza dozzina di uova sode col guscio e tutto; non basta: finì la sua cena facendo fuori anche il bicchiere che gli era servito per le bevande, mordendo, sminuzzando non so come, il vetro; una cena che per me risultò piuttosto disgustosa; l’indomani mattina incontrai per strada Germana (abitavamo abbastanza vicino, dalle parti di viale Um- 236 237 203_10_MARSILIO_Promemoria.indd 236-237 11/02/11 17.38 bria), che mi disse con aria preoccupata «Alberto è stato ricoverato all’ospedale» e a me scappò detto: «Per forza! Con tutto quello che ha mangiato ieri sera!» E lei rispose concitatamente: «Ma no, è stato investito da una motocicletta mentre camminava su un marciapiede.» Alberto dovette stare parecchi mesi all’ospedale: era stato per lui un incidente molto serio e io, a un certo punto, mi diedi da fare a trovare un altro illustratore per le Cronache e quando seppi che Dodi, una delle tre sorelle Bortolotti di cui con Luciano Amodio frequentavo la casa, era la compagna di un pittore che non conoscevo di persona, né ebbi mai l’occasione di conoscere, ma che stimavo molto e mi pareva particolarmente adatto a interpretare le mie Cronache, cioè Giuseppe Migneco, le feci avere una copia del dattiloscritto delle Cronache, e Migneco poi ebbe la carineria di farmi sapere (non ricordo se per lettera, telefono o tramite la Dodi, come è più probabile) che alcune di quelle poesie lo avevano “caricato”, cioè gli erano state utili effettivamente. Delle tre sorelle Bortolotti, la Milli era la più giovane e la più carina e vagamente io e lei ci corteggiavamo: quando tornavo a Milano, dopo aver passato l’estate a Viserba e incontravo la Milli, mi chiedevo come mai mi fosse rimasta così impressa; dopo alcune settimane mi ritornava una delle migliori ragazze su piazza. Risolse il problema un ragazzo molto deciso, comunista scatenato, con alle spalle la gloria di essere mandato dal suo partito in Sicilia a fare la grande campagna elettorale dell’aprile ’48. Era un ragazzo molto sicuro di sé mentre io allora ero soltanto un sostenitore dell’Europa unita, di una federazione europea. A un certo punto lui mi disse brusco: «Veniamo al sodo, nella guerra fra Russia e America, tu da che parte stai?» e si fidanzò con la Milli. Ma non si sposarono, la Milli sposò un giornalista alla mano di qualche riguardo e abita o almeno abitava una ventina d’anni fa, l’unica volta che l’ho vista a Roma e l’accompagnai a casa, in un bel posto dalle parti della Cassia. Terza parte Roma 238 203_10_MARSILIO_Promemoria.indd 238-239 11/02/11 17.38
Scarica