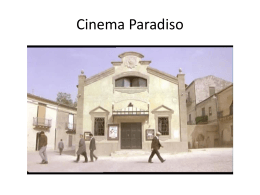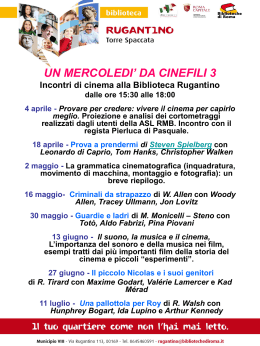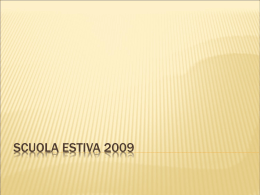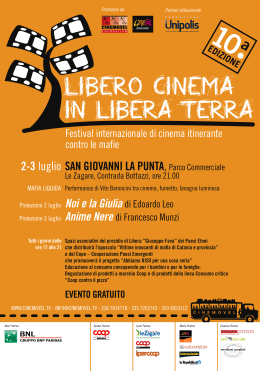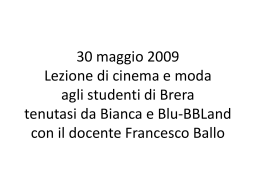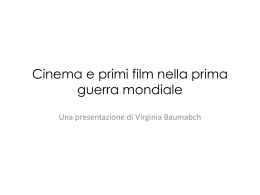Biblioteca di Linguistica diretta da Massimo Arcangeli 2 Biblioteca di Linguistica collana diretta da Massimo Arcangeli La collana prevede una serie di volumi, affidati alle cure di diversi specialisti, dedicati ad aspetti essenziali della linguistica e ad alcuni temi forti della linguistica contemporanea. Ogni volume sarà costituito da una parte teorica introduttiva, da un’ampia antologia e da un glossario ragionato, e concederà uno spazio privilegiato alla linguistica italiana. Un Dizionario ragionato di linguistica assommerà alla fine in sé tutti i dizionari acclusi ai vari volumi. A utile corredo della collana è prevista inoltre la pubblicazione di una serie di supplementi di approfondimento di singoli temi. Fabio Rossi IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO Copyright © MMVI ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, 133 a/b 00173 Roma (06) 93781065 ISBN 88–548–0799–0 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: ottobre 2006 Ringrazio Sergio Raffaelli e Luca Serianni per aver letto e glossato la prima stesura di questo libro e per avermi, come al solito, arricchito con il loro appoggio e con i loro consigli; Massimo Arcangeli (difficile immaginare un supporter più attivo di lui), per essersi assunto l’onere della pubblicazione; il personale della biblioteca del DAMS di Roma Tre, e in particolare Angelo Lucini, e quello della Cineteca della Scuola Nazionale di Cinema, per la pronta e cortese disponibilità nel reperimento dei film; Silvana de Capua e Maria Antonietta Guiso, della Sala Musica e Multimediale della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, solido punto di riferimento nel disorientante mondo delle biblioteche romane; Amy Brosius, Valeria De Lucca e Francesco Izzo, per le ricerche oltreoceano. Ringrazio ancora, per i consigli e il materiale (libri e film) prestatomi: Natalya Abdulajanova, Enzo Caffarelli, Giuseppina Capozzi (Giusi, senza la quale questo lavoro, e tutto il resto, non sarebbe stato possibile), Alessio e Patrizio Cigliano, Gianni G. Galassi, Nino Genovese (anche per aver consentito il reperimento del materiale iconografico), Elizabeth Hart, Stefano Innamorati, Lucilla Lucchese, Mauro Minenna, Paolo Minuto, Elena Pistolesi, Giulia Ricciardi, Fabio Ruggiano, Carmelo Scavuzzo, Rosaria Stuppia, Francesca Testa. Grazie infine a Mauro Dell’Acqua, Fanny De Marco, Marialuisa Di Stefano, Francesca Palermo e Loredana Sottile, dalle cui tesi (citate in bibliografia), da me seguite in qualità di relatore o correlatore, ho attinto notizie. Un ultimo ringraziamento generico, ma non per questo meno sentito, agli allievi delle Università di Messina e di Roma Tre, che mi hanno fornito numerosi spunti di riflessione e di approfondimento. Tutte le illustrazioni pubblicate nel presente volume, inclusa quella di copertina, sono state generosamente concesse da Sebastiano Gesù (archivio privato), cui desidero esprimere la mia più viva gratitudine. L’editore rimane a disposizione per ogni eventuale problema relativo ai diritti di riproduzione del materiale iconografico. INDICE 1. L’analisi linguistica del film: tendenze e terminologie 1.1. Questioni terminologiche e metodologiche . . . . . . . . . . . . . . 1.2. I testi filmici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Preliminari semiologici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Preliminari linguistici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 15 22 27 2. Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 2.1. Le origini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. La lingua scritta del cinema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. L’oralità dei primi film sonori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Anni Trenta e Quaranta: tra realismo, letterarietà e propaganda 2.5. Il Neorealismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 51 69 79 99 3. Cinema e letteratura 3.1. Considerazioni generali, con qualche cenno alle differenze tra i linguaggi teatrale e cinematografico . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. La cena delle beffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Ladri di biciclette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Le amiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. L’innocente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Passione d’amore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 134 137 143 146 155 4. Lingua, lingue e dialetti 4.1. Lingua e dialetti prima del Neorealismo . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. I dialetti nel Neorealismo e dintorni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Dopo il Neorealismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. L’unicità di Totò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Sordi e l’impietoso ritratto linguistico dell’italiano medio . . 161 188 219 230 247 5. Il “doppiaggese” 5.1. Cenni storici, tecnici e teorici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Pratiche ed esempi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Il dialetto e le lingue straniere nel doppiaggio . . . . . . . . . . . 5.4. I titoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 292 324 342 6. Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 6.1. Dal mimetismo all’espressionismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Gli ultimi anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Trascrizione integrale dei dialoghi di Poveri, ma belli . . . . . 345 392 407 9 10 Il linguaggio cinematografico Illustrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Antologia critica 521 1. Pier Paolo Pasolini, I segni della lingua (linsegni) e i segni delle immagini (im–segni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 2. Luigi Chiarini, Il dialogo cinematografico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 3. Rudolf Arnheim, Muto contro sonoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 4. Ettore Allodoli, Il (neo)purismo e lo spirito antiborghese nella lingua del cinema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 5. Paolo Milano, L’antipurismo e l’uso medio nella lingua del cinema . . . 545 6. Valentina Ruffin, Patrizia D’Agostino, Dialoghi filmici di regime . . . 549 7. Luigi Pirandello, Cinema e teatro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 8. Gian Piero Brunetta, Dalla letteratura al cinema verso la crisi del linguaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 9. Alberto Menarini, Come funziona e come andrebbe sorvegliato il parlato filmico italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 10. Sergio Raffaelli, Il dialetto nel cinema dal muto al sonoro . . . . . . . . . 583 11. Pietro Pucci, Il dialetto reinventato (italianizzato, contaminato, ibridato?) dal cinema del secondo dopoguerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 12. Raffaello Patuelli, Doppiaggio: il problema dei calchi e dell’adattamento alle abitudini linguistico–culturali del pubblico . . . . . . . . . . . . 600 13. Giacomo Debenedetti, A favore del doppiaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 14. Michelangelo Antonioni, Contro il doppiaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 15. Tullio De Mauro, Il cinema come fattore dell’unificazione linguistica 615 16. Raffaele Simone, Il cinema: da scuola di italiano a specchio delle lingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 Glossario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indice dei film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indice dei nomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indice delle illustrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 687 707 727 1. L’ANALISI LINGUISTICA DEL FILM: TENDENZE E TERMINOLOGIE 1.1. Questioni terminologiche e metodologiche Linguaggio, come si sa, è un termine ambiguo, usato ora come sinonimo, ora come iperonimo, ora come iponimo di lingua. Con linguaggio cinematografico possono intendersi almeno due concetti molto distanti tra loro: da un lato, il sistema di segni, appartenenti a codici diversi (ICONICO [→ Glossario], acustico e verbale: immagini, musica, parole scritte e orali, suoni e rumori, etc.), che costituisce nel suo complesso l’oggetto film1; dall’altro, prendendo linguaggio come sinonimo di lingua verbale (o, meglio ancora, come un suo iponimo, data l’inclusione dei dialoghi filmici nel sovrinsieme lingua), l’insieme dei dialoghi (scritti o parlati) presenti in uno o più film. Il titolo del presente volume va inteso nel secondo significato, e vede dunque la lingua o il linguaggio del film (o lingua filmata, secondo la felice etichetta di RAFFAELLI 1992) come un sottoinsieme di quello che vari studiosi hanno definito ora lingua trasmessa [→ Glossario, TRASMESSO], ora parlato riprodotto, ora parlato simulato, etc. [→ Glossario, PARLATO PARLATO], tutti esempi di falsa oralità ovvero di oralità secondaria [→ Glossario, ORALITÀ]2. 1. Come vedremo nel § 1.3, le trattazioni sul cinema (tra le più recenti, cfr. per es. AMBROSINI/CARDONE/CUCCU 2003) si servono spesso di termini nati in seno alla linguistica e alla retorica. 2. Sull’oralità secondaria (vale a dire sui mezzi e sulle strategie di comunicazione 11 12 Il linguaggio cinematografico Tuttavia, soprattutto in questo e nei §§ 3 e 5, faremo spesso riferimento all’interazione tra immagini e parole — com’è inevitabile, parlando di cinema — e dunque il titolo del libro allude anche alla prima accezione di linguaggio. Dato che i dialoghi di un film sonoro sono quasi sempre imparati a memoria da una fonte scritta (COPIONE [→ Glossario] o SCENEGGIATURA [→ Glossario]) e poi recitati, alla stregua della lingua teatrale quella cinematografica può dirsi anche parlato–recitato [→ Glossario, PARLATO PARLATO], secondo la famosissima tipologia formulata da Giovanni Nencioni3. Una delle migliori definizioni di parlato filmico (ma anche radiotelevisivo e teatrale) sembra finora quella di «scritto per essere detto come se non fosse scritto», formulata da GREGORY (1967) e ripresa da LAVINIO (1986: 16): Lo scritto per essere detto come se non fosse scritto è quello che mira a cancellare del tutto il proprio marchio di genesi scritta, per mimare con la maggiore verosimiglianza possibile le cadenze, i ritmi, le forme del parlato. Esso comprende i testi della scrittura drammaturgica, dei copioni cinematografici, degli sceneggiati televisivi, e corrisponde a quel parlato–recitando che Nencioni ricorda essere tipico del teatro naturalistico e in prosa di tipo “borghese” (citando Pirandello come uno degli autori che inventa una lingua il più possibile “parlata” già nella scrittura). Tale parlato–recitando, che imita il parlato (conversazionale o MONOLOGICO [→ Glossario) ma che non che sfruttano l’oralità nelle società che conoscono la scrittura, a differenza di quella primaria, propria delle civiltà senza un sistema graf ico di riferimento) cfr. O NG (1982/1986: 21, 191–193, 223 et passim). La categoria linguistica del trasmesso — «la comunicazione fonico–acustica, e a volte anche visiva, indiretta (mediante telefono, radio, cinema, televisione, registratori, ecc.)» — è stata individuata e descritta da SABATINI (1982: 106) e approfondita da SABATINI (1997a). Dunque, senza lasciarsi fuorviare dal termine trasmettere (che, in un senso più specifico, vuol anche dire ‘diffondere attraverso i mezzi radiotelevisivi’), la lingua dei mass media (entro cui rientra la lingua filmica) è soltanto una componente della lingua trasmessa. Per «parlato riprodotto» cfr. R AFFAELLI (1992: 152); di «simulatori di parlato» parlano invece M ANCINI /V EDOVELLI /D E M AURO (1993: 121), mentre di «falsa oralità» Z UMTHOR (1983/1984: 11) e di «falso parlato» BANFI (1999: 16). 3. Cfr. NENCIONI (1976/1983), cui si rimanda una volta per tutte per i concetti di «parlato–parlato» (vale a dire spontaneo, a faccia a faccia, non programmato) e di «parlato–scritto» (le riproduzioni scritte del parlato). 1 – L’analisi linguistica del film 13 ne possiede comunque la spontaneità, diventa poi parlato–recitato e può acquisire una sorta di “spontaneità trasposta” quando l’attore, in una sorta di transfert, si cala completamente nella parte e assume la personalità del personaggio, aggiungendo al testo verbale proferito (e nato scritto dalla penna dell’autore) tutti quei tratti paralinguistici [→ Glossario, PARALINGUISTICO] e cinesici [→ Glossario, CINESICO] inscindibili dal parlato e invece sempre inesorabilmente assenti nella scrittura, anche in quella più mimetica [→ Glossario, MIMETICO] nei suoi confronti4. Come si avrà modo di chiarire nelle pagine che seguono, dunque, ciò che più sembra caratterizzare il testo verbale di un film è proprio la sua natura intermedia tra scritto e parlato. Ma, volendo essere pignoli, l’espressione linguaggio cinematografico potrebbe designare anche altri aspetti, come per esempio quello della terminologia tecnica del mezzo (più o meno nota ai non addetti ai lavori, dall’origine di termini quali cinema, DOPPIAGGIO [→ Glossario], film, MONTAGGIO [→ Glossario], quadro, regia, SCENA [→ Glossario], SEQUENZA [→ Glossario], alla presenza di settorialismi filmici in taluni autori, come Verga o Pirandello) o della critica cinematografica. Di questo importante aspetto (che vede dunque il linguaggio cinematografico nella sua natura di lingua o linguaggio speciale) si è occupato, tra gli altri, soprattutto Sergio Raffaelli, il quale invita a distinguere tra un «uso filmico del linguaggio verbale, cioè come componente testuale dell’opera cinematografica», e un «uso extrafilmico, in quanto comprende i materiali linguistici 4. LAVINIO (1986: 19). Quella dello «scritto per essere detto come se non fosse scritto» viene dunque a collocarsi tra le varie tipologie di testo scritto (secondo la griglia di CICALESE 1999: 184). Ecco le altre: scritto dialogico mimetico del parlato (chat lines); scritto per essere detto e ampliato (conferenze); scritto per essere letto ad alta voce (avvisi orali, telegiornale, testi liturgici); scritto informale per sé stessi (diario); scritto per essere letto integralmente o consultato (a vari livelli di formalità: lettere, giornali, libri, dizionari, enciclopedie…) (ibid.). In realtà la bipartizione tra testi scritti e parlati sembra oggi eccessivamente rigida (e il cinema ne è una prova), come hanno dimostrato, per esempio, gli studi sui nuovi mezzi telematici (e–mail, chat, etc.), efficacemente definiti da PISTOLESI (2004: 29–30) come forme di «scrittura secondaria». 14 Il linguaggio cinematografico prodotti dal cinema in tutte le sue molteplici manifestazioni estrinseche al TESTO [→ Glossario] filmico, dalle tecniche alle industriali alle critiche»5. In questa sede ci occuperemo soltanto del primo uso, rimandando ai lavori dello stesso Raffaelli per il secondo6. Occorre forse qualche altra precisazione sull’impianto di questo libro, prima di entrare nel vivo della trattazione. L’ordine cronologico di norma seguito — necessario, visto che si tratta di una sorta di storia della lingua italiana attraverso i dialoghi dei film — è talora interrotto nei capitoli di taglio trasversale, come il terzo, il quarto e il quinto, i quali affrontano temi cruciali e che mal tolleravano di essere dispersi e più volte ripresi nell’elencazione di film e correnti. Si tratta, infatti, di linee–guida (i rapporti tra cinema e letteratura, la presenza dei dialetti e il doppiaggio) che accompagnano il cinema sonoro praticamente dalle origini fino a oggi. Anche in altri momenti del libro, comunque, non mancheranno i riferimenti in avanti e all’indietro, inevitabili nelle storie e soprattutto in quella del cinema, data la frequenza di fenomeni quali la citazione, la parodia, la formularità, etc., connaturati nei mezzi di comunicazione di massa. Excusatio non petita: chi scrive è conscio dell’inscindibilità delle parole dalle immagini di un film e, dunque, dell’enorme incompletezza di una storia dell’italiano filmico (inevitabilmente troppi i titoli e gli autori esclusi, fatalmente sommario il riferimento agli aspetti non verbali dei film commentati). A parziale giustificazione, l’autore adduce la ricca bibliografia esistente sulla storia e le tecniche cinematografiche a fronte dell’esiguo numero di saggi dedicati alla lingua dello schermo: un volume in più appartenente a questo secondo insieme è, si spera, meno 5. RAFFAELLI (1992: 47). Alla terminologia del cinematografo delle origini (apparecchio, cinematografia, quadro, etc.) è dedicato RAFFAELLI (1992: 21–43). Precoce intervento sui tecnicismi cinematografici è GADDA (1927). 6. Cfr. almeno RAFFAELLI (1978), (1990), (1992: 30–38, 159–162), (1993b), (1996c), (1996d), (2001: 901–907) e (2003b). Alcuni tecnicismi filmici nati in inglese e prelevati, adattati o ricalcati dall’italiano (da cartoni animati a western) sono invece analizzati da RAFFAELLI (1991: 96–97). 1 – L’analisi linguistica del film 15 Tabella 1.1 soggetto scaletta trattamento sceneggiatura copione (livello scritto) parlato filmico in presa diretta (livello orale) lista dialoghi o découpage o continuity script (livello [tra]scritto) [postsincronizzazione dei film italiani] (livello orale) traduzione adattamento (livello scritto) doppiaggio missaggio testo filmico definitivo (livello orale) sceneggiatura desunta o découpage o trascrizione del film (livello [tra]scritto) superfluo dell’ennesima miscellanea appartenente al primo. Naturalmente, come quasi ogni libro, il presente, per essere più o meno utile, necessita di essere letto in parallelo con altri: almeno le trattazioni storiche di Brunetta e quelle teoriche di Aristarco riportate in bibliografia. Inoltre, per far vivere gli esempi filmici trascritti e renderli davvero “parlanti” al cento per cento, sarebbe necessario aver visto per intero i film cui si riferiscono. L’iconografia del volume funge da minimo risarcimento di questa lacuna. La filmografia conclusiva, ordinata alfabeticamente per titolo, serve anche a individuare subito le opere analizzate, o anche semplicemente nominate, nel corso del volume. 1.2. I testi filmici Sempre preliminarmente, occorrerà chiarire a quali testi ci siamo riferiti, nelle citazioni dai film, ovvero se alla sceneggiatura o al copione (cioè testi esclusivamente scritti) sulla base dei quali il film è stato girato, o piuttosto alla versione definitiva (e dunque un testo esclusivamente orale, successivamente trascritto) del dialogo filmico. Gioverà chiarire questa complessità di tipi testuali [→ Glossario, LINGUISTICA TESTUALE] iniziando da uno schema (Tab. 1.1). Ovvero: ogni film nasce sotto forma di un SOGGETTO [→ Glossario] scritto, cioè di una FABULA [→ Glossario] con un 16 Il linguaggio cinematografico [→ Glossario] appena abbozzato, spesso tratto da un testo letterario o teatrale preesistente. Il primo tentativo di suddivisione del soggetto in grandi blocchi narrativi, eventualmente già articolati in battute [→ Glossario, TURNO DIALOGICO] e in scene (sinteticamente riassunte), prende il nome di TRATTAMENTO [→ Glossario], nel quale si danno anche informazioni più o meno dettagliate sull’ambiente della vicenda. Al trattamento (o a varie ipotesi di trattamento, come accade di solito), si arriva in genere dopo aver disposto gli eventi salienti del film in una o più scalette [→ Glossario, SCALETTA]. Mentre il soggetto è di solito brevissimo (una o due pagine, ma anche poche righe), il trattamento ha dimensioni più ampie, comunque al di sotto della sceneggiatura. La sceneggiatura è il testo (scritto) che contiene sia le battute dei personaggi, sia sommarie indicazioni sull’ambiente (del tipo: «Esterno, notte»), sia rapidi cenni di regia (indicazioni sulle inquadrature [→ Glossario, INQUADRATURA]) e di SCENOGRAFIA [→ Glossario]. Il copione consegnato agli attori, invece, contiene soltanto minime indicazioni sceniche (numero della scena, ambiente e personaggi che vi prendono parte) e le battute dei locutori [→ Glossario, LOCUTORE] (e talora è detto, esso stesso, sceneggiatura; in tal caso la sceneggiatura di cui all’accezione precedente è più precisamente detta sceneggiatura tecnica [→ Glossario, SCENEGGIATURA]). Sulla base di questi testi scritti viene recitata la prima versione in PRESA DIRETTA [→ Glossario] di un film, che, nel caso del cinema non doppiato [→ Glossario, DOPPIAGGIO], è anche la versione definitiva. Nel caso di film destinati al doppiaggio o POSTSINCRONIZZAZIONE [→ Glossario] (non soltanto quelli stranieri ma anche, come vedremo, gran parte di quelli italiani dalla fine degli anni Trenta fino a non molti anni fa), si procederà poi alla trascrizione (detta lista dialoghi, o, in inglese, CONTINUITY SCRIPT [→ Glossario], o, in francese, DÉCOUPAGE [→ Glossario]7) delle battute recitate nella presa diretta (e, nel caso di film INTRECCIO 7. Il tecnicismo francese (letteralmente ‘taglio’) è in verità equivoco poiché alta- 1 – L’analisi linguistica del film 17 straniero, alla loro TRADUZIONE [→ Glossario] adattata [→ Glossario, ADATTAMENTO] al contesto e ai movimenti labiali degli attori) e alla successiva incisione di una nuova COLONNA SONORA [→ Glossario] contenente i dialoghi recitati in sala di doppiaggio, i quali verranno poi missati e sincronizzati (da cui il nome di sincronizzazione o postsincronizzazione dato alla pratica del doppiaggio) con le immagini del film [→ Glossario, MISSAGGIO, SINCRONIZZAZIONE]. Nel caso in cui si voglia studiare la lingua del film come esempio di parlato riprodotto, l’unico testo utile sarà quello orale della versione definitiva del film, che dunque andrà, per l’ultima volta, trascritto. Nel caso in cui interessi invece mettere a confronto le varie stesure durante la lavorazione del film, anche la sceneggiatura iniziale, benché difficilmente reperibile, è di grande interesse8. Sarà bene ricordare che la progressione delle varie fasi del testo filmico [→ Glossario, TESTO] è stata qui volutamente scandita in modo rigido, per chiarire adeguatamente i vari termini9. È ovvio che, nella pratica, si possono saltare alcune fasi (scaletta, trattamento) e dare alla sceneggiatura un’importanza variabile e una scrittura più o meno dettagliata: per alcuni regi- mente polisemico: può infatti designare la sceneggiatura, il copione di montaggio, il montaggio stesso (o, più propriamente, la struttura del film nella sua composizione in unità di tempo e di spazio), la trascrizione dei dialoghi, la trascrizione finale del film corredata di tutte le informazioni riguardanti il codice iconico (indicazioni sulla scenografia, sui movimenti della cinepresa, sui piani e sui campi di inquadratura, etc.) e desunte dalla visione in MOVIOLA [→ Glossario]. 8. Le sceneggiature sono di solito archiviate dalle società di PRODUZIONE [→ Glossario] del film (cui gli sceneggiatori hanno ceduto tutti i diritti) e spesso, dopo un certo numero d’anni, vengono mandate al macero. Solo raramente vengono pubblicate. Altre volte viene invece pubblicata la trascrizione della versione definitiva del film, mentre spesso, purtroppo, non viene specificato (a conferma dello scarso interesse agli aspetti linguistici e filologici del cinema) se si tratta del testo di partenza (la sceneggiatura iniziale, detta anche sceneggiatura di lavorazione), di quello d’arrivo (la trascrizione desunta dalla visione in moviola della versione definitiva del film) o di quello intermedio (la lista dialoghi allestita per il doppiaggio) [→ Glossario, SCENEGGIATURA]. 9. Il significato dei quali è facilmente reperibile (nonostante le notevoli oscillazioni da un autore all’altro) in qualunque manuale di tecnica cinematografica. In particolare, ci siamo attenuti più o meno ai significati di DI GIAMMATTEO (1990), sotto le singole voci della sezione «Tecnica e linguaggio» del secondo volume. 18 Il linguaggio cinematografico sti essa è soltanto un pretesto (Rossellini, Fellini), per altri (soprattutto i registi americani) è ricchissima di indicazioni tecniche e scrupolosamente seguita in fase di regia e di montaggio. Inutile dire che i diversi testi scritti e orali appena descritti possono presentare, e in effetti spesso presentano, differenze notevoli tra loro, non soltanto, come ovvio, il soggetto (succinto) dalla sceneggiatura (assai estesa), ma anche le battute del copione rispetto a quelle effettivamente recitate e a quelle doppiate. Questo perché i dialoghi concepiti per iscritto raramente contengono quella dinamicità e scioltezza che si richiede perlopiù ai dialoghi recitati sul grande schermo: tipicamente, nel passaggio dallo scritto al recitato, vengono aggiunti segnali discorsivi [→ Glossario, SEGNALE DISCORSIVO], interiezioni, inflessioni regionali e vengono (o per meglio dire venivano) eliminati termini troppo gergali o volgari per questioni di comprensibilità o di censura10. Soprattutto i registi italiani, poi (a differenza di quelli americani, più legati alla fedeltà nei confronti degli sceneggiatori [→ Glossario, SCENEGGIATORE] e abituati a prevedere con grande e professionale minuziosità tutte le fasi della lavorazione del film11), amano lasciare un certo spazio all’apporto personale (improvvisazione) dei loro attori (soprattutto nei film comici: si pensi a casi come Totò, Peppino De Filippo o, più recentemente, Troisi o Benigni) e riserbarsi il diritto creativo dei cambiamenti dell’ultim’ora. Ma può anche darsi il caso, opposto, di registi che decidono di cambiare il testo della sceneggiatura non per ragioni realistiche né di improvvisazione, bensì espressive, quando non espressionistiche. È ad esempio il caso di Fellini, che talvolta faceva recitare dei numeri (cioè parole prive di senso), in presa diretta, ai suoi attori, convinto 10. Il rapporto tra sceneggiatura e dialoghi del film è stato studiato (con commento delle varianti), tra gli altri, da BRUNETTA (1970: 70–80), sui film di Pasolini, e da ROSSI (1999: 249–273), su Le amiche, 1955, di Antonioni. 11. Anche in questa sudditanza alla pagina scritta, oltreché nella preferenza per le riprese [→ Glossario, RIPRESA] in studio piuttosto che in esterno e per la presa diretta del suono piuttosto che per la SINCRONIZZAZIONE [→ Glossario], il cinema americano classico è molto più vicino al teatro rispetto a quello italiano. 1 – L’analisi linguistica del film 19 che soltanto in fase di doppiaggio avrebbe preso vita e corpo la versione definitiva (e dunque la riscrittura dei dialoghi) dell’opera filmica (si tornerà sull’argomento nel § 5.1.3). Ovviamente, se il film è straniero, preliminare alla fase del doppiaggio sarà quella della traduzione, che da versione letterale dei dialoghi diverrà ben presto versione adattata (e ADATTAMENTO [→ Glossario], infatti, si chiama il testo che ne deriva, mentre adattatore dialoghista, o DIALOGHISTA ADATTATORE [→ Glossario], è il nome dell’artefice di quel testo). Rispetto alla traduzione, l’adattamento dovrà attenersi il più possibile ai movimenti labiali degli attori e dovrà tentare di rispettare, più che la lettera, lo spirito e le funzioni del testo originale: il problema si fa cruciale nei film comici e nei giochi di parole. Soltanto a doppiaggio avvenuto, si può passare al MISSAGGIO [→ Glossario] delle varie piste [→ Glossario, COLONNA] (sonore e visive) del film e alla confezione definitiva del prodotto (al doppiaggio è dedicato l’intero § 5). Il rapporto tra sceneggiatura e testo definitivo del film, nella sua fluidità, è stato più volte felicemente paragonato al rapporto tra libretto e testo verbale della partitura di un’opera lirica. E, anche oltre questo specifico aspetto, le analogie tra film e melodramma sono infatti numerose: intanto si tratta in entrambi i casi di prodotti multimediali e multimodali, nei quali la componente verbale non è autonoma ma intimamente connessa con altre (iconica, musicale, etc.: «il libretto è come una sceneggiatura, analoga la sua funzione, una porzione di un ‘collettivo’, non un risultato né un’opera autonoma»), di prodotti di massa (almeno per quanto riguarda il melodramma romantico)12 e di 12. VITOUX (1986/1991: 39) raffronta il sistema melodrammatico all’epoca di Rossini con «la straordinaria effervescenza del cinema americano negli anni fra il 1920 e il 1940. Identica prolificità, stesso entusiasmo del pubblico, medesima avidità di novità, pari allegria, analogo girotondo di parvenus, di impresari o produttori incolti e a volte ispirati (si pensi a Barbaja che fece venire Rossini a Napoli), stesse stelle o primedonne imprevedibili, affascinanti, capricciose, desiderabili, socievoli e adulate, analoga gerarchia fra maestri e registi». Su questi temi cfr. anche ROSSELLI (1985), (1987), NICASTRO (1992: 12) e ROSSI (2005: 40–42). 20 Il linguaggio cinematografico arte, per dir così, parassitaria, cioè con un’estrema tendenza al riuso, nel senso che, per quanto concerne le fonti delle sue trame, «vive d’accatto. Si contano sulle dita di una o due mani le opere di repertorio che […] non discendano da un modello letterario diretto, sia esso drammatico o narrativo»13. E proprio per questo le ambizioni frustrate del librettista sono spesso analoghe a quelle che saranno proprie di alcune maestranze cinematografiche, quali ad esempio lo sceneggiatore (che, neanche a farlo a posta, decenni fa veniva chiamato anche LIBRETTISTA [→ Glossario])14, il doppiatore [→ Glossario, DOPPIAGGIO] o l’adattatore dialoghista. Inoltre una nutrita falange di critici, fino ad epoca abbastanza recente, considererà la parola, nel cinema così come nell’opera lirica, del tutto ancillare rispetto all’immagine o alla musica (lo vedremo, per esempio, nel brani riportati nel § 2.1 e nella → Antologia critica, §§ 3.1 e 3.2). Due sole parole, in conclusione, sulle differenti tipologie grafiche di sceneggiatura, a seconda delle cinematografie. Esiste una sceneggiatura cosiddetta all’italiana, una all’americana e una alla francese. Il primo tipo prevede lo specchio della pagina idealmente suddiviso in due colonne verticali. La colonna di sinistra contiene la descrizione dell’ambiente, del tempo atmosferico, alcune indicazioni sui movimenti della macchina da presa [→ Glossario, MACCHINA DA PRESA, MOVIMENTO DI MACCHINA] e la descrizione dei personaggi; è la cosiddetta parte descrittiva: PIAZZA DEL MERCATO – Esterno – giorno. Il commissario di polizia rionale Ociumielov attraversa la piazza. Ha un cappotto nuovo. Lo segue una guardia dai capelli rossicci, Eldirin. Non c’è un’anima in giro. Le porte aperte delle botteghe sembrano fauci affamate. D’un tratto si sente una voce gridare15. 13. BIANCONI (1986: 21–22). «Il libretto è […] quasi sempre il risultato di un riuso, di un adattamento, come tanto spesso sarà, nel Novecento, il cinema […]. [I]l libretto è perlopiù un testo di secondo grado» (COLETTI 2003: 30). 14. Ancora nel 1959 da Carlo Battisti (cfr. RAFFAELLI 1993: 48). 15. AGE (1990: 54). All’intero volumetto di Age si rimanda per le caratteristiche fondamentali della sceneggiatura come tipo di testo. 1 – L’analisi linguistica del film 21 Quella di destra contiene i dialoghi. Nella sceneggiatura all’americana la parte descrittiva è a tutta pagina mentre i dialoghi, sottostanti, sono disposti nella parte centrale. La sceneggiatura alla francese è una combinazione dei primi due tipi: la parte descrittiva è a tutta pagina, mentre i dialoghi sono scritti nella colonna di destra. Date le finalità di questo libro, abbiamo sempre utilizzato (qualora non diversamente segnalato) le trascrizioni della versione definitiva del film. In molti casi, e laddove non altrimenti dichiarato in nota, si tratta di trascrizioni personali, nelle quali si è adottata una serie di segni diacritici già ampiamente descritta in altre sedi16. Nel caso in cui si attingano trascrizioni filmiche 16. Cfr. almeno ROSSI (1999a: 21–31). Ricordiamo qui che ai punti e alle virgole abbiamo sostituito, come da convenzione largamente accettata per le trascrizioni del parlato, le barre semplici (/) e doppie (//), che indicano, rispettivamente, il passaggio da un’UNITÀ TONALE [→ Glossario] a un’altra e la fine di un enunciato con funzione e intonazione assertive. Abbiamo inoltre utilizzato le parentesi uncinate (< >) per contrassegnare il fenomeno della sovrapposizione di turno dialogico, vale a dire l’esecuzione simultanea di battute, o di porzioni di esse, da parte di due o più attori, e le parentesi quadre per porzioni di testo scarsamente o per nulla ([…]) comprensibili (le parentesi quadre racchiudenti tre puntini indicano inoltre, come di consueto, porzioni di testo omesse). Il segno sh indica la pronuncia substandard (o regionale) della sibilante palatale (come per es. in shtare ‘stare’ in certe parlate centromeridionali), mentre cj indica la pronuncia di ci elisa davanti a parola iniziante per a, o, u, in luogo dell’equivoca grafia c’ho, c’aveva e simili (mantenuta, ovviamente, nelle trascrizioni tratte da altri autori). Eventuali notazioni del trascrittore sulla situazione comunicativa (per es., a chi si rivolge il parlante) sono scritte in corsivo e tra parantesi tonde dopo il nome del locutore, che è sempre in maiuscoletto. Ai film citati ci si riferisce mediante il titolo per esteso (nei film stranieri, il titolo italiano è seguito, tra parentesi, da quello originale, se diverso), l’anno della prima proiezione pubblica (di norma per i film italiani, mentre quello della produzione per i film stranieri, così come in Guidorizzi sotto citato, seguendo inevitabilmente la difformità di datazione della bibliografia specializzata) e il nome del regista o, qualora ignoto (per il muto) o nel caso di film d’animazione, della Casa di produzione. Per una consultazione più agile, la filmografia conclusiva raccoglie l’elenco completo dei film citati nel corso del volume. Per i dati filmografici ci siamo avvalsi di BERNARDINI (1980), (1981), (1991), (1992), (1993a) e (1993b), C HITI /P OPPI (1991), L ANCIA (2001–2002) e GUIDORIZZI (1986), (1988) e (1993). Per i dati ivi mancanti, siamo ricorsi anche a M EREGHETTI (2005) e al sito «The Internet Movie Database» (http://www.us.imdb.com). Per non appesantire la filmografia, abbiamo omesso la data d’arrivo in Italia dei film stranieri (segnalandola nel testo soltanto nei casi di ritardo particolarmente interessanti), di solito differita di un anno rispetto alla DISTRIBUZIONE [→ Glossario] in patria (per la realizzazione del doppiaggio, naturalmente; periodi di espor- 22 Il linguaggio cinematografico ad altri autori, se ne adotterà il criterio di trascrizione (e dunque si useranno i punti, le virgole e gli altri segni tradizionali). 1.3. Preliminari semiologici Come si è già accennato a proposito della prima accezione, qui non presa in considerazione, di linguaggio cinematografico, la linguistica, o meglio la semiologia, si è subito interessata al cinema in quanto sistema di segni e per decenni ha pensato di ricondurre i meccanismi delle immagini a quelli delle parole, tentando cioè di spiegare il funzionamento della comunicazione iconica ricorrendo alla terminologia della retorica. I registi e i teorici russi parlarono pertanto di metafora e di metonimia, assimilando il concetto di inquadratura a quello di parola e considerando «il montaggio […] una delle figure retoriche del linguaggio cinematografico»17. tazione molto più lunghi si registrano soprattutto per i film girati durante la seconda guerra mondiale), comunque recuperabile dai repertori del Guidorizzi citati. Spiace sottolineare, ancora una volta, la frequente imprecisione con la quale, anche in repertori accreditati, vengono schedati i film (fa eccezione Bernardini). Tale mancanza di rigore scientifico (una disattenzione frequente consiste nel non specificare se l’anno apposto al film sia quello di produzione o quello di prima proiezione, ma addirittura sulla grafia dei titoli c’è oscillazione tra le diverse fonti) è evidentemente provocata dal solito pregiudizio della commerciabilità ergo scarsa dignità artistico–filologica dell’oggetto filmico. Un’ultima considerazione sulla convenzione della datazione: è preferibile scegliere la data della prima proiezione pubblica (detta anche DATA DI EDIZIONE [→ Glossario]) del film (o, se è ignota, dopo il 1913, la data del visto della censura), poiché si tratta «di una data obiettivamente accertabile e certa (mentre molto meno certa e accertabile risulta quasi sempre la data di produzione, che in certi casi può anche essere di molto anteriore)» (BERNARDINI 1992: VII). 17. LOTMAN/TSIVIAN (1994/2001: 39). Sull’analisi semiologica e retorica del film cfr. anche, almeno, EJZENŠTEJN (1963–1970/1986), BETTETINI (1984), CASETTI/DI CHIO (1990). Come esempio di metafora cinematografica si prenda La serpe, 1920, di Roberto Roberti: «le inquadrature in cui la nota ‘diva’ di quegli anni, Francesca Bertini, irretisce l’ennesima vittima, vengono intercalate con l’immagine di un serpente che ha agguantato un porcellino d’India» (LOTMAN/TSIVIAN 1994/2001: 255). Altri esempi in EJCHENBAUM (1971/1976) e in MANZOLI (2003: 46–50). Vari casi di metonimia sono ricavabili da EJZENŠTEJN (1963–1970/1986), per es. a p. 117. «Interamente costruito su una rigorosa applicazione del procedimento metonimico della parte per il tutto» è il noto film Amore pedestre, 1914, di Marcel Fabre, in cui tutta la storia si svolge mediante l’in- 1 – L’analisi linguistica del film 23 Per altri autori, invece, soprattutto in epoca più recente, il cinema, come il linguaggio delle immagini in genere, ha sue regole che non possono essere confuse con quelle dei linguaggi verbali18. Complessivamente, tuttavia, quello che ha contrassegnato gli studi di semiologia filmica fino a non molti anni fa è stato un generale disinteresse nei confronti della componente parlata del cinema, quasi che le parole fossero un elemento estraneo al mezzo, banalizzante, spesso deturpante, una specie di male necessario per avvicinare il grande pubblico. D’altro canto, se i semiologi e i filmologi hanno sottovalutato la componente verbale del film, non si può dire che i linguisti e gli storici della lingua ne abbiano fatto il centro del proprio interesse, sebbene negli ultimi anni si possa contare qualche titolo in più rispetto alla rassegna presentata in ROSSI (1996) e (1999: 13–14, 40–48): tra questi ricordiamo almeno HEISS/BOLLETTIERI BOSINELLI (1996), BOLLETTIERI BOSINELLI/HEISS/SOFFRITTI/BERNARDINI (2000), TAYLOR (2000), R AFFAELLI (2001), (2003a) e (2003b), S ETTI (2001) e (2003), ROSSI (2002a), (2002b), (2002c), (2003a), (2003b) e (2003c), A. ROSSI (2003). Passiamo ora a esaminare alcune peculiarità semiologiche dei testi audiovisivi rispetto ai testi scritti. Lo faremo in primo luogo ricorrendo alla schematizzazione di SIMONE (1991) e (2000: 71–95) sui tratti che oppongono il «testo che si legge» (prototipicamente un romanzo) al «testo che si guarda» (prototipicamente un film, al cinema o in televisione; Tab. 1.2)19. quadratura dei soli piedi dei protagonisti (BRUNETTA 1991: 80; cfr. anche FOLENA 1970a: IX e FOLENA 1970b). Metafora, metonimia e altre figure retoriche nel film muto sono state analizzate da BRUNETTA (1970: 3–33). 18. Si vedano già METZ (1964: per il quale il film non può essere considerato una lingua, bensì un linguaggio, visto che manca della doppia articolazione) e PASOLINI (1972/1991: 167–297, per il quale il cinema è la «lingua scritta della realtà» [→ Antologia critica, § 1]). 19. Per prototipo, nelle scienze umanistiche, si intende «il rappresentante migliore, “il caso più chiaro di appartenenza alla categoria, definito operativamente dal giudizio delle persone sulla ‘bontà’ di appartenenza alla categoria” […]» (BAZZANELLA 2002b: 19). Sulla necessità di adottare un modello di studio a prototipo (che tenga cioè 24 Il linguaggio cinematografico Tabella 1.2 TRATTI SEMIOTICI Ritmo autotrainato Correggibilità Convivialità Multisensorialità Gestione dei frames ed enciclopedia Citabilità Livello zero di iconicità Intelligenza attivata AMICHEVOLEZZA VISIONE + + + Simultanea Alta LETTURA + + + + Sequenziale Bassa In altri termini, il messaggio scritto presuppone un più scaltro decodificatore, in grado di gestire molti frames [→ Glossario, FRAME] non sempre semplici e in possesso di un numero spesso elevato di conoscenze pregresse. Ricordiamo che con frame (in ingl., letteralmente, ‘cornice’, ma in questo caso sarebbe più appropriata una traduzione come ‘quadro di riferimento’) e con ENCICLOPEDIA [→ Glossario] si intende una situazione (frame), e un insieme o bagaglio di situazioni (enciclopedia), già presenti nella memoria dell’INTERLOCUTORE [→ Glossario], necessarie per interpretare situazioni nuove ma analoghe a quelle conosciute. Per esempio, se mi si parla delle doti tecniche di un calciatore, dovrò richiamare alla memoria il quadro di riferimento partita di calcio, per poter capire quanto mi viene detto. Qualcuno chiama i frames anche copioni, scenari, schemi, modelli mentali o sceneggiature20. conto della tendenziale, e non assoluta, appartenenza di un oggetto a una categoria in base alla maggior concentrazione di certe proprietà tipiche e alla minor presenza di proprietà tipiche di categorie diverse), per l’analisi delle differenze modali, o diamesiche, tra scritto, parlato e trasmesso, cfr. anche BAZZANELLA (1998) e ROSSI (2003a: 451, utile anche per i concetti di canale, modo e modalità nelle differenze scritto/parlato/trasmesso). Sull’opposizione semiotica e sociologica tra visione e lettura si legga anche COSTA (1993: 17–44). 20. I frames sono «depositi di conoscenze stereotipiche che variano al variare della cultura di una data comunità» e «dovrebbero garantire e soddisfare gli ‘orizzonti di attesa’ per cui, data la conoscenza di un fatto, dovremmo essere in grado di prevederne le successive riproposizioni» (C ICALESE 1999: 178). Cfr. anche B ROWN /Y ULE (1983/1986: 303–324). 1 – L’analisi linguistica del film 25 Inoltre, il ritmo eterotrainato del messaggio iconico (vale a dire il fatto che la fruizione di un film sia soggetta a tempi e ritmi imposti da altri e non, differentemente dalla lettura di un libro, scelta liberamente dall’utente, secondo pause, rimandi all’indietro o in avanti, etc.) implica una serie di vincoli interpretativi. Vincoli cruciali nel testo filmico, tipicamente non ripetibile (a meno che non venga fruito mediante videoregistratore, lettore DVD, etc.: anche allora, però, il rivedere alcune scene costituisce una modalità, per così dire, marcata, tant’è vero che il destinatario ideale del film continua a essere il pubblico nelle sale, soggetto a un’unica irripetibile visione)21, non correggibile (se fraintendo una frase di un libro, posso correggere il mio errore tornando indietro, mentre col film abbiamo già visto come questo non sia possibile, o sia meno facile) e di durata raramente superiore alle due ore. Ovvero, ciò che un romanzo può dire in un numero teoricamente illimitato di pagine, e con infinite possibilità di rilettura e di riflessione, deve essere condensato in due ore di visione. Non sarà difficile dedurre, pertanto, come il testo filmico sia un buon candidato alla “semplificazione”, ovvero alla facilitazione della fruizione per lo spettatore. Sia detto tra virgolette, dato che, come si è già visto, quello filmico è in realtà un codice assai complesso, nato dall’intreccio di una pluralità di codici e frutto della transcodificazione, ovvero di quel continuo altalenare tra i livelli scritto e orale22. Spieghiamo alla svelta gli altri termini della tabella appena riportata. Con convivialità intendiamo la fruizione prevalentemente sociale (diciamo pure “di massa”) del prodotto filmico, differentemente dalla lettura tipicamente solitaria di un libro. La multisensorialità allude invece ai sensi chiamati in causa nella fruizione di un film (almeno due: vista e udito, ma non mancano esperimenti di odorama, ovvero di cinema “olfattivo”), di fronte 21. Sul cambiamento di fruizione del film arrecato dal videoregistratore cfr. CASETTI/DI CHIO (1990: 8–11) e ORTEOLEVA (1999: 1010–1012). 22. Cfr. BETTETINI/DE MARINIS (1977: 24). 26 Il linguaggio cinematografico al coinvolgimento esclusivo della vista nella lettura. Questi ultimi elementi (ma se ne possono aggiungere altri: il luogo e l’orario della fruizione di un film, per es., sono molto più vincolati e vincolanti rispetto a quelli della fruizione di un libro) possono sembrare, nella loro ovvietà, scarsamente associabili alle caratteristiche linguistico–testuali di un’opera. Eppure si pensi all’importanza degli elementi di disturbo e distrazione (correlati anche con il ritmo eterotrainato) nella fruizione del film e, a proposito della convivialità, ai significati aggiunti e alle interferenze che si possono verificare nel corso della fruizione stessa. L’empatia fra le componenti del pubblico è un dato ineludibile: le risate e le lacrime sono contagiose; sentir ridere può spingere a prestare più attenzione agli elementi comici o può esaltarli, così come veder piangere può sottolineare gli elementi commoventi, e caricarli di un significato diverso da quello che avremo loro attribuito senza una suggestione esterna. Le risate, le lacrime, i commenti in sala rimandano, inoltre, a un’altra differenza: quella della comunicazione del giudizio che, nel caso del film può essere contestuale alla fruizione, mentre nel libro è sempre posteriore23. Per citabilità si intende la possibilità di riportare letteralmente porzioni di testo: un libro può essere citato in ogni sua parte mediante il semplicissimo uso delle virgolette o della lettura di un brano, mentre un film, a meno che non se ne riproietti una scena, non può essere se non parafrasato (con relativa perdita dell’immagine). Il livello zero di ICONICITÀ [→ Glossario] dell’immagine (sembra quasi un paradosso) comporta il fatto che una qualsiasi immagine significa innanzitutto sé stessa (l’immagine di un cane significherà essenzialmente ‘cane’, anche se non si possono escludere utilizzazioni metaforiche o simboliche di certe immagini e la loro differente interpretazione a seconda del contesto, come dimostrato dagli esperimenti di Kulešov)24, a 23. NUVOLI (1998: 30–31). 24. Il regista e teorico sovietico Lev Vladimirovič Kulešov, com’è noto, dimostrò 1 – L’analisi linguistica del film 27 differenza del significato delle parole (scritte o orali), quanto mai oscillante, sfumato, tendente al traslato, etc. (per tacere del rapporto assolutamente arbitrario che lega il significante al significato, come dimostrato da Saussure): ricordati di dar da mangiare al cane, sei veramente un cane, quella cantante è un cane, il cane della pistola, soffro da cani, sono rimasto solo come un cane… In conclusione, tutti i tratti che oppongono il testo letto a quello visto caratterizzano il secondo come più “amichevole” del primo, vale a dire più rispettoso delle difficoltà di decodificazione dell’interprete. Non si vuol certo, con questo, screditare il film rispetto alla letteratura, ma soltanto valutare le differenze semiologiche dei due tipi di codice. È interessante osservare come il testo più facilmente fruibile, appunto quello visivo, sia anche quello che attiva un’intelligenza di tipo simultaneo, ovvero che combina contemporaneamente più livelli (si pensi alle diverse parti dello schermo cinematografico, necessarie alla completa decodificazione di una scena filmica), rispetto all’intelligenza sequenziale, attivata tipicamente dalla lettura, che richiede invece, com’è ovvio, di procedere ordinatamente da destra a sinistra, o da sinistra a destra, o dall’alto verso il basso, a seconda dei tipi di scrittura. La maggiore fruibilità del testo iconico rispetto a quello scritto e parlato ne ha fatto, non casualmente, il miglior rappresentante della civiltà globalizzata, detta spesso, per l’appunto, civiltà dell’immagine. 1.4. Preliminari linguistici 1.4.1. È nota la posizione intermedia della lingua trasmessa (e segnatamente del parlato filmico) tra la modalità orale e quella scritta, all’insegna, ancora una volta, della semplificazione, che una medesima immagine (per esempio un volto umano) è percepita in modo assai differente dagli spettatori (con espressione ora allegra ora triste, per esempio) a seconda delle immagini che la seguono e la precedono (cfr. BAZIN 1958/2000: 77). 28 Il linguaggio cinematografico Tabella 1.3 Caratteristiche della lingua trasmessa (cioè veicolata da un sistema tecnico di riproduzione sonora e/o visiva). 1. 2. 3. 4. 5. Mancata condivisione del contesto da parte di mittenti e riceventi Unidirezionalità dell’atto comunicativo (assenza di feedback) Molteplicità dei mittenti (produzione collettiva del messaggio)25 Eterogeneità dei riceventi (destinazione di massa del messaggio) Distanza tra il momento di preparazione del testo, il momento della sua esecuzione e quello della sua ricezione 6. “Simulazione” del parlato spontaneo 7. Presenza di un apparato tecnico–economico per la preparazione e la trasmissione del messaggio dell’attenuazione delle varietà e della normalizzazione linguistica, come si riassume in due schemi, il primo rielaborato sulla base di SABATINI (1982) e (1997a) (Tabb. 1.3–1.4). Anche qui gioverà spiegare alcuni tecnicismi. Con FEEDBACK [→ Glossario] (letteralmente ‘segnale di ritorno, reazione, retroazione’) si intende la capacità del parlante di sentire, e quindi di controllare, quanto sta dicendo ed eventualmente di autocorreggersi [→ Glossario, AUTOCORREZIONE]. È chiaro che questa possibilità è presente soltanto negli scambi comunicativi realmente reciproci, e non in un testo monologico in cui un mittente (autore) parla a un destinatario (pubblico) spesso lontano nel tempo e nello spazio e in più, nel caso del cinema, privato del diritto di replica (qual è, invece, l’applauso o il fischio a teatro, possibile anche al cinema, ma, ovviamente, senza controreazione degli interpreti). Lo schema seguente dà conto di quello che potremmo definire il doppio livello comunicativo del parlato filmico, cioè la comunicazione riprodotta dagli attori (perlopiù doppiati) che dialogano tra loro, e il livello, più profondo, di comunicazione tra un mittente (autori del film) e un destinatario (pubblico) che non può, evidentemente, rispondere ma soltanto ricevere (Tab. 1.5). 25. MCLUHANN (1964: 318) assimilava la fattura del film al lavoro di un’orchestra, nell’etichetta di «azione artistica collettiva». 1 – L’analisi linguistica del film 29 Tabella 1.4 TRATTI LINGUISTICI Uniformità delle unità pragmatiche [ Glossario, PRAGMATICA] e testuali (turni, frasi, enunciati) Tendenza alla monologicità Estensione delle unità (turni, frasi, enunciati) Sovrapposizioni, sporcature e altri “incidenti” dialogici Pianificazione, coerenza e coesione Ricorso ad elementi para– ed extralinguistici Complessità morfosintattica Densità lessicale Presenza del dialetto Polarizzazione in base al genere SCRITTO - ORALE - PARLATO FILMICO + + + - +/- - + - + - + + + + + + + + +/+/+/- Tabella 1.5 1° livello (comunicazione a doppio senso o interazione riprodotta): ATTORI–DOPPIATORI ATTORI-DOPPIATORI 2° livello (comunicazione a senso unico): AUTORI PUBBLICO Il dialogo di primo livello non è che un mezzo per instaurare un dialogo di secondo livello, ovvero, in altre parole, le battute dialogiche del film, così come quelle del testo teatrale, non sono altro che un «dire a nuora perché suocera intenda», dove la nuora sono gli attori e la suocera è il pubblico26. Non a caso, quando un regista inscena l’abbattimento del muro, lo sfondamento dello schermo piccolo o grande, che separa questi due diversi livelli (mittenti–destinatari ficti e autori–spettatori reali) — attivando così la funzione metalinguistica o meglio metacomunicativa (metateatrale o metafilmica [→ Glossario, METAFILMICO) — ottiene un effetto straniante sfruttabile per ottene26. TRIFONE (1994: 82) e relativa bibliografia. Sui rapporti tra cinema e teatro si tornerà nel § 3.1. 30 Il linguaggio cinematografico re comicità o terrore: si pensi, tra i tanti esempi, al raffinatissimo La rosa purpurea del Cairo (The Purple Rose of Cairo), 1985, di Woody Allen, con quel continuo rivolgersi degli attori direttamente al pubblico in sala e con l’interazione tra attori e pubblico riprodotti nel film; oppure al thriller The Ring, 2002, di Gore Verbinski (remake del giapponese Ringu, 1998, di Hideo Nakata), con la terrificante bambina morta che esce dal televisore per uccidere gli spettatori e con elementi (acqua, mosche) che passano da fuori a dentro lo schermo e viceversa. Il teatro, grazie alla compresenza di pubblico e attori nella medesima sala, dispone sicuramente di mezzi maggiori per abbattere la QUARTA PARETE [→ Glossario] (ovvero quella ideale che separa il palco dal pubblico): da Pirandello in poi è infatti abbastanza frequente l’interazione (diretta o riprodotta, come nei Sei personaggi in cerca d’autore o Stasera si recita a soggetto) tra attori e spettatori (sfruttatissima nel teatro comico, fin dalle origini greche, e nell’AVANSPETTACOLO [→ Glossario]) e, da sempre, la possibilità di questi ultimi di dare ai primi un evidente segnale di feedback (applausi, fischi, commenti a voce alta, etc.), al quale gli attori possono a loro volta reagire (ringraziando, inchinandosi, etc.). Con simulazione alludiamo alla natura realistica del parlato cinematografico, il quale, anche quando si allontana dal livello colloquiale, è comunque sempre più vicino al parlato spontaneo [→ Glossario, PARLATO PARLATO] di quanto non possa mai esserlo un testo scritto, soprattutto per via dell’assenza, nel secondo, dei cosiddetti elementi paralinguistici (pause, intonazioni) ed extralinguistici [→ Glossario, EXTRALINGUISTICO] (timbro e volume della voce, gesti, mimica facciale [→ Glossario, MIMICO], etc.). Con TURNO [→ Glossario], o turno dialogico o conversazionale, o battuta, si intende una porzione di testo orale pronunciata da un solo locutore (o parlante) e delimitata dalla presa di parola da parte di altri locutori o dalla fine del dialogo. Di solito la conversazione presuppone almeno due turni di due diversi locutori; un monologo è invece costituito da un solo turno. 1 – L’analisi linguistica del film 31 ENUNCIATO [→ Glossario] è invece il termine col quale i linguisti designano una porzione di testo, autonoma dal punto di vista dell’intonazione, del senso e della sintassi, identificabile con la realizzazione di un solo ATTO LINGUISTICO [→ Glossario] (è insomma il corrispettivo orale di quello che nello scritto è detto periodo o frase [→ Glossario, ENUNCIATO], più o meno)27. Sporcature e incidenti dialogici sono tutti quegli elementi (frequenti nel parlato reale scarsamente progettato, quasi assenti nel film doppiato) che rendono iperrealistica una conversazione: battute sovrapposte dei parlanti, parole interrotte, enunciati sospesi, frange di suoni inarticolati come certe interiezioni e pause vocalizzate [→ Glossario, PAUSA VOCALIZZATA] del tipo ehm, hm, etc. Un testo, infine, si definisce lessicalmente denso se il numero delle sue parole piene (i lessemi veri e propri, dotati di un significato autonomo: sostantivi, aggettivi, verbi, la gran parte degli avverbi) supera quello delle parole vuote (ovvero le parole grammaticali: congiunzioni, preposizioni, articoli, etc.) e se contiene poche ripetizioni. Studi recenti sulla lingua del cinema hanno mostrato come il parlato cinematografico sia in certo qual modo a metà strada tra la bassa DENSITÀ [→ Glossario] lessicale del parlato spontaneo e colloquiale e l’alta densità della lingua scritta, così come sia tendenzialmente più complesso del parlato, ma meno dello scritto, sul terreno della sintassi e della morfologia (varietà dei tempi e dei modi verbali, tipo e grado di subordinazione e altro). L’estensione dei turni e degli enunciati, inoltre, è molto superiore nel film, rispetto ai dialoghi reali, tant’è vero che non mancano scene cinematografiche in cui il parlato si avvicina al monologo. 27. Più precisamente, per enunciato si intende «il corrispettivo linguistico di un atto» (CRESTI 2000: I, 42). Un enunciato può essere sottostrutturato in unità tonali e informative (tema, o topic, rema, o comment, e altre), che ripartiscono l’informazione dell’atto in elementi dati e nuovi. All’intero primo volume di CRESTI (2000), e in particolare alle pp. 41–203, si rimanda per un’analisi e un’esemplificazione dettagliate di questi concetti. Cfr. anche ROSSI (1999a: 122–140). 32 Il linguaggio cinematografico Mentre, infine, la differenza di GENERE [→ Glossario] e di stile (tragico/comico, più o meno letterario, etc.) determina un’estrema diversificazione linguistica, sia nello scritto (basti pensare alle differenze sintattiche tra un saggio di critica letteraria, poniamo, e una lettera a un amico o una pagina di cronaca nera) sia nell’orale (si confronti un seminario universitario e una conversazione tra amici al bar), il linguaggio filmico risulta, o quantomeno risultava fino alla fine degli anni Cinquanta, tutto sommato meno polarizzato, come è emerso dal confronto di film diversi analizzati in ROSSI (1999a). In quel corpus è stato rilevato, per esempio, che gli enunciati, indipendentemente dallo stile del film e dalla situazione comunicativa, tendono ad avere il medesimo numero di parole, ad essere costituiti da una sola CLAUSOLA [→ Glossario] (o proposizione) e, nei casi di enunciati pluriclausola, a ridurre la varietà del tipo e del grado di subordinazione. Anche nelle scelte lessicali, i dialoghi filmici tendono a non allontanarsi dai lemmi compresi nel vocabolario di base28, escludendo o riducendo al minimo, quindi, gergalismi, dialettalismi, tecnicismi, arcaismi, poetismi, etc. Non si creda, tuttavia, che la modalità comunicativa del parlato cinematografico sia comodamente riconducibile a una sorta di oralità semplificata. Se infatti di semplificazione è legittimo parlare per quanto concerne la riduzione del tasso di dialettalità (per non escludere fasce di pubblico dalla completa comprensione del film) e l’attenuazione dei tratti lessicali e morfonsintattici eccessivamente al di sopra (iperletterari o arcaici) o al di sotto (iperpopolari) di un italiano dell’uso medio, non altrettanto si può dire sul piano della complessità testuale, ovvero sulla quantità di situazioni comunicative che il cinema è in grado di riprodurre. Praticamente, tutti i tipi di dialogo e di monologo possono essere rappresentati al cinema. Per esempio, per quanto riguarda il dialogo, prendendo in prestito la tipologia del LIP (p. 35), possiamo avere: 28. Cfr. DE MAURO (1980/1992). 1 – L’analisi linguistica del film 33 1) scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola libera (conversazione in tutte le sue possibili forme); 2) scambio bidirezionale non faccia a faccia con presa di parola libera (conversazioni telefoniche); 3) scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola non libera (dibattiti, interviste, interrogazioni, etc.); 4) scambio unidirezionale in presenza di destinatario/i (lezioni, conferenze, omelie, comizi, etc.); 5) scambio unidirezionale o bidirezionale a distanza (trasmissioni radiofoniche e televisive). Anche il monologo può essere distinto in diversi sottotipi (tratti da CICALESE 1999: 184), tutti riproducibili al cinema: – – – Monologo spontaneo (pensare a voce alta) Monologo scarsamente pianificato (ampliare appunti) Monologo pianificato (ripetere a memoria o leggere a voce alta). Chiaramente, così come il dialogo, anche il monologo sul grande schermo è sempre doppiamente strutturato e, anzi, ancor più del parlato a più voci, squarcia la finzione (infrange la già menzionata quarta parete, si direbbe nel linguaggio teatrale), soprattutto se pronunciato da un attore che guarda fisso nella cinepresa [→ Glossario, MACCHINA DA PRESA] (e dunque negli occhi dello spettatore, secondo il cosiddetto SGUARDO IN CAMERA [→ Glossario]), rivelandosi nella sua autentica natura di discorso al pubblico29: alcuni registi, infatti, sfruttano questo espediente proprio per coinvolgere lo spettatore e per mostrare come in realtà, pur narrando di vicende apparentemente lontane nel tempo e nello spazio, il film vuole alludere a quanto sta accadendo qui e ora30. 29. «Lo schermo svolge il ruolo di autentico interlocutore, non è uno sterile riproduttore di gesti e parole sempre uguali, bensì un soggetto del dialogo capace di intrattenere un legame di feedback con ogni singolo spettatore» (LOTMAN/TSIVIAN 1994/2001: 11). 30. Accade, per dare un esempio recente, nel film di George Clooney, Good Night, and Good Luck, 2005: film storico, in bianco e nero, sulla censura dei mezzi di informazione e la caccia alle streghe (ovvero i filocomunisti o supposti tali) durante il maccarti- 34 Il linguaggio cinematografico A questo ampio spettro, il cinema, grazie ai suoi artifici, aggiunge le possibilità di una voce che può essere ora in campo [→ Glossario, CAMPO] (ovvero prodotta da un personaggio inquadrato mentre parla) ora FUORI CAMPO [→ Glossario], con grande complessità di usi: la voce fuori campo può provenire da un personaggio in quel momento non inquadrato, ma può anche essere una voce pensiero, oppure la voce di un commentatore esterno alla vicenda narrata, o la voce del regista, dello sceneggiatore, finanche la voce di un morto (svelando così, ancora una volta, tutto l’artificio del doppio livello comunicativo del cinema)31. Abbiamo detto più volte che il testo di un film è ibrido (o, come va di moda dire oggi, multimediale, e dunque tutt’altro che semplice), poiché combina elementi tipici di diversi codici: scritto, orale, musicale, iconico, etc. In realtà, le anomalie testuali, per così dire, del cinema riguardano anche altri aspetti, come risulta dalla sintesi seguente: 1) Il film è un testo d’équipe, con conseguente attenuazione del concetto di “paternità”. Autori del film sono almeno: sceneggiatori, regista, fotografo, montatore, attori, adattatore dialoghista, direttore di doppiaggio, doppiatori, produttore…32. smo. Tuttavia il frequente ricorso allo “sguardo in camera” da parte del protagonista (giustificato, narrativamente, dal fatto che si tratta di un giornalista televisivo ripreso mentre parla in trasmissione) non fa che ricordare allo spettatore che quella temperie non si è estinta ma è ben presente ancor oggi. 31. Un assaggio di tale complessità è leggibile in ROSSI (2002b: 165–170) e in AMBROSINI/CARDONE/CUCCU (2003: 77–81). Un’analisi dell’uso della voce narrante nei film dei fratelli Taviani si può leggere in SETTI (2001: 81–93). 32. Sul concetto di paternità del film (solo per convenzione al regista spetta il ruolo di “autore” dell’opera), cfr. le considerazioni espresse in ROSSI (1999a: 48–49 n. 31) e la relativa bibliografia ivi citata. Inoltre, quasi ogni testo è anche un ipertesto (nel senso genettiano di debitore di altri testi, mediante condizionamenti stilistici, citazioni, formule irriflesse, etc.: cfr. GENETTE 1982/1997) e ciò non fa che accrescere il problema della paternità composita. GALASSI (2000: 204) e PARINI (2000: 253–258) accennano anche al problema che tale ipertestualità comporta in sede di adattamento interlinguistico: soltanto se l’adattatore di tutti i film di un regista è il medesimo (condizione abbastanza rara), per esempio, potrà rendersi conto e dar conto, nel proprio lavoro, dei fenomeni di autocitazione. 1 – L’analisi linguistica del film 35 2) È un testo aperto: scritto per essere recitato e sincronizzato [→ Glossario, SINCRONIZZAZIONE] con le immagini. 3) Manca un unico testo scritto di riferimento del film (a differenza del parlato teatrale, e, spesso, anche di quelli radiofonico e televisivo), in virtù delle varie trasposizioni testuali dal soggetto, al copione, alla lista dialoghi, etc. 4) Vi si realizza la coesistenza di caratteristiche proprie dello scritto (scarsezza di esitazioni, di ripetizioni, di autocorrezioni [→ Glossario, AUTOCORREZIONE], di suoni inarticolati, di sovrapposizioni di turno [→ Glossario, SOVRAPPOSIZIONE DI TURNO], etc.) e del parlato (voce). 5) Presenta il doppio paradosso di ogni parlato: se ne coglie la specificità rispetto allo scritto soltanto quando viene trascritto (perdendo, dunque, parte della sua peculiarità), senza essere tuttavia interamente trascrivibile. Tutte le considerazioni preliminari fin qui svolte serviranno ad inquadrare quanto verrà osservato a proposito dei concreti esempi filmici commentati nel corso del volume: vale a dire che la lingua del cinema, e in particolar modo di quello doppiato, per quanto realistica e varia, sarà sempre meno mobile e screziata del parlato reale in situazione [→ Glossario, PARLATO PARLATO ], per motivi sia interni (le peculiarità diamesiche sopra schematizzate e in primis i vincoli imposti dal medium cinematografico) sia esterni (l’eterogeneità del pubblico). In altre parole, anche nel caso del cinema, il mezzo (o, se si preferisce, il canale comunicativo) condiziona sempre il messaggio, in più di un aspetto: dall’uso della DEISSI [→ Glossario] e dell’ALLOCUZIONE [→ Glossario] all’intonazione, dal lessico alla sintassi33. 33. Sui condizionamenti del mezzo sul messaggio sono indispensabili i classici studi di MacLuhan (e in particolare MCLUHAN 1964 e 1982); una rapida panoramica sull’argomento si ha anche in ROSSI (2002b). La delicata questione del rapporto tra mezzo e messaggio (che ovviamente sarebbe interessante approfondire, anche se in altra sede) è stata recentemente riaperta da ARCANGELI (2005: 31–52), cui si rimanda anche per gli aggiornamenti bibliografici. Alcuni degli aspetti qui appena accennati saranno sviluppati nel corso del volume: in particolare, sull’uso della deissi cfr. § 3.1, sull’allocuzione §§ 4.2.2 e 5.2.4; indicazioni su intonazione, lessico e morfosintassi sono presenti in ogni capitolo. La multimedialità del testo filmico e i vincoli imposti dal mezzo e dal pubblico sul messaggio saranno approfonditi soprattutto nel corso dell’intero § 5. 36 Il linguaggio cinematografico 1.4.2. Per concludere, non va trascurato un ultimo livello di analisi della lingua filmica, ovvero quello della lingua dal cinema, vale a dire dell’influenza che il cinema ha avuto sulla lingua comune, con numerosi prestiti34. Il Menarini ha elencato molti esempi di parole ed espressioni che dai film (perlopiù dai titoli, spesso tradotti e parafrasati dall’inglese) sono penetrate nella lingua comune come sostantivi, frasi idiomatiche o semplici citazioni: alba tragica (Alba tragica [Le Jour se lève], 1939, di Marcel Carné)35, giungla d’asfalto ‘metropoli caotica’ (Giungla d’asfalto [The Asphalt Jungle], 1950, di John Huston)36, (non) essere nata/o ieri (Nata ieri [Born Yesterday], 1950, di George Cukor)37, picchiatello38, via col vento (Via col vento [Gone with the Wind], 1939, di Victor Fleming) 39 e moltissimi altri. Si aggiungano, almeno, quarto potere ‘la stampa’ (Quarto potere [Citizen Kane], 1941, di Orson Welles), quinto potere ‘la televisione’ (Quinto potere [Network], 1976, di Sidney Lumet, titolo a sua volta costruito sulla base del precedente)40, anni di piombo 34. La distinzione tra «la lingua del cinema (produzione verbale considerata in sé stessa, come fenomeno cinematografico endogeno, con ricerca di eventuali tratti pertinenti), la lingua nel cinema (la stessa produzione verbale vista come fenomeno esogeno, cioè come prolungamento settoriale della lingua comune) e la lingua dal cinema (la sua incidenza, all’opposto, sulla lingua appunto comune)» si deve ancora una volta a RAFFAELLI (1992: 48). 35. Cfr. MENARINI (1955: 76). 36. Cfr. MENARINI (1955: 75–76). 37. Cfr. MENARINI (1955: 79, 85–86). 38. Si tratta di una delle più celebri trovate del doppiaggio italiano: comparve per la prima volta in una battuta del film di Frank Capra È arrivata la felicità (Mr. Deeds Goes to Town), 1936, come traduzione (ad opera di Pio Vanzi) dell’originale pixillated ‘pazzerello’. Da allora il neologismo godette di grande fortuna (anche in un’altra accezione, bellica: ‘tipo di bombardiere’, 1940) e fu successivamente impiegato in altri film, anche nei titoli: Il nipote picchiatello (You’re Never Too Young), 1955, di Norman Taurog; Bentornato, picchiatello (Hardly Working), 1981, di Jerry Lewis; La mia vita picchiatella (Big Top Pee–wee), 1988, di Randal Kleiser (qui la distribuzione, pur di rinverdire picchiatello, cancellò il nome d’arte del titolo originale, che era stato invece mantenuto in Pee–wee’s Big Adventure, 1985, di Tim Burton). Sulla storia di picchiatello cfr. MENARINI (1955: 175–179). 39. Cfr. MENARINI (1955: 28). Dal medesimo film è diventata proverbiale la battuta conclusiva: «Domani è un altro giorno». 40. Benché l’espressione quinto potere, fino alla metà degli anni Cinquanta, desi- 1 – L’analisi linguistica del film 37 ‘periodo degli attentati terroristici degli anni Settanta’ (Anni di piombo [Die Bleierne Zeit], 1981, di Margarethe von Trotta). Ma, anche qualora non inventati dal cinema, certi termini si sono imposti proprio grazie a film famosi: paisà ‘compaesano’, detto dai soldati americani agli alleati italiani nella seconda guerra mondiale (dall’omonimo film di Roberto Rossellini, del 1946), sciuscià ‘lustrascarpe’, dall’inglese shoeshine (dall’omonimo film di Vittorio De Sica, dello stesso anno); oppure grazie all’uso insistito fatto dal cinema: sì in luogo di pronto (per calco di yes, detto al telefono nei film americani)41 e signorina ‘prostituta’ (secondo l’uso fatto dai soldati americani in Italia durante la seconda guerra mondiale). O pensiamo al modo di dire arrivano i nostri, esclamazione saliente di tanti film western, oppure a neologismi quali zombi e replicante, la cui circolazione nella lingua comune è dovuta, rispettivamente ai film di George A. Romero (per esempio Zombi, 1979) e a Blade Runner, 1982, di Ridley Scott; oppure all’uso gergale e giornalistico di eccellente (‘di personaggio in vista, o di eventi che lo riguardano’), dovuto a Cadaveri eccellenti, 1976, di Francesco Rosi. Numerosi altri calchi semantici dall’inglese, o falsi amici, propagati dal cinema americano doppiato, saranno elencati nel quinto capitolo dedicato alla lingua del doppiaggio o DOPPIAGGESE [→ Glossario]. La lingua dei giornali e della televisione, inoltre, nell’onnivoro abuso di citazioni prelevate dai campi più svariati42, sfrutta soprattutto il cinema (e in particolare i titoli dei film) nella composizione di titoli stereotipici e ammiccanti (ma la citazione più o meno letterale può essere inserita anche all’interno dell’articolo), rilanciando così, per via indiretta, l’influenza del cinema gnasse il cinema, anche detto settima arte o decima musa (cfr. MENARINI 1955: 22, 40 e ROSSI 1996: 41). 41. Cfr. MENARINI (1955: 153) e DE MAURO (1963/1993: 122). Di questo e di altri calchi dall’inglese propagati dal doppiaggio si parlerà nel § 5.2.5. 42. Il fenomeno del riuso nella lingua giornalistica è stato recentemente denominato «ripetizione polifonica» da BAZZANELLA (2004). 38 Il linguaggio cinematografico sulla lingua comune e provocando talora la completa cristallizzazione dell’espressione: quanti, tra i giovani, sono in grado di cogliere il riferimento filmico nei casi elencati qui appresso? L’esemplificazione, che sarebbe sterminata e in continua evoluzione, si limita ad alcuni casi particolarmente noti e frequenti (tra parentesi, il cognome del regista del film il cui titolo è riprodotto in tutto o in parte dall’espressione in questione): al di sopra di ogni sospetto (Petri); l’armata Brancaleone (Monicelli); l’attimo fuggente (Dead Poets Society, Weir); brutti sporchi e cattivi (Scola); bulli e pupe (Guys and Dolls, Mankiewicz); day after (Meyer); gioventù bruciata (Rebel Without a Cause, Ray); la grande abbuffata (La Grande bouffe, Ferreri); incontri ravvicinati (Close Encounters of the Third Kind, Spielberg); inferno di cristallo (The Towering Inferno, Guillermin, Allen); luci della ribalta (Limelight, Chaplin); mezzogiorno di fuoco (High Noon, Zinnemann); nove settimane e mezzo (Nine 1/2 Weeks, Lyne); scandalo al sole (A Summer Place, Daves); scene da un matrimonio (Scener ur ett äktenskap, Bergman); sedotta e abbandonata (Germi); i soliti ignoti (Monicelli); viale del tramonto (Sunset Boulevard, Wilder). Anche i personaggi dei film di successo, perlopiù americani, vengono spesso usati come antonomasie: Rocky ‘pugile, uomo forte, tenace e coraggioso’ (dall’omonimo film di John G. Avildsen, del 1976, che impose sugli schermi l’attore italoamericano Sylvester Stallone; con ben quattro seguiti, fino al 1990), Rambo ‘uomo forte e coraggioso, ma, soprattutto, che esibisce ridicolmente il prorio coraggio e la propria forza fisica’ (dal nome del protagonista, il solito Stallone, del film First Blood, 1982, di Ted Kotcheff, intitolato in italiano Rambo; con due seguiti fino 1988), Conan ‘persona dai modi primitivi e violenti’ (dai film Conan il barbaro [Conan the Barbarian], 1981, di John Milius, e Conan il distruttore [Conan the Destroyer], 1984, di Richard Fleischer, entrambi con Arnold Schwarzenegger). Ma il fenomeno è ben più antico, come mostrano esempi che per la maggior parte degli utenti, ormai, hanno perso la loro trasparenza etimologica: cretinetti (dal nome assunto in Italia 1 – L’analisi linguistica del film 39 dal personaggio di Gribouille, interpretato in molti film muti da André Deed), ridolini (Larry Semon, in Francia detto Zigoto), tontolini (l’attore francese Fernando Guillaume, in arte Polidor) 43 o i più noti, tuttora, Maciste (nome «creato da Gabriele D’Annunzio per il film Cabiria»44, 1914, di Giovanni Pastrone, e poi riproposto in numerosi film, fin agli anni Sessanta)45, Frankenstein (che deve la sua popolarità e il suo uso antonomastico come ‘uomo bruttissimo, dall’aspetto terrificante’ ben più alle celebri trasposizioni cinematografiche — a partire dal muto: Frankenstein, 1910, di J. Searle Dawley — che all’omonimo protagonista, e alla sua orribile creatura, dei romanzi di Mary Shelley)46, king kong (a partire da King kong, 1933, di Merian C. Cooper), tarzan (in decine di film a partire da Tarzan of the Apes, 1918, di Scott Sidney), zorro (che in spagnolo vuol dire ‘volpe e, fig., furbo’, in decine di film a partire dal Segno di Zorro [The Mark of Zorro], 1920, di Fred Niblo), etc.47. Per tornare a casa nostra e in epoche più recenti, pensiamo agli usi antonomastici di Fantozzi e Fracchia, introdotti dai film con Paolo Villaggio. Anche i nomi dei divi e delle dive del cinema hanno dato vita a formazioni più o meno effimere: da valentino a borelleggiare, da bertineggiare a gretagarbeggiare48. Restando sul territorio italiano, spetta a Federico Fellini il primato dei prestiti alla lingua comune (e addirittura, caso pressoché unico, anche a qualche lingua straniera: dolcevita e paparazzo sono attestati almeno anche in francese, inglese, tedesco e spagnolo): amarcord ‘ricordo personale, rievocazione nostalgica del passato’, dal romagnolo «io mi ricordo» (dal film Amarcord, 1973)49, bidone ‘imbroglio, raggiro’ (Il bidone, 1955)50, dolcevi- 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Cfr. MENARINI (1955: 97–99). MENARINI (1955: 98). Almeno fino a Maciste, gladiatore di Sparta, 1964, di Mario Caiano. Cfr. MENARINI (1955: 102–103). Cfr. MENARINI (1955: 104–115). Cfr. MENARINI (1955: 119–122). Dalla poesia di Tonino Guerra A m’arcord (GORI 1997: 60). Cfr. MENARINI (1958). 40 Il linguaggio cinematografico ta ‘maglione a collo alto e aderente’ (La dolce vita, 1960, per via dell’abbigliamento tipico di Mastroianni nel film)51, paparazzo ‘fotografo alla continua ricerca di divi in situazioni compromettenti’ (cognome di un fotografo nel solito La dolce vita)52, vitellone ‘giovane ozioso e fatuo’ (I vitelloni, 1953)53. A Totò si deve il nuovo conio pinzillacchera ‘cosa da nulla’, inserito per la prima volta in un vocabolario nel 1963, da Bruno Migliorini, che lo attribuiva a Totò e a Silvio Gigli (1930): si tratta forse di una deformazione di pillacchera ‘grumo di melma o di sterco’, con varie accezioni traslate54. Sempre a Totò si deve la fortuna goduta, negli anni Cinquanta–Sessanta, dall’espressione fa Capri, fa fino e simili55 e la divulgazione di cultismi o burocratismi, tutti con finalità ludico–parodica, quali a prescindere, eziandio, fa d’uopo, laonde, etc.56. Anche quando non si tratta di prestiti propriamente detti, ovvero di migrazione diretta di una forma da un film alla lingua comune, è indubbia la funzione del cinema come propagatore, presso tutti gli italiani, almeno a partire dal secondo dopoguerra, di un italiano più agile e sciolto, più variegato (con escursioni dalla lingua letteraria ai dialetti) e tendenzialmente allineato sui caratteri dell’italiano regionale romano (come dimostrano, tra l’altro, la diffusione, in tutta Italia, di termini uscenti in –aro 51. Ma anche la stessa espressione dolce vita, sebbene modellata sul francese douceur de vivre, è stata di fatto propagata dal film di Fellini, nel senso, difficilmente parafrasabile, di ‘miscela di malinconico edonismo e dolce far niente’ (cfr. D’AMICO 1993). 52. E ispirato a Fellini (come nome) dal personaggio di Coriolano Paparazzo (un albergatore di Catanzaro), nel libro di George Gissing, Sulla riva dello Yonio: appunti di un viaggio nell’Italia meridionale (By the Jonian Sea: Notes of a Ramble in Southern Italy, London, Chapman and Hall, 1901), Bologna, Cappelli, 1957. Mentre, come carattere, il riferimento è sicuramente al celebre fotografo Tazio Secchiaroli. Sulla scelta del cognome Paparazzo da parte di Flaiano e Fellini sono state avanzate le ipotesi più svariate. Un’ultima sintesi si può leggere in CAFFARELLI (1997). Un primo resoconto era invece in RAFFAELLI (1961). 53. In realtà il termine, a detta di Flaiano, proviene dall’abruzzese, nel significato di ‘grosso budello, cioè giovanotto scansafatiche, mantenuto dalla famiglia, che mangia a sbafo’ (cfr. GORI 1997: 55). 54. Cfr. GDLI e MIGLIORINI (1963), s.v. pinzillacchera; ROSSI (2002a: 230–231). 55. Cfr. DE MAURO (1963/1993: 179 n. 32 e relativa bibliografia). 56. Cfr. MENARINI (1955: 124) e ROSSI (2002a: 95, 108). 1 – L’analisi linguistica del film 41 anziché in –aio: mondezzaro, pallonaro, pataccaro, peracottaro; ma anche altre parole, talora di origine meridionale o gergale ma comunque esportate in italiano da Roma, quali abbioccarsi, beccamorto, borgata, bruscolini, burino, bustarella, caciara, cafone, dritto, fasullo, fesso, inghippo, lagna, locandina, mondezza, puzzone, racchio, scafare, scapicollarsi, scippo, scostumato, sfondone, spupazzare, zeppo, etc.)57. Per il riuso tipico della lingua dei media, poi, spesso i titoli di film famosi vengono parassitariamente sfruttati in abili deformazioni per altri titoli di film destinati alle platee più popolari. Maestri di questa tecnica erano i registi e i produttori dei film con Totò: Fifa e arena, 1948, di Mario Mattoli (parodia di Blood and Sand, in italiano Sangue e arena, 1941, di Rouben Mamoulian); Totò le Mokò, 1949, di Carlo Ludovico Bragaglia (parodia di Pépé le Moko, in italiano Il bandito della Casbah, 1936, di Julien Duvivier); Totò terzo uomo, 1951, di Mattoli (Il terzo uomo [The Third Man], 1949, di Carol Reed); Il più comico spettacolo del mondo, 1953, di Mattoli (Il più grande spettacolo del mondo [The Greatest Show on Hearth], 1952, di Cecil B. DeMille); Totò e Marcellino, 1958, di Antonio Musu (Marcellino pane e vino [Marcelino pan y vino], 1955, di Ladislao Vajda); Totò, Peppino e… la dolce vita, 1961, di Sergio Corbucci (La dolce vita, 1960, di Fellini); Il giorno più corto, 1963, di Corbucci (Il giorno più lungo [The Longest Day], 1962, di Ken Annakin, Andrew Marton e Bernhard Wicki); Totò e Cleopatra, 1963, di Fernando Cerchio (Cleopatra, 1934, di Cecil B. DeMille, e Cleopatra, 1963, di Joseph L. Mankiewicz); Che fine ha fatto Totò Baby?, 1964, di Ottavio Alessi (Che fine ha fatto Baby Jane? [Whatever Happened to Baby Jane], 1962, di Robert Aldrich); Totò d’Arabia, 1965, di José Antonio de La Loma (Lawrence d’Arabia [Lawrence of Araby], 1962, di David Lean). Oppure quelli dei film con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia: Sedotti e bidonati, 1964, di Giorgio Bianchi (Sedotta e abban57. Su questi temi cfr. DE MAURO (1963/1993: 118–126, 175–186, 351–352, 430–459). Su alcune delle parole elencate cfr. già MENARINI (1955: 155–158). 42 Il linguaggio cinematografico donata, 1964, di Pietro Germi); Per un pugno nell’occhio (titolo originale: Dos caraduras en Texas), 1965, di Michele Lupo (Per un pugno di dollari, 1964, di Sergio Leone, sotto lo pseudonimo di Bob Robertson); Indovina chi viene a merenda?, 1969, di Marcello Ciorciolini (Indovina chi viene a cena [Guess Who’s Coming to Diner], 1967, di Stanley Kramer); Ultimo tango a Zagarol, 1973, di Nando Cicero (Ultimo tango a Parigi, 1972, di Bernardo Bertolucci); Paolo il freddo, 1974, di Ingrassia (Paolo il caldo, 1973, di Marco Vicario); L’esorciccio, 1975, di Ingrassia (L’Esorcista [The Exorcist], 1973, di William Friedkin). Tale tecnica deformante del titolo è tuttora comunemente sfruttata, tra l’altro, nei film pornografici58. 58. Sull'«emulazione parassitaria» dei titoli (spesso a scopo umoristico) cfr. MENARINI (1955: 31–41, la citazione è a p. 38); RAFFAELLI (1979b: 480); ROSSI (2002a: 246–249). 2. IL PARLATO FILMICO DAL CINEMA MUTO AL NEOREALISMO 2.1. Le origini Il cinema non è mai stato veramente muto e la pratica del doppiaggio nasce ben prima del sonoro. Le due affermazioni non sono motivate dal gusto per il paradosso ma hanno un loro fondamento. Fin dalla sua nascita, convenzionalmente stabilita nel 1895, in Francia, ad opera dei fratelli Lumière (ma, com’è noto, non mancano esempi precedenti e in altri paesi: in primo luogo il Kinetoscope — o Kinematoscope — dello statunitense Thomas A. Edison)1, il cinema ha sempre dovuto fare i conti con il suono (l’accompagnamento musicale, prima dal vivo poi registrato) e con le parole (le didascalie [→ Glossario, DIDASCALIA], i titoli [→ Glossario, TITOLO]). Insomma possiamo dire che il testo filmico nasce, sì, dapprima e nelle sue fasi sperimentali, come semplice fotografia in movimento, ma diventa quasi subi- 1. Quello che solitamente viene considerato il primo “film” della storia è La Sortie des Usines Lumière [L’uscita dagli stabilimenti Lumière] di Auguste e Louis Lumière, proiettato per la prima volta a un pubblico pagante (ma non mancano proiezioni private precedenti) al Salon Indien di Parigi, il 28 dicembre 1895. Famosi anche gli altri titoli di quella serata: L’Arrivée d’un train à la Ciotat [L’arrivo di un treno alla stazione della Ciotat], La Sortie du port [L’uscita dal porto], Le Déjeuner du bébé [La colazione del bebè]. Numerosi sono i volumi dedicati alla fase aurorale del cinema: cfr. almeno SADOUL (1947/1965) e, per il cinema italiano, BERNARDINI (1980) e (1981). Per il primo film della storia, realizzato e già sincronizzato con le parole nel 1889 dai collaboratori di Edison, cfr. RAFFAELLI (1992: 220). 43 44 Il linguaggio cinematografico to un testo complesso che prevede la combinazione del codice iconico con altri linguaggi. Addirittura, stando alle dichiarazioni dello stesso Edison (che brevettò, tra l’altro, anche il fonografo), l’obiettivo dell’inventore americano era quello di realizzare un apparecchio (il Kinetofono) in grado di combinare immagini e suoni (parole incluse), per consentire la proiezione dell’opera lirica: si fa ancora più salda, così, la vicinanza tra film e melodramma commentata nel capitolo precedente. Insomma, come a dire che l’immagine senza la parola non soddisfa2. In Italia, le prime proiezioni arrivano nel 1895 (Kinetoscope di Edison) e nel 1896 (Cinématographe Lumière), anche se il nostro paese stenterà a passare dalla fase artigianale a quella industriale–imprenditoriale del cinema, approdandovi non prima del 1904. La prima proiezione italiana nota del Cinématographe ebbe luogo a Roma, il 13 marzo 1896, presso piazza Colonna, ad opera dello studio fotografico Le Lieure. Seguiranno a ruota tutte le principali città italiane. Nel frattempo si cominceranno anche a girare i primi film Lumière in Italia: prevalentemente scene di vita dei reali3. Per avere la prima sala di proiezione stabile bisognerà attendere il 1904: il Cinema Moderno di Piazza Esedra in Roma. Fino ad allora, ma anche oltre, il cinematografo sarà quasi esclusivamente ambulante, inserito come attrazione in spettacoli compositi ospitati da fiere, CAFFÈ–CONCERTO [→ Glossario], teatri, etc.4. Tra i grandi innovatori dei primi spettacoli cinematografici italiani va annoverato l’attore trasformista Leopoldo Fregoli, il 2. Un Cinetofonio o Cinematofonio godette di un certo successo anche in Italia: «Particolare risonanza ebbe la presentazione del ‘Cinematofonio’ a Roma, dove inaugurò la stagione autunnale del 1904 con la rappresentazione del Barbiere di Siviglia. Si sa che il film di Méliès (1903, 402 metri, 7 ‘quadri’) veniva venduto assieme a partiture musicali con arie di Rossini» (BERNARDINI 1980: 204). Sui primi tentativi di film sonoro e sincronizzato cfr. anche PAOLINELLI/DI FORTUNATO (2005: 3–4). 3. Per un sommario elenco di queste prime pellicole italiane cfr. BERNARDINI (1980: 57). 4. Un quadro di questo periodo ambulante del cinema è leggibile in BRUNETTA (1991: 7–19). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 45 quale, a partire dal 1898, iniziò a inserire nei propri numeri comici anche la proiezione di brevi filmati che lo vedevano come unico protagonista. Si tratta della tecnica pubblicizzata come Fregoligraph e realizzata mediante un proiettore Lumière, avuto proprio dagli inventori francesi, che gliene insegnarono anche l’uso e gli fornirono alcuni titoli. L’arte di Fregoli, in effetti, ben si sposava con le potenzialità del nuovo mezzo, che consentiva trucchi di vario genere (in primis, l’inversione di movimento ottenuta mediante la proiezione della pellicola al contrario). Lo stesso Fregoli racconta come, tra gli espedienti per divertire sempre di più il pubblico, avesse pensato anche a una sorta di doppiaggio ante litteram: [V]olli fare anche del cinema sonoro e parlato… venticinque anni primi all’incirca che il sonoro e il parlato fossero inventati. Come? In un modo assai primitivo, senza dubbio; ma che fu giudicato ingegnoso. Poiché in qualcuno dei miei film mi presentavo nella riproduzione di molti personaggi delle mie stesse farse, delle mie commedie satiriche e delle mie bizzarrie musicali, pensai di dare a tutte queste ombre, a tutti questi fantasmi, la loro voce. Non però attraverso dischi fonografici, ma direttamente. Nascosto tra le quinte, di fianco allo schermo (la proiezione avveniva per trasparenza, dal palcoscenico), io pronunciavo d’ogni personaggio del film le battute e cantavo i piccoli brani musicali, accompagnati dall’orchestra: tutto ciò con perfetto sincronismo, riuscendo così a dare veramente l’impressione che parole e note uscissero dalla candida tela. […] Con questo — intendiamoci bene — non intendo rivendicare il titolo e gli onori di pioniere, o del precursore del film sonoro e parlato5. Ma questo di Fregoli non dev’essere stato l’unico tentativo di sincronizzazione delle parole con l’immagine, anche se le testimonianze scarseggiano. Sappiamo per esempio che nel 1907, a Venezia, il film di Almerico Roatto Biaso el luganegher fu recitato in dialetto dietro lo schermo da una compagnia di filodram- 5. BERNARDINI (1980: 100–101). 46 Il linguaggio cinematografico matici6. È questa la fase della storia del mezzo che Raffaelli definisce come orale, da intendersi sia come battute recitate da attori dietro lo schermo, sia come lettura in sala di didascalie, commenti, titoli, parti di dialogo e riassunti di momenti salienti del film. È noto, tra l’altro, come la pratica del lettore in sala abbia accompagnato per anni il film cosiddetto muto (in Francia e in Giappone, tra l’altro, più che in Italia), per agevolare la grande maggioranza del pubblico, chiaramente analfabeta7. Non si dimentichi, del resto, come anche la parola meccanicamente riprodotta precedette quella scritta. Il tentativo di imporre sul mercato film ‘parlanti’ e ‘cantanti’ risale a prima del 1900, almeno in Francia […]. In Italia in particolare, dove già dal 1891 s’era mostrata curiosità per gli esperimenti di sincronizzazione dell’immagine con la parola 6. Cfr. RAFFAELLI (1992: 63, 150). Anche i rumori venivano talora sincronizzati dietro il telone, come ricordano le testimonianze citate da BERNARDINI (1980: 145–146). 7. Cfr. da ultimo RAFFAELLI (2003a: 18–21), ma già RAFFAELLI (1992: 59–64) e (2001: 859–861). Gustosi, a riguardo, i ricordi di prima mano di MENARINI (1955: 12, 14), a proposito del lettore di didascalie: «Le ineffabili didascalie che spiegavano quel po’ di trama che la visione non bastava a chiarire, venivano lette ad alta voce, in origine, dall’inserviente stesso, in considerazione del fatto che l’analfabetismo non era, in quei tempi, cosa da trascurarsi. Poi, per rispetto al pubblico, l’utile servizio venne abolito, e allora i più eruditi fra gli spettatori, leggevano ad alta voce, e nessuno protestava ferocemente per il disturbo come succederebbe oggi. Anzi, rammento che molte persone, soprattutto donne, cercavano di sedersi accanto a spettatori che leggessero a voce alta, e ciò per non perdere una sola parola; e se per caso qualche didascalia passava sotto silenzio, c’era sempre chi protestava: Non c’è nessuno che legga forte, qui? Erano cose che si facevano con la massima naturalezza e serietà». A proposito della sincronizzazione dal vivo, l’autore ricorda «la prima, lontana intuizione di ciò che il film sonoro avrebbe potuto offrire al pubblico, seppure sfociata in ingenui e grossolani tentativi che oggi non si possono rammentare senza buonumore: dietro lo schermo non vi era parete, bensì un ambiente di servizio, in cui prendevano posto alcuni attori professionisti o filodrammatici, i quali, dopo di aver assistito in sala alla prima proiezione del film per farsi un’idea della vicenda, passavano in quella specie di retrobottega e, con gli occhi fissi sul rovescio della tela, guardando la proiezione per trasparenza, parlavano a voce alta, inventando sui due piedi frasi e dialoghi, recitando quasi a soggetto come nella gloriosa Commedia dell’arte. Non vi erano due spettacoli, naturalmente, cui corrispondessero le medesime parole; a volte gli attori tacevano quando avrebbero dovuto parlare, e viceversa; spesso si impappinavano e confondevano scene diverse; e si sentivano voci maschili quando sullo schermo si muovevano labbra femminili. Ma il pubblico godeva, e gustava enormemente lo spettacolo». 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 47 […], solo dopo il 1903 i film sonori, che di solito proponevano pezzi di opere liriche, conseguirono successi innegabili, come suggeriscono precoci aperture di sale specializzate quali il Cinematografo Parlante a Napoli nel 1905 o il Radium Cantante a Roma nel 1906 […]. Ma i film sonori, malgrado periodici rilanci (in Italia nel 1908, nel 1912, nel 1921, verso il 1926…), non riuscirono durante il muto a uscire dallo stadio della sperimentazione e del successo effimero (un Finalmente parlo… di Ugo Gracci, con dizione di Cesare Dondini, avrebbe richiamato 150.000 spettatori in 14 giorni al Quattro Fontane e al Cola di Rienzo, nel 1921 […])8. In altre parole, lo sviluppo commerciale tardivo di tecniche quali il sonoro, così come anche il colore, non è dovuto tanto a impedimenti tecnici ed economici, bensì a pregiudizi estetici (più della critica che del grande pubblico), che identificavano nell’immagine muta e in bianco e nero la purezza della nuova arte e che consideravano più “realistica” (per certi versi, più “onirica” per altri) l’assenza del suono e del colore piuttosto che la resa imperfetta di entrambi gli elementi 9. E questo vale soprattutto per l’Italia, dove per il primo periodo stentarono ad affermarsi sistemi diversi dal Lumière (rigorosamente muto e in bianco e nero) e le preferenze del pubblico e della critica erano decisamente sbilanciate verso la linea realistico–documentaria (quella dei Lumière) piuttosto che verso il cinema di fantasia e di effetti speciali (alla Méliès): la vocazione realistica del cinema italiano, come si vede, ha origini antiche, che risalgono praticamente alla diffusione del mezzo nel nostro paese10. Nella parte antologica si possono leggere le posizioni di Pirandello [→ Antologia critica, § 7] e di Arnheim [→ Antologia critica, § 3] contro il sonoro. Si aggiungano qui almeno la 8. RAFFAELLI (1992: 59–60 n. 25). Cfr. anche BERNARDINI (1980: 199) e (1981: 66–71). 9. Rudimentali sistemi di colorazione manuale della pellicola risalgono al 1894, nei film destinati ai Kinetoscopi Edison. Sistemi meccanici di riproduzione del colore si impongono a partire dal 1906 (cfr. BERNARDINI 1980: 198–199, 205–206). 10. Per le riserve contro il sonoro e contro le didascalie in altri paesi si veda comunque RAFFAELLI (2001: 862–869). 48 Il linguaggio cinematografico celebre dichiarazione di Chaplin, che arriverà molto tardi a servirsi della voce nei suoi film (in Il grande dittatore [The Great Dictator], 1940): «Secondo me, la voce nel cinema è inutile. Sarebbe come voler dipingere una statua, come voler mettere belletto su guance di marmo. Le parole toglierebbero la parola all’immagine»11. E quella di Hitchcock: «Con l’avvento del sonoro, il cinema si è bruscamente irrigidito in una forma teatrale […]. Quando si scrive un film è indispensabile tenere nettamente distinti gli elementi di dialogo e gli elementi visivi e, ogni volta che è possibile, dare la preferenza ai secondi sui primi»12. Secondo i teorici russi, un cinema parlato sarebbe stato privo di senso (perché MIMÈSI [→ Glossario] della vita e non arte né ideologia)13, mentre la sincronizzazione poteva ottenere risultati artistici rilevanti soltanto combinando immagini e musiche: «Il cinema sonoro […] può essere realizzato come contrappunto audio–visivo»14. Per gli italiani, si ricordino almeno D’Annunzio: «Io abòmino il cinematografo sonoro, ed ho in uggia le didascalie letterarie che credono commentare il colore e il movimento delle immagini silenziose»15; e Totò: «io non ho il dono della parola e nel caso mio il dialogo smonta e immeschinisce tutto. Sono un comico muto, né antico né moderno perché non esiste la comicità antica o moderna, esiste la comicità, punto e basta. E meglio che con i dialoghi so esprimermi con la mimica»16. «Vorrei essere, come maximum, il protagonista di un cartone animato. Anche perché vorrei parlare pochissimo»17. Anche un professionista della parola al cinema, lo sce- 11. JACQUIER (1995: 255). 12. TRUFFAUT (1987: 52). 13. Del resto i russi erano sfavorevoli anche alle didascalie, soprattutto locutive, del muto, considerate come «un rimedio all’imperizia dei realizzatori» (RAFFAELLI 1991: 863). 14. EJZENŠTEJN (1986: 27). 15. ARNHEIM (1938: 3). 16. ROMEO (1997: 108). È noto che uno dei desideri irrealizzati di Totò era quello di girare un film muto (cfr. ESCOBAR 1998: 73). 17. ZAVATTINI (1940: 404). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 49 neggiatore Gherardo Gherardi, pensava che l’aspetto verbale fosse assolutamente ancillare a quello iconico: Il dialogo al cinematografo deve passare inosservato “come tale”. Niente ci deve far dimenticare che il cinematografo è ben lontano dall’avere tra le sue funzioni la predicazione, di qualunque genere essa sia. Il mondo morale di un film non deve risultare dalle sue parole, ma dai suoi fatti. Dobbiamo resistere alla tentazione della battuta felice, della buona uscita per sé stessa, della bella espressione che in altra sede può trovare la sua collocazione perfetta, ma che nel cinematografo distrae, offende e tradisce. Quando il pubblico uscendo da una proiezione esclama: «Che bel dialogo!» sia ben chiaro che ciò significa niente altro che questo: che il film è mancato. Qualunque individualizzazione del “sonoro” significa uno spostamento dell’asse estetico del cinematografo e per conseguenza un fallimento artistico18. Si legga peraltro, come contraltare (naturalmente tardivo, ma coerente con i tardivi nostalgici del muto, fino ad anni non remoti), la posizione di Pasolini in difesa del sonoro, anche se di un sonoro poetico, antinaturalistico: Capisco l’incanto dell’idea retorica del cinema come pura immagine. Anzi, addirittura io stesso faccio del cinema muto, con indescrivibile piacere. Ma fare del cinema muto non è che una restrizione metrica, come per esempio, in poesia, la terza rima, che riduce infinitamente la possibilità di parlare il parlabile, crescendo smisuratamente la possibilità di parlare l’imparlabile. I difensori (antiquati) del cinema muto come unico “optimum”, anzi, in conclusione come “norma”, appunto retorica — attribuiscono, nel cinema, alla parola, naturalmente ORALE, una funzione ancillare. Come per esempio nel melodramma. Le parole della Traviata, dicono, sono sciocche e ridicole, esteticamente non solo prive di valore, ma anzi quasi offensive al buon gusto: eppure ciò non conta niente. È la musica che conta, dicono. Questa affermazione sembra così piena di buon senso, e invece è completamente insensata. Chi dice questo ignora la “ambiguità” della parola poetica: l’ineli- 18. GHERARDI (1937: 7). Cfr. anche GHERARDI (1939). 50 Il linguaggio cinematografico minabile contrasto in essa tra “senso” e “suono” […]. La musica distrugge il “suono” della parola e lo sostituisce con un altro […]. Le parole non sono dunque affatto ancillari, nel melodramma: sono importantissime e essenziali. Solo che l’esitazione tra il senso e il suono, in esse, ha l’apparenza di un’opzione per la scelta del suono […]. Nel cinema la parola (a parte i casi meno rilevanti dei “cartelli” o dei “titoli di testa [→ Glossario, TITOLO]”) va considerata nel suo aspetto ORALE. È questo che fa perdere la testa a coloro che non hanno avuto occasione di leggere almeno Morris. E che dunque sono convinti che la lingua sia un sistema privilegiato a sé, e non uno dei tanti possibili sistemi di segni. Ora, noi siamo abituati da secoli di storia a dare valutazioni estetiche esclusivamente sulla parola SCRITTA. Essa sola ci pare degna di essere non solo poetica, ma anche semplicemente letteraria. Poiché invece nel cinema la parola è ORALE, essa viene naturalmente vista come prodotto di poco pregio, o addirittura spregiato […]. Un oggettivo esame del sistema di segni del cinema ci rivela prima di tutto che esso è audiovisivo: immagine e suono sono, come direbbe uno storico delle religioni, una “biunità”. Questa è una osservazione semiologica: che cosa se ne può fare un artista? Nulla. È una osservazione evidentemente del tutto descrittiva, esercitata su ciò che c’è. Un artista — che può benissimo non saper nulla di semiologia — può invece dirsi: «Che meravigliosa occasione! Facendo parlare i miei personaggi anziché una lingua naturalistica o puramente informativa, solo prudentemente dotata di punte di espressività e di vivacità — facendo parlare i miei personaggi, anziché questa lingua, il metalinguaggio della poesia, risusciterei la poesia orale (andata da secoli perduta anche nel teatro) come una tecnica nuova, che non può non costringere a una serie di riflessioni: a) sulla poesia stessa, b) sulla sua destinazione»19. Nel primissimo periodo del muto le didascalie mancavano e, successivamente, erano rare e brevi. Questo fattore deve aver senz’altro favorito la pratica dell’integrazione orale dei film. A enunciare i titoli e lo sviluppo dell’azione fu dapprima l’opera- 19. PASOLINI (1972/1991: 266–268). Cfr. anche APRÀ (1964). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 51 tore20. Ma anche dopo l’affermazione delle didascalie scritte si ha notizia di episodi di integrazione filmica orale: avveniva spesso con le melodie cantate dal vivo presso il telone e trascritte sullo schermo e si sa che, verso la fine del muto, il cinematografo napoletano Iride ingaggiò una coppia di attori per recitare dal vivo, in sincronia con le immagini, le didascalie del Fu Mattia Pascal (Feu Mathias Pascal), 1926, di Marcel L’Herbier. Insomma, se agli annunci degli operatori o dei lettori, alla recitazione sincronizzata dal vivo degli attori, alla musica e ai rumori si aggiungono i commenti e le esclamazioni degli spettatori, non è difficile immaginare come il film cosiddetto muto fosse in realtà fin troppo chiassoso. 2.2. La lingua scritta del cinema 2.2.1. Per didascalia si intende quella porzione di testo scritto aggiunta all’immagine filmica — sotto forma di SOVRIMPRESSIONE [→ Glossario], di SOTTOTITOLO [→ Glossario] o SOVRATITOLO [→ Glossario], di inquadratura autonoma, etc. — per integrarne o specificarne (talora pleonasticamente, rispetto all’immagine) il significato. Può essere di tre tipi: narrativa, locutiva, tematica. La prima, la più frequente, riassume gli eventi che si vedranno nella scena seguente e ha dunque funzione identificatrice, descrittrice (spiega verbalmente il significato dell’immagine) e sintetizzante (colma alcune lacune del testo iconico: «Siface, il re di Cirta, ha spogliato del reame Massinissa, che dilegua nel deserto. Asdrubale dona la sua figlia al più potente e dal non più giovane genero ottiene alleanza contro Roma»)21. La didascalia locutiva, che si afferma più tardi, riporta parole dette (o anche solo pensate) da un personaggio; è scrit- 20. Cfr. BERNARDINI (1980: 141–142, 201), anche sull’accompagnamento musicale dal vivo. 21. Cabiria, 1914, di Giovanni Pastrone (RAFFAELLI 1992: 241). 52 Il linguaggio cinematografico ta talvolta tra virgolette o preceduta da lineetta; può però anche avere forma di discorso indiretto: «Fulvio dice a Bodastorèt ch’egli non desidera se non di rivedere Maciste, l’ottimo servo fedele»22. Può essere monologica o dialogica: «‘Tu l’ami’ ‘Non è vero’ ‘La rosa ch’ella ti donò?’ ‘La soffoco nell’onda’»23. A differenza degli altri tipi, la didascalia locutiva non precede necessariamente l’immagine a cui si riferisce e, nei casi migliori, segue la prima inquadratura di un dialogo. Talora nei diverbi, tuttavia, la risposta è assente, come didascalia, ma è desumibile soltanto dalle immagini. Naturalmente, le parole scritte nelle didascalie locutive solo di rado corrispondono esattamente ai movimenti labiali degli attori. Gli sforzi iniziali dei realizzatori sono spesi per annullare l’illogica e fastidiosa divaricazione cronologica e spaziale fra la trascrizione della battuta e l’immagine del locutore. Il ritardo e la distanza sono infatti abissali nei primordi, come può confermare Il granatiere Roland (Luigi Maggi, 1911), dove la battuta «Elena, la tua fidanzata, ha sposato un ufficiale», figura davanti a una lunga inquadratura nella quale soltanto dopo un fitto dialogare e gesticolare l’oste rivolge la frase al protagonista. Presto però le distanze diminuiscono, e in molti pregevoli casi appaiono quasi eliminate, in vario modo: nel più comune la scritta dialogica s’incunea per STACCO [→ Glossario] sul duplice PIANO [→ Glossario] ravvicinato di chi inizia e conclude il discorso, come avviene per esempio in La passione di Giovanna d’Arco (Carl Th. Dreyer, 1928); altre volte appare in sovrimpressione, lungo la base del quadro e, in casi peraltro eccezionali e con procedimento mutuato dal fumetto, accanto al volto del parlante. Il muto tuttavia adotta anche soluzioni sbrigative, che sacrificano l’efficacia cinematografica, accumulando nella medesima didascalia uno o più turni dialogici […]. Nella fase matura del muto la coesione del testo filmico è talvolta conseguita con un artificio sintattico, cioè collocando in apertura delle didascalie narrative e commentative taluni connettivi [→ Glossario, CONNETTIVO] — e, ma, allora, intanto e simili — che sono propri dell’interazione linguistica serrata. 22. Cabiria (RAFFAELLI 1992: 242). 23. Rapsodia satanica, 1917, di Nino Oxilia (RAFFAELLI 1992: 246). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 53 Eco una breve sequenza di Tigre reale (Pastrone, 1916), dove quattro scritte sono intercalate da veloci inquadrature: Ma presto Giorgio ha perduto la traccia. …e ritornò con una certa Palmira. Un giorno… …e Giorgio più non vi pensava… Ma qualche giorno dopo… Si ha l’opposto effetto di dilatazione dello scarto fra parola e immagine, allorché la didascalia narrativa o commentativa adotta un tempo verbale diverso dal presente. Ora, si sa che il tempo della rappresentazione filmica per immagini si svolge al presente […]. E sullo stesso piano temporale si mantiene di solito l’enunciato integrativo della didascalia, in quanto adotta esplicite forme verbali al presente (pure la frase priva di verbo si colloca al presente, per influsso del contesto iconico). Accade invece che pellicole di modesta fattura, o all’opposto ambiziose, mescolino, per sciatteria oppure a ragion veduta, verbi al presente con verbi al passato (e, qualche volta, altri tempi ancora): forse per influsso della narrazione letteraria, oppure del film d’attualità (che suole presentare gli avvenimenti, come il giornalismo coevo, usando il passato), oppure ancora della spiegazione orale in uso nel cinema primordiale. Sono comunque forme temporali anomale, che evidenziano la distanza tra il piano dell’azione filmica e quello del remoto ed esterno narratore o commentatore. Ecco almeno un esempio di ponderata alternanza di passato, futuro e presente in un’unica didascalia espositiva, in Gli ultimi giorni di Pompei (Carmine Gallone e Amleto Palermi, 1926): La legge di Roma aveva vietato di dare gli schiavi in pasto alle belve. Ma ecco alfine un omicida. Per lui Pompei potrà godere ancora lo spettacolo. Già dal primo mattino il popolo si riversa nella Basilica, dove Glauco dovrà essere giudicato24. La didascalia tematica, infine, esprime idee di carattere universale, talora sotto forma di citazione, com’è quella dantesca (Paradiso, XIII, 52–54) di Fabiola, 1918, di Enrico Guazzoni: 24. RAFFAELLI (2001: 866–868). 54 Il linguaggio cinematografico «Ciò che non more e ciò che può morire | non è se non splendor di quella idea | che partorisce, amando, il nostro Sire»25. Gian Piero Brunetta ricorda come, in alcuni film, la parola [scritta] non ha un semplice valore deittico [→ Glossario, DEISSI], informativo o denotativo, ma occupa uno spazio consistente e tende a estendere il proprio potere sulle immagini, divenendo parte integrante del racconto, obbligando lo spettatore ad abbandonare la propria posizione statica e a divenire […] “lettore nella fabula”, guidato ora da una parola che entra nel racconto, assumendo funzioni plurime, ora alte di cantore epico, ora di un io narrante che intende interloquire con lo spettatore direttamente, ora intende rivolgersi a un personaggio del film agendo su di lui, ora è un semplice modo di comunicazione diretta26. La parola scritta, del resto, non entra nel cinema soltanto nella forma canonica della didascalia e dei titoli, bensì in tutta un’altra serie di funzioni, in qualità di scritta di scena o diegetica [→ Glossario, DIEGÈSI, DIEGETICO] (ovvero che fa parte integrante, iconicamente, narrativamente e verbalmente, della scena in corso): come insegna di un negozio, come cartello stradale o manifesto, come testo di una lettera, pagina di un libro, articolo di giornale, biglietto da visita, etc.: «la parola scritta […] è disseminata da subito in forma ipertrofica nel cinema muto e diventa un espediente e un procedimento narrativo determinante e dinamizzante per l’azione e per riuscire a coinvolgere l’esperienza dello spettatore in quella dei personaggi»27. Nei primi film della storia la didascalia manca del tutto o al massimo si risolve in poche parole che introducono la scena seguente. Ecco l’elenco delle didascalie del film Parisina (Un amore alla Corte di Ferrara nel XV secolo), 1909, di Giuseppe De Liguoro, con brani tratti dal poema omonimo di Domenico Tumiati: 25. RAFFAELLI (1992: 244). 26. BRUNETTA (1998: 22). 27. BRUNETTA (1998: 22). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 55 1) Ripudio di Stella Tolomei. Ugo è forzato a recarsi alle nuove nozze del padre 2) Parisina, col corteo nuziale, esce dal Duomo 3) Parisina apprende che è scoppiata la peste a Ferrara 4) Parisina parte per sfuggire la peste. Ugo è obbligato a scortarla 5) In viaggio 6) La sosta 7) Dall’odio all’amore 8) Il ritorno 9) «Padre ho peccato» 10) Vendetta di Venere 11) Fatale convegno 12) Lo specchio rivelatore 13) Il nano 14) Serenata funebre. «Una notte camminava | Di primavera l’amore; | E delle stelle mirava 15) L’ardore, | E cascò dentro una fossa | Piena d’ossa | L’amore» 16) La pena di morte 17) I trovatori evocano col canto le ombre degli antichi paladini28. Come si vede, la sintesi è massima e nondimeno lo stile è spesso aulicheggiante, talora goffamente («cascò dentro una fossa piena d’ossa»); frequente è il ricorso alla sintassi nominale e bandito è ogni ricorso al dialogo, al discorso diretto (se non sotto forma di citazione) e a qualsiasi mimetismo [→ Glossario, MIMÈSI ] dell’oralità. Bisognerà aspettare gli anni Dieci del Novecento, e dunque l’avvento di un cinema industrialmente e culturalmente più agguerrito, di medio e lungo METRAGGIO [→ Glossario] (1911–1912) e caratterizzato da trame sempre più complesse e bisognose pertanto di integrazioni verbali, perché le didascalie diventino più frequenti, articolate (anche in più turni dialogici), complesse (anche dal punto di vista grafico–iconico), talora non prive di velleità letterarie e affidate non più solo ad anonimi ma a professionisti della parola. Titoli- 28. RAFFAELLI (1992: 237). 56 Il linguaggio cinematografico sti (come allora si chiamavano gli autori delle didascalie, anche dette, per l’appunto, titoli, sottotitoli, cartelli, scritte, legende, diciture, scritture, etc.)29 [→ Glossario, TITOLISTA, TITOLO, DIDASCALIA ] noti e più o meno illustri sono almeno Adolfo Padovan per L’Inferno, 1911, di Padovan, Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro; Gabriele D’Annunzio per Cabiria, 1914, di Giovanni Pastrone (Figg. 1–2)30; Fausto Maria Martini per Rapsodia satanica, 1917, di Nino Oxilia; Alfredo Panzini per Gli ultimi giorni di Pompei, 1926, di Carmine Gallone e Amleto Palermi. Il caso di D’Annunzio è particolarmente importante: Cabiria segnò infatti il momento più alto del successo del cinema italiano all’estero e in tutto il mondo si gridò al capolavoro. Il film presenta più di un aspetto paradigmatico della filmografia del periodo: la libertà di manipolazione delle vicende (che caratterizzerà, d’ora in poi, i film storici in tutte le epoche) e, soprattutto, il ruolo secondario del regista, che passa in secondo piano rispetto alla Casa di produzione, ai divi e, specialmente in questo caso, all’estensore delle didascalie: in effetti ogni merito del film, secondo quasi tutti i critici, è ascrivibile a D’Annunzio e da taluni Pastrone non è neppure nominato. Vari fattori concorrono a infittire e allungare le didascalie, dalla metà degli anni Dieci. Innanzitutto la crescente complessità del racconto, come, per esempio, in Intolerance di Griffith e poi in Blade of Satans Bog (1921) di Dreyer. Inoltre, talora, le ambizioni ‘letterarie’ dei realizzatori, sollecitate e autorizzate in particolare dal ‘dannunziano’ Cabiria e molto spiccate nei cineasti italiani e francesi: si veda, da Il fuoco, l’alato esordio d’un messaggio amoroso: «Soffusa nel mistero, avvolta nelle tenebre giungerò al tuo nido…» […] L’abbondare delle didascalie è richiesto inoltre dall’ardua impostazione tematica 29. Su questi usi terminologici cfr. RAFFAELLI (1998: 190). 30. Ma ricordiamo come D’Annunzio, nonostante i titoli “urlati” del film che gliene attribuivano l’assoluta paternità, non fu probabilmente che il revisore di didascalie scritte da altri, sebbene alla sua maniera (ARISTARCO 1985: 27). Per quest’operazione di revisione il Vate percepì la stratosferica cifra di 50.000 lire d’oro (TAGLIABUE 1990: 22–27). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 57 di certi lavori […] e, infine, favorito dalla scoperta delle loro risorse spettacolari31. La prima attestazione di didascalie italiane risale al film La presa di Roma (il «primo film italiano a soggetto»)32, 1905, di Filoteo Alberini, prodotto dalla Casa di produzione romana (tra le prime nate in Italia) Alberini e Santoni: si tratta ora di brevissime frasi fatte: Niente resa!, All’armi!, All’assalto!; ora, soprattutto, di titoli elementari anteposti riassuntivamente alla scena: «L’ultima cannonata», «Bandiera bianca», Apoteosi33. Dopo il 1910 le didascalie cominciarono ad accogliere usualmente anche frasi in discorso diretto, prevalentemente domande senza risposta (suggerita dal contesto iconico). Con Cabiria, la letterarietà delle didascalie toccò senz’altro il culmine («D’Annunzio reinventa un simulacro di lingua morta compiendo un’operazione […] per certi aspetti simile a quella degli autori dei testi dei monumenti e delle lapidi commemorative e sulla sua strada si muoveranno ancora i film storici del decennio successivo»)34, come mostrano i brevi esempi seguenti: SOFONISBA: Di’ com’è egli? ANCELLA: Come il vento di primavera, che valica il deserto con piedi di nembo recando l’odor dei leoni e il messaggio d’Astarte35. È il vespero. Già si schiude la tenzone dei caprai, che la Musa dorica ispira su i flauti dispari «a cui la cera diede l’odor del miele»; Sofonisba, la figlia d’Asdrubale, l’ardente «fiore del melograno»36. 31. RAFFAELLI (1992: 238). 32. BRUNETTA (1991: 1). 33. Cfr. RAFFAELLI (1992: 42–43). Sulla parola scritta nel film muto, anche dal punto di vista grafico, qui trascurato, cfr. RAFFAELLI (1992: 217–247), PITASSIO/QUARESIMA (1998) e RAFFAELLI (2003a). 34. BRUNETTA (1991: 60). 35. RAFFAELLI (1992: 151). 36. RAFFAELLI (1991a: 84). Le didascalie successive, invece, sempre da Cabiria, sono tratte da BRUNETTA (1991: 60). 58 Il linguaggio cinematografico Dispersi dalla fame per la piaggia sconvolta, tuttavia incalzati dal terrore, i fuggiaschi scendono verso il mare. Una nave è là, abbandonata, come offerta dal favore degli Iddii. Fulvio Axilla contrasta invano al panico che lo travolge. Il buono evento seconda il romano. Ogni speranza di Salvezza è vanita. Massinissa venuto a notizia dell’assedio singolare vuol conoscere i due audaci. Non vive più, fu spenta. E sarà proprio l’ostentato scarto dalla lingua comune la cifra stilistica distintiva della gran parte della produzione filmica nostrana fino all’avvento del sonoro. Tra i tanti esempi si vedano almeno Pia de’ Tolomei, 1910, di Gerolamo Lo Savio («Il male avendo compiuto l’opera sua, Pia de’ Tolomei muore tra le braccia dello sposo dopo avergli perdonato»)37; La memoria dell’altro, 1914, di Alberto Degli Abbati («Ella ama un uomo […] che trovasi a Venezia»)38; Fabiola, 1918, di Enrico Guazzoni («Per virtù del sangue dei martiri l’anima di Fabiola sorge pura verso la luce di quella Roma onde Cristo è romano»)39; Sole, 1929, di Alessandro Blasetti («Passano i guadi le mandrie di bufale per il cambio dei pascoli e tutto schiantano e travolgono»; «Miserabile è l’animo vostro come le vostre menti… Guardate!»), dove spicca il gusto per l’inversione sintattica40. Non mancano didascalie in versi: 37. 38. 39. 40. BRUNETTA (1991: 60). RAFFAELLI (1991a: 82) BRUNETTA (1991: 60). La prima didascalia è tratta da RAFFAELLI (1991a: 82–83), la seconda da MICHELI (1990: 47). Il film blasettiano, tra l’altro, non è privo di didascalie molto più vicine al parlato colloquiale: «Questa volta glielo voglio far vedere io, a Marco, che cosa vuol dire essere uomini»; «Nulla di grave. Un urtone di certe bufalette poco educate»; «Ehi, amico! Dove ti sei cacciato?»; «Dì, buttero, non hai mica una sigaretta asciutta?» (MICHELI 1990: 47). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 59 O Mitra, re Sole, la Morte richiama alla Vita, ristora. T’implora la Madre preclara de’ Numi41. E si registrano pure esempi in lingua straniera: Sire, n’exposez pas votre vie. Ici est gloire pour tous42. Parimenti, viene messo a punto (ovviamente sulla scorta dei romanzi d’appendice) il lessico amoroso che tanta parte avrà nel melodramma cinematografico, con le sue vertigini e le sue passioni, i veleni, gli abissi e i languori nonché, ovviamente, con l’abuso del cuore e dell’amore: «Dal vertice della passione cadono le due vittime nell’abisso della voluttà ferina»; «C’era un abisso tra noi… e la vertigine ci colse» (Tigre reale, 1916, di Pastrone)43; «Mentre Tristano si dilegua, Alba sente il veleno d’amore insinuarsi in lei»; «Alba languiva nell’autunno sconsolato del cuore»; «Alba sentì confusamente che tutto l’universo è amore»; «Si velò sacerdotessa dell’amore e della morte»; «Il desiderio batteva alle porte del cuore» (Rapsodia satanica, 1917, di Oxilia)44. In altri film si possono incontrare didascalie un po’ più colloquiali, anche se sempre artefatte e di stampo teatrale, com’è il caso dei due esempi seguenti tratti da Assunta Spina, 1915, di Gustavo Serena (il prototipo del film realistico e che consacra al successo la diva Francesca Bertini): 41. 42. 43. 44. Giuliano l’Apostata, 1919, di Ugo Falena (RAFFAELLI 2001: 874). BRUNETTA (1991: 873). BRUNETTA (1991: 61). BRUNETTA (1991: 61). 60 Il linguaggio cinematografico GUARDIA: Se il vostro amico resta a Napoli, lo potrete vedere almeno due volte al mese… ASSUNTA: E quanto ci vuole? Quanto devo darvi? GUARDIA: Ah, niente… Grazie tante… MICHELE: Mi pare che tu sia diventata anche più bella, Assunta. Guardami! ASSUNTA: Lasciami! MICHELE: Perché? ASSUNTA: Perché non ne sono degna45. Oppure: Caro nipote! Caro zio! Ti presento la signorina Titina Sgambetti, mia fidanzata Ehi! Amico, quella è mia cugina! Il cuore dello zio Pancrazio batte fortemente46. Le fatiche più gravose. L’impresa dà una parte di paga in vettovaglie che si consumano nel recinto del cantiere. Dopo un’ora si ritorna al lavoro e al pericolo. All’ospedale47. Come si vede, a far da contraltare (minoritario) alla propensione per la letterarietà più trita, non manca certa ricerca della medietà linguistica, per via della già ricordata vocazione al realismo da sempre presente nel nostro cinema, accanto alle produzioni spettacolari e alle ricostruzioni storico–mitologiche: La produzione nazionale [italiana] […] — costretta da vari fattori, quali l’elementarità del messaggio filmico e le sue limitanti modalità d’emissione e di ricezione [per via dell’elevatissimo tasso di analfabetismo del nostro pubblico] — mirò ad attenersi sempre, anche negli anni aurei, a quel sistema linguistico, permeato di sostanziale medietà, che mezzi già allora in 45. RAFFAELLI (1992: 152). 46. Polidor cambia sesso, 1912, della Pasquali e C. (RAFFAELLI 1991a: 82). 47. L’emigrante, 1915, di Febo Mari (RAFFAELLI 1991a: 82). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 61 espansione come il telegrafo e il telefono, il giornalismo e persino certa letteratura stavano consolidando: assunse insomma un lessico corrente, una fraseologia stereotipata, una sintassi lineare…48. Va infine menzionato a parte il procedimento schiettamente dotto della chiosa che, animato forse da cura divulgativa oppure da pedante sufficienza, riusciva però a rendere comprensibili certe espressioni rare o idiomatiche: si veda in Cenere di Mari, 1917: «Rosalia gli mise al collo la rezeta (amuleto) e gli raccomandò di non staccarsene mai»49. Peraltro, «[l]’opinione che le didascalie, e in particolare quelle dialogiche, fossero da ammettere in via transitoria, come rimedio all’imperizia dei realizzatori del momento, predominò fino al termine del muto»50. Con lo sviluppo delle didascalie giunge anche l’immancabile crociata di puristi e difensori del buon uso linguistico. Non mancano, in effetti, già nel muto, svarioni, forestierismi e dialettalismi: Da un pezzo a questa parte siamo costretti, con dolore e vergogna, a leggere certi titoli, certe spiegazioni e certe lettere nelle quali la grammatica e la proprietà del linguaggio sono calpestate nella maniera più indegna. Non pretendiamo che le Case cinematografiche assoldino dei gran letterati per far compilare quelle diciture e quell’epistole che devono, necessariamente, essere lette dal pubblico del cinematografo; solo ci accontenteremmo che i compilatori conoscessero, sia pure superficialmente, la grammatica e la sintassi. 48. RAFFAELLI (1991a: 82). 49. RAFFAELLI (1991a: 84). 50. RAFFAELLI (2003a: 23). «Qualche volta [la parola] diventa un’agevolazione per gli spettatori meno abili, ma di solito queste didascalie sono indispensabili per la comprensione dell’intreccio e anche gli spettatori più intelligenti sarebbero persi senza queste indicazioni. […] L’arte della parola e quella dell’immagine sono qui unite a forza. Qualunque sceneggiatura che abbia bisogno di queste stampelle linguistiche per essere capita decreta un fallimento estetico nella nuova arte. Il passo ulteriore verso l’emancipazione del cinema dovrà essere decisamente la creazione di film che parlino solo il linguaggio delle immagini» (Hugo Münsterberg, 1916, in RAFFAELLI 2001: 862–863). 62 Il linguaggio cinematografico È addirittura vergognoso che quasi tutte le Case, diciamo quasi tutte, non sappiano, o non vogliano, far compilare le diciture dei loro films, in modo da non farsi correggere da uno scolaro della terza elementare. E a sostegno di quanto affermiamo si potrebbero citare infiniti esempi di brutto scrivere, che darebbero materia adatta per un articolo brillante. Non si tratta di scrivere né in forma elevata, né in poesia; si tratta solo di combinare poche parole in forma semplice, ma corretta; e ciò, almeno ci pare, non dovrebbe costituire una difficoltà insormontabile per le Case, né una eccessiva richiesta da parte del pubblico! Incredibile, ma vero; spesse volte sono scritte meglio, tali diciture, in qualche film di Casa estera, la quale potrebbe avere un’attenuante se incorresse in errori, che non quelle di molti films italiani. Con questo non vogliamo lontanamente affermare che le traduzioni che ci provengono dall’estero siano buone, sono anzi infelicissime, e potremmo fare un appunto dicendo loro: Non si tratta di tradurre né Goethe, né Schiller! Procuratevi un traduttore che conosca realmente un po’ l’italiano! Ma con quale coraggio si dovrebbe muover loro questo rimprovero quando quelle stesse Case ci potrebbero rispondere: Cominciate a reclamare contro le vostre Case, che scrivono peggio di noi! E purtroppo direbbero la verità! Noi ci auguriamo che, anche per il loro buon nome, le Case italiane in seguito cureranno un po’ più la compilazione delle loro diciture; e allora chi sa che la cultura del popolo non possa guadagnare qualcosa invece di scapitare come, senza dubbio, capita ora51. Ne conseguono, in età giolittiana, le prime norme della censura (istituita ufficialmente, per il cinema, nel 1913: dunque, nonostante un inveterato luogo comune, il controllo e l’autarchia linguistica del film iniziano nel decennio precedente la marcia su Roma): I titoli, i sottotitoli e le scritture, tanto sulla pellicola quanto sugli esemplari della domanda, debbono essere in corretta lingua italiana. Possono tuttavia essere espressi in lingua stranie- 51. A. Salvini, …e la grammatica?, in “L’illustrazione cinematografica”, 5–10 febbraio 1913, p. 10 (RAFFAELLI 1992: 167). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 63 ra, purché riprodotti fedelmente e correttamente anche in lingua italiana52. Della commissione di censura cinematografica faranno parte, tra gli altri, negli anni Venti, Alfredo Panzini, Luigi Pirandello e Silvio D’Amico53. Nel 1928 si dedicherà all’attività di revisore per la censura anche Massimo Bontempelli, impegnato, di lì a poco, nell’emendamento del primo film sonoro (Il cantante di jazz [The Jazz Singer], 1927, giunto in Italia nel 1929, di A. Crosland). 2.2.2. Data la situazione geo– e sociolinguistica italiana, non stupisce che l’uso del dialetto accompagni il cinema fin dalla sua nascita, come s’è già accennato per certi casi di integrazione orale. Il fenomeno diventa cospicuo nelle didascalie, almeno fino alla repressione dei dialetti durante il ventennio fascista. Anche se non mancano esempi altrove (per es. a Torino, dove si ricorda un Maciste alpino, 1916, di Luigi Maggi e Romano L. Borgnetto, con qualche didascalia in piemontese: «Tira neñ bôrich! At girlo la bocia? I sôn Maciste!»)54, è naturalmente a Napoli che il cinema dialettale, nella forma della sceneggiata, è di casa, fino almeno ai divieti fascisti (già a partire dal 1924), che impedirono, nel 1928, la circolazione di «‘pellicole di ambienti napoletani’ che persistessero su ‘clichés’ che offendono la dignità di Napoli e dell’intera Regione»55. Si tratta soprat- 52. «Regolamento per l’esecuzione della legge 25 giugno 1913, n. 785, relativa alla vigilanza sulle pellicole cinematografiche», approvato con Regio decreto 31 maggio 1914, n. 352 e pubblicato nella “Gazzetta ufficiale”, 9 luglio 1914, n. 162 (RAFFAELLI 1992: 170). Tale norma, con qualche aggiustamento, rimase nella sostanza invariata anche nell’epoca del sonoro. Sulla censura in ambito cinematografico cfr. in particolare RAFFAELLI (1999). 53. L’ha scoperto RAFFAELLI (1994b: 90). 54. RAFFAELLI (2003a: 198; alle pp. 195–204 si può leggere l’intera trascrizione del film). Si ricorda che Torino a metà degli anni Dieci era uno dei più importanti centri cinematografici, tanto da giustificare l’appellativo di filmopoli. Tra il 1907 e il 1914 vi nascono una quindicina di Case di produzione. Furono prodotti a Torino KOLOSSAL [→ Glossario] del calibro di Cabiria, per l’Itala Film (cfr. BRUNETTA 1991: 34–38). 55. RAFFAELLI (1992: 76). Con l’illustre precedente di ’Nfama!, 1924, di Elvira 64 Il linguaggio cinematografico tutto di casi di mistilinguismo [→ Glossario, CODE–MIXING], dal dialetto all’italiano popolare, dall’italiano regionale a quello letterario56: L’onda di popolo frenetico di chiasso e desideroso di baldoria gremisce ogni via che percorrono i reduci di Montevergine. ’A carrozza ’e Tore. ’A carrozza ’e Margaretella. Pandemonio orgiastico di baccanti. Il diapason del chiasso. AMICO DI TORE: Non ti scottare al fuoco di quegli occhi, ’a figlia ’e donna Carmela ’nnammuratu lassa e ’nnammuratu piglia!… MARIA Il vino non lo abbiamo bevuto e lo vuoi essere pagato. TORE: [a Margaretella] Come sei bella! ZIÈ ROSA …E ’n ’ato! ZIÈ ROSA: [a Tore] Cagnate strada: chella guagliona ha fatto chiagnere chiù de ’nu figlio ’e mamma!57. GIUSEPPPONE: Chi siete? MARIA: Sono la madre di Tore Spina e se posso avere l’onore vi chieggo la mano di Nanninella per mio figlio. GIUSEPPONE: Avite fatto buono a venì… diticitancelle ò figlio vuosto c’avutasse via,… ’e miseria, ne tengo na panza: Pe figliema nce vonno sorde… sorde. MARIA: [a Nanninella] A mio figlio dimenticatelo, con tale padre, per Tore non veggo che la galera o la morte. Notari, al quale la censura non solo impose la riscrittura delle didascalie «in corretta lingua italiana», ma negò, eccezionalmente, «il nulla osta per l’esportazione all’estero» (RAFFAELLI 1992: 211). Ricordiamo che Elvira Notari fu regista fecondissima (i suoi film erano assai richiesti anche all’estero, per esempio dagli emigrati italiani in America) e a capo della Casa di produzione cinematografica Film Dora, a gestione familiare, specializzata nella realizzazione di sceneggiate. 56. Per le prime formulazioni del concetto di «italiano popolare unitario» (italiano incertamente dominato da chi ha per madrelingua il dialetto) cfr. D E M AURO (1963/1993: 118–126 et passim), (1970) e (1974); CORTELAZZO (1976); SANGA (1981). Sull’italiano regionale (varietà intermedia tra dialetto e lingua, più vicina alla seconda nella morfosintassi, più al primo nella pronuncia e nella fraseologia) cfr. almeno CORTELAZZO (1977); POGGI SALANI (1982); BERRUTO (1983); CORTELAZZO/MIONI (1990); PELLEGRINI (1990); SABATINI (1990); TELMON (1993) e (1994); D’ACHILLE (2002a). 57. Da È piccirella, 1922, di Elvira Notari (RAFFAELLI 1992: 76). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 65 NANNINELLA: Padre, perché mi vuoi uccidere il cuore, Tore è la mia vita!58. Talora i film uscirono in doppia versione: con didascalie in dialetto per il mercato locale e con didascalie in italiano per il mercato nazionale, come accadde per il San Giovanni decollato, 1917, di Telemaco Ruggeri, con Angelo Musco, italianizzato fuori della Sicilia. Con le didascalie, come s’è visto nel polemico articolo del Salvini testé riportato e nelle disposizioni della censura trascritte e commentate da RAFFAELLI (1992: 163–216), nascono inoltre i primi problemi di adattamento cinematografico, che si amplificheranno (con talune risposte e innumerevoli polemiche) durante i decenni del sonoro. Per i film stranieri era normale che la produzione provvedesse a vendere agli acquirenti copie con le didascalie già tradotte: «Il lavoro di traduzione costituiva una delle normali fasi di realizzazione dell’opera cinematografica ed era assai intenso, per lo meno nelle case meglio organizzate: basti ricordare che ad esempio la romana Cines nel 1910 preparava pellicole in sette differenti lingue»59. Le lamentationes sulle cattive traduzioni si sprecano. Dalla fine degli anni dieci all’avvento del sonoro l’adattamento linguistico delle pellicole straniere — sempre più gradite, sempre più lunghe, spesso infarcite di didascalie — diventò in Italia, come del resto dovunque, normale cura della ditta acquirente, che lo faceva eseguire nel proprio paese, affidandolo a professionisti, con evidente beneficio sulla sua riuscita qualitativa60. 58. Da ’A Santanotte, 1922, di Elvira Notari (RAFFAELLI 1992: 76). 59. RAFFAELLI (2003a: 36). Ricordiamo che la Cines è la principale Casa di produzione cinematografica italiana, fondata a Roma da Filoteo Alberini nel 1906. Già nel 1907 apre sedi all’estero (a New York e, poco dopo, a Londra, Parigi, Berlino, Mosca e praticamente in tutto il mondo). Nata dalla Alberini e Santoni, la Cines chiuderà nel 1935, a causa di un incendio. Dalle sue ceneri nascerà, nel 1937, Cinecittà. Ricostituita nel 1941, dopo l’armistizio del 1943 la Cines si sposterà a Venezia e, dopo alterne vicende, sarà definitivamente assorbita da Cinecittà nel 1957. 60. RAFFAELLI (2003a: 38). 66 Il linguaggio cinematografico La traduzione s’avvia così a diventare adattamento, sempre più libero, che si configura spesso come una vera e propria riscrittura, anche dovuta, non di rado, a ragioni di censura morale e ideologica61. Il più importante RIDUTTORE [→ Glossario] (così venivano chiamati gli adattatori cinematografici) dell’epoca, Guglielmo Giannini (Pozzuoli 1891–Roma 1961, fondatore del quotidiano “L’Uomo Qualunque”, adattatore, tra gli altri, del Circo di Chaplin e della Folla di Vidor), tesse l’elogio della professione (nell’articolo sotto lo pseudonimo di L. Tucci, Il riduttore di films, in “Il Corriere dello spettacolo”, 5 maggio 1931, p. 2): Quando la pellicola giunge dall’estero, il direttore dell’agenzia di lanciamento chiama il riduttore e insieme visionano il lavoro. È brutto, è cretino? Il riduttore deve pensare a renderlo bello, interessante, intelligente. E come? Prima di tutto “fa” i titoli o didascalie. Spesso esiste un copione in lingua straniera. Il lavoro è semplificato. Prima si traducono i titoli e poi si forgiano uno per uno. Si spazzano via i superflui, si cambiano modi di dire, si mettono in bocca ai personaggi battute di spirito che mai essi si sono sognati di dire, si cerca di spiegare i movimenti, le frasi, gli stati d’animo dell’interprete della pellicola, riportandoli a una mentalità nazionale, cercando di eliminare, per quanto sia possibile, tutte quelle stridenze che, a volte, non hanno significato che per gli stranieri ma che fanno ridere o irritare il nostro pubblico62. E ancora lo stesso Giannini, a proposito della fedeltà all’originale: Questione di diritto. «Ha il riduttore il diritto — si chiede scandalizzata la critica — di manomettere il lavoro altrui?». A questo si risponde anzitutto che moltissimi direttori artistici italiani e stranieri ricorrono spontaneamente all’opera dei riduttori e ne fanno grandissimo conto. Chi scrive ha avuto l’onore di pubbliche lodi, ringraziamenti ed indennità da parte di 61. Alcuni esempi sono riportati da RAFFAELLI (1992: 163–216) e (2001: 889–890). 62. RAFFAELLI (2003a: 39). Cfr. inoltre, sulla traduzione delle didascalie, RAFFAELLI (2001: 887–890). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 67 direttori “manomessi” e felicissimi della manomissione. Ma, a parte i casi particolari, non è forse accettato e discusso in tutti i contratti teatrali che «il capocomico può apportare al lavoro tutte le modificazioni che riterrà opportune, d’accordo con l’autore»? E quando il riduttore è officiato dalla “Metro Goldwyn”, dagli “United Artists”, dalla “Paramount”, per “ridurre in italiano” un film “Metro”, “United”, “Paramount”, non opera d’“accordo con l’autore” o con chi ne fa le veci? Semmai starà al critico scrupoloso confrontare specificamente il lavoro dei singoli adattamenti con i film originali. I film d’importazione sono spessissimo titoleggiati in modo da interessare il pubblico d’origine. In un film recentissimo, in una scena fra due soldati, uno dei quali tormenta una biondina, l’altro dice: «Blondes prefer gentlemen: that try you out». Ossia: «le bionde preferiscono i signori» (e signori, per gentlemen, non traduce che troppo approssimativamente): «ciò ti esclude». Non v’ha chi non veda il nesso con il famoso romanzo di Anita Loos, perfettamente sconosciuto al gran pubblico italiano, Gentlemen prefer blondes. Che cosa dovrebbe fare il riduttore […]? Tradurre quel titolo pure spiritosissimo per chi conosce l’inglese ed il grande successo letterario americano? Starebbe fresco! Ed ove capitasse, come nel Segretario di papà una dicitura come questa: «L’Ufficio di spedizioni di J. B. e R. T. ‘where gentlemen prefer bonds’». Come dovrebbe tradurre il riduttore? Dove i «signori» (gli uomini, i gentiluomini) preferiscono «i magazzini di deposito delle dogane»? (Bonds), «le polizze»? (Bonds), «le balle»? (Bonds)? In barba alla filologia, quel che conta è il risultato in sé, non il confronto con l’originale: Un elemento essenziale di giudizio è per intanto questo: “la scorrevolezza e la comprensibilità”. Quando un film “corre”, quando i titoli non appaiono “superflui”, ma “indispensabili” (e quando non sembrano a prima vista “indispensabili” bisogna cercar di capire qual magagna mascherano), quando ottengono l’effetto desiderato di far ridere o di commuovere, allora vuol dire che la “riduzione” [→ Glossario, ADATTAMENTO] è fatta bene. Quando non si capisce il film chiaramente ed a pri- 68 Il linguaggio cinematografico missima vista, significa “sempre” che la riduzione italiana è sbagliata63. Dunque i problemi dell’adattamento dei frames da un pubblico all’altro, che tanta parte avranno nel cinema sonoro doppiato, come si vedrà nel quinto capitolo, nascono già col cinema muto. E Giannini rincara la dose, mostrando come i cambiamenti fossero non soltanto formali (linguistici) ma spesso sostanziali, anche nel tessuto iconico (invertendo le parti del film originale, per esempio) e nella trama: Sanno quante volte una moglie, in film, diventa sorella o cugina, o zia, o levatrice e stiratrice perché moglie non potrebbe assolutamente essere? […] Quanti finali di film diventano principio di primo atto, quanti personaggi cattivi diventano buoni, quanti personaggi che muoiono terminano invece il film in perfetta salute? L’aderenza dei film stranieri alla mentalità e al gusto italiano è data da noi, qui in Italia […]64. Per Giannini, insomma, il peggior difetto è la traduzione fedele. Va infine ricordato che Giannini riuscì a far riconoscere al riduttore lo statuto giuridico di coautore del film65. Anche l’estrema libertà nella traduzione (ma sarebbe meglio dire riscrittura) dei titoli (stavolta nel senso comune e non in quello di ‘didascalia’) stranieri ha origine nel muto: Saturday Night (1922): Coppia ideale; I’ll Show You the Town (1925): Siete solo stasera?; There you Are! (1926): Il segretario di papà. L’influenza delle didascalie del cinema muto sull’italiano del primo quarto del ventesimo secolo non fu rilevante. Si confermano certi stereotipi letterari d’accatto (uso esagerato di metafore spesso usurate, dello stile nominale e della prosopopea66, 63. Si tratta sempre di articoli di Giannini cit. da RAFFAELLI (2003a: 179–180). 64. Giannini cit. da RAFFAELLI (2003a: 39). 65. Cfr. RAFFAELLI (1995). 66. «Sullo scialo di figure retoriche, spesso vistosamente incongrue, basti qui addurre, a titolo esemplificativo, la catena di metafore in Gli ultimi giorni di Pompei di Caserini, 1913: ‘Le rose della gratitudine / Le spine della gelosia’, ‘L’uccello rapace’ 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 69 inversioni sintattiche, allotropia e alternanza di forme concorrenti67, uso transitivo di verbi intransitivi e viceversa e reggenze verbali desuete, lessico abbastanza — anche se quasi mai troppo — ricercato) e si avalla lo iato tra scritto e parlato, contribuendo così a collocare i divi e le dive del cinema in un mondo onirico, lontanissimo dalla realtà, desiderato ma irraggiungibile come l’alfabetizzazione di gran parte degli italiani dell’epoca. Certo però che quella lingua filmica, presa nel suo complesso — e dunque anche nell’uso fattone nei programmi di sala, nelle integrazioni orali, nei richiami degli inservienti, nei “prossimamente” dei nuovi film, etc. —, entrerà, seppure non integralmente, nelle abitudini della cinematografia successiva e alcune espressioni alloggeranno stabilmente, magari con uso figurato o scherzoso, nell’italiano contemporaneo: si prendano comica finale (dall’abitudine di proiettare cortometraggi [→ Glossario, METRAGGIO ] comici alla fine dei primi compositi spettacoli cinematografici, musicali, teatrali e di intrattenimento vario), ecco i nostri e arrivano i nostri, mani in alto (su cui cfr. § 5.2.5). Ma si pensi anche a Arrivederci e grazie, «l’ultima didascalia del film, gustosa e cara al ricordo nella sua ingenua cortesia […], cui faceva eco l’inserviente con gli altrettanto tradizionali: Signori, uscita! oppure: Si esce da questa parte!»68. 2.3. L’oralità dei primi film sonori 2.3.1. La decadenza del cinema italiano già nel primo quarto di secolo ha ovviamente varie ragioni: incapacità di rinnovare il sistema produttivo e di reggere alla concorrenza americana; [cioè Arbace], ‘Fra gli artigli del falco’; e la serie di personificazioni, da Il Fauno di Mari, 1917: ‘La Femmina’, ‘Il Vizio’, ‘La Sregolatezza’, ‘La Fortuna’, ‘L’Ingordigia’» (RAFFAELLI 1991a: 83). 67. Per es. tra disprezza, dispregia e sprezza, o tra ella e essa (nelle didascalie panziniane degli Ultimi giorni di Pompei, 1926, di Gallone e Palermi, in RAFFAELLI 1994b: 90–92). 68. MENARINI (1955: 12–13). 70 Il linguaggio cinematografico crollo del pantheon divistico nostrano (Francesca Bertini, Lyda Borelli, Emilio Ghione e gli altri praticamente esauriscono la loro presa sul pubblico all’inizio degli anni Venti), sostituito da quello delle stars d’oltreoceano; mancato rinnovamento dei soggetti e delle regie, al punto che anche le produzioni migliori del periodo tendono a un ripiegamento sulle storie e sulle tecniche del passato: Dai primi anni [V]enti il cinema italiano diventa un fenomeno così marginale sulla scena internazionale da essere praticamente ignorato. Per quasi un ventennio i film che avranno la forza di varcare il confine e confrontarsi con le altre produzioni si conteranno sull’ordine di poche decine […]. [N]egli anni dal 1923 al ’35 la produzione italiana non raggiunge mai le poche decine di titoli l’anno69. A salvare il nostro cinema, o quantomeno a dargli l’illusione della palingenesi, è l’avvento del sonoro. Il primo film sonoro (o anche parlante, parlato o dialogato, come si diceva all’epoca, e a ragione, visto che i “suoni”, quando non già le parole, caratterizzavano in realtà già il cinema “presonoro”) della storia del cinema è, convenzionalmente, l’americano The Jazz Singer, 1927, di Alan Crosland. A rigore, dello stesso regista si dovrebbe risalire all’anno precedente, con la proiezione del suo Don Juan, «film parzialmente sonorizzato con il medesimo sistema» Vitaphone70. Il primo film sonoro italiano è invece La canzone dell’amore, 1930, di Gennaro Righelli, tratto da una novella pirandelliana dal titolo (scelto forse non a caso) curiosamente antifrastico: In silenzio. E in effetti di silenzioso in quel primo film non c’è proprio nulla: per conquistare il pubblico al nuovo mezzo, la produzione non ci risparmia alcun tipo di effetto acustico, in presa diretta e postsincronizzato (mentre tutti in presa diretta sono i dialoghi): dai rumori della natura alle canzoni, dai dialoghi ai brusii. Il film cambia addirittura ambientazione [→ 69. BRUNETTA (1991: 147–154). 70. RAFFAELLI (1992: 218–219). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 71 Glossario, AMBIENTAZIONE SCENICA], rispetto alla novella, per enfatizzare il ruolo della colonna sonora: ci troviamo infatti in un negozio di dischi e la canzone–tema del film (Solo per te Lucia, parole di Bixio Cherubini, musica di Cesare Andrea Bixio) diventerà subito un grande successo. In realtà, il primo film sonoro italiano sarebbe dovuto essere Resurrectio di Alessandro Blasetti, che in effetti fu finito di girare prima del film di Righelli ma che fu presentato soltanto nel 1931, poiché fu considerato inadatto al grande pubblico e al lancio della nuova tecnica, della quale tra l’altro presentava un uso assai accorto e originale, combinando espressivamente rumori della strada e musiche (ma pochi dialoghi), a esprimere lo stato d’animo del protagonista (un direttore d’orchestra che medita il suicidio per un amore infelice). Resurrectio, che doveva inaugurare la collaborazione tra Blasetti e Stefano Pittaluga (il nuovo proprietario della Cines, che diventerà infatti d’ora in poi Cines–Pittaluga, colui che segnò la riapertura dei nuovi stabilimenti e l’inizio delle produzioni sonore), fu definito dal regista «il più colossale insuccesso della mia vita»71. I dialoghi della Canzone dell’amore non mostrano grandi differenze rispetto allo stile melodrammatico–larmoyant delle didascalie del muto: politezza irreale nell’interazione dialogica, rigidità fonica nella dizione, imputabile peraltro anche all’insensibilità dei microfoni e alla laboriosità della registrazione. Ecco la scena dell’incontro di Enrico, divenuto musicista di successo, con la sua Lucia, dopo lungo e tormentoso distacco: ENRICO: Dunque… è avvenuto qualche cosa di nuovo nella sua esistenza!… Un altro… amore? LUCIA: Sì! ENRICO: È vero? Un altro amore! LUCIA: Un altro amore, che occupa tutta la mia vita. Tu non puoi comprendere. E questo amore sarebbe stato un grande ostacolo tra noi. Tu sei un artista… 71. GORI (1983: 20). 72 Il linguaggio cinematografico ENRICO: Parole! Parole! Tu non hai nemmeno il coraggio di spiegarti. Tu mi hai sempre mentito, ecco la verità. Io ho creduto in te e tu hai distrutto tutto quello che di meglio vi era nel mio cuore: la fede, l’entusiasmo… LUCIA: Enrico! ENRICO: Vattene! Vattene! ANNA: (fuori campo) Enrico! Enrico! (in campo) Ma Enrico… Bravo! Vedo con piacere che invece di… occuparti della musica, ti occupi… della prosa! ENRICO: Smettila, ti prego! ANNA: Oh, già! Hai finalmente ritrovata la tua grande Lucia, in questa Casa… dei dischi!72. Presto, però, il parlato cinematografico «mostrò di sapersi piegare verso modi meno sostenuti, timidamente colloquiali, aprendosi anche ad apporti morfosintattici e lessicali di provenienza dialettale, in sintonia con certo realismo minore dei soggetti»73. Ne sono una prova soprattutto i film di Alessandro Blasetti e di Mario Camerini, dei quali si continuerà a parlare nel paragrafo successivo e nel capitolo dedicato ai dialetti (§ 4.1.1). Prendiamone qualche assaggio: C’hai rabbia perché non t’ha baciato a te74. MARIUCCIA: Ma perché ha fatto così? BRUNO: Ma mi lasci stare! MARIUCCIA: Ma è stato uno scherzo! BRUNO: Sì! Bello scherzo! MARIUCCIA: Ma che cosa pensa lei adesso di me? BRUNO: Io? Io non penso niente75. Tipicamente colloquiale è, nell’ultimo brano, l’agile scambio di battute, alcune delle quali prive di verbo, e quel ma introdut- 72. La prima parte è riportata da RAFFAELLI (1992: 153–154), la seconda da RAF(1994a: 275). 73. RAFFAELLI (1994a: 275). 74. Palio, 1932, di Blasetti (RAFFAELLI 1994a: 275). 75. Gli uomini, che mascalzoni…, 1932, di Camerini (RAFFAELLI 1994a: 275). FAELLI 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 73 tore dialogico [→ Glossario, SEGNALE DISCORSIVO], tanto frequente nel parlato spontaneo76. Vediamo qualche altra battuta significativa colta dall’ascolto del medesimo film (Gli uomini, che mascalzoni…), cruciale nella storia del cinema per vari motivi (a parte il lancio della celeberrima canzone Parlami d’amore Mariù, parole di Ennio Neri, musica di Cesare Andrea Bixio): intanto impone il primo divo del sonoro Vittorio De Sica, nei panni del giovane piccolo–borghese aspirante dandy, ma in fondo dal cuore semplice e generoso e, nonostante le sbandate per le signore dell’alta società, in cerca soltanto di una brava e umile ragazza. Inoltre dà il via alla corrente comica (successivamente detta dei “TELEFONI BIANCHI” [→ Glossario], per via delle scenografie degli interni inverosimilmente sfarzose, basate sul bianco e sul nuovo oggetto simbolo dell’incipiente capitalismo italiano: il telefono) caratterizzata dalla contrapposizione tra ricchi e poveri e dal gioco di equivoci nato dal tentativo di passare da una sponda sociale all’altra. Gli uomini, che mascalzoni… narra le avventure di un giovanotto, Bruno, autista privato, il quale s’invaghisce dell’umile Mariuccia e, per far colpo su di lei, si spaccia per il ricco proprietario dell’auto che guida. A causa dell’equivoco, Bruno rischierà di perdere per sempre Mariuccia, che tuttavia alla fine riuscirà a sposare, nell’immancabile lieto fine. Si registrano nel film alcune battute di tono popolare o gergale, magari di ascendenza teatrale: «Che domani d’Egitto?» esclama il commendatore alla dichiarazione (falsa) di De Sica che la macchina è rotta e che sarebbe stata riparata l’indomani77; «Ohi pelandrona! Sveglia!» intima il padre a Mariuccia. MARIUCCIA: Non sapevo che lei… che lei era/ impiegato// BRUNO: Beh/ e adesso che lo sa? Mi lasci stare// MARIUCCIA: Perché? 76. Sul ma e sull’e a inizio di enunciato o di turno dialogico cfr. SABATINI (1997b). 77. Sul modulo d’Egitto, tanto frequente in Totò, cfr. ROSSI (2002a: 244–245). Sulla sua origine cfr. LURATI (1998: 53–61) e BECCARIA (1999: 177). 74 Il linguaggio cinematografico BRUNO: Perché… perché per lei ci vogliono i signori//. Il concetto dell’inadeguatezza economica (che nell’ultimo brano è espresso in uno stile insolitamente colloquiale, garantito sia dall’indicativo al posto del congiuntivo, nella prima battuta, sia dai contrassegni del parlato come il segnale discorsivo beh e l’esitazione–ripetizione perché… perché) è ribadito dalla collega invidiosa di Mariuccia: «Ma andiamo/ quella non è roba per lei// Lì ci vuole l’automobile/ e i biglietti da mille//». Anche se il parlato del film appartiene nel complesso all’italiano standard (con marcata affettazione nella pronuncia dei personaggi più ricchi: il commendatore e sua moglie), non manca qualche pennellata dialettale (naturalmente soltanto nei personaggi secondari), all’inizio e alla fine a mo’ di cornice: «Te/ chi se ve! Cosa te fe?» (‘guarda chi si vede! Cosa fai?’) chiede l’amico a Bruno all’inizio del film. Alla fine, anche il padre di Mariuccia utilizzerà il dialetto lombardo. Tra i forestierismi si ricordano séparè (detto dal figlio della padrona della locanda dove Bruno invita a pranzo Mariuccia, per poi mollarvela) e chauffeur (detto e scritto, ma nel film compare anche il neologismo autista, proposto e accettato nel 1932 come sostituto del francesismo)78. Il film ribadisce dunque, nella trama e nei dialoghi, la morale profondamente conservatrice dei “telefoni bianchi”: l’ascesa sociale porta soltanto guai ed è bene, dunque, che ognuno si accontenti di quel che ha e rimanga al suo posto. La massima aspettativa per un uomo, dopo essersi divertito un po’, è quello di accasarsi con una donna umile e casta, senza grilli per la testa. Fortunatamente, il film di Camerini sembra lasciar spazio all’ironia, non soltanto ai danni dei ricchi e dei nobili (derisi spesso per la loro dabbenaggine, di plautina memoria, e per la snobistica ricercatezza dell’eloquio), ma anche, parrebbe, della stessa morale che intende veicolare: la battuta conclusiva del film, nella quale Bruno propone a Mariuccia di sposarlo, di non 78. Col placet della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna (cfr. RAFFAELLI 1983: 155). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 75 lavorare più e di rimanere a casa a preparare il risotto (il film è ambientato a Milano, dove il risotto è d’uopo), è pronunciata da De Sica ridendo: risata salutare (sicuramente non casuale, data la levatura del regista e dell’attore), che ammicca allo spettatore, alla critica e getta nuova luce (metafilmica?) su tutta l’opera. Un’altra commedia esemplare, dello stesso Camerini e sempre con De Sica, ormai compiutamente annoverabile nei “telefoni bianchi”, è Il signor Max, 1937, dove la morale conservatrice, con meno ironia, è assodata. Vi si racconta di Gianni, edicolante dai sogni d’oro, che ogni tanto ama concedersi un viaggio lussuoso, spacciandosi per signore: «due volte all’anno/ io voglio fare il signore/ avete capito?». Iniziando a fingersi certo ricchissimo e nobile Max Varaldo, ben introdotto nel jet set, corteggia Donna Paola (che ostenta un insopportabile birignao — o pronuncia eccessivamente scandita, specie delle affricate e delle sibilanti, impostata e vagamente settentrionaleggiante), mentre, nei panni invece di sé stesso, fa il filo alla cameriera di Paola, Lauretta. La gestione della doppia vita e del doppio amore comporta non pochi problemi a Gianni, e gustosi equivoci per il pubblico, tanto che alla fine egli deciderà di far scomparire il suo ambizioso alter ego e di sposare l’ingenua Lauretta. Anche qui figurano forestierismi («How do you do?», «very pretty», «You’re very kind», cheerio; due soli francesismi: pardon e farseur), affettati tra gli altri, da Gianni e da un suo amico, al quale Gianni confessa, irritato dalle reminiscenze liceali: «A che cosa vuoi che mi serva il greco// […]// Ho pensato che è più utile un po’ d’inglese//». Proprio l’inglese è utilizzato quale simbolo di una classe snob e boriosa e quale catalizzatore di giochi linguistici (sempre volti a screditare lo snobismo: la tecnica sarà ripresa, come vedremo, da Totò): il personaggio dell’umile giornalaio Beppe, interpretato da Virgilio Riento, ignora l’inglese e dunque pronuncia e capisce briggio per bridge (gioco di carte peraltro ignorato anche da Gianni). GIANNI: Io adesso vado a vivere con loro, faccio parte della loro coterie! 76 Il linguaggio cinematografico BEPPE: Che è? GIANNI: Sì, vuol dire che sto lì, con loro… BEPPE: Ah, codrì! (Poco dopo, il giornalaio Gianni indossa gli abiti eleganti di Max Varaldo). GIANNI: Il paletot! Come sto? BEPPE: Stai una vera… codrì!79. Ma Riento ignora anche gli elementari whisky (da De Sica affettatamente flesso anche al plurale: «sette whiskies») e beige. Lo zio di Gianni pronuncia iazz al posto di jazz e, per rimanere sulla fonetica, alcuni ricchi articolano la vibrante come uvulare (ovvero parlano con la cosiddetta r moscia), come Puccia, la sorella tredicenne di Paola. L’abilissimo mestiere di De Sica è giocato più sulla mimica e sulla gestualità che non sulla lingua, anche se non sfugge una pronuncia dell’italiano molto più “teatrale” in Max che non in Gianni e, mentre il secondo dice giovanotto, il primo preferisce giovinotto. Inoltre Max dice «siamo giunti» mentre Gianni si concede qualche romaneschismo: scenni ‘scendi’ detto al ragazzo a cui prende la bicicletta per inseguire Lauretta. 2.3.2. Ma ritorniamo al problema delle origini. Come già ricordato, il passaggio dal cinema muto a quello sonoro non fu indolore80, e questo non soltanto per ragioni tecniche (la resa dei primi sistemi di registrazione e riproduzione del suono rendeva assai problematica l’eliminazione dei rumori di fondo, particolarmente nelle scene all’aperto, e la gestione del volume, ora troppo basso per essere intelligibile, ora innaturalmente alto), 79. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 56). Di «gustose parti, volutamente parodistiche e caricaturali, di linguaggio snobistico, falsamente aristocratico» nel Signor Max parla ALLODOLI (1938: 45) [→ Antologia critica, § 4.II]. 80. Le difficoltà di transizione da un mezzo all’altro sono dimostrate anche dal basso numero di film sonori nel 1930 (6), contro i 12 film muti dello stesso anno. La proporzione si rovescia l’anno successivo: 2 film muti contro 22 sonori. Dal 1932 non vengono più prodotti film muti (cfr. BERNARDINI 1991: 891–893 e BERNARDINI 1992: 3–6). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 77 professionali (gli attori dovevano imparare daccapo a recitare, con più naturalezza rispetto alla vocalità teatrale e alla mimica ora esagerata ora troppo stilizzata del cinema muto) e produttive (tutte le Case di produzione del mondo ripartiranno da zero, costruendo nuovi impianti e ingaggiando nuove maestranze, con immensi sforzi economici), ma anche teoriche. La parola era considerata come un’impurità che veniva a contaminare lo specifico estetico dell’“arte muta”, vale a dire l’immagine in movimento, e a distogliere l’attenzione dello spettatore dalla fruizione del codice iconico. Sicuramente a sfavore del sonoro giocava anche la falsità dell’italiano dei dialoghi, che, soprattutto nei film dei primordi, mal si barcamenava tra la letterarietà ereditata dal teatro e soprattutto dalle didascalie del muto e le ambizioni realistiche, che però, come al solito, in Italia non trovavano ancora uno strumento espressivo adatto a sostituire il dialetto nella comunicazione familiare e colloquiale. È peraltro notevole che molti critici e studiosi (Allodoli, Milano, Briareo–Debenedetti riportati nella sezione antologica) e alcuni dei più illuminati cineasti (Camerini, Blasetti, Chiarini) si ponessero subito il problema di quale lingua impiegare sul grande schermo e salutassero il sonoro come una grande possibilità di svecchiamento dell’italico idioma. Secondo questi autori, il nuovo italiano cinematografico doveva essere, almeno negli intenti, antiteatrale, antiletterario e antipuristico: «intonato all’evoluzione generale della lingua e dello stile nazionale che va verso il semplice e la franchezza» (secondo il letterato e grammatico Ettore Allodoli)81; «Che linguaggio sceglierà il Cinema, fra i molti che ogni lingua possiede?» — si domandava il critico Paolo Milano — «Il più semplice, il più documentario, il più legato all’esistenza spicciola e quotidiana. Qualunque altro linguaggio più sostenuto, letterario o (come si suol dire) aulico, 81. L’Allodoli, docente di Letteratura italiana all’Università di Firenze, giornalista e narratore, fu, tra l’altro, coautore, col Trabalza, della Grammatica degli Italiani, Firenze, Le Monnier, 1934; coll’Albertoni, del Vocabolario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 1947 e col Buti della Storia della letteratura italiana, Firenze, Sandron, 1963. 78 Il linguaggio cinematografico rischierebbe d’assumere un valore artistico proprio, a tutto scapito della visione filmica, in ibrido e sterile connubio». E concludeva: «Ora, sarebbe tempo che anche il DIALOGHISTA [→ Glossario] cinematografico si associasse con lena e buon diritto a un’opera che si prosegue da più di un secolo, alla quale hanno contribuito e Manzoni e Verga e Pirandello, e a cui lavorano più o meno inconsapevolmente giornalisti e padri di famiglia e uomini della strada: la creazione di una lingua italiana di tutti i giorni»82. In un primo momento si cercò una soluzione ‘economica’, ricalcando i dialoghi relativamente dimessi di noti lavori del teatro regionale, previa attenuazione di eventuali tratti idiomatici meno comprensibili ai più. Ci si rivolse al romanesco di Petrolini (Nerone di Blasetti, Il medico per forza e Cortile di Campogalliani), al napoletano di Viviani (La tavola dei poveri di Blasetti), al vernacolo toscano di Novelli (Acqua cheta di Zambuto). Ma l’esperimento fu abbandonato dopo il 1933 per ragioni sia ideologico–culturali (ostilità del regime fascista verso il dialetto quale fomite di tendenze regionalistiche), sia anche estetiche: il dialogo talora sembrava appesantire insopportabilmente il racconto filmico, per cui ad esempio si ritenne opportuno sfoltire, in La tavola dei poveri, le battute di Viviani, già registrate in presa diretta. Nel cuore degli anni Trenta, nell’ambito d’un sistema produttivo disciplinato capillarmente da un potere politico tendente a uniformare i cittadini in ogni manifestazione di vita e persino nell’interazione linguistica (si pensi alla campagna contro il lei allocutivo [→ Glossario, ALLOCUZIONE], dal 1938), fu perseguito l’ideale di un italiano uniforme e medio, cioè regolato secondo una norma astratta, non riconducibile né all’uso teatrale o letterario né all’uso vivo, provvedendo nel contempo a isolare, per così dire puristicamente in cornice, ogni esperienza anomala: dal dialogo plurilingue (così per esempio in Il grande appello di Camerini), a quello in italiano dotato d’innesti dialettali, frequenti soprattutto nelle commedie dei ‘telefoni bianchi’, dopo il 193783. 82. ALLODOLI (1937) e MILANO (1938) [→ Antologia critica, §§ 4.I e 5]. 83. RAFFAELLI (1991: 155–156). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 79 Con la lingua, cambiano anche lo stile e i soggetti del nuovo cinema sonoro: la commedia e i film in costume diventano i generi più prolifici, soppiantando le superproduzioni storiche, letterarie e melodrammatiche in auge nel cinema muto. I modelli stranieri di riferimento saranno le commedie americane, l’operetta e le commedie tedesche e ungheresi, il teatro francese di Feydeau e testi consimili. 2.4. Anni Trenta e Quaranta: tra realismo, letterarietà e propaganda 2.4.1. Il cinema del periodo fascista ha molte anime: è, in alcuni titoli (meno di quanto si creda), cinema di propaganda. L’apice è toccato dal famigerato Scipione l’Africano, 1937, di Carmine Gallone, pieno di ostentati saluti romani e con battute del calibro delle seguenti, con lessico ricercato e sintassi complessa e ricca di inversioni: «Riposi alfine questa tribolata Italia»84; SCIPIONE: Certo avrei preferito averti al mio fianco. Come hai potuto all’amicizia di Roma, alla sicurezza del tuo regno, alla certezza della vittoria anteporre le lusinghe di una donna! SIFACE: Vuoi pretendere da un pazzo la ragione della sua pazzia! Da quando Sofonisba è entrata nella mia casa, la saggezza è uscita. L’unico mio conforto è di sapere che il maggiore nemico, il fiero Massinissa, è caduto nella stessa rete85. SCIPIONE (ai legionari): Siate nella battaglia degni del vostro passato e di Roma. Ricordate che se vincerete non soltanto diverrete padroni dell’Africa, ma darete a Roma l’impero del mondo86. 84. BRUNETTA (1977: 343). Sul cinema degli anni Trenta disponiamo ormai di una bibliografia abbastanza ricca, che può essere recuperata soprattutto nell’introduzione di Gian Piero Brunetta al bel volume di RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 11–32), pressoché in tutti i lavori di Sergio Raffaelli citati nel presente volume e in SAVIO (1975) e (1979). 85. RAFFAELLI (1994a: 277). 86. RAFFAELLI (1992: 94). 80 Il linguaggio cinematografico L’intento di film del genere è chiaramente quello di mostrare Mussolini e i suoi fiancheggiatori come ideali continuatori dei gloriosi esponenti della Roma repubblicana e imperiale. Ma, anche senza risalire all’antica Roma, si pensi a film ridondanti retorica fascista come Condottieri, 1937, di Luis Trenker, ambientato nella Firenze cinquecentesca di Giovanni dalle Bande Nere, con evidenti anacronismi linguistici e mimici (a parlare sembra proprio Mussolini, con quelle incitazioni telegrafiche: «Firenze è nostra!», «A Roma!», Camerati!): GIOVANNI: Firenze è nostra! Viva le Bande nere! A Roma! ESERCITO (Giuramento pronunciato di fronte a Giovanni, che saluta in una posa simile al saluto fascista): Nel nome di Dio onnipotente, giuro di credere al fine supremo di un’Italia grande e unita, di obbedire agli ordini del mio capo, di servire, con tutte le mie forze e fino all’ultima goccia di sangue, la sacra causa della patria! Lo giuro! GIOVANNI: Camerati! Il Gran Consiglio ci manda a casa! […] Le Bande nere sono sciolte! GIOVANNI: Chi non è pronto a morire per la sua fede non è degno di professarla!87. E a vari film di ambientazione contemporanea: UFFICIALE: Ufficiali, sottufficiali, graduati e comuni! Il nemico, accostando in fuori, si è sottratto al combattimento al quale lo aveva costretto l’azione decisa delle nostre forze. Sono contento di voi tutti. Elevate con me il pensiero ai nostri gloriosi caduti, a questi nostri cari compagni che col loro sacrificio ci hanno additato quella che oggi, domani e sempre sarà la via dell’onore, la via della gloria. DIDASCALIA FINALE: Alle sofferenze stoiche e alla fede immutabile dei feriti di tutte le armi, alla abnegazione silenziosa 87. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 151). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 81 di coloro che ne attuano le sofferenze e ne alimentano la fede88. PREGHIERA DEGLI AVIATORI: Dio onnipotente di gloria, che doni l’arcobaleno ai nostri cieli, noi saliamo nella tua luce, per cantare col rombo dei nostri motori la nostra passione. Noi saliamo verso di te dimentichi del peso della nostra carne. Noi siamo uomini. Tu, Dio dacci le ali delle aquile, lo sguardo delle aquile, gli artigli delle aquile, per portare ovunque tu doni la luce la bandiera, la vittoria e la gloria d’Italia e di Roma. Fa’ nella pace dei nostri voli il volo più ardito. Fa’ nella guerra la nostra forza la tua forza, o signore, perché nessuna ombra sfiori la nostra terra, e sii con noi come noi siamo con te89. Gli elementi della retorica oratoriale e degli slogan politici ci sono tutti: le lunghe serie allocutive («Ufficiali, sottufficiali, graduati e comuni!») — che tanto saranno derise da Totò («amici! Fratelli! Fratellastri! Compagni! Camerati! Cugini! Affini!» [Figaro qua… Figaro là, 1950, di Carlo Ludovico Bragaglia]; «macchinista! Fuochista! Ferrovieri! Facchini! Affini! Collaterali! Uomini di fatica!» [Totò a colori, 1952, di Steno e Monicelli])90 —, la sintassi elaborata, le ripetizioni («delle aquile», «la nostra forza la tua forza»), l’andamento ternario e a climax («oggi, domani e sempre»; «la bandiera, la vittoria e la gloria»), le dittologie («la via dell’onore, la via della gloria»), i chiasmi e i poliptoti («Fa’ nella pace dei nostri voli il volo più ardito», «sii con noi come noi siamo con te»), etc. Quello dell’epoca fascista è tuttavia anche un cinema alla ricerca di storie dimesse e di una lingua media (l’abbiamo visto, e lo rivedremo, con Blasetti, Camerini, Righelli e altri: emble- 88. La nave bianca, 1942, di Roberto Rossellini (RUFFIN/D’AGOSTINO 1997: 151). 89. I tre aquilotti, 1942, di Mario Mattoli (RUFFIN/D’AGOSTINO 1997: 151). 90. E altri esempi simili cit. in ROSSI (2002a: 167–168). Ma tutto lo stile retorico delle arringhe politiche è preso in giro da Totò: «Non infrangere/ non vilipendere l’integerrima categoria di coloro/ che anche sua eccellenza Togni/ nel suo ultimo discorso ha detto/ che sono/ la struttura della patria// Il cemento armato della nazione» (Totò e i Re di Roma, 1952, di Steno e Monicelli). 82 Il linguaggio cinematografico matico il realismo sognante di 4 passi fra le nuvole, 1942, di Blasetti); d’altro canto non disdegna la messa in scena (spesso ironica) della lingua borghese (con numerose pellicole dei “telefoni bianchi”: si ricordino i già citati Gli uomini, che mascalzoni… e Il signor Max) né trascura la riproduzione, benché mai integrale, dei dialetti (esemplare il blasettiano 1860, del 1934, e il cinema comico: Petrolini, Govi, De Filippo, Musco, Totò, Macario, Fabrizi e tanti altri). Sempre viva nel nostro cinema, a tutte le altezze cronologiche, è infine la seduzione della lingua letteraria, che nel periodo fascista toccherà il vertice in quell’originale mistura di arcaismo e toscanismo presente nell’adattamento blasettiano della Cena delle beffe di Sem Benelli, commentato nel successivo capitolo (§ 3.2) sui rapporti tra letteratura e cinema. In realtà, forse più ancora che letterario, il nocciolo duro della lingua filmica del periodo in questione appare scolastico e arrugginito, come si evince da numerosi tratti, talora irriflessi e decontestualizzati: dalla i– prostetica, ai pronomi egli, ella, esso, essa, ai dittonghi del tipo giuoco, e altri riportati nel brano di RUFFIN/D’AGOSTINO (1997) [→ Antologia critica, § 6]. Si tratta, comunque, di una cinematografia più complessa e interessante, meno monolitica e ingessata, anche dal punto di vista linguistico, di quanto si credesse fino a pochi anni or sono. Oggi disponiamo infatti di strumenti critici (Raffaelli, Brunetta, Micheli, Ruffin–D’Agostino e altri) e di un discreto numero di pellicole (ritrovate, rivalutate, restaurate grazie agli sforzi della filologia filmica) che meglio aiutano a mettere a fuoco questa varietà e, soprattutto, la «filmologia linguistica»91 si è ormai consolidata tanto che la componente verbale dei film non passa più inosservata, come accadeva ancora fino a dieci–quindici anni fa (da cui tanti pregiudizi sulla omogeneità di scarso interesse della cinematografia italiana del passato). 91. Così MENARINI (1955, titolo) battezzava lo studio linguistico del film, detto anche «linguistica cinematografica» a p. 9. 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 83 Sappiamo anche che, nonostante le leggi e le dichiarazioni pubbliche (sull’avversione nei confronti del “pauperismo”, anche linguistico, dei dialettalismi, dei forestierismi, dell’uso del Lei, per esempio), il cinema godeva, rispetto ad altre forme di comunicazione e di espressione artistica, di una libertà maggiore. Non a caso, proprio dalle costole filmiche italiane nasceranno alcune figure fondamentali di intellettuali antifascisti: Umberto Barbaro — animatore, insieme con Luigi Chiarini, del Centro sperimentale di cinematografia — e Visconti in primis; ma si pensi anche ai collaboratori di Vittorio Mussolini: Rossellini, Lizzani, Antonioni e altri. Questa sorta di libertà scarsamente vigilata del cinema è dovuta, in parte, alla distrazione dei legislatori e dei governanti, intenti a ben altri problemi e che preferivano affidare ad altri mezzi, quali i cinegiornali e i documentari, i messaggi strettamente propagandistici; in parte alla valutazione dei rischi sicuramente inferiori ai vantaggi del cinema, tra gli svaghi più graditi, e quindi più redditizi, degli italiani92. Né è trascurabile la presenza, tra le fila degli addetti ai 92. La nascita di Cinecittà (1937) e, due anni prima, del Centro sperimentale di cinematografia (ma già nel 1932 era in attività la Scuola Nazionale di Cinematografia, diretta da Alessandro Blasetti) fu voluta e incoraggiata dal governo mussoliniano, con evidente intento propagandistico: «Perché l’Italia Fascista diffonda nel mondo più rapida la luce della civiltà di Roma» recitava il manifesto pubblicitario della neonata Cinecittà (BRUNETTA 1991: 181). Già nel 1924 era nato l’Istituto LUCE (L’Unione Cinematografica Educativa), dedito soprattutto alla realizzazione di cinegiornali e documentari di propaganda, con qualche incursione nel cinema di finzione, anch’esso propagandistico. Gli investimenti dello Stato in campo cinematografico furono enormi (oltre all’incoraggiamento alla produzione nostrana, secondo i principi autarchici che inibivano la distribuzione di film stranieri: già nel 1935 il tetto massimo di film americani da proiettare in Italia è stabilito in 250): «Dai dati reperibili negli annuari della SIAE il pubblico, negli anni di guerra, affolla le sale cinematografiche in misura superiore agli anni di pace. Il cinema diventa il luogo privilegiato verso cui è convogliata la spesa e l’impiego del tempo libero della maggior parte della gente. Tra il 1940 e il 1942 l’incremento dei biglietti venduti è superiore del 30% e raggiunge quasi cinquecento milioni su un totale di circa 80.000 giornate di programmazione di oltre cinquemila sale sparse su tutto il territorio nazionale. Il cinema è lo spettacolo per eccellenza e gli sforzi del governo puntano a indirizzare verso questa forma di divertimento, che assorbe circa l’80% della spesa nel campo dello spettacolo. Nel 1940 si aprono 200 nuovi cinema rurali e nel 1941 sono inaugurate […] 258 nuove sale» (BRUNETTA 1991: 177). Figura essenziale, in questa fase di investimento statale sul cinema, fu Luigi Freddi (1895–1977), dal 1934 84 Il linguaggio cinematografico lavori, di esponenti illustri del fascismo: valga per tutti la figura di Vittorio Mussolini, figlio del duce, acuto e colto direttore della rivista “Cinema”, sceneggiatore (con l’anagramma di Tito Silvio Mursino), estimatore della produzione americana («Per la nostra cinematografia — scrive su “Cinema” nel 1936 — seguire la scuola americana […] può voler dire molte cose»)93 proprio mentre il padre firmava il patto con la Germania nazista. Nel cinema degli anni Trenta e Quaranta, dunque, dialetti, gerghi, varietà basse e termini stranieri trovano spazi ben più ampi che in altre forme di comunicazione coeve. Tutta questa variegata ricchezza ci è documentata, oltre che dai dialoghi filmici stessi, dai fiumi di inchiostro scorsi sui periodici specializzati dell’epoca (oltre a “Cinema”, si vedano “Bianco e nero”, “Lo schermo” e altri) per tentare di giustificare, di far capire al pubblico, le ragioni di questa scelta così originale e, almeno nel panorama della comunicazione letterario–spettacolare italiana, davvero rivoluzionaria. Proprio per questo, la sezione antologica del presente volume raccoglie alcuni interventi significativi di critici cinematografici, perlopiù ormai dimenticati (lo stesso Debenedetti, in arte Briareo, era praticamente trascurato, fino a pochi anni fa, nella sua attività di filmologo), utili non soltanto per capire la temperie culturale del periodo, gli intenti dei cineasti e i gusti del pubblico, ma anche, ciò che più ci interessa in questa sede, il clima linguistico, l’atteggiamento di chi con l’italiano doveva cimentarsi dal punto di vista pratico, oltreché estetico–terorico, per salvaguardare tre diversi orizzonti di attesa del pubblico apparentemente inconciliabili: la comprensibilità più vasta possibile (pena la scarsa vendibilità del film), la voglia di sognare e dunque di sentir parlare una lingua diversa (da persone benedirettore generale per la cinematografia e dal 1940 presidente e amministratore delegato di Cinecittà. Su Freddi cfr. BRUNETTA (1991: 186–188), RAFFAELLI (1992: 91–94), AA. VV. (1995b: 53–54). Si veda anche la produzione dello stesso Freddi (FREDDI 1929 e 1949). 93. BRUNETTA (1991: 187). Più volte viene evocata l’interessantissima figura di Vittorio Mussolini in SAVIO (1979: I, 31; III, 964–966 et passim). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 85 stanti e “per bene”) dalla propria, il realismo delle trame e dei dialoghi. Gli articoli citati mostreranno così l’urgenza di problemi che oggi fanno quasi sorridere ma che settant’anni fa (ma a volte solo cinquanta: Menarini) allarmavano non poco autori e studiosi: è possibile infrangere le regole grammaticali in nome della verosimiglianza scenica? Dove reperire un parlato medio, credibile, senza usare il dialetto? Con quale italiano tradurre l’agile freschezza dei copioni americani? Fino a che punto ci si può spingere nell’accogliere forestierismi, gergalismi, popolarismi e colloquialismi? E probabilmente questi articoli poco noti, insieme con l’azione semisommersa di tanti dialoghisti, adattatori e direttori di doppiaggio, hanno contribuito allo svecchiamento (o forse sarebbe più corretto dire alla creazione) di quell’italiano parlato dell’uso medio («la creazione di una lingua italiana di tutti i giorni», come scriveva, con tanto di corsivo enfatico, il già citato MILANO 1938: 11), cui, in realtà, il teatro (almeno a partire da Goldoni, senza citare i comici cinque–secenteschi, dal Della Porta alla COMMEDIA DELL’ARTE [→ Glossario], secoli prima, dunque, di arrivare al «parlato–recitato»94 verista e poi pirandelliano) e la letteratura (dalla Quarantana dei Promessi sposi in poi) erano già arrivati da tempo. 2.4.2. Un utile indicatore della relativa libertà espressiva del cinema in un clima di dirigismo linguistico e di autarchia è dato dalla cospicua presenza di forestierismi nei dialoghi dei film degli anni Trenta, come documentato dalla ricerca condotta da RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 43–76). Come illustrato da RAFFAELLI (1983), l’autarchia linguistica in Italia ha origini ottocentesche ma è durante il ventennio fascista che raggiunge l’acme della produzione legislativa, a partire dal decreto–legge 11 febbraio 1923, che stabiliva una tassazione quattro volte superiore per le insegne commerciali («qualunque forma di avviso, richia94. Secondo l’ormai classica etichetta di NENCIONI (1976/1983: già nel titolo). La nozione di italiano dell’uso medio, o neostandard, è stata messo a punto da SABATINI (1985) e messa in discussione da CASTELLANI (1991) e (1994). 86 Il linguaggio cinematografico mo di pubblicità o indirizzo relativo allo esercizio di industrie, commerci, professioni e qualsiasi attività a fine di lucro»)95 redatte in lingua straniera, fino al decreto–legge 5 dicembre 1938 e alla legge 23 dicembre 1940, che di fatto vietavano ogni utilizzazione di parola straniera (dapprima, nomi propri compresi) scritta nei pubblici esercizi, passando per il decreto–legge 5 ottobre 1933, che prescriveva «la doppiatura in italiano di tutti i film importati, da compiersi con personale artistico e tecnico esclusivamente nazionale»96, e il decreto–legge 4 settembre 1938 (l’anno funesto — il peggiore del regime — del divieto del Lei e, ovviamente soprattutto, delle leggi razziali), che rendeva la distribuzione dei film stranieri monopolio di Stato, con conseguente ritiro delle grandi case hollywoodiane dal mercato italiano. Per non parlare delle disquisizioni e delle pubblicazioni sui vocaboli stranieri da evitare e sui loro possibili sostituti italiani: tra i più noti, Barbaro dominio. Cinquecento esotismi esaminati, combattuti e banditi dalla lingua con antichi e nuovi argomenti, storia ed etimologia delle parole e aneddoti per svagare il lettore, di Paolo Monelli, Milano, Hoepli, 1933, e le liste di vocaboli destinate all’«eliminazione razionale dei barbarismi radicatisi nel nostro idioma», curate dalla Commissione dell’Accademia d’Italia «per l’italianità della lingua», a partire dal 14 febbraio 194197. La proibizione di nomi propri stranieri, tra l’altro, ebbe come conseguenza, nel nostro spettacolo teatrale e cinematografico, il riassetto dei teatronimi [→ Glossario, TEATRONIMO], fino ad allora comunemente esotici, e l’italianizzazione temporanea di attori già famosi: Wanda Osiris diventa Vanda Osiri, Lucy D’Albert Lucia D’Alberti, Renato Rascel Renato Rascelle. Senza dire poi della pletora di rubriche, lettere, disposizioni e veline che lasciavano inequivocabilmente percepire il clima esterofobo e dialettofobo dei tempi. 95. RAFFAELLI (1983: 127). 96. RAFFAELLI (1997b: 31–32). 97. Cfr. RAFFAELLI (1983: 246–251). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 87 Ma vediamo qualche esempio concreto, oltre a quelli già citati sopra, di forestierismi nei dialoghi filmici, a partire da Ma non è una cosa seria, 1936, di Camerini. Nell’originale pirandelliano, l’unico forestierismo è champagne, cui Camerini e sceneggiatori (Mario Soldati — lo sceneggiatore più illustre dell’epoca — e Ercole Patti) aggiungono restaurant, nécessaire, smoking, frac, cocottes, taxi, walzer, bar, sleeping–car. Ancora più evidentemente degli altri film di Camerini, l’uso e l’abuso dell’inglese e del francese simboleggiano qui la bassa caratura morale di una classe ricca, mondana e decadente, in una parola imbelle. La sottile crudeltà delle convenzioni sociali (criticata tanto da Pirandello quanto da Camerini) risulta evidente dal brano seguente, nel quale gli amici del ricchissimo Memmo non gli perdonano di aver sposato l’umile Gasperina; egli d’altronde si prende la rivincita sull’abbigliamento “da cameriere” del suo interlocutore Barranco: BARRANCO (prende Memmo in disparte): Lei ha fatto molto male a portare la signorina Gasperina in questo posto! Non è ambiente per lei! MEMMO: È il circolo migliore! BARRANCO (accalorandosi): Ma che migliore, mi faccia il piacere! Sono dei villani! Chiamano la gente a distanza: “Pss–pss… pss–pss”… “Un caffè!”… ALTRO SIGNORE (accostandosi): Ciao, Memmo! MEMMO: Ciao! BARRANCO (riprendendo il discorso): …“Una menta!”… ALTRO SIGNORE (a Barranco): Queste mente, scusi, le porta o non le porta? BARRANCO: Sente che roba? MEMMO: Scusi, cavaliere, lei… lei ha la cravatta nera… BARRANCO: Sì. E lei come ce l’ha? MEMMO: Beh, io ho lo smoking, lei ha il frac! BARRANCO: Non è lo stesso? MEMMO: Eh, no! Così la prendono per cameriere… BARRANCO (imbarazzato e offeso, aggiustandosi la cravatta): Cameriere?… A me?98. 98. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 49–50). 88 Il linguaggio cinematografico Talora i “barbarismi” compaiono proprio con intento puristico, come accade, anche se non senza certa ironia, nel film di Blasetti Contessa di Parma, 1937, sull’italianizzazione del lessico francese della moda: INDOSSATRICE: Sono una mannequin alla Maison Printemps! SIG.RA ROSSI (con scherno): Ah ah! Printemps…. Primavera! Non sente come è più bello! Primavera!! Dunque lei è un’indossatrice ai magazzini Primavera… INDOSSATRICE: Non ho mai visto un modello così grazioso. Soltanto l’idea di quei revers… SIG.RA ROSSI: Si dice risvolti! Beh, l’idea di quei risvolti? IMPIEGATO: È l’abito da sposa che chiuderà il defilé… ehm… la sfilata! EX DIRETTORE: Entendu… ehm è inteso! CONOSCENTE: Scusi, lei è campione di cosa? Di football o di automobile? GINO (seccato): Di calcio!!99. Analogamente in Tempo massimo, 1934, di Mario Mattoli: BIGLIETTAIO: …allora lei deve scendere a Pont saint Martin… GIACOMO (De Sica): Ponte di San Martino? BIGLIETTAIO: Sì. GIACOMO: Ecco, allora mi dia una prima per Ponte di San Martino e una prima per Roma. L’argine, 1938, di Corrado D’Errico: M AESTRO : Ma perché non vi decidete a comprare un pince–nez? TUDA: Che? MAESTRO: Uno… stringi–naso, quell’occhiale così… (si spiega con un gesto). 99. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 52). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 89 TUDA: Troppo lusso, caro voi, e poi io ci vedo benissimo! O in Torna, caro ideal!, 1939, di Guido Brignone: MAGGIORDOMO: Preparare un toast è un’arte! Bisogna essere stati all’estero per capire certe cose! ROSALIA: Ma che toast e toast me vai cuntann’? Chi è ’sto toast? E chiàmmalo pane abbrustolit’! Cà simu tutti quant’ fratre!100. Nonostante le numerose proposte (da parte di linguisti — Migliorini in testa —, giornalisti, politici e dilettanti di vario genere) di termini italiani sostitutivi, il cinema sembra […] nel complesso partecipare della comune tendenza dei parlanti alla conservazione linguistica, e preferisce perseverare nell’uso dei forestierismi, piuttosto che adottare sostituti dall’esito ancora incerto. Non solo cocktail non cede mai a zozza, né tennis a pallacorda, o bridge a ponte, ma pugilista è in netta minoranza rispetto a pugile e boxeur, e non si incontra mai un’altra voce proposta all’epoca: pugilatore. Il prolisso e poco affascinante giacca con le code (Villa da vendere, 1942) compare una sola volta contro le numerose occorrenze di frac. L’espressione quel certo non so che ha un certo successo, ma è difficile dire se sul suo uso abbia influito la proposta avanzata da alcuni di adottarla come sostituto di sex–appeal; quest’ultima voce resiste comunque in Papà per una notte e L’amore si fa così (1939). D’altronde, anche esotismi come garage e boxe, che sembrano nel complesso sconfitti, ricompaiono talvolta anche negli anni di guerra. […] [Nonostante questo], il cinema sonoro degli anni trenta non è sordo alla contemporanea campagna purista, facilitata nel suo compito dalla diffusione nei film di umori antisnobistici e populisti, e dall’occasionale […] fiancheggiamento all’autarchia […]. [S]embra possibile schematizzare come segue l’andamento cronologico delle ricorrenze dei forestierismi nel cinema: 1930–35: uso apparentemente disinvolto degli esotismi; 1936–39: si rinforza il loro uso nell’ambito della caratterizza- 100. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 53). 90 Il linguaggio cinematografico zione (negativa) dei personaggi snob, e iniziano a comparire le forme sostitutive; in qualche caso il rifiuto delle voci straniere è sottolineato in maniera esplicita dal dialogo; 1940–44: frequenza bassa e crescente affermazione delle forme sostitutive101. Nell’ultimo periodo considerato, alle lingue straniere, e soprattutto all’inglese, è assegnata una valenza quasi assolutamente negativa: quella di Albione è la lingua dei cattivi, dei nemici e dei traditori: MAGGIORE: Sit down, do you speak English? INDIANO: Yes, but don’t want! MAGGIORE: Non vuoi parlare inglese? Hai ragione! Anche a me non piace! Adesso che imparerai l’italiano, vedrai che bella lingua!102. Sempre discriminatorie (perché volte alla ridicolizzazione) sono le innumerevoli stilizzazioni della lingua dei neri (con SONORIZZAZIONE [→ Glossario] consonantica, infinito tuttofare, lessico poverissimo, assenza di allocutivi di cortesia: memorabile la Mammy di Via col vento [Gone with the Wind], 1939, di Victor Fleming, la versione italiana è del 1949), presenti già nelle didascalie del muto e sviluppatesi poi nel doppiaggio: Dove scarigare guesto? (Montevergine, 1939, di Campogalliani)103. 101. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 66–69). 102. Giarabub, 1942, di Goffredo Alessandrini (RUFFIN/D’AGOSTINO 1997: 144). 103. Quest’uso dell’infinito caratterizza anche la lingua dei romanzi coloniali (cfr. RICCI 2005: 140–141) e talune battute pronunciate dagli indiani nei film western. La storia degli stereotipi linguistici volti a svalutare lo straniero, il “diverso”, nel cinema italiano e americano, è ancora tutta da scrivere, anche se non è questa, ovviamente, la sede per farlo. Interessante, tra l’altro, sarebbe anche lo studio della lingua dei “primitivi” nel cinema, da Tarzan («Io Tarzan/ tu Jane») a Quando le donne avevano la coda, 1970, di Pasquale Festa Campanile (qualche accenno su questi argomenti si trova nel § 6.1.7 e in ROSSI 2006b). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 91 Per quanto riguarda il Lei allocutivo di cortesia (ritenuto, erroneamente, colpevole di essere poco italiano e di piacere molto agli imbelli e boriosi borghesi, al pari di tanti forestierismi), il cui uso fu vietato (a favore del Voi) il 14 febbraio 1938 con Disposizione del Partito nazionale fascista104, anche qui il cinema godette di una certa libertà. A fronte della netta predominanza del Lei sul Voi nei film prima del 1938, qualche Lei permane anche dopo la legge, per es. in Luciano Serra pilota, 1938, di Goffredo Alessandrini, Giuseppe Verdi (anche noto come Divine armonie), 1938, di Carmine Gallone, L’argine, 1938, di Corrado D’Errico, Montevergine e altri. Diverso il caso del doppiaggio, dove il Voi è da sempre (e fino ad anni recenti) la forma prediletta. Ma in questo caso, più che la lunga tenuta di un’abitudine fascista andrà invocato il pedissequo adattamento di You e Vous del dialogo originale. Torniamo per un momento a parlare di Luciano Serra pilota, film emblematico della «fascistizzazione imperfetta»105 del cinema italiano. Supervisionato da Vittorio Mussolini, il film sembrerebbe avere tutte le carte in regola per essere un’opera di propaganda: il divo (caro al fascismo) Amedeo Nazzari vi interpreta il ruolo del pater familias virile, coraggioso, orgoglioso e antiborghese (nell’avversione per il ricco suocero), che dà la propria vita per salvare quella del figlio, pilota nella campagna d’Africa (dove, ovviamente, gli africani sono ritratti come infami assassini). Eppure i dialoghi presentano un agile e credibile italiano dell’uso medio ben lontano da ogni retorica (che invece è tutta nei concetti e non nelle parole). Eccone qualche assaggio: «Ma guarda un po’ che iella!» esclama Nazzari nella prima parte del film, per aver perso alcuni clienti dei suoi voli turistici 104. Su tutta la storia di questa norma cfr. RAFFAELLI (1993c) e (2000). Il divieto comportò anche curiosi voltafaccia, come quello noto dell’Allodoli, che nell’articolo del 1937 [→ Antologia critica, § 4.I] preferiva il Lei al Voi, mentre un anno dopo plaudiva alla sparizione del Lei come «affermazione di cameratismo e di comunanza di fede che stringe nelle espressioni di colloquio e di scrittura tanti milioni di italiani» (RUFFIN/D’AGOSTINO 1997: 70–71). 105. BRUNETTA (1991: 179). 92 Il linguaggio cinematografico sul lago Maggiore; «Uffa/ che barba!» esclama il piccolo Aldo Serra; «Sei un ometto» dice Nazzari al figlio Aldo. Due dislocazioni a sinistra nella battuta seguente, ancora di Nazzari: «La luce ce l’hanno tagliata// Ma le sedie non le hanno ancora portate via//». Compare anche l’esclamazione perdio, tipica delle riproduzioni del parlato colloquiale anche se priva, allora, di ogni intento blasfemo: «Perdio! Tutto il gruppo in volo! Se ne occupi lei/ capitano!» dice il comandante Morelli alla fine del film, per salvare le vittime dell’assalto al treno. Come già accennato, l’allocutivo di cortesia è il Lei e non il Voi. Neppure il cameratesco Tu, come si vede nell’ultimo esempio, compare. Non mancano i forestierismi: angar ‘rimessa per aerei’ (dal fr. hangar); una cliente chiede al barista dell’albergo «Un’aranciata con molto selz». Vari iberismi, nel periodo sudamericano di Serra: «Muy bien»; «Como va/ amigo?»; Lucianito, señorita, e altri. Gli annunci del decollo di Serra vengono fatti in varie lingue (inglese incluso). Un neologismo: atterrare in accezione aeronautica, glossato dal suocero di Serra: «atterrare/ come dite voi». Ovviamente qua e là affiora la retorica fascista, comunque ridotta al minimo. Per es. nel discorso del comandante Morelli agli allievi dell’accademia per incitarli alla missione d’Etiopia: «Sono certo/ che condividerete con me/ l’orgoglio/ di rispondere fra i primi/ alla voce della patria//». E nel discorso finale, sempre di Morelli, al conferimento della medaglia d’oro al valore in memoria a Luciano Serra: «In seguito alla ferite riportate/ decedeva// Offrendo in olocausto/ per la gloria di quelle ali dalle quali invano/ il destino aveva tentato di allontanarlo// Fulgido esempio di altissime virtù militari//». 2.4.3. Numerosi film del periodo considerato, come s’è già visto negli esempi dei “telefoni bianchi”, esibiscono dialoghi in un italiano agile e scorrevole senza indulgere al dialetto (fatta salva qualche battuta di colore nei personaggi secondari). Tra questi, piace qui ricordare Via delle Cinque Lune, 1942, primo film di Luigi Chiarini, teorico cinematografico — oltreché regi- 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 93 sta —, direttore e docente del Centro sperimentale di cinematografia e fondatore, nel 1937, del periodico “Bianco e nero” (la principale rivista cinematografica dell’epoca, insieme con “Cinema”). Il film, liberamente tratto da un racconto di Matilde Serao, mette in pratica le teorie del Chiarini e si configura come un film–saggio (di raffinata fattura) del Centro sperimentale, girato nei suoi studi e con i suoi allievi e docenti (alla sceneggiatura collaborarono col Chiarini Umberto Barbaro e Francesco Pasinetti, figure–chiave del Centro). Via delle Cinque Lune, spesso tacciato di freddo calligrafismo e di bozzettismo, interessa in realtà proprio per le soluzioni linguistiche, del tutto in linea con la ricerca di un linguaggio «immediato, aderente alla condizione sociale dei personaggi e all’ambiente, assai vicino al parlare comune e alieno da qualsiasi artificio letterario», perseguita da Chiarini106. Vediamone qualche esempio: «Io piuttosto mangio pane e sputo/ ma lo strozzino/ abbi pazienza no!» esclama indignato Federico contro la seconda moglie Teta. Ecco come il protagonista Checco, sotto le mentite spoglie di un amico, perora la propria causa con la sora Teta (come la chiamano tutti, alla romana), matrigna di Ines di cui Checco è innamorato: Eh l’amore/ l’amore! I guai ce li danno a noi! Sai tu cj hai faccia tosta/ hai presenza di spirito/ mi fai un piacerone/ se sei un vero amico! E uno si crede di trovare chissà che arpia/ e invece si trova davanti una donna come voi! Ehm… non… non si capisce se… se è la madre o la figlia// Beh/ si sa/ uno ci rimane come un carciofo//: tra i numerosi tratti di italiano parlato (dislocazioni, ci “attualizzante”, esitazioni, alterati espressivi come piacerone, lessico popolare come carciofo) non figura il dialetto, neppure 106. Il brano da cui è tratta la citazione (CHIARINI 1957) è interamente leggibile nella → Antologia critica, § 2. Sulla trasposizione dalla novella della Serao (O Giovannino o la morte, ambientata a Napoli) al film cfr. CHIARINI (1942). 94 Il linguaggio cinematografico nella pronuncia (impeccabilmente italiana e cinematografica) dell’attore. Si tratta proprio di quel tipo di lingua, prettamente filmico, fatto a posta per non interferire con le immagini, lontano tanto dallo scritto letterario quanto dal parlato reale, proposto dal Chiarini e che tanta fortuna avrà nella cinematografia successiva (almeno fino alla COMMEDIA ALL’ITALIANA [→ Glossario] inclusa e al doppiaggio odierno). Tra le battute dialettali (romanesche), perlopiù umoristicamente connotate e limitate a personaggi di contorno: «A sora Te’/ er tempo che ce vo’! Nun so’ mica fiaschi che s’abbottano/ se ha da esse un lavoro fatto a regola d’arte/ no?!» (dice l’operaio a Teta che lo sollecita). Non manca, tra le note di colore folclorico, un fin troppo prevedibile sonetto del Belli su piazza Navona, recitato in un’osteria, fittiziamente (ricostruita in studio) collocata nella stessa piazza. Un ruolo notevole nello svecchiamento della lingua cinematografica è quello sostenuto dal contingente di sceneggiatori comici, quali Achille Campanile, Vittorio Metz, Marcello Marchesi, Federico Fellini, Stefano Vanzina (Steno), naturalmente con il contributo fondamentale dei registi (Mattoli, Bonnard, Bragaglia) e degli attori (Macario, Totò, Fabrizi, Magnani, Rascel…). Molte delle personalità qui appena citate provenivano dal teatro popolare comico (avanspettacolo e RIVISTA [→ Glossario]) e dalla stampa umoristico–satirica (in primis le celebri riviste “Marc’Aurelio” [1931–1954] e “Bertoldo” [1936–1943])107. Ecco dunque che nel cinema comico italiano cominciano ad alloggiare stabilmente dapprima i nonsense e i giochi di parole e poi l’impiego dei dialetti e delle lingue straniere (con stravolgimenti più o meno fantasiosi) con funzione più ludica che realistica e spesso prettamente espressionistica108. 107. Sulla relazione tra cinema e teatro comici e stampa umoristica cfr. GIACOVEL(1995: 17) e ROSSI (2002a: 27 n. 23 e relativa bibliografia). 108. Diamo ormai per assodata l’etichetta di espressionismo attribuita a Totò e ad altri comici già da Contini e poi da De Mauro, Meldolesi e altri (Cfr. ROMEO 1998b: 88 e ROSSI 2002a: 20–21, 39–40). LI 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 95 Ma, ovviamente, anche nei film comici apparentemente più innocui possono annidarsi pericoli per il regime. Per aggirare i divieti della censura (che, tra l’altro, già a partire dal 1923, vietava ogni «rappresentazione di scene offensive del pudore, della morale, del buoncostume e della pubblica decenza; di fatti contrari alla reputazione e al decoro nazionale e all’ordine pubblico, o che turberebbero i rapporti internazionali», etc., come per es. la rappresentazione «di scene, fatti o soggetti truci, ripugnanti e di crudeltà anche se a danno di animali; di delitti e di suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche e di fenomeni ipnotici e medianici; ed in generale di scene, fatti e soggetti che possono essere di scuola e incentivo al delitto»)109, molti film vengono ambientati all’estero o in un imprecisato passato. Addirittura, nell’esilarante Imputato, alzatevi!, 1939, di Mattoli — il maggior successo di Macario e il primo chiaro esempio di collaborazione tra scrittori umoristi (alla sceneggiatura lavorarono, più o meno accreditati, Vittorio Metz, Carlo Manzoni, Giovanni Guareschi, Marcello Marchesi, Steno, Ruggero Maccari, Federico Fellini e altri ancora), attori di rivista e cineasti — l’ambientazione parigina è evidentemente ritenuta insufficiente a far ingoiare ai censori una trama contenente, tra l’altro, l’abbandono di un bambino e un omicidio, e viene pertanto aggiunta una didascalia che intende prevenire il divieto: «Tutto ciò che accade in questo film è di pura fantasia e non vuol essere altro che una caricatura di fatti e istituzioni fortunatamente ben lontani dal nostro clima»110. Varrà forse la pena di ricordare che, anche se in forma più occulta, la paura nei confronti di argomenti scottanti che potessero screditare il buon nome dell’Italia all’estero perdurerà ancora negli anni Cinquanta. Oltre al noto giudizio negativo dell’onorevole Giulio Andreotti su Umberto D., colpevole, secondo lui, di mostrare agli altri i nostri panni sporchi111, Martin Scor109. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 86). 110. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 87). 111. Cfr. BRUNETTA (1991: 348, 422). 96 Il linguaggio cinematografico sese, nel suo bel film–saggio Il mio viaggio in Italia (1999, utilissima antologia dei principali film italiani, da Pastrone a Fellini, commentati dal regista americano), ricorda che alcuni film di Rossellini (Europa 51, 1952; Viaggio in Italia, 1954), nel doppiaggio dall’inglese (lingua parlata dagli attori stranieri del film in presa diretta, Ingrid Bergman inclusa) all’italiano, subirono una sorta di depurazione dei dialoghi: senz’altro non doveva esser facile, per le autorità di allora, digerire argomenti quali il suicidio (perlopiù infantile), la crisi di coppia e la dissoluzione della fiducia nei valori borghesi di rispettabilità e di benessere. L’incipiente Commedia all’italiana, dedita com’era all’ironia di costumi e malcostumi di casa nostra, non poteva non riflettere questo clima avverso al NEOREALISMO [→ Glossario]: tra le tante piccole prove, una battuta della moglie di Sordi (l’attrice Luisella Beghi) nella Bella di Roma, 1955, di Luigi Comencini, la quale, all’uscita dal cinema, si scaglia contro «questi film italiani/ pieni di stracci/ di miseria…», rifacendo il verso alla strumentale indignazione andreottiana. Sulla lingua di Totò (come degli altri personaggi sopra citati) si parlerà in gran parte nel quarto capitolo. Qui si aggiunga qualche esempio dai primi film, forse meno pirotecnici dei successivi, e quasi privi di presenze dialettali (San Giovanni decollato a parte), caratterizzati da una vena nonsense cara ai futuristi. Oggetto dell’ironia di Totò e compagni sono prima di tutto le lingue speciali, il burocratichese e tutte le formule cristallizzate e in generale gli automatismi linguistici: TOTÒ: Il funzionario civico municipale/ è un aggettivo qualificativo di genere funzionatorio// Il funzionario/ fisiologicamente funziona/ con la metamorfosi estiva della metempsicosi// La metamorfosi del funzionamento/ muove la leva idraulica delle cellule che agendo sull’arterioscleròsi del soggetto patologico/ lo fa funzionare nell’esercizio delle proprie funzioni// Hai capito? BAMBINA (Miranda Bonansea): No// TOTÒ: E neanche io// (Fermo con le mani!, 1937, di Gero Zambuto). 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 97 TOTÒ: La scimmia/ non è proprio una bestia del regno animale// Ma bensì/ una metamorfosi vulcanica/ dell’umanità integerrima// La paratomia dell’uomo sintetico/ è una sintesi delle cellule umanitarie/ che/ a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile/ escludendo ben inteso la parte addominale delle mucose logiche/ abbiamo il nervo simpatico/ che soffre d’antipatia e simpatia// Così/ che/ calcolando/ la distanza epidermica/ fra/ l’uomo e il gorilla/ assistiamo/ al caso specifico/ della vostra perfetta rassomiglianza/ con lo scimpanzé// È chiaro? Ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico// Ed è appunto attraverso questo suo linguaggio/ che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico// È chiaro? (Due cuori fra le belve, 1943, di Giorgio C. Simonelli). Tra le formule più care all’ironia di Totò ricordiamo almeno che che, no no, è (o fa) d’uopo, a prescindere, etiandio, il già citato affini e collaterali, «Io sono un uomo di mondo» e il celeberrimo «quisquilie, bazzecole e pinzillacchere». La parodia dei settorialismi ha origine antichissima (almeno dalla Commedia dell’Arte) e trova la sua prima applicazione filmica con Petrolini (sulla scorta di Molière) nel Medico per forza, 1931, di Carlo Campogalliani. Nel celebre brano del ciabattino, Totò rivendica le proprie conoscenze in materia, combinando espressionisticamente lessico scientifico, latino più o meno inventato («in primis et antimonio»), italiano deformato (pipistrello per polpastrello) e gergo “ciabattinesco”: AGOSTINO (Totò): (al calzolaio, che rivendica ventotto lire per un paio di scarpe) Menzoniero! Queste sono scarpe da fiera! CALZOLAIO: Da fiera! AGOSTINO: Da fiera! (ride) Degne di… sette lire/ sei e cinquanta al massimo// CALZOLAIO: Sei e cinquanta! AGOSTINO: Sì/ sì/ sì// CALZOLAIO: Ma che ne capite voi/ signor mio? AGOSTINO: Che ne capisco io?! CALZOLAIO: Eh// 98 Il linguaggio cinematografico AGOSTINO: Come/ che ne capisco io! O mamma! Che ne capisco io! (ridendo, togliendosi i guanti e strappando la scarpa di mano al calzolaio) Dai qua! In primis/ et antimonio/ una scarpa fine si fa di capretto/ o di vitellino di latte// CALZOLAIO: Perché/ questo qua che cos’è? AGOSTINO: Questo qua che cos’è? Ah ah! Questa è la madre/ del vitello// Chiamata volgarmente/ vacchetta// NONNO: Che professore! AGOSTINO: Secondis// Questa tinta/ è fatta col vitriuolo! CALZOLAIO: No// AGOSTINO: Sì! sì! Vitriuolo// E difatti/ un signore/ appena sopra/ vi poggia/ il dito/ del pipistrello della mano/ se lo… se lo sporca// Se lo anilifica// (mostrando il dito) Guarda// Terzis// Terzis/ questa suola/ non è battuta a dovere// E difatti/ dopo un giorno/ o due/ di marcia/ o di camminamento a piedi/ mette fuori la lingua/ come un cane da caccia// Ancora due parole// Non ho finito verbo// Gli elastici/ sono di cotone// E non di seta! E perciò cedono// Vedi// Vedi/ che cedono// La tremezza/ è usata/ fraudolente// I punti di questo guardione/ sono dati con la zappa/ e non con la lesina// Dico/ lesina// Ed infine/ mio caro amico/ le solette interne/ guarda/ CALZOLAIO: Piano! AGOSTINO: Che piano! Sono di cartone/ e non di pelle// FIGLIA: Papà! GENERO: Professore! AGOSTINO: Perciò/ mio carissimo signor ciabattino/ queste scarpe sono da fiera// Sei e cinquanta// E se non sapete fare il calzolaio/ andate a fare il farmacista! Che è meglio! Rimembris/ omnibus// Cioè/ ricordati/ uomo// Che calzolaio si nasce! Non si diventa! Ah ah! Ostregheta! (San Giovanni decollato, 1940, di Amleto Palermi). Ma anche l’italiano aulico, enfatico, teatrale e letterario, del tutto decontestualizzato, è oggetto di ironia: TOTÒ: Non vi spaventate// I.. io non sono che/ un’ombra// U… u… u… una larva// Un fantasma gentile/ un passante// Un Romeo/ di passaggio// Anzi/ di sottopassaggio// Ih ih// Un innamorato errante// Un grido! Un grido solo/ e voi vedete quest’uomo che vi sta dinanzi/ folle/ per avervi/ potuto turbare/ percuotersi/ con autopercosse// (dandosi degli schiaffetti sulla guancia, tirandosi un orecchio, emettendo dei gridolini) Ah ah ah// Eh sparire// Nel buio! Per sempre! Sì! 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 99 LAURA: Ma insomma/ si può sapere chi siete?! Che cosa volete! TOTÒ: Chi… chi… chi lo sa// No… non lo so// Comunque/ non vi adombrate// Forse/ voglio morire vicino a voi// Così/ senza un lamento// In una notte da brivido// (s’avvertono un lampo e un tuono) Il lampino! Co… con le suole di gomma// Sì// E il cuore… […] A prescindere// Pensate a me// Prima/ e dopo il pasto// (Due cuori fra le belve). ARISTIDE (Totò): È appunto con lui/ che io deggio favellare// CAMERIERA: Come? Come dite? ARISTIDE: Volgarmente/ parlare// (Il ratto delle Sabine, 1945, di Mario Bonnard)112. 2.5. Il Neorealismo 2.5.1. Alla base della lingua del cinema neorealistico c’è un paradosso: se si voleva una ripresa documentaria acusticamente fruibile bisognava necessariamente sacrificare il realismo verbale del film mediante il ricorso al doppiaggio. Per poter ottenere la massima verosimiglianza dell’immagine e anche per la limitatezza dei mezzi economici a disposizione, registi e produttori dell’immediato secondo dopoguerra (o a guerra ancora in corso, nel caso di Roma città aperta) decisero infatti di avvalersi perlopiù di attori non professionisti e di girare le scene preferibilmente in esterno o comunque non in studi cinematografici, distrutti nel conflitto. Naturalmente, la prima soluzione scelta, dal punto di vista fonico, fu quella della recitazione in presa diretta. Tuttavia, alla fine della lavorazione dei film, di fronte all’inadeguata resa sonora (sia per via delle riprese in esterno, sia soprattutto per l’inesperienza recitativa degli attori, che, quand’anche straordinariamente espressivi iconicamente, si rivelarono sgradevoli e incomprensibili all’ascolto), i cineasti furono costretti a sincronizzare gran parte delle scene servendo112. Per un’ulteriore esemplificazione dello stile espressionistico di Totò si rimanda a ROSSI (2002a). 100 Il linguaggio cinematografico si di doppiatori di professione, adottando peraltro una soluzione già ampiamente consolidata nel cinema italiano (si veda il § 5.1.2). Il risultato, che fu acusticamente quasi sempre buono, non poté non comportare uno scollamento tra codice iconico e codice verbale (ribadito dal pessimo sincronismo labiale, inevitabile per via delle forti manipolazioni apportate al testo del film rispetto alle battute pronunciate in presa diretta) e certi tratti di innaturalezza nella depurazione (quando non contraffazione) dei fenomeni dialettali più peculiari. Il caso emblematico (ma ricordato raramente) è quello di Lamberto Maggiorani, lo straordinario interprete di Antonio Ricci in Ladri di biciclette, prelevato da De Sica dalla Breda romana. Egli parla sullo schermo con la voce di un doppiatore (forse Mario Bucciarelli), che peraltro, in questo raro caso, conserva una pronuncia singolarmente realistica. Del resto, nello stesso film, è riconoscibilissima la voce di Alberto Sordi in uno dei venditori di Piazza Vittorio. Il fatto che quasi nessuno, allora ma neppure oggi, si sia interessato al problema del doppiaggio dei film italiani del Neorealismo dimostra da un lato che si trattava di un controsenso sgradevole (quasi una vergogna) e quindi da rimuovere, dall’altro che il cinema (artisticamente orientato) continua erroneamente ad essere percepito dalla critica come “pura” immagine, con una componente verbale del tutto accessoria. Occorre inoltre precisare che i film propriamente annoverabili nella corrente detta Neorealismo (che, in quanto nome di una corrente cinematografica specifica, scriveremo sempre con l’iniziale maiuscola, per distinguerlo dal generico neorealismo individuato da vari autori in altri ambiti) sono pochi, se per Neorealismo debbono intendersi non certo il semplice uso del plurilinguismo né le riprese in esterno o la rappresentazione di ambienti umili e degradati (tutti elementi già presenti nella cinematografia degli anni Trenta, come vedremo meglio nel § 4.1)113, bensì la capacità di elevare a ruolo di protagonisti tutti 113. Oltre alla più volte richiamata vocazione al vero del cinema delle origini, 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 101 quei personaggi (con la loro lingua e il loro ambiente) fino ad allora relegati a ruoli marginali — limitati a trame perlopiù di svago — e di utilizzarli (di solito coralmente) come portavoce dell’ideologia del regista, mediante l’espressione di giudizi sulla difficile situazione storica, sociale e politica dell’Italia di allora e del periodo immediatamente precedente. Non cambia tanto, rispetto alla cinematografia del passato, la quantità o la qualità d’uso dei dialetti (delle riprese en plen air e degli ambienti degradati, degli attori presi dalla strada, etc.: il filone documentaristico nasce col cinema, come sappiamo, e il realismo contraddistingue in particolare la produzione italiana, anche se tale tendenza si attenua tra la fine degli anni Trenta e i primi Quaranta), quanto la loro funzione. Pur essendo la ricerca del “vero” perseguita anche dagli intellettuali organici al regime (Blasetti in primis), i primi a parlare di neorealismo furono alcuni intellettuali di sinistra (Umberto Barbaro, Libero Solaroli), che misero in relazione il cambiamento di stile espressivo con le istanze rivoluzionarie di stampo sovietico. Neorealistici vennero definiti dapprima alcuni romanzi (Gli indifferenti di Moravia, Gente in Aspromonte di Alvaro, etc.) caratterizzati dalla fredda analiticità delle situazioni psicologiche e sociali. In altre parole, il termine neorealismo venne dapprima investito di un alone intellettuale e politico forte, poi a mano a mano svanito. La designazione cinematografica rimarrà quantomai generica (non esistono, forse, due critici che accolgano il medesimo numero di film nella categoria) e serve, semmai, più come etichetta storica ormai cristallizzata per designare i film del secondo dopoguerra caratterizzati da argomento serio e da impegno ideologico, che non come chiara appartenenza a una scuola (visto che una “scuola” neorealistica propriamente detta non è mia esistita): BRUNETTA (1991: 236) ricorda l’impennata realistica degli anni Trenta, evidente nella dichiarazione di Longanesi del 1933: «Basterebbe uscire in strada, fermarsi in un punto qualsiasi e osservare quel che accade durante mezz’ora, con occhi attenti e senza preconcetti di stile e fare un film italiano naturale e logico». 102 Il linguaggio cinematografico Il neorealismo di fatto è esistito — da un certo momento in poi — anche come classe, piano estetico e ideologico sovrastante, che consentiva di dare una base comune a vari tipi di opere e voci, senza peraltro divenire mai nessuno di questi tipi e voci. Torna alla mente una definizione di André Bazin, che centra la coesistenza di elementi in contrasto e suggerisce la necessità di considerarli come appartenenti allo stesso spazio topologico: «Il neorealismo rinchiude cane e gatto entro uno stesso sacco»114. Dato che, in questa sede, ci interessa ovviamente sopra ogni altra la componente linguistica dei film, combinando (a prototipo)115 il parametro dello stile dei dialoghi con altri attributi più volte accompagnati al Neorealismo (i ricordati intenti ideologici, la predilezione per le riprese d’esterno, per gli attori non professionisti e per i soggetti non letterari, la presenza della coralità116 piuttosto che del protagonista unico, etc.), chiameremo neorealistici soltanto i seguenti otto film: Roma città aperta, 1945, di Roberto Rossellini (sceneggiatura di Rossellini, Sergio Amidei, Federico Fellini); Paisà, 1946, di Rossellini (sceneggiatura di Rossellini, Fellini, Amidei, Klaus Mann); Il sole sorge ancora, 1946, di Aldo Vergano (sceneggiatura di Vergano, Guido Aristarco, Giuseppe De Santis, Carlo Lizzani); Sciuscià, 1946, di Vittorio De Sica (sceneggiatura di De Sica, Cesare Zavattini, Amidei, Adolfo Franci, Cesare Giulio Viola); Ladri di biciclette, 1948, di De Sica (sceneggiatura di De Sica, Zavattini, 114. BRUNETTA (1991: 300). Per l’accezione zavattiniana di neorealismo (‘eliminazione della componente tecnico–professionale del cinema, che doveva in certo qual modo farsi da sé, essere una copia fedele della realtà’), più o meno sinonimo di verismo, cfr. RAFFAELLI (1992: 106 n. 85). 115. Ovvero, come già chiarito nel § 1.3, secondo un modello che tenga conto della tendenziale, e non assoluta, appartenenza di un oggetto a una categoria in base alla maggior concentrazione di certe proprietà tipiche e alla minor presenza di proprietà tipiche di categorie diverse. 116. Riguardo alla coralità, illuminanti sono le parole di BRUNETTA (1991: 285): «In questo periodo [l’immediato secondo dopoguerra] il pubblico è destinatario e protagonista dei film realizzati. Lo schermo non è più lo specchio deformante delle piccole ‘brame’ della sala, ma la proiezione dell’anima collettiva, una superficie osmotica che in certi casi mostra una permeabilità perfetta tra i due spazi». 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 103 Oreste Biancoli, Suso Cecchi D’Amico, Franci, Gherardo Gherardi, Gerardo Guerrieri); La terra trema, 1948, di Visconti (alla sceneggiatura collaborarono Visconti e Franco Zeffirelli, oltreché, non accreditati, vari abitanti di Aci Trezza, attori non professionisti del film); Il cammino della speranza, 1950, di Pietro Germi (sceneggiatura di Germi, Fellini, Tullio Pinelli); Umberto D., 1952, di De Sica (sceneggiatura di Zavattini). Eccezioni a parte (Roma città aperta, che incassò 162 milioni di lire), i film neorealistici appena citati non furono molto apprezzati dal pubblico italiano; alcuni, come La terra trema, furono un vero e proprio fiasco (35 milioni di incasso su 120 di spesa). Il gusto del pubblico si avvicinò infatti più al genere comico (meno “dialettale” e quindi più comprensibile del genere neorealistico)117 e a quello melodrammatico in lingua colta che a quello neorealistico: Un gruppo di sei film rappresentato da I figli di nessuno, Catene, Tormento, La sepolta viva, Totò cerca casa, Core ’ngrato ha avuto […] un numero di spettatori cinque volte superiori al gruppo di altri sei film rappresentato da Ladri di biciclette, Germania anno zero, Il cammino della speranza, La terra trema, Bellissima, Umberto D., e cioè, all’incirca 30.000.000 di spettatori il primo gruppo e 6.000.000 il secondo. Alla luce di queste cifre, che un’analisi più dettagliata porta a risultati ancora maggiormente sorprendenti (il rapporto, per esempio, tra Umberto D. e Don Camillo è di uno a quattordici, il film I figli di nessuno ha avuto 7.000.000 di spettatori) si può capire il valore polemico della frase di Balázs che «nel cinema l’arte non è la cosa più importante»118. 117. «Dopo la fase di conversione cinematografica dell’avanspettacolo l’asse linguistico lungo cui si orienta e si stabilizza la produzione della commedia vede il predominio di forme centro–meridionali anche se, per buona parte degli anni cinquanta, si continua a preferire al dialetto la forma italianizzata (quasi una traduzione) di discorsi pensati in dialetto. In prospettiva si assiste, comunque, all’estensione del romanesco e all’affermazione di linguaggi gergali e marginali di piccoli gruppi» (BRUNETTA 1993: III, 331). 118. CHIARINI (1954/1976: 82). Per un’analisi storico–sociale del fenomeno è fondamentale SPINAZZOLA (1974): «Le graduatorie commerciali danno la misura esatta del fallimento dell’operazione neorealista nel suo punto programmatico più ambizioso e 104 Il linguaggio cinematografico Mentre i film del primo filone citato dal Chiarini (tutti in italiano perlopiù formale) hanno esercitato un forte potere condizionante sulle abitudini linguistiche del pubblico, «i fenomeni dialettali di certi film neorealisti non hanno [avuto] alcuna incidenza sulla conoscenza linguistica degli spettatori»119. Responsabili dell’insuccesso non furono soltanto le difficoltà linguistiche (certo determinanti per La terra trema), ma anche fattori quali il ritorno in massa del cinema hollywoodiano, fortemente inibito durante gli ultimi anni del fascismo (tra il 1945 e il 1946 furono importati 600 film!), e il grande desiderio del pubblico di evadere e di rimuovere le disgrazie appena trascorse (e all’uopo le commedie e le superproduzioni americane erano l’optimum) piuttosto che di vederle in perfetta evidenza sul grande schermo. Sono questi gli anni, tra l’altro, di massima espansione del cinema in Italia, e dunque anche quelli di massima influenza della sua lingua sulle vaste platee: dal 1945 al 1955 il numero delle sale e dei biglietti venduti sale progressivamente e il cinema batte gli incassi delle manifestazioni teatra- delicato: la volontà di indurre un mutamento radicale nei rapporti fra cinema e pubblico, quali si esplicano negli spettacoli strutturati industrialmente. […]. Solo verso il finire degli anni cinquanta questa dispersione di energie [degli autori neorealisti] si interrompe: e assistiamo al formarsi, nel clima del benessere neocapitalista e del disgelo politico, d’una seconda ondata neorealista. […] [Q]uesti film [della nuova tendenza realistica della fine degli anni Cinquanta] avallano prestigiosamente l’entrata dell’Italia nell’epoca del cinema di massa: l’epoca in cui il sistema industriale apprende a confezionare prodotti dotati, per così dire, di una comunicatività interclassista. Viene a risolversi la tensione, e se vogliamo l’equivoco su cui si reggeva il neorealismo, che progettava di rivolgersi ai ceti subalterni ma trovava gli interlocutori elettivi solo nell’ala radicale dell’intellettualità borghese» (SPINAZZOLA 1974: 11–12). In particolare sugli incassi milionari (oggi plurimiliardari) dei film con Totò cfr. BISPURI (1997): Totò a colori incassò 774.750.000, corrispondenti a 41.500.000.000 attuali, per un totale di 6.390.000 spettatori (p. 108); si tratta dell’incasso più alto tra tutti i film di Totò e di uno dei più alti nella storia del cinema italiano. 119. BRUNETTA (1993: III, 305). Cfr. anche RAFFAELLI (1992: 113): «La preoccupazione di conciliare le istanze espressive con le resistenze del mercato italiano indusse di fatto i cineasti del tempo, con il consenso di critici e di linguisti […], ad ‘alleggerire’ la componente dialettale, per esempio adottando il romanesco che, con accorta attenuazione dei tratti più peculiari, suonava non dissimile dalla variante locale dell’italiano; oppure limitando a battute isolate gli innesti schiettamente dialettali meno comprensibili». 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 105 li e sportive. Il 1955 sarà, nella storia italiana, l’anno del massimo numero di biglietti venduti. Da quell’anno in poi, un lento ma progressivo declino120. A determinare la fama dei principali film del Neorealismo furono dunque alcuni critici illuminati, soprattutto francesi121, e, in seguito, il successo, ancora una volta presso la critica e un pubblico ristretto di intellettuali, incoraggiato anche dall’assegnazione di alcuni Oscar122. 120. Nel 1955 si registrò un’affluenza di circa 819.000.000 di spettatori per un incasso di circa 116.691.000.000 di lire (cfr. QUAGLIETTI 1980: 252). Dal 1956 in poi il declino delle frequenze del pubblico è regolare e progressivo (con «una diminuzione di ben 29 milioni di unità sul totale dei biglietti venduti e una contrazione degli incassi di quasi 670 milioni» nel solo 1956, secondo SPINAZZOLA 1974: 165), fatta eccezione per qualche impennata nel 1959 e nel 1960 e per un complessivo buon livello dal 1960 al 1974, prima di una caduta repentina fino ad oggi (BRUNETTA 1991: 432). Per quantificare il crollo, basti confrontare i 750 milioni di biglietti venduti nel 1960 con i 93 milioni del 1988 (cfr. BRUNETTA 1991: 439–441). «È vero che gli incassi [in un primo momento] non ne risentono; ma ciò dipende solo dall’adozione di un rimedio fittizio, il progressivo e costante aumento del prezzo dei biglietti d’ingresso, passato da una media di 142 lire nel 1955 alle 204 del 1963» (SPINAZZOLA 1974: 165). Non sempre proporzionale il numero dei film italiani prodotti, che registra comunque un forte incremento dal 1945 al 1954, anche grazie ad una legge del 1949 che incentiva la produzione nazionale: «nel 1945 i film prodotti sono appena 25, ma già nell’anno successivo sono saliti a quota 62 […]. [N]el ’47 si producono 67 film; 54 nel ’48; 94 nel ’49; 104 nel ’50; 107 nel ’51; 148 nel ’52; 161 nel ’53; 201 nel ’54. Il ’55 e ’56 sono anni di crisi e il numero scende rispettivamente a 133 e 105 unità. Poi nel ’57 si assiste a una ripresa con 129 film prodotti, ripresa confermata dalla cifra dell’anno successivo che sale a 137» (BRUNETTA 1991: 290–291). 121. Cfr. BAZIN (1958/2000: 317–318), cit. nel § 4.2.1. 122. L’elenco completo degli italiani vincitori di Oscar si può leggere in BIZIO/LAFFRANCHI (2002). Qui ricordiamo soltanto i casi più significativi (rimandando alla nostra filmografia conclusiva per i dati completi sui film citati), senza contare le numerosissime nominations (o candidature) italiane: 1947, Sciuscià, miglior film straniero (Oscar onorario); 1949, Ladri di biciclette, miglior film straniero (Oscar onorario); 1955, Anna Magnani, miglior attrice protagonista per La rosa tatuata; 1956, La strada, miglior film straniero; 1957, Le notti di Cabiria, miglior film straniero; 1961, Sophia Loren, miglior attrice protagonista per La ciociara; 1962, Ennio De Concini, Pietro Germi e Alfredo Giannetti, migliore sceneggiatura originale di Divorzio all’italiana; 1963, 8 e 1/2, miglior film straniero; 1964, Ieri oggi domani, miglior film straniero; 1970, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, miglior film straniero; 1971, Il giardino dei Finzi Contini, miglior film straniero; 1974, Amarcord, miglior film straniero; 1987, L’ultimo imperatore, miglior film straniero e altri otto Oscar (regia, sceneggiatura, fotografia, montaggio, musica, scenografia, costumi, sonoro); 1989, Nuovo Cinema Paradiso, miglior film straniero; 1991, Mediterraneo, miglior film straniero; 106 Il linguaggio cinematografico Alla diffusione di un italiano filmico dai tratti formali, quando non aulici, in questo periodo, ha contribuito anche la grande popolarità dei film tratti da (o ispirati a) opere liriche, ben cinque soltanto nel 1946: Il barbiere di Siviglia di Mario Costa; Lucia di Lammermoor di Piero Ballerini; Rigoletto di Carmine Gallone (girato nel ’46 ma distribuito nel ’47); Il cavaliere del sogno (Gaetano Donizetti) di Camillo Mastrocinque (girato nel ’46 ma distribuito nel ’47) e, sempre di Gallone — il regista per antonomasia dei FILM–OPERA [→ Glossario] nostrani —, Avanti a lui tremava tutta Roma, una sorta di Tosca in versione metateatrale, con Anna Magnani. Nonostante i tagli e gli aggiustamenti linguistici123, questi film non fecero che confermare il successo interclassista della lingua dei libretti e la convinzione, presso il grande pubblico, che la vera poesia e la lingua elegante dovessero essere costruite a base di stereotipi e con più d’uno sguardo verso il passato. Un’ampia fetta dei divi schermici degli anni Cinquanta sarà costituita proprio da famosi cantanti lirici, da Beniamino Gigli, a Tito Gobbi, a Gino Bechi. Naturalmente spesso si ricorreva ad attori non cantanti doppiati da interpreti celebri (com’è il caso di Sophia Loren, doppiata da Palmira Vitali Marini nella Favorita, 1952, di Cesare Barlacchi, e da Renata Tebaldi nell’Aida, 1953, di Clemente Fracassi)124. Sulla stessa linea vanno collocati anche i numerosi film biografici sui compositori, da Giuseppe Verdi, 1953 (l’astro di Busseto è senz’altro il più cinegenico nei cieli operistici, per il comodo, 1998, La vita è bella, miglior film straniero e altri due Oscar (Benigni come miglior attore protagonista e Piovani miglior musica). 123. Sulle caratteristiche linguistiche del film–opera (o opera–film o cineopera) e sulle manipolazioni rispetto agli originali musicali cfr. GATTA (2005). Va da sé che quando usiamo melodramma al cinema intendiamo due diversi concetti: sia i film (musicali) tratti da opere liriche (o, meglio, opere liriche, più o meno tagliate, adattate per il cinema), sia quelli (non musicali, tipo Catene e simili) dai toni enfatici e dallo stile ridondante propri del mélodrame (ovvero ‘melologo’) francese (da cui il francesismo MÉLO [→ Glossario] con cui sono solitamente designati). 124. Anche se, in questi casi, doppiaggio non sarebbe il termine più appropriato, a rigore, visto che è l’attore ad adattarsi ai movimenti labiali del cantante (recitando, dunque, sulla base del disco) e non viceversa. 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 107 quanto improprio, sfruttamento delle tematiche patriottico–risorgimentali), di Raffaello Matarazzo, a Casa Ricordi, 1954, di Gallone, costellati di arie d’opera. Un discorso del tutto diverso, ovviamente, andrebbe fatto per quei registi che si servono di brani operistici e dello stile melodrammatico in chiave simbolica (o realistica, nel senso di rappresentazione non passiva della realtà storica) e critica (sul contrasto tra i valori morali rappresentati e quelli reali), primo fra tutti il Visconti di Bellissima (con brani dal donizettiano L’elisir d’amore) e di Senso (che si apre con Il trovatore di Verdi). Va da sé che in questi ultimi casi non si tratta di un’utilizzazione popolare, bensì ipercolta, e quindi priva di influenze linguistiche sulle ampie platee. Per tornare al Neorealismo, i principali artefici della nuova corrente furono dunque i registi De Sica, Rossellini e Visconti e lo sceneggiatore Zavattini. Grande ispiratore, per tutti, il Verga verista, nei confronti del quale piovevano dichiarazioni di ammirazione125. Naturalmente Zavattini non è l’unico sceneggiatore degno di essere ricordato nel cinema italiano dell’immediato secondo dopoguerra, ma è senz’altro il più rappresentativo e dunque l’unico del quale forniremo brevissime coordinate biografiche. Si aggiunga che solo a partire da questo momento agli sceneggiatori è attribuito un certo riconoscimento e iniziano in questi anni (o hanno cominciato poco innanzi) a dare le loro prime prove i nomi storici del cinema italiano: Sergio Amidei, Ettore Margadonna, Ennio Flaiano, Ennio De Concini, Suso Cecchi D’Amico, Age e Scarpelli, Rodolfo Sonego, Tonino Guerra, Tullio Pinelli, Federico Fellini, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi, Ettore Scola e moltissimi altri (per non parlare delle collaborazioni più o meno occasionali di scrittori, Moravia e Pasolini in testa)126. Se tutto, nel cinema, è frutto della collabo125. Cfr. ALICATA/DE SANTIS (1941/1976); TAGLIABUE (1990: 52). 126. Manca qui lo spazio per dedicarci come dovuto a questi artisti. Ci limitiamo dunque in questa nota a dire due parole sulle personalità di spicco (rimandando, tuttavia, ai capitoli successivi per annotazioni linguistiche su alcuni titoli qui appena citati). Ennio Flaiano, giornalista, critico teatrale, romanziere, commediografo, caratterizzato da uno spiccato gusto per la satira di costume, diede il suo apporto fondamentale soprat- 108 Il linguaggio cinematografico razione di più mani e di più teste, questo è particolarmente vero per la «bottega degli sceneggiatori»127, quasi sempre più di due per film (fino a casi storici come i quattordici sceneggiatori di Fabiola, 1949, di Blasetti [Fig. 3]). Non andrebbero trascurati neppure quegli sceneggiatori che per primi, insieme coi registi, hanno contribuito a svecchiare lo stile dei dialoghi preneorealistici. Pensiamo ad Alessandro De Stefani (La tavola dei poveri, 1932, di Blasetti; Acqua cheta, 1933, di Gero Zambuto; L’assedio dell’Alcazar, 1940, di Augusto Genina; La compagnia della teppa, 1941, di Corrado D’Errico) e soprattutto ad Aldo De Benedetti (Gli uomini, che mascalzoni…, 1932, di Camerini; 4 passi fra le nuvole, 1942, di Blasetti; i primi quattro film di De Sica: Maddalena zero in condotta e Rose scarlatte, 1940, Teresa tutto a celebri sceneggiature per molti film di Fellini (Lo sceicco bianco, 1952; I vitelloni, 1953; La strada, 1954; Il bidone, 1955; Le notti di Cabiria, 1957; La dolce vita, 1960; 8 e 1/2, 1963, etc.). Per altri registi, si ricordano, tra i numerosi titoli: Guardie e ladri, 1951, di Steno e M. Monicelli; La notte, 1961, di M. Antonioni. Suso Cecchi D’Amico (figlia del letterato e direttore storico della Cines Emilio Cecchi, moglie del musicologo Fedele D’Amico — figlio del fondatore dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico —, madre dell’anglista, adattatore e sceneggiatore Masolino D’Amico) è scrittrice e traduttrice colta e raffinata, a suo agio in sceneggiature di ogni genere, dal cinema d’autore e di matrice letteraria (collaborò a molti film di Antonioni e Visconti) al Neorealismo (Ladri di biciclette), dalla commedia (L’onorevole Angelina, 1947, di Zampa; Peccato che sia una canaglia, 1954, di Blasetti) agli sceneggiati televisivi (Le avventure di Pinocchio, 1972, di Comencini; Gesù di Nazareth, 1977, di Zeffirelli). Age (Agenore Incrocci) e (Furio) Scarpelli sono senz’altro tra i padri della Commedia all’italiana. Le loro sceneggiature (centinaia, quasi tutte a quattro mani) spiccano per approfondimento psicologico dei personaggi (C’eravamo tanto amati, 1974, di Scola), originalità linguistica (L’armata Brancaleone, 1966, e Brancaleone alle crociate, 1970, di Monicelli; Dramma della gelosia [tutti i particolari in cronaca], 1970, di Scola) e insuperabile senso della risata (I soliti ignoti, 1958, di Monicelli, oltre a decine di film con Totò). Age, come già visto, è anche autore di un manuale di scrittura cinematografica (AGE 1990). 127. BRUNETTA (1991: 330). Lo stesso concetto è sviluppato anche in BRUNETTA (1993: IV, 69–97) [→ Antologia critica, § 8.II], cui si rimanda anche per l’apporto fondamentale degli sceneggiatori al rinnovamento linguistico del cinema italiano del secondo dopoguerra. Si ribadisce qui che l’attribuzione dei film unicamente al regista è soluzione da noi abbracciata soltanto per convenzione e per brevità, consci che una storia della sceneggiatura cinematografica italiana, ancora tutta da scrivere, riserverebbe non poche sorprese. 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 109 Venerdì, 1941, Un garibaldino al convento, 1942), «che confezionano le trame e i dialoghi di almeno un quarto della produzione italiana del periodo»128, passando con disinvoltura da un genere all’altro. Aldo De Benedetti, per es., lavora contemporaneamente per De Sica e Bragaglia. Che dire poi del geniale critico letterario e cinematografico Giacomo Debenedetti (autore tra l’altro, sotto lo pseudonimo di Gustavo Briareo, di un acutissimo articolo sul doppiaggio [→ Antologia critica, § 13]), sulla cui figura solo di recente gli studiosi di cinema stanno indagando? Fu coautore anche di numerose sceneggiature, in molte delle quali non fu accreditato, essendo ebreo, per via delle leggi razziali: La mazurka di papà, 1938, di Oreste Biancoli; La fanciulla di Portici, 1940, di Mario Bonnard, La bisbetica domata, 1942, di Ferdinando Maria Poggioli; Il cappello da prete, 1944 (ma girato nel 1943), sempre di Poggioli, e molte altre; fu anche assistente alla regia di Camerini in Grandi magazzini, 1939. Cesare Zavattini, come si diceva, è il personaggio–chiave della nuova cinematografia italiana. Singolare esempio di artista a tutto tondo (scrittore, regista, pittore), il suo esordio alla sceneggiatura è con Darò un milione, 1935, di Camerini. Da allora scrisse oltre 130 tra soggetti e sceneggiature, fino al 1982. Le prime istanze realistiche (e soprattutto l’interesse alle storie della piccola gente e la propensione per le atmosfere rarefatte, talora naïves) appaiono in Avanti c’è posto…, 1942, di Bonnard e in 4 passi fra le nuvole, 1942, di Blasetti. Nel 1943, con I bambini ci guardano, 1944, inizia il lungo e proficuo sodalizio con De Sica, per il quale scriverà, tra l’altro, Sciuscià, 1946; Ladri di biciclette, 1948; Miracolo a Milano, 1951; Umberto D., 1952; La ciociara, 1960; Il giardino dei Finzi Contini, 1970. Per altri registi si ricordano almeno Una domenica d’agosto, 1950, di Luciano Emmer e Bellissima, 1951, di Visconti129. È con lui, praticamente, che la figura dello sceneggiatore inizia a uscire 128. BRUNETTA (1991: 200). 129. Su Zavattini cfr. almeno GAMBETTI (1986), (1997) e CALDIRON (1990). 110 Il linguaggio cinematografico dall’anonimato (talora dalla vergogna, essendo quella filmica considerata scrittura di serie b, fatta solo per arrotondare i guadagni) e a rivendicare la piena coautorialità del film. Differentemente dalla cinematografia americana, infatti, rigorosamente confezionata a tavolino prima delle riprese sul set, quella italiana ha sempre assegnato un ruolo primario alla creatività anche estemporanea di registi e attori. Grande conoscitore del cinema e delle sue dinamiche di mezzo di comunicazione di massa, Zavattini è ben conscio dei limiti espressivi che esso impone (e, conseguentemente, del suo “ritardo” rispetto alla letteratura, per sua natura più libera e anticonformista), come dimostra la presente dichiarazione rilasciata a Cesare Gambetti: Io ho fatto Umberto D., ma io nel 1937 scrivevo I poveri sono matti. Quando ho scritto I poveri sono matti, non dovevo mica fare in film Una famiglia impossibile, non dovevo fare Bionda sotto chiave, e invece ho fatto Bionda sotto chiave perché il mercato richiedeva questo, io ero pronto, mi lasciavo corrompere, non c’era allora in me una coscienza, in questo ordine di idee. Allora Umberto D. io lo avrei fatto nel ’37, quando ho esordito. L’ho fatto dopo, l’ho fatto bene, si capisce, l’ho fatto bene, ci ho messo dentro tutta la mia maturità espressiva di certe cose, ma non me ne fregava niente, perché se avessi io preso in mano la macchina da presa Umberto D. mi sarebbe già sembrato vecchio130. 130. G AMBETTI (1986: 173). Per un’interpretazione opposta del rapporto cinema/letteratura cfr. PASOLINI (1972/1991: 186): «il cinema, probabilmente dal 1936, anno dell’uscita di Tempi moderni, è sempre stato in anticipo sulla letteratura: o almeno ha catalizzato con una tempestività che lo rendeva cronologicamente anteriore, i motivi socio–politici profondi che avrebbero caratterizzato di lì a poco la letteratura. Perciò il neorealismo cinematografico (Roma città aperta) ha prefigurato tutto il neorealismo italiano letterario del dopoguerra e di parte degli anni cinquanta; i film neo–decadenti e neo–formalistici di Fellini o Antonioni hanno prefigurato il revival neo–avanguardistico italiano o lo stingimento del neo–realismo; la ‘nuovelle vague’ ha anticipato l’‘école du regard’, rendendone clamorosamente pubblici i primi sintomi; il nuovo cinema di alcune repubbliche socialiste è il dato primo e più clamoroso di un generale risveglio in quei paesi dell’interesse per il formalismo di origine occidentale, come ripresa di un motivo novecentesco interrotto ecc. ecc.». Sulla linea zavattiniana del ritardo del cinema rispetto alle altre arti si legga anche un brano da 8 e 1/2, 1963, di Fellini, anche se qui l’intento è quello, palesemente ironico, di mettere alla berlina gli intellettualismi della critica. A parlare (con marcata vibrante uvulare) è il critico cinematografico Daumier, a propo- 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 111 Come è evidente, data l’eterogeneità degli artisti in questione, il Neorealismo ebbe molte anime, sottocorrenti e sottopoetiche che non è il caso qui di commentare (dal documentarismo di stampo veristico del primo Rossellini alla tendenza al romanzato di De Sica e Zavattini, dall’ideologia marxista del primo Visconti, di Aristarco e di Vergano al misticismo di certo Zavattini e di certo Rossellini, etc., tutti problemi ampiamente dibattuti, tuttora in parte irrisolti e forse irresolubili e comunque non pertinenti al nostro lavoro)131. Sicuramente la ricerca del parlato il più possibile vicino alla realtà, dunque del dialetto, accomuna tutti, come risulta evidente dalle numerose dichiarazioni di Zavattini e di De Sica, tra gli altri. 2.5.2. Secondo alcuni, già Ossessione, 1943, di Luchino Visconti (sceneggiatura di Visconti, Mario Alicata, Giuseppe De Santis e Gianni Puccini [Figg. 4–7]), dovrebbe essere definito un film neorealistico: per il frequente uso di riprese in esterno, per la lucida descrizione di gente umile e di situazioni di angoscia e di degrado ambientale e morale (come dimenticare la canottiera sudata e sporca di Massimo Girotti nella sua prima entrata nella cucina di Giovanna, con una ZOOMATA [→ Glossario], tra l’altro, che è della storia del cinema e che ricorda molto la prima inquadratura di John Wayne in Ombre rosse, a confer- sito del progetto filmico di Guido/Fellini: «Vede/ ad una prima lettura/ salta agli occhi che la mancanza di una idea problematica/ o/ se si vuole/ di una premessa filosofica… […] rende il film una suite di episodi assolutamente gratuiti/ e può anche darsi divertenti/ nella misura del loro realismo ambiguo// Ci si domanda cosa vogliono realmente gli autori// Ci vogliono far pensare? Vogliono farci paura? Il gioco rivela fin dall’inizio una povertà d’ispirazione poetica… mi perdoni/ ma questa può essere la dimostrazione più patetica/ che il cinema è irrimediabilmente in ritardo di cinquant’anni su tutte le altre arti// Il soggetto/ poi/ non ha neanche il valore di un film d’avanguardia// Benché qua e là/ ne abbia tutte le deficienze// Ho preso degli appunti/ ma non credo che le saranno utili// Mi rimane un po’ misterioso/ il fatto che lei abbia pensato a me per una collaborazione che/ francamente/ non so come si potrebbe realizzare//». 131. Almeno di «religiosità epica di Rossellini», «marxismo estetizzante di Visconti», «paterno lirismo della piccola cronaca di De Sica–Zavattini», «dramma di libertà e di riscatto sociale del popolare De Santis» parla ORATI (1983: 151). Su questi temi è fondamentale MICCICHÈ (1978). 112 Il linguaggio cinematografico ma, se ve ne fosse bisogno, che il realismo dei nuovi registi, e in particolare di Visconti, è sempre frutto di un’incredibile ricercatezza e cultura cinematografica?)132, per la trama che, nonostante il soggetto americano (Il postino suona sempre due volte [The Postman Always Rings Twice], di James Cain, non citato nei titoli del film per ragioni di diritti d’autore)133, è così fortemente radicata nella contemporaneità italiana. Furono gli stessi critici dell’epoca (da Umberto Barbaro a Guido Aristarco) che salutarono in Ossessione il tanto atteso rinnovamento realista del cinema italiano e lo elessero a bandiera della nuova produzione filmica. Il film è ambientato nei pressi del delta del Po, a Codigoro, e vede come protagonista Giovanna (Clara Calamai), un’ex prostituta che si è sistemata sposando il padrone di uno spaccio. Innamoratasi del vagabondo Gino (Massimo Girotti), decide, insieme con lui, di uccidere il marito per riscattarne l’assicurazione. Ma i sensi di colpa fanno precipitare il rapporto, fino alla morte conclusiva di Giovanna (incinta), per un incidente d’auto (la medesima morte del marito, per un incidente simulato). Il film coniuga fatalismo e cupo pessimismo, dovuto a motivi esterni (la povertà, i pregiudizi e il crollo degli ideali: cruciale la figura dello Spagnolo, un amico di Gino evidentemente omosessuale e dalle idee sinistrorse, deluso dall’incapacità di Gino di vivere in libertà)134 e interni (i rimpianti e i rimorsi), a un’incre132. Visconti era stato, tra l’altro, assistente del celebre regista francese Jean Renoir (figlio del pittore Auguste). La cinepresa, in Ossessione, risulta insolitamente mobile, per la cinematografia coeva, con carrelli [→ Glossario, CARRELLO], ZOOM [→ Glossario], piani sequenza [→ Glossario, PIANO SEQUENZA]; anche il montaggio è particolarmente ricercato, molto più vicino ai film americani che a quelli italiani. Tutte queste caratteristiche, unitamente alla trama, fanno del film di Visconti uno dei primi film “moderni” della storia del cinema. 133. Il romanzo di Cain godette di notevole fortuna cinematografica. Oltre al film di Visconti se ne ricordano i seguenti adattamenti: Le Dernier tournant, 1939, di Pierre Chenal; Il postino suona sempre due volte), 1946, di Tay Garnett, e, col medesimo titolo, il film di Bob Rafelson del 1981. 134. A proposito dello Spagnolo scrive BRUNETTA (1991: 234): «Un personaggio vissuto a lungo in Spagna che parla in modo ambiguo e misterioso di eguaglianza e comunione dei beni. Non è certo questa figura — la cui componente omosessuale turba 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 113 dibile carica erotica dei protagonisti, insolita, nella sua esplicitezza, per l’epoca: sicuramente deve aver inciso anche la scelta di Clara Calamai (il primo seno nudo — comparse a parte — della storia del cinema nella Cena delle beffe, 1942, di Blasetti), che sostituì all’ultimo momento Anna Magnani, incinta; senza dubbio la Magnani avrebbe fatto virare il film dalla sensualità (comunque stilizzata) alla passionalità di stampo verista. Ecco come Giovanna dà libero sfogo, con Gino, alle proprie emozioni: GIOVANNA: Lo sai tu/ che cosa sia un uomo vecchio? GINO: No// Ma me lo immagino// GIOVANNA: Non puoi immaginarlo// Non puoi sapere che cosa sia per una donna/ vivere con un uomo vecchio// Tutte le volte che mi tocca con quelle mani/ grasse/ vorrei mettermi a urlare! Non sono una signora/ io// Sono una povera disgraziata// Ma non ne posso più! Che una donna potesse rivendicare il proprio diritto all’amore carnale era del tutto inaudito, all’epoca. Ma, per spostarci sul piano linguistico, non una parola, un costrutto, una sfumatura di pronuncia avvicina questa, né altre battute di Gino e Giovanna, a un parlato credibile per l’epoca (il primo congiuntivo del brano appena citato è addirittura ipercorretto). Le uniche sfumature regionali di Ossessione sono alcune battute incomprensibili, in apertura di film, qualche altro enunciato pronunciato da comparse («an fan che litighèr» ‘non fanno che litigare’, detto in ferrarese — col tipico an ‘non’ e la palatalizzazione della a dell’infinito — all’inizio del secondo tempo, a proposito di le coscienze dei giovani critici antifascisti forse più di quanto non li affascini la Spagna, costringendoli a vere e proprie acrobazie per evitare e rimuovere il problema […] — a rappresentare il senso della partecipazione antifascista alla guerra di Spagna, ma la sua presenza, la forte carica allusiva che circonda il suo passato non passano inosservate e scuotono la coscienza ormai risvegliata dello spettatore. In poche immagini Visconti sembra essere riuscito a racchiudere il non detto di un intero conflitto, a illuminare un motivo traumatico tenuto nascosto da immagini che, comunque, non sono mai state capaci di esaltare e celebrare la lotta dei paladini della fede contro le forze infernali». 114 Il linguaggio cinematografico Gino e Giovanna; poco prima, l’affittacamere parlava in napoletano) e qualche sfumatura settentrionale del marito di Giovanna, Giuseppe (Juan De Landa, ovviamente doppiato). Benché la sintassi risulti semplificata, rispetto alla media dei dialoghi filmici italiani coevi, non sfugge certa ricercatezza espressiva, di stampo teatrale, in tutte le battute del film: GIOVANNA: Ora ricordo/ il giorno che sei arrivato qui/ per la prima volta// Non avevi neanche le calze ai piedi// Capisco perché ti ho voluto così bene// Subito// E perché l’ho così odiato/ lui// Neanche se volessi/ potrei farti più del male/ ora// Nemmeno per impedirti di andare via/ se vuoi// Perché/ aspetto un bambino// Da te/ Gino// GINO: Cosa dici? GIOVANNA: Sì// Ne avevo già il dubbio// Ma ora sono certa// Dovevo parlartene// Dovevo parlarti di questa cosa/ Gino// Prima/ era tutto confuso// Ma ora ci vedo chiaro// Ci ho pensato molto// Ho pensato a noi due// Al bambino// Vedi/ perché noi/ che abbiamo rubato una vita/ possiamo renderne un’altra// Per questo/ non ho più paura// Non ho più nessun rancore/ verso di te// So/ che ti amo/ Gino// E non potrò mai/ farti del male// Ma tu/ come potrai vincere la tentazione/ di sfogare il tuo odio contro di me? Adesso/ se vuoi puoi farlo// Ti ho detto tutto// Sono qui//. A fronte di fenomeni dell’uso medio (che temporale: «il giorno che sei arrivato qui»; ridondanza pronominale: «l’ho così odiato/ lui»; lessico generico: «Dovevo parlarti di questa cosa»; frasi fatte: «ci vedo chiaro»; preferenza per la paratassi e per i brevi segmenti piuttosto che per l’ipotassi: «Sì// Ne avevo già il dubbio// Ma ora sono certa»; «Prima/ era tutto confuso// Ma ora ci vedo chiaro// Ci ho pensato molto// Ho pensato a noi due// Al bambino»), spicca il periodare ricercato («Neanche se volessi/ potrei farti più del male»; «come potrai vincere la tentazione/ di sfogare il tuo odio contro di me?»), che ha un’unica forte eccezione, nel film, con il seguente errore di consecutio temporum: «Dovevo immaginarlo/ che da un momento all’altro te ne puoi andare», dalle labbra di Giovanna nella parte conclusiva del film. Il realismo degli ambienti poveri e sordidi e stralci di lingua agile 2 – Il parlato filmico dal cinema muto al Neorealismo 115 e dialettale, come sappiamo, erano ormai di casa nella nostra cinematografia, ma qui per la prima volta non sono al servizio di argomenti edificanti, come nei film con Nazzari, per intenderci. Qui è una donna, ex prostituta e assassina, che parla, esprimendo liberamente la sensualità. E, anche se alla fine la peccatrice sarà punita con la morte, grazie alle inquadrature del regista e all’intensità degli interpreti lo spettatore è indotto a schierarsi dalla parte di Giovanna (e di Gino) contro il laido e maschilista marito, all’opposto dei film con Nazzari, in cui al legittimo marito, povera vittima, va sempre la solidarietà dello spettatore, contro la femme Pandora apportatrice, anche se spesso inconsapevole, di sventure (Luciano Serra, Montevergine, Catene). In altre parole, la lingua, ma anche lo stile complessivo del film, sembra allontanare Ossessione dai film prettamente neorealistici, per quello straordinario connubio, sempre caro al regista, di melodramma (il melomane Visconti non si lascia sfuggire una competizione popolare di canto lirico, in cui si esibisce il marito di Giovanna; la dark lady Calamai ha movenze ed espressioni sublimemente teatrali) e realismo psicologico e sociale (non linguistico). Sicuramente, almeno negli intenti dei cineasti più sensibili (come ben comprenderà lo stesso Visconti con La terra trema), la ricerca del realismo era da perseguirsi essenzialmente mediante un rinnovamento dei dialoghi, come acutamente osservava Luigi Comencini già nel 1938: È necessario ritrovare la vita italiana e non nei libri e nelle antologie […]. Gli italiani non parlano l’italiano, generalmente parlano un dialetto e ad ogni modo una lingua che è parlata e non scritta […]. Il dialoghista deve essere una persona che sappia parlare come gli impiegati e pensare come un grande scrittore che non abbia paura delle parole […]. Il più bel film italiano si svolge ancora nelle piazze e nelle vie d’Italia dove la gente parla a crocchi […] e nei campi dove lavora e nei caffè [..] dove si riunisce la sera135. 135. BRUNETTA (1991: 237). 116 Il linguaggio cinematografico Se l’imperativo del nuovo cinema deve essere quello di uscire all’aperto, di calarsi tra i poveri e i piccoli della storia lasciando i grandi sullo sfondo, di riprendere ogni regione d’Italia nelle sue scene più quotidiane, di mostrare quanto di meno “cinematografico” ci sia nell’Italia distrutta dalla dittatura e dalla guerra, tutto quello che la politica (e in gran parte anche il cinema) precedente aveva cercato di nascondere sotto il velo della retorica, è chiaro che la rottura con lo stile del vecchio cinema passa soprattutto attraverso la lingua parlata dagli attori sullo schermo e la scelta del dialetto, fatta salva la minima comprensibilità per il pubblico, diventa praticamente obbligata. E si cominceranno a riprodurre non soltanto i dialetti egemoni della tradizione teatrale, già portati sullo schermo (romanesco e napoletano, che rimarranno comunque i prediletti), ma praticamente tutte le principali varietà d’Italia (fino al trezzese della Terra trema) e anche le lingue straniere, che tanta influenza hanno avuto sulla Penisola nel secondo conflitto mondiale. Tale pluridialettalità è incoraggiata anche dal desiderio delle maestranze e delle autorità di agevolare la produzione cinematografica di altri centri italiani (Milano, Torino, Venezia, Napoli, etc.) e non della sola e solita Cinecittà. Ma ai dialetti, e dunque al commento dei film qui elencati, sarà dedicato il quarto capitolo, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti sul Neorealismo. 3. CINEMA E LETTERATURA 3.1. Considerazioni generali, con qualche cenno alle differenze tra i linguaggi teatrale e cinematografico Nella lettura del presente capitolo (che amplia quanto già pubblicato in ROSSI 2003b) il lettore dovrà richiamare alla memoria gli schemi presentati nel primo capitolo, relativamente al rapporto tra scritto, parlato e parlato filmico e tra testo che si guarda e testo che si legge (§§ 1.2, 1.3, 1.4.1). Dopo alcune considerazioni di carattere generale sul rapporto tra cinema, teatro e letteratura, verranno commentati cinque esempi specifici di trasposizione testuale, di cui segue l’elenco (corredato anche dell’edizione scelta per le citazioni) e che verranno, per brevità, d’ora in avanti richiamati compendiosamente col solo titolo: La cena delle beffe, 1942, regia di Alessandro Blasetti, sceneggiatura di Renato Castellani e Blasetti, tratto dal dramma di Sem Benelli, La cena delle beffe (1909), Milano, Treves, 1918. Ladri di biciclette, 1948, regia di Vittorio De Sica, sceneggiatura di De Sica, Cesare Zavattini, Oreste Biancoli, Suso Cecchi D’Amico, Adolfo Franci, Gherardo Gherardi, Gerardo Guerrieri, tratto dal romanzo di Luigi Bartolini, Ladri di biciclette (1946–1948), introduzione di Valerio Volpini, Milano, Longanesi, 1988. Le amiche, 1955, regia di Michelangelo Antonioni, sceneggiatura di Antonioni, Suso Cecchi D’Amico, Alba De Céspedes, tratto dal racconto di Cesare Pavese, Tra donne sole 117 118 Il linguaggio cinematografico (1949), in Id., La bella estate, Torino–Novara, Mondadori–De Agostini, 1992, pp. 215–330. L’innocente, 1976, regia di Luchino Visconti, sceneggiatura di Suso Cecchi D’Amico, Enrico Medioli e Visconti, tratto dal romanzo di Gabriele D’Annunzio, L’innocente (1892), Milano, Mondadori, 1992. Passione d’amore, 1981, regia di Ettore Scola, sceneggiatura di Scola e Ruggero Maccari, tratto dal romanzo incompiuto di Iginio Ugo Tarchetti, Fosca (1869), Milano, Mursia, 1989. La scelta dei cinque film è stata fatta volutamente in base a un ampio arco cronologico e tipologico, che spazia dalle trasposizioni fedeli ai liberi adattamenti, dal romanzo al teatro in versi. I rapporti tra cinema e letteratura sono stati studiati dai filmologi, benché non molto spesso, soprattutto negli anni Sessanta–Settanta del Novecento1. Raramente, però, si è andati oltre il piano estetico e, nel migliore dei casi, semiologico. Mancava, tra l’altro, una rassegna e un’esemplificazione dei fenomeni ricorrenti nella riscrittura di un romanzo o di un dramma in un copione cinematografico. La bibliografia più recente si è arricchita di molti titoli, anche se dedicati prevalentemente a singoli aspetti e travasi piuttosto che a una visione d’insieme2. Il cinema, fin dalla nascita, ha mostrato di non poter prescindere da altre arti, e in particolare dalla fotografia (di cui è diretto discendente), dal teatro, dalla musica e soprattutto dalla letteratura. Si trattò, dapprima, di un’esigenza di legittimazione rispetto alle arti tradizionali: «il cinema aveva bisogno […] di darsi uno status pari a quello delle altre arti, al teatro ad esem- 1. Cfr. soprattutto BALDELLI (1964); BRUNETTA (1970), (1976), (1977); PASOLINI (1972/1991: 167–187); MICCICHÈ (1979); MOSCARIELLO (1981); ABRUZZESE/PISANTI (1983); TINAZZI/ZANCAN (1983); ZAPPULLA MUSCARÀ (1984). 2. Cfr. almeno TAGLIABUE (1990); MAMONE (1992); MARASCHIO (1992); COSTA (1993); BRAGAGLIA (1993); BUSSI/SALMON KOVARSKI (1996); NUVOLI (1998); PERNIOLA (2002); MANZOLI (2003). 3 – Cinema e letteratura 119 pio e trasferire sullo schermo i soggetti di derivazione colta consentì al cinema un’ulteriore legittimazione e l’opportunità di rivolgersi anche ad un pubblico medio–borghese»3. BRUNETTA (1977: 333) [→ Antologia critica, § 8.I] ha giustamente assimilato il cinema alla «biblioteca dell’italiano medio», per via dell’usuale attività di trascrizione e divulgazione (con inevitabili conseguenze di semplificazione e banalizzazione dei testi originari) del repertorio più disparato dalle origini fino ad oggi. Tanto la filmografia d’autore quanto quella popolare, italiana e straniera, si basano, in effetti, soltanto in minima parte su soggetti originali e questo, come in parte è stato già accennato nel § 2, è particolarmente evidente nel primo periodo dell’arte filmica italiana. La vocazione letteraria dei soggetti cinematografici nasce praticamente con la nascita del film a soggetto: Tra il 1905 e il 1912 il cinema italiano, nato “ritardato” (e quindi costituzionalmente ipotonico), ci fa assistere a una massiccia immissione di vitamine e proteine letterarie nel suo corpo. “In principio fuit traductio”: già dai primi soggetti si assiste a un processo di conversione, ridefinizione e riduzione di tutti i motivi della memoria storica e letteraria, concepita come un unico testo, un giacimento aureo inestinguibile entro cui attingere a larghe mani senza il minimo complesso di inferiorità. L’epica, il romanzo, il teatro, la poesia, la letteratura popolare, subiscono lo stesso trattamento […] [I]l fatto che ci si ponga, dai primi passi, di fronte alla letteratura di tutti i tempi, come a un unico e indifferenziato grande testo isomorfico, apre un problema specifico: quello dell’esistenza di un’ideale “biblioteca dell’italiano” elaborata dall’industria letteraria alla fine dell’ottocento, che pesca i suoi modelli ideali e i testi di base nelle biblioteche di Don Ferrante e del sarto dei Promessi sposi, che si tenta di convertire — in base alla proprietà transitiva — in una corrispondente filmoteca ad uso nazionale e internazionale. Il cinema, nella logica dei produttori, diventa mezzo di allargamento degli orizzonti culturali, privilegiato e potenziale produttore di una cultura di massa veicolo forte di esportazione della cultura italiana. O una lin- 3. MARTINELLI/TORTORA (2004: 15). 120 Il linguaggio cinematografico gua franca, un’alternativa all’esperanto, che rende possibile l’esecuzione e trascrizione visiva di qualsiasi testo letterario 4. Tra le ambizioni dei nostri primi cineasti c’è quella di eternare la letteratura: «Oramai non esistono più nella letteratura pagine ingiallite e nella natura cose morte, poiché il cinematografo le anima e le fa rivivere, assicurando loro una esistenza eterna»5. Ci si accosta, pertanto, dapprima alle opere letterarie maggiori, sia perché di sicuro appiglio sul pubblico, sia per la pretesa vocazione didattica del cinema. Il lancio dei film era infatti spesso di questo tenore: «Non tralasciate di portare i vostri bambini a questo spettacolo istruttivo»6. Non stupirà, dunque, l’incredibile numero degli adattamenti cinematografici dei Promessi sposi: la prima riduzione del romanzo manzoniano è I promessi sposi, 1908, di Mario Morais, prodotto dalla L. Comerio e C. di Milano; segue L’innominato, 1909, di Mario Caserini, Cines; I promessi sposi, 1911, riduzione di Lucio D’Ambra, regia di Ugo Falena, Film d’Arte Italiana; e, con il medesimo titolo, di Eleuterio Rodolfi, Società Anonima Ambrosio, 1913; di Ubaldo Maria Del Colle e Ernesto M. Pasquali, 1913; di Mario Bonnard, Bonnard–Film, in due episodi (sonorizzati nel 1940), 1922; di Mario Camerini, 1941 (Figg. 8–9); di Mario Maffei, 1964, per non citare che i film più noti, sino ad arrivare alle riduzioni televisive (I promessi sposi, 1967, di Sandro Bolchi; con lo stesso titolo, di Salvatore Nocita, 1989; Renzo e Lucia, di Francesca Archibugi, 2001 e altri ancora)7. Naturalmente, con le trasposizioni nascono anche le prime critiche sui tagli, sulle banalizzazioni e sul generale impoverimento 4. BRUNETTA (1991: 51–52). TAGLIABUE (1990: 13–16) calcola che dal 1907 al 1920 sono circa 200 i film italiani tratti da opere letterarie, a partire da Il fornaretto di Venezia, 1907, di Mario Caserini, prodotto dalla Cines e tratto dall’omonimo dramma di Francesco dall’Ongaro. 5. Come recita “Il giornale d’Italia” agli inizi del Novecento (MARTINELLI/TORTORA 2004: esergo iniziale). 6. MARTINELLI/TORTORA (2004: 15). 7. Cfr. BETTETINI/GRASSO/TETTAMANZI (1990) e MARTINELLI/TORTORA (2004). 3 – Cinema e letteratura 121 dell’opera, a fronte, però, del complessivo apprezzamento del grande pubblico. Ben presto saranno soprattutto i principali autori stranieri ad attrarre i nostri registi e sceneggiatori. Il cinema muto italiano attinge i propri soggetti soprattutto a Balzac, Sardou, Dumas figlio, Shakespeare, Tolstoj, Dostoevskij, Ibsen, Puškin e a tanta letteratura d’appendice. E, ancor di più, al teatro vaudeville e melodrammatico, con la speranza di continuare sullo schermo i successi del palcoscenico. Pochi scrittori italiani del primo Novecento si sono sottratti al fascino della decima musa. Verga, D’Annunzio, Gozzano, Pirandello8 e moltissimi altri hanno collaborato più o meno intensamente alla realizzazione di sceneggiature per il cinema, taluni con entusiasmo (D’Annunzio, salvo vari ripensamenti), altri con vergogna, quasi tutti soltanto per i facili guadagni: «Vi prego, vi scongiuro, non dite mai che io abbia messo le mani in questa manipolazione culinaria delle mie cose», scrive Verga alla contessa Dina Castellazzi di Sordevolo, a proposito della riduzione di alcune sue opere9. Suggestive le parole di Giuseppe Petronio sul rapporto degli intellettuali italiani col cinema del primo Novecento: In un certo senso verrebbe voglia di dire che per questi letterati umanisti del primo Novecento il cinema era ciò che per il borghese (piccolo, medio, alto) era la prostituta. Era questa, o pareva, un male, ma un male necessario ad attirare e a scaricare su di sé, quasi un parafulmine, la concupiscenza maschile sicché le “vergini belle e pure”… potessero gelosamente custodire la loro verginità; egualmente il cinema scaricando su 8. Su Verga cfr. ALICATA/DE SANTIS (1941/1976), ZAPPULLA MUSCARÀ (1984: 217–309), GENOVESE/GESÙ (1996); su D’Annunzio RAFFAELLI (1977) e quando detto supra, § 2.2.1; su Gozzano SARNELLI (1996) e RAFFAELLI (2003a: 83–111); su Pirandello PIRANDELLO (1929) [→ Antologia critica, § 7], GENOVESE/GESÙ (1990), RAFFAELLI (1993b). Ingente la bibliografia su altri autori, per i quali cfr., tra l’altro, GENOVESE (1988), su Barbaro; GESÙ (1989), su Brancati; GESÙ (1992a) e (1992b), su Sciascia; MARASCHIO (1992), su Pratolini; MAMONE (1992), su Visconti e le sue fonti letterarie; GENOVESE/GESÙ (1997), su Vittorini; SALIBRA (2005), su Moravia. 9. BRUNETTA (1991: 54). Cfr. anche SARNELLI (1996: 21–22). 122 Il linguaggio cinematografico di sé le basse voglie del volgo, poteva consentire al teatro di mantenere intatta la sua verginità artistica10. L’importanza della fonte letteraria non venne intaccata dall’avvento del sonoro, al punto che il primo film parlante italiano, La canzone dell’amore, 1930, di Righelli, è tratto, come già detto, assai liberamente dalla novella In silenzio di Pirandello. Nel ventennio fascista quasi tutti i film italiani di soggetto non originale sono tratti da opere teatrali, pochi da opere narrative. Gran parte degli sceneggiatori dell’epoca è costituita da drammaturghi: Alessandro De Stefani, Aldo De Benedetti, Gherardo Gherardi, Guido Cantini, Luigi Bonelli, Sergio Pugliese, Dino Falconi, Cesare Giulio Viola, Cesare Vico Lodovici, Tomaso Smith11. Alcuni autori sono stati iperutilizzati, come fonti di soggetti, dal nostro cinema a tutte le altezze cronologiche. TAGLIABUE (1990: 84–85, 97, 150–152 et passim), per esempio, riporta 7 film tratti da Canti o episodi della Divina commedia12; 9 dal Decameron; 8 da Luigi Capuana; 7 dal Pinocchio di Collodi (cui andrà aggiunto il film di Benigni del 2002); 23 da Gabriele D’Annunzio; 18 da Edmondo De Amicis; 7 da Grazia Deledda; 13 da Carolina Invernizio; 29 da Alberto Moravia; 31 da Luigi Pirandello; 31 da Emilio Salgari; 7 da Leonardo Sciascia; 14 da Giovanni Verga, etc. Ancora oggi, i soggetti originali sono in percentuale minoritaria, rispetto a quelli tratti da romanzi, drammi o novelle13. E questo è curioso: il cinema per certi aspetti si pone come linguaggio autonomo — talora addirittura linguaggio–guida, nella civiltà dell’immagine — e tuttavia non riesce a prescindere dall’altro da sé, nella consapevolezza che la costruzione di una storia è impresa complessa e fondamentale, nella riuscita di un film, e che quindi una falsariga narrativa è spesso 10. TAGLIABUE (1990: 21). 11. Cfr. BRAGAGLIA (1993: 81–82). 12. Sulla presenza di Dante nel cinema cfr. CASADIO (1996). 13. «[A]lmeno il 70% dei film attualmente prodotti sono in varia misura debitori rispetto ad un racconto letterario» (BUSSI 1996: 14). 3 – Cinema e letteratura 123 quasi indispensabile14. C’è anche chi pensa che il cinema si rivolga alla letteratura e in genere al passato soprattutto nei periodi di crisi, come dimostrerebbe la nuova impennata di soggetti letterari e di film in costume a partire soprattutto dagli anni Novanta del Novecento. Ma il rapporto tra cinema e letteratura non è a senso unico, bensì impostato sul mutuo condizionamento delle tecniche narrative, dapprima prese in prestito e poi restituite sotto altra luce. Basti pensare al FLASHBACK [→ Glossario] (inaugurato in letteratura almeno a partire dal racconto di Ulisse ai Feaci, nell’Odissea), che diventa subito uno dei mezzi di montaggio prediletti dal cinema per movimentare la narrazione, oltreché tra le principali tecniche di RACCORDO [→ Glossario] tra blocchi narrativi e di glossa esplicativa posticipata15. Della metafora e della metonimia s’è già detto in § 1.3. Anche il DISCORSO DIRETTO RIPORTATO [→ Glossario] trova un suo corrispettivo f ilmico nella tecnica cosiddetta della S O G G E T T I VA [→ Glossario] (vale a dire nell’inquadratura che presuppone la corrispondenza tra occhio dello spettatore, occhio del regista e occhio di un personaggio del film)16. Una rapida scansione degli eventi in un romanzo, infine, è spesso detta montaggio o stile cinematografico17. Proprio in virtù della sua complessità, il rapporto tra cinema e letteratura può essere analizzato da almeno quattro diverse angolature. 1) La letteratura nel cinema. In che modo il cinema parla 14. «È molto più comodo partire da un romanzo, è un aiuto, si trova tutto un materiale, atmosfere, personaggi, un solido impianto narrativo» (testimonianza di Pietro Germi, riportata da BRAGAGLIA 1993: 141). 15. Cfr. MANZOLI (2003: 96–98). Dell’«effetto rebound» del cinema sulla letteratura parla diffusamente COSTA (1993: 45–61). 16. Cfr. PASOLINI (1972/1991: 176–183), per il quale è possibile trovare anche dei corrispettivi filmici di DISCORSO INDIRETTO LIBERO [→ Glossario]. Sulle polemiche suscitate dalle teorie semiologiche di Pasolini cfr. COSTA (1993: 128–158). 17. Simultaneità, multiprospettivismo e montaggio sono i tre elementi strutturali di cui la letteratura si è servita prevalentemente a partire dai primi del Novecento e soprattutto per influenza del linguaggio cinematografico (cfr. NUVOLI 1998: 28). 124 Il linguaggio cinematografico della letteratura? Si pensi ai film sulla biografia di poeti o sulla nascita di determinate opere (tra i tanti esempi, Gothic, 1986, di Ken Russell, su Byron e gli Shelley; Shakespeare in Love, 1998, di John Madden), oppure ad ambiziose speculazioni filmiche sulla scrittura (tra le più acute degli ultimi anni, I racconti del cuscino [The Pillow Book], 1995, di Peter Greenaway)18, o sul farsi della poesia (L’attimo fuggente [Dead Poets Society], 1989, di Peter Weir; La tigre e la neve, 2005, di Roberto Benigni). 2) Il cinema nella letteratura. La nuova arte ha sùbito influenzato la produzione letteraria, sia nelle tecniche scrittorie, sia nelle trame (nelle varie novelle di ispirazione cinematografica) e nella terminologia: basti pensare ai casi storici come quelli di Verga (Tigre reale) e di Pirandello (Quaderni di Serafino Gubbio operatore), o anche a quelli meno noti come la novella Al cinematografo, 1907, di Gualtiero Fabbri19. 3) Il cinema tratto dalla letteratura. Alcuni registi hanno dedicato una fetta consistente della propria produzione alla riduzione di opere letterarie: Mario Soldati (Piccolo mondo antico, 1941, e Malombra, 1942, da Fogazzaro; Eugenia Grandet, 1947, da Balzac), Alberto Lattuada (Il cappotto, 1952, da Gogol’; La lupa, 1953, da Verga; La mandragola, 1965, da Machiavelli; Don Giovanni in Sicilia, 1967, da Brancati [Figg. 10–11]), Mauro Bolognini (Il bell’Antonio, 1960, da Brancati [Fig. 12]; Agostino [La perdita dell’innocenza], 1962, da Moravia; Senilità, 1962, da Svevo; Metello, 1970, da Pratolini) e tanti altri. È stato questo, va riconosciuto, un contributo notevole alla presa di confidenza, da parte di molti italiani, con opere letterarie più o meno celebri, lette, spesso per la prima volta, in seguito al successo di un film. Ad accrescere i punti di tangenza tra i due linguaggi, molti autori hanno alternato l’attività letteraria 18. Cfr. BEVITORI (2000). 19. Gualtiero Ildebrando Fabbri (Bologna 1861–Foglizzo Canavese [To] 1929) «fu l’iniziatore non solo nazionale ma presumibilmente mondiale della narrativa d’ispirazione cinematografica» e «il primo professionista del giornalismo cinematografico italiano» (RAFFAELLI 1993e: 53). TAGLIABUE (1990: 29–31) parla anche del Cinematografo cerebrale, di Edmondo De Amicis, 1907. 3 – Cinema e letteratura 125 con la regia cinematografica. Il caso più noto è senz’altro quello di Pier Paolo Pasolini, ma non si possono dimenticare almeno il citato Mario Soldati, il letterato Emilio Cecchi — direttore della produzione cinematografica della Cines dal 1932 (vi collaborerà fino al 1953) e responsabile, tra l’altro, del frequente ricorso del cinema a soggetti letterari e a maestranze provenienti dal mondo della narrativa —, il drammaturgo Eduardo De Filippo, e ancora Carmelo Bene, Pasquale Festa Campanile, Giuseppe Partroni Griffi e tanti altri, fino a giungere a casi più recenti (Alberto Bevilacqua, Cristina Comencini…). Se si passa dai registi agli sceneggiatori, poi, l’elenco dei romanzieri, dei drammaturghi e dei poeti si fa sterminato: per limitarci ai nomi italiani più noti del dopoguerra, oltre all’immancabile Zavattini, si ricordano almeno Alvaro, Arpino, Bacchelli, Barbaro, Bassani, Berto, Brancati, Buzzati, Calvino, Achille Campanile, De Céspedes, Diego Fabbri, Flaiano, Guerra, Malerba, Maraini, Moravia, Parise, Pratolini, Sciascia, Testori… Camilleri e Cerami sono, tra i nomi recenti, forse i più conosciuti e apprezzati20. Oggi più di ieri, infine, per via dell’enorme pianificazione economica della macchina–cinema, è frequente, soprattutto nelle grandi produzioni statunitensi, il caso di romanzieri che scrivono le proprie opere già nell’ottica delle sceneggiature che dovranno esserne ricavate (gli esempi, più o meno recenti, vanno da Stephen King agli ultimi romanzi della serie Harry Potter della scrittrice inglese Joanne K. Rowling). Sarebbe interessante studiare il cambiamento di stile di un autore in base alla consapevolezza della prossima trasposizione di una sua opera: prevedibilmente il discorso diretto prenderà il sopravven- 20. Peccato che molti repertori, anche accurati, ignorino o non segnalino l’attività di sceneggiatori di questi autori, quasi fosse irrilevante in un profilo biografico e professionale. Si legga a titolo d’esempio la scheda su Alba De Céspedes, in Letteratura italiana. Gli Autori. Dizionario bio–bliografico e Indici. A–G, diretta da Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1990, p. 670: non una parola sulla sua partecipazione alla sceneggiatura delle Amiche e altre (per es., Nessuno torna indietro, 1945, di Blasetti, tratto dall’omonimo romanzo della stessa De Céspedes del 1938), nonostante che si accenni alla sua collaborazione con radio e giornali. 126 Il linguaggio cinematografico to sull’indiretto, le parti descrittive su quelle speculative e la scansione dei vari eventi oltreché i tratti distintivi dei personaggi si faranno più scolpiti. 4) La letteratura tratta dal cinema. Talora (piuttosto raramente, a dire il vero), soprattutto per film di grande successo, viene pubblicata la sceneggiatura (di solito quella iniziale) oppure il découpage (o trascrizione del film, corredata, oggi, di fotografie di scena, riproduzioni di fotogrammi [→ Glossario, FOTOGRAMMA ], recensioni, articoli e altro materiale PARAFILMICO [→ Glossario]) o lo STORYBOARD [→ Glossario]. Oppure vengono pubblicati libri tratti da un film o ad esso ispirati o, comunque, editi sulla scia di un successo cinematografico. Ecco dunque che l’opera filmica si trasforma in altro da sé, chiudendo così il ciclo delle trasposizioni di codice: recente ed emblematico il caso della Vita è bella, 1997, di Benigni, che ha dato vita a una canzone (Beautiful that Way, interpetata da Noa) e a un libro (Torino, Einaudi, 1998)21. Anche gli orientamenti teorici dell’analisi possono essere diversi: almeno estetico–letterario, estetico–filmologico, semiologico, linguistico, storico. Qui ci occuperemo soltanto del punto 3, ovvero di opere narrative o drammatiche trasposte in film, secondo un’ottica prevalentemente linguistica. Secondo la maggior parte degli studiosi, un film tratto da un’opera letteraria deve essere giudicato del tutto indipendentemente da quest’ultima e dunque la questione della fedeltà alla fonte è nient’altro che un falso problema: il medium cinematografico non può non operare una radicale riscrittura e reinvenzione dell’impianto narratologico, linguistico e in generale semiologico. Soprattutto nella diversa amministrazione del 21. Sulla prima collana editoriale italiana di sceneggiature (desunte dalla visione del film), per la gloriosa Cappelli di Bologna, fondata e diretta da Renzo Renzi e attiva tra gli anni Cinquanta e Settanta, cfr. MANZOLI (2003: 67), il quale ricorda anche come la trasformazione del film in libro fosse dettata, in passato, dall’esigenza di tutelarsi dal plagio e soprattutto di garantire al cinema dignità artistico–filologica pari a quella del teatro e della letteratura. Un’altra storica collana di sceneggiature è “Cinema” della Casa del Mantegna di Mantova (cfr. AGE/SCARPELLI/MONICELLI 1989). 3 – Cinema e letteratura 127 tempo e dello spazio si coglie la differenza profonda tra libro e film, benché entrambe le forme espressive ruotino attorno alle funzioni della narrazione e dell’azione: La narrazione in un libro si avvale sopra tutto del tempo in cui si snoda la scrittura. Ma non vi è dubbio che entrambi producono immagini diegetiche, e che tali immagini hanno bisogno di essere inserite in coordinate spazio–temporali interne al lettore o allo spettatore. È in questo “contenitore” creato dalla mente di chi legge un testo letterario o guarda un film, che continueranno a vivere personaggi, storie, paesaggi immaginati, come se fossero appartenuti all’esperienza reale. In virtù di questi meccanismi, i testi letterari rappresentano una tentazione ineludibile per tanti registi; ma anche se dovessero essere del tutto ignorati, resterebbe ugualmente, come ineliminabile, la struttura narrativa22. Il testo da cui è tratto un film non è dunque che un pretesto, anche negli adattamenti più fedeli. Si possono, tuttavia, individuare delle costanti nella prassi della riscrittura? Si può delineare una sorta di grammatica dell’adattamento cinematografico? La risposta è, almeno in parte, affermativa, come cercheremo di dimostrare non tanto in questa prima parte introduttiva, bensì nei cinque casi specifici e paradigmatici sotto analizzati. Cominciamo con l’osservare che il travaso di un testo narrativo o teatrale in uno filmico può seguire quattro diverse modalità. 1) La prima è la mimèsi o fedeltà pressoché totale. Soltanto pochissimi film riproducono fedelmente il testo verbale dell’opera da cui sono tratti. I motivi sono ovvi: rispetto alla libertà creativa di uno scrittore ben altri sono i vincoli nella costruzione di un film e, per limitarci al piano linguistico, se il pubblico è disposto ad accettare la lingua letteraria della pagina scritta, ben altro si aspetta dai dialoghi parlati di un film. L’eccezione che conferma la regola si ha in un genere cinematografico particola- 22. NUVOLI (1998: 14). 128 Il linguaggio cinematografico re (direi parafilmico), quello teatrale e operistico, consistente nell’allestimento cinematografico di un dramma o di un’opera lirica. Si tratta però di una sorta di teatro filmato, più che di cinema vero e proprio. E anche qui, oltretutto, non mancano casi di tagli e modificazioni rispetto al testo originale. Per fare un esempio, pubblico e critica s’indignarono per l’espunzione della celebre Canzone del salce dall’Otello verdiano (e per l’aggiunta di alcune danze), filmato da Franco Zaffirelli nel 1986. In altri generi, la fedeltà testuale è praticamente inesistente. Tuttalpiù possiamo riconoscere un certo numero di enunciati che, letteralmente, vengono prelevati dalla fonte e introdotti nei dialoghi filmici. Accade, per esempio, nella Cena delle beffe e in Passione d’amore, sotto analizzati, oppure, per un caso più recente, nella Leggenda del pianista sull’oceano, 1998, di Giuseppe Tornatore, da Novecento di Alessandro Baricco. È ovvia la minor distanza strutturale tra cinema e teatro, che tra letteratura e cinema: non è dunque casuale la maggiore fedeltà nell’adattamento di testi teatrali (per l’appunto, La cena delle beffe) rispetto a quelli narrativi. In questi ultimi, infatti, il prevalere del piano diegetico (vale a dire delle parti non dialogate, ovvero quelle della voce narrante) su quello mimetico (le battute dei personaggi) [→ Glossario, DIEGÈSI] rende spesso complesso il rispetto dei dialoghi (solitamente brevi, nel romanzo, e contrappuntati dagli interventi del narratore). Complessivamente, tuttavia, il cinema si pone nei confronti del teatro (o meglio, della letteratura teatrale) in un atteggiamento pressoché analogo a quello assunto nei confronti dei testi narrativi: è assai più frequente la riscrittura che non l’adattamento letterale e il risultato dell’operazione, come vedremo, va perlopiù in direzione della semplificazione e della normalizzazione non solo linguistiche23. 23. Il lettore dovrebbe astenersi ancora una volta, come già avvertito nel primo capitolo, dal caricare questi concetti di una connotazione per così dire moralistica: il fatto che un film tratto da un romanzo risulti fatalmente meno ricco di scarti dalla lingua media rispetto alla fonte non è necessariamente un difetto della trasposizione, bensì un’inevitabile conseguenza del passaggio da un sistema di comunicazione a un altro. 3 – Cinema e letteratura 129 Urge a questo punto una breve parentesi sui principali caratteri distintivi dei linguaggi cinematografico e teatrale24. Partiamo dalle analogie, che non sono molte: si tratta, in entrambi i casi, di diasistemi di codici (immagini, parole, rumori, suoni…), con un testo scritto di riferimento, destinati a un tipo di fruizione collettiva. Inoltre, la storia dei due mezzi, nell’ultimo secolo, si è intersecata più volte, dal momento che il cinema ha preso in prestito dal teatro sia molti termini tecnici (battuta, copione, regia, scena, scenografia, soggetto, teatro, etc.), sia gran parte dei suoi protagonisti (lo vedremo più diffusamente nel § 4.1). Per il resto, s’è già ricordato che il testo teatrale è essenzialmente opera di un singolo autore, mentre la sceneggiatura (con i suoi numerosi rimaneggiamenti prima, durante e dopo le riprese del film) è un prodotto d’équipe. L’attenuazione del ruolo dell’autore, dunque, e i continui passaggi di testo in testo e di esecutore in esecutore conferiscono ai dialoghi cinematografici maggiore agilità e inclinazione al plurilinguismo e all’ibridismo. Ma la differenza fondamentale tra le due forme risiede nel fatto che il testo teatrale è concepito per essere replicato e spesso tramandato anche nella forma scritta (molto più spesso di quanto non accada con le sceneggiature), mentre il film è concepito per il riuso in tempi brevi (ininfluente, seppure interessante sotto altri punti di vista, il caso dei cosiddetti remake, nuovi film a tutti gli effetti). Naturalmente il fenomeno è in gran parte spiegabile con il prestigio del teatro (quantomeno tragico) nel sistema delle arti, teatro ritenuto cioè immortale, al pari della letteratura “classica”, di contro alla natura commerciale ed effimera del cinema. L’irripetibilità, la deperibilità, l’illeggibilità e la maggiore vendibilità del testo filmico comportano vistose conseguenze dal punto di vista delle scelte e delle 24. Esigua, nel complesso, anche la bibliografia dedicata al parlato teatrale (se si escludono le trattazioni di taglio storico–letterario, dedicate perlopiù a singole opere o autori, e la pletora di saggi sulla lingua pirandelliana): cfr. almeno NENCIONI (1976/983); STEFANELLI (1982) e (1987); TRIFONE (1994), (1995) e (2000). Sui rapporti tra testo teatrale e testo filmico cfr. CHIARINI (1957) [→ Antologia critica, § 2] e MAMONE (1992). 130 Il linguaggio cinematografico tecniche compositive25: propria del testo cinematografico è l’esigenza di immediatezza, di dire tutto e subito per farsi capire da tutti qui e ora. Per questo il dialogo filmico ha quasi sempre uno stile mimetico mentre il dialogo teatrale si rifà alla lingua della tradizione letteraria, poco preoccupato della riproduzione della realtà. Il testimone privilegiato (soprattutto a distanza di anni) di un dramma o di una commedia è la pagina scritta, quello di un film non è la sceneggiatura. All’agile hic et nunc del parlato del cinema, il teatro (si escludono qui le forme non prototipiche quali la Commedia dell’Arte, l’avanspettacolo, la sceneggiata, etc., nonché qualche esempio di teatro “parlato–parlato” contemporaneo) contrappone un parlato più sorvegliato e antirealistico. Non sarà inutile ricordare che la maggior parte dei copioni su cui lavorano attori e registi teatrali riproduce fedelmente (non mancano le eccezioni) la lingua dell’originale, mentre le battute definitive dei film non coincidono mai con la sceneggiatura di partenza. Per tutti questi motivi il dialogo filmico, seppure commisto di strutture tipiche dello scritto e del parlato, è tendenzialmente più verosimile, direi attualizzato (cioè più vicino a un atto linguistico reale che alla lettura della pagina scritta), rispetto a quello teatrale. Non a caso l’uso traslato degli aggettivi teatrale e cinematografico, nella lingua comune (per es.: perché sei sempre così teatrale?; questo romanzo è scritto in uno stile cinematografico), è sostanzialmente antonimico: sinonimo di enfatico, artefatto, il primo, di agile e realistico, il secondo. Anche dal punto di vista prosodico, i parlati filmico e teatrale sono diversissimi. Infatti la differenza dei mezzi di diffusione (il corpo dell’attore e l’acustica del teatro per il parlato scenico tradizionale — oggi peraltro sempre più spesso amplificato —, le complesse apparecchiature magnetiche e oggi digitali di registrazione, sincronizzazione e amplificazione per il parlato filmico) fa sì che l’intonazione e la pronuncia degli 25. Cfr. A MELIO (1994: 92–94). Sulla fuggevolezza del testo f ilmico cfr. CASETTI/DI CHIO (1990: 8–11). 3 – Cinema e letteratura 131 attori al cinema non possano non essere più realistiche (paradossalmente: il microfono, pur filtrando e amplificando la voce, la rende meno artefatta) di quelle degli attori sul palcoscenico. Questo perché la manipolazione della voce consente agli attori cinematografici di rinunciare a certe tecniche di impostazione vocale essenziali a teatro (o quantomeno tuttora insegnate nelle scuole di recitazione) per una corretta ricezione del testo. Si allude qui, soprattutto, alla marcata e innaturale scansione e accentazione delle ultime sillabe delle parole degli attori di teatro e, viceversa, all’uso cinematografico di “battute sporche” e “buttate”, di “pianissimi” e addirittura di parole mute (movimenti labiali privi si suono), inattuabile o comunque scomodo a teatro; inoltre agli effetti di parlato sulla musica e sui rumori di scena, tanto frequenti sullo schermo e tanto rari sul palcoscenico26. La diversa percezione da parte dello spettatore condiziona anche la formazione del testo a livello morfosintattico e pragmatico [→ Glossario, PRAGMATICA]: l’abbondante uso di deittici [→ Glossario, DEISSI], verbali e gestuali, che a teatro permettono di individuare il destinatario e il tema dell’enunciato, al cinema diventa pleonastico grazie alla deissi intrinseca della macchina da presa, intesa come occhio del pubblico oltreché del regista e degli attori. D’altro canto, però, il maggiore “ancoraggio referenziale” e “pragmatico–situazionale” del dialogo filmico (vale a dire la sua simulazione del parlato spontaneo, con tanto di coinvolgimento emotivo degli interlocutori tra loro e con l’argomento della conversazione) rispetto al testo teatrale fa sì che nel primo s’innalzi la frequenza di segnali discorsivi e di elementi deittici. In altre parole, se prendiamo il modello bipartito (comunque troppo rigido, ancorché nato per attenuare l’eccessiva schematicità della contrapposizione tra scritto e parlato ampiamente esemplificata nei §§ 1.2, 1.3 e 1.4) messo a punto da Koch e Oesterreicher sulla distanza/vicinanza (da intendersi 26. Su alcune caratteristiche della voce amplificata al cinema si tornerà nel § 5.1.4. Dello stile recitativo “buttato” si parlerà nel § 5.3.1. 132 Il linguaggio cinematografico Tabella 3.1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IMMEDIATEZZA Comunicazione privata Interlocutore familiare Emozionalità forte Ancoraggio pragmatico e situazionale Ancoraggio referenziale Compresenza spazio–temporale Cooperazione comunicativa intensa Dialogo Comunicazione spontanea Libertà tematica DISTANZA Comunicazione pubblica Interlocutore sconosciuto Emozionalità debole Distacco pragmatico e situazionale Distacco referenziale Distanza spazio–temporale Cooperazione comunicativa minima Monologo Comunicazione preparata Fissità tematica27 come rapporto sia tra gli interlocutori, sia tra questi ultimi e il testo prodotto e ricevuto), dobbiamo collocare tanto il parlato teatrale quanto quello filmico grosso modo a metà strada tra i due poli (intendo, naturalmente, il piano del dialogo riprodotto tra gli attori, visto che quello con gli spettatori — secondo lo schema del § 1.4.1 — fa parte di un tipo di comunicazione pubblica e dunque, per definizione, “distante”), tendenzialmente spostato verso il polo della vicinanza (o immediatezza) il parlato filmico, verso quello della distanza il parlato teatrale, soprattutto nei punti 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della Tabella 3.1. 2) Riduzione–adattamento. È, insieme con la successiva, la modalità prediletta dal cinema. Il testo di partenza viene in gran parte rispettato nella trama generale, nei personaggi, nell’ambientazione, ma privato del discorso indiretto (solo raramente trasformato in voce–commento fuori campo: nel nostro corpus, solo in Passione d’amore), che, per meglio dire, viene transcodificato nella componente meramente iconica (e talora anche musicale) del film. I dialoghi vengono opportunamente trattati: 27. Lo schema è tratto da KOCH (2001: 18), ma per un approfondimento sul bipolarismo scritto/parlato (o, più correttamente, immediatezza/distanza: non tutto il parlato è immediato, né tutto lo scritto è distante) cfr. anche KOCH (1988) e (1997) e KOCH/OESTERREICHER (1985), oltre a quanto già segnalato nel § 1.4.1. 3 – Cinema e letteratura 133 ora mantenendo qualche battuta, ora tagliando, ora integrando, ora spostando parti di testo da un personaggio all’altro o trasformando un discorso indiretto in diretto, secondo criteri che rispondono fondamentalmente a un unico scopo: facilitare quanto più possibile la fruizione dello spettatore, eliminando le ripetizioni eccessive, sciogliendo i punti oscuri della trama, aggirando eventuali scogli linguistici, attenuando gli scarti dalla lingua standard. Due esempi evidenti di questa modalità di adattamento cinematografico sono Le amiche e L’innocente. 3) Radicale trasformazione. È un caso assai frequente, che vediamo qui esemplificato in Ladri di biciclette. Del romanzo di Bartolini viene rispettato quasi soltanto il titolo e lo spunto iniziale: il furto di una bicicletta. Per il resto, neppure una sola battuta del film riprende parti della fonte e lo spirito del libro è in sostanza ribaltato. Vanno annoverati in questa categoria tutti i film che dichiarano di essersi “liberamente” ispirati a una fonte preesistente e anche quelli che non denunciano alcuna fonte (solitamente per problemi di diritto d’autore, come si vedrà nel prossimo capitolo con La terra trema, 1948, di Visconti). 4) Parodia. Il genere della parodia è, ma ancor più era, assai praticato nel cinema di consumo (e anche nella televisione: tra gli esempi più felici degli ultimi anni, I promessi sposi del trio Solenghi–Marchesini–Lopez). Molti film con Totò o con il duo Franchi–Ingrassia, per esempio, nascevano come parodie più o meno puntuali di altri testi, tra i quali opere liriche (Figaro qua… Figaro là, 1950, di Carlo Ludovico Bragaglia, dal Barbiere di Siviglia di Rossini) e romanzi (Il monaco di Monza, 1963, di Sergio Corbucci, da Manzoni). Anche in questo caso, naturalmente, lo spunto letterario non è che un pallido pretesto. Anche qualora vengano rispettati personaggi, situazioni e finanche alcune battute, l’intento è di puro contrappunto umoristico, come nella lezione di musica in Figaro qua… Figaro là, laddove la scena di Rosina seduta alla spinetta pare funzionale soltanto al gioco di parole: «Non c’è Rosina/ senza spinetta». Passiamo finalmente all’analisi dei cinque film scelti, procedendo in ordine cronologico. 134 Il linguaggio cinematografico 3.2. La cena delle beffe Il confronto tra il dramma di Benelli e il film di Blasetti è stato condotto, in dettaglio, in ROSSI (1999b), di cui si riassumono qui le conclusioni. Anche quando vengono mantenuti, in parte, gli endecasillabi benelliani (del tutto immotivata è la zeppa che altera il verso più celebre del dramma: «Chi non beve con me, peste lo colga!», che diventa nel film «E chi non beve con me/ peste lo colga!»)28, la lingua del film, nonostante l’ambientazione quattrocentesca e la volontà di far parlare i personaggi in uno stile alto e teatrale (con tanto di messere e madonna ‘signora’ e con l’aggiunta, rispetto al dramma, di servente ‘serva’), è normalizzata rispetto all’originale, come risulta evidente dai seguenti brani. DRAMMA (I, vv. 96–108, 154–171): Questi due fratelli ebbi per miei compagni ne’ trastulli infantili, ne’ giochi giovanili… Costoro sono forti con letizia, come i leoni. Io sempre li guardavo con maraviglia; e, quando era incantato di loro forza, m’acciuffavan forte con le zampe e le zanne, e sbrana, e tribbia… Mi dicevano gli altri: Su, coraggio; sii un uomo; rivoltati; fa’ core!… Loro stessi, ridendo, m’aizzavano; ed appena che alzavo un dito solo, mugliando mi storpiavano le braccia… […] Ed io… rido! […] Sì, perché un’altra donna ho tolto per amarla assai più bella e più lusingatrice… 28. La battuta rimarrà per sempre attaccata a Nazzari come segno di riconoscimento ed è varie volte citata anche al cinema, come accade per esempio nei Vitelloni, 1953, di Fellini, allorché Alberto Sordi fa ridere le ballerine, sedute in trattoria, dicendo a una di loro: «Piccina mi piaci// E chi non beve con me/ peste lo colga». 3 – Cinema e letteratura Si chiama essa Vendetta. Io la saprei dipingere cotanto l’ho sognata e posseduta in sogno: la farei tutta gaia beffarda e sghignazzante, e in pieno riso mostrerebbe i denti canini e gli occhi lampeggianti verdi: la toga elegantissima scomposta da una parte in un gesto di follia le cicatrici rosse mostrerebbe sopra la carne sua martoriata… E la trista danzante ci direbbe: Chi ama me tutte le donne ama; Chi ama me tutte le gioie tocca; tutte le grazie esprimo io di me stessa. Ma, per avermi, ridi, ridi, ridi; FILM (scene 2–4): Questi due fratelli/ sono stati miei persecutori fino dall’infanzia// Costoro sono forti con letizia/ come i leoni// Io li guardavo sempre con meraviglia! E quanto più era incantato della loro forza/ mi acciuffavano forte con le zampe/ le zanne/ e mi torturavano// Mi dicevano gli altri/ abbi cuore! Sii uomo! Ribellati! Loro stessi/ ridendo/ m’aizzavano// Ed appena che alzavo un dito solo… […] Sì/ rido! Rido/ perché un altra donna/ ho scelto per amarla// Assai più bella e più lusingatrice! Essa si chiama/ Vendetta! Ah Dio! La saprei dipingere/ da quanto l’ho sognata/ e posseduta in sogno! La farei gaia/ beffarda/ sghignazzante! E in pieno riso mostrerebbe i denti canini/ e gli occhi lampeggianti/ verdi! La toga elegantissima strappata da una parte/ mostrerebbe le cicatrici rosse della sua carne martoriata! E la sento parlare! Mi direbbe/ chi ama me/ tutte le donne ama! Chi tocca me/ tutte le gioie tocca! Ma per avermi/ se vuoi avermi/ eh/ ridi! Ridi! Ridi! DRAMMA (III, vv. 404–410): Tu mi passavi accanto, come al rivo coperto di ranuncoli e di mammole, passa il torrente: canta e seco mormora, e nulla vede; e il rivo in lui si specchia… Solo la mia compagna, la mia vecchia nonna, ch’ebbe un amore sfortunato, a sperare, a sperare m’ha insegnato; 135 136 Il linguaggio cinematografico FILM (scena 12): Tu mi sei passato accanto/ come il torrente passa accanto al rivo// Passa/ e non vede nulla// Ma la mia compagna/ la mia vecchia nonna/ che ha avuto un amore sfortunato/ mi ha insegnato a sperare//. L’ordine delle parole viene spesso normalizzato («sempre li guardavo» → «li guardavo sempre»; «si chiama essa» → «essa si chiama»; «le cicatrici rosse mostrerebbe» → «mostrerebbe le cicatrici rosse»; «accanto […] al rivo […] passa il torrente» → «il torrente passa accanto al rivo»; «nulla vede» → «non vede nulla»; «a sperare m’ha insegnato» → «mi ha insegnato a sperare»). Alcuni arcaismi e poetismi vengono attualizzati (maraviglia → meraviglia; «fa’ core» → «abbi cuore»; tolto → scelto) e a termini e costrutti meno comuni vengono sostituite forme di alta frequenza (cotanto → «da quanto»; scomposta → strappata; passaggio dal passato remoto al passato prossimo: ebbi → sono stati; ebbe → ha avuto). In altri brani, si può osservare un’analoga tendenza alla normalizzazione e all’attenuazione del superstandard poetico, per quanto riguarda la morfologia verbale e la fonetica (anderesti → andresti; chieggo → chiedo; còrre → cogliere; vo’ → voglio). Alcuni costrutti desueti o tipicamente toscani vengono rammodernati e italianizzati: «somigli tuo fratello» → «somigli a tuo fratello»; «a ordine» → «in ordine»; «vorrei vederti al caso» → «vorrei vederti alla prova»; «vi consiglio a ridormirci» → «vi consiglio di ridormirci»; «la m’ha guardato» → «mi ha guardata». Qualche altro invece rimane inalterato: «date in tavola». Alcune scelte lessicali e fonomorfologiche subiscono lo stesso trattamento attualizzante e di riduzione dell’allotropia rispetto al dramma: arme → arma (rimane però nel film una sola occorrenza di arme); Fiorenza → Firenze; foco → fuoco; liscio → lisciato; mirare → guardare; stiava → schiava29. 29. Viceversa, vengono mantenuti alcuni aulicismi e toscanismi, per garantire la 3 – Cinema e letteratura 137 La riduzione di Blasetti, sebbene abbastanza fedele alla fonte (con tanto di apertura di sipario iniziale, quasi a dichiarare una messa in scena filmata del dramma tale e quale), non si limita dunque al banale taglio di versi e all’aggiunta di scene di raccordo che diano corpo e movimento ai lunghi racconti in versi di quanto è accaduto (per es. il flashback iniziale mediante il quale Giannetto rivive l’antefatto della rivalità con Neri, oppure la scena di Neri in Vacchereccia e la sua successiva fuga dal campanile), bensì opera una complessiva omogeneizzazione stilistica tendente ad attualizzare le punte espressive di Benelli. Inevitabile è anche l’eliminazione dei doppi sensi osceni del dramma, il quale, nonostante lo svantaggio di non mostrare il seno nudo della Calamai, risulta assai più “scandaloso” del film. 3.3. Ladri di biciclette È curioso che anche il film forse più emblematico del Neorealismo attinga alla letteratura prima ancora che alla cronaca30, come del resto aveva già fatto Visconti con Ossessione, 1943 e con La terra trema, 1948. La fonte è l’omonimo romanzo di Luigi Bartolini31, che in realtà più che un romanzo è propriamente un racconto, sia per le esigue dimensioni sia, soprattutto, per le modalità narrative. Non è un caso che anche altri due film del nostro corpus (Le amiche e Passione d’amore) siano tratti da racconti lunghi (o romanzi brevi? Ricordiamo anche i viscontiani Senso, 1954 [Fig. 13] e Morte a Venezia, 1971, da novelle di Camillo Boito e di Thomas Mann, o le numerose trasposizioni patente di antichità e di regionalità del film: concio ‘conciato’, desiare, gaglioffo, ingollare ‘ingoiare’, madonna, manigoldo, messere, onorando, ragna ‘ragnatela’, stracco ‘stanco’. 30. Ma diceva giustamente Antonioni: «Quando si distacca una storia dalle parole che la esprimono, che la fanno racconto compiuto in sé che cosa rimane? Rimane una vicenda che equivale a un fatto di cronaca letto su un giornale, al racconto di un amico…» (BRUNETTA (1970: 126). 31. Sui motivi della scelta, si legga DE SICA (1948). 138 Il linguaggio cinematografico filmiche delle novelle di Pirandello): la novella o il racconto, nella loro sintesi e agilità narrativa, si prestano spesso meglio del romanzo di ampio respiro alla riduzione filmica. A differenza della Cena delle beffe, Ladri di biciclette viene non soltanto integralmente riscritto, nella versione cinematografica, ma capovolge lo spirito di Bartolini, il quale, non a caso, denunciò De Sica e Zavattini per violazione dei diritti d’autore32. Il romanzo–racconto, infatti, appartiene al genere autobiografico (è scritto in prima persona e contiene numerosi riferimenti a episodi di vita reale dell’autore, in primis il suo status di pittore–scrittore antifascista) e umoristico: «romanzo umoristico del furto e del ritrovamento di una bicicletta per tre volte», recita il sottotitolo della prima edizione (1946). L’autobiografismo e l’elitarismo dell’artista–intellettuale borghese (ribadito dall’autore stesso: «La mia opera è autobiografica […]. Credo […] che l’opera d’arte […] valga soltanto come testimonianza del modo — di un individuo d’eccezione — di concepire lo stare al mondo»)33 è agli antipodi del verismo sociale di Zavattini–De Sica. Anche il tono moralistico e manicheistico di molte parti del romanzo non trova riscontro nel film: Vedo il modo del traffico; e saprei trafficare; però la verità è che sono, negli affari, un onesto provinciale, un fuorimondo, o chiamatemi come vi pare; fatto è che non ho mai voluto trafficare: considerando l’esistenza umana un breve passaggio: durante il quale non conviene trafficare, ma solo conviene contemplare; mentre la cosa migliore, per un poeta, consiste nell’osservare e nel rendere argomento di poesia anche i casi peggiori dell’umana esistenza. In altre parole: è miglior cosa, secondo me, essere poeti e poveri, rimaner poveri, vivere quasi da poveri; che non diventar ladri e tanto meno manutengoli (Bartolini, pp. 38–39). I ladri, per Bartolini, «rubano per rubare. È un loro istinto» (ID., p. 39). Anche in questo caso si assiste a un vero ribalta32. Cfr. BRAGAGLIA (1993: 133). 33. Cit. nell’edizione del romanzo curata da Valerio Volpini, Introduzione, p. 9. 3 – Cinema e letteratura 139 mento ideologico: Antonio Ricci, il povero derubato del film, si trasformerà alla fine in ladro, costretto dalle circostanze. E per lui il furto della bicicletta, prima subìto e poi tentato, è evento esistenziale, dal quale dipende la sua stessa sopravvivenza, mentre per il protagonista del romanzo è perdita più simbolica che reale, oltretutto risolubile, quella reale, con l’acquisto di altre biciclette: Non si tratta, vivendo, che di ritrovare il perduto. Lo si può ritrovare una, due volte, tre, come io, per due volte, sono riuscito a ritrovare la bicicletta. Ma verrà la terza volta e ritroverò più nulla. Così, è, ripeto, di tutta l’esistenza. È un correre a ritroso, per finalmente perdere o morire. Un correre a ritroso fin dall’infanzia! […] Si cercan fin troppe cose prima di morire (Bartolini, pp. 150–151). Un elemento del romanzo, di contro, felicemente rispettato dal film è l’avversione al cinema, più volte ribadita da Bartolini: Giudicai che costui [un ladro] fosse un attore del cinema. Un attore illustre. Ma il male è che io, non amando soverchiamente le prodezze del cinema, ed anzi (come si sa) considerando il cinema un’arte volgare e che mai potrà distaccarsi (a cagione della sua natura, essenza e necessità pratiche) dal volgare, non seguo le divinità da pellicola. Ignoro perfino i loro nomi, perfino le gesta (risapute da una qualunque signora) dei nostri divi (Bartolini, p. 26). Altrove l’autore si definisce «nemico del cinema» (Bartolini, p. 134). Il film sfrutta con raffinatezza l’alterità del mondo lustrini e paillettes rispetto alle amarezze della povertà vissuta, dell’illusione rispetto alla realtà. Questi temi sono in un caso esplicitamente dichiarati da un personaggio secondario del film: «La Domenica/ piove sempre// Smonti all’una/ e te tocca a chiùdete dentro casa// Ma me sa di’/ do’ vai?! A me/ ’sto cinematografo/ nun me va// Nun me va propio/ d’annacce//». In altri casi, vengono ribaditi iconicamente con ripetute inquadrature di manifesti e locandine in vendita nei mercati: i sorrisi e il trucco delle dive sembrano contrappuntare l’ansia e la disperazione di 140 Il linguaggio cinematografico Antonio, Bruno e compagni. La scena del furto, nella prima parte del film, si svolge in silenzio, mentre Antonio sta attaccando un gigantesco manifesto raffigurante Rita Hayworth. Ecco dunque che il film di De Sica, solo apparentemente semplice e come “fatto da sé”, si configura come testo complesso (ben più del romanzo da cui è tratto), dalle molteplici letture, una delle quali è quella metafilmica: un film sul rapporto tra Neorealismo e altri generi cinematografici. Entrando nell’analisi linguistica, l’elemento distintivo di maggior rilievo è la forte componente dialettale del film, rispetto al tendenziale monolinguismo stilisticamente sostenuto del romanzo. Nel romanzo il dialetto quasi non figura (è solo di colore e di contorno); vi si registrano soltanto le seguenti parole ed espressioni (romanesche e napoletane): pizzardone (pp. 20, 43), saccoccia (p. 34), bacherozzola (p. 34), «ma de che» (p. 37), «Sor maè, dove vai così abbonora?» (p. 53), «Sor maè, cambia discorso, cambia!» (p. 54), gargarozzo (p. 62), «Marescià, ’u vulite ascultare vui?» (p. 81), «Lo sapite? Ce steveno per buttà de sotto!» (p. 82). Mentre nel film è costitutivo e sostanziale: ammappete, anvedi, ariandare, aritrovare, arubare, baccagliare, crocchiare, fregnaccia, fregnone, incollare, mannaggia, sbolognare, sfizio, sfrucugliare, sganassone, tranve, oltre alla presenza di tutti i tratti fonomorfologici e sintattici tipici della varietà romanesca34. Rispetto al romanzo, il film riduce il turpiloquio, per evidenti questioni di censura: si ricordi che il film spiacque alla classe politica dell’epoca, in quanto divulgava un’immagine, anche linguistica, del dopoguerra ben poco incoraggiante. Nel film si registrano soltanto coglionare, cornuto, fregnaccia e fregnone, mentre nel romanzo: minchione (pp. 24, 62), poppe (p. 72), «Mannaggia ai mortacci tui!» (p. 73), beccaccione (p. 74), balordo (p. 77), bagascia (p. 80), «Non rompere i co…!» (p. 81). Assenti, sia nel romanzo sia nel film, le bestemmie, autenti- 34. Cfr. infra, § 4.2.1. 3 – Cinema e letteratura 141 ca rarità della mimèsi filmica e letteraria, ma costitutive della conversazione ai piani più bassi della scala sociale. Va comunque sottolineato che le parti più intense del film sono quelle mute. I nodi psicologico–narrativi (il furto, l’affannosa ricerca dei pezzi di bicicletta tra i banchi del mercato, il pellegrinaggio di Antonio e Bruno per le vie di Roma e la decisione conclusiva del nuovo furto) avvengono, in effetti, in assoluto silenzio, con sottofondo musicale: è «il non verbale come altra verbalità» del cinema35. È questa la potenza del linguaggio cinematografico, in grado di svolgere complesse argomentazioni senza parole: lo spettatore segue passo dopo passo il pensiero di Antonio nella penultima scena, quando matura la decisione del furto, grazie all’abile montaggio che alterna primi piani [→ Glossario, PRIMO PIANO] di Antonio e di Bruno a sequenze di biciclette (che, in un delirio quasi da film espressionistico tedesco, sembrano moltiplicarsi, ingigantirsi fino a riempire gli occhi e la mente di Antonio e dello spettatore), con la musica che accresce lo stato d’ansia, unitamente al sapiente trattamento (qui e nelle scene dei mercati, con volute oscillazioni del volume) dei rumori e delle voci indistinte di sottofondo. Il peso dato al silenzio, alle pause, alle lunghe scene mute è tipico del cinema d’impegno, dai toni documentaristici, differentemente dall’iperparlato esibito nei film di cassetta, tanto più se comici: l’umorismo italiano, si sa, passa soprattutto per il gioco verbale e quindi mal si presta alle scene poco parlate (ma pensiamo ad altri generi stranieri di comicità cinetelevisiva: Buster Keaton, Benny Hill, Mr Bean e altri moderni comici “muti”, da noi limitati al solo Maurizo Nichetti)36. Tuttavia sarebbe sbagliato e ingiusto, nei confronti di Bartolini e degli sceneggiatori del film, negare una serie di influenze (non verbali) dirette del romanzo sul film: del resto, il rapporto tra un film e la sua fonte non può certo essere valutato soltanto 35. PASOLINI (1972/1991: 263). 36. Sui valori linguistici del silenzio cfr. BANFI (1999) e BAZZANELLA (2002c). 142 Il linguaggio cinematografico sulla base dei dialoghi, visto che non di sole parole vive un film e non di solo discorso diretto un libro. Zavattini e compagni si lasciarono ispirare in più di una descrizione, nell’allestimento di alcune scene, come per esempio nell’incontro di Antonio col ladro, a Trastevere. Per chi ha in mente quella parte del film (poco prima del finale), non sarà difficile riconoscere più di un dettaglio nella pagina di Bartolini, soprattutto nella presentazione di quella «ilarità convulsa» della delinquenza romana e nei ritratti del bullo del quartiere e della madre del ladro: Via del Mattonato è una straduccia silenziosa, appoggiata al monte del Gianicolo […]. Sotto l’arco d’un androne erano cinque giovanotti. Stavano scherzando, giocarellando, come fan sempre ladri e delinquenti. Ridono in perpetuo! La loro è, però, una ilarità convulsa […]. I ladri mi riconobbero subito, e si misero a lazzeggiare. Uno, più sguaiato degli altri, si fece avanti e domandò: «Sor maè, dove vai così abbonora?». […] Risposi che andavo in cerca d’una bicicletta che m’era stata rubata due giorni or sono, in Via dei Baullari. Fece, uno, per dileggio: «E dopo due giorni ancora la vai cercando? Ancora non l’hai ritrovata?» E gli altri (mi saltarono addosso come le vespe): «Tutti vengono qui, a cercare le robe rubate: ma cosa siamo, noi? Siamo ladri?». «Io non mi sogno di dir questo,» risposi molto placidamente «ma vorrei vedere cosa fareste voi se, non essendo ricchi, ma anzi, essendo poveri impiegati, con uno stipendio che non è sufficiente per campare quindici giorni su trenta, e sia pure nutrendosi di solo pane e sole erbe, avesse a smarrire, perdere, un oggetto del valore di quindicimila lire!» Rispose uno di loro: «Sor maè, cambia discorso, cambia!». Ma, a questa provocazione, sortì fuori un altro di essi, col cappello alla brasiliana, a falde larghissime, cupola quasi conica: uno che s’atteggiava a guappo maestro e che era il più giovane fra gli altri, e che dimostrava tendenza a capeggiare; uno, cioè, dei tanti antichi squadristi, per farmi osservare che «Trastevere è Trastevere e che la vera Roma è Trastevere». E che, insomma, «erano burini tutti coloro che non consideravano alla stregua dovuta il grande Trastevere». Come si vede, costui putiva di antico romano, e di recente fascista. Se il fascismo non fosse caduto, sarebbe diventato l’aguzzino, il boia del suo gruppo rionale. 3 – Cinema e letteratura 143 […] Allora io mi misi a parlare del nobile Trastevere e dissi loro che faccio il pittore […]. Intanto veniva fuori, da una scalettina che dall’androne immette sulla strada, una vecchia. Una vecchia rugosa, una vera strega. Il giallo delle sue rughe non era inferiore a quello di certi peperoni o di zucche fradice. Gli sguardi erano indagatori: mobili oltre all’età: era vecchia cadente, stava per approssimarsi all’altro mondo: ma i suoi occhi si muovevano ben disinvolti, sciolti come quelli d’un giocoliere o d’un baro (Bartolini, pp. 14–15). 3.4. Le amiche Dopo aver esaminato i rapporti intrattenuti con la fonte dal cinema in costume (maggiore fedeltà, con inevitabili semplificazioni) e da quello neorealistico (assoluta libertà, con notevoli approfondimenti), passiamo ora a un tipico film d’autore, che mostra una modalità di sfruttamento del testo letterario di segno ancora diverso37. Intanto occorre dire che l’opera qui scelta per la riduzione non appartiene, contrariamente alla tendenza del cinema non soltanto popolare, alla letteratura cosiddetta minore; l’approfondimento psicologico dei personaggi, la capacità evocativa dello stile e l’abile ricostruzione dello sfondo sociale (la grassa e provinciale borghesia di Torino) fanno del racconto di Pavese una delle punte più alte del Novecento italiano. Se a questo si aggiunge la stesura della sceneggiatura da parte di una letterata (Alba De Céspedes), di una delle più prolifiche e valide scrittici per il cinema (Suso Cecchi D’Amico) e dello stesso Antonioni e la realizzazione della regia di uno degli autori più raffinati del cinema del dopoguerra, si comprende come non possa essere questo il caso né di un impoverimento della fonte (come purtroppo è stato più volte detto erroneamente) né del trattamento di quest’ultima come semplice spunto (sebbene pro37. Dal punto di vista tematico, la riduzione filmica di Tra donne sole è stata analizzata da BRUNETTA (1970: 125–158), mentre, per il punto di vista linguistico, si rimanda a ROSSI (1999a: 241–273). La sceneggiatura di questo e di altri film di Antonioni è leggibile in ANTONIONI (1964). 144 Il linguaggio cinematografico prio Antonioni abbia più volte sottolineato la propria assoluta indifferenza alla fedeltà nei confronti del testo di Pavese): tra il prodotto di partenza e quello di arrivo sembra infatti esserci una pressoché totale comunione di intenti. Cionondimeno Tra donne sole fu modificato profondamente, sia dal punto di vista tematico e strutturale (cadono tra l’altro, nel film, i numerosi riferimenti sessuali del racconto, quali soprattutto il rapporto omoerotico tra Rosetta e Momina) sia da quello linguistico, con un tipo di normalizzazione di segno opposto rispetto a quello dei precedenti due film: qui infatti alcuni tratti substandard (ora dialettali, ora popolari, ora semplicemente colloquiali) del testo di Pavese vengono sistematicamente eliminati o innalzati di registro. Non c’è traccia nel film di termini ed espressioni legati alla sfera sessuale, come andare a donne, andare a maschi, battere ‘esercitare la prostituzione’, casa di piacere, cazzo, fare l’amore, lesbica, marchetta, orgia, pederasta, porco, prostituta, puttana, né di insulti, seppur blandi, quali fesso, idiota, scema; e neppure di termini popolari o familiari come cine ‘cinema’, cotto ‘ubriaco’, iella, immusonito; cade l’articolo femminile preposto ai nomi propri (come in «la Nene», «la Pia», «la Lina», tratto tipico della varietà settentrionale parlata da Pavese e dai protagonisti del racconto); cadono i che polivalenti e il dativo gli ‘loro’; si riducono le dislocazioni; scompaiono le seguenti espressioni colloquiali: «cascano male», «pazza secca», «bella forza», «far becco», «bell’e finito», «diceva forca della Nene», «far[e] un […] occhio», «facciamo i novanta», «ce l’han su con l’uomo» (dove si riconoscono due altri settentrionalismi: l’apocope vocalica han — le apocopi sono molto più frequenti nel racconto che nel film — e l’uso del verbo sintagmatico [→ Glossario, SINTAGMATICO, VERBO] avercela su), «si rompeva il collo sulla strada», etc. Anche sul terreno dell’onomastica si attenuano le escursioni del romanzo verso l’alto (l’altisonante–ridicolo Febo del racconto diventa Cesare nel film, l’esotico–operistico Loris passa a Lorenzo, cadono i soprannomi come «il gobbo», «il gobbetto» e i diminutivi pseudo–affettivi come Carletto, Fefé, Gegé, Mizi, Pupé, Teresina) e 3 – Cinema e letteratura 145 verso il basso (l’ipocoristico Becuccio passa a Carlo), e viene così ridotto lo scarto tra mondo alto–borghese da un lato e mondo proletario dall’altro. La lingua del film sembrerebbe, fin qui, riflettere una varietà diafasica più alta rispetto a quella del racconto. D’altra parte, però, non mancano in Pavese — assenti nel film — numerosi termini (o perifrasi) ricercati, dotti, stranieri, tecnico–scientifici o letterari: acetilene, biacca, cocktail, condurre la macchina, confabulare, cortinaggio, costei, costui, crocchio, drappeggiare, echeggiare, gigionata, grifagno, insolentire, ligustro, linfatico, meritorio, parlamentare, piovigginare, profluvio, schifiltoso, sovente, squadernare, sweater, tabarino, tea–room, tergiversare, trasmodare, ubbia, etc. A proposito del lessico francese (prevalentemente della moda), invece, sia nel film (applique, atelier, beauté, bleu, chantilly, crêpegeorgette, garçonniere, imprimé, monde, monsieur, pardon, petite robe, santé, tout, vendeuse) sia nel romanzo (atelier, cognac, foulard, hommage à Rosette, lamé, madame, mannequin, papié [sic] collé, tailleur, tulle, volants) si registrano numerosi lemmi. In conclusione, è evidente che il film tende ad annullare lo scarto del racconto da una medietà linguistica, ovvero ne normalizza lo stile, eliminando sia le forme troppo letterarie, sia quelle troppo popolari, o regionali, o connesse con la sfera della sessualità38. Per certi aspetti, dunque, la lingua del film è meno “parlata” (cioè meno varia e più povera di colloquialismi) di quella del racconto, mentre per altri aspetti lo è di più (ovviamente, nel racconto il discorso indiretto supera largamente quello diretto). Un’ultima osservazione sull’uso del dialetto. Mentre nel racconto si avverte una regionalità leggera ma diffusa (apocope, articolo davanti ai nomi propri), che accomuna la voce dell’autore a quella dei suoi personaggi, il film, parlato dai protagonisti in un italiano medio–alto, utilizza qualche battuta dialettale nei 38. «La sceneggiatura ha operato sui dialoghi di Pavese in un senso di riduzione e di semplificazione coerente con tutta la struttura generale del lavoro» (BRUNETTA 1970: 142). 146 Il linguaggio cinematografico personaggi di sfondo, con la solita funzione di colore (architètto, suma ‘siamo’, bolètta ‘bolletta’, «va bén» e poco altro). Anche questo, in certo qual modo, va dunque nella direzione dell’attenuazione delle asperità espressive del testo di Pavese. Questa sorta di dedialettalizzazione del parlato filmico rispetto allo scritto letterario è in evidente controtendenza con la storia del cinema, che si è sempre servito delle inflessioni regionali (o, più raramente, del dialetto puro, com’è il caso della riduzione viscontiana dei Malavoglia, come vedremo nel capitolo successivo, o di Ladri di biciclette) per vivificare la lingua scritta39. 3.5. L’innocente La trama dannunziana, rispettata con qualche aggiustamento, fornisce a Visconti lo spunto per tratteggiare, in questo suo ultimo film uscito postumo, un impietoso ritratto di quella «grossa borghesia che porterà l’Italia al fascismo» (dirà lo stesso regista a proposito del film)40, ben oltre, ovviamente, le stesse intenzioni di D’Annunzio. L’atteggiamento di Visconti nei confronti dell’Innocente è il medesimo mostrato dal regista in altri film di matrice letteraria (Senso, Il gattopardo [Figg. 14–15], Morte a Venezia, etc.): alla puntuale ricostruzione storico–scenografica (il film si apre con un’ambigua dichiarazione di fedeltà: è inquadrata una mano, quella di Visconti, che sfoglia il romanzo, mentre i titoli di testa ci avvertono che si tratta di una «libera riduzione»; come a dire: il romanzo è stato letto attentamente, ma metto le mani avanti sulla mia personale interpretazione) corrisponde un approfondimento notevole dei contenuti (talora una 39. Numerosi sono gli esempi di dialettalizzazione della fonte letteraria (cfr. anche § 4.1.1). Uno di questi è La viaccia, 1961, di Mauro Bolognini, sceneggiato da Vasco Pratolini, Pasquale Festa Campanile e Massimo Franciosa dal romanzo L’eredità di Mario Pratesi e studiato da MARASCHIO (1992), la quale osserva anche l’ulteriore impennata dialettale nel passaggio dalla sceneggiatura al film. 40. DE GIUSTI (1997: 157–158). 3 – Cinema e letteratura 147 riscrittura amplificata: Senso), fino ad assumere la fonte a emblema di un’analisi dei fenomeni socioculturali dell’epoca (si pensi soprattutto alla geniale rilettura critica del Risorgimento in Senso)41. Eppure D’Annunzio, con l’intera sua opera simbolo del decadentismo, ha un ruolo fondamentale nel film, forse ancor più che nel romanzo stesso. E non mancano le spie linguistiche di questa sorta di amplificazione dell’autore. L’innocente ben si presta all’esemplificazione delle principali trasformazioni subite da un testo letterario trasposto cinematograficamente. La prima, prevedibile, modificazione consiste in un numero più o meno consistente di tagli, soprattutto della voce narrante. Per contrappeso, molte scene e molte battute vengono aggiunte, per consentire allo spettatore di comprendere le parti salienti della trama, i rapporti tra i personaggi, i collegamenti tra le scene. Un numero considerevole di modificazioni consiste anche nello spostamento di parti di testo da una scena all’altra (fenomeno frequentissimo in ogni riduzione filmica, motivato dalla necessità di bilanciare i tagli mediante certi raccordi narrativi che recuperano materiali della fonte nei luoghi del film in cui sembrano più utili per la comprensione dello spettatore), come avviene per esempio nel brano seguente. Vediamo, nel film, il protagonista Tullio che comunica alla moglie Giuliana la sua partenza per Firenze, ammettendo la propria relazione adulterina con Teresa Raffo. Il film assume qui un tono radicalmente diverso rispetto al romanzo: non soltanto non v’è traccia di alcuna crisi di coscienza né alcuno scrupolo di dissimulazione in Tullio (che nel film è molto meno multanime — secondo le parole stesse di D’Annunzio — del romanzo), ma addirittura egli dice chiaramente e freddamente alla moglie che parte con l’amante. Visconti si serve di questa scena soprattutto per chiarire allo spettatore i rapporti tra Tullio e Giuliana; a questo fine, assembla concetti disseminati da D’Annunzio in varie 41. Sui film letterari di Visconti, e in particolare sul Gattopardo, cfr. COSTA (1993: 109–127). Sulla trasposizione dell’Innocente, e sulle sue implicazioni psicanalitiche, cfr. DE GIUSTI (1997). 148 Il linguaggio cinematografico sezioni del romanzo, che peraltro, nel punto corrispondente alla scena del film, riservava agli interlocutori poche e brevissime battute (Tullio: «Partirò per Firenze». Giuliana: «Ah», p. 77). Leggiamo ora, invece, il testo radicalmente riscritto della scena filmata (che corrisponde, nei contenuti, alle pp. 67–77 del romanzo): TULLIO: Sai cosa stavo facendo? Ti stavo/ scrivendo// Ma/ dal momento che sei qui// Domani parto per Firenze// Non… non so ancora/ quanto mi tratterrò// Questa volta è una cosa seria// Dovevo/ dirtelo// GIULIANA: Vai via per sempre? TULLIO: Beh/ sempre// Che parole grosse! Senti/ Giuliana/ anche se… anche se non te ne ho mai parlato/ ci sarà… stata certamente in passato qualche… qualche anima pietosa che/ ti avrà messa al corrente delle mie infedeltà// Non te ne ho parlato io stesso/ perché/ erano storie/ senza importanza// Soprattutto perché c’era un patto chiaro/ fra noi// Fin dall’inizio// Dal momento in cui accettasti di sposarmi// L’amore c’è finché dura/ poi subentra… subentrano l’affetto/ la stima/ l’amicizia/ gli interessi comuni// Sempre che ciò sia possibile/ s’intende// Ma/ debbo ritenere di sì/ per te come per me/ visto che/ hai accettato/ senza reagire/ la situazione che/ di fatto/ si era stabilita/ fra di noi/ da parecchio tempo/ oramai// GIULIANA: Erano storie senza importanza/ come dici tu// Per questo ho cercato d’ignorarle// Di non darci peso// Per me il matrimonio dovrebbe essere… TULLIO: Sì/ il nostro matrimonio/ doveva/ essere difeso ad ogni costo// Anche dei propri risentimenti// È questo/ quello che vuoi dire? E hai avuto ragione// Sei stata/ straordinaria// Perché/ seppure il mio amore per te si è… affievolito/ come è fatale che avvenga/ l’affetto e la stima non hanno fatto altro che aumentare// Io ti voglio bene e ti rispetto come… una sorella dolcissima// Della quale io non potrei più fare a meno// Certo/ tu avresti il diritto di farlo/ ma io soffrirei moltissimo/ se tu mi abbandonassi// Vuoi continuare a vivere con me? Aiutarmi? GIULIANA: Aiutarti in che senso? TULLIO: Sopportandomi// Affrontando una situazione che/ secondo gli schemi della società/ sarebbe certamente criticata// La donna che ora amo… 3 – Cinema e letteratura 149 GIULIANA: Teresa Raffo// TULLIO: Sì// Teresa// GIULIANA: È vedova/ e libera// Che cosa ti impedisce di metterti con lei/ se ne hai voglia? TULLIO: Ma io ti ho detto che amo Teresa/ ma non che voglio sposarla/ né vivere con lei// Una donna sensuale/ bella! Io la desidero// Nessuna donna è riuscita mai ad occuparmi di sé/ come lei//. La scena, come s’è detto, in parte crea ex novo e in parte riformula concetti espressi dal narratore in diversi luoghi del romanzo, ad es. a p. 37: A poco a poco, infatti, di abuso in abuso, io era giunto a riconquistare la mia primitiva libertà col consenso di Giuliana, senza ipocrisie, senza sotterfugi, senza menzogne degradanti. Io mettevo il mio studio nell’esser leale, a qualunque costo, come altri nel fingere. Cercavo di confermare in tutte le occasioni, tra me e Giuliana, il nuovo patto di fraternità, di amicizia pura. Ella doveva essere la mia sorella, la mia migliore amica. Prendiamo un’altra scena del film: TULLIO: Eri tu che cantavi? GIULIANA: Sì// TULLIO: Esci? GIULIANA: Sì/ esco// TULLIO: Dove vai? GIULIANA: All’asta di Ducas// Non riesco ad appuntare il velo// Mi aiuti/ per favore? TULLIO: Hai un nuovo profumo// Che cos’è? GIULIANA: Crab–apple// Un profumo inglese// TULLIO: (sfogliando un libro) La Fiamma// “A Giuliana Hermil/ turris eburnea/ indegnamente offro// Filippo D’Arborio”// GIULIANA: Tu non esci? TULLIO: Conosci D’Arborio? GIULIANA: Sì// TULLIO: Non lo sapevo// Quando/ l’hai conosciuto? GIULIANA: Da tuo fratello/ quand’era qui// L’hai letto? TULLIO: Sì// Ho sfogliato qualche pagina/ qua e là al circolo// Uno scrittore mediocre// Non sei d’accordo? 150 Il linguaggio cinematografico GIULIANA: No// TULLIO: Ha uno stile così aulico/ enfatico// Al punto di essere insopportabile// GIULIANA: Come puoi dire una cosa simile? Ha uno stile/ straordinario/ quello che m’incanta// È come una musica// Non puoi/ giudicare un artista/ una persona come lui/ per aver sfogliato/ qua e là il suo libro/ al circolo// TULLIO: Te la prendi a cuore// Sarà quel grande scrittore che tu dici ma… è un maleducato// Questo almeno me lo consentirai// La dedica che ti ha scritto/ non solo/ è enfatica/ ma è anche inopportuna/ se si pensa/ che è rivolta a una signora incontrata/ una sola volta// GIULIANA: L’ho rivisto altre volte// Dopo la sera in cui l’ho conosciuto da Federico// TULLIO: Ah! Prendi la carrozza? GIULIANA: No/ preferisco fare due passi// Ci vediamo più tardi//. Leggiamo ora le sole battute di dialogo (eliminando quindi la voce del narratore) nel romanzo dannunziano (pp. 79–87): TULLIO: Canti? Ti vestivi per uscire? GIULIANA: Sì. TULLIO: Qual è, ora, il tuo profumo? GIULIANA: Crab–apple. TULLIO: Mi piace. Com’è bella l’aria che tu cantavi dianzi! GIULIANA: Tanto bella! TULLIO: Tu ti vestivi per uscire. Séguita dunque. GIULIANA: Non ho da mettermi che la giacca e il cappello. Che ora è? TULLIO: Manca un quarto alle undici. GIULIANA: Ah, già così tardi? Abbi pazienza, Tullio. Mettimi questo spillo qui, nel velo. Permetti… un momento. TULLIO: “A voi, Giuliana Hermil, TURRIS EBURNEA, indegnamente offro. F. Arborio. Ognissanti ’85”. GIULIANA: Che guardi? TULLIO: Conosci Filippo Arborio? GIULIANA: Sì. Mi fu presentato in casa Monterisi. È venuto anche qualche volta qui, ma non ha avuto occasione d’incontrarti. È assai più semplice dei suoi libri. Hai letto Il Segreto? TULLIO: Sì, l’ho già letto. GIULIANA: T’è piaciuto? 3 – Cinema e letteratura 151 TULLIO: No, è mediocre. GIULIANA: Io vado. A rivederci. Il testo, come si vede, viene rispettato abbastanza fedelmente (addirittura l’aria canticchiata da Giuliana nel film è la stessa di cui parla D’Annunzio nel romanzo: «Che farò senza Euridice?», dall’Orfeo ed Euridice, 1762, di Gluck, su libretto del Calzabigi), anche se è evidente la riduzione del superstandard dannunziano: cadono, tra l’altro, dianzi e il passato remoto passivo «mi fu presentato». Si noti inoltre, nella scena citata, la glossa esplicativa «un profumo inglese», apposta all’aroma Crab–apple ‘mela selvatica’. L’uso della glossa è tipico dell’adattamento cinematografico, per la necessità di agevolare la decodificazione di termini particolari da parte dello spettatore (si ricordi quanto accennato a proposito della gestione dei frames, nel § 1.3; se ne tornerà a parlare nei §§ 4.1.1 e 5.2.7). Infine, non sfugga la trasformazione onomastica (cioè di un nome proprio) Arborio → D’Arborio e Il segreto → La fiamma, che ci indicano, direi inequivocabilmente, il riferimento a D’Annunzio, Il fuoco, soprattutto grazie alla descrizione che segue (assente nel romanzo): «Ha uno stile così aulico/ enfatico// Al punto di essere insopportabile». Visconti e gli altri sceneggiatori, evidentemente, non si accontentano di prendere L’innocente a simbolo del decadentismo, ma prelevano l’intera opera di D’Annunzio, che viene così, in certo qual modo, sdoppiato (e il termine non è inappropriato, visto che il multanime Tullio è, già nel romanzo, analizzato proprio nella sua doppiezza) nel protagonista Tullio Hermil e nell’antagonista Filippo D’Arborio. Il solo tratto lievemente arcaizzante del romanzo che trovi, raramente, un riscontro nel film è l’accordo del participio passato con il complemento oggetto (cinque occorrenze in tutto il film, solo in costruzioni pronominali): «ti avrà messa al corrente», «ti ha seguita», «mi ha seguita», «ti ho ritrovata», «ti ho annoiata». In tutti gli altri casi il participio è al maschile anche con oggetto femminile. Neppure il frequente uso del passato 152 Il linguaggio cinematografico remoto è mantenuto: due sole le occorrenze: «Dal momento in cui accettasti di sposarmi», battuta di Tullio, nel secondo dialogo con Giuliana, e «come mi dicesti», Tullio a Teresa Raffo alla fine del film. Rari casi di deviazione dalla norma compaiono nel film: uno, ad esempio, nel dialogo tra Tullio e suo fratello Federico: «Se ci pensi, forse, lo capisci perfino te», dice Federico. Il secondo, nel dialogo tra Tullio e Giuliana dopo la nascita del bambino: «anche a me la sua presenza mi angoscia», dice Giuliana. Si tratta, comunque, di ordinari colloquialismi, che non ostacolano la comprensione del dialogo. Ai numerosi forestierismi del romanzo (inglesi, francesi e russi), corrispondono tre sole occorrenze nel film: il sopra citato Crab–apple, champagne e la frase «l’espace d’un matin», alla fine del film, assente nel romanzo. Cadono, nel film, tutti i tecnicismi, i cultismi, gli arcaismi, i poetismi ortografici, morfosintatici e lessicali, di cui è intrisa la prosa dell’Imaginifico: desinenze in –a della I persona dell’imperfetto; congiuntivi del tipo sii e dieno; grafie (e quindi pronunce) latineggianti del tipo academia, conscienza, imagine, obedire; uso transitivo di verbi quali navigare e somigliare; lemmi ricercati quali amasia, armario, aura, avo, desio, guarentire, temenza; tecnicismi medici quali amaurosi anemica, apoplessia, dipsomane, emiatrofia; tecnicismi botanici quali frutice, ireos; neologismi quali improferibile, multanime, etc. Il lessico del film, insomma, è ridotto, più omogeneo e modernizzato, rispetto a quello del romanzo. Si riporta infine il dialogo tra Tullio e la madre riguardo alla gravidanza di Giuliana: MADRE: (a un inserviente) Forse Giuseppe non ha ancora staccato il calesse// Eh? Digli di andare dal dottor Milani// Gli dici che mi fa un regalo/ se viene stasera stessa// TULLIO: Calma! Calma! Ma che esagerazioni sono queste?! Giuliana sta già bene! È stata una cosa da niente// Non è il caso/ di preoccuparsi così// MADRE: Giuliana mi ha proibito di parlartene/ finché non ne 3 – Cinema e letteratura 153 era sicura// Ma ormai non ci sono più dubbi// E te ne parlo/ anche perché… anche perché/ tu non faccia la sciocchezza/ che hai fatto oggi/ di portarla in calesse per quella strada piena di buche// Giuliana è incinta// TULLIO: Incinta! MADRE: Sì// TULLIO: Te l’ha detto lei? MADRE: No! No! L’ho capito io// Sai/ di malesseri come quello di oggi/ lei ne ha già avuti parecchi// Nausee/ capogiri/ le cose che immagini/ insomma// Allora gliel’ho chiesto// E lei mi ha detto che sperava proprio di essere incinta// Ma voleva essere sicura/ prima di parlartene// Per non illuderti/ e… e deluderti/ naturalmente// Io mi sono tanto raccomandata/ che si faccia vedere dal dottore/ perché/ finché glielo dico io/ che deve usare certe precauzioni/ lei non ci crede// Dovrebbe essere al terzo mese// Ma tu non mi tradire/ eh?! Aspetta che sia lei/ a dirtelo! S’è tanto raccomandata// Sono così contenta! Me l’avete fatto sospirare/ eh/ questo momento?! Adesso non bisogna fare più imprudenze// I primi mesi sono i più pericolosi// Per lei/ soprattutto// È così delicata// Cara/ cara creatura/ nostra! Leggiamo il corrispettivo brano del romanzo (solo le battute del dialogo: pp. 180–182): MADRE: Non ti sei accorto che Giuliana è incinta? TULLIO: Incinta! MADRE: Ebbene, Tullio? TULLIO: Non sapevo… MADRE: Ma tu mi fai paura. Il dottore dunque… TULLIO: Già il dottore… MADRE: Vieni, Tullio, siediti. TULLIO: Non sapevo… Giuliana non m’ha detto nulla. Non mi sono accorto di nulla… È una sorpresa… Il dottore, sì, mi parlò di qualche pericolo… Per ciò la notizia mi fa quest’impressione… Sai, Giuliana ora è così debole… Ma veramente il dottore non accennò a nulla di troppo grave; perché, essendo riescita l’operazione… Vedremo. Lo chiameremo qui; lo consulteremo… MADRE: Sì, sì; è necessario. TULLIO: Ma tu, mamma, sei sicura della cosa? Te l’ha confessata Giuliana, forse? Oppure… MADRE: Io me ne sono accorta, sai, dai soliti segni. È impossi- 154 Il linguaggio cinematografico bile ingannarsi. Fino a due o tre giorni fa, Giuliana negava o almeno diceva di non esserne certa… Sapendoti così apprensivo, m’ha pregata di non parlartene per ora. Ma io ho voluto avvisarti… Giuliana, tu la conosci, è così trascurata per la sua salute! Vedi: qui, invece di migliorare, mi sembra che vada ogni giorno peggiorando; mentre prima bastava una settimana di campagna per farla fiorire. Ti ricordi? TULLIO: Sì, è vero. MADRE: Le precauzioni, in questi casi, non sono mai troppe. Bisogna che tu ne scriva sùbito al dottor Vebesti. TULLIO: Sì, sùbito. Vado da Giuliana. MADRE: Va; ma stasera lasciala riposare, lasciala tranquilla. Io scendo e poi torno su. TULLIO: Grazie, mamma. MADRE: Figlio benedetto! È evidente, anche in questa scena, l’intento degli sceneggiatori di rendere il discorso più colloquiale (pur nel rispetto complessivo del dialogo originale), eliminando, tra l’altro, i tratti retorici più vistosi della prosa dannunziana (ebbene; riescita; i passati remoti parlò e accennò; la battuta «Sapendoti così apprensivo, m’ha pregata di non parlartene», con gerundio e participio concordato con l’oggetto femminile, nel film diventa: «Giuliana mi ha proibito di parlartene/ finché non ne era sicura»; «Che tu ne scriva»; «Figlio benedetto», che diventa «Cara/ cara creatura/ nostra!») e adottando, per converso, le frasi dislocate e con pleonasmi pronominali tipiche del parlato («di malesseri come quello di oggi/ lei ne ha già avuti parecchi»; «finché glielo dico io/ che deve usare certe precauzioni/ lei non ci crede»; «Me l’avete fatto sospirare/ eh/ questo momento?!»). Addirittura il conome del dottor Vebesti (evidentemente troppo ricercato) viene semplificato in dottor Milani. Inoltre, lo sgomento di Tullio nell’apprendere la gravidanza (evidentemente adulterina) della moglie, che nel romanzo è espresso dalle parole, nel film è manifestato dalla mimica impietrita (straordinaria) dell’attore (Giancarlo Giannini). 3 – Cinema e letteratura 155 3.6. Passione d’amore Concludiamo la nostra rassegna con l’adattamento della Fosca di Tarchetti nel film di Scola Passione d’amore, riduzione di natura analoga a quella dell’Innocente per quanto riguarda lo stile linguistico, anche se decisamente meno ambiziosa di quella viscontiana nella valorizzazione dell’intera opera dell’autore adattato, se si fa eccezione per l’antimilitarismo presente nel film di Scola e assente in Fosca, ma caratteristico di altre opere di Tarchetti (il romanzo Una nobile follia, del 1867). Anche qui la lingua è modernizzata (cadono le prime persone dell’imperfetto in –a; l’allocutivo di cortesia passa da Voi a Lei), le asperità scapigliate (dettate dal gusto per i termini ricercati ora perché arcaici ora perché peregrini) vengono smussate (se si fa eccezione per una lieve coloritura piemontese nella pronuncia di qualche personaggio, con l’usuale funzione di rendere il parlato filmico un po’ più vivo di quello ricostruito in un dialogo scritto) e si incontra anche in questo film una glossa per agevolare lo spettatore moderno rispetto al lettore: nel romanzo si accenna alla «ruota di Parigi» (p. 60), riferimento reso più esplicito nel film: «la ruota dei trovatelli a Parigi» (secondo la nota usanza dell’abbandono dei neonati indesiderati): «Voi sapete» io dissi per tenermi da capo sulle generali «che Rousseau, così virtuoso nei suoi libri, ha esposto cinque figliuoli alla ruota di Parigi?». Lei sa che Rousseau/ così virtuoso nei suoi libri/ ha lasciato esporre ben cinque suoi figli/ alla ruota dei trovatelli? a Parigi//. Naturalmente, il figliuoli del romanzo diventa figli nel film. Ma la banalizzazione del film è individuabile non soltanto sul piano del significante ma anche su quello semantico, a cominciare dal titolo del film. Passione d’amore, infatti, è titolo senz’altro più allettante di Fosca, ma travisa le intenzioni del Tarchetti, il quale tendeva a distinguere tra la passione (provata dal protagonista per Clara) e il sentimento molto più profondo 156 Il linguaggio cinematografico — una malattia, un’irresistibile pulsione verso la morte — nutrito per Fosca (i due nomi, Clara e Fosca, ovviamente non sono casuali) e oggetto del romanzo e del film: «Più che l’analisi d’un affetto, più che il racconto di una passione d’amore, io faccio forse qui la diagnosi di una malattia. – Quell’amore io non l’ho sentito, l’ho subito» (scrive Tarchetti a p. 29, a proposito del proprio amore per Fosca). E, poco oltre, a proposito di Clara (p. 49): «Ho voluto accennare brevemente a questa passione d’amore che fu la più vera e la più grande della mia vita, per mettere in maggior luce il contrasto di idee e di sentimenti che quell’affetto doveva produrre nella mia anima, in seguito ai fatti che imprendo a raccontare». Si riscontrano, infine, almeno due casi di vera e propria lectio facilior nella lettura psicologica dei personaggi, a proposito dell’adattamento del cap. 23, pp. 82–84. Nel romanzo, Fosca, gelosa di Clara, offre all’amato Giorgio, quasi inspiegabilmente, la propria mediazione, proponendo di fargli avere una licenza da parte del superiore di Giorgio, cugino di Fosca, proprio per andare a trovare Clara: «[…] dirò io una parola a mio cugino. Dipenderà tutto da lui. Scommetto che avrete bisogno della opera mia.» «Signora! […] non comprendo le intenzioni che vi consigliano a farmi questa offerta […].» «Rifiutereste perfino la mia mediazione?» «Non vi avrei creduta capace di offrirmela!» «Siete geloso della mia dignità! Ciò mi piace.» Ecco come viene trasformato questo dialogo nel film: FOSCA: Potrei fargliela negare [la licenza]// Parlerò io/ a mio cugino// GIORGIO: Signora/ sia più gelosa/ della sua dignità! Non offenda il suo amor proprio! FOSCA: Ognuno si ama come più gli aggrada//. È chiaro che per lo spettatore è molto più facile capire la minaccia della donna gelosa che il sottile ricatto psicologico 3 – Cinema e letteratura 157 della finta generosità. Poche righe più avanti, alla notizia che Giorgio non può sposare Clara perché già sposata, Fosca esclama: «Ah! E la stimate?» «La stima è una condizione dell’amore.» Il film così banalizza, ribaltando i termini della questione: FOSCA: E lei la stima?! GIORGIO: Sì// E poi la stima/ non è una condizione dell’amore! Il film di Scola è l’unico del corpus a servirsi della voce narrante fuori campo come corrispettivo, in alcune scene, della voce del narratore in prima persona del romanzo. In un caso, la voce narrante di Giorgio viene rispettata quasi alla lettera (ovviamente soltanto nelle prime parole, per via dei soliti tagli e delle semplificazioni stilistiche), ma posticipata rispetto al romanzo. Lo spostamento è qui particolarmente efficace e funzionale al mezzo filmico, poiché ciò che nel romanzo serviva da introduzione, spiegazione e descrizione del primo incontro tra Giorgio e Fosca nel film avrebbe, se mantenuto in quella posizione, ridotto l’effetto–sorpresa che il regista vuol ottenere nel mostrare allo spettatore l’incredibile bruttezza della donna e quindi tutta l’enormità di quell’amore: giustamente al cinema le immagini debbono parlare prima delle parole, le quali oltretutto, in una descrizione, risultano pleonastiche. È questo uno dei rari casi in cui la macchina da presa riesce a migliorare la pagina scritta, amplificandone le suggestioni. Ancora una volta i silenzi, al cinema, possono essere molto più espressivi delle parole e, per chi ha presente il film in questione, nulla potrebbe sostituirsi all’incedere silenzioso dell’ombra di Fosca (l’eccellente attrice Valeria D’Obici) dietro la vetrata della scala, l’ansia di Giorgio di vederla — accresciuta dal rumore dei passi e dalla musica — e la sua espressione attonita di fronte alla donna. Leggiamo di seguito i due brani (nel romanzo, a p. 59): 158 Il linguaggio cinematografico Dio! Come esprimere colle parole la bruttezza orrenda di quella donna! Come vi sono beltà di cui è impossibile il dare una idea, così vi sono bruttezze che sfuggono ad ogni manifestazione, e tale era la sua. Né tanto era brutta per difetti di natura, per disarmonia di fattezze — ché anzi erano in parte regolari — quanto per una magrezza eccessiva, direi quasi inconcepibile a chi non la vide; per la rovina che il dolore fisico e le malattie avevano prodotto sulla sua persona ancora così giovine […]. Dio! Come esprimere colle parole la bruttezza di quell’infelice! La sua deformità/ e le sue sofferenze/ incombevano come una sinistra presenza/ su quel luogo della stupidità militare// Dove l’ozio si alternava alle fatiche/ ma non alla noia//. Per il resto, la volontà di regista e sceneggiatori sembra essere stata quella di rendere meno inconcepibile, per il moderno spettatore, il rapporto tra Giorgio e Fosca, introducendo numerosi elementi volti ora a spiegare alcuni atteggiamenti dei protagonisti, ora a renderli più scolpiti, meno ambigui, quasi nel timore che il pubblico potesse non capire bene o non meravigliarsi abbastanza (timori frequentissimi nei cineasti): in entrambi i casi ne risulta un effetto chiaramente banalizzante. Nel romanzo, per esempio, si dice che Fosca è stata sul punto di rimanere incinta in un precedente matrimonio, mentre nel film si sottolinea che quelle nozze durarono soltanto tre ore, che Fosca è dunque vergine e che baratterebbe la vita per un’unica notte d’amore. Nel romanzo, Clara lascia Giorgio soltanto per non esserne lasciata, mentre nel film l’abbandono è motivato dall’apprendimento della relazione con Fosca (dunque, per una banale e “troppo moderna” crisi di gelosia). Anche la voce fuori campo viene giustificata (come spesso accade, al cinema) nel film: alla fine lo spettatore apprende che tutta la storia non è altro che un racconto fatto da Giorgio a un altro personaggio (che tra l’altro conclude il film con una sorta di morale femministica del tutto distante dalla fonte) e non un resoconto diaristico, come in Tarchetti. Del resto, si sa, il cinema mal tollera la rappresentazione della scrittura (con qualche eccezione, natural- 3 – Cinema e letteratura 159 mente, dal già citato I racconti del cuscino [The Pillow Book], 1995, di Greenaway, a Io ballo da sola [Stealing Beauty], 1996, di Bernardo Bertolucci, per rimanere ai tempi più recenti) così come la voce fuori campo, se non razionalmente motivata (anche qui non mancano le eccezioni illustri: Il viale del tramonto [Sunset Boulevard], 1950, di Billy Wilder, e American Beauty, 1999, di Sam Mendes, dove a parlare fuori campo è niente meno che un morto)42. 42. La funzione della voce (in campo e fuori campo) nel cinema è stata analizzata in ROSSI (2002b: 165–170). 4. LINGUA, LINGUE E DIALETTI 4.1. Lingua e dialetti prima del Neorealismo 4.1.1. Inizieremo a parlare del rapporto tra italiano e dialetti a partire dal cinema sonoro, visto che delle sperdute tracce dialettali del cinema muto abbiamo già detto nel secondo capitolo. Ricordiamo soltanto che, nel nostro Paese, la lingua scritta e parlata nel film non poteva non riflettere la reale frammentazione geo– e sociolinguistica e, d’altro canto, non poteva non rispondere alla doppia, antitetica natura del cinema come mezzo di comunicazione di massa: specchio e scuola di lingua1. La tendenza, cioè, alla normalizzazione linguistica di tipo letterario, non priva di certe ambizioni didattiche, unitamente all’esigenza di incontrare l’intero pubblico nazionale, si contrappone alla volontà di ottenere l’immedesimazione del pubblico locale, mediante il ricorso ad alcune espressioni popolari e dialettali. Tale intersecarsi di varietà (dialetto, italiano regionale, italiano letterario, italiano popolare, italiano medio — quest’ultimo nell’accezione di varietà pressoché standard, con qualche inclina- 1. Le etichette di scuola e specchio delle lingue attribuite al cinema e alla televisione sono state discusse da SIMONE (1987) [→ Antologia critica, § 16]. La stesura di questo capitolo deve moltissimo, come del resto tutto il volume, ai saggi di Sergio Raffaelli, e in particolare al suo noto capitolo sul dialetto filmico, risalente al 1983 e confluito poi in RAFFAELLI (1992: 45–144, parzialmente riportato in → Antologia critica, § 10). Abbiamo inoltre rielaborato e ampliato le considerazioni già fatte in ROSSI (2002c) e, a proposito di Alberto Sordi, in ROSSI (2003c). Altri due riferimenti imprescindibili, sull’argomento del dialetto filmico, sono GIANNARELLI (1982) e AA. VV. (1985). 161 162 Il linguaggio cinematografico zione al regionalismo, perseguita, almeno negli intenti, fin dai primi film sonori — con tutte le gradazioni intermedie proprie del continuum linguistico) accompagnerà il parlato filmico durante tutta la sua storia. È utile chiarire fin d’ora il senso di alcune spinte fondamentali, anch’esse caratterizzanti l’intera storia cinematografica italiana. Intanto, per sua natura, la mimesi schermica non può che essere parziale. Lo abbiamo già dimostrato nelle premesse semiologiche e linguistiche del primo capitolo. Il passaggio dallo scritto della sceneggiatura al recitato, la stessa prassi della recitazione davanti a una macchina da presa e, ancor più, le tecniche di sincronizzazione, missaggio e montaggio di suoni e immagini non fanno che allontanare i dialoghi filmici, nonostante la propensione al realismo di autori, attori e pubblico, dalla riproduzione fedele della realtà: [C]ome deve parlare un personaggio sullo schermo[?] Deve simulare la realtà, ed allora sarà ben difficile che un copione preparato a tavolino possa alla fine trasformarsi in un parlato attendibile; oppure sarà un’operazione metaforica, e allora la verosimiglianza non ha più molto senso. Spesso si oscilla fra questi due poli: ci si aspetta la verosimiglianza assoluta, come se il cinema fosse la registrazione di un’intervista sociolinguistica, ma poi, giustamente, ci si ricorda che il cinema è ombre elettriche, è finzione, e quindi parla d’altro2. Inoltre, anche quando si parla, velocemente e per comodità, di dialetto cinematografico, si tratterà ora di italiano regionale, a tratti più o meno approssimante alle varietà locali, ora addirittura di una sorta di lingua ibrida (creata appositamente dal cinema e per il cinema) che combina, spesso in una stessa battuta, fenomeni effettivamente regionali con tratti di italiano standard o ricercato (da scuola di dizione, per intenderci). Si contano sulle dita di una mano i film in dialetto “puro”. E quasi sempre, per giunta, al dialetto (ma anche allo stesso italiano regionale), qua- 2. CARDONA (1985: 37). 4 – Lingua, lingue e dialetti 163 lora presente, è assegnata una funzione di mero contorno, di macchia di colore, nell’ambito dell’intero film: è parlato perlopiù da comparse (brusii, voci fuori campo) o al massimo da personaggi secondari del film o da caratteristi3. Inoltre, stavolta più in linea con effettive differenziazioni note alla sociolinguistica, è parlato più dagli uomini che dalle donne, più dai vecchi che dai giovani, più dai poveri che dai ricchi (tenendo conto, eventualmente, delle ovvie intersezioni di insiemi). Per tutti questi motivi, la lingua cinematografica raramente potrà essere considerata come un documento del parlato reale (anche se talora è stato e viene fatto)4. Il suo studio diventa interessante, invece, proprio nel confronto col parlato–parlato e con altre forme espressive e nell’analisi delle analogie, delle differenze e dei diaframmi inevitabili tra la realtà e la sua copia filmica. Il lettore del presente capitolo dovrà poi essere messo in guardia da un altro possibile malinteso: quello, cioè, di estendere al piano estetico considerazioni che sono (o almeno vorrebbero essere, da parte dell’autore) prettamente descrittive. Vale a dire che l’aderenza di un dialogo cinematografico alla realtà non è certo di per sé un valore né è garanzia di maggiore o minore 3. Non mancano le eccezioni. Tra queste, Ai margini della metropoli, 1953, di Carlo Lizzani, con i protagonisti Michel Jourdan (ovviamente doppiato) e Giulietta Masina che usano una varietà di italiano decisamente più regionale (romana, ma ibridata: «Me faranno uscire») rispetto agli altri attori del film. 4. Per esempio da TRIFONE (1993), che ha analizzato il moderno romanesco di periferia proprio sulla base di un film: Amore tossico, 1984, di Claudio Caligari. Da anni, inoltre, il materiale audiovisivo viene sfruttato, anche in Italia, come sussidio didattico imprescindibile nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda (l’Università per stranieri di Siena, quella di Perugia, la Società Dante Alighieri, tra l’altro, organizzano abitualmente conferenze, seminari e lezioni che trovano nel parlato filmico italiano il loro tema prediletto). In effetti la varietà situazionale (a tutti i livelli: sia di estrazione sociale dei personaggi rappresentati, sia di eventi comunicativi inscenati) e la vocazione realistica del nostro cinema, unite alla possibilità, rispetto alle semplici audioregistrazioni, di poter osservare anche gli elementi contestuali, paralinguistici ed extralinguistici (codici gestuale, mimico, cinesico e PROSSEMICO [→ Glossario]), hanno un indubbio valore didattico (cfr. BENUCCI 1988, MICHELI 1999, TRONCARELLI 2002). Anche all’estero l’insegnamento dell’italiano passa per il cinema (cfr. almeno, per la Francia, AA. VV. 1998). Dell’utilizzazione didattica del doppiaggio per lo studio delle tecniche di traduzione si parlerà nel § 5. 164 Il linguaggio cinematografico adattabilità di quella soluzione linguistica al complessivo sistema di codici di un film: un doppiaggio antirealistico, per esempio, può essere molto più funzionale del dialetto puro (che risulterebbe forse stridente o addirittura straniante rispetto alle scelte musicali, narratologiche, fotografiche, scenografiche e alle attese del pubblico), in un film di avventura o di fantascienza. La cronologia dell’impiego del dialetto riprodotto dal cinema segue le tappe già delineate da RAFFAELLI (1992: 80–142): dal 1930 al 1945 si riconoscono almeno la fase degli anni della Cines (con le coloriture fonetiche locali dei film sonori dei primordi), quella cosiddetta degli «anni di Freddi» (rigorosamente dialettofobi) e quella degli anni di guerra (con un uso dei dialetti più consistente, dal macchiettismo al realismo); dal 1945 a oggi individuiamo almeno la fase della dialettalità imitativa (del Neorealismo), quella della dialettalità stereotipata (del NEOREALISMO ROSA [→ Glossario] e della Commedia all’italiana) e quella della dialettalità espressiva (quando non espressionistica) e riflessa (di certo film satirico, da Totò a Fellini alla Wertmüller, e di dotti recuperi filologici, da Olmi a Cottafavi). Del primo periodo, si ricordano gli involontari tratti fonetici degli attori ancora non abituati al nuovo mezzo. Per esempio, nel primo film sonoro italiano, La canzone dell’amore (1930), la protagonista Isa Pola tradisce «la propria origine emiliana nell’intonazione e in particolare nella realizzazione della sibilante»5; analogamente dicasi per certe inclinazioni romane di Elio Steiner e napoletane di Olga Capri. Neppure nel doppiato dei primordi mancano inflessioni dialettali, dapprima dovute a doppiatori italoamericani, successivamente alle discutibili scelte di qualche direttore di doppiaggio nostrano. Protagonista delle prime consapevoli utilizzazioni dialettali del cinema sonoro è senza dubbio Alessandro Blasetti (tra i più versatili registi italiani: ha diretto da film storici a commedie, utilizzando dall’italiano letterario all’italiano dell’uso medio al 5. RAFFAELLI (1992: 83). 4 – Lingua, lingue e dialetti 165 dialetto), a partire dal suo primo film parlato (Nerone, 1930), in cui Ettore Petrolini dà sfogo alla propria vena espressionistica ricorrendo anche all’uso del romanesco («Basta che lo fai divertì e il popolo è tuo»)6. Qualche tratto fonetico dell’italiano mediano (laziale) compare anche in Terra madre, 1931, ma è con Palio, 1932, che l’italiano regionale (un toscano artefatto e fiorentinizzato, nonostante l’ambientazione senese del film) assurge a protagonista: «La Fiora»; «si va a vedé le sciantose»; «non la fà tanto palloccolosa!»; bigonzo, grullo, ciuccate7. La tavola dei poveri, 1932, tratto da un testo teatrale di Raffaele Viviani (il quale partecipa anche alla sceneggiatura e interpreta il personaggio del marchese Fusaro), è un esempio di normalizzazione del napoletano in un italiano che mantiene qualche regionalismo fonetico e, raramente, anche morfologico («Signo’, vi so’ caduti dui soldi»)8. È però a 1860, del 1934 (Figg. 16–18), che spetta il merito di schiudere il più ampio ventaglio filmico dei dialetti italiani (comunque quasi sempre nelle varietà prossime all’italiano, eccezion fatta per qualche battuta in dialetto stretto nelle comparse) prima del Neorealismo. Dal siciliano («òra tu te ne vai in paise co patre Costanzo a pigghiari istruziòni precisi»; «site picciòtti/ tempo n’avete»; «ritòrno subbito/ Gisuzza/ tantu arrivu au paisi»; «va’ a pigghiarmi ’u cavallu»; «figghiu mèu!»; «unne vai/ Carmeliddu?»; amuninne ‘andiamocene’; «Garibbaldi ha dettu ch’amu fattu l’Italia!») al toscano («anche te tu vieni a Genova?»; «oh/ bisognava vvedere a Firenze l’accoglienza he gl’è stata fatta al nostro re!»; «io ’un so come la la pensa lei»; «oh/ intendiamoci/ come uomo io gli fo tanto di cappello/ ma… ma non è una bella ragione…»), dal piemontese (’nduma ‘andiamo’; suta ‘sotto’; la canzone La bèla Gigogìn) al ligure, dal veneto (nell’indimenticabile addio alla madre del volontario garibaldino: «No sta a piànser/ mama») all’inappuntabile italia6. 7. 8. RAFFAELLI (1992: 88). MICHELI (1990: 60). RAFFAELLI (1992: 89). 166 Il linguaggio cinematografico no del prete garibaldino e di qualche altro personaggio, ricorrendo addirittura al latino e alle lingue straniere (tedesco e francese) non sottotitolate, Blasetti affida proprio a questo caleidoscopio linguistico il fulcro della trama del film sull’unità d’Italia. Si tratta di un film corale, dunque, in cui il vero protagonista è il popolo e la sua lingua, o meglio i suoi dialetti (è chiara la volontà, ideologica più che realistica, di mostrare il Risorgimento come un fenomeno collettivo)9, e che fungerà da modello per analoghi esperimenti sul plurilinguismo italiano: Paisà, 1946, di Rossellini e Il cammino della speranza, 1950, di Germi. Lo stesso Blasetti, non senza un briciolo di vanità, era ben consapevole della novità di un uso così esteso del plurilinguismo sul grande schermo: con una certa fierezza mi ricordo di essere stato il primo a far sentire il siciliano accanto al toscano, al romanesco e al lombardo in un film italiano. E tutti questi dialetti riuniti a fronte della lingua francese, della lingua tedesca […], mi sembra […] anche in questo, di essermi avvicinato alla realtà10. Non mancano in 1860 alcune incongruenze, specialmente nel toscano, con forti oscillazioni nell’uso del raddoppiamento fonosintattico («bisognava vvedere» sopra citato), della gorgia e con la pronuncia non spirantizzata dell’affricata alveopalatale sorda e sonora intervocalica (in intendiamoci e ragione, per esempio): «oh/ intendiamoci/ come uomo io gli fo tanto di cappello/ ma… ma non è una bella ragione…». Si ricorda che 1860, girato in presa diretta (e da quella versione abbiamo citato le battute sopra trascritte), fu successivamente sincronizzato e parzialmente italianizzato. 9. Volontà che era tutt’uno con quella di considerare il fascismo come l’ideale continuatore popolare del Risorgimento, come dimostra la scena conclusiva del film, successivamente tagliata, «con le camicie nere che sfilano di fronte agli ultimi garibaldini con il saluto romano» (ARISTARCO 1985: 25). 10. SAVIO (1979: I, 129–130). 4 – Lingua, lingue e dialetti 167 In Vecchia guardia, 1935, compaiono il romanesco, il toscano («se tirano col manganello noi si tira con la pistola, se tiran con la pistola, noi s’adopra le bombe se adopran le bombe, noi si mette in funzione la mitragliatrice, se tiran con la mitragliatrice, miseria cane, si tira col cannone»)11 e accenti settentrionali, mentre in Un’avventura di Salvator Rosa, 1939, il napoletano. Il valore della varietà dialettale quale caratteristica positiva (e non ostacolo) dell’identità italiana è talora reso esplicito, anche in altri film, dalle dichiarazioni di qualche personaggio. Accade per esempio in una battuta dell’impresario teatrale milanese di Amo te sola, 1935, di Mattoli: IMPRESARIO: Sono veramente contento che propi chì a Milàn int’el me teàter, dopo tanto repeloto, ghe sia staa un così grande sucesso dovuto a un volontario bolognese… VOLONTARIO: Grazie, grazie… IMPRESARIO: E a uno napoletano! Con tuti questi dialeti… l’è propi una festa italiana!12. Il dialetto può addirittura servire alla difesa dell’identità nazionale contro la dominazione straniera: UFFICIALE ITALIANO: Voi non conoscete questo conte Appiani? PATRIOTA MILANESE: Sior no… int’el me locàl l’è mai vegnü! UFFICIALE FRANCESE: Come dice? UFFICIALE IT.: Dice che non l’ha mai visto. UFFICIALE FR.: Quelle idée de parler patois! Ma nel vostro locàl si riuniscono giovanotti che cantano canzoni sediziose! PATRIOTA: Com’el diss? UFFICIALE IT.: Rivoluzionarie! PATRIOTA: L’è ch’int’el me locàl, a ghè un vinéto ch’el mete alegrìa, che se l’asagiase anca lü el canta alter che la sediziosa! UFFICIALE FR.: Ah, molto convincente! Peccato però che io non beva, e allora in questo caso tu fili diritto a S. Vittore! Vedremo se la prigione ti farà sciogliere la lingua! 11. MICHELI (1990: 79). 12. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 104). 168 Il linguaggio cinematografico PATRIOTA: Mi ho fa nagòta! Non ho fatto niente! UFFICIALE FR.: Ah, adesso parli anche italiano! Vedrai che là dentro finirai per parlare anche francese!13. Un tendenziale monolinguismo di tipo letterario (peraltro giustamente ridimensionato da RUFFIN/D’AGOSTINO 1997) contraddistingue gran parte della produzione filmica dalla metà degli anni Trenta alla fine del secondo conflitto mondiale14, con particolare rigore dialettofobo dal 1935 al 193915 e con maggiore inclinazione al dialetto negli anni di guerra. Questa lingua, con forti spinte verso il superstandard e l’artefazione, soprattutto nella pronuncia (il famigerato birignao di tante stelle e stelline), è determinata anche dall’esempio dei film americani doppiati (come doppiati erano anche molti film nostrani), con i quali la nostra cinematografia intendeva mettersi in competizione. È vero, come s’è visto, che in molte pellicole dei “telefoni bianchi” e in altri generi «erano populisticamente tollerate occasionali battute in dialetto», ma è vero altresì che esse servivano piuttosto «a caratterizzare in senso etnico o sociale macchiette e figurine di contorno»16 che a riprodurre fedelmente la realtà linguistica italiana. Tra i numerosi esempi possibili citiamo almeno il bidello romano (l’attore Giuseppe Varni doppiato da Aldo Fabrizi) del film Maddalena zero in condotta, 1940, di De Sica, che, contro il raffreddore, suggerisce di «bere un bicchiere de vino a diggiuno e tre ore doppo magnà», oppure l’industriale veneto Campolmi di Ore 9: lezione di chimica, 1941, di Mattoli, che così manifesta la propria indulgenza nei confronti degli scarsi risultati scolastici della figlia: 13. La compagnia della teppa, 1941, di Corrado D’Errico (RUFFIN/D’AGOSTINO 1997: 105). 14. Ma non si dimentichi, tuttavia, ancora negli anni Cinquanta, l’assoluta inverosimiglianza sociolinguistica del parlato colto di Yvonne Sanson e di Amedeo Nazzari nei film di Raffaello Matarazzo (che, in base alla provenienza geografica e socioculturale dei personaggi rappresentati, avrebbero richiesto quantomeno l’adozione dell’italiano regionale) e in particolare in Catene, 1949 (ROSSI 1999a: 55–58, 278–282). 15. Sono i cosiddetti «anni di Freddi», come già ricordato, dal nome di Luigi Freddi, di cui s’è già parlato nel § 2.4.1. 16. CARPITELLA/DE MAURO/RAFFAELLI/NAPOLITANO (1986: 165). 4 – Lingua, lingue e dialetti 169 CAMPOLMI: […] Come vanno gli studi? DIRETTRICE: Ah, quanto agli studi, mi dispiace doverlo dire, lascia un po’ a desiderare! CAMPOLMI: Possibile? Davero? DIRETTRICE: Potrebbe riuscire magnificamente, perché è sveglia, intelligente, ma è svogliata, distratta! CAMPOLMI: Eh, si capisce, povera fia, xé l’età, vero? Bah, l’importante è che ci sia la salute! DIRETTRICE: Certo, ma capirete… insufficiente in latino, insufficiente in aritmetica, insufficiente in chimica… CAMPOLMI: D’altra parte, cosa importa, digo? Perché il latino, vero, a cosa serve, non lo deve mica parlare… e l’aritmetica? Guardate me, per esempio, io sono finanziere, e di aritmetica non ho mai capito un accidente […] DIRETTRICE: Eh, sì anche vostra figlia ragiona così, ma con questo criterio, dovrà ripetere l’anno! CAMPOLMI: Mejo, mejo, ah, mejo! Perché, più classi si ripetono, e più se impara! Io, per esempio, la terza liceale l’ho ripetuta tre volte! E non ho imparato niente lo stesso… Ma cosa volete fare, insoma, signora mia benedeta, ma meteteve un po’ nei miei panni, mi son vedovo, è vero, mi no go altro che sta fia, sola, unica, continuamente in giro, continuamente in viagio, affari, discussioni, consigli di amministrazione, dove lo trovo el tempo per ocuparme di lei? Finché sta qua, io sono tranquillissimo! […] Sapete quale sarebbe l’ideale? Appena fuori di qua, un bel marìo, un bel marito pronto là al cancelo che la speta!17. Mario Mattoli, proprio per questo spesso citato nella nostra esemplificazione, si era manifestato più volte favorevole all’adozione del dialetto di contorno: «Io sono sempre stato un fautore del dialetto nel personaggio secondario, perché credo dia vita alla vicenda»18. A volte addirittura la presenza del dialetto è ancora più superficiale e accessoria, limitandosi a qualche canzone, perlopiù napoletana, del tutto decontestualizzata dai dialoghi del film. Alcuni inserti dialettali nei film derivano dal soggetto teatrale o letterario, anche se talora i dialoghi vengono del tutto italia17. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 117–118). 18. TINAZZI (1983a: 24). 170 Il linguaggio cinematografico nizzati per lo schermo, come per esempio in Se non son matti non li vogliamo, 1941, di Esodo Pratelli, tratto dalla commedia veneziana Se no i xe mati no li volemo, 1926, di Gino Rocca. A volte, viceversa, l’adattamento è di segno opposto, come nel caso di Via delle Cinque Lune, 1942, di Chiarini, in cui, oltre al passaggio da Napoli a Roma, c’è anche l’aggiunta di varie battute dialettali di contorno, mentre nel racconto della Serao compariva soltanto la citazione di quattro versi di una canzone napoletana19. Del tutto incongrue appaiono alcune operazioni di dialettalizzazione, come per esempio il remake del francese Dora Nelson, 1939, di Mario Soldati (l’originale francese, del 1935, era diretto da René Guissart), o l’adattamento shakespeariano La bisbetica domata, 1942, di Ferdinando Maria Poggioli, entrambi con battute romanesche. Si vedano ad esempio, dal secondo film: «che li possano ammazzarli», sor/sora ‘signore/a’, sganassone ‘schiaffone’, mannaggia, «E qui fa freddo me pija na polmonite!», «voi siete bbona, siete bbona assai, come siete bbona!»20. Qualche stralcio dialettale non manca neppure nei film storici, oltre ai già visti esempi blasettiani. Si tratta essenzialmente di opere ambientate nell’Ottocento: Giuseppe Verdi, 1938, di Carmine Gallone; Torna, caro ideal!, 1939, di Guido Brignone; Piccolo mondo antico, 1941 e Malombra, 1942, di Mario Soldati; Il cappello da prete, 1944, di Ferdinando Maria Poggioli, e altri. La lingua delle ambientazioni preottocentesche è invece convenzionalmente l’italiano standard. La sola regione italiana che mantenga anche nelle ambientazioni preottocentesche una propria caratterizzazione linguistica (almeno sotto forma di inserti: Un’avventura di Salvator Rosa, Fra diavolo, La fanciulla di Portici […]) è la Campania, 19. Altri casi simili sono riportati da RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 93, parzialmente citato in → Antologia critica, § 6). 20. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 100). 4 – Lingua, lingue e dialetti 171 anche quando il soggetto è tratto da un romanzo straniero come El sombrero de tres picos di Alarçon (Il cappello a tre punte), trasferito dalla Spagna alla Campania borbonica. Per quanto riguarda l’ambientazione toscana, infine, si tende in Lorenzino de’ Medici, Sei bambine e il Perseo (liberamente ispirato alla Vita di Cellini), Boccaccio (da un’operetta di von Suppé, libretto di Zell e Genée), La cena delle beffe (da Sem Benelli) e nell’episodio cinquecentesco di Castelli in aria (dalla novella Tre giorni in paradiso di Franz Franchy), a dare vita ad una lingua caratterizzata da una sintassi complessa e letteraria e da un lessico toscaneggiante, a cui non si accompagnano però coerenti tratti fonologici e soprasegmentali21. Un fenomeno interessante, in alcuni inserti dialettali, è la presenza di glosse, che il cinema continuerà ad adottare fino ad epoca recente. Ne abbiamo visto un piccolo esempio nella Compagnia della teppa («Mi ho fa nagòta! Non ho fatto niente!»), in Ore 9: lezione di chimica («un bel marìo, un bel marito») e altrove: consiste nell’apporre, al SINTAGMA [→ Glossario] dialettale, il corrispettivo in italiano, per salvaguardare l’intelligibilità da parte del pubblico. «Un insistito procedimento di questo tipo è proprio ad esempio dell’impresario teatrale emiliano — Carlo Ninchi — di Amo te sola, del re napoletano di I cospiratori del golfo (Re burlone), 1935, di Enrico Guazzoni, del parrucchiere romagnolo di La zia smemorata, 1940, di Ladislao Vajda: PARRUCCHIERE (alla cliente): …al zèrca veramènte una biònda! Dico… cerca veramente una bionda! Non è mica una frottola signora, ve lo posso assicuràare! Si tratta d’un… d’un produttore americano. Eh, di Hollywood, naturalmènte! È alloggiato al Grande albergo! Vero tip de miliardèri… Oh, un vero tipo di miliardario! Anca vo’ sì biònda… oh, dico, anche voi siete bionda, e alòora!»22. 21. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 108–109). 22. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 109). Sull’utilizzazione delle pratiche di glossa (riformulazioni, spiegazioni, autocorrezioni, e simili, compiute dal parlante per farsi capire meglio dall’interlocutore) nel parlato cfr. ORLETTI (1983: 77–103) e FRANCESCHINI (1998: 55, 89–91). Altri esempi filmici nei §§ 3.5 e 5.2.7. 172 Il linguaggio cinematografico Tra le varietà dialettali (o meglio regionali) più frequenti al cinema ricordiamo sicuramente il veneziano, il napoletano e il romanesco (degli ultimi due si parlerà infra). Il primo risente sicuramente dell’illustre tradizione teatrale (Goldoni in testa). Il film inaugurale è Figaro e la sua gran giornata, 1931, di Camerini, interessante esempio metateatrale e metafilmico tratto dalla commedia Ostrega, che sbrego!, di Arnaldo Fraccaroli, e ambientato durante le prove del Barbiere di Siviglia in un teatrino di provincia, con intreccio tra dentro e fuori il palcoscenico. Vi si riconosce qualche battuta regionalmente colorita: «Maestro, faciamo quatro batute di dueto con la putèa?»; «È pronto il desco, overosia: se magna?»23. Enunciati mistilingui figurano anche in Canal Grande, 1943, di Andrea Di Robilant (film che comunque ha moltissime battute integralmente veneziane): «Però, digo, i regolamenti i xé i regolamenti, no? La fate tanto lunga con noi giovani, e poi i primi a mancare siete voi vèchi!»; e in Piccolo alpino, 1940, di Oreste Biancoli: «Un baston de ciocolata qui per il giovanoto. Varda ti, bocia, quelo che ti piace. Vutu quèo?», «Senti, fantolin, se ti ga fame e non ti piace niente, te facio portar un paneto!». Interessante la commutazione di codice [→ Glossario, CODE–SWITCHING] nella scena seguente delle Scarpe al sole, 1935, di Marco Elter, nella quale dal veneziano della conversazione quotidiana e spicciola si passa a inserti di italiano quando il tono si innalza al tema della guerra: DONNA: Sta fermo, co ste man sporche de polastro! BEPPE: Ciò, sporche de polastro, te ’o già magnà anca ti! El gèra bón! DONNA: No go gnanca tempo de sentirte, ’ndémo! Sempre come i tósi el vól far! […] ALTRO CONTADINO: Ohé, dico, c’è la Russia che avanza come una valanga! 23. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 115). 4 – Lingua, lingue e dialetti 173 BEPPE: Sì sì, ma i todeschi, i xé forti anca lori! ALTRO UOMO: Eh eh, se vedeste, cari miei, che lavori de fortificassión se fa noaltri su al confine! BEPPE: Noaltri che gavemo fato la guera de Menelik ce ne intendiamo! DONNA: Eh, corvi de la malora, no sté sempre a parlar de politica, no? MOGLIE: Manderàn su al fronte anca ti? Eh, di un vechio bacuco avran bisogno! BEPPE: Bah, se i gà bisogno de uno ch’el capia copàr todeschi, i me manda de sicuro! MOGLIE: Sì, quei là speteràn proprio ti per farse copar! BEPPE: Lavora, dona, che io difendo la patria e il focolare domestico!24. Tra le altre varietà regionali, un ruolo di un certo rilievo spetta al lombardo della grande attrice brillante Dina Galli, che dal palcoscenico allo schermo trasporta il suo milanese, orgogliosamente esibito, come si può vedere nella scena seguente, tratta da Felicita Colombo, 1937, di Mattoli (adattato da una commedia scritta per lei da Giuseppe Adami; il suo seguito, Nonna Felicita, dello stesso regista, è dell’anno successivo): CONTE: Vede, difficilmente noi sappiamo adattarci alle fatiche del lavoro! FELICITA: Come come come? CONTE: Sì, perché difficilmente sappiamo fare qualche cosa! FELICITA: Ma l’è mica vero! Ma l’è lei che diffama la sua casta! Ma ci sarà stato ben qualcuno nella sua famiglia che questa fortuna ha cominciato a guadagnarla, e questa contea se l’è meritata! Son mica ignoranta al punto da non sapere, sa, che i suoi antenati andava alle crociate, a combattere per Gerusalemme! CONTE: E io mi son ridotto a combattere con lei! FELICITA: Ma l’è ben per quella, che se la si levasse dai piedi, io diventerei di colpo la Gerusalemme liberata!25. 24. Gli ultimi esempi sono tratti da RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 116–118). 25. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 120–121). 174 Il linguaggio cinematografico A proposito delle tendenze dialettofobe del fascismo, ricordiamo che già nel dicembre 1931 il capo ufficio stampa di Mussolini, Gaetano Polverelli (poi ministro della Cultura popolare), aveva emanato una direttiva che imponeva di non pubblicare «articoli, poesie o titoli in dialetto»26, confermata e inasprita in più battute (1934, 1938 e oltre). E il Duce stesso in varie occasioni aveva manifestato le sue paure che il dialetto si infiltrasse nell’insegnamento scolastico. Una circolare del 1935 ostacolava le rappresentazioni teatrali in dialetto, mentre per il cinema un provvedimento del 1941 proibiva agli attori di pronunciare battute dialettali. Si registra anche, nel 1939, un anonimo articolo del “Giornale dello spettacolo”, nel quale si propone si abolire «il dialetto nel film, per la maggiore e migliore comprensione del parlato e per fare opera migliore d’italianità» e per indurre il popolo a «disabituarsi all’eloquio del natio borgo e della natia città»27. Ma, come è noto, il regime fascista aveva una doppia anima: da un lato intendeva dare di sé, soprattutto all’estero, un’immagine moderna ed efficiente (un’unica e illustre lingua per una nazione compatta e forte), che mal si conciliava con la ruralità e la frammentazione dialettale propriamente italiane; dall’altro, non intendeva rinunciare ad atteggiamenti populistici di facile presa, che traevano pimento soprattutto da una sentimentalistica rivalutazione delle origini popolari e dialettali degli italiani (e in tal senso il già citato Vecchia guardia di Blasetti è un film emblematico: da taluni amato, da altri temuto come apologia dello squadrismo che il governo voleva fingere di aver dimenticato). Oltretutto, l’anima strapaesana del fascismo poteva utilmente essere arruolata nella battaglia contro gli esotismi […] ma costituiva un fattore di resistenza ad un profondo sradicamento dei dialetti. Alle risorse lessicali dei vernacoli avevano anzi talvolta attinto, nell’intento di espellere dal nostro vocabolario le paro- 26. RAFFAELLI (1983: 153). 27. RAFFAELLI (1992: 95). 4 – Lingua, lingue e dialetti 175 le straniere, anche i più fieri sostenitori dell’italianità della lingua. L’atteggiamento nei confronti dei dialetti appare insomma l’anello più debole della politica linguistica del fascismo28. Proprio in favore del film di Blasetti, Corrado Pavolini si lasciò andare ad un’appassionata (quanto non allineata ai dettami della dirigenza) difesa dei dialetti: Si sa oggi cos’è, ahimè, l’“italiano” del teatro e del cinema: una sbalorditiva menzogna messa in giro da attori analfabeti e cafoni i quali si sono ficcati in capo d’essere supremamente “distinti”. È il francese delle pochades tradotto alla peggio e pronunciato con accento vagamente settentrionale. Una lingua italiana tuttavia esiste: e non soltanto nella letteratura. È quella che parlano, con cadenze diverse, tutti gli italiani per bene: ovverosia la enorme maggioranza degli italiani. I dialetti sono per l’appunto la lingua; con differenze da regione a regione — chi astragga gli accenti — in ultima analisi minime, trascurabili. Si è tuonato molto, in questi ultimi anni, contro i dialetti: ma c’è stata forse una piccola confusione. S’è scambiato cioè il dialetto — la più innocente delle intonazioni — con lo spirito dialettale — la più odiosa e la più intollerabile sopravvivenza di epoche asfissianti, quando nessuno vedeva più in là del proprio naso e la cronaca dell’Italia meschina si svolgeva sonnecchiando tra il farmacista e il segretario comunale. Combattere il regionalismo è opera santissima: ma voler distruggere i dialetti è non solo praticamente impossibile ma idealmente errato. Nei dialetti è il lievito stesso della lingua unitaria; essi sono i vivai inesauribili che arricchiscono e mantengono giovane la lingua. Perché dunque fingere che esista un italiano che non esiste, e parlare sulla scena o sullo schermo un esperanto da filodrammatici?29. Nel quadro complessivamente dialettofobo ed esterofobo del cinema (soprattutto non comico) di quegli anni, colpisce la spregiudicatezza del Grande appello, 1936, di Camerini, «racconto coloniale dove le varietà linguistiche traboccano: francese, spa28. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 79). 29. MICHELI (1990: 76–77). 176 Il linguaggio cinematografico gnolo, arabo, inglese nella Gibuti cosmopolita, e dialetti (il genovese sopra tutti) ancora qui e fra i militari in Abissinia, sullo sfondo ovviamente continuo di un italiano talora ‘popolare’, anche in bocca a graduati (‘Quello che ci avevo da dire ce l’ho detto!’…)»30. Il film di Camerini, tra l’altro, adotta, forse per la prima volta, un espediente che accompagnerà molto spesso l’utilizzazione filmica dei dialetti e delle lingue straniere in tutta la sua storia: i personaggi dapprima parlano nella loro lingua materna per proseguire poi nell’italiano standard. Uno dei film più interessanti, linguisticamente, alla vigilia della guerra è sicuramente Montevergine, 1939, di Carlo Campogalliani, nel quale la componente regionale non si limita a qualche inflessione meridionale nelle comparse. Vi si narra di Rocco che, accusato ingiustamente di omicidio, fugge in Sudamerica per poi ritornare, dopo anni di carcere, nella natia Montevergine. Il film trasuda di nazionalismo (i cattivi sono stranieri), di immagini della Madonna di Montevergine e anticipa le atmosfere (ma non la lingua) da melodramma dei poveri tipiche di un altro celebre film di emigrazione: Catene, 1949, di Matarazzo, con il quale, tra l’altro, condivide anche l’attore protagonista (Amedeo Nazzari). Dice a Rocco il personaggio che vuole aiutarlo ad imbarcarsi, porgendogli un foglio: «fai mèttere/ nu vist’accà//» ‘fai mettere un visto qui’. Il nostromo, genovese, così reagisce per essere stato chiamato don Bartolomeo: «Io mi chiamo Bartolomeo/ sénsa il don// A Zena [‘Genova’] solo i preti si chiamano don// E mi m’asomigio piutosto ao stocafiscio/ ch’a ’o prete//». E ancora lo stesso nostromo: «Anemo anemo!» ‘andiamo’; «Azidenti a mi e a ti che m’hai fato pasare pe scemo/ m’hai fatto pasare!»; invitando Rocco a scappare: «T’hai capio o no t’hai capio? Se no t’hai capio ti è proprio no stupido/ ti è!». L’amico Pasquale, rivedendo Rocco dopo dieci anni, esclama: «Maronna ro Carmene!»; e poi, parlando della figlia: «Tiene o ritratto tuo ’n goppa ’o commodino//». 30. RAFFAELLI (1992: 93). 4 – Lingua, lingue e dialetti 177 L’italiano di Rocco è scorrevole e credibile. Al momento di tornare in Italia, avendo appreso di essere stato assolto al processo, così parla a Emanuela: Sapete che cosa vuol dire/ avere un peso qui dentro? Per mesi/ per anni// Che vi strappa dalla famiglia/ dal paese/ dalle cose più care? Ebbene/ questo peso io non ce l’ho più// Capito? […] Posso finalmente dare un calcio a Gonzales […] e compagnia bella// E chi s’è visto s’è visto// Altro che distilleria/ e ubriaconi da sorvegliare// Me ne vado al mio paese! Fra gente onesta! Che lavora sul serio! Nel film compare anche lo spagnolo, nelle canzoni cantate in treno e in qualche battuta: «La duana/ señores» (detta dal capotreno); «Adios» (detta da Nazzari); nessuna inflessione iberica nei peruviani del film. Per rimanere in ambito non comico, nella trilogia propagandistica realizzata dal Centro Cinematografico del Ministero della Marina (La nave bianca, 1942, di Rossellini; Uomini sul fondo, 1941 e Alfa Tau!, 1942, di Francesco De Robertis) compare qualche battuta contenente dialettalismi e gergalismi. Anche nel film bellico I trecento della Settima, 1943, di Mario Baffico, i soldati parlano vari dialetti. Del resto, si sa, gli ambienti militari sono sempre (1860, 1934, di Blasetti; Paisà, 1946, di Rossellini; La grande guerra, 1959, di Monicelli; Tutti a casa, 1960, di Comencini…) i più consoni alla riproduzione delle varietà dialettali e, in generale, del plurilinguismo. I film prevalentemente dedicati ad ambienti socioculturali particolari fanno pure un certo ricorso al gergo, quando non al regionalismo. È il caso, per esempio, di Fari nella nebbia, 1942, di Gianni Franciolini, che ha per protagonista un camionista (Fosco Giachetti) il quale usa scassone ‘autotreno in cattive condizioni’31. 31. La fitta presenza del gergo nel cinema italiano e doppiato degli anni Trenta–Cinquanta è minutamente esemplificata in MENARINI (1955: 155–184). 178 Il linguaggio cinematografico Il ruolo assunto dal dialetto nei film neorealistici non giunge dunque inaspettato, ma è anticipato da alcuni titoli, soprattutto, ma non solo, commedie (la vocazione mimetica, e quindi dialettale, è insopprimibile nei generi comici italiani), degli anni Quaranta. Manca naturalmente, prima del Neorealismo, qualsiasi intento ideologico–simbolico nell’uso dei dialetti (qualche eccezione con 1860 e Montevergine), che, fino al 1945, fungono da indicatore etnico–sociale, catalizzatore comico o, tuttalpiù, da lingua del cuore contrapposta alla lingua della ragione. 4.1.2. Nel 1942 debuttano sul grande schermo l’attore teatrale genovese Gilberto Govi e il romano Aldo Fabrizi, i quali immetteranno nei film una quantità non trascurabile di dialettalismi, almeno fonetici. Nei suoi quattro film (Colpi di timone, 1942, di Gennaro Righelli; Che tempi!, 1948, di Giorgio Bianchi; Il diavolo in convento, 1951, di Nunzio Malasomma; Lui, lei e il nonno, 1959, di Anton Giulio Majano), Gilberto Govi opera un «processo di italianizzazione e di autotraduzione» del genovese, «impiegato anche nel caso della presentazione delle sue commedie dialettali a un pubblico non genovese (e poi alla più vasta platea televisiva)»32. Sempre dal teatro (perlopiù di varietà o regionale), dopo i casi di Petrolini, Viviani e Dina Galli già visti, provengono anche altri celebri attori dialettali, quali il catanese Angelo Musco (memorabili almeno le sue interpretazioni nell’Aria del continente, 1935 e Pensaci, Giacomino!, 1936, di Righelli [Fig. 19]; «Fiat voluntas Dei», 1935, di Palermi; Il feroce Saladino, 1937, di Bonnard [Fig. 20]), il veneziano Cesco Baseggio (Le scarpe al sole, 1935, di Marco Elter; La vedova, 1939, di Goffredo Alessandrini; Piccolo alpino, 1940, di Oreste Biancoli; Canal Grande, 1943, di Andrea Di Robilant, e molti altri), Erminio Macario, i De Filippo, Anna Magnani e Totò, che 32. COVERI (1996). 4 – Lingua, lingue e dialetti 179 debuttano tutti sul grande schermo negli anni Trenta e che portano con sé un bagaglio più o meno ingente di dialettalismi33. Il torinese Macario è, tra i comici citati, quello che italianizza più di tutti la propria varietà piemontese (resta però, quanto meno, qualche vocale turbata). Il suo umorismo poggia essenzialmente sull’aria svagata, sulla mimica [→ Glossario, MIMICO] da bambino, sui giochi di parole e su certi vezzi di pronuncia: lanciò la moda della sillabazione nasalizzata delle parole difficili (ban–ten–rion–lon–gin–ca–mente, car–diom–pal– mo, en–cin–clom–pe–dia, im–per–tron–fin–co, rim–pen–tin– zio–ne, spie–gan–zio–ne). Propagò anche alcune espressioni quali lo vedi come sei (che è anche il titolo del suo film più famoso, 1939, di Mattoli: «Lo vedi come sei… Lo vedi come sei?!»), strazio dell’anima, fa d’uopo, a prescindere (gli ultimi due ripresi da Totò), nonché l’abuso ironico di termini ricercati o semplici intercalari quali comunque, eziandio, laonde (i primi due furono poi ripresi anche da Totò)34. Ma a Macario sono care anche alcune forme–bandiera del romanesco (lingua umoristica e filmica per eccellenza, dato il ruolo egemone del “Marc’Aurelio” e di Cinecittà): zozzetto, stropicciarsene ‘infischiarsene’, frescone, fasullo35. E non manca qualche timido riferimento ironico alla politica autarchica del regime: CIPRIANO (Macario) (in un negozio di alimentari): Buonasera. Avete del caviale autentico? COMMESSO: Sì. CIPRIANO: Ma… Volga–Volga, steppa–steppa Oci ciornie… COMMESSO: Ah, sì sì, capisco… il nostro caviale è di buonissima qualità! CIPRIANO: Quanto al quintale? 33. Aristarco ricorda peraltro giustamente come «spesso il cinema durante il fascismo si limitasse a fare un teatro dialettale come quello di Govi, di Musco, dove di cinematografico non c’era assolutamente nulla e quindi non sarebbe neppure il caso di parlare di dialetto nel cinema, ma di dialetto caso mai nel teatro fotografato» (ARISTARCO 1985: 28). 34. Cfr. MENARINI (1955: 123–124). 35. Cfr. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 130). 180 Il linguaggio cinematografico COMMESSO: Mah… veramente noi lo vendiamo a 70 franchi al chilo, non c’è nessuno che lo compri al quintale! CIPRIANO: Ah, che tempi, però, che tempi! E… Pasticcio di fegato d’oca ne avete? COMMESSO: Sissignore! CIPRIANO: E salmone affumicato? COMMESSO: Sissignore! CIPRIANO: E wurstel? […] COMMESSO: Ja! CIPRIANO: E […]? COMMESSO: Ja wohl! CIPRIANO: E allora datemi un pezzetto di autoformaggio! COMMESSO: Autoformaggio? CIPRIANO: Quello che cammina da sé!36. Eduardo e Peppino De Filippo esordiscono al cinema nel 1932, ma è con Il cappello a tre punte, 1935, di Camerini e ancor più con Quei due, 1935, di Righelli, tratto da una commedia di Eduardo, che la coppia si consolida, con le sue peripezie anche linguistiche. Complessivamente, però, l’attività dei tre fratelli (presto, infatti, si aggiungerà Titina) è caratterizzata da una sorta di italianizzazione del napoletano (anche a teatro, soprattutto a mano a mano che le tournées li allontanavano da Napoli), grazie alla quale, tra l’altro, erano riusciti ad aggirare la censura che escludeva le compagnie dialettali dalle recensioni: Si fa presente che la disposizione diramata in data 3 settembre, col testo non occuparsi dei teatri vernacoli…, non riguarda la compagnia di prosa diretta dai De Filippo e quella diretta da Micheluzzi. Le due suddette compagnie non sono da considerarsi come appartenenti al teatro vernacolo37. Vediamo qualche esempio della lingua dei De Filippo tratto da Non ti pago!, 1942, di Carlo Ludovico Bragaglia, con Eduar36. Imputato, alzatevi!, 1939, di Mattoli (RUFFIN/D’AGOSTINO 1997: 132–133). 37. Velina del 26 settembre 1942 (RUFFIN/D’AGOSTINO 1997: 122 n. 111). Sempre dal volume di RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 122–123) sono tratti gli esempi filmici successivi. 4 – Lingua, lingue e dialetti 181 do, Peppino e Titina, dalla commedia omonima di Eduardo. Numerosi i regionalismi fonetici, morfosintattici e lessicali, ma sempre ampiamente entro la soglia della comprensibilità: troncamento dei nomi in funzione allocutiva (don Ferdinà, Savè, Carmè), posposizione dei possessivi al nome («Ma vedete se è una cosa regolare che un padrone di un banco lotto si ggiuoca tutti i soldi suoi nel banco lotto suo stesso!»), oggetto indiretto («Mi sono sognato a vostro padre»), espressioni come «statemi bbuono», parole come iettatore, incocciare ‘imbattersi in’, pazziare, scocciante. I primi tre film con Fabrizi (Avanti, c’è posto…, 1942, di Mario Bonnard; Campo de’ Fiori, 1943, dello stesso Bonnard; L’ultima carrozzella, 1943, di Mattoli, gli ultimi due con Anna Magnani; alla sceneggiatura di tutti e tre parteciparono Federico Fellini e lo stesso Fabrizi) inaugurano quel realismo (non esente, però, da un populismo sentimentalistico) romanesco della povera gente che poi, grazie a Roma città aperta (non a caso con gli stessi Fabrizi, stavolta, però, non dialettofono, e Magnani), aprirà la strada al Neorealismo e, da lì, alla Commedia all’italiana e a tante stereotipizzazioni dialettali successive. In Avanti c’è posto… (Figg. 21–23), Fabrizi porta sullo schermo la macchietta del tranviere, tratta dal suo repertorio teatrale. Vi interpreta il bigliettaio Cesare Montani, dal carattere composito che va da una sensibilità e una generosità da puro di spirito (arriverà a rinunciare alla donna che ama, cedendola all’amico di cui lei è innamorata) a momenti di (comica) irascibilità. E sapientemente (e teatralmente) composita è la lingua che parla, dall’italiano senza accento, al dialetto non privo di tinte arcaiche (dichi ‘dici’), all’italiano regionale e popolare, all’immancabile uso del gioco metalinguistico. Senza dubbio il bozzettismo folcloristico è in agguato, ma è notevole, in questo film, l’uso del dialetto non soltanto per far ridere ma anche per riferire i piccoli drammi della povera gente, non senza certa attenzione all’introspezione. Sentendo due signore che dialogano in filobus, a proposito della sfortuna nel gioco delle carte («Una scalógna!», esclama 182 Il linguaggio cinematografico una di loro), Cesare chiede: «Ma scusate/ se dice scarògna o scalògna?», e un uomo prontamente: «Scalógna». CESARE: (parlando con un uomo in filobus, a proposito del furto di un borsellino) La ragazza è entrata di là// UOMO: Di là?! A che cosa volete alludere?! CESARE: Io non alludo a gniente// UOMO: No/ voi alludete// CESARE: No/ io non alludo// UOMO: Eppure voi avete alluso// CESARE: Me possi cecamme si ho alluso// ALTRO UOMO: No/ non ha alluso// CESARE: Ma che ne sa/ questo?! Poco dopo, l’autista del filobus (interpretato da Andrea Checchi) a Fabrizi che ha preso uno schiaffo da una donna: BRUNO: Stizzìscitici// CESARE: Che? BRUNO: Stizzìscitici// CESARE: Stisciffititi un accidente! […] CESARE: (poco dopo, pagando una scommessa all’autista) Ah! Porca miseria! Tiè// E Stizzi.. sti… co… no lo dici? BRUNO: Io scommetto cento lire/ che tu/ stizzìscitici/ non lo dirai mai! CESARE: Chi ’o sa/ pe sbajo! CESARE: (a Rosella, la ragazza derubata, di cui si innamora) Mo mo ’o dichi ndo andamo? CESARE: Io no lo pijerebbe mai// (riferendosi all’autobus). Altre varietà figurano nel film. Per esempio quella meridionale (abruzzese) del caratterista Virgilio Riento (un controllore vessatore, e oltretutto direttore della banda del dopolavoro, nella quale Cesare suona i timpani), che deforma tutte le parole mediante sonorizzazione delle occlusive sorde: CONTROLLORE: (a Cesare Montani) Sendide/ Mondani… CESARE: Prego/ Montani// 4 – Lingua, lingue e dialetti 183 CONTROLLORE: E Va bene/ Mondani/ o Mondani/ non monda// Quello che monda/ è che la vettura tranviaria/ non è come i vostri timbani/ che basta picchiarci sopra qualche cosa/ bene o male viene fuori// La vettura tramviaria è legata all’orologio// E l’orologio dice che voi siete in ritardo di cingue minuti// E non m’inderrombete// Un altro ritardo e vi muldo// Tando una mano lava l’aldra// E tutte e due servono a cacciarvi fuori dalla banda// CESARE: E dopo i timpani chi li sona// RIENTO: Uhm! Tutti sono utili/ e nessuno è necessario//. Il veneto è parlato da un personaggio secondario: il padre del bambino battezzato cui Cesare deve fare da padrino: «Se vedemo dopo el concerto»; «Me la voglio gòde» ‘mi voglio divertire al concerto’. Anche mediante il ricorso a glosse: «Voglio assolutamente che sia il santolo del mi fio// Sicuro! Il padrino di mio figlio!» (alla serie, Fabrizi aggiunge il romano compare). Come di consueto, il dialetto è solo degli uomini — Magnani e poche eccezioni, perlopiù moralmente screditate, a parte — e dunque la candida protagonista Rossella (Adriana Benetti) parla un italiano ineccepibile, senza ombra di sfumature regionali. In Campo de’ Fiori, a un’ambientazione perfetta (ricreata negli studi di Cinecittà) — dove tra l’altro il ruolo egemone del mercato anticipa celebri esempi neorealistici come Ladri di biciclette38 — non corrisponde altrettanta cura linguistica, anche se il romanesco fa quasi sempre da protagonista: PESCIVENDOLO (Fabrizi): Dico/ a scapijona/ ’n potéssivo penzà ai broccoletti vostri? FRUTTIVENDOLA (Magnani): E annate/ che me fate seccà ’a frutta/ co ’sta puzza! Anche qui fanno da comparse occasionali il veneto, il napoletano e altre varietà, tanto che tale plurilinguismo farà esclama- 38. Per un mercato precedente (nella Genova di Sissignora, 1942, di Ferdinando Maria Poggioli) cfr. RAFFAELLI (1992: 97–98). 184 Il linguaggio cinematografico re Fabrizi: «Stamatina me toccano tutti forestieri// Ma i romani ndo so’?!». Nell’Ultima carrozzella, il più farsesco dei tre film (ma non meno interessante per certo realismo sociale e per le riprese in esterno), al romanesco spontaneo di Fabrizi si contrappone l’italiano asettico dei figli. Anche la lingua della Magnani è qui un italiano perfetto e teatralmente impostato (non priva di ironia, al solito, la sua pronuncia affettata), tranne quando si adira, prorompendo in autentico romanesco; per esempio all’autista, riferendosi a Fabrizi: «Aóh/ questo è più impunito de te/ eh?». Come in molti suoi film, la Magnani gioca magistralmente con la commutazione di codice italiano impettito/romanesco, che va di pari passo con la sua mimica da signora/popolana. Ma anche Fabrizi è un maestro della commutazione di codice, sebbene meno sistematicamente della Magnani. Quando fa vedere alla moglie e alla figlia i soldi della vincita alle corse dei cavalli, passa dal romanesco (con cui si entusiasma per le inattese possibilità economiche) all’italiano affettato (che fa il verso a quello parlato da Tino Scotti) per poi tornare al romanesco: Ma io un par de pedalini mi ’i potrò fà? Avrò diritto/ no? Ah/ dunque// Questi sono cartoni// Bambola/ sono cartoni! (riferendosi alle banconote che posa sul tavolo, scandendo affettatamente le parole) Da’ ’n bacio a papà// (sentendo il vecchietto interpretato da Lauro Gazzolo chiamarlo da fuori) ’O vedi quanno ce so’ questi/ (cioè i soldi) amichi come se scapicolleno! (riferito a Gazzolo che accorre mentre Fabrizi sta contando i soldi della vincita). Qualche altro esempio tratto da battute di Fabrizi: all’autista: «Ma che te sei perso un paio de frustate sul grugno/ aóh?»; «li quatrini» ‘i soldi’; «L’hai mucinato?» (‘l’hai girato’) chiede alla moglie a proposito del caffè; «Ta rovinerebbe io/ a te e tu padre!» (Fabrizi allo spasimante della figlia). Non manca qualche discesa nel turpiloquio, pur lieve: «E chi se ne frega!» dice Fabrizi di fronte alla dichiarazione della Magnani di non lasciargli mancia; Cacarella è il soprannome di uno degli amici di 4 – Lingua, lingue e dialetti 185 Fabrizi; «E ’nnamo/ mo piantamola co sti pomiciamenti!» (intima la Magnani ai due uomini che la stanno toccando). Anche in questo film Fabrizi si concede qualche arcaismo dialettale, come amichi ‘amici’, o la desinenza –amio: alla cavalla: «Te ricordi quando passamio pe Roma/ che ce guardavano tutti?». L’italiano di Tino Scotti (il balordo del film: notevole che proprio lui pronunci la parola camerata) è, come s’è detto, ridicolmente artefatto, come viene sottolineato anche dal risentito contrappunto della Magnani: Io affronto le platee/ giro il mondo/ per regalarmi qualche gioiello/ poi gli innocenti se li vanno a giocà alle corse// […] Io dico che quando uno è senza quatrini/ è capace di fare qualunque cosa! […] ’Sto morto de fame! […] Sei un morto de fame! Sei un morto de fame! Sei un morto de fame! Sei un illuso/ che non fa ride nessuno// Quando lavori te/ so’ fischi e pernacchie// Ma come vòi fà ride/ co ’sta faccia da fame/ che cj hai?! […] Ma pussa via! A dimostrazione che anche la lingua (pseudocolta) di Scotti, come la sua millantata celebrità, è tutta finzione, egli domanda a Fabrizi, scrivendogli la dedica sulla foto: «Vetturino o vittorino?». Gli altri personaggi del film s’esprimono in italiano standard con venature settentrionali (Lauro Gazzolo). Celebre il gioco linguistico basato sul fraintendimento del tecnicismo trauma, pronunciato dal dottore («Non c’è trauma»): «O povero amico mio! Era un uomo pieno di trauma!» prorompe Gazzolo. E, poco dopo, Fabrizi, vedendo un segno sulla cavalla, mostra di aver appreso il “gergo medichese”: «’Sto trauma/ qua// Ma lo shock è da escludersi». Tutti e tre i film appena commentati, oltre a confermare la tendenza del romanesco a diventare dialetto (o meglio italiano regionale) egemone della cinematografia italiana (e lo rimarrà praticamente fino ai giorni nostri)39, introducono gradualmente 39. Sui motivi, notissimi (Roma capitale amministrativa e politica, oltreché del 186 Il linguaggio cinematografico alle tematiche neorealistiche anche per via di riferimenti più o meno diretti alla realtà in corso, e in particolare alla guerra e alla povertà, con esplicito distacco, dunque, dalla produzione media coeva ben intenzionata a occultare ogni traccia del contingente. Avanti c’è posto… si chiude con l’arruolamento di uno dei protagonisti e la parata dei soldati in partenza; in Campo de’ Fiori è spesso in primo piano la mancanza di viveri e prodotti di prima necessità; L’ultima carrozzella si apre con la partenza per la guerra del figlio di Fabrizi. cinema, della radio e poi della televisione, sede delle principali scuole di recitazione e degli studi di doppiaggio, etc.), dell’egemonia del romanesco sugli altri dialetti cfr. DE MAURO (1963/1993: 124–126, 149–201); BRUNETTA (1991: 333–336); ROSSI (1999a: 65–66). Sulle peculiarità linguistiche del romanesco nello spettro diatopico italiano cfr. almeno TRIFONE (1992), TRIFONE (1993), VIGNUZZI (1988), (1994a), (1994b) e (1995), D’ACHILLE/GIOVANARDI (1995) e (2001), D’ACHILLE (2002b). Va inoltre ricordato che, sul terreno della pronuncia degli attori, prevalse, sul finire degli anni Trenta, una certa tolleranza per alcuni tratti romani (timbro vocalico, etc.), secondo l’antico principio della «lingua toscana in bocca romana», sancito dapprima da BERTONI/UGOLINI (1931a) e (1931b) e poi, in misura minore, dal DOP (cfr. SERIANNI 2002: 99–100). Naturalmente un ulteriore incremento alla tirannia del romanesco filmico sarà dato dall’emulazione di certe tendenze neorealistiche inaugurate da Roma città aperta e da Ladri di biciclette e dall’enorme popolarità di attori come Aldo Fabrizi e Anna Magnani (cui presto si aggiungeranno Alberto Sordi e tanti altri). Dalla concomitanza del prestigio di Roma come capitale del cinema con la peculiarità interna del parlato romano (la cui fisionomia dialettale è assai sfibrata, sia per la secolare vicinanza con il fiorentino e quindi con l’italiano, sia per la compagine plurilingue di Roma, centro di immigrazione) e con l’innata inclinazione del cinema all’ibridismo si sviluppa così una sorta di lingua franca del cinema, definita da Moravia più come un «italiano sfatto» (GIANNARELLI 1982, V) che un dialetto vero e proprio. Non mancano peraltro le reazioni all’abuso del romanesco rispetto all’italiano e agli altri dialetti: Migliorini parlò di «dialetto sguaiato e bonaccione della capitale» in «filmucci di terz’ordine», dotati però di «un’influenza notevole» (MIGLIORINI 1990: 117); SPINAZZOLA (1965) coniò invece la felice etichetta di neoitaliano per questa lingua tipicamente filmica intermedia tra l’italiano e il dialetto, «uno strumento espressivo ibrido e composito, ma dotato di notevole duttilità e di un efficace potere unificante». Caustico contro il dialetto filmico è Pucci [→ Antologia critica, § 11], secondo il quale «il dialetto usato in quasi tutti i films italiani è un dialetto elaborato, annacquato, arbitrario, è un dialetto che nessun parlante ‘reale’ di quell’ambiente in verità parla» (PUCCI 1959: 824). Sull’argomento cfr. ancora VALLINI (1962) e VARESE (1963: 187). Bisognerà aspettare alcune produzioni più o meno recenti (dei registi Sergio Citti, Claudio Caligari, Ricky Tognazzi, Daniele Vicari, anche ad opera di giovani attori come Ricky Memphis e Valerio Mastandrea) per tornare a sentire un romanesco meno annacquato. Sul romanesco filmico dal dopoguerra a oggi cfr. anche LILL (1994) e CICCOTTI (2001). 4 – Lingua, lingue e dialetti 187 La penetrazione del romanesco nei film è talmente profonda che talora si incontrano forme proprie della capitale anche del tutto decontestualizzate: in Villa da vendere, 1941, di Ferruccio Cerio, una delle tante commedie “all’ungherese” [→ Glossario, UNGHERESE, COMMEDIA ALL’] del nostro cinema, si colgono cocco, gagliardo, micco ‘sciocco’, malloppo ‘refurtiva’, pappagallo ‘corteggiatore inopportuno’, pollo ‘vittima designata per la truffa’ ed espressioni come «vi piacerà forte». Anche in un’altra ambientazione ungherese, La fortuna viene dal cielo, 1942, di Akos Ratoni [Ákos Ráthonyi], Anna Magnani, nelle vesti della sciantosa ungherese Zizì, prorompe a suon di «Vuole a me?» e coccobbello40. Secondo Sergio Raffaelli, l’allentarsi dei freni antidialettali nella lingua di alcuni film del periodo bellico va visto in parallelo allo «sprofondare del pubblico nelle angosce dell’indigenza, dei lutti, delle distruzioni», quasi per «un bisogno di sintonia rassicurante e consolatoria, che appunto pure un linguaggio familiare o dimesso può offrire»41. La conferma di quest’uso consolatorio del parlato filmico dialettale da parte delle produzioni di regime ci è data dalla richiesta di Luigi Freddi (noto dialettofobo), in qualità di presidente della Cines, a Mussolini, perché bloccasse la censura contro le battute dialettali del film aviatorio Gente dell’aria, 1943, di Esodo Pratelli: Roma, 6/4/XXI DUCE, perdonatemi: vorrei pregarVi di lasciare intatte le tre o quattro battute con inflessione dialettale che — nel film “Gente dell’aria” — sono pronunciate dall’attore Calindri nel ruolo del capo–officina Candiani. C’è una ragione tecnica: il Calindri è fuori colla sua compagnia drammatica, della quale bisognerebbe far sospendere gli spettacoli per richiamare l’attore onde fargli sincronizzare le battute, operazione che dovrebbe essere seguita da un rifacimento della ‘mischiatura’ delle colonne 40. RUFFIN/D’AGOSTINO (1997: 127). 41. RAFFAELLI (1992: 100–101). 188 Il linguaggio cinematografico sonore nei punti ritoccati. Tutto ciò costringerebbe inoltre a rinviare l’uscita del film ed a sospendere le proiezioni laddove è già uscito. Le rare battute dialettali, comunque, caratterizzano una figura di capo–operaio del settentrione e giovano a cattivare la simpatia popolare a vantaggio dell’effetto propagandistico. Voi sapete che io non sono tenero per i dialetti: un mio articolo appunto contro i dialetti apparve una dozzina di anni fa sul “Popolo d’Italia” e fu famoso e mi procurò un monte di grane. Nel film “Gente dell’aria” ho fatto recitare in italiano un notissimo attore dialettale, il Riento. Non ho acceduto al dialetto che per i film di Fabrizi e dei De Filippo, che costituiscono uno strumento di comicità provvidenziale sempre, ma specialmente ora, per la distrazione del pubblico. […] Vostro Luigi Freddi42. Si dovrà, tuttavia, distinguere l’impiego del dialetto come «fattore di ‘verità’» dei pochi film neorealistici (1945–1952), dalla dialettalità intesa come «concessione populistica»43, propria non soltanto della cinematografia precedente, ma anche di gran parte di quella contemporanea al Neorealismo e di molta della successiva. 4.2. I dialetti nel Neorealismo e dintorni 4.2.1. Riprendiamo in questo paragrafo il discorso interrotto nel § 2.5.2. I film commentati qui di seguito sono tutti notissimi e dunque non pare il caso di riassumerne la trama, che potrà peraltro essere facilmente recuperata, unitamente a tutte le informazioni filmologiche qui necessariamente omesse, nei principali dizionari di film (per esempio, DI GIAMMATTEO 1990, MEREGHETTI 2005) e nei volumi (BRUNETTA 1991 e 1993 in primis) citati nelle note e in bibliografia. 42. RAFFAELLI (1992: 101–102). 43. CARPITELLA/DE MAURO/RAFFAELLI/NAPOLITANO (1986: 165). 4 – Lingua, lingue e dialetti 189 L’importanza e l’innovazione linguistica principale del Neorealismo consistono non tanto nel grado di approssimazione alla realtà del dialetto riprodotto, né nella frequenza dei tratti regionali, né nel numero dei film dialettali (molto pochi), bensì nell’aver dato “dignità” al dialetto quale strumento di comunicazione: «il dialetto, così a fianco a fianco talora con l’italiano e persino con lingue straniere, assumeva per la prima volta nella storia del cinema italiano una posizione non più subalterna ma di parità assoluta»44. Al centro della scena vengono inoltre collocati tutti quei personaggi che fino a quel momento avrebbero potuto interpretare soltanto ruoli da comparsa: dar loro la parola e costruire un film sul loro «esprimere giudizi sul mondo e sulla storia»45 significa necessariamente aprire la strada al parlato–parlato in dialetto. Soltanto un’Italia che stava per conquistare finalmente una lingua parlata unitaria poteva rivalutare, e mettere in scena col dovuto distacco e senza vergogna, il plurilinguismo dialettale; non è un caso che il tasso di dialettalità presente nei film salga con l’aumento delle competenze linguistiche degli italiani e sia inversamente proporzionale al livello culturale dei destinatari del prodotto: infatti i film neorealistici registrarono un successo di élite (di critici e intellettuali), come già detto, mentre a livello popolare furono spiazzati da titoli come Catene, i cui protagonisti (un meccanico e una casalinga interpretati da Amedeo Nazzari e da Yvonne Sanson) non parlavano certo il napoletano del 1949, ma un inappuntabile italiano da manuale, o meglio l’italiano dei doppiatori. A partire dal Neorealismo, insomma, il cinema smette i panni dell’insegnante di lingua (li cederà, a partire dal 1954, alla televisione, almeno fino agli anni Settanta–Ottanta), per assumere il ruolo di «specchio delle lingue»46. Ma sarà uno specchio via via sempre più semplificante (a causa della tendenza alla stereotipizzazione 44. RAFFAELLI (1992: 107). 45. BRUNETTA (1991: 311). 46. SIMONE (1987) [→ Antologia critica, § 16]. 190 Il linguaggio cinematografico insita nel mezzo cinematografico stesso) o deformante (nelle rare soluzioni espressionistiche del nostro cinema, in seguito commentate). Tra tutti i film neorealistici, forse il meno fortemente connotato in senso dialettale è proprio quello inaugurale, il quale ha goduto, direi anche per questo motivo, del maggior successo tra il grande pubblico. La raffinatissima modulazione linguistica di Roma città aperta, 1945, di Rossellini (Fig. 24), infatti, sembra rispondere a intenti più simbolici che realistici: «il tedesco come codice della belluinità, l’italiano della consapevolezza, il dialetto degli affetti»47. A parte le coloriture romane di Anna Magnani («Ma va’ a morì ammazzata/ va’!»; «A voi che ve ne frega?») e di qualche altra figura di contorno, i dialoghi del film sono nel complesso molto formali, con punte di aulicità (si vedano i costui, coloro, il quale, i participi accordati con l’oggetto, etc.: «[DON PIETRO:] Per coloro che si sacrificano non è un sacrificio//»; «[MARINA:] Se tu m’avessi veramente amata m’avresti cambiata//»), talora addirittura sarcasticamente sottolineata: «Voi italiani/ di qualsiasi partito siate/ siete malati di retorica//»; lo stesso bambino, Marcello, si esprime quasi sempre come un libro stampato, con i congiuntivi al posto giusto: «speriamo che mia madre l’abbia saputo//». Si riportano, a conferma di tale formalità, alcune battute del celebre dialogo tra Giorgio col maggiore Bergman e di quest’ultimo con don Pietro, nella parte conclusiva del film: BERGMAN: Sentite/ signor Episcopo// Se io avessi del tempo da perdere/ mi divertirei molto/ a parlare con voi del vostro commercio// Ma purtroppo ho molta premura/ e ho della stima/ per voi// Vi farò perciò una proposta// Io so tutto di voi/ il vostro vero nome/ la vostra attività politica passata// In quanto alla presente/ io so dai miei informatori/ che voi siete… uno dei capi della giunta militare/ del comitato di liberazione nazionale// E siete in collegamento/ con il centro militare badogliano// Io ho assoluto/ urgente bisogno/ 47. RAFFAELLI (1992: 107). 4 – Lingua, lingue e dialetti 191 di conoscere nei suoi dettagli questa organizzazione/ e voi siete l’uomo più adatto per farmelo sapere// GIORGIO: […] Perché crede che io possa diventare oggi una spia? Io so che in questa casa/ forse in questo stesso ufficio/ sono state fatte le stesse proposte a dei generali italiani/ a dei badogliani/ come dite voi// So che hanno pagato con la vita/ la loro lealtà/ il loro silenzio// Io spero di non essere da meno di loro// […] BERGMAN: Come voi chiamate un uomo/ il quale non solo fornisce documenti falsi e rifugio a italiani/ che preparano attentati contro i nostri soldati/ ma dà asilo e aiuto persino a disertori tedeschi?! PIETRO: Un uomo che indegnamente cerca di esercitare la carità// BERGMAN: Costui è un traditore/ che dev’essere punito secondo le leggi di guerra del Reich! […] Il vostro amico Episcopo è alla testa di un’organizzazione militare/ della quale anche voi avete perfetta conoscenza// Se voi parlerete/ o convincerete il vostro amico a fare altrettanto/ non avrete compiuto che il vostro dovere di prete e di cittadino//. La sintassi del brano riportato presenta un’architettura complessa, sia negli usi verbali («Se io avessi del tempo da perdere/ mi divertirei molto/ a parlare con voi del vostro commercio»), sia nell’estensione degli enunciati e nel grado di incassatura («Come voi chiamate un uomo/ il quale non solo fornisce documenti falsi e rifugio a italiani/ che preparano attentati contro i nostri soldati/ ma dà asilo e aiuto persino a disertori tedeschi?!»). Anche l’estensione dei turni dialogici e l’assenza di autocorrezioni, di ripensamenti e di esitazioni, di segnali discorsivi e di strutture segmentate [→ Glossario, SEGMENTAZIONE] avvicina la lingua di Roma città aperta più allo stile della lingua scritta letteraria che a quello del parlato–parlato. Il lessico è estremamente ricercato e spesso (per l’uso di perifrasi che sostituiscono verbi comuni: avere conoscenza per conoscere) ridondante (soprattutto quello del locutore straniero Bergman: segno che, più che alla verosimiglianza, gli autori hanno teso qui al simbolismo della lingua del potere): compiere, costui, eserci- 192 Il linguaggio cinematografico tare, essere alla testa di, fornire, il quale, indegnamente, in quanto a, persino, premura, etc. D’accordo con Raffaelli, «non la dialettalità a sé stante, bensì l’adozione mimetica dell’intero repertorio di codici e di registri in uso si deve considerare fenomeno caratteristico dei pochi ma incomparabili classici del neorealismo». Per questo «la nuova stagione linguistica del cinema italiano […] inaugurata mirabilmente da Roma città aperta, che propose una rappresentazione verosimile dell’intrecciarsi tradizionale e avventizio di codici e del sottile oscillare di registri diversi», più che essere definita cinema dialettale, come troppe volte è stato detto erroneamente, va considerata cinema del realismo linguistico o, come preferisce Raffaelli, delle «varietà mimetiche»48. Concludiamo l’esemplificazione dal primo capolavoro rosselliniano con il dialogo tra Pina (Anna Magnani) e Francesco (Francesco Grandjacquet), che mostra come la carica dirompente del film non sia tanto nel modo di parlare (i tratti regionali sono ridotti al minimo — praticamente alla sola apocope — sia nella Magnani sia nell’assolutamente poco credibile doppiatore di Francesco, che a orecchio mi pare Gualtiero De Angelis) quanto nei contenuti: per la prima volta si parla di odio e paura della guerra, di volontà di agire sul mondo e sulla storia. Il tutto con uno stile, sebbene antiretorico, assolutamente sorvegliato, colto e (ben) costruito (spiccano congiuntivi, futuri, appropriatezza lessicale ed equilibrio sintattico: «Ma io credo che sia così// Che non dobbiamo aver paura/ né oggi/ né in avvenire// Perché siamo nel giusto»), che della realtà linguistica dà solo una parvenza, un simbolo, come sottolinea anche il riferimento metafilmico «l’avremmo vista [la guerra] soltanto al cinematografo»: PINA: Quanto so’ stanca! FRANCESCO: Su! PINA: Quanto so’ stanca! 48. RAFFAELLI (1996a: 311–312). 4 – Lingua, lingue e dialetti 193 FRANCESCO: Piagni? Viè un po’ de là// PINA: Ma lì c’è lui// Non me va// FRANCESCO: Che importa? È un amico// PINA: Lo so/ ma è tanto tempo che voglio parlà un po’ sola co te! FRANCESCO: Va bene// PINA: Viè qua/ viè// Hm// Mettiamoci qua// Come quando ci siamo parlati/ per la prima volta// Te ricordi// Hm? FRANCESCO: Hm// Eri venuta a bussà alla porta/ co na faccia! PINA: Lo credo! Stavi a piantà un chiodo dentro al muro/ e m’avevi buttato giù lo specchio// Non s’è rotto/ però// FRANCESCO: Ma chi si crede di essere/ lei?! Il re dell’universo/ eh?! PINA: Quanto m’eri antipatico! Abitavi qui da due mesi/ e quando scendevi pe le scale non me salutavi mai// So’ passati due anni// Com’è lontano quel tempo/ eh? E com’è diverso// Eppure c’era già la guerra! FRANCESCO: Già// Tutti si illudevano che sarebbe finita presto// E che l’avremmo vista soltanto al cinematografo// E invece! PINA: Ma quando finirà? Ci so’ dei momenti che non ne posso proprio più// ’St’inverno sembra che non debba finì mai! FRANCESCO: Finirà/ Pina/ finirà// E tornerà pure la primavera// E sarà più bella delle altre// Perché saremo liberi// Bisogna crederlo// Bisogna volerlo! Vedi/ io queste cose le so/ le sento/ ma… non te le so spiegare// Lui sì/ saprebbe farlo// Lui è un uomo istruito che ha tanto studiato/ viaggiato// Sa parlare bene/ lui// Ma io credo che sia così// Che non dobbiamo aver paura/ né oggi/ né in avvenire// Perché siamo nel giusto// Nella via giusta/ capisci/ Pina? PINA: Sì/ Francesco// FRANCESCO: Noi lottiamo per una cosa che deve venire// Che non può/ non venire// Forse la strada sarà un po’ lunga e difficile ma/ arriveremo// E lo vedremo/ un mondo migliore// E soprattutto lo vedranno i nostri figli// Marcello e… e lui// Quello che aspettiamo// Per questo non devi aver paura// Mai/ Pina! Qualunque cosa succeda// Vero? PINA: Sì/ Francesco// Ma io/ non ho paura// Mai//. Paisà, 1946, film a episodi sempre di Rossellini, rinnova il geniale plurilinguismo blasettiano di 1860, mettendo in scena italiano, lingue straniere (già il titolo è l’italo– e ispanoamericano paisano, deformato nella pronuncia un po’ dai soldati alleati e un po’ dai nostri meridionali) e dialetti con alto grado di reali- 194 Il linguaggio cinematografico smo (non mancano però le incongruenze fonetiche, specialmente nel doppiato degli episodi romano e fiorentino). In ciascuno dei sei episodi, all’impettito italiano radiofonico e cinegiornalistico della voce fuori campo extradiegetica si contrappongono le diverse parlate vive d’Italia (siciliano, napoletano, romanesco, fiorentino, romagnolo e veneto), oltreché l’inglese, il tedesco e l’italiano con forte accento americano: Me fratre e me patre sono fòra da quattro juorne// Du’ vote ca tento di lassare ’a chiesa […]// Hanno paura di mannarammici sola// Vi cj accombagno// Canoscio bene ’a strada// Vegno co voe//. Chesta è ’a chiave ’e casa// ’E ccase songhe aperte/ ma ’a chiave ’on serve chiù// Ha’ cantate buóne/ ma ’un m’è piaciute proprie//. Che vòi? Che vai cercando? È tutta la sera che ’sta brutta disgraziata sta a guardà da ’sta parte//. Ma i’ cche la vole he si sappia/ noi? Co tutto quello h’è successo/ e s’ha altro da pensare!49. E she mia moglie m’aveshe dato mente a me/ e i maialini li aveshimo meshi in te cunventi/ i tudeshchi non ce li portavano mica via! — G’avreste niénte da darme da magnare? — Quel che g’avemo// Un poca de polenta//. Dopo l’esperienza di Paisà, la cinematografia rosselliniana subirà notevoli cambiamenti di rotta, anche linguistica: le opere successive del regista (il quale tuttavia, differentemente da De Sica, non ha abdicato quasi mai all’idea di un cinema di ricerca e di impegno solo per compiacere le più ampie platee), incentrate perlopiù sulla crisi interiore (Europa ’51, 1952 [Figg. 25–26]; Viaggio in Italia, 1954), sul misticismo (Francesco, giullare di 49. Un altro brano dall’episodio toscano di Paisà è riportato e analizzato nel § 6.1.3. 4 – Lingua, lingue e dialetti 195 Dio, 1950; Giovanna d’Arco al rogo, 1954) e sui grandi scenari storici utilizzati con finalità didattica (La presa del potere da parte di Luigi XIV [La Prise de pouvoir par Louis XIV], 1966, per la televisione), faranno uso, infatti, quasi esclusivamente dell’italiano standard e del “doppiaggese” (un’eccezione è Era notte a Roma, 1960, con brani in russo e in inglese sottotitolati: ancora una volta un film di ambientazione militare e dunque inevitabilmente plurilingue). Anche il suo ultimo film neorealistico (ma già fuori dal Neorealismo, secondo la critica), Germania anno zero, 1948, è parlato quasi tutto in un italiano formale e senz’accento (com’è prevedibile, data l’ambientazione straniera), a eccezione, curiosamente, di qualche sfumatura romana e torinese in personaggi secondari all’inizio del film e di qualche battuta in inglese e in tedesco priva di sottotitoli. Il sole sorge ancora, 1946, di Aldo Vergano, fa ampio ricorso al dialetto lombardo, ad eccezione del protagonista maschile, doppiato (direi dal solito Gualtiero De Angelis) e delle protagoniste. In questa discrepanza tra italiano dei personaggi principali e dialetto delle figure di contorno il film di Vergano è allineato con le produzioni degli anni Trenta e mostra vari punti in comune con Roma città aperta (col quale condivide anche la morte finale di un sacerdote, don Camillo, qui interpretato dal futuro regista Carlo Lizzani), soprattutto nell’uso simbolico del plurilinguismo: oltre all’italiano e al dialetto (con funzione ora ideologica ora affettiva), infatti (con gradazioni intermedie nel padre del protagonista, che si esprime anche in italiano regionale) si incontra il tedesco dei soldati occupanti, l’italiano storpiato dai tedeschi (con le solite r arrotate e f al posto di v) e il latino, nella preghiera finale di don Camillo, cui rispondono i fedeli. Riportiamo, a titolo d’esempio, qualche battuta in dialetto: «Cos’è ghè?» ‘che cosa c’è?’; «Va’ là/ va’ là/ che ades vegni mi» ‘va’ che adesso arrivo io’; «Lassa che vegne» ‘lascia che arrivino’ i tedeschi; «L’è andà via» ‘è andato via’; «Porco can!»; «I tudesch» ‘i tedeschi’. Ben connotata, anche linguisticamente, è la differenza tra ricchi (Matilde, la sua famiglia e i suoi amici) e poveri (i partigiani e Laura). 196 Il linguaggio cinematografico Il sole sorge ancora, che fu finanziato dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (come anche, dell’anno successivo, Caccia tragica, di Giuseppe De Santis), ha intento più ideologico–didattico che mimetico–documentaristico (forse per questo è escluso da alcuni critici dal novero dei film propriamente neorealistici). Il film segnò il primo grande successo di Lea Padovani (nei panni della partigiana Laura) e godette di una certa fortuna anche all’estero: proprio in seguito alla visione di quest’opera, infatti, il regista canadese Edward Dmytryk chiamò la Padovani per girare il suo Cristo fra i muratori (Give Us This Day), 1949, tratto dal romanzo Christ in Concrete di Pietro Di Donato sull’emigrazione italiana negli Stati Uniti, che è solitamente considerato l’unico esempio di film straniero fortemente influenzato dalle istanze del Neorealismo italiano (il film fu prodotto dall’indipendente Rod E. Geiger, che divulgherà in America i capolavori di Rossellini)50. Ancora più realistica è la lingua di Sciuscià, 1946, di De Sica, che ha il pregio, tra l’altro, di rappresentare quasi senza censura il mondo linguistico degli adoloscenti emarginati, ricorrendo persino al turpiloquio («a fijo de na mignotta!», «a mignottoni!») e a forme di dialetto arcaiche e non usurate (dichi ‘dici’): se si considera che, per un topos filmico ben consolidato, la lingua dei bambini è sempre stata edulcorata e italianizzata ancora più artificialmente di quella degli adulti, si può comprendere tutta la forza dirompente del film. Lo stesso titolo (notoriamente, deformazione dialettale dell’inglese shoe–shine ‘[giovane] lustrascarpe’), come già visto per Paisà, intende prendere le distanze dall’italiano standard, anche se «il film di De Sica fu prudentemente sottotitolato Ragazzi»51. A proposito del turpiloquio, è chiaro che la tensione verso la realtà linguistica degli strati più bassi porti con sé anche la rap- 50. Sul film di Dmytryk cfr. BONDANELLA (1985) e (2004: 29–35). Sull’influenza del realismo letterario americano sul nostro Neorealismo (Ossessione tratto da Cain) e di quest’ultimo sul cinema americano cfr. BONDANELLA (1983) e (1985). 51. RAFFAELLI (1992: 107). 4 – Lingua, lingue e dialetti 197 presentazione delle scurrilità verbali, che comincia a fare il suo timido ingresso sullo schermo proprio col Neorealismo. Dopo l’esempio di Sciuscià spicca un inatteso «troia maledetta» nell’ipercontrollato melodramma Angelo bianco, 1955, di Raffaello Matarazzo. Per il resto, eccezioni della commedia a parte («A li mortacci de Costantino» in Una domenica d’agosto, 1950, di Luciano Emmer), bisognerà aspettare gli anni Settanta per lo sdoganamento delle forme più volgari. Ancora nel 1960, l’audace (per il tema della prostituzione) Adua e le compagne, di Antonio Pietrangeli, presenta una battuta censurata (mediante troncamento): «Ma vva’ ffanc…» (ma incensurati sono, nello stesso film zoccola, «Porco Giuda!», «’sto cavolo di sedile», mignotta, bùggere, frocio, puttane e il raro, per l’epoca, «Ma so una Madonna!» ‘non capisco proprio’, imprecazione popolare romana)52. Dagli anni Settanta a oggi c’è l’imbarazzo della scelta, già nei titoli, grazie anche agli allentati freni della censura: Culo e camicia, 1981, di Pasquale Festa Campanile; Mortacci, 1989, di Sergio Citti. E il turpiloquio, naturalmente con funzione ben diversa, entra anche nel cinema d’autore, per rappresentare la decadenza di ideali e valori («la volgarità verbale non è che una variante della scalata della violenza degli ultimi decenni e il degrado linguistico è conseguenza o fenomeno correlato al degrado morale, ideale e ambientale»)53: KONRAD (al telefono): Allora brutta stronza, spiegami un po’ cos’è questa vaccata e cerca di non raccontare fregnacce se non vuoi farmi incazzare sul serio […]. La vaccata che tu hai fatto […]. L’appartamento dei miei coglioni, dolcezza, l’appartamento, battona. BIANCA: Non capisco quello che dici… Pronto? Ma come ti permetti, piccolo imbecille, rottinculo che non sei altro, di parlarmi in questo modo. Io ti strozzo54. 52. Dello stesso anno, si ricordino anche puttana, stronzo e mignottona nello scandaloso La dolce vita, di Fellini. 53. BRUNETTA (1991: 479). 54. Gruppo di famiglia in un interno, 1974, di Luchino Visconti (COVERI/BENUCCI/DIADORI 19982: 260). Si sarà notato lo stridore, non casuale, tra il turpiloquio pesante 198 Il linguaggio cinematografico Tra i primi a servirsi sistematicamente del linguaggio scurrile nei dialoghi filmici con intento comico–ammiccante (per trovare una facile complicità col grande pubblico) sono stati i registi Umberto Lenzi e Bruno Corbucci, nella serie di film (a partire da Il trucido e lo sbirro, 1976, di Lenzi, e Squadra antiscippo, 1976, di Corbucci) che vedevano come protagonista il ladro, successivamente ispettore, romanaccio detto «Er Monnezza», interpretati dall’attore cubano–newyorkese Tomas Milian, doppiato assai efficacemente da Ferruccio Amendola. Da prodotto ultrapopolare, i film di Lenzi e Corbucci sono via via assurti a cult movie (per la postmoderna estetica del trash tipica degli anni Novanta–Duemila)55, come del resto lo storico Febbre da cavallo, 1976, di Steno. Ne è prova, in anni recentissimi, la riproposta di entrambe le produzioni: Febbre da cavallo — La mandrakata, 2002, di Carlo Vanzina (figlio di Steno), con gli stessi Gigi Proietti ed Enrico Montesano, protagonisti del primo film; Il ritorno del Monnezza, 2005, del medesimo Vanzina (tra i principali artefici — insieme col fratello, lo sceneggiatore Enrico — dell’abbassamento in senso scurrile dei pallidi resti della Commedia all’italiana), con Claudio Amendola (figlio di Ferruccio) nel ruolo del commissario. A film siffatti, s’intende quelli della prima generazione e non i loro fragili emuli, va riconosciuto almeno il merito di aver contribuito a svecchiare il “doppiaggese” e ad aver fornito un romanesco talora meno ibridato e censurato del solito. Stesso merito va individuato nelle pirotecniche deformazioni di Amici miei, e la pronuncia (come si può evincere dalla trascrizione) e la sintassi inappuntabili (da borghesi colti), con inserti lessicali in puro “doppiaggese” (dolcezza, che sembra quasi fare il verso a tanti ehi baby dei film americani). 55. Numerose le spie di questo ritorno al “pecoreccio”, dalle numerose dichiarazioni dei fratelli Vanzina (che giocano a sentirsi eredi e numi tutelari della Commedia all’italiana e che scambiano il cattivo gusto con la cultura popolare) alle note canzoni (Supercafone, 1997, La mossa del giaguaro, 2000) del cantautore romano Tommaso Zanello, in arte “Er Piotta” (termine romanesco, dalle tinte neogergali tra i giovani di periferia, dai numerosi significati, da ‘prima biglietto e poi moneta da cento lire’, a ‘cranio calvo’, a voce del verbo piottare ‘raggiungere una velocità elevata a bordo di un veicolo’), inneggianti proprio a quei film. 4 – Lingua, lingue e dialetti 199 1975, di Monicelli, con la celebre «supercazzola con scappellamento a destra». Già nel 1955 uno scandalizzato Menarini annotava, tra la fraseologia scurrile adottata nei film: mi fa un baffo, che, «per quanto di volgarissima origine, esce oggi liberamente dagli altoparlanti cinematografici», a partire da Colpo di fulmine (Ball of Fire), 1941, di Howard Hawks e da Al caporale piacciono le bionde (What Next, Corporal Hargrove), 1945, di R. Thorpe; fottersene e fottuto (già nella Grande illusione [La Grande illusion], 1937, di Jean Renoir); puttana (Il bandito, 1946, di Alberto Lattuada); vacca ‘epiteto offensivo rivolto a una donna’ (Donne [The Women], 1939, di George Cukor); «Va a dar via el cül» (Il sole sorge ancora). Analoga «ventata di scurrilità» (portata, a suo giudizio, dal clima di «crudo verismo» affermatosi col secondo dopoguerra) Menarini ravvisa nel teatro (citando una farsa intitolata Lesbiche, con Gassman) e nella stampa umoristica dell’epoca (“Marc’Aurelio”)56. Ben diverso è il caso delle bestemmie, da sempre considerate un tabù nella lingua dei media: tra i rarissimi casi, se ne riscontra una nell’iperrealistico Amore tossico, 1984, di Claudio Caligari57. Dagli anni Settanta, il turpiloquio comincia a entrare, per rimanervi stabilmente, anche nella sorvegliatissima lingua del doppiaggio: tra le prime avvisaglie, Conoscenza carnale (Carnal Knowledge), 1971, di Mike Nichols. Ladri di biciclette, 1948, di De Sica, è forse il film che meglio incarna la sostanza del Neorealismo, essendo riuscito a conciliare perfettamente le istanze veristico–documentaristiche con una costruzione narrativa e visiva la cui profonda complessità (basti pensare che il nucleo del film è ambientato in una sola giornata, svolta da un capo all’altro di Roma in 56. Tutte le citazioni sono tratte da MENARINI (1955: 183–184). 57. Qualche altro esempio è riportato da BRUNETTA (1991: 481). Un esempio recente si ha nell’Ora di religione, 2002, di Marco Bellocchio e uno recentissimo in Anche libero va bene, 2006, di Kim Rossi Stuart. 200 Il linguaggio cinematografico riprese per la maggior parte in esterni) è pari soltanto alla naturalezza (ovviamente solo apparente) di un’opera che sembra davvero essersi fatta da sé. Tale binomio incantò praticamente tutti i filmologi, a partire dai francesi, che salutarono in Ladri di biciclette una sorta di palingenesi e di nuovo centro ideale del cinema mondiale: dopo Ladri di biciclette sarebbe stato impossibile (si pensava) continuare a usare la cinepresa alla vecchia maniera: La riuscita suprema di De Sica, a cui altri non hanno fatto sinora che avvicinarsi più o meno, è di aver saputo trovare la dialettica cinematografica capace di superare la contraddizione dell’azione spettacolare e dell’avvenimento. In ciò, Ladri di biciclette è uno dei primi esempi di cinema puro. Niente più attori, niente più storia, niente messa in scena, cioè finalmente nell’illusione estetica perfetta della realtà: niente più cinema58. Del resto, della natura fortemente innovativa del film sembrava già perfettamente consapevole il suo regista: Io cercavo […] una vicenda di quelle che accadono a tutti, e specialmente ai poveri, e che nessun giornale si degna di ospitare. […]. Il mio scopo […] è di rintracciare il drammatico nelle situazioni quotidiane, il meraviglioso della piccola cronaca, anzi della piccolissima cronaca, considerata dai più come materia consunta. Che cos’è infatti il furto di una bicicletta, tutt’altro che nuova e fiammante per giunta? […]. Perché pescare avventure straordinarie quando ciò che passa sotto i nostri occhi e che succede ai più sprovveduti di noi è così pieno di una reale angoscia? La letteratura ha scoperto da tempo questa dimensione moderna che puntualizza le minime cose, gli stati d’animo considerati troppo comuni. Il cinema ha nella macchina da presa il mezzo più adatto per captarla. La sua sensibilità è di questa natura, e io stesso intendo così il tanto dibattuto realismo. Il quale non può essere, a parer mio, un semplice documento. Se il ridicolo vi è in questa storia, è il ridicolo delle contraddizioni sociali su cui la società chiude un occhio; è il ridicolo dell’incomprensione per la quale è molto 58. BAZIN (1958/2000: 317–318). 4 – Lingua, lingue e dialetti 201 difficile che la verità e il bene si facciano strada. Alla sofferenza degli umili il mio film è dedicato59. E naturalmente anche alcuni intellettuali italiani comprenderanno la statura del regista: Cesare Pavese definirà De Sica il miglior narratore italiano del momento. Gran parte del merito del film spetta sicuramente ai dialoghi, che perdono completamente la patina retorica e bigotta della fonte (provvidenzialmente alquanto tradita, come mostrato nel § 3.3: il romanzo di Luigi Bartolini, Ladri di biciclette, 1946 e poi, con leggere modificazioni, 1948), nonostante la postsincronizzazione, del resto propria di tutti i film qui commentati ad eccezione della Terra trema. I dialoghisti del film hanno optato per un romanesco di livello medio–basso dei protagonisti e di alcuni personaggi secondari, contrapponendolo talora, con grande efficacia e con chiaro intento polemico, all’italiano di tono elevato. Accade per esempio nella scena della messa di beneficenza organizzata da un gruppo di signore e signori tanto ricchi e pii quanto insensibili al dramma del derubato Antonio; l’italiano standard e il latino diventano qui i codici della freddezza, dell’ipocrisia e dell’indifferenza della chiesa nei confronti dei poveri, rigorosamente dialettofoni60: VECCHIO: Signorì/ e la minestra? DONNA1: Eh/ dopo/ dopo// Le gavette bisogna… Chi è venuto qui per la prima volta/ sappia/ che le gavette/ vanno portate nel cortile// Ecco// <Dunque/ avanti/ avanti/ presto! Su su/ non perdiamo tempo! Bravi/ così// Benissimo! Benissimo>! UOMO1: <[…]! Andiamo! Presto>! E con questa barba/ è finita? Andiamo! 59. DE SICA (1948). 60. Non senza ironia (a conferma del grande equilibrio del film tra elevatezza dei contenuti e coinvolgimento dello spettatore), come si nota nel contrasto tra le battute di Antonio e la situazione circostante: «me so’ stufato/ da statte qui a pregà» (detto da Antonio mentre i fedeli stanno pregando); «so’ disposto pure a datte/ qualche cosa», mentre i fedeli dicono: «Sono disposto/ ad affrontare/ ogni patimento»; «Ti ringrazio/ o mio Gesù/ di questo dono/ […] Che ora mi hai elargito», dicono i fedeli mentre in effetti il vecchio “elargisce” ad Antonio la propria confessione. 202 Il linguaggio cinematografico DONNA2: (nel cortile della chiesa, sistemando i recipienti per il pranzo e impartendo ordini ad alcune ragazze) Allineatele! Allineatele! Un po’ di ordine! Che poi non succeda come l’ultima volta! Ognuno/ dopo/ deve ritrovare/ la propria gavetta/ o il proprio bidone// VECCHIO: Quasi quasi/ me farebbe la barba// UOMO2: (ad Antonio) Devi farti la barba/ tu? ANTONIO: No// UOMO2: Allora/ vieni in chiesa// BARBIERE–AVVOCATO: (al vecchio) Siedi// DONNA3: (a un uomo) Tu vai in chiesa! (al barbiere) Avvocato/ ne ha ancora per molto? BARBIERE–AVVOCATO: No/ ho quasi finito// Ho questo// (guardando Antonio) Ah/ e questo// ANTONIO: No/ io no// DONNA3: Allora/ possiamo incominciare// BARBIERE–AVVOCATO: Sì// VECCHIO: (all’avvocato che lo sta radendo) Avvocà/ qui no/ pe favore// Me devo fà cresce er pizzo// Attacca a ’st’altra parte// BARBIERE–AVVOCATO: Mah// D ONNA 1: Presto/ presto/ reverendo! Il sacerdote aspetta! (all’avvocato) Lasci/ avvocato// È troppo tardi// BARBIERE–AVVOCATO: Eh sì// Ci vorrebbe altro/ <qui>! DONNA1: <Su>/ ecco/ andiamo! (a Bruno) Bambino/ vieni! (Antonio e Bruno entrano in chiesa. Musica, poi Ave Maria confusamente recitata dai fedeli in latino, in sottofondo durante le successive due battute) ANTONIO: (a un uomo seduto in chiesa vicino al vecchio) Fatte più là// (sussurrando al vecchio) Io quel giovanotto lo devo trovà// È pe ’n affare mio// Je devo parlà// Dunque/ me sai di’/ dove lo posso trovà? VECCHIO: Ma lasceme perde! Ma chi te conosce?! Ma me parli de questo/ de quello/ de quell’altro// Ma che ne so/ io/ de sti fatti qua? Non so gniente/ io! LETTORE: Pagina/ sei// (leggendo ad alta voce) “Io voglio uscire/ da questo luogo santo”// TUTTI I FEDELI: “Io voglio uscire/ da questo luogo santo”// LETTORE: “Sentendomi/ purificato nell’animo”// TUTTI I FEDELI: “Sentendomi/ purificato nell’animo”// LETTORE: “E rasserenato/ <nello spirito>”// ANTONIO: <È ’n affare che interessa pure lui// C’è da guadagnacce quarche cosa// Do’ sta>? TUTTI I FEDELI: “<E rasserenato/ nello spirito>”// 4 – Lingua, lingue e dialetti L ETTORE : “<Ritorno alla […] della mia volontà corporale>”// VECCHIO: <Ma che/ so’ obbligato a ditte do’ sta la gente>? ANTONIO: <Sì/ che sei obbligato! E se nun me lo dici/ te porto ’n questura>! TUTTI I FEDELI: “<Ritorno alla […] della mia volontà corporale>”// VECCHIO: <Ma che ho fatto/ io? Che cj ho a che vedé/ co quello>? LETTORE: (voltandosi a guardare in direzione di Antonio e del vecchio che parlano a voce alta, disturbando la messa) “Ed a ripercorrere”… VECCHIO: Ma lasceme perde! Nun me seccà! LETTORE: “Ed a ripercorrere/ le strade del dolore/ e della privazione”// TUTTI I FEDELI: “<Ed a ripercorrere/ le strade del dolore/ e della privazione>“// ANTONIO: <Tu me devi di’ ndo sta/ e basta// Che ce rimetti? Mica ce l’ho co te// Anzi/ so’ disposto pure a datte/ qualche cosa>// (Il lettore continua il salmo responsoriale con la replica di tutti i fedeli, ma è coperto dalla conversazione tra Antonio e il vecchio) VECCHIO: (alla donna4 che distribuisce i buoni per la mensa) <Che se magna>? LETTORE: “<Ho con me la tua grazia/ o Signore>”// DONNA4: <Pasta e patate>// TUTTI I FEDELI: “Ho con me la tua grazia/ o Signore”// ANTONIO: <Allora/ me lo dici>? LETTORE: “<Sono disposto>/ ad affrontare/ ogni patimento”// TUTTI I FEDELI: “<Sono disposto/ ad affrontare/ ogni patimento>”// ANTONIO: <Guarda che/ si te porto in questura/ è peggio// Lì ce rimani// Do’ sta>?! LETTORE: “<Ti ringrazio/ o mio Gesù/ di questo dono/ […]>”// VECCHIO: <Mbeh/ va’ a via daa Campanella>// TUTTI I FEDELI: “<Ti ringrazio/ o mio Gesù/ di questo dono/ […]>”// ANTONIO: <Che nummero>? VECCHIO: <Mannaggia a la… la miseria! Me pare… er quindici>// LETTORE: “<Che ora mi hai elargito>”// TUTTI I FEDELI: “<Che ora mi hai elargito>”// LETTORE: “Rendi ai miei <benefattori/ […]>”// 203 204 Il linguaggio cinematografico ANTONIO: <Allora me cj accompagni>! VECCHIO: <Io>?! TUTTI I FEDELI: “<Rendi ai miei benefattori/ […]>”// ANTONIO: <Sì! Tu>! VECCHIO: <Ma ’n ce pòi annà/ da solo>? (Il lettore continua il salmo responsoriale con la replica di tutti i fedeli, ma è coperto dalla conversazione tra Antonio e il vecchio) ANTONIO: <No! O me ce porti tu/ o te ce porto io/ co le guardie>! Perché me so’ stufato/ da statte qui a pregà! Hai capito/ sì o no? DONNA1: Silenzio! Silenzio! Se non state zitti/ vi faccio cacciar via dalla chiesa! LETTORE: “Così sia”! TUTTI I FEDELI: “Così sia”! (Canto ecclesiastico, di sottofondo durante il dialogo tra Antonio e il vecchio) ANTONIO: Allora/ me cj accompagni? <Sì o no>? VECCHIO: <[Ma ndo te devo accompagnà]>? Ma io non vengo propio da nissuna parte! Ma vedi d’annattene/ e lasceme perde// ANTONIO: Ma tu/ che ce rimetti? VECCHIO: E vattene! E famme ’sto piacere! ANTONIO: Guarda/ che perdo la pazienza/ eh? VECCHIO: Ma perdi la pazienza/ perdi quello che te pare// Che me ne frega a me// ANTONIO: Te possino ammazzatte! Viè via! Te ce porto co le guardie/ eh? VECCHIO: Ma portemece col diavolo che te se ncolla// Che me ne frega a me// DONNA3: Ss! ANTONIO: Ahó! Me ce vòi portà! VECCHIO: Ahó! Bisogna che la pianti/ sa’! Sinnò te fo vedé ’l diavolo <[che cammina] io/ sa’>? ANTONIO: <Annamo/ cammina! Alzete! Viè via>! VECCHIO: <E lasceme perde>! ANTONIO: Annamo/ cammina! Nun fà storie/ alzete! VECCHIO: Ma lasceme perde! Io nun vengo da nisuna parte/ ha’ capito? ANTONIO: Mo te faccio vedé io! VECCHIO: Ma che me fai vede! ANTONIO: Annamo/ cammina! VECCHIO: Ma lasceme perde! ANTONIO: Annamo! 4 – Lingua, lingue e dialetti 205 VECCHIO: Armeno/ er bidone me lo farai/ pijà? ANTONIO: Sì/ va be’ ma/ te cj accompagno io// Annamo! VECCHIO: Na vorta che volevo magnà da cristiano// DONNA1: (a uomo1) Li fermi! UOMO1: Ehi/ dove andate?! Non si può// <[Abbiate pazienza]>// ANTONIO: <Io sto co questo qua>// Vado a pijà la minestra// (il vecchio scappa) UOMO1: Dopo! (Antonio e Bruno cercano il vecchio, uscendo nel cortile) ANTONIO: Signorì/ è venuto un omo/ qui? DONNA2: No/ non è venuto nessuno// E poi non è ora// (alle ragazze che stanno versando la minestra) Ragazze/ mettetene un po’ di più/ lì// Ecco// Così// Un po’ meno/ in quell’altra// UOMO1: Ma insomma/ si può sapere che cosa volete? ANTONIO: Voglio uscì! UOMO1: È chiuso! Di lì non si passa! La chiave/ ce l’ha l’avvocato// E poi/ fatemi il piacere di non fare baccano! Perché qui siamo in chiesa// E in chiesa/ bisogna… (taglio brusco nel montaggio) UOMO1: Ehi! Volete andar via?! Non è questo/ il contegno da tenersi in chiesa! Venite via/ venite via! Fermatevi! ANTONIO: L’ho da trovà// È qui// L’ho da trovà// L’ho da trovà// UOMO2: Siete venuti per la messa/ o per fare chiasso?! Ma cosa volete/ insomma?! ANTONIO: Io sto cercando un vecchio ch’era qui// Je l’ho detto! UOMO1: Dopo! ANTONIO: L’ho da trovà/ io! UOMO2: Ma dove/ andate?! Dove/ andate?! ANTONIO: Lo vedi/ se c’era?! UOMO1: [No/ no]! […]! (Antonio e Bruno escono dalla chiesa). Il film, del tutto in linea con i dettami prima veristici e poi neorealistici, dedica ampio spazio alla coralità, in particolare nelle scene dei mercati romani di piazza Vittorio e di Porta Portese, con battute in gran parte sovrapposte e solo parzialmente intelligibili (elemento, questo, caratterizzante del parlato–parlato e rarissimo nel cinema postsincronizzato, per evidenti difficoltà realizzative e per salvaguardare la massima comprensibilità del grande pubblico): 206 Il linguaggio cinematografico VENDITORE1: Ma me fai lavorà! <Ma me fai lavorà>! VENDITORE2: <Mo te lo do ’n faccia/ st’affare>! VENDITORE1: <Ma che da’ ’n faccia>! Ma che ha’ da da’ ’n faccia! VENDITORE2: Ma che/ ce se’ venuto callo callo/ <[pe ’n famme lavorà]>? VENDITORE1: <Sì! Callo callo propio! […]>! VENDITORE2: <Ma che>/ ’r post’è tuo? VENDITORE1: Ma lasceme fà/ che so’ avvelenato/ stammatina/ sa’! Lasceme lavorà/ vedi d’annattene/ e <las[s]eme perde>! VENDITORE2: <Ma si ce stavo prima de te! Ma che vai cercanno>?! VENDITORE1: <[Ma de che] […]! Ma ’n ved’a nessuno/ sa’/ io>! VENDITORE2: Ma allora voi litigà! Tra l’altro, a merito ulteriore della colonna sonora del film, i rumori e le voci di sottofondo del mercato di piazza Vittorio aumentano gradatamente con l’aumentare della luce e, dunque, con la progressione dall’alba al pieno giorno. Trattandosi, però, di parlato ricostruito in sala di doppiaggio, non manca qualche lieve incongruenza, come nella battuta della madre del ladro, una vecchia di estrazione popolare, la quale, di fronte a un attacco epilettico del figlio, prorompe teatralmente: «Che non batta la testa!», con quel congiuntivo esortativo del tutto fuori contesto (sociale); oppure nella pronuncia ipersonorizzata della sibilante in una battuta di Maria: «E chi fa lagne/ scusa//». Guarda caso, si tratta di battute in bocca a personaggi femminili, i più inclini, come già detto, alla standardizzazione linguistica. A parte queste eccezioni, il film rispetta pienamente le caratteristiche fonetiche, morfosintattiche e lessicali (turpiloquio a parte, quasi assente nel film) del romanesco, sebbene non ai gradi più bassi della scala diastratica: mancano per esempio le forme tipo dichi ‘dici’ incontrate nella lingua di Fabrizi o degli sciuscià61. 61. Per un’analisi dei fenomeni dialettali dei brani qui riportati si rimanda a ROSSI (1999a: 191–203). 4 – Lingua, lingue e dialetti 207 La terra trema, 1948, di Luchino Visconti è tra i pochissimi film nei quali il dialetto sia stato integralmente riprodotto nei suoi registri più lontani da ogni forma di italianizzazione. Tutti i personaggi (non attori, ma gente del luogo) parlano nella varietà catanese di Aci Trezza. L’intento di rifarsi al verismo è già nel soggetto, tratto da I Malavoglia di Verga, benché la morale del romanzo venga pressoché ribaltata: alla fatalistica accettazione del proprio status, Visconti oppone la lotta sociale e il tentativo di affrancamento. Il film, che com’è noto doveva far parte di una trilogia sul lavoro in Sicilia finanziata dal Partito Comunista Italiano62, si impone tutt’oggi all’interesse degli studiosi proprio per la scelta ardita dei dialoghi dialettali. Eppure anche questo geniale “laboratorio linguistico” a un’analisi attenta mostra tutta la sua artificiosità dal punto di vista pragmatico e sociolinguistico: i dialoghi viscontiani furono infatti scritti in italiano e poi fatti tradurre dagli attori stessi (con l’aiuto di Franco Zeffirelli, assistente del regista insieme con Francesco Rosi). Ne consegue che l’intento ideologico dell’opera (le rivendicazioni socialistico–sindacali e le analisi storico–sociologiche di ’Ntoni), espresso in battute lunghe e articolate, spesso di sapore saggistico–letterario, mal si concili con l’ambientazione sociale e con l’applicazione integrale del dialetto dei pescatori di Aci Trezza. La funzione del dialetto nel capolavoro viscontiano, insomma, oltreché polemica («la lingua italiana non è in Sicilia la lingua 62. Il titolo completo del film è La terra trema (Episodio del mare) e appare, soprattutto nella prima parte (che avrebbe dovuto designare l’intera trilogia), irrelato dalla trama. Esso acquista senso soltanto alla luce dell’ultimo episodio della trilogia (mai girato, come neppure il secondo, dedicato alle zolfatare), che avrebbe dovuto trattare della rivolta dei contadini contro i latifondisti, una rivolta in cui la grande cavalcata dei rivoluzionari avrebbe fatto tremare tutta la terra di Sicilia. Quanto ai finanziamenti, gli scarsissimi fondi destinati dal PCI al progetto vennero presto meno e il film poté essere concluso soltanto grazie alla vendita dei beni personali di Visconti. La scarsità di fondi comportò anche la mancata inclusione dei nomi degli interpreti nei titoli del film (dai quali è assente anche il riferimento a Verga, poiché gli eredi non cedettero i diritti) e provocò una specie di sciopero (presto risoltosi) degli attori che volevano essere pagati subito: quasi che il lavoro in un film sulla rivolta contro lo sfruttamento abbia aiutato gli interpreti a prendere coscienza dei propri diritti sindacali. 208 Il linguaggio cinematografico dei poveri» recita la didascalia iniziale del film scritta da Antonello Trombadori), «è più espressiva che documentaria, più espressionistica che naturalistica», contro «qualsiasi idea di neorealistica improvvisazione o di supposta spontaneità popolare»63. Spesso, per ammissione degli stessi interpreti, Visconti e Zeffirelli prediligevano alcune parole ed espressioni soltanto per il loro suono (è il caso del frequente macari ‘anche’) e non per il contenuto. Altre volte, viceversa, il concetto da veicolare prendeva il sopravvento. Tutto questo è evidente da brani del film come il seguente (parla ’Ntoni): Carusi, sintìti a mia: uora vi ricu c’aiu pinzatu di fari… Pi tanti e tanti anni, e macari seculi, àmu avutu tutti l’occhi chiusi… macari i patri e i patri d’i nostri patri… ca nun ci verèmu cchiù chiaru! ’U virìstuvu tutti, ’na para ’i iorni arreri, comu si camminaru ’i cosi… Picchì vuliti continuari a fàrivi sfùttiri ’i Ramunnu, Larienzu e cumpagnia? Chi cci mèntunu iddi? Ca ci ànu tuttu ’u vùscutu e nuddu arrìsicu. L’arrìsicu e ’u pirìculu, l’avemu tuttu nuàutri: arrìsicu d’i varchi a d’a rroba, arrìsicu d’i nostri frati chiddi chiù nichi, ca crìsciunu e fanu ’a fini di nuàutri, ’ncazzarati intra ’na ’aggia di meseria! Iu ’u sacciu, ca vuàutri ’i faciti sempri ’sti rraggiungimenti: macari iu l’aiu fatti tanti voti. Iu sacciu ca s’arriva a ’n puntu ca tuttu si cunfunni n’a nostra testa… comu ’u cianciolu ca ’i pisci aggiranu sempri rintra e nun trovanu unni nèsciri… Allura ’nni rassignamu…64. Benché il rapporto tra il testo verghiano e quello viscontiano sia alquanto libero, è evidente la volontà di ricreare, nel film, numerose movenze stilistiche dei Malavoglia, per esempio nella frequenza dei proverbi. Ciò si verifica nel commento fuori campo, che «se […] non arriva a usare in funzione espressiva le sprezzature grammaticali verghiane, fa tuttavia ricorso a espedienti letterari — già ampiamente usati nel romanzo a un alto livello di qualità stilistica — come l’anacoluto […], capaci di 63. PARIGI (1994: 142). Sull’uso ideologico ed estetico, più che mimetico, del dialetto filmico, da Blasetti a Rossellini a Visconti, cfr. ARISTARCO (1985). Per tutte le notizie sulla genesi del film e sui suoi retroscena cfr. MICCICHÈ (1994). 64. RAFFAELLI (1992: 109). 4 – Lingua, lingue e dialetti 209 evocare, mimeticamente, la lingua degli umili»65. E anche nei dialoghi, i quali, rispetto a Verga, vengono sicilianizzati, come risulta dai seguenti raffronti tra romanzo e film (tratti da SOTTILE 2005: 45): ROMANZO: Mena l’accarezzava colla mano […] «Il mare è amaro — ripeteva — ed il marinaro muore in mare». FILM: MARA: Tutti marinari sunnu! LUCIA: ’U mari è amaru! ROMANZO: Ci penserò io a trovarvi d’andare a giornata. Voi e vostro nipote Alessi, non dubitate; — gli diceva Piedipapera — bisogna che vi contentiate di poco, sapete! «Forza di giovane e consiglio di vecchio». FILM: NONNO: ’Ntoni av’ascutari i vecchi, picchì ’u pruvebbiu anticu dici: forza di giovini e sintimentu di vecchi! L’insuccesso dell’opera (alla quale va peraltro riconosciuta, oltre a meriti linguistici, un’incredibile ricercatezza formale, soprattutto nell’asciutta descrizione dei drammi interiori, da teatro greco, nella direzione degli interpreti e negli effetti di luce nelle riprese di paesaggi e di volti) fu clamoroso, nonostante il commento fuori campo in italiano standard (scritto da Antonio Pietrangeli e letto da Mario Pisu) e un’arbitraria versione tagliata e risincronizzata in siciliano italianizzato messa in circolazione in un secondo momento66. Dovremo aspettare la fine degli anni Settanta (L’albero degli zoccoli, 1978, di Ermanno Olmi) 65. PARIGI (1994: 158). 66. La riscrittura scellerata fu curata da Francesco Rosi, secondo COSULICH (1985: 47). 210 Il linguaggio cinematografico per incontrare analoghe riproposizioni integrali del dialetto, sottotitolato (a differenza del film di Visconti), sul grande schermo: esperimenti altrettanto coraggiosi ma parimenti elitari e destinati ad attrarre più la critica che il grande pubblico. Significativo è il caso dei primi film “siciliani” di Germi, In nome della legge, 1949 (Fig. 27) e Il cammino della speranza, 1950 (Figg. 28–30): l’ambientazione e il dichiarato intento di denuncia avrebbero richiesto l’adozione del dialetto, mentre gran parte dei personaggi dei due film si esprime in un italiano quasi senz’accento, ad eccezione di alcuni personaggi secondari (qualche sicilianismo fonetico nei mafiosi minori e qualche voscienza, nel primo film), soprattutto nel secondo film (che pure, nell’impianto corale della trasmigrazione dal Sud al Nord in cerca di un lavoro, partecipa in pieno del clima neorealistico). Anche Il ferroviere, 1956, di e con lo stesso Germi (doppiato da Gualtiero De Angelis), nonostante il permanere di certe istanze neorealistiche quali l’ambientazione nel proletariato romano, non lascia trapelare alcun’effrazione alla norma linguistica, se non per un ridassero (che è popolare più che regionale) detto dal socio del protagonista. Conclude la rassegna neorealistica Umberto D.., 1952, di De Sica, film che, rispetto ai precedenti, dà ampio spazio a un protagonista unico: l’attore preso dalla strada (anzi, in questo caso dall’università di Firenze, presso cui insegnava Glottologia) Carlo Battisti 67. Per questo motivo, e anche per l’evidente volontà di depurare il romanesco e gli altri dialetti dalle tinte più marcate, il film di De Sica–Zavattini ben si presta a concludere il mimetismo dialettale del Neorealismo. Il film mostra subito il suo solido impegno sociale, dedicato al problema delle pensioni troppo basse e della depressione degli anziani, e la 67. Sulla figura di Carlo Battisti, professore e attore, e sui suoi rapporti col cinema neorealistico (in seguito alla conoscenza di De Sica, Battisti iniziò a interessarsi attivamente al cinema, con una serie di saggi e la realizzazione di alcuni documentari) cfr. BANFI (1993) e le testimonianze dello stesso protagonista (BATTISTI 1952, 1955a, 1955b, 1957). Il Battisti fu il primo, dopo il Menarini, a intravedere le grandi possibilità di uno studio scientifico della lingua del cinema (BATTISTI 1952). 4 – Lingua, lingue e dialetti 211 messa in pratica, forse ancora più radicale rispetto a Ladri di biciclette, della poetica del Neorealismo, con uno stile visivo e verbale assolutamente ridotto al minimo, scarno talora fin quasi alla provocazione, volto a far parlare più i visi, le strade, le cose che le battute dei dialoghi. Gioverà a questo proposito ricordare che la densità locutiva (la quantità di parole rispetto a quella dei silenzi, per intenderci) dei film di argomento serio e di solido impegno morale, narrativo, estetico è di norma notevolmente inferiore a quella dei film comici, brillanti o di cassetta, inevitabilmente legati, quelli comici, al gioco verbale e quelli di cassetta alla piena comprensibilità (con pochi sottintesi, dunque) del grande pubblico. Dal punto di vista linguistico, il testo di Umberto D. «propone […] uno spaccato veritiero, oltre che artisticamente funzionale, del composito repertorio delle risorse comunicative verbali d’una Roma etnicamente e socialmente eterogenea»68. Si va dall’italiano formale e senz’accento («Vorrei tenerlo ancora un po’ qui, per fargli la cura completa»), all’italiano regionale romano e all’italiano dell’uso medio («Al trenta le butto fuori la valiggia; riceverà lo sfratto!»), all’italiano standard con venature fonetiche settentrionali del protagonista («Siédi, cara; préndi lo sgabello»; «E a tè, come va?»), ai dialetti centromeridionali, in primis quello della domestica abruzzese di Umberto, Maria («poss’assette cche» ‘posso sedermi qui’»; allocutivo Tu anche come forma di cortesia: «Dovunque andrai, signor Umberto, stai meglio di qua»; «Già te ne vai, signor Umbè?»), mai, peraltro, rappresentati nelle loro forme più distanti dall’italiano. La sintassi degli enunciati è ridotta al minimo (prevalentemente paratattica e quasi mai oltre il primo grado di subordinazione) e i turni dialogici non superano mai le trenta parole. Ultrascremato è anche il lessico, raramente oltre i lessemi del vocabolario di base. L’operazione di scarnificazione condotta da De Sica con questo film è dunque a tutto tondo, investendo l’uso della mac68. RAFFAELLI (1993a: 31). Dal medesimo saggio sono tratte tutte le battute del film sotto citate. 212 Il linguaggio cinematografico china da presa, la recitazione e la lingua. Da questo “grado zero” del linguaggio filmico, che rappresenta forse il culmine della nostra cinematografia, De Sica si allontanerà subito, venendo incontro ai gusti del pubblico con commedie linguisticamente colorite (L’oro di Napoli, 1954; La riffa, 1962; Ieri oggi domani, 1963; Matrimonio all’italiana, 1964) o con grandi produzioni letterarie e internazionali (La ciociara, 1960; Il giardino dei Finzi Contini, 1970; I girasoli, 1970). 4.2.2. Contemporaneamente ai pochi film neorealistici, come s’è già detto, continua a circolare un enorme numero di film, italiani e stranieri, doppiati (entrambi) in un italiano standard prossimo alla (e talora oltre la) formalità. L’esemplificazione sarebbe fittissima. Ci limitiamo a Catene, 1949, di Raffaello Matarazzo (Fig. 31), caso tanto più interessante in quanto l’ambientazione nella Napoli del secondo dopoguerra e i protagonisti tutti di umile origine (un meccanico, una casalinga e un ladro di automobili) avrebbero lasciato supporre almeno qualche coloritura regionale. La lingua di Catene, invece, pur senza ricorrere a un lessico troppo elevato, risulta, inverosimilmente, assimilabile a una pagina scritta in uno stile scolastico, come è evidente dalla scena qui riportata. Rosa, moglie e madre felice e onorata, incontra dopo anni il suo ex fidanzato Emilio, un delinquente, il quale tenta di riconquistarla entrando in affari con il marito di lei, Guglielmo: ROSA: Se tu t’azzardi ancora/ a presentarti/ dico tutto a mio marito! EMILIO: E che cosa? ROSA: Che ci siamo conosciuti prima/ che dovevamo sposarci! Ho fatto male/ a non dirglielo/ quella sera// È stato un errore/ e me ne pento// Ma ora voglio liberarmi// Non ne posso più! E MILIO : Brava// Buona idea// E… se pensasse anche/ che siamo stati amanti? ROSA: Amanti?! E tu saresti tanto vigliacco/ tanto infame/ da dire una cosa simile/ pur sapendo che non è vero?! Ma io/ piuttosto/ t’ammazzo/ capisci?! T’ammazzo! 4 – Lingua, lingue e dialetti 213 EMILIO: Ragiona con calma/ cara// T’ho ritrovata/ e non voglio più perderti// In questi giorni/ sono stato sempre ad aspettarti/ per rivederti/ per parlarti/ ma/ tu non sei uscita più// Per questo/ m’è venuta l’idea// Ho saputo/ che tuo marito/ aveva quel progetto// E allora/ mi sono interessato veramente// Ma credi che non sia capace anch’io/ di diventare un galantuomo? È perché voglio esserti vicino// Ho bisogno/ di esserti vicino// Te l’ho detto/ sono innamorato// Come prima// Più/ di prima! Non aver paura// Non ti chiederò niente// Aspetterò// ROSA: Ma che cosa?! Che cosa?! EMILIO: Che tu ritorni come allora// Quando m’aspettavi/ venivi a cercarmi/ scordavi tutto/ per stare con me// Ti ricordi/ quella volta/ che volevi scappare di casa/ per venire da me/ che stavo a Salerno/ a fare il soldato? E quando m’accompagnasti al piroscafo/ e non volevi che partissi? T’attaccavi a me/ eri disperata// Piangevi// Uno straccio// E me ne sono andato// Ho girato il mondo// Ho fatto di tutto// Mozzo su una nave/ e banchiere a Cuba// Buffo/ no? Ho avuto a che fare con tutte le polizie// Ho avuto cento nomi/ e cento facce// Solo/ quando t’ho rivisto/ sono ritornato me stesso// E per merito tuo/ Rosa// ROSA: Emilio/ quello che è stato/ è stato// Ora ho la mia casa/ la mia famiglia/ i miei figli// Sono felice// EMILIO: Veramente? ROSA: Si/ lo sono// E voglio esserlo// EMILIO: Non è vero// Appena t’ho rivisto/ ho sentito che sei ancora innamorata di me// E che quest’amore/ non riuscirai/ a strappartelo dal cuore// È/ così? Di’ la verità/ è/ così? ROSA: Hm! Dio solo/ sa/ quanto pregai/ per guarire di quel male! E ci sono riuscita// Per questo/ ti dico/ di avere pietà di me// Te lo chiedo/ come una grazia// Lasciami! Sono una povera donna! Abbi pietà di me! Lasciami in pace! EMILIO: Senti/ Rosa… ROSA: No! Non parlare! Se in un momento di debolezza/ io finissi per cedere/ avrei tanta vergogna/ tanto schifo di me stessa/ che ti odierei! Sì/ ricòrdatelo/ ti odierei! E ora vattene/ dalla mia vita! Addio! Spiccano, tra l’altro, l’ineccepibile morfologia verbale (futuri, passati remoti, congiuntivi e condizionali; participio passato accordato con l’oggetto: «t’ho ritrovata»), la sintassi complessa (fino al quarto grado di subordinazione: «Ti ricordi/ quella 214 Il linguaggio cinematografico volta/ che volevi scappare di casa/ per venire da me/ che stavo a Salerno/ a fare il soldato?»), la presenza di figure retoriche (terne, climax, anafore e simili, sottolineate nel brano sopra citato) e la densità locutiva di enunciati e unità tonali: l’estensione media di un enunciato parlato–parlato è stabilita in 6,28 parole, mentre l’estensione delle unità tonali si attesta su una media di cinque sillabe, superando di rado le undici; nel brano citato da Catene incontriamo invece un enunciato di 21 parole e un’unità tonale di 14 sillabe («ho sentito che sei ancora innamorata di me»)69. Per non parlare della pronuncia, quasi sempre assolutamente in linea con i manuali di ortoepia (com’è naturale, per i doppiatori di professione). Si nota infine anche un’insolita frequenza (rispetto al parlato spontaneo più che allo scritto) di nomi propri e di pronomi in funzione allocutiva, evidentemente dovuta alla necessità di fornire allo spettatore tutte le coordinate per la corretta decodificazione del testo, e quindi anche di ricordargli i nomi dei protagonisti, oltreché indotta, molto probabilmente, dall’esempio del doppiaggio (come si vedrà nel § 5.2.4). In pratica, è la stessa lingua dei melodrammi hollywoodiani (ma con un’ambientazione che è debitrice in più di un tratto al nostro Neorealismo, a rimarcare lo stridore dell’operazione), e l’impressione è accresciuta dalle stesse voci dei doppiatori dei film d’oltreoceano: a parte Amedeo Nazzari, che doppia sé stesso, infatti, Yvonne Sanson è doppiata da Lidia Simoneschi (la voce italiana di Ingrid Bergman, per capirci) e Aldo Nicodemi (il ladro Emilio) ha la voce di John Wayne o di Humphrey Bogart (il celeberrimo Emilio Cigoli). Il riferimento letterario di questo genere di film è ovviamente il romanzo d’appendice e larmoyant, col quale condivide anche la vocazione popolare e l’antirealismo linguistico (direttamente proporzionali): per un corrispettivo contemporaneo, si prenda la lingua ultrasorvegliata delle soap opera, tipo Beautiful. 69. Per i valori medi del parlato–parlato cfr. CRESTI (2000: I, 149, 233 ss.). 4 – Lingua, lingue e dialetti 215 La scelta linguistica di Matarazzo fu premiata da un successo strepitoso, tanto che Catene fu il primo film italiano a superare la soglia del miliardo di lire di incasso. Da questo derivarono molti altri film dello stesso regista, con la solita fortunata coppia di attori (Nazzari–Sanson) e con le medesime caratteristiche linguistiche: Tormento, 1950, I figli di nessuno, 1951, Chi è senza peccato…, 1952, Torna!, 1954, Angelo bianco, 1955, Malinconico autunno, 1958. L’impatto sul grande pubblico non poté non avere anche una ricaduta linguistica, in virtù della carica intrinsecamente didattica di quello stile. Erano anche quei dialoghi da libro di scuola, più ancora che da teatro, infatti, oltre all’indiscussa abilità di intrecciare vicende strappalacrime di Raffaello Matarazzo e compagni, che avvincevano gli italiani semianalfabeti del dopoguerra, quegli italiani che cercavano, come sempre, l’identificazione con i personaggi dello schermo e che, da dialettofoni e poveri, sognavano in realtà di parlare la lingua delle “persone per bene”. Chi pensava che «la Sanson poteva essere una [sua] vicina di casa e Amedeo Nazzari […] uno che avev[a] intravisto»70, non s’avvedeva, forse, della perfetta operazione produttiva basata sulla (dis)simulazione: un’Italia in dissesto che dava di sé non più l’immagine (acustica) della depressione e dell’ignoranza (nei suoi mille dialetti), bensì quella delle capacità di competizione con realtà meno svantaggiate (per es., quella americana). Ma quella di Catene (e della maggior parte dei film coevi, dalle grandi produzioni storiche, quali Fabiola, 1949, di Blasetti, a tutta la filmografia straniera doppiata71, alla continuazione del filone borghese–brillante di emulazione americana: Blasetti, Camerini, il Mattoli senza Totò, il De Sica non neorealista e altri), sebbene maggioritaria, non è l’unica strada percorsa dai 70. AMELIO (1994: 32). 71. Non dimentichiamo che nel dopoguerra «i film americani in lingua italiana circolano in misura dieci volte superiore a quelli nazionali e avviano processi di apprendimento linguistico anche per quella massa di analfabeti o di persone che la scuola ha presto emarginato» (BRUNETTA 1991: 408). 216 Il linguaggio cinematografico nostri dialoghisti non neorealisti. Sopravvive anche la linea preneorealistica, per così dire, della regionalità di colore di certa produzione comica nostrana. È il caso (oltre ai vari esempi di ascendenza teatrale commentati a proposito di Totò), tra i tanti, del romanesco macchiettistico e consolatorio della Magnani, peraltro con felicissimi giochi linguistici, in Abbasso la miseria!, 1945 e Abbasso la ricchezza!, 1946, di Gennaro Righelli. Specialmente il secondo film tratteggia con irresistibile umorismo, e anche con variegato realismo linguistico, la trasformazione della popolana «sóra Gioconda» nell’arricchita «donna Gioconda», che tenta, senza riuscirci, di camuffare le proprie umili origini (rinasce così la borghese vergogna del dialetto, derisa da Righelli, che il Neorealismo aveva tentato di debellare): «Ehi/ piccolo/ per favore mi vuoi aprire il cancello/ sì? A faccia da impunito/ hai capito che me devi venì a aprì/ sì o no?»; «d’ora in poi cerchiamo di parlare solamente italiano//»; «in fondo ce l’ho nel sangue/ la nobiltà// Eh sì, noblesse oblige//». Abbasso la miseria, tra l’altro, mostra tutta la variegata realtà linguistica della capitale, nella quale è possibile udir parlare, oltreché in romano, in veneto, ligure, piemontese, napoletano… Al solito, i forestierismi tendono a essere pronunciati alla francese, anche i nomi propri («dottor Jachìl» per «dottor Jekyll»). Di ascendenza teatrale le paronomasie e le deformazioni utilizzate per deridere un’alfabetizzazione assai incerta: anatomica ‘atomica’, eliofante ‘elefante’, orario ‘uranio’, pilico ‘plico’. Anche nel primo film, infine, si coglie l’ironia sulla diglossia diafasica della Magnani: da «Ce l’hanno fatta/ finalmente//» ad «Alfin son giunti//». Il desiderio di riscatto socioeconomico attraverso la lingua è un chiodo fisso degli italiani (filmici, ma forse non solo) del secondo dopoguerra (ma anche del primo, se ricordiamo i film cameriniani con De Sica) che si ritrova sarcasticamente esibito in molte commedie: «E parli italiano/ benedetto Iddio!», ironizzerà di lì a poco Totò, in Totò a colori, 1952, di Steno e Monicelli. Tra queste, in Una domenica d’agosto, 1950, di Luciano Emmer, precoce esempio di Neorealismo rosa dai dialoghi par- 4 – Lingua, lingue e dialetti 217 ticolarmente arguti, si colgono battute come: «Parla pulito/ sennò ci riconoscono//» e «Ammappelo! Volevo dire/ è così lontano?». Soltanto la dissimulazione delle proprie origini e del dialetto può consentire il sogno dell’ascesa sociale: per questo Franco Interlenghi e le ragazze del film cercano di darsi un tono parlando un italiano ridicolmente artefatto. Ma i desideri onirici sono destinati a rimanere inesauditi, nell’ottica consolatrice e conservatrice di questi film: la felicità arride solo a chi frequenta persone dello stesso ceto e dello stesso dialetto, senza tanti grilli per la testa: Marcella ed Enrico. Un’utilizzazione delle varietà diatopiche ancora diversa è quella di alcuni film di Luigi Zampa, debitori al Neorealismo della scelta di un romanesco realisticamente riprodotto (anche se raramente nelle sue forme più basse: per esempio mangià viene preferito a magnà, miei a mia, nei brani sotto riportati) e nella scenografia (la sporcizia degli ambienti e delle persone è quasi ostentata), ma agli antipodi rispetto alle scelte ideologiche. Un film emblematico è L’onorevole Angelina, 1947, con Anna Magnani, interprete romanesca d’eccellenza, maestra nell’arte della commutazione di codice e degli enunciati mistilingui dialetto/italiano, come già visto, e soprattutto l’unica in grado di conciliare nella stessa interpretazione tre stili recitativi diversissimi: quello della grande tradizione teatrale, quello del teatro popolare (avanspettacolo) e quello dell’attrice (apparentemente) presa dalla strada. Come si vede nella scena seguente (la prima del film, in cui Angelina, la Magnani, e suo marito, un poliziotto interpretato da Nando Bruno, discorrono di problemi economici), tanto la lingua (realisticamente dimessa, eccezion fatta per qualche sibilante sonora dell’attrice: Cesira, così, bisogna), quanto i temi trattati sono pienamente neorealistici: PASQUALE: Ieri t’ho dato ’n antre ducento lire// ANGELINA: E va be’/ pure ieri abbiamo mangiato/ no/ Pasquà? PASQUALE: Già// Quanti n’abbiamo/ oggi? ANGELINA: Quattordici// Hai voja a corre/ qua// PASQUALE: Posso provà a famme da ’n antro anticipo// Ma così subbito/ sarà ’n po’ difficile// 218 Il linguaggio cinematografico ANGELINA: Per oggi me so’ avanzate ancora sessanta lire// Pio la pasta co la tessera/ me faccio prestà ’n po’ d’olio da la sora Cesira// Domani speramo che ’l sor Antonio me paghi i carzoni che j’ho fatto// PASQUALE: Se/ so’ du mesi/ che deva pagà! Io vorei sapé/ perché cj hanno fatto in modo/ che se deve mangià tutti i giorni// ANGELINA: Io vorrei sapé/ invece/ perché se deve pagà/ pe mangià// PASQUALE: La vita bisogna pure guadagnassela// ANGELINA: Ma nun basta/ è così// PASQUALE: Hm// Lo stipendio è quello che è// ANGELINA: Pasquà/ bisogna che te dai da fà/ sa’? Perché ai regazzini gnen’emporta gnente/ de tutte ste storie// PASQUALE: Nu me vorai mica rimproverà de vive onestamente?! ANGELINA: È questione che qui nun se vive/ Pasquà! Qui se more/ onestamente! (suona la sveglia) ANGELINA: Eh/ stavamo aspettà lei/ pe svejacce/ noi! Oh! Mo comincia la festa! Hm// (al neonato che dorme nel letto matrimoniale tra i genitori) Bono/ bello de mamma/ su! Bono! (agli altri figli) Adriana/ Libbero/ ’namo! Arzateve/ ch’è tardi! Nel corso del film il realismo cederà sempre più il passo al populismo, al bozzettismo, al sentimentalismo e le premesse ideologiche delle scene iniziali verranno pressoché ribaltate, fino al conclusivo addio alla carriera politica di Angelina (sotto trascritto) che, da paladina dei diritti civili, tornerà a pensare soltanto a sé e alla famiglia. Lo stesso lieto fine del film (con la scarcerazione di Angelina e gli sfollati che possono tornare legalmente ad abitare nelle case popolari) è merito non della lotta civile della protagonista, bensì del buon cuore del figlio del padrone (interpretato da Franco Zeffirelli), solo perché innamorato della figlia di Angelina: come a dire che le rivendicazioni sindacali non pagano (e, anzi, la politica rovina le famiglie degli umili, quindi va lasciata fare ai ricchi e ai potenti; al massimo si può baccajà ‘fare chiasso’) e quel che di buono si può fare è soltanto sperare nel paternalismo di qualche governante e nella provvi- 4 – Lingua, lingue e dialetti 219 denza. E, parallelamente al prevalere del qualunquismo sull’impegno sociale («E poi/ anche senza diventà onorevole/ cj ho da fà tanta de quea politica/ a casa! Fra ’n marito/ i guai/ i regazzini… Certe discussioni/ che ’a cammera manco se le sogna!»), sembra prevalere l’italiano (ora standard ora regionale) sul dialetto della sora, non più onorevole, Angelina: Non so che di’// Io ve devo di’ na cosa/ sola// Credo che non sarò mai/ onorevole// […] ’N so’ bona// Non so’ capace// Vedete/ mentre stavo dentro/ me so’ venute in mente tante idee// Il governo dovrebbe fà fà/ alla gente/ la galera obbligatoria// Come ’l servizio militare// Hm/ eh già! Un po’ perché/ tutti quanti/ ’n annetto almeno ce lo meritiamo// E un po’ perché lì dentro/ te se rischiarano le idee// Così io/ lì/ me so’ accorta che so’ solamente una come voi// Una ch’ha passato la vita a mette assieme il pranzo co la cena/ a combatte co le finestre senza vetri/ co l’umidità/ co tutti i guai che sapete meglio de me// E anche se/ come dite voi/ è merito mio/ se cj abbiamo na casa/ che manco ce sognavamo d’avercela/ ho capito che questo non è el sistema/ pe fà l’onorevole// Pe quello che me riguarda/ poi/ me so’ accorta che/ per fà la politica/ la famiglia m’andava per aria// E io ai regazzini miei ce tengo! Io me li vojo tirà su come me pare! E poi/ anche senza diventà onorevole/ cj ho da fà tanta de quea politica/ a casa! Fra ’n marito/ i guai/ i regazzini… Certe discussioni/ che ’a cammera manco se le sogna! Io so’ sicura/ che non rimpiangerete se lascio il posto a qualcuno più bravo/ più preparato de me// A qualcuno che ve possa veramente/ aiutà! A qualcuno che co più calma/ co più sistema/ non se lascerà fregà// Perciò… perciò ve dico addio! Ve saluto! Però/ quando me chiamerete pe baccajà/ sarò sempre pronta/ perché/ questa è l’unica cosa/ che me viè naturale// Così er partito nostro non se sciojerà/ no! Ma manco ala cammera/ andrà// Resterà fra noi/ baccajeremo in famiglia// Così saremo tutti quanti onorevoli// Ma onorevoli sul serio/ però! 4.3. Dopo il Neorealismo Prende piede, tra la fine del Neorealismo (convenzionalmente concluso da Europa ’51, 1952, di Rossellini) e l’inizio della 220 Il linguaggio cinematografico Commedia all’italiana (che si suole stabilire nei Soliti ignoti, 1958, di Monicelli)72, ovviamente con le immancabili sovrapposizioni e sfumature di transizione, il cosiddetto Neorealismo rosa, inaugurato da Due soldi di speranza, 1952, di Renato Castellani (Fig. 32) e prospero almeno fino a Poveri, ma belli, 1957, di Dino Risi (va da sé che queste rigide partizioni lasciano il tempo che trovano e non sono condivise da tutti gli studiosi). Il film di Castellani è linguisticamente realistico (la sceneggiatura è di Titina De Filippo e dello stesso Castellani), il che sembra cozzare abbastanza fortemente con l’ottica consolatoria a tutti i costi, più volte ribadita nel corso dell’opera e in particolare nel finale, caratterizzato da una sublimazione della povertà e da una cieca fede nella provvidenza: «E non ve ne incaricate/ perché chi cj ha creato/ non è poverello// E si ’o Padreterno vo’ che continuamo a campà/ cj ha da fà pure magnà// È o vero o nun è o vero// Sinnò che ce mette a fà/ ’n goppa a ’u munno?!». Già la didascalia iniziale del film richiama quelle neorealistiche, sottolineando che le riprese sono state fatte a Borgotrecase (ma nel film si parla di Cusano), alle falde del Vesuvio, con la partecipazione di tutta la gente del borgo. Il napoletano del film di Castellani è molto più marcato e credibile di quello patinato e oleografico di Pane, amore e fantasia, 1953, di Luigi Comencini, che a pieno titolo rientra nel filone del Neorealismo rosa (e nel quale, comunque, figura non soltanto il napoletano ma anche il romanesco, il ciociaro, il veneto e l’italiano standard). In perfetto italiano è, come al solito, la voce fuori campo: Antonio si mise il vestito buono/ e andò con una segreta speranza// Pasquale Artù fabbricava i fuochi artificiali in paese// I suoi due figli lo aiutavano// Ma spesso il lavoro era troppo// Ce ne sarebbe stato anche per un aiutante// Va bene che il mestiere era pericoloso// Ma se Pasquale lo avesse preso a lavorare… 72. Per la cronologia della Commedia all’italiana (convenzionalmente, da I soliti ignoti a La terrazza, 1980, di Ettore Scola), cfr. GIACOVELLI (1995: 11). 4 – Lingua, lingue e dialetti 221 La scelta del dialetto contro l’italiano affettato è difesa esplicitamente dalle parole del protagonista, che ribadiscono anche la morale dell’opera e, forse, la volontà di Castellani di distaccarsi dagli usi linguistici della cinematografia corrente. La vita va accettata con semplicità e ottimismo: ANTONIO: Buongiorno signor maresciallo eccellenza// Io so’ tornato ’e fà ’o soldato/ e volesse firmare il congedo// MARESCIALLO: Con undici mesi/ che sei stato in città/ non sei riuscito/ a parlare l’italiano// ANTONIO: Eh/ signor maresciallo/ se io volessi toscaneggià/ farei la figura del fesso// Invece quando parlo il dialetto mio/ mi capisco// MARESCIALLO: E tutti gli altri/ come ti capiscono? ANTONIO: Eh/ si mettono con le recchie più vicine/ e mi capiscono//. Lo spirito reazionario del film (per essere brave persone non bisogna avere grilli per la testa e non bisogna pensare troppo), del resto, trapela un po’ ovunque. Così il maresciallo replica alla richiesta di lavoro da parte di Antonio: MARESCIALLO: Tutti voi altri militari/ mi venite con questa suonata// ANTONIO: Eh/ signor maresciallo/ pe cambià ’a sonata/ abbisognerebbe cambià ’o direttore/ no i musicanti// MARESCIALLO: Il soldato ti ha messo delle idee in testa// A NTONIO : State tranguillo/ signor maresciallo// Io so’ nu buono guaglione/ e ’o saccio che idee in testa non ne devo tené//. Quanto poi alle tematiche ideologiche, il lavoro di Antonio per il PCI per l’organizzazione dello sciopero è ridotto a pura macchietta dissacratoria (Antonio sciopera solo perché pagato). È peraltro notevole che anche i protagonisti parlino dialetto, persino le donne. Ecco come Carmela (magnificamente interpretata da una giovanissima Maria Fiore) si rivolge ai genitori: «Che ’u razzo ve facesse zompà!». E non si tratta sempre delle 222 Il linguaggio cinematografico forme prossime all’italiano73: «Fa’ ’mbresso/ sagli!» ‘fai presto, sali’, intima Antonio a Carmela; «’A lettera ce l’aggio leggiuta//» dice don Vincenzo a Carmela; «’O matrimonio è nu lusso troppo proibbitissimo/ pa ’a povera gente//» dice Antonio a Carmela. Conferma la scarsa confidenza con l’italiano (verosimile, nella Campania rurale del 1950) da parte dei personaggi del film anche l’errore commesso da Carmela nel cucire la scritta sul cappello di Antonio: AUTITA (anziché AUTISTA). E soprattutto l’analfabetismo della madre di Antonio, costretta a farsi leggere la lettera del figlio da don Vincenzo, al quale raccomanda di farlo «con molto sentimento»: spassosissima, infatti, è la lettura drammatizzata e mimata dell’interprete. Anche la scena del telefono è socio– e pragmalinguisticamente verosimile, oltreché divertente: Antonio e Carmela, infatti, alle prese con un mezzo col quale non hanno confidenza, parlano a voce altissima. Anche le tematiche e l’ambientazione (ma non certo l’ideologia) di Due soldi di speranza è fortemente debitrice nei confronti del Neorealismo. Ecco il commento di un poliziotto sulla ricerca di lavoro di Antonio a Napoli: «E venite a Napoli a lavorare? Queste so’ cose ’e pazzi! Co na popolazione di due milioni di abitanti/ e ce ne sta di disoccupazione/ chillo viene a Napoli a lavorare// Favoritemi ’o libretto di lavoro//». Non mancano, ovviamente, le scene stilizzate e teatrali. Sopra tutte, quella di Antonio che va dall’uomo che ha insidiato la sorella, in pretto stile (non senza ironia) da sceneggiata napoletana: MADRE DI ANTONIO: Figlio/ figlio mio! Figlio mio/ che fai? Ti vuoi rovinare?! Che sei venuto a fà? Che sei venuto a fà? E se tu vai carcerato/ come viviamo noi? Tu non l’ia a fà/ 73. Nonostante che, come ricorda RAFFAELLI (1992: 114), i dialoghi del film siano stati fortemente italianizzati, rispetto alla prima versione in teanese stretto incisa dalla viva voce del protagonista Vincenzo Musolino. 4 – Lingua, lingue e dialetti 223 ’sta pazzia? Madonna/ non l’ia a fà! […] Statevi riparato/ per amor di Dio! Porta il coltello […] Sì/ sì/ ha detto che vi vuole ammazzare! MADRE DELLO SPASIMANTE DI GIULIANA: Mamma mia! Mamma mia! Aiuto! Aiuto/ tene ’u curtriello! Aiuto/ ca tene ’u curtiello! Maronna! Maronna! Altro topos da sceneggiata è l’insistito ricorso alle canzoni: i personaggi del film cantano sempre, come a dire: cuor contento Dio l’aiuta. Se la filosofia del film di Castellani sembra poter essere riassunta nella massima “poveri ma felici”, quella di Poveri, ma belli di Risi, ribadita fin dal titolo (la cui antitesi verrà riproposta anche nelle due scialbe continuazioni del film: Belle, ma povere, 1957 e Poveri milionari, 1959), pare ancora più superficialmente e quasi irritantemente consolatoria. Ma, se nel film di Castellani la povertà si toccava con mano, non soltanto nell’ambientazione scabra delle scenografie ancora neorealistiche ma soprattutto nel dialetto dei protagonisti, nel film di Risi (meticolosamente costruito per incontrare i gusti e le attese del pubblico) rimane solo nel titolo, non certo nella lingua che, nonostante qualche osservatore distratto74, è assolutamente distante da ogni parlato–parlato e da ogni plausibile varietà regionale, come ben mostra la trascrizione integrale riportata al termine del § 6.3. Citiamo qui, a titolo di esempio, soltanto i brani più caratteristici, sottolineandone i fenomeni di maggiore inverosimiglianza e di innaturale convivenza fra tratti formali e tratti regionali o popolari. Il primo brano è la scena di apertura del film, che vede il tranviere Alvaro (l’attore Memmo Carotenuto, doppiato da sé stesso) rincasare dopo il turno di notte e discutere con la padrona di casa e con suo figlio Salvatore, col quale condivide il letto: 74. Tra questi, Fernaldo Di Giammatteo, per il quale il film narra una «storia trasteverina, tutta in dialetto, […] secondo esigenze e lezioni neorealistiche», che «finì davvero per essere in sintonia con lo sviluppo della società italiana, soprattutto del suo costume» (DI GIAMMATTEO 1990: I, 803). 224 Il linguaggio cinematografico FRATELLO1: (aprendo la porta ad Alvaro) È arivato ninnananna// ALVARO: (al bambino) A spiritoso! (a Cecilia) Buongiorno// L’avete svegliato? CECILIA: È rientrato tardi/ ieri sera// Lo vogliamo/ far dormire un altro po’? ANNAMARIA: Almeno/ se dorme/ non fa danno// ALVARO: Si… signora Cecilia/ io vi do diecimila lire al mese/ una sull’altra// Ma alle otto/ quel fannullone/ il letto me lo deve lasciar libero// Eh! CECILIA: E va bene/ svegliatelo// Ma con le buone maniere// Non lo fate sveglià di soprassalto/ sinnò me sta nervoso tutta la giornata// ALVARO: No/ suonategli il Chiaro di luna di Schùberte// Che quello/ è delicato/ poverello// (i due bambini entrano nella camera in cui dorme Salvatore) FRATELLO1: (al fratello 2) Uno/ due/ tre// (i due bambini fanno cadere a terra con un calcio il letto di Salvatore, che si sveglia di soprassalto) FRATELLO2: Sveglia/ Salvatore! FRATELLO1: È arivato il signor Alvaro! SALVATORE: (tirando una scarpa ai due bambini che scappano) E te lo do io/ il signor Alvaro/ te lo do! Non le bastavo io/ a mamma/ che le volevo tanto bene? Dagli a fà figli// Guarda che disgraziati/ che sono venuti fuori! ALVARO: (entrando in camera e cominciando a spogliarsi) Salvatore? Scendi/ che sei arrivato alla fermata tua// SALVATORE: Ma a te/ il turno di giorno/ non te lo danno mai? ALVARO: E metti che me lo danno? Che letto v’affittate? No/ dico/ se mi danno il turno di giorno/ voi perdete l’inquilino// O ti dovessi credere/ che io la notte/ vengo a dormire abbracciato con te?! SALVATORE: (uscendo sul balcone) Romolo! Romolo! (a Marisa che si è affacciata) Oh/ ma sempre tu/ t’affacci? Che/ ti chiami Romolo? Chiama tuo fratello! MARISA: Romolo! ROMOLO: Sì? (uscendo sul balcone, in pigiama) Ciao/ Salvatore// (a Marisa) Fila! MARISA : Vi volete tanto bene/ ma perché non vi sposate? Almeno <regolate la situazione>// ROMOLO: <E fila/ su>! (a Salvatore) Ahó/ cj ho un torcicollo che non ne posso più// Me l’ha fatto venire Iolanda// SALVATORE: Si vede che non si voleva far baciare// ROMOLO: Sì! 4 – Lingua, lingue e dialetti SALVATORE: Io cj ho una lombaggine! Capirai/ con questa umidità/ quella/ sempre per prati/ vuole andare! Di’/ ma lo sai che ieri sera mi sono trovato un grillo in tasca? ROMOLO: È per quello/ che t’ho sentito che fischiavi// Sbrìgati/ va’// (Romolo e Salvatore rientrano in casa) ALVARO: (a Salvatore) Di’/ ma mamma le lenzuola non ce le cambia mai? (agitandosi nel letto, spaventato) Ahó! Ahó! E questo che è? SALVATORE: Ah! È il grillo de Iolanda// Poverello! Credevo che se ne fosse <andato// Vieni qua>/ bello// ALVARO: <Vattene>! Mannaggia! Ma come/ tu la sera vai con le donne/ e poi io nel letto ci trovo l’erba/ i papaveri/ i grilli?! E se sapevo così/ andavo a dormire a Villa Borghese! Almeno risparmiavo diecimila lire al mese/ no?! <Eh>! ANNAMARIA: <Salvatore>/ il latte si fredda// SALVATORE: Prendimi i vestiti/ e portali di là// ALVARO: Porta via tutto! E non ritornare! Perché cj ho sonno// E tu chiudi la finestra/ va’// (guardando, terrorizzato, sotto le coperte e poi rimettendosi a dormire) Eh! Ah// Hm// VFC UOMO: (gridando in lontananza da fuori, a stento percepibile) Stracciarolo! Robba vecchia […]! (Annamaria fruga nei pantaloni di Salvatore e prende una fotografia) ALVARO: (a Salvatore) Hai preso tutto? SALVATORE: Mo ti fai ’sta mesata di sonno! Ti saluto// (esce dalla camera) ALVARO: Hm// (Salvatore rientra in camera) Ahah! Ma quando ci vai/ a lavorare? SALVATORE: Mi sono scordato il borotalco// ALVARO: Ma che t’encipri/ poi! SALVATORE: Lo so io// Ahó/ se ti ricapita nel letto/ non gli far male/ al grillo// Che quello è il grillo di Iolanda//. Nella scena che segue, i due amici Romolo (Maurizio Arena, doppiato da Sergio Fantoni) e Salvatore (Renato Salvatori, doppiato da Giuseppe Rinaldi) litigano perché innamorati della stessa ragazza, Giovanna: ROMOLO: Giura// SALVATORE: Ma che vòi// ROMOLO: Giura che l’hai baciata/ e che non ti sei inventato tutto// 225 226 Il linguaggio cinematografico SALVATORE: E va bene// Giuro// ROMOLO: Di’ un po’/ ma come l’hai baciata? Perché ci sono tanti modi/ di baciare una ragazza// Ci sono pure i baci senza importanza// SALVATORE: Beh/ ci siamo baciati in un modo piuttosto importante// ROMOLO: E lei/ te li ha ricambiati? SALVATORE: Ti dirò// Ho paura che se la sia presa proprio forte// Me mette quasi paura// Sai perché? Ma mi stai/ a sentire? ROMOLO: Di’/ di’// Séguita// SALVATORE: Perché quella è una ragazza che/ se mi gira/ sono capace pure di sposarla// ROMOLO: Ah! Mi fa piacere// Allora/ quella cosa che ti volevo dire/ non te la dico più// SALVATORE: Quale cosa? ROMOLO: Riguardo alla tua futura spósa// SALVATORE: Cioè? ROMOLO: Che l’ho baciata pure io// SALVATORE: Che hai detto? ROMOLO: Che l’ho baciata pure io// (Salvatore lo prende per la canottiera) E non c’è bisogno che me metti ste manacce addosso// SALVATORE: Giura! ROMOLO: Lo giuro// SALVATORE: Quando l’hai baciata? ROMOLO: Ieri sera// Dopo che l’hai lasciata tu! Aspettavo nel portone// Anzi/ t’ho sentito che dicevi/ che non mi piacciono i tramonti// Giovanna entra/ e mi fa/ “buonasera”// “Buonasera”/ dico io// Poi una parola tira l’altra/ e le ho dato un bacio che non finiva più// S ALVATORE : Ammazza! Ce ne sono/ carogne! Ma come le donne! Di’/ ma ti pare una bella azione/ quella che m’hai fatto? ROMOLO: Ma perché? Abbiamo sempre fatto a mezzo di tutte le donne! Che/ Giovanna è diversa dalle altre? SALVATORE: Sì// Giovanna è diversa! Con lei/ non ti ci devi azzardare più! Hai capito? ROMOLO: Ma sta’ zitto/ cretino! SALVATORE: (dando un pugno sullo stomaco a Romolo) Cretino/ sei tu! ROMOLO: (allontanandolo da sé) E non ci provà più/ sai?! La prossima volta che ci provi/ ti spacco in due! 4 – Lingua, lingue e dialetti 227 Romolo ha invitato a cena Giovanna (Marisa Allasio, doppiata da Maria Pia Di Meo): ROMOLO: (seduto ad un tavolo, con Giovanna) Hai visto/ in che bel posto t’ho portata? Ti piace? GIOVANNA: Sì// Ma tu ce l’hai/ i soldi? ROMOLO: Certo/ che ce l’ho// E poi voglio vedere/ se questi amici miei non mi fanno lo sconto! CAMERIERE2: Per chi è/ ’sto pollo? CAMERIERE3: Per Romolo e Giovanna// CAMERIERE2: E tu glielo porti? Se io fossi in te/ ci penserei due volte// CAMERIERE3: (portando il pollo a Romolo) Hai ordinato pollo? ROMOLO: Eh// CAMERIERE2: Ma ce l’hai/ i soldi? ROMOLO: Sì/ ce l’ho// CAMERIERE3: Fammeli vedere? ROMOLO: (mostrandogli i soldi) Tiè// CAMERIERE3: Va bene// (gli dà il pollo) GIOVANNA: (faticando a tagliare il pollo) Oh/ ma pure questo pollo/ è antico romano? ROMOLO: Giovanna? (facendo un brindisi) Al nostro amore// GIOVANNA: Sta’ attento a non sporcarti il vestito// Che ancora non l’hai pagato// UOMO1: Ma era proprio lui? DONNA1: Ma sì// Li ho visti// ROMOLO: Questa/ è la vita che mi piacerèbbe fare// Senza pensieri/ e con un sacco di soldi// Pensa come sarèbbe bello/ se uno di questi ricconi mi adottasse// Lo sai che a un amico mio/ gli è andato a casa il principe Alfieri/ e l’ha adottato? E adesso fa il signore// Come mi piacerèbbe/ andare da papà e dirgli/ “papà/ il principe Alfieri/ mi vuole per figlio”// Che bella soddisfazione/ gli darei! LEONETTO: (avvicinandosi a Giovanna e sedendosi al tavolo) Giovanna! GIOVANNA: Leonetto! LEONETTO: Eh/ chi si rivede? Ma dov’eri andata a finire? GIOVANNA: Ho cambiato quartiere/ no? LEONETTO: Ah/ sì// Apposta/ non ti trovavamo più// E noi/ dagli a telefonarti! Lo sai chi c’è/ al nostro tavolo? GIOVANNA: Eh// LEONETTO: Gianni con la moglie/ Renata/ e Ugo con la fidanzata// Te lo ricordi/ Ugo/ eh? 228 Il linguaggio cinematografico GIOVANNA: E che mi importa/ di Ugo? LEONETTO: (girandosi verso Romolo) Eh/ scusi/ sa// Scusi tanto// GIOVANNA: Con chi s’è fidanzato? LEONETTO: Con la sorella di Quirino// Se ti volti/ la vedi// Ecco/ si stanno sedendo adesso// Quella bionda// […] GIOVANNA: S’è fidanzato con quella? Uh/ che brutti gusti/ che gli sono venuti! LEONETTO: Eh/ una volta/ cj aveva buon gusto/ eh? GIOVANNA: Hm// ROMOLO: Come si chiama/ ’st’amico tuo? LEONETTO: Eh/ scusi/ non mi sono presentato// Leonetto Berselli// ROMOLO: A Leonetto Berselli! (gli fa cenno con la mano d’andarsene) GIOVANNA: (ridendo) Beh/ ciao/ Leonetto// LEONETTO: Eh/ ciao/ Giovanna// Dopo/ passi a salutarci/ al nostro tavolo? GIOVANNA: Sì/ sì// LEONETTO: (dando uno schiaffetto sulla nuca a Romolo) Piacere// (torna al suo tavolo) ROMOLO: Chi sarèbbe/ ’sto Leoncino? GIOVANNA: Un vecchio amico// ROMOLO: Cj ha na bella faccia da stupido! GIOVANNA: Leonetto è un ragazzo molto intelligente/ se lo vuoi sapere! E ha pure la laurea di dottore// ROMOLO: Capirai quanti fessi/ cj hanno la laura! GIOVANNA: E glj hanno offerto un posto in America del Sud// ROMOLO: Sì! A raddrizzar banane! GIOVANNA: Quanto sei ignorante e cafone! ROMOLO: Ma mo che fai? T’arrabbi? Non posso sfottere gli amici tuoi? In uno stesso parlante si incontrano forme–bandiera del romanesco (mancata chiusura di e protonica in me, te, ce; je per gli e le; aferesi del dimostrativo questo e dell’articolo indeterminativo; apocope sillabica degli infiniti; presenza di ahó; a come introduttore di allocuzione: «A Leonetto Berselli!», etc.; mancano peraltro le forme diastraticamente e diafasicamente più basse del repertorio romanesco, come i possessivi plurali in –a: li mia, li tua, li sua) e forme di italiano “senza accento” o addirittura ipercorretto (sibilante sonora intervocalica in luogo 4 – Lingua, lingue e dialetti 229 della sorda; affricata alveopalatale sorda intervocalica in luogo della sibilante palatale; laterale palatale in luogo della seminconsonante /j/; dittongo uo in luogo del monottongo o; desinenza –èbbe del condizionale in luogo di –ébbe; apocope vocalica dell’infinito o infiniti non apocopati; assenza della sincope e presenza di suffissi poco frequenti, in forme come poverello, in luogo dei romaneschi poretto o poraccio; rispetto della morfologia verbale e della consecutio temporum, per es. nell’uso dei regolari congiuntivo e condizionale in luogo dell’indicativo irreale: «Se io fossi in te/ ci penserei due volte»; lessico selezionato: lombaggine, piuttosto; evitamento del turpiloquio più triviale: cafone, carogna, cretino, disgraziato, fannullone, ignorante, stupido, etc.). Ad accrescere l’inautenticità dell’operazione contribuisce lo status sociale dei personaggi del film, tutti di estrazione popolare o al più piccolo–borghese. Basterebbe una battuta come «Ahó/ se ti ricapita nel letto/ non gli far male/ al grillo// Che quello è il grillo di Iolanda» (a conclusione del primo brano sopra citato), per esemplificare l’antirealismo di questa lingua, che sembra quasi riflettere le oscillazioni tipiche delle rese scritte del dialetto (si pensi al romano dei romanzi pasoliniani): quando mai un romano “de Roma”, con tanto di ahó, pronuncerebbe ti, gli e far (per tacere d’altro) in luogo di te, je e fà? Naturalmente, oltre alla congenita ritrosia dei doppiatori a pronunciare forme dialettali, andrà riconosciuta in questa lingua ibrida — non italiano regionale né esempio di CODE–MIXING [→ Glossario] bensì «dialetto tradotto in italiano»75 — una precisa volontà degli autori del film: la scelta di una «dialettalità integrale di maniera […], soluzione linguistica per così dire endogena, fino a quel momento mai tentata», infatti, ottenuta mediante il ricorso a «interazioni verbali posticce, modulate secondo un’informalità falsamente spontanea» e costruita «a tavolino selezionando moduli locutivi elementari di dialetti reali, cancellandone drasticamente i tratti meno comprensibili al 75. ARISTARCO (1985: 32). 230 Il linguaggio cinematografico vasto pubblico nazionale e assemblandoli secondo schemi funzionali a situazioni comunicative elementari e ripetitive»76, è forse la creazione linguistica più originale del cinema italiano (indipendentemente, beninteso, dalla funzionalità e dal valore estetico), destinata a una fortuna decennale, da certo cinema d’autore (Germi) a tutta la Commedia all’italiana e oltre. Il grande pubblico apprezzò, rise e cadde nell’inganno, abituato ad accettare, d’altronde, che tutto sul grande schermo è finzione e convenzione: come si può credere che qualcuno faccia la parte di qualcun altro, altrettanto plausibile è una lingua ficta (più vicina allo scritto che al parlato) che funga da dialetto vivo. Lasciamo per il momento in sospeso — per concluderlo nel § 6 — l’excursus cronologico sul dialetto filmico, fermandoci a Poveri, ma belli, che funge da momento di transizione ben identificabile tra il Neorealismo e la Commedia all’italiana. Pare ora opportuno fare una sosta sui due massimi rappresentanti di un uso consapevole, acuto ed esteticamente rilevante del plurilinguismo e delle variazioni diastratica e diafasica sul grande schermo: Totò e Alberto Sordi. 4.4. L’unicità di Totò77 S’è già parlato, nel § 2.4.3, della carica espressionistica dell’arte verbale di Totò. Nel secondo e più produttivo periodo della sua attività, dal 1950 al 1965, de Curtis diventa senza 76. RAFFAELLI (1996a: 325–326). Per un’analisi dettagliata della lingua di Poveri, ma belli, messa a confronto col dialetto realistico di Ladri di biciclette, cfr. ROSSI (1999a: 192–219). 77. Sulla lingua di Totò si rimanda a RADTKE (1983) e (2003); ROMEO (1997), (1998a) e (1998b); ROSSI (2002a); ARONICA/FREZZA/PINTO (2003: 75–203). Si omettono, in questa sede, puntuali riferimenti ai predecessori teatrali di Totò sul terreno dell’espressionismo verbale (Scarpetta, Petito, Petrolini, Macario…) e all’attività di Antonio de Curtis come attore–autore teatrale e poeta, reperibili nei testi appena citati. La trascrizione integrale dei dialoghi di Totò a colori è in MEDELIN/ROSSI/SUPPLIZI (2003). L’analisi linguistica dettagliata di quel film è invece presente in ROSSI (1999a: 226–241). 4 – Lingua, lingue e dialetti 231 dubbio l’attore più amato dal grande pubblico (ancora no dalla critica, che lo riabiliterà pienamente soltanto post mortem) e conseguentemente tra quelli maggiormente in grado di influenzarne gli usi linguistici (Figg. 33–34). Ne è prova l’elevato numero di totoismi diventati presto proverbiali, oltre ai già citati eziandio, pinzillacchere e sono un uomo di mondo: siamo uomini o caporali?, lei non sa chi sono io, badi come parla (e parli come badi)… O anche i dialettalismi ciofeca e sfizio, diventati d’uso comune nella lingua nazionale (il primo usato soprattutto per stigmatizzare un caffè pessimo: è una ciofeca! [Totò a colori, 1952, di Steno e Monicelli; Totò, Peppino e i fuorilegge, 1956, di Camillo Mastrocinque; I due marescialli, 1961, di Sergio Corbucci]) proprio grazie all’uso fattone da Totò78. In questo periodo l’arte di Totò si affranca completamente dai retaggi della comica muta e del mimo e diventa, all’opposto, iperparlata, servendosi di tutte le gradazioni possibili a scopo ora ludico–deformante, ora ironico–satirico. Spazia dall’italiano letterario79: ANTONIO (Totò): Ride/ delle cicatrici/ chi non ha mai provato una ferita// Ma piano! Quale luce/ vedo da quel balcone? Quella finestra è l’oriente! E Giulietta/ è la promozione// (urlando) Giulietta! Giulietta! (fischia) Giulié! GIULIA (L. Zoppelli): È Romeo! ANTONIO: Deh/ Giulietta! Calami/ la scaletta! GIULIA: Siedi piuttosto// E non avere fretta! ANTONIO: Ma dove seder degg’io/ se qui sgabel non v’è? GIULIA: Siedi su quel pendio/ oppur favella in piè// ANTONIO: Favellerò di botto// In piedi/ da qui sotto// GIULIA: Hm! Che cosa domandate? ANTONIO: Domando se mi amate// GIULIA: Oh sì/ v’amo! Audace! ANTONIO: Audax fortuna iuventus! GIULIA: Sì/ v’amo! Ma al verone son venuta per dirvi/ di non 78. RADTKE (2003: 132). 79. «Il ‘gag’ dell’aulicità risalirebbe a Petrolini e sarebbe poi stato ripreso, prima del secondo conflitto, da Macario; ma certamente il napoletano Totò è riuscito meglio di tutti a trarne profitto» (DE MAURO 1963/1993: 122). 232 Il linguaggio cinematografico essere/ imprudente// Mio fratello sospetta / giustamente// E ieri sera più d’un impiegato / ha abbozzato un sorriso d’ironia! ANTONIO: Non mi importa/ se qualcuno ha già svagato// Voglio solo che presto/ siate mia! GIULIA: Mi proponete allor/ d’essere amanti! ANTONIO: Non siamo i soli// Ce ne sono tanti! Eh! GIULIA: Ma un giorno/ mi farete vostra sposa? ANTONIO: Mia sposa! No/ non posso// Come oso?! Sposare voi/ un umile impiegato morto di fame/ e sempre squattrinato! GIULIA: Potremmo fare/ qualche sacrificio// ANTONIO: È meglio farmi fare capufficio// A cuoppo cupo/ poco pepe capa// Dico… eh? GIULIA: Il vostro amore/ allora/ è interessato! ANTONIO: Giulietta mia/ che dici?! Hai equivocato! Io t’amo in ogni modo! E tu lo sai// GIULIA: Questo amore/ può metterci nei guai! ANTONIO: Non importa! Io ti darò il mio cuore! GIULIA: È troppo poco/ per un grande amore// Oltra al cuore/ io voglio tutto il resto// ANTONIO: Pure le frattaglie?! Dimmi/ io faccio presto// (aprendosi la veste sul petto) Ciappa! FRATELLO: Giulia! GIULIA: Oh! Mio fratello mi chiama! Che disdetta! ANTONIO: Che faccio? Salgo su nella stanzetta? GIULIA: Oh/ no/ Romeo/ ti prego! Non farlo/ non è giusto! ANTONIO: Laddove c’è il periglio c’è più gusto// Comunque// Ci vedremo in altro loco// Domani istesso// GIULIA: Ah! Già son tutta fuoco! ANTONIO: È un posto sicurissimo/ appartato// GIULIA: Come si chiama? ANTONIO: Domani istesso/ col mio biglietto/ dirotti/ dove è sito l’alberghetto// GIULIA: E poi? ANTONIO: Eh/ domani notte… Domani notte alfin potrai sapere… GIULIA: Che cosa? ANTONIO: Lo vuoi sapere adesso? GIULIA: Lo voglio! ANTONIO: Un anticipo? GIULIA: Hm! ANTONIO: Com’è buono il formaggio con le pere// GIULIA: Oh! 4 – Lingua, lingue e dialetti 233 FRATELLO: Giulia! GIULIA: Oh! Debbo andare// A presto/ amore mio// ANTONIO: (starnutisce) GIULIA: Salute// ANTONIO: Grazie// GIULIA: A presto/ amore mio// ANTONIO: Addio/ Giulietta// GIULIA: Addio// ANTONIO: Addio/ Giulietta// GIULIA: Addio// ANTONIO: Giulietta! GIULIA: Ho capito! Ciao! ANTONIO: Ahó/ e un t’arrabbià! Eh! Scusa tanto! […]// Parolacce/ finzioni/ e starnutone/ (ride) che s’ha da fà/ pe ’sta promozione! (Chi si ferma è perduto, 1960, di Sergio Corbucci), a quello popolare: Signorina veniamo noi con questa mia addirvi che scusate se sono poche ma settecento mila lire; noi ci fanno specie che questanno c’è stato una grande moria delle vacche come voi ben sapete.: questa moneta servono a che voi vi consolate dai dispiacere che avreta perché dovete lasciare nostro nipote che gli zii che siamo noi medesimo di persona vi mandano questo perché il giovanotto è studente che studia che si deve prendere una laura che deve tenere la testa al solito posto cioè sul collo.;.; salutandovi indistintamente i fratelli Caponi (che siamo noi) (Totò, Peppino e… la malafemmina, 1956, di Mastrocinque)80. Dai dialetti alle lingue straniere, dai gerghi81 ai linguaggi scientifici: 80. ROSSI (2002a: 82). 81. Oltre all’ironia sul gergo snob (con aulicismi, diminutivi e nomignoli soprattutto nel personaggio di Franca Valeri in Totò a colori), un gergalismo è pisello — inteso come ‘s interdentale’ (difetto di pronuncia) nel gergo teatrale — che tuttavia serve soltanto per un banalissimo bisticcio osceno: «se non avessi il pisello sarei un attore»; «e tu col pisello fai l’attore?»; «ma tu il pisello ce l’hai» (L’imperatore di Capri, 1949, di Luigi Comencini). 234 Il linguaggio cinematografico GENNARO (Totò): Con questo capello che abbiamo trovato sulla sterlina/ noi siamo sicuri/ col nostro metodo/ di acciuffare/ il complice di Castagnato// LANOCELLA (E. Turco): E come? GENNARO: È chiaro/ che questo capello è di sesso maschile? Osservi// Dico bene? UOMO DELLA SCIENTIFICA: Sì/ sì// GENNARO: Bene dico// Bene detto// Cosa facciamo? Prendiamo una capella// UOMO DELLA SCIENTIFICA e LANOCELLA: Una capella?! GENNARO: Una capella/ di sesso femminile// Esatto// Li uniamo// E li lasciamo soli/ in un ambiente ben riscaldato// Se i capelli/ tra di loro simpatizzano/ dopo ventiquattr’ore/ abbiamo/ la riproduzione// Cioè/ vale a dire/ la nascita/ del capellino// “Ma quanto è carino! Ma quanto è bellino! Rassomiglia tutto alla capella madre! Rassomiglia tutto al capello padre! Come lo chiamiamo”! Niente! Lo chiamiamo/ capello// Lo si toglie con dolce violenza dai suoi genitori sanguigni/ e lo si pone/ nell’incubatrice per adulti// Dico/ per adulti// Nell’incubatrice/ il capello testé/ sviluppa/ mette il suo bulbo/ i suoi vasi sanguigni/ la struttura ossea/ il sistema nervoso/ la cartillagine/ etti cetera/ etti cetera// Dopo nove mesi/ che cosa avviene? Che il capello/ è diventato capillone// Il neocapello/ è diventato capillone// Lo prendiamo/ lo portiamo in giro per la città in un giorno festivo/ gridando forte/ ad alta voce/ “chi ha perduto questo capello?! Gente/ chi ha perduto questo capello?!” Il primo che dice/ “è mio”/ lo si acchiappa/ e lo si schiaffa dentro// Quello/ è il colpevole! (I ladri, 1959, di Lucio Fulci). Praticamente l’intero testo dei suoi film, nei casi migliori, risulta costruito sul gioco verbale (la paronomasia e la polisemia su tutti)82 e la stessa trama diventa mero pretesto. 82. L’esemplificazione sarebbe anche in questo caso sterminata. Ci limitiamo, per la paronomasia, a due esempi da Figaro qua… Figaro là, 1950, di Carlo Ludovico Bragaglia, rimandando, per tutti gli altri, a ROSSI (2002a): ATTORE (M. Castellani): Tal quale mi vedi/ io sono un uomo/ che la passione/ di soppiatto/ devasta/ e che l’affetto uccide! FIGARO: (Totò, nei panni di Pulcinella): Anche a me/ sai? ATTORE: Che cosa? 4 – Lingua, lingue e dialetti 235 A proposito del dialetto napoletano di Totò, va detto, ancora una volta, che si tratta niente più che della solita patina fonetica FIGARO: Anch’io/ sono un uomo/ che cj ho la passione/ per un bel piatto di fagioli/ e la pasta/ e due fettuccine//. ALMAVIVA (G. Agus): Poi/ noi/ col favore della notte/ FIGARO (Totò): Sì// ALMAVIVA: Rapiamo Rosina// FIGARO: Eh/ dovevate dirmelo prima// ALMAVIVA: Perché// FIGARO: Non ho portato il rasoio// ALMAVIVA: Per che fare? FIGARO: Per raparla/ no? ALMAVIVA: Ma che cosa hai capito?! Noi/ non la rapiamo! Ma la rapiamo! FIORELLO: Hai capito? FIGARO: No// ALMAVIVA: Noi/ non la rapiamo rapiamo// Ma la rapiamo rapiamo// FIGARO: Ma scusate/ chi la rapa? ALMAVIVA: Nessuno! FIGARO: E allora perché avete detto “la rapiamo”/ se nessuno la rapa! Ohé/ giovanotto/ non facciamo scherzi! Qui/ l’unico del mestiere/ che può raparla/ modestamente/ sono io// ALMAVIVA: Ma lo vedi che non capisci niente! Si tratta di un ratto! FIGARO: Ah! Un ratto consenziente! Per la polisemia: MODELLA (L. Weibel): (credendo che Totò sia un famoso pittore) Ho sentito parlare tanto bene di lei/ maestro// [Perché] è uno dei migliori/ pittori moderni// Da che scuola/ proviene? BENIAMINO (Totò): (alludendo all’edificio scolastico che occupava abusivamente) Io dalla scuola Garibaldi// Ci stavo come sfollato// Sì sì// Eh eh// MODELLA: Sfollati a quale corrente appartengono? BENIAMINO: Beh/ sa/ corrente alternata// Con questi turni! (Totò cerca casa, 1949, di Steno e Monicelli). E si ricordi almeno quel «busto in oro del duce», evocato dal notaio Cucuzza, scambiato da Totò per un corsetto: NOTAIO (P. de Martino): […] Infine/ tra le proprietà lasciate dal generale/ l’altro suo fratello/ […] è compreso un busto in oro del duce// Un busto in oro/ del duce// PASQUALE (Totò): Ma no! NOTAIO: Sì// PASQUALE: Un busto! 236 Il linguaggio cinematografico e poco altro (pronuncia palatale della sibilante preconsonantica, come in shchifezza; qualche sonorizzazione e alterazione del timbro vocalico di e ed o, come in finalmènde, uómo; forme come into ‘dentro’, paisà, scocciare ‘infastidire’, l’interiezione uè, etc.). Il suo è un italiano regionale e anche abbastanza stereotipato; «la napoletanità di Totò insomma non può essere dedotta dal suo linguaggio verbale, ma va piuttosto al di là dei mezzi linguistici per esplodere in maniera dirompente in un altro tipo di linguaggio, quello gestuale [→ Glossario, MIMICO], molto più immediato e meno facile da controllare e da reprimere»83. Più interessante, invece, il lavoro fatto sugli altri dialetti, quasi sempre usati ora fuori contesto (il veneto ostrega, nei Pompieri di Viggiù, 1949, di Mattoli; Guardie e ladri, 1951, di Steno e Monicelli; Il medico dei pazzi, 1954, di Mattoli, e altrove; il piemontese cerèa ‘arrivederci’, in San Giovanni decollato, 1940, di Amleto Palermi; Due cuori fra le belve, 1943, di GiorNOTAIO: Un busto// In oro// PASQUALE: Ma sa/ che questo mi giunge nuovo! (ride) E chi poteva pensare che il duce portasse il busto! NOTAIO: No! PASQUALE: (imitando Mussolini) Ecco/ perché stava bello tutto dritto/ aitante// NOTAIO: Non/ no/ no/ non è che il duce/ portasse il busto! Non lo portava// PASQUALE: Ah no! NOTAIO: Ma no! PASQUALE: Portava un reggipetto// NOTAIO: Un re… Nossignore! Che reggipetto! Dice… PASQUALE: La panciera? NOTAIO: Ma neanche la panciera! PASQUALE: Ma lo sa che lei è un bel tipo? Lei prima dice il busto/ e poi se lo nega! NOTAIO: Ma non me lo nego affatto! PASQUALE: Ma come/ se lo sta negando! NOTAIO: Ma chi se lo nega! PASQUALE: Lei ha detto ch… NOTAIO: Ho detto un busto in oro// Un busto significa/ una statua// Va bene? Una statua! PASQUALE: Co… col reggipetto? Con la panciera// (Totò diabolicus, 1962, di Steno). 83. PIETRINI (2003: 115). 4 – Lingua, lingue e dialetti 237 gio C. Simonelli; Le sei mogli di Barbablù, 1950, di Bragaglia, e altrove) ora deformati e più o meno fraintesi. In Totò a colori, per esempio, il siciliano del cognato Rocco offre l’appiglio per un comico fraintendimento: unn’è ‘dov’è’ è scambiato da Totò per un nome proprio: «chi è Unnè? Chi è?». Analogo è il caso del milanese inventato, per fare il verso a un tassista: «gh’è la nebia! Chi/ a Milàn/ gh’è la nebia! È periculùs/ cùrer// Hai capito? Anzi/ ghe penso mi// Sciuminòx// È periculùs// Vai chian! E non corrèr! Si sguish!». Celebri sono anche, nello stesso film, le deformazioni del pugliese: mela femena ‘malafemmina’, dèca ‘dica’, secomera ‘sicumera’, sèndaco ‘sindaco’, gelsomene ‘gelsomino’, tulepene ‘tulipano’, orchetette ‘orchidea’, cleneca ‘clinica’, crepi ‘Capri’. Evidente è la carica dialettofobica spesso ostentata (non sempre ironicamente) dall’aristocratico principe della risata: «qui si parla in italiano/ ostrega!» (Guardie e ladri); «e parli italiano/ benedetto Iddio!»; «si ricordi che lei/ qui in Italia/ è un oshpite!» (Totò a colori); «parli italiano// Si spieghi!»; «è proibito parlare in dialetto!» (Totò e Carolina, 1955, di Monicelli); «e parla italiano!» (I due colonnelli, 1962, di Steno); «ah/ Garibaldi/ ch’hai fatto!» (contro il pugliese di Nino Taranto, in Totò contro i quattro, 1963, di Steno). Le lingue straniere sono quasi sempre utilizzate per innescare una serie di irresistibili paronomasie. Una delle scene più esilaranti, in tal senso, è il miscuglio franco–anglo–italo–tedesco col quale Totò e Peppino, in Totò, Peppino e… la malafemmina, si rivolgono al vigile urbano di Milano (che, essendo del Nord, parlerà sicuramente austriaco): Dungue/ excuse me// Bitte schön// […]// Noio/ vole… volevàn… volevòn/ savuàr/ noio volevàn savuàr l’indrìs… ja? […] Dunque/ eh/ noi/ vogliamo sapere/ per andare/ dove dobbiamo andare/ per dove dobbiamo andare// Sa/ è una semplice informazione//. Altre volte un dialetto viene scambiato per una lingua straniera, viva o morta, o viceversa. Il bitontese (varietà del pugliese parlata a Bitonto, in provincia di Bari) viene scambiato per 238 Il linguaggio cinematografico arabo, in un’incomprensibile litania nella quale si riesce a captare soltanto un iterato, minacciosissimo, mòia! detto contro Totò (Le sei mogli di Barbablù); «de visu» è scambiato per sardo: «dev’essere sardo» (Le sei mogli di Barbablù; Letto a tre piazze, 1960, di Steno); anche a «statu quo» e a «brevi manu» tocca la medesima sorte; TOTÒ: Ma allora è proprio sardo! […] Te lo dicevo/ io// Questo è sardo spaccato// CASTELLANI: Ma no/ è latino! TOTÒ: Sarà latino/ coll’accento sardo// (Le sei mogli di Barbablù). In Totò a colori, Totò crede che il giardiniere pugliese (Guglielmo Inglese) sia straniero e gli si rivolge in francese, inglese, tedesco, spagnolo e russo. Di una scritta inglese, a Milano, si dice: «è scritto in milanese» (Totò, Peppino e… la malafemmina). In Letto a tre piazze, il latino è preso per siciliano. TOTÒ: Sursum corda// Che significa? SERVITORE: Io mica parlo il francese// TOTÒ: Ah già/ questo è siciliano// (Signori si nasce, 1960, di Mattoli). Raramente l’uso del dialetto è difeso esplicitamente, rispetto all’italiano formale o al forestierismo: PASQUALE (E. Turco): Siccome il monte di pietà era chiuso/ vai dallo charcutier qui alla cantonata/ eh? FELICE (Totò): Da chi? PASQUALE: Dallo charcutier alla cantonata// FELICE: E chi è questo sciacquettiere? PASQUALE: Il pizzicagnolo// Il salumiere// FELICE: Il casadduoglio? PASQUALE: Eh// FELICE: E parla chiaro! PASQUALE: Il bottegaio// FELICE: Eh// [….] Se io vado dallo sciartonier con questo paltò/ quello me piglia a calci/ capito? (Miseria e nobiltà, 1954, di Mattoli). 4 – Lingua, lingue e dialetti 239 Il cavalier Antonio Cocozza (Totò) chiede al suo futuro consuocero, il ragionier Giuseppe D’Amore (Aldo Fabrizi), se ha un tic (‘tight’) per l’imminente matrimonio dei figli; Giuseppe, risentito, risponde: GIUSEPPE: No/ io non cj ho nessun tic// Quale tic? ANTONIO: In occasione del matrimonio/ ci vuole il tic// GIUSEPPE: Ah/ il tight/ vuol dire/ lei// ANTONIO: Tight? GIUSEPPE: Tight// A NTONIO : Che buffo nome! Noi/ a Napoli/ diciamo la sciammèria// Ragioniere/ lei si deve fare una bella sciammèria// (Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi, 1960, di Mattoli). Totò si spaccia spesso per poliglotta («modestamènde/ qualche lingua la parlo»: Totò, Peppino e… la dolce vita, 1961, di Corbucci). Nel caso seguente, combinando sempre inglese, francese e italiano storpiato, tenta di abbordare due turiste americane: ANTONIO: Excuse moi/ please/ se vous plait// Da quante/ tamp/ PEPPINO: Da quante? ANTONIO: Tamp/ voio/ voi due/ state/ in Italia// Cioè qui/ a Roma/ in Romagna/ in Romania/ va’// […] Noi/ vogliam/ savuàr/ ove/ voio/ abitàt// Dov’è la vostra/ abìt// La chesa/ va’// La chesa// PEPPINO: La chesa// ANTONIO: Quand’uno/ s’è stanc/ voglio andar a chesa// Me voglio riposare// Un tandìn PEPPINO: Ma tu stai parlando barese! (Totò, Peppino e… la dolce vita). Nello stesso film, «you’re friend?» viene tradotto da Peppino con «hai freddo?»; in luogo del night club, Totò e Peppino vanno al «natic club», con trasparente paretimologia; fischi è l’equivalente di whisky; da strip–tease nasce l’invito a spogliarsi: striptiamoci!; a «m’hanno fatto i flash» (‘fotografie’) di Totò, Peppino risponde, fraintendendo: «t’hanno fatto fesso»; l’invito ad andare a un party è frainteso da Totò con la parola parto, al che Peppino domanda «e chi sgrava?» e Totò risponde: sòreta!; 240 Il linguaggio cinematografico l’enunciato «Norma è già in trance» è così tradotto da Totò: «Norma/ sta già nel tram». Da parte loro, le americane fraintendono la domanda latina di Peppino (che si difende dall’ignoranza dell’inglese ricorrendo ai classici) «quo vadis?» ‘dove andate?’, rispondendo «no// Ben Hur», che Totò, pronto, ritorce contro Peppino: «hanno detto che assomigli a Ben Hur». Ma più spesso le lingue straniere sono guardate con sospetto e diffidenza, per il motivo opposto all’avversione per i dialetti: questi sono disprezzati per un certo snobismo contro l’ignoranza e la dabbenaggine dei parlanti, quelle proprio contro lo snobismo frustrato di chi vuole darsi un tono spacciandosi per quello che non è e non sarà mai. Alla base di entrambe le reazioni c’è l’amore di Totò per l’italiano autentico, semplice ed elegante, distante tanto dai popolarismi quanto dagli aulicismi e dai burocratismi inconsapevoli: AMALIA (A. Mangini): Oh! Ma mi manca una valigia// Vai a vedere/ caro/ se l’ho lasciata nella hall// BENIAMINO (Totò): Come? AMALIA: Nella hall// BENIAMINO: Che cosa// AMALIA: Nella hall! BENIAMINO: E chi è la ol? La portiera? AMALIA: No/ nell’atrio// FIGLIA (L. Molfesi): Nell’anticamera// Qui nei quartieri alti si dice hall// Fa più fino// BENIAMINO: Ah sì? La hall? Bah! Allora io vado giù a vedere nella hall// (aspirando esageratamente l’iniziale della parola) (Totò cerca casa). AMILCARE (M. Castellani): (a un autista) Ehi/ autista/ a che albergo andiamo? Ehi/ autista! TOTÒ: Sfido io// È tre ore che lo chiami autista// E chiamalo in italiano/ no! AMILCARE: Come? TOTÒ: Chauffeur! (Le sei mogli di Barbablù). CAPOTRENO: Lei ha il biglietto per il wagon–lit? ANTONIO (Totò): Ma che vagon lì! Ho il biglietto per questo carro… questo vagone qui// 4 – Lingua, lingue e dialetti 241 CAPOTRENO: E appunto// Lei ha il biglietto per il wagon–lit// ANTONIO: Ma perché mi vuol mandare lì/ se io il biglietto ce l’ho per qui/ scusi?! CAPOTRENO: Ma se lei ha il biglietto per qui/ vuol dire che ha il biglietto per il wagon–lit// ANTONIO: A forza/ sa! Io ho il biglietto per qui/ e lei mi vuol mandare lì! Quel signore giù/ quel colonnello in borghese/ <col cappello in divisa/ m’ha de>… CAPOTRENO: <Hm// Ma che/ il capostazione>? ANTONIO: Ma che ne so/ come si chiama?! CAPOTRENO: E [dunque]? ANTONIO: M’ha detto che questo è il mio treno// CAPOTRENO: E dunque/ se lei ha il biglietto per qui/ vuol dire che ha il biglietto per il wagon–lit// ANTONIO: E insiste/ sa! CAPOTRENO: <No>// ANTONIO: <Ma perché> mi vuol mandare lì/ se io cj ho il biglietto per qui/ <scusi>?! […] ONOREVOLE (M. Castellani): <Si calmi>/ signore// Si calmi// La prego// <Eh>// ANTONIO: <Veda/ signor fuochista/ la questione>… ONOREVOLE: <Che fuochista>! CAPOTRENO: <Che fuochista?! Ma come?! Abbia del rispetto! Ma>… ANTONIO: <La questione> sbanda// ONOREVOLE: Scusi/ a me sembra che abbia ragione il conduttore// CAPOTRENO: Oh! ONOREVOLE: Ha detto “wagon–lit”// È in francese// <Significa/ vagone letto>// ANTONIO: <Ma>… ma è tre ore/ che glielo dico// Hm… la cosa/ non è venuta vagliata// <Eh>// CAPOTRENO: <No>// È tre ore/ che io glielo spiego/ e lei non capisce! Intanto mi favorisca il biglietto// ANTONIO: È tre ore/ che glielo sto mostrando! CAPOTRENO: Ah! <Vediamo>… ANTONIO: <E so’ sei>! Avanti! CAPOTRENO: Eh già/ ha il letto numero sei// (Totò a colori). Come al solito, l’intento di Totò, dei registi e degli sceneggiatori di questi film non è tanto mimetico (anche se ne derivano, talora, ritratti indubbiamente realistici della stratificazione 242 Il linguaggio cinematografico geo– e sociolinguistica dell’Italia del dopoguerra) quanto ludico–espressionistico: le lingue straniere e i dialetti, ancor più dell’italiano, si prestano al puro gioco del significante. Ed ecco, dunque, che «shall I go?» ‘devo andare?’ viene frainteso da Totò come «cj hai la gotta?» e «come on!» come commare (Siamo uomini o caporali?, 1955, di Mastrocinque); scotch ‘bevanda’ come scocciante (Il coraggio, 1955, di Domenico Paolella); un montgomery diventa «un bel cocòmeri americano» (La banda degli onesti, 1956, di Mastrocinque); «how do you do?» ‘come va?’ viene tradotto con «due più due» e «where do you live?» ‘dove vivi?’ con «vuoi un’oliva?» (Totò, Peppino e… la malafemmina); «Rocco e Rocco» sta per ‘rock and roll’ (Totò, Peppino e i fuorilegge); un whisky e un Pernod diventano un fischio e un pernacchio (Totò a Parigi, 1958, di Mastrocinque); un’insegna al neon diventa una «mostra al nailon» (I tartassati, 1959, di Steno), etc. etc. Anche l’elevata frequenza di interiezioni, ideofoni, pause vocalizzate e suoni più o meno inarticolati, oltreché la riproduzione della balbuzie e i giochi verbali basati sull’iconicità dei nomi propri, rispondono alla medesima volontà di far regredire la lingua a una sorta di linguaggio primitivo e pregrammaticale e di utilizzare i suoni linguistici come note musicali. Infatti ideofoni e interiezioni vengono spesso cantati: È strano// (cantando) “È strano// È strano// Mi sembra molto strano// Ma/ chissà/ perché// Ah/ sì sì sì sì/ capisco// Zunzunzùn// Capisco/ forse”// (parlando) Questi vorranno venire di persona// Eh già/ vengono di persona// Tippetippetìp/ qui// E allora bisogna che io m… mi… mi affretti a terminare il secondo tempo// Strano// Perché gli ho mandato quasi tutta l’opera// Mah// Affrettiamoci a finire il secondo tembo// Eh già// Perché da un momèndo all’altro/ possono venire qua/ bussano alla porta// “Ndr”// “Chi è”? “L’editore Tiscordi”// Oppure/ “ndr”// “Chi è”? “L’editore Zozzogno”// “Eccomi qua/ il maestro// Prego/ si accomodi”// “Grazie”// (alla cameriera) Eccoci qua// Questa è la mia opera// Il mio capolavoro// Eccolo qui// Ho già trovato il titolo/ sai? Sì// La chiamerò/ Epopea italica// Magnifico// (mostrando le spartito alla cameriera) 4 – Lingua, lingue e dialetti Vedi/ cara/ qui siamo al terzo atto// Quando Cristoforo Colombo/ fa rapire/ Elena di Troia// Che poi sopraggiunge la madre di Elena… Beh/ beh/ lasciamo perdere/ vai// Mi ci vorrebbe un’ispirazione// Sendi/ mia buona e dolce fandesca/ apri meglio la finestra// Fa’ che io mi ispiri// Poiché i temi della natura/ sono sembre i suggerimèndi migliori// Sì// Fa’ che io mi ispiri// Voglio origliare// Origlio// Hmhm// (ascoltando il rumore dell’acqua di una fontana e tentando di riprodurlo con il pianoforte. Immagine della fontana) Sì/ hm/ sì! Eccola! Sì! Ah! (scrivendo sul pentagramma) Do// Do// Si diesis// Re fa// Croma// Semicroma// Biscroma// Un accidente/ in chiave// Eheheheh// (ascoltando il canto di un uccellino e tentando di riprodurlo con il pianoforte e con la voce. Immagine di due uccellini) “Chichichichì// Chichichichì// Chichichichì”// Sì// (scrivendo sul pentagramma) È una biscroma// È un si// Si/ biscroma// Biscroma si// (suonando e cantando) “Chichichichì”// Eheh// (sentendo il rumore di uno sciacquone. Immagine di Rocco al bagno. Antonio chiude il pianoforte e si alza di scatto) Bah! Ma come si può comborre in questa casa?! Ecco! Uno scroscio di igienico idraulico! Non si può creare! In questa casa non si sende altro che parolacce/ la pèndola che bolle/ la vacca che partorisce! Che ispirazione può venire fuóri?! “Clocloclocloclò// Meeh// Ssh// Ahó/ te possino ammazzà! Ma annà”… Robba da pazzi! (suona il campanello) Ro… Han… han… hanno suonato! Hanno suonato! Oh Dio/ hanno suonato! Questo dev’ess… i…; ROCCO (R. D’Assunta): (entrando, dopo aver sfondato la porta) Vuoi piantarla? Scimunito [autentico]/ ah?! ANTONIO: (cantando) “Ah/ ah/ ah/ <ah>”// ROCCO: <Vuoi finirla>/ sì o no?! ANTONIO: È un la// È un la// <Oh>! ROCCO: <Vuoi finirla>/ sì o no? ANTONIO: (cantando) “Vuoi finirla/ sì o no”? Ripeti// ROCCO: Vuoi finirla/ sì o no? ANTONIO: (cantando) “Do re mi fa sol do do/ do re mi fa sol do do/ do re mi fa sol do do/ do re mi fa <sol do do”// Sì>// ROCCO: <Ah! Ah>! ANTONIO: <Eh>// Bene/ bene// Questo me piace// Questo me piace// Sulla quarta corda// (prende il violino e tenta di riprodurre i lamenti di Rocco) Ah/ sì// ROCCO: <È pazzo>! ANTONIO: <Ah/ sì>// Ah/ sì// (Rocco rompe un vaso e esce, Antonio canta) “Taratattattara/ tatara/ ah// Vuoi finirla/ sì o 243 244 Il linguaggio cinematografico no? Tatatatatatà/ ta”// (bussano) Avanti! Avanti! Avanti! (Totò a colori). Sulla consistente presenza di sovrapposizioni dialogiche [→ Glossario, SOVRAPPOSIZIONE DI TURNO], interruzioni, segnali discorsivi e di RETRACTING [→ Glossario] incide senza dubbio la presa diretta del suono, caratteristica di quasi tutti i film con Totò, contro la tendenza generale del nostro cinema. A questa prassi e alla nota abitudine teatrale dell’improvvisazione (ancorché programmata e concordata con gli altri interpreti del film) è dovuta anche la ricca attestazione degli altri fenomeni tipici del parlato–parlato nella produzione cinematografica di Totò, la quale appare dunque soggetta a due spinte contrastanti: l’estrema stilizzazione e la carica espressionistica da un lato, la mimesi (talora anche critica) dell’oralità dall’altro. Ovviamente, nell’operazione di manipolazione delle lingue, Totò (il cui apporto creativo quale coautore del film è stato ormai ampiamente dimostrato) non è né il solo né il primo, avendo alle spalle una millenaria tradizione dalla commedia plautina alla Commedia dell’Arte, dal carnevale a Rabelais, dall’opera buffa all’avanspettacolo84. E anche significativi antecedenti cinematografici, a partire dai “telefoni bianchi” di Camerini, nei quali si sorrideva delle velleità esterofile dei borghesi e degli errori dei popolani (i già commentati usi di De Sica e di Riento nel Signor Max: cfr. § 2.3.1). Quello che lo rende nel contempo innovatore e inimitato è però la centralità, in ogni sua interpretazione teatrale e cinematografica, della componente lin- 84. Per i riferimenti alla commedia classica e dell’Arte cfr. ROSSI (2002a: 28–29); per quelli a Rabelais e al carnevale cfr. ROSSI (2002a: 166 n. 4). Il melodramma comincia ben prima dell’opera buffa a interessarsi al gioco delle lingue, come mostra Xerse, di Nicolò Minato, 1655, nel quale, al secondo atto, il personaggio di «Elviro vestito da vendi fiori» così «finge altro linguaggio» (II 1): «Ah, chi voler fiora / De bella giardina. / Giacinta indiana, / Tulipana, Gelsomina. / Ah, chi voler fiora / De bella giardina. / […] Da mia, che cercar? / Voler fiora comprar? […] / Ti chi star? / E perché dimandar? […] / Ariodate de chista / Città Signur, che star a Re vassallo / Haver figlia Romilda, e Re voler / Chista sposar, e dir, / Se nu sposar morir. / […] Nu saper altro» (cfr. ROSSI 2005: 233–244). 4 – Lingua, lingue e dialetti 245 guistica e l’assoluta congruità (non necessariamente voluta) tra attore, personaggio e risorse verbali. Ne risulta la grandezza di Totò anche (spesso soprattutto: Totò a colori) nei film più deboli, dove viene meno ogni tentativo di ingerenza da parte di sceneggiatori e registi, e l’impossibilità di trasferire quei giochi e quelle gag su un altro interprete, pena l’immediato azzeramento della risata. Il frequente ricorso alla funzione metalinguistica da parte di Totò ne dimostra la prominenza della verbalità su ogni altra componente e, nei casi migliori — così come nel vacillante rapporto con le lingue straniere e in quello di amore/odio con i dialetti (il vernacolo è caro perlopiù alle poesie e alle canzoni di Antonio de Curtis) e l’italiano popolare —, contribuisce al ritratto del parlante incolto o semicolto, nell’Italia dell’avvento della televisione, alle prese con una lingua scolastica inseguita a fatica e mai assimilata completamente85; un parlante sempre in bilico tra l’attaccamento, cosciente o inevitabile, alle proprie origini dialettali e il desiderio di sbarazzarsene il più in fretta possibile. Indubbiamente, come ha sottolineato per primo Tullio De Mauro, quel parlante ha cominciato a sentirsi più sicuro, a non vergognarsi più di aprire bocca in presenza dei “signori” e, anzi, a ridere a sua volta della loro affettazione, dei loro fa d’uopo e lei non sa chi sono io, anche grazie ai film di Totò86. 85. «I personaggi interpretati dal comico [Totò] vogliono impossessarsi della lingua nazionale e nei loro tentativi coinvolgono gli interlocutori in discussioni metalinguistiche, simulando sicurezza nel possesso delle regole grammaticali e stilistiche. Il pubblico contemporaneo rideva, ritrovando negli sforzi di Totò le proprie aspirazioni al possesso della lingua italiana» (ROMEO 1997: 114). 86. «Gli scherzi di Totò hanno aiutato i più […] ad avvertire, prima ancora che il ridicolo dell’aulicità fuor di luogo, la aulicità stessa di certi elementi lessicali, che per l’innanzi, se noti, rischiavano di essere adoperati in contesti che non li esigevano affatto» (DE MAURO 1963/1993: 122). Della «ridicolizzazione dell’italiano ‘ufficiale’, compiuta incrociando preziosismi aulici e formule burocratiche», parla SPINAZZOLA (1974: 95). Secondo CRESTI (1982: 294) Totò ha trasformato la «caratterizzazione dialettale degli ‘errori’, che per secoli è servita a connotare grottescamente il popolo dialettofono, in un’accusa rivolta ai pedanti, ai censori, o più modestamente a quelli che non avevano il coraggio di parlare semplicemente». 246 Il linguaggio cinematografico Tra i casi di metalinguaggio propriamente detti si possono citare: Capelli/ con la p// Come… Padova… Mantova… (Totò cerca moglie, 1950, di Bragaglia); ARMANDO (M. Carotenuto): Perché hanno licenziato Aldo? LUIGI (Totò): Hanno licenziato Aldo?! ARMANDO: Eh// LUIGI: Hanno licenziato Aldo?! Ho/ licenziato! Ho! Con l’acca precedente! (Gambe d’oro, 1958, di Turi Vasile); LIDIA (S. Koscina): Non si dice missìli// Si dice mìssili// Con l’accento sulla prima i// Quante volte te lo devo dire? PASQUALE (Totò): Io l’accento/ per regola e norma tua/ lo metto dove mi pare// In casa mia comando io/ fino a prova contraria// E l’accento lo voglio mettere dove voglio io// Anche sul comodino/ volendo// […] Mìssile// Una parola così antipatica// Fa venire il singhiozzo// Mìssile// (Totò nella luna, 1958, di Steno); TOBIA (G. Furia): Lasciate perdere questa donna// Ce ne stanno tante altre// TOTÒ: Ce ne stanno/ eh? Il guaio è che non ci stanno// TOBIA: Mi volete far credere che non ci stanno donne! TOTÒ: Ignorante! Impara l’italiano// Ce ne stanno/ è voce del verbo cenestare// Viceversa starci/ è l’imperfetto del verbo pomiciare// (Totò, Eva e il pennello proibito, 1959, di Steno); LOLA (G. Rovere): Io sto qua/ perché m’è accaduto un fatto strano// CESARE (Totò): Perbacco! E dove l’è caduto questo fatto? PEPPINO (P. De Filippo): No no no/ tse/ è ignorante// Non l’è caduto// L’è accaduto// CESARE: Ah! Passato remoto! (La cambiale, 1959, di Mastrocinque). E tanti altri, tra i quali la celebre discussione tra Totò e sua figlia sull’opportunità di dire succube o succubo, in Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi. 4 – Lingua, lingue e dialetti 247 4.5. Sordi e l’impietoso ritratto linguistico dell’italiano medio Nel parlato filmico degli anni cinquanta la componente straniera continuò a essere presente non meno che in quello del dopoguerra. Le situazioni che, nella rappresentazione di un’Italia pacifica e avviata a conquistare benessere interno e fascino oltre confine, inducevano popolani e piccolo–borghesi a cimentarsi maldestramente con le lingue straniere, non erano finalmente traumatiche, ma nascevano di solito dal contatto benevolo con forestieri in cerca di emozioni […]. L’uso di espressioni straniere ebbe finalità soprattutto comiche o bonariamente satiriche […]. Fu invece raro l’uso serio di lingue straniere87. Pochi attori più di Alberto Sordi hanno rappresentato i vizi e i vezzi dell’italiano medio (nella duplice accezione di lingua e di tipo umano) del dopoguerra. Un po’ come quella di Totò, ma in modo più realistico (ancorché non scevro da esagerazioni macchiettistiche) e meno teatrale, la comicità amara di Sordi si serve del contrasto tra lingua (nei suoi vari registri), lingue e italiano regionale per smascherare ora, bonariamente, le velleità di personaggi popolari (Nando Moriconi in Un giorno in pretura e in Un americano a Roma) o borghesi (Alberto nei Vitelloni), ora le mistificazioni soprattutto dei secondi (Il vedovo; Riusciranno i nostri eroi…). Benché in modo meno evidente e dirompente rispetto a Totò, anche al Sordi non regista va riconosciuto uno statuto quantomeno di coautorialità dei testi recitati. È palese, infatti, ripercorrendo quasi tutti i suoi personaggi, la propensione alla satira metalinguistica: evidentemente i registi più sensibili, a partire da Federico Fellini, e gli sceneggiatori (soprattutto il fedelissimo Rodolfo Sonego) decidono di sfruttare quelle corde già abbondantemente messe a punto dall’attore negli esordi del doppiaggio e delle produzioni radiofoniche. Data l’influenza di Alberto Sordi anche su alcuni modi di 87. RAFFAELLI (1996a: 324). 248 Il linguaggio cinematografico dire (entrati presto, proverbialmente, nella lingua comune), pare utile ripercorrere brevemente le tappe della sua carriera, non solo filmica, a partire da alcune sue dichiarazioni sul modo di intendere il linguaggio cinematografico. Sordi è un talento naturale, una centrale elettrica, la cui energia proviene da un bacino sociale di portata vastissima, mai eccedente i confini nazionali, possiede doti mimetiche difficilmente eguagliabili e, grazie alle sue capacità di osservazione, sa essere un filtro eccezionale di comportamenti collettivi88. Lo stesso Sordi, infatti, ben consapevole delle proprie capacità e del proprio ruolo nella storia del cinema italiano, ribadirà in più occasioni quest’esigenza realistico–critica: Non ero un virtuoso, ero un anonimo qualunque, perché assomigliavo alla gente comune. Mi rifiutavo di “recitare” in termini accademici, perché adottavo il linguaggio di tutti i giorni: nei film io “parlavo” come accade nella vita, entrando nel cuore degli spettatori89. E ancora, a proposito delle prime esperienze milanesi di recitazione “accademica” (fu rifiutato dall’Accademia dei Filodrammatici di Milano, a causa della marcata inflessione romanesca, salvo poi ricevere, nel 1999, il diploma honoris causa, «per essere diventato, senza alcuna tecnica acquisita dallo studio, l’attore che più di tutti rappresenta la realtà»)90: Ricordo che la mia insegnante di recitazione, all’Accademia dei Filodrammatici a Milano, mi rimproverava perché parlavo male. «Ma io parlo come parla la gente», le rispondevo. «Ma la gente non è l’attore», insisteva. «La gente guarda l’attore, e quando per strada lo sente parlare, si volta e dice ‘ma questo è un attore’. Gli attori devono far sentire al pubblico che sono attori, che recitano». E io: «Ma così perdo la mia naturalezza, 88. BRUNETTA (1991: 572). 89. SORDI (2000: 15). 90. SORDI (1999: 164). 4 – Lingua, lingue e dialetti 249 tutta la spontaneità». «Quella si acquista con la professionalità. Lei, comunque, deve parlare un linguaggio diverso da quello che parla la gente». Ma io, al contrario, cominciando a fare teatro, seppur da dilettante, capivo che dovevo limitare i miei entusiasmi, la frenesia di esibirmi, e sapermi invece rendere più accessibile al pubblico91. Alla domanda di Gloria Piccioni: «Qual è, secondo lei, la missione della comicità?», Sordi risponde: Rappresentare i problemi e le realtà della vita in modo liberatorio, così che la gente che vi si riconosce possa essere aiutata a superarli con un po’ d’ironia. E magari riuscire anche a tracciare una linea di comportamento, semplicemente mostrando certe negatività di cui, così, si diventa più consapevoli. Fornendo, insomma, sorridendo, una possibilità di redenzione92. Una comicità da commedia greca, insomma, o plautina: castigat ridendo mores. Non a caso, infatti, le interpretazioni migliori di Sordi, anche sul piano linguistico, sono quelle in cui sembra odiare i suoi personaggi, come vedremo, volerli demolire e mostrarne l’aspetto peggiore e recondito, non quelle in cui li ama o li compatisce (come nei film della vecchiaia e in quasi tutte le sue insipide regie). Non senza una buona dose di vanità, dunque («senza falsa modestia, credo Cento anni di storia di un italiano sia un affresco destinato a restare ai posteri»)93, Sordi si sentiva precursore di certe tendenze sociali e si considerava coautore, anche nei film scritti e diretti da altri, delle storie portate sul grande schermo: «Raccontare quello che succedeva alle persone, andando di pari passo con l’evoluzione del costume. […] Per me l’essenziale era attenermi alla realtà»94. «Ho sempre rappresentato le situazioni anticipandole, mai ricalcandole»95. In effetti, fin dal 91. 92. 93. 94. 95. PICCIONI (1999: 8–9). PICCIONI (1999: 28). PICCIONI (1999: 14). PICCIONI (1999: 10). SORDI (2000: 16). 250 Il linguaggio cinematografico 1966 (con Fumo di Londra), Sordi decise di passare anche dall’altra parte della macchina da presa. Già da anni partecipava attivamente ai soggetti e alle sceneggiature (almeno da Mamma mia, che impressione!, 1951, di Roberto L. Savarese), collaborando in particolar modo con Rodolfo Sonego, che scrisse per Sordi decine di film, a partire dal Seduttore, 1954, di Franco Rossi. Com’è noto, sull’apporto personale di Sordi anche a sceneggiature ufficialmente non sue, non c’è accordo tra le varie testimonianze: Monicelli tiene tuttora a precisare il ruolo determinante degli sceneggiatori e del regista, a scapito dell’attore; viceversa Suso Cecchi D’Amico. Anche sul potere condizionante di alcune scelte, soprattutto linguistiche, Sordi aveva ben visto: quante delle sue battute (pur se scritte da altri, è alla sua recitazione che debbono la celebrità) diverranno presto proverbiali? Oltre a quelle citate nel corso di questo paragrafo, si ricordino almeno le seguenti: «Ammazza che fusto!» (Un giorno in pretura, 1954, di Steno); auanagana (forse deformazione dell’inglese «I wonna go» ‘voglio andare’, Un americano a Roma, 1954, di Steno); «Ma chi te conosce a te? Pussa via/ brutta bertuccia!» (Il segno di Venere, 1955, di Risi); «Bboni! Bboni! State bboni!» (La grande guerra, 1959, di Monicelli); «E non ci facciamo sempre riconoscere!» (Il vedovo, 1959, di Risi, e, con minime varianti, in molti altri film). Il successo cinematografico di Sordi arriverà tardi (non prima degli anni Cinquanta, benché il primo film risalga al 1937: Il feroce Saladino, di Mario Bonnard), quando al comico già arrideva la fama come doppiatore e conduttore radiofonico. Sempre nel 1937 divenne la seconda voce italiana ufficiale di Ollio (Oliver Hardy), ma la sua carriera come doppiatore non si limitò alle comiche: lo riconosciamo come voce di Robert Mitchum, John Ireland, etc. e almeno, tra le tante voci doppiate del cinema italiano, nel biciclettaio di piazza Vittorio, in una scena di Ladri di biciclette, e, per i noti paradossi della postsincronizzazione (cfr. § 5.1.2), come voce di Marcello Mastroianni in Una domenica d’agosto, 1950, di Luciano Emmer. 4 – Lingua, lingue e dialetti 251 Nel 1947 esordisce alla radio nei programmi Rosso e nero e Oplà, entrambi condotti da Corrado Mantoni, e, dall’anno successivo, ha un programma tutto suo: Vi parla Alberto Sordi. Vi interpreta due bizzarri personaggi: Mario Pio e il conte Claro. Il primo era «un giovane di Azione Cattolica, con un tono petulante e perbenista che diventava fastidioso», al punto da portare i suoi interlocutori a insolentirlo; al che, nei suoi modi sempre educatissimi e affettati, prorompeva: «Dai, dai continua imperterrito, con questa sorta di vituperi»96. E «dai, continua imperterrito» diventerà ben presto il primo dei suoi segnali di riconoscimento, insieme con «compagnucci della parrocchietta», «mamma mia che impressione!» e altri. Fin da questo momento, Sordi entra nella storia linguistica nazionale a doppio titolo: come ritrattista delle incertezze del parlante italiano medio e medio–basso di fronte ai diversi livelli della comunicazione e come introduttore dei già citati sordismi. Vediamo qualche brano della lingua di Mario Pio: Accidenti aho come abbiamo già preso la velocità fantastica… Daje!… Mamma mia che impressione che me fa questa corsa sfrenata. Me pare di stare al cinematografo… Attento signó! Attento signó? Attento signó!97. Che si crede perché sa andare in automobile di potermi dire con una velocità fantastica questa sorta di vituperi? […] Dai dai continua imperterrito! […] Corri, corri da solo impeccatore delle genti, verso la meta di perdizione. Mamma mia che gente aho; gente proprio da manicomio sa, guarda pure io dove sono andato a capità. Da qualche mistificatore… C’erano almeno sette o otto agenzie sull’annunzio del giornale, che mi sono segnato pure l’indirizzo. So’ sempre padrone di andarci…98. Dai, dai, continua, continua pure imperterrito con questa sorta di invituperi. Ti approfitti non è vero? Ti approfitti della mia bontà che parlo sempre in cuore aperto in mia schiettezza e in 96. SORDI (2000: 14). 97. SORDI (2000: 31) 98. SORDI (2000: 34). 252 Il linguaggio cinematografico mio fulgido. Ma quello che ti devo dire te lo dico sai: imbecille imbecillone ci sei tu, maestro Bitonzo con la tua lingua incalunniosa, la tua bacchetta, il Panza e quell’Ester invergognosa, tiè… zan! zan!99. Segnaliamo le caratteristiche salienti di questo italiano composito: forme dotte e libresche (annunzio, genti, mistificatore), frasi fatte e parole–tormentone (fantastico), espressioni ecclesiastico–burocratiche costruite con una morfosintassi traballante, con errori di preposizione e omissioni di articolo («verso la meta di perdizione», «parlo sempre in cuore aperto in mia schiettezza e in mio fulgido»), regionalismi (dalle apocopi come capità, signó e so’ ‘sono’, al segnale discorsivo tipico di Roma: ahó) e tic, come quello di deformare alcune parole col prefisso in/m (impeccatore, incalunniosa, invergognosa, invituperi)100. Mentre Mario Pio agiva al telefono («Prondo Mario Pio// Con chi parlo/ con chi parlo io?»), il conte Claro (con gli stessi tic), nobile decaduto e scroccone, risponde alle lettere in un giornale e poi va a trovare di persona i mittenti: Io sono il conte Claro, tutti lo sanno non è vero? Sono un conte decaduto e in prima pagina mai nessuno mi c’ha veduto. Eppure nella mia vita, anche se sono sospettato, non ho mai fatto male neppure ad un animaletto… E così benché sia conte quando arriva l’ora de magnà me tocca restà a letto. M’intenda chi m’intenda ’sta frecciata da distanza. Comprendi l’importanza? Ma non ci improlunghiamo in argomenti che in un indomani potrebbero urtare la suscettibilità di alcuni ambienti di reportaggio101. L’ultimo suo programma radiofonico è del 1951: Il teatrino di Alberto Sordi. È impossibile parlare di Sordi trascurando le sue canzoni, ironiche e surreali, lontane dalla contemporanea melassa della 99. SORDI (2000: 80). 100. Che può ricordare il topos della nasalizzazione lanciato da Macario e commentato supra (§ 4.1.2). 101. SORDI (2000: 101–102). 4 – Lingua, lingue e dialetti 253 produzione italiana: «Alberto Sordi — secondo Gianni Borgna — si può considerare un innovatore della nostra musica leggera, perché ha riportato nelle canzoni l’ironia»102. Leggiamo i testi delle due più famose: Noneta e Il carcerato (ma si ricordino almeno anche Il gatto, Il milionario, Finalmente solo, Cerco una donna, Fanciulla): Noneneta, noneta / Ritmo, ritmo / O nonetina, nonetina mia, tu sei tanto stanca non puoi caminar / Ma ritmar, ritmar con me potrai. / O nonetina, nonetina mia / Tu sei paralitica / Ma ritmar, ritmar con me vorrai / O nonetina, nonetina, nonetina miaa… / Yes. Bato il taco non son mato / Bato le mani sì sì domani / Faccio uè, mi chiederà un passante cosa c’è / Cosa c’è cosa c’è / Scusi lei signore lei chi è? / Sono un carceratto / Perché questa domanda ma perché? / Ritmo sincopatto / Do–re–mi–fa–sol… la–si–do–re… mi–fa–sol–fa… mi–re–do–si–la–sol–fa–mi–re– do… / Gioco al base–ball / Sei un americano ? No son carceratto / Ritmo sincopatto / Ritmo ritmo / Faccio uè / Sì son carceratto miei signori cosa c’è / Ritmo ritmo sol per me… / Yes103. Spicca il gioco fonico dello scempiamento, che sembra fare il verso alle parlate settentrionali (venete), particolarmente divertente nel romano Sordi. Con tanto di ipercorrettismi: carceratto, sincopatto. Le norme metriche vengono infrante, con esibito distacco dalla regolarità della canzonetta italiana e comportando non poche difficoltà nei musicisti che dovettero coadiuvare Sordi, successivamente, nell’incisione di quei brani. Il contenuto dei testi, poi, rientra a pieno titolo nel filone dei nonsense (si pensi anche, come possibile modello, alle poesie petroliniane). Da quanto si è visto finora, il primo Sordi, a differenza dell’ultimo, non si presta alla facile stilizzazione del romanesco 102. SORDI (2000: 123). 103. SORDI (2000: 125, 127–128). 254 Il linguaggio cinematografico cinematografico. Infatti i suoi personaggi radiofonici e del doppiaggio ci tramandano ora l’italiano ai massimi livelli di formalità e di deregionalizzazione (doppiaggio, tranne Ollio), ora una mescidanza italo–inglese (Ollio), ora un italiano in bilico tra ambizioni di cultura e italiano regionale romano con inflessioni mediane (Mario Pio e il Conte Claro). La prima parte importante di Sordi, negli oltre 150 film da lui interpretati, è senz’altro quella di Mamma mia, che impressione!, 1951, di Savarese, sua ventiduesima pellicola. L’opera intende sfruttare, già nel titolo, il successo del personaggio Mario Pio, con le sue peculiarità linguistiche. Anche Totò e i Re di Roma, 1952, di Steno e Monicelli, attinge ai tic dello stesso personaggio: «con un fare indisinvolto». Sordi interpreta qui il sadico e viscido maestro Palocco. La sua lingua è volutamente affettata, composta di parole difficili, di frasi fatte e di espressioni bizzarre (burocratiche o formali), tra le quali ricordiamo: «Ti nascondi/ con fare furbesco» (a Totò); «Sono oltremodo radioso di vederla» (al capufficio); «In sua memoria»; «In sua vergogna»; «Il suo cuore in mia anima» e l’intercalare «Signor archivista capo», vessatorio nei confronti del povero Totò, che veste i panni dell’archivista Ercole Pappalardo, raccomandato senza licenza elementare. È questa l’unica occasione che i due grandi attori, Sordi e Totò, ebbero di recitare insieme. Entrambi così attenti alla componente linguistica, oltreché a quella mimico–scenica, pur con tutte le differenze che li distinguevano: il primo era più verbale e meno mimico del secondo, benché il secondo, con le parole, abbia giocato e innovato molto più del primo. Non sfuggano, peraltro, i numerosi tratti che li accomunavano: l’amore per il teatro, il VARIETÀ [→ Glossario], la canzone. Entrambi, all’inizio della carriera cinematografica, brillarono per una comicità del tutto lontana da quella corrente e, per questo, poco gradita al grande pubblico e alla critica ufficiale. Determinante fu per l’attore l’incontro con Federico Fellini: sempre del 1952 è infatti Lo sceicco bianco, dove Sordi interpreta, magistralmente, il ruolo eponimo dello sceicco eroe dei fumetti rosa, e dell’anno successivo è l’Albertone dei Vitelloni 4 – Lingua, lingue e dialetti 255 (entrambi i film saranno analizzati infra, § 6.1.4), suo primo vero grande successo di critica e di pubblico e ultima collaborazione con Fellini, se si esclude l’episodio di Roma, eliminato dal regista nelle copie per la distribuzione straniera del film. I toni e i modi del vitellone Alberto rimarranno per sempre attaccati a Sordi, che tuttavia non riuscirà più a ritrovare quel raffinatissimo equilibrio tra realismo e surrealismo, mai macchiettistico. Varie le scene memorabili del secondo film, dalla fame quasi mitica di Alberto (anche nel momento più tragico, durante la ricerca di Sandra, pensa solo a mangiare: «Se mangiassimo qualche cosa/ prima di uscire di città?») al celeberrimo Lavoratori?!, con pernacchia e relativo gesto scurrile del braccio ad ombrello. Da questo momento in poi la lingua di Sordi diventa un simbolo: l’italiano dell’uso medio con inconsce cadute nell’italiano regionale romano e con ambiziose salite ai piani più forbiti (nei film fino agli anni Settanta) e poi via via un romanesco sempre più greve (soprattutto nei film diretti da sé stesso), fino all’insopportabile iperromanesco autoreferenziale e volgare degli adattamenti da Molière e degli altri film storici (Nell’anno del signore…, 1969 e In nome del popolo sovrano, 1990, di Luigi Magni; Il malato immaginario, 1979 e L’avaro, 1990, di Tonino Cervi; Il marchese del grillo, 1981, di Monicelli, etc.), ritraggono alla perfezione personaggi dalla moralità più o meno vacillante. Proprio questo romanaccio rende i personaggi migliori di Sordi antipatici e patetici nel contempo e fornisce all’attore lo strumento per un’analisi talora lucidissima e spietata della società italiana. Sordi ha contribuito non poco, suo malgrado, a diffondere in tutta l’Italia l’antipatia nei confronti dei romani, ritenuti indolenti e immorali. Il pubblico e la critica più sprovveduti, infatti, non hanno saputo andare oltre l’allusione cinematografica, né hanno capito la componente simbolica del realismo sordiano: il romanaccio sciatto e sbracato, infatti, era funzionale a ritrarre un tipo morale italiano comune a Udine come a Palermo, a Bari come a Milano. I frutti linguisticamente più convincenti si colgono, non a caso, proprio nelle commedie all’italiana (la cartina al tornasole 256 Il linguaggio cinematografico delle nostre miserie sociopolitiche), tra le quali spiccano Il vedovo e Il vigile, 1960, di Zampa. Da quest’ultimo film trascriviamo tre brani. Nel primo, il vigile Otello (Sordi), spiega al figlio, in italiano standard, il proprio concetto di patria: SORDI: La patria è quella cosa che ti chiama sotto alle armi// Tu la servi rischiando la vita per undicj anni/ come ho fatto io/ e poi quando le guerre sono finite/ ti rileva la divisa/ e ti rimanda a casa disoccupato// E tu senza lavoro come mangi? Rubbi// E se rubbi la patria che fa? FIGLIO: T’arresta//. SORDI: Tu vuoi che tua madre vada in prigione? FIGLIO: No// SORDI: E allora io dico/ cara patria/ dammi un lavoro// E dammelo! Se poi io rifiuto/ mi metti in prigione come fanno i russi//. Il secondo brano vede Sordi alle prese con l’attrice Sylva Koscina, di fronte alla quale, parlando del figlio, lascia involontariamente trapelare tutta la propria indolenza e le proprie infantili fantasie di successo, tanto più inattuabili per la felice commutazione di codice finale, che precipita il discorso sul piano popolare (pisicologie) e dialettale: Ah/ sono contento! Me viene su bene// Ha molta inclinazione per la meccanica// Per i motori// Per i lavori materiali/ insomma/ vero? Io sono molto più portato per i lavori ideologici// La contemplazione/ l’osservazione/ la distensione/ vero? Guardare gli altri/ insomma/ ecco// Studiare le pisicologie umane// Se debbo confessare quali sono le mie tendenze/ debbo dire che sono più portato per… per l’arte// Il canto/ la musica/ recitare in teatro/ vero? Je faccio sentì na bella poesia? E infine il racconto fantasioso di un episodio storico, in cui anche nelle regali bocche sabaude viene infilato un calcato trasteverino: Siamo a Peschiera nel novembre del lontano 1912// È notte// Un mare de nebbia// C’è la polveriera/ e tutte le sentinelle intorno// I’ re/ di passaggio a Peschiera/ dorme all’albergo 4 – Lingua, lingue e dialetti 257 Bellavista insieme ’a reggina// Ae tre de notte/ ’a reggina se sveja e nun trova più e’ re ne’ letto// Accenne ’a luce/ e vede e’ re che se sta infilanno i pantaloni// Ando vai/ dice ’a reggina// Ando me pare/ dice e’ re// Ma che cj hai ’n’amante pure qui a Peschiera? E lasseme perde/ dice e’ re// Vado a sospenne ’e sentinelle che stanno de guardia// Ma che t’hanno fatto/ que pore sentinelle che magari a quest’ora stanno a dormì// E proprio pe questo/ dice e’ re// Le vojo mette aa prova//. Come s’è detto, il primo vero successo di Sordi fu quello dei Vitelloni, film che tra l’altro, secondo il volere della produzione, avrebbe dovuto escluderlo dal cast («Sordi è così antipatico al pubblico che può addirittura compromettere, con la sua presenza, l’esito del film»)104: Allora la comicità era ancora concepita come “opera buffa”: si scrivevano dei copioni con le gag, le cadute, le torte in faccia, e quando il comico si presentava in pubblico doveva essere immediatamente riconoscibile: con la bombetta, i baffetti, alto, grasso, gobbo, la testa grande ecc. Io impersonavo personaggi con delle caratteristiche particolari105. Sordi, in effetti, aveva un aspetto fisico troppo normale, anzi tendente al belloccio, caratteristica decisamente imperdonabile in un comico: dopo l’affermazione dei Vitelloni, apparve come un attore che non apparteneva né all’una né all’altra categoria. Era diverso da ambedue i generi e stranamente sospeso fra due mondi: troppo realista, amaro e attraente per essere un comico secondo il cliché tradizionale, troppo mordace e grottesco per essere un protagonista del cinema serio106. E poi, soprattutto, i suoi personaggi erano tutt’altro che buoni e rassicuranti e rasentavano, talvolta, la malvagità (senza 104. LIVI (1967: 85). 105. SORDI (2000: 15). 106. LIVI (1967: 95–96). 258 Il linguaggio cinematografico tuttavia mai raggiungere le punte del comico–nonsense–parodia–horror segnate, anche in questo, dal Totò di Che fine ha fatto Totò baby?, 1964, di Ottavio Alessi: in Totò la cattiveria si fa quasi surreale, mentre la negatività dei personaggi sordiani è sempre molto realistica). La caratteristica che accomuna tutti i ruoli di Sordi è la viltà, che, come disse Fellini, è quella «tipica del giovanotto cresciuto sotto il fascismo e buttato dentro una democrazia che non capisce»107. Più volte l’attore–autore ammise di trovarsi a suo agio nello smontare i personaggi negativi: Nasceva così, fra il ’54 e il ’60, l’eroe negativo che appassionava, divertiva, e che, per la prima volta da quando il cinema italiano era nato, provocava nel pubblico una catarsi alla rovescia: la catarsi dei difetti, dei cattivi sentimenti108. Soltanto un pubblico sempre più italofono poteva essere in grado di apprezzare una comicità che mettesse alla berlina le miserie anche linguistiche degli italiani. E questo non poteva accadere prima della metà degli anni Cinquanta. Tra il menefreghismo dei personaggi felliniani e l’immoralità di quelli della Commedia all’italiana, incontriamo l’indimenticabile macchietta dell’americanomane (divertito omaggio a Hollywood, tra l’altro) Nando Moriconi (pronunciato Mericoni nel secondo film), prima in Un giorno in pretura e poi in Un americano a Roma. Se in Totò l’uso delle lingue straniere era un pretesto per lo stravolgimento verbale di ascendenza teatrale, nei personaggi interpretati da Sordi l’antecedente di riferimento è senza dubbio interno al cinema stesso, con le superproduzioni western e spettacolari d’oltreoceano. La lingua di Nando, nel secondo film, è composita: 1) inglese, 2) inglese italianizzato e maccheronico, 3) “doppiaggese”. Ne trascriviamo qualche stralcio: A un poliziotto: «Abbito in questa house/ vero// Sono di questi luoghi//». 107. LIVI (1967: 103). 108. LIVI (1967: 105). 4 – Lingua, lingue e dialetti 259 Al padre: «Shut up/ pappy! C’è il tutore notturno/ qua// […] Hallo papy/ hallo papy/ non me fa disperà mamy sai/ mannaggia! […] Tra poco my father/ questo tuo boy/ andrà in America/ andrà//». Alle ballerine: Hallo girls// Ok vuol dire in ammericano molto bene vero/ abbituarsi a queste espressioni ammericane/ perché se rispondete sempre con la vostra abituale maleducazione/ io queste tavole del palcoscenico ve le faccio pistare tutta la night! Ok girls? […] Allegre girls/ mister commenda ha assicurato due minestroni a testa/ siete contente? Allegria//. A un gatto: Gattomammone// Mi sono accorto sai// Fai finta a legge il giornale/ ah/ sei una spia/ sei/ vuoi cantare? Canta i salmi// (fingendo di sparare al gatto e poi prendendolo in braccio) Tang! Tang! Tang! Ti devo sopprimere! Odo dei passi// Sei stato tu gattomammone? Hai cantato? Tiè! Becca ’sto regaluccio// Tang! Tang! Tang! Io m’apposto//. Si noti, nell’ultimo esempio, il chiaro riferimento allo stile linguistico dei doppiaggi western. Come insulto a un uomo: «Ormai hai ventun anni// È tempo che tu sappia di chi sei figlio//». Alla fidanzata Elvira: «Hello Elvy/ give me a kiss my darling//». A Molly: Darling// Look at me// Guardami negli occhi// […] Quando m’hai dato il tuo piper/ (paper ‘biglietto da visita’) e m’hai invitato a quest’approccio/ cosa covavi/ nella tua testolina? […] Quando tu mi luccasti/ quella sera/ vero/ con quei tuoi occhietti da cinese/ io capii subito che c’era un fosco desiderio/ vero// Capii dal lampeggiar//. Si segnalano gli adattamenti approccio, da approach, e luccasti, da looked, oltre ai cultismi (d’accatto) covare, fosco, lampeggiar. E infine la celeberrima scena dei maccheroni: 260 Il linguaggio cinematografico Iih! Maccaroni! Maccaroni/ questa è robba da carettieri! Io non magno maccaroni/ io sono ammeregano/ sono// Vino rosso/ io non bevo vino rosso// Lo sapete che sono ammeregano! Gli ammeregani non bevono vino rosso/ non magnano magaroni// Gli ammeregani magnano mammelatta/ mammelatta/ questa robba da ammeregani/ yogurt/ moustada… Ecco perché gli ammeregani vincono gli Apaches/ combattono gli indiani// Gli ammeregani non bevono vino rosso/ bevono il latte/ apposta non s’embreacano// Che avete visto mai un ammeregano ’mbriaco voi? Io non l’ho visto mai un ammeregano ’mbriaco// Gli ammeregani sono forti/ ’mazza gl’ammeregani ahó! Non puoi mica combattere contro gli ammeregani// Gli ammeregani mangiano mammelatta/ maccaroni! ’Naggia ahó/ (rivolgendosi al piatto di pasta) ti distruggo sai/ magarone! Che mi guardi/ con quella faccia intrepida? Mi sembri un verme/ magarone// Questa è robba da ammeregani/ vedi? Yogurt/ mammelatta/ moustada/ la moustarda// What a senai la moustada// ’N po’ de latte// Questa è robba che magnano gli ammeregani/ vedi? Robba sana/ (addenta il panino appena preparato) sostanziosa/ maccarone// ’Mmazza che zozzeria// (sputa il panino disgustato) Gli ammeregani oh! Maccarone/ m’hai provocato/ e io te destruggo/ adesso maccarone// Io me te magno! (mangia una forchettata di pasta e posa in terra il latte) Questo lo damo ar gatto/ (posa lo yogurt) questo al sorcio/ (posa la senape) questo ammazziamo le cimice/ (bevendo il vino) e io bevo er latte// So’ ammeregano io// Verme! Io me te magno! Sordi tornerà a cimentarsi spesso con le lingue straniere, soprattutto l’inglese e il francese (ma più d’ogni altra l’“italiese”, ovvero l’italiano impropriamente mescolato all’inglese), quasi sempre assai rudimentalmente apprese da autodidatta o semplicemente orecchiate, rappresentando perfettamente la superficialità, l’arte di arrangiarsi ma anche la creatività prettamente italiche (Guardia, guardia scelta, brigadiere e maresciallo, 1956, di Mauro Bolognini; Souvenir d’Italie, 1957, di Antonio Pietrangeli; Brevi amori a Palma di Majorca, 1959, di Giorgio Bianchi; Un italiano in America, 1967, dello stesso Sordi, e molti altri). Tuttavia i risultati raggiunti non saranno mai esilaranti quanto quelli di Un americano a Roma. Nel Tassinaro, 1983, di Sordi, ecco come si rivolge al cliente americano: 4 – Lingua, lingue e dialetti 261 Un little precisation, America. Voi americani dite sempre la parola bastardo, lo sai perché? V’o dico io. Perché c’avete una lingua molto, ma molto povera. Perché se io mi volessi abbassare a rispondere al tuo bastard, che a noi ce fa proprio ride, io ti potrei dare del figlio di madre ignota, del rotto nel posteriore, ti potrei mandare a fare nel medesimo, potrei fare appello anche ai tuoi morti, con eventuale partecipazione de tu nonno in carriola opzionale e coinvolgere anche tua sorella, notoriamente incline allo smandrappo e all’uso improprio della bocca, e allargà il discorso a quel grandissimo Toro Seduto de tu’ padre, a sua volta figlio di una città di cinque lettere cantata da Omero, che tu ’n sai manco chi era perché sei ignorante. Are you ignorant! […] Non alza voice with me, perché tu fai tremare me pizzo de camicia, you understand pizzo de camicia? No, no, no, tu non meni a nessuno, perché I bring my chiav english and I give in your fronte109. In Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, 1971, di Zampa, abbiamo un’altra felice stilizzazione dell’italiese, stavolta per fare il verso non all’esterofilo, bensì all’emigrato. Ecco qualche battuta: Al barbiere: «E non me fa sempre ’a sfumatura alta// Like Italian style//». All’amico Giuseppe: «Ognuno fa i business sui/ e a me nessuno ce pensa!». Alla suora infermiera francese: «Sister/ please// Dove sono le mie baggages? […] E la borsetta dove is? […] Hai visto sister se c’è tutta la moneta/ yes? C’è l’argent?». Bellissimi e abbastanza verosimili anche i calchi (floro da floor ‘pavimento’) e il code–mixing tipici degli emigrati: (a Carmela, Claudia Cardinale, parlando della propria casa) È piccola/ è di legno// Tutta dipinta a mano// Ma ci sono tutti i confòrt/ sai? Una kitch economica che si spegne da sola/ un fridge/ yes? Un fero da stiro/ la macchina da cucire/ e il floro/ il pavimento/ è tutto colorato//. 109. SORDI (2000: 229). 262 Il linguaggio cinematografico E, più avanti, in uno sfogo con i passeggeri del treno, dopo aver appreso che Carmela è una prostituta: No beer/ no coffee/ non cigarettes/ to bring her from Italy// Undicj anni/ senza entrare in un pabbi// Senza drink un coffee/ sempre risparmiare/ me so’ fumato le radici per mettere su una casa/ piena di confòrt/ una kitch economica/ un fero da stiro/ una macchina da cucire/ yes? Me da na coltellata a sangue freddo/ right? E poi te dice che è una mignotta che batteva er marciapiede? Anche altre lingue e altri dialetti passano, all’occasione, sotto la lente deformante di Sordi, benché l’attore rimanga legato essenzialmente all’italiano–romano, differentemente dal funambolismo verbale di matrice plurilinguistica ed espressionistica di un Totò, ma anche di un Gassman o di un Giannini, perfette “macchine” imitative di tutti i dialetti italiani. Nel già citato Vedovo, per esempio, il milanese della moglie (Franca Valeri), del Lambertoni e di altri è oggetto di scherno: «Ma cosha fa chi a Milan cu ’stu caldo?!»; «Avrei bisogno di una tua firmètta//»; «Permette/ shür cumendatur!»; «Andé a lavurà»; Lambertun!; «È strano/ nè?» (con ingiustificato piemontesismo). Stessa sorte spetta al romagnolo della sua amante: «Andé a magné i turtelèn!». In Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?, 1968, di Scola, è la volta, infine, delle mescidanze italo–francesi («Quelle horreur! Io sto a casa mia// Faccio/ e dico quello che mi pare// E chi n’est pas d’accord/ se ne peut aller// Ça va bien?») e italo–romano–ispano–portoghesi («Por favor! Per favor! Meu signor/ che fasite? Es proprietà privada// È robba mea! Ma non è contrabbando/ es indumento personal!»), felice contrappunto all’italiano pomposo delle note di viaggio, che, oltre ad ammiccare metafilmicamente al doppiaggio delle grandi produzioni di avventura hollywoodiane ben presenti al doppiatore Sordi, mettono a nudo le ambizioni frustrate del borghese mai affrancatosi del tutto dalla retorica e dallo stile di vita fascisti: 4 – Lingua, lingue e dialetti Appunti di viaggio numero sette// Dopo alcuni goffi tentativi di mettere in moto a spinta la Land Rover/ Regina del deserto/ ci siamo accampati precisamente a quindici/ forse a venti/ anche a trenta chilometri da Mingu// Dormiremo all’addiaccio/ circondati dal buio e dall’ignoto// Le ombre della notte/ ci sono piombate addosso di colpo// Accade/ qui ai tropici// Nell’aria misteriosa/ si ode d’istinto lontano un ossessivo tam tam// Un messaggio? Un avvertimento? 263 5. IL “DOPPIAGGESE”1 5.1. Cenni storici, tecnici e teorici 5.1.1. Il presente capitolo sembrerà, a una prima visione d’insieme, eccessivamente lungo, nell’economia di un volume dedicato al cinema italiano. In realtà abbiamo già detto che il primato dei film distribuiti nel nostro paese, e non soltanto negli ultimi decenni, spetta al cinema americano2: è la lingua doppiata, dunque, ad aver inciso più profondamente sulle abitudini verbali degli italiani. Inoltre i problemi interlinguistici e intersemiotici posti dalla pratica dell’adattamento e del doppiaggio (che è forse, indipendentemente dalla qualità dei risultati ottenuti, la creazione più originale della storia linguistica del cinema) sono paradigmatici della complessità comunicativa e testuale del cinema tout court, oltreché della traduzione in generale (e forse addirittura della postmodernità, con i giochi immotivati dell’arte combinatoria), e pertanto ben si prestano a 1. Così, tra l’autoironico e lo spregiativo, gli addetti ai lavori chiamano l’italiano ibrido (tra falsa colloquialità fatta tutta di calchi e stereotipi, pronuncia impeccabile e formalismo) specifico del doppiaggio. Tra i tanti ad usare il neologismo, GATTA (2000: 88 n. 2). 2. «[L]’80 per cento della programmazione cinematografica e il 90 per cento della fiction trasmessa in televisione in Italia è costituito da opere straniere», per la maggior parte prodotte negli Stati Uniti (HEISS 1996: 24). Queste percentuali, con qualche oscillazione di anno in anno, sono confermate anche oggi: cfr. PAOLINELLI/DI FORTUNATO (2005: 23–33). 265 266 Il linguaggio cinematografico un’ampia esemplificazione e a un commento disteso in questa sede: Le possibilità dell’arte combinatoria non sono infinite, ma non di rado sono spaventose. I greci generarono la chimera […] i geometri dell’ottocento l’ipercubo […] Hollywood ha adesso arricchito questo vano museo teratologico; per opera di un maligno artificio detto doppiaggio propone mostri che combinano le illustri fattezze di Greta Garbo con la voce di Aldonza Lorenzo [Tina Lattanzi, in Italia]. Come non pubblicare la nostra meraviglia davanti a questo prodigio penoso, davanti a queste industriose anomalie fonetico–visive?3. Ma perché illudersi che il cinema sia davvero opera d’arte totale e oggetto universale, e non anche (o solo) un testo–Frankenstein costruito per assemblaggio precario di diversi corpi ed elementi, immesso in un mercato dove la pratica della combinazione continua smembrandolo e ricomponendolo in testi ulteriori. […] Le loro voci [dei nostri doppiatori] formano il più importante tratto unificante sovratestuale (cioè eccedente un singolo testo, o la singola opera di un regista) agente all’interno del cinema italiano […]. Per ovvie e giustificate che siano le reazioni e le difese puristiche di “autori” e “critici”, e per lodevoli che siano le crociate in difesa dell’integrità dell’opera, il doppiaggio ha però lavorato e funzionato avanguardisticamente a favore dell’opera aperta molto più di qualsiasi teorizzazione di Umberto Eco4. Tant’è vero che negli ultimi anni sono fioriti corsi universitari in Traduzione multimediale per il cinema e la televisione, in cui si formano traduttori specializzati per gli adattamenti audiovisivi, e la trasposizione filmica è utilizzata sempre più spesso come strumento didattico per l’insegnamento linguistico 5. 3. Luis Borges in MARASCHIO (1982: 138). 4. GHEZZI (1995: 139, 218). 5. Si veda per esempio il corso post–laurea in Traduzione multimediale per il cinema e la televisione istituito dalla SSLiMIT (Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori) di Forlì (Università di Bologna), a partire dal 1996; frutti di quel corso sono almeno HEISS/BOLLETTIERI BOSINELLI (1996) e BOLLETTIERI BOSINELLI/HEISS/SOFFRITTI/BERNARDINI (2000). Sull’utilizzazione didattica del cinema per l’insegnamento dell’italiano, cfr. quanto già detto nel § 4.1.1 n. 4. 5 – Il “doppiaggese” 267 Cimentarsi con i testi degli adattamenti cinetelevisivi e colloquiare con gli adattatori costituisce spesso, per lo studioso di linguistica, un salutare passaggio dalla teoria alla pratica e permette di constatare che, bene o male, gli annosi temi della norma grammaticale, della fedeltà all’originale, dei molteplici livelli del testo e simili non sono freddi cimeli da biblioteca, bensì il pane quotidiano per alcune categorie professionali. 5.1.2. La storia del parlato filmico italiano è intimamente legata, fin dai primordi del sonoro, alla pratica del doppiaggio6. Abbiamo già detto (§ 2.1) come, addirittura, il doppiaggio nasca in realtà prima ancora del sonoro, dati i casi, abbastanza frequenti, di attori che, dal vivo, nascosti dietro il telone, recitavano le battute in sincronismo labiale con i personaggi del film. Ma alla tecnica della postsincronizzazione propriamente detta, intesa come incisione di una nuova colonna sonora sostituita, almeno per quanto riguarda i dialoghi, a quella originaria, si arrivò abbastanza tardi (più o meno stabilmente nel 1931, salvo singoli esperimenti precedenti, vale a dire quattro anni dopo il primo film parlato) e mediante percorsi tortuosi. L’invenzione del sonoro recò immediatamente il problema dell’esportazione dei film, ovvero della loro traduzione. La soluzione scelta in un primo momento fu quella che sembrava la più rapida ed economica: l’ammutolimento delle pellicole (visto che a partire dal decreto–legge 11 febbraio 1923, cit. nel § 2.4.2, l’uso pubblico di parole straniere, scritte o parlate, era colpito da straordinari oneri fiscali e dal 1930, con espresso riferimento al cinema, era del tutto vietato)7 e il ripristino dei car6. La storia del doppiaggio può essere letta soprattutto in QUARGNOLO (1967) e (1986); CALDIRON/HOCHKOFLER (1981); GUIDORIZZI (1986) e (1999); QUAGLIETTI (1991: 51–59); CASTELLANO (1993) e (2000). I fenomeni semiologici e linguistici dell’adattamento cinetelevisivo sono invece affrontati principalmente in SHOCHAT/STAM (1985); C AMERINI /B IARESE (1986); BACCOLINI /B OLLETTIERI B OSINELLI /G AVIOLI (1994); HEISS/BOLLETTIERI BOSINELLI (1996); ROSSI (1999d); BOLLETTIERI BOSINELLI/HEISS/SOFFRITTI/BERNARDINI (2000); PAVESI (2006). 7. Dopo un’iniziale tolleranza nei confronti dei film cantati in lingua straniera (il doppiaggio italiano ha preferito doppiare, di norma, fino agli anni Cinquanta, anche le 268 Il linguaggio cinematografico telli con didascalie in italiano. Il capolavoro di King Vidor Alleluja (Hallelujah), 1929, uscì nel 1930 in Italia privo del sonoro e «con didascalie posticce e intollerabili» 8. Non è difficile immaginare che il pubblico mal s’adattasse a rinunciare, prima ancora di esservisi assuefatto, alla novità, tanto fragorosamente pubblicizzata, dei film parlati al cento per cento (che, per la satira dell’epoca, erano ormai diventati «letti al cento per cento»)9. Fu così che si studiarono alternative quali la conservazione della COLONNA [→ Glossario] originale (fuori legge, con pochissime eccezioni, come s’è detto) e l’adozione delle didascalie (non amate dal nostro pubblico per il noto tasso di analfabetismo), l’impiego di una voce–traduzione fuori campo e infine il metodo più costoso di tutti: la realizzazione di versioni multiple. Nel 1930 la Paramount aprì uno studio in Francia, a Joinville, appositamente realizzato per questo tipo di riprese. La tecnica consisteva nel girare una stessa scena — invariati il soggetto, la scenografia e i costumi — parlata in lingue diverse; solitamente cambiava il regista e molto spesso anche gli attori. Insomma, per permettere a pubblici di lingue diverse di comprendere lo stesso film, lo si rigirava interamente tante volte quante erano le lingue richieste, fino a più di dieci versioni!10. canzoni dei film, soluzione oggi ammissibile quasi soltanto per il cinema di animazione, che assegna alla musica una componente testuale e commerciale primaria: cfr. DI GIOVANNI 2000) e di quelli di argomento sportivo, celebrativo, militare e simili, «l’ufficio di revisione fece divulgare il 22 ottobre 1930 la comunicazione di norme più rigide che sarebbero rimaste definitive: ‘Il Ministero dell’Interno ha disposto che da oggi non venga accordato il nulla osta alla rappresentazione di pellicole cinematografiche che contengano del parlato in lingua straniera sia pure in qualche parte e in misura minima. Di conseguenza tutti indistintamente i films sonori, ad approvazione ottenuta, porteranno sul visto la condizione della soppressione di ogni scena dialogata o comunque parlata in lingua straniera’» (RAFFAELLI 1992: 191). Come si vede, la comunicazione non fa riferimento a didascalie in lingua italiana. 8. RAFFAELLI (1992: 82 n. 49). 9. QUARGNOLO (1967: 66). 10. Così Mario Camerini descrive la sua esperienza di regista italiano per i film a edizioni plurime: «Una follia. La Paramount a Parigi aveva, agli inizi del sonoro, degli stabilimenti a Joinville: si giravano di seguito, sullo stesso set, con la macchina fissa, con i posti stabiliti, dodici o tredici versioni diverse. Io andai con Carmen Boni e Pilotto, facevo le mie scene e uscivo. Poi veniva il regista tedesco, poi quello spagnolo, poi 5 – Il “doppiaggese” 269 Dati i costi rovinosi di una simile operazione, gli stabilimenti di Joinville chiusero dopo soltanto un anno di attività. Tra i film in versione multipla si ricordano almeno: The Lady Lies, 1929, di Hobart Henley, rigirato in francese (Une femme a menti, 1930, di Charles de Rochefort), italiano (Perché no?, 1930, di Amleto Palermi), spagnolo (Doña Mentiras, 1930, di Adelqui Migliar), tedesco (Seine Freundin Annette, 1930, di Felix Basch), svedese (Vi Två, 1930, di John W. Brunius); Il segreto del dottore, 1930, di Jack Salvatori, versione italiana di The Doctor’s Secret, 1929, di William C. de Mille; La donna bianca, 1930, di Jack Salvatori, versione italiana di The Letter, 1929, di Jean de Limur; Il richiamo del cuore, 1930, di Jack Salvatori, versione italiana di Sarah and Son, 1930, di Dorothy Arzner; Il grande sentiero, 1930, versione italiana di The Big Trail, 1930, realizzata dal medesimo regista Raoul Walsh; La vacanza del diavolo, 1931, di Jack Salvatori, versione italiana di The Devil’s Holiday, 1930, di Edmund Goulding; La riva dei bruti, 1931, di Mario Camerini, versione italiana di Dangerous Paradise, 1930, di William A. Wellman; Luigi… la volpe, 1931, versione italiana di Men of the North, 1930, realizzata dal medesimo regista Hal Roach, girato anche in francese, tedesco e spagnolo. Va ricordato anche La segretaria privata, 1931, di Goffredo Alessandrini, rifatto sulla base di tre versioni multiple preesistenti dello stesso anno: Die Privatsekretärin, di Wilhelm Thiele, The private secretary e La secrétaire privée11. Il film più celebre tra quelli girati in versione multipla è senza dubbio Muraglie, 1931, di James Parrott, copia italiana di Pardon Us (parodia di Carcere [The Big House], 1930, di Geor- quello francese e così via» (PAOLINELLI/DI FORTUNATO 2005: 5). Cfr. anche quanto raccontato da Camerini in SAVIO (1979: I, 203–226): secondo il regista, a Joinville si arrivava a girare fino a venti copie, in lingue diverse, dello stesso film (p. 207). Su Joinville cfr. anche PAVOLINI (1936) e QUARGNOLO (1986: 33–34). Film in versione multipla furono girati anche negli stabilimenti cinematografici italiani e tedeschi (cfr. RAFFAELLI 1992: 192 n. 57). 11. Secondo la testimonianza di Goffredo Alessandrini riportata in SAVIO (1979: I, 6–56: 11–13). Dati filmografici diversi in BERNARDINI (1992: 6). 270 Il linguaggio cinematografico ge Hill), primo lungometraggio [→ Glossario, METRAGGIO] della coppia di comici Stanley Laurel e Oliver Hardy (in Italia, Stanlio e Ollio), che, in Muraglie, recitarono in italiano in presa diretta. Quella loro lingua così incerta, con accenti sbagliati (come il celeberrimo stupìdo) e consonanti deformate, lungi dall’essere un insuccesso come paventato dalla produzione, piacque invece a tal punto al nostro pubblico che nei film successivi, in seguito all’“invenzione” del doppiaggio, le varie coppie di postsincronizzatori italiani (Carlo Cassola e Paolo Canali, Alberto Sordi e Mauro Zambuto, Giuseppe Locchi e Elio Pandolfi, Sergio Tedesco e Renato Turi) dovettero sempre tentare di imitarla, contribuendo così alla formazione dello stereotipo dell’italiano parlato da anglofoni. Anche il primo film sonoro italiano (La canzone dell’amore, 1930) fu girato in versione multipla: in italiano (diretto da Righelli), in tedesco (Liebeslied, diretto da Costantin–J. David) e in francese (La Dernière berceuse, diretto da Jean Cassagne). Una tarda appendice della tecnica delle versioni multiple si ha con il film propagandistico Condottieri, 1937, di Luis Trenker, realizzato in copia italiana (nota anche col titolo di Giovanni dalle bande nere) e tedesca (col medesimo titolo di Condottieri e girata dallo stesso regista). Ancora a proposito della distribuzione all’estero dei film prima dell’avvento del doppiaggio, ricordiamo che il primo film sonoro, The Jazz Singer, 1927, di Alan Crosland, fu presentato in Italia, con il titolo Il cantante di jazz, per la prima volta al Supercinema di Roma nell’aprile del 1929 con i dischi originali e, per facilitarne la comprensione, con l’inserimento di cartelli contenenti didascalie in italiano. «Il film ebbe grande successo: nessuno sembrò accorgersi che l’introduzione dei cartelli aveva obbligato a sacrificare pezzi di scena per non perdere il sincronismo»12. Per la distribuzione italiana di Marocco (Morocco), 1930, di Joseph von Sternberg, con Marlene Dietrich, vennero 12. PAOLINELLI/DI FORTUNATO (2005: 5). 5 – Il “doppiaggese” 271 invece aggiunte, da un anonimo regista nostrano, scene nelle quali gli attori Oreste Bilancia e Alberto Capozzi, vestiti da ufficiali della Legione, commentavano l’azione in italiano. Il 1932 segnò l’abbandono quasi definitivo di tutte queste scomode tecniche di “adattamento” linguistico, ad eccezione dei sottotitoli13. Sulla nascita della postsincronizzazione non c’è accordo; pare comunque che negli Stati Uniti si doppiasse già nel 1929, a partire da Fox Movietone Follies of 1929, di David Butler, doppiato in italiano dalla Fox (Maritati a Hollywood), con adattamento dei dialoghi di Louis Loeffler (montatore e regista, sposato con un’italiana), in collaborazione con Augusto Galli14. L’“inventore” del doppiaggio è considerato Jacob Karol, che estese alle voci la tecnica della postsincronizzazione del resto già impiegata fin dal 1928 per sincronizzare con le immagini suoni e rumori registrati a parte, anche se a contendergli il primato contribuiscono tanto l’ingegnere americano Edwin Hopkins (o Koplinks) quanto Oskar Messter, padre dell’industria cinematografica tedesca, il quale il 16 ottobre 1929 aveva ottenuto un brevetto che recitava: «Un testo viene proiettato simultaneamente al film, per aiutare lo speaker o il cantante nella post–sincronizzazione»15. I film americani destinati alla distribuzione italiana vennero, dapprima, doppiati oltreoceano. Se ne occupavano perlopiù italoamericani con conoscenza assai sommaria della nostra lingua e con conseguente inserimento di errori, dai calchi semantici alla pronuncia sensibilmente difforme dalla norma, anche per via delle inconsapevoli interferenze dialettali di origine16. Contro questi “soprusi”, ma anche per ostacolare l’importazione dei 13. Quasi soltanto nei documentari, nelle interviste o in alcuni film presentati nei festival, si adotta anche la tecnica cosiddetta VOICE OVER [→ Glossario] o oversound, ovvero della voce (o voci) fuori campo che traduce il dialogo originale, pure udibile in sottofondo e leggermente anticipato rispetto alla voce–traduzione. 14. Cfr. QUARGNOLO (1986: 41). 15. PAOLINELLI/DI FORTUNATO (2005: 6). 16. Cfr. Goffredo Alessandrini in SAVIO (1979: I, 15–16). 272 Il linguaggio cinematografico film stranieri e per controllarne meglio il consumo in patria (con eventuale rassettatura ideologica, in sede di doppiaggio)17, il governo sancì l’obbligo di realizzare la versione postsincronizzata esclusivamente in Italia, con il decreto–legge 261 del 5 ottobre 1933, convertito nella legge 320 del 5 febbraio 1934 che recitava: «È vietata la proiezione nelle sale del Regno delle pellicole cinematografiche sonore non nazionali il cui adattamento supplementare in lingua italiana sia stato eseguito all’estero»; la legge disponeva inoltre che «la totalità del personale artistico e 17. Se il ruolo della censura fu dapprima abbastanza blando, per via dell’esiguo numero delle sale equipaggiate per le proiezioni sonore (appena 120 su 3000: cfr. RAFFAELLI 1992: 190 n. 3), non mancano, verso la fine del regime, episodi clamorosi, come quello di Casablanca, 1943, di Michael Curtiz, che viene distribuito in Italia nel 1946 dopo essere stato pesantemente rimaneggiato: le armi vendute da Rick agli etiopi contro l’aggressione dei fascisti italiani vengono, invece, vendute ai cinesi; l’italiano Ferrari, leader delle attività illegali a Casablanca, viene francesizzato in Ferrac; la battuta di Laszlo: «avete combattuto contro i fascisti in Spagna» sfuma in «avete combattuto per la democrazia in Spagna»; il personaggio del capitano Tonelli che fa il saluto romano al capitano Renault viene tagliato e altro ancora (cfr. MEREGHETTI 2005: 468; interi brani del film originale, con relativo adattamento italiano, sono trascritti in PAOLINELLI/DI FORTUNATO 2005: 14–17). Già nel 1938, Marco Polo fu trasformato in scozzese, per mascherare il ritratto sfavorevole degli italiani: Uno scozzese alla corte del Gran Kan (The Adventures of Marco Polo), 1938, di Archie Mayo. Notevoli, inoltre, anche dopo il crollo del regime, alcuni palinsesti onomastici del doppiaggio volti a deitalianizzare i nomi dei delinquenti filmici: il gangster Johnny Rocco viene ribattezzato Johnny Rocky, nell’Isola di corallo (Key Largo), 1948, di John Huston; il gangster Martino Roma diventa Martino Rosky, nell’Urlo della città (Cry of the City), 1948, di Robert Siodmark; l’associazione criminale Mano Nera, nel film La Mano nera (Black Hand conosciuto in Italia anche come La legge del silenzio), 1950, di Richard Thorpe, diventa spagnola (il doppiaggio italiano trasferisce l’assassinio del poliziotto da Napoli a Cuba), a scapito di tutti i riferimenti italiani disseminati nel film (canzoni napoletane, immagini del Vesuvio, gondole e torre di Pisa; cfr. FINK 1985: 214–215 e MEREGHETTI 2005: 1546–1547). Un altro caso scandaloso è quello di Marijuana (Big Jim McLain), 1952, di Edward Ludwig: prodotto durante la Guerra Fredda e in pieno maccartismo, il film, che trattava la storia di un complotto di comunisti antiamericani, venne distribuito in Italia non soltanto con il titolo modificato, ma anche con una sostanziale alterazione della trama, diventando così una storia di narcotrafficanti (PAOLINELLI/DI FORTUNATO 1995: 18). I cambiamenti apportati dagli odierni adattatori alla versione originale del film sono perlopiù limitati all’enfatizzazione della pronuncia regionale di qualche personaggio, come accade, per esempio, in Un uomo da marciapiede (Midnight Cowboy), 1969, di John Schlesinger, in cui il personaggio interpretato da Dustin Hoffman si chiamo Ratso nell’originale ma Sozzo nella versione italiana, dove il solito Ferruccio Amendola parla con marcato accento meridionale. Altri esempi saranno commentati oltre. 5 – Il “doppiaggese” 273 tecnico impiegato» fosse italiana, per favorire l’industria cinematografica nazionale18. L’intento di tutti questi divieti, naturalmente, è solo in parte l’applicazione rigida di un neopurismo linguistico: più profondamente si mirava a cancellare, insieme con la colonna sonora originale, anche i contenuti ritenuti inopportuni e, soprattutto, a favorire la produzione nazionale ostacolando, a suon di leggi, quella straniera. Il primo studio di doppiaggio italiano, affidato alla direzione di Mario Almirante, fu aperto a Roma, nel 1932, dalla Casa Cines Pittaluga. Seguirono, a breve distanza, gli studi della MGM (prima sotto la direzione di Augusto Galli, poi, dal 1934 al 1938, di Franco Schirato), della Paramount (direttore Luigi Savini), della Warner Bros (Nicola Fausto Neroni), della 20th Century Fox (Vittorio Malpassuti), dell’EIA e Artisti Associati (Sandro Salvini), dell’ICI (Vincenzo Sorelli). Fra i traduttori (o meglio adattatori) più attivi e apprezzati in questo periodo si ricordano almeno: Aldo De Benedetti, Alessandro De Stefani, Guglielmo Giannini, Pier Luigi Melani, Gian Bistolfi, Paola Ojetti, Dario Sabatello, Enrico Marino, Silvio Benedetti. Tra i primi adattatori dall’inglese si ricorda l’italoamericano Alberto Valentino, fratello di Rodolfo. Talora la figura dell’adattatore e quella del direttore del doppiaggio coincidono, com’è il caso, tra i tanti, di Guido Cantini. Tra i doppiatori più famosi degli anni Trenta spiccano almeno: Sandro Ruffini (voce, tra gli altri, di Kirk Douglas, Charlie Chaplin, Errol Flynn), Andreina Pagnani (Bette Davis, Greta Garbo, Lana Turner), Augusto Marcacci (James Stewart, Spencer Tracy), Emilio Cigoli (la voce maschile per antonomasia del cinema americano doppiato dell’epoca: Gary Cooper, Clark Gable, John Wayne, Humphrey Bogart), Rina Morelli (Carole Lombard, Judy Holliday), Tina 18. Cfr. RAFFAELLI (1992: 190–195). Il primo film giunto in Italia già doppiato, nel 1931, fu il già citato Carcere (The Big House), di Hill (cfr. RAFFAELLI 1992: 82 n. 49), mentre il primo doppiato in Italia, nel 1932, fu A me la libertà (À Nous la liberté), 1931, di René Clair, con l’adattamento di Alessandro De Stefani (QUARGNOLO 1986: 43). 274 Il linguaggio cinematografico Lattanzi (la regina del doppiaggio storico, adorata, imitata e biasimata per il suo celebre “birignao”: Greta Garbo, Marlene Dietrich, Rita Hayworth), Giulio Panicali (Robert Taylor, Tyrone Power, Bing Crosby), Gero Zambuto (Wallace Beery), Lauro Gazzolo (caratterista: Barry Fitzgerald, Bud Abbott; è la riconoscibilissima voce di tanti vecchietti dei western), Romolo Costa (il primo Clark Gable, Gary Cooper), Lidia Simoneschi (Vivien Leigh, Jennifer Jones, Ingrid Bergman), Rosina Fiorini Galli (moglie del già citato Augusto: Joan Crawford), Mario Besesti (Charles Laughton). Quasi tutti hanno esordito come attori di teatro e molti di loro hanno ricoperto vari ruoli cinematografici, talora anche come registi (Zambuto). Da allora, il ruolo artistico dell’adattatore e del doppiatore «cominciò a essere teoricamente apprezzato, come testimoniano oltretutto lusinghiere innovazioni terminologiche quali dialoghista e concertatore, che furono proposte nel 1937 da Giacomo Debenedetti per designare rispettivamente il riduttore e il direttore del doppiaggio»19. Altri neologismi si imposero rapidamente: adattamento, riduzione, ridurre e riduttore, sincronizzare, sincronizzazione e sincronismo, che diede subito vita all’abbreviazione gergale sin (oggi sinc [→ Glossario, SINCRONISMO LABIALE])20. A lungo oggetto di remore esterofobe fu doppiaggio, colpevole di ricalcare il francese doublage (a sua volta calco dell’inglese dubbing, già derivato dal francese medievale adoubler ‘addobbare’), al quale i puristi continueranno a preferire doppiatura (per l’operazione) e doppiato (per il risultato), su suggerimento del 1941 di Bruno Migliorini21. Sia doublage sia dubbing (che dunque nulla spartisce col 19. RAFFAELLI (1995: 46). Il brano di Debenedetti (sotto lo pseudonimo di Gustavo Briareo: BRIAREO 1937) è riportato in → Antologia critica, § 13. 20. Cfr. VECCHIETTI (1935: 38). Tra le coniazioni meno fortunate, tavolo sonoro («minuscolo cinematografo applicato ad un tavolino» per far scorrere la pellicola in sede di doppiaggio, ovvero moviola), in CANTINI (1935). Il neologismo moviola (nome commerciale americano derivante da movie), attestato in italiano fin dal 1930 (cfr. RAFFAELLI 1979a), compare, tra l’altro, in BRIAREO (1937: 154). 21. Il Panzini considera doppiaggio «[i]nutile, invece di doppiato o doppiatura» (cfr. PANZINI 1905/1942, s. v. doppiaggio). Su una posizione intermedia LILLI (1935), 5 – Il “doppiaggese” 275 concetto di ‘doppio’, bensì con quello di ‘foderare, rivestire’) circolano in Italia fin dal 1930. Attestati sono anche mischiaggio e mixage [→ Glossario, MISSAGGIO]22. Dal 1933, dunque, fino almeno al 1950, il doppiaggio vive il suo momento aureo, per qualità delle voci e riconoscimenti della critica. Tuttavia, nonostante la raggiunta maturità della professione (documentata dalle recensioni positive23 e dalla pre- che distingue tra doppiaggio ‘operazione’ e doppiato ‘risultato’. La storia del termine doppiaggio si legge ora in RAFFAELLI (2001: 892–893 n. 72). 22. Per esempio in CORTINI VIVIANI (1936). Di «‘mischiatura’ delle colonne sonore» parla Freddi in una sua lettera, citata nel § 4.1.2. 23. Le recensioni dei film stranieri degli anni Trenta si concludevano spesso con un breve paragrafo dedicato alla versione italiana, segno che il doppiaggio era considerato un aspetto tutt’altro che accessorio di un film e anche, ovviamente, che c’era tutto l’interesse a difendere pubblicamente la campagna di autarchia linguistica. Scrive Jacopo Comin a proposito dei Lancieri del Bengala (Lives of a Bengal Lancer), 1935, di Henry Hathaway: «L’interpretazione è stata ottima quasi sempre: a voler essere ‘pignoli’ si può notare che il Costa (Gary Cooper) è talvolta leggermente artificioso e che il Ruffini (Franchot Tone) non ha tutta quella disinvolta eleganza di recitazione che è pregio dell’originale. Ma in compenso il Marcacci (Richard Cromwell) ha almeno tanta spontaneità e freschezza quanto l’attore stesso e il Ferrari e il Cristina (Guy Standing e Aubrey Smith) danno alla loro interpretazione una solidità costruttiva piena di carattere. I dialoghi sono tradotti con abilità senza perdere il gusto dell’originale» (rubrica «I Film», in “Bianco e nero”, I, 1, 1937, pp. 77–99: 84). Oppure lo stesso Comin, a proposito dell’Impareggiabile Godfrey (My Man Godfrey), 1936, di Gregory La Cava: «Se talvolta ci avviene in queste note di trattar male qualcuno dei doppiaggi che andiamo sentendo, bisogna sempre intendere le nostre parole in relazione all’insieme dei lavori: bisogna, ossia, capire che un doppiaggio che noi consideriamo scadente lo è soltanto perché numerosissimi altri sono addirittura perfetti. In sé, magari, esso è migliore di tutto quello che si è fatto all’estero in materia. Noi abbiamo, in genere, dei direttori di doppiaggio (esempio tipico il Savini) che hanno saputo portare i nostri attori ad una perfezione non solo di sincronia, fatto puramente meccanico eppure già difficilissimo a raggiungersi, ma anche di recitazione cinematografica che non ha nulla da invidiare alla naturalezza ed alla spontaneità della presa diretta dell’originale. Non sempre tuttavia i riduttori dei dialoghi dimostrano altrettante capacità. Questo dell’‘Impareggiabile Godfrey’ è, invece, un caso in cui i dialoghi superano forse, per eleganza, per intelligenza e per gusto gli stessi dialoghi originali. Evelina Levi che ha ‘ridotto’ i dialoghi ha perfettamente compreso lo spirito dell’originale, si è inserita con un garbo squisito nell’andamento satirico del film ed ha trovato una forma italiana aderente in ogni momento ed in ogni sua parte a quella forma americana che presentava non poche e non lievi difficoltà di rielaborazione» (ID., rubrica «I Film», in “Bianco e nero”, I, 3, 1937, pp. 90–105: 98). È evidente la differenza rispetto alle recensioni odierne, che tendono perlopiù a tacere del doppiaggio. Peraltro, come si può vedere già a partire dalla sesta annata (1942) della rivista “Bianco e nero” (il periodico, fondato e diretto da Luigi Chiarini, del Centro sperimentale di 276 Il linguaggio cinematografico coce stabilizzazione terminologica), né i compensi adeguati né il riconoscimento dei diritti d’autore e nemmeno la visibilità degli esecutori del doppiaggio nei titoli dei film furono vantaggi facili da ottenere, per la categoria, al punto tale che le rivendicazioni sindacali, iniziate nel 1934, non possono dirsi pienamente esaudite se non in epoca assai recente24. La seconda generazione di adattatori è quella fiorita attorno agli anni Cinquanta, periodo che potremmo definire argenteo non certo per i risultati (in realtà migliori dei precedenti, per fedeltà alla fonte e scioltezza stilistica) quanto per lo spazio, decisamente più esiguo rispetto al primo periodo, dedicato al fenomeno del doppiaggio dalla stampa periodica generica e specializzata. I protagonisti di questa fase sono gli adattatori Roberto De Leonardis, Ferdinando Contestabile, Leonardo Magagnini, «comandanti di marina […] che conoscono a fondo, per aver viaggiato per mestiere, lingua, usi e tradizioni dei Paesi stranieri, stabiliscono contatti con le major statunitensi e impongono una svolta alla lingua del doppiaggio, liberandola dalle pastoie del ‘bell’italiano’. Da loro impareranno il mestiere i dialoghisti» della generazione successiva25, quella tuttora in corso e che, come vedremo, si fa convenzionalmente nascere nel 1972, cinematografia), i riferimenti al doppiaggio saranno sempre più sporadici, sia come saggi autonomi sia come riferimenti nelle recensioni dei film, e mancherà, nella rubrica «I film», il paragrafo intitolato L’edizione italiana. 24. È noto che i doppiatori e il direttore del doppiaggio compaiono stabilmente (e ormai obbligatoriamente) nei titoli da non più di un quindicennio. Su questi temi cfr. COMUZIO (1993: 5–6); MEGALE (1995); PAOLINELLI (1995) e (2001); DI FORTUNATO/PAOLINELLI (1996). Come già ricordato nel 2.2, fu Guglielmo Giannini il primo a rivendicare i diritti di coautorialità degli adattatori. Sulla nascita delle associazioni, sindacali e no, di adattatori e doppiatori (come, dal 1976, l’AIDAC: Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi) cfr. DI FORTUNATO/PAOLINELLI (1996). La più completa trattazione degli aspetti economici e giuridici delle professionalità connesse con il mondo del doppiaggio è, finora, PAOLINELLI/DI FORTUNATO (2005: 79–152). 25. PAOLINELLI/DI FORTUNATO (2005: 19). Ma, secondo alcuni, dagli anni Ottanta in poi il livello dell’adattamento cinetelevisivo si è drasticamente abbassato, per la «necessità di riempire al minimo costo i palinsesti delle televisioni commerciali — necessità che ha coinvolto anche la televisione pubblica in una gara al ribasso» — e per il conseguente «avvicinarsi alla professione di molti adattatori improvvisati» (ibid.). 5 – Il “doppiaggese” 277 anno di uscita del Padrino (The Godfather), di Francis Ford Coppola. Un duro colpo venne inferto al doppiaggio a partire dalla fine del 1938 (decreto–legge del 4 settembre: cfr. § 2.4.2), allorché il regime di fatto proibì l’importazione di film stranieri. In quello stesso periodo si consolidò però la prassi di postsincronizzare i film italiani. In effetti, costava meno doppiare gli attori che ottenere una buona riproduzione del suono in presa diretta, specialmente in un cinema di esterni come quello italiano. Anche gli avversari del doppiaggio si rassegneranno a considerare «preferibile un buon doppiaggio a una scadente o rumorosa presa diretta»26, dando così l’abbrivo alla paradossale consuetudine dell’attore preso dalla strada e doppiato nei film neorealistici e segnando pertanto l’ingresso dello stile doppiaggese nel cinema nostrano. Da allora, almeno fino all’ultimo ventennio del Novecento, i film italiani integralmente in presa diretta saranno una rarità. Il primo esempio noto di film italiano interamente sincronizzato è Il fornaretto di Venezia, 1939, di John Bard, pseudonimo di Duilio Coletti, con Roberto Villa doppiato da Carlo Romano, Clara Calamai da Tina Lattanzi, Osvaldo Valenti da Giulio Panicali, Enrico Glori da Emilio Cigoli, Carlo Tamberlani da Gaetano Verna. Senza contare gli sporadici casi precedenti: Marionette, 1939, di Carmine Gallone, con Beniamino Gigli doppiato da Gualtiero De Angelis per le parti non cantate; La principessa Tarakanova, 1938, di Mario Soldati, con Anna Magnani doppiata da Marcella Rovena; Scipione l’Africano, 1937, di Gallone, con Francesca Braggiotti (futura doppiatrice) doppiata da Giovanna Scotto27. Come dimostra la presenza di nomi illustri nei titoli appena citati, la postsincronizzazione dei film italiani non si può spiegare soltanto con l’imperizia degli attori. Evidentemente, con il progredire del film sonoro, il pubblico diventa sempre più esi- 26. UCCELLO (1957). 27. Cfr. DI COLA (2000). 278 Il linguaggio cinematografico gente (già assuefatto all’estetica vocale del doppiaggio dei film stranieri), ricercando sia una perfetta resa acustica, sia una dizione scevra dalle interferenze dialettali e dalle peculiarità timbriche pure ammesse a teatro28. Senza dimenticare l’estrema comodità, per i cineasti, di poter correggere successivamente (e in mancanza degli attori originari, eventualmente impegnati su altri set e, comunque, troppo esigenti e difficili da gestire, rispetto ai doppiatori di professione) errori di recitazione (battute dette male) e di acustica. L’enorme diffusione del doppiaggio di film italiani comincerà presto a generare problemi e paradossi, come ad esempio quello di nomi presenti nello stesso film sia come attori (doppiati da altri) sia come doppiatori (di colleghi: accadde a Cigoli, Gassman, Manfredi e altri), oppure il caso di stelle del cinema occasionalmente doppiate: celebri i casi di Gassman doppiato in Riso amaro, 1949, di Giuseppe De Santis; di Mastroianni doppiato da Sordi in Una domenica d’agosto, 1950, di Luciano Emmer; di Salerno e Gassman doppiati nella Tratta delle bianche, 1952, di Luigi Comencini. Da più di un decennio, ormai, molti attori hanno rifiutato, in quanto lesiva della loro professionalità, la prassi della postsincronizzazione di film italiani con voci diverse da quelle originarie. Per questo è invalsa la cosiddetta norma voce–volto, che impedisce ai distributori di far doppiare un attore italiano senza la sua esplicita autorizzazione. È cessato così l’anonimato di tanti doppiatori che hanno portato al successo divi e dive, dalla Cardinale alla Sandrelli, da Arena a Salvatori, dalla Allasio alla Muti. 5.1.3. Al doppiaggio non mancarono, fin dalle origini, critici acerrimi, che nella nuova prassi individuarono ora un assassinio dell’opera d’arte originaria, ora un male minore (ma pur sempre 28. Emilio Cigoli, intervistato da SAVIO (1979: I, 341–348), dichiara che, tra gli altri, un attore del calibro di Osvaldo Valenti fu «sempre doppiato» perché «[p]arlava un po’ con accento emiliano, oltre alla voce che non si prestava molto. Era piuttosto stridula» (p. 342). 5 – Il “doppiaggese” 279 un male) utile solo a fini commerciali, per consentire la fruizione della filmografia straniera. Una parte dei fustigatori del doppiaggio coincideva, in realtà, coi delusi del sonoro (Chaplin). Secondo la maggior parte dei registi e dei teorici del cinema, il doppiaggio era inaccettabile sul piano estetico e, per dir così, etico, per via della scissione della componente verbale da quella iconica. Per Jean Renoir è «una mostruosità, una specie di sfida alle leggi umane e divine»29. Secondo Jean–Marie Straub «una legge fascista (sulla difesa della lingua italiana!) ha fatto dell’Italia la camera a gas dei film stranieri»30. La lingua ideale del doppiaggio venne ritenuta, da taluni, la meno marcata, la più impersonale, la «più lontana dalla poesia»31, «una lingua il più possibile anonima, pur essendo grammaticalmente e sintatticamente italiana»32. Ed è proprio sul «grammaticalmente e sintatticamente italiana» che si appiglieranno le critiche dei puristi all’eccesso di forestierismi nel doppiaggio, stando, per esempio, alle critiche di Adolfo Franci riportate da Gilberto Altichieri. Altichieri, d’altra parte, ammira le «bracciate di slang» immesse nel cinema americano, e le «basse inflessioni» e i barbarismi di altre cinematografie: che senso avrebbe un doppiaggio puristico di un film realistico e plurilingue?33. Per molti altri, invece, il cinema deve essere nor- 29. CASTELLANO (1993: I, 61). 30. CASTELLANO (1993: I, 62). 31. MILANO (1938: 10) [→ Antologia critica, § 5]. 32. CHIARINI (1936: 30), il quale osserva anche che «Il traduttore deve cercare di far scomparire il più possibile la propria personalità» (ibid.). La pratica della traduzione per il cinema, infatti, fu a lungo esercitata «da un manipolo di adattatori e di doppiatori rimasto attivo, con esigui ricambi, in una situazione quasi monopolistica, fino agli anni Sessanta (il che spiega il conservatorismo della lingua del parlato, specie delle grandi case americane, in contrasto con il vivace variare di quello di produzione nazionale o europea). […] Gli adattatori provenivano di solito dal giornalismo (trai pionieri, per lo più attivi a lungo anche nel dopoguerra come collaboratori di fiducia di singole Case statunitensi, Augusto Galli, Luigi Savini, Nicola F. Neroni) […]. Non è forse casuale che siano stati esclusi, fino verso gli anni Settanta, scrittori i quali, come artisti della parola, avrebbero immesso nei dialoghi invenzioni ‘d’autore’, inopportunamente personali» (RAFFAELLI 1997a: 24). 33. ALTICHIERI (1938). 280 Il linguaggio cinematografico mativo e didattico, perché si rivolge a un pubblico più vasto e culturalmente più sprovveduto (e perciò più esposto all’errore) di quello della letteratura: il grande pubblico «va al cinema fiducioso, con l’intento di divertirsi anzitutto, ma è lieto di uscirne come da una scuola piacevole dove ha imparato molte cose»34. I film stranieri doppiati, in quanto sospetti veicoli di forestierismi, sono invisi come attentatori dell’agognata, ma mai effettivamente raggiunta, autarchia filmica italiana e vengono pertanto osservati dai puristi con particolare severità. Tanto più apprezzato è il doppiaggio quanto più si allontana dalle escursioni verso i registri più alti e più bassi. Per perseguire tale medietà, Ettore Allodoli suggerisce addirittura che «ogni film [abbia] il suo revisore linguistico obbligatorio, e annunziato sullo schermo insieme con tutti gli altri collaboratori»35. Fra tanti detrattori, vi fu, tuttavia, chi riconobbe al doppiaggio il merito di aver «debella[to] […] il vecchio birignao e sostitu[ito] al vezzo di ‘recitare’ la più precisa e concreta abitudine di ‘parlare’»36. E chi, addirittura, apprezzò gli adattamenti dei film americani molto più dei dialoghi nostrani, per quello stile nudo e diretto, senza fronzoli e abbellimenti letterari, tirate o cavatine di bella o brutta letteratura. Certi doppiati […] potrebbero molto bene insegnare come dovrebbe essere il dialogo cinematografico anche nelle nostre produzioni originali. Che purtroppo risulta, nella maggioranza dei casi, un dialogo pseudo letterario e di dubbio gusto37. Anche Paolo Milano apprezza il lavoro dei «traduttori di dialogo», i quali «azzeccano qualche volta un italiano molto più spregiudicato e fantasioso di quello di certi burocrati dialoghisti di film nostrani»38. 34. 35. 36. 37. 38. ALLODOLI (1937: 5) [→ Antologia critica, § 4.I]. ALLODOLI (1937: 9). BRIAREO (1937: 155) [→ Antologia critica, § 13]. FRANCI (1938). MILANO (1938). 5 – Il “doppiaggese” 281 Si giunge così al famoso dibattito pro/contro il doppiaggio ospitato dalla rivista “Cinema” nel 1940–1941 e inaugurato da due articoli di Diego Calcagno e di Michelangelo Antonioni, il primo favorevole, il secondo nettamente contrario. Antonioni vitupera il doppiaggio come un’anomalia tipicamente italiana, «uno dei lati negativi della nostra industria cinematografica [ch]e pone immeritatamente il pubblico italiano, rispetto a quelli stranieri, nella identica condizione di un bambino o di un ammalato, che per mangiare devono essere imboccati»39. La conclusione del sondaggio vide, com’era prevedibile, nettamente contraria la maggior parte dei critici e dei cineasti, complessivamente favorevole il pubblico, ben lieto di rinunciare alla lettura dei sottotitoli. Le nostre platee iniziarono subito a mitizzare non soltanto gli attori, ma anche le loro voci, e si abituarono ben presto all’estetica della corrispondenza tra un timbro vocale e un determinato carattere o una certa fisionomia, non più disposte ad accettare la naturalezza e alcune inevitabili difformità tra voce reale e voce attesa40. Tra gli estimatori un po’ più recenti, PESTELLI (1973) osserva: Sullo schermo […] la coloritura dialettale, che è quasi sempre caricatura, è un espediente per tirare in basso, per segnare un tono “barabba”, cioè per aggiungere una falsità alle altre. Pensiamo invece che la lingua ideale del film sia quella che meno si sente (giusta il carattere accessorio della parola rispetto all’immagine); diciamo pure, a costo di farci lapidare, la lingua del “doppiato”. La quale a guardare bene risponde alla realtà delle cose, alla spinta ascensionale che oggi gl’italiani avvertono parlando. Va ricordato, peraltro, a conferma della frequente inconciliabilità tra questioni teoriche e problemi pratici connessi con la 39. ANTONIONI (1940: 328) [→ Antologia critica, § 14]. 40. Significativa, a riguardo, la testimonianza dell’attore–doppiatore Pino Locchi, costretto in un film ad essere doppiato da un altro, «perché nessuno avrebbe creduto che un omino così magro e minuto avesse una voce fonda come la mia» (CASTELLANO 1993: I, 60–61). 282 Il linguaggio cinematografico realizzazione filmica, che lo stesso Antonioni farà doppiare integralmente tutti i suoi film, anche quelli girati con attori italiani. Tra i registi nostrani, Federico Fellini ha sempre dichiarato l’insostituibilità del doppiaggio per la propria personale visione dell’arte cinematografica, ammettendo di aver fatto recitare agli attori spesso soltanto dei numeri. Il regista vuole riserbarsi il diritto di manipolare fino all’ultimo il testo della sceneggiatura, nella convinzione che soltanto in fase di doppiaggio — grazie anche a tipici espedienti espressionistici felliniani, dagli effetti d’eco, alle voci di personaggi di sfondo che sembrano parlare in primo piano e viceversa — prenda vita e corpo la versione definitiva dell’opera filmica: «Non potrei fare a meno del doppiaggio. Anche le voci che in genere restano a uno stadio neutro, nella ripresa diretta, con il doppiaggio possono essere manipolate, esaltate, magari aggiungendo un vago accento esotico che conferisce autorevolezza e innocenza»41. È durante il doppiaggio che torno a dare grande importanza ai dialoghi. […] Io sento il bisogno di dare al sonoro la stessa espressività dell’immagine, di creare una sorta di polifonia. È perciò che sono contrario, tanto spesso, a utilizzare dello stesso attore il volto e la voce. L’importante è che il personaggio abbia una voce che lo renda ancor più espressivo. Per me il doppiaggio è indispensabile, è un’operazione musicale con la quale rinforzo il significato delle figure. Né mi serve la presa diretta. Molti rumori della presa diretta sono inutili. Nei miei film, per esempio, i passi non si sentono quasi mai. Ci sono dei rumori che lo spettatore aggiunge con un suo udito mentale, non c’è bisogno di sottolinearli: anzi, se li sente veramente, disturbano. Ecco perché la colonna sonora è un lavoro da fare a parte, dopo tutto il resto, insieme alla musica42. 41. Fellini in CASTELLANO (1993: I, 58). 42. Fellini in BISPURI (2003: 17). Non sfugge, ovviamente, la sostanziale differenza tra un doppiaggio (da italiano a italiano) esplicitamente voluto dal regista, e dunque da considerarsi a tutti gli effetti come parte integrante dell’opera ed espressione della volontà dell’autore, e doppiaggio (di un film straniero) imposto dalla distribuzione, perlopiù totalmente incurante del parere dei realizzatori originali (caso, almeno in questo, così diverso dalla traduzione di un libro, di rado compiuta senza consultare l’autore). 5 – Il “doppiaggese” 283 Nonostante le critiche (tuttora vive)43, dunque, il doppiaggio si mostrò la soluzione più apprezzata dai distributori e dal grande pubblico italiano, perché conciliava le esigenze puristiche con l’analfabetismo diffuso, a causa del quale le didascalie o i sottotitoli rappresentavano un ostacolo insormontabile. Non si dimentichi, peraltro, come riserve puristiche di natura opposta (a tutela dell’immagine, stavolta, e non della voce) colpiscano anche l’uso dei sottotitoli, “colpevoli” di alterare l’immagine (se sovrimpressi) o comunque di distoglierne l’attenzione dello spettatore44. Tra i fautori del doppiaggio, l’anglista, traduttore e adattatore Masolino D’Amico osserva che «nel cinema tutto è falso, dai fondali alla pioggia: non si vede perché non possa esserlo anche la voce degli attori»45. 43. Tra gli oppositori al doppiaggio della seconda generazione ricordiamo almeno PASOLINI (1972/1991: 266): «L’immagine e la parola, nel cinema, sono una cosa sola: un topos […]. [I] film, specialmente in Italia, per via […] del doppiaggio, sono sempre parlati male: e il tuono è una specie di rigurgito o di sbadiglio che zoppica dietro al lampo […]. In realtà il fenomeno del lampo e del tuono è un fenomeno atmosferico unico: il cinema è cioè audiovisivo». 44. Cfr. JACQUIER (1995: 265). Sull’uso dei sottotitoli (peraltro compendiari e semplificati rispetto all’originale) e in generale sulla presenza della parola scritta e tradotta nel film sonoro cfr. RAFFAELLI (2001: 891–892) e quanto detto supra, § 2.2.1. Sugli inevitabili vincoli di durata e di lunghezza imposti ai sottotitoli, HATIM/MASON (2000: 430) avvertono: «These are physical constraints of available space (generally up to 33, or in some cases 40 keyboard spaces per line; no more than two lines on screen) and the pace of the sound–track dialogue (titles may remain on screen for a minimum of two and a maximum of seven seconds)». Sull’impoverimento dell’originale procurato dai sottotitoli cfr. PAOLINELLI/DI FORTUNATO (2005: 36–41). Alle prassi alternative al doppiaggio (sottotitoli e voice over) sono dedicati i saggi contenuti in HEISS/BOLLETTIERI BOSINELLI (1996: 281–338) e in BOLLETTIERI BOSINELLI/HEISS/SOFFRITTI/BERNARDINI (2000: 111–181). 45. COVERI (1995b: 45). Sottolineare (o quantomeno non tentare di dissimulare) la falsità del doppiaggio (e dunque utilizzare una lingua antirealistica, non marcata in alcun modo, asettica o aculturale, come efficacemente chiamata da GATTA 2000: 103) è, per taluni, l’unico modo per non renderlo ridicolo e sleale: «Il primo falso in doppiaggio è l’originale stesso. Il cinema, infatti, è nato come immagine e solo a un certo punto si è messo a parlare, cosa che non appartiene alle ombre cinesi di cui il cinema, in fondo, è uno sviluppo tecnico. Sembrerà strano ma il testo doppiato, fin quando mantiene la sua alterità nei confronti del testo originale, dichiara una sua valenza innovativa, cioè si integra nell’opera d’arte, presentandola sotto una forma duplice; prima ti offre l’originale, poi ti offre il dubbio che quello che tu senti sia qualche cosa di diverso rispetto all’opera primaria. […] il doppiaggio è un falso perché non è assolutamente l’originale, anche se 284 Il linguaggio cinematografico 5.1.4. Ma vediamo ora, prima di passare all’analisi linguistica di lacerti filmici, come avviene, in sintesi, la realizzazione del doppiaggio. Abbiamo già detto, nel § 1.2, che la traduzione di primo grado, per dir così, dei dialoghi (quella, insomma, eseguita soltanto sulla base della trascrizione del parlato originale, senza necessariamente tener conto delle immagini) passa nelle mani dell’adattatore dialoghista (o dialoghista adattatore: sostanziale, e non meramente formale, la doppia etichetta), scelto o dalla società di distribuzione o da quella di doppiaggio cui la prima ha già affidato la lavorazione del film. A costui spetta non soltanto il compito di avvicinare le nuove battute il più possibile ai movimenti labiali degli attori, ma soprattutto quello di rendere i dialoghi credibili, scorrevoli, come se fossero stati scritti e recitati direttamente nella lingua di arrivo senza far sentire il tramite della lingua di partenza. È l’adattatore il responsabile unico del nuovo testo, di cui è in parte nuovo autore (donde la denominazione di dialoghista). Oneri e onori di tale compito gli sono ormai riconosciuti anche dalla legislazione vigente sul diritto d’autore, che fa esplicito riferimento all’adattatore–dialoghista (così definendolo dal 1993, mentre prima si parlava, genericamente e riduttivamente, di traduttore per il cinema) mentre tace sulla figura del traduttore vero e proprio (inteso è uguale. Però il doppiaggio, per sua natura, deve essere falso per risultare vero. Perché se tenta di essere vero, allora appare in tutta la sua modestia, in tutta la sua povertà. Cosa significa questo? Che il doppiaggio deve rispettare prima di tutto la propria falsità, deve essere assolutamente falso, a parte determinati limiti tecnici come la lunghezza delle battute — anche questo limite, tuttavia, può essere trascurato […]. Perché il falso, purtroppo, non porta con sé la figura del doppio, ma porta con sé, legato al guinzaglio, l’imbecille che ci ha creduto. Ecco perché nel momento di trasparenza, quando si fa qualche cosa che non è l’originale dobbiamo sempre far sapere che non è l’originale» (LIONELLO 1994: 46, 50). Tuttora esemplare, per il rapporto vero/falso nel cinema sonoro postsincronizzato, è Cantando sotto la pioggia (Singin’ in the Rain), 1952, di Stanley Donen e Gene Kelly, il cui doppiaggio, tra l’altro, mantiene i gustosi errori dell’originale: babbalea per babbea, spregiudizievole e dalaterio per spregiudicato e deleterio, pirografo per paragrafo, deto per data, musichevole per musicale, confermia per conferma, entusiasta per entusiastica, monotoniche per monotone, etc.: tutto concorre a ritrarre, con una comicità ancora irresistibile, la confusione babelica del tormentato passaggio dal muto al sonoro al doppiato. 5 – Il “doppiaggese” 285 come il primo traduttore della lista dialoghi del film)46. Ciò significa che all’adattatore viene riconosciuto un diritto di coautorialità, come al traduttore di un libro, in virtù dell’apporto creativo ineliminabile dalla sua attività. Le due figure del traduttore e dell’adattatore di un film, sia detto per inciso, non coincidono quasi mai: il secondo talora appalta il livello preliminare della traduzione, che altre volte gli viene già fornito dalla committenza (vale a dire dalla società di distribuzione del film). Questo duplice trattamento legale fa sì, per esempio, che chi traduce testi per i documentari venga pagato una tantum senza percepire alcun compenso come diritto di replica, a differenza di un adattatore di un qualsiasi filmato, anche se di durata minima. Dalle mani dell’adattatore, il nuovo testo passa in quelle del direttore di doppiaggio (che, sebbene di rado, può coincidere con l’adattatore stesso), il quale, vero e proprio regista delle voci del film, coadiuvato da un assistente, si preoccuperà di scegliere i doppiatori e di curare l’allestimento della nuova versione, manipolando più o meno sensibilmente il testo consegnatogli dall’adattatore e accogliendo all’occasione anche eventuali improvvisazioni dei doppiatori. La scelta del cast vocale (eventualmente anche su provino) può rispondere a varie esigenze, tra cui l’analogia timbrica con gli attori dell’originale o il “monopolio”, in un certo senso, di una voce per un certo volto (Oreste Lionello per Woody Allen, lo scomparso Ferruccio Amendola per numerosi divi americani tra cui Hoffman e De Niro, e così via). La lavorazione del film, in questa fase, avviene su brevissimi spezzoni di pellicola (dalla durata media di 30–40 secondi ciascuno), detti anelli [→ Glossario, ANELLO] (per via della forma: la coda e la testa dello spezzone sono state attaccate per consentirne una ripetizione continua)47, predisposti proprio per 46. Una prima formulazione di tali norme si può leggere nelle appendici di AA. VV. (1995a: 307–325). Un’attenta rassegna della giurisprudenza dalla prima legge sul diritto d’autore del 1941 al 2004 si legge ora in PAOLINELLI/DI FORTUNATO (2005: 79–152). 47. Naturalmente nell’epoca del digitale (ma fin dagli anni Settanta, con i nuovi 286 Il linguaggio cinematografico il doppiaggio. I doppiatori, dopo aver visto più volte l’anello da doppiare (ma quasi mai l’intero film), reciteranno le loro battute mirando alla massima aderenza alle caratteristiche di durata ed espressione dell’originale. L’ultima fase del lavoro è costituita dal missaggio (vale a dire dall’allineamento delle piste video con quelle audio, ovvero le varie colonne: alcune per le voci doppiate, un’altra per le musiche e un’altra ancora per i vari suoni e rumori — detti effetti sala, effetti speciali e effetti ambiente — denominata colonna internazionale [→ Glossario, COLONNA]) e dal passaggio del film alla moviola, operazione grazie alla quale direttore, sincronizzatore [→ Glossario, SINCRONIZZAZIONE] e fonico di missaggio sistemano i vari livelli di volume e controllano eventuali anomalie consistenti nella non perfetta corrispondenza tra immagini e suoni48. Come si vede, la pratica del doppiaggio aggiunge un ulteriore diaframma tra la realtà linguistica e la sua copia filmica: pur tacendo dei problemi di trasposizione testuale da una lingua (ovvero da un sistema culturale) a un’altra, la stessa prassi dello spezzettamento in anelli (che mai vengono “lavorati” seguendo l’ordine naturale del film, che del resto non viene seguito neppure durante le riprese, con le scene del copione girate secondo esigenze economiche — per risparmiare tempo e cambiamenti di scenografia e di attori — e non testuali) comporta un ulteriore allontanamento dalla “naturalezza” pragmatica del parlato in situazione. Per non dire poi del riformulare “a freddo” una scena fuori dal contesto in cui è stata recitata la prima volta in presa diretta, anche se il doppiatore coincide con l’attore originario. Tra l’altro, se proprio la “(in)naturalezza” della presa diretta può comportare l’inintelligibilità di alcune battute di sfondo (non tanto dal punto di vista ambientale quanto da quelproiettori telecomandati e ad avanzamento veloce) non c’è più, fisicamente, l’anello (il doppiaggio viene eseguito sulla base di una copia digitale del film), anche se ne è stato mantenuto il nome. CANTINI (1935) parlava di rotoletti. 48. Sulla prima fase del lavoro e sulla differenza tra traduzione e adattamento cfr. JACQUIER (1995) e PAOLINELLI/DI FORTUNATO (2005: 51–78); sulla seconda fase, quella della realizzazione della nuova colonna sonora, cfr. CASTELLANO (1993: I). 5 – Il “doppiaggese” 287 lo psicologico: battute alle quali si è scarsamente interessati), l’artificiosità e la convenzionalità del doppiaggese bandiscono i movimenti labiali privi di suono. È infatti possibile, spiega l’adattatore e direttore di doppiaggio Gianni G. Galassi, grazie agli odierni sistemi di registrazione del suono in presa diretta, inquadrare [in un ristorante] i due protagonisti seduti al loro tavolo in CAMPO LUNGO [→ Glossario], con una presa del suono in PRIMISSIMO PIANO [→ Glossario], avendo magari di quinta, in primo piano, due comparse che pur parlando animatamente non producono alcun suono. Nel film doppiato, invece, si determina un rapporto figura/sfondo tra dialogo e ambiente sonoro, che è diverso dal rapporto figura/sfondo tra il dialogo originale […] e il medesimo ambiente sonoro. Per ragioni psicoacustiche il nostro orecchio si attende, data la maggior trasparenza del dialogo doppiato, che tutti i suoni emessi all’interno dell’inquadratura, oltre a quelli più significativi anche all’esterno dell’inquadratura, siano ben percepibili. Proprio perché non c’è la sfocatura, la patina della presa diretta, a rendere plausibile che non si sentano le battute di Tizio, che pure muove la bocca e che magari abbiamo sentito parlare alla stessa distanza dalla macchina da presa un minuto prima. In pratica la versione in presa diretta addirittura consente di essere incoerenti ai campi sonori che la stessa inquadratura aveva stabilito un minuto prima. Questo tipo di incoerenza, nella versione doppiata, si sopporta molto meno, perché l’artificio regge solo a patto di non presentare sbavature. Dunque, in questi casi, è sempre preferibile aggiungere battute che poi al mix si cercherà di far sentire il meno possibile, in modo da darne soltanto una percezione sonora e non una percezione di senso. Si tratta sicuramente di un arbitrio, del quale riconosco tutta l’illegittimità dal punto di vista filologico, ma che ritrova poi la sua legittimità nel contribuire al consolidamento del fragile patto spettatore/film doppiato49. A conferma, e contrario o come eccezione alla regola, delle parole di Galassi, spicca l’eccellente postsincronizzazione di un film come Ladri di biciclette (già illustrata nei §§ 3.3 e 4.2.1), in 49. LICARI/GALASSI (1994: 166–167). 288 Il linguaggio cinematografico cui tutte le artificiosità del doppiaggio non fanno che esaltare l’impressione di perfetto realismo del film (ivi comprese certe battute praticamente incomprensibili pur se urlate quasi in primo piano dalle comparse nelle scene di mercato). Un altro aspetto che è bene tener presente, nell’analisi del doppiaggio, è l’estrema velocità dei tempi di lavorazione imposta, in misura crescente negli ultimi anni, dai committenti alle varie società: «è indubbio che i ritmi e i costi della realizzazione e ancora più la pratica spesso frenetica del doppiaggio favorisce [….] l’omogeneizzazione linguistica, già fastidiosamente predisposta a livello fonetico dall’utilizzazione di un numero ristretto di doppiatori»50, di direttori e di adattatori. Un adattamento di un film di media durata deve essere consegnato in dieci–quindici giorni; la realizzazione dell’intero doppiaggio, strutturata in tre turni di lavorazione giornaliera di tre ore ciascuno, occupa mediamente dieci turni (ovvero in totale una trentina di ore). Inutile dire che talora vengono imposti tempi ancora più brevi. Come si accennava poco sopra, l’adattamento e il doppiaggio di un film vengono commissionati unicamente dalla società distributrice, che, come vedremo, ne stabilisce anche il nuovo titolo. Di solito né il regista né il produttore hanno più voce in capitolo, una volta che il film varca le frontiere del paese d’origine. Un’eccezione era Stanley Kubrick, il quale, estendendo al doppiaggio la maniacalità con cui seguiva ogni fase di lavorazione, si interessava personalmente alle versioni straniere di tutti i suoi film. Talora, per tentare di fronteggiare l’impoverimento qualitativo corrispondente all’aumento della domanda e alla diminuzione coatta dei tempi di consegna, alcuni produttori nominano un supervisore dell’adattamento, il quale, secondo l’opinione degli addetti ai lavori, il più delle volte ignora l’italiano51. 50. RAFFAELLI (1992: 129 n. 112). 51. PAOLINELLI/DI FORTUNATO (2005: 44). 5 – Il “doppiaggese” 289 5.1.5. In aggiunta a tutti questi elementi che costituiscono la “falsità”, per dire così, inevitabile e congenita del doppiaggio, non sono mancati, nella storia dell’adattamento cinematografico, casi storici di intenzionale falsificazione dell’originale: approfittando della riscrittura dei dialoghi, infatti, s’è colta l’opportunità per tagliare scene e sostituire o attenuare battute compromettenti, come abbiamo visto a proposito di Casablanca e di altri film. Ci fu anche, tra la fine del muto e i primordi del sonoro, chi difese apertamente tali abitudini (applicate tanto alle didascalie quanto ai primi dialoghi), in nome di un supposto miglioramento dell’opera 52. Il film veniva così manipolato profondamente, talora anche nella trama e addirittura nel tessuto iconico, per esempio invertendo le parti dell’originale. Fin dalle origini del mezzo si profila dunque l’annoso problema della scelta tra una traduzione source oriented [→ Glossario, SOURCE ORIENTED TRANSLATION] (o filologica, ovvero attenta prevalentemente a restituire al fruitore della lingua B — la lingua in cui si traduce — un testo il più possibile vicino alla volontà dell’autore in lingua A — la lingua dell’originale) e una traduzione target oriented [→ Glossario, TARGET ORIENTED TRANSLATION] (o naturalizzante o etnocentrica, che tenta, cioè, di adattare tutti i riferimenti culturali, familiari soltanto al fruitore della lingua A, sostituendoli con riferimenti comprensibili al fruitore della lingua B). La traduzione audiovisiva (o multimediale53, com’è oggi comunemente denominata) preferisce, da 52. Si vedano le dichiarazioni di Guglielmo Giannini riportate nel § 2.2.2, cui si rimanda anche per i problemi della traduzione delle didascalie nel muto. 53. Il termine va inteso in duplice accezione: sia nel senso di trasposizione di codice (traduzione da una lingua all’altra, oppure riduzione di un’opera letteraria in un film, etc.) che tenga conto di tutti i livelli propri del testo audiovisivo, per l’appunto suoni, immagini, parole scritte e parlate; sia nell’impossibilità di concepire l’opera audiovisiva unicamente legata al teatro, al cinema e alla televisione: oggi, infatti, tali testi sono sempre più spesso destinati alla fruizione mediante computer (in DVD o on line) e addirittura telefono (cfr. HEISS 1996). Proprio la crescita progressiva di prodotti ipertestuali e multimediali on Web e in DVD fa sì che il sottotitolaggio non sia più alternativo al doppiaggio (GALASSI 2000: 203): le due competenze, anche in lingue diverse dalle tradizionali, saranno sempre più richieste e il rischio da evitare sarà quello di far prevalere il parametro della quantità (di lingue e prodotti) e della velocità (dei tempi di 290 Il linguaggio cinematografico sempre, il secondo tipo (target oriented), mentre la tradizionale trasposizione di un testo scritto (tanto più se artisticamente o scientificamente rilevante) in un altro sempre scritto opta generalmente per il primo (source oriented)54: Non bisogna […] mai dimenticare che il destinatario finale della traduzione di un libro è il lettore, mentre quello dell’adattamento di un film è lo spettatore. Si tratta di due riceventi molto diversi. Il primo agisce, per definizione, in solitudine: ha scelto più o meno consapevolmente l’opera da leggere e per farlo ha bisogno di un minimo di concentrazione. Inoltre, nella lettura, egli può fermarsi a riflettere o tornare indietro. Lo spettatore, al contrario, da solo quasi non esiste: esso si confonde con il pubblico, più casuale e distratto, di una sala. Inoltre, la sua emozione deve essere immediata: il film non può tornare indietro. È per tutti questi motivi che comunicazione e spettacolo devono essere inscindibili nell’adattamento55. La traduzione non è mai un processo che riguarda soltanto la lingua, intesa come sistema di significazione attraverso le parole, ma è sempre e comunque una traduzione culturale56. I motivi della scelta sono svariati, da quelli semiologici a quelli sociologici, come avevano ben compreso già i primi commentatori della tecnica del doppiaggio. Tra questi, spicca Raffaello Patuelli, il quale nel 1936 osserva che «l’ambientamento lavorazione imposta dalla committenza) sulla qualità. Inoltre è importante tener conto delle sottoripartizioni delle singole componenti del macrotesto audiovisivo: il dialogo, per esempio, «è solo una delle componenti — certo non la più marginale, certo la più peculiare — dell’immagine sonora del film. Immagine sonora che è fatta sì di parole, ma anche di fonemi, di rumori, di musica. In altri termini il film, più che parlare, suona» (GALASSI 1996: 411). 54. Sui due diversi tipi di traduzione (ovvero sulle abitudini socioculturali della domestication, localization o addomesticamento e della foreignization o estraniamento, cruciali nella traduttologia degli ultimi anni soprattutto ad opera di Lawrence Venuti) cfr. almeno VENUTI (1998: 154–155) e (1995/1999: I–IV, 47, 141–199 et passim); DENTON (1999: 10) e (2000); GALASSI (1999); ULRYCH (2000). 55. MEGALE (1995: 293). 56. Dall’intervista di Francesca Palermo a Gianni G. Galassi in PALERMO (2005: 132–133). 5 – Il “doppiaggese” 291 è uno dei compiti più importanti del riduttore e soprattutto dei più delicati, per il rischio continuo di sfiorare l’irriverenza, la profanazione, la goffaggine, nell’immagine, nel paragone, nel nome, nel personaggio italiano che egli sceglie a sostituzione di quello straniero, incomprensibile se tradotto letteralmente, o inespressivo per il nostro pubblico»57. Scavando sotto la patina puristica ed esterofoba, all’epoca quasi imprescindibile, colpisce la lucidità con la quale il Patuelli individua l’urgenza dell’ambientamento (ovvero dell’atteggiamento target oriented: tra gli esempi riportati, l’opportunità di adattare un’americana «onion soup» con un’italiana «zuppa di fagioli») nella “riduzione” cinematografica di un film straniero. L’intervento del Patuelli suscitò un dibattito, ospitato dalla stessa rivista “Lo schermo”, che vide favorevole il Vecchietti58 e contrario il Chiarini, il quale osservò acutamente, sempre a proposito della «zuppa di fagioli» quale sostituto naturalizzante dell’originale onion soup, che «quella zuppa di fagioli e quell’accento e quell’espressione con cui viene richiesta, tipicamente italiani, contrastano col viso sbarbato, biondo e roseo dell’americano e con l’ambiente della trattoria tipico di quel paese»59: ovvero, la zuppa di fagioli diverrebbe ancor più straniante della zuppa di cipolle, per il pubblico italiano, consapevole che la storia è ambientata negli Stati Uniti e non in Italia. Come si vede, il problema dell’adattamento dei frames (su cui cfr. qui appresso e già supra, § 1.3), importante in ogni traduzione, diventa cruciale in quella audiovisiva, dove, come giustamente notava il Chiarini, l’accordo immagine–parola non deve mai essere straniante (salvo che non lo voglia il regista, ovviamente). 57. PATUELLI (1936: 30) [→ Antologia critica, § 12]. 58. Cfr. VECCHIETTI (1936) e CHIARINI/VECCHIETTI (1936). 59. C HIARINI (1936: 30). Sullo stesso tema torneranno C HIARINI /V ECCHIETTI (1936). 292 Il linguaggio cinematografico 5.2. Pratiche ed esempi 5.2.1. A differenza dei dialoghi filmici nostrani, fin dalle origini propensi ad accogliere regionalismi e popolarismi e ad avvicinarsi più o meno al parlato–parlato, la lingua doppiata mostrò subito una sua forte identità normativa (a parte i casi di involontaria inflessione dialettale e straniera dei doppiatori delle origini) e una sua evidente neutralità stilistica, tanto più stridente quanto più si sovrapponeva ad originali comici e brillanti, caratterizzati spesso da una disinvoltura dialogica [→ Glossario, DIALOGICITÀ] anche superiore a quella dei corrispettivi generi italiani60. Proprio per queste sue caratteristiche, il doppiaggio ha contribuito attivamente all’accrescimento linguistico delle passate generazioni: come anticipato all’inizio del capitolo, la diffusione del cinema straniero (soprattutto statunitense) doppiato, infatti, era talmente alta, nel secondo dopoguerra, da rendere non esagerata l’affermazione (di Flaiano, De Mauro, Raffaelli, Brunetta e tanti altri)61 secondo la quale gli italiani hanno imparato meglio la loro lingua, prima della televisione, soprattutto grazie al cinema adattato. La sua regolarità, la politezza della dizione, l’accuratezza nella sintassi, l’attenuazione delle escursioni lessicali verso l’alto e verso il basso, la sua tendenziale immobilità diafasica, diastratica e diatopica, insomma, contengono un’intrinseca carica didattica e normativa, tanto più forte quanto più culturalmente sfornito è, e soprattutto era, il bacino 60. È quanto accade, per esempio, in Nata ieri (Born Yesterday), 1950, di George Cukor, film tutto giocato, metalinguisticamente, sugli errori grossolani degli ignorantissimi protagonisti Harry e Billie (dalla doppia negazione ai fraintendimenti, dalla deformazione lessicale alle infrazioni della morfologia verbale, dai gergalismi ai popolarismi), sistematicamente raddrizzati nel doppiaggio decisamente formale, come illustrato in ROSSI (1999a: 289–897). Oggi si tende sempre più spesso a riprodurre gli errori (voluti) dell’originale nell’adattamento italiano, come accade, per esempio, nel remake di Nata ieri (Born Yesterday), 1993, di Luis Mandoki, e, molto più fedelmente e coerentemente, in The Terminal, 2004, di Steven Spielberg, film interamente basato sul progressivo (in verità troppo veloce per essere credibile, già nell’originale) apprendimento linguistico del “russo” Tom Hanks. 61. Cfr. almeno BRUNETTA (1991: 408) e FINK (1994: 35). 5 – Il “doppiaggese” 293 d’utenza62. E il pubblico mostrava di sentirsi attratto da questa lingua da persone perbene che, ancora nel secondo dopoguerra, come ricorda Luigi Magni, era parlata soltanto da Gary Cooper e colleghi, o meglio dai loro doppiatori63. Anche grazie al doppiaggio, insomma, gli italiani hanno cominciato ad avvertire il dialetto e il parlar male (indebitamente identificati dai parlanti comuni) come qualcosa di provinciale e di socialmente squalificante. Una caratteristica che accompagnerà la lingua del doppiaggio almeno nei suoi primi quaranta anni di storia è pertanto una spiccata tendenza alla standardizzazione e all’INNALZAMENTO DIAFASICO [→ Glossario] dell’originale. Il doppiato italiano, infatti, da una parte non dispone, per note cause storiche, di modi colloquiali dimessi e disinvolti; dall’altra non è libero di ricorrere, a causa delle restrizioni linguistiche del regime, a varietà basse d’italiano o a espressioni dialettali. Perciò, non potendo gareggiare in varietà e scioltezza con lingue di maturo uso anche orale, come l’inglese, deve rinunciare a riproporre le eventuali variazioni etniche, culturali, generazionali del testo originale, nonché le diversità di codice (per cui traduce in italiano anche gli idiomi esotici). L’adattatore, volendo assicurare ai nuovi dialoghi da una parte prestigio e dall’altra naturalezza discorsiva e massima comprensibilità presso tutte le platee, cerca di foggiare — condizionato anche dalla temperie uniformatrice dell’epoca — una lingua rispettosa della norma grammaticale, appiattita su un livello medio e foneticamente neutro (di ascendenza teatrale, cioè toscano, fino alla coatta assunzione della pronuncia romano–toscana, nel 1939)64. Tale prossimità al modello scritto medio–alto ha influenzato anche la produzione filmica italiana di più largo consumo, sia per la presenza delle stesse voci doppianti (relativamente poche, fino al decennio scorso), sia perché il «grado zero dell’oralità»65 62. 63. 64. 65. Cfr. RAFFAELLI (1991b: 100). Secondo la testimonianza raccolta in GIANNARELLI (1982, V). RAFFAELLI (2001: 896). ROSSI (1999a: 458–460). 294 Il linguaggio cinematografico raggiunto dal doppiaggio si mostrerà assai presto come lo strumento più congeniale al dialogo filmico: la lingua di Catene, ma anche di tanta Commedia all’italiana, è in questo senso emblematica, come risulta dai §§ 4.2.2, 6.1.1, 6.3. La crisi economica del cinema dell’ultimo trentennio, inoltre, induce molti registi «a girare, per opportunità commerciale, i film in edizione inglese, e a offrire così al mercato nazionale un parlato italiano succedaneo, che inevitabilmente risulta di solito imbastardito dalla doppiatura (si veda, tra i non recenti esempi illustri, Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, 1973)»66. 5.2.2. Un utile strumento di verifica del tasso di formalità degli adattamenti del primo decennio della storia del doppiaggio è fornito dalla riedizione di alcuni film, motivata, com’è noto, dallo smarrimento o dal deterioramento della colonna sonora della prima versione sincronizzata, non certo dall’esigenza di un aggiornamento linguistico. Non mancano, cionondimeno, esempi più o meno riusciti di rinnovamento stilistico. Il secondo doppiaggio (1980) di Furia (Fury), 1936, di Fritz Lang, presenta numerosi e apprezzabili tentativi di un coerente aggiornamento lessicale e sintattico (si noti soprattutto il passaggio dal Voi al Tu o al Lei, già auspicato da alcuni critici dell’epoca67, lo svecchiamento degli insulti e il passaggio da una sintassi legata a una segmentata, più vicina al parlato): 66. RAFFAELLI (1994a: 283). Se, per la produzione più vicina a noi o per i film italiani dichiaratamente realistici, persuade la considerazione di PAVESI (1994: 131: «sembra […] che i poliziotti dei film americani non parlino come i poliziotti dei nostri film, gli innamorati o i genitori e i figli neppure»), per il passato e per i dialoghi italiani più impettiti ha ragione MARASCHIO (1982: 147), secondo cui «gli innamorati [dei film stranieri doppiati] tendono a parlare come la maggior parte degli innamorati dei nostri film, i genitori anche, i poliziotti anche e così via». Ma, se questa per Maraschio era la prova del positivo svecchiamento operato dai dialoghi filmici italiani su quelli doppiati, per noi, di contro, l’influenza è da leggersi nella direzione opposta. Di influenza del doppiaggese sull’italiano teleschermico (e conseguentemente anche filmico) parla GATTA (2000). 67. Tra gli altri, l’Allodoli e il Patuelli [→ Antologia critica, §§ 4.I e 12]. 5 – Il “doppiaggese” 295 POLIZIOTTO: Spegnete il motore e tenete le mani al volante. JOHN: Cos’è, un agguato? POLIZIOTTO: Andavate a tutta velocità, vero? […] POLIZIOTTO: Su le mani, presto! JOHN: Ehi, ma io non ho nessun’arma, sapete, solo delle noccioline riadattato in: POLIZIOTTO: Ferma il motore, amico, metti le mani sul volante. JOHN: Che cos’è, una rapina? POLIZIOTTO: Te la stavi filando a tutta birra, a quanto pare. […] POLIZIOTTO: Su con le mani, non fare il furbo! JOHN: Ma io non ho nessun’arma…68. UOMO: Avete forse intenzione di proteggere quel furfante? SCERIFFO: È piuttosto comico che tu, malandrino, mi richiami al rispetto della legge riadattato in: UOMO: Cosa cerca di fare? Proteggere quel verme? SCERIFFO: È il colmo che tu, scarafaggio, venga ad insegnare a me il mio mestiere69. Vorrei sapere se suo marito le ha telefonato. Oh, voglio sapere qualcosa! riadattato in: Non è che suo marito le ha telefonato, che sa qualcosa?70. Tuttavia la presenza di forme ad alta prevedibilità quali amico, «filarsela a tutta birra» e «non fare il furbo» collocano anche le battute del secondo adattamento nel più pretto doppiaggese. 68. MARASCHIO (1982: 147). 69. MARASCHIO (1982: 151). 70. MARASCHIO (1982: 152). 296 Il linguaggio cinematografico Un caso assai significativo è quello di Lilli e il vagabondo (Lady and the Tramp), 1955, della Walt Disney. Il film fu riedito nel 1997 e uscì in Italia con una nuova colonna sonora. Il caso della ridoppiatura dei film di animazione si distingue da quello degli altri film, poiché, essendo il genere rivolto ai bambini più o meno indipendentemente dall’epoca, è meno soggetto alla deperibilità e all’invecchiamento precocissimo tipico degli altri generi. Proprio per questo la produzione può decidere di rivitalizzare un titolo anche molto datato — e dunque di rimettere in moto tutta la macchina del merchandising — talora senza alcuna modificazione, altre volte mediante restauro della pellicola e, come in questo caso, riedizione della colonna sonora, rispettosa delle musiche originali, abbastanza vicina al primo adattamento (e complessivamente più fedele all’originale), ma con doppiatori (nel parlato e nel cantato) diversi71. Mettiamo subito a confronto la celebre canzone dei gatti siamesi: ORIGINALE: We are Siamese if you please// We are Siamese if you don’t please// Now we looking over our new domicile// If we like we stay for maybe quite a while// Do you seeing that thing swimming round and round? Yes// Maybe we could reaching in and make it drown// If we sneaking up upon it carefully/ there will be a head for you/ a tail for me// Do you hear what I hear? A baby cry// Where we finding baby/ there are milk nearby// If we look in baby buggy there could be/ plenty milk for you and also some for me//. 71. Il primo doppiaggio fu eseguito dalla Fono Roma e dalla CDC, adattamento a cura di Roberto De Leonardis, direzione del doppiaggio di Giulio Panicali. Come al solito, per l’epoca, il nome dei doppiatori non è specificato nei titoli del film. Il secondo doppiaggio, ad opera della SEFIT e della CDC, diretto da Francesco Vairano e adattato da Roberto De Leonardis (ma, come vedremo, all’adattamento originale sono state apportate alcune modificazioni), vede come protagonisti: Margherita Buy (Lilli), Claudio Amendola (Biagio), Marco Columbro (Whisky), Massimo Rossi (Gianni), Nancy Brilli (i gatti siamesi e Gilda) e altri. Quasi soltanto nel genere d’animazione un film può essere ridoppiato per cause diverse dallo smarrimento della colonna sonora originale (cfr. MARASCHIO 1982: 150; COMUZIO 1993: 11). 5 – Il “doppiaggese” 297 I DOPPIAGGIO: Siam siam siam del Siam/ siam siamesi// Siam flatelli ma non siamesi// Questa nuova casa ispezional dobbiam// Se ci galba folse un pezzo ci lestiam// Tu lo vedi in quella palla un pesciolin? Sì// L’hanno messo sotto vetlo/ povelin// Ola noi lo libeliamo/ ed eziandio/ ci giochiamo a testa e coda/ tu ed io// Senti quel piagnucolio? C’è un pupo là// Chissà quanto latte in gilo ci salà// Nella culla celto un po’ ne tlovelem// E un bel planzettin/ insieme ci falem//. II DOPPIAGGIO: Siam siam siam del Siam/ siam siamesi// Siam gemelli monosiamesi// Questa casa ispezionale noi dovlemo// Se ci piace molto a lungo lestelemo// Tu lo vedi in quella palla un pesciolino? Sì// L’hanno messo sotto vetlo/ povelino// Ola noi lo libeliamo/ e sai che festa// Ci mangiamo io la coda/ e tu la testa// Senti quel piagnucolio? C’è un pupo là// Chissà quanto latte in gilo ci salà// Nella culla celto un po’ ne tlovelemo// E un bel planzettino/ insieme ci falemo//. Come si vede, la canzone in inglese connota la parlata dei gatti siamesi (e dunque orientali) mediante alcune infrazioni nella morfologia verbale: errata costruzione o utilizzazione del presente progressivo («we looking», «do you seeing», «we could reaching» «we sneaking», «we finding»), assenza del morfema –s di terza persona singolare («a baby cry»), plurale al posto del singolare («there are milk»). Anche i due doppiaggi intendono connotare l’origine orientale dei due gatti, servendosi dello stereotipo linguistico della laterale al posto della vibrante (da ispezional a falem). Il primo doppiaggio, tuttavia, adotta anche l’apocope vocalica in rima, con la doppia funzione di assimilare il testo alla facile musicalità delle canzonette, cara perlopiù ai bambini (ma anche alla tradizione poetica più trita, da Chiabrera in poi)72, e, in aggiunta, di suggerire sonorità vaga72. Sull’apocope in poesia cfr. SERIANNI (2001: 103–120). MARASCHIO (1982: 152) nota che anche dal primo al secondo doppiaggio di Furia si passa dalle forme apocopate a quelle intere. 298 Il linguaggio cinematografico mente orientali: pesciolin e povelin come Ho Chi Minh, per intenderci (come già l’effetto fonico dell’uscita –ing dei gerundi originali). Quest’ultimo tratto scompare nel secondo doppiaggio, poiché avvertito, per l’appunto, come troppo usurato e datato e, oltretutto, sovrabbondante nella caratterizzazione dell’orientalismo. Dando per assodata la necessità degli autori di distaccarsi dalla versione letterale del brano (il cui contenuto è, peraltro, rispettato), soprattutto per i vincoli metrici e rimici imposti dalla canzone, non sono trascurabili neppure le altre differenze fra i tre testi. Nel primo doppiaggio compaiono forme ora ironicamente ricercate (eziandio), ora appartenenti alla tradizione tosco–letteraria (garbare), che cadono nel secondo doppiaggio, il quale, dunque, riequilibria il dislivello diafasico rispetto all’originale73. Si ha anche un caso di segno opposto: l’informale «un pezzo» si trasforma nel formale «molto a lungo». L’incongruo monosiamesi del secondo doppiaggio sembra invece un banalissimo errore di incomprensione del più appropriato «ma non siamesi» del primo. Infine, «ci mangiamo io la coda e tu la testa», più fedele all’originale inglese («there will be a head for you a tail for me»), sostituisce un ben più attenuato e ludico (forse per non turbare la sensibilità dei bambini di allora) «ci giochiamo a testa e coda tu ed io». Il fenomeno della preferenza accordata alle forme piene piuttosto che a quelle apocopate si riscontra anche nelle altre canzoni del film, come per esempio nella canzone della cagnolina “vissuta” Gilda: ORIGINALE: He’s a tramp/ but they love him// Breaks a new heart every day// He’s a tramp/ they adore him/ and I only hope he’ll stay that way// He’s a tramp/ he’s a scoundrel/ he’s a rounder/ he’s a cad/ he’s a tramp/ but I love him/ yes/ even I have got it pretty 73. Analoghi tratti di deletterarizzazione dal primo al secondo doppiaggio sono il monottongamento (giuocarci → giocarci) e la neutralizzazione dell’accordo del participio passato con l’oggetto («non mi aveva mai colpita» → colpito), in altri brani del film. 5 – Il “doppiaggese” 299 bad// You can never tell when he’ll show up// He gives you plenty of trouble// I guess he’s just a no–count pup// But I wish that he were double// He’s a tramp// If he’s a tramp he’s a good one/ and I wish that I could travel his way/ wish that I could travel his way/ wish that I could travel his way//. I DOPPIAGGIO: È un briccon/ giramondo// Spezza un cuore/ ogni dì// È spaccon/ vagabondo// Ma io spero che rimanga così// È un briccon/ è un randagio/ è malvagio/ è un tesor/ è un birbon/ ma l’adoro/ sì/ beh/ persino mi ha spezzato il cuor// Non si può mai dir quel che farà/ però sarà qualche guaio// È un fannullone/ lo si sa/ ma vorrei averne un paio// È un briccon/ vagabondo/ e peggior di lui non c’è// Ma io darei mezzo mondo/ per poter vagabondare con lui/ per vagabondare con lui/ per vagabondare con lui//. II DOPPIAGGIO: È un briccone/ giramondo// Spezza un cuore/ ogni dì// È spaccone/ vagabondo// Ma io spero che rimanga così// È un briccone/ è un randagio/ è malvagio/ è un tesoro/ è un birbone/ ma l’adoro/ anche se lui mi ha spezzato il cuor// Non si può mai dire quel che farà/ però sarà qualche guaio// È un fannullone/ lo si sa/ ma vorrei averne un paio// È un briccone/ vagabondo/ e peggiore di lui non c’è// Ma io darei mezzo mondo/ per poter vagabondare con lui/ per vagabondare con lui/ per vagabondare con lui//. Anche qui il testo tradotto presenta un lessico decisamente più selezionato rispetto all’originale (briccon, giramondo, dì), benché il secondo doppiaggio opti, in due casi di intervento diafasico di segno contrapposto, per la medietà lessicale (eliminando il formale persino) e sintattica (incrementando la coesione, eliminando la spezzatura “parlata” sì beh): «sì beh persino mi ha spezzato il cuor» → «anche se lui mi ha spezzato il cuor». Da notare infine che la cagnolina si chiama Peg nell’originale, mentre diventa Gilda nel doppiaggio. Quella della modificazione (quasi sempre italianizzazione) dei nomi propri è una caratteristica del nostro doppiaggio almeno fino agli anni Cin- 300 Il linguaggio cinematografico quanta. Altre volte viene mantenuto il nome straniero, sebbene ricondotto a una forma e a una pronuncia più facili, comuni e prevedibili per il pubblico italiano. È quello che accade, per esempio, con il cognome del protagonista di Nata ieri (Born Yesterday), 1950, di George Cukor: Harry Brock, pronunciato [bruk] nel doppiaggio74. Spesso, infine, il nome viene cambiato del tutto, ora immotivatamente (Lewt, diminutivo di Lewton, diventa Luis, in Duello al sole [Duel in the Sun], 1946, di King Vidor, forse perché più familiare per gli italiani; parimenti Curly viene semplificato in Charlie, in Ombre rosse [Stagecoatch], 1939, di John Ford), ora per innescare nello spettatore certi riferimenti socioculturali75. È sicuramente quest’ultimo il caso di Gilda (non stupisca, in un film di animazione: la Walt Disney e le sue tecniche distributive hanno sempre puntato, riuscendovi pienamente, alla seduzione degli adulti tanto quanto a quella dei bambini), assimilata ironicamente alla femme fatale interpretata da Rita Hayworth nel film omonimo del 1946, di Charles Vidor. Analogamente, il cane Jock, che parla nell’originale con marcato «Scottish accent», puntualmente sottolineato dai sottotitoli 74. Cfr. ROSSI (1999a: 295), anche su altri errori di pronuncia del film. 75. Il trattamento antroponimico di Ombre rosse ben si presta ad esemplificare gli usi del doppiaggio dell’epoca. I primi nomi vengono di solito adattati in italiano, mentre i cognomi restano invariati: Lucy Mallory diventa Lucia Mallory, Phil Sheridan → Filippo Sheridan, Richard passa a Riccardo, Luc → Luca, Violet → Violetta. Alcuni nomi privi di un corrispettivo in italiano restano tali e quali l’originale: Nancy, mentre altri vengono semplificati con un nome diverso ma simile nel suono (come già visto con Curly → Charlie); le cavalle Bessie e Banny passano a Bianchetta e Bessie. L’italianizzazione del nome proprio è senza dubbio un retaggio dei noti divieti fascisti di utilizzare forme straniere nei film (cfr. § 2.4.2). Alcune italianizzazioni di nomi hanno inaugurato vere e proprie mode, come Rossella (nome già esistente, ma certamente rivitalizzato dal film) per Scarlett, in Via col vento (Gone with the Wind), 1939, di V. Fleming. Altre volte il cambiamento del nome proprio rispetto all’originale risponde alle esigenze della censura, come nel caso del Grande dittatore (The Great Dictator), 1940, di Chaplin, studiato da RAFFAELLI (2005). Nomi italianizzati (e anche l’allocutivo di deferenza Voi) si incontrano ancora nella versione doppiata di Sabrina, 1954, di Billy Wilder, ricca, tra l’altro, di forme, già allora, più vicine allo scritto che al parlato: calatafare, desinare, dittafono, fonografo, giuocare. Spicca un settentrionalismo: «Non mi piace niente» ‘per niente’. Un esempio recente del passaggio da un nome poco familiare in Italia a uno più comune si ha nell’adattamento di About a Boy, 2002, di Paul e Chris Weitz (PALERMO 2005: 106): «Will, this is Imogene» adattato in: «Will, lei è Elisabeth». 5 – Il “doppiaggese” 301 (vedi subito sotto), diventa Whisky (ma sarebbe stato più appropriato, anche se forse meno noto ai più, Scotch, a questo punto) nel doppiaggio, dove si perde ogni altro riferimento alla Scozia se non nell’allusione alla nota bevanda in voga in quel paese. Tornando alle canzoni di Lilli e il vagabondo, anche il brano portante del film subisce lo stesso innalzamento diafasico (dall’originale al doppiaggio) e la riduzione (stavolta non l’eliminazione) dell’apocope (dal primo al secondo adattamento): ORIGINALE: This is the night/ it’s a beautiful night/ and they call it bella notte// Look at the skies/ they have stars in their eyes/ on this lovely bella notte// […] This is the night/ and the heavens are right/ on this lovely bella notte/ on this lovely bella notte//. I DOPPIAGGIO: Dolce sognar/ e lasciarsi cullar/ nell’incanto della notte// Le stelle d’or/ con il loro splendor/ sono gli occhi della notte// […] Dolce sognar/ e lasciarsi cullar/ nell’incanto della notte/ nell’incanto della notte//. II DOPPIAGGIO: Dolce sognare/ e lasciarsi cullare/ nell’incanto della notte// Le stelle d’or/ con il loro splendor/ sono gli occhi della notte// […] Dolce sognare/ e lasciarsi cullare/ nell’incanto della notte/ nell’incanto della notte//. In questo caso, in più, c’è la cancellazione di un particolare fondamentale del film: l’italianismo metalinguisticamente sottolineato «bella notte» («they call it bella notte» ‘la chiamano bella notte’), che viene neutralizzato e riportato all’interno della sintassi frasale («nell’incanto della notte»). Come di consueto, i termini italiani presenti nei film stranieri vengono o eliminati o trasformati in una lingua diversa, in sede di adattamento, per non indurre nello spettatore quel senso di spaesamento che deriverebbe dal sentir rimarcare l’italianità in un contesto integralmente italiano e, per giunta, accettato come tale soltanto per 302 Il linguaggio cinematografico tacita convenzione, ma della cui reale nazionalità si è ben consci per tutta una serie di elementi iconici e testuali: come reagirebbe il pubblico nostrano se gli si ribadisse che a Londra o a Tokyo la lingua comune è l’italiano? Sicuramente con divertimento, sarcasmo o stizza, tutte reazioni non previste dagli autori originari del film (torneremo su questo tema nel § 5.3.2). L’eliminazione di bella notte comporta peraltro qualche problema. L’espressione, infatti, non è che una delle tante tessere italiane disseminate nel film, il quale si serve della stereotipica assunzione della cultura italiana come portavoce mondiale del romanticismo e dell’amore. Tant’è vero che Lilli e il vagabondo, nella loro prima cenetta romantica, vanno nel ristorante italiano di Tony e Joe, vocalmente caratterizzati da un marcato italoamericano nell’originale, dall’inflessione siciliana nel primo doppiaggio e da quella napoletana nel secondo (sui motivi di questa trasformazione di accento si discuterà più tardi). Tony e Joe confermano vari stereotipi sugli italiani visti dagli stranieri: cucinano bene, apprezzano le belle donne e le situazioni galanti, cantano (e infatti saranno proprio loro a riprendere, sotto forma di serenata, il tema «bella notte») e amano l’opera (al punto da avere, sul muro esterno del ristorante, una locandina teatrale: «Opera House Apr. 26–27 Uncle Tom’s Cabin»)76. L’italianità che pervade tutto il film è talmente evidente e data per scontata che i sottotitoli del DVD in commercio, mentre sottolineano l’accento substandard di vari personaggi («Scottish accent», «German accent», «Irish accent», «Russian accent»), nulla dicono a proposito del marcatissimo «Italian accent» di Tony e Joe. 76. L’immagine della locandina si coglie soltanto nella versione originale del film (in DVD): non si vede nella videocassetta italiana in commercio, neppure in quella che riporta la versione restaurata del 1997, poiché il quadro risulta tagliato sul lato destro. È questa una delle numerosissime prove dell’utilità della filologia filmica: non tutte le copie del medesimo film sono uguali, soprattutto se si confrontano le copie destinate al mercato interno, quelle per il mercato straniero e quelle specifiche per la proiezione in aereo (il problema è stato soltanto sfiorato in ROSSI 1999a: 89–93), per non parlare poi dei classici “tagli” dell’immagine provocati dalla resa televisiva dei film e del fenomeno, recente, dei film “piratati” (e spesso ripresi abusivamente con telecamera digitale in sala) e immessi in internet, solitamente di qualità video e audio scadentissime. 5 – Il “doppiaggese” 303 Come s’è visto fino a questo momento, né le modificazioni dall’originale al primo doppiaggio, né quelle dal primo al secondo sembrano dettate da problemi di sincronismo labiale, esigenza decisamente poco significativa nel cinema di animazione e comunque, a detta dei realizzatori, quasi sempre un falso problema (al quale si interessano perlopiù il pubblico e i non esperti: se tutto il cast — costituito da adattatore, direttore di doppiaggio, assistente, doppiatori, fonico di sala, sincronizzatore, fonico di missaggio — è di buon livello, si riesce sempre a far tornare i conti sui movimenti delle labbra)77. Le spinte alla riscrittura (sia dei primi sia di eventuali secondi adattamenti) sembrano essere di natura formale e testuale: da un lato c’è la volontà (talora inconscia e indotta dalla tradizione didattico–letteraria italiana) di nobilitare l’eloquio o, per converso, di avvicinarlo al parlato spontaneo; dall’altro, l’esigenza di mettere il pubblico italiano nelle stesse condizioni di “comodità decodificatoria” del pubblico originario per cui l’opera è stata concepita per la prima volta: Quando regista e pubblico appartengono alla stessa cultura, esiste una connivenza di fondo. È per questa connivenza di fondo che il traduttore, il dialoghista e il direttore di doppiaggio, passando da una lingua all’altra, si devono chiedere in ogni momento: come reagirà qui il nostro pubblico? Sarà in grado di capire, di cogliere, di intuire le intenzioni del regista?78. 77. Cfr. GALASSI (1994: 64). Senza considerare qui che la battuta deve adattarsi a tutta la mimica facciale, anzi direi all’intera corporeità dell’attore, non certo soltanto ai movimenti labiali, per essere accettata come credibile dallo spettatore. PAOLINELLI/DI FORTUNATO (2005: 67–68), oltreché di «sincrono labiale», parlano dell’importanza di «sincrono gestuale» («il rispetto dei movimenti del corpo, in funzione dei quali decidere cosa far dire all’attore»), «sincrono lineare» («il rispetto della lunghezza, della durata della frase originale»), «sincrono ritmico»: «o isocronico, è il più importante, l’unico che va rispettato anche quando l’attore si trova fuori campo. È il cosiddetto ritmo interno della frase, composto da più elementi: la struttura morfo–sintattica della lingua originale, la velocità di recitazione, il timbro impresso alla frase dell’attore, che è condizionato dalla situazione e dal luogo dove si svolge la scena, il senso». 78. LICARI/GALASSI (1994: 160). 304 Il linguaggio cinematografico L’autore, quando concepisce l’opera filmica, ha in mente uno spettatore ideale, analogo al lettore ideale descritto da Umberto Eco nel suo Lector in fabula (1979). È scontato che qualunque autore di qualunque paese, a qualunque opera stia ponendo mano, ha in mente uno spettatore ideale parlante la sua stessa lingua. Quindi la fruizione dell’opera filmica in una lingua diversa da quella che è la lingua intesa dall’autore, introduce una connotazione illecita, indebita, sicuramente del tutto imprevista da parte dell’autore, un “tasso di esotismo” e di non immediatezza dovuta al processo di traduzione mentale operato dallo spettatore, anche il più smaliziato79. Vediamo a questo punto qualche altro cambiamento dal primo al secondo doppiaggio. Oltre alla sostituzione del toscano garbare con il non marcato piacere vi sono altre analoghe modificazioni: ciance → chiacchiere, codesto («non se la stia a prendere a codesto modo», dice Whisky a Lilli) → questo («Non stia a prendersela in questo modo»); sicché → cosicché; cocco bello → piccoletto. Tra il 1955 e il 1997 si è dunque verificata, non soltanto nella lingua del cinema, un’inversione di tendenza nella percezione e nell’uso del toscano, prima inteso come varietà di prestigio (letteraria e ben consona, tra l’altro, a un genere didattico quale il cinema di animazione), poi, all’opposto, come varietà periferica e quindi da evitarsi, perché marcata verso il basso (poco familiare ai bambini di oggi) e adatta solo ai generi comico–grotteschi, quando non volgari (come si vedrà meglio nel § 6.1.3). Un’unica eccezione, a conferma della regola: il coccodrillo del secondo doppiaggio pronuncia «vieni da mme» (con raddoppiamento fonosintattico dopo da, assente in italiano fuor di Toscana), in luogo del normale «da me» del primo doppiaggio. Il pregiudizio (infondato) che assegna a cocomero lo status di forma popolare o regionale ne comporta la sostituzione (in senso settentrionaleggiante e ipercorrettistico) con anguria80. Di 79. GALASSI (1994: 61). 80. Il Panzini considerava, all’opposto, anguria forma regionale (Lombardia, Veneto, Emilia), in luogo dell’italiano cocomero (cfr. PANZINI 1905/1942, s. v. anguria). 5 – Il “doppiaggese” 305 segno diverso, invece, il passaggio da «Miss Parioli» a «Miss quartieri alti» («Miss Park Avenue» nell’originale), come epiteti spregiativi di Lilli; in questo caso non si può parlare di defiorentinizzazione, ovviamente, bensì di deromanizzazione: evidentemente la Roma del 1997 non ha più il peso mediatico e culturale della dolce vita romana degli anni Cinquanta e Sessanta e pertanto la decodificazione del quartiere romano Parioli (spesso usato per designare metonimicamente persone benestanti, reazionarie e sprezzanti gli umili) non pare più così pacifica. Infine, la pronuncia dei forestierismi migliora dal primo al secondo doppiaggio: il vagabondo di Amendola non pronuncia più [dominwεts], bensì [dominεts] il cognome iberico Dominguez81. 5.2.3. Abbiamo dedicato tanto spazio al caso di Lilli e il vagabondo per mostrare come l’adattamento audiovisivo sia un’operazione di riscrittura delicata, complessa e necessariamente multimediale, che non può non tener conto dell’inseparabilità del codice iconico da quello fonico–acustico. Ha ragione Gianni G. Galassi quando osserva che l’adattamento è una prassi traduttiva che nel tradurre soltanto l’aspetto verbale, che è una sola delle componenti della scena acustica del film, in realtà finisce per tradurre il film nel suo insieme. Quindi, noi lavoriamo solo sulle parole direttamente, ma lavorando sulle parole traduciamo un intero universo sonoro e l’universo visivo che a questo universo sonoro è accompagnato82. 81. Il pessimo rapporto degli italiani con le lingue straniere (concausa del quale sarà anche la pratica del doppiaggio) ci è confermata da numerosi errori di pronuncia nei film doppiati fino a qualche decennio fa. Particolarmente frequente, tra l’altro, la pronuncia, così com’è scritto, del toponimo San Francisco (per es. nella Fuga [Dark Passage], 1947, di Delmer Daves, e in Eva contro [Eva All About Eve], 1950, di Joseph L. Mankiewicz). Si ricordi anche il Liverpùl detto in Prigionieri del passato [Random Harvest], 1942, di Mervyn LeRoy. Altri casi in MENARINI (1955: 187–188). 82. Dall’intervista di Francesca Palermo a Gianni G. Galassi in PALERMO (2005: 128–129). 306 Il linguaggio cinematografico L’esempio più spesso citato dagli esperti del settore, per dimostrare i vincoli imposti all’adattatore dal codice iconico (l’adattamento audiovisivo è stato definito giustamente una «traduzione vincolata»)83, è il seguente, tratto da Horse Feathers, 1932, di Norman Z. McLeod, con i fratelli Marx, in una scena del quale Groucho, rettore di un college, dovendo firmare un documento ha bisogno del sigillo ed esclama: «Give me the seal!» Il solerte Harpo gli porta una foca (seal in inglese può indicare sia il “sigillo” che la “foca”)84. Come adattare questo brillante gioco iconico–verbale? Solitamente i giochi di parole vengono radicalmente sostituiti con altri di pari carica comica, ma in questo caso l’immagine della foca ancorava irrimediabilmente al testo. L’idea fulminante venne all’adattatore Sergio Jacquier, il quale «risol[s]e la battuta con un geniale: ‘Focalizziamo!’»85. Un altro esempio felicissimo, sempre dalla penna generosa di Sergio Jacquier, è il gioco di paronomasia di Frankenstein junior (Young Frankenstein), 1974, di Mel Brooks: «werewolf there castle» (dove la prima parte di werewolf ‘lupo mannaro’ è paronima di where ‘dove’) adattato in: «lupo ululà castello ululì», coerente tanto con la mimica indessicale e il percettibile ululato di un lupo, quanto con la carica umoristica del contesto originale. 5.2.4. Oltre all’innalzamento diafasico rispetto alla fonte (su cui si tornerà), altri tratti tipici della lingua doppiata dei primordi erano, e sono rimasti tuttora, la bassa frequenza di sporcature, sfrangiature, false partenze [→ Glossario, FALSA PARTENZA], sovrapposizioni dialogiche, interruzioni. È come se i realizzato- 83. PAVESI (1994: 129). 84. GALASSI (1994: 62). 85. GALASSI (1994: 62). Un altro brano di difficile adattabilità, tratto dal medesimo film, è analizzato da JACQUIER (1995: 262–263). Alcuni film dei fratelli Marx sono stati doppiati in italiano soltanto in epoca recente. 5 – Il “doppiaggese” 307 ri della versione postsincronizzata del film tendessero ad azzerare le “anomalie” del parlato in situazione, vale a dire tutti quegli elementi che ne compromettono la perfetta intelligibilità. Ma sono proprio quegli elementi a rendere il parlato realistico e distante dallo scritto, anche se, appunto per questo, sono difficilmente riproducibili in uno studio di doppiaggio: per esempio, per ottenere una buona sovrapposizione dialogica occorrerebbe far recitare insieme più interlocutori, mentre la prassi del doppiaggio consiste nel separare il più possibile i turni di lavorazione, in modo da convocare i singoli attori per doppiare, nel minor tempo possibile, tutte le scene che li riguardano. Un’eccezione è costituita talora dalle scene di brusio, che dovrebbero essere tra le più realistiche del doppiaggio di un film. Purtroppo, però, vuoi per risparmiare su qualche minuto in meno di lavoro, vuoi per l’errata convinzione che il pubblico non se ne accorga, talvolta sono proprio queste le uniche scene, insieme ad alcuni brani di parlato radiotelevisivo inseriti nel film, a non essere doppiate e dunque a rimanere del tutto decontestualizzate86. Sembra specifica del testo filmico (differentemente da quelli parlato e scritto), segnatamente di quello doppiato, la ridondanza di vocativi (sia nell’allocuzione lessicale, vale a dire la presenza di nomi propri o comuni usati in funzione allocutiva, sia in quella pronominale). La funzione dell’iterazione del nome proprio è quella «di mantenere nella versione doppiata il nome che compare nell’originale (difficilmente sostituibile […] per ragioni di sincronismo labiale)»87. Si travasa dunque in italiano una peculiarità dell’inglese, trascurando il fatto che «la ripetizione del nome di battesimo spesso comunica in italiano un eccessivo calore ed una maggiore familiarità rispetto a quanto probabilmente inteso nell’originale inglese o americano»88. 86. Cfr. PAOLINELLI/DI FORTUNATO (2005: 54). 87. PAVESI (1996a: 124). Per l’influenza di questo tratto sul cinema italiano cfr. il § 4.2.2. 88. PAVESI (1996a: 127). Sul tema dell’allocuzione in prospettiva interlinguistica cfr. anche PAVESI (1994), (1996b) e LICARI/GALASSI (1994: 165–166). 308 Il linguaggio cinematografico Sempre sul terreno dell’allocuzione, tipico del dialogo in doppiaggese è anche un curioso paradosso sociolinguistico: la combinazione del Lei (allocutivo di cortesia che marca la distanza o quantomeno la non confidenza tra gli interlocutori, ma che nel doppiato sarà perlopiù traduzione del generico you inglese) con il nome proprio senza titolo (esempio: «La ringrazio/ Paul»), laddove in italiano ci si aspetterebbe un Lei + titolo (ed eventualmente + cognome, esempio: «La ringrazio, dottor Benzi»; l’alternativa Lei + nome — eventualmente preceduto da un lemma allocutivo come signorina: mi scusi, signorina Maria — pure assai comune nei doppiaggi, oppure + cognome senza titolo è ammessa quasi esclusivamente, in italiano standard, quando un superiore si rivolge a un sottoposto)89, come possiamo vedere nel seguente brano tratto da Magnolia, 1999, di Paul Thomas Anderson: «[DOTTORE:] (alla moglie di un suo paziente) Linda/ io farò il possibile per aiutarla// Ma lei deve essere forte». Altrettanto frequente è un altro “errore” socioculturale così brillantemente descritto da Bruno Zuculin: Call me Mary viene tradotto letteralmente «Chiamami Maria», mentre dovrebbe tradursi «Diamoci del tu», o per lo meno, da quel momento in poi i due sweethearts dovrebbero darsi solo del tu. Che la protagonista dica «Chiamami Maria» e che il giovane continui a darle del voi o del lei, è un solenne errore d’inglese90. Senza giungere a questi eccessi, quante volte, ascoltando un dialogo doppiato, ci avrà colpito l’incongruo uso del Lei al posto del tu, o viceversa91, e addirittura certi retaggi del Voi 89. Esattamente l’opposto, per quanto riguarda titolo + nome, di quanto accade in inglese (cfr. ULRYCH 1996: 147), che dunque, anche in questo caso, il doppiaggese si limita a ricalcare goffamente. 90. MENARINI (1955: 186). 91. A proposito della resa indebita di you inglese con tu italiano, PAVESI (1994: 141) osserva puntualmente: «Non è forse vero che tutti associano agli americani una 5 – Il “doppiaggese” 309 (pigro mantenimento del labiale di un you o vous originali o ossequio a un vecchio doppiaggese che ha fatto ormai stile e scuola?). Passando alla morfologia, spiccava, fino a non molti anni fa, una frequenza del passato remoto e del futuro mediamente più alta rispetto al parlato spontaneo e al parlato filmico italiano coevo. Il fenomeno ha almeno due spiegazioni: la solita tendenza all’innalzamento diafasico e la pigrizia degli adattatori che tendevano a ricalcare, pedissequamente, i caratteri morfologici dell’originale inglese, ricco di simple past, di forme del tipo to be going to, etc.92. 5.2.5. Sul terreno del lessico, il fenomeno più evidente è quello dei calchi più o meno inavvertiti, soprattutto dall’angloamericano, generosamente profusi dagli adattatori e spesso penetrati nella lingua degli altri mass media oltreché nell’italiano comune. Ne forniamo qui un rapido elenco in ordine sparso: dannato, dannazione e dannatamente (damn, damned; oggi perlopiù fottuto: fucking) invece di maledetto, maledizione e maledettamente; ehi, amico (ehi, man, o buddy, o mate e simili) invece di senti, bello, o della semplice eliminazione del vocativo93; abuso di interiezioni tipicamente angloamericane notevole informalità nei rapporti interpersonali? Non è allora così sorprendente se nei film tradotti la psichiatra dà e riceve del Tu dal suo paziente o l’avvocato dalla sua cliente. Naturalmente in un contesto reale ciò risulterebbe perlomeno alquanto bizzarro. Questo slittamento è possibile perché il doppiaggio crea convenzioni sue proprie. Lo spettatore impara a riconoscerle, considerandole parte di un certo esotismo […] e può quindi accettarl[e] nel contesto sociolinguistico in cui vengono prodotte». Sicuramente la scelta del momento di transizione dal Lei al Tu (diverso a seconda dei sistemi linguistico–culturali) è una delle cruces degli adattatori (cfr. PAOLINELLI/DI FORTUNATO 2005: 70–71). 92. Il fenomeno è documentato in ROSSI (1999a: 356, 365). 93. L’uso insistito e spesso incongruo del vocativo amico! («Che cosa bevi/ amico?»), ben stigmatizzato, anni fa, dal duo di comici televisivi Adolfo Margiotta e Massimo Olcese («Ehi/ amico/ dici a me? Sì/ dico a te! Fottiti!»), è marca ultratipica del doppiaggio ed è usato talvolta, al pari di altri “doppiaggesismi” come figliolo, ragazzo, etc., anche come parola–zeppa, ovvero come riempitivo per far tornare i conti del sincronismo labiale (cfr. ROSSI 1999a: 37 n. 12; PAVESI 1994: 137–138; PAVESI 1996: 125–128). Ricordiamo peraltro che amico era frequente già nelle didascalie del muto (cfr. gli esempi citati nel 2.2.1), a conferma del mutuo scambio di stereotipi tra cinema 310 Il linguaggio cinematografico (ehi, uau, iuhù, etc.) in luogo di altre propriamente italiane (oh, ah, e vai!, etc.); assolutamente (absolutely) usato come avverbio affermativo, privo di altro olofrastico di specificazione; bastardo (bastard) invece di altri insulti più comunemente italiani; dacci un taglio (cut it out) invece di smettila o piantala o finiscila; ci puoi scommettere! (you bet!, o you can bet!) invece di senza dubbio!, ci puoi giurare!, te lo giuro!, naturalmente!, lo credo bene!, e simili; esatto (exactly) invece di sì, hai ragione, sono d’accordo, etc.; non c’è problema (no problem), e simili (dov’è il problema, è un tuo problema, etc.) invece di va bene (difficile immaginare sostituti per gli altri calchi della serie); sono fiero di (I’m proud of) invece di sono orgoglioso, mi fa piacere, etc.; tranquilli! (be quiet!) invece di zitti!, silenzio!, state buoni, calmi, zitti, etc.; bene (well) ad apertura di enunciato in luogo di altri segnali discorsivi più tipicamente italiani (ecco, veramente, dunque, beh, ehm, etc.); abuso di voglio dire (I mean) invece di cioè, etc.; prego (please) invece di per favore («prego fate», «prego dite» e simili, osservava già il Menarini)94; celebrare (to celebrate) invece di festeggiare; dipartimento (department) invece di ministero; realizzare (to realize) invece di accorgersi, rendersi conto di; essere in condizione di fare (to be in condition to do) anziché poter fare, essere in grado di fare; posso aiutarla? (can/may I help you?) invece di desidera?; suggestione (suggestion) invece di suggerimento; andare a vedere qualcuno (to see someone) invece di andare a trovare qualcuno; lasciami solo (leave me alone) in luogo di un più italiano e straniero. Altre parole inequivocabilmente ricondotte dagli spettatori più attenti alla tradizione del doppiaggio (sebbene nate altrove), che le ha usurate, sono: bambola, pupa, sgualdrina e l’olofrastico affermativo già (yeah). Il doppiaggio degli ultimi anni tende a sottrarsi a certi stereotipi, come si può vedere dall’eliminazione di buddy e mate ‘compagno, amico’ negli esempi seguenti: «Excuse me, buddy» adattato in: «Scusi, le dispiace?» (peraltro diafasicamente innalzato rispetto all’originale); «Sorry, buddy» adattato in: «Scusa» (The Terminal, 2004, di Steven Spielberg [PALERMO 2005: 103]); «Marcus, where’s the phone? – Where’s the phone, mate?» adattato in: «Marcus, dov’è il telefono? – Dov’è il telefono Marcus?» (About a Boy, 2002, di Paul e Chris Weitz [PALERMO 2005: 109]). 94. MENARINI (1955: 155). 5 – Il “doppiaggese” 311 appropriato lasciami stare/in pace o vattene; sì (yes) invece di pronto nelle risposte telefoniche e di eccomi, dica e simili nelle altre risposte; sicuro (sure) invece di certo come olofrastico affermativo; l’hai detto (you said it) invece di proprio così; lo voglio (I do) invece di sì nella domanda di matrimonio dell’officiante; ah ah invece di sì, d’accordo, etc.; hm hm (o nulla) invece di prego, figurati e simili in risposta a grazie; vuoi? (will you?, would you?) nelle question tags [→ Glossario, QUESTION TAG]; abuso di ti voglio bene (I love you), a conclusione di una telefonata o di un incontro, invece di ti abbraccio, ti aspetto, etc.; abuso di ti amo (I love you) anche per affetti che l’italiano esprimerebbe con ti voglio bene; o cosa? (or what?) invece di o no, per caso e simili (oppure della semplice cancellazione): mi prendi in giro o cosa? Naturalmente non è facile dimostrare che queste forme siano nate col doppiaggio, ma è indubbia la loro propagazione nell’italiano di oggi ad opera dei film doppiati95. Né va peraltro sottovalutata la funzione del cinema doppiato come propulsore di anglicismi: da drink a saloon, da baby a mister, da cowboy, far West e western a OK, squaw, Yankee, etc. Così pure si riconoscono alcune felici creazioni degli adattatori cinematografici, come il celeberrimo picchiatello (già commentato nel § 1.4.2). Come tutte le lingue artificiali, quella del doppiaggio è resistente ai cambiamenti. L’italiano postsincronizzato contemporaneo, dunque, con alcuni inevitabili aggiornamenti e con le eccezioni che tra poco commenteremo, conferma la tendenziale innaturalezza della stagione aurea sopra descritta, con la solita propensione per uno stile formale e omogeneo, senza inflessioni 95. Dai calchi del doppiaggio metteva in guardia già il Patuelli nel 1936 [→ Antologia critica, § 12]. Cfr. inoltre almeno MENARINI (1955: 153–155, 185–188); MARASCHIO (1982: 149–150); PAVESI (1994: 137–138); ROSSI (2000). Tra i calchi precocemente entrati nell’uso comune grazie al doppiaggio, Raffaelli ricorda mani in alto! (hands up!), registrato già dal Panzini nel 1935 (cfr. PANZINI 1905/1942, s.v. hands up! e RAFFAELLI 2001: 900 n. 94) e attestato in italiano già almeno dal 1914, secondo la testimonianza riportata da RAFFAELLI (1992: 247 n. 45). 312 Il linguaggio cinematografico regionali (o con accenti artefatti), insomma quell’italiano che si è meritato epiteti quali doppiaggese, «italiano inesistente», «linguaggio improbabile […]: misteriosa lingua che passa per italiano ma non lo è», fonoromico96, «linguaggio senza carattere né sesso», «insipido e incolore»97, «scatola fonetica pseudoromanesca composta di duecento voci fondamentali che hanno reinventato una Italia che non esiste»98, «italian from nowhere»99, «italiano ‘insincero’»100. E la lista potrebbe seguitare a lungo. 5.2.6. Segue ora una rassegna di alcuni casi significativi grazie ai quali illustreremo i principali fenomeni dell’adattamento cinematografico. Occorre chiarire subito che non ci interessa allinearci alla nutritissima schiera dei detrattori del doppiaggio e alle loro lamentele sulle cattive traduzioni. I buoni e i cattivi traduttori (e gli eterni insoddisfatti dell’infedeltà della traduzione o, viceversa, i fanatici della riscrittura dell’originale) esistono in ogni ambito e non sono certo una prerogativa del cinema. Inoltre l’analisi puntuale del singolo film o del singolo autore ci pare meno significativa101 di una panoramica ragionata. La nostra personale opinione, comunque, è che il doppiaggio rimanga, tutto sommato, il male minore per consentire la fruizione della filmografia straniera, sicuramente non peggiore dei sottotitoli (solitamente più distraenti e più lontani dall’originale — perché troppo accorciati — rispetto al doppiaggio) né della proiezione in lingua originale priva di traduzione: quanti sono in grado, in Italia, di seguire senza intralci un intero film, non dico in cinese o in russo, ma pure in slang americano? Al solito, la strada migliore sembra quella della libertà di scelta lasciata allo 96. Da Fono Roma, tra le prime società di doppiaggio italiane (le dichiarazioni sono di Age [Agenore Incrocci] e di Luigi Magni in GIANNARELLI 1982, V). 97. Alberto Savinio in RAFFAELLI (1992: 85 n. 55). 98. Claudio G. Fava in CALDIRON/HOCHKOFLER (1981: 121). 99. FINK (1994: 35). 100. MENGALDO (1994: 70). 101. Si segnalano nondimeno alcuni saggi utili come esempi di analisi del film doppiato, dedicati all’adattamento della cinematografia di Eric Rohmer: LICARI (1994) e SALIBRA (2000). 5 – Il “doppiaggese” 313 spettatore; quella, per intenderci, che oggi consentono i DVD, nei quali sono disponibili versioni parlate e scritte in varie lingue. L’auspicio è che anche le moderne (o future) sale cinematografiche consentano la stessa libertà, mediante la distribuzione agli spettatori di appositi congegni (cuffie e display collocati presso ogni postazione, come già accade — per i display — in alcuni teatri d’opera stranieri). Tenteremo qui, dunque, attraverso l’esemplificazione diretta, di stilare una minigrammatica del doppiaggese, prendendo come riferimento la lingua egemone del cinema tradotto in Italia: l’inglese (nell’accezione lata che include anche l’angloamericano)102. Partiamo dall’innalzamento diafasico rispetto all’originale, che abbiamo già considerato come una delle caratteristiche distintive di questo tipo di traduzione103. «I can’t, I can’t. What are you trying to do?» adattato in: «Non posso, non ce la faccio, vuoi dirmi qual è il tuo scopo?»104: spicca l’eliminazione della ripetizione a favore della variatio e la ricercatezza formale dell’espressione «qual è il tuo scopo». «Poor Nora, is so brave» adattato in: «Povera Nora, porta la sua croce con dignità»105. «Don’t use fancy talk with me» adattato in: «E non mi faccia ipotesi subdole quando parla»; «He didn’t want to share me with the general public» adattato in: «Era geloso dell’ammirazione che suscitavo nel pubblico»106. 102. Dalla lettura dei saggi contenuti in HEISS/BOLLETTIERI BOSINELLI (1996) e in BOLLETTIERI BOSINELLI/HEISS/SOFFRITTI/BERNARDINI (2000) si ricava l’impressione che quanto da noi osservato nell’adattamento dall’inglese all’italiano valga anche per altri idiomi di partenza e di arrivo del processo traduttivo audiovisivo, incluso l’adattamento di film italiani in altre lingue. 103. Anche RAFFAELLI (1992: 55, n. 55) osserva che «l’italiano dei film doppiati risulta spesso tempestato di preziosismi sintattici e lessicali […] che male si amalgamano con il contesto». 104. Dopo l’uomo ombra (After the Thin Man), 1936, di Woodbridge Strong Van Dyke II (MARASCHIO 1982: 141). 105. Stesso film (MARASCHIO 1982: 148). 106. Nata ieri (Born Yesterday), 1950, di George Cukor. 314 Il linguaggio cinematografico «Those beach–crowd Apaches don’t like snow» adattato in: «A quei sacripanti d’indiani garba poco la neve»107: l’impennata dello stile è qui provocata dal toscanismo garbare e dal termine letterario di origine boiardesca e ariostesca sacripante. Anche l’originale inglese registrava un lemma fuori dall’uso medio, ma in quanto spostato verso il basso e il gergale, oltreché, parimenti all’italiano, ironicamente decontestualizzato (beach–crowd ‘tipo da spiaggia’): il doppiaggio traduce dunque uno scarto verso il basso con un doppio scarto verso l’alto. «You might say just the opposite» adattato in: «I termini della proposizione si potrebbero anche invertire»108. 5.2.7. Passiamo ora al fenomeno dei tagli, delle sostituzioni e delle glosse. Alla frequente utilizzazione delle pratiche di glossa nella lingua del cinema s’è già accennato nei §§ 3.5–6 e 4.1.1. Qui si aggiunga che nell’adattamento dei film stranieri queste pratiche sono spesso indispensabili (o quantomeno avvertite come tali dagli adattatori) per colmare delle lacune nella comprensione dovute ai diversi frames attivi nel pubblico della seconda lingua. L’adattatore italiano tende a non dare quasi niente per scontato, a presupporre uno spettatore distratto e poco avvezzo a fatti e riferimenti stranieri, per il quale semplifica la fruizione del film, sciogliendo quei nodi che potrebbero rallentare la decodificazione del messaggio. Di fronte al dato poco trasparente, l’adattatore ricorre alla sostituzione (se non è possibile l’eliminazione) con un elemento più familiare, non necessariamente simile all’originale, che possa rendere convincente un certo contesto. Oppure, come soluzione estrema, si affida a una spiegazione expressis verbis. Oggetto di glosse e di cancellazioni sono soprattutto, com’è facile a comprendersi, gli elementi più strettamente legati al contesto socioculturale del film: acronimi, toponimi, unità di misura, istituzioni, alimenti e bevande, giochi, titoli di libri, tra107. Ombre rosse (Stagecoatch), 1939, di John Ford. 108. Scene da un matrimonio (Scener ur ett äktenskap), 1973, di Ingmar Bergman (MARASCHIO 1982: 148). 5 – Il “doppiaggese” 315 smissioni televisive e simili, espressioni idiomatiche, ovvero tutti quei dati che, qualora trasposti letteralmente (secondo una traduzione di tipo source oriented), lascerebbero perplesso lo spettatore, secondo alcuni (ma, secondo altri, ne arricchirebbero la conoscenza). Vediamo qualche esempio chiarificatore. Gli acronimi vengono di norma sciolti, glossati o sostituiti con perifrasi di analogo significato, oppure eliminati: «It’s faster than BQE» adattato in: «È più veloce della Brooklin express»; «When the 9.12 from Toronto landed, they found four prescriptions without an MPL. He needs to have the papaer from, a Medicinal Purchase Licence» adattato in: «Era sul volo delle 9.12 da Toronto, gli hanno trovato quattro flaconi senza ricetta. Deve avere il modulo specifico, deve avere una ricetta per l’acquisto di qualsiasi medicinale»; «I need information on CBP Officer Torres» adattato in: «Io voglio informazioni sull’agente Torres»109; «How’s it coming with Herb Lazare, D.D.S.?» adattato in: «Come va con Herb Lazare, l’odontoiatra?»; «She was a senior delegate at the Model UN» adattato in: «Faceva la delegata all’ONU scolastica»110. L’ultimo esempio mostra l’urgenza dell’adattamento di un frame: nelle scuole americane alcuni ragazzi possono entrare a far parte della delegazione scolastica dell’ONU; dato che in Italia manca un’analoga istituzione, l’adattatore specifica scolastica, pur adottando l’acronimo ONU (corrispondente all’americano UN: United Nations) perfettamente comprensibile da tutti. Proseguiamo con altri esempi di deambiguizzazione, ci si passi l’aspra neoformazione, dell’originale. «She took the bus to the parking lot on K Street where her car was» adattato in: «Prende l’autobus che la porta fino al parcheggio dove aveva lasciato la macchina»111: il pubblico italiano medio associa gli 109. The Terminal, 2004, di Spielberg (PALERMO 2005: 99–100). 110. …E alla fine arriva Polly (Along Came Polly), 2004, di John Hamburg (PALERMO 2005: 122–123). 111. Suspect – Presunto colpevole (Suspect), 1987, di Peter Yates (BOVINELLI/GALLINI 1994: 91). 316 Il linguaggio cinematografico odonimi perlopiù a nomi propri di persona o di luogo e non a lettere o a numeri (com’è invece abituale per gli americani); l’adattatore ha dunque preferito eliminare questo dato. «Capital punishment is not an option in the district of Columbia» adattato in: «La pena capitale non è in vigore nello stato di Washington D.C.»112: il toponimo meno noto viene sostituito con uno più familiare agli italiani. La presenza di nomi propri (di luogo, di artisti, di personaggi letterari, titoli di opere, etc.) è un problema cruciale, per l’adattatore, per il solito fenomeno dei frames. Vi sono almeno quattro possibilità: lasciare il riferimento così come compare nell’originale (con conseguente problema della pronuncia dei nomi stranieri); tradurlo (nel caso di un titolo) letteralmente in italiano; eliminarlo (soluzione praticabile, ovviamente, soltanto se l’informazione è accessoria); trovare un corrispettivo italiano, magari passando dallo specifico al generico, che consenta al pubblico nostrano di non disorientarsi di fronte a un dato oscuro. È forse quest’ultima la soluzione preferita da molti adattatori, come rivelano anche gli esempi seguenti113. «Did you watch the Brady Bunch?» adattato in: «Lo guardavi l’Ufo Robot?»114. Il problema, come si vede, è analogo a quello della zuppa di cipolle versus zuppa di fagioli: il pubblico è più a proprio agio sentendo nominare un titolo straniero che non conosce oppure un titolo italiano (o italianizzato) noto ma del tutto fuori contesto? La domanda, che non è retorica, è destinata a rimanere aperta. «Maybe if I was like that movie kid, Haley Joel Osment I could pay her that much» adattato in: «Se fossi stato un ragazzino prodigio tipo quello del Sesto Senso avrei potuto pagarla»115: in questo caso il nome del protagonista (meno noto in Italia) 112. Stesso film (ibid.). 113. Simili esempi di adattamento di frames nel Raggio verde (Le Rayon vert), 1986, di Rohmer si leggono in SALIBRA (2000: 289–290 et passim). 114. Kramer contro Kramer (Kramer Versus Kramer), 1979, di Robert Benton (BOVINELLI/GALLINI 1994: 95). 115. About a Boy, 2002, di Paul e Chris Weitz (PALERMO 2005: 105). 5 – Il “doppiaggese” 317 viene sostituito dal titolo del film, celeberrimo anche da noi: Il sesto senso (The Sixth Sense), 1999, di M. Night Shyamalan. «All work and no play makes Jack a dull boy» adattato in: «Il mattino ha l’oro in bocca»116: i proverbi, al pari di tutte le espressioni cristallizzate, vanno ovviamente sostituiti con locuzioni analoghe. In questo caso, il proverbio scelto (forse dallo stesso Kubrick, anche per la versione italiana, e paranoicamente ripetuto dal protagonista sulla macchina da scrivere) sembra ribaltare il concetto (‘troppo lavoro aliena’, diceva più o meno l’originale, laddove l’italiano invita, antifrasticamente, ad alzarsi di buon ora per lavorare meglio e di più), anche se siamo sempre nel campo semantico lavoro/riposo (certo, il riferimento alla cupezza e alla depressione espresso dall’originale dull era più appropriato, rispetto all’ironia della versione italiana, alla tragica e surreale conclusione del film di Kubrick). «Bettina/ you ever been to the opera? […] You’re going to the Met?» adattato in: «Bettina/ tu ci sei mai stata all’opera? […] Vuoi dire a teatro/ a sentire la lirica? No/ mai//»117: l’adattatore preferisce espungere il nome (peraltro abbreviato) del più famoso teatro d’opera degli Stati Uniti, il Metropolitan Opera House (affettivamente, Met) di New York. Analogamente, «JFK/ please//» adattato in: «All’aeroporto/ per favore//»118, benché il nome dell’aeroporto di New York sia notissimo anche tra gli italiani. Un caso non molto diverso si incontra in Manhattan, 1979, di Woody Allen: «He opens at the Modern soon. I was gonna do a piece on Sol for Insight» adattato in: «Sapete presto apre al Modern Museum. Anzi io devo fare un pezzo sul Sol per Insight»119: evidentemente soltanto l’empatia tra newyorkesi permette di accorciare i nomi dei musei e dei teatri (Modern, Met). E ancora: «He begin [sic] to write letters to club, Lickey, Split, Snookie’s Sugar Bowl» adattato in: «Comincia a scrivere 116. 117. 118. 119. Shining (The Shining), 1980, di Kubrick. Stregata dalla luna (Moonstruck), 1987, di Norman Jewson. …E alla fine arriva Polly (PALERMO 2005: 122). PALERMO (2005: 115). 318 Il linguaggio cinematografico lettere a locali in New York, Lickey, Split, Snookies Sugar Bowl»120: l’adattatore ha voluto così aiutare il pubblico italiano (specificando il nome della città) non così esperto dei locali di New York. Il marchio o il tipo specifico di un prodotto può essere sostituito con un iperonimo o un termine analogo: «Can I have Cocoa Puffs?» adattato in: «Mi dai cereali al cioccolato?»121. Non mancano, peraltro, rari casi contrari di passaggio da nome comune a nome proprio, come nell’esempio seguente, in cui al semplice song dell’originale si sostituisce il titolo della canzone (del resto celebre anche in Italia) che si sta ascoltando in sottofondo: «I knew, of course, the song couldn’t last forever, that I’d soon be at home, tucked up in bed» adattato in: «Naturalmente sapevo che Killing Me Softly non poteva durare per sempre, che presto sarei stato a casa, sul mio letto»122. Lo scrupolo chiarificatorio degli adattatori italiani arriva, come si diceva, a sostituire, se possibile, nomi di persona poco noti in Italia con nomi da noi più familiari, oppure toponimi stranieri con toponimi italiani (talora anche soltanto per la convinzione di coinvolgere di più il pubblico). Accade, tra i numerosissimi esempi possibili di ieri e di oggi, nella celebre tirata antiteatrale di Eva contro Eva (All About Eve), 1950, di Joseph L. Mankiewicz: «Ma perché/ si deve credere che il teatro esista solo nell’interno di alcuni bruttissimi edifici/ ammassati nel cuore di New York/ o di Londra// Di Parigi o di Roma?». Nell’originale al posto di Roma c’era Vienna. Il teatro, dice il personaggio del regista frustrato, deve essere per tutti i gusti, non solo per il pubblico più raffinato: «Donald Duck/ Ibsen/ and the Lone Ranger/ Sarah Bernhardt and Poodles Hanneford// Lunt and Fontanne/ Betty Grable// Rex and the White Horse/ Eleonora 120. The Terminal, 2004, di Spielberg (PALERMO 2005: 96). 121. About a Boy (PALERMO 2005: 105). 122. About a Boy (PALERMO 2005: 109). Ovviamente questo è possibile soltanto con canzoni notissime anche in Italia, altrimenti avviene il contrario: «I like Santa’s Super Sleigh» adattato in: «A me piace la canzone di tuo padre» (stesso film, EAD., p. 110). 5 – Il “doppiaggese” 319 Duse// All theatre!» adattato in: «Topolino/ Ibsen e i drammi gialli// Sarah Bernhardt e i cani ammaestrati// Gianni e Pinotto e Betty Grable// Ermete Zacconi/ Eleonora Duse// Tutto teatro!». Le sostituzioni della versione italiana, come si vede, lasciano inalterato il rapporto tra teatro colto e spettacolo popolare. Successivamente: «Arthur Miller? Sherwood? Beaumont and Fletcher?» adattato in: «Eugenio Onèl? Sherwood? Alfieri o Voltaire?»: come si vede, anche laddove viene citato un autore straniero (con primo nome italianizzato) se ne può stravolgere la pronuncia (Eugene O’Neill diventa Eugenio Onèl). Più facile, nell’ultima parte del film, l’adattamento della coppia di comici «Abbott e Costello», che in italiano diventa, come in effetti accadde nella distribuzione italiana dei film dei due comici americani, «Gianni e Pinotto» (anche se i sottotitoli italiani del DVD intendono qui agevolare persino questo dato, mal adattandolo in «Stanlio e Ollio»): «Eve would ask Abbott to give her Costello» adattato in: «Eva chiederebbe a Gianni di darle Pinotto». Nel medesimo film, un «milk shake» viene tradotto con «un’orzata» (oggi indubbiamente l’anglicismo sarebbe stato mantenuto); per mettere in guardia dal pericolo di una scenata imminente s’avverte, ironicamente: «Fasten your seat belt» adattato in: «prendete i salvagente» (le cinture di sicurezza non erano molto popolari, da noi, negli anni Cinquanta). Infine, le miglia diventano chilometri soltanto a parole ma senza la debita proporzione matematica, col risultato abnorme della distanza tra Hollywood e New York di «tremila chilometri»123. 123. Gli adattatori moderni sono solitamente molto più attenti su questo fronte: «2 ounces of meat», «a 6–pound ham» e «1/4 lb of bacon» sono stati rispettivamente adattati in: «100 grammi di carne», «un prosciutto di 3 chili» e «2 etti di bacon», in 84 Charing Cross Road, 1986, di David Hugh Jones (BOVINELLI/GALLINI 1994: 92). «Mentre è accettato che la valuta rimanga quella del Paese di origine, e sarebbe impensabile tradurre al cambio corrente somme in dollari, il discorso è diverso per i pesi, le lunghezze ecc., in cui è necessario valutare se lo spettatore sia in grado di fare al volo l’equazione, senza distrarsi dalla comprensione e dal coinvolgimento nella vicenda che il doppiaggio vuole favorire. Non è quindi un abuso, a nostro parere, ‘tradurre’ le libbre in etti e le miglia in chilometri, in quanto quello che si perde in ‘localizzazione’ lo si recupera in comprensione» (PAOLINELLI/DI FORTUNATO 2005: 77). 320 Il linguaggio cinematografico Ancora nel 1979 vengono sostituiti o eliminati nomi di personaggi in realtà ben conosciuti anche dallo spettatore italiano medio: «When it comes to relationship, I’m the winner of the August Strindberg Award» adattato in: «Quando si tratta di rapporti con le donne io sono il vincitore del premio Sigmund Freud»; «This is shaping up like a Noël Coward play. Somebody should go make martinis» adattato in: «Sta diventando un film commedia anni ’50. Qualcuno dovrebbe cominciare a servire dei Martini»124. Nei casi di bilinguismo presenti nella colonna sonora originale, le glosse esplicative vengono di norma eliminate dal doppiaggio. «[SIGNORA:] (a proposito di sua sorella) She stole a man from me// S’ha preso il mio uomo// […] She’s going back to Sicily// Ritorna in Sicilia//» adattato in: «Io ero fidanzata con un uomo del mio paese/ e lei mi prese il mio uomo// […] E ora in volo per la Sicilia/ è// In Sicilia/ ritorna//»125. Quanto nell’originale era semplice traduzione dall’italiano (o dal dialetto) all’inglese, diventa semplice ripetizione o riformulazione (spesso non giustificata, come incongruo sembra lo sguardo interlocutorio dell’ascoltatore che non capisce il primo enunciato straniero) nel doppiaggio: «Pisc nee mane// Pipi in your hands […]// ’A pisciazza/ faci i caddi duri// Makes calls hard// Makes the root hard//» adattato in: «Piscia int’ee mano// Sta’ tranquillo/ non te fa male! Piscia int’ee mano! […] La pisciazza/ fa i caddi duri// Fa duro il callo// Fa dura la radice//»126. Altre volte la glossa viene mantenuta nel doppiaggio, ma da italiano/inglese si passa al bilinguismo dialetto/italiano, che può, dunque, giustificare la richiesta di spiegazione (magari per semplice supponenza) da parte dell’interlocutore, come nel seguente esempio tratto da Big Night, 1996, di Stanley Tucci e Campbell Scott: 124. Manhattan, 1979, di Woody Allen (PALERMO 2005: 113, 115). 125. Stregata dalla luna. 126. Mac, 1992, di John Turturro. 5 – Il “doppiaggese” 321 PRIMO: C’è bisogno più del sale? SECONDO: What? PRIMO: More salt? adattato in: PRIMO: Ce vo’ ’n bo’ chiù de sale? SECONDO: Scusa? PRIMO: Manca di sale? Qualunque riferimento alla lingua dell’originale viene solitamente cancellato nell’adattamento: «He asks to nuns to write English. Hundreds letters» adattato in: «Lui chiesto a suore di scrivere lettere. Centinaia di lettere»; «He doesn’t speak English» adattato in: «Quel poveretto non capisce una parola»; «What’s BH? — In English… Victor Navorski» adattato in: «Che vuol dire BH? — In suo alfabeto… Victor Navorski»127. In effetti, le altre due soluzioni (tradurre English con inglese o trasformarlo in italiano, pure praticate, in passato) sarebbero parimenti stranianti per il pubblico nostrano, il quale in un caso noterebbe la differenza tra l’italiano parlato nel film e il riferimento all’inglese e, nell’altro, non potrebbe fare a meno di sorridere nel constatare il riferimento all’italiano in un contesto integralmente straniero, come già ricordato a proposito di Lilli e il vagabondo. 5.2.8. Un altro fenomeno proprio dell’adattamento filmico consiste nella cosiddetta pratica dello spostamento, che ha la funzione di riequilibrare la connotazione stilistica e il colore sociolinguistico dell’intero film. Se, per questioni di intraducibilità, di sincronismo labiale o di aggancio con il codice iconico, non è possibile rendere certe espressioni in italiano nel momento in cui vengono dette nell’originale, si fa in modo di introdurre espressioni analoghe, o quantomeno di cifra stilistica simile, 127. The Terminal (PALERMO 2005: 96, 102). 322 Il linguaggio cinematografico in un altro momento del film (per esempio come voce fuori campo o modificando un’altra battuta). Lo spostamento può avvenire anche da un piano della comunicazione all’altro, come spiega efficacemente Gianni G. Galassi: cosa succede se in un telefilm americano c’è una battuta del tipo: «Lei dev’essere texano», motivata dallo strano accento di un personaggio? Il dialetto non si può usare, perché fa ridere il pubblico, abituato ai clichés della Commedia all’italiana. Se nelle immagini c’è qualcosa che corrisponde allo stereotipo italiano del texano (per esempio il tipico cappellone), allora i problemi dell’adattatore sono risolti. Altrimenti «il dialoghista può, per esempio, far sì che questo signore parli dei suoi pozzi di petrolio»128. Analogamente, Anita Licari afferma, a proposito dell’adattamento dei film di Rohmer: la tecnica maggiormente usata per risolvere il problema delle espressioni familiari e argotiche è quella dello spostamento, frequente soprattutto in situazioni filmiche in cui non occorre rispettare sincronie di tempo o di movimenti delle labbra. Per rendere il colore dei dialoghi francesi, si approfitta in italiano delle battute che i personaggi dicono fuori campo, di spalle, in ombra o in campi lunghi, per trasformare espressioni semplici e brevi in espressioni più lunghe e più colorite, magari con marche generazionali. Insomma, si aggiunge colore dove si può ottenere lo stesso effetto. Così Il raggio verde è costellato di espressioni come «e stai da dio», «si sta da dio», «brava, la trovata del secolo», «un vento della madonna», che non hanno, nel momento in cui vengono pronunciate, un esatto corrispondente linguistico nella versione francese, ma tentano di riequilibrare un dialogo in cui si è dovuto tradurre i vari «bosser» semplicemente con «lavorare», e i vari «c’est vachement bien», «c’est vachement bizarre» con espressioni meno gustose129. Il disvelamento (o, se si preferisce, la naturalizzazione) dell’originale a favore del pubblico nostrano viene perseguito talo128. GALASSI (1994: 67). 129. LICARI/GALASSI (1994: 159). 5 – Il “doppiaggese” 323 ra oltre il necessario, come è emerso dagli esempi, sia perché lo spettatore medio sarebbe comunque in grado di colmare da sé certe lacune interpretative, sia perché viene reso esplicito anche quanto il regista del film aveva voluto lasciare implicito per il proprio spettatore ideale, come si vedrà chiaramente nella prassi della riscrittura dei titoli. Evidentemente coesistono, nell’adattatore, due o più anime: quella del professionista sinceramente intenzionato a venire incontro al pubblico e quella dell’autore frustrato che entra in competizione con l’originale presumendo di migliorarlo130, per tacere qui dei casi di mal adattamento dovuti alla fretta e alle pressioni della committenza. Riportiamo, in conclusione e a conferma di quanto appena detto, un unico altro esempio di adattamento forse dettato da eccesso di zelo naturalizzante. Accorgendosi della presenza di troppi cuscini decorativi sul suo letto, un personaggio esclama: «Am I running a bed and breakfast?» adattato in: «Insomma ma che cos’è? La casa delle bambole?»131. Ora non v’è dubbio che l’istituzione del bed and breakfast sia più comune e di più antica origine nei paesi angloamericani che in Italia e che, dunque, 130. «[F]ino a qualche tempo fa i copioni di alcune case di distribuzione riportavano con ironia il divieto, rivolto ad adattatori e doppiatori, di cambiare o migliorare l’originale: ‘Don’t improve the movie’. Attualmente un eventuale divieto censorio riguarda solo il turpiloquio (e la bestemmia […]), se il distributore ha deciso che il film deve evitare il divieto ai minori di 18 anni, o se conta di venderlo a una rete televisiva per il prime time, quindi a un prezzo più alto» (PAOLINELLI/DI FORTUNATO 2005: 19). Più di un adattatore mi ha confermato il timore di essere considerato un cattivo scrittore dalla committenza. Per questo motivo, tra l’altro, si tende talora a preferire un termine specifico e più ricercato in luogo di uno generico dell’originale (thing, to do, etc.). Anche la frequenza del congiuntivo è talora suggerita dalla committenza, per tentare di incontrare i gusti del pubblico atteso: «L’adozione o meno del congiuntivo connota in modo evidente il parlante, ed è un elemento stilistico che si nota a prima vista, perché l’italiano è una lingua perbene fino alla pomposità. Un periodo ipotetico correttamente costruito dà luogo a un eloquio sofisticato, oltre che prolisso. Quindi facendo dire a un personaggio ‘se lo sapevo non venivo’ è evidente che do a quel personaggio una particolare connotazione tramite un uso mirato dello scarto dalla norma. L’effetto è inequivocabile» (GALASSI 1994: 67–68). Come si vede, la percezione della normatività da parte di taluni addetti al lavori è decisamente più sensibile anche rispetto ad altre forme di italiano pubblico (per esempio quello televisivo). Ringrazio in particolare l’adattatore e doppiatore Alessio Cigliano per queste informazioni. 131. …E alla fine arriva Polly (PALERMO 2005: 122–123). 324 Il linguaggio cinematografico il frame ‘arredamento lezioso e atmosfera ostentatamente ospitale’ sia più familiare per il pubblico di partenza che per quello di arrivo. Quest’ultimo, tuttavia, da anni ormai ha ben presente il significante, oltreché il significato, utilizzato nell’originale, che avrebbe potuto quindi tranquillamente essere assunto senza alcuna traduzione, come del resto avviene abitualmente nell’italiano comune (che ha accolto ormai anche l’acronimo B&B). 5.3. Il dialetto e le lingue straniere nel doppiaggio 5.3.1. Il doppiaggio si confronta fin dalle origini col problema del dialetto. Non mancavano, infatti, inflessioni regionali (inconsapevoli) nei doppiaggi delle origini, realizzati negli Stati Uniti132; tuttavia la prassi di postsincronizzare i film a Roma (dal 1932 e, per legge, dal 1933–1934), ricorrendo ad attori spesso formatisi all’Accademia di arte drammatica, comportò, almeno fino agli anni Settanta, un atteggiamento quasi totalmente dialettofobo. Non mancano le eccezioni. Tra le più note ricordiamo il romanesco del gatto randagio Romeo (irlandese, nell’originale), «er mejo der Colosseo», negli Aristogatti (The Aristocats), 1970, della Walt Disney: il toscano Renzo Montagnani doppia il gatto Romeo con apprezzabile resa di un romanesco dalle tinte arcaiche («se vedemio» ‘ci vediamo’); nel ben congegnato doppiaggio del disegno animato (dove spicca anche certo gusto per i neologismi: rapigatto ‘chi afferra un gatto’) si avvertono anche marcati accenti settentrionali nei cani Napoleone e Lafayette e siciliano in un comprimario felino. Risalendo lungo l’asse cronologico, è attestato un uso precocissimo, quanto incongruo, dell’inflessione napoletana nei pescatori dell’Uomo di Aran (Man of Aran), 1934, di Robert J. 132. Tra i numerosi esempi possibili, L’amazzone mascherata (Riders of the Purple Sage), 1931, di Hamilton MacFadden, con inflessioni tra il romanesco e il napoletano (cfr. RAFFAELLI 1992: 83). 5 – Il “doppiaggese” 325 Flaherty133 e del romanesco nel film giapponese La fortezza nascosta (Kakushi toride no sanakunin), 1958, di Akira Kurosawa; ricordiamo inoltre le sfumature partenopee di Un napoletano nel Far West (Many Rivers to Cross), 1955, di Roy Rowland e l’accento siciliano per connotare i malavitosi italoamericani in Angeli con la pistola (Pocketful of Miracles), 1961, di Frank Capra (ma il doppiaggio sicilianizzante degli italoamericani si aveva già in Marty, vita di un timido [Marty], 1955, di Delbert Mann)134. E non si dimentichi che, nell’immediato secondo dopoguerra, si tornò a doppiare qualche film oltreoceano, come nei primordi, e dunque a lasciar spazio a parlanti dall’italiano tinto ora di americano, ora di dialetto135. Il caso più interessante, tra gli usi consapevoli del dialetto nel doppiaggio, è quello di Lilli e il vagabondo e dei già citati cuoco e cameriere italiani (o forse di origine italiana: nel film non è specificato) Tony e Joe. Nel vedere la cagnolina Lilli, 133. «Nel cinema […] qualche volta il doppiatore deve sapere sparire e lasciare le cose come stanno […]. Nell’‘Uomo di Aran’ poema cinematografico di fragore oceanico, di cupezza nordica, nell’edizione italiana c’erano certe interruzioni di pescatori in dialetto che parevano e volevano forse essere napoletano, e sciupavano ogni nostra commozione davanti a quella barbarie desolata di natura che non doveva essere richiamata a visioni solari e serene, in quel momento» (ALLODOLI 1937: 8) [→ Antologia critica, § 4.I]. Analogamente Paolo Uccello, nella recensione a Fortunale sulla scogliera (Cape Forlorn), 1931, di Ewald André Dupont («I Film», in “Bianco e nero”, I, 12, 1937, pp. 107–109: 109): «I marinai che, all’arrivo di Eileen, nel faro, ne criticano la maniera di suonare e poco dopo ne intuiscono il passato di ballerina, hanno un accento lievemente toscaneggiante che stona coi tipi dei marinai che si suppongono sperduti nel lontano continente asiatico». 134. Cfr. MARASCHIO (1982: 146) e RAFFAELLI (1992: 83–85) e (1996e: 28). COVERI (1984) ricorda inoltre il Bogart napoletanizzato del Mistero del falco (The Maltese Falcon), 1941, di John Huston. Altri casi di film stranieri doppiati, almeno parzialmente, in italiano regionale sono Solaris (Soljaris), 1972, di Andrej Tarkovskij (adattato da Dacia Maraini e ignobilmente dimezzato dalla distribuzione italiana); Trash, i rifiuti di New York (Trash), 1970 (ma uscito in Italia nel 1974), di Paul Morrissey (dialoghista e direttore del doppiaggio Pasolini); La rivolta (Duvar), 1983, di Yilmaz Güney (citati da COSULICH 1985: 49). 135. Un film del periodo, caratterizzato dall’evidente inflessione straniera del doppiatore del protagonista maschile, è Prigionieri del passato (Random Harvest), 1942, di Mervyn LeRoy, film costellato, tra l’altro, di goffi aulicismi: «mi manderai in convulsioni»; lagrime; «è ben vago conforto». 326 Il linguaggio cinematografico Tony osserva, in perfetto accento italoamericano nell’originale: «This–a one»; a Lilli perplessa il vagabondo spiega: «This–a one// Oh! Tony/ you know/ he’s–a not–a speak–a English pretty good//» (rifacendo il verso al substandard di Tony, con tutte quelle –a contrassegno dell’italoamericano e con l’aggettivo good al posto dell’avverbio well). Nel primo doppiaggio del film, «This–a one» è tradotto con picciotta e così viene reso il commento del vagabondo: «Picciotta/ sì// Hm/ ragazza/ non badarci// Tony parla con una sfumatura d’accento//». Come si vede, il doppiaggio italiano ricorre al lessema dialettale (e all’inflessione evidentemente siciliana del cuoco e del cameriere) per rendere l’italoamericano dell’originale. Nel secondo doppiaggio, il siciliano diventa napoletano e, coerentemente, picciotta passa a piccerella: «Piccerella/ sì// Hm/ ragazza/ non badarci// Tony parla con una shfumatura d’accendo//» (e il doppiatore Claudio Amendola, differentemente dal doppiatore del 1955, qui rifà il verso, fedelmente all’originale, alla pronuncia di Tony). La precoce attestazione del dialetto nel cinema di animazione doppiato è degna di nota, perché coesiste con un tratto di segno opposto, vale a dire l’elevatezza formale, evidentemente motivata anche dalle ambizioni didattiche di tanti disegni animati, anche televisivi, come del resto accade nella lingua dei fumetti136. Quale può essere stato il motivo del passaggio dal siciliano al napoletano, dal primo al secondo doppiaggio di Lilli e il vagabondo? Entrambi, come abbiamo visto nel § 4, erano regioletti assai sfruttati nel nostro cinema ma, a partire dagli anni Settanta (grazie al Padrino), il siciliano assumerà un valore simbolico fortissimo e ineludibile, prima nei film americani doppia136. Sulla formalità linguistica dei disegni animati televisivi anche in epoca recente cfr. ROSSI (1999a: 78–79). Per considerazioni diverse cfr. PAOLINELLI/DI FORTUNATO (2005: 21–23). Spiccano negli ultimi anni, cionondimeno, anche alcuni casi di substandard nelle serie di animazione sempre doppiate (da I Simson a Southpark). Sulla formalità e sul tradizionalismo grammaticale della lingua dei fumetti cfr. SERIANNI (1986) e MORGANA (2003: 179). 5 – Il “doppiaggese” 327 ti e poi anche in quelli nostrani: diventerà la lingua quasi esclusiva della mafia. La sua sostituzione in un film di animazione si fa, dunque, praticamente obbligatoria. In effetti, nonostante gli esempi isolati appena ricordati, il dialetto, o meglio l’italiano regionale, entrerà stabilmente nel doppiaggio italiano soltanto dopo il 1972, anno di uscita, per l’appunto, del Padrino (The Godfather), di Francis Ford Coppola (Figg. 35–37). L’inflessione siciliana, non più limitata alle comparse ma estesa ai protagonisti, diventa così da allora il più evidente segnale di riconoscimento cinematografico degli italiani d’America, e in particolare dei mafiosi137. Soffermiamoci, dunque, sulle soluzioni linguistiche di alcuni film di mafia, a partire dalla celebre trilogia di Coppola (seguono il primo film The Godfather, Part Two, 1974 e The Godfather, Part Three, 1990), tuttora modello indiscusso e citatissimo dei film malavitosi italiani e stranieri138. Il primo problema da risolvere, in film come questi, nei quali l’italiano entra a pieno titolo tra le lingue della colonna sonora originale, consiste nel far rilevare, in sede 137. Sugli stereotipi degli italiani d’America visti da Hollywood cfr. almeno BON(1999) e (2004), CASELLA (1998) e ROSSI (2006b). 138. Benché il genere mafia movie sia di origine ben più antica (The Black Hand: True Story of a Recent Occurrence in the Italian Quarter of New York, 1906, di Wallace McCutcheon: La “Mano nera”, come è noto, è la prima associazione malavitosa italoamericana.), Il padrino può ben essere definito «the Rosetta Stone of Mafia folklore» (BONDANELLA 2004: 306). Lo dimostra l’aumento considerevole dei soggetti mafiosi dopo il primo film di Coppola (si calcolano approssimativamente 108 film americani sulla mafia fino al Padrino, 314 dopo, secondo STELLA 2003: 186–187) e la quantità incredibile di citazioni di cui l’opera è tuttora oggetto, dai limoni nei film di Piva (cfr. § 6.2.1), agli squali nel film di animazione Shark Tale, 2004, della DreamWorks (con tanto di voce di De Niro e dialetto siciliano), alla pubblicità di una nota automobile, che riprende palesemente l’incontro di don Vito Corleone con i capifamiglia (nello spot si parla anche di un Michael Cicci: un Willie Cicci compare nel Padrino I e II) del primo Padrino. Alcune espressioni del film sono poi divenute proverbiali: da pezz’e novanta (in siciliano anche nell’originale) ‘personaggio di spicco’ e, «nel linguaggio della mafia, uomo potente e temuto all’interno dell’organizzazione» (cfr. GRADIT, s. v. pezzo1, dove tuttavia non si fa menzione del film; all’inizio l’espressione designava il petardo più grosso fatto esplodere alla fine di uno spettacolo pirotecnico), a «un’offerta che non può rifiutare» («an offer he can not refuse»), e simili, che allude alla politica delle minacce e dei ricatti in stile mafioso. Anche l’accezione gergale di padrino, fatta risalire (dal GRADIT) al 1982, sembra propagata, o rivitalizzata, dal successo del film di Coppola. DANELLA 328 Il linguaggio cinematografico di doppiaggio, la differenza tra la lingua degli angloamericani (che nell’originale parlano un inglese più o meno standard) e quella degli italiani e degli italoamericani. I nostri adattatori e direttori di doppiaggio decisero di esasperare (o talora aggiungere ex novo) le tinte regionali dei secondi, per distinguerli così dai primi, i quali venivano doppiati in un italiano standard privo di inflessioni. La variabile diatopica, che serviva nell’originale unicamente per indicare la provenienza (indubbiamente culturale, oltreché geografica: si trattava dunque di un etnoletto) dei parlanti di origine italiana, si carica dunque, nel doppiaggio, di ulteriori valenze diafasiche e diastratiche (diventando una sorta di lingua–gergo della mafia: un socioletto, oltreché un dialetto), come spesso accade per l’appunto coi dialetti139. Si verifica dunque nel Padrino quanto già osservato a proposito di Lilli e il vagabondo: l’italianità è una delle chiavi di lettura (sebbene di natura diversissima, nelle due opere) fondamentali del film. I problemi nascono quando, nell’originale, vi sono riferimenti espliciti e metalinguistici alla commutazione di codice e, soprattutto, nei casi di vero e proprio inscenamento di traduzione. Accade in una celebre scena del primo Padrino, allorché Michael/Michele Corleone (Al Pacino), in Sicilia, chiede la mano di Apollonia al padre di lei, il signor Vitelli, contando sulla traduzione dell’amico bilingue Fabrizio. Leggiamo la trascrizione della scena originale: MICHAEL: Fabrizio/ traduci per me// FABRIZIO: Sì signore// MICHAEL: I apologyse if I offended you// FABRIZIO: Ci dispiace se l’ha offeso// MICHAEL: I’m a stranger in this country// FABRIZIO: È straniero in questo paese// MICHAEL: I meant no disrespect to you/ or your daughter// FABRIZIO: E non voleva mancare di rispetto né a lei né a vostra figlia// 139. I problemi della resa di idioletti, socioletti, etnoletti, regioletti e dialetti nell’adattamento cinematografico sono affrontati da SALMON KOVARSKI (2000). 5 – Il “doppiaggese” VITELLI: Ma cu iè chistu? E chi voli i’ me figghia? MICHAEL: I’m an American/ hiding in Sicily// FABRIZIO: È un americano che sta nascosto in Sicilia// MICHAEL: My name is Michael Corleone// FABRIZIO: E si chiama Michele Corleone// MICHAEL: There are people who’d pay a lot of money/ for that information// FABRIZIO: Ci sarebbe parecchia gente che pagherebbe parecchi piccioli/ per avere un’informazione accussì// MICHAEL: But then your daughter would lose a father// FABRIZIO: Ma allora vostra figlia perderebbe un padre// MICHAEL: Instead of gaining a husband// FABRIZIO: Invece di guadagnare uno sposo! CALO: A minghia/ ma s’annamurato davero chistu ccà! MICHAEL: I wanna meet your daughter// FABRIZIO: Vuole conoscere vostra figlia// MICHAEL: With your permission// FABRIZIO: Con il vostro permesso// MICHAEL: And under the supervision of your family// FABRIZIO: E con il consenso di tutta la famiglia// MICHAEL: With all/ respect// FABRIZIO: E con tutto il rispetto/ naturalmente// VITELLI: Venite domenica/ mattina// Mi chiamo Vitelli// Abito in campagna/ vicino ’o sciumi// MICHAEL: Grazie! E come si chiama vostra figlia? VITELLI: Apollonia// MICHAEL: Bene//. Questo il doppiaggio: MICHAEL: Fabrizio/ spiega che c’è un equivoco// FABRIZIO: Sì signore// MICHAEL: Io/ ecco/ mi dispiace che vi siate offeso// FABRIZIO: Parlavamo senza malizia// MICHAEL: Io sono forestiero qui// FABRIZIO: È in Sicilia che è poco// MICHAEL: E non è mia abitudine provocare la gente senza ragione// FABRIZIO: Non volevamo mancare di rispetto né a voi né a vostra figlia// VITELLI: Ma cu iè chistu? E chi voli i’ me figghia? MICHAEL: Sono un americano/ sono nascosto qui// FABRIZIO: È un amico di amici/ capite// 329 330 Il linguaggio cinematografico MICHAEL: Mi chiamo Michele Corleone// FABRIZIO: E suo padre è don Vito Corleone// MICHAEL: I miei nemici pagherebbero molto cara/ un’informazione come questa// FABRIZIO: Tenetevela per voi/ questa confidenza/ perché se qualcuno parla/ voi… mi capite! MICHAEL: La cosa potrebbe finire male// FABRIZIO: E vostra figlia poi resterebbe senza padre// MICHAEL: Invece di trovare un marito// FABRIZIO: Avete sentito che ha detto? Iddu s’a sposa! CALO: Io non ci credeva/ ma chistu s’annamurò proprio// MICHAEL: Voglio conoscere vostra figlia// FABRIZIO: Stateve attento ca vi conveni// MICHAEL: Con il vostro permesso// FABRIZIO: Non vi fate pregare// MICHAEL: E sotto il controllo della vostra famiglia// FABRIZIO: Secondo le usanze locali// MICHAEL: E con tutto/ il rispetto// FABRIZIO: Allora? VITELLI: Venite domenica// Di mattina// Mi chiamo Vitelli// Abito in campagna/ vicino al fiume// MICHAEL: Grazie// E come si chiama vostra figlia? VITELLI: Apollonia// MICHAEL: Bene//. La scena dimostra, ancora una volta, l’impossibilità di scindere la componente iconica da quella verbale. Tutta la mimica è infatti inequivocabilmente legata alla traduzione simultanea, con quel guardare, da parte di Calo e Vitelli, alternativamente ora Michael ora Fabrizio. Inoltre lo stupore di Fabrizio e di Calo di fronte alla richiesta di matrimonio di Michael, formulata in inglese, si giustifica per via del fatto che soltanto loro l’hanno capita, non certo il padre della ragazza, finché non gli viene tradotta. Se nell’originale lo spettatore non coglie alcuno scollamento tra immagini e parole, lo stesso non può dirsi per la versione italiana140, dove Fabrizio, per rendere credibile la ripetizione delle battute da italiano a italiano tenta di dare a Vitelli, 140. «[Q]uanti interpreti superflui che ripetono con dispendio mimico battute già capite!» (RAFFAELLI 1991b: 99). 5 – Il “doppiaggese” 331 per rabbonirlo, il sottotesto ammiccante e quasi gergale («è un amico di amici/ capite»), oltre che regionale, di quanto Michele sta dicendo in freddo italiano standard. Anche il code mixing viene azzerato nel doppiaggio: «Vaffangulo!» e «Vaffangulo your own!», si augurano reciprocamente la sorella di Michael e il marito, nel primo Padrino; nella versione doppiata, la risposta mistilingue diventa: «Vaffanculo pure tu!»; «Come stai/ zio? How do you do?», doppiato in «Come stai/ zio? Come va?» (Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno [Mean Streets], 1973, di Martin Scorsese). Può accadere peraltro anche l’opposto: «Charlie/ tu sei un good boy//» recita la versione doppiata della seguente battuta: «Charlie/ you’re a good boy//» (nel medesimo film di Scorsese). Ma l’amplificazione della componente dialettale nel passaggio dalla colonna sonora americana a quella italiana non è una regola. Proprio nel Padrino, infatti, non mancano fenomeni di segno opposto. Abbiamo già visto che il signor Vitelli nel primo film, al termine della scena citata, utilizza il dialettalismo sciumi, che invece il doppiaggio italianizza in fiume. E, nella stessa scena, cadono, rispetto all’originale, i dialettalismi accussì ‘così’, minghia e pìccioli ‘soldi’. Nel Padrino – parte II, nel dialogo tra la madre di Vito e don Ciccio, abbiamo battute come le seguenti: «Io non mi scantu/ di parole soi!»; «Sparagnatemi/ stu figghiu miu!»; «Mu sparagnasse!», che doppiate diventano: «Non sono le parole/ che mi fanno paura!»; «Lasciatelo a me/ ’sto figghiu miu!»; «Lasciatemelo!». Gli adattatori e i direttori di doppiaggio provvidero evidentemente a eliminare le forme più distanti dallo standard (scantari ‘avere paura’ e sparagnari ‘risparmiare’). Anche altrove il siciliano dei personaggi secondari del Padrino – parte II, specialmente nelle sezioni storiche del film, sembra più criptico (verosimilmente, per ragioni geo– e storico–linguistiche, in bocca ai siciliani d’America del primo Novecento) rispetto alla versione doppiata. Un altro esempio è «Lassel’aire», doppiato in: «Lasciatela andare». Anche Mean Streets sottolinea insistentemente l’origine italiana di tutti i personaggi (nonché del regista), non soltanto 332 Il linguaggio cinematografico mediante l’inflessione degli attori ma anche con inquadrature di poster che rappresentano Messina o Napoli e con le canzoni italiane (Malafemmena e altre). Il doppiaggio in questo caso opta per una soluzione originale e successivamente poco praticata. Anziché rendere l’italoamericano di De Niro e compagni con un’inflessione siciliana o napoletana, i curatori dell’edizione postsincronizzata scelsero un italiano informale, infarcito di turpiloquio e tempestato di anglicismi soprattutto con funzione di segnali discorsivi o allocutivi: come on, right, well, thank you, thank you very much, sure, I understand, shut up, all right, right, please, miss, OK, etc. In altre parole, i due poli del code–mixing e del CODE–SWITCHING [→ Glossario] sono stati invertiti rispetto all’originale: all’angloamericano con qualche espressione italiana o regionale (statte zitte, minghia e Maronna) e con marcata pronuncia italoamericana è stato sostituito l’italiano con qualche espressione inglese. Del tutto immotivato il passaggio dal siciliano al napoletano nella scena seguente: «Lassal’airi// Che ci stai facennu?» (originale), doppiata in: «Ehi/ ma che state facienno? Che so’ shti shtrilli?». Come si è ampiamente dimostrato, dunque, il dialetto del doppiaggio ha usi senz’altro limitati rispetto a quello della produzione nostrana, e inoltre presenta un maggior grado di innaturalezza e di italianizzazione: È chiaro che si tratta di una lingua altamente convenzionale, in cui la dialettalità o la regionalità passa attraverso stereotipi, cliché, luoghi comuni che hanno una loro coerenza presumibilmente dettata dalla tradizione cinematografica più che dalla fedeltà ad una varietà linguistica effettivamente parlata141. Se si esclude il caso dei film sulla malavita d’oltreoceano, inoltre, le società di doppiaggio sono assai di rado propense ad accogliere i regionalismi (anche solo fonetici), preferendo il ricorso a forme colloquiali o popolari comunque italiane, piuttosto che diatopicamente marcate. Questo è dovuto all’esigenza di 141. PAVESI (1994: 132). 5 – Il “doppiaggese” 333 non aggiungere ulteriori elementi tipici della realtà italiana (e dunque stranianti per il pubblico), oltre all’italiano standard, nei film di ambientazione straniera: C’è almeno un elemento del testo originale che non possiamo riprodurre: il dialetto. Perché se è possibile, come in Bulli e pupe, che è un caso limite, tentare di ricreare un gergo, è invece impossibile stabilire un’analogia tra un dialetto regionale degli Stati Uniti e un dialetto regionale italiano. Benché sembri che esistano un nord e un sud in ogni angolo del mondo, sarebbe impensabile far parlare in siciliano i nati nel New Mexico e così via fino a far parlare in valtellinese quelli che vengono dal Maine. Oltretutto […] il dialetto nel cinema italiano è portatore di un retaggio che forse trae origine dal teatro delle maschere, dalla farsa, ed è perciò condannato a connotare in modo grottesco il personaggio che parli con un qualsiasi accento142. Qualche tolleranza in più si ha nei film che inscenano la vita degli immigrati italiani, come per esempio in Mac, 1992, di John Turturro (con inflessioni siciliane nella versione originale e in quella doppiata) e in Big Night, 1996, di Stanley Tucci e Campbell Scott. Quest’ultimo film è particolarmente interessante, perché all’italoamericano dell’originale non si sostituisce il siciliano o il calabrese (sebbene i due fratelli Pileggi, protagonisti del film, provengano dall’Italia del Sud, secondo il copione), bensì un improbabile, artefatto e macchiettistico abruzzese, la cui adozione è così giustificata dall’adattatore dialoghista, Filip142. GALASSI (1994: 66–67). Proprio per questo, piuttosto che servirsi di inflessioni dialettali o di espressioni gergali italiane, gli adattatori e i direttori di doppiaggio preferiscono inventare forme e locuzioni (perlopiù insulti) pronunciate in un italiano foneticamente ineccepibile, come corrispettivi dello slang: «Poiché è impensabile travasare in un’ambientazione dichiaratamente ‘altra’ modi gergali ‘nostri’, che per quanto possano essere nuovi danno immediatamente l’impressione di trovarsi in una periferia italiana, è bene lavorare sull’invenzione, escogitando espressioni colorite e limitando al massimo la resa dell’intercalare (‘fottuto’, ‘dannato’, ‘cazzo di…’, ‘amico’), che a questo punto diventa un elemento secondario» (PAOLINELLI/DI FORTUNATO 2005: 62). Allo stesso volume si rimanda per esempi concreti di adattamento dello slang, con una ricca analisi del film Jackie Brown, 1997, di Quentin Tarantino (cfr. PAOLINELLI/DI FORTUNATO 2005: 51–78). 334 Il linguaggio cinematografico po Ottoni: «perché ormai il dialetto calabrese–siciliano al cinema è irrimediabilmente associato alla Mafia»143. Quello che rende un po’ meno distante dal parlato–parlato l’attuale doppiaggese, dunque, non è tanto la presenza di regionalismi quanto lo stile recitativo dei doppiatori di oggi rispetto a quelli di ieri. Il merito di aver rinnovato la tradizione spetta soprattutto a Ferruccio Amendola, per anni doppiatore, tra l’altro, di Hoffman, De Niro, Pacino (nel Padrino e in moltissimi altri film), Stallone. Già alla fine degli anni Sessanta, egli introdusse la recitazione cosiddetta “buttata”144, vale a dire trascurata, con impostazione meno impettita e pronuncia meno ossequiosa delle norme del DOP. 5.3.2. Come abbiamo già in parte visto con l’esempio del Padrino, un altro problema rilevante per i realizzatori del doppiaggio è quello del plurilinguismo, in particolar modo se una delle lingue dell’originale è l’italiano. Abbiamo già detto che, se il contesto lo consente, l’italiano passa a una varietà regionale, per meglio contrapporsi all’italiano standard usato come equivalente della lingua non marcata nella colonna sonora originale. Altre volte, tuttavia, i realizzatori optano per la sostituzione dell’italiano con un’altra lingua. È quanto accade in Un pesce di nome Wanda (A Fish Called Wanda), 1988, di Charles Crichton. Nell’originale, la protagonista eponima si eccita ogniqualvolta sente parlare italiano (con enunciati sempre mal costruiti e talora fuori contesto, quasi recuperati da un corso di italiano per principianti); nel doppiaggio la lingua erogena diventa lo spagnolo, con opportuno adattamento dei frames culturali (anche se lo stereotipo gastronomico regge più sull’italiano che sullo spagnolo): 143. CASELLA (1998: 454). 144. È termine adottato dallo stesso Amendola, in CASTELLANO (1993: I, 57). Analogamente, Maria Pia Di Meo (voce della Deneuve, della Streisand e di numerosissime altre dive) definisce il nuovo doppiaggio più parlat[o] (ID., p. 58). 5 – Il “doppiaggese” WANDA: Make the call// OTTO: Momento/ carissima// WANDA: No! OTTO: Eventuale// WANDA: Not Italian! OTTO: Eh! WANDA: No! No! OTTO: Per cominciare/ due insalate verdi/ con peperoni// WANDA: No! OTTO: E un linguini/ primavera// WANDA: No! OTTO: I’m going dialetto d’Inghilterra// WANDA: (dandogli nervosamente il telefono) Make the call/ Otto// You’re really Italian? OTTO: Absolutamente sì// My name is Otto// It means eight// Say arrivederci a Giorgio// WANDA: Goodbye George// OTTO: (fingendo di parlare al telefono in un marcato accento italiano): Ah yes/ I wonder if you could me be through the police/ per favo… <Ah>! WANDA: (gli dà uno schiaffo) <Otto>! DOPPIAGGIO: WANDA: Fa’ la telefonata// OTTO: Un momentito/ mi querida// WANDA: No! OTTO: Almuerzo// WANDA: Niente spagnolo// OTTO: Olé! WANDA No! No! OTTO: Para empezar/ WANDA: No! OTTO: Dos ensaladas verdes con pimientos// WANDA: No! OTTO: Y Paella a la valenciana// WANDA: No! OTTO: Y chuleta de cordero… WANDA: Fa’ quella telefonata/ Otto// Sei davvero spagnolo? OTTO: Seguro que sí// Il mio nome è Ocho// Significa Otto. Di’ hasta luego a George// WANDA: Addio George// OTTO: (al telefono) Io quería hablar con la policía/ por favor// WANDA: Otto! 335 336 Il linguaggio cinematografico ORIGINALE: OTTO : È molto pericoloso/ signorina// Molto pericoloso// Carissima// WANDA: Speak it! Speak it! OTTO: Osso buco alla milanese/ con piselli// Melanzane parmigiana/ con spinaci// Dov’è la farmacia? […] A che ora parte il treno? Dov’è la Fontana di Trevi? Mozzarella// Parmigiano// Gorgonzola//. DOPPIAGGIO: OTTO: Es muy peligroso/ señorita// Muy peligroso// Querida// WANDA: Sì/ parla! Parla! OTTO: Tortilla con jamón/ a la española// Chorizo y queso manchego// Donde está la morenita? […] Te gusta el flamenco? Aquí está la plaza de toros// Gazpacho// Manzanas// Bananas//. ORIGINALE: OTTO: Niente// […] Ecco l’uomo// Oh! (vedendo il seno di Wanda) Le due cupole grandi della cattedrale di Milano! Benito Mussolini// Dov’è il Vaticano? Oh! Ecco Roma! Volare/ Oh oh! E cantare/ oh oh//. DOPPIAGGIO: OTTO: Nada// […] Aquí está el hombre// Las dos cupolas de la catedral de Sevilla! Francisco Franco// Donde está la Plaza Mayor? Oh! Real Madrid! Toreador la la la la la//. ORIGINALE: WANDA: Archie? ARCHIE: Hm? WANDA: Do you speak Italian? ARCHIE: I am Italian! Sono italiano in spirito! Ma ho esposato una donna che preferisce lavorare nel giardino a far/ l’amore passionato/ un sbaglio/ grande! But it’s such an ugly language// What about Russian? (dopodiché passa al russo, sortendo lo stesso effetto eccitante su Wanda). 5 – Il “doppiaggese” 337 DOPPIAGGIO: WANDA: Archie? ARCHIE: Hm? WANDA: Tu parli spagnolo? ARCHIE: Io soi español! Y con todo mi espirito// Pero soi casado con una mujer/ que le gusta mas trabajare nel jardín/ que a fere l’amor// Y es un equivocación grandísima! Ma è una lingua che non mi piace// Che ne diresti del/ russo? Altre volte il riferimento a una seconda lingua viene cancellato sic et simpliciter, nel doppiaggio, con evidente impoverimento dei contenuti, specie se il film è basato proprio sulle difficoltà comunicative, come per esempio accade nella Rosa tatuata (The Rose Tattoo), 1955, di Daniel Mann. Il celebre film, tratto dall’omonimo dramma scritto da Tennessee Williams in onore di Anna Magnani, narra le vicende della siciliana Serafina (la Magnani), giunta negli Stati Uniti negli anni Trenta–Quaranta per sposare Rosario Delle Rose, che morirà all’inizio del film. Dall’unione nacque Rosa, che, all’opposto di sua madre, mostra una forte volontà di integrarsi nel sogno americano e di reprimere il ricordo delle proprie origini. Numerosi sono i brani bilingui (italiano/inglese) del film, ricondotti al solo italiano senza accento della versione postsincronizzata. «I want you teach a little Italian word// The word is bacio//», dice Rosa al fidanzato. Questa la battuta doppiata: «In tutta la sera non mi hai dato neanche… neanche un bacio//». «I couldn’t speak nothing in English/ exept of love//», dice Serafina, con il solito errore della doppia negazione, a proposito del suo arrivo negli Stati Uniti. Ecco il corrispettivo doppiato: «Rimasi ammutolita/ fin dopo la notte del matrimonio// E dopo dissi soltanto/ amore//». Serafina accusa Rosa di averle mentito e di essere uscita con un ragazzo anziché essere andata a studiare da un’amica. Quando le chiede di giurare davanti alla Madonna la ragazza rifiuta: SERAFINA: Because you don’t study no civics/ tonight// ROSA: Don’t study no civics// Why do you talk like you just came over in steerage// This isn’t Sicily/ mother/ and you are not a baroness// You do sewing//. 338 Il linguaggio cinematografico Il doppiaggio elimina il riferimento al modo di parlare di Serafina: SERAFINA: Perché sai di giurare il falso// E questo ti porta male// ROSA: Ti porta male/ ti porta male// Ti è rimasta la mentalità di una contadina siciliana// Quante storie/ mamma! Tu non sei una baronessa// Sai solo cucire//. L’adattamento trasforma dunque uno stereotipo in un altro: dall’incapacità di integrazione linguistica (resa dal duplice errore di don’t per didn’t e della doppia negazione don’t… no), rimproverata dalla figlia alla madre, al rifiuto dell’integrazione culturale (l’attaccamento alla superstizione e il rifiuto della modernità). Anche quando non compaiono riferimenti a parole specifiche, bensì soltanto a elementi della cultura italiana, il problema si fa spinoso per gli adattatori: la convenzione filmica impedisce infatti di sottolineare lo scollamento tra contesto del film (straniero) e italiano del doppiaggio, come abbiamo già visto. Pertanto tali riferimenti vengono di norma cancellati. Vediamo qualche esempio, partendo dal solito Padrino. In una scena ambientata in un ristorante italiano, il poliziotto corrotto chiede al mafioso Sollozzo: «How’s the Italian food/ in this restaurant?», doppiato in: «Che mi consigli di buono/ in questo ristorante?». Poco oltre: ORIGINALE: SOLLOZZO: (al poliziotto): I’m going to speak Italian to Mike// POLIZIOTTO: Go ahead// SOLLOZZO: (a Michael Corleone) Me dispiace// Tu/ hai sapiri/ ca chiddu ch’è successo/ tra me e tu patre/ fu una cosa di bisinìss// Io/ au un grosso rispetto/ pe tu patri// Ma tu patri/ penza all’antica! Iddu nu lo vo’ capiri che io/ sono omo de onori! MIKE: Non me deri/ sti cosi// I saccio// SOLLOZZO: ’O sai? E tu hai sapiri/ che eu/ ho aiutato ’a famiglia Tattaglia// Io credo che/ ce potemo mettere in un accordo// Io voglio pace// E lasciamo perdere co tutte sti cazzati! 5 – Il “doppiaggese” 339 MIKE: Ma vogghiu ca… SOLLOZZO: Che è? MICHAEL: Come se dice… What I want… (e seguita a parlare in inglese perché non gli vengono le parole in italiano, per lui seconda lingua e non prima come per suo padre). DOPPIAGGIO: SOLLOZZO: Scusaci/ se ora parliamo un poco io e Mike// POLIZIOTTO: Senz’altro// (la conversazione tra Michael e Sollozzo seguita in modo quasi identico all’originale, con qualche aggiustamento nella pronuncia: eu e au diventano io e ho, cade l’inflessione napoletana di Michael). MIKE: Beh/ ma non è facile// Come si dice… La pace bisogna volerla in due […]. Un altro film rappresentativo dell’italiano utilizzato dagli americani è Stregata dalla luna (Moonstruck), 1987, di Norman Jewson. Il film, che adotta tutti gli stereotipi sugli italiani (melomania, culto del cibo e delle donne, gelosia, focosità, attaccamento alla famiglia e soprattutto alla mamma, alle tradizioni e alla religione, etc.) al di fuori di quello mafioso, contiene vari brani in italiano, con alcuni errori grossolani dovuti all’evidente ignoranza da parte di autori e attori della realtà messa in scena dal copione. Il doppiaggio, in questo caso, ha il merito di riequilibrare il tenore dei dialoghi. Cominciamo dalla scena in cui la siciliana Loretta (interpretata da Cher), rientrando a casa, saluta il nonno con un improbabile «Ciao/ bello» cui segue, come risposta, un altrettanto scorretto Buonanotte (visto che si tratta di un arrivo e non di un congedo). Il doppiaggio corregge solo parzialmente con un «Ciao nonno», lasciando tuttavia invariato il buonanotte anziché sostituirlo con un più adeguato Ciao o Buonasera (come peraltro accade verso la fine del film). L’inappropriatezza pragmatica continua con il calco semantico «Ti amo» detto da Loretta al padre e viceversa, adeguatamente reso con «Ti voglio bene» nel doppiaggio. Un altro calco, stavolta morfosintattico, si ha nell’innaturale posizione del soggetto nella seguente domanda formulata dalla futura suocera di Loret- 340 Il linguaggio cinematografico ta: «How long do I have to wait? Quanto io devo aspettare?», adeguatamente sicilianizzata nel doppiaggio: «Johnny/ figghiu miu/ veni cca/ veni cca! Angora aju aspettari?». Assolutamente sconveniente è anche l’osservazione fatta dalla parrucchiera a proposito dei capelli grigi di Loretta: «Finalmente/ che brutta/ signora!», resa più diplomaticamente nel doppiaggio: «Ah/ Finalmente/ che brutto/ questo grigio!». Allontanandoci dai fenomeni prettamente linguistici, infine, traspare una visione oleografica e alterata dell’Italia anche nell’invito di Loretta al suo fidanzato affinché si ripari dal sole, quasi fosse in un safari in Africa piuttosto che al capezzale della madre in Sicilia: «Don’t stand directly under the sun// You’ve got a hat// Use your hat//» («Non stare troppo al sole// Hai il cappello/ no? Usalo/ ok?»). Anche se soltanto a livello iconico, un altro errore si ha nella scena in cui Loretta serve al cognato (di cui sta per innamorarsi) degli spaghetti sconditi come contorno di una bistecca: adattissimi per gli americani, non certo per gli italiani, neppure quelli d’America. Quando il bilinguismo dell’originale tocca una lingua diversa dall’italiano, solitamente viene mantenuto, anche se possono esservi alcune semplificazioni. Il cane russo Boris, in Lilli e il vagabondo, rivolge a Lilli l’epiteto bublichki ‘dolcezza’, inalterato nel primo doppiaggio, trasformato nel più trasparente matrioska ‘bambolina’ nel secondo. Il problema dell’adattamento di un film plurilingue, pressoché irresolubile, come s’è visto, sottolinea l’impoverimento arrecato dal doppiaggio alla versione originale del film. Per ridurre i danni, si sceglie talora di doppiare una sola delle due lingue, sottotitolando l’altra. È accaduto coi dialoghi francesi e inglesi del denso Daddy Nostalgie, 1990, di Bertrand Tavernier (dove il bilinguismo traspare fin dal titolo, provvidenzialmente non tradotto dai nostri distributori), in cui un personaggio (Dirk Bogarde, che interpreta il padre) parla prevalentemente inglese, mentre gli altri (Jane Birkin, la figlia e Odette Laure, la madre) parlano perlopiù francese e l’intero senso dell’opera si basa proprio su questo dualismo e sulla diversa percezione del mondo e 5 – Il “doppiaggese” 341 dei sentimenti. La versione italiana doppia il francese (lingua base del film), mentre usa i sottotitoli per l’inglese. Gli stessi problemi possono riguardare anche opere doppiate di autori italiani, com’è il caso di Io ballo da sola (Stealing Beauty), 1996, di Bernardo Bertolucci. La protagonista Lucy Harmon (Liv Tyler) è americana, gli amici sono parte italiani, parte francesi, parte inglesi, ma si esprimono tutti in perfetto doppiaggese (tranne l’attore Jean Marais, il vecchio antiquario, che parla italiano con marcato accento francese e con inserti integralmente francesi). Le scritte di scena (le poesie di Lucy) sono tutte in inglese, benché vengano pronunciate in italiano dalla voce–pensiero. Insomma, il raffinato testo pluricodice di Bertolucci (che anche qui, almeno negli intenti originari, come nel film di Tavenier, sembra associare alla variazione diatopica diversi modi di porsi nei confronti della realtà) viene pressoché azzerato dal doppiaggio, che dunque banalizza l’intera trama del film. Un caso particolare di convivenza forzata (indotta dal doppiaggio) di più lingue nello stesso film e di scollamento tra codice iconico e codice verbale si ha con le scritte di scena (giornali, lettere, insegne, etc.), convenzionalmente non tradotte, se non, ormai sempre più di rado, mediante scritte sovrimpresse145. Significativo, al riguardo, è il già citato Cantando sotto la pioggia: la Casa di produzione cinematografica di cui si parla nel film è la Monumentale Film, benché se ne legga chiaramente l’insegna «Monumental Pictures»; lo stesso vale per la rivista Variety, nei dialoghi doppiati Varietà. E che dire del film «Duelling Cavalier» (la cui scritta di scena è ben visibile), diventato nei dialoghi italiani «Il cavaliere spadaccino»? 145. Oppure mediante la (ormai desueta) sostituzione dell’inquadratura con un’altra, simile, ma con le scritte in italiano. Il cinema delle origini preferiva eliminare le scritte di scena mediante il taglio dell’intera inquadratura (cfr. RAFFAELLI 2001: 892). 342 Il linguaggio cinematografico 5.4. I titoli A conclusione del capitolo, gioverà spendere qualche parola sulla traduzione dei titoli dei film, spesso vituperata, da pubblico e critica, come eccessivamente quanto immotivatamente infedele146. La traduzione del titolo di un film è indubbiamente meno problematica rispetto all’adattamento dell’opera filmica nel suo complesso, giacché mancano i vincoli del sincronismo labiale e, a parte qualche eccezione di virtuosismo grafico (emblematica, di recente, la raffinatissima grafica dei titoli di testa della Mala educación, 2004, di Pedro Almodóvar, che forse anche per questo è stato distribuito col titolo originale), quelli dell’interazione tra codice iconico e codice verbale. Sussistono, d’altra parte, evidenti vincoli pragmatici: il titolo, quale carta di presentazione del film, esercita infatti «una funzione di richiamo per lo spettatore», al punto tale che nella sua traduzione «il criterio dell’efficacia» comunicativa prevale su «quello della fedeltà»147. Solo di rado il titolo è tradotto letteralmente: la Casa di distribuzione del film (essa, in effetti, e non il regista né il produttore, impone il titolo di esportazione) preferisce di solito titoli ammiccanti e ritenuti per varie ragioni più accattivanti dell’originale. Peraltro, talora la traduzione letterale non è che un calco con errori più o meno grossolani: Les Quatre–cent coups, 1959, di François Truffaut, fu tradotto in italiano con l’insensato I quattrocento colpi, laddove l’espressione francese vale ‘fare il diavolo a quattro’ o ‘essere uno scavezzacollo’; La Chèvre, 1981 (più o meno ‘il capro espiatorio’), di Francis Veber, diventa in italiano La capra, che fa pensare a un ignorante, piuttosto che a uno sbadato sfortunato come invece è il protagonista del film; The Big Heat, 1953, di Fritz Lang, diventa Il grande caldo: «Il titolo, tradotto alla lettera nell’edizione italiana, è in realtà 146. L’argomento è sviluppato in ROSSI (2006a). 147. SALSI/TRAPANI (1994: 120). 5 – Il “doppiaggese” 343 un’espressione gergale per indicare un’intensa attività di polizia contro la criminalità»148. The Nanny, 1965, di Seth Holt, passa a Nanny la governante, con fraintendimento del sostantivo nanny ‘governante’, scambiato per un nome proprio e quindi glossato. Un brutto calco è anche quello del film di Ken Russel Women in Love, 1969 (Fig. 38), tradotto Donne in amore (che oltretutto presenta spiacevoli rimandi paronomastici del tutto fuorvianti, quali in calore) anziché ‘donne innamorate’. In Dressed to Kill, 1980, di Brian De Palma, tradotto Vestito per uccidere, oltre a perdersi il doppio senso del titolo (che metaforicamente vale ‘vestito in modo provocante’), si suggerisce anche, per via della desinenza –o, che l’assassino è un uomo, anticipando, così, il finale del film. Negli ultimi anni si tende sempre più spesso a mantenere il titolo originale (in italiano cade, tutt’al più, l’articolo: The Shining, 1980, di Stanley Kubrick: Shining), eventualmente accompagnato da una traduzione (Les choristes, 2004, di Christophe Barratier: Les choristes – I ragazzi del coro) o da una glossa che chiarifica un aspetto tematico del film (The Woodsman, 2004, di Nicole Kassell: The Woodsman – Il segreto). A volte il titolo originale viene sostituito, in Italia, da un titolo esso stesso straniero: The Gang’s All Here, 1943, di Busby Berkeley, trasformato in Banana Split; Find the Lady (rititolato Call the Cops!), 1976, di John Trent, diventa nella versione italiana Cherchez la femme. Più spesso, al contrario, un titolo francese viene sostituito da uno inglese: La Route de Corinthe, 1967, di Claude Chabrol, diventa Criminal Story. Se si opta per la “traduzione” del titolo, tuttavia, la soluzione preferita dalla nostra distribuzione continua ad essere quella della radicale modificazione, spesso del tutto irrelata da motivi testuali e giustificata soltanto da ragioni commerciali. L’esemplificazione sarebbe sterminata e si limita qui dunque a due soli casi particolarmente significativi. La Fiancée du pirate, 1970, di 148. MEREGHETTI (2005: 1179). 344 Il linguaggio cinematografico Nelly Kaplan, si trasforma in Alla bella Serafina piaceva far l’amore sera e mattina: in clima di libertà sessuale non solo si cambia il titolo, ma, per il gusto della rima, anche il nome della protagonista — in originale Marie — presentando una bella commedia satirica come una ridicola farsetta da caserma. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004, di Michel Gondry, diventa Se mi lasci ti cancello: il titolo succedaneo, peraltro criticatissimo dalla stampa, svela rozzamente e impropriamente il succo della trama, cancellando, in questo caso letteralmente, la poeticità funzionale dell’originale149. Ne consegue che, talora, la modificazione del titolo operata dalla distribuzione italiana determina anche uno spostamento del target originario del film. 149. La frase (‘eterno sole di una mente immacolata’) — oltreché citazione di un verso dell’elegia Eloisa ad Abelardo di Alexander Pope — sembra essere una sorta di pubblicità della ditta che, nel film, promette un’illusoria felicità garantita dalla rimozione dei ricordi (ovviamente impossibile) di una relazione amorosa fallita. La rititolazione italiana riesce così a far cambiare le attese del pubblico sul genere del film (anche con l’aiuto della presenza dell’attore Jim Carrey, quasi sempre associato a ruoli comico–grotteschi): da commedia sperimentale, e non priva di una sua profondità psicologica, a farsa. 6. DALLA COMMEDIA ALL’ITALIANA AI GIORNI NOSTRI 6.1. Dal mimetismo all’espressionismo 6.1.1. Cercheremo, in questo capitolo conclusivo, di sviluppare alcuni spunti già introdotti nel § 4, a proposito del rapporto tra italiano standard, italiano regionale e dialetto a partire dalla Commedia all’italiana fino ad oggi. Il nostro excursus sarà qui ancora più sommario, senza la minima pretesa di completezza, del resto impossibile ora più che mai, dato il numero dei film prodotti. Se infatti per i periodi precedenti, e specialmente per il Neorealismo, è stato facile isolare titoli emblematici, per la Commedia all’italiana potremmo dire che ogni film è rappresentativo del genere, in ognuno si riscontrano usi regionali interessanti, giochi linguistici notevoli, interpretazioni che sottolineano le difficoltà degli italiani del boom economico di gestire la diglossia lingua/dialetto. Ancora una volta, procederemo per grandi accorpamenti e macrofiloni, rimandando alle numerose trattazioni sulla storia del cinema italiano, e segnatamente della Commedia all’italiana, per descrizioni più minuziose1. 1. Cfr. in particolare, oltre agli insostituibili BRUNETTA (1991) e (1993, III e IV), LIZZANI (1980) e MICCICHÈ (1965), soprattutto GILI (1980), D’AMICO (1985), NAPOLITANO (1986), CARPITELLA/DE MAURO/RAFFAELLI/NAPOLITANO (1986), DIADORI (1992), COVERI (1994) e GIACOVELLI (1995). Sull’origine dell’espressione “commedia all’italiana” cfr. CAMERINI (1986: 179–180) e RAFFAELLI (1992: 116 n. 95). Data la fortuna dell’espressione, continueremo a servircene, in luogo del meno marcato “commedia italiana” [→ Glossario, COMMEDIA ALL’ITALIANA], oggi preferito dagli studiosi. 345 346 Il linguaggio cinematografico Si delineano sempre più nettamente due opposti filoni: da un lato l’italiano senza accento dei film stranieri doppiati (salvo eccezioni come i già visti film di ambientazione italoamericana e in particolar modo quelli di mafia), dall’altro l’italiano regionale della produzione nostrana, che raramente rinuncia a inscenare almeno un personaggio diatopicamente connotato. Rimanendo nell’ambito della produzione italiana, nel cinema postneorealistico, e in quello comico in particolare, possono essere ulteriormente individuate due tendenze linguistiche (da intendersi eventualmente anche come intersecate, talora nei medesimi film): la linea che culmina con Poveri, ma belli, caratterizzata dall’innaturalismo e dall’ibridismo linguistico2, e quella, sempre scarsamente realistica ma un po’ più varia e frastagliata, di molte commedie all’italiana, che sfruttano certi clichés linguistici (corrispondenza tra dialetto e mestiere, carattere o attore) destinati a grande fortuna, spesso ancora oggi (si pensi ai personaggi borghesi interpretati dai caratteristi milanesi Massimo Boldi o Jerry Calà, per esempio). Tali stereotipi sono in parte frutto del luogo comune e del pregiudizio, in parte mediati dal teatro della tradizione (dalla commedia cinquecentesca a quella goldoniana e all’opera buffa) e dalla Commedia dell’Arte: il sessuomane e il poliziotto hanno l’accento siciliano, l’ingenuo quello bergamasco, veneto o ciociaro, il cocciuto il sardo, l’arrivista senza scrupoli il milanese, la domestica il veneto o l’abruzzese, l’imbroglione il napoletano, la prostituta il bolognese. Buono per tutti gli usi filmici, anche decontestualizzato, è poi il romanesco più o meno ibridato3: Il cinema, per restare quanto mai vicino al suo essere spettacolo popolare, ha avuto bisogno del contributo di attori prove- 2. E che ebbe più di un detrattore: ARISTARCO (1953), CHIARINI (1956), PUCCI (1959) [→ Antologia critica, § 11], VARESE (1963: 186–191), SPINAZZOLA (1965). 3. Assai significativo, per l’esemplificazione del romanesco tuttofare, è Gambe d’oro, 1958, di Turi Vasile: nonostante l’ambientazione pugliese, parlano quasi tutti con evidente accento romano (a parte Totò) e soltanto nel barbiere e nella cameriera si avverte qualche palatalizzazione di a in e, usuale in Puglia. 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 347 nienti […] da […] esperienze teatrali. Ciò anche per offrire la caratterizzazione ed il modello con definiti contorni oltre che fisionomici, dialogici, e per costituire la base d’un discorso mediante il quale estrarre dall’attore il tipo. Non si poteva, cioè, mettere in un film, supponiamo, un cocchiere senza pensare ad Aldo Fabrizi, né poteva apparire un metropolitano che non fosse Virgilio Riento. L’effetto di tali interventi era duplice: il pubblico riconosceva subito, dalle inflessioni dialettali, il carattere del personaggio, e conformava quindi ogni sua conoscenza al tipo che gli veniva proposto dal cinema. Questa identificazione tra tipo e attore trova però una maggiore precisazione nei film comici, specie in quelli interpretati da Totò, nei primi film con Alberto Sordi, con Ugo Tognazzi, e persiste tuttora nella serie dei comici Franchi–Ingrassia4. In questo senso è emblematico il plurilinguismo del film inaugurale della Commedia all’italiana, I soliti ignoti, 1958, di Monicelli; eccone i protagonisti: un napoletano, un siciliano, una veneta, un bolognese e due romani. Ovviamente la riuscita dell’operazione “trapianto dei germi neorealistici rosa nel filone comico–grottesco” è garantita dall’ottimo livello recitativo degli interpreti prediletti del genere (Gassman, in particolare, anche lui prestato dal teatro, spicca per l’incredibile propensione al mimetismo regionale5 ed esordisce come attore comico proprio nei Soliti ignoti), oltreché dall’abilità degli sceneggiatori, Age e Scarpelli in testa. A dispetto della critica ufficiale, le risorse migliori, nel cinema dagli anni Sessanta ad oggi — e non ultima la capacità di interpretare in tempo quasi reale, anche dal punto di vista linguistico, il tumultuoso passaggio epocale da una società agricola ad una postindustriale —, sono state impiegate nei generi comici piuttosto che in quelli drammatici, salvo eccezioni. Tra le migliori commedie all’italiana si ricorda senza dubbio Il sorpasso, 1962, di Dino Risi, soprattutto grazie all’abilità di 4. DORIGO (1966: 45). 5. Passando «disinvoltamente dal Busacca lombardo de La grande guerra al romanista sfegatato de I mostri» (Raffaelli in CARPITELLA/DE MAURO/RAFFAELLI/NAPOLITANO 1986: 168). Bisognerà attendere Giancarlo Giannini per ritrovare un analogo camaleontismo dialettale. 348 Il linguaggio cinematografico Vittorio Gassman nel dar vita a un pergonaggio nel contempo sbruffone e patetico, come ben risulta dalla sua lingua, romanamente colorita e infittita di riferimenti culturali spiccioli e superficiali, dal cinema alla poesia, con un orecchio teso ai dialetti diversi dal proprio («Mai lo sentii quest’Ordine. Eh, tu lo sentisti, comparuzzo?») e un altro alle lingue straniere («sono veramente sorry»). L’italiano dell’uso medio e l’italiano regionale (realisticamente eseguito) cominciano a entrare stabilmente negli schermi e a risuonare “normali”, negli orecchi degli italiani, almeno quanto l’italiano standard delle produzioni straniere doppiate, colte e popolari6: BRUNO (Gassman): E nonno, non è voluto venì? L’avete lasciato a casa? Le belle famiglie italiane. Buon viaggio! “E io me la portai al fiume credendo che fosse ragazza e invece aveva marito”. Eh, la so a memoria. Ho messo il disco di Foà da Terracina a Roma. E… come si chiama… la… La sposa infedele, di, di coso, quello spagnolo, quello un po’… ROBERTO (J.–L. Trintignant): García Lorca. B RUNO : Ah, ce l’hai pure tu il disco. Tiè, metti questo. È Modugno. Perché a me la poesia mica me convince tanto. Me piace la musica a me. Questa per esempio, questa è forte. È mistica, ’na cosa che te fa pensà, la musica. A me Modugno mi piace sempre. Quest’Uomo in frac mi fa impazzì. Perché… pare ’na cosa da niente, invece, ahó, c’è tutto: la solitudine, l’incomunicabilità, poi quell’altra cosa, quella che va de moda oggi, la… l’alienazione, come nei film d’Antonioni, no? L’hai vista L’eclisse? ROBERTO: Sì. È un film… BRUNO: Io c’ho dormito: ’na bella pennichella. Bel regista, Antonioni7. 6. «Il cinema è in grado di influire direttamente sulle competenze linguistiche degli italiani soltanto a partire dagli anni Sessanta, quando l’aderenza anche della commedia alla realtà induce a modellare il parlato filmico sulla lingua quotidiana, che per molti è un italiano con varianti per così dire ‘regionali’» (Raffaelli in CARPITELLA/DE MAURO/RAFFAELLI/NAPOLITANO 1986: 171). 7. RAFFAELLI (1996a: 329–330), donde provengono anche le due precedenti citazioni dal medesimo film. 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 349 Pochi attori più del Gassman comico (e di Sordi e Tognazzi) e pochi registi più del Risi degli anni Sessanta hanno scolpito meglio le miserie psicologiche e morali degli italiani del boom economico, parlando la lingua ora del pressappochismo e del qualunquismo, ora dell’arrivismo e del trasformismo: si veda, oltre al Sorpasso, almeno I mostri, 1963. Oltre alla lontana eredità della Commedia dell’Arte, tuttavia, non va trascurata un’altra fonte diretta della comicità filmica basata sull’uso (più o meno stilizzato) del dialetto: il teatro di varietà [→ Glossario, VARIETÀ] (all’altro elemento influente, la stampa umoristica, s’è già accennato più volte). Ne è un prezioso testimone filmato I pompieri di Viggiù, 1949, di Mario Mattoli, che riprende molti spezzoni di riviste. È qui messa in scena l’abilità di Nino Taranto nel dominare vari dialetti, secondo i soliti canoni: il napoletano (come topo d’albergo), il siciliano (come guardia della buoncostume sessuomane), il lombardo (come vigile del fuoco). Tra i pompieri figurano anche un romano e un veneto e numerosi sono i lazzi che contrappongono i settentrionali ai meridionali: come al solito, gli ambienti militari (o paramilitari) sono i favoriti per la rappresentazione (e la derisione) della stratificazione dialettale italiana. Analoga importanza, come esempio di varietà filmato, ha Luci del varietà, 1950, di Lattuada e Fellini. Del resto, la migrazione di numerosi talenti dal teatro di varietà al cinema, Totò e lo stesso Taranto in primis, non fa che accentuare gli elementi di tangenza stilistica tra i due generi. Ovviamente, l’italiano standard e quasi senza accento continua ad essere utilizzato sul grande schermo nel doppiaggio non soltanto dei film stranieri ma anche di quelli nostrani, soprattutto per prodotti popolari quali i film di GENERE [→ Glossario]: quelli mitologici e storici (il cosiddetto genere PEPLUM [→ Glossario]), fantascientifici o fantastici, western, erotici, dell’orrore, sentimental–canori (la miriade di titoli con Morandi, Mina, Caselli, Al Bano, Bobby Solo, etc.; fanno eccezione le commedie musicali della Wertmüller con Rita Pavone, colorite al solito in senso espressionistico: Rita, la zanzara, 1966 e Non stuzzica- 350 Il linguaggio cinematografico te la zanzara, 1967), polizieschi e spionistici. Come già osservato a proposito di Catene, il livello culturale dei destinatari di un film (ma anche di un romanzo) è inversamente proporzionale al tradizionalismo e alla formalità dei dialoghi. Per le produzioni più impegnate, di carattere storico, dedicate perlopiù agli eventi della seconda guerra mondiale, si oscilla tra l’italiano standard di base (che è tipico anche di altra produzione colta, dai film di Visconti, La terra trema e Rocco e i suoi fratelli a parte, a quelli di Antonioni, a quelli non romani di Pasolini, etc.) e quello regionalmente colorito di alcuni personaggi. Dopo qualche anno di latitanza, in seguito all’insuccesso di pubblico delle opere neorealistiche, il nostro cinema torna infatti a interessarsi alla guerra e alla Resistenza: dal Generale Della Rovere, 1959 a Era notte a Roma, 1960, di Rossellini; da Tutti a casa, 1960, di Comencini alla Ciociara, 1960, di De Sica, a Kapò, sempre del 1960, di Gillo Pontecorvo, e tanti altri. Anche quando s’affrontano altre epoche e altre latitudini il riferimento più o meno indiretto sembra essere sempre alla realtà storico–politica dell’Italia contempornaea (Senso, 1954, di Visconti; La battaglia di Algeri, 1966, di Pontecorvo, etc., quasi tutti in italiano non connotato diatopicamente; tra le eccezioni, La grande guerra, 1959, di Mario Monicelli, «dove, protagonisti Sordi e Vittorio Gassman, circolava una mistione attendibile di varietà regionali d’italiano e di dialetti»8, e i film di Luigi Magni, in un romanesco in bilico tra i toni della storia, della commedia e della farsaccia: Nell’anno del Signore…, 1969; La Tosca, 1973; In nome del Papa Re, 1977; In nome del popolo sovrano, 1990). Stessa oscillazione nei film di impegno politico e militante, ora più spostati verso la regionalità (Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, 1970, La classe operaia va in Paradiso, 1971 e La proprietà non è più un furto, 1973, di Elio Petri), ora verso l’italiano standard (più numerosi, questi ultimi, dato 8. RAFFAELLI (1992: 124). 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 351 che l’intento è soprattutto quello di veicolare idee, talora anche in modo dichiaratamente metaforico, piuttosto che di inscenare una realtà: da Zabriskie Point, 1970, di Michelangelo Antonioni a Sbatti il mostro in prima pagina, 1972 e Diavolo in corpo, 1986 di Marco Bellocchio). Dopo un quarto di secolo di silenzio quasi assoluto (praticamente dall’omicidio di Moro, con qualche eccezione quale Il caso Moro [I giorni dell’ira], 1986, di Giuseppe Ferrara) e di ripiegamento sulle vicende private9, il cinema di impegno politico riprende, in questi ultimi anni, con la stessa bipolarità: l’italiano standard dei film su Moro, per esempio (Piazza delle cinque lune, 2003, di Renzo Martinelli; Buongiorno, notte, 2003, di Bellocchio), fa da contraltare al romanesco di Romanzo criminale, 2005, di Michele Placido, dedicato ai fatti della Banda della Magliana. Naturalmente, il colore siciliano o napoletano è invece un ingrediente ineliminabile dei film sulla mafia o sulla camorra, di fatto mai usciti di scena, anche se divenuti sempre più frequenti dopo il successo internazionale del Padrino (Damiano Damiani in testa). Non sono molti, invece, i film che rappresentano stralci di italiano popolare, dopo la straordinaria lettera alla Malafemmina di Totò e Peppino. Tra questi, Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca), 1970, di Scola, con Monica Vitti, nei panni della fioraia Adelaide, che produce enunciati di questo tenore: «Sì, amo riamata Serafini Nello e lo appartengo!»; «Ora che il mio cuore è spaccato in due è più facile imputarsi un braccio»; «Con Nello si amavamo»10. La volontà di parlare come nei fotoromanzi, ovvero quell’italiano tanto più stereotipicamente letterario quanto più basso (e con evidenti fenomeni di analfabetismo) è il livello culturale del lettore, colloca Adelaide tra le 9. Cfr. Il bel volume Il trionfo del privato, Roma–Bari, Laterza, 1980, con saggi di Ernesto Galli della Loggia, Marina Bianchi, Natalia Aspesi, Ugo Volli, Alfonso M. Di Nola, Raffaele Simone, Nello Ajello. 10. BRUNETTA (1991: 456). Un’analisi dettagliata del film si ha in MICHELI (1994: 23–30). 352 Il linguaggio cinematografico ideali eredi delle ammiratrici dello Sceicco bianco felliniano, la cui lingua è descritta poco sotto. In lei coesistono forme dotte e scolastiche come egli e oblio e svarioni come il condizionale al posto del congiuntivo: «Oreste, omo del mio destino, io ti darò l’oblio»; «Oreste è l’omo mio e io so’ la donna sua che gli ha dato la felicità che egli non aveva mai conosciuto»; «Oreste, se un giorno tu lasceresti anche me, io t’ammazzo. E non ridere. Ma non senti anche tu che la nostra felicità potrebbe finire da un momento all’altro?»11. Tra le utilizzazioni dell’italiano popolare a fini comici, si ricordano i congiuntivi abnormi (venghi, vadi e facci per venga, vada e faccia) di Paolo Villaggio nei panni del ragionier Fantozzi, nella lunga serie di film inaugurata da Fantozzi, 1975, di Luciano Salce (ma il personaggio era nato nel 1968 in televisione). Villaggio–Fantozzi (ma si ricordi anche il personaggio di Fracchia, che lo stesso Villaggio interpretò prima sul piccolo e poi sul grande schermo) ha tra l’altro segnato il successo, presso più di una generazione, di espressioni quali megagalattico, megadirettore galattico e com’è umano lei! Se ci spostiamo, invece, sul versante dell’italiano standard, un regista molto interessante è Michelangelo Antonioni. Non tanto nei primi film (fino al Grido, 1957), dallo stile assai tradizionale quando non letterario (s’è già visto con Le amiche, 1955), quanto a partire dalla trilogia L’avventura, 1960, La notte, 1961 e L’eclisse, 1962, in cui s’inaugura l’inscenamento del blackout comunicativo e dell’alienazione (al massimo grado in Deserto rosso, 1964). La parola si fa sempre più rarefatta e gli stessi sceneggiatori di Antonioni individuano nella scarnificazione verbale il tratto distintivo del passaggio dalla sceneggiatura al film12. Dall’Eclisse in poi in alcune scene si giunge quasi al mutismo. Sono, come al solito, i personaggi femminili (interpretati da Monica Vitti, in particolare) a esprimere i messaggi 11. Dramma della gelosia (MICHELI 1994: 25). 12. Cfr. DORIGO (1966: 56). 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 353 più pregnanti del film, che spesso, peraltro, vanno in direzione della negazione, dell’impossibilità del dire, del dubbio (si noti, nel brano citato appresso, la frequenza delle negazioni e delle battute che ribadiscono l’incomunicabilità mediante il non detto e il non dicibile: «Senti/ fin qui abbiamo evitato di dirci certe cose! Perché adesso me le vuoi tirar fuori?!»; «No// Tu certe cose non me le diresti»; «non lo so» detto tre volte)13. Nell’Eclisse, film che per la ricercatezza delle soluzioni espressive ha risentito sicuramente dei registi francesi della NOUVELLE VAGUE [→ Glossario] (Resnais, in particolare), la prima scena si dilata tra una battuta e l’altra (separate talora da alcuni minuti di assoluto silenzio, senza neppure la musica di sottofondo), mentre Vittoria (la Vitti) cerca di troncare la relazione con Riccardo. Ai lunghi silenzi iniziali sono violentemente contrapposte le urla sovrapposte e confuse dei giocatori di borsa della scena successiva. Tutto (e in particolare l’architettura fredda e geometrica dell’Eur e, ovviamente, il fenomeno dell’eclisse totale di sole)14 concorre a rappresentare il disagio, lo svuotamento e l’assenza di valori e interessi della borghesia italiana all’alba del neocapitalismo: VITTORIA: Allora/ Riccardo// RICCARDO: Che c’è? VITTORIA: C’è tutto quello che abbiamo detto stanotte// RICCARDO: Sì// Decidiamo// VITTORIA: È già deciso// RICCARDO: Eh// VITTORIA: Io vado/ Riccardo// RICCARDO: Devi andare da qualche parte? 13. Non a caso, verso la fine del film (L’eclisse), Alain Delon chiederà alla Vitti, innervosito: «Ecco/ tu non sai dire altro! Non lo so! Ma insomma/ perché vieni con me? E non dirmi che non lo sai!». 14. «Durante l’eclisse probabilmente si fermano anche i sentimenti», ebbe a dire Antonioni (TINAZZI 1995: 18). Con ricercata simmetria, il film si apre, senza parole, con l’eclisse del rapporto di coppia, e si conclude, sempre in silenzio, con le splendide immagini dell’eclisse meteorologica. 354 Il linguaggio cinematografico (trascorrono, in silenzio, circa due minuti e mezzo. Riccardo fa per baciarla) RICCARDO: È l’ultima volta// VITTORIA: No/ Riccardo! Non fare così! RICCARDO: Ma cosa devo fare?! Avanti/ dimmelo tu/ cosa posso fare/ e io lo faccio! Te lo prometto! Farò tutto quello che dici/ per filo e per segno! Trovami/ qualche cosa da fare/ per quando tu sarai andata via// Io volevo farti felice! VITTORIA: Quando ci siamo incontrati avevo vent’anni// Io ero felice! (trascorrono, in silenzio, circa due minuti) VITTORIA: Senti// Volevo dirti che ieri sera ti avevo portato la traduzione di quell’articolo tedesco// Mi dispiace/ di non poter più fare questo lavoro per te// Però conosco qualcuno che può sostituirmi// Ci penso io/ se vuoi// D’altra parte/ non mi pare il caso di continuare// Oppure/ se vuoi posso continuare// RICCARDO: È questo/ che volevi dirmi? VITTORIA: Io vado// RICCARDO: Aspetta! VITTORIA: Ma cosa devo aspettare?! RICCARDO: Aspetta! Aspetta un momento! VITTORIA: Senti/ fin qui abbiamo evitato di dirci certe cose! Perché adesso me le vuoi tirar fuori?! RICCARDO: No// Tu certe cose non me le diresti// Tu non sei cattiva// VITTORIA: Sono cattiva con te// RICCARDO: Può darsi/ Vittoria// Ma non importa// Sii buona/ adesso/ e dimmi un’ultima cosa// Non mi ami più/ o non vuoi più sposarmi? VITTORIA: Non lo so// RICCARDO: Quando hai cominciato/ a non amarmi più? VITTORIA: Non lo so// RICCARDO: Ne sei proprio sicura? VITTORIA: Sì// RICCARDO: Ma… allora/ un motivo… un motivo c’è! Io le capisco/ queste cose! VITTORIA: Sì/ tu le capisci/ ma io non lo so! RICCARDO: Io volevo… VITTORIA: Farmi felice/ me l’hai già detto// Ma per continuare/ devo essere felice anch’io (Riccardo fa per baciarla) No/ per favore! Non ricominciare! RICCARDO: Hai qualcuno che ti aspetta?! 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 355 VITTORIA: No// No/ ti ho detto cento volte di no! RICCARDO: Posso telefonarti/ fra qualche giorno? VITTORIA: No//. Ovviamente la Commedia all’italiana, nella sua (spesso qualunquistica) satira sulla cultura “ufficiale”, non potrà non affinarsi le unghie sul criptico e intellettualissimo Antonioni. E infatti, puntualmente, lo sbruffone Gassman confessa all’inibito Trintignant, nel brano del Sorpasso sopra citato, di essersi fatto «’na bella pennichella» alla proiezione dell’Eclisse. Se ne ricorderà forse Fantozzi, nell’immortalare La corazzata Potëmkin (Bronenosec Potëmkin), 1925, di Ejzenštejn, inflittagli dai superiori, come «una cagata pazzesca» (Il secondo tragico Fantozzi, 1976, di Luciano Salce). La linea di Antonioni, almeno per quanto riguarda l’uso intermittente della parola, è seguita, in epoca recente, soprattutto da Marco Bellocchio, che in un caso si è dedicato proprio al fenomeno dell’afasia (Il sogno della farfalla, 1994). La storia della funzione dei silenzi al cinema (con illustri esempi stranieri, naturalmente, da Bergman ad Angelopoulos) sarebbe interessantissima ma è ancora tutta da scrivere. 6.1.2. E veniamo ora ai dialetti e agli italiani regionali. Se escludiamo l’egemonia romana (per la quale, basti la trascrizione di Poveri, ma belli sotto riportata, oltre ai titoli di volta in volta citati) e, molto più tenue almeno sul territorio nazionale, quella napoletana (nella versione italianizzata proposta dai De Filippo, Totò, De Sica, Loren e tanti altri, oppure in quella più dialettale dei film musicali e delle sceneggiate, raramente apprezzate al Nord: fra le eccezioni, Guaglione, 1956, di Giorgio Simonelli, con Claudio Villa, qualche titolo con Mario Merola e, più recentemente, con Nino D’Angelo), non sono molte, fino a tutti gli anni Settanta, le varietà regionali rappresentate con un certo realismo (benché nei registri prossimi all’italiano) e per uno spazio non limitato a singole macchiette di contorno. 356 Il linguaggio cinematografico Tra le varietà “minori” di maggior fortuna c’è senza dubbio il siciliano, da intendersi però essenzialmente come «siciliano dei film di mafia, che è quasi sempre catanese e non palermitano, una sorta di ‘siciliano per il cinema’»15. Anche il siciliano delle commedie di Pietro Germi (Divorzio all’italiana, 1961 e Sedotta e abbandonata, 1964 [Fig. 39]) viene ridotto a una più o meno marcata inflessione (perlopiù impropriamente riprodotta da attori e doppiatori non siciliani)16 per mettere in ridicolo le attitudini e i tabù dei personaggi, assumendo, dunque, un esplicito valore simbolico: «da Divorzio all’italiana in avanti lo stereotipo dell’ometto in coppola, baffi e lupara funge da scarico esorcistico per le miserie (sessuali in primis) di tutta la società»17. I mille stereotipi, tematici e linguistici, sulla Sicilia e sui siciliani sono stati confermati dalle centinaia di film sulla mafia prodotti negli Stati Uniti e che raggiungono l’apice della celebrità con la trilogia del Padrino di Francis Ford Coppola, già commentata nel capitolo precedente18. L’italoamericano tipo è quasi sempre nato in Sicilia (più raramente in Campania) o di origine siciliana e dissemina, nel suo parlato (anche nei dialoghi originali del film) almeno una dozzina di minghia!, per ribadirlo. È inoltre quasi sempre mafioso, o quantomeno fortemente incline alla violenza e contiguo ad ambienti di micro– o macrocriminalità (Means Streets, 1973, di Scorsese). Ecco dunque che anche certi tic e gag linguistici vengono addirittura amplificati, 15. COVERI (1995a). Significativa, riguardo al predominio del catanese, la battuta conclusiva della scenetta di Nino Taranto, nei Pompieri di Viggiù, in cui un pompiere siciliano così si complimenta con l’attore: «Bravo/ don Nino! Come un catanisi veru/ parlau!». 16. Dei primi film “siciliani” di Germi, In nome della legge, 1949 e Il cammino della speranza, 1950, s’è già detto. Evidentemente i tempi dello sperimentalismo (La terra trema) e del Neorealismo erano ormai conclusi, mentre quelli della Commedia all’italiana, che peraltro relegherà il dialetto al registro comico, non erano ancora maturi. 17. MASONI/VECCHI (1986: 83). 18. Sarebbero 1057 i film girati negli Stati Uniti, dal 1928 al 2000, che contengano almeno un personaggio italiano o italoamericano; inutile dire che la maggior parte di questi (il 73%) davano (e danno) di noi un’immagine negativa (cfr. STELLA 2003: 186–187). 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 357 dal Padrino in poi, anche grazie al doppiaggio, che estremizza (spesso rendendole in modo oltretutto asistematico o addirittura sbagliato) alcune peculiarità dell’italiano regionale e dei dialetti di Sicilia, come il timbro vocalico di e ed o tendenzialmente sempre aperte, la pronuncia come affricate alveolari (la c di cena e la g di gelo, per capirci) dei nessi tr e dr, l’intensità consonantica di r iniziale e di b, d, g, la tendenza all’assimilazione progressiva nei nessi con r + nasale (Carmela > Cammela: tratto limitato alla Sicilia orientale ma indebitamente esteso a tutti i siciliani, sul grande schermo), la pronuncia di –ll– più o meno come –dd– (beddu ‘bello’), alcune sonorizzazioni, ci dativo al posto di gli/le/loro, l’abuso del passato remoto e del congiuntivo imperfetto (scusasse, s’accomodasse), la tendenza a collocare il verbo in fine di frase, certi lessemi–bandiera (oltre a minchia, magari o macari ‘anche’, Vossia e Voscenza come allocutivi di cortesia, baciamo le mani), etc.19. Pochi i registi che tentano di sottrarsi all’equazione: parlata sicilianizzante (nel doppiato, oppure, in originale, italoamericana) = malavita. Tra questi, in epoca recente, i già citati John Turturro, con Mac, 1992, e Stanley Tucci e Campbell Scott, con Big Night, 1996. Tra gli italiani c’è anche chi, pur trattando di mafia, vuole liberare il campo da banali generalizzazioni, introducendo il film con una didascalia di sapore vittoriniano: Ad evitare equivoci o fraintendimenti avverto che la Sicilia che inquadra e accompagna questo film è solo per avventura Sicilia; solo perché il nome Sicilia suona meglio del nome Persia, Venezuela, Brasile o Messico. Del resto immagino che tutti i film vengano girati con una cinepresa e impressionati su una pellicola20. 19. Per le caratteristiche del siciliano cfr. ALFIERI (1992) e TROVATO (2002). 20. Didascalia iniziale di Placido Rizzotto, 2000, di Pasquale Scimeca. Il riferimento è alla nota conclusiva di Conversazione in Sicilia, di Elio Vittorini (Milano, Bompiani, 1941): «Ad evitare equivoci o fraintendimenti avverto che, come il protagonista di questa Conversazione non è autobiografico, così la Sicilia che lo inquadra e accompagna è solo per avventura Sicilia; solo perché il nome Sicilia mi suona meglio del nome Persia o Venezuela. Del resto immagino che tutti i manoscritti vengano trovati in una bottiglia». 358 Il linguaggio cinematografico Volendo schematizzare l’uso del siciliano filmico, estendendo il discorso fino a oggi, possiamo individuare almeno quattro filoni: 1) quello realistico (di solito presente nei film di denuncia tipo Mery per sempre, 1989 [Fig. 40] e Ragazzi fuori, 1990, di Marco Risi, o l’appena citato Placido Rizzotto, più vicini al dialetto puro — in alcuni personaggi — che all’italiano regionale); 2) quello attenuato (l’italiano regionale sicilianeggiante fa da contraltare a quello padaneggiante in Romanzo popolare, 1974, di Mario Monicelli e in Delitto d’amore, 1974, di Luigi Comencini [Fig. 41]), che è prevalentemente di matrice macchiettistica (dalle satire di Germi alle farse con la coppia Franchi–Ingrassia, entrambe caratterizzate da un italiano regionale con tratti di forzatura e di innaturale italianizzazione: il siciliano parlato dalla doppiatrice della Sandrelli o da Mastroianni, nei film di Germi; l’italiano di Franco e Ciccio, che di regionale ha soltanto certe intonazioni e poche parole), oppure, di rado, epicizzante (Salvatore Giuliano, 1962, di Francesco Rosi); 3) quello espressionistico, per dir così, proprio, per esempio, di certi film della Wertmüller (con volute esagerazioni e distorsioni, soprattutto ad opera di Giancarlo Giannini: Mimì metallurgico ferito nell’onore, 1972 [Fig. 42]21; Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto, 1974); 4) e infine quello doppiato dei mafia–film americani (o italiani postsincronizzati), oscillanti tra usi annacquati, incongrui ed esasperati (gli esempi sono nel § 5.3.1). Un esempio recente di siciliano attenuato credibile e non macchiettistico, perfettamente funzionale ai contenuti e simbolicamente contrapposto (in quanto lingua della mafia) all’italiano standard (lingua della ribellione e, in questo caso, della legalità e della moralità) è quello dei Cento passi, 2000, di Marco Tullio Giordana: Peppino Impastato, ostentatamente ita- 21. In questo film forme bandiera del siciliano (ancorché esasperate nella pronuncia: «figghio ’e bottana/ iè!»; «rombere la minghia!»; «amuninni picciotti!»; «tu me fai mòrere» ‘tu mi fai morire’) si alternano a pronunce francamente abnormi come fuora ‘fuori’. 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 359 lofono, rifiuta tanto il siciliano dei boss locali quanto l’americano (e l’italoamericano) di quelli d’oltreoceano22. Continuando la rassegna delle varietà regionali meno fortunate, si può citare il milanese di Ermanno Olmi (Il posto, 1961; ma le varietà padane ricorrono anche in molti altri film del regista: Il tempo si è fermato, 1960; I fidanzati, 1963 [Fig. 43]; …E venne un uomo, 1965 — riedito in versione italianizzata; Un certo giorno, 1969, etc., fino ai Recuperanti e all’Albero degli zoccoli, di cui si dirà tra poco) e il torinese nei Compagni, 1963, di Mario Monicelli, più diastraticamente modulato e verosimile il primo (Il posto, «affettuoso schizzo linguistico della Milano impiegatizia del tempo, dove la dialettalità ascendeva dal livello popolare verso le varietà diastratiche e diafasiche dell’italiano popolare di città e del contado, e senza soluzione di continuità finiva con l’includere quello formalizzato fino al ridicolo della burocrazia»)23 del secondo (I compagni, ambientato in una fabbrica nell’Ottocento e quindi in un clima culturale che non giustifica l’uso della varietà più italianizzata). Dell’emiliano e del romagnolo, a parte Fellini, si ricorderanno quasi esclusivamente i film di Pupi Avati: Una gita scolastica, 1983; Impiegati, 1984; Noi tre, 1984; Festa di laurea, 1985, e altri24. 6.1.3. Un discorso a parte richiede la Toscana, su cui faremo una breve sosta, motivata dalla recente e crescente popolarità di questa regione sul grande schermo. Le varietà toscane, a parte qualche accento involontario nei primi film sonori e poco altro25, sono tra le ultime ad essere riprodotte dal nostro cinema: 22. Un brano tratto dal film è analizzato in A. ROSSI (2003: 116–117). 23. RAFFAELLI (1996a: 331). 24. Sul dialetto romagnolo nel cinema, a partire dai primi film sonori fino agli ultimi film di Fellini, è ricchissimo di informazioni GORI (1997). 25. Per esempio, qualche film con il celebre comico e canzonettista fiorentino Odoardo Spadaro (1895–1965; quello di La porti un bacione a Firenze, per intenderci). L’ondata filodialettale inaugurata, tra i primi, da Alessandro Blasetti e poi rinvigorita dal Neorealismo, come già visto nel § 4, lascerà le varietà toscane sullo sfondo. Nel blasettiano 1860, per esempio, abbiamo già rilevato le imperfezioni presenti nella riproduzione del parlato toscano. Due altri esempi di film “toscani” sono citati da RAFFAELLI 360 Il linguaggio cinematografico le battezzò praticamente Mario Monicelli nel 1975, con Amici miei. I motivi di questo ritardo sono riassumibili in quell’errore di prospettiva, che ha caratterizzato l’intera nostra annosa questione della lingua, consistente nello scambiare una varietà diatopica (il dialetto fiorentino) per una diafasica (il registro formale), spacciando tanti riboboli per pietre preziose ed esasperando e falsando così quell’effettiva parentela (ma non coincidenza!) tra l’italiano letterario e il toscano–fiorentino, ovvero in «quel complesso […] di superiorità linguistica, che costituisce una costante e una dominante nella storia» della Toscana, ben presto identificata con la sola Firenze26. I motivi profondi dell’occultamento del toscano da parte di sceneggiatori e registi comici sono chiaramente spiegati da Roberto Benigni: La tradizione toscana del comico è poverissima […] perché [in Toscana] si parla la lingua dei padroni ed è il servo che fa ridere, non il padrone. Quando arriva uno che parla toscano viene in mente subito l’opera d’arte, la cultura, Dante Alighieri. Il toscano diventa quello che sa tutto. Invece il comico è quello che non sa nulla. Stenterello è quasi lezioso. Nel vernacolo fiorentino si sente l’imposizione della lingua, più che nella lingua italiana. Invece poi con Pinocchio, sono venute fuori tutte le caratteristiche della tragedia, della povertà toscana che è uguale a quella pugliese, a quella umbra, a quella calabrese, uguale identica27. (1992: 90–94): Acqua cheta, 1933, di Gero Zambuto, tratto da una commedia di Augusto Novelli — «film dominato da certa toscanità, peraltro assai attenuata, nell’intonazione e nella profluvie di bono, di novo, di costrutti quali la ride, noi si mangia…» — e Il re d’Inghilterra non paga, 1941, di Giovacchino Forzano, film di propaganda politica contro la perfida Albione e dai dialoghi toscaneggianti e trecenteschi. 26. NENCIONI (1983b: 33–34). Per un approfondimento su questi temi cfr. GIACOMELLI (1975), POGGI SALANI (1997), BINAZZI (1992) e (1997) e ROSSI (1999e). Secondo DE MAURO (1985: 57) Roberto Benigni è riuscito laddove generazioni di linguisti hanno fallito, dimostrando come il toscano sia un dialetto come tutti gli altri e, come tale, possa risultare ostico al resto degli italiani. 27. Testimonianza raccolta da PARIGI (1988: 174). Simili constatazioni sull’“antipatia” della parlata toscana al cinema si trovano in GIANNARELLI (1982, III). Queste considerazioni potranno essere facilmente estese anche per spiegare l’esiguità di usi comici, comunque ieri più di oggi, dei dialetti settentrionali (le lingue del Nord sono avvertite 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 361 Proprio per via della nostra storia linguistica, insomma, sia la letteratura sia il teatro vernacolari toscani (e conseguentemente il cinema) si sono solo raramente imposti all’attenzione nazionale: finché c’è la presunzione che tra toscano e italiano non vi sia alcuna frattura, non ha senso distinguere una letteratura italiana da una toscana. La resa del toscano, poi, ha risentito ancor più delle altre parlate dell’azzeramento delle microvarietà diatopiche, ovvero del livellamento operato dai vari italiani regionali, teso a identificare la parlata di una regione con quella del suo centro più prestigioso (di solito il capoluogo); tendenza che naturalmente la letteratura, il teatro e il cinema esasperano, occultando ogni altro apporto. Al pari di altre varietà, inoltre, il toscano ha subito un ulteriore processo di sdialettizzazione e normalizzazione proprio della lingua filmica. Persino in un film–bandiera del Neorealismo, Paisà, 1946, di Rossellini, l’episodio toscano (insieme con quello romano: un’altra varietà sui generis, dunque, contingua all’italiano standard) è quello più trascurato nella resa del dialetto. Infatti accanto a enunciati verosimilmente eseguiti («Ma i’ cche la vole he si sappia/ noi? Co tutto quello h’è successo/ e s’ha altro da pensare!») si hanno esempi di evidente e inverosimile mescidanza italiano–dialetto come il seguente: UOMO1: Di Lupho/ ’un si sa nulla? UOMO2: Di Lupo? Chi dice ch’è ferito/ chi dice che non è ferito/ chi dice che è in città/ chi dice che non è in città// Certo che a Firenze glj han fatto un lavoro con i fiocchi! UOMO1: Eh/ ci credo anch’io! UOMO2: E col mio aiuto/ eh! In città avevo organizzato tutto di molto/ ma di molto bene// Specialmente ora prima dell’occupazione de’ tedeschi/ si faceva le chose alla luce d’i’ ggiorno//, come il codice del potere economico e politico), con qualche eccezione (da Renato Pozzetto a Paolo Rossi) soprattutto televisiva ed escludendo, come al solito, la leggera patina fonetica di molti personaggi di contorno. 362 Il linguaggio cinematografico dove stridono, nel secondo parlante–doppiatore (il quale, voce di più di un comprimario del film, da certe caratteristiche della pronuncia e dell’intonazione è sicuramente di provenienza romana e non toscana), le affricate alveopalatali non spirantizzate (in tutte le varietà toscane si avrebbe una pronuncia del tipo [diʃe] e mai [ditʃe]) e la forma analitica della preposizione + articolo («con i fiocchi», in luogo di un fiorentino «co fiocchi»). La lingua del protagonista Massimo, poi, è un tipico italiano senza sfumature (doppiaggese), inesistente nella realtà. La causa di simile approssimazione e forzata italianizzazione del fiorentino è da ricondursi, ancora una volta, all’equivoco che il toscano (erroneamente identificato col fiorentino) non fosse un dialetto, bensì coincidesse con l’italiano tout court, e all’esigua presenza, nella nostra storia cinematografica, di attori (e soprattutto di doppiatori) di provenienza toscana. Inoltre, poiché maggiore è la distanza tra due codici, migliore (cioè meno ricco di interferenze) è il passaggio da un codice all’altro, l’impegno di un parlante italiano standard nella riproduzione del toscano è scarso e il risultato, dunque, poco soddisfacente. Anche Totò, sempre pronto a giocare con l’imitazione e la deformazione dei vari dialetti italiani, al toscano si avvicina molto di rado: con un micco ‘sciocco’ (in Totò e Carolina, 1955, di Mario Monicelli, e in Letto a tre piazze, 1960, di Steno), e con la garbata imitazione del fiorentino della moglie Ave Ninchi, con tanto di gorgia e con ’un per ‘non’ (in Totò cerca pace, 1954, di Mario Mattoli). Rispetto alla riproduzione intenzionale del toscano al cinema, vanno distinti gli usi irriflessi, talora presenti, nel passato, nei film italiani (il raddoppiamento fonosintattico fiorentino, non italiano, da nNando, si coglie, per esempio, nella voce fuori campo del film romanesco Un americano a Roma, 1954, di Steno) e anche in quelli stranieri doppiati (Lilli e il vagabondo: cfr. § 5.3.1). Parallelamente alla riscoperta del toscano come dialetto (seppure semplificato) del cinema comico, e quindi allo sviluppo di una cinematografia toscana riflessa, per così dire, si assiste dunque al riassorbimento di quei toscanismi irriflessi del 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 363 passato, spesi un tempo dai nostri doppiatori soltanto come moneta d’oro, ovvero impiegando una varietà diatopica in luogo di una diafasica. Come accennato prima, la riproduzione quasi integrale dell’italiano regionale toscano sul grande schermo inizia con Amici miei, 1975, di Monicelli (anche se ideato da Pietro Germi). Al primo film seguiranno Amici miei, atto II, 1982, dello stesso Monicelli, e Amici miei, atto III, 1985, di Nanni Loy. Nel primo, la parlata toscana ha in realtà un ruolo di sfondo (più nelle comparse che nei protagonisti, come di consueto), anche perché l’unico davvero toscano del gruppo — costituito dal francese Philippe Noiret, dal veneto Gastone Moschin, dal siciliano Adolfo Celi, dal lombardo Ugo Tognazzi e dal piemontese Duilio Del Prete — è Renzo Montagnani, che doppia Noiret. Più che il toscano vero e proprio, dunque, il film immette sullo schermo una forte dose di toscanità, ottenuta mediante un umorismo irresistibile (mai gretto), prevalentemente a sfondo sessuale. Un curioso paradosso è quello del doppiaggio, grazie al quale il fiorentino più realistico è quello dei doppiatori (di Noiret e di Blier). Nel secondo film, in cui Montagnani lascia i panni del doppiatore per vestire quelli dell’attore al posto di Del Prete, si innalza notevolmente il tasso di dialettalità (pur permanendo delle imperfezioni: spirito santo, anziché ssanto, nell’esempio seguente). Si veda la scena del battesimo del Melandri (parla un personaggio secondario): «Io thi battezzo ’n i’ nnome d’i’ ppadre/ d’i’ ffiglio/ e dello spirito santo». Come aumenta pure il turpiloquio; se nel primo film le uniche entrate erano «una sega», usato come elemento completivo di negazione (del tipo «m’importa na sega» ‘non mi importa niente’), e il delizioso gioco di parole–nonsense di Tognazzi «La supercazzola con scappellamento a destra», nel secondo film la creativa verve toscana corre quasi a briglie sciolte e ai brani verdiani e rossiniani cantati dagli amici si aggiunge il quintetto squisitamente sconcio: «Oh buchaiola/ tu mi tradisci…». Il terzo film, forse il meno felice, è però senz’altro il più realistico linguisticamente. Montagnani è meno frenato e, se Celi 364 Il linguaggio cinematografico mantiene il proprio ostentato e inossidabile italiano senz’accento, Tognazzi e Moschin si sforzano (pur con scarsi risultati) di mimare una pronuncia vagamente toscaneggiante. Come al solito, le comparse sono doppiate più verosimilmente, come si può osservare nel brano seguente (spiccano numerose spirantizzazioni, ridondanza pronominale del tipo te tu, lessico regionale — si veda rimbischerito — e giusta intonazione): UOMO: (tentando invano di parcheggiare): E ’un c’entro/ via! DONNA: Ma se sh’entra un tir/ sh’entra! UOMO: E ’un cj ha sterzo/ hesta macchina! DONNA: Ma che se’ rimbischerito/ oggi/ te? E che tu fai? UOMO: Oh/ fo! E fo che ’un c’entro?! Sembra he sh’entri/ e poi e’ ’un c’entro! DONNA: Lo so io i’ che tu sh’ha’/ the! Te tu ti se’ ’mbriachato anc’oggi! Te t’ha’ ribevuto/ sai! UOMO: Io?! DONNA: Fammi sentire i’ ffiato/ fammi! Lo sento/ sa’?! Hai bevuto/ sai?! O tu ’un me la racconti giusta/ te/ sai? UOMO: O fammi riprovare! DONNA: Ma che riprovare?! Andiamo a casa/ andiamo! Forza/ ni! Andiamo/ forza/ via! Dopo il primo Amici miei, spetta senz’altro a Roberto Benigni il merito di aver portato la parlata toscana al grande successo cinematografico e televisivo28 e ad aver così infranto definitivamente il pregiudizio che voleva il toscano “antipatico” e anticomico. Il toscano di Benigni è una varietà più rurale del fiorentino29: egli proviene infatti dalla provincia di Arezzo e ha origine contadina. La dialettalità dei primi film del Benigni attore è senz’altro superiore rispetto agli ultimi: come se il crescente successo di pubblico (anche internazionale) e di critica avesse prodotto una volontaria sprovincializzazione della lingua. In effetti, in nessun altro film l’iperparlato di Benigni sembra rag- 28. Dell’«Era Benigni», iniziata in televisione nel 1976, parla AMBROGI (1992). 29. «La mia toscanità è rurale, profondo–contadina», dichiara l’attore in PARIGI (1988: 92). 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 365 giungere le vette di quell’improvvisato e freudiano turpiloquio–sproloquio–soliloquio dialettale della scena centrale di Berlinguer ti voglio bene, 1977, di Giuseppe Bertolucci: La… la merda de la maiala/ de… de gli stronzoli ne’ cculo/ de le poppe pien di piscio con… con gli… con gli stronzoli che escan dalle poppe de’… de’ budelli/ de’… de’ vitelli/ con… con le… con le… le cosce della sposa/ che gli… che gli sorte fra le… fra le cosce […]. Con le mamme tutte ignude/ che si struscian da… dalle file/ e si… si… si sgroppan con… con la schiena/ con le poppe sbatacchiate/ su… su… con… con… senza latte che si scopran tra… tra le mucche che… che… che sta ’n fila e… e gli sorte ’n mezzo all’erba e… e… e gli ’nfila ’n mezzo a’ denti […]. L’ingegno del regista è stato qui quello di sfruttare il genio attorico e verbale di Benigni lasciandolo parlare a briglia sciolta, in un flusso di coscienza dai toni evidentemente joyciani: la lunga e insensata sequela scatologica appena citata (in minima parte) è infatti tutt’altro che gratuita, ma funzionale a esprimere il disagio del protagonista, provocato, tra l’altro, dalla supposta morte della madre, alla quale è legato da un chiaro complesso edipico, e dal proprio insuccesso con le donne. Il Benigni regista, dopo Tu mi turbi, 1983, sembra invece operare, almeno sul piano verbale, una notevole censura sull’irrefrenabilità del Benigni attore–poeta30. In particolare la sua ultima produzione, dopo aver affrontato esperimenti (riusciti) quali la patina arcaicizzante (Non ci resta che piangere, 1984, in coppia col napoletano Troisi) e l’imitazione–deformazione di altre varietà (il siciliano di Johnny Stecchino, 1991), si basa sempre meno sul potere comico del dialetto e dell’italiano regionale, 30. Di altra opinione è PARIGI (1988: 36–37), secondo la quale Benigni, consapevolmente, più che ricercare il realismo dialettale, «aderisce a quei depositi di cultura contadina, in un certo senso universali, che ancora sopravvivono […] in ogni parlato popolare […]. Benigni sa benissimo che per riportare al senso questo sistema deve forzarlo, metterlo a nudo attraverso l’esagerazione e la stilizzazione, deve superarne la dimensione naturalistica e banale operando una sorta di sublimazione dal basso». 366 Il linguaggio cinematografico puntando tutto sull’espressività dell’arte mimica di Benigni attore, sulla suggestione delle immagini e della musica (di Nicola Piovani), su trame più solide rispetto ai primi film (La vita è bella, 1997) e anche, dal punto di vista verbale, sui rapporti con la letteratura (Pinocchio, 2002) e in particolare con la poesia (La tigre e la neve, 2005; è noto l’amore e la profonda conoscenza della Commedia dantesca da parte di Benigni). A sé stante, in quanto regia non sua, il Benigni anglotoscano (perfettamente credibile sia quando parla inglese con la gorgia sia quando parla italiano regionale) di Daunbailò (Down by Law), 1986, di Jim Jarmusch. Il successo della corrente umoristico–dialettale inaugurata da Amici miei e da Benigni spiana la strada ad altri comici e più o meno improvvisati registi toscani: Francesco Nuti, Leonardo Pieraccioni (che segnano entrambi un ritorno nei ranghi, secondo i gusti degli anni Novanta, della toscanità anticonformistica alla Benigni), Alessandro Benvenuti, Marco Messeri, Paolo Hendel, David Riondino, fino ai recenti Massimo Ceccherini e Giorgio Panariello. Per citare i più noti, scialbi e annacquati quanto i loro film sono il toscano di Francesco Nuti (in cui «la toscanità […] è un segnale debole e sembra praticata […] più dai caratteristi di contorno che dal protagonista»)31 e quello di Leonardo Pieraccioni (grazie al successo del Ciclone, del 1996, uno dei film italiani dal più alto incasso nella storia del cinema, il toscano strappa al romanesco il primato di lingua filmica di cassetta), mentre più vigorosa è la parlata di Benvenuti, di Hendel e di Ceccherini. Se è vero che, per molto tempo, il cinema e la televisione hanno teso a «‘schiacciare’ linguisticamente il toscano sul fiorentino»32, il (meritamente) fortunato film di Paolo Virzì Ovosodo (1997), ambientato a Livorno e con spiccati tratti linguistici locali, sembrava fornire buone speranze per un’inversione di 31. COVERI (1994: 81). 32. BINAZZI (1997: 233). 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 367 tendenza, un nuovo modo di valorizzare l’intera tavolozza espressiva della regione Toscana e, più in generale, di accostarsi al cinema con maggior realismo sociolinguistico. Si poteva pensare addirittura a una sorta di rinascita della Commedia all’italiana, per l’elegante connubio tra umorismo, approfondimento psicologico e satira sociale. Purtroppo la speranza è durata l’espace d’un matin e i film successivi del regista (con qualche eccezione per Caterina va in città, 2003, con certa differenza tra il romano urbano e quello provinciale) hanno abbracciato soluzioni linguistiche decisamente di maniera. Concludiamo dunque la nostra rassegna toscana con qualche esempio da Ovosodo, film in presa diretta e con attori quasi tutti alle prime armi, che ha avuto, tra gli altri pregi, anche quello di adattare coerentemente l’eloquio all’età e al livello culturale dei parlanti (notevoli, anche qui, lessemi e morfemi dialettali realisticamente espressi: punta come aggettivo indefinito (‘alcuna, nessuna’), pole ‘può’, di molto, garbare): PIERO (ex–studente di liceo classico): I medici quando lo visitavano scotevano il capo// Sechondo loro non avrèbbe vissuto a lungo// Ma intanto Ivanone di morire sembrava non averci punta voglia//; BIDELLO: Oh/ ecco! Era ora// ’N se ne pole più! MIRCO (adolescente di scarsa cultura): Basta chon queste chatene// Katia/ la mi’ mamma/ ’l negozio! Tutto! Diho bene/ Piero? Vengo co te// Poi a Roma ’n ci so’ mai stato/ ’un mi par vero// Si piglia ’l treno? No/ perché dishe che a Roma c’è un visibiglio di stazioni/ eh! […] A me i poliziotti italiani mi son sempre di molto garbati! Anche i carabinieri/ eh! Però i poliziotti più/ perché cj hanno un look dinamico e moderno//. 6.1.4. Un’altra sosta andrà fatta su Federico Fellini, non tanto per la sua fama mondiale (poche pellicole al mondo sono state oggetto di culto e di imitazione più di 8 e 1/2; Fellini è, con De Sica, l’italiano che ha vinto il maggior numero di Oscar, per ben quattro dei suoi film: cfr. 2.5.1), quanto per l’assoluta 368 Il linguaggio cinematografico originalità degli usi linguistici dei suoi dialoghi, i quali si caratterizzano, tra l’altro, per «l’inserimento più o meno esteso di brani in dialetto in un contesto italiano che, chiudendoli e quasi comprimendoli in cornice, sembra attenuare e quasi annullare la loro funzione comunicativa»33. Dal parco uso di inserti o sfumature dialettali dei primi film (Lo sceicco bianco, 1952; I vitelloni, 1953; La strada, 1954; più marcato e realistico l’uso del romanesco nelle Notti di Cabiria, 1957, con la consulenza linguistica di Pasolini), si passa al pieno inscenamento del plurilinguismo, sia come cifra distintiva della realtà romana34, sia, soprattutto, come metafora (spesso di carattere onirico) dell’inafferrabilità del reale e dell’assenza di punti di riferimento, come avviene con La dolce vita, 1960, in cui all’italiano e al romanesco si alternano il napoletano, il veneto, il siciliano, l’umbro, l’italiano deformato dagli stranieri (Ekberg), l’inglese, il francese, lo spagnolo…; e, in minor grado, con 8 e 1/2, 1963, dove si riconoscono almeno romano, toscano, napoletano, romagnolo, inflessioni settentrionali e straniere, inglese, francese e tedesco. Nei film successivi (soprattutto in Amarcord, 1973, ma già in 8 e 1/2) il dialetto (autobiograficamente romagnolo) passa ad assumere una funzione quasi espressionistico–esoterica. È la lingua ora del ricordo, del sogno, della coscienza, come nella vecchia nonna rievocata in 8 e 1/2, intelligibile solo in minima parte: Azidèn d’un azidèn! La legna/ l’è tuta bagneda/ st’an! Le vagabòn de gat/ l’è com vos non// El ciapa la port de chesa/ e l’al torn solamènt per magnèr// Tet vergògn! Vat/ a lè! Oh! Al’ultima volta/ aio sbatté la porta in tla fazaza// Ah ah! E l’ho lassé fora/ par du dè// So che […] potù spusarme un’altra volta// E a putia sté sicura/ ch’al’avria a truvèr ben! Do! chi 33. RAFFAELLI (1992: 134). 34. Non dimentichiamo, tuttavia, che l’intento felliniano è sempre più espressionistico che realistico e che la Roma felliniana è in gran parte inventata e molto più interessante della reale capitale dell’epoca. Acutamente D’AMICO (1993: 71) così riassume: «Il sorpasso mostra l’Italia del cosiddetto boom come fu, e La dolce vita, la stessa Italia come sognava di essere». 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 369 l’era megl che vos no/ burdèl? Ma poi/ so’ proprio rinvurnida! Eh/ i aveo a pensé/ che s’aveo a ciapé un etr marìd/ lui/ de fond l’infèrn o el paradìs/ in dò l’è mess/ non m’avria […]35. Ora è la lingua dei diversi, delle voci fuori dal coro (l’«indemoniata» Saraghina, sempre in 8 e 1/2). Fin dal suo primo film, Fellini mostra un’insolita sensibilità nella cura dei dialoghi. Nello Sceicco bianco, infatti, insieme con Sordi, Antonioni e Flaiano, mette a punto una perfetta caricatura linguistica dell’italiano dei rotocalchi rosa, pieno di stereotipi fatti di arcaismi e poetismi inerziali e di sfondoni di italiano popolare: DONNA: Che strano. Mi sembra di non essere più io. SCEICCO (Sordi): Quando vado in barca mi succede la stessa cosa. Una strana amara felicità si impadronisce di tutto il mio essere. Oh, er gabbiano. Er gabbiano. Caro gabbiano […] Una felicità che proviene dal ricordo di una vita posteriore. Anteriore. Posteriore o anteriore? Anteriore. Quando chissà che eravamo noi due, forse io un pirata e me sa che tu, una sirena. DONNA: Che stupida, mi viene da piangere, eppure sono così felice. Sono pazza e felice, mi crede? S CEICCO : Ma mettete a sede qui. Famme il favore. Vieni, vieni36. La repentina commutazione di codice lingua aulica/romanesco, divertente e realistica insieme, mostra tutta la doppiezza cialtrona dello sceicco, che è la stessa del suo idioma: pomposo ufficialmente e rozzo non appena la sua incontenibile natura ferina ha modo di emergere. Questa duplicità linguistica simboleggia il contrasto di due mondi, quello della sciocca e vanitosa favola del fumetto e quello del rione vero e volgare. Fernando Rivoli [è questo il nome dello 35. Per un’altra trascrizione di questo brano (e di altri) e per una sua traduzione in italiano si rimanda a GORI (1997: 56–58). 36. SORDI (2000: 250). 370 Il linguaggio cinematografico sceicco] sta sospeso fra questi due mondi, dondolandosi sull’altalena, con le sue coscione, col suo sorriso fatuo e volgare, con la sua vistosa e logora acconciatura da sceicco che gli è scivolata di traverso37. Contrasto che è tutto già nel nome: Fernando ufficialmente, Nando (nome bandiera dei romani) per gli amici e, per così dire, nell’intimo38. La satira dell’italiano della stampa rosa in cortocircuito con l’italiano vivo eccelle anche nel seguente dialogo telefonico: PORTIERE: Albergo dei Fiori. WANDA: Pronto… C’è il signor Cavalli? PORTIERE: Qui la chiave non c’è. Aspettate ’nu momento, che chiamo. WANDA: No no, non lo chiami. Lo lasci dormire, poveretto. Gli dica solo… che non mi aspetti più. PORTIERE: Pronto pronto… pronto! WANDA: Gli dica che per un destino fatale ho macchiato l’onore del suo nome… L’onore del suo nome! Ma sono innocente, pura… Gli dica che… che ora sono nel fango, ma uscirò dalla sua vita… per sempre! PORTIERE: Aspettate ’nu momento, che scrivo. Pronto! WANDA: Sì! La vera vita è quella del sogno. Ma molte volte il sogno è un baratro fatale, un baratro fatale! PORTIERE: Cosa? Baratro? Bi come Bologna? Vuole ripetere per favore?39. 37. LIVI (1967: 79). 38. Lo sceicco bianco piacque molto alla critica ma non al pubblico: l’ironia era troppo sottile e il protagonista ritraeva un tipo di italiano decisamente poco consolatorio. Sordi indivuò perfettamente le peculiarità e la negatività del suo personaggio: «Io lo sapevo bene chi era lo sceicco! Era quel romano bullo, trasteverino, che avevo sempre visto per la strada o al caffè, l’avevo visto anche di fronte a casa mia, alla finestra, che si pettinava allo specchio. È uno zozzone analfabeta dentro che non scandisce neanche, ma di fuori, siccome fa i fumetti e la gente lo legge, allora si sente potente. È una specie di orco moderno, e infatti quando lei lo vede, per la prima volta, lui sta lassù sull’altalena, a venti metri da terra e canta ‘Goodbye mia piccola… Ti porterò a New York’ ed è pronto a magnarsi la creatura indifesa che lo ammira» (LIVI 1967: 79). 39. Lo sceicco bianco (RAFFAELLI 1996a: 323). 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 371 Perfettamente calibrata è anche la lingua dei Vitelloni, dove alle coloriture romane di Sordi (interprete di Albertone, accrescitivo affettuoso che lo accompagnerà per tutta la vita) è affidata la funzione, più simbolica che realistica, di ritrarre il nichilismo delle nuove generazioni (qui rappresentate appunto dai vitelloni, cinque giovanotti scioperati e mai cresciuti) schiacciate tra la fine della guerra e l’inizio del boom economico. Proprio Sordi, nella scena più felliniana del film, ne veicolerà la morale profondamente distruttiva. Siamo alla fine della festa di carnevale, Albertone è mascherato da donna, disfatto e mal truccato; ubriaco, si specchia in un enorme pupazzo con la faccia da clown e, con la voce impastata dall’alcol e ormai priva dell’autocontrollo linguistico, proferisce, con marcata cadenza romana, le seguenti battute a Moraldo (Franco Interlenghi): Sto bene/ sto// […] Andiamo a fare il bagno// […] Ma chi sei? […] Chi sei? […] Nun sei nessuno/ tu// Non siete nessuno tutti// Tutti quanti// Tutti// Ammazza// Che vi siete messi in testa/ voi! Che vi siete… E lasciami! Lasciami! E lasciami! Mi fate schifo/ mi fate! Mi fate schifo! Lasciami! E lasciami! Voglio andà solo! Voglio andare su/ io vado tranquillo// Non siete nessuno! Mi fate schifo! […] E vieni// Anzi vieni// Ma che vuoi da me? Che vuoi da me? […] Ah/ lo sai/ Moraldo? Senti// Ci dobbiamo sposare! Eh? Ci dobbiamo sposare// Hai visto Fausto? Tranquillo// Si è sistemato// È beato// A casa sua// Anche noi/ ci dobbiam… […] Ah! Sai che facciamo/ invece? Partiamo// Andiamo in Brasile// Eh? […] Prendiamo un piroscafo […]. Nell’intera produzione felliniana, il caos delle lingue, tutto ricreato in sede di doppiaggio (ma sappiamo quanto superiore dovesse essere nella presa diretta degli attori stranieri)40, serve a esprimere il disorientamento dei personaggi come anche la carica visionaria dell’autore. Il linguaggio, così come l’immagine, per Fellini, deve avere una funzione straniante, e quindi sempre, 40. Cfr. MARASCHIO (1992: 154–155 n. 11). La preferenza accordata da Fellini alla postsincronizzazione piuttosto che alla presa diretta è già stata commentata nel § 5.1.3. 372 Il linguaggio cinematografico nonostante le apparenze, antirealistica. Le studiatissime sceneggiature felliniane (con l’immancabile apporto di penne quali quelle di Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondi, Tonino Gruerra e altri) hanno ben rappresentato anche le ultime tendenze dell’italiano, favorendone a un tempo la rappresentazione e la divulgazione. Prova ne sono i fortunati neologismi già citati nel § 1.4.2: amarcord, bidone, dolcevita, paparazzo, vitellone. Vari sono i brani e i fenomeni che illustrano la natura ancipite (realistica e simbolica, autobiografica ed espressionistica) dei dialoghi felliniani. In 8 e 1/2, ad esempio, spicca l’uso frequente di diminutivi («Senti Guido/ quella cosina che mi avevi promesso?»; «Ma contento contento/ o contentino?»; «ci sarà pure qualche localino anche nel nostro albergo/ no?»; «ti trovo un po’ pallidino/ come mai?»; «neanche una piegolina»; «Stai buonino con quella borsetta/ me la rompi// Ci tengo tanto a quella borsettina… me l’ha regalata lui//»; «Orologino/ orologino/ orologino!»; «Come sei noiosina!») e di ideofoni fumettistici (sbac, sgnac, sgulp, smac, smar, snor, squit, etc.), oltreché qualche deformazione italo–inglese (di Guido/Fellini: «super tardon» ‘super tardone, vecchio’; «Una crisi di ispirescion?»; «Cosa fai? Anche tu mi rompi i coglions?»). La funzione profonda ma evidente, oltre a quella ludico–mimetica di identificare la superficialità di Carla (Sandra Milo), l’amante di Guido, e la puerile freschezza di quest’ultimo (Marcello Mastroianni, alter ego di Fellini), è quella di far retrocedere (anche in senso onirico e psicanalitico) l’espressione verbale ai suoi livelli più infantili, primitivi e quasi pregrammaticali. Analogamente si dica per le inflessioni regionali, per esempio in un brano come il seguente (sempre da 8 e 1/2): GUIDO: Di dov’è/ lei? EVA: (con accento smaccatamente romano) De Trieste! (Ride) CESARINO: Evviva l’Italia! dove la funzione ludica, quella mimetica (il romanesco come lingua egemone del cinema) e quella simbolica (disorientamen- 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 373 to e alienazione: la lingua non serve più a comunicare ma a confondere la realtà) sono perfettamente combinate e sublimate nell’ironia. Come si vede, le risorse linguistiche di 8 e 1/2 sono varie, dall’uso delle varietà diatopiche a quelle diastratiche, all’esibizione dei principali fenomeni del parlato–parlato (dalle interruzioni alla frammentazione, dai pleonasmi alle sovrapposizioni dialogiche, ai cambi di progetto, etc.), tanto che Emanuela Cresti considera questo film «il discrimine, l’ante quem e il post quem della nuova lingua del cinema italiano», una lingua paradossalmente «molto più vera di quella di tante opere realiste o naturaliste», grazie alla quale il senso dei personaggi appare con molta maggiore profondità dagli enunciati, dai dialoghi, che non da certe situazioni, dagli abiti, che mantengono sempre una vena grottesca e deformante, quasi necessaria a Fellini; come se i contenuti seri, il lato scoperto, fosse portato dalle parole e l’immagine con le sue esuberanze barocche, con l’anormalità, servisse a distrarre e a difendere in parte quello che altrimenti sarebbe troppo doloroso mostrare completamente41. Ma è soprattutto nella rappresentazione della Babele linguistica del set cinematografico (il cinema, come il circo, è sempre per Fellini metafora del gioco di specchi della vita) che il realismo/simbolismo dei dialoghi felliniani raggiunge i suoi risultati più alti: l’intersecarsi di voci e varietà, di mittenti e destinatari, getta lo spettatore in un completo disorientamento e, nel contempo, gli mostra, con una fedeltà impressionante, il carosello di richieste, suppliche, ordini, finzioni, convenevoli, etc. che caratterizzano una giornata di lavoro a Cinecittà (benché la scena seguente veda il regista Guido, alle prese con l’inizio della lavorazione del suo ultimo film, nell’albergo di un’imprecisata località termale), con l’adozione assolutamente realistica di fenomeni dell’italiano regionale e dell’uso medio (dislocazioni, farfugliamenti, ripensamenti). E il tutto, ricordiamolo, è 41. CRESTI (1982: 305–309). 374 Il linguaggio cinematografico creato ad arte in sala di doppiaggio (ancora il paradosso della massima verosimiglianza possibile soltanto mediante il ricorso alla finzione): CESARINO: (vedendo Guido che guarda un cardinale) Guido! Tra un paio de giorni/ te ce faccio parlà! Così glie puoi chiede tutti i consigli che vòi/ per il film// Che bella figura mistica / eh?! Oh/ t’ho portato i tre vecchietti// GUIDO: Mh? CESARINO: Uno è un russo / l’altro è un generale in pensione… GUIDO: Che vecchietti? CESARINO: Quelli pe la parte del padre! GUIDO: (non volendo essere riconosciuto) Ah! Copri / copri Cesarì! […] (fuggendo) Smac/ smac/ smac smac smac smac… IMPRESARIO DI CLAUDIA: Vieni qua / <buffone>! GUIDO: <Uh>! Come stai?! Che piacere rivederti! Super tardon! IMPRESARIO DI CLAUDIA: Ti ho telefonato sei volte! GUIDO: Sì/ sì/ lo so/ ho capito// È per il copione di Claudia// IMPRESARIO DI CLAUDIA: Beh/ allora? GUIDO: Eh/ ho pensato di spedirtelo// Anzi/ praticamente te l’ho già spedito// IMPRESARIO DI CLAUDIA: Ah sì?! GUIDO: Ma come ti mantieni <bene! Perché non fai più l’attore/ tu/ eh>? CONOCCHIA: <Senti/ sono stato sveglio tutta la notte>// M’è venuta un’idea per l’astronave// Se/ il piano superiore lo facessimo… GUIDO: Ah/ Conocchia! Non prendermi sotto braccio/ mi dà fastidio! E mettiti la giacca/ piuttosto! CONOCCHIA: E sì! Adesso me metterò er frac/ pe parlà co te! GUIDO: (all’impresario di Madeline) Come sta? IMPRESARIO DI MADELINE: (con accento straniero) bene// GUIDO: Avete fatto buon viaggio? IMPRESARIO DI MADELINE: Oh sì/ grazie// È da un’ora// MADELINE: Bonjour! GUIDO: Ah! Che apparizione abbagliante! Bellissima! Bellissima! MADELINE: C’est vrai? GUIDO: Oui// MADELINE: Vous me dit toujours que si bellissimima! (con accento francese) Mais non parlate mai/ della mia parte! Com’era il mio provino? 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri GUIDO: Ah/ buonissimo! Eh/ se no/ non l’avrei chiamata qui! MADELINE: Ma io/ non so ancora niente! <M’avete detto d’essere materna// Che devo manciare molto pastacciutta>// VFC: <[…]! Guido! Io sto qua>! GUIDO: […]// Sì// MADELINE: (ridendo) ah ah ah ah ah! Ho […] quasi tre kiló! Mais tuto qui? GUIDO: Ma vede/ che ne sa già lei/ più di me// MADELINE: Eh// <[…]>// VFC: <Guido>! DAUMIER: E che deve fare/ la signora? GUIDO: Ma <come! Non>… GIORNALISTA AMERICANO: <Uuh! Hallo>! GUIDO: (al giornalista) Hallo! (voltandosi) Agostini! (a Madeleine) Scusi// (a Daumier) Scusi// GIORNALISTA AMERICANO: (con accento americano) Io non voglio scocciare// GUIDO: Prego// GIORNALISTA AMERICANO: L’albergo è bello/ l’whisky eccellente/ ma io ho tre domande// GUIDO: Sì sì// Più tardi ne possiamo parlare// (ad Agostini) Cosa vuoi? Ah / sì! (agli altri) Scusate// Scusi// Agostini/ bisognerebbe… (allontanandosi con Agostini) No/ niente/ t’ho chiamato/ perché non mi va/ di rispondere a questo qua! (all’impresario di Claudia) Dimmi// IMPRESARIO DI CLAUDIA: Claudia/ ha delle offerte/ da tutte le parti del mondo// Non la posso più/ tenere ferma! qualcosa devi dirle// Scusa/ ma/ esiste un copione? Due paginette/ un’idéa! GUIDO: Ma Claudia lo sa/ che questa potrebbe essere una parte bellissima? La più bella che abbia mai fatto? No/ no/ adesso ti spiego// SIGNORA: Darling! IMPRESARIO DI CLAUDIA: Io ti parlo da amico// Tu/ Claudia/ la perdi! CESARINO: Sti vecchietti/ li vòi vedé/ o no? GUIDO: (all’impresario) Ma sei matto? È tutto pronto// (stizzito, a Cesarino) Ma insomma/ che c’è?! CESARINO: I vecchietti! GUIDO: Dove stanno? CESARINO: Stanno qua! GUIDO: (all’impresario) Scusa// CESARINO: Guarda che la signora Carla ha telefonato/ non ce vo’ stà/ in quell’albergo// È brutto// Cj ha ragione// 375 376 Il linguaggio cinematografico GUIDO: Ma che devo fare/ la porto qui?! GIORNALISTA AMERICANO: Ah… excuse me// CESARINO: Mo te chiamo i vecchietti// G IORNALISTA AMERICANO : Vorrei presentare mia piccola mogliettina// GUIDO: <Piacere>// M OGLIE DEL GIORNALISTA : (con accento americano) <Oh! Anscianté>// Piacerissimo! GIORNALISTA AMERICANO: Anche mia moglie/ scrive// Collabora/ in the ladies magazines// E/ avrebbe anche lei/ qualche domanda da fare// GUIDO: Sì sì// MOGLIE DEL GIORNALISTA: Le mie lettrici/ vanno mate/ per la storie romantiche! Potrei vederne qualche cosa? […] amorosa? CESARINO: A Guì/ eccoli qua// (a un vecchietto) Saluta il dottore// <Venite avanti/ voi! Venite avanti! Anche lei/ generale! Salutate il dottore>! VECCHIO1: <Buongiorno>// GUIDO: <Buongiorno>// VECCHIO2: <Buongiorno>// VECCHIO3: <Buongiorno>// GUIDO: <Buongiorno/ buongiorno>// VECCHIO4: Buongiorno// GUIDO: Quanti anni ha/ lei? VECCHIO3: Settanta// GUIDO: E lei? VECCHIO4: Sessantaquattro// GUIDO: Lei? VECCHIO2: Eh/ sessantotto! GUIDO: Non sono abbastanza vecchi// Non… CESARINO: Ma come? Questo sta pe morì! Ma ’n’artra vorta te porterò tre cadaveri! Tu m’avevi detto un tipo commovente// No ’o vedi questo? ’O guardi/ piagni! GUIDO: (scorgendo il produttore, cantando e inginocchiandosi con le mani al cielo, fingendo di intonare una litania islamica) <[…]>! CESARINO: <Via/ via! Via! Vi chiamo dopo io// Andiamo via>// IMPRESARIO DI CLAUDIA: Grande commendatore! GUIDO: (come sopra, mentre il produttore scende le scale al fianco della bellissima Edy, sua amante) <[…]>! PRODUTTORE: (con accento napoletano) Eh! Se tu ti inginocchi davandi a me/ io davandi a te che debbo fare! E alzati/ se no ti fai male! Eh/ eh/ eh! Come stai Guidino? <Comme va>? GUIDO: <Bene>// 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 377 IMPRESARIO DI CLAUDIA: Buongiorno/ commendatore! <È arrivato il sole nostro>! PRODUTTORE: <Sono arrivato in elicottero/ con questa>/ che strillava sembre! EDY: Dov’è/ la piscina? PRODUTTORE: (a Edy) Piccirì/ angora dobbiamo arrivare/ e statti quieta! (a Guido) Ti ha fatto bene/ la cura? GUIDO: Sì! PRODUTTORE: Ti sendi bene? (dà a Guido una scatolina) GUIDO: Che cos’è? PRODUTTORE: È una sciocchezza// GUIDO: Oh! Ma sempre a farmi regalini! PRODUTTORE: È proprio uguale al mio// EDY: Non si carica mai! GUIDO: Orologino/ <orologino/ orologino>! PRODUTTORE: <[…]>// VFC: <Ossequi commendatore// Commendatore ossequi>// GUIDO: Prego/ signori! Osservate l’orologino! PRODUTTORE: Beh/ giovanotto/ ti si sono shchiarite le idee// GUIDO: Sì// Mi sembra proprio di sì// <Comincio a>… IMPRESARIO DI CLAUDIA: <Commendatore! […] gli americani in tasca>! GUIDO: <Ci vediamo dopo/ noi>! VVFC: (voci confuse e sovrapposte di sottofondo) <[…]>// (segue canzone tedesca) (8 e 1/2). Come ogni Babele che si rispetti, si giunge al vero e proprio nonsense, alla non lingua: nella scena della maga–soubrette in grado di leggere nel pensiero, il contenuto delle elucubrazioni di Guido è l’enigmatico: «Asa nisi masa» (formula magica dei suoi giochi infantili, ma anche gioco verbale per anima). Ancora una volta il preverbale soggioga il verbale e l’espressionismo onirico finisce col prevalere sul realismo. Analogamente si dica per la rissa vocale indistinta (italiano urlato, dialetti, lingue straniere non tradotte) della folla di giornalisti, attori, macchinisti, comparse, amici, parenti… nella scena conclusiva subito prima della famosa passerella sulle note di Nino Rota. 6.1.5. Per riprendere e concludere il nostro viaggio attraverso le varietà diatopiche filmate, rarissimo è il ricorso ad altri 378 Il linguaggio cinematografico idiomi oltre a quelli finora commentati. Per il pugliese possiamo ricordare I basilischi, 1963, di Lina Wertmüller (oltre alle celebri caratterizzazioni farsesche in alcuni film con Totò42 e alle più recenti e scialbe prestazioni di Lino Banfi), «una sorta di rivisitazione dei Vitelloni, dislocata dieci anni dopo in un paese del Tavoliere delle Puglie»43. Di una certa fortuna, a livello popolare, ha goduto il pugliese comicamente deformato dal milanese Diego Abatantuono (autonominatosi, fin dagli esordi teatrali, il terrunciello) in una serie di trash movies in voga negli anni Ottanta: I fichissimi, 1981, Eccezzziunale… veramente e Viuuulentemente mia, 1982, di Carlo Vanzina, i cui titoli diventarono subito proverbiali44. Successivamente, ma sempre a livelli di estrema italianizzazione (fino ai film di Alessandro Piva esclusi, sotto commentati), si ricordano la pronuncia pugliese di Sergio Rubini (attore e regista della Stazione, 1990) e di Michele Placido e altri (in Liberate i pesci, 2000, di Cristina Comencini). Per il sardo, l’esempio più celebre è Padre padrone, 1977, di Paolo e Vittorio Taviani, che tuttavia, rispetto all’intensità della trama, tutta retta sulla difficoltà di integrazione anche linguistica del protagonista, adotta un italiano regionale del tutto comprensibile e non certo una delle varietà alloglotte parlate in Sar- 42. Spicca Guglielmo Inglese, soprattutto nei panni del giardiniere nel celebre duetto con Totò, in Totò a colori, 1952, di Steno e Monicelli. 43. BRUNETTA (1991: 529). 44. A conferma della nostalgia per il trash anni Ottanta, è di quest’anno (2006) Eccezzziunale veramente. Capitolo secondo… me, scritto da Carlo ed Enrico Vanzina e Diego Abatantuono, regia di Carlo Vanzina, con lo stesso Abatantuono. I fratelli Vanzina (sui quali cfr. anche quanto già detto nel § 4.2.1, a proposito del turpiloquio filmico) sono rimasti (insieme con Neri Parenti e pochissimi altri) quasi gli unici seguaci del film di genere e continuano a perseguire il filone, ormai totalmente sclerotizzato, dei luoghi comuni etnici e della corrispondenza maschera–dialetto (Christian De Sica romanesco, Boldi milanese, Abatantuono pugliese, etc.). Unitamente all’innegabile cattivo gusto di fondo e alla risata facile, non si può peraltro ignorare, in questi film, la stigmatizzazione del rampantismo e della corruzione propri degli ultimi decenni, perseguita anche grazie all’interpretazione di caratteristi di vaglia come Massimo Boldi, tra i principali artefici del riscatto della varietà lombarda come lingua della satira (a un livello superiore, per quanto riguarda il teatro, non si dimentichi ovviamente l’esempio di Paolo Rossi). 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 379 degna. Diverso il caso di Ybris, 1984, di Gavino Ledda (una sorta di risposta critica a Padre padrone da parte dell’autore del romanzo omonimo da cui era stato tratto quel film), decisamente espressionistico, «parlato in sardo, in latino e in greco. Quando il film venne presentato a Cagliari, il pubblico insultò Gavino Ledda perché non aveva capito nulla»45. Il lucano compare più in teoria che in pratica in Rocco e i suoi fratelli, 1960, di Luchino Visconti (Fig. 44), dedicato alle vicissitudini della famiglia Parondi emigrata dalla Lucania a Lambrate. Il capolavoro viscontiano merita una breve sosta. Abbastanza ben riprodotto è il dialetto della madre Rosaria, mentre decisamente ibrido (un generico italiano macroregionale campano) quello dei figli Vincenzo, Simone, Rocco, Ciro e Luca46. Il fatto poi che, col procedere del film, i fratelli Parondi parlino un italiano sempre più vicino allo standard è dovuto sia alla loro progressiva integrazione nella realtà sociale milanese47, sia perché l’italiano regionale aveva nel loro caso la consueta funzione simbolica, per dir così, presentativa (si introduce un personaggio connotandolo etnicamente e poi, una volta che il pubblico è in grado di riconoscerlo, lo si lascia continuare ad esprimersi in doppiaggese). Soltanto all’inizio del film, infatti, Simone (Renato Salvatori, ovviamente doppiato, come tutti gli 45. ARISTARCO (1985: 29). Opposte reazioni ebbe il pubblico sardo alla proiezione di Padre padrone, rimproverando ai registi di non essere stati abbastanza realistici e di aver italianizzato eccessivamente i dialoghi (il padre del protagonista, Omero Antonutti, tra l’altro, è nato a Udine; cfr. GIANNARELLI 1982, III). La risposta migliore a queste accuse sembra quella di Paolo Taviani: «il falso è la verità dello spettacolo, una verità superiore della realtà» (SETTI 2001: 145). Sull’uso simbolico del dialetto nei Taviani cfr. sempre SETTI (2001: 25–26, 43, 79, 137 et passim). In particolare, un’analisi dettagliata della lingua di Padre padrone è stata condotta dalla stessa autrice alle pp. 107–137. 46. CRESTI (1982: 299) osserva, tra l’altro, come all’inizio del film «ci troviamo di fronte, in maniera del tutto sorprendente, ad accenti meridionali abbastanza casuali, ma soprattutto diversi per i vari fratelli» (frutto, aggiungiamo noi, dell’imperizia dei doppiatori). 47. Integrazione che non manca di suscitare l’ironia dei fratelli più anziani: dice Vincenzo (il fratello maggiore) al più piccolo Ciro, incapace di completare un brindisi in dialetto, verso la fine del film: «E non ti vergogni? Non sai più la lingua tua// Sei diventato più cittadino di Ginetta/ tu//». 380 Il linguaggio cinematografico altri) pronuncia battute come scétete ‘svegliati’ e «un ’o saccio». Nel film trova spazio anche qualche lombardismo, per esempio nell’amico di Vincenzo, Armando: «vieni avanti ch’el fa fred// Ades te me spiegarè cus te s’è venghì a fà a st’ora chi//». Anche in palestra si parla perlopiù lombardo stretto. Il celebre discorso di Rocco (Alain Delon) a Nadia ben esemplifica l’«italiano con accento tutto cinematografico, con deboli tratti locali»48, vale a dire l’innaturale ibridismo dialetto («avessimo avé i mezzi pe campà»)/italiano regionale («Io penzo che non riesco a trovarmi/ in una grande città»)/italiano senza accento («Là dove siamo nati/ dove siamo cresciuti») tipico del cinema del periodo (si noti anche l’inverosimile ricercatezza del congiuntivo in enunciati mistilingui: «Ma penzo pure ca non sia giusto/ che sia così»): Io se avessi potuto rimanevo là// […]// È laggiù/ al paese/ ch’avessimo avé i mezzi pe campà meglio// Là dove siamo nati/ dove siamo cresciuti// Io penzo che non riesco a trovarmi/ in una grande città// E questo pecché io/ non ci sono né nato/ né cresciuto// Parlo di me/ ma penzo pure/ ai miei parendi/ ai fratelli/ ai paesani// Tandi riescono a/ abituarsi/ a ambientarsi subbito// Peffino a provà li stessi desideri ca provano gli altri// Io no// Ma penzo pure ca non sia giusto/ che sia così// A me/ me piacerebbe/ desiderare ’n’automobbile/ per esempio// Ma solo dopo avé desiderato e ottenuto tutto quello che vene prima// Voglio dire un lavoro sicuro/ fisso// Na casa// E la sicurezza d’avé da mangiare tutti i giorni// Forse non mi spiego tanto bene//. Un dialettalismo lessicale frequente nel film è cercare per ‘chiedere’: «Indando cercheme perdono» ‘intanto chiedimi scusa’ (intima Simone a Rocco nella scena dello stupro). Dialetto chiama razzismo, significativamente tra emigrati: l’allenatore romano Cerri (Paolo Stoppa) così insulta i meridionali Parondi: «Voglio pugili veri/ io! La gente seria! No i meridionali! Hanno raggione/ i milanesi! Terroni/ sete! Nun sapete fà gnente! Per 48. COVERI (1995a). 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 381 me/ è chiuso! ’N vojo vedé più nessuno!». Da non dimenticare, infine, «i lunghi silenzi di Rocco», che forse costituiscono «la parte linguistica più credibile del film: sono stati per molto tempo la situazione linguistica più diffusa degli emigrati»49. Naturalmente l’abbandono del dialetto da parte di Visconti in seguito alla Terra trema e l’opzione per un italiano solo a tratti eventualmente colorito ha giustificazioni non soltanto “di mercato” ma anche ideologiche e può essere inquadrato nel fenomeno generale del passaggio dal neorealismo (inteso, in questo caso, come acritica e cronachistica rappresentazione della realtà, anche nei suoi aspetti più bozzettistici) al realismo (inteso come interpretazione critica della realtà e come passaggio dalla cronaca alla storia). La conquista del realismo, avvenuta in letteratura grazie a Metello di Pratolini e nel cinema con Senso di Visconti (secondo SALINARI 1955 e ARISTARCO 1955), prevede anche la rinuncia al dialetto in favore dell’italiano. Anche il calabrese conta pochi titoli. Attento, fin dal suo esordio, all’uso nel contempo realistico e simbolico, mai macchiettistico, della lingua e dei dialetti è Gianni Amelio (forse l’unico regista, a giudizio di Mario Sesti, «per cui abbia significato il richiamo neorealista»)50, di cui si cita un brano dal Ladro di bambini, 1992, utile per l’esemplificazione della commutazione di codice italiano/italiano regionale/dialetto calabrese: Mio fratéllo// Viene da Milano/ fa ’o carrabbinére// Era du’ anni che nu lu vidìu// […] Ora qua otturatevi gli occhi// Ci sono tutte cose in mezzo ai piedi// La casa non è finita// Là sopra non gi faccio salire mai nessuno// Me vergogno// […] Se me lo dicevi prima mi organizzavo// Almeno per lòro/ per i bambini// Bella figura che ci facciamo! Adesso la signorina che cosa ci racconta/ a suo papà? Dove l’abbiamo accolta? È che i soldi l’abbiamo dovuti spendere tutti per il ristorande/ e qua/ vedi/ siamo accambati// Come gli albanèsi// Anzi/ péggio// Chist’è ’a menestra// Però/ piano piano/ questa casa divenderà come dico io// E poi costruiamo sòpra// Così quan49. CRESTI (1982: 300). 50. SESTI (1994: 28). 382 Il linguaggio cinematografico do… ti sposi/ una casa ce l’hai anche tu// Òra un minuto/ che vi cerco l’asciugamano/ ah? Unn’i misi? Ma lo sai che mi sòno combrata i mobbili? Li ho scelti// Ci ho dato un accònto// E poi/ appena finisco di pagarli/ me li conzegnano// Ma unn’i misi asciugamani? Interessante è anche la funzione di un calabrese criptico usato come strumento di confessione e come arma di difesa nel mediometraggio [→ Glossario, METRAGGIO] televisivo La fine del gioco, 1970, sempre di Amelio; un giornalista (Ugo Gregoretti) invita il protagonista (un bambino che vive in riformatorio) a non parlare in dialetto; il bambino, così, usa l’italiano per raccontare particolari mitigati e poco significativi della propria vita, ma si esprime in dialetto per narrare i disagi profondi del riformatorio: GREGORETTI: Tu mi rispondi rapidamente/ in italiano/ perché sennò la gente non capisce// […] BAMBINO: A chest’inverne che nun esce fòra// Che nun esce fòra eo… Pecché… GREGORETTI: Perché non parli italiano/ per favore? BAMBINO: È da quest’inverno che io non esco fuori dall’istituto/ perché mia madre/ eh/ a Natale/ no/ dopo quei giorni che m’hanno dato la licenza/ ha… ha protestato con la scusa che io la… la sera non rientravo a casa per dormire//. 6.1.6. Come si evince dai titoli fin qui citati a proposito delle varietà regionali, oltre alla Commedia all’italiana va considerato il cinema drammatico “di denuncia”, che «favorì l’instaurarsi, anche grazie a certa sua ripetitività, di un parlato tipicamente filmico»51 (senza dimenticare, però, che è il cinema comico, nelle sue varie forme, a totalizzare gli incassi maggiori, da almeno quarant’anni). Tra i numerosi esempi, si ricordano Le mani sulla città, 1963, di Francesco Rosi, col suo napoletano attenuato, e molti altri film di solido impegno civile (dello stesso Rosi e poi di Germi, Lizzani, Petri, Montaldo, etc.), quasi 51. RAFFAELLI (1996a: 334). 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 383 nessuno dei quali (con l’eccezione dei film di Pasolini), tuttavia, applicherà il dialetto, ma soltanto un italiano regionale ricco di incoerenze. Dopo il fallimento di incassi dei film neorealistici, amplificato anche dallo scoperto ostracismo dei nostri politici, pochi produttori saranno disposti a tentare strade alternative nella lingua filmica: il dialetto torna così ad essere relegato in una posizione di sfondo cromatico e in ruoli quasi esclusivamente comici. Tra i casi di attenta ricerca di realismo dialettale (per taluni con intento più filologico che realistico)52 vanno ricordati i primi film di Pasolini, che danno voce al sottoproletariato romano: Accattone, 1961, Mamma Roma, 1962 e La ricotta, 1963, con un uso del romanesco tra il realistico e l’epicizzante53; mentre più vicini al polo espressionistico risultano le raffinate soluzioni plurilinguistiche e simboliche del Vangelo secondo Matteo, 1964 (italiano aulico–biblico, accenti calabresi, musica e lunghi silenzi) e di Uccellacci e uccellini, 1966 (il romanesco di Davoli come lingua dell’ingenuità, la patina partenopea di Totò come lingua ora della vita spensierata e lontana dalle ideologie, ora dell’accorto utilitarismo, l’accento emiliano del corvo come lingua dell’ideologia marxista, la parlata umbro–laziale delle tre vecchie come lingua primitiva). 52. «Visconti si era adeguato ad un modello linguistico preesistente e antico; mentre Pasolini è andato a cogliere, con la precisione del glottologo, lessemi e morfemi da una particolare categoria di persone, li ha registrati, annotati e ristrutturati applicandoli dapprima nei romanzi e successivamente nei film» (DORIGO 1966: 51). Com’è ovvio, la ricreazione del romanesco da parte del friulano Pasolini è più realistica nei film (grazie alla viva voce di attori quali Franco Citti, Ninetto Davoli e altri) che nei romanzi (non privi di oscillazioni e incongruenze — inevitabili in un romanziere comunque interessato più alla carica espressiva di certe forme che alla loro registrazione documentaria — per le quali cfr. SERIANNI 1996). Il romanesco sottoproletario di Pasolini si estremizzerà (soprattutto in direzione del turpiloquio) nei film del regista Sergio Citti (fratello dell’attore Franco e consulente linguistico per i film romani di Pasolini): Ostia, 1970; Storie scellerate, 1973 (Fig. 45); Casotto, 1977; Mortacci, 1989 e altri. 53. Le note reazioni di insofferenza mostrate dal pubblico settentrionale all’uscita di Accattone (cfr. VALLINI 1962) andranno inserite nel più generale fenomeno della progressiva delegittimazione del prestigio della lingua di Roma analizzato da SERIANNI (2002: 89–109). 384 Il linguaggio cinematografico Oltre al romanesco di periferia, Pasolini ricorse anche al napoletano, nella riscrittura filmica del Decameron, 1971: FANTICELLA: Ehi, signurino! ANDREUCCIO: Dici a me? FANTICELLA: C’è una bella signurina, la mia padrona, ca vi vulisse parlare. ANDREUCCIO: Con tutto il cuore! FANTICELLA: Allora, signurì, venite appresso a mia, che vi sta aspettando nella sua casa54. Nulla è casuale, nelle sceneggiature pasoliniane, neppure la scelta dei nomi (quasi sempre parlanti), come si vede ancora nell’apologo Uccellacci e uccellini: Innocenti Totò e Semplicetti Grazia sono i nomi di Totò e di sua moglie, puri sottoproletari incontaminati dalle ideologie; Luna è l’eterea prostituta. Oppure nell’altro apologo La terra vista dalla luna, 1967: Ciancicato Miao è il povero e stropicciato Totò, Crisantema è la prima moglie morta e Assurdina è la metafisica seconda moglie Silvana Mangano. Del resto, così come nei romanzi, nei film pasoliniani il realismo (anche linguistico) è sempre associato al simbolismo, alla metafora, al mito e all’allegoria pittorica, dalla morte del protagonista di Mamma Roma, atteggiato a Cristo morto del Mantegna, alla Deposizione del Pontormo, rievocata nella Ricotta, al Gesù profeta del proletariato del Vangelo secondo Matteo55. Il tutto, nei film migliori, è tenuto insieme dalla forza dissacratoria dell’ironia, ottenuta ancora una volta mediante la tecnica del nomen omen: Eh, io vengo da lontano… sono straniero… la mia patria si chiama Ideologia, vivo nella capitale… la città del futuro… in via Carlo Marx, al numero mille e non più mille. E noi abbitiamo a Borgo Monnezza, Via morti de fame, 54. RAFFAELLI (1992: 132). 55. Su realismo e simbolismo in Pasolini cfr. BRUNETTA (1970: 37–122). 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 385 Numero 23, sotto er monte de le marane chiare, famoso in tutto il mondo per il martirio di S. Analfabeta56. Oppure mediante la caricatura (anche autoironica) dell’intellettuale–tipo: TEGLIESERA: Che cosa ha voluto esprimere con questo suo film? WELLES: Il mio intimo, profondo, arcaico cattolicesimo. TEGLIESERA: Che cosa ne pensa dell’Italia? WELLES: Il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d’Europa. TEGLIESERA: Che cosa ne pensa del nostro grande regista Fellini? WELLES: Egli danza… egli danza! TEGLIESERA: Che cosa ne pensa della morte? WELLES: Come marxista è un fatto che non prendo in considerazione57. Il professor Otto Volanten sostiene che ogni possibile interpretazione polifonica nella Commedia è sostanzialmente errata… Le signore trovano che il professor Otto Volanten è un tipo straordinario. Ora questo non è vero, perché si sa benissimo che le sue teorie su Dante sono copiate di sana pianta dal libro del dantista inglese Fred Efame autore fra l’altro della commedia “Mutande insanguinate a Scotland Yard” — da cui deriva James Bond — uscita a Oxford nel 1933…58. In altri film pasoliniani, poi, e in particolare negli ultimi, la mimesi linguistica lascia definitivamente il posto alla ricerca (si va da film–saggio a documentari, da lungometraggi a corto– e mediometraggi, commentati, talora dallo stesso autore in voce fuori campo, in uno stile che spazia, nell’ambito di un unico film, dalla referenzialità della trattazione sociologica alla lettura di poesie: La rabbia [prima parte], 1963; Le mura di Sana’a, 56. Uccellacci e uccellini (BRUNETTA 1970: 58–59). 57. La ricotta (BRUNETTA 1970: 55). 58. Uccellacci e uccellini (BRUNETTA 1970: 60). 386 Il linguaggio cinematografico 1964; Appunti di viaggio per un film in India, 1968; Appunti per un’Orestiade africana, 1975) e al simbolo: i dialetti tendono a scomparire (ma non le inflessioni regionali: Laura Betti, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia in Che cosa sono le nuvole?, 1968, Ugo Tognazzi in Porcile, 1969, i soliti Ninetto Davoli e Franco Citti in vari film, e altri) per far spazio alle lingue straniere, all’italiano pronunciato da voci esotiche e all’italiano senza accento dei doppiatori (Edipo re, 1967; Teorema, 1968; Medea, 1969, con Maria Callas, straordinariamente evocativa, nella presa diretta, delle difficoltà di integrazione anche linguistica del personaggio eponimo, improvvidamente doppiata, contro la volontà di Pasolini, nell’italiano senz’anima di Rita Savagnone). 6.1.7. Il dialetto riprodotto sullo schermo era ed è quasi sempre urbano e appartenente alle varietà più prestigiose, dotate cioè di una tradizione culturale (letteraria o teatrale); le rare eccezioni, come vedremo tra poco, non sono prive di incongruenze, nella mescidanza di forme appartenenti a epoche o a zone diverse. Tra i pochissimi esperimenti (lo sperimentalismo, come s’è visto, mal s’accorda con la vocazione popolare del nostro cinema) di dialettalità cosiddetta espressiva e riflessa, tra gli anni Settanta e Ottanta, vanno ricordati alcuni film di impiego pressoché integrale di varietà locali precedentemente mai ospitate dal cinema. L’operazione ha un sapore, più che realistico, di recupero quasi filologico di varietà rare e arcaiche, e potrebbe essere assimilata, sebbene a un livello più basso e culturalmente meno agguerrito, ad alcuni esempi teatrali di dotto e sperimentale recupero dei dialetti arcaici in voga negli anni Settanta, per esempio nelle produzioni di Dario Fo e di Roberto De Simone. L’intento più o meno dichiarato sembra essere quello di reagire non tanto alla progressiva scomparsa dei dialetti quanto alla dittatura dell’italiano innaturalmente asettico di marca doppiaggese e televisiva. Anche in questi casi isolati, così come già per i film neorealistici, il contributo alle competenze linguistiche attive del pubblico fu pressoché nullo. Gli esempi più noti sono sicuramente L’albero degli zoccoli, 1978, di Ermanno 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 387 Olmi59 (in bergamasco arcaico) e Maria Zef, 1981, di Vittorio Cottafavi (in friulano). Per quanto riguarda la parziale inattendibilità dialettologica dell’Albero degli zoccoli (film che subì lo stesso destino della Terra trema, ovvero una riedizione parzialmente italianizzata)60, SANGA (1985) nota l’arbitraria combinazione di forme arcaiche e moderne e COVERI (1995a) ricorda la forzata unificazione di dialetti propri di valli diverse. Alla lingua di questo film, dal sapore sacro, arcaico e indecifrabile come i geroglifici (gli stessi attori giovani bergamaschi dovettero impararla «come una lingua morta»)61, appartiene tuttavia un’indiscutibile carica evocativa, amplificata dalle scelte iconiche tipicamente olmiane (uso pittorico, più che realistico, dei colori e delle luci): DOTTORE: De chi ca l’è la bestia… L’è osta o del padrù? ANSELMO: Chesta la saress tuta nostra, per grasia del Signurr. DOTTORE: Sta olta però al Signur va la prope mia facia la grasia. ANSELMO: Ma cusa la ga? DOTTORE: Se vürì che va dise la verità me la laseress mia tirà fina a mes dè: macelèla antàt che l’è amò via, püdì ciapà almanc na quai palanca. BATISTÌ: […] al salù de la vila l’era piena de set: sciur ca sa caaia so ’l capel e sciure con la velata e pil al col. I ’ndaia e vegnia, i se saludaia: i sciur i sa conoss töc tra de lurr62. Di Maria Zef, film nato per la televisione e poi adattato per il grande schermo, infine, lo stesso regista ammise che soltanto 59. Non è questa la prima né l’ultima utilizzazione del dialetto (più o meno integralmente riprodotto) da parte di Olmi: cfr. in particolare il film per la televisione I recuperanti, 1969 (in versione cinematografica nel 1975), in italiano regionale veneto (su cui cfr. PRESA 1977), il già citato Posto, 1961 (milanese) e altri. A proposito del veneto, se ne rileverà la complessiva svalutazione come macchietta di contorno, dopo i fasti cinematografici degli anni Trenta (cfr. § 4.1.1). Qualche eccezione in RAFFAELLI (1992: 132). 60. Cfr. COSULICH (1985: 47). 61. RAFFAELLI (1992: 141 n. 123). 62. RAFFAELLI (1992: 142). 388 Il linguaggio cinematografico «mediando [cioè combinando «vari dialetti friulani»] si riuscì a tirar fuori una lingua che fu compresa da tutti i friulani»63. Qualche altro film quasi integralmente dialettale può essere citato, per questo periodo: Vermisàt, 1974, di Mario Brenta (lombardo); Quant’è bello lu murire acciso, 1976, di Ennio Lorenzini (calabrese); Atsalút päder, 1979, di Paolo Cavara (parmense), nei quali, come si vede, insolitamente il dialetto penetra fin nel titolo64. La nuova recente ondata (ma forse a questo punto già estinta?) di dialetti poco filmici sarà commentata nel paragrafo successivo. E veniamo ora a esempi di uso intenzionalmente deformato del dialetto. Accentuazione parossistica di alcuni tratti regionali si ha in molti film di Lina Wertmüller, quasi tutti almeno parzialmente parlati in più dialetti, nei quali la mimesi è quasi sempre sopraffatta da una compiaciuta deformazione farsesca. Alla variazione diatopica è spesso affidato uno scoperto ruolo simbolico, soprattutto ai settentrionalismi di Mariangela Melato (che parla la lingua ora dell’impegno politico, ora della borghesia e dell’arrivismo senza scrupoli) e ai meridionalismi (con numerose incongruenze fonetiche) di Giancarlo Giannini (la sua è la lingua ora dell’istinto, ora dell’arretratezza e dell’opportunismo bieco). In Film d’amore e d’anarchia: ovvero «Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…» (come s’è già visto per altri film, la regista adora, provocatoriamente, i titoli chilometrici, con soluzioni insolite per il cinema e che inaugureranno, peraltro, una certa moda)65, invece, la rapida successione di parlate esagerate e urlate (lombardo, romanesco, ciociaro, emiliano, napoletano, siciliano, piemontese, toscano, etc.) è l’efficace corrispettivo acustico dei primi piani espressionisticamente deformati e osten- 63. COTTAFAVI (1985: 42). 64. RAFFAELLI (1992: 140 e nn. 121–122) ricorda che dal 1978 i titoli dialettali e stranieri hanno definitiva via libera nel mercato italiano. Numerosi anche quelli in italiano espressionisticamente o regionalmente deformato, come I carabbinieri, 1981, di Francesco Massaro e alcuni film con Abatantuono, sotto citati. 65. Come per esempio nel film di Renzo Arbore, «F.F.S.S.», cioè «…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?», 1983. 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 389 tati nei loro tratti più duri (il trucco e le occhiaie delle prostitute). Del resto i (rari) film di ambientazione postribolare si prestano, un po’ come quelli militari, alla rassegna plurilingue: l’avevano già fatto, ma in modo molto più tenue, Pietrangeli con Adua e le compagne, 1960 (romanesco, napoletano, parlate settentrionali), Bolognini con La viaccia, 1961 e soprattutto De Sica nella scena della casa di tolleranza in Ladri di biciclette. Si ricordi infine il geniale «pastiche gaddiano per le grandi platee»66 di Monicelli, Age e Scarpelli: L’armata Brancaleone, 1966 e Brancaleone alle Crociate, 1970 (quest’ultimo addirittura con parti siciliane in ottonari, da opera dei pupi), con la mescidanza (non realistica) di elementi latini (più o meno maccheronici), tedeschi, francesi, ungheresi, italiani arcaici, veneti, toscani, umbri, laziali, campani, siciliani e quant’altro, con l’intento di inventare una lingua medievale intermedia tra latino, italiano e lingue “barbare”. I due film di Monicelli, tra l’altro, concedono ampio spazio ai dialetti dell’Italia mediana (spicca qualche metafonesi e dittongo mefonetico, anche a sproposito: Antuona, fetentuona, sonorizzazioni e assimilazioni progressive ND > nn), raramente assurti a dignità cinematografica (tra le eccezioni, il ciociaro di Nino Manfredi): GASSMAN: Isso tiene ragione// Isso// Semo sciolti dalo voto// E se de ogni fatto dovemo trarre la sua significazione/ issa è questa// Dio non lo vole/ Deus non vult/ est clarum// Ergo/ riprendemo la marcia// Avante/ verso Auroca//; UOMO: (parlando dell’orsa che gli ha salvato la vita) È bona// Me trovò sbacuzzato in zu la riva// Me curette/ e me portette nela grotta/ come fusse na cummare// Oh Dio/ male nu sto// Un giorno ghianne e marroni/ un giorno radicchio oppuramente ranocchi// Inzomma/ se campa// (L’armata Brancaleone); SANDRELLI: Patrone meo/ sei rindronato angòra? No// Sacci allòra ca ti sarò divota per la vita/ e per la morta// 66. RAFFAELLI (1992: 136). 390 Il linguaggio cinematografico TOFFOLO: Duge/ sie tutto malconcio e sbrusachiato// SANDRELLI: Te rinzanishco io// (Brancaleone alle Crociate). Ecco uno stralcio di dialogo in versi: GASSMAN: È costei che ha cancellato/ quella voglia/ non t’è claro? CELI: Una vogghia nun sapìa/ ca cu l’acqua antava via// SANDRELLI: Sì monarco/ fu accussì// Songhe shtrega// CELI: Missu a parti ’u fari arcignu/ fazzu un risu di sugghignu// GASSMAN: Sire/ sì/ par non lo sia// Pure è strega/ te lo giuro// CELI: Si dai prova d’essi strega/ salvi a tutta la congrega// Ma/ lu sapi ’a sorte amara/ che cumpete a la magara? Parla preti e pedagogu// V ESCOVO : Ala striga tocca ’u rògu// (Brancaleone alle Crociate). E ancora: Ti potria custà salatu stu parlari da sfruntatu! Ma su’ grande, e accussì sia: Libirati a chilla stria!67. Qua e là qualche accenno di turpiloquio, tanto più comico quanto più mascherato: Te sprofonna sant’Antuona mala striga fetentuona; figlia introchia la Maronna all’inferno ti sprofonna68. Così diverso dal libero sperimentalismo della letteratura, meno soggetta a vincoli economici e produttivi, è questo di 67. Dallo stesso film, stavolta citato da RAFFAELLI (1992: 137). 68. Ibid. Un’analisi della lingua dei due Brancaleone si può leggere in AGE/SCARPELLI/MONICELLI (1989), che riporta anche l’intera sceneggiatura del secondo film, e in DELLA CASA (2005), che trascrive i dialoghi del primo. Notazioni linguistiche sul primo Brancaleone anche in BRUNETTA (1993: IV, 97) [→ Antologia critica, § 8.II]. 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 391 Monicelli il massimo grado di rottura dalla tradizione concesso alla lingua filmica69. Esempi di espressionismo gaddiano propriamente detto mancano quasi del tutto nel nostro cinema (Totò e pochi altri a parte). Non è un caso che la più celebre trasposizione cinematografica da Gadda — Un maledetto imbroglio, 1959, di Germi, tratto da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana — abbia subito lo stesso processo di normalizzazione e di parziale sdialettizzazione (Ingravallo è nel film il genovese Germi, appena colorito in direzione settentrionale) tipico del parlato filmico in tutta la sua storia, per non parlare degli aggiustamenti d’altro tipo (dalla presenza di un colpevole, allo spostamento dell’ambientazione dalla poco filmica via Merulana alle oleografiche Piazza Farnese e Piazza Navona). 6.1.8. Così come mostra una grande disinvoltura nell’utilizzazione dei dialetti, il cinema italiano contemporaneo — data l’ormai acquisita e diffusa competenza della lingua nazionale 69. Qualche altra invenzione interessante in RAFFAELLI (1992: 136–138), dal ricercatissimo Carmelo Bene di Salomè, 1972 (con escursioni antirealistiche dal calabrese all’italiano letterario alle lingue straniere), al popolarissimo Pasquale Festa Camapanile di Quando le donne avevano la coda, 1970. Si potrebbe citare ancora qualche esempio più recente, quale il sofisticato Nostos – Il ritorno, 1990, di Franco Piavoli, con pochi dialoghi in un’incomprensibile lingua “mediterranea”. Si tratta ovviamente, Festa Campanile a parte, di esperimenti destinati a restare isolati e ad essere apprezzati, semmai, soltanto dalla critica. Dal film di Festa Campanile (che fu distribuito con tanto di Glossario italo–preistorico per gli spettatori del film, con corrispondenze del tipo: «cicciarde: zone ‘tenere’ del bipede detto animala»; «sciabadà: folk–song di epoca preistorica»), caratterizzato da una lingua che vuole porsi come pregrammaticale (priva di articoli e con desinenze ridotte al minimo: infinito tutto fare per i verbi, eliminazione delle forme in —e per i nomi) citiamo qualche altro esempio desunto dalla visione del film. Si va dai metaplasmi (animala ‘animale femmina’, facilo ‘facile’, merdo ‘merda’, montagno ‘montagna’, pescio ‘pesce’) ai cambiamenti di suffisso (streganza ‘stregoneria’), dalle effrazioni morfosintattiche (più meglio, noi mangia, più bellissimi) alla deformazione del turpiloquio (affangalo, stronzio e, nello stesso significato, strofolo, più vari termini allusivi all’ambito sessuale: slappo ‘bacio’, gioco e aluzzata ‘coito’, giocare e aluzzare ‘avere un rapporto sessuale’ — non so se correlato al raro alluzzare ‘allettare, attirare’: cfr. GRADIT). Il film ebbe anche un seguito: Quando le donne persero la coda, 1972, anch’esso, come il precedente, cosceneggiato, a rimarcarne le tendenze espressionistiche, da Lina Wertmüller. RAFFAELLI (1994a: 282) ricorda anche, su questa linea espressionistica, «una pregevole anticipazione […] già nel negletto La legge della tromba, 1962, di Augusto Tretti». 392 Il linguaggio cinematografico scritta e parlata — si accosta frequentemente anche alle lingue straniere (non più soltanto l’inglese e il francese e non più unicamente legate ai giochi di parole nati dall’ignoranza degli italiani oppure ai temi dell’emigrazione e della mafia), almeno a partire dalla Commedia all’italiana (a sé le lingue di occupanti e liberatori nel cinema neorealistico), come già accennato a proposito di Alberto Sordi e del Sorpasso. L’uso rimane perlopiù comico (includendo nel genere dal geniale plurilinguismo felliniano alle fragili emulazioni del gallismo italico anni Sessanta, compresi i titoli che adombrano accenni all’introspezione e alle difficoltà di integrazione: Fratelli e sorelle, 1992, di Pupi Avati; Il ciclone, 1996, di Pieraccioni; My Name Is Tanino, 2002, di Virzì; per scendere fino alle solite farse dei fratelli Vanzina, come Sapore di mare, 1983), ma non mancano esempi di altra natura, meno stilizzati e con lingue meno sfruttate, che mostrano tutti i problemi dell’integrazione e della convivenza etnica e culturale: Un’anima divisa in due, 1993, di Silvio Soldini; Lamerica, 1994, di Gianni Amelio; Vesna va veloce, 1996, di Carlo Mazzacurati; senza dimenticare l’ultimo felice esperimento trilingue (italiano, inglese, arabo) di Benigni nella Tigre e la neve, 200570. Isolati e poco accetti al grande pubblico rimangono gli esperimenti di pluringuismo estremo, che combinano lingue vive, morte e inventate, come i già citati Salomè, Ybris e Nostos, volutamente criptici talora fin dai titoli. 6.2. Gli ultimi anni 6.2.1. Una valutazione critica dell’ultimo quarto di secolo (1980–2005) è impresa non da poco, per l’impossibilità di osservare da lontano una fase non ancora conclusa, per la varietà dei risultati (e dunque per la conseguente difficoltà di 70. Esempi di code–mixing e di code–switching nei Vitelloni, 1953, di Fellini; Cronaca di un amore, 1950 e La signora senza camelie, 1953, di Antonioni; Mediterraneo, 1991, di Salvatores sono analizzati in A. ROSSI (2003: 120–124). 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 393 accorpare i titoli in generalizzazioni e quadri d’insieme, problema che peraltro caratterizza l’intera epoca postneorealistica trattata in questo sesto capitolo) e per l’assenza di studi (si veda comunque COVERI 1994 e 1995a). Due aspetti molto significativi, per le loro conseguenze linguistiche, sono il ritorno alla presa diretta del suono e l’applicazione (nei casi di film postsincronizzati), oggi pressoché sistematica, della cosiddetta identità “voce–volto”, secondo la quale, in base a rivendicazioni sindacali degli stessi attori, un interprete italiano non può essere doppiato, senza sua esplicita autorizzazione, da altri che da sé stesso (cfr. § 5.1.2). L’uso del dialetto non stereotipato da parte di molti registi italiani (soprattutto il romanesco dei film di Claudio Caligari e Ricky Tognazzi, il romanesco e il toscano di Daniele Luchetti e Paolo Virzì, il napoletano di Salvatore Piscicelli, Mario Martone e Pappi Corsicato, il calabrese di Gianni Amelio e il siciliano di Marco Risi), spesso con punte di integralismo non comprensibili ai più, e la tematica sociale di molti film inviterebbero a parlare di un’ondata neo–neorealistica, peraltro forse già conclusa71. Anche quelli che vent’anni fa erano chiamati i “nuovi comici” — gli attori–registi Roberto Benigni, Francesco Nuti, Carlo Verdone, Massimo Troisi e altri72 — hanno rivitalizzato (attenuandone i toni farseschi e riducendone la meccanicità) gli inserti dialettali nel cinema, che tuttavia sul versante del comico (specialmente in prodotti di consumo) non ha mai rinunciato alla caratterizzazione dialettale, talvolta anche molto marcata. Si ricordino, negli anni Settanta–Ottanta, gli attori Renato Pozzetto (lombardo), Paolo Villaggio (ligure), Lino Toffolo (vene- 71. Di neo–neorealismo parlano, tra gli altri, SESTI (1994) e COVERI (1995a). 72. «Quella dei ‘nuovi comici’ è etichetta di comodo che unifica tendenze abbastanza diverse: il romanesco giovanilese e sinistrese di Moretti (tutto diverso dal romanesco stereotipato); l’afasia di Nichetti (che infatti in Ho fatto splash non parla e in Volere volare diventa un cartoon), omaggio al grande cinema muto delle comiche classiche; la comicità televisiva, di solito settentrionale, dei Pozzetto, Calà, Boldi e Greggio (e anche Cristian De Sica). Però sembra legittimo fissarsi sui quattro citati anche perché non solo attori ma anche autori» (COVERI 1994: 80). 394 Il linguaggio cinematografico to), Lando Buzzanca (siciliano), Enrico Montesano e Luigi Proietti (romani), Lino Banfi (pugliese) e tanti altri, che hanno esasperato, con i toni della farsa, gli usi regionali già esibiti da migliaia di commedie all’italiana dei due decenni precedenti (basti pensare a Sordi, Tognazzi, Gassman, i Carotenuto, Celi, Manfredi, Chiari, Valeri, Vitti, etc., interpreti talora anche di dialetti diversi dai propri). Per questi ultimi anni, a parte gli interpreti ancora attivi tra quanti già citati, non sarà difficile constatare l’assenza di un solo attore comico non legato alla mimesi o alla deformazione dialettale, dal milanese–siciliano di Aldo, Giovanni e Giacomo al toscano di Giorgio Panariello, dal romanesco di Enrico Brignano, Sabrina Ferilli, Nancy Brilli e tanti altri al napoletano di Vincenzo Salemme e Francesco Paolantoni, dalle varietà più o meno settentrionaleggianti di Giorgio Faletti, Claudio Bisio e i numerosi comici sfornati dalle fucine di Gabriele Salvatores prima e di Zelig poi (grazie ai quali il Nord d’Italia sta riguadagnando punti su Roma e Napoli, quanto all’uso cinetelevisivo della regionalità) al camaleontismo di Antonio Albanese, per non citare che alcuni dei nomi più noti. Ne consegue l’impossibilità di individuare, oggi, un solo titolo comico o brillante privo di coloriture regionali: ed è questa, forse, la differenza fondamentale rispetto alla comicità del passato, non soltanto quella degli anni Trenta–Quaranta ma ancora quella di certe commedie degli anni Sessanta. Tra i “nuovi comici”, soprattutto Troisi ha raggiunto livelli espressivi di particolare rilievo, mettendo in scena non soltanto il napoletano, ma in generale le incertezze e le sporcature del parlato–parlato (troppo spesso, anche nei film comici, sacrificate alla sintetica pulizia della lingua artificiale del doppiaggio), i tic linguistici, spinti talora fino a una sorta di afasia (di «balbettio dell’anima» e di «indicatori afasici» — «forme tipiche del parlare in situazione […] che obbediscono alla volontà precisa dell’autore napoletano di parlare una lingua […] che non lo facesse sentire falso» — scrive assai suggestivamente e appropriatamente SOMMARIO 2004: 26, 55) e le difficoltà di integrazione socioculturale (e quindi anche linguistica), più che del 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 395 meridionale al Nord, del puro di spirito a contatto con le contraddizioni della civiltà del progresso. Il napoletano del primo Troisi è, differentemente da quello di Eduardo e di Totò, talmente lontano dall’italiano da rendere abbastanza sorprendente il suo successo di pubblico, peraltro parallelo a quello di certa canzone (Pino Daniele), segno dell’ormai matura italianizzazione che guarda con gusto e rispetto ai dialetti, senza bisogno di attenuarli per pudore: ARENA: Aóh/ i’ vulévo sapé solamènte tu che facive// Loro vanno ’o cinema// Tu che fa’/ viene? Viene ’o cinema? TROISI: Nun… nun ’o ssaccio, Rafe’// ARENA: Nun ’o ssa’? TROISI: No/ nun ’o ssaccio// ARENA: E comm’è nun ’o ssai? Si ’o ssai è sì/ e si nun ’o ssai è no! TROISI: Eh/ ma si nun ’o ssa’… ARENA: Viene ’o cinema? ’O cinema// Viene ’o cinema? TROISI: Eh/ nun ’o ssaccio// ARENA: Viene o nun viene? TROISI: Mannaggi’a miseria! Nun ’o ssaccio/ come t’aggi’a d… Mo ti… ti straccio tutto qua… ARENA: Viene o no? TROISI: Mannaggi’a miseria/ è na cosa insopportabile! ARENA: Viene… viene o no? TROISI: Nun ’o ssaccio/ Rafe’/ capito? Nu… nu… nun voglio venì// No/ nun vengo/ va buó? No// Seh… miettet’a mano int’a sacca! (Ricomincio da tre, 1981). Nonostante la progressiva italianizzazione di Troisi (come già visto per Benigni), egli ha sempre continuato, fino alla sua ultima straordinaria prestazione come attore, a portare sullo schermo il morbo dell’incomunicabilità sposato all’arte della leggerezza: E allora?! “No Mario…”. Mai…, diciamola la… Che…, pecché questo siii… deve ricordareee… di me? Come… come pieta nonnn… nu valevo, nu’… Che si ricord[a] e come postino? Uno si ricord’…: “un postino mi portava la postaaa…, quando stavo… in Italia”. Come comunista… nemmeno, ’unn 396 Il linguaggio cinematografico è che so’ stato… A me mi pareee… normale così, cioè che lui… Va be’, va be’! Mo, do’… domani andiamooo… là eee… e spediamo la robba73. Frammenti di parole, spezzoni di discorso riportato, segnali discorsivi ammassati e incoerenti, ripetizioni, storture sintattiche, balbettii e suoni inarticolati: mai come nei film di Troisi il parlato dell’insicurezza, della timidezza e della spontaneità è stato rappresentato con tale verismo poetico, con tale sforzo continuo per dare voce al non detto e all’indicibile. La fiducia forte di Troisi nei confronti di un cinema (ormai fuori moda) fatto soprattutto di parole e, dunque, di contenuti e di concetti prima ancora che di immagini è evidente anche nelle dichiarazioni del regista: La mia attenzione si è sempre rivolta più alle parole, al racconto, che non alle immagini. E questo perché penso che — avendo a disposizione mezzi come il cinema, la radio, la televisione — sia molto più importante parlare. Cinematograficamente, però, ho sviluppato questa idea anche perché non mi sento completamente a mio agio con gli strumenti tecnici. […] Fare dei film incentrati soprattutto sui dialoghi, comunque, è stata sì una necessità ma anche, ripeto, una scelta mia74. Per tornare al rapporto italiano–dialetto, è notevole il fatto che generi popolari come il western, la fantascienza, lo spionaggio e, con qualche eccezione, l’erotico non siano mai stati toccati, f ino almeno agli anni Ottanta, dall’impiego del dialetto 75, per un innalzamento stilistico tipico e più volte 73. Il postino, 1994, di Michael Radford e Massimo Troisi (SOMMARIO 2004: 175). 74. Massimo Troisi cit. in SOMMARIO (2004: 21). La dichiarazione va vista in parallelo con una, analoga, di Roberto Benigni, a sottolineare i punti di tangenza tra i due grandi artisti: «Per me il cinema è parola. Dire che è immagine è scemenza. L’intervento sul cinema si fa con la parola. Dio come intervenne sul mondo? Col verbo. Mica disse: ‘Il mondo è immagine’. E Michelangelo quando fece il Mosè non gli disse: ‘Perché non vedi’, gli disse: ‘Perché non parli’. Dire che il cinema è immagine è banale come dire che la radio è un mezzo che si ascolta. Ci sono tante cose da vedere nella radio, come ci sono tante cose da ascoltare nel cinema» (COVERI 1994: 85). 75. Cfr. TORNABUONI (1973). 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 397 osservato nei generi di consumo (letterari, oltreché cinematografici) non comici. Sempre meno netta appare oggi, peraltro, la distinzione tra cinema d’autore e cinema di cassetta (con numerose felici convergenze: Troisi, Benigni, Tornatore, Salvatores, Virzì, Muccino, Veronesi…) e, conseguentemente, del tutto estinta sembra la dicotomia tra cinema popolare (raramente in dialetto) e cinema di élite (dialettale), anche se permane la netta inferiorità numerica dei film parlati in varietà regionali settentrionali, rispetto ai prodotti romaneschi, napoletani e siciliani. Negli anni più recenti la frequenza dei film che ricorrono (più o meno realisticamente) ai regionalismi è altissima: possiamo insomma dire «che non esiste forse manifestazione linguistica della produzione italiana e anche di quella straniera doppiata, posteriori al 1975, che non abbia diritto di menzione» nella categoria dei film linguisticamente regionalizzati76. L’imperante monolinguismo letterario alla Matarazzo (soltanto l’italiano standard poteva far incassare cifre da record), insomma, è da tempo solo un ricordo: è stato ormai sostituito da un altro cliché altrettanto invadente: quello dell’italiano regionale (e talora ibrido). Proprio contro questa omologazione linguistica, la caratteristica forse di maggior rilievo dei film (ovviamente un numero minimo di titoli) dell’ultimo ventennio è proprio la riscoperta di dialetti lontani da ogni forma di italianizzazione, di ibridismo e di stereotipizzazione. Si tratta di film tutti girati in presa diretta (che da qualche anno, nel cinema italiano soprattutto d’autore, contende il primato alla postsincronizzazione), caratterizzati perlopiù da un crudo realismo e da tematiche quasi sempre “impegnate”, dall’analisi sociologica all’approfondimento psicologico. Un certo scalpore suscitò L’amore molesto, 1995, di Mario Martone, rinnovando tra l’altro le polemiche sull’uso dei sottotitoli (necessari da un lato, limitanti il campo visivo [→ Glossario, CAMPO] e l’attenzione dello spettatore, 76. RAFFAELLI (1992: 128). 398 Il linguaggio cinematografico dall’altro), film in un napoletano dalle forti tinte arcaiche. Da ricordare ancora il siciliano dei già citati Mery per sempre e Ragazzi fuori, ma anche quello più estetizzante delle Buttane, 1994, di Aurelio Grimaldi; quello critico–ludico del mafia–musical Tano da morire, 1997, di Roberta Torre; quello psicologico–espressionistico di Respiro, 2002 e del sottotitolato Nuovomondo, 2006, di Emanuele Crialese; il romanesco di insolita grevità di Amore tossico, 1984, di Claudio Caligari (dello stesso si veda anche L’odore della notte, 1998) e di Ultrà, 1991, di Ricky Tognazzi; e ancora il napoletano sottoproletario di Salvatore Piscicelli (Immacolata e Concetta, l’altra gelosia, 1980; Le occasioni di Rosa, 1981 e, meno intensamente, nei film successivi) e di Pappi Corsicato (Libera, 1993; I buchi neri, 1995). Naturalmente, il ritorno a certo integralismo dialettale è reso possibile anche dal rifiuto del doppiaggio e dall’interpretazione particolarmente intensa di alcuni attori, quali per esempio, limitandoci al neoromanesco, Claudio Amendola, Ricky Memphis, Valerio Mastandrea. Talora si ricorre anche a varietà di scarsa fortuna cinematografica, quali il barese criptico del primo film di Alessandro Piva, Lacapagira, 2000, anch’esso fruibile soltanto grazie all’ausilio dei sottotitoli, peraltro fatalmente sommari e, nei casi di turpiloquio, censurati. Se l’opera prima di Piva è ricca di lessemi dialettali (cra ‘domani’) e gergali, più vicino all’italiano è il suo successivo Mio cognato, 2003, nel quale il protagonista Rubini parla il dialetto barese mentre gli altri personaggi adottano l’italiano. L’ottica, come si vede, è ribaltata rispetto alla corrente della Commedia all’italiana, che ricorreva al dialetto, semmai, soltanto nelle figure di sfondo. Si nota qualche dialettalismo sia fonetico sia morfosintattico: ci e ce per chi e che; essere per avere: «devi essere bevuto», «devi essere mangiato», «che ti si fatto?» ‘che hai fatto?’; e qualche regionalismo/gergalismo nella fraseologia: «fare la macchina» ‘rubare l’automobile’. Si ricorre alla tradizionale pratica della glossa, per decrittare certe espressioni strettamente dialettali. Spesso è il personaggio di Vito (Luigi Lo Cascio) a fornire l’equivalente 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 399 italiano del barese (significativamente Vito, pur barese, è interrogato da tutti circa la propria origine, visto che parla un italiano tendenzialmente standard), altre volte sono gli stessi dialettofoni ad autoglossarsi quando parlano con Vito. È il caso del malavitoso Saddam: «’O canosci ’o cecate? Il cecato/ lo conosci o no?». A proposito del soprannome Saddam, è evidente l’influenza della televisione (più che del cinema, peraltro presente, quasi come chicca per cinefili, anche come citazione dal Padrino, nell’utilizzazione dei limoni come simbolo della mafia) nei soprannomi di quasi tutti i delinquenti del film: Marlon Brando, Sandokan, Jey Ar. Un’altra caratteristica della lingua dei film italiani dell’ultimo ventennio è proprio il rapporto osmotico con la televisione (ribadito dalla continua trasmigrazione di “artisti” da un mezzo all’altro, a partire da Benigni e Troisi, per arrivare ai casi recenti: da Albanese alla Littizzetto, da Greggio a Panariello…), che, nelle sceneggiature migliori, viene presa di mira come responsabile di elevare a valori la futilità, l’ignoranza e il pressappochismo anche linguistici77. Sicuramente Carlo Verdone e Nanni Moretti sono tra i primi a tratteggiare figure che si esprimono in modo ridicolo (soprattutto per l’abuso di anglicismi perlopiù mal pronunciati, per tratti di italiano popolare inavvertiti e per l’uso irriflesso di stereotipi e plastismi)78, facendo il verso a personaggi più o meno noti. Memorabile, in tal senso, la giornalista di Palombella rossa, 1989, di Moretti, che parla una lingua tutta a base di vuote frasi fatte e inutili forestierismi («tensione morale», «matrimonio a pezzi», «rapporto in crisi», «alle prime armi», «fuori di testa», Kitsch, chip, trend negativo), ai quali Moretti reagisce con stizza, fino alla violenza fisica, con battute divenute subito proverbiali: 77. Alla presenza della televisione nel nuovo cinema italiano, e in particolare nei film di Salvatores e di Virzì, è dedicato SETTI (2003). Sui rapporti semiologici, storici e produttivi tra cinema e televisione cfr. ORTOLEVA 1999. 78. Sulla «lingua di plastica» (fatta per l’appunto di espressioni cristallizzate, di stampo perlopiù giornalistico e televisivo, e di calchi dall’inglese inavvertiti come tali) cfr. CASTELLANI POLLIDORI (1990) e (1995). 400 Il linguaggio cinematografico Lei/ parla/ in modo un po’/ superficiale// Chi lo sa/ come scrive? […] Dove l’andate a prendere/ queste espressioni?! […] (urlando) Ma come parla?! […] Come parla?! Come parla?! Le parole sono importanti! Come parla?! […] Non riesco nemmeno/ a ripeterle/ queste espressioni// Noi dobbiamo essere/ insensibili// Noi dobbiamo essere indifferenti/ alle parole di oggi// […] Chi parla male/ pensa/ male! E vive male// Bisogna trovare le parole giuste! Le parole sono importanti! […] Trend negativo! (ridendo) Trend negativo! Io/ non parlo/ così// Non penso/ così// Trend negativo! Tra i casi più recenti, tra i tanti personaggi interpretati da Carlo Verdone, si ricorda il giornalista–musicologo di Maledetto il giorno che t’ho incontrato, 1992, o varie macchiette, tutte linguisticamente connotate (dalla conduttrice alla modella, da Vittorio Sgarbi ad Aldo Busi), dello sfortunato (in parte ingiustamente) Mutande pazze, 1992, di Roberto D’Agostino. Oppure il personaggio dell’aspirante star televisiva (Valentina, interpretata da Nicoletta Romanoff) in Ricordati di me, 2003, di Gabriele Muccino. Tornando a Verdone, la sua adozione del romanesco è meno stereotipata del solito (nonostante il palese condizionamento di Sordi), dapprima «nella direzione di un parlato giovanile anche sociolinguisticamente più credibile e poi uscendo decisamente dalla Roma geografica e linguistica»79. Su un piano diverso (ovvero meno legato alla parodia linguistica e più all’esibizione del rischio di scambio tra la vita reale e quella televisiva) si collocano gli interessanti esperimenti di Maurizio Nichetti, e in particolare Ladri di saponette, 1989, curiosamente in anticipo, sebbene a un livello meno intenso, rispetto alle speculazioni filosofiche di The Truman Show, 1998, 79. COVERI (1994: 82). Di «frenesia locutiva» che esprime il disagio generazionale parla RAFFAELLI (2001: 886), alludendo a Verdone. Manifesto è l’intento del regista di distaccarsi progressivamente dal macchiettismo romanesco; a prositito di Maledetto il giorno che t’ho incontrato, dichiarò infatti: «L’ho ambientato a Milano e in Cornovaglia perché volevo essere sicuro che non ci fossero nei personaggi di contorno battute come anvedi, li mortacci tua, te possino» (COVERI 1994: 82). 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 401 di Peter Weir, anche se inevitabilmente in ritardo riguardo all’approfondimento, da parte del cinema straniero, del tema della pervasività non innocente dei media: Quinto potere (Network), 1976, di Sidney Lumet e La morte in diretta (La Mort en direct), 1980, di Bertrand Tavernier. Al mondo, e dunque anche alla lingua, degli adolescenti (che è quasi sempre l’“italiano sfatto” di Roma, utilizzato più per catturare la facile risata che con un reale intento mimetico o critico) è dedicata un’amplissima fetta del mercato nazionale, da Francesca Archibugi (Mignon è partita, 1988; Il grande Cocomero, 1993), a Livia Giampalmo (Evelina e i suoi figli, 1990), al citato Muccino (Come te nessuno mai, 1999), fino ai recenti Dillo con parole mie, 2003, di Daniele Luchetti e Che ne sarà di noi, 2004, di Giovanni Veronesi. Le poche eccezioni di approfondimento sono di ambientazione non romana, come il già commentato Ovosodo. Altrettanto si dica per la lingua dei trentenni in crisi (economica, di affetti, di valori), che da almeno un ventennio in qua ha dato vita a prodotti perlopiù mediocri e quasi tutti appiattiti sul solito romano pallido, epigono della Commedia all’italiana. Inutile l’esemplificazione, che spazia da Marrakech Express, 1989, di Salvatores, all’Ultimo bacio, 2001, di Muccino. Il film inaugurale del genere “minimalismo giovanile all’italiana” è Piccoli equivoci, 1989, di Ricky Tognazzi, anch’esso nel romano sbiadito di Sergio Castellitto, Nancy Brilli, Pino Quartullo e altri “nuovi” attori, che fa rimpiangere (sebbene le lodi sperticate dei critici di allora), peraltro, i modelli americani cui si ispira più o meno esplicitamente: da certo Woody Allen al Grande freddo (The Big Chill), 1983, di Lawrence Kasdan. Maggiore originalità e identità nostrana avevano le prese in giro del “giovanilese” e del “politichese” di Nanni Moretti (Io sono un autarchico, 1977; Ecce Bombo, 1978, con quell’ironica messa alla berlina del vuoto espressivo generazionale: «Vedo gente/ faccio cose»; Bianca, 1984) e di Carlo Verdone (Un sacco bello, 1980; Bianco, rosso e Verdone, 1981). Alcune battute dei film di Moretti sono diventate subito proverbiali; oltre a quelle già cita- 402 Il linguaggio cinematografico te, si ricodi almeno: «Vabbè/ cotinuiamo così/ facciamoci del male» (Bianca). Decisamente poco praticata, invece, la figura del bambino, nel cinema italiano (con felici eccezioni storiche, almeno a partire dai Bambini ci guardano, 1944, Sciuscià, 1946, di Vittorio De Sica e Germania anno zero, 1948, di Rossellini), che tradizionalmente parla una lingua se possibile ancora più ingessata e scolastica di quella dei genitori e dei fratelli maggiori (emblematici i figli di Rosa e Guglielmo in Catene). Felici eccezioni più o meno recenti sono alcuni film di Amelio (La fine del gioco, 1970; Il piccolo Archimede, 1980; Colpire al cuore, 1983; Il ladro di bambini, 1992), Con gli occhi chiusi, 1994 e L’albero delle pere, 1998, della Archibugi, e Io non ho paura, 2003, di Salvatores, dove gran parte dei meriti andrà sicuramente attribuita all’ascendente letterario (Tozzi e Ammaniti, nel terzultimo e nell’ultimo caso). Ardita l’originalità di Certi bambini, 2004, di Andrea e Antonio Frazzi, sia per l’opzione di un napoletano strettissimo, quasi incomprensibile dall’inizio alla fine del film, sia soprattutto per l’immagine, ricca nel contempo di pathos e disincanto, dei figli della camorra, deprivati del diritto alla dignità umana e in sostanza alla vita stessa. Facendo un passo indietro, la critica ha sempre esaltato la capacità di Comencini di ritrarre bambini (per il cinema si veda almeno Incompreso [Vita col figlio], 1966, mentre per la televisione Le avventure di Pinocchio, 1972, Cuore, 1985 e La storia, 1987), dei quali tuttavia sembra dare una visione edulcolarata, strappalacrime e letteraria (come la provenienza di tutti i soggetti citati: Montgomery, Collodi, De Amicis, Morante) e, soprattutto, linguisticamente priva di interesse. Poco rappresentati, quantomeno sul piano del lessico, sono i singoli settori professionali e gergali, se si fa eccezione per il mondo della malavita e, ma più in televisione che al cinema, per quello della medicina (che con le serie, tuttora in corso, Incantesimo e ER – Medici in prima linea ha rinverdito i fasti del vecchio Dottor Kildare, degli anni Sessanta) e per quello forense. La necessità di salvaguardare una piana comprensibilità giustifi- 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 403 ca ovviamente l’esclusione dei linguaggi settoriali sul grande schermo80. A meno che non li si glossi in qualche modo o non li si utilizzi proprio in virtù della loro carica straniante: già negli anni Cinquanta, Carlo Lizzani mostrava la drammatica esclusione dalla società dell’imputato Ilari, il quale ignorava, tra l’altro, termini quali attenuante e preterintenzionale, fondamentali per la sua difesa (Ai margini della metropoli, 1953). 6.2.2. Si chiude qui la nostra carrellata, inevitabilmente sommaria, su alcune soluzioni verbali del cinema contemporaneo. L’arte filmica sembra aver esplorato tutte le strade possibili in campo linguistico e figurativo: dal punto di vista tecnico, avendo ormai imboccato la via del trattamento elettronico dell’immagine, il cinema si sta progressivamente trasformando in qualcos’altro (uno dei new media telematici). Anche come modalità di fruizione (prima mediante il videoregistratore, ora sempre più spesso mediante il personal computer o il lettore DVD, ma è già possibile la visione mediante telefono cellulare)81, il grande schermo diventa progressivamente più piccolo e la visione più solitaria e disturbata, dato il dilagare di prodotti imperfettamente confezionati e illegalmente acquisiti (tipicamente, scaricati, o, in gergo, piratati, via internet). Il quadro d’insieme sembra radicalmente mutato, nell’ultimo decennio, anche rispetto a quanto osservato per il decennio precedente da BRUNETTA (1991: 443), il quale individuava comunque nella televisione forti potenzialità di propagazione di film. Sideralmente distante sembra poi l’utopia rosselliniana del 1974: 80. Le eccezioni evitano comunque tutte il ricorso a scelte lessicali estreme, come la terminologia economica nell’Eclisse, 1962, di Antonioni o il neoitaliano tecnologico in altri film (cfr. RAFFAELLI 1996a: 330). 81. «La legislazione italiana sul cinema ha recepito e favorito questa evoluzione e la nuova definizione di ‘opera filmica’ (fissata dal I comma dell’art. 2 della legge 1° marzo 1994, n. 153), intesa ora come ‘spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura’ e solo ‘prioritariamente’ destinato alla sala cinematografica, segna un punto di svolta davvero significativo» (BERNARDINI 1999: 1048). 404 Il linguaggio cinematografico Non credo che fra cinema e televisione ci siano delle grandi differenze. Ma la televisione dà molta più libertà del cinema perché non vive immediatamente del successo, di quanti biglietti si vendono. Una televisione di stato ha degli obblighi sociali e se non li sente perlomeno si possono sollecitare, si può provocare, si può addirittura ricattare. Le strutture del cinema sono infinitamente più ristrette, sono molto più prudenti e quindi tentare qualche cosa di nuovo, perché è questo quello che conta, diventa sempre più difficile82. Oggi, in effetti, se assai ridotta appare la programmazione televisiva di film (non nati per la televisione) rispetto a quella di serials, reality shows e programmi di info–tainment, praticamente nullo, nei nostri palinsesti di prima o seconda serata, è il peso dato alla cinematografia nazionale rispetto a quella americana: Nel 2000 le sette principali reti televisive hanno programmato due film stranieri per ogni film italiano, e di questi ultimi solo uno su dieci è stato trasmesso in prima serata, mentre il 44% è passato dopo la mezzanotte83. A questo si aggiunga che il duopolio televisivo (Mediaset–RAI) tende a trasferirsi nel mondo cinematografico, dove in effetti i due principali colossi controllano gran parte della produzione e della distribuzione filmica nazionale, oltre a possedere un discreto numero di sale di proiezione. Tale colonizzazione del mercato cinematografico da parte di quello televisivo modifica non soltanto le strategie produttive e promozionali del cinema, ma anche quelle comunicative — scelte linguistiche, stili recitativi, tecniche di regia e di montaggio, etc. —, contribuendo così all’osmosi tra i due mezzi sopra commentata84. Anche sotto il rispetto linguistico i dialoghi filmici hanno battuto ogni sentiero, dal realismo allo sperimentalismo, dalla 82. Rossellini in SAVIO (1979: III, 961). 83. PAOLINELLI/DI FORTUNATO (2005: 31). 84. Su questi temi cfr. DIPOPPA (2005). 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 405 funzione mimetica a quella espressionistica, dall’impiego dei dialetti all’opera di divulgazione dell’italiano standard, all’imposizione dell’ibridismo e del doppiaggese. S’è tentato addirittura un ritorno al muto: per esempio ad opera di Mel Brooks, in America (L’ultima follia di Mel Brooks [Silent Movie], 1976, dove l’unica battuta, No!, è pronunciata dal mimo “muto” Marcel Marceau), e di Maurizio Nichetti, da noi (Ratataplan, 1979; Ho fatto splash, 1980, film muti soltanto per quanto riguarda il protagonista Nichetti; d’altro genere, il mutismo “musicato” di Ballando ballando, 1984, di Ettore Scola). La cinematografia italiana, poi, sembra da un paio di decenni destinata a non risollevarsi più rispetto alla concorrenza statunitense. Qualcuno ha anche osservato che, parallelamente al “silenzio” di numerosi cineasti italiani qualificati, molti altri sono indotti «a soluzioni stereotipate» e a «certo passivo assorbimento di espressioni ricalcate su lingue straniere e in particolare sull’inglese […] anche perché, per oppurtunità commerciale, i film italiani sono spesso girati in quella lingua» (si pensi a Bernardo Bertolucci)85. Data l’assenza dei nostri prodotti anche sul piccolo schermo, appare praticamente nulla la possibilità di penetrazione della lingua filmica italiana degli anni in corso nella lingua comune. Nonostante le stagionali impennate determinate dalla vittoria di qualche Oscar (Nuovo Cinema Paradiso, 1988, di Giuseppe Tornatore [Fig. 46], Mediterraneo, 1991, di Gabriele Salvatores e La vita è bella, 1997, di Roberto Benigni sono stati, soprattutto l’ultimo, gli ultimi nostri grandi successi nazionali e internazionali), i film italiani realizzati ma mai proiettati nelle sale (e che solo nei casi più fortunati raggiungono qualche spettatore mediante la distribuzione prima in VHS, ora in DVD) superano quelli effettivamente distribuiti. È assai lontano quel 1960 che vedeva ai primi quattro posti della classifica dei film più visti i seguenti titoli (praticamente, caso rarissimo, gli stessi osannati 85. RAFFAELLI (2001: 886–887). 406 Il linguaggio cinematografico dalla critica): La dolce vita di Fellini, Rocco e i suoi fratelli di Visconti, La ciociara di De Sica, Tutti a casa di Comencini (ma nello stesso anno erano usciti anche L’avventura di Antonioni e Kapò di Pontecorvo), segnando così, con un ritardo quasi ventennale, il riscatto, al botteghino, dei padri del Neorealismo Visconti e De Sica e l’affermazione di registi comunque d’impegno quali Fellini e il Comencini meno trito. Come anche sembra irraggiungibile il traguardo segnato dalle produzioni nostrane nel ventennio 1959–1982, con 249 film italiani che superarono il miliardo di incassi, contro solo 135 film americani86. Anche la critica, nazionale e internazionale, sembra disertare il cinema italiano contemporaneo, proseguendo un atteggiamento già lucidamente individuato da Mario Sesti una dozzina di anni fa: Capire come il giovane cinema italiano sia di fatto divenuto un corpo estraneo alle tendenze egemoni più rumorose o anche più vive del dibattito culturale, dopo esserne stato spesso uno degli epicentri negli anni precedenti, è un atto non secondario, un gesto non trascurabile87. La decima musa, che ha inaugurato il Novecento ed è stata giustamente definita come la forma artistica più rappresentativa di quel secolo, avendone celebrato i suoi miti più grandi, dal culto per l’immagine, la tecnica e il movimento alla rappresentazione dei sogni, pare aver esaurito, col nuovo millennio, ogni risorsa e ogni possibilità di essere originale e incisiva. Almeno in Italia (non è questa la sede neppure per accennare alla vivacità di altre cinematografie, dall’africana all’indiana, dalla 86. Cfr. BRUNETTA (1991: 434). Per altri dati, sempre relativi al confronto tra gli anni d’oro della cinematografia italiana e gli anni Ottanta–Novanta, cfr. TAGLIABUE (1990: 75). 87. SESTI (1994: 15). Analogamente, D’AGOSTINI (2000), cui si rimanda per una sintetica ma ricca rassegna del cinema italiano dalla metà degli anni Settanta al 2000, osserva che non sono tanto i talenti e le nuove tendenze, a mancare nel nuovo cinema italiano, quanto «l’identità, la riconoscibilità generale», vale a dire una solida «produzione saggistica» (D’AGOSTINI 2000: 1111 e n.). 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 407 coreana all’iraniana). Anche per questo, oltreché per gli inevitabili limiti di spazio e per la difficoltà dell’osservatore di commentare con distacco gli eventi più vicini, la nostra trattazione si interrompe qui, ovvero alla stagione cinematografica degli anni Novanta del secolo scorso (salvo eccezioni fino al 2006), dopo circa cento anni di storia della lingua del film italiano. 6.3. Trascrizione integrale dei dialoghi di Poveri, ma belli Di questo celebre film di Dino Risi abbiamo già parlato nel § 4.3, osservandone l’originalità della soluzione linguistica: una sorta di romanesco annacquato e innaturalmente riprodotto dai doppiatori, che diventa una lingua franca buona un po’ per tutti gli usi (perlopiù comici) del cinema italiano. A questo tipo di dialoghi, pur con tutti i limiti delle opere cui sono applicati, almeno due pregi possono essere riconosciuti: innanzitutto quello di puntare a risolvere il problema della lingua per via autonoma (come già il neorealismo), adottando un seducente impasto pseudo–dialettale, forse debitore anche di coeve esperienze dell’intrattenimento radiofonico “leggero” (ad esempio le trasmissioni per militari); inoltre, il merito di attenuare negli italiani, e in particolare negli inurbati “senza lingua”, il timore di “parlare male”, e di incoraggiarli quindi a esprimersi comunque, anche in difformità dalla norma88. Proprio per l’enorme fortuna goduta da questo stile ci è sembrato utile fornire, a conclusione della nostra rassegna, la trascrizione integrale (secondo i criteri già chiariti nel § 1.2, n. 16) dei dialoghi di Poveri, ma belli. Ricordiamo che non si tratta della sceneggiatura originale (scritta da Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa e Dino Risi; soggetto di Dino Risi), bensì di quella desunta, ovvero della riproduzione del testo orale così come compare nella versione definitiva del film. Per como- 88. RAFFAELLI (2001: 884). 408 Il linguaggio cinematografico dità del lettore, forniamo anche la numerazione delle battute, la scansione delle scene e la descrizione sintetica dell’ambientazione e degli interlocutori di ciascuna scena89. La trascrizione seguente può essere sfruttata didatticamente a vari livelli: dal confronto tra caratteristiche dello scritto, del parlato e del parlato filmico all’individuazione di fenomeni specifici quali i dialettalismi, a loro volta suddivisibili in realistici e antirealistici. Un’analisi linguistica del film di Risi, utile eventualmente anche come falsariga per percorsi di esercitazione, si trova in ROSSI (1999a: 204–219). SCENA 1: donna, Alvaro, fratelli di Salvatore 1 e 2, Cecilia, Annamaria, Salvatore, Marisa, Romolo, VFC. Scale, casa di Salvatore e balcone. Interno–esterno, mattina. 1 DONNA: Giorno/ sor Alvaro// 2 ALVARO: Bonanotte// 3 FRATELLO1: (aprendo la porta ad Alvaro) È arivato ninnananna// 4 ALVARO: (al bambino) A spiritoso! (a Cecilia) Buongiorno// L’avete svegliato? 5 CECILIA: È rientrato tardi/ ieri sera// Lo vogliamo/ far dormire un altro po’? 6 ANNAMARIA: Almeno/ se dorme/ non fa danno// 7 ALVARO: Si… signora Cecilia/ io vi do diecimila lire al mese/ una sull’altra// Ma alle otto/ quel fannullone/ il letto me lo deve lasciar libero// Eh! 89. Ecco gli altri dati tecnici del film. Interpreti: Giovanna: Marisa Allasio; Romolo: Maurizio Arena; Salvatore: Renato Salvatori; Alvaro: Memmo Carotenuto; Annamaria: Alessandra Panaro; Marisa: Lorella De Luca; zio Mario: Mario Carotenuto; il sarto, padre di Giovanna: Virgilio Riento; Ugo: Ettore Manni; il padre di Romolo: Gildo Bocci. Doppiatori: Giovanna: Maria Pia Di Meo; Romolo: Sergio Fantoni; Salvatore: Giuseppe Rinaldi; Alvaro: Memmo Carotenuto; Annamaria: Fiorella Betti; Marisa: Flaminia Jandolo; zio Mario: Mario Carotenuto; il sarto, padre di Giovanna: Virgilio Riento; Ugo: Gualtiero De Angelis; un ragazzo: Ferruccio Amendola. Produzione: Silvio Clementelli per Titanus, S. G. C. Visto della censura: 20/12/1956. Prima proiezione pubblica: 1/1/1957. Trascrizione desunta dalla videocassetta edita a Milano, Mondadori Video, 1993. L’acronimo VFC (al plurale, VVFC), nella trascrizione che segue, sta per voce fuori campo, ovvero voce di un personaggio non inquadrato e non riconoscibile al momento dell’esecuzione della battuta che lo riguarda. C.s. vale come sopra. 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 409 8 CECILIA: E va bene/ svegliatelo// Ma con le buone maniere// Non lo fate sveglià di soprassalto/ sinnò me sta nervoso tutta la giornata// 9 ALVARO: No/ suonategli il Chiaro di luna di Schùberte// Che quello/ è delicato/ poverello// (i due bambini entrano nella camera in cui dorme Salvatore) 10 FRATELLO1: (al fratello 2) Uno/ due/ tre// (i due bambini fanno cadere a terra con un calcio il letto di Salvatore, che si sveglia di soprassalto) 11 FRATELLO2: Sveglia/ Salvatore! 12 FRATELLO1: È arivato il signor Alvaro! 13 SALVATORE: (tirando una scarpa ai due bambini che scappano) E te lo do io/ il signor Alvaro/ te lo do! Non le bastavo io/ a mamma/ che le volevo tanto bene? Dagli a fà figli// Guarda che disgraziati/ che sono venuti fuori! 14 ALVARO: (entrando in camera e cominciando a spogliarsi) Salvatore? Scendi/ che sei arrivato alla fermata tua// 15 SALVATORE: Ma a te/ il turno di giorno/ non te lo danno mai? 16 ALVARO: E metti che me lo danno? Che letto v’affittate? No/ dico/ se mi danno il turno di giorno/ voi perdete l’inquilino// O ti dovessi credere/ che io la notte/ vengo a dormire abbracciato con te?! 17 SALVATORE: (uscendo sul balcone) Romolo! Romolo! (a Marisa che si è affacciata) Oh/ ma sempre tu/ t’affacci? Che/ ti chiami Romolo? Chiama tuo fratello! 18 MARISA: Romolo! 19 ROMOLO: Sì? (uscendo sul balcone, in pigiama) Ciao/ Salvatore// (a Marisa) Fila! 20 MARISA: Vi volete tanto bene/ ma perché non vi sposate? Almeno <regolate la situazione>// 21 ROMOLO: <E fila/ su>! (a Salvatore) Ahó/ cj ho un torcicollo che non ne posso più// Me l’ha fatto venire Iolanda// 22 SALVATORE: Si vede che non si voleva far baciare// 23 ROMOLO: Sì! 24 SALVATORE: Io cj ho una lombaggine! Capirai/ con questa umidità/ quella/ sempre per prati/ vuole andare! Di’/ ma lo sai che ieri sera mi sono trovato un grillo in tasca? 410 Il linguaggio cinematografico 25 ROMOLO: È per quello/ che t’ho sentito che fischiavi// Sbrìgati/ va’// (Romolo e Salvatore rientrano in casa) 26 ALVARO: (a Salvatore) Di’/ ma mamma le lenzuola non ce le cambia mai? (agitandosi nel letto, spaventato) Ahó! Ahó! E questo che è? 27 SALVATORE: Ah! È il grillo de Iolanda// Poverello! Credevo che se ne fosse <andato// Vieni qua>/ bello// 28 ALVARO: <Vattene>! Mannaggia! Ma come/ tu la sera vai con le donne/ e poi io nel letto ci trovo l’erba/ i papaveri/ i grilli?! E se sapevo così/ andavo a dormire a Villa Borghese! Almeno risparmiavo diecimila lire al mese/ no?! <Eh>! 29 ANNAMARIA: <Salvatore>/ il latte si fredda// 30 SALVATORE: Prendimi i vestiti/ e portali di là// 31 ALVARO: Porta via tutto! E non ritornare! Perché cj ho sonno// E tu chiudi la finestra/ va’// (guardando, terrorizzato, sotto le coperte e poi rimettendosi a dormire) Eh! Ah// Hm// UOMO : (gridando in lontananza da fuori, a stento percepibile) Stracciarolo! Robba vecchia […]! (Annamaria fruga nei pantaloni di Salvatore e prende una fotografia) 32 VFC 33 ALVARO: (a Salvatore) Hai preso tutto? 34 SALVATORE: Mo ti fai ’sta mesata di sonno! Ti saluto// (esce dalla camera) 35 ALVARO: Hm// (Salvatore rientra in camera) Ahah! Ma quando ci vai/ a lavorare? 36 SALVATORE: Mi sono scordato il borotalco// 37 ALVARO: Ma che t’encipri/ poi! 38 SALVATORE: Lo so io// Ahó/ se ti ricapita nel letto/ non gli far male/ al grillo// Che quello è il grillo di Iolanda// SCENA 2: Annamaria, Marisa, Romolo, uomo, padre di Romolo, ragazzi, Boccio, Giovanna, vecchio. Balcone, casa di Romolo, pianerottolo, piazza Navona e sartoria di Giovanna. Interno–esterno, mattina. 1 ANNAMARIA: (chiamando sottovoce dalla finestra) Marisa! Ne ho trovat’una nuova// (mostrando a Marisa la fotografia che ha rubato dai pantaloni di Salvatore) 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 411 2 MARISA: Hm? E chi è? La conosci? 3 ANNAMARIA: No/ ma c’è la dedica// (leggendo sul retro della fotografia) “A Salvatore/ con l’animo colmo”// 4 MARISA: Colmo di che? 5 ANNAMARIA: Ma che ne so! Ha una calligrafia! E tu hai trovato niente? 6 MARISA: Aveva un po’ di rossetto sulla camicia// Ma non era lo stesso dell’altro giorno// 7 ROMOLO: Ma che cj avrete/ da dirvi/ tutto il santo giorno// Sempre a parlare/ state// Ma non vi si secca mai/ la lingua? (a Marisa, spingendola in casa) E tu/ va’ a lavorare/ cammina! 8 UOMO: Portiere?! A Portiere?! 9 ROMOLO: Papà! Papà/ ti vogliono! Portiere! 10 PADRE: E càlmate! 11 ROMOLO: Guarda un po’/ che c’è uno che ti vuole// 12 PADRE: Ma che c’è?! 13 UOMO: Abbita qua/ Milone? 14 PADRE: Eh/ cj abbita e non ci abbita// Tu provaci// Sta al sesto piano// Anzi/ se lo trovi/ me fai un piacere? Tiè// Gli dai ’sto telegramma/ eh? (gli tira il telegramma) Ahó/ ma se non lo trovi/ me lo riporti/ eh? 15 UOMO: Ah/ ho capito// Ve serve altro? 16 PADRE: E corri/ no? Può esse una cosa urgente// 17 UOMO: Capirai! 18 MARISA: Romolo? Vuoi vedere il regalo che ho comprato ad Annamaria? 19 ROMOLO: Regalo? 20 MARISA: Oggi è il suo compleanno// Fa quindici anni// Anzi/ siccome costavano poco/ ne ho comprato un paio pure per me// (mostrando un paio di calze a Romolo che sta facendo colazione) 21 ROMOLO: Le calze di seta?! 22 MARISA: Eh// 23 ROMOLO: Ma che/ vi siete ammattite?! 24 MARISA: Hm! 412 Il linguaggio cinematografico 25 ROMOLO: Le ragazze/ all’età vostra/ portano i pedalini! E poi chi se le mette/ le calze/ d’estate?! Se cominciamo con le calze di seta/ chissà dove andiamo a finire! Ahó/ me dovete sempre rovinà ’l pasto! Già se ne buttano pochi/ di soldi/ in questa casa! <Soltanto io/ ci sto attento! Sono due anni/ che porto lo stesso vestito/ e non so quando me ne potrò fare un altro! Ci mancavano le calze di seta>! 26 PADRE: (davanti alla gabbia dei canarini, imitandone il cinguettio) <Cicì// Cicì// Cicì// Cicicicicicì// Cicicicì// Cicì>// 27 ROMOLO: <Eh! “Cicì/ cicì>/ cicì”! Ciao/ papà// 28 MARISA: Romolo? <Romolo>! 29 ROMOLO: (al padre) <E non gli dare il vino rosso/ ai canarini>/ che ti diventano verdi// 30 MARISA: Romolo! 31 ROMOLO: Ma che vuoi! 32 MARISA: Lo sai che stasera Annamaria/ dà una festa in terrazza? Ci venite/ tu/ e Salvatore? 33 ROMOLO: A fare che?! 34 MARISA: A ballare/ no? 35 ROMOLO: E che balliamo/ con voi? Il girotondo? Ciao// (esce sul pianerottolo. Dopo aver chiamato Salvatore con un fischio e aver sentito il fischio di risposta di Salvatore) Andiamo! 36 SALVATORE: (uscendo di casa di corsa) Chi arriva ultimo/ cj ha le corna! 37 ROMOLO: (correndo per le scale) Via! 38 SALVATORE: (correndo per le scale) Scappa! Eh! 39 ROMOLO: Eh! <[E scànsate]>! 40 SALVATORE: <Eh beh/ eh>! Ahó! 41 ROMOLO: (giunto in strada) Le corna/ ce l’hai te! 42 SALVATORE: (dando uno schiaffo in testa a Romolo) Senti chi parla! Eh! 43 ROMOLO: (dando uno schiaffo e un calcio a Salvatore e incamminandosi per la strada) E pìjate questo// 44 SALVATORE: Ahó/ a matto! 45 ROMOLO: Ma guarda che giornata! Ma ti pare giusto/ che uno deve andare a lavorare/ con una giornata così! Con un sole come questo! 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 413 ’Shto vigliacco de sole! Viè giù/ che te meno! Capirei uno ch’è vecchio// Uno che non sta bene// Ma un ragazzo come me/ sano/ robusto/ un bel ragazzo/ è sprecato/ a andare a lavorare con una giornata così// 46 SALVATORE: Certo/ sei sprecato a lavorare/ tu// (Romolo, vedendo passare una bella ragazza, fischia in segno di ammirazione. Nei pressi si trovano cinque ragazzi, che fanno commenti sulla passante e fischiano anch’essi in segno di ammirazione. Non essendo inquadrati quasi mai in primo piano né nominati direttamente, non è possibile assegnare a un locutore preciso le singole battute e non tutte le battute sono comprensibili. Da qui alla fine della scena, dunque, e in quasi tutte le scene in cui compaiono i cinque ragazzi, scriveremo di norma soltanto RAGAZZO, senza altra specificazione, ad eccezione di Boccio, così chiamato nella sc. 13.85, che ha un timbro vocale sempre riconoscibile) 47 RAGAZZO: (vedendo passare la ragazza) Ragazzi/ guardate chi ariva// 48 RAGAZZO: Ahó/ <ma questa è piovuta dal cielo>! 49 RAGAZZO: <Anvedi/ chi viene/ ahó>! 50 RAGAZZO: Bella de <zio>! 51 RAGAZZO: <Mamma>! 52 BOCCIO: Bella de mamma tua! 53 RAGAZZO: Anvedi/ <che fata>! 54 RAGAZZO: <Fata>! 55 RAGAZZO: <Ahó/ […]>! 56 SALVATORE: <Però>! 57 BOCCIO: <Stanotte me la sogno>! 58 RAGAZZO: <Ammazza>! 59 ROMOLO: <Je manca la parola>// 60 BOCCIO: Mannaggia/ ahó! (mentre Romolo e Salvatore passano davanti a una vetrina, i cinque ragazzi fanno dei versi e si scambiano sottovoce commenti incomprensibili) 61 RAGAZZO: Ahó! […]// 62 RAGAZZO: Chi è? Chi è? 63 RAGAZZO: […]// 414 Il linguaggio cinematografico 64 RAGAZZO: Ammazza/ […]! 65 RAGAZZO: Guardate che articolo/ in vetrina// 66 RAGAZZO: Mannaggia! 67 ROMOLO : (guardando Giovanna che sta pulendo la vetrina della sartoria) Anvedi questa! E da dove è uscita?! Ammazza/ che fata! 68 SALVATORE: E poi dicono/ che a questo mondo non c’è più bontà! Eh! 69 ROMOLO: Vita mia! Amore mio! Anima mia! 70 SALVATORE: Ma chi si muove! Chi ci va/ a lavorare?! 71 ROMOLO: E mica ti guarda/ eh! È dispettosa// 72 SALVATORE: Forse fa i complimenti// Si vuol far pregare// (dando un bacio a Giovanna attraverso la vetrina) E bacia pure bene! 73 ROMOLO: (dando anche lui un bacio a Giovanna attraverso la vetrina) Bacia freddo// 74 SALVATORE: No// (Romolo e Salvatore entrano nel negozio) 75 ROMOLO: Buongiorno// Ma che è successo? Qui è cambiato tutto// Sabato/ non c’era un calzolaio? 76 GIOVANNA: C’era// Oggi c’è una sartoria da uomo// 77 SALVATORE: Ah! E allora mi faccio fare subito un paio di calzoni// Me li fa lei? 78 GIOVANNA: Sì sì// 79 SALVATORE: Ma le misure/ le prende lei? 80 GIOVANNA: È naturale/ no? 81 ROMOLO: E allora/ se è così/ me li faccio pure io/ no? 82 GIOVANNA: Ce n’ho di bell’e fatti// Se ve li volete provare… 83 SALVATORE: <E come no>?! 84 ROMOLO: <Eh>! 85 GIOVANNA: Accomodatevi// 86 SALVATORE: (dando una gomitata a Romolo) Uh! 87 GIOVANNA: (facendo entrare Romolo e Salvatore nello spogliatoio) Intanto levatevi i vostri// Io torno subito// 88 ROMOLO: Sì// 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 415 89 SALVATORE: Ma tu che dici? Verrà lei/ a provarceli? 90 ROMOLO: E dai/ su/ svelto! Lèvateli! 91 SALVATORE: Mannaggia! Se lo sapevo/ mi cambiavo le mutandine/ stamattina// 92 GIOVANNA: Siete pronti? 93 ROMOLO e SALVATORE: Sì// 94 ROMOLO: Lo sapevo/ che quella ci stava// Ammazza! Io co le donne cj ho un fiuto! <Dai dai>! 95 SALVATORE: <Eh>! 96 GIOVANNA: (uscendo in strada) Oh/ ragazzi/ chi mi dà/ una mano? 97 RAGAZZO: Pronti! 98 RAGAZZO: Subito! (due ragazzi alzano la serranda, lasciando vedere Salvatore e Romolo in mutande. Tutti e cinque i ragazzi scoppiano a ridere) 99 RAGAZZO: <Anvedi/ ahó>! 100 RAGAZZO: <Anvedi>! Ma che è?! 101 RAGAZZO: Anvedi/ che belli/ che so’/ ahó! 102 BOCCIO: Anvedi/ ch’articolo! Guàrdate! 103 VECCHIO: (passando davanti alla vetrina e vedendo Romolo e Salvatore in mutande, mentre i cinque ragazzi continuano tutti a ridere) Che vergogna! Che tempi! 104 GIOVANNA: (a Romolo e Salvatore, rivestitisi e usciti dallo spogliatoio) Ma come?! Già ve ne andate? Non ve li provate più? Peccato! Avevo un pettinato e un millerighe/ che vi sarébbero andati proprio a pennello! 105 SALVATORE: Glielo do io/ il pennello! 106 ROMOLO: A spiritosona! (a un manichino) E tu/ che cj hai da ridere? Eh? 107 SALVATORE: (stringendo la mano al manichino) Ciao/ eh? 108 ROMOLO: (in strada, ai ragazzi che ridono) Ma che cj avete/ da ridere?! Non avete mai visto un uomo in mutande? 109 BOCCIO: Uno sì// Ma due no// 110 ROMOLO: <Ah>// 416 Il linguaggio cinematografico 111 RAGAZZO: <Ahó>/ me parevate la statua de Paolina Borghese! 112 SALVATORE: Perché? Che cj hai da ridere/ tu? 113 RAGAZZO: Perché/ ’n posso ride? Ridono tutti/ rido pur io! 114 ROMOLO: Gli altri sì// Tu no! 115 RAGAZZO: Perché io no? 116 SALVATORE: Perché ridi male! 117 ROMOLO: Ridi un po’? 118 SALVATORE: Ridi/ che mamma ha fatto i gnocchi! (il ragazzo provocato ride) 119 ROMOLO: Cj ho ragione/ che ride male?! 120 RAGAZZO: E che/ te fai mette sotto così? E menaje// Che/ cj hai paura? 121 RAGAZZO: E menaje tu! 122 RAGAZZO: A stupido! 123 RAGAZZO: Ma stupido sei tu! 124 RAGAZZO: A cretino! 125 RAGAZZO: <[…]>! 126 RAGAZZO: <Dai! E menateve>! (tutti i ragazzi corrono via) 127 SALVATORE: Sti sfaccendati! 128 ROMOLO: Andate a lavorare/ sfaticati! Ahó/ sta’ a vedere/ che quella si crede che cj ha impressionato// 129 SALVATORE: Capirai! Che mi frega/ a me/ di farmi vedere in mutande? 130 ROMOLO: È peggio per lei! Tanto/ chi la vede più? 131 SALVATORE: Hm// 132 ROMOLO: Beh/ andiamo a lavorare! Ciao// Ti saluto// 133 SALVATORE: Ciao// 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 417 SCENA 3: zio, Romolo, donna, madre, figlia. Negozio di dischi. Interno, mattina. 1 ZIO: <[…]>// 2 ROMOLO: <Buongiorno/ zio>// 3 ZIO: A quest’ora/ ti presenti/ tu? 4 ROMOLO: Eh/ <zio Mario/ ho fatto tardi>// 5 ZIO: <Dai dai/ datti da fare>/ su! (ad una cliente) Che cosa voleva ascoltare/ signorina? 6 DONNA: Toccata e fuga in la minore di Bach// 7 ZIO: Toccata e fuga! Di prima mattina! (guardando Romolo) Oh! Certo/ lei deve avere una bella sensibilità musicale/ eh? Eh/ Bach/ è sempre Bach! Si accomodi in cabina/ signorina/ che le faccio sentire la toccata// 8 ROMOLO: (a due donne che entrano nel negozio) Buongiorno/ signorina// 9 FIGLIA: Buongiorno// 10 MADRE: <Buongiorno>// 11 ROMOLO: <Buongiorno/ signora>// Vuole ascoltare qualche disco? 12 MADRE: Ma che ne so// Questa vole Bongiorno tristezza// 13 FIGLIA: Cantata da Claudio Villa/ eh! 14 ROMOLO: Sì// Ahó/ ma tutte ste donne/ “Claudio Villa/ Claudio Villa”// Ma che cj avrà? Boh! Mah! (si sente la canzone di Claudio Villa, durante la quale Romolo apre di scatto la porta della cabina d’ascolto, lasciando vedere lo zio e la donna che si baciano) 15 ROMOLO: Oh! Pardon// 16 ZIO: T’ho detto mille volte che devi bussare/ prima di entrare in cabina// 17 ROMOLO: Zio Mario/ gliel’hai data/ ’sta toccata e fuga? 18 ZIO: Non fare lo spiritoso/ che se te giochi ’sto posto/ dove vai/ a lavorare?! Io per compassione/ ti tengo qui// Lo sai/ sì?! Eh! 19 ROMOLO: A zio Mario! 20 ZIO: Che c’è? 418 Il linguaggio cinematografico 21 ROMOLO: Ricòrdati di cambiare la puntina// 22 ZIO: Ma li mort… Hm! SCENA 4: donne 1 e 2, Salvatore, Luciana, Graziella, uomini 1 e 2, ragazzo, cassiere. Stabilimento balneare sul Tevere. Esterno, giorno. 1 DONNA1: (tentando di sfilarsi il salvagente) Bagnino! Bagnino! Non m’esce più// Come faccio? 2 SALVATORE: Ha provato/ a spingere? 3 DONNA1: Oh/ cj ho provato! Cj hanno provato in due! 4 SALVATORE: E se la porti a casa! <Tanto lei domani torna/ no>? 5 DONNA1: <Oh>! (andandosene) Renato! 6 SALVATORE: Ahó/ non ti fanno pigliare il sole in pace! 7 LUCIANA: Di’ un po’/ Graziella/ e tu/ a Roberto/ che gli hai detto? 8 GRAZIELLA: Gli ho detto/ “senti/ Roberto/ se tu continui a essere così geloso/ è inutile/ che andiamo avanti// Sai che facciamo? Proviamo a stare una settimana senza vederci”// 9 LUCIANA: E lui? 10 GRAZIELLA: (a Salvatore, che le ha toccato una gamba) Ma che fa?! S’è ammattito?! 11 SALVATORE: Mi perdoni// 12 GRAZIELLA: Ma che “perdoni”! Tenga le mani a posto! Villano! 13 SALVATORE: Perché offende senza sapere/ scusi? Non è generoso/ verso uno che ha perduto il bene della vista// 14 LUCIANA: (sussurrando) Graziella/ è cieco! 15 GRAZIELLA: Oh/ mi scusi! <Non sapevo// Le chiedo scusa>// (aiuta Salvatore ad accendere una sigaretta) 16 SALVATORE: <Prego>// Grazie// Forse lei/ è una bella ragazza// E anche la sua amica/ deve essere bella// Graziella! Che bel nome! Graziella/ e poi? 17 GRAZIELLA: Graziella Fabbri// 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 419 18 SALVATORE: Che strano! Lo sa che si chiamava Graziella/ una ragazza che ho conosciuto tanti anni fa? Prima della disgrazia// È stato il mio primo amore// Aveva i capelli neri/ gli occhi grigi/ le labbra carnose/ e cj aveva pure un neo qui/ come lei// (le tocca il seno) 19 GRAZIELLA: Ahó! Ma tu ce marci! Ce vedi/ o non ce vedi? 20 SALVATORE: Ah! Ci vedo/ ci vedo! E che Dio me la conservi/ la vista! 21 LUCIANA: Ma che roba! Grande e grosso com’è! Ma non si vergogna?! 22 GRAZIELLA: Io/ al posto suo/ mi vergognerei come un ladro! 23 SALVATORE: Eh/ ma allora non siete ragazze di spirito/ eh! 24 UOMO1: Bagnino! 25 UOMO2: Ma ndove sta/ ’sto bagnino?! 26 SALVATORE: Boh! Stava qua/ se ne sarà andato// Bagnino! 27 UOMO2: Nun se trova mai/ ’sto bagnino// 28 SALVATORE: Bagnino! (al cassiere) Dammi un gettone// 29 DONNA2: (al telefono) Pronto// Chi vole? 30 SALVATORE: (al telefono) Mi chiama/ la signorina Graziella Fabbri? 31 DONNA2: (ad un ragazzo) Chiama un po’/ Graziella Fabbri? 32 RAGAZZO: (gridando) Graziella Fabbri! Ar telefono! 33 GRAZIELLA: A me? Chi mi vuole? (al telefono) Pronto! Chi è?! 34 SALVATORE: Sono Roberto// 35 GRAZIELLA: Beh? Ma non dovevamo stare/ una settimana senza vederci? 36 SALVATORE: Eh/ non ce l’ho fatta// T’ho pensato tutta ’a notte// 37 GRAZIELLA: (a Luciana) È quel matto de Roberto// Cj ha una voce! Ma come m’avrà pescato? 38 SALVATORE: Con chi parli? Chi c’è/ vicino a te?! 39 GRAZIELLA: Come/ “chi c’è”?! C’è Luciana// Ma non cambi mai! Lo vedi che sei sempre sospettoso?! 40 SALVATORE: E cj ho ragione/ a essere sospettoso! Prima/ non parlavi con uno? Come/ “quando”?! Già te lo sei scordato/ quel bel fusto di ragazzo? Come/ “chi”?! Quello che gli piacevi tanto/ che gli si era annebbiata la vista per te// 420 Il linguaggio cinematografico 41 LUCIANA: (avendo visto Salvatore al telefono) Di’/ guarda// (Graziella attacca il telefono) 42 CASSIERE: (a Salvatore, ridendo dopo aver assistito a tutta la scenetta) Ammazza/ che fijo de… (ride. Salvatore si mette in ginocchio davanti a Luciana e a Graziella per farsi perdonare. Graziella ride) 43 SALVATORE: Brava! Sono contento/ che abbiamo fatto pace// 44 UOMO1: Bagnino! 45 UOMO2: Bagnino! Ma nun se trova mai/ ’sto bagnino! SCENA 5: madre, figlia, Romolo, zio, Salvatore, Marisa, Annamaria. Negozio di dischi e stabilimento balneare sul Tevere. Interno–esterno, giorno. 1 MADRE: Figlietta mia/ non ne potevi comprare uno più allegro! 2 FIGLIA: Ma a me me piace/ <scusa>! 3 MADRE: <Ma come>?! Uno fa una spesa/ <per farsi venire la malinconia>! 4 FIGLIA: <Uff>! 5 MADRE: (a Romolo) Sentisse i dischi che abbiamo a casa/ che lagne! 6 ROMOLO: Ma vede/ cara signora/ la musica è questione di gusti// Come le donne// C’è a chi piacciono bionde/ e a chi piacciono brune// (guardando intensamente la figlia) A me/ per esempio/ mi piacciono bionde// 7 MADRE: Moviti/ che abbiamo fatto tardi! E cammina/ moviti! 8 ROMOLO: Ah! (rispondendo al telefono) Pronto? Ah/ <sei tu/ Salvatore>? 9 ZIO: (affacciandosi dalla cabina d’ascolto) <È per me>? (Romolo fa segno di no con la mano) 10 ROMOLO: Cj hai due ragazze? E come sono? 11 SALVATORE: Una è proprio bona// Micidiale// L’altra/ ti dovrèbbe piacere// Mi pare il tipo tuo// Cj ha una certa dolcezza// 12 ROMOLO: Sì/ va be’// Quella colla dolcezza/ te la tieni// 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 421 13 SALVATORE: Ma no/ vieni qua/ che poi decidiamo! 14 ROMOLO: Sì/ vengo// Sì/ arrivo// Ciao// 15 ZIO: (uscendo con la donna dalla cabina d’ascolto) Beh/ dicono tanto/ di questo Bach/ ma in fondo… (a Romolo) E tu/ non sei andato/ a prendere i dischi? 16 ROMOLO: No/ ho telefonato// <[Vado via subito]>// 17 ZIO: <E vai subito>! (dandogli dei soldi) Dunque/ so’ quattromila e otto… 18 ROMOLO: Più duecento pe le sigarette… Ciao zio// <Grazie>// 19 ZIO: <Eh>… 20 ROMOLO: (vedendo Marisa e Annamaria entrare nel negozio) E voi che fate/ qui? 21 MARISA: Ti volevo dire/ se ci prestavi un grammofono// 22 ROMOLO: Ma scusa/ chiedilo a zio/ no? È pure zio tuo! Poi io stasera non posso/ perché cj ho da fare// Gli auguri te li faccio adesso// <Toh>// (tirando le orecchie ad Annamaria) 23 ANNAMARIA: <Quanto sei ignorante>! 24 ROMOLO: Apposta// Se sono ignorante/ che mi inviti a fare? Ciao// 25 ZIO: Voi che fate? Organizzate una festa da ballo in terrazza// 26 MARISA: Sì// 27 ZIO: E a me/ non mi invitate? 28 ANNAMARIA: Ma sono tutte ragazzine// Lei si annoia/ signor Mario// 29 ZIO: E che/ sono vecchio? Eh/ so stare anche <con le ragazzine>// 30 MARISA: <Sono loro>/ che si annoiano con te// 31 ZIO: Ah/ va be’// 422 Il linguaggio cinematografico SCENA 6: Romolo, sarto padre di Giovanna, venditore, VFC, Giovanna. Piazza Navona: sartoria di Giovanna e mercato. Esterno–interno, giorno. 1 ROMOLO: (passando davanti alla sartoria di Giovanna) Buongiorno// 2 SARTO: Buongiorno// Vuol dare una guardata alle stoffe? Senza impegno// 3 ROMOLO: No// Un’altra volta/ magari/ eh? Buongiorno// 4 VENDITORE: (a Giovanna) Centocinquanta lire tutto// 5 VFC UOMO: Che uva! Che uva/ <stammatina>! 6 VENDITORE: (a Giovanna, prendendo i soldi) <Grazie>// 7 GIOVANNA: Ma/ com’è che ste carote sono così corte? 8 VENDITORE: E che ne so? Se vede che hanno preso l’acqua/ e se so’ ritirate// 9 GIOVANNA: Eh/ allora lei chissà quant’acqua ha preso! 10 ROMOLO: Ah/ ma lei si appiccica proprio con tutti// 11 GIOVANNA: Ah/ buongiorno// 12 ROMOLO: Buongiorno// 13 GIOVANNA: A momenti non la riconoscevo// Oh/ ma lo sa che lei/ coi pantaloni/ <fa tutta un’altra figura>? 14 ROMOLO: <Eh/ si vede che non m’ha visto bene>// Perché io/ spogliato/ risalto di più// 15 GIOVANNA: Ma non dica stupidaggini// E ora che fa? 16 ROMOLO: L’accompagno// 17 GIOVANNA: Ma non ha niente di meglio da fare? 18 ROMOLO: Veramente/ dovrei andare al fiume// C’è quell’amico mio/ che ha rimediato due ragazze// 19 GIOVANNA: E beh/ lei sta a perdere tempo con me? E corra/ no? 20 VENDITORE: Che peperoni! Che peperoni/ cj avemo stammatina! 21 GIOVANNA: (entrando in sartoria) Papà/ io la spesa l’ho fatta// Se vuoi andare… 22 SARTO: Brava// L’ajetto l’hai preso? 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 423 23 GIOVANNA: Sì// L’aglietto/ e pure il bicarbonato/ t’ho preso// 24 SARTO: Brava// Allora siamo d’accordo// All’una/ voglio trovare pronto// 25 GIOVANNA: Sì// All’una// 26 SARTO: Ciao// 27 GIOVANNA: Ciao// (a Romolo) Ma come?! Ancora qua? Io credevo che fosse già al fiume! Con due ragazze che l’aspettano! 28 ROMOLO: Ci vado/ ci vado// 29 GIOVANNA: Magari/ erano anche due ragazze carine// Lei sa come dice il proverbio? “Ogni lasciata è persa”// 30 ROMOLO: Apposta/ sto qui// Perché “ogni lasciata è persa”// SCENA 7: Graziella, Salvatore, Luciana, ragazzo. Stabilimento balneare sul Tevere. Esterno, giorno. 1 GRAZIELLA: Mi dispiace/ ma se veniva l’amico suo era diverso// Eravamo in quattro// Io/ Luciana/ mica la posso lasciare sola// 2 SALVATORE: Allora/ vediamoci io e lei senza Luciana// Domenica che fa? 3 LUCIANA: Beh/ che hai deciso? 4 GRAZIELLA: Andiamo// Lo abbiamo aspettato un’ora// Mi dispiace// Arrivederci// 5 SALVATORE: Arrivederci// Domenica/ le posso telefonare? 6 GRAZIELLA: Non ce l’ho/ il telefono// 7 LUCIANA: (dando un foglio di carta a Salvatore) Se vuole telefonare/ questo è il mio numero// 8 SALVATORE: Bella/ come no? Ti telefono sicuro// (tra sé) Mannaggia! (a un ragazzo) Ahó/ lo sai che Marilyn Monroe s’è messa a fà la ragazza squillo? Tiè/ te do ’l numero// (dandogli il foglio con il numero telefonico di Luciana) 9 RAGAZZO: Ah// 10 SALVATORE: (tra sé) Quel disgraziato di Romolo! Per colpa sua… 424 Il linguaggio cinematografico SCENA 8: Giovanna, Romolo. Sartoria. Interno, giorno. 1 GIOVANNA: (abbracciando Romolo per misurargli il torace) Ma se lo vuole fare sul serio/ il vestito/ o è una scusa per farsi abbracciare? 2 ROMOLO: No/ io il vestito me lo faccio// Però ci viene/ stasera al cinema? 3 GIOVANNA: Ma scusi/ lei si compra un vestito/ per farmi venire all’appuntamento? Eh/ co ’sto ragionamento/ se mi vuole vedere spesso/ che si fa? Un guardaroba? 4 ROMOLO: Perché? Lei ci verrèbbe lo stesso? Anche se non m’ordino niente? 5 GIOVANNA: Ma certo/ che ci verrei! Vuole che mi lasci sfuggire un’occasione così? 6 ROMOLO: Ma sa che io non so se lei scherza/ o fa per davvero? 7 GIOVANNA: Come la vuole/ la giacca? Sciallata? 8 ROMOLO: Sì// Con un bottone qui/ e le spalle scese// 9 GIOVANNA: Ah/ a cassa da morto// 10 ROMOLO: Sì// 11 GIOVANNA: E poi dicono che le donne/ si vestono attillate// (dando il centimetro a Romolo) Tenga// 12 ROMOLO: E che ci faccio? 13 GIOVANNA: Si misuri i calzoni// Io misuro dalla vita in su// 14 ROMOLO: (dopo essersi misurato la circonferenza della gamba) Sessanta// 15 GIOVANNA: Sessanta// Io gliel’ho detto/ eh? Guardi/ che non è mica obbligato a farselo/ il vestito// Perché papà cj ha i prezzi un po’ alti// Era seconda forbice/ da [Caraceli]// 16 ROMOLO: Ma perché?! Cj ho la faccia di uno che non paga? Ecco/ le do un acconto// Sono cinquemila lire// (guardando un portaritratti con la fotografia di un uomo) E questo/ chi è? 17 GIOVANNA: Era… il tagliatore che stava con noi// Un certo Ugo// 18 ROMOLO: Ma lei si conserva la foto del tagliatore? 19 GIOVANNA: Era un bravo tagliatore// 20 ROMOLO: Perché/ era? È morto? 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 425 21 GIOVANNA: Per me/ è come se fosse morto// 22 ROMOLO: Allora ci vediamo questa sera/ all’edicola di piazza della Pace// 23 GIOVANNA: Alle nove// 24 ROMOLO: Ma lei come si chiama? 25 GIOVANNA: Giovanna// E lei? 26 ROMOLO: Romolo// SCENA 9: Salvatore, ragazzi, Boccio, Giovanna. Piazza Navona. Esterno, giorno. 1 SALVATORE: Avete visto/ quel beccamorto di Romolo? 2 RAGAZZO: No// 3 SALVATORE: ’Sto disgraziato! Cj avevo due ragazze/ m’ha mandato in bianco// 4 BOCCIO: E che ce facevi/ co du ragazze? 5 RAGAZZO: Non ti riesce d’accollartene manco una! 6 SALVATORE: Se! Addio! 7 BOCCIO: Addio// 8 GIOVANNA: (cercando con fatica di chiudere la serranda della sartoria, mentre due ragazzi la stanno guardando) Non si scomodi/ eh?! Non m’aiuti! 9 RAGAZZO: L’aiuto sì// Ma me lo deve domandà gentilmente// 10 GIOVANNA: Io gentilmente ti direi un’altra cosa! Guarda/ ce l’ho proprio sulla punta della lingua! 11 SALVATORE: (accorrendo ad aiutare Giovanna) E qua ci vole uno gagliardo/ ci vole! Eh! 12 RAGAZZO: E chi saresti? Tu? 13 SALVATORE: (chiudendo la serranda) Ecco fatto// Là// 14 GIOVANNA: Grazie// (a Salvatore che le ha preso la borsa) Beh? Ma che fa? Mi dia la borsa// 426 Il linguaggio cinematografico 15 SALVATORE: Gliela porto io// Lei stamattina m’ha fatto un dispetto/ e io le faccio una gentilezza// Così siamo pari// 16 GIOVANNA: (a Salvatore che si avvia nella direzione sbagliata) Ma dove va? Io sto di qua// 17 SALVATORE: È proprio il destino/ che m’ha fatto incontrarla// È tutta stamattina/ che la penso// 18 RAGAZZO: Salvatore/ te sei fatto la ragazza? 19 SALVATORE: M’a so’ fatta sì// 20 BOCCIO: Ma come?! Appena arivata/ s’è beccata ’sto tartufo?! 21 SALVATORE: Si vede che le donne/ co me/ si trovano bene! 22 RAGAZZO: E se vede che so’ de bocca bona! 23 GIOVANNA: Ma sta’ zitto/ tappetto! 24 RAGAZZO: Certo che è na coppia scompagnata/ eh? 25 RAGAZZO: E sì/ perché lei è caruccia// 26 BOCCIO: È lui/ ch’è ’n cacatruccioli// (tutti ridono) 27 SALVATORE: Ha visto/ come ci sono rimasti male? Ce l’hanno con me/ perché je soffio tutte le ragazze// 28 GIOVANNA: Qualcuna gliela potrébbe lasciare// 29 SALVATORE: Adesso gliele lascio tutte// (abbracciando Giovanna, che gli scansa la mano) Ma perché fa così? Non mi vuole più bene? 30 GIOVANNA: Come?! Certo/ che le voglio bene! Adesso mi dia la borsa/ però// (la borsa cade e si versa in terra tutta la spesa) 31 GIOVANNA: Oh! 32 SALVATORE: Aspetti/ l’aiuto io// 33 GIOVANNA: Oh! Che disastro! 34 SALVATORE: (a un bambino che si è avvicinato per raccogliere le cose cadute in terra) A regazzì/ non te fregà le patate/ eh! (a Giovanna, raccogliendo il portaritratti, rotto) Oh/ mi dispiace// S’è rotto// 35 GIOVANNA: Non fa niente// Tanto l’avrei buttata via// (Giovanna straccia la foto di Ugo) 36 SALVATORE: Adesso che si è fatto libero il posto/ ci può mettere la mia/ di fotografia// Domani gliela porto// 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 427 37 GIOVANNA: Hm// 38 SALVATORE: Come si chiamava? 39 GIOVANNA: Ugo// 40 SALVATORE: Ugo/ hai chiuso// 41 GIOVANNA: Beh/ arrivederci// 42 SALVATORE: Ma già se ne va? Ma perché? Potevamo conoscerci meglio// 43 GIOVANNA: Ci conosceremo meglio un’altra volta// 44 SALVATORE: Conosciamoci meglio stasera// È libera? Che fa/ stasera? 45 GIOVANNA: E beh/ veramente avrei un impegno/ ma… ma se lei insiste… 46 SALVATORE: Eh/ insisto sì// 47 GIOVANNA: Allora ci troviamo alle nove/ all’edicola di piazza della Pace// 48 SALVATORE: D’accordo// Alle nove// Ci sarò// SCENA 10: fratello di Salvatore, Salvatore, Alvaro, Marisa, Romolo. Casa di Salvatore, balcone e casa di Romolo. Interno–esterno, sera. 1 FRATELLO: (insieme con l’altro fratello, vicino al letto in cui dorme Alvaro) Uno/ due… 2 SALVATORE: (dando uno schiaffo ai bambini, cacciandoli) Via! (ad Alvaro che dorme) Capolinea// Biglietto da venticinque termina// Non spingere// Scendiamo tutti// Siamo arivati// Scendere! 3 ALVARO: (svegliandosi di soprassalto) Ah! Ah! Che tempo fa? 4 SALVATORE: C’è una luna che spacca// 5 ALVARO: Ma che è/ ’sta puzza? 6 SALVATORE: (spalmandosi in testa la brillantina) Puzza?! È la brillantina Fiori d’Arabia! (leggendo dal barattolo della brillantina) “Vi assicura il successo nella vita”// 7 ALVARO: Ma quale Arabia? Quella dei beduini? 8 SALVATORE: Ma che vuoi capire de brillantina/ tu/ che t’ungi i capelli col grasso delle rotaie?! (uscendo sul balcone) Romolo? Romolo! 428 Il linguaggio cinematografico 9 MARISA: Che vuoi? 10 SALVATORE: Ahah! Ma sempre tu/ t’affacci? Chiama tuo fratello// 11 MARISA: Romolo? (a Salvatore) Salvatore/ ci vieni a ballare/ stasera in terrazza? 12 SALVATORE: Uh/ ma proprio fissata/ sei! 13 ROMOLO: (a Marisa) Ahó! Fila! 14 SALVATORE: Romolo/ mi sa che stasera non esco// Mi sento certi doloretti alle ossa// Quasi quasi me ne vado a letto// Che dici? 15 ROMOLO: Beh/ se stai poco bene/ è meglio che ti riguardi// Poi/ pure io non sto molto bene// Vorrà dire che/ se non esci te/ non esco neanch’io// (tirando su col naso) Ma che è/ ’st’odore curioso? 16 SALVATORE: Io non sento niente// Appena questo se n’è andato/ mi metto a letto// Mi leggo l’ultima puntata di Cittadini dello spazio// Ahó/ lo sai che so’ forti/ sti libri di fantascienza? 17 ROMOLO: Eh/ <fortissimi>! 18 SALVATORE: <Anzi>/ non mi chiamare/ eh? 19 ROMOLO: Ma chi ti chiama?! Io/ fra dieci minuti/ dormo// Buonanotte// 20 SALVATORE: Buonanotte// (alle inquadrature di Salvatore che si prepara per uscire, si succedono quelle di Romolo, che si veste canticchiando) 21 ALVARO: (guardando Salvatore che si veste) Guarda che robba/ va’! Gioventù bruciata! Va’/ va’! Va’ pe grilli pure stanotte! Fammene trovà un altro dentro al letto! Così nun pago la pigione// Guarda che robba/ va’! Eh/ sei bello! Va’ pe grilli/ va’! SCENA 11: Annamaria e Marisa. Pianerottolo. Interno, sera. (Prima Romolo e poi Salvatore escono di casa e scendono di corsa le scale, badando di non farsi scoprire l’uno dall’altro. Subito dopo di loro escono sul pianerottolo Annamaria e Marisa) 1 ANNAMARIA: Io pagherei per sapere dove vanno/ tutte le sere// 2 MARISA: Dove vuoi che vadano?! Vanno a fare l’amore con le ragazze// Con quelle che gli danno soddisfazione// 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 429 3 ANNAMARIA: Non mi potevo andare/ a innamorare di un altro! Proprio di tuo fratello! Mi fa una rabbia! 4 MARISA: E perché? Che ha/ mio fratello? E io/ allora/ che mi sono innamorata del tuo? 5 ANNAMARIA: Belle stupide/ siamo! A buttar via così/ gli anni più belli! SCENA 12: Romolo, Salvatore, Giovanna, uomo. Piazza della Pace. Esterno, notte. 1 ROMOLO: (incontrando Salvatore) E tu che fai/ qua? 2 SALVATORE: Romolo/ senti/ prima t’ho detto una bugia// Fammi il piacere/ vattene// Sto aspettando Giovanna// Quella della sartoria// Poi domani ti spiego tutto/ eh? 3 ROMOLO: Ah/ Giovanna t’ha dato appuntamento qui?! 4 SALVATORE: Beh/ cj ho provato// M’è andata bene/ eh// 5 ROMOLO: E allora/ è andata bene pure a me// 6 SALVATORE: Come sarébbe a dire? 7 ROMOLO: Eh/ cj ho appuntamento pure io// 8 SALVATORE: Ah/ ma allora quella ci provoca! Quella ci stuzzica! Quell’impunita/ burina/ analfabeta! Domani/ appena la vedo/ sai/ che le dico? Le dico… (a Giovanna che arriva) Buonasera// 9 GIOVANNA: Ho fatto tardi? 10 ROMOLO: Credevamo che non venisse// 11 GIOVANNA: E perché? Non avevamo appuntamento? 12 ROMOLO: Certo// Allora/ possiamo andare? O dobbiamo aspettare qualcun altro? 13 SALVATORE: Ma a chi ha dato appuntamento?! A me o a lui? 14 GIOVANNA: A tutti e due/ no?// E che c’è/ di male? Con due/ sto più tranquilla che con uno// 15 SALVATORE: Ma a chi l’ha dato prima/ l’appuntamento? A me/ o a lui? 16 ROMOLO: Ma che/ ti vuoi arrabbiare per questo? Si fa presto// Ce la giochia- 430 Il linguaggio cinematografico mo testa e croce/ e chi capita/ capita// Croce a te/ e testa a me// Va bene? (lanciando la monetina) Là// Croce// Buonanotte// (se ne va) 17 SALVATORE: Scusi/ signorina/ devo dire una parola all’amico mio// (rincorrendo Romolo) 18 UOMO: (a Giovanna) Bella! 19 SALVATORE: Non fare lo stupido! Andiamoci insieme/ e vediamo come si mette// Poi/ “chi muore giace/ e chi vive/ si dà pace”// Eh? 20 UOMO: Bella! Bella/ bella/ bella/ bella! 21 SALVATORE: Ahó/ arrivi tardi! Già siamo in troppi/ qua! Gira! 22 ROMOLO: Cammina/ cammina! 23 UOMO: Bella! 24 ROMOLO: Ma che/ “bella”! Gira! 25 GIOVANNA: Allora/ dove mi portate/ di bello? Al cinema/ o a ballare? 26 ROMOLO: A ballare// 27 SALVATORE: Cj ho un bel posticino/ sotto mano all’aperto/ dove si vede tutta Roma// Un ambiente fine/ gente conosciuta/ elegantissimo! SCENA 13: ragazze 1 e 2, ragazzi 1, 2, 3 e 4, Marisa, Annamaria, Boccio, Salvatore, VVFC, uomo, Giovanna, padre di Romolo. Musica di sottofondo durante tutta la scena. Terrazza della casa di Romolo e Salvatore. Esterno, notte. 1 RAGAZZA1: (al ragazzo1) Lei non balla? 2 RAGAZZO1: Balliamo// 3 MARISA: (ballando con un ragazzo) Ma che ci troverà/ Salvatore/ in quella? Io non l’ho ancora capito// 4 ANNAMARIA: (ballando con un ragazzo, rivolgendosi a Marisa) Che ci trova? Guarda come balla appiccicato// Si vede che qualcosa ci trova// 5 BOCCIO: (ballando con Annamaria) E balla appiccicata pure te/ no? Può essere che ti diverti// 6 ANNAMARIA: Ma va’/ va’! 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 431 7 RAGAZZO2: (ballando con Marisa) Queste ragazze/ non si sanno proprio divertire// 8 SALVATORE: (ballando con Giovanna) E che c’entra? Non è/ che sono fissato// Anche se dai un bacio a uno/ che fai di male? Ti levi un capriccio// E poi/ sai come dice il proverbio? “Un bacio non fa bucio”// (al ragazzo3, che passa a Salvatore la scopa, segno di scambio del compagno di danza) Ma sei proprio sicuro/ che me la devi dare a me? 9 RAGAZZO3: Eh! 10 SALVATORE: (indicando la scopa) No/ perché io/ questa/ te la posso pure far mangiare! 11 RAGAZZO3: Oh/ il gioco è gioco// (il ragazzo3 passa la scopa a Salvatore e comincia a ballare con Giovanna) 12 ROMOLO: (a Salvatore) Quanto ti dai da fare! 13 SALVATORE: E sì/ che mi do da fare! Tu/ piuttosto/ stai lì/ che mi pari la vecchietta del cacao// 14 ROMOLO: Fai una bella figura/ con quella scopa in mano! Perché non provi a farci/ “m’ama/ non m’ama”?! Potrébbe darsi che t’ama! 15 SALVATORE: Perché? Ti dispiacerébbe? 16 ROMOLO: A me? Figùrati! Pure se te la spósi! 17 SALVATORE: Se ci vuoi ballare anche tu… 18 ROMOLO: Io?! Ma chi la vede/ quella? A me m’è rimasta/ un po’ di dignità// A me/ mangiare in due nello stesso piatto/ non mi piace// (nel frattempo è finita la musica e, prima che cominci il brano successivo, si sentono in sottofondo risate e urla indistinte) 19 VFC RAGAZZO: Ahó! <[…]>! 20 SALVATORE: <Ma se cj hai mangiato fino a ieri/ nel piatto mio>! Iolanda/ te la sei scordata? Sai che ti dico? Siccome quel piatto mi piace/ ci vado a dare un’altra cucchiaiata// 21 ROMOLO: Attento che non ti strozzi! 22 SALVATORE: (passando la scopa al ragazzo3, che sta ballando con Giovanna) Tieni// Stringi questa// 23 RAGAZZO3: Oh! Ma Romolo non balla? 24 BOCCIO: A Romolo! Balla/ no? Balla pure te! 432 Il linguaggio cinematografico 25 ROMOLO: Ballo/ ballo// (comincia a ballare con una ragazza) 26 SALVATORE: (ballando con Giovanna) Giovanna/ tu non m’hai capito// Io non voglio/ un bacio da te// Ti voglio dare io/ un bacio// Tu/ in cambio/ non mi devi dare niente// 27 GIOVANNA: No! Che ragionamento! A me/ i baci/ mi piace di riceverli/ e di darli// Sennò che gusto c’è? 28 S ALVATORE : Ah/ ma allora siamo anime gemelle! Senti/ perché non andiamo là dietro/ a nasconderci? 29 GIOVANNA: Ma/ che ti sei messo/ in testa? 30 SALVATORE: Mi sono messo in testa/ di fare una scarrozzata in paradiso con te// 31 GIOVANNA: Dico/ che ti sei messo nei capelli// Che cj hai un odore! 32 SALVATORE: Perché?! Non ti piace? È la brillantina Fiori d’Arabia! 33 GIOVANNA: Senti/ Fiore d’Arabia/ se vuoi che ti do un bacio/ vatti prima a fare lo sciampo! 34 UOMO: (con una grossa scatola in mano) Sta qua/ il portiere? 35 PADRE: Sono io// Perché? 36 UOMO: Mannaggia// Mi sono fatto sei piani di scale// Dove abita/ il signor Di Stefani? 37 PADRE: Eh/ dovete tornà abbasso// L’altra scala// Al penultimo piano// Anzi/ se lo trovate/ me fate un piacere? Gli date ’st’espresso? È arrivato ieri// Può essere una cosa urgente// Eh? (tra sé, dopo che l’uomo se n’è andato) Poveraccio! 38 RAGAZZA2: (ballando con Romolo) Balli con me/ e non mi guardi mai// 39 ROMOLO: Io mi conosco// Se guardo troppo una donna/ pahf/ mi innammoro// 40 RAGAZZA2: Eh/ come fai presto! 41 ROMOLO: Ti ho detto di non stringere/ che mi conosco! 42 SALVATORE: Giovanna/ facciamo una cosa// Tu mi dai un bacio/ e non ci vediamo più// Scomparirò dalla tua vita per sempre// 43 GIOVANNA: Se mi prometti che scompari/ te lo do// (si baciano) 44 SALVATORE: Ti darei un gettone d’oro/ per come baci! 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 433 45 GIOVANNA: È che ci sono portata// Io/ nelle cose/ ci metto passione// Che ti credi? 46 SALVATORE: Eh/ me ne sono accorto// Mi fischiano le orecchie! (finisce la musica e Romolo rimane da solo con la scopa in mano. Risate e urla indistinte) 47 RAGAZZO3: Ahó! Romolo paga pegno! 48 BOCCIO: Dai/ che se fanno le penitenze! Forza/ ragazzi! 49 VFC RAGAZZO: Avanti! 50 ROMOLO: (a Boccio) Ma statte zitto! 51 VFC RAGAZZO: [Eh// Ndo vai]? 52 PADRE: <Ma che fai?! So’ le chiavi di casa>! 53 ROMOLO: (al padre, prendendo un mazzo di chiavi) <[…]>// (dando a Giovanna le chiavi di casa) Tenga// (tutti i presenti danno a Giovanna qualche oggetto personale, per organizzare le penitenze) 54 BOCCIO: (dando un pettine a Giovanna) Il mio non se lo perda/ <eh>! 55 GIOVANNA: <No>// 56 RAGAZZO4: Stia attenta/ questo è il mio/ <eh>?// 57 VFC RAGAZZO: <Questo è mio>// 58 GIOVANNA: <Qua>! A me/ a me! (prendendo a caso, tra tutti gli oggetti che le sono stati dati, un fazzoletto e mostrandolo a tutti) Di chi è/ questo? 59 RAGAZZO4: Mio// 60 GIOVANNA: (riprendendo al volo il fazzoletto che le stava sfuggendo di mano) Uh! <[Andiamo/ ragazzi]>! 61 SALVATORE: (al ragazzo4, facendo in modo che si disponga dando le spalle a tutti i presenti, per fare la penitenza) <Adesso ti metti sotto tu>// 62 VFC RAGAZZO: <Su>! 63 SALVATORE: <Buono buono// Così>// 64 BOCCIO: <Calma/ ragazzi/ calma>! 65 SALVATORE: Calma/ ragazzi/ calma/ calma! (mostrando ai presenti, tranne che al ragazzo4, la mano chiusa a pugno) Questi/ da chi li vuoi? 434 Il linguaggio cinematografico 66 RAGAZZO4: Da Marisa// 67 TUTTI: (ridendo) <Ah>! 68 SALVATORE: <Quanti>? 69 RAGAZZO4: Uno// 70 SALVATORE: Marisa? 71 MARISA: Ecco! 72 BOCCIO: Vai/ Marisa! 73 RAGAZZO 4: (a Marisa che si prepara a dargli un pugno) Ahó/ nun me fà male/ eh! (incassando il pugno) Uh! (risate generali) 74 VFC RAGAZZO: Oh! 75 RAGAZZO4: Ahó/ proprio sull’orologio de papà! Mannaggia! (il ragazzo4 sposta l’orologio dalla giacca ai pantaloni) 76 SALVATORE: (a tutti) Fermi! (al ragazzo4) Fermo fermo fermo fermo! (mimando a tutti i presenti, tranne che al ragazzo4, il movimento di un calcio) Questi/ da chi li vuoi? 77 RAGAZZO4: Da Annamaria// 78 SALVATORE: Quanti? 79 RAGAZZO4: Dieci// (risate generali) 80 VFC RAGAZZO: Chiudi gli occhi! 81 BOCCIO: Stringi i denti! (Annamaria gli dà un calcio) 82 RAGAZZO4: Ahi! (risate generali) Mannaggia! Guarda qua! M’avete rotto l’orologio! E mo/ a papà/ che gli dico/ io?! <Ma va’>! 83 BOCCIO: <Adesso ci pensa papà>/ a darti gli altri calci// 84 GIOVANNA: (prendendo a caso, tra tutti gli oggetti che le sono stati dati, un pettine e mostrandolo a tutti) Di chi è/ questo? 85 VFC RAGAZZO: È di Boccio! 86 VFC RAGAZZA: <Vai/ Boccio>! (risate generali e commenti incomprensibili) 87 BOCCIO: (mentre lo spingono e gli danno degli schiaffi in testa) <Oh>! Ahó! Fate piano/ ahó! <Fate piano>! 88 VFC RAGAZZO: <[Calma/ ragazzi]>! 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 435 89 BOCCIO: <Fate piano/ ahó>! 90 SALVATORE: <Calmi calmi calmi calmi>! 91 ROMOLO: <Beh>/ io me ne vado// 92 BOCCIO: Oh! 93 ROMOLO: <Arrivederci>// 94 GIOVANNA: <Ma perché>? Non si diverte? 95 ROMOLO: Ho capito/ che lei si diverte con poco! 96 GIOVANNA: Eh/ chi si contenta/ gode// 97 ROMOLO: E goda/ goda! Arrivederci e divertitevi// 98 BOCCIO: Beh/ mo te ne vai? 99 TUTTI: <No>! 100 RAGAZZO3: <Ahó/ devi fà la penitenza>! 101 ROMOLO: Ma la penitenza l’ho fatta a stare con voi! Cretini! 102 BOCCIO: Ma che ce ne importa/ ragazzi! Balliamo! Musica! (tutti si scatenano ballando un boogie–woogie) SCENA 14: Salvatore, Giovanna. Piazza Navona. Esterno, notte. 1 SALVATORE: Eh/ perché tu/ mamma mia/ la vedi adesso! Ma se l’avessi conosciuta vent’anni fa! Dicevano che era il ritratto della regina Margherita// E che donna di casa/ che è! 2 GIOVANNA: Senti/ parla di mamma/ ma statti con le mani a posto/ per piacere// 3 SALVATORE: Ma perché pensi subito al male? Perché t’ho messo il braccio attorno alla vita? 4 GIOVANNA: Eh/ chiamala vita! Ma che ti credi/ che cj ho la vita così alta? 5 SALVATORE: Adesso mi metto le mani in tasca// Ti va bene/ così? Ti pare che uno può parlare d’amore con le mani in tasca? Mannaggia! Ma guarda se all’età mia/ mi dovevo innamorare come un ragazzino! Ha ragione Romolo// Ho perso tutta la dignità// 6 GIOVANNA: Di’/ ma/ tu e Romolo/ vi conoscete da molto? 436 Il linguaggio cinematografico 7 SALVATORE: Eh! Ci giocavamo il latte della balia a testa e croce! È un bravo ragazzo/ Romolo// Cj ha un solo difetto// Manca di tatto// È grezzo// Senza sentimento// Per esempio io/ qualche volta/ sai che faccio? Piglio l’autobus/ e me ne vado sull’Appia antica// Tutto solo// A vedere il tramonto// Lui no// A lui/ i tramonti non gli dicono niente// 8 GIOVANNA: Lo sai che cosa m’ha detto/ stasera/ quando cj ha visti insieme? “Si diverte con poco/ eh”? 9 SALVATORE: Ma te lo dico io// Quello era avvilito/ perché tu te la fai con me// 10 GIOVANNA: Adesso mi sa che t’avvilisci pure tu// Perché sono stanca/ e vado a dormire// 11 SALVATORE: Giovanna// 12 GIOVANNA: Beh? 13 SALVATORE: La conosci/ l’Orsa maggiore? 14 GIOVANNA: Sì// 15 SALVATORE: L’ultima stella/ in fondo a destra// A mezzanotte in punto la guardi/ la guardo pure io/ e ci pensiamo// 16 GIOVANNA: Va bene// 17 SALVATORE: Ciao/ amore// (le bacia la mano) 18 GIOVANNA: Ciao// 19 SALVATORE: (tra sé) Mah! SCENA 15: Romolo, Giovanna, sarto padre di Giovanna, uomo. Cortile della casa di Giovanna. Esterno, notte. 1 ROMOLO: Che j’ha detto/ quello? Che sono grezzo/ e che non mi piacciono i tramonti? Io lo so/ che ci va a fare lui/ sull’Appia antica// 2 GIOVANNA: Ma lei che fa/ qui? 3 ROMOLO: Io vado a casa// Ma lei cj ha le mie chiavi// 4 GIOVANNA: Ah già/ il pegno// Mi scusi// 5 ROMOLO: Per carità// Buonanotte// 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 437 6 GIOVANNA: Buonanotte// 7 ROMOLO: Senta un po’// E che altro le ha detto/ di me/ Salvatore? 8 GIOVANNA: Ha detto che lei si è avvilito/ perché ci ha visti insieme// 9 ROMOLO: Ah// Senta/ a scanso di equivoci/ è bene che sappia/ che io/ lei/ non la penso per niente// E neanche mi piace/ se lo vuol sapere// 10 GIOVANNA: Eh/ non s’arrabbi tanto! Io non le piaccio? E va be’// Mica ci dobbiamo sposare/ no? 11 ROMOLO: Sposare? Ma io manco a baciarla/ ci proverei gusto! Ma lei non ha capito/ che a me non dice proprio niente? 12 GIOVANNA: Guardi/ che prima cosa/ ho capito benissimo// Seconda cosa/ dubito/ che lei non ci proverèbbe gusto// Terza cosa/ chi è/ che la vuole baciare// Qui dentro non c’è nessuno/ che la vuole baciare// Guardi// Non c’è anima viva// (si sente un rumore) Svelto/ nascondiamoci! (si nascondono in un angolo buio) Ss! È papà! 13 SARTO: Mah! Se io fossi in te/ non me la pijerei// Tua moglie ti fa le corna? Beh! Quel giorno che ti salta il ticchio/ l’ammazzi// 14 UOMO: Eh/ e… e così vado in galera// 15 SARTO: No// Perché in Italia/ la legge t’aiuta// Tu ammazzi tua moglie/ ti danno trent’anni// Ma se l’ammazzi perché ti fa le corna… 16 UOMO: Hm// 17 SARTO: ti mandano assolto// 18 UOMO: Ah/ è giusto// E sennò/ indove li metti/ i motivi d’onore? 19 SARTO: Di’/ ma pensi sul serio/ d’ammazzare tua moglie? 20 UOMO: Ah/ io no// Ma adesso/ che me l’hai messo in mente/ chi me lo leva più/ questo pensiero? 21 ROMOLO: (sottovoce a Giovanna) Mi sa che ’sta discussione va per le lunghe// 22 GIOVANNA: Perché? Sta scomodo? 23 ROMOLO: E sto stretto! 24 GIOVANNA: E faccia ’sto sacrificio/ no? 438 Il linguaggio cinematografico SCENA 16: Salvatore, ragazzi, Boccio. Piazza Navona. Esterno, notte. 1 SALVATORE: (incontrando i ragazzi della festa che stanno ballando e cantando sulla piazza, si unisce a loro) Olé! 2 RAGAZZO: Ragazzi/ guardate chi è arivato! 3 BOCCIO: Ahó/ mo ce racconti tutto/ eh? 4 RAGAZZO: Ahó/ facce ’e confidenze! 5 RAGAZZO: E dicce tutto// Che/ cj ha’ paura? 6 SALVATORE: E lasciatemi perdere! Ahó/ ma siete scorretti forte! E che è?! (a Boccio) Volevo vedere se era tua sorella/ se mi venivi a cercare i particolari! 7 BOCCIO: Di’/ l’hai mandato in bianco/ que’ amico tuo/ stasera/ eh? 8 SALVATORE: Eh/ salta chi può// Che è/ colpa mia/ se io piaccio alle donne/ e Romolo no? 9 BOCCIO: Ammazza/ <che dritto/ ahó>! 10 RAGAZZO: <[Che volpe]>! SCENA 17: uomo, sarto, Giovanna, Romolo. Cortile della casa di Giovanna. Esterno, notte. 1 UOMO: (salendo le scale con il padre di Giovanna, mentre Giovanna e Romolo si stanno baciando) Perché il divorzio/ parte da un principio importante// 2 SARTO: Certo// Se due non si vogliono più bene/ perché devono vivere insieme? Perché una volta hanno detto/ sì? 3 UOMO: Beh/ e adesso dicono/ no! 4 GIOVANNA: Allora/ sei sempre di quell’idea? Che a te/ i baci miei/ non ti dicono niente? 5 ROMOLO: Ahó/ non ti sarai mica montata la testa/ perché t’ho dato un bacio? Te l’ho dato/ perché mi ci sono trovato// 6 GIOVANNA: Beh/ allora è meglio che tolga il disturbo! Buonanotte e grazie// 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 439 7 ROMOLO: Per curiosità/ ma… tu/ i baci/ li dai a tutti? 8 GIOVANNA: A quelli che mi piacciono// E fra quelli che mi piacciono/ scelgo quello che mi piace di più// 9 ROMOLO: Ho capito// Fai le prove// 10 GIOVANNA: Tu la fai/ la prova/ ai cocomeri/ per vedere se sono rossi? E io faccio così// Bacio i ragazzi/ per sapere quello che mi piace di più// 11 ROMOLO: Beh/ allora domani/ mi fai sapere se sono il cocomero tuo// Buonanotte// 12 GIOVANNA: Buonanotte// SCENA 18: Marisa, padre di Romolo, Annamaria, Salvatore, Alvaro, Romolo. Pianerottolo del palazzo di Romolo e Salvatore. Interno, notte. 1 MARISA: Ma tu/ perché gliel’hai date/ le chiavi di casa? 2 PADRE: ’Sto disgraziato! E guarda se arriva! È quasi mezzanotte! Te l’avevo detto/ a te/ di pigliare pure l’altro mazzo// 3 MARISA: Uff! 4 ANNAMARIA: Ma dove sarà andato? Mi pareva che cj avesse i nervi/ stasera// 5 SALVATORE: Eh/ quanto gli dureranno/ sti nervi?! 6 PADRE: Eh/ mo che ariva/ se ne accorge/ quanto me durano a me! 7 SALVATORE: A sor Nerone/ potreste approfittare/ per andare una volta tanto in portineria// Così fate finta di fare il portiere// E sennò/ gli inquilini/ se ne scordano// Beh/ io vi saluto// Buonanotte// 8 MARISA: Buonanotte// (vedendo arrivare qualcuno) 9 ANNAMARIA: Eccolo! 10 SALVATORE: (vedendo Alvaro salire le scale) Ma tu che fai/ a quest’ora? 11 ALVARO: Mi sono sentito male// 12 SALVATORE: E mbeh? 13 ALVARO: E mbeh/ ch’è colpa mia? Cj ho la febbre// Mi devo mettere a letto// 440 Il linguaggio cinematografico 14 SALVATORE: Ma che/ ti sei impazzito? Mica ti metterai nel letto mio? 15 ALVARO: E che vuoi/ che mi metto pe terra? 16 ANNAMARIA: (al padre di Romolo) Perché non entrate in casa nostra? Almeno/ vi pigliate un caffè// 17 PADRE: Grazie// 18 ANNAMARIA: (vedendo arrivare Romolo) Eccolo/ che arriva! 19 PADRE: Oh! Ma che/ ti sei scordato/ che hai un padre? 20 ROMOLO: E non me lo far ricordare/ che m’avvilisco! 21 PADRE: Certo/ che ti dovresti avvilire/ che m’hai lasciato fuori di casa! Io/ al posto tuo/ mi mortificherei! 22 ROMOLO: E seppure me mortifico? Tanto hai aspettato lo stesso/ no? 23 MARISA: Ciao/ Annamaria// Ci vediamo domani// 24 ANNAMARIA: Ciao/ Marisa// Romolo? 25 ROMOLO: Sì? 26 ANNAMARIA: Ancora non ti sono passati/ i nervi? Mi sembra che ce li hai più di prima// 27 ROMOLO: Ma che vuoi?! 28 ANNAMARIA: Io niente// 29 ROMOLO: Allora buonanotte/ e auguri// SCENA 19: Alvaro, Cecilia, Annamaria, Salvatore, Romolo, Marisa. Casa di Salvatore, balcone e casa di Romolo. Interno–esterno, notte. 1 ALVARO: Ah! 2 CECILIA: (toccando con la mano la fronte di Alvaro) Ma questo scotta! Ha la febbre! (a Salvatore) E vuol dire che per stanotte ti sacrifichi/ e dormi per terra! 3 ANNAMARIA: Cj ha la febbre? 4 ALVARO: <Eh sì/ ho la febbre>// 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 441 5 SALVATORE: <Mamma/ e se questo sta una settimana a letto>? E se non s’alza più? 6 ALVARO: No/ m’alzo/ m’alzo// <Eh>! 7 CECILIA: <Annamaria>/ andiamo di là// Prendiamo un materasso/ e lo buttiamo per terra// 8 SALVATORE: (toccando la fronte di Alvaro) Hai la febbre? 9 ALVARO: Ahi! Eh! 10 SALVATORE: Fa’ sentire il polso// (Salvatore vede l’orologio di Alvaro) 11 ALVARO: Ah/ la testa! <Ah>! 12 SALVATORE: <Ahó/ ma è mezzanotte>! 13 ALVARO: Ah! 14 SALVATORE: (uscendo sul balcone e guardando le stelle) Eccola là// 15 ROMOLO: (uscendo anche lui sul balcone e guardando Salvatore) Ti sei incantato? 16 SALVATORE: Peggio/ Romolo// Mi sono innamorato// 17 ROMOLO: E ti si vede dalla faccia// E si può sapere/ di chi? 18 SALVATORE: Di Giovanna// 19 ROMOLO: Giovanna? E che cj hai fatto? 20 SALVATORE: Ammappelo! Cj ho fatto na pomiciata/ che manco te l’immagini! Ma non è questo// È che è proprio bello/ essere innamorati! Ti sembra di essere un fiore/ la mattina/ quando si sveglia/ e apre i petali// 21 ROMOLO: E tu saresti il fiore? 22 SALVATORE: Com’è bello/ Romolo! Ti senti leggero leggero// E il cuore/ te lo senti pizzicare// Sai quando bevi l’acqua minerale? Ti fa così// Certo che noi/ siamo fatti strani// Facciamo i fanatici/ i bulli/ ci diamo le arie/ le donne le pigliamo subito di petto/ e poi il cuore s’innamora pure a noi// È buffo/ eh? 23 ROMOLO: E lei? 24 SALVATORE: In questo momento/ sta in finestra/ e mi pensa// Tutt’e due/ guardiamo la stessa stella// 25 ROMOLO: Sì// L’ultima dell’Orsa maggiore/ in fondo a destra// 442 Il linguaggio cinematografico 26 SALVATORE: E come lo sai? 27 ROMOLO: A cretino! Ma se te l’ho insegnate io/ ste frescacce da dire alle donne! E non la pensare troppo/ che ti può venire la meningite! Deficiente! (entra in casa) Jela do io/ l’Orsa maggiore! Ma il pigiama mio/ chi è/ che l’ha preso?! (entrando in camera di Marisa) Senti// 28 MARISA: Potresti bussare/ prima di <entrare/ no>? 29 ROMOLO: <Sai dov’è> il pigiama mio? 30 MARISA: L’ho messo a lavare// 31 ROMOLO: E adesso come faccio? (prendendo un reggicalze) E questo che è? 32 MARISA: È un reggicalze// Non ne hai mai visti? 33 ROMOLO: (dandole uno schiaffo) Adesso anche i reggicalze/ all’età tua? Vergògnati! 34 MARISA: Ma le calze/ scusa/ come devo tenerle? 35 ROMOLO: Con un pezzo di spago/ con un elastico/ con una fettuccia/ ma non col reggicalze! Tanto a te non ti guarda nessuno! (tornato in camera sua, tra sé) A quindicj anni/ il reggicalze! Ma va’ a capire che cj hanno in testa le donne! Le donne! Sai quanto si starèbbe meglio/ senza di loro! (suona il campanello) A quest’ora/ chi sarà?! 36 MARISA: Romolo! C’è Salvatore// 37 SALVATORE: Romolo/ mi devi far dormire qua// S’è scoperto che il tranviere cj ha gli orecchioni// 38 ROMOLO: Stasera/ proprio mi mancavi! 39 SALVATORE: (sfogliando una rivista) Romolo? 40 ROMOLO: Eh? 41 SALVATORE: Che saremmo/ noi/ senza le donne? Come le piante/ senza la clorofilla// L’ho letto su Scienza e vita// La clorofilla/ gli dà la luce/ alle piante// E così/ le donne a noi// 42 ROMOLO: Mi fai proprio pena// Beh/ io spengo// Tanto a te la luce/ te la dà la clorofilla// 43 SALVATORE: (inciampando) Ahi! Mannaggia alla miseria! Ah! Ah! Ah! Ah! 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 443 SECONDO TEMPO SCENA 20: Romolo, Salvatore, Annamaria, Marisa. Casa di Romolo. Interno, mattina. 1 ROMOLO: Giura// 2 SALVATORE: Ma che vòi// 3 ROMOLO: Giura che l’hai baciata/ e che non ti sei inventato tutto// 4 SALVATORE: E va bene// Giuro// 5 ROMOLO: Di’ un po’/ ma come l’hai baciata? Perché ci sono tanti modi/ di baciare una ragazza// Ci sono pure i baci senza importanza// 6 SALVATORE: Beh/ ci siamo baciati in un modo piuttosto importante// 7 ROMOLO: E lei/ te li ha ricambiati? 8 SALVATORE: Ti dirò// Ho paura che se la sia presa proprio forte// Me mette quasi paura// Sai perché? Ma mi stai/ a sentire? 9 ROMOLO: Di’/ di’// Séguita// 10 SALVATORE: Perché quella è una ragazza che/ se mi gira/ sono capace pure di sposarla// 11 ROMOLO: Ah! Mi fa piacere// Allora/ quella cosa che ti volevo dire/ non te la dico più// 12 SALVATORE: Quale cosa? 13 ROMOLO: Riguardo alla tua futura spósa// 14 SALVATORE: Cioè? 15 ROMOLO: Che l’ho baciata pure io// 16 SALVATORE: Che hai detto? 17 ROMOLO: Che l’ho baciata pure io// (Salvatore lo prende per la canottiera) E non c’è bisogno che me metti ste manacce addosso// 18 SALVATORE: Giura! 19 ROMOLO: Lo giuro// 20 SALVATORE: Quando l’hai baciata? 21 ROMOLO: Ieri sera// Dopo che l’hai lasciata tu! Aspettavo nel portone// Anzi/ t’ho sentito che dicevi/ che non mi piacciono i tramonti// 444 Il linguaggio cinematografico Giovanna entra/ e mi fa/ “buonasera”// “Buonasera”/ dico io// Poi una parola tira l’altra/ e le ho dato un bacio che non finiva più// 22 SALVATORE: Ammazza! Ce ne sono/ carogne! Ma come le donne! Di’/ ma ti pare una bella azione/ quella che m’hai fatto? 23 ROMOLO: Ma perché? Abbiamo sempre fatto a mezzo di tutte le donne! Che/ Giovanna è diversa dalle altre? 24 SALVATORE: Sì// Giovanna è diversa! Con lei/ non ti ci devi azzardare più! Hai capito? 25 ROMOLO: Ma sta’ zitto/ cretino! 26 SALVATORE: (dando un pugno sullo stomaco a Romolo) Cretino/ sei tu! 27 ROMOLO: (allontanandolo da sé) E non ci provà più/ sai?! La prossima volta che ci provi/ ti spacco in due! (Annamaria e Marisa entrano in camera e separano i fratelli. Urla e battute sovrapposte, solo parzialmente comprensibili) 28 ANNAMARIA: Ma che fate?! Siete ammattiti?! <[…]! (a Salvatore) Ma smettila>! 29 MARISA: <Ma che succede?! Statevi buoni! […]>! 30 SALVATORE: (a Romolo) <Capirai! Me spacchi in due! Ma che me spacchi! Ma fa’ ’r piacere/ va’! E vattene! Ma cammina! (ad Annamaria) E lasciame stà>! 31 ROMOLO: (a Salvatore) <Ah! E vattene via/ va’>! 32 MARISA: (a Romolo, afferrando una stampella) <[Oh! Guarda che ti rompo questa in testa]>! 33 ROMOLO: (a Marisa, rompendo la stampella) <E tu/ lèvati di mezzo>! 34 ANNAMARIA: <[…]! [Fate presto]/ e andatevi a lavare! Che sono le nove passate! E noi dobbiamo fare i letti>! 35 MARISA: (a Romolo) <Ma vattene/ va’>! 36 SALVATORE: (a Romolo) <’Sto sbruffone>! 37 ROMOLO: (a Salvatore) <Ma cammina/ cammina/ va’>! 38 ANNAMARIA: (a Salvatore) <Fila>! 39 MARISA: (a Romolo) <Va’>! 40 ANNAMARIA: Siete peggio di due ragazzini! (a Marisa, dopo che Romolo e Salvatore sono usciti) Vuoi scommettere/ che hanno litigato per quella stupida di ieri sera? 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 445 41 MARISA: Ma non potrébbero/ una volta/ litigare per noi? (tirandosi su i capelli e guardandosi allo specchio) Di’/ se mi pettinassi così/ credi che Salvatore si accorgerébbe/ di me? 42 ANNAMARIA: Non ti illudere// L’altro giorno mi sono messa un po’ di rossetto// Lo sai che m’ha detto/ Romolo? (artefacendo la voce) “Che/ hai mangiato la pasta al sugo”? SCENA 21: Romolo, Salvatore, sarto, ragazzo. Piazza Navona e sartoria. Esterno–interno, mattina. 1 ROMOLO: Se ragionavi/ non era meglio? Invece di saltarmi addosso/ come un matto? Adesso mi dai/ ragione? Ti sei/ <convinto>? 2 SALVATORE: <Ho capito>/ ho capito// 3 ROMOLO: Salvatore// Fammi vedere/ che sei un uomo// L’hai detto tu stesso/ che non l’avresti più guardata in faccia// Cammina! Voglio vedere/ se sei capace/ di passare davanti al negozio di Giovanna/ senza guardarci dentro// Su/ bello/ va’! (mentre Salvatore passa davanti alla sartoria di Giovanna, parandosi l’occhio destro con la mano e tuttavia sbirciando nel negozio) Dammi ’sta soddisfazione! Fammi vedere che cj ho un amico dritto! (Romolo fa cenno a Salvatore di andarsene e poi entra nella sartoria) Giovanna? Giovanna! (vedendo il sarto) Buongiorno// 4 SARTO: Buongiorno// Se è venuto per il vestito/ prima di due giorni non glielo posso provare// Se invece è venuto per mia figlia/ m’ha detto che andava a combrare un disco// 5 ROMOLO: Ah sì? Grazie infinite// Buongiorno// 6 SARTO: Buongiorno// 7 RAGAZZO: (indossando una giacca visibilmente troppo grande) De spalle/ me sta bene// È de manica/ ch’è un po’ lunga// 8 SARTO: No// Hm… perché? Eh/ vedi? Hm// Ah/ qui? Eh/ ma qua… hm… (dando un morso sulla spalla della giacca del ragazzo) Eh/ vedi? No/ la manica è giushta// Sei tu/ che sei corto! 9 RAGAZZO: Io? 10 SARTO: Hm// 446 Il linguaggio cinematografico SCENA 22: Romolo, Giovanna, zio, donna. Negozio di dischi. Interno, mattina. 1 ROMOLO: Buongiorno// 2 GIOVANNA: Buongiorno// 3 ROMOLO: Zio/ la signorina la servo io// 4 ZIO: La signorina/ è già servita// (a Giovanna, prendendo i soldi) Grazie// (guardando la banconota datagli da Giovanna) Ma queste sono le cinquemila lire mie! 5 ROMOLO: E come hai fatto a riconoscerle?! 6 ZIO: Ma come?! Cj ho scritto il numero di telefono di un’amica mia// Guarda// 7 ROMOLO: Ma guarda/ tante volte/ <che giro fanno/ i soldi>! 8 ZIO: <Sì// A te te lo faccio fà io>/ il giro/ te lo faccio fare! (a Giovanna) Ecco il resto/ signorina// (a Romolo) Poi facciamo i conti/ noi due/ eh? <Sì>// 9 ROMOLO: <E sta’ bono/ zio>! Non me fà fà ste figure! Tanto te le prendi <sulla settimana>! 10 ZIO: <Fila! Vai a prendere il camioncino della pubblicità/ che già hai fatto tardi! Cammina>! 11 ROMOLO: <E va bene/ vado// E vado/ vado>! 12 ZIO: (a Romolo) Va’! (a Giovanna) Hm! Quella è l’età più shtupida/ per un uomo! 13 GIOVANNA: Eh/ certo che all’età sua/ stupidaggini se ne fanno poche// Buongiorno e arrivederla// 14 DONNA: Ce l’avete/ nu bello disco de musica allegra? 15 ZIO: Musica allegra? È finita/ la musica allegra// È finita! SCENA 23: Romolo, Giovanna, donna. Strada. Esterno, mattina. 1 ROMOLO : (a bordo di un furgoncino con altoparlante, parlando al microfono) Giovanna? Giovanna! E sali/ su! Ma sei ancora in colle- 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 447 ra per ieri sera? Giovanna! Facciamo pace/ su! Hai proprio un cuore di sasso! E su! Dai! Non fare la cattiva! Facciamo pace! 2 GIOVANNA: Uff! 3 ROMOLO: Giovanna! 4 DONNA: E fate pace! Che all’età sua/ pe non avé fatto pace/ io me so’ pentita! 5 ROMOLO: Brava/ signora// Grazie// E su/ sali! Dai! (dal furgoncino si sente una musica. Giovanna sale) Attenzione/ attenzione! Questo disco/ è in vendita da Mario Frutti// La radio per tutti! SCENA 24: Romolo, Giovanna. In riva al mare. Esterno, giorno. 1 ROMOLO: (dopo aver baciato Giovanna) Di’ un po’/ ma quanti ne hai baciati/ prima di me? 2 GIOVANNA: Te l’ho detto/ no? Gianni// Renato/ Franco… hmhmhm… quello di Fregene/ e basta// 3 ROMOLO: E Salvatore? 4 GIOVANNA: Ah/ già// Pure Salvatore// 5 ROMOLO: Non avevi nominato un certo Ugo? GIOVANNA: Ugo sì// Ma Ugo/ era un’altra cosa// 7 ROMOLO: Perché? 8 GIOVANNA: Intanto/ era il nostro tagliatore// 9 ROMOLO: Ah// 10 GIOVANNA: E poi… 11 ROMOLO: E poi? 12 GIOVANNA: E poi/ gli ho voluto bene sul serio// 13 ROMOLO: Ma chi era? Quello che cj avevi la fotografia al negozio? 14 GIOVANNA: Sì// 15 ROMOLO: Il cocomero tuo// 16 GIOVANNA: Ci volevamo bene/ come due matti// Ogni volta che lo vede- 448 Il linguaggio cinematografico vo/ mi tremavano le gambe// Lui mi voleva sposare// Diceva che non avrèbbe potuto vivere/ senza di me// E invece campa/ e/ sta benone// 17 ROMOLO: M’hai fatto venì una malinconia/ co ’sta storia di Ugo// Vieni qui// Te li faccio passare io/ sti pensieri// Lo sai ch’è mezz’ora che stiamo qui/ e ancora non è passato nessuno? 18 GIOVANNA: (mentre Romolo prova a baciarla) E mica era bello! Ma cj aveva certi occhi verdi… 19 ROMOLO: Come i miei// 20 GIOVANNA: Ma tu ce li hai neri! 21 ROMOLO: Sì/ ma… quando faccio l’amore/ mi diventano verdi// 22 GIOVANNA: Mi sa che oggi ti rimangono neri// Andiamo// Sennò facciamo tardi// 23 ROMOLO: E mo mi lasci così? Con un occhio nero e un occhio verde? E mi prenderanno per un gatto siberiano! (Giovanna ride) Mannaggia! Era cominciata così bene/ ’sta giornata! SCENA 25: Boccio, ragazzi 1 e 2, Salvatore, tre bambini. Strada. Esterno, giorno. 1 BOCCIO: (a bordo di una lambretta) Salvatore? Vòi ’n passaggio? 2 RAGAZZO1: (sulla lambretta) Ma che cj hai? Tutta la mattina co le buggere? 3 BOCCIO: E monta/ no? 4 SALVATORE: E lasciatemi perdere! Mi va d’andare solo/ <mi va>! 5 RAGAZZO2: <E va be’>/ lasciamoo perde// Cj avrà i pensieri/ <no>? 6 BOCCIO: <E che vi credete>/ che quando ci si mette/ è capace pure di pensare! (risate) 7 ROMOLO (a bordo del furgoncino, con Giovanna, parlando all’altoparlante) Giovanna/ lo griderei a tutta Roma/ che ti voglio bene// 8 GIOVANNA: Oh/ ma ti sei ammattito? Hai lasciato aperto il coso! Qua/ ti sentono tutti! 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 449 9 ROMOLO: E mbeh? Tutta Roma deve sapere/ che Romolo Toccacceri vuole bene a Giovanna// (passando con il furgoncino vicino a Salvatore) Tutta Roma/ lo deve sapere! Alla faccia di Salvatore! 10 SALVATORE: Ah! (rincorrendo il furgoncino) 11 ROMOLO: (parlando all’altoparlante, con una musica di sottofondo) Questo disco è in vendita/ da Mario <Frutti// La radio per tutti>! 12 BAMBINO: (trovando la scarpa che Salvatore ha perso correndo) <La scarpa>! 13 BAMBINO: (giocando a pallone con la scarpa di Salvatore) <Passa>! 14 BAMBINO: <All’ala>! 15 BAMBINO: <Passa>! 16 SALVATORE: <A disgraziati>! E dateme ’l mocassino mio! (rimettendosi la scarpa) A Romolo/ quanno t’acchiappo/ te faccio stà al letto na settimana! SCENA 26: Salvatore, Alvaro, Cecilia, ragazzi, Boccio, Annamaria. Casa di Salvatore. Interno, giorno. 1 SALVATORE: (a letto, vicino al letto di Alvaro, con la testa fasciata con una sciarpa) Ma proprio a me/ mi dovevi attaccare gli orecchioni? Non cj avevi/ un parente più prossimo? 2 ALVARO: (togliendosi il termometro di bocca e leggendolo) Trentasette e cinque// Va bene! Sono quasi guarito! Meno male// (passando il termometro a Salvatore) Tiè// 3 SALVATORE: Ti può venire una ricaduta// 4 ALVARO: A chi?! (vedendo che Salvatore mette il termometro sotto la coscia) Ma perché non te lo metti sotto la lingua? Piglia meglio/ la febbre// 5 SALVATORE: Io lo metto come m’ha insegnato mamma// 6 CECILIA: (entrando nella camera) Salvatore/ ce so’ sti cinque <sciagurati>// (commenti indistinti dei ragazzi) 7 RAGAZZO: <[Eh/ Salvató]>// 450 Il linguaggio cinematografico 8 RAGAZZO: <Ciao Salvatore// Come [stai]? Eh>// 9 ALVARO: <Eh? Ah>! 10 BOCCIO: <Facciamo presto>// Un minuto solo/ sora Cecì! 11 CECILIA: E mo ricominciamo a fare piazza d’Armi/ qui?! Peccato/ che non è più contagioso! Andiamo/ su! 12 RAGAZZO: Ahó/ me sembri ’n ovo de Pasqua! 13 BOCCIO: Salvató/ ti ’i sei beccati pure te/ l’orecchioni/ eh? 14 RAGAZZO: Na brutta malattia/ <sa’>?! 15 RAGAZZO: <’O sai> che se sfoga male hai chiuso/ <sì>? 16 RAGAZZO: <Le donne>/ te le scordi! 17 SALVATORE: E chi se le ricorda più/ le donne? Sono dieci giorni/ che sto così! 18 RAGAZZO: E mbeh/ ma ora sei guarito// Perché non t’alzi? (alcuni ragazzi si siedono sul letto di Alvaro) 19 ALVARO: Dico/ ragazzi! Senza complimenti! Se vi volete mettere a letto con me/ fate pure! Selvaggi! Non avete un briciolo d’educazione! 20 RAGAZZO: <E lèvete/ va’>! 21 RAGAZZO: <[…]>! 22 ANNAMARIA: (entrando con un bicchiere) Salvatore! Ha detto mamma/ che te la devi bere tutta// 23 RAGAZZO: La medicina! 24 RAGAZZO: Buona! 25 BOCCIO: Ahó! ’O sai che tu sorella s’è fatta carina? Tra du anni/ è bona pure subbito! (risate) 26 RAGAZZO: Finalmente abbiamo un amico che cj ha na sorella bona! 27 BOCCIO: Era ora! 28 RAGAZZO: Eh! 29 RAGAZZO: (dopo essersi affacciato alla finestra) Salvatore/ sono arrivati Romolo e Giovanna! 30 TUTTI: Ahó! 31 RAGAZZO: E mbeh// 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 451 32 RAGAZZO: Eh// 33 RAGAZZO: Sono entrati adesso nel portone! 34 SALVATORE: (tirandosi su di scatto e gridando) Ah! 35 BOCCIO: <Ch’è successo>? 36 ALVARO: <Che è>? 37 SALVATORE: Il termometro! (si toglie il termometro) 38 ALVARO: Te l’avevo detto/ de mettelo sotto la lingua! 39 SALVATORE: Ma che/ stanno salendo? 40 RAGAZZO: Sì// Se t’ho detto che vengono su! 41 SALVATORE: Ma/ a Romolo gliel’avete detto/ che non lo voglio più vedere? 42 BOCCIO: E che ne so? Se vede ch’è venuto pe fà pace! 43 SALVATORE: E Giovanna/ che viene a fare? 44 RAGAZZO: So’ dieci giorni che ’n te fai vede/ te verrà a trovà// 45 SALVATORE: Ma mannaggia! Ma mica la posso ricevere così! Scusatemi/ sor Alvaro/ <ma ho visite! Andatevene tutti di là/ e portatevi via questo/ che ingombra! Abbiate pazienza/ sor Alvaro>// 46 ALVARO: <Che è// Ahó>! (mentre i cinque ragazzi sollevano di peso tutti insieme il letto con Alvaro sopra) <Ma che fate/ ahó?! Ma che/ siete pazzi?! Do’ me portate>?! (battute sovrapposte e confuse dei cinque ragazzi) 47 RAGAZZO: <Ahó>! 48 BOCCIO: <Apri! [Sbrìgate]>! 49 RAGAZZO: <[Calma/ calma]>! 50 RAGAZZO: <La testa/ sor Alvà>! 51 BOCCIO: <[…] a le corna! Attento/ sor Alvà>! 52 RAGAZZO: <Forza>! 53 RAGAZZO: <Via>! 54 ALVARO: <Oh Dio/ casco! Fuorilegge! Ma che ne so/ do’ me portano! Io ’n ce capisco… Ahó>! 55 ANNAMARIA: <Ma che succede>?! 452 Il linguaggio cinematografico 56 BOCCIO: C’è Giovanna che viene a trovare Salvatore! 57 RAGAZZO: Ecco! [Annamo]! 58 BOCCIO: Attento! 59 RAGAZZO: Calma! Non spignete! Calma! 60 BOCCIO: Apri la porta! Calma/ ragazzi! 61 RAGAZZO: Dai/ entramo tutti! <[State calmi]>! 62 BOCCIO: <Dai/ dai>! SCENA 27: Giovanna, Romolo, padre. Pianerottolo di casa di Romolo e Salvatore. Interno, giorno. (Annamaria apre la porta di casa e vede Romolo e Giovanna, sul pianerottolo, che stanno suonando il campanello di casa di Romolo) 1 GIOVANNA: Ma/ non ce le hai/ le chiavi? 2 ROMOLO: Così avverto che siamo arivati// Vedrai che ti piacerà/ papà// È tanto buono// Cj ha una pazienza/ che si farèbbe schiacciare una noce in testa// (al padre che ha aperto la porta) Papà/ questa è Giovanna// 3 PADRE: Ah/ s’accomodi/ s’accomodi// 4 ROMOLO: (al padre, sottovoce) Papà/ te potevi mette la cravatta// 5 PADRE: E già/ mo mi mettevo la cravatta sul pigiama! SCENA 28: Salvatore, Annamaria, ragazzi, Boccio, Alvaro, fratello di Salvatore. Casa di Salvatore. Interno, giorno. 1 SALVATORE: (dopo aver sentito bussare alla porta) Avanti// (ad Annamaria che entra) Ma che aspetti? Falli entrare/ no? 2 ANNAMARIA: Sono già/ entrati! Ma a casa di Romolo! 3 SALVATORE: Che dici?! 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 453 4 ANNAMARIA: L’ha portata a casa sua/ per farla conoscere a suo padre// 5 RAGAZZO: (entrando nella camera di Salvatore) Avanti/ ragazzi! Forza! (i ragazzi trasportano Alvaro nella camera di Salvatore. Battute sovrapposte e confuse) 6 RAGAZZO: Dai/ tira! 7 RAGAZZO: Oh! 8 ALVARO: Oh Dio! 9 RAGAZZO: <Forza>! 10 RAGAZZO: <Oh>! 11 RAGAZZO: <Attenti/ su>! Sotto! Piano/ ragazzi! Piano! 12 ALVARO: (ad un ragazzo) Ridi/ ridi! <[Mannaggia]>! 13 RAGAZZO: <Avanti>! 14 RAGAZZO: <Giràte adesso/ là! Giràte>! 15 BOCCIO: Giràte! 16 RAGAZZO: Attenti/ attenti! […]! 17 ALVARO: Dishgraziati vigliacchi! 18 RAGAZZO: […] lo tengo io! 19 RAGAZZO: Ve ’a sete fatta/ ’a scarozzata/ eh? 20 RAGAZZO: Anvedi! 21 RAGAZZO: Eh// 22 FRATELLO: (bevendo dal bicchiere di Salvatore) Oh/ è buona! 23 SALVATORE: E danne un po’ anche a tuo fratello/ no? SCENA 29: padre di Romolo, Giovanna, Romolo, Marisa. Casa di Romolo. Interno, giorno. 1 PADRE: Sicché vi siete fidanzati/ eh? 2 GIOVANNA: Beh// 3 PADRE: Bravi/ bravi// Mi fa piacere// E me lo siete venuti a dire? Avete 454 Il linguaggio cinematografico fatto bene// Del resto io sono il padre// Vi posso dare un consiglio/ no? Anzi/ se lei permette/ avrei da dirgli una parola// 4 GIOVANNA: Dica/ dica// 5 PADRE: Non a lei// A lui// Al mio figliolo// Viè un po’ qua/ Romolo// 6 ROMOLO: Ma che vuoi? 7 PADRE: Senti// (Romolo e il padre escono dalla stanza, lasciando sole Giovanna e Marisa) 8 MARISA: (a Giovanna che guarda un ritratto) Quello è papà da giovane// 9 GIOVANNA: Ah! SCENA 30: padre di Romolo, Romolo, Giovanna, Marisa, fattorino. Casa di Romolo. Interno, giorno. 1 PADRE: Scusa una <domanda>/ 2 ROMOLO: <Ss>! 3 PADRE: ma tu m’hai preso proprio per quello che ti regge il moccolo? 4 ROMOLO: Ma che dici/ <papà>?! 5 PADRE: <Eh>! So’ tre volte/ che me porti a casa una ragazza/ e dici che ti sei fidanzato! 6 ROMOLO: Ma questa è quella buona! 7 PADRE: Ma per essere bone/ erano bone tutte! Ma ce vole pure un po’ de discrezione! Se ogni volta che vedi una ragazza/ le dici/ “ti presento papà”! In ogni modo/ stavolta/ in camera di tuo <padre/ tu non ci metti piede! Siamo intesi>? 8 ROMOLO : <Va be’// Va be’// Va be’>// (tornano da Giovanna e da Marisa) 9 PADRE: (a Giovanna) Ci scusi/ eh? Ma gli ho voluto chiedere la portata dei suoi sentimenti// Eh/ sono il padre! 10 ROMOLO: (indicando a Giovanna il ritratto del padre) Giovanna/ vedi/ quello è papà da giovane// 11 GIOVANNA: Sì/ lo so// Ti rassomiglia// (al padre di Romolo) In bello/ naturalmente// 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 455 12 PADRE: Lei scherza! Mi doveva vedere a vent’anni! Lo sa che nella traversata del Tevere a nuoto… 13 MARISA: Papà/ ci racconti un’altra volta la storia del crampo?! 14 ROMOLO: Marisa/ dacci da bere qualche cosa/ su! Va’ a prendere un po’ di vermut// 15 MARISA: Il vermut è finito// 16 ROMOLO: Ah/ è finito! Allora sai che gli diamo/ a Giovanna? La bottiglia di Lacrima Christi// Quella che ti diede padre Pellegrino// 17 PADRE: Romolo/ lo sai che quella bottiglia non si può aprire// Che è della povera mamma tua// 18 ROMOLO: E dai! Mamma è contenta/ se te la bevi! E poi oggi è il giorno adatto/ scusa// Mi sono fidanzato// (a Giovanna, dopo aver preso la bottiglia) Devi sapere/ che questa bottiglia/ ha una storia// Lo vedi/ papà se n’è andato/ perché/ quando la sente/ si commuove// Gliela regalò padre Pellegrino quando si sposarono// E gli disse/ “con questa/ ci dovete fare le nozze d’argento/ e le nozze d’oro”// Cioè/ un bicchiere ogni venticinque anni// 19 PADRE: (davanti alla gabbia dei canarini) Ci// 20 ROMOLO: Poi/ mamma è morta/ e la bottiglia è rimasta chiusa// 21 GIOVANNA: Lo vedi che tuo padre cj ha più cuore di te? Ma non ti potevi risparmiare/ questa cattiveria? 22 ROMOLO: (assaggiando il contenuto della bottiglia) Ma questa è acqua! Hai capito?! S’è bevuto pure la bottiglia di padre Pellegrino! E s’è preso il disturbo di ritapparla! Mo gliene dico quattro! 23 GIOVANNA: No/ adesso non lo mortificare! Lascialo stare/ poveretto// 24 ROMOLO: Chi?! Quello se mortifica?! Si vede/ che lo conosci poco! 25 PADRE: (davanti alla gabbia dei canarini) Cicì// Cicì// <Cicì>// 26 ROMOLO: <Senti/ Marisa/ va’ da Annamaria>// Fatti prestare un po’ di vermut// Va’/ bella/ va’// 27 PADRE: Cicì// Cicicì// Cicì// 28 ROMOLO: Sì/ <“cicì/ cicicì”>// 29 MARISA: (urlando dall’altra stanza) <Papà>! 30 PADRE: Eh! Che c’è? Vengo! 31 ROMOLO: Hai visto/ che figure mi fa fare/ quello?! 456 Il linguaggio cinematografico 32 FATTORINO: (alla porta, al padre di Romolo) C’è ’sto pacco pe voi// È un vestito// (dopo aver risuonato alla porta) E la mancia? 33 PADRE: Se non me la chiedevi/ te la davo// 34 FATTORINO: Ma va’! 35 PADRE: (tornando in soggiorno e vedendo Romolo e Giovanna che si baciano) Bravi/ bravi! Ci fosse stata questa libertà/ ai miei tempi! 36 ROMOLO: Papà/ che è ’sto pacco? 37 PADRE: Scommetti/ che il condominio s’è deciso a farmi la divisa da portiere? 38 ROMOLO: (scartando il pacco) Ma questo è il vestito mio! (a Giovanna) Che bravi! Già l’avete finito? 39 GIOVANNA: Eh// 40 PADRE: Che/ devi andà a qualche veglione? 41 ROMOLO: Papà/ questo è un vestito come se ne fanno pochi// 42 PADRE: Eh/ lo credo! 43 GIOVANNA: E perché? Non gli piace? 44 PADRE: Eh! 45 ROMOLO: Ma scusa/ un vestito così/ solo gli inglesi/ lo sanno portare! 46 PADRE: Hai ragione// Che/ sei inglese/ tu? 47 ROMOLO: Beh/ io non sono niente/ ma me lo vado a misurare// Scusate// 48 PADRE: Scusi/ gliel’ha fatto papà suo/ quel vestito? 49 GIOVANNA: Sì// 50 PADRE: E a papà suo/ chi glielo paga? 51 GIOVANNA: Ah/ chi lo paga/ non lo so// Io/ la fattura l’ho portata// (dà al padre di Romolo la fattura) 52 MARISA: E Romolo? 53 PADRE: Eh/ sta di là// (leggendo la fattura) Che lo possino amma… 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 457 SCENA 31: Romolo. Casa di Romolo. Interno, giorno. 1 ROMOLO: (provandosi il vestito davanti allo specchio) Gagliardo/ ’sto vestito! Ma chi è/ ’sto bel ragazzo?! Che fisico/ oh! (togliendo alcune mattonelle dal pavimento sotto al letto) Sta’ a vedere/ che ha cambiato mattonella un’altra volta// (trovata la mattonella giusta, prende dei soldi) Solo a titolo di prestito/ eh? SCENA 32: ragazzi, Boccio, Salvatore, Romolo, Alvaro. Balcone e camera di Salvatore. Esterno–interno, giorno. (I cinque amici di Salvatore, affacciati al balcone, guardano una ragazza in sottoveste nel palazzo di fronte. Commenti sovrapposti e confusi) 1 RAGAZZO: <Anvedi che [robba]>! 2 RAGAZZO: <Guarda […]>! 3 RAGAZZO: <E chi l’ha vista mai/ na cosa del genere>? 4 RAGAZZO: <Che bella>! 5 RAGAZZO: <Quanto me piace>! 6 RAGAZZO: Anvedi! 7 RAGAZZO: <[…]>! 8 RAGAZZO: <Ahó>! 9 RAGAZZO: <È mejo lei/ che na boccia d’acqua ner deserto/ ahó>! 10 RAGAZZO: <Ahó>! E tìrete là! Famme vedé <[quarcosa]>! 11 BOCCIO: <Io ci vado>! 12 RAGAZZO: <Vojo vedé>// 13 RAGAZZO: <Ndo vai>? 14 BOCCIO: Io scavalco// 15 RAGAZZO: Ma vai de sotto/ no? 16 BOCCIO: Io faccio <le pazzie! Mamma mia>! 17 RAGAZZO: <Guarda che robba>! 458 Il linguaggio cinematografico 18 BOCCIO: Marilina! 19 RAGAZZO: <Che robba/ ragà>! 20 BOCCIO: <Cj ha quelle labbra>! 21 RAGAZZO: Che è? 22 RAGAZZO: <[Mamma mia]>! 23 BOCCIO: <Cj ha quelle labbra>/ che sembra <na negra>! 24 RAGAZZO: <Cj ha… E cj hai raggione/ cj hai raggione>// 25 RAGAZZO: <Ma guarda quant’è bona>! 26 BOCCIO: Mannaggia! 27 RAGAZZO: Ah! (la ragazza si è sottratta alla vista dei cinque) 28 RAGAZZO: Che fa?! 29 BOCCIO: Quadro! 30 RAGAZZO: Ahó/ ndo vai?! 31 BOCCIO: [Ndo va]?! 32 RAGAZZO: (vedendo Romolo sul balcone) Ahó! Guardate un po’/ chi ariva! 33 BOCCIO: A Romolo/ ma che te sei messo/ addosso?! 34 RAGAZZO: Pari ’n ergastolano! 35 RAGAZZO: Non je potevi fà/ un pajo de calzoni a la zuava?! 36 RAGAZZO: Salvatore/ vieni a vedere// Il fidanzato de Giovanna s’è fatto er vestito novo// 37 RAGAZZO: A manichino! 38 RAGAZZO: Anvedi che […]! 39 RAGAZZO: Ma che/ ha spojato un pupazzo?! 40 RAGAZZO: Ma guarda che robba! 41 ROMOLO: A poveracci! Morti di fame! Vi piacerèbbe/ avere un vestito come questo! Potreste andare in giro a testa alta! 42 BOCCIO: A Romolo/ mo/ quando vai alla toletta/ puoi entrare dove c’è scritto “signori”! (risate, poi entrano in camera di Salvatore) A Salvató/ se quello s’è fatto un vestito così per fidanzarsi/ figuriamoci il tuo/ quando gli farai da testimone alle nozze! 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 459 43 RAGAZZO: Non vorai mica fà brutta figura co Giovanna?! 44 RAGAZZO: Eh/ certo che ’sto Romolo/ te sta proprio a sfotte/ eh? 45 RAGAZZO: Te frega la regazza/ e se fidanza a casa! 46 SALVATORE: (spingendo tutti i ragazzi fuori dalla porta) Ma ve ne volete andare?! Lo volete capire/ che <m’avete stufato>?! 47 TUTTI: <Oh>! 48 BOCCIO: <[E calma]>! 49 SALVATORE: <Fuori/ fuori>! 50 BOCCIO: (uscendo) <Càlmati>! 51 RAGAZZO: (uscendo) <[E piano]>! 52 BOCCIO: (rientrando) E non morire/ di notte! 53 SALVATORE: Ah! 54 ALVARO: Oh// Sia ben chiaro/ e dillo pure a mamma tua/ io/ questo mese/ la pigione non la pago/ eh! 55 SALVATORE: E perché? 56 ALVARO: Perché m’avete rotto le scatole! Te/ e tutti gli amici tuoi! Va bene?! (a Salvatore che si è alzato) E do’ vai/ adesso? 57 SALVATORE: Vado a vedere/ se mi trovo pure io una fidanzata// 58 ALVARO: Ma sono le cinque// Ancora è chiuso// SCENA 33: VFC, camerieri 1, 2 e 3, cliente, uomini 1, 2 e 3, Romolo, Giovanna, donne 1 e 2, Leonetto, Ugo, fidanzata di Ugo. Tutti i camerieri sono vestiti da antichi romani. I camerieri 2 e 3 sono due dei cinque ragazzi amici di Romolo e Salvatore. Ristorante all’aperto Antica Roma. Esterno, notte. 1 VFC UOMO: Un tavolo per quattro? Si accomodi// 2 CAMERIERE1: (ad una coppia di clienti) Buonasera/ dottore// 3 CLIENTE: Ah/ ciao/ caro// 4 CAMERIERE1: Prego// 460 Il linguaggio cinematografico 5 CLIENTE: (rivolgendosi a nessuno in particolare) Ciao// 6 ROMOLO: (seduto ad un tavolo, con Giovanna) Hai visto/ in che bel posto t’ho portata? Ti piace? 7 GIOVANNA: Sì// Ma tu ce l’hai/ i soldi? 8 ROMOLO: Certo/ che ce l’ho// E poi voglio vedere/ se questi amici miei non mi fanno lo sconto! 9 CAMERIERE2: Per chi è/ ’sto pollo? 10 CAMERIERE3: Per Romolo e Giovanna// 11 CAMERIERE2: E tu glielo porti? Se io fossi in te/ ci penserei due volte// 12 CAMERIERE3: (portando il pollo a Romolo) Hai ordinato pollo? 13 ROMOLO: Eh// 14 CAMERIERE2: Ma ce l’hai/ i soldi? 15 ROMOLO: Sì/ ce l’ho// 16 CAMERIERE3: Fammeli vedere? 17 ROMOLO: (mostrandogli i soldi) Tiè// 18 CAMERIERE3: Va bene// (gli dà il pollo) 19 GIOVANNA: (faticando a tagliare il pollo) Oh/ ma pure questo pollo/ è antico romano? 20 ROMOLO: Giovanna? (facendo un brindisi) Al nostro amore// 21 GIOVANNA: Sta’ attento a non sporcarti il vestito// Che ancora non l’hai pagato// 22 UOMO1: Ma era proprio lui? 23 DONNA1: Ma sì// Li ho visti// 24 ROMOLO: Questa/ è la vita che mi piacerèbbe fare// Senza pensieri/ e con un sacco di soldi// Pensa come sarèbbe bello/ se uno di questi ricconi mi adottasse// Lo sai che a un amico mio/ gli è andato a casa il principe Alfieri/ e l’ha adottato? E adesso fa il signore// Come mi piacerèbbe/ andare da papà e dirgli/ “papà/ il principe Alfieri/ mi vuole per figlio”// Che bella soddisfazione/ gli darei! 25 LEONETTO: (avvicinandosi a Giovanna e sedendosi al tavolo) Giovanna! 26 GIOVANNA: Leonetto! 27 LEONETTO: Eh/ chi si rivede? Ma dov’eri andata a finire? 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 461 28 GIOVANNA: Ho cambiato quartiere/ no? 29 LEONETTO: Ah/ sì// Apposta/ non ti trovavamo più// E noi/ dagli a telefonarti! Lo sai chi c’è/ al nostro tavolo? 30 GIOVANNA: Eh// 31 LEONETTO: Gianni con la moglie/ Renata/ e Ugo con la fidanzata// Te lo ricordi/ Ugo/ eh? 32 GIOVANNA: E che mi importa/ di Ugo? 33 LEONETTO: (girandosi verso Romolo, dopo averlo ignorato ed aver continuato a spingerlo durante tutto il dialogo con Giovanna) Eh/ scusi/ sa// Scusi tanto// 34 GIOVANNA: Con chi s’è fidanzato? 35 LEONETTO: Con la sorella di Quirino// Se ti volti/ la vedi// Ecco/ si stanno sedendo adesso// Quella bionda// (Giovanna si volta e vede Ugo e la fidanzata che si stanno sedendo al tavolo) 36 FIDANZATA: (a Ugo) E su! Non cominciare a fare il difficile! (alle amiche, sedendosi al tavolo) Ciao// 37 AMICA: Ciao/ Ugo// 38 UGO: Scusateci/ eh? 39 GIOVANNA: S’è fidanzato con quella? Uh/ che brutti gusti/ che gli sono venuti! 40 LEONETTO: Eh/ una volta/ cj aveva buon gusto/ eh? 41 GIOVANNA: Hm// 42 ROMOLO: Come si chiama/ ’st’amico tuo? 43 LEONETTO: Eh/ scusi/ non mi sono presentato// Leonetto Berselli// 44 ROMOLO: A Leonetto Berselli! (gli fa cenno con la mano d’andarsene) 45 GIOVANNA: (ridendo) Beh/ ciao/ Leonetto// 46 LEONETTO: Eh/ ciao/ Giovanna// Dopo/ passi a salutarci/ al nostro tavolo? 47 GIOVANNA: Sì/ sì// 48 LEONETTO: (dando uno schiaffetto sulla nuca a Romolo) Piacere// (torna al suo tavolo e lo si vede parlare animatamente con Ugo) 462 Il linguaggio cinematografico 49 ROMOLO: Chi sarèbbe/ ’sto Leoncino? 50 GIOVANNA: Un vecchio amico// 51 ROMOLO: Cj ha na bella faccia da stupido! 52 GIOVANNA: Leonetto è un ragazzo molto intelligente/ se lo vuoi sapere! E ha pure la laurea di dottore// 53 ROMOLO: Capirai quanti fessi/ cj hanno la laura! 54 GIOVANNA: E glj hanno offerto un posto in America del Sud// 55 ROMOLO: Sì! A raddrizzar banane! 56 GIOVANNA: Quanto sei ignorante e cafone! 57 ROMOLO: Ma mo che fai? T’arrabbi? Non posso sfottere gli amici tuoi? 58 GIOVANNA: E io li sfotto/ i tuoi? (guardando i camerieri) Ma guardali un po’! Cj hanno certe gambe/ che sembrano fichi d’India! 59 UOMO2: (al tavolo vicino) Ma tu ce l’hai/ le mutande? 60 DONNA2: (c.s.) Ma Roberto! 61 ROMOLO: Ah! Tu giudichi un uomo dalle gambe! (Giovanna guarda verso il tavolo di Ugo, Leonetto la saluta con la mano e le fa cenno di unirsi a loro, Ugo la guarda, Giovanna saluta con la mano e fa cenno, alzando le spalle e guardando Romolo, di non potere per via del proprio compagno. Romolo assiste a tutta la scenetta) 62 UGO: (alla fidanzata) E mangia! 63 FIDANZATA: Ma ti guardavo soltanto! 64 UGO: E pensa a mangiare! 65 FIDANZATA: Uffa! 66 ROMOLO: A chi hai fatto/ così? (imitando il gesto del saluto) 67 GIOVANNA: A Ugo// 68 ROMOLO: E che voleva dire/ quella mossa delle spalle? 69 GIOVANNA: Niente// Voleva dire/ che al tavolo loro non ci vado// 70 ROMOLO: No/ voleva dire che non ci vai/ perché stai con me// Ma se stavi sola/ cj andavi// 71 GIOVANNA: Che ragionamenti! 72 ROMOLO: Beh/ allora/ sai che ti dico? Se ci vuoi andare/ da Ugo/ vacci! Che io non ti tengo! 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 463 73 GIOVANNA: Senti/ Romolo/ se non la pianti/ m’alzo/ e me ne vado! (tutti dal tavolo di Ugo hanno sentito le urla di Romolo e Giovanna) 74 ROMOLO: Provaci/ e non mi vedi più! (Giovanna se ne va dal ristorante e Romolo fa per seguirla) 75 CAMERIERE3: (a Romolo) Beh? Te ne vai? (Romolo lo paga) 76 UOMO3: (vestito da auriga romano, appena fuori dal ristorante) Biga// Biga/ signore// <Biga>// 77 ROMOLO: <Ma che biga>! Giovanna! Giovanna/ non lo faccio più! Te lo prometto! Giovanna! SCENA 34: Romolo, Giovanna. Strada. Esterno, notte. 1 ROMOLO: Allora/ non vuoi far pace? 2 GIOVANNA: No! 3 ROMOLO: E facciamo pace! 4 GIOVANNA: No! 5 ROMOLO: Sì! 6 GIOVANNA: No! 7 ROMOLO: Sì! 8 GIOVANNA: No! (si baciano) Perché/ hai fatto così lo stupido/ stasera? 9 ROMOLO: Ti stavi a far notare da tutti! Guardavi in giro! Ridevi! Adesso sei fidanzata/ no? 10 GIOVANNA: Ah/ perché quando una è fidanzata/ ha finito di ridere? 11 ROMOLO: Ma no/ Giovanna/ che fai? Adesso t’arrabbi un’altra volta? Giovanna! Lo sai che ancora non m’hai fatto vedere casa tua? Mi fai salire? (Giovanna lo guarda con ironia) E adesso che hai capito? Io volevo solo vedere casa tua! Vedere se hai qualche mobile/ che può servirci/ quando siamo sposati// 12 GIOVANNA: Non ci pensare/ ai mobili/ Romolo// È presto// Casa mia/ te la faccio vedere di giorno// Quando papà è sveglio// 13 ROMOLO: Senti/ Giovanna// Perché non andiamo al negozio a sentire i dischi? Sono arrivati certi dischi meravigliosi// 464 Il linguaggio cinematografico 14 GIOVANNA: Ho sonno// 15 ROMOLO: Solo cinque minuti// 16 GIOVANNA: Anche i dischi/ è meglio <che li sentiamo di giorno>// 17 ROMOLO: <Beh/ io ti aspetto>// Se cambi idea/ bussi alla saracinesca/ e t’apro// 18 GIOVANNA: Va be’// Aspettami// 19 ROMOLO: Ciao// 20 GIOVANNA: (entrata nel palazzo, tra sé) Aspetta/ aspetta! (Romolo, rimasto solo, salta e balla in mezzo a piazza Navona) SCENA 35: Giovanna, sarto, Salvatore, Romolo. Casa di Giovanna e negozio di dischi. Interno, notte. 1 GIOVANNA: Papà! Ancora alzato? Ma che fai? Lavori? 2 SARTO: Ah/ vieni/ vieni// C’è una bella sorpresa/ per te// Sai/ quando m’hai detto che ti sei fidanzata/ non ho mica provato tanto piacere/ per la verità// Ma adesso che l’ho conosciuto/ il tuo fidanzato/ sono proprio contendo// È un bravo ragazzo! (misurando un vestito a Salvatore) Perfetto/ eh? 3 SALVATORE: (indicando la spalla della giacca) Papà/ ma qui… 4 SARTO: No/ questo sparisce// Eh/ guarda (tirando e mordendo la spalla della giacca) Hm// Ecco// Beh/ pròvati questa/ intando// (Salvatore si prova un’altra giacca) 5 GIOVANNA: Ma che hai detto/ a papà?! Ti sei ammattito?! 6 SALVATORE: Vieni qua// Dammi un bacio// 7 SARTO: (gridando dall’altra stanza) Come va/ la giacca? 8 SALVATORE: Bene/ papà// Giovanna/ dammi un bacio// Ti voglio bene// 9 GIOVANNA: No! E piantala/ di chiamare papà/ papà! 10 SALVATORE: E mo suoni la tromba? Fai “papà papà”! 11 SARTO: Beh? Beh/ e che fate? Litigate? 12 GIOVANNA: Papà/ ma che t’ha raccontato? Questo non è/ il fidanzato mio! Il fidanzato mio/ è un altro! 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 465 13 SALVATORE: Ma la sentite? Cj ha un altro fidanzato! E voi non dite niente?! State zitto! 14 SARTO: Giovanna/ di’ un po’/ ma/ non ti sarai mica fidanzata con due? 15 SALVATORE: Hai approfittato che m’ero ammalato! Volevo vedere se stavo bene! 16 SARTO: Su/ fate la pace! Se incominciate a litigare appena fidanzati! Eh! 17 GIOVANNA: Papà/ piantala! 18 SARTO: (rispondendo al telefono) Pronto// Chi parla? Pronto?! Giovanna/ vieni un po’ tu? (Giovanna va in un’altra stanza) Qui non si sente che una musica// 19 SALVATORE: Una musica? (Salvatore prende la cornetta. Alle inquadrature di Romolo che parla al telefono dal negozio di dischi si alternano le inquadrature di Salvatore che ascolta al telefono da casa di Giovanna. Musica di sottofondo) 20 ROMOLO: Giovanna// Non parlare// Ho capito// Non puoi venire/ perché papà è ancora sveglio// Appena si addormenta/ vieni però/ eh? Senti che musica// Ho messo il disco che piace a te// Con questa musica/ mi vengono certi pensieri! Ho una voglia di darti un bacio! Ti darei tanti baci/ per quante stelle ci sono in cielo! Una stella grande/ un bacio grande// Una stella piccola/ (dando un bacio alla cornetta) un piccolo bacio// 21 SALVATORE: (tra sé, mettendo una mano davanti alla cornetta) Che figlio de… Tutte frasi che glj ho insegnato io! (quasi dando un morso alla cornetta) Ahin! 22 ROMOLO: E accarezzarti/ come le onde/ accarezzano il mare// Sarèbbe/ come fare un tuffo/ dentro un mare di felicità// 23 SALVATORE: Ma dove ti tuffi/ che non sai neanche nuotare! A Romolo/ il mare/ è una brutta bestia! 24 ROMOLO: Pronto! Pronto! Ma chi parla?! 25 SALVATORE: Parlo io/ Salvatore! 26 ROMOLO: Ma che/ ho fatto il numero tuo? 27 SALVATORE: No/ hai fatto il numero giusto// E parli con Salvatore// In casa di Giovanna! E faresti bene a non dare più fastidio alla ragazza mia! (Giovanna gli strappa il telefono di mano e attacca) 28 GIOVANNA: Oh! Ma che ti prende?! Mo ti metti a fare il padrone a casa mia?! 466 Il linguaggio cinematografico 29 SALVATORE: Eh… 30 GIOVANNA: Ma chi t’autorizza/ a dire tutte ste buggie?! Ma va’ a dormire/ corri! Cammina! Vattene! 31 SALVATORE: E fammi salutare papà/ almeno! 32 GIOVANNA: Papà/ te lo saluto io! 33 SALVATORE: Hai visto che gli sono piaciuto/ a papà? 34 GIOVANNA: (sbattendolo fuori di casa) E non lo chiamare papà! (rispondendo al telefono) Pronto! Ah/ sei tu/ Romolo// Hai telefonato? Salvatore?! Eh/ t’avrà fatto uno scherzo! Io m’ero messa a letto// Ma no/ avrai sbagliato numero// Ah! Ora t’arrabbi?! Senti/ non ricominciare con la gelosia/ sennò… SCENA 36: Romolo, zio, donna. Negozio di dischi. Interno, notte. 1 ROMOLO: Sennò che?! (sentendo un rumore attacca all’improvviso il telefono e spegne la luce) 2 ZIO: (aprendo la serranda del negozio, con una donna) Si accomodi// Attenta alla testa// Ha visto/ com’è semplice? E lei è stata tre anni a dirmi di no! Eh/ adesso fumiamo una sigaretta/ ascoltiamo un disco… 3 DONNA: Sì/ ma entrare così/ di notte/ come due ladri! 4 ZIO: E beh? 5 DONNA: E poi mi promette/ che veramente ascoltiamo dei dischi? 6 ZIO: Glielo giuro! Un momento// (abbassa la serranda, accende la luce, Romolo inciampa provocando un gran rumore) 7 DONNA: Oh Dio/ che vergogna! 8 ZIO: (gridando a Romolo) Tu che fai/ qui?! Disgraziato! 9 ROMOLO: Zio Mario/ eh… cj avevo un po’ di tempo/ ero venuto a mettere un po’ d’ordine// 10 ZIO: Va bene/ caro// Adesso vai a mettere ordine in qualche altro posto// E non tornare più! Sei licenziato! 11 ROMOLO: (aprendo la serranda) Ho capito/ ho capito! Zio Mario/ se vuoi una mano/ senza complimenti/ eh? 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 467 12 ZIO: Fuori! (alla donna) Magda/ la vedo turbata// Venga// Le faccio ascoltare un microsolco! Sì? SCENA 37: Romolo, Salvatore. Piazza Navona, davanti al portone di Giovanna. Esterno, notte. (Salvatore aspetta qualche secondo fuori dalla porta di Giovanna e poi se ne va) 1 ROMOLO: (entrando di corsa nel portone, appena ha visto un uomo uscirne. L’uomo è Salvatore, ma dapprima Romolo non lo riconosce) Permesso// Grazie// 2 SALVATORE: (neanche lui ha riconosciuto Romolo) Prego// (i due si voltano, si riconoscono, Salvatore scappa, Romolo fa per rincorrerlo ma poi si ferma) SCENA 38: Giovanna, Romolo, sarto. Pianerottolo e casa di Giovanna. Interno, notte. (Romolo suona il campanello di Giovanna) 1 GIOVANNA: Salvatore/ vattene// Perché tanto non ti apro! Ma chi è?! (guardando dallo spioncino vede Romolo che si mette una mano davanti alla bocca) 2 ROMOLO: Sono Salvatore// 3 GIOVANNA: Ah/ sei Salvatore// E che vuoi? 4 ROMOLO: Giovanna// Dimmi la verità// Sei stata contenta/ di vedermi stasera/ dopo tanto tempo? Hai visto? Appena guarito/ sono venuto a casa tua// 5 GIOVANNA: Sono stata felice! 6 ROMOLO: Ah! Sei stata felice! E se Romolo sapesse che c’è stato fra noi stasera/ cosa dirèbbe? 7 GIOVANNA: Certo/ non gli farèbbe piacere// 468 Il linguaggio cinematografico 8 ROMOLO: Perché? Che c’è stato? 9 GIOVANNA: Non te lo ricordi più! 10 ROMOLO: Va be’// Un bacio// 11 GIOVANNA: Eh/ ma che bacio! 12 ROMOLO: Di’/ ma hai dimenticato/ che sei fidanzata con Romolo? Non mi dirai che Romolo/ non ti piace più! 13 GIOVANNA: Sì/ mi piace/ ma… ha un brutto carattere// È geloso/ mi controlla/ è capace di venirmi a spiare dietro le porte// 14 ROMOLO: Giovanna! 15 GIOVANNA: Ciao/ Romolo// (aprendo la porta) Adesso va’ a dormire/ che ’sto scherzo è durato anche troppo! (sbattendogli la porta in faccia) Buonanotte! 16 ROMOLO: Giovanna/ apri! 17 GIOVANNA: No! Va’ a dormire! 18 ROMOLO: (da fuori) Va be’/ domani facciamo i conti! 19 GIOVANNA: Va bene/ ne parliamo domani// 20 SARTO: Ma/ che succede/ con questi due ragazzi/ stasera?! Con quale/ dei due/ ti sei fidanzata? 21 GIOVANNA: Con Romolo// Quello che ho mandato via adesso// 22 SARTO: Ma quello che mi chiama papà/ chi è?! 23 GIOVANNA: È Salvatore// Un amico di Romolo// Gli ho dato un bacio una sera/ e poi non l’ho visto più// 24 SARTO: Gli hai dato un bacio? Allora gli volevi bene// 25 GIOVANNA: Gli volevo bene! Mi piaceva! C’è una bella differenza! 26 SARTO: Ma lo sai tu/ in sei anni di fidanzamento/ quanti baci ho dato a tua madre? Tre! E tu distribuisci baci/ come fossero di cioccolata// Insomma/ quale dei due ti piace di più?! 27 GIOVANNA: Romolo mi piace// Ma ha un brutto carattere// Stasera/ a cena/ cj ho pure litigato// Salvatore invece… Salvatore/ mi piace pure lui// 28 SARTO: Ti piacciono tutti e due?! Lo vedi che non lo sai nemmeno tu/ quello che vuoi? 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 469 29 GIOVANNA: Eh/ hai ragione// Ma credi che sia facile/ capire quando un ragazzo scherza/ o fa sul serio? Tante volte dai un bacio a uno e… e passi per una ragazza leggera// Se invece non glielo dai/ quello se ne va/ non ti cerca più/ e magari era quello giusto// Quello che ti avrèbbe voluto bene per tutta la vita// 30 SARTO: Beh/ vai a dormire// Buonanotte// 31 GIOVANNA: Buonanotte/ papà// E stai tranquillo// Non faccio niente/ di male// 32 SARTO: Hm// Ma quello che mi chiama papà/ chi è?! 33 GIOVANNA: È Salvatore! 34 SARTO: Ah/ Salvatore// Un bravo ragazzo/ sì// Serio// S’è intrattenuto più d’un’ora/ a parlare con me// S’è interessato al mio lavoro/ e indovina che cosa m’ha detto? 35 GIOVANNA: Che cosa? 36 SARTO: Che gli piacerébbe tanto/ imparare il mestiere di sarto// 37 GIOVANNA: Papà/ quello scherza// Lo vedi che ti fai incantare anche tu? 38 SARTO: No// Non credo che scherzi// Ho l’impressione che sia seriamente innamorato di te// E hai fatto male/ a mandarlo via così// (se ne va) 39 GIOVANNA: (tra sé) Sì/ forse ho fatto male// SCENA 39: Giovanna, ragazzo, Salvatore. Casa di Giovanna e bar all’aperto. Interno–esterno, notte. 1 GIOVANNA: (svegliandosi e rispondendo al telefono) Pronto// Chi è? Come? Non ho capito// Chi?! 2 RAGAZZO: ’Sto Salvatore è stato qua// Ha detto che andava… andava… (Salvatore gli fa cenni con le mani) a buttarsi al fiume// S’ammazzava// S’ammazzava! E che ne so/ perché// M’ha detto d’avvertì soltanto voi/ che forse v’avrèbbe fatto piacere// 3 GIOVANNA: Ma/ dove ha detto che andava? 4 RAGAZZO: Aspettate/ me pare che ha detto… ha detto… (sottovoce a Salvatore) Dove te butti? 5 SALVATORE: (sottovoce) A Ponte Nuovo// 470 Il linguaggio cinematografico 6 RAGAZZO: (al telefono) A Ponte Nuovo// (a Salvatore) Ha riattaccato// 7 SALVATORE: Era spaventata? 8 RAGAZZO: Je tremava la voce// 9 SALVATORE: Ci metterà/ un quarto d’ora/ per arrivare al Ponte Nuovo? Fammi ’n altro cappuccino/ va’// Dolce/ eh? SCENA 40: Giovanna, Salvatore, poliziotti 1 e 2, uomini 1 e 2, commissario. Ponte sul Tevere. Esterno, mattina. 1 GIOVANNA: (correndo e urlando sul ponte) Salvatore! Salvato… (trovandoselo tra i piedi, che dorme per terra) Ah/ stai lì?! Dormi! Ma/ non ti dovevi ammazzare/ tu? 2 SALVATORE: Perché/ ce vo’ un’ora fissa/ per ammazzarsi? Ho voluto vivere un’altra mezz’ora// 3 GIOVANNA: Non potevi svegliarmi più tardi/ allora? M’hai fatto venire fin qui per niente! 4 SALVATORE: Sai/ perché ho aspettato a buttarmi? Per vederti un’ultima volta// Per dirti/ quanto ti voglio bene// 5 GIOVANNA: Beh/ adesso m’hai vista// Bùttati! 6 SALVATORE: Ah/ m’incoraggi?! Vuoi avere questo rimorso?! 7 GIOVANNA: Devi essere di parola// Hai detto/ che ti butti? E bùttati! 8 SALVATORE: (salendo sul parapetto del ponte) Guarda che mi butto/ eh? 9 GIOVANNA: Sì// Se tu ti butti/ io mi faccio monaca! 10 SALVATORE: Guarda/ che da questa altezza/ anche il miglior nuotatore di Roma/ s’affoga! 11 GIOVANNA: Oh/ quanto la fai lunga! 12 SALVATORE: Va bene// L’hai voluto tu// Però/ se mi dici che mi vuoi bene/ posso pure non buttarmi// 13 GIOVANNA: E dai! (Salvatore si fa il segno della croce e si butta, rimanendo però in realtà sul ciglio del ponte, non visto da Giovanna) Salvatore! Aiuto! (si affaccia dal ponte) 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 471 14 SALVATORE: (alzandosi) Adesso me lo dai/ <un bacetto>? 15 GIOVANNA: <No! Vigliacco! Vigliacco! […]! Lasciami! Ma lasciami stare! Lasciami/ t’ho detto! Lasciami>! 16 SALVATORE: <Uno solo! Andiamo! Dammi un bacietto! Su! […]! Dammelo! No! No/ [aspetta]>! (arrivano in macchina dei poliziotti, scendono di corsa e soccorrono Salvatore) 17 POLIZIOTTO1: Vieni/ dammi la mano/ su! 18 POLIZIOTTO2: Ma che hai fatto? Ma che/ sei caduto? 19 SALVATORE: Hm// 20 UOMO1: Si voleva ammazzare/ signor commissario// 21 UOMO2: L’ho visto io/ che se buttava al fiume! 22 POLIZIOTTO1: Ah/ ti volevi ammazzare? Adesso vieni con noi! 23 SALVATORE: Perché? 24 POLIZIOTTO1: Perché hai commesso un reato// 25 SALVATORE: Ma quale reato! Uno non si può nemmeno ammazzare? 26 COMMISSARIO: Sai che il suicidio è un omicidio? Se ammazzi te stesso/ fai un omicidio// 27 SALVATORE: Ma io non mi sono ammazzato// 28 COMMISSARIO: Appunto per questo/ ti portiamo dentro// Per simulazione di reato// 29 POLIZIOTTO1: E sennò te portavamo all’obitorio// 30 SALVATORE: Ah/ ma allora non cj avete un minimo di sentimento// (al commissario) Si metta nei panni miei/ scusi// Stavo disperato/ avevo litigato con la mia fidanzata// 31 COMMISSARIO: Ah/ è la tua fidanzata/ <quella>// 32 SALVATORE: <Certo>// 33 COMMISSARIO: Signorina/ venga un po’ qua/ per favore// È vero/ che lei è la fidanzata di questo giovanotto? 34 GIOVANNA: Sì// 35 COMMISSARIO: E vi volete bene? 36 SALVATORE: Il nostro è un grande amore/ commissario// 472 Il linguaggio cinematografico 37 COMMISSARIO: Non per sapere i fatti vostri/ ma allora perché/ litigate? 38 SALVATORE: È quello che le dico sempre io// 39 COMMISSARIO: Beh/ se mi promettete di non litigare più/ vi lascio andare// 40 SALVATORE: Ah/ ci mancherébbe! Ormai sarà un idillio/ il nostro// Vero/ Giovanna? 41 GIOVANNA: Hm// 42 SALVATORE: Arrivederci/ commissario// E grazie// (Salvatore e Giovanna si allontanano) Giovanna! Giovanna! E dammi un bacio! Ci stanno a guardare// Dobbiamo far vedere che abbiamo fatto pace// Vuoi che vada a finire in prigione/ perché ti voglio bene? (si baciano) E che è? Pare che hai preso la medicina! Mo hanno perduto lo zucchero/ i baci miei?! Sai perché ero venuto da te/ ieri sera? Per darti questo// (le dà un anello) Ma tu non m’hai dato manco il tempo di parlare// Mi hai buttato fuori di casa! È bello/ no? 43 GIOVANNA: È bellissimo! 44 SALVATORE: Ahó/ è ’n anello impestato de brillanti! 45 GIOVANNA: Ma io non lo posso accettare// 46 SALVATORE: Perché? 47 GIOVANNA: Sono fidanzata con Romolo// 48 SALVATORE: Allora io non ti piaccio più? 49 SALVATORE: Mi piaci sì// Mi piacete tutti e due// 50 ROMOLO: Beh/ vuol dire che per un po’/ stai fidanzata con tutti e due// Poi però/ bisogna che tu ti decida// Ti deciderai? 51 GIOVANNA: Hm// 52 SALVATORE: Beh/ ma l’anello te lo posso dare pure subito// SCENA 41: Boccio, uomini 1, 2 e 3, Salvatore, padre di Romolo, Cecilia. Piazza Navona. Esterno, giorno. 1 BOCCIO: A Nando! Nando! Viè giù/ che s’è ammazzato Salvatore! 2 UOMO1: Che c’è? Ch’è successo? 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 473 3 BOCCIO: S’è ammazzato ’n amico mio! 4 SALVATORE: Ma che è successo// 5 UOMO2: Eh/ dicono che s’è ammazzato Salvatore// 6 UOMO3: Ah/ figùrate se quello s’ammazza! È giovedì/ all’una starà a casa a magnà li gnocchi// (girandosi vede Salvatore) Ma tu stai qui! A sora Cecilia! È ritornato Salvatore! È ritornato! (brusio della folla) 7 PADRE DI ROMOLO: Oh Dio! 8 CECILIA: Figlio! Figlio mio bello! 9 SALVATORE: Mamma! 10 CECILIA: Core de mamma tua! Ma ch’hai fatto/ di’! Ma perché/ te volevi ammazzà? Ma non stavi bene/ a casa tua? T’ho fatto mai mancà niente/ di’! M’hai fatto stà in pena tutta stanotte! Non hai pensato/ a mamma tua/ che soffre de core? Ma dove ce l’hai/ el sentimento? (gridando) Ma lo sai che per poco non me facevi morì? (picchiandolo) Fijo snaturato/ disgraziato/ e senza core! Co la pressione alta che cj ho! Delinguente! (tirandogli una scarpa) Sei tutto er ritratto de tu padre! Assassino! Mo t’aggiusto io! (Salvatore si rifugia dentro un portone e Giovanna se ne va) SCENA 42: Romolo, Giovanna. Sartoria. Interno, giorno. 1 ROMOLO: Son contento/ che la madre gliel’ha date// Così m’ha risparmiato la fatica a me// 2 GIOVANNA: Ma tu che fai/ qui?! (spingendo con disappunto le gambe di Romolo via dal tavolino sul quale erano appoggiate) Hm! 3 ROMOLO: T’ho portato un regalo// (facendole vedere una sveglia) Ti piace? 4 GIOVANNA: Mi regali una sveglia? 5 ROMOLO: Questa è una sveglia speciale// È un’amica mia/ che mi dice tutto// 6 GIOVANNA: Ma che stai a dire? 7 ROMOLO: Vedi? Con questa/ stasera/ vengo a casa tua// La carico// Non ti 474 Il linguaggio cinematografico faccio vedere a che ora la metto/ la chiudo nel cassetto/ e mi porto via la chiave// E tu/ domani mattina/ mi devi dire a che ora ha suonato// Perché/ quello che è successo stanotte/ che sei uscita/ e rientrata alle nove di mattina/ non deve succedere più// Siamo intesi?! 8 GIOVANNA: Di’ un po’// Ma a te/ le idee/ ti vengono in mente da solo/ o cj hai qualcuno che t’aiuta? 9 ROMOLO: (vedendo l’anello che le ha regalato Salvatore) E questo che è? 10 GIOVANNA: Ehm… è… un vecchio anello mio/ di famiglia// 11 ROMOLO: No// Questo è l’anello della sora Cecilia// Che ogni tanto Salvatore glielo frega/ quando vuol far colpo su qualche ragazza/ e poi/ quando cj ha fatto il comodo suo/ se lo fa ridare! 12 GIOVANNA: Ah! E mica è stupido/ l’amico tuo! 13 ROMOLO: Beh/ adesso te lo levi/ e glielo ridai subito! Perché sennò… 14 GIOVANNA: Sennò?! 15 ROMOLO: Perché sennò/ non me vedi più! Hai capito? 16 GIOVANNA: Vedi Romolo/ mi fa piacere/ che hai parlato così// Perché adesso ho proprio capito bene come sei fatto// Pensa/ che t’avrei pure sposato// Ma tu vieni qua con la sveglia// Mi dici/ “la carico/ la metto nel cassetto”// Oh! Ma lo sai che significa/ questo fatto della sveglia? Che se ti sposo/ avrò un marito che mi spia/ geloso/ che mi mette in croce dalla mattina alla sera! Senti/ Romolo/ restiamo buoni amici/ e basta// 17 ROMOLO: Se questa è la tua ultima parola… 18 GIOVANNA: Sì// È meglio// Credimi// 19 ROMOLO: Pensaci bene// 20 GIOVANNA: Cj ho pensato// 21 ROMOLO: Bene// Allora/ Giovanna/ auguri/ e figli maschi! Però Salvatore me la paga! 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 475 SCENA 43: Salvatore, Giovanna, Romolo, ragazzi 1 e 2, VVFC, Leonetto, Ugo, fidanzata di Ugo. Musica di sottofondo. Stabilimento balneare sul Tevere. Esterno–interno, giorno. 1 SALVATORE: Lo sai qual è il sogno mio? 2 GIOVANNA: No// 3 SALVATORE: Il sogno mio/ è smettere di fare il bagnino// 4 ROMOLO: Bagnino! Bagnino! 5 SALVATORE: Mi sa che quello è venuto per sfottere! 6 GIOVANNA: E tu ci vai? 7 SALVATORE: Per forza// Sono il bagnino/ io// (va da Romolo) 8 ROMOLO: Cabbina// 9 SALVATORE: (aprendogli una cabina) Romolo? 10 ROMOLO: Mbeh? 11 SALVATORE: Vogliamo/ far pace? 12 ROMOLO: Ti volevo menare/ non t’ho menato più/ contèntati/ e <vattene>// 13 SALVATORE: <Ahó>! (tra sé) Uh// (torna da Giovanna) 14 GIOVANNA: Che t’ha detto? 15 SALVATORE: Niente// È un povero di spirito// Andiamo in là// Sennò qui mi continuano a chiamare// 16 RAGAZZO1: (ammirando Giovanna, al ragazzo2) Ma che/ la conosci/ quella là? 17 RAGAZZO2: (c.s.) Magari! 18 SALVATORE: Adesso/ però/ mi devi spiegare/ come hai potuto pensare/ di essere fidanzata con due// Di’ la verità// Tu t’eri messa con Romolo/ per farmi ingelosire// Eh? 19 GIOVANNA: No/ è che sono fatta così/ io// Mi piace dare i baci ai ragazzi// Faccio male? 20 SALVATORE: No no// Fai bene// 21 GIOVANNA: Una ragazza/ cerca sempre/ d’essere voluta bene// E io non ci posso stare/ senza essere innamorata// E poi/ se ti devo dire la 476 Il linguaggio cinematografico verità/ quando Ugo m’ha lasciata/ m’era venuta paura che nessuno m’avrèbbe voluto più bene// 22 SALVATORE: Ma più di me/ scusa/ chi te ne può volere? Hai trovato la scarpa per il piede tuo// (si baciano) 23 VFC UOMO: (appena percepibile in lontananza) A Franco/ io me ne vado! Tu che fai? 24 VFC UOMO: (c.s.) Sto a fà ’l bagno! 25 SALVATORE: Ah! Quando mi baci/ sento suonare l’inno di Mameli// 26 GIOVANNA: Hm// 27 SALVATORE: Dammi uno schiaffo// 28 GIOVANNA: E perché?! 29 SALVATORE: Perché ho giurato di non dire più fesserie// Mi voglio cambiare// 30 GIOVANNA: E come fai/ a cambiare/ Salvatore? 31 SALVATORE: M’aiuti tu// Quando dico una fesseria/ mi dai uno schiaffo// 32 GIOVANNA: Sì! Allora povera faccia! 33 SALVATORE: Vedi/ il guaio mio/ è che io piaccio/ alle ragazze// Perché sono bello/ allegro/ le faccio divertire/ e le ragazze mi vengono appresso/ mi vogliono pure bene// 34 GIOVANNA: Hmhm// 35 SALVATORE: Ma da quando ho conosciuto te/ ho capito che è più importante voler bene/ che essere voluti bene// Ehm… dirò una fesseria/ che poi in fondo non è una fesseria/ ma/ voler bene/ significa avere qualcosa dentro// Magari essere poveracci/ di fuori/ ma/ ricchi dentro// 36 GIOVANNA: Ah// 37 LEONETTO: (accorrendo da lontano) Giovanna! Giovanna! Non gli dar retta/ che quello non ti sposa// 38 GIOVANNA: Leonetto! E che fai/ qui? 39 LEONETTO: Ti sto a spiare/ no? Hai visto/ chi c’è? Ugo/ con la sua fidanzata// 40 UGO: (dando uno schiaffo alla fidanzata) E adesso cammina! E zitta! 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 477 41 GIOVANNA: (a Ugo) Ah/ ma ’sta brutta abitudine non te la sai levare/ eh? (alla fidanzata di Ugo) Ma perché non gli dà uno schiaffone pure lei?! 42 FIDANZATA: Ma se parlo/ questo mi mena di più// Hm// 43 UGO: La fidanzata mia// 44 FIDANZATA: Piacere// 45 GIOVANNA: Hm// E questo è il fidanzato mio// 46 UGO: Finalmente l’hai trovato/ il fidanzato che ti fa portare il costume a due pezzi/ eh? 47 SALVATORE: Ma chi è/ questo! Che vole?! 48 GIOVANNA: Ma come! Non lo conosci? È l’ex fidanzato mio! 49 SALVATORE: E chi l’ha mai visto?! 50 GIOVANNA: Ma sì! L’altra sera/ a cena! Non ti ricordi? 51 SALVATORE: A cena?! Ma che/ te sei ammattita? 52 GIOVANNA: Ah/ già! Scusa/ scusa/ era Romolo// 53 SALVATORE: <Ah>// 54 UGO: <Adesso>/ confondi pure i fidanzati? Non litigate// Avrete tempo dopo sposàti// 55 GIOVANNA: <Hm>// 56 UGO: <Andiamo>/ Leonetto// Andiamo a fare il bagno/ va’// 57 LEONETTO: Ciao/ Giovanna// 58 GIOVANNA: Ciao// 59 SALVATORE: Ma va’ m… 60 UGO: (alla fidanzata) E non tirare su col naso! 61 SALVATORE: Ti piaceva quel tipo là?! Ma che ci trovavi?! 62 GIOVANNA: Non lo so nemmeno io/ che ci trovavo// E fammi ballare/ no? (ballano) E non t’arrabbiare! È acqua passata// (Ugo si volta e guarda cupo Giovanna) 478 Il linguaggio cinematografico SCENA 44: Annamaria, ragazzi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, Boccio, Romolo, Giovanna, Salvatore, VVFC, Marisa, Ugo, ragazze 1, 2 e 3, uomo, Leonetto, ragazze e ragazzi vari. Musica di sottofondo. Stabilimento balneare sul Tevere. Esterno–interno, giorno. 1 ANNAMARIA: E allora? Avete deciso/ che penitenza mi fate fare? 2 RAGAZZO1: Sì// Devi dare un bacio a uno// 3 ANNAMARIA: <Hm>// 4 RAGAZZO2: <Io sto qua>/ e so’ pronto/ eh? 5 ANNAMARIA: Ah// Avete detto/ “a uno”? (si alza e se ne va, passando davanti a un uomo grasso) 6 BOCCIO: E mo che fa? Va a dà un bacio a quer panzone? 7 ANNAMARIA: Romolo? Romolo? Vieni qua// 8 ROMOLO: (mentre sta facendo il bagno nel fiume) Che vuoi? 9 ANNAMARIA: Ti devo dire una cosa// (lo bacia) È una penitenza// (gli dà una spinta, facendolo andare con la testa sott’acqua, e scappa) 10 ROMOLO: (uscendo dal fiume e rincorrendola) Annamaria! Aspetta! (raggiungendola) Ma che t’è saltato in mente? 11 ANNAMARIA: Perché? Che ho fatto? 12 ROMOLO: Scusa/ m’hai fatto bere un litro d’acqua sporca// 13 ANNAMARIA: Ah/ è per l’acqua sporca/ che mi sei corso dietro// 14 ROMOLO: E sennò/ perché ti dovevo correre appresso// 15 ANNAMARIA: Non ti sei accorto/ che ti ho dato un bacio? 16 ROMOLO: Un bacio?! M’hai dato un bacio? E quando? Ma non era un bacio di penitenza/ quello che m’hai dato? (Annamaria fa cenno di no col capo) Era un bacio vero? (Annamaria fa cenno di sì col capo) 17 ANNAMARIA: Romolo/ sono dieci anni/ che ti voglio bene// Non te ne eri mai accorto? 18 ROMOLO: Dieci anni?! E quanti anni cj hai? 19 ANNAMARIA: Quindici// Ti sono stata sotto gli occhi per anni/ e non ti eri manco accorto che esistevo// E sì che ogni volta che chiamavi Salvatore/ m’affacciavo io// 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 479 20 ROMOLO: Certi nervi/ mi facevi venire// (Annamaria gli dà un bacio sulla guancia) Beh/ andiamo a ballare/ va’// Andiamo// (ballano vicino a Giovanna e a Salvatore) 21 GIOVANNA: Ma/ quella che balla stretta stretta con Romolo/ non è tua sorella? 22 SALVATORE: Scusa un momento// (smettendo di ballare con Giovanna e dirigendosi verso Romolo e Annamaria. Dando a Romolo un colpetto sulla spalla) Permetti? 23 ROMOLO: Che vuoi? 24 SALVATORE: Ti devo dire una parola a quattr’occhi// 25 ROMOLO: (smettendo di ballare con Annamria e seguendo Salvatore) Andiamo// 26 VFC UOMO: (appena percepibile in lontananza) Mario! 27 MARISA: Ma che è successo? 28 ANNAMARIA: Boh// 29 ROMOLO: Beh? 30 SALVATORE: Ti volevo informare che non mi piace/ come balli con mia sorella// 31 ROMOLO: Ma come/ non ti piace! Ballavo benissimo// Facevo pure le figure// 32 SALVATORE: Guarda/ cerca di non fare lo spiritoso! Con Annamaria non ci balli più! Ci siamo capiti? 33 ROMOLO: No// Non ci siamo capiti per niente// 34 SALVATORE: E io sono sicuro che m’hai capito benissimo! 35 ROMOLO: A me non risulta// 36 SALVATORE: Bada/ Romolo/ che la mia pazienza ha un limite! Già ti sei dato troppo da fare/ con Giovanna! (Ugo, che si trovava nei paraggi, non visto da Romolo e Salvatore, comincia ad ascoltare attentamente la loro conversazione) 37 ROMOLO: A parte che di Giovanna non me ne importa niente/ ma sei stato tu/ che ti sei dato da fare con lei/ quand’era la ragazza mia! 38 SALVATORE: Era la ragazza tua per modo di dire! Eh sì/ perché tu non lo sai! Ma Giovanna/ era più la ragazza mia/ che la tua// Eh già// Tu che ci facevi/ in fondo? 480 Il linguaggio cinematografico 39 ROMOLO: E tu che ci facevi? 40 SALVATORE: Se sei capace di star zitto/ te lo dico// 41 ROMOLO: Sono una tomba// 42 SALVATORE: Tutto/ Romolo// Tutto// Però mi raccomando/ eh? Acqua in bocca// Anzi… cj ho paura d’averle fatto fare un bambino// 43 UGO: (avviandosi alterato verso Giovanna e spingendo un ragazzo) Giovanna! 44 RAGAZZO3: (spinto da Ugo) Ahó/ sei matto?! (Ugo dà uno schiaffo a una ragazza, poi si accorge che non è Giovanna) 45 UGO: (alla ragazza schiaffeggiata) Oh/ scusi/ sa// Scusi tanto// 46 RAGAZZO4: (alla ragazza schiaffeggiata) Ma che è successo? Ma chi è? 47 RAGAZZA1: Ma che ne so? Chi lo conosce?! 48 UGO: (a Giovanna) Brava Giovanna! Complimenti! Ne ho sapute delle belle/ sul conto tuo! (le dà uno schiaffo) 49 ROMOLO: (avendo assistito alla scena, rivolgendosi a Salvatore) Ma come?! Quello prende a schiaffi la mamma dei tuoi bambini/ e tu te ne stai qui?! 50 GIOVANNA: (a Ugo) E tu cj hai creduto/ eh? Ti ringrazio// È proprio vero/ che non sei mai stato capace di capirmi! 51 ROMOLO: (a Salvatore) Ma che razza di uomo sei? 52 SALVATORE: (a Ugo) Che voleva dire/ ’sto schiaffo alla ragazza mia? 53 UGO: Hm/ lo senti? Questo chiede pure spiegazioni// 54 GIOVANNA: (a Salvatore) La prima volta che dicevi una fesseria/ dovevo darti uno schiaffo? E allora tieni! (gli dà uno schiaffo) 55 SALVATORE: Ma perché? Che ho detto/ ahó! 56 UGO: Hai detto che aspettavi un bambino da Giovanna// T’ho sentito io// Con queste orecchie// 57 SALVATORE: Io? E quando mai?! (a Romolo) Diglielo tu! 58 ROMOLO: Veramente/ per averlo detto/ l’hai detto// 59 SALVATORE: Ma come è possibile?! (a Giovanna) Tu lo sai// Com’è possibile?! 60 RAGAZZO2: A Salvató/ gli hai fatto fà un bambino pe corispondenza! 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 481 61 ROMOLO: A piccoletto/ e lèvati di mezzo! 62 BOCCIO: Ahó/ ma che gusto c’è/ a fà i figli così? Boh! 63 SALVATORE: (facendo a Boccio cenno di tacere e d’andarsene) <Ss>! 64 UGO: <E tu vieni>/ Giovanna! Perché io e te non abbiamo ancora finito! 65 RAGAZZA1: Eccolo/ quello che m’ha dato lo schiaffo// 66 RAGAZZO5: Ah/ è lei? (vedendo il dislivello di statura con Ugo) Ma non l’avrà mica fatto apposta// È vero/ giovanotto? 67 UGO: Scusi/ ma/ l’avevo scambiata per lei// (indicando Giovanna) 68 RAGAZZO5: (alla ragazza) Hai visto// Te l’avevo detto/ che si era sbagliato// (a Ugo) Scusi tanto/ eh? 69 UGO: (a Giovanna) Tu adesso mi devi spiegare// 70 GIOVANNA: Ma perché non ti impicci dei fatti tuoi/ scusa// 71 UGO: Ma lo sai/ che sono impiccione// È carattere// 72 GIOVANNA: Sarà carattere/ ma non t’autorizza/ a dare degli schiaffi! 73 UGO: Ma tu/ piuttosto/ devi essere più condiscendente// Te lo ricordi/ l’altra volta/ perché abbiamo litigato? Ti eri messa a girare attorno al tavolo tondo/ e non volevi che ti prendessi// Se ti facevi dare subito uno schiaffo/ potevamo anche rifare la pace// 74 GIOVANNA: Ah/ insomma m’hai piantata/ perché non mi sono lasciata dare uno schiaffo?! Mi volevi proprio bene! 75 UGO: Io voglio bene così// Se non mi gira una cosa/ devo reagire// E se te le davo/ era perché ti volevo bene// 76 GIOVANNA: No! È perché sei manesco! Sennò perché/ due minuti fa/ mi hai dato uno schiaffo? 77 UGO: Hai ragione// Vuoi vedere/ che se te l’ho dato/ è perché ti voglio ancora bene? 78 GIOVANNA: Hm! Bel ragionamento! 79 UGO: Mica ti può dispiacere// Si vede lontano un miglio/ che mi vuoi ancora bene// Vogliamo rifare la pace? È vero/ che muori dalla voglia di far pace? 80 GIOVANNA: No! (gli dà uno schiaffo) 81 UGO: Vedi/ tu mi piaci/ perché rispondi// Sennò che gusto ci sarèbbe/ a fare l’amore? 482 Il linguaggio cinematografico 82 GIOVANNA: E dammi un bacio/ invece di parlare tanto// 83 UOMO: (gridando, impedendo a Ugo e a Giovanna di baciarsi) A bagnino! 84 GIOVANNA: Non qua/ che c’è gente// (si spostano e si baciano) Ma scusa/ quella tua fidanzata/ dove l’hai messa? 85 UGO: Iole? 86 GIOVANNA: Hm// 87 UGO: Ha voluto andare a casa// Ha capito che aria tirava// 88 GIOVANNA: La facevo più stupida// (si baciano) 89 SALVATORE: (senza vederla) Giovanna? 90 GIOVANNA: (a Ugo) Tu vatti a vestire// Che poi andiamo via insieme// 91 SALVATORE: Giovanna/ dove sei? 92 VFC DONNA: <[…]>// 93 VFC UOMO: (appena percepibile in lontananza) <[A Romolo]>! 94 VFC UOMO: (c.s.) <Oh>! 95 VFC UOMO: (c.s.) Aspettame/ che vengo pure io/ co te! 96 VFC UOMO: (c.s.) <[…]>// 97 SALVATORE: <Giovanna/ mi dispiace>/ se prima hai dato retta a quello// Mica cj avrai creduto/ no? 98 GIOVANNA: Guarda/ che non sono mica arrabbiata// 99 SALVATORE: Ah/ meno male// E a quel tuo amico di prima/ quel disgraziato di Ugo/ gliene hai dette/ quattro? L’hai messo/ a posto? 100 GIOVANNA: Sì// 101 SALVATORE: Beh/ allora vatti a vestire/ e andiamo via// È l’una// 102 GIOVANNA: Salvatore// Io vado via con Ugo// 103 SALVATORE: Come?! Vai via con Ugo?! 104 GIOVANNA: Mannaggia! E mo/ come te lo dico? Mi riesce difficile// 105 SALVATORE: Ma che mi devi dire?! 106 GIOVANNA: Me lo prometti/ che non t’arrabbi? 107 SALVATORE: Di’/ di’// 108 GIOVANNA: Io e Ugo ci vogliamo ancora bene// 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 483 109 SALVATORE: Ammazza! M’hai dato una bella notizia// 110 GIOVANNA: Mi dispiace/ Salvatore// Ma con Ugo/ ci volevamo bene da prima// Ci siamo litigati per una ripicca// Io/ credevo di essermelo tolto dal cuore/ e invece… Si vede/ che lo pensavo sempre// 111 SALVATORE: Apposta/ ci hai preso in giro tutto questo tempo/ a me e a Romolo! 112 GIOVANNA: No! Mi piacevate sul serio! E poi/ cercavo d’innamorarmi di un altro// Chissà// Forse/ solo per fare dispetto a lui// Ma non ci sono riuscita// 113 UGO: Beh? Ma tu ancora non sei pronta? (guardando il vestito di Salvatore) L’ha fatto papà tuo/ ’sto vestito? 114 GIOVANNA: Sì// 115 UGO: (a Salvatore) Gìrati un po’? (a Giovanna) Ecco/ lo vedi/ gli fa difetto// È il solito difetto di papà tuo! Ma quando ci torno io/ a bottega/ questi difetti non si vedranno più// (a Salvatore) Tu passaci/ a bottega/ che te lo rimetto a posto io/ eh? (dandogli uno schiaffetto) Ciao// (a Giovanna) Andiamo? 116 SALVATORE: Giovanna? Scusa una parola// Mannaggia! E adesso mi trovo nei pasticci io// Come te lo dico? 117 GIOVANNA: Coraggio/ Salvatore// Che oggi è la giornata che ci diciamo tutto// 118 SALVATORE: Ma guarda/ che brutta figura che faccio! 119 GIOVANNA: Ma che è successo? 120 SALVATORE: Mo sembra che te lo richiedo/ perché è finito tutto// 121 GIOVANNA: Ma che cosa? 122 SALVATORE: L’anello// L’anello di mamma// 123 GIOVANNA: Oh/ scusa! A momenti me lo scordavo// 124 SALVATORE: Ma/ io te l’avrei lasciato/ ma è di mamma/ poverina// È l’unica gioia che cj ha// 125 GIOVANNA: Ho capito/ Salvatore// 126 SALVATORE: Mo chissà che cosa pensi di me! 127 GIOVANNA: Penso/ che ’st’anello/ lo regalerai a qualche altra ragazza// Ciao// (lo bacia sulla guancia) 128 VFC UOMO: […]// 484 Il linguaggio cinematografico 129 VFC UOMO: (appena percepibile in lontananza) <A spiritoso>! 130 GIOVANNA: <Sono contenta/ d’averti conosciuto>// (se ne va) 131 SALVATORE: (gridando) Giovanna? Auguri! E figli maschi! (tra sé) Mannaggia! (dà un calcio al pavimento e si fa male a un piede) Ah! Ah! Ah! Ah! 132 MARISA: Hai fatto pace/ con Giovanna? 133 SALVATORE: Cj ho fatto pace per sempre// È finito tutto// Ti fa piacere/ eh? 134 MARISA: Sì// 135 SALVATORE: Allora/ oggi ho fatto contenti tutti// (girandosi e facendo vedere il vestito a Marisa) Di un po’/ è vero che mi fa difetto dietro? Guarda un po’? 136 MARISA: Per me ti sta benissimo// 137 SALVATORE: Andiamo a casa// Ma/ è un’impressione mia/ o sei cresciuta? 138 MARISA: Eh/ sì/ che sono cresciuta! Ho quasi sedici anni! 139 SALVATORE: Perbacco! Ma allora sei una signorina! Lo sai che ti sei fatta una bella ragazza? Stasera che fai? 140 MARISA: Perché? 141 SALVATORE: Niente// Perché/ se t’andava d’uscire/ uscivamo insieme// (infilandole l’anello mentre stanno passando Romolo e Annamaria) Beh/ ma quest’anello mica me lo posso mettere al dito io! È da donna// Poi stasera me lo ridai/ eh? 142 ROMOLO: No/ glielo ridai subito// 143 SALVATORE: No/ non mi ridai niente// Anzi/ io quest’anello/ te lo regalo// Hai capito? (sillabando) Te lo regalo! (a Romolo) E tu non mi scocciare più! Perché io oggi cj ho le lune di traverso// E ti posso pure menare! 144 ROMOLO: Guarda che io conosco/ la storia dell’anello! 145 SALVATORE: Ma io te meno pure! 146 ROMOLO: Ma a chi/ meni?! <Te do ’n ceffone>! 147 SALVATORE: <E metti giù le mani>! 148 ROMOLO: Ma a chi/ meni?! 149 SALVATORE: A chi?! 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 485 150 ROMOLO: A chi/ meni?! 151 SALVATORE: A te! 152 ROMOLO: A me! 153 SALVATORE: A te! 154 ROMOLO: Ah/ sì? 155 SALVATORE: Sì! 156 ROMOLO: Beh/ adesso te lo faccio vedere io// (togliendosi la giacca e passandola a Annamaria) Pìjame la giacca// (anche Salvatore si toglie la giacca e la passa a Marisa. Il gruppo di amici di Romolo e Salvatore sono disposti a semicerchio e fanno il tifo chi per l’uno, chi per l’altro, con battute sovrapposte e solo parzialmente comprensibili) 157 RAGAZZA: Vai/ Salvatore! 158 RAGAZZO: <Vai Romolo! Vai>! 159 RAGAZZO: <Bravo>! 160 RAGAZZO: Vai Romolo! Menaje! Menaje! 161 RAGAZZO: (suonando un coperchio) Prima ripresa! 162 RAGAZZO: Bene! 163 RAGAZZO: <Via>! 164 RAGAZZO: <Dai>! 165 RAGAZZO: Daje […]! 166 RAGAZZO: E fateve male! Daje! 167 RAGAZZO: <Se studieno>! 168 BOCCIO: <Zitti>! Zitti/ che mo se studiano! 169 RAGAZZO: Mena/ Romolo! 170 RAGAZZO: Daje/ a Salvató! 171 RAGAZZO: Mena! 172 ROMOLO: E strigni i pugni! Me pari na signorina! 173 SALVATORE: Mena pure tu! 174 RAGAZZO: [Vai] col destro! 175 RAGAZZO: Daje! Forza! Tingilo de rosso! Forza! 486 Il linguaggio cinematografico 176 ROMOLO: E tìrati su/ <pupazzo>! 177 SALVATORE: <Ahi>! 178 RAGAZZO: Fatece <vede ’r sangue>! 179 RAGAZZO: (passando in mezzo ai due litiganti che, di fatto, ancora non si sono toccati) Brecche>! (tutti ridono) 180 SALVATORE: (al ragazzo, dandogli un calcio) E viaggia! 181 ROMOLO: Ahó! Nun me toccà la faccia/ che ti spacco in quattro! 182 SALVATORE: E che me frega// Dove capita/ capita! 183 RAGAZZO: <Daje/ ch’ tuo/ Romolo>! 184 RAGAZZO: <Pijelo! Pijelo>! 185 ANNAMARIA: Dai Romolo! Dai! 186 RAGAZZO: Meneje […]! 187 ANNAMARIA: (vedendo Romolo colpito da Salvatore) Ah! 188 MARISA: Ah! Bravo/ Salvatore! 189 RAGAZZO: Vai! […]! 190 RAGAZZO: [Su le due]! 191 RAGAZZO: A presuntuoso! 192 SALVATORE: (accasciandosi dopo essere stato colpito da Romolo allo stomaco) Ahi! Ah! Aiaiàh! [Proprio qua]! Ah! 193 ROMOLO: E questo vi serva di lezione a tutti! 194 RAGAZZO: Vince Romoletto pe cappa o// 195 RAGAZZO: Ma come?! Lo fate andare via così/ al nuovo campione? Manco lo salutate? (fischi generali) 196 ROMOLO: A voi/ ve meno ’altro giorno! 197 TUTTI: Oh! 198 RAGAZZO: Te chiameremo mena! 199 RAGAZZO: Oh/ che [fichi]! 200 RAGAZZO: (a Salvatore, chinato in terra) A Toro Seduto! Rocky Marciano se n’è andato// Te puoi pure arzà// 201 RAGAZZO: (a Salvatore) Te sei fatto male? 6 – Dalla Commedia all’italiana ai giorni nostri 487 202 RAGAZZO: […] ’t’a fatto gniente! 203 RAGAZZO: Ma va’ 204 RAGAZZO: T’ha dato na bottarella// 205 RAGAZZO: (a Salvatore) Tiè/ infìlate la giacca// E non t’avvilì// 206 RAGAZZO: Ma tu ce credi? 207 LEONETTO: Eh/ scusa/ Salvatore/ hai visto Giovanna? 208 RAGAZZO: <[Mo becca ’no] sganassone>! 209 SALVATORE: (prendendolo per il bavero) <Ahó>! 210 LEONETTO: Scusa/ eh! (scappando) Arrivederci! (risate generali) 211 SALVATORE: Salve/ ragazzi// Ci vediamo domani// 212 TUTTI: Ciao// 213 RAGAZZO: Ciao/ Salvató// 214 RAGAZZO: Se vedemo// 215 RAGAZZO: Addio// (Salvatore raggiunge Romolo, Annamaria e Marisa) 216 ROMOLO: Di’/ t’ho fatto male? 217 SALVATORE: Sì/ mo i pugni tuoi mi fanno male! E vattene/ va’! 218 ROMOLO: Di’ un po’/ ma che è successo/ con Giovanna/ che è andata via con Ugo? 219 SALVATORE: Niente// L’ho scaricata// 220 ROMOLO: Hm// L’hai scaricata// Salvatore/ ma la vogliamo piantare/ di fare i buffoni! La vita cj ha pure/ il suo lato serio! Lo sai/ o non lo sai?! 221 SALVATORE: Lo so// Anzi/ ho deciso di cambià vita// Voglio lavorare/ mettere su famiglia/ e avere dei figli/ che in un domani/ vadano a testa alta// E non si vergognino/ del loro padre// (vedendo due ragazze che si avvicinano) Ahó! Guarda ste due! 222 ROMOLO: Che occhi/ che cj hanno! 223 SALVATORE: Buongiorno// 224 RAGAZZA2: Buongiorno// 488 Il linguaggio cinematografico 225 RAGAZZA3: Buongiorno// 226 ROMOLO: Che/ le conosci? 227 SALVATORE: Eh! 228 ROMOLO: Di’/ vogliamo cominciare domani/ a cambiar vita? 229 SALVATORE: Mah/ ti dirò// 230 ROMOLO: (indicando a Salvatore due ragazzi che si sono avvicinati a Marisa e ad Annamaria) Ehi/ guarda là! (a Marisa e ad Annamaria) Beh? 231 SALVATORE: Che vogliono/ sti due? 232 ANNAMARIA: Ci volevano accompagnare// 233 ROMOLO: Tz tz tz// No// 234 RAGAZZO6: Perché? 235 ROMOLO: E perché no! 236 SALVATORE: Perché so’ le nostre ragazze// 237 RAGAZZO7: Ma che/ ce fate l’amore? 238 ROMOLO e SALVATORE: Sì// 239 RAGAZZO6: <Ah>! 240 RAGAZZO7: <Ah beh>/ allora scusate/ pe carità// (Annamaria e Marisa se ne stanno andando, Romolo e Salvatore si mostrano indecisi se seguire loro oppure le ragazze appena incontrate) 241 ANNAMARIA: (gridando) <Romolo>! 242 MARISA: (c.s.) <Salvatore>! 243 ROMOLO: Andiamo! (Romolo e Salvatore rincorrono Annamaria e Marisa) 244 SALVATORE: Marisa! 245 ROMOLO: Annamaria! Annamaria! 246 SALVATORE: Marisa! ILLUSTRAZIONI 1 2 Figure 1–2. Cabiria, 1914, di G. Pastrone. Figura 3. Fabiola, 1949, di A. Blasetti. 4 5 6 7 Figure 4–7. Ossessione, 1943, di L. Visconti. 8 9 Figure 8–9. I promessi sposi, 1941, di M. Camerini. 10 11 Figure 10–11. Don Giovanni in Sicilia, 1967, di A. Lattuada. Figura 12. Il bell’Antonio, 1960, di M. Bolognini. Figura. 13. Senso, 1954, di L. Visconti. Figura 14. Burt Lancaster nel Gattopardo, 1963, di L. Visconti. Figura 15. Alain Delon e Claudia Cardinale nel Gattopardo, 1963, di L. Visconti. 16 17 18 Figure 16–18. 1860, 1934, di A. Blasetti. Figura 19. Pensaci, Giacomino!, 1936, di G. Righelli. Figura 20. Il feroce Saladino, 1937, di M. Bonnard. 21 22 23 Figure 21–23. Avanti c’è posto..., 1942, di M. Bonnard. Figura 24. Roma città aperta, 1945, di R. Rossellini. Figura 25. Ingrid Bergman in Europa ’51, 1952, di R. Rossellini. Figura 26. Europa ’51, 1952, di R. Rossellini. Figura 27. In nome della legge, 1949, di P. Germi 28 29 Figure 28–30. Il cammino della speranza, 1950, di P. Germi. 30 Figura 31. Catene, 1949, di R. Matarazzo. Figura 32. Due soldi di speranza, 1952, di R. Castellani. Figura 33. Totò in un’immagine promozionale di un film mai realizzato. Figura 34. Totò a colori, 1952, di Steno e M. Monicelli. 35 36 37 Figure 35–37. Il padrino (The Godfather), 1972, di F. F. Coppola. Figura 38. Donne in amore (Women in Love), 1969, di K. Russel. Figura 39. Sedotta e abbandonata, 1964, di P. Germi. Figura 40. Mery per sempre, 1989, di M. Risi. Figura 41. Delitto d’amore, 1974, di L. Comencini. Figura 42. Mimì metallurgico ferito nell’onore, 1972, L. Wertmüller. Figura 43. I fidanzati, 1963, di E. Olmi. Figura 44. Rocco e i suoi fratelli, 1960, di L. Visconti. Figura 45. Storie scellerate, 1973, di S. Citti. Figura 46. Nuovo Cinema Paradiso, 1988, di G. Tornatore. ANTOLOGIA CRITICA1 1. Abbreviazioni utilizzate all’interno dei brani riportati: NDA: introduce una nota dell’autore (ovvero presente nel testo citato); NDR: introduce una nota del redattore, ovvero dell’autore del presente volume, esplicativa di qualche aspetto del brano citato. I film menzionati in questa antologia, ed eventualmente privi dell’indicazione del regista o dell’anno di edizione, sono reperibili nell’Indice dei film. 1. PIER PAOLO PASOLINI I segni della lingua (linsegni) e i segni delle immagini (im–segni)* La semiotica si pone indifferentemente davanti ai sistemi di segni: essa parla di “sistemi di segni linguistici”, per esempio, perché ci sono, ma questo non esclude affatto che si possano teoricamente dare altri sistemi di segni. Mettiamo: sistemi di segni mimici. Anzi, nella realtà, a integrare la lingua parlata, un sistema di segni mimici deve effettivamente essere invocato. Infatti, una parola (linsegno) pronunciata con una data faccia ha un significato, pronunciata con un’altra faccia ha un altro significato, magari addirittura opposto […]. Il camminare soli per la strada, anche con le orecchie otturate, è un continuo colloquio fra noi e l’ambiente che si esprime attraverso le immagini che lo compongono: fisionomie di gente che passa, loro gesti, loro cenni, loro atti, loro silenzi, loro espressioni, loro scene, loro reazioni collettive […]; inoltre: cartelli segnaletici, indicazioni, direzioni rotazionali in senso antiorario, e insomma oggetti e cose che si presentano cariche di significati e quindi “parlano” brutalmente con la loro stessa presenza. Ma c’è di più — direbbe un teorico: ossia c’è tutto un mondo, nell’uomo, che si esprime con prevalenza attraverso * PASOLINI (1972/1991: 167–232). 523 524 Il linguaggio cinematografico immagini significanti (vogliamo inventare, per analogia, il termine im–segni?): si tratta del mondo della memoria e dei sogni. Ogni sforzo ricostruttore della memoria è un “seguito di im–segni”, ossia, in modo primordiale, una sequenza cinematografica. (Dove ho visto quella persona? Aspetta… mi pare a Zagorà — immagine di Zagorà coi suoi palmizi verdini contro la terra rosa —… in compagnia di Abd el–Kader… — immagine di Abd el–Kader e della “persona” che camminano contro le casermette degli ex avamposti francesi — ecc.) E così ogni sogno è un seguito di im–segni, che hanno tutte le caratteristiche delle sequenze cinematografiche: inquadrature di primi piani, di campi lunghi, di dettagli [→ Glossario, DETTAGLIO] ecc. ecc. […]. [M]entre la comunicazione strumentale che è alle basi della comunicazione poetica o filosofica è già estremamente elaborata, è insomma un sistema reale e storicamente complesso e maturo — la comunicazione visiva che è alla base del linguaggio cinematografico è, al contrario, estremamente rozza, quasi animale. Tanto la mimica e la realtà bruta quanto i sogni e i meccanismi della memoria, sono fatti quasi pre–umani, o ai limiti dell’umano: comunque pre–grammaticali e addirittura pre–morfologici (i sogni avvengono al livello dell’inconscio, e così i meccanismi mnemotecnici; la mimica è segno di estrema elementarità civile ecc.). Lo strumento linguistico su cui si impianta il cinema è dunque di tipo irrazionalistico: e questo spiega la profonda qualità onirica del cinema, e anche la sua assoluta e imprescindibile concretezza, diciamo, oggettuale. Per esprimermi diligentemente: ogni sistema di linsegni è raccolto e racchiuso in un dizionario. Al di fuori di quel dizionario non c’è nulla, se non forse la mimica che accompagna i segni nell’uso parlato […]. L’operazione dello scrittore consiste nel prendere da quel dizionario, come oggetti custoditi in una teca, le parole, e farne un uso particolare: particolare rispetto al momento storico della parola e al proprio. Ne consegue un aumento di storicità della parola: cioè un aumento di significato […]. Antologia critica 525 Per l’autore cinematografico, invece, l’atto che è fondamentalmente simile, è molto più complicato. Non esiste un dizionario delle immagini. Non c’è nessuna immagine incasellata e pronta per l’uso. Se per caso volessimo immaginare un dizionario delle immagini dovremmo immaginare un dizionario infinito, come infinito continua a restare il dizionario delle parole possibili […]. In circa cinquant’anni di cinema si è venuto stabilendo, è vero, una specie di dizionario cinematografico, ossia una convenzione: che ha questo di curioso: è stilistica prima di essere grammaticale. Prendiamo l’immagine delle ruote del treno che corrono tra sbuffi di vapore: non è un sintagma, è uno stilema […]. Non esistono dunque, in realtà, degli “oggetti bruti”: tutti sono abbastanza significanti in natura per diventare segni simbolici. Ecco perché è lecita l’operazione dell’autore cinematografico: egli sceglie una serie di oggetti o cose o paesaggi o persone come sintagmi (segni di un linguaggio simbolico) che, se hanno una storia grammaticale inventata in quel momento — come in una specie di happening dominato dall’idea della scelta e del montaggio — hanno però una storia pre–grammaticale già lunga e intensa […]. Ancora una cosa: nella sua ricerca di un dizionario come operazione fondamentale e preliminare, l’autore cinematografico non potrà mai raccogliere termini astratti. Questa è probabilmente la differenza principe tra l’opera letteraria e l’opera cinematografica (se importa fare tale confronto). L’istituzione linguistica, o grammaticale, dell’autore cinematografico è costituita da immagini: e le immagini sono sempre concrete, mai astratte (è possibile solo in una previsione millenaristica concepire immagini–simboli che subiscano un processo simile a quello delle parole, o almeno delle radicali, in origine concrete, che nelle fissazioni dell’uso, sono diventate astratte) […]. Tutto questo dovrebbe, in conclusione, far pensare che la lingua del cinema sia fondamentalmente una “lingua di poesia”. Invece, storicamente, in concreto, dopo alcuni tentativi, subito 526 Il linguaggio cinematografico troncati, all’epoca delle origini, la tradizione cinematografica che si è formata sembra essere quella di una “lingua della prosa”, o almeno di una “lingua della prosa narrativa”. Questo è vero, ma […] si tratta di una prosa particolare e surrettizia: perché l’elemento fondamentalmente irrazionale del cinema è ineliminabile. La realtà è che il cinema nel momento stesso in cui si è posto come “tecnica” o “genere” nuovo d’espressione, si è posto anche come nuova tecnica o genere di spettacolo d’evasione: con una quantità di consumatori inimmaginabile per tutte le altre forme espressive […]. Si può […] affermare che la tradizione della lingua cinematografica […] è tendenzialmente naturalistica e oggettiva. È questa una contraddizione così intrigante, che va osservata bene, nelle sue ragioni e nelle sue connotazioni tecniche più profonde. Infatti […] gli archetipi linguistici degli im–segni sono le immagini della memoria e del sogno, ossia immagini di “comunicazione con se stessi” […]: quegli archetipi pongono dunque una base diretta di “soggettività” agli im–segni, e quindi un’appartenenza di massima al mondo della poeticità: sì che la tendenza del linguaggio cinematografico dovrebbe essere una tendenza espressivamente soggettivo–lirica. Ma gli im–segni […] hanno anche altri archetipi: l’integrazione mimica del parlato e la realtà vista dagli occhi, coi suoi mille segni strettamente segnaletici. Tali archetipi sono profondamente diversi da quelli della memoria e dei sogni: sono cioè brutalmente oggettivi, appartengono a un tipo di “comunicazione con gli altri” quanto mai comune a tutti e strettamente funzionale. Così che la tendenza che essi imprimono al linguaggio degli im–segni, è una tendenza piuttosto piattamente oggettiva e informativa […]. Insomma il cinema, o il linguaggio degli im–segni, ha una doppia natura: è insieme estremamente soggettivo e estremamente oggettivo (fino al limite di una insuperabile e goffa fatalità naturalistica). I due momenti di tale natura coesistono strettamente, non sono separabili neanche in laboratorio […]. Ho definito in un titolo il cinema come “lingua scritta della Antologia critica 527 realtà”. E volevo dire che: la realtà è un cinema in natura (io mi rappresento a te, tu ti rappresenti a me […]) […]. Se il cinema altro non è dunque che la lingua scritta della realtà (che si manifesta sempre in azioni), significa che non è né arbitrario né simbolico: e rappresenta dunque la realtà attraverso la realtà. In concreto, attraverso gli oggetti della realtà che una macchina da presa, momento per momento, riproduce […]. Ecco, a questo punto si può individuare il rapporto della mia nozione grammaticale del cinema con quella che è, o almeno io credo essere, la mia filosofia, o il mio modo di vivere: che non mi sembra altro, poi, che un allucinato, infantile e pragmatico amore per la realtà […]. Mi è successo […] quello che succederebbe a un tale che facesse delle ricerche sul funzionamento dello specchio. Egli si mette davanti allo specchio, e lo osserva, lo esamina, prende appunti: e infine cosa vede? Se stesso. Di che cosa si accorge? Della sua presenza materiale e fisica. Lo studio dello specchio lo riporta fatalmente allo studio di se stesso. Così succede a chi studia il cinema: siccome il cinema riproduce la realtà, finisce col ricondurre allo studio della realtà. Ma in un modo nuovo e speciale, come se la realtà fosse stata scoperta attraverso la sua riproduzione, e certi suoi meccanismi espressivi fossero saltati fuori solo in questa nuova situazione “riflessa”. Il cinema infatti, riproducendo la realtà, ne evidenzia la sua espressività, che ci poteva essere sfuggita. Ne fa, insomma, una semiologia naturale. 2. LUIGI CHIARINI Il dialogo cinematografico* Della parola il film non ha mai potuto fare a meno, neppure ai tempi del muto, quando i dialoghi erano costituiti da brevi * CHIARINI (1957). 528 Il linguaggio cinematografico didascalie che si limitavano ai momenti salienti dell’azione drammatica. Se qualche rigoroso assertore della “pura visività” le riteneva un compromesso, la confessione di un’incapacità a risolvere tutto il racconto nelle immagini (e furono tentati film senza didascalie come Il Fuoco di Pastrone), altri, invece, tra cui Pudovkin, considerarono le didascalie un vero e proprio mezzo espressivo e formularono regole poetiche per il loro impiego in rapporto all’azione e al ritmo del film. Il sonoro, dando la voce ai personaggi dello schermo, ha posto tra gli altri problemi quello del dialogo cinematografico vero e proprio, che ha portato come conseguenza un mutamento nello stile della recitazione. Datano da quel tempo i dibattiti più accesi e le indagini critiche sulle differenze tra teatro e cinema. Non v’è dubbio che il dialogo cinematografico si distingue da quello teatrale per il carattere specifico dell’immagine filmica e per il valore che in essa viene ad assumere la parola in rapporto col visivo. Si tratta di un dialogo più immediato, aderente alla condizione sociale dei personaggi e all’ambiente, assai vicino al parlare comune e alieno da qualsiasi artificio letterario. Un dialogo che, a differenza di quello teatrale, essendo un’integrazione del linguaggio unitario del film, non ha un proprio autonomo valore espressivo né una piena funzione narrativa. Una parola, una semplice interiezione acquistano un particolare colorito a seconda dell’inquadratura con cui si accompagnano, che può essere un piano dell’interlocutore (e anche qui dalla FIGURA INTERA [→ Glossario] al PRIMISSIMO PIANO [→ Glossario] v’è una notevole differenza) ma anche di chi ascolta o di un altro personaggio o di un oggetto o un ambiente o addirittura un esterno. Pudovkin osservava giustamente che nessun regista farebbe vedere, durante la lettura di una sentenza di condanna, il giudice che legge anziché il condannato mentre ascolta. Quando il parlato non corrisponde alla visione di colui che parla si dice che è usato in modo asincrono. L’ASINCRONISMO [→ Glossario] è, dunque, un altro fattore condizionante del dialogo. Il fatto che il dialogo cinematografico non sia fondato su un valore letterario a sé stante, ma per far corpo col film debba il Antologia critica 529 più possibile essere aderente al personaggio e, quindi, all’attore che lo interpreta, porta alla conseguenza che quasi mai nella realizzazione sono conservati integralmente i dialoghi previsti nella sceneggiatura. Durante la stesura del copione, infatti, spesso non si conoscono i nomi degl’interpreti perché non sono stati ancora scelti; né si può prevedere, anche se alla sceneggiatura partecipa lo stesso regista, come saranno risolte in sede di ripresa certe azioni; ciò può dipendere da numerose circostanze che vanno dalla scelta degli esterni fino alla scenografia e all’arredamento. C’è, comunque, quel largo margine di imprevisto che può consigliare il regista di mutare l’azione o addirittura ispirargli una soluzione nuova. Per tutti questi motivi i dialoghi vengono adattati con mutazioni di parole oppure si allungano o riducono le battute a seconda delle esigenze di ripresa. Un tale caso capita, per es., quando al montaggio a taglio di una scena si sostituisce un movimento di macchina (carrello, PANORAMICA [→ Glossario]) o viceversa. Queste modificazioni possono essere più o meno notevoli a seconda del “genere” del film e della diversa importanza che assume in esso il dialogo e anche in base ai metodi di direzione del regista. In certi casi, come per es. nella Terra trema di L. Visconti, si giunge per ragioni artistiche fino a improvvisarli nella loro forma definitiva in sede di lavorazione. Le battute previste dalla sceneggiatura servono solo per indicare il contenuto. Per contro nei film comici o brillanti, dove il dialogo è spesso parte rilevante, queste modificazioni sono minori, pur essendo anche qui lasciato un margine all’estro degli attori, specie quando si tratta di comici che hanno una spiccata personalità. Allorché i dialoghi assumono un particolare valore, s’immette spesso tra i collaboratori alla sceneggiatura un dialoghista, in genere uno scrittore specializzato o un commediografo particolarmente adatto al “genere” del film. L’uso del dialoghista è soprattutto diffuso nella media produzione commerciale, ma tende a scomparire con l’alzarsi del livello qualitativo del film che porta sempre più ad affidare la sceneggiatura a un unico scrittore. 530 Il linguaggio cinematografico Questi sono i problemi che si presentano quando il film si gira in presa diretta, cioè a dire quando nella copia definitiva si mantiene la colonna del parlato registrata durante la lavorazione. Capita sovente, però, di registrare durante la lavorazione una semplice colonna guida: così chiamata perché servirà, appunto, di guida in sede di doppiaggio. Le ragioni possono essere di carattere economico o tecnico: per ridurre la spesa in quanto la lavorazione procede più rapida, oppure perché non ci sono condizioni ambientali per una buona registrazione, o anche quando s’impiegano attori, professionisti o presi dalla vita, che rispondono alle esigenze figurative del personaggio, ma che non hanno la capacità di dire con una giusta intonazione le battute del dialogo. In questi casi i dialoghi stessi subiranno un’ulteriore modificazione sia per ragioni di sincronismo (adattamento cioè delle parole al movimento delle labbra degli attori) sia perché spesso nella colonna guida sono stati alterati, magari per ottenere i voluti effetti di recitazione. Nei film stranieri doppiati le modificazioni sono in genere sensibili per raggiungere quel sincronismo che difficilmente si può avere con la traduzione fedele delle parole originali. Questo lavoro presenta notevoli difficoltà specie quando si tratta di opere che nella lingua originale impiegano un gergo particolare o addirittura espressioni e inflessioni dialettali. In taluni casi i traduttori–dialoghisti, specializzati per questo tipo di lavoro, devono addirittura coniare nuovi vocaboli che, se incontrano fortuna, finiscono per essere accolti nella lingua viva. È il caso della parola “picchiatello” con cui viene tradotta in italiano, nel film Mr. Deeds Goes to Town di F. Capra, la vecchia voce dialettale del Massachussets “pixillated”, che significa “persona cui manca una rotella, eccentrico, simpatico e divertente”. Nei paesi dove non vige l’uso del doppiato, si ricorre a concisi “sottotitoli”, che si sforzano di dare il succo delle battute. Il problema dell’adattamento del dialogo di un dramma o una commedia comporta due aspetti fondamentali: il primo riguarda la diversità di ritmo tra l’azione affidata prevalentemente alle immagini (film) e quella basata soprattutto sulla Antologia critica 531 parola (testo teatrale). La dinamica del film poggia su una struttura più articolata per cui episodi che nel dramma o nella commedia sono raccontati da uno dei personaggi, vengono tradotti in azione diretta; le stesse esigenze di montaggio non tollerano, molto spesso, la lunghezza delle battute teatrali. Il secondo aspetto è dato dall’integrazione, propria del film, del parlato con l’espressione mimica in unico linguaggio, e comporta, naturalmente, la necessità di scardinare la costruzione letteraria del dialogo teatrale. La stessa recitazione cinematografica, che si avvale tanto della possibilità di analisi della macchina da presa (il Primo Piano dell’attore può cogliere le più impercettibili espressioni del volto) quanto di quelle del microfono (l’interprete cinematografico non ha bisogno di “mormorare gridando” secondo la felice espressione usata da Pudovkin per quello teatrale, giacché possono essere registrati i suoi toni più sommessi, anche i sospiri e persino l’ansimare), richiede una maggiore naturalezza del dialogo, impostato comunque su una convenzione diversa da quella teatrale. Di fronte alle opere classiche, di alto valore poetico, il problema diviene quasi insolubile e si accosta per molti riguardi a quello della trasposizione cinematografica del melodramma. Le numerose riduzioni dei drammi shakespeariani hanno provocato studi e discussioni. Se in genere la critica è stata quasi concorde nel condannare i metodi di alterazione e manipolazione intesi a rendere “cinematografici” i testi poetici di Shakespeare (l’Hamlet di Olivier, l’Othello di Welles, il Giulietta e Romeo di Castellani), non v’è dubbio che anche nelle forme più rispettose dell’integrità dell’opera letteraria, come Henry V dello stesso Olivier, l’immagine finisce per prendere il sopravvento sul parlato: nel film, insomma, lo spettacolo visivo ha un risalto che va a danno del testo […]. 532 Il linguaggio cinematografico 3. RUDOLF ARNHEIM Muto contro sonoro I.* Dato che in queste settimane cade il decennale del cinema parlato, abbiamo creduto opportuno di esaminare, come prima cosa, la posizione che il pubblico cinematografico assume di fronte a questo nuovo dono della tecnica, limitandoci alle risposte di due gruppi molto distanti, e precisamente degli operai e degli studenti. Fra gli operai, il film muto sembra che non abbia più fautori. Si delineano molto chiaramente due ragioni per cui la preferenza è data al sonoro. L’uomo semplice trova nello spettacolo filmico la possibilità di partecipare ad avventure emozionanti. Non gli importa gran che se queste avventure sieno presentate o meno con quella purezza stilistica che avvicina l’avvenimento individuale alla validità dell’idea universale; cerca lo stimolo della realtà immediata. Ora, questo senso di realtà immediata è evidentemente aumentato di molto dall’aggiunta delle voci e dei rumori all’immagine. Nel film sonoro «c’è più realismo», scrive un operaio; esso dà «maggiore vita e risalto alla scena e agli interpreti», dice un altro. Il sonoro «dà vita e animazione alla scena che si svolge». (Le parole in cui si esprime questa sensazione sono spesso quasi identiche). Conseguenza del maggiore realismo è naturalmente un effetto emotivo più intenso: «il sonoro mi dà più emozione». Un altro vantaggio del film parlato è non meno persuasivo. Il cinema muto trovava una considerevole difficoltà nello spiegare trame un poco complicate e nel far comprendere i rapporti fra i vari personaggi: bisognava ricorrere a simboli visivi, al mezzo indiretto delle didascalie, ecc. La necessità delle trasposizioni ottiche di concetti e di pensieri ha portato il cinema, indubbia- * ARNHEIM (1937). Antologia critica 533 mente, alle sue più originali e più belle espressioni, ma il silenzioso gesto di un giovane innamorato che sfiorava con le labbra il bicchiere in cui la ragazza aveva bevuto, non aveva certo la diretta comprensibilità delle poche parole banali: «Ti amo tanto!». Perciò: «Si può seguire più facilmente la trama», oppure: «Il parlato definisce meglio certe situazioni che affaticherebbero troppo la mente…». Gli stessi argomenti ritornano anche nelle risposte degli studenti («Il sonoro è alla portata di tutti i cervelli» – «ci evita lo sforzo di leggere» – «aiuta e rende esplicite molte allusioni che prima si affidavano al più difficile linguaggio della pantomima o dei giochi di inquadratura, d’obbiettivo o di illuminazione»), ma sono completati da molti altri ragionamenti di diverso genere. Gli studenti cercano di dimostrare che, al di là della loro impressione personale, il film sonoro rappresenta in sé un maggior valore assoluto: «Una frase ben detta dall’attore vale più di una frase, anche se è ben letta, dallo spettatore». Il sonoro è un mezzo di registrazione più completa: ci permette di sentire «il canto di certi magnifici artisti» e, soprattutto nei film documentari, presenta, oltre all’immagine, anche «le voci e rumori di paesi lontani». I mezzi dell’attore sono arricchiti, il suo lavoro è facilitato: gli interpreti manifestano una «personalità più spiccata» e una «mimica più economica». Data l’età degli studenti, non tutti si sentono in grado di giudicare il muto: «Ne conservo pochi e vaghi ricordi» – «Non ricordo nessun film muto». Ci troviamo di fronte a una generazione che, frequentando le sale solo da circa dieci anni, quasi non discute più il sonoro; al massimo, si sforza di giustificarlo. Una certa prevalenza dell’argomento più debole in favore del sonoro si spiega anch’essa con la giovinezza di chi lo cita: i giovani sono incantati dall’idea del “progresso” senza indagare troppo quale ne sia la portata. Infatti, chiamare “antistorica” la preferenza data al muto, è un punto di vista mai ammesso nel campo dell’arte, dove si equivalgono le opere di tutte le epoche. Altrettanto male regge l’analogia con la tecnica («significherebbe usare la candela invece della luce elettrica»), perchè anche se 534 Il linguaggio cinematografico il sonoro rappresenta un importante perfezionamento della registrazione documentaria, abbracciando come fa un maggior numero di dati reali, non è, con questo, deciso ancor niente sul valore artistico dell’innovazione. È molto più seria l’affermazione che il sonoro abbia messo a disposizione del regista «un nuovo mezzo espressivo», anche se non tutti sieno disposti ad ammettere che esso «non disturba minimamente l’immagine». Molti anzi si lamentano dell’irrigidimento subito dalla scena visiva: «Dopo l’introduzione del sonoro, il cinema, invece di diventare sonoro, è diventato più o meno teatro» – «Occorre che la musica e il suono non invadano il primo piano, perchè il cinema è e rimarrà sempre arte visiva» – «Si constata una sorta di contaminazione fra il cinema, che non è parola, e il teatro, che è, quasi esclusivamente, parola» – «Dialogo scarno: azione, azione, azione!». Abbiamo detto che la maggior parte dei giovani studenti non vede la possibilità di discutere il parlato come principio, e perciò le obiezioni qui citate non si dirigono contro il nuovo mezzo in sé, bensì contro il suo uso attuale. È «quistione di misura». Tuttavia non mancano quelli che vi sospettano un problema più fondamentale. Dà a pensare il fatto che «l’arte di alcuni grandi artisti, per es. quella di Keaton, è stata distrutta dal parlato». Per questa ragione, alcuni non esitano a dare la preferenza al muto: «Certi gesti di Charlot e della Garbo valgono qualunque battuta». I capolavori del cinema appartengono all’epoca presonora; ma potrebbe tuttavia darsi che la colpa non sia unicamente della parola parlata: «La sempre più perfetta organizzazione industriale tende a fare del film un prodotto soprattutto commerciale, anonimo, o che al massimo reca l’impronta della Casa editrice. Questa eleva il tono medio della produzione, ma non permette più a personalità potenti di esprimere liberamente il proprio mondo poetico. E le opere vitali sono più rare che mai». Un’osservazione che tocca le radici del problema estetico: «Il suono mi impedisce di gustare gesto e fotografia»; e due risposte alle affermazioni di quelli secondo i quali una maggiore completezza dei mezzi tecnici porta ad una forma artistica più Antologia critica 535 elevata: «Un vero capolavoro resta tale anche se gli è tolta la favella» – «Ogni forma d’arte in sé è completa, e quindi un muto non è da meno di un parlato». Ma c’è anche un argomento più specifico: la mancanza del dialogo; l’incompletezza del fenomeno dava alle ombre sullo schermo qualcosa di misterioso e di irreale che affascinava e lasciava maggior spazio alla fantasia dello spettatore: «Preferisco il muto perché io potevo dare ai personaggi le mie parole» – «Il muto mi faceva sognare, il parlato mi avvicina di più alla realtà; preferisco sognare però». Il che tornerebbe a dire che le creazioni del cinema muto erano più vicine a quella sfera irreale dove si muovono i fantasmi leggeri e puri dell’arte. II.* Il disagio suscitato dai film sonori è provocato, sembra, dal fatto che l’attenzione dello spettatore viene distolta, perché attratta verso due campi opposti: due mezzi combattono per conquistare lo spettatore invece di avvincerlo con forze concordi. Poiché tali mezzi si affaticano a esprimere in modo doppio l’identico soggetto, si crea una sconcertante simultaneità di due voci, ognuna delle quali non può dire che la metà di quanto vorrebbe, perché disturbata dall’altra […]. Non pare probabile che la causa del disagio suscitato dal cinema parlato sia di per sé la combinazione di immagine in movimento e parola parlata; giacché tale accoppiamento sembra giustificato dall’arte del teatro, arte antichissima e molto feconda. L’errore potrebbe invece risiedere nel modo speciale in cui il cinema parlato effettua questa tradizionale combinazione […]. [P]er giustificare l’accoppiamento di più mezzi — per esempio dell’immagine animata e della parola — in un’opera d’arte non basta il fatto che anche nella realtà elementi visivi e sonori * ARNHEIM (1938: 3–32). 536 Il linguaggio cinematografico appaiono intimamente collegati, anzi come unità inseparabile. Occorrono invece ragioni artistiche per una tale combinazione: essa deve servire per esprimere quanto con un solo mezzo non potrebbe esprimersi. Un’opera d’arte “composta” è […] possibile soltanto se organismi completi, creati dai singoli mezzi, si integrano in forma di parallelismo. Questo “doppio binario” però avrà un suo significato soltanto se i singoli elementi parziali non dicono la stessa cosa, ma si completano nel senso di esprimere in modo diverso un comune soggetto. Ogni mezzo deve parlare del soggetto a modo suo, e le differenze che nascono debbono corrispondere a quelle esistenti fra i caratteri dei mezzi stessi […]. [I]l film parlato […] avrebbe bisogno di un mezzo dominante. Questo mezzo non potrebbe essere che l’immagine animata, giacché il predominio della parola ci porterebbe al teatro […]. È possibile dunque il film parlato? Ci siamo resi conto del fatto che il dialogo costringe l’azione visiva a mettere in primo piano l’uomo che parla, e che esso irrigidisce e deforma la pantomima sullo schermo. Perciò ci sembra difficile che possa diventar artisticamente fruttifero un genere cinematografico in cui un’azione visiva predominante si basi su un conciso dialogo. Resta a vedere se può rendere di più un tipo di film in cui immagine e parola siano in equilibrio, di modo che una pantomima, abbastanza ricca per soddisfare alle esigenze dell’occhio, venga completata da un dialogo, non troppo esteso per non distruggere l’azione visiva ma tuttavia sviluppato al punto da produrre insieme all’immagine un’opera sostanziale. In senso generale e teorico, non si può non rispondere altro in proposito che citare il risultato delle nostre ricerche secondo le quali l’accoppiamento di più mezzi in un’opera d’arte non avviene generalmente sulla base di un equilibrio dei mezzi, ma invece sotto forma di una gamma gerarchica dominata da un mezzo prevalente […]. [L]’attuale produzione cinematografica […] tenta […] disperatamente di creare un complesso ricreativo combinando scene di dialogo sviluppatissime e otticamente aride con intermezzi ricchi di azione esterna nello stile, del tutto differente, del cine- Antologia critica 537 ma muto. Si verifica inoltre, rispetto all’epoca del cinema muto, un impressionante abbassamento di qualità artistica, tanto per la produzione media quanto per il livello dei film “migliori” […]. Le invenzioni tecniche della registrazione meccanica di immagini e di suoni possono essere utili all’umanità in due sensi diversi, a prescindere dalle loro importanti funzioni sociali. Possono servire per conservare fedelmente le creazioni della natura e dell’uomo, e questa applicazione di esse soddisfa a un antichissimo bisogno dell’umanità diventato molto forte specialmente nell’epoca delle scienze naturali, ossia dal Rinascimento in poi. D’altra parte esse possono aumentare i mezzi d’espressione dell’arte, in quanto offrono l’affascinante realismo della rappresentazione meccanicamente fedele e permettono un rapido variare degli ambienti e anche delle posizioni da cui il pubblico segue l’avvenimento. Questi mezzi diventano sempre più adatti alle loro mansioni “documentarie” se all’immagine monocroma e piatta si aggiungono il colore, la plasticità e il suono e se, nel caso della radio, al suono si aggiungono le immagini. Ma circa l’applicazione artistica constatiamo che, per esempio, la registrazione meccanica dei colori naturali aumenta i mezzi d’espressione dell’immagine ma anche la dipendenza della rappresentazione dal soggetto naturale, il che limita ancora di più la libertà creatrice dell’artista. Dell’influenza distruttiva del suono sull’arte dell’immagine abbiamo parlato abbondantemente. Viceversa, l’aggiunta dell’immagine televisiva distrugge le capacità creative del suono senza immagine, nella radiocommedia. Secondo che si parta dal punto di vista dell’arte o da quello della documentazione, si arriva dunque a giudicare diversamente l’utilità dei diversi mezzi di registrazione. Entro certi limiti, la fedeltà meccanica agevola l’arte e l’arte rende più fedele la fedeltà. Oltre a ciò si provocano contrasti fra i due atteggiamenti. Un’epoca artisticamente più dotata della nostra avrebbe potuto salvare e sviluppare i nuovi mezzi artistici, senza venire ostacolata dal contemporaneo perfezionarsi della riproduzione meccanica, realizzato attraverso la registrazione di un numero sem- 538 Il linguaggio cinematografico pre maggiore di elementi sensibili della realtà. Essa avrebbe potuto conservare il cinema muto accanto al film parlato, la radiocommedia accanto alla televisione. Purtroppo […] soltanto in un’epoca di poca sensibilità artistica, crediamo di aumentare l’arte perfezionando l’imitazione […]. Il mezzo meccanico vince l’uomo creativo. 4. ETTORE ALLODOLI Il (neo)purismo e lo spirito antiborghese nella lingua del cinema I.* La produzione cinematografica è […] talmente sui generis rispetto alle altre letterarie artistiche che il soggettista può rimanere allo stato di autore di canovaccio e la rielaborazione dialogico–linguistica potrebbe essere compiuta da un altro senza troppo scandalo. Quello che occorre è la massima reverenza alla lingua italiana nel momento dell’attuale sua evoluzione e nel punto della sua freschezza reale immediata. La simultaneità scorrevole delle cose sullo schermo non tollererebbe nel linguaggio nessuna riesumazione filologica e nessun fantasioso anticipo. Il popolo che affolla le sale vi si deve riconoscere in quel preciso affermarsi della personalità che è il parlare. Se si continuasse a rendere stabile una forma di espressione sbiadita, poco colorita, fatta di svenevolezze tra borghesi e aristocratiche né carne né pesce e cosparsa di sfarfalloni, grave sarebbe il danno sull’animo del pubblico il quale va al cinema fiducioso, con l’intento di divertirsi anzitutto, ma è lieto di uscirne come da una scuola piacevole dove ha imparato molte cose e sarà purtroppo tratto ad imitare, esprimendosi, certe superfluità ridicole che potranno sembrare oro colato, avendole sentite in bocca a * ALLODOLI (1937: 4–11). Antologia critica 539 quei signori in frak o a quelle signore scollate che ha ammirato con occhi luccicanti nel buio della sala di proiezione […]. [I]l linguaggio corrente dei nostri film è ormai da un certo tempo molto intonato all’evoluzione generale della lingua e dello stile nazionale che va verso il semplice e la franchezza, verso la istintiva aderenza al pensiero senza fronzoli ipocriti, senza ornamenti insulsi […]. Posto così il problema si vede la difficoltà e gli ostacoli che si oppongono invece ad adeguare al linguaggio italiano, quale è ora e quale vogliamo sia riconosciuto da tutti, il fondo linguistico del film doppiato. (A proposito di tale parola “doppiato” si è spesso scritto in note di controllo filologico che doppiaggio è parola per noi barbara e che può in ogni caso sostituirsi con il participio sostantivato “doppiato” (da doppiare, buona parola nostra per raddoppiare e metaforicamente non indegna di significare “tradurre”, il tradurre specialissimo che è il trasportare un film dall’edizione originale in un’altra. La parola si può adoperare anche come aggettivo. “Il film doppiato”. “Il doppiato del film”). Ma questo “doppiaggio” impera dovunque ancora e proprio nella terminologia ufficiale. Come si fa per bandirlo una volta per sempre?). Nel caso del doppiato, oltre alle storture convenzionali che si avvertono nel linguaggio mondano e di falsa società e nelle sue applicazioni a situazioni diversissime, anche del film italiano, si hanno in più, per la costrizione dell’adattamento, gravi inconvenienti. La diversità di durata nella pronunzia tra la nostra lingua e quella di altre lingue ha la sua esteriorizzazione proprio su labbra che si vedono muoversi e dalle quali escono suoni che si sentono, nello stesso tempo: avrebbero mai immaginato i nostri traduttori del passato secolare un simile letto di Procuste? Ma non bisogna esagerare la difficoltà: la lingua italiana ha tali risorse di sinonimi e di doppioni, di parole affini che si distingue per tale caratteristica da tutte, quasi, le altre: ha sfumature vocaboliere quante se ne vogliano. È ricchissima in forme aggettivali e sostantive, in scambi di funzioni tra categoria e categoria, in costruzioni e reggimenti verbali e preposizio- 540 Il linguaggio cinematografico nali. Un attento conoscitore della nostra lingua e di quella straniera e un osservatore al corrente dello stato attuale della lingua nazionale non dovrebbero essere imbarazzati a ricavare i risultati migliori […]. Non vogliamo che il cinema prenda l’andazzo di un divertimento letterario ridotto per piccoli borghesi. Sia una cosa diversa dal libro anche per linguaggio, ma non mai un sunto né una riduzione manualistica. L’espressione linguistica in cui si risolve cinematograficamente Dostojewski, Hugo, Dumas, Sthendal dev’essere un’espressione italiana, tutta italiana attuale ma che deve aderire e far aderire le migliaia di anime a quelle unità artistiche inconfondibili […]. Nel cinema però qualche volta il doppiatore deve sapere sparire e lasciare le cose come stanno […]. Nell’“Uomo di Aran” poema cinematografico di fragore oceanico, di cupezza nordica, nell’edizione italiana c’erano certe interruzioni di pescatori in dialetto che parevano e volevano forse essere napoletano, e sciupavano ogni nostra commozione davanti a quella barbarie desolata di natura che non doveva essere richiamata a visioni solari e serene, in quel momento. Mentre, quale drammatica efficacia, per citare a caso, nei film di motivo cinese come “Tempeste sull’Asia”, “L’Amaro Tè del generale Yen”, “Shangai Express”, ecc. il sentire dare in cinese certi secchi comandi di fucilazione o di taglio di teste! […]. È evidente che una rappresentazione in lingua originale dei film stranieri che teoricamente toglierebbe di mezzo ogni difficoltà non è possibile. Sarebbe però bello immaginare il giorno in cui i film italiani siano di tale preponderanza artistica e numerica che possano ridurre al minimo l’importazione degli altri di fuori, e all’estero siano integralmente sentiti e visti da milioni di spettatori: trionfo imperiale della lingua italiana. Questo è un ideale ma per avvicinarvisi un poco si potrebbe intanto da noi, più di quello che attualmente si faccia, spesseggiare in film dati nella lingua originale, con opportuni sottotitoli, e non a un ristretto pubblico di competenti o di amatori raffinati, ma anche al gran pubblico […]. Antologia critica 541 Ogni film dovrebbe avere il suo revisore linguistico obbligatorio, e annunziato sullo schermo insieme con tutti gli altri collaboratori […]. Revisore: che dovrebbe essere persona diversa dal soggettista o dall’autore dei dialoghi o dal traduttore o riduttore di quelli stranieri. Revisore: persona riconosciuta ufficialmente e responsabile dell’espressione italiana nei film nostrani e doppiati, che talvolta potrebbe non avere quasi nulla da obiettare e talvolta avere molto lavoro […]. Anche nelle produzioni cinematografiche migliori e più intonate alla modernità del linguaggio c’è sempre qualche cosa che non va […] [N]el dialogo […] [NDR: del film La kermesse eroica (La Kermesse héroïque), 1935, di Jacques Feyder] un «Mi pungi» […] poteva essere sostituito benissimo da un «Mi buchi». «Allò, allò» va sparendo ma ci sono ancora il «rendez–vous» e il «savoir faire». Si sente ancora a tutto spiano ripetere nella conversazione il “voi” formula di convenienza non più comune, non familiare, non propriamente nostra, e che dà al colorito dialogico un tono mondano snobistico, un tono esagerato e falso […]. «Quante nel the? una zolla, due?» (grande e dura parola, come immeschinita!), «un attimo» (qualcuno degli spettatori non dirà più «un momento» e vorrà dire anche lui «un attimo» perché l’ha sentito da una elegante signora sullo schermo), e «Addio» in principio d’incontro tra due è grottesco ché la sublime parola si pronunzia solo nel licenziarsi. E si dovrebbe togliere di mezzo «sàlubre», «règime», sdruccioli che si sentono ripetere da qualche annunziatore cinematografico, «camera da letto» (basta: «camera»). Ultimamente ho anche sentito nell’«Angelo bianco» (perché non: «Angiolo»?): «la sentinella non farà passare», «lei fa il suo dovere» dove è da notare la doppia stortura: forma oggettiva adoperata per la soggettiva e mancata sostituzione, come l’uso ormai richiede, con il dimostrativo «essa». E che dire poi dei lunghissimi imperfetti in seconda persona plurale che danno carattere eccessivamente mondano […], «mi amavate», «mi baciavate», «mi baciucchiavate», «mi aspettava- 542 Il linguaggio cinematografico te» […], ecc., che sparirebbero per il ripristino integrale della formula di convenienza col «lei» ma che, se di necessità rivolte effettivamente a un plurale, andrebbero ogni tanto (dico ogni tanto perché altrimenti sarebbe generalizzazione troppo popolare) sostituite, per un senso di compendiosa abbreviazione, come succede in realtà, con le forme della seconda singolare («aspettavi» per «aspettavate») ad evitare, come si è fatto ormai generalmente col «si» precedente la terza singolare, suoni lunghi, lenti e incomodi, come fanno anche i francesi col loro imperfetto congiuntivo, il quale può arrivare a forme ridicolissime […]. Di tali piccolezze, se così appariranno a qualcuno, è fatta non la critica a lavori di molto impegno e di grande coscienza ma l’appassionata e vigile attenzione a tutto quello che riguarda la lingua italiana, che è dovere di tutti noi parlare e scrivere in ogni occasione, con la massima consapevolezza e le cui forme bisogna riconoscere nella fase attuale a cui la nuova civiltà nostra l’ha condotta. II.* Il cinema influisce ogni giorno su milioni e milioni di esseri come il libro su alcune migliaia, e questo è un fatto nuovo di divulgazione delle cose espressive, dopo secoli e secoli; perché, anche nei periodi di massima diffusione di lettura nelle classi popolari, il libro goduto è stato sempre privilegio di una minoranza […]. [I]l tono dialogico dei film italiani (e quello dei doppiati […]) è spesso slavato, sbiadito, svenevole e privo di quell’evidenza rappresentativa, cui è invece arrivata la nostra prosa narrativa, la nostra letteratura di creazione e, in parte, anche il teatro. Il cinema, che è il più in vista e il più diffuso tra i mezzi linguistici espressivi, dovrebbe invece essere l’esempio di questo * ALLODOLI (1938: 43–47). Antologia critica 543 nuovo stile e del momento attuale, a cui è giunta la coscienza linguistica italiana. La nostra arte letteraria significa ormai, nei migliori suoi rappresentanti: franchezza, energia, assenza di colorito dialettale, provinciale, locale, proprietà più che purità nel senso vecchio, e purezza intransigente in ogni caso, consona allo spirito fonetico, morfologico, sintattico e al genio linguistico nostro. Colpi sempre diretti alla meta, abolizione di fronzoli, di doppioni, d’inutili sinonimi, di aggettivazioni non necessarie, rifiuto di francesismi, inglesismi, anche di quelli di insidiosa apparenza e che vengono quotidianamente usati, presa di possesso di cose, di immagini, di espressioni originali, ardite, rinnovamento pratico e ideale insieme della parola nella sua varia funzione, nella sua diversa collocazione, nei suoi infiniti scambi di valori e di categorie. Tutte queste belle cose che riassumono alla meglio la poetica di oggi in arte letteraria e nella quale tutti, più o meno, son consenzienti, anche se non la vogliono o non la possono o non sanno mettere in esecuzione, dovrebbero fornire la base o il clima per quella narrazione romanzesco–novellistico–drammatica sui generis, che è il dialogo o racconto del film, il quale non può straniarsi dal resto della vita espressiva italiana, riducendosi ad essere in secondo ordine o in arretrato rispetto alla letteratura degna del nome: carrozza a cavalli di fronte all’automobile e all’aeroplano: Carolina Invernizio accanto a Paola Drigo: il portavoce accanto al telefono. Dicendo questo non siamo pessimisti. Ottimisti invece […] e fiduciosi di essere nel vero da volere appunto che il cinema, come espressione parlata e quindi letteraria, si adegui al resto e sia lui stesso l’iniziatore impetuoso e geniale. Diciamo anche che in alcuni film originali italiani come Il signor Max, l’adeguazione linguistica e stilistica è abbastanza efficace, anche nelle gustose parti, volutamente parodistiche e caricaturali, di linguaggio snobistico, falsamente aristocratico. A proposito del quale, è da dire che esso nella cinematografia attuale di tutti i paesi, invade e colora di sé gran parte del dialo- 544 Il linguaggio cinematografico go e dell’azione in generale: con effetti disastrosi per il pubblico popolare. Questo può credere che così si debba dire tra parlanti, poiché in tal modo si esprimono i personaggi del cinema, messi avanti da gente istruita e che, nella maggior parte dei casi, rappresentano signori o pezzi grossi […]. Quante volte ho colto in film ultimamente visti: «le possibilità», «drammatizzare», «accordare» per concedere, «banale», «programmazione», «orchestrazione», «che bello» […], «in nome del Cielo», e zeppe simili, che pure nel doppiato si possono evitare benissimo, tenendo conto di infiniti equivalenti. E ancora: «Volete un cocktail?», «Mi piace la vostra garçonnière» […], «Papà» dice il figlio morente in Tarass Bulba, «Te ne supplico» dice alla moglie che muore Wang Lung nella Buona Terra. E papà si trova di frequente e quasi sempre nella più semplice forma di colloquio; e padre e madre, usati come vocativo, che è un mostro grammaticale poche volte veduto. «Ne vien ora» (Ramona), «sono emozionata», «non ha importanza» (Parnell), «battimi, Sahib» (Danza degli elefanti) (perché non: picchiami?), «buttagli un’offesa» […], «Ho preso in affitto un bambino» (La Jena di Barlow), «Si sarebbe sparata» (La Figlia perduta), «Mai ti ho veduto» (Anime sul mare); «mai» non ha senso negativo se non è accompagnato da «non». «Dammi del fuoco» (Incontro a Parigi), «ti reclamo» (Voglio danzare con te). «Il tenore sarà rimpiazzato» (Chi è più felice di me), «perle fine» (plurale) (Le perle della corona). Vi sono poi le storture fonetiche, che spariranno certamente quando il conguagliamento e l’unificazione, che è in atto, attraverso varie scuole di radio, di recitazione e di dizione, avrà dato i suoi frutti. Al sensibile orecchio degli spettatori arriva spesso, ricordo tra i tanti esempi: «incròciano», con l’o aperto, (Pepé le Moko), «zoppa» con la zeta sonora (Dottor Antonio), «A tutti i cósti» con l’o stretta (I Lloyds di Londra), «Rodólfo» pure con l’o stretta (Mayerling). E qualche cosa si può pescare sempre, anche quando parlano gli annunziatori, che illustrano i documentari o il giornale Luce: […] ricordo certe preziosità nella presentazione d’un gruppo di Antologia critica 545 uccelli, che per il freddo andavano intorno all’uomo: «si rinnova il miracolo francescano» nientemeno; e una sostituzione letterarissima ad una semplicissima parola: «le donne», dette pomposamente «le figlie d’Eva». 5. PAOLO MILANO L’antipurismo e l’uso medio nella lingua del cinema* Che lingua, che italiano devono parlare quelle larve danzanti, quelle siluette impalpabili e frementi che sono i personaggi del Cinema? C’è il caso che la «questione della lingua», viva e verde con tanti secoli addosso […], ottenga finalmente un paragrafo nelle estetiche dello schermo italiano? […] [C]he valore ideale, quale funzione esteticamente appropriata può avere il dialogo in un film? Gettiamoci allo sbaraglio, e, saltando a piè pari la trafila delle argomentazioni, diciamo che il dialogo sta al film come il libretto alla musica d’opera. Per noi il film è un’arte figurativa a cui il movimento impone l’obbligo di narrare. Ma una pantomima tutta silenziosa, o s’attiene a una vicenda molto povera, oppure s’inceppa nel racconto, perché le mancano le cerniere, quelle che nel film muto erano fornite dalle didascalie. Ben venga dunque il dialogo ad offrire i trapassi e i nessi logici su cui si leveranno i ritmi della visione, appunto come nell’opera lirica sull’ordito del libretto si annoda la trama della melodia. Ma come nel melodramma tutto è funzione della musica, così nel film tutto sbocca nell’immagine semovente: libretto o dialogo, sono il materiale grezzo, il recipiente, l’impalcatura, la pedana da cui l’arte prende lo slancio. E allora, se questo è vero, che dialogo si dovrà parlare? Che linguaggio sceglierà il Cinema, fra i molti che ogni lingua possiede? Il più semplice, il più documentario, il più legato all’esistenza spicciola e quotidiana. Qualunque altro lin- * MILANO (1938). 546 Il linguaggio cinematografico guaggio più sostenuto, letterario o (come si suol dire) aulico, rischierebbe d’assumere un valore artistico proprio, a tutto scapito della visione filmica, in ibrido e sterile connubio. Basta ricordare i versi di Shakespeare scanditi da Howard o dalla Shearer nel Romeo e Giulietta filmato (mentre la macchina da presa tentava di ingannare il tempo passeggiando sugli oggetti e sulle persone), per convincersi che sullo schermo si deve parlare poco, e il linguaggio di tutti i giorni. Così stando le cose, gli americani sono a cavallo. Quando si loda il dialogo dei loro film, si pensa di solito al frizzante delle battute, alla mirabile (sebbene un po’ frigida) loro tecnica della ripetizione, dell’analogia, del richiamo. Ma assai più notevole, e meglio efficace, è la lingua che i personaggi parlano: quel gergo disossato e breve che sembra fatto di ammiccamenti e di urti più che di parole, quell’inglese d’oltresponda diventato irrispettoso e pregnante. È la lingua cinematografica per eccellenza, sia detto senza complimento: cioè la lingua più lontana dalla poesia. Altro polo della storia e della civiltà linguistica è l’italiano. Una traduttrice intelligente mi osservava, tempo fa, che è meno difficile rendere italiano le celesti, immacolate movenze della prosa di Hoelderlin che non un lavoro di Sacha Guitry. Verissimo; e chi ha voglia provi. Per il linguaggio nobile esistono, in italiano, collaudate dalla tradizione più illustre e più antica d’Europa, tutte le forme e tutti gli strumenti. Ma provatevi a tradurre in modo vivente e diretto, una frase semplicissima come: «ne m’en veux pas»! «Non mi serbare rancore», anzi «non me ne serbare rancore»? Fa ridere soltanto a proporlo: chi mai nella vita lo ha detto, o lo direbbe, a una persona cara? Dopo rimuginate nel cervello tutte le impossibili soluzioni in lingua, un napoletano finirebbe per chiedere aiuto al dialetto: «No te piglià collera»! Se avete per amico qualche commediografo nostro scrupoloso e artista, stuzzicatelo sull’argomento: vi confesserà che quella della lingua è la sua croce e delizia; e che le battute dello scenone drammatico al second’atto non gli danno nessuna preoccupazione linguistica, mentre quelle del dialogo d’inizio fra il cuoco e la cameriera, moltissima. Antologia critica 547 Anni fa fece il giro delle ribalte italiane un dramma di guerra di Alberto Colantuoni, La guarnigione incantata, che qui ci interessa da un punto di vista molto particolare. Nella nota da cui l’autore fece precedere la pubblicazione a stampa del lavoro, si leggeva: «Il dissidio fondamentale tra lingua parlata e regola scritta, ostacolo fondamentale a ogni sincerità discorsiva in molte opere del nostro teatro di prosa, è superato qui — dovunque il caso lo richieda — con l’infrazione più coraggiosa di ogni ortodossia grammaticale. …Ogni sforzo degli interpreti vada quindi rivolto a non danneggiare con amplificazioni arbitrarie del colorito la necessaria umiltà di questo stile, tanto ‘vissuto’ da somigliare a un documento». Qui sto parlando di cinema, e quindi non mi dilungherò a chiarire per quali motivi io ritengo (al contrario di Colantuoni) che il Teatro con la t maiuscola non abbia gran bisogno di «linguaggio documentario»; ma il film sì! Al proposito di Colantuoni, quali risultati, nel dramma, corrispondevano? Una prova — come ogni scrittore italiano di romanzi o commedie naturaliste fa ogni volta che impugna la penna —, un tentativo di innestare le linfe del dialetto sul ceppo della lingua, di rubare al dialetto il segreto del suo vigore, di tradurre i suoi accordi in chiave di italiano. Ora, sarebbe tempo che anche il dialoghista cinematografico si associasse con lena e buon diritto a un’opera che si prosegue da più di un secolo, alla quale hanno contribuito e Manzoni e Verga e Pirandello, e a cui lavorano più o meno inconsapevolmente giornalisti e padri di famiglia e uomini della strada: la creazione di una lingua italiana di tutti i giorni. A che punto sta quest’opera collettiva? Un pezzo avanti, mi sembra. Intanto, i rapporti sempre più fitti fra regione e regione hanno creato una specie di fondo linguistico comune, a mezza strada fra lingua e dialetto. A questo riguardo gustosa è la lettura dei giornali umoristici, dove espressioni idiomatiche romane si intrecciano alle milanesi, e si stabilizza un certo gergo, sfruttabilissimo, per esempio, in un film comico. E bisogna ascoltare i dicitori del varietà, gli imbonitori di piazza, i commessi viaggiatori quando sproloquiano coi compagni di treno: tutta gente 548 Il linguaggio cinematografico che si esprime in modo spicciativo e pittoresco, anche se a certe frasi i puristi arriccerebbero il naso. Perché questo è il problema del linguaggio cinematografico: il personaggio dello schermo deve parlare come quello che lo spettatore incontra ogni giorno a un angolo di strada, al caffè, in ufficio, in un salotto. Propongo una multa per il primo sceneggiatore che ancora una volta metterà in bocca a un personaggio di film una frase come «Ho detto loro…». Vergogna! Sullo schermo si dice, anche al plurale e in barba alla Crusca, «gli ho detto», e si resta in ottima compagnia, visto che Manzoni l’ha scritto tante volte. E propongo un diploma di benemerenza per quel doppiatore della Columbia che, a riscontro di non so quale vocabolo di slang americano, ha creato la parola “picchiatello”. E in genere questi “traduttori di dialogo”, benché abbiano letteralmente le sillabe contate e debbano stendere ogni frase su un letto di Procuste, azzeccano qualche volta un italiano molto più spregiudicato e fantasioso di quello di certi burocratici dialoghisti di film nostrani. E poi, quando avremo ottenuto (se l’otterremo) un linguaggio cinematografico sempre vivo, fluido diretto? Allora sorgerà il problema di far dagli attori enunziare queste battute suggestive e familiari, in un modo egualmente familiare e suggestivo […]. [V]olete migliorare la recitazione? Migliorate le battute da recitare! Non vogliamo più incontrare attori che, aspettando il ciak in un angolo di teatro di posa, intelligentemente ti confessano: «Devo dire una frase irrecitabile!». E soprattutto vogliamo che, insieme e magari prima del resto, anche le parole d’un film italiano siano lo specchio spregiudicato e vivo della lingua che abbiamo sulle labbra e dell’esistenza ch’è la nostra. Antologia critica 549 6. VALENTINA RUFFIN, PATRIZIA D’AGOSTINO Dialoghi filmici di regime* Mentre le direttive alla stampa [NDR: negli anni del fascismo] si sforzano di nascondere all’opinione pubblica che in Italia avvengono adulteri, omicidi e suicidi, il cinema non rinuncia a rappresentare gli argomenti sgraditi, ma ambienta le vicende all’estero o in luoghi del tutto imprecisati. L’ambientazione italiana risulta possibile — a parte qualche raro caso — solo a patto di datare esplicitamente la vicenda nel passato. Per mettere in scena una torbida vicenda di vendette e gelosie che culmina con un omicidio, è sufficiente, nel caso di Tragica notte di Soldati, una datazione che, precedendo di due soli mesi la marcia su Roma, colloca l’intreccio in epoca prefascista. Eppure il film esce nel 1942, nella fase cioè di maggiore elasticità della censura […]. La commedia, che propende per l’ambientazione straniera o indefinita anche per ragioni produttive, vi ricorre con particolare frequenza quando mette in scena divorzi e adulteri […]. Al di là delle riserve riguardanti il tipo di realtà rappresentata, ad influenzare la scelta dell’ambientazione e della lingua interviene la fonte del film, sia essa teatrale o letteraria o cinematografica. A quest’ultimo tipo di influsso potrà essere collegato il parlato generalmente italiano standard della commedia brillante, i cui modelli vanno cercati in film e opere teatrali americane e mitteleuropee. L’italiano del doppiaggio e delle traduzioni teatrali si porrebbe cioè come punto di riferimento per i generi che più mirano a mettersi in competizione, anche con la pratica del remake o l’adozione di soggetti stranieri, con i film importati. L’ambientazione — almeno nominale — italiana resta però nel complesso prevalente, e se alcuni generi tendono all’esterofilia o prescindono dal collocare precisamente le loro vicende, * RUFFIN/D’AGOSTINO (
Scarica