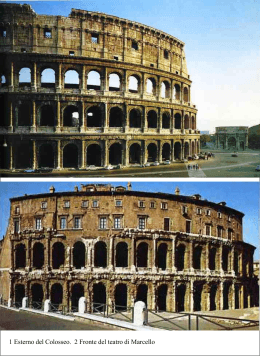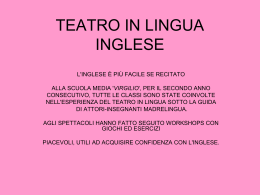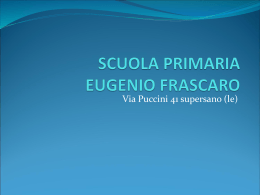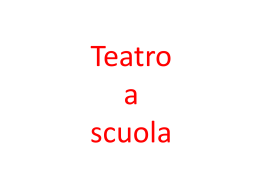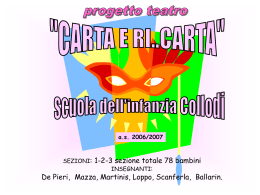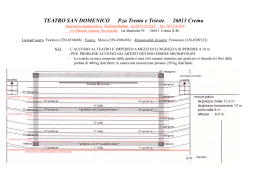COMUNE DI PIEVE DI CENTO Il sipario dipinto nel 1856 da Adeodato Malatesta Teatro Comunale “Alice Zeppilli” 150º del Teatro di Pieve di Cento 1856 - 2006 Il palazzo Comunale sede del Teatro , in una foto di inizio ‘900 (G. Melloni, dall’archivio comunale) Presentazione L’ entusiastico e generale gradimento per il restauro del Teatro Comunale, espresso in tante circostanze da cittadini, visitatori, attori e musicisti, è l’elemento di ritorno di maggiore soddisfazione per noi Amministratori che scegliemmo di restituire a tutti un luogo carico di storia e significati, sicuri di compiere una operazione logica nel percorso, intrapreso da diversi anni, di tutela e restauro del nostro patrimonio, ma anche preoccupati se le risorse stanziate e cercate fossero sufficienti e ben spese. Ricordo con quale apprensione si andava a visitare il cantiere che, in corso d’opera, evidenziava drammaticamente i guasti del tempo e le complessità del recupero funzionale e delle parti decorative. Oggi, con soddisfazione di tutti, possiamo celebrare i 150 anni di vita del Teatro che nell’estate del 1856 si presentò completamente rinnovato in sostituzione della settecentesca Sala del Teatro e nelle forme che oggi ammiriamo di nuovo, dopo il restauro terminato nel 2003. Un lungo percorso iniziato da precedenti Amministrazioni alla fine degli anni Settanta, interrotto per difficoltà economiche ma mai veramente abbandonato, poiché come altri monumenti ed opere d’arte, simboli della città, il Teatro era nel cuore dei pievesi. Così eccolo qui il nostro piccolo gioiello, intitolato nel 2003 al soprano Alice Zeppilli: da alcuni anni torna a far echeggiare la musica, a proporre una varietà di generi di prosa per il divertimento o la riflessione, a offrirsi come Museo che custodisce le memorie musicali del passato, come luogo dove è piacevole trovarsi. Ritroverà quest’anno il Teatro le note delle opere liriche, che inaugurarono una stagione che viveva dello straordinario genio di Giuseppe Verdi, e le immagini cinematografiche di grandi interpreti, per divertirsi poi alla consueta rassegna di musica etnico-folclorica “MusicaPieve”, e sperimentare l’energia e l’entusiasmo dei giovani musicisti di “Sconfinando”. Sul palco ospiterà, con “Tracce”, nuove generazioni di attori che propongono un teatro di tradizione ma anche innovativo e capace di far riflettere su temi sociali; accoglierà bambini e famiglie nelle “Domeniche a Teatro” e i tenaci e appassionati interpreti della commedia dilettale, tenaci e appassionati come il pubblico che fedeli li segue “A Teater”. Tanti lo cercano, tanti lo vogliono. Avrà da lavorare e divertirsi il nostro Teatro: ha più di 40 anni di chiusura da recuperare e 150 da festeggiare. Gianni Cavicchi Assessore alla Cultura Alice Zeppilli in una foto di scena (archivio comunale) Alice Zeppilli N ata nel 1885 a Mentone da Giuseppina Bonfiglio, di famiglia ligure, e dal direttore d’orchestra Nicola Zeppilli, originario di Fermo, la giovane Alice studiò canto con Raoul Gunsbourg, Melchiorre Vidal e Elettra Callery-Viviani. Dopo l’esordio alla Fenice di Venezia nel dicembre 1902, in Chopin di Orefice, si trasferì a Parigi per perfezionarsi con Rose Caron. Iniziò poi una serie di tournée che la portarono a Bucarest, Montecarlo (con Caruso), Buenos Aires, Egitto, Atene, Messico e finalmente a New York. Mela” la Zeppilli ebbe la fortuna di incontrare il grande impresario Oscar Hammerstein, che aveva da poco inaugurato il Teatro dell’Opera di Manhattan e che la ingaggiò per tutta la stagione 1906-1907, diretta dal grande direttore parmigiano Cleofonte Campanini. Ebbe così iniziò la prestigiosa carriera americana della Zeppilli, che avrebbe cantato negli States fino al 1914, per otto anni consecutivi, dividendosi tra New York, Filadelfia e Chicago, dove divenne una delle star delle grandi stagioni dirette da Campanini all’imponente teatro Auditorium. Con Campanini la Zeppilli cantò nelle maggiori città degli Stati Uniti. Non mancarono poi grandi esibizioni al Covent Garden di Londra, a Parigi e a Montecarlo. Nel 1913 la Zeppilli aveva sposato il pievese Giuseppe Alberghini, primo violoncello nell’orchestra di Chicago (da lei conosciuto in Egitto), per seguire il quale, richiamato sotto le armi, all’inizio del 1915 fece definitivamente ritorno in Europa. Al fronte il marito era agli ordini di Gabriele D’annunzio, che ben presto prese in simpatia i due coniugi, da lui definiti i suoi “datori di gioia” (per lui Alice era “il mio Cherubino”). Al termine del conflitto, durante il quale la cantante si era esibita in Italia, in Francia e Spagna, i coniugi Alberghini fecero ritorno in America, stabilendosi definitivamente a New York. Lì la Zeppilli, dopo aver continuato per qualche anno ad esibirsi in opere e concerti, si dedicò poi all’insegnamento del canto, mentre il marito continuava a suonare nelle più importanti orchestre americane (ma ritornando quasi tutte le estati nella villa che avevano acquistato a Pieve). Qualche anno dopo la morte del marito, avvenuta a New York alla fine del 1954, la Zeppilli si stabilì definitivamente nella villa di Pieve di Cento, dove morì il 14 settembre 1969. Particolare di un affresco del Teatro (foto archivio IBC 1980) Isabella Galletti Gianoli I sabella Galletti (nome d’arte di Filomena Rustichelli) nacque a Bologna il 30 novembre 1835 da Maria Galletti e Antonio Rustichelli, custode della basilica di S. Petronio. Applicatasi giovanissima allo studio del pianoforte, fu poi ‘scoperta’ come talento vocale dall’impresario pievese Luigi Vedrani (detto “Grillo”), che, presala sotto la propria tutela, la mandò a proprie spese a scuola dall’ex baritono Livio Tosini. Di lì a poco Vedrani fece debuttare la giovane nella stagione di Carnevale 1852 al Teatro Comunale di Pieve di Cento, come Fenena in Nabucodonosor di Verdi, in cui l’appena sedicenne cantante “eseguì a meraviglia la sua parte di comprimaria”. Dopo alcune esibizioni in altri teatri, Vedrani decise che Filomena dovesse ancora perfezionarsi e, sospesane momentaneamente la carriera, la mandò a perfezionarsi dall’ex tenore Raffaele Gamberini, sotto la cui guida la giovane fece enormi progressi. Il secondo debutto della cantante (sotto il nome di Isabella Galletti) avvenne a Spoleto nel dicembre 1855 in Bondelmonte di Pacini, in cui fu “l’ancora che salvò l’impresario da un totale naufragio”. Iniziò di lì una trionfale e lunga carriera che l’avrebbe portata sui principali palcoscenici di Italia, Spagna, Portogallo, Austria, Russia, Inghilterra ed Egitto. Affermatasi inizialmente in grandi ruoli sopranili (Norma, Beatrice di Tenda, Leonora ne Il trovatore e ne La forza del destino, Lady Macbeth e Anna Bolena), nella seconda parte della carriera la Galletti affrontò sempre più ruoli da mezzosoprano (Leonora ne La favorita e Azucena ne Il trovatore), portando al successo sulle principali scene italiane anche un’opera poi caduta nel totale oblìo: il dramma storico Dolores del compositore siciliano Salvatore Auteri-Manzocchi. Ritiratasi dalle scene nel 1883, si trasferì da Bologna a Milano per aprirvi una scuola di canto: anche come maestra “godette di molta reputazione” e fu apprezzata dallo stesso Verdi, che come cantante la definì “una vera artista” e come docente “maestra di vero canto italiano”. Morì a Milano il 31 agosto del 1901, dopo inaudite sofferenze causate da un male incurabile. I Teatri di Pieve N ella pur ricca vicenda teatrale emiliano-romagnola Pieve di Cento ha saputo ritagliarsi un posto significativo, distinguendosi come il più piccolo paese della regione che già nel Seicento avesse attivo un vero e proprio teatro “all’italiana”, aperto ad un pubblico pagante. Risale infatti alla primavera del 1672 l’inizio dei lavori per la edificazione della prima struttura teatrale pievese, situata in un edificio di via S. Carlo, che l’anno prima era stato acquistato da sette tra le famiglie più cospicue del paese, per erigervi “un teatro scenico allo scopo di esercitare i giovani della Pieve, insegnare loro azioni virtuose, e allontanarli dall’ozio”. Nel teatro, solennemente inaugurato nel Carnevale del 1673 con un’opera in musica commissionata a Bologna, cominciò subito ad operare un’Accademia di giovani, la cui attività continuò fino a oltre la metà del Il Teatro prima del restauro (foto archivio IBC 1980) Settecento. Ma il vento illuministico e gli sconvolgimenti seguiti alla rivoluzione francese portarono, inevitabilmente, alla dissoluzione delle gloriose accademie settecentesche e ad una rarefazione dell’attività teatrale a Pieve. E alla fine del secolo il teatro di via S. Carlo, la cui struttura nel tempo si era andata vistosamente deteriorando, chiuse per sempre i suoi battenti. Molte furono le proteste della gioventù pievese, che negli ultimi lustri del Settecento cominciò ad utilizzare saltuariamente, come luogo di spettacoli, la grande sala del Palazzo Comunale, che nei primissimi anni dell’Ottocento fu “ridotta ad uso di Teatro”. Come tante altre sale di spettacolo del tempo, questo “teatro della sala”, doveva essere formato da strutture lignee montate secondo una tipologia elementare, con palcoscenico e scenari di dimensioni minime e con un unico ordine di palchetti. Nel periodo post-napoleonico aumentò la richiesta di teatro da parte della popolazione e l’Amministrazione comunale apportò varie modifiche alla struttura scenica e teatrale: fu costruito un secondo ordine di palchi ed accresciuto il numero dei posti della platea. La vita teatrale pievese si andava, infatti, sempre più arricchendo: oltre alle tradizionali feste da ballo ed ai veglioni in maschera del periodo carnevalesco (con la partecipazione della orchestra pievese) e alle commedie recitate da attori dilettanti del paese, negli anni Trenta si cominciarono a tenere varie accademie musicali e a rappresentare spettacoli di prosa e di arte varia con compagnie bolognesi o di giro. Manifesto originale per l’inaugurazione del Teatro Una decisa svolta avvenne all’inizio degli anni Quaranta con la nomina del pievese Enrico Cavalli a maestro della banda e della cappella musicale. L’impulso da lui dato alla vita musicale del paese fu ben presto evidente anche in campo teatrale: già alla fine del 1844, ad oltre mezzo secolo dall’ultima esperienza di teatro in musica a Pieve, egli riuscì infatti ad allestire il melodramma La sonnambula di Bellini, che ebbe “un incontro decisamente favorevole”. Il successo arriso all’iniziativa fece sì che anche negli anni successivi “le scene di questo Teatro venissero rallegrate per l’opera”, con allestimenti a cui “nulla mancava di grandiosità e compimento” e che ebbero “un esito fortunatissimo”, con una straordinaria partecipazione di pubblico: “ogni sera il teatro era zeppo di spettatori, di forestieri accorsi, e più centinaia di persone dovevano retrocedere per non esservi capienza”. Era oramai evidente a tutti che la sala comunale, utilizzata da oltre cinquanta anni come “provvisorio Teatro scenico”, non rispondeva più alle mutate esigenze sia del pubblico pievese sia del nuovo melodramma, che, con l’ampliamento delle masse orchestrali e corali, abbisognava di spazi sempre maggiori e richiedeva costi sempre più elevati, con la conseguente necessità di maggiori entrate, che però la domanda sempre crescente del pubblico cento- pievese era ampiamente in grado di garantire. Vi era inoltre una urgente necessità di costose riparazioni alla struttura teatrale. La Municipalità pievese giunse, quindi, alla conclusione che oramai non fosse più procrastinabile “il progetto di riduzione a miglior forma di questo Teatro”, affidando l’incarico di uno studio di fattibilità all’ingegnere cen- Particolare di un affresco del Teatro (foto archivio IBC 1980) tese Antonio Giordani, che, dapprima, ipotizzò l’edificazione ex novo di un edificio autonomo, in cui, seguendo la moda e le esigenze dei tempi, la sala per gli spettacoli venisse corredata di diversi ambienti di ritrovo e di servizio. Ma l’Amministrazione comunale, esaminato il preventivo di spesa per un teatro di tal fatta, fu costretta dalle esigenze di bilancio “a ripiegare su una soluzione più economica anche se indubbiamente riduttiva: la sistemazione del «teatro della sala»”, sempre su progetto di Giordani. Tale progetto (approvato all’inizio del 1853) prevedeva un teatro inserito al primo piano del Municipio, con l’occupazione di due piani. La tipologia seguita era quella oramai collaudata del cosiddetto «teatro all’italiana», cioè sala a palchetti in più ordini sovrapposti, raccordati al palco da un arco-scenico architettonico. Grazie anche al contributo dei futuri palchettisti, già dall’agosto del 1853 si poté passare alla fase esecutiva, che durò poco meno di due anni. A metà del 1855 tutto era pronto per l’inaugurazione del nuovo Teatro Comu- nale (che sarebbe dovuta avvenire all’inizio del mese di settembre con la rappresentazione de Il Trovatore di Verdi), ma la già preannunciata grande apertura fu sospesa a causa del colera, che stava imperversando con quella che ne fu l’ultima grande epidemia nel territorio del Centopievese. L’evento inaugurale, lungamente atteso da tutto il paese, fu così rinviato di un anno: il teatro aprì i battenti la sera del 25 agosto 1856, con la messa in scena de Il trovatore, cioè la stessa partitura già prevista l’anno prima. Nulla fu lasciato di intentato perché lo spettacolo inaugurale fosse veramente “magnifico ed imponente”: fu scritturato un cast di eccellenti cantanti (tra cui il grande tenore Antonio Giuglini) e si formò per l’occasione un’orchestra eccellente, con il concorso di alcune delle migliori prime parti delle orchestre dei Teatri di Parma e di Modena. Particolare attenzione fu poi prestata da Enrico Cavalli alla formazione del coro, che, date le esigue dimensioni del palcoscenico, era obbligato ad essere di formato ridotto (12 voci maschili e 6 femminili). Si adornò, inoltre, il teatro con “decorazioni magnifiche” e con un sipario (opera del pittore modenese Adeodato Malatesta) che parve un “vero capolavoro”. La stagione lirica, che ebbe un grande concorso di forestieri, si concluse con un altro grande capolavoro verdiano, Viscardello (alias Rigoletto), superbamente interpretato dalla stessa “eletta schiera” di cantanti. Ma i Pievesi ci avevano preso gusto: infatti, ad appena un mese dal termine di quella trionfale stagione inaugurale, iniziò un corso di rappresentazioni di un’allora celebre opera comica dei fratelli Ricci, Crispino e la comare, che ottenne un “successo splendidissimo”. Ad un’attività, soprattutto operistica, abba- Particolare di un affresco del Teatro (foto archivio IBC 1980) stanza intensa nei primi anni di apertura del teatro, subentrò un periodo con sporadiche rappresentazioni. Il fattore determinante nella riduzione della attività teatrale è da individuarsi soprattutto nelle gravi difficoltà politico-economiche sopravvenute con l’unificazione italiana, difficoltà che si ripercossero direttamente sulla finanza locale, impoverendone le risorse, proprio quelle risorse che nel periodo preunitario avevano consentito di sostenere e tutelare l’istituzione di una scuola di musica e la costruzione del nuovo teatro. L’intervento della finanza locale si fece, così, sempre più debole e meno costante nel sostegno delle tradizionali stagioni d’opera, il cui onere fu accollato quasi del tutto all’impresariato privato. Già nel 1870 la Giunta, “attesa la condizione povera del paese”, per la prima volta decise di tenere il teatro chiuso, “essendo sicura che si reciterebbe alle panche della platea”. L’anno dopo, anche per le insistenti richieste dei commercianti e dei filarmonici, il teatro fu riaperto, ma già nel 1874 i suoi battenti ritornavano a chiudersi per un anno, “trovandosi disgraziatamente il Paese in circostanze tanto eccezionali per condizioni finanziarie che non è possibile concedere il teatro per qualsiasi spettacolo”. Nel 1881, dopo una stagione con ben dodici recite dell’opera Saffo di Pacini, il teatro venne chiuso perché “non presentava facilità di sfogo agli spettatori in caso di panico, per incendio od altra causa”. Fu riaperto solo nel 1885, dopo gli opportuni lavori, diretti ancora dall’ingegner Giordani, l’originale progettista del teatro. Ma, già due anni dopo, la Commissione di controllo provinciale imponeva nuovi lavori per poter dare il permesso di riapertura del teatro. Seguì una ventina d’anni con frequenti rappresentazioni operi- Particolare di un affresco del Teatro (foto archivio IBC 1980) stiche di vecchi e nuovi spartiti, da La Favorita di Donizetti a I Puritani di Bellini, da Pipelet di De Ferrari a Le educande di Sorrento di Usiglio, da Fra Diavolo di Auber a Mignon di Thomas, da Il trovatore di Verdi a Cavalleria rusticana di Mascagni e Pagliacci di Leoncavallo. Nello stesso periodo, con la nascita delle moderne organizzazioni politiche, il teatro divenne anche un centro per dibattiti e per conferenze politiche e scientifiche. Nel dicembre del 1907 si iniziò poi, per la prima volta, a fare in teatro proiezioni cinematografiche. Negli anni successivi, “considerate le condizioni attuali del teatro, nonché quelle del paese”, ci fu un utilizzo saltuario del teatro. Nel 1914 fu concessa una nuova autorizzazione per adibirlo a cinema, ma subito dopo il Comune, reputando che i lavori di adatta- mento avrebbero deturpato la sala, ne ritirò la concessione. Allo scoppio della Grande Guerra, come in quasi tutti i teatri di provincia del Regno, cessò del tutto l’attività teatrale, che però non poté essere ripresa, se non saltuariamente, neppure nei primi anni del dopoguerra, mancando il teatro dell’impianto di luce. Dopo che nel 1921 fu respinta una nuova richiesta di trasformazione in cinematografo, furono eseguiti alcuni lavori, che permisero la continuazione di una attività teatrale sempre più ridotta, a fronte di una attività politica sempre più intensa. Infatti, durante il periodo fascista, il teatro servì per innumerevoli manifestazioni di regime: fra gli inni della patria e della rivoluzione e una selva di bandiere tricolori, il fascio locale distribuiva la befana fascista ai bambini, le signore bene consegnavano i doni agli orfani di guerra, i reduci delle patrie battaglie tenevano le loro riunioni ed i piccoli italiani recitavano l'operetta Rompicollo e la fiaba Il Principino. Il colpo di grazia al teatro oramai fatiscente fu dato durante gli ultimi mesi dell’ultima guerra, quando, disgraziatamente, vi si accasermò un battaglione di truppe tedesche, che devastò tutti gli impianti, compromettendo il funzionamento del teatro stesso. Nel 1954 il teatro poté riaprire i suoi battenti grazie ad un accordo stipulato tra l’Amministrazione comunale ed il “Circolo del Voltone”, una associazione pievese che si obbligò a rifare a proprie spese e mettere in perfetta efficienza il grande salone, in cambio dell’uso per nove anni del teatro e delle sale annesse. Ma il teatro venne utilizzato prevalentemente per affollatissimi Particolare decorativo a stucco del Teatro (foto archivio IBC 1980) veglioni e feste danzanti (e, a tale scopo, il piccolo palcoscenico fu sostituito da una pedana per l’orchestra!…). Ma le limitazioni imposte negli anni Sessanta portarono al lento abbandono del teatro, con conseguente progressivo degrado di tutta la struttura, e ad una sua definitiva e lunga chiusura, imposta da ragioni di staticità e di sicurezza. Fortunatamente, negli anni Novanta, l’Amministrazione comunale diede inizio a un lento, ma progressivo recupero della struttura teatrale, che, all’inizio del Terzo Millennio, è stata finalmente restituita alla città. Come nel 1856 si è potuta così rinnovare nella “Terra della musica” un’antica tradizione, profondamente radicata nella memoria collettiva, quella del teatro, luogo deputato allo svago, agli incontri pubblici, al divertimento ma anche e soprattutto ‘luogo’ della cultura civile, una delle strutture più significative ed originali che la ‘moderna’ cultura europea abbia espresso. Adriano Orlandini Particolare di un affresco del Teatro (foto archivio IBC 1980) Fondazione Cassa di Risparmio di Cento COMUNE DI PIEVE DI CENTO Teatro Comunale “Alice Zeppilli” Piazza Andrea Costa, 17 – 40066 Pieve di Cento Tel. 051 686 26 11 – fax 051 97 43 08 [e] [email protected] [w] www.pieve.provincia.bo.it/ AMICI DEL LOGGIONE Cento The International Association of Lions Clubs Distretto 108Tb LIONS CLUB PIEVE DI CENTO Comitato degli Operatori Economici Pieve di Cento
Scarica