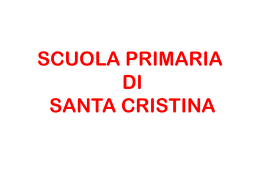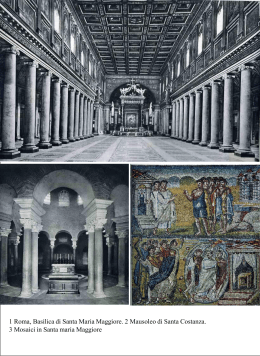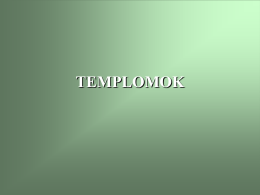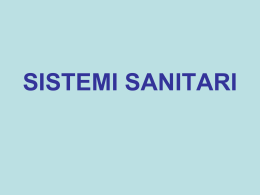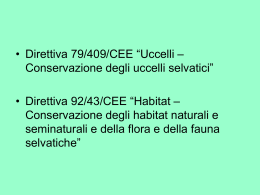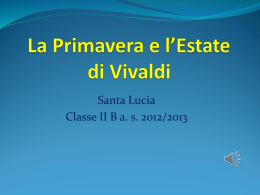Ente Gestore LEGAMBIENTE Comitato Regionale Siciliano Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” POR 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0302 SIC ITA010022 “Complesso dei Monti di Santa Ninfa, Gibellina e Grotta di Santa Ninfa” PARTE I – FASE CONOSCITIVA Il Referente Tecnico del Piano di Gestione (Giulia Casamento) Data Il Referente per il Coordinamento dei PdG (Angelo Dimarca) Il Legale Rappresentante e RUP (Domenico Fontana) Coordinamento, Definizione Strategie gestionali e Redazione del Piano di Gestione: Giulia Casamento, Angelo Dimarca, Salvatore Livreri Console. Consulenti e collaboratori del Piano di Gestione: Aspetti geologici e geomorfologici Rosario Di Pietro, Francesco Di Trapani, Paolo Madonia Flora e vegetazione, habitat comunitari, uso Dipartimento di Colture Arboree, Università di del suolo Palermo (responsabile scientifico Tommaso La Mantia, collaboratori Salvatore Pasta, Juliane Ruhl, Leonardo Scuderi) Aspetti faunistici Dipartimento di Biologia Animale, Università di Palermo (responsabile scientifico Maurizio Sarà, collaboratori Enrico Bellia, Mathia Coco, Ivy Di Salvo, Massimiliano Di Vittorio, Fabio Grillo, Gabriele Mastrilli, Andrea Milazzo, Giandomenico Nardone) Ittiofauna Dott. Antonino Duchi Aspetti urbanistici e di programmazione Vincenzo Todaro territoriale, Beni archeologici, architettonici e culturali, Paesaggio, Reti ecologiche Censimento patrimonio insediativo, Manuel Bellafiore infrastrutture e detrattori ambientali Analisi socio-economica Coop. ECO - Alessia Maso Piano di Comunicazione Coop. ECO – Cristina Alga PIANO DI GESTIONE “Complessi gessosi Santa Ninfa” SIC ITA010022 “Complesso dei Monti di Santa Ninfa, Gibellina e Grotta di Santa Ninfa” INDICE 1. PREMESSA 1.1 INTRODUZIONE 1.2 NORMATIVA E PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 1.3 LA DIRETTIVA HABITAT E LA RETE DEI SITI NATURA 2000 1.4 I PIANI DI GESTIONE 1.5 METODOLOGIA UTILIZZATA NELL’AMBITO DEL PRESENTE PIANO DI GESTIONE 2. QUADRO CONOSCITIVO 2.1 LE CONOSCENZE PREGRESSE SUL SITO (B.2) 2.2 DESCRIZIONE FISICA DEL SITO (A) 2.2.1 Inquadramento territoriale e descrizione dei confini del Sito (A.1) 2.2.2 Inquadramento climatico e caratterizzazione bioclimatica del Sito (A.2) 2.2.3 Inquadramento geologico, geomorfologico, idrogeologico (A.3) Aspetti geologici (A.3.1) Aspetti geomorfologici (A.3.1) Aspetti idrogeologici (A.3.2; A.4) Aree classificate ad elevata pericolosità per la prevenzione del rischio idrogeologico (A.3.3) Individuazione di eventuali sistemi di monitoraggio già esistenti nel territorio e/o previsti (A.3.4; A.4.2) 2.3 DESCRIZIONE BIOLOGICA DEL SITO (B) 2.3.1 Descrizione della flora, della vegetazione e degli habitat 2.3.1.1 Le conoscenze floristico-vegetazionali – precedenti indagini sul SIC (B.2) 2.3.1.2 Metodologia adottata negli studi di carattere botanico (B.3.1) 2.3.1.3 Risultati delle indagini e descrizione floristico-vegetazionale del Sito (B.3) Premessa sul grado di naturalità del territorio con dati di sintesi sull’uso del suolo Check-list della flora vascolare ed analisi fitogeografica della flora Piante vascolari presenti negli Allegati II, IV e V della Direttiva Habitat e/o nella Lista Rossa Regionale e/o di interesse biogeografico/conservazionistico Analisi del grado di invasività delle specie aliene (B.3.3) Inquadramento fitosociologico e caratterizzazione ecologica della vegetazione (B.3.2) 2.3.1.4 Descrizione degli habitat rinvenuti e Commento alla Carta degli Habitat (B.3.4) 2.3.1.5 Verifica ed Aggiornamento della Scheda Natura 2000 – flora ed habitat (B.1) 1 2 4 8 9 13 13 13 14 18 28 28 28 30 71 84 2.3.2 Descrizione faunistica del Sito 2.3.2.1 Le conoscenze faunistiche – precedenti indagini sul Sito (B.2) 2.3.2.2 Metodologia adottata negli studi faunistici (B.3.1) 2.3.2.3 Risultati delle indagini e descrizione faunistica del Sito (B.3) Check-list della fauna e descrizione delle specie rinvenute Applicazione di indici per la valutazione del valore delle singole specie ed individuazione delle specie e delle comunità di interesse conservazionistico Analisi del grado di invasività delle specie aliene (B.3.3) Presenza e distribuzione delle specie faunistiche presenti negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, nella Lista Rossa e di quelle che rispondono ai requisiti per l’inserimento nella tabella 3.3 motivazioni A e B del formulario standard Natura 2000 Descrizione del valore faunistico del territorio ed analisi delle aree di importanza faunistica del SIC (B.3.5; B.3.7) 2.3.2.4 Verifica ed aggiornamento della Scheda natura 2000 – fauna (B.1) 90 90 90 93 112 2.3.3 Descrizione agroforestale del Sito (C) 2.3.3.1 Descrizione dell’uso del suolo e commento della carta (C.2; B.3.6) 2.3.3.2 Descrizione delle aree e delle tecniche agricole Caratterizzazione delle aree agricole rispetto agli habitat ed alle specie della Dir. 92/43/CEE e brevi cenni sull’impatto delle tipologie e delle pratiche di gestione agricola su habitat e specie (C.3; C.4; C.5) 2.3.3.3 Descrizione delle aree forestali (C1) Caratterizzazione delle aree forestali rispetto agli habitat ed alle specie della Dir. 92/43/CEE e brevi cenni sull’impatto delle tipologie di gestione forestale (C.3; C.4; C.5) 2.3.3.4 Incendi 119 119 121 125 2.3.4 Descrizione del Paesaggio (F) 2.3.4.1 Caratteri significativi del paesaggio antropico e naturale (F1; F2) 2.3.4.2 Variazioni del paesaggio e tendenze evolutive delle trasformazioni territoriali (F.3) 2.3.4.3 Coerenza con le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale e con gli obiettivi del D. Lgs. 42/04 (F4; F5) 133 133 135 2.3.5 Descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali (E) 2.3.5.1 Strumenti normativi e di pianificazione di settore vigenti sul territorio (E.1) 2.3.5.2 Individuazione di aree archeologiche (E.2) 2.3.5.3 Individuazione dei beni architettonici ed archeologici sottoposti a tutela (E.3) 2.3.5.4 Coerenza con gli obiettivi del D. Lgs. 42/04. Codice dei beni culturali e del paesaggio (E.1.1) 139 139 2.3.6 Descrizione della pianificazione territoriale 2.3.6.1 Sistema vincolistico (D.2) Presenza di aree naturali protette (D.1) 2.3.6.2 Mappa catastale o definizione di macrozone demaniali 2.3.6.3 Inventario dei soggetti amministrativi e gestionali (D.4) 144 144 127 129 131 136 139 141 142 145 146 2.3.6.4 Analisi del patrimonio insediativo (D.11) 2.3.6.5 Analisi e valutazione di coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica (D.3; D.5) 2.3.6.6 Analisi e valutazione di coerenza degli strumenti di programmazione territoriale (D.5; D6) 2.3.6.7 Analisi e valutazione di coerenza di altri Piani e Regolamenti vigenti che incidono che incidono sul territorio e sulla conservazione di specie e habitat (D.5; D.6; D.7) Regolamento della Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” – zona B Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 Piano Forestale regionale Programmazione Azienda Foreste Demaniali Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2006-2011 e Piano di Azione per la Lepre italica Norme di polizia forestale 147 150 2.3.7 Descrizione del contesto socio-economico (D) 2.3.7.1 Demografia (D.9.2) 2.3.7.2 Situazione sociale (D.9.5) 2.3.7.3 Aspetti economici (D.9.1; D.9.3; D.9.4; D.10) Occupazione Attività economiche Inventario delle attività economiche presenti all'interno del Sito ed analisi delle pressioni (D.10.1) 2.3.7.4 Soggetti pubblici e privati operanti in campo ambientale (D.8) 2.3.7.5 Risorse territoriali 2.3.7.6 Potenzialità turistiche del Sito (D.9.6) 2.3.7.7 Altre ipotesi per uno sviluppo socio-economico dell’area 210 212 215 219 155 159 226 226 228 234 2.3.8 Analisi dell’attuale perimetrazione del SIC e proposte per l’inserimento di nuove aree 237 2.3.9 Relazione del Sito con la Rete Ecologica regionale ed individuazione dei corridoi ecologici presenti e potenziali (B.3.8) 239 PIANO DI GESTIONE “Complessi gessosi Santa Ninfa” SIC ITA 010022 “Complesso dei Monti di Santa Ninfa, Gibellina e Grotta di Santa Ninfa” 1. PREMESSA 1.1 INTRODUZIONE Legambiente-Comitato Regionale Siciliano, nella qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa”, ha sottoscritto in data 3.10.2007 il Protocollo d’Intesa con l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per provvedere alla redazione del Piano di Gestione denominato “Complessi Gessosi Santa Ninfa” relativo al Sito di Importanza Comunitaria ITA010022 “Complesso dei monti di Santa Ninfa – Gibellina e Grotta di Santa Ninfa”, in attuazione della misura 1.11 del Complemento di Programmazione Sicilia 20002006, adottato con deliberazione della Giunta Regionale n° 327 dell’8.8.2007. Con provvedimento del 19.12.2007 prot. 92216 l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato il Piano di Lavoro presentato dall’Ente Gestore, ai sensi e per effetti dell’articolo 3 del Protocollo di Intesa, autorizzando così la prosecuzione delle attività previste. Il presente Piano di Gestione è costituito da: - Relazione I – Fase analitica - Relazione II – Fase gestionale con schede sulle azioni - Allegato I - Scheda Natura 2000 aggiornata Costituiscono allegati e parte integrante del presente Piano di Gestione: Tavola 1 – Carta dell’inquadramento territoriale; Tavola 2 – Carta geologica Tavola 3 – Carta geomorfologica Tavola 4 – Carta del sistema idrico superficiale Tavola 5 – Carta dei dissesti Tavola 6 – Carta dei sistemi ambientali Tavola 7 – Carta della distribuzione delle specie di interesse floristico Tavola 7b – Carta delle specie floristiche a distribuzione puntiforme Tavola 8 – Carta della vegetazione – unità di paesaggio Tavola 8b – Carta della vegetazione – mosaici di alleanze Tavola 9 – Carta degli habitat Tavola 9b – Carta degli habitat Tavola 10 – Carta del valore floristico Tavola 11 – Carta delle distribuzione delle specie faunistiche Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 1 Tavola 12 – Carta del valore faunistico Tavola 13 – Carta delle aree di importanza faunistica Tavola 14 – Carta dell’uso del suolo Tavola 14b – Carta di sovrapposizione tra uso del suolo e habitat Tavola 15 – Carta di sovrapposizione tra uso del suolo e habitat delle specie Tavola 16 – Carta dei punti panoramici e delle aree di interesse paesaggistico Tavola 17 – Carta dei beni archeologici ed architettonici Tavola 18 – Carta dei vincoli Tavola 19 – Carta del regime proprietario Tavola 20 – Carta degli insediamenti e delle infrastrutture Tavola 21 – Carta della proposta di riperimetrazione Tavola 22 – Carta dei corridoi ecologici Tavola 23 – Carta delle aree critiche Tavola 24 – Carta degli interventi gestionali Repertorio fotografico su DVD. 1.2 NORMATIVA E PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO Normativa europea • Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici GUCE n. 103 del 25 aprile 1979 • Direttiva 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (in particolare, sostituisce gli allegati I e III) GUCE L 115, 08.05.1991 (G.U. 13 giugno 1991, n. 45, 2° serie speciale); • Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche GUCE n. 206 del 22 luglio 1992 • Direttiva 94/24/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1994 che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici GUCE L 164, 30.06.1994 (GU 12 settembre 1994, n.69, 2° serie speciale); • Direttiva 97/49/CE della Commissione, del 29 luglio 1997 (sostituisce l'allegato I della direttiva Uccelli) GUCE L 223, 13.08.1997(G.U. 27 ottobre 1997, n.83, 2° serie speciale) • Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997 recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche GUCE n. L 305 del 08/11/1997 Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 2 Normativa Nazionale • Legge quadro sulle aree protette (Legge 394/91) • Legge n. 157 dell’11.02.1992 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio – GURI serie generale n. 46 del 25.2.1992 • D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche – S.O. n. 219/L alla GURI n. 248 del 23 ottobre 1997 - Serie Generale • Decreto del Ministro dell'Ambiente 20 gennaio 1999 - Modificazioni degli allegati A e B del DPR n. 357/97, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE GU, serie generale, n. 23 del 9 febbraio 1999. (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati) • D.M. 3 aprile 2000 - Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE • D.M. 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002) • Legge 3 ottobre 2002, n. 221 - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE GU n. 239 del 11 ottobre 2002 • DPR 12 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/07, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - GU n. 124 del 30 maggio 2003 • D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) • D.M. 25 marzo 2005 - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea, ai sensi della direttiva 92/43/CEE • D.M. 11 giugno 2007 - Modificazioni agli allegati A, B, D ed E del DPR 357/97 e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (S.O. n.150 a GURI n. 152 del 3 luglio 2007) • D.M. 5 luglio 2007 - Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (S.O. n. 167 alla GURI n. 170 del 24 luglio 2007) • D.M. 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) (GURI Serie Generale n. 258 del 6 novembre 2007) Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 3 Normativa Regionale • Assessorato Territorio e Ambiente – Disposizioni e Comunicati. Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e 79/409/CEE (GURS n. 57 del 15.12.2000) • Assessorato Territorio e Ambiente. Elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (GURS n. 8 del 20.02.2004) • Assessorato Territorio e Ambiente. Disposizioni e Comunicati. Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (GURS n. 31 del 22.07.2005) • Assessorato Territorio e Ambiente. Circolare 23 gennaio 2004. DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni “Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” – Art. 5 – Valutazione dell’Incidenza – (GURS n. 10 del 5.3.2004) • Assessorato Territorio e Ambiente. Decreto 21 febbraio 2005. Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e 79/409/CEE (GURS n. 42 del 7.10.2005) 1.3 LA DIRETTIVA HABITAT E LA RETE DEI SITI NATURA 2000 I processi di degrado del territorio e le trasformazioni del paesaggio, l’impoverimento della diversità biologica, il processo di frammentazione degli ambienti naturali ed il loro progressivo isolamento in un contesto territoriale a crescente antropizzazione, sono temi che negli ultimi decenni sono diventati centrali nell’azione delle istituzioni pubbliche, e a partire dagli anni '80 sono diventati oggetto di numerose convenzioni internazionali. Nel 1992, con la sottoscrizione della Convenzione di Rio sulla Biodiversità, tutti gli stati membri della Comunità Europea hanno riconosciuto come priorità da perseguire la conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali, ponendosi come obiettivo quello di “anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica, in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici". In questo contesto internazionale l’Unione Europea ha approvato nel 1998 una strategia per la biodiversità che ha predisposto il quadro di riferimento normativo e programmatico per promuovere gli obiettivi della convenzione sulla diversità biologica. Al Consiglio Europeo di Göteborg del giugno 2001, i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea si sono posti l’ambizioso obiettivo di arrestare il declino della biodiversità entro il 2010, elaborando nel VI Piano d’Azione per l’Ambiente, sottoscritto dal Consiglio e dal Parlamento nel luglio 2002, i mezzi per raggiungere tale obiettivo. Al fine di ottenere una significativa riduzione dell’attuale tasso di perdita di biodiversità entro il 2010, è cruciale dare concreta attuazione alla direttiva Habitat 92/43 ed alla direttiva Uccelli 79/409 e procedere alla realizzazione della Rete Natura 2000. Con tali direttive l’Unione Europea ha posto le basi per un’organica azione, ad ampia scala geografica, di conservazione della natura e della biodiversità, con un nuovo approccio e introducendo sostanziali novità nella legislazione. Innanzitutto entrambe le Direttive elencano Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 4 le specie animali, vegetali e gli habitat di particolare interesse conservazionistico (indicando con un asterisco quelli prioritari) e prevedono l’individuazione di aree di particolare tutela, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per gli uccelli, e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC, da designare successivamente da parte del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio come ZSC - Zone Speciali di Conservazione) per le specie animali, vegetali e per gli habitat. Scopo principale della direttiva Habitat è “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il trattato”. Nella fattispecie, gli Stati membri devono mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat naturali e le specie di flora e fauna selvatiche di interesse comunitario (art. 2). Le conoscenze acquisite negli ultimi anni nel campo dell'ecologia e della biologia della conservazione hanno messo in evidenza come, per la tutela di habitat e specie, sia necessario operare in un'ottica di rete di aree, che rappresentino, con popolazioni vitali e superfici adeguate, tutte le specie e gli habitat tipici dell'Europa, con le loro variabilità e diversità geografiche. La costituzione di una rete è finalizzata inoltre ad assicurare la continuità degli spostamenti migratori, dei flussi genetici delle varie specie e a garantire la vitalità a lungo termine degli habitat naturali: si è passati quindi dalla conservazione di specifiche specie e aree alla conservazione dell’intero sistema degli ecosistemi presenti nel territorio europeo. Sulla scorta di tali considerazioni, l'Unione Europea (Direttiva Habitat, art. 3) ha stabilito la fondazione della Rete Ecologica Europea denominata “Natura 2000”, costituita innanzitutto dalle Zone di Protezione Speciale e dalle Zone Speciali di Conservazione, pianificando un sistema interconnesso di aree ad elevata valenza naturalistica ed omogeneizzando la gestione del territorio naturale e seminaturale compreso all’interno della Comunità Europea. Una “rete ecologica europea coerente” di Siti Natura 2000 ha lo scopo di garantire il mantenimento o il ripristino dei tipi di habitat naturali e degli habitat di specie in un soddisfacente stato di conservazione (art. 3). In base all’art. 10, gli Stati membri si impegnano “nell’ambito delle loro politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere più ecologicamente coerente la Rete Natura 2000”, a promuovere la gestione di quegli elementi del paesaggio che per la loro struttura lineare o il loro ruolo di collegamento possono costituire corridoi per la flora e la fauna selvatiche. La protezione delle specie di flora e di fauna dovrà anche essere assicurata mediante la predisposizione di un rigoroso regime di tutela delle specie in tutta la loro gamma naturale (artt. da 12 a 16). La Direttiva contiene diverse misure complementari in tema di sorveglianza e monitoraggio, reintroduzione di specie indigene, introduzione di specie non indigene, ricerca e istruzione. Va inoltre sottolineato che la conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali, favorendo cioè l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della rete Natura 2000. E’ importante mettere in risalto che la Direttiva Habitat ed il progetto Rete Natura 2000 attribuiscono grande importanza non solo alle aree ad alta naturalità (quelle meno modificate dall'uomo) ma anche agli ambienti seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.) e a quei territori contigui, indispensabili per mettere in relazione aree divenute distanti spazialmente ma vicine per funzionalità ecologica. Con ció viene riconosciuto il valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nzselle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 5 permesso la formazione/mantenimento di particolari ambienti. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva, in molti casi opportunamente regolamentati o riconvertiti. Elemento di carattere innovativo è l’attenzione rivolta dalla direttiva alla valorizzazione della funzionalità degli habitat e dei sistemi naturali. Si valuta infatti non solo la qualità attuale del Sito ma anche la potenzialità che hanno gli habitat di raggiungere un livello di maggiore complessità. La direttiva prende in considerazione anche siti attualmente degradati in cui tuttavia gli habitat abbiano conservato l’efficienza funzionale e che pertanto possano ritornare verso forme più evolute mediante l’eliminazione delle ragioni di degrado. Questa nuova impostazione di sistema si integra con la strategia del Consiglio d'Europa di promuovere un approccio piú comprensivo e meno parcellizzato del governo del territorio, che ha portato all’adozione della Convenzione Europea sul Paesaggio. La definizione della Rete Natura 2000 pone le sue basi di conoscenza scientifica nel progetto "CORINE Biotopes" che, dal 1985 al 1991, ha condotto ad una prima individuazione delle specie animali e vegetali presenti sul territorio europeo, degne di attenzione e/o da sottoporre a specifica tutela. Il recepimento della Direttiva Uccelli è avvenuto in Italia con la legge 157/92. Il recepimento della Direttiva Habitat è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003; dal punto di vista delle competenze amministrative, tale atto affida alle Regioni (e alle Province Autonome) il compito di individuare i siti della rete Natura 2000 e di assicurarne la tutela. Il DPR 357/97 costituisce il regolamento di attuazione della Direttiva Habitat e fissa le procedure per l’individuazione dei Siti di Interesse Comunitario (art. 3) e prevede l’adozione, da parte delle Regioni, di piani di gestione per le Zone Speciali di Conservazione e le Zone di Protezione Speciale (art. 4, art. 6). L’art. 5 prevede che nella pianificazione territoriale si tenga conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di interesse comunitario; prevede inoltre che i proponenti di progetti che potrebbero avere implicazioni sulle aree protette e per i quali non si applica la procedura di valutazione d’impatto ambientale, presentino, alle autorità competenti, una relazione sulla base della quale effettuare una Valutazione di Incidenza Ambientale. L’individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria in Italia è avvenuta su iniziativa del Ministero dell'Ambiente con il progetto“Bioitaly” con cui si è provveduto, dal 1995 al 1997, alla raccolta e sistematizzazione delle informazioni sui biotopi, sugli habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario, procedendo alla redazione di specifiche schede descrittive complete di cartografia. Le Regioni hanno provveduto ad adottare definitivamente l’elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria, trasmessi alla Commissione Europea per la successiva validazione. Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 Aprile 2000 è stato reso noto il primo “Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”, (G.U. n.95 del 22 Aprile 2000). Nel 2002 è stato pubblicato sulla GURS il primo avviso dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente sull’avvenuta redazione dell’elenco dei pSIC. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 6 Successivamente la Regione Siciliana ha effettuato una serie di verifiche e riscontri che hanno portato ad alcune modifiche dei perimetri dei pSIC ed alla integrazione delle schede descrittive delle valenze naturalistiche di ciascun sito. L’ultimo elenco è stato approvato con D.A. n.46 del 21.02.2005, con il quale si individuano le nuove ZPS ricadenti nel territorio della Regione Siciliana e si ridefinisce la lista complessiva dei siti Natura 2000. Con D.A. n. 120 del 05.05.06 sono stati approvati la trasposizione in scala 1:10.000 delle perimetrazioni dei siti Natura 2000 e l'aggiornamento delle relative schede; Va fatto rilevare che nel passaggio di scala da 25.000 a 10.000 sono state operate delle riduzioni di superfici che non sono state giustificate in alcun modo. Successivamente la Commissione Europea, con Decisione 2006/613/CE del 19 luglio 2006 ha adottato l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, tra cui rientrano quelli siciliani. Attualmente sono stati individuati 233 tra Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS); tali aree si integrano, in molti casi sovrapponendosi, ad un vasto sistema di aree protette per fini di conservazione della natura esistenti in Sicilia. In particolare: • 14 IBA (Important Bird Areas); • 2 aree umide d’interesse internazionale individuate ai sensi della Convenzione Ramsar; • 5 Aree Marine Protette (ANMP); • 76 Riserve Naturali • 4 Parchi Regionali Per perseguire gli obiettivi posti dalle Direttive 79/409 e 92/43 occorrono ancora alcuni atti e azioni amministrative importanti: • la designazione delle Zone Speciali di Conservazione sulla base degli elenchi dei siti di importanza comunitaria selezionati dalla Commissione europea • la coerente definizione delle misure di conservazione per i SIC e le ZPS, comprese eventuale misure di salvaguardia, a partire dall’approvazione dei Piani di Gestione e dal rispetto dei criteri minimi fissati dal Ministero dell’Ambiente Nel settembre 2002 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha reso pubbliche le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”: proprio qui viene ribadito il ruolo della Regione quale “soggetto incaricato delle funzioni normative e amministrative connesse all’attuazione della direttiva Habitat”, oltreché la possibilità di sottoporre la materia a propria disciplina legislativa organica. In questo contesto di crescenti impegni per gli Stati e le regioni nel perseguire la tutela della biodiversità, degli habitat e delle specie di interesse comunitario, anche la programmazione dei fondi strutturali è stata orientata alla realizzazione della Rete Natura 2000 e ed alla corretta gestione dei Siti . La prima novità sostanziale si è avuta all’interno del QCS 2000-2006 e di conseguenza del POR Sicilia 2000-2006, prevedendo in maniera esplicita l’integrazione delle politiche ambientali nelle politiche di sviluppo economico, la sostenibilità come criterio informatore delle scelte ed obiettivo da perseguire, la Rete Ecologica come grande infrastruttura territoriale per lo sviluppo sostenibile, pensata in stretta integrazione con i temi dello sviluppo rurale, della tutela e valorizzazione dei beni culturali, della promozione di specifici segmenti di offerta turistica. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 7 Ed in attuazione di tale strategia, la Misura 1.11 del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006 ha previsto, tra gli altri interventi, proprio la redazione dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000. Con il DDG n. 502 del 06.06.2007, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, ha individuati i Piani di Gestione da redigere, i Beneficiari finali e sono state, altresì, impegnate, sul cap. 842040 del bilancio della regione le somme occorrenti per il finanziamento di ciascun Piano. 1.4 I PIANI DI GESTIONE L’Articolo 6 della Direttiva Habitat contiene le più importanti disposizioni per la conservazione di specie ed habitat, prevedendo, in particolare al comma 1, l’adozione di: ¾ opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali; ¾ appropriati piani di gestione. Le misure del primo tipo costituiscono un requisito minimo, e possono essere considerate necessarie o obbligatorie. Al contrario, il Piano di Gestione deve essere adottato “se opportuno”, cioè qualora la situazione specifica del Sito non consenta di garantire uno stato di conservazione soddisfacente solamente grazie alle misure obbligatorie. Il Piano di Gestione peraltro si configura come l’unico strumento di pianificazione idoneo alla salvaguardia delle peculiarità di ogni singolo sito in grado di integrare gli aspetti prettamente naturalistici con quelli socio-economici ed amministrativi. Occorre inoltre ricordare che la Direttiva habitat impegna, in attuazione del principio di prevenzione: “Gli Stati membri ad adottare tutte le opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione il degrado (…), nonché la perturbazione (..)”. Queste misure vanno al di là delle semplici misure di gestione necessarie per garantire la conservazione già coperte dall’articolo 6, paragrafo 1. Ed ancora il comma 1 dell’articolo 4 del DPR 357/97 (integrato dal DPR 120/2003) sancisce che “le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate”. Il campo di applicazione è più ampio di quello dell’art. 5 che concerne unicamente i piani ed i progetti per i quali è necessaria la preventiva valutazione di incidenza. Esso si riferisce pertanto allo svolgimento di attività che non richiedono necessariamente un’autorizzazione preventiva, come l’agricoltura o la caccia. La Regione Siciliana non ha ancora adottato alcuna misura di salvaguardia per i SIC, ma, come già detto, con DDG-Territorio e Ambiente n. 502 del 06.06.2007 si è determinata sulla necessità di dotare ogni SIC di Piano di Gestione, che costituisce una delle possibili misure di conservazione per i Siti della Rete Natura 2000. Se le misure di conservazione e gli strumenti pianificatori già esistenti sull’area fossero stati sufficienti per conseguire gli obiettivi di conservazione fissati dalle Direttive comunitarie, non sarebbe stato necessario redigere un apposito piano di gestione, ma sarebbe stato sufficiente provvedere alle attività di monitoraggio e valutazione dello stato di conservazione del sito. Nella predisposizione del presente Piano di Gestione è stata pertanto compiuta preliminarmente la verifica dei presupposti che rendono necessario, per il raggiungimento Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 8 degli obiettivi della Direttiva e per la tutela del sito in esame, la predispozione di un Piano di Gestione autonomo. Il primo passo di tale verifica è stato la puntuale ricognizione di tutte le previsioni normative e pianificatorie che riguardano il sito. Tale ricognizione ha consentito di evidenziare che: 1) il quadro della pianificazione è piuttosto incompleto: sono assenti il PRG di Gibellina, il Piano d’Ambito, il Piano di Gestione Forestale, il Piano Territoriale Provinciale, il Piano di Utilizzazione della riserva naturale, ecc. 2) nessuno dei piani vigenti o in fase di adozione contiene la visualizzazione del perimetro del SIC né tanto meno contiene misure specifiche per la conservazione dei singoli habitat e delle specie presenti nel SIC; anzi in alcuni casi, come verrà detto meglio in altra parte della presente relazione, sono state rinvenute previsioni in contrasto con la conservazione del sito. Le previsioni regolamentari vigenti non sono sufficienti al mantenimento di uno stato di conservazione favorevole degli habitat e delle specie per le quali il Sito è stato individuato, né appaiono facilmente integrabili; dunque molte delle necessarie misure di conservazione individuate non potrebbero essere ricondotte a strumenti esistenti o in via di adozione. Ad oggi l’unico strumento idoneo a disciplinare l’uso del territorio con specifica attenzione agli obiettivi di conservazione della natura è il vigente Regolamento della riserva naturale, che riguarda tuttavia una porzione assai limitata del SIC. Pertanto, sulla base dei vincoli gravanti sul territorio e degli strumenti di programmazione e gestione territoriale, emerge l’assoluta necessità dell’elaborazione del Piano di Gestione come strumento autonomo. Infatti, la complessità delle problematiche di conservazione presenti nel Sito, e la possibilità solo parziale di recepimento delle misure di conservazione nell’ambito degli attuali e diversi strumenti di pianificazione territoriale, hanno indotto a ritenere necessaria la realizzazione di un Piano di Gestione specifico per il sito. Unica alternativa al PdG specifico sarebbe rappresentata dall’estensione della Riserva a comprendere tutto il territorio del SIC e dalla conseguente integrazione delle misure di conservazione definite come necessarie nel Regolamento dell’area protetta. Tale soluzione non appare tuttavia praticabile soprattutto per l’entità delle superfici in gioco. 1.5 METODOLOGIA UTILIZZATA NELL’AMBITO DEL PRESENTE PIANO DI GESTIONE Il Piano di Gestione è finalizzato alla individuazione delle misure esplicite finalizzate a raggiungere gli obiettivi generali della Direttiva Habitat 92/43, cioè “… il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario”, tenendo conto “… delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”. Per poter efficacemente svolgere il compito assegnato, il Piano dovrà essere: • • • • fondato su un rigoroso quadro conoscitivo, integrabile nell’ambito del Sistema Informativo Territoriale e comprendente gli aspetti della realtà socio-economica locale; specificamente dettagliato circa le misure di conservazione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico del Sito; chiaro nei contenuti e organizzato in banche dati georiferite; praticabile in termini amministrativi e di impatto socio-economico; Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 9 • flessibile e dinamico e quindi costruito per essere integrato e migliorato sulla scorta dell’esperienza concreta. In riferimento al carattere che gli si vuole conferire, il presente Piano di Gestione contiene: • la definizione del quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del Sito per le diverse componenti (fisica, biologica, socio-economica, culturale, paesaggistica), descritte sulla base delle conoscenze pregresse e di studi aggiuntivi, e comprendente la redazione di banche dati georiferite; • l’analisi delle esigenze ecologiche di habitat e specie, e l’individuazione di specifici indicatori che consentano di valutare lo stato di conservazione e di prevederne l'evoluzione; • la formulazione degli obiettivi gestionali generali e degli obiettivi specifici, sulla base di valutazioni strategiche che rispettino le finalità istitutive del sito; • la definizione della strategia gestionale e del piano delle azioni, con precise indicazioni sulla cogenza delle misure di gestione, sulla responsabilità attuativa dei vari soggetti operanti sul territorio, sull’individuazione di costi e tempi necessari per la loro realizzazione; • l’individuazione di indicatori e azioni di monitoraggio tanto sullo stato di conservazione di habitat e specie quanto sull’efficacia delle azioni gestionali. L’Ente gestore, ai sensi dell’art. 5 del Protocollo d’Intesa stipulato con l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, ha deciso di provvedere alla redazione del suddetto Piano in economia, avvalendosi di attrezzature e personale delle riserve naturali affidate in gestione e della collaborazione di professionalità esterne per specifici compiti di consulenza, di studio, progettuali e di monitoraggio. Tale scelta è motivata non solo dall’opportunità di valorizzare competenze già presenti nell’organigramma dell’Ente gestore, ma soprattutto dalla volontà di utilizzare a pieno il lavoro già svolto negli anni per la gestione delle riserve naturali coinvolte, e per meglio coordinare la pianificazione dei Siti Natura 2000 con quella delle riserve interessate (i cui piani di sistemazione sono stati approvati o sono in corso di elaborazione). Per la redazione del presente Piano di Gestione sono state svolte, in coerenza con il cronoprogramma elaborato, le attività di seguito indicate: 1) Definizione di uno specifico gruppo di lavoro per il coordinamento e la redazione del Piano di Gestione, costituito da: direttore della riserva naturale “Grotta di Santa Ninfa” dott.ssa Giulia Casamento, con le funzioni di referente tecnico del Piano e coautrice della parte gestionale; direttore della riserva naturale “Lago Sfondato” Sig. Angelo Dimarca, con le funzioni di referente regionale del coordinamento Piani di Gestione e dei rapporti con l’Assessorato e coautore della parte gestionale; direttore della riserva naturale “Grotta di Carburangeli” dott. Rosario Di Pietro, consulente per la parte geologica; dott. Salvatore Livreri Console, per la gestione del Sistema Informativo Territoriale. 2) Affidamento degli incarichi di collaborazione per lo svolgimento di specifiche analisi ambientali e territoriali finalizzate all’approfondimento ed all’integrazione delle conoscenze sul Sito. Nella tabella che segue viene riportato l’elenco dei consulenti esterni incaricati e dei relativi settori di indagine. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 10 Dottori Geologi Paolo Madonia, Francesco Di Trapani Dip.to Colture Arboree, Università PA – responsabile scientifico Dott. Tommaso La Mantia Dip.to Biologia Animale, Università PA – responsabile scientifico prof. Maurizio Sarà Dott. Antonino Duchi, Biologo Arch. Vincenzo Todaro, dottore di ricerca in Pianificazione urbana e territoriale Dott. Naturalista Salvatore Livreri Console, esperto in SIT Dott. in Sc. Ambientali Manuel Bellafiore Coop. ECO, Palermo (dott.ssa Alessia Maso e dott.ssa Maria Cristina Alga) Aspetti geologici e geomorfologici, individuazione grotte Flora, vegetazione e habitat comunitari Caratterizzazione agro-forestale, uso del suolo e linee guida per attività agro-silvo-pastorali Aspetti faunistici (anfibi, rettili, mammiferi, uccelli) Ittiofauna delle acque dolci Aspetti urbanistici e di programmazione territoriale – Beni archeologici, architettonici e culturali Paesaggio - Reti ecologiche Gestione del Sistema Informativo Territoriale Censimento patrimonio insediativo, infrastrutture e servizi a rete Analisi socio-economica e Piano di comunicazione 3) Raccolta di dati bibliografici e di documentazione tecnica. 4) Sopralluoghi su campo finalizzati ad un maggiore approfondimento del quadro conoscitivo nonché all’analisi ed alla valutazione dello stato di conservazione, della viabilità esistente, del grado di antropizzazione, della presenza di detrattori ambientali. 5) Attività di informazione preliminare, nei confronti di Enti ed Amministrazioni competenti, sulla redazione del Piano di Gestione, 6) Strutturazione del Sistema Informativo Territoriale Il Piano di Gestione è stato redatto in conformità con i seguenti documenti: • “Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000” - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. • “Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000” - Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002. • “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” - Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le Schede Natura 2000 sono state aggiornate e verificate in conformità con il “Formulario Standard NATURA 2000 per la raccolta dei dati: Note esplicative”. Le schede degli interventi gestionali sono state compilate in conformità con la nota “Linee Guida per la definizione delle strategie gestionali e delle azioni nei Siti Natura 2000”, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 23.05.2008. Nell’ambito della redazione del Piano di Gestione, ed in particolare per l’individuazione delle strategie e degli obiettivi di conservazione, sono stati consultati i seguenti documenti: • European Commission 2007. Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 11 • Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste, 2003. Piano Forestale Regionale - Linee Guida Servizio Programmazione e Monitoraggio. • Regione Siciliana. Assessorato Agricoltura e Foreste, 2006. Piano Regionale Faunistico-venatorio 2006-2011. • Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste, 2007. Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013. • Regione Siciliana. Decisione n. 2 agosto 2007. Programma Operativo Regionale. FESR 2007-2013 • LIPU-BirdLife Italia, 2003. Analisi dell’idoneità dei Piani di Sviluppo Rurale per la gestione delle ZPS e delle IBA. • Documento di lavoro (Rev. 2_21/03/2007) del “Dipartimento delle Politiche di Sviluppo della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale” avente per oggetto il “D.M. 21 dicembre 2006 – Aspetti applicativi della Direttiva 79/409/CEE e della Direttiva 92/43/CEE (Atto A1 e Atto A5) nel quadro della condizionalità”, poi modificato con il DM 13286 del 18/10/2007; • Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente – Linee guida Rete Ecologica Siciliana Corre l’obbligo di fare presente che durante la redazione del Piano di Gestione sono state incontrate numerose difficoltà, anche di carattere straordinario e non immaginabili, connesse con: • la scarsa disponibilità di dati di base nei tempi utili per una celere redazione del piano; • la raccolta delle informazioni necessarie presso altre pubbliche amministrazioni; • l’assenza di dati su aspetti di contesto e settoriali; • il grado di definizione dei documenti trasmessi da parte di altre pubbliche amministrazioni; • la mancanza di un sistema informativo territoriale omogeneo ed integrato a livello regionale; • l’assenza di banche dati a livello regionale su aspetti socio-economici o di monitoraggio delle politiche di sviluppo; • la non definizione del quadro programmatico e pianificatorio regionale, che attualmente si presenta ancora in fase di realizzazione (studi di piano e linee guida) o di approvazione in settori strategici per la salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile nel territorio e direttamente connessi con la gestione dei Siti della Rete Natura 2000. In ultimo va comunque fatto rilevare che il lavoro di analisi e di studio sul campo svolto per la redazione del Piano di Gestione ha permesso di effettuare utili approfondimenti e di colmare vuoti conoscitivi, consentendo di acquisire nuovi e inediti dati sulla presenza e distribuzione di habitat e specie di interesse conservazionistico, di maggior rilievo rispetto a quelli utilizzati alcuni anni fa per la designazione del Sito. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 12 2. QUADRO CONOSCITIVO 2.1 LE CONOSCENZE PREGRESSE SUL SITO (B.2) L’area gessosa di Santa Ninfa è stata oggetto di studi e ricerche geologiche, geomorfologiche e speleologiche già a partire dalla fine del 1800 (BALDACCI, 1886; SPATARO, 1891; MARINELLI, 1899, 1917; GEMMELLARO, 1915). Dopo un lungo periodo di stasi, nuove ricerche vengono effettuate in occasione del “Simposio Internazionale sul Carsismo nelle Evaporiti” (Bologna, 1986), e nel corso di uno studio multidisciplinare sull’area di Santa Ninfa e Gibellina coordinato dal Gruppo Nazionale Geografia Fisica e Geomorfologia (C.N.R.) – Sezione Carsismo e Speleologia Fisica. Le ricerche condotte in quel periodo portano alla realizzazione del volume “I gessi di Santa Ninfa” (AA.VV., 1989), che costituisce a tutt’oggi il testo base relativo agli aspetti geologici e geomorfologici del territorio. Scarse o nulle, invece, le ricerche in campo naturalistico prima dell’istituzione della riserva naturale “Grotta di Santa Ninfa”, avvenuta nel 1996: a parte alcune pubblicazioni di carattere floristico ed entomologico del DE STEFANI, si evidenziano solo alcuni studi botanici di carattere generale effettuati sul più vasto comprensorio della Valle del Belìce che include Partanna, Calatafimi, Salemi. Negli ultimi anni l’Ente Gestore della Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” (Legambiente Comitato Regionale Siciliano), che ricade in una piccola porzione del SIC, si è fatto promotore di attività di ricerca e studio sia relativamente ai fenomeni carsici, che ad altri aspetti ancora non sufficientemente indagati, avviando quell’attività di conoscenza che è la base per la pianificazione e la gestione di un’area protetta (CASAMENTO & PALMERI, 2001; CASAMENTO, 2001). 2.2 DESCRIZIONE FISICA DEL SITO (A) 2.2.1 Inquadramento territoriale e descrizione dei confini del Sito (A.1) Il sito ITA010022 “Complesso dei monti di Santa Ninfa – Gibellina e Grotta di Santa Ninfa” si estende per circa 660 Ha su un vasto complesso di rilievi collinari gessosi ricadenti nei comuni di Santa Ninfa e Gibellina, in provincia di Trapani (Tavola 1 – Carta dell’Inquadramento Territoriale). Si tratta di un altopiano carsico di notevole importanza naturalistico-ambientale e geologicogeomorfologica. La configurazione del paesaggio naturale è definita dall’articolata morfologia dei Monti di Gibellina e di Santa Ninfa, costituiti da una dorsale asimmetrica, allungata in direzione circa E-W ed arcuata verso S, e caratterizzati dalla presenza di imponenti pareti gessose e da ampie manifestazioni di fenomeni carsici superficiali, quali doline e inghiottitoi, intervallati da valli, valloni e zone pianeggianti. Nella dorsale si distinguono una fascia settentrionale, caratterizzata dalla presenza di una serie di rilievi allineati nello stesso senso di sviluppo della dorsale, e una fascia meridionale di altitudine inferiore; le due fasce, nelle grandi linee, individuano due distinti altopiani. Nell'altopiano settentrionale il rilievo più alto è rappresentato dal M.te Finestrelle (663 m), separato tramite un'incisione valliva (Valle Sorgo) da Rocca delle Penne (673 m) (il rilievo più alto della drosale, che tuttavia è esterno alla zona di interesse. Più a W si sviluppano i dossi di Fontana Blandina, le cui quote oscillano tra 550 e 623 m, mentre una serie di piccoli rilievi (la cui quota massima è di 562 m) compongono la Montagna della Magione che forma l'intero settore centrale; il settore occidentale è invece costituito dal Monte Castellaccio, che si Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 13 eleva fino a 546 m di quota. Quote più basse si riscontrano nei rilievi dell'altopiano meridionale, peraltro più omogeneo, ove raramente vengono superati i 500 m. Il Sito ricade nel territorio comunale di Santa Ninfa e Gibellina (TP) e per il suo inquadramento geografico si rimanda ai seguenti supporti cartografici: - Tavoletta 257 II NE (Santa Ninfa) – 1:25.000; - Elementi 618031 (S. Ninfa Nord) e 618044 (Villaggio Rampinzeri Nord) della Carta Tecnica dell'Italia Meridionale - 1:5.000. - Sezioni 618040 – 618030 – 606150 – 606160 della Carta Tecnica Regionale (1:10.000). 2.2.2 Inquadramento climatico e caratterizzazione bioclimatica del SIC (A.2) È possibile conoscere il clima locale analizzando i dati relativi alle stazioni poste entro un raggio di 10 km dall’area del SIC, ovvero Gibellina, Partanna e Santa Ninfa, le cui principali caratteristiche vengono riportate nella tabella seguente. Località Bac. Idr. Lat. Lon. Alt. T P Gibellina Belice 37,48 12,52 410 * * Partanna Modione 37,43 12,53 407 * Santa Ninfa Modione 37,46 12,52 465 * Bac. Idr. = bacino idrografico di pertinenza; Lat. = latitudine (° N); Lon. = longitudine (° E); Alt. = altitudine (m s.l.m.); T = stazione termometrica; P = stazione pluviometrica. Le precipitazioni piovose medie annue dell’area in cui ricade il SIC sono comprese tra 690 e 750 mm, e sono concentrate nei mesi autunnali e invernali. La stazione di Partanna, per la quale si dispone di dati termici (DURO et alii, 1997) mostra una temperatura media annua di 16,5 °C, con circa 4,5 mesi di aridità estiva ed un’escursione termica annua di quasi 17 °C: la temperatura si mantiene entro valori compresi tra 9 °C nel mese più freddo, gennaio (in cui non di rado scende sotto 0 °C), e 25-26 °C nel periodo più caldo (luglio-agosto). Dati pluviometrici relativi alle stazioni di Gibellina, Partanna e Santa Ninfa. mese Gibellina Partanna Santa Ninfa pp (mm) gp pp (mm) gp pp (mm) gp gen 94,0 12 97,2 11 100,0 13 feb 82,3 10 85,0 10 86,5 10 mar 69,4 9 70,0 9 69,9 9 apr 51,2 6 52,7 6 54,8 6 mag 28,8 4 28,0 3 32,6 4 giu 11,0 1 8,2 1 11,7 1 lug 3,9 1 4,0 0 5,8 1 Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 14 ago 12,3 1 8,9 1 12,0 1 set 43,2 4 42,9 4 45,1 4 ott 91,9 8 84,5 8 96,9 8 nov 97,2 9 106,0 9 112,0 10 dic 107,0 12 105,0 12 116,0 13 Anno 691,8 77 692,4 74 743,8 80 gp= giorni piovosi; pp = precipitazioni piovose (dati da DURO et alii, 1997). Nelle figure seguenti vengono presentati i diagrammi termopluviometrici (BAGNOULS & GAUSSEN, 1957) di Partanna, ottenuto sulla base dei dati effettivamente disponibili, nonché di Gibellina e Santa Ninfa, ottenuti invece attraverso il metodo di interpolazione proposto da ZAMPINO et alii (1997). Essi evidenziano come il comprensorio in esame abbia una temperatura media annua compresa tra i 15,9 °C di Santa Ninfa e i 16,5 °C di Partanna, con un’escursione termica annua pari a circa 16-17 °C (gennaio: 8,4 °C a Santa Ninfa e 8,8 °C sia a Gibellina sia a Partanna; luglio-agosto: 24,5 a Santa Ninfa e 25,6 °C a Partanna) e sia interessata da una stagione arida che dura 4-5 mesi, risultando pertanto a cavallo tra il bioclima clima termo- e mesomediterraneo della regione climatica mediterranea. Diagramma ombrotermico, temperatura e precipitazioni medie annue di Partanna. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 15 Diagramma ombrotermico, temperatura e precipitazioni medie annue di Gibellina. Diagramma ombrotermico, temperatura e precipitazioni medie annue di Santa Ninfa. Clima dell’area secondo Thornthwaite & Mather Avvalendosi del metodo di regressione proposto da PICCIONE et alii (1995), DURO et alii (1998) hanno calcolato il bilancio di Thornthwaite & Mather per la stazione di Partanna, Gibellina e Santa Ninfa. Nella tabella seguente vengono illustrati i principali parametri utili ai fini di questo metodo di classificazione, ovvero Im, Ih, Ia e Cet. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 16 Parametro Partanna Gibellina Santa Ninfa Im -18.85 -16.89 -9.33 Ih 30.77 29.91 36.36 Ia 49.62 46.80 45.69 Cet 50.61 48.74 48.86 Sulla base di quanto esposto, il clima di tutte e tre le stazioni considerate ricade nel tipo C1B’2s2b’4, ovvero C1 = subumido-subarido, B’2 = secondo mesotermico, s2 = con deficit estivo forte e b’4 = oceanico-suboceanico. Il periodo di eccedenza idrica va dall’ultima decade novembre a fine marzo, mentre il periodo di deficit idrico dura dai primi di maggio a fine ottobre. Clima dell’area secondo Pavari Sulla base dei valori noti di T media annua (16,3 °C), la T media del mese più freddo (gennaio: in media 8,6 °C) e di quello più caldo (luglio o agosto, in media 25,0 °C), le medie dei minimi annui (ca. 5,8 °C), l’area in esame ricade nella sottozona calda della zona II con siccità estiva riferita alla classe temperata calda del Lauretum. Il Pluviofattore di Lang nell’area del SIC In ragione dei valori del pluviofattore ottenuti per l’area di Partanna (692,4/16,5: 42), di Gibellina (691,9/16,2: 43) e di Santa Ninfa (743,7/15,9: 47) il comprensorio risulta ricadere nella zona climatica subtropicale e tropicale. L’Indice di aridità di De Martonne nell’area del SIC L’indice di aridità relativo, pari a 26,1 a Partanna (691,8/10+16,5), a 26,4 a Gibellina (692,4/10+16,2) e a 28,7 a Santa Ninfa (743,8/10+15,9) consente di riferire l’intero comprensorio alla classe climatica subumida. Quoziente pluviotermico di Emberger nell’area del SIC Avendo a disposizione soltanto i dati reali sul regime termometrico di Partanna, questa stazione è stata l’unica presa in considerazione per il calcolo del coefficiente di Emberger; le massime del mese più caldo pari a 31,4 °C ed un valore medio delle minime del mese più freddo pari a 5,5 °C, il coefficiente di Emberger (Q) risulterebbe pari a ca. 91,7. Questo dato bruto, abbinato alla media delle minime del mese più freddo, induce a classificare il clima del SIC come subumido ad inverno temperato. Indici di Rivas-Martínez nell’area del SIC Applicando gli indici climatici proposti da Rivas-Martínez, tutte le stazioni considerate presentano un clima marcatamente mediterraneo (Iov Partanna: 0,28; Iov Gibellina: 0,38; Iov Santa Ninfa: 0,47). Dal calcolo dell’indice di termicità (It = 3416) desumibile dalla stazione termopluviometrica di Partanna il SIC risulta ricadere nel termotipo mesomediterraneo inferiore. L’attribuzione dell’ombrotipo risulta agevole alla luce della notevole omogeneità dei dati pluviometrici disponibili: infatti le precipitazioni piovose annue oscillano ben poco Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 17 tra i ca. 692 mm di Partanna ed i ca. 744 mm di Santa Ninfa e suggeriscono di attribuire l’intero SIC all’ombrotipo subumido inferiore. 2.2.3 Inquadramento geologico, geomorfologico, idrogeologico (A.3) Aspetti geologici (A.3.1) Le formazioni gessose della regione carsica di Santa Ninfa appartengono ai depositi evaporitici della formazione Gessoso-Solfifera Messiniana depositatesi nel bacino del Mediterraneo, costituita da una successione litologica composta da Diatomiti, calcari evaporitici, gessi, sali, ed intercalazioni varie di argille. Tale successione poggia in discordanza sui depositi pre-evaporitici della formazione Terravecchia (Tortoniano sup.Messiniano inf.) ed è ricoperta in discordanza da calcilutiti e calcisiltiti pelagiche con calcareniti appartenenti all’unità dei Trubi (cfr. Tavola 2 – Carta geologica). Nell’area AGOSTINI & CUCCHI (1989) individuano 6 “Unità geolitologiche”, così suddivise: U.B. - Unità impermeabile di base; U.G. - Unità gessosa più o meno carsificabile sovrastante; U.S. - Unità marnoso-argillosa superiore; U.T. - Unità marnosa a Globigerine e marnoso-arenacea non carsificabile; U.C. - Unità conglomeratica recente, poco carsificabile; U.Q. - Depositi sciolti quaternari. U.B. - Unità di base, argillo-marnosa È costituita da argille e marne di colore grigio-azzurro facenti parte della «Formazione Terravecchia» di età Tortoniano sup. - Messiniano inf. L'Unità è composta dalle rocce più antiche affioranti in zona, è arealmente diffusa e rappresenta il substrato impermeabile e non carsificabile. Aree di affioramento significative sono quelle della zona nordoríentale, alle pendici del Monte Castellaccio e della Montagna della Magione. A NW, appena fuori dall'area studiata, affiorano limitati lembi di calcari coralligeni e detritici con sabbie gialle, probabilmente del Sahelíano inferiore. U.G. - Unità gessosa e sottounità gessarenitica E’ caratterizzata da diversi litotipi, anche se quelli più frequenti consistono in gessi da micro a macrocristallini, ed è costituita da parte dei litotípi caratterizzanti la «Formazione gessososolfifera» di età messiniana. La «successione tipo» dovrebbe essere data, dal basso verso l'alto, da alcuni metri di marne diatomifere e gessose passanti a calcari silicei e gessosi, preludenti alla potente successione di gessi anidri macrocristallini. I gessi anidri macrocristallini, che costituiscono con le intercalazioni di strati a cristalli minuti o a minute brecce gessose, il litotipo prevalente e più potente, sono seguiti dalla «Sottounità gessarenitica», consistente in arenarie e marne più o meno gessose, in gessi micro e macrocristallini fittamente laminati, e con frequenti intercalazíoni di brecce caotiche costituite da frammenti anche grossolani dell'Unità argilloso-marnosa sottostante. I gessi, specie se macrocristallini, sono abbastanza nettamente stratificati (spesso con stratificazione marcata da interlamine argillose) con strati di spessore da decimetrico a Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 18 metrico. Talvolta si rinvengono fratture riempite da calcite e, più raramente, da gesso ricristallizzato. La fratturazione ha ritmo da decimetrico a metrico. L'unità gessosa è da considerare molto carsificabile e permeabile per fratturazione e carsismo. Affiora diffusamente e costituisce l'ossatura dei rilievi di Santa Ninfa, culminando nell'arco settentrionale Montagna della Magione - Monte Campanaro - Rocca delle Penne. U.S. - Unità marnosa e argillosa superiore La sequenza gessosa è seguita da due formazioni, composte da marne e argille grigie e azzurre, talvolta interessate da sottili intercalazioni gessoso-argillitiche: tali litotipi sono legati alla chiusura del ciclo evaporitico. Anche se l'Unità comprende litotipi litologicamente e stratificamente eterogenei, dal punto di vista delle relazioni con le fenomenologie carsiche essa è da considerarsi omogenea, impermeabile e non carsificabile. Affiora con continuità alle pendici del M. Castellaccio e nell'area del M. Finestrelle. U.T Unità marnosa e marnoso-arenacea È l'Unità che praticamente chiude la successione affiorante in zona e in cui sono stati compresi i calcari pelagici, i calcari e le argille marnose con intercalazioni torbiditiche: si tratta di litotipi appartenenti alla «Formazione dei Trubi » e alla «Formazione marnosoarenacea » siciliane di età Pliocene inferiore e Pliocene medio-superiore. È da considerare poco o affatto permeabile e non carsificabile, ed affiora con continuità nei pressi dell'abitato di S. Ninfa e verso Est fino al Villaggio Rampinzeri, costituendo il basamento roccioso della valle Baiata. U.C. - Unità conglomeratica Questa Unità è stata distinta solamente per il suo interesse morfologico, in quanto nulla è la sua influenza sulle caratteristiche geoidrologiche dell'area. Si tratta di un deposito continentale regressivo consistente in sabbie più o meno cementate e in conglomerati eterogenei e poligenici, spesso con strutture incrociate, con livelli cementati ad Ostree. Affiora in limitati lembi (NW dell'abitato di S. Ninfa, pendio occidentale del Colle La Menta) ed in limitatissime aree non cartografabili rinvenute nei pressi della Grotta della Volpe Rossa e a Nord di Fontana Blandina. UQ. - Unità sciolta quaternaria Comprende í principali affioramenti di detrito di falda e di frana e dei depositi alluvionali sciolti, che sono variamente distribuiti ma particolarmente abbondanti nelle vallecole ad Est di S. Ninfa. I versanti settentrionali ed occidentali sono caratterizzati da alte scarpate, risultato dell'azione combinata di fattori tettonici e litologici. Si assiste all'arretramento del versante a seguito del crollo dei rigidi gessi macrocristallini sulle argille in deformazione e scivolamento. Il limite orientale corrisponde ad una serie di articolate vallecole ad andamento meridiano impostate o srutturate su elementi tettonici. Il limite meridionale corrisponde ad un pendio a media pendenza che intaglia la monoclinale gessosa. Gli affioramenti gessosi disegnano una sorta di arco a sviluppo Est-Ovest e concavo verso sud: la concavità viene espressa, ma anche movimentata, da strutture disgiuntive ad orientamento trasversale e longitudinale. In tal modo vengono a perimetrare alcuni settori carsici all’interno dei quali si possono collocare blocchi di gesso a struttura con pianta rettangolare trapezoidale. Tra un blocco e l'altro si allungano bacini chiusi che si approfondiscono in prossimità degli inghiottitoi. A valle degli stessi si hanno ulteriori aste Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 19 idrografiche con verso di drenaggio coerente con quello delle valli cieche, quasi ad ipotizzare l'esistenza di paleovalli. Aspetti geomorfologici (A.3.1) L’area carsica di Santa Ninfa si presenta molto articolata, caratterizzata da una serie di forme strutturali, forme prodotte da processi carsici e di versante che, combinandosi tra di loro, danno vita all’attuale morfologia del paesaggio (AGNESI et al., 1989). Per quanto riguarda le forme strutturali (forme influenzate dalla struttura geologica, ossia le condizioni di giacitura delle rocce stesse che dipendono dalla tettonica, e riguardano tutti i rapporti di posizione tra le masse rocciose, la fatturazione di queste, la disposizione degli strati, ecc.), in linea generale e per grande scala il complesso gessoso di Santa Ninfa può essere visto come una dorsale monoclinalica con una certa asimmetria che, osservata nel dettaglio, si suddivide in più sistemi di scarpate, per lo più di origine tettonica, sviluppate prevalentemente in senso E-W e N-S e rimodellate dai processi erosivi. Più in dettaglio, tra le morfostrutture individuate nell’area, ormai intensamente erose da processi esogeni, si possono riconoscere delle superfici strutturali sub-pianeggianti e superfici sub-strutturali. Le prime sono presenti in placche isolate di qualche ettaro, che si sviluppano nei pressi dell’abitato di Santa Ninfa, a quote comprese tra i 490 e i 500m; lembi minori sono riconoscibili più a nord in C.da La Menta, Case Martino, e a Nord del Villaggio Rampinzeri. Le seconde invece, riconoscibili sia nei gessi che nei testimoni residuali di calcari evaporitici, sono distribuite lungo l’altopiano settentrionale, e cioè Monte Castellaccio, Monte Finestrelle, Montagna della Magione. Per le forme riguardanti i gessi, si tratta per lo più di pianori discontinui, con ampiezza variabile tra il centinaio e qualche migliaio di metri quadrati, appartenenti a strutture più complesse come pieghe. Quelle invece riferite alle coperture carbonatiche sovrastanti i gessi, che conferiscono l’aspetto cupoliforme ad alcuni rilievi, derivano dallo smembramento delle placche calcaree dalla periferia verso il centro in seguito al procedere dell’erosione chimica dei gessi sottostanti. Altre forme associabili a forme strutturali riscontrate nell’area sono: le superfici di erosione, come la superficie di spianamento impostata sulla base della scarpata settentrionale, che arretra parallelamente a se stessa per fenomeni di crollo, e la superficie di erosione dovuta verosimilmente ad un episodio di continentalità pleistocenica, riconoscibile all’estremità nord dell’area presso masseria Lo Curto. Altre superfici similari, che troncano di netto le sequenze gessose, sono riconoscibili nell’area di Montagna della Magione, di Monte Finestrelle e di Monte Castellaccio. Le scarpate, numerose nella zona, sono generate essenzialmente da sistemi di faglia che hanno sezionato l’altopiano. Quella più significativa è la scarpata bordiera settentrionale, con andamento ad arco convesso verso nord. Il suo andamento non è regolare, in quanto spesso è interessata da faglie secondarie che la smembrano in più sezioni. Ha una pendenza media del 70%, è lunga circa 10 km ed ha un’altezza media di 100 m. Altra scarpata è quella mediana che distingue i due altopiani, estesa tra Monte Castellaccio e la C.da Fontana Blandina. Molto più irregolare rispetto alla prima, con pendenze più basse (circa 25-30%) ed altezza notevolmente inferiore, si sviluppa per circa 4 km. Altre scarpate di entità minore caratterizzano l’intera area. In ultimo, per le forme strutturali si devono considerare i versanti, che appartengono sia a valli cieche come il vallone del Biviere, il cui versante destro è in larga parte impostato lungo la scarpata che distingue i due altopiani, sia a doline allineate lungo assi di sistemi di frattura. Fra le forme morfologiche che caratterizzano il paesaggio del complesso gessoso di Santa Ninfa, sono di particolare importanza, per diffusione e varietà, quelle legate al carsismo. Esse si presentano come macro-, meso- e micro-forme epigee ed ipogee. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 20 Le forme epigee si manifestano con lo sviluppo di depressioni chiuse di medie e grandi dimensioni: valli cieche e doline con presenza a volte di inghiottitoi attivi. La più elevata densità di depressioni chiuse si riscontra nell’altipiano sommitale, ed in particolare nel settore della Montagna della Magione; nell’altipiano meridionale si risconta invece un allineamento in senso Est-Ovest di grandi depressioni, tra cui spicca quelle del Biviere. Tale valle inizialmente è incisa sui terreni argillosi e, dopo un breve tratto in direzione N-S, si imposta sull’unità gessosa, parallelamente al sistema di faglie, con direzione E-W. In corrispondenza dei terreni gessosi, visto anche la maggior resistenza meccanica all’erosione, il corso d’acqua incide una stretta valle a V assumendo a tratti l’aspetto di una forra, per poi passare nel tratto terminale in un ampia conca bordata da ripide pareti fino a 50m di altezza, alla base delle quali il corso d’acqua viene assorbito da un ampio inghiottitoio, originando un esteso sistema carsico ipogeo (“La Grotta”). Altro caso di particolare importanza è costituito dall’allineamento di doline che segue la base della scarpata situata ad Ovest dell’altopiano di Fontana Blandina. Altre forme carsiche epigee sono dei dossi di forma conica, tronco-conica e a cupola, ed in qualche caso a torre, determinate da un erosione di tipo selettiva, delle piccole placche relitte dei calcari evaporitici che poggiano sulle successioni gessose. Le microforme carsiche si presentano diffusamente e in una grande varietà di tipi, interessando tutti i litotipi gessosi ed in particolare i termini macrocristallini, dove evidentemente si realizzano le condizioni giaciturali idonee alla formazione e allo sviluppo delle microforme. Una delle zone particolarmente ricche di forme carsiche su gesso selenitico è rappresentata dall’area del Monte Castellaccio. Tra i morfotipi individuati nella zona si riscontrano le scannellature o rillenkarren, presenti in tutti i litotipi ad eccezione del gesso macrocristallino; si presentano con creste aguzze e una sezione trasversale piuttosto regolare. Nella porzione gessosa arenitica, anche su pendenza elevate oltre i 70 gradi sono presenti in due varietà; una caratterizzata da una sezione a V molto regolare e creste sottili, l’altra con creste piatte e sezioni assai regolari, generalmente di maggiori dimensioni. Poi troviamo solchi a doccia o rinnekarren, che si trovano esclusivamente nel gesso macrocristallino e che si presentano con una sezione a V separati da creste arrotondate. Altro morfotipo è costituito dai karren coperti o rundkarren, osservabili sia nel gesso microcristallino che in quello macrocristallino. Generalmente sono isolati e con sezione trasversale piuttosto arrotondata. Altre forme caratteristiche sono le vaschette di corrosione o kamenitzas con fondo piatto; sono state osservate in alcuni grossi massi di gesso macrocristallino e solitamente tendono ad essere riempite da materiale insolubile. Infine troviamo i karren ad imbuto o trichtenkarren, osservati esclusivamente nel gesso arenitico: sono delle piccole conche subcircolari con fondo piatto delimitato da pareti di qualche millimetro di altezza che si raccordano dolcemente ad esso. Un’ulteriore processo geomorfologico agente nell’area di Santa Ninfa è rappresentato dai processi di versante. Gran parte dei versanti dell’area è interessata da fenomeni franosi attivi e fenomeni quiescenti, la cui riattivazione è comunque possibile. Per quanto riguarda le tipologie di frane osservate, possono essere classificate secondo lo schema di Varnes modificato da Carrara. I più diffusi sono i crolli legati alla presenza di rocce coerenti, caratterizzate da un elevato grado di fatturazione, come anche i ribaltamenti. Si individuano anche scorrimenti legati alla presenza degli interstrati argillosi, che favoriscono il movimento, come quella di M.te Castellaccio. I terreni argillosi, invece, sono caratterizzati da colamenti. Nell’area si riscontra un elevato numero di cavità ipogee. In AA.VV. (1989) veniva evidenziata la presenza di 42 cavità (tra grotte ed inghiottitoi), mentre un recente studio svolto nell’ambito della redazione del PdG ha consentito di verificare l’attuale esistenza di 29 Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 21 cavità (di cui 4 sono risultate inaccessibili, 1 ostruita e 24 accessibili), che vengono sinteticamente riportate nella tabella seguente. Denominazione La Grotta Risorgente Inghiottitoio del Cane Impiccato Senza nome Senza nome Inghiottitoio di Casa Baldassone Pozzo presso Casa Ferreri Grotta tettonica di Monte Castellaccio Grotta inferiore delle Eccentriche Grotta superiore delle Eccentriche Inghiottitoio di Case Martino La Gronda Senza nome Inghiottitoio della Magione Senza nome Senza nome Senza nome Senza nome Inghiottitoio della Volpe Rossa Grotta dei Latitanti Senza nome Inghiottitoio dei Rovi Inghiottitoio del Canale delle Penne Senza nome Inghiottitoio del Castellaccio Diaclasi del Castellaccio Cavità tettonica a quota 525 Inghiottitoio del Biviere Descrizione E’ il sistema carsico di maggiore estensione dell’area, costituendo l'emittente della valle cieca del Biviere. Si articola in un ramo fossile ed in un ramo attivo inferiore. Elevato interesse speleologico, idrogeologico, biospeleologico. Sviluppo 1350 m, dislivello -25 m. Risorgenza della cavità precedente. Inghiottitoio attivo al fondo di una dolina. Presenta un piccolo lago d'acqua perenne ed è percorso da un torrente che può presentare notevoli piene. Sviluppo 105 m, Dislivello -30 m. Cavità mai esplorata Cavità mai esplorata Cavità mai esplorata. Stretta frattura tettonica sul versante meridionale del Monte Castellaccio. Sviluppo 23 m, Dislivello -13 m. Piccola cavità in un’area vistosamente tettonizzata, accessibile attraverso una stretta fessura. Sviluppo 11 m, Dislivello -3,5 m. Vedi scheda successiva (trattasi di diverso ingresso della medesima cavità). Sviluppo 310, Dislivello -34. Complessa cavità tettonica sviluppata lungo uno sciame di fratture tettoniche riconoscibili anche esternamente. Interessante concrezionamento. Sviluppo 310 m, Dislivello -34 m. La grotta si sviluppa inizialmente a meandro, con evidenti tracce delle improvvise e pericolose piene cui è soggetto il torrente ipogeo. Ingresso ostruito. Cavità mai esplorata. Cavità inaccessibile L'inghiottitoio drena le acque di una vasta dolina ma diviene ben presto impenetrabile per i copiosi riempimenti argillosi. Sviluppo 20 m, Dislivello -9 m. Cavità inaccessibile Cavità inaccessibile Cavità inaccessibile Cavità mai esplorata L’inghiottitoio si apre al fondo di una dolina imbutiforme. Elevato interesse speleologico, idrogeologico. Sviluppo 371 m, Dislivello -67 m. Interessante cavità di origine tettonica, con fitta vegetazione all’ingresso, costituita da tre sale interne comunicanti. Sviluppo 137 m, Dislivello -20 m. Cavità mai esplorata Inghiottitoio in una grande dolina, che si sviluppa in un bel meandro alto sino a 8 m. Sviluppo 206 m, Dislivello -29 m. L'inghiottitoio si apre al fondo della vasta valle cieca compresa tra Rocca delle Penne e Rocca Tonda. Sviluppo 106 m, Dislivello -5 m. Cavità mai esplorata. Modesta cavità posta al fondo di una piccola dolina del versante settentrionale di M. Castellaccio. Sviluppo 6 m, Dislivello -2 m. Piccola cavità. Sviluppo 9 m, Dislivello -3 m. Articolata cavità tettonica in posizione panoramica, sviluppata in ambienti impostati su elementi tettonici riscontrabili anche all'esterno. Sviluppo 121 m, Dislivello -25 m. Presenta un pozzo verticale di alcuni metri, che termina in una stanza dove si ubica un sifone che inghiotte le acque del Biviere. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 22 Le cavità carsiche di Santa Ninfa, pur aprendosi tutte in gesso, si sono dimostrate particolarmente interessanti sia dal punto di vista del concrezionamento carbonatico e subordinatamente gessoso, sia da quello delle mineralizzazioni secondarie (FORTI, 1989). Sono stati infatti evidenziati numerosi speleotemi, alcuni dei quali del tutto nuovi per l'ambiente carsico nei gessi. Il concrezionamento carbonatico presenta un notevole sviluppo soprattutto nella grotta di Santa Ninfa, ove colate, stalattiti e crostoni hanno dimensioni sino a qualche metro; notevole poi in questa grotta la ricchezza di forme che i depositi carbonatici assumono, ricchezza che è paragonabile a quella che normalmente si osserva nelle grotte nei calcari. A prescindere dalla Grotta di Santa Ninfa, solamente la Grotta di Monte Finestrelle presenta speleotemi calcarei di un certo interesse: nel tratto terminale di quest'ultima grotta, infatti, sono state osservate alcune lame isolate di dimensioni metriche. In molte delle altre cavità della zona sono presenti concrezioni calcaree, anche se sempre con dimensioni e varietà di forme minori: in generale si tratta di piccole stalattiti e colate. Nel campo delle cristallizzazioni di gesso l'interesse della area carsica di Santa Ninfa è assolutamente eccezionale: infatti la varietà e l'abbondanza delle forme cristalline rinvenute negli interstrati argillosi intersecati dai condotti carsici, e in special modo nella Grotta di Santa Ninfa, è tale da competere con quella delle Grotte Bolognesi. Sono stati osservati cristalli singoli isolati, aciculari, prismatici pseudoesagonali a volte con accrescimenti paralleli, o con accrescimento dendritico, rosette di lenticolari o di prismatici, etc. Nella grotta di Monte Finestrelle, poi, sono presenti in numero elevato grandi cristalli (sino a 0.5 m in lunghezza) lenticolari, geminati a coda di rondine o a ferro di lancia, molti dei quali di una notevole limpidezza. Sempre all'interno della Grotta di Santa Ninfa, proprio al di sopra del pozzo che immette nella zona attiva della cavità, in una sala laterale fortemente interessata da concrezionamento calcareo e ricca di deposito di guano, è stato rinvenuto un altro fosfato: la carbonatoapatite. È la prima volta che in Italia è segnalata la carbonatoapatite in una cavità nel gesso. Appare quindi in tutta chiarezza la notevole importanza che questa piccola zona gessosa riveste, non solo nel ristretto ambito italiano, per questo particolare aspetto del carsismo. Infatti per la prima volta al mondo sono state osservate alcune particolari concrezioni, quali le eccentriche di gesso e gli speleotemi poliminerali, inoltre sono state evidenziati nuovi meccanismi per la formazione di cristallizzazioni di solfato di calcio in ambiente carsico gessoso. Inoltre, la ricchezza di minerali secondari e di speleotemi, osservata soprattutto all'interno della Grotta di Santa Ninfa, è del tutto eccezionale per l'ambiente carsico gessoso ed è sicuramente da ascrivere alla esistenza di emergenze solfuree all'interno della grotta. La maggior parte delle forme carsiche di maggiori dimensioni presenti nel SIC viene riportata nella Tavola 3 – Carta geomorfologica. Non sono state riportate su carta le numerose microforme epigee (karren, vaschette, dossi, ecc.) sia per la loro dimensione che per la loro estesa diffusione nel territorio del SIC. Aspetti idrogeologici (A.3.2; A.4) Il substrato gessoso che caratterizza l’area è interessato da un’intensa fatturazione e da un carsismo piuttosto spinto, che genera una permeabilità molto elevata, drenando rapidamente verso il sottosuolo le acque di precipitazione atmosferica. Tale drenaggio avviene sia in maniera concentrata, attraverso gli inghiottitoi attivi, sia in maniera diffusa, attraverso la rete di fratture e micro-cavità che interrompe in maniera massiva la continuità fisica dei terreni gessosi. Le acque di infiltrazione efficace seguono percorsi sia relativamente lenti (nelle microfratture e microcavità) che veloci (nei condotti carsici). Talvolta, i riempimenti secondari di argille Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 23 depositati all’interno delle cavità idricamente attive tendono a rallentare la circolazione sotterranea. Il livello di base degli acquiferi esistenti nell’area è generalmente rappresentato dalla Formazione Terravecchia, sottostante stratigraficamente e geometricamente alla Formazione Gessoso-Solfifera. Piccole falde sospese possono essere presenti all’interno dell’affioramento gessoso, legate alla presenza di interstrati argillosi che ne rappresentano il livello di base. I punti di venuta a giorno delle acque sono rappresentati da piccole sorgenti, le più rappresentative delle quali sono legate all’affioramento della falda basale, ubicandosi ai margini meridionali dell’affioramento gessoso, dove esso viene a contatto con il complesso impermeabile sottostante. La risorgente della Grotta di Santa Ninfa è appunto legata a questo tipo di assetto idrogeologico. Non mancano inoltre le sorgenti in tramontane, aventi lo stesso tipo di alimentazione, dovute principalmente all’assetto strutturale della zona. Nello specifico, nell’ambito di uno studio sugli acquiferi (FAVARA et al., 2001), sono state individuate le principali falde idriche dell’area, che possono essere distinte in falde basali, falde medio-superficiali, falde estremamente superficiali. Gli acquiferi basali individuati sono due: - Il primo è ubicato nella parte settentrionale del massiccio di Monte Finestrelle. Ha un deflusso settentrionale e presenta dimensioni e velocità di deflusso sufficienti ad omogeneizzare quasi per intero le escursioni isotopiche delle precipitazioni che lo alimentano. Le sue caratteristiche chimiche indicano che l'acqua di questa falda è in equilibrio con le specie mineralogiche che costituiscono le rocce serbatoio. L'affioramento di questa falda è costituito dalla Sorgente Case Di Stefano, caratterizzata da valori di portata elevati e abbastanza costanti durante l'intero periodo dell'anno. Tra le molte sorgenti dell'area essa è ubicata alla quota più bassa (livello freatico circa 350 m s.l.m.), è probabile quindi che riceva il contributo idrico da tutte le aree di ricarica della zona. Ciò può avvenire sia in termini di apporto diretto di acque infiltranti che in termini di travaso da falde più superficiali. - Il secondo ha un deflusso preferenziale verso sud e comprende nel suo circuito il sistema Biviere-Grotta-Risorgenza-Polla. Rispetto al precedente ha velocità di deflusso più elevata e presenta volumi idrici inferiori, mostrando escursioni isotopiche ridotte rispetto alla sua ricarica meteorica. La sua potenzialità idrica è tale da riuscire ad alimentare il corso d'acqua che scorre all'interno della grotta anche quando, nel periodo estivo, il torrente Biviere è completamente in secca. Le sue caratteristiche chimiche sono simili all'altro acquifero basale. Tra i circuiti medio-superficiali possiamo includere quelli le cui sorgenti hanno quote di emergenza più elevate rispetto a quelli già trattati. La loro esistenza è dovuta agli interstrati argillosi presenti nella sequenza gessosa, che ne costituiscono il limite impermeabile locale. La loro potenzialità idrica è abbastanza limitata, infatti alcune sorgenti connesse a questi acquiferi si estinguono nel periodo estivo. Un esempio di questo tipo di falde è rappresentato dalla sorgente Rampinzeri, che mostra valori medi annui di composizione isotopica più negativi proprio in virtù del fatto che il suo bacino di alimentazione comprende le aree più elevate del complesso gessoso di monte Monte Finestrelle. L'acquifero che alimenta la sorgente di Case Monreale presenta, rispetto a tutti gli altri, un carico salino inferiore ed una connotazione bicarbonato-calcica prevalente. Un'altra caratteristica è data dalla variabilità della sua composizione chimica durante 1'arco dell'anno. Le variazioni chimiche sembrano dovute probabilmente ad un contributo occasionale in alcuni periodi dell'anno da parte di acque chimicamente assimilabili al termine selenitico. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 24 Le falde estremamente superficiali possono essere ricondotte a quelle manifestazioni sorgentizie la cui esistenza è strettamente connessa a periodi piovosi; esse presentano portate abbastanza limitate e periodi di attività inferiori a setto-otto mesi l’anno. I circuiti idrologici che alimentano questo tipo di manifestazioni sono molto superficiali, di scarsissima entità volumetrica e con velocità di deflusso estremamente elevate. In alcuni casi questi circuiti costituiscono la circolazione di “troppo pieno” di acquiferi profondi. La circolazione idrica di superficie è limitata alle sole valli cieche e ai versanti delle doline; un notevole sviluppo mostra invece la rete idrografica impostata nelle argille sottostanti i gessi, e che prende inizio dai margini della dorsale. Infatti, dalle pendici meridionali del complesso montuoso si dipartono numerosi torrenti che costituiscono le sorgenti di testa dei fiumi Belice e Modione, mentre nel versante settentrionale si originano segmenti fluviali affluenti del Fiume Freddo (Tavola 4 – Carta del Sistema idrico Superficiale). Da rimarcare il torrente Biviere, a regime torrentizio, che percorre la Valle cieca del Biviere per circa 2,5 km prima di inoltrarsi nel sottosuolo dando vita alla Grotta di Santa Ninfa, e che riemerge più a valle nella Risorgenza costituendo una delle sorgenti di testa del Fiume Modione; e il Vallone Varuari, stretto ed incassato, esterno al Sito nonostante il suo interesse geomorfologico, idrogeologico e naturalistico. Aree classificate ad elevata pericolosità per la prevenzione del rischio idrogeologico (A.3.3) Il Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana individua e classifica i movimenti franosi riscontrati nell’area del SIC (cfr. tabella sottostante). Tali dissesti vengono inoltre riportati nella Tavola 5 – Carta dei Dissesti. Si tratta di un totale di 14 frane, per nessuna delle quali il Piano prevede interventi di sistemazione. In linea più generale, come già descritto nel capitolo inerente l’assetto geomorfologico, i fenomeni di versante, con specifico riferimento ai crolli, costituiscono un elemento diffuso e fondamentale dell’evoluzione del paesaggio naturale. La velocità evolutiva di tali fenomeni è notevole, a causa delle scadenti qualità geo-meccaniche delle rocce gessose, che al tempo stesso rendono del tutto non convenienti sotto il profilo ambientale, tecnico ed economico eventuali interventi di prevenzione e stabilizzazione dei versanti. Gli unici interventi efficaci per la stabilizzazione dei fenomeni di versante sono rappresentati dalla messa in opera di presidi di protezione delle eventuali strutture antropiche interessate dai dissesti, che sono però di forte impatto ambientale e scarsamente compatibili con le esigenze conservazionistiche di un’area protetta. Pertanto, si sconsiglia la realizzazione di qualsivoglia intervento nei confronti di fenomeni gravitativi con tipologia di crollo, eccezion fatta per i casi di assoluta, comprovata e non eludibile necessità. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 25 Sigla Prov. Comune 045-9SN-012 045-9GI-006 045-9GI-056 045-9GI-058 045-9GI-059 045-9GI-060 045-9GI-061 054-9SN-012 054-9SN-013 054-9SN-014 056-9SN-002 056-9SN-003 056-9SN-004 057-9GI-003 TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP S. Ninfa Gibellina Gibellina Gibellina Gibellina Gibellina Gibellina S. Ninfa S. Ninfa S. Ninfa S. Ninfa S. Ninfa S. Ninfa Gibellina Bacino o Area Territoriale F. San Bartolomeo F. San Bartolomeo F. San Bartolomeo F. San Bartolomeo F. San Bartolomeo F. San Bartolomeo F. San Bartolomeo F. Arena F. Arena F. Arena Tra F.Modione e F. Belice Tra F.Modione e F. Belice Tra F.Modione e F. Belice F. Belice TIPOLOGIA 1 = Crollo e/o ribaltamento 2 = Colamento rapido 3 = Sprofondamento 4 = Scorrimento 5 = Frana complessa 6 = Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV) 7 = Colamento lento 8 = Area a franosità diffusa 9 = Deformazione superficiale lenta (creep, soliflusso) 10 = Calanchi 11 = Dissesti dovuti ad erosione accelerata Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano Località Cappellone Sud Case Magione Sud Case Magione Nord Casa Catalano Nord Casa Catalano Nord Casa Catalano Monte Finestrelle C.da La Menta SE Timpone Pontillo SE Timpone Pontillo C.da Baiata, Sud S.S. 119 C.da Baiata, Sud S.S. 119 C.da Baiata, Sud S.S. 119 Monte Finestrelle C.T.R. 1:10.000 606150 606160 606160 618040 618040 618040 618040 618030 618030 618030 618030 618030 618030 618040 Tipologia Attività Pericolosità Rischio STATO DI ATTIVITA’ A = Attivo I = Inattivo Q = Quiescente S = Stabilizzato artificialmente o naturalmente 5 1 5 5 1 5 1 5 1 7 1 9 9 1 S A Q Q A S A A I A A A A A PERICOLOSITA’ 0 = Bassa 1 = Moderata 2 = Media 3 = Elevata 4 = Molto elevata 0 2 1 1 3 0 3 1 3 1 3 2 2 4 1 / / / / / / 3 / 1 / / / / Note Esterno al SIC Esterno al SIC Esterno al SIC RISCHIO 1 = Moderato 2 = Medio 3 = Elevato 4 = Molto elevato 26 Individuazione di eventuali sistemi di monitoraggio già esistenti nel territorio e/o previsti (A.3.4; A.4.2) Nel territorio del SIC non sono presenti sistemi di monitoraggio relativi ad aspetti geologici. Sino a qualche anno erano comunque in corso alcuni studi, condotti dall’Università di Palermo, Dipartimento di Geologia e Geodesia, relativi alla velocità di dissoluzione dei gessi. Relativamente invece agli aspetti climatici, l’ente gestore della riserva naturale Grotta di Santa Ninfa ha attivato da alcuni anni una rete di monitoraggio climatico ipogeo all’interno della Grotta, che misura in continuo, attraverso specifici sensori, la temperatura ipogea; vengono inoltre effettuati regolari rilievi per la misura dell’umidità relativa ipogea e della concentrazione della CO2. Ciò al fine di monitorare gli equilibri ipogei e di valutare gli eventuali effetti che possono essere causati dalla fruizione della Grotta, che è regolamentata e contingentata. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 27 2.3 DESCRIZIONE BIOLOGICA DEL SITO (B) 2.3.1 Descrizione della flora, della vegetazione e degli habitat 2.3.1.1 Le conoscenze floristico-vegetazionali – precedenti indagini sul SIC (B.2) Allo stato attuale pochissimi sono i contributi alla conoscenza botanica del comprensorio della Valle del Belìce, sebbene esso ospiti ben tre Riserve Naturali già istituite (Riserva Naturale Integrale “Grotta di Santa Ninfa”, Riserva Naturale Orientata “Foce del Fiume Belice e dune Limitrofe” e Riserva Naturale Integrale “Grotta di Entella”). Alcune specie vegetali di grande interesse fitogeografico vengono segnalate da GUSSONE (1828-1832, 18431845) per Partanna, Salaparuta, Gibellina e Salemi, mentre mancano del tutto informazioni su Santa Ninfa. Le immediate adiacenze dell’area in esame sono state fatte oggetto di sporadiche visite agli inizi dell’Ottocento. Oltre al Gussone vi erborizzarono anche il Philippi (Gibellina, maggio 1833, in accordo con un campione di Odontites rigidifolius visionato e riportato in BOLLIGER, 1996), e il Lojacono-Pojero (Calatafimi, come si desume da LOJACONO-POJERO, 1888-1909). Di recente la zona è stata meta di escursioni mirate da parte dei gruppi di ricerca dell’Università di Catania (Salemi, dove BRULLO et alii, 1991 riportano Allium dentiferum Webb et Berth.) e di Palermo (Salemi, dove RAIMONDO et alii, 1994 riportano Ajuga orientalis L.; Partanna, dove gli stessi AA. riportano Allium cupanii Raf., ecc.). Tra i contributi di carattere floristico e vegetazionale concernenti sensu lato l’area in esame vanno citati anche i lavori di BARTOLO & BRULLO (1986), BERNHARDT (1986a-1988), BERNHARDT & HURKA (1989), BRULLO & SPAMPINATO (1986), MINISSALE (1995) e SCUDERI (2006). Un primo contributo monografico alla conoscenza della flora vascolare, della vegetazione e degli habitat locali è stato invece prodotto da PASTA & LA MANTIA (2001a-b). 2.3.1.2 Metodologia adottata negli studi di carattere botanico (B.3.1) Per la caratterizzazione floristico-vegetazionale sono stati utilizzati dati bibliografici recenti (risultati delle indagini condotte in passato sulla flora vascolare e sulla vegetazione del territorio - PASTA, 2001; AA.VV., 2006) e sono stati svolti diversi sopralluoghi su campo per ultimare i rilievi floristici e fitosociologici, focalizzando l’attenzione sul trend dinamicodemografico delle specie d’interesse biogeografico e conservazionistico e delle xenofite eventualmente presenti. La nuova lista della flora vascolare è stata aggiornata sotto un profilo tassonomiconomenclaturale tenendo conto del recente contributo di GIARDINA et alii (2007). In conformità con quanto prescritto dal D.M 03/09/2002 “Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000”, per l’elaborazione delle carte tematiche è stata applicata la procedura qui di seguito esposta: 1) Fotointerpretazione: sono stati riportati su base topografica (C.T.R. 1:10.000) i limiti esistenti tra i fototipi di uso del suolo/vegetazione (carta di base dei fototipi uso suolo/vegetazione). 2) Carta dell’uso del suolo: la carta si spinge sino al V livello della scala di dettaglio di Corine Land Cover (CLC) 2000 ed è conforme agli standard proposti dalla Regione Siciliana, che ne ha indicato i criteri di redazione in un apposito documento (“Criteri di Redazione della Carta dell’Uso del Suolo”). La carta deriva dall’interpretazione di immagini telerilevate (ortofoto Portale Cartografico Nazionale, Volo 2006, fuso Est), confrontate con i supporti disponibili e sottoposte ad una successiva validazione in campo. Il contenuto di questa carta esprime la tipologia degli interventi antropici (prevalentemente agricoli) all’interno del SIC. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 28 3) Carte della vegetazione e degli habitat: sulla base della carta dei fototipi sono stati realizzati diversi rilievi fitosociologici che hanno consentito di passare dalla descrizione fisionomica a quella sinecologica ed all’interpretazione sintassonomica. Nei limiti del possibile, nell’elaborazione del piano di rilevamento si è tenuto conto dell’eventuale variabilità dei fattori abiotici (geologia, altimetria, esposizione), che possono modificare la composizione specifica della vegetazione senza che ciò sia evidenziabile per mezzo delle foto aeree. I tipi ottenuti attraverso i rilievi effettuati in campo sono stati classificati al fine di redigere un prospetto sintassonomico coerente. Per giustificare e documentare le scelte operate caso per caso, in sede di presentazione della carta della vegetazione sono stati forniti maggiori dettagli sia sulle esigenze ecologiche sia sulle connessioni dinamiche dei singoli consorzi già noti nonché di quelli di nuovo rinvenimento. Più nel dettaglio, sono state elencate le associazioni e gli aggruppamenti con una precisa indentità floristico-strutturale e/o un definito ruolo dinamico. A livello di classi, ordini e alleanze si è fatto riferimento agli schemi proposti da MUCINA (1997) e da RIVAS-MARTÍNEZ et alii (1999). Per i syntaxa di rango inferiore, cioè le associazioni e le subassocazioni ci si è rifatti per lo più a BRULLO et alii (2002a). 3.1 carta della vegetazione - i sopralluoghi hanno messo in evidenza che diverse fitocenosi “condividono” gli stessi spazi, costituendo dei veri e propri “mosaici”, e che numerosi consorzi non sono cartografabili per via dell’estrema localizzazione o delle modestissime dimensioni. In fase di stesura finale della carta sono stati adottati alcuni accorgimenti per renderla più leggibile: nei casi di vegetazione a mosaico sono stati operati opportuni accorpamenti per correlare tra loro in modo inequivocabile i consorzi rinvenuti 1) con le categorie d’uso del suolo (ove possibile definite in conformità con CLC-V livello), 2) con le categorie di Corine-Biotopes e 3) con gli habitat d’interesse comunitario/prioritario ai sensi della Dir. 92/43 CEE. 3.2 carta degli habitat - in occasione dei rilievi fitosociologici sono stati inoltre effettuati gli opportuni controlli sulla rappresentatività/integrità degli habitat individuati, sull’eventuale presenza e sull’intensità e frequenza dei fattori di stress e disturbo. In questa sede vengono indicati i criteri operativi che hanno ispirato l’interpretazione degli habitat sul campo e la loro restituzione cartografica. L’intera area del Sito di Importanza Comunitaria è stata indagata in modo da redigere una legenda che permettesse un confronto immediato tra le categorie di Corine Land Cover 2000, Corine Biotope e gli Habitat della Direttiva 92/43/CEE. L’unità minima di rilevamento è di 20 × 20 m, sia per gli habitat di interesse comunitario sia per vegetazione e uso del suolo. Particolare attenzione è stata prestata alla verifica dell’effettiva presenza e della reale rappresentatività (in termini floristico-strutturali ed areali) di ciascuno degli habitat riportati nella Scheda del Sito e nella Carta degli Habitat consegnata dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e da questo commissionata alla società Agristudio s.r.l. Pertanto, ad ogni unità di habitat rilevata è stato attribuito un codice in funzione della struttura e “densità” (“p” = puro: 90-100%; “f” = frequente: 50-90%; “r” = rado: 10-50%). Dove non è stato rilevato alcun habitat (o la copertura dell’habitat all’interno del poligono era inferiore al 10% dell’unità minima di rilevamento), si è utilizzata la denominazione del Corine Biotope prevalente. Inoltre, nel Sito sono frequenti le situazioni in cui i poligoni rilevati, riconducibili ad habitat o a biotopi, presentano una struttura a mosaico. Pur essendo facilmente distinguibili tra loro, le diverse componenti intervengono in misura diversa a fisionomizzare il poligono; al fine di standardizzare la loro rappresentazione, di registrare la complessità esistente e di ottenere informazioni utili alla pianificazione degli interventi gestionali, si è deciso che il tematismo fosse rappresentato da tutti i codici degli habitat o dei biotopi presenti, seguiti, come sopra Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 29 riportato, dai codici che esprimono il “peso” di ciascuno degli habitat che partecipano al mosaico stesso (puro; frequente; rado). Il primo degli habitat che compongono il mosaico è l’habitat prevalente, che fisionomizza l’area di rilevamento. I codici p-f-r vengono riportati nel data base degli habitat esclusivamente a fini gestionali, e conseguentemente non vengono visualizzati nella carta degli habitat per maggiore semplicità e chiarezza di rappresentazione. La carta degli habitat viene pertanto redatta secondo i seguenti criteri: • nel caso di presenza di un solo habitat, il tematismo relativo è rappresentato dal codice dell’habitat senza differenziare i poligoni con diverso grado di densità (f-p-r); • nel caso di presenza di un mosaico di habitat, il tematismo relativo sarà rappresentato dai codici di tutti gli habitat tra loro interconnessi (senza differenziare i poligoni con diverso grado di densità), ed il primo tra questi sarà l’habitat prevalente; • laddove non sia stato rilevato nessun habitat (o la copertura dell’habitat all’interno del poligono sia inferiore al 10% dell’unità minima di rilevamento), il tematismo sarà rappresentato dalla formazione Corine Biotope prevalente. Ai fini del calcolo della superficie di ciascun habitat, per ciascun mosaico si è valutata qualitativamente, sulla base delle informazioni raccolte sul campo, la “superficie” occupata da ciascun habitat componente il mosaico stesso. Così facendo, è stato possibile effettuare i calcoli necessari per giungere ad una valutazione accettabile delle superfici ricoperte dai singoli habitat, necessaria per la compilazione della nuova Scheda Natura 2000. 4) Carta della distribuzione delle emergenze floristiche: sono state riportate sulla CTR l’ubicazione (punti o perimetri) delle specie più rare e localizzate. Per quanto concerne invece i taxa pregiati che nel SIC risultano comuni o sono legati ad habitat ampiamente rappresentati, si è fatto ricorso ad una sorta di carta di idoneità ambientale, riferendo cioè tali emergenze a tutti gli habitat ed ai biotopi idonei che soddisfino le loro esigenze ecologiche. 2.3.1.3 Risultati delle indagini e descrizione naturalistica del sito (B.3) Premessa sul grado di naturalita’ del territorio con dati di sintesi sull’uso del suolo Il paesaggio del SIC è caratterizzato dalla presenza di imponenti fenomeni carsici, che hanno modellato irregolarmente il substrato gessoso, e da un mosaico di colture agrarie e di aspetti naturali e semi-naturali strettamente interconnessi. Di seguito si riporta una tabella sulle aree a diverso grado di naturalità, basata sulle categorie Corine Land Cover opportunamente accorpate, al fine di fornire in maniera schematica ed immediata una prima impressione del territorio del SIC. Seguendo tale tabella è stata anche realizzata la Tavola 6 (Carta dei Sistemi ambientali). Si fa rilevare che un fattore determinante per la fisionomia attuale del paesaggio è costituito dalle tradizionali attività agro-pastorali e dalla realizzazione, negli ultimi 30 anni, di rimboschimenti ad eucalipti e a conifere, che oggi interessano circa 1/3 della superficie del Sito. Nel corso dell’ultimo decennio, tali rimboschimenti sono stati oggetto di graduali conversioni, diradamenti e processi di latifogliamento con essenze autoctone o comunque di ceppo europeo. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 30 Sistemi ambientali Macrocategorie aree edificate e aree verdi di pertinenza Sistemi umani ad viabilità utilizzazione altre aree intensiva Totale sistema vigneti oliveti e altri arboreti da frutto Sistemi umano- seminativi e prati-pascoli rurali terreni abbandonati altre colture Totale sistema praterie aride calcare, garighe e vegetazione rupicola Sistemi a diverso mantello e macchia grado di naturalità rimboschimenti di conifere e latifoglie vegetazione delle zone umide Totale sistema Totale SIC Ettari % su SIC 2,69 6,69 1,31 10,69 71,18 10,93 28,51 95,84 5,54 211,99 0,41% 1,01% 0,20% 1,62% 10,79% 1,66% 4,32% 14,53% 0,84% 32,13% 178,73 36,20 216,79 5,31 437,03 659,72 27,09% 5,49% 32,86% 0,80% 66,25% 100,00% Le aree a più elevata naturalità sono riconducibili ad un mosaico di prateria perenne e annua, frammista ad aspetti molto espressivi di gariga a labiate. Inoltre, sebbene circoscritta su ridotte superfici, la vegetazione ripariale e la macchia ad alloro ubicate lungo il Vallone Biviere rivestono un grande interesse e svolgono un ruolo cruciale, ospitando diversi habitat di interesse comunitario e biotopi d’interesse conservazionistico. Infine, nel territorio sono presenti diverse comunità legnose (mantello e macchia), le cui specie potrebbero innescare la ricostituzione di formazioni pre-forestali e forestali. Le caratteristiche ambientali e le valenze naturalistiche di ogni area verrano ampiamente trattate nelle parti successive della presente relazione. Check-list della flora vascolare ed analisi fitogeografica della flora Di seguito viene presentata la lista della flora vascolare presente nel SIC ITA010022 “Complesso Monti Santa Ninfa-Gibellina e Grotta di Santa Ninfa”. Per l’aggiornamento nomenclaturale della lista si è fatto riferimento a CONTI et alii (2005), per le orchidacee a DELFORGE (2005). La suddivisione delle famiglie è conforme a CRONQUIST (1988) per le Angiosperme dicotiledoni e a DAHLGREN et alii (1985) per le Angiosperme monocotiledoni. Le famiglie, i generi e le specie sono elencati secondo l’ordine alfabetico. Quando non specificato, le informazioni presentate in questa sede derivano da PASTA & LA MANTIA (2001a); il segno “*” evidenzia le novità floristiche riscontrate da SCUDERI (2006) e da PASTA (2006) e quelle frutto delle indagini di campo effettuate nel corso dell’ultima primavera (SP: Salvatore Pasta; JR: Juliane Rühl; TLM: Tommaso La Mantia; LS: Leonardo Scuderi; EM: Enza Marino; GC: Giulia Casamento). Vengono successivamente fornite le informazioni relative alla corologia (le sigle dei corotipi utilizzate traggono spunto da quelle proposte da ARRIGONI, 1984a) e alla forma biologica di ciascuno dei taxa vegetali censiti. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 31 Prospetto dei taxa vegetali presenti nel SIC ITA010022 Terofite (T), Emicriptofite (H), Geofite (G), Camefite (Ch), Nanofanerofite (NP), Fanerofite (P), Idrofite (I). ros = rosulate; rhiz = rizomatose; caesp = cespitose; rept = reptanti; scap = scapose; bien = bienni; lian = lianose; bulb = bulbose; suffr = suffruticose Taxon F. Biol. Corotipo PTERIDOPHYTA Aspleniaceae Asplenium ceterach L. H ros Tetidico - Europeo Equisetaceae Equisetum ramosissimum Desf. [PASTA & LA G rhiz Olartico - Paleotropicale MANTIA, 2001a, sub Equisetum arvense L., sphalm.] Gymnogrammaceae *Anogramma leptophylla (L.) Link (SP & JR) T caesp Subcosmopolita Hypolepidaceae *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (SP & JR) G rhiz Cosmopolita Polypodiaceae Polypodium cambricum L. G rhiz Mediterraneo Selaginellaceae Selaginella denticulata (L.) Link Ch rept Tetidico - Atlantico Synopteridaceae Cheilanthes maderensis Lowe H ros Tetidico - Paleotropicale PINOPHYTA Cupressaceae Cupressus arizonica Green P scap Coltivato Cupressus sempervirens L. P scap Coltivato Pinaceae Pinus cfr. nigra Arnold P scap Coltivato Pinus halepensis Mill. P scap Introdotto spontaneizzato Pinus pinea L. P scap Introdotto spontaneizzato MAGNIOLOPHYTA DICOTYLEDONES Acanthaceae Acanthus mollis L. H scap Mediterraneo Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. T scap Avventizio naturalizzato Anacardiaceae Pistacia lentiscus L. P caesp Mediterraneo Pistacia terebinthus L. P caesp Mediterraneo - Europeo Rhus coriaria L. P caesp Introdotto subspontaneo Apiaceae *Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. (SP & JR) T scap Mediterraneo Apium nodiflorum (L.) Lag. H scap CW Mediterraneo - Atlantico Athamanta sicula L. H scap SW Mediterraneo *Capnophyllum peregrinum (L.) Lange (SP) T scap CW Mediterraneo - Macaronesico Daucus carota L. s.l. H bien Subcosmopolita *Daucus cfr. muricatus (L.) L. (SP) T scap S Mediterraneo Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. subsp. asclepium H scap SW Mediterraneo *Eryngium bocconei Lam. (SP & JR) H scap Endemico siculo Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 32 Eryngium campestre L. Eryngium dichotomum Desf. *Eryngium triquetrum Vahl (SP & JR) Ferula communis L. subsp. communis Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Bég. *Hippomarathrum siculum (L.) Hoffmgg. et Link [S. Pasta e L. Scuderi in SCUDERI, 2006] Kundmannia sicula (L.) DC. *Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. (SP & JR) Oenanthe globulosa L. s.l. *Opopanax chironium (L.) Koch (SP & JR) *Orlaya daucoides (L.) Greuter (SP) Pimpinella anisoides Briganti Ridolfia segetum Moris Scandix australis L. Smyrnium olusatrum L. Thapsia garganica L. Tordylium apulum L. [PASTA, 2006] Torilis nodosa (L.) Gaertner Apocynaceae Nerium oleander L. Araliaceae Hedera helix L. Asteraceae *Achillea ligustica All. (SP & JR) Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. Anacyclus tomentosus (All.) DC. [PASTA, 2006] *Anthemis arvensis L. subsp. arvensis (SP & JR) Artemisia arborescens L. Bellis annua L. Bellis perennis L. Calendula arvensis L. *Calendula suffruticosa Vahl subsp. fulgida (Raf.) Ohle (SP & JR) Carduus argyroa Biv. Carduus pycnocephalus L. subsp. pycnocephalus Carlina gummifera (L.) Less. [= PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Atractylis gummifera L.] *Carlina lanata L. (SP & JR) Carlina sicula Ten. subsp. sicula [incl. Carlina hispanica subsp. globosa sensu PASTA & LA MANTIA, 2001] Carthamus caeruleus L. [= PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Carduncellus caeruleus (L.) C. Presl] Carthamus lanatus L. subsp. lanatus Carthamus pinnatus Desf. subsp. pinnatus [= Carduncellus pinnatus (Desf.) DC., S. Pasta in SCUDERI, 2006] Catananche lutea L. Centaurea sicula L. [= PASTA & LA MANTIA, H scap H scap H scap H scap H scap H scap Mediterraneo - Europeo SW Mediterraneo SW Mediterraneo Mediterraneo - Macaronesico S Mediterraneo SW Mediterraneo Mediterraneo SW Mediterraneo CW Mediterraneo CW Mediterraneo - Pontico Tetidico - Europeo H scap H scap H scap H scap T scap H scap T scap T scap H scap H scap T scap T scap Endemico apulo-siculo - tirrenico Mediterraneo Mediterraneo Mediterraneo - Atlantico SW Mediterraneo Mediterraneo - Europeo Tetidico - Europeo P caesp Introdotto subspontaneo P lian Mediterraneo - Europeo H scap G bulb T scap T scap NP T scap H ros T scap Mediterraneo Mediterraneo Mediterraneo Mediterraneo - Europeo SW Mediterraneo Tetidico Tetidico - Eurosiberiano Tetidico - Europeo Ch suffr Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano T scap T scap H ros T scap C Mediterraneo - Balcanico CW Mediterraneo Tetidico - Europeo Mediterraneo Mediterraneo H scap Endemico siculo H scap T scap S Mediterraneo Tetidico - Europeo H ros T scap H bien SW Mediterraneo Mediterraneo SW Mediterraneo 33 2001a, sub Centaurea nicaeensis All.] Chrysanthemum coronarium L. T scap Cichorium intybus L. H scap *Cirsium sp. (SP & JR) H bien Coleostephus myconis (L.) Cass. T scap *Conyza bonariensis (L.) Cronq. (SP & JR) T scap *Crepis bursifolia L. (SP & JR) H scap *Crepis vesicaria L. subsp. vesicaria (SP & JR) H scap Crupina crupinastrum (Moris) Vis. T scap Cynara cardunculus L. H scap Dittrichia viscosa (L.) Greuter H scap Evax pygmaea (L.) Brot. T rept *Filago eriocephala Guss. [= PASTA & LA MANTIA, T scap 2001a, sub Filago pyramidata L., sphalm.] Galactites elegans (All.) Soldano T scap Geropogon glaber L. T scap *Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W Schmidt (SP & T scap JR) *Helminthoteca aculeata (Vahl) Lack. (SP & JR) H scap Helminthoteca echioides (L.) J. Holub [= PASTA & T scap LA MANTIA, 2001a, sub Picris echioides L.] Hyoseris radiata L. H ros Hyoseris scabra L. T ros *Hypochoeris achyrophorus L. (SP & JR) T scap Hypochoeris cretensis (L.) Bory et Chaub.[S. Pasta e L. H scap Scuderi in SCUDERI, 2006] *Hypochoeris radicata L. subsp. heterocarpa (Moris) H scap Arcang. (SP & JR) *Jacobaea delphinipholia (Vahl) Pelser et Veldk. [= PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Senecio T scap coronopifolius Desf., sphalm.] *Jacobaea lycopifolia (Poir.) Greuter et B. Nord. (SP) Ch suffr Leontodon tuberosus L. H ros *Notobasis syriaca (L.) Cass. (SP & JR) T scap Onopordum illyricum L. subsp. illyricum H bien *Picris hieracioides L. subsp. spinulosa (Guss.) Arcangeli [= PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub H scap Leontodon autumnalis L., sphalm.] Pallenis spinosa (L.) Cass. H scap Phagnalon saxatile (L.) Cass. s.l. Ch suffr *Pulicaria dysentherica (L.) Gaertn. (SP & JR) H scap *Pulicaria odora (L.) Reichenb. [= PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Pulicaria vulgaris Gaertner, H scap sphalm.] Reichardia picroides (L.) Roth H scap Rhagadiolus stellatus (L.) Willd. T scap Scolymus grandiflorus Desf. H scap Scolymus maculatus L. [= PASTA & LA MANTIA, T scap 2001a, sub Scolymys hispanicus L., sphalm.] Scorzonera cana (C.A. Mey.) Griseb. H scap Scorzonera deliciosa Guss. G bulb Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano Mediterraneo Tetidico - Eurosiberiano n.d. Mediterraneo Avventizio naturalizzato Endemico apulo - siculo Mediterraneo - Europeo Tetidico Mediterraneo Tetidico - Europeo Mediterraneo - Macaronesico Tetidico - Pontico Mediterraneo Tetidico - Europeo Mediterraneo - Irano-Turaniano SW Mediterraneo Mediterraneo - Europeo Mediterraneo Mediterraneo Mediterraneo CE Mediterraneo Mediterraneo SW Mediterraneo Endemico apulo - siculo Mediterraneo Tetidico - Atlantico Mediterraneo Mediterraneo - Medioeuropeo Tetidico - Europeo CW Mediterraneo Tetidico - Europeo Mediterraneo Mediterraneo Tetidico - Europeo Mediterraneo Tetidico Tetidico - Pontico Endemico apulo - siculo 34 *Scorzonera hirsuta L. s.l. (SP & TLM) Senecio leucanthemifolius L. s.l. Senecio vulgaris L. [PASTA, 2006] *Silybum marianum (L.) Gaertner (SP & JR) Sonchus asper L. subsp. asper [PASTA, 2006] Sonchus oleraceus L. *Symphiotrichum squamatum (Sprengel) G.L. Nesom (SP & JR) Tragopogon cupanii Guss. *Tragopogon porrifolius L. (SP & JR) Urospermum dalechampii (L.) Schmidt Urospermum picroides (L.) F.W. Schmidt [PASTA, 2006] Boraginaceae Borago officinalis L. Cerinthe major L. subsp. major Cynoglossum creticum Mill. *Echium italicum L. subsp. siculum (Lacaita) Greuter et Burdet (SP & JR) Echium parviflorum Moench Echium plantagineum L. Brassicaceae *Biscutella maritima Ten. (SP & JR) Brassica nigra (L.) Koch [PASTA, 2006] Brassica rapa L. subsp. campestris (L.) Clapham [PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Brassica rapa L. subsp. sylvestris (L.) Janchen] *Brassica rupestris Raf. subsp. rupestris (SP & JR) Brassica villosa Biv. subsp. bivoniana (Mazzola et Raimondo) Raimondo et Mazzola. [PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub subsp. tinei (Lojac.) Raimondo et Mazzola] Diplotaxis crassifolia (Raf.) DC. Diplotaxis erucoides (L.) DC. Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. [PASTA, 2006] Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat [PASTA, 2006] Lobularia maritima (L.) Desv. Nasturtium officinale R. Br. Sinapis arvensis L. Sinapis pubescens L. [PASTA, 2006] Sisymbrium cfr. officinale (L.) Scop. [PASTA, 2006] Campanulaceae Campanula erinus L. Capparaceae Capparis spinosa L. subsp. rupestris (Sm.) Nyman Caprifoliaceae Lonicera etrusca Santi Lonicera implexa Aiton H scap T scap T scap T scap T scap T scap H scap NW Mediterraneo CW Mediterraneo Boreale - Tetidico Tetidico - Europeo Boreale - Tetidico Boreale - Tetidico T scap T scap H scap Avventizio naturalizzato Endemico apulo - siculo Mediterraneo CW Mediterraneo - Atlantico T scap Tetidico T scap T scap T scap Mediterraneo - Europeo Mediterraneo Mediterraneo - Europeo H bien T scap T scap Endemico siculo Mediterraneo Tetidico - Europeo T scap T scap C Mediterraneo Mediterraneo T scap Ch suffr Introdotto spontaneizzato Endemico apulo - siculo Ch suffr Ch suffr T scap T scap Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano T scap Endemico siculo Endemico siculo - nordafricano Mediterraneo Mediterraneo - Europeo H scap H scap T scap H scap T scap Mediterraneo - Macaronesico Mediterraneo Cosmopolita Mediterraneo SW Mediterraneo Tetidico - Eurosiberiano T scap Tetidico NP Mediterraneo P lian P lian Mediterraneo - Macaronesico Mediterraneo 35 Caryophyllaceae *Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. (SP) Cerastium glomeratum Thuill. [PASTA, 2006] Dianthus siculus C. Presl Gypsophila arrostii Guss. Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga Polycarpon tetraphyllum L. subsp. tetraphyllum Silene cfr. colorata Poir. Silene fruticosa L. Silene fuscata Link *Silene gallica L. (SP & JR) Silene italica (L.) Pers. subsp. sicula (Ucria) Jeanmonod *Silene latifolia Poir. (LS & EM) *Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. tenoreana (Colla) Soldano et F. Conti (SP & JR) Stellaria cfr. pallida (Dum.) Piré Stellaria media (L.) Vill. [PASTA, 2006] Chenopodiaceae Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. Chenopodium album L. Chenopodium murale L. [PASTA, 2006] Chenopodium vulvaria L. [PASTA, 2006] Cistaceae *Cistus creticus subsp. creticus (SP & TLM) *Helianthemum salicifolium (L.) Mill. (SP & JR) Clusiaceae Hypericum perfoliatum L. Convolvulaceae Calystegia sepium (L.) R. Br. Convolvulus arvensis L. Convolvulus cantabrica L. Convolvulus tricolor L. subsp. cupanianus (Sa’ad) Stace Corylaceae Corylus avellana L. Crassulaceae Phedimus stellatus (L.) Raf. [PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Sedum stellatum L.] Sedum caeruleum L. Sedum dasyphyllum L. var. glanduliferum (Guss.) Moris Sedum gypsicola Boiss. et Reuter *Sedum hispanicum L. (SP & JR) Sedum rubens L. Sedum sediforme (Jacq.) Pau Umbilicus horizontalis (Guss.) DC. Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy T scap T scap H scap Ch suffr H caesp T scap T scap Ch suffr T scap T scap H scap H bien H scap Mediterraneo - Europeo Subcosmopolita SW Mediterraneo Endemico apulo - siculo C Mediterraneo - Appenninico Tetidico - Europeo Mediterraneo - Macaronesico CE Mediterraneo Mediterraneo Tetidico - Europeo Endemico apulo - siculo Mediterraneo T scap T scap Mediterraneo Tetidico - Europeo Subcosmopolita H scap T scap T scap T scap Introdotto subspontaneo Subcosmopolita Subcosmopolita Tetidico - Europeo NP T scap CE Mediterraneo Mediterraneo - Europeo H scap Mediterraneo H scand G rhiz H scap Subcosmopolita Subcosmopolita Tetidico - Pontico T scap P caesp T scap T scap Ch succ Ch succ T scap T scap Ch succ G bulb G bulb Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano Endemico apulo-siculo - nordafricano Introdotto subspontaneo Mediterraneo SW Mediterraneo CW Mediterraneo CW Mediterraneo Mediterraneo - Europeo Mediterraneo - Europeo Mediterraneo CE Mediterraneo Mediterraneo - Atlantico 36 Cucurbitaceae Ecballium elaterium (L.) A. Rich. Cuscutaceae *Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. epithymum (SP & TLM) Dipsacaceae Dipsacus fullonum L. *Knautia integrifolia (L.) Bertol. (SP & JR) Lomelosia cretica (L.) W. Greuter et Burdet [S. Pasta in SCUDERI, 2006] Sixalix atropurpurea (L.) Greuter et Burdet subsp. grandiflora (Scop.) Soldano et F. Conti [PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Scabiosa maritima L.] Euphorbiaceae Euphorbia ceratocarpa Ten. Euphorbia characias L. subsp. characias Euphorbia dendroides L. Euphorbia exigua L. *Euphorbia falcata L. (SP & JR) Euphorbia helioscopia L. Mercurialis annua L. Fabaceae Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. . [PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Acacia cyanophylla Lindley] Anagyris foetida L. Anthyllis vulneraria L. subsp. maura (Beck) Lindb. Astragalus boeticus L. Astragalus huetii Bunge Bituminaria bituminosa (L.) Stirton Ceratonia siliqua L. Cercis siliquastrum L. Coronilla scorpioides (L.) Koch *Dorycnium rectum (L.) Ser. (SP, GC, LS, EM & JR) Hedysarum coronarium L. Hedysarum glomeratum Dietrich Hippocrepis multisiliquosa L. Lathyrus annuus L. Lathyrus aphaca L. Lathyrus clymenum L. Lathyrus ochrus (L.) DC. Lathyrus odoratus L. Lotus edulis L. Lotus ornithopodioides L. *Lupinus sp. Medicago ciliaris (L.) All. *Medicago intertexta (L.) Mill. (SP & JR) Medicago minima (L.) Bartal. *Medicago orbicularis (L.) Bartal. (SP & JR) Medicago polymorpha L. [PASTA, 2006] G bulb Tetidico - Pontico T par Tetidico - Eurosiberiano T scap T scap Tetidico - Europeo Mediterraneo Ch frut CW Mediterraneo H bien Mediterraneo Ch suffr NP P scap T scap T scap T scap T scap Endemico apulo - siculo Mediterraneo Mediterraneo Mediterraneo - Europeo Tetidico - Europeo Tetidico - Europeo Tetidico - Europeo P scap Introdotto subspontaneo P caesp H scap T scap H ros H scap P scap P scap T scap H scap H scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap Tetidico SW Mediterraneo Tetidico Endemico siculo Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano Mediterraneo - Europeo Introdotto subspontaneo Coltivato Mediterraneo - Europeo Mediterraneo Introdotto spontaneizzato Mediterraneo Mediterraneo - Macaronesico Mediterraneo - Europeo Tetidico - Europeo Mediterraneo Tetidico Endemico apulo-siculo - ellenico Mediterraneo Mediterraneo n.d. Mediterraneo CW Mediterraneo - Macaronesico Olartico Tetidico - Europeo Boreale - Tetidico 37 Medicago rugosa Desr. Medicago truncatula Gaetner Melilotus cfr. sulcatus Desf. [PASTA, 2006] Melilotus infestus Guss. Ononis alopecuroides L. subsp. exalopecuroides (G. Lòpez) Greuter et Burdet *Ononis pendula Desf. subsp. boissieri (Širj.) Devesa (SP & JR) *Ononis sieberi DC. (SP & JR) Ononis viscosa L. subsp. breviflora (Ser.) Nyman [PASTA, 2006] Pisum sativum L. subsp. biflorum (Raf.) Soldano Scorpiurus muricatus L. subsp. subvillosus (L.) Thell. Spartium junceum L. *Tetragonolobus biflorus (Desr.) Ser. (SP & JR) Tetragonolobus purpureus (L.) Moench *Trifolium alexandrinum L. (SP) *Trifolium angustifolium L. subsp. angustifolium (SP & JR) Trifolium campestre Schreber Trifolium cherleri L. *Trifolium nigrescens Viv. subsp. nigrescens (SP & JR) Trifolium physodes Steven Trifolium resupinatum L. Trifolium scabrum L. Trifolium stellatum L. *Trifolium suffocatum L. (SP & JR) *Vicia bithynica (L.) L. (SP, GC, LS, EM & JR) *Vicia narbonensis L. (SP & JR) Vicia sativa L. s.l. [PASTA, 2006] *Vicia tetrasperma (L.) Schreber (LS & EM) Vicia villosa Roth s.l. Fagaceae *Quercus ilex L. (SP) Quercus cfr. virgiliana (Ten.) Ten. Fumariaceae *Fumaria agraria Lag. (SP & TLM) *Fumaria officinalis L. subsp. wirtgenii (Koch) Arcang. (SP & TLM) Gentianaceae Blackstonia perfoliata (L.) Hudson Centaurium erythraea Rafn s.l. *Centaurium pulchellum (Swartz) Druce (SP & JR) Geraniaceae *Erodium acaule (L.) Becherer et Thell. (SP & JR) *Erodium cfr. cicutarium (L.) L’Hérit. (SP & JR) Erodium malacoides (L.) L’Hér. Geranium dissectum L. Geranium molle L. T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap P caesp T scap T scap T scap Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano T scap Mediterraneo Mediterraneo - Europeo Mediterraneo - Europeo CW Mediterraneo S Mediterraneo SW Mediterraneo CE Mediterraneo Mediterraneo Tetidico - Pontico Mediterraneo Tetidico - Europeo Endemico apulo-siculo - nordafricano Mediterraneo - Europeo Introdotto subspontaneo T scap T scap T scap H scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap Tetidico - Europeo Tetidico - Europeo Tetidico Mediterraneo - Macaronesico CE Mediterraneo - Irano-Turaniano Tetidico - Europeo Tetidico - Europeo Mediterraneo - Pontico Tetidico - Atlantico Tetidico - Europeo Mediterraneo - Europeo Introdotto subspontaneo Boreale - Tetidico Tetidico - Europeo P scap P scap Mediterraneo Coltivato T scap CW Mediterraneo - Macaronesico T scap CW Mediterraneo - Europeo T scap H bien T scap Mediterraneo - Atlantico Tetidico - Europeo Olartico H ros T scap T scap T scap T scap Mediterraneo Tetidico - Europeo Tetidico Tetidico - Europeo Tetidico - Europeo 38 Geranium purpureum Vill. *Geranium rotundifolium L. (SP, LS, JR & EM) Juglandaceae Juglans regia L. Lamiaceae *Ajuga iva (L.) Schreber subsp. pseudo-iva (DC.) Briq. [= PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Ajuga chamaepitys (L.) Schreber, sphalm.] Calamintha nepeta (L.) Savi s.l. Clinopodium vulgare L. subsp. orientale Bothmer Coridothymus capitatus (L.) Reichenb. [PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Thymus capitatus (L.) Hoffmgg. et Link] Mentha pulegium L. Mentha suaveolens Ehrh. [= Mentha rotundifolia Hudson sensu Auct.] Micromeria fruticulosa (Bertol.) Grande [= PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Satureja fruticulosa (Bertol.) Grande] *Nepeta apuleii Ucria (SP & JR) Origanum vulgare L. subsp. viridulum (Martrin-Donos) Nyman [= PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Origanum heracleoticum L.] Phlomis herba-venti L. Prasium majus L. Salvia verbenaca L. Salvia viridis L. [S. Pasta e L. Scuderi in SCUDERI, 2006] Sideritis romana L. Stachys ocymastrum (L.) Briq. Teucrium flavum L. *Teucrium fruticans L. (LS & EM) *Thymus spinulosus Ten. [già segnalato nel Formulario Standard] Linaceae Linum bienne Mill. Linum decumbens Desf. Linum strictum L. s.l. *Linum trigynum L. (SP & JR) Lythraceae Lythrum cfr. hyssopifolia L. Lythrum tribracteatum Salzm. Malvaceae Lavatera cretica L. *Lavatera trimestris L. (SP & JR) Malva cretica Cav. Malva nicaeensis All. [PASTA, 2006] Malva sylvestris L. Moraceae Ficus carica L. var. caprificus Risso Morus alba L. T scap T scap Tetidico - Europeo Tetidico - Europeo P scap Coltivato Ch suffr H scap H scap Mediterraneo Mediterraneo - Europeo Mediterraneo - Europeo Ch frut H scap H scap Mediterraneo Tetidico - Europeo Mediterraneo - Europeo Ch suffr H scap C Mediterraneo SW Mediterraneo H scap H scap Ch suffr H scap T scap T scap T scap Ch suffr NP Ch rept Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano SE Mediterraneo Mediterraneo Mediterraneo Mediterraneo - Atlantico Mediterraneo Mediterraneo CW Mediterraneo Mediterraneo CW Mediterraneo Endemico apulo - siculo T scap T scap T scap T scap Mediterraneo - Europeo SW Mediterraneo Mediterraneo Tetidico - Europeo T scap T scap Tetidico - Eurosiberiano Mediterraneo - Europeo T scap T scap T scap T scap H scap Mediterraneo Mediterraneo Mediterraneo Mediterraneo Tetidico - Europeo P scap P scap Introdotto spontaneizzato Introdotto subspontaneo 39 Myoporaceae Myoporum tenuifolium G. Forster Myrtaceae Eucalyptus camaldulensis Dehnh. *Eucalyptus globulus Labill. Oleaceae Fraxinus angustifolia Vahl Fraxinus ornus L. Olea europaea L. var. europaea Olea europaea L. var. sylvestris (Mill.) Lehr. Onagraceae *Epilobium cfr. hirsutum L. (SP & TLM) Orobanchaceae *Orobanche amethystea Thuill. (SP & JR) Orobanche crenata Forssk. *Orobanche lavandulacea Reichenb. (SP & JR) Orobanche ramosa L. s.l. Oxalidaceae Oxalis pes-caprae L. Papaveraceae Papaver rhoeas L. Plantaginaceae Plantago afra L. subsp. afra *Plantago afra L. subsp. zwierleinii (Nicotra) Brullo (SP & JR) *Plantago bellardii All. subsp. bellardii (SP) Plantago lagopus L. Plantago lanceolata L. Plantago serraria L. Polygalaceae Polygala monspeliaca L. Polygonaceae Rumex cfr. conglomeratus Murray *Rumex bucephalophorus L. s.l. (SP & JR) Rumex crispus L. *Rumex thyrsoides Desf. (SP & JR) Portulacaceae Portulaca oleracea L. s.l. Primulaceae Anagallis arvensis L. subsp. arvensis Anagallis foemina Mill. [PASTA, 2006] *Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby (SP & JR) Cyclamen repandum Sibth. et Sm. Samolus valerandi L. Punicaceae Punica granatum L. P caesp Introdotto subspontaneo P scap P scap Introdotto subspontaneo Introdotto subspontaneo P scap P scap P scap P caesp Introdotto subspontaneo Mediterraneo - Medioeuropeo Introdotto subspontaneo Mediterraneo H scap Subcosmopolita T par T par T par T par Mediterraneo - Atlantico Tetidico - Pontico Tetidico Olartico G bulb Introdotto spontaneizzato T scap Avventizio naturalizzato T scap Tetidico - Europeo Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano T scap T scap T scap H ros H ros Endemico siculo S Mediterraneo Tetidico - Europeo Tetidico - Eurosiberiano Mediterraneo T scap Mediterraneo H scap T scap H scap H scap Tetidico - Europeo Mediterraneo Boreale - Mediterraneo SW Mediterraneo T scap Introdotto spontaneizzato T scap T scap T scap G bulb H scap Tetidico - Europeo Subcosmopolita Mediterraneo - Macaronesico N Mediterraneo Subcosmopolita P scap Introdotto subspontaneo 40 Ranunculaceae Anemone hortensis L. Clematis cirrhosa L. Clematis vitalba L. Nigella damascena L. Ranunculus arvensis L. Ranunculus bulbosus L. s.l. Ranunculus bullatus L. Ranunculus ficariiformis F.W. Schultz *Ranunculus millefoliatus Vahl (SP & JR) Ranunculus muricatus L. Ranunculus paludosus Poir. [= PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Ranunculus flabellatus Desf.] Resedaceae Reseda alba L. *Reseda luteola L. (SP & JR) Rosaceae Agrimonia eupatoria L. Crataegus azarolus L. Crataegus monogyna Jacq. Cydonia oblonga Mill. Potentilla reptans L. Prunus domestica L. Prunus dulcis (Mill.) Webb Prunus spinosa L. Pyrus amygdaliformis Vill. *Rosa canina L. (SP e TLM) Rosa cfr. micrantha Sm. Rosa sempervirens L. Rubus ulmifolius Schott Sanguisorba minor Scop. s.l. Sorbus domestica L. Rubiaceae Asperula aristata L. fil. subsp. scabra (C. Presl) Nyman *Galium aparine L. (SP & JR) *Galium murale (L.) All. (SP & JR) *Galium pallidum C. Presl (SP & JR) *Galium parisiense L. (SP & JR) *Galium verum L. (SP & JR) Galium tricornutum Dandy Galium verrucosum Hudson Rubia peregrina L. s.l. Sherardia arvensis L. Valantia muralis L. Rutaceae *Ruta chalepensis L. (SP & JR) G rhiz P lian P lian T scap T scap H scap H ros G bulb H scap T scap H scap N Mediterraneo Mediterraneo - Irano-Turaniano Tetidico - Europeo Tetidico - Europeo Tetidico - Eurosiberiano Mediterraneo - Europeo Mediterraneo Mediterraneo Mediterraneo Tetidico Tetidico - Atlantico T scap H scap Mediterraneo - Irano-Turaniano Tetidico - Europeo H scap P scap P caesp P scap H ros P scap P scap P caesp P scap NP NP NP NP H scap P scap Subcosmopolita Introdotto subspontaneo Mediterraneo - Pontico Introdotto subspontaneo Boreale - Tetidico Introdotto subspontaneo Introdotto subspontaneo Mediterraneo - Europeo Mediterraneo Mediterraneo - Eurosiberiano Mediterraneo - Medioeuropeo Mediterraneo - Atlantico Tetidico - Atlantico Tetidico - Europeo Introdotto subspontaneo H scap T scap T scap H scap T scap H scap T scap T scap P lian T scap T scap Endemico apulo-siculo - appenninico Olartico Mediterraneo Endemico siculo Mediterraneo - Europeo Tetidico - Eurosiberiano Mediterraneo - Europeo Mediterraneo Mediterraneo - Atlantico Tetidico - Europeo Mediterraneo Ch suffr S Mediterraneo - Sahariano Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 41 Salicaceae Populus alba L. Populus nigra L. Salix pedicellata Desf. Santalaceae Osyris alba L. Saxifragaceae Saxifraga bulbifera L. Scrophulariaceae Bellardia trixago (L.) All. Cymbalaria pubescens (C. Presl) Cufod. [S. Pasta in SCUDERI, 2006] *Kickxia spuria (L.) Dumort. subsp. integrifolia (Brot.) R. Fernandes (SP & JR) Linaria reflexa (L.) Desf. subsp. reflexa Odontites rigidifolius (Biv.) Benth. Parentucellia latifolia (L.) Caruel in Parl. Parentucellia viscosa (L.) Caruel in Parl. Scrophularia canina L. *Verbascum creticum (L.) Cav. (SP & JR) Verbascum sinuatum L. Veronica anagallis-aquatica L. Veronica cfr. persica Poir. [PASTA, 2006; SCUDERI, 2006] Veronica hederifolia L. [PASTA, 2006; SCUDERI, 2006] Simaroubaceae Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Solanaceae Lycium europaeum L. Mandragora autumnalis Bertol. Solanum nigrum L. Tamaricaceae Tamarix africana L. Theligonaceae Theligonum cynocrambe L. Ulmaceae *Ulmus canescens Melville (SP & JR) Ulmus minor Mill. [già riportato in AA. VV., 1996] Urticaceae Parietaria judaica (L.) L. *Parietaria lusitanica L. (SP & JR) Urtica dioica L. Urtica membranacea Poir. [Pasta, 2006] Valerianaceae Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne [PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Centranthus calcitrapa (L.) DC.] Centranthus ruber (L.) DC. P scap P scap P caesp Mediterraneo - Eurosiberiano Mediterraneo - Eurosiberiano Mediterraneo NP Mediterraneo - Europeo H scap C Mediterraneo - Balcanico T scap Mediterraneo - Irano-Turaniano Ch rept T scap T scap T scap T scap T scap H scap H bien H bien H scap T scap T scap Endemico siculo Tetidico - Europeo CW Mediterraneo Endemico siculo Mediterraneo - Irano-Turaniano Tetidico - Atlantico Mediterraneo - Europeo SW Mediterraneo Mediterraneo - Irano-Turaniano Olartico - Paleotropicale Avventizio naturalizzato Tetidico - Europeo P scap Introdotto spontaneizzato NP H ros T scap Introdotto subspontaneo Mediterraneo Cosmopolita P scap CW Mediterraneo T scap Mediterraneo P scap P scap CE Mediterraneo Tetidico - Europeo H scap T rept H scap T scap Tetidico - Europeo Tetidico - Europeo Subcosmopolita Mediterraneo - Macaronesico T scap Ch suffr Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano Mediterraneo - Pontico Mediterraneo - Atlantico 42 Fedia graciliflora Fischer et C. A. Meyer [PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Fedia cornucopiae (L.) T scap Gaertner] SW Mediterraneo - Balcanico Verbenaceae Verbena officinalis L. H scap Olartico - Paleotropicale Vitaceae Vitis vinifera L. P lian Coltivato MAGNIOLOPHYTA MONOCOTYLEDONES Agavaceae Agave americana L. P caesp Introdotto subspontaneo Alliaceae *Allium ampeloprasum L. (SP & JR) G bulb Tetidico - Pontico Allium nigrum L. G bulb Mediterraneo - Macaronesico Allium roseum L. G bulb Mediterraneo Allium subhirsutum L. G bulb Mediterraneo Amaryllidaceae Narcissus serotinus L. G bulb Mediterraneo Narcissus tazetta L. G bulb Mediterraneo - Macaronesico Araceae Ambrosina bassii L. G rhiz SW Mediterraneo Arisarum vulgare Targ.-Tozz. G rhiz Mediterraneo Arum italicum Mill. G rhiz Mediterraneo - Atlantico Biarum tenuifolium Schott G rhiz Mediterraneo Arecaceae Chamaerops humilis L. NP Mediterraneo Asparagaceae Asparagus acutifolius L. G rhiz Mediterraneo Asparagus albus L. Ch frut CW Mediterraneo Asphodelaceae Asphodeline lutea (L.) Reichenb. G rhiz CE Mediterraneo Asphodelus ramosus L. G rhiz CW Mediterraneo - Macaronesico Colchicaceae Colchicum bivonae Guss. G bulb C Mediterraneo - Balcanico Colchicum cupanii Guss. G bulb Mediterraneo Cyperaceae Carex distachya Desf. H caesp Mediterraneo Carex flacca Schreber subsp. serrulata (Biv.) Greuter G rhiz Mediterraneo - Europeo *Carex hispida Willd. [PASTA & LA MANTIA, 2001, G rhiz sub Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, sphalm.] Mediterraneo *Cyperus longus L. (SP, LS, EM, GC & JR) G rhiz Olartico - Paleotropicale Dioscoreaceae Tamus communis L. G rad Mediterraneo - Europeo Hyacinthaceae Charybdys pancration (Steinh.) Speta [PASTA & LA G bulb MANTIA, 2001, sub Urginea maritima (L.) Baker] Tetidico Loncomelos narbonense (Tourn.) Raf. [PASTA & LA G bulb MANTIA, 2001, sub Ornithogalum narbonense L.] Mediterraneo Muscari commutatum Guss. G bulb CE Mediterraneo Muscari comosum (L.) Mill. [PASTA & LA MANTIA, G bulb Tetidico - Europeo Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 43 2001, sub Leopoldia comosa (L.) Parl.] *Ornithogalum gussonei Ten. (SP & JR) Prospero autumnale (L.) Speta [PASTA & LA MANTIA, 2001, sub Scilla autumnalis L.] Iridaceae *Gladiolus communis L. subsp. byzanthinus (Mill.) Douin (SP & JR) Gladiolus cfr. italicus Mill. Iris planifolia (Mill.) Dur. et Schinz Romulea cfr. ramiflora Ten. Juncaceae *Juncus bufonius L. (SP & JR) Juncus cfr. effusus L. *Juncus fontanesii J. Gay (SP, LS, EM, GC & JR; PASTA & LA MANTIA, 2001, sub Paspalum distichum L., sphalm.!) Orchidaceae Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge [PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Barlia robertiana (Loisel.) Greuter] *Ophrys bertolonii Moretti (GC) Ophrys bombyliflora Link Ophrys ciliata Biv. *Ophrys exaltata Ten. [già segnalato nel Formulario Standard] *Ophrys garganica O. et E. Danesch [già segnalato nel Formulario Standard] Ophrys grandiflora Ten. [PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Ophrys tenthredinifera Willd.] Ophrys incubacea Bianca [S. Pasta e L. Scuderi in SCUDERI, 2006] *Ophrys lupercalis Devillers et Devillers-Terschuren [PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Ophrys fusca Link, p.p.] *Ophrys lutea Cav. subsp. lutea [già segnalato nel Formulario Standard] *Ophrys obaesa Lojac. [PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Ophrys fusca Link, p.p.] *Ophrys oxyrrhynchos Tod. (SP & JR) Ophrys panormitana (Tod.) Soó Ophrys sicula Tin. *Orchis anthropophora (L.) All. (SP) *Orchis collina A. Russell (SP & TLM) Orchis intacta Link [PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Neotinea maculata (Desf.) Stearn] Orchis italica Poir. *Orchis lactea Poir. [già segnalato nel Formulario Standard] *Orchis longicornu Poir. (SP & JR) *Orchis papilionacea L. s.l. (SP & JR) Serapias lingua L. Serapias parviflora Parl. G bulb G bulb G bulb CE Mediterraneo Tetidico - Europeo G bulb G bulb G bulb Mediterraneo Tetidico - Europeo SW Mediterraneo Mediterraneo - Macaronesico T caesp H caesp Cosmopolita Cosmopolita Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano G rhiz Tetidico - Paleotropicale G bulb Mediterraneo - Atlantico G bulb G bulb G bulb G bulb G bulb G bulb G bulb G bulb Mediterraneo - Atlantico C Mediterraneo Mediterraneo - Macaronesico Mediterraneo Endemico apulo - siculo Endemico apulo-siculo - tirrenico Endemico apulo - siculo CW Mediterraneo G bulb CW Mediterraneo G bulb G bulb G bulb G bulb G bulb G bulb G bulb G bulb G bulb G bulb G bulb G bulb G bulb G bulb Mediterraneo - Atlantico Endemico siculo Endemico apulo - siculo Endemico siculo Mediterraneo Tetidico - Europeo Mediterraneo - Pontico Tetidico - Atlantico Mediterraneo Mediterraneo SW Mediterraneo Mediterraneo - Pontico Mediterraneo - Atlantico Tetidico - Atlantico 44 *Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq. [già segnalato nel Formulario Standard] Poaceae Aegilops geniculata Roth *Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea (SP & JR) Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) Dur. et Schinz *Andropogon distachyos L. (SP & TLM) *Anthoxanthum odoratum L. (SP & JR) Arundo collina Ten. [PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Arundo plinii Turra] Arundo donax L. Avena cfr. barbata Link [PASTA, 2006] Avena sterilis L. Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. Briza maxima L. Briza minor L. *Bromus fasciculatus C. Presl (SP & JR) *Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus (SP & JR) Bromus cfr. rigidus Roth [PASTA, 2006] Bromus madritensis L. Bromus rubens L. Bromus sterilis L. *Catapodium hemipoa (Sprengel) Laìnz subsp. occidentale (Paunero) H. et S. Scholz (SP & JR) Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard subsp. rigidum Cynodon dactylon (L.) Pers. Cynosurus echinatus L. *Cynosurus effusus Link (SP & JR) Dactylis glomerata L. s.l. Dasypyrum villosum (L.) Borbás *Echinaria capitata Desf. subsp. todaroana (Ces., Pass. et Gibelli) Arcang. (SP & TLM) *Festuca arundinacea Schreber s.l. (SP & JR) *Helictotrichon cincinnatum (Ten.) Röser (SP & JR) Hordeum leporinum Link Hordeum vulgare L. [PASTA, 2006] Lagurus ovatus L. subsp. ovatus Lamarckia aurea (L.) Moench Lolium multiflorum Lam. Phalaris coerulescens Desf. Phalaris truncata Guss. Phleum echinatum Host Phragmites australis (Cav.) Trin. Piptatherum miliaceum (L.) Cosson subsp. miliaceum Poa annua L. Poa bulbosa L. *Poa trivialis L. subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. fil. (SP & JR) Polypogon monspeliensis (L.) Desf. G bulb T scap T scap H caesp H caesp H caesp G rhiz G rhiz T scap T scap H caesp T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap T scap G rhiz T scap T scap H caesp T scap T scap H caesp H caesp T scap T scap T scap T scap T scap H caesp H caesp T scap G rhiz H caesp T caesp H caesp H caesp Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano T scap Mediterraneo - Europeo Tetidico - Pontico Subcosmopolita SW Mediterraneo Tetidico - Paleotropicale Mediterraneo - Eurosiberiano Mediterraneo Introdotto spontaneizzato Tetidico - Pontico Tetidico - Pontico Tetidico - Eurosiberiano Mediterraneo Mediterraneo - Atlantico Tetidico Subcosmopolita Mediterraneo Tetidico - Europeo Tetidico - Europeo Tetidico - Eurosiberiano CW Mediterraneo - Atlantico Tetidico - Europeo Cosmopolita Tetidico - Europeo CW Mediterraneo Olartico Tetidico - Pontico Endemico siculo Tetidico - Eurosiberiano Endemico apulo-siculo - nordafricano Mediterraneo - Europeo Introdotto subspontaneo Mediterraneo - Atlantico Tetidico Tetidico - Europeo Mediterraneo - Macaronesico S Mediterraneo CE Mediterraneo Olartico Tetidico Cosmopolita Tetidico - Eurosiberiano Mediterraneo - Europeo Olartico - Paleotropicale 45 Polypogon viridis (Gouan) Breistr. Stipa capensis Thunb. Trachynia distachyos (L.) Link [PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Brachypodium distachyum (L.) P. Beauv.] Triticum durum Desf. [PASTA, 2006] *Trisetaria aurea (Ten.) Pignatti (SP & JR) Vulpia bromoides (L.) J.E. Gray Vulpia ciliata (Danth.) Link *Vulpia geniculata (L.) Link subsp. geniculata (SP & JR) Smilacaceae Smilax aspera L. Typhaceae Typha angustifolia L. [PASTA & LA MANTIA, 2001a, sub Typha latifolia L., sphalm.] H caesp T scap Tetidico - Eurosiberiano Subcosmopolita T scap Tetidico Introdotto subspontaneo Mediterraneo Tetidico - Europeo Tetidico - Europeo T scap T scap T scap T scap T scap CW Mediterraneo P lian Tetidico - Paleotropicale G rhiz Olartico A 504 specie (delle 506 rinvenute per le quali la classificazione si è potuta spingere sino al livello intraspecifico) è stato possibile attribuire un corotipo. Lo spettro corologico che ne deriva tradisce la peculiarità del bioclima locale: le entità tetidico-europee sensu lato – coincidenti con taxa mesofili legati ai contesti più freschi umidi della Sicilia - costituiscono infatti ben il 30% della flora locale. Il SIC mantiene tuttavia chiari connotati di mediterraneità, come dimostra la presenza di ben 203 taxa mediterranei sensu lato e di 42 elementi tetidici sensu lato. Tra questi si segnala una quarantina di taxa legati ai climi mediterranei aridi (S Mediterranee s.l., CE Mediterranee s.l., Mediterranee-Irano-Turaniche s.l., e Mediterranee-Sahariane s.l.) che connotano fortemente il paesaggio pseudosteppico locale. Il numero decisamente sostenuto di specie ad ampia distribuzione (32) e di xenofite (45) suggerisce una certa vulnerabilità dei consorzi locali all’invasione da parte di specie esotiche e/o tendenzialmente invasive. Specie ad ampia distribuzione e/o xenofite 15% Olartiche s.l. 6% TetidicheEuropee s.l. 30% Mediterranee s.l. 41% Tetidiche s.l. 8% L’analisi dello spettro biologico (cfr. figura seguente) conferma la peculiarità floristicostrutturale del paesaggio vegetale dell’area in esame. Le terofite infatti rappresentano Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 46 “appena” il 43,7% della flora vascolare complessiva (nei contesti più marcatamente mediterranei tale percentuale supera sempre - e spesso largamente - il 50%), la somma delle emicriptofite e delle geofite è pari a circa 2/5, mentre le specie legnose (camefite, nanofanerofite e fanerofite) costituiscono oltre il 17% della flora dell’area considerata. Questi dati suggeriscono le buone potenzialità forestali del contesto in cui ricade il SIC. Camefite (Ch) Nanofanerofite (NP) 2% 5% Fanerofite (P) 10% Terofite (T) 45% Geofite (G) 14% Emicriptofite (H) 24% Piante vascolari presenti negli Allegati II, IV e V della Direttiva Habitat e/o nella Lista Rossa Regionale e/o di interesse biogeografico/conservazionistico Vengono considerate “emergenze floristiche” quei taxa vegetali che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti: 1) protetti da normative e direttive internazionali (CITES, Direttiva 92/43/CEE); 2) inclusi nelle “Liste Rosse” regionali (RAIMONDO et alii, 1994, 2001; CONTI et alii, 1997); 3) endemiti esclusivi della Sicilia, del dominio apulo-siculo e dell’area centromediterranea sensu lato; 4) rari su scala nazionale, regionale e/o provinciale; 5) ai margini del loro areale di distribuzione (per lo più mediterranee sud-occidentali e centro-orientali) e/o del loro range altitudinale. Alla luce dei criteri su esposti, viene di seguito presentata una lista aggiornata dei taxa vegetali di maggiore pregio fitogeografico e/o conservazionistico presenti nel SIC in esame. Il patrimonio botanico complessivo del SIC ammonta a ben 90 emergenze floristiche. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 47 Liste Rosse Rgionali CITES Taxa vegetali di interesse presenti nel SIC ITA010022 (da PASTA & LA MANTIA, 2001a, agg. e mod.). Nella colonna “Liste Rosse Regionali” viene indicato, in conformità con le sigle proposte dall’IUCN (RIZZOTTO, 1995), il grado di rischio per i singoli taxa a livello nazionale: “VU” – vulnerabile; “LR” pericolo moderato. I taxa sottolineati figuravano già nel Formulario Standard di Natura 2000, quelli in grassetto sono inediti per il SIC. EL = estremamente localizzato. LR + LR + LR LR LR VU + LR 5 LR LR Nome scientifico Ambrosina bassii L. Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard Asperula aristata L. fil. subsp. longiflora (Waldst. et Kit.) Hayek1 Astragalus huetii Bunge Barlia robertiana (Loisel.) Greuter2 Biscutella maritima Ten. Brassica rupestris Raf. subsp. rupestris Brassica villosa Biv. subsp. bivoniana (Mazzola et Raimondo) Raimondo et Mazzola3, 4 Calendula suffruticosa Vahl subsp. fulgida (Raf.) Ohle Capnophyllum peregrinum (L.) Lange Carlina sicula Ten. subsp. sicula Carthamus caeruleus L. subsp. caeruleus Carthamus pinnatus Desf. subsp. pinnatus Catananche lutea L. Catapodium hemipoa (Sprengel) Laìnz subsp. occidentale (Paunero) H. et S. Scholz Cheilanthes maderensis Lowe Colchicum bivonae Guss. Convolvulus tricolor L. subsp. cupanianus (Sa’ad) Stace Crepis bursifolia L. Crocus longiflorus Raf. Cyclamen repandum Sibth. et Sm. Cymbalaria pubescens (C. Presl) Cufod. Daucus muricatus (L.) L. Dianthus siculus C. Presl Diplotaxis crassifolia (Raf.) DC. Echinaria capitata Desf. subsp. todaroana (Ces., Pass. et Gibelli) Arcang. Echium italicum L. subsp. siculum (Lacaita) Greuter et Burdet Eryngium bocconei Lam. Eryngium dichotomum Desf. Eryngium triquetrum Vahl Euphorbia ceratocarpa Ten. Fedia graciliflora Fischer et C.A. Meyer Galium pallidum C. Presl Gypsophila arrostii Guss. Helictotrichon cincinnatum (Ten.) Röser Helminthoteca aculeata (Vahl) Lack. Hippomarathrum siculum (L.) Hoffmgg. et Link Jacobaea delphinifolia (Vahl) Pelser et Veldk. Jacobaea lycopifolia (Poir.) Greuter et B. Nord. Lathyrus odoratus L. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano Note EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL 48 + LR + + + + + + + + + + + + + LR LR LR + + + + + + LR LR LR LR LR + + + 1 Laurus nobilis L. Linum decumbens Desf. Lomelosia cretica (L.) W. Greuter et Burdet Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. Micromeria fruticulosa (Bertol.) Grande Neotinea maculata (Desf.) Stearn6 Nepeta apuleii Ucria Odontites rigidifolius (Biv.) Benth. Ononis alopecuroides L. subsp. exalopecuroides (G. Lòpez) Greuter et Burdet Ononis pendula Desf. subsp. boissieri (Širj.) Devesa Ononis sieberi DC. Ophrys bertolonii Moretti Ophrys bombyliflora Link Ophrys exaltata Ten.3 Ophrys garganica O. et E. Danesch Ophrys incubacea Tod. Ophrys lupercalis Devillers et Devillers-Terschuren7 Ophrys lutea Cav. subsp. lutea3 Ophrys lutea Cav. subsp. minor O. et E. Danesch 8 Ophrys obaesa Lojac.7 Ophrys oxyrrhynchos Tod. Ophrys panormitana (Tod.) Soó Ophrys tenthredinifera Willd.9 Ophrys vernixia Brot.10 Opopanax chironium (L.) Koch Orchis anthropophora (L.) All. Orchis collina A. Russel Orchis italica Poir. Orchis lactea Poir.3 Orchis longicornu Poir. Orchis papilionacea L. s.l. Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga Phagnalon saxatile (L.) Cass. subsp. saxatile Pimpinella anisoides Briganti Plantago afra L. subsp. zwierleinii (Nicotra) Brullo Rosa micrantha Sm. Rumex thyrsoides Desf. Salvia viridis L. Scorzonera cana (C.A. Mey.) Griseb. Scorzonera deliciosa Guss. Sedum caeruleum L. Sedum gypsicola Boiss. et Reuter Serapias lingua L. Serapias parviflora Parl. Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq.3 Silene fruticosa L. Silene italica (L.) Pers. subsp. sicula (Ucria) Jeanmonod Thymus spinulosus Ten.3 Tragopogon cupanii Guss. Vicia narbonensis L. EL EL EL EL EL EL EL EL EL Il suo nome corretto è oggi Asperula aristata L. fil. subsp. scabra (C. Presl) Nyman; 2 Il suo nome corretto è oggi Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge; 3 Entità segnalate per il SIC dai redattori del Formulario Standard; 4 Sussistono forti dubbi sulla reale autonomia dei taxa intraspecifici del ciclo di Brassica Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 49 villosa Biv. In base alla morfologia dei semi le piante locali sono state precedentemente riferite a Brassica tinei Lojac. (PASTA, 2001; SCUDERI, 2006).; 5 “VU” in CONTI et alii (1997). Il grado di minaccia è stato aggiornato alla luce di dati personali inediti; 6 Il suo nome corretto è oggi Orchis intacta Link; 7 Microspecie cui va ricondotta la citazione di Ophrys fusca Link del Formulario; 8 Il suo nome corretto è oggi Ophrys sicula Tineo; 9 Il suo nome corretto è oggi Ophrys grandiflora Ten.; 10 Il suo nome corretto è oggi Ophrys ciliata Biv.. Gran parte delle specie dipendono da un regime di disturbo moderato e soltanto le rupicole e litofile esclusive sembrano necessitare di contesti privi o raramente soggetti a disturbo. Le specie veramente rare all’interno del SIC sono: Ambrosina bassii, Astragalus huetii, Ophrys garganica, O. oxyrrhynchos, Brassica rupestris subsp. rupestris, Brassica villosa subsp. bivoniana, Calendula suffruticosa Vahl subsp. fulgida, Capnophyllum peregrinum, Catananche lutea, Crepis bursifolia, Cymbalaria pubescens, Daucus muricatus, Diplotaxis crassifolia, Echinaria capitata subsp. todaroana, Helictotrichon cincinnatum, Jacobaea lycopifolia, Lomelosia cretica, Nepeta apuleii, Orchis anthropophora, Orchis longicornu, Rumex thyrsoides, Salvia viridis, Scorzonera cana, Thymus spinulosus, Vicia narbonensis. E’ stata redatta una carta delle distribuzione delle emergenze floristiche (Tavola 7) che riporta l’ubicazione delle stazioni in cui sono state rinvenute le specie di cui all’elenco precedente (tranne Ophrys garganica, che risulta diffusa in diversi ambienti del SIC). A tali specie sono state aggiunte Carthamus pinnatus subsp. pinnatus, Orchis papilionacea, Silene fruticosa, in quanto estremamente localizzate all’interno del SIC. Analisi del grado di invasività delle specie aliene (B.3.3) Nell’area del SIC sono state censite diverse decine di specie introdotte ed oggi definitivamente spontaneizzate o subspontanee e numerose avventizie casuali o del tutto naturalizzate. La seguente scheda di sintesi riporta sia le principali specie individuate che la loro distribuzione negli ambienti del SIC. Specie Distribuzione ed ambienti interessati Oxalis pes-caprae Ovunque nel territorio del SIC Symphyotrichum squamatum Comunità igrofile delle sponde dei corpi idrici Conyza bonariensis Ambienti marginali Ailanthus altissima Abbastanza diffusa, minaccia l’habitat 5230 ed i lembi di ripisilva a Populus sp. pl., Salix pedicellata e Ulmus sp Eucalyptus sp. Aree demaniali gestite dall’Azienda Foreste Demaniali Arundo donax Limitati popolamenti sulle sponde dell’invaso artificiale Agave americana Presente in ambienti degradati di prateria perenne e gariga Myoporum tenuifolium Utilizzato come siepe nelle aree demaniali forestali e subspontaneo in alcuni nucleo di macchia e mantello Lantana camara Presente lungo un tratto di viabilità - Oxalis pes-caprae è una specie invasiva d’origine sudafricana che ha ormai colonizzato ogni ambiente disturbato e seminaturale di tutta la fascia infra-, termo- e mesomediterranea di Sicilia. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 50 - Symphyotrichum squamatum e Conyza bonariensis sono composite che sembrano aver fatto ingresso solo di recente nel SIC: la prima interferisce con le comunità igrofile delle sponde dei corpi idrici (canali, laghi artificiali, ecc.), mentre la seconda attualmente colonizza gli ambienti marginali legati all’attività forestale (massicciate delle strade di servizio, spiazzi delle torrette) ma potrebbe ben presto invadere incolti ed aspetti di prateria annua e perenne: entrambe queste specie possono essere eradicate attraverso l’estirpazione e la distruzione prima della fruttificazione. - Ailanthus altissima è una specie a crescita rapidissima che in Sicilia trova il suo optimum negli aspetti di mantello riferiti al Pruno-Rubion ulmifolii, mostrando tuttavia la capacità di inserirsi come specie pioniera già all’interno delle formazioni erbacee perenni subnitroigrofile del Bromo-Oryzopsion miliaceae. Nel SIC esso appare minacciare da vicino l’habitat prioriario 5230 ed i lembi di ripisilva a Populus sp. pl., Salix pedicellata e Ulmus sp. pl. corripondenti all’habitat 92A0. Va monitorata ed eventualmente bloccata la sua espansione in altri contesti freschi e ombrosi del SIC (risulta già oggi piuttosto frequente in corrispondenza di piccoli impluvi incassati e tende a creare densi popolamenti monospecifici in corrispondenza di diversi inghiottitoi). - Eucalyptus sp. pl. è stata diffusa dall’Azienda Foreste nelle aree di demanio nelle prime attività di rimboschimento (anni ’70-’80). - Arundo donax forma popolamenti sulle sponde dell’invaso artificiale, e va eradicata o comunque monitorata in modo che non interferisca con gli altri (ben più interessanti) aspetti di vegetazione anfibia. - Agave americana (piuttosto diffusa in aspetti degradati di prateria perenne e gariga), Myoporum tenuifolium (subspontaneo presso alcuni nuclei di mantello e di macchia ad alloro nel Torrente Biviere, ed utilizzato nelle aree demaniali) e Lantana camara L. (usata per mitigare l’effetto estetico di una massicciata stradale in Contrada La Menta) vanno attentamente monitorate per ridurre la loro invasione di ecosistemi seminaturali. Per ridurre il rischio di ulteriori ingressi vanno adottate alcune semplici misure precauzionali, evitando ad esempio l’introduzione di terreno vegetale e pietrisco provenienti dall’esterno, riducendo al minimo indispensabile l’estensione e l’intensità di manutenzione di ecotoni antropogeni come le strisce parafuoco e la viabilità di servizio della forestale. Inquadramento fitosociologico e caratterizzazione ecologica della vegetazione (B.3.2) Qui di seguito si propone un prospetto sintassonomico delle cenosi presenti nel comprensorio in oggetto; esso si rifà sostanzialmente a quanto esposto da PASTA & LA MANTIA (2001a-b). Vegetazione acquatica Consorzi di macroalghe dulciacquicole sommerse CHARETEA FRAGILIS Fukarek ex Krausch 1964 CHARETALIA HISPIDAE Sauer ex Krausch 1964 CHARION FRAGILIS (Krause ex Krause et Lang 1977) Krause 1981 Charetum vulgaris Corillion 1957 Vegetazione anfibia e igrofila Consorzi a grandi elofite rizomatose dei margini degli ambienti umidi PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novák 1941 Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 51 PHRAGMITETALIA W. Koch 1926 em. Pignatti 1954 PHRAGMITION COMMUNIS W. Koch 1926 Phragmitetum communis (W. Koch 1926) Schmale 1939 Typhetum angustifoliae (Allorge 1921) Pignatti 1953 Helosciadetum nodiflori Br.-Bl. (1931) 1952 AGROSTIO-ELYTRIGION ATHERICAE Brullo et Siracusa 2000? aggr. a Festuca arundinacea e Phalaris coerulescens Vegetazione dei pascoli mesoigrofili perenni MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937 PLANTAGINETALIA MAJORIS R. Tx. et Preising in R. Tx. 1950 MENTHO-JUNCION INFLEXI De Foucault 1984 aggr. a Pulicaria dysentherica e Mentha suaveolens Vegetazione degli ambiti rupestri Vegetazione casmofitica delle pareti rocciose poco disturbate ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977 ASPLENIETALIA GLANDULOSI Br.-Bl. et Meier 1934 DIANTHION RUPICOLAE Brullo et Marcenò 1979b Diplotaxio crassifoliae-Brassicetum tinei Brullo et Marcenò 1979 aggr. a Brassica rupestris subsp. rupestris Vegetazione casmo-nitrofila delle pareti rocciose disturbate PARIETARIETEA Oberdorfer 1977 TORTULO-CYMBALARIETALIA Segal 1969 PARIETARION JUDAICAE Segal 1969 Capparidetum rupestris O. de Bolòs et Molinier 1958 CYMBALARIO-ASPLENION Segal 1969 aggr. a Parietaria judaica e Athamanta sicula Vegetazione brio-pteridofitica casmocomofitica ANOMODONTO-POLYPODIETEA Rivas-Martínez 1975 ANOMODONTO-POLYPODIETALIA O. de Bolòs et Vives in O. de Bolòs 1957 POLYPODION SERRATI Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine et Nègre 1952 Selaginello denticulatae-Cymbalarietum pubescentis Brullo, Marcenò et Siracusa 2004 BARTRAMIO-POLYPODION CAMBRICI O. de Bolòs et Vives in O. de Bolòs 1957 aggr. a Sedum dasyphyllum, Ceterach officinarum e Umbilicus horizontalis SELAGINELLO DENTICULATAE-ANOGRAMMION LEPTOPHYLLAE Rivas-Martínez, Fernández-González et Loidi 1999 Anogrammo leptophyllae-Selaginelletum denticulatae Molinier 1937 CHEILANTHETALIA MARANTO-MADERENSIS Saenz et Rivas-Martínez 1979 PHAGNALO SAXATILIS-CHEILANTHION MADERENSIS Loisel 1970 corr. Perez et Al. 1989? Aggr. a Cheilanthes maderensis Vegetazione ruderale e vegetazione nitrofila degli agro-ecosistemi Vegetazione segetale delle colture cerealicole PAPAVERETEA RHOEADIS Brullo, Scelsi et Spampinato 2001 PAPAVERETALIA RHOEADIS Hüppe et Hofmeister ex Theurillat et Al. 1995 RIDOLFION SEGETI Nègre ex El Antri in Rivas-Martínez, Fernández-González et Loidi 1999 Capnophyllo peregrini-Medicaginetum ciliaris Di Martino et Raimondo 1976 Vegetazione ipernitrofila delle aree fortemente pascolate ONOPORDETEA ACANTHII Br.-Bl. 1964 CARTHAMETALIA LANATI Brullo in Brullo et Marcenò 1985 Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 52 ONOPORDION ILLYRICI Oberdorfer 1954 Carlino siculae-Feruletum communis Gianguzzi, Ilardi e Raimondo 1996 aggr. a Dipsacus fullonum Vegetazione nitrofila dei suoli calpestati POLYGONO-POËTEA ANNUAE Rivas-Martínez 1975 POLYGONO ARENASTRI-POËTALIA ANNUAE R. Tx. in Géhu, Richard et R. Tx. 1972 POLYCARPION TETRAPHYLLI Rivas- Martínez 1975 Trisetario aureae-Crepidetum bursifoliae Brullo 1980 Vegetazione ruderale e vegetazione nitrofila delle colture orticole e arboree, degli incolti e degli eucalipteti STELLARIETEA MEDIAE R. Tx. Lohmeyer et Preising ex von Rochow 1951 POLYGONO-CHENOPODIETALIA ALBI R. Tx. et Lohmeyer in R. Tx. 1950 em. J. Tx. 1966 FUMARION WIRTGENII-AGRARIAE Brullo in Brullo et Marcenò 1985a SOLANO NIGRI-POLYGONETALIA CONVOLVULI (Sissingh in Westhoff, Dijk et Passchier 1946) O. de Bolòs 1962 DIPLOTAXION ERUCOIDIS Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber et Walas 1936 Chrozophoro tinctoriae-Kickxietum integrifoliae Brullo et Marcenò 1980 THERO-BROMETALIA (Rivas-Goday et Rivas-Martínez ex Esteve 1973) O. de Bolòs 1975 HORDEION LEPORINI Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber et Walas 1936 corr. O. Bolòs 1962 ECHIO-GALACTITION TOMENTOSAE O. de Bolòs et Molinier 1969 Aggr. a Dactylis hispanica e Elaeoselinum asclepium FEDIO GRACILIFLORAE-CONVOLVULION CUPANIANI Brullo et Spampinato 1986 Vegetazione a megaforbie sciafilo-nitrofile (colture arboree e margini di boschi) GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecký 1969 URTICO-SCROPHULARIETALIA PEREGRINAE Brullo in Brullo et Marcenò 1985a ALLION TRIQUETRI O. de Bolòs 1967 Acantho mollis-Smyrnietum olusatri Brullo et Marcenò 1985a CONVOLVULETALIA SEPIUM R. Tx. 1950 SENECIONION FLUVIATILIS R. Tx. 1950? Aggruppamento ad Arundo donax Vegetazione microfitica sciafilo-nitrofila delle radure delle formazioni pre-forestali e forestali GERANIO-CARDAMINETEA HIRSUTAE (Rivas-Martínez, Fernandez-Gonzalez et Loidi 1999) Rivas-Martínez et Al. 2001 GERANIO PURPUREI-CARDAMINETALIA HIRSUTAE Brullo in Brullo et Marcenò 1985a VALANTIO-GALION MURALIS Brullo in Brullo et Marcenò 1985a Vegetazione delle praterie perenni e annue Consorzi terofitici basifili STIPO-TRACHYNIETEA DISTACHYAE Brullo in Brullo, Scelsi et Spampinato 2001 STIPO-TRACHYNIETALIA DISTACHYAE Rivas-Martínez 1978 TRACHYNION DISTACHYAE Rivas-Martínez 1978 Thero-Sedetum caerulei Brullo 1975 em. Brullo in Bartolo, Brullo et Marcenò 1982 STIPO-BUPLEURETALIA SEMICOMPOSITI Brullo in Brullo, Scelsi et Spampinato 2001 SEDO-CTENOPSION GYPSOPHILAE Rivas-Goday et Rivas-Martínez ex Izco 1974 aggr. a Filago eriocephala e Medicago minima aggr. a Sedum gypsicola e Sedum sediforme PLANTAGINI-CATAPODION MARINI Brullo 1985 aggr. a Stipa capensis aggr. a Hedysarum glomeratum Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 53 Consorzi delle praterie termoxerofile perenni a dominanza di geofite POËTEA BULBOSAE Rivas-Goday et Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978 POËTALIA BULBOSAE Rivas-Goday et Rivas-Martínez in Rivas-Goday et Ladero 1970 LEONTODONTO TUBEROSI-BELLIDION SYLVESTRIS Biondi, Filigheddu et Farris 2001 aggr. a Charybdys pancration e Asphodelus ramosus Consorzi delle praterie termoxerofile perenni a dominanza di emicriptofite LYGEO-STIPETEA TENACISSIMAE Rivas-Martínez 1978 HYPARRHENIETALIA HIRTAE Rivas-Martínez 1978 AVENULO-AMPELODESMION MAURITANICI Minissale 1995 Astragalo huetii-Ampelodesmetum mauritanici Minissale 1995 teucrietosum flavi n. provv. HYPARRHENION HIRTAE Br.-Bl., P. Silva et Rozeira 1956 Sanguisorbo verrucosae-Magydaretum pastinaceae Bartolo, Brullo, Minissale et Spampinato 1990 BROMO-ORYZOPSION MILIACEAE O. de Bolòs 1970 Thapsio garganicae-Feruletum communis Brullo 1984 Euphorbio ceratocarpae-Arundinetum collinae n. provv. aggr. a Calendula suffruticosa subsp. fulgida Vegetazione pre-forestale e forestale zonale Vegetazione suffruticosa delle garighe basifile CISTO-MICROMERIETEA JULIANAE Oberdorfer 1954 CISTO-ERICETALIA Horvatič 1958 CISTO-ERICION Horvatič 1958 Micromerio fruticosae-Coridothymetum capitati n. provv. aggr. a Cistus creticus Vegetazione della macchia-foresta sempreverde mediterranea QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. et O. de Bolòs 1950 QUERCETALIA ILICIS Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martìnez 1975 QUERCION ILICIS Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martìnez 1975 ? aggr. a Laurus nobilis QUERCETALIA CALLIPRINI Zohary 1955 OLEO-CERATONION SILIQUAE Br.-Bl. 1936 ex Guinochet et Drouineau 1944 em. RivasMartínez 1975 Euphorbio dendroidis-Anagyridetum foetidae subass. artemisietosum arborescentis Biondi et Mossa, 1992 aggr. a Chamaerops humilis Vegetazione arbustiva dei margini del bosco termo- e mesomediterraneo (“mantello”) RHAMNO-PRUNETEA Rivas Goday et Borja Carbonell ex R. Tx. 1962 PRUNETALIA SPINOSAE R. Tx. 1952 PRUNO-RUBION ULMIFOLII O. de Bolós 1954 aggr. a Ulmus minor aggr. a Rubus ulmifolius e Rhus coriaria aggr. a Rubus ulmifolius e Smilax aspera Rubo ulmifolii-Tametum communis R. Tx. in R. Tx. et Oberdorfer 1958 Rubo ulmifolii-Dorycnietum recti Brullo, Minissale, Scelsi et Spampinato 1993 Vegetazione forestale azonale Consorzi mesoigrofili decidui QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 54 POPULETALIA ALBAE Br.-Bl. ex Tchou 1948 POPULION ALBAE Br.-Bl. ex Tchou 1948 Ulmo canescentis-Salicetum pedicillatae Brullo et Spampinato 1991 Nel testo che segue vengono forniti i ragguagli generali sulla composizione floristica, l’ecologia e la distribuzione delle classi di vegetazione note o rinvenute nel comprensorio e sulla loro importanza ai fini della conservazione della fitodiversità complessiva del territorio stesso. Le unità di vegetazione vengono riportate nella Tavola 8. Vegetazione acquatica Consorzi di macroalghe dulciacquicole sommerse La classe Charetea vulgaris include tutte le comunità di Carofite sommerse. Si tratta di comunità acquatiche, pioniere e piuttosto sciafile, tipiche di acque calme; diffuse nel piano basale e collinare. Specie guida: Chara sp. pl. Charetum vulgaris Corillion 1957 Specie caratteristica: Chara vulgaris Ecologia: cenosi tipica delle acque basiche da meso- a eutrofiche. Distribuzione nel SIC: localizzato nella polla naturale posta sul margine orientale della valle cieca del Biviere. Vegetazione anfibia Consorzi a grandi elofite rizomatose dei margini degli ambienti umidi Sulle sponde della polla naturale posta sul margine orientale della valle del Biviere, dell’invaso artificiale presente nell’area rimboschita e di quello ubicato a settentrione, nonché sulle sponde del Torrente Biviere si osservano consorzi igrofili da attribuire alla classe Phragmito-Magnocaricetea, che comprende tutte le formazioni dominate da grandi elofite. Più precisamente, lungo il torrente Biviere e sino all’inghiottitoio e sui bordi dei due specchi d’acqua si osservano aspetti di vegetazione mono- o paucispecifica ascrivibili all’ordine Phragmitetalia, tipico di acque stagnanti o lente. Le associazioni riscontrate, che potenzialmente dovrebbero svilupparsi in modo continuo, sono il Phragmitetum communis, il Typhetum angistifoliae e l’Helosciadetum nodiflori (tratto medio-alto del torrente Biviere). Si tratta di cenosi caratterizzate da una bassa ricchezza specifica; pur non rivestendo in sé un grande valore naturalistico, esse costituiscono tuttavia delle unità ecologicamente e fisionomicamente significative. Specie guida: Phragmites australis e Typha angustifolia. Phragmitetum communis (W. Koch 1926) Schmale 1939 Specie caratteristica: Phragmites australis Ecologia: questo consorzio, ben adattato ad un elevato tenore di nutrienti del suolo, forma densi popolamenti pressoché monospecifici sulle sponde dei corpi idrici soggetti a frequente impaludamento, prediligendo la foce dei fiumi e i margini di zone palustri, dove realizza coperture del 100%. Distribuzione nel SIC: diffuso lungo il tratto terminale del Torrente Biviere che corre all’interno della Conca del Biviere, in corrispondenza della polla si arricchisce di specie differenziali della subass. typicum Pignatti 1953, come Equisetum ramosissimum, Potentilla reptans, Mentha suaveolens e Ranunculus bulbosus. Questa subassociazione, legata ad acque Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 55 mesotrofiche e suoli che si mantengono umidi a lungo, è nota per diverse località della Sicilia sud-occidentale. Typhetum angustifoliae (Allorge 1921) Pignatti 1953 Car. Ass.: Typha angustifolia Ecologia: vegetazione costituita quasi sempre da popolamenti monospecifici, legata a stazioni con acque basse e mesotrofiche e fondali melmosi, comune nei bracci morti dei fiumi e nei tratti di fiumi e canali con acque impaludate o più o meno stagnanti, soggetti a sommersione prolungata. Distribuzione nel SIC: se ne osservano nuclei sui margini dell’invaso artificiale. Helosciadetum nodiflori Br.-Bl. (1931) 1952 Car. Ass.: Apium nodiflorum Ecologia: vegetazione semisommersa a ciclo estivale dei tratti esterni e poco profondi delle sponde fluviali e degli stagni a regime idrico lento pressocché costante con una buona limpidità e tenore d’ossigeno. Frequente anche nei canali e nei fossati del piano basale (tra 0 e 350 m s.l.m.), forma abitualmente popolamenti piuttosto densi (copertura 80-100%). Distribuzione nel SIC: si riscontra frammisto ai popolamenti di Phragmites lungo il tratto terminale del Torrente Biviere, presso la polla e tra la polla e l’inghiottoio. Aggruppamento a Festuca arundinacea e Phalaris coerulescens In poche aree sono stati rilevati lembi di prateria igrofila di dimensioni non cartografabili, uno dei quali è situato poche centinaia di m sotto l’invaso artificiale. Vi si registra la significativa presenza di Lathyrus odoratus e Cichorium intybus. In assenza del disturbo dovuto alla manutenzione dell’alveo e delle contigue strisce parafuoco tale cenosi, riconducibile all’Agrostio-Elytrigion athericae, occuperebbe probabilmente maggiori estensioni e mostrerebbe una maggiore continuità ed espressività sotto un profilo fisionomico e floristico. Un ambiente analogo è stato riscontrato al margine settentrionale del SIC in C.da La Menta; tale toponimo deriva forse proprio dalla presenza di aree umide, probabilmente rimaneggiate nel tempo per fare spazio alle colture agrarie. Vegetazione dei pascoli mesoigrofili perenni Cenosi ad elevata produttività si sviluppano su superfici non cartografabili interessate dalla presenza di una sorgente o dal ruscellamento di acque piovane invernali, e quindi poco salate e ricche di sedimenti limoso-argillosi. Si tratta di consorzi molto eterogenei e di difficile collocazione sintassonomica, riferibili alla classe Molinio-Arrhenatheretea, all’ordine Plantaginetalia majoris e all’alleanza Mentho-Juncion inflexi. Specie guida: Festuca arundinacea s.l., Mentha suaveolens, Verbena officinalis, Cichorium pumilum, Trifolium resupinatum, ecc. Aggruppamento a Pulicaria dysentherica e Mentha suaveolens Si riscontra in prossimità della polla già citata e manifesta marcate caratteristiche subigrofile e subnitrofile. In corrispondenza di tale formazione crescono peraltro i pochi individui noti per il SIC di Lathyrus annuus, Vicia bithynica, Cyperus longus, Juncus fontanesii, Carex hispida, Verbena officinalis, ecc. Vegetazione degli ambiti rupestri Vegetazione casmofitica delle pareti rocciose poco disturbate La classe Asplenietea trichomanis raggruppa tutti gli aspetti di vegetazione naturale delle pareti rocciose, delle fessure e dei muri. I consorzi rupicoli del comprensorio vanno ricondotti all’ordine Asplenietalia glandulosi e, in particolare, al Dianthion rupicolae (BRULLO & Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 56 MARCENÒ, 1979), alleanza endemica dell’area centro-mediterranea. Splendidi e tipici esempi di consorzi riferibili ai syntaxa di rango superiore si osservano lungo tutta la parete esposta a Nord della valle del Biviere, nonché sul versante settentrionale di M. Castellaccio, negli anfratti ombrosi delle rupi poste ai piedi del versante meridionale di M. Finestrelle , a NE dell’invaso artificiale e sulle Balze del Campanaro e del Cappellone. Specie guida: Lomelosia cretica, Silene fruticosa. Diplotaxio crassifoliae-Brassicetum tinei Brullo et Marcenò 1979 Car. Ass.: Diplotaxis crassifolia e Brassica villosa subsp. tinei. Ecologia: formazione tipica delle rupi verticali, è endemica del settore siculo centromeridionale (prov. di AG, EN e CL), dove colonizza i gessi e gli altri substrati della Serie Gessoso-Solfifera (calcari marnosi, calcareniti, ecc.), tra 100 e 800 m s.l.m., sia in località dell’interno che in stazioni costiere, dove realizza una copertura media del 40%. Distribuzione nel SIC: l’associazione come tale è assente nel SIC, perché le specie caratteristiche suindicate crescono in stazioni separate. Ciò è probabilmente dovuto al secolare disturbo antropico che, soprattutto a causa degli incendi, non ha risparmiato neppure le guglie gessose idonee ad ospitare tale cenosi. Aggruppamento a Brassica rupestris subsp. rupestris Sulle rupi settentrionali delle balze gessose di Contrada La Menta il cavolo rupestre, mai segnalato prima su substrati gessosi, forma un aggruppamento che occupa le cenge all’interno di un mosaico atipico, dominato da aspetti di mantello a Ulmus minor, forse facilitati dalla presenza di acqua nel sottosuolo, e di macchia termofila subcasmofila ad Euphorbia dendroides. Vegetazione casmo-nitrofila delle pareti rocciose disturbate Gli aspetti casmo-nitrofili ed eliofili dei Parietarietea si rinvengono in maniera sporadica e poco tipificabile; essi vanno attribuiti all’ordine Tortulo-Cymbalarietalia e all’alleanza Parietarion judacae. Specie guida: Athamanta sicula, Capparis spinosa susp. rupestris, Centranthus ruber, Parietaria (judaica, lusitanica). Capparidetum rupestris O. de Bolós et Molinier 1958 Car. Ass.: Capparis rupestris Ecologia: consorzio casmo-nitrofilo ed eliofilo dei versanti verticali o subverticali di bassa quota (di rado lo si osserva sopra i 500-600 m s.l.m.), vicaria in ambienti disturbati ed antropizzati (vecchi muri di strade ed edifici) le associazioni del Dianthion rupicolae. Alquanto diffusa in Sicilia, questa associazione è stata osservata anche in Italia, nella Penisola Iberica e alle Baleari. Distribuzione nel SIC: se ne osservano sparuti esempi sul versante settentrionale del Vallone Biviere, presso Case Martino. Aggruppamento a Parietaria judaica e Athamanta sicula Nel corso dei sopralluoghi sono stati riscontrati in diverse località del SIC (balze di C.da Cappellone, Campanaro, C.da Castellaccio, ecc.) consorzi poco tipificabili, riferibili all’alleanza Cymbalario-Asplenion. Si tratta certamente di aspetti rimaneggiati e di sostituzione rispetto alle cenosi del Dianthion rupicolae. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 57 Vegetazione brio-pteridofitica casmocomofitica In diversi contesti rupicoli sono stati rinvenuti aspetti (di solito alquanto localizzati e mai cartografabili) riferibili agli Anomodonto-Polypodietea e, in particolare, alle alleanze Polypodion serrati e Selaginello denticulatae-Anogrammion leptophyllae. Specie guida: Anogramma leptophylla, Asplenium ceterach subsp. ceterach, Cheilanthes maderensis, Polypodium cambricum, Sedum (dasyphyllum, hispanicum), Umbilicus (horizontalis, rupestris). Selaginello denticulatae-Cymbalarietum pubescentis Car. Ass.: Selaginella denticulata e Cymbalaria pubescens Ecologia: cenosi marcatamente sciafila, predilige la base di rupi e muretti a secco a discreto sviluppo verticale con un discreto apporto di nutrienti. Distribuzione nel SIC: appare circoscritta alle pareti esposte a settentrione di C.da Castellaccio. Aggruppamento a Sedum dasyphyllum, Asplenium ceterach e Umbilicus horizontalis Si riscontra nelle cenge e sui massi delle aree franose esposte a Nord. Anogrammo leptophyllae-Selaginelletum denticulatae Car. Ass.: Anogramma leptophylla Ecologia: cenosi sciafila, predilige la base di rupi e muretti a secco a breve sviluppo verticale, spesso contigua ad aspetti del Valantio-Galion muralis. Distribuzione nel SIC: presso la polla, in corrispondenza di un piccolo anfratto naturale, e in siti analoghi sul versante meridionale di M. Finestrelle e di C.da La Menta, si rinvengono aspetti dominati da piccole felci, riferibili all’associazione, pertinente all’alleanza Aggruppamento a Cheilanthes maderensis Questa cenosi briopteridifitica casmocomofitica delle balze e delle cavità su gesso tollera periodi di parziale soleggiamento. Se ne rinvengono nuclei sparsi C.da Castellaccio, M. Finestrelle, presso la polla, ecc. Vegetazione ruderale e vegetazione nitrofila degli agro-ecosistemi Vegetazione segetale delle colture cerealicole Le comunità dei seminativi asciutti vanno riferite all’ordine Papaveretalia rhoeadis e all’alleanza Ridolfion segeti. Le indagini di campo hanno reso possibile giungere ad ipotizzare l’associazione di riferimento per i locali campi di frumento. Specie guida: Allium nigrum, Anagallis arvensis, Avena (barbata, sterilis), Bromus (madritensis, sterilis), Calendula arvensis, Carduus (argyroa, pycnocephalus), Daucus muricatus, Euphorbia (exigua, falcata), Fumaria agraria, Galium (parisiense, tricornutum, verrucosum), Kickxia spuria subsp. integrifolia, ecc. Capnophyllo peregrini-Medicaginetum ciliaris Di Martino et Raimondo 1976 Car. Ass.: Medicago ciliaris e Capnophyllum peregrinum. Ecologia: vegetazione segetale legata ai suoli alluvionali e vertisuoli ricchi di limo e argilla a reazione leggermente basica, con carattere marcatamente termofilo; consorzio legato a seminativi in rotazione con prati a leguminose o a riposo pascolativo. Comune per lo più nelle aree costiere della Sicilia centro-occidentale (Agrigentino, Palermitano, Piana di Gela e di Catania e Pietraperzia). Nel Trapanese è noto per Nubia, Birgi, Marausa, Paceco, Borgo Fazio e i dintorni della stazione ferroviaria di Salemi (DI MARTINO & RAIMONDO, 1976). Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 58 Vegetazione ipernitrofila delle aree fortemente pascolate La classe Onopordetea acanthii, che racchiude tutti gli aspetti di pascolo ipernitofilo a carattere xerofilo e ruderale, è rappresentata in Sicilia dall’alleanza Onopordion illyrici. Specie guida: Carthamus caeruleus subsp. caeruleus, Carthamus lanatus subsp. lanatus, Cynara cardunculus, Daucus carota, Dipsacus fullonum, Helminthotheca echiodes, Nepeta apuleii, Notobasis syriaca, Onopordum illyricum subsp. illyricum, Phlomis herba-venti, Picris hieraciodes, Reseda luteola, Scolymus (grandiflorus, maculatus), Silybum marianum, Sinapis pubescens. Carlino siculae-Feruletum communis Gianguzzi, Ilardi e Raimondo 1996 Car. e Diff. Ass.: Asphodelus ramosus, Carlina sicula subsp. sicula, Cynoglossum creticum, Ferula communis, Iris planifolia, Mandragora autumnalis e Rumex thyrsoides Ecologia: consorzio discontinuo, povero da un punto di vista pabulare, con caratteri subnitrofili, tipico dei litosuoli calcarei e gessosi su substrati pianeggianti o quasi e pertanto poco soggetti all’erosione, con forte rocciosità affiorante, sottoposti da secoli al sovrappascolo. Si riscontra nel piano climatico termomediterraneo e, talora, nella parte basale del mesomediterraneo. Al suo interno si possono riconoscere due gruppi di specie separate fenologicamente: una vernale-tardovernale ed una estivale-serotina. Comune nella Sicilia nordoccidentale e centrale (GIANGUZZI et alii, 1996). Aggruppamento a Dipsacus fullonum Si tratta di un consorzio monospecifico che ricopre brevi tratti ai margini di aree umide (polla, ambiente umido di C.da La Menta al limite settentrionale del SIC, tratto medio del Torrente Biviere), in rapporto di contiguità-continuità con il mantello a rovo (Pruno-Rubion ulmifolii) e la prateria igro-nitrofila ad Arundo collina ed Euphorbia ceratocarpa (Bromo-Oryzopsion: vedi oltre). Andrebbe ulteriormente verificata la possibile presenza nel SIC delle associazioni Scolymetum maculato-grandiflori Brullo et Marcenò 1985a, Onopordo illyrici-Cirsietum scabri Brullo et Marcenò 1985a e Phlomido herba-venti-Nepetetum apuleii Brullo et Marcenò 1985a. Vegetazione nitrofila dei suoli calpestati La classe Polygono-Poëtea annuae racchiude tutte le comunità terofitiche dei contesti ruderali calpestati. Localmente essa è rappresentata dall’associazione Trisetario aureae-Crepidetum bursifoliae Brullo 1980. Specie guida: Polycarpon tetraphyllum, Trifolium suffocatum. Trisetario aureae-Crepidetum bursifoliae Brullo 1980 Car. Ass.: Trisetaria aurea e Crepis bursifolia Ecologia: vegetazione rada tardo-vernale (talora estivale) termofila ed eliofila dei suoli compattati dei bordi delle strade, dei sentieri interpoderali, viali dei giardini, contesti plateali; indifferente ai substrati e diffusa su tutta l’isola (BRULLO, 1980). Vegetazione ruderale e vegetazione nitrofila delle colture orticole e arboree, degli incolti e degli eucalipteti Gli aspetti di vegetazione infestante a ciclo estivale-autunnale dei vigneti e degli uliveti rientrano nei Solano-Polygonetalia (all. Diplotaxion erucoidis e Fumarion wirtgenioagrariae), nei Sisymbrietalia officinalis (all. Hordeion leporini e ass. Chrozophoro tinctoriae- Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 59 Kickxietum integrifoliae) e nei Brometalia rubenti-tectorum (all. Echio-Galactition tomentosae). Negli eucalipteti si osserva una vegetazione riferibile all’Hordeion leporini per la frequenza di alcune caratteristiche di alleanza, come Hordeum leporinum, Carduus pycnocephalus e C. argyroa, alternata ad aspetti dell’Echio-Galactition, cui sono legati dinamicamente. Inoltre, si osservano specie subigrofile riferibili al Fedio-Convolvulion cupaniani. Altrove sono stati rilevati consorzi eterogenei caratterizzati da un’elevata frequenza di terofite caratteristiche dell’Hordeion leporini e dei Brometalia rubenti-tectori. Per questo motivo si è deciso di accostare la vegetazione erbacea del sottobosco degli eucalipteti a quella delle aree antropizzate. Specie guida: Anagallis arvensis, Anthemis arvensis, Astragalus hamosus, Borago officinalis, Brassica (nigra, rapa subsp. campestris), Capsella bursa-pastoris, Cardamine hirsuta, Cerastium glomeratum, Cerinthe major subsp. major, Chenopodium (album, murale, vulvaria), Convolvulus arvensis, Conyza bonariensis, Coronilla scorpioides, Crepis vesicaria, Cynoglossum creticum, Diplotaxis (erucoides, tenuifolia), Ecballium elaterium, Echium (italicum subsp. siculum, plantagineum), Erodium malacoides, Euphorbia (helioscopia, peplus s.l.), Fedia graciliflora, Fumaria officinalis subsp. wirtgenii, Galactites elegans, Geranium (dissectum, molle, purpureum, rotundifolium), Hedysarum coronarium, Kickxia spuria subsp. integrifolia, Lamium amplexicaule, Lathyrus (aphaca, ochrus), Lavatera trimestris, Lotus ornithopodioides, Malva (nicaeensis, sylvestris), Tetragonolobus purpureus, Theligonum cynocrambe, Torilis nodosa, Trifolium (nigrescens subsp. nigrescens, physodes), Urospermum (dalechampii, picroides), Urtica membranacea, Veronica (hederifolia, persica), Vicia (tetrasperma, villosa s.l.), ecc. Fumarion wirtgenio-agrariae Brullo 1985 Car. All.: Fumaria agraria, Fumaria officinalis subsp. wirtgenii, Linaria reflexa subsp. reflexa, Veronica hederifolia Ecologia: vegetazione delle erbe infestanti nelle colture invernali-primaverili dei vigneti. A questo syntaxon vanno ascritti gli aspetti di vegetazione primaverile infestante delle colture sarchiate, diffusa sino a 600-700 m s.l.m., nell’area climacica dell’Oleo-Ceratonion, del Quercion ilicis e dell’Erico-Quercion ilicis. Distribuzione nel SIC: presente nelle colture sarchiate (vigneti, uliveti, orti) e negli eucalipteti, verificato al Vallone Biviere all’interno del SIC (PASTA, 2006). Chrozophoro tinctoriae-Kickxietum integrifoliae Brullo et Marcenò 1980 Car. Ass. e All.: Diplotaxis erucoides, Helminthotheca echioides, Kickxia spuria subsp. integrifolia Ecologia: si tratta di una cenosi termofila, eliofila e marcatamente nitrofila, presente su suoli basici di varia natura (calcari, gessi, argille, marne, ecc.). Si riscontra frequentemente nelle colture permanenti (vigneti, mandorleti, uliveti) o erbacee (orti), è caratterizzata dalla predominanza di terofite e geofite bulbose o rizomatose e si sviluppa tra giugno e ottobre su terreni soggetti a periodiche lavorazioni del suolo e concimazioni. In Sicilia mostra di avere il suo optimum tra 0 e 800(900) m. s.l.m . È stata rilevata in provincia di Trapani presso Birgi, a Marsala, Mazara del Vallo, M. Cofano, nonché in diverse aree gessose come Milena, Campofranco, Serradifalco, ecc. Distribuzione nel SIC: probabilmente presente nelle colture sarchiate (vigneti, uliveti, orti) e negli eucalipteti presenti nel SIC, anche se durante il periodo d’indagine non è stato possibile verificare la presenza di Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 60 All’ordine Brometalia rubenti-tectoris ed all’alleanza Hordeion leporini vengono riferiti gli aspetti di vegetazione dominata da specie nitrofile opportuniste a ciclo annuale, tipiche delle colture estivo-autunnali e dei vigneti ad impronta ruderale, delle aree incolte, dei campi abbandonati o a riposo pascolativo. L’elevato numero di specie tipiche degli ambienti terofitici di tipo steppico rende conto della peculiarità ecologica e dell’aspetto marcatemente xerico e mediterraneo dei raggruppamenti subnitrofili che vengono riferiti a tali syntaxa di rango superiore. I consorzi riferiti invece all’alleanza Echio-Galactition tomentosae si rinvengono per lo più in aree incolte o a riposo pascolativo, dove si ha un particolare tipo di rotazione della cerealicoltura col pascolo brado di bovini e ovini. Il prato-pascolo che si insedia nei campi nell’anno in cui vengono a cessare le normali pratiche colturali (in particolare aratura e concimazione del terreno) risulta ricco di specie pabulari. Aspetti riconducibili a questa alleanza si rinvengono pure, sebbene più raramente, in stazioni ruderali come gli accumuli di macerie ed i bordi delle strade in aree suburbane, in condizioni di debole nitrificazione del suolo, mentre in caso di elevato apporto nitrico subentrano associazioni dell’Hordeion leporini (contesti ruderali e colture cerealicole). Aggruppamento a Dactylis hispanica e Elaeoselinum asclepium Si tratta di una comunità caratterizzata dalla ricchezza floristica e dal pregio floristico particolarmente elevati (cfr. Tab. 10.3). L’elevata frequenza e concomitanza di specie caratteristiche del Fedio-Convolvulion cupaniani (vedi oltre), dell’Echio-Galactition tomentosae (Galactites elegans, Centaurea sicula, Centaurea solstitialis subsp. schouwii, Verbascum sinuatum, Echium plantagineum, Medicago sp. pl., Hedysarum coronarium, Trifolium sp. pl., Vicia sp. pl., ecc.) e del Thero-Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925 (Dactylis glomerata s.l., Elaeoselinum asclepium subsp. asclepium, Kundmannia sicula, Bellis perennis, Ophrys sp. pl., Orchis sp. pl., ecc.), essa viene provvisoriamente collocata all’interno di questa alleanza. Per l’elevato numero di orchidee e di specie trasgressive dei Lygeo-Stipetalia, tale consorzio andrebbe forse riferito alle praterie perenni del TheroBrachypodion ramosi, verso cui in assenza di disturbo essa sembra poter evolvere nell’arco di pochi anni: si tratta dunque di una sorta di “habitat incipiente”. Fedio-Convolvulion cupaniani Brullo et Spampinato 1986 Car. All.: Brassica rapa subsp. campestris, Cerinthe major subsp. major, Convolvulus tricolor subsp. cupanianus, Fedia graciliflora, Geranium dissectum, Medicago intertexta, Melilotus infestus, Ranunculus ficaria subsp. ficariiformis, Scorpiurus vermiculatus, Tetragonolobus purpureus. Ecologia: vegetazione tardo-vernale subnitrofila tipica di substrati marnosi e argillosi, si rinviene per lo più nei vigneti, in aree incolte o ai bordi delle strade e sentieri di campagna. Nonostante l’eterogeneità degli ambienti in cui si rinviene, essa mostra una notevole omogeneità floristica, probabilmente dovuta alla peculiarità edafica. I prati che forma sono infatti caratterizzati da un ricco contingente di terofite adattate agli ambienti argillosi e limosi, pesanti ed un pò asfittici, umidi o addirittura inondati d’inverno, marcatamente xerici e fessurati d’estate. Gli aggruppamenti locali andrebbero forse interpretati come aspetti impoveriti dell’Ononido alopecuroidi-Vicietum siculae Brullo e Marcenò 1985a, di cui sono effettivamente presenti due specie caratteristiche, Daucus muricatus e Ononis alopecuroides subsp. exalopecuroides. Si tratta di un’associazione nitrofila tipica di stazioni collinari soggette a clima di tipo mesomediterraneo, diffusa in tutta la Sicilia centroccidentale (Monti di Palermo, Nisseno, Ficuzza e Corleonese), legata a stazioni quali i bordi e le scarpate che fiancheggiano strade e sentieri di campagna, su substrati marnosi e argillosi, con suoli abbastanza freschi ed umidi nel periodo primaverile; spesso essa risulta topograficamente e Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 61 dinamicamente connessa con formazioni ad Arundo collina nei tratti a maggiore pendenza e ad aspetti a Festuca arundinacea in quelli pianeggianti (BRULLO & SPAMPINATO, 1986). Vegetazione a megaforbie sciafilo-nitrofile (colture arboree e margini di boschi) All’ordine Urtico-Scrophularietalia peregrinae e all’alleanza Allion triquetri vanno riferiti gli aspetti sciafili e nitrofili rinvenuti all’ombra degli arbusteti e nel sottobosco della macchia ad alloro, mentre gli aspetti più igrofili andrebbero forse ascritti all’ordine Convolvuletalia sepium ed all’alleanza Senecionion fluviatilis. Specie guida: Calystegia sylvatica, Galium aparine, Smyrnium olusatrum, Urtica membranacea, ecc. Acantho mollis-Smyrnietum olusatri Brullo et Marcenò 1985 Car. Ass.: Acanthus mollis e Smyrnium olusatrum Ecologia: consorzio termofilo tipico delle aree suburbane, urbane o rurali, si sviluppa in stazioni ombreggiate, in prossimità dei muri o sotto la chioma degli alberi. Tipico dei giardini abbandonati e delle zone archeologiche, si riscontra spesso in prossimità di casolari di campagna o di agglomerati rurali. Realizza coperture molto dense e si osserva tra 25 e 550 m s.l.m. Distribuzione nel SIC: questo consorzio si riscontra nelle aree più ombrose al di sotto dei frutteti, delle formazioni di mantello e come sottobosco della macchia ad alloro e dei nuclei di ripisilva a salici e pioppi della forra del Torrente Biviere. Aggruppamento ad Arundo donax Ecologia: vegetazione anfibia dei tratti esterni e poco profondi delle sponde dei fiumi e degli stagni a regime idrico lento e variabile con tenore trofico medio-elevato e scarso tenore d’ossigeno nella stagione secca. Frequente anche nei canali e nei fossati del piano basale (tra 0 e 350 m s.l.m.), forma abitualmente popolamenti molto densi (copertura 80-100%). Distribuzione nel SIC: si riscontra su una sponda dell’invaso artificiale. Vegetazione microfitica sciafilo-nitrofila delle radure delle formazioni pre-forestali e forestali All’alleanza Valantio-Galion muralis vanno riferiti gli aspetti di vegetazione naturale microfitica annuale sciafilo-nitrofila a ciclo primaverile. L’habitat ideale di questo consorzio sono le superfici poste sotto la chioma degli alberi ed arbusti più periferici delle stazioni di macchia e di mantello (riferibili alle allenze Quercion ilicis, Oleo-Ceratonion e Pruno-Rubion ulmifolii; aspetti riferibili a questo consorzio seminaturale, il cui apporto nitrico è garantito da residui vegetali ed animali, sono frequenti anche sulle pareti rocciose o sui muretti degli stessi ambienti. Questa tipologia di vegetazione effimera si riscontra di frequente sotto il mantello a Rhus coriaria lungo il lato meridionale del Vallone Biviere. Specie guida: Centranthus calcitrapae, Cardamine hirsuta, Geranium purpureum, Geranium rotundifolium, Theligonum cynocrambe, Torilis nodosa, ecc.. Vegetazione delle praterie perenni e annue Consorzi terofitici basifili I consorzi effimeri di erbe annue sono comuni nelle radure nel mosaico costituito dalla gariga a labiate e dalle praterie a graminacee perenni (Ampelodesmos mauritanicus o Hyparrhenia hirta), mentre costituiscono praterelli pressocché puri in corrispondenza di “isole” di affioramenti gessosi. Esempi tipici ed interessanti si trovano disseminati su suoli sottili e rocciosi nelle aree soleggiate di tutta l’area SIC. Tale tipologia di vegetazione presenta un’elevata ricchezza floristica ed ospita numerose camefite succulente, geofite bulbose e terofite (scapose e succulente) di grande interesse scientifico-conservazionistico. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 62 Questi consorzi, fortemente condizionati dalla natura chimica e fisica del substrato geologico per la quasi completa mancanza di suolo, vanno ascritti alla classe Stipo-Trachynietea distachyae e, più precisamente, all’ordine Stipo-Trachynietalia distachyae (BRULLO, 1985). Essi partecipano alla “Pseudosteppa con erbe perenni ed annue dei Thero-Brachypodietea” (cod. 6220), habitat prioritario ai sensi della Direttiva 92/43 CEE (cfr. Tab. 5.1). Specie guida: Aira caryophyllea subsp. caryophyllea, Arenaria leptoclados, Asterolinon linum-stellatum, Trachynia distachyos, Briza maxima, Catapodium rigidum subsp. rigidum, Cynosurus (echinatus, effusus), Evax pygmaea, Hedypnois rhagadioloides, Hedysarum glomeratum, Hippocrepis multisiliquosa, Hyoseris scabra, Hypochoeris achyrophorus, Lagurus ovatus subsp. ovatus, Linaria reflexa subsp. reflexa, Lotus edulis, Ononis sieberi, Phleum echinatum, Plantago (lagopus, serraria), Romulea ramiflora, Rumex bucephalophorus s.l., Salvia viridis, Senecio leucanthemifolius, Sideritis romana, Silene (colorata, gallica), Stipa capensis, Tordylium apulum, Trifolium (angustifolium, cherleri, stellatum), Vulpia ciliata, ecc. Thero-Sedetum caerulei Brullo 1975 em. Brullo in Bartolo, Brullo et Marcenò 1982 Car. Ass.: Arenaria leptoclados, Pedimus stellatus, Plantago afra subsp. zwierleinii, Sedum rubens e Sedum caeruleum. Ecologia: vegetazione microfitica delle piccole conche in cui uno strato di terriccio dello spessore di appena 1 cm copre la roccia madre inalterata (di natura carbonatica, gessosa o basaltica). Di norma colonizza il substrato in seguito alla formazione di cenosi pioniere di muschi e licheni. Questo consorzio appare legato dinamicamente sia all’aggruppamento a Stipa capensis, diffuso qua e là nei contesti più soleggiati della riserva, sia alle garighe dominate da Coridothymus capitatus (vedi oltre). Nella riserva sono stati osservati aspetti riconducibili a tre varianti: a Rumex bucephalophorus s.l., a Sedum stellatum (già citata da BRULLO et alii, 1982 per ambienti ombreggiati e riparati dal vento, come gli spuntoni di roccia ricoperti da muschio) o a Petrorhagia saxifraga (ampi affioramenti rocciosi soleggiati e ventilati). Distribuzione nel SIC: rupi ombrose esposte a settentrione del versante meridionale del Vallone Biviere e di M. Finestrelle. All’ordine Stipo-Bupleuretalia semicompositi (Car. Ord.: Bromus fasciculatus, Crupina crupinastrum, Polygala monspeliaca, Scorzonera deliciosa, ecc.) e, più precisamente, all’alleanza Sedo-Ctenopsion gypsophilae vengono riferiti i prati xerici effimeri, fedeli a substrati gessosi in assenza pressocché completa di suolo e con frequente copertura lichenica del Mediterraneo centro-occidentale, finora noti per la Sicilia e Spagna ma certamente presenti sugli stessi substrati nell’area maghrebina (BRULLO, 1985, IZCO et alii, 1986). Nel SIC in esame tali syntaxa di rango superiore sono rappresentati dalle cenosi illustrate qui di seguito: Aggruppamento a Filago eriocephala e Medicago minima Comunità microfitica dei piccoli dossi gessosi. Di norma colonizza contesti piuttosto soleggiati ed inclinati e prende contatto sia con gli altri aggruppamenti terofitici sia con gli aspetti del Valantio-Galion muralis sia con la gariga a labiate (vedi oltre). Distribuzione nel SIC: rupi e macerie gessose del Vallone Biviere e di M. Castellaccio. Aggruppamento a Sedum gypsicola e Sedum sediforme In corrispondenza delle guglie e degli spuntoni rocciosi la comunità precedente cede spazio a camefite succulente come Sedum gypsicola, specie nota solo per la Sicilia e la Spagna (BRULLO et alii, 1989) e legata esclusivamente ai substrati gessosi, e Sedum sediforme. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 63 All’alleanza Plantagini-Catapodion marini vanno attribuiti invece i praterelli xerici effimeri caratterizzati dalla dominanza di specie precoci a breve ciclo vegetativo, diffusa per lo più in stazioni costiere e raramente all’interno delle regioni del Mediterraneo centro-occidentale (Sicilia, Sardegna, Corsica, Italia meridionale, Francia meridionale e Baleari). Si tratta di consorzi pionieri indifferenti alla natura geolitologica del substrato ma fedeli a suoli leggermente salati a causa della prossimità al mare o a stagni salmastri, o ancora ad affioramenti ricchi in sali. Aggruppamento a Stipa capensis Sugli orli pianeggianti intorno alla valle cieca del Biviere si osservano aspetti effimeri dominati da queste due graminacee e nobilitati dalla presenza di Echinaria capitata subsp. todaroana e numerose altre terofite xerofile. Aggruppamento a Hedysarum glomeratum Su substrati gessosi alquanto alterati, ma anche su quelli marnoso-sabbiosi, si rinvengono dei praterelli terofitici particolarmente ricchi, fisionomizzati da Hedysarum glomeratum, cui si accompagnano specie spesso Parentucellia latifolia, Medicago minima, Helianthemum salicifolium, e diverse altre entità tipiche degli Stipo-Trachynietea, quali Trifolium scabrum, Hypochoeris achyrophorus, Trachynia distachyos, ecc. Tali aspetti tendono generalmente ad evolvere verso praterie ad Elaeoselinum asclepium o verso le formazioni dell’AstragaloAmpelodesmetum mauritanici, mentre laddove il terreno diviene più superficiale vengono sostituiti da aspetti del Thero-Sedetum caerulei. In prossimità degli ambienti rupestri gessosi, si arricchiscono talora della presenza di Sedum gypsicola. Consorzi delle praterie termoxerofile perenni a dominanza di geofite Alla classe Poëtea bulbosae, all’ordine Poëtalia bulbosae ed all’alleanza Leontodonto tuberosi-Bellidion sylvestris vengono riferiti i consorzi a geofite bulbose e tuberose che partecipano al mosaico di prateria perenne e annua delle zone pascolate soggette a clima mediterraneo e submediterraneo d’Italia (BIONDI et alii, 2001). Tali consorzi rivestono grande interesse per il pregio biogeografico e conservazionistico di molte delle specie che vi partecipano, e mostrano una sorta di “doppia stagionalità”, poiché molte geofite possiedono un ciclo serotino mentre altre sono tardo-vernali o primaverili. Aggruppamento a Charybdys pancration e Asphodelus ramosus Dove il sovrappascolo e la frequenza degli incendi hanno comportato una forte erosione del mosaico di prateria a graminacee perenni e della gariga a labiate si registra la presenza di una prateria perenne degradata dominata da geofite come Charybdys maritima e Asphodelus ramosus frammista a praterelli terofitici ricchi di specie trasgressive degli incolti. Aspetti simili si osservano soprattutto lungo i margini settentrionali della riserva naturale. Vegetazione delle praterie termo-xerofile perenni a dominanza di emicriptofite La classe Lygeo-Stipetea raggruppa le praterie xerofile perenni del Mediterraneo. L’ordine Hyparrhenetalia hirtae include gli aspetti tipici degli affioramenti rocciosi, che prediligono le stazioni ben protette dai venti. Specie guida: Ampelodesmos mauritanicus, Asphodelus ramosus, Pallenis spinosa, Bituminaria bituminosa, Foeniculum vulgare subsp. piperitum, Hyoseris radiata, Lobularia maritima, Magydaris pastinacea, ecc. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 64 All’alleanza Avenulo-Ampelodesmion mauritanici vanno riferiti gli ampelodesmeti disturbati che si possono osservare sui versanti più acclivi e rocciosi del comprensorio. Essi derivano dalla distruzione degli aspetti forestali originari e sono dinamicamente connessi con la gariga a Coridothymus capitatus. In varie aree della Sicilia gli ampelodesmeti costituiscono un vero e proprio disclimax (MARCENÒ & COLOMBO, 1982; MINISSALE, 1995). Astragalo huetii-Ampelodesmetum mauritanici Minissale 1995 Car. Ass.: Astragalus huetii Ecologia: confinato nei terreni non coltivabili (pendici impervie e affioramenti gessosi), l’ampelodesmeto rappresenta spesso il consorzio con più alto grado di naturalità all’interno della riserva. Presente su substrati calcareo-marnosi e calcareo-gessosi su suolo molto esiguo, in aree con precipitazioni medie annue di 500-600 mm e temperature medie annue di 16-18° C, questa formazione deriva per degradazione dai consorzi della Quercetalia ilicis e dell’Oleo-Ceratonion o da aspetti di gariga riferibili al Cisto-Ericion. È noto per diverse località della Sicilia centro-meridionale e sud-occidentale. Distribuzione nel SIC: aspetti riferibili a questa cenosi sono diffusi sui versanti inclinati adiacenti al Vallone Biviere e al torrente Biviere e frequenti anche nei rimboschimenti giovani e/o radi a conifere. In realtà però Astragalus huetii è ben più localizzato, mentre più frequente è una facies piuttosto impoverita, probabilmente a causa del frequente ripetersi degli incendi. Localmente frequente e significativa in termini di biomassa appare la presenza di Teucrium flavum, per cui viene proposta una subass. teucrietosum flavi n. provv., negli anni scorsi rinvenuta peraltro anche altrove nel comprensorio di Santa Ninfa e Gibellina (es.: Loc. M. Coco e Buturro). All’alleanza Hyparrhenion hirtae (Car. All.: Hyparrhenia hirta s.l., Andropogon distachyos, Convolvulus althaeoides, Phagnalon saxatile s.l., Lathyrus clymenum s.l., Micromeria graeca s.l., Physanthyllis tetraphylla) vanno invece riferiti i consorzi presenti in aree più esposte e degradate, su spessori di suolo ancor più sottili. Il più delle volte si tratta di aspetti pesantemente disturbati dal pascolo ovi-caprino, che è stato tuttavia possibile attribuire alle seguenti due fitocenosi: Thapsio garganicae-Feruletum communis Brullo 1984 Car. Ass.: Ferula communis, Thapsia garganica, Hippomarathrum siculum Ecologia: consorzio alquanto termoxerofilo, piuttosto diffuso nelle aree incolte di Sicilia, caratterizzate da estesi affioramenti rocciosi, limitatamente a stazioni ben protette dai venti (margini di macchia o dei valloni), predilige stazioni costiere, anche se si rinviene nei contesti più caldi della Sicilia interna, soprattutto negli ambienti marnoso-argillosi dell’Agrigentino e del Nisseno e sulle vulcaniti delle pendici occidentali etnee. Per la sua spiccata xerofilia è parso più appropriato collocare quest’associazione nell’alleanza Hyparrhenion hirtae anziché nel Bromo-Oryzopsion. Resta da chiarire se il Cachryo (= Hippomarathro) siculiHyparrhenietum hirtae, associazione menzionata da BRULLO et alii (2001) e mai pubblicata sia o meno una facies xerica di quest’associazione. Distribuzione nel SIC: tende a svilupparsi in contesti aperti e disturbati in corrispondenza di litosuoli esigui su substrati gessosi con discreto tenore di argilla. Forma nuclei in aree subpianeggianti con forte rocciosità affiorante, ad esempio ai margini meridionali e settentrionali della valle cieca del Biviere. Sanguisorbo verrucosae-Magydaretum pastinaceae Bartolo, Brullo, Minissale et Spampinato 1990 Car. Ass.: Magydaris pastinacea, Sanguisorba minor s.l. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 65 Ecologia: questa prateria discontinua, tipica dei substrati sassosi o dei suoli a tessitura grossolana, è stata descritta per Lampedusa da BARTOLO et alii (1990), che la citano anche per la Sicilia nordoccidentale e le Egadi. Distribuzione nel SIC: forma lembi di vegetazione subnitrofila e subigrofila a carattere glareicolo molto localizzati; questi si rinvengono presso l’inghiottitoio, alla base delle pareti subverticali che cingono la vale cieca del Biviere, e in ambienti analoghi poco a Nord dell’invaso artificiale. Nei contesti disturbati e dove si verifica un’intenso sovrappascolo, è possibile osservare diversi consorzi pseudosteppici subnitrofili riferibili all’alleanza Bromo-Oryzopsion miliaceae. Gli aspetti più omogenei sono stati riferiti ad una nuova associazione: Euphorbio ceratocarpae-Arundinetum collinae n. provv. Car. Ass.: Euphorbia ceratocarpa Ecologia: diffuso in diverse località interne della Sicilia centro-occidentale, tra 100 e 700 m s.l.m., nell’area climacica del Quercion ilicis (S. Pasta, oss. pers.), questo consorzio penetra marginalmente nell’area dell’Oleo-Ceratonion. Si insedia per lo più sugli argini superiori di torrenti che scorrono in terreni argillosi, argilloso-sabbiosi o argilloso-conglomeratici, realizzando il più delle volte dense coperture (80-100%). Distribuzione nel SIC: diffuso in corrispondenza dei margini del Torrente Biviere sino al suo sbocco nella valle cieca, dove prende contatto sia con i consorzi pionieri del FedioConvolvulion cupaniani, sia con gli aspetti di mantello (Pruno-Rubion ulmifolii) sia con i canneti a Phragmites australis. Aggruppamento a Calendula suffruticosa subsp. fulgida Consorzio paucispecifico e poco strutturato, probabilmente insediatosi da poco sul materiale sciolto di natura calcarea usato per ricoprire lo spiazzo orizzontale usato per le manovre e la sosta dei mezzi della forestale nel sito in cui è stata edificata una torretta di controllo su M. Finestrelle. Vegetazione pre-forestale e forestale zonale Vegetazione suffruticosa delle garighe basifile La gariga a timo arbustivo, pertinente alla classe Cisto-Micromerietea julianae, all’ordine Cisto-Ericetalia e all’alleanza Cisto-Ericion multiflorae, è la formazione più espressiva dell’area considerata ed è ricca di specie ad elevata valenza biogeografica. Allo stato attuale costituisce la forma più matura di copertura presente sui versanti acclivi e rocciosi del SIC. Se non risentisse del disturbo dovuto al pascolo e al rimboschimento, tenderebbe ad innescare processi di ricostituzione della macchia secondaria. Nelle zone più elevate del SIC sono stati rilevati aspetti di mosaico di prateria perenne e gariga a labiate “nobilitati” dalla presenza di specie di un certo interesse biogeografico, come Carthamus pinnatus subsp. pinnatus e Thymus spinulosus, la cui presenza suggerisce che il comprensorio in esame avrebbe (o ha avuto in passato) le potenzialità per ospitare Carduncello pinnati-Thymetum spinulosi Brullo et Marcenò in Brullo 1984, prateria discontinua ad emicriptofite e camefite a chiara impronta oromediterranea affine a quelle diffuse sui principali sistemi montuosi dell’isola e riferite alla classe endemica RumiciAstragaletea siculi Pignatti et Nimis in E. Pignatti et al. 1980 em. Mucina 1997 (BRULLO, 1984; PIGNATTI et alii, 1980; BRULLO et alii, 2005; SCUDERI, 2006). Specie guida: Carlina gummifera, Cistus creticus s.l., Corydothymus capitatus, Micromeria graeca s.l., Micromeria fruticulosa, ecc. Micromerio fruticulosae-Coridothymetum capitati n. provv. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 66 Diff. Ass.: Asperula aristata subsp. scabra e Odontites rigidifolius. Ecologia: la composizione floristica del consorzio rilevato risulta del tutto originale rispetto a quelli descritti in precedenza per il territorio siciliano (BRULLO et alii, 1997). Come differenziali locali di associazione vengono designate due piante a ciclo vegetativo estivale, la cui ecologia rispecchia efficacemente la marcata xericità del biotopo colonizzato da questa tipologia di gariga. All’interno di questa formazione si rinvengono qua e là nuclei di Agave americana del tutto naturalizzata. Distribuzione nel SIC: presente in maniera discontinua a causa del pascolo e dell’attività di rimboschimento, la gariga è maggiormente diffusa sulla destra idrografica del torrente Biviere e sulle creste di C.da Cappellone, Campanaro, Montagna, soprattutto in corrispondenza delle rotture di pendio, dove prevale sulle formazioni di prateria xerica e prende talora contatto con i consorzi casmofitici. Aggruppamento a Cistus creticus Si tratta di un nucleo non cartografabile localizzato ai margini settentrionali del SIC a ovest della montagna della Magione tra casa Paternò e montagna della Magione; esso si differenzia dai suddetti aspetti di gariga solo per la prevalenza di Cistus creticus. Vegetazione della macchia-foresta sempreverde mediterranea Questi aspetti vengono riferiti alla classe Quercetea ilicis, boschi di leccio e, probabilmente, di quercia castagnara (Quercus virgiliana), dovettero un tempo essere presenti nel comprensorio, come sembra suggerire la presenza di qualche individuo di quest’ultima specie alle porte di Santa Ninfa (S. Pasta, ined.), a Salemi, a Castelvetrano ed a Partanna (W.W.F. GRUPPO ATTIVO DI PARTANNA, 1995; SCUDERI, 2006; PASTA et alii, 2008). Individui isolati di leccio sono stati peraltro osservati nel territorio di Santa Ninfa sia a Rocca delle Penne (S. Pasta, A. Dimarca, G. Casamento e T. La Mantia, primavera 2005) sia all’interno del SIC nelle balze rocciose che dominano le Case della Magione durante i sopralluoghi primaverili. Nello stesso comprensorio l’odierna presenza di diversi toponimi con “Pionica” (nome siciliano di Paeonia mascula L.) suggeriscono che in tempi non troppo remoti vi fossero contesti idonei alla sussistenza di specie esclusive (e quindi di lembi) di lecceto e/o di querceto semideciduo. Specie guida: Anagyris foetida, Asparagus acutifolius, Chamaerops humilis, Clematis cirrhosa, Cyclamen repandum, Euphorbia dendroides, Laurus nobilis, Lonicera (etrusca, implexa), Osyris alba, Pistacia (lentiscus, terebinthus), Prasium majus, Quercus ilex, Rosa sempervirens, Ruta chalepensis, Smilax aspera, Teucrium fruticans. Aggruppamento a Laurus nobilis La presenza di diverse specie caratteristiche dei Quercetalia ilicis e del Quercion ilicis (Asparagus acutifolius, Carex distachya, Clematis cirrhosa, Lonicera implexa, Osyris alba, Prasium majus, Rosa sempervirens, ecc.) avvalora l’ipotesi che almeno parte del comprensorio fosse un tempo ricoperta dalla macchia-foresta sempreverde. Queste specie convivono nel fitto popolamento di alloro presente nella porzione più incassata del Torrente Biviere. Le informazioni sull’ecogeografia dell’alloro (GIACOBBE, 1939; RAIMONDO et alii, 1981; PASTA & TROÌA, 1994) ci inducono a non escludere a priori che il nucleo sia autoctono, come suggerisce peraltro il suo perfetto inserimento nel contesto in esame e la presenza di ambienti analoghi anche in C.da Stretto a Partanna. Qui come altrove in Sicilia questa essenza sembra prediligere microambienti umidi, mescolandosi ad essenze decidue tipiche dei climax forestali mesofili. Come già sottolineato da SCUDERI (2006), il carattere sporadico e relittuale di questo tipo vegetazionale non permette di pervenire ad un’attribuzione sintassonomica certa; in ragione Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 67 del forte grado di antropizzazione delle aree in cui si rinvengono i lembi superstiti, non è apparso opportuno spingersi oltre nell’inquadramento fitosociologico di questo aggruppamento. La presenza sporadica di Hedera helix suggerirebbe di attribuire tale consorzio all’Hedero helicis-Lauretum nobilis Bueno et Fernándes Prieto 1991, associazione dell’alleanza Arbuto unedonis-Laurion nobilis Rivas-Martínez, Fernández-González et Loidi 1999 già segnalata in Sicilia da BRULLO et alii (2001). Se soggetta a disturbo, la macchia ad alloro degrada verso arbusteti del Rubo ulmifolii-Tametum communis, mentre per evoluzione naturale potrebbe tendere verso il Lauro nobilis-Quercetum ilicis (Br.-Bl. 1967) RivasMartínez 1975, formazione forestale a Quercus ilex e Laurus nobilis. Si pone in risalto il fatto che la macchia a Laurus nobilis figura nella lista degli habitat prioritari della Direttiva 92/43 CEE: “Matorral arborescente con Laurus nobilis” (cod. 5230). Euphorbio dendroidis-Anagyridetum foetidae subass. artemisietosum arborescentis Biondi et Mossa 1992 Diff. Subass.: Anagyris foetida e Artemisia arborescens Ecologia: macchia discontinua ad euforbia ad alberello, olivastro e carrubbazzo, interpretabile come vicariante subnitrofila e marcatamente xerofila del Rhamno alaterni-Euphorbietum dendroidis (Trinajstič 1973) 1984 em. Géhu et Biondi 1987. Colonizza balze rocciose gessose e disturbate dall’incendio e dal pascolo ovi-caprino. Distribuzione nel SIC: localizzata sulle rupi esposte a Nord di C.da La Menta (di cui Brassica rupestris subsp. rupestris colonizza nel cenge) e in una ridotta area di C.da Castellaccio esposta a Sud. Aggruppamento a Chamaerops humilis In corrispondenza del limite nord-occidentale del SIC è stata invece rilevata una formazione di macchia rada a palma nana; si tratta di lembi residuali che possono essere interpretati come aspetti impoveriti del Pistacio lentisci-Chamaeropetum humilis Brullo et Marcenò 1985b: tale ipotesi appare rafforzata dal fatto che a poca distanza vegetano sporadici individui di Pistacia lentiscus, che tuttavia non partecipano a questo aggruppamento. In corrispondenza di questa formazione è stato riscontrato un cospicuo popolamento di Astragalus huetii. Vegetazione arbustiva dei margini del bosco termo- e mesomediterraneo (“mantello”) L’area del SIC ospita diverse specie legnose tipiche dei consorzi forestali e pre-forestali decidui ad impronta europea. Legato dinamicamente ai termini più mesofili del Quercion ilicis, il mantello, riferibile alla classe Rhamno-Prunetea, ospita attualmente la maggior parte delle specie legnose arbustive autoctone. Esso è caratterizzato dalla preponderanza di arbusti, frutici e alberelli decidui come quelli sotto elencati. Specie guida: Clematis vitalba, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa (canina, micrantha), Rubus ulmifolius, Spartium junceum, Ulmus minor. Dove le sponde del Torrente Biviere si presentano più accidentate e acclivi, sì da conferirgli un aspetto di forra, osserviamo lembi di mantello strutturalmente e floristicamente impoveriti, riferibili ai Prunetalia spinosae. Si tratta di aggruppamenti arbustivi radi che derivano probabilmente dal degrado di consorzi forestali del climax originario. Il più delle volte si tratta di consorzi paucispecifici sciafili e subnitrofili dominati da Rubus ulmifolius. In alcuni piccoli impluvi posti sulla destra idrografica del torrente Biviere, sotto le rupi esposte a Nord di C.da Menta e sotto la vetta del Cappellone si rinvengono lembi di mantello a Ulmus minor, presenti anche a ridosso dell’inghiottitoio, mentre a Nord e a Sud della valle cieca del Biviere, in C.da Castellaccio e sulle pendici meridionali di M. Finestrelle si osservano densi popolamenti di Rhus coriaria e/o Rubus ulmifolius e/o Prunus spinosa. Molto Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 68 spesso corrispondono ad ex-coltivi (soprattutto ex-frutteti), un tempo realizzati in corrispondenza di piccole vallecole incassate e protette dal sole e dal vento. Oggi questi consorzi sono sempre più spesso colonizzati - e rapidamente sostituiti - da popolamenti monofitici ad Ailanthus altissima. Nella parte incassata del Torrente Biviere, in corrispondenza dei lembi di macchia ad alloro e dei nuclei di ripisilva a salici e pioppi si osservano aspetti di mantello a liane difficili da cartografare e da tipificare: in particolare, si osserva un aggruppamento a Rubus ulmifolius e Smilax aspera e, nei contesti più freschi ed ombrosi, aspetti riferibili al Rubo ulmifoliiTametum communis R. Tx. in R. Tx. et Oberdorfer 1958. Rubo ulmifolii-Dorycnietum recti Brullo, Minissale, Scelsi et Spampinato 1993 Car. Ass.: Dorycnium rectum Ecologia: densa formazione spiccatamente igrofila di nanofanerofite lianose su piccoli dossi ed alla base di scarpate che circondano bacini e piccoli corsi d’acqua; si riscontra nella fascia climacica potenziale delle formazioni boschive neutrocline ed acidofile dell’Oleo-Ceratonion e, marginalmente del Quercion ilicis. Costituisce spesso una cintura di collegamento tra le comunità dei Populetalia albae e dei Phragmitetalia e colonizza aree temporaneamente inondate e chiuse superiormente da scarpate. Nel Trapanese questa cenosi era già nota per i Gorghi Tondi e Lago Preola (BRULLO & RONSISVALLE, 1975) e per il canyon della Riserva Zangara a Castelvetrano (PASTA et alii, 2008). Vegetazione forestale azonale Consorzi mesoigrofili decidui Nell’area del SIC è presente Tamarix africana, specie caratteristica della classe NerioTamaricetea Br.-Bl. et O. de Bolòs 1958, che racchiude tutte le ripisilve termoigrofile pioniere mediterranee. Tuttavia, i popolamenti osservati non presentano un’estensione significativa e non formano consorzi né stabili né omogenei, per cui non vengono trattati né nel testo che segue né vengono rappresentati su carta. Alcuni nuclei di vegetazione arborea ripariale, dominati dai pioppi e dal salice pedicellato e talora, dal frassino ossifillo, presenti per lo più in corrispondenza del Torrente Biviere, vanno invece riferiti all’ordine Populetalia albae e alla classe Querco-Fagetea (BRULLO & SPAMPINATO, 1991). In Sicilia essi popolano il più delle volte le valli strette, profonde e molto inclinate, con microclima fresco, tipiche dell’alto corso dei fiumi. Contrariamente a quanto ipotizzato da PASTA & LA MANTIA (2001a), l’origine autoctona dei nuclei di vegetazione forestale igrofila appare supportata dalla presenza, discontinua ma diffusa, di aspetti analoghi non solo in diverse località interne della provincia di Trapani ma anche nel SIC (C.da Castellaccio e presso Case Magione) e, con aspetti davvero interessanti e meritevoli di essere inseriti nel SIC, nell’impluvio (C.da Varuari) che corre parallelo ai margini orientali di quest’ultimo. Queste formazioni vanno tutelate per il loro ruolo idrogeologico e faunistico; allo stato attuale, peraltro, esse appaiono perfettamente inserite nel paesaggio del SIC. Specie guida: Arum italicum, Populus (alba, nigra), Salix pedicellata. Ulmo canescentis-Salicetum pedicillatae Brullo et Spampinato 1991 Car. Ass.: Ulmus canescens Ecologia: il bosco misto di pioppo bianco, pioppo nero e salice pedicellato rappresenta in Sicilia un aspetto di vegetazione arborea mesoigrofila a carattere azonale spinto. Questa formazione si riscontra all’interno del macroclima mediterraneo, normalmente tra 400 e 700 m s.l.m., nella fascia climacica della Quercetea ilicis e, talora, della Quercetea calliprini, Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 69 dove tende a formare delle bordure molto strette lungo i corsi d’acqua, con un sottobosco pressoché impenetrabile. L’associazione in esame è alquanto frequente in Sicilia centrooccidentale (Monti di Palermo, Trapanese al Torrente Salemi, Madonie e Monti Sicani). Distribuzione nella riserva: se ne riscontrano due piccoli tratti con un livello di integrità medio-alto all’interno della parte incassata del Torrente Biviere ed uno semplificato e più antropizzato nelle adiacenze della polla della valle cieca omonima. L’analisi della Carta della Vegetazione (Tavola 8) mette in evidenza che ben 2/3 del paesaggio locale sono contraddistinti da incolti in evoluzione (all. Echio-Galactition e FedioConvolvulion cupaniani), da consorzi nitrofili (Fumarion wirtgenii-agrariae, Diplotaxion erucoidis) e ruderali (Parietarion judaicae, Onopordion illyrici, Bromo-Oryzopsion miliaceae, Hordeion leporini) legati ai rimboschimenti e alle colture permanenti o da comunità segetali legate alle colture ceralicole (all. Ridolfion segeti). Il restante 30% del territorio del SIC è caratterizzato da un mosaico spesso discontinuo e frammentato di consorzi che contribuiscono in misura diversa alla fisionomia del paesaggio seminaturale locale. Particolarmente frammentaria e discontinua appare la vegetazione fluviale, rupicola e degli affioramenti rocciosi. Comprendere le potenzialità dinamiche del territorio in esame facilita una lettura “in prospettiva” delle informazioni contenute nella Carta della Vegetazione, permettendo inoltre l’accorpamento delle unità di vegetzione censite in una prospettiva dinamica. A tal proposito, nel SIC è possibile individuare diverse serie di vegetazione a forte condizionamento edafico: Serie termoxerofila degli affioramenti e dei litosuoli gessosi, costituita da un mosaico di praterelli terofitici (all. Plantagini-Catapodion marini e Sedo-Ctenopsion gypsophilae) e che può progredire verso praterie a Hyparrhenia hirta (all. Hyparrhenion hirtae) e garighe (all. Cisto-Ericion multiflorae) sino a costituire cenosi di macchia termofila nei contesti più acclivi, rocciosi e soleggiati (all. OleoCeratonion: Pistacio-Chamaeropetum humilis, Rhamno-Euphorbietum dendroidis). Serie edafoigrofila dei suoli argillosi delle aree di compluvio, la cui evoluzione è meno prevedibile. La prateria subnitro-igrofila ad Arundo collina ed Euphorbia ceratocarpa (all. Bromo-Oryzopsion miliaceae) può evolvere verso cenosi arbustive di mantello (all. Pruno-Rubion ulmifolii) sino all’ingresso delle specie della ripisilva (all. Populion albae). Serie mesoxerofila dei litosuoli e dei suoli bruni gessosi, per successione progressiva i praterelli terofitici (all. Trachynion distachyae) e probabilmente gli incolti (EchioGalaction tomentosae) possono evolversi verso praterie ad Ampelodesmos mauritanica (all. Avenulo-Ampelodesmion), garighe a labiate (all. Cisto-Ericion multiflorae) sino alla formazione di aspetti di macchia-foresta (Quercion ilicis: OleoQuercetum virgilianae?). Questo dinamismo interessa anche i coltivi abbandonati dove, avvalendosi di suoli più profondi, lo stadio intermedio può essere dominato da aspetti paucispecifici di mantello (all. Pruno-Rubion ulmifolii). Si precisa che: - i nuclei di macchia bassa ad alloro circoscritti al fondo del Torrente Biviere hanno un significato del tutto avulso dalle serie suaccennate; - legate esclusivamente alla presenza della polla sono le comunità idrofitiche (all. Charion fragilis) e igrofile (all. Mentho-Juncion); - le comunità anfibie e subnitrofile a canne (Phragmition australis) sono sporadiche lungo le sponde del Torrente Biviere, della polla e dell’invaso artificiale e Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 70 potrebbero forse evolvere in boscaglie termoigrofile pioniere (all. Tamaricion africanae). 2.3.1.4 Descrizione degli habitat rinvenuti e commento alla Carta degli Habitat (B.3.4) Nelle seguenti tabelle si riportano le informazioni relative agli habitat del SIC ITA010022 contenute nella Scheda Natura 2000 (versione dicembre 2005) e nella relazione di commento della Carta degli Habitat redatta da Agristudio s.r.l. Habitat presenti nel SIC ITA010022 (dati da Scheda Natura 2000 – versione 2005). Superficie Codice e denominazione degli habitat indicati nel Formulario Standard Natura 2000 (ha) % 3170* - Stagni temporanei mediterranei 1,0 5331 - Formazioni ad Euphorbia dendroides 10,0 5332 - Garighe dominate da Ampelodesmos mauritanicus 30,0 5333 - Macchia rada a Chamaerops humilis 1,0 6220* - Pseudosteppa con erbe perenni ed annue dei Thero-Brachypodietea 15,0 6310 - Dehesas con Quercus suber e/o Quercus ilex 1,0 8214 - Versanti calcarei dell’Italia meridionale (Dianthion rupicolae)2 5,0 9320 - Foreste di Olea e Ceratonia 2,0 Totale superficie SIC interessata da habitat 65,0 Habitat presenti nel SIC ITA010022 (dati da Agristudio s.r.l.) Codice e denominazione degli habitat individuati in Carta Natura 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 5331 - Formazioni ad Euphorbia dendroides 6220* - Pseudosteppa con erbe perenni ed annue dei Thero-Brachypodietea Totale superficie SIC interessata da habitat Superficie (ha) % 0,3 1,7 30,2 32,2 La lettura critica del Manuale d’Interpretazione degli Habitat (“EUR27”), abbinata ai sopralluoghi ed ai rilievi di campo, utili ai fini di una migliore “comprensione” del paesaggio naturale di santa Ninfa, hanno permesso di arricchire la lista degli habitat di Santa Ninfa, che vengono riportati nella seguente tabella. Codice 3140_r 5230*_f 5331_r / 6220*_r 5331_r / 8214_r CATEGORIE DI RILEVAMENTO DELLA CARTA DEGLI HABITAT Denominazione Superficie degli habitat e dei mosaici di habitat (ha) % individuati nei sopralluoghi Acque dure oligo-mesotrofiche con vegetazione bentica di 0,03 0,01 Chara spp._rado *Matorral arborescente con Laurus nobilis_frequente 0,28 0,04 Formazioni ad Euphorbia dendroides _rado / *Pseudo-steppa 0,21 0,03 con graminacee perenni e piante annue dei TheroBrachypodietea_rado Formazioni ad Euphorbia dendroides _rado / Versanti 2,37 0,36 calcarei dell’Italia meridionale (Dianthion rupicolae)_rado Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 71 6220*_p 6220*_f 6220*_f / 5332_r 6220*_f / 5333_r 6220*_r 8214_p 8214_f / 6220*_r 92A0_f 92A0_f / 5230*_r 8310 *Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei Thero-Brachypodietea_puro *Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei Thero-Brachypodietea_frequente *Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei Thero-Brachypodietea_frequente / Gariga ad ampelodesma_rado *Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei Thero-Brachypodietea_frequente / Macchia rada a palma nana_rado Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei Thero-Brachypodietea_rado Versanti calcarei dell’Italia meridionale (Dianthion rupicolae)_puro Versanti calcarei dell’Italia meridionale (Dianthion rupicolae)_frequente / Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei Thero-Brachypodietea_rado Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba_frequente Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba_frequente / *Matorral arborescente con Laurus nobilis_rado Grotte non aperte al pubblico Totale superficie SIC interessata da (mosaici di) habitat 46,06 6,98 41,56 6,30 52,76 8,00 0,99 0,15 34,24 5,19 1,61 0,24 1,50 0,23 0,61 0,27 0,09 0,04 n.q. 182,51 n.q. 27,66 n.q. = allo stato non quantificabile Come già detto nella parte metodologica, i codici degli habitat sono stati individuati tenendo conto della condizione rilevata del SIC, in cui sono frequenti, all’interno dei poligoni di rilevamento, strutture a mosaico. Inoltre a ciascun habitat è stato attribuito un indice (p-f-r) che esprime il “peso” di ciascuno degli habitat che partecipano al mosaico stesso (puro; frequente; rado). Il primo degli habitat che compongono il mosaico è l’habitat prevalente, che fisionomizza l’area di rilevamento. I codici p-f-r vengono riportati nel data base degli habitat esclusivamente a fini gestionali, e conseguentemente non vengono visualizzati nella carta degli habitat per maggiore semplicità e chiarezza di rappresentazione, come già spiegato nella parte metodologica. Qui di seguito vengono sinteticamente descritti gli habitat ed i mosaici di habitat osservati nel territorio. 3140_r - Acque dure oligo-mesotrofiche con vegetazione bentica di Chara spp._rado: a questa categoria viene riferito il popolamento sommerso di Chara vulgaris osservato all’interno della polla e le sue adiacenze. 5230*_f - *Matorral arborescente con Laurus nobilis_ frequente: il tratto più incassato del Torrente Biviere è caratterizzato da un’interessante lembo di macchia termoigrofila sempreverde a Laurus nobilis, riferibile senza dubbio a questo habitat prioritario “, cui si accompagnano aspetti di mantello. Alla stessa categoria viene riferito il mosaico cui partecipano alcuni pini introdotti. 6220*_p - *Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei TheroBrachypodietea_puro: in questa categoria vengono raggruppati gli aspetti più integri del mosaico di prateria ad Ampelodesmos, praterelli terofitici e gariga a labiate. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 72 6220*_f - Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei TheroBrachypodietea_frequente: molto spesso la complessa trama costituita da aspetti più o meno integri di prateria ad Ampelodesmos, dai praterelli terofitici e dalla gariga a labiate è interotta da giovani rimboschimenti (es.: pino d’Aleppo e/o pino domestico indiverse località, pini + lecci + roverelle presso Casa Paternò, pini + ornielli + lecci + roverelle + cipressi sopra Case della Magione C.da Castellaccio o da nuclei di mantello a sommacco). Tutti questi aspetti appaiono caratterizzati da una certa omogeneità floristica e fisionomica, impressa dalla dominanza degli aspetti di prateria e pertanto vengono inclusi in questa categoria. 6220*_f / 5332_r - Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei TheroBrachypodietea_frequente / Gariga ad ampelodesma_rado: si tratta di aspetti di mosaico degradato di prateria perenne e annua dominata da Ampelodesmos e/o Hyparrhenia con Asphodelus, caratterizzati dalla presenza di Artemisia arborescens e lembi di gariga rada a Coridothymus capitatus. Raggruppa gli aspetti degradati di prateria e gariga. 6220*_f / 5333_r - Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei TheroBrachypodietea_frequente / Macchia rada a palma nana_rado: mosaico di prateria ad Ampelodesmos mauritanicus, praterelli dei litosuoli e nuclei radi di macchia a palma nana (facies impoverita con Prasium, Teucrium flavum ed Artemisia arborescens), localizzati in C.da La Menta, al limite NW del SIC. 6220*_r - Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei TheroBrachypodietea_rado: in questa categoria vengono raggrupati gli aspetti di mosaico di prateria perenne (ad Ampelodesmos, a Hyparrhenia e Ferula o ad Arundo collina) e di gariga a labiate talmente disturbati dal pascolo da registrare la prevalenza di aspetti di prateria a terofite e geofite (es.: Asphodelus) ed un’elevata frequenza e copertura di specie nitroxerofile e ruderali. Talora a queste praterie degradate partecipano con base coperture specie di mantello come Rhus coriaria e Ulmus minor. 5331_r / 6220*_r - Formazioni ad Euphorbia dendroides _rado / Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei Thero-Brachypodietea_rado: mosaico rappresentato da un piccolissimo nucleo di macchia termofila rada con Euphorbia dendroides ed aspetti di prateria termoxerofila perenne annua sul versante merdionale delle colline di C.da Castellaccio. 5331_r / 8214_r - Formazioni ad Euphorbia dendroides _rado / Versanti calcarei dell’Italia meridionale (Dianthion rupicolae)_rado: questa categoria è rappresentata da un mosaico di macchia termofila rada con Euphorbia dendroides e comunità casmofitiche sui versanti di C.da La Menta che delimitano a nord il SIC. 8214_p - Versanti calcarei dell’Italia meridionale (Dianthion rupicolae)_puro: esempi tipici di consorzi riferibili a questo syntaxa si osservano lungo tutta la parete esposta a Nord della valle del Biviere, nonché sul versante settentrionale di M. Castellaccio, negli anfratti ombrosi delle rupi poste ai piedi del versante meridionale di M. Finestrelle, a NE dell’invaso artificiale e sulle Balze del Campanaro e del Cappellone. 8214_f / 6220*_r - Versanti calcarei dell’Italia meridionale (Dianthion rupicolae)_frequente / Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei TheroBrachypodietea_rado: in questa categoria aspetti densi del Dianthion rupicolae si alternano a nuclei radi e degradati di prateria perenne e annua degradata (Asphodelus, poca Artemisia), lembi di gariga a Coridothymus e prateria più integra ad Ampelodesmos o Hyparrhenia. 92A0_f - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba_frequente: a questa categoria vengono riferiti sia nuclei circoscritti, discontinui e di ridotta estensione di boscaglia riparia a Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 73 olmi, salice pedicellato e pioppi sia aspetti analoghi in cui si registra la passata introduzione di pini. 92A0_f / 5230*_r - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba_frequente / *Matorral arborescente con Laurus nobilis_rado: questa categoria include nuclei di ripisilva igrofila a salici e/o a pioppi con alloro e, in alcuni poligoni, con olmo. 8310 - Grotte non aperte al pubblico - grotte di origine carsica caratterizzate da inghiottitoi più o meno profondi, e con ambienti ipogei più o meno ampi e diversificati. Gli ingressi sono caratterizzati da aspetti di vegetazione naturale legati ad un microclima più fresco ed umido, le cavità ospitano quasi certamente – in analogia con la Grotta di Santa Ninfa (la maggiore delle cavità presenti nel comprensorio e l’unica finora studiata), che presenta una fauna cavernicola altamente diversificata, con elementi troglofili - popolamenti faunistici almeno troglofili, con specie endemiche, rare e/o localizzate (sia tra i Chirotteri che relativamente a taxa di invertebrati quali Coleotteri, Tricotteri, Crostacei Isopodi e Amfipodi, Molluschi, ecc.). Nella seguente tabella sono riportati i tematismi di rappresentazione della Carta degli Habitat (Tavola 9), con l’indicazione della superficie complessiva di ciascun habitat o mosaico di habitat e della percentuale rispetto alla superficie totale del SIC. Codice 3140 5230* 5331/6220* 5331/8214 6220* 6220*/5332 6220*/5333 8214 8214/6220* 8310 92A0 92A0/5230* TEMATISMI DI RAPPRESENTAZIONE DELLA CARTA DEGLI HABITAT Denominazione Superficie degli habitat e dei mosaici di habitat (ha) % individuati nei sopralluoghi Acque dure oligo-mesotrofiche con vegetazione bentica di Chara 0,03 0,01 spp. Matorral arborescente con Laurus nobilis 0,28 0,04 Formazioni ad Euphorbia dendroides/Pseudo-steppa con 0,21 0,03 graminacee perenni e piante annue dei Thero-Brachypodietea Formazioni ad Euphorbia dendroides/ Versanti calcarei dell’Italia 2,37 0,36 meridionale (Dianthion rupicolae) Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei Thero- 121,86 18,47 Brachypodietea Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei Thero52,76 8,00 Brachypodietea/ Gariga ad ampelodesma Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei Thero0,99 0,15 Brachypodietea/ Macchia rada a palma nana Versanti calcarei dell’Italia meridionale (Dianthion rupicolae) 1,6 0,24 Versanti calcarei dell’Italia meridionale (Dianthion 1,50 0,23 rupicolae)/Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei Thero-Brachypodietea Grotte non aperte al pubblico n.q. n.q. Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 0,60 0,09 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba/ *Matorral 0,27 0,04 arborescente con Laurus nobilis Totale superficie SIC interessata da habitat e mosaici di habitat 182,50 27,66 n.q. = allo stato non quantificabile Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 74 Nella Carta degli Habitat sono anche visualizzate le categorie Corine Biotope delle aree ove non sono stati rinvenuti habitat, che si riportano nella tabella seguente. Biotopi secondo la classificazione Corine Biotopes 23.11 Corpi idrici aperti privi di tappeti di Carofite 31.81 Formazioni arbustive di margini forestali, siepi e (nuclei di) ricolonizzazione su suoli alquanto ricchi 31.8A Arbusteti termofili submediterranei con Rubus ulmifolius 31.D Giovani piantagioni di latifoglie decidue 34.81 Prati aridi subnitrofili a vegetazione post-colturale 53.11 Formazioni a cannuccia di palude 53.61 Comunità a canna del Po 53.62 Formazioni a canna del Reno 82.3 Seminativi e colture erbacee estensive 82.3A Sistemi agricoli complessi 82.4 Vivai 83.111 Oliveti tradizionali 83.152 Frutteti meridionali 83.211 Vigneti tradizionali 83.3112 Impianti di pini europei 83.322 Eucalitteti 83.325 Altri impianti arborei artificiali a latifoglie 85.31 Giardini ornamentali 86 Città, paesi, siti industriali 86.2 Villaggi 86.22 Fabbricati rurali 86.31 Insediamenti industriali, artigianali, commerciali e spazi annessi 86.413 Cave di pietra 87.2 Comunità ruderali Sulla base delle proporzioni misurate e rilevate in campagna, è stata effettuata una stima semiquantitativa del “peso” di ciascun habitat facente parte dei mosaici individuati; i rapporti ponderali stimati sono stati i seguenti. Tematismi della Carta degli Habitat 6220* Pseudo-steppa con graminacee perenni Thero-Brachypodietea_r 6220* Pseudo-steppa con graminacee perenni Thero-Brachypodietea_f 6220* Pseudo-steppa con graminacee perenni Thero-Brachypodietea_p 6220* Pseudo-steppa con graminacee perenni Thero-Brachypodietea_f + 5332 gariga ad ampelodesma_r 6220* Pseudo-steppa con graminacee perenni Thero-Brachypodietea_f + 5333 Macchia rada a palma nana_r 5331 Formazioni ad Euphorbia dendroides_r + Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano “Peso” habitat presenti e piante annue dei 100 e piante annue dei 100 e piante annue dei 100 e piante annue dei 60 e piante annue dei 40 55 45 65 75 6220* Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei Thero-Brachypodietea_r 5331 Formazioni ad Euphorbia dendroides_r + 8214 Versanti calcarei dell’Italia meridionale (Dianthion rupicolae)_r 5230* Matorral arborescente con Laurus nobilis_f 8214 Versanti calcarei dell’Italia meridionale (Dianthion rupicolae)_p 8214 Versanti calcarei dell’Italia meridionale (Dianthion rupicolae)_f + 6220* Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei Thero-Brachypodietea_r 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba_f + 5230* Matorral arborescente con Laurus nobilis_r 3140 Acque dure oligo-mesotrofiche con vegetazione bentica di Chara spp._r 8310 Grotte non aperte al pubblico 35 60 40 100 100 85 15 90 10 100 100 Queste considerazioni quali-quantitative hanno permesso di valutare con buona approssimazione la superficie effettivamente ricoperta da ogni singolo habitat nel SIC. Codice e denominazione degli Habitat presenti nel SIC Estensione (Ha) (%) 0.03 0,01 3140 - Acque dure oligo-mesotrofiche con vegetazione bentica di Chara spp. 5230* - Matorral arborescente con Laurus nobilis 0,31 0,05 5331 - Formazioni ad Euphorbia dendroides 1,56 0,24 5332 - Garighe dominate da Ampelodesmos mauritanicus 21,11 3,20 5333 - Macchia rada a Chamaerops humilis 0,40 0,06 6220* - Pseudosteppa con erbe perenni ed annue dei Thero- 154,42 23,41 Brachypodietea 8214 - Versanti calcarei dell’Italia meridionale (Dianthion rupicolae) 3,83 0,58 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 0,85 0,13 8310 – Grotte non aperte al pubblico * * Totale superficie SIC interessata da habitat 182,51 27,66 * Si tratta di un habitat ipogeo per cui in questa fase non è stato possibile rilevare la sua superficie La superficie complessiva interessata da habitat di interesse comunitario è pari al 27,66% del SIC, più bassa di quanto riportato in precedenza nelle due diverse edizioni del Formulario Standard. La quasi totalità di tale superficie (26,61%) corrisponde agli habitat 5332 e 6220*, corrispondenti ai mosaici di prateria perenne e annua e gariga, mentre appena l’1,05% del SIC è caratterizzato da aspetti riferibili ai rimanenti sei habitat. Relativamente alla struttura ed alla distribuzione degli habitat rinvenuti, emerge una maggiore coesione-continuità tra i poligoni ricadenti lungo il sistema di crinali che contorna il limite settentrionale del SIC (tra l’altro per la gran parte attribuibili al cod. 6220*), mentre l’area meridionale presenta poligoni poco coesi, piccoli e sparsi; quest’ultima area, tuttavia, ospita in via esclusiva tre interi habitat (3140, 5230* e 92A0), costituiti da lembi discontinui in Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 76 corrispondenza dell’impluvio del Torrente Biviere in zona di riserva. La tutela attiva degli impluvi, oltre a garantire la diffusione delle specie e la maggiore connessione-continuità degli habitat 5230* e 92A0, consentirà la ricostituzione dell’habitat 92D0 (Foreste riparie galleria termomediterranea Nerio-Tamariceteae), la cui presenza in passato è testimoniata da piccoli popolamenti di Tamarix. Si segnala inoltre che i rimboschimenti, per la loro estesa superficie e per la loro copertura del territorio, svolgono una forte azione di “competizione” nei confronti degli habitat (ed in particolare dei mosaici di prateria e gariga), pregiudicandone il grado di naturalità e l’integrità; conseguentemente, la gestione naturalistica degli impianti artificiali gioca un ruolo fondamentale nella pianificazione del SIC. L’analisi della distribuzione delle specie di interesse conservazionistico e/o biogeografico ha evidenziato quanto segue: - 21 dei 90 taxa vegetali vivono esclusivamente all’interno di habitat d’interesse comunitario: si tratta di Astragalus huetii, Brassica rupestris subsp. rupestris, Brassica villosa subsp. bivoniana, Catapodium hemipoa subsp. occidentale, Cheilanthes maderensis, Cymbalaria pubescens, Diplotaxis crassifolia, Echinaria capitata subsp. todaroana, Helictotrichon cincinnatum, Hippomarathrum siculum, Laurus nobilis, Lomelosia cretica, Odontites rigidifolius, Petrorhagia saxifraga subsp saxifraga, Plantago afra subsp. zwierleinii, Salvia viridis, Scorzonera deliciosa, Sedum caeruleum, Sedum gypsicola, Silene fruticosa e Thymus spinulosus. Di contro, sono 16 (Calendula suffruticosa subsp. fulgida, Capnophyllum peregrinum, Carthamus caeruleus subsp. caeruleus, Convolvulus tricolor subsp. cupanianus, Crepis bursifolia, Daucus muricatus, Echium italicum subsp. siculum, Euphorbia ceratocarpa, Fedia graciliflora, Lathyrus odoratus, Ononis alopecuroides subsp. exalopecuroides, Ononis pendula subsp. boissieri, Opopanax chironium, Rosa micrantha, Tragopogon cupanii e Vicia narbonensis) i taxa esclusivi dei biotopi. La maggior parte delle restanti entità è presente anche nelle unità del paesaggio agrario (seminativi, colture permanenti, incolti e contesti ruderali marginali). - Ben 59 delle 90 tracheofite pregiate inviduate nel SIC prediligono l’habitat “pseudosteppa con graminacee perenni e piante annue dei Thero-Brachypodietea” (cod. 6220), 48 la “gariga ad Ampelodesmos” (cod. 5332); 16 (di cui 7 esclusive) vivono sui “versanti calcarei dell’Italia meridionale (Dianthion rupicolae)” (cod. 8214) e 13 nella “macchia rada a palma nana” (cod. 5333). Nessuna specie d’interesse biogeografico è stata invece riscontrata nell’habitat d’interesse comunitario “acque dure oligomesotrofe con vegetazione bentica di Chara spp.” (cod. 3140), 4 nelle “formazioni ad Euphorbia dendroides” (cod. 5331) e 2 nell’habitat prioritario “matorral arborescente con Laurus nobilis” (cod. 5230). - Relativamente ai biotopi, va rimarcato il delicato ruolo di rifugio svolto dagli incolti e dai rimboschimenti di recente impianto e/o aperti-diradati: 29 sono le emergenze floristiche effettivamente o potenzialmente presenti nei “Prati aridi subnitrofili a vegetazione post-colturale” (cod. CB 34.81), 18 quelle presenti nella “Comunità a canna del Po” (cod. CB 53.61), 15 negli “Altri impianti arborei artificiali a latifoglie” (cod. CB 83.325). Meno ricchi ed interessanti si rivelano i rimboschimenti più datati e fitti: 7 sono i taxa vegetali pregiati riscontrati o probabilmente presenti nei biotopi 83.3112 “Altri impianti di pini europei” e 83.322 “Eucalitteti”. 3 sono le emergenze floristiche che vivono nei “seminativi e colture erbacee estensive” (cod. CB 82.3), 3 nei consorzi ruderali sui bordi delle strade, delle trazzere e a ridosso dei muri dei casolari Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 77 abbandonati, riferiti all’unità CB “Vegetazione ruderale” (cod. CB 87.2), poche nelle colture permanenti sarchiate “Oliveti tradizionali”, “Frutteti meridionali” e “Vigneti tradizionali” (rispettivamente cod. CB 83.111, 83.152, e 83.211). Le conoscenze sull’auto- e sinecologia di ciascuna specie pregiata consentono di valutarne l’idoneità ambientale “potenziale” rispetto agli habitat ed ai biotopi riscontrati nel territorio in esame. Ne risulta la seguente tabella, in cui vengono riportati sia i casi in cui i taxa sono stati effettivamente riscontrati in determinati habitat o biotopi (= +), sia i casi di presenza potenziale (= p), quando i taxa mostrano una notevole idoneità ambientale per quegli habitat e/o biotopi. Con la sigla “e” vengono indicati quei taxa di cui è stata verificata sul campo la presenza esclusiva all’interno di un singolo habitat o biotopo. I dati esposti nella tabella offrono una prima indicazione sulla distribuzione dei taxa nei diversi habitat e biotopi e, indirettamente, sul valore floristico di questi ultimi. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 78 Correlazione tra le esigenze ecologiche delle specie di interesse conservazionistico ed i principali Habitat e Biotopi presenti nel SIC ITA010022. Taxa effettivamente (= +) e potenzialmente (= p) presenti; e = taxa attualmente esclusivi di un singolo habitat o biotopo. p + + + + + + 87.2 83.325 83.322 83.3112 83.211 83.152 83.111 82.3A 82.3 53.62 p p 53.61 34.81 p 53.11 31.D + 31.8A 8214 p + + 31.81 6220* p 92A0 5333 p + + p Calendula suffruticosa Vahl subsp. fulgida (Raf.) Ohle Capnophyllum peregrinum (L.) Lange Carlina sicula Ten. subsp. sicula Carthamus caeruleus L. subsp. caeruleus Carthamus pinnatus subsp. pinnatus Catananche lutea L. Catapodium hemipoa (Sprengel) Laìnz subsp. occidentale (Paunero) H. et S. Scholz p P p p p + p + p + + + e p + e + + + + p e Cheilanthes maderensis Lowe Colchicum bivonae Guss. Convolvulus tricolor L. subsp. cupanianus (Sa’ad) Stace + Crepis bursifolia L. Crocus longiflorus Raf. Cyclamen repandum Sibth. et Sm. + Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano Biotopi 5332 Ambrosina bassii L. Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard Asperula aristata L. fil. subsp. longiflora (Waldst. et Kit.) Hayek Astragalus huetii Bunge Barlia robertiana (Loisel.) Greuter Biscutella maritima Ten. Brassica rupestris Raf. subsp. rupestris Brassica villosa Biv. subsp. bivoniana (Mazzola et Raimondo) Raimondo et Mazzola 5331 5230* Habitat 3140 Taxa d’interesse biogeografico o conservazionistico + + + + p + + + e + + p + + + e + p + p p p 79 Cymbalaria pubescens (C. Presl) Cufod. Daucus muricatus (L.) L. Dianthus siculus C. Presl Diplotaxis crassifolia (Raf.) DC. Echinaria capitata Desf. subsp. todaroana (Ces., Pass. et Gibelli) Arcang. Echium italicum L. subsp. siculum (Lacaita) Greuter et Burdet Eryngium bocconei Lam. Eryngium dichotomum Desf. Eryngium triquetrum Euphorbia ceratocarpa Ten. Fedia graciliflora Fischer et C.A. Meyer Galium pallidum C. Presl Gypsophila arrostii Guss. Helictotrichon cincinnatum (Ten.) Röser Helminthoteca aculeata (Vahl) Lack. Hippomarathrum siculum (L.) Hoffmgg. et Link Jacobaea delphinifolia (Vahl) Pelser et Veldk. Jacobaea lycopifolia (Poir.) Greuter et B. Nord. Lathyrus odoratus L. Laurus nobilis L. Linum decumbens Desf. Lomelosia cretica (L.) W. Greuter et Burdet Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. Micromeria fruticulosa (Bertol.) Grande Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 87.2 83.325 83.322 83.3112 83.211 83.152 83.111 82.3A 82.3 53.62 53.61 53.11 34.81 31.D 31.8A 31.81 92A0 8214 Biotopi 6220* 5333 5332 5331 5230* Habitat 3140 Taxa d’interesse biogeografico o conservazionistico e + + + p e e + + + + + + + + + + + + + + + + e + p + + + + + + + + + + p p + + + + + + + + + + p p + + p + + + p + p + p + + + p e + + + + + + + + + + 80 p p + Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 87.2 83.325 83.322 83.3112 83.211 83.152 83.111 82.3A 82.3 53.62 53.61 + + Ononis pendula Desf. subsp. boissieri (Širj.) Devesa Ononis sieberi DC. Ophrys bertolonii Moretti Ophrys bombyliflora Link Ophrys exaltata Ten. Ophrys garganica O. et E. Danesch Ophrys incubacea Tod. Ophrys lupercalis Devillers et Devillers-Terschuren Ophrys lutea Cav. subsp. lutea Ophrys lutea Cav. subsp. minor O. et E. Danesch Ophrys obaesa Lojac. Ophrys oxyrrhynchos Tod. Ophrys panormitana (Tod.) Soó Ophrys tenthredinifera Willd. Ophrys vernixia Brot. Opopanax chironium (L.) Koch Orchis anthropophora (L.) All. Orchis collina A. Russel Orchis italica Poir. Orchis lactea Poir. 53.11 p 34.81 p 31.D 31.8A 92A0 8214 6220* 5333 5331 5332 + p + Biotopi 31.81 Neotinea maculata (Desf.) Stearn Nepeta apuleii Ucria Odontites rigidifolius (Biv.) Benth. Ononis alopecuroides L. subsp. exalopecuroides (G. Lòpez) Greuter et Burdet 5230* Habitat 3140 Taxa d’interesse biogeografico o conservazionistico + + + p + + + + + + + + p p p p + + + + + + + + p p + + + p + p p p p + + + + + + + + + + + + p + + + + + + + p p + p p p + p p + p + + + + 81 p p + + 87.2 83.325 83.322 83.3112 83.211 83.152 83.111 82.3A 82.3 53.62 + 53.61 p p 53.11 34.81 31.8A 31.81 92A0 8214 + + 31.D p p + + + + + e p p e + e + p p p p Thymus spinulosus Ten. Tragopogon cupanii Guss. Vicia narbonensis L. Tot. “+” Tot. “p” Tot. “e” Tot. Complessivo + + Biotopi 6220* + p p + + + 5333 5332 Orchis longicornu Poir. Orchis papilionacea L. s.l. Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga Phagnalon saxatile (L.) Cass. subsp. saxatile Pimpinella anisoides Briganti Plantago afra L. subsp. zwierleinii (Nicotra) Brullo Rosa micrantha Sm. Rumex thyrsoides Desf. Salvia viridis L. Scorzonera cana (C.A. Mey.) Griseb. Scorzonera deliciosa Guss. Sedum caeruleum L. Sedum gypsicola Boiss. et Reuter Serapias lingua L. Serapias parviflora Parl. Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq. Silene fruticosa L. Silene italica (L.) Pers. subsp. sicula (Ucria) Jeanmonod 5331 5230* Habitat 3140 Taxa d’interesse biogeografico o conservazionistico + p + + e + + + p + + + + + + + + 0 0 0 0 Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 2 0 0 2 1 3 0 4 31 17 0 48 p e + p + + 7 6 0 13 44 10 5 59 9 0 7 16 1 0 0 1 1 3 1 5 1 4 1 6 15 14 0 29 24 5 0 29 + p 1 0 0 1 16 2 0 18 0 1 0 1 1 1 1 3 p p 1 7 0 8 2 1 0 3 2 0 0 2 3 0 0 3 7 0 0 7 7 0 0 7 8 6 1 15 2 0 1 3 82 La realtà territoriale esaminata appare tuttavia ben più complessa, giacché nella maggior parte dei poligoni (descritti nelle carte e nel SIT con il codice Habitat o Corine Biotope prevalente) sono rinvenibili mosaici di habitat e biotopi. Conseguentemente, anche le specie partecipano in modo variabile alla composizione ed alla valenza floristica complessiva di ciascun poligono. La Carta del Valore Floristico (Tavola 10) è stata redatta attribuendo ad ogni poligono un valore pari al numero di specie di interesse conservazionistico della flora, rilevate sul campo o potenziali. L'elenco delle specie, e quindi il valore floristico, è pertanto legato al singolo poligono e non alla categoria (Habitat Direttiva o Corine Biotope) cui il poligono appartiene. Per tale ragione a parità di codice habitat o biotope si possono avere poligoni a differente valore floristico in funzione della reale distribuzione delle specie sul territorio. Nella Tavola le aree sono campite diversamente in funzione del numero di specie (nessuna specie rilevata=0; 1-5 specie; 6-20 specie; 21-40 specie; oltre 40 specie). La carta conferma quanto detto sopra nella trattazione sulla ricchezza degli habitat/biotopi: gli ambienti più ricchi in specie sono le praterie, le garighe e le rupi, mentre gli ambienti più poveri in numero di specie di interesse risultano i vigneti, gli oliveti, gli ambienti ruderali. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 83 2.3.1.5 Verifica ed aggiornamento della scheda natura 2000 – flora ed habitat (B.1) Si precisa che le Schede Natura 2000 cui si fa riferimento nel presente capitolo sono quelle trasmessaci ufficialmente dal Servizio VI dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente nel dicembre 2007. Aggiornamento Sezione 3.1. Tipi di habitat presenti nel Sito e relativa valutazione Sulla base delle indagini effettuate, è stata confermata la presenza dei seguenti habitat: 5331 - Formazioni ad Euphorbia dendroides - Un nucleo piuttosto discontinuo e poco rappresentativo sotto un profilo fisionomico-strutturale di macchia rada ad Euphorbia dendroides si riscontra frammisto a specie squisitamente rupicole sui versanti settentrionali di Contrada La Menta, al limite Nord del SIC e, su una superficie ridottissima, sui versanti meridionali delle alture di C.da Castellaccio. Tale habitat, trascurato in fase di redazione della Carta Preliminare degli Habitat, nella versione definitiva della Carta degli Habitat partecipa a due diversi mosaici. 5332 - Garighe dominate da Ampelodesmos mauritanicus – A questo habitat vengono riferiti soltanto gli aspetti molto densi e rappresentativi, ancorché frequentemente disturbati dal passaggio del fuoco, di mosaico di gariga a Coridothymus capitatus e Micromeria fruticulosa frammisti all’ampelodesma. Gli ampelodesmeti puri sono stati invece riferiti all’habitat prioritario 6220. 5333 - Macchia rada a Chamaerops humilis – Un piccolo nucleo, peraltro estremamente discontinuo e poco rappresentativo sotto un profilo fisionomico-strutturale, di macchia rada a Chamaerops humilis si riscontra al limite nord-occidentale del SIC. Questo habitat partecipa ad un mosaico. 6220* - Pseudosteppa con erbe perenni ed annue dei Thero-Brachypodietea - A tale habitat vengono riferite le formazioni di prateria ad Ampelodesmos mauritanicus, a Hyparrhenia hirta e ad Asphodelus ramosus e Charybdys pancration, nonché consorzi terofitici effimeri che si rinvengono al loro interno o negli spazi aperti nella gariga gipsicola a Coridothymus capitatus e Micromeria fruticulosa. Tale habitat partecipa a gran pare dei mosaici del SIC. 8214 - Versanti calcarei dell’Italia meridionale (Dianthion rupicolae) - I versanti rocciosi ospitano consorzi rupicoli; quelli più interessanti ed integri si rinvengono sui versanti esposti a settentrione di M. Castellaccio, di C.da La Ment, Cappellone, Cmapanaro e sulle rupi che sovrastano C.da Magione e, all’interno della riserva, a oche centinaia di m a NE dell’invaso artificiale e sulle rupi che racchiudono la valle cieca del Biviere. E’ stata inoltre accertata la presenza di tre habitat precedentemente non rilevati: 3140 - Acque dure oligomesotrofe con vegetazione bentica di Chara spp. – Il fondo della polla posta al limite orientale della valle cieca del Biviere ospita questo habitat su una superficie di pochi metri quadrati. Pur trattandosi di un’area di dimensioni ben inferiori al limite cartografabile, vale la pena di prenderla in considerazione anche in ragione del suo importante ruolo faunistico. 5230* - Matorral arborescente con Laurus nobilis - Il tratto più incassato del Torrente Biviere è caratterizzato da un’interessante lembo di macchia termoigrofila sempreverde a Laurus nobilis, riferibile senza dubbio a questo habitat prioritario, come già indicato nella Carta Preliminare degli Habitat. 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba - Sebbene molto circoscritti, discontinui e di ridotta estensione, i locali nuclei di boscaglia riparia a salice pedicellato, olmi e pioppi va riferito senza dubbio a questo habitat comunitario Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 84 Infine, sono stati eliminati dalla scheda Natura 2000 i seguenti tre habitat, non rilevati durante i sopralluoghi: 3170* - Stagni temporanei mediterranei - In ragione del regime idrico di tipo astatico della polla posta presso lo sbocco del Torrente Biviere nell’omonima valle cieca, che costituisce l’unico specchio d’acqua naturale del SIC, le sponde erano state riferite (PASTA & LA MANTIA, 2001a) a tale habitat prioritario. I redattori del Formulario hanno seguito questa tesi senza ulteriori verifiche. In realtà questo habitat va depennato sulla base di solide argomentazioni ecologiche e floristiche: i sopralluoghi effettuati nell’arco degli ultimi dieci anni hanno infatti permesso di appurare che la polla presenta in realtà un regime pressoché costante e le occasionali variazioni del livello idrico dipendono più dalla captazione a uso irriguo che da una reale stagionalità. Inolte, nel medesismo arco di tempo non è stata rinvenuta nessuna microfita anfibia caratteristica degli Isoëto-Nanojuncetea. 6310 - Dehesas con Quercus suber e/o Quercus ilex – Non è stato riscontrato un benché minimo lembo di vegetazione riferibile all’habitat delle dehesas, indicato per il SIC dai redattori del Formulario. In occasione dei sopralluoghi sono stati individuati tre soli individui spontanei di leccio su un versante roccioso. 9320 - Foreste di Olea e Ceratonia - Questo habitat figura nel formulario di numerosissimi SIC della Sicilia perché ad esso Agristudio s.r.l. ha ricondotto gran parte degli aspetti di macchia termoxerofila dell’alleanza Oleo-Ceratonion e dell’ordine Quercetalia calliprini in genere. Va tuttavia precisato che sia le circoscritte formazioni di macchia ad Euphorbia dendroides o a Chamaerops humilis sono già riferite rispettivamente agli habitat 5331 e 5333. Per completezza di trattazione si riporta pure il seguente habitat, indicato nella Carta degli Habitat redatta da Agristudio s.r.l. e consegnata dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente come documentazione di base, che non è stato rinvenuto su campo durante i sopralluoghi ed i rilievi: 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici – A questa categoria, che include tutti i consorzi di arbusteto della fascia bioclimatica infra- e termomediterranea, erano stati riferiti dai redattori della Carta degli Habitat redatta da Agristudio alcuni poligoni interpretati come mosaico di aspetti di macchia non tipificabile. I sopralluoghi hanno permesso di verificare che si trattava in realtà di consorzi ruderali. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano Grado di conservazione Valutazione globale 0,01 Superficie relativa Nuova segnalazione % copertura Aggiornamento Rappresentatività 3140 - Acque dure oligomesotrofe con vegetazione bentica di Chara spp Carta Habitat Agristudio s.r.l. Habitat Scheda Natura 2000 Per ciascun habitat sono stati inoltre modificati, in conformità con il “Formulario Standard per la raccolta dei dati – Note esplicative”, i dati relativi alla copertura, alla rappresentatività, alla superficie relativa, al grado di conservazione ed alla valutazione globale, come sotto riportato. D C C C 85 3170* - Stagni temporanei mediterranei 5230* - Matorral arborescente con Laurus nobilis 5330 - Arbusteti termomediterranei e pre-desertici 5331 - Formazioni ad Euphorbia dendroides 5332 - Garighe dominate da Ampelodesmos mauritanicus 5333 - Macchia rada a Chamaerops humilis 6220* - Pseudosteppa con erbe perenni ed annue dei TheroBrachypodietea 6310 - Dehesas con Quercus suber e/o Quercus ilex 8214 - Versanti calcarei dell’Italia meridionale • Eliminato 0,05 D C C C • Nuova segnalazione Eliminato • Conferma 0,24 D C B C • Conferma 3,20 A B B B • Conferma 0,06 D C C C Conferma 23,41 A A B A • • • • Eliminato • Conferma 0,58 D C B C * C C C C 0,13 D C C C • Nuova segnalazione Nuova segnalazione Eliminato 8310 - Grotte non aperte al pubblico 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9320 - Foreste di Olea e Ceratonia Rappresentatività: A (eccellente), B (buona), C (significativa), D (presenza non significativa); Superficie relativa: A: 100 > = p > 15%, B: 15 > = p > 2%, C: 2 > = p > 0%; Grado di conservazione: A (eccellente), B (buona), C (media o ridotta); Valutazione globale: A (eccellente); B (buono), C (significativo). *Habitat ipogeo con superficie non valutabile in questa fase Aggiornamento Sezione 3.2.g “Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE” Dianthus rupicola Biv. R Scheda Natura 2000 NOME SCIENTIFICO Popolazione E’ stato eliminato Dianthus rupicola Biv. in quanto non rinvenuto né segnalato nel territorio di Santa Ninfa (SCUDERI, 2006). • Aggiornamento Eliminato Aggiornamento Sezione 3.3 “Altre Specie importanti di flora e fauna” Sono state eliminate le seguenti 4 specie dalla versione precedente della Scheda Natura 2000: - Colchicum cupanii Guss. ed Euphorbia dendroides L. in quanto non protetti da alcuna direttiva o convenzione, non risultano rari o minacciati a livello nazionale, regionale o provinciale e non rivestono particolare pregio biogeografico. - Leucojum autumnale L. in quanto non é mai stata segnalata per il territorio di Santa Ninfa (SCUDERI, 2006). Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 86 - Matthiola tristis (L.) R. Br. [= M. fruticulosa (L.) Maire] in quanto la presenza di nel Trapanese è dubbia, giacché essa è stata segnalata per Erice e M. Cofano dal solo PONZO (1900b). Nessuna di queste due ultime entità è stata osservata nel SIC in oltre dieci anni di osservazioni in diverse stagioni. • • • • • • • • • • • • • • Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano Motivazione Ambrosina bassii Anacamptis pyramidalis Asperula scabra subsp. longiflora Astragalus huetii Barlia robertiana Biscutella maritima Brassica rupestris subsp. rupestris Brassica villosa subsp. bivoniana Calendula suffruticosa subsp. fulgida Capnophyllum peregrinum Carlina sicula subsp. sicula Carthamus caeruleus subsp, caeruleus Carthamus pinnatus subsp. pinnatus Catananche lutea Catapodium hemipoa subsp. occidentale Cheilantes maderensis Colchicum bivonae Colchicum cupanii Convolvulus tricolor subsp. cupanianus Crepis bursifolia Crocus longiflorus Cyclamen repandum Cymbalaria pubescens Daucus muricatus Dianthus siculus Diplotaxis crassifolia Echinaria capitata subsp. todoroana Echium italicum subsp. siculum Eryngium bocconei Eryngium dichotomum Eryngium triquetrum Euphorbia ceratocarpa Euphorbia dendroides Fedia graciliflora Galium pallidum Popolazione NOME SCIENTIFICO Scheda Natura 2000 Sono stati invece confermati 33 taxa indicati nella Scheda Natura 2000 e sono state inoltre inserite altre 54 specie; di queste, 16 figurano nelle liste rosse regionali di CONTI et alii (1997), 25 sono riportate in Appendice II della Convenzione CITES, mentre le altre rivestono un certo interesse biogeografico-conservazionistico (endemiche, stenocore, rare a livello regionale o provinciale). Aggiornamento V R C V C C V R V V C R R V A C B AB C B AB AB D D B D D D Nuova segnalazione Confermata Confermata Nuova segnalazione Confermata Confermata Nuova segnalazione Confermata Nuova segnalazione Nuova segnalazione Confermata Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione C D Nuova segnalazione R C R C V C R V V C V R R C R R C C C R A D D D B D C AB D D D AB B B D D B C D B Nuova segnalazione Confermata Eliminato Confermata Nuova segnalazione Nuova segnalazione Confermata Nuova segnalazione Nuova segnalazione Confermata Confermata Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Confermata Eliminato Nuova segnalazione Nuova segnalazione 87 Gypsophila arrostii Helictotrichon cincinnatum Helminthoteca aculeata Hippomarathrum siculum Jacobaea delphinifolia Jacobea lycopifolia Lathyrus odoratus Laurus nobilis Leucojum autunnale Linum decumbens Lomelosia cretica Magydaris pastinacea Micromeria fruticulosa Matthiola tristis Neotinea maculata Nepeta apuleii Odontites rigidifolia Ononis alopecuroides subsp. exalopecuroides Ononis pendula subsp. Boissieri Ononis sieberi Ophrys bertolonii subsp. bertolonii Ophrys bombyliflora Ophrys exaltata Ophrys fusca Ophrys garganica Ophrys incubacea Ophrys lupercalis Ophrys lutea subsp. lutea Ophrys lutea subsp. Minor Ophrys obaesa Ophrys oxyrrinchos Ophrys panormitana Ophrys tenthredinifera Ophrys vernixia Opopanax chironium Orchis anthropophora Orchis collina Orchis italica Orchis lactea Orchis longicornu Orchis papilionaceae Petrorhagia saxifraga subsp. saxifraga Phagnalon saxatile subsp. saxatile Pimpinella anisoides Plantago afra subsp. zwierleinii Rosa micrantha Rumex thyrsoides Salvia viridis Scorzonera cana Scorzonera deliciosa Sedum caeruleum Sedum gypsicola Silene italica subsp. sicula Serapias lingua • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano C V C R C V R R R C V R C C R V R D D D A D D D D D D D D B D C A B Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Eliminato Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Confermata Eliminato Confermata Nuova segnalazione Confermata R D Nuova segnalazione R R R R R R R R R C R R V R R R R V R C R V R R R R C R V V V R C C R R D D C C C C C C C C C C ABC AC C AC D C C C C C C D A B AB A D D D B D A B C Nuova segnalazione Nuova segnalazione Confermata Confermata Confermata Confermata Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Confermata Confermata Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Confermata Confermata Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Confermata Confermata Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Confermata Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Confermata Nuova segnalazione Nuova segnalazione Confermata Confermata 88 Serapias parviflora Serapias vomeracea Silene fruticosa Silene italica subsp. sicula Thymus spinulosus Tragopogon porrifolius subsp. cupanii Vicia narbonensis • • • • • Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano R R V R R R V C C D B B B Dd Confermata Confermata Nuova segnalazione Confermata Confermata Confermata Nuova segnalazione 89 2.3.2 Descrizione faunistica del Sito 2.3.2.1 Le conoscenze faunistiche – precedenti indagini sul Sito (B.2) Le precedenti conoscenze faunistiche del Sito sono compendiate e sintetizzate in CASAMENTO & PALMERI (2001), che riportano la prima check-list dei vertebrati conosciuti per l’area, rimarcando come le notizie storiche siano scarse e poco approfondite. Un altro recente contributo zoologico specifico sulle comunità di Scarabeoidea si deve a ZUNINO & VARRICA (2001). Inoltre, relativamente alla fauna cavernicola, si segnala che la Grotta di Santa Ninfa (esterna al perimetro del Sito) rappresenta una delle cavità siciliane più esplorate in ambito biospeleologico (CASAMENTO, 2001). Dall’istituzione della riserva naturale ornitologi e naturalisti hanno effettuato diversi sopralluoghi ed escursioni arricchendo la check-list e fornendo all’Ente gestore della riserva numerosi dati inediti. 2.3.2.2 Metodologia adottata negli studi faunistici (B.3.1) Metodologie delle indagini di campo Di seguito si riportano le principali metodologie di campo adottate per il rilevamento delle specie animali presenti nel SIC, suddivise per gruppi tassonomici. PESCI E’ stata effettuata un’indagine ittiologica nel piccolo invaso artificiale posto nella porzione settentrionale del Sito, utilizzando le seguenti metodiche: - osservazione diretta di presenza ittica in superficie e cattura tramite retino immanicato; - posa di nasse finalizzate alla cattura della fauna ittica, tramite l'uso di un gommoncino, in modo da campionare i diversi ambienti presenti. I pesci catturati sono stati separati per nassa e per specie, quindi contati e, previa anestesia, sono stati misurati tramite ittiometro (al mm) ed un campione di essi è stato pesato tramite bilancia elettronica con precisione al grammo. ANFIBI E RETTILI Sono state effettuate escursioni diurne e notturne, dedicate all’avvistamento diretto di anfibi e rettili ed all’ascolto degli anfibi in canto. Sono stati ispezionati anche laghetti collinari, pozze temporanee, fontanili e risorgive. Le coordinate di ogni stazione di osservazione sono state rilevate tramite GPS, in modo da poter redigere la carta di distribuzione delle specie. Il metodo qualitativo scelto ha permesso di rilevare le specie presenti, prescindendo dalla loro abbondanza numerica. Non è stato sempre possibile determinare con esattezza le due specie di lucertola presenti. UCCELLI 1. Passeriformi - Sono stati effettuati diversi punti d’ascolto casuali di 10 minuti ciascuno (BLONDEL 1975, FULLER & LANGSLOW 1984) in orari compresi tra le 06:00 e le 09:00 di mattina, e negli ambienti principali del SIC. Le specie ed il numero d’individui che rispondevano in ogni stazione venivano annotati; la frequenza relativa delle specie negli ambienti è stata standardizzata a 100, dividendo il numero delle presenze di una singola specie in un singolo ambiente sul totale delle presenze riscontrate. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 90 2. Rapaci notturni - Sono stati censiti con il metodo del play-back(SARÀ & ZANCA 1989A), consistente nel sollecitare il canto o verso di risposta degli individui territoriali delle diverse specie con un richiamo registrato. Questo metodo si basa sulla logica comportamentale degli animali che, udendo un intruso conspecifico nel proprio territorio, emettono un richiamo di risposta per rimarcare il proprio territorio; la risposta del proprietario del territorio sarà proporzionale alla vicinanza del playback (intruso) al centro del territorio. Sono stati scelti percorsi automobilistici ed a piedi, articolati in stazioni opportunamente distanziate, compatibilmente con i luoghi di sosta e la morfologia dei luoghi. Durante ogni stazione si emetteva il richiamo registrato di ogni singola specie secondo la sequenza: 1 minuto di emissione - 1 minuto di intervallo - 1 minuto di emissione. Poi s’iniziava l’ascolto della risposta per 5 minuti; quindi si ripeteva il richiamo di un’altra specie. Sono state sollecitate 5 specie di Rapaci notturni: Allocco (Strix aluco), Assiolo (Otus scops), Civetta (Athene noctua), Barbagianni (Tyto alba) e Gufo comune (Asio otus). 3. Rapaci diurni – Sono stati effettuati appostamenti ed escursioni nell’area del SIC per l’avvistamento e la localizzazione dei siti riproduttivi e dei territori di alimentazione dei Rapaci diurni. Sono stati usati binocoli Leica 8*40, 10*40 e cannocchiali Leica Apo Televid 10-60. 4. Uccelli migratori - Sono stati effettuati appostamenti ed escursioni nell’area del SIC per l’avvistamento e la localizzazione dei migratori e delle specie svernanti.. Nel caso di avvistamento si prendeva nota delle direzioni di volo e si è cercato in alcuni casi di seguire gli stormi per identificare alcuni tratti delle rotte migratrici e gli eventuali punti di sosta. Nel caso dei piccoli uccelli si sono effettuate stazioni di osservazione ed ascolto alla ricerca di individui e stormi posati durante la sosta o il foraggiamento. Gli individui avvistati sono stati identificati in base alle differenze di dimensioni, forme e piumaggio, visibili con binocoli e cannocchiali. MAMMIFERI 1. Chirotteri - Sono stati effettuati censimenti visivi e sonori all’uscita dei principali siti di rifugio, a partire da mezz’ora dopo il tramonto sino a due ore dopo. Relativamente agli habitat di alimentazione, sono state scelte in maniera random stazioni e percorsi all’interno del SIC in cui effettuare i campionamenti sonori della durata di 10 minuti ciascuno. I segnali d’ecolocalizzazione emessi dai chirotteri contattati in volo, sono stati captati con un bat detector D980 (PETTERSSON ELEKTRONIC AB, UPPSALA) in divisione di frequenza e immediatamente convertiti con la modalità in espansione temporale; il segnale in uscita è stato registrato su cassette, collegando il bat detector con un registratore portatile. I segnali registrati sono stati successivamente analizzati con il programma Bat Sound 1.0 (PETTERSSON ELEKTRONIC AB, UPPSALA) che mostra gli spettrogrammi dei segnali, quindi sono stati estrapolati i dati caratteristici del segnale in esame e questi, una volta inseriti in un database di riferimento, sono stati confrontati con segnali d’identità nota (RUSSO & JONES, 2002). Il confronto statistico ha fornito l’identità del segnale incognito e il grado di attendibilità del risultato. Per avvalorare i dati, si è posto un valore minimo di attendibilità del risultato (80%), al di sotto del quale i risultati ottenuti sono stati invalidati. 2. Piccoli Mammiferi – Sono stati rilevati tramite analisi delle borre (cfr. MASSA & SARÀ 1982; SARÀ & MASSA 1985; SARÀ & ZANCA, 1988; 1989B) e trappolamenti. Relativamente alla borre, sono stati effettuati sopralluoghi lungo le pareti, case in rovina ed anfrattuosità, al fine di individuare posatoi e nidi di rapaci notturni. Le borre ritrovate sono state portate in laboratorio per aprirle, ripulire i campioni ossei e identificare le specie presenti. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 91 I trappolamenti sono stati effettuati attraverso l’ausilio di trappole incruente per la cattura di alcune specie (cfr. SARÀ & CASAMENTO 1993; CASAMENTO & SARÀ 1993), al fine di determinare la presenza delle specie e non la loro abbondanza e densità di popolazione. Le trappole erano di quattro modelli diversi (LOT, Trip trap, Ugglan e gabbie metalliche) per assicurare la copertura selettiva e prendere specie di diverse dimensioni. 3. Altri Mammiferi - Oltre ai metodi precedenti, si è proceduto al rilevamento delle tracce delle specie di mammiferi di maggiori dimensioni e di quelle non riscontrabili attraverso l’analisi delle borre o l’impiego di trappole. Le escursioni mirate, soprattutto condotte al tramonto o la mattina presto, sono state dedicate all’avvistamento diretto e al rinvenimento delle tracce e deiezioni di istrice, riccio, volpe e coniglio. Inoltre sono state rilevate tutte le aree coperte dai buchi che testimoniano i sistemi di tane delle arvicole del Savi, di coniglio e di istrice. I rilevamenti si sono concentrati in tutta l’area del SIC, le tracce e le osservazioni sono state cartografate rilevando le coordinate del punto con il GPS. Metodologia adottata per la redazione delle carte tematiche Per la gestione delle informazioni relative alla distribuzione faunistica è stato sviluppato un progetto GIS all’interno del quale sono state inserite tutte le informazioni georeferenziate relative alla tipologia e alla distribuzione degli habitat. Per ciascun habitat (o poligono relativo) è stato calcolato sia il perimetro che l’area. E’ stato costruito un geodatabase strutturato secondo il modello ‘entità/relazioni’, che è stato successivamente implementato all’interno del progetto GIS principale. Nel database, costituito da diverse schede, sono state inserite le informazioni relative alla Scheda Natura di ciascuna specie presente all’interno della riserva, e gli habitat in cui la specie è presente. Il file vettoriale relativo alla distribuzione degli habitat è stato così “relazionato” secondo una procedura di “join” , su un attributo comune, al geodatabase contenente le informazioni faunistiche. Dal progetto così strutturato è stato possibile eseguire tutte le query e le operazioni di selezione per l’identificazione dell’areale di distribuzione di ciascuna specie all’interno del SIC, con la possibilità di distinguere 4 categorie di habitat suddivise in 4 categorie principali: • • • • habitat di riproduzione: ovvero habitat frequentato da una determinata specie, sia stanziale che nidificante estiva (uccelli), esclusivamente per la riproduzione e le attività connesse (corteggiamento, roosting, guardiania del sito, ecc). habitat di alimentazione: habitat frequentato da una determinata specie, sia stanziale che nidificante estiva (uccelli), esclusivamente per le attività connesse all’alimentazione ed alla caccia e le attività connesse (controllo e marcaggio del territorio, ecc); habitat di alimentazione e riproduzione: in tutti i casi in cui non esiste una distinzione netta tra i due habitat sopra definiti, e la specie si riproduce negli stessi habitat che rappresentano anche il suo territorio di alimentazione; habitat di migrazione: habitat usato dalle specie (uccelli) durante le soste, le tappe ed i transiti delle migrazioni autunnali ed invernali; sono inclusi sia gli habitat usati per la sosta, il riposo, il riparo durante avverse condizioni meteorologiche, la concentrazione degli stormi e la presa delle termiche, che quelli usati per l’alimentazione durante la migrazione o l’ingrasso nel periodo pre-migratorio. Sono stati così prodotti una serie di file vettoriali relativi all’area di distribuzione, uno per ciascuna specie censita all’interno della riserva (esclusivamente per i taxa degli anfibi, rettili, uccelli e mammiferi). Sono state infine condotte analisi spaziali per l’individuazione della Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 92 componente faunistica di ciascun habitat e, per stabilirne il valore faunistico, è stata messa a punto una procedura per l’attribuzione di un valore oggettivo a ciascun habitat. Sono stati utilizzati i seguenti software, ArcInfo (ESRI) quale software GIS, Access (Microsoft) per lo sviluppo del da base, WGeo per la georefenziazione delle entità e Statistica 7.0 (Statsoft Inc.) per le elaborazioni statistiche. La carta di distribuzione è stata redatta per ogni singola specie, e riporta i dati puntuali di presenza rilevati su campo e la distribuzione sulla base di dati bibliografici e dell’idoneità ambientale. Questa carta riporta inoltre un tematismo con gli elementi puntuali di maggiore interesse, quali nidi, pozze, posatoi, dormitori, transiti, ecc. La carta delle aree di importanza faunistica è una carta di sintesi che rappresenta le aree di maggiore interesse faunistico presenti nel Sito, ed in particolare: - aree di presenza di specie e/o di comunità rilevanti - aree di distribuzione (reale e potenziale) di specie e/o di comunità rilevanti - elementi puntuali di maggiore interesse quali nidi, pozze, posatoi, dormitori, transiti, ecc. Dove opportuno sono state riportate anche le informazioni relative ad aree esterne ma contigue al Sito, frequentate da specie/comunità di interesse conservazionistico. 2.3.2.3 Risultati delle indagini e descrizione faunistica del sito (B.3) Check-list della fauna vertebrata e descrizione delle specie rinvenute Di seguito è riportata la check-list commentata di tutte le specie rinvenute o segnalate nel passato per il SIC. Complessivamente nel SIC sono citati 118 taxa di vertebrati; di questi, 93 provengono dagli studi effettuati per la redazione del PdG, mentre 85 erano già noti per il SIC. Classe Specie P P P P P A A A A R R R R R R R R R R U U Rutilus rubilio Tinca tinca Carassius auratus Carassius sp. Gambusia hoolbroki Bufo bufo spinosus Discoglossus pictus Bufo gr. viridis Rana bergeri x hispanica Chalcides ocellatus tiligugu Emys trinacris Hierophis viridiflavus Lacerta bilineata Natrix natrix sicula Podarcis sicula Podarcis wagleriana Tarentula mauritanica Chalcides chalcides Zamenis longissimus Alauda arvensis Accipiter nisus Dati Studi PdG x x x x x x x Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano x x x x x x x x Dati storici e bibliografici Scheda Natura 2005 x x x x x x x x x x x x x x x x x 93 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U Anthus campestris Anthus pratensis Apus apus Athene noctua Buteo buteo Calandrella brachydactyla Carduelis cannabina Carduelis carduelis Certhia brachydactyla Cettia cetti Circus aeruginosus Circus cyaneus Circus pygargus Cisticola jundicis Columba livia Columba palumbus Coracias garrulus Corvus corax Corvus corone cornix Corvus monedula Coturnix coturnix Cululus canorus Cyanistes caeruleus Delichon urbicum Emberiza cirlus Erithacus rubecula Falco biarmicus Falco peregrinus Falco tinnunculus Ficedula hypoleuca Ficedula albicollis Fringilla coelebs Fulica atra Galerida cristata Garrulus glandarius Gallinula chloropus Hieraaetus pennatus Hirundo rustica Lanius senator Larus michaellis Loxia curvirostra Lullula arborea Luscinia megarhynchos Merops apiaster Miliaria calandra Milvus migrans Monticola solitarius Motacilla alba Muscicapa striata Oenanthe hispanica Oenanthe oenanthe Oriolus oriolus Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 94 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Otus scops Parus major Passer hispaniolensis Pernis apivorus Phoenicurus ochrurus Phylloscopus collybita Phylloscopus sibilatrix Pica pica Regulus ignicapillus Saxicola rubetra Saxicola torquata Scolopax rusticola Serinus serinus Streptopelia decaocto Streptopelia turtur Strix aluco Sturnus unicolor Sylvia atricapilla Sylvia cantillans Sylvia conspicillata Sylvia melanocephala Troglodytes troglodytes Turdus merula Turdus philomelos Tyto alba Upupa epops Apodemus sylvaticus dichrurus Crocidura sicula Erinaceus europeus consolei Hypsugo savii Hystrix cristata Lepus corsicanus Martes martes Microtus savii nebrodensis Mus domesticus Mustela nivalis Myotis blithi Myotis myotis Oryctolagus cuniculus Pipistrellus kuhlii Pipistrellus pipistrellus Rhinolophus ferrumequinum Rattus rattus Suncus etruscus Vulpes vulpes Totale Vertebrati x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 88 Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 83 38 95 Delle 118 specie citate per il SIC, sono state considerate effettivamente presenti 109 specie, in quanto sono state escluse alcune specie (Circus pygargus, Coturnix coturnix, Hieraaetus pennatus, Lanius senator, Loxia curvirostra, Oenanthe ispanica, Oriolus oriolus, Phylloscopus sibilatrix, Saxicola rubetra) perché riferite a segnalazioni dubbie o trattandosi di specie che solo occasionalmente sono state rinvenute nell’area (ad es. Phylloscopus sibilatrix, Oenanthe Hispanica, ecc.), e per le quali occorrono successivi approfondimenti. La presenza o l’assenza di queste specie non varia il profilo faunistico ed il valore d’importanza del Sito, e pertanto si rimanda al piano di monitoraggio e ad ulteriori specifici studi per la verifica della loro presenza. 82 specie di vertebrati, delle 109 specie considerate, soddisfano i criteri di inserimento nella Scheda Natura. Pesci Anfibi Rettili Uccelli Mammiferi SPECIE CONSIDERATE Pesci Anfibi Rettili Uccelli Mammiferi SPECIE INSERITE IN SCHEDA NATURA STUDIO PdG N % 5 4,6% 4 3,7% 10 9,2% 71 65,1% 19 17,4% 109 100% SCHEDA NATURA N % 2 2,4% 4 4,9% 7 8,5% 54 65,8% 15 18,3% 82 100% PESCI Nel complesso sono state individuate 6 forme ittiche: al riguardo va evidenziato che diversi carassi risultavano di piccole dimensioni e privi di pigmentazione, per cui sul campo non è stato possibile evidenziare se appartenessero comunque a Carassius auratus o a Carassius carassius: si è scelto di indicare questi esemplari come Carassius sp. Non è stata catturata la carpa, che pure è stata recentemente immessa a seguito dello svuotamento di una vasca di irrigazione; verosimilmente il numero immesso (meno di trenta individui) rendeva molto difficile la cattura di tali esemplari in tempi di campionamento così limitati; alternativamente, ma meno probabilmente, gli esemplari non hanno attecchito. Nessuna specie è autoctona in Sicilia: tutte le specie sono di introduzione, alcune verosimilmente molto antica (tinca, carassio dorato), altre più recente (gambusia), altre molto recenti (rovella). Alcune di esse non sono neanche autoctone in Italia, come il carassio dorato e la gambusia. Due specie sono di particolare interessa conservazionistico: la rovella e la tinca, le cui popolazioni naturali in Italia appaiono dare segni di contrazione. La rovella in particolare risulta essere un endemismo della penisola italiana ed in particolare dell'Italia centromeridionale. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 96 Per quanto concerne la provenienza delle specie nell'ambiente campionato è assodato che sono state frutto di una o più immissioni effettuate almeno 15 anni fa dal proprietario del fondo, che le avrebbe catturate nel fiume Belice. La gambusia è stata osservata pressochè in tutto il laghetto, in particolare lungo la fascia più prossima alle rive; il popolamento è apparso piuttosto abbondante. Per quanto riguarda le catture tramite le nasse, la specie più frequentemente catturata (5 nasse su 9; 5 su 7 se si considera che due nasse non hanno riportato alcuna cattura in entrambi i giorni), come anche la numericamente più abbondante, è stata la rovella, seguita dal pesce rosso e dalla tinca. ANFIBI E RETTILI Nell’ambito dei rilevamenti su campo sono state contattate tre specie di anfibi. Di queste, il discoglosso è il meno frequente ed il più localizzato. Diversi individui singoli di rospo comune sono stati contattati, alcuni investiti sulle strade di accesso al SIC. Durante lo svuotamento del laghetto per i lavori di rinaturazione svolti nell’estate 2007 sono stati contate un centinaio di rane verdi, dato che conferma l’elevata frequenza di osservazione riportata in tabella. Relativamente al Bufo gr. Viridis, si segnala che, nell’ambito di una recente indagine sulla biogeografia e sulla sistematica di questo gruppo nel bacino del Mediterraneo, è stato messo in evidenza che le popolazioni siciliane sono differenziate dalle altre popolazioni a livello sia genetico, sia morfometrico; tale indagine ha portato alla descrizione di una nuova specie endemica (Bufo siculus, precedentemente riportatato come B. viridis) che rappresenta il sister taxon della specie nord-africana B. boulengeri. Nella Sicilia orientale è inoltre presente una seconda specie di Rospo smeraldino (Bufo balearicus), che sembra essere giunto dal sud Italia durante gli abbassamenti del livello del mare che hanno caratterizzato le glaciazioni del Pleistocene (STÖCK et al., 2008). Attualmente sono in corso ulteriori indagini con lo scopo di individuare l’area di distribuzione delle due specie nella Sicilia. I rospi smeraldini rinvenuti a Santa Ninfa dovrebbero quindi appartenere alla nuova specie Bufo siculus, tuttavia, poiché non è stato possibile effettuare delle analisi genetiche di controllo, si preferisce in questa sede utilizzare il vecchio nome Bufo gr. viridis (anche considerato che lo status di protezione della Direttiva 92/43 e delle Liste Rosse è riconosciuto a quest’ultima specie). Per quanto riguarda le rane verdi, queste costituiscono un gruppo di anfibi anuri caratterizzato da una notevole varietà di forme, dimensioni e colori, che ne rendono difficile l’identificazione (LAPINI, 2005). La sistematica dei taxa presenti nel territorio italiano non è ancora ben definita. Le popolazioni siciliane, in mancanza d’indagini che possano chiarire il loro stato sistematico, vengono attribuite al synklepton costituito da Rana bergeri e R. klepton hispanica presente nell’Italia peninsulare (CAPULA, 2006). Si tratta di popolamenti misti dei due taxa, che, poiché risultano difficilmente distinguibili sul campo, vengono generalmente trattati come un’unica entità. Le specie più interessanti rinvenute nell’area sono 1) Bufo gr. viridis, che rappresenta l’anfibio meno comune e più localizzato (e anche l’unico anfibio endemico siciliano nella denominazione Bufo siculus); 2) Discoglossus pictus, specie abbastanza comune nell’isola, ma dalla ridotta area di distribuzione in quanto presente solo in Sicilia, nelle isole di Malta e Gozo, e in parte nord Africa; è inoltre un interessante entità tipica mediterranea, opportunista e perfettamente adattata alle condizioni ambientali xeriche. Entrambe le specie sono inserite nell’allegato IV della Direttiva Habitat; il Discoglosso dipinto è anche presente nell’Appendice II della Convenzione di Berna e nella Lista Rossa italiane delle specie minacciate, il Rospo smeraldino nell’Appendice III della Convenzione di Berna. Sono state rinvenute sei specie di rettili. Le due specie di lucertola ed il ramarro risultano molto comuni in tutti gli ambienti del SIC; il biacco si rinviene con una certa frequenza, la Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 97 specie è soggetta a mortalità stradale e se scoperta viene sistematicamente uccisa; il gongilo è il rettile meno frequente e più localizzato. Durante lo svuotamento del laghetto per i lavori di rinaturazione svolti nell’estate 2007 è stata catturata una natrice dal collare, specie non contattata nei rilevamenti. UCCELLI Il censimento è stato effettuato sia per gli svernanti che per i nidificanti. Lo svernamento è stato censito in 5 diverse tipologie ambientali che sintetizzano gli habitat della maggior parte delle specie censite. Sono state contattate 32 specie di uccelli, tra cui tre rapaci diurni (gheppio, lanario e poiana). La ricchezza specifica maggiore si riscontra nella gariga ad Ampelodesma, nel mosaico vegetazionale e nel rimboschimento con sottobosco di Ampelodesma. Le zone a vigneto, seppur con lembi o ai margini della gariga, sono le più povere di specie, insieme ai rimboschimenti chiusi. 25 Ricchezza specifica 20 15 10 5 co bo s co tto bo s so tto en to im ch bo s rim rim bo s m ch os im se nz en to a +s o ta z ai co ga ve ge rig a ga +v ig n io n et rig a o al e 0 Nella tabella sono riportate le frequenze standardizzate sul totale delle stazioni di osservazione e di ascolto effettuate in gennaio e febbraio, in modo da quantificare la presenza delle specie negli habitat censiti. La specie più frequente ed ubiquitaria è il pettirosso, insieme ad alcune specie generaliste come l’occhiocotto, la gazza ed i carduelini; le specie più legate alla vegetazione arborea sono localizzate nei rimboschimenti (rampichino, fiorrancino, luì piccolo); interessante il rilevamento della beccaccia, che evidentemente sverna con una piccola popolazione. La presenza di queste specie è un indice della maturazione dei rimboschimenti. Altre specie tipicamente boschive come il fringuello ed il colombaccio usano anche gli ambienti aperti per foraggiare. La presenza del sottobosco ad Ampelodesma all’interno dei rimboschimenti permette l’insediamento di una ricca popolazione di passeriformi di macchia, come l’occhiocotto, lo scricciolo ed il pettirosso. L’allodola e la pispola risultano localizzati nei mosaici vegetazionali, la civetta nella gariga. La poiana, il lanario ed il gheppio cacciano preferenzialmente negli ambienti aperti. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 98 Specie Alauda arvensis Lullula arborea Phylloscopus collybita Regulus ignicapillus Turdus philomelos Motacilla alba Falco biarmicus Scolopax rusticola Streptopelia dacaocto Anthus pratensis Athene noctua Buteo buteo Certhia brachydactyla Corvus corone Garrulus glandarius Passer hispaniolensis Phenichurus ochrurus Saxicola torquata Cisticola juncidis Columba palumbus Emberiza cirlus Falco tinnuculus Fringilla coelebs Troglodytes troglodytes Carduelis carduelis Parus major Turdus merula Carduelis cannabina Pica pica Sylvia melanocephala Serinus serinus Erithacus rubecula Ricchezza specifica Gariga e pseudo steppa Vigneto e lembi gariga Mosaico vegetazionale Rimboschimento Rimboschimento con sottobosco senza sottobosco 2,86% 5,71% 8,57% 2,86% 11,43% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 11,43% 14,29% 14,29% 14,29% 17,14% 8,57% 5,71% 2,86% 5,71% 8,57% 2,86% 8,57% 2,86% 11,43% 17,14% 2,86% 17,14% 11,43% 5,71% 14,29% 11,43% 20,00% 14,29% 20,00% 25,71% 25,71% 25,71% 28,57% 28,57% 31,43% 37,14% 48,57% 7 20 20 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 5,71% 2,86% 2,86% 2,86% 5,71% 2,86% 2,86% 5,71% 2,86% 5,71% 2,86% 2,86% 2,86% 11,43% 2,86% 5,71% 2,86% 5,71% 8,57% 11,43% 14,29% 21 F% Totale 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 5,71% 5,71% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 8,57% 2,86% 2,86% 2,86% 5,71% 5,71% 2,86% 2,86% 5,71% 2,86% 2,86% 10 32 La nidificazione è stata rilevata negli stessi habitat, e sono state contattate 36 specie di uccelli, tra cui quattro specie rapaci (gheppio, poiana, pellegrino, lanario), che frequentano la gariga come habitat per l’alimentazione. Analogamente agli habitat di svernamento, la ricchezza specifica maggiore si è riscontrata nel rimboschimento con sottobosco di Ampelodesma, cui seguono tutti gli altri ambienti con 13-16 specie. La fisionomia della comunità cambia alquanto, oltre al nucleo di specie stanziali, formato da 31 specie equivalenti al 70,5% dell’avifauna censita; in primavera vengono a mancare le specie svernanti (beccaccia, codirosso spazzacamino, pettirosso, allodola, pispola, ecc) che sono sostituite da specie estivanti che nidificano nell’area del SIC (gruccione, upupa, sterpazzolina, usignolo, tortora selvatica). Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 99 30 Ricchezza specifica 25 20 15 10 5 se nz a to rim bo sc hi m en rim bo sc hi m en so tto bo sc o to +s ot to bo sc o e m os ai co ve ge ta zi on al a+ vi gn et o ga rig ga rig a 0 Nella tabella sono riportate le frequenze standardizzate sul totale delle stazioni di osservazione e di ascolto effettuate in maggio e giugno 2007 ed aprile e maggio 2008, in modo da quantificare la presenza delle specie negli habitat censiti. La specie più frequente è lo strillozzo, che comunque si incontra solo negli ambienti aperti. Altre specie con elevata frequenza sono il colombaccio, che nidifica nei rimboschimenti ed utilizza i mosaici e le garighe per alimentarsi, ed altre specie come l’occhiocotto ed il beccamoschino, che riescono ad utilizzare gli ambienti aperti e la gariga che forma il sottobosco del rimboschimento. Le specie più legate alla vegetazione arborea sono localizzate nei rimboschimenti (rampichino, fiorrancino, cinciarelle, cinciallegra, ghiandaia, ecc). La presenza del sottobosco ad Ampelodesma all’interno del rimboschimento permette l’insediamento di una ricca popolazione di scricciolo, già rilevata nel censimento degli svernanti, e di altre specie come l’upupa, il fringuello, ecc. Il rimboschimento è anche l’habitat di nidificazione di una coppia di poiana. La tortora dal collare è stata contattata con poca frequenza nel rimboschimento. Specie Columba palumbus Troglodytes troglodytes Miliaria calandra Cisticola juncidis Emberiza cirlus Pica pica Sylvia melanocephala Turdus merula Carduelis carduelis Garrulus glandarius Parus major Galerida cristata Certhia brachydactyla Saxicola torquata Gariga e pseudo steppa 13,89% 11,11% 5,56% 5,56% Vigneto e lembi gariga 2,78% 2,78% 5,56% 5,56% 2,78% Mosaico Rimboschimento Rimboschimento vegetazionale con sottobosco senza sottobosco 2,78% 8,33% 5,56% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 11,11% 8,33% 2,78% 2,78% 19,44% 22,22% 16,67% 5,56% 5,56% 16,67% 2,78% 8,33% 16,67% 8,33% 11,11% 13,89% 2,78% 11,11% 2,78% 5,56% 5,56% 5,56% 2,78% 2,78% 2,78% Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 5,56% 2,78% 5,56% F Totale 41,67% 30,56% 27,78% 25,00% 25,00% 22,22% 22,22% 22,22% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 13,89% 13,89% 100 Carduelis cannabina Passer hispaniolensis Sylvia cantillans Buteo buteo Corvus corone Fringilla coelebs Athene noctua Cettia cetti Luscinia megarhynchos Serinus serinus Sylvia atricapilla Cyanistes caeruleus Merops apiaster Streptopelia turtur Falco tinnuculus Lullula arborea Regulus ignicapillus Falco biarmicus Streptopelia decaocto Upupa epops Falco peregrinus Tyto alba Ricchezza specifica 5,56% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 5,56% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 8,33% 8,33% 2,78% 5,56% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 5,56% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 14 13 15 26 16 11,11% 11,11% 11,11% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 36 Complessivamente la comunità di uccelli che usa gli ambienti del SIC, rilevata durante il periodo di campionamento, è formata da 31 specie residenti, due delle quali (lanario e pellegrino) usano il SIC come territorio di caccia ma nidificano esternamente; 8 specie svernanti e 5 specie nidificanti estive. A queste specie vanno aggiunte lo storno nero (Sturnus unicolor) la taccola (Corvus monedula) ed il piccione selvatico (Columba livia), rilevati al di fuori delle stazioni d’ascolto, soprattutto nei mosaici vegetazionali ed in aree di gariga, sia d’inverno che d’estate e le specie contattate nei rilevamenti forniti dall’ente gestore. Relativamente ai rapaci notturni, è stata evidenziata la presenza di 3 specie; l’assiolo è la specie più frequente, con un popolazione formata da un minimo di 8 coppie, equivalenti ai maschi in canto territoriale che hanno risposto al playback. Segue la civetta, con un minimo di 4 coppie (probabilmente la popolazione si aggira sulle 6-7 coppie), e l’allocco con una sola coppia, localizzata a ridosso delle pale eoliche che confinano con il SIC. Il costone di roccia, con gariga, rimboschimento e arborati e campi coltivati nel fondo valle è risultata la stazione di ascolto più ricca, ovvero quella dove sono state contattate tutte e tre le specie. La comunità di Strigiformi è formata da una quarta specie, rilevata non al playback, ma grazie alle ricerca delle borre: il barbagianni. Il sito dell’unica coppia di barbagianni è fuori dal SIC (Stazione di S. Ninfa). Relativamente ai rapaci diurni, si evidenzia che gheppio (almeno 2 coppie) e poiana frequentano regolarmente le aree del SIC, tendono a cacciare ed a effettuare i display di corteggiamento sugli habitat aperti; la poiana caccia e perlustra frequentemente anche i rimboschimenti, dove probabilmente nidifica una coppia. Il lanario ed il pellegrino nidificano nelle vicinanze del SIC, ma usano il territorio del SIC come terreno di caccia. Lo sparviero Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 101 (Accipiter nisus) ha recentemente colonizzato le aree a rimboschimento, com’è avvenuto in habitat simili e limitrofi (ad es. Piana degli Albanesi). Lo studio della migrazione ha consentito di escludere alcune specie prima segnalate (ad esempio Coturnix coturnix e Lanius senator). Oltre alle specie già discusse sopra, nel SIC sono state contattate altre 10 specie migratorie: Ficedula hypoleuca e Muscicapa striata sono migratori primaverili contattati negli ambienti boschivi e negli arboreti, mentre Oenanthe oenanthe, Anthus campestris, Calandrella brachydactyla sono state contattate negli habitat di gariga e più steppici. Hirundo rustica è un comune migratore nei mesi di marzo ed aprile e probabilmente alcune coppie nidificano in aree agricole esterne nei dintorni del SIC. Dalla tarda estate a tutto l’autunno l’area del SIC è interessata dalla migrazione di Milvus migrans e Circus aeruginosus. L’albanella reale (Circus cyaneus) sverna nei dintorni del SIC ed è stata contattata più volte nel parco eolico limitrofo. Nell’inverno del 2008, infine, nel parco eolico limitrofo è stato contattata un’aquila anatraia maggiore (Aquila clanga). MAMMIFERI Chirotteri - Durante i rilevamenti effettuati presso l’entrata della Grotta di S. Ninfa sono stati registrati 4 segnali d’ecolocalizzazione, risultati appartenere a due Rhinolophus hipposideros (Ferro di cavallo minore), specie che è stata avvistata anche all’interno della cavità. Alcuni individui di R. hipposideros sono stati censiti anche presso un secondo sito ipogeo, dove trova rifugio anche un’altra specie di Rinolofide, il Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum). I censimenti condotti presso gli altri 3 siti di potenziale roosting, una parete rocciosa con cavità e anfratti, e due inghiottitoi presenti nella zona del SIC, hanno dato esito negativo. Relativamente agli habitat di alimentazione, sono state contattate 6 specie di chirotteri (cfr. Tabella) per un totale di 82 segnali d’ecolocalizzazione. Le due specie di Rinolofidi sono le più rare, mentre le specie antropofile e generaliste sono le più frequenti, prima fra tutte Pipistrellus kuhlii, seguita da Hypsugo savii e Pipistrellus pipistrellus. Ad eccezione di R. hipposideros e R. ferrumequinum, registrati nel momento in cui uscivano dai rifugi, le altre specie sono state generalmente contattate durante il volo di foraggiamento. L’habitat di foraggiamento più ricco di specie è lo stagno, dove si registrano anche specie più selettive come il Miniopterus schreibersii ed il Pipistrellus pipistrellus. Le specie generaliste sono state contattate presso le aree di gariga e all’interno dell’area di rimboschimento, e alcuni esemplari di P. kuhlii sono stati registrati in volo di foraggiamento presso le luci stradali. La comunità di chirotteri censita presenta tre specie che sono di particolare interesse conservazionistico, per la protezione delle quali si richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Piccoli Mammiferi – Sono state contattate 6 specie, che rappresentano la quasi totalità della tipica comunità di piccoli mammiferi presente nelle aree a gariga ed agricole che formano il paesaggio agrario di Santa Ninfa e di tante altre analoghe zone della Sicilia nord-occidentale. La settima specie, non contattata è il quercino. Per essere sicuri della sua presenza/assenza sono necessari studi più approfonditi. I trappolamenti sono stati effettuati nelle zone di gariga della Menta, nell’alloreto e nel rimboschimento. Il ratto nero domina come frequenza in questi tre habitat, mentre non è stato ritrovato nelle borre rinvenute nelle zone di mosaico vegetazionale. Il Ratto nero frequenta e sembra relativamente comune sia nelle zone di gariga che nelle zone di rimboschimento con sottobosco più fitto ed umido. La diffusione di questa specie va attentamente monitorata, in Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 102 quanto il ratto è un forte competitore del quercino e preda uova e nidiacei di uccelli nel sottobosco e tra gli alberi. La comunità più ricca di micromammiferi si trova nelle zone di gariga e nel mosaico vegetazionale, dove vive la crocidura di Sicilia, endemismo insulare, insieme al mustiolo, altra specie interessante di mammifero insettivoro, al topo selvatico ed all’arvicola del Savi. La litologia compatta dei substrati carsici non permette un forte insediamento dell’arvicola, che è ristretta alle zone dove il suolo è più morbido. Nel corso delle escursioni sono stati rilevati diversi sistemi di tane, poco estesi e circoscritti. Degno di nota è l’adattamento del topo selvatico ad ambienti di gariga, soprattutto nelle zone di dolina o con litologia tormentata, dove questa specie, di solito dall’ecologia più boschiva, riesce a ricavare nutrimento e riparo. Altri Mammiferi – Il coniglio, la volpe e l’istrice sono le specie più frequenti, in tutti gli habitat del SIC. Degna di nota la buona popolazione di istrice. Il riccio europeo appare molto più localizzato alle zone agricole ed ai mosaici. La lepre italica è molto rara, l’habitat del SIC non è idoneo a questa specie che frequenta zone meno pietrose, accidentate e con suoli meno calcarei e aridi. La sua presenza è ristretta alle zone vallive più ampie, occupate dal vigneto, perlopiù esterne al SIC. Infine, è degno di nota il rinvenimento di tracce di cinghiale ibrido, si tratta delle prima prova certa di presenza dentro il SIC di questa specie, che va attentamente monitorata e gestita. Fauna invertebrata Nell’ambito selle attività del Piano di Gestione non è stato possibile effettuare studi sulla fauna invertebrata. I dati noti, nonché i risultati di alcuni rilevamenti compiuti durante i sopralluoghi per il Piano di Gestione, sono frutto di raccolte casuali e pertanto non sono sufficienti a definire la presenza dei diversi taxa, la loro distribuzione ed il loro ruolo ecologico. Sino a prima della redazione del Piano, gli unici dati organici sono riferiti alla fauna ipogea della Grotta di Santa Ninfa (CASAMENTO, 2001), che è però esterna al perimetro del SIC, e a qualche raccolta di insetti appartenenti prevalentemente agli ordini dei Coleotteri. Per ricostruire un quadro preciso della fauna invertebrata del Sito sono necessari studi più accurati e prolungati nel tempo; i dati attuali necessitano di approfondimenti e non consentono di compiere delle elaborazioni sulla fauna invertebrata. Per questo motivo si è ritenuto di non inserire alcuna specie nella Scheda Natura 2000. Applicazione di indici per la valutazione del valore delle singole specie ed individuazione delle specie e delle comunità di interesse conservazionistico del Sito Sulla base delle specie rinvenute su campo e/o segnalate dall’ente gestore, sono state individuate le specie target, su cui focalizzare in modo particolare l’attenzione. La scelta di tali specie è stata fatta preferendo specie-target differenti in relazione alle diverse categorie ambientali presenti nel contesto ambientale del SIC, ciascuna rappresentativa di un gruppo affine ecologicamente, in modo da assolvere a funzioni ecologiche differenti. Sono state prese in considerazione: • specie di interesse conservazionistico inserite in Liste rosse nazionali e locali; • specie endemiche e/o localizzate, o comunque di interesse biogeografico; Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 103 • specie che, sebbene relativamente diffuse e comuni, presentano una certa vulnerabilità alla frammentazione ambientale, svolgendo quindi un ruolo chiave nella funzionalità dei sistemi ecologici. Per valutare le singole specie è stata messa a punto una metodologia, delineata in GIUNTI et al. (2008) e in MASSA & CANALE (2008), che si basa essenzialmente nell’attribuzione di punteggi variabili in base alle tipologie in cui ogni specie ricade, in modo da fornire un indice che permette di ordinare le specie secondo un ordine decrescente di importanza e priorità. Tale indice è attribuito ad ogni singola in base ai criteri ecologici della specie desumibili dalle fonti bibliografiche relative alla Sicilia, dalle conoscenze dirette degli operatori esperti della fauna e della situazione ambientale ed ecologica del SIC; in breve considerando il grado di minaccia e lo status di popolazione che la specie ha nel SIC. Le specie sono state pesate attribuendo un punteggio secondo la tabella sottostante che riporta il caso dei mammiferi, anfibi e rettili: LISTA ROSSA DIR. 92/43/CEE SPECIE CATEGORIA ENDEMISMO ITALIANA (ALL. II) PRIORITARIA IUCN SICULO Categoria Valore Categoria Valore Categoria Valore Categoria Valore Categoria Valore Assente 0 Assente 0 Assente 0 Assente 0 Assente 0 LR 1 Presente 1 Presente 1 LR 1 Presente 1 VU 2 VU 2 EN 3 EN 3 CR 4 CR 4 Gli uccelli sono stati pesati alla stessa maniera, sostituendo l’allegato I della Direttiva 79/409/CEE ed aggiungendo lo status europeo degli uccelli (BIRDLIFE, 2007) e la categoria SPEC (TUCKER & HEATH 1994). In questo modo è stato ottenuto un valore intrinseco per ognuna delle emergenze faunistiche e questo valore è poi stato moltiplicato per il grado di minaccia nel SIC. Il grado di minaccia, sulla scorta di quanto riportato nelle schede descrittive per ciascuna specie di interesse comunitario viene sinteticamente valutato con la seguente scala decrescente: - Elevato = 3 - Medio = 2 - Basso = 1 - Assente = 0 Il risultato pesa le specie sia in termini del loro valore assoluto di conservazione (valore intrinseco) che in termini di valore relativo all’area del SIC. In termini ponderali una specie con alto valore intrinseco, cioè inserita in allegati di Direttive, in pericolo, rara e con particolari minacce nel SIC, otterrà un punteggio maggiore di una specie di minor interesse conservazionistico e con uno status di popolazione e di minacce nel SIC basso o nullo. L’indice così ottenuto va tarato sulla fenologia delle specie presenti, per una più corretta valutazione del reale peso che le minacce e criticità hanno sull’ecologia e la distribuzione delle specie presenti nell’ambito dell’area protetta. In altre parole, una specie stanziale è soggetta a minacce potenziali per un tempo più lungo di una specie migratrice. I punteggi ottenuti dalla moltiplicazione del valore intrinseco x il grado di minaccia sono stati pertanto divisi per il tempo di permanenza che una specie mostra nel SIC, secondo i criteri seguenti: • 1 per le specie stanziali, con tempo di permanenza di 12 mesi l’anno; • 2 per le specie nidificanti estive, con tempo di permanenza tra 6 e 12 mesi l’anno; • 3 per le specie svernanti o migratori regolari di singolo o doppio passo che sostano per 1-6 mesi l’anno; Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 104 • 4 per le specie migratrici occasionali o accidentali, osservabili solo raramente nel SIC e per convenzione con un tempo di permanenza < ad 1 mese. Questa standardizzazione permette di valutare correttamente la differenza tra specie ad alta e media priorità di conservazione, ma stanziali e quindi potenzialemte soggette ad un rischio e a minacce prolungate nel SIC, rispetto magari ad una specie ad altà priorità ma accidentale. La procedura di selezione ha consentito di evidenziare un elenco di 21 specie, elencate nella tabella seguente, che hanno un punteggio superiore o uguale alla media dei punteggi e che sono considerate indicatori del SIC. Su queste specie si concentreranno le analisi successive relative alle strategie di conservazione ed alle azioni da intraprendere. La tabella successiva indica le 21 specie indicatrici selezionate attraverso l’applicazione dell’indice sopra riportato. Viene anche riportato nell’ultima colonna il valore per indicatore ecologico (VIE) presente nel SIC. . Classe Specie VIE U Falco biarmicus 24 U Tyto alba 12 M Rhinolophus hipposideros 12 U Lullula arborea 12 M Lepus corsicanus 8 M Rhinolophus ferrumequinum 8 U Calandrella brachydactyla 7 U Falco peregrinus 6 U Otus scops 5 U Scolopax rusticola 4,67 A Discoglossus pictus 4 U Upupa epops 4 U Streptopelia turtur 4 U Columba livia 4 M Miniopterus schreibersii 4 A Bufo gr. viridis 3 M Oryctolagus cuniculus huxleyi 3 M Crocidura sicula 3 U Anthus campestris 3 U Milvus migrans 3 U Alauda arvensis 3 Analisi del grado di invasività delle specie aliene (B.3.3) Relativamente al taxon dei Pesci, tutte le specie riscontrate sono alloctone della fauna ittica siciliana (anche se alcune - ad esempio la tinca) sono state introdotte da secoli), ed alcune di quella italiana. La specie aliena che può risultare più problematica per l’area in questione è la gambusia, come predatrice di uova e soprattutto larve delle altre specie: va tra l'altro notato che la sua maggiore diffusione è stata riscontrata in zona litorale, dove è maggiore la presenza di vegetazione e quindi dove si collocano le aree elettive di riproduzione delle altre specie presenti. Risulta quindi necessario effettuare delle indagini specifiche sull'alimentazione di Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 105 questa specie, in relazione alla biologia riproduttiva delle altre specie, ma anche in relazione a tutta la rete trofica lacustre (zoo-fitoplancton) al fine anche di evidenziarne gli eventuali effetti sull'evoluzione della trofia dell'ambiente stesso. Relativamente agli altri taxa di vertebrati, nel SIC non sono state riscontrate specie aliene presenti stabilmente e con consistenti popolazioni. Sono tuttavia state rinvenute le seguenti specie: 1) La tortora dal collare (Streptopelia decaocto), specie alloctona, che ormai ha stabilmente invaso la Sicilia dalla fine degli anni ’80 (AA.VV, 2008), è presente nelle aree urbane e agricole intorno al SIC. Individui penetrano nelle zone agricole alberate ed a vigneto per alimentarsi e probabilmente alcune coppie nidificano nel margine sud-occidentale del SIC. L’espansione della specie in Sicilia, le cui interazioni competitive nell’uso dell’habitat con la tortora selvatica (Streptopelia turtur) non sono state ancora indagate, è limitata nelle zone ad insediamento diffuso tra il SIC e l’abitato di S. Ninfa, tipicamente sule alberature stradali e gli arboreti e frutteti. La tortora dal collare frequenta raramente i rimboschimenti artificiali estesi e fitti, e gli ambienti aperti steppici. La plasticità ecologica della specie rende ipotizzabile un futuro insediamento stabile nel SIC, che andrebbe monitorato e adeguatamente compreso. 2) Sono state rinvenute le tracce della presenza del cinghiale ibrido, la cui diffusione sta creando diversi scompensi ecologici in aree protette (Bosco della Ficuzza, Madonie), probabilmente per diffusione di individui da aree vicine o per immissione volontaria da parte di persone o associazioni locali. La presenza di questa specie va attentamente monitorata e vanno repressi tutti i tentativi illegali d’immissione. La presenza del cinghiale ibrido e la sua diffusione in aree di Parco o di riserva ha causato, in altre zone della Sicilia, la tolleranza dell’esercizio venatorio in queste aree protette, in mancanza d’altro mezzo di controllo, che è subito degenerata in bracconaggio generalizzato. 3) Il ratto nero è risultato abbastanza frequente nelle zone di rimboschimento più fitto. Non è una specie alloctona recente, essendo residente nell’isola fin dal tempo dei Romani, tuttavia è una specie che crea problemi igienici e di contaminazioni,e la cui presenza può determinare campagne di derattizzazioni ed interventi che possono avere riflesso sulle comunità selvatiche naturali. Inoltre la specie è un diretto competitore del quercino ed è un predatore e distruttore di nidi di uccelli. Anche per questa specie vanno previste azioni di controllo e monitoraggio con metodi ecologici e pianificati su scala locale. 4) Nel SIC sono frequenti i cani vaganti, soprattutto nei pressi degli insediamenti agricoli. Non è stata riscontrata una frequenza molto elevata, ma la loro presenza è un fattore di minaccia per tutta la fauna che nidifica o si alimenta sul terreno. Presenza e distribuzione delle specie faunistiche presenti negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, nella Lista Rossa e di quelle che rispondono ai requisiti per l’inserimento nella tabella 3.3 motivazioni A e B del formulario standard Natura 2000 Sulla base dei dati disponibili, sono state create le Carte di Distribuzione per le specie ritenute sensibili del SIC (Tavola 11), distinguendo l’habitat di riproduzione (HAB_RIPR), quello di alimentazione (HAB_ALI), quello di riproduzione e alimentazione (HAB_RIPR&ALI) per le specie in cui la precedente distinzione non è possibile, quello di migrazione (HAB_MIGR). Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 106 La tabella che segue mostra la percentuale di habitat-biotopo occupato da ciascuna specie (suddiviso come sopra), evidenziando il grado di ampiezza ecologica mostrato dalle specie del SIC. Le specie rinvenute, come in ogni comunità, variano da quelle con ampie preferenze ambientali e quindi vasta distribuzione - come la Podarcis sicula ed il Pipistrellus kuhlii – fino a quelle più localizzate in singoli habitat (Lullula arborea, ecc), che mostrano le maggiori esigenze ecologiche. La tabella permette quindi di identificare immediatamente le specie più esigenti da quelle più opportuniste e generaliste, e consente altresì di evidenziare gli habitat utilizzati e frequentati dalle specie più rare. Nella tabella sono indicate in grassetto le specie indicatrici selezionate. N habitat occupati 33 28 25 24 23 21 21 % habitat occupati 89,19% 75,68% 67,57% 64,86% 62,16% 56,76% 56,76% 20 18 17 17 16 16 54,05% 48,65% 45,95% 45,95% 43,24% 43,24% 16 15 15 14 14 13 43,24% 40,54% 40,54% 37,84% 37,84% 35,14% 13 13 13 13 13 12 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 8 35,14% 35,14% 35,14% 35,14% 35,14% 32,43% 29,73% 29,73% 29,73% 27,03% 27,03% 27,03% 27,03% 24,32% 24,32% 24,32% 21,62% Specie Podarcis sicula Pipistrellus kuhlii Delichon urbicum Apus apus Pipistrellus pipistrellus Hierophis viridiflavus Hystrix cristata Hirundo rustica Falco peregrinus Bufo bufo spinosus Columba livia Hypsugo savii Milvus migrans Oryctolagus cuniculus huxleyi Chalcides ocellatus tiligugu Motacilla alba Fringilla coelebs Tyto alba Crocidura sicula Erinaceus europeus consolei Erithacus rubecula Merops apiaster Phoenicurus ochrurus Upupa epops Lacerta bilineata Anthus pratensis Natrix natrix sicula Sylvia cantillans Circus aeruginosus Circus cyaneus Falco biarmicus Streptopelia turtur Miniopterus schreibersii Oenanthe oenanthe Podarcis wagleriana Bufo gr. viridis HAB_RIPR HAB_ALI HAB_RIPR&ALI HAB_MIG 89,19% 8,11% 8,11% 8,11% 5,41% 67,57% 59,46% 56,76% 56,76% 2,70% 37,84% 5,41% 48,65% 48,65% 40,54% 35,14% 37,84% 5,41% 10,81% 5,41% 56,76% 16,22% 43,24% 10,81% 5,41% 8,11% 32,43% 40,54% 40,54% 37,84% 29,73% 35,14% 8,11% 27,03% 35,14% 2,70% 32,43% 5,41% 8,11% 35,14% 21,62% 32,43% 29,73% 5,41% 24,32% 29,73% 27,03% 27,03% 5,41% 2,70% 27,03% 13,51% 21,62% 8,11% 24,32% 24,32% 13,51% Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 8,11% 107 21,62% Muscicapa striata Rhinolophus 21,62% ferrumequinum 21,62% Sylvia conspicillata 18,92% Ficedula hypoleuca Apodemus sylvaticus 16,22% dichrurus 16,22% Microtus savii nebrodensis 16,22% Rhinolophus hipposideros 13,51% Alauda arvensis 13,51% Discoglossus pictus 13,51% Luscinia megarhynchos 13,51% Otus scops 13,51% Scolopax rusticola 10,81% Anthus campestris 10,81% Turdus philomelos 8,11% Calandrella brachydactyla 5,41% Lepus corsicanus 2,70% Lullula arborea 8 8 8 7 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 2 1 21,62% 2,70% 18,92% 21,62% 18,92% 16,22% 16,22% 2,70% 13,51% 13,51% 13,51% 13,51% 13,51% 8,11% 10,81% 10,81% 5,41% 8,11% 5,41% 2,70% Descrizione del valore faunistico del territorio ed analisi delle aree di importanza faunistica del SIC (B.3.5; B.3.7) La figura sottostante riassume la ricchezza specifica per habitat e per uso, riguardo a tutte le specie stanziali di anfibi, rettili, uccelli e mammiferi ed agli uccelli nidificanti estivi. 45 40 35 Ricchezza specifica 30 25 20 15 10 5 53 31 622 62 _r/6 0 *_ 20 22 f *_ 0* f/5 _r 33 2_ r 34 62 .81 20 82 6 *_p 14 22 _r 0 *_ /6 22 r 0_ r 82 .3 31 .8 A 31 .8 53 1 31 83. _r 11 /8 1 21 4_ 92 A 52 r 0_ 30 f/5 *_ 23 f 0* _ 83 r .1 52 53 .1 83 1 .2 11 53 .6 1 53 .6 83 2 .3 2 92 5 A 0_ 23 f .1 83 1 .3 2 31 2 40 _r 31 . 82 D 14 _p 86 .2 86 .2 2 82 .3 A 8 83 7.2 .3 11 2 85 .3 1 83 10 82 ,4 86 .3 86 1 ,4 13 0 HAB_RIPR HAB_ALI HAB_RIPR&ALI Gli habitat di interesse comunitario presentano il più alto numero di specie, ed in particolare le pseudo-steppe con graminacee perenni e piante annue dei Thero-Brachypodietea (cod. 6220*) e le garighe ad Ampelodesma (cod. 5332). Tra le formazioni vegetali non classificate come habitat di interesse comunitario, i biotopi 82.3 (seminativi e colture erbacee estensive) e Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 108 83.111 (oliveti tradizionali) rientrano nel gruppo degli ambienti più ricchi di specie, sebbene facciano parte del sistema colturale. Gli ambienti del sistema colturale e quelli dei rimboschimenti presentano una ricchezza di specie media o medio bassa. I dati sulla ricchezza delle specie per habitat e/o biotopo hanno consentito di realizzare la Carta del Valore Faunistico (Tavola 12), che è stata redatta attribuendo ad ogni poligono un valore pari al numero di specie della fauna, sia rilevate su campo che potenziali. L'elenco delle specie, e quindi il valore faunistico, è pertanto legato al singolo poligono e non alla categoria (Habitat Direttiva o Corine Biotope) cui il poligono appartiene. Per tale ragione a parità di codice habitat o biotope si possono avere poligoni a differente valore faunistico. Nella Tavola le aree sono campite diversamente in funzione del numero di specie (nessuna specie rilevata=0; 1-5 specie; 6-20 specie; 21-30 specie; oltre 30 specie). La carta conferma quanto detto sopra nella trattazione sulla ricchezza degli habitat/biotopi: gli ambienti più ricchi in specie sono le praterie, le garighe e le rupi, mentre gli ambienti più poveri in numero di specie di interesse risultano i vigneti, gli ambienti ruderali, i rimboschimenti. Il criterio quantitativo (n. di specie presenti) può non essere esauriente del valore faunistico complessivo del SIC, in quanto gli habitat (grotte - 8310; acque dure oligomesotrofiche con Chara - 3140; versanti calcarei dell’Italia meridionale - 8214) ed i biotopi (corpi idrici - 23.11; villaggi - 86.2; fabbricati rurali - 86.22) poveri in numero di specie sono il sito di riproduzione esclusivo di alcune specie che si alimentano negli habitat di gariga e pseudo-steppa; la scomparsa dei siti di riproduzione, per quanto banali, può pertanto comportare l’impoverimento faunistico degli habitat di interesse naturalistico più ricchi di specie. Ne consegue che la diversità biologica del Sito va tutelata nella sua interezza al fine di assicurare il mantenimento di tutte le categorie ambientali presenti, necessarie alle esigenze ecologiche delle varie specie presenti. Nella figura successiva sono evidenziati gli habitat utilizzati nel SIC dagli uccelli migratori. Anche in questo caso le pseudo-steppe con graminacee perenni e piante annue dei TheroBrachypodietea (cod. 6220*) e le garighe ad Ampelodesma (cod. 5332) sono gli habitat che sostengono il maggior numero di specie svernanti e di contingenti di uccelli in migrazione, insieme alle zone umide (cod. 23.11). HAB_MIG 12 Ricchezza specifica 10 8 6 4 2 62 20 * _f /5 33 2_ 23 r 82 .11 14 _p 87 .2 86 .2 86 .2 82 2 .3 A 83 92 10 A0 _f 5 3. /5 11 23 0* 83 _ r .1 53 5 31 8 2 _r 6. /8 31 21 4 5 2 _r 30 *_ 53 f .6 2 8 6 2 2 ,4 20 * 83 _ p .2 11 53 . 83 61 .3 25 85 83 .31 .3 11 34 2 .8 31 1 62 .8A 20 62 * _f 20 * 9 2 _r A0 53 31 83 _f _ 82 r/6 .322 14 22 _r 0* /6 _r 22 0_ r 82 .3 31 . 83 81 .1 31 11 40 _r 31 86 .D ,4 13 0 Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 109 I dati successivi riportano il dato di ricchezza specifica degli habitat-biotopi, sia come numero complessivo di specie rilevate in ogni categoria, sia come dato disaggregato in base alla fenologia di ciascuna specie (distinguendo tra specie residenti, nidificanti estive, svernanti e migratorie). Nella valutazione dei dati sotto riportati, bisogna tenere conto che vi sono alcune specie con doppia fenologia (ad esempio il fringuello è sia residente che svernante). DIRHAB_CB 5331_r/6220*_r 6220*_f 34.81 6220*_f/5333_r 6220*_r 6220*_p 82.3 8214_r/6220_r 31.8A 5331_r/8214_r 83.111 31.81 92A0_f/5230*_r 83.152 83.211 5230*_f 83.325 92A0_f 83.322 31.D 8214_p 53.11 53.61 53.62 23.11 3140_r 82.3A 86.2 83.3112 85.31 86.22 87.2 8310 82.4 86.31 Totale 49 48 47 47 46 44 40 40 29 29 26 26 25 22 20 20 19 18 17 15 15 14 14 14 13 13 11 10 9 8 8 7 5 4 1 Residenti 32 33 31 33 29 31 24 26 20 16 17 18 18 13 11 17 10 12 9 8 8 13 13 13 9 9 6 6 4 4 7 4 5 2 1 Nidificanti estivi 9 9 8 8 9 8 9 8 6 7 7 5 5 7 4 2 6 4 5 5 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 0 0 0 Svernanti Migratori 5 4 4 3 7 3 4 3 5 4 3 3 6 3 3 4 2 2 4 3 3 0 2 2 2 1 3 0 6 0 1 0 2 2 2 1 2 2 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 Infine si riporta la presenza delle specie per habitat-biotopo indicando quante delle suddette specie sono inserite negli allegati delle Direttive Habitat ed Uccelli. Questo tipo di analisi evidenzia che alcune aree caratterizzate dalla presenza di poche specie ospitano un’alta percentuale di specie altamente protette. Gli habitat-biotopi del sistema naturale arido e steppico hanno una maggiore ricchezza specifica, vengono utilizzati da molte specie stanziali e da molte migratrici e generalmente Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 110 sono frequentate come habitat di alimentazione. Invece altri habitat-biotopi (ad esempio 8310; 86.22, 53.61, 53.62) sono poveri di specie, anche se le specie che vi si rinvengono sono generalmente indicatrici, specialiste ed inserite in allegati delle Direttive CEE. Ricchezza N. specie in specifica Direttive 86.31 86.22 86.2 85.31 83.3112 83.325 83.322 83.211 53.11 53.61 53.62 82.4 82.3A 83.152 31.D 83.111 23.11 31.81 34.81 87.2 82.3 31.8A 5230*_f 3140_r 92A0_f 5331_r/6220*_r 8310 8214_r/6220_r 8214_p 5331_r/8214_r 6220*_r 92A0_f/5230*_r 6220*_p 6220*_f 6220*_f/5333_r 1 8 10 8 9 19 17 20 14 14 14 4 11 22 15 26 13 26 47 7 40 29 20 13 18 49 5 40 15 29 46 25 44 48 47 1 5 5 5 6 9 8 8 9 9 9 1 2 12 8 13 6 12 18 3 17 12 10 6 8 20 3 16 9 14 18 13 16 17 16 N. specie in Direttive/N. specie totali % 100 62,50 50 62,50 66,67 47,37 47,06 40 64,29 64,29 64,29 25,00 18,18 54,55 53,33 50 46,15 46,15 38,30 42,86 42,50 41,38 50 46,15 44,44 40,82 60 40 60 48,28 39,13 52,00 36,36 35,42 34,04 L’elaborazione dei dati di distribuzione delle specie rispetto agli habitat e ai biotopi consente di mettere in evidenza gli ambienti più utilizzati, e di evidenziare quantitativamente le aree di importanza faunistica, che vengono rese in termini di ricchezza specifica delle specie che frequentano una determinata tipologia ambientale. Sulla base dei dati di presenza e distribuzione delle specie in ciascun habitat-biotopo, tenendo conto del numero totale di specie, del numero di specie inserite negli allegati delle Direttive e Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 111 del rapporto tra queste e il numero totale, è stato elaborato un indice che ha permesso di redigere la Carta delle aree di importanza faunistica (Tavola 13). 2.3.2.4 Verifica ed aggiornamento della scheda natura 2000 – fauna (B.1) Gli studi effettuati per la redazione del Piano di Gestione hanno permesso di aggiornare la Scheda Natura 2000 del Sito – aggiornamento 2005. Si precisa che le Schede Natura 2000 cui si fa riferimento nel presente capitolo sono quelle trasmessaci ufficialmente dal Servizio VI dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente nel dicembre 2007. In particolare sono state confermate 31 specie già citate, e sono state aggiunte alla Scheda altre 42 specie prima non citate. Sono stati inoltre rivisti tutti i dati relativi sia allo status che alle dimensioni delle popolazioni del SIC e, di conseguenza, quelli relativi alla valutazione del Sito stesso. Per le specie non contattate durante i sopralluoghi, i parametri di popolazione e di valutazione si intendono uguali a quelli riportati nella precedente scheda. Aggiornamento Sezione 3.2.a “Uccelli elencati nell’allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE” Sulla base degli studi effettuati, non viene confermata la presenza dell’aquila minore (Hieraaetus pennatus), un rapace migratore e svernante in Sicilia, che nel 2004 e 2005 aveva avuto un insolito massiccio svernamento in Sicilia (BAGHINO et al., 2007), non ripetuto negli anni successivi. Quindi la specie è da considerare occasionale nel SIC e la sua presenza dipende dalla variabile fenologia di migrazione delle popolazioni europee. Sono state aggiunte due nuove specie prima non segnalate: - albanella reale (Circus cyaneus) - è uno svernante regolare in Sicilia e nell’area SIC (1-2 individui costantemente osservati nell’inverno 2008). tottavilla (Lullula arborea), un alaudide che nel SIC è presente con una piccola popolazione nidificante. - Si è inoltre provveduto a mutare lo status delle altre specie rinvenute, che, segnalate tutte in precedenza con lo status presente (P), vengono adesso segnalate nella nuova scheda con uno status più idoneo e corrispondente alle abbondanze riscontrate sul campo. ● VALUTAZIONE SITO ● Confermata Confermata Calandrella brachydactyla ● Confermata Circus aeruginosus R Anthus campestris Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano R Globale Isolamento Conservazione Popolazione Tappa Nome Svernamento Aggiornamento Nidificazione/riproduzione Migratoria Residente Scheda Natura 2000 POPOLAZIONE D D C D 112 ● Confermata Falco biarmicus V D ● Confermata Falco peregrinus V D ● Eliminata Confermata Hieraaetus pennatus Nuova segnalazione Nuova segnalazione Circus cyaneus ● Milvus migrans R C D R D R Lullula arborea D Aggiornamento Sezione 3.2.b “Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE” ● Eliminata Confermata Delichon urbicum ● Confermata Ficedula hypoleuca ● Confermata Hirundo rustica ● Eliminata Lanius senator Apus apus C D C D C D Globale ● Anthus pratensis D Isolamento ● Confermata R Conservazione R Popolazione Fringilla coelebs ● Nuova segnalazione Confermata Tappa Nome Svernamento Aggiornamento Nidificazione/riproduzione POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO Migratoria Residente Scheda Natura 2000 Non viene confermata la presenza di cinque specie: Lanius senator, Oenanthe hispanica, Oriolus oriolus, Phylloscopus sibilatrix, Saxicola rubetra. Le specie non contattate sono migratori primaverili, alcuni poco frequenti come la monachella (Oenanthe hispanica) o molto elusivi come il luì verde (Phylloscopus sibilatrix) e registrabili di solito grazie all’uso di reti di cattura per inanellamento. In questi casi, la mancata conferma può essere imputata sia all’irregolarità del passaggio e della sosta nell’area di pochi individui, che al mancato rilevamento durante le visite condotte per l’aggiornamento. Sono state inserite sette nuove specie in precedenza non segnalate: Fringilla coelebs, Phoenicurus ochrurus, Alauda arvensis, Erithacus rubecula, Motacilla alba, Streptopelia turtur, Turdus philomelos. Si tratta di svernanti regolari nell’area SIC; il fringuello (Fringilla coelebs) è anche nidificante, quindi andrebbe segnalato nella sezione 3.3, ma viene inserito qui perché in inverno si aggiungono rilevanti contingenti svernanti nell’area. Per tutte le specie sono stati cambiati i parametri relativi alla popolazione come indicato in tabella. Coturnix coturnix Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano R C D D 113 ● Confermata Luscinia megarhynchos C D ● Confermata Merops apiaster C D ● Confermata Muscicapa striata R D ● Eliminata Oenanthe hispanica ● Confermata Eliminata Oenanthe oenanthe R D ● ● Eliminata Oriolus oriolus Phylloscopus sibilatrix ● Eliminata Saxicola rubetra ● Confermata Scolopax rusticola R D ● Confermata Sylvia cantillans C D ● Confermata Sylvia conspicillata C D ● Confermata Upupa epops R D Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Alauda arvensis R D Erithacus rubecula C D Motacilla alba C D Phoenicurus ochrurus C D Streptopelia turtur R D Turdus philomelos R D Aggiornamento Sezione 3.2.c “Mammiferi elencati nell’Allegato II 92/43/CEE” della Direttiva La precedente Scheda Natura 2000 non riportava specie di mammiferi. L’aggiornamento e gli studi per il PdG hanno permesso di contattare tre specie di pipistrelli inseriti in allegato II della Direttiva 92/43/CEE. VALUTAZIONE SITO Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Miniopterus schreibersii P D Rhinolophus hipposideros Rhinolophus ferrumequinum P D P D Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano Globale Isolamento Conservazione Popolazione Tappa Nome Svernamento Aggiornamento Nidificazione/riproduzione Migratoria Residente Scheda Natura 2000 POPOLAZIONE 114 Aggiornamento Sezione 3.2.e “Pesci elencati elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/CEE La precedente Scheda Natura 2000 non riportava specie di Pesci. Sebbene considerata alloctona per la Sicilia, viene inserita la Rovella, in quanto specie endemica della penisola italiana ed in particolare dell'Italia centro-meridionale, le cui popolazioni naturali in Italia appaiono dare segni di contrazione. VALUTAZIONE SITO Isolamento Globale Tappa >100 Conservazione Rutilus rubilio Popolazione Nuova segnalazione Nome Svernamento Aggiornamento Nidificazione/riproduzione Migratoria Residente Scheda Natura 2000 POPOLAZIONE C B A C Aggiornamento Sezione 3.2.f. “Invertebrati elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/CEE Viene eliminata l’unica specie segnalata in precedenza (Rosalia alpina) perché si tratta di una specie molto rara in Sicilia, legata esclusivamente ai faggeti d’alta quota. ● VALUTAZIONE SITO Eliminata Globale Isolamento Conservazione Popolazione Tappa Nome Svernamento Aggiornamento Nidificazione/riproduzione Migratoria Residente Scheda Natura 2000 POPOLAZIONE Rosalia alpina Aggiornamento Sezione 3.3 “Altre specie importanti di Flora e Fauna” Relativamente al taxon dei Pesci, viene inserita Tinca tinca, inserita in Lista Rossa italiana (NT), le cui popolazioni italiane sono in rarefazione. Sono state confermate tutte le specie di Uccelli, eccetto la quaglia (Coturnix coturnix) ed il crociere (Loxia curvirostra). Questo fringillide si alimenta degli strobili delle conifere, ed è noto in Sicilia per pullulazioni e colonizzazioni irregolari in diversi rimboschimenti artificiali; evidentemente la popolazione registrata nel 2005 non si è insediata stabilmente, in quanto nonostante specifiche ricerche non è stata più contattata. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 115 Sono state aggiunte all’elenco venti (20) nuove specie di uccelli; si tratta di specie perlopiù comuni nidificanti in Sicilia e nel SIC, che andavano inserite ai sensi di convenzioni internazionali. Per quanto riguarda i Mammiferi, sono state confermate le specie già citate: lepre italica Lepus corsicanus e riccio europeo, che ha uno status sottospecifico che lo pone come valido endemismo siciliano (cfr. SEDDON et al., 2001). Sono state inoltre aggiunte altre dieci (10) specie di Mammiferi, di cui tre Chirotteri. Relativamente agli Anfibi, la precedente Scheda Natura 2000 non riportava la presenza di alcuna specie. Vengono in questa sede inserite quattro (4) specie: la forma sottospecifica endemica di rospo comune (Bufo bufo spinosus), il rospo smeraldino siciliano (Bufo gr. viridis), un endemita in corso di studio e definizione, il discoglosso (Discoglossus pictus) ed il complesso della rana verde di Uzzell e di Berger. Per quanto riguarda i Rettili, la scheda riportava la presenza di tre specie, che vengono confermate. Sono state inoltre inserite altre 4 specie. Nuova segnalazione ● P Tinca tinca Motivazione Globale Isolamento Conservazione VALUTAZIONE SITO Popolazione Tappa Svernamento Nome Nidificazione/riproduzione Aggiornamento Residente POPOLAZIONE Migratoria Classe Scheda Natura 2000 Per quanto riguarda gli Invertebrati, le due specie citate sono state eliminate in quanto considerate segnalazioni dubbie. Non sono state inserite altre specie in quanto si tratta ancora di dati non certi che necessitano di ulteriori approfondimenti. >100 D A C D CD 1-5 D CD C D ACD 1-5 D CD U Athene noctua ● Confermata Confermata U Buteo buteo ● Confermata U Columba livia ● Confermata U Falco tinnunculus ● U Loxia curvirostra ● Eliminata Confermata U Strix aluco 2 D CD ● Confermata U Sturnus unicolor C D CD U Carduelis cannabina C D CD U Carduelis carduelis C D CD U Certhia brachydactyla C D CD C D CD R D CD Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Eliminata Nuova segnalazione U Cisticola jundicis U Coturnix coturnix U Cyanistes caeruleus Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 116 Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Confermata ● ● Confermata Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione U Emberiza cirlus C D CD U Galerida cristata C D CD U Miliaria calandra C D CD U Otus scops C D ACD U Parus major C D CD U Passer hispaniolensis C D CD U Regulus ignicapillus R D CD U Saxicola torquata C D CD U Serinus serinus C D CD U Sylvia atricapilla C D CD U Sylvia melanocephala Troglodytes U troglodytes C D CD C D CD U Turdus merula C D CD 1-5 D ACD U Accipiter nisus R D M Crocidura sicula Apodemus sylvaticus M dichrurus Erinaceus europeus M consolei M Lepus corsicanus P D CD ABC D P D B P V D D BCD AB M Hypsugo savii C D ACD C C C D B M Oryctolagus cuniculus C D A M Pipistrellus kuhlii Pipistrellus M pipistrellus C D ACD C D ACD M Suncus etruscus P D CD M Martes martes P D ACD A Bufo bufo spinosus C D A Discoglossus pictus C D BC ABC D U Tyto alba M Hystrix cristata Microtus M nebrodensis B C B CD savii Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 117 Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Confermata ● ● Confermata Confermata ● Nuova segnalazione Nuova segnalazione Nuova segnalazione Rana A bergerixhispanica C D CD A Bufo gr. viridis R D BCD R Chalcides chalcides Chalcides ocellatus tiligugu Natrix natrix sicula R D CD R R D D R Podarcis wagleriana R D BCD BC ABC D R Hierophis viridiflavus C D CD R Lacerta bilineata C D CD R Podarcis sicula C D CD V D B R R ● Eliminata I Duvalius silvestrii ● Eliminata I Pedius siculus Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 118 2.3.3 Descrizione agroforestale del sito (C) 2.3.3.1 Descrizione dell’uso del suolo e commento della carta (C.2; B.3.6) La Carta dell’Uso del Suolo (Tavola 14) evidenzia come quasi il 33% del SIC sia interessato da rimboschimenti a conifere (boschi di pini mediterranei e cipressi: 28,62%), boschi di latifoglie esotiche (3,63%) e rimboschimenti misti di conifere e latifoglie (Quercus ilex, Cupressus spp., Fraxinus spp., Robinia pseudacacia e Ailanthus altissima con buone potenzialità di conversione: 0,62%); i più giovani impianti artificiali hanno gradualmente sottratto spazio a membri della vegetazione seriale corrispondenti agli habitat 5332, 6220* e 8214 (LA MANTIA & PASTA, 2001b). Circa il 40% della superficie del SIC viene riferita a praterie aride calcaree (26,14%: praterie perenni ad Ampelodesmos mauritanicus ed aspetti di mosaico di prateria perenne e annua fortemente pascolate, con Asphodelus ramosus, Artemisia arborescens e Coridothymus capitatus) o a terreni abbandonati (14,53%), ricoperti da vegetazione erbacea in evoluzione dominata da Elaeoselinum asclepium, Dactylis glomerata s.l. e/o Arundo collina o da aggruppamenti spinosi dei Carthametalia. La prima categoria riveste un elevato pregio naturalistico perché corrisponde sostanzialmente alle praterie perenni ad Ampelodesmos mauritanicus ed ai consorzi terofitici ad esse associati, cioè all’habitat “garighe dominate dall’ampelodesma” (cod. 5332) e alla “Pseudosteppa con erbe perenni ed annue dei TheroBrachypodietea” (cod. 6220). Gran parte delle unità di paesaggio di maggiore pregio naturalistico appare piuttosto localizzata: i boschi di specie igrofile (nuclei di ripisilva igrofila a pioppi e salici) interessano lo 0,13% del SIC, gli aspetti di macchia lo 0,43%, la vegetazione rupicola a potentille lo 0,47%. Gli elementi della vegetazione seriale più rappresentati sono i pruneti (5,05%) e la gariga pura (0,48%). I poligoni attribuiti a quest’ultima classe d’uso corrispondono a formazioni pure a Coridothymus capitatus o a mosaici di gariga a labiate ed aspetti di prateria perenne e annua, comunque dominati dal timo capitato. Di scarso rilievo sono le coltivazioni arboree quali noceti e oliveti, che coprono rispettivamente lo 0,1 e circa l’1,5% della superficie del SIC. Ruolo ben più rilevante esercitano i vigneti (quasi l’11%). Le colture orto-floro-vivaistiche corrispondono ad un’area adibita fino a qualche anno fa a vivaio forestale, ampio circa 0,9 ha. La vegetazione rupicola a potentille include tutti i consorzi riferibili al Dianthion rupicolae; il valore della sua estensione areale (3,11 ha) è riferito alla proiezione piana e non allo sviluppo reale delle pareti. Alle paludi interne viene riferito sia il canneto ad Arundo donax sia i canneti a Arundo collina che colonizzano i versanti umidi e freschi, mentre i canneti a Phragmites includono sia i canneti a Phragmites che le formazioni a Typha delle sponde dei corpi idrici (naturali ed artificiali). La categoria “aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati” va riferita alle infrastrutture dell’Azienda Foreste Demaniali (uffici, museo forestale ed area attrezzata, magazzini, opificio, rifugio). Le aree verdi urbane sono localizzate intorno alle case rurali. I seminativi semplici in aree non irrigue (colture ceralicole: grano duro) e la categoria 21121, cui vanno riferiti gli orti veri e propri, si estendono su poco più del 4,3% della superficie del SIC. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 119 Codice 1121 1123 121 1222 141 211 21111 21121 21213 2212 2225 2231 2232 231 242 2242 3116 3117 3121 313 3211 32222 3231 32312 3232 3331 412 4121 5122 CLASSI CORINE LAND COVER Denominazione Case sparse Aziende agricole e annessi, casali, cascine e masserie Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati Viabilità stradale e sue pertinenze Aree verdi urbane Terreni abbandonati Seminativi semplici in aree non irrigue Seminativi semplici (cereali, leguminose e colture orticole in pieno campo) Colture orto-floro-vivaistiche Altri vigneti Frutteti Colture permanenti miste con prevalenza di oliveti Altri oliveti Prati e prati-pascoli avvicendati Sistemi colturali e particellari complessi Noceti Boschi di specie igrofile Boschi di latifoglie esotiche Boschi di pini mediterranei e cipressi Rimboschimenti misti di conifere e latifoglie Praterie aride calcaree Pruneti Macchia Macchia a lentisco Gariga Vegetazione rupicola a potentille Paludi interne Canneti a Phragmites Laghi artificiali Totale SIC Superfici Ha % 1,70 0,26 0,47 0,07 0,27 0,04 6,69 1,01 0,52 0,08 95,84 14,53 27,97 4,24 0,53 0,08 0,86 71,18 0,28 0,31 9,99 2,06 3,17 0,67 0,87 23,92 188,78 4,09 172,48 33,33 0,28 2,59 3,14 3,11 3,54 0,41 0,49 659,71 0,13 10,79 0,04 0,05 1,51 0,31 0,48 0,10 0,13 3,63 28,62 0,62 26,14 5,05 0,04 0,39 0,48 0,47 0,54 0,06 0,07 100 La Carta di sovrapposizione tra uso del suolo ed habitat delle specie (Tavola 15) è stata redatta utilizzando l’elaborato informatizzato “Carta degli habitat delle specie” (B.3.6), che associa ad ogni poligono rilevato sul campo la somma del valore floristico e del valore faunistico di cui alle relative carte precedentemente discusse (Tavole 10 e 12). La Tavola 15, che costituisce una modalità di rappresentazione della carta degli habitat delle specie, consente di evidenziare la ricchezza floristica e faunistica in funzione delle diverse categorie di uso del suolo rappresentate. Nella Tavola le aree sono campite diversamente in funzione del numero di specie floristiche e faunistiche di interesse (nessuna specie rilevata=0; 1-20 specie; 20-50 specie; 50-90 specie; oltre 90 specie). La carta visualizza immediatamente le categorie di uso del suolo (CLC) più ricche in specie, corrispondenti alle praterie aride calcaree, alle garighe, ai terreni abbandonati, ai pruneti. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 120 2.3.3.2 Descrizione delle aree e delle tecniche agricole “La caratterizzazione dei sistemi agricoli costituisce il presupposto conoscitivo di partenza per qualunque attività di valutazione, gestione o pianificazione dei comprensori rurali soprattutto all’interno delle aree protette” (BECHINI et al., 2007) Nella descrizione delle aree agricole e delle tecniche agricole è necessario ed utile premettere alcune considerazioni relative alle norme sulla condizionalità. Il Regolamento comunitario 1782/2003 sulla riforma della PAC e sui regimi di sostegno diretti ha introdotto il cosiddetto "Disaccoppiamento", che consiste nel regime di pagamento unico concesso alle aziende indipendentemente dalla produzione. Per beneficiare degli aiuti l’agricoltore si impegna a rispettare comunque le “norme sulla condizionalità" che prevedono: - Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), cioè impegni derivanti da 19 direttive comunitarie in materia ambientale. Dal 2005 le aziende nei siti Natura 2000 devono inoltre rispettare: gli Atti A 1 - conservazione degli uccelli selvatici e A 5 - conservazione degli habitat; - Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), cioè pratiche diverse a seconda delle caratteristiche dell'azienda e del territorio, chiamate anche Norme, stabilite a livello nazionale e regionale, obbligatorie ed aggiuntive. La Regione Siciliana ha definito con D.D.G. n. 3220 del 28 Dicembre 2007 dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste le norme di “condizionalità” che gli agricoltori (che accedono ai pagamenti della PAC) devono rispettare a livello regionale a decorrere dal 1° gennaio 2008 e specificate nei seguenti allegati: Allegato 1 – Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III del Reg. (CE) 1782/03; Allegato 2 - Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato IV); Sub-allegato 2/A - Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree soggette a vincolo paesistico. Le norme sulla condizionalità perseguono quattro obiettivi: - proteggere il suolo mediante misure idonee; - assicurare un livello minimo di mantenimento dell'ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat; - mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche; - proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate. Ogni obiettivo prevede l’adozione di specifiche modalità di gestione dei terreni (regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio, gestione delle stoppie e dei residui vegetali; difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali; protezione del pascolo permanente, gestione delle superfici ritirate dalla produzione; manutenzione degli oliveti; mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, ecc). Ferma restando l’importanza dal punto di vista ambientale delle suddette norme, nel caso specifico dei Siti in esame assumono particolare rilievo le seguenti norme: NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali All’interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, la bruciatura delle stoppie è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione. NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 121 Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l’avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo. NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l’uso adeguato delle macchine Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura, assicurando altresì un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno. Sono quindi previsti i seguenti adempimenti: a) manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l’efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque; b) esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d’uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni: a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno; b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l’ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti. NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni: a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144; b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell’impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi. NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell’ambito dei regimi di aiuti di cui all’allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni: a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati; c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE; d) Il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c). In questa fase è difficile una valutazione dell’impatto “positivo” che le suddette norme hanno avuto nel tempo nel territorio in esame, non essendo stato possibile ricostruire un inventario Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 122 dei regimi di aiuto e dei sostegni finanziari e quindi delle aziende obbligate ed analizzare in concreto la gestione della singola azienda. Inoltre alcune deroghe previste dalle disposizioni regionali andrebbero evitate, le norme sulla condizionalità andrebbero estese a tutti gli operatori agricoli e sarebbe opportuno inserire delle specifiche disposizioni integrative per il Sito in esame di cui si dirà nel capitolo sugli aspetti gestionali e le norme di attuazione. Se da un lato pertanto le norme regionali sulla condizionalità andrebbero modificate ed integrate con riferimento alla specifica condizione dei Siti Natura 2000 e dello stato di conservazione degli habitat, dall’esperienza concreta sul campo emerge con tutta evidenza uno scarso rispetto e l’assenza di una seria azione di sensibilizzazione/consapevolezza degli agricoltori e di repressione delle violazioni più eclatanti. In particolare, per quanto riguarda la gestione delle stoppie e la prevenzione incendi, la protezione del suolo e dei pascoli ed il benessere degli animali, la lavorazione dei terreni. Va altresì premesso che non esistono banche dati contenenti informazioni quantitative su pratiche agricole e forestali, pascolo e incendi all’interno del SIC; non esiste soprattutto un inventario delle aziende agricole, dei loro ordinamenti e dei regimi di aiuto che vengono erogati nell’area, né i tempi stretti imposti per la redazione del Piano hanno consentito di realizzarlo. Per questo già il Piano prevede tra le azioni prioritarie di monitoraggio l’effettuazione di un inventario dell’agricoltura a livello locale compresi i regimi di aiuto erogati. Gli studi effettuati per la redazione del Piano di Gestione hanno consentito di ottenere le prime importanti informazioni sulle aree agricole e sulle tecniche utilizzate, che vengono riportate di seguito. Seminativi in aree non irrigue Sotto questa denominazione sono inclusi i seminativi locali, rappresentati quasi esclusivamente dal frumento duro, spesso presenti transitoriamente in seguito all’estirpazione dei vigneti, come testimonia la loro distribuzione all’interno del SIC. Oggi in massima parte tali aree sono state riconvertite in vigneti ed uliveti, a causa delle problematiche economiche che hanno investito la cerealicoltura siciliana nel recente passato. Ciò è avvenuto anche nel SIC, dove i seminativi sono presenti con una superficie di circa 28 Ha (appena 4,24% della superficie complessiva). La riduzione della superficie cerealicola prosegue una tendenza che vede il contenimento delle coltivazioni nelle aree maggiormente vocate alla produzione e nei territori più accessibili alla meccanizzazione, oltre a costituire un effetto della politica di set-aside e della contrazione del mercato. Se dovesse proseguire l’andamento di mercato che ha visto un innalzamento del prezzo del grano duro, è possibile che ciò induca una nuova espansione nella coltivazione di cereali. La riduzione delle superfici determina indirettamente dei problemi ambientali perché in passato le colture da pieno campo (cereali e leguminose) e la pastorizia erano strettamente connesse tra loro. Pascoli e seminativi partecipavano ad una rotazione triennale o quinquennale. Durante il periodo autunnale, a raccolto ultimato, gli animali venivano fatti pascolare sui campi di stoppie. Le attività di granicoltura e pastorizia erano complementari, al punto che la prima avrebbe avuto di che soffrire se fosse mancato il letame prodotto dagli animali allevati sulle terre su cui entrambe insistevano. Una delle soluzioni che riusciva a contemperare opposte esigenze era data dalla rotazione delle colture: i territori erano divisi in appezzamenti di varia estensione in rapporto alla superficie complessiva di cui costituivano ognuno un terzo. Il primo appezzamento era lasciato a riposo; nel secondo si coltivavano leguminose da granella (fave) o da foraggio Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 123 (veccia o fieno); nel terzo infine si coltivava grano. Il sistema di rotazione triennale (detto a tirziria) differiva da quello quadriennale, che prevedeva un anno di ringrano e dunque concedeva meno spazio al pascolo; esso differiva anche dal sistema quinquennale, che invece, dopo le annate di fave e grano, prevedeva due annate di fieno, prima di ritornare al grano: in complesso due quinti del territorio erano destinati a pascolo, invece del terzo della rotazione triennale. I principali vantaggi conseguiti da una rotazione efficace sono: 1) controllo degli agenti patogeni; 2) controllo delle infestanti; 3) aumento della stabilità produttiva. Di fondamentale importanza risulta l’inserimento, all’interno della rotazione aziendale, di una leguminosa foraggera, per la capacità, propria di queste specie, di arricchire il terreno di azoto. Inoltre le leguminose, avendo radici che si spingono in profondità, portano in superficie, attraverso i propri elaborati radicali, fosforo e potassio. Tali colture, nel caso di un’azienda cerealicola, soprattutto se in riconversione, devono aprire il nuovo schema di rotazione, prendendo cioè il primo posto in testa alla rotazione. Su vaste superfici del SIC oggi si adotta un sistema di coltivazione estremamente semplificato: la rotazione prevede l’alternarsi di un anno di frumento con un anno di pascolo. Ciò consente in qualche misura di reintegrare la fertilità del suolo grazie all’apporto di letame proveniente dagli animali al pascolo. Nell’annata di pascolo, il campo viene affittato ai pastori integrando in questo modo il reddito e riservandosi di intervenire con le lavorazioni prima dell’andata a seme delle erbe infestanti. Solamente qualche azienda adotta un sistema colturale che fa uso di tecniche agronomiche più appropriate. Per la preparazione del suolo si interviene con una lavorazione a circa 25-35 cm di profondità, seguita da lavori complementari, ma ciò può determinare in quei suoli un’accelerazione dei fenomeni erosivi. Con una variabilità che tiene conto della precessione colturale, le quantità di fertilizzanti distribuite oscillano mediamente tra 80 e 150 kg/Ha di azoto e 80 e 100 kg/Ha di fosforo. Tuttavia nelle aziende viene spesso sfruttata la fertilità residua determinata dal pascolo o si interviene effettuando un unico intervento in presemina (ottobre-novembre). In poche aziende ormai si interviene anche in copertura (gennaio) con concimi azotati organici con titolo in N elevato. Ad esclusione di poche aziende concimate razionalmente, la quantità di fertilizzanti adoperati non compensa le asportazioni. In queste aree il frumento non presenta gravi problemi fitosanitari se non in annate agrarie con decorso climatico particolarmente umido. La varietà attualmente più utilizzata in ambedue i sistemi colturali è il “Simeto”, che copre una percentuale vicina al 60%. Vigneti La superficie coperta dal vigneto, escludendo quella coperta dal seminativo associato a vigneto, appare molto concentrata nel Trapanese (più del 35% dell’intera superficie provinciale), finendo per caratterizzarne il paesaggio agrario, con vigneti in prevalenza da vino, contrassegnati da presenze puntuali di grande rilevanza qualitativa (vini ad indicazione geografica tipica). Questa situazione si riflette sul SIC, di cui i vigneti ricoprono quasi l’11% della superficie complessiva con 71,18 Ha, ed in particolare nell’area della Riserva. La coltura della vite nel Trapanese, molto diffusa in forma “pura”, raramente associata ad altre colture, soprattutto nel mosaico colturale del seminativo associato a vigneto, appare estremamente varia sia per le tradizioni locali di coltivazione, sia per la presenza di numerosi impianti recenti. Vanno scomparendo gli impianti a tendone, usati prevalentemente per gli impianti a Trebbiano toscano posto ad un sesto quadro di 3×3 m, mentre vanno aumentando le giovani spalliere con varietà internazionali quali Cabernet Sauvignon, Merlot, ecc. Tra le varietà siciliane ad uve nere si va diffondendo sempre più il Nero d’Avola, introdotto in quest’area nel 1968, che ha sostituito il Perricone ed il Nerello mascalese, che comunque non interessavano grandi superfici. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 124 La tecnica colturale tradizionale applicata nel SIC prevede delle ripetute lavorazioni a partire dalla vendemmia, mentre per i trattamenti antiparassitari vengono utilizzati zolfo e rame ma in alcuni casi si ricorre a fungicidi sistemici. La concimazione viene effettuata annualmente a fine inverno ricorrendo a fertilizzanti ternari in dosi variabili a seconda del suolo e spesso delle convinzioni dell’agricoltore. Oliveti All’interno dei rimboschimenti si rinvengono delle piante sparse di ulivo che testimoniano una maggiore diffusione locale della coltura in passato. Oggi gli oliveti sono una coltivazione poco diffusa (9,99 Ha) pari all’1,51% della superficie complessiva del SIC in alcuni piccoli appezzamenti. La coltura dell’olivo caratterizza comunque in modo rilevante l’economia rurale e il paesaggio agrario del Trapanese, essendo particolarmente diffusa nelle aree interne collinari e nelle pianure anche in prossimità della costa. I piccoli appezzamenti presenti mantengono le caratteristiche fisionomiche dei vecchi impianti olivicoli. La nuova olivicoltura interessa poche superfici, spesso incluse nella categoria sistemi colturali e particellari complessi a causa della loro esiguità, talora in corrispondenza di aree un tempo interessate dalla cerealicoltura; queste sono state trasformate in impianti intensivi ricorrendo a varietà tradizionali a duplice attitudine, come la “Nocellara del Belice”, o da olio, quali la “Cerasuola” e la “Biancolilla”. Le tecniche agronomiche riscontrate sono riconducibili a quelle in uso nell’olivicoltura convenzionale. Vengono effettuate mediamente quattro lavorazioni, la prima in autunno per facilitare la raccolta delle olive, e le altre in primavera ed estate. In alcune aziende si ricorre al diserbo chimico, e la tecnica colturale risulta vicina alla non lavorazione. Gli attrezzi usati sono normalmente dei polivomeri o delle frese. Poco diffuso, anche se in espansione, appare il sovescio, a causa dell’intralcio che provoca alle altre operazioni colturali, come la potatura. Nelle aree olivicole da olio degli ambienti collinari interni si interviene in genere con circa 7 q/Ha di concimi ternari. Le avversità entomologiche dell’olivo non sono tali da determinare gravi problemi, ma, come è accaduto per gli agrumi, hanno subito un processo di recrudescenza dovuto all’uso inadeguato dei prodotti antiparassitari. Il problema principale è rappresentato, in tutte le aree dove viene coltivato l’olivo, dalla Mosca delle olive (Dacus oleae). In genere la si combatte con due trattamenti effettuati in estate/autunno con prodotti a base di dimetoato. Sistemi colturali e particellari complessi Questa categoria è stata adottata per le superfici di scarsa estensione in cui si è osservata la presenza di più di due categorie di uso del suolo. In particolare, vi sono state incluse quelle superfici agrarie le cui produzioni sono spesso destinate all’autoconsumo. Nel complesso tale categoria d’uso del solo occupa 3,17 Ha, pari a circa lo 0,5% della superficie complessiva del SIC, e risulta confinata in alcune aree più densamente antropizzate. Caratterizzazione delle aree agricole rispetto agli habitat e alle specie della Dir. 92/43/CEE e brevi cenni sull’impatto delle tipologie e delle pratiche di gestione agricola su habitat e specie (C.3; C4; C5) Non sono presenti nel SIC aree con colture intensive, bensì colture estensive che non possono essere considerate “ad alto impatto”, e che tuttavia si presentano (cfr. carta dell’uso del suolo) strettamente connesse, ed in alcuni casi interdigitate, alle formazioni naturali autoctone di pregio (in particolare alle aree a gariga e a prateria, ed ai consorzi acquatici ed idrofili). Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 125 Conseguentemente si registra una certa pressione dell’agricoltura nei confronti delle aree naturali, ed il primo obiettivo deve essere quello di condurre l’attività agricola evitando manomissioni agli aspetti di vegetazione naturale. Escludendo qualsiasi possibilità di espansione delle colture agrarie in aree seminaturali, l’impatto indiretto su habitat e specie può dipendere dalle tecniche di gestione e dalle ripercussioni sull’agro-ecosistema. Le problematiche principali riguardano la conduzione del suolo, in questi ultimi anni oggetto di profondi ripensamenti. In passato, i processi produttivi che intervenivano sull’agroecosistema poco si curavano delle ripercussioni provocate; col tempo, ci si è resi conto che, se si vogliono conseguire produzioni più salubri e nel contempo evitare il degrado ambientale, non si può prescindere dai complessi equilibri naturali che stanno alla base del sistema “suolo-pianta-atmosfera”: si impone pertanto una valutazione più critica degli interventi colturali, al fine di valorizzare le risorse dell’ecosistema. Per quanto riguarda la viticoltura (la coltura più diffusa nel territorio del SIC), l’impatto maggiore è determinato dalle lavorazioni e, più in generale, dalla gestione del suolo. Tradizionalmente il controllo delle erbe infestanti viene eseguito meccanicamente con ripetute lavorazioni durante il corso dell’anno. Tuttavia, quelle esercitate in autunno e durante l’inverno, in coincidenza con gli eventi piovosi, determinano forti fenomeni erosivi. Questo processo è ancora più grave all’interno dell’impluvio del Biviere e lungo le pareti delle doline, in quanto facilita la lisciviazione di materiale eroso dentro gli inghiottitoi. Le ragioni per le quali vengono effettuate queste lavorazioni sono molteplici ma possono essere definite essenzialmente come “culturali”; infatti sono stati accertati numerosi inconvenienti dovuti alle ripetute lavorazioni effettuate nel periodo autunno-inverno (effetti negativi sulla struttura del suolo, sul contenuto in sostanza organica, sulle attività e sugli equilibri biologici del sistema suolo-pianta, accelerazione dei processi erosivi in condizioni di acclività, ecc.). Oggi, invece, vengono riconosciute alla flora spontanea alcune funzioni positive, ovvero l’azione positiva nei confronti dell’entomofauna utile (la cui presenza riduce la proliferazione dei parassiti), con ulteriore beneficio per la coltura in atto e per l’ambiente in generale; viene applicata ormai diffusamente in molte aree la tecnica dell’inerbimento, che induce un miglioramento delle caratteristiche fisico-chimiche e dell’attività biologica del terreno, la riduzione dell’erosione superficiale, l’aumento del tasso di sostanza organica. Alcune ricerche condotte di recente in Sicilia hanno dimostrato la validità del modello proposto (DI LORENZO et alii, 1999; GRISTINA et alii, 2004), che è anche stato sperimentato con buoni risultati da una delle principali aziende agricole presenti nel Sito, sulla base di un protocollo di intesa stipulato con l’Ente gestore della riserva naturale “Grotta di Santa Ninfa”. Una delle ragioni per cui questa pratica virtuosa non è ancora diffusa è costituita dal fatto che le aziende che praticano l’inerbimento subiscono la presenza continua degli animali al pascolo, che arreca gravi danni alla struttura del suolo. Relativamente al pascolo, attualmente nell’area del SIC è presente esclusivamente un pascolo ovino, con un numero di capi stimato in non meno di 600. Il pascolo viene praticato su porzioni significative del Sito, su quasi tutte le tipologie di soprassuolo (dagli incolti alle garighe ai rimboschimenti alle praterie) ma con intensità e frequenze diverse a secondo delle zone. A causa dell’impatto del pascolo le cenosi erbacee presenti nel Sito sono lontane, in diversa misura, dalla condizione di equilibrio; risulta quindi necessaria la regolamentazione di questa attività, a meno di una forte riduzione delle risorse, se non addirittura della loro scomparsa. Più in particolare, le conseguenze di un’errata gestione dei pascoli si possono così riassumere: 1. decadimento della qualità pabulare dei pascoli; 2. aumento della necromassa, costituito da materiale vegetale non utilizzato, al quale si Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 126 risponde solitamente con gli incendi; 3. arresto dei processi di rinaturalizzazione all’interno dei rimboschimenti, impedendo l’affermarsi di specie arbustive ed arboree autoctone; 4. riduzione della biodiversità e banalizzazione della flora (nei casi di pascolo eccessivamente intenso e frequente). Per quest’ultimo aspetto le soluzioni non sono univoche; la cessazione totale del pascolo, infatti, favorirebbe i processi di evoluzione della vegetazione verso forme più complesse ma ciò potrebbe portare alla scomparsa di alcuni habitat. Per una corretta gestione del pascolo si deve tenere conto di due aspetti principali, legati all’opportuno dimensionamento dei carichi animali ed alle tecniche ottimale di pascolamento da applicare. 2.3.3.3 Descrizione delle aree forestali (C.1) Nel territorio del SIC sono presenti alcune limitate aree caratterizzate da formazioni forestali autoctone (Matorral di Laurus nobilis; Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba), che sono anche habitat di interesse comunitario e che sono state quindi trattate in altra parte della presente relazione. Nella tabella seguente sono riportati, per ciascuna formazione, i vari tipi di classificazione in uso per gli ecosistemi forestali. Codice Direttiva Habitat EUNIS European forest types 5230* − Matorral arborescenti di Laurus nobilis F5.18 - Laurus nobilis matorral 6.9.5 - Other sclerophyllous forests 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba G1.112 Mediterranean tall Salix galleries Tipologie forestali regionali 6.12.3 15.3 − Mediterranean and Formazioni a Macaronesian Salix e riparian forest Populus sp. pl. Corine Biotopes 91 / Pal. Class. 01 32.18 - European laurel matorral 44.14 Mediterranean tall willow galleries Gran parte del territorio del SIC è invece interessato dalla presenza di diffusi rimboschimenti, realizzati dall’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana su aree demaniali, a partire dagli anni ’70 (in seguito al terremoto della Valle del Belìce), utilizzando Pinus halepensis, Pinus pinea, Eucaliptus camaldulensis, Cupressus sp. pl. e Acacia cyanophylla. I rimboschimenti presenti all’interno del SIC presentano una notevole uniformità con quelli eseguiti all’interno del perimetro della Riserva (LA MANTIA & PASTA (2001b) e quindi “.. presentano una forte omogeneità perché coetanei e realizzati con le tecniche di gradonamento e scasso in tutta l’area”. Le aree rimboschite svolgono un ruolo predominante nell’area del SIC, e dalla loro futura gestione dipende in buona misura l’evoluzione del paesaggio vegetale dell’intero comprensorio, anche perché gli impianti più recenti sono stati spesso realizzati in corrispondenza delle formazioni seminaturali (gariga, prateria, consorzi rupestri, macchie e arbusteti). I rimboschimenti sono il risultato di una intensa politica di forestazione che ha caratterizzato l’Isola dal secondo dopoguerra. Dopo gli anni Cinquanta, il paesaggio agrario e forestale Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 127 dell'Isola ha subito infatti notevoli cambiamenti. L’azione di conservazione del suolo e di difesa idraulico-forestale, sostenuta da forti finanziamenti per creare occupazione, ha trasformato alcuni ambienti naturali, nonché ampie superfici un tempo utilizzate a pascolo, in boschi alloctoni, quasi sempre costituiti da diverse specie di eucalipto e da resinose adatte agli ambienti mediterranei. I tecnici forestali non tennero conto, anche perché il problema non era ancora sentito, di scegliere opportunamente le specie da usare nei rimboschimenti ai fini della salvaguardia del paesaggio e delle specie preesistenti. Rimboschimenti ad Eucalyptus Dagli anni ’50 agli anni ’70 del XX secolo estesi popolamenti (35.664 ettari) puri (53%) e misti (47%) di eucalitto furono realizzati in Sicilia (AZIENDA FORESTE DEMANIALI REGIONE SICILIANA, 1976). Tali impianti, spesso per via delle limitazioni di carattere ambientale e selvicolturale, si presentano oggi deperienti, senescenti, danneggiati da incendi e da attacchi del coleottero cerambicide Phoracanta semipunctata Fabr. (BARBERA et alii, 2001). Indipendentemente dal substrato, dal clima e dalle caratteristiche topografiche delle aree di impianto, in Sicilia i rimboschimenti ad Eucalyptus appaiono in genere piuttosto poveri dal punto di vista floristico e ospitano aspetti di vegetazione molto banali. Ciò è dovuto principalmente alla spiccata efficienza degli eucalipti nel competere per le risorse. Controverso appare invece l’effetto dell’allelopatia (FLORENCE, 1996 in LA MANTIA & PASTA, 2001b). Su questo specifico aspetto esiste una vasta bibliografia, prodotta per lo più nei paesi nei quali l’eucalipto è diffuso in sistemi agroforestali. Gli studi condotti nelle regioni mediterranee confermano l’attività allelopatica degli eucalipti; essa si esplica in forme diverse, inducendo ad esempio una minore nodulazione nelle leguminose, un rallentamento nel processo di degradazione delle foglie e, più in generale, una minore crescita delle altre piante (DOMINGUEZ et alii, 1994 e 1998; SOUTO et alii, 1995; MOURA et alii, 1996; REIGOSA et alii, 1998 in LA MANTIA & PASTA, 2001b). All’interno del SIC sono presenti alcune aree con presenza di fustaie monospecifiche edificate esclusivamente con Eucalyptus camaldulensis. La loro densità risulta in molti casi eccessiva, non essendo mai stati effettuati interventi di diradamento. Inoltre, la mancanza di interventi congiunti di risarcimento e di diradamento genera una forte irregolarità nella distribuzione delle piante dei popolamenti, sicché si osserva un’alternanza tra aree eccessivamente dense e radure (LA MANTIA & PASTA, 2001b). La vegetazione presente all’interno dei rimboschimenti ad eucalipto di Santa Ninfa è rappresentata per lo più da consorzi nitrofili riferibili alla classe Stellarietea mediae e da aggruppamenti subnitrofili ed eliofili della classe Artemisietea vulgaris. Questi consorzi non differiscono in maniera sostanziale da quelli degli incolti limitrofi, e non mostrano una benché minima tendenza ad evolversi verso formazioni più complesse e a maggior grado di naturalità. All’interno sono state rinvenute poche specie perenni (Teucrium flavum, Rubia peregrina, Asparagus acutifolius, Asphodelus ramosus, Urginea maritima, Narcissus serotinus, Barlia robertiana) e qualche stentato individuo di Ampelodesmos mauritanicus e di Crataegus monogyna. È stata rilevata una certa rinnovazione di olivastro e pino d’Aleppo; questi ultimi derivano senza dubbio dalle pinete contigue, mentre l’olivastro è stato invece disseminato quasi certamente dai tordi (Turdus philomelos) e, in misura minore, dagli storni (Sturnus vulgaris) e dai merli (Turdus merula). Va rimarcato che le piantine, soprattutto quelle di olivo, crescono spesso addossate al tronco degli eucalipti, forse perché meno disturbati dai danni inferti dal bestiame che pascola nell’area (LA MANTIA & PASTA, 2001b). Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 128 Rimboschimenti a pino d’Aleppo Nelle aree demaniali interne al SIC, le pinete a pino d’Aleppo, di circa 30 anni di età, costituiscono gli impianti artificiali di maggior estensione. In molti casi i pini sono misti ai cipressi (Cupressus sp. pl.). Anche per le pinete, i popolamenti appaiono in molti casi eccessivamente densi, in quanto i diradamenti, al pari delle spalcature, sono stati effettuati tardivamente, alla fine degli anni 90. Nel recente passato l’AFDRS ha realizzato impianti caratterizzati da una densità molto elevata (alcuni popolamenti mostrano ancora oggi una densità pari a 1.800 piante/ha) mentre la densità finale dovrebbe essere di 400 piante ad ettaro (CIANCIO, 1986a); in alcune aree si rinvengono invece aspetti di pineta giovane e rada realizzati con tecniche di impianto che non alterano eccessivamente la fisiononomia della vegetazione preesistente. Laddove la pineta è stata invece impiantata con un sesto ampio, o dove sono stati effettuati precoci diradamenti su richiesta dell’ente gestore della riserva naturale, si assiste spesso al rigoglioso sviluppo della gariga a Thymus capitatus e dell’ampelodesmeto. A Santa Ninfa i più densi rimboschimenti presentano un’estrema povertà floristica. Vi si rinvengono le seguenti specie erbacee perenni: Elaeoselinum asclepium, Thapsia garganica, Teucrium flavum, Achillea ligustica, Asphodelus ramosus, Urginea maritima e Barlia robertiana. La rinnovazione naturale appare molto ridotta ed è del tutto assente nelle aree soggette a pascolo intensivo (da LA MANTIA & PASTA, 2001b). Rimboschimenti a Pino domestico Si tratta di impianti piuttosto giovani e a sesto ampio, realizzati con tecniche a basso impatto e presenti su una superficie ridotta. Sono pertanto analoghi, floristicamente e ecologicamente, alla prateria xerofila perenne ad ampelodesma in cui si trovano inseriti, e che costituisce una tra le formazioni più espressive dell’intero SIC. Le caratteristiche stesse degli impianti fanno sì che essi non alterino eccessivamente la fisiononomia della vegetazione preesistente, anche per gli interventi di diradamento eseguiti su richiesta dell’ente gestore della riserva naturale. Impianti misti a conifere, Acacia cyanophylla ed Eucalipti Gli impianti forestali misti comprendono diverse essenze esotiche a rapido accrescimento, come le latifoglie Acacia cyanophylla ed Eucalyptus camaldulensis, e le conifere Pinus halepensis e P. pinea, Cupressus sempervirens e C. arizonica. Molti di questi impianti sono stati realizzati solo nel passato, all’interno del SIC e in aree contigue. Essi mantengono l’aspetto di gariga e/o di prateria xerica, in cui si rinvengono individui sparsi di conifere, di eucalipti o misti. Anche sotto il profilo ecologico e floristico poco si discostano dalle tipologie di vegetazione seminaturale in cui sono inseriti. Nonostante catturi grandi quantità d’acqua, nel complesso l’acacia può essere considerata utile per la preparazione dei terreni, aumentando il tenore d’azoto del terreno e proteggendo dall’irraggiamento eccessivo le plantule delle specie della macchia. Vista la sua scarsa longevità, questa specie finisce col cedere spazio alla specie spontanee. Caratterizzazione delle aree forestali rispetto agli habitat e alle specie della Direttiva Habitat e brevi cenni sull’impatto delle tipologie di gestione forestale (C3; C4; C5) In relazione alle peculiarità idrogeologiche e geomorfologiche dell’area, il rimboschimento svolge un ruolo importante. Tuttavia, l’utilità delle pinete e degli eucalipteti nel contenere i Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 129 fenomeni erosivi viene spesso sopravvalutata, soprattutto se confrontata con l’azione svolta dalle formazioni erbacee ed arbustive, il cui sviluppo viene ostacolato dai rimboschimenti stessi, e se si tiene conto dell’assenza di rinnovazione degli eucalitteti (CHISCI et alii, 1991; CANTORE et alii, 1994). Inoltre, comparando qualitativamente la ricchezza floristico-vegetazionale dei rimboschimenti con quella delle contigue aree seminaturali, risalta il ruolo di “serbatoio vegetale” giocato da queste ultime, mentre gli impianti artificiali appaiono alquanto poveri (LA MANTIA & PASTA, 2001b). Dal confronto tra i dati rilevati nell’eucalipteto e quelli relativi alla pineta emerge una maggiore diffusione delle specie legnose autoctone ed una maggiore ricchezza specifica complessiva nel primo tipo di popolamento, in accordo con quanto affermato da PIGNATTI (1993); di contro, il sottobosco delle pinete, sebbene piuttosto povero, presenta un maggior grado di naturalezza floristico-strutturale. Tali considerazioni preliminari vanno però sottoposte ad un’analisi floristica più dettagliata, che tenga conto anche della flora annua. Gli impianti più recenti sono stati spesso realizzati in corrispondenza delle formazioni seminaturali corrispondenti alle cenosi preforestali (che coprono complessivamente circa il 6,5% del SIC). Andrebbe invece favorita la tutela e la diffusione spontanea di tali comunità, giacché il mantello (Rhamno-Prunetea), la gariga (Cisto-Micromerietea) e la prateria xerofila (Lygeo-Stipeta e Stipo-Trachynietea) ospitano gran parte della flora di maggior pregio, che potrebbero innescare una graduale successione progressiva verso consorzi di macchia e macchia-foresta sempreverde e di querceto. Va senz’altro evitato nel futuro il ricorso agli eucalipti, anche in ragione del fatto che negli ultimi anni essi hanno mostrato una preoccupante tendenza alla naturalizzazione, mentre dovrà essere privilegiato l’impianto di specie autoctone partendo da germoplasma certificato. Andranno inoltre attuate tecniche di riconversione dei rimboschimenti esistenti (LA MANTIA & PASTA, 2001b) finalizzate a favorire la diffusione di specie autoctone, come il taglio a buche (in selvicoltura una “buca” viene definita come “spazio aperto nel soprassuolo, non predefinito in termini di ampiezza e di sequenza spaziale e temporale, tale da garantire la rinnovazione del bosco”: MERCURIO, 1999), nonché intensi diradamenti, intervenendo contemporaneamente con la piantumazione di latifoglie autoctone senza quindi far cessare la funzione di conservazione del suolo. Grosse difficoltà possono sorgere negli eucalipteti per il ricaccio delle ceppaie. La rinaturalizzazione delle pinete contribuirebbe inoltre a ridurre il rischio di incendi, per la vulnerabilità intrinseca di queste conifere resinose, esaltata dall’assenza di regolari trattamenti di diradamento. La densità eccessiva di molti dei rimboschimenti ostacola tra l’altro l’insediamento delle specie legnose autoctone che, qualora riescano a germinare, sono destinate a crescere stentatamente sotto la fitta copertura dei pini. In questi boschi si assiste invece spesso a modesti processi di rinnovazione naturale ad opera dello stesso pino d’Aleppo o di specie come l’ulivo, mancando i serbatoi naturali delle latifoglie autoctone. Nel caso che si attuino gli auspicati interventi di rinaturalizzazione, dovrebbe cessare - o quantomeno essere ridotto e regolamentato - il pascolo che, unitamente al rischio di incendi, costituisce la principale causa di degrado per le formazioni seminaturali quali la macchia, la gariga, le praterie e le comunità rupestri e la vegetazione degli ambienti umidi. Un aspetto particolare della gestione dei rimboschimenti è costituito dalla manutenzione dei viali parafuoco, che in alcune aree esterne alla riserva naturale viene effettuata con mezzi meccanici aumentando i fenomeni erosivi ed il dissesto del territorio. All’interno della riserva sono visibili gli effetti estremamente positivi delle tecniche di manutenzione dei viali parafuoco prescritti dall’ente gestore, e che consistono nello sfalcio manuale e in alcuni tratti nel pirodiserbo. Innegabili sono poi gli effetti positivi sulla percezione del paesaggio e sulla drastica riduzione dell’erosione. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 130 2.3.3.4 Incendi Relativamente agli incendi, il territorio del Sito presenta un rischio potenziale medio, come risulta dall’analisi della pianificazione regionale di settore; tuttavia, l’incidenza reale degli incendi forestali è stata ed è tuttora bassa, sia a causa di dinamiche sociali non avverse al bosco (che viene anche utilizzato per il pascolo), che per la capillare organizzazione del servizio antincendio da parte dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, che si esplica in modo particolare nei territori demaniali. Comprendendo quindi al suo interno due demani forestali, l’intera area del SIC è ben sorvegliata ed attrezzata sia per la prevenzione che per lo spegnimento degli incendi. Relativamente alla prevenzione, tra la fine di maggio e gli inizi di giugno di ogni anno gli operai forestali stagionali effettuano i lavori di manutenzione ordinaria dei viali parafuoco, che hanno la funzione di arrestare un eventuale incendio proveniente dalle aree esterne ai demani forestali (ma non quella di prevenire gli incendi dolosi). Per quanto riguarda invece l’avvistamento degli incendi e la loro repressione, all’interno del SIC sono presenti: due torrette di avvistamento fra loro in collegamento visivo, presidiate nel periodo estivo 24h/24 e costantemente in contatto con la Sala Radio di Trapani; l’autobotte e la squadra di spegnimento composta da 8 uomini muniti di flabelli ed un autista; sulla cima di M. Finestrelle viene inoltre collocata nel periodo estivo una vasca per l’approvvigionamento idrico da parte degli elicotteri. Infine, a Salemi è presente un’area di stazionamento per gli elicotteri del servizio antincendio e nel vicino demanio forestale di Senapa sono presenti ulteriori presidi, uomini e mezzi. Le aree forestali, quindi, non sono soggette regolarmente ad incendi: dall’istituzione della riserva naturale, avvenuta nel 1996, si sono verificati solo 2 incendi, entrambi di superficie inferiore ai 2 Ha; prima dell’istituzione della riserva, circa 15 anni fa, un incendio più esteso ha colpito l’area demaniale di Castellaccio. Pur non interessando, o interessando solo marginalmente, le aree forestali, il problema degli incendi all’interno del SIC esiste, e riguarda prevalentemente le aree a seminativo e gli incolti-pascoli-garighe, essendo legato ad aspetti puntuali e di tipo più “culturale”. E’ ancora forte la pratica di bruciare le stoppie dopo la mietitura anche nei periodi in cui è tassativamente vietata dalle disposizioni antincendio e dalle norme sulla “condizionalità”, che prevede anche la difesa attiva dagli incendi per le aree ritirate dalla produzione. La bruciatura delle stoppie assume connotati molto gravi ed estesi nel più vasto comprensorio a seminativi che circonda il SIC, ed in particolare nella pianura fra Gibellina e Alcamo, dove gli incendi interessano centinaia di ettari, vengono innescati al di fuori dei rigorosi termini previsti dalle leggi vigenti per quanto riguarda le modalità di prevenzione ed i periodi, e spessissimo non vengono spenti né repressi in quanto considerati ordinaria pratica agricola. I rischi maggiori di incendio nel SIC provengono proprio dalla propagazione all’interno del sito di fuochi originati al suo esterno, in modo particolare nella porzione settentrionale del SIC. Inoltre, a causa di una pratica secolare utilizzata dai pastori, vi è sempre il rischio di incendi tardo-estivi alle formazioni di Ampelodesma per sfruttare i successivi ricacci come pascolo, anche se tale fenomeno appare in regressione; invece è pratica maggiormente diffusa – nel SIC come nel resto della Sicilia – effettuare i lavori agricoli lungo i margini esterni delle colture per determinare il progressivo assottigliamento delle contigue aree seminaturali nonché “ripulire” il terreno dalla biomassa eccessiva, attraverso l’incendio puntiforme di roveti, filari e gruppi di alberi, macchie e forre degli alvei, impluvi, ecc., che invece svolgono un ruolo ecologico importantissimo nel mantenimento della biodiversità sia vegetale che animale. In questo contesto è determinante l’atteggiamento “culturale” che caratterizza la comunità locale (in gran parte costituita da agricoltori) e gli stessi operatori del settore forestale e antincendio, che non considerano veri e propri incendi i fuochi che interessano incolti e vegetazione naturale. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 131 Un aspetto degno di valutazione e di ulteriori approfondimenti sugli effetti degli incendi dei seminativi dal punto di vista faunistico è emerso durante le osservazioni ed i sopralluoghi effettuati nell’ambito delle indagini per la redazione del PdG: gli estesi seminativi ubicati nella pianura tra Gibellina e Alcamo, se percorsi dal fuoco nel periodo tardo-estivo, costituiscono zone di alimentazione per specie importanti dell’avifauna (ad esempio i grillai), e luogo di raduno dei migratori autunnali (ad esempio i nibbi bruni). Fatta comunque salva la rigorosa tutela delle formazioni vegetali naturali di maggiore interesse che fisionomizzano il paesaggio vegetale dell’area, potrebbe essere utile una diversa regolamentazione di tali fuochi (esclusivamente nei seminativi di pianura). Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 132 2.3.4 Descrizione del Paesaggio (F) 2.3.4.1 Caratteri significativi del paesaggio antropico e naturale (F.1; F.2) Il SIC “Complesso dei Monti di S. Ninfa-Gibellina e Grotta di S. Ninfa” si inserisce in un contesto territoriale i cui caratteri distintivi sono l’esito dell’evoluzione di un territorio che ha visto il sovrapporsi di diverse culture che lo hanno colonizzato e dominato già in epoca elimogreca. Le civiltà pre-greche e l’influenza di Selinunte e Segesta, l’articolazione territoriale dei casali arabi e la localizzazione dei castelli medievali (Salaparuta e Gibellina), la fondazione degli insediamenti agricoli seicenteschi (Santa Ninfa e Poggioreale) e la relativa ripartizione fondiaria hanno contribuito alla formazione della struttura insediativa a matrice fortemente rurale che presenta ancora l’assetto generale delineato nei secoli XVII e XVIII, che si basava su un rapporto diretto tra organizzazione urbana e uso agricolo del suolo (cfr. ASS. REG.LE BB.CC.AA. E P.I., Linee Guida per il Piano Territoriale Paesistico Regionale, Scheda Ambito 3 “Area delle colline del trapanese”). Pur permanendo nella sua generale caratterizzazione territoriale, il paesaggio agrario tradizionale ha strutturalmente cambiato carattere: un tempo prevalentemente costituito dal latifondo con la significativa prevalenza di seminativo, oggi con un regime proprietario fortemente parcellizzato e significativamente interessato dalla coltivazione della vite. A queste componenti vanno relazionate quelle relative agli aspetti naturali (habitat) e seminaturali (aree boscate), che contribuiscono a restituire un paesaggio dalle notevoli valenze paesaggistiche e ambientali. In relazione agli aspetti naturali, la componente fondamentale che determina l’assetto di questo paesaggio è il sistema collinare che dai rilievi di Santa Ninfa giunge fino a Poggioreale secondo la direttrice Ovest-Est. Il territorio del SIC ricadente nel comune di Santa Ninfa è per gran parte caratterizzato da un paesaggio collinare che si articola su una successione sedimentaria di età compresa tra il Tortoniano ed il Pliocene, ed i cui rilievi presentano quote massime comprese tra i m 465 e i m 554 in corrispondenza del crinale, costituito da Monte della Magione e da Monte Castellaccio. Il territorio del SIC ricadente nel comune di Gibellina raggiunge con il Monte Finestrelle quota m 662. La configurazione di questo paesaggio è, pertanto, definita dalla articolata morfologia dei Monti di Santa Ninfa e di Gibellina, caratterizzati dalla presenza di imponenti pareti gessose e da ampie manifestazioni di fenomeni carsici superficiali, quali doline e inghiottitoi, intervallati da valli cieche, valloni e zone pianeggianti che contribuiscono a definire un paesaggio articolato, dall’aspetto morfologico disomogeneo (un classico “paesaggio carsico”). Le doline presenti sono caratterizzate da versanti di natura gessosa al cui fondo si aprono gli inghiottitoi, che ricevono le acque superficiali che scorrono sulle argille sottostanti. Nell’area di Montagna della Magione le doline sono tra loro ravvicinate e a contatto, formando un caratteristico paesaggio definito “carso ad alveare”. Tra le forme carsiche superficiali che caratterizzano fortemente il paesaggio sono da considerare i Karren, solchi causati dalle acque meteoriche sulle rocce gessose, di notevole rilievo per varietà, tipologia e diffusione. L’area del SIC è inoltre ricca di forme carsiche ipogee: nell’altopiano sono state rilevate una trentina di grotte dallo sviluppo più o meno esteso, quasi tutte in corrispondenza di inghiottitoi; tra queste, la principale è la Grotta di Santa Ninfa, esterna al perimetro del SIC ma costituente la maggiore e la più interessante, per concrezionamento, fauna e sviluppo. Al tempo stesso si tratta di un paesaggio fortemente antropizzato, i cui caratteri naturali in senso stretto sono oramai residuali e concentrati all’interno del SIC e della riserva naturale. In particolare, il versante settentrionale del SIC, lungo il confine che coincide con la SP n. 75 della Magione, è caratterizzato dalla presenza di alte pareti rocciose al cui piede si estende Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 133 un’area coltivata e puntellata di edilizia rurale, che nel corso del tempo si è evoluta in edilizia residenziale di tipo stagionale; a questo segue in direzione Ovest un paesaggio di tipo naturale (località Campanaro-Cappellone) caratterizzato dalla presenza di habitat prioritario 6220*. Il versante settentrionale centrale è caratterizzato dall’uso agricolo del suolo con prevalenza di seminativo, con penetrazione nel versante meridionale. Il versante settentrionale orientale segue l’assetto della parte occidentale con una parete rocciosa naturale (M. Finestrelle) al piede della quale si estende una base agricola con una struttura insediativa di tipo ruraleresidenziale posta lungo la SS n. 188 Centro Occidentale Sicula. Nel versante meridionale, l’assetto del paesaggio diviene più complesso. Il paesaggio naturale si caratterizza ad Ovest per la presenza del complesso di M. Castellaccio (all’interno del SIC), di notevole rilievo paesaggistico per l’imponente mole isolata del monte, per la vegetazione rupestre e per la presenza del rimboschimento. In direzione Est segue prima un paesaggio fortemente antropizzato in cui, prevalentemente all’esterno del SIC, alla coltivazione agricola dei suoli si associa edilizia residenziale in forte e significativa crescita, e subito dopo il paesaggio di interesse naturale della Montagna della Magione, caratterizzato dalla presenza di Formazioni ad Euphorbia dendroides associata a Pseudo-steppa con graminacee perenni e piante annue dei Thero-Brachypodietea, habitat prioritario. Segue un paesaggio complesso caratterizzato da ambienti naturali o abbandonati, costituiti per lo più da formazioni di macchia disposta sui substrati meno favorevoli per l’agricoltura ai quali si combinano i coltivi a vigneto (tra Montagna della Magione e Contrada Fontana Blandina) e a vigneto/oliveto e gli ampi rimboschimenti. Qua il paesaggio è dominato dall’area boscata di Finestrelle, frammista ad appezzamenti di terreno coltivato a vigneto e vigneto associato ad oliveto o a seminativo (intorno alle Case Catalano, a Nord-Ovest di Monte Finestrelle). Nella parte alta di c.da Biviere e, in particolare, lungo i valloni, permangono ancora le tracce della macchia mediterranea che un tempo caratterizzava in maniera più significativa questo paesaggio. La parte più significativa del paesaggio antropico è quella caratterizzata essenzialmente dalla coltivazione agricola dei fondi. Nel versante meridionale, in particolare, il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di sempre più estese superfici agricole a vigneto, delimitate dalla struttura morfologica delle doline. La morfologia carsica ha, infatti, influenzato le scelte colturali che hanno subito una ulteriore evoluzione con la macchinizzazione del processo produttivo e della lavorazione dei campi. In generale ancora oggi si evince un incremento generalizzato della coltivazione della vite, di cui sono facilmente rilevabili i nuovi impianti, che in molti casi hanno comportato nel passato la ricolmatura delle doline con materiale detritico e terreno di riporto (BURRI, 1989) ed il progressivo spietramento (e conseguenziale accumulo di pietrame di risulta) per l’aumento della superficie agricola utilizzabile. Questa operazione di dissodamento di nuove terre a fini agricoli ha comportato un evidente e progressivo diradamento della copertura vegetale e della superficie arborea favorendo in molti casi processi di erosione del suolo e fenomeni franosi. A questo processo di estensione del sistema di produzione agricolo va anche attribuita la realizzazione di laghetti artificiali utili all’approvvigionamento idrico delle aree agricole. A questa componente colturale viene sempre più ad affiancarsi una componente antropica più impattante, quella relativa all’espansione del sistema insediativo costituito da edilizia residenziale e sviluppo della viabilità carrozzabile. La prima componente raggiunge livelli più intensi in direzione della crescita insediativa dei centri urbani (Santa Ninfa e Gibellina) e lungo le principali arterie di collegamento. Essa interessa in particolar modo il limite meridionale del SIC, Monte Castellaccio e Contrada Mostra, e a Nord, le pendici dei monti, attestandosi lungo la SS n. 188 Centro Occidentale Sicula e lungo la SP n. 75 della Magione nel tratto compreso tra Case della Magione e Casa Palermo. Si tratta di edilizia residenziale Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 134 stagionale che, per le caratteristiche tipologiche e strutturali, appare scarsamente relazionata all’architettura rurale tradizionale e alle esigenze funzionali legate alla conduzione agricola dei fondi. Lungo il versante settentrionale, essa presenta la tipica struttura insediativa “a pettine” che, in relazione alla parcellizzazione della proprietà fondiaria, si estende perpendicolarmente agli assi stradali. La seconda componente impattante, principalmente realizzata a servizio della prima e della coltivazione della vite (BURRI, 1989), è costituita dal sistema infrastrutturale che tende a sostituire nella sua totalità la rete di mulattiere e di sentieri che, in particolare, caratterizzavano la Montagna della Magione e il Monte Finestrelle. Questa viabilità è costituita da una fitta rete di piste in terra battuta realizzate dall’Azienda Foreste, che attraversano i rilievi carsici ricoperti dai rimboschimenti. La Carta dei punti panoramici e delle aree di interesse paesaggistico (Tavola 16) mette in evidenza le zone interne al SIC che rivestono un valore particolare relativamente all’assetto del paesaggio naturale, e che sono state diffusamente descritte . 2.3.4.2 Variazioni del paesaggio e tendenze evolutive delle trasformazioni territoriali (F.3) La ricostruzione post-terremoto ha profondamente variato la struttura insediativa della media valle del Belice ed ha attenuato l’isolamento delle aree interne generando una nuova centralità definita dal tracciato dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo e dall’asse Palermo-Sciacca. Tale processo di trasformazione del territorio ha interessato direttamente il contesto nel quale si colloca il SIC, determinando significativi fenomeni di trasformazione dell’assetto del paesaggio che possono essere individuati essenzialmente nella nuova edificazione e nella realizzazione di nuove strade sui tracciati dei sentieri. Il fenomeni insediativi hanno interessato prevalentemente il versante meridionale della Montagna della Magione seguendo la direttrice principale di espansione urbana di Santa Ninfa prevista dal PRG a ridosso di Poggio Calvario (zone C1.2 e C1.3, poste rispettivamente ad est ed a nord-ovest di poggio Calvario). Essi interessano in particolar modo il limite meridionale del SIC, intorno a Monte Castellaccio, e a Nord, le pendici delle pareti rocciose, attestandosi lungo la SS n. 188 Centro Occidentale Sicula e lungo la SP n. 75 della Magione. La rete di piste in terra battuta realizzate dall’Azienda Foreste, se da una parte ha consentito facilità di spostamento e soprattutto una maggiore sicurezza contro gli incendi che periodicamente colpiscono i boschi demaniali, dall’altra ha favorito l’aumento della pressione antropica, agevolando la mobilità dei mezzi meccanici per la lavorazione dei suoli agricoli, e contestualmente appare sempre più come elemento diffuso di frammentazione lineare interni all’area. Come si evince dallo Studio agricolo-forestale del 1994 di supporto al PRG, prima del sisma del 1968 il paesaggio che interessava il territorio del SIC era caratterizzato dalla cerealicoltura ed in minore misura dalla viticoltura e dall’olivicoltura; le coltivazioni a orti e a frutteto erano esclusivamente limitate alle vallecole presenti tra i rilievi gessosi ove era possibile l’approvvigionamento idrico. Il paesaggio del SIC, in seguito al sisma del 1968, cambia notevolmente anche in relazione alla realizzazione dei rimboschimenti e al cambiamento colturale, che a sua volta dipende dall’avvento della meccanizzazione nella produzione agricola e dallo sviluppo della viticoltura nelle produzioni agricole. I rimboschimenti operati dall’Azienda Foreste Demaniali a partire dal Piano predisposto nei primi anni settanta sono intervenuti in un contesto territoriale fortemente caratterizzato da fenomeni di dissesto idrogeologico causati dalla composizione argillosa dei suoli e dalle morfologia del terreno caratterizzata da forti pendenze. La meccanizzazione della coltivazione Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 135 dei terreni ha consentito la messa a coltura di terreni marginali difficilmente raggiungibili e in certi casi il rimodellamento della superficie coltivabile con lo spostamento di grandi quantità di terreno. Il cambiamento colturale a vantaggio del vigneto è stato favorito a partire dalla fine degli anni sessanta dalle agevolazioni all’accesso al credito agrario e dalla diffusione delle cooperative vitivinicole che hanno costituito un facile tramite tra la produzione e i mercati. Per quel che riguarda il processo di riconversione produttiva in agricoltura, che ha visto negli ultimi venti anni la progressiva sostituzione delle colture cerealicole con le colture viticole, in alcune zone associate all’oliveto e al seminativo, l’evoluzione della struttura agraria ha comportato anche il continuo e progressivo spietramento di suoli non coltivati, la realizzazione di terrazzamenti con muretti o scarpate. A tale processo si sono anche talvolta associati fenomeni di degrado come la ricolmatura della zona posta a Nord Nord-Est di Monte Castellaccio (all’esterno del SIC) dove in una ampia area sono state accumulate le macerie degli edifici post-sisma del 1968 e quella limitrofa al perimetro del SIC, lungo la SS 119, all’interno del confine della riserva, attualmente in corso di riqualificazione da parte dell’ente gestore. Altra forma di pressione sull’assetto del paesaggio è esercitata dal pascolo che, soprattutto in passato, ha contribuito alla perdita di biodiversità negli habitat naturali e seminaturali presenti nel SIC. Infine, seppur esterna al SIC, costituisce una significativa causa di alterazione del paesaggio tanto del versante settentrionale, quanto di quello meridionale, la centrale eolica realizzata lungo il crinale che da Rocca delle Penne muove in direzione di Poggioreale, con un impatto diretto sul Monte Finestrelle (sito archeologico), per prossimità più direttamente interessato. 2.3.4.3 Coerenza con le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale e con gli obiettivi del D. Lgs. 42/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio (F.4; F.5) Per quel che riguarda nello specifico la pianificazione paesistica, la Regione Siciliana ha approvato con D.A. n. 6080 del 21.05.1999 le Linee Guida per il Piano Paesistico Regionale, mentre la redazione del Piano d’Ambito è stata affidata alla Soprintendenza ai BB.CC. AA. Di Trapani. Il SIC “Complesso Monti di S. Ninfa-Gibellina e Grotta di S. Ninfa” ricade all’interno dell’Ambito 3 (“Area delle colline del trapanese”), per il quale non è ancora stato completato l’iter di formazione del relativo piano. Per il territorio interessato dal SIC, che viene considerato dal PTPR di interesse geomorfologico, naturalistico, speleologico (Gessi e Grotta di Santa Ninfa) e, più in generale di interesse paesistico, sono previsti specifici indirizzi di tutela e di salvaguardia del patrimonio esistente. In assenza del Piano d’ambito le indicazioni delle Linee Guida per il PTPR devono essere recepite all’interno degli strumenti di pianificazione ordinaria (PTP e PRG), così come stabilito all’art. 5 delle Linee Guida:“Nei territori non soggetti a tutela ai sensi delle leggi sopracitate, le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale valgono quale strumento propositivo, di orientamento e di conoscenza per la pianificazione territoriale provinciale e per la pianificazione urbanistica comunale.” In relazione a quanto detto, e in assenza del Piano Territoriale Paesistico, rimangono quindi validi gli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale che persegue i seguenti obiettivi generali (Indirizzi normativi delle Linee Guida, Parte seconda, art.1): a) stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, difesa del suolo e della bio-diversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità; Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 136 b) valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni; c) miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le attuali che per le future generazioni. Tuttavia, gli strumenti urbanistici presenti non recepiscono con azioni concrete tali indicazioni, determinando una incoerenza rispetto al quadro normativo di riferimento in materia di tutela del paesaggio. In particolare, negli indirizzi del Piano Territoriale della Provincia di Trapani (Progetto di Massima) si individuano potenziali profili di incoerenza con le indicazioni delle Linee Guida relative in particolare al rapporto tra indirizzi per la tutela del patrimonio culturale (naturale e naturalistico) e indirizzi per lo sviluppo socio-economico, con particolare riferimento al settore del turismo, che tuttavia, allo stato attuale di elaborazione del Piano, non possono trovare specifica puntualizzazione. Né risultano attivi programmi o iniziative a tutela delle componenti del paesaggio presenti nel territorio del SIC. Inoltre, la possibilità di realizzare in Zona E “costruzioni residenziali” (Comune di Santa Ninfa, Piano Regolatore Generale, Norme Tecniche di Attuazione, art. 28) non esclusivamente relazionate alla conduzione dei fondi agricoli, costituisce oltre che un fattore di rischio per la salvaguardia di gran parte del paesaggio agrario e percettivo del SIC, anche una condizione di incoerenza con gli indirizzi di tutela delle Linee Guida. In relazione agli Indirizzi normativi specifici delle Linee Guida (Parte seconda), ed in riferimento alle linee strategiche individuate al Titolo II, “Indirizzi per sistemi e componenti” (Artt. 9-17), si evidenzia quanto segue: 1) in relazione agli indirizzi per la tutela del settore Geologia, geomorfologia, idrologia (art. 9) si rileva una tendenziale incoerenza tra le indicazioni delle Linee Guida, che prevedono azioni di “conservazione, difesa, prevenzione e restauro delle singolarità geologiche, delle formazioni paleontologiche, dei valori scenici e panoramici propri degli elementi fisici del paesaggio, dei processi naturali, degli equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici” e la realtà del territorio, che appare in molti casi soggetto a fenomeni franosi. Gli unici ambiti sottoposti a controllo e salvaguardia sono i due demani forestali e la Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa”. Per il resto si assiste a fenomeni di degrado, come i crolli delle pareti rocciose che interessano tanto il versante meridionale (Monte Finestrelle) quanto quello settentrionale (parte rocciosa compresa tra Località Campanaro-Cappellone e la Serralonga). Nel caso specifico di Monte Finestrelle (Gibellina) tale fenomeno di degrado e incuria interessa tanto la componente naturale (parete rocciosa) tanto quella culturale di interesse archeologico (necropoli) con il rischio di compromissione dell’eccezionale paesaggio ad essa relazionato. 2) in relazione agli indirizzi per la tutela del Paesaggio dei mosaici colturali (art. 12.f) si rileva una tendenziale incoerenza con il processo di alterazione e frammentazione in atto di tali paesaggi, causato dalla crescente pressione insediativa. I valori legati a questo tipo di paesaggio, che secondo le Linee Guida dovrebbero essere tutelati attraverso l’attivazione di forme di salvaguardia paesaggistica e ambientale in coerenza con la conservazione di espressioni locali aventi particolare valore storico e paesaggistico da individuare e perimetrare specificamente, non risultano ad oggi adeguatamente salvaguardati. I principali elementi di criticità sono connessi alle dinamiche di tipo edilizio nelle aree tradizionalmente interessate dalla residenza stagionale e in quelle destinate all’attività agricola. 3) in relazione agli indirizzi per la tutela del Paesaggio percettivo (art. 17) non sono ad oggi stati individuati adeguati studi o strumenti (in sede di pianificazione territoriale e urbanistica) per la tutela di questa categoria di paesaggio. In assenza di Piano Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 137 Territoriale Paesistico e di Piano Territoriale Provinciale che recepisca gli indirizzi di salvaguardia contenuti nelle Linee Guida, risulta assente una lettura interpretativa d’area vasta che contestualizzi il SIC nel proprio ambito territoriale di riferimento e non consenta l’alterazione di questa categoria di paesaggio come sembra profilarsi negli ultimi anni. La centrale eolica realizzata lungo il crinale che da Rocca delle Penne muove in direzione di Poggioreale, seppur esterna al SIC, costituisce una significativa causa di alterazione del paesaggio percettivo tanto del versante settentrionale, quanto di quello meridionale. Il D.Lgs. 42/04 definisce paesaggio “una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni” (art. 131.1). La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili (art. 131.2). Nel caso del SIC “Complesso Monti di S. Ninfa-Gibellina e Grotta di S. Ninfa” i caratteri del paesaggio come interazione tra natura e storia cui fa riferimento DLgs 42/04 risultano quanto mai evidenti. Le categorie di paesaggio presenti nel SIC (paesaggio di interesse geologico, paesaggio di interesse culturale-tradizionale, paesaggio di interesse percettivo) rientrano in particolare in quelle indicate all’art. 136.1: - le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; - i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; - le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Per queste categorie di paesaggio, oltre all’assenza di specifici strumenti di salvaguardia e tutela quali il Piano Territoriale Paesaggistico, previsto all’art. 143, e di programmi specificatamente rivolti alla sua salvaguardia, risultano assenti le specifiche attività di formazione e educazione che le amministrazioni pubbliche devono attivare ai sensi dell’art. 132.3. Né risultano attivati processi di sensibilizzazione sociale e civile finalizzati alla diffusione della conoscenza dei valori connessi a tale paesaggio (art. 135.3) che potrebbero concretamente contribuire alla futura conservazione del suo assetto. Le uniche attività in tal senso presenti sono quelle promosse dall’Ente Gestore della Riserva e dall’Azienda Regionale Foreste Demaniali – Ufficio Provinciale di Trapani e relative al territorio di propria competenza (riserva e demani forestali). Per l’estensione territoriale del SIC e per le caratteristiche specifiche di questo paesaggio, il maggiore elemento di criticità rimane tuttavia legato all’assenza del Piano Paesaggistico e di tutte quelle misure di salvaguardia che ad esso sono attribuite. Tra queste risulta di particolare rilevanza il coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione, normato dall’art. 145, e il rapporto di sovraordinamento che intercorre tra la prima e i secondi stabilito all’art. 145.3: “Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione.” Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 138 2.3.5 Descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali presenti nel Sito Natura 2000 (E) 2.3.5.1 Strumenti normativi e di pianificazione di settore vigenti sul territorio (E.1) La tutela dei valori archeologici, architettonici e culturali è disciplinata oggi dal D.Lgs 42/04 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) , che costituisce l’evoluzione dell’originaria Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 (“Tutela delle cose di interesse artistico o storico”), modificata ed integrata dal Decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352”), che sottopone a tutela i Beni culturali (Titolo I). In relazione agli strumenti di pianificazione di settore, il riferimento principale è costituito dalle Linee Guida del Piano Paesistico Regionale del 1996. 2.3.5.2 Individuazione di aree archeologiche (E.2) Il SIC si sviluppa lungo le propaggini occidentali del sistema collinare costituito dai Monti di Santa Ninfa e Gibellina che da Santa Ninfa si spingono, in direzione Ovest-Est, fino a Poggioreale. Questo configurazione morfologica segna fortemente il territorio circostante costituendo un elemento di spartiacque tra le aree che gravitavano intorno a Selinunte e quelle che si trovavano sotto il controllo diretto di Segesta e costituendo un ideale punto di osservazione e controllo del territorio circostante ricchissimo di aree di antica antropizzazione. Tuttavia, questo territorio non è stato oggetto di campagne di studi organici che ne rilevassero il valore reale, che rimane pertanto ancora in gran parte sconosciuto, come sembrano testimoniare i numerosi siti di interesse archeologico segnalati e ancora per molti aspetti non adeguatamente studiati. All’interno del SIC sono diversi i siti di interesse archeologico presenti, che testimoniano una frequentazione insediativa antica in epoca risalente ad un periodo compreso tra il neolitico e il sec. XII, e che hanno generato la diffusione di un particolare interesse storico per l’area. Diverse sono state le campagne di studio, i sopralluoghi e le ricognizioni effettuate da gruppi di ricerca sul patrimonio di interesse archeologico presente nell’area. Tuttavia, risulta assente una campagna archeologica sistematica che, interessando tutto il territorio, cerchi di fare chiarezza sull’effettiva ampiezza degli insediamenti, sulla loro articolazione e sulle relative datazioni. Tra i vari studi svolti nell’area, è possibile ricordare l’attività di ricerca promossa dal Gruppo Archeologico Palermitano nel 1973 (prevista all’interno del programma “Operazione Santa Ninfa 73” promosso dall’Associazione Aiuti Internazionali del Ministero dell’Interno in aiuto alle popolazioni siciliane colpite del terremoto del 1968). Le aree interessate dalle indagini sono state: 1. Contrada Castellaccio. Ritrovamento di frammenti di tipo indigeno relativi ad un insediamento proto-storico (TODARO, 1973), decorati e databili tra il VI e il V secolo a.C. (TODARO, 1973; MANNINO, 1974). Si tratta in particolare di due tipi di materiale: terracotta incisa e frammenti e utensili in felce e ossidiana di epoca neolitica e dell’età del rame (TODARO, 1973; BURRI, 1989). Le caratteristiche morfologiche del sito e la presenza del toponimo, assieme al ritrovamento di tracce di un’antica cinta muraria, testimoniano la presenza di una struttura difensiva. 2. Località Timpone Pontillo (esterna al SIC). Altura gessosa (313 m) posta a Nord del Castellaccio, in cui sono stati ritrovate tombe scavate lungo il versante meridionale Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 139 della collina con frammenti ceramici con una possibile datazione collocabile tra il XIII e il XII sec. a.C. (TODARO, 1973; MANNINO, 1974). Il sito è stato stravolto dai lavori per la realizzazione dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo dei primi anni ’70. Altri studi sono quelli condotti da MANNINO (1974), all’interno dei quali, tra i ritrovamenti, vengono ricordati i seguenti: 1. Località Timpone Pontillo (esterna al SIC). Ritrovamento di tombe scavate lungo il versante meridionale della collina con presenza di frammenti ceramici. 2. Contrada Ciaramitaro (esterna al SIC). Area sita a circa 2 Km a Nord di Santa Ninfa nella quale sono stati ritrovati frammenti di epoca romana. 3. Località Castellaccio (area SIC). Frammenti di tipo indigeno, acromi e con decorazione dipinta, databili al VI-V sec. a.C. 4. Montagna della Magione (area SIC). Rilevabili pareti rocciose con ritrovamenti di materiale risalente all’età tardo-romana (MANNINO, 1974; BURRI, 1989). 5. Località La Rocca (esterna al SIC). Gruppo di tombe a fossa scavate nella roccia. 6. Collinetta vicino e a Sud di Monte Finestrelle (esterna al SIC) con resti di tombe “a grotticella” (FALSONE, 1977; MANNINO, 1974). 7. Monte Finestrelle (area SIC) in territorio di Gibellina, necropoli dove sono stati ritrovati vasi poi ceduti nel 1898 al Museo di Gibellina dalla baronessa Angela De Stefani (MANNINO, 1974) nella parete rocciosa sita a Nord–Est. Tale necropoli, assieme all’ampio repertorio fittile ritrovato nella zona testimonia la presenza di un impianto insediativo ampio e diffuso su questo territorio. La Necropoli di Monte Finestrelle è ricavata nelle pareti gessose che caratterizzano il versante meridionale del sistema dei Monti di Santa Ninfa e Gibellina. Le tombe rupestri, circa 40, sono disposte su più livelli l'una accanto all'altra in file orizzontali. Del Monte Finestrelle (il toponimo, che appare già in un documento del XVII secolo, fa riferimento alle forma dei sepolcri) dà testimonianza anche INGOGLIA (1981) indicando la presenza di “25 finestrelle, appaiate a due, a tre, a quattro, a cinque” della dimensione di metri 2x1; si tratta di una necropoli proto-storica con tombe sicule primitive del tipo a camera (BURRI, 1989), caratterizzata dalla presenza di grotte artificiali scavate lungo la parete del Monte Finestrelle, rocca gessosa di notevole valore archeologico e paesaggistico. La struttura originaria era costituita da un vestibolo con una porta a cornice rientrante e dalla cella funeraria disposti su una pianta semi-circolare/semiellittica o rettangolare. Le tombe più antiche risalgono all'età del bronzo, mentre quelle a pianta rettilinea si collocano intorno ai primi secoli del I millennio a.C. I reperti rinvenuti nella necropoli sono diversi, tra questi il gruppo più considerevole è costituito da una ventina di oggetti acquisiti dal Museo archeologico di Palermo (tra cui un corno fittile di età preistorica, due ciotole monoansate di tipo villanoviano e una importante anfora ornata da un motivo ad angoli dipinti in bruno). Tutti i tumuli sono in cattivo stato di conservazione a causa degli agenti atmosferici e dell’incuria dell’uomo. Anche all’interno della Grotta di Santa Ninfa sono stati ritrovati reperti archeologici di un qualche interesse. Un altro studio è quello che ha portato alla elaborazione della Carta dei Siti Archeologici della Sicilia (CABIANCA & PINZELLO, 1990), pubblicata per conto dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente quale contributo per la redazione del Piano Urbanistico Regionale. Nella Carta risultano individuati e censiti i seguenti siti archeologici: 1. Castellaccio (Santa Ninfa, interno al SIC) - Presenze archeologiche sporadiche di epoca fenicio-punica; Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 140 2. La Grotta (Santa Ninfa, esterna al SIC) - Presenze archeologiche sporadiche di epoca romana; 3. Cima Pontillo (Santa Ninfa, esterno al SIC) - Necropoli dell’età del bronzo. Infine, in relazione al quadro istituzionale di riferimento, le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale del 1996 individuano all’interno del SIC le seguenti aree archeologiche: 1. Castellaccio di Santa Ninfa (Santa Ninfa) - Località preistorica – età del ferro – indigena X-VI secolo (arcaica), elima (sito indefinito); 2. Montagna della Magione (Santa Ninfa) - Insediamento tardo-romano e medievale; 3. Monte Finestrelle (Gibellina-Santa Ninfa) - Centro indigeno; 4. Monte Finestrelle Nord (Gibellina) - Abitato e probabili necropoli di epoca protostorica – IX-VIII secolo – età del ferro (proto elimo). Esterne al SIC ma prossime al suo perimetro sono inoltre presenti le seguenti aree archeologiche: 1. Case della Magione (Gibellina) - Insediamento medievale; 2. Monte Finestrelle Nord 1 (Gibellina) - Abitato e probabili necropoli di epoca protostorica – IX-VIII secolo – età del ferro (proto elimo); 3. Rocca delle Penne (Gibellina) - Insediamento frequentato in epoca protostorico e in età romana. Nessuna di queste aree risulta tutelata attraverso un apposito vincolo archeologico. Nella Tavola 17 (Carta dei Beni Architettonici ed Archeologici) viene riportata l’ubicazione delle principali aree archeologiche sopra descritte, sia interne che limitrofe all’area del SIC. 2.3.5.3 Individuazione dei beni architettonici sottoposti a tutela (E.3) Nell’area del SIC non risultano presenti né beni architettonici di interesse, né tanto meno beni architettonici sottoposti a specifico vincolo di tutela. Disseminate sul territorio del SIC permangono le tracce di strutture edilizie tradizionali e di qualche abbeveratoio (in località Fontana Blandina). Si tratta di piccole strutture a una o due elevazioni con copertura piana o a falde inclinate, realizzate in pietra di estrazione locale a faccia vista (muratura portante con impasto a malta di gesso) o intonacate, ridotte per lo più allo stato di rudere. Gli unici esempi di architettura rurale di un certo interesse storico-testimoniale sono presenti lungo il versante meridionale, in Località Biviere, e lungo il versante settentrionale, in Località Montagna della Magione e Case Magione. Gli edifici che vengono attualmente realizzati per lo più a fini residenziali stagionali lungo le principali arterie di collegamento dei centri abitati presentano una struttura in cemento armato e sono tamponati con laterizi forati, non conservando nulla della tradizionale architettura rurale locale. A Sud dell’area della Riserva si trova il Castello di Rampinzeri, complesso residenziale risalente al sec. XVII. Si tratta di una struttura di particolare valore storico-culturale caratterizzata da baglio (la denominazione di “castello” va attribuita alle successive modifiche in stile neogotico apportate nell’Ottocento) con ampia corte interna, oggi solamente in parte leggibile a causa del crollo del lato sinistro della struttura originaria. All’interno dell’impianto, rivestono particolare interesse etno-antropologico e storico-architettonico l'antico frantoio e una cappella in stile neogotico che si aprono nel cortile esterno. Nella Tavola 17 (Carta dei Beni Architettonici ed Archeologici) vengono riportati i manufatti di maggiore interesse architettonico presenti all’interno del SIC e nelle sue immediate Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 141 vicinanze, sebbene nessuno di questi sia sottoposto a specifico vincolo di tutela; tra gli edifici esterni al SIC si segnala il Castello di Rampinzeri, che è stato inserito sia per il notevole valore storico, architettonico e culturale dell’immobile, sia perché la sua destinazione nell’immediato futuro prevede l’utilizzo come sede della riserva naturale, centro visitatori e museo naturalistico, con evidenti refluenze sulla promozione della fruizione e della sensibilizzazione ambientale all’interno del Sito. Si segnala inoltre che nell’ambito degli studi per la redazione del Piano di Gestione è stato redatto uno specifico censimento degli immobili presenti all’interno del SIC. 2.3.5.4 Coerenza con gli obiettivi del D. Lgs. 42/04. Codice dei beni culturali e del paesaggio (E.1.1) Il D.Lgs. 42/04 dichiara all’art. 2 che il patrimonio culturale “è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.Lgs. 42/04, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'Art. 134 del D.Lgs. 42/04, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. All’art. 30 si stabilisce che lo Stato e le Regioni hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata dal D.Lgs. 42/04 all’art. 29, mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. Il D.Lgs. 42/04 introduce le seguenti categorie di intervento: 1. Prevenzione: complesso di attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto; 2. Manutenzione: complesso di attività e di interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti; 3. Restauro: intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Tuttavia, tutti i beni archeologici e architettonici presenti nel SIC e analizzati in precedenza versano in misero stato di conservazione; in molti casi risultano ridotti a rudere. In particolare, i beni di interesse archeologico presenti non sono sottoposti a speciale tutela (vincolo archeologico) e sono costantemente sottoposti a degrado a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici. Quelli scavati in pareti rocciose (Finestrelle), in particolare, non sono adeguatamente interessati da interventi di messa in sicurezza e di stabilizzazione dei versanti franosi. In relazione ai beni architettonici, ai sensi del D.Lgs. 42/04 rientrano tra i beni culturali “le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etno-antropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale” (art. 10.4.l). Per tali beni il D.Lgs. 42/04 dichiara che “I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione” (art. 20.1). Tuttavia i pochi beni architettonici presenti non risultano adeguatamente conservati. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 142 Tale stato di conservazione e l’assenza di specifiche progettualità in atto, indirizzate al recupero del suddetto patrimonio, evidenziano un grave stato di incoerenza con gli indirizzi del D.Lgs. 42/04 sopra ricordati. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 143 2.3.6 Descrizione della pianificazione territoriale 2.3.6.1 Sistema vincolistico (D.2) Denominazione del vincolo Vincolo idrogeologico Provvedimento normativo R.D. 3267 del 30/12/23 Prescrizioni di polizia forestale Provvedimento specifico Fasce di rispetto L. R. 78/76 dei boschi e delle L.R. 16/1996, aree boscate L.R. 13/99 L.R. 6/2001 Vincoli Divieti di alcune attività e regolamentazione di altre sottoposte a preventivo nulla osta Parziale inedificabilità Soprintendenza Divieto della ai BB. CC.AA. modificazione di Trapani dell’assetto territoriale senza preventivo nulla osta Ente Gestore Divieti di alcune della Riserva – attività e Legambiente regolamentazione di altre Assessorato sottoposte a Regionale preventivo nulla Territorio e osta Ambiente Riserva Naturale Integrale (R.N.I.) L.R. 98/81 L. R. 14/88 Vincolo paesaggistico (Boschi, Fiumi, Torrenti e Corsi d’acqua, riserve naturali, zone di interesse archeologico) Fiumi e torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi – Acque pubbliche Sito di Interesse Comunitario D.Lgs. 42/04 (vincoli ex legge Galasso 431/85) Soprintendenza ai BB. CC.AA. di Trapani Divieto della modificazione dell’assetto territoriale senza preventivo nulla osta T.U. 1777/33 R.D. 215/33 Genio Civile di Trapani Divieti di alcuni interventi ed altri a preventiva autorizzazione Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Servizio 2 Ente Gestore Riserva Legambiente Comuni Valutazione di incidenza per interventi che possono compromettere la conservazione di habitat e specie Direttiva 92/43/CEE e DPR 357/97 D.A. 289 del 16/05/95 e n. 526 dell’11/08/95 Soggetto gestore Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Trapani Distaccamento Forestale di Castelvetrano Comuni Circolare ARTA 23 gennaio 2004 e D.A. n. 21 febbraio 2005 Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 144 I principali vincoli vigenti nell’area del SIC sono riportati anche in Tavola 18 (Carta dei Vincoli). Presenza di aree naturali protette (D.1) All’interno del SIC ITA010022 ricade la Riserva Naturale Integrale “Grotta di Santa Ninfa”, istituita dall’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.14/88, con DD.AA. 16 maggio 1995 e 11 agosto 1995 (pubblicati in S.O. n. 4 a G.U.R.S. n. 4 del 25.1.1996). La riserva è affidata in gestione a Legambiente - Comitato Regionale Siciliano, che ha il compito di provvedere alla salvaguardia dell’ambiente naturale, di promuovere la ricerca scientifica, di favorire le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva. La Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” è di tipo integrale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.14/88. Il motivo preponderante nella scelta di tutela risiede nell’elevato interesse geomorfologico del territorio dell’area protetta, che viene istituita “al fine di conservare nella sua integrità l’ambiente naturale in quanto sono notevoli le possibilità di studio dell’idrologia attuale e passata, della speleogenesi, di aspetti legati alla formazione di mineralizzazioni particolari (aspetti di minerogenesi sia di solfato di calcio che di calcite). Manifestazioni di acqua sulfurea”. Alla luce degli studi condotti e delle ricerche sul campo, le motivazioni sopra riportate appaiono decisamente riduttive rispetto alle valenze naturalistiche del territorio, riferibili in gran parte ad emergenze geomorfologiche legate alla presenza di imponenti fenomeni carsici superficiali ed ipogei, ma anche a rilevanti aspetti del paesaggio e della vegetazione, caratterizzati da interessanti formazioni ripariali e da gariga sugli affioramenti gessosi. Il decreto istitutivo ha suddiviso il territorio della Riserva in due distinte aree a differente destinazione d’uso, in funzione delle caratteristiche ambientali, dello stato di antropizzazione e dei diversi obiettivi gestionali: • la zona A (riserva) è costituita dall’ambiente ipogeo (sistema inghiottitoio-grottarisorgenza), che si sviluppa per circa 1350 m, e da due limitate aree di 5 m di raggio intorno all’ingresso della grotta ed all’inghiottitoio; • la zona B (preriserva), estesa per circa 140 Ha (di cui 110 ricadenti nel Comune di Santa Ninfa e 30 nel Comune di Gibellina), comprende la Valle del Biviere, che costituisce parte del bacino di alimentazione della grotta. 2.3.6.2 Mappa catastale o definizione di macrozone demaniali La proprietà demaniale all’interno del SIC è estesa circa 363,14 Ha, ed è suddivisa in: Demanio forestale Demanio fluviale Ha 362 0,54 % su SIC 54,92 0,08 La rimanente parte (297,04 Ha) ricade in regime di proprietà privata. Risulta evidente che una così estesa percentuale di superficie demaniale rappresenta un’ottima precondizione per una facile realizzazione di interventi gestionali del Sito. La Tavola 19 (Carta del regime proprietario) visualizza le aree caratterizzate da un differente regime. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 145 2.3.6.3 Inventario dei soggetti amministrativi e gestionali (D.4) Il quadro delle principali competenze amministrative e gestionali di natura pubblica relative all’area compresa entro il perimetro del SIC è schematicamente riassunto nella tabella seguente: Soggetti amministrativi e gestionali Competenze sul territorio Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente Coordinamento Piani di Gestione Siti “Rete Natura 2000” – Attuazione Direttiva 92/43 – Valutazione di Incidenza dei piani Azienda Regionale Foreste Demaniali- Ufficio Provinciale di Trapani Gestione tecnico-amministrativa del Demanio Forestale Corpo Forestale Regionale (Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani e Distaccamento Forestale di Castelvetrano) Gestione del Vincolo idrogeologico Vigilanza in materia ambientale, urbanistica e paesaggistica Servizio di prevenzione e repressione antincendio Sistemazioni idraulico-forestali Istruttoria progetti per incentivi nel settore forestale Provincia Regionale di Trapani Amministrazione ordinaria del relativo territorio provinciale – pareri del Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve Soprintendenza ai BB. CC. e AA. di Trapani Tutela del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico presente – Gestione vincoli Genio Civile Gestione delle acque pubbliche, sistemazioni idrauliche – Polizia idraulica Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura Assistenza tecnica e istruttoria progetti per incentivi in agricoltura Comune di Santa Ninfa Amministrazione ordinaria del relativo territorio comunale – Vincoli di natura urbanistica Comune di Gibellina Amministrazione ordinaria del relativo territorio comunale– Vincoli di natura urbanistica Legambiente Comitato Regionale Siciliano Ente gestore R.N.I. “Grotta di Santa Ninfa” Ente incaricato per la redazione del Piano di gestione del SIC ITA010022 “Complesso Monti di S. Ninfa-Gibellina e Grotta di S. Ninfa” I soggetti aventi funzioni amministrative e gestionali afferiscono ad una duplice categoria di competenze: - Competenze ordinarie: sono quelle relative alla ordinaria amministrazione del territorio (Regione Siciliana, Provincia di Trapani e Comuni di Santa Ninfa e Gibellina). Competenze speciali: sono quelle relative alla tutela dei beni di carattere paesaggistico e ambientale (Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani, Ente gestore della Riserva.), o alla gestione dei vincoli presenti nel territorio (Azienda Regionale Foreste Demaniali – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, ecc.). Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 146 2.3.6.4 Analisi del patrimonio insediativo, delle infrastrutture e dei detrattori ambientali (D.11) Nell’ambito della redazione del Piano di gestione è stato effettuato il censimento del patrimonio insediativo, delle infrastrutture e dei detrattori ambientali presenti all’interno del SIC. Tali manufatti vengono visualizzati nella Tavola 20 (Carta degli insediamenti e delle infrastrutture). Patrimonio insediativo Il SIC è interessato prevalentemente da caseggiati e fabbricati destinati ad attività agro-silvopastorali o, in misura decisamente inferiore, ad abitazione residenziale. Su un totale di circa 200 elementi censiti, circa un terzo (70) ricade nel territorio della riserva naturale “Grotta di Santa Ninfa”. Il patrimonio insediativo è essenzialmente caratterizzato da edifici rurali, nella maggioranza dei casi allo stato di rudere e risalenti agli inizi del secolo scorso (‘900), se non addirittura precedenti, secondo le testimonianze fornite da abitanti del luogo. La rimanente parte è suddivisa tra abitazioni (di regola residenze stagionali nel periodo estivo) e magazzini rurali e stalle. Sono presenti in una limitata area alcune strutture pubbliche di servizio e di supporto della fruizione, di proprietà dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali. a) b) c) d) a) composizione per tipologia del patrimonio insediativo; b) aggregazione degli insediativi per tipo di proprietà; c) incidenza della proprietà sulle tipologie costruttive degli insediativi; d) stato di conservazione del patrimonio di edifici in gesso in relazione alla proprietà. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 147 La maggior parte dei ruderi e degli edifici rurali in gesso ricadono in aree demaniali gestite dall’AFFDDRS, a testimonianza del maggiore uso agricolo del territorio prima del terremoto del ’68 e dell’acquisizione delle aree da parte dell’Azienda Foreste; si tratta per la maggior parte di manufatti in pessimo stato di conservazione e quindi difficilmente recuperabili, a meno di un massiccio consolidamento delle pareti ancora erette e di una ricostruzione di quelle crollate totalmente o parzialmente. Oggi sono pochissime le strutture utilizzate, prevalentemente per magazzino o ufficio; alcune tra queste strutture in gesso, a tipologia tradizionale, rivestono elevate potenzialità ai fini della promozione della fruizione (bivacco; punti base dell’escursionismo; ecc.). All’interno del SIC le aree caratterizzate da una maggiore densità di insediamenti sono (cfr. Tavola 20): - il confine settentrionale, in prossimità con la SS 188, in cui è presente una tipica struttura insediativa “a pettine” che, in relazione alla parcellizzazione della proprietà fondiaria, si estende perpendicolarmente agli assi stradali; - il confine settentrionale, in prossimità di Case della Magione, lungo la SP n. 75. Si tratta di edilizia residenziale stagionale che, per le caratteristiche tipologiche e strutturali, appare scarsamente relazionata all’architettura rurale tradizionale e alle esigenze funzionali legate alla conduzione agricola dei fondi. All’esterno del SIC, ma in zone contigue (tali da costituire pressioni ed impatti) le aree caratterizzate da insediamenti sono: - il limite meridionale del SIC tra Monte Castellaccio e Contrada Mostra; - da c.da Mostra fino a case Baldassone, più a sud; - il confine meridionale del SIC presso c.da Biviere. Si registra inoltre, nella porzione centro-orientale del SIC, la presenza di una estesa masseria (Case Catalano) con stalle, recinti, magazzini, ecc. Infrastrutture e detrattori ambientali Viabilità - La fitta rete di viabilità rurale e forestale che attraversa il territorio del SIC costituisce un forte elemento di antropizzazione del territorio, con notevoli ripercussioni tanto nel paesaggio quanto a livello ecologico-funzionale. Alla viabilità originaria di alcune aree del SIC, connessa alla presenza di edifici abitati ed alla conduzione delle passate attività agricole, si è aggiunta negli anni ’80 quella legata alle attività forestali, realizzata dall’Azienda Regionale Foreste Demaniali al fine di favorire una più agevole azione del personale di servizio nelle diverse attività svolte. La viabilità raggiunge la massima estensione nelle aree rimboschite ubicate nella porzione centro-orientale del SIC, determinando un fitto ed esteso reticolo. Lungo la viabilità forestale, costituita da piste in terra battuta o in detrito di cava, sono presenti cancelli e barre per la chiusura delle piste e per consentire l’accesso esclusivo dei mezzi di servizio; tuttavia le piste non vengono chiuse nel periodo estivo in modo da poter favorire, in caso di incendio, un rapido ingresso dei mezzi di intervento, ed inoltre le recinzioni perimetrali sono in molti casi divelte, permettendo così l’accesso anche a mezzi motorizzati non autorizzati. Tra l’altro ormai per prassi la stagione antincendio perdura sino al tardo autunno, per cui le piste forestali sono aperte anche nel periodo venatorio, favorendo in maniera ingiustificata ed inaccettabile la pratica del bracconaggio. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 148 Strutture dell’Azienda Foreste Demaniali – Nelle aree del demanio forestale presenti all’interno del SIC (Finestrelle e Castellaccio) l’Azienda Foreste Demaniali possiede ed utilizza diverse strutture e manufatti sia a fini di fruizione, sia come strutture di servizio. In particolare, presso il demanio Castellaccio sono presenti piccoli manufatti in gesso utilizzati come ufficio di cantiere, come magazzino e come punto base per la squadra di spegnimento antincendio; presso il demanio Finestrelle sono ubicati l’ufficio di cantiere, il museo etnoantropologico, l’area attrezzata con tavole, giochi e bagni, magazzini, opificio, rifugio, vivaio (non più utilizzato e recentemente affidato in comodato d’uso all’ente gestore della riserva naturale, che sta attuando interventi per il suo ripristino ed utilizzo). Inoltre ogni demanio forestale è delimitato da cancelli (muniti di scalandrini in legno per il passaggio pedonale) e da barre in ferro, nonché da una recinzione perimetrale in paletti (di castagno e/o zincati) e filo spinato, che in molti casi si presenta in pessimo stato di conservazione e che l’Azienda Foreste ha iniziato a sostituire con una più consona recinzione in paletti di castagno e rete metallica zootecnica a maglie larghe, che consente il passaggio della fauna minore. All’interno del demanio Finestrelle sono inoltre ubicati due piccoli invasi artificiali, realizzati a fini antincendio: il primo, ricadente anche nel territorio della riserva naturale “Grotta di Santa Ninfa”, è stato recentemente riqualificato nell’ambito di un progetto presentato congiuntamente nell’ambito del POR Sicilia 2000-2006 dall’Ente gestore della riserva naturale e dall’Azienda Regionale Foreste Demaniali (Ufficio Provinciale di Trapani) e svolge attualmente un indubbio ruolo naturalistico, mentre il secondo è vuoto da tempo per cedimento del fondo. Infine, all’interno dei due demani sono ubicate le torrette di avvistamento incendi, in lamiera e ferro, che vengono utilizzate dal personale stagionale dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste nell’ambito del servizio antincendio boschivo. Elettrodotti - Il territorio del SIC è attraversato da una serie di linee elettriche dell’ENEL ad alta, media e bassa tensione. La palificazione per le linee domestiche è concentrata nelle aree di confine del SIC o in prossimità delle vie carrabili più importanti. Le linee elettriche possono provocare impatti di tipo sia paesaggistico (in modo particolare per le strutture di sostegno) che faunistico (mortalità per collisione dell’avifauna); inoltre quelli ricadenti nei boschi inducono frammentazione nella copertura forestale, in quanto vengono effettuati ripetuti tagli degli alberi in corrispondenza delle linee per evitare problemi di avvicinamento alle chiome e conseguenti corto circuiti. Ciò potrebbe avere anche un effetto positivo, poiché nelle aree così diradate si assiste all’ingresso di specie tipiche di ambienti più aperti, che evolvono verso formazioni di gariga e di prateria. Detrattori ambientali – Tra i principali detrattori ambientali presenti nel territorio del SIC si segnalano: 1) due limitate aree (in c.da La Menta e alla base delle pareti del Campanaro) con scarico abusivo di inerti e di rifiuti vari; presentano anche materiali pericolosi (ad esempio resti di coperture in amianto) e sono ubicati in zone di particolare pregio. 2) in alcune puntuali zone del SIC sono presenti tracce visibili di inerti e materiali di demolizione provenienti dalla rimozione delle macerie del terremoto (anni ’70–’90) ed utilizzati per il colmamento di alcune aree; tali zone oggi sono state messe a coltivazione, ma appare necessaria una riqualificazione del paesaggio attraverso la rimozione dei resti superficiali di tali cumuli. 3) all’interno del demanio forestale di Finestrelle è ubicato un sistema idrico antincendio protetto da muretti in conci di tufo, in pessimo stato di conservazione, che provoca un notevole impatto visivo anche in virtù della sua mancata contestualizzazione naturale; Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 149 ai muretti si aggiungono i pozzetti di drenaggio della viabilità, nonché le vasche in calcestruzzo ubicate nelle vicinanze del laghetto Biviere, che possono provocare danni alla fauna selvatica. All’esterno del Sito, ma in area contigua, si segnala la presenza di un impianto eolico, ubicato sul confine orientale, che costituisce senza dubbio l’infrastruttura di maggior rilievo presente nel territorio. L’impianto prevedeva la realizzazione di alcune torri eoliche all’interno del SIC, poi eliminate dalla stessa ditta (ENDESA) in seguito al confronto con l’ente gestore della riserva naturale “Grotta di Santa Ninfa”. Le torri eoliche hanno provocato impatti sulla vegetazione, in quanto la realizzazione della viabilità di servizio e delle piazzole ha comportato la distruzione della vegetazione naturale esistente, in gran parte riconducibile ad aspetti di prateria xerica, e la frammentazione degli habitat; provocano impatti di tipo paesaggistico, per l’alterazione del profilo della dorsale gessosa su cui sono state realizzate, ed in particolar modo relativamente alla cima di Rocca delle Penne, di elevato rilievo paesistico e geomorfologico; possono causare impatti faunistici, in particolare relativamente all’avifauna, per collisione con le pale. 2.3.6.5 Analisi e valutazione di coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica (D.3; D.5) Pianificazione territoriale provinciale La Provincia di Trapani non dispone ancora di uno strumento di pianificazione territoriale. Tuttavia, è stato recentemente approvato il Progetto di Massima del Piano Territoriale Provinciale. Nelle scelte e negli indirizzi del Progetto di Massima viene stabilito come obiettivo prioritario del Piano la promozione di uno sviluppo equilibrato del territorio provinciale. Secondo quanto stabilito nella Relazione, i contenuti del Piano devono definire le componenti strutturali del territorio, attraverso un adeguato quadro conoscitivo delle risorse presenti: “Il P.T.P. deve tenere conto delle diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione territoriale ed ambientale delle sue parti, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive e delle valenze ambientali presenti.” Il P.T.P. propone, quindi, come principale finalità, il recupero, la qualificazione e la valorizzazione del territorio attraverso progetti che tengano conto delle sue vocazioni “naturali”, in coerenza con la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, delle tradizioni culturali e del patrimonio storico. Il fine dichiarato è di razionalizzare le risorse materiali, ambientali ed umane della Provincia ed identificare i criteri per la localizzazione degli interventi necessari al superamento degli squilibri economici esistenti. Lo Schema di Massima individua i seguenti ambiti tematici di intervento sui quali costruire le ipotesi di riequilibrio territoriale: 1) Valorizzazione del patrimonio storico artistico paesaggistico del territorio; 2) c)Infrastrutture e trasporti; 3) Agricoltura e Pesca; 4) Portualità turistica; 5) Salvaguardia dei litorali; 6) Marmo; 7) Termalismo; 8) Turismo. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 150 A partire dai suddetti ambiti di intervento, lo Schema di Massima seleziona i seguenti “Sistemi”: 1. 2. 3. 4. Sistema fisico Sistema ambientale Sistema agrario Sistema insediativo Gli interventi sul sistema ambientale si riferiscono principalmente all’individuazione e alla definizione progettuale di aree la cui trasformazione produttiva sia compatibile con le necessità di salvaguardia ambientale e di controllo e contenimento degli effetti dell’inquinamento. La tutela del sistema ambientale viene prioritariamente prevista come condizione necessaria per garantire una concreta coesistenza tra i valori da tutelare e le istanze di sviluppo e le “possibilità di sfruttamento moderato del territorio”. Il territorio del SIC “Complesso dei Monti di S. Ninfa-Gibellina e Grotta di S. Ninfa”, e in particolare quello della Riserva, viene considerato all’interno delle Politiche per la tutela ed il risanamento ambientale come area di pregio naturale e culturale che contribuisce a definire un unico sistema di interesse naturale, assieme alle altre aree presenti nel territorio provinciale. La Provincia, dunque, si propone di promuovere la formazione di nuovi parchi naturali, e al contempo intende promuovere la valorizzazione economica del territorio mettendo in circuito riserve e parchi sia naturali che archeologici, proponendo e strutturando percorsi ed itinerari. Tale processo di valorizzazione dei beni culturali e naturali punta pertanto a mettere in connessione il patrimonio esistente con il contesto territoriale di riferimento, facendo di questo un presidio della memoria storica del territorio. Al contempo, all’interno delle Politiche per i beni culturali, ambientali ed il turismo viene fatto riferimento ad un processo di valorizzazione di tale patrimonio che non sempre appare coerente, nelle attuali linee programmatiche del Progetto di Massima, con gli indirizzi di tutela e salvaguardia necessari. “Le aree tutelate rappresentano complessivamente il 3% circa del territorio Provinciale. Una percentuale elevata rispetto ad altre province siciliane, ma nettamente inferiore a quella rilevata a livello nazionale, in cui le aree protette rappresentano circa il 7% del territorio totale. Su di esse si deve fare affidamento per ampliare l’offerta ed accrescere i motivi di prolungamento delle permanenze dei turisti. Invero nel campo della salvaguardia ambientale è finora prevalso un orientamento strettamente conservazionista che ha di fatto rallentato, se non proprio impedito, la valorizzazione economica di queste risorse. E la valorizzazione, per evidenti ragioni di sostenibilità ambientale, non può che essere quella di natura turistica” Pianificazione urbanistica comunale Gli strumenti urbanistici dei comuni nei cui territori ricade il SIC sono: Piano Regolatore Generale del comune di Santa Ninfa, approvato con D. A. n. 47 del 3/4/00; Piano Comprensoriale n. 4 per il comune di Gibellina, approvato con D.P. Reg. Sic. n. 6/A del 13/1/73. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 151 Piano Regolatore Generale di Santa Ninfa Il Piano Regolatore Generale di Santa Ninfa si inserisce in un contesto territoriale disciplinato, dal punto di vista urbanistico, dal Piano Comprensoriale n. 4 del 1973 (comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Margherita Belice, Santa Ninfa) e dal successivo Piano di Ricostruzione relativo al centro abitato di Santa Ninfa. Pur essendo stato approvato nel 2000, il P.R.G. non contiene al suo interno la perimetrazione del SIC né, quindi, la relativa normativa di tutela e salvaguardia, derivante dal recepimento della Direttiva Habitat (92/43/CEE) con il D.P.R. 357/97. Lo strumento urbanistico, conseguentemente, non contiene previsioni o indirizzi specifici che tengano conto di tale effettiva presenza. Negli indirizzi generali, il P.R.G. integra linee di tutela a scelte di sviluppo e di crescita insediativa. Dall'analisi della realtà territoriale nonché dai sopralluoghi effettuati, si evince che il territorio di Santa Ninfa si caratterizza prevalentemente per le valenze paesaggistiche e ambientali (gessi, aree boscate etc.) e dall'ordinamento colturale che offre un paesaggio culturale di notevole interesse. Tra le categorie di tutela, il P.R.G. evidenzia le seguenti: Naturalistica: relativa, in particolare, al patrimonio boschivo tutelato ai sensi della L. 431/85 e al patrimonio geomorfologico presente nella Riserva “Grotta di Santa Ninfa”; Archeologica: relativa alle diverse aree di interesse archeologico, tra le quali, in particolare, la Necropoli di Monte Finestrelle. In relazione alla regolamentazione dell’uso del suolo, nella Carta P1bis relativa alle Destinazioni d’uso del territorio comunale, il territorio del SIC è interessato dalle seguenti categorie di zone: Zona E Zona Agricola Zone E1 Boschi Fascia di rispetto ai sensi della L. 431/85. Le Zone E1 sono quelle che coincidono con le aree boscate (Castellaccio e Finestrelle) e appartengono al Demanio Forestale. Le Fasce di rispetto sono quelle che, ai sensi della L. 431/85, per un’ampiezza di 200 metri, si estendono lungo il perimetro delle aree boscate (Zone E1). Le Zone E sono le zone agricole, che includono anche le aree in abbandono e non coltivate, che occupano la rimanente parte del SIC. Le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. specificano all’art. 10 che le “Zone E sono destinate prevalentemente ad usi agricoli”. In particolare, all’art. 28 se ne specificano le attività e gli usi consentiti: in esse, oltre alle attività connesse alla conduzione dei fondi agricoli, inclusa la costruzione di edifici, è consentita la realizzazione di “costruzioni residenziali” con un indice di densità fondiaria pari allo 0,03 mc/mq e con un numero di piani fuori terra non superiore a due. Tale condizione, che rischia di tradursi in uno stimolo all’edificazione, appare la principale causa del sistema di pressioni che incominciano ad essere esercitate sul perimetro del SIC, in particolare in Contrada La Menta e intorno a Monte Castellaccio, e più a Nord-Est, a Sud di Contrada Campanaro. Si tratta di edilizia residenziale stagionale che sorge lungo le principali vie di comunicazione (SS n. 188 Centro Occidentale Sicula e SP n. 75 della Magione nel tratto compreso tra Case della Magione e Casa Palermo) e che, per le caratteristiche strutturali e architettoniche, appare scarsamente relazionata alla conduzione agricola dei fondi. Infine, all’art. 29 si specificano le attività e gli usi consentiti nelle Zone E1. Queste sono le parti del territorio comunale coperte da boschi (rimboschimenti di Contrada Castellaccio e Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 152 Monte Finestrelle); in esse “sono consentite tutte e sole le opere connesse alla manutenzione e gestione dell’ambiente naturalistico, quali sistemazioni di terreno, realizzazioni di sentieri, rimboschimenti”. Nelle relative fasce di rispetto (art. 37) non è consentita alcuna nuova costruzione, e qualsiasi modificazione della naturale configurazione dei luoghi e dello stato di fatto va preventivamente assoggettata al parere della Soprintendenza. La normativa di settore ha subito negli anni numerose modifiche ed oggi le fasce di rispetto attorno ai boschi non si configurano più come aree ad inedificabilità assoluta. In ragione della diversità delle norme del PRG, che appaiono più rigorose rispetto a quelle della normativa di settore, appare urgente un chiarimento sul reale regime di vincolo vigente nelle fasce attorno ai boschi, ed un monitoraggio sulla regolarità delle costruzioni sinora realizzate, con particolare riferimento alle aree di M. Castellaccio esterne al SIC, già nello Studio Agricolo forestale del 1991 realizzato a supporto del P.R.G. era stata classifica come Zona di elevato interesse paesaggistico-ambientale. La normativa che regolamenta l’attività edilizia in corrispondenza delle fasce di rispetto delle aree boscate è oggi la L. R. 6/2001 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”. Si tratta di una legge finanziaria che, come spesso succede, introduce elementi di grave deregolamentazione delle norme di tutela del territorio, questa volta riferita alle fasce di rispetto delle aree boscate che vengono di fatto assimilate alle aree agricole (in riferimento alla densità edilizia territoriale consentita). In relazione allo stato di attuazione del P.R.G., in seguito agli incontri con i responsabili degli uffici tecnici del comune di Santa Ninfa, si rileva che la discarica per sfabbricidi prevista in pieno SIC, non verrà realizzata. Infine, si sottolinea che il valore del paesaggio del SIC è stato rilevato in sede di approvazione definitiva del PRG: nel Decreto Assessoriale n. 47 del 3/4/00 di approvazione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio e delle Prescrizioni esecutive del comune di Santa Ninfa, il dimensionamento delle zone residenziali di edilizia stagionale, tendente a soddisfare anche fabbisogni di provenienza extracomunale, viene notevolmente ridimensionato e soprattutto concentrato in prossimità del centro abitato. In considerazione del potenziale danno sull’attuale configurazione dell’ambiente e del paesaggio e in relazione alla ingiustificata necessità di espansione edilizia, il Decreto Assessoriale elimina le previsioni di zone di espansione edilizia (Zone C3), in diverse parti del territorio comunale e tra queste, per quel che riguarda il SIC, quelle previste in contrada Castellaccio. “Non si condividono le previsioni di edilizia stagionale C3.1, C3.2, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6, C3.7 esterne al centro urbano per le motivazioni sopra citate anche in considerazione del fatto che le stesse si collocano in un contesto territoriale interessato dalla presenza di orditure colturali che va preservato per la valenza paesaggistica del territorio. Pertanto le stesse sono classificate zone E verde agricolo”. Piano Comprensoriale n. 4 - Gibellina Il comune di Gibellina, a quasi quarant’anni dalla sua redazione, è ancora oggi dotato di uno strumento urbanistico obsoleto quale è il Piano Comprensoriale n. 4, approvato per la ricostruzione dei centri abitati della Valle del Belice colpiti dall’evento sismico del 1968. Dei comuni colpiti dal terremoto, per Gibellina stessa e per Salaparuta, Poggioreale e Montevago il piano Comprensoriale prevede il trasferimento dei centri abitati. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 153 Il centro abitato di Gibellina è stato ricostruito a circa 18 Km dal sito originario, in una zona pianeggiante vicina alle grandi vie di comunicazione (stazione ferroviaria di Salemi e autostrada Palermo-Mazara del Vallo). In base a quanto stabilito dalla normativa regionale, il Piano Comprensoriale, con efficacia di P.R.G., è stato attuato attraverso la redazione di Piani Particolareggiati e di Piani di lottizzazione. Il Comprensorio n. 4 è stato suddiviso in 19 zone. Se per il centro abitato di Gibellina il Piano Comprensoriale ha previsto il totale trasferimento con un evidente impatto sul contesto ambientale, per il territorio attualmente interessato dal SIC non risulta presente alcuna indicazione di trasformazione/conservazione territoriale, eccetto l’individuazione delle zone archeologiche di monte Finestrelle (Gibellina) e Castellaccio (Santa Ninfa) che il Piano classifica come Zone V6 la cui destinazione è “Verde archeologico”. L’art. 28 (Titolo quinto - Zone a Verde) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Comprensoriale prevede per tali zone la sistemazione a verde e la realizzazione di opere e “attrezzature a sevizio delle zone archeologiche [...] che possono essere promosse solo dalle competente Soprintendenza”. Per tutto il resto del territorio, il Piano Comprensoriale prevede la prevalente destinazione a Zona E “Verde agricolo”. Precedendo cronologicamente la perimetrazione del SIC e non prevedendo significative azioni di trasformazione del territorio da questo interessato, il Piano Comprensoriale non presenta condizioni di conflittualità con le istanze di tutela previste per il SIC. Il recepimento e l’attivazione delle misure di tutela preventive previste dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE) e dal D.P.R. 357/97 da parte dei soggetti territoriali presenti, ed in particolare da parte dei comuni interessati, registra grandi ritardi e difficoltà di attuazione. Infatti, in generale a livello comunale in pochissimi casi i tecnici sono al corrente dell’esistenza di un SIC sul territorio del proprio comune, ignorandone comunque l’estensione territoriale, la natura reale e quella giuridica, gli adempimenti normativi consequenziali (es. Valutazione di incidenza) etc.. In relazione a quanto detto, le più significative condizioni di incoerenza territoriale legate agli aspetti normativi e pianificatori presenti vanno rintracciate nell’assenza del SIC negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale i cui iter di formazione precedono la data di individuazione e perimetrazione del SIC. Risulta pertanto di prioritaria importanza l’introduzione del perimetro del SIC e della relativa normativa di salvaguardia e tutela nella futura revisione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. In relazione alle specificità del territorio interessato dal SIC e in rapporto ai fenomeni naturali e antropici che agiscono su di esso, la coerenza tra le politiche di trasformazione/conservazione del territorio e le istanze di tutela del SIC va rintracciata tra le quattro componenti che informano gli strumenti di pianificazione e programmazione: 1. 2. 3. 4. politiche di tutela ambientale; politiche forestali; politiche agricole; fenomeni insediativo di tipo residenziale. In relazione agli strumenti analizzati, a livello territoriale il quadro delle politiche in atto restituisce un territorio fortemente interessato da azioni ed interventi finalizzati tanto alla conservazione del patrimonio esistente (patrimonio culturale naturale e antropico), quanto alla promozione dello sviluppo locale (settore agricolo e turistico), che tuttavia risultano scarsamente coordinati tra loro. Tale condizione va principalmente attribuita all’assenza di una pianificazione territoriale d’area vasta che costituisca il quadro di riferimento istituzionale per le azioni di tutela (Piano Paesistico Ambito 3) e di sviluppo del territorio (Piano Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 154 Territoriale della Provincia di Trapani) e che metta a sistema la moltitudine di politiche in atto che spesso si sovrappongono e che appaiono utili più ad attrarre risorse finanziarie esterne a fini quasi esclusivamente privati che a innescare reali processi di sviluppo di qualità. A ciò si somma, a livello locale, l’inadeguatezza e il mancato aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali (P.R.G. di Santa Ninfa e P.C. n. 4 - Gibellina), nel caso di Gibellina addirittura obsoleti in quanto riferiti ad un momento storico completamente diverso, che, oltre a non riportare la perimetrazione del SIC, contengono indicazioni che potrebbero causare progressivi e significativi impatti sul patrimonio culturale (habitat/specie e paesaggio) in esso presente (edificabilità a fini residenziali in zona agricola prevista dal P.R.G. di Santa Ninfa). Infine, in assenza di una pianificazione urbanistico-territoriale aggiornata e adeguata alle esigenze di tutela del SIC, un significativo ruolo di coordinamento nelle azioni di salvaguardia ricadenti in questo territorio è svolto dall’Ente Gestore della Riserva “Grotta di Sanata Ninfa” che, oltre alla costruzione di quadri analitico-conoscitivi che assumono come ambito di riferimento l’intero territorio del SIC, coordina di fatto il sistema di interventi realizzati a servizio sia della Riserva sia del SIC. Ciò, già prima delle indicazioni fornite dalla Regione Siciliana per l’elaborazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, ha consentito la predisposizione di quadri conoscitivi ampli e organici ampliati in sede di redazione del Piano. Nell’ambito di tale attività, risultano inoltre di particolare rilevanza ai fini di un governo integrato delle istanze di tutela e salvaguardia con le esigenza di sviluppo socio-economico del territorio i partenariati stipulati tra l’Ente Gestore della Riserva e gli altri enti che agiscono su questo territorio al fine di garantire un adeguato coordinamento degli interventi e la maggiore efficienza possibile nelle azioni di tutela. I principali partenariati stipulati sono: Protocollo di Intesa (stipulato nel 1998 e tuttora valido) con l’Azienda Regionale Foreste Demaniali per la gestione naturalistica dei rimboschimenti ricadenti nel territorio della riserva naturale; Protocollo di Intesa (stipulato nel 2006 e tuttora valido) con privati per la gestione della Conca del Biviere e la mitigazione degli impatti causati dalle lavorazioni agricole; Accordo con privati (stipulato nel 2006) per la cessione di aree in comodato d’uso gratuito; Accordo con privati (stipulato nel 2008) per la gestione naturalistica di aree. 2.3.6.6 Analisi e valutazione di coerenza degli strumenti di programmazione territoriale (D.5; D.6) Dal punto di vista delle politiche territoriali, il territorio del SIC si inserisce al centro di un vasto comprensorio a forte economia agricola, che si estende nella zona centro-orientale della Provincia di Trapani, comprendendo i comuni della Valle del Belìce: Vita, Salemi, Gibellina, Santa Ninfa, Poggioreale, Salaparuta, Partanna e Castelvetrano. Le politiche territoriali presenti, interessando principalmente il comparto agricolo, sono quindi caratterizzate prevalentemente dal processo di riconversione produttiva che ha visto negli ultimi venti anni la progressiva sostituzione delle colture cerealicole con le colture viticole e l'affermarsi, in alcune zone, dell'oliva nocellara del Belice. Accanto a questi settori, inoltre, la “rinascita” socio-economica che investe il cotesto territoriale di riferimento interessa anche le più recenti politiche sul turismo e sul recupero del patrimonio culturale. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 155 Gli strumenti di programmazione territoriale che interessano i comuni nei cui territori ricade il SIC sono: Patto Territoriale Agricolo “Valle del Belice” (Santa Ninfa e Gibellina); Piano Strategico ”Valle del Belice” (Santa Ninfa e Gibellina); PIT Alcesti (Santa Ninfa); PIT Alcinoo (Gibellina); Progetto CISTE Piano per gli Insediamenti Produttivi Progetti della riserva naturale “Grotta di Santa Ninfa” Patto Territoriale Agricolo “Valle del Belìce” Il Patto Territoriale, che interessa i comuni di Contessa Entelina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice, Santa Ninfa e Vita, è finalizzato alla promozione dello sviluppo dell’agricoltura attraverso l’erogazione di finanziamenti ai produttori locali. Con il decreto dell’11.5.2001 il Ministero ha ammesso a finanziamento n. 53 iniziative imprenditoriali distribuite sui comuni del comprensorio, per un totale di investimenti agevolabili di circa € 25.500.000,00. Gli investimenti riguardano tre Aree di Intervento: Interventi per il miglioramento della produzione primaria e/o della condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli; Interventi per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli da parte di Cooperative e Associazioni agricole; Interventi per la promozione dei prodotti e dei servizi offerti dalle Associazioni. Piano Strategico “Valle del Belice” Il Piano Strategico interessa i comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Vita, Partanna, Salaparuta, Poggioreale, Salemi, Calatafimi –Segesta, Gibellina, Menfi, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago. La scelta dell’area vasta comprendente i comuni indicati nasce dalle caratteristiche di omogeneità di una porzione di territorio fortemente caratterizzato da risorse endogene da valorizzare a fini turistico-relazionali. In particolare nell’area insistono zone culturali e archeologiche di notevole prestigio (Parco di Selinunte, Parco di Segesta, Cave di Cusa, Grotta di Santa Ninfa, Rotta dei Fenici) e aree termali di pregio (Comune di Montevago e Comune di Calatafimi). Inoltre, tutti i comuni dell’area sono accomunati dalla produzione di un prodotto di qualità (olio, nocellara del Belice, Vino doc di Salaparuta - Planeta – Donna Fugata, Formaggio del Belice) che dovrà essere valorizzato anche per fini turistici. PIT Alcesti Il Progetto Integrato Territoriale “Alcesti” è indirizzato al potenziamento della qualità dell’offerta turistica dell’area, attraverso la realizzazione di nuovi servizi e l’articolazione e differenziazione del prodotto turistico nel suo complesso. L’idea forza del PIT si articola intorno alla volontà di potenziare l’offerta turistica attraverso l’incremento della qualità e della quantità delle risorse turistico-culturali, naturalistiche e produttive fondamentali per lo sviluppo socio-economico dell’area, partendo proprio dal turismo di qualità come strumento per migliorare i servizi esistenti e attivare nuove destinazioni turistiche e nuova occupazione Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 156 attraverso un complesso di interventi in grado di coagire sui diversi elementi che costituiscono il prodotto turistico. Gli obiettivi specifici del PIT si concentrano principalmente sui seguenti aspetti: 1. l’integrazione dell’offerta turistica in maniera da attivare la compartecipazione dell’intero territorio stimolando la riattivazione e l’infrastrutturazione di itinerari visti alla base della qualità dell’offerta del patrimonio ambientale al fine di decongestionare i centri maggiori di Selinune e Segesta; 2. la sostenibilità dell’offerta come elemento di base in direzione della quale orientare la gestione del territorio, funzionale alla realizzazione di nuovi prodotti di offerta turistica, rivolti a segmenti di domanda emergenti, in particolare quello culturale e paesaggistico. In relazione al territorio del SIC, il PIT ha finanziato il progetto “Opere di prima infrastrutturazione della riserva naturale Grotta di Santa Ninfa e valorizzazione cavità sotterranea in c/da Grotte/Biviere”. Il progetto, localizzato in aree esterne al SIC ma pensato ed attivato nell’ottica di una migliore gestione e promozione della riserva e dello stesso SIC, è stato promosso dal Comune di Santa Ninfa in collaborazione con l’Ente gestore della Riserva “Grotta di Santa Ninfa”, e prevede: - l’acquisizione del Castello di Rampinzeri e le relative azioni di primo consolidamento e restauro. All’interno del Castello troveranno spazio la sede della Riserva, il Centro Documentazione ed il Centro Visitatori, e potrà esservi allocato anche il centro studi sul Carsismo; - la realizzazione del collegamento funzionale tra Castello - futura sede della riserva ed il territorio protetto, attraverso la riqualificazione di percorsi in terra battuta già esistenti e la collocazione di opportuna segnaletica. Attualmente è stata completata l’acquisizione del Castello di Rampinzeri, per il quale sono in corso gli interventi di recupero. PIT Alcinoo Il Progetto Integrato Territoriale “Alcinoo” si propone come obiettivo generale quello di promuovere l'aumento complessivo di valore aggiunto delle produzioni agricole e turistiche rurali attraverso un approccio integrato che favorisca l'interconnessione tra le diverse risorse del territorio in una logica di sistema. L’idea forza del PIT punta a valorizzare la tradizione agricola della zona e la presenza di prodotti tipici per farne il punto di forza di un modello di “accoglienza rurale sostenibile”. Il modello di sviluppo che propone si basa sulla valorizzazione della vocazione agricola attraverso la qualificazione delle produzioni, la diversificazione delle attività aziendali e la promozione di forme di coordinamento e messa in rete degli operatori agricoli. Il modello di sviluppo rurale sostenibile da affermare si basa quindi: sulla promozione delle produzioni agricole di qualità ad alto valore aggiunto, anche attraverso l’intervento sulle filiere di trasformazione, sull’integrazione delle attività agricole con l’offerta di servizi per il turismo rurale, culturale ed enogastronomico, sulla definizione e promozione sui mercati italiani ed esteri dell’identità locale dell’area. L’obiettivo generale si specifica nei seguenti obiettivi specifici: 1. il riconoscimento della qualità e la riscoperta dell’identità dell’area per i prodotti ed i servizi anche attraverso la realizzazione di specifici marchi territoriali di riconoscimento; 2. il rafforzamento della filiera del vino e dei prodotti tipici, attraverso un processo integrato di qualificazione dei prodotti, organizzazione della produzione e commercializzazione; Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 157 3. la infrastrutturazione mirata del territorio finalizzata a favorire la sua valorizzazione (infrastrutture turistiche, collettive a servizio delle filiere, infrastrutture di supporto alla qualità dell’ambiente e della vita); 4. il consolidamento delle attività produttive già presenti e/o la creazione di nuove attività imprenditoriali con particolare riferimento alle iniziative di valorizzazione turistica; 5. la realizzazione di uno strumento di valorizzazione globale del territorio di rilevante ritorno di immagine e di efficace visibilità e quindi valido veicolo di comunicazione (percorso del Gusto), come progetto pilota nell’ambito della strategia di sviluppo dell’intera provincia,con particolare riferimento al progetto CISTE; 6. l’aumento del flusso turistico nell’area e della vendita di prodotti tipici a maggior valore aggiunto. Con il PIT agli interventi approvati è stato riconosciuto un finanziamento complessivo pari a € 29.996.558,00. Progetto CISTE “La via del Sale e il Patrimonio della Sicilia Occidentale” è un progetto europeo che vede coinvolte regioni spagnole, francesi e irlandesi nella promozione di servizi turistici integrati. Obiettivo del progetto è quello di sviluppare un sistema di costruzione di itinerari basato su siti: - adeguati a standard qualitativi e quantitativi; - con sistemi comunicativi sinergici e supporti infrastrutturali omogenei; - collegati da un Tema territorialmente caratterizzante, - che stimolano l’interesse delle popolazioni locali e la mobilità dei turisti. CISTE è un’associazione senza fini di lucro di diritto francese, a composizione europea, registrata su GU FR 14-08-1996. La Provincia Regionale di Trapani, uno dei fondatori dell’Associazione, con il supporto tecnico dell’Azienda Provinciale del Turismo, ha realizzato il progetto europeo Ciste (già finanziato dalla Commissione europea ART.10 FESR). Piano per gli insediamenti produttivi Pur ricadendo in un altro settore di interesse, si segnala che il piano per gli insediamenti produttivi locale ha visto la realizzazione, nel Comune di Santa Ninfa, di un Centro Servizi, ubicato lungo la statale 119 che collega Castelvetrano e Partanna, in collaborazione con gli altri comuni della Valle del Belice. Tale Centro è stato concepito come struttura polivalente accentratrice di tutti quei servizi di supporto alle attività produttive. L’opera è stata finanziata dall’Assessorato Regionale alla Cooperazione con fondi dell’Unione Europea. Le aree sono già state assegnate ad artigiani e a piccole e medie imprese industriali. Progetti della Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” Più direttamente coinvolgenti il territorio del SIC, sia per ubicazione che per settore di interesse (riqualificazione ambientale, promozione della fruzione) sono i progetti elaborati e/o proposti dall’ente gestore della riserva naturale “Grotta di Santa Ninfa”, il cui territorio ricade per il 90% all’interno del SIC; gli interventi di gestione della riserva contribuiscono quindi direttamente alla tutela del SIC. Inoltre, per quanto riguarda la porzione del SIC esterna alla riserva (circa 500 Ha), l’Ente gestore della riserva ha inviato ai Comuni di Santa Ninfa e Gibellina indicazioni inerenti la normativa relativa al SIC, promuovendo al contempo indagini scientifiche indirizzate alla conoscenza del SIC e svolgendo anche un’azione di vigilanza. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 158 Tra gli interventi promossi dall’Ente Gestore della Riserva, attualmente in fase di ultimazione da parte dell’Azienda Foreste Demaniali – UPA di Trapani e del Comune di Santa Ninfa (amministrazioni pubbliche nella qualità di stazioni appaltanti della Riserva) si citano i seguenti progetti: Individuazione e recupero del sentiero pedonale della Valle del Biviere, finalizzato al potenziamento ed alla promozione della fruizione naturalistica sostenibile; Salvaguardia dei biotopi e interventi di restauro ambientale nella Valle del Biviere, relativo ad interventi di riqualificazione ambientale di tratti del torrente Biviere e finalizzato all’aumento della biodiversità; Sistemazione e riqualificazione del tracciato viario esistente di accesso alla Riserva, finalizzato al potenziamento ed alla promozione della fruizione naturalistica sostenibile; Acquisizione e recupero dell’area circostante la Grotta di Santa Ninfa, finalizzato alla riqualificazione di aree degradate, all’aumento della biodiversità, al potenziamento della fruizione sostenibile; quest’ultimo progetto è esterno al perimetro del SIC, ma ricade in aree omogenee e limitrofe al SIC, che si vorrebbe inserire all’interno del SIC, ed inoltre è in stretto collegamento funzionale con l’area del SIC. 2.3.6.7 Analisi e valutazione della coerenza di altri piani e regolamenti vigenti che incidono sul territorio e sulla conservazione di specie e habitat (D.5; D.6; D.7) Vengono presi in esame alcuni dei principali strumenti di programmazione e regolamentari attualmente vigenti sul territorio e che hanno un’incidenza (talvolta negativa) sul Sito e sulla conservazione degli habitat e delle specie. Vengono formulate altresi’ delle osservazioni sul grado di idoneità degli stessi al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto delle disposizioni attuative della Direttiva 92/43. Regolamento della Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” – zona B Come si evince dall’analisi dell’inquadramento territoriale e della carta dei vincoli, circa 100 ettari del SIC ricadono all’interno della zona B (preriserva) della Riserva Naturale Integrale “Grotta di Santa Ninfa”. Il regolamento costituisce parte integrante del decreto istitutivo dell’area protetta approvato nel 1995. Si riportano le principali disposizioni che concorrono alla tutela degli aspetti naturalistici evidenziati nel quadro conoscitivo. All’interno della zona di preriserva è consentito esercitare le attività agricole e zootecniche, purché condotte a livello di impresa agricola esistenti, ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore. Il pascolo è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento ed il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del cotico erboso, previa apposita autorizzazione dell'ente gestore il quale determinerà i limiti temporali, le zone e il numero di capi di bestiame ammissibile, eventualmente distinti anche per specie. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 159 Gli interventi sui popolamenti forestali sono consentiti esclusivamente per finalità naturalistiche e gli interventi di rimboschimento delle zone nude e di ricostituzione boschiva delle aree degradate devono rispondere a criteri naturalistici e devono essere realizzati impiegando specie autoctone e sistemi di preparazione del suolo localizzata. E' inoltre incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate. Dal punto di vista urbanistico-edilizio il regolamento prevede la sostanziale inedificabilità, e le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso finalizzata alla fruizione e all'attività di gestione della riserva. Nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è consentito effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 (gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione della riserva, mentre il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e non per tracce di fabbricati assimilabili a ruderi;); le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi sono consentite solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta; effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali. Per gli interventi ammissibili è previsto il nulla osta dell’Ente gestore. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, all’interno della riserva vigono alcuni particolari divieti riguardanti in particolare: qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste; la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete; l'esercizio di qualsiasi attività industriale; realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti; impiantare serre; eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal regolamento. Inoltre è vietato esercitare la caccia, apportare qualunque forma di disturbo alla fauna vertebrata ed invertebrata, distruggere o asportare vegetali di ogni specie, l 'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone, istituire centri e aziende che prevedano comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento. Il regolamento della riserva prevede altresi’ l’erogazione di indennizzi quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agrosilvo-pastorali. Il regolamento della riserva contiene disposizioni sufficienti a garantire la conservazione degli habitat e delle specie e non contiene obiettivi conflittuali con le disposizioni generali ed attuative della Direttiva 92/43. Tuttavia alcuni strumenti operativi importanti, soprattutto nel campo della pianificazione territoriale e del sostegno alle attività tradizionali non sono stati ancora attuati. Basti pensare alla mancanza del Piano di Utilizzazione (che i Comuni non hanno redatto) o alla mancata predisposizione da parte dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del Programma di Intervento a sostegno delle attività tradizionali. L’Ente Gestore della Riserva ha avviato e realizzato alcuni importanti interventi nel campo della rinaturalizzazione del territorio, della conservazione delle emergenze naturalistiche e della fruzione dell’area, stipulato un protocollo d’intesa con l’Azienda Foreste Demaniali – Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 160 UPA di Trapani per la gestione naturalistica dei demani forestali ricadenti all’interno della riserva, acquisito in comodato dei terreni ricadenti all’interno del SIC per finalità di conservazione stipulando un contratto con un’azienda agricola al fine di inziare a gestire in modo sostenibile le aree coltivate. Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 Nel febbraio 2008 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007-2013. Il PSR consentirà l’attuazione degli interventi necessari a sostenere lo sviluppo del settore agricolo, alimentare e forestale, nonché la conservazione e valorizzazione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile dei territori rurali della regione nei prossimi 7 anni. La strategia regionale persegue, da un lato, il rafforzamento del sistema produttivo e il suo rilancio competitivo, dall’altro l’integrazione delle componenti territoriali, sociali economiche e ambientali, e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura. Il Programma incentiva anche l’adozione di percorsi di progettazione integrata diretti a favorire la maggiore organicità degli interventi e un maggiore livello di concentrazione delle risorse disponibili attraverso l’uso combinato di più misure e/o l’associazione tra più beneficiari. Coerentemente con questo obiettivo, il Programma è orientato al rafforzamento del ruolo dei partenariati locali, utilizzando “Leader” quale strumento privilegiato per la realizzazione di programmi di sviluppo locale. Il Programma si articola su quattro “Assi” e circa 30 “Misure”, che definiscono gli ambiti dell’intervento regionale per le aree rurali. Asse prioritario 1: miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale; Asse prioritario 2: ambiente e gestione del territorio; Asse prioritario 3: diversificazione dell'economia rurale e qualità della vita in ambiente rurale; Asse prioritario 4: Leader. Il Piano di Sviluppo Rurale contiene un’articolata analisi di contesto che in alcuni casi è utile premettere per comprendere meglio obiettivi, coerenza e limiti del documento stesso, anche in relazione alle possibilità offerte ai territori che ricadono all’interno del SIC in esame. Il sistema agro-alimentare siciliano deve far fronte ai cambiamenti innescati dalle recenti riforme e principalmente dalla riforma della Politica Agricola Comune (PAC). Il “disaccoppiamento” e la “condizionalità”, infatti, dischiudono prospettive (autosufficienza energetica, colture energetiche rinnovabili, diversificazione produttiva, agricoltura multifunzionale) del tutto nuove e in gran parte ancora da esplorare per l’impresa agricola, chiamata ad operare le sue scelte in un quadro di convenienze economiche non più determinate dagli strumenti di sostegno bensì dalle reali dinamiche dei mercati agroalimentari liberalizzati. Per ciò che riguarda l’uso del suolo, dai dati di contesto contenuti nel PSR, risulta che la maggior parte della superficie regionale (63,5%) è coperta da territorio agricolo, seguono gli ambienti naturali con il 23,8%, i territori boscati prevalentemente boschi degradati e di latifoglie) con il 7,5% e, le superfici artificiali (urbanizzazione, infrastrutture, industrie, porti etc.) che occupano il 4,8% del territorio. L’erosione idrica è, nel territorio siciliano, il più importante e diffuso processo di degradazione del suolo. La superficie forestale siciliana ammonta a 338.171 ettari. Di questi, secondo la classificazione FAO-FRA 2000, 256.303 ettari (il 75,8%) sono “bosco” mentre 81.868 (il 24,2%) costituiscono “altre terre boscate”. L’indice di boscosità regionale, pari al 13,2%, è nettamente inferiore a quello nazionale, pari al 34,7%. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 161 Per quanto riguarda l’uso agricolo del suolo, la superficie agricola utilizzata (SAU), che è di 1.250.703 ettari, è rappresentata quasi per la metà (il 49,4%) dai seminativi, a seguire le coltivazioni legnose agrarie (31,8%) e infine i prati permanenti e pascoli che occupano quasi il 19%. Con riferimento, invece, alla struttura del tessuto aziendale agricolo il numero di aziende agricole in Sicilia al 2005 ammonta a 246.992, e fa registrare una diminuzione del 15,5% rispetto al 2000. La dimensione media aziendale in termini di SAU nel 2005 è pari a 5 ettari. L’analisi della dimensione fisica mette in evidenza che il 31% delle aziende agricole (pari a 76.649 aziende) ha meno di un ettaro di SAU e occupa però soltanto il 3,2% della SAU regionale; il 48% ha una superficie agricola utilizzata tra 1 e 5 ettari, e occupa il 22% della superficie agricola siciliana; quasi il 20% delle aziende si trova nella classe 5-20 ettari, e appena l’1,3%, pari a 3.122 aziende, ha un’estensione superiore ai 50 ettari, coprendo però ben il 25% della SAU regionale. Con riferimento alla dimensione aziendale in termini di UDE si conferma in Sicilia la prevalenza delle aziende di piccola dimensione; infatti il 57,9% non raggiunge le quattro UDE (quindi i 4.800 euro di RLS) mentre le aziende oltre 12 UDE sono il 17,7% e intercettano il 61% della SAU. In generale l’analisi della tendenza regionale mostra una diminuzione del numero di aziende agricole, la lieve flessione della SAU, l’aumento della dimensione in termini di reddito lordo standard aziendale in UDE. Secondo i dati Eurostat 2000 la percentuale di agricoltori siciliani che ha una formazione di base o completa ad indirizzo agricolo in Sicilia è pari al 4,3%. Di rilievo la presenza di produzioni di alta qualità a forte immagine, anche per la presenza di produzioni DOP, IGP, DOC, IGT. Nell’ambito delle produzioni di qualità un ruolo importante per l’agricoltura regionale è rivestito anche dal comparto dell’agricoltura biologica. La Sicilia, infatti, può annoverarsi tra le regioni con le più ampie basi produttive. Appare utile riportare la tabella dell’analisi SWOT contenuta nel PSR Sicilia 2007/2013: Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 162 Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 163 In funzione del diverso grado di ruralità, in Sicilia sono state identificate quattro tipologie di aree rurali che coprono l’intero territorio regionale e costituiscono la base di riferimento per la territorializzazione delle azioni del PSR. Il territorio regionale è così ripartito in quattro aree: A. Aree urbane. B. Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata. C. Aree rurali intermedie . D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo. Il territorio del SIC in esame (comuni di Santa Ninfa e Gibellina) ricade nella macroarea C. In relazione a tale previsione, appare utile analizzare la distribuzione delle priorità territoriali per asse. Asse PSR ASSE 1 ASSE 2 ASSE 3 ASSE 4 Priorità territoriale individuata dal PSR Nessuna priorità territoriale Priorità determinate da altre specifiche normative comunitarie anche in materia ambientale (aree montane, zone svantaggiate, siti Natura 2000, zone vulnerabili ai nitrati, ecc) Macroaree C (aree rurali intermedie) e D (aree rurali con problemi complessivi di sviluppo) Macroarea B(aree rurali ad agricoltura intensiva) con riferimento alle misure 311, 313, 321 Macroaree C (aree rurali intermedie) e D (aree rurali con problemi complessivi di sviluppo), con alcuni interventi nelle macroarea B(aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata) Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 164 Nel Piano di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento alle aree di interesse naturalistico ed ai Siti Natura 2000, si dichiarano come fabbisogni di intervento la conservazione della biodiversità (tra le massime priorità), seguita dalla tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico, dal mantenimento delle attività agricole e zootecniche tradizionali nelle zone svantaggiate, dalla diffusione di pratiche agricole e forestali sostenibili finalizzate a preservare ed a migliorare le risorse naturali (acqua, suolo, biodiversità), dalla difesa dagli incendi e dalla mitigazione dell’effetto serra e contrasto al cambiamento climatico. In funzione dell’analisi dei fabbisogni emersi dall’analisi di contesto e al fine di dettagliare ed adattare la strategia definita a livello nazionale dal PSN e dagli Obiettivi Comunitari Strategici in materia di sviluppo rurale, il programma individua le priorità strategiche regionali per asse cui discendono la scelta e la gerarchia delle misure di sviluppo. La strategia dell’Asse 1 è relativa al miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale. È volta quindi al miglioramento della capacità imprenditoriale e tecnico professionale degli addetti ed al ringiovanimento del tessuto imprenditoriale, all’ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitivo, al potenziamento ed all’ampliamento delle reti infrastrutturali ed alla promozione e sviluppo delle produzioni agricole di qualità. L’Asse 2 riguarda il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale il cui obiettivo quindi è valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio attraverso interventi volti a promuovere la tutela e/o la conservazione del paesaggio agro-forestale, l’equilibrio territoriale, la diffusione di pratiche agricole e forestali sostenibili, nonché le iniziative ambientali ed economiche che procurano benefici alle comunità rurali. Le sue misure, imperniate sulla salvaguardia dell’ambiente, si affidano, nel loro insieme, all’utilizzo di pratiche produttive aziendali ecosostenibili, che possano contribuire alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle caratteristiche peculiari del territorio regionale, cercando di fornire un valore aggiunto alle attività, sia agricole sia complementari ad esse, che consenta di conseguire un vantaggio competitivo. Le misure che concorrono alle priorità regionali individuate per l’Asse 2 sono: - La conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico. Nella nuova programmazione la Regione intende proseguire nel sostegno agli agricoltori che contribuiscono alla conservazione della biodiversità e in generale alla gestione sostenibile del territorio, attraverso l’introduzione o il mantenimento di metodi di produzione compatibili con l’esigenza di tutela degli ambienti naturali e miglioramento di quelli a rischio di degrado, che consentono tra l’altro l’ottenimento di prodotti che danno maggiori garanzie di salubrità, rispondendo così alla richiesta di fasce sempre più ampie di consumatori. Si potrà attuare l’incentivazione attraverso il pagamento delle indennità pratiche di gestione sostenibile del territorio che permettano di conservare i paesaggi tradizionali caratterizzati da colture quali il nocciolo, il frassino da manna, il carrubo, il castagno da frutto, il noce da frutto, il mandorlo ed inoltre i cappereti, i vigneti e gli oliveti. Nell’ambito degli interventi di riforestazione particolare cura sarà dedicata alla scelta delle specie, al fine di conservare i boschi non solo dal punto di vista strutturale ma anche nei confronti della diversità genetica. A tale scopo andrà privilegiato l’utilizzo delle specie autoctone e, ove possibile, locali, in modo da garantire la diversificazione floristica e preservare la naturale diversità delle specie e degli habitat. Ai fini del raggiungimento della priorità della “Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico” la Regione attiverà le misure 211, 212, 214 e 216, 221, 222, 223, 226 e 227. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 165 - Tutela e gestione sostenibile del territorio. Al fine di assicurare la salvaguardia dei territori ad elevato valore paesaggistico per la presenza di sistemi agricoli e forestali tradizionali e sistemazioni tipiche del paesaggio siciliano, è necessario garantire la presenza di comunità rurali vitali nello svolgimento delle attività agricole e zootecniche. Tali misure si coniugano, peraltro, con l’esigenza della salvaguardia dagli incendi che, come evidenziato dall’analisi, rappresentano ogni anno una delle principali cause di alterazione degli equilibri ambientali. In quest’ottica, le azioni che si intendono intraprendere sono finalizzate a salvaguardare e sostenere il ruolo multifunzionale delle foreste, in particolare attraverso la prevenzione dei rischi ambientali, la conservazione e il miglioramento dei sistemi forestali ad alta valenza naturalistica ed ambientale. In particolare, gli interventi saranno indirizzati su più direttrici: protezione dall’erosione e dai dissesti idrogeologici; mantenimento e incremento della sostanza organica; mantenimento e miglioramento della struttura del suolo. Tali linee d’intervento sono volte anche alla tutela delle risorse paesaggistiche. - Tutela della risorsa suolo. In tal senso è ritenuto strategico il contributo dei sistemi silvicoli e forestali, per i quali la Regione intende: aumentare le superfici interessate (sia private che demaniali); mantenere, conservare e sviluppare le funzioni protettive dei boschi; realizzare azioni di contrasto e prevenzione dei rischi ambientali ed in particolare la difesa dei boschi dagli incendi; ricostituire il soprassuolo boschivo danneggiato da disastri naturali e da incendi. Le misure del PSR che contribuiranno alla conservazione e alla difesa del suolo saranno le seguenti: 211 e 212, 214 e 216, 221, 222, 223, 226 e 227. - Tutela delle risorse idriche. A tale scopo è prevista l’incentivazione alla costituzione di fasce di vegetazione arbustiva e/o arborea lungo i corsi d’acqua per il controllo dell’inquinamento diffuso, e l’integrazione nelle pratiche agricole e nelle attività di afforestazione e agroforestazione della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE). Per il raggiungimento della priorità “Tutela delle risorse idriche” il PSR prevede di intervenire attraverso le misure 214 e 216, 221, 222, 223, 226 e 227. - Aumento della produzione di biomassa e diffusione di pratiche/attività per la riduzione dei gas serra. Sarebbe opportuno incentivare l’introduzione di sistemi colturali finalizzati a ridurre l’impatto delle attività agricola sugli agroecosistemi, al miglioramento della struttura del suolo ed all’adozione di avvicendamenti colturali che contemplino la presenza di colture da rinnovo utilizzabili a scopi energetici. Questo in un’ottica di ecosostenibilità che non metta a rischio la biodiversità. Inoltre, la Regione intende intervenire sulla riduzione delle emissioni dei gas serra e sulla massimizzazione dei sink di carbonio nei terreni agricoli e nei terreni forestali (attraverso l’ampliamento della superficie boscata regionale). Le misure che concorrono a questa priorità sono 211, 212, 214 e 216, 221, 222, 223, 226 e 227. La strategia dell’Asse 3 è relativa ad un miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale. In tale ottica gli interventi saranno mirati al miglioramento dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni locali ed al mantenimento e/o creazione di opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali. Infine l’Asse 4 verifica l’attuazione dell’approccio Leader cioè mira al rafforzamento delle capacità progettuali e gestionali locali ed alla valorizzazione delle risorse endogene dei territori. Gli Orientamenti Strategici Comunitari prevedono che «Le risorse destinate all’asse 4 (Leader) dovrebbero contribuire a conseguire le priorità degli assi 1 e 2 e soprattutto dell’asse 3, ma sono anche determinanti per la priorità del miglioramento della governance e per la mobilitazione del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali.» Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 166 La realizzazione di alcuni obiettivi prioritari di Asse richiede, in diversi casi, una mobilitazione di misure e strumenti che travalicano le competenze del singolo Asse. L’efficacia delle misure separate, infatti, sarebbe oltremodo potenziata se la singola impresa potesse ricorrere, attraverso una domanda unica, all’uso combinato di una serie di misure, anche contenute in Assi differenti. Di seguito si riportano alcune osservazioni sulle misure che possono maggiormente contribuire all’attuazione delle previsioni del Piano di Gestione. La Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” prevede tra l’altro la realizzazione di nuovi impianti colturali nonché la ristrutturazione, la riconversione colturale e varietale, l’espianto, l’ammodernamento e l’adeguamento e degli impianti alle esigenze dei consumatori e ai nuovi orientamenti dei mercati nonché la realizzazione di nuovi impianti di piantagioni arboree a ciclo breve (short rotation), per la produzione di biomasse a finalità energetica, purché sostenibili dal punto di vista ambientale. Tale misura non appare compatibile in ogni sua previsione con gli obiettivi di conservazione del Sito, soprattutto per quanto concerne la necessità di regolamentare in maniera rigorosa, anche con limiti quantitativi, le conversioni colturali e in particolare la modifica da colture da pieno a campo ad arboree e di vietare gli impianti di piantagioni arboree a ciclo breve (short rotation) Opportunità sono invece offerte per alcune imprese che vogliono qualificare le produzioni dalle seguenti misure: Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”, che prevede contributi in conto capitale agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare quali “Regolamento CEE n. 2092/1991 del Consiglio in materia di produzione agroalimentare con metodo biologico; Regolamento CE n. 509/2006 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agro-alimentari” ; Misura 133 “Attività di informazione e promozione” che ha per obiettivo della misura la promozione e sviluppo delle produzioni agricole di qualità. Le misure dell’Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” possono costituire uno strumento operativo per l’attuazione di alcune previsioni del Piano di Gestione, hanno maggiori refluenze (positive e negative) sul Sito ed evidenti implicazioni tecnicoagronomiche. Le misure 211 e 212 non operano nel Sito in esame in quanto i territori non sono classificati aree svantaggiate. La misura 213 andrebbe attivata con urgenza perché strategica per il perseguimento degli obiettivi della Direttiva 92/43 e per l’attuazione concreta delle previsioni del Piano di gestione e nella parte gestionale vengono fornite precise indicazioni in tal senso. La misura 214 favorisce l’assunzione da parte degli agricoltori di impegni agroambientali che, andando al di là dei requisiti obbligatori in materia di “condizionalità”, potranno determinare un maggiore contenimento dei fattori di pressione del settore agricolo sulle risorse naturali e nel contempo contribuire alla tutela e valorizzazione delle stesse, grazie alla diffusione di forme di coltivazione e di allevamento e modelli di gestione e o utilizzazione di tali risorse ispirate ai principi dello sviluppo sostenibile adottati dall’Unione Europea. Obiettivi della misura includono la conservazione della biodiversità delle specie e la tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico; la tutela e gestione sostenibile del territorio e Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 167 tutela della risorsa suolo; la tutela delle risorse idriche; l’aumento della produzione di biomassa e la diffusione di pratiche e/o attività per la riduzione dei gas serra. La misura 214 si articola in sottomisure. La sottomisura 214/1, riguardante l’adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili, è rappresentata principalmente dall’Azione 214/1A, che indica metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibili. L’azione 214/1A concorre in forma diretta agli obiettivi specifici dell’asse 2, prioritariamente alla tutela delle risorse idriche, attraverso una riduzione dell’impatto inquinante sulle acque dei suoli e alla gestione razionale della risorsa idrica, concorre anche alla tutela della risorsa suolo tramite l’adozione di tecniche di gestione conservative in grado di migliorare la fertilità complessiva e contrastare il declino della sostanza organica nonché i fenomeni di erosione e desertificazione nelle aree sensibili, alla tutela della biodiversità a seguito della diminuzione delle quantità di fitofarmaci e fertilizzanti ed all’impiego di prodotti a minore impatto. L’azione 214/1B riguarda l’agricoltura e la zootecnia biologica, tende a favorire un approccio globale alla gestione/utilizzazione sostenibile delle risorse, consente processi di innovazione e sviluppo aziendale più significativi e duraturi, rispetto all’attuazione di singoli e specifici interventi agroambientali. Concorre in forma diretta agli obiettivi specifici dell’Asse 2, ed in particolare alla tutela della biodiversità, in correlazione all’impiego di fitofarmaci e fertilizzanti a bassissimo impatto; al miglioramento della struttura del suolo grazie all’adozione di sistemi di gestione del suolo (rotazioni, utilizzo di letame o compost organici, etc.) in grado di migliorare la fertilità complessiva ed a contrastare sia il declino della sostanza organica che i fenomeni di erosione e di desertificazione nelle aree sensibili; la gestione razionale della risorsa idrica; la riduzione dell’impatto inquinante sulle acque attraverso l’introduzione di tecniche di produzione basate sulla esclusione dell’impiego di fertilizzanti di sintesi, sulla esclusione del diserbo chimico con l’introduzione di operazioni manuali/meccaniche e sul ricorso a forme di difesa che escludono l’impiego di prodotti potenzialmente inquinanti; la riduzione delle emissioni di gas serra a seguito di tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale che riducono le emissioni nell’atmosfera (uso di letame maturo, ricorso ai sovesci). L’azione 214/2A ha come obiettivo la preservazione della biodiversità con centri pubblici di conservazione. Beneficiari dell’azione 214/2 A sono l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste, Enti Parco, Orti botanici delle Università, altri Enti o Istituti pubblici che svolgono attività di conservazione del germoplasma di specie e varietà autoctone. Non si comprende come tra i beneficiari non siano stati compresi gli enti gestori delle riserve naturali, alcuni dei quali hanno realizzato importanti progetti di conservazione in situ della biodiversità. La misura 216 “Investimenti non produttivi in aziende agricole” si articola nella 216/A, investimenti associati alla 214/1 attraverso l’adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili. L’azione prevede l’impianto di fasce costituite da essenze vegetali, arbustive ed arboree variamente consociate, di larghezza media minima di 10 m, fino ad un massimo di 50 m, nei pressi di laghi, fiumi, torrenti e corsi d’acqua. L’Azione 216/B riguarda investimenti aziendali per altri obiettivi agroambientali e per la valorizzazione delle aree per pubblica utilità per la pubblica fruizione. La sottoazione 216/B/1 promuove interventi per la biodiversità. Nell’ambito di tale azione possono essere effettuati investimenti non produttivi che hanno come obiettivo l’incremento dell’agrobiodiversità Una precisazione merita il riferimento alla possibilità di realizzare le siepi ripariali. Queste svolgono una funzione preziosa (LA MANTIA, 1997; MASSA E LA MANTIA, 1997), tuttavia quelle realizzate nell’ambito della precedente programmazione agricola non sortiscono Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 168 l’effetto sperato a causa delle errate scelte tecniche compiute; nella parte gestionale meglio si dirà di impatti connessi e correttivi da apportare. La misura 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli” intende supportare la riconversione di superfici agricole con imboschimenti per molteplici finalità, quali la protezione dell’ambiente e degli habitat naturali, la prevenzione dai disastri naturali e la mitigazione del cambiamento climatico. La misura sarà attuata nei terreni agricoli idonei ad ospitare popolamenti forestali, sia arborei che arbustivi, e si articolerà attraverso imboschimenti permanenti multifunzionali ovvero a prevalente o esclusiva funzione protettiva, realizzati esclusivamente con specie autoctone, anche arbustive, tipiche dell’ecosistema locale, comunque idonee alle caratteristiche pedoclimatiche dell’area da impiantare. Non sono ammissibili al finanziamento i prati ed i prati-pascolo, in considerazione della loro importanza ai fini ecologici, paesaggistici e di conservazione dell’avifauna. Gli imboschimenti dovranno essere effettuati nel rispetto del Piano Forestale e del Piano Antincendio vigenti e, nelle aree Natura 2000, nel rispetto dei Piani di Gestione e o delle misure di conservazione del sito. La misura 222 “Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli” prevede la concessione di aiuti destinati all’impianto di specie forestali autoctone, anche di tipo arbustivo, in filari o in gruppi (boschetti, filari, esemplari isolati e siepi) con funzione produttiva, protettiva, paesaggistica ed ambientale, in terreni investiti con colture agricole tradizionali estensive. Gli impianti devono essere adatti alle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali delle stazioni d’impianto ed, in particolare, devono incrementare la biodiversità dei luoghi. Gli impianti dovranno essere effettuati nel rispetto del Piano Forestale e del Piano Antincendio vigenti e, nelle aree Natura 2000, nel rispetto dei Piani di Gestione e/o delle misure di conservazione del Sito. Gli impianti devono essere adatti alle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali, in particolare la biodiversità, ed idonei ad agevolare, possibilmente, la riproduzione e il rifugio della fauna e dell’avifauna stanziale e migratoria; trovano applicazione le pertinenti disposizioni poste dal decreto 16 giugno 2005 recante “linee guida di programmazione forestale” adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Con la misura 223 “Primo imboschimento di superfici non agricole” sono previsti interventi di imboschimento, con specie autoctone anche arbustive, con finalità protettiva da realizzare su terreni incolti in zone a rischio erosione, desertificazione e idrogeologico ed interventi di imboschimento con finalità produttiva con latifoglie e/o conifere da realizzare su terreni agricoli abbandonati prioritariamente nella area B del PSR. Gli impianti dovranno essere effettuati nel rispetto del Piano Forestale e del Piano Antincendio vigenti e, nelle aree Natura 2000, nel rispetto dei Piani di Gestione e/o delle misure di conservazione del sito. Non si condivide la mancata attivazione della misura 224 Indennità Natura 2000, che costituirebbe uno strumento più idoneo per il perseguimento degli obiettivi della Direttiva nelle aree silvicole, in relazione agli svantaggi che possono derivare dalle prescrizioni poste dai Piani di Gestione di SIC e ZPS. Gli obiettivi perseguiti dalla misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi” sono l’attivazione di azioni di contrasto alle calamità Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 169 naturali e di difesa preventiva, attiva o passiva, contro gli incendi al fine di mantenere, conservare e sviluppare le funzioni protettive delle risorse forestali; ricostituire il potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi. Gli impianti dovranno essere effettuati nel rispetto del Piano Forestale e del Piano Antincendio vigenti e, nelle aree Natura 2000, nel rispetto dei Piani di Gestione e/o delle misure di conservazione del sito. La misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi” tende a supportare la riqualificazione degli ambiti forestali mediante investimenti, che per il proprietario costituiscono un costo netto, atti a migliorare l’ambiente e il territorio in termini ecologici potenziando la biodiversità delle specie, delle popolazioni e degli habitat (rinfittimento degli impianti con specie forestali autoctone a minore produttività ma vantaggiose per la biocenosi e finalizzate alla stabilità dell’ ecosistema), conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio (tramite anche idonei dispositivi di protezione quali gabbie di esclusione, shelter, recinzione di protezione, ecc.), e attività consolidamento della funzione protettiva delle foreste. Le misure 221, 222, 223 e 227 richiamano problematiche più tipicamente forestali, anche se alcune hanno refluenza sulla gestione degli “agroecosistemi” intesi come sistemi ecologici e non come semplici ordinamenti colturali (come invece li definisce il PSR). Le misure 221 e 223 riguardanti il primo imboschimento di terreni agricoli o di superfici non agricole meritano alcune considerazioni in relazione all’impatto sulle aree a seminativo, a pascolo e sugli incolti. La realizzazione di boschi è senz’altro un fatto positivo per i molteplici vantaggi che da essi derivano. E’ però un’azione che va attuata con cautela, tenendo conto che, come è stato scritto da LA MANTIA & BARBERA (2007), la maggior parte delle specie oggi in diminuzione in Italia e in Europa sono legate agli ambienti cerealicolo-zootecnici, come confermano specifici studi regionali (LA MANTIA & MASSA, 2007). Inoltre un ruolo importante nel frammentare gli agroecosistemi, e talvolta anche nel modificare-distruggere formazioni vegetali naturali, è stato svolto anche dai contributi europei destinati agli impianti di arboricoltura da legno o alla riforestazione sensu latu in aree agricole o incolte: senza nulla togliere agli indiscutibili vantaggi che tali impianti potrebbero comportare, se realizzati con tecniche opportune, certamente gli impianti realizzati in precedenza (spesso senza le necessarie valutazione di compatibilità ambientali e con continuo utilizzo di specie estranee alle serie vegetali di pertinenza e con il massiccio impiego di germoplasma non autoctono) non garantiranno i risultati per i quali erano stati realizzati (LA MANTIA et alii, 2004B), mentre sono invece certi i danni a livello paesaggistico e sulla conservazione della biodiversità (LA MANTIA, 2002). Pertanto non si condivide l’enfasi posta a premessa del PSR sull’attuazione delle precedenti misure di primo imboschimento di superfici agricole (misure specifiche del Regolamento 2080/92 e misura H del PSR 2000/2006), che non si sono dimostrate idonee a perseguire gli obiettivi di aumento della superficie boscata (nel senso di soprassuoli stabili e ben governati) di produzione dei legname, di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, di desertificazione, di cambiamento climatico. Le misure 226 e 227 pongono invece più stringenti problemi di impatto per l’infrastrutturazione prevista per la gestione dei sistemi forestali. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 170 Ulteriori e forti limiti nell’impostazione del PSR riguardano: • l’individuazione di prati e prati-pascolo come aree da escludere da ogni intervento, atteso che tale tipologia di ordinamento colturale non trovo concreto riscontro in Sicilia; • la definizione di sistemi agroforestali al di fuori dei criteri stabiliti a livello internazionale e nazionale per la codifica di tali sistemi; • la mancata previsione degli obblighi di pianificazione per la gestione forestale, perlatro imposta dalla normativa vigente e dalle linee guida del piano forestale; • il riferimento a tipologie di uso del suolo per consentire le trasformazioni da incentivare che non hanno alcun riferimento alal codificazione di habitat, biotopi e uso del suolo, rendendo non univoca e gravida di effetti non positivil’attauzione di alcune misure. Inoltre non si comprende come tra i beneficiari delle misure 223, 226 e 227, per le finalità di rinaturalizzazione e di riqualificazione e fruizione dei sistemi forestali, non siano stati previsti gli enti gestori delle riserve naturali. Gli interventi previsti nel terzo Asse “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”, sono diretti a migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e a promuovere la diversificazione delle attività economiche, per creare e consolidare l’occupazione. Vengono individuate tre priorità: • Miglioramento dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni locali; • Mantenimento e/o creazione di opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali; • Promozione della formazione, acquisizione di competenze e animazione dei territori. Le misure attivabili puntano a sostenere gli investimenti per la creazione e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali in attività complementari all’agricoltura, quali l’agriturismo, ma anche in attività non agricole, oltre a favorire l’incremento di servizi e infrastrutture e la riqualificazione e tutela dei territori rurali, le attività di formazione, informazione e animazione. Le Misure 311 “Diversificazione verso attività agricole”, 313 “Incentivazione di attività turistiche”, 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”, 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, 331 “Formazioni e informazione”, possono contribuire in maniera forte al rafforzamento delle aree rurali in cui ricadono i Siti della Rete Natura 2000, alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio tradizionale fisso, alla conservazione di siti di elevato pregio naturalistico, al mantenimento e ripristino del paesaggio agrario tradizionale, alla promozione della multifunzionalità delle imprese agricole ed al loro coinvolgimento nella gestione e valorizzazione delle aree di interesse naturalistico. Le misure 311, 312 e 321, prevedendo interventi di trasformazione urbanistico-edilizia in materia di agriturismo e creazione di nuovi servizi, realizzazione di impianti, servizi a rete, acquedotti rurali, impianti per la produzione di energia, possono avere un impatto significativo sui Siti. Come meglio si dirà più avanti, l’impatto sulla conservazione di habitat e specie sarà legato ai criteri di selezione, alla qualità delle progettazioni e ad una più puntuale definizione degli interventi ammissibili. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 171 Sul piano strategico non si comprende poi l’esclusione tra i beneficiari (per esempio della misura 323) degli enti gestori delle riserve naturali, in relazione anche alla distribuzione sul territorio dei beni che si intendono valorizzare. Complementari al raggiungimento degli obiettivi sovraesposti sono anche indicate misure ed azioni di informazione, quali la creazione di siti web, materiale cartaceo informativo, seminari tematici, conferenze stampe, informazione sui media, scambio di best practices, nonché misure specifiche di informazione e pubblicità rivolte al pubblico. L’Asse quarto è finalizzato all’“Attuazione dell’approccio Leader”, e con esso la Regione punta a favorire la maggiore integrazione delle iniziative, sia a livello territoriale che di filiera. In particolare l’Asse è volto a rafforzare le capacità progettuali e gestionali locali e a valorizzare le risorse interne dei territori. Le azioni sono realizzate da Gruppi di Azione Locale (GAL), costituiti da un partenariato pubblico-privato rappresentativo che, attraverso il Piano di Sviluppo Locale (PSL), esprime strategie di sviluppo integrato locale per il proprio territorio. Nella precedente programmazione l’area del SIC in esame non è stata interessata da alcun programma Leader, e si ritiene che tale esperienza invece potrebbe essere utile per rafforzare ed integrare le azioni di conservazione del Sito e tutela della biodiversità in una logica di rete di sistema, e con un obiettivo specifico in direzione della costruzione della rete Ecologica nel comprensorio della Valle del Belice, come meglio definita nello specifico capitolo del Piano di Gestione. Nell’ulteriore valutazione del PSR utile appare la consultazione della Valutazione Ex-Ante e della Valutazione Ambientale Strategica effettuate sul Programma. Si tratta di documenti analitici ben redatti e ricchi di osservazioni critiche e spunti per il miglioramento del Programma stesso, e soprattutto per un più utile adattamento agli obiettivi di gestione dei Siti Natura 2000. Dalla Valutazione Ambientale Strategica sul PSR emerge, come si vedrà meglio nella parte riguardante l’impatto delle attività agro-silvo-pastorali, che in molte misure sono individuabili azioni o interventi in potenziale contrasto con gli obiettvi posti dai Piani di Gestione. Nel Programma si afferma che tutti gli interventi da effettuarsi all’interno delle aree protette e dei Siti Natura 2000, dovranno rispettare le misure di salvaguardia dettate dai rispettivi Piani di Gestione o, in mancanza, dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza e di impatto ambientale, se occorrente; inoltre, dovranno sempre assicurare la conservazione e lo sviluppo della biodiversità. Tuttavia tale affermazione, non sempre tradotta come prescrizione e criterio di ammissibilità chiaro in tutte le misure (a differenza di quanto contenuto del PO FESR 2007/2013), rinvia ai criteri di selezione che saranno adottati dall’Autorità di Gestione e ad una più chiara definizione degli interventi da assoggettare a valutazione di incidenza. Cio’ assume particolare rilievo anche alla luce della passata esperienza del POR Sicilia 2000/2006 e PSR 2000/2006 che è stata caratterizzata per una scarsa applicazione della Direttiva 92/43 e del DPR 357/97 ed anzi ha visto il finanziamento, con i fondi strutturali, di interventi non compatibili con la conservazione di habitat e specie. L’incertezza e la reversibilità degli impatti connessi con le previsioni del PSR sono da correlare anche alla qualità della progettazione, alla severità delle selezioni e, non ultime, alle Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 172 modalità di realizzazione delle azioni svolte in relazione al contesto ambientale in cui si inseriscono. La VAS e le previsioni del PSR stesso, pur contenendo alcune utili indicazioni di mitigazione e di compatibilità ambientale, hanno spostato l’obiettivo di incrementare l’efficacia ambientale dello stesso alla fase di attuazione (evitando riscritture sostanziali della parte programmatica) e dovranno comportare però una più attenta stesura dei documenti attuativi (bandi pubblici, ecc.). L’efficacia ambientale del programma potrà essere incrementata soltanto se verranno fissati idonei requisiti di ammissibilità e criteri di selezione certi, oltre a criteri aggiuntivi in relazione ai Siti ove si realizzeranno gli interventi. Tutto ciò dovrà passare attraverso un coinvolgimento degli enti gestori delle aree naturali protette e degli enti con responsabilità diretta nella gestione dei Siti. In generale va poi osservato che il PSR individua modalità di intervento valide per l’intero territorio regionale e non specificatamente per ciascun sito o tipologie di siti. Pertanto rimangono attuali le perplessità già sorte nella passata programmazione, rimarcate attraverso da CASAMENTO (2007) che, con riferimento al PSR precedente, scrive “Inoltre, il Piano di Sviluppo Rurale, avviato fin dal 2001 dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste in attuazione di specifici regolamenti comunitari, si è mostrato non idoneo per il comprensorio della Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” e per gran parte del territorio rurale siciliano, a causa dei criteri di ammissibilità previsti che hanno escluso le piccole aziende o molte colture che tipicizzano il paesaggio agrario tradizionale e non è quindi riuscito ad imprimere una svolta nella politica regionale di settore.”. Critiche più generali alla programmazione europea e al PSR in particolare erano state inoltre mosse da BORIN E MONTI (2007). In conclusione il PSR necessiterebbe di una migliore definizione delle misure, degli interventi e dei requisiti di ammissbilità a livello di singolo Piano di Gestione. Infatti alcuni requisiti (dimensione in UDE e superficie delle aziende, finalità delle misure e tipologie degli interventi, condizioni specifiche di accesso, ecc.) non consentono l’accesso alle misure di tanti agricoltori che operano all’interno dei Siti Natura 2000 e che dai Piani di Gestione vengono individuati come beneficiari di azioni gestionali. Peraltro, mentre per alcune misure riguardanti l’ammodernamento delle aziende e delle filiere può appartire corretto riferirsi alla dimensione economica e territoriale delle aziende, nel campo della conservazione della biodiversità ciò porta ad effetti distorti, in quanto l’obiettivo dovrebbero essere gli habitat e le specie. Conseguentemente una grossa azienda che persegue generici obiettivi come l’adozione dei metodi di agricoltura biologica, non direttamente rapportati alla conservazione di habiat e specie, potrà accedere ai finanziamenti; di contro una piccola azienda le cui attività possono impattare o influire positamente sulla conservazione di habiatt e specie particolarmente rari, non potrà accedere alle misure del PSR. Tale valutazione critica è rafforzata dalla constatazione delle misure che il PSR Sicilia non ha attivato, a differenza di quanto avvenuto in altre regioni: Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 173 da cui emerge con particolare gravità, come già detto, la mancata attivazione delle misura 213, 224 e 225. Qualche ulteriore osservazioni sul rapporto di coerenza tra le previsioni del PSR e la situazione ambientale regionale, soprattutto nella direzione di valutare se le azioni individuate sono in grado di aggredire le criticità individuate e di perseguire gli obiettivi posti, discende dalla considerazione che alcuni importanti indicatori non sono stati rilevati. Così non è stata fatta una congrua stima dell’indicatore di impatto “Lotta alla riduzione della biodiversità” sulla base del “Farmland Bird Index” (come richiesto dalla normativa), a causa della scarsità di dati per la Sicilia, che sarebbero utili ad una idonea determinazione di tale indice e del suo trend nel tempo. La determinazione dell’indicatore di impatto “Conservazione delle zone agricole e silvicole ad alto valore naturale” richiede una quantificazione delle superfici agricole e silvicole, ricadenti in zone ad elevata valenza naturale. Tale indicatore è stato invece stimato su base statistica (confronto tra diverse categorie di uso del suolo), senza disporre di dati sull’esatta “qualità” ambientale delle aree interessate. Inoltre, se si osservano gli obiettivi che il PSR assegna a ciascuna misura “agroambientale” per l’incremento della superficie delle zone agricole e silvicole ad alto valore naturale, come si evince dalla tabella seguente, il contributo della strategia del PSR al conseguimento di obiettivi di tutela del patrimonio naturalistico regionale è davvero assai limitato Mantenimento delle aree agricole e forestali ad alto valore ambientale Misure PSR 211 212 214 216 221 222 223 226 227 Totale PSR Variazioni in ettari nelle aree ad alto valore naturale 942 445 225 250 843 135 315 95 50 3.300 Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 174 Con riferimento al problema dell’inquinamento delle acque causato da nitrati e pesticidi (indicatore di obiettivo n.21 del PSR) si afferma che non vi sono dati attualmente disponibili. Se si osservano gli indicatori di realizzazione emergono ulteriori dubbi sulla reale capacità del programma di perseguire gli obiettivi di conservazione della biodiversità e di finanziamento degli interventi dei Piani di Gestione. Basti pensare che, a fronte di 220.000 ettari interessati dalla misura 214 (in sostegno al biologico), si stimano in termini di risultato in soli 5000 ettari le aree in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla biodiversità e ai sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico, e si stimano in termini di impatto in soli 225 ettari la variazione relativa alla conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale. La prosecuzione del sostegno pubblico sia per l’introduzione, sia per il mantenimento del metodo di produzione biologica nelle aziende agricole, viene giustificata nel Programma (ma senza fornire dati specifici) con la constatazione che i servizi ambientali derivanti da tale metodo, e di cui beneficiano i consumatori e la collettività nel suo insieme, non risultano, allo stato attuale, sufficientemente valorizzati dal mercato in termini di prezzi assicurati agli agricoltori. In conclusione, anche in relazione all’articolazione del piano finanziario, si formula un’ampia riserva sulle reali possibilità contenute nel PSR Sicilia 2007/2013 di sostenere un intervento di portata strategica per diminuire la perdità di biodiversità e per valorizzare i Siti Natura 2000 nell’ambito delle politiche sullo sviluppo rurale, dando attuazione alle previsioni dei Piani di Gestione. Piano Forestale Regionale Durante la fase di redazione del presente Piano di Gestione è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Forestale Regionale, in attuazione della normativa regionale vigente e delle stringenti indicazioni poste dalla Commissione Europea già all’inizio della Programmazione dei Fondi Strutturali 2000/2006. Il Piano è oggi disciplinato dall’art 5 bis della LR 16/96 introdotto con l’articolo 6 della LR 14/2006. In tale settore sono già operative le Linee guida del Piano Forestale regionale, approvate con Decreto dell’Assessore regionale all’Agricoltura e Foreste del 15 ottobre 2004. Le stesse sono rimaste inattuale in molte parti, laddove si pensi che l’art. 4 tassativamente recita che “tutte le attività di interesse forestale devono essere intraprese nel rispetto delle prescrizioni tecniche individuate nelle linee guida ed, in particolare, di quelle intese ad assicurare una gestione sostenibile del territorio e la conservazione della biodiversità. Gli uffici preposti non possono esprimere pareri o rilasciare atti comunque autorizzativi ad interventi per l’uso o l’incremento del patrimonio forestale se in contrasto con le prescrizioni tecniche sopra richiamate”. Basti pensare a quanto è avvenuto con l’attuazione del Regolamento 2080/92 o della misura H del PSR 2000/2006 (citiamo solo il ricorso al germoplasma alloctono) o la mancata pianificazione della gestione del demanio forestale regionale e di quello dei comuni a decenni dalla scadenza degli obblighi imposti dalla legge. In base all’art. 3, comma 1, del D.Leg.vo 18 maggio 2001, n. 227 “le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 175 loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali”, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità, al contrasto dei combiamenti climatici e dei processi di desertificazione, anche in attuazione delle numerose risoluzioni adottate in ambito internazionale e comunitario. Di seguito si riportano le azioni proposte più significative. Negli elaborati di Piano, le principali cause di degradazione del bosco sono state identificate negli incendi, nel pascolo in bosco, negli attacchi parassitari, nei danni da errata esecuzione degli interventi, nonché in danni di nuovo tipo, come varie forme di inquinamento (piogge acide, emissioni di gas tossici, uso massiccio di anticrittogamici e antiparassitari) o a presunti cambiamenti climatici in atto. Obiettivo primario del Piano Forestale è la salvaguardia del patrimonio esistente, specie in una regione come la Sicilia dove, ogni anno, la sopravvivenza dei boschi è messa a dura prova da numerosi fattori naturali ed antropici negativi che agiscono con la massima intensità. Le azioni in tal senso tendono a rendere i popolamenti più stabili e meglio difendibili in caso d’incendio. Al tempo stesso, però, occorre attivare gli strumenti ritenuti idonei a rimuovere le cause, reali o presunte, di conflittualità sociale che prima o poi si scaricano sull'elemento più debole: il bosco. Si riportano alcuni tra gli obiettivi strategici contenuti nella proposta di Piano Forestale con l’indicazione di inetrevnti da realizzare e nuove modalità operative da assumere come prassi ordinaria. 1) Innanzitutto il miglioramento dei boschi esistenti, favorendo le specie cosiddette minori, introducendone altre scomparse in epoca più o meno recente, aumentando la complessità strutturale in senso orizzontale e verticale, privilegiando la rinnovazione per seme rispetto a quella vegetativa. In questo ambito rientra, laddove le condizioni fisiche ed economiche lo consentono, la conversione dei boschi cedui in fustaie. 2) Segue l’ampliamento della superficie boschiva, introducendo un nuovo approccio per quanto riguarda le caratteristiche della copertura da realizzare. Nel Piano si osserva che tanto la difesa idrogeologica, quanto il contrasto dei cambiamenti climatici o la difesa della diversità biologica vanno riferiti non solo ai boschi veri e propri ma anche a tutte le altre forme di vegetazione: macchia, vegetazione preforestale, alboricoltura da legno. In questo senso vanno incoraggiati il rinverdimento di cave, la bonifica di discariche ed aree industriali inquinate, le barriere verdi frangivento, l'istituzione di parchi urbani e sub-urbani il rinverdimento di scarpate fluviali e stradali, sia pure nel rispetto delle rispettive norme di sicurezza. 3) Anche la funzione turistico-ricreativa dei boschi assume rilievo. La valutazione dei danni provocati all’ambiente dall’eccessiva frequentazione turistica risulta ancora poco indagata, anche perché, a causa dei lunghi cicli forestali, eventuali riflessi negativi si manifestano a distanza di tempo. Proprio per questo, alle prescrizioni e ai vincoli imposti per legge si devono affiancare incentivi volti al sostegno dello sviluppo economico e sociale compatibile, specialmente per i territori più svantaggiati. Strumenti fondamentali del redigendo Piano forestale sono la Carta e l'Inventario Forestale Regionale, concepiti in modo da essere l’uno di servizio all’altro: l’elaborato cartografico dovrà individuare entità e confini dei tipi forestali e preforestali presenti nell’Isola, all’interno dei quali saranno condotti rilievi puntuali approfonditi per le necessarie notizie di dettaglio. Tutto ciò in coerenza con gli standards internazionali e nazionali (FRA2000 – Forest Resources Assessment, ISAFA, 1998), coi sistemi di nomenclatura regionali e nazionali di uso comune, con la classificazione dei tipi di copertura del suolo (programma europeo Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 176 CORINE e relativi sviluppi nazionali), con le nuove definizioni di bosco, foresta ed altre aree forestali come deciso da TBFRA - Temperate and Boreal Forest Resources Assessment. Il Piano contiene pure: gli Indirizzi per la gestione dei boschi ricadenti nella aree protette. La maggior parte dei boschi di Sicilia, specie di quelli naturali, ricade ormai all’interno di Parchi e Riserve regionali, Siti d’interesse comunitario (S.I.C.), Zone di protezione speciale (Z.P.S.). È possibile dunque ipotizzare modelli gestionali più rigidi che altrove, senza per questo dover temere penalizzazioni a carico dei proprietari ed eccessive tensioni sociali. In definitiva la “sostenibilità“ della gestione forestale richiede che anche nell'ambito delle aree protette ogni scelta sia riferita a casi concreti, cercando di individuare il punto di equilibrio più avanzato possibile nell’atto in cui essa matura. gli Indirizzi per la gestione dei boschi artificiali. Punto di partenza per una seria programmazione degli interventi, deve essere il censimento di tutti i popolamenti suddivisi per aree omogenee, e l’individuazione per ciascuno di essi della funzione prevalente o esclusiva attribuita, in relazione alla morfologia dei luoghi, alle specie legnose presenti, ai ritmi d’accrescimento, alle condizioni di mercato. Gli interventi devono mirare innanzitutto alla loro salvaguardia dall’incendio e, secondariamente, ad accelerare quei processi che portano alla formazione di popolamenti più stabili, sia nei confronti dello stesso incendio, sia nei confronti degli altri fattori ambientali. gli Indirizzi per la gestione dei boschi produttivi. In Sicilia non esistono boschi altamente produttivi, per una serie di motivi. Obiettivo importante dovrebbe mirare ad evitare l’abbandono della montagna, gratificare i proprietari e le imprese boschive, aumentare l’occupazione bracciantile, assicurare regolari rifornimenti alle industrie e all’artigianato locali, sfruttare la vocazione turistico ricreativa di molti complessi, creare meno aggravio all’erario pubblico. Il miglioramento tecnologico in tutte le fasi della gestione forestale (impianto, ricostituzioni, cure colturali, utilizzazioni, trasformazione dei prodotti); il miglioramento della formazione professionale di tutti gli operatori coinvolti ; l'incoraggiamento di forme di gestione associata; il sostegno delle iniziative volte alla redazione dei piani di gestione; la costruzione di opifici territoriali di prima lavorazione dei prodotti; la costituzione di un osservatorio regionale del commercio dei prodotti forestali; l'incoraggiamento di attività integrative a quella forestale, quali la coltivazione di funghi, piccoli frutti, piante aromatiche e medicinali . gli Indirizzi per il miglioramento tecnologico. Riguardano azioni come la normalizzazione della struttura e dello sviluppo del popolamento dei boschi ed interventi per riequlibrare la loro composizione specifica; gli Indirizzi per la gestione della fauna selvatica. Sono regolati da: a) Direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici; b) Direttiva CEE n. 43 del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica; c) Regolamento CEE n. 2078 del 30 giugno 1992, relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale; d) Regolamento CEE n. 2080 del 30 giugno 1992, rivolto al rimboschimento delle superfici agricole dismesse. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 177 Nella gestione forestale, particolare importanza viene attribuita alla riproduzione delle singole specie e alla loro difesa dai predatori, ma anche alla conservazione e/o all'introduzione di essenze arbustive ed arboree che possono costituire altrettanti fonti alimentari. Particolare cura dovrà essere posta agli habitat delle specie protette che ricadono in montagna e che coincidono con forme di vegetazione forestale o preforestale (bosco, macchia, zone cespugliate), ambienti umidi (torrenti, laghetti, acquitrini, vegetazione riparia), vegetazione rupestre, cave e caverne, zone sassose. Infine, a supporto delle azioni sopramenzionate, il Piano Forestale auspica un impulso alla ricerca e alla sperimentazione ed un’adeguata educazione ambientale. Il Piano Forestale elenca anche i criteri di gestione forestale sostenibile. La conformità ai criteri di gestione forestale sostenibile è affidata alla verifica, per ciascun criterio, di un certo numero di indicatori (variabili quantitative o descrittive) documentabili in un contesto d’ordinaria gestione. A queste categorie sono talora giustapposti anche indicatori relativi alle cause generatrici primarie e agli impatti, secondo il noto modello DPSIR (drivers, pressure, state, impact, responses, vd. ANPA 1998). Infine vengono indicati gli Standards di buona gestione suddivisi in Standards generali e tematici. Questi ultimi descrivono in dettaglio i criteri da utilizzare per la fustaie d’origine naturale, per il Piano di Gestione, per le tipologie forestali e preforestali e per la regimazione idrica. Per la redazione del Piano Forestale Regionale sono state avviate diverse linee di ricerca, alcune delle quali hanno una ricaduta concreta sulle modalità di gestione dei rimboschimenti e di realizzazione di nuovi. In particolare le linee di ricerca sui “Criteri per la realizzazione di impianti di riforestazione ed afforestazione e definizione di modelli di arboricoltura da legno per l’ambiente siciliano. Piano triennale per gli interventi di riforestazione ed afforestazione in relazione all’obiettivo di ampliare la superficie silvicola”, la “Caratterizzazione dei boschi da seme ed indirizzi per il settore vivaistico forestale”, gli “Indirizzi e modelli per la stesura di piani forestali sovraziendali applicabili sull’intero territorio dell’Isola”, la “Valutazione della biodiversità forestale” e la “Gestione forestale sostenibile”. Delle indicazioni contenute nel Piano Forestale e preliminarmente presentate all’incontro tenutosi a Palermo il 23 giugno 2008 su “La rete Natura 2000 in Sicilia: pianificazione e gestione forestale” si è tenuto conto nella definizione delle azioni di gestione forestale previste dal presente Piano di Gestione. In linea generale non emergono evidenti profili di conflitto tra le previsioni del Piano Forestale e le azioni di pianificazione e gestione dei Siti Natura 2000. Devono tuttavia formularsi alcune osservazioni: • il Piano è stato redatto senza una compiuta base conoscitiva (mancano ancora l’Inventario e la Carta forestale) e non sembra avere tenuto conto della Carta della Natura e della Carta dei Corridoi Ecologici approvati dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; • il Piano contiene obiettivi definiti solo a scala regionale (troppo ampia), e quindi non possono escludersi profili di contraddittorietà delle previsioni o meglio ancora necessità di puntuali verifiche con condizioni territoriali specifiche; • gli enti gestori delle riserve naturali, al cui interno ricadono enormi superfici boscate, non sono stati coinvolti nelle consultazioni per la Valutazione Ambientale Strategica, come invece è avvenuto per gli Enti Parco; Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 178 • i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, operando ad una scala di estremo dettaglio (almeno 1:10.000) stanno pervenendo ad una maggiore conoscenza delle formazioni forestali ed alla individuazione di obiettivi gestionali a livello territoriale, senza che sia stato risolto il nodo del rapporto tra Piani di Gestione di SIC-ZPS e i futuri piani forestali sovraziendali. Deve infine farsi rilevare che alcune misure “forestali” del PSR Sicilia 2007/2013 sono in contrasto con le Linee guida forestali emanate con Decreto 15 ottobre 2004, che individuano nella redazione dei piani di assestamento o di gestione lo strumento essenziale per programmare ed attuare gli interventi di gestione forestale. Programmazione Azienda Foreste Demaniali Per l’entità dei demani forestali ricadenti all’interno del Sito, per il Sito in esame assume rilievo anche la programmazione di settore dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana. Tuttavia è emerso che tali demani non sono governati da Piani di Gestione (o di assestamento previsti dalla normativa forestale) e che l’unico riferimento è costituito dal “Piano Triennale delle opere pubbliche” dell’Azienda Foreste che, nel caso dei demani forestali interni al SIC, prevede esclusivamente cure colturali (spalcature, diradamenti, eliminazione piante malate, risarcimenti) e pulizia dei viali parafuochi. Tuttavia da tempo l’ente gestore della riserva naturale Grotta di Santa Ninfa e l’UPA di Trapani hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la gestione naturalistica dei complessi boscati ricadenti all’interno della riserva. Appare quindi necessario integrare il protocollo in coerenza con gli obiettivi posti dal Piano di Gestione, rivedere la programmazione ordinaria dell’Azienda Foreste Demaniali e modificare alcune prassi gestionali alla luce delle misure di conservazione e dei nuovi obiettivi gestionali che riguardano il Sito, rafforzando anche la concertazione con gli enti gestori coinvolti. In tale prospettiva, alla gestione del Sito Natura 2000 può concorrere in via ordinaria, attraverso le attività di manutenzione ma soprattutto attraverso nuove progettazioni, l’azione quotidiana dell’Azienda Foreste Demaniali. Programma Operativo Regionale. FESR 2007-2013 Il Programma Operativo del FESR 2007/2013 costituisce lo strumento di programmazione per l’attivazione delle risorse comunitarie in materiale di infrastrutture, ambiente, turismo e sviluppo locale. L’obiettivo generale del Programma si può enunciare come segue: “Innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio dell’economia regionale attraverso il rafforzamento dei fattori di attrattività di contesto e della competitività di sistema delle attività produttive in un quadro di sostenibilità ambientale e territoriale e di coesione sociale”. Il Programma si articola in 7 Assi prioritari denominati “Reti e collegamenti per la mobilità”, “Uso efficiente delle risorse naturali”, “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo”, “Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione”, “Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali”, “Sviluppo urbano sostenibile”, “Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica”. I primi tre assi fanno prevalente riferimento a fattori di attrattività di contesto, i due successivi alla “diffusione della società della conoscenza e imprenditorialità” e gli ultimi due hanno contenuto trasversale. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 179 I caratteri distintivi del Programma possono riassumersi in alcune opzioni trasversali che concernono la collocazione mediterranea del processo di sviluppo della Sicilia, la necessità di dare attuazione alle pianificazioni settoriali già intraprese nel corso della programmazione 2000-2006, l’opportunità di sviluppare meccanismi di competitività del sistema produttivo regionale incentrati sui sistemi di imprese, l’attenzione alla sostenibilità territoriale dell’azione programmatica, con distinzione specifica per le aree urbane, per quelle rurali e per i sistemi locali. Quanto alle principali linee strategiche, l’azione di rafforzamento dei fattori d’attrattività si rivolge innanzitutto al settore delle infrastrutture di trasporto e della logistica, con conseguenti problemi di forte impatto ambientale del Programma. Un secondo importante fattore d’attrattività è quello delle risorse naturali per il quale l’analisi dei punti di forza e di debolezza ha individuato, come criticità principali, i ritardi nel raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, l’incompleta attuazione della gestione integrata in materie di acque e rifiuti e la presenza di un elevato rischio idrogeologico in molte aree della regione. Nel settore dell’energia, obiettivi prioritari dell’azione di programmazione riguardano la riduzione della dipendenza dalle fonti tradizionali e la promozione della diffusione di fonti rinnovabili con connesso adeguamento degli impianti, l’integrazione delle tematiche energetiche con la programmazione nel campo della ricerca e dell’innovazione, la razionalizzazione della domanda di energia. In campo ambientale si vuole in particolare promuovere la riconversione dei sistemi di produzione verso tecniche e modalità sostenibili, il miglioramento della gestione delle risorse naturali agendo sulla dotazione di infrastrutture e di servizi collettivi e sulla prevenzione dei rischi, l’attuazione della pianificazione settoriale in materia di acqua, rifiuti, e protezione della natura, lo sviluppo di piani di prevenzione del rischio, la promozione di interventi di risanamento e riequilibrio ambientale di grande impatto e la creazione di un sistema di servizi e infrastrutture a rete per i sistemi locali di impresa in modo da sostenere l’adozione di eco-innovazioni da parte delle micro e PMI. L’azione di programmazione si indirizza anche alla riqualificazione nelle politiche ambientali e culturali attraverso la realizzazione di una più efficace sinergia tra azione di preservazione e azione di fruizione. Ciò al fine di meglio definire l’identità dei luoghi attraverso la costituzione di circuiti e reti tematiche, e di aumentare anche l’attrattività dei territori, soprattutto di quelli ancora non in grado di offrire importanti assets sul mercato extra-locale. La politica ambientale del programma è anche legata a gravi situazioni di contesto del territorio regionale in materia di risorse naturali. Il territorio siciliano rivela alcuni problemi relativi alla qualità dell’aria, registrando concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti previsti dalla normativa nei principali centri urbani e nelle aree dei poli industriali. Con riguardo alla produzione di Gas serra, nonostante il modesto livello di industrializzazione che caratterizza il contesto regionale, si rileva un livello emissioni di CO2 significativamente elevato rispetto alle emissioni totali nazionali. Relativamente all’uso del suolo, l’aumento della copertura artificiale determina un generale incremento delle superfici impermeabilizzate, e costituisce una minaccia poiché rappresenta un fenomeno pressoché irreversibile di perdita di suolo. Tra le forme di degrado del suolo presenti in Sicilia va citata inoltre quella della desertificazione: la Sicilia è infatti una delle regioni del Mediterraneo maggiormente soggetta al rischio di desertificazione, con circa il 50% del territorio regionale classificato a rischio medio emedio-elevato ed il 7% a rischio elevato. Per quanto riguarda la tematica del dissesto idrogeologico, ad aprile 2006 i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) pubblicati ed approvati interessavano una superficie di 18.414 Km2, pari Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 180 al 72% dell’intero territorio regionale. Sono stati sinora censiti 21.249 dissesti e di questi l’8,3% è indicato come area pericolosa sia dal punto di vista geomorfologico che idraulico, mentre le aree a rischio interessano il 2,16% della superficie regionale. Relativamente alle acque interne, la Sicilia è dotata di 82 corpi idrici superficiali interni definiti significativi ai sensi del decreto legislativo 152/99, di cui 38 corsi d’acqua il cui monitoraggio (definito in base al S.E.C.A.) ha assegnato la II classe (ovvero buona) al 12% delle stazioni di campionamento, la III classe (sufficiente) al 35%, la IV classe (scadente) al 29%, mentre solo il 24% ha avuto assegnato la classe Va (pessima). Per una valutazione definitiva occorre pero’ completare il quadro conoscitivo alla luce degli obiettivi e delle indicazioni date dalla Direttiva 2000/60. I corpi idrici sotterranei considerati significativi sono 76, e sono stati classificati nel 2005, nella maggioranza dei casi, in base all’indice S.A.A.S – Stato Ambientale delle Acque Sotterranee, nella classe “buona”. In particolare, il 4% presenta uno stato ambientale sufficiente, il 29% uno stato scadente, una quota dell’11% rientra in uno stato ambientale definito “particolare”, ovvero tale per cui le caratteristiche qualitative e/o quantitativenon sono determinate da un significativo impatto antropico ma dovute alla presenza naturale di particolari specie chimiche o ad un potenziale quantitativo di scarso rilievo, così da comportare limitazioni nell’uso della risorsa. Un aspetto da considerare attentamente riguarda il fenomeno di salinizzazione delle falde acquifere sotterranee, da collegare in gran parte al prelievo idrico da pozzi per uso irriguo. In termini di raccolta differenziata la quota in Sicilia, essa è ancora al di sotto dei livelli dell’area Convergenza (8,2%) e dei valori medi nazionali (24,3%). Tale quota è quindi lontana dall’obiettivo del 15% da raggiungere già nel 2003 fissato con ordinanza ministeriale n. 3190 del 22 marzo 2002 (art. 4, c.1) o da quello del 25% fissato a Lisbona. Risulta pertanto evidente che la quasi totalità dei rifiuti solidi urbani prodotti (circa il 95%) continua ad essere smaltita in discarica. La criticità investe anche i trattamenti di compostaggio delle frazioni umide dei rifiuti urbani complessivi, per i quali la Sicilia mostra notevoli ritardi con valori prossimi all’1,3% contro il 20,5% nazionale e l’altrettanto basso 1,7% dell’area Convergenza (APAT, 2005). Il bilancio energetico regionale conferma, in termini di consumi finali, la prevalenza dei prodotti petroliferi (64%), sull’energia elettrica (19%) e sul gas naturale (in crescita), con una quota ancora residuale di fonti rinnovabili (2,5%) fortemente in ritardo rispetto ai valori dell’area Convergenza (7,2%), alla quota del 16,9% dell’Italia in complesso e infine ai valori osservati a livello UE25 (13,9%, ). Stesso profilo rivestono i consumi regionali d’energia elettrica coperti da fonti rinnovabili. Pertanto, il cammino verso il raggiungimento dell’obiettivo di Lisbona (25%) appare molto arduo. L’analisi SWOT di seguito presentata è strutturata in modo tale da rappresentare in primo luogo i principali elementi di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce relative al complesso del Programma. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 181 Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 182 Nel Programma assumono rilievo i tempi posti in merito all’integrazione delle politiche ambientali nelle politiche di sviluppo La Regione, nella sorveglianza dell’attuazione e nel sistema di monitoraggio, definisce gli indicatori ed i criteri/modalità di verifica e di rispetto dell’attuazione del principio di sostenibilità ambientale e di conformità alle normative ambientali, sottoponendoli periodicamente, con cadenza almeno annuale, all’approvazione del Comitato di Sorveglianza. Il Programma, nel corso della sua attuazione, sarà orientato a: - rafforzare la governance regionale e locale in materia di sostenibilità ambientale assicurando l’implementazione degli aspetti ambientali quale principio trasversale in tutte le diverse fasi (programmazione, attuazione monitoraggio valutazione); - rafforzare i processi partecipativi e di concertazione in tutte le fasi del Programma mediante il coinvolgimento dei diversi portatori d’interesse significativi nel campo della sostenibilità ambientale; - contribuire al miglioramento della qualità di progettazione in tutte le fasi del ciclo del progetto anche mediante il ricorso al pieno utilizzo degli strumenti di comunicazione; - assumere opportuni meccanismi procedurali per garantire l’integrazione degli aspetti relativi alla sostenibilità ambientale in tutte le fasi di attuazione degli interventi (criteri di selezione/modalità di esecuzione/sistema indicatori/meccanismi valutazione) provvedendo, anche, a definire e introdurre idonei punteggi e criteri premiali, sia di natura quantitativa che qualitativa; - prevedere, con riferimento al processo di Valutazione Ambientale Strategica, appositi strumenti di monitoraggio e valutazione che, attraverso set d’indicatori specifici, consentano di verificare in modo puntuale i risultati quantitativi e qualitativi che l’attuazione del Programma produce sulle componenti ambientali, con specifica attenzione agli impatti diretti o indiretti degli interventi. Al fine di ricondurre ad un insieme unitario i principi di sostenibilità ambientale che devono essere perseguiti dalla nuova programmazione 2007-2013, si ricostruisce un quadro sintetico dei principali obiettivi di sostenibilità scaturiti dalle criticità evidenziate dalla analisi del contesto regionale. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 183 Temi ambientali e criticità regionali Cambiamenti climatici ed energia A livello regionale si registrano emissioni di gas serra significative e sensibilmente superiori ai limiti indicati dal protocollo di Kyoto. La situazione siciliana (2003) è caratterizzata da una netta prevalenza di combustibili fossili e da una scarsa incidenza delle fonti rinnovabili che producono solo lo 0,4% del totale Le fonti di emissione principali sono rappresentate dal comparto energetico e dai trasporti. Atmosfera La tematica dell’inquinamento atmosferico è strettamente connessa alla precedente ed è responsabile del deterioramento della qualità dell’aria che respiriamo con ricadute negative anche sul suolo, e sui corpi idrici attraverso la deposizione di sostanze inquinanti presenti nell’atmosfera. Gli studi scientifici hanno messo in relazione le pesanti ricadute sanitarie dovute alla presenza di sostanze inquinanti nell’atmosfera ed hanno dimostrato che alcune di queste sostanze sono accertati agenti cancerogeni. A livello regionale sono stati riscontrati nei principali centri urbani e nelle aree industriali siciliane superamenti dei valori normativi per alcune tipologie d’inquinanti. Inoltre il sistema di monitoraggio della qualità dell’aria appare ancora deficitario e le province di Trapani, Ragusa ed Enna sono ancora del tutto sprovviste di centraline di monitoraggio Come per la precedente tematica i settori maggiormente responsabili delle emissioni in atmosfera sono gli impianti energetici ed industriali ed i trasporti. Natura e Biodiversità La regione si caratterizza per una grande ricchezza di biodiversità e per la presenza di aree protette che interessano più del 10% della superficie regionale alle quali si aggiungono i Siti di interesse comunitario (SIC eZPS) della rete Natura 2000 e le aree marine protette. La principale minaccia per la conservazione di questo patrimonio è rappresentata dagli incendi che annualmente distruggono gli ambienti naturali. Altri elementi di criticità riguardano la riduzione delle aree naturali della fascia costiera soggette ad elevate Obiettivi di sostenibilità Gli obiettivi prioritari consistono nella progressiva riduzione dell’impatto ambientale e climalterante della produzione e consumo di energia, mediante azioni composite di promozione delle fonti rinnovabili (obiettivi al 2010 ex Dir. 2001/77/CE e prospettive al 2020 decise nel Consiglio dell’UE del marzo 2007) e sostegno all’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali (Dir. 2006/32/CE sui servizi energetici) Per il perseguimento di tali obiettivi la regione siciliana dovrà esitare tempestivamente il piano energetico regionale e dotarsi di strumenti appropriati di conoscenza per la stima delle emissioni prodotte ed il monitoraggio degli inquinanti. La più recente strategia delL'Unione europea per contrastare l’inquinamento atmosferico fissa obiettivi di riduzione di taluni inquinanti e rafforza il quadro legislativo di lotta all'inquinamento atmosferico secondo due assi principali: il miglioramento della legislazione comunitaria in materia di ambiente e l'integrazione del problema "qualità dell'aria" nelle pertinenti politiche, con specifico riferimento alla "Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico" COM(2005) 446. Sulla base della situazione accertata nel 2000, la strategia fissa come obiettivi per il lungo termine (2020): una riduzione del 47% della perdita di speranza di vita dovuta all'esposizione al particolato; una riduzione del 10% dei casi di mortalità acuta dovuti all'ozono; una diminuzione delle eccessive deposizioni acide nelle foreste (74%) e sulle superfici di acqua dolce (39%); una riduzione del 43% delle zone i cui ecosistemi sono soggetti a eutrofizzazione Con riguardo alla situazione regionale permangono come obiettivi prioritari l’esitazione dei piani di risanamento dell’aria sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 351/99 e dal D.M. 261/2002 e l’attuazione di un sistema di monitoraggio adeguato alle prescrizioni normative. Le politiche di contrasto all’inquinamento atmosferico dovranno essere supportate dalla diffusione delle migliori tecnologie disponibili con particolare riguardo alla riduzione degli impatti ambientali del settore energetico industriale e da politiche mirate a limitare le emissioni del settore trasporti. L’obiettivo primario consiste nel dare piena attuazione alle Direttive CE Habitat e Uccelli in conformità agli indirizzi del Sesto Programma Europeo di Azione Ambientale ed ai nuovi obiettivi per arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre (COM(2006) 216). Si dovranno sostenere le azioni di tutela e conservazione delle specie e degli habitat individuati nei siti Natura 2000 anche al fine di mitigarne la frammentazione e promuovere la connettività ecologica all’interno della regione biogeografica mediterranea. L’ implementazione della rete di monitoraggio mirata a Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 184 pressioni antropiche, il basso livello di pianificazione dei territori di pregio naturalistico ed i ritardi nell’attuazione delle direttive Habitat e Uccelli. Paesaggio e patrimonio culturale La regione Siciliana per la sua storia e per le caratteristiche naturali esprime una grande diversità di paesaggi e la presenza di un patrimonio monumentale, archeologico d’importanza nazionale ed internazionale. Ampi segmenti di questo patrimonio si trovano in stato di degrado o di abbandono anche a causa delle profonde trasformazioni dovute a processi di urbanizzazione ed infrastrutturazione territoriale non sempre correttamente pianificati che hanno comportato la presenza di ampi fenomeni di abusivismo e lo spopolamento delle aree interne. Altri aspetti che esercitano pressioni negative per la conservazione del paesaggio riguardano la significativa presenza di siti inquinati e l’incremento delle attività estrattive non supportate da una pianificazione adeguata. Il fenomeno degli incendi costituisce un elemento di periodico degrado di aree di rilevanza paesaggistica. Produzione e gestione dei Rifiuti La produzione di rifiuti regionale è smaltita per la quasi totalità in discarica. Tali impianti risultano spesso autorizzati a livello emergenziali con potenziali rischi d’inquinamento delle matrici ambientali La percentuale di raccolta differenziata raggiunge valori significativamente inferiori alla media nazionale ed ai valori indicati a livello normativo; di contro si registra un trend di incremento nella produzioni regionale di rifiuti Si riscontra un attuazione ancora parziale del servizio di gestione integrata. Risorse Idriche Il sistema di gestione delle risorse idriche regionale mostra elevate perdite nelle reti di adduzione e distribuzione dell’acqua e le famiglie che denunciano migliorare la conoscenza sulla biodiversità (specie animali e vegetali), rappresenta lo strumento fondamentale per migliorare le politiche di salvaguardia. Per perseguire tali obiettivi le politiche regionali dovranno completare la pianificazione dei siti tutelati e garantire adeguate misure di salvaguardia e di gestione delle aree protette regionali e comunitarie. Il potenziamento dei sistemi di prevenzione e lotta agli incendi in complementarietà con le politiche di sviluppo rurale costituisce un aspetto prioritario delle politiche di tutela. Per la conservazione della biodiversità marina gli obiettivi prioritari sono rappresentati dall’istituzione di nuove aree protette e dall’attuazione dei piani di gestione per la protezione delle zone marine. L’obiettivo della nuova programmazione 2007-2013 deve riguardare il mantenimento e la valorizzazione delle risorse paesaggistico-culturali tramite la pianificazione d’ambito in conformità alle indicazioni contenute nel Codice dei Beni Culturali, il ripristino delle molte aree degradate attraverso la realizzazione di interventi di restauro, manutenzione e recupero del patrimonio esistente in stretta connessione con i sistemi turistici e con i servizi idonei al miglioramento e diversificazione dell’offerta culturale ed attenti alla qualità della vita dei cittadini ed all’incremento di un flusso turistico destagionalizzato. Le strategie di tutela dovranno integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio con particolare riguardo alle strategie inerenti la salvaguardia della natura e della biodiversità. Gli obiettivi da perseguire dovranno mirare sia alla progressiva limitazione della produzione di rifiuti attraverso la raccolta differenziata e il riciclaggio sia all’incremento della qualità del servizio di gestione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, nonché agli indirizzi della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti. A livello Regionale un obiettivo centrale è rappresentato dal miglioramento dell’efficienza del sistema di raccolta gestione e smaltimento dei rifiuti attraverso la piena realizzazione del Servizio di gestione integrata dei rifiuti e l’avvio di organiche politiche di riciclaggio e di prevenzione e minimizzazione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti. Obiettivo vincolante è la piena conformità a quanto previsto dal quadro normativo. Gli obiettivi principali dovranno mirare all’efficienza lungo tutte le fasi del ciclo di gestione delle risorse idriche, al risparmio idrico, alla tutela dei corpi idrici Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 185 irregolarità nella distribuzione dell’acqua sono quasi il triplo dei valori medi nazionali . Carenze di rilievo, si riscontrano in termini di popolazione coperta dal servizio di rete fognaria con depurazione completa dei reflui convogliati. I dati forniti dal Ministero dell’ambiente relativi alla copertura del Servizio idrico integrato, pongono la Sicilia nel 2004 in coda a tutte le regioni italiane, con una quota di popolazione servita pari al 73,6% contro l’81,4 del Mezzogiorno e all’84,9 dell’Italia. Le province dove si rilevano le situazioni peggiori sono quelle di Catania e Trapani. Per quanto riguarda la qualità dei corpi idrici monitorati si riscontrano situazioni eterogenee. Si riscontrano problematiche relative alla salinizzazione delle falde idriche Appare necessario migliorare il quadro conoscitivo sui prelievi idrici nei diversi settori Suolo Sottosuolo e Desertificazione Il territorio Siciliano si caratterizza per una elevata vulnerabilità al rischio idrogeologico, sismico, vulcanico e di desertificazione Le cause di tale vulnerabilità hanno origine naturale ma sono state aggravate delle trasformazioni del territorio di origine antropica Tra gli eventi naturali ad evoluzione lenta che pongono maggiori rischi sia socioeconomici che ambientali, rientrano quelli indotti dalla erosione costiera.. Fenomeni di degrado del suolo sono correlati alla significativa presenza di siti contaminati e potenzialmente contaminati che hanno per lo più origine da attività di smaltimento di rifiuti e da attività industriali. Fenomeni d’inquinamento rilevanti sono stati accertati nelle tre aree industriali identificate a livello nazionale come aree ad elevato rischio di crisi ambientale nonché al completamento alla pianificazione di settore, al fine di adeguarsi alla Direttiva 2000/60/CE. Gli interventi sostenuti dovranno trovare collegamento ed integrazione con quanto promosso nel Piano di sviluppo rurale per un uso sostenibile delle risorse idriche e per prevenire fenomeni di salinizzazione delle falde idriche. Particolare attenzione dovrà essere attribuita alle attività di risparmio idrico, soprattutto in relazione al reimpiego delle acque reflue. Coerentemente con il Sesto Programma Europeo di azione per l’ambiente e con riferimento al documento programmatico “Verso una strategia tematica per la protezione del suolo“ COM(2002) 179, gli obiettivi consistono nel contenimento dei rischi naturali dando piena attuazione ai Piani di Assetto Idrogeologico e ad azioni finalizzate alla prevenzione del rischio di desertificazione. La strategia promossa dovrà essere indirizzata a ripristinare la funzionalità idrogeologica dei sistemi naturali, limitare e ridurre l’erosione costiera, identificare, e ridurre la pericolosità delle aree a rischio e dovrà trovare complementarietà e sinergia con gli interventi sostenuti dal Piano di sviluppo rurale ed in particolare con le politiche forestali . La bonifica dei siti inquinanti e potenzialmente inquinati rappresenta un obiettivo prioritario per contrastare fenomeni di degrado e contaminazione del suolo che deve essere integrato con azioni di riqualificazione e valorizzazione socio economica delle aree bonificate. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 186 Ambiente Urbano L’ambiente urbano, per l’elevata concentrazione della popolazione che vi risiede, è oggetto di fenomeni d’inquinamento ambientale che hanno ricadute negative anche sulla salute dei cittadini. La maggiore concentrazione urbana in Sicilia si è sviluppata lungo la fascia costiera, soprattutto tirrenica dove si trovano le più grandi aree metropolitane. A questo fenomeno ha fatto riscontro una riduzione della popolazione residente nei centri minori delle aree più interne e montane che ha dato luogo a squilibri territoriali in termini di localizzazione di servizi e infrastrutture. Tra le principali criticità delle aree urbane si riscontra l’inquinamento atmosferico e acustico da correlare alla bassa qualità del sistema di trasporto pubblico urbano con conseguenti fenomeni di cogestione nei centri più grandi dovuti al traffico veicolare. Altri aspetti problematici riguardano l’elevata produzione di RSU non differenziati e l’inadeguatezza dei servizi essenziali quali quello idrico fognario depurativo che mostrano deficit rilevanti in termini di abitanti serviti e conformità alle normative Mobilità e Trasporti I trasporti rappresentano una fonte inquinante di rilievo soprattutto per l’aria ma ha ricadute anche sulle altre matrici ambientali. Il sistema di trasporti regionale rileva una bassa efficienza del servizio pubblico sia urbano che extraurbano, con la conseguenza che la mobilità avviene preferenzialmente su gomma con veicoli privati, causando fenomeni di congestione e rischi sanitari per inquinamento dell’aria cittadina e per i fenomeni d’inquinamento acustico. Gli incidenti da trasporto sono causa di mortalità rilevante e necessitano di interventi per migliorare la sicurezza delle reti di trasporto. Ambiente e Salute Il quadro conoscitivo degli impatti sulla salute per fenomeni d’inquinamento ambientale, pur presentandosi ancora molto frammentato ha comunque evidenziato correlazioni dirette tra danni alla salute ed inquinamento delle matrici ambientali. I principali fattori di rischio per la salute umana riguardano l’ inquinamento atmosferico ed acustico, le radiazioni (UVA, radiazioni elettromagnetiche e da radon) l’inquinamento della catena alimentare; l’inquinamento del suolo. In Sicilia le indagini effettuate hanno rilevato un’incidenza superiore di alcune patologie per la popolazione residente nelle Tenuto conto della natura transettoriale delle questioni attinenti alla gestione urbana, qualsiasi strategia per il miglioramento dell'ambiente urbano richiede un coordinamento con le altre politiche ambientali interessate, vale a dire la lotta contro il cambiamento climatico (costruzioni che favoriscano l'efficacia energetica, piani di trasporto urbano, ecc.), la tutela della natura e della biodiversità (riduzione della proliferazione delle città, recupero di aree industriali abbandonate, presenza di parchi e giardini urbani ecc.), la qualità della vita e la salute (riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, ecc.), l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali nonché la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. Gli obiettivi prioritari riguardano pertanto la tutela della salute dei cittadini attraverso la riduzione della popolazione esposta sia a fattori inquinanti (inquinamento atmosferico, acustico) quanto a fattori di rischio (da attività produttive pericolose in ambiente urbano o da fenomeni naturali: fiumi interrati, eventi calamitosi, barriere artificiali). La promozione di un sistema di trasporto pubblico sostenibile, il miglioramento della gestione dei servizi essenziali finalizzati ad un innalzamento complessivo della qualità della vita nei centri urbani , in coerenza con la “Strategia tematica sull’ambiente urbano” (COM/2005/718). Obiettivo trasversale rimane il riequilibrio territoriale da incentivare favorendo l’interconnessione e lo sviluppo dei centri minori. Gli obiettivi prioritari mirano a rendere più efficiente il sistema dei trasporti promuovendo l’intermodalità,lo sviluppo di nodi logistici e i mezzi di trasporto collettivi, quali ferrovie e trasporti marittimi unitamente al trasporto pubblico locale. In tal modo si potrà anche disincentivare il trasporto stradale con possibili effetti positivi sugli impatti inquinanti del settore, specie in termini di emissioni e di cogestione. Un ulteriore obiettivo è la realizzazione di importanti progetti per le infrastrutture dei trasporti su scala europea, le cosiddette reti transeuropee di trasporto o TEN (Trans European Networks). Obiettivi strettamente correlati e concorrenti riguardano l’utilizzazione di vetture a minor impatto ambientale basate sul consumo di fonti energetiche alternative ai carburanti fossili. Gli obiettivi principali riguardano la riduzione della popolazione esposta a fattori inquinanti, con particolare riferimento all’ambiente urbano ed alle aree industriali .L’integrazione tra strutture ambientali e sanitarie è prevista nel D. Lgs 229/99, che mira a favorire il coordinamento degli interventi per la salute e l’ambiente, definendo, a vari livelli, i settori di azione congiunta e i relativi programmi attuativi. Le Regioni, devono definire “le modalità ed i livelli di integrazione fra politiche sanitarie ed ambientali prevedendo la stipulazione di accordi di programma e convenzioni tra le USL, Aziende Sanitarie e le ARPA, con particolare Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 187 aree ad elevato rischio di crisi ambientale che corrispondono alle aree dove sono insediati i grossi poli industriali petrolchimici. Danni diretti sulla salute a causa dell’inquinamento atmosferico sono stati accertati nelle aree metropolitane di Palermo e Catania (indagine MISA). Altri fattori di rischio per la salute della popolazione riguardano il rischio antropogenico dovuto a industrie soggette a rischio d’incidente rilevante e la popolazione esposta a rischio idrogeologico. riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio. Le azioni prioritarie dovranno riguardare l’identificazione dei rischi per la salute umana, soprattutto per i bambini e gli anziani, l’inserimento della tematica ambiente e salute nelle altre politiche e nelle norme sull'aria, sulle acque, sui rifiuti e sul suolo; il potenziamento della ricerca nel campo della salute e dell'ambiente; il divieto e la limitazione dell'uso dei pesticidi più pericolosi e la sicurezza della catena alimentare. Da considerare anche gli obiettivi di contenimento dell’inquinamento acustico, principalmente con riferimento alla Direttiva 2002/49/CE e relativi provvedimenti di recepimento e attuazione. Obiettivi rilevanti a livello regionale riguardano inoltre la riqualificazione delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale e la riduzione della percentuale di popolazione soggetta a rischio idrogeologico e antropogenico. I temi ambientali trovano specifico riscontro degli Assi 2 e 3, di cui si riportano obiettivo globale e obiettivi specifici ed analisi swot: ASSE 2 - USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI La strategia di sviluppo consiste nel raggiungimento del seguente obiettivo globale d’asse: “Garantire adeguati livelli di servizio nel settore delle risorse naturali attraverso un aumento di efficienza in un’ottica di sostenibilità e di difesa/prevenzione del rischio”. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 188 ASSE 3 - VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITÀ CULTURALI E DELLE RISORSE PAESAGGISTICOAMBIENTALI PER L’ATTRATTIVITA’ TURISTICA E LO SVILUPPO La strategia di sviluppo consiste nel raggiungimento del seguente obiettivo globale d’Asse, ossia “valorizzare i beni e le attività culturali e ambientali quale vantaggio comparato della regione per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti e aumentare l’attrattività turistica ”. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 189 Per le connessioni operative con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e con la Rete Ecologica Siciliana, appare utile un esame più di dettaglio di alcuni obiettivi dell’Asse 3: Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo. L’obiettivo specifico 3.2 “rafforzare la rete ecologica siciliana”, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in un’ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo, si articola nei seguenti obiettivi operativi: Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 190 • Obiettivo operativo 3.2.1: Rafforzare la valenza e l’identità naturalistica dei territori Nel ciclo di programmazione precedente sono stati messi a punto gli strumenti di conoscenza e di pianificazione di area vasta del territorio della Rete Ecologica siciliana di livello regionale. Con la programmazione 2007-2013 dovranno essere definite le pianificazioni dei singoli sistemi integrati ad alta naturalità e, in attuazione dei Piani di Gestione dei diversi siti, oppure, nei siti ricadenti all’interno dei Parchi e delle Riserve già istituite nel rispetto delle norme di salvaguardia individuate nella pianificazione vigente, si dovranno creare le condizioni di contesto, sia in termini di politiche di sviluppo sia in termini di infrastrutturazione dei territori della Rete Ecologica, per garantire la buona riuscita degli interventi più direttamente a favore della biodiversità, da realizzarsi a carico del PO FEASR, e verrà realizzato un nodo pubblico di osservazione della biodiversità per la tutela e la fruizione delle risorse naturali. La realizzazione di tali azioni garantirà una diffusa animazione sociale ed economica, anche in chiave turistica, dei territori interessati. • Obiettivo operativo 3.2.2: Incentivare lo sviluppo imprenditoriale che opera nel settore della valorizzazione dei beni ambientali e naturalistici e della correlata promozione del turismo diffuso, coerentemente con i modelli ed i piani di gestione e conservazione dei siti Rete Natura 2000 parchi e riserve L’obiettivo si propone di rafforzare e incentivare il tessuto imprenditoriale che opererà in coerenza con i modelli e i futuri piani di gestione e conservazione (piani territoriali dei parchi, piani di sistemazione ed utilizzazione delle riserve) dei siti Rete Natura 2000, parchi e riserve del territorio insulare. Si tratta di incentivare il tessuto imprenditoriale sia nei settori produttivi legati alle attività e ai mestieri tradizionali ed alla fruizione turistica dei luoghi, sia nei servizi connessi alla promozione e valorizzazione dei territori e delle relative produzioni, ad eccezione delle azioni più direttamente legate alla biodiversità che saranno oggetto dell’intervento del FEASR. Con tale obiettivo si intende rivitalizzare, anche in senso turistico, aree a rischio di marginalità e contrastare processi di impoverimento di risorse umane (nuova emigrazione) che versano in una situazione di crisi e che hanno dato luogo a significativi fenomeni di “esodo rurale”. Gli obiettivi operativi prima enunciati si articolano in una serie di linee di intervento: • azioni volte alla realizzazione di un nodo pubblico di osservazione della biodiversità per la tutela e la fruizione delle risorse naturali compatibilmente con quanto previsto dal Reg. (CE) 1080/06; • azioni di supporto alla realizzazione della rete ecologica regionale, innanzitutto dei Comuni montani, tramite interventi di infrastrutturazione integrata (realizzazione del Sentiero Italia - dorsale settentrionale sicula), azioni di ripristino e restauro naturalistico, al fine di prevenire rischi e promuovere la protezione della natura; • azioni eco-innovative di supporto alle PMI che operano nei siti Rete Natura 2000 e parchi e riserve e azioni di marketing territoriale e promozione di marchi d’area; • azioni di adeguamento delle strutture pubbliche esistenti realizzate secondo criteri di edilizia sostenibile; • servizi integrati ambientali alle associazioni di PMI e alle confederazioni artigianali; • azioni congiunte di tutela, sviluppo sostenibile e promozione imprenditoriale del sistema della Rete Ecologica Siciliana; • azioni di rafforzamento della competitività delle produzioni locali e delle filiere produttive dei territori della Rete Ecologica siciliana (sono escluse le attività di Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 191 • • produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato); azioni di promozione e catalizzazione dello sviluppo locale sostenibile anche attraverso lo strumento delle Agende 21; interventi di valorizzazione ambientale e di incentivazione alle imprese ubicate nei comuni di montagna in un’ottica di complementarietà con la politica di sviluppo rurale. Più di una perplessità, in riferimento alla strategia complessiva di Asse ed agli obiettivi che si intendono perseguire per il rafforzamento della Rete Ecologica Sicilia, suscita la specifica previsione di “azioni rivolte al sostegno di attività di società ed associazioni impegnate nella tutela, valorizzazione e fruizione dell’ambiente e delle risorse naturali, al fine di aumentare la sensibilità sui temi ambientali attraverso la pratica di attività motorie ecocompatibili, compresi interventi di adeguamento ciclabile di sentieri esistenti (con esclusione del sostegno ai costi di gestione e funzionamento). Posti questi elementi, appaiono utili e doverose alcune valutazioni critiche sulla compatibilità del Programma con gli obiettivi posti dai Piani di Gestione e con gli obiettivi più generali della Direttiva 92/43. Nella presente trattazione verranno riportati anche alcuni dati ed osservazioni contenute nella Valutazione Ex-Ante del Programma, in particolare per quelle misure direttamente connesse con l’attuazione della Rete Ecologica Siciliana. Per quanto riguarda l’Asse II, la strategia perseguita è ritenuta coerente in termini di attenuazione delle criticità ambientali riscontrate. In termini ambientali si ritiene positiva l’attuazione di una strategia di riduzione della dipendenza dalle fonti tradizionali, la promozione della diffusione di fonti rinnovabili, di carburanti alternativi e la razionalizzazione della domanda di energia. Corretto appare altresì il proseguimento delle strategie di attuazione della gestione integrata in materie di acque e rifiuti e le azioni finalizzate ad attenuare i rischi, sia naturali che di origine antropica. Innovativo appare il sostegno ad una strategia di riconversione dei sistemi di produzione verso tecniche e modalità sostenibili, con un forte impulso ad azioni eco-efficienti, intervento contenuto in particolare negli obiettivi operativi 2.1.1 e 2.4.3. Tali obiettivi, se compiutamente conseguiti, presentano positivi riflessi, sia ambientali che economici, con il sostegno all’attivazione di filiere produttive di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili e del riciclaggio dei rifiuti a livello di sistemi locali d’impresa e distretti produttivi, favorendo l’adozione di sistemi di gestione ambientali. Vale la pena evidenziare l’esistenza di forti legami di complementarietà tra l’obiettivo globale dell’Asse II (realizzare un uso efficiente delle risorse naturali) e l’obiettivo specifico 3.2, relativo allo sviluppo della Rete Ecologica. A tale proposito, a fronte di una collocazione di quest’ultimo obiettivo non pienamente coerente con le esigenze connesse ad un approccio integrato al tema della sostenibilità, si segnala la necessità di definire procedure di attuazione e meccanismi operativi coordinati, in grado di sfruttare le sinergie potenziali esistenti. Alla luce delle esperienze pregresse nei precedenti cicli di programmazione, e nello specifico dalle lezioni del passato riferite all’asse I del POR 2000-2006, vanno altresì rafforzate le integrazioni tra le azioni di governance e le strategie ambientali, con particolare riferimento agli obiettivi operativi 2.2.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 In merito all’Asse II viene suggerito inoltre di separare chiaramente in fase di attuazione la gestione degli interventi connessi all’attuazione dei Piani di Assetto Idrogeologico da quelli previsti dal Piano Forestale. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 192 Per quanto riguarda l’ Asse III, che ha particolare rilievo per le politiche a favore della Rete Ecologica e dell’attuazione dei Piani di Gestione, un primo aspetto riguarda il giudizio di pertinenza dell’analisi SWOT rispetto all’analisi di contesto relativo ai sistemi culturali e ambientali formulato dal Valutatore del PO FESR nella seguente tabella: SWOT Presenza nell’analisi di contesto PUNTI DI FORZA Elevato valore in termini di ricchezza biologica floristica e faunistica Estensione del territorio naturale protetto Disponibilità di risorse (beni culturali, storici ed archeologici e aree naturali) di rilievo internazionale diffuse su tutto il territorio regionale OPPORTUNITÀ Carta della Natura OPPORTUNITA’ Piano Regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi Presente Presente Presente L’analisi di contesto mette in evidenza la ricchezza ambientale regionale La Sicilia ha un’elevata quota di territorio protetto L’analisi di contesto cita il vasto patrimonio regionale Non presente L’analisi non riporta la che con la misura 1.11 della precedente programmazione si è recentemente finanziata la realizzazione della Carta della Natura che fornisce i primi strumenti di conoscenza del territorio regionale Non presente Date le evidenze dell’analisi di contesto, è plausibile che tale Piano possa essere un’opportunità per la regione Date le evidenze dell’analisi di contesto, è plausibile che tale Piano possa essere un’opportunità per la regione Date le evidenze dell’analisi di contesto, è plausibile che tale Piano possa essere un’opportunità per la regione Piano forestale regionale ed inventario forestale regionale Non presente Strumenti di pianificazione in aree protette Non presente MINACCE Insostenibilità dei costi sociali direttamente collegabili al degrado ambientale Osservazioni Non presente Pertinente La tabella seguente riguarda invece la riscontrabilità nell’analisi di contesto di dati a supporto della strategia dell’ Asse III: 3.2 - Rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in un’ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo 3.2.1: Rafforzare la valenza e Riscontrabile l’identità naturalistica dei territori anche attraverso la diffusione della sensibilità per i temi dello sviluppo sostenibile 3.2.2: Incentivare lo sviluppo Non valutato imprenditoriale, coerentemente con i modelli ed i piani di gestione e conservazione dei siti Rete Natura 2000, parchi e riserve Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano L’analisi di contesto evidenzia la non piena valorizzazione delle risorse naturali e la mancata affermazione dei principi di prevenzione e tutela L’analisi di contesto non riporta elementi utili al riguardo 193 Per la Valutazione Ex Ante, la strategia di sviluppo dell’Asse III, incentrata sulla valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico ambientali, appare poco coerente, sotto il profilo ambientale, con alcuni degli obiettivi operativi e delle linee di intervento declinati in seno allo stesso Asse. La strategia dell’Asse non appare altresì definita con chiarezza dal punto di vista ambientale in termini di connessioni tra i due obiettivi specifici, che non appaiono collegati in termini di strategie di eco-sostenibilità. La dimensione ambientale è scarsamente considerata negli obiettivi operativi e nelle azioni contenute nell’obiettivo specifico 3.1 che appare disattento ai temi della gestione ambientale ecoorientata di siti spesso sottoposti a carichi antropici eccessivi, o comunque ad alto grado potenziale di interazione con gli effetti indotti dall’inquinamento. Particolarmente necessaria appare l’integrazione dei principi di ecosostenibilità in seno all’obiettivo operativo 3.1.6, “rafforzare i fattori di contesto, lo sviluppo di infrastrutture e dei servizi anche nelle aree rurali” con riferimento alle seguenti azioni: - realizzazione di infrastrutture culturali per il miglioramento della qualità della vita dei residenti valorizzazione delle identità locali; interventi integrati di riqualificazione di contesti architettonici e urbanistici di pregio storico; interventi di riqualificazione di contesti rurali di pregio storico culturale. L’integrazione strategica dei principi di sostenibilità ambientale è positivamente riscontrata nel caso dell’obiettivo specifico 3.2, connesso al rafforzamento della rete ecologica siciliana, sia in termini di contenuti che di trasversalità ambientale di obiettivi ed azioni. Più in dettaglio, la coerenza ambientale tra obiettivi e strategia appare correttamente definita nel caso degli obiettivi operativi 3.2.1 e 3.2.2, riguardanti la rete ecologica, e si condivide in tal senso la necessità di rafforzare le rete ecologica siciliana in un’ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile. Si rileva positivamente la particolare attenzione delle linee di intervento contenute nell’obiettivo operativo 3.2.2 alle tematiche dell’ecoefficienza del tessuto imprenditoriale che opererà nel tessuto territoriale della rete ecologica. Nel contempo si segnala però che nella linea di intervento “azioni per il sostegno alle società ed associazioni sportive impegnate nella tutela, valorizzazione e fruizione dell’ambiente e delle risorse naturali al fine di aumentare la sensibilità sui temi ambientali, attraverso la pratica di attività motorie ecocompatibili, (ob. Operativo 3.2.1), la definizione dei contenuti dell’azione appare vaga sotto il profilo ambientale, soprattutto nella definizione di pratiche motorie ecocompatibili e dell’aumento di sensibilità sui temi ambientali, già affrontato peraltro in altre azioni dello stesso obiettivo operativo. In ogni caso si segnala l’opportunità di prevedere criteri di selezione degli interventi in grado di premiare la maggiore sostenibilità ambientale dei progetti anche in termini di efficienza energetica, di interventi di eco-innovazione e di impegno all’acquisizione della certificazione ambientale per i parchi e le aree archeologiche, attribuendo altresì un significativo peso specifico agli stessi nella procedura di selezione degli interventi. Inoltre in prima approssimazione, si può affermare che la coerenza interna dell’Asse III risulta solo parziale. Non aver incluso all’interno di tale priorità anche il tema dell’attrattività turistica, infatti, potrebbe precludere in fase di attuazione il perseguimento di un approccio strategico ed integrato in questo ambito, con conseguenze negative sull’efficacia finale degli interventi programmati in termini di portata dei risultati attesi e di loro sostenibilità nel tempo. Occorre anche aggiungere che l’Asse III presenta una proliferazione di obiettivi operativi che determina elevati rischi di duplicazioni rispetto a quanto già previsto all’interno di altre priorità. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 194 In particolare, l’obiettivo operativo 3.1.1 sembra riproporre attività e tipologie di intervento già previste esplicitamente o in maniera implicita all’interno di altri obiettivi dell’asse (è il caso degli interventi nel territorio della rete ecologica in evidente sovrapposizione con quanto previsto dall’obiettivo 3.2.2 o dell’azione di integrazione tra imprenditorialità turistica e risorse culturali, che appare una duplicazione rispetto a quanto previsto dall’obiettivo 3.1.2), mentre alcune azioni dell’obiettivo 3.1.2 risultano a forte rischio di sovrapposizione con le azioni previste dagli obiettivi 5.1.1 e 5.1.3 (è il caso del sostegno alla creazione di nuove attività produttive e del sostegno ai servizi avanzati alle imprese e ai gruppi di imprese). Mentre quelli relativi alla pianificazione paesaggistica e alla riqualificazione dei contesti rurali dovrebbero essere coordinati con l’obiettivo 3.2, per il legame logico con l’obiettivo dello sviluppo della rete ecologica, in vista di un più generale e trasversale obiettivo di riequilibrio territoriale. Con specifico riferimento alla strategia di valorizzazione delle risorse naturali e culturali e di potenziamento dell’attrattività turistica, porre particolare attenzione alla definizione di meccanismi di coordinamento e di gestione operativa in grado di assicurare un approccio integrato al perseguimento degli obiettivi specifici 3.1, 3.2 e 5.3. L’analisi delle allocazioni finanziarie proposte mostra che oltre i 2/3 delle risorse dell’Asse III sono destinati all’obiettivo specifico 3.1 (Valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare l’attrattività dei territori, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti), mentre la quota assorbita dalle categorie di spesa riconducibili all’obiettivo 3.2 (Rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la bio-diversità in un’ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo) è pari al 31% circa. Viene altresi’ sottolineato che in relazione all’obiettivo specifico 3.2 del PO FESR, entrambi gli obiettivi operativi manifestano coerenza con il PRSR. Nello specifico, l’obiettivo operativo 3.2.1 (Rafforzare la valenza e l’identità naturalistica dei territori anche attraverso la diffusione della sensibilità per i temi dello sviluppo sostenibile) appare genericamente coerente con talune misure dell’Asse III del PRSR, mentre l’obiettivo operativo 3.2.2 appare genericamente coerente con talune misure dell’Asse II del PRSR Da una valutazione complessiva emerge che l’Asse III potrà avere una ratio funzionale all’interno del PO solo se il programmatore riuscirà a promuovere e a trasformare contestualmente e sinergicamente la dotazione locale di risorse naturali, paesaggistiche, culturali. Solo così sarà possibile perpetuare una mirata programmazione che vede nella capacità di valorizzare i beni culturali ed ambientali il volano per il radicamento e la diffusione, in ambito regionale, di mirate ed efficaci modalità di sviluppo di medio-lungo termine. Sarebbe stato sicuramente più efficace, per la strategia complessiva dell’Asse III, che il PO avesse considerato all’interno dello stesso, perfettamente integrato, il settore turismo così come previsto dagli orientamenti nazionali. La dimensione ambientale è invece poco presente in altre parti del Programma. Benché citata nella strategia e priorità dell’Asse IV (diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione), l’integrazione delle tematiche energetiche ed ambientali con la programmazione nel campo della ricerca e dell’innovazione non appare sufficientemente esplicitata. Viene suggerito in tal senso di rafforzare i forti legami potenziali tra innovazione tecnologica, efficienza energetica ed innovazioni ambientali, anche con riferimento agli obiettivi operativi dell’Asse IV ed alla possibile introduzione di linee di intervento dedicate a queste tematiche. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 195 La dimensione ambientale è invece poco presente nell’obiettivo specifico 5.3, nel quale il solo obiettivo operativo 5.3.2 prevede delle azioni a valenza ambientale, e le tematiche connesse al turismo sostenibile sono poco declinate e più limitate ad interventi di eco-efficienza impiantistica che all’effettivo sostegno di una strategia ambientale integrata alle attività turistiche. Vanno pertanto meglio esplicitate e rafforzate le importanti connessioni potenziali tra modalità di gestione eco-orientate e contenuti degli obiettivi operativi 5.3.1 e 5.3.2. Va in tal senso sottolineato come le attività di ecoturismo e la eccellente immagine dei distretti turistici sotto il profilo ambientale costituiscono dei fattori di successo già sperimentati in altre parti d’Europa ed anche nel contesto nazionale. Per ciò che concerne le filiere turistiche, la strategia d’Asse appare pertanto da rafforzare con riferimento alle tematiche ambientali, e ciò anche in relazione all’aumento della consistenza percentuale del turismo “verde”. Per quanto riguarda i due obiettivi specifici 5.1 e 5.2 si suggerisce l’opportunità di prevedere criteri di selezione degli interventi in grado di valutare il livello di sostenibilità dei progetti anche in termini di efficienza energetica, tipologia di fonte energetica utilizzata, ed interventi di ecoinnovazione, attribuendo altresì un significativo peso specifico agli stessi nella procedura di selezione. Per l’obiettivo specifico 5.3 si ritiene necessario aggiungere l’impegno all’acquisizione della certificazione ecolabel, allorquando pertinente, per le strutture ricettive turistiche, a garanzia di eccellenza in termini di prestazioni ambientali. Inoltre non appaiono comunque richiamati adeguatamente i contenuti della COM (2005) 718 def. dell’11.1.2006, relativa ad una strategia tematica sostenibile sull’ambiente urbano. La COM suddetta potrebbe essere utilmente ripresa nella individuazione dei criteri di selezione degli interventi, al fine di rafforzarne il contenuto di ecocompatibilità. Infine il valutatore rileva positivamente come gli obiettivi operativi 7.1.3 e 7.1.4 siano permeati di tematiche riconducibili alla sostenibilità ambientale e all’ecoefficienza. Per rafforzare le azioni di governance, si suggerisce comunque di introdurre tra le linee di attività previste nell’obiettivo operativo suddetto la realizzazione di database ambientali, con particolare riferimento alla batteria di indicatori prevista dagli “EU environment related indicators” da rilevare e monitorare nel territorio regionale. Tale batteria di indicatori può utilmente integrare la relazione dello stato dell’ambiente della Sicilia e può parimenti consentire un confronto comparato con il trend e con le prestazioni ambientali dell’Unione Europea. Indicativa è comunque una delle considerazioni finali contenute nella Valutazione Ex Ante del PO FESR 2007/2013 laddove si afferma che la prova finale di coerenza sarà data da una definizione più puntuale, in fase di prima attuazione, di aspetti attualmente appena delineati dal Programma (criteri di selezione e declinazione territoriale degli intervenuti). Nell’esame del PO FESR 2007/2013 appare utile tenere presente anche i risultati della Valutazione Ambientale Strategica ed i suoi riflessi operativi sul PO FESR. Occorre pero’ dire che tale documento è meno ricco di dati, spunti di riflessione, suggerimenti e proposte rispetto alla VAS sul PSR. In base alla Direttiva Comunitaria 42/2001/CE sulla “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, la procedura di VAS si pone nell’ambito delle iniziative volte al rafforzamento degli strumenti finalizzati a garantire la sostenibilità ambientale dello sviluppo regionale ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, integrando la Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 196 dimensione ambientale nel PO lungo tutto il processo (comprese le fasi di attuazione e gestione). Operativamente la VAS sul PO FESR è stata sviluppata in riferimento ai seguenti principi: - integrazione di considerazioni ambientali nella fase di elaborazione del programma; - applicazione di procedure valutative nella fase di redazione programma relative agli effetti significativi sull’ambiente e ai possibili scenari alternativi; Complessivamente sono stati ritenuti adeguati gli indicatori prescelti e le misure di monitoraggiopreviste. La scelta ha privilegiato un set di indicatori costituito in prevalenza da parametri già monitorati dall’ARPA negli anni precedenti e ciò dovrebbe consentire, nel lasso temporale di attuazione del PO, di valutare il trend evolutivo con buona efficacia. Considerato che nel documento relativo al monitoraggio si evidenzia la possibilità di integrare ulteriormente gli indicatori descrittivi qualora si presenti la necessità di ridefinire le tematiche connesse alla sostenibilità, si suggerisce di integrare e monitorare la batteria di indicatori prevista con gli “EU environment related indicators” a scala regionale. Tale batteria di indicatori può utilmente integrare la relazione dello stato dell’ambiente della Sicilia e può parimenti consentire un confronto comparato con il trend e con le prestazioni ambientali dell’Unione Europea. Nella tabella che segue si suggeriscono, a livello indicativo, alcuni criteri di premialità e/o di mitigazione/compensazione per incrementare la sostenibilità ambientale del programma. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 197 Assi e obiettivi specifici del P.O. FESR Suggerimenti per la mitigazione, compensazione, criteri per l’integrazione degli aspetti ambientali, criteri di premialità Asse 1 - Reti e collegamenti per la mobilità 1.1: Completare, qualificare funzionalmente e potenziare le rete di trasporto ferroviaria e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di migliorare l’accessibilità ed accrescere la competitività del territorio. 1.2: Accrescere la dotazione e la funzionalità dei nodi infrastrutturali in grado di favorire l’intermodalità e l’ottimale trasporto delle merci e delle persone, con particolare attenzione alla specificità insulare del territorio. 1.3 - Ridurre la mobilità con mezzo proprio nelle aree urbane, completando e potenziando i sistemi di trasporto pubblico di massa delle aree metropolitane Interventi volti alla predisposizione di piani di mobilità sostenibile e alla loro realizzazione Interventi mirati a ridurre i livelli di incidentalità delle reti di trasporto attraverso l’attivazione di sistemi di sicurezza. Interventi mirati ad aumentare il ricorso, nei flussi di traffico passeggeri e merci, di modalità di trasporto collettivo Interventi mirati a ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento atmosferico ed acustico attraverso il raggiungimento di specifici target di riduzione del traffico veicolare privato verificabili con l’adozione di sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati. Interventi finalizzati all’introduzione di soluzioni innovative nell’organizzazione della logistica dei sistemi di trasporto funzionali al contenimento dei consumi energetici da combustibili fossili e delle emissioni in atmosfera Interventi per lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico a basse emissioni inquinanti in atmosfera Interventi finalizzati a mitigare gli impatti ambientali delle reti di trasporto che attraversano i territori di pregio naturalistico ed elevata rilevanza ambientale Azioni di mitigazione degli impatti causati dalle infrastrutture (trasporti) sulla fauna, quali ecodotti e ponti faunistici, tunnel per la piccola fauna, sottopassi, recinzioni dedicate e installazione di sagome anticollisione su pannelli fonoassorbenti, ecc. Gli interventi devono prevedere se necessario azioni di consolidamento di scarpate e ripristino della copertura vegetale, di regimazione idrica con tecniche d’ingegneria naturalistica, e la riqualificazione delle aree interessate dai lavori di cantiere Interventi finalizzati a sviluppare piani e/o programmi di mobilità ecosostenibili (percorsi ciclabili e pedonali green way) nelle aree della rete natura 2000 Interventi che prevedono specifiche misure di mitigazione per la tutela di aree umide e dei corpi idrici se ricadenti o prossimi alle aree d’intervento. Asse 2 - Uso efficiente delle risorse naturali 2.1 - Promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la razionalizzazione della domanda di energia, adeguare e monitorare gli impianti di produzione e le reti di distribuzione. Interventi che garantiscono il raggiungimento di specifici target di riduzione delle emissioni dei gas serra e che prevedano un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti 2.2 - Completare gli investimenti infrastrutturali già previsti dalla programmazione vigente, e attuare la pianificazione settoriale e territoriale specie per Interventi volti al conseguimento della certificazione energetica degli edifici pubblici Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 198 Assi e obiettivi specifici del P.O. FESR conformarsi alla normativa ambientale nel settore idrico ed in particolare per favorire il raggiungimento della Direttiva CE 2000/60 2.3 - Attuare la pianificazione nel settore forestale, ambientale e del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale. 2.4: Migliorare l’efficienza nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di un tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e promuovendo interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di grande impatto Suggerimenti per la mitigazione, compensazione, criteri per l’integrazione degli aspetti ambientali, criteri di premialità Interventi che prevedono la riduzione dei livelli d’inquinamento dei corpi idrici. Interventi finalizzati a ridurre la percentuale di popolazione esposta a rischio idrogeologico e di desertificazione basati su tecniche di ingegneria naturalistica. Interventi che prevedono azioni di prevenzione del rischio industriale rilevante in aree di particolare criticità ambientale Progetti finalizzati al raggiungimento di determinate performance/target di raccolta differenziata anche attraverso interventi sperimentali finalizzati ad utenze determinate o ad aree campione Raggiungimento di determinate performance di riduzione della quantità e pericolosità di sostanze inquinanti emesse in atmosfera dal settore energetico. Interventi e/o programmi mirati all’introduzione di Ecoinnovazioni per il contenimento della produzione di rifiuti anche atrraverso il riciclaggio Interventi di riqualificazione e bonifica ambientale di siti contaminati da discariche che contribuiscono a ridurre in maniera rilevante i livelli d’inquinamento ambientale nelle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale e/o nelle aree di particolare rilevanza ambientale Interventi che prevedono azioni di miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici (es fitodepurazione) Interventi di riqualificazione e bonifica ambientale di siti contaminati che contribuiscono a ridurre in maniera significativa i livelli d’inquinamento ambientale in aree di rilevante pregio ambientale e/o paesaggistico Interventi di recupero di aree umide ed ambiti fluviali Interventi che prevedono azioni di riqualificazione delle aree costiere Interventi di monitoraggio mirati a migliorare il quadro conoscitivo del rischio idrogeologico e di desertificazione Interventi di riqualificazione e bonifica ambientale di siti contaminati che contribuiscono a ridurre in maniera rilevante i livelli d’inquinamento ambientale in aree di rilevante pregio ambientale e/o paesaggistico Interventi che prevedono l’incremento della popolazione servita da servizio fognario depurativo con priorità alle aree maggiormente critiche per popolazione equivalente servita/ provincia/comune Interventi che prevedono azioni per prevenire processi di salinizzazione e/o inquinamento delle falde idriche Misure specifiche di mitigazione dell’impatto ambientale adottate per la realizzazione e/o ampliamento degli impianti Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 199 Assi e obiettivi specifici del P.O. FESR Suggerimenti per la mitigazione, compensazione, criteri per l’integrazione degli aspetti ambientali, criteri di premialità Interventi per incrementare il risparmio idrico che prevedono sistemi di monitoraggio e conoscenza delle performance conseguite. Asse 3 - Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività e lo sviluppo 3.1: Valorizzare i beni e le attività culturali per Processi di aggregazione di imprese che prevedono aumentare l’attrattività dei territori, per rafforzare la ecoinnovazioni finalizzate ad incrementare l’efficienza coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei energetica, a ridurre le emissioni in atmosfera derivanti residenti dai consumi energetici con particolare riguardo ai gas serra e/o all’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili 3.2 Rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta Interventi di recupero e riqualificazione che adottano naturalità e conservando la bio-diversità in un’ottica di criteri di edilizia sostenibile sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo Interventi che prevedono la certificazione energetica degli edifici esistenti Interventi mirati all’introduzione di Eco-innovazioni di processo e di prodotto per il contenimento delle pressioni ambientali (risparmio idrico ed energetico, riduzione emissioni in atmosfera e produzione di rifiuti) Acquisizione di certificazioni ambientali a livello di marchio di area Imprese o sistemi d’imprese che posseggono o si impegnano a conseguire certificazione/gestione ambientale (ISO 14001-EMAS) e/o certificazioni di prodotto (es Ecolabel). Estendere le azioni di valorizzazione anche al patrimonio culturale e naturalistico del mare, nonché alle attività tradizionali della pesca. Estendere le azioni di ricerca per la conservazione del patrimonio culturale anche alla biodiversità in coerenza con il Sesto programma d’azione per l’ambiente della Comunità europea (COM/2001/0031). Asse 4 - Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione 4.1: Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema pubblico della ricerca e imprese private favorendo la cooperazione e il trasferimento tecnologico prevalentemente nell’ambito di distretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre innovazioni presso le PMI, i consorzi di imprese e i distretti produttivi 4.2: Potenziare attraverso l’utilizzo delle TIC la capacità competitiva del sistema delle PMI e allargare i benefici per i cittadini derivanti dalla diffusione delle TIC Interventi di ricerca finalizzati a migliore le conoscenze sulle ricadute sanitarie dovute a fattori d’inquinamento ambientale con riguardo particolare alle aree urbane ed industriali. Interventi di ricerca finalizzati a ridurre la quantità e la pericolosità delle sostanze chimiche utilizzate nei cicli produttivi. Interventi di ricerca finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto funzionali a ridurre la produzione e pericolosità di rifiuti e/o ad ottimizzare i sistemi logistici delle filiere di riciclaggio Servizi telematici finalizzati a ridurre gli spostamenti per l’acquisizione di prestazioni erogate dai sevizi pubblici Interventi finalizzati allo sviluppo di materiali Bio innovativi facilmente biodegradabili (es bioplastiche ) Sviluppo di servizi innovativi che utilizzano TIC a Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 200 Assi e obiettivi specifici del P.O. FESR Suggerimenti per la mitigazione, compensazione, criteri per l’integrazione degli aspetti ambientali, criteri di premialità supporto delle filiere di riciclaggio dei rifiuti e/o della gestione delle risorse idriche Interventi di ricerca finalizzati a migliorare i sistemi di monitoraggio e di valutazione dello stato qualiquantitativo degli ecosistemi e/o introdurre tecniche ecoinnovative per la riqualificazione ambientale Interventi di ricerca finalizzati a migliorare le performance ambientali per i servizi pubblici essenziali Programmi di ricerca finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti da trasporti Programmi di ricerca finalizzati a ridurre i consumi energetici nell’edilizia residenziale Programmi di ricerca funzionali al riuso delle risorse idriche nelle aree urbane Progetti che prevedono collaborazioni/cooperazioni con Imprese o sistemi di imprese con certificazioni/gestioni/ ambientali (ISO 14001-EMAS) e/o certificazioni di prodotto (es Ecolabel) Programmi di ricerca per l’utilizzazione di fonti rinnovabili e risparmio energetico Asse 5 - Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali e del turismo 5.1: Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo sviluppo di distretti e la formazione di gruppi di imprese, facilitando l’accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni esistenti con la riqualificazione delle aree industriali e produttive, in un’ottica di miglioramento della qualità e della competitività complessiva del sistema delle imprese 5.3: Rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano attraverso l’ampliamento, la riqualificazione e la diversificazione dell’offerta turistica ed il potenziamento di investimenti produttivi delle filiere turistiche Interventi che prevedono l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto per l’incremento dell’ efficienza energetica e/o l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili Processi di aggregazione di imprese che prevedono ecoinnovazioni finalizzate ad incrementare l’efficienza energetica, a ridurre le emissioni in atmosfera derivanti dai consumi energetici con particolare riguardo ai gas serra e/o all’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e/o al riciclaggio dei rifiuti. Acquisizione della certificazione energetica degli edifici esistenti Interventi mirati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto per la riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti Interventi mirati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto per il risparmio idrico ed il riuso Progetti corredati da misure di minimizzazione degli impatti del cantiere Interventi mirati a promuovere modalità di turismo eco sostenibile Interventi mirati a conseguire elevati standard di qualità ambientale nell’offerta recettiva Imprese o sistemi d’imprese che posseggono o si impegnano a conseguire certificazione/gestione ambientale (ISO 14001-EMAS) e/o certificazioni di Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 201 Assi e obiettivi specifici del P.O. FESR Suggerimenti per la mitigazione, compensazione, criteri per l’integrazione degli aspetti ambientali, criteri di premialità prodotto (es Ecolabel). Asse 6 - Sviluppo urbano sostenibile 6.1: Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e nei medi centri 6.2: Creare nuove centralità e valorizzare le trasformazioni in atto nelle città, realizzando nuovi poli di sviluppo e identità locali a rilevanza urbana Interventi mirati a ridurre o a minimizzare l’inquinamento luminoso e acustico dei centri urbani. e/ a ridurre o a minimizzare i consumi energetici per l’illuminazione dei centri urbani Acquisizione della certificazione energetica degli edifici pubblici esistenti Interventi di recupero e riqualificazione che prevedono l’utilizzazione di Fonti di energia rinnovabili e/o mirati all’incremento dell’efficienza energetica del settore edilizio Interventi volti a sviluppare sistemi innovativi di trasporto pubblico a basse emissioni inquinanti Progetti inseriti in piani integrati di mobilità sostenibile Interventi finalizzati ad introdurre innovazioni funzionali per l’incremento dell’ efficienza energetica e/o all’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nell’ambito dei servizi pubblici Progetti corredati da misure di minimizzazione degli impatti del cantiere Interventi mirati al raggiungimento di definite performance di raccolta differenziata e di alimentazione di filiere di riciclaggio nella gestione dei servizi pubblici urbani Interventi mirati al raggiungimento di definite performance di risparmio idrico ed al riuso Interventi che prevedono di incrementare la dotazione di verde pubblico/ in ambito urbano Interventi mirati al recupero di aree degradate per la realizzazione di parchi e giardini pubblici e/o funzionali allo sviluppo di corridoi ecologici Interventi che prevedono servizi collettivi a basso impatto ambientale Interventi mirati alla conservazione e recupero di parchi e giardini di rilevanza storica e culturale. Imprese o sistemi d’imprese che si impegnano a conseguire certificazione/gestione ambientale (ISO 14001-EMAS) e/o certificazioni di prodotto (es Ecolabel). Asse 7 - Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica 7.1: Rafforzare le capacità tecniche di gestione del territorio e la capacità di amministrare Azioni che impegnano le Amministrazioni pubbliche a determinate performance di green pubblic procurament Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 202 Assi e obiettivi specifici del P.O. FESR Suggerimenti per la mitigazione, compensazione, criteri per l’integrazione degli aspetti ambientali, criteri di premialità Azioni che prevedono la formazione del personale delle P.A. sulla V.A.S. Per quanto l’impatto ambientale che azioni ed interventi promossi dal PO FESR possono determinare, il documento di VAS si limita a segnalare che l’incertezza e la reversibilità degli impatti sono da correlare da un lato, alla qualità e alle modalità di realizzazione delle azioni svolte in relazione del contesto ambientale interessato e dall’altro agli effetti degli interventi previsti dai Piani e Programmi di settore che hanno refluenze sul territorio regionale. Le indicazioni di mitigazione e di compatibilità ambientale del programma possono incrementare l’efficacia ambientale dello stesso nella fase di attuazione. Tali modifiche riguarderanno la fase di stesura dei documenti attuativi (bandi pubblici, ecc.), contenenti una serie di elementi che possono decisamente incrementare l’efficacia ambientale del Programma. In ogni caso nel Rapporto Ambientale è indicata la necessità di selezionare e finanziare interventi in accordo agli strumenti di pianificazione vigente e tale indicazione è stata recepita con una formulazione correttamente rigorosa dal PO FESR 2007-2013 che prevede il non finanziamento di interventi all’interno di SIC e ZPS sino a quando non saranno operativi i relativi Piani di Gestione. Ulteriori considerazioni conclusive riguardano l’idoneità del programma a perseguire gli obiettivi complessivi posti dalla rete Natura 2000. Dalla territorializzazione della spesa emerge che l’attenzione a questi territori è più nominale che reale. Se si guarda agli indicatori di realizzazione edi risultato dell’ASSE III il quadro è ancora più sconfortante come dimostrano le tabelle seguenti: Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 203 Inoltre non appare esserci stato un serio approfondimento di gran parte dei fallimenti della precedente programmazione in materia di Rete Ecologica e sui correttivi necessari in termini attuativi. Il ritardo dell’attuazione delle misure della rete ecologica (Misure 1.11, 1.12 e 1.13) ha determinato ad oggi la mancanza di strumenti di pianificazione dei siti Natura 2000. Con la misura 1.11 si è finanziata la realizzazione della Carta della Natura (che fornisce i primi strumenti di conoscenza del territorio regionale - cartografie, schede Natura 2000 aggiornate, schede relative alle aree di studio revisionate) ma che non viene utilizzata a fini pianificatori e Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 204 di verifica di compatibilità nell’ambito delle procedure autorizzatori, mentre non è ancora presente un sistema informativo georeferenziato. La valutazione di efficacia e coerenza sul Programma in alcuni ambiti non appare supportata da dati concreti in quanto quelli resi disponibili dal sistema di monitoraggio appaiono molto parziali e non consentono di svolgere una verifica complessiva da cui trarre indicazioni puntuali. Emerge con forza l’assenza della dimensione ambientale negli obiettivi operativi e nelle azioni contenute in altri obiettivi come l’obiettivo specifico 5.3, nel quale il solo obiettivo operativo 5.3.2 prevede delle azioni a valenza ambientale, e le tematiche connesse al turismo sostenibile sono poco declinate e più limitate ad interventi di eco-efficienza impiantistica che all’effettivo sostegno di una strategia ambientale integrata alle attività turistiche. Va in tal senso sottolineato come le attività di ecoturismo e la eccellente immagine dei distretti turistici sotto il profilo ambientale costituiscono dei fattori di successo già sperimentati in altre parti d’Europa ed anche nel contesto nazionale. La strategia d’Asse sulla filiera turistica andrebbe rafforzata con riferimento alle tematiche ambientali, e ciò anche in relazione all’aumento della consistenza percentuale del turismo “verde”. La ripartizione delle risorse in favore della Rete Ecologica, che riguarda in gran parte territori rurali ed aree marginali, non è per nulla adeguata alle necessità del settore, anche se si deve tenere conto del fatto che il Piano Regionale di Sviluppo Rurale, destina, non in piena armonia con il Programma FESR, risorse specifiche alla promozione delle risorse naturali. In conclusione, anche in relazione all’articolazione del piano finanziario, si formula un’ampia riserva sulle reali possibilità contenute nel PO FESR Sicilia 2007/2013 di sostenere un intervento di portata strategica per diminuire la perdità di biodiversità e per valorizzare i Siti Natura 2000 nell’ambito delle politiche sullo sviluppo rurale, dando attuazione alle previsioni dei Piani di Gestione. Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2006-2011 e Piano di Azione per la Lepre italica In Sicilia non esiste una tradizione di pianificazione e gestione del patrimonio faunistico e di programmazione del prelievo venatorio, in funzione della consistenza e dinamica delle specie cacciabili. Anche tutta la parte programmatica e pianificatoria prevista dalla normativa (LR 33/97) non è stata concretamente attuata, basti pensare che gli ATC-Ambiti Territoriali di Caccia non sono stati mai attivati come sistema di gestione partecipata (cacciatori, ambientalisti, agricoltori, tecnici) pur essendo previsti dalla legge regionale 33/97 e prima ancora dalla legge 157/92. In questo contesto si colloca il piano faunistico venatorio regionale. Quello vigente (2006-2011) è stato approvato in via provvisoria dalla Regione, senza la preventiva procedura di VAS e VI solo al fine di dare avvio alla stagione venatoria del 2007 e non è stato mai pubblicato sulla GURS (a differenza del precedente piano). Il piano regionale faunistico-venatorio assume come obiettivo il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, anche attraverso misure di protezione e salvaguardia delle specie di mammiferi ed uccelli minacciati di estinzione ed il recupero ai fini faunistici di aree degradate. Il Piano regionale faunistico-venatorio descrive gli ambiti sub regionali, denominati ‘aree omogenee’ . Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 205 I comprensori omogenei così individuati fungono da riferimento territoriale, rappresentando gli ambiti entro cui l’azione delle ripartizioni faunistico-venatorie si svolge per tutti i programmi faunistici ed i piani di miglioramento ambientale. La pianificazione territoriale destina a “protezione della fauna” la quota del 25% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia. Stabilisce poi che sino ad un massimo del 15% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, il territorio è destinato a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. All’interno di questa percentuale viene operata una ulteriore riserva destinando il 50% di tale superficie, corrispondente al 7,5% del territorio agro-silvo-pastorale (ASP) provinciale, alle aziende agro-venatorie; il 25%, corrispondente al 3.75% del territorio ASP provinciale, alle aziende faunistiche-venatorie ed il restante 25%, corrispondente all’altro 3.75% del territorio ASP provinciale, ai centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti di fauna a scopo di ripopolamento. Il territorio ASP provinciale in cui vige il divieto di caccia per fini di protezione non raggiunge la quota del 25%. Il Piano prevede incredibilmente che il calendario venatorio dovrà individuare annualmente, all’interno di una o più zone protette, un’area dell’estensione pari alla quota eccedente il 25% del territorio ASP protetto della provincia o dell’isola minore interessata, in cui, per quell’annata, è possibile effettuare il prelievo venatorio. Si fa rilevare la necessità di estendere al più presto la porzione di territorio sottoposto a protezione nelle province dove non è stato raggiunta ancora la quota del 25% prevista dalla norma. Tra le principali rotte di migrazione sono state anche individuate quella della Sicilia sud occidentale – Direttrice sud-ovest nord-est (dalle Pelagie a Termini Imerese) ed a ovest, dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: Capo Feto, Santa Ninfa, Roccamena, Marineo, S.Nicola l’Arena, che investe in pieno il SIC in esame unitamente al vicino sito della Grotta di Entella. L’indice medio di densità venatoria, determinato con DDG 582 del 07/04/2003, valido fino al 2008, è pari a 0.0218 cacciatori/ettaro, corrispondente a 45.96 ettari/cacciatore. La densità venatoria massima dovrebbe essere rapportata non alla superficie dell’ambito e al numero di cacciatori residenti ma alle capacità di carico dei territori in funzione della consistenza e dinamica delle popolazioni faunistiche. Per questo il Piano di Gestione deve servire a razionalizzare anche il prelievo venatorio, con particolare attenzione all’esercizio della migratoria che di fatto oggi è libero su tutto il territorio regionale. Si sono inoltre delimitati 18 ambiti subprovinciali tra cui l’ambito territoriale di caccia Trapani 2 che comprende Santa Ninfa. Il piano regionale faunistico venatorio deve operare nella attuazione di interventi atti a favorire la riproduzione naturale della fauna adeguati alla realtà del territorio regionale. La legge regionale n. 33/97 inoltre prevede la predisposizione e l’attuazione di piani ed iniziative di miglioramento ambientale ai fini faunistici da parte delle Ripartizioni faunistico venatorie. Specifici interventi devono riguardare con priorità la coturnice siciliana, la lepre ed il coniglio siciliano nei comprensori omogenei vocate per le dette specie. Gli interventi diretti a queste specie e riguardanti le aree incluse negli ambiti territoriali di caccia di norma rientreranno nei programmi di gestione degli stessi ambiti. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 206 Le azioni di miglioramento degli habitat hanno come obiettivo indiretto quello di migliorare le dinamiche demografiche delle specie precedentemente indicate. Relativamente ad esempio alla Coturnice, in considerazione dell’andamento della popolazione, rilevato in diminuzione per il periodo 1984/92, gli interventi di miglioramento ambientale degli habitat in cui vive hanno priorità assoluta di finanziamento. La sua alimentazione comprende leguminose ed in particolare cicerchia e veccia, di cui consuma semi e foglie; amilacee (smilace o salsapariglia nostrale); convolvulacee (vilucchio) e umbellifere (coriandolo selvatico) di cui vengono consumati i semi. Consuma anche bulbi di liliacee, tuberi di ciclamino e rizomi di acetosella. Si ciba di numerose specie di artoprodi, fra cui assumono particolari importanza gli insetti e fra questi le formiche e diverse specie di coleotteri. Negli areali di elezione della coturnice si dovrebbero quindi: incentivare delle colture a “perdere”, cioè semina e rinuncia alla raccolta su parcelle di piccola estensione di coltivazioni appetita alla coturnice; incrementare e/o conservare superfici ad incolto cespuglioso intercalato alle coltivazioni; creare punti di alimentazione e di abbeveratura artificiali e/o posatoi e dormitori artificiali; posticipare lo sfalcio e l’aratura o l’interramento delle stoppie. Inoltre, durante le operazioni di sfalcio e di raccolta dei foraggi, si dovrebbe partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga con ridotta velocità delle macchine e lavorazione leggera (non più di 7 cm di profondità), alzando le barre di taglio di almeno 10 cm. dal suolo e prevedendo sistemi di allontanamento del selvatico, attraverso ad esempio l’applicazione delle cosiddette “barre d’involo” sistemate anteriormente agli organi falcianti. Infine si dovrebbero ripristinare e/o conservare dei tradizionali muretti a secco e instaurare apprestamenti per evitare e/o diminuire l’erosione dello strato superficiale, come graticelle con materiale vivente, brigliette in pietrame secco, drenaggi con pietrame, etc. Tali interventi dovranno interessare aree non inferiori a 5 ha. Laddove la specie si è rarefatta, si potrà procedere a reintroduzioni con soggetti forniti dal Centro pubblico di smistamento e riproduzione dei quali sia attestata la caratteristica di autoctonicità genetica. Negli areali di elezione della lepre gli interventi elencati sopra dovranno riguardare una superficie di almeno 0.1-0.4% del territorio interessato e le coltivazioni a perdere dovranno riguardare cereali autunno-vernini o foraggere, in particolare leguminose, mentre non deve essere previsto alcun intervento incrementivo o conservativo di superfici cespugliate ed arbustivi, in quanto la lepre preferisce le siepi, e comunque quelle meno fitte, solo per partorirvi; dovrebbe invece essere previsto l’incremento e/o la conservazione del margine erboso delle bordure di passaggio fra le componenti coltivate, coltivato/bosco, coltivato/margini dei corsi d’acqua, coltivato/siepi frangivento. Per il coniglio, gli interventi dovranno interessare superfici non inferiori a 10 ha. Gli interventi di miglioramento e conservazione dell’habitat per l’avifauna migratoria consistono nel: 1. mantenimento e/o ripristino della vegetazione sia sommersa ed emergente che dei terreni circostanti, attraverso semine e trapianti delle essenze più tipiche; 2. mantenimento e/o ripristino del profilo irregolare, con insenature e anfratti delle rive o degli argini, eventualmente con la creazione di prolungamenti dell’area umida, di prati e radure umidi attorno al bacino principale; 3. mantenimento e/o mantenimento di spiagge, dune, isolotti di ghiaia o di terra e/o zattere galleggianti ancorate al fondo per favorire la nidificazione e la sosta per diverse specie di avifauna favorendovi lo sviluppo della vegetazione; 4. predisposizione di fasce permanenti (20-30 m) di vegetazione spontanea o seminata (avena) come separazione tra i terreni coltivati intensamente e la zona umida; Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 207 Oltre alle specie sopra citate (coturnice, lepre, coniglio) si prevede la possibilità della reintroduzione di specie estinte o di specie rarefatte quali pollo sultano, gallina prataiola e, per i rapaci, nibbio reale, capovaccaio, grifone, che non hanno tuttavia rilevanza per il Sito in esame. Il controllo della fauna viene indicato come di competenza delle ripartizioni faunisticovenatorie. Gli interventi destinati al controllo della fauna per la difesa delle colture agricole sono affidati al coordinamento dell’Osservatorio Faunistico Siciliano. Questi interventi coincidono con quei metodi ecologici richiamati dalla legge per tutte le operazioni di controllo, e che si concretizzano infatti in tutti quegli apprestamenti che creano barriere fisiche, quali ricovero notturno degli animali domestici, recinzione e reti con particolari accorgimenti antipredatori, repellenti chimici agenti sul sistema olfattivo o gustativo, cannoncini p generatori di suoni anche con versi di allarme e/o acustici, recinzioni elettrificate a tutela dei fondi, nonché nell’alimentazione complementare intesa come offerta di cibo alternativo per allontanare il selvatico dal fondo. Gli interventi di cattura e di abbattimento devono essere effettuati dalle Ripartizioni Faunistico-Venatorie a mezzo del proprio personale, di dipendenti del corpo delle Guardie Forestali e di altri agenti venatori dipendenti da enti pubblici. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali le ripartizioni opereranno a mezzo delle guardie addette ai parchi o alle riserve se presenti, e con i soggetti sopra menzionati, ad esclusione dei proprietari e conduttori dei fondi e delle menzionate guardie volontarie. Gli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole verranno effettuati dalle Ripartizioni Faunistico-venatorie a carico del fondo previsto per il finanziamento dal citato art 7, mentre per gli interventi di controllo per ragioni diverse dalla tutela dell’agricoltura e per la realizzazione dei piani di cattura e di abbattimento si provvederà con il capitolo di spesa che finanzia compiti istituzionali. Il Piano Faunistico Venatorio non è stato sottoposto a preventiva procedura di VAS e VI, e addirittura al suo interno non vengono citati i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale. Pertanto la pianificazione venatoria oggi è in assoluto contrasto con gli obiettivi di realizzazione della Rete Natura 2000. Nell’ambito della pianificazione venatoria e della gestione faunistica appare utile pure il riferimento all’adozione del “Piano d’Azione nazionale per la Lepre italica” redatto dall’INFS nel 2001, che prevede, a livello locale, le seguenti azioni: • aggiornamento delle conoscenze sulla Lepre italica, • pianificazione di una rete ecologica per la conservazione della specie, • promozione e sostegno delle azioni di miglioramento dell’habitat in aree di pianura e bassa collina, • prevenzione degli abbattimenti illegali, • diffusione dei principi della gestione venatoria sostenibile. Norme di polizia forestale La Regione Siciliana possiede da tempo una legislazione avanzata in materia forestale, anche se poi l’attuazione è stata segnata da enormi ritardi e dalla mancata applicazione proprio delle parti innovative (redazione di piani gestione, utilizzo di sole specie autoctone, tutela dagli incendi della vegetazione e non solo dei boschi). Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 208 In questa sede appare utile richiamare l’attenzione su due aspetti della normativa forestale, quella connessa con le prescrizioni di massima e polizia forestale e quelle riguardanti la prevenzione e repressione degli incendi. Sul primo aspetto si ricorda che le norme di polizia forestale attualmente vigenti per la provincia di Trapani sono state adottate con D.A. n. 5 del 20 gennaio 2006 . In via generale non si rilevano grossi profili di contrasto con la tutela del SIC, basti pensare che le stesse sottopongono a divieto di estirpazione i cespugli di Ampelodesma, Sommacco e quelli tipici della macchia mediterranea, anche se molte disposizioni non tengono conto delle “innovazioni culturali e tecniche” in materia di conservazione della natura. Si osserva che, a parte una scarsa applicazione di alcune disposizioni (esercizio del pascolo, modalità di coltivazione dei terreni, uso del fuoco, periodi ed autorizzazioni per i tagli silvocolturali), le prescrizioni di polizia forestale non tengono conto della tutela di alcune specie della flora e degli habitat e dei cicli biologici della fauna selvatica, soprattutto degli uccelli nidificanti; inoltre nell’autorizzazione alla trasformazione dei terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione non vengono tenute in considerazione le necessità di conservazione di habitat e formazioni vegetali di grande interesse conservazionistico, come praterie e incolti in evoluzione. Già la precedente normativa regionale (art. 6 della LR 16/96) prevedeva che le prescrizioni di massima e di polizia forestale venissero definite tenendo conto anche delle esigenze di tutela ambientale. Tale disposizione è contenuta anche nella nuova legge forestale (LR 14/2006) che, all’articolo 8, prevede che le prescrizioni di massima e polizia forestale possano essere aggiornate in qualsiasi momento, se opportuno, ed in sede di prima applicazione della nuova legge entro 180 giorni dalla sua pubblicazione. Il suddetto termine è già scaduto, e comunque tale adeguamento appare oggi necessario e non più rinviabile anche a seguito degli ulteriori approfondimenti e delle previsioni gestionali contenuti nel presente Piano di Gestione. Per quanto riguarda invece gli aspetti connessi con la prevenzione e la repressione degli incendi, la normativa regionale da tempo ha operato un’importante svolta nell’approccio strategico a tale questione, individuando non solo nei boschi ma nella vegetazione l’oggetto delle azioni di tutela. Ciò comporta un profondo mutamento culturale da parte degli operatori ed una completa rivisitazione di assetti organizzativi e prassi gestionali. Anche alla luce dei risultati delle ricerche e delle analisi svolte nell’ambito della redazione del presente Piano di Gestione, emerge la necessità di riorientare l’azione di prevenzione e spegnimento verso formazioni ritenute sino ad oggi minori quali le praterie ad Ampelodesma, le garighe, le formazioni a canneto lungo le sponde dei torrenti. Si impone inoltre un radicale rafforzamento delle azioni finalizzate al costante aggiornamento del catasto degli incendi ed all’applicazione delle sanzioni per l’uso non corretto del fuoco in agricoltura, a partire dal mancato rispetto delle norme sulla condizionalità Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 209 2.3.7 Descrizione del contesto socio-economico (D) Il Sito di Importanza Comunitaria ITA010022 ricade nel territorio dei Comuni di Santa Ninfa e Gibellina, in provincia di Trapani. Il Sito è ubicato nella Valle del Belice, nota per il violento terremoto che nel 1968 devastò l’area causando centinaia di morti, un migliaio di feriti e circa centomila persone senza tetto, distruggendo completamente diversi comuni (Poggioreale, Montevago, Santa Margherita Belice e Gibellina) e danneggiando gravemente i comuni limitrofi. Il terremoto del Belice rappresenta una delle più grandi catastrofi, avvenute in Italia nel dopoguerra, anche a causa del ritardo dei soccorsi, della mancanza di preparazione dello Stato, dei paradossali errori della fase di ricostruzione, dell’emigrazione forzata delle popolazioni e del degrado di chi, rimasto sul luogo, è stato costretto a vivere per anni nelle baracche. Le vicissitudini del dopo-terremoto sono intrise di interessi e speculazioni, cattiva programmazione, mafia e amministrazioni corruttibili. Ingenti furono le somme stanziate dallo Stato per la ricostruzione, intervento straordinario che durò più di 35 anni e che può essere suddiviso in due periodi: un modello di gestione centralizzato fino al 1976 e uno basato sul decentramento dopo la legge n. 178 del 29 aprile 1976. In entrambi i casi non si riuscì ad ottenere risultati efficaci, né si riuscì ad ad individuare i vari e veri responsabili. Dopo il disastro, diversi artisti hanno dedicato le proprie opere per la ricostruzione della zona e per la riqualificazione della vita delle popolazioni. La ricostruzione del Belice è tuttavia il risultato anomalo di una sperimentazione architettonica, del tutto indifferente alle necessità sociali e strutturali del luogo, che non ha rispecchiato affatto i modelli tradizionali della zona e non è stata in grado di rispondere alle esigenze della popolazione. Dal punto di vista socio-economico, il Sito di Importanza Comunitaria ITA010022 è inserito in un comprensorio a preminente economia agricola, situato nella zona interna della provincia di Trapani, che comprende i comuni della Valle del Belice: Vita, Salemi, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Partanna e Castelvetrano. Tutto il comprensorio è caratterizzato da: - rischio sismico e problematiche della ricostruzione scaturite dal terremoto del 1968; - riconversione produttiva in agricoltura, che ha visto negli ultimi venti anni la progressiva sostituzione delle colture cerealicole con le colture viticole e l'affermarsi in particolari zone di altre colture specializzate come l'oliva Nocellara del Belice; - prospettive di sviluppo socio-economico legate all'industria agro-alimentare, al turismo e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Santa Ninfa Il comune di Santa Ninfa conta una popolazione di 5.219 abitanti (dati Comune 2008) ed occupa una superficie di 63,51 kmq nella parte interna della Sicilia occidentale, tra i comuni di Salemi, Calatafimi, Gibellina, Salaparuta, Partanna e Castelvetrano. La densità di popolazione è dunque di circa 82 abitanti per kmq. L'assetto della popolazione sul territorio è caratterizzato dalla presenza di un unico centro abitato; a differenza di quanto accaduto presso altri comuni terremotati, infatti, la ricostruzione non ha dato origine ad un nuovo insediamento, ma è avvenuta nello stesso sito nel vecchio centro, mantenendo quasi integralmente la preesistente configurazione urbanistica e creando, però, un diverso rapporto tra spazi costruiti e spazi liberi. Sono state predisposte all’interno dei lotti vaste aree destinate a posteggi e spazi verdi. Tranne qualche casa patrizia ed alcune chiese che, per la loro importanza storica ed architettonica, sono state ristrutturate, le abitazioni preesistenti al sisma del 1968 sono state demolite. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 210 Il nuovo centro si è sviluppato in direzione sud–est rispetto al centro storico e precisamente nelle contrade di Crispella, Acquanova e Granozzi. Il paese di Santa Ninfa, che prese il nome della santa palermitana protettrice del paese, cominciò a formarsi nel primo decennio del XVII secolo secondo le modalità tipiche di tutti i comuni feudali sorti con il privilegio dello “Ius populandi” (DE STEFANI – PEREZ & ACCARDI, 1987). Nel 1605 il feudo di Rampinzeri fu venduto a Luigi Arias Giardina che iniziò l’opera di popolamento favorendo nuovi insediamenti (specialmente da Palermo, Noto e Mussomeli); nel 1613 ebbe confermata da Filippo III di Spagna la licenza di edificare un nuovo centro che gli era stata concessa fin dal 1609 dal vicerè di Sicilia. Sia il Giardina che i suoi discendenti cercarono quasi tutti “di promuovere lo sviluppo sociale e civile della comunità locale, dal momento che essi di solito stabilivano la loro residenza nel feudo”. Il paese fu dotato, infatti, di numerose chiese, di scuole pubbliche (anche di grammatica latina ed italiana e di aritmetica) e nel ‘700 fu sede di una fiera rinomata, una delle principali della Sicilia; furono selciate le strade e sistemate le sorgenti d’acqua. L’abitato urbano, spinto dall’urgenza di offrire case alla popolazione che aumentava di giorno in giorno, si estese dal nucleo primitivo che occupava la collina “Castello” alle altre due colline “Rocche” e “Croci”. Con la fine delle feudalità Santa Ninfa fu aggregata al Vallo di Trapani e al distretto di Mazara del Vallo e rientrò nella circoscrizione di Partanna, rimanendovi fino al 1843.Dopo l’Unità d’Italia si affermarono tre correnti di opinione (massonica, socialista e cattolica) che influenzarono in maniera determinante la vita sociale del tempo. In particolare, alla corrente cattolica si dovette la fondazione di banche popolari, mentre l'ideale socialista ebbe la sua concreta realizzazione nell'istituzione (1887) della “Società di Mutuo Soccorso Umberto I” e nell’organizzazione dei Fasci dei lavoratori. A Santa Ninfa, subito dopo l’Unità d’Italia, si registrava uno dei più bassi indici di reddito pro capite ed una condizione molto precaria dell’economia. Il secondo dopoguerra ha visto, anche nel paese di Santa Ninfa, un graduale miglioramento della vita economica grazie alla nascita e alla crescita di alcune imprese ed aziende che hanno avuto il merito di offrire un lavoro meno precario ed incerto di quello offerto dall’agricoltura e dall’allevamento. Gibellina Il Comune di Gibellina ha una popolazione di 4.468 abitanti ed occupa una superficie di 45,01 kmq. I comuni contigui sono Castelvetrano, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Poggioreale, Salaparuta. La densità di popolazione è di 99 abitanti per kmq. La localizzazione attuale del paese di Gibellina è dovuta alla ricostruzione post terremoto del 1968: in seguito alla distruzione totale della vecchia Gibellina, il paese è stato ricostruito a 18 km di distanza dal precedente insediamento di origine medievale. La ricostruzione, avvenuta dopo lunghi anni di disagi e difficoltà, è stata pensata secondo le avanguardie architettoniche dell’epoca: una città giardino, costruita come quintessenza del "moderno", caratterizzata dall'ampiezza delle strade, dalla grande distanza tra le abitazioni e tra queste e le vie, con struttura urbanistica caratterizzata dall'alternarsi di strade carrabili e pedonali, con case a schiera dotate di piccolo giardino. Molti abitanti hanno oggi accettato la nuova città, così come realizzata ma in parte trasformata dall’uso quotidiano. Un dato antropologico importante di cui tener conto nel valutare le resistenze all’abbandono della vecchia città in nome della ricostruzione del nuovo è lo svolgimento dell’itinerario delle processioni, che coinvolgono ancor oggi Gibellina Vecchia, non solo la parte nuova. Prima del terremoto Gibellina era una piccola cittadina con poco più di 6.000 abitanti situata a m. 421 sul livello del mare. L'abitato sorgeva sul feudo Busecchio, estendendosi sui cinque colli di Piano di Corte, Santa Caterina, Matrice, Mulino del Vento e del Castello Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 211 Chiaramontano e si estendeva dal torrente Gebbia, a sud, al colle Mulino del Vento, a nord. Da qui lo stemma del paese: una torre su cinque colli. La superficie agraria e forestale era destinata alle coltivazioni erbacee (seminativo, pascoli e prati) e alle coltivazioni legnose (vite, olivo e mandorli) ma il terreno, ricco di argilla e da secoli ormai povero d'acqua, rendeva poco con una conseguente povertà diffusa. La proprietà fondiaria era estremamente frammentata. 2.3.7.1 Demografia (D.9.2) Analizzando i dati e le serie storiche della popolazione residente nei comuni di Santa Ninfa e Gibellina, risulta evidente come entrambi i Comuni hanno mantenuto un numero di residenti abbastanza stabile nel tempo. Dal 1971 al 1981 entrambi registrano un calo della popolazione, mentre nei 10 anni successivi si evince un aumento della popolazione, che risulta essere consistente nel caso di Gibellina mentre di minima entità a Santa Ninfa. Tra il 1991 e il 2001 invece assistiamo ad un decremento della popolazione di Gibellina pari a circa il 7%, mentre più contenuto è il dato su Santa Ninfa, che vede diminuire la propria popolazione di circa il 4 %. Osservando gli andamenti più recenti, tra il 2001 e il 2007 le dinamiche demografiche dei due paesi di differenziano: la popolazione di Gibellina diminuisce ulteriormente, mentre quella di Santa Ninfa aumenta. Popolazione residente per comune e anno Comune 1971 1981 1991 2001 2007 Gibellina Santa Ninfa 4865 5340 4802 5267 5027 5294 4677 5086 4468 5234 Fonte: ISTAT – Dati al 1° gennaio Dall’analisi dei dati ISTAT del 2007 emerge che nel Comune di Gibellina ci sono 1.870 nuclei familiari, con una media di 2,4 componenti a famiglia, mentre nel comune di Santa Ninfa sono presenti 2.107 nuclei familiari, con una media di 2,5 componenti ciascuno. Tale dato risulta essere in linea con quello riferito all’intera provincia di Trapani, che risulta essere di 2,7 componenti per nucleo familiare. Bilancio demografico anno 2007 e popolazione residente al 31 Dicembre - Gibellina Maschi Femmine Totale 2122 2346 4468 Nati 14 17 31 Morti 24 26 50 Saldo Naturale -10 -9 -19 Iscritti da altri comuni 25 30 55 Iscritti dall'estero 7 7 14 Altri iscritti 1 0 1 Cancellati per altri comuni 43 45 88 Cancellati per l'estero 3 2 5 Altri cancellati 0 0 0 Popolazione al 1° Gennaio Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 212 Saldo Migratorio e per altri motivi Popolazione al 31 Dicembre -13 -10 -23 2099 2327 4426 Numero di Famiglie 1870 Numero medio di componenti per famiglia 2.4 Bilancio demografico anno 2007 e popolazione residente al 31 Dicembre - Santa Ninfa Maschi Femmine Totale 2548 2686 5234 Nati 25 20 45 Morti 19 27 46 Saldo Naturale 6 -7 -1 Iscritti da altri comuni 22 30 52 Iscritti dall'estero 16 13 29 Altri iscritti 0 1 1 Cancellati per altri comuni 36 40 76 Cancellati per l'estero 10 8 18 Altri cancellati 1 1 2 Saldo Migratorio e per altri motivi -9 -5 -14 2545 2674 5219 Popolazione al 1° Gennaio Popolazione al 31 Dicembre Numero medio di componenti per famiglia 2.5 (Dati ISTAT) Popolazione residente nel Comune di Santa Ninfa al 1 Gennaio 2007 per età e sesso Eta' Totale Maschi Totale Femmine da 0 a 9 anni Da 10 a 19 anni Da 20 a 29 anni Da 30 a 39 anni Da 40 a 49 anni Da 50 a 59 anni Da 60 a 69 anni Da 70 a 79 anni Oltre 80 anni TOTALE 227 301 300 369 364 320 279 243 145 2548 248 255 298 367 395 320 302 300 201 2686 Maschi + Femmine 475 556 598 736 759 640 581 543 346 5234 (Dati ISTAT) Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 213 Popolazione residente nel Comune di Gibellina al 1 Gennaio 2007 per età e sesso Eta' Totale Maschi Totale Femmine da 0 a 9 anni Da 10 a 19 anni Da 20 a 29 anni Da 30 a 39 anni Da 40 a 49 anni Da 50 a 59 anni Da 60 a 69 anni Da 70 a 79 anni Oltre 80 anni TOTALE 196 208 286 340 275 271 232 195 119 2122 161 219 288 343 301 320 244 294 176 2346 Maschi + Femmine 357 427 574 683 576 591 476 489 295 4468 (Dati ISTAT) Un’analisi maggiormente approfondita è stata effettuata rispetto al Comune di Santa Ninfa. Il dato che emerge dal bilancio demografico fornito dall’ufficio anagrafe del Comune, mostra una popolazione complessiva al gennaio 2008, di 5.219 unità, in leggero calo rispetto all’anno precedente. Dati demografici Comune di Santa Ninfa Totale Femmine 2674 (Comune, 2008) Maschi 2545 (Comune, 2008) Popolazione straniera residente 60 (Comune, 2008) Popolazione minorenne 926 (Istat, 2007) Popolazione straniera minorenne 4 (Comune, 2008) Percentuale 51,24% 48,76% 1,15% 16,64% 0,08% La composizione della popolazione vede una presenza straniera di 60 persone, solo 4 delle quali sono minori, che rappresentano l’1,15% della popolazione. Popolazione residente nel Comune di Santa Ninfa al 1 Gennaio 2007 8170-80 60-69 Età [anni] 50-59 Femmine 40-49 Maschi 30-39 20-29 10-19 0-9 -600 -400 -200 0 200 400 600 Individui Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 214 La piramide dell’età mostra un dato molto simile a quello del resto d’Italia: una popolazione dove il numero degli anziani è notevole, mentre il numero dei bambini non è molto elevato. E’ evidente che la popolazione femminile è numericamente superiore rispetto a quella maschile: il dato non sorprende per quanto riguarda gli anziani, data la maggiore speranza di vita alla nascita delle donne rispetto agli uomini, ma risulta più anomalo nel range che va dai 40 ai 49 anni. Tale dato è probabilmente influenzato dal fenomeno dell’emigrazione, che coinvolge principalmente gli uomini del territorio. 2.3.7.2 Situazione sociale (D.9.5) Santa Ninfa Il Piano di Zona del distretto socio-sanitario n. 54, di cui il Comune di Santa Ninfa fa parte, vede come ente capofila il Comune di Castelvetrano. Redatto ai sensi dell’art. 19 della legge 328/2000, il Piano di Zona rappresenta lo strumento attraverso il quale i Comuni appartenenti al Distretto socio-sanitario n. 54, propongono una serie di interventi ed azioni sociali a favore della collettività, grazie alla collaborazione tra un partenariato allargato (A.U.S.L., Terzo Settore, enti terzi ecc.). Oltre Santa Ninfa sono compresi i seguenti Comuni: Castelvetrano, Salaparuta, Poggioreale, Campobello di Mazara, Partanna. Dall’analisi della documentazione del Distretto si evince che, dal punto di vista sociosanitario, Santa Ninfa non presenta situazioni particolarmente difficili, o particolari, rispetto alla media dei comuni di dimensioni analoghe. A favore delle fasce più deboli l’Amministrazione comunale ha attivato interventi che vanno dalla semplice erogazione di contributi continuativi e straordinari alle famiglie meno abbienti all’implementazione di un progetto per promuovere l’inserimento lavorativo di persone con disagio sociale ed economico. Interventi di tipo sociale attivati dall’Amministrazione Comunale di Santa Ninfa (dati Comune di Santa Ninfa, febbraio 2008) Tipologia d’intervento Numero d’utenza Assistenza continuativa mensile 14 Contributi straordinari 35 Bonus Socio – Sanitario 8 Contributo a sostegno dei canoni di locazione 7 Prestazioni sociali agevolate ai sensi della legge 16 448/98 (assegno maternità) Prestazioni sociali agevolate ai sensi della legge 23 448/98 (assegni al nucleo con 3 minori) Progetto Auxsilia (area povertà)* 5 *il progetto Auxsilia è un servizio civico di solidarietà volto al contrasto della povertà con la concessione di contributi, attraverso l’inserimento lavorativo di persone con disagio sociale ed economico. Con l’aiuto dei Volontari del Servizio Civile, si attuano interventi quali Laboratori ludicoricreativi per 5 diversamente abili, allo scopo di favorirne l’autonomia personale e l’integrazione sociale, insieme ad un servizio di disbrigo pratiche e compagnia per 25 anziani, con l’obiettivo di diminuire il grado di solitudine ed aiutarne l’autonomia. Per quanto riguarda la scuola, due sono gli Istituti presenti a Santa Ninfa: l’Istituto Comprensivo “L.Capuana” e l’IPSIA - Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 215 L’Istituto Autonomo Comprensivo “L. Capuana” comprende le Scuole dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado. Tutte le strutture constano di spazi molto ampi, luminosi, funzionali, dove è possibile promuovere attività “strutturate”, ludiche e sportive. Ogni edificio è dotato di locali adibiti a cucina e mensa. Gli utenti del servizio di refezione scolastica sono stati 470 nell’anno scolastico 2007/2008. Sono invece 480 gli alunni che fruiscono del servizio scuolabus ed è presente anche un servizio scuolabus per portatori di handicap. Questi elementi hanno favorito la frequenza assidua e quasi totale degli alunni in età dell’obbligo, rendendo insignificante il fenomeno della dispersione scolastica: come risulta infatti dai dati della tabella sotto riportata, non ci sono evasioni dall’obbligo scolastico, gli abbandoni sono solamente 3 alla scuola secondaria di primo grado, non vi sono prosciolti ed il numero degli alunni non ammessi è complessivamente pari a 16. L’Indice Dispersione Scolastica Globale (I.D.S.G), ricavato sommando il numero di evasori, di abbandoni, di prosciolti e non ammessi è notevolmente basso, pari a 0,82% nella scuola primaria mentre è pari al 9,88% nella scuola secondaria di primo grado. Dispersione Scolastica Comune di Santa Ninfa A.S. 2006/2007 SCUOLA PRIMARIA SCUOLE S. NINFA Ist. Comprensivo "L. CAPUANA" ISCRITTI EVASORI ABBANDONI PROSCIOLTI NON AMMESSI I.D.S.G. N° N° % N° % N° % N° % N° % 243 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,8 2 0,82 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCUOLE S. NINFA Ist. Comprensivo "L. CAPUANA" ISCRITTI EVASORI ABBANDONI PROSCIOLTI NON AMMESSI I.D.S.G. N° N° % N° % N° % N° % N° % 172 0 0,0 3 1,7 0 0,0 14 8,1 17 9,88 Fonte: M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Osservatorio prevenzione Dispersione Scolastica e promozione successo formativo Secondo l’analisi riportata all’interno del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Capuana, la Scuola dell’Infanzia è frequentata dalla quasi totalità dei bambini con risultati più che soddisfacenti sia dal punto di vista della socializzazione che da quello dello sviluppo cognitivo. Ciò crea tutti i presupposti per il successo scolastico nella Scuola Primaria. L’IPSIA - Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato, che dall’anno scolastico 1998/1999 fa parte dell’Istituto “F. D’Aguirre” di Salemi, è l’unica Scuola Secondaria Superiore presente a Santa Ninfa. All’IPSIA convergono ragazzi di tutta la Valle del Belice per il conseguimento del titolo di Operatore Elettrico e Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche. Dall’analisi socio–culturale effettuata dall’Istituto si evince che i giovani fruiscono di ottime possibilità di scolarizzazione e di sano impiego del tempo libero. Nonostante questa condizione, da una osservazione della realtà, supportata da dati forniti dai Servizi Sociali del Comune, emergono alcuni casi di adolescenti avvezzi all’alcool e all’uso di sostanze stupefacenti, più o meno leggere, oltre a sporadici casi di vandalismo volti al danneggiamento di arredi urbani e strutture pubbliche. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 216 Poiché nel Comune di Santa Ninfa è presente un'unica Scuola Secondaria Superiore, sono numerosi i giovani che si recano in altri Comuni per completare gli studi. Per agevolare quest’opzione, e renderla accessibile a tutti, il Comune ha attivato un servizio che concede un rimborso spese. Il numero di beneficiari di tale contributo è stato di 215 nell’A.S. 2007/2008. Va sottolineato che questo dato non esaurisce il numero di giovani che proseguono gli studi dopo il conseguimento del diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado in altri Comuni, in quanto non tutti gli aventi diritto fanno richiesta del rimborso spese al Comune. Il tasso di scolarità è definito dal rapporto tra il numero di iscritti nelle scuole e il numero di giovani nell'età tipica per tali scuole. Nell'interpretazione dei dati ottenuti, riportati nella seguente tabella, occorre tenere presente che: 1. gli iscritti possono avere età differenti dal quelle usate come riferimento (ad esempio im caso di bocciature); 2. gli iscritti non necessariamente sono anche residenti e alcuni dei residenti potrebbero essere iscritti in altri sistemi d'istruzione sia della stesso territorio (p.es. pur essendo in età da scuola media potrebbero essere ancora iscritti in una scuola elementare) che di un altro territorio (p.es. potrebbero frequentare una scuola nell'unità territoriale confinante); 3. l'iscrizione non implica la frequenza delle lezioni; 4. in presenza di obbligo scolastico e bassissima evasione dell'obbligo stesso il tasso di scolarità supera praticamente sempre il valore del 100%; 5. in presenza di fenomeni migratori che coinvolgono giovani in età scolastica vi possono essere differenze dovute al fatto che i giovani vengono iscritti a scuola molto prima che vengano registrati tra la popolazione residente; 6. in presenza di una insufficiente offerta scolastica vi può essere un importante fenomeno di pendolarismo scolastico, per cui il numero di giovani residenti che si iscrive in una scuola di un'altra zona può causare un notevole abbassamento del tasso di scolarità. COMUNE DI SANTA NINFA POPOLAZIONE NUMERO GRADO DI TASSO DI FASCE ETA’ RESIDENTE AL ALUNNI ISTRUZIONE SCOLARITÀ 1° GENNAIO 2007 A.S. 2006/2007 6 – 10 anni Scuola primaria 242 243 100,41% Scuola secondaria di 11 – 13 anni 169 172 101,77% primo grado Scuola secondaria di 14 – 18 anni 264* 84* 31,82% secondo grado Rielaborazione dati ISTAT e M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia *Dato riferito al 2003 Sulla base delle considerazioni sopra riportate, è possibile osservare, relativamente al Comune di Santa Ninfa, per la scuola primaria e quella secondaria di primo grado, la presenza di un indice superiore al 100% contro un indice pari a circa il 32% nella scuola secondaria di secondo grado, verosimilmente dovuto al fenomeno migratorio che riguarda i giovani che scelgono indirizzi diversi rispetto all'offerta presente nel Comune. Nel territorio di Santa Ninfa operano da anni numerose associazioni di volontariato che hanno avuto notevole importanza nell’offrire risposte alle diverse esigenze della popolazione e nel promuovere la cultura della donazione, della solidarietà e della responsabilità: Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 217 - - L’AVIS, fondata nel 1977, ha un centro di caccolta fisso e a livello provinciale si colloca come il centro più efficiente, registrando un indice percentuale di donazioni in rapporto al totale di abitanti dei comuni trapanesi pari al 25,66%, con 140 donatori. L’AIRC opera a Santa Ninfa grazie ad alcuni volontari ed è divenuta recentemente punto di riferimento per i comuni di Salemi e Gibellina. L’AIDO, fondata nel 1995 con l’adesione di 30 associati, in questi ultimi anni ha avuto un notevole incremento raggiungendo più di 125 iscritti, quasi tutti giovani. Il Gruppo Scout di Santa Ninfa (Agisci) vanta una esperienza trentennale ed è impegnata in un’attività di formazione di ragazzi e ragazze. Attualmente il Gruppo Scout di S. Ninfa è impegnato a favore degli anziani e ammalati del paese, a favore dei ragazzi della “Casa della Fanciulla”, dei disabili dell’Oasi di Torretta e dell’AIAS. La Sezione di Santa Ninfa dei Reduci e Combattenti e l’Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra riunisce molti anziani. L’associazione “Padre Giacomo Cusmano” collabora nella gestione di case d’ospitalità e attività sociali diverse. Il Corpo Nazionale di Protezione Civile – sezione di Santa Ninfa, oltre ad occuparsi delle classiche attività cui è preposto, presta la sua opera durante le feste tradizionali e religiose. La Parrocchia è molto attiva nelle attività sociali, e comprende un coro polifonico, la Caritas e un gruppo di volontariato vincenziano che promuove iniziative caritatevoli e di assistenza. Diverse sono inoltre le associazioni sportive che propongono ai giovani momenti di aggregazione e di sana utilizzazione del tempo libero. Gibellina Dal punto di vista della dispersione scolastica, anche il Comune di Gibellina presenta una situazione particolarmente positiva. L’indice di dispersione scolastica globale è pari al 3,05% nella scuola primaria ed è dovuto alla somma di un alunno evasore e 5 non ammessi; mentre nella scuola secondaria di primo grado tale indice è bassissimo, ossia pari allo 0,80%, determinato da un unico caso di evasione. Dispersione Scolastica Comune di Gibellina SCUOLA PRIMARIA SCUOLE GIBELLINA Ist. Compr. "PAPA GIOVANNI XXIII" ISCRITTI EVASORI ABBANDONI PROSCIOLTI NON AMMESSI I.D.S.G. N° N° % N° % N° % N° % N° % 197 1 0,5 0 0,0 0 0,0 5 2,5 6 3,05 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCUOLE ISCRITTI EVASORI ABBANDONI PROSCIOLTI NON AMMESSI I.D.S.G. GIBELLINA N° N° % N° % N° % N° % N° % Ist. Compr. "PAPA GIOVANNI XXIII" 125 1 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,80 Fonte: M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Osservatorio prevenzione Dispersione Scolastica e promozione successo formativo Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 218 Relativamente al tasso di scolarità, nella tabella che segue viene evidenziato per la scuola primaria un tasso di scolarità inferiore al 100%, verosimilmente a causa di un significativo Indice di Dispersione Scolastica. Per la scuola secondaria di primo grado, si osserva un indice superiore al 100% (vedi considerazioni sopra riportate). L'assenza di un'offerta formativa relativa alla scuola secondaria di secondo grado determina la necessità per i giovani che intendono completare gli studi di riferirsi ad altri Comuni. COMUNE DI GIBELLINA POPOLAZIONE NUMERO GRADO DI TASSO DI FASCE ETA’ RESIDENTE AL ALUNNI ISTRUZIONE SCOLARITÀ 1° GENNAIO 2007 A.S. 2006/2007 98,5% 6 – 10 anni Scuola primaria 200 197 Scuola secondaria di 11 – 13 anni 122 125 102,46% primo grado Scuola secondaria di 14 – 18 anni 212 secondo grado Rielaborazione dati ISTAT e M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia A Gibellina sono presenti numerosi enti no profit, tra i quali spicca per importanza il CRESM - Centro Ricerche Economiche e sociali per il Meridione, Agenzia di Sviluppo che opera in tutto il Mediterraneo. Tra le associazioni culturali presenti nel Comune di Gibellina si ricordano: - la Società Operaia Circolo Ricreativo; la Fondazione Orestiadi; l’Associazione Compagnia Caterina Sagna; l’associazione culturale Circolo Nuovo; l’AVIS; l’AIDO; l’AGESCI; la Caritas; l’Associazione Comunita' Alloggio Padre Pio. Diverse sono inoltre le associazioni sportive che propongono ai giovani momenti di aggregazione e di sana utilizzazione del tempo libero. 2.3.7.3 Aspetti economici (D.9.1; D.9.3; D.9.4; D.10) Santa Ninfa ha colto l’occasione della ricostruzione post terremoto per realizzare uno sviluppo economico locale fondato sulla creazione o ampliamento di piccole imprese tanto da costituire un modello per molte realtà limitrofe (ROSTAN, 1998). La sua economia si basa sull’agricoltura, principalmente vite ed in minor parte ulivi, grano, ortaggi e frutta. Conseguentemente sono sorte diverse attività legate ad essa: la cantina sociale, gli oleifici, i caseifici, ditte impegnate nella realizzazione di impianti per l’irrigazione. Le attività industriali ed artigianali sono in buona parte legate all’indotto dell’edilizia: conglomerati, calcestruzzo, lavorazione marmi, legno, ferro e alluminio, oltre che messa in opera di impianti di condizionamento e riscaldamento e produzione di tubi. Notevole importanza hanno, anche dal lato occupazionale, alcune ditte di preparazione e conservazione di dolci locali, allestimento banchetti e ristorazione. Rilevante importanza riveste il settore della lavorazione e commercializzazione della carne. Altro settore in rapida Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 219 crescita è quello della produzione e commercializzazione di apparecchiature elettroniche per la ricezione e trasmissione televisiva, costruzione di antenne ed amplificatori di segnali TV. Molte delle ditte locali fanno parte del Consorzio Area Artigianale e Commerciale di Santa Ninfa. Gibellina - Attualmente, dal punto di vista economico, il settore vitivinicolo è uno dei principali motori di sviluppo dell’economia locale. Dal 2005 è stato creato il Distretto Vitivinicolo della Sicilia Occidentale, che vede coinvolti attori economici e sociali delle province di Trapani e Palermo piuttosto eterogenei: Enti Locali, consorzi di tutela, associazioni, Strade del vino, agenzie di sviluppo, enti di ricerca, enti di formazione, una banca, associazioni di categoria, cantine sociali, industrie vinicole, aziende vitivinicole, aziende agricole, consorzi di cantine, distillerie, aziende di commercio di vino, aziende di commercializzazione macchine/prodotti enologici. L’obiettivo perseguito attraverso la costituzione del Distretto è quello di mettere in atto una strategia di lungo respiro, illustrata nel “Patto di Distretto” (vedi il sito www.cresm.it), per il rilancio di tutto il comparto vitivinicolo Siciliano. Il settore del commercio riveste un ruolo importante, insieme all’industria e ai servizi. Ci sono anche attività manifatturiere ed imprese di costruzioni, ma in misura nettamente inferiore rispetto a Santa Ninfa. Occupazione Relativamente al settore dell’occupazione, il Comune di Santa Ninfa e quello di Gibellina fanno parte del medesimo Sistema Locale del Lavoro, il n. 651 denominato “Castevetrano”. I sistemi locali del lavoro sono aggregazioni di comuni che derivano da una ricerca condotta da Istat e il Dipartimento di Economia dell’Università di Parma a partire dai dati relativi al pendolarismo dei componenti delle famiglie per motivi di lavoro, ricavati dagli appositi quesiti posti nel Censimento Generale della Popolazione del 2001. L'obiettivo di base è la costruzione di una griglia sul territorio determinata dai movimenti dei soggetti per motivi di lavoro; l'ambito territoriale che ne discende rappresenta l'area geografica in cui maggiormente si addensano quei movimenti. In questo modo si aggregano unità amministrative elementari (Comuni) individuati sul territorio dalle relazioni socio-economiche. Laddove non siano disponibili dati aggiornati riferiti ad un determinato comune, come nel caso dell’occupazione, ci si riferirà ai SLL. Stima degli occupati residenti e delle persone in cerca di occupazione per Sistema Locale del Lavoro (Media 2001; dati in migliaia) – Fonte ISTAT 2001 Forze di lavoro Codice SLL Denominazione 651 CASTELVETRANO Popolazione con meno di 15 anni Occupati 9 14 Persone in cerca di occupazione Totale 4 18 Non Forze di lavoro 34 Tasso PopolaTasso Tasso di zione Popoladi di con più zione attività occupa- disocc. zione di 15 totale anni 43 52 42,0 33,0 21,5 Dalla tabella sopra riportata, si evince che il tasso di disoccupazione media dei Comuni facenti parte del SLL di Castelvetrano è del 21,5%. Tale dato risulta allarmante se comparato agli altri SLL italiani, infatti il SLL 651 si situa al 685° posto nella classifica rispetto alla disoccupazione dei 785 SLL presenti in Italia. Nonostante questo, tuttavia, si deve sottolineare Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 220 che tale dato è di ben 5 punti percentuali inferiore rispetto alla media dei Comuni Siciliani, che risulta essere del 26,5%. Relativamente al dato dell’occupazione, si segnala un dato di particolare rilievo perché direttamente connesso con la gestione di territorio ubicata all’interno del SIC: si tratta dell’occupazione stagionale nel settore forestale. L’Azienda Regionale Foreste Demaniali – UPA di Trapani assume annualmente circa 150200 operai stagionali (residenti nei Comuni di Santa Ninfa e di Gibellina) per gli interventi di manutenzione dei demani forestali (ripulitura dei viali parafuoco, manutenzione di immobili e strutture, interventi di gestione forestale: spalcature, diradamenti, piantumazioni, ecc.). Analogamente, l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani assume annualmente circa 50 addetti all’avvistamento ed allo spegnimento degli incendi. E’ bene sottolineare che si tratta di operai stagionali, che nel resto dell’anno risultano ufficialmente disoccupati. Attività economiche Dai dati Istat 2001 si evince chiaramente che il settore portante dell’economia dell’area del S.I.C. è l’agricoltura, che conta un numero elevato di imprese attive. A Santa Ninfa anche il tessuto industriale risulta essere molto importante, soprattutto se ad esso si somma il dato relativo alle aziende che operano nel settore delle costruzioni. Il commercio conta numerose unità locali, mentre i servizi e la ristorazione presentano dati nella media. Gibellina invece è più strutturata dal punto di vista della ristorazione, ed infatti recenti progetti hanno visto la nascita di una rete di B&B che rende maggiormente complessa e completa la filiera del turismo. Unità locali attive per settore di attività per Comune Santa Ninfa Gibellina Agricoltura, caccia, silvicoltura 461 516 Industria 106 60 Attività manifatturiere 56 30 Costruzioni 40 30 Commercio 152 116 Servizi 68 51 Alberghi e ristoranti 7 16 Trasporti, magazzinaggio, 12 7 comunicazioni Intermediazione monetaria e 9 7 finanziaria Attività immobiliari, noleggio, 20 4 informatica, ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali Istruzione 1 4 Sanità e altri servizi sociali 2 3 Altri servizi 17 10 Imprese non classificate 1 2 Totale 779 745 Elaborazione su dati Istat 2001 Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 221 L’economia del comune di Santa Ninfa è legata, oltre che alle attività tradizionali dell’agricoltura (olivo – vite - grano) e dell’allevamento (bovini – ovini - polli), ad attività commerciali, industriali ed artigianali il cui sviluppo è stato facilitato dalla posizione geografica del luogo e dalla capacità imprenditoriale degli abitanti. Come si evince dalla tabella riportata, le imprese di costruzioni, e quelle legate al settore dell’edilizia, sono molto numerose. Sono presenti aziende che operano nel settore dell’elettronica, commercializzando anche all’estero. La produzione di pasta fresca e dolci risulta essere molto importante; due aziende, nate prima del terremoto, ancor oggi continuano la propria attività e ad esse se ne sono aggiunte altre che operano nel medesimo campo. Per quanto riguarda il commercio, il numero di esercenti a posto fisso, secondo i dati forniti dal Comune di Santa Ninfa, aggiornati al 13.02.2008, è di 89. Imprese industriali e artigiane presenti del Comune di Santa Ninfa per settore di attività n. ditte Settore Attività 10 Industria Costruzioni 1 Industria Costruzione Parti Meccaniche 8 Artigiano Parrucchiera E Barbiere 7 Artigiano Meccanico 5 Artigiano Fabbro 4 Artigiano Installazione Impianti En.Elettrica 4 Artigiano Pasticcere 4 Artigiano Panificio 3 Artigiano Produzione Pasta Fresca 3 Artigiano Costruzioni 2 Artigiano Falegname 2 Artigiano Tappezziere 2 Artigiano Riparazione Installazione Elettrodomestici 2 Artigiano Lavorazione Marmi 2 Artigiano Ricami 2 Artigiano Fotografo 1 Artigiano Tinteggiatore 1 Artigiano Vetraio 1 Artigiano Biscottificio 1 Artigiano Carrozziere 1 Artigiano Lattoniere 4 Varie Autotrasportatore 1 Varie Installazione Segnaletica Stradale 1 Varie Scuola Guida (Elaborazione su dati Comune di Santa Ninfa, 2008) Per quanto concerne l’agricoltura, le coltivazioni della vite e dell’ulivo in particolare, insieme a tutta la filiera produttiva agro-alimentare, rappresentano il fulcro produttivo dell’intero territorio della Valle del Belice. Le denominazioni di origine protetta e geografica tipica DOC nonché i prodotti tipici presenti sul territorio e le produzioni agro-alimentari di nicchia, costituiscono le nuove frontiere dello sviluppo agricolo e agro-alimentare di qualità e allo stesso tempo la via maestra della competitività economica in un quadro si sviluppo locale integrato e sostenibile. Nonostante questo, le strozzature di tipo informativo, tecnologico, promozionale e soprattutto quelle che si riferiscono alla mancata messa a rete delle strutture e delle iniziative, insistono nel perdurare i loro effetti sul sistema produttivo e distributivo dei prodotti agro-alimentari, con effetti negativi sulle possibilità di sviluppo del settore. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 222 Nel territorio di Santa Ninfa e Gibellina sono presenti prodotti tipici importanti: - la Nocellara del Belice, oliva da mensa, è un prodotto D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta), secondo quanto stabilito dalla normativa CE n.134/98. l’olio extravergine delle Valli Trapanesi è un prodotto D.O.P. che proviene da cultivar quali Cerasuola, Biancolilla e Nocellara. l’olio della Valle del Belice è un prodotto D.O.P., il suo areale comprende i comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Salaparuta, Santa Ninfa e Poggioreale. la Vastedda del Belice è un prodotto Slow Food, in attesa del riconoscimento D.O.P. E’ un formaggio di latte di pecora a pasta filata. Comune Santa Ninfa Gibellina Presenza di prodotti tipici per comparto Olio-olive Formaggi Vino Caciocavallo palermitano; Melone Valle Belice Vastedda palermitana; Marsala d’inverno Vastedda del Belice Melone Alcamo Valli trapanesi d’inverno Marsala Fonte: Coreras, 2005 frutta Le attività artigianali, manifatturiere e non, costituiscono un patrimonio di esperienze che, opportunamente valorizzate ed integrate a sistema con il resto dei settori economici locali, può rappresentare un volano per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. In particolare, costituisce un patrimonio della cultura locale l’attività di produzione di prodotti di sartoria e merletti a Santa Ninfa, ereditata dalle precedenti generazioni. Santa Ninfa è membro del Coordinamento tra i Comuni d’Italia per la Valorizzazione dei Merletti, Ricami e Tessuti d’arte. Questa attività viene svolta prevalentemente in maniera informale, senza essere considerata a tutti gli effetti un’attività economica e produttiva: secondo i dati forniti dal Comune, esistono solamente due realtà iscritte alla Camera di Commercio che operano in questo settore. Altre attività artigianali diffuse nel territorio comunale di Santa Ninfa appartengono al settore alimentare: sono presenti 11 aziende di produzione di pasta, dolci, etc. Ad esse si aggiungono le attività artigianali classiche, quali barbieri e parrucchieri, meccanici, fabbri, falegnami, tappezzieri, installatori di impianti elettrici, riparatori di elettrodomestici Di notevole rilevanza è la presenza di un’Area Artigianale, estesa su una superficie di mq 81.500, adiacente al centro abitato ed a meno di 500 metri dall’Asse del Belice, in buona parte realizzata ed i cui lotti, già urbanizzati ed ultimati, sono stati assegnati agli artigiani. All’interno dell’Area Artigianale è sorto un Centro Direzionale dotato di strutture per Mostre, Mercati, Convegni degli artigiani. Tale struttura si propone come punto di riferimento non solo per l’economia santaninfese, bensì per tutta l’area limitrofa. L’ospitalità nei Comuni di Santa Ninfa e Gibellina è caratterizzata dalla presenza di piccole strutture diffuse sul territorio. Infatti la struttura più grande conta 12 posti letto, mentre in tutti gli altri casi ci si trova di fronte a piccoli B&B a conduzione familiare. Il numero di B&B a Gibellina è notevolmente aumentato nel giro di pochi anni, grazie a due progetti (“Extra Belice” e "Agecava - Agenzia per le Case Vacanza”) del CRESM che propongono un turismo diffuso sul territorio. Il progetto “Extra-Belice” è una iniziativa triennale finanziata dalla Provincia regionale di Trapani. Il CRESM, in collaborazione con il circolo di Legambiente “Crimiso” di Castelvetrano, il Centro documentazione ambientale e l’Archeoclub di Partanna, ha redatto e diffuso un manuale pratico per l’avvio e la gestione di un B&B, lavorando al contempo alla Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 223 realizzazione di itinerari (monumentali, enogastronomici, naturalistici), relativi alla Valle del Belice. Ente capofila del progetto "Agecava", portato avanti con altri partners siciliani e tunisini, è il Comune di Gibellina, in collaborazione con l'Agenzia di sviluppo del Comune tunisino di Zarzis; obiettivo prioritario è promuovere attività extalberghiere da inserire in una rete mediterranea e gestite da gente del luogo. PROVINCIA DI TRAPANI ESERCIZI RICETTIVI ALBERGHIERI ED EXTRALBERGHIERI PER COMUNE - 2005 COMUNI ERICE MARSALA PANTELLERIA GIBELLINA SAN VITO SANTA NINFA TRAPANI ALTRI COMUNI TOTALE PROVINCIA 28 38 20 10 74 TOTALE POSTI LETTO 1054 1310 1432 59 5231 12 1 12 28 381 36 933 4702 140 4984 195 9686 10612 259 9105 402 19717 ESERCIZI ALBERGHIERI NUMERO 13 11 13 0 43 ESERCIZI ALBERGHIERI POSTI LETTO 909 943 1240 0 2266 ES.EXTRA ALBERGHIERI NUMERO 15 27 7 10 31 ES. EXTRA ALBERGHIERI POSTI LETTO 145 367 192 59 2965 0 0 1 8 552 55 143 TOTALE ESERCIZI Fonte: Provincia di Trapani – elaborazione su dati APT Osservando più in dettaglio i dati riferiti ai Comuni di Santa Ninfa e Gibellina, emerge che le poche strutture presenti presentano caratteristiche omogenee: offerta esclusiva di posti letto in strutture extralberghiere (Bed and Breakfast e Case vacanze), molti dei quali presentano caratteristiche tali da rientrare nella categoria di strutture a 3 stelle. Rispetto ai dati del 2005, è importante l’incremento dei posti letto nel Comune di Santa Ninfa, dove nel 2006 è stato aperto un nuovo B&B con 9 posti letto. ESERCIZI RICETTIVI SANTA NINFA E GIBELLINA - anno 2007 Comune Tipologia di Categoria Numero esercizi Posti Letto esercizio Complessivi Santa Ninfa Casa Vacanza 1 12 B&B 3 stelle 1 9 Gibellina B&B 3 stelle 2 22 2 stelle 5 27 1 stella 3 10 (Fonte: APIT Trapani - Annuario Trapani Hotels) Dal raffronto con la capacità ricettiva totale della Provincia, e in particolare di alcuni specifici Comuni, emerge un palese sotto dimensionamento dell’offerta ricettiva nell’area S.I.C. ove si trova solo lo 0,78% di tutti i posti letto extra-alberghieri del territorio provinciale. Rispetto alla situazione nei diversi Comuni, ovviamente emerge una forte concentrazione delle strutture nei territori più conosciuti, o comunque che si affacciano al mare. Dal raffronto con la capacità ricettiva totale della Provincia, e in particolare di alcuni specifici Comuni, emerge un palese sotto dimensionamento dell’offerta ricettiva nell’area SIC, ove si trova solo lo 0,78% di tutti i posti letto extra-alberghieri del territorio provinciale. Rispetto Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 224 alla situazione nei diversi Comuni, ovviamente emerge una forte concentrazione delle strutture nei territori più conosciuti, o comunque che si affacciano al mare. Inventario delle attività economiche presenti all'interno del Sito ed analisi delle pressioni (D.10.1; C.1.1 in “Valutazione Esigenze Ecologiche”) Non esistono dati quantitativi sulle attività economiche riferiti al territorio del SIC, per cui non è stato possibile in questa sede redigere tale inventario. Dall’analisi della carta dell’uso del suolo si possono trarre alcuni elementi sulle superfici del Sito interessate da attività agricole, che rappresentano la principale attività economica. Connessa con l’attività agricola è quella dell’allevamento ovino, che rileva sotto il profilo della zootecnia. All’interno del SIC non sono presenti impianti e attività industriali, strutture commerciali, opifici, cave, strutture e attività turistico-ricettive. Il territorio del SIC è interessato prevalentemente dalle seguenti pressioni antropiche: 1. Pressioni da attività agricola. Caratterizzate dal processo di riconversione produttiva che vede la progressiva sostituzione delle colture cerealicole con le colture viticole e l'affermarsi, in particolari zone, di altre colture come l'oliva, queste si contraddistinguono per la diffusione di tecniche di lavorazione agricola dei suoli che determinano effetti negativi sul paesaggio, generano fenomeni erosivi, l'intasamento e l'occlusione degli inghiottitoi e delle doline da parte dei materiali erosi, accumuli di pietre etc.. L’attuale produzione agricola ha portato a pesanti rimaneggiamenti del terreno in relazione agli avvicendamenti colturali e la progressiva sottrazione di habitat naturale a fini produttivi. Gli impatti provocati dalle attività agricola sono diffusamente descritti nel paragrafo 2.3.3.2. 2. Pressioni da diffusione insediativa. L’attuale diffusione insediativa, generata a partire dagli anni settanta, trova due principali matrici di riferimento. Da una parte la costruzione di strutture edilizie a servizio dell’uso agricolo dei fondi, dall’altra la conversione di queste e la nuova costruzione di edilizia residenziale stagionale. Essa esercita una progressiva pressione che si concentra in particolar modo lungo il perimetro meridionale del SIC, intorno a Monte Castellaccio, e a Nord, lungo il confine del SIC coincidente con la SP n. 75 della Magione nel tratto compreso tra Case della Magione e Casa Palermo. Si tratta di edilizia residenziale stagionale che, per le caratteristiche architettoniche, appare scarsamente relazionata alla conduzione agricola dei fondi. Tale fenomeno, per i livelli di progressiva intensificazione e diffusione, appare in crescita. Gli impatti causati da tale pressione sono stati descritti diffusamente nel paragrafo 2.3.6.4 3. Impatto da viabilità carrozzabile. La viabilità interna del SIC presenta un articolazione territoriale che per estensione e per dimensione genera un evidente impatto, anche in termini di frammentazione ambientale, in particolare all’interno demanio forestale “Finestrelle”. Essa ha quasi completamente sostituito il tracciato dei sentieri preesistenti, e si configura come una con-causa delle pressioni generate dal sistema di produzione agricola. Gli impatti provocati da tale tipologia di pressione sono diffusamente descritti nel paragrafo 2.3.6.4. 4. Pressioni da pascolo. Altra forma di pressione è esercitata dal pascolo praticato diffusamente che, soprattutto in passato, ha contribuito alla riduzione dei livelli di biodiversità negli habitat naturali e seminaturali presenti. Gli impatti provocati da tale tipologia di pressione sono diffusamente descritti nel paragrafo 2.3.3.2. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 225 2.3.7.4 Soggetti pubblici e privati operanti in campo ambientale (D.8) I principali soggetti pubblici e privati operanti in campo ambientale all’interno del SIC ITA010022 sono riassunti nella seguente tabella: Soggetti istituzionali Amministrazioni Comunali (S. Ninfa e Gibellina) Azienda Regionale Foreste Demaniali – Ufficio Provinciale di Trapani Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani Distaccamento Forestale di Castelvetrano Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani Provincia di Trapani Ispettorato Agrario Istituti scolastici di Santa Ninfa e Gibellina Ente gestore della riserva naturale “Grotta di Santa Ninfa” Sociali Imprese agricole e zootecniche Operai stagionali per la gestione dei complessi boscati - AFDRS Operai stagionali per l’avvistamento e la prevenzione antincendio - IRF Escursionisti (sentieri, MTB, equitazione) Club Ippico “La Giumenta” Santa Ninfa Comunità locale Associazione “La Poiana” S. Ninfa Cacciatori Associazioni di categoria Legambiente Comitato Regionale Siciliano 2.3.7.5 Risorse territoriali Il territorio del SIC offre numerose attrattive, interessanti per una fruizione turistica di nicchia, non massificata ed attenta alle peculiarità e alle tradizioni locali. Risorse naturali e paesaggistiche: - - Paesaggio carsico dei gessi. Aree di pregio naturalistico e vegetazionale. Aree boscate di Finestrelle e di Castellaccio, gestite dall’Azienda Foreste Demaniali di Trapani. All’interno dei demani forestali sono presenti: 9 un museo etnoantropologico che custodisce oggetti del mondo contadino; 9 un’area attrezzata con tavoli, panche, altalene e bagni; 9 un rifugio; 9 piccoli manufatti in gesso che potrebbero essere utilizzati per la promozione della fruzione. La Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa”, istituita nel 1995 e affidata in gestione a Legambiente. Risorse del Comune di Santa Ninfa Risorse storiche, monumentali e archeologiche: - Il centro abitato conserva poche testimonianze dell’impianto e dei monumenti risalenti al ‘700 e all’800; tra questi, si ricordano la Chiesa del Purgatorio, la Chiesa della Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 226 - Badia, la Chiesa di Sant’Anna, Palazzo Patti, Palazzo Mauro, Palazzo Piazza. Tra le opere moderne, la Fontana della Melagrana di Nino Cordio. Il Castello di Rampinzeri è un antico baglio fondato nel 1600; nel corso dei secoli ha subito diverse trasformazioni architettoniche che lo hanno nobilitato con una facciata neogotica, ripresa anche nell’adiacente cappella. Il re Vittorio Emanuele vi fu ospitato nel 1937.Parte del Baglio ospita attualmente il club ippico “La Giumenta” ed il ristorante “Castello di Rampinzeri”. Nell’ambito del PIT Alcesti il Comune di Santa Ninfa ha recentemente acquistato il Castello; in base ad un protocollo di intesa stipulato con Legambiente - ente gestore della riserva naturale “Grotta di Santa Ninfa”, la parte oggetto dei lavori di restauro è destinata a sede, centro visitatori e centro di documentazione dell’area naturale protetta. Musei e biblioteche: - Museo d’arte contemporanea “Nino Cordio” - Museo dell’emigrazione presso la Società operaia di mutuo soccorso (con annessa Mostra fotografica permanente sull’emigrazione Siciliana) - Mostra fotografica permanente di fotografie del terremoto del 1968 presso il Municipio. - Biblioteca del Bellafiore (3.000 volumi sull’arte in Sicilia). - Biblioteca della società operaia di mutuo soccorso (5.000 volumi) Risorse gastronomiche: - la Salsiccia - il Formaggio di pecora - la Brucculata - l’Agghiumunniatu - la Mataloccu Artigianato: - Il merletto - Santa Ninfa fa parte del Coordinamento tra i Comuni d’Italia per la Valorizzazione dei Merletti, Ricami e Tessuti d’arte. Feste religiose: - Festa di San Giuseppe - 19 Marzo - Festa di Santa Ninfa - 12 novembre Risorse del Comune di Gibellina Risorse monumentali ed archeologiche: - - il nuovo centro è stato costruito con la partecipazione di numerosi artisti contemporanei, che diedero al paese una connotazione urbanistica, architettonica, ma soprattutto artistica unica al mondo. La città si presenta come una città museo. Si citano la Stella di Pietro Consagra (1980); il Meeting di Consagra; - il Centro civico e culturale, opera di Gregotti, Pirone e Samonà (1972); le opere di scultura in pietra e in metallo (C. Cappello, P. Schiavocampo, N. Vigo). la Necropoli sicana presso Monte Finestrelle il Museo Civico d’arte contemporanea Palazzo Di Lorenzo, che nel cortile conserva la facciata di un antico edificio della vecchia Gibellina, opera di Francesco Venezia. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 227 - il Cretto di Burri, una delle opere di land art più grandi del mondo. Musei e biblioteche - - Museo della memoria del terremoto: recentemente, vicino al Cretto di Burri, in un edificio semidistrutto dal terremoto, ma messo in sicurezza da interventi successivi, è stato allestito questo piccolo museo, con fotografie e documenti dell’epoca che mostrano la tragedia che colpì la Valle del Belice. Museo delle trame mediterranee presso le Case Di Stefano, una masseria ottocentesca ristrutturata sede della Fondazione Orestiadi. 2.3.7.6 Potenzialità turistiche del Sito (D.9.6) Ad oggi, qualsiasi analisi sullo stato attuale delle potenzialità turistiche del SIC deve partire da quanto realizzato in questi anni dalla riserva naturale “Grotta di Santa Ninfa”, in esso ricadente, che dal 1996 attua azioni gestionali nel settore della promozione della fruizione naturalistica. In particolare, gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono i seguenti: - realizzazione di sentieri naturalistici (progetto “Individuazione e recupero sentiero pedonale Valle del Biviere”), per circa 8 km; - manutenzione ordinaria dei sentieri già esistenti (3,2 km); - organizzazione e svolgimento di visite guidate nel territorio protetto epigeo, per un numero complessivo variabile da 1.000 a 1.400 visitatori/anno (tra scuole, escursionisti, associazioni). Nel grafico sottostante viene riportato l’andamento delle visite guidate lungo i sentieri della riserva naturale dal 1998 al 2008; si nota che il numero dei visitatori è aumentato esponenzialmente nei primi 4 anni, per poi attestarsi ad un livello medio di 1.100 visitatori nei restanti anni. Nell’ultimo anno, il numero degli utenti è di nuovo aumentato, anche in relazione ad un’aumentata attività di promozione del territorio da parte dell’ente gestore. Si fa presente: 1) che i dati riportati sono riferiti esclusivamente alle visite guidate dal personale delle riserve, e non i visitatori auto-organizzati che decidono autonomamente di svolgere escursioni nel territorio; 2) che i dati non sono relativi alle visite svolte all’interno della grotta, che sono invece strettamente regolamentate e contingentate per motivi di tutela ambientale (max 300 visitatori/anno); 3) che nel corso del 2009 saranno ultimati alcuni interventi, attualmente in corso di realizzazione, di strutturazione della riserva (sentieri naturalistici, percorsi didattici, aree attrezzate, ecc.), con un conseguente incremento dei servizi offerti per la promozione della fruizione e delle potenzialità turistiche del Sito. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 228 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 - realizzazione di progetti di educazione ambientale e didattica naturalistica (laboratori, attività, moduli tematici, campi annuali) con le scuole del comprensorio; - realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di divulgazione, mostre tematiche, convegni, incontri; - affidamento di servizi di educazione ambientale e di fruizione naturalistica ad un’associazione locale; - realizzazione di pubblicazioni (opuscoli anche didattici e depliant), materiali (poster, pannelli e tabelle didattici) depliant, cd-rom, video su sui vari aspetti naturalistici del territorio della riserva. Relativamente alla strutturazione del territorio per fini di fruizione, si segnalano: - l’apertura del Centro Visitatori della riserva a Santa Ninfa, in una struttura di proprietà comunale affidata in comodato d’uso all’ente gestore, dotato di pannelli tematici, roccioteca, materiali divulgativi e didattici; - l’acquisizione, da parte del Comune, del Castello di Rampinzeri per realizzare la sede della riserva, il centro visitatori ed il museo naturalistico; - la realizzazione di un’area accoglienza visitatori in c.da Grotta con sentieri didattici, area attrezzata, giardino degli odori, macchia mediterranea, ecc. A fronte di quanto già realizzato (o in corso di realizzazione), che consegna al territorio un buon livello di infrastrutturazione e di servizi per la fruizione naturalistica, e nonostante l’importanza e la varietà delle risorse culturali, artistiche, architettoniche, naturali e paesaggistiche descritte nel paragrafo precedente, l’area in cui ricade il SIC attualmente non è considerata una meta turistica rilevante, ed i turisti che visitano la zona non vi permangono, conseguentemente il settore non ha sull’economia locale le ricadute che potrebbe avere se opportunamente valorizzato. Tale intuizione è stata fatta propria dalla programmazione prevista per il territorio, in particolare dai PIT Alcinoo e Alcesti, ed infatti consistenti investimenti sono previsti in tal senso. La densità turistica si esprime attraverso il rapporto tra gli arrivi turistici in una determinata località e la sua superficie espressa in Kmq. La Regione Sicilia occupa una posizione centrale nello scacchiere delle Regioni italiane: infatti la densità turistica nel 2005 è pari a 158,37. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 229 Variegato risulta il quadro all’interno dell’Isola, dove sono ancora elevate le differenze tra una provincia e l’altra. Densità turistica nelle province siciliane ( 2004 – 2005) Superficie Arrivi Densità turistica PROVINCIA kmq 2004 2005 2004 2005 var. ass. Agrigento 3.042 388.579 395.321 127,74 129,95 2,22 Caltanissetta 2.128 51.122 48.699 24,02 22,88 -1,14 Catania 3.552 674.146 673.589 189,79 189,64 -0,16 Enna 3.562 61.747 55.430 17,33 15,56 -1,77 Messina 3.247 997.519 1.010.011 307,21 311,06 3,85 Palermo 4.992 1.151.338 1.154.996 230,64 231,37 0,73 Ragusa 1.614 197.714 212.234 122,50 131,50 9,00 Siracusa 2.109 340.640 362.371 161,52 171,82 10,30 Trapani 2.461 366.705 385.065 149,01 156,47 7,46 TOTALE 26.707 4.229.510 4.297.716 158,37 160,92 2,55 Fonte: Regione Siciliana. Assessorato Turismo. Osservatorio Turistico Dai dati sopra riportati, Trapani risulta essere la terza provincia dopo Messina e Palermo per densità turistica, con 149 arrivi per kmq nel 2004 e 156 arrivi per kmq nel 2005. Questo dato non mostra le differenze all’interno del territorio in termini di presenze in ciascun Comune ed in particolare in ciascun sito di rilevanza turistica. E’ tuttavia evidente che località come Selinunte, Segesta, Erice, le isole Egadi, la Riserva dello Zingaro, il mare di San Vito lo Capo, Mozia sono di forte richiamo turistico, e pertanto aumentano notevolmente la consistenza degli arrivi nella provincia. L’indice di turisticità territoriale misura la capacità di un territorio di sopportare il carico turistico; esso dipende dalla somma della popolazione residente e dalle presenze che soggiornano in quei determinati luoghi e si esprime attraverso il rapporto tra la popolazione residente e le presenze turistiche. Indice di turisticità nelle province siciliane ( 2004 – 2005) Popolazione Presenze Indice di Turisticità PROVINCIA 2004 2005 2004 2005 2004 2005 var. ass. Agrigento 456.612 457.039 937.983 1.044.229 0,49 0,44 -0,05 Caltanissetta 275.221 274.001 131.112 131.832 2,10 2,08 -0,02 Catania 1.071.883 1.075.657 1.689.454 1.756.040 0,63 0,61 -0,02 Enna 174.426 174.199 126.986 104.068 1,37 1,67 0,30 Messina 657.785 655.640 3.944.957 3.951.916 0,17 0,17 0,00 Palermo 1.239.272 1.239.808 3.279.549 3.331.396 0,38 0,37 -0,01 Ragusa 306.741 308.103 873.837 885.100 0,35 0,35 0,00 Siracusa 398.178 398.330 1.037.502 1.180.840 0,38 0,34 -0,05 Trapani 432.963 434.435 1.244.649 1.361.242 0,35 0,32 -0,03 TOTALE 5.013.081 5.017.212 13.266.029 13.746.663 0,38 0,36 -0,01 Fonte: Regione Siciliana. Assessorato Turismo. Osservatorio Turistico Dalla tabella sopra riportata, si rileva che nella provincia di Trapani l’indice di turisticità è in calo: nel 2004 era dello 0,35, mentre nel 2005 è dello 0,32. Le presenze sono aumentate di quasi 120 mila unità, dato importante e fortemente positivo. Il valore mostra come, in considerazione del grandissimo patrimonio culturale, ambientale, monumentale ed archeologico posseduto, la Provincia di Trapani può, a ragione, individuare nel turismo uno dei settori trainanti della propria economia e del proprio sviluppo. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 230 Si tratta tuttavia di proporre attrattive che integrino quelle delle maggiori località, per favorire un turismo maggiormente diffuso sul territorio, che decongestioni alcune aree (soprattutto quelle costiere nel periodo estivo) e favorisca uno sviluppo sostenibile. Risulta evidente la posizione marginale e debole del territorio del SIC ITA010022, la cui notorietà e la fruizione si attestano a livelli molto al di sotto della sua reale importanza. Occorre dunque, attraverso la creazione di una rete effettiva ed integrata fra i diversi soggetti operanti nel campo della tutela e della promozione del territorio e attraverso l’elaborazione e la proposta di itinerari “trasversali”, dare visibilità a tutte le risorse culturali, naturalisticoambientali ed eno-gastronomiche presenti, evidenziando le potenzialità di quelle “in ombra” e le connessioni esistenti. Il territorio del SIC fa parte di un patrimonio di beni che devono essere oggetto di visibilità e promozione integrata affinché possano insieme costituire il valore aggiunto per l’innovazione dell’offerta e la crescita dell’intera area provinciale. Considerando l’importanza della tutela e salvaguardia del territorio, soprattutto considerata la sua rilevanza dal punto di vista ambientale e naturalistico, è rilevante l’approccio del modello che viene proposto all’interno della programmazione del territorio; infatti il turismo può essere una grande risorsa per lo sviluppo, ma può avere un impatto anche pesantemente negativo sul territorio, se non correttamente gestito. Per cercare di frenare gli effetti negativi prodotti sul territorio derivanti da un uso scriteriato dello stesso, debbono essere avviati interventi a promozione di un sistema turistico locale dove il luogo di produzione e quello di consumo coincidano, l’attrattiva diventi un fattore produttivo locale ed sia possibile definire precisi indicatori di sviluppo locale proprio in una logica sistemica delle interdipendenze tra beni culturali, turismo e comunità locali. I Sistemi Turistici Locali, definiti dalla L135/2001 come “contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti appartenenti anche a Regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate”, diventano un modello che si contrappone alla logica del modello di turismo industriale, e rendendo possibile una gestione partecipata del servizio turistico, pongono le basi per l’implementazione di un’offerta turistica in grado di contribuire ad uno sviluppo locale sostenibile. In questa stessa ottica si pone l’idea del turismo sostenibile, che nasce innanzitutto dal riconoscimento che questo settore non può essere considerato come isolato dal contesto sociale, economico e ambientale in cui viene realizzato. L’impatto del settore turistico sul territorio risulta molto significativo, in termini diretti (pagamento di servizi da parte del turista), indiretti (acquisti da parte dei fornitori di servizi turistici) e indotti (capacità di spesa degli addetti al settore turistico). Ma oltre a questo si deve prendere in considerazione una nuova contabilità, che tenga conto anche del “consumo” dell’ambiente per determinare la vera creazione di valore del turismo. Risulta dunque fondamentale la realizzazione di politiche e azioni in grado di migliorare la qualità della vita per i residenti, di creare una corretta relazione del turista con l’ambiente e di attivare un corretto uso delle risorse produttive locali. In sostanza la strategia è quella di ridurre al minimo i danni sull’ambiente, valorizzare lo scambio interculturale tra comunità ospitante e visitatori e ottimizzare i vantaggi per la comunità locale derivanti dai flussi turistici. Il turismo diffuso sul territorio, la cui ricaduta coinvolge un numero elevato di piccoli operatori (come quelli della rete dei B&B di Gibellina) consente la realizzazione di politiche e Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 231 azioni in grado di migliorare la qualità della vita per i residenti, di creare una corretta relazione del turista con l’ambiente e di attivare un corretto uso delle risorse produttive locali. L’AITR -Associazione Italiana Turismo Responsabile ha promosso la diffusione di una “Carta d’identità per i viaggi sostenibili”, in cui vengono individuati i comportamenti di tre protagonisti fondamentali del turismo: il turista, l’industria turistica, la comunità ospitante. Tenuto conto che le leve causali del cambiamento sono i comportamenti, le finalità che il documento si propone sono: • • • • Sviluppare una maggiore attenzione all’interazione tra turisti, industria e comunità ospitanti, per favorire un vero rispetto delle diversità culturali, e una disponibilità di adattamento ad abitudini e modi diversi dai propri, in modo tale da favorire l’apertura necessaria per vivere in una società interculturale; Rendere gli utenti coscienti del proprio ruolo di consumatori del prodotto-viaggio, da cui dipendono la qualità dell’offerta e il destino di milioni altri individui nei luoghi di destinazione; Ridurre al minimo i danni dell’impatto socioculturale e ambientale prodotto dai flussi turistici; Rispettare e incoraggiare il diritto delle comunità locali a decidere sul turismo nel proprio territorio e stabilire con loro rapporti continuativi di cooperazione sociale. L’obiettivo dunque è quello di creare itinerari mirati a raggiungere un punto d'incontro geografico e culturale e volti alla diffusione di un turismo che rispetti le esigenze delle persone e dei luoghi visitati. In particolare, il turismo responsabile coinvolge piccoli gruppi di 10-15 persone in un viaggio precostituito da una rete di soggetti che operano a livello locale. Figura centrale durante il viaggio è la figura dell’accompagnatore, un vero e proprio mediatore culturale, che conosce la cultura locale, ma allo stesso tempo funge da ponte tra essa e la cultura di provenienza dei viaggiatori. Tale presenza costante rende possibile una lettura del territorio molto particolareggiata, che va al di là del mero impatto immediato derivante dall’evidente particolarità di un luogo. Infatti grazie ad un apposito lavoro di decodificazione dei diversi aspetti e segni della cultura locale è possibile entrare in un luogo, conoscendone le contraddizioni, ma anche riuscendo a leggere al di là di stereotipi e pregiudizi. Spesso i viaggi di turismo responsabile si avvalgono di piccoli pulmini per gli spostamenti, e ciò rende più agevole la fruizione di località che altrimenti sarebbero difficilmente accessibili. I tour operator di viaggi responsabili sono particolarmente interessati ad un turismo che non sia di massa, fatto di piccoli numeri, che cerca di rendere costanti attraverso una promozione diversificata, che consenta una certa regolarità delle presenze durante l’anno al fine di destagionalizzare l’offerta. Con il termine “turismo verde” si intendono quegli itinerari naturalistici promossi al fine di conoscere il territorio principalmente dal punto di vista naturalistico. Inizialmente questo genere di turismo era considerato di nicchia e rivolto solamente a un target di viaggiatori escursionisti esperti. Attualmente, esso è diventato un modo di viaggiare sempre più diffuso, che coinvolge sia viaggiatori “fai da te”, sia tour organizzati. Nell’Europa Centro Settentrionale vi sono tour operator specializzati in questo tipo di proposte, che si rivolgono a giovani, ma anche a famiglie ed anziani. Perché un territorio sia fruibile da questo punto di vista sono indispensabili: • la presenza di segnaletica lungo sentieri ed itinerari, in modo che ciascuno possa individuarli percorrerli singolarmente; • la possibilità di ricorrere a guide escursionistiche esperte. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 232 Nell’area in cui ricade il SIC, così come in gran parte della Sicilia, la segnaletica è ancora in via di realizzazione e quindi il visitatore non è indotto a seguirla. Entro l’anno, tuttavia, saranno realizzati circa 8 km di sentieri segnalati nel territorio della riserva ed in parte anche in aree esterne, nell’ottica di estendere in futuro tale azione ad altre parti del SIC. Attraverso la creazione di un sistema di fruizione turistica integrato e sinergico, le tante risorse ambientali e naturalistiche, culturali, artistiche, architettoniche, legate alla memoria storica e alla tradizione locale potrebbero richiamare un numero importante di visitatori. Oltre alla messa in rete delle tante realtà che gestiscono le risorse presenti nel territorio, perché il sistema funzioni è necessario adottare una metodologia di fruizione che induca il turista a non visitare solamente un luogo, il museo, oppure la riserva naturale; si deve invece indurre il viaggiatore a percorrere il territorio, a conoscerlo in profondità, facendogli intuire l’intreccio tra i diversi aspetti della cultura e della tradizione locale e l’importanza del legame tra quest’ultima e le risorse territoriali. In questo modo il turista avrà il desiderio di conoscere meglio i tanti diversi aspetti e si fermerà sul territorio. In tale ottica, sono sempre più diffuse le Tourist Card, delle carte che danno accesso a numerosi siti di rilevanza turistica diffusi sul territorio, ma anche che danno diritto ad usufruire di sconti negli esercizi convenzionati. La Carta non è gratuita, in modo tale che il viaggiatore scelga di “comprare” l’intero pacchetto proposto, con mini-guide per il percorso che ciascuno sceglierà di costruire in base ai propri interessi. Così facendo si aumenterà la propensione a visitare un maggior numero di siti, si faranno conoscere anche le alternative “minori”, si promuoverà l’economia locale. Importante in questo senso è la comunicazione iniziale dell’operazione, che probabilmente dovrebbe essere sostenuta, solo nella fase di start up, da un finanziamento pubblico. Infatti la sostenibilità dell’iniziativa dovrebbe successivamente basarsi sul “prezzo” della Card, che deve essere sufficiente a sostenerne i costi di produzione e comunicazione. Turismo durevole - La diversità biologica e culturale e i caratteri peculiari del paesaggio rappresentano la risorsa chiave del turismo e la loro tutela attiva rappresenta uno dei più importanti fattori di sostenibilità. Per questa ragione occorre favorire la nascita di progetti (e la realizzazione di attività) di riqualificazione, tutela e valorizzazione del paesaggio anche in vista dello stimolo/incentivazione di attività economiche legate al turismo sostenibile. La Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d’Europa, ottobre 2000) ha introdotto una nuova concezione del “paesaggio” riconoscendogli non soltanto il ruolo di componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale ma anche un ruolo attivo e dinamico, valorizzandone anche la componente culturale e sociale del vissuto delle comunità. Nel Preambolo della C.E.P. viene formalmente sancito che “… il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività economica, che, se salvaguardata, gestita e pianificata in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro…”. Particolare interesse, ai fini della nostra analisi, riveste la Carta Europea del Turismo durevole nelle Aree Protette: elaborata da un gruppo formato da rappresentanti europei delle aree protette, del settore turistico e dei loro partner è il risultato di una prima riflessione, avviata già nel 1991 dalla Federazione Europarc, volta a favorire la concreta applicazione del concetto di sviluppo durevole, a protezione delle risorse a vantaggio delle generazioni future, per uno sviluppo economico vitale ed uno sviluppo sociale equo. Obiettivi della Carta sono la promozione di un turismo conforme ai principi dello sviluppo durevole (sostenibile), che coinvolga, attraverso un metodo di lavoro fondato sulla partecipazione e condivisione di metodi e obiettivi, le istituzioni che gestiscono le Aree Protette, i professionisti del turismo Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 233 (imprese turistiche e tour operators) e le comunità (i protagonisti) locali. La Carta definisce “turismo durevole”, una “ qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree protette”. In particolare, gli Obiettivi che la Carta persegue sono: • garantire la miglior integrazione del turismo nell’ambiente naturale, culturale, economico e sociale e la coerenza spaziale e temporale del suo sviluppo; • organizzare la ripartizione delle responsabilità ovvero definire l’impegno individuale e collettivo per l’autorità che gestisce l’area protetta, per le imprese turistiche situate nell’area protetta, per gli organizzatori di viaggi verso e nell’area protetta. A tal fine vengono individuate come prioritarie le seguenti azioni: • miglioramento della qualità dell’offerta turistica, • creazione di un’offerta turistica specifica (promozione di prodotti e di attività turistiche ai fini della scoperta e dell’apprezzamento del patrimonio naturale e culturale locale); • sensibilizzazione del pubblico (al fine di comprendere e apprezzare il patrimonio naturale e culturale locale, di orientare il comportamento del pubblico nel rispetto dell’ambiente e di fornire un’informazione di qualità e di facile accesso); • formazione del personale (sul tema dello sviluppo durevole e del turismo durevole); • protezione e miglioramento della qualità della vita degli abitanti dell’area protetta (garantire un rapporto di qualità fra clienti e abitanti); • difesa e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e storico (far sì che le attività proposte siano compatibili con gli obiettivi di conservazione dell’area protetta, per valorizzare il patrimonio e per perseguire obiettivi di turismo durevole); • sviluppo economico e sociale (sostenere l’economia locale e sviluppare nuove forme di occupazione); • controllo dell’affluenza e della tipologia turistica (conoscenza e controllo del flusso turistico al fine di garantire la protezione dell’ambiente naturale, culturale e sociale e offrire un’esperienza di qualità ai visitatori). 2.3.7.7 Altre ipotesi per uno sviluppo socio-economico dell’area Per quanto riguarda il settore primario ed in particolare l’agricoltura, è evidente che la strada intrapresa a livello regionale, legata ad una agricoltura di qualità, è certamente quella corretta, ma ancora non sufficientemente diffusa e valorizzata nel comprensorio del SIC. Le connessioni economiche tradizionali tra Agricoltura e Turismo fanno riferimento alla capacità di attivazione economica che il turismo ha nei riguardi del comparto agricolo. In particolare ci si riferisce agli effetti diretti (che coinvolgono il comparto locale, come nel caso di “prodotti tipici” acquistati dal turista nell’azienda agricola) o indiretti (quando vi è un passaggio intermedio tra il comparto agricolo e il turista, come nel caso della richiesta da parte di imprese del settore Food&Beverage e dell’acquisto presso punti vendita della distribuzione alimentare) che incidono sulla produzione, sul reddito e sull’occupazione e sono generati dalla domanda turistica dei prodotti agricoli. Oggi, accanto ad un turista “indifferente” ai prodotti enogastronomici locali, abbiamo un turista “sensibile”, per il quale i prodotti tipici e la ristorazione rappresentano dei fattori d’influenza importanti nella scelta della vacanza. Sino a giungere al “turista enogastronomico” che fa della produzione agricola, sia essa prodotto tipico o intermediato/mediato dalla ristorazione elemento primario. Nel turismo enogastronomico, la tipicità e l’unicità delle produzioni agricole locali, ed in generale l’offerta enogastronomica, Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 234 sono la determinante fondamentale del viaggio e della scelta della destinazione. Perché ciò avvenga è necessario un sistema dell’offerta organizzato - che abbia un sistema di commercializzazione che entra in contatto con il turista; - caratterizzato da una sufficiente ampiezza del sistema Food&Beverage; - che integri la proposta turistica con il tessuto produttivo agricolo e agroalimentare locale. (CORERAS, 1995). Da uno studio effettuato dall’Osservatorio turistico della Regione Umbria, si evince che oltre 2/3 dei vacanzieri portano a casa almeno un prodotto tipico locale, ed in particolare prodotti gastronomici e vino sono quelli più frequentemente acquistati (rispettivamente nel 47,3% e nel 27,1% dei casi). Ciò dimostra sinteticamente le potenzialità di un settore in cui ancora non si è puntato a sufficienza in un paese come l’Italia (al secondo posto dopo la Francia per numero di prodotti classificati con il marchio D.O.P. e Igp), riconosciuto nel mondo per le sue peculiarità culinarie e per i suoi prodotti genuini, ed ancor più in una regione come quella siciliana, dove la “buona tavola” è considerata un aspetto fondamentale della cultura locale. Il turismo enogastronomico e l’agriturismo, in un’area come quella in cui ricade il SIC. dove l’agricoltura ancor oggi è una delle principali risorse del territorio, risultano essere adeguati alle caratteristiche della produzione di qualità che caratterizza l’area, rispettosi delle “capacità di carico” del territorio, in sinergia con la promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio. Artigianato e Industria Dal punto di vista della produzione manifatturiera, un settore di notevole rilievo dal punto di vista della produzione di qualità anche se di nicchia, della valorizzazione degli antichi mestieri e che potrebbe avere una forte valenza per quanto concerne il richiamo turistico, è l’artigianato del merletto e del ricamo. Per realizzare una promozione in questo campo, sarebbero necessari prima di tutto adeguati interventi di recupero e rivalutazione dell’attività di ricamo e merletto in chiave socioculturale ed economica, vista la perdurante e progressiva perdita di consapevolezza delle proprie tradizioni produttive da parte della popolazione. Tale ripresa di consapevolezza ed interesse nei confronti di questa tradizione deve mirare al coinvolgimento di giovani in attività sartoriali di alta qualità, in modo tale che siano essi stessi a condurre un processo di evoluzione e modernizzazione del settore basato sulla tradizione e che si muova da una conoscenza pregressa. Infine, largo spazio deve essere concesso ad un’attenta e mirata campagna di comunicazione, volta a far conoscere questa peculiarità locale nel resto del territorio Siciliano e al di fuori di esso. Obiettivo è lo sviluppo del commercio di tali prodotti, anche perché esso possa fungere da elemento di richiamo turistico, tale da poter influenzare anche altri comparti economici, cosicché larga parte della popolazione locale possa beneficiarne. Dall’analisi della situazione dell’economia locale sopra riportata, risulta evidente l’importanza dei settori industriale ed artigianale, che coinvolgono un numero importante di aziende. La maggioranza di queste attività sono considerate portanti per l’economia locale, sia per quanto riguarda l’elemento dell’occupazione, sia per quanto concerne le possibilità di sviluppo economico dell’area. Se normalmente è da considerarsi di grande importanza lo studio dell’impatto che un’impresa può avere rispetto all’ambiente circostante e alla salute delle popolazioni che vivono nelle aree limitrofe, la vicinanza ad un Sito di Importanza Comunitaria rende ancor più necessaria l’osservanza e il rispetto delle norme che tutelano ambiente e salute dei cittadini. A tal fine, per assicurare il rispetto di vincoli e criteri di realizzazione delle produzioni, smaltimento di rifiuti ed eventuali reflui, immissioni in atmosfera, ecc., e più in generale per Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 235 assicurare un effettivo rispetto del territorio e dell’ambiente, diventa indispensabile il potenziamento dell’azione di controllo e di monitoraggio, che dovrebbe essere programmato dalle istituzioni locali in maniera costante ed efficace, avvalendosi della sinergia dei diversi enti che a livello territoriale operano per la salvaguardia del territorio e per la tutela della salute. Per concludere, si ritiene importante fare riferimento al contesto europeo, ed in particolare alla strategia di Lisbona, sancita dal Consiglio europeo del marzo 2000, fondata su tre pilastri: o un pilastro economico che deve preparare la transizione verso un’economia competitiva, dinamica e fondata sulla conoscenza. L’accento è posto sulla necessità di adattarsi continuamente alle evoluzioni della società dell’informazione e sulle iniziative da incoraggiare in materia di ricerca e di sviluppo; o un pilastro sociale che deve consentire di modernizzare il modello sociale europeo grazie all'investimento nelle risorse umane e alla lotta contro l'esclusione sociale. Gli Stati membri sono invitati a investire nell'istruzione e nella formazione e a condurre una politica attiva per l'occupazione onde agevolare il passaggio all'economia della conoscenza; o un pilastro ambientale aggiunto in occasione del Consiglio europeo di Göteborg nel giugno 2001 attira l’attenzione sul fatto che la crescita economica va dissociata dall’utilizzazione delle risorse naturali. Gli obiettivi posti a Lisbona debbono essere recepiti e fatti propri dalle amministrazioni locali e da tutti i soggetti che operano sul territorio, con una particolare attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica,che garantisca il benessere delle popolazioni locali e delle generazioni future. La programmazione e la creazione di politiche che affrontino i fattori critici, promuovano le potenzialità, ma allo stesso tempo garantiscano la sostenibilità ambientale, sociale ed economica per le generazioni future, ma anche per i cittadini di oggi, risulta essere una questione chiave. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 236 2.3.8 Analisi dell’attuale perimetrazione e proposte per l’inserimento di nuove aree In primo luogo si fa presente che, come già segnalato più volte nella presente relazione, l’originaria perimetrazione del pSIC ITA010022 era molto più ampia dell’attuale, estendendosi lungo la dorsale collinare che da Santa Ninfa si prolunga in direzione di Gibellina vecchia. Tale perimetrazione è stata successivamente ridotta dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente senza alcuna motivazione tenico-scientifica, nonostante la presenza in tali aree di habitat e specie di interesse comunitario, rilevate anche nei recenti sopralluoghi, e che confermano la correttezza dell’originaria proposta. Il perimetro del SIC è stato anche leggermente modificato, attraverso limitate e puntuali riduzioni, anche nel passaggio di scala dal 25.000 al 10.000. Nell’ambito degli studi per la redazione del PdG non è stato possibile estendere le indagini di dettaglio all’area inclusa nell’originaria perimetrazione, che in questa fase si ritiene di proporre come parte di un più vasto “corridoio ecologico” (meglio descritto nel capitolo successivo), riconoscendo la sua importanza naturalistica sia come stazione di specie e habitat di interesse conservazionistico, sia come rotta migratoria, sia per continuità ed omogeneità geomorfologica e territoriale La conoscenza del territorio circostante il SIC, nonché alcuni specifici sopralluoghi svolti in aree contigue, hanno consentito invece di individuare alcune aree di limitata estensione che, sia per naturalità che per funzionalità ecologica, meriterebbero di essere inserite all’interno del perimetro del SIC. Le aree proposte sono le seguenti (Tavola 21 – Carta della proposta di riperimetrazione): 1) L’area di Serralonga, nella porzione settentrionale del SIC, ospita un habitat prioritario (6220*), diverse specie floristiche di interesse ed una comunità animale di tipo steppica analoga a quella presente nelle contigue aree del SIC; essa riveste inoltre un elevato valore geomorfologico per la presenza di imponenti e diffusi karren e di doline con inghiottitoi (classificati come habitat comunitario cod. 8310). Per omogeneità territoriale e per continuità ecologica ed ambientale andrebbe certamente inclusa nel perimetro del SIC. 2) In c.da Mostra (versante meridionale del SIC), l’attuale perimetrazione dovrebbe essere estesa includendo la sommità della parete rocciosa ed il sistema di affioramenti gessosi con habitat 6220* e 5332. 3) In c.da La Menta, l’attuale perimetro non segue limiti certi ed esclude aree con le stesse caratteristiche naturalistiche e di assenza di antropizzazione che possiedono le contigue aree del SIC. 4) Lungo il confine ovest del SIC, il limite dovrebbe essere esteso fino a comprendere la parete rocciosa che ospita i più maturi popolamenti a palma nana (habitat comunitario cod. 5333), che sono stati incredibilmente non inclusi. 5) In c.da Castellaccio (una delle aree di maggiore interesse del SIC) l’attuale perimetrazione non segue un limite certo ed esclude aree con le stesse caratteristiche di quelle contigue, peraltro in una zona che gli studi di Piano individuano come critica per le pressioni che si esercitano sul Sito. 6) Il versante gessoso su cui si apre l’ingresso della Grotta di Santa Ninfa, la maggiore e più interessante delle numerose cavità presenti nel territorio, non è incluso nell’attuale perimetro del SIC, pur essendo la grotta citata nel nome del Sito. Da un lato si tratta di un’evidente errore dovuto certamente alla difficile individuazione dell’ingresso della grotta, dall’altro di un’evidente incongruenza atteso che dal SIC attualmente è tenuto fuori il sistema ipogeo più interessante di tutto l’altopiano carsico su cui si estende il Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 237 Sito. Inoltre il versante gessoso ospita habitat di interesse comunitario (cod. 6220* e 5332). 7) Il Vallone in Loc. Varuari, in prossimità del confine orientale del SIC,riveste un notevole valore naturalistico per la presenza di splendidi nuclei di ripisilva (habitat comunitario 92A0), più maturi e conservati di quelli presenti lungo l’alveo del torrente Biviere all’interno del SIC. In questa fase non si prendono in considerazione proposte di modifica dei confini comportanti riduzione della superficie del SIC, considerata la rigorosa posizione assunta dai servizi della Commissione Europea circa le procedure da seguire e le motivazioni da addurre. Si fa tuttavia presente che in alcuni tratti il confine del SIC non tiene conto di limiti orografici e fisici del territorio e potrebbe ben essere razionalizzato anche con piccole esclusioni di aree, facilitando la coincidenza tra i limiti aziendali e/o orografici, anche al fine di rendere più semplici ed efficaci l’azione dell’Ente Gestore. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 238 2.3.9 Relazioni del Sito con la Rete Ecologica Regionale ed individuazione dei corridoi ecologici presenti e potenziali (B.3.8) Il concetto di “rete ecologica” al quale si fa riferimento nel percorso di elaborazione dei piani di gestione di SIC e ZPS deriva direttamente dai principi della Direttiva Habitat, in cui la rete ecologica è finalizzata alla tutela delle specie minacciate per garantire la conservazione della biodiversità, ed in cui le relazioni da garantire tra i nodi sono di tipo ecologico-funzionale, calibrate sulle esigenze di spostamento di singole specie (specie-specifiche) o connesse con la maggiore naturalistà di un Sito da tutelare. La rete ecologica può quindi essere definita come un sistema costituito da aree protette e da altre aree naturali e seminaturali, tra loro interconnesse tramite “corridoi ecologici” che rendono un sistema frammentato un sistema naturale coerente, che supporta una maggiore diversità biologica. E’ possibile individuare l’articolazione funzionale di una rete ecologica nelle seguenti zone: • • • • Core areas: aree ad alta naturalità; Buffer zones: zone cuscinetto a protezione delle aree nodali; Ecological corridors e stepping stones: elementi lineari o areali per le connessioni di tipo ecologico-funzionale tra aree nodali; Nature restauration areas: aree naturali da recuperare e aree di restauro ambientale. Nella suddetta articolazione funzionale viene, inoltre, posto in evidenza il valore della “rete” come modello amministrativo di gestione del sistema delle aree di interesse naturale, protette e non. In questo caso l'obiettivo primario della “rete” diventa di ordine organizzativogestionale e la scala di azione viene definita da fattori di ordine prevalentemente amministrativo. Non si tratta, infatti, necessariamente di modelli reticolari coincidenti con le strutture biologiche o ecologiche del territorio ma, spesso, di indirizzi strategici di orientamento delle politiche di conservazione della natura e, in alcuni casi, delle strategie e degli strumenti di governo del territorio. La realizzazione di una “rete ecologica” non origina dubbi a livello teorico, tuttavia risulta complessa da declinare a livello pratico ed operativo, soprattutto nella costruzione e nel mantenimento delle condizioni territoriali di connettività tra nodi, in quanto presenta implicazioni sia di origine ecologica che di tipo “politico-amministrativo”, in relazione ai soggetti ed agli strumenti di governo del territorio interessati. È necessario quindi integrare le tradizionali strategie di conservazione della natura con una politica generale di pianificazione dell’utilizzo del suolo (JONGMAN in JONGMAN & PUNGETTI, 2004). L’identificazione della rete ecologica è un procedimento molto complesso anche perché occorre tener conto sia della struttura fisica del territorio (uso del suolo, idrografia, topografia) sia della funzionalità e morfologia dei suoi elementi (collegamenti, barriere, nuclei, zona tampone, ecc.). La creazione di un sistema a scala locale di nodi e corridoi dovrebbe pertanto avvenire in varie fasi: 1. individuazione dei nodi funzionali 2. individuazione dei corridoi ecologici e/ delle stepping stones; 3. definizione ed esecuzione degli interventi previsti. Relazioni del SIC con la Rete Ecologica Siciliana La “Rete Ecologica Siciliana” definita con i progetti “Carta della natura” e “Corridoi ecologici” nell’ambito dell’attuazione della Misura 1.11 del POR Sicilia 2000-2006 ed approvata dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, assegna al SIC ITA010022 il ruolo di “stepping stone” (pietra da guado). La carta della rete ecologica riporta nelle Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 239 vicinanze del SIC (lato ovest) un’altra stepping stone, corrispondente alle aree demaniali di Buturro, Torello e Mondura, ed alcuni corridoi lineari corrispondenti a valloni e torrenti. Non tiene conto invece delle aree naturali e/o seminaturali presenti verso est e verso sud, caratterizzate dalla presenza di habitat e specie di interesse comunitario, né della rotta di migrazione autunnale dei rapaci che interessa queste aree e che è già riconosciuta nel Piano Faunistico Venatorio 2006-2011. Pertanto l’articolazione della rete ecologica siciliana, nel comprensorio intorno al SIC ITA010022, non è rispondente alle valenze naturalistiche né è idonea a garantire la tutela delle emergenze naturalistiche presenti. Si propone pertanto, alla luce dei risultati delle indagini condotte nell’ambito del PdG, una rivisitazione della rete ecologica apportando delle modifiche ed integrazioni almeno nella individuazione di corridoi ecologici esterni al Sito, in cui attivare interventi di tutela e riqualificazione ambientale finalizzati all’aumento della connettività ambientale, alla tutela di habitat ed alla diffusione di specie. Proposte di corridoi ecologici (Tavola 22) La realizzazione di una carta dei corridoi ecologici presuppone una buona conoscenza del territorio esterno al SIC, sia in ambito floristico-vegetazionale che faunistico, ma anche relativamente agli aspetti urbanistici e di uso del suolo. Sarebbe quindi necessario ed auspicabile attivare uno studio di dettaglio che individui da un lato le emergenze naturalistiche (specie e/o habitat) da tutelare e da mettere in connessione, dall’altro le aree che possono fungere da corridoi ecologici per caratteristiche ecologiche o funzionali. Tuttavia, sulla base dell’esperienza gestionale maturata nei 10 anni di gestione della riserva naturale “Grotta di Santa Ninfa”, nonché della buona conoscenza naturalistica ed amministrativa del territorio circostante e dei sopralluoghi specifici effettuati nell’ambito della redazione del PdG, in questa fase è già possibile individuare e proporre alcune direttrici preferenziali di collegamento tra il SIC e le aree circostanti, demandando ad un momento successivo una più precisa individuazione dell’estensione e della tipologia della connessione (pietra da guado, area di collegamento diffuso, aree da rinaturalizzare, corridoi lineari, ecc), nonché della classificazione del SIC ITA010022 come “nodo”. Dall’analisi delle aree di interesse naturalistico contigue e/o vicine al SIC emergono con forza due principali direttrici: 1) la prima è costituita dalla dorsale gessosa dei Monti di Santa Ninfa e Gibellina che da Santa Ninfa si spingono, in direzione Ovest-Est, fino a Poggioreale e, superata la valle del Belìce, sino alla Rocca di Entella. Si tratta di un elemento la cui conformazione morfologica segna fortemente il territorio circostante, ne ha per molti aspetti determinato l’evoluzione storicoculturale e configura oggi l’assetto complessivo del suo paesaggio; per caratteristiche morfologiche e naturalistiche, per la sua articolazione e per la forte integrazione tra aree di interesse naturalistico, aree agricole di pregio e siti di interesse storico-culturali, la dorsale gessosa costituisce il principale elemento del sistema di connessioni ecologico-ambientali che dovrebbe caratterizzare la rete ecologica di questo territorio. In tale area sono stati rinvenuti alcuni elementi importanti della flora, tra cui alcuni nuclei di Quercus ilex, di Pistacia lentiscus, di Euphorbia dendroides (che costituiscono un fatto di rilievo per il comprensorio), e soprattutto di Dianthus rupicola, specie non presente nell’attuale SIC e che invece correttamente aveva motivato nel passato una più ampia estensione del SIC, proprio alle aree che si propone di inserire nella rete ecologica. Inoltre, l’area è stata individuata dal Piano Faunistico Venatorio 2006-2011 come “rotta migratoria” per alcune specie di rapaci diurni Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 240 (nibbio bruno, falco pecchiaiolo, grillaio) che la utilizzano nel periodo tardo-estivo, sfruttando le termiche in corrispondenza delle pareti per prendere quota, e riparandosi nelle aree boscate durante la notte. Tale fenomeno è stato confermato dagli studi faunistici condotti nell’ambito della redazione del PdG. Si fa infine presente che lungo la dorsale gessosa ricadono due aree demaniali forestali (la prima tra queste dista soltanto 2,3 km dal SIC, verso est), alcune delle quali caratterizzate da estese formazioni ad Ampelodesma, che possono costituire la trama della continuità di habitat e aree seminaturali. 2) la seconda direttrice è stata individuata verso sud, ed in particolare verso l’area demaniale di Sinapa. Il collegamento individuato è costituito da alcuni valloni e torrenti (corridoi lineari) che attraversano un’area costituita da zone agricole frammiste a praterie, garighe, macchie, nuclei di vegetazione ripariale. Il Piano di Gestione propone, proprio in direzione di arginare i fenomeni di frammentazione e di valorizzare le aree contigue al SIC, di effettuare in tali territori azioni di tutela diretta degli habitat e di promuovere incentivi in materia di misure agroambientali e sviluppo rurale coerenti con l’esistenza del SIC e con l’ipotesi di una più ampia articolazione della rete ecologica di questo territorio, che possiede tutte le caratteristiche per articolare più vaste politiche di miglioramento dell’ambiente e delle aree rurali, promuovendo ed innescando processi economici fondati sulla valorizzazione delle risorse naturali. All’interno del SIC, l’analisi geomorfologica, paesaggistica e naturalistica (floristicovegetazionale e faunistica) mette in evidenza la presenza di due principali nodi territoriali che assumono un ruolo predominante (core areas): - Castellaccio-Magione, caratterizzato dalla mole del Castellaccio e dal paesaggio carsico di Montagna della Magione, dagli affioramenti gessosi con vegetazione casmofitica, a gariga e a prateria xerica, dalle aree boscate del demanio forestale. - Finestrelle-Biviere, caratterizzato dalle pareti rocciose di M. Finestrelle, dalla presenza di affioramenti gessosi con aspetti di gariga, dalle aree boscate del demanio forestali e dalla presenza della riserva naturale. Le pareti e balze rocciose di C.da Menta, Cappellone e Finestrelle costituiscono un primo corridoio di connessione tra i due nodi sopra citati, superando gran parte del sistema di interferenza antropica causato dalla viabilità interna e dall’uso agricolo del suolo; un altro corridoio è stato individuato nell’asse del torrente Biviere, che attraversa la riserva naturale e che costituisce un elemento lineare di elevato valore naturalistico e con funzioni di dispersione e di rifugio. Assumono, infine, funzione di nature restauration areas le aree caratterizzate dalla crescente pressione insediativa che interessano in particolar modo il limite meridionale del SIC, intorno a Monte Castellaccio e lungo la SS n. 188 Centro Occidentale Sicula, e a Nord, le pendici del rilievo lungo la SP n. 75 della Magione, tra Case della Magione e Casa Palermo. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 241 Per quanto riguarda gli interventi di connessione interni al SIC, e con riferimento alla carta dell’uso del suolo, vale la pena di evidenziare alcuni punti utili come indirizzo per interventi tesi ad aumentare l’interconnessione degli habitat presenti nel SIC. 1) Lungo il margine nord-orientale del SIC, in corrispondenza di C.da Campanaro e sopra le Case Magione, bisogna avviare estesi diradamenti ed eliminazione di specie alloctone all’interno dei rimboschimenti che interrompono aspetti pregevoli di mosaico di prateria e gariga; al contempo vanno riviste le modalità di manutenzione ordinaria dei viali parafuoco, va modificato il tracciato di alcuni di essi per evitare manomissioni alle formazioni vegetali naturali. In tale zona vanno salvaguardati i contigui consorzi rupestri dai danni da incendio. 2) L’area del Castellaccio si presenta molto composita ma omogenea dal punto di vista gestionale: gli impianti forestali artificiali vanno gradualmente convertiti in modo da favorire l’espandersi del mosaico di prateria e gariga, dare spazio ai popolamenti di Quercus ilex (messi a dimora circa 15 anni fa), ed eventualmente definire le aree in cui introdurre sperimentalmente la quercia castagnara. 3) Va ripristinata una maggiore continuità della ripisilva e garantita una zona buffer più ampia per la tutela delle comunità di vegetali limitrofi e di popolazioni di anfibi. 4) Va garantita (anche attraverso la realizzazione di fasce parafuoco soggette a pascolo controllato) l’evoluzione degli incolti ad alta fitodiversità che caratterizzano vaste aree a W e SE delle balze di C.da Cappellone. Per un progetto ambizioso come quello della Rete Ecologica, diventa essenziale la capacità degli enti (gestori di aree naturali protette, amministrazioni comunali, Azienda Foreste, ecc.) di “stare in rete”, condizione imprescindibile perché il sistema possa dispiegare in pieno tutte le sue potenzialità e promuovere azioni coordinate ed integrate al fine di orientare allo sviluppo sostenibile delle risorse naturali il complesso del territorio. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 242 In questa ottica appare utile segnalare la necessità di attivare, da parte dell’Assessorato erritorio e Ambiente, una vera e forte strategia basata su coordinamento, linee guida coerenti e strumenti gestionali specifici. Pertanto, la possibilità di perseguire concretamente gli obiettivi posti nonché il grado di efficacia della gestione dipendono molto da alcune azioni che deve intraprendere la Regione ed in particolare dall’emanazione di alcuni atti di indirizzo e regolamentari da parte dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa” Ente Beneficiario Legambiente Comitato Regionale Siciliano 243
Scarica