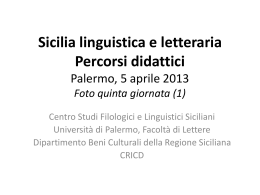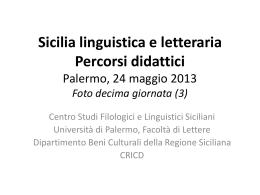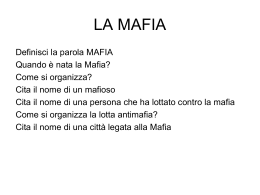UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE CURRICULUM STORIA DEL DIRITTO CICLO XXV LA DIFESA DELLA MAFIA GIURISTI IN SICILIA NEI PROCESSI DI MAFIA TRA OTTO E NOVECENTO TUTOR CH.MO PROF. FRANCESCO MIGLIORINO CH.MA PROF.SSA FLORIANA COLAO COORDINATORE CH.MO PROF. MASSIMO MECCARELLI DOTTORANDA DOTT.SSA ROBERTA D’AQUINO ANNO 2014 Indice Introduzione............................................................................................4 Quadro storico – normativo....................................................................5 Definire il diverso. Declinazioni della mafia di fine '800.......................8 Note Biografiche...................................................................................20 SIMONE CUCCIA.......................................................................................20 PIETRO GRAMIGNANI.............................................................................21 ANDREA GUARNERI................................................................................22 GIAN BATTISTA IMPALLOMENI............................................................25 GIOVANNI LUCIFORA..............................................................................27 PIETRO MESSINEO...................................................................................28 ANTONIO MARINUZZI.............................................................................29 GIUSEPPE MARIO PUGLIA......................................................................30 PAOLO PATERNOSTRO.............................................................................31 GAETANO SANGIORGI............................................................................32 Capitolo I Ad Auxilium Vocatus: la parola del giurista nelle Cronache Palermitane...........................................................................................33 1.1. Avvocati, Politici e Professori................................................................33 1.2. Stile e Retorica: l’architettura dell’arringa............................................35 1.3. Strategie difensive tra questioni pregiudiziali, rilievi processuali e vizi di forma.........................................................................................................38 1.4. Appello al Tribunale della Coscienza....................................................46 1.5. La voce pubblica tra prova morale e prova legale.................................50 Capitolo II L’avvocato Penalista e la classe forense siciliana nel processo all’Italia risorgimentale........................................................................................59 2.1. Diritto di difesa o difesa del diritto?......................................................59 2.2. La difesa della mafia tra Foro e Aule Parlamentari...............................69 2.3. Azioni e proposte degli avvocati per la causa siciliana.........................85 2 Capitolo III La difesa tra i due Codici. Continuità e discontinuità dell’ars defendendi tra “associazione di malfattori” e “associazione per delinquere”............................................................................................96 3.1. L’organizzazione come elemento soggettivo del reato..........................98 3.2. La partecipazione dei socii ai delitti: reato associativo e singole responsabilità..............................................................................................106 3.3. Tra consumazione e atti preparatori. Il contributo del pensiero della scuola classica alla causa siciliana..............................................................110 3.4. Dal thema associativo a quello della complicità nel delitto.................114 3.5. Il bene giuridico tutelato. La nozione di “pubblica tranquillità”.........125 3.6. Manutengolismo: vittime o protettori della mafia? Il caso di una estorsione di due giumente.........................................................................133 3.7. La difesa positivista di Giuseppe Mario Puglia...................................144 3.8. Tra Codice Penale e Codice della Mafia: una difesa sicilianista.........155 3.9. Le difese alla prova del giurì. Sentenze di assoluzione tra arte oratoria e intimidazioni ai giurati................................................................................162 Capitolo IV La Toga per le vittime della mafia: gli avvocati di Parte Civile..........173 4.1. La funzione civile dell’avvocato penalista..........................................173 4.2. Tra Verità Sostanziale e Processuale. Giuseppe Marchesano: «giovane e coraggioso» avvocato nel processo Notarbartolo. Gaetano Spina, avvocato nel processo Amoroso & Compagni: «contro la lega dei tristi» ................177 3 Introduzione Dis – cursus1 scriveva Roland Barthes , è un correre qua e là con la mente, è il trascorrere con la parola da una cosa all’altra. È comporre trame, tracciare percorsi e dare ad essi vita per mezzo della pronuncia. Vi sono discorsi, come quelli che non suppongono contraddizione, che possono essere concepiti per essere scritti. Ve ne sono altri, come le arringhe, destinati a creare una convinzione durante il dibattito che, in nome della loro stessa natura, devono, invece, rimanere orali. Il retore imprime nella mente del proprio uditorio una fugace popolarità, destinata, però, a inclinarsi lentamente verso l’oblio. Tutto l’ingegno dell’oratore, nella sua massima esaltazione, si manifesta attraverso parole che svaniscono una volta terminata la perorazione. Il tono, la voce, l’atteggiamento, i movimenti del viso, i gesti che accompagnavano armoniosamente la frase e quasi la punteggiavano, non possono trascriversi. Preso atto di questi limiti insuperabili, lo sguardo si rivolge alle fonti, al bagaglio trasmesso dalla storia: sono i resoconti stenografici che hanno cristallizzato quel momento unico e irripetibile e il cui studio rappresenta oggi cifra di riferimento per la ricostruzione dell’arte di difesa che, per la prima volta tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del diciannovesimo secolo, tracciò linee e marcature, cancellò e smussò, argomentò e persuase «del tenebroso sodalizio della mafia»2. 1 R. BARTHES, Fragments d’un discours amoureux, Paris, Èd. du Seuil, 1977, p. 13. S. LUPO, «Il tenebroso sodalizio». Un rapporto sulla mafia palermitana di fine Ottocento, in «Studi Storici», anno 29, n. 2, anno 1988, p. 463. 2 4 Quadro storico – normativo Il lavoro di tesi assume come parametro storico l’arco temporale compreso tra la seconda metà del diciannovesimo secolo e il primo decennio del ventesimo e come riferimento geografico lo scenario italiano postunitario e, segnatamente, quello siciliano. All’indomani del crollo del Regno delle Due Sicilie, infatti, ebbe lentamente inizio la fase di costruzione dell’Italia unita. Primo elemento di amalgamazione tra le province del neonato Regno italico fu necessariamente l’unificazione legislativa. In Sicilia sono cambiate le leggi, i governi, le dominazioni e pure la materia giuridica, il diritto, cessando il suo ciclo vitale fra le interlinee del particolarismo del diritto comune, adesso è enucleato e condensato all’interno dei codici, ove si esaurisce. Lo studio pertanto è condotto nell’ambito normativo costituito dal Codice penale Sardo esteso per il Regno d’Italia e dal successivo Codice del 1889. L’oggetto principale dell’indagine è rappresentato dall’esame della fattispecie criminale associazionistica nella sua evoluzione codicistica, cioè nel passaggio dall’ipotesi di Associazione di malfattori prevista dall’articolo 426 del Codice penale Sardo, a quella di Associazione per delinquere disciplinata dall’articolo 248 del Codice “Zanardelli” . Forma oggetto di analisi il metodo retorico, la strategia difensiva, la tecnica argomentativa utilizzata dagli avvocati appartenenti al ceto forense siciliano che nel periodo storico di riferimento assunsero il patrocinio di soggetti legati alle organizzazioni criminali della mafia. L’indagine speculativa è svolta assumendo come angolo di 5 visuale quattro processi celebratisi in Corte d’Assise di Palermo, così menzionati dalla stampa del tempo: Processo ad Angelo, detto “Don Pino”, Pugliesi del 18683, Processo alla Cosca degli “Stuppagghieri” di Monreale del 18784, Processo alla Cosca “Amoroso & Compagni” del 18835 e Processo “per i quattro scomparsi” del 19016. L’intero esame è condotto dal banco della Difesa. Tra tutti i momenti di vita del diritto, certamente il maggiormente dinamico è quello che si consuma sullo sfondo dell’aula del Tribunale quando viene offerta la parola alla difesa. Nell’oratoria e nella dialettica dell’avvocato il diritto prende forma, diventa vivo, sfugge al rigido inquadramento suo proprio, tipico di quando si trova imprigionato nella lettera del legislatore. Qui la materia sembra quasi avere una propria anima e dei propri sentimenti e non si è ancora traslitterata nel giudizio incontrovertibile e fisso del giudice. Dentro l’aula del Tribunale, il diritto è dinamico, si rinnova nel continuo movimento che le diverse arringhe degli oratori imprimono a dargli, mentre le parole pronunciate dagli stessi difensori contribuiscono a forgiare le armi, rappresentate da quelle norme, oggetto di sottile e brillante arguzia interpretativa. Le arringhe degli avvocati rappresentano così il pluralismo delle voci che si possono udire all’interno dell’aula, alle quali fa da 3 A. AJELLO, Angelo Pugliesi, ovvero, D. Peppino il lombardo: resoconto del dibattito celebrato avanti la Corte di Assise ordinaria del circolo di Palermo con la inserzione di tutti gli atti, e specialmente degl’interrogatori degli accusati Pugliesi, Raja e Mistretta, Palermo, Tip. G. B. Gaudiano, 1868. (Di seguito indicato come: Processo Pugliesi). 4 G. MENZA, Le cronache delle Assise di Palermo – riordinate, raccolte e ampliante, Palermo, Tip. Del Giornale di Sicilia, 1878. (Di seguito indicato come: Processo Stuppagghieri). 5 Processo Amoroso e Compagni, Palermo, Tip. Del Giornale di Sicilia, 1883. (Di seguito indicato come: Processo Amoroso). 6 Processo pe’ i quattro scomparsi di Palermo, Palermo, Tip. Del Giornale di Sicilia, 1901. (Di seguito indicato come: Processo per i quattro scomparsi). 6 eco un’altra attrice non protagonista dello stesso dramma che si sta celebrando: la voce pubblica. Concludendo, da un punto di vista squisitamente metodologico, il presente lavoro di tesi è stato ideato in 4 capitoli. Una compiuta analisi delle fonti ha suggerito il ragionevole metodo di approccio alle medesime che è stato utilizzato. Si è infatti proceduto, nell’ordine: a cogliere le fasi salienti della celebrazione dell’arringa, accomunate tra loro dal ricorso a precisi meccanismi retorici; alla individuazione e discernimento dei rilievi di carattere procedurale, celanti a loro volta critiche al sistema giuridico esistente e moniti alla politica del tempo; al rilievo delle categorie giuridiche difensive enucleabili e sintetizzabili in uno studio comparativo. Coerentemente i temi sono stati sviluppati nei capitoli mantenendo il medesimo ordine di trattazione: pertanto nel primo è stato analizzato l’aspetto stilistico – retorico e quello tematizzante i rilievi di carattere formale e procedurale. Il secondo e il terzo capitolo sono stati dedicati all’analisi delle categorie giuridiche emerse dallo studio delle arringhe esaminate, con una particolare attenzione alla ricostruzione del ruolo e dell’immagine del ceto forense isolano; mentre nel quarto è stato spostato l’angolo di visuale sul banco degli avvocati difensori di parte civile nei medesimi processi per le associazioni di mafia, oggetto del presente studio. 7 Definire il diverso. Declinazioni della mafia di fine '800 Il presente lavoro di ricerca pone sotto la lente di ingrandimento materiali giuridici consistenti nei primi processi celebrati ad associazioni criminali riconducibili alla mafia siciliana. Se da un lato, generazioni di storici, sociologi e giuristi con tesi talvolta affini, altre volte divergenti, concordano nel ricondurre al momento immediatamente postunitario la nascita e l’affermazione in Sicilia dell’associazionismo mafioso, dall’altra parte, in un tale contesto, i contorni appaiono sfumati, i rischi di confusione con forme di criminalità e di micro-criminalità locale più che verosimili, le possibilità di equivocare con forme latenti di brigantaggio, tutt’altro che remote. È per questo che si è deciso preliminarmente di interrogare fonti coeve esistenti sul tema, al fine cioè di scoprire la percezione che in pieno Ottocento si avesse del fenomeno, attingendo dalle più complete qualificazioni proposte da coloro i quali, dalla parte del neonato stato italiano – come prefetti, questori e ministri – per primi furono investiti del difficile compito di definire il diverso. Questo studio ha disvelato l’esistenza di caratteri propri, di precisi metodi di azione, di tratti permanenti, di peculiari e secolari riti di affiliazione e di “affratellamento” alla famiglia, tali da sgomberare il campo visivo da ogni eventuale ombra circa la effettiva sussistenza, nei casi esaminati, di meccanismi di interazione afferenti al modo di essere e di operare della mafia siciliana. Già in epoca preunitaria, la percezione del fenomeno recava 8 con sé chiari indici rivelatori. Si faceva, infatti, riferimento ad associazioni segrete, gerarchiche; erano previsti dei “capi zona” per ogni quartiere e il pagamento di una somma mensile per i bisogni comuni. Il primo documento storico ufficiale addirittura preunitario nel quale si rinviene una compiuta definizione del fenomeno risale al 3 agosto 1838, quando il Procuratore Generale di Trapani Pietro Calò Ulloa così relazionava al Ministro della Giustizia Cataldo Parisio: La venalità e la sommissione ai potenti ha lordato le toghe di uomini posti nei più alti uffici della magistratura. Non vi ha impiegato che non sia prostrato al cenno ed al capriccio di un prepotente e che non abbia pensato al tempo stesso a trae profitto dal suo Uffizio. Questa generale corruzione ha fatto ricorrere il popolo a rimedi oltremodo strani e pericolosi. Vi ha in molti paesi delle Fratellanze, specie di sette che dicono partiti, senza colore o scopo politico, senza riunione, senz’altro legame che quello della dipendenza da un capo, che qui è un possidente, là un arciprete. Una cassa comune sovviene ai bisogni, ora di esonerare un funzionario, ora di difenderlo, ora di proteggere un imputato, ora di incolpare un innocente. Sono tante specie di piccoli Governi nel Governo. Il popolo è venuto a tacita convenzione con i rei. Come accadono i furti, escono i mediatori ad offrire transazione pel ricuperamento degli oggetti involati. Il numero di tali accordi è infinito. Molti possidenti perciò hanno creduto meglio divenire oppressori, e s’iscrivono nei partiti7. Compiamo un passo avanti. Nel corso dell’anno 1871, nel quadro di una irrisolvibile questione di ordine pubblico, dal ministero dell’interno giungevano 7 E. PONTIERI, Il riformismo borbonico nella Sicilia del ’700 e dell’800, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli, 1965, pp. 225-235. 9 continue e pressanti richieste di informazioni, si cercava di definire i contorni della specificità siciliana e, in particolare, sul finire del mese di marzo, il ministro Lanza decise di interpellare in questi termini i prefetti dell’isola: «attendo tuttora di conoscere [...] se abbiano acquistato consistenza i sospetti che si avevano intorno a un possibile risvegliarsi della segreta ma operosa associazione della mafia». Il ministro chiedeva «di conoscere se per avventura ne siano stati scoperti o arrestati i componenti»8. Solo qualche anno più tardi, nel 1873, in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario, il Procuratore del re Girolamo Floreno, rivolgendosi alla città di Palermo, nel suo discorso pensò di affidarsi all’invettiva retorica: «L’angelo della Palingenesi possa col caduceo della giustizia mondarti di quel lubrico insetto, la mafia, che sfigura il tuo volto immortale, che corrode le tue membra d’amazzone»9. Lucidissima fu anche l’analisi che ne fece il prefetto di Trapani Giuseppe Cotta Ramusino, il quale fu in grado di fornire un quadro dettagliato che recava con sé il pregio di una compiuta comprensione del fenomeno che andava oltre i singoli episodi delittuosi che erano stati prima osservati come isolati, sganciati da quell’unicum. La visione del prefetto Giuseppe Cotta Ramusino invece era matura al punto tale da aver saputo cogliere e leggere quegli stessi fatti in un insieme unitario. La solidarietà di una azione o cooperazione qualsiasi è il principale vincolo dominante [...]. La maffia infatti invade tutte le classi della 8 A. CRISANTINO, Della segreta e operosa associazione della mafia una setta all’origine della mafia, Sellerio, Palermo, 2000, p. 29. 9 Discorso inaugurale per l’apertura dell’anno giuridico 1873 al Tribunale di Palermo, letto dal Procuratore del Re Girolamo Floreno, in A.CRISANTINO, della segreta, cit. p. 30. 10 società: il ricco se ne avvale per serbare incolume dalla piaga del malandrinaggio la sua persona e le sue proprietà, o se ne fa strumento per mantenere quella preponderanza che ora vede venirgli meno per lo svolgersi e progredire delle libere istituzioni; il ceto medio vi si dà in braccio e la esercita, o per timore di vendetta o perché la ritiene mezzo potente per acquistare malintesa popolarità, o per ottenere ricchezza, o per riuscire al compimento dei propri desideri ed ambizioni; il proletario infine si rende più agevolmente maffioso, sia per l’odio naturale verso chi possiede qualche cosa, o trovasi in posizione più elevata, sia perché abituato a reagire contro l’autorità pubblica e i suoi atti sia per l’aborrimento che in genere nutre pel lavoro e l’occupazione. La maffia del proletario o della classe infima del popolo ordinariamente non tende però ad altri fini se non a quelli di imporre rispetto ai vicini abitanti o di fare rapine od estorcere danaro al ricco incutendo timore o con minacce spesso troppo crudelmente portate ad effetto o col recargli un danno nella possidenza o nella persona [...]10 Secondo l’interpretazione di Francesco Renda se tutti erano coinvolti nella mafia, non tutti vi prendevano parte con gli stessi scopi e con gli stessi effetti. È vero che dal punto di vista del codice penale, il delitto rimaneva sempre delitto, l’associazione per delinquere non cambiava di natura in ragione dell’origine sociale dei suoi componenti. Politicamente e culturalmente, nondimeno, la delinquenza praticata nelle classi subalterne era cosa assai diversa dalla delinquenza esercitata dalle classi dominanti o emergenti. Il barone delinquente o il gabelloto delinquente non era la stessa cosa del contadino o del bracciante delinquente. Era diversa la pericolosità sociale, ma era soprattutto diversa la capacità di fronteggiare e rendere vana la giustizia. In ogni caso a stabilire collegamenti coi pubblici poteri non era il contadino il bracciante. La delinquenza subalterna per un processo di chimica sociale diveniva mafia solo quando si miscelava con 10 Rapporto sulla mafia del Prefetto Giuseppe Cotta Ramusino, Palermo 31 luglio 1874, in Atti del Parlamento Italiano, Camera dei Deputati, Progetti di legge e Relazioni, Sessione 1874 -75. Allegato alla Nota del 18 febbraio 1875. 11 la delinquenza dirigente11 Un altro spaccato di realtà si ritrova poi nei rapporti della questura, in cui, tra gli altri, il mandamento Orto Botanico di Palermo (la principale zona operativa delle associazioni analizzate) veniva descritto come: molto popolato di maffiosi e associati tra loro per delinquere in ogni genere di reati contro le persone e le proprietà. Si tengono associati per mantenere la supremazia sui pastai, fornai, mugnai e crivellatori allo scopo di fare rincarare i prezzi [...]. Ne ricavano significativi vantaggi, perché la loro camorra resta indomabile e ogni azione legislativa e governativa resta innocua12 Il giornale palermitano “Lo Statuto” il 22 febbraio 1877 uscì con un articolo durissimo Assumere che non esistano in Sicilia asssociazioni di malfattori, è lo stesso che cancellare la nostra storia e distruggere gli archivi dell’isola nostra. Le abitudini, i rapporti, il linguaggio delle nostre prigioni hanno da un pezzo costituito questo vincolo morale sublimato dalle politiche convulsioni che è diventato ciò che oggi chiamasi omertà e mafia13 E ancora. Un pregevole e corposo contributo al tema della qualificazione della mafia si rinviene tra le pagine degli appunti 14 di Leopoldo Franchetti nel suo viaggio in Sicilia. Nel 1876, il giovane toscano ebbe modo di «conversare» con numerosissime personalità e di annotare nel suo diario giornaliero le risultanze di tali incontri, oltre alle proprie impressioni. La loro rilettura costituisce oggi una 11 F. RENDA, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, Vol. I, Sellerio, Palermo, 1984, p. 200. ASP, GQ, anni 1860-1886, BUSTA 410 – Informazioni riservate di Gabinetto. 13 Lo Statuto, giornale politico quotidiano, Palermo, 22 febbraio 1877. 14 L. FRANCHETTI, Politica e mafia in Sicilia. Gli inediti del 1876, a cura e con introduzione di Antonio Jannazzo, Bibliopolis, Napoli, 1995. 12 12 incomparabile cifra di riferimento per una corretta interpretazione della percezione dell’epoca sul fenomeno della mafia. Illuminante in questo senso fu – tra gli altri – il colloquio con il Cavaliere Antinori, prefetto di Caltanissetta che spiegò a Franchetti: la mafia è un sentimento medievale. Mafioso è colui che crede di poter provvedere alla tutela e all’incolumità della sua persona e dei suoi averi, mercé il suo valore e la sua influenza personale indipendentemente dall’azione dell’autorità e delle leggi15. Questo è lo spirito della mafia – annotava Franchetti – che esplicandosi in ceti diversi si estrinseca sotto forme diverse. Dal signore che comincia ad adoperarsi a favore d’un malandrino arrestato, che gli paga l’avvocato, gli mantiene la famiglia, scrive un bigliettino al giudice, al prefetto, al direttore del carcere, a quello che prende per campiere un fior di malandrino per meglio garantire la sua proprietà, giù giù fino al contadino e all’operaio che nasconde un latitante, al latitante che si dà alla macchia16. Un altro quadro descrittivo dai toni nitidi e dai contorni definiti emerge poi dall’incontro che Franchetti fece a Girgenti con il delegato di P. S. Dacio Lodi, di origini ferraresi. Nella magistratura, marcio spaventevole. Non v’è che il procuratore del re piemontese, gli altri tutti siciliani. Bisogna andare alla Corte d’Assise per vedere che razza di baraonda. Non si capisce più chi siano i magistrati, i giurati, i detenuti. Il carabiniere a Corte d’Assise non sta impassibile come sul continente, ma c’è come una corrente magica di relazioni tra lui e l’imputato. I locali della pretura sono indecenti e con tutto questo, i soli magistrati locali possono interrogare questa gente che parla dialetto ineleggibile a continentali e che risponde più cogli occhi 15 16 Ivi, p. 22. Ibidem. 13 che colla voce. I mezzi della mafia sono le intimidazioni, che si possono fare soltanto con una occhiata17. Ancora. Di «mafia dei berretti» e di «mafia dei cappelli» – a voler cioè significare la distinzione tra bassa e alta mafia – parlò a Franchetti, il sottoprefetto di Nicosia, il Conte Alfonso dei Conti, spiegando come: talvolta addirittura l’una si coalizza contro l’altra. Gabelloti e campieri qualche volta sono imposti dalla mafia. Si agisce sempre appoggiandosi a parentele e aderenze. Si abborda l’autorità dicendo sono parente e amico del tale o tal’altro pezzo grosso. L’autorità deve conoscere per ogni affare tutti i decreti circolari, pareri del consiglio di Stato etc. perché vengono armati di quelli fino ai denti18. Infine, lo studio ha rilevato come probabilmente, la definizione maggiormente compiuta, quella che ricalca fedelmente i dogmi tipici del fenomeno mafioso, con i suoi canoni di omertà, con le sue logiche di spartizione, gestione e controllo del territorio, con il suo scopo sociale, storicamente volto alla configurazione di uno “stato nello stato”, è quella che si ricava dalla conversazione avuta da Leopoldo Franchetti con l’avvocato Francesco Gestivo. Questi spiegò come: mafia sia un termine vago, in quanto alle associazioni particolari di natura mafiosa o camorrista esistenti in Palermo, bisogna ricordarsi anzi tutto come qui il feudalesimo ebbe più lunga vita che altrove, così si protrassero più le associazioni di arti e di mestieri. Qui vi è una associazione dei mugnai, una dei pastai, una dei fornai, una dei facchini, 17 18 Ivi, pp. 137-138. Ivi, p. 96. 14 etc. Queste associazioni specialmente nei loro rapporti con i soci talvolta varcano i limiti del giusto. Per esempio, nel 1860 vi fu l’abolizione della tassa sul macinato governativo che pagavasi ai Borboni. Ebbene, i mugnai coalizzandosi mantennero la molenda al medesimo prezzo lucrando così l’ammontare della tassa [...] Vi è poi la società della posa che esige un tanto a salma di grano depositato nei magazzini. Il fondo così formato serve ai vari scopi. La società dei facchini ha diviso la città in tanti quartieri e ognuno non può lavorare fuori dal suo quartiere a meno di dare i danari guadagnati ai facchini dei quartieri in cui è stato fatto il lavoro. [...] Tutte queste società hanno segni e parole di riconoscimento, statuto e affogliamento. Vi sono società di facinorosi organizzate con statuti e tutto. Si va dai capi per far commettere un delitto, esercitare una vendetta, ecc. Sono questi che servono alle prepotenze dei gabelloti della Conca d’Oro sui proprietari ecc. I gregari e gli instrumenti di tutte queste società sono bassa gente. Ma i capi portano cappello e marsina. Sono questi che con varie influenze circuiscono le autorità e le impediscono di agire contro le rispettive associazioni. Il vincolo di solidarietà si spiega anche nelle campagne per le gabelle, per imporre gabelloti, guardiani, etc. 19 Ancora, sul finire del 1874 con l’intensificarsi del numero di omicidi all’interno di ambienti ristretti – il che rinviava a precise lotte per il monopolio della gestione del territorio – cominciò una cospicua corrispondenza epistolare fra il nuovo questore di Palermo, Rastelli e il ministro, volta ad accertare se i delitti fossero opera di singoli malviventi oppure di associazioni strutturate. A detta del questore, nella borgata di Palermo detta Uditore operavano associazioni non del tutto formalizzate (mancavano gli statuti scritti) che avevano però forme e regole precise, quali il giuramento iniziatico per i nuovi adepti. Il questore faceva la descrizione della cerimonia, che rinviava a formule massoniche filtrate attraverso la 19 Ivi, pp.197-198. 15 carboneria. Secondo le informative acquisite, l’associazione sarebbe stata ramificata in altre borgate e non tutti gli associati si conoscevano tra loro. Per questo essi erano soliti utilizzare un segnale di riconoscimento, una sorta di dialogo in codice che: «mostra indole volgare e difetto di intelligenza». La ricerca dei “caratteri tipici” tesa a identificare e isolare le associazioni criminali della mafia fece intensificare le relazioni tra la questura di Palermo, i sotto prefetti di Corleone, Sciacca e Alcamo e il prefetto di Girgenti. In uno di questi rapporti venne anche stilato una sorta di identikit: La setta tende al sangue e alla difesa dei suoi componenti quante volte cadranno nelle mani della giustizia. Per fare questo è necessario che si tenga una cassa, quindi con il furto l’impinguano, e sebbene essi non siano soprattutto dei ladri, quando capita l’occasione se ne approfittano. Il Prefetto di Girgenti rispose di avere trovato dei punti di contatto tra gli ultimi arrestati, il più significativo dei quali era che gli affiliati si riconoscevano dal detto: «mi doli stu scagghiuni», che dal dialetto siciliano si traduce in: «mi fa male questo dente canino». Certamente questo elemento non poteva da solo essere sufficiente a fondare l’esistenza di associazioni segrete, ma intanto era la prova di un tessuto semantico persistente. Come ha osservato Amelia Crisantino infatti, Scagghiuni sono i canini superiori. Dire di avere un dolore lì localizzato, in un’epoca priva di analgesici e dove il dentista si identificava col barbiere, equivaleva con l’avere un problema da risolvere. Se poi l’altro lamentava lo stesso fastidio, allora i due avevano qualcosa in comune20. 20 A. CRISANTINO, Della segreta e operosa associazione, cit. p.181. 16 Sempre il prefetto di Girgenti aveva rilevato all’interno delle associazioni, l’esistenza di un tribunale, la struttura militare armata di sicari, la formula di un giuramento e un rito tenebroso per affiliare nuovi associati: […] se si considera che [tali associazioni] hanno a quanto finora si conosce a scopo prevalente l’abigeo, ed il danneggiamento e la manomissione della proprietà rurale non è difficile l’argomentazione che entrambe formano una sola cosa con quelle piccole ramificazioni che ho ragione di credere esistano in codesto circondario, e che partecipano della stessa natura21 Il questore Forte scrisse che: gli Stuppagghieri, costituitisi coi principi e con le costumanze della mafia, di cui non sono che una singolare procreazione, osservano il principio dell’omertà, la sostanza del quale si riduce al silenzio, al mendacio, alla dissimulazione ed alla violenza. Le altre associazioni, nacquero da una unica cellula e poi si ramificarono: a causa dell’unione dei più pericolosi soggetti di ogni paese, avendo per sostrato la maffia in tutte le sue più svariate manifestazioni. I riti tenebrosi e strani degli affiliati non sono dissimili, come pure i segni di riconoscimento, perché comune è lo scopo. Hanno tribunali composti da affiliati e regolamenti; i capi si conoscono, perchè altrimenti non potrebbero mantenere quell’unione e dare quel potente impulso a delinquere22 21 22 ASP, GQ, BUSTA 440, cit. ASP, GQ, anni 1860-1886, BUSTA 410 – Informazioni riservate di Gabinetto. 17 In conclusione, l’analisi ha rischiarato molte luci sulla interpretazione semantica del termine mafia e poche ombre sulla sua esatta strutturazione come fenomeno criminale. Riprendendo la lucidissima e compiuta analisi che ne fece Francesco Renda è possibile senz’altro affermare come: il tratto distintivo della violenza mafiosa fin dal suo primo sorgere era appunto questa capacità di operare all’interno del sistema e di porsi al servizio di interessi dominanti, ricevendone in compenso protezione e servizio. Senza questo collegamento coi pubblici poteri, la violenza non era mafiosa, ma solo delinquenza comune 23 Lo storico ravvisa le cause di questa particolare trasfigurazione dell’associazionismo criminoso come mezzo di crescita sociale, economica, politica e come fonte di potere e talvolta di egemonia, nel fatto che «a essere coinvolti nella mafia furono i membri più spregiudicati della emergente borghesia agraria e gli esponenti più rozzi e retrivi della stessa vecchia nobiltà», non ultimi «anche contadini e braccianti», ma costoro, secondo ancora l’analisi di Renda «non ne costituirono mai l’elemento decisivo24. Sul piano strettamente giuridico, in pieno Ottocento, ovvero in una epoca in cui il fenomeno si trovava ancora in via di affermazione, risulta poi di tutta evidenza come l’esigenza di distinguere la mafia dai reati comuni avesse condotto a imprimerle una configurazione di setta. E del resto, le logiche sottostanti il suo funzionamento, aderenti a canoni di segretezza, di rituale, di omertà evocano proprio immagini settarie25. Tutte le associazioni a 23 F. RENDA, Storia della Sicilia, cit. p. 199. Ibidem. 25 A. CRISANTINO, Della segreta e operosa associazione, cit. p. 24. 24 18 delinquere esaminate possiedono quindi i cromosomi tipici propri della mafia siciliana, che storicamente non ha quasi mai vissuto di meccanismi di auto – dichiarazione, quanto invece di auto – rappresentazione, sicché sono fattori di interpretazione univoci che ci consentono di affermare come: l’associazione di Don Angelo Pugliesi, la setta degli Stuppagghieri di Monreale, la banda dei Fratelli Amoroso e Compagni – le cui documentazioni processuali formano fonte primaria del presente lavoro – furono tra le prime manifestazioni in Sicilia di associazionismo mafioso a fare ingresso nelle aule di tribunale. 19 Note Biografiche SIMONE CUCCIA Simone Cuccia nacque ad Augusta, in provincia di Siracusa il 15 marzo 1841. Figlio di Luca, ufficiale dell’esercito borbonico, facente parte della colonia albanese di Mezzojuso. Conseguì la laurea in giurisprudenza presso la facoltà di Palermo nel 1862. Brillante avvocato del foro palermitano, ricoprì anche l’incarico di docente universitario nelle seguenti discipline: storia del diritto, introduzione alle scienze giuridiche e diritto processuale penale. Considerato uno dei “creatori” della sociologia criminale, è suo uno studio sulla catalogazione delle varie forme di delinquenza e si occupò anche dei vari tipi di malattie mentali dei soggetti coinvolti. Si interessò altresì della delinquenza femminile. Nel 1882 lasciò la cattedra per dedicarsi all’attività politica. Fu infatti eletto deputato alla Camera nel I Collegio di Palermo e venne confermato ininterrottamente sino alla morte. In precedenza aveva ricoperto altre cariche pubbliche cittadine, nel 1867 fu infatti eletto consigliere provinciale di Palermo e un anno più tardi consigliere comunale del capoluogo siciliano. Fu, poi membro del consiglio del Banco di Sicilia e vice presidente del “Circolo Giuridico” di Palermo. Nel 1888 fu relatore del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia. Collaborò attivamente alla compilazione del Codice Penale “Zanardelli”, di cui fu relatore assieme a Villa, Marcara e Nocito. Morì a Palermo, ove è sepolto nel cimitero monumentale della città, il 22 febbraio 189426. 26 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Leg. XVIII, 1 Sess., Discussioni, tornata del 23 febbraio 1894, pp. 6112 e ss. 20 PIETRO GRAMIGNANI Pietro Gramignani nacque a S. Caterina Villarmosa in provincia di Caltanissetta27, il 12 dicembre 1815. Si addottorò in legge il 25 ottobre 1838. Avvocato, di cultura poliedrica, fu uno studioso, un letterato, uno scrittore. Patriota, egli sottoscrisse la mozione di decadenza della dinastia Borbone dal trono di Sicilia il 13 aprile 1848. Il figlio, Vittorio Emanuele, raccolse, ordinò e pubblicò le «Memorie storico – biografiche di Pietro Gramignani», un saggio che attraversa tutta la vita e le battaglie combattute dal padre. Si spense il 10 luglio 1893. 27 G. M. BERTOLO, La rivoluzione del 1848 e la provincia di Caltanissetta, Tip. dell’Ospizio prov. di beneficenza, Caltanissetta, 1898, p. 517. 21 ANDREA GUARNERI Andrea Guarneri nacque a Palermo il 15 maggio 1826. Dopo un’educazione classica intraprese studi giuridici, filosofici e storici presso l’università del capoluogo siciliano. Nel 1848 partecipò attivamente ai moti insurrezionali dell’isola e ottenne l’incarico di commissario straordinario del governo a Caltanissetta. Fu docente di etica e diritto naturale, di filosofia teoretica e procedura civile presso la facoltà di legge della città di Palermo. Ricoprì importanti cariche pubbliche, fu infatti consigliere comunale e provinciale del capoluogo siciliano. Studioso di diritto antico siciliano, fu presidente della Società Siciliana per la Storia Patria di Palermo. Nel 1860, svolse un ruolo di primo piano nell’insurrezione che precedette lo sbarco di G. Garibaldi e il 2 giugno 1860 fu nominato ministro di Grazia e Giustizia nel governo dittatoriale. In questa fase Andrea Guarneri tentò un’opera di mediazione tra il partito d’azione, d’ispirazione democratica, e il partito cavouriano, o piemontese, politicamente moderato, che puntava all’annessione incondizionata dell’isola al Regno sabaudo. Il 20 giugno 1860 prese apertamente posizione in favore dei cavouriani e si dimise dall’incarico governativo in polemica con la paventata intenzione di Garibaldi di rinviare l’annessione. In questo periodo Andrea Guarneri elaborò il progetto d’istituzione di un Consiglio straordinario di Stato per la Sicilia che avrebbe conservato all’isola una certa autonomia nell’ambito dell’ordinamento del costituendo Stato unitario. L’auspicio che l’unificazione italiana non comportasse un accentramento amministrativo tale da soffocare le realtà regionali e, in particolare, 22 il tradizionale spirito autonomistico siciliano, costituì da allora un elemento costante della sua attività politica. Successivamente, il 5 febbraio 1880 fu nominato senatore del regno. Nel 1886 pubblicò a Palermo la sua opera più importante, “Il Senato d’Italia. Parole di un Senatore”. Nel saggio descriveva l’ordinamento e il concreto funzionamento del Senato e, constatato il suo ruolo secondario nella politica nazionale, ne proponeva una riforma radicale. Andrea Guarneri osservava che la Camera alta aveva perso considerevolmente importanza in favore di quella elettiva. Inoltre, all’interno del Senato si era costituito una sorta di “corpo permanente”, un gruppo ristretto di senatori, membri delle commissioni più rilevanti, che, grazie alla loro assiduità e coesione, indirizzavano la politica dell’assemblea. La riforma proposta prevedeva innanzi tutto l’istituzione delle regioni, considerate da Guarneri «la struttura naturale della nazione italiana», che a suo dire «avrebbero dovuto essere organizzate già da lunga pezza, se non fosse stata la tema troppo eccessiva di restaurazione degli antichi Stati, ed un patriottismo troppo esaltato, quasi una specie di italianismo fanatico». L’elezione dei senatori sarebbe stata affidata ai Consigli regionali. Ciò avrebbe trasformato il Senato in un organo di rappresentanza delle regioni del Regno e favorito quel processo di decentramento amministrativo da sempre auspicato. Al riguardo Guarneri richiamava l’esempio degli Stati Uniti d’America. Successivamente, nel saggio “Il Senato d’Italia (studio contemporaneo)”, in «La Riforma sociale», riprese il tema attenuando le sue proposte; in particolare, ritenne che si dovesse 23 mantenere la nomina regia dei senatori. Andrea Guarneri svolse in Senato un’intensa attività di opposizione ai governi della Sinistra, criticando la pratica del trasformismo parlamentare e la tolleranza ritenuta eccessiva nei confronti dei movimenti sindacali e socialisti. Si oppose all’estensione del suffragio elettorale e, più in generale, all’evoluzione in senso democratico dell’ordinamento. Il suo intervento più rilevante ebbe luogo il 22 apr. 1902 con la presentazione di un’interpellanza al capo del governo G. Zanardelli “sulle condizioni politiche e sociali” del paese. In essa il egli sottolineava come le profonde trasformazioni sociali ed economiche verificatesi nella società italiana avessero determinato l’urgenza di una nuova legislazione sociale. Alla conclusione dell’animato dibattito in aula Guarneri presentò un ordine del giorno di critica alla politica del governo respinto, per pochi voti, dall’assemblea. Si spense a Palermo il 5 ottobre 191428. 28 Atti e documenti di A. Guarneri, Biblioteca della Società siciliana di storia patria, Fondo Lodi, carpetta 16, camicia I. 24 GIAN BATTISTA IMPALLOMENI Giovan Battista Impallomeni nasce a Milazzo il 29 ottobre 1846. All’età di ventidue anni consegue il diploma di laurea in giurisprudenza presso l’università di Messina, ove inizierà ad esercitare la professione di avvocato. Nel 1873 vinse il concorso in magistratura, carriera che lascerà quando nel 1890 sarà proclamato vincitore del concorso alla cattedra di Diritto e procedura penale presso l’università di Parma. Qualche anno più tardi venne poi chiamato alla cattedra di diritto penale dall’università di Palermo. Tra le difese più celebri che patrocinò nella lunga e brillante carriera di avvocato, ricordiamo quella in favore di Giuseppe De Felice Giuffrida e compagni nell’ambito del processo penale che li vedeva imputati quali organizzatori dei Fasci dei lavoratori in Sicilia. La passione politica lo porterà alla nomina a consigliere comunale di Palermo, avvenuta nel 1895. Qualche anno più tardi fu impegnato nuovamente nelle aule di tribunale, in difesa degli imputati De Andreis, Turati e altri dirigenti socialisti, in un importante processo avente chiari risvolti politici. Lasciò alla penalistica italiana uno straordinario contributo attraverso numerosissime pubblicazioni sulle riviste scientifiche, una copiosa produzione monografica, l’edizione di imponenti opere quali: «Il Codice Penale Italiano illustrato» e «Le istituzioni di diritto penale». L’intervento sul domicilio coatto pubblicato nel 1897 in «Giustizia Penale» fu motivato dalla presentazione alla Camera di un progetto governativo di riforma di questo istituto, già approvato dal Senato: esso rivela le intuizioni di Impallomeni sulle 25 pericolosità insite nella legge penale, e, in generale, nelle norme che intendevano istituire le misure di sicurezza. Con la nuova legge si voleva imprimere all’istituto del domicilio coatto un «carattere di maggiore legalità, ed un’applicazione più ristretta, accompagnata da guarentigie veramente efficaci». Nel disegno di legge, appariva, però, la seguente disposizione: «Possono essere assegnati a domicilio coatto coloro che con atti preparatori abbiano manifestato il deliberato proposito di attentare, con vie di fatto, all’ordinamento della famiglia o della proprietà». Impallomeni comprese e smascherò subito il pericolo celato in questa norma: essa dava un nuovo e più rischioso carattere all’istituto, trasformandolo, da apparente misura contro le classi pericolose dei malfattori, in legge politica di sospetto29. Morì a Roma il 7 marzo 1907. 29 COLAO F., Giovan Battista Impallomeni avvocato tra libertà politiche, questione sociale, «eccesso di potere nel giovane Regno d’Italia», in Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea a cura di F. MIGLIORINO E GIACOMO PACE, Il Mulino, Bologna, 2013. 26 GIOVANNI LUCIFORA Nacque a Palermo il 23 marzo 1832. Da sempre appassionato di storia del diritto siciliano, nel 1905 pubblicò un corposo saggio dal titolo: “La Rivoluzione siciliana del 1848-49: preceduta da un sunto storico dei principali avvenimenti svoltisi in Sicilia e specialmente in Palermo, dal principio del secolo XVIII, fino agli anni più vicini alla rivoluzione suddetta”. Fu socio della Società Siciliana per la Storia Patria di Palermo. Dopo la laurea, conseguita presso la facoltà di giurisprudenza della Regia Università di Palermo, dedicò tutta la sua vita alla avvocatura e ricoprì importanti cariche pubbliche cittadine, tra cui quella di assessore al comune con delega alla istruzione30. Si spense all’età di 79 anni nella sua città di Palermo. 30 G. LUCIFORA, La Rivoluzione siciliana del 1848-49: preceduta da un sunto storico dei principali avvenimenti svoltisi in Sicilia e specialmente in Palermo, dal principio del secolo XVIII, fino agli anni più vicini alla rivoluzione suddetta, Bondi, Palermo, 1905. 27 PIETRO MESSINEO Pietro Messineo nacque a Palermo il 27 giugno 1829. Di poliedrica cultura, profondo conoscitore di letteratura, di storia e di arte, stimato e conosciuto avvocato del foro palermitano, lasciò un cospicuo numero di pubblicazioni, molte delle quali in materia di storia risorgimentale. Repubblicano – massone, il 17 luglio 1877 indirizzò a Caprera a Giuseppe Garibaldi un telegrammanel quale dichiarava l’unione del suo “Consiglio supremo palermitano” col “Grande Oriente d’Italia31”. Morì a Palermo il 25 marzo 1897. 31 «Officine massoniche Palermo, riunite ieri sera Tempio Palazzo conte Federico, udita lettura concordato stipulato tra Grande Oriente d’Italia e Supremo Consiglio di Palermo, lieta unione compiuta assicurante potenza, prosperità istituzione, esprimono voto ringraziamento rappresentanti Grande Oriente Roma e Supremo Consiglio Palermo. Pongono saluto affetto Gran Maestro onorario Garibaldi» in ASP, BUSTA 42, FILZA. 25. 28 ANTONIO MARINUZZI Antonio Marinuzzi, figlio di Michele, nacque a Palermo il 25 agosto 1851. Celebre oratore e appassionato cultore di storia del diritto pubblico siciliano, fu socio della Società siciliana per la Storia Patria di Palermo. Avvocato, rivestì importanti cariche pubbliche, fu infatti consigliere comunale, pro–sindaco della città di Palermo, nonché Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo. Eletto deputato nel collegio di Palermo nelle legislature XVII, XXI e XXII. Fu nominato senatore del Regno il 3 giugno 1911. Di ideologia liberal – costituzionale, fu un seguace della politica di Crispi. Alla sua morte, avvenuta a Palermo il 19 aprile 1917 donò alla biblioteca comunale della città la sua preziosa raccolta di opere di diritto pubblico siciliano. In senato, il collega senatore Benedetto Scillamà nel giorno della morte lo ricordò con queste parole: Antonio Marinuzzi non prescelse l’avvocheria per bramosia di lucro, come dimostrò la sua morte, ma per geniale, intima vocazione. Ben tosto egli si fece ammirare nel foro palermitano per l’eloquenza della sua parola, per la forte dialettica dei suoi ragionamenti, sicché fu salutato principe e maestro del foro penale siciliano. Fondò in Palermo una scuola di diritto penale e nell’immenso corteo che accompagnò il suo feretro, si è visto uno stuolo di tanti giovani avvocati piangere la sua morte, chiamandolo maestro amato32. 32 Atti parlamentari, Senato del Regno, Discussioni, 20 giugno 1917. 29 GIUSEPPE MARIO PUGLIA Giuseppe Mario Puglia nacque a Palermo il 2 gennaio1823. Celebre avvocato e giureconsulto, assunse le difese processuali dei patrioti Nicolò Garzilli, Francesco Bentivegna, Giovanni e Francesco Riso e dell’arcivescovo di Monreale Benedetto D’Acquisto. Nel 1862, Giuseppe Garibaldi, tenuto prigioniero nel forte di Varignano, lo delegò insieme all’avvocato Emanuele Viola, nella difesa del processo che si stava intentando contro di lui. Investito di importanti cariche pubbliche, fu presidente della deputazione provinciale, deputato al Parlamento italiano dal 1886 al 1890. Fu chiamato a rendere una deposizione in occasione della commissione d’inchiesta sulle condizioni morali ed economiche della provincia di Palermo del 186633. Avo dell’omonimo Giuseppe Mario Puglia, anch’egli avvocato, studioso e seguace della scuola positiva, la cui dottrina influenzerà moltissimo l’elaborazione di un suo saggio dal titolo: “Il mafioso non è un associato per delinquere”. 33 Archivio Storico Comunale di Palermo, schede biografiche, (1820-1840). 30 PAOLO PATERNOSTRO Paolo Paternostro nacque a Misilmeri, in provincia di Palermo il 17 ottobre 1821. Fu un patriota, sedette alla Camera dei Comuni nel biennio 1848-1849; partecipò alla rivoluzione siciliana, celebre rimase il suo “Proclama alla Gancia” di Palermo quando arringò la folla a ribellarsi contro il regime, nei cui confronti il 13 aprile 1848 presentò una mozione tesa alla decadenza dell’intera dinastia Borbone. Fu poi costretto ad esiliare in Egitto. Dopo l’Unità d’Italia rivestì importanti cariche pubbliche, fu dapprima designato prefetto della città di Arezzo, fu poi consigliere della Corte dei Conti, nonché eletto deputato alla Camera tra le file della Destra nella VIII legislatura e nelle successive X; XII e XII confluì nella sinistra costituzionale. Il 15 maggio 1876 fu nominato senatore del Regno. Di idee sinceramente costituzionali, fu tra i pochi politici siciliani che maggiormente avversarono l’autonomismo e il regionalismo. Si spense a Palermo il 6 dicembre 188534. 34 Atti parlamentari, Senato del Regno, Discussioni, 7 dicembre 1885. 31 GAETANO SANGIORGI Gaetano Sangiorgi, figlio di Salvatore, nacque a Corleone, in provincia di Palermo il 25 febbraio 1823. Dopo la laurea in giurisprudenza conseguita presso l’università di Palermo, si dedicò all’avvocatura. Stimato e celebre oratore del foro del capoluogo, fu un patriota. Nei moti insurrezionali di Sicilia venne assunto alla carica di Segretario di Stato per la sicurezza pubblica sotto la dittatura del Generale Garibaldi e quindi a quella di Segretario di Stato dell’interno sotto la prodittatura. Nel 1862 insegnò diritto amministrativo presso la Regia Università di Palermo. Fu eletto nella X legislatura deputato alla camera tra le file dei liberal – moderati, più tardi, il 16 novembre 1882 venne nominato Senatore del Regno. Morì a Palermo il 1° gennaio 188435. 35 Senato della Repubblica, Archivio Storico – Senatori dell'Italia liberale (1861-1922). 32 Capitolo I Ad Auxilium Vocatus: la parola del giurista nelle Cronache Palermitane Mentre noi discutiamo, suonano gli echi di pallide e stentate intonazioni, con le quali una vera associazione, quella della callida speculazione dell’uomo sull’uomo, tenta strappare all’onda che travolge, l’ultimo frusto di una potenza che crolla. Si puniscano i rei: ma si crei la colpa prima. Avv. Angelo Gestivo Puglia 1.1. Avvocati, Politici e Professori Nella Sicilia di fine XIX secolo, la figura del Difensore rispecchiava ancora quella dell’antica professione che affondava le proprie radici storiche in una lunga tradizione di autonomia corporativa36. Per una prima ricostruzione del carattere del ceto forense isolano giova senz’altro rilevare come una storia degli avvocati non possa ritenersi scissa da quella della borghesia37, intendendo come tale una formazione sociale i cui componenti risultano contrassegnati dal possesso di proprietà, di istruzione, di diritti, di interessi comuni, di ideologie affini, di circuiti di affari e di attività. La vicinanza alla borghesia si manifesta anche nel fatto che la classe avvocatizia nel XIX secolo prese parte al movimento nazionale nelle sue varie articolazioni: liberali, repubblicane e democratiche38. È proprio a partire da qui che si condensa la figura 36 H. SIEGRIST, Gli avvocati nell’Italia del XIX secolo. Provenienza e matrimoni, titolo e prestigio in «Meridiana» n. 14 del 1992, pp.145-181. 37 M. MALATESTA, Professionisti e gentiluomini. Storia delle professioni nell’Europa contemporanea, Einaudi, Torino, 2006, p. 21. 38 H. SIEGRIST, Gli avvocati nell’Italia del XIX secolo.cit. pp.145-181. 33 dell’avvocato politico. Le più alte e notabili cariche della classe forense isolana scorrono su importanti nomi che scrissero la storia dell’ultimo scorcio dell’Ottocento siciliano: Simone Cuccia, Paolo Paternostro, Giovanni Lucifora, Antonio Marinuzzi, solo per citarne alcuni. L’elemento che accomunava tutti questi grandi giuristi era senz’altro la poliedrica cultura che li contraddistingueva. Nelle allegazioni essi offrivano diverse chiavi di lettura applicativa della legge. Tracciando un solco di elaborazione dottrinale, essi, non solo fornivano una soluzione al caso concreto ma più spesso enucleavano valori e principi di massima, astrattamente validi e destinati a riproporsi ciclicamente. Lo studio delle fonti ha restituito l’immagine di un ceto forense, quello palermitano, vivace e propositivo, perfettamente inserito nel panorama dell’avvocatura italiana, che per dirla con le parole di Hannes Siegrist: «dominava il campo giuridico, non solo per la sua numerosità, ma anche per la forte impronta che essa conferì all’immagine del giurista: gli avvocati infatti partecipavano allo sviluppo e al controllo delle scienze giuridiche»39. I giuristi siciliani, desiderosi di affermare e consolidare il ruolo di prestigio personale e della propria famiglia40, dimostrarono tutti una conoscenza ampissima in materie scientifiche, umanistiche, letterarie, filosofiche, storiche e impreziosirono le arringhe e gli scritti con citazioni extra-giuridiche di notevole spessore. 39 H. SIEGRIST, Profilo degli avvocati italiani dal 1870 al 1930. Omogeneità istituzionalizzata ed eterogeneità reale di una professione classica, in «Polis», VII, 2 agosto 1994, p. 223. 40 A. CAPPUCCIO, Il tocco, la toga e l’abito nero: la professione forense nella Sicilia dei Borboni in Tra foro e scienza giuridica. Le fonti per la storia dell’avvocatura in Sicilia nell’età della codificazione, SGB, Messina, 2010, pp. 25 e ss. 34 Si trattava di riferimenti dotti e aulici che testimoniano un gusto autentico nel ricercare un linguaggio che fosse sintesi efficace di eloquenza e di tecnicismo, tra sapere giuridico e non. Come l’analisi ha rivelato questi giuristi furono uomini politici del loro tempo, nonché, quasi in tutti i casi, docenti di diritto presso l’Università degli Studi di Palermo41. E questa trivalenza traspare fortemente dalle loro difese processuali, nelle quali sono veicolate polemiche politiche, proposte di legge o insegnamenti di estrazione eminentemente accademica. 1.2. Stile e Retorica: l’architettura dell’arringa Il processo è tradizionalmente il luogo dell’argomentazione. È dominato dalla retorica: la procedura fornisce le forme, ma è la retorica che correda i contenuti. L’oratoria giudiziaria può definirsi un’arte applicata a una finalità pratica. In pieno Ottocento si assistette ad un fiorire di saggi, libelli e monografie42 densi di consigli dai quali trarre spunto per la costruzione tecnica delle proprie arringhe difensive, nonché ricchi di suggerimenti circa lo stile da mantenere durante il dibattimento. Opere lontane da sterili e asettici formulari e consistenti in piccoli vademecum, scritti da avvocati per altri avvocati. Frutto di studio severo dei classici della retorica antica, condensati di esperienza vissuta, non avevano mai un piglio lezioso, ma piuttosto 41 B. PASCIUTA, Itinerari di una cultura giuridica: la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo dalla fondazione al fascismo (1805-1940), in «Annali di Storia delle Università italiane», 12, anno 2008, pp. 387-421. 42 M. GARCON, Sull’oratoria forense, Giuffrè, Milano 1957.; G. B., DE LUCA Lo Stile legale, Il Mulino, Bologna, 2010; P. TRINCHERA, L’arringa penale, Ed. Vittoria, Milano, 1932. 35 rappresentavano una sorta di testimone che i più anziani trasmettevano ai giovani che si apprestavano a varcare la soglia delle aule giudiziarie. Una pagina della rivista L’eloquenza ci restituisce un mosaico di qualità che dovevano appartenere al patrimonio di un buon oratore forense: Egli deve essere innanzi tutto uno psicologo per vedere dentro l’anima dell’imputato, per coglierne l’intenzione, il movente, la necessità talora che lo spinge al delitto, per vagliarne l’entità umana; un giurista per atteggiare il fatto al diritto e trattare le molteplici questioni, profonde e sottili che sorgono dai dibattiti; un artista per dar rilievo, forza, grazia, efficacia al contenuto, anzi per pensarlo sub specie pulchritudinis; un dialettico per annodare la catena dimostrativa degli argomenti e muovere pronto ed agguerrito negli scatti, nelle aggressioni, nelle diversioni della polemica verbale; un paziente pratico, industre e avveduto, per non restar sopraffatto dalle insidie dei piccoli contraddittori e discender talora – il meno possibile – al livello del pubblico43 L’architettura di una arringa doveva possedere tre caratteri, sintetizzabili in firmitas, utilitas, venustas i quali dovevano coesistere nei giusti dosaggi per dar vita a un discorso di successo. Uno sfoglio veloce degli scritti in tema di eloquenza giudiziaria insegnava ad esempio come fosse buon uso sottoporre ogni ragionamento logico al rigore del sillogismo, che avrebbe formato l’ossatura e fornito, spesso, lo schema proprio della discussione, senza però che questo riducesse l’arringa a una mera enunciazione di aride proposizioni, ma contribuendo anzi a svilupparne, invece, il ritmo, tipica espressione dell’ethos oratorio. 43 A. GIAMPA, L’Eloquenza Antologia, anno II, Vol. I, 1912, pp. 474-475. 36 Appartiene a Chaḯm Perelman la distinzione fra il persuadere44 e il convincere45, due concetti rigorosamente distinti. Il primo è un fenomeno di natura psicologica, che concerne la capacità a muovere l’adesione a livello emotivo di un uditorio, spingendolo ad aderire a una tesi sulla base di suggestioni che fanno appello alla psicologia di chi ascolta. Il secondo si traduce nel fare appello non alla psicologia e quindi alle componenti emotive, ma alla razionalità di chi ascolta; fornire argomenti che, non per la loro suggestione psicologica, quanto per la loro forza logica inducano chi ascolta a convenire su una tesi. A questi pilastri della edificazione dell’oratoria forense, la letteratura scientifica ne aggiunge un terzo che è espressione della teoria argomentativa della negazione, ovvero la confutazione. Tale metodo consiste nel procedere per eliminazione successiva delle ipotesi contraddittorie o infondate. L’oratore, in sostanza, porta gradualmente alla luce l’infondatezza di tutte le convinzioni fondanti l’accusa. Seppur presentate da essa come “certe”, attraverso questo percorso, scemano lentamente in “opinioni”. Tale metodo non si fonda sul tentativo di vincere l’interlocutore con la propria abilità retorica, ma mira a condurlo, con una serie di brevi domande e risposte, a rivedere i limiti dei propri assunti, fino a riconoscere la prevalenza della verità rispetto alla falsità delle presunzioni della controparte. Riepilogando, in estrema sintesi, almeno tre sono i pilastri 44 C. PERELMAN, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, Einaudi, Torino, 1966. C. PERELMAN, Il campo dell’argomentazione. Nuova retorica e scienze umane, Pratiche Editrice, Parma 1979. 45 37 fondanti del ragionamento oratorio che costituiscono il modello architettonico presente in tutte le arringhe dei giuristi oggetto di studio e che sono rappresentati dalla persuasione, dalla convinzione e dalla confutazione. Si tratta di schemi46 all’interno dei quali si inseriscono le strategie difensive tipiche e i diversi modelli stilistici di retorica. Ovverosia, quei canali attraverso cui crescono e si affermano, per il tramite della parola dell’avvocato gli imperativi dell’argomentazione47 intorno al concetto giuridico di mafia. 1.3. Strategie difensive tra questioni pregiudiziali, rilievi processuali e vizi di forma Prima di addentrarsi nelle specifiche della difesa tecnica delle associazioni criminali della mafia è possibile già enucleare il ruolo svolto dall’avvocato penalista seguendo i contorni del sistema procedurale del tempo in un processo contrassegnato da due aspetti fondamentali. Da un lato, l’introduzione della giuria popolare 48, che accentuava gli aspetti retorico-dialettici della attività in aula, in avallo ai principi di oralità e pubblicità, su cui era improntato l’intero sistema processuale. Dall’altro, la bipartizione del processo49 stesso, in un momento istruttorio, a carattere inquisitorio e in un altro dibattimentale, di modello accusatorio, comportando la 46 B. MORTARA GARAVELLI, Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense, in La lingua, la legge, la professione forense, Giuffrè, Milano, 2002, p. 3; G. Alpa, “Forensic Linguistics”: il linguaggio dell’avvocato nell’evoluzione dell’ordinamento, dei metodi interpretativi, delle prassi e della tecnologia in L’avvocato e il processo. Le tecniche di difesa, a cura di M. Mariani Marini e M. Paganelli, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 21 e ss. 47 A. HIRSCHMAN, Retoriche dell’intransigenza, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 22-23. 48 L. LACCHÈ, Un luogo “costituzionale” dell’identità giudiziaria nazionale: la Corte d’Assise e l’opinione pubblica (1859-1913), in Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento, a cura di Floriana Colao, Luigi Lacchè e Claudia Storti, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 77-120. 49 M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860 – 1990) in L. Violante (a cura di), Storia d’Italia, Annali, 29, Legge, diritto, giustizia. Einaudi, Torino 1998, pp. 487-551. 38 esclusione della difesa tecnica dalla prima fase, determinava la presenza dell’avvocato solo nell’ultimo momento, quello della discussione, appunto. Questi tratti somatici caratterizzanti il processo penale di fine Ottocento furono riproposti, in chiave di polemica e di contestazione, nelle arringhe e nelle allegazioni degli oratori che si avvicendarono nella difesa di soggetti imputati del reato di associazione per delinquere50. E infatti ripercorrendo i resoconti stenografici51 e confrontando le risultanze degli stessi con la letteratura mafiologica52 del tempo, il primo elemento a emergere è il ruolo giocato dagli avvocati attraverso le arringhe difensive. Si evidenzia un contributo notevole o meglio ancora, determinante in termini di creazione e di stabilizzazione di significati che ritorneranno come delle costanti lungo tutto il percorso di tesi. È qui che la tipizzazione dei tratti classici del processo penale ottocentesco incontra le peculiarità dei meccanismi retorici propri del patrocinio dell’associazionismo criminale. Come parametro iniziale si assuma il processo celebrato contro la cosca degli Amoroso & Compagni 53 del 1883, un sodalizio maffioso che nella Conca d’Oro di Palermo, precisamente nel quartiere Orto Botanico, seminava da anni terrore e violenza, attraverso il compimento di efferrati reati, facendosi forza dell’impunità goduta fino al momento del suo arresto e che trovandosi in dichiarata guerra con la famiglia avversaria dei 50 L. LACCHÈ, Alle origini della associazione per delinquere. Crimen Plurimum, concorso e reato plurisoggettivo tra Antico Regime e XIX secolo, in Annali della F. di Giurisprudenza di Macerata, Milano 1989, p. 671. 51 Processo Pugliesi, Processo Stuppagghieri, Processo Amoroso, Processo per i quattro scomparsi. Cit. 52 G. ALONGI, La maffia, Tip. Fratelli Bocca, Palermo, 1886; F. COLACINO, La fratellanza, in «Rivista di discipline carcerarie», XV, fasc. 5 e 6, anno 1885; A. CUTRERA, La mafia e i mafiosi, Gi Effe Edizioni, Palermo, 1900. 53 Processo Amoroso. cit. 39 Badalamenti. Per questi motivi, la banda degli Amoroso – come scrisse qualche anno più tardi il delegato di pubblica sicurezza Antonino Cutrera – «unita dal vincolo mafioso»54, fu arrestata e dovette rispondere di ben dieci carichi d’imputazione. Il primo era l’art. 426 del codice penale sardo-italiano, il reato di associazione di malfattori. Un processo che vide sedere nei banchi della difesa «le più grandi notabilità del foro palermitano, ad auxilium advocati» per: «portare una parola di sollievo ai poveri sventurati che siedono dietro le gabbie»55, come disse l’avvocato Agostino Tumminelli nel suo exordium. Poc’anzi si faceva cenno alle critiche che sul piano formale gli avvocati erano soliti muovere in apertura del dibattimento al sistema processuale vigente. Ne forma esempio lo scontro tra i difensori e i magistrati, quando l’avvocato Pietro Messineo sollevò un incidente, rilevando che il suo assistito non era stato ascoltato nel processo istruttorio sui medesimi fatti sui quali adesso veniva interrogato56. E in effetti, questioni preliminari di questo stesso genere furono sollevate anche nell’ambito del processo Pugliese, nel quale gli avvocati, con una certa veemenza, denunciarono abusi e illegalità nella conduzione della fase istruttoria e in particolare nella gestione degli interrogatori di polizia. Così l’avvocato Purpura nel processo Amoroso, in un passo della sua arringa difensiva lesse le risultanze istruttorie dalle quali si evidenziava come «i cinque propalatori della causa dopo avere trascorso un mese insieme nei cancelli della questura, rimasero insieme per cinque mesi A. CUTRERA, La mafia e i mafiosi, cit., p. 156. Arringa Tumminelli, in Processo Amoroso, p. 243. 56 Arringa Messineo, in Processo Amoroso, p. 227. 54 55 40 nell’ospedale del carcere giudiziario»57. La circostanza fu interpretata dal difensore con la prospettazione alla giuria di due ipotesi alternative: «o restarono cinque mesi all’ospedale per essere stati trattati in Questura in un modo che qui non è luogo dire – oppure – rimasero nell’ospedale ben pasciuti per remunerarli delle rivelazioni loro fatte nella questura medesima»58. Più diretto fu l’avvocato Masnada nel processo Pugliesi: «fu il bastone, O Signori, che spinse l’imputato a confessare. Questa confessione è figlia della prepotenza e dell’arbitrio, andrebbe da voi disconosciuta perché è ottenuta con le sevizie»59. Nel corso del medesimo dibattimento anche gli avvocati Francesco La Farina e Gaetano Zucco parlarono di maltrattamenti e abusi da parte della polizia, così gravi da dover ritenere irrimediabilmente inficiata la confessione resa dai loro difesi in quelle circostanze. L’incidente, tra l’altro, fu l’occasione per lo sfogo di un altro difensore, l’avvocato Simone Cuccia che denunciò i rischi connessi all’attuale sistema processualpenalistico del quale egli auspicava una celere riforma perchè: «il magistrato inquirente che non può non subire le prime impressioni, non può non procedere in seguito collo spirito prevenuto contro l’imputato» 60. E la critica era rivolta al sistema inquisitorio che lasciava all’avvocato un ruolo marginale nella tensione tra giudice e imputato. L’intervento del difensore avveniva, infatti, dopo la pubblicazione degli atti, a processo informativo e offensivo chiuso, quando 57 Arringa Purpura, in Processo Amoroso p. 209. Ibidem. 59 Arringa Masnada, in Processo Pugliesi p. 23. 60 Arringa Cuccia, in Processo Amoroso, p. 146. 58 41 l’avvocato temeva essersi già consolidato nella mente del magistrato il più grande dei rischi: il pregiudizio. Nella dialettica processuale, però, in mancanza di prove certe, la strategia difensiva dell’avvocato si improntava lungo la linea della discrepanza tra gli atti generici raggiunti dall’accusa e le risultanze probatorie processuali. Un altro oratore, l’avvocato Alfonso Siragusa sostenne l’argomento della inattendibilità del teste, cogliendo le sfumature tra le dichiarazioni rese da un propalatore nel procedimento inquisitorio e quelle fornite dallo stesso nel momento del dibattimento. Rivolgendosi ai giurati non lesinò l’uso di un registro piuttosto duro nel dire: «questa non è critica, non è speculazione difensiva, è verità, verità processuale!»61. Del resto, per dato costante62, in una arringa pronunciata a difesa del sodalizio mafioso, il vizio di forma, il cavillo intelligentemente trovato, poteva risultare essere determinante per la difesa e questo perché i processi di mafia poggiavano quasi sempre su una imbastitura composta esclusivamente da un insieme di testimonianze. Per l’oratore riuscire a colpire al cuore la integrità della propalazione resa dal teste poteva equivalere a una uscita vittoriosa dal processo e questo perché, in assenza di altri elementi, il castello accusatorio, eretto sulla base delle risultanze dei cosiddetti elementi generici, veniva così a perdere consistenza, sgretolandosi sotto gli occhi dei giurati. Un taglio dello stesso genere si rinviene nella difesa pronunziata dall’avvocato Agostino Tumminelli, il quale sollevò un vizio di procedura contemplato dall’articolo 311 del codice di procedura penale sulla qualità delle 61 62 Arringa Siragusa, in Processo Pugliesi, p. 28. Proc. Amoroso; Proc. Stuppagghieri; Proc. Pugliesi; Proc. Per i quattro scomparsi. 42 propalazioni del teste chiave del processo, che era stato sentito nella fase istruttoria in qualità di denunziante, ma le cui dichiarazioni scritte furono poi lette nel corso dei dibattimento, in pregiudizio alla norma citata, che discerneva invece le diverse posizioni tra testimone, querelante e denunziante e riservava solo alle propalazioni provenienti dai testimoni l’attitudine a essere lette nella successiva fase dibattimentale. Non mancò anche un riferimento storico, infatti, l’oratore concluse la sua memoria rimarcando che già le leggi borboniche imprimevano un diverso peso e una diversa trattazione alle dichiarazioni: «siano esse rese da soggetti aventi qualità di testi o di semplici denunzianti»63. Un ulteriore evidente rilievo procedurale cui si fece largo ricorso nel tentativo di invalidare l’intero processo venne attinto dalla qualità del testimone. Infatti, il processo Pugliese era stato imbastito sulla base della propalazione resa al magistrato proprio dal suo capo banda ‘Don Peppino’, il quale era già stato nel 1857 condannato all’ergastolo. L’avvocato Masnada si domandò se meritasse fede la dichiarazione di un individuo che aveva commesso così tanti reati da essere condannato all’ergastolo: «può elevarsi a prova la di costui dichiarazione?». Non andò meglio nel corso del processo contro la cosca Amoroso & Compagni, ove l’intero procedimento fu imbastito sulla scorta di alcune lettere che un tale Rosario La Mantia aveva spedito alla questura di Palermo e nelle quali era stato spiegato l’organigramma dell’associazione criminale, nonché erano stati forniti dettagli sui nomi degli affiliati. Queste lettere avevano dato il primo impulso alle indagini sulla base delle quali si era poi arrivati 63 Arringa Tuminelli, in Processo Amoroso, p. 243. 43 all’arresto dei fratelli Amoroso. L’autore delle lettere, un tale Rosario La Mantia era stato anche sentito dalla questura che ne aveva così raccolto le confidenze. La stranezza risiedeva nel fatto che al teste – chiave del processo, su sua semplice richiesta era stato rilasciato dalla questura il passaporto con cui poco prima dell’inizio del processo il La Mantia aveva espatriato. La circostanza, di non poco rilievo processuale, fu evidenziata dagli avvocati Simone Cuccia e Paolo Paternostro i quali chiesero a gran voce l’estromissione dal processo delle lettere, in quanto sul loro contenuto non sarebbe stato possibile interrogare l’autore in quanto si trovava fuori dai confini nazionali. Per gli avvocati, che sollevarono più di un incidente su questo profilo, quella assenza valeva a dire che il processo era stato «inventato» dalla questura, diversamente essa non avrebbe rilasciato il passaporto al teste principale proprio a ridosso dall’apertura del dibattimento 64. E del resto, la tesi del teorema giudiziario, della magistratura che crea una ipotesi di reato per attuare un disegno politico, sarà un modello destinato a riproporsi ciclicamente negli schemi difensivi esaminati. Lungo lo stesso filone, ma con un registro più colorito, si rinviene una argomentazione simile in un passo dell’arringa dell’avvocato Paolo Figlia, che suggeriva ai giurati di pensare alla figura che potrà farne la città di Palermo dinanzi al Regno intero: «si inventano le associazioni a delinquere e se una vittoria si ha – questi processi non si finirà più di crearli»65. Rimanendo nell’ambito dello stesso processo, in un altro intervento, l’avvocato Purpura sostenne la tesi che soltanto le confessioni rese innanzi al 64 65 Arringa Paternostro, in Processo Amoroso, p. 211.. Arringa Figlia, in Processo Amoroso, p. 235 44 giudice potessero essere credibili e non invece quelle extragiudiziali: il D’Alba confessò davanti alla Pubblica Sicurezza e davanti all’autorità giudiziaria negò tutto – ma perché? Ecco la domanda che un onesto e intelligente giurato deve farsi dapprima. [...] E ciò perché innanzi al giudice D’Alba diceva quello che doveva dire mentre innanzi alla P. S. diceva quello che gli si faceva dire66. In conclusione, ripercorrendo a ritroso il sentiero tracciato dai discorsi degli avvocati si evidenziano dei chiari elementi sintomatici del fenomeno della mafia. Si tratta di nomi, qualificazioni, accezioni e talora allusioni che di fatto collocano l’avvocato al centro di un ruolo fondamentale e insostituibile nella cristallizzazione dei caratteri imperativi dell’argomentazione sulla mafia, già solo per la natura della sua professione. L’avvocato è un uomo di parte, non ha obblighi di verità, ma solo di fedeltà al dovere di lealtà e di probità nella conduzione del proprio ufficio, nei confronti del proprio assistito67. Nel processo di mafia si assiste ad un mutamento di quel rapporto tipicamente privato, confidenziale che s’instaura tra l’oratore e il suo cliente, che qui cambia, assumendo toni maggiormente pubblicistici. Il carattere dell’avvocato in questa tipologia di processi sembra andare addirittura oltre il naturale concetto di “favore della difesa” che Francesco Carrara aveva già individuato come: «tratto distintivo di tutti i popoli civili»68. 66 Arringa Purpura, in Processo Amoroso p. 208. D. GIURIATI, Arte forense,Roux e Favale, Torino, 1878, p. 422. 68 F. COLAO, Avvocati del risorgimento nell’Italia della restaurazione, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 353. 67 45 1.4. Appello al Tribunale della Coscienza Lo studio in senso comparatistico delle arringhe pronunciate dagli avvocati nei processi di mafia oggetto di ricerca non può esulare dall’analisi del metodo utilizzato in un particolare e precipuo momento del discorso quale è quello della perorazione. Qualunque sia stato l’ordine di presentazione degli argomenti, la dimostrazione è ora terminata e occorre dirlo. Da un punto di vista squisitamente formale, se i principi di chiarezza e di utilità 69 devono continuare ad adornare, come le altre parti del discorso, anche quest’ultimo momento, è possibile affermare con altrettanta certezza che una perorazione deve essere sempre più breve rispetto agli altri segmenti che compongono l’arringa. Essa mira, infatti, a far constatare che la promessa delineata all’esordio è stata osservata, che la dimostrazione è stata ultimata e che, dunque, il proprio ufficio si sta quasi per compiere. La costruzione della perorazione appare generalmente informata alla categoria aristotelica70, secondo la quale è buona abitudine ingraziarsi l’ascoltatore e renderlo contestualmente ostile all’avversario, esaltarsi o umiliarsi, mettere in moto le passioni dell’uditorio e ricordare i fatti salienti in forma risolutamente sintetica. L’elemento che accomuna tutte le chiuse oggetto di studio è, sotto un profilo stilistico, il ricorso al campo della logica oppure a quello degli affetti, talora i due luoghi sono utilizzati in sincrono, tal’altra rappresentano l’occasione per gli avvocati per dar sfoggio a uno degli argomenti maggiormente vocati nelle difese di crimini di mafia: la voce pubblica. Nella perorazione lo stile è sicuramente più 69 70 M. GARCON, Sull’oratoria forense, Giuffrè, Milano, 1957, pp. 64-73. E. VERCESI – E. SANTINI, L’eloquenza, Vallardi, Milano, 1938, pp. 47-52. 46 ampio, le parole che chiuderanno l’arringa saranno le ultime a essere udite dai giurati e allora certamente dovrà farsi in modo che queste restino loro ben impresse, non a caso i Greci erano soliti chiamare il momento conclusivo dell’orazione, coronamento. Atteggiandosi, sovente, come un appello, una supplica, un’ultima preghiera, l’intelaiatura della perorazione produce effetti anche nei confronti degli elementi tipici dell’ethos oratorio, per cui la voce diventa più calda, la frase più solenne, il tono più elevato, talvolta si ricorre all’uso di metafore e di iperboli per apparire maggiormente persuasivi e incisivi. I suggerimenti di grandi maestri di oratoria forense, quali Mittermayer, Giuriati e Garçon indirizzavano, tra l’altro, l’avvocato a tenere una giusta postura che non desse le spalle né al pubblico, né alla Corte, in modo tale da guadagnare un’ampia visuale per poter scrutare sui volti dei presenti ciò che le loro parole riuscivano a suscitare, nonché l’utilizzo di una corretta cadenza per poter facilitare l’ascolto della parte conclusiva dell’orazione. Preliminarmente pertanto all’indagine nel merito e nei contenuti delle arringhe difensive degli avvocati nei processi di mafia oggetto di studio, si intendono qui ripercorrere rapidamente usi e strategie di persuasione nelle perorazioni finali. Breve ed estremamente concisa ma allo stesso tempo densa di significato fu la chiusa pronunciata nel “Processo per i quattro scomparsi” dell’avvocato professor Giambattista Impallomeni che, al termine di una vigorosa arringa che aveva visto magistralmente trattati accanto a temi eminentemente giuridici, motivi di taglio più sociologico, oltre che politici, rivolgendosi alla giuria concluse dicendo: «con le offese alla giustizia, non si curano le piaghe 47 sociali»71. Dietro queste poche parole si cela in realtà un discorso molto più ampio di quanto non possa sembrare in apparenza. Impallomeni, riesce ad andare oltre le scolastiche prescrizioni di una perorazione, egli mira a persuadere l’animo dei giudici e per farlo rimette loro un dilemma ancora più grande: mentre qualifica, senza nominarla, la mafia come una piaga sociale, fa un monito cui non è possibile sfuggire, fa appello al rischio che venga consumata una ingiustizia. Egli imprime in questo modo nella giuria popolare una sorta di sinistro presagio e lo fa volontariamente per appesantire la decisione finale. Vediamo un altro esempio. Si accennava, poc’anzi, al tema della voce pubblica quale figura assai ricorrente nelle perorazioni, sotto le sue variopinte e policrome rappresentazioni. Nell’ambito del Processo Amoroso, l’avvocato Gargano ebbe cura di precisare come nella istruzione dello stesso «l’opinione pubblica si è pronunziata, ma di questo voi Giurati non dovrete tener alcun conto»72. A questo punto egli ricorre a uno dei metodi tipici e molto efficaci di costruzione della perorazione: utilizza infatti una metafora che per il suo contenuto ben si presta a una immediata comprensione da parte dell’uditorio. Cita «per così mostrarvi ciò che è la voce pubblica»73 il Dante nel Convito: «pecore e non uomini, purché il primo grida, gridano tutti», prosegue aggiungendo la qualificazione che il Sommo Poeta diede dell’opinione pubblica nello stesso verso: «e ciò che fa la prima, le altre fanno». La citazione è chiaramente di natura extragiuridica ma va interpretata nell’ottica del sottostante messaggio giuridico che si 71 Arringa Impallomeni, in Processo per i quattro scomparsi, p. 8. Arringa Gargano, in Processo Amoroso, p. 219. 73 Ibidem. 72 48 propone di trasmettere, ovvero il valore intrinseco e la conseguente portata della voce pubblica come fattore autonomo nei processi oggetto di studio. La tecnica è direttamente attinta dalle regole di retorica classica, era di applicazione parecchio diffusa e consentiva di far permeare nella mente dei giurati un concetto di rilevanza giuridica ricorrendo a un campo di cognizione immediata: pensiamo proprio a Dante nel Convito e alla proposizione semplice con la quale egli spiega il significato dell’opinione pubblica. Sempre nello stesso senso, l’avvocato Agostino Tumminelli nel medesimo processo ammonì i giurati a giudicare «separando l’oro dal rame»: la scelta, ancora una volta, è per un linguaggio semplice, diretto, popolare, atto, specie quando si sostanziava in una metafora, a imprimere subito nella mente dei giudici togati, il concetto che si voleva loro trasmettere. Ancora più incisivo a tal riguardo fu l’avvocato Giovanni Lucifora nel processo alla banda di Peppino Pugliesi del 1868, quando concluse la sua energica arringa, richiamandosi alla qualifica che la pubblica opinione ne fece in principio, definendolo un «mostruoso processo», esortando i giurati a non volerlo chiudere con un altrettanto «mostruoso»74 verdetto. La scelta di inserire nella perorazione finale rivolta ai giurati, un aggettivo qualificativo già appellato dalla pubblica opinione non è casuale ma è frutto di un sottile ed arguto ragionamento logico – giuridico, agevolmente comprensibile attraverso uno speciale focus sulla giuria. 74 Arringa Lucifora, in Processo Pugliesi, p. 97. 49 1.5. La voce pubblica tra prova morale e prova legale In pieno Ottocento liberale75, una frangia qualificata dell’opinione pubblica diventa opinione giudiziaria76, i rischi connessi sono visibili sia che l’opinione pubblica intervenga nel giudizio come parte, quindi come voce pubblica, sia che vi faccia ingresso come giuria77, come «opinione pubblica saggiamente rappresentata»78, come espressione per la sua dimensione costituzionale di una istanza giurisdizionale chiamata a rappresentare direttamente l’opinione pubblica nei processi penali79. L’avvocato Giovanni Lucifora80 si rivolse alla giuria, al tribunale della pubblica coscienza, utilizzando la qualifica che la pubblica opinione aveva già fornito del processo, perché mirava ad ottenere un verdetto assolutorio che rispecchiasse la volontà della stessa opinione pubblica, di cui la giuria costituiva quella saggia rappresentazione81. L’avvocato Schirò a conclusione della sua arringa nel processo Pugliese, rivolgendo una ultima «preghiera» ai giurati «pazienti», subordinò al solo vaglio di tutte le «pruove» emerse nel dibattimento, la formazione di un verdetto scevro da qualsivoglia condizionamento, sottolineando contestualmente l’esistenza di «tre 75 C. FIORE, Il controllo della criminalità organizzata nello Stato liberale: strumenti legislativi e atteggiamenti della cultura giuridica, in «Studi Storici», n. 29, 1988, p. 421. 76 P. MARCHETTI, Introduzione in Inchiesta penale e pregiudizio, una riflessione interdisciplinare. Atti del Convegno di Foggia 5-6 Maggio 2006, Esi, Napoli, 2007, p. XIII. 77 G. CIANFEROTTI, Logica del processo, logica del giudizio e opinione pubblica, in Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento, Il Mulino, Bologna, 2008, p.16 78 L. LACCHÈ, Un luogo “costituzionale” dell’identità giudiziaria nazionale:la Corte d’Assise e l’opinione pubblica, in Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 77-78. 79 G. CIVILE, Per una storia sociale dell’opinione pubblica: osservazioni a proposito della tarda età liberale, in «Quaderni Storici» 104, 2000. p. 11. 80 Arringa Lucifora, in Processo Amoroso, p. 237. 81 L. LACCHÈ, L’opinione pubblica saggiamente rappresentata. Giurie e Corti d’Assise nei processi celebri tra Otto e Novecento, in P. MARCHETTI, Introduzione in Inchiesta penale e pregiudizio, una riflessione interdisciplinare. Atti del Convegno di Foggia 5-6 Maggio 2006, pp. 89-147. 50 giudici supremi» che si stagliavano al di sopra: «la pubblica opinione, la nostra coscienza, Iddio»82. Questo argomento riconosceva come primo giudice della triade, proprio la pubblica opinione secondo un ruolo e una dimensione che in pieno Ottocento liberale aveva i contorni propri di un «tribunale della pubblica opinione»83. Solo quindici anni più tardi, l’avvocato Simone Cuccia al processo Amoroso auspicherà ai giurati «un verdetto negativo, che sarà dato con la piena soddisfazione della coscienza del giudice e sarà coronato dal plauso della pubblica opinione»84. Parimenti, sempre nello stesso senso rinveniamo nella perorazione dell’avvocato Sangiorgi, discussa nel medesimo processo, un caloroso invito rivolto ai membri della giuria a decidere «rivendicando dal pietoso suffragio della pubblica opinione che benedice e suggella il vostro verdetto di libertà!»85. L’analisi ha rivelato come specularmente a questo, l’opinione pubblica potesse intervenire nel processo come parte, come voce pubblica. Questo ruolo rappresentava addirittura una costante nei processi di associazione per delinquere di tipo mafioso. Le fitte pagine dei rapporti dei questori di polizia trasudano, infatti, di notizie conosciute per mezzo della voce pubblica86. I testimoni chiamati in escussione al processo, alle domande del Presidente della Corte d’Assise su come avevano saputo di un determinato fatto rispondevano con sicurezza che: «lo disse la voce pubblica». 82 Arringa Schirò, in Processo Pugliesi, p. 43. L. LACCHÈ, Un luogo “costituzionale” dell’identità giudiziaria nazionale. cit. p.78. 84 Arringa Cuccia, in Processo Amoroso, p. 251. 85 Arringa Sangiorgi, in Processo Amoroso, p. 111. 86 ASP, GQ, ANNO 1880, BUSTA 7 – Processo Stoppaglieri. 83 51 Questo corpo invisibile, che non ha un volto, non possiede un nome, non è perseguibile a termini di legge per quello che racconta,ha però una voce assordante che si insinua dentro e fuori dalle mura dell’aula del Tribunale. In un delicato compito quale è quello della difesa, questo aspetto non sfugge di certo a quello che è il primo attore della sacra rappresentazione del processo, ovvero l’avvocato. Egli, infatti, sfrutta l’elemento della voce pubblica come un fattore di distorsione della asserita logica processual – penalistica87. «Dalle confidenze anonime non può farsi base per una sentenza!»88 fu il monito lanciato ai giurati dall’avvocato Gianbattista Impallomeni nel corso del processo. Erano gli albori del XX secolo quando il celebre avvocato denunciò con grande veemenza quello che ritenne il punto debole dell’accusa, ma già nel 1876 il processo contro la famigerata associazione mafiosa degli Stuppagghieri di Monreale poté essere imbastito proprio sulla scorta di un confidente, che fu poi definito «l’apostata», il quale rivelò riti, statuti e codici della cosca operante nelle campagne dell’agro palermitano89. Naturalmente a quella attività di impulso processuale si rannodò una raccolta di notizie che permise nuovamente alla voce pubblica di entrare nel dramma giudiziario da protagonista e di stagliarsi ancora in quell’angusto interstizio tra prova legale e prova morale. In questo senso, la perorazione dell’avvocato Pergola fu costruita, però, in maniera diversa da quella dell’avvocato 87 CIANFEROTTI, Logica del processo, cit. p.17. Arringa Impallomeni, in Processo per i quattro scomparsi, p. 11. 89 A. CRISANTINO, Della segreta e operosa associazione, cit. p. 110. 88 52 Impallomeni. Mentre il secondo affrontò direttamente i giurati con una chiusa breve e dal carattere quasi ammonitorio, il primo fece invece ricorso a figure retoriche particolarmente incisive, quali ad esempio la prolessi. Ciò innescò un meccanismo di continue interrogazioni cui lo stesso oratore si accingeva immediatamente a rispondere per porne subito dopo delle altre, in un fervente e continuo crescendo, volto a suggellare definitivamente la perorazione finale. Ove finalmente l’assertiva della voce pubblica? Forse da quanto piacque alle parti interessate da ultimo deporre? Ma se di voce pubblica era a farsi puntello in un edificio così barcollante, come spiegherete Voi che di questa voce informante, non mai fecero menzione? Se una voce pubblica sorgeva, non era questa nel demanio di tutti? Ove le persone del popolo, che avrebbero dovuto ascoltarsi? E gli offesi perché non la raccolsero, e non la denunziarono sin dalle prime esplorazioni della giustizia, e quando più volte spronati vennero dalla stessa a dare dei lumi alla medesima? Ma si parla di voce pubblica ove nissuno dei numerosi testimonii che vennero intesi ne fece menzione? Si argomenta di voce pubblica sol perché è l’offeso, che la palleggia senza accennarne le sorgenti? Si rattoppi quanto si vuole, se fracida è la stoffa, il suo tessuto non regge. 90 La perorazione dell’avvocato Antonio Marinuzzi nel processo Amoroso appariva più un monito, egli infatti si rivolgeva ai giurati, chiamandoli «uomini di coscienza» e subordinava precise conseguenze ai possibili risvolti del verdetto finale: «come coraggiosamente affronterete la mafia e le sue minacce se condannerete, con egual coraggio affronterete l’opinione pubblica 90 ASP, CA, anno 1878. BUSTA 188. 53 falsamente impressionata se assolverete»91. La giuria popolare aveva un compito preciso, l’oratore avverte che qualunque scelta deciderà di fare, occorrerà del coraggio, in un caso, infatti, si tratterà di affrontare la mafia, nell’altro l’opinione pubblica. Antonio Marinuzzi costruì abilmente questo argomento, memore probabilmente della polemica suscitata da un articolo apparso sul quotidiano palermitano “Lo Statuto” 92 e di fatto continuamente alimentata dalla stampa e, grandemente, dagli accesi dibattiti a livello politico regionale e nazionale, riguardanti l’utilità della previsione dell’istituto del giurì quale garanzia di libertà popolare. L’articolo proponeva in tono polemico le ragioni fisiologiche e psicologiche che ostavano a un giudicar sereno: dalla facile impressionabilità dei giurati, al pensiero che forse costoro non potevano strutturalmente essere all’altezza di un così arduo compito; talvolta, infatti – come rilevato anche da Altavilla – erano fattori estrinseci quali l’irritabilità nervosa o la simpatia mostrati da un imputato a finire con l’incidere pesantemente sul verdetto finale93. Nello stesso senso militava la consapevolezza che: «attorno a ogni Corte d’Assise esista una formale o non formale associazione di gente che vive corrompendo in ogni modo i giurati94». L’articolo si spinge fino all’esaltazione della specialità della realtà siciliana rispetto al resto d’Italia: «qui da noi a questo lavorìo si aggiunge l’altro che agisce sul corpo dei giurati per atti di mafia 91 Arringa Marinuzzi, in Processo Amoroso, p. 203. LO STATUTO, giornale politico, 13 giugno 1878. 93 E. ALTAVILLA, La psicologia giudiziaria, Tipografia Sociale Torinese, Torino, 1925, p. 19. 94 LO STATUTO, cit. 92 54 grossolana o raffinata». Il sottile e impalpabile veleno giunge a intimidire i giurati per via diretta o indiretta, per esempio, riporta il giornale, uno dei mezzi più usati era quello di far sapere al giurato ritenuto più timoroso che cinque membri erano già favorevoli all’imputato e che il verdetto dipendeva esclusivamente da lui. «Ciò provoca la convinzione che egli sia spiato e conseguente quello perde capacità e senso critico»95. L’avvocato Antonio Marinuzzi, che tra le altre, ricoprì anche la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, cultore di storia del diritto pubblico siciliano, era un profondo conoscitore delle regole che sottendevano alle logiche proprie delle aggregazioni mafiose e non mancò di ostentarlo alla giuria nella elegante ma incisiva forma utilizzata nella perorazione finale96. Un ultimo pensiero fu rivolto dagli avvocati Paolo Figlia e Agostino Tumminelli alla storia, per usare le parole di Cicerone in un passo del “De Oratore”: «Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis». La supplica finale al Tribunale della Coscienza informa che: «la storia non è fatta dai giurati, né dai difensori, né dai magistrati togati, ma sarà essa, invece, che giudicherà tutti97». Il volto garantistico del processo sfumava quando ci si addentrava nel terreno del probabile e del possibile. L’eterno interrogativo era se gli indizi da soli fossero sufficienti a costituire una prova, contro ogni coerenza semantica98. 95 Ibidem. Arringa Marinuzzi, in Processo Amoroso, p. 203. 97 Arringa Tumminelli, in Processo Amoroso, p. 242. 98 MARCHETTI, Inchiesta penale e pregiudizio, cit. p. 33. 96 55 È proprio nel campo degli indizi che il confine tra libero convincimento e prova legale si affievolisce. Ed è in queste fessure che trovò compimento la perorazione dell’avvocato Giovanni Lucifora. Il giurista ricordò l’anno 1865 e come l’andamento delinquenziale post postunitario avesse provocato quei rigori provvidi e improvvidi che confluirono nella legge di Pubblica Sicurezza dello stesso anno, contenente tutta una serie di misure repressive, tra cui l’ammonizione: «per un sospetto, per una diceria si ammoniva»99. Il difensore scelse questo percorso, disvelando il proprio orientamento politico, per introdurre l’argomento successivo. Inserì la difesa del suo assistito in quel chiaroscuro nel quale poteva intravedersi come l’imputato non era mai stato ammonito ai sensi della rigida normativa esistente. Per di più un delegato mandamentale di Pubblica Sicurezza 100 gli aveva da poco rinnovato il porto d’armi, mentre parallelamente, la «voce pubblica» lo andava dipingendo sanguinario, ladro, manutengolo, mafioso. Fu proprio a questo punto che l’oratore mise in evidenza tutta la discromia esistente tra il sistema delle prove legali e il binomio inscindibile tra la fama e l’infamia. In un susseguirsi irrefrenabile di voci, in un pluralismo di suoni che vibravano forte tra i vicoli bui di Palermo sul farsi del crepuscolo, per poi sommergersi e riaffiorare alle prime luci dell’alba, incarnati nelle sibilline ombre dei confidenti di polizia, 99 Arringa Lucifora, in Processo Amoroso, p.237. ASP, GQ, ANNO 1880, BUSTA 7., cit. 100 56 che velocemente si apprestavano a lasciare la questura, dopo aver reso ai funzionari, quelle dichiarazioni inconfessabili e averle lasciate lì, prive di paternità. La questione venne maneggiata dall’avvocato Giovanni Lucifora101 e rappresentò una reale difesa della mafia, nel suo significato più autentico. L’omertà, elemento contraddistintivo per eccellenza, erige un muro attorno alla associazione, le falle a questo sistema sono costituite proprio dai racconti che ne fanno, nei loro modi e con i loro tempi, i confidenti di polizia, che non sono altro che altri mafiosi, che non si esponevano però al punto di offrire la loro testimonianza in tribunale. La voce pubblica pertanto additava, riconosceva, chiamava, ma inequivocabilmente si scontrava contro il concetto di prova legale. Durante gli interrogatori, alla domanda: «come lo sapeste?» sovente si udiva questa risposta: «lo disse la voce pubblica». Un avvocato come Giovanni Lucifora non aveva alcuna difficoltà nel sostenere quale fosse il valore legale da attribuire a tali dichiarazioni: nullo. Il tema venne ancorato alla irrisolta dialettica tra esigenza di prova legale e libero convincimento del giudice102. Mentre il giurista inneggiava al Codice Penale, ribadiva come la comunità avesse il diritto e il dovere di essere disciplinata per un verso e di sottostare per l’altro, solo all’impero della legge codificata. 101 Arringa Lucifora, in Processo Amoroso, p. 237. A. SANTANGELO CORDANI, Le retoriche dei penalisti a cavallo dell’unità nazionale, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 51-52. 102 57 Sulla precarietà del sistema probatorio dell’accusa, fondato sulla propalazione di Peppino Pugliese e sul contributo offerto dalla voce pubblica, l’avvocato Lucifora concluse esortando così la giuria: «nella alternativa, si salvino i rei, piuttosto che condannare un innocente!»103. 103 Arringa Lucifora, in Processo Amoroso, p. 237. 58 Capitolo II L’avvocato Penalista e la classe forense siciliana nel processo all’Italia risorgimentale 2.1. Diritto di difesa o difesa del diritto? Il tema della qualificazione giuridica della mafia e della sua affermazione come fenomeno dotato di caratteristiche proprie, autonomo, siciliano, scorre lungo i binari della ricerca della sua stessa identità storica. A tracciarne i confini, a cancellarne i tratti, ad abbozzarne le forme concorre senza dubbio il coro polifonico delle voci degli avvocati che, da protagonisti indiscussi nell’arringo, negli anni settanta del diciannovesimo secolo, si calano all’interno di un altro luogo, ovvero quello politico – istituzionale, per ivi affermare o negare, per dire o smentire, certamente per qualificare. Lo studio degli interventi dibattimentali, le interrogazioni, le relazioni rese dagli avvocati nella veste di deputati del Regno contribuiscono a svelare, ad aprire, a discernere il pensiero giuridico di una classe forense, quella siciliana, che intorno a temi scottanti processava o pretendeva di processare l’Italia risorgimentale. La figura del penalista di fine Ottocento è anch’essa in via di definizione e la ricerca di elementi di classificazione passa attraverso l’arte della retorica, tracciando un moto circolare del ministero forense. E infatti, l’archetipo dell’avvocato moderno come bene 59 evidenziato da Pasquale Beneduce è il naturale depositario della “pubblica confidenza”104, sente il peso di una sorta di investitura naturale che lo colloca in una posizione di continuo conflitto, ora con l’Ordine, ora con il Parlamento, ora con il Tribunale e il tutto in nome e in difesa della propria autonomia, che si trasfonde poi per osmosi in quella del cittadino di cui ha assunto la difesa, quindi ancora nella collettività intera. Assumere la difesa di soggetti asseritamente affiliati alla malavita organizzata implicava necessariamente una presa di posizione di carattere pubblico da parte dell’avvocato nel momento in cui venivano coinvolti temi di risonanza nazionale quale il trattamento dell’ordine pubblico in Sicilia. Da questo momento il difensore inizia a vestire quell’habitus ibrido di soggetto funzionario di una potestà pubblica e sociale e contemporaneamente di autore privato dei discorsi pubblici105. Nella poderosa polemica scoppiata all’indomani dell’Unità, la perorazione delle cause penali e, segnatamente di quelle oggetto del presente lavoro106 diventano un terreno dove disputare questa duplice difesa, che restituisce una immagine dell’avvocato come quella di un soggetto collocato ad una distanza irriducibile tra causa privata e libertà forense da una parte, e causa nazionale e libertà politica dall’altra. È per questo che la trama della storia della avvocatura siciliana della seconda metà del diciannovesimo secolo non può essere ricostruita se non attraverso le maglie di quelle tappe 104 P. BENEDUCE, Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell’Italia liberale, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 96. 105 Ibidem. 106 Processo Pugliese; Processo Amoroso; Processo Stuppagghieri; Processo per i quattro scomparsi. 60 risorgimentali che scandirono e accompagnarono il momento post postunitario. La lente d’ingrandimento va pertanto posta sulla classe parlamentare isolana, esplicativa di quel sostrato sociale, storiograficamente definito baronaggio politico, interessato alla conservazione degli interessi e dei potentati locali, e al quale il potere espresso e realizzato dal fenomeno mafioso era subordinato. La classe de’ così detti malandrini – descrive, infatti, Giovanna Fiume nel suo saggio – era in rapporti di favore sia con i proprietari terrieri che con le autorità, mentre i controllori che avrebbero dovuto essere quelli preposti alla repressione, affiliavano mafiosi e si muovevano palesemente al di fuori dello schema delle regole 107, come meglio si vedrà in appresso. All’indomani dell’unificazione, la società politica siciliana si presentava divisa in due schieramenti, ai liberali – unitari, che avevano riconosciuto le istituzioni del regno d’Italia, si contrapponevano i liberali – autonomisti e gli autonomisti tout court, una corrente non affatto omogenea, formata dalla vecchia aristocrazia fondiaria che si era alleata con la borghesia agraria e cittadina e cui faceva da minimo comune denominatore l’avversione verso il nuovo stato e nei confronti dei funzionari piemontesi108. La specialità risiedeva nel fatto che mentre i primi costituivano in parlamento la sicilia “legale” , ovvero sedevano nelle file del governo, i secondi pur stando all’opposizione, all’interno dell’isola rappresentavano la maggioranza dei deputati, 107 G. FIUME, Paradigma giudiziario e storia politica della mafia, in «Quaderni storici», n. 93 (1996) p. 758. 108 G. C. MARINO, Storia della mafia, Il Sapere, Roma, 1997, p. 37. 61 la Sicilia “reale” . Per contrapposizione con la destra al potere, questo agglomerato di composita estrazione, si schierava apertamente a sinistra. Essi erano i portatori di istanze e di quell’insieme di valori siciliani che formavano una sorta di statuto storico dell’isola. Su un tracciato giusnaturalistico che coniugava ambiguamente progresso e conservazione, la Sinistra sicilianista col suo partito regionista propugnava l’anticentralismo, presentato come antistatualismo, a presidio delle libertà individuali. Premeva per il potenziamento dei poteri e della sovranità alla regione, cui doveva essere riconosciuta la dignità di conservare la propria cultura e identità109. Tra i nomi illustri degli esponenti del partito ritroviamo l’avvocato Andrea Guarneri, l’avvocato Pietro Gramignani, l’avvocato Francesco Gestivo. Il carattere della difesa processuale degli avvocati “regionisti” mostra dei tratti peculiari molto comuni, intimamente legati alla dottrina propria di tale corrente che individuava nel rispetto dell’identità delle singole regioni d’Italia, il ruolo salvifico per la sopravvivenza del neonato Stato italiano. Essi infatti si interrogavano sulle possibili conseguenze eversive di quei principi giacobini alienati nella teoria del potere centralizzato, a termini dei quali: non soltanto: «le varie parti di una grande nazione sarebbero condannate a perdere l’iniziativa della 109 G. C. MARINO, L’opposizione mafiosa: mafia, politica, stato liberale, Flaccovio, Palermo,1986, pp. 34-35. 62 loro vita politica e giuridica»110, ma per di più questo stato di cose avrebbe preparato il terreno per il proliferare della dottrina socialista: «che tutto pretende dallo stato»111. Tra i due mali, i seguaci della corrente autonomista, offrivano quale unica soluzione percorribile l’adesione al decentramento politico amministrativo, che da un lato avrebbe funto da arresto alle seduzioni eversive della demagogia e dall’altro avrebbe evitato i due grandi rischi: la sommossa da una parte e il socialismo dall’altra. Specularmente, essi invitavano il governo al: «più completo rispetto delle proprietà e del libero cambio di ogni servizio che è a dire il libero uso che Iddio ci concesse e dei loro prodotti»112. Tutto questo, filtrato nella realtà della Sicilia, si traduceva in una nemmeno tanto malcelata intimazione a non alterare né l’ordine dell’apparato latifondista isolano, né quell’impianto allargato di perpetuazione parassitaria – mafiosa – della roba113 dalla campagna alla città114. Così, nel confronto Sicilia/Stato liberale, l’autonomismo, rinnovata versione del sicilianismo, rappresentava uno dei principali collanti ideologici sfruttati dal baronaggio politico115 – ovverosia l’espressione di quel connubio tra il sostrato aristocratico e quello politico siciliano – per tenere unite forze di diversa estrazione, confluenti nel comune sentire di opposizione al Governo. Di una opposizione mafiosa116. 110 Anonimo, Il sistema regionale richiesto dalla natura e dalla garanzia del diritto umano, Ed. Tipografiche Palermo, Palermo, 1863, p. 5. 111 Ibidem. 112 Anonimo, Il sistema regionale, cit. p. 5. 113 Nell’ampio significato di interessi locali latifondistici isolani. 114 G. C. MARINO, Storia della mafia, cit. p. 57. 115 Ibidem. 116 G. C. MARINO, L’opposizione mafiosa, cit. p. 36. 63 A proposito di sicilianismo, su cui proprio l’autonomismo si innesta, appare opportuno citare una semplice ma completa rappresentazione, nella quale esso è descritto come: «quel particolare atteggiamento mentale e pratico che affonda le sue ragioni principalmente in un forte attaccamento al particolarismo isolano»117. Un sentimento che: «si oppone a tutto ciò che abbia di mira il mutamento delle condizioni tradizionali dell’isola, dal punto di vista economico – sociale, come dal punto di vista politico»118. La concezione non risponde a logiche di mero provincialismo, ma ha radici così tanto profonde da giungere a innervare tutto il tessuto isolano e a vascolarizzare compiutamente i vasi del ceto politico locale. E così, tornando al centro del dibattito in atto, vi era il profilarsi dello spettro dell’applicazione dei metodi di eccezione in Sicilia che avrebbe comportato un evidente trattamento illiberale nell’isola, contrario alle stesse teorie sotto cui era nato il nuovo Stato italiano. Le misure eccezionali, ancora, risuonavano di echi del recente passato. Non erano infatti troppo lontane quelle “liste di fuorbando” istituite sotto il governo borbonico con la legge n. 789 del 1817 in cui venivano inseriti i nomi dei malviventi presenti nelle campagne e con cui si lasciavano otto giorni di tempo a parenti e amici dei fuorbanditi, a decorrere dalla pubblicazione delle liste, per illustrare i motivi dell’assenza dei loro congiunti. Decorsi gli otto giorni, i soggetti indicati nelle liste venivano dichiarati “rei 117 F. BRANCATO, Mafia e formazione dello stato italiano in «Quaderni del Meridione», anno XXI – n. 81, p. 6. 118 Ibidem. 64 di morte” e potevano essere uccisi dalla forza di polizia o da qualunque privato119. Subito dopo l’Unità, ancora, la situazione del tutto incontrollabile dell’ordine pubblico interno condusse alla proclamazione nel 1862 dello stato d’assedio in Sicilia, cui seguì la promulgazione della legge n. 1409 del 1863 c.d. legge Pica con l’obiettivo di reprimere il brigantaggio e la mafia120. Gli interventi si sostanziavano spiccatamente in azioni di polizia, venivano istituiti tribunali militari e soprattutto aumentavano le possibilità di fare ricorso, in mancanza di prove certe della commissione di reati, agli strumenti preventivi – amministrativi. La cura dell’eccezione in Sicilia continuò poi con la legge n. 294 del 1871 in materia di pubblica sicurezza, nella quale l’art. 105 allargò la cerchia dei soggetti sottoponibili all’ammonizione e al domicilio coatto includendovi per la prima volta i maffiosi. Il corpo forense isolano ebbe un sussulto allorché ci si rese conto che limitatamente ai soggetti ritenuti sospetti ladri, grassatori e mafiosi il contenuto del precetto di ammonimento cui doversi uniformare era semplicemente e laconicamente: «a non dar adito a ulteriori sospetti», senza loro prescrivere obblighi più specifici121. Il risultato finale era che l’ordine di non violare gli obblighi derivanti dall’ammonizione si appalesava così incerto e imprecisato che la sanzione penale sarebbe potuta scattare per una minuzia e a 119 ARCHIVIO DI STATO DI LECCE, Collezione delle leggi e dei decreti reali del regno delle due Sicilie, anno 1817, semestre II, Napoli, Dalla Real Tipografia della Cancelleria generale, v. Appendice I, documento n. 12 p. 228. 120 Il testo fa esplicito riferimento alla camorra. Va detto però che all’epoca il termine non era di uso univoco nella letteratura. Per una ampia letteratura: F. CARFORA, voce Maffia, in Digesto Italiano, XV, parte I, 1903-1907, pp. 56 e ss. 121 G. TESSITORE, Emergenza e garantismo nella legislazione antimafia, in «Nuovi Quaderni del Meridione», XXIII, ottobre-dicembre 1985, n. 92, pp. 408 e ss. 65 discrezione insindacabile dell’autorità amministrativa, cui competeva il compito di controllare e di valutare il comportamento del prevenuto dopo la pronuncia di ammonizione122. Come dire, una politica incentrata ad arbitrare la giustizia, violando i fondamenti della legalità. Per usare le parole di Mario Sbriccoli123: «non si trattava solo di giurisdizione contro amministrazione, di codice penale contro legge di pubblica sicurezza, di giudici da una parte e di polizia dall’altra». L’allarme lanciato dal ceto avvocatizio palermitano si inseriva in un ambito ben preciso. E infatti, a ben vedere le regole repressive sono per loro stessa natura rivestite da un dualismo che non involge solo il tema dell’ordine pubblico. È per questo che al centro di numerose arringhe degli avvocati deputati rinveniamo modelli di difesa che mutuano registri dal campo delle impressioni. Spostare la percezione dell’imputato da bandito a uomo dabbene aveva un immediato risvolto giuridico, poteva infatti equivalere a una probabile assoluzione, perché solo i malandrini potevano essere destinatari di misure restrittive come il carcere, non certo i galantuomini. La convinzione e la qualificazione esatta erano pertanto determinanti. L’avvocato Antonio Marinuzzi, afferente alla Sinistra crispina, ad esempio, nel concludere la sua arringa a Catanzaro, durante il processo d’appello per la setta degli Stuppagghieri di 122 L. LUCCHINI, Voce Ammonizione, in Dig. It., vol. IX, 1895, p. 44. M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano, in «Storia d’Italia» Annali, vol. XIV, Torino, 1998, p. 491. 123 66 Monreale, utilizzò argomenti di estrazione, potremmo dire politica, allorché esortò i giurati calabresi: «a fare giustizia dei fratelli siciliani» così indicando i rei al banco dell’accusa, definendoli: «galantuomini che da anni ingiustamente soffrono il carcere». Le cronache giudiziarie dell’epoca124 ci testimoniano gli esiti dell’arringa di Antonio Marinuzzi che scosse i giurati al punto da far registrare tra loro voci per le quali: «bisogna far giustizia a quegli infelici innocenti che non sono briganti ma galantuomini e ciò si vede dai loro vestimenti ed aspetto». Proprio sul punto delle impressioni suscitate nella giuria dagli imputati vi è una interessante pagina di un rapporto riservato in cui il delegato dei R. Carabinieri, Pio Cicognani, in trasferta a Catanzaro per seguire il processo, «per tenere a freno gli amici degli imputati e sorvegliare i più importanti testimoni a carico» 125 relaziona al questore di Palermo: «Qui si credeva che gli Stuppagghieri fossero briganti, e vedutili senza cappello pizzuto, non laceri e non malvestiti, dicono che sono galantuomini, che le loro fisionomie sono buone, senza sapere che sono iene peggiori dei briganti»126. Ancora una volta ritornava il motivo sul duplice livello di legalità che: «investiva e discerneva i galantuomini dai birbanti, destinandoli così a due modelli punitivi diversi, giungendo a far prevalere in maniera pericolosa, l’opportunità sulla regola giuridica, lo scopo sul diritto»127. La congiuntura in cui opera il ceto forense palermitano è 124 ASP, GQ, anno 1880, BUSTA 7 – Memorie sul dibattimento dinanzi alla Corte d’Assise di Catanzaro il 17 febbraio 1880 del Delegato di Monreale Cicognani al Questore di Palermo, Monreale 8 Marzo 1880. 125 A. CRISANTINO, Della segreta e operosa associazione, cit. p. 251. 126 ASP, GQ, anno 1880, BUSTA 7 – Carteggio delegato Cicognani. 127 M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti cit. p. 491. 67 quella in cui la classe politica governativa della Destra cerca di fare entrare nel sistema del modello punitivo il concetto di emergenza e, per il suo tramite, proprio quel doppio livello di legalità, costituito dal codice da un lato e dalle leggi di pubblica sicurezza dall’altro128. Sul tavolo delle trattative, in concreto, era in gioco il conseguimento di obiettivi politicamente desiderabili attraverso la negoziazione di libertà, diritti e garanzie. Le questioni aperte si avviluppavano tutte intorno al paradosso della libertà e al conflitto tra ordine e libertà. In tutto questo, attraverso la costruzione della ideologia di mafia che si andava affermando tra foro e aula altalenando tra i diversi campi di: «invenzione del governo della destra per colpire le opposizioni», «onorata società che senza vincoli si occupava di gestire in proprio gli interessi della Sicilia depredata dagli invasori di turno» e «patrioti in attesa di riconoscimento da parte del governo per aver saputo tenere l’ordine pubblico interno meglio dell’azione statale» gli avvocati deputati siciliani istruivano un processo contro l’Italia risorgimentale. In definitiva, il periodo post postunitario in Sicilia costituisce un autentico laboratorio, dove le idee di Montesquieau, i suoi concetti di matrice liberale sulla separazione dei poteri, intesa come garanzia contro l’arbitrio del potere statale, dove il pensiero di Kant e il suo credo fondato sulla libertà, l’uguaglianza e l’indipendenza, come principi sui quali dovesse reggersi uno stato civile, vengono filtrati dai deputati siciliani e, velati nella difesa della mafia, propugnati sotto forma di una azione che si stagliava come una autentica difesa del diritto. 128 M. SBRICCOLI, La penalistica civile: teorie ed ideologie del diritto penale nell’Italia unita, in «Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti», Giuffré, Milano, 2009, p. 177. 68 2.2. La difesa della mafia tra Foro e Aule Parlamentari È nella dialettica parlamentare, nei rapporti tra governo e minoranza, sfociati poi in una feroce controversia regionalistica, intorno a temi scottanti quali la questione dell’ordine pubblico e il tema sulla opportunità di applicare o meno misure di carattere eccezionale per il trattamento della questione siciliana, che è possibile scorgere una speciale forma di difesa della mafia. A realizzarla sono, ancora una volta, gli stessi avvocati che, tolte le toghe, si calano in questo scenario da protagonisti indiscussi. Come rilevano gli studi di Hannes Siegrist129 a quel tempo il parlamento era composto quasi esclusivamente da giuristi. Uomini di grande cultura, abituati per professione, plasmati, “deformati” al difendere e al rappresentare ora il proprio assistito, ora la classe politica di appartenenza, ora il ceto sociale di riferimento. Portatori, per definizione, di valori intrinseci ad ogni paradigma sociale, che nella parola dell’avvocato – politico, potevano trovare la più sicura, compiuta ed elegante traduzione. Come ebbe a dire Giuseppe Zanardelli, l’avvocato «nell’assiduo esercizio della difesa delle cause private, si tempra e si ammaestra a difendere la più bella delle cause, la causa della patria nelle assemblee nazionali»130. Gli stessi Simone Cuccia, Francesco Gestivo, Pietro Gramignani, Andrea Guarnieri, Giovanni Gorritte, Paolo Paternostro furono tutti impegnati politicamente e fronteggiarono 129 130 H. SIEGRIST, Gli avvocati nell’Italia del XIX secolo, cit., pp. 145-181. G. ZANARDELLI, L’avvocatura, Barbera, Firenze, 1891, p. 50 e pp. 49-74. 69 dai banchi delle aule parlamentari l’acceso dibattito che in quei momenti interessava primariamente la Sicilia. Ritorna ancora l’analogia tra la difesa delle libertà del foro e la difesa delle libertà politiche, causa privata e causa della patria. L’arco temporale in analisi è lo stesso che formò oggetto di speculazione da parte del giurista Karl Joseph Anton Mittermaier, il quale in una copiosa produzione scientifica ebbe modo di sottolineare la «provvida attitudine riformista»131 dei penalisti italiani. Una figura, come detto in apertura, in ricerca della propria identità e in affermazione del proprio ruolo, che partecipa da protagonista alla costruzione del nuovo stato unitario, fornendo mattoni sotto forma di materiali di cultura giuridica e aggiungendo la politica alla scienza. La speculazione operata dal profilo del ceto forense siciliano restituisce l’immagine di un intento edificativo condotto sotto forma di contributi di affinamento tecnico, in piena fioritura intellettuale tra i due codici, nonché di revisione razionale dei metodi della giustizia penale, nella raccolta dell’eredità giuridica illuminista. L’elemento di sintesi finale ottenuto al termine dell’analisi e nel quale riposa il pensiero degli avvocati siciliani, è definibile come l’intenzione di porre alla base della difesa, la dimostrazione della natura politica dell’accusa di associazione per delinquere. Al centro della polemica vi era innanzitutto la ricerca della reale conoscenza delle condizioni in cui versasse la Sicilia. Elemento questo, assai ricorrente nei preamboli dei discorsi degli avvocati siciliani, che polemizzando con il governo, 131 M. SBRICCOLI, La penalistica civile , cit. p. 176. 70 rilevavano allo stesso modo, ma poi maneggiavano in maniera ambigua, la species siciliana. Proprio a tal proposito, in un opuscolo stampato nel 1867, l’avvocato regionista Andrea Guarneri scriveva, a nome dell’intero partito: «Ed in vero ciò che ci ha sempre colpiti, quando nel continente si è ragionato delle cose dell’Isola, è la mezza per non dire la completa iscienza, in cui si è colà di noi e delle nostre cose»132. Le tavole della statistica penale, cartina tornasole largamente utilizzata allo scopo di disvelare la marcata anormalità della regione siciliana rispetto al resto d’Italia in termini di omicidi, ferimenti, furti, grassazioni e abigeati mostravano chiaramente un dislivello in termini numerici tra i reati commessi in Sicilia e quelli compiuti nel resto d’Italia133. Ma vi era di più. Nell’isola, rispetto che in continente, il concetto di delinquenza inteso come fattore da riconoscere e reprimere per mezzo dell’azione dello stato, assumeva connotati del tutto peculiari allorché si intendesse con esso non comune malandrinaggio, ma mafia. Vi è una analisi molto lucida del fenomeno contenuta in un documento nel quale il Procuratore presso la Corte di Assise di Palermo rendicontava all’allora Ministro di Grazia e Giustizia Paolo Vigliani, quale fosse lo stato della pubblica sicurezza in Sicilia, nel quale viene affermato come: 132 A. GUARNERI, La inchiesta parlamentare sui fatti di Palermo, Maggiori, Palermo, 1867, p. 5. Statistiche penali in Allegati a Atti Parlamentari, Camera dei Deputati - Sessione del 187475. 133 71 il maffioso è adibito e ricercato per apportare voti in comizi elettorali, onde la sia autorità cresce e reputasi sempre più necessario, s’impone in tutte le più comuni operazioni della vita sociale, e quando è preso di mira dalla giustizia, trova nelle classi abbienti a sua volta sua protezione e favore. Per questo congegno artifizioso, la maffia dà e riceve protezione ad un tempo, e tanto più acquista forza, quanto più spesso vede fare ricorso a lei anziché all’azione legittima dell’autorità. Così è che ha acquistato lena e vigore, si è venuta imponendo nelle città e nelle campagne, e col suo ascoso potere ha creato il silenzio dove è il reato, reso muti i testimoni e le parti offese, impaurito molti giurati, e quindi assicurata la impunità, che è il sommo incoraggiamento al malfare, facendo entrare nella coscienza dei malfattori il convincimento che le leggi sono impotenti a colpirlo. Questa impotenza reale o supposta, e la credenza contraria del potere della maffia, assai spesso corroborate dal fatto delle aspre vendette prese contro testimoni ed altri che abbiano deposto in giudizio contro i malfattori, sono la causa principale della gran moltitudine di manutengoli di ogni genere, che sostengono il malandrinaggio; perciocché oltre alla simpatia che sventuratamente riscuote chi mostra sfidare il potere costituito, le condizioni topografiche soppramodo propizie, cioè estensioni vastissime di terreno disabitato, deserto, frastagliato da monti aridissimi, disagevoli, ricchi di grotte, di nascondigli, con rarissimi centri di popolazione, senza strade o altri mezzi facili di comunicazione, costringono ad essere, anche chi poco vi avrebbe disposto, manutengolo dei malfattori 134 Un altro magistrato, Francesco Scarlata, presso la Corte di Assise di Palermo compie una ulteriore specifica, distinguendo tra alta mafia o mafia in guanti gialli e bassa mafia. «La seconda rappresentata da artigiani e contadini, la prima formata da professionisti, da proprietari terrieri, da speculatori e da commercianti»135. 134 G. COSTA, Riassunto di rapporti intorno alle condizioni della sicurezza pubblica nell’isola di Sicilia, Roma, 18 gennaio 1878, in Allegati – Atti Parlamentari Camera dei Deputati sess. 1874 – 75 – documenti - progetti di legge e relazioni. 135 F. SCARLATA, L’associazione per delinquere e la “mafia”, Ed. Tip. Palermo, Palermo, 1897. 72 Nel segno della continuità, più avanti, Giovanni Lorenzoni, a capo di una commissione parlamentare che condusse una inchiesta sulle condizioni dei contadini nel Mezzogiorno e in Sicilia, ebbe a distinguere tra una mafia alla base, «come quella che nelle campagne e nei comuni dell’interno, impiega una vasta schiera di gregari, che materialmente compiono i reati e che in tempi di elezioni fanno pressioni per questo o quel candidato»; e una mafia in alto, «negli stessi paesi e in città, in cui “alcuni capi sacerdoti”, “ben vestiti”, con il loro “ufficio o luogo di riunione”, che continuamente confabulano e stabiliscono financo i delitti da commettere, insidie da tendere, per cui impartiscono gli opportuni ordini ai gregari che ciecamente eseguono. Insomma, la mafia si è istituzionalizzata»136. Queste erano le tinte del quadro di comprensione del fenomeno a livello centrale. Il nodo cruciale restava il metodo giuridico con il quale intervenire a disinfestare l’agro siciliano. In maniera del tutto speculare a ciò, sia in termini di percezione quanto in termini di traslazione, la missione degli uomini politici siciliani che vestivano la toga negli anni settanta del secolo diciannovesimo, si sostanziava nella difesa quando attaccata e nel presidio costante, nei momenti in cui la disputa era sopita, della ideologia liberalista, fondamento dello stato di diritto. E infatti la dottrina liberale risulta essere intimamente legata alla struttura semantica delle difese condotte dagli avvocati siciliani in tribunale. 136 G. LORENZONI, Inchiesta sulle condizioni dei contadini nelle Provincie Meridionali e nella Sicilia, vol. VI, Sicilia, Tip. Az. G. Berter e c., Roma 1910, p. 650. 73 Lì si scomponeva il carico d’imputazione di associazione al mal fare, rubricata all’articolo 426 del codice penale sardo esteso per il regno d’Italia e si tendeva a rappresentare giuridicamente i fatti come accaduti in maniera disgiunta e disancorata da una associazione organizzata. Fuori dalle aule giudiziarie, superati i vincoli posti dall’ancien regime e su basi rinnovate rispetto agli estremismi giacobini, gli avvocati politici propugnavano dai banchi del parlamento, una energica difesa della libertà di associazione, baluardo irrinunciabile dell’ideologia liberale. Questo passaggio è fondamentale perché, come vedremo, in sede politica si parlerà sì di associazione, ma non di malfattori. Indagando dentro agli affari di Sicilia, si rileva come il gioco del baronaggio politico, di cui proprio i deputati e i senatori siciliani erano rappresentanti, si esplicasse in una altalena di contraddizioni soltanto apparenti. Di fatto, i proprietari terrieri, i latifondisti, se interpellati, si dichiaravano vittime della mafia e si definivano abbandonati dal governo centrale, ma poi non denunciavano e ne diventavano invece protettori, nel significato che più innanzi sarà precisato di manutengoli. E infatti, vi era, nel quadro di una convergenza sistemica di interessi e pratiche parassitarie, una sostanziale comunione di mentalità e di valori culturali che univa mafiosi, galantuomini e baroni. Questi ultimi, peraltro, erano abituati da secoli ad avvalersi, per dichiarati fini di ordine sociale, coincidenti con le istanze della autodifesa di classe, del servizio di malfattori, ai quali offrivano protezione e garanzie d’impunità. 74 La complessa struttura di tale servizio si era poi evoluta in un sistema di organiche complicità che pur mantenendo la differenziazione di rango tra le due parti, agiva come un meccanismo di conservazione sociale a vantaggio di entrambe. Spostandoci adesso sul piano politico, ci si avvede come muovendo dalle denunzie dei prefetti, ciclicamente ritornasse la questione sugli strumenti da adottare per fronteggiare la situazione turbolenta che infestava le campagne siciliane, scenari dei già descritti abigeati, grassazioni, furti e omicidi. Di contro, lo scudo difensivo dei parlamentari isolani opponeva un rifiuto netto a un trattamento diverso e illiberale per la Sicilia. In questo denunciavano con clima, vigore gli le avvocati loro politici palermitani preoccupazioni per le manifestazioni di autoritarismo del governo verso l’isola, paventavano i rischi per la questione del garantismo e dell’uso strumentale delle leggi, difendevano a oltranza i valori di matrice liberale. Questo schema assunse nella pratica i connotati, come meglio vedremo, di un attacco preventivo: mentre si rifiuta la specificità siciliana, si aggredisce per paura di essere attaccati. Il pluralismo di voci proveniva dai ferventi dibattiti parlamentari, dalle dichiarazioni che gli stessi rilasciavano, dai comizi che si improvvisavano, che venivano poi, a loro volta, amplificati per mezzo della carta stampata e che conseguivano così il risultato di uscire dai salotti dei circoli e dalle aule delle Camere, per giungere e permeare tutto lo strato sociale dell’isola. Al di là delle immagini oleografiche, in filigrana sarà 75 possibile intravedere come i deputati avvocati siciliani portassero avanti con fervore tali difese che poi nei fatti andavano a corrispondere in maniera sovrapponibile agli interessi della mafia. L’occasione viene offerta quando nell’ottobre del 1874, in un clima politico-istituzionale già teso, il governo Minghetti, a ridosso delle elezioni politiche, annunciò: «un rafforzamento delle prefetture mediante una legge eccezionale valida solo in certi tempi e in certi luoghi». In pratica si discuteva della sola Sicilia. A quasi quindici anni dall’unificazione la gestione dell’ordine pubblico nell’isola appariva quasi irrisolvibile. La questione involgeva a livello locale la condizione di insicurezza in cui versavano le province siciliane e a livello nazionale ed estero la dilagante impressione di precarietà politica che si andava sempre più diffondendo, minando la reputazione dell’appena creato stato italiano. I rapporti dei prefetti informavano il governo centrale sull’andamento nelle periferie dell’isola e non si appalesavano troppo benevoli. Tra tutti, il giudizio più duro fu forse quello espresso dal prefetto di Caltanissetta, Guido Fortuzzi che proponeva: domicilio forzoso fuori dalla Sicilia, sospensione generalizzata della giuria popolare e cessazione per moltissimi casi dell’habeas corpus nell’isola137. Deciso ad intervenire, il governo decretò nell’estate del 1874 di inviare in Sicilia, il Segretario generale degli Interni, Luigi Gerra, perché rendicontasse sulla direzione dell’ordine pubblico nell’isola. 137 Atti Parlamentari, Stampati, Sessione 1874 75, XII legislatura. p. 20. 76 Gli esiti del rapporto Gerra138 furono infausti: venne riferito di un procuratore del Re del circondario di Termini Imerese impaurito dalla mafia. Ciò, messo in correlazione con la fase istruttoria di un processo che egli stava tenendo contro una banda di ricattatori lasciò prognosticare a tutti un risultato assolutorio. Un altro proscioglimento sospetto ancora nella fase istruttoria aveva interessato un diverso magistrato appartenente ad un’altra sezione di accusa della Corte di Assise di Palermo139. Si decise pertanto di mutare completamente indirizzo e si proposero le misure eccezionali. Questo scatenò la protesta dei deputati siciliani, ovvero di quella minoranza che in Sicilia rappresentava la maggioranza. Ripercorrendo il sentiero dei loro interventi ci si avvede come il coro di indignazione che pure assunse registri diversi in base al colore politico di espressione di ciascuno, presentasse a una visione finale, panoramica, un leitmotiv unitario, certa espressione di una classe sociale, quella avvocatizia palermitana, auto rappresentativa, con un proprio carattere e una marcata identità. Ci sembra opportuno muovere l’analisi dagli esponenti del partito regionista. L’avvocato Andrea Guarneri aveva già in precedenza sferrato un duro attacco nei confronti del governo quando nel 1867 aveva mandato alle stampe un saggio nel quale cristallizzava l’anomalia siciliana come un naturale momento di transizione nel passaggio al nuovo stato unitario, fisiologico al punto da non dover necessitare di alcuna cura specialistica da condurre con mezzi straordinari. 138 139 ASP GQ BUSTA 7 – Carte Minghetti, rapporto Gerra 24 luglio 1874. Ibidem. 77 Così scriveva: «Esagerate quanto voi volete l’azione pervertitrice della mafia, gli eccessi della stampa, le ire e le mene del partito clericale, le arti degli autonomisti, tutto ciò potrebbe darvi la spiega di un fatto transitorio, non già di una agitazione e di un malcontento costante – e quel che è peggio crescente»140. In un passaggio, il giurista sembra esprimere anche un giudizio di valore sulla mafia mentre ha cura di qualificarla: «azione pervertitrice». Indubbiamente l’appellativo utilizzato rimanda a un campo di anormalità, di alterazione, quando non di degenerazione. Nell’accostamento con una altra fonte, costituita da un resoconto stenografico della Camera, che registra la voce dello stesso Andrea Guarneri, sembra però essere meglio specificato il significato del termine. Opportunamente ricondotto al contesto sociale locale, esso si coglie nella chiave di lettura dal sapore più prettamente politico che viene polemicamente suggerita dal giurista in merito alla disputata questione dell’ordine pubblico. E così, nell’anno della presentazione del progetto di legge in parlamento, Andrea Guarneri, che proveniva dall’esperienza di primo prefetto dopo l’Unità della città di Agrigento pose in aula questa significativa e forse provocatoria domanda: «il prefetto Maniscalco, se fece dei prodigi in fatto di sicurezza, credete che li abbia fatti con misure eccezionali? Li fece con i grandi rapporti che si era creato con i proprietari delle provincie, i quali si tenevano in obbligo di tenerlo al corrente di tutto, ond’è che di tutto era estesamente informato». Il riferimento nemmeno tanto velato è a quel sistema legato a 140 A. GUARNERI, L’inchiesta per i fatti di Palermo, cit. p. 6. 78 doppio nodo, di connivenza tra il latifondo, i possidenti e la malavita locale. Qualche anno più tardi sembrò fargli eco un altro autonomista, l’avvocato Francesco Gestivo che definì il processo che si stava svolgendo nei confronti della setta degli Stuppagghieri di Monreale, come una: «offesa ai tanti cittadini […] ma la storia mostrerà a nudo le chimere e le false denunzie degli accusatori che dovrebbero comparire sullo scranno come calunniatori»141. Non mancò, nella chiusa ai giurati, un riferimento politico: «siate patrioti e non mezzo al fine del sistema che vuole impiantarsi politicamente, anche macchiare questa popolazione per trattarli da Iloti»142. Anche nell’avvocato Francesco Gestivo, già difensore nel processo contro la banda di Peppino il Lombardo, ritroviamo una chiara denuncia politica contro il governo dei moderati e apertamente nei confronti dell’adozione delle leggi eccezionali che avrebbero il fine ultimo di trattare il popolo siciliano, secondo la metafora utilizzata, come quella parte della gente di Sparta ridotta in schiavitù dalla polis greca. Restando all’interno del medesimo processo, un altro difensore, l’avvocato Giovanni Gorritte si rivolse ai giurati chiedendo se era giusto: «mandare all’estero ed ai posteri»143 l’accusa dell’esistenza di una organizzazione a delinquere in un paese: «ove nacque l’Italica favella, ove si parlarono quattro lingue, la greca, la latina, l’araba e l’italiano»144. 141 ASP, GQ, BUSTA 7. – Informativa. Questore del Re presso il Tribunale di Palermo, 29 novembre 1876. 142 Ivi, in Al Questore dal delegato Varvaro, Memorie sul dibattimento dinanzi alla Assise di Palermo, 26 aprile 1878. 143 ASP, GQ, BUSTA 7, cit. 144 Ibidem. 79 Ancora qui il richiamo è a registri di tipo sicilianisti e precede di qualche anno lo stile adottato dall’avvocato Paolo Figlia, seguace della sinistra crispina, titolare di un seggio alla camera dopo le elezioni del 1882. In una trascrizione nei resoconti del processo contro l’associazione Amoroso e Compagni rinveniamo un frammento nel quale egli disse: «non esiste nessuna associazione, pensate piuttosto alla figura che ne fa il nostro paese»145. Lungo lo stesso solco di impronta regionista si colloca anche il pensiero dell’avvocato Pietro Gramignani, anch’egli nel collegio difensivo del processo contro Don Peppino detto “il Lombardo”. Egli andò oltre sostenendo la tesi del complotto politico, a termini del quale il bandito sarebbe stato ingaggiato dal governo e spedito in Sicilia dal generale Medici nella qualità di agente provocatore, con l’obiettivo di controllare il territorio, di infiltrarsi, di creare un contatto stabile con la malavita dei bassifondi dell’interno isola: latitanti, renitenti alla leva militare, ovvero quei soggetti portatori sani del germe delinquenziale, tecnicamente idonei a ingrossare le file delle retrovie militari delle associazioni criminali. «In questo discorso [..] che disvela sempre più la inverosimilitudine [che] sia don Peppino l’ergastolano Pugliese, appare piuttosto che sia uno dei tanti saccentoni ispettori spediti dal governo centrale, a visitare e rivisitare questa bella ma infelice, non mai compresa, regione del nuovo reame d’Italia»146. La polemica di Pietro Gramignani avvenne però solo a processo concluso. L’accertamento della identità del bandito 145 Arringa Figlia, in Processo Amoroso p. 236. P. GRAMIGNANI, Il brigante calabrese in Sicilia, Angelo Pugliese, Ed. Tip. Palermo, Palermo, 1868, p. 8. 146 80 Pugliese non fu messa in discussione nel processo, sebbene la sostituzione di persona non rappresentasse una ipotesi tanto residuale in quel particolare momento storico nel quale l’esatta identificazione di briganti, latitanti e delinquenti stanati nelle campagne non era poi così scontata. Piuttosto, l’argomento dell’avvocato regionista Pietro Gramignani sostenuto in una sua opera pubblicata nel 1868, può essere bene considerato un precursore della teoria che più in avanti avrebbe avuto un certo risalto negli ambienti culturali e politici, ovvero quella secondo la quale il banditismo fosse una costruzione della Destra storica, creata artatamente allo scopo di giustificare ancora davanti gli occhi del paese l’applicazione delle misure eccezionali. Al fine ultimo di trattare diversamente la Sicilia. Con lo scopo politico di controllare l’opposizione di sinistra che nell’isola con i suoi 48 collegi rappresentava il rischio maggiore per la tenuta del governo. E in effetti, una delle più veementi denunce che giunse dal ceppo dei parlamentari siciliani nei confronti della destra al potere fu quella di essere considerati inclusivamente e non meglio chiaramente dei mafiosi. Il termine del resto era ancora così filologicamente in via di classificazione che fu utilizzato dal governo per indicare in termini onnicomprensivi una vasta e non omogenea categoria di soggetti, accomunati dal fatto di essere considerati tra i nemici del potere costituito: clericali, borbonici, di estrema sinistra, criminali. L’accusa di mafia era così un modo per eliminare sul piano politico l’opposizione. 81 ** ** ** È interessante analizzare adesso le argomentazioni con cui un altro gruppo di deputati avvocati siciliani, ovvero quelli afferenti alla corrente della sinistra costituzionale difesero i superiori interessi di matrice liberale contro il modello della destra storica al governo. Il luogo è sempre lo stesso. Il dibattito intorno al trattamento della annosa quaestio siciliana. L’analisi muove dalla ricostruzione degli interventi dell’avvocato palermitano Paolo Paternostro, deputato e poi nel 1876 nominato senatore sempre tra le file della sinistra costituzionale. In apertura al suo discorso alla Camera, nel corso della tornata del 5 maggio 1875, il deputato in risposta alle dure e ritenute offensive parole del prefetto Guido Fortuzzi contenute nel rapporto di cui si è fatto prima menzione, auspicò la sua «destituzione telegrafica»147. Entrando nel merito dell’esame del testo e, con specifico riferimento al tema della mafia, l’avvocato Paolo Paternostro citò subito un episodio riportato dalla carta stampata sul ferimento di due carabinieri di cui però non furono mai ritrovate testimonianze. A giudizio del deputato siciliano il caso era del tutto falso, costruito, montato ad arte e inventato dai soliti rappresentanti della pubblica sicurezza, incapaci e collusi, allo scopo proprio di screditare ulteriormente la reputazione dei siciliani agli occhi del paese. Più verosimilmente, invece, aderendo alla ricostruzione dello 147 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Stampati anno 1874-75, p. 3931. 82 storico Domenico Novacco: «era segno che [si trattava di] un delitto di mafia o almeno che nella zona in cui il delitto era avvenuto la paura della mafia era più grande di quella dei carabinieri»148. Le accuse di Paolo Paternostro nel corso della sua esposizione in aula si spostarono poi sul gioco contraddittorio delle qualificazioni: «La parola mafia è di moda; il primitivo senso si è alterato. Oggi mafia quasi suppone voglia dire tutti i reati previsti e non previsti dal codice penale. Molti prefetti chiamati a definire i mafiosi si imbrogliarono, non definirono»149. Ancora una volta, a essere invocato è il rispetto del principio di legalità, in mancanza di una strutturazione precisa del reato di mafia, il difensore rifiuta categoricamente la sua inclusione nell’alveo delle associazioni di malfattori del codice penale, come una voce inclassificata capace di attrarre in via residuale tutti i reati pretesamente ivi contenuti. L’affondo contro i prefetti che «non riuscirono a definirla», che «si imbrogliarono», cela un ulteriore attacco contro gli apparati locali del governo, costituiti a livello periferico dalle prefetture. Lungo il medesimo filone che ruota ancora attorno alla interpretazione del termine mafia si inserisce poi la voce di un altro autorevole principe del foro palermitano, Giuseppe Falcone, il quale in occasione di una conferenza tenuta nel Circolo Calabrese di Napoli di cui egli fece parte, tenne una brillante relazione 150 nella quale riferì alla comunità dei colleghi extra foro circa il binomio mafia – omertà. 148 D. NOVACCO, La mafia nella discussione parlamentare del 1875, in «Quaderni del Meridione», gen – mar. 1963, n. 1, p. 128. 149 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, cit. p. 3935. 150 G. FALCONE, Mafia e Omertà – Conferenza tenuta il 03 febbraio 1895 nel Circolo Calabrese in Napoli, Napoli – Stabilimento Tipografico R. Pesole, 1898. 83 Le argomentazioni sostenute sono volte ancora una volta alla difesa e salvaguardia dell’establishment locale, nel pensiero dell’avvocato Giuseppe Falcone si rinviene una concezione naturalistica della mafia come un prodotto locale, generata dalle «quistioni sociali»151 e che nulla ha a che vedere con associazioni formalizzate come la camorra o il brigantaggio. Viene proposta una riflessione: «se soltanto il delitto in genere in essa [nella mafia] s’impersona e si rispecchia, forse che il Codice penale è una legge eccezionale per la sola Sicilia, o che soltanto nella Sicilia vi sono lagrime da asciugare, piaghe da lenire e vittime umane da vendicare?»152. L’argomento denota una ricognizione sotto un profilo al più di criminalità comune, come tale da trattare e curare con le norme ordinarie – giacché la delinquenza si rinviene in ogni regione d’Italia – e con l’impianto del solo codice penale deve essere repressa. La formula costante che si rintraccia in questi modelli retorici è sempre una invocazione a modelli di normalizzazione. Ciò che senz’altro risalta è come il pensiero dell’avvocato Giuseppe Falcone acquisti una pregnanza particolare perché è espresso sì all’interno di un luogo forense, quale è un circolo giuridico, ma è caricato di ulteriore significato perché egli si fa portatore della divulgazione del concetto di mafia fuori dalla Sicilia – e già questo è un canone di testimonianza – ma dentro una terra con problematiche assai affini, da cui però il giurista siciliano intende prendere le dovute distanze. 151 152 Ivi, p. 6. Ibidem. 84 2.3. Azioni e proposte degli avvocati per la causa siciliana Una rassegna degli interventi dibattimentali ha fin qui consentito l’emersione delle aspre critiche mosse dai deputati siciliani nei confronti della politica della destra al potere, non mancarono però voci propositive. Sul finire del mese di maggio del 1874, la cronaca giornalistica del tempo riporta di un incontro tenutosi in una sala del Palazzo di Città di Palermo, in occasione del quale si riunirono i “regionisti” e i “repubblicani” per: «discutere e deliberare su ciò che occorreva fare di fronte alla insistenza con cui il Ministero voleva approvati dal Parlamento taluni provvedimenti eccezionali»153. Lo scopo della riunione era quello di votare un ordine del giorno da trasmettere, per mezzo dell’allora sindaco, Emanuele Notarbartolo, alle autorità politiche centrali, affinché la voce delle correnti di opposizione che si erano alleate nel fronte comune antigovernativo giungesse in parlamento muovendo direttamente dal territorio siciliano. Gli esponenti del partito regionista, gli avvocati Simone Cuccia, Andrea Guarneri, oltre al duca di Cesarò e al barone Turrisi e quelli del partito repubblicano, gli avvocati Camillo Finocchiaro Aprile e Agostino Tumminelli votarono all’unanimità, a nome di tutta la cittadinanza154 il seguente ordine del giorno: 153 154 ASP, BUSTA 30, F.12 – Rapporto riservatissimo del reggente. G. C. MARINO, L’opposizione mafiosa, cit. p. 135. 85 Un voto del Parlamento contro la proposta di legge sui provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza è necessario, perché tali provvedimenti non giovano al fine cui sono rivolti e riescono anzi dannosi e lesivi della libertà. Invochiamo che le condizioni del paese siano meglio constatate con una inchiesta parlamentare; diamo incarico ad una commissione di motivare questo voto. Si invita il Sindaco di Palermo a valersi delle facoltà conferitegli dalla legge per farsi interprete presso il governo del Re e del Parlamento, dei voti della cittadinanza palermitana155 Tale azione racchiude e condensa i propositi dell’opposizione siciliana e ha il pregio di presentarsi come un fronte comune, un blocco unitario contro l’approvazione delle leggi eccezionali, nel quale forze appartenenti a colori politici diversi si fondono in un unico atto sottoscritto indistintamente da tutti. In quel momento, la politica della destra storica al governo rappresentava un pericolo per gli interessi locali del ceto alto -borghese siciliano. Pur tuttavia, una indagine a posteriori, come sostenuto anche dallo storico Giuseppe Carlo Marino156 ha rilevato, invero, come l’approccio del governo dei moderati all’affare di Sicilia non sembrasse di per sé volto a minacciare gli interessi dei proprietari terrieri isolani. Il pericolo però c’era e si palesava indirettamente, giacché avviata con l’unificazione la fase di smantellamento del vecchio apparato borbonico prima, prodittoriale dopo, veniva ad essere ora intaccato tutto un sistema di ruoli e di funzioni sociali, che avrebbe da lì a poco comportato lo spodestamento di un numero enorme di burocrati, impiegati, faccendieri a fronte dell’ingresso di funzionari 155 156 L’amico del popolo, Giornale Politico – Palermo, 29 maggio 1875. G. C. MARINO, l’opposizione mafiosa, cit. p. 59. 86 nordici e di nuove leggi. Tale fenomeno poi si riverberava a cascata sulla classe dei professionisti. Fu stimato infatti che sulla sola città di Palermo, intorno alla gestione amministrativa – istituzionale ruotassero ben 26.597 liberi professionisti157. Ciò consente di comprendere oltremodo le preoccupazioni del ceto alto borghese e i motivi per cui gli esponenti politici siciliani, per la risoluzione del problema dell’ordine pubblico in Sicilia, oltre alla pungente critica nei modi e nei toni già visti, avessero avanzato proposte proprie, alternative allo spiegamento delle misure eccezionali. Proposte che si sostanziavano però nell’invocazione di una gestione – per così dire – privata della cosa pubblica siciliana. Ed è per questo che nella “Petizione alle Camere legislative d’Italia sui provvedimenti straordinari” le voci dell’avvocato Simone Cuccia, dell’avvocato Andrea Guarneri, dell’avvocato Camillo Finocchiaro Aprile e del barone Nicolò Turrisi Colonna si unirono all’unisono nell’estremo tentativo di bloccare l’iter del progetto in parlamento per l’adozione dei mezzi eccezionali. Il deputato siciliano Luigi La Porta, membro della commissione alla Camera, presieduta da Agostino De Pretis, incaricata di riferire sul disegno di legge, chiese a chiare lettere di: «fortificare quel corpo dei militi a cavallo che il governo mostrava di tenere in così basso conto158». A fare, poi, da contorno e da contenuto alle voci dei deputati, tutta l’opinione pubblica a difesa della Sicilia formalmente offesa 157 158 Ibidem. G C. MARINO, l’opposizione mafiosa, cit. p. 51. 87 dalla prepotenza nordica si levò in un grido di protesta che accese tumulti in numerosi comuni, mentre la carta stampata di giornali di area massonica, tra cui su tutti “La Lince” e “Il Precursore” ribattevano con fare martellante: la necessità che il servizio sia affidato a persone del paese: chi oserebbe dar colpo alla Sicilia intera delle azioni di pochi individui, sol perché il governo non ha voluto capire una buona volta che le persone addette alla sicurezza pubblica debbono conoscere i luoghi, il dialetto e le persone, e che quindi debbono essere siciliane esclusivamente 159 Il contenuto della richiesta di fortificare il corpo dei militi a cavallo non è che un’altra strategia difensiva con cui il corpo forense nel campo politico tentava di difendere il solito apparato latifondista e a garantire i vecchi e sempre validi schemi di controllo privato – mafioso degli affari locali. Rafforzare i militi a cavallo equivaleva a giungere all’obiettivo finale di gestire in proprio l’ordine pubblico siciliano e a spese dello stato. Ciò perché i militi a cavallo160 istituiti l’8 giugno 1860 per fronteggiare l’anarchia seguita al disfacimento del Regno delle Due Sicilie, altro non erano che un corpo formato da siciliani di eterogenea provenienza: garibaldini, liberali, ex reclute dell’esercito borbonico, nati e vissuti in Sicilia, conoscitori del gergo e dei luoghi. Ciascuna compagnia era responsabile della tenuta dell’ordine pubblico in una determinata zona nella quale erano obbligati a 159 Sicurezza pubblica in Sicilia, in «Il Precursore», n. 83, Palermo 26 marzo 1875. L. RIALL, La Sicilia e l’unificazione italiana – politica liberale e potere locale (1815 – 1866), Torino, 1998, p. 143. 160 88 garantire la sicurezza in ordine a furti, abigeati, grassazioni161. Allo scopo di rafforzare il legame col territorio fu stabilito che al proprietario che avesse denunciato presso la locale sezione dei militi, l’avvenuta consumazione di un furto, il danno sarebbe stato risarcito al derubato mediante una trattenuta dallo stipendio del milite che non aveva saputo tenere l’ordine e evitare così il delitto. La logica sottostante era quella di indurre i militi a tener alto il livello di attenzione sulle zone di propria competenza162. L’effetto che si produsse fu invece di tutt’altro genere. I militi a cavallo infatti entrarono nella rete di connivenza di malandrini, gabelloti e guardiani dei giardini e, travalicando il proprio ordine di servizio, finirono col trovare compromessi, barattando silenzio e omertà, ora dietro una partecipazione al bottino, ora dietro l’invito rivolto ai malviventi di cambiare zona163. Il sistema di corruzione agiva sotto l’egida delle “componende”164 sui cui tavoli la giustizia poteva essere negoziata privatamente. Ne consegue agevolmente come i militi a cavallo nella sostanza fossero una sorta di milizia privata 165, di polizia rurale, legata a doppio nodo alle logiche del latifondo e a quelle della mafia e questo, gli stessi avvocati deputati siciliani, espressione del ceto del baronaggio che a giorni alterni lamentava l’assenza delle istituzioni, lo sapevano bene. Invocare maggiori poteri ai militi a cavallo equivaleva così a 161 F. BRANCATO, La mafia nell’opinione pubblica e nelle inchieste dall’Unità al fascismo, Pellegrini, Cosenza, 1986, p. 89. 162 Ibidem. 163 R. MANGIAMELI, Gabellotti e notabili nella Sicilia dell’interno, in «Italia Contemporanea», 156, anno1984, p. 49-50. 164 Ibidem. 165 G. C. MARINO, l’opposizione mafiosa, cit., pp. 77-78. 89 ottenere maggiori garanzie di conservazione dell’ordine locale e degli interessi dei proprietari terrieri, con immediato effetto, come visto, anche sulle metodologie di salvaguardia e di perpetuazione parassitaria della mafia sul territorio. A vantaggio dei piccoli proprietari, dei latifondisti, dei baroni e dei mafiosi. Nel medesimo alveo, a ribadire ancora la concezione di una gestione privata della res publica siciliana, si ascrive la difesa condotta dall’avvocato Francesco Gestivo stavolta fuori dalle aule dei tribunali, in sede di commissione parlamentare. È naturale – riferisce – che un individuo che ha avuto timore di soffrire qualche danno o nella proprietà o nella vita ha dovuto associarsi a qualche altro, che per la sua posizione sociale aveva ugual timore, e si è formata una specie di lega degli abbienti contro i non abbienti, in senso che ha avuto a perdere qualcosa giusto per non perdere di più, e si è associato ad altri della stessa condizione per porre un argine contro le invasioni degli scroccatori. Dunque nei dintorni di Palermo si è formata un specie di guardia nazionale, e il Giammona, come altri proprietari di giardini, gabbellotti e altri che sono nella stessa condizione, si sono associati e sono prevalsi con la loro unione al punto di non fare succedere delitti, né reati, né scrocchi. E che ne è avvenuto? E’ avvenuto che hanno riscosso l’odio di coloro che non hanno potuto fare quello che han fatto loro; quindi le denunce contro di loro, li han dipinti come persone facinorose, mafiose, sospette166 Tra le righe di tale relazione, si intravede un altro segmento di una chiara difesa del fenomeno criminale in chiave politica, 166 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, a cura di S. CARBONE R. GRISPO, L’Inchiesta parlamentare sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia (1875-1876), Cappelli, Bologna 1969 – Intervista Gestivo pp. 452 – 463. 90 secondo un motivo ancora di taglio regionista. Ai Giammona, padre e figlio di professione giardinieri167,in quello stesso periodo era stata comminata la misura di polizia del domicilio coatto168, l’avvocato Francesco Gestivo, facendo sempre leva sullo strumento dello stato di diritto come unico scenario giudicabile prospettabile, lanciò una sorta di sfida nei confronti delle autorità, chiedendo loro di condurre i Giammona in tribunale «senza distrarli dai [loro] giudici naturali»169. In realtà, in quel momento, non vi erano prove a sufficienza per imbastire un processo contro i Giammona e questo l’avvocato Francesco Gestivo è verosimile credere, lo sapesse bene. Facciamo un passo indietro. Si diceva di questo giardiniere che fosse «uomo d’ordine e patriota» proprio perché aveva saputo mantenere l’ordine pubblico nelle contrade meglio di come non avessero saputo fare le autorità del regno. L’argomento dell’arguto difensore si spinge addirittura a voler far ritenere che la denuncia contro i propri difesi (Giammona e gli altri) che vengono descritti facinorosi e mafiosi, fosse un dispetto commesso nei loro confronti dall’autorità di pubblica sicurezza che di fatto non riusciva nel compito di garantire la salvaguardia dei luoghi e l’incolumità delle persone e per questo cercava di gettare discredito sulla comunità siciliana170. Il tema politico si lega immediatamente a quello giuridico. Infatti, benché si fosse dinanzi a una forma di associazione 167 Qui giardiniere deve intendersi nel senso di “guardiano dei giardini”. S. LUPO, Storia della mafia, Donzelli Virgolette, 1993, Roma, p. 111. 169 Ibidem. 170 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, a cura di S. CARBONE R. GRISPO, L’Inchiesta parlamentare sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia, cit. pp. 462 – 463. 168 91 tra proprietari e altri gabelloti, essa non poteva assurgere alla qualificazione criminale perché non raggiungeva lo scopo previsto dalla lettera della norma, ovvero di delinquere, anzi nella accezione propria del codice penale del tempo, di malfare. Si trattava di altro. Erano i garanti dell’ordine e dei valori sociali. Era una «lega di abbienti contro non abbienti», era un altro dei tentativi del popolo siciliano di autodeterminarsi, di produrre da sé il vaccino, di governarsi. La materia si innesta immediatamente in uno dei capisaldi dell’ideologia liberale di quegli anni, ovverosia quella difesa strenuamente condotta a presidio della libertà di associazione, baluardo dello stato di diritto. E la voce dell’avvocato Francesco Gestivo è ancora una roboante cassa di risonanza affinché tali istanze potessero giungere alla conoscenza del governo centrale. Il registro muta invece quando l’interlocutore del difensore di Giammona e compagni diventa Leopoldo Franchetti, che incontrerà in occasione del suo viaggio in Sicilia. Al viaggiatore toscano, l’avvocato Francesco Gestivo spiega serenamente: «Qui fioriscono associazioni di mafia per la gestione monopolistica della gabella e della guardiana, dotate di “statuto e affigliamento” [affiliazione]. Molte di Palermo estendono la loro azione fino a Termini o almeno corrispondono e s’intendono con simili società in quel paese171». Durante la conversazione sono offerti al Franchetti anche rudimenti per la comprensione del fenomeno, viene infatti spiegato dall’avvocato Gestivo come i briganti provengano dal ceto medio, 171 L. FRANCHETTI, Politica e mafia in Sicilia, cit. p. 198. 92 mentre i nobili siano il vero «fondamento della maffia172». Tale asserto giocherà un ruolo fondamentale nella creazione e nel mantenimento di un altro degli imperativi dell’argomentazione sulla mafia, su cui si ritornerà più innanzi, ovvero quello che involge la duplice dialettica: “protezione o favoreggiamento” e “vittime o manutengoli”? Il difensore, dal canto suo, si dice certo che alla base del processo contro Don Peppino il Lombardo vi sia un complotto politico – giudiziario teso ad assolvere i potenti proprietari terrieri, i Nicolosi e a condannare l’asserito brigante173. Ritornando adesso dentro alle mura del tribunale, un altro documento, una memoria difensiva predisposta dall’avvocato Francesco Gestivo, offre una spiegazione sui motivi alla base della persecuzione della magistratura nei confronti di Giammona e del proprio figlio Giuseppe sia da ascrivere «alla doppia e imperdonabile colpa di vivere del proprio e di aver curato a non farsi né rubare né sopraffare174». In un altro luogo, ancora e cioè nella sede della già vista inchiesta parlamentare175, l’accanimento delle autorità nei confronti del proprio difeso era stato ricollegato dal giurista alla circostanza che il proprio cliente fosse a Monreale un capo-elettore della sinistra, quindi pure lui, inviso al governo dei moderati, perciò mafioso, infine da epurare. Il domicilio coatto, visto attraverso la costruzione retorica del pensiero giuridico dell’avvocato Francesco Gestivo, in effetti, si 172 Ivi, pp. 36, 46, 49. Ivi, p. 196. 174 ASP, GP, 1875, BUSTA 35, F. 6 – Memoria del 29 dicembre 1875. 175 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, a cura di S. CARBONE R. GRISPO, L’Inchiesta parlamentare sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia, cit. pp. 462-463. 173 93 presta a essere l’istituto giuridico meglio idoneo alla espunzione dal tessuto sociale di certi soggetti «tristi»176. Compiamo adesso un passo indietro, riprendendo le ultime battute del dibattito parlamentare nella tornata del 4 giugno 1875 quando i toni del discorso si fecero ancora più accesi. I resoconti stenografici restituiscono la voce dell’avvocato Paolo Paternostro: «le leggi eccezionali sono una grassazione politica»; quella di Francesco Crispi: «avrete la rivoluzione»; quella di Gabriele Colonna Romano duca di Cesarò: «la mafia e il manutengolismo sono nel governo»177. Tuttavia, nonostante il voto contrario del blocco unitario dell’opposizione della sinistra e di tutte le correnti a essa affiliate, il progetto di legge venne approvato il 19 giugno 1875 alla Camera e dieci giorni più tardi al Senato178. L’esito del dibattito parlamentare sfociò nella legge n. 2579 per la costituzione di una giunta per l’inchiesta sulle condizioni sociali, economiche e sull’andamento dei pubblici servizi nell’isola e la impopolare legge n. 2580 attuativa dei provvedimenti eccezionali in Sicilia. In conclusione, in questi schemi di difese, che siano elaborati dentro o fuori dalle aule dei tribunali, è possibile intravedere un filo conduttore che concorre bene a fondare uno dei segmenti del concetto di perorazione della mafia, ovvero quello che vuole la sua riconduzione su di un campo politico. Ci si arriva nella maggior parte dei casi per negazione, 176 Arringa Cuccia, in Processo Pugliesi, p. 47. Atti Parlamentari, Camera, dei Deputati, tornata del 4 giugno 1875 p. 3888. 178 G. TESSITORE, Emergenza e garantismo nella legislazione antimafia, in «Nuovi Quaderni del Meridione» XXIII, ottobre-dicembre 1985, n. 92, pp. 408 ss. 177 94 attraverso un percorso argomentativo che giunge invece a dire in positivo, in modo traslucido, cosa sia o non sia la mafia, con chi si allei, cosa faccia. Lungo questo solco, gli avvocati palermitani iniziano a maneggiare argomenti descrittivi e qualificativi del fenomeno destinati a ritornare ciclicamente nella storia dei processi di questo genere. Ad esempio, i temi della complicità e della connivenza tra apparati dello stato, tra la polizia e gli amministratori, tra le sottospecie delle differenti polizie che sono transitate in Sicilia, molto ricorrenti negli schemi di difese di fine Ottocento, saranno ripresi e sviluppati da altri avvocati difensori circa un decennio più tardi in occasione dello svolgimento del processo Notarbartolo179. Segno, questo, di un moto unico, costante. Di una retorica forense solidificata e stratificata negli anni, che bene riusciva a tenere in aula alla prova dell’arringa o in parlamento all’esperimento dell’intervento. Dall’analisi comparativa dei discorsi pronunciati dagli avvocati politici siciliani è emersa una strategia difensiva di tipo, come si è detto, circolare, che nella perorazione della causa nazionale riflette come un gioco di specchi quella di classe, che dietro la perorazione della causa liberale cela in fondo quella privata, di quella stessa associazione mafiosa che in sede giudiziaria sta altrimenti patrocinando. 179 G. DE FELICE, Maffia e delinquenza,Politica, criminalità e magistratura tra il delitto Notarbartolo ed il processo Codronchi-De Felice, Boemi, Milano, 1900, p. 42. 95 Capitolo III La difesa tra i due Codici. Continuità e discontinuità dell’ars defendendi tra “associazione di malfattori” e “associazione per delinquere” Premessa Percorrere le retoriche adottate dagli avvocati che per primi assunsero la difesa del fenomeno della criminalità organizzata siciliana ha consentito di individuare e isolare metodologie diverse, allo stesso momento, seme e frutto della cultura giuridica ma anche politica sottesa alla classe forense isolana. In aula i difensori sono chiamati a combattere la pubblica accusa, a confrontarsi, sovente a scontrarsi su temi spinosi. Il processo con la sua teatralità rappresenta lo scenario perfetto per lo svolgimento del dramma giudiziario. E così, dinanzi alla incriminazione per associazione di malfattori ai sensi dell’articolo 426 del codice penale sardo esteso per il regno, gli avvocati opponevano ad esempio argomentazioni basate sulla mancata consumazione del reato, in una società intrisa di dottrina liberale per la quale nessuno poteva essere imprigionato senza un principio di esecuzione del reato. Questo a sua volta apriva un dibattito sul valore effettivo da attribuire ai mezzi preparatori, se fossero o meno idonei a fondare l’attuazione del reato o se fosse più corretto circoscrivere l’ambito all’alveo del mero tentativo. Una seconda strategia adoperata allo scopo di scardinare 96 l’accusa di associazione di malfattori era quella di tentarne la derubricazione a mero concorso di persone nel reato, per poi, attraverso questo varco, distinguere tra associati e complici, tentando così una discesa lungo i gradini della scala penale. Altro tema ricorrente sarà costituito poi dalla ricerca della prova della mancata lesione del bene giuridico tutelato dalla norma, cioè quel turbamento della pubblica tranquillità che a certe condizioni poteva non dirsi affatto scosso. Ancora, lungo il solco di una impronta tra il giuridico e il semantico, si ritrovano analisi del fenomeno criminale che muovono dalla ricerca dell’elemento psicologico nel reato. Asse portante di ogni figura criminale, esso andava rinvenuto nella comunione d’intenti, nella formulazione di un programma criminoso e in una – quanto mai dibattuta e controversa – interpretazione della nozione di organizzazione che doveva necessariamente trovarsi alla base della societas sceleris al fine di poterla giudicare colpevole del reato ascrittole. Abbastanza frequente era poi l’esigenza degli avvocati di patrocinare la posizione di proprietari terrieri ma anche di semplici contadini, dall’accusa formulata in loro danno di essere stati manutengoli dei maffiosi. Per avere cioè tenuto condotte idonee ad agevolarli, favorendo armi o munizioni, o prestando ricovero e ricetto presso le proprie case, o fornendo loro riparo mentre la questura era intenta a ricercarli. Tale campo di difesa si avvilupperà sempre intorno al seguente interrogativo: erano scientemente favoreggiatori o piuttosto vittime inermi incapaci di ribellarsi al potere intimidatorio della consorteria e costretti a favorirli dal timore? 97 Infine, a metà tra codice penale e codice della mafia, tra esasperazione e folklore siciliano, tra icone e dialetti, si rinviene una difesa metagiuridica del fenomeno, che si vuole designare sicilianista. Sarà filtrando questi schemi difensivi che si otterrà un mosaico variopinto di voci che restituirà nel pensiero giuridico degli avvocati palermitani, la strategia difensiva processuale delle associazioni della mafia di fine Ottocento. Vale a dire attraverso le analisi di taglio positivista dell’avvocato Giuseppe Mario Puglia, nel maneggio di argomenti fondati sulla complicità nel delitto degli avvocati Giuseppe Gargano, Antonio Alessi e Giovanni Dies, negli esempi di vere e proprie difese sicilianiste perorate dagli avvocati regionisti Bartolomeo D’Ondes Reggio, Lorenzo Maggio e Antonio Marinuzzi, fino ad arrivare a modelli derivati da impianti classici del diritto penale, ad opera degli avvocati Alessandro Stoppato e Alessandro Paternostro. 3.1. L’organizzazione come elemento soggettivo del reato Già a partire dall’esperienza pre unitaria, i codici dei vari regni italici si presentavano abbastanza concordi nel modo di intendere l’associazione di malfattori. Una comparazione tra il codice delle Due Sicilie 180, il codice Parmense181 e quello di Toscana182 rivelano, infatti, una previsione 180 Art. 147 “È accompagnato da violenza pubblica ogni crimine commesso da tre individui almeno, riuniti a scopo criminoso, di cui due almeno sono portatori di armi proprie” . 181 Art. 264 “Ogni associazione di malfattori contro le persone o le proprietà è un crimine” . 182 Art. 201 “Sono puniti con la carcere da séi mesi a tre anni coloro, che in tre o più persone usano violenza, ad oggetto di ristringere od impedire in qualunque maniera la libertà dell’ 98 normativa recante un medesimo bene giuridico protetto, ovvero la pubblica tranquillità, nonché una univoca condotta tipizzata, ovverosia l’oggetto del delinquere rivolto contro le persone o le proprietà. Con l’unificazione e l’estensione nel 1865 dell’applicazione del codice penale per il regno di Sardegna al regno d’Italia, sino al codice Zanardelli del 1889, la materia sarà disciplinata dall’articolo 426, a tenore del quale: “ogni associazione di malfattori in numero non minore di cinque, all’oggetto di delinquere contro le persone o le proprietà, costituisce per sé stessa un reato contro la pubblica tranquillità”. Un problema interpretativo e applicativo sorgeva quando si controverteva intorno al momento in cui potesse ritenersi esistente l’associazione o su come dovessero essere giudicati quelli che tra i presunti associati, non risultassero essere implicati nella totalità dei reati commessi unitariamente dalla setta. Con riguardo al primo tema, seppur con sfumature diverse, la dottrina183 e la giurisprudenza184 chiarirono che per la giuridica esistenza della associazione dovesse sussistere tra i consoci una comune intenzione nell’attuazione del programma criminoso, il che implicava una necessaria organizzazione della stessa in un sistema. Dal punto di vista degli avvocati, il maneggio di argomenti fondati sull’elemento psicologico del reato era considerato decisivo perché il mancato raggiungimento della prova sulla industria o del commercio, d’invadere o di occupare luoghi o edifizi che non sieno di uso pubblico, di rimuover o alterar confini legalmente stabiliti, di sfogar odj o esercitar vendette” . 183 COSTANTINO, UGUENTI, SFORZA, Voce: Associazione di malfattori o per delinquere, in «Digesto Italiano», Vol. IV, parte 2. 184 Cass., 21 agosto 1912, Mazzeo, in «Suppl. Riv. Pen»., 1912, 358; Cass., 30 marzo 1912, Camastro, in «Riv. Pen.», LXXVI, 562; Cass., 9 aprile 1896 Lucchini, in «Gius. Pen»., 1896, 644; Cass. un. Pen., 1896, 764, Ivi. 99 “organizzazione” sarebbe valso a negare l’esistenza dell’associazione stessa, con un notevole impatto in termini di determinazione della pena. Sulla necessarietà di un atto positivo che si sostanziasse in un principio di organizzazione, i commentatori al codice penale del tempo avevano scritto: L’associazione criminosa fino a che si manifesti per semplici parole ed anche per semplici riunioni non è incriminata dalla legge; ed anche per semplici riunioni non è incriminata dalla legge; come anche la semplice risoluzione di agire. Fin qui l’associazione è in via di semplice preparazione, può essere stornata col pentimento dei suoi componenti, la società non può risentirne ancora allarme, e tutto concorre a lasciarla impunita finché non trascenda ad un atto positivo di organamento185 E del resto, la logica stessa del reprimere una associazione per delinquere per il solo fatto che essa esista, indipendentemente dai reati commessi, affermava l’avvocato Cuccia186 si comprende alla luce della «preoccupazione per la collettività intera che conosce della costituzione di una tale societas e teme per l’incolumità propria e delle proprie cose»187. Con riferimento al secondo tema, invece, cioè la misura dell’incidenza sulla esistenza dell’organizzazione nel caso di mancato compimento da parte di taluni socii di tutti i reati ascritti alla congrega, una sentenza della Corte di Cassazione di Torino aveva statuito: «l’individuo riconosciuto in sentenza membro della associazione è contabile dei fatti dei suoi socii quand’anche non vi 185 G. MADIA, Commentario sul Codice Penale Italiano, Tipografia di Gennaro fabbricatore fu Gennaro, Napoli, 1862, ARTICOLO 426, p. 431. 186 Arringa Cuccia, in Processo Amoroso, p. 252. 187 Ivi, p. 157. 100 abbia concorso coll’opera materiale»188. Tra le pagine dei resoconti stenografici dei processi oggetto di studio, retoriche fondate proprio sull’elemento dell’organizzazione della società criminale si rinvengono nelle arringhe di Giuseppe Mario Puglia, in quelle di Simone Cuccia e di Francesco Di Franco. «Non basta che taluni uomini si riuniscano e che delinquano anche replicatamente perché si riconosca l’esistenza del reato. Essi saranno colpevoli, risponderanno dei loro fatti delittuosi ma non saranno degli associati, dei responsabili del reato di associazione finchè non saranno organizzati»189. Si rivolge così alla giuria, l’avvocato Giuseppe Mario Puglia nel processo Pugliese, tracciando anche i connotati che dovrebbe possedere la societas sceleris per dirsi tipizzata nella fattispecie di reato. «Deve infatti trattarsi di una riunione che per la sua compattezza, per la regolarità dei suoi movimenti, minaccia di sollevarsi a potere»190. L’interpretazione esegetica compiuta dal Puglia intorno al concetto di organizzazione getta le basi per un lavoro di ricerca volto a scoprire il momento della fondazione dell’associazione, della sua estensione, del suo svolgimento. Discende dal concetto stesso di organizzazione, ancora, il meccanismo per il quale si dia corso alla formazione e compilazione di elenchi degli affiliati, ulteriore fattore sintomatico esterno per la esatta qualificazione dell’esistenza di una associazione giuridicamente organizzata. 188 Cass. 15 settembre 1854 – Ricorso Albera, Demarchi ed altri – Bettini 1854. Parte I, p. 756. Arringa Puglia, in Processo Pugliesi, p. 137. 190 Ibidem. 189 101 È però storicamente insito nelle organizzazioni avvinte dal vincolo della mafia, quello di non mettere per iscritto nulla che sia riconducibile all’associazione, proprio per evitare che in seguito agli arresti di taluni affiliati si giungesse a scoprire l’organigramma della societas. E del resto, che realizzare liste di nomi degli associati fosse una pratica rischiosa ne aveva già riferito lo stesso capo banda Angelo Pugliese nel corso del dibattimento del processo, quando interrogato sulla esistenza di elenchi e statuti dell’associazione sub judice aveva risposto proprio di non averne voluti formare durante lo svolgimento dell’attività criminale191. Un identico teorema, ancora, si ritrova nel processo agli Stuppagghieri di Monreale, in cui il capo Salvatore Marino non volle alcun riferimento scritto dell’ordinamento dei mafiosi, sul presupposto che tanto gli affiliati si riconoscevano tra loro per mezzo di un gergo particolare noto soltanto ai membri della setta192. Della esistenza di tali segni di riconoscimento ci testimonia il delegato di polizia Antonio Cutrera che nel proprio saggio scrive di: «segni di riconoscimento in tutte le associazioni, conosciuti in tutta la Sicilia, usati, diversi nella forma, ma identici nella sostanza, da tutti i mafiosi, ogni qual volta vogliono costoro accertarsi che la persona con cui s’incontrano sia un affiliato alla mafia»193. Sempre nell’alveo della questione sull’elemento della organizzazione si ascrive la difesa dell’avvocato Francesco Di Franco, il quale nel processo Pugliese spiegava gli specifici connotati che dovevano sussistere affinché una associazione a delinquere potesse dirsi giuridicamente perfetta: ovvero un sistema 191 Interrogatorio ad Angelo Pugliese Don Peppino il Lombardo, in Processo Pugliesi, p. 5. Interrogatorio Salvatore Marino in Processo Stuppagghieri, p. 33. 193 A. CUTRERA, La mafia e i mafiosi, cit., p. 124. 192 102 di corrispondenza tra i socii e il capo, speciali convenzioni per render noto il bottino e per dividerlo e distribuirlo secondo le rappresentanze, i gradi e i meriti di ognuno. Viene fatto all’uopo ricorso all’utilizzo di una metafora di efficace significato: «deve esistere una illecita società nella quale il fondo sociale è il ricavato dei reati e nella quale i socii prendono tutto quanto è la loro abilità, desunta dal grado»194. Le risultanze dibattimentali, in effetti, mostravano militare in favore della linea difensiva tracciata dal difensore, in quanto l’accusa aveva ritenuto di legare la prova dell’esistenza della banda nel fatto che un omicidio fu consumato su decisione dispotica del capo, ma questo – per dirla con le parole dell’avvocato Di Franco – smentiva già in sé la sussistenza di una associazione, che invece laddove fosse realmente esistita avrebbe dovuto adottare le decisioni in regime “costituzionale”, con l’accordo di tutti o almeno a maggioranza195. Lo stesso argomento lo ritroviamo più avanti trattato dall’avvocato Simone Cuccia, il quale smentiva che potesse sussistere una associazione di malfattori senza che si fosse formato il raggiungimento probatorio su alcuni connotati caratterizzanti il requisito della organizzazione. Ovvero: l’esistenza di una nota dei soci, una cassa sociale, un sistema di corrispondenza sociale a tenore del quale i diritti e i doveri degli affiliati siano perfettamente regolati196. Identico il pensiero per l’avvocato Giuseppe Mario Puglia: 194 Arringa Di Franco, in Processo Pugliese p. 189. Ibidem. 196 Arringa Cuccia, in Processo Amoroso, p. 252. 195 103 «non esiste associazione in cui non si annotino i partecipanti»197. L’argomento non poteva non dirsi sostenuto anche dall’interpretazione giurisprudenziale germogliata negli stessi anni intorno al significato da attribuire a gesti temporalmente antecedenti alla commissione del delitto, come ad esempio, la riunione di persone. Così la Corte di Cassazione di Palermo: «non si ha un’associazione organizzata e perfetta nel senso inteso dall’art. 426 c. p. sardo se abbia avuto luogo soltanto una risoluzione presa di concerto o di conserva e dell’associazione siasi fatta una semplice manifestazione di parole, quand’anche siasi tenuta qualche riunione per intendersi a combinarla»198. E così anche la Corte di Cassazione di Torino: «non ogni riunione di persone, anche per uno scopo delittuoso, vale a costituire l’associazione di malfattori, se l’unione è precaria, effimera, momentanea, accidentale, ancorché avesse per oggetto di commettere reati contro la proprietà; in tal caso rientra nei casi ordinari della correità o complicità nei singoli reati commessi»199. Ad un esame panoramico, ciò che emerge è certamente come il principio cardine che governa tutto il sistema delle difese processuali esaminate sia quello di separare, di scindere, di abbattere la teorizzazione stessa dell’associazione, il concetto del gruppo di persone riunite allo scopo di malfare, di minare alla pubblica tranquillità della società. Giuseppe Mario Puglia nella sua chiusa ai giurati infatti afferma: «se la giustizia vuole condannati i colpevoli, vuole che a 197 Arringa Puglia, in Processo Pugliese, p. 192. Cass. di Palermo 13 giugno 1873 in «La Legge», 1873, 1, p.110. 199 Cass. Di Torino 14 maggio 1867 in «Gazzetta dei Tribunali», 1867, 2, p.115. 198 104 ciascuno sia data tanta responsabilità quanta ne attirano i fatti da lui consumati»200. Questo monolitico impianto che regnò quasi incontrastato sino alla fine del secolo diciannovesimo subì poi un cambiamento di indirizzo dopo l’entrata in vigore del nuovo codice penale per il regno d’Italia del 1889, come le pronunce giurisprudenziali dei tribunali siciliani ci informano. «Non occorre che sia provata l’esistenza d’uno statuto, né che si conosca il modo preciso come fosse la banda organizzata: basta che risulti assodato il Comune intendimento tra cinque o più persone, a scopo di determinate specie di delitti nel comune interesse»201. Nella costruzione del nuovo modello associativo contenuto nel novellato articolo 248 del codice penale infatti la concezione di organizzazione non si poggia più essenzialmente sulla ricerca della prova dell’esistenza dei capi, quindi su un fattore da indagarsi dall’esterno, ma sul semplice fatto positivo della costituzione dell’associazione per delinquere «che è reato sui generis, e per sé stante, sicché non occorrono altri determinati delitti, commessi o da commettersi, per ritenerla esistente e punibile, prevedendo e punendo la legge espressamente anche il solo fatto della semplice associazione»202. 200 Arringa Puglia, in Processo Pugliese, p. 166. Causa c. Vernaccini e compagni. Tribunale di Sciacca, 30 maggio 1893, in «Circolo Giuridico» – Decisioni penali, p. 321. 202 Ibidem. 201 105 3.2. La partecipazione dei socii ai delitti: reato associativo e singole responsabilità Ancora sulla interpretazione e corretta applicazione della disciplina codicistica, specie negli anni antecedenti alla istituzione di una Cassazione unica per il regno d’Italia, più frammentario appare lo scenario quando si risale ulteriormente la corrente del tema della organizzazione. Uno degli interrogativi era infatti questo: essere organizzati, essere legati da un comune intento implicava, infatti, solo che le decisioni sui misfatti da compiersi dovessero essere assunte di comune accordo tra i socii o anche che dovessero essere materialmente eseguite da tutti gli aderenti alla setta? La Corte di Cassazione di Firenze nel gennaio del 1865203 aveva statuito lapidariamente che: «si considerano malfattori senz’altro coloro che si associano per commettere misfatti». Il vuoto normativo veniva così riempito richiedendo un comportamento positivo: la commissione del delitto. Lungo questo solco fiorirono costruzioni difensive degli avvocati basate proprio sulla mancata partecipazione di tutti gli accusati ai delitti per i quali si stava processando l’associazione. Un esempio di tale meccanismo difensivo è rintracciabile nell’arringa pronunciata dall’avvocato Simone Cuccia nell’ambito del processo Amoroso204, in cui il difensore riteneva di rinvenire la prova che non si era trattato di una associazione nel senso inteso dall’accusa proprio dal fatto che non tutti i presunti affiliati avevano preso parte ai delitti imputati alla setta, così come altri delitti erano stati commessi da soggetti non associati. 203 204 Pandolfini e Senesi in «Foro It.» XVII, 1, 91. Firenze, 14 gennaio 1865. Arringa Cuccia, in Processo Amoroso, p. 248. 106 Le problematiche attorno alla corretta applicabilità del reato associativo tormentarono intere generazioni di giuristi, in particolar modo, come osservato da Luigi Lacchè «al fenomeno di estensione della fattispecie associativa corrispondeva una valutazione volta ad aggravare il peso delle unioni criminali»205. In questo senso ancora, la teorica di Sighele, contrassegnata da una specie di chimica degli elementi criminali, concorre ad unificare il fattore di pericolosità insito in ogni sodalizio con quello della eccezionalità del tipo di intervento206. «L’azione che risulta dal concorso di più persone non è quindi mai un’addizione, ma è sempre un prodotto207». Un esempio di continuità tra meccanismi di retorica forense cristallizzati sotto la vigenza del codice penale sardo italiano e altri sviluppatisi nei processi celebrati con il nuovo codice Zanardelli si rinviene nella difesa spiegata dall’avvocato Gian Battista Impallomeni in occasione del processo celebratosi a Palermo nel 1904 definito dalla cronaca giudiziaria del tempo “per i quattro scomparsi”. L’arringa di Impallomeni in questo processo si aprì in tono polemico, denunciando il ragionamento seguito dai magistrati che avevano emesso la sentenza d’accusa «senza avere un concetto esatto della portata del reato rubricato dall’articolo 248 c. p.»208. Riprendendo la linea di pensiero già tematizzata da Simone Cuccia vent’anni prima, ecco riemergere nuovamente la problematica legata al significato dell’essere organizzati allo scopo 205 L. LACCHÈ, Alle origini della associazione per delinquere: crimen plurium, concorso e reato plurisoggettivo, cit. pp. 672-673. 206 S. SIGHELE, La psicologia della complicità, in «Archivio di Psichiatria», 14 (1893), p. 98. 207 Ibidem. 208 Arringa Impallomeni, in Processo per i quattro scomparsi, p. 12. 107 di delinquere. I singoli reati sono per l’accusa la prova dell’esistenza della associazione, eppure non tutti i responsabili degli omicidi sono fra gli associati, come non tutti gli associati sono implicati nei processi di omicidi, mentre ritenuta l’associazione dovrebbero essere ritenuti i correi, perché gli assassinii consumati avrebbero dovuto giovare a tutto quanto il sodalizio209 Pur costituendo l’articolo 248 del nuovo codice penale italiano l’evoluzione di una lunga gestazione di studi, la sua fase applicativa risultava ancora problematica. Come risolvere la questione quando alcuni dei componenti la presunta associazione non avessero materialmente partecipato al delitto commesso solo da alcuni? Come raggiungere la prova positiva sulla adesione psicologica di quelli al misfatto? E proprio questo è il senso di un passaggio dell’arringa difensiva di Impallomeni che oltre a ricoprire il ministero forense, rivestiva il ruolo di docente universitario presso la facoltà di giurisprudenza di Palermo: «si insegna ordinariamente che la organizzazione costituisca la nota caratteristica di questo reato»210. Ci si riferisce alla comunione di intenti, alla intenzione di unirsi per commettere delitti la cui prova deve essere sostenuta dall’accusa. Per Impallomeni, come per Cuccia, gli elementi raccolti allo scopo di imbastire questi processi, che vengono qualificati come delle creazioni edificate al solo scopo di screditare l’immagine della 209 210 Arringa Impallomeni, in Processo per i 4 scomparsi, p. 13. Ibidem. 108 Sicilia dinanzi al neonato stato italiano, possono al più lambire il tema della complicità nel delitto, il che equivaleva a una iscrizione del fenomeno, al più, nella disciplina sul concorso di persone nel reato211. Tale distinzione è gravida di importanti conseguenze: un conto era infatti ritenere che tutti gli imputati facessero parte di una unica società criminale, punibile da sé, per il solo fatto della sua esistenza, con il risultato che tutti gli affiliati sarebbero stati indiscriminatamente colpiti dalle pene previste dall’articolo 248, un altro era sconfessare tale assunto, ammettere laddove provata la commissione di un delitto in concorso tra più persone e con riguardo alla pena, riscrivere la sanzione in termini di responsabilità graduata a carico degli imputati, proporzionale all’apporto effettivamente prestato. Il teorema ebbe una notevole fortuna, non fosse altro perché tutti i procedimenti esaminati presentavano l’analogia per cui non tutti gli imputati in sentenza istruttoria per i singoli reati erano chiamati a rispondere anche per il reato associativo e ancora tra i presunti associati non tutti avevano preso parte ai singoli reati. Ciò consentiva all’acuto giurista l’estrapolazione di due figure sintomatiche, atte a confutare la prova accusatoria: la contraddizione e l’incompatibilità. Mediante l’utilizzo della prima egli sollevava una apparente antinomia: o si trattava per intero di associazione – e allora il giudicante avrebbe dovuto incriminare tutti i correi, oppure di soli 211 G. B. IMPALLOMENI, Del concorso di più persone nel reato, in «Rivista Penale», Palermo XXVI, 1900, p. 32. 109 reati comuni – e in tal caso a cadere sarebbe stata l’intera imputazione formulata dall’accusa. Il pensiero giuridico di Impallomeni riguardo i processi associativi in esame oppone, al rigido formalismo della prescrizione dell’articolo 248 del codice penale, il dubbio che forse, delineare le singole responsabilità, nella formula graduata propria del concorso di persone nel reato avrebbe «salvato gli innocenti e condannato i rei»212. 3.3. Tra consumazione e atti preparatori. Il contributo del pensiero della scuola classica alla causa siciliana Il momento dibattimentale rappresenta, come già ampiamente rilevato, il terreno d’elezione in cui la lettera della norma incontra ed entra in interazione, per intervento dialettico del difensore, con l’ipotesi concreta di applicazione. Da questo incontro, che sovente si tramuta in uno scontro, nella particolare congiuntura post unitaria, tra il vecchio codice penale e il nuovo in gestazione, tra idee conservatrici e spinte propositive, scaturiscono interessanti sviluppi e dinamiche del pensiero dei giuristi siciliani intorno al reato associativo. In particolare, lo spoglio delle risultanze dibattimentali ha disvelato, accomunati da un comune terreno scientifico, raccolti in un omogeneo sentire politico, una cerchia di giuristi classici. Naturali eredi della filosofia politica dell’Illuminismo, per loro l’aspirazione alla certezza del diritto passava attraverso l’assegnazione alla norma penale di un connotato di tassatività. Soltanto la puntuale descrizione della condotta penalmente 212 Arringa Impallomeni, in Processo ai quattro scomparsi, p. 12. 110 vietata e la limitazione della punibilità alle fattispecie previste, avrebbe potuto garantire la giusta equidistanza tra l’esigenza di controllo sociale e la contrapposta esigenza di tutela dell’individuo di fronte all’arbitrio dello Stato213. Nei processi contro le associazioni della mafia esaminati, le riserve dei giuristi si addensano attorno alla configurazione del reato associativo, ispirata ad una logica di “anticipazione del pericolo”, che finisce per assoggettare a pena anche atti meramente preparatori, i quali – come veemente sostenuto dagli avvocati siciliani – «offrono a malapena un punto di appoggio per l’incriminazione, ma non bastano a fondare e punire l’asserita associazione»214. Dal principio cardine di tutta la scuola penale classica moderna, della tassatività della norma penale, discende poi un altro impianto della cultura giuridica ottocentesca, ovvero quello a tenore del quale potesse essere punibile soltanto l’atto che avesse costituito un principio di esecuzione del reato e non invece un semplice atto preparatorio215. Ed è proprio l’interazione tra questo principio, o forse più correttamente – di questo baluardo della penalistica moderna – con la figura del reato associativo, ad aver portato alla elaborazione di una seconda categoria difensiva del fenomeno criminale della mafia in Sicilia. A sostenerla sono in due diversi luoghi gli avvocati Alessandro Paternostro e Alessandro Stoppato. 213 G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, Il Mulino, Bologna, 1976, pp. 227-259. 214 Arringa Paternostro, in Processo Amoroso, p. 212. 215 A. STOPPATO, La scuola giuridica italiana e il progresso del diritto penale, in «La Scuola Positiva» XIX, 1909, p. 309. 111 Entrambi hanno una estrazione accademica oltre che “avvocatizia”, Paternostro infatti insegnò diritto costituzionale presso la regia università di Palermo dai primi anni Ottanta del secolo decimonono sino al 1899, Stoppato fu ordinario di procedura penale all’università di Bologna dal 1898 al 1904. Il primo patrocinò la posizione di un tale Lo Verde nel processo Amoroso, il secondo fu il difensore di uno dei ritenuti sicari dell’assassinio Notarbartolo. Il loro pensiero giuridico si innesta sul filone interpretativo cristallizzato dalla giurisprudenza a tenore della quale: per essere punibile l’associazione di malfattori deve trascendere in un atto preparatorio, prendere corpo e diventare organizzazione, poiché se essa dovesse «rinvenirsi in tutti i reati premeditati e commessi su riunione di cinque persone, si confonderebbe con la premeditazione e la complicità216 Per i due giuristi non è pensabile procedere alla incriminazione fin tanto che non si raggiunga la prova positiva che il reato abbia avuto un principio di esecuzione, non potendo essere sufficiente un mero atto preparatorio217. La materia fu oggetto di veri e propri terremoti interpretativi, infatti da lì a poco, una nuova pronuncia giurisprudenziale intervenne a mutare l’ermeneutica: È indifferente altresì che la prova del concerto risulti da speciali convenzioni e da fatti estrinseci speciali che non siano i reati stessi, perché sta nella sua essenza che l’associazione si verifichi come reato 216 Cass. Napoli 20 luglio 1870, in «Monitore Milano», XI, p. 985. Arringa Paternostro, in Processo Amoroso, p. 211; Arringa Stoppato, in Processo Notarbartolo, p. 450. 217 112 appena l’accordo comune sia formato, che si dispieghi se non come una precisa organizzazione, al certo che importi concerto, determinazione di commettere una serie di azioni delittuose in che appunto è riposto il dolo massimo, la ragione per cui la legge, in vista del pericolo della tranquillità pubblica, punisce l’associazione prima ancora di qualunque principio di esecuzione ai singoli reati: perché data l’esistenza dell’associazione il delitto sociale si consuma col danno potenziale e la potenza di nuocere ad un numero indefinito di cittadini, nell’associazione, è dal momento che essa esiste e fino a che esista 218 Tuttavia, si è riscontrato come in maniera pressoché immutata tra il primo e il secondo codice, la linea interpretativa degli avvocati difensori dei processi esaminati, seguendo un iter logico di impronta “classica” si fece spazio in quegli interstizi lasciati dalla normativa penale. Infatti, secondo questa corrente interpretativa, il momento della costituzione della associazione, fin tanto che se ne cominci l’esecuzione, rappresenta un mero atto preparatorio che non trovando esplicita sanzione nell’ordinamento, in aderenza al generale divieto di interpretazioni estensive della norma penale, non potrà da sola condurre a una incriminazione219. In conclusione, nel composito alveo che caratterizza le diverse categorie difensive utilizzate dagli avvocati nel palcoscenico giudiziario, probabilmente la difficoltà specifica della cultura giuridica liberale di affrontare il problema della mafia trae origine dalle riserve verso il reato associativo, riserve di principio che, per usare le parole di Marcella Marmo: «dall’area della repressione più o meno discrezionale del dissenso politico più o 218 Cass., 3 agosto 1893, Addis, Cass. un. Pen., 1894 in «Riv. Pen», 15. A. STOPPATO, La scuola penale classica, cit.p. 309; Arringa Paternostro, in Processo Amoroso, p. 211. 219 113 meno violento, la cultura giuridica liberale estendeva al reato “comune” di associazione per delinquere»220. 3.4. Dal thema associativo a quello della complicità nel delitto Una autonoma categoria difensiva cui gli avvocati fecero spesso ricorso durante il momento dibattimentale si fonda su una tra le più intricate e combattute questioni del diritto penale antico e moderno, ovvero la teorica della complicità nel delitto. Ancora una volta il momento processuale rappresenta il banco di prova sul quale misurare la staticità delle norme scritte. Invero, nel corso della ricostruzione del fatto dinanzi agli occhi dei giurati emergono i pretesi ruoli assunti da ciascuno degli imputati nel reato. Dal profilo della difesa, riuscire a stabilire l’esatta determinazione della responsabilità di ognuno dei compartecipi nel delitto produrrebbe immediati risvolti sia rispetto al principio di causalità, che nei riguardi della teoria della pena221. L’impatto sulla causalità si determina perché risulta necessario comprendere l’incidenza del singolo sulla causazione del reato. L’impatto sulla teoria della pena si spiega nell’esigenza di attribuire una diversa gradazione della punizione in rapporto al ruolo effettivamente assunto. L’obiettivo ultimo è quello di spostare il piano dal concetto di 220 M. MARMO, Il reato associativo tra costruzione normativa e prassi giudiziaria, in «La città e il Tribunale», a cura di G. CIVILE E G. MACHETTI, Libreria Dante & Descartes, Napoli, 2004, pp. 111-170. 221 L. LACCHÈ, Alle origini, cit. p. 670. 114 “associati”, che sottende l’esistenza di una società dedita al malfare con tutti i canoni previsti dalla legge, a quello di meri “complici”, che meglio colloca le responsabilità di ognuno su latitudini penali diverse e variegate. Una sintetica ma doverosa ricostruzione del quadro normativo in materia di complicità rivela come l’impianto normativo del codice penale Sardo Italiano adottasse il modello differenziato, che distingueva tra le figure di compartecipazione primaria e secondaria, materiale e morale, a seconda del rilievo e del tipo di intervento che il concorrente aveva avuto nel reato222. Sotto il capo IV «degli agenti e dei complici», l’articolo 102 infatti qualificava agenti principali: il mandante, il provocatore, l’istruttore, ovverosia coloro i quali avevano dato mandato, o indotto o istruito taluno al delitto223. L’articolo 103 individuava invece i complici in: coloro che istigheranno o daranno le istruzioni o le direzioni per commettere un reato. Coloro che avranno procurato le armi, gli strumenti o qualunque altro mezzo che avrà servito all’esecuzione del reato, sapendo l’uso che si destinava di farne. Coloro che senza l’immediato concorso all’esecuzione del reato avranno scientemente aiutato o ad assistito l’autore o gli autori del reato nei fatti che lo avranno preparato o facilitato, od in quei fatti che lo avranno consumato224 Il successivo articolo 104 stabiliva il regime delle pene 222 S.SIGHELE, La psicologia della complicità, cit. p. 112. Codice Penale Sardo-italiano, esteso per la Sicilia, r.d. 17 febbraio 1861, n. 32, l. 19 gennaio 1862, n. 421 - art. 102. 224 Codice Penale Sardo-italiano, esteso per la Sicilia, r.d. 17 febbraio 1861, n. 32, l. 19 gennaio 1862, n. 421- art. 103. 223 115 previste per le figure individuate negli articoli 102 e 103225. Pertanto era stabilito che: gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato. I complici saranno puniti come gli autori del reato quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato commesso. Negli altri casi la pena dei complici sarà diminuita da uno sino a tre gradi secondo le circostanze Il sentiero della complicità consente così di percorrere strade alternative, attraverso i passaggi offerti dal principio di causalità e dalla teorica sulla pena. Procedendo ancora sull’indagine, il successivo Codice Zanardelli226 condividerà il medesimo impianto, prevedendo sotto il titolo IV «del concorso di più persone in uno stesso reato», l’articolo 63 in tema di correità che sostituiva il vecchio 102 e l’articolo 64 in tema di complicità in luogo del precedente 103. Ancora sotto la vigenza del primo codice penale italiano, era consentita l’indagine sulla condotta effettivamente tenuta dal complice, al fine di graduarne la pena per il caso in cui il reato si sarebbe consumato ugualmente anche senza il suo intervento. Il dibattito che accompagnò l’evoluzione normativa in materia di complicità nel delitto fu acceso, combattuto, criticato. Appare quindi opportuno soffermarsi sulle interpretazioni proposte dagli avvocati siciliani, sulla ricostruzione degli argomenti difensivi scaturenti dal maneggio dello strumento tecnico-giuridico dell’elemento della complicità nel delitto, in rapporto sempre al 225 Codice Penale Sardo-italiano, esteso per la Sicilia, r.d. 17 febbraio 1861, n. 32, l. 19 gennaio 1862, n. 421- art. 104. 226 Nuovo Codice Penale per il Regno D’Italia, app.to con R. Decreto 30 giugno 1889, n. 6133, Napoli, 1912. 116 reato associativo. Una visione panoramica delle carte processuali pone in risalto, infatti, una serie di discorsi pronunziati dagli avvocati nei processi a cavaliere tra i due codici, accomunati dal ricorso al medesimo campo: roteare l’evento da ipotesi di reato di associazione per malfattori – o per delinquere secondo la nuova dizione – a quella di mera complicità del reo nel singolo delitto, per poi all’interno di tale categoria suddistinguere tra complici necessari e non, allo scopo di attenuare la pena. Effettivamente, la condivisione di un simile impianto da parte della giuria si sarebbe tramutato in una derubricazione dalla fattispecie associativa, più grave perché dotata di una maggiore quantità politica, a forme graduate di complicità nei singoli reati, con immediati benefici in termini di pena. Ciò si ascriveva ancora al principio più generale, capostipite di tutte le linee difensive esaminate, teso a negare l’esistenza di una unitaria societas della mafia. E il migliore strumento per perseguire tale intento era quello della frammentazione dell’unicum prospettato dall’accusa nei mille rivoli dei singoli reati e delle isolate e spaiate vicende personali. Muoviamo l’analisi dall’argomento sostenuto dall’avvocato Antonio Gargano che nel processo Amoroso assunse la difesa dei fratelli Minì, accusati di essere associati alla banda Amoroso per aver partecipato, nell’interesse della stessa, alla consumazione di un omicidio, avvenuto in un fondo all’ingresso del quale i due erano stati collocati nel ruolo di guardie. La difesa del Gargano227 principia da due dati fattuali e 227 Arringa Gargano, in Processo Amoroso, p. 219. 117 circostanziali da soli bastevoli a neutralizzare qualsivoglia contributo apportato dai Minì al delitto: ovvero il fatto che fosse notte, quindi l’assenza di luce, il buio e la circostanza che il fondo, teatro del delitto, fosse recintato, quindi di per sé chiuso, delimitato. Il primo dato, cioè, l’assenza di luce, concorre a rafforzare il tema sulla mancata certezza che i guardiani indicati fossero proprio i due fratelli Minì, posto soprattutto che uno dei testimoni, un tale Caravello, in sede dibattimentale aveva riferito: “È vero che ho detto al questore di aver visto i Minì, ma ora debbo confessare che soltanto mi parvero loro: e ciò in coscienza228”. Il secondo dato, ovverosia che il delitto si fosse consumato in un fondo chiuso, recintato, non era affare di poco conto, in quanto a detta dell’avvocato Gargano, nessuno avrebbe potuto entrarvi senza il volere dei custodi229. La puntuale descrizione del fatto è compiuta allo scopo di sovrapporre ad essa, la lettera della norma prevista dall’articolo 104 del codice penale sardo italiano, che come visto, circoscriveva la punibilità dei complici come quella degli autori, solo quando la loro cooperazione fosse stata tale che senza di essi il delitto non sarebbe stato commesso. Quale responsabilità quindi poteva ascriversi in capo ai due Minì? Asseriva Gargano che: «se davvero fecero la vedetta, fu una inutile, una soverchia precauzione»230. Per avvalorare ulteriormente la propria tesi, basata sul fatto che nelle circostanze descritte il delitto avrebbe potuto essere 228 Arringa Gargano, Processo Amoroso, p. 219. Ivi, p. 220. 230 Ibidem. 229 118 comunque commesso, l’avvocato aggiunge anche una nota di colore: «E poi si è detto che il maleficio avvenne l’ultimo giorno del Festino: chi eravi in campagna a quell’ora?» Il “Festino”231 a Palermo è la festa in onore alla Patrona della città, Santa Rosalia, un evento celebrativo denso di tradizione, passione e folklore che coinvolge tutta la popolazione a partecipare al rito solenne per l’intera durata dei giorni prevista. Il senso dell’argomento è che in un giorno come quello, tutti si trovavano in città a festeggiare la Patrona, le campagne erano deserte e la commissione del delitto sarebbe stata ulteriormente avvantaggiata da questo dato fattuale al punto tale che la supposta presenza di due guardiani posti all’ingresso del fondo doveva palesarsi superflua rispetto alla fattibilità del delitto. L’effettivo ruolo ricoperto dai fratelli Minì nell’omicidio appariva dopo il discorso dell’avvocato Gargano certamente più vago e sfumato. Attraverso tale itinerario, l’avvocato mirava a ricondurre la posizione del proprio difeso dall’alveo associativo dove l’accusa lo aveva collocato, a quello della complicità non necessaria al delitto, in un momento, quello postunitario, in cui la dottrina si presentava divisa in due correnti scientifiche. La prima rifiutava la distinzione di responsabilità tra i compartecipi, sul presupposto che il complice affiliandosi al delitto avesse inteso associarsi a tutte le eventualità dello stesso. La seconda scuola, di impronta più pratica, riuniva gli avvocati oggetto di studio i quali, patrocinatori della sacralità del 231 S. CABIBBO, Santa Rosalia tra cielo e terra. Storia, rituali, linguaggi di un culto barocco, Sellerio, Palermo, 2004. 119 diritto di difesa, premevano per l’accoglimento di un principio maggiormente liberale, che graduasse invece la pena tenendo conto della effettiva condotta di ogni complice232, sull’assunto che l’essere compartecipe implicasse già il rifiuto a voler divenire l’autore materiale nel delitto. Questa teoria rivela un differente elemento psicologico del reato, sufficiente a negare l’equiparazione tra autore materiale e complice, per questo motivo l’avvocato Gargano, in chiusura rivolgendosi alla giuria, afferma: «Sarebbe ingiusto considerare alla stessa stregua, coloro che si sono macchiati di sangue, da quelli che non lo hanno fatto»233. Tale tesi fu sostenuta più tardi, con una formula stilistica meno grezza e più raffinata, da Gian Battista Impallomeni, il quale in un proprio scritto pubblicato nella Rivista Penale di Lucchini234, ribadì il concetto che se era vero che ogni causa era necessaria al prodursi di un dato evento, non poteva parimenti dirsi che la potenza spiegata dalla partecipazione di più individui al delitto fosse la stessa per tutti, con il risultato che pertanto la pena non avrebbe potuto colpire i concorrenti in maniera omogenea, ma bensì in formula graduata. Ascritto allo stesso pensiero giuridico, già un quarantennio prima, un argomento di ugual tenore era stato sostenuto dall’avvocato Schirò nel processo Pugliese al fine di patrocinare la posizione del proprio assistito, un tale D’Amico, accusato di aver preso parte all’agguato mortale di un membro appartenente alla 232 T. PADOVANI, Francesco Carrara nel primo centenario dalla morte, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 253-298. 233 Arringa Gargano, in Processo Amoroso, p. 219. 234 Impallomeni, del concorso di più persone, cit. p. 12. 120 banda rivale. «Egli partecipò per caso a quell’assassinio. Sarebbe autore o complice?»235. Il concetto di partecipazione casuale al delitto viene spiegato dal difensore nel senso che il proprio assistito non volle intenzionalmente far parte di quella spedizione di morte, ma il proprio consenso fu estorto con l’uso della violenza e il timore. La mancata partecipazione morale all’omicidio (che se dimostrata, assolverebbe dall’accusa) viene dimostrata dall’avvocato Schirò con l’utilizzo di un esempio che egli illustra direttamente ai giurati: «Se venisse un assassino e vi dicesse col pugnale alla gola: bussate a quella porta ˗ e voi la bussereste ˗ vi sarebbe forse un magistrato che verrebbe ad accusarvi di complicità?»236. Il racconto fatto da uno dei propalatori su quell’episodio, infatti, posiziona la figura del D’Amico nel ruolo di colui che bussa alla porta di casa della vittima, mentre assegna agli altri socii il compito di consumare l’omicidio non appena lo sventurato avesse varcato l’uscio. Il testo della propalazione narra però come lo stesso D’Amico, subito dopo aver compiuto l’azione, sia fuggito via a piedi allontanandosi dal luogo del delitto. L’avvocato Schirò ripercorre le condotte codicistiche suscettibili di integrare i canoni della complicità e li rinviene soltanto nell’azione di «dirigere, istigare, scientemente cooperare alla consumazione del delitto»237. Il comportamento tenuto dal D’Amico che secondo la propalazione fugge via dal teatro 235 Arringa Schirò, in Processo Pugliese, p. 54. Ibidem. 237 Ibidem. 236 121 dell’omicidio è strutturalmente incompatibile con una partecipazione fisica e morale al delitto. Con argomenti simili, ancora nel processo Amoroso, dall’avvocato Paolo Figlia viene fatto ricorso al meccanismo della compartecipazione al delitto, per negare l’associazione e per collocare la responsabilità del proprio assistito nel gradino più basso della scala penale238. In questo caso, si trattava di definire la condotta di un tale Caravello colpevole di avere condotto nel fondo Romano, già visto, Gaspare Amoroso che in quel luogo fu poi trucidato dai Badalamenti. Anche qui, la linea difensiva seguita dall’avvocato Figlia è tesa a dimostrare sul piano formale il ruolo di complice non necessario e su quello sostanziale la sua non imputabilità per carenza dell’elemento soggettivo, psicologico del reato. In ordine al primo punto, il difensore conclude che Gaspare Amoroso andò volontariamente presso il fondo Romano, con la immediata conseguenza che avrebbe potuto recarvisi con chiunque altro. Diversamente se Caravello lo avesse legato e portato nel luogo indicato, allora quella sarebbe stata complicità necessaria, perché si sarebbero verificati i presupposti richiesti dalla legge: l’intenzione di cooperare nel delitto e la circostanza che senza l’azione di quel complice lo stesso non avrebbe potuto realizzarsi. Con riferimento al secondo punto, il Caravello, nel corso del dibattimento aveva sostenuto di essere stato ingannato e tradito perché gli altri non gli avevano rivelato il proposito criminale. 238 Arringa Figlia, in Processo Amoroso, p. 237. 122 «Per esservi la complicità deve esservi la scienza del male»239. *** Un’altra delle condotte tipiche ascrivibili al campo della complicità al delitto è quella di prestare scientemente armi. L’articolo 103 del codice penale sardo italiano, infatti, annoverava tra i soggetti colpevoli di complicità al delitto anche coloro che procurarono le armi che servirono al reato, avendo avuto conoscenza dell’uso al quale esse erano state destinate. E’ l’avvocato Alessi240 a sostenere una linea difensiva costruita su questo tema per il proprio assistito, un tale Lo Verde, accusato di essere associato alla banda Amoroso per avere ad essi fornito una carabina che fu poi utilizzata per l’omicidio di Badalamenti nel fondo Romano. Il giurista in apertura al proprio discorso spiega come il discrimine che fonda l’imputabilità e che tramuta un atto di per sé innocuo – come la consegna di un fucile – in un delitto sia costituito dalla sciens, dalla consapevolezza che quell’arma servirà ad un uso criminale. «Non si dà concorso fisico, senza scienza, né si contrae responsabilità penale senza che quella vi sia, e formi il dolo in colui che, come complice, la legge vuol punire»241. L’elaborazione giurisprudenziale242 aveva enucleato il principio per cui in determinate circostanze la scienza, la consapevolezza, l’elemento psicologico necessario ad integrare il 239 Ibidem. Arringa Alessi, in Processo Amoroso, p. 226. 241 Ibidem. 242 Cass., 17 luglio 1870, Messi, in «Foro It.», 1870, I, 477. 240 123 reato, potesse risultare dalla qualità stessa del mezzo somministrato, per esempio fornire una chiave falsa, un grimaldello lasciava presagire una scienza presunta. Così argomentava il difensore Alessi: Somministrare in buona fede un fucile ad un amico per usarne alla caccia non può costituire complicità, quand’anche l’arma si fosse impiegata a commettere un reato. La carabina non è un’arma che lascia presagire sé stessa il dolo, non è stato provato che essa apparteneva al mio assistito, potrebbe averla solo restituita agli Amoroso 243 Un altro momento interpretativo sulla teorica della complicità applicata al tema della mafia si rinviene nell’articolo pubblicato dal delegato di polizia, Antonino Cutrera244. Il saggio pone in risalto l’elemento della complicità, quale caratteristica propria del vincolo mafioso, secondo la logica positiva assurta da Sighele245 e teorizzata dagli avvocati difensori. Gli assunti di partenza da cui muove Cutrera sono che l’unione degli individui aumenta il coraggio di ciascuno, che questo favorisce la tendenza criminosa latente in ognuno e che gli odi di sangue o di onore sono quelli con il maggiore potere suggestorio. La mafia ben si presta a essere la naturale depositaria di tutti questi elementi e ciò permette di comprendere la commissione di quei delitti particolarmente feroci e sanguinari, che passano tutti attraverso il meccanismo della complicità e che rispondono sempre agli stessi canoni dell’omertà e del mutuo soccorso tra i socii. 243 Arringa Alessi, in Processo Amoroso, p. 226. A. CUTRERA, La mafia e i mafiosi, cit. p. 23. 245 S. SIGHELE, La teorica positiva, cit. p. 68. 244 124 3.5. Il bene giuridico tutelato. La nozione di “pubblica tranquillità” Prima dell’entrata in vigore del codice Zanardelli, lo spazio di applicabilità della fattispecie associativa non era esente da contrasti interpretativi e da tensioni gravitanti intorno anche alla esatta portata del bene giuridico tutelato. La strutturazione della norma codicistica dell’articolo 426 del codice penale sardo – italiano, infatti, lasciava troppo indefinito l’indice di quelli che potevano essere annoverati tra i reati – scopo dell’associazione. Quando lo scopo di ledere la pubblica tranquillità avrebbe potuto dirsi raggiunto? Quali singoli reati avrebbero dovuto essere commessi per integrare la fattispecie associativa? Proprio su questi vuoti interpretativi, gli avvocati – almeno sino alla promulgazione del codice penale del 1889 – delinearono una categoria difensiva che nelle intenzioni avrebbe dovuto condurre all’assoluzione dei propri difesi, secondo un iter logico principiato dal presunto mancato raggiungimento dello scopo del reato nei fatti contestati dall’accusa. Tali argomentazioni rivestivano due strutture: l’una sostanziale, l’altra formale. Tutte miravano a far venire meno l’accusa di associazione. Nel processo Amoroso, «uccisi e uccisori erano tutti birbanti, si uccidevano fra di loro»246 affermava l’avvocato Giovanni Lucifora. 246 Arringa Lucifora, in Processo Amoroso, p. 238. 125 Non si poteva sostenere che da questo fosse turbata la pubblica tranquillità perché non erano danneggiate le proprietà e le persone, «allora sarebbe l’interesse nostro in giuoco, sarebbero in pericolo i nostri beni e i nostri cari congiunti – tutti sarebbero soggetti alla carabina e al pugnale dell’assassino»247. Il ragionamento dell’avvocato Giovanni Lucifora militava nel senso che gli omicidi consumati tra gli Amoroso e i Badalamenti allo scopo di assicurarsi il primato del controllo della sezione Orto Botanico (quartiere) di Palermo, essendosi realizzati tra loro stessi – tra delinquenti appartenenti a due fazioni – potessero al più offendere il sentimento della comunità, non già la tranquillità pubblica, proprio sul presupposto che tali reati fossero un qualcosa di privato, destinato a rimanere tale. «Che importa a noi gente dabbene se gli Amoroso e i Badalamenti si scannano fra loro?»248. All’interno di questo discorso, vi è già contenuta la quintessenza della comprensione del fenomeno della mafia. Innanzitutto, il difensore fa riferimento al canone della guerra per il controllo del territorio, schema tipico del fenomeno criminale siciliano249. È tra i precursori di coloro i quali molto più avanti, sosterranno l’esclusione dell’associazionismo della mafia dal novero dei reati contro l’ordine pubblico, proprio sul presupposto che la sua azione non minacciasse la comunità, ma che si fosse semplicemente dinanzi a una lotta tra partiti avversi, da reprimere 247 Ivi, p. 239. Ibidem. 249 S. LUPO, Storia della mafia, cit., p. 78; S. LUPO, Il giardino degli aranci, Il mondo degli agrumi nella storia del Mezzogiorno, Marsilio, Venezia, 1990, p. 66. 248 126 con le forme ordinarie, facendo uso dei singoli strumenti di reato di volta in volta richiesti (omicidio, grassazione, ferimento etc.) senza alcun risvolto di carattere pubblicistico, senza che dalla sua opera assurgesse alcun turbamento per la comunità250. Lo studioso Gaetano Mosca nel 1900 aveva già osservato che «il carattere di vendetta o di offesa verso una determinata persona è una vera specialità della delinquenza siciliana»251, la quale si distingueva per la sua radicale antisocialità. D’altronde, sociologicamente, riscontra Giuseppe De Cesare252, lo stesso Mosca aveva rilevato che lo spirito mafioso si manifestava con maggior forza nei piccoli paesi più che nelle città, nelle classi povere più che in quelle colte e ricche, anche se non mancavano punte di mafiosità nelle famiglie blasonate, così da poter concludere, in parziale contrapposizione con i positivisti che la mafia non era effetto dell’eredità o della razza, ma dell’ambiente in cui si viveva. Pur nondimeno, anche per l’avvocato Paolo Figlia nel medesimo processo, non poteva dirsi raggiunto lo scopo voluto dalla norma perché «gli assassinii rinvenuti nella contrada Orto Botanico non furono nessuno per associazione»253. Si trattava di cose private, «di storiche inimicizie tra la famiglia dei Badalamenti e quella degli Amoroso»254. Il difensore ritiene che non potrà dirsi turbata la pubblica tranquillità per il fatto che un Badalamenti uccise un Amoroso e gli Amoroso uccisero due Badalamenti, in quanto si trattava di vendette personali causate da odi di famiglia. 250 L. LACCHÈ, Alle origini, cit. p. 673. 251 G. MOSCA, Che cosa è la mafia, Bologna, 1900, p. 34. 252 G. DE CESARe, Voce Mafia in «Nuovo Digesto Italiano» p. 138. Arringa Figlia, in Processo Amoroso, p. 235. 254 Ibidem. 253 127 La teorizzazione di questo argomento ebbe una notevole fortuna in ambito di difesa della mafia, tant’è che venne riproposto con un certo successo anche in momenti processuali diversi e trovò un discreto consenso anche in ambito giurisprudenziale, persistendo ben oltre l’entrata in vigore del nuovo codice penale del 1889. In Sardegna, a proposito di reati commessi da associazioni strutturalmente affini alla mafia siciliana: il reato di associazione a delinquere si sostanzia nella riunione di cinque o più persone con l’intento comune di compiere una serie di reati indeterminati e non già questo o quel reato contro questa o quella persona, per motivi determinati ed in seguito a determinate occasioni 255 Il fine generico di commettere delitti inteso come scopo sociale che da solo avrebbe legittimato l’associazione criminale trovò ulteriore conferma in una pronuncia della Corte di Cassazione nel 1894, la quale aveva stabilito che: non costituisce associazione a delinquere il fatto di cinque o più persone che si riuniscano allo scopo di commettere un determinato reato; l’associazione per delinquere deve avere lo scopo generico di commettere una serie di delinquenze, di quelle enunciate nell’art. 248 sia pure che nel formarsi dell’associazione non ne sia determinata la specie, tanto da costituire un pericolo per l’ordine pubblico e la pubblica tranquillità256 Con il nuovo codice penale italiano, pertanto, matura ulteriormente la teorizzazione antica sul carattere autonomo che deve possedere l’associazione criminale per poter essere processata 255 256 A. Cagliari, 3 luglio 1911, Delogu, «Giur. Sarda», 1911, 287. Cass. Pen, in «Riv. Pen». 1894 vol. I, p. 312. 128 e condannata, ovverosia quel quid aggiunto che connoti la stessa di una impronta soggettiva propria, sganciata dai componenti che l’hanno costituita. Nel caso di associazioni a delinquere legate dal vincolo della mafia almeno per tutto l’Ottocento questa linea immaginaria tracciata da decenni di processi appare piuttosto evanescente e allora ecco che omicidi consumati tra bande rivali possono essere semplicisticamente e riduttivamente letti dagli avvocati difensori come meri odi di famiglie contrapposte, come dei gesti certamente vili ma inidonei a sublimare allo stato di organizzazione criminale di cui la società può temere e per la quale la stessa deve difendersi. *** Mantenendo il focus di esame puntato ancora sull’elemento dello scopo del reato associativo, come accennato innanzi, una ulteriore connessa questione interpretativa si avviluppava intorno alla irrisolta polemica su quali singoli reati dovessero effettivamente commettersi per potersi dire integrata la fattispecie associativa. Uno sguardo alle fonti rileva come nel processo Amoroso ad esempio, gli imputati siano tutti accusati di aver commesso delitti contro le persone, ma non siano chiamati a rispondere anche di reati contro la proprietà. Secondo una interpretazione letterale del dettato normativo, in effetti tanto già basterebbe per dirsi raggiunto lo scopo della previsione codicistica dell’articolo 426 che descrive le due condotte a delinquere tipizzate in maniera non cumulativa, ma alternativa: «contro le persone o le proprietà». 129 L’argomentazione dell’avvocato Simone Cuccia257 si spinge però a dimostrare come il tipo di società messo avanti dal Pubblico Ministero non solo non sia provato, ma sia anche di tipo impossibile. Nel caso in esame, non furono registrati delitti contro la proprietà, ma solo contro le persone, pertanto il difensore deduce sillogisticamente che per l’accusa i rei si associarono, «col fine stabile e duraturo dell’attività sociale»258 – «per uccidere soltanto, per esercitare private vendette, per sfogare personali rancori». Mentre, la giurisprudenza259 ha riscontrato numerosi casi di associazioni costituite allo scopo di delinquere contro la proprietà, «società di malfattori nate solo per ammazzare non ve ne sono mai viste»260. Più verosimilmente, continua l’avvocato, quando esse sono esistite hanno avuto uno scopo politico, come è stato per “la società dei pugnalatori di Palermo261”. Simone Cuccia, tra i compilatori del codice penale Zanardelli, sa bene che la condotta sufficiente alla incriminazione per il reato associativo sia quella di aver commesso anche delitti contro le persone, ma conclude l’arringa affermando che «tante cose ammesse dal codice non trovano riscontro o lo trovano assai 257 Arringa Cuccia, in Processo Amoroso, p. 252. Ibidem. 259 Cass., 22 dicembre 1897, Lo Sardo, in «Giur. Pen». Tor., 1898, 21; Legge 1898, I, 132; Gazz. Proc., 1898, 298. 260 Arringa Cuccia, in Processo Amoroso, p. 252. 261 P. Sciascia, I Pugnalatori, 4 ed. Adelphi, Milano, 2007. È un saggio storico. La ricostruzione storica verte attorno ad una strana serie di delitti che avvenne durante a Palermo la notte del 1 ottobre 1861. In tredici luoghi diversi di Palermo, tredici persone tra loro sconosciute vennero pugnalate contemporaneamente suscitando grande clamore e mistero nella città. Il saggio ricostruisce il processo condotto da Guido Giacosa, onesto magistrato piemontese appena giunto in Sicilia, che svelerà alcuni dei retroscena di un complotto testo a destabilizzare la situazione del nascente stato Italiano. 258 130 difficilmente nel fatto»262. Sul tema della determinazione o meno del catalogo dei delitti astrattamente commissibili dall’associazione criminale era intervenuto anche il giurista Impallomeni che nel proprio trattato scriveva: «l’associazione per delinquere, societas delinquendi, è la società formata fra cinque persone allo scopo di commettere de’ delitti, determinati o da determinarsi, il che è indifferente»263. Tale linea interpretativa per converso fu criticata dal coevo Luigi Maino che sull’argomento scrisse: perché una associazione sia punibile a termini dell’articolo 248 c. p., essa deve essere diretta non già ad un reato determinato, ma in genere a commettere una serie di delitti. La società per reati determinati darà luogo soltanto all’applicazione delle norme sulla correità e complicità, o anche ne’ congrui casi alla applicazione dell’art. 253 264 La questione ruotante intorno al concetto di scopo nel reato in esame, stante i contrasti interpretativi sorti, fu ampiamente dibattuta in sede di lavori preparatori al nuovo codice penale italiano. In uno dei progetti presentati, infatti, a proposito dei delitti che commessi in regime associativo avrebbero dato luogo alla incriminazione era stata inserita la locuzione: «benché di specie non ancora determinata». Si lasciava così un margine discrezionale mediamente ampio in ordine a cosa potesse produrre una imputazione per il reato associativo. Margine che fino a quel momento era stato utilizzato dagli 262 Ibidem. G. B. IMPALLOMENI, Trattato di diritto penale, Vol. II, p. 320. 264 L. MAINO, Commento al codice penale italiano (2 voll).,1890-94, 3a ed.1911, Vol. 1, p. 705. 263 131 avvocati difensori nei processi esaminati allo scopo proprio di negare che un determinato delitto, isolatamente considerato, potesse ascriversi al tema più grande del reato associativo. Ed infatti, nel testo definitivo del nuovo articolo 248 del codice penale italiano, l’inciso «delitti benché di specie non ancora determinata» fu soppresso. La motivazione addotta fu la seguente: La Commissione non ha creduto che nel designare lo scopo di una associazione, onde qualificarla associazione per delinquere, si possa seguire il sistema del progetto di legge, che parla in genere di associazione a commettere delitti, benché di specie non ancora determinata; ciò per il pericolo facilissimo di confondere qualche volta una innocua associazione politica con una società criminosa 265 Marciano osservò come il Guardasigilli credette di accogliere la formula proposta dalla Commissione, senza accorgersi che, senza volerlo, eliminando un equivoco, ne rendeva possibile un altro266. Difatti nella Relazione al Re, allegata al testo definitivo del Codice, è detto: «Mi parve savio e prudente seguire il consiglio della Commissione della Camera elettiva con l’indicare nell’art. 248 la specie di delitti che possono costituire l’associazione criminosa preceduta nel capo II. Non è veramente giustificata né opportuna la limitazione esistente nel Codice sardo, che parla di associazione per commettere reati soltanto contro le persone o la proprietà; ma l’ammetterla per qualunque delitto, e “benchè di specie non ancora determinata” avrebbe potuto facilmente dare adito a pericolose interpretazioni»267. 265 G. MARCIANO, Associazione per delinquere e concorso criminoso, in «Questioni di diritto», Napoli, 1926, p. 260. 266 Ibidem. 267 Ibidem. 132 Dal ventiseiesimo verbale della Commissione di Revisione emerge che Emilio Brusa propose la soppressione dell’inciso “benchè di specie non ancora determinata”, ma Luigi Lucchini si oppose osservando: «Quanto alla soppressione delle parole “benchè di specie non ancora determinata” la riterrei dannosa, evitando esse molte questioni pratiche e chiarendo l’intendimento della legge». Ma, più tardi, continua Gennaro Marciano: «in sede di redazione definitiva, il Guardasigilli, si lasciò preoccupare dal criterio politico, e, senza molta ponderazione, l’inciso venne soppresso, dando luogo, così, agli equivoci frequenti nella pratica della vita giudiziaria»268. La soppressione di tale inciso, dando prevalenza ad un criterio politico anziché sociologico, criminologico e psicologico, pare abbia dato maggior rilevanza all’elemento dell’organizzazione dei socii, piuttosto che al perseguimento di reati compiuti da sodalizi mafiosi, ma travestiti da vendette tra privati, atavici odi familiari e guerre per il controllo del territorio, di per sé inidonei, a primo acchito, ad integrare la fattispecie criminosa del reato associativo. 3.6. Manutengolismo: vittime o protettori della mafia? Il caso di una estorsione di due giumente «Manutengolo è un vocabolo che difficilmente si trova nel dizionario o che almeno non è di buona lega, senza dubbio un cruscante se ne scandalizzerebbe. Se lo cerchiamo nel codice 268 Ibidem. 133 penale, la parola non la si troverebbe neppure»269. È questo l’incipit con cui l’avvocato Simone Cuccia inaugura nel processo Pugliese la propria arringa difensiva nei confronti di alcuni soggetti imputati del reato di assistenza agli associati. La fattispecie criminale che colpiva chi – estraneo alla associazione – avesse fornito armi, munizioni, alloggio, ricovero o luogo di riunione ai membri della consorteria. Per questo, storicamente legato al reato di associazione per delinquere è quello di assistenza agli associati previsto già dal codice sardo – italiano e poi confluito nel codice Zanardelli. Lo scopo della norma era così quello di troncare quel sistema di connivenza tra i delinquenti e altri soggetti anche esterni alla banda stessa ma colpevoli di aver prestato materialmente aiuto agli associati e di averli quindi indirettamente agevolati nel compimento dei delitti. Decisiva al fine dell’integrazione di tale figura criminosa era la sussistenza dell’elemento psicologico, occorreva che vi fosse stata intenzionalità nell’azione, cioè che il soggetto avesse voluto consapevolmente cooperare e aiutare gli associati. La costante giurisprudenza aveva infatti sempre escluso il reato previsto dall’articolo 429 del codice penale poi rifluito nel 249 del nuovo codice, nei casi in cui non si era raggiunta la certezza probatoria sulla volontarietà dell’azione270. Proprio intorno alla sussistenza o meno dell’elemento soggettivo del reato, ovverosia del dolo, si innesta un argomento difensivo largamente condiviso tra gli avvocati siciliani che per il 269 Arringa Cuccia, in Processo Pugliese, p. 34. U. CONTI (a cura di), Prima raccolta completa della Giurisprudenza sul codice penale, Vol. II, Milano, 1926, pp. 112-113. 270 134 suo contenuto contribuisce a descrivere e a fondare un altro segmento sulla percezione del fenomeno criminale di tipo mafioso. Il filo conduttore di questa autonoma categoria difensiva sarà costituito dall’irrisolta dialettica tra il binomio vittima/protettore della mafia. Infatti, essere colpevoli di avere scientemente e volontariamente assistito gli associati equivale giuridicamente a esserne protettori, mentre aver assistito gli associati per paura di subire ritorsioni e di mettere a rischio la propria incolumità e quella della propria famiglia, equivale invece a esserne vittime. Per il giurista palermitano Simone Cuccia, muovendo dall’assunto di partenza che la volontarietà nel compimento di una certa azione presuppone la libera determinazione nella scelta, la struttura del reato in esame, punendo solo chi avesse aiutato scientemente e volontariamente gli associati, non può in alcun modo sovrapporsi alla realtà emersa nel corso del dibattimento. E questo perché volontario è quell’aiuto prestato in assenza di qualsivoglia costrizione o imposizione, mentre «la posizione scoraggiante di chi si trova in aperta campagna tra gli alberi e gli animali, in un luogo dove la presenza di un soldato o di un pubblico funzionario è un avvenimento inaspettato e sempre passeggero»271 è tale da non consentire alcuna libera scelta da parte «di agricoltori e di pecorai»272. L’avvocato Simone Cuccia fa un chiaro appello alla esimente dello stato di necessità, che esclude la punibilità quando chi ha commesso il fatto si trovava costretto dalla necessità di salvare sé o 271 Arringa Cuccia, in Processo Pugliese p. 76. Ibidem. 272 135 altri da un pericolo273. Una rilettura della difesa tracciata da Simone Cuccia palesa al contrario elementi tipici idonei a fondare proprio l’esistenza di una associazione della mafia, elementi che sono contenuti già nella sua stessa percezione sociale come un fattore di pericolo per la vita e per le cose. Il passaggio nelle vaste campagne di una banda armata suscitava timore nella popolazione «che viveva in romite capanne»274 e questo perché la forza promanante dal vincolo associativo era tale da non consentire una libera determinazione nelle genti che vi abitavano. E del resto, lo stesso capo banda, Don Peppino ne parla nella propalazione a proposito del campiere Giordano: «non altrimenti che tutte le famiglie di quella fattoria si affaccendavano a darmi il benvenuto e rifocillarmi, con i miei compagni, né avrebbero potuto trattarci altrimenti perché tutti sanno che nella vita occorre, talvolta, fare di necessità virtù»275. La costruzione del discorso di Simone Cuccia si rifà a un registro politico oltre che tecnico giuridico nel senso già visto. Ed infatti, egli nella duplice veste di avvocato e di deputato lancia un duro attacco nei confronti delle istituzioni, colpevoli di non sapere mantenere l’ordine pubblico nell’isola e di scaricarne le relative responsabilità sulla popolazione siciliana. Spesso accade che un drappello di reali Carabinieri, dopo aver lungamente inseguito di feudo in feudo un malandrino, ritorna trafelato 273 G. MADIA in «Comentario sul Codice Penale italiano con le modifiche per le provincie napoletane», 1862, p. 122. 274 Arringa Cuccia, in Processo Amoroso, p. 232. 275 Ibidem. 136 e con le mani vuote al quartiere e incomincia a imprecare contro tutti i proprietari, contro tutti i gabelloti, contro tutti i lavorieri delle terre per cui han transitato e li dicono tutti manutengoli se non altro perché non sono accorsi colle loro armi onde facilitare le ricerche del latitante 276 Non erano dunque protettori, ma vittime della mafia. «Quante volte – concludeva Cuccia – in questa medesima città di Palermo non ci siamo fatti noi cittadini, di qualunque ordine e condizione, manutengoli per “procurarci l’inviolabilità della roba e della vita”?»277 Un argomento di simile taglio aveva il pregio di fare molta presa sui membri della giuria popolare, suscettibili delle impressioni e dei condizionamenti della mafia nei modi già esaminati. Tuttavia, la percezione della convivenza tra associati e gente della campagna come fenomeno necessario, dettato dalla condizione e dallo stato d’insicurezza nel quale versavano le zone più isolate e impervie della Sicilia, così come sostenuta dall’avvocato Simone Cuccia nel processo celebratosi nel 1868, pur assurgendo a categoria avviata a riproporsi nel tempo, sarà destinata a mutare radicalmente più tardi, all’interno dello stesso comprensorio di Palermo e con l’avvento del nuovo codice penale italiano. Il tribunale del capoluogo siciliano, infatti, in una sentenza del 1903, collazionata nella rivista del Foro Siciliano 278 statuì la condanna per assistenza agli associati di cui al novellato articolo 249 codice penale, in danno di soggetti riconosciuti colpevoli di 276 Ibidem. Ibidem. 278 Tribunale di Palermo, 10 dicembre 1903, Alaimo in, «Foro Sic.», 1904, 1. 277 137 favoreggiamenti verso gli imputati di associazione per delinquere, che “per essere sicuri negli averi e nella vita” erano soliti pagare periodicamente agli associati a delinquere, premi in denaro o derrate. In altra sede, commentando lo stesso processo Pugliese, un altro avvocato palermitano, Pietro Gramignani, che vi prese parte in veste di difensore di un tale Valenzi, ebbe cura di tratteggiare il senso del manutengolismo in Sicilia come: «un termine elastico piovutoci dalle Alpi, un qualcosa di meno del reato di favoreggiamento. Una generale disposizione della popolazione siciliana a coprire il malandrinaggio che il governo in modo indiscriminato con operazioni militari e con l’impiego di provocatori destinati a produrre nuova delinquenza»279. Al di là della polemica politica strenuamente condotta nei confronti della destra al potere, la qualificazione giuridica del difensore sulla figura dell’assistenza agli associati, che ha cura di distinguere dal reato di favoreggiamento, è certamente coerente con la linea giurisprudenziale a cavallo tra i due codici280. Così ancora il tribunale di Palermo nel 1903: «coloro che prestano aiuto e favoreggiamento ad una banda di briganti debbono punirsi a norma dell’art. 249 c. p. e non possono rientrare nella ipotesi dell’art. 225 c. p.». Da una pagina dello studio condotto da Leopoldo Franchetti emerge un ritratto del manutengolismo siciliano come un fenomeno intimamente legato alle logiche mafiose di gestione del latifondo. Una esatta comprensione del termine implica una analisi 279 P. GRAMIGNANI, Sicurezza pubblica, in «La posta elettorale», 20 luglio 1868, p. 33-34. Tribunale di Palermo, 10 dicembre 1903, Alaimo, in «Foro Sic.», 1904, 1. 280 Ibidem. 274 138 comparativa con quello di protezione. Un concetto quest’ultimo da intendersi non in senso univoco, cioè della persona estranea all’associazione che offre aiuto all’associato, ma come una sorta di protezione negoziata, in cui il manutengolo riceve dall’associato garanzie, sicurezza, scorta, a fronte di un servizio di vigilanza sui beni e sulle cose. Così scriveva Franchetti: «se i proprietari accettano di ricevere cortesemente i malviventi, li albergano, li rivestono, li armano non è certo per carità cristiana. Non è per uno spirito di rassegnazione e di umiltà poco verosimile281». Il proprietario terriero abita lontano dalle campagne, ma ha interesse a che la propria roba, i propri fondi, il proprio bestiame non vengano saccheggiati dalla criminalità organizzata. Per questo, scrive Franchetti, occorre che tra i soggetti addetti alla guardianìa, cioè i campieri, il signore abbia in servizio almeno uno che sia in relazione con loro, che possa fungere da interlocutore per riavere, dietro la corresponsione di un compenso, la restituzione del bestiame rubatogli. Questo campiere, rispetto agli altri – racconta Franchetti nel proprio memoriale – riceve un compenso diverso, non proporzionale al proprio ufficio, ma del resto non si tratta di un salario, piuttosto del premio di assicurazione o di riscatto contro l’abigeato che il proprietario versava come una tassa alla banda o all’associazione282. Il ruolo assunto dal campiere si ascrive a pieno titolo nella logica di controllo del territorio e nella gestione privatistica degli 281 L. FRANCHETTI, Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, Firenze, Vallecchi, 1926, p. 30. 282 Ivi, p. 32. 139 affari che sono alla base dell’apparato dell’organizzazione della mafia, disegnato sul modello dell’idea di stato. Il campiere assume così la veste di un funzionario collocato stabilmente sul territorio che limitatamente alla zona di propria competenza esplica la propria attività, financo riscuotendo tasse per conto della organizzazione, che così alimenta il proprio fondo sociale. Il proprietario è cosciente del fatto che ha bisogno del campiere per garantirsi l’inviolabilità della roba, il contadino non può fare altro che piegarsi alle richieste degli affiliati che si trovino ad attraversare i fondi ove essi vivono e così la doppia rete di protezione unisce in un vincolo inestricabile protetti e protettori, mafiosi e latifondisti, contadini e campieri. Non dissimile era stato il giudizio del prefetto di Palermo Gioacchino Rasponi, il quale dopo sette mesi di permanenza nel capoluogo siciliano era stato in grado di rendicontare al Ministro Girolamo Cantelli come: «I manutengoli partecipano ai guadagni dei malandrini per timore o per calcolo e sono i più pericolosi perché, avvalendosi della loro rispettabile posizione sociale per censo o per carica, proteggono, difendono, scagionano i birbanti»283. Nel corso dello stesso anno, una altra autorevole voce giungeva a dare il proprio contributo al composito quadro sul tema del manutengolismo. Era quella del Sostituto Procuratore del Re, Sangiorgi, che in un passo della propria relazione sull’amministrazione della giustizia, disse: 283 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione 1874 – 1875, Leg. XII, Documenti, 5 giugno 1875, doc. n. 24, All. A-1, Relazione del Prefetto di Palermo, Palermo, 31 luglio 1874, p. 14. 140 Disprezziamo col nobile sdegno di coscienza incontaminata la turpe ingiuria di comunanza di sentimenti coi tristi di qualunque risma, respingiamo l’accusa di manutengolismo ma non neghiamo che mafiosi e latitanti trovano alloggi e soccorsi per paura. Ribelliamoci, denunciamoli, contiamoli. Davanti ai buoni cittadini sono poca cosa, facciamo una lega degli onesti contro i malvagi284 Lo studio delle fonti ha così rivelato per questa via, la diversa interpretazione che fu data, sempre dall’avvocato Simone Cuccia, ad una condotta che per l’accusa parve contrassegnata dagli elementi di una estorsione. Da un osservatorio privilegiato è stato possibile leggere nella strategia difensiva operata dallo stesso giurista in un altro segmento dibattimentale del processo, elementi che mentre negano, finiscono invece con il certificare l’esistenza di chiari indici di mafiosità nei comportamenti degli imputati. La linea difensiva degli avvocati militava nel senso di scomporre le condotte allo scopo specifico di abbattere l’unitarietà che fonda l’associazione. Il ruolo del campiere isolatamente considerato può avere un indice di reità prossimo allo zero, ma calato nel contesto poc’anzi descritto, egli diventa un anello della organizzazione, un funzionario facente funzioni territorialmente dislocato. E infatti, proprio la condotta di un campiere associato alla banda Pugliese si disvelò, come nella puntuale ricostruzione del Franchetti, in un comportamento rispondente a chiari canoni mafiosi. 284 Sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1875. Relazione letta dal Sostituto Procuratore del Re Cav. A. Sangiorgi alla Corte di Appello di Palermo il 5 gennaio 1876, Palermo 1876 – in A. CRISANTINO, della segreta e operosa, cit., p. 91. 141 Gli elementi ci sono tutti. Il ruolo assunto è quello dell’intermediario che dopo la consumazione di un furto nel fondo di cui era guardiano, si adopera per il recupero della refurtiva e per la riscossione della tassa da versare tramite i malfattori all’associazione. La vicenda riguardava l’abigeato di due giumente, rubate e poi fatte ritrovare dopo pochi giorni ai legittimi proprietari, i quali, su consiglio di Francesco Miceli (associato alla banda Pugliese) avrebbero consegnato a lui stesso una somma di complessive dieci onze, che il Miceli avrebbe poi versato ai picciotti (i ladri) a titolo di «ringraziamento per il vantaggio di essere stati dispensati dalle vie giudiziarie per riaversi gli animali rubati». Questa ricostruzione, «pur integrando un deplorevole negozio», a detta del difensore non racchiude gli elementi caratteristici della estorsione. La fattispecie prevista dall’articolo 601 del codice penale sardo italiano imponeva per la consumazione del reato non già una consegna spontanea di denaro o altri oggetti indicati dalla legge, ma bensì una dazione che fosse coartata da violenza morale. Occorreva, inoltre, che tale coazione fosse stata l’effetto di minacce, non generiche, ma di morte, di incendio o di altro grave danno; e in terzo luogo, necessitava che esse fossero state realizzate con segrete ambasciate, o con biglietti anonimi o altrimenti facendosi vedere colle armi. Tutti elementi che concordano nell’imprimere all’estorto, la serietà, la pericolosità concreta e la verosimiglianza nell’attuazione delle predette intimidazioni. La lega di forza di Simone Cuccia in questa difesa, deriva dalla circostanza che dagli interrogatori condotti durante il 142 dibattimento non era emersa in alcun modo una condotta da parte del Miceli che potesse integrare gli estremi di una minaccia, così come ampiamente descritta dallo stesso difensore nella sua epigrafe. I due proprietari terrieri presso i quali Miceli prestava servizio come campiere all’interrogatorio avevano infatti negato di aver subito alcun tipo di imposizione o di minaccia e affermarono che fu solo il desiderio di gratificarsi con i ladri che avevano restituito le giumente rubate, che li determinò a consegnare quelle somme. Le ragioni sottostanti un pensiero di questo tipo da parte dei due proprietari terrieri sono rinvenibili a detta di Simone Cuccia nell’ignoranza e nella perversa educazione del popolo. Rimandano insomma a un irrisolto problema di civiltà giuridica insito in certi strati della società, ma non sono bastevoli per fondare il reato. Di talchè, pur considerando l’avvenimento del pagamento di dieci onze ai ladri per mezzo dell’intermediario mafioso Miceli, come un «illecito negozio», esso non poteva essere qualificato “estorsione” e punito a termini dell’articolo 601 del codice penale. E allora cos’era? Era la merce di scambio per l’opera svolta dal campiere Miceli, ma accadimenti di questo tipo si preferiva lasciarli rientrare in quella zona grigia fatta di suggerimenti, ammiccamenti, consigli non richiesti, che se isolatamente considerati possono avere una quantità penale prossima allo zero, se ricostruiti nel tessuto sociale e politico del tempo rischiarano, invece, gli elementi tipici della condotta e del metodo di azione della mafia. Lo stesso Franchetti ebbe modo di riscontrarlo nel suo 143 viaggio nell’isola: «La complicità apparente è universale. Ma in Sicilia l’apparenza di complicità non ha significato. Chi troverà il mezzo di distinguere quella che viene imposta dal terrore, da quella spontanea e lucrosa?»285. 3.7. La difesa positivista di Giuseppe Mario Puglia Una sintesi ragionata e stabilizzata tra gli scritti pubblicati in riviste giuridiche quali “La Scuola Positiva” e “Archivio di Psichiatria”, la pubblicistica Lombrosiana, l’influenza etnologica di Pitrè e gli studi di Alongi che condussero alla formazione di un’altra categoria difensiva del fenomeno della mafia (destinata a riproporsi ciclicamente nel tempo) è condensata nella voce del celebre giurista palermitano Giuseppe Mario Puglia, nipote dell’omonimo di cui si è già detto. Le prime anticipazioni si reperiscono già a partire dal 1886 quando il delegato di polizia Giuseppe Alongi pubblicò il suo saggio intitolato “La maffia”286. Seguace, anzi neofita, come ha cura di definirsi, della scuola dell’illustre professore Ferri, egli studiò i fattori inerenti alle persone (antropologici) e quelli relativi all’ambiente fisico, applicando le direttive dell’impianto positivista «ai fattori della maffia»287. E così Alongi tratteggia un quadro descrittivo del carattere, dell’indole siciliana, avendo cura di specificare che un disegno unitario non sia tracciabile in quanto «dal nobile di nascita al 285 L. FRANCHETTI, Condizioni politiche e amministrative, cit. p. 38. G. ALONGI, La maffia, cit. 287 Ivi, p. 36. 286 144 contadino, dall’abitante della grande città e della marina a quello di montagna, intercedono una serie di differenze importantissime»288. Così, eccettuati i contadini della montagna, i più poveri e umili, «la nota dominante del carattere siciliano è un esagerato sentimento di sé stesso, un egoismo sconfinato, un orgoglio, una pienezza individuale che ad ogni occorrenza si manifesta»289. Una nota caratteriale che da sola considerata non è un difetto, né una virtù, ma, continua Alongi: «a seconda della classe sociale, l’educazione e l’ambiente domestico, può andare all’eroismo, alle virtù più pure o scivolare all’omicidio impulsivo o premeditato»290. Un’altra lente di ingrandimento è poi posta sugli affetti di famiglia, intesi dal siciliano «con una prepotenza egoistica sempre apparente e traboccante, così anche tutti gli altri affetti ove l’io, il possessivo si affaccia sempre vivo e vistoso. Il siciliano quasi senza volerlo sente sé stesso in tutto ciò che lo riguarda, negli affetti come nella proprietà, nelle idee come nei sentimenti»291. Questa analisi rappresenta un primo fondamentale elemento, intorno al quale fioriranno altre speculazioni di impronta positiva di cui le difese cosiddette sicilianiste saranno permeate, costruendo alternative concezioni del fenomeno mafioso in risposta al reato associativo e proponendo mezzi e strumenti sulle sue cure giuridiche. Compiamo un passo indietro. Si accennava poc’anzi ad una indagine condotta sull’influenza climatica allo sviluppo della 288 Ibidem. Ivi, p. 39. 290 Ibidem. 291 Ivi, p. 40. 289 145 degenerazione mafiosa isolana. Così, esamina Alongi, «la natura del suolo ha anch’essa il suo ruolo a predisporre alla criminalità. Il latifondo spopola la campagna e ne forma sicuro rifugio dei malandrini: le grassazioni, i ricatti, il brigantaggio trovarono sempre ambiente favorevole laddove mancano vie rotabili e ferrate»292. Altri elementi concorrenti sono riscontrati nelle stagioni e nella produzione agraria. Alongi, infatti fu ufficiale di pubblica sicurezza in diversi comuni del circondario di Palermo e poté così riscontrare come: «i furti predominino nella stagione invernale o di scarso raccolto, mentre i reati di sangue crescono nelle annate abbondanti o nei luoghi ove la produzione principale è il vino»293. Ancora più marcato fu Cesare Lombroso quando pubblicò il saggio “Sulle associazioni al mal fare – studi di antropologia – brigantaggio, camorra e mafia” – poi confluito nella sua opera “L’uomo delinquente”. In questo scritto, la mafia viene tratteggiata come antropologicamente affine alla camorra, ma da essa distinta per avere il fenomeno siciliano «una maggiore tenacità nel segreto e una più ampia estensione negli alti ceti sociali»294. La percezione del fenomeno da parte del medico veronese si spinge ben oltre i contorni disegnati dalla norma codicistica e chirurgicamente interpretati dall’avvocato difensore nei termini già visti, in quanto secondo Lombroso: La mafia esiste senza che se ne riconoscano dei veri capi gerarchici […] 292 Ivi, p. 38. Ivi, p. 39. 294 C. LOMBROSO, Sulle associazioni al mal fare, in «Riv. Pen.», anno 1875, p. 170. 293 146 ma ciò non toglie – almeno all’antropologo – l’idea dell’associazione. Ciò non mostra se non la sua diffusione in tutti i ceti, la sua condizione, direbbero i medici, endemica, per cui non ànno bisogno di questo stimolo speciale per formarsi e mantenersi e non vi ricorrono se non in grandi circostanze295 Non può mancare una analisi sociologica che, dall’osservatorio privilegiato del padre dell’antropologia forense, riconosca caratteri fisici e fattori sociali in grado di supportare la derivazione criminale del fenomeno: che nel fondo la camorra e la mafia non siano se non varianti di volgari malandrinaggi, si vede da ciò, che essi presentano, i caratteri propri dei comuni delinquenti; per esempio amano di andar ricchi d’anelli, di vestire un uniforme quasi loro propria e noi abbiamo veduto che questo è uno degli speciali caratteri dei ladri. Ed, al paro dei delinquenti, essi ànno un gergo loro particolare […] e ànno la sede principale nelle carceri, precisamente come quasi tutti i malfattori associati 296 Speculare è invece lo scritto apparso sulla stessa rivista “Archivio di Psichiatria” nel 1880 a firma stavolta di un magistrato. È Francesco Lestingi, Procuratore di Girgenti, una zona infestata dalla mafia della “Fratellanza”297. Questi, pur mantenendosi lungo le stesse posizioni positiviste, aveva sostenuto che la mafia solo in talune circostanze avesse assunto vere e proprie caratteristiche di associazione. Così fu per esempio la cosiddetta mafia dei colli, la quale ai proprietari imponeva giardinieri (coloni) per una determinata gabella (fitto), spesso 295 Ivi, p. 172. Ivi, p.174. 297 T. V. COLACINO, La Fratellanza, in «Rivista di discipline carcerarie», anno1885, p. 87. 296 147 da 10 a 20 volte inferiore al giusto, pena l’uccisione del colono che avesse accettato di coltivare il fondo contro il volere della mafia. Sicché il proprietario, per necessità, non trovando cui locarlo, doveva subire la violenza e parte di gabella risparmiata andava a beneficio di tutti i soci298 Il giudizio di Lestingi sulla mafia è che solo in talune condizioni la stessa si rivela sotto forma di associazione: «come la camorra, e da questa ne ricalca l’organismo e lo scopo, ma ciò è l’eccezione non la regola»299. Il Procuratore di Girgenti non ha però dubbi sulla cura cui sottoporre il fenomeno, una volta che la contaminazione tra la delinquenza e il mafioso si sia verificata. Si combatte con mezzi ordinari, come si farebbe nei confronti di ogni altro individuo sospetto, «coll’aggiunta solo che trovandosi in un paese di caratteri suscettivi, impetuosi, ardenti, come il sole sotto cui si alimentano, occorrerà raddoppiare l’antiveggenza nel prevenire, l’operosità e la scaltrezza nel sorvegliare, l’energia nel reprimere»300. È su questo humus che si innesta e si sviluppa il pensiero dell’avvocato Giuseppe Mario Puglia, discendente da una notabile famiglia di giuristi palermitani. Teorizzatore di una concezione del fenomeno della mafia che per decenni ha influenzato la comprensione sociale dello stesso. La massima espressione del pensiero dell’avvocato Puglia sul tema della mafia si rinviene in un saggio di cui egli è autore, mandato alle stampe dalla rivista “La Scuola Positiva – Rivista di 298 Ibidem. F. LESTINGI, La mafia in Sicilia, in «Archivio di Psichiatria», 1880, p. 293. 300 Ibidem. 299 148 diritto e procedura penale”. In un’epoca in cui la mafia poteva essere tutto o niente, la presa di posizione del giurista palermitano ebbe un impatto molto forte sui vari livelli della società italiana anche per il significato celato dietro il modo in cui l’avvocato Puglia scelse di affermare e diffondere il proprio pensiero, ovvero affidandosi alle pagine di una rivista di credo positivista. L’analisi del saggio mostra sin dalle sue prime battute, come l’esigenza di intervenire in materia sia sorta spontaneamente nell’avvocato Puglia, a voler ribadire ancora una volta il concetto guida del presente lavoro di tesi, sulla unitarietà e circolarità del meccanismo di difesa della mafia. La pubblicazione del difensore infatti giunge al di fuori delle aule giudiziarie, non appare neppure scaturire da una singola esperienza processuale in particolare, ma sembra piuttosto il frutto di un pensiero di più ampio respiro, multidisciplinare, poliedrico. Giuridicamente costituisce un persuasivo argomento retorico in chiave positivista sul tema della difesa della mafia. In apertura, Giuseppe Mario Puglia ha cura di comunicare subito al lettore la ratio sottostante al suo intervento, ovvero quella «di ricordare che cosa sia il mafioso, poiché qualche collegio giudiziario in Sicilia non ha esitato a confondere la mafia con l’associazione per delinquere»301. Sin dalle prime righe, l’avvocato Puglia, in maniera sottile ma efficace, apre una polemica contro la magistratura del suo tempo alla quale riconosce il dovere di partecipare all’opera 301 G. M. PUGLIA, Il mafioso non è un associato per delinquere in «La Scuola Positiva – Rivista di pen. e proc. Pen.», Anno X. Fasc. 10 – 11, p. 1. 149 epurativa nei confronti di soggetti che hanno compiuto reati e che devono essere giudicati e condannati secondo le leggi vigenti. Specularmente, egli suggerisce all’organo giudicante di arrestarsi e di «cedere il passo all’autorità politica quando si tratta di individui che non possono essere giudicati – perché non si potrebbe procedere contro di essi senza commettere ingiustizie – ma che per misura di igiene sociale occorrerebbe allontanare dalla società»302. Sotto l’influenza della fiorente dottrina positivista, l’elaborazione compiuta dall’avvocato Puglia conduce a negare radicalmente che «la mafia sia una riunione di persone legate da un fine criminoso», mentre viene individuata in «una morbosità psichica insita nel popolo siciliano»303. I diversi contesti sociali ed educativi nei quali gli individui hanno vissuto, hanno poi condotto la parte della popolazione isolana che ha avuto i mezzi per evolversi, a vincere questo sentimento e un’altra parte – disgraziata – rimasta spesso senza sue colpe allo stato grezzo, ad accentuarlo o modificarlo. Si sviluppò così una esasperata esaltazione dell’io, un concetto di onnipotenza sulla propria persona, unito a un generale senso di supremazia sugli altri. Per spiegare le ragioni storiche che condussero alla formazione di questo comune sentire, il Puglia si servì di una analogia e spiegò infatti, che come per lunghi secoli in Italia era mancato uno spirito d’italianità, a causa dello smembramento che aveva interessato la penisola, in cui ogni singolo “staterello” era in 302 303 Ibidem. Ivi, p. 2. 150 lotta fratricida con l’altro per affermare la propria esistenza, così, in scala di riduzione si era verificato in Sicilia. Nell’isola infatti la totale assenza di una organizzazione politica stabile aveva condotto all’affermazione del principio della mancanza di una personalità dello stato, per cui il cittadino non era nemmeno tale, non aveva coscienza di far parte di una organizzazione sociale e soprattutto era incosciente dei diritti e dei doveri propri dei cittadini. In una situazione di disordine simile, la comunità appariva pressoché primitiva, ben lontana dalla civiltà evoluta propria di altri stati. I governi stranieri che si succedettero infatti non ebbero alcun interesse ad instaurare nell’isola alcuna educazione politica, nessun senso dello stato, alcun concetto di supremazia statale, per cui ovunque si affermò una generale lotta per la sopravvivenza. L’assenza di un qualsivoglia intento di controllo e di intervento da parte dei governi contribuì poi a far perdere nel siciliano ogni forma di fiducia verso la legge e si affermò al contrario la valorizzazione dell’individuo. Da quel momento, nel vuoto statale, si ebbe la palingenesi della mafia. Un meccanismo psicologico dunque che aveva permesso al siciliano di resistere alle invasioni opponendo al dominatore straniero la convinzione della propria forza individuale. A suggellare la concezione di Giuseppe Mario Puglia mancava ancora un tassello che egli prese in prestito dalla cultura positivista, teorizzando come poi «nelle varie generazioni a seguito di inevitabili alterazioni dovute alle sorprese dell’ereditarietà e a connubi con altri sentimenti propri del siciliano, quel sentimento 151 originario aveva cambiato fisionomia»304 trasformandosi in qualcosa di diverso. Esso si colorò di connotati quali la prodezza, il fiero desiderio di prepotere, la baldanza, la generosità d’animo, senza abbandonare mai l’aspetto principale: il concetto di superiorità della propria forza individuale. L’accezione di uomo mafioso valse così a identificare colui che non aveva necessità di far ricorso all’aiuto di nessuno perché otteneva i propri diritti o asseriti tali da sé, senza servirsi di giudici, utilizzando solo il proprio criterio305. Fin qui, gli assi portanti dell’interpretazione e della spiegazione sociologica del fenomeno criminale di tipo mafioso emersi dall’esame delle fonti. Adesso, una volta ricostruito il sostrato del pensiero dell’avvocato Giuseppe Mario Puglia, appare opportuno analizzare l’edificazione dell’argomento giuridico in difesa della mafia che egli teorizzò snodato lungo due bisettrici. Da una parte, infatti, il ritratto del mafioso così come tratteggiato dal giurista risulta incompatibile con i canoni della fattispecie associativa dell’articolo 248 del codice penale italiano e questo perché il mafioso nell’atto stesso di associarsi ad altri quattro almeno, per commettere un delitto, squalificherebbe sé stesso e si troverebbe ad ammettere la propria incapacità individuale e a riconoscere la forza del gruppo, il che collima con l’essenza mafiosa appena descritta. Dall’altra parte, secondo il pensiero dell’avvocato Puglia, per 304 305 G. M. PUGLIA, Il mafioso non è un associato, cit. p. 6. Ibidem. 152 potersi parlare di associazione, così come la lettera normativa richiedeva, occorreva senz’altro che essa fosse stata retta da «una mente direttiva, chè se ciò mancasse, ogni membro agirebbe secondo il suo criterio e cesserebbe l’organizzazione delittuosa sociale»306. Una direzione implica a sua volta l’esistenza di uno o più capi, prefigura «una disciplina che leghi i singoli soci alla volontà del capo»307. Ebbene, la descrizione resa dall’avvocato porta ad escludere che il mafioso che era tale proprio per non riconoscere alcuno al di sopra del proprio io, potesse strutturalmente adattarsi all’obbedienza, subordinarsi a un capo e aderire a uno statuto. La difesa del giurista si addentra ancora sino a spiegare la natura di quel legame che la magistratura ha inteso erroneamente far corrispondere con il vincolo delle associazioni per delinquere e che invece, altro non sarebbe, se non una relazione di simpatia, nel suo significato bio-psicologico, ovvero quella naturale armonia che si stabilisce tra soggetti di analogo temperamento e natura. La stessa corrente attrattiva che lega per analogia di carattere, di professione, di fede, gli uomini onesti, parimenti connette soggetti delinquenti. Finché il sentimento rimane allo stadio puro non è inquadrabile come un patto associativo, quand’anche si instaurasse tra mafiosi. Il reato associativo può dirsi invece consumato solo quando entri in gioco una parziale alterazione dello stato etico – psichico del delinquente, che degenera il sentimento di simpatia tra i 306 307 G. M. PUGLIA, Il mafioso non è un associato, cit. p. 3. Ibidem. 153 consociati in un aliquid novi, che è il vincolo associativo, l’intenzione al misfare. La teorica elaborata da Puglia si spinge sino a temi di carattere procedurale, sul trattamento processuale e sulla gestione amministrativa di soggetti mafiosi. Il giurista sembra quasi neutralizzare la questione sociale della mafia, finisce con l’ingabbiarla nelle maglie del determinismo biologico per riscriverne la trattazione in termini positivisti. Nel fare questo, Giuseppe Mario Puglia si ricollega all’idea già tematizzata dalla scuola positiva, formulando una concezione di pena sganciata dal modello retributivo, consapevole che la volontà del soggetto mafioso non può dirsi libera, ma anzi è chiusa, è costretta dai lacci biologici e sociali308. Lo stesso motivo si rinviene quando il giurista consiglia di spostare il piano della questione sul tavolo politico per ivi ricercare modelli in grado di agire sulla pericolosità sociale e ancora quando, nel suggerire un rimedio atto a estirpare il soggetto malato dalla società, fa appello alla misura di polizia del confino. In conclusione, la polemica sostenuta da Giuseppe Mario Puglia lascia dei margini interpretativi che evocano la cura giuridica del particolare, del diverso, dell’eccezionale e che pongono le basi per un problema ancora più grande, destinato a riproporsi con diversi esiti nell’ormai prossimo avvento dell’epoca fascista, ovverosia: la trattazione del tema della mafia all’ombra della relazione tra emergenza e garantismo. Tutti i processi esaminati e ciascuna difesa analizzata hanno portato all’emersione di un fil rouge che sembra legare a doppio 308 Ivi, p. 7. 154 nodo le vicende dei soggetti accusati di essere affiliati alla mafia con la difesa strenua dei dogmi dell’ideologia liberale. 3.8. Tra Codice Penale e Codice della Mafia: una difesa sicilianista Dall’analisi del materiale d’archivio consultato è emersa una categoria difensiva che pare correre tra le pagine del codice penale per infilarsi in quelle di un non scritto ma noto codice della mafia. Si tratta di linee patrocinate normalmente da avvocati afferenti alla corrente politica regionista, disvelatrici di una cultura giuridica a vocazione enciclopedica, che in apparenza parla il dialetto siciliano, ma che pretende di essere capita universalmente e che immersa nel sistema di contraddizioni apparenti manovrate dagli avvocati, invoca rispetto e attenzione. È una retorica che tra folklore, esasperazione e insularismo si ostina ora a difendere, ora a negare la mafia, ma nel farlo offre così tanti dettagli e peculiarità che finisce invece col descriverla. Muoviamo l’indagine dall’avvocato Andrea Marinuzzi, il quale in quel tempo si trovava a Catanzaro, dove si stava svolgendo il secondo grado del processo di appello contro la setta degli Stuppagghieri di Monreale. In primo grado, il processo si era celebrato a Palermo e si era concluso con una sentenza che aveva riconosciuto la giuridica esistenza della associazione di malfattori nei confronti della cosca guidata da Salvatore Marino. Poi, il processo di secondo grado dovette svolgersi fuori dalla Sicilia, in Calabria perché fu dichiarato un caso di legittima suspicione. Qui, il verdetto della giuria fu di segno opposto e tutti gli 155 imputati vennero assolti. L’avvocato Marinuzzi affidò le sue parole ad un telegramma che venne trasmesso a Palermo e pubblicato sul giornale L’Amico del Popolo, nel quale la vittoria forense ottenuta fuori casa veniva celebrata in questi toni: «odierno avvenimento altra severa meritata lezione a chi, figlio o ospite nostra cara Sicilia impunemente la deprime e sconosce»309. Non meno tenue nei toni era stato lo stesso Marinuzzi nel corso dello svolgimento del processo d’appello, quando aveva tuonato alla Corte come le accuse volte a dimostrare la fondatezza della associazione criminosa non fossero altro che «una parte del disegno della destra volto ad accreditare la legge straordinaria di Pubblica Sicurezza»310. Ancora una volta il ricorso è a registri politici, traspare una difesa d’ufficio della Sicilia e anche della mafia. È ancora l’appassionato Marinuzzi, stavolta al processo Amoroso, a provocare un incidente con il presidente della Corte. L’episodio riportato dai resoconti stenografici, infatti, narra come nel corso di una udienza, Giuseppe Amoroso, zio degli imputati, rivelò fatti che accusavano costoro dell’assassinio di suo figlio (loro cugino). Uno degli imputati, Emanuele Amoroso lo sfidò quindi a giurare sull’anima del padre, il quale rappresentava l’ascendente comune della vittima e dei sospetti assassini. Il presidente osservò: «qui non vi è che un solo giuramento, quello previsto dalla legge». Ma proprio l’avvocato Marinuzzi, difensore di Emanuele Amoroso, aprì una polemica al fine di ottenere che il teste giurasse come indicato dalla difesa, spiegando 309 310 L’amico del popolo, 4 marzo 1880, Palermo. ASP, GP, ANNO 1880, BUSTA 7. 156 al presidente che «quel tipo di giuramento non va per il caso, perché il volgo non vi crede»311. Il sociologo e criminologo tedesco Henner Hess, studioso del fenomeno mafioso, interpretò quel gesto come un segno inequivocabile della distanza socio – culturale che separava lo Stato dai siciliani, una lacuna tra «socialità e morale statale che produce l’atteggiamento mafioso»312. Più verosimilmente, aderendo alla tesi di Salvatore Lupo 313 si trattò di una abile mossa di Marinuzzi, volta a costruire davanti agli occhi dei giurati, l’immagine dei propri difesi come di soggetti ingiustamente accusati, che si riconoscono negli stessi valori familistici della gente comune e che quindi non possono avere trucidato un loro stretto congiunto, così come l’accusa vorrebbe far credere. Lo stesso schema della rilettura in chiave sicilianista degli eventi permane anche nei processi celebrati in vigenza del codice Zanardelli, in cui gli avvocati Bartolomeo D’Ondes Reggio e Lorenzo Maggio ebbero cura di esaltare la “specialità” siciliana che tale è divenuta «in virtù delle misure eccezionali cui è stata sottoposta»314. La difesa è ancora una volta condotta aderendo a registri di matrice positivista, in cui l’esistenza della mafia viene paradossalmente ammessa, ma come fenomeno etico deplorevole, la cui cura, che viene definita dagli avvocati “moralizzazione”, non può e non deve passare attraverso un verdetto di condanna. 311 Arringa Marinuzzi, in Processo Amoroso, p. 203. H. HESS, Mafia Zentrale Herrschaft und lokale Gegenmacht, Tübingen, 1970, p. 44. 313 S. LUPO, Storia della mafia, cit. pp. 167-168. 314 Arringa V. D’Ondes Reggio, Processo ai quattro scomparsi, p. 6. 312 157 In particolare, il D’Ondes Reggio rimette la soluzione alle autorità politiche, affinché approvino leggi giuste a partire dalle quali «muova quel processo di rinnovamento che la Sicilia tanto si auspica». Il Maggio, nel corso della stessa udienza spiegò come l’atteggiamento omertoso che la pubblica accusa intese essere un coefficiente mafioso, non era altro che una condizione divenuta naturale nella cultura siciliana, recentemente maltrattata dall’inasprimento delle misure di polizia attuate nell’isola con la legge n. 2580/1875. «In Sicilia di rado si ricorre alla autorità giudiziaria, di cui non a torto si diffida, per salvaguardare i propri diritti»315 è la massima con cui Lorenzo Maggio sintetizza il risultato di un’annosa politica di repressione realizzata con ammonizioni, assegnazioni a domicilio coatto e provvedimenti sommari considerati intollerabili. L’analisi della sua arringa difensiva lascia intravedere una nozione di mafia percepita come entità patologica, quasi come un veleno proprio di cui la stessa Sicilia possiede anche l’antidoto, che potrà inocularsi a patto che «i funzionari di polizia procederanno con oculatezza e correzione e i magistrati della giustizia renderanno sentenze equanime ed imparziali»316. Non sembra poi esservi accordo tra accusa e difesa nemmeno sulla semantica delle parole. In tema di associazioni affiliate alla mafia, il rilievo sul gergo utilizzato è un tema non suscettibile di rimanere in ombra. Così, l’uso di un certo termine diventa causa di 315 316 Arringa Maggio, in Processo Pugliese, p. 198. Ibidem. 158 un incidente processuale. Era in corso in una delle prime udienze del processo Amoroso l’interrogatorio di uno degli imputati, il quale nel descrivere l’ufficiale di pubblica sicurezza che lo aveva tratto in arresto, disse che egli era a cavallo, «colla statìa a lato»317. Mentre il presidente pregava i giurati di prestare attenzione alla “tecnicità” di questi vocaboli, il pubblico ministero spiegava che «Statìa sta per sciabola ed è parola di maffia»318. Subito pronto l’intervento dell’avvocato Gargano a correggere il tiro, osservando che «è semplicemente dialetto siciliano»319. Nella stessa logica si ascrive nel processo Pugliese, la linea difensiva dell’avvocato Gaetano Sangiorgi quando si tratta di spiegare alla Corte il significato dell’espressione verbale proferita in sede di interrogatorio dal suo assistito, un tale Valenza al quale era stato chiesto «se avesse giammai conosciuto il Don Peppino, capitano di una masnada che portava dovunque la rapina e lo incendio»320. Il presunto associato rispose: «non lo conosco»321. Il difensore è così investito dell’ulteriore onere di chiarire il senso della portata della dichiarazione resa in aula. L’uso di quel gergo non è infatti da intendersi letteralmente, qui non si traduce nel senso di non averlo mai visto, ma nella accezione di non avere alcuna relazione con lui, «di non avere mai avuto rapporti con lui»322. In un diverso momento dello stesso processo Pugliese si è fatto appello a registri di impronta etnologica, come quando l’avvocato Schirò negò la possibilità che si fosse in presenza di una 317 Processo Amoroso, p. 73. Ivi, p. 74. 319 Ibidem. 320 Processo Pugliese, p. 35. 321 Ivi, p. 36. 322 Ibidem. 318 159 associazione di malfattori sulla base del presupposto che qui in Sicilia, mancando in generale lo spirito di associazione, una associazione vera di malfattori non si è potuta costituire giammai. La disfiducia degli uni con gli altri, come manca nelle più utili imprese, così fortunatamente manca nei fatti delittuosi, che sono la vera piaga della società323 Altrove invece si è addirittura fatto ricorso a un campo attinente le qualità genealogiche di uno degli imputati, definito in sentenza istruttoria maffioso324. L’avvocato Messineo per impressionare la giuria sulla estraneità del proprio assistito alla banda Amoroso, dimostrò infatti che l’imputato, un tale Salvatore Di Paola, avesse un fratello prestante servizio in una delegazione della Pubblica Sicurezza, osservando come: «la maffia, signori, se sente solo da lontano l’odore della polizia non fa amicizia e poteva il Di Paola essere associato a maffiosi, a malfattori, essendo fratello di uno della P. S.?»325. Non meno densa di significato appare la considerazione dell’avvocato Leopoldo Caputo quando nel voler togliere credibilità alla propalazione resa dall’unico teste, un tale Gambino, sulle cui rivelazioni fu istruito il processo Amoroso, precisò alla Corte l’illogicità che Leonardo Amoroso, presunto associato, avesse riferito al Gambino simili circostanze, in quanto «ripugna con l’indole della maffia attribuita agli Amoroso, questa smania di rivelare al primo venuto»326. L’assioma di Caputo non deve sembrare privo di fondamento 323 Arringa Schirò, in Processo Pugliese, p. 160. Arringa Messineo, in Processo Amoroso, p. 227. 325 Ibidem. 326 Arringa Caputo, in Processo Amoroso, p. 233. 324 160 o frutto di un maldestro tentativo di salvare il proprio difeso ricorrendo a riflessioni evanescenti o aeriformi. Ciò perché è sufficiente scorgere le dichiarazioni rese proprio dai capi – banda al processo per riscontrare la tangibilità di un codice non scritto della mafia. Così spiegava Angelo Pugliesi327: «premetto coll’osservare che nel codice della mafia siciliana vi ha un articolo che punisce di morte il malandrino che rivela a chicchessia i misfatti da esso con altri commessi»328. Infine, la più celebre forse, difesa d’ufficio della mafia fu quella tuonata dal «presidente della vittoria»329 Vittorio Emanuele Orlando, il 28 giugno 1925 al Teatro Massimo di Palermo, nel comizio elettorale per la “Unione Palermitana per la libertà” di cui era capolista e che competeva con le formazioni fasciste capeggiate da Alfredo Cucco. In quei frangenti in cui era in piena attuazione la campagna di repressione della mafia guidata dal prefetto Cesare Mori, Orlando così si rivolse alla platea: Or vi dico, Signori, che se per mafia si intende il senso dell’onore portato fino all’esagerazione, l’insofferenza contro ogni prepotenza e sopraffazione, portata sino al parossismo, la generosità che fronteggia il forte ma indulge al debole, la fedeltà alle amicizie, più forte di tutto, anche della morte. Se per mafia si intendono questi sentimenti, e questi atteggiamenti, sia pure con i loro eccessi, allora in tal senso si tratta di contrassegni individuali dell’anima siciliana, e mafioso mi dichiaro io e sono fiero di esserlo!330 327 Processo Pugliese, Interrogatorio, p. 50. Processo Pugliese, p. 131. 329 P. PEZZINO, Alle origini del potere mafioso: Stato e società in Sicilia nella seconda metà dell’Ottocento, «Passato e Presente», n. 8, 1985 cit. p. 38. 330 G. C. MARINO, Partiti e lotta di classe in Sicilia da Orlando a Mussolini, Bari 1976, p. 22. 328 161 3.9. Le difese alla prova del giurì. Sentenze di assoluzione tra arte oratoria e intimidazioni ai giurati I resoconti stenografici e le pubblicazioni avvenute sui giornali quotidiani di Palermo hanno infine restituito gli esiti dei travagliati e difficili dibattimenti che si sono celebrati in aula di Assise. Al termine della requisitoria del pubblico ministero, in esito alle arringhe difensive, dopo aver discusso la parte civile, la Corte ritirata in camera di consiglio decideva il verdetto finale e la sua lettura concludeva il processo. L’esame delle sentenze involgenti i procedimenti esaminati appare utile al fine di comprendere gli esiti delle difese degli avvocati che sono state analizzate e il ruolo in essi giocato da elementi esterni. Il primo processo analizzato, quello contro la banda di Angelo Pugliese, dopo oltre quattro mesi di udienze fu largamente assolutorio per venti imputati su trentasei331. Tra i sedici condannati figurò un solo proprietario, Petta, arrestato in flagranza, mentre il suo socio Anzalone venne assolto insieme a Valenza, a D’Angelo e ad altri campieri come Runfola332. Durissimo fu il commento del procuratore generale Giuseppe Borsani mentre relazionava al Ministro: «È uno scandalo aggiunto ai molti che dimostrano non essere in Sicilia soggetti alla legge penale gli uomini che hanno denaro»333. La teoria del procuratore circa il fallimento del processo 331 Processo Pugliese – Sentenza in ASP, fondo Sentenze C. Assise Ord. Vol. 2349 anno 1868. MANGIAMELI, Banditi e mafiosi, cit. p.104. 333 ACS, GG, b.14, f. 121 – Il procuratore gen. Borsani al Ministro, 31 maggio 1868. 332 162 affondava sulla asserita irregolare gestione dello stesso – come osservato da Rosario Mangiameli334 – che si era trascinato per un tempo lunghissimo, con sedute brevi, rinvii ingiustificati che avevano letteralmente annacquato «lo straordinario entusiasmo che si era sollevato nel pubblico al suo cominciamento e allora si è potuto consumare un grande atto di ingiustizia335». La perdita di interesse, secondo Borsani, era stata realizzata secondo un principio originale, che non aveva tenuto conto della cronologia e della logica nello svolgimento dei fatti, ma solo dell’ordine alfabetico degli imputati. Una enorme confusione tesa proprio a «rompere e disgiungere la naturale concatenazione delle prove», accentuata anche dalla altrettanto disordinata audizione di 191 testimoni distribuiti in maniera da far parlare per ultimi quelli della difesa e a grande distanza di tempo quellli dell’accusa, mentre i «giurati assistevano dormendo un placido sonno»336. Un capitolo a parte è poi dedicato dal procuratore al tema della corruzione: «Il danaro ha soffocato ancora una volta la giustizia: d’un famoso processo non rimane or più che la memoria di pochi cenciosi mandati a espiare nelle galere la colpa comune ai ricchi impuniti!»337. Appena due giorni dopo, lo stesso Borsani scrisse una nuova nota al Ministro, nella quale comunicava l’intenzione di riaprire il procedimento perchè riteneva ora di «avere ottenuto prova dei turpi mercati proposti ai giurati»338 e affermò che «il prezzo di ogni assoluzione si era aggirato sulle duecento onze»339. 334 MANGIAMELI, Banditi e mafiosi, cit. p. 104. ACS, GG, b.14, f. 121 – Il procuratore gen. Borsani, cit. 336 Ivi. 337 Ibidem. 338 ACS,GG, cit. Nota del proc. Gen al min. Del 2 giugno 1868. 339 Ibidem. 335 163 L’estate di quello stesso anno il procuratore Borsani fu trasferito ad altra sede. La questione delle giurie popolari e delle leggi speciali tendenti a sospenderle era un tema spinosissimo sul quale il magistrato aveva preso posizione anche in altre occasioni, tra cui il discorso inaugurale dell’anno giudiziario dello stesso 1868: Mentre la mano del sicario uccide il testimonio nella popolosa Palermo, la lurida figura del mafioso si aggira attorno al giudice de fatto, e lo circuisce e tenta e minaccia! Maledetto vituperio della civiltà e dell’umanità! Ma il più è vero che non è bastemente sentita la degnità dell’istituzione [...]. Qui può dirsi davvero che la legge fa violenza al cittadinoo e, lui, riluttante, costringe a tutelare la sua libertà340. Come osservato da Rosario Mangiameli, le convinzioni di Borsani non trovavano molti consensi tra la magistratura palermitana del tempo, propensa invece a conservare i diritti delle giurie popolari341. Per citare ancora il caso in esame, tra coloro che si felicitarono per il lavoro svolto con il presidente della Corte Achille La Manna – ovvero il primo responsabile delle irregolarità dichiarate da Borsani – vi fu il collega Giuseppe Di Menza, vale a dire il magistrato che da lì a poco avrebbe presieduto importantissimi processi, tra cui, quello contro la setta degli Stuppagghieri di Monreale, scrivendone la storia. Con riferimento adesso proprio al processo celebrato contro la banda degli Stuppagghieri di Monreale, il cui dibattimento in 340 G. BORSANI, Discorso inaugurale letto alla Corte d’Appello di Palermo il 3 gennaio 1868, Palermo 1868, p. 8. 341 MANGIAMELI, Banditi e mafiosi, cit. p. 105. 164 primo grado, davanti la Corte di Assise di Palermo, durò dal 25 aprile all’8 maggio 1878, i giurati in questo caso affermarono l’esistenza dell’associazione. Dei diciotto accusati, sei furono assolti, dodici condannati come gregari dell’associazione alla reclusione, due, Salvatore Strano e Vincenzo Sinatra furono condannati all’ergastolo, perchè autori dei due omicidi di Stefano Di Mitri e di Salvatore Caputo. Il corriere giudiziario, pubblicato in appendice al Giornale di Sicilia, mentre i giurati si trovavano ancora chiusi in camera di consiglio, riportò i commenti che la attenta e solerte opinione pubblica (che non aveva perso un solo giorno di udienza) aveva iniziato a far circolare: Che cosa faranno i giurati? Dopo quello che hanno udito e visto vorranno essi davvero condannare 18 persone di Monreale accusati nulla meno che come capi e gregarii di una società segreta di sanguinarj? Ma non è un mettere alla più dura delle pruove il coraggio civile e la pazienza di codesti poveri cittadini che vengono sì lungi, e che hanno a tornare sulla schiena di un mulo alle loro contrade natie? Non sarebbe stato questo il caso di un rimando ad altre Assise? A quelle di Milano, di Ancona o di Perugia per esempio? O la società segreta non è provata e i giurati debbono assolvere per manco di prove; o è provata davvero e allora debbono assolvere per paura di vedersi un sicario alle calcagna!342 La sentenza a quanto pare spiazzò tutti, la società degli Stuppagghieri era esistita davvero e per dirla ancora con le parole del Giornale di Sicilia: 342 L. ZINNA, Cronache di mafia di fine ’800, Tip. Giornale di Sicilia, Palermo, 1878. 165 non era un Comitato d’Internazionali dipendente dagli ordini di Carlo Marx, siccome qualche agente di polizia volle supporre; non era un Circolo Repubblicano come a nonno Giuseppe Cavallaro si fe’ credere: era una società segreta di malfattori che dalle vecchie società avea preso il giuramento di sangue, aggiungendovi le sacre immagini, il fuoco e le ceneri per ultima solennità; avea preso dai tribunali Wehmici la pronta e misteriosa esecuzione dei suoi atti, e dai Beati Paoli i sicari e le vendette di sangue343. La sentenza di primo grado fu oggetto di ricorso presso la Corte di Cassazione di Palermo che, per un vizio relativo alla composizione della giuria, annullò e rinviò all’Assise di Termini Imerese. Il 23 agosto del 1879 il procuratore generale Mirabelli presentò istanza perchè per motivi di sicurezza e di legittima suspicione la causa fosse rimessa ad altra Corte del continente. L’istanza fu accolta e il processo fu spostato presso la corte di appello di Catanzaro. Nelle motivazioni della Corte di Cassazione rispetto all’istanza di di rimessione ad altra sede, si fa riferimento a scelte dovute a le difficoltà incontrate nel primo dibattimento contro gli accusati e le maggiori rivelatesi nel giudizio di rinvio presso le Assise di Termini Imerese, le influenze sinistre ivi spiegate e gli intimidamenti e le seduzioni dei giurati e testimoni, più volte e con vari mezzi tentate344. A Catanzaro la condanna fu azzerata e gli imputati assolti. Anche in questa sede il processo presentò delle anomalie certamente ascrivibili a fattori esterni alla difesa tecnica. 343 344 Ivi, p. 125. CRISANTINO, Della segreta e operosa, cit. p. 250. 166 A riferirle è il delegato di Polizia, Pio Cicognani, inviato dal questore di Palermo a seguire il dibattimento. La causa durò dal 17 febbraio al 4 marzo 1880. Il delegato di Polizia notò subito come tutti i 12 giurati fossero di Catanzaro, che gli avvocati avevano molte relazioni di parentela ed amicizia in una città che appariva indifferente al processo. Il capo dei giurati era un avvocato che nel corso della escussione dei testimoni faceva domande tramite il presidente della Corte, come se lavorasse per la difesa. Le udienze qui erano scarsamente affollate a differenza che nel processo di primo grado a Palermo. Tutti attenuarono le proprie deposizioni scritte. Lo stesso presidente della Corte in una pausa tra una udienza e l’altra aveva riferito al Cicognani come fosse un processo tutto indiziario e come tale destinato a finire. Il giornale locale non si occupava del processo345. Nelle ultime relazioni al Questore, Cicognani si mostrava demoralizzato: «I giurati di Catanzaro non conoscono l’indole dei Siciliani e specialmente quella dei cittadini di Monreale, le loro abitudini, il loro carattere»346. Il verdetto uscì e, come preannunciato, fu ampiamente favorevole per la difesa. Laconico e sbrigativo il commento del questore: «avvalendosi di tutte le amicizie gli avvocati hanno ottenuto un verdetto favorevole, così da poter percepire dalle parti un doppio emolumento, e poi, il capo dei giurati era un avvocato»347. L’avvocato Simone Cuccia, dal canto suo, si preoccupò di inviare un telegramma al giornale palermitano “L’amico del 345 ASP, GQ, anno 1880, B. 7. Ibidem. 347 Ibidem. 346 167 popolo” che uscì il 5 marzo 1880 con questo articolo: L’avvocato Cuccia ci ha comunicato un telegramma ricevuto oggi da Catanzaro, che annunzia di avere, oggi stesso, quella Corte d’Assise dietro il verdetto negativo dei giurati, dichiarati assolti tutti i giudicabili dall’accusa di associazione di malfattori. Pare ormai assicurato che tutte le cause distratte dalle Corti di Assise di Sicilia e rimesse altrove per motivi più o meno fondati di pubblica sicurezza debbano avere un esito sfavorevole per l’accusa348. A favore della abolizione della giuria popolare e proprio riprendendo le fila del processo farsa contro gli Stuppagghieri di Monreale, si schierò apertamente il delegato di polizia Antonino Cutrera quando dal suo volume tuonò: quante assoluzioni scandalose ci ha dato questa istituzione, quanti vergognosi mercanteggiamenti, quanti insulti alla giustizia ed alla libertà di un popolo civile, verrebbero risparmiati se la bilancia della dea Temi invece che ai giurati scelti dalla cieca sorte, irresponsabili e spesso incoscienti, fosse affidata a giudici togati, i quali, ad una lunga educazione giuridica, uniscono un nome ed una reputazione da salvaguardare, una condizione sociale da custodire. [...] La giuria è una istituzione che ha dato ormai prove troppo eloquenti non della sua inutilità, ma del danno che può cagionare e ha cagionato all’amministrazione della giustizia. Ne è esempio il processo agli Stoppagglieri [...], onde un consesso di pizzicagnoli, barbieri e fittaiuoli può essere chiamato a decidere fra due perizie in cause di veneficio e di falsità349. Il 17 ottobre 1883, dopo più di cinquanta giorni di 348 349 L’amico del popolo, 5 marzo 1880 – Telefax Simone Cuccia. CUTRERA, La mafia e i mafiosi, cit. pp. 143-144. 168 dibattimento, si concluse il processo contro la cosca dei fratelli Amoroso & Compagni. Esaurite le consuete formalità, il presidente fece la relazione finale del processo e diede lettura di una serie di avvertimenti ai giurati. Ricordò così all’uditorio come in precedenza, nel 1874, gli Amoroso erano già stati processati per associazione di malfattori ma: «il timore che incutevano essi era tanto che i testimoni non parlarono e si dovette chiudere la processura con sentenza di non farsi luogo»350. Il nuovo processo invece fu imbastito con nuove prove, tra cui le famose lettere tra Rosario La Mantia e Salvatore Marino (affiliato questi alla famiglia degli Stuppagghieri) e questa volta era stato possibile riannodare quelle dichiarazioni con asserzioni di testi escussi in aula. Il presidente ebbe cura poi di specificare come almeno dalla ricostruzione dell’accusa: «in ogni reato non manca il nome degli Amoroso, i quali non si chiamavano Stoppaglieri, non si chiamavano Fratuzzi351, ma si chiamavano Amoroso»352. Una volta fatti uscire i detenuti dall’aula, il presidente lesse l’avvertimento ai giurati La legge non chiede conto ai giurati dei mezzi pei quali si sono convinti. Essa non prescrive loro alcuna regola dalla quale debbono far dipendere la piena e sufficiente prova. Essa prescrive loro d’interrogare se stressi nella sincerità della loro coscienza quale impressione abbiano fatto sulla loro ragione e le prove riportate contro gli accusati e i mezzi della loro difesa. Essa propone loro questa sola domanda che racchiude tutta la misura 350 Processo Amoroso, p. 264. Discorso del presidente. Cosca del territorio di Bagheria. 352 Ibidem. 351 169 dei loro doveri: avete voi l’intima convinzxione della reità od innocenza dell’accusato? I giurati mancano al loro principale dovere se nel dormare la loro dichiarazione considerano le conseguenze che la medesima potrà avere per l’accusato353. L’esistenza della banda dei fratelli Amoroso & Compagni venne accertata e le condanne disposte furono per nove affiliati alla pena di morte, per due ai lavori forzati a vita, per quattro ai lavori forzati per ventidue anni, per uno a venti anni, per uno a cinque, per un altro a tre e per due a tre anni di carcere. Alle parti civili costituite fu liquidata una provvisionale pari a £. 6000354. Le condanne a morte tuttavia non furono mai eseguite e la sentenza non risulta essere stata appellata. Ultimo in ordine cronologico dei procedimenti trattati è quello noto come “Processo per i 4 scomparsi di Palermo”355. Appare utile alla trattazione una brevissima contestualizzazione. L’istruttoria fu curata dal questore Ermanno Sangiorgi, le indagini partirono da una azienda di agrumi sita nel fondo Laganà – dove in una grotta erano stati scoperti quattro cadaveri in decomposizione – e passarono successivamente a due influenti famiglie palermitane, i Florio e i Whitaker. Sangiorgi scoprì che i cadaveri occultati nella grotta del Fondo Laganà appartenevano a dei picciotti che Francesco Noto, capo della cosca mafiosa dell’Olivuzza, aveva fatto inserire presso la famiglia Florio come cocchieri, e che successivamente aveva ucciso per vendicarsi di uno sgarbo da loro commesso; lo stesso Noto lavorava nella tenuta dei 353 Ivi, p. 267. Ibidem. 355 L’Ora, Corriere politico quotidiano della Sicilia, 3-4 maggio 1901. 354 170 Florio in qualità di giardiniere, mentre il fratello Pietro, vice capo della cosca svolgeva il ruolo di guardiano. La potente famiglia Florio si guardò bene dal collaborare con la questura, che così iniziò a cercare testimoni disposti ad aiutare le indagini. L’occasione si presentò nell’ottobre 1899, quando un uomo già noto alle forze dell’ordine, Francesco Siino, sfuggì miracolosamente ad un agguato. Egli era il capo della cosca di Malaspina ed era considerato da Sangiorgi il «capo regionale o supremo» della mafia356. Dalle sue deposizioni il questore diede vita a un dossier di 485 pagine manoscritte nelle quali svelava organigramma, scopi, metodi di agire, riti di iniziazione, rapporti con la classe notabile della città, stanziamenti sul territorio della Conca d’Oro di Palermo: noto come rapporto Sangiorgi, fu la prima mappa storica ufficiale del meccanismo della mafia siciliana. Sulla scorta di tali informazioni, la notte tra il 27 e il 28 aprile 1900 la questura procedette a una retata di arresti di soggetti legati alla mafia locale357. Il processo ebbe inizio il 3 maggio 1901358 ma proprio nel corso del dibattimento il testimone chiave Siino ritrattò tutte le dichiarazioni e anche gli altri testi si prodigarono in attestati di stima degli imputati, che vennero descritti come «veri gentiluomini». La sentenza359 riconobbe soltanto 32 imputati colpevoli di aver dato vita a un’associazione criminale e, tenuto conto del tempo già trascorso in carcere, molti furono rilasciati il 356 LUPO, Storia della mafia, cit. pp. 136-137. Ivi, pp. 145-146. 358 L’Ora, Corriere politico quotidiano della Sicilia, 3-4 maggio 1901, cit. 359 L’Ora, Corriere politico quotidiano della Sicilia, 1-2 giugno 1901, cit. 357 171 giorno dopo360. Il commento laconico del questore Sangiorgi fu: «non poteva essere diversamente, se quelli che li denunziavano la sera, andavano a difenderli la mattina»361. Quello del prefetto di Palermo, Francesco De Seta: «la mafia [...] è stata ridotta all’inazione»362. Con buona fortuna degli avvocati difensori, per usare le parole di Salvatore Lupo: «in assenza di un pentito disposto a testimoniare in giudizio, la realtà associativa della mafia rimane impossibile da dimostrare»363. 360 LUPO, Storia della mafia, cit. pag. 142; J. DICKIE, Cosa Nostra, Laterza, 2005, pag. 95. U. SANTINO, Dalla Mafia alle Mafie, Rubettino, Roma-Bari, 2006, pag. 153. 361 Corriere della Sera, 30-31 ottobre 1901. 362 Relazione del prefetto De Seta del 24 ottobre 1900 in ACS, PS, AAGGRR 1879-1903, B. 1. 363 LUPO, Storia della mafia, cit. p.138. 172 Capitolo IV La Toga per le vittime della mafia: gli avvocati di Parte Civile 4.1. La funzione civile dell’avvocato penalista In materia penale, l’obbligatorietà della difesa tecnica ad opera di un avvocato rappresenta una garanzia codicistica e, insieme, una questione deontologica. In prima battuta essa è una necessità processuale, al cui mancato rispetto è subordinata la nullità assoluta del procedimento stesso. Tale principio trova estrinsecazione normativa all’art. 275 del codice di procedura penale sardo che con L. 2 aprile 1865 era stato esteso all’intero territorio nazionale e che era entrato in vigore il 1° gennaio 1866364, con qualche modifica relativa, fra l’altro, alle attribuzioni della camera di consiglio e all’obbligo di immediata pronuncia della sentenza, dopo il dibattimento. Le prescrizioni codicistiche regolamentanti la disciplina dei difensori era contenuta nel capo I del libro II del codice di procedura citato, agli artt. 275–280 ove era previsto che: «nelle cause per crimini o per delitti, l’accusato o imputato comparendo all’udienza deve essere assistito da un difensore sotto pena di nullità. Davanti alle corti il difensore deve essere un avvocato365». Il tema della necessarietà della presenza di un avvocato in sede penale si rinviene prima ancora che nella codificazione 364 Codice di Procedura Penale colla relazione del Ministro Guardasigilli fatta a S.M. in udienza del 26 novembre 1865, Torino, Cerutti e Derossi, 1866. 365 Ivi. 173 processualpenalistica, in quel complesso di regole di etica e di deontologia forense, cui l’avvocato naturalmente è chiamato da sempre a rispondere. Ne viene fatto un primo accenno, limitatamente ai Procuratori, con la legge n. 1938 del 1874, istitutiva degli ordini professionali all’art. 47 per il quale: “I Procuratori non possono senza giusta causa rifiutare il proprio ministero”. Come osservato da Guido Alpa366, la sistematizzazione di tali precetti appartiene agli anni trenta perchè sino al tardo Ottocento il rispetto dei principi di etica nell’adempimento della professione era convinzione così diffusa e consolidata dall’essere considerata ovvia, tanto dal non necessitare una disciplina scritta. In quel tempo la deontologia forense era appannaggio più che degli Ordini, della naturale auto regolamentazione della classe avvocatizia, riposava più che nei precetti positivi, nei “galatei dell’avvocato”367, raccolte di regole di etica, buon senso e buon gusto cui il giurista avrebbe dovuto uniformarsi dentro e fuori dalle aule dei tribunali. Per copiosa letteratura368 sul tema, è certo che la difesa tecnica dovesse informarsi a principi di integrità, disinteresse personale verso la causa e di verità per il fine della giustizia. Seppure ciò fu sempre accettato e condiviso, per un altro verso vivace fu il dibattito intorno alla questione se l’accettazione del mandato difensivo potesse conoscere dei limiti. 366 G. ALPA, L’avvocato, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 13. V. MORENO, Il galateo degli avvocati, Napoli, La Toga, 1938; C. CALDARA E. CAVAGNARI, Avvocati e Procuratori, Il Mulino, Bologna, 2004; G. ALPA G. DANOVI, Un progetto di ricerca sulla storia dell’avvocatura, Il Mulino, Bologna, 2003. 368 A. PADOA SCHIOPPA, Avvocati e Avvocatura dell’Ottocento, Bologna, 2009; G. B. DE LUCA, Lo stile legale, cit. 367 174 Una interpretazione rigorosa farebbe propendere per una risposta in senso negativo, tuttavia, scriveva il napoletano Emanuele Altavilla: «l’avvocato può esimersi dal partrocinare cause ripugnanti, purchè non sia stato nominato d’ufficio difensore»369. La nomina ad avvocato d’ufficio esulando dal conferimento del mandato difensivo ad opera del cliente, usciva quindi dai canoni etici ed entrava in quelli giuridici di prescrizione codicistica previsti dall’ultima alinea dell’articolo 275 a termini del quale: «ove egli non lo abbia scelto il presidente o il pretore glielo nominerà370». Del resto, il mandato difensivo viene tradizionalmente dipinto come un ministero sacro371, Zanardelli scriveva: «perchè anche il patrocinio d’una causa cattiva è legittimo ed obbligatorio, perchè l’umanità lo ordina, la pietà lo esige, la consuetudine lo comporta, la legge lo impone»372. In effetti, il carattere della obbligatorietà della difesa tecnica nei processi penali ha contribuito a imprimere un tratto permanente alla professione di avvocato, ne ha disvelato una attitudine sociale, ha chiarito come dietro al rapporto imputato/difensore vi fosse un autentico ruolo civile del professionista nell’adempimento del proprio mandato373. Un nitido esempio del carattere civile delle difese penali emerge in uno scritto, che pare quasi un atto di rivendica, mandato alle stampe dall’avvocato palermitano Pietro Gramignani nel 1889, nel quale egli spiegava come: «la missione del difensore deve E. ALTAVILLA, L’avvocato penale, Istituto delle edizioni accademiche, 1937, vol. I, p. 109. Codice di Procedura Penale del Regno d’Italia colla relazione del Ministro Guardasigilli, cit. 371 M. VENDITTI, Parole, arringhe e discorsi, in L’Eloquenza, 1, 1937, p. 24. 372 G. ZANARDELLI, L’avvocatura, Firenze, Barbera, 1891, p. 109. 373 P. BENEDUCE, Il corpo eloquente, cit., p. 111. 369 370 175 esercitarsi là dove vi è una lacrima a tergere, un soccorso a dare, un argine a porre perchè una famiglia non sia desolata»374. Pietro Gramignani affermava ancora come: «quanto più c’era bisogno di difesa, tanto più avrebbe creduto di adempiere bene il proprio debito quel difensore che si fosse negato a prestare il suo sacro ministero agli infelici sofferenti?». Perchè, per usare le parole di Vincenzo Moreno «una volta che l’avvocato ha assolto i propri uffizi, proprio questi lo rendono pieno di quella urbanità, che è primo e più certo indizio di civiltà sociale, l’urbanità dei mestieri»375. 374 375 P. GRAMIGNANI, La posta elettorale, Palermo, 1889, p. 5. V. MORENO, Il galateo, cit. In G. ALPA, L’avvocato cit. p. 111. 176 4.2. Tra Verità Sostanziale e Processuale. Giuseppe Marchesano: «giovane e coraggioso» avvocato nel processo Notarbartolo. Gaetano Spina, avvocato nel processo Amoroso & Compagni: «contro la lega dei tristi» Un tentativo di ricostruzione del ruolo e della dimensione dell’avvocato di parte civile non può che muovere dalla ricerca della sua esatta collocazione tra gli interstizi della verità sostanziale e processuale. Appare utile alla trattazione un propedeutico e sintetico raffronto con la figura generale del penalista e del suo tipico rapporto con il concetto di “Verità”. Com’è noto, corollario al tema dell’accettazione del mandato difensivo è l’agire secondo una condotta leale e proba nei confronti del cliente, atta a non generare un caso di “patrocinio infedele”376. La nozione di lealtà, secondo una ricostruzione carrariana377, non deve però declinarsi in una “obbligazione positiva” fino al punto da ammettere la colpa del proprio assistito dinanzi al giudice, bensì in una “obbligazione puramente negativa”, tale da consentire in alcuni casi, al più, “la reticenza” dell’avvocato. La questione di ordine etico – deontologico, dilemma e nello stesso tempo contrassegno tipico dell’avvocato penalista, deve essere correttamente inquadrata nell’ottica secondo la quale questi, in ossequio al mandato ricevuto, non mira a ricercare una verità assoluta, quanto, invece, una verità processuale che sia conforme agli interessi del suo difeso. L’avvocato si preoccupa non già di indagare se l’imputato sia 376 G. DI RENZO VILLATA, Il patrocinio infedele in Italia tra Otto e Novecento, in «Officium Advocati», Frankfurtam Main, 2000, 66. pp. 316 e ss. 377 F. COLAO, Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione,. cit. p. 356. 177 effettivamente innocente, quanto se tale appaia all’uditorio. In definitiva, il proprio ministero può dirsi compiuto sia nel caso in cui il suo assistito, realmente innocente venga assolto, che nell’ipotesi diversa in cui riesca a far collocare la responsabilità del suo cliente – colpevole – lungo una diversa scala penale. L’avvocato di parte civile risponde a delle regole parzialmente diverse. Già il codice di procedura penale sardo – italiano agli artt. 109 – 120378 statuiva come «ogni persona offesa o danneggiata da un reato potesse costituirsi parte civile nel giudizio penale, benchè non avesse portato querela». La costituzione di parte civile poteva avvenire «in qualunque stato della causa», con il solo limite che «non fosse terminato il pubblico dibattimento379». L’art. 277 del citato codice prescriveva poi che la parte civile nelle cause di competenza del pretore potesse «comparire personalmente all’udienza, oppure facendosi rappresentare da persona munita di procura speciale». «Nelle cause di competenza dei tribunali correzionali o delle corti doveva farsi rappresentare da un procuratore esercente rispettivamente innanzi il tribunale o la Corte che deve giudicare380». Professionalmente, egli fa il proprio ingresso nel dramma giudiziario al fine di patrocinare gli interessi civili della parte lesa nel processo penale. In tema di conferimento del mandato, una sentenza della Corte di Cassazione di Torino del 1884381 aveva statuito «per la 378 Codice di Procedura Penale del Regno d’Italia, colla relazione del Ministro, cit. Ivi. 380 Ibidem. 381 Corte di Cassazione Torino, anno 1884, sentenza collazionata in «Codice di Procedura Penale del Regno d’Italia, illustrato secondo la più recente giurisprudenza, con note e richiami», a cura dell’avvocato Erminio Malchiodi, Vallardi Ed., Milano, 1890. 379 178 legittimità della rappresentanza della parte civile davanti ai tribunali e alle corti non si richiede il mandato scritto, basta che la parte presente all’udienza dichiari di voler essere rappresentata dal procuratore, pure presente, che accetti». E la ragione, come avverte la Cassazione di Firenze382, «sta nel mandato tacito che gli viene dalla parte civile ed accettante». Un altro tema rilevante involge la ratio stessa sottostante ad ogni costituzione di parte civile, ovverosia che cosa fondasse titolo per la legittimazione dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale. In particolare, l’avvocato professore Giuseppe Mario Puglia nelle sue “Istituzioni di diritto penale”383 argomentò come: si è discusso se il dolore morale sia per sè stesso titolo sufficiente per lo esercizio dell’azione civile. Noi non crediamo che il mero dolore morale possa servire di base all’esercizio dell’azione civile. L’azione civile nascente dal reato non mira che alla riparazione del danno prodotto dallo stesso, e sebbene questo danno possa essere materiale o morale, pure non è a ritenersi come danno morale il semplice dolore provato per la consumazione del reato. Il danno morale che può servir qual titolo all’esercizio dell’azione civile è quello che nei suoi risultamenti si converte in danno materiale o meglio pecuniario: ciò appunto avviene nei reati di diffamazione, ingiuria etc. E adunque secondo Noi, è contrario ai rigorosi principi della scienza ed alla legge che ci governa, ammettere l’esercizio dell’azione civile laddove un risarcimento effettivo di danni sia impossibile. Abbandonando un tale criterio, bisogna necessariamente vagare nell’arbitrio e ricorrere sovente nei gravi inconvenienti o di dovere ammettere molte persone, parenti e perfino gli amici del danneggiato o offeso a costituirsi parte civile, ovvero di ammettere la costituzione di parte civile ed escludere poi la condanna al risarcimento del danno perchè danno valutabile 382 Corte di Cassazione di Firenze, anno 1871, sentenza collazionata in «Codice di Procedura Penale del Regno d’Italia, illustrato secondo la più recente giurisprudenza», cit., p. 23. 383 F. PUGLIA, Istituzioni di diritto penale, Napoli 1884, p. 23. 179 pecuniariamente infatti non si è verificato. L’argomento sostenuto dal Puglia intorno alla ammissibilità o meno della parte civile al fine dell’ottenimento di un indennizzo pecuniario che tenesse conto del solo danno morale subito per la perdita di un parente, fu avversato da chi invece sosteneva la tesi opposta, che ravvisava proprio nel dolore patito dall’uccisione di un congiunto, in quella affectio familiaris, la necessità di una equa riparazione che la costituzione di parte civile nel processo penale avrebbe potuto assicurare. Nelle cronache oggetto del presente lavoro si registra infatti come i familiari della famiglie Amoroso e Notarbartolo furono ammessi all’esercizio dell’azione civile nei processi contro i mandanti e gli esecutori materiali dei delitti in cui i loro congiunti erano rimasti uccisi. Ancora sulle note caratteristiche di questo attore del processo penale, va rilevato come tratto peculiare, il fatto che nel difensore di parte civile gravi un doppio onere: quello, connotato dal rapporto professionale, di garantire la migliore tutela civilistica del proprio cliente e quello, strettamente etico-deontologico, di verificare la correttezza, formale e sostanziale, dell’ipotesi accusatoria. Vi è quasi un ribaltamento della funzione e del ruolo fin qui visti. L’aderenza rigorosa ai principi della giustizia e il rispetto delle basilari norme di condotta professionale, si spingono a imporre all’avvocato la rimessione del mandato ogni qualvolta sia palese l’innocenza dell’accusato384. 384 GARCON, Oratoria forense, cit. p. 18. 180 Le ragioni sottese sono agevolmente desumibili: il difensore dell’imputato interviene quando il delitto è già compiuto e ha il dovere di sostenere l’estraneità ai fatti del suo difeso o di limitarne la responsabilità, mentre il rappresentante di una parte civile «calunniatrice» agevolerebbe scientemente la consumazione di un delitto a danno dell’accusato385. Lo sostiene l’avvocato Giuseppe Marchesano: «No, non affermo la menzogna, perchè la menzogna al fine della causa oltre che una viltà morale, mi pare una viltà intellettuale»386. Dello stesso segno è l’avvocato Salvatore Donatuti quando nel proprio appello ai giurati afferma: «credetemi, se non avessi avuto il convincimento [...] io non avrei avuto il coraggio di presentarmi innanzi a voi»387. Inquadrato, seppur sinteticamente, il ruolo della figura dell’avvocato di parte civile, l’esame involge adesso l’aspetto retorico. Il meccanismo d’indagine ha posto in rilievo vari aspetti interpretativi delle due fattispecie in esame, l’art. 426 del codice penale sardo e il 248 del codice penale Zanardelli. Muovendo, ordinatamente, dal soggetto attivo del reato, il primo problema a profilarsi è quello del nomen iuris. Come si vedrà, infatti, la nozione di malfattore, ristretta o dilatata, rappresenta un elemento di discontinuità tra i meccanismi di difesa registrati prima e dopo l’entrata in vigore del codice del 1889. Altri momenti interpretativi si snodano nella ricerca dei 385 E. ALTAVILLA, L’avvocato penale cit. p. 103. G. MARCHESANO, Corte di Assise di Bologna, Processo contro Raffaele Palizzolo e C., Arringa dell’avv. G. Marchesano (Parte Civile Notarbartolo) – Resoconto Stenografico, Palermo, Tipografia Calogero Sciarrino, 1902, p. 318. 387 Arringa Donatuti, in Processo Amoroso, p. 185. 386 181 presupposti oggettivi e soggettivi atti a fondare la sussistenza dei reati attraverso la verifica in concreto dei dogmi tipizzati dalla norma. Per questo, sono posti sotto la lente d’ingrandimento lo stesso problema relativo alla qualificazione della mafia come ente associativo, nonché i due aspetti fondanti l’associazione stessa: il vincolo e l’organizzazione. Infine, è valutata l’idoneità concreta delle società criminali a ledere il bene giuridico protetto dalla norma: la pubblica tranquillità, prima, l’ordine pubblico poi. Il primo focus è dunque attorno alla nozione di malfattore tra teoria e prassi applicativa, sulla cui ricostruzione storica corrono i due diversi filoni interpretativi intessuti dai giuristi di parte civile. La questione non è meramente accademica, giacché i suoi risvolti portano in sede di lavori preparatori al codice penale del 1889 – con lo stratificarsi di sentenze di vario segno 388 e con la polemica più volte sfociata nelle aule parlamentari – all’accoglimento della modifica della stessa locuzione in favore dell’adozione del sostantivo meno equivoco di persone. Per una migliore contestualizzazione delle linee difensive strutturatesi intorno a questi temi, appare utile un breve e sintetico raffronto tra le diverse interpretazioni a vocazione europea nate sotto l’imperio del codice penale sardo esteso per il Regno. L’esegesi intorno alla lettera della norma disvela, infatti, l’esistenza di due scuole di pensiero, l’una è quella che in Francia fa capo a Carnot389 e che in senso restrittivo considera soddisfatto il F. BENUSSI, Associazione a delinquere, in «Giust. Pen.», 1908; A. Carcani, Associazione per delinquere – Studi sul codice penale, 1894. 389 CARNOT, Voce Associazione di malfattori in «Digesto Italiano», anno 1907, p. 80. 388 182 presupposto dell’articolo solo se ad essersi associati siano individui che «sonsi già resi colpevoli di cattive azioni e che sono abituati a commettere crimini». L’altra, di portata estensiva, condivisa tra gli altri, da Rauter, Morin e poi da Boitard390, sostiene con fermezza la non tassatività della prescrizione in esame, affermando che «non è necessario che gli associati, o per misfatti o per condanne, avessero già nota di malfattori», mentre il Franzoni391 in Italia ha cura di precisare come «il vocabolo malfattore significhi, in genere, persone dedite al mal fare». È all’interno di questo dibattito di fine Ottocento che si inserisce la ricostruzione operata dall’avvocato di parte civile Gaetano Spina392. A suo giudizio, il verdetto della giuria deve fondarsi su un esame che involga le vite degli accusati. Nelle loro valutazioni i giudici di fatto: «devono tenere davanti tutto il passato degli imputati». La precedente condotta diviene così un elemento estrinseco per la costituzione di un momento necessario del reato: il soggetto attivo. Gaetano Spina fornisce anche i parametri attraverso i quali misurare il loro grado di delinquenza. E, così, l’indice di colpevolezza viene in qualche modo ancorato a «vecchie processure», per cui sono richiamati processi celebrati nei cinque anni precedenti nei quali gli Amoroso, seppur latitanti, erano già RAUTER, MORIN ed altri, Voce Associazione di malfattori, in «Digesto italiano», p. 81. FRANZONI, Voce Associazione di malfattori, in «Digesto italiano», p. 80. 392 Arringa Spina, Processo Amoroso, p. 181. 390 391 183 stati imputati per altri misfatti393. Ancora. I presupposti della colpabilità sono da ricercare nelle informative di polizia, nelle note al questore, in cui i nomi degli imputati già compaiono, insomma in tutti quei luoghi da cui agevolmente tradurre il significato del termine malfattore. Il composito dato storico, così delineato, viene qui sfruttato per qualificare gli accusati come figure dedite al mal fare, già abituate al crimine. Il nomen assume una pregnanza per certi aspetti creativa. A sostegno viene richiamata dall’avvocato di parte civile la codificazione penale francese che in passato aveva indicato nei malfattori: «esseri perversi che facendo il mestiere di ladri o di briganti, s’accordano di porre in comune i loro misfatti»394. Anche volendo considerare che ci si trova dinanzi a una difesa di parte civile, appare evidente l’intento dell’avvocato Spina di voler porre l’accento sui precedenti cattivi degli accusati, rimanendo così sostanzialmente ancorato a una visione antica e già in via di superamento. È una teorica, questa sulla concezione di malfattore che attraversa tutto il momento postunitario e che sovente si rintraccia nelle arringhe degli avvocati oggetto di ricerca, almeno tutte le volte in cui si è trattato di rappresentare «in turpi processure, soggetti onorevoli e rispettabilissimi». La nozione restrittiva di malfattore, infatti, mal si confà a qualificare giuridicamente la parte di classe borghese siciliana, rappresentante dell’alta mafia, che nel momento postunitario era 393 394 Ibidem. Ibidem. 184 anch’essa stata chiamata a comparire in Assise. Si trattava di latifondisti, proprietari terrieri, baroni, uomini che rivestivano cariche politiche, i cui destini erano legati a doppio filo con le vicende mafiose avviluppatesi intorno al binomio baronaggio/gabella395. Il significato del maneggio da parte degli avvocati di un simile argomento si può cogliere alla luce di una lettura comparatistica tra la concezione restrittiva di malfattore e un altro termine, un’altra espressione simbolica e nello stesso tempo ridondante nei discorsi degli avvocati palermitani: il concetto di galantuomo, in chiave siciliana. C’è un illuminante passo: Nella prima edizione del processo per l’assassinio Notarbartolo alle Assise di Milano parecchi testimoni vennero a dire che nel paese di Villabate vi erano solo tre galantuomini, dichiarazione che, fatta da un abitante di quel paese, destò viva ilarità nel pubblico: ilarità che divenne anche maggiore, quando venne a risultare che uno di quei tre galantuomini aveva avuto dei conti a regolare con la giustizia. E tutto questo fu un semplice equivoco per una falsa interpretazione, perchè in Sicilia la parte del popolo per galantuomini intende, non già le persone oneste, ma bensì quelle di condizione signorile396 Un galantuomo, così inteso, non poteva essere qualificato malfattore. I termini mutano al mutare della qualità degli imputati. Che si tratti di bassa delinquenza o di alta mafia, la differenza nei registri e nel ruolo stesso dell’avvocato di parte civile diventa consistente. 395 F. DI BARTOLO, Imbrigliare il conflitto sociale. Mafiosi, contadini, latifondisti, in «Meridiana» n. 63, anno 2008, p. 32. 396 F. RENDA, Il processo Notarbartolo, ovvero per una storia dell’idea di mafia, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», anno 68, 1972, fascicolo 1, p. 48. 185 La specialità dell’apparente ossimoro malfattore/galantuomo permette di ricavare dei modelli di difesa processuale che richiamano a loro volta aspetti sociali. Tratti di rottura si evidenziano già nel processo Notarbartolo. Rispetto a quella appena vista, di segno completamente opposta è la teoria dell’avvocato Marchesano, al quale spetta l’ardua impresa di demolire l’immagine di un potente personaggio come Raffaele Palizzolo, per il quale proprio la reputazione pubblica costituiva il più insormotabile degli ostacoli. Così, se nella prima il passato era studiato e inquadrato come elemento costitutivo del soggetto attivo del reato, in questa si tratta di capovolgere l’apparente vita integerrima di un uomo politico in vista come il Palizzolo al fine di dimostrarne la colpevolezza. In un tessuto sociale, economico e giudiziario ad elevato grado di contaminazione come questo, non è facile sostenere un simile compito. Gli ossessivi insabbiamenti hanno abbondantemente permeato l’attività istruttoria. L’accertamento della verità sostanziale fatica così ad emergere da un terreno viscoso e ispido e a imporsi su quella processuale che, tra spinte politiche e abili rinvii dilatori, rischiava di prevalere in ogni momento di questo lungo processo. Anche qui si milita, dunque, verso la ricerca di un «uomo malfattore, o per dirla secondo la nuova qualificazione, delinquente, ragion per cui, mantenendo ancora il focus su questa nozione, ci accingiamo a percorrere la linea interpretativa dell’avvocato Giuseppe Marchesano. Il teorema da dimostrare consiste nel rovesciare l’immagine del “galantuomo” e questo risultato viene raggiunto attraverso un 186 rigoroso e documentale ragionamento logico – giuridico che si snoda in un percorso a più livelli, di forma ellittica, scaturenti l’uno dall’altro. A essere indagata è la capacità a delinquere del Palizzolo, cioè quell’attitudine a compiere atti penalmente rilevanti. In quest’ottica assurgono a indici rivelatori due aspetti: l’animus perversus e i mezzi utili al delitto. Entrambi vengono ricavati da un unico ma compiuto elemento di prova: i rapporti che Palizzolo intratteneva con la mafia. Appare utile soffermarsi sul significato e sulla portata dell’elemento attinto dall’avvocato di parte civile a fondamento della propria strategia difensiva: la capacità a delinquere. La scelta nell’utilizzo di tale argomento nella edificazione del discorso giuridico del Marchesano397 va osservata in correlazione con l’immagine pubblica “dell’avversario”, Raffaele Palizzolo, corrispondente a quella di un galantuomo. L’aggressione a quella “onorabilità ostentata” attraverso la dimostrazione dell’esistenza di un animus perversus e di intelligenza di mezzi costituisce la brillante intuizione che concorrerà a decretare la vittoria per il giovane avvocato palermitano. La ricostruzione operata dal giurista riesce a superare il vaglio della pienezza della prova che risulta formata oltre che da testimonianze, soprattutto da risultanze scritte. L’impianto difensivo si propone di provare l’esistenza di una fitta rete di contatti costituita da corrispondenze di interessi e da scambi di favori, di cui il Palizzolo si sarebbe servito prima nelle 397 G. MARCHESANO, Corte di Assise di Bologna, cit. p. 338. 187 elezioni e poi per ordire il delitto Notarbartolo. L’elemento probatorio è costituito da una serie di lettere manoscritte dal Palizzolo e indirizzate ai questori dei vari mandamenti palermitani, dalle quali emergeva il ruolo d’influenza esercitato su una cerchia ben definita di individui di estrazione delinquenziale398. Per essi l’imputato era solito frapporsi con una opera di autentica mediazione, per chiedere favori, deroghe alle regole, ora per far evitare la pena del confino a uno, ora per cancellare una ammonizione a un altro. Si trattava di soggetti sottoposti a un vero e proprio protettorato, ingaggiati dallo stesso Palizzolo in qualità di castaldi o di guardiani delle proprie terre. Se questo giustificava in qualche modo la legittimazione a premere sui questori, dall’altro evidenziava la personalità di un potente uomo politico che risultava attorniato da pregiudicati, ammoniti, in qualche caso latitanti, formalmente ai suoi servigi domestici o rurali, materialmente rappresentanti la prova vivente dello scambio di intese. Erano uomini, cioè, “a disposizione”399 del Palizzolo. Per Marchesano può concludersi che: «la protezione offerta al delinquente è protezione al delitto stesso»400. Si giunge così alla dimostrazione del teorema anzidetto. I rapporti con la mafia provano la capacità morale a delinquere, ossia l’attitudine psicologica, l’animo a commettere reati, mentre i rapporti con i singoli mafiosi attestano la facilità a procurarsi i mezzi del delitto, significa altrimenti non dovere ingaggiare dei 398 Ivi, p. 339. Ivi, p. 340. 400 Ivi, p. 341. 399 188 sicari, bensì attivarsi all’interno delle proprie conoscenze. Del resto, un delitto clamoroso come quello del banchiere Notarbartolo, per le modalità, per la raffinatezza con cui è stato ideato, non avrebbe potuto mai consumarsi senza una fitta rete di coperture mafiose e colui il quale ne era titolare, protettore e depositario era proprio il Palizzolo. La ricostruzione di questo passo dell’arringa del Marchesano permette di rivedere il concetto di delinquente, riannodandolo a quello più siciliano di galantuominismo. L’analisi delle difese di parte civile continua passando attraverso la ricerca della corrispondenza tra i dogmi richiesti dalla norma e quelli emergenti dai fatti di causa. Il terreno di elezione, stavolta, è rappresentato dalla definizione stessa di associazione mafiosa, dal significato di vincolo e dal paradigma dell’organizzazione. Il primo elemento che emerge dagli atti è di tipo qualificativo: la mafia è una organizzazione spontanea, quasi istintiva della delinquenza. [...] È un sentimento naturale, uno spontaneo concerto, una solidarietà che riunisce tutti i ribelli alle leggi della società civile. [...] Più grave e più pericolosa di qualunque organizzazione artificiale, appunto perchè non è un contratto, ma è una maniera di vivere 401 La tendenza è verso la ricerca della oggettivizzazione del fenomeno che, pur nella sua specialità, presenta i tratti somatici propri della delinquenza, nelle altre difese sapientemente dissimulati o quanto meno oscurati. 401 G. MARCHESANO, Corte di Assise di Bologna, cit. p. 346. 189 Nella missione dell’avvocato di parte civile è possibile scorgere, infatti, dinamiche difensive estranee alle logiche già esaminate, che avevano per buona parte percorso un filone ideologico opposto e miranti cioè alla soggettivazione del fenomeno mafioso e alla sua restrizione a grido sicilianista, o antropologico, o addirittura folkloristico. La singolarità del fenomeno, invece, qui viene utilizzata proprio per misurare l’alto grado di pericolosità di queste organizzazioni, comparativamente maggiore rispetto a quelle artificiali proprio perché la loro natura risiede in un ben determinato e tipico modo di vivere. Tale argomento ne anticipa l’altro ad esso concatenato: il significato codicistico del vincolo. Esso viene rinvenuto da Giuseppe Marchesano, in forma embrionale, in questa «speciale solidarietà che li unisce spontaneamente tutti»402. Ma vi è di più. A questo livello, per così dire, spirituale, se ne accompagna un altro materiale, che a sua volta si riannoda con il tema dell’organizzazione. Il riferimento è al vincolo militare che vuole una ripartizione interna e suddivisa in singole cosche delle varie famiglie aderenti al consorzio, ciascuna con i propri capi e le proprie ramificazioni sul territorio. Il Marchesano sottolinea questo aspetto403, ponendo l’accento sul meccanismo di comunione dei socii e di insubordinazione rispetto ai loro superiori e protettori che attesta definitivamente 402 Ivi, p. 358. Ibidem. 403 190 l’esistenza e il fondamento del vincolo. Questo tipo di accertamento rappresenta una tappa obbligata della difesa di parte civile e del resto, del carattere essenziale del pactum sceleris e del suo inequivocabile accertamento giudiziale troviamo traccia in una sentenza del tribunale di Girgenti dove si legge: «i camorristi e i mafiosi se non risulta che siano tassativamente e specificatamente legati da regole e patti sociali, non possono rispondere del reato previsto dall’art. 248 c. p.»404. È a questo punto che si introduce il tema, molto dibattuto in dottrina e in giurisprudenza, circa il significato dell’elemento della organizzazione quale connotato tipico. La ricostruzione di questo elemento essenziale affonda le sue radici nella stessa impronta interpretativa lasciata dal vincolo. E infatti, quell’unione di intenti, facultata dalla comune solidarietà, salda la parte, per così dire, spirituale del connubio; mentre la distribuzione degli appartenenti in singoli clan strutturati ne sigilla la parte, diremo, materiale. A conclusioni simili era già pervenuto l’avvocato Spina, nel processo Amoroso, individuando il vincolo criminoso «che è il principale criterio della società a delinquere»405 nel comune interesse di chi propone ed esegue il delitto. A questo punto è già possibile tracciare una prima linea di analisi comparativa dei meccanismi di difesa di parte civile studiati tra i due codici. Essi rivelano tratti comuni, sintetizzabili in una perorazione atta, in primo luogo a cristallizzare la forza e la concretezza del vincolo dell’associazione per delinquere, che risulta A. GUADAGNI, Sentenza del Tribunale di Girgenti, 7 aprile 1903, in «Foro Siciliano», I 1903. Arringa Spina, in Processo Amoroso, p. 181. 404 405 191 adesso legata da una relazione di natura ideale rinvenibile nella volontà del raggiungimento dello scopo comune e da un’altra di tipo materiale che si ritrova nel sistema di corrispondenza che connette i socii ai loro capi e protettori. Le stesse concezioni si ritrovano in una sentenza della Cassazione di Napoli che nelle motivazioni scrive: «l’essenza di codesto reato è nella organizzazione delle bande, la quale presuppone più che una riunione, un vincolo tra i soci di gerarchia e di disciplina»406. Un altro momento esegetico, tematizzato nelle arringhe di parte civile, involge la ricerca nelle associazioni sub judice, di quei presupposti che, ricalcando due connotati emblematici del fenomeno criminale mafioso, ne attestano chiaramente la suscettibilità a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma: la pubblica tranquillità. In un’ottica più macroscopica, si tratta di un primo compiuto tentativo di concepire rigorosamente il diritto penale come strumento di tutela dei beni giuridici ed è frutto di una concezione di fondo – ispirata sia al positivismo scientifico, sia al liberalismo progressista di fine Ottocento – che valorizza l’idea di «scopo» nel diritto penale, più in generale teorizzata da Jhering407. L’analisi è quindi adesso svolta ponendo sotto esame la qualità e l’attitudine di queste associazioni criminali a costituire un pericolo per la comunità e ciò nella ricerca del punto di corrispondenza tra esse e il contenuto antisociale dell’illecito. Così, l’avvocato Gaetano Spina nell’incipit alla sua orazione: 406 407 Cass Napoli 20 sett. 1870 – causa Ruffo/Scilla ed altri in «Riv. Pen.», 1870. R. VON JHERING, Lo scopo nel diritto, trad. di M. G. Losano, Torino, v. 1, 1972. 192 «favoriti dal terrore dei loro nomi, legati tra loro dal più feroce patto di sangue»408. Il rinvio, nemmeno tanto implicito, è a due fondamentali luoghi, capaci di misurare il grado di minaccia per il bene giuridico tutelato dalla norma. Vediamo come. Il riferimento è al ruolo e alla dimensione che assume l’intimidazione prodotta dalla loro fama e al meccanismo di affiliazione della punciuta409 che, sugellando il vincolo, aumenta la pericolosità sociale del consorzio criminale, proprio in virtù della sua inscindibilità. L’argomento assume una forte pregnanza persuasiva se si considerano i due elementi in maniera tra loro combinata, vediamoli prima singolarmente. Come ci testimoniano celebri autori, tra i quali Giuseppe Alongi410, l’ingresso nel gruppo criminale è storicamente preceduto dalla consumazione di riti di iniziazione a metà tra il mistico e il settario. Il meccanismo della punciuta era già stato attestato negli anni settanta del diciannovesimo secolo dalle rivelazioni di Salvatore Marino, ex appartenente alla setta degli Stuppagghieri, che della pratica aveva fornito una dettagliata descrizione411. Il rituale di affiliazione produce così un duplice effetto, uno interno e l’altro esterno alla organizzazione. Nel primo, infatti, suggella definitivamente l’appartenenza e l’adesione psichica dell’iniziato alla setta, plasmando proprio quell’affectio societatis 408 Arringa Spina, in Processo Amoroso, p. 181. G. LO VERSO E G. LO COCO, La psiche mafiosa: storie di casi clinici e collaboratori di giustizia, Franco Angeli, Milano, 2003; G. BIANCHI, Le associazione di malfattori, studio di sociologia criminale, in «Riv. Dir. Pen.», anno 1908. 410 G. ALONGI, La Maffia, cit., p. 39. 411 A. CRISANTINO, Della segreta e operosa associazione. cit. p. 111. 409 193 che la norma richiede, ovvero la consapevolezza di partecipare all’associazione quale componente. Il neofita veniva presentato al consiglio dei capi sezione da due soci emeriti o padrini, quindi avveniva la consegna dell’immagine di una santina, sulla cui effigie venivano sparse le gocce di sangue fuoriuscito a seguito della puntura effettuata sul pollice della mano destra, realizzata solitamente con un legno appuntito di un ramo di albero di arancio. A quel punto, la santina veniva fatta bruciare, mentre l’iniziato pronunciava la formula del giuramento di fedeltà, devozione e sottomissione alla cosca412. Nel secondo significato, favorisce l’immediata riconduzione al gruppo, il che forma il primo segmento di intimidazione che, a sua volta, fomenterà la fama criminale dell’associazione stessa, di cui si dirà tra poco. E veniamo adesso alla costruzione di questo secondo componente maneggiato nell’incipit dell’avvocato Spina. La nozione di fama criminale si spiega alla luce della considerazione che l’associazione, per la sua semplice esistenza, è capace di incutere uno stato di timore diffuso sul territorio nel quale opera. L’attività concretamente svolta sulle terre di giurisdizione propria di ciascuna famiglia, infatti, alimenta la stessa reputazione criminale che avvolge il sodalizio. E ciò per una ragione: il controllo delle contrade e la gestione degli affari si esplica attraverso atti di violenza e di minaccia – «ogni sospiro una vendetta, l’assassinio un’abitudine»413 – proseguiva l’avvocato 412 413 Ibidem. Arringa Spina, in Processo Amoroso, p. 182. 194 Spina nella sua arringa. Ciò è sufficiente per creare condizioni di assoggettamento e atteggiamenti di omertà tali da erigere attorno alla associazione un autentico muro di protezione. Questa barriera permette, proprio nel significato delle parole dell’avvocato Spina, quel «principio di favore» che protegge gli associati stessi da qualsivoglia attacco esterno. In definitiva, il meccanismo retorico realizzato attraverso il ricorso ai topoi fama criminale/patto di sangue evoca chiare immagini di allarme sociale e, dinanzi agli occhi dei giurati, getta le prime granitiche fondamenta circa la sussistenza di quella minaccia alla pubblica tranquillità che la norma dell’articolo 426 del codice penale sanziona. Tale ultimo rilievo necessita di un approfondimento, volto a chiarire l’aspetto essenziale che caratterizza l’associazione strutturandola tra i delitti contro la pubblica tranquillità. Per illustrarlo, l’avvocato Ferdinando Puglia richiama l’immagine tradizionale dell’associazione come reato di pericolo permanente. «In codesta organizzazione, presa in tutte le sue forme più svariate, da quella dei briganti a quella dei camorristi e dei mafiosi, in codesta associazione in corpo è il pericolo della tranquillità pubblica, è la ragione per cui la legge la colpisce prima che agisca, è la giustificazione della pena»414. Altri autori hanno teorizzato come «il legislatore ha voluto colpire le associazioni organizzate, nelle quali l’accordo di più volontà che agiscono per impulso unico, sotto il rigore di una certa 414 F. PUGLIA, Criminalità collettiva, in «Archivio di Psichiatria», II, anno1901, p. 112. 195 disciplina, costituisce la vera minaccia all’ordine pubblico, e racchiude una maggiore quantità d’imputabilità politica»415. È appena il caso di segnalare come nel secondo Ottocento, i concetti di “quantità politica”, di “ordine pubblico”, di “difesa sociale” avessero raggiunto un buon grado di elaborazione e i moti interpretativi e argomentativi intorno al concetto e alla struttura del reato di associazione di malfattori ne rappresentano un significativo esempio. A conclusione di questo discorso, emerge come la difesa di parte civile risponda a dei meccanismi logici per certi aspetti assai differenti dalla difesa dell’imputato. Dal punto di vista strettamente giuridico, nel secondo caso, il difensore toglie, dissimula, rarefa gli elementi di colpevolezza, nel primo caso, invece, tende a ricercarli, ad assemblarli, a offrirli in fruizione alla giuria. Trave portante rimane il rispetto di quel dovere di verità, nel significato che si è innanzi detto. Lo scopo ultimo deve essere sempre la certezza del diritto e il rispetto della legge per i fini della giustizia, così come vuole la formula del giuramento d’ingresso alla professione forense. Sono spazi, anzi, nei quali la ricerca della verità sostanziale è fortemente agognata. E in nome di questo, non ci si può permettere di «fabbricare ingiuste assoluzioni»416, asserisce l’avvocato Gaetano Spina, deputato e seguace della politica di Crispi. Autentico avvocato di parte civile, dentro e fuori dalle aule dei tribunali, egli, denunciando le gravi condizioni della giustizia 415 416 A. CARCANI, Associazione per delinquere studi sul codice penale, Ed. Effe,1894, p. 64. Arringa Spina, in Processo Amoroso, p. 182. 196 nell’isola, si fece promotore di una legge che: facultasse la Corte d’Assise a non rispettare il verdetto del del giurì, anche nel caso di erronea liberazione pronunziata a favore dell’accusato e inviare la causa ad altra sessione e ciò sul motivo che l’interesse sociale, come prescrive che l’innocente sia salvo, così addimanda che il reo venga punito e che la legge imperante autorizzando il Magistrato dell’Assise ad annullare il verdetto di una ideale colpabilità, nella stessa guisa dovrebbe cessare il verdetto dell’ingiusta assoluzione 417. L’analisi delle arringhe difensive oltre ad aprire scenari nuovi rispetto a quelli già incontrati, ha il pregio di colmare dei vuoti apparenti e di dare “senso” ad aspetti del diritto penale sostanziale e processuale di non poco conto. Ancora: analizzare le difese delle famiglie delle vittime assassinate dagli Amoroso e di quella del banchiere ucciso Emanuele Notarbartolo risolve, talvolta, i problemi di qualificazione giuridica che si sono incontrati, oltre a fornire particolari della cultura giuridica e della comprensione del fenomeno mafioso, per i tempi, decisamente rilevanti. Attraverso le tappe dei discorsi dei due avvocati, Gaetano Spina e Giuseppe Marchesano, è possibile rileggere a ritroso i registri adottati dagli avvocati difensori già analizzati e offrire nuove letture interpretative delle fattispecie previste dall’art. 426 codice penale sardo-italiano e dal successivo art. 248 del codice penale Zanardelli. In particolar modo, la difesa delle vittime della mafia, dal taglio speculare a quella propria degli imputati, ha il pregio di mettere in luce il fenomeno criminale per quello che è effettivamente, riuscendo così a superare, quando non addirittura a 417 Ibidem. 197 ridimensionare, la considerazione che un’ampia fetta dell’opinione pubblica avesse intorno all’idea di una mafia «buona e cavalleresca». Attraverso la voce dell’avvocato di parte civile, così, vengono veicolati i meccanismi di interazione, i criteri di operatività, la tipica pericolosità sociale della mafia, che gradualmente e tramite un processo lungo e laborioso, inizia quella lenta trasfigurazione che la porterà lentamente ad essere percepita come nient’altro che una organizzazione siciliana di natura criminale. Il dato finale che emerge, ad uno sguardo panoramico nel raffronto con le categorie difensive analizzate, disvela inequivocabilmente il carattere circolare proprio del meccanismo di difesa processuale della mafia. 198 FONTI ARCHIVISTICHE ARCHIVIO DI STATO PALERMO, b. 30, f.12 – rapporto riservatissimo del reggente. ARCHIVIO DI STATO PALERMO, GQ, busta 410. ARCHIVIO DI STATO PALERMO, GQ, busta 429. ARCHIVIO DI STATO PALERMO, GQ, busta 440. ARCHIVIO DI STATO PALERMO, CA, b. 188, 1878. ARCHIVIO DI STATO PALERMO, Gabinetto Questura, anno 1880, busta n. 7. ARCHIVIO DI STATO PALERMO, Gabinetto Questura, anno 1880, busta n. 7 – Carte Minghetti, rapporto Gerra 24 luglio 1874. ARCHIVIO DI STATO PALERMO, Gabinetto Questura, anno 1880, busta n. 7 – Informativa. Questore del Re presso il Tribunale di Palermo, 29 novembre 1876. ARCHIVIO DI STATO PALERMO, Gabinetto Prefettura, 1875, b. 35, f. 6 – Memoria del 29 dicembre 1875. ARCHIVIO DI STATO DI LECCE, Collezione delle leggi e dei decreti reali del regno delle due Sicilie, anno 1817, semestre II, Napoli, Dalla Real Tipografia della Cancelleria generale, v. Appendice I, documento n. 12 p. 228. BIBLIOGRAFIA AJELLO A., Angelo Pugliesi, ovvero, D. Peppino il lombardo : resoconto del dibattito celebrato avanti la Corte di Assise ordinaria del circolo di Palermo con la inserzione di tutti gli atti, e specialmente degl’interrogatori degli accusati Pugliesi, Raja e Mistretta, Palermo, Tip. G. B. Gaudiano, 1868. ALONGI G., La maffia, Tip. Fratelli Bocca, Torino 1886. ALTAVILLA E., La psicologia giudiziaria, Tipografia Sociale Torinese, Torino, 1925. ALTAVILLA E., L’avvocato penale, Tipografia Del Bianco e Figli, Istituto delle Edizioni Accademiche, vol. I, Udine, 1937. ALPA G., “Forensic Linguistics”: il linguaggio dell’avvocato nell’evoluzione dell’ordinamento, dei metodi interpretativi, delle prassi e della tecnologia in 199 Interpretazione e dialettica giudiziaria (a cura di) MARIANI MARINI A., Giuffrè, Milano, 2003. ALPA G., L’avvocato, Il Mulino, Bologna, 2008. ALPA G. DANOVI R., Un progetto di ricerca sulla storia dell’avvocatura, Il Mulino, Bologna, 2003. ANONIMO, Il sistema regionale richiesto dalla natura e dalla garanzia del diritto umano, Ed. Tipografiche Palermo, Palermo, 1863. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, a cura di S. CARBONE R. GRISPO, L’Inchiesta parlamentare sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia (1875-1876), Cappelli, Bologna, 1969. BARTHES R., Fragments d’un discours amoureux, Paris, Èd. du Seuil, 1977. BENEDUCE P., Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell’Italia liberale, Il Mulino, Bologna, 1996. BIANCHI G., Le associazioni di malfattori, studio di sociologia criminale, in «Riv. Dir. Pen.», anno 1908. FALCONE G., Mafia e Omertà – Conferenza tenuta il 3 febbraio 1895 nel Circolo Calabrese in Napoli, Napoli, Stabilimento Tipografico R. Pesole, Napoli, 1898. FERRARI G. A. e MANZIN M., La retorica fra scienza e professione legale. Questioni di metodo, Il Mulino, Bologna, 2004. BERTOLO G. M., La rivoluzione del 1848 e la provincia di Caltanissetta, Tip. dell’Ospizio prov. di beneficenza Caltanissetta, 1898. BRANCATO F., Mafia e formazione dello stato italiano in «Quaderni del Meridione», n. 81, 1983. BRANCATO F., La mafia nell’opinione pubblica e nelle inchieste dall’Unità al fascismo, Pellegrini, Cosenza, 1986. CABIBBO S., Santa Rosalia tra cielo e terra. Storia, rituali, linguaggi di un culto barocco, Sellerio, Palermo, 2004. CALDARA C. CAVAGNARI E., Avvocati e Procuratori, Il Mulino, Bologna, 2004. CARBONE S., GRISPO R. (a cura di), L’inchiesta sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia (1875-76), Grifo, Bologna, 1968. CARMIGNANI G., Teoria delle leggi della sicurezza sociale, Tomo II, Pisa, 1831. 200 CIANFEROTTI G., Logica del processo, logica del giudizio e opinione pubblica, in Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento, Il Mulino, Bologna, 2008. CIVILE G., Per una storia sociale dell’opinione pubblica: osservazioni a proposito della tarda età liberale, in «Quaderni Storici», Il Mulino, Bologna, 2000. COLACINO, T. V., La Fratellanza, in «Rivista di discipline carcerarie», 1885. CONTI U. (a cura di), Prima raccolta completa della Giurisprudenza sul codice penale, Vol. II, Società Editrice Libraia, Milano, 1926. COLAO F., Avvocati del risorgimento nell’Italia della restaurazione, Il Mulino, Bologna, 2006. COLAO F., Giovan Battista Impallomeni avvocato tra libertà politiche, questione sociale, «eccesso di potere nel giovane Regno d’Italia», in Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea a cura di F. MIGLIORINO E GIACOMO PACE, Il Mulino, Bologna, 2013. COSTANTINO, UGUENTI, SFORZA, Voce: Associazione di malfattori o per delinquere in «Digesto Italiano», Vol. IV, Unione Tipografico Editrice, Torino, 1895. COSTANZO A., L’argomentazione giuridica, Giuffrè, Milano, 2003. CRISANTINO A., Della segreta e operosa associazione della mafia una setta all’origine della mafia, Sellerio, Palermo, 2000, p. 29. CUTRERA A., La mafia e i mafiosi, Gi Effe, Palermo,1900. DE LUCA G. B., Lo Stile legale, Il Mulino, Bologna, 2010. DE CESARE G., Voce “Mafia” in «Nuovo Digesto Italiano». DE FELICE G., Maffia e delinquenza,Politica, criminalità e magistratura tra il delitto Notarbartolo ed il processo Codronchi-De Felice,Boemi, Milano, 1900. DI BARTOLO F., Imbrigliare il conflitto sociale. Mafiosi, contadini, latifondisti, in «Meridiana», n. 63, anno 2008. FERRARI G. A. e MANZIN M. (a cura di), La retorica fra scienza e professione legale. Questioni di metodo, Giuffrè, Milano, 2004. FIORE C., Il controllo della criminalità organizzata nello Stato liberale: strumenti legislativi e atteggiamenti della cultura giuridica, in «Studi Storici», 201 n. 29, Roma, 1988. FIUME G., Paradigma giudiziario e storia politica della mafia, in «Quaderni storici», n. 93, Il Mulino, Bologna, 1996. FRANCHETTI L., Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, Vallecchi, Firenze, 1926. FRANCHETTI L., Politica e mafia in Sicilia. Gli inediti del 1876, a cura e con una introduzione di A. Jannazzo, Bibliopolis, Napoli, 1995. GARCON M., Sull’oratoria forense, Giuffrè, Milano, 1957. GIANFORMAGGIO L., L’argomentazione giuridica interpretativa: avvocati e giudici, in Teoria e tecnica dell’argomentazione giuridica, a cura di MARINI MARIANI A., Giuffré, Milano, 2003. GIULIANI A., Logica: b) teoria dell’argomentazione, in Enc. del dir., XXV, Milano, 1975. GIURIATI D., Arte forense ,Roux e Favale, Torino, 1878. GRAMIGNANI P., Il brigante calabrese in Sicilia, Angelo Pugliese, Ed. Tip. Palermo, Palermo, 1868. GRAMIGNANI P., Sicurezza pubblica, in «La posta elettorale», 20 luglio 1868. GUARNERI A., L’inchiesta parlamentare sui fatti di Palermo, F, Maggiori Palermo, 1867. IMPALLOMENI G. B., Del concorso di più persone nel reato, in «Rivista Penale», Palermo, XXVI, 1900. IMPALLOMENI G. B., Trattato di diritto penale, Vallardi, Milano, 1908. HESS H., Mafia Zentrale Herrschaft und lokale Gegenmacht, Tübingen, 1970. HIRSCHMAN A., Retoriche dell’intransigenza, Il Mulino, Bologna, 1991. LACCHÈ L., Alle origini della associazione per delinquere. Crimen Plurimum, concorso e reato plurisoggettivo tra Antico Regime e XIX secolo, in «Annali della F. di Giurisprudenza di Macerata», Milano, 1989. LACCHÈ L., Un luogo “costituzionale” dell’identità giudiziaria nazionale: la Corte d’Assise e l’opinione pubblica (1859-1913), in Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento, a cura di COLAO F., LACCHÈ L. e STORTI C., Il Mulino, Bologna, 2008. LESTINGI F., La mafia in Sicilia, in «Archivio di Psichiatria», 1880. 202 LOMBROSO C., Sulle associazioni al malfare, in «Riv. Pen.», anno 1875. LORENZONI G., Inchiesta sulle condizioni dei contadini nelle Provincie Meridionali e nella Sicilia, vol. VI, Sicilia, Tip. Az. G. Berter e c., Roma 1910. LO VERSO G., LO COCO G., La psiche mafiosa: storie di casi clinici e collaboratori di giustizia, Ed. Franco Angeli, Milano, 2003. LUCCHINI L., Voce “Ammonizione”, in «Digesto Italiano», vol. IX, Unione Tipografico Editrice, Torino, 1895. LUPO S., Il giardino degli aranci. Il mondo degli agrumi nella storia del Mezzogiorno, Marsilio, Venezia, 1990. LUPO S., «Il tenebroso sodalizio». Un rapporto sulla mafia palermitana di fine Ottocento, in «Studi Storici», anno 29, n. 2, anno 1988. LUPO S., Storia della mafia, Donzelli Virgolette, 1993, Roma. MADIA G., Commentario sul Codice Penale Italiano, Tipografia di Gennaro fabbricatore (fu Gennaro), Napoli, 1862. MALATESTA M., Professionisti e gentiluomini. Storia delle professioni nell’Europa contemporanea, Einaudi, Torino, 2006. MANGIAMELI R., Gabellotti e notabili nella Sicilia dell’interno, in «Italia Contemporanea», 1984. MANZIN M., La questione retorica alle origini dell’umanesimo giuridico, in CAVALLA F. (a cura di), Retorica, processo, verità. Principi di filosofia forense, Cedam, Padova 2005. MARCHESANO G., Corte di Assise di Bologna, Processo contro Raffaele Palizzolo e C., Arringa dell’avv. G. Marchesano (Parte Civile Notarbartolo) – Resoconto Stenografico, Palermo, Tipografia Calogero Sciarrino, 1902 MARCHETTI P. (a cura di), Inchiesta penale e pregiudizio. Una riflessione interdisciplinare, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007. MARCIANO G., Associazione per delinquere e concorso criminoso, in «Questioni di diritto», Napoli, 1926. MARINI MARIANI A., Il linguaggio, la condotta, il metodo, Il Sole 24 Ore, Milano, 2000. MARINO G. C., L’opposizione mafiosa: mafia, politica, stato liberale, Flaccovio, Palermo,1986. 203 MARINO G. C., Storia della mafia, Il Sapere, Roma, 1997. MARINO G. C., Partito e lotta di classe in Sicilia da Orlando a Mussolini, De Donato, Bari, 1976. MARMO M., Il reato associativo tra costruzione normativa e prassi giudiziaria, in «La città e il Tribunale», Napoli, 2004. MENZA G., Le cronache delle Assise di Palermo – riordinate, raccolte e ampliante, Palermo, Tip. Del Giornale di Sicilia, 1878. MORENO V., Il galateo degli avvocati, La Toga, Napoli, 1938. MORO P., Fondamenti di retorica forense. Teoria e metodo della scrittura difensiva, Libreria al Segno, Pordenone, 2004. MORTARA GARAVELLI B., Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense, in La lingua, la legge, la professione forense, Giuffrè, Milano, 2002. MOSCA G., Che cosa è la mafia, Tip. Garagnani, Bologna, 1900. NOVACCO D., La mafia nella discussione parlamentare del 1875, in «Quaderni del Meridione», gen-mar., 1963. PADOA SCHIOPPA A., Avvocati e avvocatura dell’Ottocento, Il Mulino, Bologna, 2009. PADOVANI T., Francesco Carrara nel primo centenario dalla morte, Giuffrè, Milano, 1991. PASCIUTA B., Itinerari di una cultura giuridica: la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo dalla fondazione al fascismo (1805-1940), in «Annali di Storia delle Università italiane», 12, anno 2008. PERELMAN C., Trattato dell’argomentazione: la nuova retorica, Einaudi, Torino, 1966. PERELMAN C., Il campo dell’argomentazione. Nuova retorica e scienze umane, Pratiche, Parma, 1979. PEZZINO P., Alle origini del potere mafioso: Stato e società in Sicilia nella seconda metà dell’Ottocento, «Passato e Presente», n. 8, 1985. Processo dei fratelli Amoroso & Compagni, Palermo, Tip. Ed. del Giornale di Sicilia, 1883. Processo pe’ i quattro scomparsi di Palermo, Palermo, Tip. Ed. del Giornale di Sicilia, 1901. 204 PUGLIA F., Criminalità collettiva, in «Archivio di Psichiatria», fasc. III, 1901. PUGLIA G. M., Il mafioso non è un associato per delinquere in «La Scuola Positiva Rivista di pen. e proc. Pen.», Anno X. Fasc. 10 – 11. RENDA F., Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, Vol. I, Sellerio, Palermo, 1984. RENDA F., Il processo Notarbartolo, ovvero per una storia dell’idea di mafia, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», anno 68, 1972, fascicolo 1. RIALL L., La Sicilia e l’unificazione italiana – politica liberale e potere locale, Einaudi,Torino, 2004. SANTANGELO CORDANI A., Le retoriche dei penalisti a cavallo dell’unità nazionale, Giuffrè, Milano, 2011. SBRICCOLI M., Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860 – 1990) in VIOLANTE L. (a cura di), Storia d’Italia, Annali, 29, Legge, diritto, giustizia. Einaudi, Torino, 1998. SBRICCOLI M., La penalistica civile: teorie ed ideologie del diritto penale nell’Italia unita, in Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti., Giuffré, Milano, 2009. SCARLATA F., L’associazione per delinquere e la “mafia”, Ed. Tip. Palermo, Palermo, 1897. SCIASCIA P., I Pugnalatori, 4° ed. Adelphi, Milano, 2007. SEMAMA P., Argomentazione e persuasione, Giuffrè, Milano, 1974. SIEGRIST H., Gli avvocati nell’Italia del XIX secolo. Provenienza e matrimoni, titolo e prestigio in «MERIDIANA» n. 14 del 1992. SIGHELE S., La psicologia della complicità, in «Archivio di Psichiatria», 14, 1893. STOPPATO A., La scuola giuridica italiana e il progresso del diritto penale, Monti, Bologna, 1909. TARELLO G., I ragionamenti dei giuristi tra teoria logica e teoria dell’argomentazione, in Diritto, enunciati, usi, Il Mulino, Bologna, 1974. TARELLO G., Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, Il Mulino, Bologna, 1976. TESSITORE G., Emergenza e garantismo nella legislazione antimafia, in «Nuovi Quaderni del Meridione», XXIII, anno 1992. 205 VECCHINI A., in L’eloquenza, anno I, 1911. VELLUZZI V., Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2002. VERCESI E. SANTINI E., L’eloquenza, Vallardi, Milano, 1938. ZANARDELLI G., L’avvocatura, Barbera, Firenze, 1891. ATTI PARLAMENTARI Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1874-75, XII legislatura, Progetti di legge e Relazioni, Allegato alla Nota del 18 febbraio 1875. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1874-75, XII legislatura, Allegato, Statistiche penali. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1874-75, XII legislatura, Stampati. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1874 –75, XII legislatura, documenti - progetti di legge e relazioni. Atti Parlamentari, Senato del Regno, Discussioni, 20 giugno 1917. GIORNALI L’AMICO DEL POPOLO, Giornale Politico, Palermo, 29 maggio 1875. L’AMICO DEL POPOLO, Giornale Politico, Palermo, 4 marzo 1880. LO STATUTO, Giornale Politico, Palermo,13 giugno 1878. IL PRECURSORE, n. 83, Palermo 26 marzo 1875. IL GIORNALE DI SICILIA, Palermo, anni 1876, 1877, 1878, nn. vv. IL PAESE, Palermo, anni 1877, 1878, nn. vv. 206
Scarica