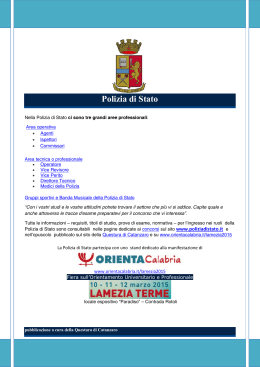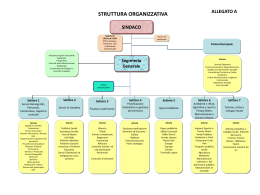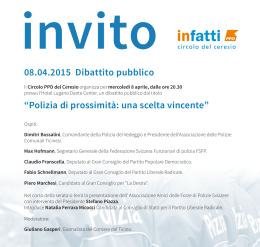CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, AL SERVIZIO DI UNA SOCIETA’ CHE CAMBIA Manuale per le Polizie Locali nella società transculturale Scuola Interregionale di Polizia locale Via F. Busani 14 - 41122 Modena Tel: 059/285135 Fax: 059/283780 Cell. 334/6866741 Email: [email protected] Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità www.scuolapolizialocale.it Finito di stampare nel maggio 2014 L’immagine di copertina ci è stata fornita dal Comando di Polizia Municipale di Prato, Unita Operativa Educazione stradale e alla legalità 1 SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE Contro le discriminazioni, al servizio di una società che cambia Manuale per le Polizie Locali nella società transculturale Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità di Marina Pirazzi e Cristian Poletti 2 I diritti umani sono il diritto di nascita di ciascuno in questo mondo. Non perché siamo nati in un luogo o in un altro ma per il fatto che siamo nati. Siamo titolari di diritti umani perché siamo esseri umani e rimaniamo esseri umani anche se non abbiamo un passaporto, un visto o un permesso di soggiorno. Morten Kjaerum, Direttore dell’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) dell’Unione Europea 3 Indice PREFAZIONE......................................................................................................................................................... On. Cécile Kashetu Kyenge ................................................................................................................................ 8 PREFAZIONE......................................................................................................................................................... Scuola Interregionale di Polizia Locale .............................................................................................................. 9 1. INTRODUZIONE ........................................................................................................................................ 10 1.1 UNA POLIZIA PER I DIRITTI UMANI ...................................................................................................... 11 1.2 PER CHI E’ QUESTO LIBRO ................................................................................................................... 12 1.3 PERCHE’ QUESTO LIBRO ...................................................................................................................... 13 1.4 LE FONTI............................................................................................................................................... 14 1.5 NOTE PER LA LETTURA......................................................................................................................... 15 2. I DIRITTI UMANI COME FONDAMENTO DELL’AGIRE DI POLIZIA ............................................................. 17 2.1 IL SERVIZIO DI POLIZIA E I DIRITTI UMANI ........................................................................................... 18 2.1.1 Il fondamento giuridico dei diritti umani ........................................................................................... 18 2.1.2 Il servizio di polizia dalla prospettiva dei diritti umani ....................................................................... 20 3. PREGIUDIZI E STEREOTIPI ........................................................................................................................ 23 3.1 COSA SONO PREGIUDIZI E STEREOTIPI ................................................................................................ 24 3.1.1 Quando ci accorgiamo della loro esistenza? ...................................................................................... 26 3.1.2 Per una razionale difesa dalla tentazione di usare stereotipi ............................................................ 29 3.2 4. PREGIUDIZIO MANIFESTO E SOTTILE ................................................................................................... 30 CULTURA, ETNIA, MODELLI DI SOCIETA’ ................................................................................................. 32 4.1 LE CULTURE.......................................................................................................................................... 33 4.1.1 Che cosa s’intende per cultura ........................................................................................................... 33 4.1.2 La culturalizzazione dei conflitti ......................................................................................................... 36 4.2 L’INVENZIONE DELL’ETNIA......................................................................................................................... 38 4.3 I MODELLI D’INCORPORAZIONE DEI MIGRANTI NELLE SOCIETÀ .............................................................. 40 4.3.1 Multiculturalismo ............................................................................................................................... 41 4.3.2 Assimilazionismo ................................................................................................................................ 42 4.3.3 Interculturalità .................................................................................................................................... 44 4 4.3.4 Transculturalità................................................................................................................................... 46 4.4 L’ETNOCENTRISMO E LE SUE RESPONSABILITÀ ......................................................................................... 48 4.4.1 Alcuni spunti di riflessione e un primo bilancio.................................................................................. 49 4.5 CITTADINANZA........................................................................................................................................... 50 4.5.1 Verso l’integrazione? Il ruolo dell’Europa .......................................................................................... 50 4.5.2 Integrazione o cittadinanza? ............................................................................................................. 51 5. DAL RAZZISMO ALLA DISCRIMINAZIONE ................................................................................................. 54 5.1 VECCHI E NUOVI RAZZISMI .................................................................................................................. 55 5.2 DISCRIMINARE ..................................................................................................................................... 55 5.2.1 Tre livelli di discriminazione .............................................................................................................. 56 5.2.2 Strategie di esclusione ........................................................................................................................ 58 5.3 DISCRIMINAZIONE: DEFINIZIONI E CONCETTI ..................................................................................... 60 5.3.1 Discriminazione diretta ...................................................................................................................... 60 5.3.2 Discriminazione indiretta ................................................................................................................... 63 5.3.3 Le molestie costituiscono discriminazione ......................................................................................... 65 5.4 DISCRIMINAZIONE ISTITUZIONALE ...................................................................................................... 66 5.5 DISCORSI D’INCITAMENTO ALL’ODIO .................................................................................................. 70 5.6 EFFETTI DI STEREOTIPI E DISCRIMINAZIONI .............................................................................................. 71 5.6.1 Fare fronte allo stress ......................................................................................................................... 72 5.6.2 Danni secondari .................................................................................................................................. 75 5.7 LE INDAGINI SULLA PERCEZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE ............................................................... 76 5.8 DOVE SEGNALARE DISCRIMINAZIONI .................................................................................................. 80 5.9 IL CONTRIBUTO DEI MIGRANTI ALLA SOCIETA’ E ALLO STATO ITALIANO ........................................... 82 6. CRIMINALIZZAZIONE E STIGMATIZZAZIONE DEI MIGRANTI .................................................................... 84 6.1 LA QUESTIONE CRIMINALE IN ITALIA ........................................................................................................ 85 6.1.1 Perché, secondo le statistiche, gli immigrati delinquono più degli italiani? ...................................... 88 6.1.2 Alla ricerca di un capro espiatorio? .................................................................................................... 92 6.1.3 La stigmatizzazione del “nemico”: tautologia della paura ................................................................. 93 6.1.4 Nuove strategie di controllo sociale e “guerra alla povertà” ............................................................. 95 6.2 PERPLESSITÀ SULL’USO DELLE STATISTICHE UFFICIALI.............................................................................. 99 6.3 IL RICORSO ALL'ETHNIC PROFILING NELL'ERA ATTUARIALE .……………………………………………………………….103 6.4 LA QUESTIONE EMERGENTE DELLE SECONDE GENERAZIONI ................................................................. 106 6.5 PER UNA POLIZIA AL SERVIZIO ANCHE DEL MIGRANTE .......................................................................... 108 7. L’IDENTITÀ DELLA POLIZIA LOCALE: CHE COSA FA E CHE COSA DOVREBBE FARE ................................ 111 5 7.1 IDENTITA’ IN CAMBIAMENTO .................................................................................................................. 112 7.1.1 Un ventennio di trasformazioni ........................................................................................................ 112 7.1.2 La Polizia Locale dei Comuni (o Polizia Municipale) ......................................................................... 114 7.1.3 La Polizia Locale delle Province ........................................................................................................ 118 7.2 QUESTIONI APERTE SULL’IDENTITÀ PROFESSIONALE DELLE POLIZIE LOCALI ......................................... 120 7.3 VERSO UN NUOVO PATTO CON LA CITTADINANZA ................................................................................ 123 8. GESTIRE LA DIVERSITÀ ........................................................................................................................... 127 8.1 DIVERSITA’ ............................................................................................................................................... 128 8.2 LA POLIZIA E LA GESTIONE DELLA DIVERSITA’ ......................................................................................... 130 8.2.1 Un sistema organizzativo che si muove nella stessa direzione ........................................................ 132 8.2.2 Due casi a confronto ......................................................................................................................... 133 8.3 GESTIRE LE DIVERSITÀ ............................................................................................................................. 141 8.3.1 Elaborare una dichiarazione d’intenti o un codice etico .................................................................. 141 8.3.2 Preparare il personale a lavorare in un ambiente di lavoro aperto alle diversità............................ 143 8.3.3 Elaborare una procedura trasparente di assunzione del personale e di sviluppo della forza lavoro. ................................................................................................................................................................... 145 8.3.4 Fare della polizia lo specchio della società ....................................................................................... 148 8.3.5 Approntare un sistema per le segnalazioni di reclami, lagnanze, denunce ..................................... 150 8.3.6 Intraprendere iniziative simboliche .................................................................................................. 151 8.3.7 Usare strumenti di marketing per combattere la discriminazione .................................................. 152 8.3.8 Costruire ponti con le comunità ....................................................................................................... 153 9. TRATTARE CASI DI DISCRIMINAZIONE ................................................................................................... 158 9.1 INDICAZIONI PER IL TRATTAMENTO DI EPISODI DI DISCRMINAZIONE RAZZIALE ................................... 159 9.1.1 Definizione di episodio razziale ........................................................................................................ 159 9.1.2 Il sostegno alla vittima ...................................................................................................................... 160 9.2 COME RELAZIONARSI ALLE VITTIME DI EPISODI RAZZIALI ...................................................................... 162 9.2.1 Come comportarsi se protagonista di un episodio di discriminazione è un operatore di Polizia .... 162 9.3 IL COMPORTAMENTO PROFESSIONALE DELL’OPERATORE DI POLIZIA LOCALE ..................................... 163 9.3.1 Standard minimi per la registrazione di episodi razziali ................................................................... 164 10. LAVORARE INSIEME: UNA POSIZIONE CONDIVISA ............................................................................ 166 10.1 COSA PUÒ AGEVOLARE UN’INTERAZIONE PROBLEMATICA .................................................................. 167 10.2 COSA PUÒ COMPLICARE GLI INTERVENTI ............................................................................................. 168 10.3 IN PROSPETTIVA: RISPETTARSI, CONOSCERSI, “LAVORARE INSIEME” .................................................. 169 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................................ 171 APPENDICI ..................................................................................................................................................... 175 6 7 PREFAZIONE On. Cécile Kashetu Kyenge La polizia italiana ha compiuto un profondo percorso di crescita, tuttora in corso, verso una sempre maggiore democratizzazione e apertura alla società che cambia. Molte sono le esperienze che hanno accompagnato questo cammino, per citarne solo alcune, penso ad esempio: all’ingresso delle donne, all’accresciuto grado di istruzione del personale, all’aggiornamento continuo, al contatto con i giovani attraverso i corsi di legalità e ovviamente al glorioso impegno antimafia. Il corpo di polizia ha come prerogativa l’uso legittimo della forza. La forza non è purtroppo espellibile dalla società, ma la differenza tra un uso giusto e un uso ingiusto è ben chiarito da Don Milani. Se la Legge e chi la fa valere costituiscono la forza dei forti allora disuguaglianza e ingiustizie sono destinate a crescere; se invece divengono la forza dei deboli allora si può sperare in una società più equa. Quando il soggetto più vulnerabile – sia esso un malato, un senzatetto o una bambina – avrà la certezza che la sua debolezza potrà essere compensata dalla forza dello Stato, che lo Stato lo saprà difendere anche contro il più ricco, potente e tracotante dei cittadini, allora potremo dire di vivere in una società giusta. Affinché questo fine possa compiutamente realizzarsi occorre che le istituzioni siano in grado di riconoscere e superare i propri limiti, attraverso una formazione approfondita e permanente. A tal riguardo, le forze dell’ordine come e più di altre istituzioni, devono affrontare la sfida della società multiculturale. Il personale di polizia, infatti, si confronta costantemente con immigrati e nuovi cittadini. Li incontra negli Uffici Stranieri delle Questure, talvolta come autori di reato, talvolta come vittime, testimoni o collaboratori di giustizia. Implementare le competenze relazionali multiculturali è dunque un compito ineludibile. Così come è fondamentale imparare a riconoscere, prevenire e correggere le diverse forme di razzismo: quello che avviene tra semplici cittadini, ma pure quello istituzionale che si annida all’interno degli apparati dello Stato. Ciò richiede ad agenti e funzionari – già impegnati in un’attività delicata, rischiosa e carica di responsabilità – un ulteriore sforzo di aggiornamento professionale e di revisione delle procedure e delle prassi operative. Ma è pur vero che l’accrescimento delle capacità permette di svolgere il proprio lavoro con più consapevolezza e soddisfazione. Io credo che descrivere il proprio Paese come un Eden dove tutto è perfetto non è un modo maturo di amarlo, ogni società umana è affetta da limiti ed errori, ma ha la fortuna di essere perfettibile. La forma più saggia di amare e rispettare il proprio Paese, credo sia quella di chi si impegna a migliorare se stesso e le proprie istituzioni, ristabilendo la missione che ne giustifica l’esistenza. Sono certa che questo manuale sosterrà gli uomini e le donne impegnati in polizia ad essere sempre più all’altezza di un mondo complesso e in trasformazione, un mondo in cui la differenza è ricchezza e il pluralismo la linfa della democrazia. On. Cécile Kashetu Kyenge 8 PREFAZIONE Scuola Interregionale di Polizia Locale La Polizia Locale è il principale regolatore della vita quotidiana nello spazio pubblico. Se oggi sempre più spesso si parla dell’ importanza del suo operato, ciò non nasce da un vero cambiamento di funzioni avvenuto nel tempo quanto dalla trasformazione urbana e sociale, rapida e profonda, intervenuta nelle città e nei territori, che rappresentano il contesto operativo della Polizia. In tale scenario complesso, la Polizia Locale svolge un ruolo articolato di monitoraggio e di regolazione di ciò che avviene nello spazio pubblico e, per esercitarlo al meglio, deve essere sempre più qualificata, professionale, attrezzata e deve sapere riconoscere, segnalare ed interpretare i cambiamenti che hanno luogo. Partendo dalla constatazione che la Polizia Locale, a differenza delle forze di Polizia, rappresenta, per il mondo degli stranieri immigrati e degli altri gruppi minoritari a rischio di discriminazione, la manifestazione più immediata e diretta della presenza delle istituzioni locali sul territorio, si sente il bisogno di supportarne l’intervento e la professionalità, adeguandoli ai bisogni di una società plurale e diversificata, cosiddetta “multietnica”. Questo è uno degli obiettivi che si pone, col proprio operato, la Scuola interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, centro di formazione nato nel 2008, allo scopo di sviluppare e progressivamente uniformare il sapere e le competenze specifiche della Polizia Locale. L' esperienza di SIPL nasce dalla volontà di Enti Territoriali impegnati da anni nella promozione e qualificazione di un servizio di Polizia Locale, ispirato ai principi del Codice europeo di etica per la polizia adottato dal Consiglio d'Europa nel 2001 e, in particolare, ai principi di servizio e di prossimità ai cittadini, con l'obiettivo di rispondere più efficacemente alla domanda di sicurezza delle comunità locali. Proprio tale Codice europeo raccomanda che “la Polizia svolga le sue funzioni in maniera equa, ispirata in particolare dai principi di imparzialità e non discriminazione”, a tutela dei diritti di tutti. In questo percorso, si colloca la realizzazione del presente volume, utile per la formazione di Comandanti, Addetti al coordinamento e controllo ed agenti delle Polizie Locali, sul tema della gestione dei rapporti con soggetti appartenenti a gruppi etnici e religiosi minoritari e di nazionalità straniera, che sarà adottato all’interno dei corsi di formazione sulla “gestione delle diversità”, erogati da questa Scuola, ma anche nei percorsi di prima formazione rivolti ad operatori neo-assunti. Ciò allo scopo di favorire la consapevolezza di un necessario impegno contro ogni forma di discriminazione, di fare chiarezza sui principi fondamentali della comunicazione interculturale, di eliminare la riproduzione di quegli atteggiamenti mentali, fondati su pregiudizi e discriminazioni a danno di minoranze o di cittadini, responsabili soltanto di provenire da una nazione altra da quella italiana o di rappresentare una diversità. Dott.ssa Liuba Del Carlo Direttore 9 1. INTRODUZIONE 10 1.1 UNA POLIZIA PER I DIRITTI UMANI Scriviamo questo libro a pochi mesi da un fatto di cronaca la cui notizia, dalla Grecia, ha fatto il giro d’Europa, rafforzando al suo passaggio stereotipi, pregiudizi e discriminazioni assai diffusi contro le persone rom o generalmente identificate in Italia con l’appellativo di “zingari”. Le notizie riportano di una bimbetta bionda quasi certamente rapita, così sospetta la polizia e così riportano i mass-media, da una coppia rom in Grecia. 1In Europa si diffonde una specie d’isteria che affonda le radici in miti medievali e stereotipi razzisti: i rom (gypsy, gitanos, zingari, ecc.) rapiscono i bambini. Come conseguenza, la polizia in Grecia fa irruzione negli insediamenti dei rom; un gruppo di uomini in Serbia cercano di strappare al padre rom una bambina di pelle chiara; le autorità irlandesi allontanano due piccoli biondi con gli occhi blu dalle loro famiglie; in Italia un padre rom è bloccato su un autobus perché tiene per mano una bambina bionda. 2 Immaginiamo ora di camminare con nostra figlia in una strada del centro città quando un poliziotto si avvicina e ci chiede chi è la bambina, sostenendo che non può essere nostra figlia perché non ci somiglia e ci intima di seguirlo in stazione per i controlli. In un attimo la nostra vita prende una piega drammatica che non immaginiamo nemmeno possibile per noi, mentre troviamo questa situazione perfettamente normale e accettabile per un rom, perché, quando si tratta di rom, siamo pronti a credere qualunque cosa. Quando la gente soffre per la crisi economica, quando alcuni politici soffiano sul fuoco dell’odio, si scatenano gli atti di violenza più feroci, specie su quei gruppi oppressi e discriminati perché è permesso fare di loro il capro espiatorio di tutti i problemi della società. Ritorniamo alla nostra storia e alle sue repliche nel resto d’Europa. Dopo qualche verifica si è ovunque accertato che i bambini in questione erano rom e non sequestrati da rom, come riportato nelle accuse iniziali. E’ bastata dunque una sola storia, per la quale è stata poi accertata tutt’altra verità, per umiliare 12 milioni di europei. 3A contraddire lo stereotipo sta il fatto che, mentre non siano stati documentati casi di rom che rapiscono bambini non rom, sono innumerevoli i casi dove i bambini rom sono allontanati dalle loro famiglie. Il Centro Europeo per i Diritti dei Rom (ERRC) riporta che nel 2011 esisteva “una significativa sovra-rappresentazione” di bambini rom nelle istituzioni di cura in Italia, così come in molti Paesi dell’Europa orientale: “I ricercatori e gli attivisti hanno indicato come ragioni per 4 l’allontanamento dei bambini dalle loro famiglie rom alti livelli di pregiudizio e razzismo” . Per dirla con le parole di Sarah Isal: “L’inclusione dei rom in Europa rimarrà impossibile fino a quando l’atteggiamento nei confronti dei rom si fonderà sulla paura e la falsa convinzione della loro inferiorità e alterità, sia essa intesa come biologica o culturale. Dobbiamo impegnarci di più nell’insegnamento della storia e nello smantellare gli insulsi miti delle diverse razze e gerarchia delle razze nell’educazione di 1 15 ottobre 2013: la polizia greca trova nel campo rom di Farsala una bambina bionda con gli occhi azzurri che immediatamente ritiene rapita. I genitori putativi ammettono, dopo diversi interrogatori, di averla ricevuta da una donna bulgara molto povera che non sapeva a chi affidarla e di non averla in alcun modo rapita. La vera madre, Sasha Ruseva, si saprà successivamente, bulgara e residente in Grecia al momento della nascita di Maria, dopo essere ricomparsa a distanza di settimane ed aver confermato la versione dell’”affido informale”, è stata sottoposta al test del DNA che ne ha confermato la maternità. Gli investigatori hanno accertato che Maria era stata venduta dalla famiglia di origine alla coppia rom Salis/Dimopoulou per ottenere i soldi utili a far ritorno in Bulgaria, circa 250 euro. Sono scattate le manette per i genitori putativi con l’accusa di presunto rapimento e falsificazione di documenti, così come è stato confermato l’arresto in Bulgaria per i genitori naturali, accusati di aver venduto la propria figlia. Fonti: Il Fatto Quotidiano online, 24/10/2013 http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/24/grecia-bimba-bionda-trovata-in-campo-rom-trovati-veri-genitori-in-bulgarialavevano-venduta/756004/ e This is Cornwall online, 31/10/2013 http://www.thisiscornwall.co.uk/DNA-tests-confirmMaria-daughter-Bulgarian-woman/story-20013416-detail/story.html#axzz2lqWBCEhy 2 http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2013/11/04/time-to-drop-the-roma-myths/ 3 http://www.fra.europa.eu/en/theme/roma. I dati aggiornati al 2012 forniti dal FRA (Fundamental Rights Agency) indicano che la popolazione rom si assesti sui 10-12 milioni in Europa, dei quali circa 6 milioni all’interno dell’UE. 4 Comunicato stampa ENAR del 29 ottobre 2013. 11 tutta Europa: la storia e la cultura dei rom dovrebbero essere parte di ogni programma scolastico”. 5 Nell’episodio che abbiamo riportato ritroviamo elementi ricorrenti nel processo di criminalizzazione e di oppressione di un gruppo di esseri umani. Questo libro tratta di tutto ciò che può aiutarci a capire perché fatti come questo avvengono e in che modo un operatore di Polizia Locale possa agire rispettando e promuovendo i diritti umani, nel contrasto alle discriminazioni, come forza presente sul territorio che, per tradizione storica e vocazione istituzionale, si pone al diretto servizio delle proprie comunità. In modo coerente con quello stile di prossimità al cittadino che ne caratterizza la missione, essa è infatti tenuta a rilevarne costantemente i bisogni e ad offrire soluzioni ai tanti problemi presenti all’interno della collettività. Alla base di questo testo è la convinzione che la corretta gestione delle diversità è: > vantaggio per tutti. Il rispetto e la valorizzazione delle diversità e l’assenza di discriminazioni beneficiano la società in termini di meno segregazione e ostilità tra gruppi diversi nella popolazione. > compito di tutti. E’ compito di ciascuno di noi contribuire a riportare i conflitti identitari non negoziabili alle vere ragioni dei contrasti che sono invece negoziabili, per ridurre le ostilità, aumentare la coesione sociale e rendere desiderabile la costruzione congiunta della cultura e della società in cui insieme viviamo. > compito speciale delle forze di polizia, che devono contribuire non solo a ridurre e prevenire i crimini ma anche a rafforzare la coesione sociale della e nella comunità umana di riferimento, avendo come guida del proprio agire il rispetto dei diritti umani. > dentro e fuori l’organizzazione di polizia. Non si può assicurare la cura delle diversità e il contrasto alle discriminazioni se non si conduce la stessa battaglia all’interno della polizia, così come si fa per qualunque organizzazione. Gli autori di questo testo condividono l’affermazione del Forum italiano di sicurezza urbana (FISU): La sicurezza ha valore solo se produce maggiore libertà per tutti. 6 1.2 PER CHI E’ QUESTO LIBRO Questo testo è orientato alla costruzione di specifici percorsi di formazione di ufficiali ed operatori di Polizia Locale rispetto al trattamento dei soggetti appartenenti a gruppi etnici minoritari. Esso s’inquadra nel progetto “Contro le discriminazioni, al servizio di una società che cambia: manuale per le Polizie Locali nella società transculturale”, co-finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità, a sostegno dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti, in quanto la gestione delle diversità etno-razziali, che primariamente tratta, è assunta dal manuale come paradigma da allargare ad altri campi di discriminazione e di valorizzazione delle diversità. L’esserci riferiti preferibilmente ai campi di possibile discriminazione per appartenenza etnica o razziale, nazionalità e religione non esclude affatto l’applicazione ad altri campi di molti dei principi e delle azioni qui suggeriti; riferimenti alle discriminazioni per l’orientamento sessuale, di genere e legati alla 5 6 Sarah Isal, Presidente ENAR. Frase riportata nel comunicato stampa ENAR del 29 ottobre 2013. Traduzione nostra. FISU, Nuove politiche per la sicurezza, nuove politiche per le città, Piacenza 9/10 giugno 2005. 12 disabilità sono infatti frequenti nel testo e coerenti con l’“approccio orizzontale” perorato dall’Unione europea, e applicato anche da UNAR 7, per lottare contro tutte le forme di discriminazione. Questo nostro approccio va, inoltre, inserito, nel più ampio principio del rispetto dei diritti umani, ed in particolare della trasparenza e dell’obbligo di rispondere ai fondamenti della democrazia, che va applicato all’intero operato di ogni organizzazione di polizia; l’obiettivo è quello che negli anni a venire non si verifichino più nel nostro Paese non solo le possibili discriminazioni che abbiamo appena indicato ma, più in generale, quegli episodi di violenza e omertà che, anche nel nostro recente passato, hanno colpito individui e gruppi non appartenenti ad alcuna categoria umana a rischio di discriminazione. Nella scrittura del manuale ci siamo ispirati alle strategie di mainstreaming e di gestione delle diversità. Con la prima s’intende che bisogna integrare la lotta al razzismo e alla discriminazione nell’insieme dei settori di attività di polizia, inserendo quindi il tema trattato nel normale lavoro, dalla definizione di policy all’adozione di procedure e pratiche. Con la seconda s’intende riconoscere le differenze e rispettare le identità e le affiliazioni di gruppo di ciascun individuo, senza però ridurlo costantemente a quell’unico tratto che lo unisce ad un gruppo e senza considerarlo rappresentante di quel gruppo. Ancorché l’intento sia stato quello di redigere un testo di utilità pratica, lo stesso non ha la pretesa di essere una raccolta di “ricette” quanto, piuttosto, lo spunto per un’analisi che lascia molte questioni aperte al giudizio professionale dell’operatore responsabile, nel rispetto della libertà di pensiero e di atteggiamento e nel riconoscimento delle difficoltà personali che possono rendere delicati alcuni compiti particolari dell’operatore di polizia. Sebbene il testo, come si è detto, ambisca ad essere uno strumento pratico, utile alla pianificazione e all’impostazione di modalità di lavoro spesso totalmente nuove per gli operatori di polizia, non abbiamo voluto rinunciare a proporre quegli elementi di riflessione teorica che ci sembravano imprescindibili per la comprensione di quanto suggerito nella seconda parte del testo. Siamo inoltre convinti che gli elementi teorico-concettuali contenuti nel testo possano essere particolarmente utili a chi ha compiti di formazione ed aggiornamento del personale. 1.3 PERCHE’ QUESTO LIBRO Negli ultimi trent’anni l’Italia è stata meta di crescenti flussi migratori che ne hanno trasformato profondamente il tessuto sociale. Oggi essa è divenuta, senza alcun dubbio, un Paese multietnico e pluriculturale, per effetto di un processo storico irreversibile che ha tuttavia incontrato non poche resistenze e perplessità. La presenza di cittadini stranieri, depositari di culture e tradizioni diverse, porta, infatti, all’emergere di nuovi bisogni e di nuove occasioni di potenziale conflitto che qualunque servizio di Polizia non può omettere di gestire. Ciò vale in particolar modo per le strutture di Polizia Locale presenti sul territorio che, per tradizione storica e vocazione istituzionale, si pongono al diretto servizio delle proprie comunità di appartenenza.Tanto più per quelle strutture di Polizia Locale che hanno adottato il modello della polizia di prossimità come elemento caratterizzante della propria missione. Al tempo stesso, le Polizie Locali hanno conosciuto negli ultimi dieci anni un graduale aumento del numero e dell’importanza delle proprie funzioni, accompagnato da una parallela esigenza di evoluzione della professionalità degli operatori. Esse si sono chiaramente trasformate in un servizio di Polizia con competenze generali in materia di sicurezza urbana 8 e rappresentano, per il mondo degli stranieri immigrati e degli altri gruppi minoritari a rischio di discriminazione, la manifestazione più immediata e diretta della presenza delle istituzioni locali. Le Polizie Locali, quindi, sono oggi chiamate, più incisivamente che nel passato, ad adeguare alle proprie mutate funzioni la cultura organizzativa e le competenze del personale, in modo coerente con gli 7 Ufficio Nazionale Anti-discriminazione Razziale, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le pari opportunità e l’integrazione. 8 Com’è noto, con l’espressione “sicurezza urbana” si intende ricomprendere comunemente tutta una sfera di fenomeni non strettamente riconducibili al tradizionale concetto di “ordine e sicurezza pubblica”, ma di più ampia portata, che hanno a che fare con la qualità della vita percepita dalla popolazione e che richiedono, oltre alla tradizionale protezione dell’incolumità personale, anche uno sforzo di rassicurazione sociale da parte di tutti gli attori istituzionali territorialmente competenti (Selmini, 2004, pag. 10). 13 obiettivi generali delle proprie strutture: la protezione dei diritti di tutti gli individui, attraverso una gestione dei multiformi conflitti che si producono nelle società contemporanee, una gestione capace di valorizzare le differenze e rispettare le identità presenti all’interno del corpo sociale. L’idea della realizzazione del manuale “Contro le discriminazioni, al servizio di una società che cambia” e della sua adozione all’interno dei corsi di formazione sulla gestione delle diversità erogati dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale alle strutture di Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana è coerente con tale esigenza. Destinatari del manuale sono i responsabili di servizio e delle attività formative delle tre regioni direttamente interessate dal progetto; esso è altresì suscettibile di essere adottato – come modello di riferimento – per analoghi corsi di formazione esistenti in altre regioni italiane. Il progetto interessa, così, tutti coloro cui è affidato il compito di formare, aggiornare, guidare l’agire quotidiano dei propri uomini, orientandolo al rispetto della diversità e alla promozione dell’integrazione, per una Polizia Locale sempre più efficiente, efficace, comunicativa, che rappresenti l’orecchio e la voce delle comunità. In quale altro modo può essere usato il manuale? Non sapremmo dirlo meglio di come lo ha detto un cittadino di origine etnica minoritaria nella sessione plenaria del Tavolo di confronto: Meglio che il manuale vada in giro, nelle scuole di polizia, nelle associazioni, magari si possono organizzare incontri tra polizie municipali e associazioni per la presentazione del libro. Sarebbe di gran lunga più funzionale di un convegno che richiama le stesse persone, poi c’è sempre quello che si porta via una copia del libro che magari poteva servire ad un altro! Cittadino, Tavolo di confronto, sessione plenaria 1.4 LE FONTI Per la redazione del testo ci siamo basati su diverse fonti, prime fra tutte le nostre esperienze di lavoro con la Polizia di Stato italiana e con alcune Polizie municipali del Nord e Centro Italia e il lavoro di formatori per la Scuola Interregionale per le Polizie locali. Abbiamo anche preso parte a progetti transnazionali europei sull’agire della polizia nelle società multiculturali e in progetti contro le discriminazioni negli anni dal 1998 al 2005, occasioni di apprendimento e osservazione fondamentali, che ci hanno offerto la possibilità di conoscere l’operare di almeno undici polizie europee e un ben più nutrito numero di associazioni di contrasto alle discriminazioni. Abbiamo inoltre attinto a ricerche da noi sviluppate all’interno delle rispettive attività professionali e all’ampio materiale disponibile in rete, sia prodotto dalle polizie di altri Stati, dalla Commissione europea e dal Consiglio d’Europa, sia da istituzioni indipendenti dell’Unione europea, come ad esempio l’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA). Una particolare menzione va alle interviste di gruppo che in questo testo sono citate come Tavolo di confronto. Nell’arco di una giornata, tre gruppi (cittadini di origine etnica minoritaria, agenti e dirigenti di polizie locali dalle tre regioni afferenti alla Scuola per un totale di 26 persone), si sono raccolti presso la Scuola, a Modena. I gruppi si sono dapprima incontrati separatamente per due ore e, con l’ausilio di un facilitatore, hanno affrontato alcuni casi di studio da noi preparati, gli stessi per i tre gruppi. Abbiamo quindi riunito la sessione plenaria per il confronto dei diversi punti di vista e per concordare delle conclusioni che in sintesi riportiamo al capitolo 10. Molto di quanto è scritto in questo testo è in piena coerenza con il contenuto emerso da quel tavolo di confronto e, quando le frasi espresse dai partecipanti calavano nella vita e nelle esperienze personali i principi che andavamo enunciando, le abbiamo riportate dandone rilievo. Infine, abbiamo attinto a qualche passaggio del manuale “Il servizio di polizia per una società multiculturale”, adottato nel 2004 dal Ministero dell’Interno per la Polizia di Stato italiana, di cui fummo coautori. Ringraziamo il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per 14 gli Istituti d’Istruzione e l’associazione COSPE per averci permesso di riprendere alcuni temi che avevamo anticipato allora, sia pur più brevemente. Un ringraziamento va anche al professor Gabriele Prati (Università di Bologna) per avere certificato il capitolo su pregiudizi e stereotipi; alla prof. Anna Maria Manganelli Rattazzi (Università di Padova) per l’uso del questionario sui pregiudizi sottili e manifesti; al Gruppo di ricerca FarSiCura dell’Università di Milano-Bicocca (ed in particolare, alla sua coordinatrice, prof.ssa Sonia Stefanizzi), che ha materialmente realizzato tutte le ricerche IReR Lombardia più volte citate nei capitoli sulla sicurezza e sulle polizie locali, e con il quale, oltre ad aver condiviso una lunga e proficua attività di ricerca sul campo, ci lega una comune visione sui temi della sicurezza urbana e della formazione delle forze di polizia; a Leonardo Costa, studente dell’Università di Bologna in tirocinio presso Extrafondente che ha fornito prezioso aiuto nelle traduzioni e nelle ricerche bibliografiche. 1.5 NOTE PER LA LETTURA Sentiamo la necessità di precisare alcune annotazioni sulla terminologia usata. Abbiamo usato la parola discriminazione per lo più associata agli aggettivi razziale e religiosa. Tuttavia, anche quando il termine è usato isolatamente (salvo che non sia diversamente espresso), esso si riferisce, per evitare ripetizioni faticose alla lettura, alla discriminazione in campo razziale, etnico e religioso. Problematico è l’uso di termini come cultura, etnia, etnia minoritaria o minoranza etnica, razza: essi sono usati nel tentativo di identificare la base della discriminazione razziale, soprattutto nella forma del razzismo culturale; sappiamo che gli stessi termini possono risultare inappropriati o offensivi per alcuni. Abbiamo adottato la terminologia di origine etnica minoritaria, certamente di derivazione anglosassone, perché essa rispecchia quella ufficiale degli accordi europei e delle leggi italiane in materia. Sappiamo però che anch’essa può essere contestata e di ciò diamo parzialmente conto nel testo. Purtroppo non esistono termini privi di associazioni o significati di valore e perfino la parola “razza”, anche se ormai inaccettabile come divisione scientificamente fondata degli esseri umani, continua ad avere un significato sociale che si manifesta nel razzismo che rimane da combattere. Può sembrare strano che organizzazioni diverse, comprese le istituzioni internazionali, soprannazionali e nazionali usino la parola “razza”, quando gli stessi biologi da tempo hanno riconosciuto come la divisione degli esseri umani in “razze” non abbia fondamento scientifico. Così come per le organizzazione internazionali, l’eventuale uso della parola “razza” in questo testo non implica l’accettazione di alcuna teoria fondata sull’esistenza di “razze umane”. Usare il termine “razziale” però offre la possibilità di dare un nome, e quindi riconoscere e combattere, la discriminazione che viene operata da alcuni soggetti e organizzazioni nei confronti di altri sulla base dell’appartenenza razziale, permettendoci così d’identificare il razzismo. 15 PARTE PRIMA: CAPIRE 16 2. I DIRITTI UMANI COME FONDAMENTO DELL’AGIRE DI POLIZIA 17 2.1 IL SERVIZIO DI POLIZIA E I DIRITTI UMANI Gli operatori di polizia troppo spesso considerano i diritti umani un ostacolo invece che il fondamento del loro lavoro ma negli ultimi decenni la polizia è sempre più vista come fornitore di servizi per una comunità piuttosto che come un “forza”. Questo cambiamento di visione è intrinseco nel più ampio concetto dello Stato democratico, uno Stato di diritto ispirato dalla prospettiva del rispetto dei diritti umani. Inevitabilmente questa nuova prospettiva allarga i tradizionali obiettivi del mantenimento dell’ordine pubblico e della lotta al crimine a diversi elementi: il ruolo speciale della polizia come esecutore materiale di quel “monopolio dell’uso legittimo della forza” (M. Weber) detenuto dallo Stato; la sua professionalità; la necessità di un’azione rigorosamente mantenuta entro i limiti della legalità; l’obbligo di rispondere delle proprie azioni all’interno del corpo di polizia e all’esterno, non solo nei confronti dei decisori politici ma anche e soprattutto verso le comunità locali dei comuni o delle province in cui esse svolgono il servizio; la trasparenza e la relazione di fiducia con gli individui e le comunità. Uno sguardo ai diritti umani diventa dunque imprescindibile. 2.1.1 Il fondamento giuridico dei diritti umani Il fondamento giuridico per tutta la legislazione sui diritti umani è ancora oggi la ‘Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dall’Assemblea Generale dell’allora nascente Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) il 10 dicembre 1948. Si trattò di un fatto rivoluzionario: per la prima volta veniva scritto un documento che conteneva il “codice etico” di condotta degli uomini a livello mondiale, andando oltre i limiti dei confini statali che caratterizzavano le precedenti carte dei diritti umani (dalla dichiarazione d’indipendenza della Virginia nel 1775 e dalla Rivoluzione francese in poi). La Dichiarazione fu l’atto fondativo del nuovo “diritto internazionale dei diritti umani”, che metteva in discussione il principio tradizionale e assoluto della “non ingerenza” negli affari interni di un altro Stato, operando per la prima volta una limitazione alla sovranità nazionale. L’idea di fissare una carta internazionale dei diritti venne nel corso della seconda guerra mondiale, quando fu evidente la necessità di fondare un nuovo ordine mondiale in cui fossero banditi i massacri e le atrocità delle ultime due guerre. Si ebbero alcune contestazioni nella stesura del testo, contestazioni che venivano soprattutto dai Paesi a maggioranza islamica, guidati da Arabia Saudita e Pakistan, che espressero delle riserve in materia di religione e di vita familiare. Contro la proposta occidentale si schierarono anche i Paesi dell’Europa socialista. La Dichiarazione Universale, concepita all’interno delle dinamiche della guerra fredda, fu alla fine un compromesso fra posizioni diverse che, tuttavia, trovarono un punto d’incontro. Si dovette attendere fino al 1966 perché fossero approvati dalle Nazioni Unite i due “Patti Internazionali”, ovvero il “Patto Internazionale sui diritti civili e politici” e il “Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali”, che dovevano tradurre i principi fondamentali enunciati nella Dichiarazione in norme vincolanti per gli Stati che avevano ratificato il documento. Tutti assieme, con l’aggiunta dei “Protocolli” opzionali ai Patti, formarono la “Carta Internazionale dei Diritti Umani”. Aperti alle ratifiche da parte degli Stati, il Patto sui diritti civili e politici entrò in vigore nel 1973 mentre l’altro entrò in vigore nel 1976. L’Italia ratificò entrambi nel 1978. Il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali estendeva la sfera dei diritti inclusi nella Dichiarazione al diritto alla parità di remunerazione tra uomini e donne, a quello al miglioramento delle proprie condizioni di vita, alla tutela delle lavoratrici madri, alla protezione dei bambini dallo sfruttamento economico e sociale. In seno al Consiglio d’Europa fu elaborata la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 18 novembre 1953. La ratifica italiana avvenne con la legge n. 848 del 1955; essa fu successivamente ratificata (o vi è stata l'adesione) da parte di tutti i 47 Stati membri (al 22 giugno 2007) del Consiglio d'Europa. Ad integrazione della Convenzione furono elaborati alcuni Protocolli aggiuntivi, tra cui il Sesto nel 1983 che prevede l’abolizione della pena di morte. La Convenzione, dopo aver enunciato i diritti fondamentali, istituì la Commissione europea per i diritti umani e la Corte europea per i diritti dell’uomo (Corte EDU) che, assieme al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, hanno il compito di garantire il rispetto dei diritti da essa sanciti. Il 18 dicembre 2000 la Commissione Europea approvò la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che riunisce in un testo unico i diritti enunciati in fonti diverse e aggiorna la precedente Convenzione Europea. Nel preambolo si afferma che i popoli europei hanno deciso di condividere un futuro di pace, fondato sui “valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà”, nonché sui principi di democrazia e dello Stato di diritto. L’articolo 21 (CAPO III-UGUAGLIANZA) impone l’obbligo di non discriminare, vietando qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilità, l'età o l’orientamento sessuale. La “Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli” per un sistema africano di protezione dei diritti umani fu adottata nel quadro dell’“Organizzazione per l’Unità Africana” (OUA) e siglata a Banjul il 10 gennaio 1981. Un’esperienza importante è quella svolta dalla comunità degli Stati arabi, per le specificità culturali che la distinguono dall’esperienza dei Paesi europei. Da un lato, infatti, c’è il giusnaturalismo e la libertà della persona, dall’altro la legge islamica, in cui l’individuo è sottomesso a Dio, da cui ogni cosa dipende. All’interno della Lega degli Stati Arabi nel 1966 fu istituita una Commissione Permanente Araba per i Diritti Umani, che cominciò l’elaborazione di una Carta Araba dei Diritti Umani. Alcuni progetti furono presentati sin dal 1971 ma l’adozione della Carta arrivò solo il 15 settembre 1994. Una volta gettate le basi del diritto internazionale dei diritti umani, l’evoluzione successiva vide un progressivo processo di “specializzazione”, attraverso la stipula di convenzioni e accordi internazionali su singoli diritti, preceduti spesso da dichiarazioni delle Nazioni Unite.Tra le altre, ricordiamo la “Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale” (in vigore dal 1969, con 156 Stati aderenti al 2001, tra cui l’Italia dal 1975); la “Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti”, adottata il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987, che ha istituito il Comitato contro la tortura; la “Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna”, adottata il 18 dicembre 1979 ed entrata in vigore il 3 settembre 1981 (ratificata da 166 Stati al 2001, in Italia dal 1985), la “Convenzione sullo status di rifugiato”, sottoscritta a Ginevra il 25 luglio 1951; la “Convenzione sui diritti dell’Infanzia” (entrata in vigore il 2 settembre 1990, con 191 Stati parte al 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991). L’ampliarsi e storicizzarsi della legislazione in materia di diritti umani nel tempo ha reso meno attuale il tema della pretesa “universalità” di norme che in pratica provenivano da un’unica matrice culturale, come molti hanno criticato in passato. Da un lato ci sono gli universalisti, fautori della tesi della rivoluzionarietà dei diritti umani in quanto nuova etica globale; dall’altro i relativisti, in ambito prevalentemente antropologico, sostenitori della tesi dell’egemonia politico-diplomatica e culturale dell’Occidente nell’elaborazione dei diritti umani. Secondo Antonio Papisca9, il fatto che i diritti umani siano innati e connaturati alla persona, dunque inalienabili e inviolabili come nella tradizione liberale, è un baluardo in difesa degli stessi e della persona contro ogni mutamento storico o politico che possa rimetterli in discussione. Non a caso tra i maggiori critici dell’universalità dei diritti umani ci sono soprattutto Stati autoritari (come Malaysia, Singapore, Emirati Arabi, Cina). Dall’altro lato, un numero crescente di organizzazioni per i diritti umaniasserisce la loro universalità, anche in Asia eAfrica. Se inizialmente la piattaforma dei diritti fu il frutto del lavoro di pochi Stati occidentali, dagli anni ‘60 in poi gli Stati del Sud del mondo sono stati protagonisti della loro evoluzione. Anche la dicotomia del tempo della guerra fredda tra diritti civili e politici contro diritti sociali ed economici si è venuta ricucendo tra gli anni ‘80 e ‘90, quando in varie dichiarazioni si è affermata 9 Antonio Papisca è professore di Tutela internazionale dei diritti umani e di Organizzazione internazionale dei diritti umani e della pace nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Padova. 19 l’indivisibilità dei diritti umani. In altre parole, non era vero che per raggiungere un certo grado di ‘sviluppo’ economico certi Stati erano legittimati ad ignorare o trascurare diritti politici o sociali di libertà e democrazia. Solennemente ciò fu affermato nella Dichiarazione conclusiva della Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna nel 1993. 2.1.2 Il servizio di polizia dalla prospettiva dei diritti umani 10 Come si è detto, anche in Italia, così come in altri Paesi d’Europa, la polizia è sempre più vista come fornitore di un pubblico servizio e come un’organizzazione che difende i diritti umani. Tuttavia gli operatori di polizia faticano a tracciare una linea netta tra il loro doppio obbligo di proteggere e al tempo stesso rispettare i diritti umani. Nell’applicare e difendere i diritti umani, gli operatori di polizia affrontano non poche difficoltà dovendo, in ogni concreta situazione, usare un certo margine di discrezionalità per bilanciare interessi che possono apparire in conflitto tra di loro. L’interferenza della polizia con i diritti umani di una persona ritenuta colpevole di non rispettare la legge deve essere il più possibile limitata, in linea con i principi di necessità e proporzionalità 11; al tempo stesso, la polizia deve fornire protezione efficace a una persona in pericolo. Trovare l’equilibrio tra queste due posizioni provoca certamente un certo grado di stress e tensione agli operatori di polizia nel loro lavoro. Si tratta, nel caso dell’uso della forza, della sfida più alta che un servizio di polizia basato sul rispetto dei diritti umani deve affrontare, ossia la protezione dei diritti umani con i mezzi meno violenti e invasivi possibili. Gli operatori di polizia occupano una posizione speciale nella società democratica perché lo Stato conferisce loro il potere esclusivo di usare la forza contro i cittadini, quando necessario. I diritti umani, però, derivano dall’intrinseca dignità della persona umana e perciò impongono restrizioni importanti sulle azioni di polizia e sull’uso della forza, legandoli strettamente ai principi di legalità, proporzionalità e necessità. I poliziotti devono non solo rispettare i diritti umani ma proteggerli, per esempio arrestando qualcuno per proteggere i diritti umani di altri. E’ proprio questo dovere di protezione dei diritti umani che fa dei diritti umani il fondamento del lavoro di polizia ed il suo obiettivo. Si può ottenere una pace sociale durevole solo a patto che i diritti umani siano rispettati e protetti, perché ciò è nell’interesse di tutti; in questo processo la polizia è un elemento chiave,proprio perché nel rilevare i reati e le azioni illegittime contribuisce a proteggere e a mantenere il rispetto dei diritti umani. E’ forse opportuno richiamare la differente applicazione dei diritti umani agli individui e agli Stati. Da un punto di vista strettamente legale, le violazioni dei diritti umani possono aversi solo a causa di azioni o omissioni verso gli individui. L’azione di una persona contro un’altra, diciamo un omicidio, certamente viola la legge, integrando gli estremi di un crimine, ma non i diritti umani. Insomma, è evidente che l’azione o l’omissione da parte dello Stato che risulti in un omicidio ha conseguenze diverse sul piano dei diritti umani da quelle di un omicidio commesso da un privato cittadino. Questo esempio ci può aiutare a comprendere il ruolo della polizia rispetto ai diritti umani: ci sono più questioni da prendere in considerazione. Un pubblico ufficiale che, in servizio, commettesse un omicidio violerebbe certamente i diritti umani, in quanto non sarebbe stato in grado di onorare l’obbligo dello Stato di rispettare il diritto alla vita. Quando un pubblico ufficiale, come un operatore di polizia municipale, usa la forza al punto da causare un decesso, allo Stato corre obbligo di condurre un’investigazione imparziale e indipendente sull’accaduto. La Corte europea dei diritti umani (ECHR) ha più volte valutato come eccessivo l’uso della forza da parte di pubblici 10 Questo paragrafo è liberamente ispirato al Fundamental rights-based police training. A manual for police trainers, FRA – European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), 2013. 11 I principi di necessità e proporzionalità sono usati per determinare se un’azione che lede i diritti umani sia necessaria per raggiungere un obiettivo e se le misure adottate siano proporzionate all’obiettivo perseguito. In una società democratica certi diritti possono venire limitati solo se esistono effettivamente necessità impellenti. L’idea base di proporzionalità tratta il rapporto tra l’obiettivo da raggiungere e i mezzi impiegati. Insomma, il fine non giustifica i mezzi e diviene fondamentale raggiungere gli obiettivi nel modo meno intrusivo possibile. 20 ufficiali e in violazione dei diritti umani, in quanto non necessaria e sproporzionata 12. Se lo Stato manca nel prendere iniziative appropriate per impedire o prevenire l’omicidio di una persona sottoposta a minaccia di morte, esso viola l’obbligo che impone allo Stato di proteggere il diritto alla vita. Il rispetto dei diritti umani comportadiritti ed obblighi per gli individui e per gli Stati. Mettendo a fuoco il ruolo e i compiti degli operatori di polizia, possiamo raggruppare in sintesi questi quattro punti sui diritti umani: 1. aiutano gli operatori di polizia a decidere cosa è permesso o vietato; 2. forniscono una cornice che conferisce forma alla struttura organizzativa della polizia; 3. precisano i doveri degli operatori di polizia, in quanto rappresentanti dello Stato e delle sue istituzioni, di rispettare e proteggere gli individui; 4. garantiscono che anche gli operatori di polizia sono portatori di diritti. Quantunque le leggi disegnino il quadro e le linee guida per le azioni di polizia, permane sempre una certa discrezionalità e indipendenza di ciascun operatore nello svolgimento del proprio lavoro, in quanto la legge non potrà mai regolare ogni singola situazione nella quale l’operatore possa trovarsi(per esempio quale auto fermare o come rispondere ad un comportamento provocatorio). E’ proprio questo margine di discrezionalità che dà la possibilità all’operatore di adattare la propria risposta ad ogni singolo caso ma, naturalmente,la gestione di questa discrezionalità risulta particolarmente complicata perché, nella maggior parte dei casi, il poliziotto deve agire in condizioni complesse, poco chiare ed emotivamente ansiogene, come per esempio un litigio o una rissa o anche atti più gravi. I poliziotti sono chiamati ad intervenire quando qualcosa è andato storto o c’è un problema e devono prendere delle decisioni immediate, spesso in una manciata di secondi e senza avere potuto studiare il caso e preparare l’azione. Tutto ciò richiede un altissimo senso di responsabilità. Per converso, i dirigenti, i magistrati e la cittadinanza analizzano il caso e il comportamento del poliziotto dopo i fatti, conoscendone già l’esito e con un tempo adeguato a disposizione. Va da sé che si tratta di due prospettive necessariamente differenti e tutti costoro non saranno mai in grado di afferrare la situazione nella sua dinamica in tempo reale. Eppure, è proprio quando si pone mano alla discrezionalità dell’agire di ogni singolo poliziotto, specie in condizioni di particolare stress, che i principi etici e dei diritti umani diventano significativamente rilevanti, non come una necessaria “conoscenza” ma come un atteggiamento interiorizzato. Quando un operatore di polizia arresta un sospettato, egli sta interferendo con il diritto umano di quel sospettato, con la sua libertà personale e con la sicurezza di cui parla l’Art.5 della Convenzione europea sui diritti umani (EHCR). Interferire con quei diritti umani può essere giustificato dalla necessità di proteggere i diritti di altri o di applicare la legge; ma se l’operatore di polizia agisce senza una base legale giustificabile, uno scopo legittimo o non rispetta i principi di necessità e proporzionalità, allora quell’operatore di polizia sta violando il diritto alla libertà di quel sospettato, diritto protetto dall’articolo citato. In queste complesse condizioni, cosa si può fare? In queste pagine vogliamo proporvi alcuni punti che abbiamo selezionato da un documento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e che individua una serie di regole fondamentali per ridurre al minimo l’incertezza del poliziotto nel suo operare e per migliorarne la capacità professionale, con particolare riferimento ai temi trattati in questo testo. La pratica dei Diritti Umani 13 Per tutti gli operatori di polizia 12 Nel caso la forza sia usata per autodifesa, sia appropriata ed in linea con i principi di necessità e opportunità, l’eventuale morte che risultasse non costituirebbe violazione dei diritti umani. 13 Professional Training Series No. 5/Add.3, Human Rights Standards and Practice for the Police, Expanded Pocket Book on Human Rights for the Police. UNITED NATIONS, New York and Geneva, 2004. Pagg. 8 e 9 21 Adottare programmi di addestramento in servizio per poter comprendere meglio i propri poteri legali e le loro limitazioni. Ricordarsi che “l’obbedienza agli ordini dei superiori” non può essere una giustificazione per violazioni dei diritti umani come l’uccisione illegittima e la tortura. Conoscere bene le procedure interne ed esterne per segnalazioni e reclami. Riportare violazioni della legge e dei diritti umani. Conoscere la comunità che si serve. Incontrate i rappresentanti ed i leader delle varie comunità etniche e razziali. Prendere parte a pattugliamenti a piedi ed attività di servizio alla comunità nei quartieri ad alta concentrazione di persone di origine etnica straniera. Prendere posizione contro gli stereotipi etnici o razziali e contro gli oltraggi perpetrati nella comunità e all’interno della stazione di polizia. Partecipare a programmi di addestramento sulle relazioni etniche, offerti dal vostro servizio. Parlare coi membri dei gruppi minoritari all’interno delle comunità che servite per comprendere i loro bisogni, le loro lamentele e i suggerimenti. Siate sensibili e pronti a rispondere. Per comandanti e supervisori Organizzare formazione in servizio per sensibilizzare i poliziotti all’importanza delle buone relazioni etniche/razziali e a un servizio di polizia equo e non discriminatorio. Sviluppare un piano d’azione riguardo le relazioni etniche, in consultazione con le varie comunità etniche. Emettere ordini chiari riguardo a comportamenti linguaggio e atteggiamento appropriati a persone di diversa provenienza. Valutare le politiche di selezione, assunzione e promozioni per assicurare equità tra i vari gruppi. Reclutare attivamentemembri appartenenti a minoranze etniche o razziali e appartenenti ai gruppi sottorappresentati nel vostro servizio di polizia. Stabilire meccanismi per ricevere, regolarmente, i reclami e i suggerimenti dei membri dei gruppi etnici, razziali, religiosi e linguistici della comunità. Adottare strategie di polizia di prossimità. Incaricare un coordinatore per le relazioni con le minoranze. Punire i comportamenti discriminatori, insensibili o comunque professionalmente inappropriati. Premiare gli agenti per le iniziative di supporto alle relazioni di comunità. Riprenderemo e approfondiremo molti di questi punti nei capitoli che seguono. 22 3. PREGIUDIZI E STEREOTIPI 23 3.1 COSA SONO PREGIUDIZI E STEREOTIPI “Se per dialogare con un senegalese o un cinese, devo passare al vaglio quello che so sulla cosiddetta cultura cinese o senegalese (o, peggio, affidarmi a un mediatore culturale, usandolo come fornitore di schemi) e poi, da lì, discendere attraverso una serie di categorizzazioni minori (età, scolarizzazione, tempo di migrazione, etc.) o maggiori (genere, condizione sociale, religione) a mettere a fuoco l’individuo che ho davanti, quante energie mi rimarranno per accettare la sua nuda presenza e le sue parole, la sua capacità di spiazzarmi e di stupirmi perché straniero (lui) e non vittima di pregiudizi (io)? Sarà più sano, adeguato, efficace, un atteggiamento di ascolto non viziato dal presupposto della sua appartenenza. Giuseppe Faso, Centro Interculturale empolese-valdelsa Il pregiudizio è un giudizio, o opinione, aprioristico, cioè espresso prima di avere avuto esperienza o conoscenza, in genere con connotazione negativa, verso persone, gruppi o altri oggetti sociali salienti. Secondo quanto riportato da Mazzara 14, lo stile cognitivo tipico della personalità con pregiudizi è stato individuato dai ricercatori in una chiara tendenza a pensare per stereotipi, in quanto basata sulla conoscenza rigida e valutativa delle differenze etnico-razziali ma potremmo dire di qualunque differenza ascritta ad un gruppo, come per esempio le donne, le persone omosessuali, le persone disabili o, persino, i poliziotti. Mazzara definisce questo fenomeno “accentuazione percettiva”. Secondo lo psicologo, si ha la tendenza a percepire oggetti o individui di una stessa categoria come più simili tra loro di quanto non siano nella realtà e a percepire, invece, oggetti e individui appartenenti a categorie diverse molto più dissimili di quanto non siano. Si crea in questo modo un legame automatico fra l’appartenenza ad un gruppo e il possesso di determinati tratti. Mazzara ci ricorda inoltre che tale legame, ammesso che esista, è di tipo probabilistico: i tratti, anche quelli che consideriamo tipici del gruppo, non sono mai distribuiti in maniera omogenea all’interno del gruppo stesso. I pregiudizi sono dunque giudizi che ci facciamo su altri senza conoscerli e, poiché appresi come parte del processo d’inculturazione 15, sono molto resistenti. Il pregiudizio etnico è la predisposizione a percepire, giudicare, agire in maniera sfavorevole nei confronti di appartenenti a gruppi etnici diversi dal proprio. Lo stereotipo è l’immagine semplificata di una categoria di persone o di un evento, condivisa nei tratti essenziali da molte persone. Secondo teorie di stampo psico-sociale, lo stereotipo è una forma di organizzazione preventiva dei dati necessaria alla conoscenza di una realtà che, a causa della sua estrema complessità, non può essere conosciuta in quanto tale ma solo attraverso dei processi di semplificazione e di organizzazione delle conoscenze. La categorizzazione è il principale di questi meccanismi e avviene raggruppando stimoli ed eventi in insiemi il più possibile omogenei. Una volta formati, tali insiemi tendono a permanere immutati anche di fronte ad esperienze diverse, in questo modo condizionando a loro volta i processi cognitivi di percezione ed elaborazione dei dati della realtà. L’altro processo che entra in gioco nella formazione degli stereotipi è la generalizzazione, cioè la tendenza costante della mente umana ad estendere ad ampie serie di eventi le osservazioni effettuate sui pochi eventi disponibili. Dalla combinazione di categorizzazione e generalizzazione nasce lo stereotipo, ossia una combinazione di immagini rigide, valutazioni e aspettative che si ascrivono ad una categoria per descriverla e per giustificare il nostro comportamento. Attraverso l’assegnazione di nomi e il loro raggruppamento in categorie, gli esseri umani ordinano il loro mondo fisico e sociale, e proprio le categorie ci servono per mettere in 14 Mazzara, B. M. Stereotipi e pregiudizi. Bologna, Il Mulino, 1997. “Inculturazione: nelle scienze umane, assimilazione della cultura d’appartenenza durante il processo di socializzazione (o fase infantile del processo d’integrazione sociale) dell’individuo.” (Enciclopedia Treccani). Si distingue dal processo di acculturazione che è “processo di interazione tra due o più gruppi che hanno culture differenti” (Gallino L., Dizionario di sociologia”). 15 24 evidenza analogie e differenze. L’attribuire ad una categoria cose, eventi, persone, ci permette di trattarle allo stesso modo anche se non le conosciamo per esperienza diretta. Non è questa l’unica natura che si riconosce allo stereotipo; molti vi riconoscono un’origine sociale, in quanto derivato essenzialmente dal contesto culturale, economico e politico dove svolge l’importante funzione di spiegare e razionalizzare l’organizzazione esistente: lo status dei gruppi, le dinamiche di maggioranza e minoranza, la distribuzione sociale delle risorse, i processi di produzione e trasmissione della cultura e delle ideologie sociali. Esso è, in concreto, ciò che attiva le dinamiche psico-sociali di differenziazione e di disuguaglianza di potere. Le teorie di stampo sociale trovano che questi elementi siano determinanti e che, dunque, lo stereotipo non sia, o non sia soltanto, l’effetto di un’errata procedura cognitiva ma piuttosto il risultato del contesto nel quale avviene la definizione dell’identità. Qualunque sia l’origine che si riconosce agli stereotipi, è opportuno avere chiaro che il pregiudizio deriva dallo stereotipo che ne è il “nucleo cognitivo”, cioè “quell’insieme di elementi di informazioni che vengono rielaborati in un’immagine coerente in grado di sostenere e riprodurre il pregiudizio” (Mazzara, 1997). Sarà d’altronde facile per chiunque comprendere che nessuno nasce con una dotazione di pregiudizi: un neonato non ha e non può avere alcun pregiudizio sulle donne o sulle persone omosessuali e così via; li apprenderà in famiglia, a scuola, nel gruppo religioso, dagli amici e in tutti i contesti di socializzazione in una scala di ampiezza che arriva ai mezzi di comunicazione di massa e al discorso politico. Gli stereotipi sono socialmente condivisi e la capacità di creare stereotipi riflette il potere culturale e sociale di un gruppo su un altro gruppo. Certamente gli stereotipi fanno parte della vita quotidiana, tanto che ognuno di noi può riconoscere in questa breve lista degli stereotipi che forse condivide, più o meno consapevolmente o con convinzione: “le donne non sanno guidare” “gli italiani sono passionali” “gli ingegneri sono razionali” “gli inglesi sono freddi” “gli omosessuali sono creativi” Gli stereotipi non sono tutti negativi e infatti la letteratura ne distingue quattro tipologie che esemplifichiamo alla figura che segue. POSITIVI E ACCURATI POSITIVI E INACCURATI Le donne sono più prudenti degli uomini alla guida. Vero come è dimostrato dal fatto che alcune agenzie di assicurazione hanno proposto premi meno onerosi per le donne. Gli omosessuali (maschi) sono tutti artisti. Falso la maggior parte degli uomini omosessuali lavora in ogni settore delle attività produttive, dall’informatica, alla sociologia, all’insegnamento. NEGATIVI E ACCURATI NEGATIVI E INACCURATI Gli uomini commettonoun numero maggiore di crimini rispetto alle donne. Vero Secondo i dati Istat del 2011: numero di crimini denunciati alle forze di Polizia totale 901.008, di cui maschi 735.937 (81,7%) e femmine 165.071 (18,3%). Gli immigrati delinquono molto di più degli italiani. Falso Controllare al capitolo 6.2 25 3.1.1 Quando ci accorgiamo della loro esistenza? Non stupirà sapere che dei giudizi basati su stereotipi ci accorgiamo più facilmente quando questi riguardano il nostro gruppo di appartenenza e hanno valenza negativa. Se qualcuno dicesse: “I vigili sanno solo fare le multe ma non ci sono mai quando uno ne ha bisogno”, probabilmente vi sentireste offesi, umiliati e certamente riconoscereste un giudizio stereotipato. Quando qualcuno dicesse invece: “gli operatori di polizia municipale sono professionalmente molto preparati e onesti”, vi farebbe certamente piacere e vi ci vorrebbe qualche minuto in più per capire che anche questa, seppur positiva, è una visione stereotipata degli operatori di polizia locale. Come dicevamo, gli stereotipi sono veicolati e amplificati dai mezzi di comunicazione di massa (giornali, televisione, internet) e dalle interazioni sociali, per es. quelle che avvengono nei gruppi di appartenenza (gruppo sportivo, culturale, politico, ecc.). Dall’interazione diretta, al contrario, ci si può aspettare con maggiore probabilità una diminuzione del pregiudizio, come confermano centinaia di studi sperimentali 16. Bisogna però osservare delle condizioni che favoriscono la prevenzione o la riduzione del pregiudizio nel contatto tra i gruppi (Arcuri e Cadinu, 1998). Esse sono: il sostegno sociale e istituzionale il contatto intimo piuttosto che superficiale l’uguaglianza di status nell’interazione la cooperazione al fine di raggiungere uno scopo comune la piacevolezza del contatto. Ecco di seguito alcuni esempi di stereotipi molto diffusi che si dissolvono appena si approfondisce il tema. Generalmente, quel che si dice o pensa delle donne musulmane (anche di quelle che vivono in Europa) quando le si vede aggirarsi nelle città italiane con un abbigliamento riconoscibile e con le varie forme di velo sulla testa o anche a coprire tutto o una parte del volto, è che “sono succubi di una cultura misogina”, “non si vestono così volontariamente” e, a chiosa, “Ecco come sono le donne musulmane. Ecco come sono i musulmani”. A questo proposito, un interessante studio è stato condotto, per conto della King Baudouin Foundation 17, in diverse città europee con un’ampia concentrazione di donne musulmane (tra cui Torino per l’Italia), su donne musulmane con diversa nazionalità di provenienza per capire che ruolo giocasse la religione islamica nel definire le esperienze delle donne musulmane europee. La ricerca svela un quadro in cui le donne musulmane si dipingono con grande varietà, legata alla loro educazione e scolarità, classe sociale, età, condizione maritale, presenza o assenza di una famiglia estesa. Insomma un quadro molto variegato, complesso e fluido, dove diversi comportamenti, spesso di segno opposto, convivono. Pur nella varietà, queste donne hanno alcuni punti fermi: Amano e seguono la religione liberamente, vista come “fonte razionale di moralità personale che l’individuo è libero di seguire” e non si sentono affatto sottomesse alla loro fede. Sono contro le imposizioni “etniche” e non religiose di quelle comunità o leader religiosi che “sfruttano” l’Islam per imporre, appunto, norme di condotta ingiustificatamente rigorose. Si sentono discriminate dove e quando non è loro permesso di praticare la loro fede come vorrebbero o quando sono rappresentate erroneamente come sottomesse all’Islam. Ritengono che il loro successo nella vita dipenda dalla conoscenza della lingua del Paese di residenza e dalle opportunità di lavoro. Sono contente di trovarsi in Europa perché qui vige un sistema di libertà, di governo secondo la legge, di rispetto delle diversità e delle pari opportunità. 16 Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of personality and social psychology, 90(5), 751. 17 Silvestri S. (City University London and Cambridge University), Europe’s Muslim women: potential, aspirations and challaenges. King Baudouin Foundation, Nov. 2008. 26 Per il resto, come scrive l’autrice della ricerca, i loro Ecco invece un esempio di stereotipo lento a morire: i cinesi desideri per il proprio futuro e per fingono di non capire ma capiscono benissimo quel che serve! le future generazioni sono “sorprendentemente normali”: i La comunicazione è importante. I cinesi non vengono dalla stessa loro sogni sono di essere rispettate città o regione. Anche all’interno delle comunità cinesi ci sono come individui, di vivere in pace situazioni di sfruttamento che la gente subisce e non vorrebbe ma nel quadro della legalità, di devono fare i sacrifici nel laboratorio per pagare 13.000 euro. ricevere una buona formazione, di Bisogna considerare le enormi difficoltà della lingua. Io, per avere un lavoro dignitoso, una esempio, ho fatto il mediatore e interprete in sanità e vi assicuro famiglia felice. Lo studio conclude che ho avuto serie difficoltà a capire e farmi capire dal malato con la seguente considerazione: cinese. Dovete considerare che i cinesi vengono dalle parti più “alcune situazioni drammatiche disparate della Cina e parlano lingue diverse, spesso vengono che coinvolgono donne dalla campagna e non hanno studiato. Sicché mi capita di dovere musulmane, così come le tensioni parlare di tiroide con il malato, io dico “tiroide” in cinese ma che vediamo tra comunità quello non capisce. Non vi dico poi quando si tratta di problemi musulmane in Europa e tra queste ginecologici…. Capisco ancora meno. Per questo anche i poliziotti e le comunità di origine autoctona, devono comprendere che è bene fare un po’ di formazione per loro sono molto più probabilmente la (per i cinesi, ndr). conseguenza di conflitti Cittadino, Tavolo di confronto 1 intergenerazionali che riguardano il processo sfaccettato di emancipazione piuttosto che il risultato di un progetto fondamentalista di islamizzazione pan-europeo”. 18 I risultati di questo studio ci allertano, tra l’altro, circa un fenomeno oggi diffuso, descritto e studiato da molti autori e che, con le parole del sociologo Marco Aime, chiameremo “eccessi di culture” 19. Una forma di “fondamentalismo culturale” 20 che serve la retorica dell’esclusione nell’Europa contemporanea, secondo il quale gli esseri umani sono per natura portatori di culture distinte e incommensurabili e i rapporti fra portatori di culture differenti sono intrinsecamente conflittuali (il tema è approfondito al cap. 4). E’ ciò che, per esempio, ci fa spiegare come un fatto culturale il conflitto tra un’adolescente di origine marocchina che vuole restare fuori la sera fino a tardi, truccarsi mettendosi un rossetto pesante e suo padre che vi si oppone; agli occhi di molti italiani esso appare immediatamente come uno scontro tipicamente marocchino (o musulmano) mentre, come suggerisce Marie Rose Moro 21, è più tipicamente lo scontro di un’adolescente che vuole maggiore libertà e di un padre che teme per lei. Qualcosa che ci accomuna, piuttosto che dividerci! I nostri giudizi e le giustificazioni che ne diamo sono fortemente influenzati dal nostro etnocentrismo: ciò significa che siamo convinti che la nostra risposta al mondo – la nostra cultura – è quella giusta, gli altri sbagliano o “non sono normali”. Ci sembra che i nostri valori Ho rapporti con la stampa, ci vado ogni e il nostro modo di vivere siano universali e corretti per settimana, io non sto zitto …. però noi tutti, gli “altri” non capiscono questa ovvietà. Il semplice sinti siamo dal 1420 che siamo in Italia contatto con persone appartenenti ad altre culture può ma c’è sempre la mentalità che gli addirittura rafforzare i nostri pregiudizi, tanto gli occhiali del zingari rubano i bambini. La stampa dà nostro etnocentrismo ci rendono ciechi a tutto tranne a sempre la colpa agli zingari. Ci possono quello che vogliamo vedere. gettare delle bombe ma l’opinione Ricordiamo però che la dimensione collettiva, pubblica non dice nulla. ideologica, istituzionale che gli stereotipi spesso assumono Cittadino, Tavolo di confronto 1. rende inadeguato un approccio puramente individuale a 18 Op. cit., pag.6. Nostra traduzione. Aime M., Eccessi di culture, Giulio Einaudi editore, Torino, 2004. 20 Secondo la definizione di Verena Stolcke, cit. in Aime M. “Eccessi di culture”, pag.17 21 Professore di Psichiatria del bambino e dell’adolescente presso l’Università Paris Descart; dal 2001, Dirigente il Servizio di Psichiatria del bambino e dell’adolescente dell’Ospedale Avicenne (Bobigny), Francia. Atti della conferenza “Famiglie migranti e stili genitoriali” promossa dall’Istituzione G. Minguzzi per il Servizio Sicurezza sociale e sanità della Provincia di Bologna. 19 27 questi fenomeni. Citando Mantovani: “I nazisti non erano persone che avessero, ciascuna per conto proprio, maturato un personale astio contro gli ebrei. Essi erano invece membri a pieno diritto di un’illustre cultura europea- trasmessa da famiglie, scuole, chiese, partiti, giornali e storielle sugli ebrei – che portava in sé, nella sua storia, alcuni dei germi di quella violenza” 22. Ogni tanto, fortunatamente, alcuni articoli di stampa possono invece servire a sfatare stereotipi talmente radicati da esser divenuti vere e proprie leggende metropolitane, come il mistero legato ai funerali dei cinesi: Muoiono anche loro come noi. Anche loro vengono sepolti nei cimiteri comuni, nelle fosse oppure negli ossari e nei loculi. Per alcuni si celebra un funerale secondo le regole occidentali, per altri invece i parenti preferiscono rispettare la tradizione che in Cina viene chiamata “festa bianca”. Le voci italiane e straniere che fanno degli immigrati cinesi degli immortali sono più che altro una leggenda metropolitana. Partita da Parigi negli anni 70, dove la presenza della comunità asiatica era ed è tuttora particolarmente significativa, la storia del popolo che non muore mai arriva fino all’Italia, passando per la Germania, i Paesi Bassi e San Francisco. La considerazione da cui si parte è sempre la stessa: ma perché non si vede mai un funerale cinese? Che fine fanno i corpi dei defunti? E le supposizioni non fanno che alimentare il mistero. [...] Marie Holzman, scrittrice e sinologa nel suo libro Asia a Parigi (1985) si domanda ironicamente se i cinesi non abbiano raggiunto l’immortalità perché cresciuti a riso e ginseng, e sostiene (e qui senza scherzi) l’ipotesi del passaggio di documenti dei deceduti per l’ingresso illegale di altri connazionali. Le autorità parigine prendono sul serio la signora Holzman e aprono un’inchiesta. Il risultato dà torto alla studiosa: il tasso di mortalità cinese a Parigi risulta così basso perché il 71% della popolazione immigrata nella città è sotto i 35 anni e solo il 3% raggiunge i 65 anni. Le voci però non si fermano e arrivano in Italia. A Torino nell’agosto del 2000 viene presentata un’interpellanza dal consigliere comunale Giuliana Gabri che invita il sindaco e l’assessore della città ad avviare un’indagine sulla mancanza di decessi di persone di nazionalità cinese. A Milano, sul quotidiano La Padania del 25 settembre 2002 c’è scritto che il capogruppo del consiglio comunale e segretario provinciale Matteo Salvini ha sollecitato Prefettura e Questura a tenere sotto controllo le nascite e i morti della comunità di Chinatown. […] «Si deve sfatare questo mito dei cinesi che non muoiono mai, spiega Daniele Cologna, ricercatore dell’area immigrazione straniera presso il Centro Studi Ricerca Synergia di Milano. È una questione che non ha fondamento. Non c’è nessuna ragione perché ci si ponga il problema solo per loro e non per gli altri immigrati. Si devono guardare i dati statistici sui residenti della città di Milano». Ed effettivamente, le tabelle dell’ufficio anagrafe milanese parlano chiaro. Secondo un esame dell’evoluzione demografica dal 1997 al 2001 dei residenti filippini, egiziani e cinesi a Milano, non c’è alcuna differenza di rilievo nella mortalità di questi tre gruppi (nazionali di immigrati). Il tasso medio di mortalità per mille abitanti tra cinesi e filippini è identico (0,6‰) e quello degli egiziani si discosta di poco (0,8‰). «La ragione sta nel fatto che la maggior parte degli immigrati cinesi sono molto giovani – continua Cologna -. Il boom del fenomeno migratorio verso l’Italia è avvenuto negli anni 80 quindi è ragionevole pensare che non ci siano stati ancora così tanti decessi». Delle tre popolazioni, egiziana, filippina e cinese, quest’ultima è nettamente la più giovane. I dati relativi a Milano al 31.12.2002 indicano che il 28% degli immigrati cinesi su un totale di 10.919 ha meno di 17 anni. Questo significa che più di un cinese su tre residente a Milano è minorenne. Ma la storia non finisce qui. Quanti sostengono di non aver mai visto una lapide di un cinese nella nostra città non hanno forse sfruttato a pieno le potenzialità della tecnologia. La ricerca per Milano è piuttosto semplice. Basta recarsi in un cimitero, digitare un cognome come Cheng o Chu sul computer d’accoglienza per trovarne parecchi. Tumulati e sepolti, nelle nostre stesse cellette. […] In realtà, i cinesi non amano questo rituale [della cremazione] e preferiscono un funerale ‘normale’ in abito scuro con tanto di prete, bara, cerimonia e cimitero. Proprio come noi. E che riposino in pace. Giulia Guerri, articolo di stampa “Abbiamo scoperto dove vengono sepolti i cinesi che vivono a terni e in altre localita’ italiane”, Terni Magazine, 20/11/2009. 22 Mantovani G., op. cit., p. 37 28 3.1.2 Per una razionale difesa dalla tentazione di usare stereotipi Proponiamo ora un elenco di ragioni che devono trattenerci dall’usare pregiudizi e stereotipi, ragioni che, pur valendo per chiunque, assumono importanza particolare per l’agire professionale di operatori di polizia che rischiano, applicando veri e propri stereotipi piuttosto che il “ragionevole sospetto”, di cadere nella trappola del “profilo etnico” di cui trattiamo diffusamente al cap.6.3. Anche abbracciando la definizione degli stereotipi come il risultato di una pigrizia mentale, un meccanismo di economia delle risorse di cui disponiamo per conoscere il mondo, dobbiamo però essere consapevoli che essi sono uno strumento conoscitivo altamente imperfetto, in troppi casi fuorviante e spesso strumento di oppressione. Occorre infatti ricordare che pregiudizi e stereotipi: non sono da noi creati personalmente ma sono appresi dall’ambiente, dalle tradizioni e da tutto ciò che ci rimanda ad una cornice culturale che provvede a fornire di senso ciò che incontriamo sulla nostra strada. Ciò che vogliamo dire è che, come conseguenza, il razzismo non nasce solo da un atteggiamento mentale di una data persona ma esso è nutrito, anche nell’inconsapevolezza della persona stessa, da una cultura che, attraverso una religione, una legge dello Stato o una convinzione morale condivisa e rispettata, consegna al singolo individuo ciò che può apparire come un “semplice”, personale pregiudizio. Sappiamo invece che arrivano da lontano i pregiudizi, come quelli nefasti nei confronti degli ebrei (l’Europa cristiana medievale e moderna), dei neri africani schiavizzati nel nuovo mondo da conquistatori della vecchia Europa, degli italiani del Sud immigrati nelle regioni settentrionali per cercare lavoro e via elencando. A conferma della dipendenza degli stereotipi (e, dunque, dei pregiudizi) da una cultura e da una divisione delle persone tra gruppi con potere diseguale, è interessante sapere che, sebbene rigidi finché resistono, essi cambiano nel tempo col cambiare delle condizioni storico-politiche. Lo dimostrarono le prime ricerche condotte negli USA nel 1951 circa gli stereotipi che descrivevano i giapponesi e i tedeschi (nemici fino a poco tempo prima nella seconda guerra mondiale); questi stereotipi avevano connotazioni estremamente negative e ostili mentre, col passare degli anni, al ripetersi del sondaggio, emergevano caratteristiche come l’industriosità e l’intelligenza di quei due popoli. tendono a funzionare in modo inconsapevole, tanto da divenire generalizzazioni che non ammettono smentita. Di fronte alla prova del contrario scopriamo le “eccezioni”: quando la realtà non corrisponde al nostro pregiudizio è più facile per noi cambiare la nostra interpretazione della realtà piuttosto che cambiare il pregiudizio. tendono ad essere rigidi e attivano una percezione selettiva delle informazioni, tale da influire sulle attese per il futuro (aspettative) e sul ricordo del passato. Per esempio, dovendo incontrare un cittadino rumeno potrei aspettarmi che sia aggressivo e pericoloso perché, tra le notizie di rapine in banca lette in passato sul giornale, mi ricordo solo quelle in cui si parlava di “bande di rumeni”. attivano il meccanismo della “profezia che si autoadempie” (R.K. Merton): le aspettative sugli altri portano indirettamente l’altro ad agire in modo coerente con le nostre aspettative. Pensiamo al caso in cui si diffondessero delle voci infondate circa l’imminente fallimento di un istituto bancario. Molti dei correntisti si precipiterebbero a chiudere i loro conti correnti presso l’istituto e, con il loro comportamento, creerebbero le condizioni perché l’istituto possa effettivamente fallire. sono ostacoli alla comunicazione per più ragioni: predispongono le persone a percezioni e giudizi parziali; interferiscono con la capacità di cogliere l’individualità dell’interlocutore; rendono difficile stabilire un rapporto basato sulla fiducia; incrementano la tendenza a recepire solo quelle informazioni che confermano il proprio punto di vista. a volte essi generano un fastidio che non dipende dal contenuto negativo dello stereotipo ma dal fatto che le persone inquestione si sentono oggetto di una generalizzazione invece di sentirsi considerate come individui; il fatto che alcuni individui corrispondano ad alcuni stereotipi non vuol dire che questi siano ‘veri’ per tutti i membri di un dato gruppo. 29 Sono intervenuto in un capannone, situato in una brutta zona di Bologna, ci hanno chiamati per un sospetto di lavoro in nero, ma per fortuna non minorile. All’interno del capannone si trovavano 10 persone, ognuna davanti a una macchina da lavoro; il titolare era un ragazzo molto giovane. Iniziamo il controllo chiedendo i documenti e da subito sono stati tutti gentilissimi, anche se la difficoltà principale era comunicare. Il controllo amministrativo ebbe esito negativo, erano tutti in regola e ognuno possedeva il proprio visto. Il gruppo di cinesi aveva in subappalto la produzione di borse di un marchio grosso della moda. Quando sono intervenuto, avevo paura che scappassero, ma per fortuna non è stato così. Ci hanno detto che la ditta madre fa controlli su tutto ogni settimana, per questo anche i bagni e l’igiene erano perfetti. I cinesi credevano che fossimo dei responsabili dell’azienda (non dei poliziotti) perché eravamo in borghese.Certe cose stanno cambiando, non sempre è veritiero lo stereotipo dei cinesi clandestini o dei cinesi che sfruttano il lavoro minorile. Operatore di polizia, Tavolo di confronto 2. 3.2 PREGIUDIZIO MANIFESTO E SOTTILE Grazie ad alcuni studi si è potuta confermare l’esistenza di forme, per così dire, «tradizionali» di pregiudizio e forme di cosiddetto «razzismo moderno» (Pettigrew, 1997), dove i pregiudizi rimangono anche se non vengono espressi apertamente. Si evita l’espressione manifesta dei sentimenti negativi verso chi è fuori dal proprio gruppo, ritenendo se stessi dei democratici e progressisti, politicamente corretti. Nel modello di Pettigrew, le espressioni di ostilità verso le minoranze nella vita sociale si esprimono attraverso: il pregiudizio manifesto o diretto (caldo, controllabile e intenzionale), che consiste sia in atteggiamenti di rifiuto dei membri di un gruppo a cui non apparteniamo e che percepiamo come una potenziale minaccia, sia nell’opposizione ad instaurare con loro contatti intimi. Le posizioni si manifestano nelle espressioni ostili “noi” e “loro”: la “nostra” cultura, i “nostri” valori, la “nostra” religione sono messi in pericolo dalla “loro” cultura, dai “loro” valori e dalla “loro” religione; il pregiudizio latente: coloro che mostrano pregiudizi latenti si trovano in una situazione di conflitto fra la tendenza a favorire il gruppo di cui fanno parte (frutto di processi cognitivi e motivazionali normali) che si esprime nel parlare di noi in modo positivo e di loro in modo negativo (noi non uccidiamo, paghiamo le tasse anche per loro, abbiamo valori e norme civili, portiamo la democrazia, ecc.) e il desiderio di essere egalitari che deriva invece dall’avere interiorizzato le norme di equità sociale. Nei comportamenti e nelle affermazioni di queste persone è possibile cogliere tale ambivalenza interiore; il pregiudizio sottile che esprime un atteggiamento negativo, spesso inconsapevole, che si manifesta in modi socialmente accettabili; può essere avvicinato al «razzismo moderno», in quanto implica una difesa dei valori individualistici, tipici delle culture occidentali, unita alla credenza che i gruppi minoritari beneficino di favori. Ne è un esempio questa frase: "Io rispetto ogni scelta legittima e lecita della persona ma credo che nell'ambito di una struttura come l'esercito, dove le attività si svolgono sempre insieme, sia opportuno non dichiarare ed evidenziare la propria omosessualità”. Oppure: "Anche nella mia carriera mi sono imbattuto in episodi di omosessualità e ho fatto in modo che certe situazioni incresciose non si verificassero di nuovo, e che chi ne era coinvolto venisse ricollocato ed impiegato in altre aree". Il questionario messo a punto da Pettigrew fu applicato anche in Italia in una ricerca coordinata da Anna Maria Manganelli Rattazzi 23nel 1997. La ricerca permise di descriverne i risultati identificando tre tipologie di portatori di pregiudizi: fanatici, egalitari (o democratici),sottili. 23 Professore ordinario di psicologia presso l’Università di Padova. 30 Vi invitiamo a rispondere al questionario che, per gentile concessione degli autori, è riportato in appendice e a valutare “senza pregiudizi” la vostra appartenenza ad una delle tre categorie. Per chi ha responsabilità di assicurare che il personale di polizia non subisca il fascino dello stereotipo nel proprio agire professionale è utile ripetere, in conclusione, che: l’identità di ciascuna persona è multipla; non è composta da un solo tratto ma da diversi elementi; non è possibile prevedere cosa farà una persona prendendo a riferimento un solo tratto della sua personalità. E’ anche utile sapere che gli stereotipi producono effetti sulle persone stereotipizzate, tra cui questi: qualunque fallimento può essere visto come una conferma dello stereotipo; un fallimento si riflette su tutto il gruppo, non solo sull’individuo interessato; i punti precedenti producono ansia e inibizione delle performance; si può avere un abbassamento dell’autostima; si può mettere in atto un processo di disidentificazione col proprio gruppo per mantenere la stima di sé. 31 4. CULTURA, ETNIA, MODELLI DI SOCIETA’ 32 4.1 LE CULTURE Nei rapporti fra la polizia e i vari gruppi o categorie che compongono la società, quello con le comunità di persone di origine etnica minoritaria o di culture straniere sembra suscitare particolare diffidenza tra le parti e numerose incomprensioni. Nel contesto dei rapporti fra la polizia e gruppi della comunità locale, i gruppi di minoranza etnica sono identificati come gruppi particolari, con proprie caratteristiche alle quali spesso gli operatori di polizia non sono preparati a rispondere, né individualmente, né come servizio pubblico. Dedichiamo perciò un capitolo all’approfondimento dei concetti di cultura ed etnia, consapevoli che, nella società contemporanea, una volta strappati al mondo nel quale sono nati e poi divulgati (la ricerca antropologica), i concetti di “cultura”, “etnia”, “gruppo etnico” cessano di essere costrutti culturali e si reificano, come se fossero qualcosa di oggettivo ed esistente nella realtà. Oggi queste parole sono usate dalla generalità delle persone ma pochi sanno a cosa si riferiscono davvero. Dal punto di vista del singolo operatore di polizia non è necessario che ogni poliziotto diventi un esperto di antropologia per capire il significato generale e l’importanza di questi concetti nel proprio lavoro; è però bene che egli conosca la cornice più ampia nella quale si iscrive il proprio agire, per sentirsi un pezzo importante, anzi fondamentale, nella costruzione di una società coesa, che ha a cuore la difesa dei diritti umani. Per questa ragione il capitolo presenta brevemente alcune teorie sui concetti di cultura ed etnia e sulle conseguenti pratiche. 4.1.1Che cosa s’intende per cultura Sebbene ogni individuo sia unico, dobbiamo riconoscere che i suoi valori e le sue azioni possono essere legati, con gradi e intensità diverse, alle aspettative e alle norme prevalenti nella società in cui vive. Cosa sia una cultura è tema dibattuto e controverso, per lo più studiato in campo antropologico, tanto che l’etnologo americano Clyde Kluckhohn (1905-1960) raccolse un repertorio di 164 definizioni di cultura. Alcuni autori, nei primi anni ’90, affermarono che il concetto di cultura è “un imbarazzo”,“un impiccio”, per le sue incongruenze e per lo scarso potere di elemento di riferimento, sia sul piano empirico che teorico. È solo alla fine del ‘700 che il termine cultura viene usato in riferimento a popoli enazioni e non più solo come attributo dell’individuo “colto”. Si deve ad Edward Tylor una prima, fortunata, definizione di cultura: «La cultura, o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell’insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società». (Tylor, 1871) Franz Boas, altro padre fondatore dell’antropologia culturale, partiva dall’assunto che una cultura è data dall’esistenza di una storia comune ad un gruppo e di una lingua nella quale si esprime la cultura in questione. Nell’accezione di Boas, e di tutta l’antropologia moderna, le culture non esistono in una gerarchia ma sono pari tra loro, anche se stereotipi, pregiudizi e oppressioni stanno a dimostrare che esistono dei rapporti di forza tra gruppi diversi. Oggi si tende a vedere la cultura come il risultato di un accordo tra individui che “negoziano” un certo significato. Ne segue che la cultura non è definita una volta per tutte ma è qualcosa che scaturisce dall’interazione e dall’accordo tra soggetti comunicanti; pertanto, essa non potrà che essere in continuo movimento. Basti pensare all’evoluzione del diritto di famiglia in Italia e al delitto d’onore: elementi ritenuti 33 basi fondamentali e imprescindibili della nostra cultura e famiglia 24, come la patria potestà e l’uxoricidio in caso di adulterio fino ai primi anni ’70 del secolo scorso, sono finalmente stati modificati, stabilendo, nel primo caso, la parità tra madre e padre, e avendo dichiarato il secondo reato grave e senza attenuanti. C’è poi chi 25 vede la cultura come un insieme di mappe che ci sono fornite e per mezzo delle quali esploriamo la realtà. Quando ci avventuriamo in terre sconosciute non possiamo fare a meno delle mappe ma dobbiamo anche essere consapevoli che, per quanto accurate, esse non esauriscono il territorio e ogni individuo dovrà trovare un proprio modo di orientarsi una volta trovati i capisaldi da esse forniti. Inoltre, le persone usano le loro mappe più o meno lacunose per orientarsi rispetto ai propri obiettivi e per questo ognuno arricchisce di dettagli importanti la propria, che può dunque differire anche notevolmente dalla mappa di uno stesso territorio perfezionata da un’altra persona. Si è però anche affermata in un passato recente l’idea di cultura come qualcosa di analogo ai programmi del computer, arrivando a definire la cultura come “il software della mente”. Secondo Hofstede 26, ogni persona ha un software mentale, costituito da una serie di file di sistema. È la cultura che definisce la programmazione mentale collettiva la quale distingue i membri di un gruppo o categoria da quelli di un altro gruppo o categoria. Nonostante i continui e sempre più rapidi cambiamenti in tutte le società del mondo globalizzato, secondo questo autore: “Tutte le società umane hanno in comune alcuni problemi di base che sono sempre esistiti e che continueranno ad esistere. Sono i problemi di (in)uguaglianza, della solidarietà di gruppo, del ruolo dei generi, del futuro incerto e del bisogno di gratificazioni. Nel corso dei millenni le diverse società hanno sviluppato le proprie soluzioni a questi problemi e le hanno trasmesse alle generazioni successive. Per coloro che appartengono ad una società le proprie soluzioni appaiono naturali, razionali e moralmente giuste, ma da una società all’altra le soluzioni sono diverse e per ragioni che non appaiono sempre ovvie. Questo è l’ambito dei valori fondanti che costituiscono l’elemento centrale delle culture nazionali e si scopre ciò solo quando si entra in contatto con un’altra cultura” 27. Questa visione è però oggi giudicata insoddisfacente da molti studiosi perché considera la cultura come qualcosa che rende tutto uniforme e non permette la comprensione della grande variabilità di credenze, convinzioni e comportamenti anche tra persone appartenenti ad una stessa cultura. Questa prospettiva inoltre commette il grossolano errore di considerare nazionalità e cultura come sovrapponibili. Infine, essa sembra sottostimare il fatto che le culture s’incontrano in continuazione e si scambiano idee, oggetti, persone e che tutte le culture sono il prodotto di interazioni, di scambi, di influssi provenienti da altrove: non esiste dunque una cultura “pura”. Ogni società è profondamente influenzata da ogni altra ed è il risultato di dinamiche che si sviluppano al proprio interno e di influenze indotte dalla presenza di altre culture che ogni società assorbe e rielabora secondo le proprie premesse culturali e le proprie strutture sociali. Di ciò dà conto il brano che riportiamo, citato in L’identità etnica (Fabietti, 1998) da Studio dell’Uomo, un trattato di antropologia pubblicato nel 1936 da Ralph Linton. 24 Struttura elementare per descrivere qualsiasi cultura, secondo le metodologie classiche dell’etnografia Mantovani G., L’elefante invisibile. Tra negazione e affermazione delle diversità: scontri e incontri multiculturali, Giunti, Firenze, 1998 26 Hofstede G., Culture and Organization: Software of the Mind, McGraw-Hill, 1991 27 Hofstede, op. cit.,Preface to the recise edition xii, traduzione a nostra cura. 25 34 “Il cittadino americano medio si sveglia in un letto costruito secondo un modello che ebbe origine nel vicino Oriente ma che venne poi modificato nel Nord Europa prima di essere importato in America. Egli scosta le lenzuola e le coperte che possono essere di cotone, pianta originaria del vicino Oriente; o di lana di pecora, animale originariamente addomesticato nel vicino Oriente; o di seta, il cui uso fu scoperto in Cina. Tutti questi materiali sono stati filati e tessuti secondo procedimenti inventati nel vicino Oriente. Si infila i mocassini, inventati dagli indiani delle contrade boscose dell’Est, e va nel bagno, i cui accessori sono un misto di invenzioni europee ed americane, entrambe di data recente. Si leva il pigiama, indumento inventato in India, e si lava con il sapone, inventato dalle antiche popolazioni galliche. Poi si fa la barba, rito masochistico che sembra sia derivato dai sumeri o dagli antichi egiziani (…). Andando a fare colazione si ferma a comprare un giornale, pagando con delle monete che sono un’antica invenzione della Lidia. Al ristorante viene a contatto con tutta una nuova serie di elementi presi da altre culture: il suo piatto è fatto di un tipo di terraglia inventato in Cina; il suo coltello è d’acciaio, lega fatta per la prima volta nell’India del Sud, la sua forchetta ha origini medievali italiane, il cucchiaio è un derivato dell’originale romano (…). Quando il nostro amico ha finito di mangiare si appoggia alla spalliera della sedia e fuma, secondo un’abitudine degli indiani d’America (…). Mentre fuma legge le notizie del giorno, stampate in un carattere inventato dagli antichi semiti, su di un materiale inventato in Cina e secondo un procedimento inventato in Germania. Mentre legge i resoconti dei problemi che s’agitano all’estero, se è un buon cittadino conservatore, con un linguaggio indo-europeo, ringrazierà una divinità ebraica di averlo fatto al cento per cento americano.” Fabietti U., L’identità etnica, Carrocci Editore, Roma, 1998. Pagg. 22/23 Uno tra i più importanti contributi all’antropologia moderna negli ultimi anni è stato fornito da Jean Loup Amselle, secondo il quale la purezza della cultura è un mito. Ci dice Amselle che non esistono culture che non siano meticce e che il meticciato culturale è un non-senso, perché qualsiasi società è sin dalla sua nascita meticcia; le culture sono già entità mescolate che “rinviano all’infinito l’idea di una purezza originaria”. L’impatto di una cultura nuova su una cultura autoctona non consiste tanto in una meccanica azione di rigetto, ma in un confronto che fa sì che la civilizzazione “invasa” selezioni elementi della nuova cultura, rielaborandoli e facendoli propri. 28 Seguendo questi ragionamenti, saremo portati ad ammettere che non esistono peculiarità etniche e culturali irriducibili ma piuttosto una corrente continua di influssi tra aree di origine e aree d’insediamento. Le società, tutte le società, sono dunque miste; non riconoscerlo sarebbe l’ennesimo modo di “razzizzare” una cosa che è altro: cioè individui che, incontrandosi, sospendono la propria identità per crearne una nuova. Quante volte sentiamo dire o diciamo noi stessi “Fanno così perché sono cinesi!” come se esistesse un essenzialismo orientale. Sfogliando quotidiani, nel parlare comune, nei comunicati di alcuni politici può capitare di leggere o udire espressioni grottesche quali “individui di etnia latinoamericana” o “clandestini di etnia cinese”, quando sappiamo che per Latino-america intendiamo un continente ben più vasto dell’Europa e la Repubblica Popolare Cinese riconosce cinquantasei gruppi etnici ufficiali, dai mongoli nell’estremo Nord ai tibetani al Sud. La verità è piuttosto che “quei cinesi” si comportano in un certo modo perché sono cinesi di una certa area di quell’immenso Paese, provengono da zone rurali oppure altamente urbanizzate e tecnologizzate, sono cinesi di una certa età, di questi anni, che sono qui in Italia, insomma sono questi cinesi qui. Dunque, a quale tradizione, a quale cultura cinese ci stiamo riferendo? Come per i cinesi (o i tunisini, ecc.), si sente dire “l’Islam è così”, “così fanno i musulmani”, non sapendo di quale Islam stiamo parlando, praticato in quale Paese, da quale parte della società e ignorando, peraltro, che nella maggior parte dei casi, certi comportamenti hanno a che fare con elementi radicati in una tradizione preislamica, nell’educazione, nel fatto di vivere in città o in campagna, nell’instabilità della società, nella volontà di controllo degli uomini sulle donne e in molti altri fattori sociali. Molte consuetudini cosiddette “islamiche” (per esempio il ripudio della moglie o le mutilazioni genitali femminili) contraddicono gli stessi principi religiosi islamici non meno di quanto l’avere rapporti prematrimoniali e il divieto di abortire 28 Logiques métisses: anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs, Paris, Payot, « Bibliothèque scientifique Payot », 1990 ; trad. it. 1999, Logiche meticce, Torino, Bollati Boringhieri. 35 confliggano con il dettato cristiano. Pensiamo infine alla primavera egiziana di questo ultimo biennio e vedremo chei musulmani egiziani si trovavano schierati pro e contro Morsi, in quest’ultimo caso condividendo la battaglia assieme a laici, atei e cristiani. Ci ricorda un antropologo italiano: “Quando gli uomini entrano in conflitto non è perché hanno costumi o culture diverse ma per conquistare il potere e, quando lo fanno seguendo schieramenti etnici, è perché quello dell’etnicità diventa il mezzo più efficace per farlo”. 29 Completa il ragionamento Amselle, argomentando che è difficile fornire una spiegazione strettamente economica dello sterminio nazista, ed è difficile spiegare in modo convincente le ragioni puramente capitalistiche dell’apartheid sudafricano. Il genocidio, e più in generale tutte le politiche che si basano sull’etnia, sulla razza e sul sangue, sono, secondo Amselle, meglio spiegabili sottolineando l’importanza degli elementi simbolici e rituali come collanti identitari per rivendicazioni che hanno altre origini. Amselle, con la sua “decostruzione dell’oggetto etnico” 30, intese dimostrare che l'etnia è una categoria storica, sottolineando la relatività delle appartenenze etniche, senza per questo negare agli individui il diritto di rivendicare l'identità delle proprie scelte. 4.1.2 La culturalizzazione dei conflitti Guerre “etniche”, partiti e movimenti che raccolgono consensi attorno a programmi di esclusione e di “purezza del sangue”, conflitti di stampo nazionalista-religioso, razzismi quotidiani sono fenomeni che vorremmo vedere estinti, eppure non è così. Per spiegarli servono interpretazioni di carattere storico, economico e politico, come il controllo delle materie prime, il commercio delle armi, l’imposizione di modelli di sviluppo, oltre ad elementi di dinamica psico-sociale, come l’appartenenza, la differenza, il pregiudizio, lo stereotipo. Sembrerebbe un fatto incontrovertibile, sostenuto dalle ricerche di tipo psico-sociale e antropologico, che tutti i gruppi umani sono etnocentrici, manifestano cioè una tendenza a vedere il proprio gruppo come positivo e desiderabile e gli altri gruppi come inferiori, barbari, incivili. Seguendo Fabietti, l’etnicità costituisce: “un complesso pratico-simbolico sfaccettato, il quale ha la sua ragion d’essere in motivi di ordine politico, ideologico, simbolico, psicologico, affettivo, economico, che solo se letti simultaneamente possono rendere conto con sufficiente plausibilità del fenomeno”. 31 Questo complesso è il risultato di un processo sociale: sorge e si sviluppa nell’interazione quotidiana con gli altri; ne consegue che solo riconoscendosi nell’altro, l’individuo riconosce se stesso. 32 L’identità etnica nasce da una serie di processi complessi ed è pensabile solo in questi termini di “contrasto”: per poter pensare me stesso devo poter pensare a qualcun altro. Lo stesso accade quando definisco gli altri. L’identità ci viene attribuita dagli altri: veniamo “etichettati” (secondo la labelling theory – la teoria dell’etichettamento) e perciò identificati in ragione dei saperi e dei saper fare che possiamo mettere in campo in circostanze date: è lo sguardo degli altri che ci fa essere. Ritornando a Fabietti, l’identità etnica è quindi una definizione del sé e dell’altro collettivi che affonda le proprie radici in rapporti di forza tra gruppi che riconoscono di avere gli stessi interessi in precise 29 Fabietti U., L'identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1995, pag 151. 30 Decostruzione dell’oggetto etnico: studiando le identità etniche, scoprire che esse non sono date una volta per sempre ma che esse sono costruzioni sociali/culturali operate dall’uomo nel corso della storia, a volte addirittura inventati di sana pianta. Amselle J.L., M'Bokolo E. , Au cœur de l'ethnie: ethnies, tribalisme et État en Afrique, Paris, La Découverte, 1985 ; rééd. 1999 «La Découverte-poche»; trad. it. 2008, L'invenzione dell'etnia, Roma, Meltemi Editore. 31 Fabietti U., op. cit. pag.11. 32 L. Sciolla (a cura di), Identità. Percorsi di analisi in sociologia, Rosenberg & Sellier, Torino, 1983. 36 circostanze storiche, sociali e politiche. Tanto è vero che le identità etniche cambiano, nascono e muoiono. Si pensi ad esempio alla novità della rappresentazione etnica degli abitanti del Nord-Est da parte della Lega Nord (anno di fondazione 1989) e del richiamo alle origini celtiche fino a pochi anni prima da nessuno rivendicato. Appare evidente come esse siano un costrutto culturale suggerito e richiesto da ragioni di tipo politico ed economico, di per sé legittime. Una volta costruite però, le “etnie” assumono una consistenza molto concreta per coloro che vi si riconoscono. Prova ne sono i tanti conflitti narrati e analizzati come etnici i quali, per converso, non sono altro che il risultato di processi di etnicizzazione voluti e favoriti dall’esterno o da gruppi che competono, in precisi momenti storici, per l’accesso a determinate risorse materiali o simboliche. Il pregiudizio diventa dunque strumentale agli interessi di una classe, al potere costituito. Le teorie per spiegare il fenomeno dell’etnicizzazione e della culturalizzazione dei conflitti sono tante, sono cambiate negli anni e provengono da discipline tanto diverse come la biologia, la genetica, l’etologia, la psicologia, la psicologia sociale, l’antropologia e la sociologia. La nostra esperienza ci ha messo a disposizione alcuni casi: ne raccontiamo uno occorso durante un lavoro condotto nel vicinato di un quartiere limitrofo alla stazione ferroviaria di una città italiana di medie dimensioni, oggi abitato, per più del 50%, da cittadini di origine straniera. Chiameremo questa vicenda la “Storia di Gianni, Hamidou e gli altri” 33. Un esempio Storia di Gianni, Hamidou e gli altri Presso il negozio d’invio denaro di Gianni si ritrovano, soprattutto in estate, molti giovani di varie origini che, approfittando della bella stagione, si attardano sotto il portico, ridendo, schiamazzando, alcuni anche interpellando in modo molesto gli abitanti della zona che osano richiamarli al rispetto di regole di civile convivenza. Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale sono spesso chiamati ad intervenire. I protagonisti della storia si schierano e in questa fase gli schieramenti sono espressi dall’immagine che segue. Come si capisce dai nomi dei protagonisti, non vi è alcuno schieramento etnico o culturale ma ciascuno assume una posizione secondo il disturbo che riceve da questi assembramenti: i residenti italiani lamentano di non riuscire a riposare la notte, la sporcizia sotto il portico, la fatica di farsi largo tra la folla per entrare in casa propria. Simili sono le lamentele della dirigente dell’hotel e del ristorante cinese. Geppino, il barbiere, e Hamidou e Shanmi non hanno nulla contro Gianni, il suo negozio e gli avventori perché tutto avviene per lo più quando i loro negozi sono già chiusi e loro sulla strada di casa, lontano dalla stazione. Gianni si difende sostenendo che non ha alcun diritto né autorità per forzare i clienti a spostarsi dal portico e che, in fondo, si 33 I nomi dei personaggi della storia non hanno alcun riferimento con la realtà. 37 tratta di giovani che non hanno altro luogo per socializzare; il suo negozio è un po’ come il bar del paese o del quartiere dove si trovavano i nostri padri. L’amministrazione comunale tenta una via per cercare una soluzione al problema, coinvolgendo tutti i protagonisti. Al primo incontro, Vanna esordisce con parole aspre e offensive nei confronti dei neri e degli immigrati che stazionano davanti al negozio di Gianni. A questo punto, gli immigrati si trovano uniti a difesa della loro condizione comune (l’immigrazione), e della loro presupposta comune cultura. Corrono già parole forti. A Geppino e Giuliano, che per natura sarebbero più concilianti e moderati, non resta altro che fare fronte comune per la difesa dell’“italianità” e della loro peculiare cultura in quella specifica città. L’incontro si chiude con molta tensione. Altri incontri saranno organizzati nell’ambito del processo partecipativo per rendere la vita migliore in tutto il quartiere ma Gianni non sarà più presente perché, di fatti, del suo negozio e del problema che genera non si parlerà più. Il contrasto su un problema ben circoscritto è diventato etnico e culturale. Un fatto di identità inconciliabili. La cronaca ci offre numerosi esempi di culturalizzazione e razzializzazione di problemi socioeconomici alla base di discriminazioni. Uno tra tutti, il noto caso di Adro (Brescia) il cui sindaco negò la mensa a una quarantina di bimbi di genitori per lo più stranieri che erano rimasti indietro con il pagamento della retta dell’istituto onnicomprensivo (asilo, elementari, medie). In seguito emulato da altri sindaci, Lancini asseriva «È stata la rivolta degli italiani», spiegando perché si era arrivati a una sorta di «tolleranza zero» contro la morosità nel pagamento delle rette della mensa scolastica gestita da un'associazione di genitori. «Mi chiedevano - continua - perché dobbiamo essere solo noi italiani a pagare la mensa? La crisi esiste per tutti». 34A noi pare che il caso di Adro, come altri simili, non risalga all’eccessiva presenza di cittadini stranieri sul territorio e, “dunque”, alla necessaria limitazione dell’accesso al welfare da parte degli stranieri, tant’è vero che tra i bambini esclusi ve n’erano anche alcuni di famiglie italiane in condizione di povertà. Il problema è piuttosto quello della revisione delle scelte che riducono i servizi e ne scaricano l’onere sulle famiglie. Culture, etnia, alterità sono parole via via fagocitate dal razzismo che tende a camuffarsi, non più razzializzando ma essenzializzando etnie e culture. 4.2 L’INVENZIONE DELL’ETNIA Secondo il sociologo Max Weber (1864-1920), l’etnicità è il sentimento di condividere un’ascendenza comune riconducibile alla lingua, o ai costumi, o alla somiglianza fisica o alla storia vissuta, siano questi tratti oggettivi o mitologici. E’ difficile separare nettamente i concetti di cultura, razza, etnia e persino nazione perché essi sono stati spesso usati come equivalenti, non solo nel linguaggio quotidiano ma anche nel linguaggio scientifico e la fortuna di un concetto, piuttosto che di un altro, è molto legato al momento storico e alla società che l’ha prodotto per i propri fini. Per gli antropologi, coloro che per primi hanno usato quei termini, l’etnia è un’invenzione; non nel senso di creazioni fantastiche, beninteso, ma “una fabbricazione a partire da alcuni dati reali la cui unicità viene enfatizzata, esagerata, allo scopo di determinare in senso unico l’oggetto preso in considerazione” (Fabietti, 1995). 34 http://www.corriere.it/cronache/10_aprile_07/mensa-retta_ea885a1e-4273-11df-a011-00144f02aabe.shtml. 7 aprile 2010 38 Così le potenze coloniali si servivano dei primi studi antropologici per enfatizzare delle divisioni tra gruppi, fissandole poi in etnie, con caratteristiche distinte e irriducibili, allo scopo di dividere le popolazioni dominate e prevenire eventuali progetti di unità. Così fecero ad esempio i francesi in Algeria, contrapponendo arabi e berberi, e così fecero i belgi, stabilendo gerarchie tra i gruppi dei territori da loro controllati, come tra Tutsi e Hutu in Ruanda 35. Secondo i primi studi di antropologia, è generalmente considerato gruppo etnicoun gruppo di persone che condividono un’identità collettiva basata su un senso comune della storia degli antenati. I gruppi etnici possiederebbero quindi una cultura propria, dei costumi, delle norme e delle tradizioni. Altre caratteristiche che si riconoscerebbero condivise sono la lingua, le origini geografiche, la letteratura e la religione. Un gruppo etnico può essere maggioritario o minoritario in una più ampia comunità. L’etnicità è un fenomeno culturale e distinto da quello di “razza” che è percepito avere una base biologica: la cultura è invece appresa e tramandata di generazione in generazione. Questo il pensiero dei primi antropologi che accompagnavano le imprese coloniali e che cercavano strumenti per conoscere e descrivere una realtà diversa. Oggi è necessario procedere alla decostruzione dell’oggetto etnico, ovvero scoprire che le identità etniche non sono date una volta per sempre, ma sono “oggetti” costruiti dall’uomo nel corso della storia, a volte inventati di sana pianta : “Realizzando monografie etnografiche che descrivono strutture sociali, attività economiche e pratiche religiose come se fossero specifiche del gruppo di volta in volta preso in considerazione, si finiva per tracciare i confini di tale gruppo, estraendolo ed evidenziandolo dal contesto in cui era inserito”. 36 Secondo Amselle le logiche meticce sono l’altra faccia delle logiche classificatorie, perché il meticciato presuppone che esistano razze diverse, diverse identità etniche, pur dando un giudizio positivo sul loro intrecciarsi. E’ sbagliato il presupposto che esistano identità etniche e razziali differenti; esiste invece un sincretismo originario inestricabile, pertanto “la nozione di meticcio e quella di razza a essa connessa, è un nonsenso”. Riferendosi alla Francia, Amselle afferma che “non esistono 'francesi di razza' perché tutti i francesi sono già meticciati”. Kilani (2001) arriva ad affermare che l’appartenenza etnica è uno stato d’animo: “L’ascrizione ad un’identità culturale da parte di un’altra serve a separare il “noi” dal “loro”. (…) la cultura, come l’etnicità, non esiste in quanto struttura, ma come uno stato d’animo, un fatto della coscienza che organizza le differenze e le eterogeneità fra le società, e fra gli individui e gruppi sociali all’interno di una società”. (…) essi esprimono uno stile di vita, un insieme di simboli condivisi dagli individui che ne fanno parte, simboli ai quali però essi non danno necessariamente il medesimo contenuto e neppure la stessa interpretazione.” 37 Insomma, il concetto di etnia, così come quello di cultura, nasce in anni lontani per affermare la distinzione tra “noi” e “loro”, dove per loro si intendevano le società cosiddette “primitive”. Ancora oggi non abbiamo abbandonato l’etichettamento degli altri in modo spregiativo: “ (…) una frazione considerevole dei media e dei cittadini italiani – che pure discendono da ours, ritals, macaronis,dagos,katzelmacher, babis, cristos – ancor oggi percepisce i migranti e gli appartenenti a minoranze (in particolare i rom e i sinti) come massa informe e omogenea di pezzenti, marginali o delinquenti, comunque come specie altra dai cittadini”. 38 Ne è un retaggio l’uso asimmetrico (come lo definisce A. Rivera) che si fa dell’aggettivo “etnico”, per esempio associato alla musica per indicare la musica degli “altri”, oppure la moda e la cucina, rimandando 35 Ciò determinò una situazione di conflittualità tra i due gruppi che condusse ad esiti drammatici. Nel 1994 circa 800.000 tra uomini, donne e bambini furono massacrati in non più di 100 giorni. Il massacro si trasformò in un genocidio che eliminò un milione di persone. 36 Amselle J.L, Logiche meticce. Antropologia dell’identità in Africa e altrove, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, p. 189 37 Gallissot R., Kilani M., Rivera A., L’imbroglio etnico in quattordici parole-chiave, 2001, Edizioni dedalo, Bari. 38 Rivera A., Due anni di scena razzista in Italia. Protagonisti e comprimari, vittime e ribelli, pag.14 in Cronache di ordinario razzismo. Secondo Libro bianco sul razzismo in Italia, 2011, Ed. dell’Asino, pag. 14. 39 all’idea di un mondo originale e primitivo, quello che esiste prima e al di là dell’arrivo della società postindustriale avanzata. Al contrario, per la definizione stessa di “etnia” e “gruppo etnico” che qui abbiamo riportato, non esistono differenze tra gli abitanti della Val Camonica e quelli della Valle del Limpopo. Ci dicono gli antropologi, quello che si fa oggi è un uso distorto dei termini coniati dall’antropologia che devono essere intesi per quello che sono, delle “finzioni”, cioè delle convenzioni che rendono possibile un discorso. Dobbiamo essere sempre vigili affinché non accada quel che sta tuttora accadendo in Italia, dove sono stati inventati miti di etnie del Nord per giustificare dei cambiamenti nell’assetto istituzionale del Paese e per rappresentare l’espressione di interessi precisi di certi strati sociali. A questo punto l’etnia è intesa non come strumento di analisi ma come ideologia, altrettanto falsa di quella che esalta l’italianità come se in Italia esistesse un’unica etnia e non fosse invece, questo Paese, come la Francia di Amselle, il risultato del sovrapporsi di gruppi e tradizioni, peraltro, esse stesse, in continuo cambiamento. 4.3 I MODELLI D’INCORPORAZIONE DEI MIGRANTI NELLE SOCIETÀ Ragionare di cosa sia la cultura è necessario perché la realtà della cultura è una conseguenza della concezione di cultura che si ha. Se crediamo che le culture siano un’insieme di tradizioni, leggi, valori fissi nel tempo, che poggiano su un territorio (nazionale o regionale), inevitabilmente approderemo ai modelli multiculturalista o assimilazionista o interculturalista; se penseremo alle culture come costrutti culturali, complessi di norme e valori in costante cambiamento e adattamento, più facilmente approderemo ad un modello di tipo transculturale. Il dibattito europeo su immigrazione e cittadinanza è stato spesso presentato come un dibattito tra multiculturalismo e assimilazione. In verità, questa posizione semplifica esageratamente la questione, trascurando che le somiglianze tra i due modelli sono più significative delle differenze. Entrambi hanno infatti contribuito a fissare alcuni luoghi comuni su immigrazione e cittadinanza, primo fra tutti, il mito di un’Europa omogenea e di Paesi europei omogenei al loro interno, diversificatisi solo in seguito all’arrivo delle migrazioni dal Sud e dall’Est del mondo. Per dirla con le parole del noto studioso e giornalista britannico Kenan Malik 39: “La nozione di una facile assimilazione degli immigrati europei del passato - scrive lo storico Max Silverman - è un mito. Oggi pensiamo l’immigrato portoghese o italiano culturalmente simile al proprio ospite francese. Settant’anni fa erano visti come degli alieni, come i musulmani sono visti oggi, dediti al crimine e alla violenza, e difficilmente assimilabili alla società francese.” Le tre posizioni citate all’inizio del paragrafo, o modelli di società, dimostrano una perdita di memoria stupefacente del cittadino europeo: esse infatti si rifanno a un mito piuttosto che a una verità storica e ciò è dimostrato dall’intricatissima storia di migrazioni interne, dominazioni di civiltà su altre, colonizzazioni, guerre, scambi culturali e linguistici che hanno fatto dell’Europa ciò che essa è oggi. Dunque non c’è nulla di nuovo nelle società cosiddette “plurali” contemporanee; quel che è diverso è invece la percezione che oggi abbiamo di vivere in una società particolarmente plurale, di una pluralità che si gioca nel campo culturale. Sia per il multiculturalismo che per l’assimilazionismo, certe differenze (culturali, etniche e religiose) hanno assunto un significato particolare e preponderante, mentre altre, come l’appartenenza di classe o a generazioni diverse sono divenute meno rilevanti o addirittura sono scomparse come strumenti di lettura 39 “The notion of the easy assimilation of past European immigrants’, the historian Max Silverman has written , ‘is a myth’. Today we think of Italian or Portuguese migrants as culturally similar to their French hosts. Seventy years ago they were viewed as alien as Muslims are today, given to crime and violence, and unlikely to assimilate into French society”.(traduzione nostra).“Immigration and citizenship in Europe”, discorso pronunciato alla Trudeau Foundation Conference , Halifax (Nova Scotia), Canada, 17-20 novembre 2011. 40 dei fatti sociali. E’ la combinazione di amnesia storica e di un punto di vista del tutto parziale di ciò che costituisce le differenze che ha dato forma alle argomentazioni multiculturaliste e assimilazioniste. Cercando di presentarne gli aspetti positivi e negativi, riportiamo ai paragrafi successivi una sintetica trattazione dei modelli di società oggi disponibili e praticati, offrendo alcuni esempi per chiarire come la scelta di un modello abbia effetti evidenti e concreti nella vita delle persone e infine anche sull’agire di polizia, perché la definizione di cultura che adottiamo è, al tempo stesso, una descrizione della società e una prescrizione per gestirla. 4.3.1 Multiculturalismo “Multiculturalismo” indica la compresenza di più culture in uno stesso contestostorico-geografico; il concetto poggia sulla coesistenza (o separazione) di gruppi distinti, ciascuno salvaguardando aspetti della propria cultura d’origine. Nell’Europa del secondo dopoguerra rappresentava certamente un significativo passo avanti verso un nuovo ordine sociale, verso il riconoscimento delle minoranze etno-linguistiche, contro i fascismi e nazismi dei decenni precedenti. Il multiculturalismo è il sogno anglosassone di convivenza pacifica di culture diversein uno stesso territorio, sviluppato su un modo tollerante per integrare le minoranze piuttosto che assimilarle al “British way of life” (lo stile di vita britannico): oggi in Gran Bretagna si ammettela coesistenza di procedure e leggi distinte per distinti gruppi sociali. Il multiculturalismo britannico è stato per anni percepito come la risposta più riuscita ed eticamente accettabile di compresenza di diversi gruppi “etnici” in una stessa nazione (in contrasto con l’assimilazionismo francese) ed è certamente al multiculturalismo che siamo debitori di una più approfondita comprensione della discriminazione etnica, razziale e religiosa e di battaglie contro il razzismo combattute anche sulla scena europea. I rischi di questo modello sono evidenti nell’esacerbarsi delle divisioni tra gruppi etnici che hanno portato a processi segregativi e ghettizzanti (visibili anche nella segregazione urbana nelle città anglosassoni e americane), a un preoccupante fondamentalismo culturale, il “comunitarismo”, vale a dire l’idealizzazione esasperatadella cultura o del Paese d’origine da parte delle minoranze, nell’accentuazione dell’autenticità e delle origini pure. Chi sostiene il comunitarismo considera che l’identità dell’individuo si costruisca solo in seno alla comunità che, così facendo, si contribuisce a mantenere inalterata, libera dal peso della cultura dominante e capace di difendere e fare rispettare le proprie particolarità. Per i difensori del comunitarismo multiculturalista non esiste altra prospettiva fuori della comunità di appartenenza ed è impossibile distaccarsi dalla sua storia e dalla sua cultura, una cultura peraltro pretesa come originaria, al di là dei cambiamenti e delle evoluzioni che, per quell’effetto di continua trasformazione già citato, non esiste più nemmeno nei Paesi di provenienza dei padri di chi la rivendica oggi nel nostro continente. Vi è chi osserva dall’interno della stessa società britannica (specie in campo femminista) che l’attenzione alle “comunità” da parte delle istituzioni pubbliche è spesso sfociata nell’offrire legittimità alle voci religiose più conservatrici all’interno di quelle comunità solo perché tuonavano più alte, accreditandole di essere le più autentiche proprio perché le più conservatrici (Malik, 2011), sebbene innumerevoli indagini tra i musulmani britannici abbiano dimostrato che meno del 10% si sente da loro rappresentato. In particolare, gruppi femministi come WAF (Women Against Fundamentalism – Donne contro il fondamentalismo) rigettano di questo approccio il presupposto che le minoranze culturali siano omogenee al loro interno e che la relazione dei singoli con una presunta cultura d’origine sia la medesima per tutti. In particolar modo, questi gruppi contestano che ai cosiddetti leader sia concessa dallo Stato e dalle altre autorità di governo l’autorità di determinare cos’è la “vera cultura” e la tradizione di una specifica comunità (intesa come gruppo etnico-culturale), senza prendere in considerazione le divisioni di potere all’interno delle comunità stesse come, per esempio, le disparità tra uomini e donne (Sahgal and Yuval-Davis, 1992). Questi aspetti negativi della concreta evoluzione del multiculturalismo hanno fatto dire ad Amartya Sen che si tratta piuttosto di un “monoculturalismo plurale”. 41 PRAGMATICAMENTE Nel Maggio 2011 i professori universitari appartenenti alla UCU (University and College Union) si dichiararono favorevoli al diritto di indossare il burqa e qualsiasi altro indumento religioso all’interno delle università britanniche. “Ognuno dovrebbe essere libero di indossare gli indumenti che preferisce per assecondare il proprio credo religioso” ha detto Alan Whitaker, presidente dell’UCU. “Questo è sempre stato uno dei principi del sindacato, che ha una lunga storia laica ma che non per questo può essere considerato antireligioso. Siamo a favore della libertà di ognuno di praticare la propria religione e di seguirne i costumi – e questo può includere anche il precetto di indossare un determinato tipo di abbigliamento”. La UCU spiega che alla base di questa decisione vi è la volontà d’incoraggiare la partecipazione agli studi universitari da parte di persone appartenenti alle minoranze etniche, soprattutto le donne. Si tratterebbe quindi di un grande passo avanti nell’ambito della multiculturalità, in quanto concomitante, tra l’altro, alla decisione da parte del governo francese di bandire l’uso del velo dagli edifici pubblici, un’iniziativa che, secondo l’unione dei docenti inglesi, è sintomo di una crescente “islamofobia”. Anche la London School of Economics si è espressa dichiarando: “Un importante principio dell’educazione è combattere la superstizione ed il pregiudizio. Persone di qualsiasi fede, o di nessuna, hanno il diritto di vestirsi come considerano appropriato.” Fonte: sito del quotidiano “Indipendent” (29.05.2011) http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/lecturers-back-students-right-towear-the-burkha-2290407.html 4.3.2 Assimilazionismo L’assimilazionismo, ossia il processo per il quale individui o gruppi di diversa origine etnica sono assorbiti nella cultura dominante di una società, è considerato il tentativo più efficace di evitare il comunitarismo. S’intende generalmente che l’assimilazione si attui attraverso l’adozione della lingua, l’adesione al sistema di valori del gruppo dominante e, in sostanza, con l’abbandono del modo di vivere precedente, considerato tradizionale. Ovviamente l’assimilazione può essere scelta o essere il prodotto di politiche precise, come lo fu nel caso della colonizzazione, per esempio, francese. E’ una tendenza, secondo i sostenitori di altri modelli, a “universalizzare il particolare” dove il punto di vista dell’oppressore è presentato come imparziale; ne consegue che quando gli oppressi non si adeguano agli standard, la loro differenza diventa un costrutto di devianza e inferiorità (Young M., 1990). L’assimilazionismo, contrariamente al multiculturalismo, esprime la tendenza del gruppo maggioritario a inglobare quello minoritario, facendo in modo che esso rinunci alla sua differenza sulla scena pubblica e accetti i modi di vita e la cultura della maggioranza. L’espressione dell’identità e delle proprie specificità socio-culturali è relegata alla sfera privata di ciascuno e l’ottenimento della nazionalità è considerato un impegno irrevocabile. Questo tipo di società ha trovato in Francia la sua applicazione contemporanea più evidente. 42 Anche la Francia però è in movimento. L’Alto Commissariato per l’Integrazione (HCI) , che ha sempre sostenuto l’applicazione di una laicità dello stato intesa in senso stretto, fu sciolto nel 2012 quando avanzò la proposta di vietare ogni segno religioso nelle aule delle università pubbliche, estendendo così il divieto imposto dalla legge del 2004 (Legge n. 228 del 2004 – Rispetto della laicità 40) la quale ribadisce, precisandolo, il divieto di portare il velo islamico durante i corsi nelle scuole secondarie e lo fa in ragione dei “valori di uguaglianza e di rispetto dell’altro (…) il rispetto della libertà di coscienza” (cap. II – I principi). “Le convinzioni religiose degli studenti non danno loro il diritto di opporsi ad un insegnamento. Non si può ammettere, ad esempio, che certi studenti pretendano, in nome di considerazioni religiose o altro, contestare il diritto di un professore d’insegnare certe materie perché è maschio o femmina o il diritto di una persona che non appartiene alla loro confessione di fare una presentazione di tale o tal altro fatto storico o religioso 41.” Qui non si tratta solo del velo islamico e di certe consuetudini di separare maschi e femmine che possono causare ad alcuni professori difficoltà nell’organizzare gruppi di lavoro misti; la legge si riferisce anche alle contestazioni ricevute da alcuni professori da parte di praticanti neobattisti o cristiano-evangelici che criticano le teorie darwiniane dell’evoluzionismo in favore delle idee creazioniste. Nel 2011 è stata varata la legge che vieta di portare il velo integrale sulla pubblica via, sebbene l’80% della popolazione musulmana di Francia arrivi dal Maghreb e non si senta affatto toccata dalla questione del burqa. L’opinione di alcuni è che “anteporre a tutto un fenomeno marginale come il burqa porta a ignorare la maggioranza silenziosa che si secolarizza. (…) Ciò che sarebbe ricevuto favorevolmente da una gran parte della comunità islamica è (piuttosto) un discorso pubblico che condannasse tutti gli atti d’islamofobia e che affermasse che l’islam fa parte integrante della società” (Hisham Benaissa, CNRS, 2013) 42. PRAGMATICAMENTE (a) Si legge su L’Express del giugno 2011 che il Ministro dell’Interno francese si è opposto all’acquisizione della nazionalità francese da parte di un algerino sposato a una francese, pur avendone tutti i requisiti richiesti dalla legge. Il giudizio di “comportamento incompatibile con il principio di parità tra uomini e donne” è stato pronunciato sulla base della relazione che accompagnava la richiesta di cittadinanza e che riportava che “la sposa francese non prendeva la parola se non dopo l’accordo di suo marito”. Il codice civile prevede altresì che “il governo possa opporsi all’acquisizione della nazionalità francese ad unapersona straniera per matrimonio in caso di indegnità o difetto di assimilazione o nel caso di effettiva poligamia” 43. Nel caso specifico il Ministero ha riscontrato un difetto di assimilazione, confermato anche da altre annotazioni stilate durante l’incontro in Prefettura, quali la dichiarazione della donna che il marito desiderava che lei non uscisse sola e che non lavorasse. 40 L. n° 2004-228 du 15-3-2004 RESPECT DE LA LAÏCITÉ - Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. 41 L. n° 2004-228 du 15-3-2004 RESPECT DE LA LAÏCITÉ, cap. II, art.2.4-Gli obblighi che conseguono, per gli studenti, dal rispetto del principio di laicità non si limitano alla questione dei segni di appartenenza religiosa. “Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s’opposer à un enseignement. On ne peut admettre par exemple que certains élèves prétendent, au nom de considérations religieuses ou autres, contester le droit d’un professeur, parce que c’est un homme ou une femme, d’enseigner certaines matières ou le droit d’une personne n’appartenant pas à leur confession de faire une présentation de tel ou tel fait historique ou religieux (traduzione nostra). 42 Citato in Elvire Camus “Voile intégral : une loi difficilement applicable” in Le Monde, 2 agosto 2013: http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/08/02/voile-islamique-une-loi-difficilement-applicable_3455937_3224.html 43 Traduzione nostra. 43 PRAGMATICAMENTE (b) Quest’anno, François Hollande si è pronunciato a favore di una legge che vieti il velo islamico in certe imprese private, in reazione ai fatti dell’asilo Baby Loup (2008), dove un’impiegata era stata licenziata per essersi rifiutata di togliere il velo. La Halde (Autorità per la lotta alle discriminazioni e per l’uguaglianza), consultata dalla donna, aveva sostenuto che si trattasse di un atto discriminatorio su base religiosa. La Corte di Cassazione (marzo 2013) aveva difatti annullato il licenziamento di Fatima Afif perché il fatto costituisce, “trattandosi di un asilo privato, una discriminazione su base religiosa” 44. Successivamente (ottobre 2013), successivi gradi di giudizio hanno ribaltato la sentenza, sostenendo che non si tratta di discriminazione ma di rispetto del principio di laicità. 45 4.3.3 Interculturalità Il modello dell’interculturalità è quello dell’interazione positiva e pacifica che non solo vuole conoscere l’altro ma, pur preservando le integrità identitarie di ogni cultura, tende all’accettazione e alla comprensione delle differenze. Si tratta di un tentativo di reagire ad un concetto di culturache porterebbeinevitabilmente alla collisione, come gli esempi di multiculturalismo e di assimilazionismo ci hanno mostrato. In altre parole si può dire che l’interculturalità è un approccio sociale, di relazioni, di comunicazione, di dialogo, basato sulla convinzione che le diversità presenti in culture differenti dalla nostra possano rappresentare fonte di arricchimento, ma anche sull’evidenza che il confronto tra culture non necessariamente debba concludersi con il prevalere dell’una o dell’altra, né con l’annullamento delle due per confluire in una nuova e terza cultura. E’ un modello cha ha avuto fortuna nel dibattito italiano tra coloro che aspirano ad una società plurale e non discriminatoria. Al contrario dell’assimilazionismo, esso riconosce che le autorità pubbliche devono essere imparziali invece di accettare un’etica maggioritaria, se si vogliono evitare le tensioni comunitarie. Al contrario del multiculturalismo, esso tenta di rivendicare un nucleo comune che non lasci spazio al relativismo morale. Diversamente da entrambi, riconosce un ruolo chiave alla società civile dove, con la necessaria premessa del riconoscimento reciproco, il dialogo interculturale può risolvere i problemi della vita quotidiana in un modo che i governi da soli non possono garantire. Nella prospettiva interculturale descritta da Balboni (1991), si tratta di: conoscere gli altri tollerare le differenze fino a quando non entrano nella sfera dell’inaccettabile immoralità rispettare le differenze che non ci pongono problemi morali e rimandano solo a differenti storie accettare che alcuni modelli culturali in certe parti possono essere meglio dei nostri sapere mettere in discussione i modelli culturali con cui siamo cresciuti. In questa prospettiva appare però evidente che il modello non esce dalla trappola delle diverse moralità, rendendo visibile il suo riferimento all’esistenza di nuclei etnici e culturali fondamentalmente distinti. Alcuni sostengono che sarebbe meglio trovare il terreno comune nei diritti umani, assumendo che la violazione di un diritto umano non può mai essere invocata in nome di libertà religiosa o pratiche culturali di minoranze, né può la maggioranza giustificare discriminazioni, razzismi, discorsi d’odio. Stéphanie Le Bars, Le port du voile à l'université remis en question, LE MONDE, 5 agosto 2013 http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/08/05/le-droit-de-porter-le-voile-a-la-fac-remis-enquestion_3457436_3224.html# 45 Le Monde, 27.11.2013, http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/11/27/l-affaire-baby-loup-en-quatrequestions_3520954_3224.html 44 44 Appare evidente, a nostro parere, che alla base dell’interculturalità c’è una concezione ancora fondamentalmente essenzialistica 46 della cultura, come lo è nel multiculturalismo e nell’assimilazionismo, una concezione che riduce l’identità culturale a ormai discutibili nozioni d’identità nazionale ed etnica e considera le culture come entità discrete e riconoscibili, come delle isole, perciò separate, che non possono risolvere il problema dell’incomunicabilità. Insomma, una forma di pluralismo culturale che mira a mantenere le differenze come fonte di arricchimento, producendo una strategia difficile da applicare e con decisioni a volte contraddittorie, tanto da rischiare di portare ad un relativismo esasperato (che rinuncia a porre alcuni valori come assoluti, ritenendo tutti i valori accettabili) o a una forma del cosiddetto “razzismo differenzialista”: poiché siamo così diversi, e ognuno con diritto di rimanere tale, l’unica soluzione è “ciascuno a casa propria”. Non sarà difficile riconoscerne esempi nel caso italiano. Può sfociare anche nel mancato riconoscimento delle diversità all’interno delle comunità minoritarie e dei loro conflitti interni. Le differenze e i conflitti di classe, genere, nazionalità e tra generazioni, anche in questo caso, come nei precedenti modelli, sono ignorate e le differenze si fermano sulla soglia delle “comunità etniche”. PRAGMATICAMENTE In Italia il quadro legislativo riguardo l’utilizzo del burqa e del niqab 47 da parte delle donne islamiche vive di contraddizioni: nel testo approvato in Commissione affari costituzionali della Camera (24.11.2011) si prevede espressamente il divieto di utilizzo degli indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati burqa e niqab, divieto sanzionato con una pena dell’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Inoltre, si propone l’introduzione del reato di costrizione all’occultamento del volto, la cui condanna in via definitiva preclude l’acquisizione della cittadinanza. Questa legge ad oggi è in fase di approvazione, per via dei vari cambi di governo succedutisi dal momento della proposta ad oggi. Fonte: http://politica.nanopress.it/articolo/burqa-vietato-in-italia-ecco-come-funziona-negli-altri-paesi/28541/ Nelle aule giudiziarie italiane le donne islamiche possono indossare il velo, secondo quanto prevede la propria tradizione religiosa. A deciderlo, il Consiglio Superiore della Magistratura che il 23 febbraio 2012, a maggioranza, ha approvato una delibera nella quale si stabilisce che “deve essere garantito il pieno rispetto di quelle condotte che, senza recare turbamento al regolare e corretto svolgimento dell’udienza, costituiscono legittimo esercizio del diritto di professare il proprio culto, anche uniformandosi ai precetti che riguardano l’abbigliamento e altri segni esteriori“ (secondo l’art.19 della Costituzione).Il caso è stato sollevato dopo che, nell’ottobre 2013, un presidente di sezione aveva invitato, durante un’udienza, un’interprete nominata dal PM e comparsa in aula a capo coperto ma con il volto ben visibile, a togliersi il velo; quest’ultima tuttavia si era opposta, rinunciando così all’incarico e abbandonando l’aula. Il magistrato aveva subito spiegato che da parte sua non vi era stato alcun intento discriminatorio ma solo il dovere di far rispettare un obbligo di legge. Fonte: http://www.leggioggi.it/2012/02/23/csm-si-al-velo-islamico-nelle-aule-di-giustizia/ 46 Come se esistesse una “essenza” , una sostanza culturale dalla quale tutto discende. Il concetto si rifà alla ricerce dell’essenza delle cose propria dei pensatori pre-socratici e nella filosofia platonica ed aristotelica. 47 Il niqāb (arabo: )ﻧﻘﺎﺏè un velo presente nella tradizione araba preislamica e in quella islamica, che copre l'intero corpo della donna, compreso il volto, lasciando scoperti solo gli occhi. Si differenzia dal burqa afghano che presenta invece una sorta di retina davanti agli occhi per permettere alla donna di vedere senza scoprire gli occhi. 45 4.3.4 Transculturalità La transculturalità è prima di tutto un fatto: la conseguenza delle insite differenziazioni e complessità delle società moderne, dove tutto si estende e passa attraverso diverse culture. Le culture sono realtà in continua trasformazione il cui inevitabile processo d’interazione fa sì che sia impossibile tracciare tra di esse chiare linee di demarcazione (Wolfgang Welsch, 1999). Transculturation è il termine coniato, intorno alla fine degli anni ’40, da Fernando Ortiz, etnologo ed antropologo cubano, allo scopo di definire lo specifico fenomeno di fusione e di convergenza di culture nella cultura afro-cubana. Questo fenomeno di fusione riflette la tendenza naturale delle persone, nel tempo, a risolvere i conflitti, piuttosto che ad esacerbarli, piegando la propria ed altrui cultura verso uno stesso sentire, verso una cultura comune detta, appunto, “transcultura”. Seguendo ancora Welsch, i processi generali che intervengono in un contesto di genesi transculturale sono estremamente variegati e complessi. Ad esempio, nella società contemporanea, sia i conflitti che le loro soluzioni sono fortemente amplificati dalle moderne tecnologie (di trasporto, di comunicazione, ecc..) e l’antica tendenza alla deriva di culture ed alla separazione culturale è soppiantata da forze potenti, generalmente rappresentate da interessi economici, politici o sociali, che spingono le differenti culture verso un confronto continuo e, in definitiva, verso la convivenza sociale in un contesto transculturale. Le conseguenze che ne derivano possono essere così riassunte: 1. l’identità culturale non corrisponde necessariamente a quella civica e nazionale e nemmeno a quella dominante nel gruppo etnico o religioso di appartenenza. L’attenzione, a livello collettivo, come individuale, si sposta dalle origini all’esperienza, all’incontro qui ed ora. 2. la nozione di identità nazionale diventa più fluida e mutevole (o meglio la sua rappresentazione, perché nella realtà già è così) e l’ “italianità”, per es., o la “cinesità” andrebbero ricercate non nel passato remoto ma nel vissuto quotidiano del presente. 3. niente è mai completamente altro da sé. Quando si conosce un immigrato, gli si parla, si entra in relazione con lui o lei, egli diventa persona. Si scopre allora che ha molte cose in comune con noi, non è più il rappresentante stereotipizzato di un’etnia o di una cultura ma un individuo con una storia, la sua storia. Quando è “loro” contro “noi”, siamo nel razzismo ma in quello culturale, non più biologico. Spostando il razzismo su un piano culturale è più facile aggirare le accuse di razzismo; si tratta però sempre di una spinta alla differenziazione, da qui il nome dei nuovi razzismi identificati come “differenzialismo” o anche culturalismo differenzialista. In conclusione, si tratta di non chiudere le persone in scatole o categorie precostituite e, in base a questo, predeterminare i loro bisogni e le loro aspirazioni, con confini immutabili che altro scopo non hanno, se non quello di inferiorizzare e sfruttare. PRAGMATICAMENTE (a) Prendiamo il caso della ricerca EMBES (Ethnic Minority British Election Study), condotta dopo le elezioni britanniche del 2010, che ad ogni elezione viene riproposta allo scopo d’interpretare il voto espresso dagli elettori; è risultato che le comunità asiatiche (contrariamente alle aspettative) tendono ad essere più soddisfatte della democrazia e a identificarsi maggiormente nella Gran Bretagna di quanto accada alla popolazione bianca autoctona. In altre parole, nella misura in cui c’è un problema d’integrazione in una società e di cittadinanza, non è semplicemente un problema d’immigrati o di persone di origine immigrata ma un problema che accomuna a questi la popolazione indigena. Immaginando che una simile ricerca fosse condotta in Italia, siamo certi che otterremmo risultati simili. Fonte: http://www.runnymedetrust.org/uploads/EMBES%20Intro.pdf 46 PRAGMATICAMENTE (b) Una ricerca condotta da Abis Analisi e Strategie, dal titolo “G2, Una generazione orgogliosa”, sottolinea l’atteggiamento dei giovani musulmani di seconda generazione residenti in Italia nei confronti della politica e dello Stato. Dalla ricerca emerge che essi vedono la politica, e quindi i politici, come una “casta” lontana dagli interessi del Paese, non credono nei partiti e non pensano che destra e sinistra siano categorie distintive. Il loro atteggiamento è quindi paragonabile a quello dei giovani italiani che sono distanti e disinteressati alle questioni politiche. C’è da notare, comunque, come i giovani musulmani di seconda generazione siano sì lontani dalla politica ma interessati e coinvolti quando si tratta di politiche verso l’immigrazione, perché da questo dipende chiaramente il loro futuro e quello delle loro famiglie: “Sull'immigrazione la destra è troppo critica, la sinistra troppo aperta, Amato, Ferrero sono troppo aperti, la Bossi-Fini troppo chiusa, ci vorrebbe una via di mezzo, chi non si comporta bene viene punito, chi lavora deve essere accontentato, non siamo tutti uguali.” Fonte: “G2: una generazione orgogliosa, Una ricerca sui musulmani in Italia”. Ricerca presentata il 29 settembre 2011 al convegno "Giovani musulmani in Italia: un’integrazione possibile?" (Roma) da Italianieuropei con Genemaghrebina e Centro Studi Americani. Pubblicata on-line su diversi siti. L’esperienza delle persone che hanno reso parte al Tavolo di confronto tenutosi presso la Scuola interregionale di Polizia locale conferma quanto il quadro delle situazioni che il poliziotto si trova a fronteggiare sia molte volte assai diverso da quel che è diffuso dalla vulgata stereotipica. Vediamone alcuni brani. “Ho un amico egiziano che vive a Milano; sopra di lui abitano dei napoletani che ogni sera ascoltano la musica napoletana a tutto volume. La polizia non interviene nemmeno più perché ormai è una consuetudine.” Cittadino, Tavolo di confronto in sessione plenaria “Problemi di questo tipo (schiamazzi, feste, rumori insopportabili per gli altri condomini) ne abbiamo ma non legati alla presenza di stranieri negli appartamenti. Queste problematiche sono legate agli studenti italiani e spagnoli. Noi abbiamo 5 chiamate per notte di questo tipo e solo 1 su 50 riguarda una famiglia straniera…” Operatore di polizia, Tavolo di confronto in sessione plenaria. “A Bologna non sono solo gli stranieri che fanno schiamazzi e feste ma anche gli italiani: ad esempio gli studenti, quando organizzano feste universitarie in appartamento o più semplicemente fruendo degli spazi collettivi, comportano problemi di convivenza civile con la comunità cittadina. Siano studenti italiani o ad esempio studenti spagnoli in Erasmus, crediamo che nessuno sia diverso quando si parla di feste e schiamazzi”. Operatore di polizia, Tavolo di confronto in sessione plenaria. “Io mi sono trovata ad andare a casa dei tipici figli di papà che avevano dato una festa, ecco lì c’è la “strafottenza” vera, mi hanno risposto più volte con l’affermazione “io ho i soldi quindi non mi frega”, il problema vero è che in queste situazioni non possiamo nemmeno dire che abbiamo problemi di mediazione o culturali, qui troviamo solo la maleducazione.” Operatore di polizia, Tavolo di confronto in sessione plenaria. 47 “Gli immigrati soffrono di vittimismo, pensano che i comportamenti maleducati o sbagliati che vengono a loro rivolti siano dovuti sempre a razzismo. Anche gli stranieri sono influenzati dai mass media perché la cronaca riporta tanti casi di razzismo. Invece è un problema di cultura e educazione diversa molte volte.” “Anche gli immigrati devono studiare e adeguarsi. Devono essere educati e non partire dall’idea che sono stranieri.” “Spesso i giovani della comunità sinta o rom sono in torto perché ascoltano la musica tardi a volume alto, quindi è giusto che venga la polizia. Non c’entra il diverso, è una questione di educazione.” “E’ grottesco che ci si pongano dei problemi su come affrontare un gruppo di migranti che schiamazza, fa rumore fino a tardi. Ci sono delle regole che valgono per tutti.” Alcuni interventi di cittadini, Tavolo di confronto 1. 4.4 L’ETNOCENTRISMO E LE SUE RESPONSABILITÀ E’ un fatto che molte persone sono orgogliose della propria cultura perché essa esprime ciò a cui danno valore, cosa sono e cosa vogliono essere. La cultura, e il linguaggio che la esprime, fanno da sfondo ad ogni accadimento della vita e producono pensieri e azioni che diamo per scontati e diventano routine da non mettere in discussione. Cultura e linguaggio hanno spesso l’effetto di veicolare idee e concetti che vanno al di là di ciò che veramente ciascuno intenzionalmente intende, creando pensieri e comportamenti abitudinari dei quali possiamo persino essere inconsapevoli (ne abbiamo scritto al cap. 3).Il senso di appartenenza, il dare per scontate una serie di cose, ha anche un aspetto positivo, quello di sentirsi sicuri e “integrati” e di avere radici; ci permette di affrontare il quotidiano senza dovere mettere in dubbio qualsiasi cosa facciamo. Per molti di noi la visione del mondo che abbiamo ereditato culturalmente è l’unica che conosciamo e, incontrando un’altra cultura che ha una visione del mondo acutamente in contrasto con la nostra, stentiamo a riconoscerla come una delle tante possibilità di espressione della natura umana, rigettandola nell’errato o persino nell’inumano. Ecco allora che siamo incappati nell’etnocentrismo, cioè la tendenza a vedere il mondo attraverso i limitati confini della propria cultura e a proiettare su altri gruppi il proprio insieme di valori e norme. L’etnocentrismo offre il maggiore contributo al razzismo, perché non riconosce l’importanza delle differenze culturali per le persone coinvolte e si basa sulla falsa premessa che ci sono culture superiori alle altre. L’etnocentrismo si traduce nella riduzione di un’altra cultura a pochi, stereotipati, elementi (gli albanesi sono violenti, i cinesi sono furbi, gli italiani sono brava gente oppure, secondo i punti di vista, gli italiani sono mafiosi). Nell’approccio etnocentrico la cultura di appartenenza viene assunta a termine di paragone, più o meno insindacabile, per cui ciò che viene dagli altri è rozzo, barbaro, incivile. E’ comprensibile che l’incontro con differenti culture possa anche disorientare, mettendoci a confronto con mondi così diversi che addirittura certe cose possono apparire per noi moralmente ripugnanti, mentre sono un gesto necessario e appropriato per altre. Pensiamo, per esempio, alle mutilazioni genitali femminili praticate in alcune zone del pianeta e ritenute da molti di noi una pratica disumana e una violazione di più di un diritto umano, mentre per alcuni gruppi sociali sono un rituale necessario per segnare il passaggio da un’età all’altra della donna, oppure sono considerate un’esigenza estetica o sanitaria, comunque il modo che gli uomini hanno trovato per controllare la sessualità femminile e “favorire” la docilità delle donne. Come comportarci dunque di fronte a queste sconcertanti differenze? La risposta non è facile, però è d’aiuto sapere che queste differenze esistono, essere preparati ad un incontro che può essere anche molto 48 disorientante, non abdicare a principi che riteniamo imprescindibili (certamente i diritti umani) e nel contempo non respingere necessariamente nella “incultura” o inciviltà, nella barbarie, ciò che è diverso. Purtroppo nessuna cultura è esente dal produrre pregiudizi e l’etnocentrismo è un male universalmente diffuso. Per molto tempo gli europei hanno pensato che esistesse un’unica storia lineare del progresso umano e che in essa le culture primitive dovessero essere collocate in un continuum che, partendo da forme più arretrate, salissero fino alla cultura per eccellenza, quella occidentale. Questa concezione è ora respinta da tutte le discipline sociali. Appare evidente che ogni cultura ha dei problemi nel sistema di valori cui si ispira e difficilmente si potrà trovare una cultura che sia migliore, più giusta o anche solo più razionale di un’altra: non è forse nostra (di bianchi europei) la prerogativa di avere schiavizzato e deportato milioni di neri dall’Africa o di avere ucciso la quasi totalità degli abitanti autoctoni delle Americhe o, più recentemente, di avere liquidato milioni di ebrei, zingari, omosessuali e dissidenti politici? E non siamo forse noi gli stessi che affittiamo le camere per somme indecenti agli immigrati, i clienti delle prostitute nigeriane e albanesi e quelli che offrono i documenti necessari ad ottenere il soggiorno solo dietro il pagamento di una mazzetta? 4.4.1 Alcuni spunti di riflessione e un primo bilancio Abbiamo affrontato il tema della mutevolezza delle culture nel tempo e nel luogo; ora dobbiamo riconoscere anche che, all’interno di una stessa cultura, in un dato momento storico, esistono insiemi comunicativi e di comportamento che i sociologi hanno designato “sub-culture”, intendendo con ciò non segmenti di popolazione collocati in posizione di minor valore, bensì il riconoscimento che esistono persone che, essendo italiane, sono però classificabili anche come di lingua ladina o di religione valdese; che esistono posizioni politiche differenziate che fanno parlare di sub-culture di destra e di sinistra. O ancora la sub-cultura giovanile e, al suo interno, potremmo distinguere i diversi segmentidei neo-punk e dei giovani in carriera che indicano addirittura stilidi vita diversissimi e quasi opposti. Proponiamo, in conclusione di questa breve trattazione, alcuni punti che possono costituire argomento di analisi con i vostri colleghi: la cultura italiana è ricca e complessa, tanto che possiamo individuare diverse culture regionali o di porzioni ancora più limitate. Non esiste dunque “una cultura italiana” e tantomeno ne esiste “una” immobile nel tempo; non è sempre facile riconoscere la propria identità culturale né le proprie origini o ‘retroterra’ culturali o etnici perché è impossibile ridurre l’identità di una persona ad un solo tratto; non è possibile conoscere tutto della cultura italiana; nessuno incorpora o esprime tutta la cultura italiana ma solo qualche aspetto; nessun individuo può rappresentare la cultura italiana. Quindi possiamo comprendere che: ogni cultura è ricca e complessa e mutevole nel corso del tempo; una cultura è più grande dell’identità culturale di qualsiasi individuo; l’identità etnica e culturale di una singola persona non rappresenta la totalità di un’etnia o cultura; non importa quanto sappiamo di un’etnia o di una cultura, la persona che ci troviamo davanti non è una cultura, non rappresenta una cultura e non è tipica di una cultura: quella persona è un individuo. 49 4.5 CITTADINANZA 4.5.1 Verso l’integrazione? Il ruolo dell’Europa L’Europa, specie nell’ultimo decennio, ha elaborato numerosi documenti, in cui si è provato ad armonizzare le politiche d’immigrazione e d’integrazione.Il Consiglio europeo di Tampere (1999) è stato il primo a formalizzare l’idea che fosse urgente assicurare maggiore garanzia dei diritti fondamentali agli stranieri residenti nei Paesi europei: “L’Unione europea deve garantire l’equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri. Una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell’UE.” Nel 2003 fu raggiunto un accordo secondo il quale l’integrazione dovrebbe essere intesa come un “processo a doppio senso”, basato sui diritti reciproci e i relativi obblighi dei cittadini di Paesi terzi residenti legali e della società ospitante che provvede alla piena partecipazione dell’immigrato. Questo implica, da una parte, che è responsabilità della società ospitante assicurare che i diritti formalidegli immigrati vengano applicati al punto da poter dare all’individuo la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale culturale e civica; dall’altra parte, che gli immigrati debbano rispettare le norme fondamentali ed i valori della società ospitante ed abbiano la possibilità di partecipare attivamente al processo di integrazione, senza rinunciare tuttavia alla propria identità culturale 48. Nel 2004 il Consiglio dell’Unione Europea produsse i Principi fondamentali comuni sull’integrazione (Common Basic Principles – CBP), oltre a manuali, forum, siti e fondi per il finanziamento dell’integrazione dei cittadini di Paesi terzi (FEI). Non intendiamo ripercorrere questa copiosa produzione ma riportare i CBP, una guida semplice e non vincolante attraverso la quale, nelle intenzioni del Consiglio dell’Unione Europea, gli stati membri possono fissare e valutare le loro politiche. 49 1. L'integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri. 2. L'integrazione implica il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione Europea. 3. L'occupazione è una componente fondamentale del processo d'integrazione ed è essenziale per la partecipazione degli immigrati, per il loro contributo alla società ospite e per la visibilità di tale contributo. 4. Ai fini dell'integrazione sono indispensabili 1)conoscenze di base della lingua, della storia e delle istituzioni della società ospite; 2) mettere gli immigrati in condizione di acquisirle è essenziale per un'effettiva integrazione. 5. Gli sforzi nel settore dell'istruzione sono cruciali per preparare gli immigrati e soprattutto i loro discendenti ad una partecipazione più effettiva e più attiva alla società. 6. L'accesso degli immigrati alle istituzioni nonché a beni e servizi pubblici e privati, su un piede di parità con i cittadini nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una migliore integrazione. 7. L'interazione frequente di immigrati e cittadini degli Stati membri è un meccanismo fondamentale per l'integrazione. Forum comuni, il dialogo interculturale, l'educazione sugli 48 European Commission, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament onImmigration, Integration and Employment, COM(2003) 336, Brussels, 3 June 2003. 49 “Common Basic Principles on Immigrants Integration” in Council of the European Union, 2618th Meeting of the Justice and Home Affairs Council, 14615/04, Brussels, 19 November 2004. 50 immigrati e la loro cultura, nonché condizioni di vita stimolanti in ambiente urbano potenziano l'interazione tra immigrati e cittadini degli Stati membri. 8. La pratica di culture e religioni diverse è garantita dalla Carta dei diritti fondamentali e deve essere salvaguardata, a meno che non sia in conflitto con altri diritti europei inviolabili o con le legislazioni nazionali. 9. La partecipazione degli immigrati al processo democratico e alla formulazione delle politiche e delle misure di integrazione, specialmente a livello locale, favorisce l'integrazione dei medesimi. 10. L'inclusione delle politiche e delle misure d’integrazione in tutti i pertinenti portafogli politici e a tutti i livelli di governo e di servizio pubblico è una considerazione importante nella formulazione e nell'attuazione della politica pubblica. 11. Occorre sviluppare obiettivi, indicatori e meccanismi di valutazione chiari per adattare la politica, valutare i progressi verso l'integrazione e rendere più efficace lo scambio di informazioni. Nonostante l’aumento senza precedenti del coinvolgimento dell’Unione Europea nelle politiche in materia di integrazione degli immigrati, l’impatto dell’UE sulle politiche nazionali di integrazione negli ultimi quindici anni è stato seriamente limitato. I limiti sono, per la maggior parte, autoimposti: la mancanza di poteri di applicazione è ovviamente un fattore importante che concorre a spiegare la modestia del ruolo dell’Unione Europea (Carrera S., 2008). Ricordiamo infine, per la particolare pertinenza che ha con gli scopi di questo testo, la Dichiarazione di Milano “Integrating Cities” che riconobbe il ruolo chiave delle città nelle politiche di integrazione ed il bisogno di rafforzare le loro voci. Essa ha inoltre lanciato il cosiddetto “processo di integrazione delle città” come una piattaforma per incoraggiare il dialogo tra città riguardo ai CBP a livello locale. 50 4.5.2 Integrazione o cittadinanza? Considerando le riflessioni sin qui condotte, ci pare evidente che la questione delle differenze culturali deve essere inquadrata nel contesto più ampio dei diritti di cittadinanza e delle correlate responsabilità. Il compito dello Stato diventa allora quello di trasformare la società, per far sì che in essa cittadini diversi, con tutte le loro differenze, dentro e fuori le rispettive presunte comunità, siano trattati equamente. Una delle caratteristiche della nostra epoca è la disillusione nei confronti degli uomini politici, la crisi del modello di rappresentanza, il senso d’impotenza che sentiamo come cittadini di fronte ad istituzioni politiche lontane e corrotte. Certamente si tratta di sentimenti che colpiscono anche i migranti e i gruppi minoritari, portandoli verso un senso di alienazione. Eppure, questo distacco è probabilmente più acuto tra gli italiani in generale che tra i migranti mentrei richiami (legislativi, massmediatici, nei discorsi politici, ecc.) alle divisioni tra immigrati e cittadini italiani si sono irrobustiti e i migranti sono diventati ancor più il capro espiatorio per la frammentazione della società. Questo processo non ha colpito solo l’Italia ma ha invaso l’Europa, come dimostrano i successi di movimenti populisti, reazionari ed apertamente neonazisti. “Non solo la convinzione che l’immigrazione crei problemi di integrazione e di cittadinanza fa confusione sulla vera questione ma, fomentando l’ostilità contro gli immigrati che molti arrivano a credere incapaci (o non desiderosi) d’integrazione, crea nuove tensioni. Facendo ciò si rende la vita più dura, e molto spesso anche più pericolosa e violenta, agli appartenenti alle minoranze e agli immigrati in genere, creando ulteriori barriere contro l’integrazione. Pensare 50 Firmata dall’allora Commissario per la libertà la sicurezza e la giustizia Franco Frattini, Letizia Moratti (ex sindaco di Milano) e Ivo Opstelten (ex sindaco di Rotterdam). 51 che vi sia un problema d’immigrazione e cittadinanza aiuta proprio a creare quel problema d’immigrazione e cittadinanza”(Kenan Malik, 2011). 51 Per questa ragione, e per tutto quanto precede, questo capitolo portail titolo “cittadinanza” piuttosto che “integrazione”. Per radicare una diversa immagine dell’immigrazione è indispensabile promuovere il protagonismo e l’effettiva partecipazione alla vita politica, sociale, oltre che economica, delle persone di origine straniera. Vanno messe in campo iniziative e strumenti che consentano una socialità e una partecipazionenello spazio pubblico che sono oggi di fatto negate a milioni di migranti e alle loro famiglie. Prendere la parola e contare nelle decisioni che riguardano la collettività deve essere un obiettivo prioritario per chi vuole ridare all’idea di cittadinanza un significato inclusivo e di ampliamento dello spazio dei diritti (Miraglia, 2011). Citiamo, per tutti, il caso delle migliaia di bambine e bambini che nascono in Italia, nascono come cittadini stranieri, e stranieri rimangono fino a ben oltre il raggiungimento della maggiore età (se, oltre che della legge, teniamo conto anche delle difficoltà burocratiche e amministrative che si frappongono all’ottenimento della cittadinanza italiana). Oggi il tema pressante è dunque quello della cittadinanza e non dell’integrazione; è la necessità di promuovere tutte le forme di partecipazione, a partire da quella politica e istituzionale rappresentata nel diritto di voto. Centinaia di migliaia di persone che lavorano e pagano le tasse per contribuire al bene comune non partecipano alla definizione del sindaco, del consiglio comunale e tantomeno del governo nazionale. E’ questa la prima forma di discriminazione. Per fortuna, coloro che noi chiamiamo “seconde generazioni” e che raccolgono giovani nati in Italia da genitori stranieri o giunti in Italia nei primi anni di vita, italiani di fatto ma non di diritto, hanno avviato esperienze associative interessanti. Sta a noi, italiani, e anche agli operatori di polizia, favorire la crescita e il consolidamento della loro operazione di “coping attivo e pianificato”, rendendo ai loro occhi meno attraente il comportamento di sfida e di reinvenzione etnica antagonista (si vedano i relativi approfondimenti al cap. 5.6). Certo, come Balibar (1992) sottolinea, la nozione di cittadinanza deve assumere l’esistenza di differenze tra cittadini, altrimenti ridiventerebbe escludente e discriminatoria. L’appartenenza della gente ad uno Stato, i loro diritti e le loro responsabilità sono mediate dalla loro appartenenza ad altre collettività sub, attraverso e sovra statali. Il loro collocarsi in queste collettività, così come le differenze di genere, classe, sessualità, momento nel ciclo di vita, abilità, ecc. devono essere riconosciute e trattate in ogni progetto di cittadinanza che voglia essere inclusivo e democratico. 51 “Not only does the belief that immigration creates a problem of integration and of citizenship misunderstand the real issue, but in fostering hostility against immigrants, whom many come to believe are incapable of integrating, or unwilling to, such belief also establishes new tensions. In so doing it not only makes life harder, and often more violent and dangerous, for immigrants and minorities, it also constructs new barriers to integration. The very belief that there is a problem of immigration and citizenship helps create the problem of immigration and citizenship.” http://www.kenanmalik.com/lectures/trudeau_citizenship.html, 2011. 52 “Lo Stato ha un ruolo essenziale. Se non alziamo la nostra visione rischiamo di non cogliere il fondamentale ruolo dello Stato che deve mettere i poliziotti in grado di lavorare al meglio e i cittadini in grado, nelle giuste condizioni, che siano autoctoni o di origine straniera, di essere esemplari e rispettosi della legge. Se lo Stato emette leggi lacunose, allora a noi non resta che ricadere nel buon senso, nella sola possibilità delle “gentilezza”, nel rappresentarsi in un qualche modo, tentare un approccio che non leda l’altro. Il quadro legislativo italiano attuale mette in seria difficoltà tutti a essere rispettosi della legge. Dobbiamo invece riconoscere che il quadro dell’immigrazione in Italia è terribile. Basterebbe per questo citare un esempio molto semplice per mostrare il ritardo che abbiamo rispetto agli altri Paesi UE, il caso della cittadinanza alle G2 (il reclamato jus soli): ti trovi davanti un italiano e lo devi trattare come straniero mentre l’altro non vuole essere trattato da straniero. Quando il vecchietto dice “voialtri là del Congo…” “no, invece io sono italiano”. Se burocraticamente non ti si riconosce la tua appartenenza si complica di più il rapporto con l’altro. Questo vale anche per chi non è cittadino italiano, quelli che sono gli ultimi arrivati, quelli che non hanno fatto domanda di cittadinanza italiana, quelli che non si sentono di essere italiani, ecco che il quadro legislativo li lega allo Statoper l’aspetto reddituale: sei più italiano se lavori per lo Stato italiano, sei meno italiano se non lavori. Vi faccio un esempio: io che ho scelto di studiare e non di lavorare non sono cittadino italiano, giro con un Permesso di soggiorno e vengo trattato da straniero quando io mi sento totalmente italiano, mentre mio padre e altri, che non parla nemmeno bene l’italiano emagari è anche meno integrato di me, è invece cittadino. Lo Stato riconosce loro il fatto di versare dei soldi, il rapporto è d’interesse economico: “Guarda, per me puoi anche non essere cittadino, l’importante è che mi paghi i contributi perché io possa pagare le pensioni. Se invece vuoi integrarti nel tessuto sociale ed economico dell’Italia non sei riconosciuto.” È lo Stato che ha il ruolo primario di metterci nelle condizioni di rispettare le leggi, altrimenti non ci rimane che il buon senso da usare in questo lavoro di oggi e nella pratica quotidiana delle relazioni tra cittadini stranieri e operatori di polizia.” Cittadino, Tavolo di confronto in sessione plenaria. 53 5. DAL RAZZISMO ALLA DISCRIMINAZIONE 54 5.1 VECCHI E NUOVI RAZZISMI Il razzismo classico, quello che si fa risalire a Joseph-Arthur de Gobineau, imputa la diversità culturale ad un elemento naturale, assegna all’altro un valore negativo e spiega tutto individuando nell’elemento genetico-razziale la supposta inferiorità. Le teorie che stanno alla base di questo razzismo sono state da tempo confutate sul piano biologico e genetico. E’ facile inoltre dimostrare che una persona appartenente ad una “razza”, se sin da piccola cresciuta ed educata in un ambiente del tutto diverso da quello di appartenenza “razziale”, crescerà come persona socialmente “media” secondo gli standard della cultura nella quale è stata allevata. Oggi difficilmente si troverà qualcuno che si dichiari apertamente razzista nel senso appena indicato. Ciò non significa che il razzismo, sia come ideologia, sia come pratica quotidiana, stia scomparendo. Tutt’altro. Esso si presenta piuttosto in forme più sottili e perciò più subdole e difficili da combattere: dalla nozione di “razza” si è passati a quella di “etnia” e gran parte del dibattito attuale sul razzismo riguarda in realtà non la “razza” biologica, bensì l’appartenenza etnica, la diversità culturale e la conflittualità interetnica. Ci sono persino rischi di razzismo in quelle teorie che, come il relativismo culturale (concetto caro a molti autori in campo antropologico ed etnografico), nel loro intento originario volevano arrivare ad un’idealizzazione della differenza, alla diversità vista come valore, come fonte di confronto e di arricchimento. Per questa via, invece, estremizzandone i contenuti, molti oggi arrivano al “giustificazionismo culturalista”, la forma di razzismo oggi più diffusa che considera comunque e sempre valide e rispettabili tutte le manifestazioni di cultura e considera ingiusta ogni pressione esterna finalizzata alla modifica di quei tratti. Essa é particolarmente insidiosa perché non necessariamente parte dalla superiorità della propria cultura ma piuttosto dall’irriducibile differenza tra le culture, ogni cultura avendo prodotto senso nel contesto in cui si è sviluppata e dove ha diritto di conservarsi, purché non esca da quel contesto o territorio e non minacci il diritto degli altri alla propria identità culturale. In sostanza, il ragionamento è semplice: tutti gli esseri umani sono uguali ma sono legati a sistemi di significato che si sono differenziati, le “culture” appunto, che vanno rispettate nella loro diversità. Si può arrivare così a sostenere che “ognuno deve stare a casa sua”.Riferendosi al caso francese, Amselle scrive che anche la destra estrema di Le Pen, così come gli estremisti razzisti sudafricani, sono per il differenzialismo, naturalmente “per un relativismo che sfocerebbe in una situazione di apartheid”. I sostenitori di questa posizione sono convinti che la decadenza comincia quando le culture interagiscono e creano fenomeni di sincretismo, in sostanza confusione, delle culture e dei suoi prodotti. Altrove in questo testo, per converso, si riferisce di come tutti gli approcci antropologici, sociologici e di psicologia sociale riconoscano che quelli che appaiono come “risultati” di una cultura “non sono mai stati prodotte da culture isolate, bensì da culture che, volontariamente o involontariamente, combinavano i loro giuochi rispettivi e realizzavano con vari mezzi (migrazioni, influenze, scambi commerciali e guerre) quelle coalizioni (necessarie a produrre quei risultati). (…) La possibilità che una cultura ha di totalizzare quel complesso insieme di invenzioni di ogni ordine che chiamiamo una civiltà, è funzione del numero e delle culture con cui essa partecipa all’elaborazione – il più delle volte involontaria – di una comune strategia.” 52 5.2 DISCRIMINARE Esiste discriminazione quando qualcuno è trattato meno favorevolmente degli altri a causa di un suo tratto personale specifico, quale classe, genere, “razza” o appartenenza etnica, disabilità, orientamento sessuale, età, religione o visione del mondo. Questa discriminazione diventa un’esperienza di oppressione perché agita da soggetti in un rapporto di potere diseguale, o da due gruppi sociali, di cui uno più potente e l’altro meno potente. L’oppressione così intesa implica calpestare i diritti di un individuo o di un gruppo e 52 Lévi-Strauss C., Razza e storia e altri studi di antropologia”, Einaudi, Torino, 1968, pag.136 55 creare svantaggio per questo gruppo e per i singoli che vi appartengono. Le disparità sono mantenute attraverso processi di discriminazione che hanno l’effetto di distribuire le opportunità della vita, il potere e le risorse in un modo che rafforza le relazioni di potere già esistenti. E’ proprio attraverso questo processo interattivo tra discriminazione e disparità che lo status quo è mantenuto. Tutti gli Stati membri dell’Unione Europea hanno accettato la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD) obbligandosi, con questo passo, a prevenire, proibire, punire e sradicare tutte le forme di discriminazione razziale e incitamento all’odio razziale. Tuttavia, sebbene esistano ormai da anni strumenti legali che offrono protezione dalle discriminazioni alle minoranze di vario tipo, ivi comprese le minoranze etniche, religiose e nazionali, queste minoranze continuano a subire atti di razzismo, discriminazioni e violenze fisiche e verbali. Il razzismo, nelle sue forme antiche e moderne,quando è agito e produce effetti, è una forma di discriminazione. La Dichiarazione Internazionale delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale 53 afferma che: “Costituisce discriminazione razziale ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, sul colore, sulla nascita, sulle origini nazionali ed etniche che abbia lo scopo di modificare o limitare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio su un piano di parità dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o qualunque altro campo”. Nel 1978 l’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, dichiarò che “Qualunque teoria che asserisca che gruppi “razziali” o etnici siano intrinsecamente superiori o inferiori - sottintendendo così che alcuni avrebbero il diritto di dominare o eliminare altri che sarebbero inferiori - o che attribuisce un giudizio di valore alle differenze razziali, non ha fondamento scientifico ed è contraria ai principi morali ed etici dell’umanità.” “Tutti uguali – tutti diversi” é lo slogan che nel decennio 2000 ha avuto grande diffusione in Europa, grazie all’impegno della Commissione Europea nella lotta alla discriminazione razziale lanciata nel 1997, proclamato “Anno europeo contro il razzismo”. In quell’anno l’Unione Europea inseriva l’Art.13 nel Trattato dell’Unione (Trattato di Amsterdam). In base a questo articolo, L’Unione ha acquisito maggiori poteri e autorità d’intraprendere opportune misure per combattere le varie forme di discriminazione per motivi relativi a sesso, “razza” o origine etniche, religione, credo, disabilità, età e orientamento sessuale, determinando anche l’approvazione di standard minimi di lotta contro le discriminazioni che hanno cambiato le leggi interne di più di un Paese, tra cui l’Italia. 5.2.1 Tre livelli di discriminazione Esistono meccanismi che producono e riproducono discriminazione. Tali meccanismi soggiacciono alle discriminazioni perpetrate su qualunque base (razziale, etnica, religiosa, per orientamento sessuale, di genere, per disabilità, età ecc.) e agiscono a tre livelli: 54personale, culturale e strutturale. I tre livelli interagiscono inoltre tra di loro rafforzandosi vicendevolmente. In questa breve trattazione seguiamo le riflessioni di Thompson (1998) per la loro capacità descrittiva e d’orientamento all’azione. Livello personale Avviene nei pensieri, sentimenti, atteggiamenti e azioni di un individuo, ed è tanto più efficace quanto più il soggetto è in posizione di potere. La manifestazione evidente di ciò è il pregiudizio, cioè il formarsi un’opinione, un giudizio, e rifiutare di cambiarlo o abbandonarlo 53 Entrata in vigore nel 1969; firmata dall'Italia il 13 marzo 1968, ratificata solo nel 1976 ed entrata in vigore il 4 febbraio 1976. 54 Adattato da Thompson N., Promoting Equality – Challenging discrimination and oppression in the human services, Londra, Macmillan, 1998 56 anche di fronte ad un’evidente prova contraria (si veda il capitolo 3). Può conseguirne una discriminazione consapevole o inconsapevole, in ogni caso l’effetto non cambierà. E’ importante riconoscere che il pregiudizio (e la discriminazione che ne può seguire) non è unidimensionale e coinvolge persone diverse in situazioni diverse: una donna nera può essere vittima di razzismo e sessismo e tuttavia discriminare le persone omosessuali o le persone disabili. Livello culturale Sebbene ogni individuo sia unico, dobbiamo riconoscere che i suoi valori e le sue azioni sono, in diverso grado secondo gli individui, legati alle aspettative e norme prevalenti nella società in cui vive. E’ a livello culturale che gruppi e individui possono essere esclusi ed emarginati nella creazione del “noi” e del “loro”, per esempio nei libri di storia, nelle trasmissioni televisive, nella produzione cinematografica, nel discorso pubblico, specie nelle esternazioni dei politici 55. Si è già detto che il senso di appartenenza, il dare per scontate una serie di cose ha l’aspetto positivo di farci sentire sicuri e integrati, di avere radici, permettendoci di affrontare il quotidiano senza dovere mettere in dubbio qualsiasi cosa facciamo; insomma uno strumento necessario per non avere un corto circuito informativo. Ribadiamo però che il pericolo in agguato è l’etnocentrismo, cioè la tendenza a vedere il mondo attraverso i limitati confini della propria cultura e a proiettare su altri gruppi il proprio insieme di valori e norme sulla base della falsa premessa che ci sono culture superiori alle altre.Si tratta di meccanismi di esclusione che hanno operato anche quando le donne cominciarono a lavorare in polizia o nell’edilizia o quando gli stranieri cominciarono a immigrare. L’arrivo di una minoranza in un’organizzazione inizialmente provoca incertezza nella maggioranza, la gente non si sente più tanto sicura sul comportamento da tenere (“posso ancora raccontare quella barzelletta? come mi devo comportare con una persona così?”), al punto che questa insicurezza fa dimenticare ai membri della maggioranza le tante differenze all’interno del proprio gruppo di appartenenza (le persone sposate e quelle singole, chi ha figli e chi non ne ha, il ceto di appartenenza, l’orientamento politico, ecc.). Ora essi hanno occhi solo per le differenze tra maschio e femmina, tra abile e disabile, tra autoctono e immigrato. E questa insicurezza, per difesa, porta ad un rafforzamento della cultura dominante, la cultura del “qui si fa così”. L’esagerazione delle differenze ha anche un’altra seria conseguenza: quella di spianare la strada per l’esclusione delle minoranze, cosicché a donne, anziani, gay e lesbiche, disabili, minoranze etniche sono date minori opportunità di trovare lavoro e di carriera. Per questi outsider diventa quindi difficile penetrare nei circuiti formali e informali dove si prendono veramente le decisioni. Un esempio può chiarire meglio questo livello: alle donne italiane non è stato permesso diventare magistrato o ricoprire alti incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione fino al 1963 56, sulla base dello stereotipo che vuole le donne incapaci di giudicare serenamente perché troppo emotive; in questo modo si biologizzava un carattere che può forse appartenere a qualche donna ma certamente anche a molti uomini, e si negava la verità che ci sono persone adatte ad essere giudice ed altre no, indipendentemente dal loro sesso, come l’evidenza degli altri Paesi meno arretrati su questo punto e la stessa esperienza italiana degli anni successivi hanno ampiamente dimostrato. Livello strutturale I modelli culturali non esistono nel vuoto ma sono in constante interazione con fattori sociali, politici ed economici. Benché esso sia presente anche negli altri due livelli, s’introduce qui più 55 ECRI così si esprime nel suo ultimo Rapporto sull’Italia (2012) al punto 56: “(…) Nei media, i Rom e i migranti sono in particolare associati ad attività criminali e di conseguenza a una minaccia per la pubblica sicurezza; delle immagini negative e stigmatizzanti (alcune delle quali comunicate talvolta da responsabili politici) di richiedenti asilo e di musulmani sono state inoltre ripetutamente diffuse. Tali pubblicazioni e diffusioni contribuiscono ad avvelenare un clima già intollerante nei confronti dei gruppi minoritari. Alcuni osservatori vedono tra l’altro una correlazione tra la pubblicazione di tali articoli e il successivo verificarsi di incidenti xenofobi.” 56 La legge che ha reso possibile il superamento di questa discriminazione istituzionale è la n.66 del 9 febbraio 1963. 57 pienamente l’elemento del potere. Le idee sessiste, per esempio, non sorgono per caso ma per proteggere privilegi: in questo caso, per mantenere gli uomini in posizione di potere e privilegio. Molti autori contestano che il razzismo sia dovuto alle idee e ai pregiudizi delle persone: ciò che veramente importa sono le strutture di potere, le istituzioni e le pratiche sociali che producono e riproducono l’oppressione razziale e gli effetti delle discriminazioni. Le strutture cui si fa riferimento sono il mondo del lavoro, il sistema scolastico, il sistema giudiziario e di polizia, la Pubblica Amministrazione, i mass media, la politica. Sono state per prime le studiose femministe a mettere in dubbio l’ideologia che sottende ad una società patriarcale e sessista, basata su una differenza biologica che confinerebbe “naturalmente” la donna nella casa e nell’allevamento dei figli. Allo stesso modo il razzismo si basa sull’idea che ci siano “razze” (o culture, o etnie) diverse, alcune delle quali inferiori alle altre. Ed è proprio questo processo di attribuire un significato alle differenze e di assegnare ad ognuna livelli di valore diversi che sta alla base della discriminazione, dell’oppressione e dell’esclusione. Un fenomeno che è il risultato di una costruzione sociale e storica è trattato come un evento naturale o come l’inevitabile risultato di caratteristiche naturali, cosicché, per esempio, la divisione sociale del lavoro tra uomini e donne è ritratta come il prodotto di caratteristiche e differenze fisiologiche tra i sessi. In altre parole, fenomeni storico-sociali sono privati del loro aspetto storico e descritti e considerati come eternamente ricorrenti e immutabili. Lo stesso processo di “naturalizzazione” interviene quando si considera la vecchiaia come “naturalmente” un periodo di ritiro e disimpegno dalla vita sociale, così come, all’altro capo dello spettro dell’età, sta la costruzione sociale dell’infanzia che, pur essendo cambiata nel corso dei secoli anche all’interno della nostra stessa società, viene ancora relegata a una posizione priva di potere e con scarsa enfasi sui diritti. Così come per le persone disabili è ancora presente un’immagine sociale che li vede prevalentemente come destinatari di cura ed assistenza, lontani quindi da un’esperienza di vita in cui la presenza di un deficit non nega la possibilità di costruire e godere una qualità di vita globale. 5.2.2 Strategie di esclusione Philomena Essed 57, in un suo famoso studio che, pur con alcuni limiti, rimane una pietra miliare nella descrizione e tipizzazione delle strategie di esclusione da parte dei gruppi dominanti, identificatre diverse strategie per limitare l’influenza degli outsider che possono essere usate senza volere oppure deliberatamente. Tali strategie si riscontrano in tutte le società a maggioranza bianca (nelle aziende, nella Pubblica Amministrazione, ecc.) e il modello può essere applicato a qualunque gruppo subordinato. Il modello proposto da Essed (al di là che la soglia di tolleranza possa collocarsi effettivamente attorno al 4% di presenza di una minoranza o no, limite che sarebbe contraddetto da altre indagini) riguarda i trattamenti non equi sia all’interno dell’organizzazione, sia da parte dell’organizzazione verso l’esterno e vale anchenel caso delle polizie locali, come di ogni altra istituzione pubblica o organizzazione privata. Pensiamo, ad esempio, ai casi di un operatore di polizia omosessuale o donna, oppure al caso di una persona di religione musulmana o di origine etnica minoritaria che si presenti al comando di polizia per segnalare di essere stato vittima di un caso di razzismo. Come più volte si sottolinea in questo testo, un’organizzazione è libera da discriminazione e attiva nel promuovere la piena integrazione dei propri lavoratori e la piena rappresentazione degli interessi di tutta la comunità che serve, solo se affronta l’equità nei confronti di entrambe le categorie menzionate, lavoratori o clienti-utenti. Essed individua tre modalità di reazione alla presenza di minoranze in un’organizzazione (e nel contesto ampio della società) che elenchiamo sinteticamente di seguito. 57 Philomena Essed, Understanding everyday racism, SAGE Publication,1991 58 1. Emarginazione – una forma di esclusione > Ignorare le forme di discriminazione I lavoratori di un’organizzazione non si sentono responsabili per quelle relazioni che escludono gli altri. Razzismo, omofobia, sessismo, ecc. non sono messi in questione da nessuno e lo status quo permane. > Il pensiero gerarchico Il gruppo dominante è convinto della propria superiorità: gli uomini sono superiori alle donne, la cultura europea è la norma ed è superiore. > Ostacoli alle pari opportunità Ci sono molti modi per rendere l’ingresso difficile agli “altri” o la loro progressione in carriera. Ciò può avvenire in forme più o meno sottili: mancato riconoscimento delle qualità, tattiche di scoraggiamento, sovraccarico di lavoro, trattenere informazioni fondamentali. 2. Problematizzazione – ideologie usate dal gruppo dominante per legittimarsi > Denigrare la personalità Le persone sono etichettate come inaffidabili o eccessivamente sensibili. > Denigrare la cultura Le differenze sono spiegate in termini di cultura “loro sono indietro rispetto a noi” o addirittura gli altri sono considerati incivili. > Denigrare su base biologica Le persone sono etichettate come “problematiche” attraverso un processo di criminalizzazione o ascrivendo loro, per esempio, aberrazioni sessuali. 3. Contenimento – una forma di repressione > Negazione della discriminazione Si può ignorare la discriminazione evitando di prendere posizione o con una posizione attiva di diniego in risposta a lamentele di razzismo, sessismo o altro. > Amplificare le differenze I responsabili e i dirigenti possono (anche inavvertitamente) amplificare le differenze riservando certi lavori alle minoranze o possono introdurre meccanismi di decisione che premiano la maggioranza. > Il paternalismo Il paternalismo può assumere molte forme, dalla protezione all’aspettativa della gratitudine, che rafforzano la dipendenza. > Negazione della dignità Le persone possono essere sminuite o umiliate. > Intimidazione Molestie e intimidazioni possono assumere varie forme, dalla violenza fisica o sessuale, alle minacce verbali e prepotenze per creare un’atmosfera ostile attraverso scherzi o forme di ridicolizzazione. > Ritorsioni L’assertività può essere punita, le promozioni provocano gelosia e si covano invidie, tutti modi per pensare a o consumare una vendetta. 59 5.3 DISCRIMINAZIONE: DEFINIZIONI E CONCETTI Il nostro ordinamento giuridico prevede, così come nel dettato europeo, due forme di discriminazione: diretta e indiretta. 5.3.1 Discriminazione diretta Si ha discriminazione diretta quando: “per la razza o l’origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga”. 58 La stessa definizione si applica nel campo delle discriminazioni sul lavoro, secondo il decreto legislativo n.216 del 2003 59. Queste definizioni richiamano peraltro quella contenuta nel Testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo n.286/1998, rivisto poi dalla Legge “Bossi-Fini” nel 2002): “1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”. (Art.43, comma 1) E’ opportuno richiamare l’attenzione sull’espressione “abbia lo scopo o l’effetto”. La congiunzione disgiuntiva “o” indica senza alcun dubbio che nel caso in cui lo scopo non fosse dichiarato o nemmeno interpretabile come tale la volontà dell’autore dell’atto, in ogni caso, costituiscono discriminazioni quelle azioni che producono l’effetto di creare una disuguaglianza del tipo descritta dall’articolo. Non ci si potrà insomma liberare dall’accusa per il solo fatto di non averne avuto l’intenzione. Il comma 3 precisa: “Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea presenti in Italia”. 58 Art.2, comma 1 del D.Lgs 215 /2003, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. La direttiva n.43 e il decreto 215/2003 vietano la discriminazione razziale ed etnica in materia di occupazione, istruzione, sicurezza sociale e assistenza sanitaria, fornitura di beni e servizi, compreso l’alloggio. 59 D. Lgs 216/2003, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro negli ambiti di religione o convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. L’art.1, c.1 recita infatti che si ha discriminazione diretta “a) (…) quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga. 60 Alcuni esempi Gli esempi che seguono sono presi da diverse fonti, comprese fonti dirette degli autori. Bangla tour Nel mese di dicembre 2013 la Procura di Roma aprì un’inchiesta sui pestaggi di diverse persone di cittadinanza straniera compiuti ad opera di giovani militanti di estrema destra nella capitale. La notizia dei pestaggi era venuta alla luce dopo l’arresto di un diciannovenne e un sedicenne romani che il 18 maggio dello stesso anno avevano picchiato a sangue un minorenne originario del Bangladesh, finito in ospedale col labbro e il sopracciglio spaccati. In quell’occasione il quotidiano la Repubblica intervistò altri giovani appartenenti all’ambiente neofascista capitolino dalle dichiarazioni dei quali risultò che queste aggressioni erano viste come una sorta di rito di passaggio. Uno degli arrestati, per dichiarazione del suo stesso avvocato, ammise che per lui picchiare i bengalesi non era solo un modo per divertirsi ma una crociata, una battaglia che doveva combattere a tutti i costi, una sorta di iniziazione per essere accettato nel gruppo Forza Nuova che chiamava queste spedizioni “Bangla tour”. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero almeno cinquanta i cittadini bengalesi aggrediti in un anno, soprattutto nei quartieri dove la comunità è più numerosa. Veri e propri raid, in cui gruppi di giovanissimi si davano appuntamento presso le sedi di Forza Nuova per poi partire per le spedizioni contro i cittadini stranieri, bengalesi soprattutto, “perché sono mansueti, non reagiscono e soprattutto non denunciano”, spiegava a Repubblica uno degli aggressori. 60 Iscrizione ad un’università privata Prendiamo un altro caso da noi raccolto nel 2007. Si tratta di una ragazza di origine cinese che intendeva iscriversi all’università privata Bocconi: “Feci domanda d’iscrizione alla Bocconi attraverso internet. Sul sito avevo visto che io che ho un diploma preso in una scuola italiana sono considerata nel test di ammissione come uno studente italiano. Ero convinta cioè di essere considerata esattamente come un italiano. Ho fatto il test di ammissione e sono stata ammessa, ma quando vado per iscrivermi un impiegato mi dice che, dato che sono di cittadinanza extracomunitaria, devo pagare subito la fascia più alta. Avevo già avuto l’esito del test, che avevo passato, per questo potevo iscrivermi, ma in quel momento vengo a sapere che devo pagare una cifrasensibilmente più alta. Ho visto che la cifra era impossibile per me, allora mi sono ritirata e sono andata a iscrivermi in un’altra università, a Forlì.” Assistita da un avvocato membro dell’associazione ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), la ragazza cinese si convinse ad intentare una causa legale che vinse e l’università Bocconi fu costretta a cambiare il regolamento. Doppie tessere sanitarie Una donna nata in Ucraina decide di cambiare abitazione spostandosi in un centro limitrofo. Tra i vari passaggi amministrativi necessari c’è anche quello del cambio del medico di famiglia. Il marito si reca presso il competente ufficio comunale per chiedere informazioni e gli viene comunicato che per cambiare medico di base è sufficiente recarsi presso l’Anagrafe e presentare un’apposita domanda. Qualche giorno dopo, è la signora ucraina a recarsi presso il comune per presentare la domanda che, purtroppo e con grande sorpresa della donna, ben tre impiegati comunali si rifiutano di accettare. La spiegazione fornita è la seguente: gli immigrati “imbrogliano e si fanno due tessere sanitarie”. Il commento di UNAR al caso da loro raccolto ci fa notare in primo luogo che gli operatori hanno agito in modo palesemente illegittimo e sarebbe interessante verificare su quali basi, se non a partire dal pregiudizio contro gli immigrati, abbiano deciso di non accettare la domanda della donna. In secondo luogo, ma ancor più importante, preme evidenziare come siano gli uffici a diretto contatto con il pubblico il luogo dove, in più casi di quanto si pensi, la discrezionalità può sostituirsi al diritto. È, d’altronde, “plausibile che in quel determinato comune 60 Fonte: CIRDI, 18 dicembre 2013: http://www.cirdi.org/notizie/la-procura-apre-uninchiesta-sui-raid-razzisti-a-roma/ 61 ci possano essere stati dei problemi con la duplicazione delle tessere sanitarie, ma da qui ad affermare che gli immigrati siano tutti imbroglioni il passo è lungo”(UNAR). Assegnazione di alloggi ERP (Edilizia residenziale pubblica) Molte delle azioni legali intentate per discriminazione in questi anni sono state nei confronti di pubbliche istituzioni riguardo all’accesso alle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica(ERP). In questi casi il ricorso al giudice ha dato spesso esito positivo, con la riformulazione delle delibere regionali o comunali che escludevano o rendevano più difficoltoso l’accesso agli alloggi di edilizia popolare per i cittadini immigrati, inserendo clausole apparentemente neutre (per es. assegnare 10 punti per la residenza nel comune da almeno 10 anni). Sono noti alcuni dei primi casi. In Lombardia fu bocciato dal TAR per violazione dei principi di uguaglianza tra i cittadini il regolamento del Comune di Milano che assegnava 5 punti per il possesso della cittadinanza italiana. La sentenza 21 marzo 2004 n. 3614 del Tribunale di Milano con la quale fu accolta l’azione civile contro la discriminazione promossa ai sensi dell’art. 44 del T.U. 286/1998, dichiarò discriminatorio il sistema di assegnazione degli alloggi ERP in quanto finiva per imporre agli stranieri, pur regolarmente soggiornanti in Italia, condizioni più svantaggiose di accesso agli alloggi e ciò solo in ragione del loro status di cittadini stranieri. Il Comune di Torino pubblicava nell’ottobre 2001un regolamento che richiedeva allo straniero il requisito di essere legalmente soggiornante e quello di svolgere una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni dalla presentazione della domanda. In questo caso il TAR del Piemonte respinse il ricorso rilevando, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, “che la prescrizione di tale requisito per gli stranieri non implica una violazione del principio di parità di trattamento, trovando essa giustificazione nella preoccupazione del legislatore regionale di evitare che gli alloggi pubblici vengano assegnati a soggetti che non abbiano ancora un legame sufficientemente stabile con il territorio (e possano abbandonarli per trasferirsi altrove), rendendoli comunque inutilizzabili per altri soggetti aventi diritto e frustrandone in tal modo la funzione socio‐assistenziale” (TAR per ilPiemonte, sez. I ‐Sentenza del 13 febbraio 2002, n. 323). Porti il velo: non c’è lavoro per te La Nuova Venezia riporta in cronaca del gennaio 2011 l’intervista alla signora Silvia Olivetti di Marghera che dichiara «Sono diventata musulmana, ora vengo penalizzata». Trentasei anni, laureata in Storiaa Ca’ Foscari, una specializzazione in Multiculturalità, un’altra in Lingua inglese conseguita a Cambridge, conoscenza ottima di inglese, francese e arabo, discreta di tedesco e spagnolo, un’esperienza pluriennale nel commercio e nel turismo, ha gestito un’edicola e ha avuto altri impieghi ma da un anno e mezzo è iniziato il calvario. «Sono italiana e musulmana. Da quando porto il velo (un semplice fazzoletto sul capo) nessun potenziale datore di lavoro mi prende in considerazione». Da quando si è convertita all’Islam, una decina d’anni fa, e soprattutto da quando, 18 mesi fa, ha deciso di indossare sempre il velo e di indicarlo espressamente nella propria scheda nessuno prende più in considerazione il suo curriculum. «Non è e non deve essere un fazzoletto a qualificare un candidato – protesta Silvia – Conosco moltissime pluri-laureate relegate a casa a causa del loro fazzoletto. Qui in Veneto ci lamentiamo del fatto che molte famiglie di immigrati vivono sulle spalle dei contribuenti chiedendo contributi e sussidi continui a sostegno del loro reddito e non ci viene in mente che concedendo una possibilità di inserimento lavorativo alle donne musulmane e velate, le loro famiglie smetterebbero di avere bisogno di contributi e sussidi». Sporco negro Durante la partita di Coppa Italia Sudtirol-Matera disputata nell’agosto 2013, dopo aver subito un fallo di gioco, il centrocampista Iannini si era rivolto al diciannovenne calciatore del Sudtirol Caleb Ansah Ekuban, nato in Italia da genitori ganesi, apostrofandolo come «nero di merda». L’arbitro lo aveva immediatamente espulso e la giustizia sportiva lo aveva punito con dieci giornate di squalifica per aver «rivolto ad un avversario un epiteto insultante espressivo di discriminazione razziale». La giustizia penale, alla quale erano stati trasmessi gli atti come previsto dalla legge “Mancino” contro il razzismo, ha invece assolto il giocatore lucano dall’accusa d’ingiuria aggravata ritenendo «non punibile» la frase. In attesa delle motivazioni, dal dispositivo si desume che l’insulto è stato considerato come la conseguenza dello stato d’ira determinato 62 dall’intervento subìto dall’avversario e come tale non punibile in base all’articolo 599 del codice penale. Ekuban, che non si è costituito parte civile, ha spiegato in udienza che la parola utilizzata era stata “nero”e non “negro”. Il legale di Iannini ha affermato che i giudici hanno tenuto conto del fatto che l’espressione era stata rivolta in un momento di agonismo e non aveva alcuna finalità razzista né a sfondo discriminatorio. Nel 2005 ricordiamo un caso in cui la Cassazione giudicava che l'espressione ''sporco negro'' - pronunciata da un italiano mentre aggredisce persone di colore alle quali provoca serie lesioni non denota, di per sé, l'intento discriminatorio e razzista di chi la pronuncia perché potrebbe anche essere una meno grave manifestazione di “generica antipatia, insofferenza o rifiuto” per chi appartiene a una “razza” diversa (sic et simpliciter!). In pratica - dice la Suprema Corte annullando con rinvio, nei confronti di un giovane triestino, la condanna in appello per ingiuria aggravata dai motivi di odio razziale - la nozione di discriminazione “non può essere intesa come riferibile a qualsivoglia condotta che sia o possa apparire contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione, non solo dei diritti ma anche nella pratica dei rapporti quotidiani, fra soggetti di diversa razza, etnia, nazionalità o religione”. Secondo la sentenza, perché si configuri la vera discriminazione, occorre che ci sia “restrizione o preferenza basata sulla razza, che abbia lo scopo di distruggere o compromettere il godimento in condizioni di parità dei diritti e delle libertà fondamentali” (citazione della Corte dalla Convenzione di New York sui diritti dell'uomo del 1966, entrata in vigore nel 1969). Dimentica, la sentenza, che basta l’effetto per la legge italiana ed europea e non interessano le intenzioni dell’autore. Dunque, per la Cassazione dire ''sporco negro'' può essere una semplice ingiuria, come tale perseguibile solo a querela di parte e non d'ufficio come avviene per i reati aggravati. Ricordiamo l’allora presidente dell'Archivio dell'Immigrazione, Massimo Ghirelli, commentare così la sentenza della Cassazione: “(sentenza) esemplare del clima di sdoganamento dei peggiori stereotipi di un'Italia che si sperava scomparsa da sessant'anni. Da settori della chiesa, della politica e perfino delle istituzioni, riemergono come fantasmi linguaggi, atteggiamenti e comportamenti che consideravamo sepolti nella vergogna della storia. Alla luce di questa incredibile sentenza, non ci resta che definire questi giudici degli sporchi bianchi: con generica antipatia”. 5.3.2 Discriminazione indiretta La discriminazione indiretta è definita dall’art.2, comma 1 del decreto legislativo 215 del 2003 e similmente dall’art.2, comma 1 del decreto legislativo 216 del 2003 61. Si ha: b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. La normativa prevede espressamente il ricorso ai dati statistici per fondare la presunzione della discriminazione che punta l’attenzione sugli effetti che alcune misure e pratiche hanno su certi gruppi e in cui è più difficile trovare una prova.Si tratta, in questo caso, di situazioni e di comportamenti apparentemente neutri ma che oggettivamente svantaggiano o discriminano una certa categoria di persone. Un esempio: vietare l’assunzione di persone con il capo coperto, apparentemente non è discriminatorio perché non ci si riferisce ad alcuna categoria precisa; tuttavia, nei fatti, colpisce solo le persone (uomini e donne) che, per pratica religiosa, usano il copricapo. Indubbiamente la discriminazione indiretta copre un ampio spettro di azioni discriminatorie in quanto l’accertamento va effettuato sullo svantaggio oggettivo provocato non ad un individuo precisamente identificato ma ad una categoria. Purtroppo i Paesi dove si raccolgono sistematicamente i dati attraverso statistiche ufficiali, dal censimento nazionale al monitoraggio nei luoghi di lavoro, sono 61 D.lgs 216/2003: “b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.” 63 pochi e solo da alcuni anni in Italia istituzioni come UNAR, organizzazioni non governative o pubbliche territoriali hanno avviato questo processo. I due decreti legislativi (che recepiscono nell’ordinamento giuridico italiano le direttive europee n.78 e n.43), precisano che non sussiste discriminazione se essa è oggettivamente giustificata da una finalità legittima. Ad esempio, per preservare i principi di un’organizzazione religiosa, per permettere speciali forme di reclutamento dei giovani al lavoro, per il mantenimento dell’ordine pubblico e la prevenzione di crimini. Naturalmente, i mezzi impiegati devono essere legittimi, appropriati e necessari. Non sussiste inoltre discriminazione se il datore di lavoro è obbligato da leggi nazionali ad adottare misure adeguate per ovviare agli svantaggi delle persone disabili. Opportunamente la direttiva europea citata, precisa nelle considerazione preliminari al punto 17: “La presente direttiva non prescrive l'assunzione, la promozione o il mantenimento dell'occupazione né prevede la formazione di un individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione, fermo restando l'obbligo di prevedere una soluzione appropriata per i disabili.” Alcuni esempi Gli esempi che seguono sono presi da diverse fonti. Tariffe etniche A parità di altre condizioni, con Zurich, un cittadino italiano pagava 465 euro, un albanese 665 euro, Quixa chiedeva invece 414 euro a un italiano, 625 euro a un camerunese. Secondo le due compagnie, le differenze tariffarie erano giustificate dalle statistiche che mettono in relazione la cittadinanza con “una tipologia di comportamento di guida e, di conseguenza, una tipologia di rischio”. Per Asgi (Associazione studi giuridici sull’immigrazione) e Avvocati per Niente Onlus questo si risolveva però in una discriminazione dei clienti immigrati, pratica vietata dalla legge. Anche l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali aveva già raccomandato che le assicurazioni proponessero “tariffe indipendenti dalla cittadinanza” dei clienti. Le compagnie di assicurazione Zurich e Quixa 62 hanno rinunciato volontariamente alle tariffe etniche prima di essere costrette a farlo dalla sentenza di un giudice. In due comunicati quasi identici, prima della sentenza, le compagnie ribadiscono la loro buona fede e la “totale assenza di qualsiasi intento discriminatorio”, annunciando di rinunciare “in via definitiva” al parametro della cittadinanza per la definizione delle tariffe. Lo stesso era accaduto qualche mese prima con Genialloyd. Copricapo vietato Un grande magazzino vieta ai suoi impiegati a contatto diretto con i clienti di usare un copricapo, annullando così le possibilità di accedere a quel posto di lavoro alle persone che, per esempio per convinzione religiosa, dovessero portare un copricapo (come donne musulmane, uomini sikh). L’azienda deve dimostrare di avere ragioni fondate per imporre questa norma che diventa altrimenti illegittima. Assegnazione di alloggi ERP (Edilizia residenziale pubblica) I casi dei regolamenti comunali per l’assegnazione di alloggi ERP compaiono anche nella fattispecie della discriminazione indiretta quando, per es., prevedono una maggiorazione di quattro punti a favore dei nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età superiore od uguale a 65 anni, purché residenti nel territorio comunale da almeno 10 anni, requisito che tende, evidentemente, a penalizzare le persone immigrate che sono mediamente più giovani. E’ questo il caso della legge regionale Friuli Venezia Giulia del 2008 che, per giunta, in altro comma, introducel’ulteriore requisito della residenza anagrafica o dello svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da almeno dieci anni, anche non continuativi, di 62 Fonte: http://www.stranieriinitalia.it/attualita-assicurazioni._zurich_e_quixa_rinunciano_alle_tariffe_etniche _14673.html, 23 febbr. 2012 64 cui cinque nel territorio regionale. Insomma, sebbene non si faccia in questo caso alcun riferimento esplicito all’esclusione di una categoria etnica, razziale o nazionale, tuttavia, la disposizione, apparentemente neutra, ha l’effetto di escludere delle categorie chiaramente individuabili. Questi regolamenti sono stati oggetto di segnalazione di ASGI alla Commissione dell’UE per violazione del diritto comunitario e, analogamente, si è espresso UNAR circa l’ipotesi di una discriminazione indiretta realizzata nei confronti di cittadini comunitari o di extracomunitari titolari di Permesso di lungo soggiorno o Carta di soggiorno o di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria. La discriminazione consisterebbe nel prevedere un’anzianità di residenza tale da porre i non autoctoni in una posizione di svantaggio particolare e sproporzionato rispetto ai cittadini italiani. 5.3.3 Le molestie costituiscono discriminazione Sia per discriminazione diretta, sia per discriminazione indiretta, valgono questi principi: è discriminazione l’ordine di discriminare; sono discriminazioni le molestie. Nei decreti legislativi 215 e 216 del 2003, è definita molestia “un comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all’art.1” di entrambi i decreti“avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo”, ovunque ciò si verifichi. In Italia è molto in uso la parola mobbing che designa un comportamento simile alla molestia, se non per essere caratterizzata da due qualità che le sono proprie e dal contesto preciso nel quale esso avviene: il luogo di lavoro. Mobbing, nella definizione di Leymann e Gustavsson (primi anni ’80) è la ripetuta e prolungata vessazione di natura psicologica esercitata nel contesto lavorativo. Sono dunque la reiterazione e la frequenza a trasformare un’azione, anche non particolarmente distruttiva, in un processo che può avere esiti seri per la persona coinvolta direttamente, per coloro che le sono vicini e per l’organizzazione nella quale essa lavora (Depolo, 2003). Ogni lavoratore, indipendentemente dalle caratteristiche della propria personalità e del proprio carattere, può essere oggetto di molestie morali qualificabili come mobbing; tuttavia, oltre alla soglia individuale di resistenza alla violenza psicologica, alcune caratteristiche personologiche o situazionali possono favorirne l’insorgenza o la diffusione. Sono potenziali bersagli soprattutto: lavoratori con elevato coinvolgimento nell’attività svolta, o con capacità innovative e creative; soggetti con ridotte capacità lavorative o disabili collocati obbligatoriamente nel posto di lavoro, ma osteggiati dal datore di lavoro, dal preposto, dai nuovi compagni di lavoro; "diversi" sotto vari punti di vista e tratti socio-culturali (provenienza geografica, religione, abitudini di vita, orientamento sessuale). lavoratori rimasti estranei a pratiche illecite di colleghi. 63 Alcuni esempi Gli esempi che seguono sono tratti dai Rapporti UNAR 2006 e 2007. Allo sportello dell’USL Una donna, richiedendo una prestazione ambulatoriale, presenta l’esenzione dal pagamento per motivi economici, come previsto dalla legge. La difficile situazione economica che sta attraversando è enfatizzata pubblicamente dall’operatrice di sportello, la quale le rivolge in tono offensivo diverse domande ad alta voce, fra le quali: “Perché non paga? Non lavora? E perché non lavora? E suo marito, anche lui, come tutti gli stranieri, perché non lavora? Certo, fate tutti così voi stranieri, neanche pagate i contributi!”. 63 R. Gilioli e Co. “Un nuovo rischio all’attenzione della medicina del lavoro: le molestie morali (mobbing). La medicina del Lavoro vol.92 n.1 gen-feb 2001 65 In azienda Un operaio lavora nella società di smaltimento rifiuti. Non ha mai avuto problemi con i colleghi di lavoro ma da quando il suo responsabile gli ha affidato dei lavori al di fuori delle sue normali mansioni (che assolve con buoni risultati), i colleghi hanno cominciato ad avere atteggiamenti discriminatori nei suoi confronti. Soprattutto due di loro lo molestano dicendogli che “gli stranieri devono tornare a casa loro, non c'è posto in Italia per tutti”. Oltre quella di essere di colore, la colpa dell’operaio è di essere una persona che si impegna nel lavoro, accettando di farsi carico di incombenze non proprie. Riportiamo il commento del redattore UNAR: “Il posto dello straniero è sempre un passo indietro rispetto all’italiano, mai farsi notare, mai mettere in cattiva luce, anche involontariamente, i propri colleghi. Altrimenti c’è bisogno di rimettere il negro a posto, ricordandogli che, per quanto sia zelante e capace, non può aspirare ad una condizione superiore a quella che gli è stato concesso di avere.” Nel campo rom In un campo sosta, dove risiede una comunità rom di quindici persone di origine italiana, alle sette di mattina arriva la Polizia. La via d’accesso al campo viene bloccata con le volanti, dalle quali scendono poliziotti in divisa e in borghese. Gli abitanti delle roulotte e dei caravan vengono fatti uscire dalle loro abitazioni, ci sono anche dei bambini. Non è notificato nessun reato né fatta alcuna perquisizione, si tratta di un “normale” controllo. I poliziotti iniziano a fotografare l’area e si affacciano all’interno delle abitazioni; poi passano alle persone fotografando uno a uno tutti gli adulti, facendo loro reggere un cartello con su scritte le generalità di ognuno; stesso trattamento tocca ai bambini. Di fronte alle proteste di alcuni rom che non vogliono farsi fotografare, i rappresentanti delle forze dell’ordine rispondono di non fare storie, altrimenti sarebbero stati portati in questura. Una volta terminata questa inedita procedura di identificazione, i poliziotti risalgono in macchina e se ne vanno. 5.4 DISCRIMINAZIONE ISTITUZIONALE La discriminazione istituzionale può essere così definita: Il fallimento collettivo di un’organizzazione nel rappresentare pienamente, ed in ogni aspetto, la comunità che serve, a causa delle origini “razziali” o etniche, della religione o credo, orientamento sessuale, età, disabilità o genere di alcuni membri di quella comunità. Può essere rilevata nelle procedure, negli atteggiamenti e nei comportamenti che portano alla discriminazione attraverso un pregiudizio involontario, ignoranza, incuranza e stereotipo che si traducono in svantaggi per i membri di una comunità. Può verificarsi nel fallimento a fornire un servizio appropriato e professionale a tutti i membri del pubblico e in un fallimento nell’assicurare l’uguaglianza di opportunità ai dipendenti di un’organizzazione o di un’organizzazione dipendente.Il fallimento delle procedure dell’organizzazione stessa nel rilevare la discriminazione, o nell’intraprendere azioni contro di essa, può essere visto come un indicatore di discriminazione nell’organizzazione (o “istituzione”). Questa definizione ricalca quasi perfettamente quella contenuta nell’inchiesta Macpherson (Gran Bretagna, 1997-99) che, per la natura dell’evento al quale era legata (qui narrato e analizzato al cap. 8.2), si riferiva solo alla discriminazione razziale, mentre in questa citazione l’abbiamo estesa agli altri campi di possibile discriminazione identificati dalle leggi in vigore in Italia. Questo tipo di discriminazione può essere difficilmente identificato e soprattutto provato; si tratta di controllare se le procedure, i flussi di comunicazione, la cultura dell’istituzione stessa, garantiscono l’erogazione di un servizio equo e professionalmente adeguato a tutta la comunità che serve e a tutte le persone che ci lavorano. Non è però il 1999 l’anno in cui per la prima volta si sente parlare di razzismo istituzionale. I meccanismi del razzismo istituzionale erano già evidenziati negli studi condotti in USA negli anni ’60 delle 66 lotte per i diritti civili e mettevano in luce la complessità del fenomeno: si partiva dallo svantaggio scolastico dei bambini del ghetto, perché costretti a frequentare delle scuole meno buone, da cui discendevano minori opportunità di formazione professionale; si aggiungevano lo svantaggio sul piano abitativo e gli effetti negativi della segregazione urbana (cioè scarse conoscenze e relazioni utili, assenza di opportunità culturali e di sport e svago) e così via. Il razzismo istituzionale era dunque costituito dal quadro socio-economico e culturale generale di implicita discriminazione che riproduceva – nonostante i provvedimenti progressisti – lo svantaggio continuodei neri nella società americana. La definizione dell’inchiesta Macpherson ha ricevuto larghi consensi in Europa (sebbene abbia ricevuto in patria anche contestazioni) perché ha il vantaggio di rendere immediatamente evidenti gli effetti e i settori di un’organizzazione che vanno tenuti sotto controllo per non incorrere nel rischio di discriminazione istituzionale;in particolare, ha chiarito che un’organizzazione deve essere chiamata a rispondere delle proprie leggi, regolamenti e pratiche, anche nel caso in cui fosse un proprio singolo operatore a concretizzare l’azione discriminatoria. Essa non mira cioè a etichettare negativamente gli individui, che rimangono comunque responsabili dei propri atti, ma ne fa principalmente un problema dell’organizzazione nel suo insieme. Per cominciare ad affrontare il problema, ciascuno, nel proprio ruolo e funzione, ma chiaramente in primis i dirigenti, deve porsi alcune questioni di fondo: stiamo agendo in modo equo? Il servizio che forniamo raggiunge tutte le comunità e risponde ai loro bisogni? Applichiamo lo stesso standard professionale in ogni situazione? E’ chiaro che chi ricopre posizioni di potere ha un dovere speciale nel fornire la leadership ma è altrettanto vero che ciascuno, nella propria organizzazione, deve capire cosa ci si aspetta da lui o da lei. La discriminazione istituzionale avviene non per l’atteggiamento o il comportamento di una persona (per esempio, uno o più operatori di polizia); esso può addirittura aversi a dispetto delle opinioni decisamente opposte al razzismo degli individui e ha carattere sistematico. La discriminazione interpersonale invece avviene tra individui e dà un nome a certe manifestazioni di dominio razziale, sessista, ecc. nelle interazioni e pratiche quotidiane che coinvolgano individui e non organizzazioni. Riprenderemo questi concetti nella seconda parte del testo, quando affronteremo direttamente l’agire della polizia. Le ricerche che associano lo studio della percezione di discriminazione nelle minoranze etniche allo status socio-economico degli intervistati, mettono in evidenza che la discriminazione istituzionale porta alla concentrazione dei gruppi di minoranza etnica in condizioni sociali ed economiche svantaggiate 64. Molte ricerche hanno ripetutamente dimostrato che le persone appartenenti a minoranze etniche hanno redditi più bassi, sono concentrati in aree geografiche più povere sia dal punto di vista dell’ambiente, sia dal punto di vista economico, in condizioni abitative di bassa qualità, sovraffollate, in lavori poco appetibili, e in periodi di disoccupazione più lunghi delle persone appartenenti alla maggioranza. L’ultimo rapporto pubblicato della rete regionale anti-discriminazione dell’Emilia-Romagna (2011) ci dice che 32 casi su 69 sono di discriminazione istituzionale operati da Enti locali, ASL e Aziende ospedaliere, Istituzioni scolastiche, forze di polizia, trasporto pubblico. Alcuni esempi Gli esempi che seguono sono tratti da diverse fonti; in particolare, “Senza lavoro” e “Documenti Prego” sono presi dal rapporto UNAR 2007 e Islamofobia da ENAR Shadow report 2011. Popolazioni rom, sinte e camminanti Il caso delle popolazioni rom, sinte e camminanti, sfortunatamente, offre chiari e plurimi esempi di discriminazione istituzionale. Ne citiamo qui solo alcuni: la salute, la segregazione nei campi, l’accesso al lavoro e la questione linguistica. La Comunità di Sant’Egidio stimava la speranza di vita alla nascita della popolazione rom attorno ai 45-50 anni nel 2007. Una ricerca condotta dalla CRI (Croce Rossa Italiana) su 4927 rom e sinti dei campi di Roma conferma il dato tendenziale di quella stima, calcolando che solo il 2,8% della popolazione è al di sopra dei 60 anni e appena il 6,32% appartiene alla fascia di età tra i 50 e i 60 anni. Questi dati evidenziano una speranza di vita intollerabilmente al di sotto degli standard del nostro Paese e 64 Krieger N, Rowley DL, Herman AA, Avery B, Philips MT. Racism, sexism and social class: implications for studies of health, disease and wellbeing. Am J Prev Med. 1993;9(suppl 2):82–122. 67 si discostano leggermente, in negativo, dai dati medi riferiti all’Europa dei 27. La realtà dei campi nomadi, con pochissime eccezioni, non esiste in altri Paesi europei: “Si tratta di una realtà caratterizzata, per usare il linguaggio delle convenzioni internazionali, da condizioni inumane e degradanti (…) e incompatibili con qualsiasi progetto di inclusione e integrazione, dove si riproducono quelle condizioni di crudele emarginazione i cui effetti si riversano poi nella vita delle città. È lì che generazione dopo generazione si perde il popolo delle discariche, un popolo fatto per più del quaranta per cento da bambini fino ai quattordici anni.” 65 Quanto al lavoro, anche la Commissione straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani nella XVI Legislatura (2011) riporta che essere riconosciuti come rom è un ostacolo a trovare lavoro, anche per chi aveva iniziato percorsi di formazione-lavoro che apparivano promettenti. Infine, non è mai stata applicata ai rom e alla lingua romanès la legge 482 del 1999 che riconosce le minoranze linguistiche italiane: “È paradossale (…) che il riconoscimento dell’esistenza della minoranza rom esista ma solo in negativo,attraverso gli atti del Ministero dell’Interno che per le sue funzioni si occupa in primo luogo di questioni di sicurezza. Si tratta di aspetti simbolici ma nessuno può sottovalutare l’importanza straordinaria che i simboli assumono.” 66L’antiziganismo è ormai talmenteradicato e diffuso nella nostra società,così come nelle nostre forze di polizia, da essere ormai considerato da diverse fonti come una forma distinta di ideologia razzista che si manifesta in tutte le forme della discriminazione, specie le più violente: i discorsi d’odio, lo sfruttamento e tutte le forme di discriminazione più visibili. Valeriu Nicolae afferma che “L’antiziganismo è una forma molto specifica di razzismo, un’ideologia di superiorità razziale, una forma di disumanizzazione e di razzismo istituzionale.(…) Poggia, da un lato, su paure immaginarie, stereotipi negativi e miti, e, dall’altro, sulla negazione o la cancellazione dalla coscienza pubblica della lunga storia di discriminazione contro i rom.” 67 Una catena di disparità di trattamento Alcune norme di livello nazionale sono intervenute negli anni a restringere la tendenziale parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri non comunitari. Eccone una lista, specialmente collegata alla tendenziale parità nelle prestazioni assistenziali riconosciuta dall’art. 41 del T.U. 286/98 tra cittadini italiani e cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia: a) La restrizione del diritto all’assegno di maternità alle donne non comunitarie titolari di carta di soggiorno introdotta dalla legge finanziaria per l’anno 2000 che ha anche confermato l’esclusione dei cittadini stranieri provenienti da Paesi terzi dal godimento dell’assegno familiare indirizzato ai nuclei familiari numerosi; b) la restrizione, operata dalla legge finanziaria 2001, ai soli titolari di carta di soggiorno dell’accesso all’assegno sociale, ulteriormente aggravata dal d.l. 112/2008, noto come decreto anti-crisi, con la previsione del requisito di un soggiorno decennale sul territorio nazionale; c) Sempre il D.L. 112/2008 ha riservato ai cittadini italiani indigenti la possibilità di richiedere la cosiddetta “carta acquisti”, mentre la residenza almeno decennale sul territorio nazionale è stata prevista per accedere ai fondi di sostegno all’inserimento abitativo; d) il tentativo, per fortuna sventato, di escludere i cittadini stranieri privi di documenti dall’accesso ai servizi sanitari essenziali. Requisiti più restrittivi Il sindaco di Gavardo (BS) Emanuele Vezzola, Pdl, con un’ordinanza “in materia di iscrizione anagrafica e di disposizioni igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza”, sottopone alcune aree del Comune a controlli da parte della Polizia municipale sull’idoneità abitativa e le condizioni igienico-sanitarie degli immobili. Un’operazione studiata appositamente per scoraggiare le richieste di residenza dei cittadini stranieri o la 65 SENATO DELLA REPUBBLICA XVI Legislatura 2008/2013 - Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Sintesi del rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di Rom, Sinti e Caminanti in Italia, febbraio 2011, pag.5. 66 Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani , op. cit., pag.5. 67 “Anti-Gypsyism is a very specific form of racism, an ideology of racial superiority, a form of dehumanisation and of institutionalised racism.(…) It is based, on the one hand, on imagined fears, negative stereotypes and myths and, on the other, on denial or erasure from the public conscience of a long history of discrimination against Roma.” Fonte: Valeriu Nicolae, www.ergonetwork.org/antigypsyism.htm (traduzione nostra). 68 loro ospitalità, in alcune località, vie, numeri civici, dove si concentra maggiormente la popolazione immigrata (l’elenco fornito dal Comune comprende centosei indirizzi da “censire”, ndr). Secondo l’ordinanza, nel caso in cui si ospiti un cittadino straniero, non ci si deve limitare a comunicarlo (entro quarantotto ore, come prevede la legge) all’autorità locale di pubblica sicurezza, ma si dovrà specificare anche la durata e il termine dell’ospitalità, il numero e il “tipo” di persone inbase alla capienza dell’alloggio e i dati catastali dell’immobile. L’ordinanza ha ricevuto la condanna dell’UNAR in quanto il provvedimento“viola il principio di parità di trattamento, specie nella parte in cui si introducono nuovi e più restrittivi requisiti riguardanti la comunicazione di ospitalità.” 68 Senza lavoro: arrestato e deportato La persona in questione aveva imboccato un processo di proficuo inserimento nella società italiana attraverso il lavoro in fabbrica. Come centinaia di migliaia di operai immigrati, era riuscito a sistemarein Italia la sua famiglia in una prospettiva di stabilizzazione. La crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008, e tuttora in corso, interrompe però bruscamente questo processo. Avendo perso il lavoro stabile, l’uomo è costretto a cercarsiun lavoro qualunque, ovviamente precario, e in questa prospettiva si trasferisce in Campania.Nel frattempo è disoccupato – o comunque risulta tale nei periodi di lavoro in nero – e in base alle normative sul permesso di soggiorno perde la condizione di regolarità in Italia. Senza lavoro, senza più la possibilità di tenere con sé la famiglia, si arrangia in lavori in nero (gli unici disponibili per gli uomini con la sua esperienza lavorativa durante la crisi) e vive con la spada di Damocle della deportazione e dell’arresto per il reato di immigrazione clandestina, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 15.07.2009 n. 94. La vicenda riflette quello che la nostra legislazione sull’immigrazione prevede: il lavoratore straniero licenziato se ne deve andare e, se non se ne va, deve essere arrestato e deportato. Islamofobia Sono i cittadini di religione musulmana le persone maggiormente colpite da episodi di discriminazione in Europa. E’ ciò che emerge dal rapporto 2011-2012 sul razzismo nell’UE, pubblicato dal Network europeo contro il razzismo (Enar), in occasione del 21 marzo 2013, Giornata internazionale per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Ad essere particolarmente colpite sono le donne, che rappresentano l’85% dei casi riportati di islamofobia. Queste ultime, infatti, soffrono la discriminazione di genere oltre che una discriminazione per la religione di appartenenza.L’islamofobia crea difficoltà a molti musulmani in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda l’accesso all’istruzione, all’alloggio, al lavoro e a beni e servizi. Inoltre, viene spesso riservato loro un diverso trattamento da parte delle forze di polizia e per quanto riguarda il ricorso alla giustizia. Documenti prego! E non dimentichi il bagaglio Il sig. O., accompagna all’aeroporto un suo amico in partenza per il Camerun. Insieme ai due c’è anche il fratello dell’amico. L’uomo in partenza ha con sé un grosso bagaglio (sei valigie). Mentre i due fratelli fanno la spola con il check-in della Air France, O. rimane pochi metri lontano vicino ai bagagli dove è avvicinato da un agente della polizia aeroportuale che gli chiede i documenti ed il motivo per il quale stava lasciando quei bagagli in mezzo all’aeroporto; nemmeno il tempo di rispondere che l’agente se ne va, per poi tornare poco dopo con un collegache gli chiede nuovamente i documenti. O. ha con sé il permesso disoggiorno e la patente di guida ma non il passaporto. Con questa scusaviene chiamato da una parte dai due agenti e portato in un angolo nei pressidel posto di polizia aeroportuale, dove uno dei poliziotti tira fuori la pistola einizia a minacciarlo con frasi del tutto inappropriate. O. chiede di poter chiamare una sua amica avvocato, che riesce amettersi in contatto con il posto di polizia, alla quale l’agente risponde che O. era stato fermato perché privo di passaporto e carta d’identità. L’avvocato ribatte che il permesso di soggiornoe la patente sono documenti di riconoscimento validi. Allora l’agenterincara la dose affermando che O. ha aggredito e minacciato le forzedell’ordine. Il camerunese viene poi portato in questura dove gli vengonofatte delle foto segnaletiche e prese le impronte digitali. Riportato in aeroporto O. è di nuovo avvicinato da un agente che 68 8 ottobre 2010 Gavardo (BS) Lombardia. Fonte: “la Repubblica” 69 gli chiede diseguirlo dal suo capo. Al posto di polizia c’è qualcosa per lui: una multa diduemilaottocento euro per abbandono di bagaglio in aeroporto. 5.5 DISCORSI D’INCITAMENTO ALL’ODIO Si tratta di discorsi intrisi di odio e che incitano all’odio verso certe categorie di persone. L’espressionehate speech è entrata in uso in Europa negli ultimi decenni ed oggi è particolarmente usata in riferimento ad internet e alla pressoché infinta possibilità che il sistema offre di amplificare la portata e l’effetto di questa fattispecie di discriminazione. Come sempre, i discorsi d’incitamento all’odio possono attaccare le diverse categorie di persone cui abbiamo più volte fatto riferimento in questo testo. In Italia ne danno esemplare dimostrazione molti gruppi ed esponenti della politica. Le manifestazioni di questa tipologia di discorso pubblico (particolarmente nei confronti di minoranze etniche e religiose e delle persone omosessuali) sono tali, tanto note e tanto umilianti per chi ne è bersaglio che non riteniamo necessario ripeterle qui a mo’ di esempio. Tutto ciò a dispetto di leggi in vigore da anni come il D.L. n.122/1993 “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” (nota come Legge Mancino) che all’art. 1 - Discriminazione, odio e violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi afferma: “ 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, (…) è punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi propaganda in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.” Prima della cosiddetta Legge Mancino, esisteva già la legge Scelba del ‘52 che chiariva cosa doveva considerarsi come ricostruzione del disciolto partito fascista e collocava anche la propaganda razzista tra le manifestazioni sintomatiche di ciò che doveva essere vietato. L’impunità di fatto della maggior parte delle espressioni pubbliche ed autorevoli di discorsi d’incitamento all’odio in Italia e la loro frequenza è stata notata anche da ECRI 69 che, nel suo terzo rapporto sull’Italia (2006), aveva espresso preoccupazione circa l’uso di discorsi razzisti e xenofobi da parte dei politici, che prendevano di mira vari gruppi ma specialmente extracomunitari, rom, musulmani. Nel successivo rapporto del 2012, ECRI annota: 50. Si deve constatare che la situazione non è migliorata da allora; al contrario, invero, sembra che si stia moltiplicando l’uso del discorso razzista e xenofobo in politica. Responsabili politici a livello locale, ma anche esponenti di spicco del governo, hanno rilasciato dichiarazioni ostili, se non addirittura aggressive, nei confronti di neri, africani, musulmani, rom, romeni, richiedenti asilo e migranti in genere. Alcuni responsabili politici, tra cui dei membri del governo, sono giunti a proporre la segregazione degli stranieri nei trasporti pubblici o a scuola, ad applicare l’epiteto di “animali” ai membri di certi gruppi minoritari e a definire come un’“invasione” l’arrivo in Italia dei richiedenti asilo. Aggiungiamo noi che, recentemente, anche la neo-Ministra Cécile Kyenge (prima persona al contempo di origine straniera, nera e donna, ad assumere un incarico di governo) 70 ha ricevuto gravi insulti 69 ECRI è l’istituzione europea sui diritti umani del Consiglio d’Europa, composta da esperti indipendenti, che monitora i problemi di razzismo e xenofobia; prepara relazioni e produce raccomandazioni per gli Stati membri. Il Consiglio d’Europa è l’organizzazione continentale che si occupa del rispetto dei diritti umani. Include 47 stati membri 28 dei quali fanno parte dell’UE. Tutti gli stai membri del CoE hanno sottoscritto la Convenzione europea sui diritti umani, un trattato che ha lo scopo di proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. 70 Ministro per l’Integrazione con delega alle politiche giovanili nel Governo Letta; durata del mandato dal 28/04/2013 al 22/02/2014. 70 pubblici da altri politici. Perché preoccupano queste manifestazioni d’odio? Perché, come è dimostrato, il discorso razzista o xenofobo riflette politiche e misure discriminatorie o contribuisce alla loro adozione; l’insieme di questi fattori alimenta l’intolleranza, la discriminazione razziale, la xenofobia e il razzismo presso la popolazione e tende a legittimare tali fenomeni (ECRI, 51; 2012). A ciò si aggiunge quel che già abbiamo indicato come “danno secondario”: il discorso di incitamento all’odio corrode profondamente la fiducia di chi ne è fatto oggetto nell’abilità e nella volontà dello Stato (primi fra tutti i servizi di polizia e la magistratura) di proteggerlo al pari degli altri individui. I discorsi d’incitamento all’odio razziale, religioso e sull’orientamento sessuale non sono certo appannaggio della sola Italia ma quel che è peculiare del nostro Paese è la sostanziale impunità di chi proferisce questi discorsi da una posizione d’influenza e potere, laddove in altri Paesi, come la Francia o il Regno Unito o il Belgio, quando un atto razzista più o meno grave o discriminatorio viene espresso pubblicamente scattano sia una forma di autocensura collettiva, per cui si tende a non esprimere apertamente questo tipo di allocuzioni, sia denunce e sanzioni. In Italia prevale invece una posizione di muta acquiescenza. Eppure, non sarà difficile comprendere che i discorsi intrisi di odio, specie se continuamente riaffermati, sono nocivi e dolorosi quanto un violento attacco fisico, a volte persino di più perché toccano direttamente l’aspetto emotivo, accrescendo lo stress degli individui e dell’intera categoria. L’area dei discorsi d’incitamento all’odio rimane in ogni caso e ovunque una delle aree più controverse in quanto gli autori si difendono dietro il diritto di esprimersi anche degradando gli altri. E’ ormai diffusa,a nostro avviso, una pericolosa tendenza a rivendicare una maggiore protezionedella libertà di espressione, anche quando questa sia tale da determinare sofferenza e fastidio nella maggior parte di coloro che risultano destinatari di violenti attacchi verbali. Uno dei compiti più ardui degli Stati oggi è di bilanciare la libertà di espressione con il diritto dei cittadini a non essere vilipesi, adottando misure adeguate a garantire entrambi i diritti. La libertà di espressione è indubbiamente un fondamento della democrazia e un diritto umano che permette il rispetto di altri diritti umani. Vi è un acceso dibattito in quest’epoca su come contemperare questo diritto con il diritto ad essere liberi da discriminazioni.A noi pare chiarificatore il pensiero espresso del giudice Papalia che indica opportuno il ricorso al principio del bilanciamento (richiamato dalla Cassazione e sul quale la dottrina è concorde): “Quando le opinioni pongono in discussione il regime e l’assetto democratico di unoStato possono essere penalmente sanzionate perché la libertà di espressione, pur essendo una delle condizioni di base per il progresso delle società democratiche e per lo sviluppo di ciascun individuo, non è una libertà assoluta. La legittimità delle norme antirazzismo si basa proprio sul giustificato bilanciamento tra questi due principi previsti dalla Costituzione. (…)Perché questa prevalenza? Perché la dignità umana è il fondamento di tutte le Costituzioni. Qualcuno addirittura sostiene che la dignità umana è un diritto che preesiste alla Costituzione e, come tale, nessuna Costituzione potrebbe disconoscerlo. Si tratta di diritto umano fondamentale che costituisce l’essenza di uno Stato democratico ed è fondante di tutti gli altri diritti fondamentali. Allora, sotto il profilo del bilanciamento, non v’è dubbio che deve riconoscersi possibile, anzi necessaria, la limitazione del diritto della libera manifestazione del pensiero edella libertà di espressione, quando l’esercizio di questi diritti confligge con l’altro diritto del rispetto della dignità umana.” 71 5.6 EFFETTI DI STEREOTIPI E DISCRIMINAZIONI Essere oggetto di stereotipi e discriminazioni produce stress e danni alla salute, quali ipertensione, depressione, malattie cardiovascolari ed altro. Lo provano numerose ricerche condotte nei decenni passati negli USA, in GB e Canada, non solo su minoranze etniche ma anche su persone appartenenti ad altre 71 Citato in Cause strategiche contro la discriminazione, (2008), pag.20 71 categorie a rischio di discriminazione, come gay e lesbiche 72. Una meta-analisi pubblicata nel 2001 nel Regno Unito 73 conferma una più alta prevalenza di depressione, tra le popolazioni in provenienza dall’Asia meridionale e nei gruppi afro-caraibici, di psicosi, nei gruppi afro-caraibici, e un più alto tasso di suicidi rispetto alla popolazione britannica bianca. Un fattore di rischio sociale frequentemente identificato da chi usufruisce dei servizi e degli specialisti è il razzismo. Le ricerche hanno dunque concettualizzato il razzismo come produttore di ansia. La percezione che un individuo ha della società come razzista e l’esperienza di minori ma quotidiani atti di discriminazione sono, secondo la letteratura citata, “un formidabile agente stressogeno”. Di particolare rilevanza sono i risultati del IV Studio Nazionale sulle minoranze etniche (GB) che ha fornito chiara evidenza di un’associazione tra razzismo interpersonale e malattia mentale (Karlsen & Nazroo, 2002) e dalla quale risultò che coloro che avevano subito un attacco razzista soffrivano tre volte di più di depressione e cinque volte di più di psicosi. Lo studio termina osservando che, sebbene la ricerca si sia concentrata sugli effetti della discriminazione razziale, va riconosciuto che l’oppressione e l’intolleranza delle differenze colpisce numerosi gruppi, tra cui anziani, donne, omosessuali. Anche autorevoli e recenti studi svolti negli Stati Uniti confermano disagio psichico e problematiche di ordine psichiatrico come conseguenze di razzismo quotidiano o attacchi violenti. Non ci risultano, invece, indagini specifiche sul temasvolte in Italia, dove, tuttavia, esistono studi a valenza locale che, dimostrando come i lavoratori immigrati siano frequentemente vittime di mobbing, documentano la diffusione tra questi delle note e comprovate conseguenze sullo stato di salute del lavoratore mobbizzato. Tra queste ricerche ricordiamo quella realizzata nel 2009 dall'Osservatorio Ires in collaborazione con Cgil nel territorio milanese, secondo cui 1 su 2 lavoratori di origine straniera ha subito molestie o vessazioni nel proprio luogo di lavoro, mentre il rapporto nel caso degli italiani è di 1 su 3. Nell’ambito di un progetto di Arcigay su lavoro e persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender/transessuali 74, attraverso la somministrazione di un questionario on line ad un campione di 1990 persone volto a comprendere più in profondità l’entità di episodi di omofobia e di discriminazione che avvengono sul posto di lavoro, il 13% dei rispondenti ha riportato di essere stato trattato ingiustamente in virtù della propria identità sessuale; di questi, oltre il 40% dichiara di averne subito conseguenze negative a livello psicologico (ansia e depressione). 5.6.1 Fare fronte allo stress Carver 75 e altri ricercatori americani, in seguito a ripetute e approfondite ricerche, misero a punto nel 1989 un repertorio di 11 76coping strategies, ovvero strategie di fronteggiamento dello stress, ancora oggi paradigma di riferimento, note con il nome di COPE Scale. Sono definite strategie di fronteggiamento (o coping) gli sforzi specifici, sia a livello dei comportamenti, sia a livello psicologico, che le persone adottano per dominare, tollerare, ridurre o 72 Dovidio e Gaertner, riportato in Relation Between Racial Discrimination, Social Class, and Health Among Ethnic Minority Groups, Saffron Karlsen, MSc, and James Y. Nazroo, PhD, Am J Public Health. 2002;92:624–631. HUEBNER D.M., NEMEROFF C. J., DAVIS M. C., 2005, vol. 24, no5, pp. 723-740 [18 page(s) (article)] (2 p.3/4). Arizona State University, USA. Krieger N, Rowley DL, Herman AA, Avery B, Philips MT. Racism, sexism and social class: implications for studies of health, disease and wellbeing. Am J Prev Med. 1993;9(suppl 2):82–122. 73 Chakraborty A. (MRCPsych. St Ann’s H., London), McKenzie K. (MRCPsych, Royal Free & University College Med. School, London), Does racial discrimination cause mental illness?, British Journal of Psychiatry (2002), 180, 475-477. 74 Lelleri R. (a cura di), 2011. “Io Sono Io Lavoro. Report finale della prima indagine italiana sul lavoro e le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender/ transessuali” – volume redatto per Arcigay nazionale 75 Carver C. S. University of Miami, Scheier M. F. Carnegie Mellon University, Weintraub J. K. University of Miami, Assessing Coping Strategies: A Theoretically Based Approach,Journal of Personality and Social Psychology ,1989, Vol. 56, No. 2, 267-283. 76 Inizialmente 13, poi accorpate a 11. 72 minimizzare eventi causa di stress 77. Riportiamo di seguito una sintetica rappresentazione delle undici strategie. Evitamento . Evitarei luoghi e le occasioni che si conoscono o immaginano causa di stress: non passare da una certa strada perché è facile incontrare gruppi violenti; quando possibile (nel caso di stigma non visibile come per le persone omosessuali o di religione minoritaria) non manifestarsi, per es., sul luogo di lavoro. Negazione. Negare o minimizzare. Il processo di negazione dell’evento ha dato luogo a diverse interpretazioni. C’è chi considera la strategia efficace proprio perché, minimizzando l’evento, minimizza anche il carico di stress, facilitando così il fronteggiamento e chi, come lo stesso Carver, sostiene che la negazione può essere solo causa di ulteriori problemi, a meno che l’evento non possa effettivamente essere ignorato a tutto vantaggio della persona colpita. E’ noto infatti che la negazione di eventi reali e sui quali non si può agire (“non lo ha fatto perché è un razzista”, “non voleva offendermi”, ecc.) permette all’evento stesso di divenire meno serio nella rappresentazione della vittima, impedendo così la possibilità di mettere in atto strategie di coping più efficaci. Marginalizzazione. Altrimenti detta strategia cognitiva distraente. La persona cerca di non pensare all’evento e adotta comportamenti e tattiche che servono a togliersi il pensiero dalla testa: sognare ad occhi aperti, fuggire riparando nel sonno o immergendosi nella TV o tattiche ancor più dannose come rifugiarsi nell’alcol o nell’uso di droghe. Accettazione. E’ difficile, per definizione, considerare che l’accettazione sia una tattica efficace di fronteggiamento. Tuttavia, l’accettazione è la risposta di alcuni in almeno due casi: come prima reazione di un evento stressante; come tattica in un secondo momento quando ci si dovesse rendere conto che l’evento stressante è inevitabile e nulla può essere fatto per evitarlo. Questo comportamento è più comune tra gli immigrati che tra i giovani di cosiddetta seconda e terza generazione che si sentono appartenere alla società nella quale sono cresciuti e ne rivendicano pertanto il godimento pieno dei diritti. Sfogo di emozioni negative. Si manifesta con il lamento, il pianto e altre forme di apertura per fare uscire le emozioni però in maniera non strutturata, non rielaborata. Una risposta di questo tipo può essere a volte funzionale, come quando si attraversa un periodo di lutto, per adattarsi alla perdita di una persona amata. Tuttavia, c’è ragione di credere che un periodo di “lutto” troppo prolungato può seriamente impedire la regolazione positiva del comportamento. Ricerca di sostegno affettivo. Cercare consiglio, assistenza, informazione, sostegno morale, simpatia. Se la persona si sente rassicurata, è possibile che questo primo passo si sviluppi poi in un coping attivo. D’altro canto, è però vero che nella maggior parte dei casi questa ricerca di sostegno è orientata alla possibilità di sfogarsi, portando dunque a un comportamento non precisamente adattivo. Reinterpretazione (o ristrutturazione) positiva. Dissociarsi dal gruppo, trasformare lo stigma da problema in sfida o emblema identitario. Ne abbiamo esempi nei giovani francesi di origine algerina delle banlieueche si auto-definiscono beurs o racaille 78,la “promozione” del termine Black orgogliosamente proferito da parte del movimento antirazzista britannico, includendo nel gruppo persino gli irlandesi discriminati nel Regno Unito, rispondendo così chiaramente a quel che riconoscono essere un unico obiettivo del razzismo istituzionale (bianchi vs neri). Un esempio chiaro di risocializzazione di tipo etnico-linguistico in Italia è quello delle bande giovanili generate nel seno dell’immigrazione latinoamericana, come quelle studiate da Queirolo Palmas a Genova tra i migranti provenienti dall’Equador (pandillas). L’autodefinizione di latinos da parte dei giovani equatoriani, anche nati in Italia, la riscoperta della propria lingua d’origine, la frequentazione di amici e compagnie esclusivamente latinoamericane come ricerca di comunanza etnica nelle relazioni, rappresentano tutti segni del processo di etnogenesi per il quale i giovani di 77 Carver et alii, op. cit. Il termine “beur” sta ad indicare tutti i cittadini nati in Francia di origine nordafricana, nati quindi da immigrati tunisini,marocchini, ecc.; si tratta infatti della contrazione della parola “arabeu” (arabo), pronunciato con un senso di superiorità. Il termine “racaille” invece è puramente dispregiativo, e si può tradurre con “feccia”. 78 73 origine immigrata si reinventano latinos nel Paese d’approdo. L’essere latinos non è una qualità sostanziale delle società da cui provengono, bensì un prodotto della migrazione, reazione alla percezione di discriminazioni nei loro confronti. Allo stesso modo le pandillas, nella loro estrema visibilità pubblica, diventano orizzonte di riscrittura della propria identità di giovani in un Paese straniero: se i media riducono i giovani latinos a potenziali criminali organizzati in bande che si scontrano per la conquista della città, i giovani, a loro volta, “pensano se stessi e ridisegnano le narrazioni del sé in rapporto a questa categorizzazione subita”, come effetto riflesso dello “specchio del rifiuto.” 79 Affiliazione a gruppi religiosi. Ci si può volgere alla religione per diverse ragioni, ovviamente. La religione può servire come fonte di supporto emotivo, oppure come veicolo di reinterpretazione positiva o coping attivo. Non sono estranei a ciò i conflitti etno-religiosi e la radicalizzazione di parte dell’Islam in Europa. Forse costituiscono la fonte di tensione più vasta nell’Europa dei nostri tempi, come certamente testimoniano numerosi episodi nel Regno Unito, in Olanda e Francia 80, senza dimenticare certi discorsi politici e massmediatici in Italia. Coping trattenuto. Il fronteggiamento dello stress è messo in attesa che si presenti un’opportunità più appropriata, la persona si trattiene per non agire prematuramente. Questa tattica ha in sé un aspetto passivo nel senso che, difatto, non agisce. Accantonare ogni altra attività. Mettere cioè da parte ogni altro progetto, per evitare di essere distratto da altri eventi, anche a costo di lasciare le altre cose andare a rotoli per potersi dedicare alla gestione dello stressor o agente stressogeno. Coping attivo e pianificato.E’ il processo attraverso il quale le persone si attivano per rimuovere o ridurre la causa dello stress, anche attraverso la pianificazione di strategie e passaggi per meglio trattare il problema. E’ la risposta di chiricorre in tribunale, anima gruppi fautori del cambiamento sociale e politico, cerca altri simili e fonda un’associazione di lotta e contrasto, ecc. E’ certamente una via più ardua da percorrere in caso di stigma invisibile (per es., musulmani o gay). Le risposte degli individui discriminati o appartenenti a categorie a rischio di discriminazione (anche se non l’hanno subita in prima persona) possono essere tutte queste. Ognuno reagisce sulla base della propria personalità, del contesto sociale e affettivo nel quale è cresciuto o si trova in quel momento o del momento storico e della fase sociale che il Paese sta attraversando. Quest’ultimo caso appare molto interessante per comprendere un fenomeno come quello raccontatoci da un funzionario di polizia olandese, responsabile dell’Ufficio antidiscriminazioni della polizia nella città di Rotterdam. Erano trascorsi quasi dodici mesi dall’attacco alle torri gemelle di New York e l’elaborazione dei dati di casi di discriminazione su base religiosa (contro l’islam) segnalati in città e nel resto del territorio di competenza di quell’ufficio erano calati in modo impressionante, da una media di circa seicento degli anni precedenti a una cinquantina. La revisione delle registrazioni dimostrò che la gran parte delle denunce di assalti e violenze quell’anno erano state riportate come tali, senza menzione della motivazione religiosa, sebbene i dati demografici della vittima registrassero costantemente “di religione musulmana”. Cos’era accaduto? Probabilmente il clima generale era avvertito talmente ostile alle persone di religione musulmana da indurre chi professava questa religione a tacere sulla matrice razzista dell’attacco subito e gli operatori di polizia a loro volta a non registrarecome “razzista”, come avrebbero dovuto, qualunque attacco ovunque la vittima fosse di religione musulmana o di pelle nera. Alcuni studiosi 81 descrivono il sorgere di aversive racism 82, il razzismo di chi appoggia valori egualitari, di chi considera se stesso come libero da pregiudizi, in verità capace di discriminare in modi sottilmente 79 Luca Queirolo Palmas, 2006. Prove di seconde generazioni. Giovani di origine immigrata tra scuole e spazi urbani. Franco Angeli. Pag. 145. 80 A questo proposito si veda Emerson M. (edited by), ETHNO-RELIGIOUS CONFLICT IN EUROPE. Typologies of radicalisation in Europe’s muslim communities. Centre for European Policy Studies, Brussels, 2009. 81 Dovidio e Gaertner, riportato in Relation Between Racial Discrimination, Social Class, and Health Among Ethnic Minority Groups, Saffron Karlsen, MSc, and James Y. Nazroo, PhD, Am J Public Health. 2002;92:624–631. 82 razzismo opposto/contrario. Forme di razzismo razzionalizzate sono anche il differenzialismo culturalista, cioè il razzismo che fa del rispetto della differenza la propria forza, in quanto, proprio per neutralizzare le strategie che si erano costruite in riposta al razzismo, si è fatto forte del riconoscimento del diritto all’autonomia, del diritto all’indipendenza, 74 razionalizzati. E’ possibile e probabile che queste forme razionalizzate di razzismo siano più difficili da identificare e più difficile sia coglierne gli effetti. Gli autori della ricerca “Relazione tra la discriminazione razziale, classe sociale e salute tra i gruppi di minoranza etnica” (condotta in USA nel 2002) hanno potuto ipotizzare che la discriminazione espressa in modo indiretto e razionalizzato produce effetti altrettanto negativi sulla salute delle persone di minoranza etnica quanto le forme di discriminazione più evidenti, anche se le prime rimangono più difficili da misurare. 5.6.2 Danni secondari La discriminazione perpetrata sulla base di un particolare aspetto della personalità che un individuo condivide con tanti altri appartenenti allo stesso gruppo sociale (nero, lesbica, anziano, disabile, ecc.) porta con sé, a differenze di altre forme di ingiustizia subite dai singoli, due danni secondari rispetto a quello diretto all’individuo bersaglio. Quando un individuo vive l’esperienza di discriminazione razziale si crea come un “effetto alone” che va a colpire ogni persona che condivide quel tratto identitario,in modo che tutti si sentiranno potenziali obiettivi, dunque potenziali vittime. Avremo a quel punto una comunità che condivide la paura e, spesso, l’anticipazione di un possibile attacco violento. Diviene semplice così capire come, su scalaampia, gli atti di discriminazione ottengono l’effetto di isolare e polarizzare i gruppi, creando tensioni nel tessuto sociale e minando la coesione sociale, proprio quella coesione sociale che i servizi di polizia hanno invece il compito di contribuire a irrobustire. Al danno diretto si aggiunge spesso per la stessa vittima un altro danno secondario: la percezione, cioè, da parte della persona discriminata, di rifiuto e mancanza di supporto da parte della società. Sentirsi isolati rafforza il senso di vittimizzazione anche dopo l’incidente. Spesso gli attacchi e le discriminazioni avvengono senza testimoni ma ciò che umilia e ferisce ancor di più è il fatto che quando ci sono testimoni generalmente non intervengono. Le persone avvertono che devono fronteggiare la situazione completamente soli e la società, in generale, sembra essere indifferente alla loro esperienza. Questo fenomeno non solo rientra nella tipologia degli agenti stressogeni ma appare anche nella lista delle ragioni che inducono le vittime di discriminazione a non segnalare o denunciare l’ingiustizia di cui sono stati oggetto o di cui pensano di essere stati oggetto (fenomeno noto con il nome di underreporting). Tanti hanno studiato le ragioni dell’underreporting ma a noi piace dirlo con le parole della Polizia di Northumbria (Inghilterra settentrionale) che, nei primi anni di questo secolo, si interrogò seriamente sul numero ridotto di denunce che ricevevano. Arrivarono così ad enunciare una serie di motivi per i quali le vittime di “episodio razziale” decidono dinon farne denuncia, potendo di conseguenza pianificare meglio la loro comunicazione, il loro impegno nellaformazione degli operatori di polizia e la costruzione di buone relazionicon le comunità di origine etnica minoritaria e con le altre organizzazioniimpegnate nel campo. Secondo la Polizia di Northumbria, queste sono le principali cause delle mancate denunce: timore di rappresaglie da parte degli esecutori dell’episodio difficoltà di comunicazione legate alla lingua sfiducia o timore nei confronti delle istituzioni mancanza di fiducia nel fatto che le istituzioni saranno in grado di agire o vorranno agire sensazione che le istituzioni rispondano generalmente in maniera insufficiente alle necessità delle minoranze etniche insufficiente comprensione delle procedure burocratiche riluttanza ad ammettere di essere stato vittima di odio razziale convinzione che l’incidente sia stato troppo banale perché valga la pena di sporgere denuncia. La recente Conferenza sui diritti fondamentali-2013 su “Combattere i crimini d’odio nell’UE” (organizzata da FRA, European Union Agency for Fundamental Rights) ha messo in evidenza che è ancora poco sviluppata la capacità di offrire supporto alle vittime. In particolare, le numerose persone vittime di salvo, naturalmente, dedurre da questa posizione la legittimità dell’espulsione dell'altro dal corpo sociale e a giustificarne la possibile eliminazione fisica, addirittura fino al genocidio. Si veda, su questo Taguieff P., La force du préjujé, 1988. 75 reati d’odio intervenute hanno denunciato il trattamento negativo ricevuto dalla polizia: spesso le persone non sono informate dei loro diritti, non ricevono consigli su come comportarsi successivamente, non sono presi sul serio (FRA website,13.11.2013). Un’altra causa di mancata segnalazione di atti di discriminazione subiti o percepiti come tali è il fenomeno dell’ “attribuzione ambigua” (attributional ambiguity). Uno studio nel Regno Unito trovò che le persone che inizialmente avevano affermato in un questionario di non avere subito discriminazioni, successivamente, nel corso di un’intervista in profondità, dissero di avere subito discriminazioni ma che trovavano troppo difficile riferirne e discuterne 83. Come mai? Il tema dell’attribuzione ambigua è stato trattato in numerosissimi studi psicologici e pare si possa mettere, per il momento, una parola definitiva sul fatto che le persone stigmatizzate, contrariamente a quel che si è tentati di credere, tendono ad attribuire la colpa a se stesse piuttosto che agli altri. Major e Crocker (1993) raggiunsero la conclusione che i membri di gruppi stigmatizzati “vivono in uno stato cronico di ambiguità di attribuzione delle cause del comportamento degli altri nei propri confronti”. Partendo dall’assunto che attribuire eventi negativi al pregiudizio degli altri nei propri confronti abbia un effetto di auto-protezione, i due studiosi ipotizzarono per la loro ricerca che questa ambiguità di attribuzione fornisse ai gruppi stigmatizzati numerose e benefiche opportunità per giustificare proprie performance scarse (per es., a scuola o sul lavoro), riuscendo in questo modo a mantenere l’autostima e ad accusare altri di razzismo nei propri confronti. Il loro studio, inaspettatamente, ma con la conferma di numerose ricerche empiriche successive, mostrò al contrario e con tutta evidenza che individui stigmatizzati sono tendenzialmente riluttanti nel biasimare i pregiudizi o la discriminazione degli altri per giustificare propri comportamenti deludenti; insomma, tendono a giustificare prendendosi la colpa piuttosto che accusare altri di razzismo nei loro confronti, anche nei casi in cui l’ambiguità è molto ristretta e poco opinabile. Ruggiero e Taylor (1995, 1997) giunsero alla stessa conclusione 84e postularono, in base alle loro ricerche empiriche, che vivere nella condizione di ambiguità di attribuzione cronica – che costringe la persona a considerare regolarmente il pregiudizio come una possibile spiegazione per un proprio insuccesso – nuoce al benessere delle persone appartenenti a gruppi svantaggiati. Tale ambiguità circa il ruolo del pregiudizio nei risultati che uno ottiene nella vita è fonte di grande stress perché è un costante ricordo del rifiuto e svalutazione da parte della cultura maggioritaria. Tant’è che numerosissimi studi hanno confermato queste conclusioni anche per quanto riguarda altri gruppi a rischio di discriminazione (donne, neri americani, poveri), sottolineando che doversi muovere in contesti sociali sentendosi costantemente un probabile bersaglio di pregiudizio e discriminazione è esperienza che mette a dura prova. Gli autori concludono che la situazione di attribuzione ambigua può essere auto-protettiva solo nel senso che fornisce opportunità per negare che il pregiudizio o l’odio possano effettivamente essere la vera causa di un trattamento negativo, in quanto l’ammettere l’odio e il pregiudizio per una caratteristica che, spesso, non è nemmeno possibile cambiare, inevitabilmente porterebbe ad ammettere il rigetto e la svalutazione di sé da parte della società, esperienza troppo dolorosa per essere confessata a sé e agli altri. 5.7 LE INDAGINI SULLA PERCEZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE Il Rapporto UNAR 2011 (l’ultimo pubblicato nel momento in cui scriviamo) rileva un “aumento esponenziale” dell’emersione dei fenomeni di discriminazione negli anni 2010 e 2011, passando dalle 373 istruttorie 85 del 2009, alle 767 del 2010, fino alle 1000 gestite nel corso del 2011, con una crescita 83 Parker H, Botha JL, Haslam C. “Racism” as a variable in health research—can it be measured? J Epidemiology & Community Health. 1994;48:522. 84 Michael T. Schmitt, Nyla R. Branscombe, The meaning and consequences of perceived discrimination in disadvantaged and privileged social groups, University of Kansas, in W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.), European Review of Social Psychology (2002), V. 12, pp. 167-199. Chichester , England : Wiley. 85 Il termine “istruttoria” si riferisce a una procedura complessa relativa ad un atto o più atti (….) che impegna l’Ufficio usualmente nella redazione di un approfondito parere giuridico cui fa seguito un intervento di rilievo esterno dell’Ufficio stesso, consistente nella notifica a rimuovere (o compensare) la discriminazione o, nei casi previsti dalla Legge, alla formulazione di una notizia di reato. 76 complessiva nel biennio pari al 300%. Va tenuto conto che contribuisce all’enorme aumento registrato nel rapporto 2011 la possibilità, per la prima volta, di riportare casi di supposta discriminazione subiti da persone che rientrano in tutte le categorie citate dalle leggi in materia: razziale, etnica, religiosa, nazionale, per età, orientamento sessuale, disabilità, convinzioni personali. Questo successo non deve però farci pensare che tutti i casi di discriminazione subiti (o creduti tali) siano effettivamente denunciati o segnalati. Ad esempio, l’ultima indagine on-line realizzata da FRA nel 2012 su un campione di 5.900 ebrei autocertificatisi, ci dice che due terzi degli intervistati (66%) ritiene che l’antisemitismo sia un problema negli Stati membri dell’UE oggetto dell’indagine 86. Tre quarti degli intervistati (76%) sostengono che l’antisemitismo sia peggiorato negli ultimi cinque anni nel Paese in cui vivono. «A volte sono scioccato dal fatto che i miei figli, che sono svedesi di terza generazione, non si sentano sicuri.» (Uomo, 50-54 anni, Svezia). Gli ebrei dell’Unione europea (UE) continuano a subire insulti, episodi di discriminazione, molestie e persino atti di violenza fisica che non sembrano svanire nel passato. Nei dodici mesi precedenti l’indagine, il 26% di tutti gli intervistati ha vissuto un episodio o episodi di insulti verbali o molestie per il fatto di essere ebreo – il 4% ha subito violenza fisica o è stato minacciato di violenza. Quasi due terzi (64%) di coloro che hanno subito violenze fisiche o minacce di violenza non hanno segnalato nemmeno l’episodio più grave alla polizia o ad altre organizzazioni. Dall’indagine emerge che le vittime tendono a non riferire alla polizia o ad altre organizzazioni specializzate i reati antisemiti subiti, persino quelli che considerano più gravi o quelli che li colpiscono maggiormente. Nel maggio 2006 si concluse uno studio pilota sulla percezione della discriminazione in campo razziale ed etnico del Centro di monitoraggio di Vienna sul razzismo e la xenofobia 87. Lo studio si basava sui dati raccolti in 12 Paesi dell’Unione nell’arco di 4 anni (2002-2005), attraverso un questionario al quale avevano risposto 11.000 persone con un retroterra d’immigrazione. Lo studio mostra che un numero significativo di migranti in tutti i Paesi ha vissuto un’esperienza soggettiva di discriminazione nella loro vita quotidiana, specie nel lavoro e nelle transazioni commerciali, nei rapporti con la polizia e nella scuola. Il documento finale della ricerca pubblicato dall’allora EUMCafferma che l’alto tasso di esperienza soggettiva di discriminazione (o discriminazione percepita) dovrebbe essere considerato come causa ed espressione dell’insoddisfazione dei migranti circa il loro status attuale nella società. Inoltre, la percezione di essere occasionalmente o sistematicamente discriminati per ragioni di razzismo o xenofobia potrebbe avere l’effetto di alienarealla società nella quale vivono i gruppi che si sentono colpiti 88. Il rapporto mise anche in evidenza una distanza veramente significativa tra la quantità di discriminazione sperimentata e il tasso di segnalazione di queste discriminazioni alle autorità pubbliche:lo 86% di coloro che avevano riportato di avere subito episodi di discriminazione non lo avevano riferito ad alcuna autorità o istituzione. In alcuni casi si trattava di mancanza di opportunità di segnalare o denunciare gli episodi, in altri dell’ignoranza di queste possibilità. Nel 2009, lo stesso Centro di monitoraggio, nel frattempo trasformatosi in FRA, diede avvio alla campagna MIDIS 89, intervistando 23.500 immigrati e minoranze etniche negli Stati Membri dell’UE e rilevando che il 55% di essi percepiva il razzismo verso le minoranze come estremamente diffuso nel proprio Paese, il 37% aveva subito atti di discriminazione negli ultimi 12 mesi ma l´82% non aveva segnalato il caso a nessuno, ancora una volta confermando la diffusione dell’underreporting. Rumeni, albanesi e nordafricani sono i gruppi indagati in Italia. Il 94% dei nordafricani intervistati pensa che la discriminazione su base etnica o sull’origine sia molto diffusa nel Paese, contro il 77% dei romeni e il 76% degli albanesi: la maggiore visibilità dei primi, evidentemente, li rende più vulnerabili. La stessa ricerca affrontava il tema della discriminazione multipla, definibile come la discriminazione su più campi nei confronti della stessa persona, per esempio, una persona di origine nord-africana e di religione musulmana; una donna omosessuale e anziana. La ricerca ha rivelato che le persone di origine etnica minoritaria sono più suscettibili alla discriminazione multipla di quanto lo siano le persone appartenenti alla maggioranza (comparazione tra i dati EU_MIDIS e quelli di Eurobarometro Speciale 296 86 I risultati della ricerca presentati riguardano Belgio, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Svezia e Regno Unito, paesi in cui, nel complesso, si calcola risieda circa il 90% della popolazione ebraicaeuropea. 87 EUMC, Migrants’ experiences of racism and xenophobia in 12 EU member states. Pilot study, May 2006. 88 EUMC, 2006, op. cit. 89 FRA, European Union Minorities and Discrimination Survey, 2009. 77 dello stesso anno). Il concetto di discriminazione multipla è importante perché esso riconosce il fatto che un individuo può essere discriminato sulla base di più di un campo, in quanto una persona non solo può avere un’origine etnica minoritaria ma anche una certa età e genere, poiché, come sappiamo, l’identità di ciascuno è sempre multipla. Riguarda invece la popolazione gay/lesbica/bisessuale/transessuale/transgender (LGBT) l’indagine on line, di nuovo condotta da FRA90, sulla percezione delle discriminazioniche ha raccolto 93.070 testimonianze, di cui 13.255 in Italia. Quasi la metà (47%) di tutti gli intervistati ha dichiarato di essere stata discriminata o molestata in prima persona nell’anno precedente all’indagine per motivi legati all’orientamento sessuale. Uno dei problemi più significativi nel rilevare e provare le discriminazioni, come abbiamo scritto, è che le vittime denunciano e segnalano i casi di cui sono protagoniste in misura enormemente minore di quanto essi avvengano nella realtà (underreporting). Come abbiamo visto nel citato rapporto della polizia della Contea di Northumbria, ciò accade per molte e diverse ragioni: paura di ritorsione, ignoranza delle possibilità offerte di segnalazione e presa in carico del caso da parte di associazioni e istituzioni, sfiducia nelle istituzioni e nella possibilità di soluzione del caso o di eliminazione o attenuazione del problema, tendenza a minimizzare il problema per non esasperare il clima o perché è doloroso ammettere di essere vittima di razzismo, scarsa conoscenza della lingua.Come abbiamo visto nel capitolo precedente, tra i motivi alla base di questo fenomeno ci sono la maggior parte delle strategie di coping e, particolarmente, quella di considerare l’evento banale o doloroso e quindi da negare o da accettare come parte delle ingiustizie del mondo. Accanto all’underreporting agisce l’underrecording , il fenomeno in base al quale le persone addette alla registrazione di casi di discriminazione hanno una tendenza a sottovalutare la portata discriminatoria dell’evento e registrano di conseguenza un numero inferiore di casi a quello che viene segnalato. Anche qui, diverse le ragioni: atto volontario che minimizza l’evento perché non percepito come discriminatorio; desiderio di evitare un lavoro aggiuntivo; richiesta della stessa vittima che segnala ma chiede di non registrare; a volte una difesa corporativa di colleghi. I due fenomeni vanno insieme a costituire il problema della mancata emersione dei casi di razzismo e discriminazione razziale (ma lo stesso vale per gli altri campi di discriminazione). Se la gente riporta solo una parte minima degli atti discriminatori di cui ritiene di essere vittima, se gli operatori tendono a non registrare come atti di discriminazione tutto ciò che è loro riportato e che potrebbe rientrare nella tipologia, sorge il problema di sapere come arrivare a cogliere la dimensione reale del fenomeno. E’ così che nascono gli studi sulla discriminazione percepita dalle potenziali vittime. Ci si potrà chiedere a che scopo affidarsi a valutazioni tanto soggettive come la percezione della discriminazione, ovvero affidarsi a quel che persone appartenenti a categorie a rischiodi discriminazione pensano essere la discriminazione agita nei loro confronti, sia in modo indiretto nei confronti della categoria alla quale sentono di (o sono ritenuti) appartenere, sia in modo diretto nei confronti di se stessi.Proviamo a spiegare il valore di questo tipo di studi. Nello studiare le discriminazioni percepite si opera come negli studi sulla vittimizzazione (indagini nate negli anni ’60 negli USA) per cercare di stimare, con la migliore approssimazione possibile, il numero di reati effettivamente subiti dalle vittime, poiché questo numero è ignoto, certamente non riconducibile all’esiguo numero di crimini denunciati. In questo tipo di ricerche si chiede a un campione rappresentativo della popolazione di riportare qualunque reato che sia stato commesso contro di loro in un dato periodo (in genere sei mesi o un anno). Una delle primissime ricerche fu realizzata a Washington, Chicago e Boston e la conclusione fu che, secondo i dati riportati dagli intervistati, le registrazioni ufficiali della polizia di Chicago riportavano meno di un quarto dei crimini considerati “gravi” ed effettivamente commessi. Ricerche condotte in Gran Bretagna hanno mostrato che le persone nere, i giovani e i poveri sono molto più probabili vittime di crimini di quanto siano i bianchi, gli anziani e la classe media. In Italia, l’ISTAT (Istituto nazionale di statistica) conduce con cadenza quinquennale dal 1997 un’indagine di vittimizzazione che consente di definire entità e diffusione del fenomeno della criminalità rispetto ai reati rilevati, rilevare la percentuale del sommerso, evidenziare quali sono i gruppi 90 FRA, EU LGBT survey - European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey - Results at a glance, 2013. 78 della popolazione più a rischio e delineare il quadro della sicurezza dei cittadini dal punto di vista soggettivo. L’ultima indagine pubblicata (2010),condotta attraverso intervista telefonica su un campione nazionale di 60.000 individui, afferma che genere ed età sono gli elementi che fanno variare maggiormente il rischio di vittimizzazione nel caso di reati contro la persona (non pare sia considerata l’origine però): donne e giovani hanno maggiori probabilità di subire reati. Il punto è: quanto affidabili sono queste indagini? Possono fornire un’immagine limpida del tasso reale di criminalità? Sfortunatamente non si tratta di misurazioni perfette. Secondo un’analisi di Timoty Mason (Université de Paris 8) 91, tre cause fondamentali possono ridurne l’affidabilità: 1. memoria selettiva – gli eventi possono essere dimenticati, apparire meno o più importanti, secondo la posizione sociale e gli accadimenti che hanno fatto seguito all’evento. Per esempio in GB una ricerca condotta da Sparks e altri nel 1977, risultò probabilmente distorta nei risultati secondo gli stessi autori: le persone bianche e di classe media riportavano più minacce e tentativi di furto dei neri e dei poveri che, interrogati successivamente in incontri di verifica, consideravano questi eventi nemmeno meritevoli di essere riportati, tanto frequenti sono nella loro vita. 2. imbarazzo o riserbo – le vittime di violenza sessuale, per esempio, riferiscono meno frequentemente. Invero è provato che donne che hanno denunciato una violenza sessuale allapolizia non fanno altrettanto nelle indagini di vittimizzazione. 3. mancata attribuzione di peso o mancanza di conoscenza - la gente tende, per esempio, a non riportare atti di vandalismo o non sa a chi riferirli. In conclusione, le indagini sulla vittimizzazione suggeriscono che esiste una grande quantità di comportamenti spiacevoli che non sono mai riportati alla polizia ma non si può dire che ci diano un’immagine accurata di quanto realmente avviene perché, ancora una volta, si tratta di stime per difetto, anche se l’affinamento continuo delle tecniche di rilevazione rende sempre più accurate le stime sui reati. Infine, ed inoltre, come le cifre ufficiali “esse sono il risultato negoziato di lavoro sociale” 92 (su questo concetto si veda il cap. 6). Alla stregua delle indagini sulla vittimizzazione vanno interpretate le indagini sulla discriminazione percepita. Le statistiche ufficiali della polizia o della giustizia penale rappresentano solo la punta dell’iceberg e sottovalutano la gravità della situazione reale: le discriminazioni rimangono invisibili, i colpevoli restano impuniti, mentre le vittime non ricevono il sostegno e l’aiuto al quale avrebbero diritto. Questo coincide con i risultati delle indagini sopra richiamate (ricordiamo che, nell’ultima ricerca di FRA citata, il 37% ha subito atti di discriminazione negli ultimi 12 mesi ma l´82% non ha segnalato il caso a nessuno). Un alto tasso di esperienza soggettiva di discriminazione (o discriminazione percepita) dovrebbe essere considerato come causa ed espressione dell’insoddisfazione dei migranti circa il proprio status attuale nella societàe, come molti studi hanno provato, causa di gravi malesseri psico-fisici e di comportamenti che possono incidere negativamente sulla relazione con la società d’arrivo. Con le parole di ECRI (European Commission on Racism and Intolerance) 93: “Obiettivo di questa tipologia di indagini è rendersi conto dei problemi di razzismo e di intolleranza, così come vengono percepiti dalle vittime attuali o potenziali. Al di là della veridicità oggettiva dei risultati di tali indagini (tuttora oggetto di dibattito scientifico), il riconoscimento della validità dell'esperienza e della percezione delle vittime potenziali costituisce un messaggio importante, sia per l’assieme della popolazione, sia per gli stessi gruppi vulnerabili.” Gli studi sulla discriminazione percepita offrono alle minoranze visibili 94, alle persone di origine etnica e a tutte le categorie svantaggiate, l’idea che la società nella quale vivono non è “solo” ostile. Più che mai 91 In W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.), European Review of Social Psychology (2002), V. 12, pp. 167-199. Chichester, England: Wiley. 92 Mason T., cit. 93 ECRI (Commissione Europea contro Razzismo e Intolleranza) fu stabilito dal Summit dei Capi di Stato e di Governo dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa nel 1993. 94 la discriminazione è più facile e più comune quando le differenze etniche si vedono (colore della pelle, abbigliamento ecc.) e ci si sente più vulnerabili e quindi più soggetti a discriminazioni. 79 diventa importante che le persone a rischio di discriminazione acquisiscano conoscenza delle opportunità che si aprono loro, conoscenza degli strumenti aloro disposizione, consapevolezza di ciò che stanno vivendo, assertività nell’esporre le proprie visioni, nella certezza che la società saprà rispondere alle loro istanze, così come a quelle della maggioranza bianca e autoctona o eterosessuale o normodotata. In Italia, la diffusione di indagini di questo tipo sui gruppi a rischio è limitata. Solo di recente (agosto 2008) il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stipulato una convenzione con l’ISTAT per la realizzazione della prima indagine multiscopo per “Discriminazioni di genere, per orientamento sessuale e identità di genere ed origine etnica”. Per il 2010 era prevista la realizzazione di 10.000 interviste a persone di 14 anni e più e per il 2011 l’analisi e la diffusione dei dati. Non abbiamo tuttavia trovato i risultati della ricerca. Risale al dicembre 2006 una ricerca promossa dal Centro provinciale sulle discriminazioni di Parma e provincia 95, attraverso la somministrazione di 180 questionari a persone di origine straniera che vivono sul territorio e che fruiscono dei servizi individuati come punti di rilevazione. I dati raccolti dalla ricerca coincidono perfettamente con gli studi citati. 5.8 DOVE SEGNALARE DISCRIMINAZIONI In un contesto come quello italiano, oggi molto simile a quello di altri Paesi dell’Unione, sia per presenza di persone di origine etnica immigrata e di minoranza visibile, sia per esistenza di leggi contro le discriminazioni e chi ne è autore, è necessario capire le dimensioni e le qualità del fenomeno. UNAR L’Ufficio preposto alla raccolta di segnalazioni di casi di discriminazione razziale è nato nel dicembre 2004 (UNAR – Ufficio Nazionale Anti-discriminazione Razziale), in ottemperanza al D. Lgs. 215/2003 (che recepisce il dettato della direttiva europea n.43/CE/2000). Questo Ufficio ha la grande responsabilità di indicare un indirizzo ad altre istituzioni e di indicare alle persone vittime di discriminazione (o che si credono tali) che la società e lo Stato italiano li considerano cittadini a tutti gli effetti, titolari di diritti e non solo di doveri. Nell’ottica di allargare la rete di supporto alle vittime di discriminazione avvicinando ai cittadini i luoghi per la segnalazione dei casi, molte Regioni si stanno dotando, o si sono già dotate, di centri antidiscriminazione, in accordo e in stretta collaborazione con UNAR. Regione Emilia-Romagna L’Emilia-Romagna ha fatto da apripista con la firma, nel 2007, di un Protocollo d’intesa sottoscritto con il Dipartimento Diritti e Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, sindacati, associazioni del terzo settore, Difensore civico e Consigliere di parità della Regione Emilia-Romagna. Il Protocollo d’intesa ha dato vita al Centro regionale, fondato su una rete di punti antidiscriminazione disseminati su tutto il territorio e articolati su più livelli: > i nodi di raccordo, punto di riferimento principale per ciascun territorio, fanno capo prioritariamente ad Enti locali, si occupano di attività informative, promozionali, di sensibilizzazione e supportano i nodi antenna nell’orientamento e consulenza dell’utenza. > i nodi antenna, che possono fare capo a enti locali, organizzazioni del terzo settore, sindacati, associazioni di categoria, ecc., si distinguono, in relazione alla tipologia di attività svolte, in sportelli, che svolgono la funzione di punti di accesso per l´utenza e di raccolta della segnalazione e punti informativi e/o di supporto, che hanno la funzione di offrire indicazioni utili ai nodi per sostenerli nella soluzione dei casi. 95 Centro provinciale sulle discriminazioni, Tra razzismi quotidiani e discriminazioni istituzionali. La percezione della discriminazione tra gli immigrati nella provincia di Parma, Dos. N.5-Aprile 2005 , Assessorato alle Politiche sociali e sanitarie, Provincia di Parma. 80 Regione Liguria La Regione Liguria ha istituito nel 2012 il Centro regionale contro le discriminazioni per offrire azioni di prevenzione, monitoraggio, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione basate su genere,orientamento sessuale, razza, origine etnica o nazionalità, condizioni di disabilità, età, religione e convinzioni personali.Il Centro ligure ricalca la struttura del sistema emiliano-romagnolo, oggi sistema proposto da UNAR. La costituzione del Centro è, infatti, finalizzata alla promozione di un sistema di rete territoriale di prevenzione, contrasto e monitoraggio contro tutte le forme di discriminazione, il quale è strutturato nel modo seguente: > un nucleo centrale di coordinamento regionale, presso la Regione Liguria, Assessorato Politiche attive del lavoro e dell'occupazione, Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione, Trasporti – Settore Politiche del lavoro e delle migrazioni; > almeno un nodo di raccordo per ciascun territorio provinciale, quale punto di riferimento principale per ogni Provincia; > più antenne territoriali per ciascun territorio provinciale, quali concreti punti di accesso per l'utenza; > più punti informativi, i quali operano al fine di fornire all'utenza indicazioni generali. Regione Toscana In data 19/12/2009 la Regione Toscana sigla l’accordo con UNAR per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni. A seguito di questo accordo gli impegni che Regione Toscana e UNAR si assumono sono molteplici (di seguito elencati i principali): > attivare rapporti di collaborazione permanente, al fine di rilevare, combattere e prevenire ogni forma di discriminazione, anche attraverso l'affermazione di buone prassi in materia di lotta alla discriminazione e tutela della dignità personale e sociale della persona e dei cittadini; > promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale delle comunità locali; definire e promuovere annualmente [… ] iniziative congiunte di sensibilizzazione sui temi dell'antidiscriminazione con particolare riferimento al mondo giovanile. Alla fine del 2009 la Giunta regionale fissò i criteri generali per la concessione di un contributo finanziario per la costituzione di un “Osservatorio permanente per la lotta contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”, con i compiti di censire e monitorare i casi di discriminazione, studiare il fenomeno, predisporre eventuali e conseguenti azioni di intervento e prevenire i fenomeni di intolleranza e violenza e di tutela della cittadinanza della Toscana nella lotta alle discriminazioni di orientamento sessuale. In una prima ricognizione sulle risorse offerte sul territorio regionale (maggio 2012) risulta che il 68% dei comuni toscani intervistati hanno al loro interno organismi con specifica attribuzione di competenze LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, intersessuali) ma 203 comuni (76%) non ha mai attuato iniziative al riguardo. OSCAD Nell’agosto 2010 si riunisce per la prima volta l' Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori (OSCAD), voluto dall’allora Capo della Polizia Antonio Manganelli. L’Osservatorio è parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale ed è composto da rappresentanti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Si occupa di ricevere le segnalazioni di atti discriminatori compiuti da operatori delle forze di polizia e di altre strutture operanti nel campo della sicurezza 96 da parte di istituzioni, associazioni di categoria e privati cittadini, per monitorare i fenomeni di discriminazione determinati da razza o etnia, nazionalità, credo religioso, genere, età, lingua, disabilità fisica o mentale, 96 Segnaliamo che nella pagina di presentazione dell’OSCAD sul sito istituzionale della Polizia di Stato si parla di “atti discriminatori attinenti alla sfera della sicurezza”. Lasciamo valutare al lettore quanto con questa formulazione sia comprensibile per l’utente finale che si tratti degli atti discriminatori compiuti da soggetti appartenenti alle forze di polizia nazionali o locali. 81 orientamento sessuale, identità di genere. Intende inoltre attivare interventi mirati di Carabinieri e Polizia di Stato sul territorio e seguire l'evoluzione degliatti discriminatori denunciati alle forze di polizia. Nell’aprile 2011 OSCAD e UNAR hanno sottoscritto un protocollo d’intesa nel quale si dichiara che è loro obiettivo primario facilitare la denuncia da parte delle vittime degli atti discriminatori e si definiscono i flussi di informazioni tra i due organismi: UNAR trasmetterà a OSCAD i casi di rilevanza penale mentre il contrario avverrà nei casi che non avranno tale valenza. L'Osservatorio avrebbe il compito di stilare una relazione sull'attività svolta e l'analisi dei dati raccolti. Dobbiamo purtroppo constatare che dall’anno della firma di quel protocollo d’intesa (2011) i due organismi non hanno redatto (o almeno non hanno reso pubblica) alcuna relazione annuale sul lavoro svolto, né sui dati raccolti e le relative elaborazioni statistiche, né sulla descrizione dettagliata di casi emblematici ed i loro esiti, dando segno di un’opacità che non può certo suscitare giudizi positivi sul loro operare. Non intendiamo con questa affermazione suggerire che non esista un’azione di OSCAD ma certamente che OSCAD-UNAR stanno venendo meno ad uno dei loro compiti fondamentali che è la redazione di rapporti precisi e piani di lavoro pubblici. Sappiamo, ad esempio, che sono stati denunciati a UNAR casi di grave discriminazione perpetrati da operatori di polizia anche locale ma nulla di ciò risulta evidente ai cittadini. Sul sito della Polizia di Stato, nelle pagine riservate ad OSCAD, tutto si ferma al 2011. Le scarne informazioni fornite si riassumono in questi elementi: 130 atti segnalati a OSCAD nel primo anno di attività, 56 di questi trasmessi alla magistratura; 11 persone arrestate e 33 denunciate a piede libero per atti discriminatori; 21 segnalazioni riguardavano contenuti discriminatori inseriti su Internet. Altre segnalazioni sono state trattate dalle forze di polizia sul territorio o dall'Unar. 5.9 IL CONTRIBUTO DEI MIGRANTI ALLA SOCIETA’ E ALLO STATO ITALIANO Questo breve paragrafo ha lo scopo di contrastare il luogo comune che i migranti siano solo un costo per la collettività italiana, quantunque ciò abbia ben poco a che fare con il dovere di non discriminare e la buona pratica di mettere in atto tutte le possibili azioni di promozione e rispetto delle diversità. Per converso, i dati che riportiamo sembrano metterein luce un percorso istituzionale che restringe progressivamente i diritti di cittadinanza sociale dei cittadini stranieri presenti nel nostro Paese. Gli immigrati in Italia sono circa 5 milioni; gli occupati sul territorio 2,5 milioni (fonte ISTAT, 2013).Naturalmente ciò riguarda solo gli immigrati in condizione di regolarità, gli unici a rientrare nelle statistiche. Per spiegare l’alto numero di disoccupati bisogna prendere in considerazione la terza possibilità del lavoro in nero che sfugge alla rilevazione in quanto le persone che vi sono impiegate risultano disoccupate. La Fondazione ISMU (Iniziative e studi sull’etnicità) stimava che al 1° gennaio 2013 non avessero un valido titolo di soggiorno 294.000 stranieri. La componente irregolare rappresenterebbe quindi il 6% del totale delle presenze, a conferma del livello quasi “fisiologico” assunto da un fenomeno che i venti di crisi hanno fortemente ridimensionato. Sempre più stranieri lasciano invece l’Italia. In base alle revisioni censuarie dell’ISTAT, la Fondazione ISMU calcola che nel 2011 siano circa 200mila gli immigrati che hanno spostato la loro residenza all’estero e stima che anche nel 2012 il numero dei trasferimenti sia stato altrettanto consistente. In aumento pure gli italiani in viaggio: il numero dei nostri connazionali emigrati verso l’estero è risultato pari a 68mila unità, mentre nel 2011 se ne contavano 50mila e 40mila nel 2010. Il dossier statistico in materia di immigrazione redatto da Caritas per il 2012 indica alcuni dati riguardo il “peso economico” degli immigrati in Italia, un’analisi articolata e dettagliata dei costi e dei benefici del fenomeno migratorio dal punto di vista finanziario: si analizza cioè quanto contribuiscono gli immigrati in termini di tasse e quanto ricevono in termini di servizi (sanità, istruzione, servizi sociali comunali, giustizia ecc.). Secondo i dati forniti da Caritas, il bilancio costi/benefici per le casse statali è in attivo di 1,5 miliardi di euro circa. L’interpretazione di questo dato indica quindi che gli immigrati 82 producono per l’Italia molto più di quanto consumano. 97Queste cifre confermano un trend riscontrabile già dall’analisi dei dati presenti sul dossier statistico del 2010, dove il complesso delle spese relative agli utenti stranieri dei servizi di welfare era quantificabile in 10 miliardi di euro, a fronte degli 11 ottenuti nello stesso anno dallo Stato (7,5 miliardi sottoforma di contributi previdenziali e 3,5 miliardidi gettito fiscale), andando quindi a creare un utile di circa 1 miliardo di euro. 98 Uno studio presentato da ISMU nel 2010 mostra chiaramente che i cittadini stranieri percepiscono mediamente un compenso più basso di quello degli italiani. La conseguente minore contribuzione è però ampiamente compensata da un minore trasferimento di prestazioni pensionistiche, legate all’anzianità, che sono invece rilevanti per i cittadini italiani. In altri termini: “lo studio dimostra che gli istituti di tassazione e spesa pubblica considerati stanno operando un rilevante trasferimento netto di risorse dagli immigrati verso gli italiani.” 99 Ricaviamo ancora dagli approfondimenti di Pugliese che una stima prudente valuta in circa 178 milioni l’anno le risorse minime che l’Italia investe nel contenimento delle migrazioni (controllo delle frontiere esterne, costruzione e gestione dei Cie, esecuzione dei rimpatri), risorse che non comprendono quelle stanziate per la cooperazione con i Paesi terzi finalizzata al contrasto dell’immigrazione illegale, né i costi del personale impiegato nell’attività di sorveglianza dei centri e nell’esecuzione delle espulsioni. A fronte di ciò solo 34,2 milioni di euro sono annualmente destinati in media alle politiche di inclusione sociale. 97 Dossier Statistico Immigrazione 2012, Caritas/Migrantes Dossier Statistico Immigrazione 2010, Caritas/Migrantes, Edizioni IDOS, pag 311. 99 Pugliese E., I lavoratori immigrati nella crisi e il razzismo istituzionale inLunaria (a cura di), 2011, Cronache di ordinario razzismo. Secondo Libro bianco sul razzismo in Italia, Edizioni dell’Asino. 98 83 6. CRIMINALIZZAZIONE E STIGMATIZZAZIONE DEI MIGRANTI 84 6.1 LA QUESTIONE CRIMINALE IN ITALIA Parlare di stigmatizzazione o di criminalizzazione dei migranti nel nostro Paese può apparire, per certi versi, provocatorio. Esiste infatti, da diversi anni, una tendenza abbastanza consolidata, sia nell’opinione pubblica che negli operatori che si occupano quotidianamente di questioni inerenti alla sicurezza, a dare per scontato che una fetta consistente della popolazione immigrata presente sul nostro territorio (soprattutto di quella “clandestina” e/o proveniente da Paesi extracomunitari) sia dedita ad attività illecite – magari con qualche differenziazione o “specializzazione” criminale a seconda della nazionalità di provenienza – e che quindi l’immigrazione, accanto ad alcuni indubbi vantaggi per l’economia nazionale, costituisca un problema per la sicurezza dell’Italia (o, perlomeno, contribuisca ad alimentarlo). Si tratta di opinioni ormai talmente radicate nella collettività da sembrare quasi delle verità assolute e dimostrate, anche perché nel recente passato hanno ricevuto conferma dalle statistiche ufficiali che si occupano di tracciare il quadro della criminalità nazionale, e sono state sovente riaffermate dai titoli strillati a voce e su carta dai nostri mezzi di comunicazione, dalle retoriche degli uomini politici che si sono alternati alla guida del Paese, dai discorsi dei nostri colleghi di ufficio e della gente comune. In questo modo tali convinzioni si sono cristallizzate, quasi come veri e propri assiomi o, per adottare un linguaggio di tipo sociologico, sensi comuni. Anche davanti all’assoluta novità, in Italia, della comparsa delle seconde generazioni di migranti, la tentazione è stata spesso quella di associare tale nuova presenza al concetto di “rischio sociale” (andando a prendere le problematicità emerse in altri Paesi e chiedendosi se potevano comparire anche nel nostro), piuttosto che insistere sulla necessità di intraprendere fin da subito percorsi normativi o amministrativi che potessero favorire l’inserimento di questi giovani nelle realtà urbane italiane. In questo capitolo ci proponiamo proprio lo scopo di instillare qualche dubbio nei nostri lettori a proposito di tali “verità assolute”: ci permettiamo, cioè, di mettere in discussione il senso comune imperante nell’opinione pubblica che vede il migrante (di prima o seconda generazione) come elemento tendenzialmente propenso a delinquere più della popolazione locale o comunque costituente un rischio per la nostra sicurezza. Mostreremo che queste convinzioni, dipinte come certezze acquisite nella nostra attuale società, sono in realtà da parecchio tempo oggetto di aspre e vivaci discussioni all’interno del dibattito criminologico che si è sviluppato, dapprima, nel continente americano (oggetto di considerevoli afflussi di manodopera immigrata, anche italiana, già dalla fine del XIX secolo) e, in seguito, in territorio europeo a partire dal secondo dopoguerra. Tali opinioni di senso comune poggiano, in realtà, su basi assai meno solide e dimostrate di quanto non si possa pensare, in un primo momento, di fronte alla quasi totale unanimità di consensi che si può rinvenire sui principali mezzi di informazione. Infine – cosa ancor più importante per un manuale destinato ad operatori di polizia – riteniamo che acquisire un maggiore spirito critico nei confronti di queste “facili certezze” sulla pericolosità dei migranti possa giocare un ruolo di fondamentale importanza per evitare che tali convinzioni, associate a talune pratiche operative di gestione della sicurezza urbana ed alle pressanti richieste di sicurezza a cui gli operatori di polizia sono sottoposti, possano involontariamente condurre ad una complessiva criminalizzazione degli immigrati da parte delle forze di polizia stesse. In Italia il tema della devianza 100 degli stranieri e del loro contributo alla criminalità nazionale è emerso in tutta la sua rilevanza solo a partire dai primi anni Novanta. Da quando, cioè, scoprimmo di essere non più terra di emigranti in cerca di fortuna nelle regioni settentrionali o all’estero, ma meta di individui in cerca di lavoro e di ospitalità; da quando, quindi, l’immigrazione è diventata, anche in Italia, un fenomeno strutturale e non transitorio. 100 Il concetto di devianza utilizzato in questo manuale è di tipo sociologico: per devianza in questa sede si intende il comportamento che si discosta, devia, da quello che è considerato il comportamento “normale” dai membri di una data società in un determinato contesto storico e geografico. Esso ricomprende, perciò, sia il comportamento criminale, che viola il diritto penale positivo, sia comportamenti che si discostano dall’ordine morale e/o culturale consolidato in una determinata formazione sociale. 85 In realtà la questione della criminalità degli immigrati è un problema annoso, vecchio almeno quanto l’immigrazione stessa. Come constatava Georg Simmel, nel suo famoso saggio “Excursus sullo straniero” (1908), “lo straniero è l’ospite che forse resterà”: una persona diversa da noi, che però può desiderare di inserirsi stabilmente nella nostra società e diventare come noi, avanzando (in maniera più o meno esplicita) pretese di riconoscimento, di uguaglianza, di giustizia. Per queste ragioni, è facile capire come l’ostilità dei gruppi autoctoni nei confronti degli stranieri e la preoccupazione che la loro presenza costituisca una minaccia per gli equilibri e gli stili di vita consolidati siano sentimenti storicamente presenti all’interno di svariate formazioni sociali di ogni epoca e latitudine, al di là del fatto che tali sentimenti siano effettivamente fondati e possano essere amplificati da altri fattori sociali, economici o politici presenti in ogni singola società. Quindi, risulta altrettanto comprensibile che, fin dagli albori delle scienze sociali e di quelle criminologiche in particolare, l’attenzione degli studiosi dei Paesi maggiormente interessati dal fenomeno si sia soffermata sul comportamento degli stranieri all’interno delle rispettive società di approdo, ed abbia tentato di trovare risposte certe e scientificamente dimostrabili a due fondamentali interrogativi: se, come paventato dagli atteggiamenti xenofobi di volta in volta presenti nell’opinione pubblica, gli stranieri delinquessero effettivamente di più rispetto alla popolazione locale ecostituissero una potenziale minaccia; e, in caso di risposta affermativa al primo quesito, per quali ragioni ciò avvenisse. In questo capitolo cercheremo di illustrare, in maniera sintetica ma esauriente, il dibattito criminologico sviluppatosi in Italia intorno a tale questione nell’ultimo ventennio (un dibattito che a sua volta è figlio delle posizioni già affermatesi nel XX secolo in altri contesti accademici), ma anche in che modo gli elementi economici, culturali e istituzionali presenti sulla scena pubblica italiana possano aver giocato un ruolo non secondario nella complessiva stigmatizzazione dei migranti quali potenziali rischi per la sicurezza pubblica. Volendo passare in rassegna le principali ricerche sviluppate in Italia sulla criminalità dei migranti, possiamo cominciare ad affermare che non c’è una grande tradizione scientifica sull’argomento. E per ragioni che sono ben note a tutti coloro che si sono occupati di tali fenomeni: in primo luogo perché il nostro Paese, fino all’ultima parte degli anni Ottanta, era considerato terra di emigrazione verso l’estero e non di immigrazione dall’estero. Quindi, le prime ricerche di una certa rilevanza sull’immigrazione straniera in Italia e sui fenomeni ad essa collegati iniziano con l’inizio degli anni Novanta, quando il tema dell’immigrazione raggiunge sempre più spesso importanti spazi sui mezzi d’informazione ed entra a pieno titolo nelle agende del mondo politico e di quello scientifico. A dire il vero, in passato avevamo già conosciuto un importante fenomeno migratorio: non si trattava, però, di migranti stranieri, ma della migrazione interna dalle regioni centro-meridionali dell’Italia verso le zone del cosiddetto “triangolo industriale”, che ebbe il suo momento culminante fra gli anni Cinquanta e Sessanta, ma continuò a più riprese anche nei successivi decenni. Anche in quel caso furono intraprese svariate ricerche, soprattutto nel corso degli anni Settanta, sul rapporto fra immigrazione e criminalità nelle regioni settentrionali, ricerche che arrivarono, in maniera pressoché concorde, a queste conclusioni: esisteva, effettivamente, un contributo rilevante degli immigrati meridionali alla criminalità di quelle regioni; emergeva, inoltre, una chiara sovra-rappresentazione di immigrati meridionali all’interno della popolazione carceraria di quelle regioni (ossia la percentuale di immigrati meridionali in carcere era nettamente superiore a quella della popolazione immigrata presente in quelle regioni); erano, in particolare, evidenti i disagi psicologici e sociali legati alla seconda generazione (ai figli degli immigrati stessi), cosa che aveva portato molte ricerche a rilevare uno stretto rapporto fra immigrazione e criminalità minorile nelle regioni settentrionali; infine, parallelamente a tali fenomeni, si erano diffusi all’interno della popolazione autoctona di quelle regioni, stereotipi negativi (spesso a sfondo razzista) nei confronti del “meridionale”. Più controverse (e mai del tutto risolte) furono invece le discussioni teoriche sui motivi che spingevano gli immigrati meridionali ad offrire un contributo rilevante alla criminalità e sulle accuse, mosse all’epoca, nei confronti delle agenzie di controllo (forze dell’ordine e sistema giudiziario), relative ad una loro presunta azione discriminatoria a danno della popolazione immigrata, volta ad assecondare quegli stereotipi negativi. Venendo alle più recenti ricerche sulla criminalità degli immigrati stranieri in Italia, le ricerche esistenti svelano un ventaglio di approcci abbastanza ampio sull’argomento. E tuttavia occorre mettere in 86 chiaro che, pur nella differenza di opinioni, esiste allo stato attuale un aspetto relativamente condiviso da tutti questi studi, una sorta di “patrimonio comune” a cui essi fanno riferimento. Esso consiste nella consapevolezza che il contributo quantitativo nei tassi percentuali di criminalità e di delittuosità 101 registrati nell’arco del ventennio –seppur con scostamenti a volte significativi nei singoli reati –mostra una chiara sovra-rappresentazione degli individui stranieri rispetto al campione degli italiani. Ciò risulta evidente anche quando si cerca di comparare – pur con tutte le difficoltà di ordine metodologico che ciò comporta – campioni correttamente confrontabili, utilizzando cioè campioni di cittadini italiani che siano in qualche modo paragonabili a quelli degli immigrati, secondo le tradizionali variabili socio-demografiche del sesso, dell’età, della scolarizzazione, della condizione familiare ed economica (per citare le più comunemente utilizzate) 102. Si conviene anche sul fatto che questa sovra-rappresentazione non riguarda indiscriminatamente tutti i comportamenti criminali ma prevalentemente alcuni di questi fenomeni. Riguarda soprattutto la cosiddetta criminalità “opportunistico-predatoria”, alcuni reati contro la persona, lo spaccio di stupefacenti. Secondo gli ultimi dati statistici, aggiornati al 2009 103, la quota degli stranieri sul totale dei denunciati è pari, ad esempio, al 59,1% per i “furti negli esercizi commerciali”, al 56,53% per il “furto con destrezza”, al 51,24% per le rapine in abitazione, al 34,2% per tutti i reati connessi alla droga 104. Ma anche nei reati in cui è meno cospicuo l’apporto deviante dei soggetti stranieri, come ad esempio nel caso degli omicidi consumati (33% sul totale dei denunciati) o delle estorsioni (25,57%), è tuttavia evidente una chiara sovrarappresentazione di immigrati rispetto ai cittadini italiani se si pensa che, secondo i dati resi noti dalla Caritas nello stesso anno di pubblicazione del Rapporto ministeriale sulla sicurezza, gli stranieri presenti regolarmente in Italia incidevano sulla popolazione per il 7,5% sul totale della popolazione, e superavano di poco lo 8% anche facendo una grossolana stima per eccesso degli immigrati irregolari 105. Se, anziché le percentuali degli stranieri denunciati, si vogliono prendere in considerazione le cifre relative agli stranieri condannati o a quelli incarcerati nel nostro Paese sui rispettivi totali, le cifre non si discostano di tanto. Anzi, a proposito di quest’ultimo aspetto, alcuni autori hanno parlato di una progressiva “sostituzione” dei cittadini meridionali (che dal secondo dopoguerra furono per lungo tempo uno dei “noccioli duri” della popolazione carceraria) con gli immigrati, se si pensa che nell’arco di un ventennio la loro presenza all’interno degli istituti di pena è passata dal 16% sul totale della popolazione carceraria nel 1991 al 28% nel 2000 per arrivare al 36,72% nel 2010 106. Un altro punto del dibattito su cui generalmente si conviene è che la sovra-rappresentazione degli stranieri nella statistica della delittuosità non si distribuisce indifferentemente tra le diverse nazionalità: variano le caratteristiche tra una nazionalità e l’altra e talora vi sono differenze marcate anche a seconda delle aree geografiche di provenienza all’interno della stessa nazione di origine. Molti dei reati predatori considerati in precedenza fanno quindi segnalare un forte grado di concentrazione su alcuni gruppi nazionali, ad esempio, nel triennio 2007-2009, gli autori di furti con destrezza di nazionalità romena hanno da soli rappresentato il 23,9% del totale dei denunciati per quel reato, mentre nello stesso periodo gli 101 Distinguiamo i due concetti da un punto di vista statistico: i tassi di delittuosità prendono in considerazione le denunce per fatti delittuosi presentate all’Autorità Giudiziaria; le statistiche sulla criminalità si riferiscono, invece, solamente ai delitti per i quali l’Autorità Giudiziaria ha iniziato l’azione penale. 102 In verità, una voce parzialmente dissonante c’è: secondo Franco Pittau, confrontando campioni di cittadini autoctoni paragonabili con quelli degli immigrati e togliendo dal computo dei reati quelli contro la normativa sull’immigrazione, la maggiore “produttività criminale” dei migranti sarebbe limitata agli stranieri irregolari, mentre gli immigrati regolari avrebbero tassi di delittuosità in tutto e per tutto simili a quelli dei cittadini italiani (cfr. Caritas/Migrantes, “XIX Dossier Statistico sull’Immigrazione”, 2009). 103 I dati si riferiscono al “Rapporto sulla criminalità e sicurezza in Italia 2010”, a cura di Marzio Barbagli e Asher Colombo, pubblicato nell’estate 2011 dal Ministero dell’Interno. Trattandosi dell’ultimo rapporto ministeriale a contenere disaggregazioni statistiche particolareggiate relativamente alla nazionalità degli autori di reato denunciati all’Autorità Giudiziaria del nostro paese, il Rapporto costituisce tuttora un punto di riferimento sulla questione, sia per il reperimento dei dati che per le critiche alle modalità di presentazione e di produzione degli stessi (di cui si parlerà in seguito). 104 Gli autori del Rapporto del 2010 sottolineano come proprio per i reati connessi alla vendita-spaccio di sostanze stupefacenti si sia registrato un continuo aumento della percentuale di autori stranieri sul totale dei denunciati, in controtendenza con il resto dei reati che, pur registrando percentuali di coinvolgimento anche superiori, dal 2007 in poi ha conosciuto una timida inversione di tendenza (Barbagli e Colombo, 2011: pagg. 321-322). 105 Dati ricavati dal 11° Rapporto Caritas sull’Immigrazione del 2011. 106 Dati contenuti nel VII Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione pubblicato dall’Associazione Antigone nel 2011, dall’eloquente titolo “Prigioni malate”. 87 autori di rapine in pubblica via di nazionalità marocchina hanno costituito il 10,9% del totale per quel reato: “per alcuni reati, poche nazionalità da sole contribuiscono in misura più rilevante di altre a determinare il peso che gli stranieri hanno tra coloro che commettono delitti nel nostro Paese” (Barbagli e Colombo, cit., pag. 325). Un altro aspetto generalmente condiviso riguarda le regioni italiane in cui il fenomeno della criminalità degli immigrati risulta maggiormente problematico: i tassi di delittuosità degli stranieri sono decisamente più alti nelle regioni settentrionali che in quelle meridionali, talora con fortissime differenze relativamente ai reati di furto, contrabbando, spaccio di droga e sfruttamento della prostituzione. Un ultimo aspetto condiviso dalla quasi totalità delle ricerche effettuate sul rapporto fra criminalità ed immigrazione è, infine, relativo alla diversa incidenza dei migranti rispetto agli italiani anche relativamente alle vittime di reato. Così come nel caso degli autori, anche la quota di vittime di nazionalità straniera presenta un’evidente sovra-rappresentazione rispetto alle vittime di nazionalità italiana. Tale quota è particolarmente significativa per i reati più violenti, come l’omicidio tentato (circa il 30% del totale delle vittime è straniera) e consumato (25%), le violenze sessuali contro donne (31,3%), le lesioni dolose (intorno al 20%). Le statistiche mostrano anche che il rapporto fra autore e vittima di un reato è prevalentemente intra-group, cioè che è molto più facile essere fatti oggetto di un comportamento illecito da parte di un autore della propria nazionalità. La frequenza con cui i reati avvengono all’interno dello stesso gruppo cresce passando dai reati in cui autore e vittima non entrano in contatto a quelli in cui entrano in contatto: si abbassa per alcuni tipi di reati contro la proprietà come i furti in abitazione o i furti su/di auto o motoveicoli, mentre è massima nelle lesioni dolose, negli omicidi tentati e consumati. 107 Ovviamente questi dati dicono tanto e dicono poco: sono dati puramente descrittivi di un fenomeno, così come vengono registrati dalle statistiche ufficiali che, come vedremo in seguito, si prestano già di per sé ad una serie di obiezioni. Dove ci si comincia a dividere – ed a dividere fortemente – è ovviamente quando si passa da un’analisi puramente descrittiva a tentativi interpretativi o esplicativi di questo fenomeno. Volendo tracciare un quadro brutalmente sintetico delle diverse posizioni teoriche al riguardo, si può dire che sono sostanzialmente due oggi in Italia – ed in tutti i principali Paesi europei – gli approcci esplicativi: un primo approccio sostiene che le statistiche siano effettivamente il termometro di una situazione reale, ossia del fatto che gli immigrati oggi delinquono di più – o meglio, hanno una maggiore propensione a delinquere – rispetto alla popolazione autoctona. Una posizione in deciso contrasto con la tradizione classica degli studi sul rapporto tra criminalità e immigrazione che, a partire dalle pionieristiche ricerche degli anni ‘20 e degli anni ’30, aveva sempre sostenuto la tesi contraria: che, cioè, la prima generazione di immigrati avesse in realtà una propensione a delinquere più bassa di quella della popolazione residente, mentre esistevano concreti rischi rispetto alla seconda generazione di immigrati, specie se non ancora del tutto integrata all’interno della società di arrivo. C’è invece un secondo approccio, al cui interno si diversificano molte posizioni, decisamente critico verso questa lettura, che sostiene che tali statistiche non siano un neutro termometro di una situazione ma che siano il frutto, il prodotto di una complessiva situazione di penalizzazione, stigmatizzazione, se non di vera e propria discriminazione istituzionale nei confronti dei migranti. All’interno di questi due orientamenti abbiamo poi una varietà di posizioni diversificate circa l’aspetto eziologico: alle cause, cioè, che determinerebbero (o concorrerebbero a determinare) questa situazione di sovra-rappresentazione statistica dei migranti fra le maglie del sistema giudiziario del nostro Paese. Presenteremo ora le principali posizioni all’interno di questi due approcci interpretativi. 6.1.1 Perché, secondo le statistiche, gli immigrati delinquono più degli italiani? Il primo tipo di approccio, che parte dai numeri delle statistiche ufficiali per sostenere l’esistenza di una superiore propensione criminale dei migranti (soprattutto, come abbiamo visto, per i reati predatori 107 Anche questi dati sono presi dal “Rapporto sulla criminalità e sicurezza in Italia 2010”, a cura di Marzio Barbagli e Asher Colombo, Ministero dell’Interno, 2011. 88 “di strada” e con specializzazioni nei vari gruppi nazionali) fa innanzitutto riferimento alla teoria criminologica classica di Robert K. Merton dell’anomia o “frustrazione strutturale”. Si tratta di un approccio interpretativo che pone l’accento sull’individuo deviante e sui percorsi psicologici che possono condurlo a delinquere. Per Merton ogni uomo è essenzialmente un animale sociale che interiorizza le norme della società di riferimento e le fa proprie. In ogni società esistono delle mete culturali, ossia degli obiettivi generalmente condivisi da tutti gli appartenenti ad una formazione sociale (nelle società occidentali, ad esempio, tali mete possono essere rappresentate dal prestigio sociale o dalla ricchezza individuale, ecc.); ed esistono dei mezzi legittimi, ossia degli strumenti leciti, a disposizione di ciascun individuo per raggiungere tali mete (il lavoro, il risparmio, l’istruzione, ecc.). I mezzi legittimi, però, all’interno di ciascuna struttura sociale sono distribuiti in maniera squilibrata fra i suoi vari membri che si ritrovano così ad avere opportunità diseguali di raggiungere in modo lecito le mete prefissate. Secondo questa teoria, quindi, l’individuo che commette un reato è spinto da una situazione di frustrazione strutturale, provocata da questa situazione di squilibrio fra le mete sociali e la struttura di opportunità presente, fortemente diseguale: il criminale, pur condividendo le mete fissate dalla società, rifiuta i mezzi leciti previsti per raggiungerle e cerca di arrivare all’obiettivo comune (il successo economico) attraverso la scorciatoia dei mezzi illeciti (i crimini). Questa teoria è detta anche della “deprivazione relativa”, perché secondo gli studiosi che la sostengono non sarebbe necessario appartenere alle classi sociali economicamente più disagiate per avvertire quella “frustrazione strutturale” idonea a spingere al comportamento criminale: ogni individuo, infatti, adatta le mete che intende raggiungere (le proprie aspirazioni personali) al tipo di società o di gruppo sociale in cui si trova inserito. Per questi motivi si parla di deprivazione “relativa”: un esponente delle classi agiate non commetterà reati per procurarsi i mezzi di sussistenza (che già possiede) ma per elevare ulteriormente il proprio livello economico e prestigio sociale. Attualizzando la teoriaai giorni nostri, molti di coloro che appartengono al primo filone interpretativo, utilizzano la teoria mertoniana applicandola alla criminalità degli immigrati. Secondo questi autori, i migranti sarebbero portati a delinquere perché, attratti dalle mete sociali del nostro Paese o, più in generale, dei Paesi occidentali (ricchezza, benessere individuale), le farebbero proprie senzaavere, però, le reali opportunità di raggiungerle, perlomeno in tempi brevi. Questa situazione di oggettivo svantaggio sarebbe colmata attraverso il ricorso al comportamento criminale. Inoltre, la motivazione che spingerebbe il migrante a delinquere non sarebbe data tanto da una sua situazione di emarginazione assoluta ma dalla povertà “relativa” rispetto al contesto locale in cui vive. In particolare, secondo Marzio Barbagli (il principale autore dei Rapporti statistici sulla sicurezza in Italia ed uno dei più importanti criminologi del primo approccio interpretativo cui abbiamo fatto riferimento), questa tesi farebbe luce sui motivi per i quali anche gli immigrati della prima generazione, dagli anni ’70 del XX secolo in poi, sarebbero spinti a delinquere in misura superiore ai cittadini autoctoni. Nella società del consumo di massa pubblicizzato da mezzi di comunicazione sempre più globali, la meta sociale da raggiungere sarebbe rappresentata dal successo economico facile ed immediatamente “spendibile” all’interno delle società di arrivo; al tempo stesso, a partire dal 1970 in poi, in tutte le nazioni europee, sono state adottate norme sull’immigrazione sempre più restrittive che hanno reso meno agevole rispetto ai decenni precedenti l’inserimento lavorativo ed economico dei migranti nelle società di approdo. Ciò porterebbe fatalmente un certo numero di immigrati a propendere per un percorso criminale nel momento in cui essi si rendono conto dell’impossibilità di raggiungere in tempi brevi il successo economico. Inoltre, la teoria della deprivazione relativa spiegherebbe particolarmente bene per quali ragioni gli immigrati delinquono di più nelle regioni settentrionali (caratterizzate da minori difficoltà d’inserimento sociale e lavorativo e da un più alto livello di benessere socio-economico rispetto a quelle meridionali) che nel Sud: dove la meta sociale del successo economico è posta ad un livello più alto, il ricorso al comportamento criminale deve essere maggiormente praticato da colui che, pur sprovvisto di mezzi adeguati, intenderebbe raggiungerla in tempi brevi. Questo approccio teorico si sofferma sulla componente psicologica dell’individuo che sceglie (o sceglierebbe) di delinquere, all’interno di un contesto sociale che influenza tali scelte; peraltro, essa appare maggiormente adatta a spiegare i comportamenti devianti all’interno di società utilitaristiche e fortemente competitive come quella americana (in cui le mete sociali sono condivise da tutti, ma non da tutti raggiungibili) piuttosto che in nazioni dove i valori di riferimento sono meno univoci. Inoltre essa fornisce 89 chiavi di lettura convincenti per i reati di tipo predatorio o contro la proprietà, mentre risulta meno convincente per comprendere altri tipologie di delitti. Così, altre posizioni appartenenti al primo filone interpretativo preferiscono adottare un’altra tesi, nel tentativo di spiegare la maggiore propensione alla devianza dei migranti e l’apparente “specializzazione criminale” dei diversi gruppi nazionali relativamente al coinvolgimento nella commissione di differenti tipi di reato: la teoria criminologica di Edwin Sutherland dell’ “associazionismo differenziale”. Per Sutherland l’approccio mertoniano che faceva discendere la propensione criminale dei soggetti da una situazione di deprivazione-povertà (ancorché da intendersi in modo relativo) da cui essi cercano di allontanarsi è semplicistica e erronea: essa tiene conto di una molla motivazionale esclusivamente individuale ma non tiene conto (o dà per scontati) altri meccanismi alla base dei comportamenti degli individui. Per dirla con le stesse parole di Sutherland: La povertà nella città moderna generalmente significa segregazione nelle zone abitative ad affitto minimo, dove gli abitanti sono isolati da molte delle influenze culturali della città e costretti invece a entrare in contatto con molte delle influenze più degradanti. La povertà generalmente significa un basso status sociale, con poco da perdere, poco da rispettare, poco di cui andare fieri, pochi stimoli a migliorare la propria condizione. Significa anche generalmente povere condizioni abitative, povere condizioni igienico-sanitarie, scarsità di servizi di comunità attraenti. Significa generalmente che entrambi i genitori trascorrono lunghe giornate fuori casa, con la fatica, lo scarso controllo dei figli e l'irritazione che accompagnano tale situazione. Significa generalmente l'abbandono scolastico in giovane età e l'inizio di un lavoro di tipo industriale, con il conseguente ulteriore indebolimento dei controlli famigliari, lo sviluppo di risentimento antisociale e la mancanza di contatti culturali. La povertà, accompagnata dallo spettacolo della ricchezza nelle vetrine, nelle strade e al cinema, significa generalmente invidia e odio nei riguardi dei ricchi, insieme alla sensazione di star molto perdendo della vita a causa della mancanza di soddisfazione dei desideri fondamentali. […] È tuttavia sorprendente quanti poveri non diventino delinquenti, piuttosto di quanti lo diventino. (Sutherland, “Criminology”, 1924: pagg. 169-170, cit. in Melossi, 2002: pagg.152-153) Per spiegare la propensione al comportamento illecito di determinati individui, più che sulla povertà – assoluta o relativa che fosse – Sutherland puntava l’attenzione ai meccanismi di comunicazione e di apprendimento che ognuno di noi sperimenta fin dalla più tenera età attraverso le interazioni con gli altri soggetti che caratterizzano la nostra vita. Pensiamo, ad esempio, a come molti italiani diventano, nel corso della propria esistenza, tifosi di calcio: da un’iniziale curiosità infantile per un oggetto sferico che impariamo a chiamare palla, all’osservazione degli adulti in gruppo davanti ad un televisore (o, in passato, una radio) a seguire una partita, fino al giorno in cui qualche esperto inizia a spiegare al novizio le regole del gioco (compresa quella, per molti incomprensibile, del fuorigioco), questi va allo stadio o al campo sportivo di paese a seguire dal vivo un incontro e a poco a poco apprende le regole e le tattiche associate al gioco, si appassiona a quello sport e magari lo pratica pure con gli amici. Allo stesso modo, il comportamento deviante o criminale, secondo Sutherland, non è meramente legato ad una semplice pulsione individuale: è innanzitutto un comportamento socialmente appreso, attraverso le interazioni e le comunicazioni che ogni individuo ha sperimentato nel corso della propria esistenza, prima all’interno del nucleo famigliare ristretto, poi nei gruppi di amici ed infine nelle altre cerchie sociali (professionali e non) che frequentiamo man mano che passiamo dall’età infantile a quella adulta. In particolare Sutherland parla di “associazionismo differenziale”, ponendo l’accento sulle associazioni concettuali-comunicative che si sviluppano durante queste interazioni sociali: secondo l’autore, una persona non nasce delinquente, ma lo diventa. E lo diventa se, e nella misura in cui, gli inputcomunicativi favorevoli a compiere un comportamento illecito che avrà ricevuto durante il proprio percorso esistenziale prevarranno ai suoi occhi sugli input comunicativi contrari al compimento di atti illeciti. Se un individuo (un qualunque individuo) nel corso della propria vita sarà cresciuto o avrà vissuto in ambienti e gruppi sociali in cui un comportamento illecito viene accettato o addirittura incoraggiato, egli sarà maggiormente propenso a mettere in pratica tale comportamento. Si può dire che l’individuo, in questi casi, imparerà ad essere delinquente, ed in particolare potrà perfezionare: a) le tecniche di 90 commissione di un reato (e di elusione dei controlli volti ad impedirlo); b) i meccanismi motivazionali che lo spingono a compiere il reato e a considerarlo moralmente accettabile agli occhi suoi e della sua cerchia di abituale frequentazione. La teoria di Sutherland venne da lui applicata nel secondo dopoguerra alla criminalità dei “colletti bianchi” (espressione che viene utilizzata proprio nel titolo della sua opera più famosa: “White Colllar Crime”, del 1949), ma in Italia viene oggi utilizzata per spiegare come mai la sovra-rappresentazione degli stranieri nelle statistiche della delittuosità, criminalità e della penalità non si distribuisca in modo uniforme tra le diverse etnie ma, anzi, vi sia un forte grado di concentrazione su alcuni gruppi nazionali per alcuni reati: secondo alcuni autori il fenomeno migratorio oggi è sempre meno associabile a progetti pionieristici di singoli isolati individui, va invece inserito all’interno di vere e proprie filiere migratorie, spesso organizzate sulla base dell’appartenenza nazionale (se non regionale) dei migranti. Chi arriva si appoggia su gruppi di connazionali già strutturati e presenti nel Paese e, nel caso in cui il gruppo di appoggio faccia ricorso al proprio interno a comportamenti devianti, è presumibile che le tecniche di commissione dei reati e le motivazioni “morali” all’azione siano trasmesse ai nuovi arrivati, in misura differenziale a seconda del tipo di specializzazione e di inserimento del gruppo di appoggio. Vi sono, invece, altri autori che spiegano le statistiche riprendendo le tesi dell’interazionismo simbolico. Questi studiosi hanno rilevato, nel corso di una serie di ricerche, come in Italia sia in atto una diffusione di definizioni simboliche assolutamente ostili nei confronti dell’immigrato (ed in particolar modo dell’immigrato clandestino). Ciò avverrebbe da un lato a livello comunicativo, con la proliferazione, all’interno dei mass-media e dell’opinione pubblica, di luoghi comuni e di stereotipi che tendono ad individuare nell’immigrato extracomunitario un soggetto potenzialmente pericoloso per gli equilibri della nostra società; dall’altro lato queste definizioni ostili sarebbero confermate anche a livello normativo, con l’adozione di politiche sempre più restrittive nei confronti del fenomeno migratorio, tali da amplificare l’esclusione sociale di questi soggetti. Quindi, una parte di questi immigrati, definiti come “ontologicamente pericolosi o devianti” e posti ai margini della nostra società, tenderebbe sempre più ad identificarsi con le immagini negative che li riguardano e ad amplificare il proprio comportamento deviante, seguendo il meccanismo del cosiddetto “etichettamento”: demonizzati ed isolati dal resto della società, questi soggetti troverebbero un proprio percorso di autorealizzazione, la propria identità individuale, attraverso l’adesione al ruolo di outsider assegnato loro dalla società, finendo per amplificare ed incrementare il proprio livello di devianza in una sorta di profezia che si auto avvera (si veda anche il cap.5.6.1: reinterpretazione positiva). Questo tipo di interpretazione è proposta soprattutto per spiegare alcuni comportamenti illeciti di tipo espressivo commessi da migranti delle seconde generazioni e, in generale, da gruppi giovanili, ma non sembra adatta a descrivere dinamiche più strutturate nel compiere certi tipi di reato. Una sorta di mediazione fra queste diverse teorie viene proposta da Asher Colombo, autore di una ricerca di tipo etnografico condotta all’interno di alcuni gruppi di immigrati algerini che vivevano in condizioni di marginalità ed illegalità nella città di Milano 108. Colombo aveva rilevato da un lato che le scelte iniziali che spingevano la maggior parte dei ragazzi immigrati a dedicarsi ad attività devianti non erano dovute ad una situazione di assoluta miseria o disperazione ma al desiderio di raggiungere, con mezzi rapidi e quindi illeciti, le mete sociali (successo economico e prestigio sociale) di quella società consumistica occidentale che essi stessi, spinti dal richiamo dei mezzi di comunicazione di massa, avevano preso come nuovo punto di riferimento della loro esistenza. Dall’altra parte, però, mano a mano che le forme di trasgressione diventavano da occasionali a “professionali” (con l’innesco di meccanismi di apprendimento e perfezionamento delle tecniche criminali all’interno di tali cerchie), quei ragazzi sviluppavano una “identità deviante” di gruppo che li portava sempre più a far coincidere i loro comportamenti individuali con le rappresentazioni ostili della società esterna. Per riuscire ad accettare più facilmente la strada che avevano scelto di percorrere, finivano per considerarsi a pieno titolo “nemici” di una società che li escludeva, finendo per radicalizzare il loro atteggiamento criminale. 108 Vedi A. Colombo, “Etnografia di un’economia clandestina”, Il Mulino, 1998. 91 6.1.2 Alla ricerca di un capro espiatorio? Fin qui l’approccio che possiamo definire “giustificazionista”, che cioè intende legittimare i risultati emersi dall’elaborazione delle statistiche ufficiali, cercando al contempo di motivare la tendenza della popolazione immigrata a delinquere di più rispetto a quella italiana. C’è però un secondo approccio, che potremmo definire “critico”, che contesta i risultati delle statistiche ufficiali, ed afferma che gli stranieri non delinquono di più degli italiani masemmai incappano nel sistema penale più facilmente rispetto agli italiani. Che la loro sovraesposizione nelle statistiche sulla delittuosità e criminalità sarebbe dovuta al criterio di selettività del sistema penale, il quale tenderebbe a colpire soggetti che hanno un livello più basso di legami e difese sociali, quindi gli immigrati in primis. Che le statistiche ufficiali della criminalità non indicherebbero, pertanto, una maggiore propensione degli immigrati a delinquere rispetto ai cittadini autoctoni, semmai una maggiore propensione delle forze dell’ordine e del sistema giudiziario italiani a “pescare” fra le fila della popolazione immigrata i soggetti passibili di essere denunciati, condannati ed incarcerati. In questo secondo filone di interpretazioni possiamo annoverare tutti coloro che sostengono che i migranti siano oggettivamente divenuti un bersaglio, un capro espiatorio a disposizione di partiti politici e opinion maker,per ricompattare una società italiana frammentata da crisi economiche e trasformazioni sociali di una certa importanza. Infatti,è nei periodi di crisi, di transizione e di mutamento che si possono verificare vere e proprie situazioni di inquietudine sociale contrassegnate da irrazionalità e paura, con un conseguente aumento della domanda di sicurezza che la popolazione rivolge alle istituzioni. Il ricorso al capro espiatorio si materializza laddove le istituzioni (consapevolmente o meno) cercano di ritrovare la coesione sociale perduta attraverso l’individuazione di una categoria di individui considerati nemici, criminali o comunque pericolosi per il resto della società, contro cui dirigere la propria attività di reazionerepressione. Attraverso la lotta comune contro questo nemico, colpevolizzato per le difficoltà che essa vive, la società può ritrovare una propria identità collettiva; il “sacrificio della vittima” le consente di ricostituire una pace più o meno duratura, allontanando l’attenzione della collettività da quelle che sono le reali cause della situazione di crisi, cause spesso di natura strutturale, difficilmente risolvibili se non attraverso una ridefinizione delle politiche e degli equilibri di potere esistenti in una determinata congiuntura sociale. È interessante notare che, secondo l’impostazione classica della teoria, perché si formi un capro espiatorio non è necessario che le accuse mosse contro di esso siano motivate o verosimili. La cosa importante è che a tali individui siano attribuiti crimini “primari”, diretti contro i principi cardine dell’ordinamento giuridico o morale; inoltre questi soggetti devono essere un capro espiatorio credibile e quindi appartenere possibilmente ad una categoria sociale già di per sé stigmatizzata, a causa delle proprie caratteristiche culturali, fisiche, economiche ecc. I soggetti che posseggono determinate caratteristiche possono addirittura rivestire il ruolo di nemico opportuno (Christie, 1986), di bersaglio comune “ideale” contro cui unire i propri sforzi per ricompattare la società grazie alla mobilitazione contro questo avversario. Quali sono i requisiti che fanno di una categoria di soggetti il “nemico opportuno” perfetto? In primo luogo essi dovranno apparire forti e temibili, senza tuttavia esserlo. Solo un nemico apparentemente forte potrà, infatti, giustificare l’allarme diffuso nella generalità dei consociati e l’adozione, da parte delle autorità che lo fronteggiano, di poteri repressivi emergenziali; tuttavia il nemico deve essere, in realtà, debole nella struttura dei rapporti di forza della società, in modo da poter essere agevolmente emarginato e sconfitto. Una seconda caratteristica di questi bersagli è la loro apparente invincibilità: il buon nemico non può morire. Tutt’al più può essere indebolito o sostituito, ma mai annientato completamente, per poter mantenere alto il livello di guardia e consentire a chi deve combatterlo l’adozione di misure di contrasto prorogabili a tempo indeterminato, a seconda del livello di minaccia percepibile in un dato momento. Una terza particolarità di questo nemico dovrà essere la sua visibilità: il nemico ideale deve essere agevolmente identificabile dai membri di una società, sia per facilitarne la stigmatizzazione nel processo di costruzione sociale del sentimento di insicurezza, sia per renderne più semplice il riconoscimento e l’isolamento da parte delle istituzioni preposte al controllo sociale. La visibilità di una categoria sociale può essere data, ad esempio, dalla diversità dei suoi membri rispetto agli altri consociati (in termini fisici, culturali o morali), ed è generalmente accresciuta dalla sua vicinanza al contesto di riferimento. Ecco 92 perché nella scelta del nemico opportuno vengono comunemente privilegiati individui presenti all’interno della società che sono, al tempo stesso, maggiormente minacciosi ma anche più vulnerabili, comportano minori costi nello sforzo “bellico” da sostenere e permettono una più agevole ricostruzione dei confini identitari della comunità di riferimento. Infine un’ultima caratteristica del nemico ideale è l’indeterminatezza dei suoi confini: la categoria stigmatizzata come capro espiatorio deve essere abbastanza determinata nella sua identità di gruppo da consentirne la sua individuazione e stigmatizzazione da parte dei consociati ma mantenere al contempo confini sfumati e fluttuanti, in modo tale da potervi far rientrare nuovi soggetti ed essere adattata, a seconda delle esigenze e delle emergenze politiche e mediatiche del momento. Da questo punto di vista, i migranti costituiscono per molti aspetti un nemico pubblico ideale per ogni tipo di rivendicazione identitaria: apparentemente forte, numeroso, invincibile (tanto da far rispolverare nei media concetti come quello di “invasione” o di “minaccia” più adatti a contesti bellici che al fenomeno in questione) ma altrettanto evidentemente relegato ai margini delle società di approdo e spesso privo di adeguate possibilità di tutela politica dei propri interessi; un nemico visibile e identificabilein modo sufficiente da poter essere isolato e fatto oggetto di particolari strumenti di contenimento o repressione da parte delle istituzioni, ma al tempo stesso dai confini sfumati e cangianti, evocabile quindi anche laddove si parli di problemi che toccano la prima o la seconda generazione di migranti, questo o quel gruppo nazionale, o soggetti di nazionalità composita (come i rom) ma comunque considerata straniera, a prescindere dalle carte di identità. 6.1.3 La stigmatizzazione del “nemico”: tautologia della paura L’esempio più efficace dell’applicazione della teoria del nemico opportuno ai migranti proviene dall’analisi di Alessandro Dal Lago che analizza i meccanismi riproduttori degli stereotipi ostili all’immigrazione nell’odierna società italiana. Così come in altri Paesi europei, anche in Italia una fetta importante di mass-media, politici e benpensanti si è unita in un fronte comune ostile ai migranti che ha caratterizzato il discorso pubblico sull’immigrazione degli ultimi vent’anni. A partire dai primi anni Novanta, infatti, in Italia l’immigrazione inizia ad essere definita quasi esclusivamente in termini di illegalità e di degrado, mentre la fonte privilegiata delle notizie è costituita da un nuovo attore sociale: il cittadino che protesta contro il degrado e contro l’immigrazione. Secondo Dal Lago, si è così innescata una spirale di corto-circuito comunicativo che ha condotto alla costruzione di un’immagine collettiva che associa l’immigrato ad un potenziale delinquente; un processo di stigmatizzazione del migrante che l’autore genovese definisce “tautologia della paura”(Dal Lago, 1999: pp. 94-95). Si tratterebbe, in particolare, di un meccanismo tautologico(ossia la circolarità viziosa di un ragionamento che non fa che ripetere se stesso), nella misura in cui la semplice enunciazione dell’allarme percepito (“l’invasione degli immigrati delinquenti”) mira a dimostrare la realtà che esso denuncia. In questo modo le definizioni soggettive di una situazione diventano reali, oggettive, e ciò è tanto più vero quanto più riguardano aspetti socialmente delicati, come la paura del nemico. Ma in che modo giunge ad imporsi come indiscutibilmente vero questo cumulo di banalità e luoghi comuni? Secondo Dal Lago il meccanismo parte da un ribaltamento delle figure di vittima e carnefice: ogni discriminazione degli stranieri, infatti, viene tradizionalmente attuata mediante il ricorso a meccanismi di vittimizzazione della componente maggioritaria della popolazione e di colpevolizzazione delle minoranze. I primi sono solitamente vittime di torti, cittadini che si autodefiniscono deboli o abbandonati dalle istituzioni, che si coalizzano per fare giustizia; gli aggressori (o presunti tali) sono, invece, corpi estranei, invasori, “nemici della società indifesa”. Il ruolo di difensori della società ferita viene assunto da quelli che Dal Lago chiama imprenditori morali, avanguardie di benpensanti che s’accollano il compito di scuotere un’opinione pubblica passiva ed inconsapevole. Nelle società contemporanee operano imprenditori morali molto più efficaci che in passato, capaci non solo di trasmettere sentimenti di paura ad un numero consistente di persone, ma anche di alimentarla e, a volte, crearla artificialmente attraverso i mezzi di 93 comunicazione di massa. Luoghi comuni, pregiudizi, leggende metropolitane 109 possono diventare, grazie all’informazione di massa, prima risorse simboliche, e poi “verità sociali oggettive”. Questo perché i giornalisti, nel costruire le notizie in materia, non fanno altro che ricorrere a dei frame, risorse simboliche immediatamente accessibili, contribuendo così a dare credito a stereotipi che essi stessi hanno contribuito a creare. La capacità di una definizione soggettiva ed allarmistica di diventare oggettiva e pacificamente condivisa è data da diversi fattori: l’accordo degli attori che devono produrre queste affermazioni, la legittimità pubblica di questi soggetti e la possibilità, da parte dei media, di imporre le loro definizioni,selezionando i temi da considerare prioritari e le modalità di presentarli. Quest’ultima funzione (che in lingua inglese è denominata agenda-setting) si rivela decisiva, perché la stampa può elaborare delle definizioni pubbliche, delimitando al tempo stesso il campo di ciò che è rilevante e ciò che non lo è, e selezionando le notizie utilizzate allo scopo. La definizione dell’allarme da parte dei mass-media a sua volta viene legittimata e confermata dall’esistenza di attori che rivendicano la rappresentanza della comunità locale, che sarebbe minacciata dal pericolo di criminalità degli stranieri. Infatti, grazie alla comparsa del “cittadino che protesta” (vittima per eccellenza dell’allarme immigrazione), le reazioni o conferme soggettive si traducono inevitabilmente in risorsa politica, alimentando le retoriche dei partiti o dei gruppi che rappresentano i cittadini. Perché tale risorsa sia utilizzabile dai diversi attori politici ed istituzionali non è necessario che essa corrisponda ad un reale sentimento di massa: basterà che venga evocata dall’informazione e confermata dalla viva voce dei “protagonisti”. L’innesto in questo corto circuito di imprenditori politico-morali fa sì che la risorsa politica locale conquisti il rango di risorsa primaria nell’agenda politica. In questo modo, secondo Dal Lago, l’emergenza immigrazione sarebbe diventata pian piano una verità indiscutibile. Nel modello della “tautologia della paura” un ruolo strategico viene assunto dal cittadino, nella veste di “definitore soggettivo della situazione”. È colui che offre incessantemente ai media la voce e giustifica la trasformazione di una risorsa simbolica in un frame morale e sociale dominante. I luoghi comuni utilizzati da questi nuovi attori (singoli o organizzati in comitati) nelle loro definizioni del problema sicuritario hanno conquistato progressivamente il ruolo di definizioni ufficiali della realtà da quando sono stati fatti propri sia da quasi tutti i partiti politici (nell’evidente intento di disputarsi la rappresentanza dei cittadini nella veste di difensori della loro sicurezza), sia dal “senso comune colto”, praticato da intellettuali o osservatori. Il bisogno di sicurezza, da luogo comune allarmistico e populista, diventa un frame ricorrente del teatro politico, una risorsa primaria cui attingere per ritradurre e gestire le emergenze e le difficoltà della vita collettiva nella ricerca del consenso. Il meccanismo può essere graficamente rappresentato in questo modo: 109 Si pensi, ad esempio, al caso dei rom che rapiscono i bambini, già citato nel capitolo introduttivo. 94 RISORSA SIMBOLICA (“Gli stranieri sono una minaccia per i cittadini”) DEFINIZIONE SOGGETTIVA DEGLI ATTORI LEGITTIMI (“Abbiamo paura: gli stranieri ci minacciano”) DEFINIZIONE OGGETTIVA DEI MEDIA (“Gli stranieri sono una minaccia: i cittadini stessi lo confermano”) TRASFORMAZIONE DELLA RISORSA SIMBOLICA IN “FRAME”DOMINANTE (“È dimostrato che gli stranieri minacciano la nostra società”) CONFERMA SOGGETTIVA DEGLI ATTORI LEGITTIMI (“Siamo minacciati ed abbandonati dalle istituzioni”) INTERVENTO DEL RAPPRESENTANTE POLITICO LEGITTIMO (“Se non interviene il governo, ci penseremo noi a difendere i cittadini”) EVENTUALI MISURE NORMATIVE CHE CONFERMANO IL “FRAME” DOMINANTE (che potrà ora, poiché confermato, essere invocato ad ogni nuova emergenza) I pregiudizi ed i luoghi comuni esistenti in larghi settori della società italiana, confermati come “indiscutibilmente veri”, e la diffusa percezione d’insicurezza ad essi collegata avrebbero così innescato un perverso meccanismo circolare attraverso il quale sono stati legittimati gli interventi di carattere repressivo e normativo nei confronti dei migranti e la loro progressiva esclusione dalla nostra società. Secondo Dal Lago, quindi, la criminalità stessa degli immigrati sarebbe diventata l’esito finale di tale processo di costruzione sociale perché funzionale a tale logica di esclusione. L’immigrazione sarebbe anzi diventata una vera e propria metafora sociale della devianza: ad una diversità fisica e comportamentale che già di per sé rende complicato l’inserimento nella nostra società, si somma un complessivo processo di colpevolizzazione pubblica dell’immigrato che sfocia nell’individuazione di una categoria sociale ontologicamente pericolosa, da respingere alle frontiere, relegare ai margini della società o reclutare nelle fila della popolazione carceraria. Grazie a meccanismi sociali di etichettamento e di esclusione impliciti ed espliciti, la generalità dei consociati viene così divisa in maggioranze di cittadini nazionali (dotati di diritti e garanzie formali) e minoranze di stranieri illegittimi, cui tali garanzie vengono negate di diritto e di fatto. L’umanità viene divisa tra persone e non-persone. 6.1.4 Nuove strategie di controllo sociale e “guerra alla povertà” L’idea che lo strumento penale e, più in generale, le attenzioni delle istituzioni del controllo 110 vengano concentrate su intere categorie di individui marginali e stigmatizzati è ripresa anche da altri autori, che inseriscono tale tendenza all’interno di una cornice interpretativa di più ampio respiro. Secondo questi autori, infatti, nelle società contemporanee il controllo sociale non è più esercitato sui singoli soggetti (rei o socialmente pericolosi) ma su soggetti collettivi che vengono dapprima marchiati dallo stigma della devianza e successivamente emarginati dalla scena sociale. Ovviamente anche le strategie messe in opera dalle agenzie di controllo sociale risentono dei mutamenti congiunturali che si verificano nell’economia 110 Con questa locuzione intendiamo ricomprendere tutte quelle istituzioni che si occupano di definire i comportamenti conformi al sistema di norme giuridiche e morali esistente in seno alla società e di punire chi devia da essi: forze di polizia e sistema giudiziario in primis. 95 mondiale, nelle organizzazioni statali e nelle diverse formazioni sociali che storicamente si susseguono. Non è possibile isolare il discorso punitivo e le strategie del controllo dal contesto politico-sociale nel quale si sviluppano e al quale si rivolgono. Secondo diversi autori, dagli anni Settanta del secolo passato ad oggi stiamo assistendo al tramonto dello Stato-nazione, dei sistemi di welfare, dell’economia basata sul sistema di produzione fordista e delle istituzioni che si reggevano su quegli equilibri. A livello di politica generale, questa fase coincide con l’esplosione della cosiddetta “crisi fiscale dello Stato”, che ha indotto i principali Paesi occidentali a rivedere, anche drasticamente, le proprie politiche assistenziali di stampo social-democratico in sostegno dei ceti meno abbienti. Dapprima negli Stati Uniti di Nixon e Reagan e poi nella Gran Bretagna thatcheriana si assiste ad una drastica politica di contenimento della spesa sociale: parallelamente viene ridotta l’incidenza dei sindacati sulle politiche del lavoro e vengono abbondantemente snellite le normative garantiste in materia di assunzioni e licenziamenti, con la flessibilità che diventa il vero e proprio criterio generale di accesso al lavoro e di trattamento retributivo. Nel settore penale, crollano i vari investimenti sulle politiche preventive o rieducative, volte ad un trattamento non puramente repressivo della devianza:tali politiche vengono infatti accusate da molti osservatori come antieconomiche e scarsamente efficaci dal punto di vista della prevenzione della criminalità. Tutto ciò, secondo il sociologo francese Loic Wacquant, ha prodotto due tipi di conseguenze: da un lato l’esplosione della precarietà e della povertà di massa nei Paesi caratterizzati dall’avvento di queste politiche neo-liberiste, con una distanza sempre più marcata fra i ceti abbienti e quelli popolari e con un drastico contenimento della cosiddetta classe media 111. Dall’altro lato, l’altra conseguenza di tali politiche è stata l’esplosione della percezione di insicurezza e della criminalità nelle metropoli americane, insieme ad un vertiginoso aumento del tasso di incarcerazioni (dal 1982 al 1997 la popolazione carceraria americana addirittura triplica, arrivando a contare 1.785.079 detenuti) 112. Wacquant parla apertamente di una correlazione fra l’ “atrofia deliberata dello stato sociale”e la “ipertrofia del sistema penale” 113: negli USA la crescita esponenziale dei detenuti, infatti, non attraversa trasversalmente gli strati sociali e coinvolge solo marginalmente i membri della criminalità organizzata; essa si abbatte sostanzialmente contro piccoli delinquenti condannati per questioni di spaccio al dettaglio di droga, furto, taccheggio e disturbo della quiete pubblica, reclutati nella stragrande maggioranza fra le famiglie del sottoproletariato afro-americano residente nelle città maggiormente colpite dal contenimento delle politiche sociali. Nel 1998, 6 detenuti americani su 10 erano neri o latinos, meno della metà aveva un impiego al momento dell’arresto, mentre i due terzi provenivano da famiglie al di sotto della soglia di “estrema povertà”. Tale correlazione, secondo Wacquant, non si limiterebbe ad essere di tipo statisticoma sarebbe intenzionale: l’autore francese parla infatti di “guerra alla povertà”, di “governo della miseria” condotto attraverso lo strumento penale. Infatti, la crescita vertiginosa del ricorso allo strumento detentivo rappresenterebbe l’altra faccia della medaglia delle politiche neo-liberiste di snellimento del settore pubblico e di contrazione delle garanzie nel mercato del lavoro: si tratterebbe di una precisa politica di “criminalizzazione della miseria”, funzionale all’imposizione di una condizione salariale precaria e sottopagata come unica condizione di accesso al mercato del lavoro e alla conversione della spesa pubblica assistenziale in spesa pubblica per alimentare i sistemi punitivi-repressivi dello Stato. Il bersaglio di tale politica diventa la categoria di individui resa superflua o indesiderabile dalla duplice riforma del mercato del lavoro e del sistema di welfare: le frazioni declinanti della ex-classe operaia, i neri poveri e gli immigrati clandestini che vivono nelle grandi città. Sono questi i soggetti che negli USA vengono considerati “oggettivi produttori di rischio” e sottoposti all’attenzione selettiva da parte delle istituzioni del controllo. 111 Wacquant registra come nel ventennio 1975-1995 negli USA il numero di persone considerate sotto la soglia di povertà abbia raggiunto i 35 milioni di individui, con un tasso di povertà doppio o triplo rispetto a quello dei Paesi dell’Europa occidentale; fra questi, addirittura 14 milioni erano sotto la soglia di “estrema povertà” (ossia con reddito inferiore del 50% alla soglia di povertà federale), il doppio rispetto alla situazione di vent’anni prima. 112 I dati sono presi dal testo di L.Wacquant “Parola d’ordine: tolleranza zero”, Feltrinelli, 1999. 113 Altri autori parlano di un passaggio dall’era del welfare state all’epoca del warfare state, ossia di uno Stato orientato alla militarizzazione all’interno ed all’esterno dei propri confini. 96 Da questa situazione scaturisce, ovviamente, una ridefinizione delle strategie e degli obiettivi del controllo sociale. L’attenzione non è più rivolta al singolo (criminale o deviante) e non ha più la finalità di “rieducarlo” ad una corretta vita sociale: il controllo sociale viene esercitato nei confronti di gruppi di individui, in particolare su quei gruppi considerati oggettivamente pericolosi. Lo scopo dell’azione punitiva si trasforma nella ridistribuzione e nella gestione del rischio di criminalità, considerato un fenomeno socialmente inevitabile (e quindi non prevenibile mediante gli ormai troppo costosi “sostitutivi penali”). Alcuni autori parlano di strategie di controllo di tipo attuariale (Feeley e Simon, 1994; De Giorgi, 2000), riprendendo una terminologia tipica del mondo assicurativo: queste strategie, infatti, si comportano esattamente come fanno le assicurazioni rispetto al rischio di un incidente, considerando normale il rischio di criminalità. Ridistribuire un carico di rischio significa dichiarare l’impossibilità di ridurlo; significa prescindere dal singolo fattore di rischio per concentrarsi invece su una valutazione d’insieme. Nel versante giudiziario delle strategie di controllo ciò comporta, ad esempio, che, considerata una determinata categoria di soggetti ritenuti pericolosi, la gravità della sentenza di condanna inflitta al singolo soggetto non dipenda tanto dalla sua condotta individuale (e dal grado di “disvalore oggettivo” contenuto nella sua condotta) ma piuttosto dal complessivo livello di “rischiosità” del gruppo in cui egli è inserito. Se tale soggetto ha già conosciuto precoci casi di recidiva ed appartiene a una classe pericolosa, poco importerà che egli sia, soggettivamente, più o meno pericoloso: la sentenza dovrà necessariamente assumere connotati di durezza. Si sviluppa, quindi, da un certo momento in poi, l’idea che gli esseri umani devono essere trattati diversamente a seconda della classe (di rischio) cui appartengono. L’individuo ha rilievo solo in quanto sia possibile riferirlo ad un’intera categoria, sulla base di una prognosi probabilistica e statistica della sua rischiosità basata su recidiva e gruppo di appartenenza. Le strategie del controllo si radicano, insomma, nella gestione di determinati gruppi, di determinate categorie di soggetti verso i quali viene diretta la sorveglianza, la deterrenza e la neutralizzazione. Nel versante, invece, del controllo in habitat urbano, le politiche e pratiche di sicurezza urbana di matrice attuariale tendono, da una parte, a spersonalizzarsi, dirigendosi più sull’ambiente che sugli individui; dall’altra, a “collettivizzarsi”, visto che il rischio è un fattore collettivo. Continua a permanere una logica preventiva, ma muta il significato di ciò che s’intende per prevenzione. Prevenire non significa più attivare strategie per la rimozione delle “cause sociali della devianza”, ma riprogettare l’ambiente fisico nel quale si costituiscono e interagiscono i gruppi da tenere sotto controllo: prevenzione situazionale, più che prevenzione sociale. La prevenzione situazionale, che consiste in una serie di pratiche finalizzate alla riduzione delle circostanze ambientali che favoriscono i comportamenti devianti (senza alcuna considerazione per i fattori sociali, culturali ed economici che stanno alla base dell’esperienza deviante), è il nuovo modello di strategia operativa nella gestione urbana del rischio criminale. Il fatto che l’attenzione si concentri non più sui singoli, ma sui gruppi, comporta che il controllo si dirige verso quelle forme di interazione sociale che si sviluppano nell’ambito dei gruppi marginali, etichettati come devianti. Si tratterà, quindi, di gestire, sorvegliandole secondo criteri di efficienza e di minor costo, le popolazioni a rischio che abitano i territori dell’esclusione. A questa nuova articolazione delle strategie e delle pratiche del controllo sociale non corrisponde, peraltro, l’esaurimento del ruolo storicamente assolto dagli strumenti classici di trattamento della devianza. Ad esempio l’istituto del carcere mantiene un’importanza centrale anche con le nuove pratiche di matrice attuariale; anzi, ad una riduzione qualitativa delle funzioni degli istituti di pena, corrisponde un’espansione quantitativa del loro ruolo. Aumenta, infatti, la popolazione carceraria, una popolazione per la quale il penitenziario è un luogo di contenimento provvisorio. Ed aumentano nuove forme di reclusione ed incapacitazione degli individui, forme di “controllo amministrativo” che nella sostanza hanno le medesime funzioni degli strumenti penali, pur essendo sprovvisti delle relative garanzie. Le pratiche attuariali si disegnano, allora, come nuove tecniche per selezionare gruppi di individui da tenere sotto controllo, prima di tutto nell’ambiente urbano e metropolitano. Questi gruppi, quando gli strumenti di prevenzione situazionale non bastano al contenimento del rischio, sono destinati a popolare le carceri. È così per i tossicodipendenti, per i disoccupati, e soprattutto per gli immigrati e i loro discendenti nei Paesi d’arrivo. Nella società dell’insicurezza e del tramonto dello stato sociale, sono queste categorie di soggetti ad essere sempre più spesso designate come pericolose, portatrici di rischio. Ed è nei loro 97 confronti che le istituzioni deputate al controllo sociale – in primis le forze di polizia – concentrano buona parte delle proprie quotidiane attenzioni. Questa posizione teorica trova sostenitori anche in Italia, i quali interpretano il fenomeno della criminalità dei migranti ribaltando la questione: la sovra-rappresentazione di questi soggetti fra i clienti del sistema penale non sarebbe il frutto di una loro maggiore propensione a delinquere ma semmai l’esito della crescente applicazione delle politiche neo-liberiste nate negli Usa degli anni 70-80 dello scorso secolo ai nostri contesti geografici. Anche nel nostro Paese, seppure con un ritardo di una ventina d’anni rispetto al contesto americano e di una decina rispetto alla Gran Bretagna thatcheriana, nel corso degli anni Novanta abbiamo assistito ad una progressiva contrazione delle politiche di welfare ed allo svuotamento delle normative garantiste del mercato del lavoro, con un aumento della precarietà del lavoro e del numero di persone al di sotto o ai margini della soglia della povertà 114. Le occasioni di lavoro si sono drasticamente ridotte, e laddove esistano, quasi sempre è la flessibilità l’unica possibilità di ingresso nel mercato del lavoro. In questa situazione di drastica contrazione della spesa pubblica e di scarse possibilità occupazionali, le carceri tendono a riempirsi (tanto che periodicamente si rende necessario un provvedimento di indulto per rendere le condizioni degli istituti di pena in qualche modo gestibili). Il fatto che si riempiano prevalentemente di immigrati e tossicodipendenti non sarebbe altro che l’applicazione in terra nostra delle forme di “governo della miseria” e della marginalità sociale di cui parlava Wacquant a proposito del contesto statunitense: l’altra faccia della medaglia delle politiche neo-liberiste, per poter segregare e gestire una popolazione oggi diventata superflua rispetto alla situazione del mercato del lavoro e della spesa sociale, attraverso un sistema giudiziario particolarmente selettivo e punitivo nei loro confronti. Allo stesso modo, sta cambiando anche in Italia il modello di controllo sociale adottato dalle forze di polizia nelle nostre città. Anche nei nostri contesti le politiche di sicurezza urbana stanno progressivamente abbandonando interventi basati sulla prevenzione sociale e sul tentativo di rieducare i trasgressori delle norme per adottare il modello situazionale, basato sulla proliferazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sulla riprogettazione urbanistica degli spazi pubblici e sulla spersonalizzazione del controllo. Anche qui è esplosa, a partire dagli anni Novanta, la questione sicurezza nelle città e la richiesta di sicurezza che la popolazione rivolge alle forze di polizia ha spesso come proprio bersaglio categorie di soggetti considerate di per sé “rischiose”, più di tutto gli immigrati visibili negli spazi pubblici. Alcuni autori, fra i quali citiamo Salvatore Palidda 115, sostengono così che nelle società attuali le forze di polizia, per fronteggiare la criminalità degli immigrati, adottino un atteggiamento non puramente “reattivo”, cioè di risposta alle richieste di sicurezza ed alle denunce provenienti dalla società civile, ma sempre più spesso “proattivo”, che anticipa ed al tempo stesso cerca di conformarsi a tali richieste. Tutto ciò porterebbe le forze dell’ordine ad assecondare gli interessi dei cittadini autoctoni insicuri, incrementando così gli interventi di natura repressiva che hanno come bersaglio gli immigrati ed altre fasce marginali della popolazione (considerate portatrici di degrado ed insicurezza e pericolose per l’ordine sociale) rispetto ad altre forme di gestione della sicurezza urbana. Una tesi abbastanza simile è quella proposta da Dario Melossi che nel corso delle sue ricerche si è sovente soffermato sul ruolo che la devianza degli stranieri ricoprirebbe all’interno della nostra società. Riprendendo le tesi del sociologo nordamericano Kai Erikson (secondo il quale la discussione pubblica di casi famosi ed esemplari di devianza è un modo attraverso il quale una società ridefinisce collettivamente i confini della propria morale e di ciò che è lecito ed illecito), secondo Melossi la questione pubblica della criminalità degli immigrati è arrivata ad assumere una sorta di “funzione specchio” delle disfunzioni e dei comportamenti illeciti già esistenti nel nostro Paese e sicuramente preesistenti rispetto all’arrivo dei migranti. Attraverso l’ostilità nei confronti degli immigrati e la loro demonizzazione, la popolazione italiana avrebbe in qualche modo rimosso o allontanato i sospetti relativi alla società che essa stessa ha costruito ed ai codici morali agonizzanti esistenti al suo interno, addossando le colpe di tale disfacimento su un bersaglio comodo ed agevolmente stigmatizzabile e sottoponibile al “sacrificio”. Ed una delle principali 114 È di qualche mese or sono la notizia secondo la quale, complice anche la crisi economica apertasi nel 2008, secondo gli ultimi dati Eurostat nel nostro paese è ormai il 29,9% di cittadini a vivere sulla soglia o al di sotto della soglia di rischio di povertà, pari a circa 18,2 milioni di abitanti (fonte: articolo di stampa “18 milioni di italiani a rischio povertà o esclusione. Ecco il ritratto delle vittime della crisi economica”, di Raffaele Ricciardi, repubblica.it, 15/12/2013). 115 In particolare, all’interno del volume “Polizia postmoderna” (Feltrinelli, 2000). 98 modalità attraverso cui questo specchio ha gettato cattiva luce sulla popolazione migrante è stato un utilizzo disinvolto, se non scientificamente erroneo, dello strumento delle statistiche ufficiali sulla delittuosità a danno della popolazione immigrata. Da questo strumento il capitolo ha preso le mosse e su di esso ora ci accingiamo a ritornare. 6.2 PERPLESSITÀ SULL’USO DELLE STATISTICHE UFFICIALI Abbiamo segnalato in precedenza l’uso spesso disinvolto che i rappresentanti del mondo politico ed informativo fanno delle statistiche ufficiali sulla criminalità degli immigrati, spesso citate come autorevole ed indiscutibile conferma delle tesi dominanti nell’opinione pubblica sulla “pericolosità sociale” degli immigrati e sulla loro propensione a delinquere in misura maggiore rispetto alla popolazione autoctona. Abbiamo anche visto che, in realtà, nel dibattito criminologico attualmente esistente in Italia, sono stati sollevati dubbi sulla veridicità ed attendibilità di tali statistiche (che noi stessi, a titolo puramente illustrativo, abbiamo sommariamente illustrato in precedenza). Vediamo ora, in particolare, quali sono le principali obiezioni che vengono sollevate in merito all’attendibilità ed all’utilità di questi dati. Diciamo subito che, per tutta una serie di considerazioni, anche a nostro giudizio le statistiche ufficiali sulla criminalità (e, quindi, anche quelle inerenti alla criminalità degli immigrati) non possono essere considerate perfettamente illustrative della situazione realmente esistente nel nostro paese. In primo luogo, infatti, queste cifre rappresentano solamente i delitti di cui le forze dell’ordine vengono a conoscenza nell’espletamento delle loro funzioni, e non di tutti i reati che effettivamente sono stati realizzati in un determinato lasso di tempo: esiste, perciò, il problema della cifra oscura della criminalità, costituita dal numero degli eventi delittuosi che si sono realmente verificati, ma che non sono stati denunciati o scoperti, e sono così rimasti esclusi dal computo delle statistiche criminali. L’esistenza di questa cifra oscura, difficilmente quantificabile per molti dei reati considerati, ci impedisce di considerare pienamente attendibili questi dati ufficiali sulla criminalità registrata, in assenza di approfondite ricerche volte a far emergere il livello di criminalità nascosta (ad esempio attraverso inchieste di vittimizzazione puntuali e sistematicamente organizzate). Una seconda difficoltà in merito alle statistiche ufficiali sulla criminalità, attinente alla validità scientifica di queste cifre, valeva forse per il passato mentre oggi è venuta meno: in effetti, fino al 1999 il grado di costanza e di coerenza con cui le procedure di rilevazione dei dati sono state applicate, rispetto ai criteri prestabiliti, da parte delle agenzie preposte alla produzione dei dati (forze dell’ordine ed Autorità Giudiziaria) e di quelle deputate alla loro raccolta (ISTAT) ha suscitato sovente perplessità. In passato non sempre queste fonti si erano rivelate attendibili, proprio a causa di errori commessi nella classificazione e/o raccolta dei dati. Questi problemi, peraltro, sono stati quasi del tutto risolti, prima grazie all’introduzione del sistema informatizzato di registrazione delle denunce, imposto dal Ministero degli Interni dal 1999; poi dalla nascita del sistema unico di banca dati relativi alla delittuosità per le forze di polizia, denominato SDI (Sistema D’Indagine). Il nuovo metodo di raccolta dei dati, se inizialmente può aver provocato qualche ulteriore scompenso, dovuto a qualche differenza esistente nelle classificazioni di reato fra il vecchio ed il nuovo sistema, dal 2006 116 ha l’indubbio merito di aver reso finalmente omogenei i criteri di rilevazione statistica adottati dalle diverse forze dell’ordine in tutte le città italiane. Vi è, poi, un ultimo ordine di considerazioni da fare, ancora più importante rispetto ai due precedenti, ed è quello relativo all’interpretazione di questi dati ufficiali sulla criminalità: poiché essi non misurano direttamente la realtà effettiva, ma quella identificata, segnalata e denunciata del fenomeno, c’è il rischio tangibile che queste cifre siano molto più indicative dell’attività concretamente messa in pratica dalle forze dell’ordine che non del livello di devianza realmente esistente sul territorio. Che, in altre parole, questi dati – anche quando siano corretti ed attendibili – siano comunque condizionati dalle scelte operative attuate dalle polizie, dalla scala di priorità adottata nei loro interventi, dalle modalità concrete 116 Anno in cui lo SDI, introdotto nel 2004, è entrato a regime e fornisce dati “consolidati”, ovvero ufficiali. 99 con cui pongono in essere la loro attività investigativa e di controllo del territorio (e, quindi, anche dai luoghi comuni e dalle convinzioni personali dei singoli operatori di polizia, nonché dalle pressioni che essi ricevono ad opera dei decisori politici, dei mass-media e della locale cittadinanza). Questi aspetti sono stati al centro di una polemica rivolta da alcuni criminologi italiani, come il bolognese Dario Melossi, al principale realizzatore delle statistiche viste all’inizio del capitolo, Marzio Barbagli 117. Melossi fa notare come, per operare il raffronto fra denunciati di nazionalità italiana e denunciati di nazionalità straniera, Barbagli non possa servirsi dell’universo delle denunce, all’interno delle quali la parte preponderante è costituita dalle denunce contro ignoti, ma sia costretto a limitarsi alle cosiddette “denunce contro noti”, che costituiscono all’incirca il 23% dell’intero insieme di denunce all’Autorità Giudiziaria. Quindi, poiché in genere – a causa del problema sopracitato del numero oscuro – già di per sé le denunce registrate (contro noti e ignoti) non arrivano a coprire che il 35% circa dei reati avvenuti, tutte le considerazioni sulla maggiore propensione alla delittuosità dei migranti rispetto alla popolazione autoctona si basano su dati che arrivano a coprire non più del 8% dei reati avvenuti in Italia. Ma c’è di più: la gran parte delle “denunce contro noti” non proviene da denunce presentate dai cittadini che restano vittime di un illecito (nella stragrande maggioranza, tali denunce sono rivolte contro ignoti), ma provengono dall’impulso, dall’intervento o dall’attività di indagine delle forze di polizia. Pensiamo che intere categorie di reati (fra le quali, alcune sono quelle in cui gli immigrati presentano altissimi tassi di sovra-rappresentazione statistica rispetto agli italiani), come le leggi in materia di immigrazione, false dichiarazioni e falsità in atti, riproduzioni abusive, rissa, resistenza a pubblico ufficiale, reati di droga e ricettazione sono reati per i quali è fondamentale l’intervento o l’indagine da parte delle forze dell’ordine. Secondo Melossi, “paragonare, come fa Barbagli, la percentuale delle denunce nei confronti degli stranieri alla percentuale di stranieri sulla popolazione significa ignorare l’enorme funzione di filtro che le agenzie di controllo svolgono per selezionare, su dieci reati potenziali, quell’uno che produrrà infine una denuncia” (Melossi, cit., pag. 453). La questione del filtro operato dalle forze di polizia nella propria attività è una questione di fondamentale importanza. Un esempio abbastanza interessante delle pratiche di polizia che possono produrre oggettive discriminazioni (a danno degli stranieri) nella produzione delle statistiche ufficiali può essere fornito dalle risultanze di una serie di interviste effettuate alla fine degli anni Novanta nella regione Emilia-Romagna, aventi ad oggetto la sicurezza dei cittadini ed i controlli subiti da parte delle forze dell’ordine. In particolare venne sottoposta a due differenti campioni rappresentativi, rispettivamente, della popolazione autoctona e di quella immigrata residenti nella regione emiliano-romagnola la medesima domanda: “Nel corso degli ultimi dodici mesi le è capitato di essere fermato per la strada mentre era in automobile o a piedi, anche per un semplice controllo dei documenti, dalla polizia stradale, carabinieri o guardia di finanza?”. La risposta a quella domanda metteva in evidenza forti differenze a seconda della provenienza nazionale dell’interpellato. Infatti, se ad una prima sommaria analisi poteva quasi sembrare che vi fossero disparità di trattamento a danno della popolazione autoctona (il 38,5% del campione “italiano” affermava di essere stato fermato nel corso dell’ultimo anno, contro il 31% del corrispondente campione di immigrati), la situazione cambiava radicalmente prendendo in considerazione la discriminante “fermi in auto / fermi a piedi”. In questo caso risultava che, mentre il 37,4% del campione di residenti autoctoni (pari al 97,3% dei cittadini di nazionalità italiana che avevano ammesso di essere stati fermati) era stato controllato dalle forze dell’ordine mentre si trovava all’interno della propria automobile e solo l’1,1% del campione mentre era a piedi, nel caso degli stranieri residenti in Emilia-Romagna il 22% del campione era stato fermato mentre era in macchina ed il 9% mentre era a piedi. Il che significa che gli stranieri erano fermati quasi nove volte di più degli italiani attraverso il “fermo a piedi”, che ben più del “fermo in auto” (che è dovuto perlopiù a ragioni di traffico automobilistico e raramente si basa sui tratti fisionomici del guidatore) esprime un’intenzione di controllare una persona sulla base del suo aspetto esteriore e per motivi collegati ad una potenziale criminalizzazione del soggetto. E questa sproporzione era ancora superiore prendendo in considerazione l’ulteriore discriminante del sesso: il 14% dei maschi di origine immigrata erano fermati a piedi, contro l’1,4% dei maschi di origine italiana, con un rapporto di dieci ad uno. Si noti, infine, che il 117 Ci riferiamo all’articolo di D.Melossi “Soliti noti”, in “Etnografia e ricerca qualitativa”, 2010, III (3), pagg. 449-458. 100 campione di immigrati intervistati era composto esclusivamente da immigrati residenti, e quindi regolarizzatisi ormai da tempo nel nostro paese; è del tutto ipotizzabile che il dato sul “fermo a piedi” di tutti gli stranieri (comprendendo al loro interno quelli irregolari, da poco arrivati in Italia) comporterebbe una sproporzione ancora superiore, a scapito dei soggetti stranieri. Mettendo in luce questi dati non si vuole certo accusare le forze di polizia italiane di adottare intenzionalmente pratiche di comportamento discriminatorie e criminalizzanti nei confronti degli immigrati: è indiscutibile, infatti, che le sproporzioni esistenti fra italiani e stranieri per quanto riguarda, ad esempio, i “fermi a piedi” siano in buona parte dovute alle normative vigenti nel nostro paese in materia di immigrazione, che assegnano alle forze dell’ordine il compito di controllare il rispetto degli obblighi e delle formalità previste dalla legge da parte degli immigrati presenti sul territorio italiano. Peraltro, è altrettanto indubbio che tali ricorrenti pratiche di “fermo selettivo” adottate nei confronti degli stranieri possano facilitare la diffusione di stereotipi e tipizzazioni negative anti-immigrati all’interno dei corpi stessi di polizia (inevitabilmente portati a considerare “individui sospetti” e quindi “da fermare e controllare” i soggetti che maggiormente presentino tratti somatici distintivi della loro diversità e della loro potenziale “irregolarità”), alimentino un effetto indiretto di “selezione criminale” negativa nei loro confronti (con ciò che può conseguire a livello di statistiche ufficiali della delittuosità) e provochino una risentita reazione degli immigrati stessi, che diventano sempre più propensi a considerare l’agente di polizia come un mero “controllore-persecutore”, chiamato a svolgere le sue funzioni esclusivamente contro gli stranieri e non (anche) al loro servizio. Per tutti questi motivi, secondo Melossi, “le forze dell’ordine si trovano alle radici del processo di criminalizzazione. È lì che tutto inizia” (D.Melossi, cit., pag. 454). Da quando una pattuglia di polizia, intenta a “fare numeri” 118 ad un angolo di strada, inizia a fermare selettivamente e a compiere controlli di identità su soggetti visibilmente appartenenti ad etnie minoritarie per verificare la regolarità della loro posizione rispetto alle leggi sull’immigrazione; da quando, alla ricerca di un individuo sospetto, l’azione discrezionale dell’agente di polizia si sofferma – pur in assenza di chiari indizi che puntino in quella direzione – verso soggetti di chiare origini straniere. In che misura in questi casi si può parlare di “pregiudizio” ed in che misura di “esperienza professionale” che orienta l’azione dell’agente?La sindacalista di polizia Rita Parisi ebbe a dire diversi anni fa, durante un workshop organizzato dalla facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Milano, che “i poliziotti [non sono] più razzisti dialtri, è che come molti faticano a riconoscere un atto razzista. […] A leggerei giornali gli immigrati sono tutti delinquenti. A ciò aggiungete il fatto che ilpoliziotto divide il mondo tra sospetti e non sospetti; e che per lui trovare lospacciatore straniero è la cosa più semplice del mondo. Allora capirete perché ledirettissime sono piene di stranieri” (cit. in Melossi, 2010, pag. 455). Una volta che il meccanismo viene innescato, si sviluppano successivamente tutta una serie di conseguenze negative a cascata sul percorso giudiziario del migrante denunciato e sottoposto a giudizio che contribuiscono in maniera rilevante a quell’evidente sovra-rappresentazione nelle statistiche della delittuosità e nella popolazione carceraria di cui si è parlato in precedenza. Già da diversi anni Massimo Pastore, in seguito a scrupolose analisi delle statistiche penali del nostro paese, sostiene che il sistema giudiziario italiano presenti svantaggi oggettivi per gli immigrati, ponendo in atto un’applicazione particolarmente selettiva del sistema punitivo nei loro confronti. In particolar modo, Pastore fa rilevare come, a parità di reato commesso, la custodia cautelare in carcere viene imposta più spesso agli immigrati in attesa di giudizio che ai cittadini italiani nelle stesse condizioni; inoltre, a parità di pena inflitta, gli stranieri godono in misura minore delle misure alternative al carcere e delle pene sostitutive rispetto agli autoctoni; infine, sarebbero presenti svantaggi oggettivi anche nella gestione dei riti processuali abbreviati, nonché nell’istituto del patrocinio gratuito (o “d’ufficio”) per gli imputati stranieri (cfr. M.Pastore, 1995). Il fatto che i controlli di tipo discrezionale operati dalle forze dell’ordine vengano esercitati in maniera selettiva a seconda della diversa nazionalità degli interessati o del loro colore della pelle e si risolvano in evidenti svantaggi per gli appartenenti ai gruppi etnici minoritari riceve, inoltre, autorevoli conferme da una fitta serie di ricerche svolte in questi ultimi anni in altri paesi europei sull’operato delle locali forze di polizia; nonostante le evidenti differenze di normative e pratiche poliziesche che si 118 Espressione con cui nelle forze di polizia si usano definire le operazioni di pattugliamento del territorio espressamente rivolte al miglioramento delle statistiche in materia di fermi e di segnalati all’Autorità Giudiziaria. 101 incontrano da paese a paese, tali ricerche convergono in maniera pressoché uniforme su questo aspetto, tanto che alcuni autori parlano, a questo proposito, di razzismo istituzionale delle forze dell’ordine (provocato, cioè, non tanto dalle convinzioni personali dei singoli agenti, ma dal concreto funzionamento dell’apparato repressivo e dalle pratiche poliziesche in uso nei vari paesi). La stessa pratica di fermo selettivo operata dalle forze di polizia in ragione dei tratti somatici visibilmente appartenenti ad un’etnia minoritaria ha ricevuto una sua denominazione ed è diventata un interessante oggetto di ricerca, tematizzato tanto nei paesi americani quanto in quelli europei: l’ethnicprofiling (o racial profiling, espressione più utilizzata negli USA). 6.3 IL RICORSO ALL’ETHNIC PROFILING NELL’ERA ATTUARIALE Il concetto di ethnic profiling riprende, dal punto di vista lessicale, la conosciuta pratica investigativa del criminal profiling, ossia della costruzione di profili ipotetici della personalità o del modus operandi di soggetti devianti, basata sull’applicazione di tecniche di analisi psicologica o di criminologia clinica e finalizzata al supporto per gli investigatori alla ricerca dei possibili autori di un reato. Nel caso però dell’ethnicprofiling il concetto assume un’accezione assolutamente negativa, priva di ogni valenza scientifica o criminologica: per ethnic (o racial) profiling, infatti, si intende l’utilizzo del fattore individuale legato all’appartenenza etnica, razziale o nazionale di un individuo come unica o principale discriminante in virtù della quale si ritiene di sottoporre quell’individuo ad un’azione di polizia (arresto, fermo o semplice controllo di identità). Quando l’iniziativa della forza di polizia contro un soggetto non si basa sul suo comportamento o su un indizio/informazione contro il soggetto, ma il sospetto si fonda unicamente sul fatto che quel soggetto appartenga ad un particolare gruppo etnico, siamo di fronte ad un caso di ethnic profiling, ossia di costruzione di un profilo deviante su di un soggetto basata su di un pregiudizio legato alla sua appartenenza etnica o alle sue origini nazionali. Si tratta, com’è ovvio, di un comportamento gravemente discriminatorio e lesivo del diritto di ogni singolo cittadino di ricevere un equo trattamento da parte delle istituzioni preposte al rispetto della legge. Contrario, quindi, all’art. 3 comma 1 della nostra Costituzione (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”), così come alle leggi fondamentali di ogni Paese democratico 119. Eppure, si tratta di un comportamento oggi largamente praticato all’interno delle forze di polizia di quegli stessi Paesi democratici, a tal punto che sono nati degli osservatori indipendenti che registrano casi giudiziari acclarati di ethnic/racial profiling (come la Open Society Foundations o lo Institute on Race and Justice presso la Northeastern University, che ha creato la Racial Profiling Data Collection, ecc.) e che gli stessi responsabili delle forze di polizia in quei Paesi hanno ammesso l’esistenza del problema, collaborando con alcuni di questi osservatori alla realizzazione di linee guida per la formazione dei propri agenti, nel tentativo di ridurre la sua incidenza. Ma come mai l’ethnic profiling è un comportamento così praticato all’interno delle forze di polizia? In parte l’applicazione di queste pratiche discriminatorie può dipendere dalle propensioni razziste del singolo operatore di polizia o dall’inconscio radicamento di stereotipi razzisti all’interno della cosiddetta “cultura della mensa” esistente in alcune strutture, o da deformazioni professionali dovute al dover concentrare la propria attività su una specifica area popolata in prevalenza da soggetti devianti di origine etnica minoritaria o in specifici contesti (come un aeroporto) che richiedono l’applicazione di controlli volti a contrastare reati legati all’immigrazione. Ma, se il problema fosse legato solo a pregiudizi individuali e piccole deformazioni professionali, probabilmente non avrebbe ricevuto la massiccia tematizzazione verificatasi nell’ultimo ventennio di letteratura criminologica. In realtà, secondo diversi autori, il problema andrebbe collegato a quella generale tendenza dell’evoluzione delle strategie di controllo di cui si parlava in precedenza, che si stanno trasformando in 119 Si tratta di una pratica definita come illegale tanto dall’ECRI (European Committee against Racism and Intolerance) quanto dal CERD (Comitato delle Nazioni Unite sull’Eliminazione della Discriminazione Razziale). 102 pratiche di tipo attuariale. Anzi, secondo il sociologo Bernard Harcourt, il racial profiling non sarebbe altro che l’applicazione sul campo, al livello micro, delle strategie attuariali operate dalle istituzioni deputate al controllo. Ricordiamo che nel paradigma attuariale, così come nel mondo assicurativo dal quale tale termine proviene, il concetto centrale in base al quale operano le istituzioni punitive è quello del rischio. L’obiettivo delle forze di polizia è quello di ridurre il rischio del fenomeno criminale (considerato di per sé ineliminabile) entro soglie fisiologiche di tollerabilità sociale, andando a dirigere gli sforzi investigativi e repressivi nei confronti di quei gruppi sociali e di quei soggetti considerati maggiormente esposti al rischio di commettere atti criminosi. Attraverso un’analisi minuziosa delle decisioni giudiziarie di numerose corti americane, Bernard Harcourt mostra come, a partire dagli anni Novanta, abbia fatto strada l’utilizzo di strumenti statistico-attuariali da parte dei giudici nelle motivazioni delle sentenze sull’applicazione delle pene sostitutive o delle misure alternative al carcere, relativamente a quella che noi definiremmo “prognosi di pericolosità sociale” del soggetto, ossia una previsione del futuro criminale dell’individuo, costruita su una serie di caratteristiche del soggetto di per sé relativamente neutre (livello di educazione, impiego, età e luogo delle aggressioni, esistenza di precedenti penali), ma che in realtà conducevano ad un’oggettiva penalizzazione (attraverso la negazione delle misure alternative e l’applicazione di pene detentive più dure) per i gruppi sociali già svantaggiati per il loro status sociale e luoghi di residenza all’interno delle città, ed in particolare per afro-americani e latinos. Allo stesso modo, secondo Harcourt, l’utilizzo delle logiche attuariali si è diffuso in quegli stessi anni anche nelle pratiche poliziali, attraverso il ricorso al racial profiling. L’idea che nella commissione di determinati crimini 120 fossero statisticamente alcuni gruppi socialmente stigmatizzati (i neri e i latinos concentrati negli slum delle grandi metropoli) ad essere più coinvolti di altri ha giustificato e accresciuto il ricorso alla selezione su base etnica dei soggetti sottoposti alle pratiche di stop and search (i fermi per identificazione e perquisizione personale) condotte dalle pattuglie, ben al di là di quelli che potessero essere specifici indizi contro gli individui coinvolti 121. Tutto ciò ha condotto ad un’amplificazione della sovrarappresentazione criminale dei gruppi sociali sottoposti al profiling, attraverso un meccanismo distorsivo che lo stesso Harcourt ha denominato “ratchet effect” (effetto traino): la costruzione di profili devianti basati su caratteristiche etniche, sebbene apparentemente sia giustificata dalle statistiche criminali, non farà altro che concentrare l’attività di polizia sugli appartenenti a tali categorie di soggetti, trainando le fasi investigative e giudiziarie in direzione di quei gruppi, e rinforzando ulteriormente le statistiche a loro danno (visto e considerato che le stesse statistiche non sono altro che il frutto delle attività investigative e giudiziarie delle forze di polizia). Con un’altra metafora, Melossi chiama questo “effetto della rete da pesca”: se peschiamo di più in un certo tratto di mare, è chiaro che in quel luogo prenderemo più pesci che altrove; il prendere più pesci a sua volta verrà interpretato come verifica dell’appropriatezza della decisione di pescare di più proprio in quel tratto di mare, per cui si deciderà di investire ancora più risorse in quel punto, e così via, fino a raggiungere una situazione che è al tempo stesso di esaurimento di quel tratto di mare, oltre che di assoluto spreco delle risorse. Ora, quello che negli USA è un problema collegato principalmente al concetto di razza, nei paesi europei viene declinato all’interno del concetto di etnia, ma i termini della questione restano in tutto e per tutto simili a quelli analizzati da Harcourt oltreoceano: in modo a volte consapevole e a volte no, è invalsa nelle pratiche delle forze di polizia europee la tendenza a far uso dell’ethnic profiling nella quotidiana attività di individuazione dei sospetti contro i quali dirigere le attenzioni delle pattuglie sul territorio. Altra questione è come riconoscere un caso di profiling basato sull’appartenenza etnica minoritaria all’interno delle pratiche di controllo operate nei confronti di stranieri: è infatti evidente che non tutte le perquisizioni operate nei confronti di soggetti appartenenti ad etnie minoritarie siano illegittime in quanto fondate sul pregiudizio razziale! È, ad esempio, del tutto normale che la descrizione di un sospettato (che può essere alla base della decisione di fermare e identificare un soggetto lungo una strada) possa includere 120 Come i reati di droga, contro i quali in molte città americane s’è assistito nel corso degli anni Novanta a campagne di massiccio contrasto e repressione, nella logica della “tolleranza-zero”. 121 Si pensi che nel corso dell’anno 2006 il New York Police Department ha condotto all’incirca mezzo milione di stop and search su soggetti sospettati di coinvolgimento in attività criminali, e che l’89% di tali pratiche ha coinvolto soggetti non bianchi: in seguito alla comparsa di tali statistiche sui media, il NYPD ha richiesto all’organismo indipendente che aveva condotto tale ricerca (il RAND Center on Quality Policing) di sviluppare una serie di raccomandazioni e linee guida per individuare e risolvere il problema all’interno del NYPD. 103 connotazioni di tipo razziale:il fatto che una persona segnalata comesospettata di aver commesso un reato abbia l’aspetto di un nero alto 1 metro e 80 e ciò conduca a fermare soggetti compatibili con tale descrizione è ovviamente ineccepibile sotto ogni punto di vista. Ma in questo caso abbiamo oggettivi elementi investigativi che stanno alla base della selezione degli individui da sottoporre a controlli di polizia. In altri casi, il limite fra comportamento corretto dettato dall’esperienza professionale e pratica discriminatoria basata sul pregiudizio nei confronti di una minoranza etnica è maggiormente discutibile. Proviamo a presentare di seguito due differenti casi: il primo è un caso giudiziario divenuto famoso come archetipo di ethnic profiling commesso da una forza di polizia europea (spagnola) e condannato come tale anche in sede giudiziaria; il secondo è un caso tratto da un’esperienza di ricerca personalmente condotta qualche anno fa in Francia (cfr. C.Poletti, 2007: pagg. 190-191). Alcuni esempi Il caso di Rosalind Williams Il 6 dicembre 1992, Rosalind Williams arrivò alla stazione ferroviaria di Valladolid Campo Grande, su un treno in provenienza da Madrid. Era con suo marito, Federico Augustin Calabuig e loro figlio. Poco dopo essere scesi dal treno, un operatore di polizia della Policia Nacional avvicinò la signora Williams e le chiese di mostrare il suo documento d’identità. L’operatore di polizia non chiese lo stesso documento al marito e al figlio, né ad alcun altro passeggero che si trovasse sulla piattaforma di arrivo. La sig.ra Williams e suo marito chiesero le ragioni di tale controllo. L’operatore rispose che era obbligato a controllare l’identità delle persone che avevano “il suo aspetto”, aggiungendo che “molti di loro sono immigrati illegali”. Continuò spiegando che, nel controllare la sua carta d’identità, egli stava obbedendo a un ordine del Ministro dell’Interno che ordinava, appunto, agli operatori di Polizia di controllare le identità, in particolare “delle persone di colore”. La sig.ra Williams fornì la sua carta d’identità e prese il numero identificativo dell’operatore esposto sul badge. Successivamente, inviò una lettera di lamentela alla Jefatura Superior de Policia de Valladolid. Secondo il CERD (Comitato delle Nazioni Unite sull’Eliminazione della Discriminazione Razziale) quell’operatore di polizia aveva agito in modo illegale, violando in diversi punti Il trattato internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e lo Stato spagnolo doveva delle scuse pubbliche alla signora Williams. Queste le tappe,in sintesi, della lunga battaglia di Rosalind Williams: Dic. 1992. RW è fermata alla stazione di Valladolid. Dic. 1992. RW invia un esposto al Comando Nazionale della Polizia di Stato. Respinto Feb. 1993. RW invia un esposto al Ministero dell’Interno. Respinto Apr. 1994.RW fa appello alla Corte Nazionale di Giustizia. Nov. 1996. La Corte Naz. di Giustizia respinge l’appello. Motivazioni: c’è un obbligo di produrre i documenti d’identità e la polizia è autorizzata a chiedere agli stranieri di identificarsi. Siccome la sig.ra Williams è di razza nera, era più probabile che fosse straniera. Ott. 1998. RW fa appello alla Corte Costituzionale. Gen. 2001. La Corte Costituzionale respinge l’appello. Motivazioni: simili a quelle prodotte dalla Corte Naz- di Giustizia. Set. 2006. Il caso è inviato al CERD. RW è assistita da un gruppo di associazioni antirazziste. Giu. 2009. La sentenza del CERD è pubblicata Il dispositivo si basa sui seguenti principi: 1) Jus Cogens. La proibizione delle discriminazioni razziali è riconosciuta dai più importantitrattati internazionali (sottoscritti anche dalla Spagna) ed è norma di diritto internazionale cogente che crea un obbligo agli stati di fare in modo che le discriminazioni non accadano. 2) Discriminazioni dirette e indirette. Le leggi internazionali ed europee (adottate anche a livello nazionale) proibiscono le discriminazioni, dirette e indirette. 104 3) Pubblici ufficiali. I pubblici ufficiali sono agenti dello stato e lo stato è sottoposto ad un obbligo positivo di assicurare che essi non discriminino, anche emanando leggi apposite. 4) Ethnic/racial profiling. Quel modo di applicare le leggi che poggia su generalizzazioni circa la razza, l’etnicità o l’origine nazionale invece che sull’evidenza specifica e oggettivamente identificabile è una forma di discriminazione razziale che viola le leggi sui diritti umani. Dic. 2009. E’ la scadenza data dal CERD al governo spagnolo per rendere pubblicamente le proprie scuse. Ad un anno di distanza dalla sentenza, il governo spagnolo,sebbene abbia dato qualche forma di pubblicità alla decisione del CERD e abbia presentato in forma privata le proprie scuse alla signora Williams, non ha ancora riconosciuto pubblicamente la responsabilità del trattamento discriminatorio riservatole, né ha proceduto a risarcirle i danni. Osservazione diretta di uno stop and search a Parigi Continuiamo (la pattuglia di Police Nationale e io) la nostra passeggiata davanti all’ingresso del centro commerciale Les Halles; mentre i due agenti che ciaccompagnavano sono fermati da una coppia di ragazzi stranieri che chiede loro un’informazione su dove si trovi una certa strada, il luogotenente è intento a raccontarmi la dislocazione delle guardie di vigilanza privata all’interno del centro commerciale […] I due agenti continuano a fornire indicazioni ad altre persone, ma noto che mentre l’agente di sesso maschile è concentrato nel rispondere alla richiesta di informazioni, la ragazza ha l’aria distratta e sembra osservare qualcos’altro che ha attirato la sua attenzione. All’improvviso si rivolge al luogotenente, per chiedergli se avrebbe dovuto comportarsi come in una normale missione di servizio o se avrebbe dovuto limitare la propria azione, tenuto conto della mia presenza come ricercatore. Il luogotenente le risponde che ha avuto precise istruzioni di comportarsi nella stessa identica maniera di qualunque altra giornata, che tutt’al più avrebbe lasciato a loro due il compito di gestire da soli l’intervento e che lui sarebbe rimasto a distanza di sicurezza in mia compagnia. La ragazza fa allora notare al luogotenente la presenza di due “giovani sospetti” in cima ad una scalinata e chiede il permesso di procedere ad un’attività di controllo dei documenti. Mentre i due agenti si avvicinano ai piedi della scalinata, io ed il luogotenente restiamo fermi ed osserviamo a distanza: rivolgo lo sguardo ai due ragazzi e li noto per la prima volta: due giovani di apparente origine straniera (maghrebino uno, africano o antillese il secondo), vestiti da rapper ed appollaiati sopra una balaustra in cima alla rampa di scale. Mentre i due agenti fanno per salire le scale stando bene attenti a non destare sospetti, i due giovani notano l’arrivo dei poliziotti e accennano ad allontanarsi dalla scala, in direzione opposta all’arrivo degli agenti. A quel punto la ragazza intima ai due giovani di fermarsi per un controllo di identità, e quelli cominciano a scappare di corsa per i negozi del centro commerciale, subito inseguiti dai due poliziotti. Il luogotenente mi fa un cenno, e cominciamo anche noi a dirigerci di corsa sulla scalinata; nel frattempo, estrae la radio di servizio e chiama rinforzi all’interno del centro commerciale. Continuiamo la corsa attraverso i negozi, ad un centinaio di metri dal vero e proprio inseguimento, quando ad un certo punto sbucano di fronte ai due ragazzi in fuga due agenti di polizia su pattini a rotelle che, arrivando dall’altro lato del centro commerciale, tagliano loro la strada e li costringono a scappare in una zona interstiziale fra negozi, chiusa e senza possibilità di fuga. I due giovani si fermano con le mani in alto e dicono di non aver fatto niente. Arrivano i due agenti a piedi, che chiedono urlando ai due fuggiaschi perché fossero scappati, e procedono al loro ammanettamento: uno faccia a terra e l’altro faccia al muro. Dopo qualche secondo, arriviamo anche io ed il luogotenente, ed una decina di secondi più tardi arriva sul posto un’altra coppia di poliziotti appiedati che fa da cordone di sicurezza davanti al luogodell’arresto per impedire l’afflusso di curiosi dai negozi del centro commerciale. I due agenti della nostra pattuglia procedono alla perquisizione personale: uno dei due giovani non ha con sé i documenti, mentre l’altro è apparentemente scappato senza alcuna ragione. Il luogotenente mi spiega che i due ragazzi verranno ora condotti al posto di polizia del locale servizio di polizia giudiziaria per procedere all’identificazione del giovane senza documenti, mentre l’altro sarà rilasciato dopo aver ricevuto un’apposita ramanzina verbale (attività di osservazione diretta, Parigi, Quartiere Les Halles, 25/01/2006). 105 Ora, al di là della notevole capacità di organizzazione nello svolgimento dell’attività di controllo del territorio e di repressione di ogni potenziale minaccia all’ordine pubblico in uno spazio pubblico considerato strategico dalla polizia parigina come la zona adiacente al centro commerciale di Les Halles, quali sono gli elementi che hanno portato l’agente di polizia a considerare sospetti i due giovani sottoposti al controllo dei documenti? In questo caso non possediamo tutti i dati e non possiamo sapere se dietro quel profiling sospetto ci fosse una descrizione di altri individui resisi responsabili di azioni devianti che fosse compatibile con l’aspetto fisico dei due ragazzi di banlieue oppure semplicemente… il loro aspetto da ragazzi di banlieue. In questo secondo caso, saremmo palesemente davanti ad un caso di ethnic profiling alla francese. La cosa sotto certi aspetti emblematica, semmai, è la reazione dei due giovani di fronte all’intimazione del fermo per controllo da parte dell’agente di polizia: una fuga con inseguimento degna dei migliori film d’azione hollywoodiani, malgrado uno dei due giovani non avesse alcuna ragione di metterla in pratica. L’idea che questa scena 122 suggerisce è che, a prescindere dall’applicazione di ethnic profiling o meno in questa singola circostanza, il rapporto fra polizia francese e giovani di banlieue di origini straniere sia ben lontano da quello che dovrebbe esistere fra cittadini e forze dell’ordine in un Paese democratico e che sia permeato da un reciproco e ben saldo sentimento di diffidenza e di ostilità 123. 6.4 LA QUESTIONE EMERGENTE DELLE SECONDE GENERAZIONI La questione dell’inserimento dei migranti di seconda generazione in Italia è un tema di strettissima attualità, nella misura in cui il fenomeno migratorio ha raggiunto in molte aree della nostra nazione dimensioni rilevanti e un carattere di stabile permanenza nel tessuto economico e socio-relazionale dei suoi vari contesti. Come molti degli studiosi di questioni migratorie in Italia, intenderemo con l’espressione “seconde generazioni” tutti i figli dei soggetti di nazionalità straniera che sono emigrati verso il nostro Paese. In realtà, potremmo distinguere, più specificamente, una seconda generazione in senso stretto (formata da soggetti nati in Italia da genitori immigrati, che in Paesi diversi dal nostro sarebbero contraddistinti fin dalla nascita dal possesso della nazionalità della nazione di approdo) e una componente formata da ragazzi arrivati in Italia accompagnando i propri genitori lungo il percorso migratorio o in seguito a ricongiungimento familiare. L’inserimento delle seconde generazioni di migranti è un tema di straordinaria importanza: essa – rispetto a quella degli immigrati di primo approdo – sembra mettere ancor più in discussione la capacità di tenuta degli equilibri sociali di un determinato contesto, nella misura in cui il Paese di arrivo non riesca a garantire adeguati percorsi di inserimento nelle realtà scolastica, lavorativa e sociale dei ragazzi di origini straniere. Specialmente nel caso in cui questi ultimi siano nati e cresciuti nel Paese in cui i loro genitori sono immigrati, essi si trovano, infatti, a condividere con i coetanei di origini autoctone percorsi scolastici e formativi, esperienze relazionali impostate sulla parità, sistemi valoriali e mete sociali di riferimento. Ben si comprende, allora, come, nella misura in cui questi giovani sperimentino sulla propria pelle trattamenti differenziali e/o discriminanti sulla scorta di una diversa origine “etnica”, essi possano vivere tale situazione come un’autentica ed intollerabile ingiustizia, ancor più di quanto non l’abbiano potuta percepire in tali termini i propri genitori. Tutto ciò può andare a discapito del loro inserimento nel tessuto sociale del Paese in una duplice direzione: sia relativamente alla fragilità delle condizioni economiche e psicologiche in cui i migranti di seconda generazione colpiti da tali traiettorie di disillusione e discriminazione possono venirsi a trovare; sia rispetto all’eventuale adozione di atteggiamenti “rancorosi” nei confronti della società di approdo. In una recente ricerca condotta in Regione Lombardia si è cercato di mettere alla prova le 122 Per contestualizzare storicamente l’episodio osservato, va detto che esso avvenne a distanza di due mesi da una delle più note rivolte dei giovani di banlieue nei confronti delle forze dell’ordine francesi, quella del novembre 2005. Tali émeutes non arrivarono a toccare che marginalmente la città di Parigi, ma furono di grande intensità nella banlieue del Dipartimento di Seine-Saint Denis, posto immediatamente a nord della capitale francese. 123 Sul conflittuale rapporto fra giovani provenienti dall’immigrazione e polizia in Francia e sugli esiti di stigmatizzazione di tali soggetti all’interno dell’opinione pubblica francese, cfr. il saggio scritto dal sociologo francese Fabien Jobard “Sociologia politica della racaille”, in H.Lagrange e M.Oberti, “La rivolta delle periferie. Precarietà urbana e protesta giovanile: il caso francese”, Bruno Mondadori, 2006. 106 dimensioni dell’inserimento delle seconde generazioni in quei contesti, nel tentativo di individuare l’eventuale attivazione di traiettorie di esclusione o emarginazione 124. La prima fondamentale dimensione che funge da cartina di tornasole per misurare l’inserimento delle seconde generazioni nella nostra realtà sociale è, ovviamente, quella scolastica. Già diverse polemiche condotte a livello politico e mediatico hanno teso ad evidenziare una tendenza (presente soprattutto dalle scuole secondarie in poi) per gli alunni stranieri ad essere vittima di bocciature e ripetenze più frequentemente rispetto agli italiani, ed una maggiore difficoltà per gli insegnanti delle classi con una presenza più consistente di stranieri a rispettare i programmi scolastici, a causa delle difficoltà linguistiche di questi. In realtà si tratta spesso di luoghi comuni, ed occorrerebbe sottolineare alcune fondamentali distinzioni che ci aiutano a comprendere meglio cosa comporti la presenza di alunni stranieri a scuola. Fondamentale si rivela la differenziazione fra chi è nato in Italia e qui ha vissuto in modo relativamente continuativo il percorso d’inserimento scolastico e socio-relazionale e chi, invece, è arrivato più di recente, cominciando il percorso nelle scuole italiane in un secondo momento. La prima fascia di soggetti, infatti, non sembra presentare particolari differenze di apprendimento e di successo scolastico rispetto agli alunni autoctoni: in questi casi, semmai, il problema può essere di tipo psicologico, dovuto al sentirsi trattati come stranieri, nonostante percorsi formativi e esperienze extrascolastiche del tutto analoghe a quelle dei coetanei. È invece chi è entrato da poco o ha avuto un percorso educativo frammentato che può presentare profili scolastici maggiormente problematici. Per gli ultimi arrivati c’è spesso una sensazione di spaesamento, che li fa sentire inadeguati rispetto alle competenze richieste in ambiente scolastico e privi dei riferimenti amicali e familiari costruiti lungo un percorso di diversi anni nel Paese di origine. Per i nati in Italia e coloro che sono in Italia da tempo, il rischio è invece quello di sperimentare una disillusione rispetto alle effettive possibilità di “sentirsi italiano” e di integrarsi a pieno titolo non solo in aula ma anche in ambito extrascolastico, e più tardi in quello lavorativo, nelle relazioni fra pari. In che modo i ragazzi che sperimentano queste forme di disagio vengono aiutati da coetanei, famiglie e insegnanti? Rispetto ai compagni di scuola, diversi soggetti intervistati in quella ricerca sostenevano che cominciassero ad affiorare alcuni casi, se non di vera e propria intolleranza, di ostilità nei confronti dei ragazzi di origine straniera. E, laddove anche ciò non fosse avvenuto, era una spontanea propensione a fare gruppo con coloro che sperimentano analoghe condizioni di inserimento e riescono a condividere codici comunicativi e comportamentali affini a determinare una sorta di “selezione” nei gruppi di pari. In qualche modo, spinti dalla ricerca di trovare punti in comune con altri coetanei o di evitare le ostilità altrui, molti ragazzi sperimentavano (volontariamente o meno) anche nei rapporti amicali quei percorsi di isolamento dell’alterità e di distinzione (se non di vera e propria marginalizzazione) che potevano costituire il presupposto di una futura esclusione. Dal canto loro, gli insegnanti sembravano impotenti di fronte a queste traiettorie di disagio. In molti casi, essi sperimentavano l’impossibilità di sostenere adeguati percorsi di sostegno di questi ragazzi (attraverso esperienze di educazione interculturale ritenute costose ed abbandonate dalla maggior parte degli istituti di diversi contesti) con un misto di rassegnazione e frustrazione; in altri casi, invece, vivevano la situazione con apatia, preoccupati più del puntuale rispetto dei programmi scolastici che della possibilità di assicurare effettive traiettorie di inclusione per i propri alunni di origini straniere.D’altro canto, anche la famiglia cessa di essere un punto di riferimento realisticamente praticabile per molti appartenenti alle seconde generazioni. Il dialogo con la famiglia di origine è complicato e i ragazzi sentono di parlare due lingue diverse: a volte, solo simbolicamente, per l’inconciliabilità dei codici valoriali di riferimento (più vicini alla società di origine per i genitori, più simili a quelli della società di approdo per i figli); in diversi casi, anche da un punto di vista linguistico, per la desuetudine o l’incapacità delle nuove generazioni nell’utilizzo della lingua madre e la mancanza di risorse comunicative comuni fra figli e genitori su cui costruire una relazione non puramente formale. Ovviamente, anche questo tipo di spaesamento intrafamiliare (che per i ragazzi già emarginati dai propri coetanei può innescare una percezione di “doppia assenza” a livello identitario simile a quella descritta nella sua opera più famosa da Abdelmalek Sayad) acuisce il senso di disagio dei ragazzi e rilancia l’importanza dei gruppi di pari segmentati come loro prevalente forma di espressione e di appoggio. 124 Cfr. Rapporto IReR Lombardia, “Politiche di sicurezza per lo sviluppo sostenibile del territorio: rischio reale e percepito. Allargamento ai rischi emergenti in Regione Lombardia”, 2010. 107 Cosa succede quando questi giovani escono dal percorso scolastico e iniziano la propria carriera lavorativa? Il paradosso, causato dalle attuali normative nazionali sull’immigrazione che impongono l’ottenimento del permesso di soggiorno anche per i figli di immigrati maggiorenni nati in Italia che attendono di ottenere la doppia cittadinanza, è che spesso la scelta del percorso di inserimento professionale segue logiche che non hanno nulla a che vedere con la riuscita o meno del proprio cammino scolastico: fatti salvi i casi di famiglie di origine abbienti, il percorso principale per questi ragazzi si struttura dapprima verso scuole secondarie di formazione professionale, immediatamente finalizzate ad ottenere competenze tecnico-professionali utili per una rapida assunzione; successivamente, verso un inserimento nel mondo del lavoro anticipato a quello dei coetanei, mediante impieghi a bassa qualificazione professionale e a bassa retribuzione, in modo non dissimile dalle logiche e dalle possibilità occupazionali offerte anni prima ai loro genitori. Tutto ciò all’interno di un frame generale di accresciuta ostilità nei confronti dei migranti in genere, del quale molti attori politici approfittano per impostare in chiave antiimmigrato una serie di messaggi al cittadino ed in cui i media giocano un ruolo di non secondaria importanza nell’amplificazione di stereotipi negativi nei confronti degli stranieri, sia di prima e di seconda generazione (cfr. par. 6.1.3). In sostanza, si configura il pericolo di una definitiva disillusione per il giovane migrante di seconda generazione, rispetto all’effettiva possibilità di far valere il proprio percorso scolastico e le competenze apprese a prescindere dalle proprie origini famigliari. Il rischio di creazione di una nuova underclass disillusa e rancorosa rispetto alle disparità prodotte dal nostro Paese nei confronti dei suoi membri sembra realistico, nella misura in cui l’Italia non riuscirà a costruire un proprio credibile modello di inserimento dei ragazzi delle seconde generazioni. A cominciare da un auspicabile intervento sugli attuali meccanismi legati all’ottenimento della cittadinanza: rimuovendo ad esempio per i ragazzi di origine straniera nati e soggiornanti nel nostro Paese un istituto come quello del rinnovo del permesso di soggiorno, si andrebbe nella direzione di garantire loro pari opportunità rispetto ai coetanei, specie nella fase di orientamento scolastico e di passaggio alla realtà lavorativa. Non mancano, peraltro, accanto alle traiettorie potenzialmente escludenti descritte in precedenza, anche tentativi di convogliare nell’impegno civile le energie dei ragazzi di origine migrante: abbiamo assistito in questi ultimi anni all’emersione delle prime associazioni formate direttamente da giovani delle seconde generazioni che hanno come punto di riferimento la rete G2 – sorta a partire dal 2005 – e che intendono promuovere percorsi di rivendicazione politica in senso ampio (tesa al riconoscimento dei diritti dei figli dei migranti in Italia) e, più in generale, di presa di coscienza della propria specifica condizione. Parallelamente, sul versante economico, si comincia ad assistere ai primi progetti di imprenditoria straniera creati e gestiti da giovani delle seconde generazioni. Si tratta, per il momento, di vere e proprie avanguardie, formate da soggetti con un’elevata scolarità (quasi tutti sono iscritti all’Università, condizione ancora infrequente fra i ragazzi delle seconde generazioni) e in possesso di risorse culturali e relazionali superiori alla media. Ma il fenomeno merita, comunque, di essere segnalato e, ovviamente, incoraggiato. 6.5 PER UNA POLIZIA AL SERVIZIO ANCHE DEL MIGRANTE Occorre che le forze di polizia maturino un’evoluzione dei propri atteggiamenti e comportamenti nei confronti dei soggetti di origine etnica minoritaria, evitando – ove possibile – il ricorso sistematico a pratiche invasive di controllo e/o perquisizione che indirettamente comportano una disumanizzazione dei rapporti con i soggetti di origine etnica minoritaria e possono amplificare, all’interno della popolazione immigrata di prima e di seconda generazione, la diffusione di un generale sentimento di diffidenza e di ostilità nei confronti delle forze dell’ordine. Occorrerebbe, al contrario, sforzarsi di mantenere la “dimensione umana” al centro delle interazioni fra agenti ed immigrati, di concepire lo svolgimento della propria funzione in un’ottica di “servizio”. Un servizio rivolto non solo ai tradizionali referenti dell’attività del poliziotto (i cittadini italiani) ma anche ai nuovi arrivati ed ai loro figli, nel quadro di una società sempre più diversificata e multiculturale. Proprio per rispondere ai cambiamenti della nostra società, anche il 108 servizio offerto dalle forze di polizia dovrà necessariamente mutare, avvicinandosi maggiormente alle esigenze concrete della cittadinanza. In quest’ottica appare centrale il tentativo, avviato in questi ultimi anni da tutte le forze di polizia di avvicinarsi maggiormente alle esigenze ed ai problemi del cittadino comune, attraverso un dialogo costante e costruttivo con i principali rappresentanti delle istanze della popolazione civile. Uno sforzo che può essere sufficientemente riassunto all’interno del concetto di polizia di prossimità, una filosofia d’azione nel lavoro di poliziotto che, pur continuando a svolgere le tradizionali competenze delle rispettive strutture, amplia gli obiettivi di fondo dell’agire poliziesco. Con l’avvento della polizia di prossimità, la posta in gioco non è limitata alla prevenzione dei reati o dei comportamenti anti-sociali che minano la percezione di sicurezza della popolazione ma, più in generale, diventa la salvaguardia della pace sociale o il ripristino di apprezzabili condizioni di pacificazione sociale, laddove tali presupposti fossero venuti meno. Un traguardo che, pur passando necessariamente attraverso l’affermazione di una situazione di legalità diffusa, richiede altresì di affrontare tutta una serie di circostanze non direttamente riconducibili alla sfera penale (conflitti di vicinato, atti di “inciviltà”, infrazioni scolastiche, problemi di degrado, ecc.) ma che sono ugualmente suscettibili di minare alle fondamenta gli equilibri sociali esistenti in un determinato territorio. Tali comportamenti, pur non essendo sanzionati dalle leggi penali, possono, infatti, rivelare un disprezzo per le regole di condotta generalmente condivise o per le autorità vigenti nelle diverse istituzioni della società civile, se non una mancanza totale di rispetto nei confronti degli altri: se ignorati, essi possono dar vita a disagio sociale, creare insicurezza, provocare atti delittuosi in senso stretto e mettere a repentaglio gli equilibri e la pace sociale della zona. Si passa, quindi, da un’ottica puramente repressiva, in risposta ad emergenze di carattere criminale che affiorano in una determinata zona, ad un’ottica preventiva e quasi-educativa, che parte da una conoscenza approfondita delle specificità esistenti sul territorio e punta ad anticipare i problemi sociali cercando di allontanare o di far scemare le tensioni direttamente dall’interno. È chiaro, però, che questo obiettivo richiede al poliziotto un lavoro svolto più in profondità, costantemente a contatto ed in relazione con il territorio e con le diverse componenti sociali che lo animano. La polizia deve, così, diventare una delle componenti stabili che sono presenti ed interagiscono sul territorio, conquistandosi il riconoscimento e l’appoggio delle altre: solo attraverso questo appoggio fiduciario e queste relazioni durature essa può costruire un sistema di intelligence collettiva che porta ad una più agevole comprensione delle dinamiche sociali esistenti ed alla tempestiva conoscenza di ogni episodio suscettibile di minacciare la pace sociale. Nel quadro di questo sforzo di avvicinamento alle molteplici componenti presenti sul territorio, le relazioni della polizia con i gruppi di origine etnica minoritaria andranno a rivestire un’importanza sempre più decisiva per il successo dell’azione delle forze di polizia, proporzionalmente alla crescita della consistenza numerica e della visibilità sociale di tali gruppi, nonché delle seconde e terze generazioni (a prescindere dalla nazionalità dei soggetti che ne faranno parte). Riuscire a relazionarsi nella misura più corretta e soddisfacente con questi gruppi puòfacilitare il compito delle forze di polizia a più livelli: accresce il livello di fiducia reciproca, legittima e stabilizza i rapporti di collaborazione con i rappresentanti riconosciuti di tali gruppi, aumenta il numero e la qualità di informazioni a disposizione della polizia per conoscere le dinamiche sociali e le potenziali fonti di attrito sul territorio, rende più semplici e socialmente “accettati” gli eventuali interventi di tipo repressivo necessari al mantenimento dell’ordine sociale. Una situazione, a ben vedere, molto differente da quella attuale, in cui spesso i compiti di controllo e di reperimento delle informazioni vengono espletati attraverso pratiche selettive di stop and search che semmai alimentano l’ostilità reciproca, rendono praticamente inattuabili forme di collaborazione spontanea ed arrecano ulteriore disagio ed esclusione sociale ai soggetti di origine etnica minoritaria. Sarà, pertanto, fondamentale per le forze di polizia italiane intendere nella maniera più corretta quel concetto di “polizia di prossimità” importato dalle polizie di altri Paesi. Fare in modo, cioè, che questo avvicinamento alle esigenze ed alle istanze della cittadinanza non si rivolga esclusivamente all’ala forte di questa cittadinanza, alla categoria degli “inclusi”, ai loro valori ed alle loro richieste e che, di conseguenza, l’attività stessa della polizia non finisca per convergere sempre più con le aspettative di questi cittadini di serie A, a scapito degli appartenenti ai gruppi sociali minoritari e stigmatizzati (migranti ed altri soggetti marginali). Una polizia al servizio di una parte soltanto della popolazione svelerebbe il volto più 109 odiosamente repressivo della propria funzione, acuirebbe le tensioni e gli squilibri già esistenti nella nostra società, fallirebbe nel proprio compito di mantenere (o ristabilire) la pace sociale. Ecco spiegato, quindi, il motivo per cui noi riteniamo di primaria importanza che le forze di polizia cerchino di impostare nella maniera più corretta ed equilibrata possibile le proprie relazioni con i soggetti di origine etnica minoritaria ed i loro rappresentanti, combattendo quei pregiudizi e stereotipi diffusi nella società che possono condizionare il proprio operato e compromettere fin dall’inizio tali rapporti. Su queste basi ci si gioca l’obiettivo di una reale pacificazione sociale, grazie al contributo attivo (e dall’interno della società stessa) di una forza di polizia moderna ed al servizio dei cittadini. Perché se la strada di un maggiore avvicinamento fra polizie e cittadini è stata tracciata, un’altra questione è, invece, come percorrerla e dove essa ci può portare. 110 7. L’IDENTITÀ DELLA POLIZIA LOCALE: CHE COSA FA E CHE COSA DOVREBBE FARE 111 7.1 IDENTITA’ IN CAMBIAMENTO Le polizie locali si sono caratterizzate, nell’ultimo ventennio, per aver dato vita ad una sorprendente evoluzione, che ha interessato ad un tempo l’organizzazione dei propri effettivi, i compiti svolti dagli operatori sul territorio ed il ruolo, globalmente inteso, di tali strutture all’interno del comparto della sicurezza. Le polizie locali dei Comuni e delle Province stanno, infatti, progressivamente affrancandosi dalla tradizionale immagine che le connotava in precedenza, seppur in modo difforme le une dalle altre. Le prime hanno accentuato una già presente propensione ad affermare una competenza pressoché generalista su una vasta gamma di funzioni afferenti alla sicurezza urbana ed alla qualità della vita dei cittadini; la storica figura del “vigile urbano” intento quasi esclusivamente a sanzionare infrazioni al codice della strada o a quello commerciale ormai sopravvive più nell’immaginario collettivo della popolazione italiana che nella realtà dei fatti. Le polizie provinciali, invece, hanno aggiunto nuove competenze – alcune delle quali esercitate in modo tendenzialmente specialistico, ad esempio in materia di tutela ambientale – a quelle di vigilanza ittico-venatoria che spettavano ai tradizionali “guardiacaccia”. Oggi si può dire che un numero crescente di polizie locali sta raggiungendo l’obiettivo di fondo di trasformarsi in forze di polizia a tutto tondo, dotate di pari dignità rispetto a quelle forze dell’ordine con cui, seppur in funzione ausiliaria, sempre più frequentemente collaborano nella gestione della sicurezza sul territorio. E quest’evoluzione dell’identità e delle funzioni si è compiuta nonostante tali strutture debbano convivere con tutti i limiti più o meno gravi posti alla loro azione da normative ormai risalenti 125, da una mole di lavoro crescente a fronte di organici spesso inadeguati, dagli inevitabili tagli al budget conseguenti alle difficoltà in cui versano gli Enti locali di riferimento. Anche perché, a ben vedere, le trasformazioni che oggi possiamo osservare nel funzionamento e nell’organizzazione delle polizie locali sono il frutto di rilevanti cambiamenti a livello normativo, politico e sociale, che hanno caratterizzato il nostro paese da una ventina d’anni a questa parte. 7.1.1 Un ventennio di trasformazioni Sotto l’aspetto normativo, il primo segno di questa evoluzione di ruoli e competenze si ebbe con l’approvazione della legge quadro n. 65/86, sull’ordinamento della “polizia municipale”: gli ambiti di intervento di questo tipo di struttura furono, infatti, estesi, fino a produrre «una sorta di affiancamento di compiti analoghi a quelli che la legge n. 181/81 al suo articolo n. 24 assegna alla Polizia di Stato» (Cristalli 2001, pag. 52). Sebbene in questa legge mancasse un riferimento esplicito al «coinvolgimento della Polizia Locale come soggetto attivo, e spesso determinante, di collaborazione alle politiche di sicurezza in ambito urbano e sul territorio», queste «tematiche hanno invece via via assunto un’importanza crescente a partire dai primi anni Novanta» (Paolozzi e Ricciardelli 2004, pag. 207). Con l’avvento nell’ambito del diritto amministrativo del c.d. “principio di sussidiarietà” – attraverso la legge 142/90 e le successive leggi Bassanini – si assiste nel corso di quel decennio ad un significativo sforzo di decentrare la linea decisionale della Pubblica Amministrazione verso le amministrazioni locali: Comuni, Province e Regioni vengono, così, considerati gli enti esponenziali della popolazione su tutta una serie di diritti ed interessi collettivi, non ultimo quello alla sicurezza ed alla qualità della vita del cittadino. In quest’ottica devono inquadrarsi gli anni a cavallo del nuovo millennio, segnati dal protagonismo delle Regioni in materia di sicurezza urbana e di organizzazione-formazione delle polizie locali. A cominciare dalla legge regionale emiliano-romagnola n. 3/1999 per passare a quella di Regione Lazio n. 15/2001 o a quella lombarda n. 4/2003 di “riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e 125 La normativa di riferimento sulla Polizia Locale nel nostro paese è tuttora la legge quadro n. 65/1986, mentre negli anni sono andati falliti o caduti nel dimenticatoio dell’iter parlamentare i vari tentativi di dare al comparto una nuova disciplina organica al passo con i tempi. L’ultimo dei quali, il DDL “Saia-Barbolini”, è stato depositato nel 2009, nel corso della XVI legislatura. 112 sicurezza urbana”, viene così sancito il nuovo spazio d’azione degli enti locali nella promozione di politiche per la sicurezza a livello locale e di accordi interistituzionali e collaborazioni con le altre agenzie dello Stato responsabili per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. In questo modo la Polizia Locale assume il ruolo specifico di organo tecnico a disposizione degli enti locali Comune e Provincia (e, più specificamente, dei sindaci e dei Presidenti di Provincia, che vigilano sui servizi effettuati dalle rispettive strutture) per lo svolgimento delle attività di controllo del territorio e per l’esecuzione delle politiche locali di sicurezza, compatibilmente con le proprie competenze istituzionali. Negli stessi anni, dal punto di vista politico, la crisi dei grandi partiti ideologici di massa (iniziata con il crollo del muro di Berlino ed acuitasi in seguito agli scandali giudiziari di Tangentopoli) e l’approvazione della legge sull’elezione “diretta” di sindaci e Presidenti di Provincia (legge n. 81/93) contribuiscono a dare a queste figure istituzionali una nuova centralità nel dibattito politico del nostro paese. In precedenza gli amministratori locali che formalmente detenevano competenze decisionali dirette, nella sostanza erano spesso costretti a cedere il passo ad altri tipi di attori, che finivano con l’esercitare un’influenza superiore alla loro nella concreta determinazione delle politiche sul territorio. In particolare, un ruolo predominante nel nostro paese era assunto dal livello centrale dei partiti politici, che sovente gestiva le risorse a livello locale in modo clientelare, consentendo ai propri organi periferici di negoziare con gli interessi economici sparsi nel paese voti e tessere in cambio di preziosi appoggi e congrui finanziamenti. Tutto ciò, unendosi alla cronica situazione di frammentarietà delle competenze e di immobilismo della nostra burocrazia, comportava spesso lo scavalcamento delle istituzioni locali, o il loro utilizzo per finalità che solo raramente si preoccupavano di valorizzare le risorse presenti sul territorio (Diani, 1992; Della Porta, 2006). La figura del sindaco (e, in misura inferiore, quella del Presidente di Provincia) acquisisce dalla prima metà degli anni Novanta una rilevanza fino ad allora sconosciuta: se fino al 1993 la carica di primo cittadino offriva ben poche opportunità di policy-making e si risolveva spesso in un ruolo di raccordo fra politiche centrali ed esigenze locali, ora il “nuovo” sindaco mette sul piatto della bilancia una serie di competenze ed un grado di indipendenza e di autonomia dalle scelte centrali dei partiti per molti versi inediti. Al tempo stesso, però, il sindaco diventa anche il bersaglio privilegiato della popolazione locale contro cui dirigere ogni forma di aspettativa e di protesta, relativamente alle problematiche emergenti sulla scena locale. Gli onori e gli oneri collegati a questo nuovo ruolo di decisore effettivo in ambito urbano richiedono, dunque, un sindaco sempre più capace di attivarsi in modo solerte davanti alle preoccupazioni e sollecitazioni dei propri cittadini e di giocarsi quotidianamente il proprio consenso, davanti ad una ribalta mediatica e ad un’opinione pubblica attente come non mai alle scelte dell’amministrazione. Non è, dunque, casuale che i sindaci siano frequentemente assurti a protagonisti anche relativamente alla tutela della sicurezza urbana dei propri cittadini: davanti alla crescente domanda di sicurezza proveniente dalla popolazione, essi sono stati chiamati a giocare un ruolo di primo piano nella traduzione di tali istanze in progetti concreti di rassicurazione sociale e/o di collaborazione con le altre istituzioni competenti. Progetti sui quali, in numerosi casi, essi si sono giocati il consenso della cittadinanza, il rinnovo del proprio mandato elettorale e la possibilità di costruire una promettente carriera politica. Dunque, parallelamente a questo nuovo attivismo di sindaci ed amministratori locali, le forze di polizia locale siano state chiamate a giocare un ruolo sempre più consistente sul tema della sicurezza urbana: tali strutture hanno, infatti, dovuto tradurre gli input politici in azioni concrete sul territorio, andando ad assecondare le iniziative assunte sul tema della sicurezza dai vertici delle rispettive amministrazioni locali. Che si trattasse di creare nuclei specializzati nella repressione di determinati reati, o di dare esecuzione ad ordinanze prese ad hoc dal sindaco, o di accrescere la presenza rassicurante di divise di polizia nei quartieri delle città, le polizie locali si sono sempre più spesso trovate a rivestire i panni di istituzione-collante (o gate-keeper, per utilizzare un’espressione di derivazione anglo-americana) fra cittadinanza ed amministrazione locale in materia di sicurezza, riproducendo ad un livello tecnico-operativo le tendenze della politica locale ad occuparsi in misura crescente di tali aspetti della vita urbana. Ad una stagione della concertazione (che diversi autori limitano alla seconda metà degli anni Novanta), in cui la nascita di nuclei interforze fra polizie locali e polizie nazionali conseguiva alla stipulazione di numerosi accordi inter-istituzionali sul tema della sicurezza del territorio, si passa con il nuovo millennio alla cosiddetta «stagione dell’emergenza» (Pavarini 2006, pagg. 12-15), in cui la crescente pressione mediatica sul tema dell’insicurezza delle nostre città costringe gli enti locali ad assumere iniziative 113 sicuritarie visibili e tempestive, spesso efficaci più nel breve periodo che a gioco lungo. Polizie ed amministrazioni locali vanno a braccetto, ed al ruolo da protagonista che sindaci via via sempre più intraprendenti si auto-ritagliano (tanto da meritare, in alcuni commenti giornalistici, l’appellativo di “sindaco-sceriffo”) corrisponde un’azione delle polizie locali sempre più incisiva e puntuale nella repressione dei reati di natura predatoria e nell’individuazione di situazioni di degrado e irregolarità sul territorio (sovente associabili all’emersione del sentimento di insicurezza della popolazione). Allo stesso tempo, però, le polizie locali sono pronte ad assecondare tutto quel filone di interventi di prevenzione socio-comunitaria dell’insicurezza promosse da diverse amministrazioni comunali: tali iniziative puntano ad un ripristino dei legami sociali nei quartieri disagiati delle città o ad una ricostituzione del necessario controllo sociale informale fra cittadini. In quest’ottica, gli operatori di polizia locale coinvolti fungono sovente da agenti di mediazione e di pacificazione sociale, sfruttando fino in fondo quel patrimonio di conoscenze e di competenze relazionali insito nella tradizionale figura di primi inter pares a disposizione della comunità di appartenenza. Infine, anche da un punto di vista sociale, sono mutati nell’ultimo ventennio gli scenari in cui si situano le azioni quotidiane delle forze di polizia locale. Da una parte, le città hanno cambiato volto, sulla spinta dalle grandi trasformazioni economiche della società “globale”: anche al di fuori delle grandi metropoli, esse si sono popolate di nuovi utenti occasionali (i c.d. city users, vedi Martinotti, 1993), che sono attirati dalle possibilità di intrattenimento culturale, commerciale e ricreativo dei centri urbani e frequentano gli spazi pubblici ad esso dedicati in modo più flessibile rispetto al passato. Al contempo, gli abitanti di queste città devono fare i conti con la presenza di questi “ospiti ingombranti” e parallelamente assistono al declino delle sedi abituali di svolgimento della vita sociale (parrocchie, fabbriche, circoli ricreativi, ecc.) e dei ritmi ripetitivi della società industriale. In passato, i ritmi di vita sembravano scanditi in maniera regolare dai turni delle fabbriche e dagli orari dei negozi, degli uffici, delle scuole: ogni cittadino (così come ogni appartenente alle forze di polizia) poteva essere certo che ad una data ora, in una determinata strada, si sarebbe trovato davanti ad un certo tipo di persona, e un individuo “sospetto” poteva essere facilmente notato. Oggi non è più così: i devianti giungono a confondersi tra la moltitudine dei saltuari city-users, in un quotidiano urbano non più scandito dagli orari della società urbana tradizionale. Si può dire che il passaggio dalla società industriale a quella c.d. post-industriale già di per sé rivoluzioni gli equilibri di vita preesistenti della popolazione. Nel nostro paese, poi, questa percezione viene ulteriormente acuita dall’arrivo delle popolazioni migranti nelle nostre città e dalla trasformazione dell’Italia da terra di emigrazione a paese di immigrazione. La presenza degli immigrati stranieri si associa di frequente ad un rapido turn-over della popolazione residente in diversi quartieri delle nostre città, accelerando quella percezione di perdita di controllo sul proprio ambiente quotidiano che già era stata innestata dalle trasformazioni socio-economiche di cui si parlava in precedenza. Soprattutto nei quartieri popolari delle grandi città, una fascia di popolazione italiana che va rapidamente invecchiando è abbinata alla presenza dei nuovi arrivati, che spesso sono percepiti come “invasori” dalla popolazione autoctona, più per la tendenza ad esportare stili di vita e modelli comportamentali insoliti e mal sopportati dai vecchi residenti, che non per una loro reale pericolosità per gli altri abitanti. Non sorprende, dunque, che uno dei fenomeni più evidenti di quel periodo sia stata la crescita imperiosa della “domanda di sicurezza” che i residenti delle città italiane hanno rivolto alle forze dell’ordine. 7.1.2 La Polizia Locale dei Comuni (o Polizia Municipale) 126 Come già in precedenza ricordato, le Polizie Locali dei Comuni (o Polizie Municipali) stanno conoscendo sostanziali cambiamenti, che toccano sia le funzioni espletate dagli operatori di queste strutture, sia l’identità professionale precostituita. Tale trasformazione è innanzitutto ribadita a livello 126 Il materiale empirico di questo paragrafo è preso da una recente ricerca condotta sulle polizie locali in Lombardia cui abbiamo personalmente contribuito: Rapporto IReR Lombardia (2008),“Determinazione di standard minimi di servizio ed organico di Polizia Locale per ambiti territoriali della Lombardia”. 114 normativo da diverse legislazioni regionali (in assenza di una legge quadro nazionale al passo coi tempi). Accanto alle tradizionali attività di polizia stradale e polizia amministrativa, ed alle relative prerogative di polizia giudiziaria, da intendere in modo più ampio rispetto al passato, gli elementi autenticamente innovativi sono dettati in relazione all’impegno di queste strutture nel settore della sicurezza urbana. «la sicurezza urbana, è un termine anche per noi nuovo, averlo affrontato… non è nella cultura della polizia locale parlare di sicurezza urbana, è un termine secondo me calato dall’alto e quindi non ancora entrato in una fase di gestazione. Sicurezza urbana vuole dire dare la possibilità di una convivenza civile a tutta la cittadinanza, quindi che cosa serve per questa convivenza civile, per far si che le persone si sentano bene nel proprio territorio, quindi garantire che non ci siano aree di degrado, garantire che ci sia una sicurezza reale, non solo. Perché adesso parliamo molto di insicurezza percepita, noi vogliamo che ci sia una sicurezza reale, però per quanto riguarda i nostri compiti… perché molti ci vedono come quelli che dovrebbero dare questa garanzia, pero ci sono altre polizie che hanno un compito più forte rispetto alla sicurezza, noi facciamo un lavoro di prevenzione, altri fanno un lavoro di repressione. » [intervista a un ufficiale PM – regione Lombardia] Innanzitutto, diverse normative regionali hanno cercato di dare una concreta attuazione alla normativa di rango nazionale che attribuisce alle polizie locali una “funzione ausiliaria di pubblica sicurezza” rispetto all’operato delle forze dell’ordine: l’ambito elettivo di competenza delle polizie municipali è orientato alla tutela della «sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento» (come recita testualmente la legge regionale n. 4/2003 di Regione Lombardia). I confini sono dunque relativi sia alla materia (i fenomeni attinenti alla sicurezza urbana, con tendenziale esclusione delle problematiche di ordine pubblico, che restano di esclusiva competenza delle forze di polizia nazionali) sia alla sfera territoriale (di carattere locale) degli interventi posti in essere. Le modalità attraverso le quali esercitare questa forma di presidio del territorio e vigilanza vogliono, invece, mettere in risalto le risorse specifiche a disposizione dei corpi di Polizia Locale: è attraverso la conoscenza della conformazione e delle esigenze dei territori presenti all’interno della regione che essa può svolgere efficacemente il proprio compito. Tale conoscenza, inoltre, dovrebbe «essere sorretta da adeguati strumenti di analisi volti ad individuare le priorità da affrontare, il loro livello di criticità e le azioni da porre in essere». Fra le azioni da privilegiare, l’ultima parte del 2° comma dell’art. 14 cita espressamente le forme di prevenzione delle problematiche di sicurezza, ponendo così in diretta relazione i nuovi profili operativi delle polizie locali con le tradizionali funzioni di pacificazione sociale delle prime forme di vigilanza urbana presenti nelle nostre città. Inoltre, le normative regionali fanno spesso riferimento al profilo eminentemente preventivo dell’attività di Polizia Locale: attraverso un’attività di pacificazione sociale sul territorio che richiama le prime forme di vigilanza urbana presenti nelle nostre città, oppure attraverso la «formazione e informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale» nei confronti della collettività locale. Al di là dell’evoluzione normativa delle competenze della polizia locale, è però sul campo che si possono riscontrare le più evidenti novità: tali trasformazioni hanno comportato una complessiva ridefinizione della stessa identità della figura professionale. Come abbiamo già ricordato, il vigile urbano si contraddistingueva per essere qualcuno “del posto”, una persona ben inserita nel suo contesto di riferimento e capace di leggere con relativa semplicità le vicende che si verificavano sotto il suo controllo, sulle quali era spesso chiamato ad intervenire. «I vigili, anzi i “survegliant”, come si diceva a Milano, sono stati da sempre un'espressione della comunità. Nascono dal basso, sono scelti fra i cittadini. E almeno questo all'inizio. Parlano la stessa lingua o lo stesso dialetto dei cittadini, s'intendono meglio coi cittadini e sono da questi più raggiungibili che non un poliziotto intercambiabile, con una divisa blu o nera, che viene da altri posti, che magari può parlare il piemontese o magari il sardo, eccetera. Non sono però milanesi. Ora, al di là che Milano ormai è la “piccola mela”, dove il melting pot è concreto… Però è rimasta questa considerazione della gente per il vigile che è un “nostro” poliziotto.» [intervista a un comandante PM – regione Lombardia] 115 In quest’ottica, l’azione specializzata dell’operatore di Polizia Municipale tendeva a conciliare due differenti aspetti: da una parte, il lato repressivo della propria attività, collegato quasi esclusivamente alle competenze specialistiche esercitate in materia di polizia stradale ed amministrativa. Accanto a tali funzioni, poi, una serie di compiti di natura più marcatamente sociale miravano a tutelare il benessere della collettività di riferimento, sfruttando quel bagaglio di conoscenze e competenze sui delicati equilibri presenti in ciascun contesto. Un patrimonio che gli operatori delle strutture potevano far valere per la vicinanza (fisica e relazionale) rispetto a tali problematiche: il “vigile” è sempre stato un membro della comunità per la quale svolgeva un servizio specializzato, qualcuno che conosceva molto persone, luoghi e attività e condivideva con il contesto in cui operava riferimenti valoriali e norme di comportamento. Insomma, una sorta di poliziotto di prossimità ante litteram, che accanto ad alcuni compiti specializzati di carattere meramente amministrativo, poteva svolgere un compito di rassicurazione e problem-solving per la propria comunità di appartenenza. «Io credo che il bisogno di sicurezza delle nostre popolazioni sia aumentato non perché siano di converso diminuite le condizioni di sicurezza (che anzi credo siano su un livello costantemente buono se non in lieve miglioramento), ma perché è in realtà molto diminuita la percezione della sicurezza da parte della popolazione. Allora è evidente che quando uno vive una situazione di insicurezza percepita - non necessariamente coincidente con quella reale - individua in più interlocutori istituzionali, in più divise di colore diverso, un interlocutore istituzionale che lo possa aiutare, che gli possa soddisfare un bisogno di sicurezza. La polizia locale ha questo vantaggio rispetto alle altre forze di polizia: innanzitutto è una polizia molto più radicata sul territorio rispetto alle altre […] È più radicata sul territorio, nel senso che il personale della polizia locale in stragrande maggioranza vive quel territorio e permane in quel corpo di polizia municipale magari anche per tutta la sua carriera lavorativa. Quindi si radica nel tessuto di conoscenze ecc. ecc. Mentre il personale delle forze di polizia di Stato può essere soggetto ad una mobilità sul territorio nazionale. Io posso andare nella polizia locale di altre città su mia volontà, non posso esserci mandato. È questa la differenza sostanziale. Allora, tra l'altro, l'operatore di polizia locale è vissuto anche - e io di questo sono particolarmente felice - come un poliziotto o vigile o agente, come lo si può chiamare, più facile da raggiungere, che probabilmente incute anche meno timore reverenziale rispetto agli altri. Questo però ha degli aspetti patologici, perché i comportamenti degeneranti per il fatto che c'è meno timore e meno rispetto nei confronti di questa figura istituzionale hanno ovviamente delle conseguenze dannose e negative. Però in termini invece fisiologici e positivi, cioè nel rapporto con la gente buona pulita e onesta, questo approccio più familiare è in realtà facilitante proprio anche nel chiedere cose che difficilmente si osano chiedere agli altri; ecco perché sempre di più la gente si sente spinta a chiederci più protezione, più sicurezza.» [intervista a un comandante PM – regione Lombardia] «Sta cambiando anche nella mentalità da parte delle varie amministrazioni. L'amministrazione si sciacqua la bocca adesso con la sicurezza, e l'unico organo con cui può far vedere che si occupa di sicurezza è l'operatore in divisa, l'operatore della polizia locale. […] Quindi la gente ci chiede anche ogni tanto di intervenire su cose...prima magari ci chiedeva solo di intervenire su cose piccole come la sosta, poca importanza, e invece adesso ci si sofferma su cose di maggiore importanza. E poi hanno cambiato gli obiettivi da parte del comando e noi ci stiamo adeguando tranquillamente. L'obiettivo adesso è la sicurezza, e noi ci stiamo portando verso la sicurezza: gli operatori vanno sempre avanti di questo passo.» [focus group con agenti PM – regione Lombardia] Da un lato, le Polizie Municipali hanno visto ampliarsi l’orizzonte delle proprie competenze: da servizi di vigilanza limitati a determinate materie, diventano ora corpi di polizia tendenzialmente generalisti in materia di sicurezza urbana, al servizio dell’ente comunale di riferimento. Rispetto a tale funzione “onnicomprensiva” di garanti della sicurezza urbana e del benessere del cittadino, le tradizionali attività della Polizia Locale sono ora esercitate come funzioni specialistiche e continuano a ricoprire una parte 116 preponderante del volume delle attività degli operatori. Dall’altro lato, l’accresciuta responsabilità degli amministratori locali (ed in particolare, dei sindaci) in materia di sicurezza urbana e la diffusione delle sempre più pressanti richieste di sicurezza avanzate dalla popolazione nei confronti delle forze dell’ordine in questi ultimi decenni, hanno di gran lunga aumentato la pressione della cittadinanza e dei referenti politici nei confronti delle strutture della Polizia Locale, soprattutto nei contesti urbani (o metropolitani) in cui il sentimento di insicurezza si è maggiormente diffuso. All’interno dei tavoli di concertazione (in primis, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso ogni Prefettura) e delle forme negoziali di cooperazione interistituzionale in tema di sicurezza, la Polizia Locale è così un attore che gioca un ruolo non secondario, sia per il peso degli organici e per le dotazioni a disposizione delle strutture che per la buona conoscenza del territorio. Anche se questo ruolo tende spesso a non essere riconosciuto appieno (per non dire sottovalutato) dalle forze dell’ordine, che si considerano le uniche depositarie delle istanze di sicurezza (con la S maiuscola) della popolazione. Così, nel confronto con le polizie nazionali, emergono talvolta motivi di polemico risentimento, dovuto ad un’evidente discrasia fra il prestigio sociale di gran lunga superiore attribuito a quelle istituzioni (anche a causa della particolare abilità delle forze dell’ordine nel trasmettere un’immagine di dedizione ed efficienza attraverso la sfera mediatica) e la quantità e qualità di mansioni svolte attualmente sul territorio dalle strutture di Polizia Locale. «qua c'è un tavolo operativo presso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si andava lì e lì ci si dividono i compiti. “Allora, c'è da fare un'attività di controllo al parco: questa settimana la fanno la Polizia Municipale e la Guardia di Finanza… o meglio, la Polizia Municipale e i Carabinieri, e in questi altri pomeriggi la fanno Polizia di Stato e Finanza”. Perché Polizia di Stato e Carabinieri insieme… mai [sorride]. C'è un coordinamento in questo senso, e ci si divide i compiti. Però il più delle volte la parte più impegnativa ce l'ha la polizia municipale. E come mai? Domanda: Perché ha una consistenza numerica superiore agli altri corpi? No, ma perché… ed è lì che si vede il re in mutande, se non proprio nudo… Abbiamo i problemi di qui e di là e noi cosa possiamo farci… dobbiamo controllare dei negozi, e chi li controlla? La Polizia Municipale. Dobbiamo fare degli sgomberi e ci sono da fare delle ordinanze, e chi le fa le ordinanze? Le ordinanze dipendono dal sindaco, e quindi la Polizia Municipale. C'è da intrattenere delle relazioni con il centro sociale? Ci può mica andare la Polizia Municipale che ha un'immagine meno… repressiva?» [intervista a un comandante PM – regione Lombardia] «Parto io con un esempio perché è emblematico. Come servizio di scorta ad una nota personalità, che arriva a Milano, devono andare i nostri motociclisti perché conoscono le strade. E quando la nota personalità è particolarmente nota, nel momento in cui arriva sul posto l'ufficiale di polizia è vicino ai nostri a cui dice: “Adesso però allontanatevi, perché tra poco arrivano i giornalisti”.» [focus group con agenti PM – regione Lombardia] «La percezione del ruolo è comunque un po' problematica, e il problema nostro di fondo, al di là di quello insanabile della mancanza dell'identità nazionale, è la carenza di una comunicazione efficace. C'è una comunicazione, noi stiamo uscendo un po' allo scoperto. Abbiamo il sito Internet, ci facciamo vedere, abbiamo aumentato la visibilità dei veicoli, abbiamo cambiato le uniformi per renderle più visibili, compariamo sulla stampa con una frequenza che non si era mai verificata, quasi quotidianamente, e devo dirlo ultimamente anche in termini positivi. Ma ci manca un background comunicativo, una tradizione comunicativa che altri hanno e noi non abbiamo. Per cui siamo in una fase in cui la gente effettivamente fa fatica a capire cosa facciamo.» [intervista a un comandante PM – regione Lombardia] 117 7.1.3 La Polizia Locale delle Province 127 Forse in misura ancor più marcata rispetto alle più note Polizie Municipali, anche la Polizia Locale delle Province (o Polizia Provinciale) ha conosciuto una netta evoluzione del proprio ruolo e delle proprie competenze nell’ultima decina d’anni. Da strutture di vigilanza genericamente inserite nel quadro dei settori di agricoltura e/o ambiente all’interno dell’amministrazione provinciale con poteri limitati ai controlli in materia ittico-venatoria (tanto da essere comunemente definiti “guardiacaccia” sia nell’immaginario collettivo, che in un buon numero di province), le Polizie Provinciali sono diventate forze di polizia a tutto tondo, su tutte le materie di competenza dell’ente Provincia. Tutto ciò, ovviamente, ha comportato un complesso percorso di evoluzione legato, in primo luogo, ad una significativa estensione delle funzioni e dei compiti spettanti a tali strutture: alle tradizionali competenze in materia ittico-venatoria e di controllo faunistico sul territorio, si sono ora aggiunti nuovi incarichi in materia di polizia ambientale e di polizia stradale (limitatamente alle strade provinciali) ed una variegata serie di compiti di polizia amministrativa, relativamente all’applicazione di normative emanate dalle singole province in alcuni determinati settori (dalla regolamentazione delle agenzie turistiche al controllo di auto-officine e autoscuole; dai controlli in materia di pubblicità alla verifica del parco veicolare del sistema di trasporto pubblico; ecc.). D’altra parte, uno dei problemi nelle trasformazioni di queste strutture è proprio dovuta al richiamo alle competenze dell’ente Provincia: infatti, le attività svolte sul territorio da ciascuna polizia provinciale possono concretamente divergere di molto, da provincia a provincia, in ragione dell’ordine di priorità stabilito dall’input politico dell’amministrazione di riferimento. Se la consueta competenza delle polizie provinciali in materia faunistica ed ittico-venatoria e la nuova attribuzione in materia di polizia ambientale non entrano mai in discussione, uno dei profili di attività maggiormente controversi è invece quello relativo alla polizia stradale, che non tutte le amministrazioni provinciali considerano prioritaria rispetto alle attribuzioni del corpo. La conseguenza è che la varietà di compiti e funzioni svolte dalle strutture all’interno di ciascuna realtà provinciale spesso mette a dura prova la capacità degli organici (in genere estremamente limitati) di riuscire a coprire in modo pienamente efficace porzioni di territorio estese e difficilmente raggiungibili. «Svolgiamo moltissime funzioni, sono elencate in un testo, ce l’ho da qualche parte, che sono un centinaio, 99 funzioni, mi pare, che adesso spettano alla Polizia Provinciale, inquadrandola essenzialmente in corpo di Polizia a 360 gradi. È un corpo di Polizia, per cui in mezzo alla strada ha competenza ed obbligo giuridico di far osservare tutte le leggi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune, per cui qualunque violazione di natura amministrativa o penale, ovviamente, può essere oggetto di azione, quindi a 360 gradi siamo un corpo di Polizia: arrestare i ladri, fare controlli stradali, cose di ogni tipo. Poi abbiamo dei compiti più specifici che vanno dall’ambiente alla caccia e pesca che sono vecchie tradizioni della Polizia Provinciale e sono sempre state funzioni Provinciali, tant’è che tutti i guardiacaccia e i guardiapesca sono passati alle dipendenze del corpo di Polizia Provinciale. E tutta la gestione della caccia, l’immissione, il bracconaggio, le specie protette, tutto che riguarda la caccia, e altrettanto ciò che riguarda i pesci, l’ittiofauna con asciutta, pulizia, manutenzione del fondale e via di seguito. E poi abbiamo l’ambiente: controllo dei rifiuti, deposito di rifiuti, deposito e rottamazione delle macchine, officine di rilascio bollini blu, officine di controllo di ogni tipo. Abbiamo le agenzie turistiche, controllo di inquinamento dell’aria, controllo acustico, controllo inquinamento delle acque eccetera… Abbiamo competenze di polizia amministrativa oltre quelle della Provincia, ovviamente tutte quelle della Provincia, tutti i settori della Provincia ci chiedono il concorso per verifiche varie per tutte le strutture, i parchi, le licenze, il taglio delle piante nei parchi, l’osservanza delle norme e in più anche la Polizia amministrativa che deriva da tutti gli enti 127 Il materiale empirico di questo paragrafo è preso da due recenti ricerche cui abbiamo personalmente contribuito condotte sulle Polizie Provinciali in due differenti Regioni italiane: Emilia-Romagna e Lombardia. Cfr. Cristian Poletti (2006), “La polizia provinciale: “uscire dal bosco” senza smarrirsi”, Rapporto di ricerca, Regione Emilia-Romagna – Dipartimento Politiche per la Sicurezza e la Polizia Locale; Rapporto IReR Lombardia (2008), “Determinazione di standard minimi di servizio ed organico di Polizia Locale per ambiti territoriali della Lombardia”. 118 locali esterni: anche se non c’è una norma o una competenza della Provincia, laddove c’è violazione, abbiamo possibilità, capacità o dovere di intervenire. Poi nel nostro settore abbiamo anche compiti aggiuntivi di protezione civile… » [intervista a un comandante PP – regione Lombardia] «Il problema [dell’individuazione degli indirizzi politici] sta forse all’interno delle province, in da chi dipende il corpo: se dipende dal presidente, come dovrebbe, questo ha una funzione più distaccata, quindi questo problema si sente meno, se dipende dall’assessorato alla caccia e la pesca, farai solo quello, così come se dipende da un altro assessorato. Se non fino ad arrivare a cose aberranti per cui si finisce per fare controlli solo a chi è antipatico al funzionario di quel servizio! » [intervista a un comandante PP – regione E/R] «la grande difficoltà è che la Regione ha stabilito le materie, però le nostre polizie provinciali tra cui per prima quella che io dirigo, e poi alcune polizie provinciali della nostra regione che hanno seguito da alcuni anni una diversa preponderanza rispetto ad alcune materie - hanno orientato la propria attività dando diverse priorità: ad esempio, esiste una tiepida lettura del codice della strada che prevede che le polizie provinciali svolgano attività di polizia stradale, ma la nostra regione probabilmente se l'è ritrovata, senza che questo fosse nel suo interesse. » [intervista a un comandante PP – regione E/R] Così, accanto alla trasformazione dei contenuti della propria attività, le polizie locali delle Province hanno visto radicalmente ridefinita anche la propria immagine: da piccolo nucleo inserito nell’organico provinciale, dedito esclusivamente alla tutela faunistica ed alla vigilanza sulle attività di caccia e pesca e formato prevalentemente da appassionati del settore o amanti della natura, l’approdo alla creazione di un vero e proprio corpo di polizia a tutto tondo (sia pur mantenendo alcune specializzazioni elettive) non si è certo rivelato indolore e di semplice gestione. «Ci sono a tutt'oggi delle grossissime difficoltà strutturali, e di due tipi: una riguarda il personale, che vede messa in discussione una sua aspettativa. Mi è stato detto tranquillamente "ma dottore, sono venuto qui per fare l'operatore faunistico, non l'operatore di polizia" e questo è un aspetto, un problema generale, non relativo solo alla nostra realtà. Le PP sono praticamente tutti ex guardiacaccia, quindi chi entrava nella polizia provinciale era potenzialmente un aspirante cacciatore a tempo pieno… successivamente, con lo sviluppo dell'ambientalismo e della cultura ambientalista, sono diventati operatori dei soggetti che avevano un taglio culturale più faunistico, ambientalista. Si tratta quindi di personale che non è entrato con il taglio culturale di tutore della legalità, parola pesante nel nostro paese. [...] c'è chi vede questo passaggio come una trasformazione in "poliziotto" e in questo modo raggiunge una sua precedente aspirazione, ma si tratta di una piccola percentuale che vede con favore il cambiamento di iniziare a fare il poliziotto; poi c'è la grande maggioranza che sono quelli tradizionali, entrati per svolgere una funzione di operatore faunistico, soprattutto caccia e pesca e questi si fa fatica, ci vorrà del tempo, però piano piano si trasformeranno, come ha fatto nel tempo la PM… c'è poi una piccola pattuglia fortemente ostile, perché non è nella sua cultura, è una cultura totalmente contraria a diventare questo tipo di soggetto, e dove anche nell'andare a fare una perquisizione c'è una refrattarietà a questo tipo di intervento, non lo sentono, e questo è lo zoccolo duro. » [intervista a un comandante PP – regione E/R] «I più vecchi rischiano di rimanere sconvolti dai cambiamenti, dopo tutta la vita a svolgere una determinata routine. D’altra parte i giovani per lo più non danno la stessa disponibilità e spesso finiscono per guardare l’orologio… anche perché quando sei polizia, non è un lavoro come un altro, sei esposto ai rischi, devi risolvere dei problemi, magari anche solo attraverso il dialogo. Io mi posso ritenere soddisfatto del mio nucleo, ma se penso a quello che facevano prima e a quello in cui sono stati catapultati oggi, capisco che ci sia stato uno sconvolgimento. Ci vuole 119 tempo e pazienza, da parte loro e da parte mia e i risultati verranno nel tempo. » [intervista a un comandante PP – regione E/R] «C'è un problema in parte di professionalizzazione, ma a questo si può ovviare, ma soprattutto un problema di organici. Su tutta la provincia abbiamo un nucleo di 20 persone di cui: 1 è il comandante, 4 svolgono compiti di natura amministrativa, e solo 15 persone possono stare in giro… Quando la Polizia Provinciale si limita ai suoi compiti, già non c'è più modo di fare altro. […] c'è quindi un problema formazione relativo agli organici: la formazione va fatta in orario di lavoro, e se ci sono già carenze di organico, queste si acuiscono. La formazione delle risorse umane è indispensabile, come nelle aziende, per crescere. Ma va trovato un punto di equilibrio per evitare che le carenze di organico pesino sul servizio. » [intervista a un referente politico – regione E/R] Questa profonda trasformazione ha spesso dato luogo alle difficoltà proprie delle fasi di transizione: spaesamento e necessità di ridefinizione della propria identità professionale (e resistenza al cambiamento, in alcuni casi) per gli operatori inseriti nelle precedenti strutture, investimenti sulla formazione delle nuove reclute (limitati dalle croniche ristrettezze di budget delle amministrazioni coinvolte), sforzi di ridefinizione degli obiettivi e delle competenze professionali per i vertici dei corpi. Relativamente a questi ultimi, in diversi contesti le province hanno puntato su figure professionali provenienti da altri corpi di polizia già consolidati, nel tentativo di trapiantare attraverso la figura del comandante una professionalità poliziale tutta, peraltro, da costruire 128. Si può ben dire che questa fase di transizione nella ridefinizione di un’identità professionale sia ancora in corso di compimento, con situazioni assai divergenti anche sotto questo aspetto all’interno delle differenti realtà provinciali. 7.2 QUESTIONI APERTE SULL’IDENTITÀ PROFESSIONALE DELLE POLIZIE LOCALI Le polizie locali si sono trovate in prima linea nella necessità di fornire una risposta alla domanda di sicurezza della popolazione negli ultimi venti anni. Sono state investite da queste richieste sia in forma diretta, attraverso le chiamate dei cittadini alle centrali operative, le lettere e gli esposti giunti sulla scrivania dei comandanti o le puntuali richieste di intervento rivolte personalmente ai tanti “vigili” dislocati sul territorio, sia in forma indiretta, attraverso le direttive impartite dal decisore politico al livello dell’amministrazione locale di riferimento (a sua volta, sempre più spesso coinvolto nelle politiche locali per la sicurezza). Come si è detto in precedenza, tale domanda ha avuto come oggetto principale i fenomeni di microcriminalità e di degrado urbano, ed è stata a sua volta fortemente influenzata dai mass-media, che hanno enfatizzato la rilevanza del fenomeno criminale in determinati contesti, dando voce alle proteste dei cittadini singoli o organizzati (ad esempio, nei comitati di quartiere 129). In tal modo, le Polizie Locali hanno dovuto rimodulare le loro priorità di servizio, accordando un’importanza sempre più centrale alla funzione di rassicurazione sociale ed ai compiti di presenza dissuasiva e/o punitiva contro la commissione di comportamenti incivili o delinquenziali nei quartieri delle nostre città. Se è vero che il rapporto con la cittadinanza sia spesso reso difficoltoso dall’immagine di “gabellieri” che ancor oggi è presente nella mentalità comune, e se una fetta rilevante della popolazione continua ad associare le sole polizie nazionali al compito di tutelare la pubblica sicurezza, cionondimeno l’impegno delle Polizie Locali nel settore della sicurezza urbana è ora un tratto caratterizzante delle attività delle loro pattuglie. Anzi, in un sempre più consistente numero di occasioni, sono le stesse forze dell’ordine 128 In diverse occasioni s’è corso anzi il rischio di innescare pericolose crisi di rigetto (per gli operatori del corpo o per gli stessi comandanti in arrivo da realtà professionali di diverso prestigio), nel caso in cui al rinnovamento del vertice non fosse seguito, poi, un adeguato supporto alla trasformazione dell’intera struttura (cfr. Poletti, 2006). 129 Sul ruolo che i comitati hanno giocato nella definizione e gestione delle problematiche di sicurezza urbana in taluni contesti locali, si vedano Della Porta e Andretta, 2001, Poletti, 2003. 120 – all’interno dei Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – a rivolgersi alle strutture di polizia locale esistenti sulla zona per chiedere la loro collaborazione, allorquando l’esiguità delle loro strutture decentrate e/o la scarsità dei mezzi a disposizione mette a nudo le loro difficoltà nel controllare il territorio efficacemente, di fronte all’esplosione della domanda di sicurezza della popolazione. Con esiti spesso più che lusinghieri per la capacità dei corpi di Polizia Locale di farsi apprezzare anche da tali strutture, nei casi in cui queste forme di cooperazione sono state praticate e perseguite in modo convinto. Se, quindi, le polizie locali hanno arricchito le funzioni svolte sul territorio dai propri operatori, andando a coprire in modo sempre più massiccio ed efficace anche il settore d’intervento della sicurezza urbana, sorge però qualche interrogativo, a proposito della parallela evoluzione della propria identità professionale, rispetto a quella costituitasi storicamente e consolidatasi nel tempo. Fin dalla sua nascita, la figura del poliziotto locale (o meglio, del “vigile urbano”, per riprendere la tradizionale denominazione di questa figura professionale) si connotava per l’appartenenza alla comunità locale di riferimento - tale da farne, appunto, un primus inter pares, più che una figura al di sopra degli altri consociati - nonché per i profili di elevata specializzazione dell’attività di vigilanza svolta. In un certo senso, si potrebbe anzi dire che le nuove figure di polizia di prossimità nascano come tentativo di ricostituire quel legame solido tra tutori dell’ordine e comunità locali che nel passato rappresentava la caratteristica fondamentale del “vigile urbano” (al di là dell’aderenza nominalistica a uno schema di polizia importato dall’estero, come il community policing, che a volte viene citato più per adesione a mode poliziali del momento che per effettiva adesione a principi e valori). Le competenze in materia di polizia stradale e amministrativa andavano sostanzialmente ad esaurire il comunque ampio profilo repressivo della Polizia Municipale. A tali funzioni, poi, si aggiungevano attività di stampo più marcatamente sociale, tese a tutelare direttamente o indirettamente il benessere della collettività di riferimento, concretamente attuabili proprio per la profonda conoscenza dei delicati equilibri presenti in ciascun contesto sociale e per la vicinanza con soggetti cui tali interventi si indirizzavano. Non solo. Il vigile urbano è sempre stato – in modo congenito, potremmo dire – un “concittadino”, un membro della comunità al servizio della quale svolgeva un servizio specializzato; era qualcuno che conosceva molto bene persone, luoghi e attività, e condivideva con il contesto in cui operava i riferimenti valoriali e le norme tacite di comportamento nella vita quotidiana. Insomma, una sorta di mediatore sociale ante litteram, che accanto ad alcuni compiti specializzati di carattere meramente amministrativo, svolgeva una funzione allargata di rassicurazione e problem-solving per la comunità di appartenenza. Questo discorso accomunava i contesti di più limitate dimensioni – in cui questa prospettiva di prossimità rispetto al cittadino era esaltata anche dai ridotti confini della comunità stessa – alle grandi città, in cui spesso l’idea di una collettività coesa fa riferimento ad unità territoriali più piccole come i quartieri o i rioni (si pensi ai richiami nostalgici sovente operati da gruppi attivi anche sui temi della sicurezza, come i comitati di quartiere 130). I processi sociali più importanti degli anni Sessanta e Settanta (sviluppo industriale, migrazioni interne, mobilitazioni politiche di massa, rapido sviluppo urbano, mutamenti culturali) sembrano ormai acquisiti, dati per scontati, e riletti come una sorta di età dell’oro: i quartieri avevano una chiara e forte identità, l’habitat urbano era conosciuto e relativamente sicuro, le culture locali e gli stili di vita erano noti e prevedibili, anche per la ripetitività degli orari di fruizione degli spazi pubblici. Oggi, invece, le realtà urbane contemporanee (o della postmodernità) si contraddistinguono per caoticità, opacità, differenziazione culturale e disordine sociale. Come abbiamo evidenziato anche in precedenza, city users, migranti, pendolari sembrano dare vita, nelle descrizioni raccolte, a un caleidoscopio sociale, in grado di mettere a dura prova le capacità cognitive sia dei vecchi residenti sia dei tutori dell’ordine. E fra questi, anche gli operatori delle polizie locali. Collegata a queste trasformazioni della realtà sociale è intervenuta, con gli anni Novanta, la già ricordata evoluzione delle funzioni e delle competenze tipiche della Polizia Locale, che ha imposto una 130 Anche se in realtà va detto che molto spesso questi richiami nostalgici finiscono per mitizzare un passato spesso molto diverso da quello vagheggiato. Si pensi, per esempio, alle grandi città industriali del Nord che negli anni Sessanta hanno vissuto un impetuoso sviluppo economico ed sono state interessate da trasformazioni demografiche, sociali e culturali di portata anche più ampia di quelle in corso. In sostanza, non sempre le nostre città erano costituite da tante piccole comunità urbane ordinate e coese, nonostante, a distanza di qualche decennio, esse siano spesso rappresentate come meno complesse ed insicure delle attuali. 121 radicale messa in discussione dell’identità professionale storicamente appartenenti alle polizie municipali. Questo cambiamento comporta, com’è facile da immaginare, nuove sfide per la Polizia Locale. Una prima questione riguarda la necessità di aggiornare la qualificazione professionale di agenti ed ufficiali del corpo, chiamati al giorno d’oggi a svolgere un numero di compiti spesso sproporzionato rispetto alle piante organiche delle strutture e decisamente innovativi rispetto al passato. Questa riqualificazione è resa ancor più complicata dalle ricorrenti ristrettezze di budget e dalle norme che disciplinano gli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, due aspetti che ostacolano a loro volta un veloce ricambio degli effettivi e che richiedono sforzi di adattamento non ignorabili agli operatori sul territorio. Infatti, accanto ai tradizionali compiti del “vigile urbano”, la cui esecuzione risulta peraltro sempre più complessa, agenti e funzionari delle Polizia Locali devono sommare competenze nuove e sempre più importanti in materia di polizia giudiziaria, sicurezza urbana, polizia di prossimità. L’entità di tali trasformazioni e la velocità con cui sono intervenute possono verosimilmente rendere conto del fatto che stenti ancora a sedimentarsi una nuova identità professionale moderna e condivisa all’interno del corpo. E qui sorge la seconda questione, ancor più delicata ed importante rispetto alla prima. Una volta, cioè, che sembra necessario ritracciare i confini di una professione che evolve di pari passo con le nuove e più articolate funzioni in tema di sicurezza urbana, quale potrebbe essere il risultato di questa evoluzione? Si potrebbe pensare ad una nuova identità professionale per gli appartenenti al corpo di Polizia Locale? Allo stato attuale, appare evidente che non sia possibile parlare di un’identità univoca e condivisa, proprio perché nei diversi contesti in cui la Polizia Locale svolge la propria attività, i moduli operativi e gli accenti forniti all’azione delle pattuglie possono mutare questa identità anche in modo radicale. A realtà locali in cui le strutture sembrano riproporre in forma semplicemente aggiornata quella tradizionale immagine di “pacificazione sociale” a disposizione della collettività, si mescolano altre strutture, in cui l’impostazione in chiave prevalentemente sicuritaria della presenza sul territorio degli operatori ha comportato l’assunzione di modelli “polizieschi” in voga presso le forze dell’ordine nazionali. Si pensi, ad esempio, al dibattito sorto qualche anno fa in merito all’opportunità di dotare di armi le pattuglie di Polizia Locale sul campo, un dibattito che, al di là della questione in sé e per sé considerata, andava probabilmente a porre in discussione quale dovesse essere, più in generale, la nuova identità professionale da attribuire al corpo di Polizia Locale. Queste incertezze rischiano di lanciare la Polizia Locale al costante inseguimento di competenze e specificità proprie di altre forze di polizia (soprattutto per quegli ufficiali e agenti che vorrebbero privilegiare il tratto più marcatamente sicuritario della propria identità professionale), più che verso una razionale e completa realizzazione del proprio percorso evolutivo. L’identità professionale sembradefinirsi spesso in negativo, ossia basarsi più su ciò che non si è (o non si è più), piuttosto che su ciò che si è diventati: da un lato, rispetto a un passato ormai lontano e idealizzato, verso il quale si guarda con affetto, ma anche con una decisa volontà di cambiamento; dall’altro lato, rispetto all’immagine ed al prestigio che caratterizzano le altre forze di polizia (in particolare, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato). Quest’ultimo punto rappresenta un nervo scoperto nell’identità professionale della Polizia Locale. Sia che la si accetti, sia che la si ritenga totalmente infondata, la questione della gerarchia tra forze di polizia (o, perlomeno, del differente prestigio sociale che le contraddistingue) costituisce uno dei leit-motiv su cui viene impostato il confronto con le altre strutture. Un confronto, peraltro, che vede, almeno in termini di riconoscimento istituzionale, perdente la Polizia Locale, come testimoniato dai cerimoniali che vengono seguiti ogniqualvolta un’autorità politica si reca in visita in città, dal peso che la stampa nazionale e locale le attribuisce rispetto all’ampia visibilità e popolarità delle forze dell’ordine, o dal ruolo spesso secondario delle polizie locali rispetto a queste ultime all’interno dei più alti tavoli di concertazione fra istituzioni competenti in materia di sicurezza (il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica o i tavoli tecnici istituiti presso le Questure dei comuni capoluogo). La questione del prestigio e del riconoscimento sociale delle funzioni effettivamente esercitate dagli operatori ci porta ad un ulteriore problema collegato alla nuova identità professionale della Polizia Locale: quello relativo alla propria immagine pubblica. È il cittadino, infatti, che, spesso e volentieri, ribadisce una gerarchia tra forze di polizia in base alle funzioni più o meno “nobili” che le stesse sarebbero deputate a svolgere. Queste ultime considerazioni introducono il tema dei rapporti con l’esterno, sicuramente una delle aree maggiormente problematiche per la Polizia Locale. In questo senso, il corpo paga probabilmente una certa mancanza di abitudine ad interfacciarsi con la sfera mediatica; una difficoltà sia interna alle varie 122 strutture (sono poche le polizie locali che possono permettersi l’assunzione di professionisti della comunicazione quali addetti ad un proprio “ufficio stampa”, a differenza di quanto avviene da diversi anni nelle Questure e nei Comandi dell’Arma) che, più in generale, legata alla difficoltà per le stesse amministrazioni locali di rappresentare in modo dignitoso ed univoco le proprie strutture di Polizia Locale alla cittadinanza. A tali difficoltà di comunicazione esterna, s’aggiungono una serie di storture provocate dalla lentezza con cui altri settori delle amministrazioni comunali rispondono alle nuove necessità d’azione degli Enti locali in materia di sicurezza. Laddove le pattuglie di Polizia Locale non riescano ad ottenere il necessario supporto del settore viabilistico, piuttosto che dei lavori pubblici, dei servizi sociali o delle aziende municipalizzate, sarà infatti molto difficile che gli agenti coinvolti ottengano risultati concreti nelle azioni intraprese per dare risposta ai problemi segnalati dal cittadino. Ciò renderà estremamente complicato l’avvio di quel meccanismo virtuoso che punta alla fiducia del cittadino partendo dal problem solving; un meccanismo che altre forze di polizia – seppure con mezzi decisamente più “spuntati” di quelli a disposizione delle polizie locali – stanno attuando con successo da qualche anno nei quartieri delle nostre città. Quest’incapacità di comunicare verso l’esterno in modo efficace e redditizio genera, ovviamente, confusione nella popolazione e va ad amplificare (o, perlomeno, non riesce a ridurre) quella mancanza di appeal, dovuta all’immagine ostile che promana dall’attività sanzionatoria tradizionalmente svolta dal corpo. È proprio in questa direzione che dovrebbero essere invece investite maggiori energie, nel tentativo di ridurre il gap in termini di visibilità, efficacia comunicativa e prestigio sociale, rispetto alle forze di polizia nazionali. 7.3 VERSO UN NUOVO PATTO CON LA CITTADINANZA Per tutta questa serie di questioni aperte, accanto al completamento del percorso di riqualificazione professionale già intrapreso dalle strutture di Polizia Locale, occorrerà, molto probabilmente, arrivare a sottoscrivere una sorta di “patto implicito con la cittadinanza”, anche attraverso un’adeguata opera di comunicazione pubblica che riesca a trasmettere l’immagine di strutture non semplicemente votate ai profili repressivi e sanzionatori, ma volte alla riscoperta della propria innata vocazione sociale, di primi inter pares espressi dalle comunità locali, vicini alle problematiche che si manifestano al suo interno e affiancati dagli altri servizi delle amministrazioni locale in un’azione prevalentemente preventiva (e non repressiva). Oltretutto, tale opzione sembra perfettamente coerente con alcuni dei Valori deontologici che dovrebbero conformare l’azione delle forze di polizia, contenuti in due differenti documenti, entrambi altamente significativi. In primo luogo, il “Codice Europeo di Etica per la Polizia”, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nella Raccomandazione Rec(2001)10 del 19 settembre 2001, che costituisce il primo strumento sovranazionale di armonizzazione delle differenti legislazioni emanate in materia di sicurezza nei paesi europei: attraverso i suoi 66 articoli sugli obiettivi programmatici del servizio di polizia, sul modello organizzativo e sul rapporto delle strutture poliziali con istituzioni e società democratiche, il codice si pone come guida per la redazione di ogni “codice deontologico” di forze di polizia pubbliche o pubblicamente autorizzate nei paesi europei (ancorché non sia stato mai formalmente recepito dalla nostra legislazione nazionale). Ebbene, all’art. 18 il Codice recita: La polizia deve essere organizzata in modo da promuovere buone relazioni tra la polizia e i cittadini e, dove appropriato, l’efficace cooperazione con altri enti, comunità locali, organizzazioni non governative e altri rappresentanti dei cittadini, inclusi i gruppi delle minoranze etniche. Il secondo documento che intendiamo citare è invece ancor più ritagliato sull’etica e sui valori fondamentali della Polizia Locale: si tratta della c.d. “Carta di Monticiano”, che raccoglie alcuni dei principi fondamentali posti alla base dell'etica deontologica dell'agente di Polizia Locale nelle tre regioni – EmiliaRomagna, Liguria, Toscana – che si riconoscono nel modello formativo offerto dalla Scuola Interregionale di 123 Polizia Locale SIPL. In particolare, richiamiamo il primo dei Valori citati nella Carta, quello della Collettività/Comunità: La polizia locale opera in un territorio: ambito territoriale definito che rappresenta una comunità ed esercita per questa collettività un servizio, finalizzato al benessere e alla qualità della vita e al rafforzamento dei legami sociali. È importante il supporto dei cittadini: l’efficienza della polizia dipende anche dal loro coinvolgimento attivo. La Polizia Locale è garante dei diritti del cittadino, con particolare attenzione ai soggetti deboli. Dunque, il servizio alla collettività locale ed al cittadino – includendo in questo termine anche i soggetti appartenenti alle minoranze etniche – deve essere una delle principali missioni delle forze di polizia delle democrazie europee, ed in particolare anche delle nuove strutture di Polizia Locale. È chiaro che le trasformazioni sociali che sono intervenute negli ultimi decenni a mutare le realtà urbane del nostro paese – ed in particolare, il massiccio arrivo delle popolazioni migranti nelle nostre città e la trasformazione dell’Italia da terra di emigrazione a paese di immigrazione – hanno comportato importanti conseguenze rispetto alla composizione delle collettività locali stesse, e quindi hanno reso quanto mai pressante anche per le nostre realtà locali il richiamo al principio contenuto nel Codice etico europeo. Quel riferimento presente nella Carta di Monticiano al “cittadino”, i cui diritti devono essere garantiti dalle strutture di Polizia Locale, non può essere inteso in senso ristretto solamente a colui che possiede lo status giuridico di cittadinanza: in questo modo si escluderebbe un numero rilevante di soggetti che vivono e lavorano nelle città, che fruiscono ed al tempo stesso danno origine ad opportunità e servizi presenti al suo interno, e che dunque compongono la comunità locale. Ivi compresa una fetta significativa di migranti di seconda generazione che, a causa dell’attuale configurazione delle norme nazionali sulla cittadinanza, continua ad essere esclusa dalle possibilità di ottenimento rapido dello status giuridico di cittadino, nonostante i solidi legami spesso costruiti all’interno delle collettività locali italiane. D’altra parte, nella Carta di Monticiano è presente il riferimento ai “soggetti deboli” della popolazione cui la Polizia Locale dovrebbe prestare particolare attenzione: senza voler generalizzare, un numero rilevante di migranti presenti nel nostro paese si trova oggettivamente ad avere meno diritti rispetto a chi gode dello status di cittadino, non riesce a rappresentare adeguatamente le proprie esigenze presso le istituzioni, e si ritrova in una situazione di marginalità sociale difficilmente districabile. L’obiettivo del progressivo avvicinamento delle forze di polizia locale alla cittadinanza in generale, compresi i gruppi di origine etnica minoritaria può inoltre favorire la riaffermazione della tradizionale identità dell’operatore: da temuto “gabelliere” che agisce con strumenti prevalentemente repressivi (in maniera non sempre coerente con il contesto sociale su cui vanno ad influire) ad agente umanizzato e inserito nella realtà sociale, che riesce anche a costruire risorse di intelligence sfruttando al massimo la conoscenza profonda del territorio e delle relazioni sociali (più o meno conflittuali) ivi presenti, allo scopo di mantenervi o di ristabilirvi la pace sociale. “Secondo me la Polizia Municipale deve fare conoscere quello che fa, per es. il lavoro di educazione che fate nelle scuole è molto importante e va rafforzato. Va fatto nelle scuole ma va ripetuto anche nelle associazioni di categoria o di stranieri, per es. CNA, Confcommercio, chiamando le aziende affiliate, in una cena, per spiegare cosa devono fare: sono cose che costruiscono la sicurezza e la fiducia. Bisogna creare situazioni informali dove ci si conosce tranquillamente, una cena, per es., con i poliziotti in borghese. Questo è un modo che avvicinerebbe molto e tranquillizzerebbe, perché le facce contano, e più conosci le persone e più la fiducia aumenta. Noi, per es., ci siamo visti ad altri tavoli per la sicurezza e piano piano è cresciuta la confidenza. Un poliziotto che ha fatto formazione a degli adolescenti di diversa nazionalità (anche italiani), la prima volta era uno “sbirro”, la seconda volta l’hanno invitato loro. Qualcosa è crollato, hanno fatto conoscenza, ora c’è rispetto e sanno cosa fa la persona: fino a qua fanno loro …. Magari si può capire che ci sono tanti numeri da chiamare, non solo il 112. Bisogna costruire più conoscenza, e attraverso questa, più rispetto, e convincersi che magari chiamare la polizia può risolvere più facilmente un caso”. Cittadino, Tavolo di confronto in sessione plenaria. 124 A prescindere dall’istituzione di specifiche figure professionali (come i “vigili di quartiere”) incaricati di operare seguendo le regole e le procedure proprie della cosiddetta “polizia di prossimità”, l’obiettivo di un’umanizzazione delle forze dell’ordine e di un concreto avvicinamento ai problemi ed alle esigenze della popolazione dislocata sul territorio deve essere trasversale alle diverse strutture di polizia. Si tratta di considerare il lavoro di operatore di polizia in un’ottica “di servizio”, in cui gli interventi da effettuare e l’adozione delle specifiche misure da prendere devono necessariamente tenere conto anche dell’impatto sociale che essi provocheranno sul territorio. In determinati casi, ad esempio, a pratiche di tipo coercitivorepressivo (che comportano elevati costi sociali per i loro destinatari e rischiano di acuire situazioni conflittuali) possono essere preferibili interventi più “morbidi”, in modo da non esasperare le tensioni esistenti e prevenire possibili scontri. In altri frangenti sarà, invece, necessario intervenire a prescindere dal fatto che siano state violate norme penali: la reazione ferma e pronta al verificarsi di semplici “atti di inciviltà” che però rischiano di minare gli equilibri instauratisi in una determinata zona può prevenire la futura commissione di veri e propri reati, con tutto il carico di conflitti sociali che essi comportano. In quest’ottica occorre però che gli operatori di polizia sviluppino un’approfondita conoscenza del territorio nel quale essi sono chiamati ad operare; una conoscenza che va acquisita direttamente dall’interno e mediante un costante ed articolato rapporto con i diversi gruppi e le altre istituzioni ivi presenti. È necessario, in altre parole, che le forze dei polizia diventino una fra le varie componenti sociali che animano stabilmente l’ambiente urbano di riferimento. Per raggiungere questo scopo è sicuramente necessario che gli agenti, compatibilmente con le sempre più evidenti limitazioni di organico, frequentino con assiduità il territorio, in modo da diventare una punto di riferimento al suo interno e da sviluppare quei rapporti interpersonali con i membri dei diversi gruppi, che costituiscono il fulcro dell’azione di “prossimità alla popolazione”. Ma, ancora più importante, occorre anche che questo sforzo di avvicinamento a tutte le diverse componenti sociali presenti sul territorio di riferimento avvenga in maniera socialmente equa. Che sia aperto, cioè, anche a quei gruppi aventi consistenza numerica o importanza socio-economica minoritaria all’interno del contesto di riferimento (anzi, che nei confronti di tali gruppi venga posta una particolare attenzione). Infatti, una polizia che si ponesse al servizio della parte maggioritaria della popolazione, consacrandone di fatto la posizione di preminenza all’interno del corpus sociale, non farebbe altro che aggravare le tensioni e gli squilibri già esistenti nella nostra società, fallendo nel proprio compito di garantirne (o ristabilirne) la pacificazione e di mantenersi al passo con le trasformazioni che la attraversano. Per una forza di polizia pienamente democratica e superare positivamente le nuove sfide professionali, le strutture di Polizia Locale devono avere come punto di riferimento una società multiculturale e devono essere capaci di comprenderne i bisogni e soddisfarne le esigenze attraverso la propria quotidiana attività sul campo. È dunque necessario che si crei (o si confermi) un nuovo implicito patto con la cittadinanza, incluse le minoranze al suo interno, che vada a caratterizzare la rinnovata vocazione della Polizia Locale a porsi come servizio per la propria comunità di riferimento; la Polizia Locale sappia relazionarsi anche con la popolazione migrante e sappia porsi anche al suo servizio, garantendo così la “qualità della vita” anche a questa fetta importante (ancorché minoritaria) di popolazione che vive nelle nostre città. 125 PARTE SECONDA: AGIRE 126 8. GESTIRE LA DIVERSITÀ 127 8.1 DIVERSITA’ Come abbiamo cercato di spiegare nella prima parte del testo, le identità dei gruppi sono ben lontane dall’essere omogenee, assolute, ben definite etra di loro discrete; al contrario, esse sono soggette a cambiamenti costanti dovuti all’interazione sociale di individui indipendenti. Affermare ciò non è come negare l’esistenza di numerose e diverse culture e forme identitarie nella nostra società italiana moderna; si vuole, con queste affermazioni, evidenziare l’errore comune di ricercare, attraverso un focus incentrato sulla cultura e la religione, culture ben definite e statiche che coesistono fianco a fianco. In quest’ultima visione c’è il rischio di fomentare la posizione di chi tende a richiudersi su se stesso in una percezione reazionaria e negativa degli altri gruppi, invece di muoversi nell’ottica di una società democratica, aperta e inclusiva. La costante culturalizzazione oggi in atto, questa fissazione sulle culture non cattura la relazione dinamica tra culture ed esseri umani. In questa seconda parte del testo ci concentriamo sull’idea di diversità, delle tante diversità che ciascuno di noi mette in campo, e della loro gestione per il meglio di ciascuno e della società nel suo insieme. Sono state dapprima le grandi imprese multinazionali a porsi il problema di come gestire le tante diversità diffuse nei diversi continenti dove avviene la produzione, l’assemblaggio di parti, il marketing, ecc. Anche in Italia la diversità del mercato del lavoro cresce continuamente come risultato di diverse cause concorrenti: il cambiamento del ruolo e delle aspirazioni delle donne, il declino economico, la relazione tra lavoro e famiglia, l’aumento della speranza di vita e l’invecchiamento della popolazione (quindi della forza lavoro disponibile), la spinta ad inserire nel lavoro le persone disabili al pari delle persone normodotate e il fatto che in Italia il 7,4% della popolazione residente è straniera 131. Sono dunque le aziende che hanno aperto la strada della gestione della diversità, strumento che si sta diffondendo anche nelle istituzioni e nelle grandi organizzazioni no profit, così come nello spazio più ampio della società. La gestione della diversità s’impone e s’imporrà sempre più perché assicura vantaggi anche alle istituzioni, in particolare perché riduce le forme di discriminazione diretta e indiretta e le spese dovute alle cause legali che anche nel nostro Paese alcune istituzioni hanno già dovuto sopportare. Essa riduce la fuga dei lavoratori e i costi per l’assunzione e la formazione: numerose ricerche attestano che c’è un collegamento chiaro tra la cultura di un luogo di lavoro (una cultura che soddisfai lavoratori) e il tasso di trattenimento, la capacità cioè di quel luogo di lavoro di trattenere i propri dipendenti, soprattutto i migliori (perché spesso chi se ne vaè chi ha più talento esa di poterlo spendere altrove). Per gli stessi motivi, una buona gestione delle diversità riduce l’assenteismo. Va da sé che la buona gestione delle diversità e un sistema di contrasto alle discriminazioni non è un’operazione a costo zero. Ciò comporta la creazione e la continuità di un nuovo sistema di raccolta delle informazioni da parte del settore delle risorse umane (statistiche aggiornate di ciascun lavoratore per età, sesso, e altre variabili significative, oltre alla serie storica delle promozioni e degli spostamenti); la formazione del personale di quel settore, coinvolto nella selezione e sviluppo dei lavoratori; la spendita di tempo per i dirigenti e i lavoratori, soprattutto all’avvio del nuovo sistema; l’adeguamento del personale, vecchi e nuovi lavoratori, alle nuove modalità di lavoro e di relazioni interne e con il pubblico; la comunicazione all’esterno delle nuove posizioni e dei piani d’azione per applicarle; il monitoraggio continuo che fornisce ai dirigenti le informazioni per confermare o aggiustare il piano. Tutto ciò potrebbe richiedere anche un piccolo investimento in tecnologia e, forse in un primo momento, potrebbe essere necessario ricorrere a consulenti esterni. Questi investimenti avranno un ritorno in termini di maggiore impegno ed efficienza delpersonale e di maggiore fiducia della collettività; certo, non si tratterà di benefici che si possano cogliere dall’oggi al domani, almeno i più complessi, come la fiducia delle diverse comunità. 131 ISTAT http://www.istat.it/it/archivio/96694 128 Anche la Polizia Locale, dunque, deve sapere riconoscere i vantaggi e le opportunità che la buona gestione della diversità offre per gestire la complessità della sua forza lavoro e per gestire al meglio il servizio che offre ad una società transculturale. La prima parte del testo ha evidenziato come la discriminazione sia parte integrante della vita quotidiana e come non sempre si tratti di atti eccezionali, isolabili e identificabili nelle cause; si è piuttosto di fronte ad eventi ordinari, all’interno di relazioni sociali ordinarie, dove persone, istituzioni e organizzazioni di ogni tipo commettono atti dalle conseguenze quasi sempre gravi e dolorose e dagli effetti che si riverberano sulla coesione sociale. Prendere in considerazione le diversità e rispondere alle diversità è dunque un punto fondamentale senza il quale sarà difficile contrastare le discriminazioni, soprattutto quelle istituzionali. Come dicevamo in precedenza, non sono solo “loro” che devono essere integrati, inclusi perché svantaggiati, stranieri, minoranza ma, poiché ognuno ha una propria individualità fatta di plurime identità, tutti dobbiamo essere integrati per ottenere il meglio dalla società e per contribuire come meglio possiamo. Vediamo, dunque, come si definisce la “gestione della diversità” o Diversity management: Il Diversity management è una tecnica manageriale che ha come obiettivo dichiarato, oltre a quello etico che può essere a buon diritto soggettivo, il miglioramento delle condizioni di lavoro e l’aumento dell’efficacia ed efficienza organizzativa. (…). Il Diversity management va oltre il problema delle discriminazioni, poiché mira soprattutto a valorizzare i talenti individuali tenendo conto anche dei vantaggi che ne possono derivare all’organizzazione. 132 Si tende a distinguere due dimensioni della diversità, secondo una delle prime tipizzazioni elaborate da Loden e Rosener nel 1991, dove appare evidente che le differenze primarie non sono mutabili, mentre le secondarie possono cambiare (e per lo più lo fanno) nel corso della vita: PRIMARIA SECONDARIA Età Situazione familiare Genere Educazione Origine etnica Religione Razza Reddito Orientamento sessuale Stile di lavoro Caratteristiche mentali e fisiche Esperienza militare Localizzazione geografica Vale la pena di richiamare brevemente l’attenzione sul fatto che le differenze secondarie sono frutto della società all’interno della quale è elaborata la categorizzazione (per es., l’esperienza militare era probabilmente più significativa negli Stati Uniti d’America dei primi anni ’90 di quanto lo sia nell’Italia del XXI secolo) e del momento storico-sociale. E’ perciò altresì chiaro che la lista delle diversità secondarie può allungarsi e cambiare per effetto dei fattori appena indicati. Accettare le diversità significa riconoscere le differenze e rispettare le identità e le affiliazioni di gruppo di ciascun individuo, senza però ridurlo costantemente a quell’unico tratto che lo unisce ad un 132 Mapelli A. (SDA Bocconi), Introduzione al Diversity Management, pag.12 in Raccolta contributi della Scuola di Alta Formazione in Diversity Management. Modelli, Metodi e Case Study, Regione Piemonte, 16-20 novembre 2009. 129 gruppo o senza considerarlo rappresentante di quel gruppo. Significa vedere la persona e vederla nella sua interezza e complessità. Colei che scrive è, ad esempio, donna, di 57 anni, con un orientamento politico, agnostica, italiana, lavoratrice, senza figli, ecologista e via elencando. Provate a redigere una lista delle tante diversità che compongono la vostra identità e scoprirete, come me, che alcune di esse sono cambiate nel tempo, perdendo o acquistando importanza, e che sulla scena sociale giocherete l’una o l’altra con più evidenza e passione, secondo il contesto, l’occasione, le condizioni esterne e il vostro stato d’animo. Gestire la diversità nel luogo di lavoro significa mettere qualsiasi persona che lavorain condizione di realizzare il suo potenziale; ciò equivale a ottenere da ognuno tutto ciò che è ragionevole attendersi e permettere ad ognuno di dare ciò che può dare. Una gestione attiva della diversità può ottenere il meglio dalla diversità stessa sia che essa serva l’individuo, un’organizzazione o la società nel suo complesso. Tendiamo a credere al vecchio proverbio “tratta gli altri come vorresti essere trattato tu”. Se guardiamo al proverbio nella prospettiva della valorizzazione delle diversità, cominceremo però a chiederci cosa s’intende per esempio con “rispetto”, se il significato attribuito alla parola è lo stesso per tutti: significa salutare al mattino? lasciare qualcuno solo, in particolari momenti? cercare sempre il contatto degli occhi quando si parla? La risposta dipende dal’individuo: possiamo condividere valori simili, come il rispetto o il bisogno di riconoscimento, ma il modo in cui manifestiamo questi valori attraverso il comportamento può variare anche sensibilmente da gruppo a gruppo e da individuo a individuo, anche all’interno dello stesso gruppo e della stessa appartenenza “culturale”. Come potremo dunque conoscere le aspettative e i bisogni dei diversi individui? Basterà probabilmente rovesciare il proverbio in questo modo: “tratta gli altri come loro vogliono essere trattati”(CE, Manuale di formazione sul Diversity Management, 2007), muovendoci dalla posizione che diamo per scontata (il nostro modo è il migliore) verso la prospettiva sensibile alla diversità (prendiamo il meglio dalla grande varietà di modi diversi). Parlare di diversità presuppone logicamente che ci sia un elemento con cui questa diversità è comparata e valutata come deviante rispetto a una norma, ma questo rapporto va inteso in senso di dinamica fra maggioranza e minoranza, non nel senso di una gerarchia. Dunque, minoranze sono tutti quei gruppi che differiscono da un presunto standard di “normalità statistica”. Proprio qui sta il concetto di differenza che è unicamente esito della negoziazione sociale. 8.2 LA POLIZIA E LA GESTIONE DELLA DIVERSITA’ Il primo dicembre 2009 la Polizia Metropolitana di Londra (MPS) lanciò la nuova “Strategia per la Diversità e le Pari Opportunità 2009-2013”. Abbiamo selezionato per voi alcuni passaggi fondamentali del documento 133 che successivamente commenteremo. Diversità e Pari opportunità non sono solo parole: sono elementi imprescindibili per la nostra abilità di offrire un serizio di polizia a Londra che sia efficace e hanno implicazioni in qualunque cosa facciamo.(…) Questo nuovo piano darà impulso alla nostra risposta ai nodi critici della diversità e delle pari opportunità e la migliorerà, definendo i nostri passi per affrontare la discriminazione e l’inuguaglianza e per comprendere e usare al meglio la diversità di Londra e la nostra forza lavoro. (…) 133 Metropolitan Police Service -Diversity and Citizen Focus Directorate, ..ACHIEVING EQUALITY, IMPROVING CONFIDENCE. MPS DIVERSITY AND EQUALITY STRATEGY 2009-2013. Mayor’s Office for Policing and Crime, LONDON 2012. 130 Il Settore Pubblico - Dovere delle Pari Opportunità della legge sulle Pari opportunità del 2010 richiede che la MPS tenga nella dovuta considerazione la necessità di: • eliminare le discriminazioni illegittime, le molestie, la vittimizzazione ed ogni altra condotta proibita dalla legge; • fare crescere l’uguaglianza delle opportunità tra coloro che condividono una caratteristica protetta134 e coloro che non la condividono; • rafforzare le buone relazioni tra le persone che condividono una caratteristica protetta e le persone che non la condividono. Ma per essere una polizia efficace a Londra dobbiamo andare oltre la conformità alla legge: dobbiamo eliminare le discriminazioni e le molestie, promuovere e proteggere i diritti umani e fornire a chiunque il pari trattamento.(…) Siamo impegnati a fornire servizi di polizia che incontrano i bisogni di tutte le comunità. Vogliamo che tutte le comunità abbiano fiducia che saranno trattate da noi in modo giusto, con dignità e rispetto, assicurandoci che ognuno abbia accesso ai nostri servizi. Questo aspetto non è qualcosa che si aggiunge ai nostri scopi e alle nostre attivià principali: esso è fondamentale per il servizio di polizia nella Londra del XXI secolo.(…) Questa strategia contiene 4 temi per i quali abbiamo sviluppato delle azioni correlate: 1. Servizi imparziali e sensibili. Questo è il cuore della strategia, un approccio che riconosce la funzione unica della polizia e integra diversità e pari opportunità in qualunque funzione, azione e servizio della polizia. 2. Impegno verso la comunità: rafforzare il nostro impegno verso tutte le comunità, ascoltando i loro bisogni e rispondendo. 3. Forza lavoro e cultura: costruire e sviluppare una forza lavoro talentuosa e una cultura aziendale che promuove il rispetto reciproco e il lavoro di squadra nella MPS. 4. Prestazioni e governance: controllare i progressi, assumerci la responsabilità e il dovere di rendere conto delle nostre prestazioni. La strategia per le uguali opportunità della Polizia Metropolitana di Londra ingloba la quasi totalità dei punti essenziali per far sì che l’agire di polizia in una società diversificata sia all’altezza di tale società. Eccoli qui in sintesi. 1. Coinvolgimento di ogni settore e attività di un servizio di polizia; in sostanza un’azione di mainstreaming 135. 2. Non si combattono discriminazioni e non si promuovono pari opportunità e pari trattamento se non si affrontano lavorando contemporaneamente all’interno e all’esterno della polizia, cioè nei confronti dei propri operatori e nei confronti della popolazione cui il servizio si rivolge. 3. Costruire un clima nell’organizzazione dove prevale il senso della squadra e del rispetto reciproco. 4. La polizia deve essere agente di coesione sociale, non solo limitandosi a non discriminare ma adoperandosi attivamente per migliorare le relazioni tra la maggioranza e le minoranze (protette dalla legge) ed essendo il primo difensore dei diritti umani. 134 L’Equality Act 2010 disegna il quadro di riferimento per le pari opportunità, la diversità e la discriminazione. Vi sono elencate 9 caratteristiche degli individui protette dalla legge: età, disabilità, ricollocazione di genere, stato matrimoniale, gravidanza e maternità, razza, religione o credo, genere e orientamento sessuale. 135 Il Gender mainstreaming è una strategia per l’uguaglianza delle opportunità tra i sessi definita per la prima volta nella Piattaforma di Pechino per l’azione risultata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne (1995) e successivamente ripresa da United Nations Economic and Social Council nel 1997. Con questo concetto si riconosce che non si possono raggiungere cambiamenti significativi nell’uguaglianza tra i generi aggiungendo programmi marginali per le donne. Ciò che è richiesto è un cambiamento nelle politiche generali e nelle pratiche che ne danno applicazione e nella conseguente allocazione delle risorse. Il mainstreaming è il mezzo per combattere quel processo istituzionale che porta alla discriminazione e che forma parte della cultura, dell’amministrazione e della governance in un Paese o in un’organizzazione: se l’uguaglianza di genere è il fine, il mainstreaming ne è la strategia. Oggi il termine è acquisito alla promozione delle pari opportunità in tutti i campi (genere, razza o etnia, orientamento sessuale, ecc.). 131 5. Nessuna comunità deve avere diverso accesso ai servizi di polizia e per questo bisogna impegnarsi per guadagnare la fiducia di tutti i cittadini. 6. Controllare e valutare sistematicamente i risultati ottenuti e renderne conto a tutta la cittadinanza con trasparenza. Alla base di questo approccio stanno la consapevolezza e la convinzione che la buona gestione delle diversità è: vantaggio per tutti, minoranze e maggioranze, privilegiati e non; compito di tutti, non solo della dirigenza e non solo del settore delle risorse umane; dentro e fuori l’organizzazione, nel trattamento riservato ai propri lavoratori e nel servizio offerto ai propri utenti o clienti; affare della polizia che è un’organizzazione come le altre, anzi diversa. “La polizia ha una responsabilità maggiore rispetto alle altre istituzioni e organizzazioni perché dispone di poteri repressivi e coercitivi che vanno usati con grande attenzione” 136. 8.2.1 Un sistema organizzativo che si muove nella stessa direzione La diversità conferirà buoni risultati alla Polizia Locale se l’organizzazione stessa e i diversi settori dell’organizzazione saranno ugualmente, e con pari impegno, sintonizzati su una buona gestione delle diversità. In altre parole: la direzione, le politiche, le pratiche di gestione delle risorse umane, la comunicazione e la cultura dell’organizzazione devono essere “a prova di diversità” 137. Questo significherà, per esempio, che la direzione deve essere competente sugli aspetti fondamentali delle società transculturali e che i nuovi arrivati devono essere valutati sulle loro qualità e non sulla base del genere, della razza, dell’orientamento sessuale o di una disabilità. Solo se questi requisiti sono rispettati la soddisfazione sul luogo di lavoro e la soddisfazione dei clienti (o utenti) sarà ugualmente distribuita tra i diversi gruppi all’interno dell’organizzazione e nei gruppi della comunità che la polizia serve. Solo così possiamo contare su una diversità che contribuisce ad ottenere i risultati ambiti. Un esempio Osservazione regolare e controllo della situazione (Polizia della Contea di Stoccolma) Un processo di lavoro sistematico e orientato al risultato che tratti di diversità non richiede solo obiettivi chiari e regolamenti. È anche vitale procedere ad aggiornamenti regolari e processi di valutazione per verificare il raggiungimento degli obiettivi. Senza unefficiente mezzo per monitorare e valutare la situazione non è possibile, in sostanza, trarre qualsiasi tipo di conclusione sui progressi raggiunti. Per creare una buona base per un lavoro sistematico sulle diversità, la Polizia della Contea di Stoccolma nel 2002 ha svolto una verifica sulle diversità all’interno della propria organizzazione, con l’aiuto del National Institute for Working Life e il Dutch consultant EGA. Lo scopo di questa verifica non fu solo quello di avere il quadro della situazione riguardo le diversità all’interno dell’organizzazione ma anche di sviluppare strumenti da usare per autovalutazioni future e per il regolare monitoraggio nell’organizzazione. Prima di passare all’analisi di fatti e buone pratiche, è bene chiarire quel che s’intende con l’espressione “cultura dell’organizzazione” oggi soventeusata. In ogni gruppo organizzato di individui si sviluppano nel tempo certi modi di pensare, atteggiamenti e comportamenti. E’ questo il fenomeno al quale ci si riferisce quando si parla del clima o della cultura di 136 Braccesi C., Recasens A., IL FUTURO DELLA POLIZIA LOCALE IN EMILIA-ROMAGNA E NON SOLO, dicembre 2006. 137 Espressione usata in PROMOTING DIVERSITY AND PREVENTING DISCRIMINATION IN POLICE FORCES the final product of the EU-funded project “Minority Representation in Police Organisations – Transnational Measures for the Exchange of Information and Good Practice” nov. 2004. 132 un’organizzazione; approssimativamente si potrebbe anche dire “quelle cose che si danno per scontate”. Una definizione oggi abbastanza condivisa di cultura di un’organizzazione è questa:l’insieme delle norme, dei valori e delle convinzioni sulla realtà che si sviluppano in un’organizzazione via via che i suoi membri collaborano tra di loro e con l’ambiente esterno. 138 La cultura di un’organizzazione non solo esiste nei fatti ma riguarda tutti gli appartenenti a un’organizzazione e ha una specifica funzione: rafforzare la solidarietà tra i membri, fornire un’identità all’individuo, facilitare la comunicazione interna, offrire modelli di comportamento agli individui nelle loro interazioni con gli altri (dentro e fuori l’organizzazione), in sostanza accrescere l’integrazione dell’organizzazione stessa. E’ facile comprendere che, con gli stessi mezzi adoperati per adempiere a tali funzioni, la cultura di un’organizzazione può essere anche causa di esclusione e di problemi per i nuovi arrivati e per le minoranze. Lo abbiamo visto bene nel modello elaborato da Philomena Essed (presentato al par. 5.2.2) e nelle conseguenze delle discriminazioni sulla soddisfazione, sulla salute, sul benessere del lavoratore e, in ultima analisi, sulla sua integrazione nell’organizzazione e la sua volontà di continuare a farne parte, sull’erosione della fiducia nella polizia da parte di alcuni gruppi nella comunità che la polizia serve e, in combinazione con altre forme di esclusione, sull’alienazione di questi gruppi dalla società nel suo insieme. Per portarci ad un esempio concreto, non è certo esplicitato, in leggi o regolamenti, che un operatore di polizia non dovrebbe essere omosessuale, tuttavia la cultura dell’organizzazione è tale per cui la quasi totalità degli operatori, compresi i dirigenti, possono affermare che “non c’è alcun problema se un operatore è gay (o lesbica), l’importante è che non lo dica”. Non sarà difficile comprendere che questo modo di essere è discriminatorio perché non permette ad una persona di essere se stessa, di parlare del proprio compagno (o compagna) con la stessa libertà di un eterosessuale e la porta a dover porre attenzione a qualunque atto o parola pronunci per non tradire la sua appartenenza a quella categoria di persone. Per evitare questi esiti nefasti, i dirigenti delle organizzazioni, polizia compresa, devono impegnarsi attivamente e con costanza alla cultura che l’organizzazione esprime, al clima nelle relazioni tra i lavoratori, ai valori e all’etica dell’organizzazione, in tutti i comparti e a tutti i livelli. Ciò implicherà inevitabilmente l’elaborazione di politiche chiare e sanzioni certe per comportamenti inopportuni (molestia, discriminazione, ecc.) e la formazione di tutti i lavoratori su atteggiamenti compatibili, atteggiamenti che dovranno essere a loro volta rafforzati dalla cultura espressa dall’organizzazione, attraverso l’enunciazione di valori chiave, la loro comunicazione e l’impegno e l’esempio dei dirigenti. Prima di passare alla dimostrazione di quel che un servizio di polizia può fare nel concreto, presentiamo due casi eclatanti che chiariranno meglio i temi sin qui trattati e le pagine che seguiranno. 8.2.2 Due casi a confronto Il caso Stephen Lawrence, Londra, 22 aprile 1993 Una svolta fondamentale nell’agire della polizia inglese che ha prodotto ampie ricadute in tutto il Regno Unito e in Europa, non solo per la polizia ma per le istituzioni pubbliche in generale, è il caso dell’assassinio del giovane Stephen Lawrence. Stephen, 18 anni, fu assassinato la notte del 22 aprile 1993 mentre, con un amico, aspettava un autobus nel Sud-Est di Londra. Stephen e l’amico furono attaccati da un gruppo di cinque o sei giovani bianchi che gridarono “ehi, ehi negro!” e si lanciarono verso di loro. L’amico di Stephen, Duwayne Brooks, gli urlò di correre via ma in quel momento il ragazzo era già stato catturato e sommerso dal gruppo. Un testimone poté vedere l’attacco,quando Stephen fu accoltellato due volte dal gruppo dei ragazzi 138 Diversity in the work place, pag.20. Traduzione nostra. 133 bianchi. Nonostante gli sforzi per salvarlo, fu dichiarato morto a mezzanotte. La polizia, chiamata sul luogo dai testimoni, annotò nel suo primo rapporto che si trattava di un “regolamento di conti tra due afrocaraibici” (cioè due neri). Da quel momento cominciò da parte della MPS di Londra una serie di negligenze nelle indagini e di sospetti e accuse nei confronti di Duwayne, nonostante l’esistenza di testimoni cui la famiglia Lawrence credette e che la polizia non cercò. Dopo ulteriori investigazioni richieste con tenacia dalla famiglia Lawrence, furono dapprima fermati cinque sospettati ma non riconosciuti colpevoli. Nel corso dell’inchiesta parlamentare che fece seguito alle indagini si definì l’omicidio come razzialmente motivato, intendendo con ciò asserire che il ragazzo Lawrence fu assassinato perché nero; si riconobbe inoltre che il modo in cui la polizia e la Procura della Corona avevano trattato il caso dimostrava razzismo 139. Il duro verdetto di “razzismo istituzionale” fu riconosciuto come il fattore decisivo nel comportamento della polizia e nel fallimento dell’investigazione sull’assassinio del ragazzo, segnando un nuovo inizio nelle relazioni tra la polizia e le minoranze etniche in Gran Bretagna. Il rapporto d’inchiesta parlamentare dell’ex giudice Sir William Macpherson criticò senza incertezze l’agire della polizia e puntò il dito contro la Polizia Metropolitana di Londra che ritenne responsabile per il fallimento nell’inchiesta investigativa. Secondo il giudice, il razzismo istituzionale dimostrato dalla polizia aveva portato ad errori fondamentali nell’indagine, in primo luogo il rifiuto del primo gruppo di poliziotti arrivati sul luogo di riconoscere che il delitto era razzialmente motivato. Il razzismo istituzionale, secondo il rapporto, aveva avuto un ruolo importante nell’investigazione condotta dalla MPS sull’assassinio del giovane Lawrence e, in particolare, nel trattamento delle famiglie delle vittime e della vittima sopravvissuta, nel fallimento degli operatori di polizia nel riconoscere un crimine motivato da ragioni razziali e nella lentezza e mancanza d’impegno al momento dell’investigazione. Il Rapporto Macpherson, commissionato dal governo inglese nel 1997 e terminato nel 1999, in circa centomila pagine di analisi, documenti e prove, condannò anche come insensibile e non scusabile il trattamento riservato dalla poliziaai genitori del ragazzo, perché solo grazie alla loro tenacia si era potuta appurare la verità e scoprire gli autori del crimine. Il razzismo istituzionale secondo il Rapporto Macpherson è: “il processo grazie al quale le persone di origine etnica minoritaria sono sistematicamente discriminate da organizzazioni private e pubbliche. Si può dire che c’è stato razzismo istituzionale se l’effetto prodotto da certe leggi, pratiche e abitudini è “razzialmente” discriminatorio”. Si tratta di un razzismo così profondamente intessuto nella trama di un’organizzazione che risulta molto difficile considerare responsabili un solo individuo o un gruppo di individui che ne fanno parte. Sostiene il Rapporto che nessun singolo dirigente di polizia, ma nemmeno un gruppo di dirigenti, può essere considerato direttamente responsabile per ciò che è spiegato come un involontario o inconsapevole atto di razzismo che porta, per esempio, all’incredibile sproporzione di fermi a piedi a scopo di controllo (stop and search) compiuti su uomini neri. Le raccomandazioni emerse dal Rapporto descrissero le politiche e le strategie intese a combattere questo razzismo istituzionale ma, invece di creare un soggetto separato per vigilare sulla loro effettiva applicazione, stabilì che di questa applicazione è responsabile ciascun operatore, nessuno escluso, ein primis, ovviamente, i dirigenti. Casi di chiaro razzismo da parte di operatori di polizia nei confronti del pubblico certamente esistono e sono da trattare anche sul piano della responsabilità individuale e, di per sé, non mostrano certo evidenza di razzismo endemico nella polizia; 139 Il caso fu poi riaperto in sede di giustizia penale nel 2011, in seguito all’emergere di nuovi fatti. Nel gennaio 2012 Gary Dobson e David Norris furono riconosciuti colpevoli dell’omicidio di S.L. e condannati all’ergastolo, pena commutata in 15 anni perché all’epoca dei fatti erano minorenni. 134 questo è però anche il modo più semplice di procedere. Più spesso,i due piani di razzismo coesistono e si combinano. Il fatto che, in seguito agli accadimenti riportati, la polizia cominciò a spiare la famiglia Lawrence e tutti i loro conoscenti, comprese le organizzazioni di lotta che li sostenevano, dimostra che quel razzismo non è semplicemente il prodotto di pratiche spersonalizzate e diffuse ma che esso è anche appoggiato dal vertice e filtra attraverso la catena del comando. Per la prima volta, dei dirigenti di polizia dovettero spiegare alla pubblica opinione il loro ruolo nell’applicazione di politiche apertamente razziste e nel chiedere agli operatori al loro comando di agire di conseguenza. Neville Lawrence, padre di Stephen, dichiarò: “Mi è chiaro che la polizia è convinta che la famiglia di una vittima di colore nero sia composta da criminali violenti in alcun modo degni di fiducia.” (MacPherson Report, 1999). Dopo il caso Stephen Lawrence L’inchiesta sul caso Lawrence portò, come si è detto, ad una profonda riforma dell’agire di polizia e del sistema giudiziario, per sviluppare una tolleranza zero nei confronti del razzismo. L’obiettivo della riforma di polizia era indicato nell’eliminazione del pregiudizio razziale e dello svantaggio a danno di alcuni gruppi e la dimostrazione di equità in tutti gli aspetti del servizio di polizia e il sistema giudiziario. Le conclusioni cui portò il rapporto giudicarono il comportamento della polizia come il risultato di: incompetenza professionale razzismo istituzionale fallimento di leadership dei capi Le settanta raccomandazioni che ne seguivano riguardano questi ambiti: Migliorare il sistema di segnalazioni e registrazioni Collaborare di più con le comunità e le altre agenzie Fissare standard per investigare casi di razzismo Adottare un diverso modo di rapportarsi alle vittime e alle loro famiglie Produrre nuove regole per gli Stop & Search (fermi a piedi a scopo di controllo) Formare efficacemente all’antirazzismo e contro le discriminazioni tutti gli operatori e dirigenti di polizia, dunque non limitandosi più alla mera “sensibilizzazione” al tema Inserire esperti di anti-discriminazione e membri della comunità nella formazione Selezionare meglio il personale Monitorare regolarmente le attività ed essere sempre trasparenti nel proprio agire Riportiamo alcuni esempi che dimostrano in quale misura le raccomandazioni sono state messe in atto. Le Polizie di Inghilterra e Galles adottarono da subito (la Scozia seguì a breve) una nuova definizione di caso di discriminazione razziale che guidasse gli operatori nel registrare gli eventi e dare seguito alle azioni necessarie: “(E’ un caso di razzismo) qualsiasi episodio che venga percepito dalla vittima, o da chiunque altro, come un caso di discriminazione razziale, a prescindere da qualunque voce contraria.” Benché questo tema sia trattato più diffusamente nel capitolo 5,si vuole qui richiamare l’attenzione del lettore a una questione centrale: l’operatore di polizia che venisse a conoscenza di un caso di sospetta discriminazione 140 avrà l’obbligo di registrarlo come tale, se tale lo percepisce, anche nel caso in cui la vittima o i testimoni avessero opinione contraria, pensassero cioè non trattarsi di discriminazione o di crimine d’odio. Questa definizione operativa di discriminazione, razzismo o crimine d’odio è stata adottata anche da altre polizie europee (Olanda, Belgio, per esempio), nello stesso periodo. La revisione radicale delle procedure di Stop & Search fu un altro esito dell’inchiesta parlamentare, revisione condotta in piena collaborazione con rappresentanti delle comunità di minoranza etnica, con l’esito di produrre un manuale che espone le nuove regole e i diritti e doveri di entrambe le parti. Oggi, la Polizia Metropolitana di Londra, per es., redige rapporti mensili sulle azioni di Stop & Search in ciascun 140 Come già più volte ribadito, anche questo concetto serve per altri campi di discriminazione. 135 quartiere della città, producendo elaborazioni statistiche che permettono di conoscerne la ragione, la durata,le conseguenze e l’origine etnica delle persone controllate. Queste informazioni sono ovviamente pubbliche, rispondendo al dovere di accountability (“rendere conto”) dell’istituzione poliziale nei confronti della propria comunità di riferimento. Infine, fu introdotta la grande riforma della polizia e di tutta l’amministrazione pubblica, l’Equality Standard (legge sulle uguali opportunità) che impone di essere attivi contro le discriminazioni e nella buona gestione delle diversità. Il rapporto Macpherson accettò e sottoscrisse l’affermazione dell’allora Commissione per l’uguaglianza razziale (CRE) che il fenomeno del razzismo istituzionale non esiste solo nella polizia ma in qualunque altra istituzione. Il governo di Jack Straw decise, in seguito, di allargarea tutta la pubblica amministrazione, al sistema sanitario, alla scuola, al mondo dello sport, il tracciato segnato per la polizia dal rapporto Macpherson. Oggi in tutto il Regno Unito qualsiasi istituzione pubblica, in base ad una modifica apportata nel 2000 alla legge sulle relazioni razziali (Race Relations Act), è tenuta non solo a non discriminare ma altresì a promuovere attivamente le pari opportunità e il pari trattamento e a renderne conto pubblicamente. Ciò si applica anche alla polizia. Una commissione di lavoro, in ventiquattro mesi, produsse l’Equality Standard per gli enti locali (1995), un obbligo di legge che ha subito negli anni alcune revisioni, basate sulle sperimentazioni e valutazioni della sua prima applicazione negli enti locali. L’ Equality Standard fu dapprima sviluppato come strumento per mettere in grado gli enti locali (e le altre istituzioni) di realizzare il mainstreaming di genere, razza e disabilità nelle politiche e nelle pratiche locali ad ogni livello. Lavorando attraverso lo Standard, gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche (sanità, scuole, sport, ecc.) identificano gli svantaggi associati al genere, alla disabilità e alle altre categorie protette e si adoperano per eliminare le barriere che creano lo svantaggio. Nella prima versione dell’Equality Standard furono fissati cinque livelli all’interno dei quali le istituzioni, attraverso un sistema analitico guidato, dovevano posizionarsi inizialmente per produrre un piano d’azione che potesse loro permettere di passare al livello superiore nella prevenzione delle disuguaglianze e delle discriminazioni e nella gestione delle diversità. I cinque livelli : I. Impegno dichiarato sull’equità II. Valutazione della situazione di partenza e consultazione con la comunità III. Piano d’azione con obiettivi e beneficiari identificati IV. Sistema di monitoraggio e indicatori V. Valutazione e revisione degli obiettivi Per sviluppare il proprio Equality Standard, l’Agenzia nazionale per il miglioramento della linea politica della Polizia (NPIA) avviò ampie consultazioni all’interno del servizio di polizia stesso e con le rappresentanze sindacali, le associazioni dei funzionari, le associazioni impegnate contro le discriminazioni e per le pari opportunità e i membri delle comunità. Il caso Emmanuel Bonsu, Parma, 28 settembre 2008 141 Emmanuel è un ragazzo nero, residente a Parma, che,alle ore 18,25 del 28 settembre 2008, fu bloccato e picchiato in un parco cittadino dalla Polizia Municipale (dapprima 3 operatori in borghese, poi un quarto in divisa) che lo scambiò per un pusher. Emmanuel, come confermarono dei testimoni, non oppose resistenza ma si diede a una fuga disperata, credendosi vittima di un attacco razzista. Raggiunto, fu picchiato e calciato mentre era a terra raggomitolato su se stesso per difendersi dalle botte. Dichiarò poi di essersi sentito “meglio”, mentre lo picchiavano, quando arrivò il poliziotto in divisa perché capì che si trattava della polizia, confidando per questo che tutto si sarebbe rapidamente concluso e chiarito. Portato in cella, fu invece denudato, fotografato come se fosse un trofeo, con la busta contenente i verbali e la scritta “Manuel NEGRO”. Più volte fu chiamato “scimmia” e costretto a muoversi come una scimmia.I poliziotti caricarono le foto sul computer, cancellandole poi maldestramente, tanto da poter 141 La vicenda di Emmanuel Bonsu è stata ricostruita confrontando gli articoli di La Gazzetta di Parma, La Repubblica (pagine locali) e Il Fatto Quotidiano. 136 essere ritrovate dagli inquirenti. Racconterà Manuel:“Mi hanno perquisito. Prima, al parco, mi avevano svuotato le tasche e preso il cellulare, la tessera dell’autobus, la tessera della biblioteca e qualche moneta. [Poi, al comando]mi facevano girare fuori e dentro, fuori e dentro dalla cella. Avevo paura. Mi hanno obbligato a fare delle firme ma io mi sono opposto più volte, volevo chiamare a casa”. Alla fine Emmanuel cedette e firmò il verbale. Il padre (contattato solo alle 23) arrivò a mezzanotte e, sotto shock, appena vide il figlio, chiese ragioni agli agenti del comando che giustificarono le ammaccature e le ecchimosi con un’incredibile “caduta”. Il padre si infuriò, chiese spiegazioni ma gli venne detto di andarsene e fu letteralmente buttato fuori dal comando. All’uscita, intorno alle 3, al padre fu consegnata la busta con lo stemma del Comune di Parma: conteneva i verbali, con sopra la scritta “Emmanuel negro”. Condotto all’ospedale, Emmanuel avrebbe subito successivamente alcuni interventi all’occhio. In tribunale il giovane Bonsu chiarì che un poliziotto in borghese «Ha messo i piedi sulla mia testa…quando ero per terra, questo qua mi ha puntato la pistola, continuava a picchiarmi, ha detto negro di merda…poi ha detto che aveva proprio la voglia di spaccarmi la faccia». Il 30 settembre 2008 la famiglia Bonsu, con il verbale, la busta, il referto dell’ospedale, denunciò l’accaduto ai Carabinieri. Nello stesso giorno il Comune lanciò un comunicato stampa dove si congratulava con gli agenti per l’arresto di un famoso pusher nella zona dell’ex Eridania. Nessun cenno era fatto a ciò che era accaduto a Emmanuel e alla sua denuncia. La polizia sostenne che si era trattato di un “fermo movimentato”, negò gli insulti razzisti, le violenze e le umiliazioni, accusando Bonsu di essere un palo dello spacciatore. Tuttoquesto venne smentito dai testimoni,che smentirono anche il fatto che gli agenti si fossero qualificati. Contro Emmanuel Bonsu fu formulata un’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto di mostrare le proprie generalità. Il 14 gennaio 2009 quattro dei dieci vigili indagati furono arrestati e posti agli arresti domiciliari, gli altri sei sospesi dal servizio. Le accuse ai quattro, pesantissime, furono spiegate così dal Procuratore Capo Gerardo Laguardia: “Forse quei vigili non hanno capito la gravità delle accuse. Li abbiamo arrestati dopo una lunga indagine, ci siamo andati con i piedi di piombo, ma era necessario impedire loro di continuare a lavorare al comando. Le accuse sono violenza privata, perquisizione arbitraria, falso, calunnie, e soprattutto sequestro di persona”. E poi l’aggravante: “Discriminazioni razziale, odio etnico o razziale” spiegò il procuratore. Alla domanda posta dai giornalisti al Procuratore capo Laguardia “ Il Comune ha collaborato?”, la risposta secca del magistrato è “No”. Qualche giorno dopo l’Assessore alla sicurezza Monteventi si dimise. Nei mesi successivi, i quattro vigili avrebbero lasciato i domiciliari e sarebbero stati trasferiti a mansioni di segreteria in vari uffici dell’Amministrazione. Il sindaco Vignali accusò Emmanuel Bonsu di avere scritto di suo pugno “negro” sulla busta. Il Comune di Parma è stato anch’esso chiamato in giudizio perresponsabilità civile.Nell’ottobre 2011 la sentenza del Tribunale di primo grado ha condannato sette operatori di Polizia Municipale fino ad un massimo di 7 anni e 9 mesi e al risarcimento di 135.000 euro. Dopo il caso Emmanuel Bonsu Il caso Bonsu permette molti approfondimenti che, confidiamo, potranno essere parte di diverse discipline nei corsi proposti dalla Scuola Interregionale di Polizia locale, da altri istituti di formazione e nei comandi di Polizia Locale. E’ ormai trascorso un lasso di tempo sufficiente a riconsiderare l’evento con il distacco che un fatto così doloroso non permetteva nell’immediato; oggi possiamo affrontare con gli strumenti della professionalità dell’operatore di polizia un episodio che, pur non avendo per fortuna l’esito drammatico del caso Lawrence, permette molte e significative conclusioni. Soprattutto, permette di mostrare che le Polizie Locali avrebbero la capacità e l’etica professionale per rendere trasparente il proprio operato, così come in Italia non avviene normalmente per altre forze di polizia e così come avviene invece molto più normalmente all’estero. Permette di ragionare sulla necessità per la Polizia Municipale di guadagnare fiducia offrendo trasparenza e mostrando che l’Istituzione Polizia Locale è sempre dalla parte del cittadino, anzi dei cittadini nella loro ampia gamma di diversità. 137 Nella scienza della gestione delle risorse umane un episodio come questo si presenta come un “caso critico” (si badi: non un caso di critica): l’occasione per la dirigenza di analizzare con precisione e onestà l’accaduto assieme ai propri operatori, cogliendone gli insegnamenti da trasformare in cambiamenti nelle prassi, nelle procedure e nelle regole. Il caso Bonsu ci pone alcune domande ineludibili: a) In base a quale modo di operare ha agito la Polizia Municipale? Quali sono i doveri di un operatore di PM in un caso come questo? b) C’è razzismo nell’episodio Bonsu? C’è discriminazione? C’è qualcosa che è sanzionato dalle leggi italiane? Quali leggi? c) Avrebbero potuto agire diversamente il comando di PM della città, il Sindaco, l’Assessore alla sicurezza? d) Che impatto ha avuto sulla collettività quell’episodio? Che impatto ha avuto sugli stessi operatori di polizia? Crediamo che le domande trovino risposte adeguate nei diversi capitoli di questo libro. Qui vogliamo porre alla vostra attenzione due diverse questioni: per un verso, l’effetto gravemente negativo che l’episodio ha sulla coesione sociale in città; per l’altro, la difficoltà da parte della polizia a trattare l’incidente come caso critico dal quale apprendere comportamenti diversi e un diverso approccio istituzionale. Non sarà sorprendente sapere che l’episodio ebbe su Emmanuel un effetto così negativo da cambiarne profondamente il carattere, tanto che i suoi insegnanti e i familiari denunciarono, a due anni dall’evento, che Emmanuel si era chiuso in un profondo silenzio, non andava più a scuola, aveva paura e non usciva più. Dobbiamo però considerare anche l’impatto sulla città. Da un lato gruppi di persone di origine straniera si coalizzarono dietro l’unica, comune, bandiera di “extracomunitari”, di “stranieri” (specie le persone di origine africana), superando le loro interne differenze, in conflitto con la società autoctona, particolarmente dopo le dichiarazioni del Sindaco e dell’Assessore che elogiarono l’azione antidroga della PM, tacendo su tutto il resto. Dall’altro, fomentati anche dall’opacità con cui il caso fu trattato, si formarono gruppi il cui slogan era “sono vigile dentro”, frase che intendeva elogiare le azioni muscolari della polizia contro gli “stranieri”; circolarono dichiarazioni del tenore “non è razzismo, avranno delle ragioni”. Per contro, anche nella popolazione autoctona si aprì una spaccatura: su un fronte, i residenti che giudicavano vergognoso il comportamento della polizia e delle autorità comunali, con parole anche più forti e amare di quelle espresse dagli “africani”; sull’altro, i difensori ad oltranza dei poliziotti anti-immigrati. Insomma, il caso si è riverberato negativamente sulla città e ha seriamente minacciato la sua tenuta sociale. Sull’altro versante della riflessione che proponiamo sta l’occasione perduta dalle polizie locali (e non intendiamo solo quella di Parma) di cogliere l’ “occasione” (se così si può dire) per trattare il caso e fare di esso un incidente da cui apprendere, per dare impulso a una revisione generale dell’approccio dell’istituzione al servizio di polizia in una società multiculturale, multietnica, differenziata e plurale. Per meglio argomentare questo punto, ci riferiremo alla nostra esperienza nel Corso di aggiornamento per Comandanti di Polizia Municipale e Provinciale tenuto dalla Scuola nella primavera del 2012, dove eravamo stati chiamati a trattare del tema delle discriminazioni e della gestione delle diversità. Da un brevissimo questionario distribuito in apertura dell’intervento e compilato da 51 comandanti risultò quanto segue: > Metà dei comandanti (7 dei quali emiliani) non conosceva il caso Emmanuel Bonsu e solo 7 includevano la parola discriminazione nel racconto dell’accaduto. > Coloro che conoscevano il caso Bonsu consideravano la prima parte dell’operazione (cattura nel parco cittadino) un “semplice” e “accettabile” errore di valutazione, mentre non accettavano di prendere in considerazione l’ipotesi di operazione guidata da “profilazione etnica” (ethnic profiling, v. cap. 6.3), concetto chiaro a tutte le polizie d’Europa, ancorché dibattuto. > Solo 3 comandanti sapevano che esistono delle leggi in Italia che puniscono la discriminazione, sia sul piano del diritto civile sia sul piano del diritto penale, e che indicano con chiarezza i pubblici ufficiali come possibili autori di atti discriminatori. 138 > La parità di genere è ritenuta da molti incomprensibile e ingiustificabile, specie se applicata alla propria professione. Una sola persona aveva sentito parlare del “soffitto di vetro”, la metafora che indica l'ostacolo invisibile che incontra la donna nell'ambito del lavoro, laddove intraprenda azioni per progredire in carriera 142. Per fortuna, il tavolo di confronto ha mostrato che le cose sono cambiate anche in alcune Polizie Locali e nella mentalità di alcuni poliziotti, probabilmente tanti. “Mi sono trovato meglio a collaborare con colleghe donne. Non è una battuta, è la realtà. Prima, 36 anni fa, erano comuni frasi come “Ma vai a fare la calza” e quindi le colleghe, che dovevano giustamente difendere il proprio ruolo, potevano avere una punta di aggressività in più. Poi sono scomparse altre problematiche, e alcune specifiche caratteristiche delle donne aiutano… la sensibilità, la furbizia. E’ importante porsi in maniera tranquilla, usare la gentilezza con la comunità cinese e le altre comunità, non prendere degli atteggiamenti per comportamenti falsi.” Operatore di PM, Tavolo di confronto 3. Riprendiamo in questo testo quel che avemmo occasione di chiarire allora. Non interessa qui solamente, né principalmente, accusare e condannare un drappello di operatori di Polizia Locale secondo la facile sentenza delle “mele marce” o anche di parzialmente assolverli “perché nella concitazione di una cattura non si può guardare per il sottile”. Si tratta di capire cosa ha sbagliato l’istituzione, se si è macchiata di discriminazione istituzionale e se, conseguentemente, ha preso tutte le misure per riformare il proprio agire. Pensiamo che, se la gestione della diversità e il contrasto al razzismo (e alle altre forme di discriminazione come l’omofobia, il sessismo, ecc.) fossero assunte come elemento di mainstreaming nella politica, nella strategia e nelle azioni delle Polizie Locali, le Polizie Locali avrebbero allora preso in considerazione almeno questi punti come elementi strutturali su cui intervenire: 1. Capacità di gestione: analisi dell’incidente critico. Il caso Bonsu è da considerare “incidente critico”, oggetto perciò di analisi accurata, perché è importante studiare quel che va bene per poterlo ripetere ma è ancor più importante, per un dirigente e il suo staff, studiare quel che va male affinché si possano mettere in atto azioni correttive. 2. Fermezza dal punto di vista etico e deontologico. Intendendo per etica l’aspetto personale dei valori che muovono ciascuno e per deontologia quell’etica che riconosce i valori, gli obiettivi e gli standard comuni della professione di polizia, la polizia deve approfondire quanto l’etica personale di alcuni operatori sia in contrasto con la deontologia professionale e fino a che punto questi riconoscano come limite alla propria azione il rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo, in particolare del divieto di discriminare come uno dei fondamenti dell’agire di polizia 143. 3. Superamento dell’autoreferenzialità e pratica della trasparenza. Da anni molte polizie europee lavorano con soggetti non-colleghi per comprendere come, dall’esterno, possano essere viste certe loro pratiche. In Gran Bretagna, per esempio, si chiamano “community contributors”; più di un decennio fa il responsabile delle azioni di contrasto alle discriminazioni della Polizia di Rotterdam (Olanda) trascorreva gran parte del proprio tempo lavorativo nell’ufficio dell’associazione RADAR (il più grande centro per la raccolta di segnalazioni di discriminazione a Rotterdam) per rendersi conto di persona e apprendere a lavorare sulle discriminazioni, fissando tra la polizia di Rotterdam e l’organizzazione RADAR un meccanismo per lo scambio regolare di dati, informazioni e buone 142 In quella circostanza era stata da me inserita una domanda sulla discriminazione di genere (argomento già trattato da tempo anche in Italia), ed in particolare sul concetto di “soffitto di vetro” (certamente un esempio di discriminazione strutturale), per arrivare gradualmente a trattare quello di discriminazione istituzionale,per rendere più semplice la comprensione del carattere escludente della discriminazione e per suggerire che la polizia (come qualunque altra organizzazione) deve preoccuparsi di non discriminare all’esterno, come all’interno della propria struttura. 143 Artt.3, 25,36, 40,44 del Codice Europeo di Etica per la Polizia (CEEP) e Carta di Monticiano “La Polizia locale è garante dei diritti del cittadino, con particolare attenzione ai soggetti deboli”. 139 pratiche. Nella nostra esperienza abbiamo, invece, notato una franca insofferenza a intrusioni esterne che non sono percepite come pienamente legittime. Un filo lega questo aspetto alla mancanza di trasparenza del dibattito, se dibattito si è avuto in qualche comando di polizia, e delle conseguenze che la polizia ne ha tratto. 4. Processo di riforma dell’agire di poliziache spiegasse alle comunità gli errori compiuti e le azioni correttiveidentificate per il breve, medio e lungo periodo. 140 8.3 GESTIRE LE DIVERSITÀ Per gestire al meglio le diversità dentro la polizia e da parte della polizia nei confronti della comunità che essa serve, basta applicare a questo tema gli strumenti di una corretta gestione delle risorse umane. Ben poco è da inventare; gli elementi fondamentali restano i seguenti: l’impegno e l’esempio del vertice. la descrizione di partenza della situazione aziendale: a) raccolta di dati sulla composizione dello staff, disaggregato sulla base della sua diversità; delle progressioni di carriera; della capacità dell’organizzazione di trattenere il personale, specie il più capace; b) raccolta di dati sulla comunità: la sua composizione etnica, le associazioni di persone a rischio di discriminazione sul territorio; le istituzioni o organizzazioni che raccolgono segnalazioni di discriminazione; le discriminazioni segnalate, ecc. l’identificazione delle aree critiche: analisi delle politiche, delle procedure e delle prassi, alla luce delle diversità e dell’imperativo di non discriminare la definizione degli obiettivi, della strategia e degli indicatori di risultato la progettazione dell’intervento (piano d’azione) Il monitoraggio, la valutazione e la riprogrammazione Nei paragrafi seguenti, descriviamo le aree d’intervento da considerare, portando esempi di buone pratiche messe in atto da polizie di diversi Paesi. Gli esempi sono tratti da esperienze personali e dal testo Promoting diversity and preventing discrimination in police forces (Promuovere la diversità e prevenire la discriminazione nelle forze di polizia) 144. 8.3.1 Elaborare una dichiarazione d’intenti o un codice etico E’ certo che una dichiarazione d’intenti o di missione o un codice etico possono rimanere parole vane se non esiste tutto il resto che deve renderle concrete, se non c’è nessuno che debba rendere conto della loro applicazione e della verifica su questa applicazione. Nei passaggi successivi elencheremo tutti quegli elementi che serviranno a far sì che le dichiarazioni non siano parole al vento. Va però chiarito sin d’ora che l’opinione condivisa da esperti di gestione delle diversità, da manager delle diversità(dentro e fuori le polizie) e da gran parte delle organizzazioni che combattono le discriminazioni,è che le dichiarazioni di missione e visione, i codici di condotta e i codici etici hanno un loro valore intrinseco e un loro impatto. Una Carta della diversità è un documento breve, sottoscritto da un’organizzazione, nel nostro caso dall’istituzione pubblica Polizia Municipale di una città o dal livello regionale. Esso delinea brevemente le misure che la polizia intraprende per promuovere la diversità e le pari opportunità nel posto di lavoro e nel contatto con i cittadini, specie relativamente a razza o origine etnica, orientamento sessuale, genere, età, disabilità e religione. Deve assicurare che il reclutamento e la selezione degli operatori avviene attraverso direttive e pratiche non discriminatorie e che la stessa selezione e la formazione sono mirate a inserire e mantenere nel corpodi polizia individui in grado di rispettare i principi di un servizio di polizia democratico in uno stato democratico. Questi strumenti di gestione servono agli scopi di chiarire all’interno e all’esterno che la polizia non opera discriminazioni e si adopera piuttosto per il rispetto e la valorizzazione delle diversità, spiegando insomma la posizione dell’istituzione al riguardo. Una dichiarazione d’intenti, pubblica e bene pubblicizzata, è il modo migliore per fare arrivare il messaggio. Un altro scopo è di esercitare influenza sulla cultura di quel servizio di polizia, attirare utenti e dipendentiper accrescerne la fiducia. 144 PROMOTING DIVERSITY AND PREVENTING DISCRIMINATION IN POLICE FORCES è il prodotto finale del progetto “Minority Representation in Police Organisations – Transnational Measures for the Exchange of Information and Good Practice” nov. 2004, progetto finanziato dall’Unione Europea. 141 Il modo migliore per procedere alla definizione di un codice etico o una dichiarazione d’intenti è di coinvolgere in partenza tutti gli interessati:, in special modo, gli operatori di polizia e i rappresentanti di cittadini e di associazioni attive sul tema. In ogni caso, i dipendenti devono essere pienamente consapevoli del processo e dei contenuti perché sono coloro che mettono in pratica gli obiettivi dell’organizzazione e, indipendentemente dalla posizione che ricoprono, devono sentiredi contribuire alla strategia complessiva per poterla poi applicare con piena consapevolezza.La Carta può enunciare solo i principi fondamentali (politici, etici) dell’organizzazione ma può spingersi anche ad enucleare principi guida molto pratici. I dirigenti e i supervisori devono organizzare e seguire questo processo promuovendo la formazione del personale, curando il materiale informativo e avendo cura di procedere conil continuo coinvolgimento di tutti (per es.: seminari introduttivi per il nuovo personale). BUONE PRATICHE Codice etico - Corpo Nazionale della Polizia di Spagna (Spagna) “Articolo 20- Principio di uguaglianza e di non discriminazione. 1-La polizia deve offrire il suo servizio senza alcun tipo di discriminazione di origine, lingua, razza, etnia, religione, credenze, sesso, età, ideologie, disabilità o condizione sociale. 2-La polizia deve svolgere le proprie funzioni in maniera equa, attenendosi ai principi di imparzialità e di non discriminazione. In particolare dovrà porre attenzione al linguaggio utilizzato, al comportamento e a tutti quegli aspetti della comunicazione verbale e non verbale che possono indurre una sensazione di comportamento discriminatorio. 3-Nelle interazioni dovrà rispettare allo stesso modo tutti gli individui o gruppi di cittadini, le loro tradizioni, il credo e gli stili di vita, fintanto che siano compatibili con la legge e che non comportino un’alterazione della sicurezza urbana.” Nel Decalogo che chiude il codice con i 10 principi fondamentali che devono ispirare il comportamento della polizia e dei poliziotti, al punto 6 si dice: “6-Evitare qualsiasi discriminazione per questioni di razza, etnia, religione, credo, sesso, età, ideologia, disabilità o qualunque altra di natura simile.” Il nostro obbligo di legge per le pari opportunità – Polizia della Contea di Northumbria (Gran Bretagna) “La Polizia di Northumbriaha l’obiettivo di includere i diritti umani e le pari opportunità in tutto ciò che possa servire per offrire un servizio che vada incontro alle necessità dei cittadini e supporti la propria organizzazione. (…) Per adempiere a questo obbligo, la Polizia di Northumbria deve tenere in considerazione la necessità di: A-Eliminare la discriminazione, le molestie (di stampo sessuale o razzista, ndr), la vittimizzazione ed ogni altra condotta proibita dal patto. B-Assicurare uguali opportunità tra persone che hanno caratteristiche protette e non. 1-Le caratteristiche protette tutelate dall’”Equal Duty” sono: età, disabilità, ricollocazione di genere, unioni civili e matrimoniali, gravidanza e maternità, razza, religione o credo, sesso e orientamento sessuale. 2-Favorire le relazioni tra persone in possesso di caratteristiche protette e chi non ne ha (cioè non è a rischio di discriminazione, ndr). Sotto questi doveri specifici, la Polizia di Northumbria deve: 1-Pubblicare sufficiente materiale informativo che mostri come essa assecondi l’obbligo delle pari opportunità. 2-Preparare e pubblicare obiettivi di uguaglianza e pari opportunità. La forza di polizia deve inoltre: 142 1-Considerare le informazioni che sono pubblicate internamente e a livello nazionale prima di preparare i propri obiettivi. 2-Assicurarsi che gli obiettivi siano specifici e misurabili. 3-Disporre le modalità di misurazione dei progressi. Come pubblica autorità, il servizio di polizia non deve mai agire in modo incompatibile con la Legge sulle pari opportunità eil Police and Crime Commissioner (PCC) 145 ha il dovere di supervisionare le loro azioni.” 8.3.2 Preparare il personale a lavorare in un ambiente di lavoro aperto alle diversità La preparazione del personale avviene attraverso l’informazione e la formazione, lo sviluppo della cultura della polizia e l’attivazione di piani di contrasto alla discriminazione. La formazione è uno strumento importantissimo ma deve valere per tutti. Anche chi risponde al telefono o è addetto alla ricezione delle persone deve aver avuto la possibilità di riflettere sugli stereotipi e sulle discriminazioni nei confronti dei rom o dei transessuali. Non basta però un’occasione di formazione. Come per qualunque altra competenza di un operatore di polizia, anche le conoscenze, le competenze e gli atteggiamenti acquisiti nella prima formazione vanno periodicamente “rinfrescati”. Non è inoltre questo l’unico limite di una formazione una tantum, isolata da altre misure; come abbiamo più volte ripetuto, è necessario creare un ambiente dove i lavoratori si sentano liberi e sicuri di discutere tali questioni, dove anche un’opinione discriminatoria possa essere (nei momenti, nelle sedi e con i modi opportuni) espressa e presa in considerazione e portata alla riflessione comune. E’ necessario un luogo di lavoro dove i dirigenti e i supervisori sono d’esempio, dove si controlla e si valuta, dove i sindacati sono coinvolti e incoraggiati a fare proposte su come combattere la discriminazione e dove si ricerca lo sguardo e la valutazione esterna di associazioni che combattono le discriminazioni. Siccome è molto più facile e meno costoso aggiungere qualche giorno di servizio per la polizia piuttosto che cambiare la struttura nella quale si opera, il rischio più alto è che si punti sulla formazione come panacea per la soluzione di ogni problema. Ciò ci costringe a porre ancor più attenzione alla formazione che è impartita. La Carta di Rotterdam 146 fissa nove punti per la formazione degli agenti di polizia, di cui a noi preme ricordare i seguenti quattro: La formazione come strumento per stimolare l’impegno Ovviamente, gli agenti di polizia devono essere convinti della necessità di trasformare il carattere monoculturale delle forze di polizia in senso multiculturale a tutti i livelli dell’organizzazione. La formazione può essere uno strumento efficace per stimolare tale impegno, migliorando la comprensione del ruolo della polizia come agente di coesione della società. L’atteggiamento degli agenti di polizia nei confronti di questi cambiamenti e il loro impegno nel portarli avanti è essenziale nel determinarne il successo. 145 Il Police and Crime Commissioner è un corpo eletto incaricato di garantire un servizio di polizia efficiente ed efficace di un territorio in Inghilterra e Galles. I primi rappresentanti furono eletti nel novembre 2012, sostituendo le Autorità di polizia ora abolite. 146 La Carta di Rotterdam. Il servizio di polizia nella società multietnica. Documento redatto alla Conferenza di Rotterdam, 30 maggio-1 giugno 1996. Durante la conferenza, un gruppo di 120 partecipanti (operatori di polizia, associazioni di persone di origine etnica minoritaria, associazioni di lotta contro le discriminazioni, funzionari di amministrazioni locali, nazionali ed europei) discussero e approvarono la Carta che diventò in seguito una guida per le polizie di buona parte d’Europa. La Regione Emilia-Romagna ne curò una traduzione assieme a COSPE e Dipartimento della Pubblica Sicurezza che è scaricabile dal sito della Scuola Interregionale di Polizia Locale SIPL. 143 Le scuole di formazione della polizia devono anticipare Il reparto operativo della polizia non è l’unico responsabile della trasformazione di un’organizzazione monoculturale in senso multiculturale. Per adattare le pratiche di formazione ad affrontare un ambiente di lavoro multiculturale, le scuole di formazione della polizia devono avvalersi delle esperienze reali degli agenti di polizia. Formazione di base La formazione di base dovrebbe trattare anche di temi quali il riconoscimento degli elementi di comportamento razzisti, comprenderne l’importanza ed imparare a reagire in modo professionale. Questo include l’acquisizione di competenze per il trattamento delle denunce di incidenti di razzismo. Formazione in partenariato La polizia deve coinvolgere ONG e/o appartenenti alle comunità etniche minoritarie nei programmi di formazione, in quanto sono anch’essi utenti dei servizi di polizia. Inoltre, dovrebbero essere coinvolti in programmi di formazione per formatori sui vari aspetti della diversità culturale. BUONE PRATICHE Sviluppo della leadership - Polizia della Contea di Stoccolma (Svezia) Tutti i capi della polizia appena nominati all’interno del Dipartimento di Polizia della Contea di Stoccolma devono frequentare un programmadi sviluppo della leadership, di durata annuale.L’addestramento consiste in diversi moduli, dove vengono affrontati ed evidenziati vari aspetti della gestione del personale. La Polizia di Stoccolma ha da tempo incluso un modulo di comunicazione interculturale e di gestione delle diversità all’interno del programma di formazione obbligatoria di base e tiene seminari su questioni relative alle diversità per l’intero team di direzione. E’ già un fatto acquisito da anni la formazione sulle diversità di gruppi particolarmente importanti per la buona gestione della diversità come, per esempio, il personale addetto alla ricezione del pubblico e chiunque abbia contatti intensi e diretti col pubblico nell’attività quotidiana. Strategia per la diversità 147– Polizia della Contea di Northumbria (Gran Bretagna) “Scopi e obiettivi. L’efficace applicazione della Strategia per la diversità raggiungerà questi scopi: > Una direzione strategica chiara e una forza lavoro condotta e gestita con competenza. > Una cultura inclusiva dove gli individui si sentono sostenuti, valorizzati e riconosciuti per il loro contributo. > Migliore accessibilità alle opportunità di lavoro, all’informazione e ai servizi di polizia. > Un ambiente di lavoro libero da pregiudizio, discriminazione, vittimizzazione e molestie. > Condizioni di lavoro giuste ed eque. > Un coerente e partecipato approccio alla valutazione e al miglioramento continuo. Avere una forza di polizia che rappresenti la comunità locale e che coinvolga efficacemente il nostro staff, il pubblico e le organizzazioni partner è fondamentale per permetterci di raggiungere questo obiettivo: fornire un servizio migliore ai clienti, aumentarne la fiducia e raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo posti per il 2020. Per questo la nostra strategia è la seguente: > Fornire un quadro operativo alla forza di polizia per promuovere l’uguaglianza, evitare le discriminazioni e promuovere relazioni positive tra lo staff, la comunità e i fornitori, in modo da 147 “Northumbria Police. Diversity strategy.” Data di pubblicazione sconosciuta. 144 attirare e mantenere in servizio individui di talento che riflettano il mix etnico e sociale della nostra comunità locale. > Fornire un approccio coordinato, coerente e duraturo per guidare ed integrare la diversità in tutti gli aspetti dell’attività principale, per offrire un servizio mirato per i clienti, di alta qualità, e che sia libero da pregiudizi, discriminazione, vittimizzazione e molestie. > Costruire sulle basi definite dal Northumbria Police Equality Scheme, riconoscendo i suoi limiti, andare oltre i requisiti legislativi, valorizzando tutti i bisogni degli individui, dei gruppi e delle comunità. La nostra visione è di rendere regolare 148 la gestione delle diversità all’interno dell’organizzazione per creare una cultura dell’inclusione che assicuri che la Polizia di Northumbria fornisca un servizio di polizia accessibile e di alta qualità, capace di riconoscere i bisogni degli individui per migliorare la fiducia della comunità e ridurre crimini e disordini. 8.3.3 Elaborare una procedura trasparente di assunzione del personale e di sviluppo della forza lavoro. Elaborare una procedura trasparente di assunzione del personale e della sua progressione in carriera è importante, perché tale procedura dimostra, all’interno e all’esterno, l’impegno dell’organizzazione a riflettere la società e le comunità per cui opera. Si potrebbe obiettare che in Italia si entra in polizia (qualunque servizio di polizia) attraverso concorso pubblico e anche molti passaggi di carriera sono scanditi da prove che selezionano le conoscenze e le competenze acquisite dall’operatore. Tuttavia non sorprenderà sapere che alla data di scrittura del manuale le donne che occupano il posto di Questore in Italia sono solo tre (Cuneo, Pavia e Palermo,unico capoluogo di Regione), mentre quelle che occupano la posizione di Comandante di Polizia Municipale in capoluoghi di Regione sono due (Firenze e Perugia). Eppure, è trascorso tempo a sufficienza da quando le donne fecero il loro ingresso in polizia (1981) “a parità di mansione e di carriera”, tempo sufficiente per maturare tutti i requisiti per accedere alle posizioni apicali. Qualcosa evidentemente non funziona nel meccanismo perché non sono poche le poliziotte che concorrono per i posti apicali, con competenze e voti altissimi nelle prove, ma nel computo finale esse sono raramente selezionate. Senza contare che poichél’Italia, di fatto, non applica misure che garantiscono la pari opportunità (come la possibilità di conciliare casa e lavoro),è arduo per una donna assumere un incarico di vertice in un Paese dove ancora è opinione e pratica sociale prevalente che la cura dei figli e degli anziani sia affidata alle donne invece che a entrambi i coniugi. Il tema si pone più seriamente per le donne nelle Polizie Municipali perché il loro ingresso in servizio avvenne negli anni Settanta, ancor prima che nella Polizia di Stato, grazie alle imponenti trasformazioni della società di quel decennio che modificarono la legislazione civile e penale; in quegli anni le strutture di Polizia Municipale cominciarono ad ammettere personale femminile, con mansioni e stato giuridico identici a quelli degli uomini. Proprio al riguardo delle pari opportunità di accesso delle donne nei corpi di Polizia Municipale è ormai un caso di scuola quello della PM di Rubiera (RE) (non l’unica ma la prima) che, circa un trentennio fa, pose l’asticella dell’altezza minima del poliziotto municipale a cm. 168. Il Comune perse una causa legale perché si poté dimostrare, con evidenza statistica, che il requisito violava la legge delle pari opportunità, costituendo un chiaro caso di discriminazione indiretta: non si stabiliva, infatti, formalmente che le donne non dovessero essere ammesse ma, nei fatti, il filtro avvantaggiava in modo del tutto sproporzionato gli uomini che sono mediamente più alti delle donne(per il concetto di discriminazione indiretta si veda il cap.5.3). Non fu possibile dimostrare che per essere un buon operatore di Polizia Municipale bisognasse essere alti almeno un metro e sessantotto centimetri perché, così com’è stato 148 “to mainstream” nel testo. 145 dimostrato da altre polizie, il personale deve essere selezionato su requisiti di performance come, per esempio, saper correre cento metri in un certo tempo, e non sull’altezza. Il caso potrebbe porsi anche per gli aspiranti poliziotti municipali non in possesso di cittadinanza italiana ma, per esempio, del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Vedremo in altro paragrafo casi, rilevati in altre nazioni, che hanno risolto questo apparente ostacolo. Mi auguro che ci sia presto un’evoluzione della società italiana e che altre etnie possano accedere alle forze dell’ordine. Operatore di Polizia, Tavolo di confronto, Sessione plenaria. E’ una questione che da noi non si pone, perché anche nella seconda generazione, vi è un fortissimo rifiuto a lavorare con le forze di polizia: per loro nessun extracomunitario dovrebbe lavorare con la Polizia. In Francia questo è possibile ma lì siamo alla quarta/quinta generazione. Loro ci vedono come persone da cui mettersi sulla difensiva. Il padre è sulla difensiva, il figlio è sulla difensiva e probabilmente anche il nipote lo sarà. Anche nella Polizia di Stato e nei Carabinieri ci sono solo pochissimi nordafricani, che sono in Italia dagli anni ‘80. Operatore di Polizia, Tavolo di confronto, Sessione plenaria. Dunque, una procedura equa e trasparente di selezione del personale e della sua carriera sarebbe un modo efficace per cercare di aumentare la componente di dipendenti provenienti da gruppi sottorappresentati. Un altro necessario elemento è l’accurata formazione di chi deve selezionare il personale e pubblicizzare il reclutamento con i canali e nei luoghi più appropriati per raggiungere un pubblico normalmente meno raggiungibile. Quest’ultimo strumento ci permette d’introdurre il concetto delle “azioni positive”, utili acompensare gli svantaggi che certe persone hanno per la loro origine etnica o razziale, genere, disabilità ecc., in modo da metterli veramente in una condizione di pari opportunità. Le istituzioni pubbliche intervengono da anni anche in Italia per promuovere le donne, esistono le quote per le persone disabili: le azioni positive sono molto importanti per acquisire credibilità come organizzazioni che promuovono la parità. Esse devono essere pubblicizzate e non taciute, trasparenti e giustificate, perché sono legali e necessarie per non discriminare ingiustamente. Le azioni positive possono essere classificate in: misure morbide Annunci di aziende (o strutture di Polizia Locale) che sollecitano l’invio di candidature d’individui sottorappresentati. Per es., in Ungheria si sono realizzati in questi ultimi anni dei campi estivi e sono state offerte delle borse di studio per reclutare rom nella pubblica amministrazione, compreso in polizia. misure dure Un’azienda che offre formazione professionale riservata ai lavoratori ultra-cinquantenni. La Commissione Europea, per es., offre tirocini riservati a laureati rom. Le azioni positive differiscono dalla discriminazione positiva, termine usato per misure che vanno oltre questi limiti. Sono uno strumento di discriminazione positiva le “quote”, per esempio in Italia le quote riservate alle persone disabili o le tanto discusse quote rosa in politica. Per citare un corpo di polizia, nella polizia dell’Irlanda del Nord esiste un sistema di quote per aumentare la percentuale di cattolici che non è proporzionata alla numerosità dei cattolici tra i cittadini. Guardando a un futuro non troppo lontano, è 146 possibile che si apra uno spazio in Europa per ammettere la discriminazione positiva nei confronti di rom, sinti e camminanti, notoriamente fra i gruppi che subiscono maggiormente discriminazioni di ogni sorta in Italia e nel complesso dell’Europa. Reclutato il personale, sarà poi necessario seguirlo costantemente e quindi monitorarne i dati oggettivi (chi lavora per l’organizzazione e in quale funzione, chi rimane e chi se ne va, chi è promosso e chi rimane fermo, ecc.) e usare strumenti qualitativi che indaghino le opinioni del personale. BUONE PRATICHE Corsi di preparazione per specifici gruppi di minoranze – Polizia della Contea di Stoccolma (Svezia) Alcuni gruppi di minoranza sono ampiamente sottorappresentati, e alcune volte completamente assenti, all’interno della forza di polizia di Stoccolma. La Polizia della Contea di Stoccolma quindi lavora insieme con le municipalità locali per creare uno speciale corso di preparazione per adolescenti appartenenti ad alcune comunità di immigrati. L’obiettivo è di fornire ai partecipanti competenze sia teoriche che pratiche, in modo che in futuro essi possano qualificarsi per sostenere le prove di ammissione all’Accademia di Polizia. Lo scopo è di aprire ai gruppi di minoranze etniche la professione di poliziotto. Partecipazione ad eventi tenuti da gruppi di minoranze – Polizia regionale di Haaglanden (Paesi Bassi) Molte minoranze hanno tradizionalmente un’immagine negativa della polizia. Agli occhi degli immigrati, dei gay e delle lesbiche la polizia rappresenta la maggior parte della società che vuole escluderli. Quindi il numero di candidati appartenenti a questi gruppi è davvero basso. Per avere un contatto con queste comunità, la polizia partecipa attivamente in eventi speciali ospitati proprio dai gruppi di minoranze, come parate gay e festival degli immigrati. Invitare le associazioni di immigrati ad osservare il lavoro della polizia – Polizia della Contea di Stoccolma (Svezia) Gli adolescenti delle comunità di immigrati in Svezia spesso si consultano coi propri genitori prima di scegliere una strada professionale o educativa. Quindi i genitori immigrati costituiscono un target importante per queste attività promozionali della polizia della Contea di Stoccolma. Un modo per avere un contatto con questo gruppo è attraverso la densa rete di associazioni di immigrati attive nella regione di Stoccolma. Comitati misti di selezionatori – Polizia della Contea di Stoccolma (Svezia) La Polizia della Contea di Stoccolma è conscia del rischio che i risultati del processo di selezione potrebbero essere non attendibili, se vi fosse la presenza di un solo genere all’interno dei comitati di selezione. Per minimizzare il rischio che le selezioni (ed i risultati) possano essere distorti dall’età e dal genere degli intervistatori, tutti i team di selezione presentano almeno una donna ed un uomo, generalmente con diverso grado ed età. Gli intervistatori sono addestrati dalla polizia della Contea di Stoccolma, in comunicazione interculturale e metodologie di selezione. 147 Miglioramento del processo di selezione e assunzione per le posizioni di comando – Polizia della Contea di Stoccolma (Svezia) Il reclutamento interno della Polizia di Stoccolma è stato, per lungo tempo, gestito in modo che la struttura interna del personale è rimasta identica, in evidente dissonanza con i cambiamenti sociali ed il crescente flusso di minoranze all’interno dell’organizzazione. Tra le altre cose, c’è stata una forte tendenza a reclutare “pescando dal proprio nido” quando si trattava di nominare nuovi capi e il giudizio di merito tra i candidati è stato largamente viziato da raccomandazioni da parte di superiori, invece che soggetto a un normale processo di selezione e qualificazione. Con l’intento di migliorare la qualità generale del processo di selezione, la Polizia della Contea di Stoccolma ha sviluppato ora uno standard di reclutamento basato sull’analisi della posizione e sul profilo comportamentale, e il personale addetto al reclutamento ha ricevuto un manuale per assolvere nel miglior modo il proprio compito. Uno scopo importante dei cambiamenti introdotti, a parte il migliorare la qualità generale del reclutamento, è stato anche quello di aumentare la fiducia delle minoranze nei confronti del processo di selezione per le alte posizioni all’interno dell’organizzazione, incoraggiandoli quindi a candidarsi per qualifiche superiori. 8.3.4 Fare della polizia lo specchio della società Una forza di polizia composta in maggioranza da uomini bianchi non riflette le diversità di una società, ed è quindi meno credibile ed identificabile in questo senso rispetto a quanto potrebbe essere una forza mista. Per affermare la propria importanza come forza legittima nell’odierna società diversificata, la polizia deve dimostrare capacità d’includere le diversità all’interno della propria organizzazione. Affermare che la polizia è specchio della società si riflette in un’ovvia concretezza numerica: indicache all’interno di una forza di polizia, donne, migranti, gay e lesbiche, ad esempio, sono proporzionalmente rappresentatinei differenti ruoli e occupazioni. La verità è che le minoranze etniche/razziali e omosessuali sono ancora poco rappresentate nelle organizzazioni di polizia, e trovare una donna che occupi una posizione prestigiosa è spesso eccezione piuttosto che regola. La diversità nella forza di polizia, e in qualsiasi altra organizzazione, è ovviamente qualcosa che non prende forma da sé. Tant’è che questa scarsa rappresentanza all’interno della polizia è spesso spiegata con le manchevolezze dei gruppi minoritari stessi: scarsa conoscenza linguistica, scarsa educazione, culture devianti (nel caso dei migranti), espressioni di stili di vita devianti (ad esempio persone con un differente orientamento sessuale), mancanza di ambizione (nel caso delle donne), ecc. Invece abbondanti studi dimostrano che vi sono almeno due possibili spiegazioni per questa scarsa presenza. La prima spiegazione trova il suo fondamento nei pregiudizi dei sistemi di reclutamento e di selezione del personale, che rende le organizzazioni meno accessibili ai membri appartenenti a delle minoranze. Il secondo motivo è il frequente ricambio dei membri delle minoranze causato da meccanismi discriminatori diretti e indiretti all’interno delle organizzazioni. BUONE PRATICHE La persona giusta per il posto giusto. Campagna per il reclutamento mirato – Polizia regionale di Haaglanden (Paesi Bassi) In Olanda, le forze di polizia hanno sempre avuto difficoltà nell’attirare candidati appartenenti alle minoranze. L’analisi dei dati sul reclutamento mostrò che negli anni ‘90 il numero di candidati stranieri era davvero basso, se rapportato alla popolazione di stranieri lavoratori. Per migliorare la situazione vennero istituite speciali campagne di reclutamento, mirate proprio alle persone straniere. A questo fine i 148 reclutatori inserirono nella loro campagna promozionale molte visite a moschee, caffetterie e luoghi di ritrovo informali, avvalendosianche dei network e dei media propri dei migranti. Il caso dell’Olanda, oggi La dichiarazione di missione della polizia olandese, come inserito nel quadro normativo nazionale, indica che la diversità non è più vista come una priorità (come specificato precedentemente nel Piano di lavoro per la Diversità della Forza di Polizia olandese 2001-2005) per avere raggiunto gli obiettivi che si erano proposti. Nonostante questo, il quadro normativo nazionale dichiara la diversità nella polizia una questione importante e addirittura fondamentale per mantenere la polizia informata sugli sviluppi nella società. La diversità all’interno della forza di polizia è anche considerata necessaria quando si tratta di adeguare e personalizzare il compito della polizia stessa. Ogni sezione della polizia, perciò, cerca di rappresentare la società diversificata e plurale e continuerà a monitorare il necessario aumento percentuale delle minoranze etniche e a prendere eventualmente azioni adeguate. Cambiare le strategie di comunicazione – Polizia della Contea di Stoccolma (Svezia) In seguito all’analisi del materiale informativo e divulgativo, la Polizia della Contea di Stoccolma è arrivata alla conclusione che il materiale prodotto non rifletteva il tipo di polizia eterogenea che essi volevano rappresentare. In generale, le immagini mostrano il poliziotto “tosto”, “macho”, che attraversa il fuoco e l’acqua, e troppo poca attenzione è data alle attività quotidiane, come l’assistenza al pubblico, la mediazione di conflitti, la presenza nella comunità. Per migliorare la situazione, la Polizia della Contea di Stoccolma sta ora lavorando ad una strategia che incrementi le possibilità di reclutamento di agenti con diversi background. L’obiettivo è di indicare chiaramente su tutti gli opuscoli, sui testi e nel materiale video che tipo di persona si stia cercando, ad esempio donne e uomini con vari background culturali e, allo stesso tempo, fornire un quadro realistico del lavoro quotidiano dei servizi di polizia. Chi comunica le informazioni è pure un aspetto importante;la Polizia sta quindi compiendo uno sforzo per assicurarsi che tutte le attività di reclutamento mirato svolte al di fuori dell’organizzazione (nei licei, in incontri di promozione per il reclutamento, ecc.) siano svolte da un gruppo misto di agenti che includa uomini, donne e appartenenti a minoranze etniche. Permettere agli stranieri di fare domanda per entrare in polizia – Polizia regionale di Haaglanden (Paesi Bassi) Avere la nazionalità olandese era un prerequisito per fare domanda per entrare nelle forze di polizia. Di conseguenza, chi non possedeva tale nazionalità non presentava nemmeno domanda. Basandosi sul fatto che, sebbene possedere la nazionalità olandese fosse per gli agenti di polizia requisito obbligatorio e definito dalla legge,tale obbligo nonfosse necessariamente esteso ai candidati per l’Accademia, oggi è permesso richiedere la nazionalità olandese dopo aver superato i test ed essere stati pre-selezionati per unirsi alle forze di polizia olandesi. 149 8.3.5 Approntare un sistema per le segnalazioni di reclami, lagnanze, denunce Molti ENAR Shadow Reports 149 (Rapporto ombra di ENAR- European Network Against Racism) ripetono che in tanti sistemi giudiziari e di polizia c’è una forte resistenza (se non aperto diniego) a riconoscere motivi razziali in certi atti di violenza e molestia. I rapporti che le ONG redigono evidenziano non solo la mancanza di sostegno alle vittime ma denunciano che troppo spesso le vittime diventano oggetto d’investigazione quando si presentano per segnalare gli attacchi che hanno subito o sono messe nella posizione di corresponsabilità, in quanto la molestia o l’attacco violento sarebbe stato provocato da loro perché la “mancanza d’integrazione” causa rabbia e frustrazione negli altri. Alcuni Stati riportano che le stesse forze della sicurezza si rendono autrici di molestie, abusi e violenza contro le minoranze ed è accertato che l’opinione diffusa che la molestia o l’attacco razzista (o omofobo) siano giustificati se un reato è stato commesso da un individuo di minoranza etnica fa sì che, in questo caso, le vittime tendano a non denunciare, rinunciando a difendere un loro diritto fondamentale. L’efficacia dell’investigazione della polizia e i rapporti che essa redige sono fondamentali affinché tutto quel che ne conseguirà dia la giusta importanza e il corretto riconoscimento della responsabilità degli autori. Va segnalato, però, che a differenza dell’Italia la gran parte delle polizie del Nord Europa hanno sistemi per la segnalazione di discriminazioni, sia interni (da parte dei propri lavoratori) che esterni (da parte del pubblico), con procedure chiare e semplici e facilmente accessibili anche dal web, con personale preparato a trattare questi casi. La MEP di Londra, per esempio, offre la possibilità sul proprio sito, con due semplici click, di denunciare un caso di reato d’odio. E’ importante, inoltre, siglare accordi con associazioni, affinché i casi che sono loro segnalati di discriminazioni subite da parte di personale di polizia possano essere comunicati con rapidità alla polizia, in modo che essa possa prendere immediatamente i provvedimenti che il sistema interno prevede in questi casi. Al capitolo 9 approfondiremo come agire nel caso una persona si presenti a voi per denunciare una molestia razziale o un caso di violenza. Qui ci limitiamo a indicare le tappe fondamentali per approntare una procedura interna che accolga e tratti le segnalazioni di supposte discriminazioni all’interno dell’organizzazione: Descrivere procedure per segnalazioni informali e formali Indicare il personale di riferimento Istruire il personale per le indagini Informare tutto il personale della procedura e del sistema messo in atto Indicare una procedura per istruttoria informale Indicare una procedura per istruttoria formale Come condurre i colloqui Redigere i verbali Le azioni disciplinari ed eventuali servizi di counselling per la vittima e per l’autore. BUONE PRATICHE Centro di competenza sulle diversità – Polizia regionale di Haaglanden (Paesi Bassi) Le competenze pratiche sulla non-discriminazione e sulle questioni relative alle diversità sono spesso frammentarie. Il risultato è che le forze di polizia regolarmente re-inventano l’acqua calda. Per supportare le forze di polizia olandesi nello sviluppo e nel miglioramento di politiche sulle diversità è stato fondato un Centro di Competenze sulle Diversità, dove sono raccolte tutte le informazioni e le conoscenze disponibili 149 ENAR (Rete europea contro il razzismo) è una rete di organizzazioni di tutta Europa che combattono razzismo, discriminazione razziale e xenofobia , promuovono pari opportunità per tutti. I rapporti ombra di ENAR sono compilazioni di informazioni e dati raccolti dalle organizzazioni associate. Hanno periodicità annuale e si propongono di colmare le lacune nei dati ufficiali ed accademici, offrendo anche la prospettiva delle organizzazioni non governative. 150 sulla diversità e gli atti di discriminazione, con particolare attenzione a quelli che vedono come autori i poliziotti stessi. Punti di contatto riservati – Polizia regionale di Haaglanden (Paesi Bassi) In Olanda, degli studi hanno mostrato che il tasso di ricambio lavorativo per gay, lesbiche, donne e immigrati erano inaccettabilmente alti. L’alto tasso di ricambio lavorativo può essere stato causato dalla continua intimidazione, dalle molestie e dalla mancanza di un’istituzione alla quale rivolgersi per rimediare a questi comportamenti. Per risolvere il problema, la polizia Olandese ha impiegato delle “persone di fiducia” (‘vertrouwenspersonen’) che lavorano all’interno della forza di polizia per ricevere le rimostranze e i reclami e offrire suggerimenti e supporto. Sono stati creati dei Comitati per i Reclami, come strumenti per combattere le intimidazioni, le molestie, le discriminazioni e i comportamenti scortesi. I consigli dei Comitati per i reclami e il codice disciplinare interno spaziano da una semplice reprimenda fino al licenziamento. 8.3.6 Intraprendere iniziative simboliche Per sfruttare appieno la componente persuasiva della comunicazione, è importante comunicare in tutti i modi possibili i valori praticati da un’organizzazione, anche in modo simbolico. Per esempio, anche l’arredamento, i cartelli o manifestiappesi alle pareti, possono suggerire qualcosa sullo stile di comunicazione interna ed esterna e trasmettere contenuti e suscitare emozioni. Basti pensare al diverso messaggio che veicolano delle fotografie che ritraggono solo poliziotti maschi o comunque bianchi o, invece, fotografie che rappresentano una comunità plurale, sia essa esterna o interna alla polizia. BUONE PRATICHE Transessuali benvenuti in polizia – Polizia della Contea di Northumbria (Gran Bretagna) Quando nel 2003 avemmo occasione di partecipare ad una visita presso il Comando della polizia a Newcastle, nel Nord dell’Inghilterra, fummo accolti da un piccolo drappello di dirigenti e dal responsabile del servizio per la diversità che mostrarono con orgoglio la foto in prima pagina del giornale locale: vi appariva una bella signora sulla cinquantina. Il titolo suonava più o meno così: La polizia di Northumbria è orgogliosa di annunciare la promozione della signora X al grado di Chief Constable. L’articolo raccontava la storia della signora che, entrata in polizia vent’anni prima come uomo, aveva vissuto la trasformazione da maschio a femmina durante la sua attività come poliziotto, non essendo in questo processo intralciata da alcun impedimento ad assumere un grado di responsabilità molto alto. 151 Australia Non è la Polizia del Punjab. Winnipeg, Canada, 2012. Gurvinder Singh Chal, 35 anni, non è un agente della polizia del Punjab. E’ un operatore reclutato di recente al Servizio di Polizia di Winnipeg. Indossa il turbante per ragioni culturali e religiose e sarà parte della sua uniforme d’ordinanza. 8.3.7 Usare strumenti di marketing per combattere la discriminazione L’immagine di un’organizzazione dipende dai mezzi che usa per farsi conoscere: pubblicazioni, filmati, volantini, dichiarazioni pubbliche. Promuovere la propria immagine usando foto che riflettono la diversità incoraggia l’idea che ciascuno è benvenuto e può sentirsi sicuro in quell’organizzazione.E’ dunque bene che la polizia includa sempre nel proprio materiale pubblicitario verso l’esterno e di formazione e aggiornamento rivolto al proprio personale, tutta la possibile gamma delle diversità (donne e uomini di diverso aspetto, di diversa età, ecc.) e tutte le dichiarazioni a favore della diversità, in difesa dei diritti umani e contro le discriminazioni cui la polizia si attiene. BUONE PRATICHE Rapporto annuale sulle pari opportunità 2012 – Polizia della Contea di Northumbria (Gran Bretagna) Questo rapporto mostra come la Polizia di Northumbria si sta adeguando all’Equality Act e come sta decidendo i propri obiettivi gestionali attraverso l’informazione sull’uguaglianza. INTRODUZIONE DEL COMMISSARIO DI POLIZIA SUE SIM “La Polizia di Northumbria ha l’impegno di fornire il miglior servizio possibile alle nostre comunità, assicurandosi che tutti abbiano un accesso equo a tutti i servizi, trattando tutti con rispetto, sempre.Possiamo fare questo solo conoscendo le nostre comunità, incontrandovi negli incontri pubblici, essendo disponibili nei luoghi che frequentate, ascoltando le vostre 152 preoccupazioni e dandovi in risposta informazioni rilevanti e appropriate. Vogliamo continuare a sviluppare una migliore comprensione dei bisogni della nostra comunità diversificata fornendo al pubblico, al nostro staff e ai nostri partner opportunità d’influenzare il modo in cui identifichiamo le nostre priorità e progettiamo e forniamo i nostri servizi. In qualsiasi momento vi mettiate in contatto con noi, cercheremo di rispondere sempre nel modo più appropriato. I vostri agenti locali sono lì per aiutarvi, pattugliando le aree dove dite ci sia più bisogno di loro. Conosceteli, utilizzate il nostro sito web e, più di tutto, lavorate con noi per una comunità più sicura dove vivere.” Sito web 150 MPL, Polizia Metropolitana di Londra (Gran Bretagna) “Contrastare reati di odio come crimini razzisti, violenza domestica e crimini di stampo omofobo è una priorità per la MEP. A controllo di queste attività vi sono le Unità di sicurezza per la comunità (Community Safety Units), localizzate in ognuno dei nostri 32 quartieri.Crediamo fermamente di poter rendere migliore la vita di chi soffre per colpa di crimini di odio, proteggere le loro famiglie, le loro comunità e prevenire la rivittimizzazione. Questo è possibile prendendo energicamente parte all’azione contro chi perpetra questi crimini, rispondendo ai bisogni delle vittime e lavorando in collaborazione con organizzazioni esterne. Se siete stati vittime di un crimine d’odio, o pensate di esserlo stati, lasciate che vi aiutiamo. Vi offriremo supporto e vi daremo assistenza pratica e consigli che vi aiutino a decidere quale possa essere il prossimo passo. Perché rivolgervi a noi? I crimini d’odio feriscono tutti noi. Colpiscono al cuore le nostre comunità (…) e noi abbiamo a cuore il proteggere le persone che vivono nelle nostre comunità. Siamo qui per aiutare chiunque abbia risentito del pregiudizio, dell’ignoranza e della violenza degli altri. Con il supporto di uno staff addestrato all’interno del vostro Community Safety Unit locale, faremo tutto il possibile per aiutarvi ad affrontare ciò che vi è accaduto. Non è sempre facile capire se ciò che vi è accaduto è reato. Se qualcuno vi insulta per strada o invia posta elettronica offensiva a causa della vostra religione, del vostro orientamento sessuale o disabilità, è un reato? O vi devono ferire fisicamente perché quell’atto si possa definire tale? Se vi sentite incerti su questi punti, per favore chiamateci. E’ il nostro lavoro ricostruire l’accaduto e garantire che siano prese le misure più appropriate.” 8.3.8 Costruire ponti con le comunità Abbiamo usato uno dei titoli della Carta di Rotterdam per rimarcare come quel documento, così come quasi tutte le strategie delle polizie delle quali siamo a venuti a diretta conoscenza 151 e che per lo più hanno adottato di fatto o formalmente la Carta, consideri con molta serietà la necessità delle polizie di aprirsi alla comunità che serve in tutte le sue sub-culture, agli individui e alle associazioni, sia quelle omogenee al loro interno (gay e lesbiche, minoranze etniche, ecc.), sia quelle miste e soprattutto impegnate nel contrasto alle discriminazioni. Poiché i principi della Carta di Rotterdam scaturirono dall’approfondito lavoro di un nutrito gruppo misto per nazionalità e per appartenenza o meno alle forze di polizia, ci pare che nulla possa esprimere meglio questo concetto di alcuni dei punti che riportiamo dalla Carta medesima. 150 La voce “hate-crime” si trova facilmente sulla home page e basta un click per avere tutte le informazioni necessarie dove appaiono per prime le seguenti parole. 151 Tra queste, certamente Irlanda, Inghilterra, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia, Germania, Catalogna. 153 Costruire ponti tra le minoranze etniche e la polizia 1. Promuovere fiducia e cooperazione Costruire ponti tra le minoranze etniche e la polizia costituisce una sfida professionale. È parte importante di un approccio da parte della polizia orientato ai servizi in una società democratica ed è essenziale nel promuovere fiducia e cooperazione. 3. Superare gli atteggiamenti mentali antagonistici Per favorire la creazione di un clima di fiducia, la polizia deve attivamente cercare di ottenere un feedback dalle comunità etniche minoritarie sull’efficacia e l’appropriatezza delle politiche e dei programmi. Questo significa andare oltre un atteggiamento mentale antagonistico per entrambe le parti e creare una relazione operativa e costruttiva tra la polizia, le ONG e le organizzazioni dei cittadini. Tutte le parti in gioco possono trarre benefici da partnership tra pubblico e privato come queste. Queste misure devono essere prese in considerazione soprattutto in situazioni in cui le tensioni tra la polizia e le comunità etniche di minoranza sono evidenti. “Tavoli di discussione con i clienti” e “tavole rotonde” che possono avvicinare gruppi antagonistici si sono dimostrati utili in situazioni di questo tipo. 4. Promuovere la credibilità La polizia deve attivamente cercare opportunità per promuovere la propria credibilità nella lotta contro il razzismo. Innanzitutto, questo vuol dire riconoscere il razzismo e la sua esistenza. In secondo luogo, dovrebbe essere promosso l’attivo coinvolgimento della polizia nelle attività esterne contro il razzismo. Infine, la polizia dovrebbe prendere l’iniziativa nello stabilire accordi formali con altre agenzie per collaborare nella lotta contro il razzismo. 5. Agenti di collegamento Le difficoltà o i fallimenti della comunicazione tra la polizia e le minoranze costituiscono un problema specifico che, a sua volta, richiede speciale attenzione e soluzioni specifiche. Programmi che rafforzano i legami tra la polizia e le comunità etniche minoritarie come, ad esempio, la nomina di agenti di collegamento per le relazioni con le comunità minoritarie, hanno dato risultati positivi. Quello che rimane fondamentale per la polizia é conoscere bene la società e il territorio che serve, così come sarebbe se il bacino dei destinatari fosse più omogeneo o percepito come tale. Una parte di questa conoscenza costituisce l’intelligence: chi fa che cosa, chi esce di galera, chi dispone improvvisamente di molti soldi, chi sparisce, chi frequenta chi, quali famiglie sembrano entrare in crisi ecc. Ma dietro questo ci deve essere una conoscenza dei modi di vivere, delle abitudini, dei valori delle persone che abitano nelle zone per le quali siete responsabili, informazioni, queste, necessarie per interpretare fatti ed accadimenti. BUONE PRATICHE Tavoli locali di consultazione per la prevenzione del crimine – Polizia Nazionale Ellenica (Grecia) In Grecia la legge stabilisce che, in ogni municipalità con una popolazione con più di tremila residenti,si deve creare un “Tavolo speciale di consultazione per la prevenzione della criminalità”. Il “Tavolo” è composto da un gruppo di scienziati ed esperti specializzati nei campi della criminologia (giudici, criminologi, psicologi, sociologi, agenti di polizia), assistenti sociali e medici, rappresentanti delle classi produttive e di varie istituzioni sociali. Organi di consultazione come questi possono essere di grande valore quando si tratta di promuovere la questione della diversità all’interno della polizia, così come per stabilire dei legami più stretti di cooperazione tra la polizia e le minoranze locali. 154 Strategia della diversità – Polizia della Contea di Northumbria (Gran Bretagna) Un servizio di polizia di quartiere (community policing) e rassicurazione sociale è un elemento di riforma chiave e permanente, necessario a rendere la polizia più a misura di cittadino e localmente responsabile nel rispondere ai bisogni delle comunità. Questo significa usare squadre di polizia dedicate e che utilizzino tecniche moderne ed aggiornate per fornire una presenza visibile e rassicurante, che prevengano e scoprano i crimini e sviluppino relazioni costruttive e durature coi membri della comunità. Lavorare in squadra con altre agenzie è anch’esso fondamentale per integrare al meglio la polizia di quartiere e per permettere al servizio di soddisfare il proprio ruolo di rassicurazione e sicurezza della comunità. Direzione cittadini e diversità; Raggiungere le pari opportunità, accrescere la fiducia. La Strategia 2009-2013 della MPS per la diversità e le pari opportunità - MPL, Polizia Metropolitana di Londra (Gran Bretagna) “Coinvolgimento della comunità - AZIONI CHIAVE: > Migliorare la nostra comprensione delle diverse comunità di Londra e usare queste informazioni per migliorare il nostro approccio al coinvolgimento della comunità. > Assicurarsi che le attività di coinvolgimento incontrino i bisogni di tutte le comunità, incluse le comunità meno ascoltate, così che tutte le comunità avranno più coinvolgimento nell’azione di polizia a Londra. > Migliorare il lavoro di squadra coi nostri partner e le organizzazioni di volontariato per essere più efficaci ed efficienti nel coinvolgimento della comunità. > Utilizzare i rapporti di collaborazione già esistenti tra polizia e comunità per prevenire la radicalizzazione di alcuni individui. > Internamente, assicurare che siamo coinvolti e ricettivi ai bisogni delle persone nell’organizzazione. > Tenere la popolazione di Londra e il nostro stesso staff costantemente informato del lavoro che realizziamo.” Polizia locale di Portomaggiore e Voghiera (Italia) Nel 2008, i Comuni di Portomaggiore e Voghiera (FE) realizzarono il progetto “Membri interculturali nella Polizia Municipale”: l’obiettivo primario era quello di superare le barriere sociali e culturali tra residenti locali e immigranti attraverso il reclutamento di stranieri che lavorassero fianco a fianco con le forze di polizia. Il personale assunto condusse attività ausiliarie, contribuendo a ridurre le barriere linguistiche e culturali ogniqualvolta la polizia si trovava a dover trattare con soggetti interessati a vario titolo dal fenomeno dell’immigrazione. Sebbene la legislazione nazionale non permettesse loro di avere contratti di durata superiore ai tre mesi, e nonostante il rifiuto da parte di alcune comunità straniere a prendere parte a determinate attività (in particolare quelle legate alla promozione dei diritti delle donne), il progetto ha avuto successo, aiutando le comunità straniere a risolvere problemi di carattere quotidiano. Un altro risultato conseguito è stata la positiva reazione da parte delle forze di polizia e l’accoglienza e il rispetto dimostrato dai residenti locali nei confronti dell’iniziativa. Rete di poliziotti gay e lesbiche – Polizia regionale di Haaglanden (Paesi Bassi) Molti impiegati gay, lesbiche ed appartenenti a minoranze devono condividere coi propri colleghi le loro esperienze di lavoro in polizia in quanto persone gay, lesbiche o appartenenti a minoranze. Quindi sono stati creati dei network nazionali e regionali, come l’”Homo network Amsterdam” e il “Integration network Haaglanden” per fornire un forum di sostegno agli omosessuali in polizia. 155 Priorità 2012-13 per le pari opportunità – Polizia della Contea di Northumbria (Gran Bretagna) Rispondere ai bisogni di individui e comunità diversificate La polizia di Northumbria effettua regolarmente un sondaggio sul grande pubblico per chiedere la loro opinione sulla qualità del servizio offerto dalla polizia e come questo possa migliorare la vita nel loro vicinato. Ogni anno vengono intervistate almeno 15.000 persone con diversi background da parte del USS (User Satisfaction Survey) e dal SCS (Safer Comunities Survey) e su richiesta sono forniti i risultati. Questo aiuta la polizia ad identificare i bisogni dei vari gruppi e a rispondervi, modificando le proprie priorità future.In questi sondaggi la polizia raccoglie informazioni riguardo all’età delle persone, al genere, alla religione, alla loro etnia e disabilità. I risultati La polizia di Northumbria continua ad avere i migliori risultati del Paese sulla soddisfazione delle comunità. Gli ultimi dati indicano che ben il 92,4% delle vittime di un reato sono contente della loro esperienza in generale con la polizia. Per poter comprendere meglio le comunità e assisterle con servizi migliori vengono effettuate ulteriori analisi dei dati, leggendoli alla luce delle caratteristiche demografiche, di età, genere, etnia e disabilità. Anche in questi casi non sono state rilevate differenze significative nelle risposte. Storicamente la polizia ha tuttavia identificato una differenza tra il grado di soddisfazione dei bianchi vittime di crimini e i neri o appartenenti a una minoranza etnica, che erano generalmente meno soddisfatti dal servizio ricevuto. Dal 2008 si è fatto molto per colmare questa distanza, ad esempio alcune campagne di comunicazione e l’ulteriore formazione del personale di prima linea. Il risultato è che la distanza della valutazione positiva dei due gruppi si è leggermente ridotta. Continuiamo a fornire ai Comandanti d’Area analisi dettagliate sui numeri delle vittime di reato appartenenti a minoranze etniche contattate attraverso i sondaggi e le indagini, e a fornire anche il grado di soddisfazione rispetto al loro specifico servizio. Oltre a ciò, nel corso del 2012, l’Equality Board ha commissionato una serie di interviste di gruppo e individuali con vittime lesbiche, gay, bisex e transgender (LGBT) e contatti con la comunità LGBT in generale, per stabilire l’efficacia degli agenti nel trattare con persone di quelle comunità. I risultati sono stati in generale molto positivi. Solo un ristretto numero di partecipanti ha notato che i poliziotti sembravano in imbarazzo quando trattavano i loro casi. È stato perciò messo a punto un procedimento per assicurarsi che gli operatori comprendano e affrontino ogni punto che possa avere preoccupato quel tipo di vittime; un procedimento che sta permettendo agli operatori di comprendere ad un livello più personale e profondo come rispondere ai bisogni dei singoli individui. Le forze dell’ordine sono presenti in determinate zone solo perché ricevono degli ordini operativi che vengono dai dirigenti, che a loro volta subiscono pressioni politiche.Inoltre le forze dell’ordine non sono informate sui progetti della comunità e quindi non possono coordinarsi o sfruttare delle situazioni che potrebbero aiutare il loro lavoro. Non sono in rete! Non sanno nemmeno quello che fanno gli altri corpi delle forze dell’ordine. Le forze dell’ordine dovrebbero ascoltare le esigenze della comunità e non porsi sempre come il poliziotto che deve imporre una legge. Per le forze dell’ordine c’è un po’ la mentalità che devono difendere i cittadini considerando cittadini solo i bianchi italiani. Dovrebbero andare incontro alla società civile, ascoltare di più le associazioni e partecipare a degli incontri per capire meglio i bisogni dei cittadini stranieri. Cittadino. Tavolo di confronto 1 Il problema è che sono poche le comunità che si rendono disponibili. Sì, avranno un loro imam di riferimento, ma un conto è la comunità strutturata e un altro è la delinquenza strutturata che è appartenente a quella comunità ma segue le regole della comunità delinquenziale. A noi servirebbe avere un operatore extracomunitario per avere qualcuno capace di interloquire con lo spacciatore, non con la comunità. Operatore di polizia. Tavolo di confronto 3 156 C’è bisogno di una collaborazione tra associazioni e forze dell’ordine, dei tavoli di discussione perché vi sia una discussione privata, non in mezzo alla strada, in pubblico, per esempio davanti a un bar, cosa che intimidisce la clientela. Devono smettere la divisa a volte, per avvicinarsi ai cittadini e promuovere incontri presso i luoghi importanti per la comunità: chiese, moschee, associazioni culturali… Cittadino. Tavolo di confronto, Sessione plenaria. A volte gli stranieri accusano con leggerezza gli operatori di razzismo. Cittadino. Tavolo di confronto, sessione plenaria. Ci sono mancanze anche da parte degli immigrati, c’è un buco anche dall’altra parte: non si conoscono le regole, quindi bisognerebbe fare della formazione, organizzare degli incontri formativi. Cittadino. Tavolo di confronto 1 Da quindici anni mi adopero per proteggere la mia comunità. Vorrei formare dei giovani come mediatori culturali ma non ci riesco. Mi chiamano anche in TV con Frizzi alla RAI, ieri ho incontrato Napolitano, mi hanno chiamato a Roma a parlare della mia cultura. Però nella mia città, Reggio Emilia, non ci riesco. Non solo a Reggio Emilia ma anche in altre città. Da tanto tempo sto cercando di preparare dei mediatori nostri, sinti, ma non ci riesco, non c’è un nomade cha faccia il mediatore culturale per i nomadi, magari lavorando anche in affiancamento a sedentari ma non solo sedentari, non solo gagi: cosa ne sanno i gagi della nostra cultura? Le autorità devono capire che siamo noi i protagonisti, noi sappiamo di cosa c’è bisogno per la nostra cultura. Però sindaci e assessori continuano a mandarci i sedentari, i gagi dentro i campi nomadi. E per noi quei gagi, non tutti, sono delle spie, sono come delle spie che vanno a riferire tutto. Se noi invece ci sediamo, con la polizia, i vigili, i carabinieri, il sindaco…. ma non siamo riconosciuti e questo ci dispiace molto. Cittadino, Tavolo di confronto 1. Indispensabile da parte di tutti è quella disponibilità all’ascolto che spesso noi dimentichiamo, perché a volte ci arrocchiamo su posizioni che non sempre sono corrette. Se invece ci rendessimo disponibili all’ascolto, potremmo cogliere diverse informazioni e avremmo la possibilità di lavorare con più facilità con altri organi del Comune, in sinergia. Disponibilità all’ascolto verso tutti, anche verso il cittadino, perché spesso è il cittadino a dirci qual è la problematica. Il cittadino spesso si sente messo da parte e ci sentiamo dire “non mi ascolta nessuno”. Operatore di polizia, Tavolo di confronto 2. 157 9. TRATTARE CASI DI DISCRIMINAZIONE 158 9.1 INDICAZIONI PER IL TRATTAMENTO DI EPISODI DI DISCRMINAZIONE RAZZIALE L’accertamento relativo ad un caso di razzismo è, come ogni altra attività d’indagine, un processo di problem solving la cui efficacia non può prescindere da una chiara identificazione del problema. Nel caso di un episodio razziale l’elemento “razziale” deve essere identificato sin dall’inizio con estrema chiarezza. Pertanto dovrebbe essere approntato un modulo specifico per ricomprendere tra i dati registrati anche quelli relativi all’appartenenza“razziale”, etnica, nazionale, alla cittadinanza, al colore della pelle, al credo religioso, che oggi non sono normalmente raccolti, evidenziando– a seconda del caso – il dato in base al quale è stata presuntivamente operata la discriminazione. Inevitabilmente, dare maggiore importanza all’investigazione di questi casi implica un impegno maggiore di risorse umane ed economiche nonché di tempo e, come sempre, il costo di un’indagine efficace è elevato. D’altra parte, il costo del fallimento di un’indagine sarebbe ancora più alto perché andrebbe ad incidere sul livello di fiducia della società e, inquesto caso particolare, delle comunità di origine etnica minoritaria nei confronti della polizia, oltre che sulla qualità di vita individuale e collettiva, sull’integrità della vita umana e sulla stabilità sociale. 9.1.1 Definizione di episodio razziale La definizione di “episodio razziale” o “caso di razzismo” si estende a ricomprendere comportamenti e atteggiamenti che non necessariamente danno luogo ad un reato penalmente perseguibile. È importante sottolineare che, per essere classificato tale, un episodio razziale deve semplicementeingenerare nella vittima, nell’operatore di polizia che interviene o nei terzi, la percezione di una discriminazione effettuata sulla base dell’elemento“razziale”, etnico, nazionale o religioso. L’ampiezza di questa definizione serve per assicurare la rilevazione di ogni elemento utile all’accertamento di casi in cui risulta spesso estremamente difficile identificarepersino l’esistenza di un episodio, allo stesso modo in cui risultava difficile far emergere, nel passato, casi di violenza sessuale o come risulta difficile rilevare, ancora nel presente, episodi di estorsione. Infatti, la circostanza che la vittima di un reato di estorsione ometta di segnalarlo alle competenti autorità non solleva queste ultime dall’onere di procedere autonomamente all’attività di intelligence necessaria al suo accertamento e, analogamente, se una persona vittima di un episodio di razzismo non intende denunciarlo come tale, gli operatori di polizia dovrebbero ugualmente avviare un’indagine sul fatto. Perché è così importante rilevare un episodio razziale? È importante farlo per la specificità di tale categoria di episodi che è ascrivibile ai seguenti fattori: > l’incidente non produce effetti solo sulla vittima diretta ma sull’interacomunità; > le vittime di un “episodio razziale” possono essere dunque innumerevoli; > la società intera risente delle tensioni ingenerate da questa categoria di episodi; > c’è l’alto rischio del ripetersi dell’incidente; > sussiste un’elevata probabilità che l’incidente rappresenti solo il tassello di un puzzle più ampio che, se ricostruito nella sua interezza,può fornire un quadro completo degli autori; > esiste il rischio che, laddove non identificati e neutralizzati, gli autori di un “episodio razziale” possano commetterne di più gravi; > potrebbe sussistere la possibilità che gli autori di tali episodi si organizzino formalmente o informalmente in strutture associative dedite a questo tipo di attività. 159 Il servizio di polizia, il cui compito è di sostenere in ogni caso le vittime di tutti i reati, nei casi di episodi razziali è chiamato ad offrire un sostegno ancora più forte. Questo non significa riservare alla vittima di tali incidenti un trattamento speciale, quanto piuttosto dare il giusto peso a questo genere di episodi, in ragione della paura e della pressione psicologica ingenerata nei soggetti che hanno subìto la condotta discriminatoria. La tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, costituzionalmente garantita e incisivamente ribadita nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, deve essere garantita senza ricorso ad alcuna forma di discriminazione. Laddove, pertanto, l’operatore di polizia non fornisse alla vittima di un “episodio razziale”un sostegno adeguato e proporzionato alla gravità del fatto, verrebbe meno alla sua missione che è quella di costruire una relazione di servizio con un’altra persona che entra in contatto con lui, quasi sempre in una posizione di potenziale difficoltà psicologica. Ai fini di un’investigazione efficace, é importante delineare la figura del trasgressore. Un’attività di intelligence condotta su un episodio razziale richiede dati completi e accessibili sugli autori conosciuti di tali episodi, come pure una comprensione ampia del tipo di persona che può rendersi protagonista di tali episodi, il suo modo di pensare, i suoi valori, i suoi comportamenti ,le sue frequentazioni. Ricerche condotte in questo campo hanno evidenziato che sussiste un grado di prevedibilità delle azioni che giovani trasgressori compiranno con l’andare del tempo, se non vengono messi in atto programmi correttivi. Spesso, infatti, essi si fanno coinvolgere in forme di abuso e di intimidazione via via sempre più violente. Per esempio, già a partire dall’età di quattro anni, i bambini possono mostrare a scuola, o per la strada, comportamenti discriminatori acquisiti nell’ambito della famiglia. Cominciando dagli insulti e da atteggiamenti di “bullismo” (prepotenza), si può passare poi nell’età adolescenziale e giovanile a veri e propri reati razziali. È anche significativo che, mentre gli anziani in genere non commettono reati di questo tipo, le loro opinioni e comportamenti possono avere un’influenza notevole sui giovani. Un obiettivo primario per la polizia deve essere dunque identificare, indagare e perseguire gli autori di tali episodi in modo soddisfacente per la vittima e la comunità. Qualora l’episodio discriminatorio non avesse dato luogo ad un reato perseguibile penalmente, la polizia deve intraprendere azioni alternative in partnership con altre associazioni, gruppi e istituzioni competenti in relazione al caso. Gli operatori di polizia che si occupano di episodi razziali sovente si trovano a gestire un dialogo ad alta carica emotiva con vittime e testimoni. Questo dialogo, al di là dell’episodio specifico per il quale si interviene, può riguardare anche altri precedenti episodi dello stesso tipo, mai denunciati o riferiti, ai quali si dovrà estendere l’attività investigativa. Considerata la mancanza, attualmente, di una procedura standardizzata (se non presso UNAR e nodi territoriali collegati), è estremamente importante che chi ha la responsabilità di gestione e direzione dia ai propri sottoposti un esempio continuo di comportamenti eticamente corretti nell’approccio ad ogni episodio di discriminazione razziale, rendendosi garante anche dell’uguale correttezza del comportamento dei suoi dipendenti. Dovrà essere sua cura, inoltre, aggiornare continuamente il personale per garantire che possieda le conoscenze e le competenze appropriate alla gestione di questo particolare tipo di episodio. È inoltre massimamente importante che l’organo di vertice della polizia stabilisca una chiara policy rispetto alla trattazione degli episodi di discriminazione razziale, delineando i comportamenti e lo stile di atteggiamento che gli operatori di polizia debbono assumere al riguardo. Infine, va tenuto presente che operatori che lavorano a lungo o ripetutamente in questo ambito possono avere bisogno di un sostegno psicologico perché sottoposti a forme particolari di stress. I responsabili del personale dovranno essere in grado di rilevare i sintomi di stress professionale negli operatori di polizia, in modo da avviarli prontamente alla struttura preposta all’attività di sostegno. 9.1.2 Il sostegno alla vittima Quando ci si deve occupare della vittima di un episodio razziale, è importante capire quello che prova la vittima stessa, altrimenti certi suoi comportamenti o atteggiamenti possono sembrare inappropriati o inutili, se non addirittura di ostacolo. È necessario cercare d’identificarsi con lei percapire la gravità 160 dell’impatto psicologico, il senso d’isolamento, d’impotenza, di rabbia, di frustrazione e vulnerabilità che si prova nella sua situazione. Per le persone che sono visibilmente diverse, come persone di certe etnie minoritarie o nazionalità, persone che convivono in un rapporto visibilmente omosessuale o persone che portano abiti particolari come simboli della loro religione o persone con una disabilità visibile, non esiste nemmeno l’opzione dell’evitamento (si veda per questo il cap. 5.6). Essere vittima per il colore della pelle, per la sessualità e per la fede è ben più doloroso rispetto all’essere vittima, ad esempio, per la propria professione e sarebbe d’altra parte inaccettabile che queste persone dovessero essere costrette a cambiare casa, nascondere le proprie inclinazioni sessuali o vestirsi diversamente. Come inaccettabile sarebbe anche che un poliziotto dovesse cambiare la propria professione per evitare di essere bersaglio di attacchi. Molte vittime hanno un atteggiamento negativo verso la polizia, tanto che alcuni studi dettagliati hanno mostrato che in alcuni Paesi (e l’Italia parrebbe essere tra questi) i casi di razzismo risultano quelli meno denunciati. A volte le vittime sentono di aver ricevuto poca protezione nel passato e nella loro esperienza collettiva hanno subito degli incontri ostili e pregiudizievoli con la polizia. Le paure da parte delle vittime includono che all’incidente o reato non sarà data molta importanza; che la reazione del poliziotto possa essere a sua volta discriminatoria; che informazioni personali possano essere conservate e “schedate”. In una comunità chiusa, ogni incidente ha un impatto che va oltre la vittima e la sua famiglia stretta, divenendo parte dell’esperienza collettiva, nutrendo le percezioni del gruppo verso la società, rafforzando gli stereotipi e il senso d’isolamento. Costruire ponti fra la polizia e le comunità a rischio sarebbe, in un mondo perfetto, il compito di tutte e due le parti. Purtroppo la diffidenza di certe comunità di origine etnica minoritaria o nazionale rende loro difficile questo passaggio; questo fatto, in sé pienamente comprensibile, deve essere capito ed accettato dalla polizia. In ogni caso, la responsabilità formale e professionale per costruire ponti di comunicazione resta saldamente nelle mani della polizia e spetta alla polizia trovare il modo giusto. La vittima di un caso di razzismo rischia di essere due volte vittima: dapprima per l’incidente che ha subito, e in seguito se la risposta della polizia è di indifferenza, insofferenza o rifiuto di riconoscere la gravità dell’esperienza. Gli operatori di polizia possono pensare che questa sensazione del diventare vittima una seconda volta sia scarsamente giustificata o irrazionale, ma ciò è irrilevante; il compito della polizia è semplicemente far sì che questa reazione non avvenga. Questo fattore è di fondamentale importanza nel combattere episodi razziali e deve essere riconosciuto e capito da tutti gli operatori di polizia a contatto col pubblico. Gli effetti psicologici possono lasciare ferite gravi e incidenti apparentemente lievi possono essere devastanti per comunità intere. In questi casi gestire con sensibilità i rapporti fra polizia e vittima mette a dura prova le competenze interpersonali, comunicative e interculturali della polizia e di ciò l’operatore deve essere consapevole per potere gestire al meglio l’indagine e risolvere il caso. È bene anche ripetere che nei casi di razzismo si ha spesso il fenomeno della “vittimizzazione ripetuta”, che si presenta quando uno stesso reato viene più volte perpetrato a danno della medesima persona o in uno stesso luogo, in un determinato periodo di tempo. Alcune ricerche menzionate nel manuale della Polizia inglese Hate Crime Management (la gestione dei reati d’odio) hanno evidenziato che: > la vittimizzazione tende a ripetersi, cosicché l’esperienza passata costituisce il migliore indicatore della vittimizzazione futura. L’analisi delle abitazioni e delle persone già coinvolte in un “episodio razziale” costituisce, dunque, un buon indicatore delle potenziali future vittime di episodi analoghi. La consapevolezza di ciò aiuta ad individuare la potenziale vittima di un “episodio razziale” ed il suo autore eventuale, come pure ad identificare le circostanze di luogo e di tempo in cui lo stesso potrebbe essere perpetrato. Ne consegue un più efficace ed economico impiego delle risorse disponibili; > un secondo “episodio razziale” tende a seguire rapidamente il primo. Se ciò non accade entro un lasso di tempo ravvicinato, il rischio della ripetizione dell’evento tende a diminuire. Per avere un effetto significativo non sarà necessario impiegare a lungo misure di prevenzione speciale; > prevenire la vittimizzazione ripetuta protegge i gruppi sociali più vulnerabili senza doverli identificare come tali; 161 > la vittimizzazione ripetuta è fenomeno più frequente, sia in termini assoluti che proporzionali, in quelle aree a più alta incidenza della criminalità che rappresentano anche le zone interessate dai reati più gravi. Inoltre questo fenomeno può interessare soprattutto i soggetti più indifesi e incapaci di esprimersi. 9.2 COME RELAZIONARSI ALLE VITTIME DI EPISODI RAZZIALI Anche se ogni incidente è un caso unico e come tale va trattato, esistono tuttavia alcuni obiettivi fondamentali che tutti gli operatori che si occupano di “episodi razziali” dovrebbero tenere presenti, al di là dell’obiettivo investigativo relativo al reato in sé: alleviare le paure della vittima: è necessario che la polizia si renda conto pienamente delle gravi conseguenze degli episodi “razziali”; spiegare - se la vittima non fa obiezioni - che i dettagli dell’incidente possono essere condivisi con altre istituzioni competenti in ordine al problema; ottimizzare raccolta e analisi di dati, sfruttando anche quelli provenienti da fonti aperte (p. es. Internet) e dalla comunità, e assicurando che tutta l’informazione sia inserita e consultabile in un data-base auspicabilmente interforze; migliorare la fiducia della vittima nella polizia e sviluppare i contatti con la comunità in modo da costruire una relazione fiduciaria reciproca; sviluppare un rapporto di sostegno alle vittime in modo che si sentano tranquille nel testimoniare contro gli indagati-imputati; raccogliere informazioni su una gamma di incidenti che esula da quelli strettamente illegali per avere una prospettiva più ampia sulla natura della “vittimizzazione ripetuta”; circoscrivere i rischi di una reiterazione dell’ “episodio razziale”; incoraggiare gli operatori di polizia, nonostante le apparenti difficoltà o reticenze, a procedere contro un “episodio razziale” come metodo primario per combatterne l’insorgenza; assicurare che i bisogni delle vittime e dei testimoni siano portati a conoscenza del Pubblico Ministero competente (il flusso di informazioni polizia-Pubblico Ministero deve mantenersi costante per l’intera durata del processo); coordinarsi con tutte le altre istituzioni ed organizzazioni esterne che hanno competenza nell’azione di sostegno alle vittime e di prevenzione in ordine alla reiterazione di episodi di questo genere. 9.2.1 Come comportarsi se protagonista di un episodio di discriminazioneè un operatore di Polizia Un episodio di questo tipo è estremamente grave perché significa rinnegare uno degli obiettivi fondamentali di qualunque servizio di polizia: proteggere ogni persona e garantire l’applicazione della legge e il rispetto dei diritti fondamentali di ogni individuo. Lo spirito di corpo esistente all’interno di un servizio di polizia può essere una difficoltà all’emersione di tali episodi: esso potrebbe portare gli operatori a ignorare, sottostimare o coprire determinati comportamenti posti in essere dai loro colleghi nei confronti di soggetti esterni all’organizzazione o di loro stessi colleghi. Per fronteggiare questa eventualità, due sono gli obiettivi da perseguire: effettuare un monitoraggio interno continuo seguito da rilievi disciplinari, laddove vengano individuate condotte discriminatorie operate da appartenenti alla polizia; sviluppare uno stile trasparente nella trattazione di segnalazioni concernenti comportamenti scorretti eventualmente assunti dagli operatori di polizia. 162 9.3 IL COMPORTAMENTO PROFESSIONALE DELL’OPERATORE DI POLIZIA LOCALE Il rapporto che si instaura con la vittima di un caso di razzismo deve tener conto dei seguenti elementi: soddisfare quanto più rapidamente possibile i bisogni della vittima, cominciando dalla necessità di avere una presenza immediata della polizia, fino all’ottenimento da parte di essa di una risposta attiva che sia innanzitutto connotata da umanità e comprensione; le prime impressioni sono importanti. Sarà fondamentale, sin dall’inizio, dimostrare empatia e rispetto verso la vittima. Questo atteggiamento rientra a pieno titolo nella professionalità dell’operatore di polizia, fondata, prima che sul saper fare, sul saper essere. Il rapporto di empatia dovrà essere mantenuto nel tempo e reso oggetto di monitoraggio costante; fiducia e confidenza possono essere sviluppate se si dimostra quanto seriamente la polizia considera l’episodio razziale. L’iter investigativo va dunque opportunamente illustrato alla vittima sin dall’inizio, facendo quanto è necessario perché quest’ultima si senta coinvolta attivamente e seriamente considerata; è indispensabile, pertanto, ascoltare le opinioni della vittima e agire di conseguenza, rinforzando in questo modo il senso di coinvolgimento e di fiducia di quest’ultima verso la polizia. La trasparenza nell’approccio e il coinvolgimento di organizzazioni esterne saranno anch’esse di aiuto; con un atteggiamento sensibile e professionale è possibile documentare gli episodi razziali attraverso verbali dettagliati e precisi, idonei a fornire fonti di prova importanti per l’accertamento in sede penale e per la rilevazione del reale impatto dei casi di razzismo; le opinioni della vittima rispetto al procedimento legale sono molto importanti (per esempio in ordine alla disponibilità della stessa a testimoniare). La polizia dovrà mantenere un coordinamento continuo con l’ufficio del P.M. competente, curando, ove possibile, di farsi delegare le comunicazioni con le vittime con cui ha costruito un rapporto fiduciario; è indispensabile approntare dei modelli di servizio chiari relativi alle performance della polizia nei casi di intervento su episodi di discriminazione. Ad esempio, può considerarsi un risultato positivo di azione il fatto che sia stato tratto in arresto l’autore di un reato razziale o che la situazione non si ripeta entro un certo lasso di tempo (da quantificare) dopo l’intervento della polizia. Qualunque tipo di risultato difforme dagli standard in tal senso approntati verrebbe considerato come negativo; il monitoraggio continuo e la valutazione dell’indagine garantiranno il raggiungimento e il mantenimento degli standard. La risposta della polizia deve rimanere sempre positiva ed efficace, adeguandosi ai bisogni della vittima e alla loro evoluzione nel tempo; qualunque sia la dimensione dell’indagine, è consigliabile che la vittima abbia un referente unico all’interno dell’organizzazione di polizia con il quale si sente maggiormente a proprio agio; la polizia può assurgere a punto di riferimento di tutte le comunità ed organizzazioni locali idonee a fornire supporto nello specifico ambito. Questo approccio integrato alle problematiche dell’ episodio razziale è in grado di fornire alla vittima il migliore supporto possibile; gli operatori impegnati nel settore della prevenzione hanno un ruolo chiave nell’assistere e consigliare le vittime; laddove le circostanze lo richiedano, dovrà essere approntato un adeguato programma di protezione dei testimoni; 163 sarebbe opportuno formare in maniera specifica degli operatori di polizia incaricati di mantenere il rapporto con la vittima del caso di razzismo e con il suo nucleo familiare; tutti i contatti con la vittima, siano essi personali, telefonici o postali, debbono essere documentati negli atti di indagine; sarebbe opportuno approntare un opuscolo illustrativo sul servizio erogato dalla polizia a vantaggio delle vittime dei casi di razzismo e di discriminazione in genere; ogni volta che ciò sia possibile, è consigliabile avvalersi dell’apporto collaborativo dei mediatori culturali; è opportuno pianificare una “strategia di uscita” che lasci la vittima e la famiglia soddisfatte dello svolgimento dell’indagine e dell’appoggio fornito. Ecco un episodio, riportato in “Il servizio di polizia per una società multiculturale” 152che presenta alcune delle complessità appena descritte: Un giorno nel Quartiere di Brozzi, una zona dove abitano tanti immigrati cinesi di Firenze, un cinese trova le gomme della sua macchina tagliate. Nei giorni seguenti la stessa cosa succede ad altri immigrati cinesi della zona. Alla fine qualcuno denuncia il fatto alla polizia. Dopo un mese un giovane italiano è arrestato per aver danneggiato le macchine dei cinesi ma è accusato solo di normali atti di delinquenza, non di atti di discriminazione, mentre èmolto chiaro che ha tagliato le gomme soltanto alle macchine dei cinesi e mai a quelle di italiani. 9.3.1 Standard minimi per la registrazione di episodi razziali È indispensabile per l’attività di accertamento di un caso di razzismo registrare il fattore in base al quale è avvenuta la discriminazione. I fattori di discriminazione possono essere molteplici: alla classica discriminazione basata su aspetti fisionomici (colore della pelle, forma degli occhi, ecc.), si è affiancata la discriminazione basata sull’essere espressione reale o presunta di una data cultura o appartenenza effettiva o ritenuta tale ad un determinato gruppo etnico (ad es. rom) o religioso (ad es. musulmano, ebreo ecc.). Chiaramente questi fattori non sono scissi l’uno dall’altro, per cui il credo religioso può essere ad un tempo percepito anche come fattore culturale (ad esempio, si parla spesso impropriamente della cultura musulmana, piuttosto che della religione musulmana). Sebbene siamo consapevoli della complessità della situazione, sappiamo però che, se non si riesce a identificare e registrare sui sistemi informatici di intelligence il discriminante di ciascun episodio, non avremo materiale su cui lavorare: come indagare, per esempio, sulla matrice antisemita di un episodio se non si riconosce l’appartenenza reale o presunta della vittima alla religione ebraica? È poi da notare che non sempre la cittadinanza della vittima è sufficiente a rilevare l’origine della discriminazione, perché molti figli di immigrati hanno, e sempre più spesso avranno, la cittadinanza italiana ma il colore della pelle e altri tratti somatici che ne rivelano, in apparenza, una provenienza diversa. L’operatore di polizia che riceve la denuncia dovrebbe quindi poter raccogliere queste informazioni minime fondamentali sulla vittima: > il nome completo della persona che presenta la denuncia; > l’indirizzo; > la data di nascita; > il sesso; > la religione, sulla base di una lista delle principali religioni praticate dai gruppi presenti sul territorio, preventivamente predisposta dalla Polizia insieme con le comunità religiose. Dove la 152 Il servizio di polizia per una società multiculturale, pag.124. 164 religione dichiarata non fosse tra quelle previste nell’elenco, occorrerebbe definirla in uno spazio apposito; > il gruppo etnico di appartenenza, sulla base di una lista di principali gruppi etnici e nazionali presenti sul territorio, preventivamente predisposta dalla polizia insieme con le comunità, oppure il gruppo etnico dichiarato dalla persona nel caso in cui esso non sia ricompreso tra quelli figuranti nell’elenco; > occupazione; > anni di scolarità; > la lingua madre ed eventuali altre lingue conosciute; > se è stata vittima di altri incidenti negli ultimi dodici mesi; > se gli altri incidenti sono stati denunciati o segnalati; > se la denuncia è fatta da persona diversa dalla vittima, si devono registrare per questa persona gli stessi dati richiesti alla vittima e la relazione che li lega. È bene, inoltre, raccogliere almeno questi ulteriori dati sul tipo d’incidente: > specificare il tipo di evento, sia nel caso in cui si tratti di un reato, sia che non si tratti di reato; > se non si tratta di un crimine, descrivere in dettaglio i fatti; > descrivere il luogo dove sono avvenuti i fatti, ad esempio abitazione, luogo di culto, strada, posto di lavoro, trasporto pubblico, ecc. 165 10. LAVORARE INSIEME:UNA POSIZIONE CONDIVISA 166 Per chiudere questo testo, vorremmo tornare ad alcuni degli spunti di riflessione usciti da quella giornata di confronto fra cittadini di origine etnica minoritaria e ufficiali e agenti della Polizia Locale che si è svolta presso la sede della Scuola Interregionale di Polizia Locale, a Modena. Come si è già detto, pur senza nessuna pretesa di rappresentatività delle diverse realtà del nostro Paese e delle differenti sfaccettature del rapporto fra forze di polizia e migranti, tuttavia riteniamo che quell’esperienza abbia portato alla luce alcuni aspetti sui quali ci preme ora ritornare, sia relativamente ai contenuti emersi, sia allo spirito con cui in quell’occasione si è cercato di lavorare insieme, costruttivamente. A tre distinti gruppi di persone (costituiti rispettivamente da cittadini di origini straniere, agenti di polizia e ufficiali di strutture di Polizia Municipale provenienti dalle tre regioni che fanno riferimento alla Scuola Interregionale) abbiamo chiesto, prima separatamente, poi riuniti in sessione plenaria, di commentare tre ipotetici casi di intervento di polizia con profili potenziali di “problematicità” nella gestione del rapporto fra operatore in servizio e soggetto appartenente ad un’etnia minoritaria: un controllo presso un capannone industriale adibito a produzione manifatturiera da parte di migranti cinesi; un intervento in un appartamento privato in cui vivono ragazzi ganesi, in seguito alla segnalazione di schiamazzi in orario notturno; un’operazione congiunta interforze di controllo a un phone center gestito da un immigrato pakistano. Abbiamo così invitato ciascuno dei tre gruppi separati a pensare ai possibili comportamenti e stati d’animo dei protagonisti degli esempi, sottolineando gli elementi che potevano portare ad una positiva conclusione della vicenda e quelli che potevano condurre ad un finale insoddisfacente. Al di là della specificità o genericità dei casi, lo scopo era quello di utilizzarli come punti di partenza per confrontare quelle situazioni ipotetiche e i possibili esiti delle relative interazioni con le esperienze personali dei partecipanti al tavolo, facendone scaturire riflessioni da condividere e discutere con gli altri partecipanti. Un’idea che, va detto subito, ci sembra abbia prodotto risultati interessanti, nella misura in cui, pur partendo da punti di vista a volte molto distanti, le opinioni degli intervistati sono state per molti versi convergenti ed hanno poi generato ulteriori spunti di riflessione nella fase di discussione plenaria. Proviamo ad evidenziarne alcuni. 10.1 COSA PUÒ AGEVOLARE UN’INTERAZIONE PROBLEMATICA Tutti gli interventi di Polizia Locale prospettati ai nostri intervistati presentavano profili di possibile problematicità: un’operazione di controllo in contesti che presentano incognite o sono valutati (anche in virtù delle pressioni e dei luoghi comuni anti-immigrato presenti nell’opinione pubblica) come potenzialmente pericolosi per l’incolumità degli operatori richiede loro una corretta gestione delle inevitabili tensioni che ad essa si accompagnano. D’altra parte, gli stranieri sottoposti a controllo vivono spesso tale situazione come fonte di stress e disagio: l’aspetto esteriore, dettato dal colore della pelle o dai tratti somatici immediatamente riconoscibili, può comportare una percezione di vulnerabilità; il fatto che la loro condizione di straniero li renda sottoponibili spesso e volentieri a controlli da parte delle forze di polizia (se non altro relativi al rispetto delle norme sull’immigrazione) non fa altro che amplificare tale sensazione e complicare le relazioni con chi deve effettivamente condurre tali operazioni. Vi sono però alcuni elementi su cui, pur da differenti punti di vista, migranti e poliziotti convengono come fattori che rendono più agevoli tali interazioni: in primo luogo, la professionalità degli operatori. Una professionalità che, ovviamente, viene declinata in modo differente dagli operatori di polizia e dai cittadini di origine straniera ma le cui sfaccettature costituiscono tanti aspetti di un’unica dimensione. Per ufficiali ed agenti di Polizia Locale essa è legata in primo luogo alla capacità di leggere l’intervento, di avere cioè quelle informazioni sul contesto e quella capacità di analizzare le situazioni che conducono ad una preparazione dell’operazione di polizia calibrata, ben definita nei suoi obiettivi e nelle modalità; da questa comprensione dell’intervento deriva la possibilità che all’intervento vengano chiamati a partecipare operatori più o meno specializzati su determinati fenomeni o professionisti esterni alla struttura di polizia che possono però facilitarne l’operato (interpreti, mediatori o esponenti di altri settori dell’amministrazione comunale): lo scopo è comunque quello di avere ben chiari fin dall’inizio l’obiettivo 167 dell’azione e di riuscire a comunicarlo in modo efficace e possibilmente disteso agli individui sottoposti a controllo. Dall’altra parte, lo sguardo relativo alla professionalità delle pattuglie è rivolto proprio alla fase dell’interazione con gli agenti di polizia: ciò che viene richiesto dai cittadini stranieri è una disponibilità all’ascolto e una chiarezza di comunicazione che spesso manca nelle occasioni di contatto con le pattuglie di polizia; la capacità di comprendere le situazioni in cui gli interventi sono svolti (ad esempio, quando la presenza dei bambini negli ambienti di lavoro è indice di sfruttamento minorile e quando, invece, è semplicemente legata all’impossibilità di provvedere diversamente alla loro cura domestica) e, più semplicemente, di capirsi nella comunicazione lessicale è giudicata fondamentale per il buon esito delle operazioni. Oltre ad un più generico rispetto che talvolta, specie nelle interazioni più “muscolari”, viene a mancare. Un secondo elemento su cui si concentrano le persone che hanno partecipato ai tavoli di confronto è la collaborazione con gli altri attori potenzialmente coinvolti negli interventi: questi altri soggetti possono e devono essere coinvolti nel modo più efficace possibile per farsì che determinati tipi di intervento possano essere gestiti in modo ottimale. Parliamo, ad esempio, della gestione delle collaborazioni con i vari settoridell'istituzione comunale che possono essere implicati in alcuni profili dell'intervento; una cooperazione che sembra funzionare in modo molto più immediato e diretto nei Comuni di medie e piccole dimensioni – facilitata dall’immediatezza dei rapporti interpersonali – piuttosto che in quelli di grandi dimensioni, stando alle parole degli ufficiali di Polizia Locale. Oppure parliamo della possibilità di creare tavoli di confronto con le associazioni imprenditoriali immigrate, che non vanno intese come rappresentanti di “coloro che rubano il posto agli italiani” ma hanno specifici interessi economici in gioco (spesso risentono dell’attuale crisi come le aziende gestite dagli autoctoni) e possono rivelarsi un alleato prezioso, sia per conoscere meglio determinati fenomeni che per trovare dei punti di equilibrio fra lo svolgimento dell’attività imprenditoriale da un lato ed il rispetto della legalità dall’altro. E un’ultima ancor più importante forma di collaborazione, indicata soprattutto dai cittadini di origine straniera, è il dialogo con le associazioni e le comunità migranti: le forze di polizia spesso non sono informate sui progetti della comunità e quindi non possono coordinarsi o sfruttare delle condizioni che potrebbero aiutare la comprensione delle situazioni con cui entrano in contatto e lo svolgimento del loro lavoro. Tutto ciò in vista di un tentativo di più generale avvicinamento ad una società civile sempre più multietnica: l’impressione degli immigrati è invece quella di essere di fronte a una mentalità poliziesca che considera come cittadino da difendere soprattutto il “cittadino bianco italiano”. 10.2 COSA PUÒ COMPLICARE GLI INTERVENTI Altri elementi vengono, invece, indicati come complicazioni nelle interazioni fra migranti e operatori di polizia. In primo luogo, vi sono fattori ambientali, legati alle condizioni di vita ed ai contesti geografici in cui certe operazioni vengono condotte. In quartieri contrassegnati da un elevato ricambio della popolazione, in cui scarsa è la conoscenza fra vicini di casa e molte sono le occasioni di conflitto legate ai differenti stili di vita, la convivenza fra autoctoni e migranti è sottoposta a frequenti tensioni, e l’intervento di polizia, se non è condotto in modo imparziale ed efficace, può aggravare i problemi. D’altro canto, alcuni intervistati di origine straniera ammettono come talvolta manchi nell’immigrato stesso la volontà di fare uno sforzo per convivere educatamente e rispettosamente con i propri vicini e che una certa tendenza al vittimismo, unita ad uno scarso rispetto per l’autorità soprattutto da parte dei più giovani, si stia facendo strada. Da parte loro, gli operatori di polizia che operano nelle città di più grandi dimensioni hanno riconosciuto che il problema degli schiamazzi notturni riguarda ben poco le persone di origine etnica minoritaria ma soprattutto i giovani italiani, studenti o residenti. Un secondo aspetto negativo su cui tutti i nostri intervistati sono intervenuti è il ruolo dei mass media a proposito delle questioni legate all’immigrazione: sia gli operatori di polizia che i migranti hanno sottolineato l’eccessivo sensazionalismo che sembra connotare il mondo della stampa quando si parla di 168 notizie che hanno come protagonista un soggetto di origini straniere. Per alcuni si può parlare di una vera e propria “etnicizzazione della notizia”. Quando ad essere protagonista di una notizia è uno straniero, non si parla mai genericamente di “vittima” o di “ragazzo/a” ma si viene etichettati con la nazionalità o la religione di appartenenza (“il marocchino”,”il tunisino”,”gli islamici”), e spesso si viene definiti con connotazioni negative: “Se si parla di immigrati ci sono sempre delle allusioni al peggio anche nelle parole che si utilizzano per descrivere gli immigrati (flusso, ondata, ecc. ) si allude sempre ad un disastro…”. Questo ovviamente è un problema, nella misura in cui i media influenzano le opinioni della gente, facilitano la diffusione di stereotipi negativi sui migranti e a volte dettano l’agenda delle priorità (e le relative campagne sicuritarie) anche agli amministratori da cui dipendono le forze di Polizia Locale che, per contro, non hanno in genere alcun potere di impostare con la stampa o la televisione i toni di una notizia. Infine, molti intervistati hanno segnalato l’esistenza di un senso diffuso di diffidenza e di ostilità, sia pure per molti versi latente, come tratto distintivo delle relazioni fra forze di polizia e soggetti di origine straniera, soprattutto di giovane età. Gli operatori di polizia affermano come spesso si sentano poco rispettati nelle occasioni di contatto con i giovani migranti (almeno quanto non sono rispettati dai cittadini italiani, dai quali sono spesso percepiti più come gabellieri che come poliziotti veri e propri). Al tempo stesso, fra gli immigrati in molti ammettono che i mediatori della propria comunità che collaborano con le forze di polizia sono malvisti e spesso trattati alla stregua di “spie”, perché c’è una scarsa conoscenza di ciò che fa la polizia al di là del momento conflittuale del controllo e, più in generale, manca una relazione di fiducia reciproca che renda normale o desiderabile uno sbocco professionale in polizia per queste comunità. 10.3 IN PROSPETTIVA: RISPETTARSI, CONOSCERSI, “LAVORARE INSIEME” E’ proprio da queste ultime considerazioni che potremmo partire per cercare di andare al di là di un presente ancora colorato a tinte fosche, andando a citare due stralci di intervista che sono emersi durante la sessione plenaria del nostro tavolo di confronto, entrambe pronunciate da giovani di origine straniera. Da un lato, un’affermazione precisa ed incalzante che sottolinea le condizioni “istituzionali” che dovrebbero essere alla base di ogni tentativo di superare queste diffidenze e costruire fiducia reciproca: “Lo Stato ha un ruolo essenziale. Se non alziamo la nostra visione rischiamo di non cogliere il fondamentale ruolo dello Stato. Lo Stato deve mettere i poliziotti in grado di lavorare al meglio e i cittadini in grado, nelle giuste condizioni, che siano autoctoni o di origine straniera, di essere esemplari e che rispettano la legge i cittadini. Se lo Stato emette leggi lacunose, allora ricadiamo nel buon senso, nella sola possibilità della “gentilezza”, nel rappresentarsi in un qualche modo, tentare un approccio che non leda l’altro, mettere l’altro nelle condizioni di rispondere alle leggi. Il quadro legislativo italiano attuale mette in seria difficoltà tutti a essere rispettosi della legge. Dobbiamo invece riconoscere che il quadro dell’immigrazione in Italia è terribile. Basterebbe per questo citare un esempio molto semplice per mostrare il ritardo che abbiamo rispetto agli altri paesi europei: il caso della cittadinanza alle G2 (il reclamato jus soli). Ti trovi davanti un italiano e lo devi trattare come straniero mentre l’altro non vuole essere trattato da straniero. Quando il vecchietto dice “voialtri là del Congo”…No, invece io sono italiano. Se burocraticamente non ti si riconosce la tua appartenenza si complica di più il rapporto con l’altro.” Dall’altro lato, un intervento in chiave micro, che propone di costruire conoscenza e fiducia reciproca partendo dalle persone più che dalle istituzioni: 169 “…secondo me la Polizia Municipale deve fare conoscere quello che fa; per esempio il lavoro di educazione che fate nelle scuole è molto importante e va rafforzato. Va fatto certo sempre nelle scuole ma va ripetuto anche nelle associazioni di categoria o di stranieri, per es. CNA, Confcommercio, chiamando le aziende affiliate con loro, in una cena, per spiegare cosa devono fare: sono cose che costruiscono la sicurezza e la fiducia, ecc. Bisogna creare situazioni informali dove ci si conosce tranquillamente, una cena per esempio con i poliziotti in borghese. Questo è un modo che avvicinerebbe molto e tranquillizzerebbe, perché le facce contano e più conosci le persone e più la fiducia aumenta. Noi per esempio ci siamo visti ad altri tavoli per la sicurezza e piano piano è cresciuta la confidenza. Raccontavo di un poliziotto che ha fatto formazione a degli adolescenti di diversa nazionalità (anche italiani), la prima volta era uno “sbirro”, la seconda volta l’hanno invitato loro, l’hanno richiesto loro il secondo intervento. Qualcosa è crollato, hanno fatto conoscenza, ora c’è rispetto e sanno cosa fa la persona: fino a qua fanno loro... Magari si può capire che ci sono tanti numeri da chiamare, non solo il 112. Bisogna costruire più conoscenza, attraverso questa più rispetto, e convincersi che magari chiamare la polizia può risolvere più facilmente un caso.”. Queste due affermazioni mi sembrano emblematiche delle difficoltà attuali che il nostro Paese sperimenta nella gestione del fenomeno migratorio: esse sembrano partire da prospettive abbastanza distanti ma a ben vedere sono assolutamente complementari tra loro. Infatti, in uno Stato democratico dotato di un proprio modello di integrazione-inserimento della popolazione migrante, il riconoscimento dei più elementari diritti civili per gli immigrati che contribuiscono ad accrescere il benessere economico di tutti dovrebbe essere il nucleo fondativo di una convivenza civile all’insegna della fiducia e del rispetto reciproco. In realtà la situazione dei migranti in Italia è ben distante da quella prospettiva ideale (così come, d’altronde, lo è anche in realtà nazionali più mature della nostra): il fenomeno migratorio è ancora abbondantemente stigmatizzato da massmedia, potere politico e opinione pubblica come minaccia più che risorsa, come spauracchio da agitare ad ogni emergenza sicuritaria, nazionale o locale che sia. E le forze di polizia spesso si trovano in quella scomoda posizione situata fra l’incudine delle inquietudini sicuritarie della popolazione ed il martello di amministratori pronti a soddisfare tali richieste con campagne di rassicurazione efficaci più sul versante della comunicazione mediatica che su quello della convivenza civile. Ora, in attesa che dalle istituzioni arrivino risposte più dettate dai bisogni della collettività che dalle agende dei media, riteniamo importante che lo sforzo di gettare dei ponti fra le diverse comunità stanziate sul territorio arrivi dal basso; da iniziative che poggiano su quella stessa voglia di “lavorare insieme” per conoscersi e rispettarsi mutualmente che ha animato il nostro tavolo di confronto. In quest’ottica, lo sforzo che sta operando la Polizia Locale delle tre regioni afferenti alla Scuola Interregionale di evolvere verso una naturale vocazione di struttura al servizio della comunità di riferimento sembra procedere verso la giusta direzione. Una forza di polizia democratica e professionale dovrà avere come proprio punto di riferimento una società multiculturale, dovrà essere capace di comprenderne i bisogni e di soddisfarne le esigenze attraverso la propria quotidiana attività sul campo. Senza smettere la divisa (come suggeriva uno dei brani citati in precedenza), semmai valorizzandola, riempiendola di nuovi significati, ponendola sempre più convintamente anche al servizio della popolazione di origini straniere. Al tempo stesso, la popolazione migrante dovrà superare le proprie diffidenze, considerare le polizie locali come una delle tante strutture che garantiscono i diritti della collettività, e – tra gli altri – un possibile sbocco professionale. È chiaro a tutti che un manuale da solo non cambia la situazione. Non abbiamo né l’ingenuità né la presunzione per pensarlo. Se però attraverso questo manuale sarà stato compiuto anche solamente un piccolo passo verso la giusta direzione intrapresa dalla Scuola nella propria attività di formazione e dalle strutture di Polizia Locale nella quotidianità del servizio, allora sarà valsa la pena di averlo compiuto. Insieme. 170 BIBLIOGRAFIA Antigone Onlus (2011); Le prigioni malate – VIII Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione; Edizioni dell’Asino Concha Antón, Carmen Quesada (2008); Igualdad de trato y no discriminación: Guía de recomendaciones para la formación de fuerzas y cuerpos de seguridad; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Tullio Bandini, Uberto Gatti, Maria Ida Marugo, Alfredo Verde (1991); Criminologia; Milano, Giuffrè Massimo Barbagli (2002); Immigrazione e reati in Italia; Bologna, Il Mulino Massimo Barbagli, Asher Colombo(2011); Rapporto sulla criminalità e la sicurezza in Italia 2010; Ministero dell’Interno Caritas Italiana, Fondazione Migrantes (2009); XIX Dossier Statistico sull’Immigrazione; Edizioni IDOS Caritas Italiana, Fondazione Migrantes (2010); XX Dossier Statistico Immigrazione; Edizioni IDOS Sergio Carrera (2008); Benchmarking Integration in the EU. Analyzing the debate on integration indicators and moving it forward; Integration Program, Bertelsmann Foundation, Gütersloh Charles S. Carver, Michael F. Scheier, Jagdish Kumari Weintraub (1989); Assessing Coping Strategies: A Theoretically Based Approach (Journal of Personality and Social Psychology Vol. 56, No. 2, 267-283); American Psychological Association, Inc. Nils Christie (1986); Suitable Enemies; in H.Bianchi e R. Van Swaaningen, Abolitionism; Free University Press, pagg. 42-54 Asher Colombo (1998); Etnografia di un’economia clandestina – Immigrati algerini a Milano; Bologna, Il Mulino Fabrizio Cristalli (2001); Il sistema della polizia municipale; in F. Cristalli e P. Reggio (a cura di), Polizia locale: organizzazione e formazione, Franco Angeli Alessandro Dal Lago (1999); Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale; Milano, Feltrinelli Cuerpo Nacional de Policìa (aprile 2013); Código ético; España Alessandro De Giorgi (2000); Zero tolleranza. Strategia e pratiche della società di controllo; DeriveApprodi Donatella Della Porta (2006), La politica locale, Il Mulino Donatella Della Porta, Massimiliano Andretta (2001); Movimenti sociali e rappresentanza: i comitati spontanei dei cittadini a Firenze; in “Rassegna Italiana di Sociologia”, 1/2001 Mario Diani (1992); Dalla ritualità delle subculture alla libertà dei reticoli sociali; in “Democrazia e diritto”, n.2, Edizioni Tritone 171 ECRI (European Commission against Racism and Intolerance (2012); Rapporto dell’ECRI sull’Italia (quarto ciclo di monitoraggio) EGA HRM Consult (2004); Promoting diversity and preventing discrimination in police forces. Minority Representation in Police Organisations – Transnational Measures for the Exchange of Information and Good Practice Philomena Essed (1991); Understanding everyday racism, SAGE Publication European Network Against Racism (ENAR), Northern Ireland Council for Ethnic Minorities (NICEM) (2009); Combating Racist Crime and Violence: Testimonies and Advocacy Strategies; Brussels European Union Agency for Fundamental Rights (2010); EU-MIDIS European Union Minorities and Discrimination Survey n.5; Data in Focus Report, Multiple Discrimination European Union Agency for Fundamental Rights (2013);Fundamental rights-based police training.A manual for police trainers Malcolm Feeley, Jonathan Simon (1994); Actuarial justice: The emerging new criminal law; in D. Nelkin, The future of criminology; Sage Publications, pagg. 172–201 Michael L. Frazer (October 25-27, 2007); J. G. Herder and the Politics of Difference; Prepared for Presentation at the Immigration, Minorities and Multiculturalism In Democracies Conference, Montreal, QC, Canada David Garland (2004); La cultura del controllo; Il Saggiatore Bernard Harcourt (2007); Against Prediction. Profiling, Policing and Punishing in an Actuarial Age; The University of Chicago Press IReR Lombardia (2007); Indagine sulla realizzazione di politiche integrate per la sicurezza nella città: la percezione degli operatori dei servizi di Polizia Locale e delle Forze di Polizia Nazionale; Rapporto di ricerca IReR Lombardia (2008); Determinazione di standard minimi di servizio ed organico di Polizia Locale per ambiti territoriali della Lombardia; Rapporto di ricerca IReR Lombardia (2010); Politiche di sicurezza per lo sviluppo sostenibile del territorio: rischio reale e percepito. Allargamento ai rischi emergenti in Regione Lombardia; Rapporto di ricerca Hugues Lagrange, Marco Oberti (2006); La rivolta delle periferie. Precarietà urbana e protesta giovanile: il caso francese; Bruno Mondadori Lunaria (a cura di) (2011); Cronache di ordinario razzismo. Secondo Libro bianco sul razzismo in Italia; Edizioni dell’Asino Iris Marion (1990); Justice and the Politics of Difference; Princeton University Press Guido Martinotti (1993); Metropoli. La nuova morfologia sociale delle città; Il Mulino Dario Melossi (2002); Stato, controllo sociale, devianza; Milano, Bruno Mondadori 172 Dario Melossi (2010); Soliti noti; in Etnografia e ricerca qualitativa; III (3), pagg. 449-458 Metropolitan Police Service -Diversity and Citizen Focus Directorate (2012); Achieving equality, improving confidence. Mps diversity and equality strategy 2009-2013; Mayor’s Office for Policing and Crime, London NAGA, Associazione Volontaria di Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Stranieri e Nomadi (2009); Razzismi quotidiani. La voce degli stranieri e dei media su razzismo e discriminazione Susanne Noor, Lars Nelleman Thisted (2005), Diversity in the workplace – Ehen we are equal, but not the same.Borsen Forlag, Copenhagen Organisationdes Nations Uniespour l’éducation,la science et la culture (2004);Coalition européennedes villes contre le racisme (ECCAR); Nuremberg Salvatore Palidda (2000); Polizia post-moderna: etnografia del nuovo controllo sociale; Milano, Feltrinelli Salvatore Palidda (2008); Mobilità umane. Introduzione alla sociologia delle migrazioni; Cortina Raffaello Editori Federica Paolozzi, Maurizio Ricciardelli (2004); Polizia locale e innovazione legislativa, in Politiche e problemi della sicurezza in Emilia-Romagna: 1994-2004. Decimo rapporto annuale 2004; «Quaderni di Cittàsicure», N. 30 Massimo Pastore (1995); Produzione normativa e costruzione sociale della devianza e criminalità tra gli immigrati; in Quaderni ISMU 9/95 Massimo Pavarini (a cura di, 2006); L’amministrazione locale della paura; Carocci Marina Pirazzi (a cura di) (2008); Cause strategiche contro la discriminazione; Quaderni COSPE Marina Pirazzi (20/05/2012); Relazione alla scuola interregionale di polizia locale sulle serate gestite nel corso di aggiornamento per comandanti di polizia municipale e provinciale (da “The Equality Standard for the Police Service , National Policing Improvement Agency”, 2009, UK) Marina Pirazzi, Patrick Johnson, Claudia Di Persio (a cura di) (2004); Il servizio di polizia per una società multiculturale. Un manuale per la Polizia di Stato; Ministero dell’Interno e COSPE Cristian Poletti (2003); La partecipazione dei comitati di cittadini alle politiche di sicurezza in ambito urbano: una ricerca sui comitati di cittadini modenesi; in “Dei delitti e delle pene”, n.1-2-3/2003 Cristian Poletti (2006); “La polizia provinciale: “uscire dal bosco” senza smarrirsi”; Rapporto di ricerca, Bologna, Regione Emilia-Romagna – Dipartimento Politiche per la Sicurezza e la Polizia Locale Cristian Poletti (2007); La Polizia fra Controllo e Consenso: Etnografia della Polizia di Prossimità; tesi di dottorato in Studi Europei sul Territorio discussa presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca Fabio Quassoli (2006); Riconoscersi. Differenze culturali e pratiche comunicative; Cortina Raffaello Editori Luca Queirolo Palmas (2006). Prove di seconde generazioni. Giovani di origine immigrata tra scuole e spazi urbani; Franco Angeli 173 Rossella Selmini (a cura di, 2004); La sicurezza urbana; Il Mulino Senato della Repubblica XVI Legislatura 2008/2013 (febbraio 2011); Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Sintesi del rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di Rom, Sinti e Caminanti in Italia Sonia Stefanizzi (2012); Il teatro della sicurezza. Attori, pratiche e rappresentazioni; Et Al. Pierre-André Taguieff (1988); La force du préjujé. Essai sur le racisme et ses doubles; La Découverte United Nations (2004); Human Rights Standards and Practice for the PoliceExpanded Pocket Book on Human Rights for the Police (Professional Training Series No. 5/Add.3 ); New York and Geneva Caterina Volpato, Anna Maria Manganelli Rattazzi (2000); Pregiudizio e immigrazione. Effetti del contatto sulle relazioni interetniche. Ricerche di Psicologia, 24, pp. 57-80 Caterina Volpato, Anna Maria Manganelli Rattazzi (2001); Forme sottili e manifeste di pregiudizio verso gli immigrati. Giornale Italiano di Psicologia, 28, 165-189 Loic Wacquant (2006); Punire i poveri. Il nuovo governo dell'insicurezza sociale; DeriveApprodi Nira Yuval-Davis (1999); Institutional Racism, Cultural Diversity and Citizenship: Some Reflections on Reading The Stephen Lawrence Inquiry Report; Sociological Research Online, vol. 4 no. 1 174 APPENDICI 175 MISURARE IL PREGIUDIZIO: LA SCALA DI PETTIGREW E MEERTENS Il seguente test ha lo scopo di rilevare il suo grado di pregiudizio sottile e manifesto. Negli spazi lasciati vuoti bisognerà inserire il gruppo target, specifico o generale (immigrati in genere, cinesi, nordafricani ecc.) nei confronti del quale vuole valutare il livello di pregiudizio. Al termine del test troverà le istruzioni da seguire per calcolare il punteggio relativo alla scala di pregiudizio. Il questionario è qui presentato nella forma applicata nel 1997 nel vicentino in una ricerca condotta dalle docenti ANNA MARIA MANGANELLI RATTAZZI (Università di Padova) e CHIARA VOLPATO (Università di Trieste). 176 Le viene chiesto di esprimere un giudizio di accordo-disaccordo in merito ad una serie di affermazioni. Per rispondere basterà mettere una crocetta sull’alternativa che meglio esprime la sua opinione tenendo conto del fatto che i numeri hanno il seguente significato: 1 2 Assolutamente In disaccordo in disaccordo 3 4 5 6 Un po’ in disaccordo Un po’ d’accordo D’accordo Assolutamente d’accordo 1. Sarebbe preferibile che i/gli_________ che vivono nel nostro paese evitassero i posti in cui la loro presenza non è gradita. 1 2 3 4 5 6 2. Italiani e i/gli_________ non potranno mai sentirsi a loro agio gli uni con gli altri, anche nel caso in cui diventassero amici. 1 2 3 4 5 6 3. Nella maggior parte dei casi i/gli_______ che vivono nel nostro paese e che ricevono aiuti dall’assistenza sociale potrebbero farne a meno se solo ci mettessero più impegno. 1 2 3 4 5 6 4. Molti dei gruppi che si sono stabiliti in Italia, tempo addietro, sono riusciti a vincere i pregiudizi nei loro confronti e ad integrarsi nella vita del nostro paese. I/Gli________ dovrebbero fare la stessa cosa senza godere di speciali favoritismi. 1 2 3 4 5 6 5. La maggior parte dei politici locali si preoccupa troppo dei/degli_______ e non abbastanza dell’italiano medio. 1 2 3 4 5 6 6. Il problema è che alcune persone non ci mettono l’impegno necessario per riuscire. Se i/gli__________ si sforzassero di più, potrebbero raggiungere lo stesso livello di benessere degli italiani. 1 2 3 4 5 6 7. Sarei disposto ad avere rapporti sessuali con un/una _____________. 1 2 3 4 5 6 8. I/Gli__________________ discendono da popolazioni che possiedono abilità meno sviluppate e questo fatto spiega come mai non se la cavano altrettanto bene della maggior parte degli italiani. 1 2 3 4 5 6 9. I/Gli_______________ occupano posti di lavoro che spetterebbero agli italiani. 1 2 3 4 5 6 10. I/Gli__________ che vivono qui trasmettono ai loro figli valori ed abilità che non sono quelli necessari per avere successo in Italia. 1 2 3 4 5 6 11. Non avrei nulla in contrario a lavorare alle dipendenze di un/a_____________ adeguatamente qualificato/a. 1 2 3 4 5 6 12. Non avrei nulla in contrario se un/a ___________, con una posizione economica simile alla mia, sposasse un membro della mia famiglia. 1 2 3 4 5 6 177 Indichi quanto differiscono e quanto sono simili i/ gli _________ rispetto agli italiani. Per rispondere usi la seguente scala, tenendo conto che: 1 2 3 4 5 6 Sono molto diversi Sono diversi Sono un po' diversi Sono un po' simili Sono simili Sono molto simili 13. I valori che insegnano ai loro bambini. 1 2 3 4 5 6 14. Le loro credenze e pratiche religiose. 1 2 3 4 5 6 15. I loro valori e abitudini sessuali. 1 2 3 4 5 6 16. Il modo in cui parlano l’italiano. 1 2 3 4 5 6 17. Pensando alla caratteristica dell'onestà, dovrebbe dire quando a suo parere, sono diversi o simili i/gli __________ che vivono qui rispetto agli italiani come Lei. 1 2 3 4 5 6 Per rispondere alle domande 18 e 19 usi la scala indicata tenendo conto che: 1 2 3 4 5 Mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso 18. Quanto spesso si è sentito/a solidale con i/gli ________________ che vivono qui? 1 2 3 4 5 19. Quanto spesso ha provato ammirazione per i/gli ____________ che vivono da noi? 1 2 3 4 5 Per rispondere alla domanda 20 usi la scala sotto riportata: 1 2 3 4 5 Mi darebbe molto fastidio Mi darebbe fastidio Mi darebbe un po' fastidio Non mi darebbe fastidio Non mi darebbe assolutamente fastidio 20. Supponga che un membro della sua famiglia abbia avuto un bambino con una persona il cui colore della pelle e le cui caratteristiche fisiche siano diverse dalle sue. Se ciò accadesse, quanto le darebbe fastidio il fatto che il bambino possa non assomigliare per niente ai membri della sua famiglia? 1 2 3 4 178 5 CALCOLO DEL PUNTEGGIO Le domande che compongono la scala di pregiudizio sottile sono le seguenti dieci: 1 4 6 10 13 14 15 16 18 19 Le domande che compongono la scala di pregiudizio manifesto sono le seguenti dieci: 2 3 5 7 8 9 11 12 17 20 ATTENZIONE Prima di eseguire la somma dei punteggi, vanno invertiti i punteggi di alcune domande - per la scala di pregiudizio sottile i punteggi da invertire sono quelli degli item: 13 Domande 13, 14, 15, 16, 18, 19 Domande 18, 19 14 15 16 18 19 (1=6, 2=5, 3=4, 4 =3, 5=2, 6=1) (1=5, 2=4, 3=3, 4=2 , 5=1) - per la scala di pregiudizio manifesto i punteggi da invertire sono quelli degli item: 7 Domande 7, 11, 12, 17 Domanda 20 11 12 17 20 (1=6, 2=5, 3=4, 4=3, 5=2, 6=1) (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1) Dopo aver invertito i punteggi degli item sopraindicati si esegue la somma dei punteggi, che sarà compresa tra 10 e 58 per la scala di pregiudizio sottile e tra 10 e 59 per quella di pregiudizio manifesto. La mediana teorica dei punteggi e’ pari a 34,5 per la scala di pregiudizio manifesto e a 34 per quella di pregiudizio sottile. Per ogni rispondente si stabilisce se il suo punteggio sommato è superiore o inferiore alla mediana teorica in ogni scala e in base a ciò lo si può classificare in una delle tre tipologie. Nella descrizione delle tre tipologie (fanatici, egalitari, sottili), punteggio alto significa quindi superiore alla mediana teorica, punteggio basso significa inferiore. 179 Le tre tipologie Fanatici: coloro che presentano punteggi alti in entrambe le scale; infatti, chi mostra di possedere un forte pregiudizio di tipo manifesto, a maggior ragione, tende a discriminare gli outgroup in modo sottile. Egalitari (o democratici): chi ha una scarsa propensione a discriminare in modo sottile dovrebbe mostrare anche una bassa propensione verso le forme di pregiudizio più aperte. Sottili: coloro che non manifestano apertamente pregiudizi verso gli outgroup, ma sono pronti a farlo se hanno a disposizione un modo socialmente accettabile. 180 COMPENDIO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE SULLA DISCRIMINAZIONE ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo - NU 1948 (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948). Art.2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (Adottato e aperto alle firme, ratifiche e accesso dalla risoluzione dell’Assemblea Generale 2200A (XXI) del 16 Dicembre 1966, entrata in vigore il 23 Marzo 1976, in accordo con l’Articolo 49). Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) ordina ai governi di proibire per legge qualsiasi “odio nazionale, razziale e religioso che possa fomentare la discriminazione, l’ostilità o la violenza” (articolo 20). Commissione per l’Eliminazione delle Discriminazioni Razziali (CERD) (La Commissione si riunisce a Ginevra e consta normalmente di due sessioni all’anno della durata di tre settimane l’una) La Convenzione sull’Eliminazione delle Discriminazioni Razziali (CERD) dichiara che le politiche governative basate sulla superiorità razziale o sull’odio violano i diritti umani fondamentali, mettono in pericolo relazioni amichevoli tra le persone, la cooperazione tra nazioni e la sicurezza e la pace internazionale. Mette fuorilegge il razzismo ad un livello orizzontale, dallo Stato (ad esempio dalla polizia o dal sistema giudiziario) verso i propri cittadini, e ad un livello verticale tra i cittadini stessi. L’Articolo 4 del CERD obbliga gli Stati ad adottare “misure positive ed immediate” per combattere il razzismo. Tramite l’Articolo 14 gli individui possono avanzare reclami alla commissione del loro Paese. I legislatori degli Stati che hanno firmato per l’ICCPR e il CERD sono obbligati a creare una normativa penale specifica per condotte devianti, incluse la brutalità e la violenza, ispirate da pregiudizi. Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n.143/1975 (ratif. Con legge 158/81) (Convenzione sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti.) La Convenzione riconosce "[…]piena uguaglianza di diritti” rispetto ai lavoratori nazionali, estesa anche ai familiari, successivamente confermata nell’ordinamento italiano dall’art. 2 del Testo Unicosull’immigrazione d.lgs. 286/98. UNIONE EUROPEA Trattato di Amsterdam (art. 13) (Firmato il 2 ottobre 1997 dagli allora 15 paesi dell'Unione Europea ed è entrato in vigore il 1º maggio 1999) 181 E’ opportuno ricordare che il principio di non discriminazione ha trovato una piena adesione a livello comunitario con l’art. 13 del Trattato di Amsterdam: “Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.” Carta dei Diritti fondamentali UE- 2000 (Proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo.) (Capitolo 3, “Equality”, Articolo 21) È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l’orientamento sessuale. Decisione quadro per combattere razzismo e xenofobia (Il 28 Novembre 2008 il Consiglio dell’UE ha adottato la Decisione quadro 208/913/JHA per combattere certe forme ed espressioni di razzismo e xenofobia in termini di legge.) Anche se il campo penale non è di solito nelle competenze della Comunità Europea, il Consiglio dell’UE può decidere misure minime in campo penale. La Decisione quadro per combattere razzismo e xenofobia fornisce una base di leggi e regolamenti ai quali dovrebbero attenersi gli stati in caso di reati relativi a razzismo e xenofobia. La Decisione sostiene che tali comportamenti devono essere considerati reato in tutti gli stati membri e punibili con pene efficaci, proporzionate e dissuasive. Il focus principale della Decisione è nella prevenzione del pubblico incitamento alla violenza e all’odio contro le persone sulla base di razzismo e xenofobia. Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani (ECHR) (Aperto alle firme il 4 Novembre 1950; entrato in vigore il 3 Settembre 1953) Diritti di particolare rilevanza nella lotta contro la violenza razzista includono il diritto di essere liberi da torture o da trattamenti e punizioni inumane o degradanti (articolo 3). L’articolo 8 afferma che chiunque ha il diritto al rispetto per la propria vita familiare e privata, la propria casa e la corrispondenza. L’articolo 10 è particolarmente significativo come diritto della libertà di espressione. Questo diritto dovrebbe includere la libertà di opinione e di ricevere e impartire informazioni e idee senza interferenze dalla pubblica autorità. Il diritto alla libertà di espressione non è un diritto assoluto, ma soggetto a certi doveri e responsabilità. Tali limitazioni giustificano l’intervento delle pubbliche autorità per prevenire il crimine e proteggere la pubblica sicurezza o i diritti degli altri. L’articolo 14 elenca, in modo che non si pretende esaustivo, i campi protetti da norme di uguaglianza quali i campi di discriminazioni razziali, religiose, di genere, linguistiche e politiche. L’articolo 14 è significativo in riferimento alla violenza per mano di operatori pubblici. Le autorità statali hanno il dovere di prendere tutti i provvedimenti ragionevoli per stabilire se vi sono motivazioni di tipo razzista nei reati. Fallire nel riconoscere e gestire efficacemente la differenza tra una situazione di tipo razzista ed una senza connotazione di questo tipo potrebbe soddisfare il requisito di trattamento ingiustificato e inconciliabile con l’articolo 14. Convenzione Europea sul Crimine su Internet (Entrata in vigore il 1 Luglio 2004. Il 1 Marzo 2006 entra in vigore il Protocollo Addizionale alla Convenzione) Come afferma il rapporto del Consiglio della Convenzione sul Crimine in internet, l’aumento della tecnologia basata su internet mette alla prova le concezioni legali esistenti. Le informazioni fluiscono più liberamente attorno al mondo e i confini non sono più un limite a questo flusso. Coloro che hanno intenzione di disseminare materiale xenofobo e razzista si trovano sempre più frequentemente in luoghi diversi dai luoghi dove producono i loro effetti. Dato che le leggi nazionali sono generalmente confinate ad 182 un territorio specifico, è necessario fare appello a delle leggi internazioni adeguate e a strumenti legali che possano essere applicati anche oltre i limiti territoriali nazionali. La Convenzione sul Cyber Crimine fu elaborata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo, con la partecipazione attiva degli stati “osservatori” del Consiglio d’Europa, Canada, Giappone e USA. A quegli Stati che hanno ratificato il protocollo addizionale è richiesto di criminalizzare la disseminazione di materiale razzista e xenofobo attraverso i sistemi informatici, così come le minacce e gli insulti motivati da razzismo e xenofobia. ITALIA Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 3, Comma 1 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzionedi sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizionipersonali e sociali.” Il principio di uguaglianza si applica anche agli stranieri, senz’altro rispetto a principi e diritti fondamentali ma anche per altre posizioni, se la legge non ne preveda una differenziazione su basi “ragionevoli” (ad esempio: non è uguale il diritto di ingresso sul territorio nazionale del cittadino e dello straniero, posto il potere internazionalmente riconosciuto ad ogni Stato di ammettere o meno un non cittadino sul proprio suolo). Potrebbe ritenersi che, poiché l’art. 3 Cost. usa il termine “cittadini”, abbia come unici destinatari solo ed esclusivamente costoro; la dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno superato la letterale interpretazione, estendendo la portata della norma a tutti gli individui, dunque, anche agli stranieri. Il problema si pone, invece, nel senso di individuare quali diritti siano attribuibili anche agli stranieri (oltre che ai cittadini). Non è agevole perché la definizione di “diritto inviolabile” risente, alla pari di ogni altro concetto generale, del mutamento sociale, politico e storico, così che per alcuni è inviolabile o fondamentale il “diritto al lavoro” o il “diritto all’abitazione”, mentre per altri sono fondamentali quei “soli” diritti che afferiscono alla libertà della persona, a cui corrisponda, in pari grado, un interesse pubblico o meglio un valore costituente elemento dell’ordinamento democratico. In questa seconda classificazione vengono in rilievo il diritto d’asilo (art. 10, co. 3 Cost., corrispondente al dovere dello Stato di protezione nei confronti di regimi illiberali), il diritto alla difesa (artt. 24 e 113 Cost., corrispondente all’interesse statale ad un equo esercizio del potere giurisdizionale), i vari diritti di libertà in senso stretto - di credo religioso, di pensiero, di domicilio, di corrispondenza, ecc. (corrispondenti all’impegno dello Stato di organizzarsi in forma democratica), il diritto all’unità familiare, all’istruzione del minore, alla salute, tutti corrispondenti ad interessi anche pubblicistici (Zorzella, 2008). DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286, T.U. Articolo 43, comma 1 “(…), costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”. Articolo 43, comma 3 “Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.” 183 “Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia”. Articolo 43, comma 2 In ogni caso compie un atto di discriminazione: il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente; (…) DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 215, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica La direttiva n.43 del 2000 e il decreto 215/2003 vietano la discriminazione razziale ed etnica in materia di occupazione, istruzione, sicurezza sociale e assistenza sanitaria, fornitura di beni e servizi, compreso l’alloggio. DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 216, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. La direttiva n.78 del 2000 e il decreto 216/2003 vietano la discriminazione sul lavoro per religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Riprendendo uno strumento previsto nell’art.44 del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d. lgs. 25 luglio 1998, n.286), i due decreti legislativi consentono di agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni anche attraverso le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale o, per quanto riguardale discriminazioni razziali, attraverso le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato e tenuto presso il Ministero delle Pari Opportunità. Sono stati previsti poteri piuttosto ampi per il giudice che può provvedere al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio e l’adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. DECRETO LEGGE 26 aprile 1993, n. 122, Articolo 1 Discriminazione, odio e violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (omissis) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, (…) è punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi propaganda in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, ISTIGA a commettere o commette violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Già la legge Scelba del 1952 chiariva cosa doveva considerarsi come ricostruzione del disciolto partito fascista e collocava anche la propaganda razzista tra le manifestazioni sintomatiche di ciò che doveva essere vietato. La “Legge Mancino” completa il quadro della normativa penale ridefinendo il reato di diffusione o incitamento o commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ed introducendo sanzioni accessorie per coloro che fossero condannati per tali reati, per es. l’obbligo di svolgere lavori socialmente utili, restrizioni alla libertà personale o nell’esercizio di alcuni diritti civili. Nel contempo punisce le manifestazioni pubbliche di ostensione di simboli razzisti (Zorzella, 2008). LEGGE 20 maggio 1970, n. 300, Art. 15, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; 184 b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso. LE FUNZIONI E LE ATTIVITA’ DI POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA STRADALE Rilevazione sinistri Assistenza viabilità eventi sportivi e culturali Accertamento violazione veicoli in sosta Accertamento violazione veicoli in movimento Regolazione del traffico Partecipazione diretta udienze Giudice di Pace Educazione stradale nelle scuole Educazione stradale per la cittadinanza (p.e. assemblee) Rilascio contrassegni invalidi Autorizzazioni passi carrabili Parere in materia di segnaletica Redazione ordinanze stradali Rilascio permessi Zone Traffico Limitato Altro POLIZIA GIUDIZIARIA Ricezione denunce per reati Ricezione querele Attività investigativa a seguito di reati ambientali Attività investigativa a seguito di reati contro il patrimonio Attività investigativa a seguito di frodi e/o truffe Attività investigativa a seguito di reati contro la P.A. Attività investigativa a seguito lesioni dolose a persone Attività investigativa a seguito di reati del Codice della Strada Effettuazione di arresti di persone Identificazione di stranieri Accompagnamento di stranieri al confine Funzioni di Pubblico Ministero in udienza del Giudice di Pace Altro 185 POLIZIA AMMINISTRATIVA Rilascio licenze ed Autorizzazioni Tulps Controllo pubblici esercizi/alberghi/etc. Pareri su materia di pubblici esercizi Esecuzione ordinanze di sgombero Esecuzione ordinanze anti prostituzione Esecuzione ordinanze per igiene pubblica Altro POLIZIA COMMERCIALE Controllo presenze e gestione mercati settimanali Controllo presenze e gestione fiere e manifestazioni Pareri in materia di commercio Altro ASSISTENZA AI CITTADINI E POLIZIA DI PROSSIMITA’ Attività di protezione civile Salvataggi di persone/cose Interventi per presenza animali pericolosi Interventi per animali abbandonati/persi/feriti Accoglienza e sostegno donne maltrattate Accoglienza e sostegno minori Collaborazione con i servizi sociali/sanitari Sportelli informativi per il pubblico Altre attività informative per i cittadini (incontri, guide, ecc.) Recupero oggetti e documenti Sportelli/linee telefoniche di assistenza alle vittime di reato Altre forme di sostegno alle vittime di reato Assistenza ai cittadini extracomunitari Attività di prevenzione della devianza giovanile Interventi sul disagio minorile Interventi per la risoluzione di conflitti familiari/di vicinato Interventi per al risoluzione di conflitti nello spazio pubblico Campagne preventive contro la criminalità Servizio vigile di quartiere/frazione Servizi di rilevazione del disordine urbano Campagne di educazione al senso civico Prevenzione tossicodipendenza 186 TSO E ASO Altro POLIZIA DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO Pattugliamento del territorio Interventi di ordine pubblico con altre forze di polizia (p.e. stadio) Altro POLIZIA TRIBUTARIA Controllo sui tributi locali Raccolta informazioni economiche su cittadini Altro POLIZIA TRIBUTARIA Controllo sui tributi locali Raccolta informazioni economiche su cittadini Altro POLIZIA EDILIZIA Controlli in materia edilizia Verifica rispetto ordinanze Altro ALTRE FUNZIONI (VARIE) Redazione ordinanze ingiunzioni L. 689/81 Notifiche Scorta gonfalone Presenza sedute consiglio comunale Autorizzazioni pubblicità fonica Autorizzazioni occupazione suolo pubblico Autorizzazioni pubblicità Altre autorizzazioni Ricevimento denunce cessioni fabbricato Accertamenti anagrafici Ricezione denunce infortuni sul lavoro Ricezione oggetti rinvenuti Licenze di caccia e di pesca Altro 187 188 I PARTECIPANTI AL TAVOLO DI CONFRONTO Modena, 28 settembre 2013 Maurizio Andorlini Alessandra Bagnara Stefania Ballestracci Daniela Biondi Andrea Carlini Roberta Conti Alessandra de Rosa Michele di Giusto Pandelica Fanel Fausto Fanti Yassine Lafram Fabio Lanata Gian Lorenzo Lazzari Flora Leoni Oussama Mansour Luca Marti Giuseppe Paceti Alfio Parma Marco Porcu' Manuela Sansavini Maria Pia Santi Sefaf Siid Negash Idris Maria Stagliano' Vladimiro Torre Mahta Woldezghi Yi Yao Già comandante Vice comandante Operatore Cat. C Operatore Cat. C Operatore Cat. C Operatore Cat. C Operatore Cat. D Operatore Cat. D Operatore Cat. D Operatore Cat. D Operatore Cat. D Operatore Cat. D Operatore Cat. C Operatore Cat. D Operatore Cat. C Operatore Cat. D Operatore Cat. D Operatore Cat. C Operatore Cat. C SESTO FIORENTINO PM RAVENNA PM GENOVA PM RAVENNA PM GENOVA PM RAPALLO PM GENOVA PM BOLOGNA Rom di Bologna PM BOLOGNA Associazione giovani musulmani d’Italia PM RAPALLO PM RAVENNA PM PRATO Blogger yallaitalia.it PM BOLOGNA PM SESTO FIORENTINO PM BOLOGNA PM GENOVA PM RAVENNA PM PRATO Mediatore linguistico-culturale PM SESTO FIORENTINO Them Romanò Centro Interculturale Mondo Insieme Centro italocinese Ferrara 189 Marina Pirazzi, è formatrice SIPL e consulente per diverse organizzazioni; socia fondatrice e legale rappresentante dell’Associazione fra professioniste Extrafondente, assieme a Laura Pozzoli, e socia fondatrice dell’associazione senza fine di lucro EOS – Extrafondente Open Source. Dopo tredici anni trascorsi all’estero in diversi Paesi, occupandosi della componente di informazione, educazione e comunicazione di progetti sanitari, oggi é particolarmente impegnata nello sviluppo di azioni di contrasto alle discriminazioni e di sviluppo e promozione delle diversità. Dopo la laurea in Scienze politiche, ha conseguito un diploma sull’insegnamento agli adulti presso l’Università di Liverpool. Insegna in diversi contesti, sia sui temi legati alla discriminazione e alle pari opportunità, sia sulle metodologie di progettazione e progettazione partecipata. Ha coordinato numerosi progetti europei, in particolare sul tema dell’agire della polizia nelle società multiculturali ed è coautrice de “Il servizio di polizia per una società multiculturale. Un manuale per la Polizia di Stato”. Cristian Poletti, attualmente in servizio presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” dell’Università di Padova, è formatore SIPL. In precedenza è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca. Dopo la sua laurea in giurisprudenza all’Università di Bologna, ha concentrato i suoi interessi di ricerca nel campo della sociologia della devianza, sviluppando – all’interno del laboratorio di ricerca FarSiCura – svariate ricerche sui temi della sicurezza urbana e delle nuove pratiche di controllo esercitate nei contesti urbani. Nel 2007 ha ottenuto il dottorato di ricerca in “Studi Europei Urbani e Locali” in cotutela con l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Science-Po), con una tesi comparativa sulla polizia di prossimità in Francia ed in Italia. Ha pubblicato articoli sulle riviste italiane “Dei delitti e delle pene” e “Studi sulla questione criminale” e sulla rivista francese “ Revue Française de Science Politique”; ha contribuito alla realizzazione del manuale per la Polizia di Stato italiana “Il servizio di polizia per una società multiculturale. Un manuale per la Polizia di Stato” ed ha svolto negli anni molteplici attività come formatore per le forze di polizia sui temi della sicurezza urbana. 190 Scuola Interregionale di Polizia Locale Via F. Busani, 14 – 41122 Modena Tel. 059 285135 Fax. 059 283780 Cell. 3346866741 Email. [email protected] www.scuolapolizialocale.it 191 CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, AL SERVIZIO DI UNA SOCIETA’ CHE CAMBIA Manuale per le Polizie Locali nella società transculturale Scuola Interregionale di Polizia locale Via F. Busani 14 - 41122 Modena Tel: 059/285135 Fax: 059/283780 Cell. 334/6866741 Email: [email protected] Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità www.scuolapolizialocale.it
Scarica