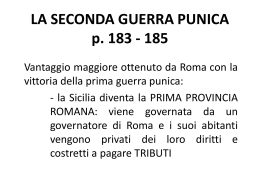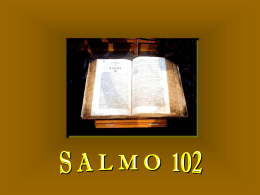Percorso tematico Il ritratto del nemico Livio Percorso tematico Basta un richiamo all’esperienza comune di lettori (o di telespettatori) di vicende incentrate su un grande conflitto (dai film western ai cartoni animati dei “supereroi”) per comprendere come l’accurata descrizione del nemico, in tutta la sua potenza e in tutta la sua pericolosità, sia una componente ineliminabile dell’intreccio narrativo, un ingrediente insostituibile per conferire pathos e drammaticità al racconto. Non è quindi casuale che proprio da un’accurata descrizione di Annìbale, Livio cominci la decade della sua opera storica dedicata specificamente alla seconda guerra punica, che molti manuali registrano infatti come “guerra annibalica”. I capitoli XXI,1-4 hanno precisamente questa funzione: Annibale entra in scena, e tutti sanno che da questo momento l’intera vicenda narrata ruoterà intorno a lui. Livio, d’altra parte, non era (e sapeva di non essere) il primo a descrivere Annibale, e neppure il primo a mettere in scena, con tutti i trucchi del grande narratore, un micidiale nemico di Roma: Polibio, sia pure in greco, aveva raccontato la storia della seconda guerra punica e descritto Annibale prima di lui (Storie III, 8-12), e più di un cenno ne aveva dato anche Cornelio Nepote (Vita di Annibale 1-2), mentre Sallustio aveva dedicato pagine memorabili di entrambe le sue monografie allo schizzo di Catilina (Cat. 5) e di Giugurta (lug. 5-8). Nelle pagine che seguono abbiamo raccolto la descrizione polibiana degli “esordi” di Annibale, i due testi sallustiani suddetti e i primi quattro capitoli della decade annibalica di Livio. A conclusione del percorso, compare una breve pagina di Gianni Cipriani; in chiusura presentiamo alcuni “ritratti” di grandi nemici del XX secolo: Hitler e Stalin. Polibio: Annibale Il racconto che lo stesso Annìbale, in Polibio, fa della sua precoce spedizione in Spagna con il padre Amìlcare e del suo giuramento “antiromano” è caratterizzato da un’atmosfera di riservatezza e di mistero. 8. Fabio, lo storico romano, dice che, oltre all’ingiustizia perpetrata a danno dei Saguntini, anche la tracotanza e l’ambizione di Asdrubale furono cause della guerra annibalica. Questi infatti, ottenuto vasto potere nelle regioni dell’Iberia, ritornato in Africa, avrebbe tentato di abolire la costituzione vigente e trasformare in monarchia il governo cartaginese. Ma i cittadini che erano al potere, resisi conto del suo piano, si sarebbero accordati per opporglisi: Asdrubale a sua volta, sospettando i loro maneggi, si sarebbe allontanato dall’Africa e da allora in poi avrebbe governato l’Iberia a suo piacimento, senza più prestare obbedienza al senato cartaginese. Annibale, che f in dall’adolescenza aveva condiviso e ammirato i suoi disegni, nel succedergli al comando dell’Iberia, avrebbe usato lo stesso sistema di governo di Asdrubale. Così anche in quell’occasione egli avrebbe fatto guerra ai Romani di propria iniziativa, contrariamente al parere dei Cartaginesi. Nessuno dei Cartaginesi autorevoli infatti avrebbe approvato la condotta di Annibale nei riguardi di Sagunto. Detto questo, aggiunge come, dopo la presa di Sagunto, siano giunti a Cartagine i messi romani, per chiedere ai Cartaginesi la immediata consegna di Annibale e, in caso non fosse concessa, per dichiarare loro la guerra. Ma che cosa potrebbe rispondere il nostro storico, se qualcuno gli domandasse quale occasione sarebbe stata più propizia ai Cartaginesi, o quale atto più giusto e vantaggioso, – dal momento che f in da principio, a suo dire, erano contrari all’azione di Annibale, – che accondiscendere alle richieste dei Romani, consegnare il responsabile delle ingiustizie compiute e togliere facilmente di mezzo, per opera d’altri, con ragioni plausibili, il comune nemico della città, procurando nello stesso tempo la sicurezza al paese, stornando la guerra che lo minacciava, e vendicandosi mediante un semplice decreto? Nulla, evidentemente. Ma i Cartaginesi non solo non fecero nulla di tutto questo, ma per diciassette anni ininterrottamente combatterono secondo la volontà di Annibale e non abbandonarono la lotta f inché, delusi in tutte le loro speranze, non ebbero corso l’estremo pericolo con la patria e i loro cari. 9. Ma perché mai volli citare Fabio e quanto egli scrisse? Certo non perché i suoi giudizi meritino fede e io tema che qualcuno gli possa credere – a qualunque lettore infatti, anche indipendentemente dalla mia dimostrazione, apparirà di per se stessa l’assurdità di quanto egli dice – ma per mettere in guardia quanti prenderanno in mano i suoi libri, perché non badino al titolo, ma al loro contenuto reale. Alcuni infatti non si curano dei fatti narrati, 1 IL RITRATTO DEL NEMICO quanto della persona dello storico, e osservando che lo scrittore fu contemporaneo agli avvenimenti e fece parte del senato romano, ritengono senz’altro credibile tutto quanto egli dice. Io affermo invece che i lettori devono bensì tener conto dell’autorità di chi scrive, ma non stimarla indiscutibile e per lo più trarre il loro giudizio dall’attento esame dei fatti. Per ritornare alla guerra fra Romani e Cartaginesi – da questo punto infatti abbiamo cominciato la nostra digressione – si deve ritenere che ne sia stata causa prima l’animosità di Amilcare soprannominato Barca, padre di Annibale: per nulla domato dopo la guerra in Sicilia, poiché aveva conservato intatte, nelle operazioni da lui dirette, le forze con le quali aveva combattuto intorno all’Erice, ed era venuto a patti cedendo alle circostanze, solo in seguito alla sconf itta subita dai Cartaginesi nella battaglia navale, egli covava intero il suo risentimento contro i Romani, e spiava l’occasione propizia a un attacco. Se non fosse avvenuta la sommossa dei mercenari contro i Cartaginesi certamente, per quanto era in lui, avrebbe iniziato i preparativi per un’altra impresa militare. Prevenuto dai disordini interni, dovette occuparsi esclusivamente di quelli. 10. Quando, repressa la suddetta ribellione, i Romani dichiararono loro la guerra, i Cartaginesi dapprima si mostrarono disposti a negoziare su ogni punto, convinti che, poiché la loro causa era giusta, sarebbe senz’altro prevalsa: abbiamo già trattato di questi fatti nei libri precedenti, prescindendo dai quali non sarebbe possibile comprendere bene né quanto diciamo ora, né quanto diremo in seguito. Poiché i Romani rif iutavano di trattare, vinti dalle circostanze, sebbene a malincuore, impotenti a fare altro, i Cartaginesi cedettero la Sardegna e accondiscesero pure a pagare altri milleduecento talenti oltre a quelli già pattuiti, pur di non essere costretti ad affrontare una guerra nelle condizioni in cui versavano. Questa dunque è la seconda importantissima causa della guerra scoppiata più tardi. Amilcare infatti, aggiunta al suo antico risentimento l’ira concepita per questa ragione dai suoi concittadini, non appena ebbe represso la ribellione dei mercenari e così ebbe garantito la sicurezza al suo paese, subito si accinse con ogni impegno alla conquista della penisola iberica, pensando di servirsene come base per la guerra contro i Romani. Il successo dei Cartaginesi in Ispagna è da ritenere la terza delle cause della guerra annibalica, perché, f iduciosi nelle forze così ottenute, essi coraggiosamente si accinsero alla nuova impresa. Con molte prove si potrebbe dimostrare che Amilcare, benché morto dieci anni prima che essa scoppiasse, ebbe gran parte nella preparazione della seconda guerra punica, ma penso che quanto sto per narrare sarà suff iciente a suffragare la mia affermazione. 11. Quando Annibale, debellato, si allontanò inf ine dalla patria e andò a vivere presso Antioco, i Romani, intuendo i disegni degli Etoli, inviarono ambasciatori presso il re di Siria, desiderosi di conoscerne chiaramente le intenzioni. Gli ambasciatori, vedendo che Antioco era favorevole agli Etoli e desideroso di combattere contro i Romani, si diedero ad adulare Annibale con l’intenzione di renderlo sospetto ad Antioco, e riuscirono nel loro intento. Mentre, col passar del tempo, il re diff idava sempre più gravemente di Annibale, una volta il discorso venne a cadere sulla strana freddezza che si era insinuata nei rapporti del re con l’ospite cartaginese. In tale occasione, dopo essersi difeso in molti modi, a corto di altri argomenti, Annibale ricorse a un aneddoto: raccontò cioè che quando suo padre stava per partire con le truppe per la spedizione in Iberia, egli, che aveva allora nove anni, si era trovato presso l’altare sul quale quello sacrif icava a Zeus. Celebrato il sacrif icio con auspici favorevoli, Amilcare, fatte le libagioni agli dèi e compiuti i riti abituali, aveva pregato gli altri che assistevano alla cerimonia di allontanarsi un poco e, chiamato a sé Annibale, gli aveva domandato benevolmente se volesse accompagnarlo nella spedizione. Egli aveva accettato ben volentieri, anzi l’aveva pregato con insistenza, come sogliono fare i fanciulli, di condurlo con sé. Presolo per la destra, il padre l’aveva allora condotto presso l’altare e, fattigli toccare i sacri arredi, gli aveva ordinato di giurare che mai sarebbe stato amico dei Romani. Egli chiedeva dunque ad Antioco che, informato di questo episodio, se macchinava qualche atto ostile ai Romani, si sentisse sicuro e avesse f iducia di Annibale, certo di avere in lui il più sincero dei sostenitori. Ma qualora volesse stringer con quelli patti di amicizia, non attendes2 Livio Percorso tematico se accuse precise: senz’altro diff idasse di lui e si tenesse sulla difensiva: egli avrebbe sempre fatto contro i Romani tutto ciò di cui era capace. 12. Antioco dopo il racconto e le dichiarazioni di Annibale, convinto che egli avesse parlato con piena sincerità, abbandonò ogni precedente sospetto. Dell’ostilità di Amilcare verso i Romani e di tutto il suo programma, questa si deve considerare testimonianza inconfutabile, confermata del resto dai fatti: egli rese Asdrubale, marito di sua f iglia, e Annibale suo f iglio nemici tanto implacabili dei Romani, che odio più feroce del loro non potrebbe esistere. Asdrubale morì troppo presto per poter rendere palesi a tutti i suoi sentimenti: ma ad Annibale le circostanze concedettero di dimostrare f in troppo apertamente l’inimicizia ereditata dal padre contro i Romani. Bisogna dunque che gli uomini di stato di nulla si preoccupino più che di conoscere a fondo i sentimenti di chi compone una inimicizia o conclude un’alleanza e considerino se i nemici vengono a patti solo sotto la pressione delle circostanze o se siano intimamente domati: nel primo caso dovranno continuare a guardarsene, ricordando che continuamente sono in attesa delle circostanze favorevoli, altrimenti potranno aver f iducia negli antichi nemici, come in sudditi o amici fedeli, e approf ittare senza esitazione, se sia necessario, dei loro servigi. (Trad. C. Schick) Cornelio Nepote: Annibale La presentazione di Annibale nella vita omonima di Cornelio Nepote appare dominata da una significativa equazione: come Roma fu la più grande città della storia, così Annibale fu il più grande avversario di Roma. Inutile dire come la grandezza del nemico torni a maggior lode della vittoria dei “nostri”. 1.1. Annibale cartaginese, f iglio di Amilcare. Se è vero – e nessuno ne dubita – che il popolo romano ha superato in valore tutte le altre genti, non si può negare che Annibale di tanto abbia primeggiato in avvedutezza tra gli altri condottieri, quanto il popolo romano eccelle per coraggio su tutte le nazioni. 2. Tutte le volte che combatté con i Romani in Italia, sempre ebbe la meglio, ed il successo f inale – così pare –, sarebbe toccato a lui, se in patria il malvolere dei suoi concittadini non ne avesse indebolito la posizione. Ma la gelosia di molti ebbe il sopravvento sul valore di uno solo. 3. In lui l’odio per i Romani, trasmessogli dal padre come un’eredità, era così radicato che egli morì prima che esso si placasse: anche cacciato dalla patria e costretto a ricorrere a protezioni straniere, non cessò mai, almeno nei suoi disegni, di muovere guerra ai Romani. 2.1. Per non parlare di F ilippo, che egli, da lontano, indusse a farsi nemico di Roma, seppe accendere nell’animo di Antioco – a quel tempo il più potente di tutti i re – tanto ardore guerriero, che questi fece ogni sforzo per portare dal Mar Rosso le armi contro l’Italia. 2. Era giunta a corte una delegazione romana incaricata di sondare le intenzioni di Antioco e di indurre il re, con segreti maneggi, a sospettare che Annibale, corrotto dai Romani, avesse cambiato partito; e le insinuazioni non erano cadute nel vuoto. Allora Annibale, che si era accorto della cosa e si vedeva ora escluso dagli affari di carattere riservato, 3. scelto il momento opportuno si presentò al re, richiamò alla memoria di lui molte prove sia della sua lealtà che del suo odio antiromano, e aggiunse: «Quand’ero un bambino di non più di nove anni Amilcare mio padre, sul punto di partire da Cartagine per la Spagna come comandante supremo, stava sacrif icando vittime a Giove Ottimo Massimo. 4. Mentre si svolgeva la sacra cerimonia mi domandò se volevo partire con lui per la guerra. Contentissimo cominciavo ad insistere che non esitasse a condurmi, quando egli mi disse: “Lo farò, se mi farai la promessa che ti chiedo”. Mi condusse presso l’altare, presso al quale aveva dato inizio al sacrif icio, e, fatta scostare ogni altra persona, mi fece giurare, con la mano sull’ara, che non avrei mai avuto amicizia con i Romani. 5. Il giuramento fatto a mio padre è stato da me rispettato f ino a questa mia età, in maniera tale che a nessuno è lecito supporre che io possa 3 mutare sentimento per il tempo che mi resta. 6. Perciò se hai qualche intenzione amichevole verso i Romani, non farai cosa imprudente lasciandomi all’oscuro; ma il giorno che ti preparerai a combatterli, agirai contro il tuo interesse, se non assegnerai a me il comando». (Trad. L. Agnes) Sallustio: Catilina e Giugurta Un nobile decaduto, una serie di capacità e di virtù irrimediabilmente piegate al male, sullo sfondo di una civitas in cui è ormai stabilmente penetrato il germe della corruzione: è il ritratto sallustiano di Catilina, l’uomo che tenne per breve tempo in apprensione l’intero stato, minacciandone una repentina distruzione. Il chiaroscuro che domina il ritratto ha più di un elemento in comune con l’esquisse liviana di Annibale. 5.1. Lucio Catilina, nato da illustre famiglia, fu vigorosissimo di intelletto e di corpo, ma di indole malvagia e depravata. 2. F in dall’adolescenza gli tornarono gradite le guerre intestine, le stragi, le rapine, le discordie civili, e in questi misfatti esercitò la sua giovinezza. 3. Corpo resistente alla fame, al freddo, alle veglie, oltre ogni credere. 4. Animo audace, subdolo, mutevole, simulatore e dissimulatore di ogni cosa; bramoso dell’altrui, sperperatore del proprio, sfrenato nelle passioni; 5. di eff icace facondia, di scarsa saggezza, la sua mente insaziabile aspirava a cose smisurate, incredibili, irraggiungibili. 6. Dopo la dittatura di Lucio Silla, lo aveva invaso una pazza bramosia di impadronirsi dello Stato; né si faceva scrupolo dei mezzi con i quali l’avrebbe appagata, pur di procurarsi il potere. 7. Di giorno in giorno l’animo indomito era sempre più sconvolto dalla scarsità delle rendite e dalla consapevolezza dei misfatti; due moventi che egli aveva acuito con la condotta che già ho menzionato. 8. Lo spingevano inoltre i corrotti costumi dei cittadini, travagliati da due mali funesti e tra loro opposti, la fastosità e la brama di ricchezze. 9. E giacché l’occasione mi ha portato ad accennare ai costumi della città, l’argomento stesso pare mi inviti a rifarmi indietro e a ricordare brevemente le istituzioni dei nostri padri in pace e in guerra, i sistemi con cui ressero lo Stato, e quanto illustre lo abbiano lasciato: e come, trasformandosi a poco a poco, da bellissimo <e virtuosissimo> sia divenuto miserando e corrottissimo. Come Annibale, anche Giugurta è un nordafricano di grandi doti, di spiccato carattere, di non comuni resistenza e intelligenza. E come Annibale è uomo privo di scrupoli, incapace di mantenere la parola data, abilissimo nel mentire e dissimulare. Come il Cartaginese, anche il Nùmida mostra sin dall’infanzia i caratteri positivi e negativi che ne determineranno il destino. IL RITRATTO DEL NEMICO 5.1. Mi accingo a narrare la guerra che il popolo romano condusse contro Giugurta, re dei Numidi, anzitutto perché fu grande, sanguinosa e di alterne vicende, in secondo luogo perché allora, per la prima volta, si affrontò la tracotanza della nobiltà: 2. contesa che sconvolse ogni legge divina ed umana e pervenne a un tal grado di furore che solo la guerra e la devastazione dell’Italia posero f ine alle discordie civili. 3. Ma prima di iniziare la narrazione richiamerò qualche fatto precedente, aff inché il complesso degli avvenimenti risulti più chiaro e più evidente ai lettori. 4. Durante la seconda guerra punica, nella quale il condottiero dei Cartaginesi, Annibale, aveva inferto il più grave colpo alla potenza dell’Italia da quando il nome romano era salito in fama, Massinissa, re dei Numidi, accolto in amicizia da Publio Scipione – cui fu in sèguito dato il soprannome di Africano per il suo valore – aveva compiuto molte e nobili imprese guerresche. Per le quali, vinti i Cartaginesi e fatto prigioniero Siface, il cui impero si affermò in Africa potente e vasto, il popolo romano fece dono al re di tutte le città e dei territori da lui occupati con le armi. 5. Quindi si stabilì una amicizia utile a Massinissa, leale e onorevole per noi. Ma la sua vita e il suo impero terminarono contemporaneamente. 6. Morti di malattia i fratelli Mastanabale e Gulussa, ottenne quindi il regno, da solo, il f iglio Micipsa. 7. Questi generò Aderbale e Iempsale e tenne presso di sé, educandolo in 4 Livio Percorso tematico modo identico ai suoi f igli, Giugurta, f iglio del fratello Mastanabale, che Massinissa aveva lasciato senza diritti, perché nato da una concubina. 6.1. Egli, appena fu giovinetto, vigoroso di corpo, bello di volto, ma soprattutto brillante di ingegno, non si lasciò corrompere dalla mollezza e dall’ozio, ma, secondo il costume di quel popolo, cavalcava, si addestrava con l’arco, gareggiava con i coetanei nelle corse e, benché eccellesse su tutti per gloria, tuttavia a tutti era caro. Inoltre, dedicava molto tempo alla caccia: per primo, o tra i primi, colpiva i leoni e le f iere: moltissimo agiva, pochissimo parlava di sé. 2. Benché Micipsa, dapprincipio, si fosse compiaciuto di tutto questo, pensando che i meriti di Giugurta sarebbero stati di onore al suo regno, tuttavia, quando si rese conto che quel giovane aumentava sempre più il suo prestigio, mentre egli era ormai avanzato in età e piccoli ancora i suoi f igli, profondamente impensierito da questo fatto, molte cose rimuginava nel suo animo. 3. Lo spaventava la natura umana, avida di comando e pronta ad appagare le passioni dell’animo, per di più l’occasione propizia offerta dall’età sua e dei suoi f igli, capace di traviare, con la speranza della preda, persino uomini privi di ambizione; inoltre, il caldo favore dei Numidi per Giugurta, tale da fargli temere, se avesse soppresso con l’inganno un uomo così meritevole, qualche sedizione o guerra civile. 7.1. Stretto da queste diff icoltà, appena si rese conto che né con la violenza né con le insidie si poteva eliminare quell’uomo tanto gradito al popolo, decise, poiché Giugurta era pronto di braccio e desideroso di gloria militare, di metterne a repentaglio la vita e di tentare in quel modo la sorte. 2. Quindi, durante la guerra di Numanzia, Micipsa, inviando al popolo romano schiere ausiliarie di cavalieri e di fanti, sperando che, o per ostentazione del proprio valore o per la ferocia dei nemici Giugurta sarebbe facilmente caduto, lo pose a capo dei Numidi che destinava alla Spagna. 3. Ma le vicende si svolsero molto diversamente da come aveva congetturato. 4. Infatti Giugurta, siccome era di indole instancabile e brillante, appena conobbe il carattere di Publio Scipione, allora condottiero dei Romani, e la tattica dei nemici, con attività assidua e con grande zelo, con l’ubbidienza umilissima e con l’affrontare spesso i pericoli, aveva ottenuto in breve tale rinomanza che riusciva carissimo ai nostri e temutissimo ai Numantini. 5. E in verità, cosa diff icilissima fra tutte, era coraggioso in battaglia e saggio nel consiglio, qualità delle quali l’una, per la preveggenza, suole generare il timore, l’altra, per l’audacia, la temerità. 6. Quindi il generale aff idava a Giugurta l’attuazione di quasi tutte le imprese diff icili, lo annoverava tra i suoi amici, e di giorno in giorno l’aveva più caro, constatando il felice esito di tutti i suoi piani e di tutte le sue imprese. 7. A questo si aggiungevano la liberalità d’animo e la sagacia dell’ingegno, doti con le quali aveva stretto a sé, in familiare amicizia, molti Romani. 8.1. In quella circostanza c’erano nel nostro esercito molti uomini nuovi e molti nobili, per i quali le ricchezze erano preferibili al bene e all’onestà, intriganti in patria, influenti presso gli alleati, più noti che degni di stima; essi accendevano con reiterate promesse l’ambizioso animo di Giugurta: se il re Micipsa fosse scomparso, lui solo avrebbe potuto impadronirsi del potere in Numidia: egli possedeva somme capacità e a Roma tutto si poteva comprare. 2. Ma quando, distrutta Numanzia, Publio Scipione decise di congedare gli ausiliari e di tornare in patria egli stesso, dopo aver ricompensato e lodato splendidamente Giugurta in pubblica adunanza, lo portò nella sua tenda e qui segretamente lo ammonì di coltivare l’amicizia del popolo romano apertamente piuttosto che con mezzi occulti e di non abituarsi a sperperare denaro con alcuno; essendo rischioso comperare da pochi ciò che è della comunità. Se avesse persistito nelle sue buone qualità, ne avrebbe ottenuto come conseguenza naturale gloria e regno: se invece avesse voluto precipitare troppo gli eventi, sarebbe caduto in rovina proprio per colpa delle sue ricchezze. (Trad. P. Frassinetti) Llvio: Annibale Che Polibio sia tra le fonti del ritratto liviano di Annibale (XXI, 1-4) sembra indiscutibile. Ma altrettanto chiaro è che esso è decisamente mutato nel tono e nello spirito. Il “volto” di Annibale che emerge dalle 5 righe dello storico patavino è indubbiamente tratteggiato sul modello dello storico greco, ma le tinte e i pennelli sono più simili a quelli di Sallustio. L’ “Annibale della storia” di Polibio è qui già il grande nemico di Roma, l’avversario abilissimo e terribile che può distruggere la città. IL RITRATTO DEL NEMICO 1.1. In questa sezione particolare della mia opera mi è consentito premettere ciò che moltissimi storici di solito dichiarano come introduzione generale al loro lavoro: narrerò la guerra più degna di essere ricordata tra tutte quelle che mai siano state combattute, quella che i Cartaginesi, sotto la guida di Annibale, combatterono con il popolo romano. 2. Mai infatti stati o popoli più potenti guerreggiarono tra loro, né mai gli stessi Romani e Cartaginesi ebbero tante forze e vigore; inoltre essi ponevano a confronto tecniche militari non l’una all’altra sconosciute, ma già sperimentate durante la prima guerra punica; e a tal punto mutevoli furono le sorti del conflitto e dubbio l’esito, che i vincitori furono più dei vinti vicini al rischio della rovina. 3. Combatterono, inoltre, spinti da un odio quasi più grande delle forze impiegate, poiché i Romani ritenevano cosa indegna che i vinti di propria iniziativa muovessero guerra ai vincitori, mentre lo sdegno dei Cartaginesi nasceva dalla convinzione che sui vinti fosse stato esercitato un potere superbo e avido. 4. Si dice anche che Annibale all’età di circa nove anni abbia pregato con le moine dei fanciulli il padre Amilcare di condurlo con sé in Ispagna, mentr’egli, sul punto di far passare colà l’esercito – al termine della guerra africana – compiva un sacrif icio; e, fatto avvicinare all’altare, toccati i sacri oggetti del culto, sia stato costretto a giurare che, non appena gli fosse possibile, sarebbe stato nemico del popolo romano. 5. Quell’uomo dall’orgoglio smisurato era tormentato dalla perdita della Sicilia e della Sardegna; giacché la Sicilia era stata ceduta per l’eccessiva precipitazione nel perdere ogni speranza e la Sardegna durante la ribellione africana era stata sottratta con l’inganno dai Romani, che per di più avevano imposto il pagamento di una indennità di guerra. 2.1. Poiché era tormentato da questi pensieri, sia durante la guerra africana, la quale ebbe luogo sùbito dopo la pace imposta dai Romani, per cinque anni, sia poi durante i nove anni trascorsi nell’accrescere i domini cartaginesi in Ispagna, il suo comportamento fu tale 2. da fare risultare chiaro che egli aveva in mente una guerra di proporzioni più vaste di quella che stava conducendo, e che, se fosse vissuto più a lungo, sotto la guida di Amilcare avrebbero portato guerra all’Italia i Cartaginesi i quali ve la portarono sotto la guida di Annibale. 3. La morte di Amilcare, che giunse molto a proposito, e la troppo giovane età di Annibale differirono la guerra. Nel periodo che intercorse tra il padre e il f iglio ebbe il comando per circa otto anni Asdrubale, il quale in un primo tempo si era accattivato le simpatie di Amilcare, a quanto dicono, con la sua f iorente giovinezza, 4. poi era stato accolto da lui come genero in virtù di altre qualità, certamente dell’animo, e, in quanto genero (di Amilcare), con l’appoggio del partito dei Barca, la cui influenza era grande sia presso l’esercito sia presso il popolo, non certamente per volontà dei primi cittadini aveva ottenuto il comando militare. 5. Egli, usando nell’agire l’avvedutezza più che la forza, ingrandì i domini cartaginesi stringendo legami d’ospitalità con i piccoli re locali e cattivandosi il favore di nuove popolazioni mediante vincoli d’amicizia con i loro capi, più che ricorrendo alla guerra o alle armi. 6. E tuttavia la pace non valse affatto a salvaguardarlo più della guerra; un barbaro lo trucidò davanti agli occhi di tutti, infuriato perché egli gli aveva ucciso il padrone; e, arrestato dagli astanti con la stessa espressione del volto che avrebbe avuta se fosse riuscito a fuggire, anche mentre era straziato dalle torture mantenne il volto atteggiato in modo da sembrar perf ino ridere, per una gioia più forte dei dolori. 7. Con questo Asdrubale, poiché era stato straordinariamente abile nell’attirare e nell’annettere al suo dominio le popolazioni (della Spagna), il popolo romano aveva rinnovato il trattato, nel senso che il f iume Ebro doveva essere conf ine tra l’una e l’altra sfera d’influenza e ai Saguntini, situati a metà tra le zone d’influenza dei Romani e dei Cartaginesi, doveva essere conservata l’indipendenza politica. 3.1. Circa il successore di Asdrubale non ci furono dubbi alla scelta preliminare da parte dei soldati, con la quale il giovane Annibale era stato portato nel pretorio e nominato comandante generale con grandi grida e applausi di unanime consenso, seguiva il favore del popolo. 2. Non appena Annibale era diventato adulto, Asdrubale l’aveva chiamato presso di 6 Livio Percorso tematico sé con una lettera; e la cosa era stata discussa anche in senato. 3. Mentre il partito dei Barca si adoperava a ottenere che Annibale si avvezzasse alla vita militare e succedesse al padre nel comando, Annone, capo dell’altro partito, disse: “Da un lato, Asdrubale pare formulare una giusta richiesta; dall’altro, tuttavia, io ritengo che non gli si debba concedere ciò che chiede”. 4. Avendo richiamato su di sé l’attenzione di tutti, stupiti poiché egli aveva espresso il suo parere in modo tanto ambiguo, soggiunse: “Asdrubale a buon diritto ritiene di potere reclamare dal f iglio quella grazia giovanile che egli stesso offrì al padre di Annibale perché ne godesse; ma per noi non è affatto decoroso che i nostri giovani si avvezzino alle voglie dei comandanti, come se fosse questo il tirocinio nel servizio militare. 5. O forse questo temiamo, che il f iglio di Amilcare troppo tardi veda i poteri illimitati e il lustro del regno di suo padre, e che noi non abbastanza per tempo diventiamo sudditi del f iglio di quel re, al cui genero i nostri eserciti sono stati lasciati in eredità? 6. Io ritengo che codesto giovane debba esser tenuto in patria, sottomesso alle leggi, sottomesso ai magistrati; ritengo che gli si debba insegnare a vivere con diritti uguali a quelli di tutti gli altri, perché non accada che un giorno o l’altro questo fuocherello dia luogo a un grande incendio”. Pochi, e all’incirca tutti i migliori, erano d’accordo con Annone; ma, come di solito succede, la maggior parte ebbe la meglio sulla parte migliore. 4.1. Annibale, inviato in Ispagna, f in dal momento del suo arrivo si attirò il favore di tutto l’esercito; 2. i veterani credevano che Amilcare giovane fosse stato loro restituito; vedevano nell’espressione del volto (di Annibale) lo stesso fresco vigore e nei suoi occhi la stessa energia, nel volto gli stessi lineamenti, la stessa f isionomia del padre. Poi in breve tempo egli fece sì che le fattezze del padre in lui riprodotte contassero minimamente nel conciliargli le simpatie; 3. non ci fu mai un temperamento più adatto nello stesso tempo a due qualità tra loro del tutto opposte, l’ubbidire e il comandare. Perciò non si sarebbe potuto distinguere facilmente se fosse più caro al comandante o all’esercito; 4. tutte le volte che in un’azione si richiedevano intrepidezza e coraggio, né Asdrubale preferiva scegliere a comandante alcun altro, né i soldati sotto la guida di un altro avevano maggior f iducia o baldanza. 5. Nel cercare i pericoli aveva moltissima audacia, nel mezzo dei pericoli moltissima prudenza; nessuna fatica poteva f iaccare il suo corpo o sopraffare il suo animo; 6. sapeva tollerare in ugual misura il caldo e il freddo; nel mangiare e nel bere si regolava in base al bisogno naturale, non al piacere della gola. Alla veglia e al sonno non dedicava momenti ben distinti dalla successione del giorno e della notte; 7. si riposava nei momenti lasciati liberi dal servizio; e non si procurava il riposo con morbide coltri né con il silenzio: molti spesso lo videro coricato per terra, coperto da un mantelletto militare, tra gli avamposti e i corpi di guardia dei soldati. 8. Nel modo di vestire non si distingueva per nulla dai colleghi di pari grado; al contrario le sue armi e i suoi cavalli attiravano gli sguardi. Era di gran lunga il primo dei cavalieri e nello stesso tempo anche dei fanti; era il primo a scendere in battaglia, l’ultimo a ritirarsene. 9. Queste sue eccezionali virtù erano pareggiate da enormi vizi: una crudeltà disumana, una malafede peggio che cartaginese, nessun senso del vero né del sacro, nessun timore degli dèi, nessun rispetto per i giuramenti, nessuno scrupolo di coscienza. 10. Con questo temperamento incline a virtù e a vizi, per tre anni prestò servizio sotto il comando supremo di Asdrubale, senza trascurare nulla di ciò che uno destinato a diventare un grande generale doveva fare e imparare. (Trad. P. Ramondetti) “Annibali” a confronto Nelle righe che seguono, Gianni Cipriani tira le somme sul ritratto liviano di Annibale, in particolare sulla base di un confronto con Polibio. È sempre affascinante rintracciare nelle biograf ie dei grandi uomini quei tratti della personalità che si ritrovano poi sviluppati, in modo eccezionale, in età matura. Ma al critico, che indaga curiosamente sui germi di quella che sarà, col passare degli anni, la gigantesca statura morale e politica di Annibale, resta ben poco da scoprire. Solo un episodio dei suoi 7 IL RITRATTO DEL NEMICO primi anni giovanili ci è dato di conoscere, anche in modo f in troppo insistente, e riguarda, com’è noto, il giuramento di odio verso i Romani prestato davanti agli altari. Polibio (III, 11), secondo la sua versione, ci narra che, mentre Annibale si trovava presso la corte del re Antioco, i Romani, prevedendo il pericolo di un nuovo conflitto, mandarono ambasciatori per conoscere meglio le intenzioni dei loro nemici e per cercare, come poi avvenne, di intorbidare i loro rapporti. Poiché Antioco si era insospettito per i frequenti contatti occorsi fra i rappresentanti romani e Annibale, questi, notata la freddezza del suo ospite, raccontò, allora, per riconquistarsene la f iducia, un episodio della sua fanciullezza, di quando aveva cioè nove anni: suo padre, in procinto di partire per la Spagna, stava celebrando per l’occasione dei sacrif ici in onore di Zeus onde assicurarsene il favore durante il corso della spedizione; alla f ine della cerimonia, dedotti favorevoli auspici e concluse le libagioni, Amilcare aveva fatto allontanare momentaneamente i presenti e, chiamato a sé il f iglio, gli aveva proposto affettuosamente di accompagnarlo in quella campagna militare. Annibale aveva accettato di buon grado e aveva addirittura insistito come fanno i bambini; il padre allora lo aveva preso per la destra e, condottolo vicino all’altare, gli aveva ordinato di giurare, con le mani sugli arredi sacri, che mai avrebbe trattenuto rapporti di amicizia con i Romani. L’episodio, come eccezionale e singolare documento della giovinezza di Annibale, suscita, nei fatti, un complesso di interrogativi, da quello concernente la sua genesi a quello relativo alla sua funzionalità all’interno di una biograf ia. La questione si complica, poi, se si analizza il rilievo emblematico che Livio dà a questo micro-racconto e all’eco che questa sua rielaborazione ha poi lasciato nelle versioni successive del medesimo aneddoto. […] Livio capovolge, a sua volta, i termini del dibattito: la prospettiva, suggerita da Polibio, di un individuo (Amilcare) tutto chiuso nei limiti di un suo progetto strettamente personale, lascia lo spazio alla presentazione di un personaggio (Annibale) che sintetizza e incarna la volontà guerriera di tutta una nazione. Appena preceduta dalla considerazione introduttiva, secondo cui nella seconda guerra punica si affrontarono due potenze al massimo del loro rigoglio f isico e spirituale, si staglia immediatamente davanti agli occhi del lettore, in funzione sempre centrale e dinamica, la f igura di Annibale, quale espressione emblematica del genio nazionale, carico di odio e ansioso di rivincita. Si giustif icano e si apprezzano allora i ritocchi apportati da Livio, anche se, al proposito, non condividerei l’opinione complessiva esposta dal Girod: a suo parere, lo storico patavino avrebbe trattenuto, dopo la lettura diretta di Polibio, determinati elementi parziali del racconto e li avrebbe poi adattati ad una nuova prospettiva, orientata in una voluta, anche se non violenta antitesi con quella dello storico greco. Dal mio punto di vista, la descrizione liviana della scena del giuramento di Annibale rivela proprio attraverso le sue originali modif icazioni la spia di una duplice tecnica di elaborazione del dato a disposizione: i risultati ottenuti vanno, infatti, decodif icati a più livelli di lettura, fra loro paralleli ma al tempo stesso anche interdipendenti. In un caso, l’attenzione è attratta dal f ine processo di caratterizzazione a cui il personaggio di Annibale è sottoposto f in dall’inizio della terza decade: nell’altro caso, invece, a imporsi è l’orchestrazione dei tempi e dei modi con i quali il lettore viene orientato sulla materia di cui lo si sta rendendo partecipe. […] Dopo queste premesse, mi sembra allora logico sottolineare l’intenzionalità con cui Livio ha inserito due scene, dai contorni leggendari così apertamente denunciati, nei punti strategici della narrazione: quasi come due quadri a sé stanti, esse contengono raff igurata la sorte di Annibale, quando non è ancora ben def inito il rapporto che il comandante cartaginese f inirà progressivamente per intrattenere con il popolo romano. Le ragioni, quindi, dell’anticipata collocazione cominciano a chiarirsi ancor meglio, specie se si considera che, storicamente, l’azione offensiva di Annibale, almeno f ino all’attraversamento dell’Ebro, non rappresenta ancora, secondo il punto di vista uff iciale dei Cartaginesi, una violazione dei trattati di pace esistenti fra le due popolazioni. Proposta f in dall’inizio, la scena del giuramento conferisce una connotazione torbida e sospetta anche alle azioni preliminari del cartaginese ribelle. Il lettore lo intuisce subito e questo, ancora una volta, grazie all’accorta trasformazione del modello polibiano da parte di Livio. La pregnanza di tutta l’afferma8 Livio Percorso tematico zione che Annibale, in modo solenne, fa davanti agli altari deriva in massima parte, se non totalmente, dall’espressione se cum primum posset hostem fore populo Romano, tendenziosamente sostitutiva del “mai sarebbe stato amico dei Romani” di Polibio e del numquam me in amicitia cum Romanis fore di Cornelio Nepote. Dunque l’eroe Annibale, protagonista della guerra contro Roma, entra immediatamente in scena, prima ancora che sia tracciato, nell’ambito della narrazione, il destino dei suoi predecessori Amilcare e Asdrubale, e questo denuncia la volontà liviana di sottolineare la valenza del Cartaginese come personaggio-chiave della vicenda. Che si tratti di un’arbitraria scelta narrativa […] lo dimostra il fatto che, decurtata dell’episodio relativo al giuramento, la lettura del proemio della terza decade non denuncerebbe alcuna lacuna: il corso del racconto, privo di questo strappo, scorrerebbe tranquillamente, rispettando in modo fedele la cronologia reale degli avvenimenti. Ma le intenzioni di Livio, senza ombra di dubbio, obbediscono molto di più alla logica di un racconto che non a quella della mera annalistica. La presenza di Annibale ad apertura di libro soddisfa, di fatto, la norma che vuole l’ “eroe” in scena nei momenti-chiave della narrazione: e l’inizio di un racconto lo è senz’altro – come fa notare Hamon. Non solo. L’ “eroe” è già attivo dalla sua prima comparsa: si giustif ica, pertanto, l’ennesima differenza fra il testo polibiano e quello liviano. All’Annibale, che, nella versione di Polibio, replica con le moine all’invito fattogli dal padre, subentra, nella ricostruzione liviana, l’ “eroe” che, nonostante l’età, esprime già una decisa volontà, accompagnata da gesti che suggeriscono in anticipo, grazie alla complessa sfera semantica del termine blandientem, un tratto signif icativo dell’indole del Cartaginese. Hitler, Stalin e gli altri A conclusione di questo percorso, riportiamo alcuni “ritratti” di grandi nemici del XX secolo: in questo caso non si tratta di testi, ma di fotomontaggi e di vignette, che raffigurano Hitler (i primi tre), e Stalin insieme a Roosevelt e Churchill (la quarta): neppure nei disegni, d’altra parte, le regole non scritte della raffigurazione del nemico vengono meno. Il primo, tratto dal giornale americano “Picture Post” del 9 settembre 1939, rappresenta un Hitler giovane, con lo sguardo gelido e risoluto, l’elmo prussiano con il pennacchio, al centro dell’Europa, con uno slogan che recita “un uomo contro l’Europa”: una figura di nemico pericoloso e degno di ogni rispetto, non troppo distante, forse, da quella che Livio traccia di Annibale nel suo ritratto del grande condottiero cartaginese. Nei due fotomontaggi di John Hearfield, invece, il Fuhrer è divenuto un nemico sanguinario e feroce, una bestia selvaggia e implacabile, che si può e si deve soltanto annientare. Una vera e propria caricatura è il quarto disegno, un manifesto di propaganda fascista (tratto da “Simplicissimus”) in cui sono messi alla berlina, come avversari, su diversi fronti, del regime, il presidente americano Franklin Delano Roosevelt, il premier britannico Winston Churchill e il dittatore sovietico Stalin; in canottiera e mutan- 1. Copertina del “Picture Post” del 9 settembre 1939. 2. John Hearf ield, Adolfo, il superuomo, ingoia oro e vomita sciocchezze, 1932. 9 doni, i nemici della Roma fascista sono affaticati equilibristi, obbligati da un gioco umiliante a sostenersi a vicenda. Il quadro non cambierebbe se ci si avvicinasse maggiormente ai giorni nostri: basterebbe sfogliare le pagine dei quotidiani dell’epoca della guerra del Golfo o ancora della primavera del 1999, prima e durante i bombardamenti Nato su Belgrado, per ritrovare nei ritratti occidentali del dittatore irakeno Saddam Hussein o del tiranno serbo Milosevic i segni caratteristici della rappresentazione del nemico: sanguinario, pazzo, assassino, feroce, spietato, pericolosissimo o grottesco, da combattere e da eliminare. IL RITRATTO DEL NEMICO 3. John Hearf ield, La crisi. “Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più forte del reame?”, 1933. 10 4. Le contraddizioni degli occidentali in una vignetta del “Simplicissimus”. Churchill e Roosevelt “cercano di aiutare” Stalin. Percorso tematico Quello che non ho Ogni autore porta in sé un progetto di opera: molti, nelle pagine iniziali, desiderano anzi esporlo subito ai propri lettori, per chiarire loro fin da principio quello che troveranno (contenuti, stile, ideologia …) se proseguiranno nella lettura. Tanto Tibullo e Properzio – nelle prime elegie dei rispettivi “canzonieri” quanto Ovidio, per esempio, nei primissimi versi dell’Ars, esprimono una sorta di programma letterario, di “credo” artistico. Nel contempo essi indicano – con quella che in termini tecnici prende il nome di recusatio, “rifiuto” – da quali forme d’arte (o di pensiero, o di stile, o da quali temi), perlopiù di moda, o diffuse, o toccate da generale apprezzamento, ci si intende distaccare: “Omero è un poeta grandissimo, ma io non oserei certo mettermi su quel piano” potrebbe essere un tipico esempio di questo atteggiamento, che nel riconoscere l’altrui eccellenza, rivendica per sé un diverso tipo di espressione artistica. Con il termine di recusatio, in letteratura, si indica anzi precisamente quella “ricusazione” che un poeta fa di un genere letterario ritenuto più elevato (secondo la gerarchia aristotelica che proclamava il primato di epica e tragedia rispetto agli altri generi), per scegliere una forma d’arte più “bassa” ma presentata come più adatta a sé. Nella prima elegia della sua raccolta (I, 1 Testo 1), Tibullo ricusa contemporaneamente le ricchezze (Divitias alius …), i contenuti guerreschi e la poesia alta che ne faceva tradizionalmente l’oggetto del canto. Allo stesso modo, nel primo componimento del primo libro delle sue elegie (I, 1 Testo 3), Properzio traccia una sorta di “manifesto dell’amore elegiaco”, prendendo nel contempo le distanze dalla poesia epica e dai suoi toni magniloquenti: nell’uno o nell’altro caso, questi poeti, come già anche Virgilio bucolico e Orazio (di cui riportiamo l’Ode I, 6), non svalutano la poesia che non scelgono (cioè l’epos), cui dichiarano anzi in teoria di aspirare, ma affermano di non avere le capacità per perseguirla. Una generazione prima, i neoteroi e Catullo avevano invece decisamente rinnegato i moduli epici, il poetare gonfio e solenne, ponendosi con ciò sulla scia di Lucilio, il grande satirografo dell’età arcaica (II secolo a.C.), schierato a favore di una poesia tenuis, e soprattutto di Callimaco, quel poeta-filologo greco che, nel III secolo a.C., aveva svalutato il méga biblíon, il “grande libro”, a vantaggio della poesia breve, dotta e raffinata, smarcandosi con ciò da quell’ombra di Omero che aveva sempre accompagnato ogni poeta greco: nel prologo degli Aitia (in greco “Cause”: un poema sulle origini mitiche di denominazioni e usanze folkloriche o religiose) e nell’epigramma 28 che riportiamo, il poeta proclama a chiare lettere le sue simpatie e le sue antipatie letterarie. In altri tempi, una piccola recusatio è contenuta anche nella prima canzone in lode di Beatrice, nel capitolo 19 della Vita Nuova di Dante Alighieri, la celeberrima Donne ch’avete intelletto d’amore. Ma le recusationes non sono strettamente limitate ai fenomeni stilistici o ai contenuti di un’opera: esistono “rifiuti” di natura ideologica, che investono l’intera “visione del mondo” (Weltanschauung) di un autore; è il caso di Palazzeschi, che nel Saltimbanco rivendica una sorta di autonomia del poeta persino rispetto alle forme della tradizione, o di Montale, che nei Limoni (in Ossi di seppia) presenta la propria lirica, fatta di immagini programmaticamente anti-auliche, delle disarmonie e delle ruvidezze della realtà, in precisa polemica contro i “poeti laureati” (e il pensiero va immediatamente a D’Annunzio). Qui, la recusatio torna a essere contrapposizione netta di mondi inconciliabili, proprio come in quella canzone di Fabrizio De André, un vero e proprio inno alla genuinità antiborghese di chi rifiuta l’“avere” del perbenismo arrivista, che ha dato il titolo al nostro percorso (“Quello che non ho, è una camicia bianca, / quello che non ho, è quel che non mi manca / quello che non ho, sono le tue pistole / per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole ... Quello che non ho, è di farla franca, / quello che non ho, è un segreto in banca ... Quello che non ho, è un orologio avanti / per correre più in fretta, e avervi più distanti ... ”). Callìmaco “Tuonare” (come fanno con gran fragore i poeti epici, soprattutto i cattivi imitatori di Omero) “non è compito mio, ma di Zeus”: a Callìmaco si addicono piuttosto le poesie brevi e raffinate, autentici distillati purissimi di parole ricercate, che assommano in sé brevità, dolcezza e dottrina. Sono i capisaldi della poetica ellenistica, che verrà importata in Roma in età scipionica e che verrà recepita soprattutto dai poetae novi della cerchia di Catullo. 5 Orazio Percorso tematico [Da ogni dove (?)] i Telchini gracidano contro il mio canto, ignari della Musa, cui non nacquero cari, perché non un unico poema continuo ho concluso o i re in molte migliaia di versi [celebrando (?)], [o gli antichi (?)] eroi, ma per breve tratto [volgo] il mio carme, come un bambino, e ho non pochi decenni. 1 10 15 20 25 30 35 40 Ma ai Telchini questo io [rispondo]: Razza […] che sa rodere [solo il suo] fegato! […] era (?) di pochi versi. Ma fa scendere di molto il piatto della grossa [quercia (?)] la Legislatrice ferace. [E] de[i] due, che Mimnermo sia dolce, le sottili [poesiole], ma non la grande donna lo insegna. [Per grande tratto] in Tracia d’Egitto [voli pure] la gru, che gode [del sangue] pigmeo, e a gran distanza i Massageti saettino l’uomo [di Media]: i [piccoli usignoli] sono più dolci così. Andate in malora, progenie di Malocchio funesta: da ora con l’arte la poesia [giudicate], e non con lo scheno persiano. E non chiedete a me che un canto di grande fragore produca. Tuonare non è compito mio, ma di Zeus! Perché quando in principio la tavoletta posai sulle ginocchia, così a me disse Apollo Licio: «[…] cantore [amatissimo], quanto più pingue la vittima [alleva], ma, o amico, la Musa sottile. [Ed inoltre] anche questo [ti] ordino: dove non passano i carri pesanti là cammina. Che non dietro le impronte degli altri [tu spinga il tuo cocchio,] né per la via larga, ma per sentieri non calpestat]i, pur se guiderai per strada più angusta». [A lui ho ubbidito]: tra quelli cantiamo che il suono acuto [della cicala] amano e non degli asini il grido. Proprio come la bestia orecchiuta ragli pure [un altro]: possa [i]o essere la lieve, l’alata, ah, veramente, perché la vecchiaia – perché la rugiada io canti mangiando cibo stillante dall’aere splendente – e poi di quella mi spogli, che così tanto mi grava come l’isola tricorne su Encelado funesto. […] perché quanti le Muse guardarono fanciulli con sguardo non torvo, non li respingono, canuti, dal loro favore. […] non più muovere l’ala […] allora [è] più attivo. Epigr. XXVIII 5 Odio il poema ciclico1, né una strada mi piace che molti porti qui e lì. Non sopporto un amante vagabondo, né dalla pubblica fonte bevo: schifo ogni bene comune. Lisania, tu sei bello, più di ogni altro bello! ma prima di poterlo dir chiaro, un’eco risponde: «è di un altro, quello». (Trad. G.B. D’Alessio) Orazio QUELLO CHE NON HO Sarà Vario a celebrare il coraggio di Agrippa in versi epici: il poeta è un umile cantore di banchetti, e la sua Musa – dice – non farebbe che svilire la gloria dell’amico (Od. I, 6). Una recusatio dell’umiltà, in tipico stile “augusteo”. Sulle ali del canto meonio Vario potrà celebrare il tuo coraggio, le tue vittorie sul nemico 1. poema ciclico: con questo termine si indica l’uso sciatto e ripetitivo dello stile formulare epico, considerato tipico del cosiddetto «ciclo» epico. 2 Orazio e le prodezze compiute in terra e in mare dai soldati al tuo comando. 10 15 20 Percorso tematico 5 Io non oso cantare tutto questo, Agrippa, né l’ira terribile e ostinata di Achille, le traversie per mare dell’astuto Ulisse, né gli orrori della casa di Pèlope: troppo per i miei limiti; il riserbo e la Musa, che in sordina modula la mia poesia, mi vietano di svilire, per vizio d’ingegno, la tua e la gloria ineguagliabile di Cesare. Chi altri ancora potrebbe celebrare degnamente Marte chiuso nello splendore delle armi, Merione nero della polvere di Troia, o Diomede simile a un dio per mano di Pallade? Io, io canto i banchetti, l’accanirsi incruento delle liti fra giovani e fanciulle, sia che frivolo come sono io bruci o sia vuoto d’amore. (Trad. M. Ramous) Dante Nel capitolo 19 della Vita Nuova, il poeta si trova a camminare lungo un corso d’acqua, e a maturare un irrefrenabile desiderio di cantare in lode di Beatrice. Questo canto dovrà “ricusare” lo stile elevato e selezionarne piuttosto uno con cui il poeta possa sentirsi sicuro di completare l’opera sua, leggeramente, “con semplice modestia”. La recusatio, come in Orazio “di modestia”, è qui anche una sorta di scelta fittizia del proprio pubblico: donne e donzelle amorose, delicate e sensibili, perché il tema amoroso che Dante ha in mente di cantare, non è cosa da parlarne altrui. Donne ch’avete intelletto d’amore, i’ vo’ con voi de la mia donna dire, non perch’io creda sua laude f inire, ma ragionar per isfogar la mente. Io dico che pensando il suo valore, Amor sì dolce mi si fa sentire, che s’io allora non perdessi ardire, farei parlando innamorar la gente. E io non vo’ parlar sì altamente, ch’io divenisse per temenza vile; ma tratterò del suo stato gentile a respetto di lei leggeramente, donne e donzelle amorose, con vui, ché non è cosa da parlarne altrui. Palazzeschi Più che una definizione del poeta, una sorta di recusatio (rispetto a tante fanfare di vati contemporanei), questa parodica prosopopea sintetizza bene, nella sua giocosità, le discussioni sulla natura della poesia che animarono i primi decenni del secolo XX. Sono forse un poeta? No, certo. 3 Non scrive che una parola ben strana la penna dell’anima mia: “follìa”. Son dunque un pittore? Neanche. Non ha che un colore la tavolozza dell’anima mia: “malinconìa”. Un musica allora? Nemmeno. Non c’è che una nota nella tastiera dell’anima mia: “nostalgìa”. Son dunque ... che cosa? Io metto una lente davanti al mio cuore per farlo vedere alla gente. Chi sono? Il saltimbanco dell’anima mia. Eugenio Montale La poetica delle cose, anche di quelle da secoli trascurate dai versi dei “poeti laureati”, è una sorta di recupero della disarmonia del reale, che può diventare armonia del canto, purezza di poesia. 5 10 15 QUELLO CHE NON HO 20 25 30 4 Ascoltami, i poeti laureati si muovono soltanto fra le piante dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi fossi dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla; le viuzze che seguono i ciglioni, discendono tra i ciuff i delle canne e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. Meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall’azzurro: più chiaro si ascolta il susurro dei rami amici nell’aria che quasi non si muove, e i sensi di quest’odore che non sa staccarsi da terra e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra, qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è l’odore dei limoni. Vedi, in questi silenzi in cui le cose s’abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di Natura, il punto morto del mondo, l’anello che non tiene, il f ilo da sbrogliare che f inalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d’intorno, la mente indaga accorda disunisce 45 Percorso tematico 40 Orazio 35 nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata Divinità. Ma l’illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. La pioggia stanca la terra, di poi; s’affolta il tedio dell’inverno sulle case, la luce si fa avara – amara l’anima. Quando un giorno da un malchiuso portone tra gli alberi di una corte ci si mostrano i gialli dei limoni; e il gelo del cuore si sfa, e in petto ci scrosciano le loro canzoni le trombe d’oro della solarità. 5 Percorso tematico La Terra vista dall’alto L’immagine della terra vista dall’alto che Seneca introduce nella Prefazione al libro I delle Naturales quaesTesto 11) è stata ampiamente recepita dalla letteratura europea: oltre all’esempio dantesco protiones ( Testi a confronto, p. 716), ricordiamo qui altri due testi, molto distanti nel tempo ma posto in antologia ( ugualmente riconducibili al topos senecano. Severino Boezio Dopo Seneca, in età tardoantica (alla fine del V secolo), anche il filosofo Severino Boezio (475-525) riprende la visione della Terra dall’alto nel trattato “La consolazione della filosofia” (De consolatione philosophiae, II prosa 7): qui la Filosofia, personificata, ammonisce Boezio a non dare troppa importanza alla gloria terrena ricordandogli appunto le ridotte proporzioni del pianeta rispetto al resto dell’universo. È evidente la memoria del passo senecano: anche Boezio, infatti, pur eliminando il paragone degli uomini con le formiche, parla della terra come di una angustissima area; qui il significato, però, non è più quello specifico di “aia”, ma quello più generico di “ridottissima superficie”, “spazio angusto”. Come hai appreso dalle dimostrazioni degli astronomi, risulta che l’intera sfera terrestre ha la dimensione di un punto in relazione allo spazio celeste, cosicché, in altre parole, se la si mette a confronto con la grandezza della sfera celeste, può essere considerata come praticamente priva di estensione. Ora, di questa così minuscola zona dell’universo, soltanto un quarto circa è abitato da esseri viventi a noi noti, come ben sai dalle prove portate da Tolomeo1. Se a questo quarto tu sottrai mentalmente quanto è occupato dal mare e dalle paludi, e le vaste estensioni assetate dei deserti, a mala pena resterà agli uomini una ridottissima superficie da abitare. Voi dunque, accerchiati e racchiusi in una frazione, per così dire, infinitesimale di un punto, state a far progetti sul come estendere la vostra fama e mettere in bella mostra il vostro nome, come se potesse avere, in qualche modo, ampia e grandiosa risonanza una gloria soffocata entro limiti tanto ristretti e insignificanti? (Trad. O. Dallera) 1 Tolomeo: astronomo, matematico e geografo greco (II secolo a.C.). Giovanni Pascoli L’immagine della terra che appare dall’alto come uno spazio minimo e insignificante potrebbe aver influenzato anche Giovanni Pascoli (1855-1912): nella strofa finale della poesia X Agosto (nella raccolta Myricae) la Terra appare, dall’alto del cielo, come un “atomo opaco del Male”, una piccola entità malvagia in contrasto con l’immensità del cielo, che pietosamente la “inonda” di stelle. La poesia, del resto, prende spunto da un’osservazione astronomica: il fenomeno delle stelle cadenti, visibile nella notte di san Lorenzo, il 10 di Agosto; il poeta ne dà una spiegazione psicologica e intimistica mettendo in relazione il “pianto” di stelle che il cielo sembra riversare sulla Terra con la triste vicenda autobiografica dell’assassinio del padre, ucciso da mano ignota sulla via di casa proprio la sera del 10 agosto 1867. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle1 per l’aria tranquilla arde e cade, perché sì gran pianto nel concavo cielo2 sfavilla. 5 Ritornava una rondine al tetto: l’uccisero: cadde tra spini ella aveva nel becco un insetto: la cena de’ suoi rondinini. 1 tanto di stelle: tante stelle. Seneca Percorso tematico 2 concavo cielo: la volta celeste. 1 10 15 20 Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano; e il suo nido è nell’ombra, che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido: l’uccisero: disse: Perdono; e restò negli aperti occhi un grido: portava due bambole in dono. Ora là nella casa romita3, lo aspettano, aspettano in vano: egli immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano. E tu, Cielo, dall’alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh! d’un pianto di stelle lo inondi quest’atomo opaco del Male! LA TERRA VISTA DALL’ALTO 3 romita: solitaria. 2 Percorso tematico La grande Germania Tacito Percorso tematico Il ritratto cesariano dei Germani (De bello Gallico VI, 21-24 Testi 4-6) sottolinea a più riprese, non solo la barbarie, ma anche la purezza e il valore di queste genti. La vita e i costumi delle popolazioni germaniche esercitarono sempre un grande interesse, che diviene autentico fascino, sui civilizzati romani, attratti da quel vivere primitivo e puro che ricordava le loro stesse origini e poteva assurgere quasi a simbolo di una purezza e di una moralità – sotto la dura scorza di usanze e modi di vita pressoché selvatici – ormai perdute. I Germani di Tacito Alla descrizione cesariana dei Germani, si ricollega Tacito, il più importante storico dell’età imperiale (55120 d.C. circa), nella sua Germania. Riportiamo qui i capp. 13-20. 13.1. Non trattano alcuna faccenda, né pubblica né privata, se non con le armi indosso: ma è usanza che ognuno le prenda solo quando la città l’ha riconosciuto in grado di servirsene. Allora, nell’assemblea stessa, o uno dei capi o il padre o i parenti armano il giovane di scudo e di framea: questa è per loro la toga virile, questa per i giovani la prima distinzione onorif ica; f ino allora vengono considerati appartenenti alla famiglia: dopo, allo Stato. 2. Un altissimo titolo di nobiltà o grandi benemerenze di antenati conferiscono ad alcuni dignità di principe f in dalla prima giovinezza; tutti gli altri si aggregano a capi più robusti e già da tempo provati, e non è motivo di vergogna farsi vedere nel loro séguito. Vi sono anzi delle distinzioni nel séguito stesso, a giudizio di colui che esso accompagna: e grande è l’emulazione, sia tra i compagni, per stabilire a chi tocchi il primo posto accanto al capo, sia tra i capi, chi abbia i seguaci più numerosi e più agguerriti. 3. Questa è la dignità, queste son le forze: essere circondati sempre da una schiera numerosa di giovani scelti è ornamento in tempo di pace, difesa in tempo di guerra. E non soltanto nella propria patria, ma anche presso le genti vicine acquista rinomanza e gloria chi è segnalato dal numero e dal valore del séguito; lo si ricerca per le ambascerie lo si colma di doni, e spesso la sua sola fama fa vincere una guerra. 14.1. Sul campo di battaglia è disonorante per il capo esser superato in valore, per il séguito non uguagliare il valore del capo. È poi infamia e vituperio per la vita intera ritornare salvi dalla battaglia senza di lui: difenderlo, vegliare sulla sua sicurezza, ascrivere a gloria sua anche i propri atti di coraggio è supremo dovere. I prìncipi lottano per la vittoria, il séguito per il principe. 2. Se la tribù in cui sono nati s’intorpidisce in una pace lunga e inerte, molti giovinetti nobili ne raggiungono volontariamente un’altra, che allora conduca una guerra; tanto è sgradita a quel popolo la tranquillità, perché tra i rischi è più facile divenire famosi e perché non si mantiene un séguito numeroso se non con la violenza e con la lotta. Infatti dalla liberalità del capo si ottiene quel famoso cavallo da guerra, quella famosa framea, cruenta e vittoriosa; banchetti e imbandigioni non raff inate, ma copiose, tengono luogo di soldo. 3. Le guerre e i saccheggi forniscono i mezzi alla munif icenza; e indurli ad arare la terra o ad aspettare il raccolto sarebbe meno facile che indurli a provocare il nemico e a meritarsi ferite. Anzi, sembra loro pigrizia e viltà acquistar col sudore ciò che potrebbero procurarsi col sangue. 15.1. Quando non fanno guerra, trascorrono molto tempo a cacciare e ancora di più ad oziare, dediti al sonno e al cibo; i più forti e bellicosi non fanno nulla, ché la cura della casa, dei penati e dei campi è lasciata alle donne e ai vecchi e ai meno validi della famiglia. Essi intanto poltriscono: strana contraddizione della natura, che i medesimi uomini abbiano caro l’ozio e detestino la pace. 2. È usanza che le tribù rechino spontaneamente ai capi un tanto a testa di bestiame o di biade, che, accettato in omaggio, sovviene pure alle loro necessità. I doni più apprezzati sono quelli dei popoli conf inanti, offerti o da privati o a spese pubbliche: cavalli scelti, armi grandiose, medaglioni e collane. Ora hanno imparato da noi a prendere anche denaro. 1 LA GRANDE GERMANIA 16.1. È noto che i popoli germanici non abitano alcuna città e non sopportano nemmeno case riunite fra loro. Vivono in dimore isolate e sparse qua e là, a seconda che una fonte o una pianura o un bosco li ha attirati. Fondano villaggi non di edif izi insieme connessi, all’uso nostro: ciascuno lascia uno spazio libero intorno alla propria casa, o contro il pericolo d’incendio o per imperizia del costruire. 2. Non adoperano neppure pietre squadrate né tegole: per tutto si servono di legname greggio, senza preoccuparsi di renderne piacevole l’aspetto. Rivestono però accuratamente certe parti di una terra così f ine e lucida, da imitare la pittura e i disegni colorati. 3. Son soliti anche scavare dei sotterranei, e li caricano al di sopra di abbondante letame, per rifugio contro l’inverno e per depositarvi le biade, perché in tal modo mitigano il rigore del freddo; inoltre, se mai viene un nemico, saccheggia le località in vista, ma ciò che è nascosto sotto terra o rimane ignorato, o sfugge per il fatto stesso che bisogna farne ricerca. 17.1. Per abito portano tutti un saio trattenuto da una f ibbia o – mancando questa – da una spina; altrimenti, stanno nudi e passano intere giornate accanto al focolare. I più ricchi si distinguono per una sottoveste non fluttuante, come i Sarmati e i Parti, ma serrata e aderente alle membra. Portano anche pelli di f iera, senza raff inatezze quelli più vicini alla riva, con maggiore eleganza quelli dell’interno, dove non arriva il commercio a portare alcun lusso. Scelgono gli animali e, dopo averli scuoiati, screziano i velli con pezzi di pelle dei mostri che vivono nel più remoto Oceano e nel mare sconosciuto. 2. Le donne vestono in maniera non diversa dagli uomini; senonché si coprono per lo più con tessuti di lino guerniti di porpora, e non prolungano la parte superiore del vestito a formare maniche. Le braccia sono nude f ino alla spalla, e anche il sommo del petto rimane scoperto. 18.1. I matrimoni però sono severamente regolati, e non vi è nei loro costumi nulla che meriti maggior lode. Infatti, quasi soli tra i barbari, si accontentano d’una moglie per ciascuno, eccettuati pochissimi, non per avidità sensuale, ma perché la nobiltà del loro sangue fa sì che molte famiglie ne ambiscano il connubio. 2. Non la moglie al marito, ma il marito alla moglie porta la dote. Assistono alla cerimonia i genitori e i parenti e valutano i doni, scelti non per appagare il gusto femminile né per fornire ornamenti alla sposa: sono buoi, e un cavallo imbrigliato e uno scudo con framea e spada. In cambio di tali doni si riceve la moglie, ed essa per parte sua porta qualche arma al marito: essi considerano questo il vincolo più forte, questo l’arcano rito, queste le divinità coniugali. 3. Perché la donna non si creda estranea ai nobili pensieri e alle vicende della guerra, dagli auspici stessi, all’inizio del matrimonio, è avvertita ch’essa viene associata alle fatiche ed ai pericoli, che in pace come in guerra soffrirà e oserà tanto quanto il marito. Questo è il signif icato dei buoi aggiogati, del cavallo bardato, delle armi donate. Così deve vivere e morire: quanto essa riceve, dovrà consegnarlo inviolato e sacro ai f igli, dai quali lo riceveranno le nuore e a loro volta lo trasmetteranno ai nipoti. 19.1. Vivono dunque ben difese nel loro pudore, non corrotte da attrattive di spettacoli né da eccitamento di conviti. Uomini e donne ignorano ugualmente i segreti della scrittura. Rarissimi, tra gente così numerosa, gli adulterii, dei quali il castigo è immediato. Ne è esecutore il marito, che scaccia di casa la donna, dopo averla denudata e averle reciso le chiome, e sotto gli occhi dei parenti la insegue a sferzate per tutto il villaggio. Non c’è infatti perdono per colei che si è prostituita: né bellezza, né gioventù, né ricchezza le farebbero trovare uno sposo. Perché là i vizi non destano riso, e non si dà il nome di moda al corrompere e all’essere corrotti. 2. Più sagge ancora sono quelle tribù, dove vanno a nozze soltanto le vergini, e la speranza e i voti della sposa non si appagano che una volta; esse prendono un solo marito, così come hanno un solo corpo e una sola vita, perché il loro pensiero e il loro desiderio non vadano oltre e perché non il marito, ma il matrimonio sia da loro amato. Limitare il numero dei f igli o uccidere qualcuno di quelli nati in soprannumero è ritenuto colpa infamante, e là i buoni costumi valgono più che le buone leggi in altri paesi. 20.1. I bambini crescono in ogni casa nudi e sudici, eppure acquistano quelle membra, quelle corporature che noi guardiamo con meraviglia. Tutti vengono allattati dalla propria madre; non si aff idano mai ad ancelle o a nutrici. Nessuna raff inatezza di educazione distin- 2 Tacito Percorso tematico gue il padrone dal servo: trascorrono la vita tra i medesimi animali domestici e sul medesimo terreno, f inché l’età viene a distinguere dagli altri i nati liberi e il coraggio a rivelarli. 2. I giovani conoscono tardi il godimento sessuale, il che assicura loro una inesauribile forza virile. Né vi è fretta di maritare le fanciulle, che uguagliano gli uomini nel vigor giovanile e nella statura; vanno a nozze quando forti al pari di loro, e i f igli rinnovano la gagliardia dei genitori. 3. I f igli delle sorelle sono tenuti dallo zio nello stesso conto che dal padre. Alcuni ritengono anzi ancora più sacro e più stretto quel legame di sangue, e quando ricevono ostaggi lo preferiscono, come se vincolasse più saldamente gli animi e più largamente il parentado. Eredi però e successori sono a ciascuno i f igli, e non si fanno testamenti. In mancanza di prole, subentrano nella successione i fratelli, gli zii paterni, gli zii materni. Quanto più numerosi sono i parenti, sia dello stesso sangue, sia acquistati per via di matrimoni, tanto più onorata è la vecchiaia; e non c’è alcun vantaggio a non avere discendenti. (Trad. A. Arici) Il mito della razza Il quadro dei Germani di Tacito, che accentua la moralità e la schiettezza di quella popolazione (in opposizione a tutti gli infingimenti e le ipocrisie della Roma imperiale), si diffonderà nella cultura tedesca sino a dar vita a un vero e proprio mito della razza. Ne parla, nella pagina che segue, Luciano Canfora. La storia della «ricezione» di Tacito nel mondo germanico è parte non secondaria della storia della cultura tedesca, così come della formazione di una coscienza nazionale in Germania. Disse Alexander von Humboldt che la scoperta dell’America alla f ine del Quattrocento e la «riscoperta» delle opere di Tacito rivestivano, per lui, un ugualmente alto signif icato. E forse non era solo un paradosso. In particolare la Germania viene letta come descrizione autentica – anche perché dovuta ad un romano – di quello che un dotto francese chiamerà «le berceau de la race». Ma, appunto, parlando di «razza» a proposito della Germania tacitiana, questo dotto intendeva riferirsi ad un’area assai più vasta di quella strettamente germanica: pensava ai moderni anglosassoni, il cui «self-government» discende – a suo dire – dal «libero individualismo» di cui si osservano i «germi» appunto nella «culla della stirpe», cioè nella descrizione tacitiana del libero Germano. E del resto nella stessa Francia i Germani di Tacito erano stati sentiti, nel secolo precedente, come «antenati». Ed anzi in piena tormenta napoleonica uno scrittore per niente francofobo come Jean Paul, alias Johann Paul Richter, ricorderà, dinanzi alla straripante egemonia francese, che in fondo «la maggioranza dei Francesi non sono Galli, ma Germani trapiantati». E nondimeno è in Germania che l’opuscolo tacitiano ha avuto, sin dal suo riapparire tra le mani degli umanisti, una funzione pratico-polemico-apologetica. Uno dei primi, e più noti, esempi è la «replica» dei dotti tedeschi al pamphlet di Enea Silvio Piccolomini De situ moribus et condicione Theutoniae descriptio (1496). Degli umanisti sono eredi, anche sotto questo rispetto, gli uomini della Riforma: l’Arminio di Annali II, 88 e la Germania saranno, in quel momento di rinascita anche nazionale, testi capitali. Un’altra data-simbolo è il 1914 («spirito del ’14», «idee del ’14» ecc.). Un episodio marginale può avere il suo signif icato: proprio in quell’anno Rudolf Borchardt, italianista e raff inato scrittore, impegnato anche lui nella «mobilitazione degli spiriti», traduce la Germania tacitiana (Tacitus, Deutschland), che def inisce, nella dedica a Friedrich Leo, «sacrum Taciti libellum». Anche Norden, che lavora sulla Germania tacitiana negli anni ’14 -’20, collega, alquanto enfaticamente, questo suo lavoro al clima del primo anno di guerra, ed anzi motiva, come vedremo, la scelta di questo tema di studio in quanto forma per così dire di «cultura militante», in quanto modo di «ricondurre ad unità studio e vita» (p. VII). Ma intanto, fuori della cerchia degli studiosi, il «sacro libriccino», come lo chiamava Borchardt, diventava oggetto di riflessione per politici e ideologi. Una lettera di Guglielmo II a Stewart Houston Chamberlain (1901), in cui il sovrano conf ida all’amico e teorico pangermanista che la «formazione classica» gli era sempre parsa insuff iciente rispetto ad un 3 necessario «rilancio del pangeimanesimo» – ragione per cui le Grundlagen del Chamberlain gli sembravano aver gettato «miracolosa luce in queste tenebre» – è indizio signif icativo del nuovo clima. Anche la lotta contro la Repubblica verrà condotta, da destra, nel nome degli antichi Germani: «Un tempo i Tedeschi erano un nobile popolo – dirà nel ’23 Gustav Roethe, sommo germanista –; ma proprio i nobili, precipui caratteri dell’onore e della fedeltà sono andati irrimediabilmente perduti da quando ha vinto quella rivoluzione di disertori e di ammutinati, il cui miserabile trionfo è stato sostanzialmente ribadito dall’assemblea nazionale»; e poco dopo ricorderà, nello stesso discorso, che i Tedeschi «anche oggi» hanno bisogno di un «edler königlicher Führer». Sono questi gli anni del dibattito storico-politico intorno al cosiddetto «Kontinuitätsproblem», una discussione resa quanto mai attuale dalla sconf itta. La f ine traumatica della Repubblica segnerà, anche, l’esplosione di una «rinascita germanica» di cui l’opuscolo tacitiano sarà benef iciario. Engels e il libero germano Il mito del “libero e grande Germano”, in pieno ’800, poté affascinare anche Engels, come appare ancora da Canfora. LA GRANDE GERMANIA Non sarà superfluo aprire una breve parentesi per mostrare come alcuni dei concetti-base ruotanti intorno al mito degli antichi Germani li troviamo operanti, nel quadro di una particolare attenzione all’antica società germanica come «forma pre-capitalistica», nell’inedito engelsiano Zur Urgeschichte der Deutschen (1881). Anche nelle pagine engelsiane si coglie una forte avversione verso l’imposizione ai Germani del «diritto romano»: un diritto straniero imposto a tribù che erano assuefatte invece ad un ben diverso «diritto germanico». Non mancano nel contesto (Die ersten Kämpfe mit Rom) tratti sconcertanti: quale ad esempio la contrapposizione razziale tra i Germani e gli Orientali, ovviamente a vantaggio dei primi. Varo – scrive Engels – giunge in Germania dopo un «fruttuoso» soggiorno in Siria (dove, ricorda Velleio, aveva dimostrato di non avere a spregio il denaro), e si propone di governare i Germani con lo stesso stile. Alla imposizione in Germania del diritto romano Engels dedica parole di pesante sarcasmo: Varo era venuto con un mezzo millennio di anticipo, la Germania non era ancora matura. Parafrasando vari capitoli della Germania (VII, XII, XXI), Engels tratteggia con autentico entusiasmo la vita del «libero Germano» precedente l’oppressione romana: «Il libero Germano, che, secondo Tacito, poteva essere battuto, ed in rari casi, unicamente dal sacerdote [cfr. Germania, VII, 2: neque animadvertere, neque vincire, ne verberare quidem, nisi sacerdotibus permissum], che pagava con la vita soltanto il tradimento contro il suo popolo [cfr. XII, 1: distinctio poenarum ex delicto: proditores et transfugas arboribus suspendunt], ma che altrimenti poteva pagare con una multa ogni offesa, anche l’omicidio [XXI, 1: luitur etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero], che inoltre era abituato ad esercitare la vendetta di sangue per sé e per i suoi parenti direttamente [ibid.: suscipere tam inimicitias seu patris seu propinqui quam amicitias necesse est], ebbene ora doveva sottomettersi alle verghe e all’ascia del littore. E tutto questo per nessun altro scopo che quello di spalancare le porte al dissanguamento del paese attraverso la tassazione ecc.» (MEW, XIX, pp. 442-443). Il diritto romano viene schernito per le sue lungaggini procedurali e contrapposto alla prassi giudiziaria dei Germani «abituati ad amministrare giustizia ed emettere verdetti essi stessi, in poche ore, in pubblico, dinanzi al popolo giudicante, secondo un costume ereditario». «Ed ora – prosegue – i Germani dovevano rinunciare al loro libero tribunale dove il compagno giudicava il compagno e sottoporsi al giudizio di un singolo individuo che trattava le questioni in lingua straniera». Chiaramente non mancano, in queste pagine, uscite singolari, quale quella della multa in danaro come pena per l’omicidio o l’esaltazione della velocità del procedimento giudiziario 4 Tacito Percorso tematico presso i Germani. E naturalmente si possono istituire facili e solleticanti analogie con la tradizione «anti-latina» della cultura tedesca, una tradizione che parte dalla lotta antifrancese (e trova ovviamente un ascendente nella lotta di Lutero contro Roma) e diventa «Los vom Rom» (distacco da Roma) come parola d’ordine della minoranza tedesca in lotta contro la monarchia austroungarica (crogiòlo in cui si formano il giovane Hitler e il giovane Much) e sfocia nella ripresa nazista della parola d’ordine (questa volta in funzione antiebraica) «L’uomo tedesco vuole giudici tedeschi, che lo capiscano e parlino la lingua della sua stirpe», oltre che nel già citato principio XIX del programma del ’26 per un «diritto comune germanico». In realtà questo approccio, forse unilaterale, lascerebbe in ombra il carattere precipuo dell’indagine – certo non felice – di Engels sull’antica società germanica. Essa s’inquadra, come la engelsiana Storia dell’Irlanda di circa un decennio prima, nella ricerca sulle società precapitalistiche, il cui frutto «pubblico» sarà Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates (1884). Molesto risulta il ricorso a termini quali «Race» e «Racenmischung», tanto da costringere il recente interprete italiano ad una «difesa d’uff icio» poco persuasiva. La stessa def inizione della sconf itta di Varo ad opera di Arminio come «uno dei più decisivi punti di svolta della storia» o il giudizio su Arminio come «grande uomo di stato», che pur si accompagnano ad una garbata presa in giro del grottesco «Hermannsdenkmal» di Bandel da poco portato a termine (1875), appare francamente eccessiva e in certa misura conforme alla ben nota esaltazione di cui l’agguato di Teutoburgo è stato oggetto nella cultura e nella «mitologia di massa» in Germania. Certo, per Engels si tratta della vittoria di una nazione oppressa, e l’episodio gli offre l’occasione per una tirata sulla legittimità del ricorso all’astuzia contro «popoli e classi sfruttatrici». “Tirata” che poi è ben singolarmente vicina a tutta una tradizione tedesca, da Hutten a Kleist, mirante a scagionare Arminio dall’accusa di «fellonia» e ad accordare le opposte tradizioni di Tacito (Germania, XXII, 4: «gens non astuta») e Velleio (II, 118: «genus natum mendacio») sulla f ides germanica. Da Tacito al Nazismo Ma furono soprattutto i nazisti a sfruttare, a fini nazionalistici, il “modello dell’antica società germanica” così come esso era stato tratteggiato da Tacito. Si legga ancora Canfora. È forse superfluo aggiungere che sotto molteplici aspetti, non inessenziali, si possono analogamente riconoscere suggestioni e riprese intenzionali di antichi miti e comportamenti. Un discorso a parte meriterebbe, ad esempio, la condizione della donna, vista nel III Reich – secondo la def inizione della massima dirigente del movimento femminile, Gertrud ScholtzKlink – come «sacerdotessa della famiglia e della nazione». Qui è operante, evidentemente, la suggestione tacitiana dell’VIII capitolo della Germania, dedicato al prestigio delle donne germaniche nella vita pubblica: «inesse quin etiam sanctum aliquid et providum putant, nec aut consilia earum aspernantur aut responsa neglegunt. Vidimus sub divo Vespasiano Veledam diu apud plerosque numinis loco habitam; sed et olim Auriniam et complures alias venerati sunt, non adulatione nec tamquam facerent deas». Sempre in questo campo si potrebbe far cenno della proposta di Gerda Bormann perché fosse consentita la poligamia «ai più valorosi» (e Bormann annota sul margine: «Il Fuhrer la pensa così!»), che trova forse un qualche riscontro nell’usanza antica di consentire «plurimas nuptias» ad una élite, «non libidine sed ob nobilitatem» (Germania, XVIII, 1). Naturalmente è molto discutibile che in casi del genere si possa parlare di ispirazione immediata ricavata dal testo tacitiano. Questo può dirsi, semmai, a proposito del Bauerntum di Darré, il quale del resto adopera assiduamente la testimonianza tacitiana, e adduce ad esempio Germania XX, 3 («virgines pares validaeque miscentur, ac robora parentum liberi referunt») come prova storico-documentaria della tesi – su cui indugia – secondo cui la donna nordica è, oltre che bella, forte. Ed a questa libertà di costumi delle antiche fanciulle germaniche si lega l’esaltazione, altrettanto insistente, del mito della fecondità femminile come «capitale prezioso» della nazione, secondo la def inizione hitleriana. 5 LA GRANDE GERMANIA Anche rispetto al corrente atteggiamento di avversione (e persecuzione) nei confronti dei «diversi» un passo tacitiano poteva essere usato come «archetipo». Ed anzi già da tempo era stato letto in tal senso. Il ben noto «corpore infames caeno ac palude iniecta insuper crate mergunt» di Germania XII, 1 era servito a Müllenhoff per ricordare che, se questo «vizio» aff iorava anche presso i Germani (sul che si poteva comunque discutere), essi però lo punivano con la massima pena! E più tardi, negli anni del nazismo, Much […] si affretterà a precisare che, a rigore, «il vizio dell’amore maschile», secondo Posidonio (= Diodoro V, 32, 7), era assai più diffuso in Gallia, e che, comunque, Quintiliano assicura «nihil tale novere Germani et sanctius vivitur ad Oceanum, (Decl. III, 16). Più drasticamente Otto Steiner sosterrà addirittura, qualche anno più tardi, che «corpore infames» non poteva signif icare «i pederasti» ma doveva riferirsi ai giovani autolesionisti, riluttanti al servizio militare. Sul piano del diritto, la stessa gradazione delle pene, per cui la pena di morte viene riservata ai traditori, da «annientare con barbarica spietatezza», secondo il dettame hitleriano, rinvia all’analoga «distinctio poenarum ex delicto» in vigore presso gli antichi Germani, i quali per l’appunto «proditores et transfugas arboribus suspendunt» (XII, 1). E più in generale si può pensare alla stessa concezione del diritto e della magistratura, non più distinta dal potere politico (perché di fatto asservita e brutalmente privata della sua funzione specif ica ed autonoma): un fenomeno per il quale si può invocare la «indistinzione» dei poteri dell’antica assemblea germanica, tanto apprezzata anche da Engels. La lista dei “richiami” potrebbe proseguire. E va anche detto che l’opuscolo tacitiano “si prestava” ad una «Usurpation» politico-attualizzante, anche per certa sua sympatheia verso il mondo germanico. Si pensi ad uscite come «nemo enim illic vitia ridet, nec corrumpere et corrumpi saeculum vocatur» (XIX, 3), ovvero a giudizi che parevano apprezzamenti morali positivi come «gens non astuta» (XXII, 4), o ad espressioni che potevano assumere signif icati «profetici» come il ben noto «urgentibus imperii fatis», che, implicando forse una intuizione della f ine o del declino dell’impero romano, poteva essere inteso, per il contesto in cui f igurava, come una sorta di anticipazione del «destino» germanico ad ereditare, per così dire, il ruolo direttivo universale che era stato di Roma. Si trattava poi anche – e questo non va trascurato – di punti salienti del testo, di passi su cui si era esercitato l’acume degli interpreti (oltre che la fantasia dei “patrioti”). Né è questo il luogo per affrontare, o meglio riaprire, il problema della genesi del singolare scritto tacitiano. Credo nondimeno che conservi tutta la sua validità la suggestione mommseniana, secondo cui l’opuscolo va messo in relazione con le Historiae, il cui iniziale teatro di operazioni è appunto la Germania, e quindi va posto sullo stesso piano degli altri due excursus etnograf ici tacitiani. Forse non è un caso se proprio Eduard Norden, nella Römische Literatur per l’Einleitung lipsiense dà giusto rilievo a questa sensata ipotesi sulla genesi della Germania, un’ipotesi che di per sé fa giustizia di tante speculazioni partigiane sull’interesse tacitiano per i Germani. 6 Percorso tematico La ferita d’amore Nel libro IV dell’Eneide virgiliana (vv. 1- 89 Testo 1 ), l’insorgente passione della regina di Cartagine, Didone, per il suo ospite troiano, Enea, è descritta come una terribile ferita (v. 2 vulnus) d’amore. Il motivo della “ferita d’amore” è sempre stato comune nella storia della letteratura come in quella dell’arte, basti pensare alla cospicua iconografia fiorita intorno alla figura mitologica di Cupido/Eros fanciullo, il figlio della dea dell’amore, Venere, e alle sue temibili frecce (vedi il percorso iconografico a pp. 3 ss.). Del tutto analoga l’idea dell’amore come fuoco inestinguibile, che penetra nelle membra e brucia la persona còlta dalla passione amorosa. Già nel Cantico dei cantici (un libro dell’Antico Testamento che costituisce altresì il maggior canto d’amore della poesia ebraica), lo sposo (4, 9) dice all’amata qualcosa come “tu mi hai ferito il cuore, / mia sorella, sposa / mi hai ferito il cuore con uno solo dei tuoi sguardi / con una sola gemma della tua collana”, e la sposa (8, 6) canta il famoso “forte come la morte è l’amore, / tenace come gli inferi è la passione: / le sue vampe son vampe di fuoco”. Una poetessa greca dell’età arcaica (VII/VI secolo a.C.), Saffo di Mitilene, aveva ricordato questo fuoco che si insinua sotto la pelle in un celebre carme in cui è descritta la complessa sintomatologia del morbo d’amore (fr. 31 V. p. 181). La poesia erotica latina svilupperà a sua volta l’idea dell’amore come militia e come guerra, dell’amante come soldato e dell’amato/a come roccaforte da espugnare. Questo complesso immaginario sarà raccolto e ulteriormente sviluppato dai poeti del Dolce Stil Novo per divenire quindi patrimonio comune della letteratura amorosa di tutti i tempi e di tutte le latitudini. Qui di seguito presentiamo tre testi latini sulla “ferita d’amore”, a cominciare dal “padre” Ennio (fr. 254 V.), il grande poeta del III secolo a.C., per arrivare ai due principali poeti dell’età cesariana, Catullo (c. 64, vv. 245-250) e Lucrezio (De rerum natura IV, vv. 1045-1056), e per concludere, la celeberrima Era in penser d’amor di Guido Cavalcanti, uno dei massimi poeti del Dolce Stil Novo, che espone – per il seducente tramite di una pastorella pietosa – una sorta di fisiologia della “ferita d’amore”. Ennio Una delle più famose e citate tragedie di Ennio, la Medea exul, doveva ricalcare la Medea del tragediografo greco Eurìpide (V secolo a.C.), e rappresentare quindi le penose vicende della sventurata amante di Giàsone. Nel descrivere la passione della sua padrona, in un prologo che traduce quasi parola per parola il dramma euripideo, la nutrice ricorre all’immagine della ferita d’amore. Volesse il cielo che nel bosco del Pelio mai fosse caduta a terra, tagliata dalla scure, quella trave di abete e che da qui non avesse mai avuto inizio la costruzione della nave che ora ha preso il nome di Argo perché, trasportato su di essa, il f ior f iore degli eroi argivi, su ordine del re Pelia, cercò di ottenere (con l’inganno) dai Colchidi il vello d’oro dell’ariete. Ché la mia padrona Medea, dal cuore dolorante, ferita da una violenta passione d’amore, non avrebbe mai lasciato la sua patria per andare raminga. (Trad. A. Traglia) Catullo Nel carme 64, Catullo ricorda il mito di Tèseo, che ritornato in patria dopo la felice spedizione cretese deve però addolorarsi per il suicidio del padre, provando una pena simile a quella da lui stesso inflitta ad Arianna, la figlia di Minosse da lui “ferita”, sedotta e abbandonata. La “ferita”, qui, è però più quella dell’abbandono che non quella dell’innamoramento (vv. 245-250). 245 250 Virgilio Percorso tematico Così, mentre entrava tutto f iero nella dimora regale in lutto per la morte di suo padre, a Teseo fu inflitta una pena simile a quella che con mente immemore aveva inferto egli stesso alla f iglia di Minosse. La quale, affacciata in avanti a guardar triste la chiglia che si allontanava, ferita, molteplici affanni nel suo animo rivolgeva. Lucrezio La parte conclusiva del quarto libro del De rerum natura è in buona parte dedicata a descrivere i perniciosi effetti della passione d’amore, nel quadro di una discussione scientifica – tutta improntata alla 1 dottrina fisica epicurea – sulla genesi e sullo sviluppo della brama sessuale. Ciò non toglie, naturalmente, che Lucrezio riutilizzi immagini poetiche nei propri versi: tra queste, ai vv. 1045-1056, ha un certo spazio quella della “ferita d’amore”. 1045 1050 1055 Le parti stimolate si gonf iano di seme: nasce il desiderio di eiacularlo dove s’appunta la brama mostruosa, ed esso cerca quel corpo da cui l’animo è ferito d’amore. Infatti per lo più tutti cadono sulla propria ferita e il sangue sprizza nella direzione da cui è vibrato il colpo, e se il nemico è vicino il getto vermiglio lo irrora. Così dunque chi riceve la ferita dai dardi di Venere, siano essi scagliati dalle femminee membra d’un fanciullo, o da donna che irradi amore da tutto il corpo, si protende verso la creatura da cui è ferito e arde di congiungersi a lei, e di versare in quel corpo l’umore del proprio corpo. (Trad. L. Canali) Guido Cavalcanti Durante un pellegrinaggio a Santiago de Compostela, Guido si dovette fermare a Tolosa, dove fu infiammato d’amore da una donna provenzale. Gli effetti di questa passione sono descritti, e quasi dissezionati, nella famosa ballata Era in penser d’amor. Era in penser d’amor quand’i’ trovai due foresette nove. L’una cantava: «E’ piove gioco d’amore in noi». 5 10 15 LA FERITA D’AMORE 20 25 30 2 Era la vista lor tanto soave e tanto queta, cortese e umìle, ch’i’ dissi lor: «Vo’ portate la chiave di ciascuna vertù alta e gentile. Deh, foresette, no m’abbiate a vile per lo colpo ch’io porto; questo cor mi fue morto poi che ’n Tolosa fui». Elle con gli occhi lor si volser tanto che vider come ’l cor era ferito e come un spiritel nato di pianto era per mezzo de lo colpo uscito. Poi che mi vider così sbigottito, disse l’una, che rise: «Guarda come conquise forza d’amor costui!» L’altra, pietosa, piena di mercede, fatta di gioco in f igura d’amore, disse: «’L tuo colpo, che nel cor si vede, fu tratto d’occhi di troppo valore, che dentro vi lasciaro uno splendore ch’i’ nol posso mirare. Dimmi se ricordare di quegli occhi ti puoi». Alla dura questione e paurosa la qual mi fece questa foresetta, 45 50 Percorso tematico 40 Virgilio 35 i’ dissi: «E’ mi ricorda che ’n Tolosa donna m’apparve, accordellata istretta, Amor la qual chiamava la Mandetta; giunse sì presta e forte, che f in dentro, a la morte, mi colpîr gli occhi suoi». Molto cortesemente mi rispuose quella che di me prima avea riso. Disse: «La donna che nel cor ti pose co la forza d’amor tutto ’l su’ viso, dentro per li occhi ti mirò sì f iso, ch’Amor fece apparire. Se t’è greve ’l soffrire, raccomàndati a lui». Vanne a Tolosa, ballatetta mia, ed entra quetamente a la Dorata, ed ivi chiama che per cortesia d’alcuna bella donna sie menata dinanzi a quella di cui t’ho pregata; e s’ella ti riceve, dille con voce leve: «Per merzé vegno a voi». A corredo del percorso letterario sul tema della ferita d’amore, riportiamo una serie di immagini antiche in cui Eros/Cupido è effigiato con le armi proprie della sua funzione (ossia l’arco e le frecce) e/o con le ali. Un’altra caratteristica piuttosto diffusa è la sua giovane età, quasi a sottolineare da un lato l’innocenza, dall’altro la capricciosa casualità dei suoi atti: l’amore insomma, sembra dire l’iconografia, è un gioco che fa male, governato da un bimbo allegro e capriccioso. 1. Gemma etrusca. Londra, British Museum, IV secolo a.C. 2. Fregio del coperchio di un sarcofago di età romana. Napoli, Museo Archeologico Nazionale. 3 LA FERITA D’AMORE 3. Intaglio. Vienna, Kunsthistorisches Museum, I secolo d.C. 4. Intaglio. Brunswick, Herzog Anton-Ulrich Museum, I secolo d.C. 4 5. Monile pendente di una collana. Mariemont (Belgio), I-II secolo d.C. 6. Lékythos attica. Forth Worth (Texas), Kimbell Art Museum, 490 a.C. Virgilio Percorso tematico 7. Cratere italiota a forma di calice. Lipari, Museo Archeologico Eoliano, 360 a.C. ca. 10. Copia dell’Eros arciere di Lisippo. Roma, Musei Capitolini. 8. Rilievo in bronzo. Francoforte, Liebighaus, IV secolo a.C. 9. Piastra per un bastone. Berlino, Staatliches Museum, IV secolo a.C. 11. Copia dell’Eros arciere di Lisippo. Venezia, Museo Archeologico. 5
Scaricare