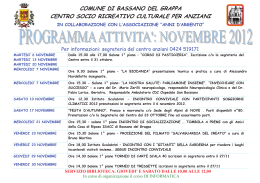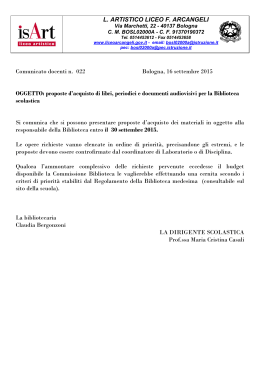Biblioteca Nel proporre la selezione di titoli che seguono, RSP segue i criteri della più vasta copertura a lei possibile dei temi di suo interesse. Tutto ciò che si segnala è ritenuto, a vario titolo, significativo per lo studioso di storia politica. La scelta principale è di prediligere la tempestività nelle segnalazioni e l’essenzialità nelle argomentazioni per ampliare lo spettro della copertura dei temi. RSP ha tuttavia pensato che fossero possibili limitate «eccezioni». Sono i volumi inseriti nell’area «Focus» che la redazione ha ritenuto di segnalare chiedendo al recensore di espandere la sua analisi, perché ci sono parsi tali da suscitare più ampia discussione. Il sito della rivista (http://www.arsp.it/) ospita inoltre la rubrica «Discussione Biblioteca», dove è possibile leggere eventuali repliche degli autori recensiti, nella prospettiva di allargare gli strumenti utili per il confronto delle idee. Focus Daniel T. Rodgers, Age of Fracture, Cambridge-London, The Belknap Press of Harvard University Press, 2011, pp. 352. Age of Fracture è un libro importante non solo per coloro che si occupano in modo professionale o per interesse culturale di Stati Uniti d’America, pur se la ricostruzione di ciò che è avvenuto nelle strutture profonde del pensiero economico, sociale, politico, filosofico a partire dagli anni Settanta e Ottanta del Novecento riguarda fondamentalmente quel paese. È un libro che tutti dovrebbero leggere perché ci interroga, prima ancora che come studiosi e storici, come cittadini che vogliono comprendere i mutamenti che stiamo vivendo, in che modo si è operata una rivoluzione culturale che ha cambiato le coordinate intellettuali, i paradigmi, le categorie politiche che avevano retto lo sviluppo della costruzione dello Stato-nazione e della società negli Stati Uniti e in Europa all’indomani della Seconda guerra mondiale. Come scrive Rodgers, «strong readings of society had been one of the major intellectual projects of the middle decades of the twentieth century […] twentieth-century social thinkers had encircled the self with wider and wider rings of relations, structures, contexts, and institutions» (p. 4). Negli Stati Uniti post Seconda guerra mondiale, testi, come quelli di C. Wrights 69 Ricerche di Storia Politica 1/2014 Mills, White Collar: The American Middle Classes (1951), di Hannah Arendt, Origins of Totalitarianism (1951), o David Riesman, The Lonely Crowd (1950), testimoniavano di una riflessione politica e sociale che cercava di sistematizzare la complessità sociale e politica entro strutture, classi, norme sociali e politiche. A partire dall’ultimo quarto del Novecento, qualcosa si rompe, si frantuma, appunto, per riprendere il titolo del volume. Continua Rodgers, «one heard less about society, history, and power and more about individuals, contingency, and choice. The importance of economic institutions gave way to notions of flexible and instantly acting markets. History was said to accelerate into a multitude of almost instantaneously accessible possibilities. Identities became fluid and elective […] In the last quarter of the century, the dominant tendency of the age was toward disaggregation» (p. 5). Rodgers, già autore nel 1998 di un altro libro che ha dominato il dibattito storiografico americano, Atlantic Crossings che metteva in luce la dimensione transatlantica dello sviluppo del pensiero sociale e politico dei primi decenni del Novecento, continua a centrare la sua analisi sulla dimensione del pensiero politico e sociale, concentrandosi sui testi che hanno alimentato il dibattito pubblico e intellettuale degli anni Settanta e Ottanta. Come è stato osservato da altri recensori (Robert West- brook fra gli altri), l’A. propone una sorta di syllabus in cui troviamo testi che hanno determinato le coordinate di mutamento del paradigma sociale postbellico: Alvin Toffler, Future Shock (1970), John Rawls, A Theory of Justice (1971), Clifford Geertz, The Interpretation of Culture (1973), Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (1974), William Julius Wilson, The Declining Significance of Race (1978), Michael Walzer, Spheres of Justice (1983), Allan Bloom, The Closing of the American Mind (1987), Judith Butler, Gender Trouble (1990), Francis Fukuyama, The End of History (1992). A questa lista bisogna poi aggiungere testi di autori non americani, ma che per l’A. hanno profondamente influenzato il dibattito americano, a partire da Sorvegliare e punire di Michel Foucault. D’altra parte, come si mette in evidenza fin dall’inizio del libro, ciò che Rodgers vuole raccontare è una «war of ideas» – slogan conservatore tratto da una frase di Peggy Noonan, nota opinionista del «Wall Street Journal», nonché consulente di Reagan alla Casa Bianca – non tanto nel senso di una ricostruzione del conflitto profondo e lacerante fra liberal e conservatori (che pure ha giocato un ruolo cruciale nel determinare i mutamenti del quadro politico e concettuale contemporaneo). Come precisa l’A., la sua non vuole essere l’analisi di un «single movement of ideas that swept everything before it», ma il più ambizioso progetto di dare conto di movimenti simultanei che hanno riguardato ambiti, discipline, categorie sociali diverse. Per certi versi, riprendendo l’ipotesi che muoveva l’A. nella sua riflessione del 1998, l’obiettivo è quello di dare conto degli incroci, delle ibridazioni e delle simultaneità di analisi e tendenze che, complessivamente, avrebbero mutato le coordinate del pensiero sociale e politico statunitense: «it is a story of the debates across a half-dozen fronts through which Americans tried to reimagine themselves and their society» – dalla crisi economica degli anni Settanta, alla base della rimodulazione del capitalismo e dei mercati in chiave finanziaria e globale, al ripensamento del concetto di identità dopo le guerre culturali e le lacerazioni dovute a un uso assertivo e arroccato delle categorie di razza e genere, dal linguistic turn a una riformulazione del nesso libertà-obbligazione sia in chiave di ordine politico interno sia in relazione alle sfide poste dal crollo del comunismo. Ciò che Rodgers 70 Biblioteca mette in luce è come tutto ciò si produca attorno non a un’idea dominante, ma attraverso «a contagion of metaphors» (p. 10). Così, ad esempio, le idee centrate sulla supremazia del mercato elaborate all’interno dei dipartimenti universitari di economia si diffondono nelle scienze sociali; alcuni concetti propri della teoria dei giochi diventano parte integrante del dibattito pubblico e politico. I confini disciplinari e gli ambiti concettuali diventano così più fluidi e porosi, in apparente contraddizione con la tendenza alla iperspecializzazione. È il quadro complessivo che Rodgers offre, più che l’analisi dei singoli temi, a costituire l’aspetto originale e il contributo più rilevante del libro. Molte delle questioni affrontate – dalla retorica populista che da Reagan in avanti si produce sulla contrapposizione tra governo e popolo alle guerre culturali, dall’enfasi sulle virtù taumaturgiche del mercato alla messa in discussione del concetto di sorellanza dentro il dibattito femminista, solo per citarne alcune – sono note e ampiamente discusse. Nello stesso anno di pubblicazione di questo volume, Tony Judt, sviluppando tesi delineate in un articolo apparso sulla «New York Review of Books» nel 2009, analizzava, pur se in un altro contesto argomentativo, alcune questioni sollevate dall’A. (Guasto è il mondo, 2010). Ciò che mancava è una sintesi che, ricostruendo i diversi tasselli e mettendo in luce le reti e le contaminazioni, fosse in grado di dare conto della portata, ampiezza e pervasività di un vero e proprio cambio di paradigma, per riprendere l’ipotesi di Thomas Kuhn. Un grande affresco che, a partire dall’esperienza statunitense, è in grado di gettare luce sui mutamenti complessivi che hanno riguardato il mondo occidentale (e non solo) negli ultimi tre decenni. Non è possibile in questa sede entrare nel dettaglio dei sette, complessi capitoli, oltre a un prologo e a un capitolo conclusivo, di cui è composto il libro per la quantità di temi e questioni affrontati, a partire dal capitolo iniziale che, analizzando i mutamenti della retorica presidenziale, mette in luce come le categorie e le parole d’ordine che avevano retto la costruzione discorsiva durante la Guerra fredda vengano spazzate via a favore di dispositivi narrativi, come quelli utilizzati da Reagan, centrati sull’individualizzazione dei desideri e delle esperienze, sul sogno americano come espressione del vivere comune. Dalla riproposizione dell’idea di mercato come concetto astratto alla rivolta contro l’essenzialismo da parte di intellettuali afroamericani e femministe come Judith Butler; dalla riflessione teorico-politica sul tema della giustizia e della comunità al dibattito costituzionale promosso dai conservatori intenti a ripristinare il concetto di «original intent» dei padri fondatori; dai conflitti sull’uso della storia e della memoria all’esaltazione del modello liberale, della fine della storia e della shock therapy come via obbligata per la transizione dal comunismo alla democrazia. Sono tutte questioni, queste, che mettono in luce come si sia operata la frattura dei sistemi di pensiero e istituzionali a favore di una visione individualizzata, contingente, fluida e disancorata. Un mutamento paradigmatico, quindi, quello che ci propone Rodgers, che non viene messo in crisi neppure dal trauma dell’11 settembre, che pure sembrava aver riscoperto il valore dei «common bonds» e della necessità di una nuova cultura civica. Come mettere insieme i pezzi rimane l’interrogativo a cui l’A. non dà, come è ovvio, una risposta, anche se appare evidente che è questo lo scopo del suo libro, favorire un dibattito che sia in grado di individuare nuovi fondamenti del vivere civico. Vi sono, tuttavia, tre questioni su cui vorrei soffermare l’attenzione perché meriterebbero di essere sottolineati dal punto di vista del dibattito storiografico in particolare. La prima riguarda la centralità che anche in questo libro appare evidente degli anni Settanta del Novecento come decennio periodizzante, come inizio della frattura. Sono i conflitti degli anni Settanta (più di quelli degli anni Sessanta che, come l’A. mette in evidenza, si basavano sull’utilizzo degli stessi dispositivi concettuali elaborati nei decenni precedenti) all’origine di una serie di cambiamenti nella riflessione, nelle modalità e nelle pratiche sociali, a partire dalla messa in discussione del principio di autorità. La seconda riguarda il fatto che l’analisi ad ampio raggio offerta da Rodgers, mettendo in luce intrecci e diffusione di metafore, aiuta a comprendere come la caratteristica più significativa della frattura sia la scomparsa della storia, non nel senso inteso da Fukuyama, ma della storia come orizzonte concettuale e metodologico. All’interno del processo di frantumazione, ciò che si produce 71 Biblioteca è anche un collasso spazio-temporale che, in nome della contingenza, da un lato, e dell’universalizzazione di concetti e desideri (libertà, diritti umani, giustizia) dall’altro, rende la storia inutilizzabile e schiacciata sulla memoria. Nella retorica di Reagan «history was ‘a river’ […] ����������������������������������� History was an unbroken line of reassurance up and down which the imagination could freely run» (p. 222), osserva Rodgers. Non solo Reagan rendeva il passato, paradossalmente, il presente della nazione, entrambi dentro la costruzione di un immaginario rassicurante e pacificatore; non solo sulla storia e sul suo uso venne combattuta una battaglia tra multiculturalisti e assimilazionisti, ma in un contesto in cui il tempo era considerato «penetrabile» – dai costituzionalisti conservatori che in un balzo all’indietro volevano riportare nel presente «the original intent» dei padri della costituzione, agli economisti e agli scienziati politici della shock therapy e della transizione «veloce» dai regimi autoritari alla società di mercato – la storia, come disciplina e come metodo, non serve più se non, appunto, come terreno di battaglia ideologica e politica. Terza osservazione: l’A. avverte che è consapevole del limite del suo libro, vale a dire quello di aver trascurato la dimensione internazionale e globale di tale dibattito. Auspica, anzi, che ben presto venga pubblicata una storia globale del pensiero sociale e politico del tardo Novecento. Tuttavia, forse un’attenzione maggiore alla dimensione globale sia per quel che riguarda le pratiche politiche e sociali sia per quel che concerne la riflessione avrebbe aiutato a individuare quegli elementi in grado di fornire una risposta all’interrogativo di fondo: come mettere assieme i pezzi? Anche perché il «globale» si è riversato nelle accademie, negli istituti e fondazioni americane, come dimostra lo sviluppo degli studi postcoloniali che avvenne proprio nell’età della frantumazione. È all’interno di questo filone, attento a una risignificazione dei concetti di confine e di potere, che si possono intravedere analisi che tendono a individuare nuove forme di ricomposizione sociale e politica come pure, a partire dalle pratiche e reti transnazionali che si sono costruite proprio dagli anni Ottanta, a riflettere sugli effetti negativi del processo di globalizzazione, sfidando la costruzione egemonica basata sull’individualismo atomistico e sul mercato e avanzando una contro narrazione basata sui concetti di solidarietà e di «beni comuni». Raffaella Baritono Brendan Simms, Europe. The struggle for supremacy from 1453 to the present, London, Allen Lane-Penguin, 2013, pp. 690. Libro assai discusso nel contesto anglo-statunitense, poco fuori di questo, il lavoro dello storico di Cambridge è da tanti punti di vista una provocazione. Prima di tutto per l’ampio sviluppo temporale che prende in considerazione, cioè dalla caduta di Costantinopoli in mano ottomana sino ai giorni nostri. Il «lungo periodo» non è un oggetto di moda ai nostri tempi di grande specializzazione, anche perché è obiettivamente molto difficile dominare la letteratura specialistica che è disponibile per un arco di tempo così lungo. In secondo luogo perché cerca di rovesciare uno schema interpretativo divenuto dominante: il primato della politica interna rispetto alla politica estera nell’analisi dell’evoluzione dei vari sistemi politici (un tema assai dibattuto nella storiografia tedesca degli anni Settanta, su cui Simms si è in buona parte formato). In terzo luogo perché ha accettato la sfida di una «storia interpretante», cioè una lettura globale degli eventi di un certo periodo per ricercarvi un elemento esplicativo unificante. È riuscito nell’impresa? Francamente la risposta non può essere completamente positiva, pur se, a mio modesto avviso, buona parte delle critiche che il libro ha sollevato sono un po’, come dire, tradizionaliste. La tesi che sta alla base di questo lavoro è in fondo semplice e non nuovissima: l’imporsi e poi il declinare di una «questione europea» che muta di connotati negli oltre cinque secoli oggetto dell’analisi, ma che non tramonta. Al centro di essa starebbe una «questione tedesca» che si cerca a volte di espungere e marginalizzare, ma che rimane sempre il perno attorno a cui ruota la nostra storia. Per questo si inizia in fondo dall’evento simbolico che pone l’Europa nella necessità di bat- 72 Biblioteca tersi contro un nemico comune, l’espansionismo ottomano, che, sottolinea Simms, non vuole semplicemente conquistare alcuni suoi territori, ma subentrare ad essa come potere universale. Questa l’ambizione dei sultani che conquistano il luogo simbolico dell’Impero romano d’Oriente per muovere alla conquista di quello d’Occidente. In conseguenza la questione del «Sacro romano impero» assume da allora una nuova veste e inizia la battaglia per la supremazia di un ruolo quantomeno di «regia» di un sistema politico europeo unitario, che diventa necessario per poter affrontare quella che con termine attuale potremmo definire una nascente globalizzazione. Come si vede, la tesi è affascinante e per certi versi plausibile. Ovviamente nasce, presumiamo, da un’interpretazione del passato alla luce del dibattito presente sulla debolezza del sistema politico europeo nel muoversi all’interno della crisi globale in cui siamo immersi. Giustamente alcuni hanno rivelato che forse l’origine di questo libro è nel precedente lavoro di Simms del 2001, in cui denunciava l’incapacità europea (e specialmente britannica) di affrontare la crisi dei Balcani (Unfinest Hour: Britain and the Distruction of Bosnia, 2001). Rimane il fatto della debolezza di una ricerca quando si parte dalla necessità di dimostrare una tesi che si è costruita a priori. Non che in parte questo percorso sia inevitabile, se non si vuol fare pura erudizione: la ricerca è sempre la verifica di un’ipotesi. Il problema è che bisognerebbe evitare di chiedere a questi percorsi di diventare la chiave per spiegare «totalmente» qualsiasi problema ci si ponga. I critici di Simms hanno avuto buon gioco a sparare al bersaglio su singoli punti, a partire dal fatto che siamo dinnanzi alla spiegazione della storia europea nel suo complesso basandosi praticamente solo su letteratura in inglese e in tedesco, dunque su un approccio molto connotato sul piano culturale. Tralasciamo qui di ripercorrere singole sviste che sono anche comprensibili quando si cerca di dominare un materiale così vasto. Il problema è più generale, ovvero: come si riesce a dimostrare una tesi tanto «pesante». Confesso la mia perplessità sull’uso disinvolto delle citazioni da discorsi di personaggi illustri. Specie nell’Ottocento e nel Novecento i protagonisti politici producono ciascuno maree di interventi del più vario genere e, con un po’ di abilità retorica, si trova sempre la frasetta di questo o quello che porta acqua al proprio mulino. Se non si è in grado di mostrare che quella specifica citazione è veramente emblematica di un convincimento strutturante il pensiero del personaggio richiamato, la cosa perde di rilievo e diventa artificio. E tuttavia, se si deve fare così per ogni citazione, in un volume come questo le dimensioni si amplierebbero a dismisura e dunque viene chiesto al lettore un atto di fede. Questo però non può essere chiesto allo storico di professione che legge, il quale comincia a dubitare della rilevanza dei rinvii nei casi che conosce e tende a estendere i suoi dubbi a quelli che non conosce. Faccio alcuni esempi. Quando si legge il quadro che Simms offre delle cause di scoppio della Prima Guerra mondiale (pp. 292-93) si è stupiti di come diventi semplice e lineare un processo aggrovigliato che prese un mese per giungere ad una soluzione (e notiamo che la questione italiana è buttata lì del tutto superficialmente). Altrettanto non ci sembra molto convincente che per sostenere che gli Usa entrano in guerra perché vogliono esser parte della nuova questione europea, si richiamino traffici tedeschi nella rivoluzione messicana in appoggio a Huerta (p. 289). Assai criticata è stata la ricostruzione che Simms fa della crisi degli anni Trenta del Novecento, con la tesi che a crearla fu la distruzione francese delle banche tedesche in un’ottica di distruzione del dominio tedesco sul centro Europa piuttosto che la Grande Depressione (pp. 341-42), così come la asserzione che Brüning sarebbe caduto per la sua incapacità di resistere alla Francia sulla questione del riarmo tedesco e questo, non la crisi economica, avrebbe portato al potere Hitler. Più condivisibile la tesi, certo non nuova, che alla fine la trasformazione politica post 1945 fosse determinata da «the clash of three Utopias», quella democratica, quella comunista e quella nazionalsocialista, con il fallimento del progetto hitleriano di unificazione europea sotto il suo dominio (p. 380). Tuttavia anche in questo caso ci si può chiedere se non sarebbe il caso di chiedersi se, almeno per la utopia democratica e per quella comunista, non si debbano operare distinzioni ed analisi al loro interno. Altrettanto più di un dubbio mi assale circa la asserita spinta europeista 73 Biblioteca del 1948, che mi pare Simms sopravvaluti (pp-39798). Così ci si può chiedere se sia convincente interpretare la crisi del 1956, sulla cui centralità è facile convenire, come un momento di rilancio della frattura all’interno della costituenda unione europea per la lettura che ne diede la Gran Bretagna, per cui una soluzione «europeista» di quella crisi avrebbe dato centralità alla rinata Repubblica federale tedesca, come finirà per fare la Cee. Un passaggio assai chiarificatore di quanto la tesi di Simms sia un letto di Procuste in cui costringere la storia del mondo è quando afferma (p. 456) che, nonostante crisi come quella di Corea, del Vietnam, di Cuba, della guerra arabo-israeliana, «the real prize, however, was always Germany». Si potrebbe continuare in questa disamina, ma non avrebbe molto senso. Bisogna invece richiamare la tesi finale a cui approda Simms. L’Europa ha oggi necessità di rinascere come elemento importante del sistema delle relazioni internazionali, ma non potrà farlo se non riesce a trovare una sintesi fra potenza economica e potenza militare (e in fondo è la mancanza per cinque secoli di questa sintesi che l’ha ridotta così). Ciò sarà possibile solo con una integrazione fra lo stato che ha la potenza economica (la Germania) e quello che ha ancora la potenza militare (la Gran Bretagna). Lasciamo stare la plausibilità o meno di questa proposta, e torniamo a occuparci della questione storiografica che questo libro ha il merito di porre. Infatti, esso è discutibile (molto), ma indubbiamente stimolante e merita un’attenta considerazione. La questione fondamentale è una: si può davvero ritenere che esista nella storia una spiegazione «egemone» per interpretarla? Simms sembra ritenere di sì e, per esempio, afferma che lo sviluppo di un sistema «democratico» (cioè di coinvolgimento rappresentativo nella produzione delle decisioni politiche, anche se non sono questi i termini usati) dipende in misura determinante dalle esigenze di una politica internazionale basata sulla competizione totale e dunque sul consenso. In fondo è una ripresa della tesi weberiana del 1917-18, ma sconta la mancata presa in considerazione di molti altri fattori. Per esempio la crescita del ruolo della spesa pubblica e dunque della tassazione, la nascita del «Kulturstaat», cioè di un sistema pubblico che pretendeva di gestire quasi tutti gli aspetti che riguardavano la «civilizzazione», la lotta per la sopravvivenza delle aggregazioni sociali di natura non-statuale (da quelle religiose a quelle di mestiere) hanno avuto con la creazione delle moderne forma-partito un ruolo altrettanto decisivo nella formazione dei sistemi democratici assieme alle elaborazioni culturali che hanno stimolato. I dibattiti di questo tipo possono essere ampliati. Ciò non viene detto però per svalutare lo sforzo che Simms ha fatto. Il recupero di una storia interpretante (e di lungo periodo) è una sfida a mio giudizio non eludibile e questo libro la affronta con grande coraggio e con uno sforzo di ricerca imponente e assolutamente apprezzabile. Si tratta adesso di far entrare questa sfida nel dibattito storiografico, approfondendo le questioni che pone, tentando altre strade ermeneutiche. La questione che ci viene messa davanti circa una necessaria nuova interpretazione della «questione europea» è cruciale, al di là dell’accettare o meno che tutto ruoti attorno alla questione tedesca, ma, a mio avviso, riconoscendo che essa è stata indubbiamente uno dei perni (non il solo) attorno a cui si è mossa la storia del nostro continente nella modernità. [Si rimanda al sito della rivista, www.arsp. it, per eventuali repliche dell’autore]. Paolo Pombeni Generale David W. Ellwood, Una sfida per la modernità. Europa e America nel lungo Novecento, Roma, Carocci, 2012, pp. 404. Gli Stati Uniti e il messaggio «fate come noi» rivolto agli europei nonché la reazione di questi ultimi nel corso di quello che è giustamente definito il secolo lungo ovvero il Novecento: è questo il tema del saggio di Ellwood, «il libro di una vita��������������������������������������� »�������������������������������������� , come egli dice, che giunge a coronamento di un’attività quasi quarantennale. Anche se il tema è la proiezione del potere americano all’estero, non è questo un saggio di politica estera in senso stretto. Qui infatti vediamo una società nel suo insieme che si propone a un’altra, un tema piuttosto frequentato in particolare negli ultimi 20-25 anni, che l’autore ha il merito di sottrarre alla contrapposizione fra americanismo e antiamericanismo divenuta nel corso del tempo sempre più stantia, anche con l’ambizione di dire qualcosa che potrebbe suonare in larga misura come definitivo. La tesi di Ellwood è così riassumibile: da fine Ottocento l’impulso americano alla modernizzazione dell’Europa si è esercitato con maggiore intensità in tre momenti: i tre dopoguerra, il periodo successivo alla Prima guerra mondiale, alla 74 Biblioteca Seconda e alla fine della Guerra fredda, all’insegna rispettivamente del fordismo, della filosofia della crescita, della globalizzazione. Questi tre impulsi hanno incontrato reazioni differenti da parte europea. Nella prima fase la fascinazione si è limitata a componenti che Ellwood definisce di centro-sinistra tentando semmai di importare esclusivamente il modello produttivo; nella seconda l’Europa occidentale nel complesso ha accolto l’appello che proveniva dall’emergente superpotenza americana, più conscia dei propri mezzi e più determinata quindi, anche perché si è trattato di un cospicuo impegno materiale (accordi di Bretton Woods e Piano Marshall) nel quale – va sottolineato, forse con più forza rispetto a quanto fa l’autore – è presente anche l’America istituzionale oltre che il modello sociale. Gli europei hanno accolto in particolare la stretta correlazione fra prosperità e democrazia, ovvero fra crescita economica e solidità politica. In altri termini l’Europa occidentale ha reagito positivamente al nuovo che veniva dagli Stati Uniti, ma adoperandosi al tempo stesso a non cancellare il meglio che veniva dalla tradizione. A questo riguardo, in tema cioè di successo dell’intervento americano in Europa nel secondo dopoguerra, verrebbe da aggiungere qualcosa al discorso di Ellwood: il modello americano è stato accolto (con l’ovvia esclusione delle varie sinistre) anche perché al Piano Marshall si è combinato al Patto Atlantico garantendo un bene da tempo assai carente in Europa ovvero la sicurezza. Infine nel terzo dopoguerra il messaggio americano, aderendo in pieno alla prospettiva della globalizzazione, ha fatto perno su deregulation, libera competizione, libero mercato. Ma in questo caso quello che un altro autore definisce il nuovo militarismo americano ha scombinato le carte. Nel testo l’intervento americano è colto attraverso l’uso di quello che Joseph Nye ha definito come soft power, ovvero l’insieme delle politiche che inducono gli altri a «volere ciò che gli americani vogliono» senza ricorrere allo strumento militare; ma possiamo leggere alla luce di tale concetto tutte e tre le fasi che si sono dette. Per osservare che cosa? Come il soft power abbia avuto successo solo quando si è accompagnato all’hard power fondendosi con esso. Non è avvenuto dopo la Prima guerra mondiale né per tutti gli anni Venti e Trenta, quando a Washington non c’era la minima predisposizione a usare l’hard power. È avvenuto invece dopo la seconda quando soft power e hard power sono andati assieme per un bel po’ cioè fino agli anni Sessanta, allorché la leadership americana ha cominciato ad avvertire che il peso dell’intervento diventava eccessivo mentre gli europei, chi più chi meno, hanno cominciato a rivendicare maggiore autonomia abbracciando – come dice Ellwood – un modello ibrido di modernità fatto di consumismo unito a statalismo. Di nuovo non è avvenuto dopo la fine della Guerra fredda quando l’iperpotenza americana non ha trovato un rapporto omogeneo fra le due componenti, con l’uso dell’hard power che ha scatenato un’ondata di antiamericanismo senza precedenti, travolgendo forse in via definitiva il modello americano di modernità. Al riguardo Obama sembra aver intuito che la sfida americana stava ormai volgendo al termine e ha inteso scindere modernità da americanizzazione. Ma dal 2007 la crisi economica, ponendo rapidamente fine all’iperpotenza americana, ci sta facendo assistere – conclude l’autore – al gran finale dell’impero culturale americano. Con le ultime notazioni, assieme al libro, si chiude il ciclo: la sfida per la modernità non sembra più prerogativa di uno. Giampaolo Valdevit 75 Biblioteca Meredith Lair, Armed with Abundance. Consumerism and Soldiering in the Vietnam War, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2011, pp. 296. Il dibattito sulla guerra del Vietnam è stato di solito definito come l’invasione da parte di una potenza imperialista di un piccolo paese che combatteva per la sua indipendenza o come lotta per la libertà contro l’espansionismo comunista (sovietico e cinese). Il libro Armed with Abundance di Meredith Lair, molto documentato, mette in questione ambedue le tesi concentrandosi sulla macchina organizzativa e tecnologica americana. I dati sono impressionanti: furono costruiti 12 milioni di metri cubi di case, 100 aeroporti, 700 miglia di strade, 75 di ferrovie, apprestati 8000 letti di ospedale e via dicendo. Dei due milioni e mezzo di uomini inviati in Vietnam, solo il 25% circa parteciparono ad azioni di guerra. La gran parte dei militari aveva funzione di supporto. Il libro spiega come questi ausiliari vivevano e soprattutto consumavano, quali erano le loro funzioni e come erano strutturati i servizi a loro destinati. I servizi offerti servivano a mantenere il morale, a motivare e aumentare l’efficienza militare, a distrarre tutti questi uomini (e donne) trasportati in una società e una cultura così diversa e che spesso non capivano le ragioni della guerra; si voleva fare in modo che i soldati, anche se lontani del proprio paese, si sentissero vicini almeno nel life style. Il libro si concentra su come fu gestita quella che l’autrice, non senza una tragica ironia, chiama la «guerra alla noia». La sezione dell’esercito Special Services organizzò decine di corsi universitari o di formazione professionale, si distribuirono decine di migliaia di radio, giradischi, televisioni, che potevano essere acquistati con buoni o per pochi soldi agli outlets (310 nel 1970). Furono costruiti 1500 impianti sportivi, 50 piscine, centinaia di librerie, 38 centri d’intrattenimento, con teatri, cinema ecc. Vennero invitati molti cantanti e attori (circa 3200 nel 1970). Circa 2000 club, bar, discoteche erano presenti nel 1969, con un grande consumo di alcol, perfino di marijuana; ogni giorno molti soldati potevano andare in gita alle spiagge. E le aziende americane che organizzavano le vendite per corrispondenza e che ottenevano le concessioni trassero grandi profitti. Venivano pubblicati decine di giornali, riviste, in cui spesso si cercava di vendere l’immagine della guerra giusta della libertà contro il comunismo (anche se le più popolari erano le riviste pornografiche). Tuttavia molti soldati non riuscivano ad accettare questa immagine di liberatori di un popolo, così povero, che li combatteva con una feroce guerriglia. In quegli anni iniziò il fenomeno dei contractors, a pagamento, che diventò rilevante in Iraq: era finita l’idea di un servizio militare come espressione di servizio e di senso civico. Gli ausiliari americani portarono alla moltiplicazione di prostitute, all’aumento del mercato nero, inflazione, con migliaia di vietnamiti che vivevano solo fornendo loro ogni tipo di servizio. Naturalmente vi era una forte tensione, irritazione, da parte di coloro che erano al fronte, in condizioni di vita dure, rischiando la vita, verso gli ausiliari, che vivevano nel comfort, nelle retrovie, nonostante vi fosse un certo avvicendamento. Tuttavia tornati a casa, spesso si unirono nelle stesse associazioni di veterani, per ottenere dallo Stato vari benefici; per molti quell’esperienza, contro un nemico mai visto, e vissuta in situazioni agevoli e sicure, trovò una rielaborazione psicologica, per andare incontro alle aspettative di sacrifici e atti di eroismo mai compiuti. Questa interessante riconsiderazione della storia di quella guerra forse avrebbe potuto prendere in considerazione anche come vivevano, come combattevano, come morivano i soldati nei vari fronti (perirono 58000 americani e un milione di vietnamiti) e ancora, nonostante i consumi concessi, che effetto aveva sulla morale e la psicologia dei soldati, sia ausiliari che al fronte, l’opposizione alla guerra in patria. Giovanni Aldobrandini Andrew N. Rubin, Archives of Authority: Empire, Culture and the Cold War, Princeton, Princeton University Press, 2012, pp. 200. Sulla base di un’ampia ricerca condotta in archivi privati e pubblici inglesi e americani, Andrew Ru- 76 Biblioteca bin, docente di inglese a Georgetown e studioso del filosofo e sociologo tedesco Theodor Adorno, offre un prezioso contributo al filone di studi dedicati alla diplomazia culturale della Guerra fredda, dimostrando come il trasferimento di potere avvenuto tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti all’indomani della Seconda guerra mondiale, non si limitò alla sfera puramente politico-diplomatica e di sicurezza, ma riguardò anche il mondo della cultura. Tuttavia, a differenza di altri lavori dedicati alla diplomazia culturale americana durante la Guerra fredda, Archives of Authority non ricostruisce soltanto i canali e le modalità attraverso i quali sia il governo britannico che quello americano finanziarono, soprattutto nella prima fase della Guerra fredda, artisti, letterati, mostre, concerti e iniziative culturali di vario genere, ma si interroga anche sul tema più ampio e scivoloso degli effetti della diplomazia culturale nel panorama letterario del mondo occidentale e più in generale sui canoni della cultura occidentale nel dopoguerra. A partire dal caso di George Orwell e della sua collaborazione con la sezione segreta del Foreign Office britannico, il cosiddetto IRD (Information Reserach Department), a cui lo scrittore inviò una lista di presupposti comunisti britannici, Rubin analizza il ruolo e l’attività di organizzazioni come il British Council e il Congress for Cultural Freedom, interrogandosi sull’influenza che questi organismi esercitarono non solo sulla letteratura anglosassone, ma anche sul pensiero dei filosofi e sociologi tedeschi appartenenti alla scuola di Francoforte, che emigrarono negli Stati Uniti durante il nazismo, come Theodor Adorno e Max Horkheimer. Con una narrazione che in molte parti assume il tono e la cadenza di una storia di spionaggio, il libro dimostra che la pubblicazione e la traduzione in molte lingue delle opere di autori come, George Orwell, Albert Camus, Richard Wright, Isaiah Berlin, Hugh Seton-Watson, o l’italiano Ignazio Silone su riviste sponsorizzate e finanziate dal CCF e dalla CIA, come «Encounter», «Tempo Presente», «Der Monat», «Preuves», facilitò enormemente la loro celebrità, a scapito di altri autori politicamente scomodi o semplicemente non allineati, che furono invece ignorati o demonizzati. Gli scritti di questi autori, celebrati negli Stati Uniti come la migliore espressione del pensiero contemporaneo, contribuirono così a creare e plasmare nuovi canoni letterari e a modellare l’immagine del totalitarismo sovietico in Occidente, come dimostrato dai famosissimi romanzi di Orwell La fattoria degli animali e 1984. Se, come sostiene Rubin, i canoni della cultura non possono essere esclusivamente ricondotti all’azione dei governi, il libro dimostra comunque che le logiche della Guerra fredda, soprattutto nella sua fase più acuta che durò fino alla metà degli anni Cinquanta, condizionarono, manipolarono, influenzarono la letteratura mondiale, cercando di renderla funzionale agli obiettivi della politica estera americana. Maria Eleonora Guasconi Dick Van Lente (ed.), The Nuclear Age in Popular Media. A Transnational History, 1945-1965, New York, Palgrave MacMillan, 2012, pp. 280. Questo importante libro ha per oggetto le immagini del nucleare che emergono nelle più popolari riviste illustrate di otto paesi fra il 1945 e il 1965, ovvero fra lo scoppio delle prime bombe atomiche e la fase nella quale la questione nucleare lasciò il posto ad altri temi nel discorso pubblico internazionale. Gli otto paesi comprendono le due superpotenze Usa e Urss, la Gran Bretagna, protagonista di progetti di ricerca significativi nel campo, le due Germanie, l’Olanda, esempio di paese piccolo dotato di un ambizioso programma nucleare, e il Giappone e l’India. Il primo, superato lo shock di Hiroshima e Nagasaki e le riserve nutrite inizialmente dall’opinione pubblica e dal ceto politico rispetto a questa sfera, farà dell’energia nucleare una componente cruciale del proprio processo di modernizzazione; la seconda, abbraccia, subito dopo l’indipendenza, il nucleare civile come strumento indispensabile di sviluppo e solo dopo le tensioni con la Cina nei primi anni Sessanta e il primo test nucleare cinese del 1964 avvia una discussione sull’opportunità di dotarsi dell’arma atomica. Il libro si sforza con successo di tenere aperto il proprio quadrante in chiave transnazionale e comparativa, puntando l’attenzione sui flussi di informazioni che circolano entro la comunità scienti- 77 Biblioteca fica internazionale e nei media, attraverso e al di là dell’assetto bipolare internazionale. Scienziati e media, con le loro rispettive agende, sono due dei quattro fattori attorno ai quali l’analisi ruota, gli altri due essendo gli investitori, essenzialmente governativi, nel settore, e il serbatoio di idiomi culturali e pratiche discorsive preesistenti negli immaginari collettivi delle singole culture nazionali, immaginari ai quali il discorso pubblico ricorre per elaborare le immagini su questo tema. Il risultato è una ricostruzione sospesa tra affinità e differenze, temi comuni e diverse declinazioni a seconda della collocazione del singolo paese nella mappa geopolitica internazionale, delle sue condizioni generali e dei suoi piani economici e politici, delle risorse, in particolare energetiche, a sua disposizione. Quattro grandi temi attraversano la narrazione, riflettendo le discussioni rinvenute nelle riviste: le reazioni a Hiroshima e Nagasaki; le forme militari e civili-pacifiche della tecnologia nucleare; la crescita dei movimenti di protesta antinucleari. In generale domina, specie nel primo decennio, una visione dicotomica del fenomeno, sospesa tra le preoccupazioni legate agli effetti devastanti dell’utilizzo militare dell’atomo, «considerato dall’inizio una minaccia per l’intero pianeta», e l’utopia positiva delle «applicazioni pacifiche» della «fissione nucleare in medicina, agricoltura, ingegneria e produzione di energia» che «avrebbero beneficato tutta l’umanità» (pp. 1-2). È la rivista sovietica «Ogonyok» a sottolineare costantemente con particolare forza questo secondo elemento, contrapponendo senza esitazioni il proprio uso civile a quello militare statunitense. A sua volta, «Life» punta dapprima sugli aspetti positivi civili, in un certo senso anticipando e poi facendosi interprete dell’offensiva eisenhoweriana del peaceful atom, per poi lasciar trapelare, a cavallo degli anni sessanta, gli echi delle preoccupazioni che vanno accumulandosi a livello nazionale e internazionale. Ma è impossibile riassumere nei limiti di una scheda la ricchezza di indicazioni, metodologiche e di contenuto, che emergono dal libro. Semmai c’è da augurarsi di vedere l’analisi allargarsi anche ad altri paesi, compreso il nostro, e approfondirsi, con un esame ravvicinato, basato su materiali d’archivio, dei rapporti tra i vari soggetti (governi, scienziati, media) all’interno dei singoli paesi. Ferdinando Fasce Europa Steven A. Barnes, Death and Redemption. The Gulag and the Shaping of Soviet Society, Princeton, Princeton University Press, 2011, pp. 352. Ivan Čistjakov, Storia di un guardiano del Gulag, Milano, Bruno Mondadori, 2012 (cura e traduzione di Francesca Gori, ed. or. 2008), pp. 234. Da quando l’Urss è crollata e gli archivi sono stati, in parte, aperti, memorialistica e storiografia ufficiale si sono confrontati, più spesso scontrati, nell’interpretazione della storia del gulag. Per limitarci a due opere divenute negli ultimi anni punti di riferimento di quanti si interessano alla materia, libro di documenti è la Storia del Gulag di Oleg Chlevnjuk (2004), incentrata sulla definizione delle fasi della politica del Cremlino e l’articolazione del sistema repressivo, e incline a accreditare la sostanziale attendibilità dei dati ufficiali sulle vittime, che ridimensionano di varie volte le valutazioni della memorialistica. Libro di memorie è Gulag di Anne Applebaum (2003), la cui scoperta ambizione è di aggiornare Arcipelago Gulag di Solženicyn attraverso la creazione di una mappa concettuale che pone al centro le sofferenze dei prigionieri dei lager, e sullo sfondo le vittime delle altre forme di repressione del regime, e la questione del loro numero. Il lavoro di Barnes prova a conciliare questi due approcci e analizza «the role played by Gulag in the Soviet polity» attraverso le «apparent contradictions» di una storia nella quale «exploitations, oppression, and mass death coexisted with reeducation, redemption, and mass releases» (p. 2). Memorie dei prigionieri e gli archivi centrali dell’amministrazione del gulag sono integrati da una ricerca negli archivi del Karlag, nel Kazachstan, uno dei più importanti del sistema concentrazionario sovietico, il cui scopo è di definire il feedback che spinse i vertici del partito a modi- 78 Biblioteca ficare le strategie di repressione. L’obiettivo della rieducazione dei prigionieri restò centrale sino alla metà degli anni Trenta; dopo di allora fu confinato ai documenti interni, nei quali «the failure to pay adequate attention to educational work itself could result in severe criticism from the higher levels» (p. 59). Sebbene la funzione principale di questa pratica fosse di trovare una legittimazione ideologica allo sfruttamento dei prigionieri, essa non mancava di un ruolo pratico. Ogni anno dal gulag venivano rilasciati circa il 20% dei prigionieri, per lo più criminali comuni, la grande maggioranza delle 18 milioni di persone che negli anni di Stalin popolarono il sistema concentrazionario sovietico e l’impegno profuso per abituarli a lavorare all’interno di un collettivo, e a rispettare l’autorità, rispondeva all’esigenza di attuare una forma elementare di difesa sociale. I risultati furono scarsi. La mobilitazione patriottica dei prigionieri al tempo della guerra, che Solženicyn nega, ma che è confermata dai dati sulla aumentata disciplina del lavoro e dalle richieste di invio al fronte, ebbe poco a che vedere con l’impegno del regime e fu determinata dalla volontà di partecipare a una causa nazionale. Dalla corrispondenza centro-periferia esce confermata la tesi di Chlevnjuk, secondo la quale i dirigenti del partito erano consapevoli che «the Gulag was significantly unproductive per capita» (p. 129), anche in relazione a un sistema economico che non brillava per la sua efficienza. Il danno economico era notevole, se si tiene conto che al momento della sua massima espansione, all’inizio degli anni Cinquanta, la popolazione di campi, colonie di lavoro e luoghi di deportazione superava i 5 milioni, con un contributo all’economia nazionale che si aggirava attorno al 10%. È comprensibile che i prigionieri, puniti alla minima violazione delle disciplina, abbiano attribuito al gulag finalità essenzialmente economiche, di sfruttamento del lavoro schiavistico, ma l’interrogativo che si pone all’interpretazione storica riguarda piuttosto le ragioni che impedirono ai vertici del potere di trarre le conclusioni da quanto scrivevano nei documenti interni, e riconoscere che il «gulag was a financial catastrophe for the Soviet state» (p. 39). La ���������� rispos- ta di Barnes è che, per facilitare la «grande svolta» degli anni Trenta, «the Soviet authorities attempted with great haste to cleanse the newly emerging society of the criminals, class enemies and political opponents they believed could contaminate the new world» (p. 255). ����������������������������� La stessa operazione fu ripetuta al tempo della Guerra con i «popoli nemici», minaccia alla ritrovata unità patriottica. Il costo in vite umane fu enorme (per il solo gulag si aggira attorno agli 1,6 milioni di persone) ma non rivela una volontà di eliminazione fisica che giustifichi analogie con la Shoah. L’interpretazione di Barnes è convincente: non minimizza le responsabilità personali, ma coglie la sostanziale debolezza di un regime impossibilitato a mandare a morte l’enorme numero di persone internate nel sistema concentrazionario, incapace di rieducarle, inetto, quando, dopo il 1953, iniziò lo smantellamento del gulag, a guidare il reinserimento di prigionieri comuni e politici nella società. Per comprendere appieno come il gulag abbia continuato a funzionare per decenni nonostante l’inefficienza e l’assenza di precisi compiti, manca una più chiara cognizione dell’apparato repressivo, del quale conosciamo la struttura, le dimensioni dell’organico, che nel momento di massima espansione sfiorò le 400.000 unità, ma non la composizione personale. L’assenza di memorie e la perdurante inaccessibilità degli archivi degli apparati di polizia fanno ritenere che la lacuna non sia destinata a essere colmata. Il diario di Ivan Čistjakov, comandante di una unità armata del lager della ferrovia Bajkal-Amur, è quindi una «testimonianza storica unica», come scrive Irina Ščerbakova nella postfazione all’edizione italiana. Purtroppo il diario comprende solo gli anni 193536 e il suo autore è un personaggio atipico, con ambizioni di narrazione letteraria, ben rese dalla traduzione italiana, costretto a scegliere la carriera di guardia del gulag per sfuggire all’arresto, dopo l’espulsione dal partito. Il freddo, la sporcizia, gli spossanti spostamenti lungo centinaia di chilometri di ferrovie, l’inutile impegno per impedire le evasioni dei prigionieri, ricorrono ossessivamente nelle pagine del diario. La disperazione per una vita che si consuma in un ambiente privo di stimoli, è ingigantita dal disprezzo nei confronti di colleghi «ignoranti, illetterati, senza cultura», il cui comportamento lo conferma nel giudizio che 79 Biblioteca chi «vuole restare nell’esercito» lo fa «perché come civile è buono a nulla» (pp. 70 e 99). Al confronto desta ammirazione la capacità delle prigioniere (non dei prigionieri) di formare spontaneamente un «collettivo di criminali con i propri usi e costumi da ladro» e una gerarchia, in cui «la capo brigata è atamano, pascià, mamma» (p. 65). Čistjakov non menziona particolari episodi di fanatismo o di sadismo fra le guardie; è la routine burocratica a generare eccessi di repressione, ai quali ammette di non essersi stato sempre capace di sottrarsi. Egli stesso finì con l’essere travolto da questa banalità del male. Arrestato nel 1937, morì al fronte nel 1941, dopo aver vissuto una vita che, anche da uomo libero, aveva considerato una condanna. Fabio Bettanin Fabio Bertini, Figli del 48. I ribelli, gli esuli, i lavoratori dalla Repubblica Universale alla Prima Internazionale, Roma, Aracne, 2013, pp. 564. Il volume di Fabio Bertini racconta i molteplici percorsi che legarono i progetti rivoluzionari eminentemente politici delle rivoluzioni del 1848 con i programmi di emancipazione sociale che un quindicennio più tardi caratterizzeranno la Prima Internazionale. Tale evoluzione viene analizzata attraverso una attenta e puntuale analisi degli intrecci tra storie personali e collettive, ma anche tra storie delle idee e delle ipotesi organizzative. Il volume descrive sia i dibattiti teorici che animano i diversi filoni dell’emigrazione politica europea (democratici, anarchici, socialisti, repubblicani eccetera), sia i processi riorganizzativi dell’azione rivoluzionaria. Inoltre, nel libro viene anche dedicato ampio spazio alle vicende biografiche e intellettuali di alcune grandi personalità che svolgono il ruolo di leadership ideologica, simbolica o militante. In questa prospettiva, il lavoro di Bertini si presenta non solo come occasione per raccontare e interpretare in modo originale un universo di processi sociali e politici, ma, come già evidenziato da Maria Grazia Meriggi nella sua stimolante presentazione che introduce il volume, è anche occasione paradigmatica per confrontarsi con alcune questioni storiografiche e metodologiche fondamentali. Infatti, nel libro vengono affrontate problematiche teoriche spesso considerate dicotomiche come classe/nazione/internazionalismo, questione nazionale/questione sociale, biografie individuali/ storie collettive, ideologie/modelli organizzativi, micro storia/grande storia, proponendo soluzioni interpretative innovative. In particolare, appare stimolante l’analisi del rapporto tra nazione e classe che nella congiuntura europea post-1848 sembrano essere vissuti dai protagonisti delle rivoluzioni sconfitte come termini non antitetici. Il lavoro di Bertini evidenzia come l’anelito patriottico per l’indipendenza nazionale e l’aspirazione per percorsi di emancipazione sociale vengono vissuti dai rivoluzionari europei come parte del medesimo processo di liberazione. Al contempo, dalla complessa interazione tra rivendicazioni nazionali e solidarietà di classe prende anche avvio quel processo di internazionalizzazione del movimento dei lavoratori di cui la Prima Internazionale emerge come primo momento di sintesi. Bertini, riesce a raccontare questa storia concentrandosi su una congiuntura decisiva della storia europea e mettendo in dialogo la storia collettiva del mondo del lavoro con quella della democrazia. Bertini situa a Londra lo spazio fisico principale, dove si dipana questa esperienza di saldatura tra le diverse emigrazioni politiche e le avanguardie del movimento dei lavoratori. Infatti, dopo il 1848, la capitale inglese è il luogo dove una realtà socio-economica all’avanguardia nei processi di accumulazione capitalista funge da palcoscenico per molteplici intersezioni tra i mille rivoli dell’universo degli esuli europei, la forza del movimento operaio inglese e le tradizioni sedimentate del tradeunionismo e del cartismo. Infine, un ulteriore merito del lavoro di Bertini è l’aver affrontato queste questioni sulla base di una ricchissima varietà di fonti archivistiche e coeve ed insieme facendo riferimento ad una vasta bibliografia. In particolare, si segnala l’uso combinato di fonti interne ed esterne all’universo rivoluzionario, per cui la citazione di riviste radicali si alterna con l’analisi della stampa quotidiana o il riferimento alle carte diplomatiche del Foreign Office. Stefano Agnoletto 80 Biblioteca David Childs, Britain since 1945. A Political History, London-New York, Routledge, 2012, pp. 500. È ormai giunto alla settima edizione (uscì la prima volta nel 1979) questo ormai classico volume di David Childs sulla storia politica britannica dal dopoguerra ad oggi. Rispetto all’edizione del 2005 troviamo un interessante affresco della più stretta attualità: le dimissioni di Tony Blair e il governo di Gordon Brown, la crisi finanziaria esplosa nel 2007 e le sue conseguenze, i problemi legati all’immigrazione e i complessi rapporti con l’Unione Europea, la nuova special relationship con gli Stati Uniti di Obama e infine le elezioni del 2010 con la nascita di un esecutivo di coalizione, il primo dal 1945. La trattazione, in cui prevalgono le questioni della politica interna, ma con un’attenzione costante alle relazioni internazionali, alle dinamiche della Guerra fredda e della decolonizzazione, è organizzata attorno ai governi che si sono succeduti dalla fine della guerra mondiale ad oggi. Del resto, la relativa stabilità del sistema politico britannico e dei suoi esecutivi – a differenza, ad esempio, del caso italiano – viene in aiuto agli storici quando debbono dare una forma organica e sistematica ai loro lavori. Nel volume di Childs si incontrano così i «fine men» (p. 5) del governo laburista di Attlee, gli uomini dell’austerity e dell’edificazione del welfare State; Churchill e l’amara consapevolezza che la Gran Bretagna aveva ormai perduto lo status di grande potenza; poi ancora Macmillan, primo ministro negli anni del grande sviluppo economico e della affluent society, il governo del laburista Harold Wilson e le tensioni sociali della seconda metà degli anni Sessanta; la «rivoluzione» thatcheriana e il nuovo volto del conservatorismo inglese; il New Labour e i governi Blair, cui sono dedicati ben tre capitoli; per arrivare infine all’esperimento coalizionista tra conservatori e liberali del 2010, «the coalition of millionaires» (p. 427) – scrive Childs in riferimento all’alto numero di ministri provenienti dall’élite economico-finanziaria. La struttura del libro e la presenza di brevi e compatti paragrafi potrebbero far pensare a un testo di stampo manualistico rivolto principalmente a studenti e giovani studiosi di storia inglese. Ma se è vero che Britain since 1945 costituisce un ottimo strumento per chi si affaccia allo studio della Gran Bretagna contemporanea, sarebbe in verità molto riduttivo considerarlo un semplice manuale. Non solo, infatti, Childs utilizza, accanto ad un’ampia bibliografia, fonti primarie che consentono di arricchire e approfondire la trattazione, ma soprattutto non si limita alla mera narrazione degli eventi. Analizza in modo critico l’evoluzione interna ai principali partiti (ad esempio la crisi del laburismo a partire dagli anni Cinquanta e le sfide della New Left), descrive il contesto socio-culturale nel quale sono maturate le grandi trasformazioni politiche di questi sessant’anni, si sofferma sui nodi problematici che hanno segnato la storia britannica più recente, dalla questione irlandese al terrorismo dell’IRA, dalla decolonizzazione al processo di integrazione europea, dalle tensioni prodotte dalla presenza degli immigrati al rapporto coi paesi del Commonwealth. È un volume corposo – quasi 500 pagine includendo l’appendice finale – ma grazie alla scrittura piana dell’Autore, alla presenza di numerose, ma brevi, citazioni che lasciano la parola ai protagonisti rendendo più vivace la narrazione, alla divisione del materiale in tanti agili paragrafi la lettura ne risulta tutt’altro che pesante o difficile. Un bell’esempio di come si possa scrivere un buon libro di storia politica destinato tanto agli addetti ai lavori quanto al grande pubblico. Giulia Guazzaloca Carlos Dardé, Antonio Cánovas y el liberalismo conservador, Madrid, Faes-Gota a Gota, 2013, pp. 178. Dopo sei anni di moti rivoluzionari e di stravolgimenti politici – come la rivoluzione del settembre del 1868, la detronizzazione di Isabella II, la seconda Guerra carlista, la monarchia di Amedeo I, la Prima repubblica, le insurrezioni degli internazionalisti e dei cantonalisti –, che per alcuni spagnoli significarono momenti d’angustia e per altri una ragione di festa, nel 1875 la dinastia borbonica poté rioccupare il trono di Spagna. Da quel 81 Biblioteca momento ebbe inizio il regno di Alfonso XII, che fu regime monarchico di ordine liberale ma non pienamente democratico, e con esso iniziò anche la Restaurazione (1875-1921), che pose fine all’instabilità e alla lotta politica scatenatisi nel 1808, definibile anche come guerra civile. In quel frangente nacque lo Stato-nazione spagnolo nella sua versione liberale, che portò ad un periodo di pace e stabilità comparabile unicamente all’attuale regno di Juan Carlos I. L’artefice principale della Restaurazione fu senza ombra di dubbio il politico liberal-conservatore e orginario di Malaga, Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897). Nel 1876, durante un discorso alle Cortes, sarebbe stato lo stesso Cánovas a descrivere il carattere di quella Restaurazione: «Io avevo in mente un’idea chiara, un sistema; ed ho il diritto di riconoscere che quell’idea si sia rivelata corretta e che questa palpitante verità verrà riconosciuta dalla storia». Guardando ai fatti dalla prospettiva privilegiata della posterità, possiamo concludere che ebbe ragione. La principale causa del suo successo politico attenne alla superiorità da lui riconosciuta alla politica sulla violenza. Il regime restauratore poté contraddistinguersi, infatti, per una grande longevità: durò mezzo secolo e fu abbattuto solo nel 1923, quando intervenne il generale Primo de Rivera. Per siffatte ragioni Cánovas può essere considerato uno degli statisti di maggior prestigio della storia spagnola sino ai nostri giorni. Carlos Dardé gli ha dedicato una biografia eccellente, che è al tempo stesso rigorosa e sintetica. L’autore conosce alla perfezione il periodo della Restaurazione, come risulta evidente in ogni singola pagina del volume. Dardé è anche autore di una biografia del re Alfonso XII e ha partecipato ad una serie di esposizioni di grande qualità – presentate con cataloghi splendidi – dedicate a Cánovas e al suo principale rivale, Sagasta. Il lavoro di Dardé pubblicato nel 2003 e intitolato La aceptación del adversario. Política y políticos de la Restauración deve altresì considerarsi un testo di riferimento per l’approssimazione allo studio della Spagna contemporanea. Con il volume Antonio Cánovas y el liberalismo conservador, Dardé è poi riuscito, in poco più di un centinaio e mezzo di pagine, a ricostruire la vita di Cánovas, descrivendo, senza cadere in banalizzazioni o seguendo sentieri già eccessivamente battuti, anche il funzionamento della poli- tica nella Spagna dell’ultimo quarto del Novecento. Gli scritti e i discorsi di Cánovas, precedentemente raccolti in sette tomi di tredici volumi, ci accompagnano in ogni momento della lettura del testo. Cánovas del Castillo fu di origini modeste e si dedicò alla politica in giovane età. Negli anni Quaranta dell’Ottocento aderì al gruppo politico dei moderati, detti «puritani». I contatti con i progressisti vennero però meno a partire dall’esperienza rivoluzionaria del 1854. Nel 1864 Cánovas divenne ministro del Governo nell’esecutivo di coalizione tra moderati e unionisti presieduto da Alejandro Mon. In quei sei anni di democrazia si formò definitivamente quel politico liberal-conservatore che piú avanti avrebbe dato impulso alla Restaurazione, guidando in più occasioni il governo spagnolo, secondo i dettami politici del chiamato turnismo. Dardé riconosce a Cànovas una sostanziale onestà intellettuale, benché ammetta che in alcuni momenti il liberale si sia fatto prendere la mano dai consigli di seguaci o subordinati. Ma il Cánovas politico non poté mai nascondere il letterato che fu. Egli fu, infatti, un instancabile politico ma anche un ottimo storico, che diresse la Real Academia della Storia fino al 1897, quando un attentato anarchico gli tolse la vita. Leggendo la magnifica biografia di Dardé è possibile concludere che il contributo più importante di Antonio Cánovas del Castillo fu quello di far intendere, per dirlo con sue parole, che «la politica è un metodo di convivenza degli uomini nelle grandi società chiamate nazioni, e che affinché si possa realizzare una vita in comunità sono necessari costanti compromessi». Jordi Canal Piero Finelli, Gian Luca Fruci, Valeria Galimi (a cura di), Parole in azione. Strategie comunicative e ricezione del discorso politico in Europa fra Otto e Novecento, Milano, Mondadori-Le Monnier, 2012, pp. 194. Frutto di un seminario pisano organizzato e diretto da giovani studiose e studiosi, questo volume 82 Biblioteca cerca di colmare un vuoto della storiografia italiana – perlomeno quella contemporaneistica – nei confronti del linguaggio e delle sue implicazioni politiche. Qui non è il discorso politico tout court a essere al centro dell’attenzione, ma bensì la sua ricezione, cioè in buona sostanza gli effetti che esso produce. Che è ambito assai delicato e di non sempre facile verificabilità. Tanto che anche qui, come vedremo, non mancano i problemi. Il volume è ripartito in una serie di interventi di studiosi, in buona parte italiani, ma aperti a case studies che spaziano dalla Francia e dall’Italia (i più numerosi) alla Spagna e alla Germania, in un lasso temporale che va da dagli anni Trenta dell’Ottocento all’alba del secondo conflitto mondiale. Trattandosi di linguaggio, di discorso e di retorica, il confronto interdisciplinare con i linguisti, i filosofi e gli studiosi di letteratura sarebbe d’obbligo, anche se qui è ospitato solo un rappresentante dei letterati, con una riflessione di Federico Bertoni sulla teoria della ricezione. Segue, a completare la parte metodologica, il saggio forse più importante del volume, quello di Lucien Jaume, storico delle dottrine politiche, studioso del discorso della Rivoluzione francese e di Tocqueville. A partire da una brochure a fini elettorali di François Guizot, piuttosto tarda nella carriera del politico e storico francese, perché risalente al 1851, Jaume offre una raffinata lezione di metodo per la comprensione dei testi politici e soprattutto degli «effetti di senso», con la tesi che «l’effetto di senso non sta in ciò che il testo ‘dice’ ma in ciò che ‘esprime’ per la comunità cui si rivolge e che esso porta immaginariamente inciso su di sé» (p. 26). I saggi successivi, benché non privi di riflessioni metodologiche, sono invece prevalentemente empirici: si va dal discorso di insediamento del presidente del Consiglio Casimir Périer il 18 marzo 1931 (Alain Laquièze) al discorso di Mussolini del 20 settembre 1922 (Joel Hauterbert), dalla ricezione dell’editto di amnistia negli Stati del papa del 1846 (Ignazio Veca), agli stereotipi della retorica elettorale liberale nella Spagna di fine Ottocento (Marcella Aglietti) ala ricezione pubblica del discorso plebiscitario in Germania e in Italia negli anni Trenta (Enzo Fumiani), fino alle strategie comunicative del famoso discorso radiofonico del segretario del Pcf Maurice Thorez alla radio nel 1936 (Valeria Galimi); mentre i contributi di Re- nato Camurri e di Cathrine Brice, pur interessanti, appaiono piuttosto periferici rispetto all’intento metodologico del volume. Pur ricorrendo svariate volte il termine di «ricezione» e i suoi sinonimi, spesso a una raffinata analisi testuale non consegue un’altrettanta precisa ricognizione sugli effetti di questi discorsi. In alcuni casi, infatti, si procede per supposizioni, in altri, a partire dalla documentazione, si istituiscono dei nessi casuali tra il discorso e i suoi effetti politici non sempre convincenti. Anche perché, tranne per i periodi molto recenti, è difficile poter ricostruire nella loro completezza tutti gli elementi del discorso, che non sono solo ciò che il politico dice, ma come lo dice, dove lo dice, di fronte a chi lo dice e come l’auditorio che lo recepisce immediatamente interagisce con l’oratore. Problemi assai complessi e forse insolubili, almeno per i periodi precedenti la Seconda guerra mondiale. Ciò non toglie che il volume rechi un suo importante contributo, di cui gli studi successivi su questi argomenti dovranno forzatamente tenere conto. Marco Gervasoni Ricardo García Cárcel, La herencia del pasado. Las memorias históricas de España, Barcellona, Galaxia Gutemberg, 2011, pp. 760. Nel corso dell’ultimo decennio, la Spagna ha conosciuto una vera a propria «ossessione memoriale» e il numero delle pubblicazioni dedicate alle diverse memorie traumatiche novecentesche è andato aumentando esponenzialmente. Non di rado i «frequentatori» della storiografia iberica hanno avuto la sensazione che fossero ripetuti all’infinto i soliti cliché. Non è sicuramente il caso di questo volume. García Cárcel, ordinario di storia moderna presso l’Universidad Autónoma de Barcelona, si confronta senza timori con un tema di strettissima attualità e con il pericolo di andare a toccare molti nervi scoperti, e lo fa partendo da un personale disagio per quanto sta succedendo nel suo Paese. L’A. ci offre uno studio ambizioso e ben strutturato. Per il 83 Biblioteca numero delle fonti utilizzate, l’ampiezza dei temi trattati e il rigore scientifico, in ogni capitolo del voluminoso tomo il lettore ha la consapevolezza di trovarsi dinnanzi ad un testo solido e convincente. Merito dell’A. non è solo quello di analizzare la stretta attualità del tema memoriale in Spagna, ma di riuscire a inserirla in una riflessione sul lungo periodo, una riflessione che ancora mancava nonostante le tante pubblicazioni dedicate alla memoria apparse negli ultimi anni. Il saggio si presenta come una riflessione ampiamente documentata sui ciclici «sequestri» della storia da parte di coloro che, alternativamente, si ergono a «guardiani» delle memorie di Spagna. García Cárcel costruisce il suo discorso attorno a due pilastri. In primis una critica feroce a quello che chiama un eccessivo «presentismo» praticato da molti suoi colleghi e, in secondo luogo, la consapevolezza che la memoria è «plurale e oscillante», che è necessario parlare di memorie storiche, al plurale. Nel primo capitolo (pp. 49-111) l’A. ricostruisce i dibattiti sviluppatisi in Spagna nel corso degli ultimi anni attorno al tema della memoria storica; un’attenzione particolare è riservata allo stretto legame esistente, in qualsiasi epoca, tra memorie e generazioni. Questo primo capitolo è un’introduzione necessaria alla lettura dei seguenti. Nel secondo l’A. s’interroga sull’evoluzione dei miti fondativi della Spagna, molto interessante la breve riflessione sul destino delle memorie degli «altri» spagnoli, coloro che sono stati espulsi nel corso dei secoli dalla comunità nazionale: i mussulmani e gli ebrei (pp. 150-170). La legittimità, o meno, dei diritti storici sui quali si basa la costituzione del 1978 è affrontata nel terzo capitolo. Il nucleo centrale del libro è la parte più interessante. Nei capitoli quarto e quinto (pp. 241-356) si affrontano, infatti, alcuni grandi nodi irrisolti: i rapporti tra le memorie delle nazionalità storiche che compongono la geografia spagnola e la persistenza di conflitti dal carattere ideologico che hanno contribuito a spaccare la società spagnola. Nel sesto capitolo si elencano le diverse memorie formatesi dopo la Guerra civile del 1936-1939 e la lunga dittatura franchista. Gli ultimi due capitoli (pp. 505-641) sono dedicati ai due grandi flussi di memorie che si sono delineate dopo la transizione alla democrazia di fine anni Settanta: una memoria «soddisfatta», quella dei vincitori e dei conserva- tori, e una memoria «dolente», quella degli sconfitti del 1939 e degli esiliati. In sintesi quella di García Cárcel ci sembra una riflessione rigorosa e quanto mai necessaria, un’analisi che aiuta ad andare oltre l’idea che le vicende spagnole possano essere considerate come un’eccezionalità nel contesto europeo. Siamo davanti a un volume destinato a diventare un punto di partenza per chiunque, nei prossimi anni, si vorrà ancora occupare di memoria in Spagna e in Europa. Nel 2012 al volume è stato conferito il prestigioso Premio Nacional de Historia de España. Enrico Acciai Jordi Guixé Coromines, La república perseguida. Exilio y represión en la Francia de Franco, 19371951, València, PUV, 2012, pp. 498. Il libro in oggetto è il frutto di un lavoro pluriennale e nasce dalla rielaborazione della tesi di dottorato che l’A. ha realizzato in co-tutela tra l’Universidad de Barcelona e quella di Paris III – Sorbonne-Nouvelle. Jordi Guixé è stato, in anni recenti, il responsabile delle relazioni internazionali del Memorial Democàtic della Gerneralitat de Catalunya. La natura di uno studio nato a cavallo tra due storiografie, tra loro spesso anche distanti, si riflette positivamente sul saggio che siamo qui chiamati a recensire, dandogli un importante taglio transnazionale. Il lavoro potrebbe essere diviso in tre blocchi cronologici corrispondenti a tre differenti fasi nei rapporti tra la Spagna franchista e il suo vicino francese: la Guerra civile (1936-1939), la Seconda guerra mondiale (1939-1945) e il dopoguerra (1946-1951). Dalla lettura emerge chiaramente come, nonostante nel corso di quindici anni si siano alternati diversi interlocutori istituzionali francesi, i rapporti con il regime franchista siano sostanzialmente rimasti sempre collaborativi, in particolar modo per quanto riguarda la repressione degli esuli spagnoli. La prima parte del saggio (pp. 29-76) è dedicata alla costituzione delle agenzie d’informazione e di spionaggio franchiste in Francia a 84 Biblioteca guerra civile ancora in corso. Secondo Guixé ci furono almeno cinque importanti centri informativi attivi nel sud della Francia già dal 1937, si trattava di strutture in contatto diretto con il quartier generale di Franco. La seconda parte del libro, costituita dai capitoli II-VI (pp. 77-321), si apre con un’attenta analisi dei patti diplomatici stretti tra Spagna e Francia all’indomani della conclusione della Guerra civile che, di fatto, diedero il via alla repressione franchista in territorio francese. Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale e il crollo della Francia, la già difficile situazione degli esuli spagnoli si fece ancora più complicata. Il periodo più duro fu quello che s’inaugurò con l’instaurazione del governo di Vichy, quando la Francia cominciò a cercare scientificamente di «disfarsi di circa 100.000 spagnoli ostili al regime» (p. 278). Interessanti le puntuali ricostruzioni dei soprusi cui fu vittima Manuel Azaña, presidente della Repubblica sconfitta da Franco (pp. 243250), e della cattura del presidente catalano Lluís Companys, poi giustiziato a Barcellona nell’ottobre del 1940 (pp. 250-256). L’A. ci ricorda come per i franchisti la diplomazia fosse intesa «come un’arma per ottenere un doppio risultato: rafforzare il regime e annichilare ogni resistenza repubblicana fuori dalla Spagna» (p. 92). L’ultima parte del volume (pp. 323-473) è riservata ai convulsi anni del dopoguerra. Dopo alcuni passaggi tesi che corrisposero con i mesi immediatamente successivi alla sconfitta della Germania nazista, Franco seppe abilmente ricollocarsi nelle dinamiche della Guerra Fredda. Alle tensioni prodottesi a ridosso del 1945 fecero, infatti, seguito una normalizzazione dei rapporti diplomatici con la Francia e l’emersione di nuovi «punti di contatto» in funzione anti-comunista (pp. 379-433). Ci sembra che i meriti principali del volume siano sostanzialmente tre. Il primo è di non appiattirsi sulle vicende delle vittime, come invece spesso accade nella storiografia spagnola quando si è chiamati a confrontarsi con il trauma dell’esilio repubblicano successivo alla guerra civile. Il regime franchista, sin dai suoi primi passi, iniziò una sistematica politica repressiva verso chi aveva scelto la via dell’esilio, e l’A. segue in parallelo le vicende di vittime e carnefici in una narrazione sicuramente completa. In tal senso desta molto interesse il quarto capitolo (pp. 173-219) interamente dedicato ai profili biografici di due figure di primo piano dello spionaggio franchista in Francia: Pedro Urraca e Víctor Druillet. Il secondo merito riguarda la capacità di inserirsi pienamente nel dibattitto storiografico francese più attuale e di individuare le responsabilità delle autorità francesi ben oltre il solo governo di Vichy. Infine, Guixé, con la sua riflessione, ci ricorda come il 1945 non vada considerato come uno spartiacque della storia europea: le continuità e le persistenze furono molte e questa riflessione ce lo dimostra brillantemente. L’autore, grazie a questo saggio, si è aggiudicato la seconda edizione del premio España y sus Exilios. Enrico Acciai Thede Khal, Larisa Schippel (eds.), Kilometer Null. Politi������� sche Transformation und gesellschaftliche Entwicklungen in Rumänien seit 1989, Berlin, Frank & Timme, 2011, pp. 488. Questo volume collettaneo propone una riflessione sulle molte e diverse sfaccettature della transizione dai regimi comunisti alla democrazia in uno dei Paesi in cui questo passaggio è avvenuto nel modo più traumatico: la Romania. I contributi, scritti da studiosi romeni, austriaci e tedeschi, risultano alquanto eterogenei per le tematiche affrontate e per l’impostazione, che varia da saggi scientifici ad articoli dal taglio più politologico o giornalistico. La prospettiva adottata si concentra sia sulle trasformazioni interne che sulla proiezione dei cambiamenti in atto verso l’esterno. Sul mutamento della società romena, della sua organizzazione e della sua immagine intervengono, ad esempio, i saggi di Sergei Melcher e Ines Grigorescu dedicati alla trasformazione urbanistica di Bucarest. Considerando il cambiamento radicale dell’assetto della città voluto e almeno in parte realizzato da Ceaucescu, l’analisi di come e quanto stia cambiando la capitale appare un buono strumento per valutare la transizione. Analogamente indicativa degli effetti del passaggio alla democrazia sull’orizzonte simbolico della società romena, sostiene George 85 Biblioteca Bogdan Târa, è la trasformazione del linguaggio politico, bloccato, durante il comunismo, su una lingua di legno che attribuiva un valore semantico filocomunista a vocaboli di per sé neutri. Oltre alla maturazione di una società slegata dagli schemi imposti dal monopartitismo, fattore importantissimo risulta essere quello della capacità della classe politica di superare schemi e modelli del passato. Viene a questo scopo dedicato ampio spazio alla delicata questione della trasformazione del quadro legislativo e giudiziario (nei saggi di Trappe, Ursachi-Grosescu e Alunaru). Il superamento del passato appare non sempre facile, come dimostrano i numerosi contributi dedicati alla memoria del comunismo, che illustrano la difficoltà a relazionarsi con quel periodo. Tra essi va segnalata la storia, ricostruita da Martin Jung, del memoriale delle vittime del comunismo di Sighet, voluto dalla poetessa Ana Blandiana e da altri intellettuali, e rispetto al quale le autorità romene hanno mantenuto un atteggiamento inizialmente di disinteresse, se non di aperta ostilità, per poi passare al sostegno e al riconoscimento ufficiale solo in tempi recenti. Più facile, anche se non per questo meno condizionato dai cambiamenti politici in atto, il rapporto con un altro passato, quello ben più remoto del tempo dei Daci, già utilizzato durante il comunismo per dimostrare l’autonomia della storia romena dall’Occidente e recuperato dopo il 1989. Relativamente alla proiezione esterna del Paese, due questioni vengono soprattutto affrontate: quella dei rapporti internazionali dopo la fine del comunismo e quella dell’immagine esterna della Romania. La politica estera degli ultimi venti anni è oggetto di un’attenta ricostruzione nel saggio di Heuberger, che sottolinea la centralità dei rapporti con Unione Europea e Nato nella ridefinizione della collocazione geopolitica dello Stato. Il contributo di Avram, invece, si concentra sull’altro tema caldo del periodo post-comunista: quello delle relazioni con la Repubblica di Moldova. Per quanto riguarda l’immagine del Paese all’esterno, appare convincente l’interpretazione di Salden sulla persistenza degli stereotipi sulla Romania e sulla popolazione romena, dimostrata attraverso la lettura della stampa francese e tedesca. L’interrogativo che sottende i vari interventi, presentato nel saggio introduttivo di Vintilă Mihǎilescu, riguarda il tipo di transizione che il Pa- ese ha affrontato. Quanto il caso romeno presenta peculiarità specifiche e legate alla propria storia, precedente e contemporanea al regime comunista? Quanto, invece, va inserito nel quadro della trasformazione in corso in Europa orientale nella fase di transizione verso la liberaldemocrazia? Nel tentare di dare una risposta, l’autore riconosce che una serie di equivoci hanno reso assai complessa la maturazione di un sistema politico democratico. In primo luogo, l’incapacità di distinguere tra anticomunismo e non comunismo. La società e la politica romena hanno perseverato nel proposito di porsi come rigidamente anticomuniste, in questo modo però non riuscendo nell’operazione di superamento del comunismo stesso. Mihǎilescu imputa questa difficoltà alla presenza di un senso di colpa che il Paese non sarebbe riuscito a superare: non avendo avuto alcuna forma significativa di resistenza anticomunista ed essendo l’anticomunismo partito da un omicidio (quello di Ceausescu e della moglie), la società romena avrebbe avuto la necessità di «gridare più forte» il suo anticomunismo, allo scopo di convincersi (e di convincere gli altri) di una discontinuità che non è fino in fondo plausibile, né possibile. Gli oltre quaranta anni di comunismo, sostiene l’autore, hanno infatti profondamente inciso sulla società, tanto che l’illusione di poterli cancellare riallacciandosi al passato precomunista sarebbe di fatto impossibile, anche perché implicherebbe il riallacciarsi a una società contadina arretrata che non esiste più. Emanuela Costantini Hiroaki Kuromiya, Conscience on Trial. The Fate of Fourteen Pacifists in Stalin’s Ukraine, 19521953, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2013, pp. 212. Dopo le ricerche dedicate ai meccanismi di funzionamento del Terrore negli anni Trenta, Kuromiya (storico giapponese da più di tre decenni trapiantato negli Stati Uniti) rivolge la propria attenzione agli ultimi anni del potere di Stalin. Con il fine di indagare i pensieri della popolazione sovieti- 86 Biblioteca ca durante lo stalinismo maturo, l’A. sottopone a un’analisi quasi microstorica due faldoni contenenti le carte di un procedimento contro quattordici «avventisti riformati» (così erano chiamati in Urss gli avventisti del settimo giorno che rifiutavano gli accordi del 1924 fra la propria gerarchia religiosa e il potere bolscevico). Questi credenti, contraddistinti da un pacifismo assoluto derivante dalla fedele osservanza del sesto comandamento («Non uccidere») e dal riposo settimanale al sabato, erano considerati dissidenti perché teoricamente si rifiutavano di prestare servizio militare e di lavorare nei sei giorni decisi dal regime. I membri del gruppo, localizzato attorno alla cittadina di Bila Cerkva nella regione di Kyïv, furono arrestati nel 1952 e condannati a pene pesanti (dai 10 ai 25 anni di reclusione nel Gulag); gli appelli presentati da alcuni di loro furono respinti nel 1953 ma, dopo la morte di Stalin, il procedimento fu rivisto e quasi tutti riuscirono a tornare a casa negli anni successivi, anche se la definitiva riabilitazione venne soltanto con la glasnost’ gorbacioviana. Kuromiya spera che una lettura intensiva dei documenti individui nelle carte di questo processo delle «spie» in grado di svelare qualcosa di più sul loro universo ideale e valoriale, risolvendo un’impasse della ricerca storica sull’Unione Sovietica: persino la rivoluzione archivistica del 1991 non ha, infatti, permesso di supplire alla mancanza di fonti sul mondo interiore dell’uomo comune sovietico, che era stato abituato dagli anni di repressioni a non lasciare tracce dei propri genuini pensieri. In realtà, ciò che riesce a Kuromiya è un’eccezionale prova d’abilità nella critica (interna quanto esterna) dei documenti, che però non può che ribadire la difficoltà ad afferrare le opinioni dei cittadini sovietici: egli dimostra come i verbali di interrogatori e processo, scritti dal personale dello stesso sistema repressivo, siano dei falsi che dovevano servire al fine dei persecutori, ovvero la condanna di un’inesistente setta religiosa antisovietica. Il carattere falsificatorio delle carte viene dimostrato con un puntuale raffronto di tutte le informazioni e le contraddizioni, fornendo un magistrale esempio di critica documentaria. La coltre di falsità sarebbe rimasta impenetrabile se non fosse stato per la presenza nei faldoni degli appelli dei condannati (questi sì almeno parzialmente scritti dalle vittime con l’aiuto dell’avvocato) grazie ai quali Kuromiya intuisce come almeno uno dei condannati, Vasilij Belokon’, accusato di essere il principale ispiratore del gruppo, fosse in realtà un collaboratore dei servizi segreti. L’esame attento della sua condotta e del suo appello sembra, infatti, corroborare l’ipotesi che vedrebbe in Belokon’ un provocatore, di fatto l’unico nesso d’unione fra gli altri avventisti che altrimenti non esistevano come gruppo e avevano anzi tentato di non entrare in conflitto con il potere bolscevico, vivendo la propria religiosità come un fatto privato (alcuni avevano addirittura prestato il servizio militare). L’impianto accusatorio si basava sul fatto che non venisse rivelato il ruolo di Belokon’, che nell’appello cercò di far comprendere la propria posizione per salvarsi dalla condanna, pur senza poter rivelare la propria identità. Se la ricerca di Kuromiya sull’universo ideale���������������������������������������������� della popolazione sovietica risulta meno proficua di quanto il lettore meno avveduto si sarebbe potuto aspettare, il libro costituisce un mirabile esempio di critica e analisi dei documenti sovietici. Simone Bellezza Lorenzo Mechi, L’Organizzazione Internazionale del Lavoro e la ricostruzione europea. Le basi sociali dell’integrazione economica (1931-1957), Roma, Ediesse, 2012, pp. 212. È ormai un dato acquisito che l’integrazione europea abbia rappresentato un fattore di stabilizzazione economica e sociale dell’Europa occidentale post bellica. Tuttavia, fatta eccezione per alcuni studi sul Piano Marshall, non esistono ricerche che abbiano collocato il processo di unificazione nel quadro dei tentativi di regolazione pacifica del conflitto tra capitale e lavoro. È da questa constatazione che parte l’attenta analisi che Mechi dedica all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), creata alla Conferenza di Parigi nel 1919, e inserita nella Società delle Nazioni (SdN), con la duplice finalità di assicurare il superamento delle tensioni sociali e sostenere l’interdipendenza economica e quindi l’apertura dei mercati. 87 Biblioteca A dispetto della sua dichiarata vocazione «mondiale», almeno fino alla metà degli anni Trenta l’OIL fu controllata dagli Stati europei, cosicché l’attività dell’organizzazione venne indirizzata in prevalenza verso l’individuazione di forme di unificazione economica del vecchio continente. Durante la Seconda guerra mondiale, l’OIL si schierò a fianco delle democrazie e il successivo scoppio della Guerra fredda collocò naturaliter l’OIL (che nel frattempo era divenuta un’agenzia dell’ONU) sul versante occidentale, come dimostra il suo pieno coinvolgimento nello European Recovery Program. Tra i principi sottesi al Piano Marshall vi era la politics of productivity, che aveva favorito il boom economico americano durante la guerra e che era del tutto coerente con l’obiettivo perseguito dall’OIL di sostenere la crescita economica attraverso la collaborazione di classe, così da garantire l’armonia sociale. Nel quadro del Piano Marshall l’Organizzazione cooperò alla gestione dei flussi migratori intra-europei, volti a riequilibrare i mercati del lavoro nazionali; varò il manpower programme, un ambizioso piano teso ad aiutare i sedici paesi dell’ERP a riorganizzare i servizi di collocamento e le strutture di formazione, selezione e istruzione dei lavoratori migranti; infine, e fu questo l’ambito a cui si destinarono le maggiori risorse, l’OIL si impegnò nella formazione professionale, attraverso numerose e variegate iniziative. Finalità dell’organizzazione e centralità (non esclusività, beninteso) delle problematiche europee giustificano il problema storico affrontato dall’A. – il contributo di «lungo periodo» fornito dall’OIL alla costruzione delle basi sociali dell’integrazione europea – e la relativa periodizzazione, che va dagli anni in cui inizia il collasso dell’assetto internazionale creato a Versailles fino alla nascita della Comunità economica europea e di Euratom (1957). Tra i risultati principali a cui approda la ricerca vi è l’accertamento della continuità nella valutazione formulata dall’OIL sulle conseguenze sociali causate dall’unificazione delle economie europee. Una continuità che è chiaramente visibile dal confronto tra il memorandum del gennaio del 1931 che l’OIL dedicò alle implicazioni sociali dell’unione doganale prevista dal piano di Unione federale presentato nel 1929 da Aristide Briand alla SdN e il rapporto (che ebbe una certa influenza) che l’organizzazione presentò nel 1956 durante i negoziati per il trattato di Roma. Alla base di entrambi i documenti vi era la fiducia nell’approccio liberista e la convinzione che lo sviluppo prodotto dall’apertura dei mercati avrebbe di per sé provocato un miglioramento degli standard di protezione sociale all’interno degli Stati coinvolti nel processo di unificazione. Non era perciò necessario provvedere a una armonizzazione sovraordinata, sul piano europeo, delle legislazioni sociali nazionali. Peraltro, a questa impostazione non si è caparbiamente mai rinunciato, neppure nei momenti in cui la crescita economica è risultata fiacca o del tutto assente. Emergono così le radici di lungo periodo di schemi liberisti che oggi mostrano la corda, e il cui superamento – come sostiene Mechi nelle conclusioni al volume – può effettuarsi attraverso l’elaborazione di politiche sociali europee realmente incisive, accompagnate da misure a sostegno della crescita e dell’occupazione. Daniele Pasquinucci Catriona Pennell, A Kingdom United. Popular Responses to the Outbreak of the First World War in Britain and Ireland, Oxford-New York, Oxford University Press, 2012, pp. 308. È attraverso una grande quantità di materiale documentario – lettere, diari, memorie, quotidiani, periodici – che Catriona Pennell, docente all’Università di Exeter, fa emergere la complessità e varietà di reazioni del popolo inglese e irlandese allo scoppio della Prima guerra mondiale. L’intento del libro è proprio quello di rivedere le semplificazioni che a lungo hanno accompagnato la ricostruzione di quegli eventi: innanzitutto il cosiddetto «war enthusiasm» che, nutrendosi di un fervido e dilagante jingoismo, avrebbe unito e compattato tutti gli inglesi a favore dell’intervento e, all’opposto, il pacifismo e la volontà di «disimpegno» dei nazionalisti irlandesi. Ma le cose furono più complesse e sfaccettate di così e le reazioni emotive di oltre 40 milioni di inglesi e irlandesi alla dichiarazione di guerra difficilmente si possono racchiudere entro «the myth of war enthusiasm» (p. 4). 88 Biblioteca Certo, una vasta mobilitazione e un forte sostegno popolare alla decisione del governo di dichiarare guerra alla Germania ci furono e le folle esultanti per le strade di Londra e davanti a Buckingham Palace la sera del 4 agosto 1914 ne erano una prova evidente; ma ad animarle non era il fervore nazionalistico o l’eccitazione bellicista, bensì la consapevolezza della grave violazione commessa dai tedeschi invadendo il Belgio neutrale. La guerra, complice anche la campagna propagandistica messa in atto dal governo, apparve subito alla maggior parte dei britannici come «a war for the defence of civilization against German ‘barbarianism’» (p. 35). E tre, secondo l’A., furono le motivazioni con cui inglesi e irlandesi accettarono e giustificarono l’intervento militare del loro paese: la Germania, che con la sua politica aggressiva già da tempo minacciava la pace in Europa, era la sola responsabile dello scoppio delle ostilità; la Gran Bretagna, dal canto suo, doveva preservare il suo «onore nazionale» e non permettere ai tedeschi di decidere gli equilibri europei e mondiali; inoltre era suo compito appoggiare belgi e francesi, la cui sconfitta sarebbe stata «a disaster for British interests as well as honour» (p. 58). Ma vi erano, seppur largamente minoritari, anche i pacifisti, sia fra gli inglesi – quanti ritenevano la guerra irrazionale e moralmente ingiusta – sia soprattutto fra i nazionalisti irlandesi più radicali, per i quali il «vero nemico» restava la Gran Bretagna e, convinti che «Ireland needed its men to protect Irish shores from the British imperialist threat» (p. 184), attivarono un’intensa campagna anti-coscrizione. Il volume, diviso in capitoli tematici che analizzano sostanzialmente il primo anno e mezzo di guerra, offre un interessante spaccato del vissuto del popolo britannico, intrecciando le vicende politiche con la vita quotidiana della gente comune, il dibattito intellettuale coi tormenti personali e familiari dei tanti – uomini, donne, bambini – che videro la loro esistenza sconvolta dalla guerra. Una storia «dall’alto» e «dal basso», insomma, nella quale si fondono le voci dei protagonisti, celebri e sconosciuti, le analisi e le interpretazioni dell’A. e una grande quantità di dati e statistiche (per esempio sul reclutamento o sulla disoccupazione). Dopo un primo capitolo sul luglio 1914, dominato dall’ansia per il precipitare della situazione europea ma ancora fortemente condizionato dai problemi di politica interna (le rivendicazioni delle suffragette, il movimento operaio, le tensioni fra unionisti e nazionalisti in Irlanda), la Pennell si sofferma nei due capitoli successivi – «The National Cause» e «The Enemy» – sull’immaginario collettivo che fece da sfondo all’intervento militare britannico: nel quale, più ancora dell’orgoglio patriottico, ad emergere era l’ideale di un paese che da sempre si poneva a difesa delle libertà e dei diritti. L’identità nazionale britannica ne uscì dunque rafforzata; rafforzata soprattutto in merito a quei valori di inclusione, libertà, tolleranza, rispetto delle leggi che il militarismo tedesco – il «nemico» – aveva inderogabilmente calpestato. Il racconto delle atrocità commesse dall’esercito tedesco in Belgio, oltre ad alimentare una vera e propria «spy-mania» e «spy-obsession» (p. 102), fu all’origine dell’autorappresentazione che gli inglesi diedero della guerra e di se stessi: una guerra giusta contro «a barbaric, ruthless, and dispotic adversary» (p. 230) combattuta in nome di quegli ideali che costituivano l’essenza dell’identità nazionale britannica. I due capitoli successivi affrontano invece il tema della guerra vera e propria: la violenza con cui anche i civili si dovettero confrontare, per i bombardamenti sulla costa nordorientale, l’arrivo dei rifugiati belgi e dei soldati feriti, e le complesse operazioni di reclutamento dei volontari; straordinaria, specie nei primi due anni di guerra, fu la risposta degli inglesi alla leva benché, di nuovo, non la si possa genericamente ascrivere all’«entusiasmo». Il sesto capitolo – «John Bull’s Other Island» – dedicato all’Irlanda mostra come, a parte alcune frange estremiste, i nazionalisti sostennero la causa della guerra, sia in nome degli stessi valori che animavano gli inglesi, sia nella speranza che la vittoria sulla Germania potesse rafforzare la causa irlandese e garantire all’Irlanda un’autonomia analoga a quella dei Dominions. Il settimo e ultimo capitolo – «Settling into War» – analizza come, a dispetto della parola d’ordine lanciata dal governo «business as usual», la guerra sconvolse fin da subito l’economia, i rapporti sociali e familiari, la vita e le abitudini degli individui: degli uomini partiti per il fronte, ma anche delle donne, ampiamente reclutate nelle industrie e nei servizi rimasti privi di manodopera maschile, e dei bambini anch’essi toccati, in modo diretto o indiretto, dalla mobilitazione collettiva. Ma dopo il disorientamento 89 Biblioteca iniziale subentrarono l’accettazione, la ricerca di una nuova normalità «inside the war» (p. 215) e con esse, a poco a poco, anche la consapevolezza che non sarebbe stata una guerra breve, «over by Christmas» (p. 225). Giulia Guazzaloca Paul Preston, El Zorro rojo. La vida de Santiago Carrillo, Barcellona, Debate, 2013, pp. 398. Paul Preston, autore di testi come El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después o Francisco Franco. La lunga vita del caudillo, ha di recente proposto uno studio biografico dedicato alla figura di Santiago Carrillo, esponente di primo piano del Partito comunista spagnolo, scomparso nel settembre del 2012 all’età di 97 anni. Santiago Carrillo fu segretario del Pce dal 1960 al 1982 ed è considerato uno dei protagonisti della storia spagnola del Novecento. La sua figura, ancora oggi controversa, si presta ad un dibattito storiografico formato da critici ed apologeti, al quale Preston sembra desideroso di voler partecipare. Figlio di un dirigente asturiano del Partito socialista, il giovane Carrillo si affiliò al Psoe di Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. Già in giovane età iniziò a guardare con interesse il Pce, di cui apprezzava la tenacia rivoluzionaria e la fermezza del sentimento antifascista. Dopo il levantamiento di Franco del 1936, Carrillo divenne responsabile della resistenza di Madrid. Durante i lunghi mesi di assedio della capitale, le autorità repubblicane permisero le esecuzioni a morte di molti fascisti e filomonarchici, considerati pericolosi per il prosieguo della guerra. Si trattò di una vicenda controversa che avrebbe screditato l’immagine pubblica di Carrillo sino ai giorni nostri. Al termine del conflitto Carrillo decise di passare definitivamente al fronte comunista. Nel Pce realizzò una rapida carriera politica, che lo portò nel 1960 alla segreteria del partito. Negli anni di esilio organizzò la lotta clandestina contro Franco, fomentando l’infiltrazione di militanti comunisti nell’organizzazione sindacale del regime. Negli anni Settanta, poi, mosse il partito verso l’euroco- munismo e si adoperò, dopo la morte del dittatore, per la pacificazione nazionale e la conclusione del processo costituente e democratico del 1978. Su Santiago Carrillo sono state scritte numerose biografie, molte delle quali inclini ad elogiarne la storia personale. Il volume di Preston non può di certo essere considerato una di queste. Lo storico britannico offre in El Zorro rojo un’immagine decisamente critica del leader comunista, presentato come un opportunista e un arrivista interessato a raggiungere i vertici del partito ad ogni costo. Il tradimento al padre Wenceslao negli anni Cinquanta e la conduzione stalinista del Pce negli anni Sessanta sono elementi che Preston giudica emblematici del carattere antidemocratico del leader comunista. Per questa ragione l’autore dà ampio spazio a documenti e testimonianze di ex dirigenti del Pce, come Cluadín, Semprún, Pradera o Lister, che ebbero con Carrillo una relazione conflittuale. Poco spazio è invece dedicato al pensiero politico del leader comunista e alle sue riflessioni strategiche, giudicate tutto sommato secondarie nella narrazione biografica. Nel computo generale dell’opera il libro di Preston è valutabile positivamente circa il suo tentativo di guardare con occhio critico e non celebrativo la figura di Carrillo. D’altro canto va riconosciuto che l’autore affronti l’argomento in modo a tratti fazioso: ogni scelta di Carrillo viene ricondotta a presunti calcoli di potere e doppiogiochismi, che finiscono per ridurre il racconto ad una cronaca di lotte interne al partito. In realtà Carrillo ebbe un pensiero politico ed agì seguendo una visione del mondo. L’impronta stalinista degli anni Cinquanta va ricondotta al clima di Guerra fredda, mentre quando negli anni Settanta si spinse per una revisione ideologica del suo partito, da molti settori del Pce si levarono grida al tradimento. Si trattò di una lettura semplificata e a tratti banale che, in certo modo, Preston riprende quando sostiene che il fallimento del progetto politico del Pce debba essere ricondotto al solo opportunismo del segretario, stridente con l’onestà e l’eroismo dei militanti. Un giudizio forse affrettato su chi, per logica utilitaristica o meno, contribuì in maniera imprescindibile alla costruzione di un sistema democratico ancora vigente nella Spagna di oggi. Luca Costantini 90 Biblioteca Robert Saunders, Democracy and the Vote in British Politics, 18481867. The Making of the Second Reform Act, Farnham-Surrey-Burlington, Ashgate, 2011, pp. 302. Robert J. Blyth, Andrew Lambert, Jan Rüger (eds.), The Dreadnought and the Edwardian Age, Farnham-Surrey-Burlington, Ashgate, 2011, pp. 244. Il fatto che il più grande ampliamento dell’elettorato nella politica britannica, il Reform Act del 1867, fu approvato da un governo Tory, ha impegnato gli storici per un lungo periodo e ha fatto emergere una pletora d’interpretazioni. A tal proposito, la principale distinzione interpretativa è tra coloro che attribuiscono un ruolo rilevante alla pressione esterna, ossia al considerevole malcontento che produsse la sensazione che una rivoluzione potesse essere imminente a meno di non soddisfare le richieste popolari. Contro questa interpretazione, altri, e specialmente Maurice Cowling, sostengono che il corso degli eventi fu quasi interamente dettato dalle tattiche che la situazione parlamentare imponeva sui principali protagonisti, in modo evidente Gladstone e Disraeli. Questo lavoro adotta una prospettiva più ampia analizzando come la questione della riforma della rappresentanza si sia evoluta nel ventennio precedente, come abbia interagito con le altre questioni rilevanti del periodo, in particolare con il dibattito libero commercio versus protezionismo, e come essa sia stata gestita da Lord John Russell o Palmerston per proteggere e avanzare la loro posizione personale. Nella sua analisi l’autore offre pertanto un esteso esame del corso e della natura della politica britannica nel periodo compreso tra il declino del cartismo e l’inizio della democrazia politica. Vi fu sempre un numero quasi illimitato di visioni di come la concessione del voto, la distribuzione dei seggi e la complessità della registrazione poteva essere gestita. In maniera non sorprendente, infatti, molti esponenti del Parlamento erano essi stessi confusi su ciò che poteva essere nell’interesse loro e del partito. Questo fattore permise ai leader dei partiti di avere un più ampio margine di manovra e in questo caso Disraeli si dimostrò il più abile nello sfruttarlo. Solo a fatto compiuto egli attribuì a queste tattiche, spesso adottate a causa di una pressione diretta, l’apparenza di qualche forma di coerenza ideologica. Non molto di quello che questo studio offre risulterà nuovo per coloro che hanno familiarità con il periodo, ma si tratta di un resoconto attentamente sfumato. Nel febbraio 2006 il National Maritime Museum ha ospitato una conferenza per celebrare il centenario del varo della Dreadnought, la nave da guerra celebrata all’epoca come l’arma finale, in maniera analoga alla bomba atomica quarant’anni dopo. Gli atti della conferenza qui pubblicati spaziano largamente dalla tecnologia navale all’impatto del varo della Dreadnought sul movimento delle suffragette. Questa ripercussione improbabile è richiamata nel paper di Lucy Delap. Nel febbraio 1910 nello «scherzo di Dreadnought» un gruppo di persone, che includeva una donna, ossia Virginia Woolf, visitò la nave presentandosi come la famiglia reale dell’Abissinia. Mascherati con facce nere e barbe false, essi furono ricevuti sulla nave agghindata a colori. L’evento è ricordato nel racconto breve di Virginia Woolf A Society. Tale episodio le permise di acquisire «un nuovo senso della brutalità e della stupidità degli uomini» e di divenire subito dopo una volontaria per il suffragio delle donne. Altri interventi, ad esempio quello di Martin Daunton sul finanziamento dell’espansione navale, sottolineano il pesante sforzo che le spese navali imposero sul budget nazionale, già provato al limite dalle necessità di un giovane Stato sociale. Ma i sostenitori dell’espansione navale tedesca, il Kaiser e Tirpitz, si trovarono in una posizione ancora più difficile rispetto ai britannici. I poteri finanziari del governo del Reich erano notoriamente carenti e man mano che la guerra dei due fronti divenne una questione centrale per la Germania negli anni dopo il 1910, Tirpitz non poté fare più affidamento sulle risorse necessarie per tenersi al passo con i britannici. Il programma di costruzione navale tedesco, per un lungo periodo con un ampio grado di sostegno popolare, ha pertanto ampiamente contribuito a ciò che i tedeschi percepirono come l’«accerchiamento», senza attribuire peraltro alla Germania un vantaggio decisivo. Altri interventi affrontano il 91 Biblioteca contesto tecnico e operativo della Dreadnought, mentre nel paper finale Paul Kennedy riflette sulla Dreadnought e sulle Maree della Storia. Egli cita l’acuta contemporanea osservazione che a Jutland il detenuto tedesco ha assaltato il secondino del suo carcere, ma ha fallito nell’evasione. I britannici non realizzarono un’altra Trafalgar, ma nel 1918 la High Seas Fleet tedesca si arrese. Edgar Feuchtwanger Jerrold Seigel, Modernity and Bourgeois Life. Society, Politics and Culture in England, France and Germany since 1750, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 626. Più dei due termini che ritroviamo nel titolo, modernità e vita borghese, al centro del volume sta la congiunzione che nelle narrazioni storiche dell’età contemporanea tradizionalmente li unisce. Posto cioè che si tratta di due realtà di difficile e incerta definizione, su cui pesa l’eredità della lettura marxiana da un lato e delle teorie della modernizzazione dall’altro, l’autore si chiede se effettivamente qualcosa colleghi modernità e borghesia, nella loro parallela e lunga genesi tra la metà del Settecento e la Grande guerra, e di cosa in effetti si tratti. Una domanda così impegnativa merita un’articolata introduzione che cerca di sgomberare il campo da possibili fraintendimenti: innanzitutto non si intende parlare di borghesia in termini di classe, come a lungo si è fatto. L’autore dubita anzi si possano individuare evidenze di un soggetto unico «borghesia» che agisca nei vari paesi in modo autonomo a livello non locale. Al pari della nazione, la borghesia è piuttosto una comunità immaginata e come tale, sostiene, andrebbe trattata. Ciò di cui vuole parlare sono allora «forme e stili di vita» borghesi, nell’accezione proposta da Georg Simmel, un complesso di pratiche sociali e culturali che si sviluppano nei paesi europei nel corso dell’Ottocento distinguendosi nettamente da stili, codici, dispositivi espressivi aristocratici. Non meno semplice peraltro è definire il termine modernità, che qui indica un set di elementi diversi, e diversamente combinati tra loro, che riguardano ambiti come la misurazione del tempo, la produzione di moneta, i rapporti tra i sessi, i codici morali. Quanto dunque è borghese la modernità e viceversa? Più che fornire una vera e propria risposta a questo interrogativo abbastanza scivoloso l’autore cerca di leggere in questa prospettiva le traiettorie storiche di tre grandi paesi europei – Gran Bretagna, Francia e Germania – attribuendo una marcata centralità alla dimensione della comunicazione, allo sviluppo e al crescente addensamento nell’Ottocento di reti di connessione a distanza che trasformano sia la società, che la politica e la cultura. Se i veicoli principali di tali reti connettive sono le ferrovie, le strade, i sistemi postali, i circuiti culturali sempre più articolati della repubblica delle lettere e dello spettacolo, le trasformazioni di cui si parla riguardano alcune grandi «reti di significato» (networks of meanings) che estendono e amplificano variamente l’attività umana nella modernità borghese e che l’autore identifica negli elementi seguenti: i mercati, gli Stati, la sfera dell’informazione/comunicazione. Sono reti già esistenti in Antico regime ma che nel corso dell’Ottocento divengono sempre più autonome, sviluppano proprie regole di funzionamento, forniscono nuovi collegamenti tra centri e località e crescenti opportunità a chi può accedervi. Gli sviluppi di tali networks si combinano però diversamente nei tre casi nazionali e ciò crea traiettorie complessive molto diverse. In Gran Bretagna l’integrazione politica, sociale e culturale è più precoce e soprattutto agisce in mutua sinergia; in Francia l’integrazione politica basata sul ruolo dello stato e sulla presenza del grande centro parigino sconta invece un’integrazione più lenta, incompleta e negoziata del mercato nazionale. Infine in Germania è piuttosto la rete culturale ad attivarsi prima e più compiutamente, a fronte di trasformazioni tardive e incomplete sul piano politico e sociale. L’apparente linearità del modello è attraversata poi da interessanti paradossi su cui Seigel tende a indugiare: la Gran Bretagna come il paese più precocemente borghese ma anche quello in cui più persistenti sono i residui di una società aristocratica; la Germania, cioè il meno borghese tra i paesi considerati, come il luogo dove si sviluppa la riflessione più sistematica e interessante su rivoluzione borghese e modernità. Una parte 92 Biblioteca consistente del volume, la terza, è infine dedicata all’ampliamento ottocentesco della sfera culturale, al suo farsi sempre più palpabile, concreta e diffusa, in una dimensione estetica (secondo la definizione di Weber) che quanto più soggiace alle leggi del mercato tanto più sviluppa reazioni di rifiuto e di autocritica della modernità (così è ad esempio per la bohème artistica di fine secolo, anticipazione delle avanguardie successive). Quella di Seigel è in sostanza una grande sintesi ambiziosa e affascinante, utile tra l’altro nel fare il punto sullo stato degli studi sui tre paesi. E tuttavia, chiuso il denso volume, continua a rimanere qualche dubbio sulla possibilità di un uso al singolare di entrambi i termini in oggetto. L’autore stesso mostra in effetti alcune perplessità in proposito e nelle conclusioni ritorna ad una suggestione già presente in Marx e cantata magistralmente da Baudelaire: è in fin dei conti una radicale fluidità, una propensione strutturale al cambiamento, il segno distintivo della modernità borghese ottocentesca? Carlotta Sorba Edith Sheffer, Burned Bridge. How East and West Germans made the Iron Curtain, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 358. C’è molto da imparare dal lavoro di Edith Sheffer sulla storia del confine tra le due Germanie. Nel libro, frutto di una tesi dottorale, si affronta con gli strumenti della microstoria la separazione tra le due Germanie e si descrive con sensibilità e con stile letterario come la divisione delle zone di occupazione si sia trasformata in una separazione culturale e politica. Allontanando lo sguardo dal Muro di Berlino, su cui si sono concentrati molti studi sulla Guerra fredda, attraverso lo scavo approfondito degli archivi comunali, governativi, militari e di partito, inclusi quelli della Sed, si guarda alla costruzione del confine tra aree rurali e urbane, al rapporto tra campagna e industria, ai rituali civili e alla costruzione della lealtà politica soprattutto, ma non esclusivamente, nella Germania orientale. Burned Bridge, ovvero Gebrannte Bruecke è il nome della antica strada che collega i due paesi di Neustadt (Baviera) e Sonneberg (Turingia), presso Coburg, dove dal 1945 una barriera avrebbe marcato la divisione della zona di occupazione sovietica da quella statunitense. L’A. inquadra nel primo capitolo la dinamica di lungo periodo del confine tra le due cittadine, già nell’Ottocento partecipi di un distretto conosciuto per la produzione di giocattoli, con la specificità di Neustadt, dominata dall’artigianato, e di Sonnenberg presto segnata da un impianto industriale. Tale differenza incide sul loro rapporto con Weimar e col nazionalsocialismo, a cui la comunità bavarese aderisce prima e più ampiamente, ma con consensi elettorali oltre il 50% nel 1933 in entrambe le cittadine. La lotta alla disoccupazione e la guerra porteranno a una integrazione con l’ampliamento della base industriale e la presenza di lavoro forzato collegato ai campi di concentramento. Saranno non a caso i neonazisti bavaresi e i nostalgici all’Est tra i più radicali contestatori del confine dopo il 1945. L’ottica di lungo periodo consente di apprezzare meglio l’esito di maggior fascino della ricerca, che riguarda il periodo 1945-1961, in cui si produce il distanziamento tra abitanti improvvisamente proiettati in un conflitto tra le grandi potenze. L’occupazione accomuna e separa, produce violenze sui civili e sulle donne in entrambi i luoghi ma anche differenze nel trattamento e nelle condizioni materiali. Nella prima parte del libro, che va dal 1945 al 1951, Sheffer ricostruisce la permeabilità dei confini tra la zona di occupazione sovietica e quella americana, il mercato nero, il tentativo di conservare gli scambi economici precedenti nonostante i divieti, le deroghe per consentire sia gli scambi economici di derrate sia il pendolarismo dei lavoratori, la richiesta di protezione dalle truppe dell’altra zona. L’introduzione del marco nel 1948 separa le due economie e produce un primo importante distanziamento, crea le prime tensioni a Ovest contro le incursioni dei soldati sovietici e stimola l’esodo dei civili dall’Est. Le conseguenze si materializzano progressivamente con l’emigrazione e la fuga dei lavoratori specializzati fino a che nel giugno 1952 la zona di occupazione orientale mostra le sue difficoltà nel controllo del confine e lancia l’Operation Ungeziefer (operazione parassiti) per la pulizia dei confini dalle persone ritenu- 93 Biblioteca te non affidabili, perché sospette di prossimità al capitalismo. L’assonanza col linguaggio del Terzo Reich non basta a spiegare l’effettivo carattere dell’operazione di controllo sui confini, in quanto, con uno sforzo prezioso, l’A. mostra che circa due terzi dei deportati non soddisfacevano i requisiti formali previsti per l’allontamento o per l’espulsione: nella selezione delle vittime prevale invece la discrezionalità burocratica, la denuncia (o la protezione) dei vicini o meglio la debolezza del governo della Germania orientale, incapace di distinguere la popolazione in base alla fedeltà al socialismo. Il confine si materializza davvero solo allora, perché l’operazione di denuncia del «collaborazionismo» con l’Occidente comporta oltre 8.000 deportati in tutta la zona orientale e circa un migliaio nella sola Sonnenberg. Si spacca la cittadinanza di Sonneberg, tra chi sente il dovere morale di aiutare i perseguitati e chi si allinea con le truppe e con il regime socialista. E anche a Ovest si mostrano le crepe, l’assenza di solidarietà, la cooperazione a volte esplicita alla divisione, il dubbio se accogliere sempre i dissidenti e i perseguitati, al governo. La ricerca di Sheffer consente di individuare nomi e cognomi delle famiglie, il ruolo delle autorità, il rapporto tra politica e cultura. Si tratta di un passaggio importante che completa le ricerche di Naimark e mostra il funzionamento quotidiano del regime di occupazione in entrambe le regioni. La periodizzazione proposta dall’A., dopo la originale sottolineatura della cesura del 1952, considera una fase di stabilizzazione fino alla costruzione del Muro di Berlino del 1961. Nella seconda parte del volume la rivolta del 1953 in Germania Est viene così chiarita perché collegata alla solidificazione del confine, alle restrizioni crescenti, all’aumento delle quote imposte ai lavoratori. Nel tempo si crea una fascia territoriale allargata a protezione dei confini. L’attività agricola in quelle aree viene penalizzata, il territorio si modifica anche paesaggisticamente, gli edifici ai confini vengono abbandonati. Dopo la nascita ufficiale della Repubblica democratica nel 1955, il Muro del 1961 materializza un confine ormai già stabilito nelle coscienze e gestito ormai con pugno di ferro da uno stato di polizia. La terza parte copre la fase 1961-1989, quando il confine è ormai introiettato nelle coscienze e sostiene un sentimento di appartenenze separate. Gli accordi dell’Ostpolitik consentono il ritorno dei transfrontalieri. Quando la divisione è accolta si pongono le basi per il suo crollo, e Gebrannte Bruecke recupera una funzione simbolica quando l’1 luglio 1990 viene scelta per la firma dell’accordo per l’abolizione dei controlli alla frontiera tra le due Germanie. A un lavoro così innovativo non si possono muovere rimproveri ma qualche osservazione. Il prezzo della microstoria è la separazione tra la vicenda macro e quella micro, tra le grandi potenze e il consenso. Eccessiva è l’enfasi sulla creazione della cortina di ferro «dal basso», mentre avrebbe giovato un maggior riconoscimento dell’adattamento progressivo della popolazione a decisioni dall’alto, uno scavo della politica del «magnete» di Adenauer e la percezione in Baviera delle generose provvidenze per i profughi tedeschi di oltre cortina. E tuttavia si impara molto sulla stabilizzazione politica, sui margini di movimento delle autorità nell’esercizio del potere in periferia e soprattutto sul ruolo dei cittadini e dell’informazione dell’Ovest nel consenso alla costruzione del Muro. Sheffer non contesta le narrative dominanti delle responsabilità sovietiche e del regime socialista della DDR, al limite le rafforza, ma ha aperto una pista di ricerca che supera i vecchi canoni dicotomici della Guerra fredda e non si potrà trascurare in futuro. Carlo Spagnolo Georgina Sinclair (ed.), Globalising British Policing, Farnham, Ashgate, 2012, pp. 446. Nonostante la lunga tradizione imperiale, gli studi riservati alle attività inglesi di polizia coloniale hanno goduto nel tempo di una relativa attenzione da parte della stessa storiografia locale. Il testo a cura di Sinclair cerca di offrire un compendio degli studi più significativi sull’argomento, ristampando articoli (in totale, 18) apparsi su diverse riviste britanniche a partire dagli anni Venti e Trenta del secolo scorso fino ai giorni nostri. Grazie a ciò è possibile notare come i primi articoli prodotti tra le due guerre possano oggi offrire soprattutto un interessante profilo dell’immagine che i funzionari e 94 Biblioteca gli investigatori diedero di se stessi e del loro operato ai propri concittadini. Spesso basati su fatti vissuti direttamente, però, questi lavori appaiono oggi dei resoconti che trascuravano le attività coercitive attuate sul campo e non ponevano adeguata attenzione alle reazioni delle popolazioni locali che subivano tale controllo. Sono stati gli studi apparsi dopo la Seconda guerra mondiale, scientificamente più approfonditi e pertinenti, che sono stati in grado di meglio delineare le attività di policing delle forze di sicurezza britanniche nel vasto impero. Non è possibile qui riportare i molteplici spunti che affiorano dalla lettura del testo. Si desidera ricordare quello che ci pare più significativo, riguardante il ruolo centrale assunto dall’esperienza del controllo del territorio irlandese nella creazione sia della New Policy britannica (con il Metropolitan Police Service Act del 1829) sia delle polizie coloniali. In passato, tale ruolo era stato sottovalutato, tanto che molti studiosi nella prima parte del secolo (come Jeffries, The Colonial Police, 1952) sostennero l’esistenza di una netta separazione tra le pratiche della polizia metropolitana e quelle delle polizie coloniali. Più recenti studi (raccolti nel testo), invece, hanno rivalutato tale giudizio, notando quanto l’esperienza in Irlanda (fino all’inizio degli anni Venti parte del Regno Unito) ebbe effetti significativi sulla formazione delle forze di polizia metropolitana, indotte a svolgere anche sul suolo britannico sia il compito di controllo territoriale, sia attività di repressione della istanze politiche della classe lavoratrice. È più noto quanto l’esperienza irlandese fece sentire i suoi effetti nelle colonie. Il testo ricorda come, per esempio, la Mounted Police canadese fu formata a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento con una robusta aliquota di personale irlandese, seguendo un preciso disegno delle autorità britanniche secondo cui le capacità mostrate dagli agenti che avevano operato in Irlanda avrebbe dato effetti positivi anche nel controllo del territorio canadese. Circa un secolo dopo, sciolta la Royal Irish Constabulary (a seguito dell’indipendenza della Repubblica d’Irlanda), una parte dei suoi vecchi agenti fu inviata in Palestina, nel tentativo di disporre di personale abile nell’attività di repressione delle attività ribellistiche delle popolazioni locali. Più in generale, sia gli articoli più vecchi (in virtù dei ricordi personali che contengono) sia quelli più recenti (maggiormente efficaci dal punto scientifico) contenuti in Globalising British Policing indicano le difficoltà delle varie polizie locali nel trasformarsi da forze di controllo militare di un territorio in vere e proprie forze di sicurezza civile. Ciò dipese dal fatto che il Colonial Office mantenne primaria voce in capitolo nella definizione delle priorità di sicurezza nell’Impero. Le tre fasi di policing identificate dagli esperti per la nascita di forze di polizia nei territori controllati da Londra avrebbero dovuto prevedere prima la creazione di una polizia militare, atta ad assicurare il controllo del territorio (che sarebbe in parte coincisa con le forze armate), poi la nascita di una polizia semi-militare sul modello irlandese (utile anche in caso di un conflitto con le popolazioni locali o con soggetti esterni) e, infine, la formazione di una vera e propria polizia civile, modellata sul sistema britannico. Dall’incrocio dei dati forniti dagli articoli contenuti nel testo, si nota come di rado le forze dell’ordine nelle colonie riuscirono a superare il secondo livello, fallendo nel tentativo di divenire vere e proprie polizie civili. La combinazione di ufficiali giunti dalla madrepatria, di personale tratto dalle comunità di settlers e di indigeni non riuscì a divenire qualche cosa di più di una polizia semi-militare, più attenta a reprimere moti indipendentisti che non ad assicurare una equilibrata attività investigativa super-partes. Anche l’attività di policing in India seguì questa evoluzione, per quanto il subcontinente fosse sotto il controllo di un apposito ministero, che favorì l’istituzione di un sistema duale, basato su un insieme di leggi locali e di legislazione britannica, con gravi ricadute nella gestione della decolonizzazione dopo il 1945. L’incapacità di superare tali limiti, d’altro canto, causò effetti deleteri anche nello stesso territorio britannico. In particolare, in Irlanda del Nord, dove la convivenza tra le comunità protestante e cattolica è sempre stata un punto dolente, le attività di policing videro per lungo tempo le forze locali del Royal Ulster Constabulary agire più secondo criteri mutuati dall’ambito militare (pattugliamenti da parte di gruppi di uomini in armi) che non secondo i normali criteri britannici di sorveglianza del territorio, che vedono le forze di polizia svolgere le loro attività disarmate e con discrezione. Al di là della ben nota peculiarità della regione, i lavori riportati nell’utile testo cu- 95 Biblioteca rato da Sinclair aiutano a capire quanto non solo la tradizione settaria, ma anche quella che vedeva le forze di polizia agire nell’isola come forze necessarie al mantenimento di un ordine imposto abbiano contribuito a rendere fino alla fine del Novecento il RUC alieno alla popolazione cattolica e alla stessa tradizione di policing britannica. Lucio Valent Robert Tombs, Isabelle Tombs, La France et le RoyaumeUni: Des ennemis intimes, Paris, Armand Colin, 2012, pp. 500. Il libro qui recensito è una versione tradotta, ampliata e migliorata di un testo pubblicato in inglese nel 2006 con il titolo That Sweet Enemy: The French and British from the Sun King to the Present. Solida sintesi di cinquecento pagine, l’opera analizza duecento anni (Otto e Novecento) di rapporti tra Francia e Gran Bretagna, riportando sia questioni e analisi politiche, preminenti nell’economia del lavoro, sia complessi elementi sociali, culturali e di costume (dalla moda al rugby). Ne deriva un ritratto intenso (che si pone sulla scia del bel libro di Mullen e Munson, The Smell of the Continent, recensito sul numero 3 del vol. XIV di «Ricerche di Storia Politica») di un rapporto osmotico che, soprattutto nell’Ottocento e fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale, contribuì al superamento, almeno parziale, della storica inimicizia che aveva diviso i due paesi per tutto il secolo precedente. Nel testo l’impianto storico-geopolitico è molto solido. Robert e Isabelle Tombs definiscono la sconfitta subita dalla Francia nella guerra dei Sette Anni come un momento di svolta fondamentale per il paese. Osservazione più che pertinente se si pensa che tale sconfitta cagionò la fine del suo Impero oceanico e delle ambizioni marittime di Parigi. Ciò significò che la classe dirigente francese, lasciatasi alle spalle il dilemma terra-oceano che per decenni aveva comportato l’adozione di una politica e di una strategia non sempre chiare, poté rivolgere la propria attenzione in via definitiva al continente e ai problemi che esso causava al paese. È vero che dovettero trascorrere ancora cinquanta anni e gli eventi esaltanti e tragici della Rivoluzione francese prima e dell’epopea di Napoleone Bonaparte dopo perché Parigi potesse dedicare gran parte delle sue risorse al continente europeo. Dall’inizio dell’Ottocento in poi la linea non si interruppe più. Ciò non aprì un’epoca di pace, come noto: il nuovo orientamento portò comunque con sé guerre (da quelle contro la Russia del 1853-1856 e l’Austria del 1859, ai conflitti con Prussia e Germania del 1870, 191418, 1939-45). D’altro canto, però, l’attenzione maggiore rivolta al continente permise l’apertura di nuove relazioni con il nemico di una volta, la Gran Bretagna. In fondo, le ragioni che dividevano i due paesi (le colonie) erano meno profonde di quelle che li portavano a unirsi (la comune paura della Germania e l’altrettanto comune desiderio di creare degli imperi coloniali complementari e non alternativi). È per questo motivo che, per una parte del Novecento, Parigi e Londra sono state tra loro alleate, creando una sorta di asse portante delle relazioni politiche europee e mondiali che, in positivo, ha teso a contrapporsi ai negativi fattori di divisione e tensione nel continente rappresentati dall’inimicizia tra Germania, Gran Bretagna e Francia. Dal nostro punto di vista, va detto, questa interpretazione può essere accolta solo ricordando come pur non portandole a un conflitto, le agende di Parigi e Londra per l’Europa furono spesso opposte e, perfino, inconciliabili. Si pensi al sostegno garantito dal Regno Unito all’unificazione di Italia e Germania in chiave anti-napoleonica alla metà dell’Ottocento o, qualche decennio dopo, le diverse valutazioni sulla politica di sicurezza europea dopo il 1918. Altrettanto interessante è l’attenzione posta da Robert e Isabelle Tombs alla riemersione delle divergenze tra i due paesi e le due classi dirigenti dopo il 1945 e il ridimensionamento della Germania. Nel momento in cui la Francia, fino a quel momento paese contadino, si avvicinò agli standard e agli stili di vita di una Gran Bretagna da sempre strenua sostenitrice del libero commercio, l’oggetto del contendere divenne l’atteggiamento da adottare nei confronti del continente europeo. Sia Londra che Parigi cercarono a lungo di individuare lo strumento migliore per garantire a se stesse un futuro da grande potenza. La Francia – almeno dall’episodio di Suez in avanti – optò per l’Europa cercandovi un sostegno qualificato e 96 Biblioteca vedendo nelle sue comunità il naturale completamento del proprio progetto storico e politico. La Gran Bretagna, invece, scelse a lungo di guardare agli Stati Uniti, salvo poi riorientarsi con grande fatica verso il continente. Un processo, questo, mai davvero completato se si pensa che oggigiorno Londra, pur vantando importanti commerci, ha flussi di scambio con l’Europa minori rispetto agli anni Sessanta. Gli A., d’altro canto, notano come i due paesi abbiano cambiato a partire dagli anni Ottanta la loro opinione riguardo le organizzazioni europee. Se in precedenza la Gran Bretagna aveva osservato con preoccupazione l’unificazione europea e la Francia l’aveva cercata (seppure entro un ambito prevalentemente gaullista e, quindi, confederale), dall’Atto Unico in avanti Londra, grazie alla ritrovata ricchezza economica, scelse di sostenere con sempre maggiore decisione l’allargamento della Comunità e poi dell’Unione europea, giudicandola quale via migliore per ottenere quel libero mercato euro-atlantico tanto agognato negli anni Cinquanta. Dal canto suo, Parigi decise di sostenere un’integrazione parzialmente federale dell’Europa (dopo averla a lungo esclusa) giungendo negli anni Duemila a rifiutare una Costituzione che sembrava troppo vicina all’idea inglese di mercato e troppo lontana all’ideale di un continente saldamente unito. Per quanto forse non del tutto condivisibile, questa ricostruzione appare suggestiva e, posta in coda di un testo comunque solido dal punto di vista interpretativo e storiografico, invita il lettore a ulteriori approfondimenti. Lucio Valent José Varela Ortega, Los señores del poder y la democracia en España: entre la exclusión y la integración, prefazione di Shlomo Ben-Ami, Barcellona, Galaxia Gutenberg, 2013, pp. 554. Nel 1977 José Varela Ortega pubblicó un volume intitolato Los amigos políticos. Quest’opera, divenuta in poco tempo un riferimento storiografico per lo studio della Spagna contemporanea, analizzava con piglio innovatore la storia della Restaurazione e del caciquismo. Le interpretazioni contenute in quel volume vennero più avanti approfondite nell’opera collettanea del 2001, intitolata El poder de la influencia. La produzione storiografica di José Varela iniziata negli anni Settanta si completa oggi con l’uscita del saggio Los señores del poder y la democracia en España: entre exclusión y la integración, che offre in modo sensato e ragionevole una rilettura della storia politica spagnola degli ultimi duecento anni. I «signori del potere» menzionati dall’autore sono in buona sostanza i politici di professione o gli imprenditori della politica. Questi si caratterizzano per desiderare a tal punto il potere da finire, in maniera quasi automatica, con l’abusarne. Pur non agendo necessariamente per ragioni di avidità o di corruttela, il loro esercizio del potere porterà inevitabilmente ad una logica politica di esclusività, nella quale ogni oppositore verrà considerato come vero e proprio nemico. In tal senso l’autore ricorda la peculiarità della storia spagnola, segnata sovente dall’affermazione di sistemi politici incapaci di realizzare quote accettabili d’integrazione politica. Come recita il sottotitolo del volume, la storia spagnola dal 1808 ad oggi può essere interpretata partendo dalla diade esclusone-integrazione. L’epoca dei colpi di Stato e delle guerre civili venne interrotta dalla Restaurazione, che portò in Spagna un regime liberale d’integrazione, retto su un patto di alternanza di governo e sulla figura di Cánovas del Castillo. Dopo la dittatura di Primo de Rivera seguì la seconda Repubblica democratica, che si rivelò poco stabile ed eccessivamente radicale, e che portò pertanto alla Guerra civile e al franchismo. Con la transizione democratica, invece, la Spagna è tornata a sperimentare lo scambio politico e il mutuo riconoscimento delle parti come regola di convivenza. Ciò non toglie, come ricorda l’autore senza rifuggere la polemica, che il governo di Zapatero e l’invenzione della «memoria storica» abbiano dato un colpo alla filosofia dell’integrazione, riportando in auge quella dell’esclusione. Il libro è ricco di note, a dimostrazione dell’accurata conoscenza della letteratura da parte dell’autore. Non ci troviamo in tal senso di fronte ad un testo semplice. Le comparazioni tra i casi 97 Biblioteca nazionali europei ed americani sono costanti, così come numerosi sono i riferimenti ad altre epoche storiche, in special modo all’antica Roma, o ad autori e testi classici di ogni epoca, da Aristotele a Cicerone, da Locke a Tocqueville, da Lenin a Berlin, da Ortega y Gasset a Hayek. Il desiderio dichiarato dall’autore nell’introduzione del volume di stimolare il dibattito sembra, dunque, trovare compimento nel corso dell’opera; e la lettura di questo volume, assieme alle riflessioni sui «signori del potere» in esso contenute, risulta in fin dei conti imprescindibile per tutti coloro che si interessino alla storia politica. Jordi Canal Stephen Velychenko, State Building in Revolutionaty Ukraine. A Comparative Study of Governments and Bureaucrats, 1917-1922, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2013, pp. 434. Questo volume è il risultato di anni di ricerca da parte di Velychenko, rappresentante della diaspora ucraina nei paesi del Commonwealth britannico, ora ricercatore all’Università di Toronto. Anche l’interrogativo che guida lo studio è legato ai ragionamenti dei nazionalisti ucraini in esilio: fin dalle memorie dei protagonisti, la sconfitta della creazione di una repubblica nazionale autonoma durante la guerra civile del 1917-1922 aveva fra le sue cause principali la mancanza di un ceto medio intellettuale che credesse nel progetto nazionale e disposto a lavorare nella macchina amministrativa delle tante effimere repubbliche ucraine di quegli anni. Tale interpretazione era corroborata dalle ricerche sull’Ottocento, come quelle di John-Paul Himka, che individuavano nel clero uniate della Galizia asburgica l’unico ceto veramente convinto del progetto nazionale ucraino. Velychenko, grazie a una mole incredibile di documentazione, che va dalle carte delle amministrazioni statali alle memorie personali, testa questa interpretazione fornendo il primo studio delle burocrazie statali in Ucraina dalle rivoluzioni del 1917 alla definitiva conquista bolscevica, includendo anche i casi del regime bianco di Denikin e dell’anarchico Machno. Il risultato è una ricerca di grande interesse e dai risultati inediti. Innanzitutto viene chiarito che i nazionalisti ucraini erano contrari alla creazione di una corposa burocrazia, convinti che il nuovo stato si sarebbe contraddistinto per una sostanziale democrazia dal basso. Anch’essi però, proprio come Lenin, si sarebbero velocemente ricreduti una volta giunti al potere, divenendo fautori di un ampliamento progressivo dei ministeri senza i quali era impensabile poter governare. L’accento viene posto sull’impreparazione teorica dei capi nazionali a gestire tali apparati e sulla loro indecisione a prendere le distanze dal governo di Mosca e dichiarare l’indipendenza. La seconda novità è costituita dalla dimostrazione che tutti i governi che si alternarono sul suolo ucraino si servirono sostanzialmente dello stesso personale amministrativo, che continuò a crescere e che solitamente non poneva discriminanti ideologiche nei confronti dei governi. Fu possibile trovare russi disposti a imparare l’ucraino pur di mantenere il proprio posto di lavoro e che il potere comunista del 1917-18 arruolasse quegli stessi amministratori che avevano lavorato per lo storico poi primo presidente dell’Ucrai- na indipendente Hruševs’kyj. La tesi che vedeva nella mancanza di una burocrazia ideologicamente connotata la causa dell’insuccesso della costruzione statuale nazionale ucraina viene così smentita. Sole eccezioni furono i bianchi di Denikin, ispirati dal razzismo e che punivano tutti coloro che avessero collaborato con gli altri poteri, e i bolscevichi tornati al potere dopo il 1919. I comunisti si distinsero per una lenta sostituzione del personale amministrativo, rimpiazzato da individui politicamente più affidabili (spesso provenienti dalla Russia) o da categorie prima emarginate, come le donne o gli ebrei. Questi ultimi videro nel potere bolscevico che li emancipava un’occasione di carriera e la loro alta percentuale nella nuova amministrazione, unità allo sconcerto di trovare ebrei in posizioni a loro vietate precedentemente, andò a rafforzare lo stereotipo antisemita che vedeva nel potere comunista una congiura ebraica. Lo studio di Velychenko è quindi fortemente innovativo sia dal punto di vista della documentazione che da quello dell’interpretazione, anche se la costruzione dell’argomentazione centrale non risulta sempre efficace e spesso si perde nella descrizione di una miriade di esempi sì interessanti ma che fanno perdere efficacia discorsiva al testo. Simone Bellezza Italia Luigi Ambrosi, Prefetti in terra rossa. Conflittualità e ordine pubblico a Modena nel periodo del centrismo (1947-1953), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 232. Il libro ricostruisce le modalità con cui furono affrontate situazioni cariche di conflittualità, di violenza politica e sociale dal 1947 al 1953, anni caratterizzati dall’esclusione delle sinistre dal sistema di partiti e da un profondo anticomunismo riflesso della Guerra fredda. Per farlo l’A. sceglie la provincia di Modena perché in quella zona si 98 Biblioteca addensarono e ribollirono problemi tanto di natura politica (la difficile convivenza di ex partigiani con ex fascisti tornati sulla scena pubblica; il radicarsi del processo alla Resistenza» e la forte intransigenza antifascista nei confronti dell’Uomo qualunque e dell’Msi) quanto sociale (agitazioni industriali, vertenze bracciantili e mezzadrili). La provincia di Modena presentava, inoltre, una specificità per la consistente presenza, tra gli agenti di Ps, di ex combattenti delle forze partigiane al comando di questori che avevano iniziato la loro carriera sotto il regime fascista e che ne erano rimasti fortemente influenzati. Non siamo in presenza di uno studio sull’amministrazione pubblica, bensì di un libro di storia politica tout court. Attraverso il caso di Mo- dena abbiamo uno scorcio del clima da «“guerra civile” a bassa intensità» (p. 110) che poteva esserci, se non in tutta Italia, almeno in buona parte di essa. L’opera, inoltre, seguendo i profili biografici di tre prefetti che entrarono in carriera prima della Grande Guerra e che vissero il cambiamento di tre regimi – liberale, dittatoriale, repubblicano – adattandosi e uscendone, di fatto, indenni, mette in pratica il suggerimento di Pavone di «“umanizzare” il concetto di “continuità dello Stato”» (p. 225). Il prefetto Luigi Pianese (maggio 1947-febbraio 1948) affrontò una fase particolarmente calda in cui odi e vendette della passata guerra civile furono alla base di incidenti come quello di Pavullo e Nonantola nel 1947. Alla vigilia delle elezioni del 18 aprile 1948 Pianese fu sostituito da Giovan Battista Laura (marzo 1948-ottobre 1950) che ebbe un valido aiuto nel questore Fausto Salvatore e nel suo successore Carmelo Marzano. Quest’ultimo caratterizzò il suo operato per metodi che riguardarono la limitazione della libertà di espressione e di riunione, applicando effettivamente la legislazione fascista di Ps con continuità e con «esplicita strumentalità politica, che trascendeva pericolosamente il piano della funzione prescrittagli, un’applicazione […] che non placava le tensioni ma le alimentava» (p. 94). Laura gestì la psicosi preelettorale di piani insurrezionali e la tensione dopo l’attentato a Togliatti, ma il suo nome rimane legato all’eccidio del 9 gennaio 1950 quando, nel corso di una manifestazione dei sindacati per impedire la riapertura dopo una serrata delle Fonderie Riunite, le forze dell’ordine uccisero sei manifestanti e ne ferirono altri. La gestione di Elmo Bracali (ottobre 1950-giugno 1953) fu caratterizzata da una vigilanza e da un controllo costante sull’attività dei comuni di sinistra (riducendo di fatto la potestà dei sindaci con provvedimenti amministrativi), da sequestri di licenze, dal divieto di iniziative pubbliche organizzate dalle sinistre. Se fino alle elezioni del 18 aprile e all’attentato a Togliatti la capacità organizzativa e paramilitare comunista rappresentò effettivamente un pericolo concreto (cosa che non giustifica l’atteggiamento repressivo delle forse di Ps), dal 1951 la conflittualità e i pericoli eversivi diminuirono notevolmente: l’A., seguendo le tappe della storia nazionale e internazionale, dimostra come la formula della repressione preventiva rimase quella 99 Biblioteca preferita dai prefetti che continuarono a limitare sistematicamente i diritti civili a comuni cittadini con effetti, spesso, controproducenti. Supportato da un ampio ventaglio di fonti – fascicoli personali dei prefetti, relazioni prefettizie su singoli episodi, fonti a stampa – il libro offre un’utile riflessione sulla gestione della protesta in una zona specifica, ma getta anche luce, sperando che sia seguito da altri studi, sulle strategie di intervento statale nei conflitti nella neonata Repubblica. Camilla Poesio Pier Luigi Ballini (a cura di), Sonnino e il suo tempo (1914-1922), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, pp. 350. Il volume è il proseguimento di una ricerca, curata dallo stesso P. L. Ballini, avviata una decina di anni fa, che ha dato i primi frutti con la pubblicazione di Sidney Sonnino e il suo tempo, Firenze, 2000. Il periodo preso in considerazione nel volume in esame è quello riguardante il primo conflitto mondiale fino al dopoguerra. Anche questo nuovo studio si caratterizza per l’ampiezza e l’interesse degli interventi, così da costituire, insieme al volume precedente, una vera e propria summa del pensiero e dell’azione politica di Sonnino. Il volume dedica, naturalmente, un notevole spazio al ruolo di Ministro degli Esteri ricoperta da Sonnino per diversi anni, in una della fasi più delicate della storia italiana. Il leader toscano assunse la guida agli Esteri dal novembre 1914 al giugno 1919, quando gli successe Tommaso Tittoni. Sonnino rimase quattro anni mezzo alla guida degli Affari Esteri e precisamente nei governi presieduti da: Salandra, Boselli e Orlando. Per ciò che concerne la durata del suo impegno, si tratta di uno dei più lunghi dell’Italia liberale, dopo Emilio Visconti Venosta, Tommaso Tittoni e Antonino di San Giuliano. Il ruolo di Sonnino s’intreccia con il tormentato ingresso dell’Italia nel primo conflitto mondiale, con il noto cambio di alleanza. Questo delicato passaggio e il successivo legame con l’Intesa sono ben ricostruiti negli interventi di Luca Riccardi, Sonnino e l’Intesa durante la Prima guerra mondiale, e Ludovica De Courten, Sonnino tra imperialismo e nazionalismo. Il difficile equilibrio della conservazione. Si inseriscono in questo filone anche l’originale relazione di Laura Brazzo, Sidney Sonnino, il ministro degli Esteri e la Palestina (1917-1919), che getta luce su una tematica poco nota negli studi storici, e Italo Garzia, Sonnino alla Conferenza della pace, che pone in rilievo quanto fosse irrealistica l’esecuzione integrale del Patto di Londra, portata avanti da Sonnino, in uno scenario internazionale profondamene mutato rispetto al 1915. Si tratta di un volume molto documentato come confermano anche altre relazioni condotte su materiale documentario per lo più inedito o edito da poco tempo; ci riferiamo, in particolare, alla relazione di Aldo A. Ricci, Sidney Sonnino nella documentazione dell’Archivio Centrale dello Stato; Elio D’Auria, Sidney Sonnino, la politica estera e la questione adriatica nei «Documenti Diplomatici Italiani», e Fabio Grassi Orsini, Sonnino nel «Diario» Imperiali, pubblicato, a cura dell’Archivio del Senato della Repubblica, nel 2006. Il volume dedica, opportunamente, spazio anche alla percezione della stampa internazionale sull’azione del ministro, in particolare con i saggi di Emanuela Minuto, Note su Sonnino ministro degli Esteri nella stampa britannica, e di Daniela Rossini, Sonnino visto dagli Stati Uniti: i leader americani e la politica estera italiana nel periodo della cobelligeranza (1917-1918). Sono, inoltre, dedicate a tematiche di carattere generale le informate relazioni di Pietro Pastorelli, Sonnino e l’Europa; Rolando Nieri, Il rapporto politica interna-politica estera nella concezione di Sidney Sonnino, e Maria Marcella Rizzo, Salandra e Sonnino: una parabola del liberalismo italiano, che, molto opportunamente, delinea un profilo di lungo periodo del rapporto fra i due leaders politici che parte dalla fine dell’Ottocento. Il volume si occupa anche dell’ultimo Sonnino, che nel 1919 rifiutò di presentarsi alle elezioni politiche, in particolare con le relazioni di Paola Carlucci, Senza politica: l’ultimo Sonnino (1919-1922), e Antonio Cardini, Sonnino e la crisi dello Stato liberale. Una fase nella quale il leader toscano, anche a causa di problemi di salute, mostrò, certamente, una minore vivacità intellettuale. 100 Biblioteca Il volume, che si avvale di un’imponente documentazione proveniente anche da archivi internazionali, oltre che di un intelligente utilizzo della corposa documentazione edita, è un valido strumento per approfondire l’azione politica di uno dei maggiori esponenti liberali italiani ed anche le relazioni internazionali di uno dei periodi più complessi e delicati del primo Novecento. Antonio Scornajenghi Stefania Bartoloni, Il fascismo e le donne nella «Rassegna femminile italiana» 1925-30, Roma, Biblink, 2012, pp. 180. Il libro di Stefania Bartoloni ricostruisce nel dettaglio le travagliate vicende della «Rassegna femminile italiana», fondata da Elisa Majer Rizzioli. Il libro si articola in quattro capitoli e dedica attenzione soprattutto alla prima fase della rivista, quella della fondazione. Nel primo capitolo l’autrice inquadra la fondazione della «Rassegna» nel più ampio contesto della stampa femminile del dopoguerra, svelando fili di continuità di lungo periodo nella stampa femminile italiana tra fine Ottocento e Novecento. I capitoli successivi sono dominati dalla «Rassegna femminile italiana» e dalla storia di Elisa Majer Rizzioli, ispettrice dei fasci femminili e protagonista del fascismo femminile delle origini. In particolare, nel secondo capitolo Bartoloni traccia un breve profilo biografico della fondatrice, che condivide con Margherita Sarfatti le origini veneziane ed ebraiche e la scelta di fare di Milano la sua città di elezione, oltre che un precoce avvicinamento al fascismo delle origini. In questo percorso, appare particolarmente rilevante la forza del desiderio di Rizzioli di fondare un giornale femminile, che procede di pari passo con lo sviluppo della sua carriera politica ed è precedente all’ufficializzazione del suo ruolo di Ispettrice dei fasci femminili, nel dicembre del 1924. Nel terzo capitolo l’autrice analizza il primo anno di vita del giornale, organo ufficiale dell’Ispettorato dei fasci femminili. In questo capitolo vengono presi in considerazione il contenuto dei primi numeri del giornale, il ruolo politico e istituzionale svolto da questo periodico nel movimento femminile fascista e le reazioni suscitate dalla sua comparsa nel movimento fascista in generale, fino alla chiusura, ordinata dal Partito nel dicembre 1925. L’ultimo capitolo è dedicato infine a spiegare le ragioni della chiusura, nei delicati equilibri del Pnf di metà anni Venti, e permette di capire come la Rizzioli sia giunta, nonostante tutto, ad ottenere di poter pubblicare una seconda serie del giornale, dal gennaio 1927. L’ultimo numero del periodico venne, infatti, pubblicato nel luglio 1930, ad un mese esatto dalla morte della sua fondatrice e con un numero interamente dedicato a lei. La storia di questo periodico riflette bene le ambiguità con cui la dirigenza del fascismo guardava all’autonomia della «Rassegna», e delle dirigenti del movimento femminile fascista in generale, e al suo ambizioso progetto di costruire questo spazio di organizzazione politica e culturale per le donne. Queste ambiguità giungono all’apice con la chiusura, nel 1925, sotto le pressioni del mondo nazionalista, che mai aveva apprezzato il dinamismo della Majer Rizzioli e che era poco disponibile a tollerare spazi di pur controllata autonomia femminile. La rinascita del giornale, sempre diretto dalla Majer Rizzioli, ma con un ruolo meno ufficiale nei confronti dei Fasci femminili, cui era comunque dedicato, rivela molto dell’incertezza nell’adozione delle politiche sulla militanza femminile. La vicenda della «Rassegna femminile italiana» mostra il conflitto tra la struttura istituzionale del fascismo e il ruolo di Mussolini nei confronti della Rizzioli e del movimento femminile fascista più in generale, rivelando le tensioni esistenti sul destino da riservare alla militanza femminile in questo nuovo contesto istituzionale e politico. Le difficoltà di questo periodico ben rappresentano le ambigue sorti delle donne nel fascismo, amplificate in questa fase di realizzazione della dittatura. Questo libro costituisce un ulteriore piccolo tassello di un’indagine sulla stampa femminile durante il fascismo che ha bisogno di altri approfondimenti per permetterci di avere un quadro meno statico della cultura e dell’organizzazione culturale delle donne nel Ventennio. Giulia Albanese 101 Biblioteca Maurizio Degl’Innocenti, La società volontaria e solidale. Il cantiere del welfare pubblico e privato, Manduria, Lacaita, 2012, pp. 462. Ragionare di crisi del welfare State e in particolare di quello italiano è un esercizio di moda già da alcuni decenni. Anche in questo volume, la diagnosi impietosa delle inefficienze e storture della spesa sociale dello Stato in Italia, aggravate, in tempi di crisi economica, da fondati dubbi sulla tenuta complessiva del sistema, costituisce il punto di partenza. L’A. raccoglie una serie di contributi, in parte già editi, che ruotano intorno al tentativo di ricostruire la genealogia di un modello di welfare complementare a quello statale e fondato sul cosiddetto «terzo settore». Quella rete, cioè, di istituzioni (mutue, cooperative, consorzi, circoli ricreativi e sportivi, organizzazioni del volontariato) che nel linguaggio della politica europea è noto oggi come il settore della «economia sociale». Di più ampio respiro è il saggio di apertura che analizza in chiave comparata la nascita e l’evoluzione del mutualismo cooperativo nell’Europa tra Otto e Novecento, soffermandosi sul quadro normativo che nei vari Paesi ha accompagnato l’assorbimento della libera mutualità nel quadro delle assicurazioni obbligatorie gestite o controllate dallo Stato. Seguono una serie di contributi di ricerca più concentrati sull’esperienza italiana in età liberale e giolittiana con studi sulla nascita delle prime cooperative assicurative, di credito, di consumo, sulle università popolari e sulle case del popolo, nonché sul ruolo di settori importanti della classe dirigente liberale e di quella emergente del socialismo riformista nell’investire in queste nuove forme di aggregazione, assistenza, educazione politica delle masse operaie e contadine. Non mancano brevi incursioni anche nel periodo fascista e in quello repubblicano: del primo si ripercorrono le iniziative legislative in tema di mutualità e del secondo si seguono le vicende della costituzione dei circoli Arci. In conclusione si presentano una serie di dati statistici volti a fornire un’istantanea dello Stato e dell’importanza del «terzo settore» nella società contemporanea. Lo schema interpretativo che innerva i diversi contributi è improntato al rifiuto di schemi ideologici o politologici troppo netti. In particolare, cioè, quelli che considerano la costruzione dei sistemi di welfare un merito esclusivo della sinistra socialista, nonché quelli che lo considerano un prodotto, unicamente, della logica «interventista» e razionalizzatrice dello Stato. In quest’ottica il mutualismo e la cooperazione, anziché residui superati di un passato corporativo, vengono presentati come esperimenti di integrazione sociale rispondenti alle specifiche esigenze di sicurezza delle moderne società industriali. Esperimenti che nascevano «dal basso» e che poi diversi linguaggi politici (liberale, cattolico, repubblicano, socialista, fascista) si preoccuparono di declinare in modo funzionale alle proprie esigenze, in rapporto dialettico con la lenta affermazione dello Stato nazionale quale principale fornitore di servizi alla collettività. Dando vita, così, a sistemi di welfare complessi e stratificati di cui quello italiano non è che uno dei tanti esempi. Potrà la «società volontaria e solidale», ovvero un associazionismo fondato sul rifiuto della logica del profitto, sulla democrazia interna e sull’investimento nelle relazioni interpersonali, salvare il welfare europeo? Se non altro, l’A. ci tiene a sottolineare come la sua storia, travagliata e non sempre vincente, sia una parte integrante del suo codice genetico. Se appare convincente la scelta di organizzare una raccolta di studi intorno a questo stimolante filo conduttore, tanto più perché si giova di un’ottica comparata, dispiacciono la mancanza, in qualche saggio, di una chiara indicazione della fonte dei numerosi dati statistici e normativi, nonché la poca cura redazionale dei termini stranieri. Claudia Mantovani Filippo Focardi, Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 308. Il volume in questione è il risultato di una serie di riflessioni condotte in precedenza dall’A. e costituisce, pertanto, una sintesi conclusiva di queste. 102 Biblioteca Nel volume Focardi cerca di ricostruire le origini del mito del soldato italiano bravo e umano e, di contro, dell’imago del tedesco cattivo e crudele. Nel far ciò bene sottolinea come alla base di tale mito ci fosse la propaganda anglo-americana che, a più riprese, insisté sul fatto che la guerra era stata imposta da Mussolini all’Italia, scelta di vertice tra il duce e Hitler, di fronte a un popolo italiano ostile al conflitto e, in fondo, da sempre diffidente nei confronti dell’alleato germanico. Una propaganda anti-regime, dunque, e non anti italiana che, anzi, cercava di solleticare il sempre presente risentimento anti tedesco degli italiani. Questi temi propagandistici vennero prontamente ripresi dalle forze in campo in Italia e, in particolar modo, dalla Monarchia e dai partiti radunati nel Cln. Il motivo centrale di tale rielaborazione fu dovuta a questioni di carattere internazionale, ossia al tentativo di dissociare l’Italia dall’inevitabile sconfitta, cercando di presentarla come meno responsabile nello scatenamento del conflitto e, dunque, tentando di alleviare le condizioni di pace che si sapevano essere molto dure. Ma i motivi di tale rielaborazione del ruolo italiano nel secondo conflitto mondiale rispondevano anche a scopi più contingenti. La Monarchia voleva dissociare le proprie responsabilità da quelle del regime e, dunque, presentarsi come istituzione credibile ancora in grado di reggere il paese, i partiti antifascisti volevano autoassolvere il popolo italiano e con esso se stessi dalle responsabilità nell’aver favorito nel primo dopoguerra l’ascesa del fascismo. Questa concomitanza di interessi, politici e internazionali, produsse tra il 1943 e il 1947 la rielaborazione del ruolo italiano nella guerra, cercando di presentare le truppe impegnate nei vari fronti, appunto, come esponenti della civiltà italica e latina e, dunque, prive della brutalità tipica, invece, delle truppe germaniche. Conseguenza inevitabile dal momento che se si voleva affermare la «bontà» del soldato italiano era necessario avere un contraltare che, in effetti, non poté che essere il soldato tedesco presentato come educato ma crudele e, al fondo, ciecamente obbediente agli ordini superiori e privo quasi di umanità. Ulteriore conseguenza di tale processo di rielaborazione che avrebbe avuto molta fortuna ben al di là del 1947, fu una visione se non benevola senz’altro edulcorata del fascismo. Se questo processo avviatosi in maniera più o meno consapevole non era inevitabile, e alcuni partiti rifletterono sulle responsabilità del fascismo e sui suoi legami profondi con la società italiana, è pur vero che il riciclaggio in atto nei vari partiti del personale ex fascista e l’insistenza sul carattere fondamentalmente buono del soldato italiano, protettore reale degli ebrei negli scacchieri dove avevano operato le truppe italiane, non poté che produrre un’immagine attenuata del regime fascista rispetto a quello nazista. Che questa differenza sia storicamente e scientificamente provata è ancora dibattuto tra gli storici; certo è che le origini di una certa immagine benevola del fascismo affondano le loro origini proprio nell’elaborazione del mito del bravo italiano. Un mito che, seppur vada riletto in maniera maggiormente critica, come suggerito dall’A., affonda le proprie basi anche nel reale comportamento dell’esercito italiano che, pur macchiandosi di alcune atrocità come avvenne nello scacchiere danubiano-balcanico, non può essere paragonato al comportamento delle truppe naziste nel corso del conflitto, e in particolare all’atteggiamento tenuto dall’esercito germanico sia sul fronte russo sia nel continuo rastrellamento dell’elemento ebraico nei territori occupati. Un buon libro, dunque, quello di Focardi che va letto per comprendere bene quei processi di rimozione delle responsabilità italiane nel secondo conflitto mondiale; processi che furono favoriti innanzitutto dagli Alleati e, poi, per finalità affatto diverse da tutti gli attori politici presenti nella penisola. Andrea Ungari Fabrizio Giulietti, Storia degli anarchici italiani in età giolittiana, Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 308. Come sottolinea ampliamente Giampietro Berti nella sua prefazione il lavoro di Giulietti «colma un vuoto rilevante relativo al movimento anarchico nell’età giolittiana e al primo quindicennio del Novecento» consegnandoci una monografia 103 Biblioteca completa. La svolta liberale, per Giulietti, infatti, costituisce un nuovo contesto che da un lato favorisce una nuova ripresa operativa del movimento, dall’altro, ne segna una «sorta di metamorfosi identitaria» generando una eterogeneità di indirizzi e orientamenti ideologico-culturali che si vanno progressivamente ad assommare alla tradizionale concezione socialista-anarchica internazionalista. Ci si imbatte, quindi, volendo semplificare, nelle tre correnti principali del movimento: quella organizzatrice, quella individualista e quella antiorganizzatrice, ma anche nelle tendenze minori anarcosindacalista, antimilitarista ed educazionista e nelle variegate derivazioni (neomalthusiana, evoluzionista, anticlericale, cristiana, geometrista, esperantista). Nel tentativo di dipingere un affresco organico, Giulietti coglie la vitalità, i labili confini e le sfumature (si pensi alla critica al «partito» come condizione comune della sfera antiorganizzatrice e alle ben più articolate opinioni sempre in questa sfera, nonostante le pregiudiziali di principio, sui rapporti da tenere con il costituendo movimento sindacale). La forza del libro sta, infatti, proprio nel riuscire ad ancorare le vicende esaminate, i momenti cruciali che investono il movimento anarchico, all’interno di uno scenario più ampio che tratteggia i conflitti politici e sociali che hanno caratterizzato la storia italiana dalla svolta di fine secolo alle agitazioni contro la guerra in Libia fino alla Grande Guerra, senza ad esempio trascurare il complesso rapporto tra la «classe» – che Giulietti vede molto spesso ancora legata a pratiche tradizionali di tutela paternalistica o ad un rivendicazionismo di tipo corporativo e riformista – e movimento anarchico. Attraverso la lettura del libro, quindi, seguiamo lo smarrimento del movimento nel passaggio dalla semiclandestinità di fin de siècle alla ripresa operativa e al rilancio nel nuovo equilibrio politico; ne osserviamo l’arricchimento teorico di cui un momento centrale, malgrado i limiti e le defezioni, è il dibattito legato al congresso romano del 1907; ne scrutiamo il consolidamento nell’attività di agitazione e propaganda (cap. 2) come in occasione delle agitazioni congiunte con repubblicani e socialisti in favore dell’educatore libertario spagnolo Francisco Ferrer y Guardia del 1906 prima ancora dell’imponente ondata di mobilitazione dell’ottobre 1909. Il lavoro è inoltre arricchito da un impegno archivistico-bibliografico, come mostra l’attenta ricostruzione delle iniziative anarchiche e anche la ricca appendice di documenti archivistici inediti, relativi ai rapporti stilati dagli organi di polizia sul movimento e su alcune sue singole manifestazioni dal 1904 al 1913. Ma privilegiata è sicuramente la parte finale che ricostruisce le vicende negli anni successivi al congresso di Roma, fase di grande vitalità per gli organizzatori e non solo, che vedrà inoltre la nascita dell’USI; è questo un momento di forte radicalizzazione del conflitto sociale e dell’attività di propaganda del movimento con le campagne antimilitariste contro la guerra in Libia e la mobilitazione pro-Augusto Masetti e che culminerà negli eventi della «settimana rossa» con gli anarchici questa volta nel ruolo di indiscussi protagonisti in occasione dei moti popolari del giugno 1914 (cap. 3). Questa precisa architettura analizza, quindi, il complesso mondo di un movimento fatto di tante famiglie che tendono a sfuggire ad una visione unitaria; e lo fa enfatizzando il tratto più caratteristico, quell’esser un arcipelago, alle volte anche da un punto di vista quasi squisitamente geografico, fatto di una miriade di conferenze, giornali, opuscoli, lotte sindacali e d’opinione ampiamente testimoniate nel testo. Ne escono definite con precisione quella ricchezza e vitalità del movimento che sono sempre derivate, «al pari della sua debolezza e della sua organica incapacità a definire obbiettivi di breve e medio periodo, dal suo continuo sfuggire alle forme di organizzazione politica tipiche dei partiti in senso proprio e attuale» (Antonioli-Masini, Il sol dell’avvenire, 1999). Ilaria Del Biondo Marco Scavino, La svolta liberale 18991904. Politica e società in Italia alle origini dell’età giolittiana, Milano, Guerini e Associati, 2012, pp. 266. Gli ultimi anni dell’Ottocento e i primi del Novecento sono un periodo cruciale della storia italiana. Essi rappresentano un momento di svolta che 104 Biblioteca ha riguardato vari ambiti: politico, economico, sociale e culturale. Nel volume in esame l’a. approfondisce gli aspetti politici che caratterizzarono quegli anni, in particolare le modalità con le quali il Paese affrontò il delicato passaggio fra i due secoli e diede inizio alla svolta liberale impersonata da Giuseppe Zanardelli e Giovanni Giolitti. Una densa fase storica che l’a. ben ricostruisce in questo volume di scorrevole lettura. Il volume è suddiviso in tre capitoli di ampiezza disomogenea: il primo è un’introduzione di carattere economico, sociale e politico dove si analizzano sinteticamente alcuni nodi riguardanti lo sviluppo industriale e agricolo di lungo periodo e l’incapacità della classe dirigente di fronteggiarli in maniera adeguata. Prima di Rudinì, poi Pelloux affrontarono la questione sociale con metodi repressivi, senza comprendere in profondità i mutamenti in corso nella società italiana ed europea, limitandosi a difendere la cittadella liberale dalla presunta invadenza dei «rossi» e dei «neri». Il secondo capitolo entra più nel merito della questione e parte, come momento periodizzante, dalle elezioni del giugno 1900 dopo le quali Pelloux si dimetterà da capo del governo. Il regicidio di Monza (luglio 1900), avvenuto ad opera dell’anarchico Gaetano Bresci, e il clima che ne scaturì, non bloccarono la svolta, anzi in un certo senso l’accelerarono con l’avvento di Vittorio Emanuele III «assai meno conservatore» (p. 63) del padre sotto il profilo politico e maggiormente sensibile ai nuovi mutamenti in corso nel Paese. Il governo è presieduto dal senatore Giuseppe Saracco, il quale da più parti era stato considerato «garanzia di continuità degli equilibri parlamentari, senza per questo essere visto dalle opposizioni come una minaccia di ulteriori tentazioni autoritarie» (p. 40). Dopo la crisi del governo Saracco, maturata nel febbraio 1901 in seguito alla vicenda dello scioglimento della Camera del Lavoro di Genova da parte del prefetto Garroni avvenuto nel dicembre, il re incaricò di formare il nuovo esecutivo Zanardelli, prestigioso e anziano leader della Sinistra storica. Questi fu affiancato da Giolitti come ministro dell’Interno: è l’inizio della svolta. La nuova compagine di governo lasciò maggiore libertà al conflitto sociale (scioperi compresi), limitando la sua azione alla tutela dell’ordine pubblico, non quindi intervenendo a favore dei datori di lavoro alterando la dinamica del mercato. Il terzo capitolo, decisamente il più lungo, con le sue oltre centoventi pagine, esamina in maniera particolareggiata gli equilibri e le contraddizioni della svolta. L’A. analizza ampiamente le vicende del partito socialista, il suo aspro conflitto interno fra intransigenti e riformisti, che caratterizzerà l’intero periodo giolittiano, nonché le vicende del mondo cattolico anch’esso in grande fermento. L’autore, nel complesso, pur sottolineando l’importanza della svolta impressa da Zanardelli e Giolitti, scorge una progressiva stabilizzazione moderata (già con il governo Giolitti dell’ottobre 1903 e poi con il fallimento dello sciopero generale del settembre 1904 e le successive elezioni politiche di novembre). Certo, viene da chiedersi quale prospettiva avesse Giolitti nel 1903 dal momento che i riformisti socialisti rifiutarono di entrare nel governo, se non quella di costituirne uno con le forze politiche disponibili a sostenerlo, spostando, inevitabilmente, l’asse del governo più a destra. Ricordo, infatti, che nemmeno i radicali accettarono gli inviti giolittiani a partecipare. Il volume è basato su fonti documentarie edite e a stampa (molti quotidiani e riviste di diversa coloritura politica, e atti parlamentari) e su una bibliografia che non sempre tiene nel debito conto il più recente dibattito storiografico su questioni rilevanti (Mezzogiorno, crisi di fine secolo, ruolo dei cattolici). Malgrado ciò il volume resta un interessante punto di riferimento nel dibattito storiografico sulle vicende politiche di fine Ottocento inizio Novecento. Antonio Scornajenghi Wolfgang Schieder, Mythos Mussolini. Deutsche in Audienz beim Duce, München, Oldenbourg Verlag, 2013, pp. 404. L’abilità di Mussolini nel costruirsi il proprio mito è stata sottolineata varie volte con riferimento a vari aspetti della presenza pubblica del duce. In questo volume si studia un aspetto particolare, ma assai importante e sin qui mai esplorato con appositi studi, di questa attività: la gestione delle udienze. Come Schieder illustra in maniera esaustiva nell’am- 105 Biblioteca pio saggio introduttivo di 200 pagine, si trattava di un’attività accuratamente pianificata che occupava una quota notevole della politica di Mussolini. Oltre agli incontri più o meno di routine con i vertici della burocrazia politica e statale, una parte cospicua era destinata a consentire l’accesso al duce di personalità italiane e straniere che si riteneva interessante e/o utile influenzare. In questo libro ci si occupa dei visitatori tedeschi, ma sappiamo bene che analoga attenzione fu riservata ad altri, tanto che c’era una certa smania da parte degli stranieri di passaggio a Roma di poter incontrare Mussolini. Lo storico tedesco registra l’importanza che rivestiva lo scenario (la Sala del Mappamondo a Palazzo Venezia) e i vari gradi di ritualità dell’evento (Mussolini che aspetta alla scrivania, o che va incontro all’interlocutore, che lo congeda con maggiore o minor calore, ecc.). Schieder distingue due categorie di visitatori: giornalisti, intellettuali, artisti; uomini politici, in questo caso sia della fase di Weimar (vi è un colloquio significativo con Brüning) che del versante nazista (l’incontro con Goebbels del 29 maggio 1933). È stato ricostruito un registro completo delle udienze, ma vengono riprodotti nella seconda parte del libro quei resoconti degli ammessi alle udienze che è stato possibile rintracciare e che hanno un qualche interesse. Sono state individuate ben 86 relazioni (circa un quarto dei tedeschi che ebbero questo onore) e ne vengono pubblicate 32, ciascuna con adeguata introduzione sul personaggio che le ha redatte. Si tratta di materiali disomogenei, perché in alcuni casi sono resoconti pubblicati più o meno a breve distanza dalle visite, in altri di brani di memorie scritte nel dopoguerra. Nel primo caso dominano molte volte le suggestioni del contesto temporale (a partire dalla «fama» da cui Mussolini era circondato) nonché le esigenze del reportage giornalistico. Nel secondo caso si leggono apprezzamenti che difficilmente all’epoca sarebbero stati fatti: vediamo per esempio il caso della famosa regista Leni Riefenstahl, ricevuta il 28 febbraio del 1936. Qui leggiamo l’impressione di avere avuto davanti «ein wenig Caruso in Uniform» (p. 310) non sappiamo quanto deformata dall’intervenuta consapevolezza di come era finita, o una lunga tirata sulla questione sudtirolese che anch’essa non è del tutto concordante con il tempo storico in cui avviene l’incontro. La cura che Mussolini poneva nella gestione di questi eventi era mirata a un preciso piano politico: consolidare la propria immagine soprattutto all’estero, trasformando coloro che venivano a parlare con lui in involontari propagandisti della sua grandezza, e di quella del suo regime. Contava sul fascino che riusciva in un modo o in un altro a esercitare sui suoi interlocutori (anche facendo sfoggio di qualche competenza linguistica, acquisita nelle sue peregrinazioni giovanili). Con i giornalisti il duce evitava le classiche interviste, optando invece per «colloqui» che poi davano origine non solo ad articoli su vari periodici, ma anche a libri, talora destinati a grande diffusione in più lingue. Due i casi più famosi qui documentati: uno assai noto, quello di Emil Ludwig, l’altro molto meno, quello di Luise Diel. Sono due storie quasi antitetiche. Ludwig conduce i suoi colloqui prima dell’avvento al potere di Hitler e l’immagine di Mussolini che si fece e che diffuse fu quella di un dittatore moderato, non aggressivo (niente guerre in vista), che non aveva intenzione di fare del fascismo un «articolo d’esportazione» e che non nutriva alcun pregiudizio antisemita. Era l’immagine che una parte cospicua della pubblica opinione nella Germania pre-nazista voleva farsi della «soluzione italiana» alla crisi postbellica con cui anch’essa faceva i conti. Al contrario la Diel, una giornalista non di prima grandezza che però riuscì ad avere il maggior numero continuativo di udienze dal 1934 al 1939 (ben 21), trasmise la fascinazione acritica sia dell’uomo che del regime fascista. Schieder ha il merito di avere ricostruito nei dettagli e in modo molto interessante questa strategia di comunicazione del duce che peraltro si fondava, come non manca di sottolineare, anche su doti personali fra l’istrionico e l’istinto politico. Paolo Pombeni Andrea Spiri, La svolta socialista. Il PSI e la leadership di Craxi dal Midas a Palermo (1976-1981), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 174. Andrea Spiri prosegue con questo volume il suo lavoro di ricerca sulla storia del Psi nell’era Cra- 106 Biblioteca xi (cfr. i due volumi da lui precedentemente curati per Marsilio, rispettivamente nel 2006 e nel 2010: Bettino Craxi, il socialismo europeo e il sistema internazionale e Bettino Craxi, il riformismo e la sinistra italiana), basato essenzialmente su un’attenta analisi della stampa coeva e l’utilizzo dei documenti posseduti dalla Fondazione Craxi. L’A. mantiene sempre, con merito, il tono distaccato dello studioso, conscio com’è delle difficoltà di tracciare un bilancio dell’opera di Craxi, anche nel breve, ma decisivo periodo che va dalla sua elezione a segretario del Psi al congresso di Palermo del 1981, in cui consolidò definitivamente la sua leadership all’interno del partito. Due sono quindi i temi centrali del libro: l’evoluzione delle dinamiche interne al Psi e la lotta condotta da Craxi (con il decisivo contributo di Luciano Pellicani e degli intellettuali della redazione di «Mondoperaio», con i quali, pure, i rapporti furono, in alcune fasi, di acceso contrasto) contro il predominio comunista nella sinistra italiana, sullo sfondo delle drammatiche vicende del sequestro Moro e della fine dei governi di unità nazionale. I motivi del successo (sia pure effimero) di Craxi si possono indubbiamente riscontrare, all’interno del Psi, nell’aver ridato orgoglio e senso di appartenenza ai militanti di un partito ripiegato su se stesso e reduce da anni di sconfitte; all’esterno, nell’aver colto i segnali di cambiamento e i bisogni di modernizzazione della società italiana. Motivi che Craxi tentò di incarnare con la sua leadership personale e con il lancio di parole d’ordine come la «grande riforma»: ma il tentativo di risolvere la «questione socialista» (la debolezza, non solo elettorale, di un soggetto socialista stretto tra il potere democristiano e, a sinistra, l’egemonia comunista) attraverso il rilancio del riformismo socialista e la ricerca di un proprio spazio politico fallì, in parte proprio a causa delle scelte strategiche craxiane del periodo preso in esame da Spiri. Se la ricerca dell’autonomia era indubbiamente la condizione sine qua non per la stessa sopravvivenza del Psi dopo la sconfitta elettorale del 1976, la segreteria Craxi non riuscì a cambiare, in sedici anni, pur considerando le indubbie difficoltà che dovette affrontare, i dati di fondo individuati da Norberto Bobbio in un convegno organizzato da «Mondoperaio» in quello stesso luglio 1976 che vide l’elezione di Craxi ai vertici del Partito, es- sere cioè il Psi «partito medio, coalizzato e non coalizzante, necessario ma non sufficiente». La «governabilità» (alternata con un movimentismo portato fino alla spregiudicatezza), il leaderismo, la polemica ideologico-culturale (sempre aggressiva e talora strumentale, anche se spesso ispirata da convincenti ragioni di fondo) sembrano cioè essere stati funzionali a un’abilità più tattica che strategica (come peraltro per il suo mentore e maestro, Pietro Nenni): il primum vivere non diventò quasi mai deinde philosophari e i limiti di questa concezione della politica (moderna, con l’attenzione all’uso degli strumenti di comunicazione di massa, e anticipatrice del fenomeno della «personalizzazione») appariranno con tutta evidenza nel mondo post 1989, quando anche l’indubbio carisma personale su cui Craxi aveva fondato molte delle sue fortune cominciò rapidamente ad appannarsi. Giovanni Scirocco Vito Tanzi, Italica. Costi e conseguenze dell’unificazione d’Italia, Torino, Grantorino, 2012, pp. 290. Vito Tanzi, nato a Mola di Bari nel 1935, è stato professore di economia e di finanza pubblica in varie università americane, direttore del Fiscal Affair Department del Fondo Monetario Internazionale (1981-2000), e sottosegretario all’economia e alle finanze nel secondo governo Berlusconi (20012003). Può vantare cinque lauree honoris causa e un elenco di pubblicazioni assolutamente ricco e prestigioso. Quello qui recensito è il suo primo libro di storia – per la precisione di storia economica – scritto a seguito di una curiosità evoluta in una vera e propria passione, come lui stesso ci spiega nell’introduzione. Il tema, in effetti, è di quelli affascinanti, resi ancor più coinvolgenti da un dibattito molto vivace, che negli ultimi due o tre decenni ha portato studiosi più che autorevoli a schierarsi su posizioni anche molto distanti. Si tratta dell’unificazione d’Italia e degli aspetti economici legati a questo processo. In questa sede, nell’impossibilità di ripercorrere tutto il dibattito storiografico, ci li- 107 Biblioteca miteremo a chiarire che si sono via via fatte strada due interpretazioni differenti. La prima è quella che vede nel Regno di Sardegna una compagine più moderna e meglio attrezzata rispetto agli altri Stati italiani risorgimentali, forte di un apparato istituzionale, di un impianto giuridico, di un sistema di infrastrutture e soprattutto di un tessuto economico-produttivo nel complesso superiori a quelli del Regno delle due Sicilie, dello Stato della Chiesa o dei ducati tosco-emiliani. In tal senso, lo Stato Sabaudo esercitò un ruolo di drive, e una volta realizzata l’unità nazionale si adoperò per estendere le caratteristiche virtuose del Piemonte al resto d’Italia, uniformando la pubblica amministrazione, investendo nelle infrastrutture delle altre regioni, stimolando processi di istruzione e alfabetizzazione. La seconda interpretazione, invece, capovolge radicalmente questo approccio. L’Unità nazionale si sarebbe conseguita a beneficio del Regno di Sardegna e a spese di tutti gli altri Stati, compreso il Regno delle due Sicilie, che anzi pagò in assoluto gli oneri maggiori. Le politiche economiche e fiscali messe in campo all’indomani del 1861 avrebbero nei fatti penalizzato l’economia e la società meridionale, aggravando vari problemi sociali e interrompendo violentemente un percorso di modernizzazione che il Mezzogiorno continentale aveva autonomamente intrapreso. Vito Tanzi si colloca essenzialmente entro questa seconda compagine – a volte definita «meridionalista» o anche, nelle interpretazioni più radicali, «controrisorgimentale» – se non altro perché l’obiettivo della sua analisi è dimostrare che il Regno di Sardegna fu salvato dal fallimento grazie all’unificazione, poiché poté trasferire il suo debito pubblico sul resto del paese. Sulla base della documentazione utilizzata, Tanzi ci spiega che la classe dirigente sabauda scelse un modello politico-amministrativo centralista che finì per penalizzare le regioni meridionali, mentre un assetto maggiormente federativo avrebbe potuto portare ad un processo più graduale e indolore, e ad una sostanziale attenuazione della «questione meridionale». Si tratta di un libro che vivacizza un poco il dibattito, e lo aggiorna nei limiti di presentare alcune fonti inedite. Pessima la veste redazionale dell’editore Grantorino, che non ha promosso al- cun adeguato intervento di omogeneizzazione e revisione del testo, continuamente caratterizzato da refusi e da differenti criteri stilistici. In questo compito, l’autore è stato evidentemente (e colpevolmente) lasciato solo. Tito Menzani Leonardo Varasano, L’Umbria in camicia nera (1922-1943), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, pp. 588. Sui motivi che suggeriscono di continuare a studiare il fascismo locale si sofferma Alessandro Campi nell’introduzione di questo robusto volume, osservando che dietro l’apparente immobilismo della società umbra il regime fascista introduceva elementi innovativi «e persino modernizzatori», che contribuivano lentamente ma stabilmente a mutare lo scenario locale. La relazione storiografica tra locale e nazionale in età fascista è racchiusa in questa apparente contraddizione, che se consideriamo bene attraversa l’intera vicenda nazionale. Da un lato il panorama locale appare caratterizzato da elementi di staticità assai più marcati rispetto al dato nazionale; dall’altro lato le graduali trasformazioni degli assetti sociali ed economici locali sopravvivono meglio ai passaggi di regime politico. In sintesi possiamo dire che la provincia italiana è senz’altro più ritrosa ad assorbire le spinte innovative, ma anche meno soggetta ad oscillazioni e cambiamenti improvvisi di rotta. L’Umbria costituisce inoltre un terreno di verifica particolarmente interessante di questa dialettica locale-nazionale, a causa soprattutto del suo isolamento dalle vie di comunicazione nazionali che, unitamente alla sua posizione centrale nell’asse peninsulare, conferisce a questa regione un ruolo al tempo stesso strategico e periferico nelle vicende del fascismo. Se qui veniva collocato il quartier generale per la marcia su Roma, dopo che lo squadrismo umbro aveva offerto ampia testimonianza della sua dedizione alla causa, l’esaurirsi dell’onda d’urto rivoluzionaria determinava subito dopo una chiusura del fascismo umbro nel suo orizzonte provinciale. Non a 108 Biblioteca caso la stessa ricerca di Varasano, particolarmente attenta e originale nella ricostruzione degli elementi di formazione della nuova società politica, sembra poi procedere in maniera assai più sbrigativa allorché il fascismo degli anni Trenta giunge a un consolidamento che nella realtà locale si confonde spesso con un rinnovato immobilismo della classe politica e un più scarso dinamismo della vita sociale. In questo caso conveniva forse puntare l’osservazione sui livelli di partecipazione della società umbra alle vicende nazionali, anziché sulle strutture territoriali del regime. Sarebbe stato utile, per fare solo un esempio, approfondire le oscillazioni del consenso registrabili in passaggi cruciali come la questione concordataria, l’impresa coloniale oppure la guerra mondiale (cui il volume dedica uno spazio forse troppo marginale), mentre il sovraccarico della retorica ufficiale non consente di discernere agevolmente tra opere del regime, magniloquenza della propaganda e realizzazioni concrete. Nelle documentate pagine dedicate al problema delle vie di comunicazione – problema quanto mai essenziale in un territorio come quello umbro – Varasano ha però modo di osservare che degli ambiziosi progetti iniziali fu portata a compimento la sola tratta SpoletoNorcia, iniziata per altro nel lontano 1913. In realtà per poter cogliere il senso più profondo delle trasformazioni intervenute in una simile realtà locale occorrerebbe pensare a una storia del fascismo senza il condizionamento dei fascisti, vale a dire sottraendosi al rendiconto necessariamente ripetitivo della vita interna di ognuno degli apparati di regime. Non mancano anche in questo volume angolazioni interessanti e opportunamente fuorvianti rispetto alla linea ufficiale (per citare due casi del tutto diversi: le pagine dedicate alla resistenza morale di Capitini e la vicenda operaia della Terni), ma la politica del regime appiattisce in pochi anni l’orizzonte politico in una uniformità senza apparenti vie di uscita. Tullio Cianetti, uno degli uomini nuovi del fascismo umbro, aveva avvertito anzitempo tale pericolo: «Un giovane partito, formato di giovani, rimarrà compatto fin tanto che esisteranno i pericoli e la lotta per la conquista del potere, ma la compattezza diminuirà man mano che gli uomini vincitori si adageranno sugli allori anche se sono animati dal migliore slancio rivoluzionario». Quando i fascisti invecchiano, per dirla con Brancati, anche il «migliore slancio rivoluzionario» diventa un lenitivo retorico per reduci della prima ora e opportunisti di più recente conversione, mentre la politica chiede dietro a sé ogni stimolo di innovazione. Paolo Varvaro Storia delle relazioni internazionali Nancy Bernkopf Tucker, The China Threat: Memories, Myths, and Realities in the 1950s, New York, Columbia University Press, 2012, pp. 312. Nancy Tucker è stata una delle principali analiste delle relazioni sino-americane e tra le pochissime che hanno focalizzato l’attenzione non solo sulla Repubblica Popolare Cinese ma anche su Taiwan e Hong Kong. Questo, purtroppo, è e rimarrà il suo ultimo libro: Tucker è morta nel dicembre 2012. Il volume inizia con un’analisi dei principali policymaker statunitensi e cinesi e del contesto in cui adottano le loro decisioni di governo, proseguendo poi con una valutazione delle politiche attuali. Il libro presenta uno stile franco e diretto ed è impreziosito da una splendida selezione di vignette sulla politica contemporanea. Da Tucker apprendiamo che il presidente Eisenhower e il suo segretario di Stato, John Foster Dulles, erano nel complesso più interessati all’Europa che all’Asia. I problemi sollevati dalla Cina venivano considerati tutt’al più distrazioni, che ricadevano sull’amministrazione in virtù della pressione esercitata da inopportuni sostenitori dei Nazionalisti cinesi residenti sul suolo americano e dalle iniziative degli stessi cinesi. L’Eisenhower descritto da Tucker appare «intrappolato dal suo tempo», prono a un’opinione pubblica che si presumeva essere profondamente ostile alla Cina e refrattario a mettere a rischio interessi più vicini alle sue reali preoccupazioni in seguito a un’eventuale svolta in politica estera. Alla luce del ritratto che Tucker ci offre di un presidente tutto sommato benevolo, pragmatico e in qualche modo confusionario, sorprende poi scoprire che Eisenhower minacciasse sovente di usare la forza, perfino le armi nucleari, brandite durante i negoziati per l’armistizio nella Guerra di Corea. Non che avesse reali intenzioni di usarle, ma 109 Biblioteca riteneva che le minacce potessero volgere a proprio vantaggio i negoziati. Che ciò poi non si realizzasse è, secondo Tucker, irrilevante. L’A. descrive la politica complessiva di Eisenhower come desiderosa di mantenere «fredda» la cold war. Un proposito che tuttavia non escludeva il rovesciamento di governi democraticamente eletti in Iran e Guatemala, il sostegno per la diffusione di attività paramilitari a sfondo anticomunista e la guerra psicologica, nonostante le forme «calde» di repressione che tali iniziative producevano. Quando il governo cinese rispose alla fortificazione delle isole di Jinmen e Quemoy, situate in acque internazionali, bombardandole, Eisenhower interpretò tale gesto come un atto di aggressione, equivocando così quello che dopo tutto era la risposta a una provocazione. Certo, Mao non comprese a sua volta Eisenhower, immaginando che un’esibizione di forza avrebbe dissuaso gli Stati Uniti dal firmare un trattato di mutua difesa con Taiwan, quando invece un qualsiasi attento osservatore della politica americana avrebbe potuto dirgli che l’effetto sarebbe stato esattamente l’opposto. Il resoconto che Tucker fornisce delle crisi dello Stretto di Taiwan – materia di un precedente studio, Strait Talk: United StatesTaiwan Relations and the Crisis with China – è persuasivo: ciascuno dei contendenti inclini ad evitare la guerra ma senza mai apparire deboli, cosa che però finiva per produrre uno stato di tensione massima. Ad ogni modo, è la conclusione di Tucker, gli anni di Eisenhower furono l’inizio di una «lenta transizione verso un approccio più realistico e flessibile». Si allentarono le sanzioni statunitensi nell’ambito del commercio internazionale, iniziarono i primi contatti diplomatici e, nonostante ne esistessero le condizioni, non ci fu nessuna guerra. Ciò che risulta poco convincente nell’analisi di Tucker è la ripetuta imputazione alla politica interna dei fallimenti dell’amministrazione nell’elaborare una politica più intelligente nei confronti della Cina. Si tratta di una spiegazione che necessita di una valutazione più attenta. Non è per esempio così evidente che Eisenhower avrebbe pagato un prezzo politico pesante per fare quello che Nixon avrebbe fatto venti anni dopo. E anche se lo avesse fatto, ne sarebbe valsa la pena? Marilyn B. Young James Hevia, The Imperial Security State. British Colonial Knowledge and EmpireBuilding in Asia, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2012, pp. 304. Il libro di Hevia si inserisce autorevolmente nella vasta bibliografia sulla storia del colonialismo britannico in Asia. Pur riferendosi costantemente ai classici sulla materia (Bernard Cohn, Christopher Bayly, Christopher Andrew, David Dilks, per citare solo i più recenti), Hevia innova il tradizionale approccio alla materia, facendo ricorso ad una dimensione dell’imperialismo britannico poco nota e soprattutto sottostimata. Le sue fonti privilegiate sono, infatti, i numerosi rapporti militari e informativi che furono prodotti nel lungo, importante periodo che va dal 1880 al 1940, quando si avvertirono i primi scricchiolii nel gigantesco apparato imperiale di Londra. In sostanza, Hevia ritiene che il flusso di informazioni sui più svariati aspetti della presenza britannica in Asia, che l’intelligence militare britannica inviò alla madrepatria, costituì un elemento conoscitivo prezioso per la conservazione della saldezza dell’impero asiatico di Londra. Tali informazioni, redatte in forme standardizzate e perciò ora facilmente individuabili e consultabili, costituiscono un corpus prezioso di documentazione archivistica di alto valore storico, che Hevia ha consultato e studiato. Dal punto di vista della politica internazionale tra la fine dell’Ottocento e la Prima guerra mondiale, la documentazione considerata da Hevia ripropone il vecchio ma cruciale problema del Great Game russo-britannico in Asia Centrale, dove appunto il servizio informativo militare di Londra giocò un ruolo fondamentale nel ricacciare indietro le mire di Mosca verso territori strategicamente vitali per la conservazione dell’impero asiatico britanni- 110 Biblioteca co. Hevia giustamente rileva come la modernità dei sistemi informativi di Londra ebbe la meglio sugli antiquati metodi della Russia zarista. In particolare, subentrò nell’intelligence militare britannica una nuova concezione geo-strategica, in virtù della quale l’apparato militare coloniale dovesse essere considerato in termini unitari, non frammentati, così da istituire linee di comunicazione attive tra le colonie asiatiche grazie alle innovazioni tecnologiche che Londra era in grado di mettere in campo. La rivoluzione industriale inglese del secolo precedente ebbe un ruolo decisivo nella ristrutturazione, razionalizzazione e professionalizzazione dell’apparato militare e informativo britannico nell’impero. In particolare, Hevia sottolinea come, per ottenere risultati qualitativamente importanti, occorresse «un’entità permanente in grado di monitorare, sistematizzare, trasmettere e applicare le più recenti scoperte scientifiche nel campo della tecnologia e dell’utilizzo delle informazioni» (p. 20). Perciò, fu necessario abilitare un gruppo di specialisti all’integrazione delle nuove tecnologie nell’apparato militare e alla pianificazione delle guerre future. L’ultima parte dell’ottimo libro di Hevia è dedicata ai riflessi che sull’opinione pubblica inglese ebbero le innovazioni tecnologiche volte alla conservazione e forse all’ampliamento dell’impero. Quest’ultima prospettiva allarmava coloro che vedevano nell’imperialismo del proprio paese l’esatto contrario di una vera democrazia e dei principi liberali che l’avevano innervata, per non parlare dei costi umani e materiali che tale impresa implicava. L’ultimo quarto dell’Ottocento vide l’ampliarsi in Gran Bretagna della discussione pubblica su tale argomento. Soprattutto dopo la fine della prima guerra mondiale, sull’onda della vittoria, molti inglesi ritennero che il «fardello dell’uomo bianco» potesse essere ancora sostenuto per la maggior gloria dell’impero britannico. Ma, prima della Grande Guerra, per Londra si trattava ormai di confrontarsi con nuove potenze in ascesa, come la Germania e il Giappone. Lo stratega americano Alfred Thayer Mahan, esaminando la situazione geo-politica mondiale e giudicando esaurito il Great Game con la Russia zarista, riteneva che l’impero asiatico britannico avesse ancora la funzione strategica di preservare l’Asia Centrale e la Cina dalle mire imperialistiche di Giappone e Germania, la cui tendenza espansionistica, para- dossalmente, «era in parte legata alla stabilità regionale assicurata dalla Gran Bretagna» (p. 252). Antonio Donno Gregory D. Miller, The Shadow of the Past. Reputation and Military Alliances before the First World War, Ithaca-London, Cornell University Press, 2012, pp. 234. L’interdisciplinarietà, quando non è una parola usata per pavoneggiarsi nei convegni, può produrre risultati interessanti o comunque meritevoli di attenzione. Il libro di Gregory D. Miller non è un libro di storia in senso proprio; è invece un libro che usa la storia per mettere a fuoco un problema che attiene alla teoria delle relazioni internazionali. Ancora, poi, l’analogia tematica che sta alla base della riflessione dell’autore è mutuata più che dall’economia in senso stretto dalla teoria aziendale. Da alcuni anni, sempre più spesso, in molte ditte industriali e commerciali le «public relations» tendono a essere sostituite dal cosiddetto «reputation management». Si ritiene, infatti, che per la prosperità delle aziende, più che la suasiva capacità di tessere buoni rapporti con clienti e fornitori, conti l’affidabilità della ditta, la coerenza complessiva delle scelte compiute nel corso degli anni. Miller applica queste nozioni allo studio delle relazioni internazionali, ritenendo che anche per gli Stati la reputazione acquisita nel tempo sia un fattore essenziale per massimizzare i benefici ottenibili in politica estera. Certo, l’autore è consapevole che non esiste una perfetta corrispondenza tra mercato e relazioni tra Stati, ma ritiene che le analogie indubbiamente presenti consentano di mutuare proficuamente dei parametri valutativi passibili di applicazione. Peraltro l’importanza per gli Stati di mantenere una buona reputazione non è una scoperta del tutto nuova, ma è già stata notata in passato non solo da studiosi di politica estera, ma anche da classici della politica tout court. A tal proposito Miller non manca di allineare alcune citazioni machiavelliane, sottolineando come il segretario fiorentino distingua, nell’ambito della 111 Biblioteca buona reputazione degli Stati, la fermezza nelle decisioni e l’affidabilità in senso proprio. Il periodo preso in esame va dall’inizio del Novecento al 1914, subito prima dello scoppio della Grande Guerra. In sostanza gli anni centrali della belle époque, quando le capacità negoziali e la rodata esperienza delle diplomazie europee riuscirono a lungo ad evitare che le tensioni tra le varie potenze degenerassero in modo irreparabile. In particolare la materia viene periodizzata in quattro fasi. La fine dello splendido isolamento britannico (1901-1905); la prima crisi marocchina (1904-1907); la crisi della Bosnia Erzegovina (1907-1911); la crisi di Agadir (1910-1914), che precede di poco l’inizio del primo conflitto mondiale. A ciascuna fase è dedicato un capitolo, non strutturato come un racconto unitario, bensì come una sintesi delle ragioni che orientano le scelte dei principali attori nazionali coinvolti. Una ricostruzione in cui ha un ruolo centrale la percezione che ogni nazione ha dell’affidabilità delle altre. L’analisi è condotta con precisione e l’autore tende a valorizzare la sua tesi centrale, ma l’importanza della reputazione per la stipula di alleanze vantaggiose, non dimentica altri fattori (potenza, interesse, geografia) che possono sopravanzare quell’aspetto nel calcolo politico complessivo. Peraltro, poi, Miller non manca di sottolineare un aspetto che, nel periodo indagato assume una rilevanza particolare. Gli Stati che hanno una maggiore possibilità di scelta tra vari alleati, come la Gran Bretagna, possono tenere conto anche dell’affidabilità; per converso le potenze che non hanno davanti a sé un ampio ventaglio di opzioni, come l’Austria-Ungheria, debbono necessariamente rimanere nell’ambito delle alleanze già stipulate, senza potersi preoccupare della credibilità dei partner. Maurizio Griffo Robert B. Rakove, Kennedy, Johnson, and the Nonaligned World, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, pp. 292. Sebbene sia la politica interna che quella internazionale dei due presidenti americani degli anni Sessanta, Kennedy e Johnson, continuino a ispirare un numero impressionante di biografie e saggi, Robert Rakove ritiene di aver individuato un angolo innovativo. Nel suo primo libro egli analizza il modo in cui i due presidenti, assieme ai loro principali collaboratori in politica estera, hanno reagito all’affermarsi di nuovi leader dei paesi decolonizzati; in particolare all’ascesa di quei leader nazionalisti che contribuirono alla nascita del Movimento dei Non Allineati e fecero del non schierarsi con nessuna delle due Superpotenze il fulcro della propria azione internazionale. Il risultato di una ricerca puntigliosa condotta su un numero rilevante di fonti archivistiche anche non statunitensi – che però giocano un ruolo marginale e ancillare rispetto alle tradizionali fonti diplomatiche – può essere così sintetizzato. Kennedy, anche sfruttando appieno le possibilità offerte dalla diplomazia personale e il fascino di leader giovane e idealista, riuscì a instaurare rapporti veri e profondi con i leader di paesi come l’India, l’Egitto, l’Indonesia e il Ghana, il cui rifiuto del passato colonialismo li portava a rivendicare l’indipendenza dai blocchi e cooperare sul piano internazionale per salvaguardare la propria autonomia. Rakove definisce questo nuovo approccio kennediano «engagement»: non solo elasticità politica ma anche atipici contributi allo sviluppo economico quali il finanziamento della centrale idroelettrica sul Volta nel Ghana di Nrkumah e dell’acciaieria di Bokaro nell’India di Nehru. Questa politica sarebbe sostanzialmente fallita dopo l’assassinio di JFK, sia a causa della diversa strategia internazionale di Johnson, maggiormente fondata sul premiare gli alleati che sull’incoraggiare i Non Allineati, sia per il crescente impegno militare in Vietnam che progressivamente assimilò gli Stati Uniti a una nuova potenza imperialista, sia per l’incapacità statunitense di distaccarsi in Africa dal supporto al colonialismo portoghese e, in generale, a governi reazionari quando non apertamente razzisti. Il libro potrebbe ascriversi a quel filone di studi sulla politica internazionale degli Stati Uniti, e in generale sulla Guerra fredda, che cerca di aprire orizzonti oltre lo scontro fra le due superpotenze. Rakove si richiama esplicitamente alla lezione di Westad nel suo The Global Cold War in cui si descrive la battaglia ideologica e militare di 112 Biblioteca Washington e Mosca per la conquista del cuore e delle menti dei cittadini del Terzo Mondo. Rispetto alle tesi di Westad, Rakove, sebbene non lo affermi esplicitamente, compie uno sforzo ulteriore nel prendere sul serio le leadership dei paesi di nuova indipendenza e il loro tentativo di instaurare una diplomazia parallela. Particolarmente interessanti e lucide risultano infatti quelle parti del volume in cui si tracciano le origini della solidarietà afroasiatica con la conferenza di Bandung nel 1955, il parallelo emergere del Non Allineamento con la conferenza di Belgrado nel 1961, il definitivo eclissarsi del progetto afro-asiatico sostenuto dalla Cina e fondato su una lotta mondiale all’imperialismo con il fallimento della Bandung II ad Algeri nel 1965, e infine la conseguente ripresa del progetto più «riformista» del Non Allineamento. Su quel che Rakove scrive c’è assai poco da discutere. Più rilevanti alcune omissioni che tenderebbero a far sfumare il giudizio riguardo la portata dell’innovazione kennediana. In primo luogo non c’è nessun riferimento al finanziamento che Kennedy approvò a oltre cento operazioni «sotto copertura» per sovvertire governi di paesi stranieri non solo in America Latina. In secondo luogo la portata dell’innovazione sul piano degli aiuti allo sviluppo non è realmente discussa nel dettaglio e risulta pertanto poco o per nulla convincente. Giuliano Garavini Peter Romijn, Giles ScottSmith, Joes Segal (eds.), Divided Dreamworlds? The Cultural Cold War in East and West, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2012, pp. 240. Il filo conduttore dei saggi qui raccolti è costituito dai «mondi di sogno», dalle utopie e dalle proiezioni ideali prodotte collettivamente in ragione della (o nonostante la) Guerra fredda, intesa come scontro tra culture e ideologie. Il libro è frutto di un lungo lavoro di gestazione e selezione che i tre curatori hanno condotto sin dal 2008, anno in cui l’Università di Utrecht ha ospitato una conferenza che ha fornito la cornice concettuale e i casi di studio confluiti nel volume. Quest’ultimo si divide in tre parti, conformi ad altrettanti intenti dei curatori: illustrare come arti e scienze abbiano conosciuto fenomeni di trasferimento, circolazione e influenza persino nelle fasi in cui la cortina di ferro sembrava opporre un’insormontabile barriera culturale oltreché fisica; ribadire attraverso gli esempi quanto il conflitto bipolare sia stato presentato a lungo anche come una sfida tra modelli alternativi di una «modernità» che entrambi i campi rivendicavano; e infine ricordare quanto l’uso pubblico della storia da parte di autorità ufficiali dopo il 1989 abbia contribuito tanto a plasmare la nostra percezione del passato, quanto a influenzare la diplomazia culturale anche nel contesto geopolitico in mutamento. Il volume denuncia una notevole eterogeneità tra i contributi, che il comune richiamo alla «nuova storia culturale della Guerra fredda» non riesce a limitare; questo nonostante l’elevata qualità media dei saggi, con alcune punte di eccellenza. Certamente notevole è l’odissea letteraria di Arthur Miller ricostruita da Nathan Abrams: uno scrittore impegnato nella difesa della libertà dell’arte e per questo alternativamente blandito o ricusato dai due blocchi, a seconda che prevalesse la critica all’arruolamento della cultura nella Guerra fredda culturale di Washington o la condanna delle censure di regime imposte da Mosca. La vicenda rivela in definitiva l’importanza primaria che le autorità attribuivano alla dimensione culturale della contrapposizione bipolare; allo stesso tempo, le difficoltà incontrate da Miller testimoniano quanto fossero ristretti per chiunque i margini di libertà intellettuale e di rifiuto delle categorizzazioni. Altrettanto interessante è il saggio di Marsha Siefert sulle politiche di co-produzione cinematografica tra paesi appartenenti ai due campi contrapposti. Più delle occasioni specifiche di collaborazione, la rilevanza del saggio risiede nell’approfondimento delle ragioni per cui tale politica di collaborazione era perseguita: dal fattore economico alla necessità di impedire che la contrapposizione ideologica imponesse un’eccessiva uniformazione culturale rispetto a Hollywood. Quanto ai miti contrapposti della modernità, Natalie Scholz e Milena Veenis illustrano diffusamente come entrambi i regimi politici tedeschi abbiano cercato di far propria la causa del «modernismo» come stile di arredamento, seppure per ragioni diverse e soprattutto con strategie 113 Biblioteca comunicative persino antitetiche. Tuttavia, la prova del comune interesse di entrambi contribuisce a minare la dicotomia tra modernismo e socialismo reale che rappresentava un tema standard nelle narrative sulla Guerra fredda culturale. Infine, il contributo di Justinian Jampol è un eccellente esempio di equilibrio tra testimonianza professionale e ricerca storico-culturale: egli stesso direttore del Wende Museum di Los Angeles, che raccoglie artefatti dell’epoca della Guerra fredda, Jampol illustra quanto le tecniche e le scelte politiche (in senso lato) di raccolta e riproposizione delle memorie e delle testimonianze condizionino inevitabilmente i successivi tentativi di ricostruzione storica; e come questo a sua volta influisca sulla memoria collettiva e sulle narrazioni ufficiali che hanno seguito la conclusione del conflitto bipolare. In definitiva, tuttavia, il volume rischia di non definire un proprio segmento di pubblico, data la varietà dei temi trattati; e poco convincente in tal senso risulta il tono dimostrativo e programmatico della prefazione, secondo cui i saggi dovrebbero contribuire a una profonda revisione del paradigma interpretativo del conflitto bipolare come irriducibile antagonismo tra «due blocchi monolitici che si confrontavano in un gioco a somma zero». Nel momento in cui il libro arriva all’attenzione dei lettori, si può affermare che una concezione ben più dinamica e problematica della Guerra fredda è divenuta ormai moneta corrente anche per buona parte degli studiosi dei fenomeni politici. Né questo volume, al di là dei suoi meriti, sarà sufficiente a persuadere chi dal proprio atollo storiografico continua a combattere una guerra ormai conclusa da tempo. Giovanni Bernardini Hans Stark, La politique internationale de l’Allemagne. Une puissance malgré elle, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2011, pp. 324. Basato su una ristretta selezione di monografie, saggi e articoli in lingua inglese e, soprattutto, francese e tedesca, il volume ricostruisce i primi vent’anni della politica estera della Germania riunificata. Attraverso una poco originale periodizzazione che fa coincidere le tappe di sviluppo della politica con le quattro formule di governo succedutesi nel periodo considerato, in particolare, il volume analizza il modo in cui la più grande potenza economica europea ha voluto, e saputo, interpretare le nuove condizioni e, di conseguenza, le nuove responsabilità derivanti dalla fine della Guerra fredda e dai cambiamenti della geopolitica mondiale. Se gli ultimi due governi di Helmut Kohl (1991-1998) furono segnati dalla volontà di affermare con maggior determinazione gli interessi nazionali tedeschi senza, però, mettere minimamente in discussione i pilastri dell’europeismo e dell’atlantismo, il primo (1998-2002) e, soprattutto, il secondo (2002-2005) governo di Gerhard Schröder si mossero secondo logiche più autonome rispetto ai tradizionali condizionamenti storici e geopolitici. Pur riconoscendo il valore degli impegni e delle alleanze internazionali del paese, infatti, il cancelliere Schröder puntò a sviluppare una politica estera basata sul presupposto della «normalità» della nazione e dello Stato tedesco e, quindi, sul diritto della Germania a tutelare i propri interessi, e promuovere i propri valori, su un piano di parità rispetto alle principali potenze mondiali. L’europeismo, alimentato dalle convinzioni federaliste dell’influente ministro degli Affari Esteri Joschka Fischer, rimase un cardine della politica estera tedesca ma, sulla scorta degli avvertimenti della Corte costituzionale, delle resistenze delle autorità regionali e dei sentimenti euro-scettici di una parte crescente dell’opinione pubblica, il governo di Berlino non rinunciò a esprimere e far valere un proprio punto di vista, orientato da considerazioni e interessi orgogliosamente nazionali, in materia di contributo tedesco all’Unione Europea, di riforma della Politica Agricola Comune, e di ridefinizione dell’assetto istituzionale comunitario. Allo stesso tempo, senza che venisse esplicitamente ritirato, il sostegno tedesco all’Alleanza Atlantica e, in particolare, agli Stati Uniti fu contraddetto dagli sforzi condotti da Berlino per realizzare un autonomo pilastro europeo in materia di sicurezza e difesa e, soprattutto, dalla clamorosa rottura diplo- 114 Biblioteca matica consumatasi tra Berlino e Washington su strumenti e obiettivi della guerra al terrorismo e sulla scelta statunitense di attaccare e invadere l’Iraq. Infine, sia il tradizionale europeismo sia il tradizionale atlantismo tedeschi vennero messi a dura prova dal controverso partenariato strategico stretto con la Russia di Vladimir Putin e, per altri versi, dalla tenace, e fallimentare, battaglia per ottenere un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La grande coalizione guidata da Angela Merkel (2005-2009) si mosse, nonostante gli originari proclami dei cristiano-democratici e, soprattutto, dei cristiano-sociali, su una linea di sostanziale continuità con la politica estera condotta dai governi rosso-verdi. Complice la presenza di Frank-Walter Steinmeier, braccio destro dell’ex-cancelliere Schröder, al vertice del Ministero degli Affari Esteri, il governo tedesco continuò a coltivare un europeismo estremamente attento alla difesa degli interessi nazionali, soprattutto in materia economico-finanziaria, una linea atlantica non priva di momenti dialettici e, persino, conflittuali con gli Stati Uniti, soprattutto riguardo alla gestione politico-militare del processo di stabilizzazione in Afghanistan e, a sorpresa, un orientamento pro-russo che non mancò di rafforzare incomprensioni, e tensioni, con i vicini dell’Europa centro-orientale, a cominciare dalla Polonia. Dominato, da una parte, dalla crisi dell’euro e dell’euro-zona e, dall’altra, dalla crisi libica, il secondo mandato di Angela Merkel (2009-), questa volta alla testa di una coalizione di centro-destra, è sembrato infine segnato dalla difficoltà e, in una certa misura, dalla riluttanza a conciliare il ruolo di grande potenza economica e le responsabilità finanziarie, politiche e persino militari che da questo conseguono. Utile compendio alla comprensione e allo studio della recente politica estera tedesca, il volume si distingue per una curiosa propensione a considerare la Germania anti-europea quando si oppone alle scelte francesi, anti-atlantica quando si oppone alle scelte statunitensi e, in generale, nazionalista, e irresponsabile, quando si oppone alla scelta di partecipare alle missioni militari. Simone Paoli Americhe Jason M. Colby, The Business of Empire. United Fruit, Race, and U.S. Expansion in Central America, Ithaca, Cornell University Press, 2011, pp. 288. Il volume di Jason Colby s’inserisce in un filone di ricerca consolidato, che analizza i nessi tra l’espansionismo statunitense e l’azione di grandi imprese private in America Centrale tra gli ultimi decenni dell’Ottocento e gli anni della Grande Depressione, nel passaggio tra capitale britannico e nordamericano, qui descritto in termini molto concreti. S’innesta in una sorta di «storia sociale dell’impero», che ha beneficiato sinora soprattutto di studi locali sul canale di Panama e sulla base di Guantanamo. Protagonista è la United Fruit Company (UFCO) nelle sue politiche di «razzializzazione» e segmentazione della forza lavoro impiegata. Tra il 1870 e le prime due decadi del Novecento infatti, alla forza lavoro nera – anglofona, essenzialmente giamaicana ed ereditata dal sistema britannico – viene progressivamente incorporata la componente ispanica. È questa un’operazione che, sebbene provocata anche da pressioni locali e inizialmente funzionale a un divide et impera dei lavoratori, produrrà tensioni sociali e razziali di non facile gestione. I lavoratori neri – parte integrante della «modernizzazione» statunitense, cui le élite centroamericane facevano grande affidamento – non godevano più, nelle enclaves della UFCO, della precedente retorica «inclusiva», bensì risentivano di una cultura razzista ed escludente apparentemente simile a quella del Sud statunitense, ma che in realtà affondava le sue radici anche nella mentalità schiavista coloniale spagnola. E sebbene accolti con grande slancio a fine Ottocento finiscono di fatto per allarmare i notabili locali, che si fanno espressione, specialmente negli anni precedenti alla Grande Depressione, di slanci nazionalisti e protezionisti verso eventuali minacce di «degradazione razziale», oltre che portavoce indiretti del 115 Biblioteca malcontento della forza lavoro ispanica, sua diretta rivale. I due casi di studio prescelti, antipodali nelle loro «alchimie razziali», sono il Costa Rica e il Guatemala, paesi in cui la UFCO si espande rapidamente e in maniera capillare. L’uno più pacifico, con poche tensioni razziali, un sistema di opinione pubblica piuttosto libero che presto denuncerà le mire imperialistiche statunitensi. L’altro, dominato dalla violenza politica, con una classe dirigente ossessionata dal separare la forza lavoro indigena da quella dei ladinos bianchi. L’esito sarà comunque simile, ovvero una netta restrizione nell’adozione di manodopera nera. Nel contesto più generale degli anni Trenta, dunque, Colby ipotizza che anche la UFCO adotterà localmente la sua «politica di buon vicinato». L’originalità del testo risiede sia nel metodo che nei contenuti. L’autore attinge da fonti provenienti da molteplici archivi, britannici, statunitensi e centroamericani, risolvendo con intuito le difficoltà di reperimento poste dalla stessa UFCO, che ai primi anni Ottanta ha praticamente distrutto la documentazione attinente alla regione latinoamericana. Articola inoltre un paradigma diffuso di lettura, che tendeva a vedere l’operato di queste multinazionali come obbediente alle direttive di Washington, ipotizzando invece come la cultura e le pratiche d’impresa hanno piuttosto forgiato, o quantomeno agito in sinergia paritaria, con gli imperativi della politica governativa. Inoltre, mette in relazione le politiche di segmentazione e riorganizzazione della forza lavoro con le dinamiche interne ai singoli casi paese. È questo un aspetto sottovalutato dalla storiografia, che, troppo spesso tendeva ad analizzare le dinamiche delle enclave bananeras come «bolle», isolate dai contesti locali; si sottovalutavano dunque le interazioni con le èlite nazionali, cruciali invece secondo Colby nel determinare vere e proprie virate nella costruzione dell’impero nel «cortile di casa» centroamericano. Benedetta Calandra Gregory A. Daddis, No Sure Victory. Measuring U.S. Army Effectiveness and Progress in the Vietnam War, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 334. Sappiamo che gli americani interpretarono il loro impegno militare in Vietnam come una guerra industriale, di logoramento, in cui il crescente impiego di uomini e materiali avrebbe condotto un nemico più debole all’inevitabile punto di rottura. Appare paradigmatico che a sovrintendere all’apparato bellico statunitense vi fosse un uomo della Ford, Robert McNamara. Come è noto, le cose non andarono nel senso contemplato dal paradigma fordista. Nonostante le numerose vittorie e le gravi perdite inflitte ai vietcong, alla fine gli americani dovettero alzare bandiera bianca. Ciò che è meno risaputo, e che il volume di Daddis illumina, è il modo in cui l’esercito statunitense diede vita nel corso del conflitto a un vasto sforzo di misurazione dei risultati ottenuti sul campo, raccogliendo una impressionante mole di dati sui più diversi aspetti della guerra. Si trattava, per certi versi, dell’applicazione all’ambito militare dei sistemi di valutazione delle strategie produttive e commerciali messe in atto dalle corporations, resi possibili dallo sviluppo dei calcolatori e della statistica. L’autore, attraverso un attento spoglio delle fonti militari, illustra e analizza documenti come i rapporti mensili dell’esercito intitolati Measurement of Progress. La sua conclusione è che all’abilità e all’accuratezza nel raccogliere i dati non corrispose un’analoga capacità a elaborarli in un quadro coerente e a trarne quindi una lezione realistica. In mancanza di criteri chiari per leggere le cifre, l’attività di misurazione divenne fine a se stessa. Il risultato fu che i vertici politico-militari gestirono la guerra senza mai avere una cognizione adeguata del suo andamento. Emerse tutta la difficoltà di valutare il grado di efficacia delle operazioni antiguerriglia, contro un nemico irregolare e sfuggente. L’esperienza accumulata dagli analisti dell’esercito durante la Seconda Guerra mondiale, che pure aveva visto un’imponente opera di studio e raccolta dati da parte americana, si rivelò all’atto pratico un precedente poco utile. Questa volta non si combatteva un conflitto simmetrico contro forze 116 Biblioteca ben identificabili come quelle tedesche: non vi era un fronte da sfondare, occupare un territorio non voleva dire aver progredito verso la vittoria finale. Chiaramente, non era solo un problema matematico di elaborazione delle cifre raccolte, ma soprattutto un problema culturale di comprendere il tipo di conflitto che si stava combattendo e la visione del mondo dei propri avversari. Condizionati dal modello della guerra industriale, gli americani sottovalutarono l’asimmetria nelle forze e in quello che i due contendenti erano disposti a soffrire prima di arrendersi. Un’altra questione evidenziata dall’autore è che non si stabilì un legame funzionale fra le raccolte statistiche e i diversi modelli operativi messi in opera, dalle operazioni Search and Destroy all’attività difensiva nelle aree «bonificate» dai guerriglieri. Invece, l’analisi dei dati e ancora prima la scelta di quali aspetti era utile misurare sarebbero dovute avvenire in stretta correlazione con specifiche forme di contrasto della guerriglia. Così non fu, e a tale esito concorsero sia interrogativi irrisolti sul tipo di guerra più efficace da combattere, sia la forza culturale della visione fordista sopra richiamata. Il volume ha suscitato un’ampia discussione, travalicando i confini accademici e interagendo con la stretta contemporaneità. Esso, infatti, presenta delle chiare implicazioni rispetto alle guerre asimmetriche che le forze armate americane si sono trovate a combattere dopo l’11 settembre in Afghanistan e in Iraq, nel corso delle quali più volte è stata sottolineata la difficoltà nel comprendere se le operazioni attuate stessero più o meno avvicinando la vittoria. Forse, come nel caso del Vietnam, la volontà politica di presentare un quadro ottimistico all’opinione pubblica americana ha condizionato il modo di gestire i calcoli statistici. Gianluca Fiocco Donna R. Gabaccia, Foreign Relations. Ameri������ can Immigration in Global Perspective, Princeton, Princeton University Press, 2012, pp. 272. In base al principio che le nazioni sovrane debbano decidere in piena autonomia chi ammettere nel proprio territorio, dalla fine dell’Ottocento gli Stati Uniti hanno rivendicato il diritto a considerare l’immigrazione come una questione di esclusiva pertinenza della politica interna americana. Tale posizione ha finito per condizionare anche gli storici che hanno, perciò, rivelato la tendenza a esaminare i flussi di individui diretti negli Stati Uniti al di fuori del contesto dei rapporti internazionali di Washington. La concisa sintesi di Donna R. Gabaccia intende superare questo orientamento negli studi per proporre una lettura della plurisecolare immigrazione negli Stati Uniti in una prospettiva globale. L’autrice ripercorre le diverse fasi della gestione di tale fenomeno, dal periodo tardo coloniale alle odierne polemiche legislative, ricorrendo spesso alla presentazione di singole storie di vita esemplificative delle esperienze dei migranti e delle loro famiglie transnazionali. In particolare, il volume mette in luce come, a partire dall’ultimo ventennio dell’Ottocento, il Congresso abbia rafforzato le sue prerogative in materia di regolamentazione dell’immigrazione, scorporando questi aspetti dalla negoziazione dei trattati internazionali di competenza del potere esecutivo. Pertanto, il controllo dei flussi è venuto a ricadere nell’ambito della politica interna, ponendo le premesse per la successiva legislazione restrizionista scaturita dalle pressioni degli xenofobi nel primo dopoguerra. Tale andamento è culminato nel 1994 con la stipula del North American Free Trade Agreement che, alla libera circolazione delle merci e dei capitali tra Canada, Stati Uniti e Messico, non ha fatto corrispondere quella delle persone. Più che nella specifica ricostruzione di questi sviluppi, il contributo più rilevante della monografia risiede soprattutto nella novità del paradigma interpretativo. Per l’A., la questione dell’immigrazione negli Stati Uniti costituisce la risultante dell’interazione tra i meccanismi istituzionali dall’alto, rappresentati specialmente dalle relazioni internazionali di Washington, e le dinamiche dal basso, funzione dei rapporti che i membri dei diversi gruppi nazionali americani hanno mantenuto con la terra d’origine. Così, per esempio, da un lato, alla fine del Settecento e per gran parte dell’Ottocento i flussi migratori in entrata si giovarono dell’espansionismo economico americano e della diplomazia che lo sostenne, poi- 117 Biblioteca ché alcuni trattati bilaterali stabilirono la libertà di ingresso negli Stati Uniti per i cittadini delle nazioni con cui Washington intratteneva scambi commerciali. Dall’altro, i naturalizzati americani hanno sempre cercato di influenzare la legislazione sull’immigrazione, principalmente per favorire i ricongiungimenti familiari. In realtà, hanno pure provato a condizionare la politica estera statunitense verso i paesi d’origine, ma il libro sorvola su questi tentativi. La dimostrazione che gli immigrati mantengono forti legami con la terra ancestrale allinea Foreign Relations alle conclusioni di studi precedenti nel mettere in discussione la caratterizzazione della società statunitense in termini di melting pot. Inoltre, l’enfasi su come chi è soggetto alle politiche immigratorie sia consapevole che a determinare tali disposizioni sono gli Stati nazionali confuta l’ipotesi che proprio il declino di questi ultimi in un mondo globalizzato si collochi all’origine del transnazionalismo dei migranti, cioè della loro capacità di condurre un’esistenza sospesa tra la madrepatria e la società adottiva. Meno persuasiva risulta, invece, l’A. quando utilizza l’esito della sua riflessione per indicare una via per il superamento dell’odierna impasse legislativa al Congresso sulla riforma dell’immigrazione, un campo che sfugge fatalmente all’indagine storiografica. Stefano Luconi James T. Kloppenberg, Reading Obama. Dreams, Hope, and the American Political Tradition, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2011, pp. 302. Si pone obiettivi ambiziosi James T. Kloppenberg nella prefazione all’edizione economica di Reading Obama: spiegare «come e perché Barack Obama è diventato il campione di moderazione che abbiamo visto finora alla Casa Bianca», e «perché preferisce la conciliazione alla provocazione». Ma è lo stesso studioso di Harvard, tra i più influenti storici delle idee nel panorama statunitense, a contenere poco più avanti le attese del lettore: il volume colloca le origini della visione obamiana della politica nell’alveo della tradizione del pragmatismo americano, tuttavia «queste idee non spiegano tutto su di lui» e sul suo operato. Altri fattori hanno un peso rilevante, come il carattere, la famiglia e l’educazione del Presidente, lo stato delle relazioni razziali nel Paese, la vita politica di Chicago e le dinamiche istituzionali di Washington. Eppure, insiste Kloppenberg, le idee hanno avuto una grande importanza nella vita di Obama fin dalla sua adolescenza. Attraverso un esame attento dei suoi scritti e discorsi, l’autore conclude che Obama è «un intellettuale», una figura piuttosto rara nella storia dei Presidenti degli Stati Uniti, soprattutto negli ultimi decenni; in particolare, Kloppenberg sostiene che i due libri di Obama (I sogni di mio padre e L’audacia della speranza) devono essere considerati «le opere più significative scritte da una persona poi eletta alla presidenza degli Stati Uniti dai tempi di Woodrow Wilson». Per avvalorare le sue tesi l’autore insiste su tre elementi che innervano l’intera narrazione: il ruolo della filosofia pragmatista nella visione di Obama, il peso dei dibattiti accademici degli anni Ottanta e Novanta nella formazione intellettuale del quarantaquattresimo Presidente e, infine, la continuità della sua figura con la tradizione politica americana. Il pragmatismo – secondo Kloppenberg «il principale contributo americano alla tradizione filosofica occidentale», la cui elaborazione, negli ultimi decenni dell’Ottocento, si deve soprattutto a William James e John Dewey – ha avuto un ruolo decisivo nella costruzione delle politiche progressiste nel corso del Novecento. La filosofia pragmatista, infatti, sfida i dogmi – siano essi religiosi o scientifici – ed esalta il dubbio, la provvisorietà, la continua verifica delle ipotesi attraverso la sperimentazione. Si distingue in questo senso da quello che l’autore definisce «pragmatismo volgare», cioè «la brama istintiva di ciò che è possibile ottenere nel breve periodo». Al contrario, il pragmatismo filosofico è strettamente legato al metodo democratico, e la sua applicazione alla sfera sociale ha ispirato la nascita, nel contesto statunitense, di numerosi movimenti di riforma. Obama completa la sua formazione intellettuale – e qui siamo al secondo elemento analizzato dall’autore – nei due decenni in cui, negli Stati Uniti, il pragmatismo e lo storicismo prevalgono 118 Biblioteca sull’universalismo nei campi delle scienze umane e sociali. Di qui, secondo Kloppenberg, la visione di Obama della democrazia come «conversazione» e della Costituzione americana come base di una «democrazia deliberativa»; o, ancora, la consapevolezza della precarietà delle convinzioni individuali, anche di quelle più profonde, tanto che in una democrazia liberale e in una società pluralistica persino i credenti – e qui è l’Obama che si definisce «cristiano e scettico» a parlare – sono chiamati ad aprire le loro proposte al dibattito e alla ragione. Rappresentato dai suoi detrattori come essenzialmente estraneo ai principi che definiscono la nazione americana, Obama è in realtà profondamente radicato nella storia e nella tradizione politica del Paese. Affrontando il terzo e ultimo degli elementi citati sopra, Kloppenberg ricorda come la ricerca del compromesso sia parte dell’esperienza statunitense almeno quanto la partigianeria oggi imperante nei palazzi di Washington. Ma l’autore va oltre, mostrando con efficacia, ad esempio, come la tensione ideale del Presidente verso l’uguaglianza (solo uno dei temi proposti nel volume) sia incardinata su una tradizione che risale ai Padri fondatori, che ha attraversato la storia del Novecento e ispirato generazioni di politici e attivisti democratici. Antonio Soggia Bruce Levine, The Fall of the House of Dixie. The Civil War and the Social Revolution that Transformed the South, New York, Random House, 2013, pp. 442. Com’era prevedibile, in questi cinque anni di centocinquantenario della Guerra civile nordamericana (2011-2015) le pubblicazioni su quello che resta a tutt’oggi l’argomento più frequentato della storiografia statunitense continuano a uscire con ritmo inarrestabile. Questo di Levine è destinato a rimanere come uno dei contributi più importanti di questa stagione. La cosa non stupisce, essendo l’autore, come ricorda, James Oakes, un’altra figura di punta della ricerca su questo tema, in seconda di copertina, «uno dei principali storici della Guerra civile dei nostri tempi». Allievo di Herbert G. Guman, ha cominciato una ventina d’anni fa con The Spirit of 1848 (Urbana, 1992), dedicato ai «quarantottardi» tedeschi emigrati negli Usa all’epoca del conflitto e poi arruolatisi nelle file nordiste (tra questi anche il famoso Joseph Weydemeyr, militare e giornalista amico di Marx, colonnello dell’Unione). Ha proseguito con un lavoro di sintesi di grande fortuna (Half Slave Half Free, New York, 1992) e più recentemente con Confederate Emancipation. Southern Plans to Free and Arm Slaves During the Civil War (New York, 2006), che gettava luce per la prima volta sul fallimentare progetto sudista di manomissione degli schiavi in cambio dell’arruolamento. Di questo progetto Levine parla anche nel nuovo libro, che costituisce la più efficace sintesi della guerra vista dal Sud. Basato su un sapiente intreccio di fonti primarie e letteratura, l’affresco spazia dalla società sudista al momento dello scoppio della guerra, al suo assetto politico, alle vicende militari, sempre ricondotte efficacemente alla complessa trama del nesso economia-società-politica. Ecco allora emergere la centralità del Proclama di Emancipazione del settembre 1862, riletto alla luce del profilo di Abraham Lincoln abilmente disegnato da Eric Foner (Fiery Trial, 2010), ovvero di un politico moderato, che tuttavia, nel fuoco di un conflitto senza precedenti, di fronte alla triplice esigenza di indebolire la Confederazione sudista, rafforzare le risorse dell’Unione e persuadere l’opinione pubblica mondiale della bontà della causa unionista, cedette alle pressioni di quanti, e stavano crescendo nel Nord, spingevano in direzione esplicitamente antischiavista: la minoranza abolizionista, i militanti neri come l’ex-schiavo Frederick Douglass, i radicali del suo stesso partito e segmenti sempre più ampi dell’opinione pubblica nordista. E colpì al cuore la Confederazione, sottraendole il capitale più prezioso e la ragione di esistenza. Ecco soprattutto l’attenzione alla reazione quotidiana, minuta degli schiavi, che costituivano quasi un terzo della popolazione sudista e che Levine segue passo passo, sulle orme del grande studioso nero W.E.B. DuBois di Black Reconstruction (1935), restituendocene la complessa e trava- 119 Biblioteca gliata maturazione individuale e collettiva, prima del Proclama e dopo, e poi all’arrivo delle truppe nordiste. Levine mostra come, superando enormi e comprensibili difficoltà, gli afroamericani abbandonarono i piantatori al loro destino, per arruolarsi nell’esercito unionista, ricevendone dapprima rifiuti, in nome del pregiudizio forte anche al Nord, poi l’accettazione come ausiliari e infine come soldati a pieno titolo. E soprattutto provarono a fare società, aprirono chiese autonome, crearono scuole, tentarono di appropriarsi delle terre, abbandonate dai padroni, accumularono esperienza economica e politica, che avrebbero cercato di far valere nel dopoguerra, una volta ufficialmente liberati. Si possono discutere singoli punti di questo libro, come ad esempio il fatto che stranamente non dedica spazio alla dimensione di politica estera del Proclama. Ma è difficile negargli il titolo di una pietra miliare della storiografia in materia. Ferdinando Fasce Julian E. Zelizer, Governing America. The Revival of Political History, Princeton, Princeton University Press, 2012, pp. 416. Dopo la prima lettura dell’ultimo lavoro di Julian E. Zelizer, prolifico autore e docente di storia politica della University of Princeton la cui casa editrice dà alle stampe il volume di cui trattiamo in questa occasione, mi sono posto una domanda di non poco conto. Si tratta di un lavoro originale e importante per lo studio della storia politica degli Stati Uniti, oppure siamo dinnanzi a un modo per ripensare in modo organico alcuni saggi, che l’Autore ha pubblicato nel corso degli anni, per portare alle stampe un nuovo libro e soddisfare i parametri sempre più alti del publish or perish in auge oltreoceano e oggi anche nelle nostre università? Siccome la mia risposta propende per la prima ipotesi, quindi che si tratti di un lavoro rilevante, mi sono avventurato in una seconda lettura del testo per scoprire meglio quali sono i punti dirimenti di una riflessione ampia che parte dal New Deal rooseveltiano e si conclude con la presidenza Obama. Dobbiamo subito evidenziare a proposito che la maggior parte dei capitoli – suddivisi in quattro parti: 1) Thinking about the Field, 2) Paying for Government: Taxes, Money, and Fiscal Reform, 3) The Rules of the Games: The Politics of Process, 4) Politics and Policy: The Case of National Security – cercano di ricomporre la frattura tra scienziati politici e storici. I primi che considerano gli storici come studiosi che «raccontano solo storie» (p. 41), i secondi che considerano gli scienziati politici esclusivamente concentrati sulle loro teorie astratte e troppo distanti dalla lezione che la storia ha impartito e continua a impartire (p. 45). In questa frattura hanno avuto gioco facile gli economisti che hanno imposto il loro governo della società portando alla crisi della politica stessa. Insomma, è l’economia che detta l’agenda dei politici e non viceversa; e sono gli economisti che dominano il campo nelle scelte politiche. Da qui emerge palese il rischio di compiere gli errori del passato, mettendo le esigenze dei cittadini in secondo piano. Sono infatti i cittadini americani ad aver espresso più volte nel corso della storia una resistenza duratura verso il pagamento delle tasse e questo di fatto ha limitato gli interventi del pubblico per costruire un supporto di lungo termine ai programmi federali. Programmi che tuttavia hanno mostrato, come nel caso del New Deal di Roosevelt e della Great Society di Johnson, la loro utilità nel corso della storia. Ecco dunque per Zelizer la necessità per gli storici politici di mettere al centro del loro studio le politiche fiscali e l’economia politica (p. 105). Facendo il verso a Cornel West e al suo «la razza conta», Zelizer ci dice che è «il processo politico che conta» anche se questo è a sua volta influenzato da momenti storici come appunto la lotta per i diritti civili e le questioni interne sul tappeto negli anni Sessanta e Settanta. Sembra evidente che, secondo l’Autore, sono questi gli anni in cui 120 Biblioteca si definisce un nuovo modo di governare gli Stati Uniti e nascono idee originali per gestire il difficile rapporto tra i governati, i cittadini americani, e i governanti, le istituzioni rappresentate in particolar modo dalla Presidenza e dal Congresso. Eccoci dunque a pensare al perenne braccio di ferro tra il Congresso e il Presidente, e da qui il tentativo dei Repubblicani di usare le procedure congressuali per avere il controllo del Congresso e di assicurarsi il passaggio delle leggi per loro prioritarie (p. 194). Dell’ultima parte che riguarda il National Security System e la politica estera americana ha già riferito Irene Carnazza sul precedente numero di questa rivista, facendo notare come in questo campo «le scelte di volta in volta fatte dalle differenti amministrazioni si sono infatti rivelate più spesso esito delle necessità contingenti della competizione elettorale» piuttosto che di politiche ben definite, e l’atteggiamento ondivago di Barack Obama alle prese con la crisi siriana non è che l’ennesima conferma di quanto affermato. Per concludere possiamo dire che si tratta di un volume utile, seppur nella sua frammentarietà, a definire un campo di studi quale quello della storia politica degli Stati Uniti che in questi ultimi anni sta vivendo un vero e proprio revival – l’A. usa il termine «Rinascimento» –, sia per porre i riflettori su alcuni personaggi del passato che la hanno influenzata – come ad esempio il Senatore democratico J. William Fulbright – sia per meglio capire le scelte dei leader politici di oggi sempre più preoccupati del loro rapporto con i media piuttosto che di risolvere i problemi dei cittadini. Il messaggio ci appare così chiaro, anche se forse si nota l’assenza di una riflessione conclusiva, forse considerata da Zelizer lapalissiana, ma non altrettanto da chi scrive. Marco Sioli Africa, Asia, Medio Oriente Joseph Hanlon, Jeanette Manjengwa, Teresa Smart, Zimbabwe Takes back Its Land, Sterling, Kumarian Press, 2013, pp. 246. La radicale politica di riforma agraria intrapresa a metà del 2000 dal governo zimbabweano guidato da Robert Mugabe continua a essere al centro di un serrato dibattito politico e accademico. Era inevitabile che, in un continente in cui le riforme della proprietà della terra sono storicamente passate attraverso i meccanismi di mercato, un modello di riforma che prevedeva l’esproprio della terra senza il pagamento di alcun indennizzo ai proprietari (se non per i miglioramenti apportati) sollevasse interesse e anche polemiche. Il libro di Hanlon, Manjengwa e Smart si differenzia dalle altre analisi del Fast Track Land Resettlement Programme (FTLRP) per il tentativo di collocare questo processo di riforma nel più ampio quadro storico della lotta per l’affermazione della giustizia sociale in Zimbabwe. I primi capitoli del libro sono dedicati a una ricostruzione della politica di colonizzazione britannica in Rhodesia, con i suoi drammatici effetti sulla popolazione nera, espropriata di gran parte della terra e spinta a vivere in riserve. La lotta armata di liberazione nazionale, combattuta contro il regime della minoranza bianca che aveva unilateralmente proclamato l’indipendenza della Rhodesia del Sud nel 1965, aveva tra le sue principali rivendicazioni proprio la redistribuzione della terra tra i contadini neri. È davanti ai deludenti risultati della riforma della terra attuata dal governo di Mugabe nei primi due decenni successivi all’indipendenza dello Zimbabwe nel 1980 che i piccoli contadini e i veterani della guerra di liberazione decisero nel 2000 di avviare una massiccia ondata di invasioni delle aziende agricole di proprietà dei bianchi. Lo «Zimbabwe [che si] riprende la terra» rappresenta quindi, secondo Hanlon, Manjengwa e Smart, l’ultimo tassello di una lotta per l’emancipazione che il governo non poteva che assecondare. 121 Biblioteca Per quanto la ricostruzione storica della questione della terra in Zimbabwe fornita dagli autori riproponga una lettura ormai consolidata degli eventi, l’interpretazione della realizzazione del FTLRP da essi fornita appare parziale. In particolare, sfugge agli autori il fatto che il governo di Mugabe si sia risolto a intraprendere il FTLRP dopo la sconfitta subita al referendum costituzionale del febbraio del 2000 e davanti al rischio molto concreto di una vittoria del Movement for Democratic Change (MDC) alle elezioni che si sarebbero svolte nel successivo mese di giugno. L’insistenza di Hanlon, Manjengwa e Smart sul fatto che le invasioni di terre sarebbero cominciate spontaneamente, senza e, addirittura, contro la volontà del governo, li porta a trascurare di considerare la manipolazione delle invasioni esercitata a fini elettorali dal partito di governo, ma viene contraddetta dalle interviste degli stessi autori ad alcuni contadini. Questi ultimi, infatti, raccontano di essere stati spesso accompagnati su mezzi di trasportato forniti dall’esercito nelle aziende agricole dei bianchi e di essere stati aiutati delle autorità locali nell’occupazione delle terre. Più in generale, sfugge del tutto all’analisi di Hanlon, Manjengwa e Smart il fatto che il FTLRP rientrava in un più vasto tentativo intrapreso da Mugabe e dai vertici della Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF) finalizzato a mantenere – a qualsiasi prezzo – nelle loro mani le redini del potere politico. Limitandosi a definire «una crisi di governance» (p. 96) quanto avvenuto in Zimbabwe dal 2000, gli autori non solo passano sotto silenzio la violenza politica che si è abbattuta sugli esponenti e i sostenitori del MDC, le gravi violazioni dei diritti umani compiuta dagli apparati di sicurezza e dalle milizie della ZANUPF e la crescente militarizzazione delle istituzioni dello Stato, ma trascurano anche di considerare il FTLRP come un processo che ha messo drammaticamente in discussione il significato stesso di termini quali «democrazia», «diritti» e «liberazione» in Africa australe. Al contrario, gli autori sono così preoccupati di presentare la riforma agraria di Mugabe come una vittoria delle istanze della giustizia sociale da non accorgersi che le stesse lotte di liberazione nazionale, pur con tanti limiti e contraddizioni, mirarono storicamente ad assicurare simultaneamente l’emancipazione politica e l’accesso alle risorse per le popolazioni dell’Africa australe. Una volta collocato il FTLRP in una prospettiva storica, Hanlon, Manjengwa e Smart passano a considerare gli effetti della riforma agraria, presentando i risultati di una ricerca sul campo da loro svolta nella regione del Mashonaland tra il 2010 e il 2011. Questa seconda parte del libro appare alquanto confusa. I dati quantitativi presentati sono per lo più tratti dagli studi recentemente effettuati da altri gruppi di ricerca, come quello dell’Institute of Development Studies di Brighton o quello dell’African Institute for Agrarian Studies di Harare. Le interviste svolte dagli autori confermano quanto già rilevato da queste ricerche. In particolare, l’accento viene posto sulla ripresa della produzione agricola che si è registrata negli ultimi anni, nonostante l’assenza di un politica governativa a sostegno dei piccoli contadini. Emergono anche difficoltà e problemi, come la disparità tra i generi nell’allocazione degli appezzamenti di terra, la bassa produttività di molte aziende agricole e l’assenteismo di una percentuale significativa di coloro che hanno ricevuto dal governo grandi estensioni di terra al fine di sviluppare produzioni di tipo commerciale. Tutti problemi, secondo Hanlon, Manjengwa e Smart, che non vanno però considerati come elementi di debolezza del FTLPR, dal momento che, come spesso ripetono, una riforma agraria impiega almeno una generazione per dare i suoi frutti. Una conclusione, questa, che ancora una volta mette a nudo il carattere fortemente ideologico dell’analisi presentata in questo libro. Arrigo Pallotti Susan Williams, Who Killed Hammarskjöld? The UN, the Cold War, and White Supremacy in Africa, London, Hurst & Co., 2012, pp. 306. Il processo di decolonizzazione del Congo fu accompagnato da gravi violenze e gettò il paese nell’instabilità politica e militare, aggravata dal 122 Biblioteca contesto internazionale della Guerra Fredda. Nel grande quadro delle vicende che contrassegnarono l’indipendenza congolese, due sono gli episodi che a più riprese hanno suscitato l’interesse degli storici: l’assassinio del primo ministro Patrice Lumumba nel gennaio del 1961 e la morte del Segretario Generale delle Nazioni Unite Dag Hammarskjöld, in seguito ad una sciagura aerea che ebbe luogo nella notte tra il 17 e il 18 settembre del 1961 nei pressi di Ndola, una cittadina nel nord dello Zambia (all’epoca Rhodesia del Nord). In questo libro l’analisi di Susan Williams si concentra sulla morte di Hammarskjöld, nel tentativo di gettare nuova luce sulle circostanze che circondarono l’incidente aereo di cui rimase vittima. Nei primi capitoli, dopo avere sinteticamente tratteggiato i motivi che spinsero Hammarskjöld a recarsi a Ndola per negoziare con Moise Tshombe, il primo ministro del Katanga, un cessate il fuoco che ponesse fine all’improvvisa recrudescenza del conflitto tra le truppe katanghesi, sostenute da mercenari e da ex soldati belgi, e i caschi blu dell’Onu, Williams analizza i resoconti delle commissioni di inchiesta che vennero nominate per investigare le cause dello schianto dell’aereo su cui viaggiava il Segretario Generale. Mentre tanto le due commissioni rhodesiane dei primi anni Sessanta, quanto la commissione svedese formata tre decenni più tardi giunsero alla conclusione che la causa del disastro aereo andava ricondotta ad un errore del pilota, la commissione di inchiesta creata dall’Onu subito dopo l’incidente non escluse la possibilità che l’aereo fosse stato l’oggetto di un sabotaggio o il bersaglio di un attacco. Alla luce di una vasta ricerca e sulla base non solo delle fonti custodite in numerosi archivi, ma anche di interviste svolte con alcuni testimoni e funzionari dell’Onu e del governo svedese, Williams mette in luce in particolare le lacune dei rapporti redatti dalle commissioni di inchiesta rhodesiane. Esse hanno a che fare con il fatto che tutte le deposizioni fornite da testimoni africani vennero giudicate non attendibili. Nonostante infatti questi ultimi si fossero trovati concordi nell’affermare non solo di avere visto un bagliore in cielo e di avere poi sentito uno schianto, ma anche di avere udito il rumore di più di un aereo in volo sui cieli di Ndola la notte dell’incidente, delle loro testimonianze non si tenne conto nella stesura dei rapporti finali. Non attendibili vennero anche giudicate le affermazioni di Harold Julien, l’unico membro dell’equipaggio sopravvissuto (per pochi giorni) all’incidente, che affermò che vi era stato uno scoppio a bordo dell’aereo prima che quest’ultimo precipitasse. Nei capitoli successivi Williams utilizza le fonti da lei raccolte per portare alla luce quella che secondo lei fu la causa dello schianto dell’aereo di Hammarskjöld: l’intervento di un aereo (verosimilmente pilotato da un mercenario) che colpi l’Albertina di proposito o per errore, nel tentativo cioè di costringere quest’ultima a cambiare rotta e, verosimilmente, atterrare in Katanga. Per sostenere questa tesi Williams utilizza non solo le deposizioni rese all’epoca (e in alcuni casi ripetute all’autrice) dai testimoni africani, ma anche le affermazioni fornite da alcuni mercenari che combatterono in Katanga e, infine, il racconto di Charles Southall, un agente dell’intelligence statunitense che la notte tra il 17 e il 18 settembre del 1961 udì un pilota affermare via radio di avere colpito il DC6 su cui viaggiava Hammarskjöld. Il mandante dell’attacco all’aereo del Segretario Generale rimane un punto irrisolto del libro. Williams sottolinea una confluenza di interessi tra i leader della Central African Federation, il governo britannico (il cui High Commissioner in Rhodesia, Lord Alpert, presente all’aeroporto di Ndola la notte dell’incidente, non vendendo atterrare l’aereo di Hammarskjöld affermò che quest’ultimo aveva senza dubbio cambiato destinazione, persuadendo i responsabili dell’aeroporto a rimandare al giorno dopo l’avvio delle ricerche dell’Albertina), gli interessi minerari belgi in Katanga e la CIA a ostacolare le attività di Hammarskjöld in Congo e, in partico- lare, il suo tentativo di mediazione con Tshombe, ma le fonti non consentono all’autrice di attribuire con certezza delle responsabilità. Due sono i limiti principali del libro. In primo luogo la grande abbondanza di particolari con cui vengono riportate le testimonianze raccolte dall’autrice frammenta in certi tratti l’analisi, rendendo la lettura faticosa. In secondo luogo la ricostruzione dell’approccio di Hammarskjöld al conflitto in Congo risulta alquanto sommaria. Di fatto, limitandosi a ripetere più volte che l’azione del Segretario Generale era finalizzata a rafforzare il ruolo internazionale dell’Onu e ad assicurare che il Congo non cadesse preda degli interessi europei, Williams rinuncia a intraprendere una lettura politica degli avvenimenti che contraddistinsero l’indipendenza del Congo e delle scelte che Hammarskjöld si trovò a compiere e che finirono per attirare sul Segretario Generale dell’Onu le critiche tanto dei governi africani, quanto dei diversi schieramenti della Guerra fredda. Al di là di questi limiti, il libro di Williams ha avuto l’indubbio merito di riaccendere ancora una volta l’interesse politico e accademico sulle circostanze della morte di Dag Hammarskjöld, con una ricerca che solleva una serie di importanti interrogativi sulla politica perseguita non solo dai paesi europei e dagli Stati Uniti, ma anche dal governo della Central African Federation nel frangente dell’indipendenza del Congo. L’eco internazionale suscitato dalla pubblicazione del libro ha condotto all’annuncio della creazione di una nuova commissione di inchiesta, il cui rapporto finale verrà ufficialmente presentato alle Nazioni Unite. Arrigo Pallotti Storia delle idee e del pensiero politico Julian Wright, H.S. Jones (eds.), Pluralism and the Idea of the Republic in France, New York, Palgrave Macmillan, 2012, pp. 270. «Pluralismo», in questo volume che riunisce studiosi d’area francese e anglosassone, è una cate- 123 Biblioteca goria usata in opposizione a quella di «giacobinismo»: termine che designa la particolarità della tradizione repubblicana francese, connotata dalla centralizzazione amministrativa, dal disconoscimento della legittimità delle istituzioni della società civile; e da «un modello astratto di cittadinanza, in cui l’identità di cittadino come cittadino francese, quando egli/essa agisce nello spazio pubblico, si ritiene soppianti tutte le altre identità collettive» (p. 3). L’assunto dei diversi contributi è di mostrare come, in alternativa, nel repubblicanesimo francese tra Otto e Novecento s’incontri un secondo filone, pluralistico appunto, che non guarda allo stato centralizzato e valorizza le identità della società civile. Di fronte alle sfide oggi portate dalla globalizzazione e dal multiculturalismo al «modello» giacobino, l’obiettivo è anche quello di suggerire nuovi approcci ai problemi del presente (si veda in particolare Alain Chatriot, Epilogue: French Politics, History and a New Perspective on the Jacobin State). Il volume si divide in due parti. Nella prima sono esplorate le radici intellettuali del pluralismo repubblicano, anche se – l’avvertenza è d’obbligo – gli autori indagati non usano mai il termine, che è stato introdotto in America da Laski nel 1915 (ispirato però a sua volta dalla tesi di dottorato del 1910 di Paul-Boncour: si veda Wright nel saggio Vision and Reality: Joseph Paul-Boncour and Third Republic Pluralism); e che viene diffuso in Francia negli anni Trenta da Georges Gurvitch (così Joshua Humphreys in Utopian Pluralism in TwentiethCentury France). Alla ricerca delle radici, i saggi percorrono la strada del rapporto tra il concetto di pluralismo e i vari termini a disposizione degli attori, come «liberalismo», «realismo» e «corporativismo». Tre principali concezioni sono messe a fuoco. La prima concerne il liberalismo uscito dal dramma della Rivoluzione. Andrew Jainchill (Liberal Republicanism after the Terror: Charles-Guillaume Théremin and Germaine de Staël) e Steven Vincent (Liberal Pluralism in the Early Nineteenth Century: Benjamin Constant and Germaine de Staël) indagano il ruolo di queste figure (la prima oggi dimenticata) nell’invenzione del moderno repubblicanesimo, mostrando le possibili tensioni da loro individuate tra politica e realtà sociale. La seconda corrente, studiata da Annelien de Dijn (A Strange Liberalism: Freedom and Aristocracy in French Political Thought), riguarda la concezione che, da Montesquieu a Bertrand de Jouvenel passando per Tocqueville, vede nella società corporata la garanzia della libertà contro il dispotismo. La terza posizione, infine, studiata da Georges Navet (P.-J. Proudhon: Pluralism, Justice and Society) e Michael C. Behrent (Pluralism’s Political Conditions: Social Realism and the Revolutionary Tradition in Pierre Leroux, P.-J. Proudhon and Alfred Fouillée), esprime, sotto la specie del corporativismo, un pluralismo che guarda ai gruppi sociali come dotati di vita loro propria, indipendente dal riconoscimento da parte dello Stato. La seconda parte, più che sulla storia intellettuale, si focalizza sui movimenti e le congiunture politiche, seguendo gli sviluppi dell’idea del pluralismo sotto la Terza Repubblica. Che Nicolas Rousselier studi la storia elettorale (Electoral Antipluralism and Electoral Pluralism in France) o Magali della Sudda indaghi quella dell’associazionismo (Associations and Political Pluralism: The Effects of the Law of 1901); che Paul Smith (Pluralism, Parliament and the Possibility of a «Sénat fédérateur», 1940-1969) segua la persistenza di un progetto pluralista di riforma del Senato; che Carl Bouchard (Regionalism, Federalism and Internationalism in First World War France) o Jean-Michel Guieu (State Sovereignty in Question: The French Jurists between the Reorganization of the International System and European Regionalism, 1920-1950) mettano in luce i nessi tra movimenti internazionali e critiche del modello giacobino, i saggi convergono verso un’unica conclusione. Il quadro della cultura politica e soprattutto delle «realtà» sociali sotto la Terza Repubblica risulta assai più variegato di quanto una consolidata letteratura storiografica e politologica incentrata sull’egemonia del modello giacobino aveva fin qui fatto credere. Regina Pozzi La recensione del volume El estado como benefactor di M.D. Lorenzo Río, pubblicata nel fascicolo 3/2013, è uscita erroneamente a firma M. De Giuseppe, mentre l’autrice è N. La Banca. 124 Biblioteca Hanno collaborato a questa sezione: Enrico Acciai, Università degli Studi della Tuscia Stefano Agnoletto, Kingston University, London Giulia Albanese, Università di Padova Raffaella Baritono, Università di Bologna Simone Bellezza, Università di Trento Giovanni Bernardini, Fondazione Bruno Kessler, Trento Fabio Bettanin, Università L’Orientale, Napoli Benedetta Calandra, Università di Bergamo Jordi Canal, EHEES, Paris Emanuela Costantini, Università di Perugia Luca Costantini, Università di Bologna Ilaria Del Biondo, Università di Teramo Antonio Donno, Università del Salento Ferdinando Fasce, Università di Genova Edgar Feuchtwanger, University of Southampton Gianluca Fiocco, Università di Tor Vergata, Roma Giuliano Garavini, Università di Padova Marco Gervasoni, Università del Salento Maurizio Griffo, Università Federico II, Napoli Maria Eleonora Guasconi, Università di Genova 125 Biblioteca Stefano Luconi, Università di Padova Claudia Mantovani, Università di Perugia Tito Menzani, Università di Bologna Arrigo Pallotti, Università di Bologna Daniele Pasquinucci, Università di Siena Camilla Poesio, Università di Venezia Paolo Pombeni, Università di Bologna Regina Pozzi, Università di Pisa Giovanni Scirocco, Università di Bergamo Antonio Scornajenghi, Università degli Studi di Roma Tre Marco Sioli, Università di Milano Antonio Soggia, Università di Torino Carlotta Sorba, Università di Padova Carlo Spagnolo, Università di Bari Andrea Ungari, Luiss Guido Carli, Roma Giampaolo Valdevit, Università di Trieste Lucio Valent, Università di Milano Paolo Varvaro, Università di Napoli Marilyn B. Young, New York University
Scarica