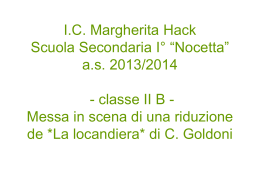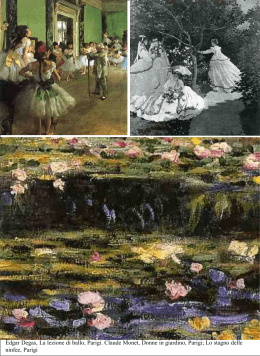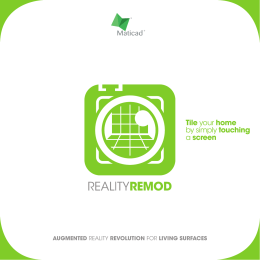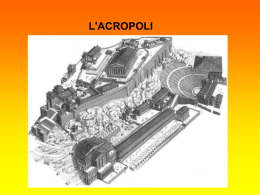Questo libro è dedicato essenzialmente ai giovani, col proposito di far loro conoscere in modo più
approfondito e dettagliato, l'arte immensa di questo nostro grande Genio, figlio della nostra terra, che ha
fatto palpitare i cuori di tutti, che è stato e lo è tutt'ora, il più grande ambasciatore della cultura musicale
italiana nel mondo.
Lettera ai giovani
Caro giovane,
ascolta la musica di Verdi! Ti sentirai trasportare in un mondo apparentemente 'irreale, immerso
in una musica che tuttavia parla ai nostri sentimenti 'reali, piena di note che fanno 'venire i brividi,
come si usa dire quando senti invaderti dentro da qualcosa che neanche tu riesci a controllare.
Ascolta la musica di Verdi! Se sei un sentimentale troverai quello che cerchi nel preludio del terzo
atto di Traviata oppure nel canto mistico della "Vergine degli angeli" nella Forza del destino. Se
hai un temperamento forte, troverai maggiore emozione nell'ascoltare il "Credo"dell'Otello oppure
l'aria "Cortigiani, vil razza dannata" nel Rigoletto. Se poi ascolterai Aida, sarai portato a chiederti
come mai un europeo come Giuseppe Verdi abbia potuto scrivere una musica così evocativa
dell'Egitto dei Faraoni.
L'esecutore più famoso, l'artista che più di tutti seppe interpretare la carica vitale della musica di
Verdi, fu un altro parmigiano: il maestro Arturo Toscanini; nelle sue esecuzioni era capace di
interpretare la musica di Verdi esattamente nella maniera che lo stesso Maestro esigeva: con
sentimento e forza drammatica!
Ma queste cose le scoprirai ascoltando la musica di Verdi. Poi tutto ti verrà naturale, perché è
musica che va direttamente nel profondo dell'anima, per non uscirne più.
Questo libro è una occasione per scoprire l'arte di un grande uomo. Esso ti viene offerto
dall'Associazione culturale "Parma Lirica", che da trent'anni opera per divulgare la musica lirica
allo scopo di coinvolgere giovani e anziani in cicli di manifestazioni musicali.
Per il centenario della morte di Giuseppe Verdi (1813-1901) abbiamo infatti pensato di raccogliere
in un volume la sintesi della vita e delle opere del grande musicista al fine di avvicinare i giovani
alla musica lirica. Sempre per questo grande evento commemorativo abbiamo predisposto la
proiezione in video di gran parte dei suoi melodrammi. Le proiezioni saranno offerte ai ragazzi
appartenenti alle scuole medie inferiori, accompagnati dai loro insegnanti, dietro richiesta della
scuola di appartenenza; si terranno ogni giovedì mattina per gruppi di 120 studenti e saranno
precedute da un'illustrazione storico-critica svolta da un nostro esperto.
Caro studente, la nostra iniziativa riguarda tutta una tradizione che è nostra e che abbiamo il
dovere di salvaguardare. Noi lo vogliamo fare con il tuo aiuto.
Verdi fotografato a Parigi da Nadar (ca. 1866-67)
Marcello Conati
Giuseppe Verdi
e il suo tempo
Introduzione
alla cronologia verdiana
Come ci ricorda Massimo Mila "Verdi nacque in un'epoca in cui il solo mezzo conosciuto di
locomozione terrestre era la carrozza a cavalli. Quando morì, le ferrovie allacciavano la terra nella
loro rete; da due anni Agnelli aveva fondato la Fiat. [...] Verdi nacque in un'Italia divisa e in
un'Europa occupata a schiacciare gli eserciti di Napoleone e i princìpi di libertà, uguaglianza e
fraternità.Alla sua morte, l'Italia era al terzo ed ultimo re del suo regno unito; il socialismo si
diffondeva in Europa. [...] Non solo la vita di Verdi fu lunga, e la sua forza creativa conservò una
freschezza eccezionale fino alla più tarda età; ma questa vita si svolse in un'epoca che non ha forse
l'eguale per abbondanza e vastità di cangiamenti". Egli nacque infatti quando la rivoluzione
industriale era appena agli albori, almeno in Italia. L'illuminazione era ancora a lampade di
petrolio e a candele; la posta continuava a viaggiare per diligenza (con speditezza peraltro non di
molto inferiore a quella della posta normale dei nostri giorni...), con tassa a carico del destinatario
(non esistevano ancora i francobolli). Morì che già esisteva il telegrafo, venivano istituiti i primi
"treni-lampo", le strade erano percorse dalle prime automobili, era stato inventato il grammofono,
si produceva già la Coca-Cola, s'andava diffondendo il gioco del calcio e cominciavano le prime
Olimpiadi...
Visse ottantasette anni, tre mesi e diciassette giorni. La sua intensa attività di artista si estese
pressoché ininterrotta per un arco di tempo durato oltre settant'anni, avendo egli iniziato a
comporre la sua prima sinfonia, sembra, all'età di tredici anni (in quell'anno, 1826, Beethoven dava
l'addio all'arte con il Quartetto op. 135, Weber moriva dopo aver fatto rappresentare l'Oberon) e
avendo praticamente smesso all'età di ottantaquattro anni (Puccini e Richard Strauss erano nomi
ormai famosi, sorgeva l'astro di Debussy, Schònberg s'apprestava a comporre Die verklarte
Nacbt).
Fu autore di opere destinate a conquistare una popolarità che ancora oggi non accenna
minimamente a diminuire. E attraverso queste opere conferì ulteriore popolarità ai grandi e meno
grandi autori della letteratura europea, da Shakespeare a Schiller, da Byron a Voltaire, da Hugo a
García Gutiérrez, da Dumas a Saavedra. Incise profondamente sulla prassi esecutiva riformando la
disposizione delle orchestre e i criteri delle prove musicali. Lottò perché la direzione musicale di
un'opera fosse affidata a un solo responsabile e s'impegnò in prima persona per l'adozione di un
unico diapason. Contribuì inoltre alla riforma dei conservatori musicali e collaborò alla legge per
la tutela della proprietà artistica. Sempre in moto. Ma soprattutto sempre attento, con le antenne
costantemente protese a captare tutti i segnali di trasformazione provenienti dalla società in cui
viveva e operava, società complessa in cui convivevano gl'impulsi dell'avanzante civiltà borghese e
le norme della tradizione contadina. Per Verdi la cultura - intesa non come fatto decorativo,
letterario, nozionistico, bensì come modo di porsi di fronte alla realtà e come capacità di acquisire
gli strumenti per trasformarla - era una necessità vitale. Il non ostentarla l'esito di consapevolezza.
Non restò mai indietro, non si riposò mai sui propri allori (nemmeno quando parve di poterlo fare),
non si lasciò sopraffare dalle mode e dai mutamenti né rinunciò a cimentarsi in nuove imprese. In
breve: non volle né si lasciò mai superare dagli uomini e dagli eventi.Anche quando sembrò
trovarsi in difficoltà di fronte all'avanzata delle nuove generazioni, portatrici di nuovi ideali
estetici, non si arrestò mai, ma - pur brontolando contro Scapigliati, avveniristi, wagneristi,
sinfonisti, quartettisti, oltremontani, veristi e quant'altro - continuò ad avanzare verso nuovi
traguardi artistici. Con il Don Carlos vinse la sfida con Meyerbeer e con il Mefistofele di Boito.
Con il Quartetto per archi dimostrò che anch'egli sapeva fare musica strumentale. Ritenne d'aver
concluso la propria carriera di artista con l'Aida e con la Messa da Requiem; ma dopo la morte di
Wagner riprese la penna in mano per avanzare ulteriormente nell'arte: e vennero Otello e il
miracoloso Falstaff. E non fu ancora tutto. Convinto assertore del primato della voce umana
ovvero del canto, a oltre ottant'anni compose i Pezzi sacri, vetta della musica corale d'ogni tempo.
Fu anche uomo politico: allo scoppio dei moti del 1831, benché ancora minorenne, chiese di entrare
nella Guardia Nazionale; animato da idee repubblicane e anticlericali partecipò in prima persona
agli eventi del 1848 fiancheggiando l'azione di Mazzini, per il quale scrisse anche un inno
patriottico; amico di Luigi Bonaparte, divenuto Napoleone III, si accostò gradualmente al
programma politico di Cavour e accettò, benché riluttante, la sua richiesta di farsi eleggere
deputato al primo Parlamento italiano.
Fu inoltre agricoltore, nel senso pieno della parola: seppe amministrare i suoi possedimenti
terrieri, sempre tenendosi a giorno sui progressi più recenti dell'agronomia, indicando ai propri
fattori come addestrare cavalli, scegliere sementi, potare alberi, concimare terreni... Stimava
coloro, egli diceva, "che sanno spendere a tempo e luogo mille franchi, e che sanno economizzare il
centesimo"; sulla base di questa "teoria" riuscì ad accumulare un'immenso patrimonio, di cui
saranno poi altri a godere.
Fu infatti benefattore: non si contano le sue numerose elargizioni a beneficio di collaboratori
(Cammarano, Piave) e di conoscenti, e le sue tante sottoscrizioni per aiutare terremotati,
alluvionati, colerosi; attinse al proprio patrimonio per far erigere un ospedale a Villanova d'Arda
per i poveri della zona e, poco più tardi, la Casa di Riposo per Musicisti, alla quale destinò la
maggior parte dei suoi averi.
Fu una lunga, poliedrica attività, la sua, continuamente rinnovatasi a stretto contatto con le
trasformazioni della società. E quali trasformazioni! Se non si hanno costantemente presenti date e
avvenimenti di una vicenda secolare, la figura di Verdi uomo e artista sfugge a una piena
comprensione.Tanta attività non è riducibile a una formula, né l'artefice a una definizione.
Giuseppe Verdi (fotografia, Parigi, 1860-62 ca.)
Cronologia 1813
Giuseppe Verdi*
1813
Domenica 10 ottobre: nasce Giuseppe Verdi, primogenito di Carlo e di Luigia Uttini, entrambi
discendenti di famiglie di locandieri e di affittuari; l'evento viene festeggiato all'osteria del padre
Carlo con canti e balli.
11 ottobre: viene battezzato con i nomi di Giuseppe Fortunino Francesco; "il padrino del neonato
volle che, in segno di letizia, venisse il bambino accompagnato al sacro fonte col suono di allegre
fanfare da una brigata di suonatori girovaghi"; nello stesso giorno si celebra anche il matrimonio
del fratello di Carlo Verdi, Marco Antonio.
1814
Aprile: per ripararsi dalle scorrerie dei Russi la madre di Verdi si rifugia col piccolo Giuseppe in
cima al campanile della chiesa delle Roncole. (GV a Roito:"I soldati Russi commettevano atrocità
nelle campagne. Nella stessa chiesa di Roncole uccidevano, violavano donne. Presso Polesine una
famiglia di forti contadini, un padre e due figli armati di tromboni, nascosti dietro un pozzo,
vendicavano le efferatezze dei Russi uccidendoli a trombonate. Le scorrerie dei Russi nei dintorni
di Roncole provenivano dai reggimenti del generale austriaco Nugent formati di varie nazionalità.
Il 16 Aprile fu l'ultimo giorno delle ostilità").
1815
Le campane della chiesa delle Roncole e i musicisti popolari, fra cui un violinista ambulante
soprannominato Bagassèt, danno al piccolo Giuseppe le prime idee della musica.
* N.B. Nella seconda colonna della presente Cronologia ("Arte e Cultura") sono stati inseriti alcuni dati riguardanti avvenimenti artistici e culturali
che, sebbene non presentino grande rivelanza a confronto con altri dati, hanno tuttavia qualche attinenza, diretta o indiretta, con l'opera e con
l'attività di Verdi.
Arte e cultura
1813
17 gennaio: muore a Vienna Zacharias Werner, autore del dramma Attila.
6 febbraio: Venezia, La Fenice: Rossini, Tancredi.
21 febbraio: Genova, S. Agostino: Simone Mayr, La rosa bianca e la rosa rossa.
22 maggio: nasce a Lipsia Richard Wagner. Venezia, Teatro in S. Benedetto: Rossini, L'Italiana in
Algeri. 29 settembre: muore a Montmorency André Grétry. 28 novembre: Napoli, S. Carlo: Mayr,
Medea in Corinto, su libretto di Felice Romani.
8 dicembre: Vienna: Beethoven, Settima Sinfonia. 26 dicembre: Milano, Scala: Rossini,Aureliano in
Palmira. George Byron, La sposa d'Abido, poemetto. - Ugo Foscolo inizia il poema Le Grazie. Carlo Porta, I desgrazi de Giovannin Bongee.
1814
23 maggio: Vienna, Hofoperntheater: Beethoven, Fidelio (terza versione).
14 agosto: Milano, Scala: Rossini, Il turco in Italia.
17 ottobre: Milano, Scala: Mozart, Don Giovanni (sarà ripreso nel marzo del 1816).
G. Bymn, Il corsaro, poemetto.
C. Porta, La Ninetta del Verzee.
Francisco Goya, Le fucilazioni del 3 maggio 1808, dipinto
L'editore Giovanni Ricordi pubblica il suo primo catalogo e diventa copista e suggeritore alla
Scala.
1815
8 giugno: Venezia, S. Benedetto: Carlo Coccia, Clotilde.
18 agosto: Milano, teatro Re: Silvio Pellico, Francesca da Rimini, dramma.
6 settembre: nasce a Lodi Giuseppina Strepponi.
4 ottobre: Napoli, S. Carlo: Rossini, Elisabetta, regina d'Inghilterra.
Donizetti, dopo aver studiato alla scuola di Mayr, si perfeziona al Liceo Musicale di Bologna.
Gian Battista Niccolini, Nabucco, tragedia in versi. Alessandro Manzoni, Quattro inni sacri. - G.
Byron, Parisina, poema.
Antonio Canova, Le tre Grazie, scultura
Politica, società, scienza, scoperte
1813
Febbraio: Russia, Prussia e Gran Bretagna danno vita alla sesta coalizione.
Agosto: vittoria di Napoleone a Dresda.
16-19 ottobre: battaglia di Lipsia; Napoleone è costretto alla ritirata.
Dicembre: gli eserciti della coalizione invadono la Francia. Viene fondata a Pisa la Scuola normale
superiore.
1814
13 febbraio: i reggimenti austriaci del generale Nugent entrano a Parma. 9 marzo: ricacciati dai
Francesi, dopo una settimana gli Austriaci ritornano a Parma.
Marzo: gli eserciti della coalizione entrano in Parigi. Scorrerie di soldati russi nelle campagne del
bussetano.
6 aprile: trattato di Fontainehleau: Napoleone è costretto ad abdicare; tornano al trono i Borboni
con Luigi XVIII. Fine del regno d'Italia. Vittorio Emanuele I riprende possesso del Piemonte e Pio
VII dello stato pontificio; gliAustriaci occupano Milano: il Lombardo-Veneto viene annesso
all'impero asburgico. 14 aprile: a Maria Luigia, moglie di Napoleone, viene assegnato il ducato di
Parma, Piacenza e Guastalla.
4 maggio: Napoleone si ritira nell'isola d'Elba.
30 giugno: a Parma viene costituita una Reggenza provvisoria in nome di Maria Luigia.
1° agosto: Pio VII ripristina l'ordine dei Gesuiti.
1° novembre: si apre il congresso di Vienna.
Stephenson realizza la prima locomotiva a vapore.
1815
26 febbraio: Napoleone lascia l'isola d'Elba e sbarca a Cannes; sua marcia trionfale a Parigi, dove
viene acclamato imperatore.
30 marzo: proclama di Rimini; Gioacchino Murat incita gli Italiani alla lotta per l'indipendenza.
Sconfitto a Tolentino si rifugia in Corsica.
1° aprile: nasce a Schónhausen Otto von Bismarck.
9 giugno: si conclude il-congresso di Vienna. L'Italia torna alla frammentazione prenapoleonica,
con il Lombardo-Veneto sotto il dominio dell'Austria.
15-18 giugno: battaglia di Waterloo; Napoleone sconfitto si consegna prigioniero agli Inglesi che
lo deportano nell'isola di S. Elena.
Cronologia 1816
Giuseppe Verdi
1816
22 marzo: nasce Francesca Giuseppa Verdi, sorella di Giuseppe.
12 agosto: si costituisce in Busseto una Società Filarmonica sostenuta da Antonio Barezzi e diretta
da Ferdinando Provesi.
1 1 novembre: Carlo Verdi prende in affitto un piccolo podere alle Roncole.
1817
Secondo una testimonianza della madre, raccolta dal bussetano Ercole Cavalli, "il bambino era
d'indole abbastanza
buona, docile ed obbediente; ma era molto introverso e am-ante della solitudine. LI ma quando
erano di passaggio organetti o musici ambulanti, era impossibile trattenerlo, essendo necessario la
forza per riportarlo a casa".
1818
Il piccolo Verdi inizia a studiare con don Pietro Baistrocchi, che gli apprende anche a suonare
l'organo e a cantare. Il parroco delle Roncole, don Carlo Arcari, gli insegna "i primi rudimenti di
lettura e di scrittura".
Arte e cultura
Ugo Foscolo va in esilio volontario in Svizzera, quindi (1816) a Londra.
1816
14 gennaio: Venezia, Fenice: Pietro Generali, I baccanali di Roma.
20 febbraio: Roma, Argentina: Rossini, Il barbiere di Siviglia.
27 aprile: Schubert termina la sinfonia in Do min. (Tragica).
2 maggio: viene fondata a Parma una scuola di musica.
5 giugno: Napoli: muore Giovanni Paisiello. 1° settembre: Praga: Ludwig Spohr, Faust.
4 dicembre: Napoli,Teatro del Fondo: Rossini, Otello. Luigi Cherubini, Requiem in Do min.
Johann Nepomuk Miilzel costruisce il primo metronomo. Giovanni Berchet, Lettera semiseria di
Grisostomo. Walter Scott, I puritani di Scozia, romanzo. Madame de Staél sulla"Biblioteca
Italiana" esorta gli Italiani
alla lettura e alla traduzione della letteratura straniera.
1817
25 gennaio: Roma, Valle: Rossini, Cenerentola.
31 gennaio: Vienna, Theater an der Wien: Franz Grillparzer, L'avola , dramma.
31 maggio: Milano, Scala: Rossini, La gazza ladra. 11 novembre: Napoli, S. Carlo: Rossini, Armida.
Wolfgang Goethe, Viaggio in Italia.
G. Byron, Manfred, dramma.
August W. Schlegel, Corso di letteratura drammatica, tradotto da G. Gherardini.
1818
6 febbraio: Milano, Scala, Salvatore Viganò, Otello, ballo.
5 marzo: Napoli, S. Carlo: Rossini, Mosè in Egitto.
21 aprile: Vienna: E Grillparzer, Saffo, tragedia. 17 giugno: nasce a Parigi Charles Gounod.
5 agosto: Milano, Scala: Adalbert Gyrowetz, Il finto Stanislao.
3 settembre: esce a Milano il primo numero del "Conciliatore", fondato da Luigi Porro
Lambertenghi; vi
Politica, società, scienza, scoperte
Settembre: lo zar Alessandro I promuove la Santa Alleanza "fra trono e altare": ne fanno parte
Russia, Prussia e Austria. Il parlamento britannico respinge ogni diritto d'intervento: la Gran
Bretagna diventa così la patria dei liberali.
13 ottobre: sbarcato a Pizzo Calabro nel tentativo di riconquistare il trono di Napoli Gioacchino
Murat viene catturato e fucilato.
Nuovo metodo di pavimentazione stradale introdotto dallo scozzese J. L. Mc Adam.
Negli Stati Uniti viene varata la Fulton, prima nave a vapore da guerra.
1816
19 aprile: la duchessa Maria Luigia fa il suo ingresso a Parma.
Pio VII sopprime la tortura e i diritti feudali.
Gran Bretagna: vengono istituiti i dazi sul grano; la crisi economica e la disoccupazione suscitano
tumulti da parte dei lavoratori.
Il duca di Weimar concede la costituzione.
Londra: introduzione dell'illuminazione a gas.
1817
In Italia inizia a diffondersi la Carboneria. Moti carbonari nelle Marche.
L'egittologo Battista Belzoni scopre a Luxor la tomba di Seti I e penetra nella piramide di Cheope.
Il governo del Lombardo-Veneto introduce l'istruzione obbligatoria per tutti i bambini fra i sei e i
dodici anni.
1818
12 dicembre: la duchessa di Parma, Maria Luigia, visita Busseto.
Gran Bretagna: dilagano gli scioperi nelle filande.
12 Francia ottiene l'evacuazione dai suoi territori delle truppe alleate.
La Baviera ottiene una costituzione.
C. E Drais von Sauerbronn costruisce la draisina, bicicletta primitiva, mossa con la spinta dei piedi.
Cronologia 1819
Giuseppe Verdi
1819
A Busseto viene decisa l'apertura di un ginnasio di studi.
1820
Il padre regala a Giuseppe una spinetta; il ragazzo comincia a sostituire Baistrocchi all'organo.
luglio: Ferdinando Provesi viene nominato organista della collegiata di S. Bartolomeo in Busseto.
A questo periodo o a periodo di poco posteriore risale l'episodio di GV chierichetto, che serve
messa nella chiesa delle Roncole, essendo officiante il cappellano don Giacomo Masini: "nel
momento che il chierico deve versare il vino nel calice l'organista si mise a suonare e il piccolo
Verdi rimane immobile a ascoltare come estatico la musica; il prete lo richiama all'ufficio, egli non
ode, il prete allora gli dà un pugno che lo getta giù dai gradini dell'altare"; Dio t' manda na sajeta!
sarebbe stata la risposta adirata del piccolo Giuseppe.
Arte e cultura
collaborano Pellico, Gonfalonieri, Berchet, Romagnosi, Borsieri.
23 settembre: Milano, Scala: Pacini, Il barone di Dolsbeim.
3 dicembre: Napoli, S. Carlo: Rossini, Ricciardo e Zoraide.
W Scott, Le prigioni di Edimburgo, romanzo. Jean-Charles Sismondi termina di pubblicare la sua
Storia delle repubbliche italiane del Medioevo. G. B. Sonzogno fonda a Milano una casa editrice.
1819
19 gennaio: Venezia, S. Benedetto: Pacini, La sposa fedele.
24 settembre: Napoli, S. Carlo: Rossini, La donna del lago.
Ottobre: Bellini è ammesso al Conservatorio di Napoli. 11 ottobre: Milano, Scala: Viganò, I Titani,
ballo. 23 ottobre: Parigi, Odéon: Casimir Delavigne, / vespri siciliani, tragedia.
22 dicembre: Parigi, Opera: Spontini, Olimpia.
26 dicembre: Milano, Scala: Rossini, Bianca e Falliero. - Venezia, S. Samuele: Gaetano Donizetti, Il
falegname di Livonia.
Walter Scott, La fidanzata di Lammermoor, romanzo. Pompeo Ferrari, Teatro di Schiller, recato
per la prima volta dal tedesco in italiano.
1819-1822: Michele Leoni, Tragedie di Shakespeare, in traduzione italiana.
Giacomo Leopardi, L'infinito.
Alessandro Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica. Schopenhauer, Il mondo come volontà e
rappresentazione.
Théodore Géricault, La zattera della medusa, dipinto.
1820
11 maggio: Trieste,T. Grande: Pacini, La sacerdotessa dirminsul.
Giugno: Ricordi pubblica i 24 Capricci di Niccolò Paganini. 3 dicembre: Napoli, S. Carlo: Rossini,
Maometto II. 26 dicembre: Roma,Valle: Pacini, La gioventù di Enrico V A. Manzoni, Il conte di
Carmagnola, tragedia. - G. Byron, Marino Faliero, tragedia.
W. Scott, Ivanhoe, romanzo.
Francisco Goya, Le pitture nere.
Politica, società, scienza, scoperte
1819
Metternich organizza a Karlsbad un convegno di ministri in cui vengono decretate la censura sulla
stampa e misure repressive contro le associazioni studentesche.
Gli Stati Uniti acquistano la Florida dalla Spagna.
In America del Sud le lotte di liberazione guidate da Simón Bolivar conducono alla proclamazione
della Grande Colombia, con Bolivar presidente.
Gli Inglesi occupano Singapore.
Il medico francese R.T. Laennec inventa lo stetoscopio. Il piroscafo Savannah compie in 26 giorni
la prima traversata dell'Atlantico.
6 febbraio: Parigi, Opera: nella messinscena di un'opera viene per la prima volta sperimentata la
luce a gas.
1820
Gennaio: rivoluzione in Spagna; il re è costretto al ripristino della costituzione del 1812.
Luglio: nel regno di Napoli la rivolta guidata da Guglielmo Pepe costringe il re a concedere la
costituzione. Intanto in Sicilia scoppiano tumulti contro il centralismo napoletano.
13 ottobre: in Lombardia la scoperta delle "vendite" carbonare conduce all'arresto di Silvio Pellico,
Piero Maroncelli, Luigi Porro Lambertenghi, Pietro Borsieri; condannati a morte, la loro pena
viene commutata in carcere da scontare nella fortezza dello Spielberg.
Negli Stati Uniti viene dichiarata abolita la schiavitù nei territori a nord del 36° parallelo.
Hans Chr. Oersted scopre l'elettromagnetismo.
Cronologia 1821
Giuseppe Verdi
1821
Alle Roncole si forma un piccolo gruppo di cantori per le cerimonie sacre, diretto da don Pietro
Parenti; il piccolo Giuseppe ne fa parte.
Stefano Cavaletti ripara la spinetta sulla quale studia Giuseppe e non chiede compenso "vedendo la
buona disposizione che ha il giovinetto Giuseppe Verdi d'imparare a suonare questo istrumento".
7 maggio: Carlo Verdi chiede di avere un banco nella collegiata di S. Bartolomeo in Busseto. 24
agosto: nasce a Zibello, in provincia di Parma, Emanuele Muzio.
1822
GV viene assunto come organista della chiesa delle Roncole
1823
Allo scopo di "dargli un'educazione che lo esonerasse dal lavoro manuale" e anche per consiglio e
incoraggiamento del negoziante e filarmonico Antonio Barezzi, Carlo Verdi conduce il figlio a
Busseto per fargli continuare gli studi in quel ginnasio e lo alloggia in casa del ciabattino Pietro
Michiara detto Pugnatta.
2 maggio: muore a Frescarolo Pietro Baistrocchi, organista della chiesa delle Roncole.
Novembre: GV viene ammesso al ginnasio di Busseto e riceve lezioni da don Pietro Seletti, Carlo
Curotti e Giacinto Volpini. Conserva tuttavia il posto di organista alle Roncole.
Arte e cultura
1821
5 gennaio: muore a Milano Carlo Porta.
23 febbraio: muore a Roma il poeta John Keats.
24 febbraio: Roma, Apollo: Rossini, Matilde di Shabran.
3 marzo: Milano, Scala:Viganò, Giovanna d'Arco, ballo.
18 giugno: Berlino: Weber, Il franco cacciatore. 10 agosto: muore a Milano Salvatore Viganò.
12 ottobre: nasce a Ravenna Angelo Mariani.
30 ottobre: Milano, Scala: Mercadante, Elisa e Claudio. G. Byron, I due Foscari e Caino, tragedie.
Manzoni lavora a Fermo e Lucia.
Francesco Hayez, I vespri siciliani, dipinto.
G.W. E Hegel, Lineamenti della filosofia del diritto.
A Parigi la Casa Érard costruisce il pianoforte "a doppio scappamento".
Giovan Pietro Vieusseux fonda a Firenze la rivista "Antologia".
1822
4 febbraio: Venezia, Fenice: Morlacchi, Tebaldo e Isolino.
16 febbraio: Napoli, S. Carlo: Rossini, Zelmira.
8 luglio: muore per annegamento nel Mar Tirreno il poeta Percy Bysshe Shelley.
Settembre: Bologna, Comunale: Giacomo Serafini, La distruzione d'Aquileia, ballo.
13 ottobre: muore a Venezia lo scultore Antonio Canova.
Ottobre: Schubert, Sinfonia Incompiuta.
26 dicembre: Roma,Valle: Filippo Celli,11 Corsaro. Alessandro Manzoni, Inni sacri e Adelchi,
tragedia. Ippolito Pindemonte pubblica una traduzione italiana
dell'Odissea.
Jean Francois Champollion decifra il valore fonetico e ideografico dei geroglifici egiziani.
1823
19 gennaio: Torino, Regio: Mercadante, Didone abbandonata.
3 febbraio: Venezia, Fenice: Rossini, Semiramide.
6 febbraio: Milano, Scala: Pacini, La vestale.
Luglio: Vicenza, Eretenio: Feliciano Strepponi, Francesca da Rimini.
28 luglio: Kassel: Ludwig Spohr,Jessonda.
25 ottobre: Vienna: Weber, Euryanthe. Novembre: Stendhal, Vita di Rossini.
1 823-1 825: Stendhal, Racine e Shakespeare.
Politica, società, scienza, scoperte
1821
7 marzo: gli Austriaci, chiamati dal re di Napoli che nel frattempo ha rinnegato la costituzione,
sconfiggono gli insorti a Rieti.
14 marzo: Carlo Alberto concede una costituzione, ma sconfessato da Carlo Felice si ritira in
Toscana.
23 marzo: insurrezione carbonara ad Alessandria, guidata da Santorre di Santarosa.
26 marzo: insurrezione a Messina.
10 aprile: Vittorio Emanuele I abdica in favore del fratello Carlo Felice e nomina reggente il nipote
Carlo Alberto.
5 maggio: muore a S. Elena Napoleone.
Viene arrestato Federico Confalonieri; la condanna a morte gli viene commutata in carcere da
scontare nella fortezza dello Spielberg.
Agustin Iturbide proclama l'indipendenza del Messico dalla Spagna. Il Venezuela entra a far parte
della Grande Colombia. In Perù vengono cacciati gli Spagnoli e dichiarata l'indipendenza del
paese.
A Parma viene compiuto il ponte sul Taro.
1822
Gennaio: al congresso di Epidauro viene proclamata l'indipendenza della Grecia dalla Turchia;
inizia la guerra di liberazione.
Il figlio del re del Portogallo proclama l'Impero indipendente del Brasile e si proclama imperatore
col nome di Pedro I.
Dura repressione dei Carbonari a Modena.
Ottobre-dicembre: congresso di Verona convocato dalle potenze della Santa Alleanza per valutare
la situazione italiana dopo i moti del '21. La Francia viene incaricata di reprimere i moti in Spagna.
Parigi, Opéra: prima applicazione della illuminazione a gas in teatro.
I primi passi della fotografia: Daguerre realizza il diorama; J. N. Niepce riesce a ottenere le primi
immagini stabili.
1823
29 aprile: si conclude a Parma il processo contro i Carbonari.
20 agosto: muore Pio VII; gli succede Leone XII.
25 settembre: si conclude a Parma un secondo processo contro Liberali e Carbonari.
In Spagna i moti vengono repressi dall'esercito francese; feroci rappresaglie da parte di
Ferdinando VII.
2 dicembre: dottrina di Monroe contro ogni tentativo di intervento nel continente americano.
Guatemala, Nicaragua, Honduras, EI Salvador si proclamano indipendenti.
Cronologia 1824
Giuseppe Verdi
1824
GV riceve lezioni di musica, sembra, anche dall'organista don Pietro Arquati.
Risale forse all'inverno di quest'anno l'episodio, raccontato dallo stesso GV, del rischio di
annegamento in un canale costeggiante la strada fra le Roncole e Busseto per una caduta
provocata dal ghiaccio e dalla scarsa visibilità, e del suo salvataggio da parte di una contadina
accorsa alle sue grida d'aiuto.
1825
Inizia a studiare contrappunto e composizione con Ferdinando Provesi, maestro di cappella e
organista in S. Bartolomeo nonché maestro di musica della Società Filarmonica.
Inizia a comporre musica; risalirebbe a questo periodo una sinfonia, intitolata Capricciosa, che sarà
eseguita il 15 agosto 1868 per l'inaugurazione del nuovo teatro di Busseto.
1826
4 agosto: GV sostiene l'esame di "grammatica superiore", dimostrando di non aver fatto "nessun
progresso" sebbene fornito "di qualche talento".
È "in grado di comporre e di ammaestrare la gioventù"; scrive e fa eseguire marce e rondò per
banda.
"Dagli anni 13 fino ai diciotto [...] ho scritto una farragine di pezzi: Marcie per banda a centinaia:
forse altrettante brevi Sinfonie che servivano per chiesa, pel teatro e per accademie: cinque o sei tra
Concerti e Variazioni per pianoforte che io stesso suonava nelle accademie: molte Serenate,
Cantate,Arie, moltissimi Duetti, Terzetti e diversi pezzi da chiesa, di cui non ricordo che uno
Stabat Mater".
Arte e cultura
Francesco Lucca fonda lo stabilimento musicale che porta il suo nome.
1824
4 febbraio: Roma,Valle: Donizetti, Laio nell'imbarazzo.
8 marzo: Venezia, Fenice: Giacomo Meyerbeer, /1 crociato in Egitto.
19 aprile: muore a Missolungi George Byron.
7 maggio: Vienna: Beethoven, Nona Sinfonia.
4 settembre: nasce ad Ansfelden (Austria)Anton Bruckner.
Giuseppe Carpani, Le Rossiniane ossia Lettere musico-teatrali.
G. Byron, Don Giovanni, una satira epica.
Eugène Delacroix, Massacro di Scio, dipinto.
1825
12 gennaio: Napoli, Conservatorio: Bellini. Adelson e Salvini.
7 maggio: muore a Vienna Antonio Salieri.
19 giugno: Parigi, T. Italiano: Rossini, Il viaggio a Reims, cantata scenica.
31 ottobre: Milano, Canobbiana: Vaccai, Giulietta e Romeo.
19 novembre: Napoli, S. Carlo: Pacini, L'ultimo giorno di Pompei.
29 novembre: per la prima volta a New York si tiene una stagione d'opera.
10 dicembre: Parigi, Opéra-Comique:Adrien Boieldieu, La dama bianca.
Aleksandr Pushkin, Boris Godunov, dramma storico. L'editore Ricordi acquista i fondi
dell'archivio della Scala e pubblica il suo terzo catalogo.
1826
21 febbraio: Venezia, Fenice: Mercadante, Donna C'aritea.
26 marzo: Parigi, Opéra: Rossini,Mosè (nuova versione). 12 aprile: Londra: Weber, Oberon.
30 maggio: Napoli, S. Carlo: Bellini, Bianca e Gernando.
5 giugno: muore a Londra Carl Maria von Weber.
16 agosto: Milano, Scala: Giovanni Galzerani, Il corsaro, azione mimica.
9 ottobre: Parigi, Opéra: Rossini, L'assedio di Corinto. Mendelssohn, Sogno di una notte di mezza
estate, musiche di scena.
Schubert, Die Winterreise, ciclo di Lieder.
Tommaso Grossi: I Lombardi alla prima crociata, poema.
Walter Scott, Woodstock, romanzo.
Politica, società, scienza, scoperte
H. Ch. Oersted isola l'alluminio.
1824
16 settembre: muore a Parigi Luigi XVIII; sale al trono Carlo X di Borbone, che restaura il potere
assoluto della monarchia: leggi contro la libertà di stampa, ritorno dei Gesuiti, scioglimento della
Guardia nazionale.
Pietro Giordani viene condannato all'esilio.
In Gran Bretagna viene concesso ai lavoratori il diritto di associazione e di sciopero.
In America Latina l'ondata rivoluzionaria sfocia nell'indipendenza del Perù.
1825
In Gran Bretagna vengono legalizzate le Trade Unions. 8 maggio: Santorre di Santarosa muore in
difesa di Sfacteria, in Grecia, nella guerra contro i Turchi.
In America Latina viene dichiarata l'indipendenza della Bolivia.
1° dicembre: muore lo zar Alessandro I; le società segrete danno vita alla rivolta militare
"decabrista", che viene duramente repressa dal nuovo zar Nicola I.
I francesi Chevreul e Gay-Lussac inventano la candela stearica.
In Inghilterra viene inaugurata la prima linea ferroviaria per il trasporto di passeggeri.
1826
Congresso di Panama: fallisce il progetto di Bolivar per un'unione federativa sudamericana.
Joseph N. Niepce ottiene la prima immagine fotografica. Fourneyron realizza la turbina idraulica.
Cronologia 1827
Giuseppe Verdi
1827
Carlo Verdi si aggiudica per asta l'affitto, per nove anni, del podere vescovile di Madonna dei
Prati.
1828
GV scrive una sinfonia per la rappresentazione a Busseto del Barbiere di Siviglia di Rossini, e una
cantata per baritono e orchestra su versi di Alfieri, intitolata I deliri di Saul.
14 settembre: durante un violento temporale scoppiato nel corso di una cerimonia religiosa nel
santuario di Madonna Prati - alla quale GV, che "doveva cantare nei vespri", giunge in ritardo - un
fulmine cade nell'abside "nel centro del coro sulla testa d'una madonna" uccidendo quattro preti e
due secolari. GV "ebbe una scossa nervosa da quel orribile spettacolo e rimase malato per più d'un
mese".Tra i preti fulminati era don Giacomo Masini (vedi 1820).
1829
24 ottobre: GV concorre al posto di organista a Soragna; ma la sua domanda non viene accolta.
Diventa assistente di Provesi. Compone brani di musica sacra e pezzi per banda.
1830
19 febbraio: grande accademia in casa Barezzi delle due Società Musicale e Poetica; Provesi vi
presenta composizioni di "quel genio, che in oggi risorge, e che diverrà il più bell'ornamento di
questa Patria".
Arte e cultura
1827
8 marzo: Milano, Scala: Pacini, Gli Arabi nelle Gallie.
27 marzo: muore a Vienna Ludwig van Beethoven. 10 settembre: muore in Inghilterra Ugo
Foscolo.
27 ottobre: Milano, Scala: Bellini, II pirata.
21 novembre: Napoli, Nuovo: Donizetti, Le convenienze teatrali.
Andrea Maffei inizia con La sposa di Messina la traduzione delle tragedie di Schiller
Alessandro Manzoni:/ promessi sposi (prima edizione). Victor Hugo, Cromwell, tragedia.
G. Leopardi, Operette morali.
Heinrich Heine, Libro dei canti.
Louis-AdolphcThiers, Storia della rivoluzione francese.
1828
1° gennaio: Napoli, S. Carlo: Donizetti: L'esule di Roma.
28 febbraio: Parigi, Opéra:Auber, La muta di Portici.
6 marzo: Paganini inizia da Vienna la tournée che lo
rivelerà ai pubblici di tutta Europa.
20 marzo: nasce a Skien, in Norvegia, Henrik Ibsen.
29 marzo: Lipsia: Heinrich A. Marschner, Der Vampyr.
7 aprile: Genova, inaugurazione del teatro Carlo Felice; Bellini, Bianca e Fernando.
16 aprile: muore a Bordeaux Francisco Goya. 20 agosto: Parigi, Opéra: Rossini, Il conte Ory.
28 agosto: nasce a Jasnaja Poljana Lev N.Tolstoj.
13 ottobre: muore a Milano Vincenzo Monti.
18 novembre: muore a Verona Ippolito Pindemonte.
19 novembre: muore a Vienna Franz Schubert. Frainois-Joseph Méry, La battaglia di Tolosa,
dramma.
1829
14 febbraio: Milano, Scala: Bellini, La straniera.
16 maggio: Parma, inaugurazione del Teatro Regio; Bellini, Zaira.
12 giugno: Berlino: Spontini,Agnese di Hobenstaufen. 3 agosto: Parigi, Opéra: Rossini, Guillaume
Tell. 24 ottobre: Parigi, Comédie:Alfred de Vigny, // moro di Venezia, tragedia; id., Lettera a lord
***, manifesto del teatro romantico.
20 novembre: Trieste, Grande: E Strepponi, Gli IllinesL Goethe, Anni di pellegrinaggio di
Wilhelm Meister, romanzo.
Nasce a Parigi il periodico "Revue des Deux Mondes".
1830
Gennaio: Firenze: G. B. Niccolini, Giovanni da Procida, dramma in versi (composto nel 1817).
Politica, società, scienza, scoperte
1827
5 marzo: muore a Como Alessandro Volta.
Giugno: dopo dieci mesi di assedio i Turchi occupano Atene.
Luglio: conferenza di Londra; Gran Bretagna, Francia e Russia si impegnano per l'indipendenza
della Grecia.
20 ottobre: battaglia di Navarino; la flotta anglo-francorussa sconfigge quella ottomana.
G. S. Ohm formula la legge sulla resistenza elettrica.
1828
Giugno: moti nel Cilento e a Salerno, dove viene proclamata la costituzione francese.
Pace di Montevideo fra Argentina e Brasile; l'Uruguay diventa indipendente.
Scoppia un conflitto tra Russia e Turchia.
Ferrante Aporti fonda a Cremona una scuola infantile per la custodia e l'educazione di bambini da
due anni e mezzo a sei.
1829
10 febbraio: muore papa Leone XII; gli succede Pio VIII.
14 settembre: pace di Adrianopoli che sancisce la fine del conflitto fra Russia e Turchia; viene
confermata l'autonomia della Serbia e viene concessa alla Russia l'annessione della Moldavia e
della Valacchia.
1° dicembre: muore Pio VIII; gli succede Gregorio XVI. In Gran Bretagna viene dichiarata la
parità di diritti per i cattolici.
Il boemo Ressel sperimenta a Trieste la propulsione a elica su una nave a vapore.
1830
3 febbraio: col Protocollo di Londra viene creato il regno di Grecia.
Cronologia 1831
Giuseppe Verdi
Aprile: la Società Filarmonica esegue durante la processione del Venerdì Santo quattro marce di
GV. GV inizia a dare lezioni di canto e di piano alla figlia di Antonio Barezzi, Margherita, sua
futura sposa. Termina gli studi al ginnasio.
"Finiti i miei studi nel ginnasio di Busseto mio padre mi dichiarò che non avrebbe potuto
mantenermi nell'Università di Parma, e mi decidessi a lavorare nel mio villaggio natìo. Questo
buon vecchio [Antonio Barezzi], saputo questo, mi disse: «Tu sei nato a qualche cosa di meglio, e
non sei fatto per vendere il sale e lavorare la terra. Domanda a codesto Monte di Pietà la magra
pensione di 25 franchi al mese per quattro anni, ed io farò il resto; andrai al Conservatorio di
Milano e, quando lo potrai, mi restituirai il denaro speso per te»".
1831
Febbraio: allo scoppio dei moti insurrezionali GV si offre a far parte della Guardia Nazionale di
Busseto, ma viene rifiutato non avendo ancora compiuti i 18 anni (anni più tardi ricorderà che "era
a quell'epoca un gran gridare Viva questo e viva quello").
14 marzo: si trasferisce in casa di Antonio Barezzi e prosegue a dare lezioni di canto e piano alla
figlia Margherita.
28 marzo - 3 aprile: fa eseguire in pubblico una sua nuova composizione: Le lamentazioni di
Geremia, per voce di baritono, sulla versione italiana del testo biblico di Evasio Leoni.
16 maggio: Carlo Verdi chiede al Monte di Pietà di Busseto un sussidio per il figlio Giuseppe
affinché possa "perfezionarsi nell'arte musicale"; la domanda è appoggiata da vari attestati, fra cui
quelli di Provesi e del canonico Seletti.
14 dicembre: analoga richiesta Carlo Verdi rivolge alla duchessa Maria Luigia perché interceda
presso il Monte di Pietà di Busseto.
1832
13 febbraio: grazie a un contributo diAntonio Barezzi, il Monte di Pietà di Busseto accorda a GV
"dilettante di musica" una borsa di studio di 300 lire annue per quattro anni, onde "possa essere
mantenuto altrove allo studio dell'arte bella"
20 maggio: gli viene rilasciato un passaporto valido per lo spazio di un anno.
Arte e cultura
28 gennaio: Parigi, Opéra:Auber, Fra Diavolo.
20 febbraio: Milano, Scala: Louis Henry, Macbetto. azione mimica.
25 febbraio: Parigi, Comédie: V. Hugo, Hernani.
14 marzo: Milano, Scala: Pacini, Giovanna d'Arco.
5 dicembre: Parigi: Berlioz, Sinfonia fantastica.
26 dicembre: Milano,T. Carcano: Donizetti,Anna Bolena Stendhal, Il rosso e il nero, romanzo.
Niccolò Tommaseo, Dizionario dei sinonimi. Eugène Delacmix, La libertà che guida il popolo,
dipinto. Giunio Bazzoni e Giacomo Sormani pubblicano Opere di Shakespeare (comprendenti fra
l'altro Re Lear e Macbeth).
A Capolago (Canton Ticino) la Tipografia e libreria Elvetica inizia la sua attività, rivolta
soprattutto alla diffusione delle idee di Mazzini.
1831
15 gennaio: Roma,T. Apollo: Pacini, Il corsaro.
22 gennaio: Napoli, Nuovo: Pietro Raimondi,R ventaglio.
6 marzo: Milano,T. Carcano: Bellini, La sonnambula. 3 maggio: Parigi, Opéra-Comique: Louis
Hérold, Zampa. 11 agosto: Parigi:V. Hugo,Marion de Lorme, tragedia. 5 settembre: nasce a Parigi
Victorien Sardou.
17 settembre: Lucca, Giglio: prima esecuzione italiana del Guglielmo Tell di Rossini, con il tenore
Duprez.
11 ottobre: Milano, Scala: Luigi Ricci, Chiara di Rosemberg.
14 novembre: muore a Berlino Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
21 novembre: Parigi, Opéra: Meyerbeer, Robert le diable. 26 dicembre: Milano, Scala: Bellini,
Norma.
V. Hugo, Notre-Dame de Paris, romanzo.
Leopardi, Canti. - A. l'ushkin, Evgenij Onegin, poema.
1832
13 gennaio: muore a Trieste Feliciano Strepponi, padre di Giuseppina.
7 febbraio: Torino, Regio: Mercadante, I Normanni a Parigi.
Politica, società, scienza, scoperte
In Francia il governo reazionario di Polignac provoca una profonda crisi. Il 27 luglio scoppia
un'insurrezione popolare che dopo le tre "gloriose giornate" costringe Carlo X all'abdicazione e
alla fuga in Inghilterra. Il partito dei borghesi proclama Luigi Filippo I, duca di Orléans, re dei
Francesi. Sostenuta dalla politica capitalistica di FranQois Guizot, si apre l'età aurea dell'alta
borghesia. In politica estera si afferma il principio del non intervento. L'ondata rivoluzionaria si
propaga in Belgio, in Polonia e in Italia.
Novembre: rivolta di Bruxelles; viene dichiarata l'indipendenza del Belgio.
15 novembre: a Parma Macedonio Melloni tesse l'elogio delle barricate di Parigi.
Mazzini viene arrestato dalla polizia del regno di Sardegna e mandato in esilio.
In Polonia, Varsavia insorge contro il dominio russo.
La Grande Colombia si smembra nelle repubbliche di Colombia, Venezuela ed Ecuador.
Viene inaugurata la linea ferroviaria fra Manchester e Liverpool.
1831
2 febbraio: Roma: viene eletto papa Gregorio XVI, assertore dell'infallibilità del papato e
promotore di una politica antiliberale.
Febbraio: insurrezioni a Bologna (4 febbraio), a Modena, nelle Romagne, in Umbria e nelle
Marche; intervento
austriaco in Italia. 11 febbraio: rivoluzione a Parma; deposta Maria Luigia, si costituisce un
governo provvisorio. - 13 marzo: a Parma viene ristabilita la sovranità di Maria Luigia.
10 marzo: viene istituita la Legione Straniera per garantire l'occupazione francese di Algeri.
27 aprile: muore Carlo Felice; sale al trono del regno di Sardegna Carlo Alberto.
26 maggio: viene giustiziato a Modena Ciro Menotti. Luglio: Mazzini fonda a Marsiglia la
"Giovine Italia".
8 agosto: Maria Luigia rientra a Parma.
Memorandum delle grandi potenze al papa per l'avvio di riforme nello stato pontificio.
Conferenza di Londra: viene riconosciuta l'indipendenza del Belgio.
L'esercito russo soffoca la rivolta di Varsavia.
Michael Faraday scopre l'induzione elettromagnetica. Vengono prodotti i primi fiammiferi con
accensione per strofinio.
1832
Gennaio: gli Austriaci occupano la Romagna.
Rivolte liberali nello stato pontificio.
8 agosto: con la convenzione di Nauplia il regno di Grecia viene assegnato a Ottone di Baviera.
Cronologia 1833
Giuseppe Verdi
Fine maggio: parte per Milano e prende alloggio presso il bussetano prof. Giuseppe Seletti in
contrada Santa Marta. 22 giugno: fa domanda per essere ammesso al conservatorio come "allievo a
pagamento di pensione".
Fine giugno: sostiene l'esame di ammissione davanti a una commissione composta da Francesco
Basily, Gaetano Piantanida, Antonio Angeleri e Alessandro Rolla.
2 luglio: nonostante l'esito positivo nella prova di composizione (cimforme il parere di Basily e di
Piantanida "applicandosi esso con attenzione, e pazienza alla cognizione del contrappunto, potrà
diriggere la propria fantasia che mostra di avere, e quindi riuscire plausibilmente nella
composizione"), la domanda del giovane Vedi viene respinta per più ragioni: non aver dimostrato
sufficiente abilità al pianoforte (conforme il giudizio di Angeleri "avrebbe bisogno di cambiare la
posizione della mano, locché [...] attesa l'età di 18 anni si renderebbe difficile"), essere egli
cittadino forestiero, aver superata l'età massima e infine per la ristrettezza del numero dei locali
riservati agli allievi.
18 luglio: l'esito negativo viene comunicato a Rolla che suggerisce a GV di prendere lezioni
private da Vincenzo Lavigna o da Benedetto Negri. GV sceglie Lavigna.
Agosto: inizia a studiare con Lavigna, che gli fa già scrivere una sinfonia. È sempre a pensione da
Giuseppe Seletti. Autunno: assiste ad alcune rappresentazioni d'opera alla Scala.
1833
Inverno: prosegue a studiare con Lavigna soprattutto contrappunto ("Canoni e Fughe, e Fughe e
Canoni in tutte le salse"), e approfondisce la conoscenza dei grandi compositori del passato
(Corelli, Haydn, Mozart, ecc.). Va spesso a teatro; in maggio alla Scala ascolta la Malibran. Intanto
al Teatro Filodrammatico di Milano Pietro Massini istituisce un'accademia di musica aperta ai
giovani e ai dilettanti.
Giugno: GV rientra a Busseto per un periodo di vacanza.
26 luglio: muore Provesi,"parmigiano, maestro di musica, poeta spontaneo, da fortuna obliato",
lasciando vacante il posto di direttore della Filarmonica e di organista della collegiata.
11 10 agosto muore la sorella Francesca Giuseppa, cui GV era molto affezionato.
Settembre: GV ritorna a Milano per proseguire gli studi con Lavigna e va ad abitare da solo in via
S. Pietro all'Orto "la casa a destra dal lato opposto del vicolo che riesce nella galleria De
Cristoforis, una bella casa"; consuma i suoi pasti al l.eon d'Oro: una minestra costava 6 soldi di lira
milanese, una frittata 6 soldi, un piatto di carne 6 soldi, un dessert 6 soldi, vino e pane 10 soldi; in
tutto "non si arrivava a spendere due lire milanesi equivalenti a un franco e sessanta centesimi e si
mangiava bene".
Settembre: entra in contatto con il maestro Pietro Massini. 11 novembre: Lavigna gli rilascia un
attestato in suo favore.
Dicembre: da Milano GV fa domanda per concorrere al posto lasciato vacante da Provesi; ma la
sua domanda verrà sottaciuta dal parroco di S. Bartolomeo, don Ballarini, che nominerà un tale
Giovanni Ferrari di Guastalla.
1834
Durante il periodo di studio con Lavigna GV ha occasione di conoscere il figlio di Mozart, Carlo,
impiegato alle finanze del governo lombardo, e gli esegue più volte al piano il capolavoro del
padre, il Don Giovanni.
11 aprile: al Teatro Filodrammatici di Milano istruisce e dirige il coro ed è maestro al cembalo per
l'esecuzione dell'oratorio di Haydn, La creazione. È forse in questo periodo che fa conoscenza con
Andrea Maffei, socio del Filodrammatici.
Maggio: l'esecuzione della Creazione viene ripetuta al Casino dei Nobili, questa volta sotto la
direzione del giovane GV.
18 giugno: Giovanni Ferrari viene nominato organista e maestro di cappella della collegiata di
Busseto. Giugno: GV rientra a Busseto per le vacanze, e dirige in più occasioni l'orchestra della
Società Filarmonica.
28 giugno: ricorre presso il Presidente dell'Interno "per non essere stato dall'opera parrocchiale di
Busseto ammesArte e cultura
12 marzo: Parigi, Opera: Filippo Taglioni, La silfide, ballo, con Maria Taglioni.
22 marzo: muore a Weimar Wolfgang Goethe.
12 maggio: Milano, Canobbiana: Donizetti, L'elisir d'amore.
29 maggio: Parigi: I)umas (in collaborazione con E Gaillardet), La torre di Nesle, dramma.
21 settembre: muore a Abbotsford sir Walter Scott.
22 novembre: Parigi:V. Hugo, Le roi s'anzuse, tragedia. Chopin, 3 Nocturnes op. 9. - Mendelssohn,
primo quaderno delle Romanze senza parole.
Torino, Carignano: Silvio Pellico, Ester d'Engaddi, dramma.
S. Pellico, Le mie prigioni.
W Goethe, Faust, seconda parte.
Felice Le Monnier fonda a Firenze una casa editrice.
1833
2 gennaio: Roma, Valle: Donizetti, Il furioso dell'isola di S. Domingo.
19 gennaio: muore a Parigi Louis Hérold.
2 febbraio: Parigi:V. Hugo, Lucrezia Borgia, tragedia.
14 febbraio: Milano, Scala: Coccia, Caterina di Guisa.
27 febbraio: Parigi, Opera: Auber, Gustave III ou Le bal masqué.
16 marzo: Venezia, Fenice: Bellini, Beatrice di 7énda.
17 marzo: Firenze, Pergola: Donizetti, Parisina.
7 maggio: nasce ad Amburgo Johannes Brahms.
15 maggio: muore l'attore inglese Edmund Kean. 22 luglio: Parigi, Opéra: Cherubini, Ali Baba.
9 settembre: Roma,Valle: Donizetti, Torquato Tasso. 26 dicembre: Milano, Scala: Donizetti,
Lucrezia Borgia. Wagner compone la sua prima opera, Le fate. Felix Mendelssohn-Bartholdy,
Sinfonia detta L'italiana. M. d'Azeglio, Ettore Heramosca, romanzo. - Balzac,
Eugenia Grandet, romanzo.
1834
26 marzo: Parigi: Rossini, Soirées musicales.
31 agosto: nasce a Paderno Fasolaro (Cremona)Amilcare Ponchielli.
29 settembre: Milano, Conservatorio: l'allieva Giuseppina Strepponi canta nel saggio finale.
8 ottobre: muore a Jarcy (Parigi) Adrien Boieldieu.
18 ottobre: Napoli, S. Carlo: Donizetti: Buondelmonte (.uriria Stuarda).
14 novembre: concerto di Paganini a Parma.
28 novembre: Parigi,Teatro Italiano:Vincenzo Gabussi, Emani.
Politica, società, scienza, scoperte
In Gran Bretagna il governo di lord Grey vara il"Reform Act" che estende il suffragio ai
proprietari di beni immobili.
La Polonia viene proclamata provincia russa.
Joseph Henry scopre il fenomeno dell'autoinduzione e realizza il primo motore elettrico.
1833
Ottobre: in Spagna, alla morte di Ferdinando VII, il fratello don Carlos avanza pretese al trono.
Il parlamento inglese abolisce la schiavitù dei negri in tutti i domini britannici e limita a otto ore il
lavoro dei fanciulli nelle fabbriche.
Venezia, La Fenice: prima applicazione della illuminazione a gas in un teatro italiano.
1834
17 febbraio: Maria Luigia sposa in terze nozze il conte di Bombelles.
Fallisce in Savoia una spedizione mazziniana, cui aderisce fra gli altri Gerolamo Ramorino.
Mazzini scioglie a Berna la "Glovine Italia" e fonda la "Giovane Europa".
Dura repressione negli stati italiani dei moti liberali, in difesa dell'assolutismo politico, con arresti
e processi.
Rivolta operaia a Lione.
Gli Anglo-francesi intervengono in Spagna in appoggio alla regina Isabella nella successione al
trono; ha inizio la guerra civile promossa dal pretendente don Carlos
Cronologia 1835
Giuseppe Verdi
so al Concorso per la nomina di Suonatore organista e Maestro di Cappella in luogo del defunto
Ferdinando Provesi".
4 agosto: scrive a Lavigna perché si interessi a un libretto promessogli da Tasca.
12 ottobre: partecipa a un'Accademia vocale e strumentale della Società Filarmonica di Busseto
facendovi eseguire proprie musiche: una sinfonia "a pien'Orchestra", una Romanza per tenore, un
"Tema Originale per Clarinetto", un Recitativo ed Aria per soprano, un Capriccio per pianoforte
eseguito da lui stesso, un Recitativo ed Aria per Tenore, e una "Sinfonia finale".
14 novembre: assiste a Parma a un concerto benefico di Paganini, presente la duchessa Maria
Luigia (ricorderà anni più tardi: "Era un concerto con orchestra. Dopo le prime battute degli
stromenti quando Paganini incominciò a suonare, l'orchestra d'un tratto parve spenta, tanta
sonorità si sprigionava da quel violino!").
Ritorna a Milano per riprendere gli studi con Lavigna e per concluderli.
15 dicembre: il governo ducale decide che il posto di maestro di cappella di BuSseto sia messo a
concorso.
1835
Aprile: al Filodrammatico di Milano dirige come maestro al cembalo la Cenerentola di Rossini.
19 aprile: giorno di Pasqua, a Busseto la Società Filarmonica suona in piazza e in chiesa, dove
esegue un Tantum ergo "scritto di fresco dal bravissimo Verdi", che secondo Demaldè "riunisce in
sé la perizia dell'autore, il buon gusto, la novità, l'eleganza, la Filosofia, ed insomma inspira
divozione ".All'incirca a questo periodo risale anche la composizione di una marcia funebre, che
GV riutilizzerà poi nell'ultimo atto del Nabucco.
25 giugno: Maria Luigia respinge come infondato il ricorso di GV per la mancata ammissione al
concorso del posto di organista e maestro di cappella in Busseto; ma fa convocare l'Anzianato di
Busseto per deliberare in merito all'assunzione di un maestro di musica "istruttore della gioventù
indipendente dall'Organista".
5 luglio: Giuseppe Seletti informa Barezzi:"Lavigna non vuol dirmi totalmente che Verdi non sia
negligente, ma mi raccomanda di avvertirti che dopo il ritorno a Milano,Verdi non ha ricevuto che
36 lezioni".
15 luglio: Lavigna rilascia a GV un attestato in cui dichiara aver egli "studiato il Contrappunto
sotto la mia direzione ed ha percorso gli studi lodevolmente delle fughe a due, a tre, ed a quattro
voci; come pure Canoni, Contrappunto doppio ecc. Credendolo perciò abilitato a disimpegnare la
professione al pari di qualunque accreditato Maestro di Cappella".
16 luglio ca.: completati gli studi con Lavigna, GV rientra a Busseto recando con sé un libretto di
Antonio Piazza (Rocester) per un'opera che Massini ha promesso di far rappresentare al Teatro
Filodrammatici di Milano.
28 luglio: a Massini:"Io scrivo l'opera (come tu sai) e quando ritornerò in Milano spero di aver
abbozzato tutti i pezzi. Dammi notizie di tutti i Cantanti che avrai sentito nella Accademia che a
quest'ora avrai data, onde potermi regolare nella estensione delle voci".
29 agosto: con sovrano rescritto vengono proibite le musiche in tutte le chiese di Busseto.
11 ottobre: su sollecitazione di Lavigna e di Massini, GV fa istanza alla Fabbriceria della Basilica
Collegiata di S. Giovanni in Monza per essere assunto come maestro di cappella. Intanto
l'Anzianato di Busseto approva la spesa per l'assunzione di un maestro di musica incaricato di
istruire gratuitamente i giovani, limitando lo stipendio a sole 687 lire annue.
28 novembre: Lavigna sollecita la presenza di GV a Milano per concorrere al posto di Monza.
Inizio dicembre: appresa la notizia dell'incarico che sta per ottenere a Monza, i filarmonici
insorgono perché GV resti a Busseto per assumere in patria il posto di maestro di musica. Lavigna
a GV: "Ho letto quanto mi scrivi ed altro non ho potuto intenderne che ti trovi rattristato e assai
afflitto. Se ti fossi stato più chiaro spiegato, se più confidente, t'avrei maggiormente capito"; e
intanto lo sollecita a rinnovare l'istanza per il posto di Monza, assicurando che prenderà tutto
l'impegno per lui.
15 dicembre: GV comunica a Lavigna la rinuncia al posto di Monza:"il partito filarmonico" nel
rinfacciargli "i benefizii [...1 ricevuti dalla patria" giunse "ad atterrirmi colle minacce, e perfino ad
obbligarmi a restare in Busseto, qualora io fossi visto partire. Se il mio benefattore Barezzi non
avesse a soffrire per me l'odio quasi generale del paese, io sarei partito subito".
18 dicembre: Barezzi a Seletti:"abbiamo dovuto cedere a questa furente volontà degli amici, e tanto
più si è dovuto farlo, in quanto che si è voluto aprire una volontaria soscrizione per compiere pel
Verdi all'annuo stipendio sino a L. 1000. Io ed il Verdi conosciamo il peso del sacrifizio; ma l'onore
esigeva che si facesse".
Arte e cultura
26 dicembre: Milano, Scala: Donizetti, Gemma di Vergy.
Berlioz, Aroldo in Italia, sinfonia.
Schumann fonda la "Neue Zeischrift fair Musik".
Torino, Carignano: Carlo Marenco, La famiglia Foscari, dramma. - Alfred De Musset,
Lorenzaccio, dramma. - Georg Biichner, Woyzeck, tragedia.
Tommaso Grossi,Marco Visconti, romanzo. - Edward G. Bulwer-Lytton, Gli ultimi giorni di
Pompei, romanzo.
Gogol, Taras Bul'ba, racconto. - A. Pushkin, La donna di picche, racconto.
1834-1842: Poemi di Giorgio Lord Byron recati in italiano da Giuseppe Nicolini.
1835
19 gennaio: la Strepponi esordisce al Grande di Trieste nella Matilde di Shabran.
24 gennaio: Parigi,Teatro Italiano: Bellini, I Puritani.
28 gennaio: Napoli, S. Carlo: Giuseppe Persiani, Ines de Castro.
12 febbraio: Parigi:Alfred de Vigny, Chatterton, tragedia.
14 febbraio: Roma, Valle: Pietro Antonio Coppola, La pazza per amore.
23 febbraio: Parigi, Opera: F. Halévy, L'ebrea.
12 marzo: Parigi, Teatro Italiano: Donizetti, Marin
22 marzo: Madrid: Angel de Saavedra, Don Alvaro o La forza del destino, dramma.
28 aprile: Parigi: V. Hugo,Angelo, dramma.
8 giugno: muore a Milano Gian Domenico Romagnosi.
27 luglio: nasce a Val di Castello Giosuè Carducci.
16 settembre: Johann Moritz e Wilhclm Wieprecht brevettano a Berlino un nuovo strumento, il
bass-tuba.
23 settembre: muore a Puteaux (Parigi) Vincenzo Bellini.
26 settembre: Napoli, S. Carlo: Donizetti, Lucia di Lamnzernzoor
25 dicembre: Maria Luigia affida a Paganini il compito di riorganizzare l'orchestra ducale.
Antonio Somma, Parisina, dramma. - G. Biichner, La morte di Danton, dramma.
Hans Christian Andersen inizia a pubblicare le sue Fiabe. Balzac, Papà Goriot, romanzo. - Edward
G. BulwerLytton, Rienzi, l'ultimo dei tribuni romani, romanzo.
Lorenzo Bartolini, La fiducia in Dio, scultura.
Politica, società, scienza, scoperte (guerra carlista).
Viene costituita l'unione doganale tedesca (Deutscher Zollverein).
In Gran Bretagna si affermano le Trade Unions, organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il francese L. Braille inventa l'alfabeto a punti in rilievo per i ciechi.
L'americano C. M. McCormick brevetta la mietitrice meccanica.
1835
Settembre: in Francia dopo le repressioni operaie entrano in vigore leggi eccezionali che scatenano
tumulti popolari.
Alfonso Lamarmora istituisce un corpo di tiratori scelti detti "bersaglieri".
I Turchi sbarcano a Tripoli mettendo fine all'indipendenza della Libia.
Scoppia un'epidemia di colera in Italia e in Europa; durerà fino al 1836.
Samuel Colt inventa la pistola a tamburo.
In Germania viene costruita la prima ferrovia.
1835-1837: Daguerre mette a punto la prima tecnica per la riproduzione fotografica.
Cronologia 1836
Giuseppe Verdi
1836
6 gennaio: GV suona per la prima volta l'organo a Busseto nella chiesa dei Francescani. "Non si è
mai veduta la Chiesa zeppa come jeri e la Collegiata senza fedeli" commenta Demaldè; secondo
Cavalli vi fu un tale schiamazzo fuori della chiesa contro i "ferrariani" che fu vietato a GV di
suonare l'organo nelle chiese di Busseto sotto pena di
vietargli anche i concerti. Secondo il biografo Pougin, in questo periodo i successi di GV come
compositore e organista "erano tali che lo si disputava da tutti i lati e che le cittaduzze e i villaggi
nei dintorni di Busseto, come Soragna, Monticelli, Castell'Arquato, Lugagnano, ecc. volevano
averlo a tutti i costi [...1. La folla accorreva da tutte le parti, l'affluenza era enorme".
Gennaio: la Società Filarmonica apre un concorso per l'incarico di maestro di musica e direttore
della stessa.
27-28 febbraio: GV sostiene l'esame di concorso a Parma con il maestro Alinovi, riuscendo
vincitore.
5 marzo: è nominato maestro di musica di Busseto.
Intanto inizia la composizione della sua prima opera, Rocester, confidando di rappresentarla,
tramite Massini, al Filodrammatico di Milano.
4 maggio: si unisce in matrimonio con Margherita Barezzi; insieme si recano a Milano in viaggio
di nozze.
Rientrati a Busseto prendono alloggio a palazzo Tedaldi.
Mette in musica l'ode di Manzoni Il cinque maggio.
14 settembre: muore di colera a Milano Vincenzo Lavigna.
16 settembre: GV informa Massini d'aver terminato la composizione dell'opera.
21 settembre: spera di far rappresentare l'opera a Parma e fa chiedere ad Antonio Piazza alcune
modifiche di versi al libretto.
Novembre: compone un nuovo Tantum ergo per voce e orchestra.
1837
1° gennaio: il suo Tantum ergo viene eseguito nella collegiata di Busseto con accompagnamento
d'organo.
i O gennaio: invia all'oboista Giacomo Mori delle Variazioni che gli erano state inviate per essere
da lui corrette.
22 gennaio: dirige un'accademia della Società Filarmonica; nel programma una sua Sinfonia e
un'aria da I deliri di Saul.
26 maggio: nasce la figlia Virginia.
18 giugno: nella chiesa dei Francescani a Busseto viene eseguita una Messa a tre voci, forse
composta da GV.
8 ottobre: nella chiesa arcipretale di Croce S. Spirito, nel comune di Castelvetro, in occasione della
sagra del S. Rosario, GV esegue con i filarmonici bussetani una sua Messa, che la "Gazzetta
privilegiata di Milano" segnala come "eletta musica, quale cioè a sacra cerimonia conveniva; poiché
in essa erano le armonie sì ben accomodate alla significazione dei sacri concetti, che ti destavano nell'animo i sentimenti più vivi della pietà e della
Religione. 12 quale cosa diciamo a tutta lode del Sig. Verdi".
Ottobre: alla scopo di far rappresentare il suo Rocester al Teatro Regio di Parma ottiene di
incontrare l'impresario Granci; ma questi rifiuta, non volendo arrischiare la stagione con l'opera
d'un esordiente.
3 novembre: scrive a Massini perché interceda presso l'impresario della Scala, Bartolomeo Merelli,
onde far rappresentare la sua opera in un teatro di Milano.
1838
4 febbraio: dirige un'accademia della Società Filarmonica, presentando una sua nuova Sinfonia e
un'aria.
18 febbraio: dirige un'altra accademia della Società Filarmonica, con l'esecuzione di alcune sue
composizioni: Recitativo ed aria, Divertimento per tromba e una Sinfonia Finale.
25 febbraio: dirige una terza accademia della Società Filarmonica, con l'esecuzione di musiche sue:
un Recitativo ed aria, Introduzione, variazioni e coda per fagotto, un Duetto buffo e un Capriccio
per corno.
Arte e cultura
1836
4 febbraio: Venezia, Fenice: Donizetti, Belisario. 29 febbraio: Parigi, Opéra: Meyerbeer, Gli
Ugonotti. 1° marzo: Madrid: García Gutiérrez, IZ trovatore. 29 marzo: Magdeburgo:Wagner, Il
divieto d'amare. 17 aprile: S. Pietroburgo: Nikolaj Gogol', L'ispettore generale, commedia.
22 maggio: Diisseldorf: Mendelssohn, Paulus, oratorio.
6 giugno: Napoli, Nuovo: Donizetti, Il campanello dello speziale.
17 giugno: Torino, Carignano: C. Marenco, Pia de. Tolomei, dramma.
31 agosto: Parigi: Dumas, Kean, dramma.
23 settembre: muore a Manchester Maria Malibran.
17 ottobre: Parigi: A. Anicet - Bourgeois - E Cornu, Nabuchodonosor, dramma.
9 dicembre: Pietroburgo: Glinka, Ivan Sussanin. Mazzini, Filosofia della musica; id., Della Fatalità
considerata com'elemento drammatico.
Domenico Guerrazzi, L'assedio di Firenze, romanzo. Cesare Cantù pubblica il primo volume della
sua Storia universale.
1837
10 febbraio: muore in duello a S. Pietroburgo Aleksandr Pushkin.
18 febbraio: Venezia, Apollo: Donizetti, Pia de' Tolomei.
11 marzo: Milano, Scala: Mercadante, Il giuramento. 1° aprile: Parigi: ripresa del Guglielmo Tell
di Rossini col tenore Duprez (la rivoluzione del Do di petto).
5 maggio: muore a Torre del Greco Nicola Zingarclli.
14 giugno: muore a Napoli Giacomo Leopardi.
2 settembre: Napoli, S. Carlo: Donizetti, Roberto
Devereux.
5 dicembre: Parigi, Invalides: Berlioz, Grande Messe
des Morts.
22 dicembre: Lipsia: Gustav Albert Lortzing, Zar und
Zimmermann.
Ch. Dickens, Il circolo Pickwick, romanzo.
Gogol', Il cappotto, racconto.
Temistocle Solera, I miei primi canti, poesie.
1838
10 marzo: Venezia, Fenice: Mercadante, Le due illustri rivali.
13 marzo: Trieste, Grande: Federico Ricci, La prigione di Edimburgo.
17 agosto: muore a New York Lorenzo Da Ponte.
Politica, società, scienza, scoperte
1836
19 giugno - 15 settembre: a Parma scoppia un'epidemia di colera.
Rivoluzione in Spagna e insurrezione a Lisbona. In Francia Luigi Bonaparte tenta di sollevare la
guarnigione di Strasburgo per rovesciare Luigi Filippo. Il Texas si stacca dal Messico e chiede di
entrare a far parte degli Stati Uniti.
In Sudafrica i Boeri scacciano gli Inglesi dalla colonia del Capo e fondano lo stato libero
dell'Orange.
Nikolaus von Dreys realizza il primo fucile a retrocarica ("ad ago").
Parigi: costruzione dell'Arco di Trionfo.
1837
20 giugno: muore Guglielmo IV d'Inghilterra; gli succede la nipote Vittoria che regnerà fino al
1901.
Il re dell'Hannover sospende la costituzione.
Mazzini in esilio a Londra ricostituisce la "Giovine Italia".
Samuel E B. Morse realizza il primo telegrafo scrivente. W. E Cooke e Ch. Wheatstone inventano
un telegrafo elettromagnetico a cinque aghi.
1838
8 settembre: Ferdinando I d'Austria viene incoronato re del Lombardo-Veneto. Concede l'amnistia
ai condannati dello Spielberg.
Nasce in Inghilterra il programma dei (:artisti, primo movimento politico operaio.
Cronologia 1839
Giuseppe Verdi
Maggio: si reca a Milano per pochi giorni.
11 luglio: nasce il figlio Icilio.
12 agosto: muore la figlia Virginia.
8 settembre - 10 ottobre: si reca di nuovo a Milano con la moglie Margherita. Si rivolge a Massini,
al conte Borromeo e a un certo ingegner Pasciti per ottenere di rappresentare la sua opera (già
Rocester, ora Oberto) in una serata benefica alla Scala organizzata dalla Pia Accademia
Filarmonica. Intanto pubblica presso l'editore G. Canti le sue prime
composizioni: Sei romanze per canto e pianoforte.
28 ottobre: rientrato da Milano, si dimette dall'incarico di maestro di musica in Busseto.
1839
6 febbraio: lascia Busseto con la famiglia e si stabilisce a Milano, in via S. Simone (Porta Ticinese).
Aprile: è presentato alla Strepponi, cui fa ascoltare la sua opera. Il parere positivo di altri cantanti
(Moriani,Ronconi e Marini) persuade Merelli a farla rappresentare in una serata benefica.
22 aprile: scrive a Giuseppe Demalde:"Il mio spartito L.] si eseguirà forse al Teatro La Scala con
Moriani, Ronconi, la Strepponi e la Kemble". Copia di propria mano tutte le parti della sua opera
"per risparmio di spesa".
Maggio: a causa della malattia di Moriani la rappresentazione di Oberto viene rimandata; intanto
Merelli suggerisce a GV di far apportare alcune modifiche al libretto rivolgendosi a Solera.
4 settembre: GV chiede un prestito al suocero Barezzi: "Lei sa a che siano rivolte le mie mire e le
mie speranze: Non certamente la speranza di accumulare ricchezze, ma quella di essere qualche
cosa fra gli uomini".
Settembre: l'editore Canti gli pubblica due romanze: L'esule (su versi di Solera) e La seduzione, e il
Notturno "Guarda che bianca luna", per soprano, tenore, basso e flauto obbligato.
27 settembre ca.: il giornale "Il Pirata" annuncia prossima la rappresentazione alla Scala
dell'Oberto.
6 ottobre: GV a Massini:"Le faccende della mia Opera vanno tuttora bene. I cantanti sono tutti
contenti e le donne hanno le parti: lo spartito resta di mia proprietà [.. Ricordi mi disse di avere il
diritto di stampa senza dare nissun
compenso. Questo non mi sembra giusto". 22 ottobre: muore il figlio Icilio.
17 novembre: Milano, Scala: prima rappresentazione di Oberto, conte di S. Bonifacio; il successo è
molto buono; l'opera viene replicata fino al termine della stagione.
Novembre-dicembre: Merelli offre a GV un contratto per tre opere a 4.000 lire austriache
ciascuna. La prima di esse dovrà essere Il proscritto, su libretto di Gaetano Rossi (che però a GV
non piace), da rappresentarsi nel prossimo autunno.
10 dicembre: l'editore Giovanni Ricordi inizia a pubblicare i pezzi dell'Oberto nella trascrizione per
pianoforte a 4 mani.
1840
Gennaio-febbraio: per necessità di cartellone Merelli chiede a GV un'opera buffa su argomento da
scegliersi fra
"vari libretti di Romani"; il compositore sceglie come il "meno male" il libretto del Finto Stanislao,
già musicato dal compositore boemo Gyrowetz per la Scala nel 1818; il titolo viene mutato in Un
giorno di regno.
Marzo: inizia a comporre Un giorno di regno; ma deve lottare con una salute malferma: mal di
gola, dapprima; frequenti dolori gastrici in seguito.
18 giugno: muore la moglie Margherita per encefalite. 22 giugno: GV si reca a Busseto.
Luglio: rientra a Milano e termina la composizione di Un giorno di regno.
5 settembre: Milano, Scala: prima rappr. di Un giorno di regno, con esito disastroso. 17 ottobre:
Merelli rimette in scena l'Oberto, che rinnova il successo.
9 novembre: GV rispedisce a Busseto tutti i mobili della sua casa di Milano e va ad abitare in una
pensione in
Arte e cultura
10 settembre: Parigi, Opéra: Berlioz, Benvenuto Cellini.
27 ottobre: Milano, Scala: Nabucodonosor, ballo, coreografia di Antonio Cortesi.
28 ottobre: nasce a Parigi Georges Bizet.
8 novembre: Parigi: V. Hugo, Ruy Blas, dramma.
Carlo Rusconi, Teatro completo di Shakespeare, tradotto dall'originale in prosa italiana.
Cesare Cantù, Margherita Pusterla, romanzo. - Charles Dickens, Oliver Twist, romanzo.
1839
2 marzo: Venezia, Fenice: Vaccai, La sposa di Messina.
9 marzo: Milano, Scala: Mercadante, Il bravo. Nasce a Karevo Modest P Musorgskij.
20 aprile: esordio della Strepponi alla Scala con I puritani.
3 maggio: muore a Parigi Ferdinando Paer.
18 maggio: alla Scala la Strepponi ottiene un grande successo nell'Elisir d'amore.
22 giugno: ancora un grande successo della Strepponi alla Scala in Lucia di LammetTnoor.
23 agosto: Padova, Nuovo:Alessandro Nini, La marescialla d'Ancre.
30 ottobre: Torino, Carignano: Giovanni Speranza, I due Figaro.
24 novembre: Berlioz, Romeo e Giulietta, sinfonia drammatica.
Chopin, Ventiquattro preludi.
Giuseppe Revere, Lorenzino de' Medici, dramma. Balzac, Splendori e miserie delle cortigiane,
romanzo,
prima parte. - Stendhal, La certosa di Parma, romanzo. Carlo Cattaneo fonda a Milano "Il
Politecnico".
1840
11 febbraio: Parigi, Opéra-Comique: Donizetti, La figlia del reggimento. -Torino, Regio: Nicolai, Il
tempia rio.
10 marzo: Napoli, S. Carlo: Mercadante, La vestale.
14 marzo: Madrid: José Zorrilla y Moral, EI Zapatero y el Rey, dramma.
10 aprile: Parigi, Opéra: Donizetti: I martiri.
25 aprile: nasce a Votkinsk Pietro Ciajkovskij. 27 maggio: muore a Nizza Niccolò Paganini.
8 settembre: Lucca, Giglio: Poniatowski, Giovanni da Procida.
29 novembre: Napoli, S. Carlo: Pacini, Saffo.
2 dicembre: Parigi, Opéra: Donizetti, La favorita.
Politica, società, scienza, scoperte
Gli Inglesi occupano Aden, in Arabia.
Raffaele Piria scopre l'acido salicilico, per uso antireumatico.
1839
Nicola Fabrizi fonda a Malta la "Legione italica" allo scopo di fomentare la rivoluzione nell'Italia
meridionale mediante una "guerra per bande".
In Spagna si conclude la guerra "Carlista".
3 ottobre: viene inaugurata la prima linea ferroviaria italiana fra Napoli e Portici.
Il francese Louis Daguerre mette a punto un procedimento fotografico su lastre di rame
(dagherrotipia). L'americano Charles Goodyear mette a punto il processo di vulcanizzazione della
gomma.
1840
Fallisce il secondo tentativo dei "bonapartisti" di provocare un'insurrezione in Francia; Luigi
Bonaparte viene arrestato.
Parigi: traslazione delle ossa di Napoleone sotto la cupola degli Invalidi.
Gli Inglesi occupano la Siria e riconoscono l'indipendenza dell'Egitto dalla Turchia.
Sale sul trono di Prussia Federico Guglielmo IV. Scoppia la "guerra dell'oppio" fra Cina e Gran
Bretagna. Gli Inglesi si insediano in Nuova Zelanda.
6 maggio: cominciano a circolare in Gran Bretagna i primi francobolli, inventati da R. Hill.
18 agosto: viene inaugurata la linea ferroviaria fra
Cronologia 1841
Giuseppe Verdi
Contrada degli Andegari presso la Scala, non lontano dall'abitazione di Solera. Cerca di ottenere
da Merelli lo scioglimento del contratto; l'impresario, che ha fiducia nel giovane maestro, cede alle
sue insistenze, tuttavia dichiarandosi pronto a rinnovare il contratto il giorno che si decidesse a
"riprendere la penna".
1 1 novembre: Ricordi inizia a pubblicare i pezzi di Un giorno di regno nella riduzione per canto e
pianoforte.
Dicembre: GV si reca a Genova per l'allestimento dell'Oberto al teatro Carlo Felice. Intanto
Merelli gli propone di musicare un libretto di Solera, Nabucco, rifiutato dal compositore austriaco
Otto Nicolai, e di cedere a questi Il proscritto. GV accetta contro voglia di leggere il Nabucco; ma
poi ne rimane preso.
1841
9 gennaio: assiste alla rappr. di Oberto al Carlo Felice di Genova; scrive a un amico:"non ha
destato quel fanatismo che destò a Milano, ad onta che l'esecuzione fosse in complesso buona".
15 gennaio: rientra a Milano.
Fine gennaio: comincia a musicare, a poco a poco, il Nabucco, e chiede a Solera alcune modifiche al
libretto, fra cui la sostituzione di un "duettino amoroso tra Fenena ed Ismaele" con un "una
profezia pel Profeta Zaccaria".
Ottobre: termina la composizione di Nabucco nella convinzione che venga rappresentato alla Scala
nella prossima stagione di carnevale, comprendente tre opere nuove già precedentemente fissate,
nonostante che Merelli gli avesse già fatto presente che "il dare una quarta opera di autore quasi
esordiente era pericoloso per tutti".
Dicembre: viene pubblicato il cartellone della Scala, ma il Nabucco non vi è annunciato; GV,
furente, scrive una "leiteraccia" a Merelli; questi gli promette di dare l'opera in periodo di
quaresima, ma, per ragioni di economia, con costumi e scene di ripiego.
1842
22 febbraio: la Strepponi si ripresenta alla Scala nel Belisario, ma le sue condizioni vocali sembrano
ormai compromesse; Donizetti al cognato Vasselli :"il suo Verdi non la voleva nell'opera sua e
l'impresa lo ha obbligato". Iniziano intanto le prove di Nabucco.
9 marzo, Milano, Scala: prima rappr. di Nabucco, esito eccellente; viene replicato il concertato
finale.
GV inizia a frequentare il salotto della contessa Clara Maffei e quello di Giuseppina Appiani. Abita
sempre in Contrada degli Andegari, vicino alla Scala.
7 aprile: Ricordi inizia a pubblicare i pezzi del Nabucco nella riduzione per canto e pianoforte.
6 maggio: GV compone una romanza, Chi i bei dì m'adduce ancora per l'album di Sofia de' Medici.
In questo periodo matura la scelta dell'argomento della terza opera contrattata con Merelli per la
Scala, da ricavarsi da un episodio del poema I lombardi alla prima crociata di Tommaso Grossi.
21 maggio: alla Fenice che gli chiede un'opera nuova per la prossima stagione di carnevale,
risponde d'essere già impegnato con Merelli alla Scala.
Luglio: si reca a Busseto. 21 luglio: rientra a Milano.
13 agosto: con nuovi interpreti il Nabucco viene ripreso alla Scala per la stagione d'autunno: se ne
fanno 57 recite.
Settembre: si reca a Busseto per cinque o sei giorni; va anche a Bologna e vi conosce Rossini:"il
quale mi ha accolto assai gentilmente e l'accoglienza è parsa sincera. [...] Quando penso che
Rossini è la reputazione mondiale vivente, io mi ammazzerei e con me tutti gli imbecilli. Oh è una
gran cosa essere Rossini!"
18 settembre: rientra a Milano e s'inoltra nella composizione dei Lombardi.
Dicembre: su richiesta della cantante Almerinda Granchi, impegnata alla Fenice di Venezia nella
parte di Fenena in Nabucco, apporta alcune varianti alla melodia della Preghiera.
Arte e cultura
19 dicembre: nasce a Milano Giulio Ricordi.
26 dicembre: Firenze, Pergola: prima esecuzione italiana del Roberto il diavolo di Meyerbeer.
N.Tommaseo, Fede e bellezza, romanzo.
Edgar Allan Poe, Racconti del grottesco e dell'arabesco.
Giovanni Prati, Edmengarda, poema.
Milano, Brera: Hayez, L'ultimo abboccamento di
Giacomo Foscari figlio del Doge Francesco colla propria famiglia prima di partire per l'esilio(...1,
dipinto. Nicolini traduce il Macbeth di Shakespeare.
1841
11 febbraio: Roma, Apollo: Donizetti, Adelia, protagonista Giuseppina Strepponi.
3 marzo: Milano, Scala: Nicolai, // proscritto.
28 giugno: Parigi, Opéra: Coralli e Perrot, Giselle, ballo, con musica di A.Adam.
4 ottobre: Bologna, Comunale: Livio Morosini, Caterina Howard, azione mimica.
26 dicembre: Milano, Scala: Donizetti, Maria Padilla. Schumann, Prima Sinfonia.
M. d'Azeglio, Niccolò de' Lapi, romanzo.
Ludwig Feuerbach, L'essenza del cristianesimo.
1842
7 gennaio: Parigi: Rossini, Stabat Mater
24 febbraio: nasce a Padova Arrigo Boito.
26 febbraio: Trieste, Grande: Domenico Ronzani,
Caterina Howard, ballo.
15 marzo: muore a Parigi Luigi Cherubini.
23 marzo: muore a Parigi Stendhal.
12 maggio: nasce a Montaud Jules Massenet.
19 maggio: Vienna,Teatro di Porta Carinzia: Donizetti, Linda di Chamounix.
20 ottobre: Dresda: Wagner, Rienzi.
9 dicembre: Pietroburgo: Glinka, Russlan e Ljudmila.
10 dicembre: Napoli, S. Carlo: Pacini, La fidanzata corsa. 31 dicembre: Lipsia: Lortzing, Der
Wildschatz. Mendelssohn, Sinfonia detta La Scozzese.
Otto Nicolai fonda a Vienna la Società Filarmonica. Maffei pubblica la traduzione italiana del Don
Carlos di Schiller.
A. Manzoni, I promessi sposi (edizione definitiva). Michele Amari, La guerra del Vespro siciliano,
romanzo storico. - Gogol', Le anime morte, romanzo. - Eugène Sue, / misteri di Parigi, romanzo.
Lord Byron, Opere complete, tradotte in prosa italiana da Carlo Rusconi.
Politica, società, scienza, scoperte
Milano e Monza.
L'Austria stipula con il Regno di Sardegna e altri stati italiani (meno il Regno delle Due Sicilie)
una convenzione per la protezione del diritto d'autore.
Jean Joseph Louis Blanc, L'organizzazione del lavoro. Pierre-Joseph Proudhon, Che cos'è la
proprietà?.
1841
"Convenzione degli stretti" fra Russia e Inghilterra: il Bosforo e i Dardanelli sono dichiarati chiusi
alle navi da guerra, a eccezione di quelle turche.
Luigi De Cristoforis inventa un motore a nafta. Werner von Siemehs inventa un sistema per
applicare la galvanoplastica alla copertura di oggetti in metallo.
1842
29 agosto: "Trattato di Nanchino": si conclude la "guerra dell'oppio"; la Cina cede alla Gran
Bretagna la base di Hong-Kong.
Primo tentativo di sciopero generale in Inghilterra.
Il medico americano C. Long introduce negli interventi chirurgici l'anestesia per mezzo di etere.
Cesare Correnti, Teoria della statistica.
Cronologia 1843
Giuseppe Verdi
1843
Gennaio ca.: va ad abitare in un appartamento al n.601 di corso Francesco (l'attuale corso Vittorio
Emanuele), dietro il Duomo. L'arcivescovo di Milano, Gaisruck, interviene presso il barone
Torresani, capo della polizia, per far vietare i Lombardi; Torresani propone alcune modifiche che
incontrano il deciso rifiuto del compositore.
11 febbraio: Milano, Scala: prima rappr. di I Lombardi alla prima crociata; esito molto buono.
L'opera viene dall'autore dedicata alla duchessa di Parma.
20 marzo: GV si reca a Vienna, dove arriva il 4 aprile, per dirigere tre recite di Nabucco. La Fenice
di Venezia gli avanza la proposta per un'opera nuova da darsi nel carnevale 1843-44.
9 aprile: accetta di massima la proposta della Fenice e fa alcune osservazioni sul contratto ("in ciò
che riguarda all'istromentazione, io sono solito farla incominciate le prove a cembalo").
1 1 aprile: rientra a Milano. Il 14 riparte per Parma, dove si rappresenta Nabucco con la Strepponi.
Il 20 si reca a Bologna per alcuni giorni. Il 14 maggio a Parma s'incontra nuovamente con Rossini,
in viaggio per Parigi. Il 18 si reca per alcuni giorni a Busseto a visitare la madre. Il 23 rientra a
Milano.
25 maggio: al contratto con la Fenice fa inserire la clausola con la quale si riserva di scegliere gli
"artisti che dovranno eseguire l'opera" dall'elenco della compagnia scritturata.
6 giugno: propone alla Fenice, come argomento della nuova opera, o il Re Lear o il Corsaro oppure
La fidanzata d'Abido.
9 giugno: il segretario della Fenice, Guglielmo Brenna, gli suggerisce, come librettista, Francesco
Maria Piave, che gli propone un libretto intitolato Crómvello, da un racconto di Walter Scott,
Hallan Cameron.
29 giugno: GV contropropone nuovi argomenti: Caterina Howard, Cola di Rienzi, La caduta dei
Longobardi. Il 4 luglio aggiunge alla lista I due Foscari, inviandone il programma, e accantona gli
argomenti precedentemente segnalati.
10 luglio: si reca a Senigallia per dirigervi I Lombardi.
26 luglio: non essendo stati approvati dalla Fenice i soggetti dei Foscari e della Caterina Howard,
accetta di prendere in considerazione il Cromvello di Piave purché questi sia "buon poeta
conoscente dell'effetto teatrale, e delle forme musicali".
1° agosto: rientra a Milano.
8 agosto: a Piave in merito al Cromvello:"ln quanto alla durata dei pezzi la brevità non è mai un
difetto. I metri poi come lei vuole. Io poi non metto mai ceppi al genio dei poeti ".
2 settembre: insoddisfatto dell'argomento di Cromvello il presidente della Fenice, Mocenigo,
suggerisce a GV di musicare o Hernani o La torre di Nesle.
5 settembre: GV a Mocenigo:"Oh se si potesse fare l'Hernani sarebbe una gran bella cosa! [...1 non
vi sarebbe che di ridurre e stringere; l'azione è fatta: e l'interesse è immenso".
17 settembre: Piave si rassegna a scrivere Emani; intanto Brenna fa presente a GV che Mocenigo
"esige per condizione espressa" che sia scritta una parte importante per il contralto Carolina
Vietti".
20 settembre: Brenna inoltra a GV il programma di Emani così come concertato fra Mocenigo e
Piave onde parare possibili interventi della censura.
Settembre - ottobre: GV s'impegna con Merelli per un'opera alla Scala (sarà Giovanna d'Arco).
2 ottobre: a Piave, raccomandando brevità:"Per l'amor di Dio non finisca col Rondò ma faccia il
terzetto: e questo terzetto anzi deve essere il miglior pezzo dell'opera". Inizia a comporre l'Emani.
8 ottobre: si reca al Teatro Comunale di Bologna per assistere al Nabucco; s'incontra con Rossini.
10 ottobre: da Cassano d'Adda, ospite dei conti della Somaglia, propone alla Fenice di affidare al
tenore la parte di Emani e al contralto quella di Carlo. Ma Brenna (26 ottobre) insiste a favore
della Vietti per la parte di Emani.
27 ottobre: la "selva" di Emani (al momento intitolato Don Gomez da Silva) viene approvata sub
conditione dall'autorità politica veneziana.
Arte e cultura
Hayez lavora a un grande dipinto storico: La sete patita dai primi Crociati sotto Gerusalemme.
Nasce la "Gazzetta musicale di Milano", edita da Ricordi.
1843
3 gennaio: Parigi,T. Italiano: Donizetti, Don Pasquale. 17 gennaio: Madrid: Garda Gutiérrez,
Sinu5n Boccanegra. 2 febbraio: Torino, Regio: Mercadante, Il Reggente.
22 febbraio: Venezia, Fenice: G.B. Ferrari, Gli ultimi giorni di Suli.
28 marzo: Napoli, S. Carlo: Vincenzo Battista, Anna La Prie.
5 giugno: Vienna, Porta Carinzia: Donizetti, Maria di Rolian.
Estate: Milano, T Re: Gustavo Modena forma una propria compagnia composta di giovani attori
(fra cui Tommaso Salvini).
13 novembre: Parigi, Opéra: Donizetti, Don Sebastiano.
27 novembre: Londra, Drury Lane: Michael William Balfe, The bohemian Girl.
28 novembre: Palermo, Carolino: Pacini, Medea.
26 dicembre: Genova, Carlo Felice: Mazzucato,Hernani. R. Schumann, Il paradiso e la Peri,
oratorio profano.
Parigi: Berlioz pubblica il suo Grande trattato di strumentazione e d'orchestrazione moderne.
G. B. Niccolini, Arnaldo da Brescia, dramma in versi.
Andrea Maffei inizia la pubblicazione del Teatro completo di Schiller in traduzione italiana.
Giulio Carcano pubblica in traduzione italiana il Re Lear, primo volume del Teatro completo di
Shakespeare.
Andrea Maffei, Roberto, romanzo. Giovanni Prati, Canti e Ballate, poesie.
Carlo Bini, Scritti editi e postumi, a cura di G. Mazzini.
Giovanni Dupré, Caino, statua.
Vincenzo Gioberti, Del primato morale e civile degli italiani.
Saren Kierkegaard, Aut-Aut.
L'editore Pomba di Torino pubblica la traduzione italiana della monografia di Felix Papencordt
Cola di Rienzo e il suo secolo.
Politica, società, scienza, scoperte
1843
15 agosto: insurrezione mazziniana a Bologna.
Viene iniziata in Inghilterra la produzione del perfosfato come fertilizzante.
Cronologia 1844
Giuseppe Verdi
28 ottobre: Emanuele Muzio ottiene dal comune di Busseto una pensione per perfezionarsi nella
musica a Milano.
7 novembre: Mocenigo lascia a GV la facoltà di scelta dei ruoli vocali. 10 novembre: GV assegna al
tenore la parte di Emani, al baritono quella di Carlo.
28 novembre: l'editore Ricordi acquista dalla Fenice la proprietà della nuova opera di GV, ora
intitolata L'onore castigliano.
1° dicembre: GV parte alla volta di Venezia. Vi arriva il 3, prende alloggio in Casa Bollini al Ponte
delle Ostriche e inizia le prove dei Lombardi.
26 dicembre: alla Fenice i Lombardi cadono, a causa soprattutto di un tenore insufficiente.
29 dicembre: stante la cattiva prova del tenore, GV chiede il rinvio di Emani alla venuta di Carlo
Guasco in quaresima.
1844
Gennaio: alla ricerca di un tenore per Emani, compie un rapido viaggio a Verona, dove si dà il
Nabucco con la Strepponi. Per l'impossibilità di trovare un tenore, l'Emani viene rinviato alla
quaresima.
Febbraio: è invitato dalla Società dei Nobili di Milano a scrivere una Cantata per il 6° Congresso
degli Scienziati. 15 febbraio: iniziano le prove di Emani.
29 febbraio: firma con Lanari un contratto per un'opera da darsi a Roma in autunno. 9 marzo:
Venezia, La Fenice: prima rappr. di Emani; esito ottimo.
17 marzo: a Barezzi:"Il pubblico m'ha fatto ogni sorta d'accoglienza e l'altra sera m'hanno
accompagnato a casa colla banda". Rientra a Milano.
21 marzo: accetta una proposta di Vincenzo Flaùto per un'opera al S. Carlo di Napoli su libretto di
Salvadore Cammarano e fissa le condizioni del contratto riservandosi la facoltà di scelta dei
cantanti.
Fine marzo: si reca a Busseto. Il 13 aprile rientra a Milano in compagnia di Emanuele Muzio. 15
aprile: Muzio inizia a studiare musica con GV; sarà il suo unico allievo.
18 aprile: scrivendo a Piave giudica eccellente il programma del Lorenzino de' Medici; ma
prevedendo difficoltà da parte della censura, gli ripropone l'argomento dei Due Foscari.
Maggio: non trova "musicabile la poesia del cav. Maffei" per la Cantata alla Società dei Nobili;
chiede di rivolgersi a Felice Romani.
8 maggio: acquista alle Roncole il podere Plugaro.
9 maggio: il Lorenzino essendo stato rifiutato dalla censura, scrive a Piave di pensare ai Due
Foscari.
14 maggio: ricevuto da Piave il libretto dei Due Foscari, gli chiede delle modifiche, e intanto inizia
a musicarlo. Firma con Lanari un contratto per un'opera da darsi alla Fenice nel carnevale 184546.
17 maggio: Romani accetta di scrivere la poesia della Cantata.
18 maggio: GV ringrazia l)onizetti che si è offerto di dirigere le prove di umani a Vienna.
22 maggio: spedisce la 'selva' dei Foscari a Roma per l'approvazione della censura.
30 maggio: l'Emani va in scena per la prima volta a Vienna diretto da Donizetti.
14 luglio: rinuncia a scrivere la Cantata per l'eccessiva lunghezza del libretto, intitolato Flavio
Gioia, inviatogli da Felice Romani.
Agosto: si reca a Bergamo dove si dà Emani con la Strepponi; il 20 parte per Busseto.
Agosto-settembre: firma il contratto per due opere da darsi al S. Carlo di Napoli nel giugno 1845 e
nel giugno 1847.
Settembre: Solera smentisce di aver ricavato il libretto della Giovanna d'Arco da Schiller: "è
dramma affatto originale italiano".
1 settembre: GV rientra a Milano e porta a compimento la composizione dei Due Foscari.
settembre: parte per Roma via mare (Livorno - Civitavecchia) e vi arriva il 3 ottobre.
Arte e cultura
1844
2 gennaio: Dresda,': Imperiale:Wagner, Der fliegende Holliinder.
12 gennaio: Napoli, S. Carlo: Donizetti, Caterina Cornaro.
Febbraio-marzo: Milano, T Re: Giacinto Battaglia, La famiglia Foscari, dramma.
6 marzo: nasce a Tichvin Nikolaj A. Rimskij-Korsakov. 9 marzo: Parigi, Opéra: Perrot, Esmeralda,
ballo.
28 marzo: Madrid, T. de la Cruz: José Zorilla y Moral,
Don Giovanni Tenorio, dramma.
28 aprile: Reggio Emilia: prima rappr. Italiana della Maria di Rohan di Donizetti.
27 maggio: Angelo Mariani esordisce come primo violino direttore a Trento.
1° giugno: Milano, Re: Lauro Rossi, Il borgomastro di Schiedam.
25 luglio: muore a Nancy il drammaturgo RenéCharles de Pixérécourt.
Autunno: Milano,T. Re: la ventiduenne attrice Adelaide Ristori recita il prologo della Giovanna
d'Arco di Schiller, tradotto da A. Maffei.
5 dicembre: Napoli, Nuovo: Mercadante, Leonora.
8 dicembre: Parigi, Conservatorio: Félicien David, Il deserto, ode-sinfonia.
30 dicembre: Amburgo, Stadttheater, Friedrich von Flotow, Alessandro Stradella.
Mendelssohn, Concerto in Mi minore per violino e orchestra.
Giuseppe Vollo, La famiglia Foscari, dramma. Alexandre Dumas, I tre moschettieri, romanzo.
Milano, Brera: Hayez, Il Doge Francesco Foscari destituito con decreto del Senato Veneto, dipinto. Kierkegaard, Il concetto dell'angoscia.
Cesare Balbo, Le speranze d'Italia.
C. Cattaneo, Notizie naturali e civili su la Lombardia.
Politica, società, scienza, scoperte
1844
12-20 giugno: tentativo insurrezionale in Calabria dei fratelli Bandiera, che, traditi, vengono
fucilati a Rovito (Cosenza).
23 settembre: insurrezione a Rimini. Rivolta operaia in Slesia.
La Francia muove guerra al Marocco.
24 maggio: viene inaugurata, fra Washington e Baltimora, la prima linea telegrafica.
Milano: 6° Congresso degli Scienziati.
Il dentista americano H. Well impiega il protossido d'azoto come anestetico.
Giovanni Cavalli inventa il cannone rigato a retrocarica. Carlo Matteucci, Trattato di
elettrofisiologia.
Cronologia 1845
Giuseppe Verdi
3 novembre: Roma,Teatro Argentina: prima rappr. di I due Foscari; esito discreto la prima sera;
ottimo nelle repliche.
7 novembre: parte da Roma in diligenza per rientrare a Milano. Il 10 assiste a Bologna a una recita
dell'Emani. L'l l arriva a Milano e inizia a comporre la Giovanna d'Arco.
Dicembre: alla Scala presiede alle prove della ripresa dei Lombardi, opera inaugurale della stagione
1844-45; scrive Muzio: "Egli grida che pare un disperato; batte tanto i piedi che pare suoni
l'organo con la pedaliera; suda tanto che gli cadono le goccie sullo spartito".
1845
Gennaio: inizia la strumentazione della Giovanna d'Arco; l'editore Lucca acquista l'opera che
scriverà per Venezia.
15 febbraio: Milano, Scala: prima rappr. di Giovanna d'Arco; esito buono. A Piave: "È la migliore
delle mie opere senza eccezione e senza dubbio".
23 febbraio: riceve da Cammarano il programma dell'Alzira:"Ne sono contentissimo sotto ogni
rapporto. Ho letto la tragedia di Voltaire [...]. Io sono accusato di amare molto il fracasso e di
trattare male il canto: non ci badi: metta
pure della passione e vedrà che scriverò passabilmente. [...] È inutile che le dica di tenersi breve".
24 febbraio: affida a Piave il libretto dell'opera per Venezia:"Bisogna E...] che tu lasci a me la
facoltà di fare quelle accomodature che crederei opportune".
27 febbraio: Muzio informa che il maestro rifiutando un altro contratto a Merelli non intende più
scrivere per la Scala e rimetter piede in quel teatro.
12 marzo: s'impegna con Lucca per un'opera da darsi in Italia nel 1848 e propone la pubblicazione
di sei Romanze.
13 marzo: parte per Venezia per la messinscena dei Due Foscari al teatro in S. Benedetto.
25 marzo: a Cammarano, dopo aver ricevuto alcuni brani di Alzira: "È inutile che vi raccomandi
brevità [...]. L'Impresa mi scrive che fino a Luglio non ha altra donna che la Bishop. Se la Tadolini
non canta è inutile parlarne [...]. Perdonatemi un'osservazione: Non vi sembrano troppe tre
cavatine di seguito?...".
30 marzo: i Due Foscari vanno in scena al teatro in S. Benedetto. Il 2 aprile è già di ritorno a
Milano. Abita un appartamento alla Contrada del Monte.
3-5 aprile: avverte Piave che Maffei gli "farà lo sbozzo dell'Attila".
10 aprile ca.: viene assalito da "un gran male di stomaco" che lo costringe a una momentanea
inattività. Il 18 informa Cammarano della propria malattia e chiede di protrarre l'Alzira di un
mese. Il 25 spedisce a Napoli i certificati medici attestanti la sua malattia ("anoressia e dispnea").
28 aprile: si reca sul lago di Como per una breve vacanza insieme a Maffei, Solera,Toccagni e altri
amici.
10-12 maggio ca.: l'editore francese Marie Escudier fa visita per la prima volta a GV e tratta con
lui la cessione della proprietà delle sue opere per la Francia.
Maggio: l'editore Lucca inizia a pubblicargli 6 Romanze per canto e pianoforte.
20 giugno: GV parte per Napoli; l'Alzira è già composta, salvo il finale ("perché non aveva la
poesia") e la strumentazione. Il 26 arriva a Napoli; la sera assiste a una recita dei Foscari accolto
dall'entusiasmo dal pubblico.
10 luglio: termina la composizione di Alzira; non gli resta che strumentarla; visita i dintorni di
Napoli.
16 luglio: affida a Solera, più esperto di Piave in soggetti "grandiosi", il libretto di Attila.
30 luglio: informa Maffei d'aver finito anche la strumentazione:"Non saprei dare alcun giudizio di
questa mia opera perché l'ho fatta, quasi senza accorgermene, e senza nessuna fatica perché se
anche cadesse me ne dorrebbe poco ".
2 agosto: iniziate le prove d'orchestra, l'opera risulta piuttosto breve; Muzio informa:"affinché un
sì bel lavoro non andasse senza la prefazione l'impresa ha pagato [...] 200 ducati, ed il signor
Maestro vi ha fatta la sinfonia".
12 agosto: Napoli, S. Carlo: prima rappr. di Alzira; esito discreto. Alla contessa Appiani:"Sono
feroci questi napoletani, ma hanno applaudito. La Bishop mi aveva preparato un partito che
avrebbe voluto per forza far cadere questa povera creatura. Con tutto ciò l'opera starà in
repertorio".
21 agosto: parte da Napoli. I1 26 arriva a Milano, dove Solera gli consegna il libretto di Attila. Il 3
settembre si reca a Busseto e inizia la composizione di Attila.
Arte e cultura
1845
25 gennaio: Milano, Scala: V. Battista, Rosvina de la Forest.
4 marzo: Venezia, Fenice: Pacini, Lorenzino de' Medici. 6 marzo: Napoli, S. Carlo: Mercadante, Il
vascello di Gama.
18 giugno: Firenze, Pergola: Pacini, Buondelmonte.
20 giugno: Milano, Canobbiana: prima esecuzione italiana integrale dell'ode-sinfonia Il deserto di
E David.
l 2 luglio: Londra, Her Majesty's Th.: Perrot, Pas de quatre, con la Taglioni, la Cerrito, la Grisi e
la Grahn.
19 ottobre: Dresda: Wagner, Tannbauser
11 novembre: Parigi, Porte-St-Martin: Dennery, Marie
Jeanne ou la Femme de peuple, dramma.
15 novembre: Venezia, Apollo: Francesco Malipiero,
Attila.
2 dicembre: muore a Bergamo Simone Mayr.
Milano, Conservatorio: Emilio Arrieta, Ildegonda, su
libretto di Solera.
Mendelssohn, Romanze senza parole.
Maffei pubblica la traduzione italiana della trilogia del
Wallenstein di Schiller.
Arnaldo Fusinato, Il medico condotto, romanzo.
Mérimée, Carmen, racconto. - Edgar A. Poe, Il corvo,
racconto.
L. Feuerbach, L'essenza della religione.
Max Stirner, L'Unico e la sua proprietà.
Viene inaugurato a Bonn il monumento a Beethoven.
Politica, società, scienza, scoperte
1845
23 settembre: insurrezione liberale a Rimini; viene promulgato il "Manifesto di Rimini", redatto da
Luigi Carlo Farini, dichiarazione programmatica con la quale si chiedono profonde riforme liberali
nello stato pontificio, e che ha ampia diffusione nelle Romagne e nelle Marche.
Il ministro francese Guizot invia Pellegrino Rossi a Roma nel vano tentativo di negoziare con il
papa alcune riforme allo stato pontificio.
Grave crisi economica in Francia; si rafforza l'opposizione operaia.
Nel Granducato di Toscana viene installato sulla linea Livorno-Pisa-Firenze il primo impianto
telegrafico italiano.
Nella Manica viene installato il primo cavo telegrafico sottomarino.
M. d'Azeglio, Degli ultimi casi di Romagna. Gino Capponi, Sui moti di Rimini.
Cronologia 1846
Giuseppe Verdi
Settembre-ottobre: GV acquista in Busseto il palazzo Dordoni-Cavalli.
1 1 ottobre: rientra a Milano, ma subito riparte per Clusone, ospite di Clara Maffei.
16 ottobre: s'impegna con l'editore Lucca per un'opera nuova da rappresentarsi "in un primario
teatro d'Italia con compagnia d'alto cartello nel carnevale 1848". Per la prima volta un'opera di
Verdi viene eseguita a Parigi: il Nabucco al Teatro Italiano.
28 ottobre: rientrato a Milano riceve la visita dell'impresario Benjmin Lumley col quale firma un
contratto per un'opera da darsi a Londra.
30 ottobre: viene colto da forti dolori di origine reumatica che lo obbligano a letto.
5 novembre: ringrazia Jacopo Ferretti, che gli dà notizia del successo di Alzira a Roma, "dei
suggerimenti" per migliorare l'opera: "Il male è nelle viscere e, ritoccando, non si farebbe che
peggio".
Metà novembre: gli perviene dal direttore dell'Opéra, Léon Pillet, la richiesta di rappresentare i
Lombardi in francese con alcune aggiunte, fra cui i ballabili.
24 novembre: partito Solera in settembre per la Spagna al seguito della moglie cantante, GV
decide di rivolgersi a Piave per le modifiche al libretto di Attila; lo informa che sta lavorando allo
schizzo del Re Lear per Londra e gli chiede un maestro di francese che lo metta in condizione di "leggere, tradurre, e parlare"; intanto è a
letto ammalato.
6 dicembre: arriva a Venezia. Scrive una nuova cavatina nella Giovanna d'Arco, opera inaugurale
della stagione della Fenice 1845-46, per la Loewe.
25 dicembre: chiede a Solera l'approvazione delle modifiche apportate da Piave al libretto di Attila.
1846
All'inizio dell'anno cade gravemente ammalato (febbre gastrica); si teme addirittura per la sua vita
(un giornale tedesco lo dà addirittura per morto).
6 gennaio: l'Emani viene rappresentato per la prima volta a Parigi.
11 gennaio: la Strepponi canta per l'ultima volta in teatro (Nabucco a Modena).
25 gennaio: GV informa l'editore Lucca che per Londra musicherà il Corsaro su libretto di Piave.
1 1 febbraio: chiede a Luccardi il figurino di Attila come appare in uno degli affreschi di Raffaello
nelle stanze del Vaticano.
Febbraio: supera la grave malattia che lo ha colpito, ma il miglioramento, fra riprese e ricadute, è
lento e non definitivo: la prima di Attila viene procrastinata.
24 febbraio: a I.ucca, che gli propone altro argomento per l'opera di Londra:"io faccio o il Corsaro
o niente", e gliene invia il 'programma' perché lo trasmetta a Lumley.
Marzo: la sua salute migliora; riesce a finire l'opera e a dirigerne le prove.
17 marzo: Venezia, La Fenice: prima rappr. di Attila; esito ottimo.
22 marzo: un certificato medico attesta che GV"fu curato di una febbre gastrica che durò molte
settimane e recidivò"; dopo la terza recita di Attila e un banchetto in suo onore, lascia Venezia in
compagnia di Maffei e rientra a Milano.
6 aprile: i medici gli prescrivono un lungo periodo di riposo. Il 10 invia certificati medici a Londra
per rinviare di un anno l'opera che deve scrivere per quel teatro.
17 maggio: si accorda con Lanari "sul genere fantastico dell'opera che deve scrivere per Firenze".
16 giugno: fa da testimonio, insieme a Carcano, all'atto di separazione fra Andrea e Clara Maffei,
redatto dal notaio Tommaso Grossi.
Dopo il 17 giugno ca.: con Andrea Maffei si reca per alcuni giorni a Venezia; il 24 rientra a Milano.
3 luglio: si reca a Recoaro con Maffei per un periodo di cura; il 27 rientra a Milano.
13 agosto: Muzio informa che GV ha in mente tre soggetti, l'Avola di Grillparzer, i Masnadieri di
Schiller e Macbetb: "se avrà Fraschini farà l'Avola", altrimenti farà Macbeth dove non necessita un
tenore di forza.
Agosto: Maffei accetta di scrivere per lui il libretto dei Masnadieri.
Arte e cultura
1846
1° febbraio: Donizetti viene internato nella casa di cura di Ivry.
7 febbraio: Torino, Regio: Pacini, La regina di Cipro.
3 marzo: Milano, Scala:Augusto Huss, Gustavo III re di Svezia, ballo. - London, Her Majesty's
Th.: Perrot, Catarina o La figlia del bandito, ballo.
21 marzo: Adolphe Sax brevetta una nuova famiglia di strumenti da lui inventati, quella dei
sassofoni.
1 ° aprile: Parigi, Opéra: Mazilier, Paquita, ballo.
31 maggio: Vienna, Th. an der Wien: Lortzing, Der Waffenschmied.
11 giugno: London, Her Majesty's Th.: Perrot, Lana Rookh o La rosa di Lahore, ballo.
27 giugno: Parma, Regio: Gualtiero Sanciti, Luisa Strozzi.
Luglio: Napoli, Fondo: Salvatore Pappalardo, Il corsaro. 26 agosto: Birmingham: Mendelssohn,
Elijah, oratorio.
12 settembre: si inaugura a Verona il teatro Nuovo con l'Attila di Verdi.
10 novembre: Napoli, S. Carlo: Mercadante, Orazi e Curiazi.
12 novembre: Parigi:Théophile Gautier (in collaborazione con N. Parfait e con musiche di M.
Pilate), La Juive de C'onstantine, dramma.
Dicembre: Parigi, Opéra-Comique: Berlioz, La dannazione di Faust.
Firenze, Pergola: Antonio Cortesi, I vespri siciliani, ballo.
Michele Costa viene nominato direttore stabile della Philharmonic Society di Londra.
Politica, società, scienza, scoperte
1846
14 maggio: muore a Parma Vincenzio Mistrali. 1° giugno: Roma: muore Gregorio XVI. 16 giugno:
elezione di Pio IX.
Giugno: manifestazioni a Parma in favore di Pio IX e dimostrazioni contro il vescovo Neuschel.
16 luglio: Pio IX concede l'amnistia dei prigionieri politici negli Stati della Chiesa.
Grave crisi agricola in Europa, accompagnata dalla distruzione dell'intero raccolto di patate.
Scoppia in Irlanda una gravissima carestia, che provoca un forte movimento migratorio verso gli
Stati Uniti e pone le condizioni per ripetute rivolte.
In Gran Bretagna, in seguito alle agitazioni popolari, il primo ministro Peel abolisce la legge sui
dazi sul grano e avvia una politica economica basata sul libero scambio.
In Irlanda nasce il movimento indipendentistico "la giovane Irlanda" che organizza azioni
terroristiche in polemica con la lega nazionalista di O' Connell.
Insurrezioni popolari a Cracovia e in Galizia, dove i contadini massacrano i proprietari terrieri.
L'Austria si annette la repubblica di Cracovia.
Scoppia la guerra fra Stati Uniti e Messico per i confini del Texas.
Trattato dell'Oregon: Stati Uniti e Gran Bretagna fissano i confini tra Canada e Stati Uniti sul 49°
parallelo.
Cronologia 1847
Giuseppe Verdi
19 agosto: GV sollecita Lanari per la scrittura del baritono Varesi,"il solo artista attuale in Italia
che possa fare la parte che medito".
22 agosto: a Piave:"Forse, forse, (ma silenzio!) faremo il Macbet. [...] L'impresa è gigantesca E...).
Per Dio che sogetto colossale!... Quante novità!... Quanta poesial..."
27 agosto: rifiuta di restituire a Piave il libretto del Corsaro, di cui, quasi senza accorgersene, ha
sbozzato "alcune delle cose" più simpatiche: "il Duetto della prigione ed il terzetto ultimo".
31 agosto ca.: a Cammarano, informandolo d'aver accettato il rinvio della seconda opera per Napoli
all'autunno 1847: "In quanto agli argomenti ne ho in vista diversi, per cui la vostra censura
troverebbe da dire, nonostante uno sarebbe passabile:Amore e Raggiro di Schiller. È un magnifico
dramma di grand'effetto in teatro e di passione".
4 settembre: invia uno schizzo del Macbeth a Piave, che lo raggiunge a Milano alla fine del mese.
Ottobre: inizia la composizione di Macbeth.
5 o 6 ottobre: scrive alla Strepponi in procinto di trasferirsi a Parigi per aprirvi una scuola di canto
("Questa lettera la metteranno sul mio cuore quando mi seppelliranno").
Ottobre: la Strepponi prende alloggio a Parigi in un appartamento in rue de la Victoire n. 13, nelle
vicinanze dell'Opéra.
23 ottobre: Maffei termina il libretto dei Masnadieri.
Novembre ca.: su richiesta del tenore Mario de Candia, GV scrive una nuova cabaletta per la prima
rappr. dei Due Foscari al Teatro Italiano di Parigi (17 dicembre 1846).
2 dicembre: avverte l'editore Lucca del rinvio dell'opera per Londra al giugno 1847 e accetta la
proposta di Flaùto (li differire la seconda opera per Napoli all'ottobre 1848.
4 dicembre: informa Lumley di essere insoddisfatto del libretto del Corsaro e d'aver pertanto
risolto "di far fare un altro libretto nei I masnadieri di Schiller", soggetto che ritiene di maggior
effetto e più adatto alla compagnia, e del quale ha già "musicato quasi la metà".
Fine dicembre: termina la composizione dei primi due atti di Macbeth.
29 dicembre: vende lo spartito del Macbeth a Ricordi ponendo come condizione che non se ne
permetta la rappresentazione alla Scala, teatro "dove non si sa o non si vuole montare come si
conviene le opere, specialmente le mie".
1847
2 gennaio: invia alla cantante Barbieri Nini la parte di Lady Macbeth nel P atto:"Il soggetto è
preso da una delle più grandi tragedie che vanti il teatro ed io ho cercato di farne estrarre tutte le
posizioni con fedeltà, di farlo verseggiare bene e di farne un tessuto nuovo e di fare della musica
attaccata, il più che poteva, alla parola ed alla posizione; ed io desidero che questa mia idea la
comprendano bene gli artisti, in somma desidero che gli artisti servano meglio il poeta che il
maestro".
5 gennaio: Giuseppina Strepponi chiede notizie di GV a Giovannina Lucca.
7 gennaio: GV al baritono Felice Varesi:"or eccoti un Duettino, un Duetto grande ed un finale.- Io
non cesserò mai di raccomandarti di studiare bene la posizione, e le parole; la musica viene da se.
Insomma ho più piacere che servi meglio il poeta del maestro".
21 gennaio: rimproverando Piave d'aver trascurato gli ultimi due atti del Macbeth, lo informa
d'essersi rivolto a Maffei per accomodarli con versi musicabili.
28 gennaio: spedisce a Ricordi la prefazione al libretto di Macbeth.
31 gennaio: spedisce altri pezzi alla Barbieri Nini osservando:"questo è un dramma che non ha
nulla in comune cogli altri, e tutti dobbiamo fare ogni sforzo per renderlo nel modo più originale
possibile. Io credo poi che sia ormai tempo di abbandonare le formule solite, ed i soliti modi".
1° febbraio: termina la composizione di Macbeth e inizia a strumentarlo.
18 febbraio: arriva a Firenze in compagnia di Muzio e alloggia alla Pensione Svizzera.
20-24 febbraio: conosce Giuseppe Giusti (cui si presenta con una commendatizia di Alessandro
Manzoni), il drammaturgo Nicolini, lo scultore Bartolini, lo scrittore e politico Gino Capponi,
visita lo studio dello scultore senese Giovanni Dupré (che gli ritrae la mano), e rivede Luciano
Manara, che aveva conosciuto nel 1844 a Venezia.
Arte e cultura
B. Bermani, Schizzi sulla vita e sulle opere del Maestro Giuseppe Verdi (estratto dalla "Gazzetta
musicale di Milano").
Antonio Tosoroni, Metodo per il corno a 3 pistoni.
Giuseppe Pelitti realizza un tipo di tuba contrabbassa detta pelittone.
Torino, Carignano: Francesco Dall'Ongaro, Il fornaretto di Venezia, dramma. - Tommaso
Gherardi Del Testa, Con gli uomini non si scherza, commedia.
Maffei pubblica la traduzione italiana dei Masnadieri di Schiller.
A. Dumas, Il conte di Montecristo, romanzo. - Emily Bronté, Cime tempestose, romanzo.
Aleardo Aleardi, Lettere a Maria, poesie.
Vincenzo Vela, La preghiera del mattino, scultura.
Giuseppe Mazzini, Scritti d'un italiano vivente.
Esce l'ultimo dei 36 volumi della Storia universale di Cesare Cantù.
1847
23 gennaio:Antonio Ghislanzoni debutta a Lodi come cantante.
4 febbraio: Firenze, Pergola: L. Ricci, Il birrajo di Preston.
23 marzo: Milano, Scala: Pasquale Bona, Don Carlo. 28 aprile: Milano, Re:Antonio Cagnoni, Don
Bucefalo.
10 giugno: Vienna, Hofoper: Matteo Salvi, Caterina Howard.
11 giugno: Parigi,Th.-Historique:A. Dumas -A. Maquet, Intrigue et amour (da Cabala e amore di
Schiller).
22 luglio: Londra, Covent Garden: Giovanni Casati, La rosiera, ballo.
25 settembre: Torino, Carignano: Nini, Il corsaro.
20 ottobre: Parigi, Opéra: Arthur Saint-Léon, La fanciulla di marmo, ballo, musica di C. Pugni.
4 novembre: muore a Lipsia Felix von Mendelssohn.
Novembre: Adolphe Sax viene nominato direttore della fanfara dell'Opéra di Parigi.
25 novembre: Vienna, Hofoper: Flotow, Marta.
Novembre: Goffredo Mameli compone l'inno Fratelli d'Italia, subito musicato da Michele Novaro.
Politica, società, scienza, scoperte
1847
13 marzo: Pio IX concede una cauta attenuazione della censura.
Maggio: in Toscana viene concessa una parziale abolizione della censura.
L'esercito austriaco occupa Ferrara.
Granducato di Toscana, Piemonte e Stato pontificio firmano i preliminari per una lega doganale.
In Francia Louis Blanc cerca di unificare operai e piccola borghesia con il suo programma del
"diritto al lavoro" e l'istituzione dei Stabilimenti nazionali gestiti dallo stato per dare lavoro ai
disoccupati.
In Belgio vittoria elettorale dei liberali.
La Francia ottiene il pieno controllo dell'Algeria. L'opposizione liberale ungherese, guidata da
Lajos Kossuth, chiede all'Austria riforme radicali.
Settembre: la nomina di Bartolomeo Romilli, da parte di Pio IX, a vescovo di Milano in
successione a Gaisruck, determina manifestazioni di giubilo che degenerano in scontri provocati
dalla polizia, con morti e feriti; fra gli altri viene arrestato Antonio Ghislanzoni.
Ottobre: il duca di Lucca, oberato di debiti, cede il proprio stato al granducato di Toscana. Ne
segue una con-
Cronologia 1848
Giuseppe Verdi
27 febbraio: iniziano le prove di Macbeth.
12 marzo: Antonio Barezzi raggiunge GV a Firenze per assistere alla prima del Macbeth.
14 marzo: Teatro della Pergola: prima rappr. di Macbeth; esito buono nei primi due atti, discreto
negli altri due.
19 marzo: Giuseppe Giusti esorta GV ad accompagnare con la sua musica l'anelito di riscatto degli
italiani:"La musica è favella intesa da tutti [...1. Il fantastico, è cosa che può provare l'ingegno; il
vero prova l'ingegno e l'animo. Vorrei che gl'ingegni italiani [...] s'astenessero dalla vaga venere
dei congiungimenti forestieri".
20-21 marzo: GV parte da Firenze, sosta a Bologna e rientra a Milano.
25 marzo: dedica il Macbeth a Barezzi:"Da molto tempo era ne' miei pensieri d'intitolare un'opera a
Lei che m'è stato e padre, e benefattore, ed amico. Ora eccole questo Macbeth che io amo a
preferenza delle altre mie opere".
27 marzo: risponde a Giusti: "intendo cosa vuoi dire. Oh se avessimo un poeta che ci sapesse ordire
un dramma come tu l'intendi! Ma sgraziatamente [...] se vogliamo qualche cosa che almeno faccia
effetto bisogna a nostra vergogna ricorrere a cose non nostre".
Aprile: comincia a comporre la musica dei Masnadieri.
20 maggio: nel proporre a Ricordi un contratto per un'opera nuova, per la prima volta inserisce
una clausola riguardante le percentuali sui noli dei suoi spartiti.
26 maggio: parte con Emanuele Muzio per Londra. 11 1° giugno arriva a Parigi, dove rivede la
Strepponi; vi sosta per quattro giorni. I17 arriva a Londra e porta a termine la composizione dei
Masnadieri. Conosce Giuseppe Mazzini e Luigi Bonaparte, il futuro Napoleone III.
1 ° luglio ca.: inizia la strumentazione dei Masnadieri.
22 luglio: Londra, I ler Majesty's Theatre: prima rappr. di I masnadieri; esito buono.
27 luglio ca.: parte da Londra per Parigi.
2 agosto: informa Lucca di avere in vista i seguenti argomenti: il Corsaro,l'Avola e la Medea nella
vecchia versione di Felice Romani.
Agosto: spedisce Muzio a Milano per curare la stampa dei Masnadieri e intanto sottoscrive un
contratto con l'Opéra di Parigi per rappresentarvi un'opera su libretto nuovo di Vaéz e Royer,
adattandovi la musica dei Lombardi.
22 agosto: informa la Appiani che ha gran desiderio di visitare Donizetti, ma finora ne è stato
sconsigliato:"l'apparenza del suo fisico è buona, se non che egli tiene costantemente il capo curvo
sul petto e gli occhi chiusi [...] e non
dice quasi mai una parola".
16 settembre: inizia le prove di Jérusalem. Va ad abita in Rue neuve St. Georges n. 6.
26 novembre, Parigi, Opéra: prima rappr. di Jérusalem; esito buono. Ricordi dedica lo spartito alla
Strepponi. L'editore Lucca pubblica una sua romanza per canto e piano, Il poveretto.
1848
Gennaio: termina la composizione del Corsaro. Barezzi gli fa visita a Parigi. Febbraio: GV firma
un contratto per un'opera da darsi all'Opéra di Parigi. 12 febbraio: spedisce a Lucca la partitura del
Corsaro.
17 febbraio: Muzio informa che GV tratterà per Napoli l'argomento Cola di Rienzi.
12 marzo: la Fenice avanza a GV la proposta per un'altra opera nuova; ma la proposta abortisce
subito a causa dei capovolgimenti determinati dall'insurrezione del Quarantotto.
Marzo: Emanuele Muzio partecipa alle "cinque giornate" di Milano.
Marzo-aprile: Maffei scrive un Inno popolare su incarico del governo provvisorio e lo invia a GV
perché lo musichi. 5 aprile: GV arriva a Milano da Parigi. Prosegue poi per Busseto; vi sosta pochi
giorni, quindi ritorna a Milano.
20 aprile: Cammarano ritiene poco drammatico l'argomento del Rienzi e contropropone o la
Congiura dei Fieschi o il Vespro siciliano o la Virginia; alla fine suggerisce la Battaglia di Legnano
sulla traccia della Battaglia di Tolosa di Méry.
Arte e cultura
17 dicembre: S. Pietroburgo: Dargomyzshkij, Esmeralda. E Liszt si stabilisce a Weimar.
Ricordi pubblica la Missa Papae Marcelli di Palestrina e, in traduzione italiana, il Grande trattato
di strumentazione e orchestrazione di Berlioz.
Theobald Boehm, Sulla costruzione del flauto e sui recenti miglioramenti allo strumento ("sistema
Boehm").
Charlotte Brontéjane Eyre, romanzo. Longfellow, Evangeline, poemetto narrativo. Giovanni
Dupré, Abele morente, scultura. Karl Man, La miseria della filosofia.
Nasce a Milano "L'Italia musicale", periodico edito dalla casa Lucca. Cavour fonda il giornale "Il
Risorgimento".
Politica, società, scienza, scoperte
troversia di frontiera fra Toscana e ducato di Modena.
3 novembre: viene siglata un'unione doganale fra Piemonte,Toscana e Stato Pontificio.
Novembre: in Svizzera guerra del Sonderbund; l'esercito federale sconfigge le truppe dei cantoni
cattolici.
17 dicembre: muore a Parma la duchessa Maria Luigia. Le succede sul trono del ducato Carlo II di
Borbone.
Dicembre: la società milanese è agitata da fermenti rivoluzionari. Campagna di astensione dal
fumo, indetta per protestare contro le tasse.
In Inghilterra viene introdotta la giornata lavorativa di dieci ore per i giovani.
Hoe realizza la prima rotativa per la stampa continua. Ascanio Sobrero ottiene la nitroglicerina.
Il medico J.Y. Simpson impiega per la prima volta il cloroformio come anestetico.
Justus von Liebig ottiene l'estratto di carne.
Viene prodotto per la prima volta in Inghilterra il latte in polvere.
Cesare Correnti, L'Austria e la Lombardia, trattato economico e finanziario.
1848
12 febbraio: Milano, Scala: Perrot, Faust, ballo, musica di Panizza.
Febbraio: Liszt viene nominato direttore del teatro di corte di Weimar.
28 marzo: Venezia, Fenice: Pacini, Allan Cameron. 8 aprile: muore a Bergamo Gaetano Donizetti.
27 aprile: Rossini viene fatto segno a dimostrazioni ostili da parte di liberali; turbato, fugge a
Firenze.
8 maggio: Vienna, Burgtheater: Friedrich Hebbel, Maria Maddalena, tragedia.
13 giugno: Londra, Her Majesty'sTh.: Perrot - Pugni, Le quattro stagioni, ballo.
4 luglio: muore a Parigi Francis-René de Chateaubriand, autore di Atala.
Politica, società, scienza, scoperte
troversia di frontiera fra Toscana e ducato di Modena.
3 novembre: viene siglata un'unione doganale fra Piemonte,Toscana e Stato Pontificio.
Novembre: in Svizzera guerra del Sonderbund; l'esercito federale sconfigge le truppe dei cantoni
cattolici. 17 dicembre: muore a Parma la duchessa Maria Luigia. Le succede sul trono del ducato
Carlo II di Borbone. Dicembre: la società milanese è agitata da fermenti rivoluzionari. Campagna
di astensione dal fumo, indetta per protestare contro le tasse.
In Inghilterra viene introdotta la giornata lavorativa di dieci ore per i giovani.
Hoe realizza la prima rotativa per la stampa continua. Ascanio Sobrero ottiene la nitroglicerina.
Il medico J.Y. Simpson impiega per la prima volta il cloroformio come anestetico.
Justus von Iiebig ottiene l'estratto di carne.
Viene prodotto per la prima volta in Inghilterra il latte in polvere.
Cesare Correnti, L'Austria e la Lombardia, trattato economico e finanziario.
1848
12 febbraio: Milano, Scala: Perrot, Faust, ballo, musica di Panizza.
Febbraio: Liszt viene nominato direttore del teatro di corte di Weimar.
28 marzo: Venezia, Fenice: Pacini, Allan Cameron. 8 aprile: muore a Bergamo Gaetano Donizetti.
27 aprile: Rossini viene fatto segno a dimostrazioni ostili da parte di liberali; turbato, fugge a
Firenze. 8 maggio: Vienna, Burgtheater: Friedrich Hebbel, Maria Maddalena, tragedia.
13 giugno: Londra, Her Majesty's Th.: Perrot - Pugni, Le quattro stagioni, ballo.
4luglio: muore a Parigi Francis-René de Chateaubriand, autore di Atala.
1848
12 gennaio: rivolta di Palermo guidata da Rosolino Pilo; la Sicilia chiede la separazione dal
Napoletano. - 10 febbraio: Ferdinando II di Napoli è costretto a promulgare una costituzione.
17 febbraio: Leopoldo II diToscana concede uno Statuto.
22 febbraio: scoppia la rivoluzione a Parigi; Luigi Filippo è costretto ad abdicare.
Mazzini fonda a Parigi la "Associazione nazionale italiana".
Marzo: la rivoluzione dilaga in Europa; insorgono Bruxelles, Budapest e alcuni stati tedeschi
(Baden, Assia, Nassau, Wiirttemberg, Brunswick, Turingia). In Ungheria i liberali guidati da
Kossuth reclamano l'autogoverno dall'Austria.
5 marzo: Carlo Alberto concede lo Statuto.
Cronologia 1848
Giuseppe Verdi
21 aprile: a Piave:"Figurati se io voleva restare a Parigi sentendo una rivoluzione a Milano. [...].
L'ora è suonata, siine pur persuaso, della sua liberazione. [...] Sì, sì, ancora pochi anni forse pochi
mesi e l'Italia sarà libera, Una, repubblicana. [...] Bravo mio Piave, bravi tutti Veneziani bandite
ogni idea municipale, doniamoci tutti una mano fraterna e l'Italia diventerà ancora la prima
nazione del mondo!".
8 maggio: ritorna a Busseto, dove acquista alcuni terreni in S.Agata su cui sorge il casale che
diventerà la sua villa, ma nella quale prenderanno intanto alloggio i suoi genitori; cede in permuta
il podere di Plugaro e acquista il palazzi) Orlandi, che intende eleggere a sua prossima dimora.
Maggio: accetta la richiesta di Mazzini di comporre un inno patriottico.
31 maggio: parte da Milano (vi farà ritorno vent'anni dopo) alla volta di Parigi.
6 giugno: Mazzini a Goffredo Mameli:"mandami un Inno che diventi la Marsigliese italiana; e
della quale il popolo, per usare la frase di Verdi, scordi l'autore e il poeta".
Luglio: GV va ad abitare a Passy con Giuseppina Strepponi; inizia la composizione della Battaglia
di Legnano.
22 luglio: propone a Piave di scrivere un libretto su Ferruccio "personaggio gigantesco, uno dei
più grandi martiri della libertà italiana", suggerendogli d'ispirarsi all'Assedio di Firenze di
Guerrazzi.
8 agosto: firma - con Aleardi, Carcano e altri - una petizione di Guerrieri-Gonzaga, membro del
Governo provvisorio della Lombardia, rivolta al generale Cavaignac e al ministro Bastide affinché
la Francia intervenga per impedire il ritorno di Milano sotto la dominazione austriaca.
24 agosto: alla Maffei che vuol sapere l'opinione di Francia sulle cose d'Italia scrive: "chi non è
contrario è indifferente: aggiungo di più che l'idea dell'Unità Italiana spaventa questi uomini
piccoli, nulli che sono al potere [...1. In una parola: la Francia non vuole l'Italia nazione. [...] del
resto anche la Francia è in un abisso di guai". - In conseguenza del disordine arrecato agli affari
teatrali dagli avvenimenti politici "rapidi e violenti" e non avendo ricevuto il libretto "a tempo
debito", avverte l'impresario Guillaume di considerare "distrutto, annullato" il contratto di Napoli;
in pari data Flaùto, subentrato a Guillaume, conferma la validità del contratto spostandone la
scadenza al 1849.
15 settembre: prende tempo per decidere sul contratto per Napoli e intanto sollecita da
Cammarano la poesia per l'opera sulla quale s'era impegnato con Ricordi.
24 settembre: a Cammarano che, minacciato dall'impresa del S. Carlo di un processo per rifusione
di danni, gli aveva chiesto soccorso: "L'Impresa di Napoli, con mezzi poco legittimi e poco umani,
vuol ottenere quanto il solo adempimento a doveri contratti doveva assicurarle. Voi, uomo onesto,
padre di famiglia, artista distinto sareste la vittima di tutti questi ignobili intrighi. [...] a riguardo
vostro, a solo vostro riguardo, scriverò l'opera per Napoli l'anno venturo, dovessi rubare due ore
tutti i giorni al mio riposo, alla mia salute!"; intanto gli chiede alcune modifiche all'ultimo atto
della Battaglia di Legnano.
Settembre: ricevuta la poesia da Mameli. compone l'inno Suona la tromba, per voci maschili.
6 ottobre: risponde alla Barbieri Nini sull'interpretazione musicale e scenica del Corsaro: "non è
opera che esiga grandi elementi ad eccezione dei cantanti principali. [...] fate che l'opera sia divisa
in due soli atti. Il primo atto alla fine del finale [secondo] il secondo col terzetto. Guadagnerà in
interesse, in brevità, in tutto" (riunendo in uno i primi due atti).
9 ottobre: Cammarano gli invia la poesia del terzo atto della Battaglia di Legnano.
18 ottobre: GV spedisce l'inno a Mazzini: "Possa quest'inno, fra la musica del cannone, essere
presto cantato nelle pianure lombarde".
25 ottobre: Trieste,Teatro Grande: prima rappr. di 1Z corsaro, assente l'autore; esito abbastanza
buono. 29 ottobre: Cammarano spedisce a GV la poesia dell'ultimo atto della Battaglia di Legnano.
21 novembre: GV a Vincenzo Luccardi:"A Ricordi in forza di vecchio contratto devo uno spartito:
una volta scritto sono finiti i miei obblighi. Dietro sua preghiera io accondiscendeva venire a Roma
con mio sacrifizio perché i mille franchi che ho chiesto non bastano certamente pel viaggio da
Parigi a Roma, e da Roma a Parigi. [...] Perché non mi dici una parola [delle] faccende politiche
di Roma?... [...] È vero che sono artista, se non per talento, almeno per passione, ma tu lo sai,
abborro da tutto ciò che è mestiere! L'arte è bella ma non converrebbe farla per bisogno!"
23 novembre: a Flaùto:"io sono estremamente franco, deciso, qualche volta irascibile, selvaggio
anche se volete, ma giammai né difficile né prezioso [...]. Certo mentirei se vi dicessi che io sono
stato contento altra volta di Napoli; ma,
Arte e cultura
2 settembre: muore a Parma Pietro Giordani.
3 novembre: muore a Venezia per le ferite riportate nella sortita di Mestre Alessandro Poerio.
30 novembre: Napoli, S. Carlo: Donizetti, Poliuto (postumo).
Carlo Alberto Bosi, Addio, mia bella, addio, canto patriottico.
Souvestre - Bourgeois, Stifellius, tradotto in italiano. William M.Thackeray, La fiera delle vanità,
romanzo. Henri Murger, Scene della vita di bohème, racconti. Antonio Rosmini, Delle cinque
piaghe della Santa Chiesa.
Karl Marx e Friedrich Engel pubblicano il Manifesto del partito comunista.
John Stuart Mill, Principi di economia politica.
Politica, società, scienza, scoperte
13 marzo: l'insurrezione si estende a Vienna; Metternich è costretto alle dimissioni; l'imperatore
Ferdinando concede una costituzione moderatamente liberale.
17 marzo: insorge Venezia. Il 18 insorge Milano (le Cinque Giornate). Nello stesso giorno insorge
anche Berlino. Il 20 insorge Parma.
23 marzo: il Piemonte dichiara guerra all'Austria; a Venezia viene proclamata la Repubblica di S.
Marco.
22 marzo: a Venezia Daniele Manin e Niccolò Tommaseo instaurano la Repubblica di S. Marco. A
Modena, cacciato il duca Francesco V, s'insedia un governo provvisorio.
Marzo: in Prussia Federico Guglielmo IV è costretto a concedere alcune leggi liberali.
7 aprile: Mazzini ritorna in Italia.
29 aprile: Pio IX pronuncia un'allocuzione pacifista e ritira le truppe pontificie.
30 aprile: battaglia di Pastrengo.
Maggio: a Milano Cristina di Belgiojoso fonda la "Società per l'Unità d'Italia".
15 maggio: a Napoli colpo di stato di Ferdinando II.
15 maggio: dimostrazione di massa del proletariato parigino promossa da Louis-Auguste Blanqui e
dai suoi compagni, con invasione del parlamento.
25 maggio: plebiscito a Parma per l'annessione al regno di Sardegna.
29 maggio: battaglia di Curtatone e Montanara.
30 maggio: battaglia di Goito.
23-26 giugno: a Parigi insurrezione operaia a seguito della chiusura degli Stabilimenti nazionali,
seguita da una sanguinosa repressione a opera del ministro della guerra Eugène Cavaignac (oltre
3.000 insorti massacrati, 15.000 deportati senza processo).
Giugno: viene represso nel sangue il movimento rivoluzionario a Praga e in Boemia.
23-25 luglio: battaglia di Custoza.
25 agosto: Carlo III rientra a Parma.
28 agosto: armistizio di Salasco.
Ottobre: a Vienna, bombardata, viene spietatamente soffocata l'insurrezione.
8 ottobre: a Livorno Giuseppe Montanelli propone una Costituente italiana.
15 novembre: a Roma assassinio del ministro Pellegrino Rossi; il papa fugge a Gaeta.
Novembre: Francia: viene promulgata la costituzione della Seconda Repubblica.
l 0 dicembre: Luigi Bonaparte trionfa alle elezioni presidenziali.
Dicembre: le agitazioni popolari inducono Ferdinando I ad abdicare; gli succede il nipote
diciottenne Francesco Giuseppe.
La Toscana viene governata da un triumvirato formato da D. Guerrazzi, G. Montanelli e G.
Mazzoni.
Svizzera: i cantoni si danno una nuova costituzione
Cronologia 1849
Giuseppe Verdi
credetemi, l'esito non è quello che m'ha disgustato, ma una infinità di pettegolezzi che nulla aveva
a che fare con un'Opera [...]. Sono sei anni che scrivo continuamente, che giro da paese in paese e
non ho mai detto una parola a giornalista, mai pregato un amico, mai fatto la corte al ricco per
aver un esito. Mai, mai [...].Voglio ora persuadervi che se non vengo a Napoli non dipende dalla
mia volontà: vorrei potere sinceramente provare ai Napoletani che io pure posso faré qualche cosa
che non sia del tutto indegno di questo Teatro".
Novembre-dicembre: GV e Giuseppina Strepponi lasciano la residenza di Passy e abitano in rue de
la Victoire n. 13.
23 novembre: chiede a Cammarano alcune modifiche al libretto della Battaglia di Legnano; quanto
al soggetto dell'opera per Napoli chiede che vi siano "caratteri ben decisi, passione, movimento,
molto patetico e soprattutto vi sia il grandioso e lo spettacoloso senza di cui io non credo possibile
un successo in un gran teatro", e suggerisce Fieramosca o, in alternativa, L'assedio di Firenze di
Guerrazzi o il Ferruccio; sapendo che a Napoli si sta per dare Macbetb, sconsiglia di dare alla
Tadolini, la cui voce "ha dell'angelico", una parte come la Lady che ha "del diabolico", e infine dà
alcuni suggerimenti per la messinscena delle apparizioni dei re.
20 dicembre: parte per Roma.
1849
7 gennaio: Escudier pubblica una romanza da camera dedicata alla Strepponi, L'abandonnée.
15 gennaio: GV si dichiara formalmente sciolto da ogni impegno con l'Opéra di Parigi non avendo
ricevuto il libretto nei termini stabiliti.
16 gennaio: porta a termine la composizione e la strumentazione della Battaglia di Legnano.
18 gennaio: iniziano le prove dell'opera.
27 gennaio, Roma,Teatro Argentina: prima rappr. di La battaglia di Legnano; esito ottimo.
Inizio di febbraio: parte da Roma e rientra subito a Parigi.
14 febbraio: scrive a Cammarano per il libretto dell'Assedio di Firenze.
16 febbraio: assiste in sala Pleyel all'ultimo concerto di Chopin.
24 marzo: espone a Cammarano in una lunga lettera "tutte le pazzie che [gli] saltano in testa"
intorno all'Assedio di Firenze, e per la scena del Campo di Orange suggerisce "una scena
stupenda" che si trova nel Wallenstein di Schiller: "soldati, vivandiere, zingari, astrologhi, persino
un frate che predica alla maniera più comica e deliziosa del mondo".
14 aprile: Cammarano informa che l'Assedio di Firenze trasformato in Maria de' Ricci è stato
respinto dalla censura borbonica "per l'inopportunità del soggetto nelle attuali circostanze
d'Italia"; prende in considerazione Amore e raggiro di Schiller, a suo tempo proposto da GV.
3 maggio: Cammarano spedisce il programma del libretto di Eloisa Miller facendo presente la
necessità di superare tre ostacoli: "primo dover togliere quanto non sarebbe ammissibile dalla
censura; secondo innalzare a maggior nobiltà il Dramma, o per lo meno alcuno de' suoi
personaggi; terzo stringere il numero di questi personaggi ".
12 maggio: Carlo Verdi va ad abitare con la moglie nel casale di S.Agata.
17 maggio: a Cammarano:"vi confesso che avrei amato due primedonne, e mi sarebbe piaciuta in
tutta l'estensione del suo carattere la favorita del principe precisamente come l'ha fatta Schiller.
[...] ma infine so che non si può fare quello che si vuole e sta bene anche così. Mi pare peraltro che
tutto quell'infernale intrigo tra Valter e Wurm, che
domina come il fato tutto il dramma non abbia qui tutto il colore e tutta la forza che vi è in
Schiller. Non dimenticate di conservare in tutta la parte di [Wurm] quel certo non so che di
comico che servirà a dare maggior risalto alle sue finezze e alle sue scellerataggini".
1 1 giugno: Cammarano approva le opinioni del maestro:"Se non temessi la taccia di utopista, sarei
tentato a dire che per ottenere la possibile perfezione di un'opera musicale dovrebbe una mente
sola essere autrice dei versi e delle note: da questo concetto emerge chiara la mia opinione che due
essendo gli autori, è d'uopo almeno che essi fraternizzino, e che se la Poesia esser non deve serva
della Musica, non deve nemmeno esserne tiranna".
14 luglio: giuntagli notizia dell'entrata dei francesi a Roma, GV scrive a Luccardi:"La forza ancora
regge il mondo! La giustizia? A che serve contro le bajonette!!".
29 luglio: lascia Parigi con la Strepponi, la quale si reca a Firenze per sistemare il figlio Camillo;
GV si dirige alla volta di Busseto.
Arte e cultura
1849
10 febbraio: Parigi, Porte-St-Martin: Souvestre - Bourgeois,Lepasteun ou l'Évangile et le foyer
(Stifelliusl.
9 marzo: Berlino, Reale: Otto Nicolai, Le allegre comari di Windsor
12 marzo: muore a Milano lo scenografo Alessandro Sanquirico.
14 aprile: Parigi, Vaudeville: E. Legouvé - E. Scribe, Adriana Lecouvreur, dramma.
16 aprile: Parigi, Opera: Meyerbeer, Le prophète; per la prima volta viene sperimentato l'"arco
voltaico" per l'artificio del sole sorgente.
Maggio: Wagner partecipa all'insurrezione di Dresda; costretto a fuggire, ripara dapprima a
Weimar, quindi in Svizzera.
1° settembre: Milano, Canobbiana: Lauro Rossi, Il domino nero.
25 settembre: muore a Vienna Johann Strauss sr., autore della Marcia di Radetzky.
7 ottobre: muore a Baltimora Edgar Allan Poe.
17 ottobre: muore a Parigi Fryderyk Chopin.
22 novembre: Parigi, Th.-Historique: A. Dumas - A. Maquet, Il conte Hermann, dramma. - Parigi,
Variétés: Théodore Barrière, Vita di bohème, commedia (dai racconti di Murger)
Wagner, L'opera d'arte dell'avvenire.
George Sand, La piccola Fadette, romanzo.
Lamartine, Graziella, racconto.
Gustave Courbet, Gli spaccapietre, dipinto. - Millet, Il seminatore, dipinto.
C. Correnti, I dieci giorni della insurrezione di Brescia nel 1849.
Nasce a Londra, per iniziativa di Dante Gabriele Rossetti e altri, il movimento "preraffaellita".
F'edor Dostoevskij è condannato a morte; la pena gli è commutata in 4 anni di deportazione in
Siberia.
A Roma viene fondato l'"Osservatore Romano", trisettimanale politico cattolico (dal 1851 diventa
quotidiano; dopo il 1870 organo ufficiale della Santa Sede).
Politica, società, scienza, scoperte
federale sul modello americano.
Si conclude la guerra fra Stati Uniti e Messico: oltre al Texas anche California e Nuovo Messico
entrano a far parte della confederazione nordamericana.
In California vengono scoperti importanti giacimenti d'oro.
Curtis produce il chewing-gum.
1849
9 febbraio: viene proclamata la Repubblica Romana e dichiarato decaduto il potere temporale del
papa.
Febbraio: il granduca Leopoldo II fugge a Gaeta; si forma un governo provvisorio retto da un
triumvirato e viene proclamata la repubblica toscana.
20 marzo: Carlo Alberto denunzia l'armistizio di Salasco; riprendono le ostilità fra Piemonte e
Austria.
23 marzo: battaglia di Novara; l'esercito piemontese viene sconfitto dagli austriaci.
23 marzo - 1° aprile: Brescia insorge contro gli Austriaci, che tuttavia prevalgono.
29 marzo: Carlo Alberto abdica al trono; gli succede Vittorio Emanuele II.
29 marzo: a Roma si costituisce un triumvirato formato da Mazzini, Saffi e Armellini, con
Garibaldi al comando delle truppe repubblicane.
Aprile: l'Ungheria si proclama repubblica indipendente e si difende contro gli eserciti di Austria e
di Russia. In Germania viene approvata la costituzione di uno stato federale, ma il re di Prussia
rifiuta la corona imperiale offertagli.
Aprile: Luigi Napoleone invia una spedizione a Roma al comando del generale Oudinot.
25 aprile: l'esercito francese sbarca a Civitavecchia e inizia l'assedio di Roma.
Maggio: insurrezione di Dresda.
22 maggio: fucilazione del comandante Gerolamo Ramorino, ritenuto responsabile della disfatta di
Novara.
25 maggio: gli Austriaci entrano in Toscana per restaurare il granduca.
3 giugno: strenua difesa di Garibaldi contro Borbonici e Francesi; muoiono Enrico Dandolo (3
giugno), Luciano Manara (29 giugno), Goffredo Mameli (6 luglio), Emilio Morosini. Il 3 luglio i
francesi entrano a Roma; Garibaldi tenta invano di raggiungere Venezia insieme alla moglie Anita,
a padre Bassi e a Ciceruacchio; riesce a sfuggire alla cattura e dopo la morte di Anita nelle valli di
Comacchio ripara in Toscana.
Luglio: con l'aiuto degli Austriaci Leopoldo ritorna a Firenze e instaura un regime autoritario.
Cronologia 1850
Giuseppe Verdi
10 agosto: arriva a Busseto prendendo possesso del palazzo Orlandi che elegge a propria dimora in
attesa dell'arrivo di Giuseppina.
13 agosto: Cammarano gli spedisce il libretto completo della Miller.
Fine agosto: il figlio di Giuseppina, Camillo, viene alloggiato a Firenze presso la famiglia di Livia
Zanobini e accolto nello studio dello scultore Bartolini.
Agosto-settembre: GV è intento alla composizione di Luisa Miller
7 settembre: accetta la proposta di Flaùto di scrivere un'altra opera nuova da darsi a S. Carlo dopo
la Pasqua del 1850; per l'argomento suggerisce a Cammarano Le Roi s'amuse di Victor Hugo.
8 settembre: Giuseppina Strepponi entra in palazzo Orlandi; si ufficializza così la sua unione con
GV. Fine settembre: porta a termine la composizione di Luisa Miller.
3 ottobre: parte con Antonio Barezzi alla volta di Genova. Il 6 da Genova si dirige via terra alla
volta Napoli, compiendo il tratto Pisa-Firenze su strada ferrata.11 13 raggiunge Roma, occupata dai Francesi, e vi
sosta alcuni giorni per la quarantena causata dal colera. Il 27 arriva a Napoli e prende alloggio
all'I-Rotel de Rome.
1° novembre: nel vedere che l'impresa del S. Carlo, che naviga in cattive acque, tarda a pagargli la
prima rata del compenso dovutogli, protesta a Flaùto: "A voi son noti i sagrifizi che ho fatto, ed i
danni sofferti; voi conoscete i miei
obblighi; voi sapete che io sono venuto a Napoli per aderire alle vostre preghiere, e rendere un
piccolo servigio a Cammarano [...J.- I gran successi sono difficili in Napoli, e sopratutto per me ".
3 novembre: a Escudier:"Le cose del nostro paese sono desolanti! L'Italia non è più che una larga e
bella prigione! [...] Un paradiso per la vista: un inferno per il cuore! Il governo dei vostri a Roma
non è migliore degli altri d'Italia".
Novembre: Barezzi visita Napoli e i dintorni insieme a GV; il 14 ritorna a Busseto.
8 dicembre, Napoli, S. Carlo: prima rappr. di Luisa Miller; esito mediocre la prima sera, discreto
nel corso delle repliche.
14 dicembre: lascia Napoli via mare imbarcandosi sul vapore Capri e rientra a Busseto prima di
Natale.
1850
2 gennaio: propone a Cammarano il soggetto del Trovatore dal dramma di Garcia Gutiérrez.
31 gennaio: scioltosi dall'impegno di Napoli, cede a Ricordi l'opera che doveva scrivere per il S.
Carlo, con l'incarico farla rappresentare in un teatro primario nel novembre del 1850.
28 febbraio: stende la traccia di un libretto dal Re Lear di Shakespeare e la spedisce a Cammarano.
9 marzo: Marzari, presidente della Fenice di Venezia, gli propone un contratto per un'opera nuova.
28 aprile: firma il contratto con la Fenice; propone a Piave alcuni argomenti (fra cui Kean, non
gradito alla Fenice, e Gusmano il Buono), ma caldamente gli raccomanda il dramma di Hugo Le
Roi s'amuse, invitandolo a ottenere il permesso di musicarlo.
8 maggio: approva la proposta di Piave per un libretto ricavato da Le Pasteur, ou l'Évangile et le
Foyer di Souvestre e Bourgeois, noto in Italia col titolo di Stiidius, e ne chiede uno schizzo.
Metà giugno: Piave si reca a Busseto per lavorare ai libretti di Stiffello e della Maledizione (titolo
di quello che sarà poi Rigoletto). Intanto la Fenice, in grave crisi economica, sospende i contratti
dei cantanti scritturati per il carnevale 1850-51.
17 giugno: a Giulio Carcano, che gli propone di musicare una sua 'riduzione' dell'Amleto di
Shakespeare:"fatalmente questi grandi argomenti esigono troppo tempo ed io ho dovuto per ora
rinunziare al Re Lear. [...] Ora se il Re Lear è difficile, l'Amleto lo è ancor di più".
25 luglio: la Fenice supera le difficoltà economiche e i contratti vengono riconfermati.
14 agosto: a GV e a Piave giunge notizia delle gravi difficoltà per ottenere l'approvazione del
libretto della Maledizione. Piave rientra a Venezia per cercare di superare gli ostacoli della
censura.
13 e 29 settembre: Fétis pubblica due virulenti articoli contro GV, poi tradotti in italiano. Sui
giornali teatrali italiani si accende una lunga polemica, cui il compositore rimane totalmente
estraneo.
28 settembre: GV si reca al Comunale di Bologna per rappresentarvi Macbeth (3 ottobre) e Luisa
Miller (10 ottobre). L' il ottobre rientra a Busseto.
Arte e cultura
1850
20 gennaio: muore a Firenze lo scultore Lorenzo Bartolini.
Gennaio: Carlo Tenca fonda il periodico "Il Crepuscolo".
28 febbraio: Venezia, S. Benedetto: Luigi e Federico Ricci, Crispino e la comare.
31 marzo: muore a Firenze Giuseppe Giusti.
8 aprile: Bruxelles,Th. du Cirque: E. Muzio, Giovanna la Pazza.
8 giugno: Londra, Her Majesty's Th.: Halévy, La tempesta, " opera italiana".
25 giugno: Lipsia, Stadttheater: R. Schumann, Genoveffa.
11 luglio: Napoli, Nuovo: Nicola De Giosa, Don Checco.
Luglio: viene fondata a Lipsia la Bach-Gesellschaft. 1 8 agosto: muore a Parigi Honoré de Balzac.
28 agosto: Weimar: va in scena il Lohengrin di Wagner diretto da Liszt, assente l'autore.
Settembre: Rossini ritorna a Bologna.
Novembre: Palermo, Cavolino: Paolo Fodale,Anna Erizzo. 27 dicembre: Madrid: Garda
Gutiérrez,ll tesoriere del re. Anonimo [ma Wagnerl, L'ebraismo in musica.
Francesco De Sanctis, Sulle opere drammatiche di Schiller, prefazione alla iraduzione di A. Maffei.
Chateaubriand, Memorie d'oltretomba (postume).
Politica, società, scienza, scoperte
Venezia viene cinta d'assedio dagli austriaci. 27 luglio: muore a Oporto Carlo Alberto.
6 agosto: pace di Milano fra Piemonte e Austria. 8 agosto: viene fucilato a Bologna padre Ugo
Bassi. 10 agosto: viene fucilato a Rovigo Ciceruacchio con i suoi due figli.
13 agosto: pace di Vilagos; fallisce la rivoluzione ungherese; Kossuth si reca in esilio.
24 agosto: stremata dalla carestia e dal colera,Venezia cede agli Austriaci; fine della Repubblica di
S. Marco.
8 settembre: Mazzini, Saffi e Aurelio Saliceti fondano a Londra un comitato per l'indipendenza
italiana.
Settembre: Garibaldi s'imbarca per l'America meridionale.
20 novembre: Vittorio Emanuele II, sciolto il parlamento, rivolge ai sudditi il proclama di
Moncalieri contro l'opposizione democratica. Massimo d'Azeglio è a capo del nuovo governo.
Pravaz inventa la siringa ipodermica.
Livingstone esplora il deserto del Kalahari.
1850
Febbraio: il parlamento piemontese su proposta del ministro della giustizia Giuseppe Siccardi
emana le leggi miranti a limitare i privilegi ecclesiastici e ad abolire i tribunali ecclesiastici.
12 aprile: Pio IX rientra a Roma e avvia una politica reazionaria.
10 ottobre: Camillo Benso conte di Cavour entra a far parte del governo di d'Azeglio come
ministro dell'agricoltura e del commercio.
In Francia il presidente Bonaparte avvia una politica conservatrice (riforma elettorale restrittiva,
leggi sul controllo della stampa e sul diritto di riunione, estensione dell'autorità del clero in
materia d'insegnamento).
La Prussia abbandona la guerra per il possesso dello Schleswig-Holstein.
Il Regno di Sardegna stipula con la Francia una convenzione per la protezione del diritto d'autore.
McClure scopre il passaggio a Nordovest per il Pacifico. Il chimico britannico Thomas Graham
distingue i colloidi dai cristalloidi.
Nasce a New York la società Singer per la costruzione di macchine da cucire.
Laura Solera Mantegazza fonda a Milano il primo asilo nido per lattanti.
La popolazione in Europa è stimata in 260 milioni di abitanti; la popolazione mondiale è calcolata
in un miliar-
Cronologia 1851
Giuseppe Verdi
22 ottobre: riceve da Piave il libretto completo della Maledizione.
29 ottobre ca.: parte da Busseto; raggiunge Piave a Venezia; insieme arrivano a Trieste il 31.
Intanto anche la censura triestina solleva obiezioni e chiede modifiche al libretto di Stiffelio.
11 novembre: la Fenice comunica a GV che la censura è assai preoccupata "per la dissolutezza di
cui va gonfio" il dramma Le Roi s'amuse e ingiunge l'immediata presentazione del libretto.
16 novembre: spedisce il libretto della Maledizione alla Fenice per l'approvazione della censura. Trieste,Teatro Grande: prima rappr. di Stiffelio; esito discreto.
19 novembre: ospite nella villa dell'ex-tenore Giovanni Severi compone la berceuse Fiorellin che
sorgi appena dedicata al figlio neonato dell'ospitante.
20 novembre: parte alla volta di Busseto, da dove scrive a Piave circa eventuali modifiche alla
Maledizione, raccomandando non siano alterati caratteri, soggetto, posizioni; è disposto a
rinunciare alla "posizione in cui Francesco va colla chiave in camera di Bianca".
1° dicembre: la Fenice comunica a GV l'assoluto rifiuto da parte della censura veneziana del
libretto La maledizione; intanto, per salvare stagione e contratti, essa corre ai ripari incaricando
Piave di modificare il libretto.
9 dicembre: la censura veneziana approva la nuova versione del libretto della Maledizione,
intitolata Il duca di Vendome.
14 dicembre: GV rifiuta categoricamente di adattare la musica della Maledizione al Duca di
Vendome:"La maledizione del vecchio così terribile e sublime nell'originale, qui diventa ridicola LI
Osservo infine che si è evitato di fare Triboletto brutto e gobbo!! Per qual motivo? Un gobbo che
canta dirà taluno! E perché no?... [...] Io trovo appunto bellissimo rappresentare questo
personaggio esternamente defforme e ridicolo, ed internamente appassionato e pieno d'amore"; e
piuttosto lascia intravedere a quali modifiche egli potrebbe acconsentire.
21-23 dicembre: stretta fra le ingiunzioni della censura e il pericolo di una citazione per danni da
parte dell'impresa, la Fenice avvia trattative con il compositore per superare la vertenza.
30 dicembre: Piave e Brenna arrivano a Busseto per concordare con GV le modifiche da apportare
alla Maledizione: il luogo dell'azione, il nome di alcuni personaggi, la gobba, il sacco... Brenna
riparte subito per Venezia. Piave si trattiene per lavorare alle modifiche al libretto.
1851
11 gennaio: Piave è di ritorno a Venezia; il titolo dell'opera è mutato in Rigoletto. Ma i guai con la
censura non sono terminati; il commissario di polizia Martello richiede continui interventi ai versi,
ai nomi dei personaggi, alle situazioni.
21 gennaio: GV dichiara al notaio Balestra "di essere diviso" dal padre Carlo "di casa e di affari
[...]. Presso il mondo Carlo Verdi deve essere una cosa e Giuseppe Verdi un'altra".
26 gennaio: Piave annuncia a GV che la censura veneziana finalmente approva il libretto del
Rigoletto.
5 febbraio: GV termina la composizione di Rigoletto. 18 febbraio: parte per Venezia e inizia subito
le prove.
11 marzo: Venezia, La Fenice: prima rappr. di Rigoletto, con esito trionfale.
15 marzo: GV parte da Venezia e rientra a Busseto.
18 marzo: propone all'impresario Lanari un contratto per il Trovatore; e intanto ne stende uno
scenario.
9 aprile: spedisce a Cammarano lo scenario del Trovatore.
Maggio: fa traslocare i genitori a Vidalenzo e a stia volta si trasferisce con Giuseppina nel casale di
S.Agata, dove fa subito iniziare i lavori di restauro per trasformarlo in villa.
Fine maggio: subisce un furto nella casa di S.Agata.
30 giugno: muore a Vidalenzo la madre del maestro, Luigia latini (era nata a Saliceto il 30
settembre 1787).
Settembre: la Fenice propone a GV un contratto per un'opera nuova per il carnevale 1851-52; ma il
compositore rifiuta, occupato dal Trovatore e disgustato per le "immense noie sofferte" a causa
della censura veneziana.
10 dicembre: irritato dai pettegolezzi dei bussetani, GV parte con la Strepponi per Parigi.
Arte e cultura
Charles Dickens, David Copperfield, romanzo. - Nathaniel Hawthorne, La lettera scarlatta,
romanzo. Alfred Tennyson, In memoriam 11.11. Hallam, poesie. Soren Kierkegaard, Esercizio di
Cristianesimo. Terenzio Mamiani della Rovere, Le confessioni di un metafisico.
Victor Hugo è costretto all'esilio.
Viene fondato a Napoli il periodico "Civiltà Cattolica". Politica, società, scienza, scoperte
do e 171 milioni di individui.
Carlo Pisacane, La guerra combattuta in Italia negli anni 1848- '49.
M. Melloni, La termocrosi.
1851
24 gennaio: muore a Majolati Gaspare Spontini.
15 febbraio: Napoli, Nuovo: Vincenzo Battista, Erme-linda (Esmeralda).
16 aprile: Parigi, Opéra: Gounod, Sapho.
1° maggio: dopo aver subito un nuovo affronto, Rossini si stabilisce a Firenze.
11 maggio: Napoli, Nuovo: Errico Petrella, Le precauzioni.
14 agosto: Parigi: Eugène Labiche, Un cappello di paglia di Firenze, vaudeville.
22 novembre: Verona, Nuovo: Carlo Pedrotti: Fiorina. - Parigi,Th. Lyrique: E David, La perla del
Brasile.
23 dicembre: muore a Torino Giovanni Berchet.
Ricordi pubblica il trattato di Biihm sul flauto (1847) in traduzione italiana.
Wagner, Opera e dramma.
V Gioberti, Del rinnovamento civile d'Italia.
Herman Melville, Moby Dick o La balena bianca, romanzo.
Gérard de Nerval, Viaggio in oriente.
A Schopenhauer, Parerga e Paralipomena.
Politica, società, scienza, scoperte
Do e 171 milioni di individui.
Carlo Pisacane. La guerra combattuta in Italia negli anni 1848-49.
M. Melloni. La ternocrosi
1851
Cavour assume il ministero delle finanze.
A Napoli viene scoperta la setta "dell'Unità italiana"; i tribunali borbonici condannano Luigi
Settembrini alla pena capitale commutata in ergastolo, Silvio Spaventa all'ergastolo commutato in
esilio, Carlo Poerio al carcere. Francesco De Sanctis è costretto all'esilio.
Ottobre: nel regno di Sardegna il ministro d'Azeglio è costretto alle dimissioni per l'opposizione
del re al progetto di introdurre il matrimonio civile.
2 dicembre: colpo di stato di Luigi Bonaparte, che scioglie il parlamento e reprime sul nascere una
rivolta popolare.
Prima Esposizione mondiale dell'industria al Palazzo di Cristallo di Londra.
Primo collegamento telegrafico sottomarino fra Calais e Dover.
Heinrich Daniel Ruhmkoff inventa e produce il rocchetto di induzione.
Jean-Bernard Foucault mediante un gigantesco pendolo sospeso alla volta del Panthéon di Parigi
offre la prima prova sperimentale della rotazione terrestre.
Twining e Harrison inventano un refrigeratore.
Cronologia 1852
Giuseppe Verdi
1852
21 gennaio: a Barezzi, alludendo alla propria convivenza con Giuseppina:"Io non ho nulla da
nascondere. In casa mia vive una signora libera indipendente, amante come me della vita solitaria,
con una fortuna che la mette al coperto da ogni bisogno. Né io, né lei dobbiamo a chicchessia conto
delle nostre azioni, ma d'altronde chissà quali rapporti
esistono fra noi? Quali gli affari? Quali i legami? [...] che io reclamo la mia libertà d'azione, perché
tutti gli uomini ne hanno diritto, e perché la mia natura è ribelle a fare a modo altrui. [...1 la
perdita di venti o trenta mila franchi non
sarà mai quella che m'impedirà di trovarmi una patria altrove".
24 gennaio: la Fenice gli chiede un'opera nuova per il carnevale 1852-53.
4 febbraio: accetta in via preliminare la proposta della Fenice in attesa di conoscere la compagnia
di canto. 20 febbraio: propone alla Fenice la scrittura di una primadonna di rango.
28 febbraio: firma con l'Opéra un contratto per un'opera nuova (i futuri Vespri siciliani). 7 marzo:
parte con Giuseppina da Parigi. Il 18 rientrano a S.Agata.
13 aprile: la Fenice è in difficoltà nella ricerca di una primadonna, essendo le cantanti proposte da
GV già tutte impegnate.
19 aprile: la Fenice scrittura quale primadonna Fanny Salvini Donatelli; e invia Brenna a S.Agata
per conoscere il parere di GV.
25 aprile: GV firma un compromesso in base al quale si riserva se nella sua nuova opera debba
agire la Salvini Donatelli, dichiarandone la idoneità o meno entro il 15 gennaio 1853. In quello
stesso giorno anche Lanari è in visita dal maestro in vista dello Stiffelio a Bologna.
4 maggio: firma con la Fenice il contratto per l'opera nuova con l'impegno di consegnare il libretto
entro luglio per l'approvazione dell'autorità politica.
9 maggio: il padre di GV, Carlo, supera una grave malattia.
20 giugno: Piave arriva a S.Agata per rifare il quarto atto di Stiffelio per Bologna; ma non se ne
farà niente.
Fine luglio: GV chiede una proroga per la consegna del libretto, Piave non avendogli ancora
presentato un soggetto "originale e piccante".
17 luglio: muore a Napoli Salvadore Cammarano, lasciando incompiuto il libretto del Trovatore.
26 luglio: GV chiede alla Fenice un'ulteriore proroga, fissandola per la fine di settembre.
15 agosto: Piave, sempre alla disperata ricerca di un soggetto per l'opera nuova di Venezia,
propone la Juive de Constantine di Gautier e Parfait; GV chiede copia di questo dramma a Marie
Escudier.
22 settembre: riceve notizia del conferimento della Legion d'onore da parte del presidente della
repubblica francese, Luigi Bonaparte, con decreto del 10 agosto.
Fine settembre: Piave si reca a S.Agata per terminare il libretto per Venezia (l'Ebrea di Costantina
o, forse, La forza del destino secondo l'indiscrezione di un giornale teatrale?).
20 ottobre: Piave comunica alla Fenice d'aver finito il libretto, quando, al momento di partire,
"Verdi s'infiamma d'altro argomento" e deve dunque restare per scrivere un nuovo libretto
intitolato Amore e morte (ossia La dama dalle camelie).
29 ottobre: GV ringrazia Marie Escudier per avergli spedito la Dame aux camélias.
21 novembre: il libretto di Amore e morte ottiene l'approvazione della censura veneziana con il
titolo Traviata.
Dicembre: GV inizia la composizione di Traviata e termina quella del Trovatore.
Arte e cultura
Charles-Augustin de Sainte-Beuve inizia a pubblicare le Conversazioni del lunedì.
Nasce il quotidiano "New York Times".
Viene fondata a Londra l'agenzia di stampa "Reuter".
1852
2 febbraio: Parigi, Théàtre du Vaudeville: Dumas fils, La darne aux camélias,"pièce mélée de
chant". 21 febbraio: muore a Mosca Nikolaj Gogol'.
7 marzo: Trieste, Grande: Francesco Cortesi, II trovatore (La schiava).
25 marzo: Monaco, Hoftheater: Hebbel, Agnese Bernauer, tragedia.
15 maggio: viene inaugurato a Ravenna il teatro Alighieri.
13 giugno: Weimar, Hoftheater: R. Schumann, Manfred, poema drammatico.
7 agosto: Firenze, Ginnasio Drammatico: Paolo Ferrari, Goldoni e le sue sedici commedie nuove.
12 agosto: Napoli, Fondo: Petrella, Elena di Tolosa.
14 agosto: Vicenza. Eretenio: Giuseppe Apolloni, Adelchi.
4 settembre: Parigi,Th.-Lyrique:A.Adam, Si fétais
7 ottobre: muore a Firenze l'impresario Alessandro Lanari.
8 dicembre: Breslavia: Gustav Freytag, I giornalisti, commedia.
15 dicembre: Wagner conclude il ciclo poetico dell'Anello dei Nibelunghi.
26 dicembre: prima rappr. italiana del Profeta di Meyerheer alla Pergola di Firenze.
Angelo Mariani viene nominato direttore stabile dell'orchestra di Genova.
L'editore Pirola di Milano porta a termine la pubblicazione, iniziata nel 1842, delle Opere edite e
inedite del cav. Andrea Maffei, contenenti il Teatro completo di Schiller.
Harriet Beecher-Stowe, La capanna dello zio Tom, romanzo.
Ivan Turgenev, Memorie di un cacciatore, racconti. Giuseppe Giusti, Versi editi e inediti, pubbl.
postuma. A. Comte, Catechismo positivista.
Jules Michelet, Storia della rivoluzione francese.
Politica, società, scienza, scoperte
1852
14 gennaio: Luigi Bonaparte promulga una nuova costituzione.
Febbraio: Cavour effettua il "connubio" delle forze parlamentari di centro con quelle di sinistra
guidate da Urbano Rattazzi.
Estate: a Mantova vengono arrestati i componenti di un sottocomitato mazziniano, diretto dal
sacerdote don Enrico Tazzoli. Processati, nove di essi sono condannati a morte per impiccagione.
2 dicembre: attraverso un plebiscito Luigi Napoleone ottiene i poteri imperiali assumendo il titolo
ereditario di imperatore dei Francesi con il nome di Napoleone III.
24 dicembre: Cavour diventa primo ministro del governo piemontese.
Con il protocollo di Londra i ducati di Schleswig e Holstein restano sotto la sovranità danese, pur
con autonomia interna.
Nell'Africa meridionale gli Inglesi riconoscono l'indipendenza del Trasnvaal, dove si sono ritirati i
Boeri. David Livingstone esplora lo Zambesi.
Nel regno di Sardegna viene abolito lo studio del latino nelle università.
Su incarico di Napoleone III l'urbanista Eugène Haussmann progetta la ristrutturazione di Parigi.
Cronologia 1853
Giuseppe Verdi
20 dicembre: si dirige con Giuseppina alla volta di Livorno dove salpa per Civitavecchia;
Giuseppina si trattiene a Livorno, da dove si reca per qualche giorno a Firenze.
24 dicembre ca .: arriva a Roma e inizia subito le prove del Trovatore al teatro di Apollo.
1853
6 gennaio: GV chiede che i costumi della Traviata rimangano "dei tempi presenti" (la richiesta
verrà ignorata dalla Fenice; i costumi saranno trasportati all'anno 1700).
16 gennaio: alla Fenice cade un'opera nuova di Carlo Bosoni; si rende necessaria un'opera di
ripiego; nonostante la riluttanza della Salvini Donatelli viene scelto l'Emani.
19 gennaio: Roma, Teatro Apollo: prima rappr. di Il trovatore, con successo trionfale.
22 gennaio: fiasco dell'Emani alla Fenice a causa del cattivo stato di salute dei cantanti. GV parte
da Roma, e rientra via mare imbarcandosi a Civitavecchia; a Livorno si ricongiunge con
Giuseppina. Il 27, transitando da Bologna,
riceve cattive notizie della stagione della Fenice.
30 gennaio: fa scrivere alla Fenice che si rende necessaria la scrittura di una nuova primadonna,
che la Traviata non è ancora terminata, il libretto nemmeno, che è ammalato e che pertanto non
assicura di andare a Venezia. La Fenice, allarmata, spedisce Piave a S.Agata.
3 febbraio: da S.Agata Piave informa la Fenice sull'esito dell'incontro con il maestro; conferma il
suo cattivo stato di salute, rassicura che il maestro continua a lavorare alla Traviata, che accetta la
Salvini Donatelli, e che l'opera avrebbe comunque fatto un "fiasco completo".
8 febbraio: la Fenice invia a S.Agata anche Brenna nel tentativo di appianare le difficoltà e
convincere il maestro a venire a Venezia.
12 febbraio: Brenna rientra a Venezia con Piave dopo aver avuto ampie rassicurazioni da GV.
13 febbraio: a Venezia cominciano le prove di Traviata; intanto a S.Agata GV provvede a
terminare l'opera.
21 febbraio: GV arriva a Venezia e termina la strumentazione della Traviata.
6 marzo: Venezia, La Fenice: prima rappr. di Traviata. Il primo atto viene applaudito; gli altri due
atti cadono, causa principale il cattivo stato di salute del tenore e la svogliatezza del baritono.
7 marzo: GV considera l'esito un fiasco; tuttavia la Traviata viene rappresentata per altre nove
sere con alto numero di spettatori e ottimi incassi.
10 marzo: riparte da Venezia; il 12 arriva a S.Agata.
23 aprile: a Somma, che gli propone un libretto:"Vivente il povero Cammarano, io gli aveva
suggerito il Re Lear. Dategli un scorsa".
Primavera: la Traviata sta per essere rappresentata a Roma, ma esigendo la censura papalina
nuove e consistenti modifiche al libretto, GV fa ritirare la partitura.
22 maggio: propone a Somma una traccia di libretto del Re Lear.
12 luglio: riceve da Somma la prima parte (Introduzione) del libretto del Re Lear. 29 agosto:
muore a Busseto la suocera di GV, Maria Barezzi.
9 settembre: riceve il secondo atto del libretto del Re Lear
15 ottobre: parte con Giuseppina alla volta di Parigi e va ad alloggiare al n. 4 di rue Richer.
7 novembre: paga a Somma 2.000 lire austriache per il libretto del Re Lear.
1854
18 gennaio: chiede a De Sanctis informazioni sulla tarantella.
8 febbraio: riceve da Scribe il libretto completo di Les Vépres siciliennes; a Somma: "speravo di
poter musicare prima il Re Lear per l'Italia, ma mi è stato impossibile".
Arte e Cultura
1853
7 febbraio: Milano, Re: E. Muzio, Claudia.
15 marzo: muore a Milano l'editore Giovanni Ricordi. Novembre: Wagner inizia la composizione
dell'Oro del Reno.
10 novembre: Milano, Scala: Giuseppe Rota, I Bianchi e i Neri, ballo, musica di Dominiceti.
10 dicembre: H. Berlioz, L'infanzia di Cristo, oratorio. 10 dicembre: muore a Milano Tommaso
Grossi. Ferdinand Bliithner fonda a Lipsia una fabbrica di pianoforti. - Henry Steinway (Steinweg)
fonda a New York una fabbrica di pianoforti.
Fusinato, Poesie.
Giovanni Gozzadini scopre a Villanova (Bologna) un sepolcreto dell'età del ferro, che rivela una
nuova civiltà, detta "villanoviana".
Su pressione del governo austriaco a Capolago viene chiusa la Tipografia e Libreria Elvetica.
1854
31 gennaio: muore a Torino Silvio Pellico.
9 febbraio: Napoli, S. Carlo: Petrella, Marco Visconti. 16 febbraio: Parigi, Opéra-Comique:
Meyerbeer, La stella del nord.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
1853
6 febbraio: fallito tentativo insurrezionale mazziniano a Milano e a Brescia.
3 marzo: nove patrioti mazziniani - fra i quali don Tazzoli, Carlo Poma e Tito Speri - vengono
impiccati sugli spalti della fortezza di Belfiore.
Fallimento dei moti insurrezionali mazziniani a Sarzana. Luglio: lo zar Nicola I invade i principati
danubiani di Moldavia e Valacchia posti sotto la sovranità turca. Ottobre: la Turchia dichiara
guerra alla Russia; ha così inizio la guerra di Crimea.
Viene costruita la prima ferrovia transalpina, la Vienna - Trieste.
Viene fondata la società farmaceutica Carlo Erba. Giovanni Ansaldo, sotto la spinta di Cavour,
fonda un gruppo metalmeccanico destinato all'industria navale, a quella ferroviaria e agli
armamenti.
1854
26 marzo: a Parma viene assassinato Carlo III; gli succede il figlio Roberto sotto la reggenza di
Maria Luisa Teresa di Berry.
Marzo: una squadra navale americana comandata dal
Cronologia 1855
Giuseppe Verdi
Marzo: si reca per pochi giorni a Londra per le prove del Trovatore. Intanto apporta alcune
modifiche allo spartito di Traviata per la ripresa che si sta allestendo a Venezia al teatro in S.
Benedetto.
6 maggio: la Traviata risorge a Venezia al teatro in S. Benedetto, assente l'autore, trattenuto a
Parigi. 18 maggio: Antonio Barezzi si sposa in seconde nozze con Maddalena Fagnoni, sua ex
domestica.
Maggio: GV e Giuseppina si ritirano a trascorrere l'estate in campagna prendendo in affitto una
villa a Mandres (Seine et Oise).
26 maggio: a De Sanctis:"la Traviata che si eseguisce ora al S. Benedetto è la stessa, stessissima
che si eseguì l'anno passato alla Fenice, ad eccezione di alcuni trasporti di tono, e di qualche
puntatura E... I non un pezzo è stato cambiato, non un pezzo è stato aggiunto, o levato, non
un'idea musicale è stata mutata".
6 luglio: incarica De Sanctis di rivolgersi al poeta Bardare per il rifacimento della Battaglia di
Legnano: "Io non vorrei un semplice cambiamento di nomi, di titolo, e di parole e di qualche verso,
ma un sogetto affatto nuovo, egualmente interessante e dello stesso carattere".
Agosto: viene nominato Ufficiale della Legion d'onore. Muore a Locate Triulzi il fratello di
Giuseppina, Davide.
9 settembre: a De Sanctis:"Ho appena finiti quattro atti della mia opera francese. Mi restano il
quinto, i balletti, e l'istromentazione. L.] Un'opera all'Opéra è fatica da ammazzare un toro".
1° ottobre: cominciano le prove dei Vespri siciliani all'Opera; ma vengono interrotte dopo pochi
giorni a causa della scomparsa della primadonna Sofia Cruvelli, fuggita sulla Costa Azzurra col
suo fidanzato.
20 ottobre ca.: GV chiede lo scioglimento del contratto e la restituzione dello spartito (lei Vespri,
ma senza risultato.
Novembre: accetta intanto di dirigere le prove del Trovatore al Teatro Italiano; a De Sanctis:
"voglio vedere se mi è possibile fare eseguire qui la mia musica come voglio io".
20 novembre: la Cruvelli riappare sulla scena dell'Opéra. 29 novembre: riprendono le prove dei
Vespri.
26 dicembre: prima rappr. del Trovatore al Teatro Italiano di Parigi, diretto da GV; il successo è
strepitoso.
1855
Muore l'agente teatrale Camillo Cirelli.
3 gennaio: GV si rivolge al direttore dell'Opéra, Crosnier, lamentando la scarsa collaborazione di
Scribe nel rimediare al quinto atto dei Vespri e della sua assenza alle prove, e osservando inoltre
che il soggetto è pericoloso: ferisce i francesi perché sono massacrati, e ferisce gl'italiani perché
Scribe, alterando il carattere storico di Procida, ne ha fatto un comune cospiratore con l'inevitabile
pugnale alla mano: "je suis Italien avant tout, et coute qui coute, je ne me rendrai jamais complice
d'une injurie faite à mon pays".
14 gennaio: scrive al presidente della Fenice, Mocenigo, di non poter accettare la proposta di un
contratto per il carnevale 1855-56.
14 febbraio: analoga risposta invia al nuovo presidente,Tornielli.
17 febbraio: si lamenta con De Sanctis del fiasco di Traviata a Napoli:"Perché sul vostro S. Carlo
non si potrà rappresentare indifferentemente una Regina od una paesana, una donna virtuosa od
una puttana? Perché non un medico che tasta il polso, non dei balli mascherati etc. etc.? E...I Il 2°
atto è migliore del primo. Il terzo è migliore di tutti j..1.Vorrei potervi far sentire da uno che
sapesse cantare l'andante Di Provenza per farvi capire che è il miglior cantabile che m'abbia scritto
per Baritono".
10 aprile: informa De Sanctis d'aver terminato la composizione dei Vespri, salvo i ballabili; gli
chiede di mandargli "una Siciliana vera; vale a dire, una canzone del popolo e non una canzone
fabricata dai vostri maestri".
13 giugno: Parigi, Opéra: prima rappr. di I.es Vépres siciliennes, con successo caloroso.
6 luglio: spedisce a Ricordi la partitura dei Vespri con la traduzione italiana intitolata Giovanna de
Guzman.
Metà luglio: GV e Giuseppina si recano per pochi giorni a Londra; scopo del viaggio quello di
impedire che le sue opere, e in particolare il Trovatore, vi siano rappresentate senza pagare il
diritto d'autore.
Agosto: rientrati a Parigi, prendono in affitto un villino a Enghien-les-Bains per trascorrervi un
periodo di vacanza.
Arte e Cultura
23 febbraio: Weimar: Liszt, I preludi, poema sinfonico. 25 aprile: nasce a Napoli Ruggero
Leoncavallo.
Giugno: Treviso: Paolo Giacometti, La colpa vendica la colpa, commedia.
18 ottobre: Parigi, Opéra: Gounod, La Nonne sanglante.
21 novembre: Trieste, Grande: Balfe, Pittore e duca, libretto di Piave.
Hanslick, Del bello in musica.
Roma, Valle: Gherardi Del Testa, La scuola dei vecchi ossia Il padiglione delle monelle, commedia.
Firenze: inaugurazione del teatro Pagliano (poi teatro Verdi) con il Rigoletto.
Manuel Garda jr., maestro di canto, inventa il laringoscopie.
I fratelliAlinari aprono a Firenze un laboratorio di fotografia. Viene fondato a Parigi il periodico
"Le Figaro".
1855
23 gennaio: Venezia, Fenice: Giuseppe Apolloni, L'ebreo.
10 febbraio: Mantova, Sociale: Sanelli, Gusmano il prode. - Napoli, S. Carlo: De Giosa, Ettore
Fieramosca.
20 marzo: Parigi, Gymnase: Dumas fils, Le demimonde, commedia.
Aprile: Rossini si trasferisce con Olimpia Pélissier definitivamente a Parigi.
30 aprile: muore a Londra Sir Henry Rowley Bishop, compositore, autore di Home, Sweet Home.
Maggio: Wagner dirige a Londra una serie di otto concerti sinfonici con proprie musiche. Prima
trionfale tournée di Adelaide Ristori a Parigi. Lo scultore Vela presenta il suo Spartaco
all'Esposizione di Parigi.
1° luglio: muore a Stresa Antonio Rosmini.
11 novembre: muore a Copenaghen il filosofo Saren Kierkegaard.
25 novembre: Venezia, S. Benedetto: Serafino De Ferrati, Pipelet.
31 dicembre: nasce a S. Mauro di Romagna Giovanni Pascoli.
Giovanni Ruffini, esule a Londra, pubblica Il dottor Antonio, romanzo.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
commodoro M. C. Perry penetra nella baia di Tokyo e impone al Giappone relazioni commerciali
(trattato di Kanagawa), ponendo fine al suo isolamento.
22 luglio: fallito tentativo insurrezionale a Parma da parte dei mazziniani; viene istituito lo stato
d'assedio; seguono alcune condanne a morte.
Nella guerra di Crimea Francia e Gran Bretagna si alleano alla Turchia contro la Russia.
Giugno-agosto: moti insurrezionali in Valtellina. Ottobre: inizia l'assedio di Sebastopoli.
La Francia organizza la colonia del Senegal.
Gli Inglesi riconoscono l'indipendenza dell'Orange in Sudafrica.
Stefano Jacini, La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia.
Eugenio Barsanti e Felice Matteucci inventano il motore a scoppio a due cilindri.
Viene realizzata l'applicazione dell'aria compressa alle macchine perforatrici destinate allo scavo di
gallerie.
Viene inaugurata la ferrovia Torino - Genova. L'americano E. G. Otis brevetta l'ascensore. Nadar
apre a Parigi il suo studio fotografico. Si diffonde l'impiego di coloranti sintetici.
1855
10 gennaio: il Piemonte firma un'alleanza con Francia e Inghilterra; e invia una spedizione militare
in Crimea.
Contro la volontà di Vittorio Emanuele II, Cavour fa approvare una legge che sopprime 334 ordini
religiosi e rivendica la sovranità del potere civile nei confronti del clero.
Esposizione Universale a Parigi al Palazzo dell'Industria.
16 agosto: il contingente piemontese è impegnato in Crimea nella battaglia della Cernaia.
8 settembre: cade Sebastopoli; lo zar firma un armistizio.
In Etiopia sale al trono il negus Teodoro II che avvia con decisione un processo di
modernizzazione del paese.
G. Ravizza inventa il "cembalo scrivano", una delle prime macchine da scrivere a tastiera.
Appaiono i primi bicicli, realizzati da Michaux, precursori della moderna bicicletta.
Lo svedese C. E Lundstróm inventa i fiammiferi di sicurezza.
Cronologia 1856
Giuseppe Verdi
Ottobre: GV e Giuseppina ritornano a Parigi, in rue Richer.
21 ottobre: GV rinvia il rientro in Italia cedendo alla richiesta di Calzado di rimettere in scena il
Trovatore al Teatro Italiano. Intanto, con l'aiuto di Giuseppina, controlla la traduzione francese di
quest'opera in vista di un'eventuale allestimento all'Opéra.
28 novembre: spedisce a Ricordi la disposizione scenica dei Vespri.
20 dicembre.: GV e Giuseppina partono da Parigi. Il 21 sostano ad Aléssandria, dove Muzio sta
dirigendo Traviata. Il 22 arrivano a S.Agata.
1856
Gennaio: si reca a Parma con Muzio ad assistere a una rappresentazione della Giovanna di
Guzman (versione italiana dei Vespri siciliani); propone al duca di Parma un trattato
internazionale per la protezione del diritto d'autore.
9 febbraio: riceve da Vittorio Emanuele II il titolo di Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro.
10 marzo: invita Piave a raggiungerlo a S.Agata per le modifiche al libretto di Stiffelio (il futuro
Aroldo).
23 marzo: sapendo del suo imminente viaggio a S.Agata la presidenza della Fenice incarica Piave
di avviare le trattative con GV per un'opera da darsi nel carnevale 1856-57.
27 marzo: Piave arriva a S.Agata.
2 maggio: GV firma un contratto con il S. Carlo di Napoli (il futuro Un ballo in maschera).
15 maggio: firma un contratto con la Fenice di Venezia (il futuro Simon Boccanegra). 25 giugno: si
reca a Venezia con Giuseppina per la stagione dei bagni.
21 luglio: riparte da Venezia per rientrare a S.Agata.
31 luglio: parte nuovamente per Parigi, ma solo per affari.
Agosto: elabora in prosa l'intero libretto del Simon Boccanegra e lo spedisce a Piave per la
versificazione.
22 settembre: firma un contratto per far rappresentare il Trovatore in francese all'Opéra.
Ottobre: stante la lontananza da Piave, al fine di accelerare la composizione del Boccanegra si
rivolge per la versificazione del libretto anche a Giuseppe Montanelli, esule a Parigi.
25 ottobre - 3 novembre: GV e Giuseppina sono ospiti di Napoleone III nella villa imperiale di
Compiègne. Novembre: rientrano a Parigi, prendendo alloggio in un appartamento al n. 20 di Rue
Neuve-des-Mathurins.
Dicembre: dirige le prove del Trovatore in francese all'Opéra, vi aggiunge i ballabili e porta
qualche modifica allo spartito, in particolare al finale dell'opera.
1857
12 gennaio: Parigi, Opéra: prima rappr. del Trovatore in francese con l'aggiunta del balletto.
13 gennaio: GV parte da Parigi per S.Agata a terminarvi la composizione del Boccanegra.
19 febbraio: parte con Giuseppina per Venezia.
12 marzo: Venezia, La Fenice: prima rappr. di Simon Boccanegra; esito mediocre.
15 marzo: rientra a S.Agata; firma un contratto per la stagione inaugurale del nuovo teatro di
Rimini (il futuro Aroldo).
10 aprile: firma un contratto per far rappresentare Simon Boccanegra nella stagione inaugurale del
nuovo Municipale di Reggio Emilia. Piave arriva a S.Agata per il rifacimento del libretto di
Stiffelio e per le modifiche al libretto del Boccanegra.
10 maggio: parte per Reggio Emilia con Giuseppina.
10 giugno: Reggio Emilia, Municipale: rappr. del Simon Boccanegra con alcune modifiche.
14 giugno: rientra a S.Agata con Giuseppina dopo aver assistito alle prime tre recite.
Arte e Cultura
Lev N.Tolstoj, Racconti di Sebastopoli.
Arthur de Gobineau, Saggio sull'ineguaglianza delle razze umane.
Marco Minghetti, Della libertà religiosa. Herbert Spencer, Princìpi di psicologia.
Gustave Courbet, L'atelier e Ragazze sulle rive della Senna, dipinti; rifiutato dall'Esposizione
Universale, dove viene allestita una retrospettiva di J.-A. Ingres, Courbet edifica per protesta il
Pavillon du Réalisme.
1856
Gennaio: Torino, Alfieri: Paolo Ferrari, La satira e Panini, commedia in versi.
18 gennaio: Parigi,Th.-Lyrique:A.Adam, Falstaff
23 gennaio: Parigi, Opéra: Mazilier -Adam, Il corsaro, ballo.
17 febbraio: muore a Parigi Heinrich Heine.
21 febbraio: Parigi, T Italiano: Giovanni Bottesini, L'assedio di Firenze.
4 marzo: Milano, Scala: Petrella, L'assedio di Leyda.
6 maggio: nasce a Pribor (Moravia) Sigmund Freud.
Maggio: Milano, Canobbiana: Rota, Il conte di Montecristo, azione mimica.
26 luglio: nasce a Dublino George Bernard Shaw.
29 luglio: muore a Endenich Robert Schumann.
30 agosto: Cremona: Ponchielli, /promessi sposi.
4 novembre: Verona, Nuovo: Carlo Pedrotti, Tutti in maschera.
L'attore Tommaso Salvini inizia a interpretare Shakespeare (Otello e Amleto a Vicenza).
Friedrich Wilhelm Cari Bechstein fonda a Berlino una fabbrica di pianoforti.
Antonio Ghislanzoni, Gli artisti da teatro, romanzo. Theodor Mommsen, Storia romana.
1857
15 febbraio: muore a Berlino Mikhail Glinka.
21 aprile: Reggio Emilia, inaugurazione del teatro Municipale; Achille Peri, Vittor Pisani.
2 maggio: muore a Parigi Alfred de Musset.
31 maggio: Reggio Emilia, Municipale: Rota, Carlo il Guastatore, ballo, musica di P Giorza.
11 luglio: Rimini, inaugurazione del nuovo teatro Comunale con Il trovatore diretto da Angelo
Mariani.
Flaubert, Madame Bovary, romanzo. - José M. de Alencar, Il Guarany, romanzo. - Octave Feuillet,
Il romanzo di un giovane povero.
Baudelaire, I fiori del male. - Algernon Charles Swinburne, Ode a Mazzini.- L. Mercantini, La
spigolatrice di Sapri, poesia. - Jan Neruda, Fiori di cimitero, poesie.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
1856
30 marzo: il Congresso di Parigi chiude la guerra di Crimea; la Russia rinuncia alle foci del
Danubio, viene riconosciuta l'integrità dell'impero ottomano, viene dichiarata la neutralità degli
Stretti. In una seduta suppletiva, Cavour illustra, appoggiato da Napoleone III, la questione
italiana.
Lo zar Alessandro II auspica l'abolizione della servitù della gleba.
Nell'impero ottomano viene garantita la parità di diritti politici e civili ai sudditi di religione
cristiana. Riprende in Cina la "guerra dell'oppio".
Henry Bessemer mette a punto il suo convertitore per la trasformazione della ghisa in acciaio.
Il chimico francese Pierre Berthelot riesce a ottenere sinteticamente gli idrocarburi.
Francesco Cirio apre la prima fabbrica di piselli in scatola. Presso Diisseldorf viene trovato il
primo cranio dell'"uomo di Neanderthal".
Una spedizione britannica raggiunge la punta Dudour sul Monte Rosa.
1857
Massimiliano d'Asburgo succede a Radetzsky come governatore del Lombardo-Veneto.
28 giugno: sbarco a Sapri di Carlo Pisacane; fallito il tentativo insurrezionale, Pisacane si uccide il
2 luglio; Giovanni Nicotera viene incarcerato.
Agosto: Daniele Manin e Giuseppe La Farina fondano a Torino la Società Nazionale per
l'unificazione dell'Italia sotto casa Savoia. Vi aderisce anche Garibaldi.
Si interrompono le relazioni diplomatiche fra regno di Sardegna e Austria.
Inizia nel Bengala l'insurrezione degli Indiani contro gli Inglesi.
Viene posato il primo cavo telegrafico che attraversa l'oceano Atlantico.
Cronologia 1858
Giuseppe Verdi
Luglio: porta a compimento la trasformazione di Stiffelio in Aroldo.
20 luglio: GV e Giuseppina partono alla volta di Rimini, prendendo alloggio dapprima all'albergo
Posta, quindi al più comodo Albergo dell'Aquila.
16 agosto: Rimini, nuovo Comunale: prima rappr. di Aroldo, diretto da Angelo Mariani, con
grande successo. 28 agosto: a Busseto viene decisa la costruzione di un teatro; i lavori inizieranno
due anni dopo.
Settembre: incarica Antonio Somma di scrivere il libretto per l'opera di Napoli; l'argomento è
tratto dal libretto di Scribe, Gustave III ou Le bal masqué, musicato da Auber (Opéra di Paiigi,
1833).
19 ottobre: spedisce il libretto a Napoli per l'approvazione della censura.
Novembre: la censura napoletana chiede numerose modifiche al libretto del Gustave
Dicembre: Somma si reca a S.Agata per le modifiche al libretto, ora intitolato Una vendetta in
domino.
1858
5 gennaio ca.: GV e Giuseppina partono per Napoli; il 7 s'imbarcano a Genova; vi arrivano il 15. 28
gennaio: GV presenta il libretto della Vendetta in domino alla censura.
17 febbraio: la censura napoletana ricusa il libretto e ne fa approntare una versione addomesticata,
dal titolo Adelia degli Adimari. GV si rifiuta di prenderla in considerazione.
Marzo: l'impresa del S. Carlo cita il GV in giudizio accusandolo di inadempienza. Intanto questi si
incontra con l'impresario Vincenzo Jacovacci e firma con lui l'impegno di far rappresentare la
Vendetta in domino a Roma.
Aprile: la vertenza con il S. Carlo viene ricomposta: in cambio della mancata Vendetta in domino,
GV s'impegna a tornare a Napoli in autunno per mettervi in scena il Simon Boccanegra.
23 aprile: lascia Napoli imbarcandosi per Genova; il 29 aprile è già di ritorno a S.Agata.
Aprile-maggio: la censura romana richiede modifiche al libretto e propone una versione intitolata
11 conte di Gothemburg.
12 maggio: annuncia a Clara Maffei la conclusione di "sedici anni di galera":"Dal Nabucco in poi
non ho avuto, si può dire, un'ora di quiete".
22 giugno: spazientito dalle tergiversazioni della censura papalina, invia un ultimatum a Jacovacci
chiedendo il ritiro del libretto.
Giugno-luglio: trascorre con Giuseppina un periodo di riposo ai bagni termali di Tabiano.
3 luglio: l'avv.Vasselli, cognato di Donizetti, giunge a una soluzione positiva: la censura papalina
accetta le situazioni più scabrose della Vendetta in domino, ma propone di trasportare l'azione
fuori d'Europa.
20-25 luglio: accogliendo il suggerimento di Vasselli, GV si reca a Venezia e s'incontra con Somma
per le modifiche al libretto della Vendetta in domino richieste dalla censura papalina.
Settembre: il libretto della Vendetta, ora intitolato Un ballo in maschera,viene approvato dalla
censura romana.Tuttavia Somma,"nauseato" dai continui interventi della censura e dalle modifiche
fatte subire al libretto, si rifiuta di firmarlo.
20 ottobre: GV con Giuseppina s'imbarca a Genova alla volta di Napoli.Vi arriva il 23.
24 ottobre: inizia le prove del Boccanegra; e intanto modifica la disposizione dell'orchestra
riunendo le sezioni di viole, violoncelli e contrabbassi.
28 novembre: al S. Carlo va in scena Simon Boccanegra con successo.
1859
10 gennaio: GV e Giuseppina partono da Napoli alla volta di Roma via mare: vi arrivano il 15,
andando ad alloggiare in "una bruttissima casa" in via Campo Marzio 2.
16 gennaio: inizia le prove di Un ballo in maschera.
17 febbraio: Roma, teatro Apollo: prima rappr. di 17n ballo in maschera; grande successo.
Arte e Cultura
A. Maffei pubblica la traduzione italiana del Paradiso perduto di Milton e del Teatro completo di
Schiller. Brofferio inizia a pubblicare I miei tempi. Jean-Baptiste Corot, Concerto all'aperto,
dipinto. - Jean-Frarwois Millet, Le spigolatrici, dipinto.
1858
1° gennaio: Varsavia: Stanislaw Moniuszko, Halka (versione definitiva).
26 gennaio: Milano, Scala: Petrella, Jone.
21 ottobre: Parigi, Bouffes-Parisiens: Offenbach, Orfeo all'inferno.
15 dicembre: Weimar, Hoftheater: Peter Cornelius, Il barbiere di Bagdad.
22 dicembre: nasce a Lucca Giacomo Puccini. Muore lo scultore Pompeo Marchesi.
C. Pisacane, Saggi storici, politici, militari sull'Italia, postumi.
Mazzini fonda il periodico "Pensiero e azione".
1859
16 febbraio: un decreto del governo francese fissa il diapason a 870 vibrazioni semplici
19 marzo: Parigi,Th. Lyrique: Gounod, Faust.
25 aprile: Milano, Scala: prima rappr. italiana della Marta di Flotow.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
A Sheffield in Inghilterra viene fondata la prima società calcistica e nasce l'Alpin Club.
K.Marx,Intmduzione alla critica dell'economia politica. Felice Orsini, Memorie politiche.
1858
5 gennaio: muore a Milano il governatore generale del Lombardo-Veneto maresciallo Johann
Radetzky.
14 gennaio: fallisce l'attentato di Felice Orsini contro Napoleone III.
21 luglio: Plombières: accordi segreti fra Cavour e Napoleone III per un'alleanza tra Francia e
Piemonte contro l'Austria.
1 ° ottobre: muore a Vienna l'ingegnere Luigi Negrelli, autore del progetto della rete ferroviaria
svizzera e di un progetto per il taglio del canale di Suez, poi attuato da Lesseps.
In Inghilterra un decreto legislativo abolisce le discriminazioni nei confronti di cittadini ebrei.
La Russia si annette il territorio dell'Amur.
In Messico scoppia una guerra civile fra liberali, sostenitori di riforme contro il potere della
Chiesa, e conservatori.
In India gli Inglesi soffocano la rivolta. la Gran Bretagna scioglie la Compagnia delle Indie e
assume direttamente il governo dell'India attraverso un viceré.
Stanislao Cannizzaro enuncia la teoria atomica, nota come "legge Cannizzaro", che rende possibile
la classificazione degli elementi.
L'egittologo Auguste Mariette inizia una campagna di scavi, raccogliendo materiali che
costituiranno il nucleo del Museo egizio del Cairo.
1859
10 gennaio: Vittorio Emanuele III dichiara in parlamento di non essere insensibile "alle grida di
dolore" che si levano da molte parti d'Italia. Gli accordi dell'incontro di Plombières vengono
sanzionati da un trattato di alleanza tra regno di Sardegna a impero francese.
Cronologia 1860
Giuseppe Verdi
20 febbraio: l'Accademia Filarmonica Romana elegge GV a membro onorario.
13 marzo: GV e Giuseppina partono da Roma via mare alla volta di Genova.
18 marzo: arrivano a Genova, dove sostano all'albergo Croce di Malta, in via Carlo Alberto, per
assistere alle prove dell'Aroldo diretto da Mariani.
20 marzo: rientrano a S.Agata passando per Piacenza già in stato d'assedio.
23 giugno: a Clara Maffei:"dopo che quelli illustrissimi [gli Austriaci] hanno fatto saltare i forti di
Piacenza, sono successe e succedono anche in questo guscio tante cose, tanti allarmi, tante notizie
e vere e false che non si ha mai un'ora di calma. Finalmente se ne sono andati! o almeno si sono
allontanati; e voglia la nostra buona stella allontanarli di più in più [...[. Quanti prodigi in pochi
giorni! non par vero! E chi avrebbe creduto a tanta generosità nei nostri alleati! Per me confesso
LI che io non credevo alla venuta dei Francesi in Italia, e che in ogni caso non avrebbero
sparso, senza idea di conquista, il loro sangue per noi. Sul primo punto mi sono ingannato; spero e
desidero ingannarmi sul secondo: che Napoleone non smentirà il proclama di Milano".
GV e Giuseppina trascorrono un breve periodo di riposo ai bagni termali di Tabiano.
14 luglio: a Clara Maffei:"La pace è fatta! La Venezia rimane all'Austria!". E dov'è dunque la tanto
sospirata e promessa indipendenza dell'Italia? Cosa significa il proclama di Milano? Oh che la
Venezia non è Italia? Dopo tante vittorie, quale risultato! Quanto sangue per nulla! quanta povera
gioventù delusa! E Garibaldi, che ha persino fatto il sacrifizio delle sue antiche e costanti opinioni,
in favore di un Re, senza ottenere lo scopo desiderato!".
29 agosto: si reca a Collonges-sous-Salève nella Savoia (ancora facente parte del Regno di
Sardegna) e vi sposa Giuseppina Strepponi con rito religioso officiato dall'abate Mermillod.
4 settembre: rientra a S.Agata; i bussetani lo eleggono loro rappresentante delle province
parmensi.
15 settembre: va in delegazione dal re a Torino per dichiarare l'annessione del ducato di Parma al
Piemonte.
16 settembre: incontra a Leri il conte di Cavour, dimissionario.
18 settembre: riparte da Torino e rientra a S.Agata.
Ottobre: finanzia l'acquisto di 100 fucili "di fabbrica inglese" per la Guardia Nazionale di Busseto.
1° dicembre: Mariani è ospite a S.Agata.
17 dicembre: GV a Cesarino de Sanctis:"Ritornato da Roma non ho più fatto musica, non ho più
visto musica, non ho più pensato a musica. Non so nemmeno di che colore sia quella ultima mia
opera e quasi quasi non la ricordo".
28 dicembre: gli viene annunciata la nomina a membro dell'Accademia Imperiale dell'Istituto di
Francia, nomina caldeggiata, fra gli altri, da Auber e da Berlioz.
1860
3 gennaio: GV e la moglie si recano a Genova a trascorrere il periodo invernale andando ad
alloggiare alla Croce di Malta.
Gennaio: raccomanda Piave, nel frattempo trasferitosi a Milano, a Massimo d'Azeglio, governatore
di Milano, per ottenergli il posto di poeta e direttore di scena alla Scala.
10 febbraio: a Escudier: "Dacché non fabbrico più note pianto cavoli e faggiuoli etc. etc. ma
quest'occupazione non bastandomi più, mi son dato alla caccia!".
11 marzo: rientra a S.Agata.
28 aprile: agli amministratori comunali di Busseto:"Il Municipio di Busseto fece opera
lodevolissima votando, e donando un cannone al Re [...]. Non colle feste e le illuminazioni, ma
colle armi e coi soldati potremo divenire forti, rispettati, e padroni in casa nostra. E non bisogna
dimenticare che lo straniero potente e minaccioso è tuttavia in Italia".
Arte e Cultura
29 giugno: esce il primo numero di "Il Pungolo", giornale fondato da Leone Fortis.
3 ottobre: nasce a Vigevano Eleonora Duse.
20 novembre: esce a Milano il primo numero di "La Perseveranza. Giornale politico quotidiano".
11 dicembre: muore a Napoli il trentottenne poeta Nicola Sole, amico di GV.
28 dicembre: Parigi, T. Italiano: Gaetano Braga, Margherita la mendicante, su libretto di Piave.
Johannes Brahms, Primo Concerto per pianoforte e orchestra.
L. Mercantini, Canzone italiana; musicata da Alessio Olivieri, diviene nota come Inno di Garibaldi.
Abramo Basevi, Studio sulle opere di G. Verdi. - Nicola Marselli, Saggi critici sulla ragione della
musica moderna.
1859-1866: Franois V. Hugo pubblica tutte le tragedie di Shakespeare in traduzione francese.
Ivan A. Goncarov, Oblomov, romanzo. - George Meredith, La prova di Richard Feverel, romanzo.
Charles de Sainte-Beuve, Port-Royal.
Frédéric Mistral, Mirella, poema. Con la pubblicazione della raccolta poetica Parnasse
contemporain nasce il movimento dei "parnassiani".
Thomas Moore, Gli adoratori del fuoco, traduzione di Andrea Maffei dedicata a GV.
E Hayez, Il bacio, dipinto. - Jean-Francis Millet, L'Angelus, dipinto.
Charles Darwin: Sull'origine della specie per selezione naturale.
Viene fondato a Firenze il giornale "La Nazione". A Bologna nasce la casa editrice Zanichelli.
1860
Marzo: Parigi: Richard Wagner fa visita a Rossini. 7 luglio: nasce a Kalischt (Boemia) Gustav
Mahler.
21 settembre: muore a Francoforte Arthur Schopenhauer. 6 ottobre: Asti: inaugurazione del teatro
Alfieri. 26 dicembre: Ancona: inaugurazione del teatro Vittorio Emanuele.
Luigi Arditi, Il bacio, valzer, per Marietta Piccolomini. Aleksandr N. Ostrovskij, L'uragano,
dramma.
D. Guerrazzi, Pasquale Paoli, romanzo storico. - George Eliot, Il mulino sulla Floss, romanzo.
Giosuè Carducci, Juvenilia, poesie.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
Garibaldi costituisce il corpo dei Cacciatori delle Alpi.
23 aprile: ultimatum dell'Austria al Piemonte; inizio delle ostilità. Il 29 l'esercito austriaco entra in
Piemonte.
Aprile: Il granduca Leopoldo II abbandona la Toscana; si forma un governo provvisorio retto da
Bettino Ricasoli.
1° maggio: a Parma si forma una giunta provvisoria in nome di Vincili° Emanuele II.
4 giugno: battaglia di Magenta.
8 giugno: i franco-piemontesi entrano in Milano.
9 giugno: a Parma la reggente Maria Luisa di Borbone viene deposta; viene nominata una
Commissione di Governo, guidata da Diodato Pallieri.
11 giugno: muore a Vienna il principe von Metternich.
23-24 giugno: battaglie di Solferino e di S. Martino.
8 luglio: Napoleone III firma l'armistizio di Villafranca.
12 luglio: dimissioni di Cavour; al suo posto viene nominato Alfonso La Marmora.
18 agosto: Carlo Luigi Farini viene nominato Dittatore delle province modenesi e parmensi.
5 settembre: a Parma primo plebiscito per l'annessione del Ducato al.Piemonte. Il 5 ottobre viene
messo a morte, a furor di popolo, il colonnello Alfonso Anviti.
10 novembre: pace di Zurigo tra Francia, Piemonte e Austria.
II parlamento piemontese approva la legge Casati sulla pubblica istruzione; estesa al regno d'Italia
rimarrà in vigore fino al 1923.
Dicembre: le leggi piemontesi vengono estese alla Lombardia e successivamente alle altre regioni
italiane.
2 dicembre: a Charlestown negli Stati Uniti viene impiccato John Brown, organizzatore della
campagna per l'abolizione della schiavitù in Kansas e in Virginia.
Antonio Pacinotti progetta e costruisce il primo generatore di corrente continua, prototipo
dell'odierna dinamo. Barsanti e Matteucci realizzano un motore a scoppio a pistone libero. Il fisico
francese Gaston Planté realizza il primo accumulatore.
Inizia la costruzione del canale di Suez.
1860
20 gennaio: Cavour viene richiamato al potere. 11-12 marzo: plebisciti in Emilia eToscana; loro
annessione al Regno dell'Alta Italia.
24 marzo: Nizza e la Savoia sono annessi, con plebiscito (secondo gli accordi di Plombières), alla
Francia. Aprile: moti insurrezionali in Sicilia.
5-6 maggio: da Quarto, presso Genova, ha inizio la spedizione dei Mille. - 11 maggio: Garibaldi
sbarca a Marsala e il 14 a Salerai assume la dittatura della Sicilia in nome di Vittorio Emanuele II.
- 15 maggio: battaglia di Calatafimi.- 27 maggio: Garibaldi entra in Palermo.- 2027 luglio: i
garibaldini conquistano Milazzo e Messina. Cronologia 1861
Giuseppe Verdi
4 maggio: a Ricordi: "Da parecchi anni abito in campagna una bicocca così malandata, così
modesta, così, direi quasi, indecente che mi vergogno perfino a farla vedere agli amici più intimi
[...]. sono tre anni che volevo farla aggiustare, né intendevo farne palazzo o villa, ma solamente
casa abitabile. Diverse circostanze mi hanno impedito d'effettuare finora questo mio progetto; ma
da pochi giorni il lavoro è stato cominciato".
Luglio: con la moglie trascorre un periodo di riposo alle terme di Tabiano.
9 agosto: a Mariani: "Sono qui fra mattoni e calce e muratori... sono in piena fabbrica: mi alzo alle
cinque, sparo qualche fucilata alle quaglie che non sono tanto imbecilli d'andare nella rete; si fa
dopo colazione; do un'occhiata ai muratori; si fa un piccolo sonno da un'ora alle due; si dà dopo
passo alle cose di casa e si scrivono lettere; si pranza, si fa un passeggiata fino a notte, si torna a
casa, quattro chiacchere ed a letto per alzarsi l'indomani alle cinque".
2 dicembre: si reca a Genova.
5 dicembre: Giuseppina a GV:"Ti giuro [...1 che io molte volte sono quasi sorpresa che tu sappia la
musica! Per quanto quest'arte sia divina e il tuo genio degno dell'arte che professi, pure il
talismano che mi affascina e che io adoro in te, è il tuo carattere, il tuo cuore, la tua indulgenza per
gli errori degli altri, mentre sei tanto severo a te stesso. La tua carità piena di pudore e di mistero la tua altera indipendenza e la tua semplicità da fanciullo, qualità proprie di quella tua natura che
seppe conservare una selvaggia verginità d'idee e di sentimenti in mezzo alla cloaca umana! O mio
Verdi, io non sono degna di te e l'amore che mi porti è una carità, un balsamo ad un cuore qualche
volta ben triste, sotto le apparenze dell'allegria. Continua ad amarmi, amami anche dopo morta
ond'io mi presenti alla Divina Giustizia ricca del tuo amore e delle tue preghiere, o mio
Redentore!".
7 dicembre: GV rientra a S.Agata.
23 dicembre: il tenore Enrico Tamberlick, facendosi intermediario del direttore dei teatri imperiali
di S. Pietroburgo, Sabouroff, chiede a GV di comporre un'opera per quel teatro; la richiesta viene
appoggiata da Mauro Corticelli, segretario dell'attrice Adelaide Ristori, in tournée in Russia.
1861
10 gennaio: Cavour vuole che GV si candidi per il nuovo parlamento italiano: la sua presenza
contribuirà ad elevarne il decoro "dentro e fuori d'Italia".
16 gennaio: GV si reca a Torino per chiedere udienza a Cavour prendendo alloggio all'albergo
Feder (Trombetta).
11 18, di buon mattino, s'incontra con Cavour per respingere il suo invito; ma alla fine cede alla
sua richiesta. 11 19 rientra a S. Agata. Il 21 s'incontra a Borgo S. Donnino con il suo competitore
di collegio, Giovanni Minghelli Vaini, per informarlo d'essere stato costretto da Cavour ad
accettare la candidatura.
27 gennaio: viene eletto deputato al primo parlamento italiano come rappresentante del collegio di
Borgo S. Donnino ottenendo al primo turno 298 voti contro 185 del concorrente Minghelli Vaini,
e al ballottaggio 339 voti contro 206.
Fine gennaio: accetta la proposta del teatro di S. Pietroburgo per un'opera nuova e propone come
soggetto il Ruy Blas di Hugo.
1 1 febbraio: a Giuseppe Piroli:"Ignoro se alla Camera di Torino il posto che prende un Deputato
abbia significato politico come in Francia. [...] Io non voglio essere né bianco né rosso, ma
desidero restare indipendente nelle mie opinioni ".
12 febbraio: Piroli a GV:"Il posto da me scelto è al Centro Sinistro, cioè tra i ministeriali ad ogni
costo e l'opposizione, e il numero che altri aveva già scelto per voi debb'essere all'Estrema Sinistra,
dove sederanno Brofferio e soci".
14 febbraio: GV si reca a Torino con la moglie per partecipare alla prima seduta del parlamento
italiano.
Marzo: fa sapere al teatro di Pietroburgo che non firmerà il contratto se prima non sarà approvato
il soggetto che intende musicare.
12-14 aprile: s'incontra a Torino con il figlio di Tamberlick,Achille, espressamente giunto con
ampi poteri per negoziare il contratto con il teatro di Pietroburgo, e invita Piave a raggiungerlo.
Maggio: dopo una sosta a Genova, ne riparte con Giuseppina e prende dimora provvisoria a
Busseto, essendo la villa di S.Agata sottosopra per lavori di ampliamento e di restauro.
30 maggio: parte per Torino, per definire il contratto per Pietroburgo. Il 3 giugno firma il
contratto: l'argomento sarà La forza del destino, dal dramma Don Alvaro di Angel Saavedra duque
de Rivas, che giudica "potente, singolare
Arte e Cultura
Jacob Burckhardt, La civiltà del rinascimento in Italia.
Marc Monnier pubblica a Parigi una sua inchiesta: È l'Italia il paese dei morti?.
1861
14 febbraio: Parma, Regio: Tommaso Benvenuti, Guglielmo Shakespeare, su libretto di Piave.
20 febbraio: muore a Parigi Eugène Scribe.
21 febbraio: muore aTorino l'attore Gustavo Modena, riformatore della recitazione drammatica.
5 marzo: muore annegando nel Mar Tirreno Ippolito Nievo.
13 marzo: Parigi, Opéra: insuccesso del Tannhauser di Wagner.
Maggio: esordio europeo di Adelina Patti al Covent Garden di Londra.
18 luglio: Parigi, Gymnase:Victorien Sardou,Piccolino, commedia.
4 settembre: Milano, Conservatorio: Faccio e Boito, Le sorelle d'Italia, cantata.
6 settembre: Fermo: Giacometti, La morte civile.
20 settembre: muore a Firenze Gian Battista Niccolini. 1847-1861: Francesco Dall'Ongaro,
Stornelli.
S. Pietroburgo: Balakirev costituisce il "possente cenacolo" ovvero "gruppo dei Cinque": oltre a lui
ne fanno parte Borodin, Kjui, Musorgskij e Rimskij-Korsakovjules Pasdeloup istituisce a Parigi i
Concerti Popolari di musica classica. Liszt si stabilisce a Roma.
Nasce a Firenze la Società del Quartetto, la prima in Italia. Charles Baudelaire, I paradisi artificiali,
saggi. F. Dostoevskij, Memorie da una casa di morti. Chr. Fr. Hebbel, I Nibelunghi, trilogia.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
4-6 agosto: eccidio di Bronte; feroce repressione dei moti popolari da parte di Nino Bixio. - 20
agosto: Garibaldi sbarca in Calabria a avanza verso Napoli. - 2 settembre: battaglia del Volturno. 6 settembre: re Francesco II di Borbone fugge da Napoli; il giorno dopo Garibaldi entra a Napoli.
Mazzini, Cattaneo e i democratici spingono Garibaldi a non sancire l'annessione al Piemonte e a
proseguire per Roma. Di fronte alla reazione di Cavour, Garibaldi indice due plebisciti per
l'annessione al Regno d'Italia.
Settembre: un esercito piemontese sconfigge le truppe pontificie a Castelfidardo ed entra in
Ancona. - 21 ottobre: viene votata l'annessione dei territori meridionali italiani al regno di
Sardegna. - 26 ottobre: incontro di Teano. - 4 novembre: plebisciti nelle Marche e in Umbria.
La Francia occupa la Siria.
Negli Stati Uniti viene eletto presidente Abraham Lincoln; nasce la secessione negli stati del sud.
Il chimico francese Mége-Mouriès ottiene la margarina. Inizia la costruzione della metropolitana
di Londra.
1861
2 gennaio: al trono di Prussia sale Guglielmo I, sostenitore dell'unità nazionale tedesca sotto il
primato prussiano.
13 febbraio: dopo lungo assedio l'esercito piemontese costringe alla resa Gaeta, dove si era
rifugiato Francesco II; fine del regno di Napoli.
17 febbraio: con regio decreto viene istituita in Italia la leva militare.
19 febbraio: lo zar Alessandro II abolisce la servitù della gleba.
- Marzo: si inaugura aTorino il primo parlamento italiano, formato da 443 deputati eletti nelle
varie regioni e 213 senatori di nomina regia.
17 marzo: proclamazione del Regno d'Italia sotto la sovranità di Vittorio Emanuele II.
12 aprile: negli Stati Uniti inizia la guerra di secessione. 6 giugno: Torino: muore il conte di
Cavour. Alla guida del governo gli succede Bettino Ricasoli.
La popolazione del regno d'Italia ammonta a 22 milioni di individui.
Firenze: prima esposizione artistico-industriale italiana. Firenze: primo congresso delle Società
operaie di mutuo soccorso.
In Inghilterra A. Parkers realizza la celluloide.
A Londra entrano in servizio i tram a cavalli.
Cronologia 1862
Giuseppe Verdi
e vastissimo [...1 fuori del comune"; comincia a stenderne il libretto in prosa, incaricando Piave
della versificazione. Rientra a Busseto.
7 giugno: è colpito dall'improvvisa morte di Cavour; all'Arrivabene:"Non ho il coraggio di venire a
Torino; né potrei assistere ai funerali di quell'Uomo. Quale sventura! Quale abisso di guai!".
15 giugno: ritorna a Torino per affari. Ma comincia già a lavorare alla Forza del destino.
Metà luglio: rientra a S.Agata dove lo raggiunge Piave per portare a termine il libretto della
Forza.
Ottobre: accetta "di rappresentare musicalmente l'Italia" all'Espcisizione internazionale di Londra
nella primavera del 1862 (a rappresentare Germania e Francia vi sono invitati, rispettivamente,
Meyerbeer e Auber).
10 novembre: termina il terzo atto della Forza.
22 novembre: comunica a Tito Ricordi:"l'opera è finita, salvo la strumentazione".
24 novembre: parte con Giuseppina alla volta di S. Pietroburgo, con sosta a Torino e quindi a
Parigi, dove arriva il 28. Il 6 dicembre arriva a S. Pietroburgo.
1862
Gennaio: s'ammala improvvisamente la primadonna Emma Lagrua; mancando la compagnia di
canto di una valida sostituta, viene deciso di rinviare d'un anno la rappresentazione della Forza del
destino.
28 gennaio: GV e consorte si recano per alcuni giorni a Mosca.
9 febbraio: lasciano S. Pietroburgo.
24 febbraio: arrivano a Parigi; s'accinge a comporre una cantata - l'Inno delle nazioni su versi del
giovane Arrigo Boito, per orchestra, coro e tenore - per l'Esposizione internazionale di Londra.
27 febbraio: scrive a Vincenzo Luccardi a Roma per contattare la cantante Carolina Barbot per
cantare nella Forza del destino a Pietroburgo nel prossimo autunno.
10 marzo: la Barbot accetta la scrittura per Pietroburgo.
29 marzo: GV ringrazia Boito per i versi della cantata e gli dona un orologio: "vi ricordi il mio
nome, ed il valore del tempo".
31 marzo: termina di comporre l'Inno delle nazioni.
1° aprile: Giuseppina precede il marito a Londra con lo spartito della cantata. GV rientra a S.Agata
per pochi giorni e ne riparte alla volta di Londra.
20 aprile: arriva a Londra. 1:Inno delle nazioni viene rifiutato dal maestro Michele Costa con il
pretesto che esso non rientra nei termini stabiliti dalla commissione londinese, che contemplano
un brano strumentale senza uso di
voci, e che inoltre non v'era tempo sufficiente perché il coro apprendesse le parti.
24 maggio: l'Inno delle nazioni viene eseguito al Her Majesty's Theater di Londra sotto la
direzione di Luigi Arditi.
31 maggio: GV e consorte ripartono da Londra.
2-6 giugno: sostano a Parigi.
7-13 giugno: sostano a Torino. 11 13 sono di nuovo a S.Agata.
30 giugno: GV riparte per Torino per le sedute parlamentari.
Luglio: rientra a Busseto. Gli fa visita il tenore Fraschini per ripassare la sua parte nella Forza del
destino, prevista in febbraio a Madrid.
Fine agosto: GV e consorte ripartono per la Russia, via Parigi, dove sostano alcuni giorni. Il 5
settembre arrivano a Pietroburgo.
Primi di ottobre: compiono nuovamente una breve visita a Mosca, dove assistono a una recita del
Trovatore.
8 novembre: lo Zar gli conferisce la Croce dell'ordine di S. Stanislao.
10 novembre: Pietroburgo,Teatm Imperiale: prima rappr. di La forza del destino, con successo
eccellente.
9 dicembre: parte con la moglie da Pietroburgo; il 15 arriva a Parigi. Intanto l'editore Escudier
comincia a porre in vendita i pezzi della Forza del destino.
Arte e Cultura
Telemaco Signorini, Il ghetto di Venezia, dipinto. Emilio Treves fonda a Milano la casa editrice
omonima.
1862
29 febbraio: Parigi, Opéra: Gounod, La regina di 17 marzo: muore a Nizza Jacques Fromental
Halévy.
24 aprile: Firenze, teatro Niccolini: Gherardi Del Testa, Le coscienze elastiche, commedia.
12 maggio: Parigi, Opéra-Comique: E David, LallaRoukh.
17 giugno: muore a Fucecchio Giuseppe Montanelli (aveva collaborato al libretto del Simon
Boccanegra).
9 agosto: Baden: Berlioz, Béatrice et Bénédict.
22 agosto: nasce a St-Germain-en-Laye Claude Debussy.
1 1 novembre: Milano, Scala: prima rappr. italiana del Faust di Gounod.
30 novembre: con decreto governativo l'ex orchestra ducale di Parma viene riunita alla Scuola di
musica.
S. Pietroburgo:Anton Rubinstein fonda il Conservatorio; Balakirev e Lomakin fondano la Scuola
libera di musica. Dopo tredici anni di esilio Wagner rientra in Germania. L'austriaco Ludwig
Michel ordina il catalogo delle opere di Mozart. La casa editrice Breitkopf & Hiirtel inizia a
pubblicare l'Opera omnia di Palestrina.
Gustave Flaubert, Salammbd, romanzo. - 'Victor Hugo: I miserabili, romanzo. - Ivan Turgenev,
Padri e figli, romanzo.
Vittorio Betteloni, In primavera, poesie. - Meredith, Amore moderno, poesie. - Emilio Praga,
Tavolozza, versi.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
1862
Marzo: dimissioni di Ricasoli; gli succede Urbano Rattazzi.
23 maggio: a Francoforte Ferdinand Lassalle fonda l'Associazione generale dei lavoratori tedeschi
(si tratta del primo partito socialista).
29 agosto: nel tentativo di raggiungere Roma, Garibaldi viene ferito all'Aspromonte in uno
scontro con l'esercito italiano; incarcerato, gli viene concessa un'amnistia; si ritira a Caprera. Il
maggiore de Villata fa fucilare senza processo alcuni volontari garibaldini.
24 settembre: viene firmata una convenzione fra Italia e Francia per la protezione della proprietà
artistica. Dicembre: si dimette Rattazzi; gli succede Luigi Carlo Farini.
Prussia: Otto von Bismarck diventa presidente del consiglio e ministro degli esteri del regno di
Prussia.
Con il consenso delle grandi potenze si attua la fusione dei principati di Moldavia e di Valacchia (la
futura Romania) e ne viene riconosciuta l'autonomia.
Negli Stati Uniti Lincoln decreta l'emancipazione degli schiavi negli stati secessionisti.
I Francesi conquistano Saigon, prima tappa dell'occupazione della Cocincina.
Secondo un censimento del ministero di agricoltura industria e commercio esistono in Italia 443
società di mutuo soccorso.
Il livornese Pietro Bastogi costituisce la Società italiana per le strade ferrate meridionali, divenuta
poi società finanziaria.
l: americano R. I. Gatling realizza un nuovo modello di mitragliatrice.
Foucault calcola la velocità della luce.
Cronologia 1863
Giuseppe Verdi
1863
6 gennaio: GV e consorte partono da Parigi alla volta di Madrid. Vi arrivano l' 11. GV inizia
subito le prove della Forza del destino.
21 febbraio: Madrid, Real: rappr. della Forza del destino; vi assiste l'autore del dramma, Angel de
Saavedra duque de Rivas (che non cela la propria insoddisfazione).
3-6 marzo: GV visita, con la moglie, Cordoba, Siviglia, Cadice, Granada nonché l'Escurial, a
proposito del quale scrive all'Arrivabene il 22 marzo:"non mi piace. È un ammasso di marmi [...1
nell'insieme vi manca il buon gusto. È severo, terribile come il feroce sovrano che l'ha costruito".
14 marzo: GV e consorte partono da Madrid per Parigi nonostante che in questa città l'epidemia di
colera non sia del tutto cessata.
18 marzo: arrivano a Parigi e vanno ad alloggiare al n. 57 di Avenue des Champs-Elysées. Aprile:
GV si appresta a presenziare le prove di Les Vépres siciliennes, in ripresa all'Opéra.
Maggio: GV a Tito Ricordi: "Si dice che la Forza del Destino sia troppo lunga, e che il pubblico sia
spaventato dei tanti morti! D'accordo: ma una volta ammesso il sogetto, come si trova altro
scioglimento?".
Maggio-giugno: scrive una nuova aria nei Vespri siciliani per il tenore Villaret.
26 giugno: muore all'ospedale di S. Maria delle Grazie in Siena, forse per contagio colerico, il figlio
di Giuseppina, Camillo, alle soglie del conseguimento della laurea in medicina e chirurgia.
9 luglio: GV inizia all'Opéra le prove d'orchestra dei Vespri siciliani.
16 luglio: ha un battibecco con il direttore d'orchestra, Pierre Dietsch (già ritenuto da Wagner
responsabile del fiasco del Tannhiiuser); al colmo dell'irritazione, abbandona seduta stante le
prove. Dietsch viene sostituito da George Hainl.
20 luglio: Parigi, Opéra: ripresa dei Vespri siciliani.
21 luglio: GV parte da Parigi; il 22 sosta aTorino; il 25 è a S.Agata; ritorna il 30 aTorino; rientra a
S.Agata il 1° agosto.
3 ottobre: a Tito Ricordi:"In quanto alla Società del Quartetto ti prego di lasciarmene fuori.Tu sai
che io sono un'asino in musica e che non capisco affatto quella che i dotti battezzano per musica
classica".
Ottobre: si reca a Torino per partecipare alle sedute parlamentari.
30 ottobre: concorda con Piave sulla necessità di apportare alcune modifiche alla Forza del
destino:"ma prima di tutto bisogna pensare allo scioglimento e trovare il modo di evitare tanti
morti".
1864
20 gennaio ca.: GV ritorna aTorino con Giuseppina.
Febbraio: sosta a Genova.
25 febbraio: torna ancora a Torino.
Marzo: rientra a S.Agata.
Giugno: s'incontra a Genova con Escudier; trattative per la rappresentazione del Macbeth in
francese al Th. Lyrique di Parigi con l'aggiunta di un balletto.
Fine giugno: fa ritorno a S.Agata.
2 luglio: a Ricordi:"sono sempre imbrogliatissimo per cambiare lo scioglimento [della Forza del
destino]. Ne feci fare uno da Piave; un altro ne mandò or ora De Lauzières da Parigi, e né l'uno, né
l'altro mi piacciono. Lasciatemi pensare ancora un poco".
4 luglio: l'Académie des Beaux Arts di Francia lo elegge a proprio membro al posto del defunto
Meyerbeer, con 23 voti su 37.
3 settembre: rifiuta di far parte della commissione per il monumento a Guido d'Arezzo.
27 settembre: Escudier propone a GV di far rappresentare il Macbeth in francese al Théàtre
Lyrique di Parigi con alcune modifiche, fra cui l'aggiunta di un balletto.
22 ottobre: a Escudier:"Ho scorso il Macbet per fare le arie di ballo, ma ohimè! alla lettura di
questa musica sono
Arte e Cultura
1863
17 gennaio: nasce a Mosca Konstantin Stanislavskij. 12 marzo: nasce a Pescara Gabriele
d'Annunzio. 4 aprile: Torino: Vittorio Bersezio, Le miserie d'monssù Travet, commedia.
29 settembre: Parigi,Th. Lyrique: Bizet, I pescatori di
perle.
4 novembre: Parigi, Th.-Lyrique: Berlioz, I Troiani Cartagine.
11 novembre: Milano, Scala: Faccio, I profughi fiamminghi.
22 novembre: Boito, Ode saffica.
7 dicembre: nasce a Livorno Pietro Mascagni. 21 dicembre: muore a Roma Gioachino Belli. Il
teatro imperiale di Vienna adotta il diapason 'francese' di 435 Hz.
Hermann Ludwig Helmholtz, Fondamenti fisiologici per la teoria della musica.
Théophile Gautier, Capitan Fracassa, romanzo. Ernest Renan, Vita di Gesù.
Cernyshevskij, Che fare?.
Per iniziativa di T. Mommsen viene iniziata la pubblicazione del Corpus inscriptionum latinarum.
Jean-Auguste Ingres, Il bagno turco, dipinto. - Parigi, Salon des Refusés: Manet, Colazione
sull'erba, dipinto.
Gottfried Semper, Lo stile nelle arti tecniche e tettoniche, trattato.
1864
4 febbraio: Madrid: Garda Gutierrez. La Venganza catalana, dramma.
5 marzo: Parigi, Gymnase: A. Dumas fils, L'amico delle donne, commedia.
8 marzo: Torino, Regio: Petrella, La contessa d'Amalft. 14 marzo: Parigi: Rossini, Petite messe
solennelle. 19 marzo: Parigi,Th. Lyrique: Gounod, Mireille. 2 maggio: muore a Parigi Giacomo
Meyerbeer. Settembre: esordio italiano diTeresa Stolz nel Trovatore
al Teatro Nuovo di Spoleto.
17 dicembre: Parigi, Variétés: Offenbach, La bella
Elena, operetta.
Nasce, per iniziativa di Giulio Ricordi, Boito e altri, la
Società del Quartetto di Milano.
Biornstjerne Bjarnson, Sigurd Slembe, trilogia drammatica.
Erckmann - Chatrian, L'amico Fritz, romanzo.
Aleardo Aleardi, Canti.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
1863
Marzo: si dimette Farini; gli succede Marco Minghetti. Approvazione della legge Pica per la
repressione del `brigantaggio' nell'Italia meridionale.
6 agosto: a Portici viene represso nel sangue uno sciopero operaio.
La Francia promuove una spedizione militare in Messico incontrando forte resistenza, e impone il
suo protettorato alla Cambogia.
Contravvenendo al protocollo di Londra, Cristiano IX di Danimarca annette lo SchleswigHolstein. Si riapre il conflitto con la confederazione germanica.
Negli Stati Uniti l'esercito nordista, guidato dal generale Grant, sconfigge i sudisti a Chattanooga.
L'esercito zarista reprime un'insurrezione democratica scoppiata in Polonia.
A Londra viene inaugurata la prima linea metropolitana sotterranea.
Ernest Solvay fonda la società per la fabbricazione industriale della soda.
L'ingegnere Eugenio Villoresi progetta un canale fra il Ticino e l'Adda; sarà realizzato fra il 1880 e
il 1891. Iniziano i lavori di costruzione del Canale Cavour fra il Po e il Ticino; termineranno nel
1866.
Viene fondato il Politecnico di Milano.
Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano.
1864
Conferenza di Ginevra: per iniziativa di Henri Dunant vengono poste le basi per la costituzione
della Croce Rossa internazionale.
Febbraio: scoppia la guerra austro-prussiana contro la Danimarca per lo Schleswig-Holstein.
Settembre: ministero del generale Lamarmora.
Convenzione fra Italia e Francia: la Francia ritira le proprie truppe da Roma contro l'impegno
dell'Italia a non annettere lo Stato della Chiesa e a trasferire la capitale da Torino a Firenze.
28 settembre: a Londra, su iniziativa di Marx, nasce la prima Internazionale socialista dei
lavoratori.
30 ottobre: pace di Vienna; la Danimarca cede lo Schleswig-Holstein a Prussia e Austria.
Novembre: negli USA Lincoln viene rieletto presidente.
8 dicembre: Pio 1X promulga il Sillabo di conferma del concetto di potere temporale della Chiesa e
di condanna di 80 proposizioni filosofiche, politiche e religiose, fra cui la libertà di stampa, di culto,
d'opinione.
Cronologia 1865
Giuseppe Verdi
stato colpito da cose che non avrei voluto trovare. Per dire tutto in una parola vi sono diversi pezzi
che sono o deboli, o mancanti di carattere che è ancor peggio".
23 ottobre: si reca a Torino per le sedute parlamentari.
Fine novembre: rientra a S.Agata e affronta la revisione del Macbeth, incaricando Piave della
stesura dei nuovi versi.
20 dicembre: Boito dona a GV, in anticipo, una copia del suo poemetto Il Re Orso.
1865
3 febbraio: GV completa la revisione del Macbeth.
5 febbraio: si reca a Genova per trascorrervi il resto dell'inverno. I1 12 fa una corsa a S.Agata per
assistere il padre ammalato e rientra subito a Genova. Il 18 si reca a Torino per partecipare alle
sedute parlamentari riguardanti la legge sulla proprietà artistica. Il 27 febbraio rientra a Genova
dopo un'altra corsa a S.Agata per visitare il padre. Il 5 marzo si reca di nuovo a Torino.
11 marzo: a Escudier a proposito dell'aria del sonnambulismo nel Macbeth:"Chi ha visto la Ristori
sa che non si devono fare che pochissimi gesti [...]. La Ristori faceva un rantolo; il rantolo della
morte. In musica non si deve, né si può fare; come non si deve tossire nell'ultim'atto della Traviata;
né ridere nello scherzo od è follia del Ballo in Maschera. Qui vi è un lamento del corno inglese che
supplisce benissimo al rantolo, e più poeticamente".
Fine marzo: si trasferisce a S.Agata.
21 aprile: Parigi,Théàtre Lyrique: prima rappr. della nuova versione di Macbeth.
22 aprile ca.: si reca a Torino per le sedute parlamentari; rientra a S.Agata il 25.
28 aprile: a Escudier a proposito delle critiche parigine al Macbeth:" Chi trova che io non
conoscevo Shachespeare quando scrissi il Macbet. Oh, in questo hanno un gran torto. Può darsi
che io non abbia reso bene il Macbet, ma che io non conosco, che io non capisco e non sento
Shachespeare no; per Dio, no. È•un poeta di mia predilezione, che ho avuto fra le mani fin dalla mia
prima gioventù e che leggo e rileggo continuamente".
19 giugno: GV risponde a Escudier accettando di scrivere per l'Opera "tutto dipende da un
libretto. Un libretto, un libretto, e l'opera è fatta".
22 giugno: a Tito Ricordi: "Vi ho pensato molto, ed ho pregato amici e nemici di darmi un'idea per
cambiare lo scioglimento della Forza del destino. Io non ho saputo né altri han saputo trovare cosa
migliore di quella che vi è".
30 luglio: si congratula con Giuseppe Piroli per la sua nomina a consigliere di stato: "E per primo
consigliate il Governo ad essere meno indulgenti coi preti di campagna che una volta o l'altra
finiranno col rivoluzionarvi tutti i contadini".A Busseto viene intanto terminata la costruzione del
nuovo teatro cui GV è contrario:"in tutte le circostanze io mi sono sempre dimostrato avverso alla
costruzione d'un teatro di troppa spesa [...] perché riescirà inutile nell'avvenire".
17 luglio: Escudier a S. Agata per avviare trattative per un'opera nuova da darsi all'Opera; ha con
sé il libretto di una Cleopatra e lo scenario del Don Carlos. GV rifiuta Cleopatra, ripensa al Re
Lear, suggerisce El Zapatero y el Rey di Zorrilla y Moral; ma infine decide per Don Carlos.
21 luglio: GV invia all'Opera l'abbozzo contenente i principali punti di scena del Don Carlos.
17 agosto: tramite i buoni uffici del notaio Angelo Carrara accetta la dedica del teatro di Busseto.
Settembre: tenta inutilmente d'impedire la pubblicazione dell'inno "Suoni la tromba" già di
proprietà di Mazzini. Discute con Perrin le modifiche alla Forza del destino per l'Opera.
Metà settembre: rinuncia a candidarsi di nuovo al parlamento; al suo posto si presenta il prof.
Scolari, che, eletto, opta tuttavia per il collegio di Guastalla, lasciando il seggio a Piroli.
Fine settembre: trascorre con Giuseppina un periodo di cura a Tabiano.
20 novembre: parte con la moglie alla volta di Parigi via Genova. Vi arriva il 28 e "dopo aver
cambiato tre case" va ad alloggiare in un appartamento in Avenue des Champs-Élisées n. 67.
24 dicembre: va in visita da Rossini.
Arte e Cultura
G. B. Cavalcaselle e Joseph A. Crows iniziano la pubblicazione della Storia della pittura in Italia.
Cesare Lombroso, Genio e follia.
Vittorio Bersezio fonda aTorino la"Gazzetta piemontese".
1865
23 gennaio: muore a Moneglia Felice Romani.
l' aprile: muore a Blevio la cantante Giuditta Pasta.
16 aprile: Milano, T. Re: la compagnia francese Meynadier fa conoscere per la prima volta in Italia
un'operetta di Offenbach, Monsieur Choufleury restera chez lui.
28 aprile: Parigi, Opéra: Meyerbeer, L'africana (postuma).
30 maggio: Genova, Carlo Felice: Faccio, Amleto, su libretto di Boito.
10 giugno: Monaco di Baviera, Hoftheater: Wagner, Tristano e Isotta.
22 giugno: muore a Madrid Àngel de Saavedra.
8 agosto: muore a Venezia Antonio Somma.
23 settembre: grande successo di Teresa Stolz alla Scala di Milano nella Giovanna d'Arco di Verdi.
4 novembre: Bologna, Comunale: prima rappr. italiana dell'Africana di Meyerbeer.
Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique, ultimo volume
(rist.: 1878).
Giuseppe Rovani, Cento anni, romanzo. - Lewis Canon, Alice nel paese delle meraviglie, romanzo.
Boito, Il Re Orso, fiaba in versi. Edouard Manet, Olympia, dipinto.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
11dicembre: Firenze diventa capitale d'Italia.
In Messico continua la resistenza di Benito Juàrez contro l'esercito francese; Napoleone III
proclama l'arciduca Massimiliano d'Austria imperatore del Messico.
In Francia viene riconosciuto il diritto di sciopero.
Louis Pasteur mette a punto il procedimento di "pastorizzazione" del vino.
L'aMericano G. M. Pullman costruisce i primi vagoni-letto.
1865
15 aprile: Abramo Lincoln viene assassinato da un fanatico schiavista; gli succede Andrew
Johnson.
Giugno: inizia il trasferimento della capitale italiana da Torino a Firenze; la decisione provoca
moti insurrezionali a Torino, duramente repressi dal governo Minghetti.
Dicembre: il congresso degli Stati Uniti approva il 13° emendamento della costituzione, con il
quale si abolisce la schiavitù.
Viene approvata dal Parlamento italiano una nuova legge per il regolamento del diritto d'autore.
14 luglio: l'inglese E.Whymper raggiunge per la prima volta la vetta del Cervino.
Gregor Mendel, Ricerche sugli ibridi delle piante (vi sono esposte le tre leggi dell'ereditarietà).
Cronologia 1866
Giuseppe Verdi
Fine dicembre: frequenta teatri e concerti; all'Arrivabene: "L'Africaine non è certamente la miglior
opera di Meyerbeer. Ho sentito anche la sinfonia del Tannhauser di Wagner. È matto!!!". Rinuncia
alla Forza del destino in francese all'Opéra e segna un contratto per un'opera nuova su libretto di
Méry e Du Lode (sarà Don Carlos).
1866
14 febbraio: offre un ricevimento a un ristretto gruppo di amici (fra i quali la Patti, Fraschini,
Ronconi, Delle Sedie, Du Lode) in onore di Jean-Pierre Dantan, autore di un busto di Verdi e di
una statua caricaturale che ritrae il compositore come un "leone seduto".
17 marzo: parte con la moglie da Parigi; il 18 sosta a Nizza in visita da Méry ammalato.
24 marzo: dopo una sosta a Genova rientra a S. Agata; annuncia ad Arrivabene d'aver terminato a
Parigi il primo atto del Don Carlos.
14 aprile: a Ricordi:"tutto il male della Forza del destino non sta nello scioglimento [...] ! Del
resto quel scioglimento è quasi impossibile mutarlo né io vi farò più nulla, perché ne ho proprio
piena l'anima di opere e di teatri! Ho un'altra opera a scrivere! così non fosse...".
6 maggio: esprime all'Arrivabene preoccupazione per l'imminente guerra contro l'Austria e gli
comunica d'aver fmito il terzo atto del Don Carlos.
10 maggio: a Piroli:"Se vi è guerra io sono proprio ai primi posti, e converrà far fagotto perché è
certo che io sarei preso di mira non tanto dai Tedeschi quanto dai preti...".
6 giugno: a Escudier:"Ho finito il Terzo atto [del Don Carlos], ed ho incominciato il Quarto.
Finito questo considero finita l'opera, perché il Quinto atto si fa e si deve fare in un momento".
16-21 giugno: chiede a Du Lode alcune modifiche al quarto atto di Don Carlos e propone per il
finale del quinto atto un processo degli Inquisitori.
Giugno: Boito e Faccio partono volontari per la guerra.
4 luglio: GV informa Escudier d'aver terminato il quarto atto di Don Carlos.A causa della morte di
Méry il libretto viene condotto a termine da Camille Du Lode.
5-22 luglio: con la moglie si reca a Genova, prendendo alloggio all'Albergo Croce di Malta, per
trattare l'acquisto di un appartamento a palazzo Sauli, in strada S. Giacomo sul colle di Carignano,
ove trascorrervi il periodo invernale. Quindi proseguono per Parigi.
6 luglio: a Escudier: "leggo nei giornali cosa che mi mette nella più grande desolazione. L'Austria
cede la Venezia all'Imperatore dei Francesi?!!! È egli possibile? E cosa ne farà l'Imperatore? La
riterrà? La vorrà dare a noi? Ma noi non possiamo accettarla e spero che i nostri ministri la
rifiuteranno".
24 luglio: arriva con la moglie a Parigi, andando ad alloggiare ancora in Avenue des ChampsÉlisées. Fine luglio: lavora all'ultimo atto di Don Carlos.
11 agosto: all'Opéra ha luogo la prima prova con i cantanti del Don Carlos.
19 agosto: GV con la moglie si reca a Cauterets (Pirenei), dove lavora all'ultimo atto di Don
Carlos.
12 settembre: parte da Cauterets alla volta di Parigi, facendo tappa a Pau e quindi a Bordeaux.
15 settembre: giunto a Parigi continua a lavorare alla partitura del Don Carlos e intanto assiste
alle prove. 28 settembre: scrive al proprio fattore di S.Agata per l'istruzione della nipote Filomena.
18 novembre - 12 dicembre: tratta con Ricordi la cessione dei diritti di rappresentazione del Don
Carlos in Italia. 10 dicembre: comunica ad Arrivabene d'aver terminato il Don Carlos anche nella
strumentazione, salvo i ballabili.
1867
14 gennaio: muore a Busseto Carlo Verdi, padre del maestro (era nato a Roncole il 28 agosto
1875).
15 gennaio ca.: GV termina la composizione dei ballabili per il Don Carlos.
24 febbraio: ha luogo la prima prova generale del Don Carlos; l'opera risulta troppo lunga: si
rendono necessari alcuni tagli, fra cui l'Introduzione del primo atto e il concertato dopo la morte di
Posa.
Arte e Cultura
1866
15 gennaio: muore a Torino Massimo d'Azeglio.
7 febbraio: Roma, Apollo: Petrella, Caterina Howard. 25 febbraio: nasce a Pescasseroli Benedetto
Croce.
24 marzo: Vienna, Carltheater: Franz von Suppé, Cavalleria leggera, operetta.
5 maggio: esce a Milano il quotidiano "Il Secolo", edito da Sonzogno.
17 maggio: nasce nel Calvados Erik Satie.
30 maggio: Praga, Bedrich Smetana, La sposa venduta (prima versione).
17 giugno: muore a Parigi il poeta e librettista FranwisJoseph Méry.
17 novembre: Parigi, Opéra-Comique: A. Thomas, Mignon.
28 novembre: muore a Budapest la cantante Sofia Loewe.
Johann Strauss jr., Sul bel Danubio blu, valzer. - Anton Bruckner, Prima Sinfonia in Do min.
Dostoevskij, Delitto e castigo, romanzo. - Hugo, I lavoratori del mare, romanzo. - Meredith,
Vittoria, romanzo.
Eduard Mikike, Mozart in viaggio a Praga, racconto. Edmondo De Amicis, La vita militare,
racconti.
Hippolyte Taine, Viaggio in Italia.
Vittorio Betteloni,tombra dello sposo, poesie. - Gioacchino Belli, Sonetti (edizione postuma e
purgata). -A. Ch. Swinburne, Poesie e ballate. - Paul Verlaine, Poemi saturnini.
Giovanni Fattori, Diego Martelli, dipinto.
V. Vela, Napoleone morente, scultura.
Charles Henri de Coussemaker inizia la pubblicazione dei Scriptores de musica Medii Aevii.
Francesco De Sanctis, Saggi critici. Nasce la "Nuova Antologia", continuazione dell'Antologia" di
Vieusseux.
1867
13 gennaio: Milano, Scala;Antonio Bazzini, Mranda.
25 marzo: nasce a Parma Arturo Toscanini.
27 aprile: Parigi, Th. Lyrique: Gounod, Romeo e Giulietta.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
1866
Aprile: viene firmato un trattato segreto di alleanza fra Italia e Prussia in funzione antiaustriaca.
Giugno: scoppia la guerra tra Prussia e Austria.
19 giugno: l'Italia dichiara guerra all'Austria.
24 giugno: l'esercito italiano viene sconfitto a Custoza. Lamarmora è costretto alle dimissioni; gli
succede Ricasoli.
3 luglio: i Prussiani sconfiggono gli Austriaci a Sadowa e giungono a pochi chilometri da Vienna.
20 luglio: l'ammiraglio Persano subisce una pesante sconfitta presso l'isola di Lissa.
21 luglio: Garibaldi sconfigge gli Austriaci a Bezzecca e si avvia a occupare il Trentino.
26 luglio: l'Austria chiede un armistizio alla Prussia.
8 agosto: a Garibaldi viene ordinato di arrestare l'avanzata in Trentino; egli esegue con il famoso
dispaccio "Obbedisco".
12 agosto: a S. Andraz, frazione di Cormons, viene firmato l'armistizio fra Italia e Austria.
23 agosto: pace di Praga tra Prussia e Austria; la Prussia annette i ducati dello Schleswig-Holstein
e dell'Hannover.
16-22 settembre: insurrezione popolare a Palermo e in provincia; viene invocata la repubblica.
3 ottobre: pace di Vienna tra Italia e Austria; l'Austria cede il Veneto a Napoleone III, che a sua
volta lo consegna all'Italia. Con un plebiscito il Veneto proclama la propria annessione al regno
d'Italia.
Creta insorge contro iTurchi per l'annessione alla Grecia. Nasce nelTennes.see, Stati Uniti, la
setta del Ku-Klux-Klan. Il francese A. A. Chassepot costruisce il fucile ad ago" a retrocarica.
1867
Aprile: si dimette Bettino Ricasoli; gli succede Rattazzi.
Giugno: in Messico, dopo il ritiro delle truppe di Napoleone III, Massimiliano d'Asburgo viene
catturato e fucilato; Jukez torna alla presidenza.
Cronologia 1868
Giuseppe Verdi
11 marzo: Parigi, Opéra: prima rappr. di Don Carlos che ottiene un "successo di stima". 12 marzo:
GV con la moglie lascia Parigi alla volta di Genova sostando a Nizza.
14 marzo: prende possesso dell'appartamento in palazzo Sauli.
1 ° aprile: a Escudier:"Ho letto [...] il resoconto sul D. Carlos dei principali giornali di Francia.
Infine sono un wagnedano quasi perfetto. Ma se i critici avessero fatto un po' più d'attenzione
avrebbero visto che le stesse intenzioni vi sono nel terzetto dell'Emani, nel Sonnambulismo del
Macbet ed in tanti altri pezzi etc. etc... Ma la questione non sta nel sapere se appartiene il D.
Carlos ad un sistema, ma sta nel sapere se la musica è buona o cattiva".
24 aprile: la città di Genova gli conferisce la cittadinanza onoraria.
Maggio: GV e consorte decidono di affiliare la figlia di un lontano cugino, di nove anni, di nome
Filomena. Metà maggio: Giuseppina si reca a Milano e fa visita a Clara Maffei e ad Alessandro
Manzoni.
24 maggio: GV a Clara Maffei inviandole una propria fotografia per Manzoni:"Quanto invidio mia
moglie d'aver visto quel Grande! [...1 Voi ben sapete quanta e quale sia la mia venerazione per
quell'Uomo che, secondo me, ha scritto non solo il più gran libro dell'epoca nostra ma uno de' più
gran libri che sieno usciti da cervello umano. [...] Io aveva sedici anni quando lo lessi per la prima
volta".
16 giugno: all'Arrivabene:"Ci vuol altro che mettere delle imposte sul sale e sul macinato e rendere
ancora più misera la condizione dei poveri. Quando i contadini non potranno più lavorare ed i
padroni dei fondi non potranno, per troppe imposte, far lavorare, allora moriremo tutti di fame.
Cosa singolare! Quando l'Italia era divisa in tanti piccoli Stati, le finanze di tutti erano fiorenti! ora
che siamo tutti uniti, siamo rovinati. Ma dove sono le ricchezze d'una volta?!"
24 giugno: a Piroli:"Se il Sella va alle Finanze so bene che le condurrà come farebbe un carabiniere,
ma prima di prendere delle forti misure mi pare che bisognerebbe studiare quello che è possibile di
fare. Quando Egli metterà imposte che non si potranno pagare cosa succederà? Il malcontento, la
disperazione, tutti i disordini che ne sono la conseguenza...".
30 giugno: Antonio Barezzi è gravemente ammalato; GV a Clara Maffei: "Povero vecchio, che mi
ha voluto tanto bene! E povero me che per poco ancora, e poi nol vedrò più!!! Voi sapete che a lui
devo tutto, tutto, tutto. Ed a lui solo, non ad altri, come l'han voluto far credere".
21 luglio: muore a Busseto Antonio Barezzi.
15 agosto: GV e consorte partono per Parigi con sosta a Torino. Il 1.° ottobre ripartono per
rientrare a S. Agata.
Ottobre: GV assume come segretario e fattore Mauro Corticelli, già impresario, agente teatrale e
segretario dell'attrice Adelaide Ristori. Si reca a Bologna per assistere ad alcune prove del Don
Carlos.
27 ottobre: Bologna, Comunale: prima esecuzione italiana di Don Carlo, diretta da Angelo
Mariani. Novembre: GV e consorte si trasferiscono a Genova.
5 dicembre: a Milano Piave viene colto da un attacco apoplettico che lo costringe a vegetare,
immobilizzato a letto, per il resto della vita.
1868
17 febbraio: preoccupato per il Don Carlos da rappresentarsi alla Scala dopo il Mefistofele di Boito,
scrive a Ricordi:"per eseguire bene il D. Carlos musicalmente e scenicamente ci vogliono 40 giorni
con tutto il personale del teatro completamente libero d'altri impegni".
12 marzo: dopo aver chiesto a Escudier e a Du Lode informazioni sull'Amleto di Thomas, ne riceve
il libretto: "È impossibile far peggio. Povero Shaespeare! come te l'han conciato! E...] EThomas ha
un gran merito se ha avuto successo con un libretto mancato".
25 marzo: gli viene conferita la cittadinanza onoraria di Bologna.
Marzo: a Ricordi, che dopo il fiasco del Mefistofele insiste perché il maestro venga a Milano per le
prove del Don Carlos:"11 momento è opportuno?!! Imbecilli!... ma che?... son io fatto per godere
sulle rovine degli altri? Io son di quelli che va dritto per una strada senza guardar né a dritta né a
sinistra, che fa quanto può, e quanto crede, che non vuole né momenti opportuni, né appoggi, né
protezioni".
25 marzo: il Don Carlos alla Scala ottiene successo.
Arte e Cultura
28 giugno: nasce ad Agrigento Luigi Pirandello.
31 agosto: muore a Parigi Charles Baudelaire.
20 ottobre: Milano, S. Radegonda: Braga, Gli avventurieri.
23 novembre: Firenze, Niccolini: Achille Torelli, I
mariti, dramma.
6 dicembre: muore a Pescia Giovanni Pacini.
26 dicembre: Parigi, Th.-Lyrique: Bizet, La bella fanciulla di Pertb.- Firenze, Pergola: Borri, Il figliuol prodigo, ballo.
Massimo d'Azeglio, I miei ricordi.
Ippolito Nievo, Le confessioni di un italiano, romanzo (pubbl. postuma). - Émile Zola, Teresa Raquin, romanzo. - Iginio Ugo Tarchetti, Una nobile follia, romanzo.
Henrik Ibsen: Peer Gynt, dramma.
Conrad Ferdinand Meyer, Ballate.
Dupré, Cavour, statua.
Marx pubblica il primo volume del Capitale.
Bertrando Spaventa, Princìpi di filosofia (Logica e
metafisica).
Muore a Parma il conte Jacopo Sanvitale.
Viene fondato a Firenze il quotidiano "La riforma", ispirato da E Crispi.
1868
11 gennaio: Milano, Scala: Monplaisir, La Camargo, ballo, musica di Dall'Argine.
30 gennaio: Milano,T. Re: P Ferrari, Il duello, commedia. 25 febbraio: Milano, Scala: Monplaisir,
Brahma, ballo, musica di Dall'Argine.
5 marzo: Milano, Scala: Boito, Mefistofele; fiasco.
9 marzo: Parigi, Opéra:Thomas, A mleto.
10 aprile: Brema: Brahms, Un requiem tedesco.
1° maggio: Firenze, Alfieri: Emilio Usiglio, Le educande di Sorrento.
16 maggio: Praga: B. Smetana, Dalibor
6 giugno: nasce a I.ubecca Thomas Mann.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
Giugno: Francesco Giuseppe attraverso un accordo politico con la nazione ungherese sancisce una
struttura dualistica, l'impero austro-ungarico, e viene incoronato re d'Ungheria.
Estate: epidemia di colera in varie regioni italiane. Ottobre: Rattazzi è costretto alle dimissioni; gli
succede Luigi Federico Menabrea.
3 novembre: a Mentana la spedizione di Garibaldi per conquistare Roma viene sconfitta dai
Francesi, armati dei nuovi fucili Chassepot; due operai romani, Giuseppe Monti e Gaetano
Tognetti, vengono condannati alla decapitazione dal tribunale pontificio.
Vittorio Emanuele II costituisce un corpo di carabinieri a cavallo, detti corazzieri, per scorta
personale.
La Russia vende l'Alaska agli Stati Uniti.
Con un Reform Act il ministro inglese Disraeli estende il diritto di voto ai lavoratori urbani.
La Gran Bretagna concede l'autogoverno alla federazione del Canada.
L'imperatore del Giappone stabilisce la capitale a Tokyo e avvia un rinnovamento della società
giapponese.
Bakunin costituisce a Napoli la prima sezione italiana dell'Internazionale.
Il francese P. Michaux costruisce le prime biciclette a pedali (applicati alla ruota anteriore).
In Italia le società ginnastiche si riuniscono in federazione. Esposizione Universale di Parigi.
Il francese J. Monier realizza il cemento armato 1867. Il chimico svedese Alfred Nobel brevetta la
dinamite.
1868
13 aprile: una spedizione inglese sconfigge a Magdala il negus Teodoro II, che poco dopo si uccide.
22 aprile: a Torino il principe Umberto di Savoia sposa la cugina Margherita.
21 maggio: a causa delle spese sostenute nella guerra del 1866 e al fine di raggiungere il pareggio
del bilancio viene istituita l'impopolare tassa sul macinato (due lire per ogni quintale di grano),
ovvero la "tassa dei poveri".
In Spagna viene cacciata la regina Isabella II.
Unitasi all'Ungheria, la Croazia ottiene una relativa autonomia assumendo il nome di regno di
Croazia e Slovenia.
L'esercito zarista occupa Samarcanda e Buchara.
Cronologia 1869
Giuseppe Verdi
Aprile: si trasferisce da Genova a S.Agata; assume informazioni intorno a un Collegio femminile di
Torino dove far educare la nipote Filomena.
15 maggio: indignato per un'affermazione del ministro Broglio, ritenuta denigrante per i
compositori italiani succeduti a Rossini, rifiuta la Croce di Commendatore della Corona d'Italia
appena conferitagli.
16-20 maggio: Giulio Ricordi conduce Antonio Ghislanzoni in visita a S.Agata; è il primo contatto
per una possibile collaborazione per la revisione della Forza del destino.
Fine maggio: Clarina Maffei è ospite a S.Agata e fa visita alla casa natale del maestro. Giugno: GV
fa una donazione in favore della figlia di Piave.
30 giugno: si reca a Milano, che non rivedeva da vent'anni, prendendo alloggio all'Ilótel Milan, per
far visita ad Alessandro Manzoni.
Luglio: inizia le pratiche in vista della affiliazione della nipote Filomena (nata il 14 novembre
1859), cui sarà dato il nome di Maria, e ottiene di regolarizzare in sede civile il matrimonio
religioso contratto con Giuseppina in Savoia nel 1859.
28 luglio: all'Arrivabene:"non scrivo Falstaff né altre opere".
22 agosto - 15 settembre: con la moglie si reca alle cure termali di Tabiano, dove viene intervistato
da Michele Lessona intorno ai suoi anni giovanili (v. Lessona, Volere è potere ).
Ottobre: fa ricercare invano nel cimitero di Milano, fuori di Porta Magenta, i resti della moglie
Margherita e dei suoi due figli.
Ottobre: propone la pubblicazione di un Album, con musiche di sei diversi compositori, a beneficio
della famiglia di Piave.
Novembre: Ghislanzoni si mette all'opera per trovare un nuovo finale alla Forza del destino.
Novembre: per onorare la memoria di Rossini, GV propone che i maggiori compositori italiani
scrivano una Messa da Requiem "da eseguirsi nell'anniversario della sua morte. [...) La Messa
dovrebbe essere eseguita nel S. Petronio della città di Bologna che fu la vera patria musicale di
Rossini".
13 dicembre: si trasferisce a Genova e affronta la revisione della Forza del destino.
15 dicembre: a Tito Ricordi:"Verrò io stesso a Milano per fare le prove che crederò necessarie alla
Forza del Destino cambiando il finale ultimo e diversi altri squarci qua e là"; a Giulio:"Avete fatto
male a dire che io non ho mai pensato a Giulietta e Romeo. Ci ho pensato molto e molte volte, e
potrebbe ben darsi che io finissi a farne un'opera".
1869
Metà gennaio: insieme a Giuseppina si reca a Torino per condurre la nipote Maria al Collegio della
Provvidenza. 19 gennaio: spedisce a Ricordi la musica nuova della Forza del destino.
24 gennaio: si reca da solo a Milano per iniziare le prove della Forza del destino.11 10 rientra a
Genova. Il 15 ritorna a Milano in compagnia di Giuseppina per le prove d'orchestra.
27 febbraio: Milano, Scala: prima rappr. della nuova La forza del destino; esito buono.
28 febbraio: GV e consorte ripartono per Genova.
4 marzo: al critico Filippo Filippi che nella melodia "Pace, mio Dio" aveva avvertito un'imitazione
dell'Ave Maria di Schubert: "io, nella mia somma ignoranza musicale, non saprei da quanti anni
non sento l'Avo di Schubert; e m'era perciò ben difficile imitarla. Non creda che dicendo "mia
somma ignoranza musicale", sia per fare un po' di blague. No: è la pura verità".
Marzo: Giulio Ricordi "sogna" un progetto di collaborazione fra GV e Boito per il Nerone.
29 marzo: per l'Album Piave, al quale hanno già aderito Auber e Thomas, fa incaricare la vedova
Piave di rivolgersi a Federico Ricci e a Mercadante:"Manca un sesto! Ci vorrebbe un nome! Chi?
I.a signora Piave od altri non potrebbero raccomandarsi alla Giovannina Lucca per farlo fare a
Vagner?".
Aprile: si trasferisce con la moglie a S.Agata, dove riceve in visita l'impresario Perrin che gli
propone un'opera da ricavarsi dal recentissimo dramma di Sardou Patrie!
Arte e Cultura
21 giugno: Monaco di Baviera, Hoftheater: Wagner, I maestri cantori di Norimberga.
19 luglio: una legge del governo italiano introduce la tassa del 10% sugli incassi lordi dei teatri e
sopprime la dote erariale ai teatri reali.
15 agosto: inaugurazione del Teatro Verdi di Busseto con Rigoletto e l'esecuzione della
Capricciosa,"graziosa Sinfonia che Verdi scrisse nell'età di dodici anni".
9 novembre: Bologna, Brunetti: Giacometti, Maria Antonietta, dramma.
11 novembre: Bologna, Comunale: Costantino Dall'Argine, // barbiere di Siviglia.
13 novembre: muore a Passy (Parigi) Gioacchino Rossini.
Bazzini, Re Lear, ouverture. - Max Bruch, Concerto per violino in Sol min. - Edvard Grieg,
Concerto per pianoforte e orchestra.
E Dostoevskij, L'idiota, romanzo.
Amilcare Zanella, Versi.
Silvestro Lega,11 pergolato e La visita, dipinti.
Adriano Cecioni, Bimbo con il gallo, scultura.
1869
2 gennaio: Milano, Scala: Monplaisir, La Semiramide del Nord, ballo.
14 gennaio: Parigi, Odéon: Frarwois Coppée, Il viandante, commedia.
17 gennaio: muore a S. Pietroburgo il compositore Aleksandr S. Dargomyzskij.
30 gennaio: Parigi, Fantaisies-Parisiennes: Federico Ricci, Una follia a Roma.
6 febbraio: muore alla Castagnola di Lugano Carlo Cattaneo.
3 marzo: Parigi, Opera: Gounod, Faust, nuova versione.
18 marzo: Parigi, Porte-St-Martin: Sardou, Patrie!, dramma.
25 marzo: muore a Milano Iginio Ugo Tarchetti, esponente della Scapigliatura.
3 aprile: Milano, Scala: Filippo Marchetti, Ruy Blas. 25 maggio: inaugurazione a Vienna della
nuova I lofoper con Don Giovanni di Mozart.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
Negli Stati Uniti il congresso riconosce ai negri i diritti politici.
A Creta iTurchi reprimono un tentativo indipendentistico. Esposizione di Torino.
A Parigi viene disputata la prima gara ciclistica. E. Lartet scopre gli scheletri di Cro Magnon.
1869
Gennaio: l'applicazione della tassa sul macinato provoca numerosi disordini e tumulti contadini,
con epicentro a Parma e in Emilia, che si estendono a tutta la Padania e alla Toscana (in appena
due settimane si contano 250 morti, 1000 feriti e 4000 rivoltosi arrestati); viene proclamato lo
stato d'assedio in molte province, fra cui Bologna, Parma e Reggio Emilia.
Agosto: in EisenachAugust Bebel e Wilhehn Liebknecht fondano il partito operaio
socialdemocratico di ispirazione marxista.
17 novembre: viene inaugurato il canale di Suez.
Novembre: dimissioni di Menabrea.
8 dicembre: inizia il concilio Vaticano I.
Dicembre: Giovanni Lanza succede a Menabrea. Agitazioni contadine nel parmense e nel reggiano.
In Gran Bretagna diviene primo ministro William Ewart Gladstone.
Viene realizzata la prima macchina per la fototipia.
Cronologia 1870
Giuseppe Verdi
Primi di giugno: il comitato per le onoranze a Rossini pubblica il programma definitivo per la
Messa-Rossini; a GV viene assegnato il "Libera me, Domine".
23 giugno: viene decorato Cavaliere dell'Ordine del Merito Civile di Savoia.
Metà luglio: GV e Giuseppina rischiano di annegare nel laghetto della villa di S.Agata a causa di
un improvviso rovesciamento della barca sulla quale si trovavano.
Fine luglio: GV si reca a Genova con la moglie.
2 agosto: a Escudier:"Vorrei ben fare quest'opera [Patrie!) con Sardou, ma quando penso alle prove
del D. Carlos mi vengono i brividi".
Agosto: compone il "Libera me, Domine" per la Messa-Rossini, e il 20 agosto lo spedisce a Ricordi.
19-24 agosto: nasce un dissidio con Mariani, impegnato nell'organizzazione delle feste rossiniane a
Pesaro, a proposito della Messa-Rossini da eseguirsi a Bologna in S. Petronio.
21 agosto: rientra a S.Agata con la moglie; quindi si recano per alcuni giorni alle cure di Tabiano.
6 ottobre: a Du Locle:"Ho ricevuto Patrie che ho letto d'un-fiato. Bel Dramma, vasto, potente e
soprattutto scenico". L'impresario Scalaberni espone pubblicamente i motivi per i quali rifiuta di
cedere i propri scritturati per l'esecuzione della Messa-Rossini.
27 ottobre: a Giulio Ricordi che aveva proposto un rinvio dell'esecuzione della Messa-Rossini e
successivamente il trasferimento dell'avvenimento da Bologna a Milano, oppone un netto
rifiuto:"Lo scopo è fallito dal momento che la Messa non verrà eseguita: 1° in Bologna, 2°
all'anniversario della morte di Rossini" e suggerisce di restituire i pezzi ai rispettivi autori.
4 novembre: la commissione milanese per la Messa-Rossini rinunzia definitivamente al progetto.
Novembre: compone uno Stornello per l'Album a beneficio della famiglia di Piave. Fine novembre:
si trasferisce con la moglie a Genova.
8 dicembre: a Du Lode, rifiutandosi di scrivere per Parigi:"a me è assolutamente impossibile
passare di nuovo sotto le Forche Caudine dei vostri teatri, avendo la coscienza che per me non è
possibile un vero successo che scrivendo come sento io, libero da qualunque influenza, e senza
riflettere che io scriva per Parigi, piuttosto che pel mondo della luna".
Dicembre: Ricordi pubblica l'Album a beneficio della famiglia di Piave contenente composizioni di
Auber, Cagnoni, Mercadante, Ricci,Thomas e dello stesso Verdi (Stornello).
Fine dicembre: Du Lode, ospite a Genova, informa GV dell'intenzione del Khedivé d'Egitto di
chiedergli un'opera per i festeggiamenti del Canale di Suez.
1870
8 gennaio: si acuisce il dissidio con Mariani; a Ricordi:"Io ne ho avuto abbastanza della lezione
datami per la MessaRossini, ed io non m'immischierò mai più in affari musicali quando c'entra
Mariani". L' 11 gennaio a Carlino Del Signore:go non accuso Mariani di aver mal agito: l'accuso di
non aver agito. [...] Se in quel progetto [la Messa-Rossini] eravi cosa che gli spiacesse, egli
doveva rifiutare l'incarico che la Commissione di Milano gli aveva affidato. Ma, accettato, correva
a lui doppiamente l'obbligo di agire".
23 gennaio: chiede a Du I.ocle di mandargli gli scritti di Wagner e il dramma Acte et Néron di
l)umas. Gennaio: muore a Cremona Rosa Cornalba, madre di Giuseppina Strepponi.
10 febbraio: Giulio Ricordi tasta il terreno per un Nerone su libretto di Boito con musica di Verdi.
26 marzo: GV parte da Genova con Giuseppina per Parigi; va ad alloggiare all'Henel de Bade.
Incontra, fra gli altri, Draneth Bey e Sardou. Il 22 aprile fa ritorno a Genova.
26 aprile: rientra a S. Agata. A Du Lode, che insiste perché accetti la proposta del Khedivé
d'Egitto, oppone un rifiuto, non volendo affrontare un lungo viaggio per mare.
30 aprile: GV a Clara Maffei:"non so ancora cosa sia stato a fare a Parigi [...].Ho frequentato
molto i teatri: in quei di musica nulla di buono, ad eccezione della Patti che è meravigliosa. LI Il
Maestro non scrive e non ha nessuna voglia di scrivere. Potrebbe però darsi lo facesse più tardi per
l'Opéra Comique stante l'amicizia per Du I.ocle, ma è ben difficile, ben difficile".
Arte e Cultura
22 settembre: Monaco di Bavkra:Wagner, L'oro del Reno. 2 ottobre: Lecco: Petrella, I promessi
sposi.
30 ottobre: Parigi, Gymnase: Ludovic Halévy e Henri Meilhac, Froulrou,commedia.
1° novembre: al Cairo viene inaugurato con Rigoletto il nuovo teatro dell'opera.
Muore a Bade lo scultore Jean-Pierre Dantan.
Ugo Tarchetti, Fosca, romanzo. - V. Hugo, L'uomo che ride, romanzo. - Flaubert, L'educazione
sentimentale, romanzo. -Tolstoj, Guerra e pace, romanzo. - Louisa May Alcott, Piccole donne,
romanzo.
Alphonse Daudet, Lettere dal mio mulino, racconti. Michele Lessona, Volere è potere (contiene un
capitolo su GV).
Politica, Società, Scienza, Scoperte
Il chimico russo D. I. Mendeleev espone la sua classificazione periodica degli elementi.
Il belga Z. Gramme costruisce un generatore di corrente continua.
L'americano G.Westinghouse brevetta il freno pneumatico.
1870
15 marzo: Lisbona, S. Carlos: Luigi Danesi, Fata Nix, ballo, musica di Giorza.
19 marzo: Milano, Scala: Gomes, Il Guarany.
30 aprile: nasce a Komarom (Ungheria) Franz Lehar. 23 maggio: Saint-Léon - Delibes, Coppelia,
ballo. 8 giugno: muore a Londra Charles Dickens. 26 giugno: Monaco di Baviera:Wagner, La
Valchiria. 7 luglio: Parigi, Opéra-Comique: Flotow, L'ombra. 25 settembre: Praga, Bedrich
Smetana, La sposa venduta (versione definitiva).
Novembre: Milano, Teatro Milanese: Cletto Arrighi, El barchett de Boffalora, commedia in
milanese.
5 dicembre: muore a Puy (Dieppe)Alessandro Dumas padre.
17 dicembre: muore a Napoli Saverio Mercadante.
31 dicembre: Milano, Scala: Borri, La dea del Walhalla, ballo, musica di A. Baur.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
Il chimico russo D.I. Mendeleev espone la sua classificazione periodica degli elementi.
Il belga Z. Gramme costruisce un generatore di corrente continua.
L’americano G. Westinghouse brevetta il freno pneumatico.
1870
Marzo: scoppiano moti repubblicani a Piacenza, Bologna, Pavia.
22 aprile: nasce a Simbirsk Nicolaj Lenin.
19 agosto: con il pretesto della successione al trono di Spagna, offerto a Leopoldo di Hohenzollern,
parente del re di Prussia, la Francia dichiara guerra alla Prussia.
27 agosto: a Pavia viene fucilato il caporale Pietro Barsanti, di idee repubblicane.
1 settembre: l'armata francese guidata da Patrice de Mac-Mahon viene sconfitta dall'esercito
prussiano guidato da Helmuth von Moltke a Sédan; Napoleone III è fatto prigioniero.
4 settembre: in Francia viene proclamata la Terza Repubblica; un governo provvisorio organizza
la difesa nazionale.
20 settembre: attraverso la breccia di Porta Pia l'esercito italiano occupa Roma ponendo fine allo
Stato della Chiesa.
Cronologia 1871
Giuseppe Verdi
Metà maggio: riceve da Du Lode un 'programma' di libretto (Aida) redatto da Auguste Mariette
Bey. La lettura convince il maestro: "È ben fatto; è splendido di mise en scene, e vi sono due o tre
situazioni, se non nuovissime, certamente molto belle".
2 giugno: comunica a Du Lode i termini del contratto per l'opera al Cairo sulla base di un
compenso di 150.000 franchi; fra le clausole quella di designare persona di sua fiducia per dirigere
l'opera al Cairo, non intendendo affrontare un viaggio per mare.
Fine giugno: Du Lode è a S.Agata per definire col maestro il libretto in prosa di Aida.
25 giugno: GV informa l'ignaro Giulio Ricordi dell'impegno contratto con il teatro del Cairo e lo
prega di interpellare Ghislanzoni per la versificazione del libretto di Aida.
Giugno-luglio: coadiuvato da Giuseppina traduce il "programma" di Aida e ne stende il libretto in
prosa.
15 luglio: ospita Ghislanzoni, che accetta l'incarico, e ringrazia Du Lode per le informazioni su
strumenti musicali egizi. Primi di agosto: riceve da Ghislanzoni i versi del primo atto di Aida.
9 agosto: si reca a Genova, dove inizia la composizione di Aida.II 13 rientra a S.Agata, dove lo
raggiunge Ghislanzoni per lavorare al libretto di Aida.
13 settembre: GV completa il secondo atto di Aida.
30 settembre: a Clara Maffei:"Questo disastro della Francia, come a voi, mette a me pure la
desolazione in cuore. È vero che la blague, l'impertinenza, la presunzione dei francesi era ed è
malgrado tutte le loro miserie insopportabile: ma infine la Francia ha dato la libertà e la civiltà al
mondo moderno. E se essa cade, non c'illudiamo, cadranno tutte le nostre libertà e la nostra civiltà.
Io avrei amato una politica più generosa, e che si pagasse un debito di riconoscenza. Centomila de'
nostri potevano salvare forse la Francia e noi. In ogni modo avrei preferito segnare una pace vinti
coi francesi, a questa inerzia che ci farà disprezzare un giorno. La guerra europea, non la
eviteremo, e noi saremo divorati. Non sarà domani, ma sarà E...]. Quanto all'affare di Roma è un
gran fatto, ma mi lascia freddo LI perché non posso conciliare Parlamento e Collegio dei cardinali,
libertà di stampa e Inquisizione, Codice Civile e Sillabo E...]. Papa e Re d'Italia non posso vederli
insieme nemmeno in questa lettera".
27 ottobre: porta a termine il terzo atto di Aida.
31 ottobre: riceve da Ghislanzoni i versi dell'ultima scena.
13 novembre ca.: termina il quarto atto. Ghislanzoni si reca nuovamente a S.Agata per gli ultimi
ritocchi.
13 dicembre: GV si trasferisce a Genova. Chiede adAntonio Gallo e a Cesare Vigna di rinvenirgli a
Venezia un madrigale di Monteverdi.Apporta alcuni ritocchi al finale del secondo atto di Aida.
20 dicembre ca.: rifiuta il posto di direttore del conservatorio di Napoli, offertogli dal ministro
della P.I. e rimasto vacante dopo la morte di Mercadante.
1871
1° gennaio: ribadisce a Francesco Florimo il proprio rifiuto ad accettare la nomina di direttore del
conservatorio di Napoli. Il 4 gennaio allo stesso, dopo aver esposto alcune idee sull'indirizzo da
dare agli studi musicali in conservatorio: "Auguro troviate un uomo dotto soprattutto e severo
negli studj. Le licenze e gli errori di contrappunto si possono ammettere e son belli talvolta in
teatro: in Conservatorio, no.Torniamo all'antico: sarà un progresso".
Gennaio: dopo aver portato ancora nuovi ritocchi al finale del secondo atto, porta a termine la
strumentazione dell'Aida.
30 gennaio: a Giulio Ricordi, che insiste per un Nerone su poesia di Boito, propone di rinviare a
epoca più opportuna tale progetto.
5 febbraio: sollecita da Ricordi un articolo sulla necessità attuale di direttori d'orchestra veramente
capaci. Febbraio: discute con il ministro Cesare Correnti un progetto di riforma dei conservatori
italiani. Primi di marzo: presiede a Firenze la commissione per la riforma dei conservatori.
11 aprile: approva, con alcune riserve, l'articolo di Ricordi sui direttori d'orchestra e condanna gli
interpreti creatori:"Nò: io voglio un solo creatore, e mi accontento che si eseguisca semplicemente
ed esattamente, quello che è scritto".
Arte e Cultura
Giulio Briccialdi presenta un nuovo flauto che unisce le caratteristiche del modello Ziegler al
sistema Btilun.
Giovacchino Bimboni espone un tipo di trombone da lui costruito nel 1850 ca., il bimbonifono.
E Dostoevskij, I demoni, romanzo. - I.Turgenev, Re Lear della steppa, romanzo. - Jules Verne,
Ventimila leghe sotto i mari, romanzo.
Biornstjerne Bjornson, Poesie e canti.
Roberto Ardigò, Psicologia come scienza positiva.
G. Fattori, Buoi al carro, dipinto. - T Signorini, Novembre, dipinto.
Cletto Arrighi fonda il Teatro Milanese.
Viene fondato a Firenze il giornale "Fanfulla". Politica, Società, Scienza, Scoperte
2 novembre: con un plebiscito Roma e il Lazio proclamano l'annessione al regno d'Italia; il papa si
rinchiude nel Vaticano e scomunica Vittorio Emanuele II.
Con la bolla Pastor aeternus il Concilio Vaticano proclama il dogma dell'infallibilità del papa in
materia di fede e di morale.
Viené aperta la galleria del Moncenisio.
1871
18 gennaio: Londra, Italian Opera Buffa Comp.: Bottesini, Ali Baba.
4 marzo: Genova, Nazionale: Cagnoni, Papà Martin.
12 maggio: muore a Parigi I)aniel Auber.
Giugno: Pisa, Politeama: Ferdinando Martini, Chi sa il gioco non l'insegni, commedia.
10 luglio: nasce a Parigi Marcel Proust.
Agosto: Lauro Rossi succede a Mercadante nella direzione del conservatorio di Napoli.
8 settembre: J. Brahms, Il canto del destino.
16 settembre: Lecco, Sociale: Braga, Reginella.
17 ottobre: Milano T Re: Felice Cavallotti, I pezzenti, dramma storico in versi.
1° novembre: Bologna, Comunale: prima esecuzione in Italia di un'opera di Wagner, Lohengrin.
1868-1871: L Settembrini,Lezioni di letteratura italiana,
Politica, Società, Scienza, Scoperte
2 novembre: con un plebiscito Roma e il Lazio proclamano l’annesione al regno d’italia, il papa si
richiude nel Vaticano e scomunica Vittorio Emanuele II.
Con la bolla Pastor aeternus il Concilio Vaticano proclama il dogma dell’infallibità del papa in
materia di fede e di morale.
Viene aperta la galleria del Moncenisio
1871
18 gennaio: a Versailles i principi tedeschi proclamano la nascita del secondo Reich; Guglielmo
assume il titolo di imperatore.
Gennaio: sottoposta a un lungo assedio, Parigi si arrende ai prussiani.
3 febbraio: Roma viene proclamata capitale del Regno d'Italia.
Febbraio: L'assemblea nazionale francese elegge Adolphe Thiers a capo dell'esecutivo.
18 marzo: alla notizia dell'armistizio scoppia a Parigi una rivoluzione popolare socialista che dà
origine alla Comune.
10 maggio: pace di Francoforte; la Francia cede alla Prussia l'Alsazia e la Lorena e deve pagare
un'indennità ingentissima.
13 maggio: il parlamento italiano approva la legge
Cronologia 1872
Giuseppe Verdi
23 aprile: rientra a S.Agata da Genova. Per dirigere Aida al Cairo in luogo di Muzio, richiesto da
GV ma non gradito a Draneth Bey, viene scritturato Giovanni Bottesini, a sua volta non gradito al
maestro.
31 maggio: riceve a S.Agata la visita dello scenografo Girolamo Magnani con cui discute la
messinscena di Aida alla Scala.
Maggio: Draneth Bey si reca a S.Agata per ricevere disposizioni da Verdi per Aida al Cairo.
Giugno-luglio: fissata Teresa Stolz come Aida alla Scala, GV è alla ricerca di un'interprete per
Amneris.
10 luglio: raccomanda a Ricordi che la collocazione degli strumenti dell'orchestra della Scala sia
come egli aveva stabilito: vale a dire con gli archi che "accerchiano e chiudono nel mezzo gli
istromenti da fiato specialmente gli ottoni"; auspica che un giorno si possa togliere i palchi di
proscenio portando il sipario alla ribalta e di rendere "l'orchestra invisibile. Questa idea non è mia, è di Wagner: è buonissima". 4 agosto: spedisce a Ricordi il
primo atto di Aida.
Agosto: nel terzo atto di Aida rifà il coro iniziale, aggiunge un "pezzettino solo per Aida" ("O cieli
azzurri") e ritocca il terzetto finale.
2 settembre: spedisce l'ultimo fascicolo della partitura di Aida a Ricordi.
18-20 settembre ca.: a Milano per alcuni giorni, s'incontra con Girolamo Magnani per le scene di
Aida e propone un riassetto dell'orchestra della Scala.
Ottobre: richiede un flauto in La per Aida e si occupa dei figurini.
19 novembre: si reca a Bologna per assistere a una recita del Lohengrin di Wagner e annota le
proprie impressioni sullo spartito.
20 novembre: si trasferisce a Genova. Vi accoglie i principali interpreti dell'Aida alla Scala per le
prime prove di canto.
2 dicembre: opera un cambiamento alla fine del duetto Aida - Amncris nel secondo atto. 10
dicembre: scrive a Bottesini per chiedergli un parere sull-effetto" dell'ultimo duetto.
23 dicembre: compone una sinfonia per l'Aida per sostituirla al preludio.
24 dicembre: Il Cairo,Teatro Kediviale: prima rappr. di Aida. 28 dicembre: spedisce a Ricordi la
sinfonia di Aida.
1872
2 gennaio: in compagnia di Giuseppina arriva a Milano e inizia le prove di Aida alla Scala.
Gennaio: dopo aver provato in orchestra la sinfonia di Aida, la fa ritirare riconoscendone la
"pretenziosa insulsaggine".
8 febbraio: Milano, Scala: prima rappr. europea di Aida; successo caloroso.
Febbraio: gli viene conferita la cittadinanza onoraria di Parma.
20 febbraio: rientra a Genova con la moglie. In marzo si reca per alcuni giorni a S. Agata,
s'incontra a Borgo S. Donnino con il maestro Giovanni Rossi e fa una scappata a Milano; trattative
con Napoli per Aida; rifiuta di darla all'Opera di Parigi.
2 aprile: si reca a Parma per sovrintendere alle prove di Aida.
17 aprile: a De Sanctis, rispondendo alle critiche di"wagnerismo" in Aida:"Cosa mi parlate di
melodia, di armonia! Di Wagner nemmen per sogno!! Al contrario, se si volesse ascoltare e capir
bene si troverebbe l'opposto... totalmente l'opposto".
20 aprile: l'Aida va in scena alTeatro Regio di Parma, presente l'autore.
Maggio: GV e consorte rientrano a S.Agata. Per alcuni giorni Teresa Stolz è loro ospite.
Luglio: dietro le insistenze di Ricordi accetta il progetto di portare l'Aida in tournée in Germania;
ma il progetto fallisce per lo scetticismo delle stesso Ricordi. Ribadisce il rifiuto di dare Aida
all'Opéra:"Non ho che brutti ricordi musicali di Parigi e non verrò se non quando siansi meglio
organizzati que' teatri!".
4-15 luglio: trascorre alcuni giorni a Genova. In agosto si reca a Tabiano con la moglie.
Arte e Cultura
Giuseppe Giacosa, Una partita a scacchi, dramma in versi. Giovanni Verga, Storia di una capinera,
romanzo. Giosuè Carducci, Levia gravia, poesie. - Stéphane Mallarmé, Erodiade, poema. - A. Ch.
Swinburne, Canti antelucani.
K. Marx, La guerra civile in Francia.
Giuseppe Pitré dà inizio alla Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane.
Esposizione internazionale di musica a Londra. Adolfo Bartoli e Riccardo Fulni fondano a Venezia
l'"Archivio Veneto".
Il pittore ferrarese Giovanni Boldini si trasferisce a Parigi.
Heinrich Schliemann inizia gli scavi in Asia Minore e nel Peloponneso, che condurranno alla
scoperta di Troia e di Micene.
C. Darwin, L'origine dell'uomo e la selezione sessuale.
1872
Gennaio: Milano, Re vecchio: Cossa, Nerone.
21 gennaio: muore a Vienna Franz Grillparser.
4 febbraio: Milano, Scala: Antonio Pallerini, Le due
gemelle, azione coreografica, musica di Ponchielli.
28 febbraio: S. Pietroburgo: Dargomyszkij, Il convitato di pietra (postumo).
Marzo: Alberto Mazzucato succede a Lauro Rossi nella
direzione del conservatorio di Milano.
10 marzo: muore a Pisa Giuseppe Mazzini.
1° ottobre: Parigi, Vaudeville: Alphonse Daudet,
L'Arlesiana, con musiche di scena di Bizet.
23 ottobre: muore a Neuilly-sur-Seine Théophile Gautier.
7 novembre: Bologna, Comunale: prima rappr. italiana del Tannhauser di Wagner.
20 novembre: muore a Milano l'editore Francesco Lucca.
4 dicembre: Bruxelles: Charles Lecocq, La figlia di madama Angot, operetta.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
delle "guarentigie" intesa a regolare i rapporti fra stato italiano e papato; Pio IX si rifiuta di
riconoscerla.
Maggio: con il consenso dei prussiani l'esercito francese entra a Parigi dando inizio a una
ferocissima repressione, guidata da Mac-Mahon, del movimento della Comune (30.000 condanne a
morte e migliaia di deportazioni).
21-28 maggio: "settimana di sangue" a Parigi.
Thiers, già a capo dell'esecutivo che ha represso la Comune, viene eletto primo presidente della
Terza repubblica.
Luglio: viene avviato il trasferimento della capitale d'Italia da Firenze a Roma.
La popolazione del regno d'Italia ammonta a 27 milioni di individui.
In Gran Bretagna le Trade Unions ottengono il riconoscimento giuridico.
In Giappone l'imperatore abolisce l'ordinamento feudale; vengono chiamati tecnici europei.
Esposizione industriale a Milano.
Antonio Meucci brevetta un apparecchio telefonico.
R. I.. Maddox e G.W. Eastman apportano progressi decisivi nella fotografia (lastra al bromuro e
introduzione della gelatina).
Viene inaugurato il traforo del Fréjus, iniziato nel 1857.
1872
Bismarck avvia una violenta campagna contro il papato "asservitore delle coscienze" e contro i
cattolici tedeschi (Kulturkampt), avversi alla supremazia della Prussia protestante, e scioglie
l'ordine dei Gesuiti.
La nomina di Amedeo di Savoia a re di Spagna provoca la terza guerra "carlista".
Sul trono d'Etiopia sale Giovanni IV
Il generale G.D. Perrucchetti fonda il corpo degli alpini. Entra in funzione adArcetri un
osservatorio astronomico. Marinoni mette a punto la rotativa a carta continua. Augusto Righi,
L'elettrometro a induzione.
Cronologia 1873
Giuseppe Verdi
22 agosto: rifiuta Aida a Roma; a Torelli: "Per buoni elementi di esecuzione non intendo parlare
soltanto della Compagnia cantante, ma delle masse orchestrali e corali, del vestiario, dello
scenario, degli attrezzi, del movimento
scenico e della finezza dei coloriti ".
Settembre: a S.Agata si occupa del giardino e della costruzione di una grotta.
Ottobre: rifà il duetto Filippo - Posa nel Don Carlos e apporta un taglio al duetto Elisabetta - Don
Carlos nel quinto atto. - Polemica con Guerrazzi per aver rifiutato di collaborare all'Albo
rossiniano di Guidicini, che gli aveva richiesto un parere su un'opinione di Rossini intorno al
merito dei cantanti nell'esecuzione delle opere in musica.
10 novembre ca.: parte con la moglie via mare, sul vapore Colombo, alla volta di Napoli per
dirigervi Don Carlos e Aida; vanno ad alloggiare all'Heitel de Russie.
12 novembre: arriva a Napoli.
2 dicembre: al S. Carlo di Napoli va in scena il Don Carlos, presente l'autore; poco dopo,Teresa
Stolz si ammala di gola e le recite vengono sospese.
1873
Gennaio: GV inizia intanto le prove per Aida, in attesa della guarigione della Stolz.
Febbraio: a Milano viene promossa una pubblica sottoscrizione a favore di un monumento a
Napoleone III. GV si sottoscrive con 200 lire; all'Arrivabene:"Napoleone è stato il solo francese
che abbia amato il nostro paese; più Egli ha arrischiato la pelle per noi!".
Marzo: compone il Quartetto in Mi minore per archi.
Marzo ca.: Vincenzo Gemito scolpisce un ritratto in creta di GV e di Giuseppina, a compenso di
una somma che lo esoneri dal servizio militare.
30 marzo: l'Aida va in scena al S. Carlo di Napoli, presente l'autore.
1 aprile: GV fa eseguire in forma privata il suo Quartetto all'Albergo delle Crocelle, dove ora
alloggia; all'Arrivabene:"Ho scritto proprio nei momenti d'ozio di Napoli un quartetto. I: ho fatto
eseguire una sera in casa mia senza dargli la minima importanza, e senza fare invito di sorta.
Erano presenti soltanto sette od otto persone solite a venire da me. Se il quartetto sia bello o
brutto non so... so però che è un quartetto!".
9 aprile: parte da Napoli per rientrare a S.Agata.
Fine aprile: utilizzando il"Libera me, Dornine"già composto per la Messa-Rossini, decide di
completare la Messa da requiem.
10 maggio: si reca a Parma per assistere a una recita della Forza del destino, e a Genova per
smobilitare l'appartamento di palazzo Sauli.
22 maggio: è colpito dalla morte di Alessandro Manzoni.
1 giugno: si reca a Milano per visitare la tomba di Manzoni.
3 giugno: propone al sindaco di Milano di scrivere una Messa da morto per l'anniversario di
Manzoni:"È un impulso, o dirò meglio, un bisogno del cuore che mi spinge a onorare, per quanto
posso, questo Grande che ho tanto stimato come Scrittore, e venerato come Uomo, modello di
virtù e di patriottismo!".
25 giugno: parte per Parigi con la moglie. Vi arriva il l° luglio; continua nella composizione della
Messa.
Primi di settembre: parte con Giuseppina da Parigi attraversando per la prima volta la nuova
galleria del Frejus e rientra a S.Agata.
Settembre: a Ricordi: "Per l'Aida io sono del parere ora di renderla popolare. Dopo cinque successi,
mi pare ora soverchio il rigore: [.. .] datela ove credete meglio... e datela in molti teatri insieme".
17 settembre: a Piroli:"Parigi è una gran bella città, ed i Parigini sono più matti ancora di prima!
LI Non so se farà un gran bene il viaggio del nostro Re [in Germania e Austria]. A me pare che è
una protesta che si poteva risparmiare, eppoi cosa volete che vi dica, io detesto questo engoament
per tutto quello che è tedesco!".
Ottobre: chiede a Florimo in visione alcune cantate di Alessandro Scarlatti; riceve i due busti
scolpiti da Gemito. Dicembre: continua nella composizione della Messa.
30 dicembre: si trasferisce con la moglie a Genova.
Arte e Cultura
César Franck, Rédemption, poema sinfonico.
Muore a Napoli il commediografo Pasquale Altavilla, autore fra l'altro di Li contraste tra duje
mpressarie pe li mmuseche de li maste Verdi e Donizetti e Na famiglia ntusiasmata pe la museca de
lo Trovatore.
Friedrich W. Nietzsche, La nascita della tragedia.
A. Daudet, Tartarino di Tarascona, romanzo. - G. Eliot, Middlemarch, romanzo.
F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana. Henry Morton Stanley, Come trovai Livingstone.
1873
12 gennaio: Nikolaj A. Rimskij-Korsakov, La fanciulla di Pskov.
16 febbraio: Milano, Scala: Gomes, Fosca. 25 febbraio: nasce a Napoli Enrico Caruso.
29 aprile: muore a Milano il basso Ignazio Marini.
Maggio: nasce la Società Orchestrale Fiorentina, diretta da Jefte Sbolci.
22 maggio: muore a Milano Alessandro Manzoni.
29 maggio: Weimar: E Liszt, Christus, oratorio.
Maggio: Verona, Arena: esordio di Eleonora Duse in Giulietta e Romeo di Shakespeare.
13 giugno: muore a Genova Angelo Mariani.
23 settembre: muore a Cecina Domenico Guerrazzi. Ottobre: l'Opéra è preda delle fiamme.
23 novembre: Trieste, Casino Schiller: esordio del giovanissimo pianista Ferruccio Weiss Busoni.
30 novembre: Bologna, Comunale: Stefano Gobatti: I Goti.
Ministero della P. I., Istituti e società musicali in Italia. Statistica: l'indagine registra la presenza di
267 scuole di musica in gran parte mantenute dai municipi; 1.494 bande con 40.478 suonatori; 113
fanfare con 2.195 suonatori; 65 accademie filarmoniche con 4.849 soci; 6 società del quartetto con
391 soci.
Il belga Meerens propone un diapason a 432 vibrazioni.
Jules Verne, Il giro del mondo in ottanta giorni, romanzo. - É. Zola, Il ventre di Parigi, romanzo.
Anatole France, I poemi dorati.
Paul Cézanne, La casa dell'impiccato, dipinto.
Antonio Stoppani, Corso di geologia. Paolo Mantegazza, Fisiologia dell'amore.
L'editore Treves fonda la "Nuova Illustrazione Universale" (dal 1875 "L'Illustrazione Italiana").
Politica, Società, Scienza, Scoperte
1873
9 gennaio: muore a Chislehurst in Inghilterra Napoleone III.
1° maggio: si apre a Vienna l'Esposizione universale.
24 maggio: in Francia cade Thiers; la maggioranza conservatrice elegge presidente della
repubblica il maresciallo Mac-Mahon, favorevole alla restaurazione monarchica.
9 luglio: si dimette Lanza; gli succede Minghetti. Vittorio Emanuele III va in Germania in visita
ufficiale.
11 novembre: in Spagna Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, abdica al trono per l'opposizione di
conservatori e repubblicani. Viene istituita la Prima repubblica.
Berlino: Russia, Austria e Germania si coalizzano nella "Lega dei tre imperatori" in difesa
dell'ordinamento monarchico e per il mantenimento dello "status quo" nella penisola balcanica.
Golgi individua le cellule nervose con metodo cromatico. Hansen isola per la prima volta un
batterio.
Michail Bakunin, Stato e anarchia.
James Maxwell, Trattato sull'elettricità e il magnetismo.
Cronologia 1874
Giuseppe Verdi
1874
Metà gennaio: assiste al Carlo Felice a una recita dei Promessi sposi di Ponchielli. 28 gennaio: alla
Scala va in scena il Macbeth nella nuova versione.
Metà febbraio: GV assiste al Carlo Felice di Genova a una recita dei Goti di Gobatti.
24 febbraio: il Consiglio comunale di Milano accetta l'offerta verdiana della Messa pro defunctis.
7 marzo: a Piroli a proposito dei Goti di Gobatti:"Sono scritti da uno che non sa nulla di musica né
di poesia LI
Se non studierà, Egli potrà avere le migliori idee del mondo, ma non gli serviranno a nulla, perché
gli manca assolutamente la lingua per comprenderle"; e all'Arrivabene a proposito di Ponchielli:"sa
la musica, ma nella sua Opera non
v'è individualità".
11 marzo: protesta per le mutilazioni dell'Aida a Napoli; a Ricordi: "se avessi voluto fare il
mercante, nissuno m'a-
vrebbe impedito di scrivere dopo la Traviata un'opera all'anno, e formarmi una fortuna tre volte
maggiore di quella che ho! Io aveva altri intendimenti d'arte (lo prova la cura che mi son preso per
le ultime opere)".
Marzo: fa una corsa a Milano per stabilire la chiesa in cui si eseguirà la Messa da Requiem, e
sceglie quella di S. Marco.
16 aprile: termina la composizione della Messa.
2 maggio: arriva a Milano e inizia subito le prove della Messa. 10 maggio: è in trattative per far
eseguire la Messa a Parigi.
Metà maggio: in una corrispondenza dall'Italia Hans von Biilow giudica la Messa `una nuova
emanazione del Trovatore'.
22 maggio: Milano, chiesa di S. Marco: prima esecuzione della Messa da Requiem sotto la
direzione dell'autore.
25 maggio: la Messa viene eseguita alla Scala sotto la direzione di Franco Faccio.
26 maggio: parte per Parigi; vi arriva il 29, andando ad alloggiare all'Hotel de Bade e inizia subito
le prove della Messa.
9 giugno: dirige la Messa da requiem all'Opéra-Comique.
Fine giugno: con Giuseppina fa una corsa a Londra in vista di una possibile esecuzione della
Messa. l ° luglio: rientra a Parigi e dopo una settimana parte per S.Agata dove arriva il 13.
Fine agosto: Giuseppina si reca a Genova per il trasloco dei mobili da palazzo Sauli a palazzo
Doria.
Metà ottobre: alla Maffei:"I sessant'anni sono passati e non m'importa di loro, né di quelli che
verranno, siano essi o molti o pochi... Sono nei campi dalla mattina alla sera, e non faccio null'altro,
non leggo, non scrivo, nulla nulla nulla".
2 novembre: rifiuta di scrivere un inno "pel divino Ariosto".
15 novembre: viene nominato, ma solo per censo, senatore del regno. 21 novembre ca.: prende
possesso dell'appartamento di palazzo Doria.
Novembre: medita di riscrivere per la sola voce di contralto il "Liber scriptus" della Messa, già
composto ed eseguito per coro a 4 voci.
1875
Gennaio: è in trattative con Ricordi per la tournée della Messa da Requiem a Parigi, Londra,
Berlino e Vienna, e intanto scrive la nuova versione del "Liber scriptus". Il 31 gennaio la spedisce
a Ricordi.
20 febbraio ca.: fa una corsa a Milano per definire la tournée della Messa. Il 25 rientra a Genova,
per poi trasferirsi con la moglie il 3 aprile a S.Agata.
10 aprile: arriva a Milano e prova subito i cantanti per la tournée europea della Messa da Requiem.
12 aprile: parte da Milano, sosta a Torino e arriva a Parigi il 14 alloggiando all'Hotel de Bade. 19
aprile: dirige la Messa all'Opéra-Comique.
Arte e Cultura
1874
27 gennaio: muore a Milano Giuseppe Rovani.
8 febbraio: S. Pietroburgo, Marijnskij: Musorgskij, Boris Godunov.
7 marzo: Milano, Scala: Ponchielli, I Lituani.
21 marzo: Genova, Carlo Felice: Gomes, Salvator Rosa. 21 marzo: Bruxelles, FantaisiesParisiennes: Charles
Lecocq, Giroflé-Girofla, operetta.
5 aprile: Vienna: Johann Strauss jr., Il pipistrello. Aprile: nasce la Società Orchestrale Romana
diretta da Ettore Pinelli.
1 ° maggio: muore a Firenze Niccolò Tommaseo. 13 settembre: nasce a Vienna Arnold
Schoenberg.
Guerrazzi, Manzoni, Verdi e l'albo rossiniano, con
note biografiche di B.E. Maineri.
Vienna: Grillparzer, Libussa (postuma).
Giuseppe Rovani, Le tre arti.
Pedro Antonio de Alarcón, Il cappello a tre punte, romanzo. - Flaubert, La tentazione di
Sant'Antonio, romanzo. - Nikolaj Leskov, L'angelo sigillato, romanzo.
P Verlaine, Romanze senza parole.
H. Schliemann, Le antichità troiane.
Parigi: si inaugura nel laboratorio di Nadar il primo Salon dei pittori "impressionisti"; Claude
Monet, Impressione, sole nascente; ean Renoir,// palco, dipinti.
Quintino Sella promuove la restaurazione dell'Accademia dei Lincei.
Politica, Società, Scienza, Scoperte 1874
Estate: tumulti popolari in Romagna e a Bologna, guidati da anarchici e internazionalisti.
Pio IX pronuncia il "non expedit" che vincola i cattolici italiani ad astenersi dall'attività politica.
In Spagna un colpo di stato militare abbatte la repubblica e restaura la monarchia ponendo sul
trono Alfonso XII, figlio di Isabella II.
In Svizzera viene introdotto l'istituto del referendum popolare.
In Francia viene introdotto, sull'esempio russo, l'obbligo del servizio militare.
In Gran Bretagna cade il governo Gladstone; gli succede il secondo ministero Disraeli.
30 novembre: nasce a Blenheim Winston Churchill. Il medico norvegese G.A. Hansen scopre il
bacillo della lebbra.
Convenzione di Berna: viene fondata l'Unione postale universale.
1875
5 gennaio: a Parigi viene inaugurato il nuovo Opéra, costruito dall'architetto Charles Garnier.
20 gennaio: Milano, Scala: Luigi Manzotti, Pietro Micca, ballo.
25 gennaio: S. Pietroburgo,T. Imperiale:A. Rubinstein, Il demone.
23 febbraio: Firenze, Pergola: Salvatore Auteri-Manzocchi, Dolores.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
1874
Estate: tumulti popolari in Romagna e a Bologna, guidati da anarchici e internazionalisti.
Pio IX pronuncia il "non expedit" che vincola i cattolici italiani ad astenersi dall'attività politica.
In Spagna un colpo di stato militare abbatte la repubblica e restaura la monarchia ponendo sul
trono Alfonso XII, figlio di Isabella II.
In Svizzera viene introdotto l'istituto del referendum popolare.
In Francia viene introdotto, sull'esempio russo, l'obbligo del servizio militare.
In Gran Bretagna cade il governo Gladstone; gli succede il secondo ministero Disraeli.
30 novembre: nasce a Blenheim Winston Churchill. Il medico norvegese G.A. Hansen scopre il
bacillo della lebbra.
Convenzione di Berna: viene fondata l'Unione postale universale.
1875
Il presidente del consiglio Minghetti annuncia il raggiungimento del pareggio del bilancio.
10 ottobre: discorso di Stradella (Agostino Depretis).
In Germania al congresso di Gotha nasce il partito socialdemocratico tedesco dalla fusione
dell'associazione operaia fondata da Lassalle e del partito operaio fondato da Bebel e Liebknecht.
Nella penisola balcanica la Bosnia-Erzegovina, sostenuCronologia 1876
Giuseppe Verdi
Fine aprile: gli viene conferita la croce di Commendatore della Legion d'Onore.
Maggio: richiesto dal comitato per le onoranze a Donizetti e Mayr di una composizione sacra da
eseguirsi in occasione della traslazione delle ceneri dei due compositori nella cattedrale di
Bergamo, GV rifiuta, considerando ormai cessata la sua attività di musicista.
8 maggio: parte alla volta di Londra.
15 maggio: dirige la Messa da Requiem all'Albert Hall; per la prima volta viene eseguita la nuova
versione del "Liber scriptus" per contralto solo.
2 giugno: parte da Londra alla volta di Vienna, via Parigi; prende alloggio all'HIStel Munsch.
11 giugno: dirige la Messa all'Hofoperntheater, alla presenza dell'imperatore Francesco Giuseppe,
che gli conferisce la più alta onorificenza al merito culturale, la croce con stella dell'Ordine di
Francesco Giuseppe.
19 giugno: dirige Aida (con i cantanti della Messa) all'Hofoperntheater.
22 giugno: visita il Conservatorio di Vienna; gli vengono mostrati gli autografi musicali di
Beethoven e di Schubert.
26 giugno: parte da Vienna, sosta a Venezia e il 28 è di ritorno a S.Agata, irritato perché Ricordi
non ha prolungato la tournée fino a Berlino.
10 luglio: la tournée della Messa, ora diretta da Faccio, prosegue al teatro Malibran di Venezia.
Luglio: dopo essersi fatto mandare da Ricordi tutti i contratti dal Rigoletto in poi, apre una
vertenza con l'editore per la constatata irregolarità nel pagamento dei noli dovutigli.
19 settembre: si conclude a Firenze la tournée della Messa.
Ottobre: la Messa da requiem viene ripresa a Vienna sotto la direzione di Hans Richter; Richard
Wagner e Cosima assistono da un palco all'esecuzione.
15 novembre: si reca a Roma per prestare giuramento al Senato e rientra subito a Genova.
29 dicembre: accomoda la vertenza con Ricordi chiedendo un indennizzo di 50.000 lire.
1876
5 febbraio: all'Arrivabene: giudica Gounod "grandissimo musicista, il primo Maestro di Francia,
ma non ha fibra drammatica. Musica stupenda, simpatica, dettagli magnifici, ben espressa quasi
sempre la parola... intendiamoci bene, la parola, non la situazione"; quanto al teatro "a repertorio"
sul modello dell'Opéra e dei teatri di Germania, lo ritiene
impraticabile in Italia.
4 marzo: si trasferisce da Genova a S.Agata.
15 marzo: all'Arrivabene:"io non voglio fare un proponimento, ma difficilmente scriverò ancora".
20 marzo: parte alla volta di Parigi.
22 marzo: giunto a Parigi inizia le prove dell'Aida in italiano.
22 aprile: dirige l'Aida al Teatro Italiano; intanto fa tradurre l'opera in francese.
26 aprile: a Piroli: "Sento che Nigra lascia Parigi! Peccato! Non troveranno Ambasciatore per qui
migliore di lui"
30 maggio: dirige la Messa da Requiem al Teatro Italiano.
1° giugno: il suo Quartetto per archi viene eseguito in forma privata nell'appartamento di GV
all'Hòtel de Bade, esecutori Sivori, Marsick, Delsart e Viardot.
7 giugno: GV parte da Parigi; si guastano i rapporti con Du Lode per inadempienze economiche di
questi e cominciano a logorarsi quelli con Escudier a causa dei diritti d'autore.
18 giugno: rientra a S.Agata.
12 luglio: invia a Ricordi e a Escudier le bozze di stampa corrette del Quartetto per archi. Agosto:
la nipote Maria termina gli studi al collegio di Torino. 15 agosto: si reca con la moglie a Torino.
Arte e Cultura
3 marzo: Parigi, Opéra-Comique: Bizet, Carmen.
7 marzo: nasce a Ciboure (Pirenei) Maurice Ravel. 10 marzo: Vienna, Hofoper: Karl Goldmark, La
regina dí Saba.
3 giugno: muore a Bougival (Parigi) Georges Bizet. Agosto: Milano, Conservatorio: Alfredo
Catalani, La falce," egloga orientale".
4 ottobre: Bologna, Comunale: risorge il Mefistofele di Boito in nuova versione.
26 dicembre: muore a Milano Emilio Praga. Grieg, Peer Gynt, musiche di scena.
Karl Riemann, Musiklexicon.
Hanslick, Die moderne Oper
1875-1882: Giulio Carcano inizia a pubblicare una nuova versione italiana delle tragedie di
Shakespeare.
A. Maffei pubblica la traduzione italiana del Ratcliff di H. Heine.
L. Capranica, Giovanni dalle Bande Nere, romanzo. Pasquale Villari, Lettere meridionali.
1876
3 gennaio: Roma, Valle: Cossa, Messalina, dramma, con musiche di scena di Luigi Mancinelli.
5 marzo: muore a Milano Francesco Maria Piave. I funerali vengono fatti a spese di Verdi. - Esce a
Milano il primo numero del "Corriere della sera" fondato dal napoletano Eugenio Torelli-Viollier.
8 aprile: Milano, Scala: Ponchielli, La Gioconda.
8 giugno: muore a Nohant (Berry) George Sand.
14 giugno: Parigi, Opéra: Delibes, Sylvia, balletto.
13 agosto: Bayreuth: inaugurazione del Festspielhaus;
Wagner, L'anello del Nibelungo.
3 novembre: muore a Napoli Luigi Settembrini.
4 novembre: J. Brahms, Prima Sinfonia op. 68 in Do magg.
28 dicembre: Napoli, Nuovo: De Giosa, Napoli di (ai,
C. Franck, Les Bolides, poema sinfonico.
G. B. Shaw inizia l'attività di critico musicale.
Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer, romanzo. J. Verne, Michele Strogoff, romanzo.
Mallarmé, // meriggio di un fauno.
William Morris, La storia di Sigurd il Volsungo,
poema.
Pierre-Auguste Renoir, ti mulino della Galette, dipinto.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
ta dalla Serbia, insorge contro i Turchi.
La Gran Bretagna acquista la maggioranza delle azioni della Compagnia del canale di Suez.
L'Italia e altre nazioni firmano la "convenzione del metro" con l'adozione del sistema metrico
decimale introdotto in Francia all'inizio dell'Ottocento.
1876
18 marzo: cade il ministero Minghetti.
25 marzo: nasce il primo governo Depretis; e codesso la politica del "trasformismo".
Novembre: elezioni generali in Italia.
Dicembre: nasce a Reggio Emilia una Lega contro la tassa sul macinato.
In Francia viene approvata la costituzione della Terza repubblica.
Negli Stati Uniti gli Indiani, guidati da Toro Seduto, in lotta contro l'occupazione delle loro terre,
annientano a Little Big Horn un reggimento di cavalleria guidato dal generale Custer.
In Messico con un colpo di stato Porfirio Diaz instaura una dittatura personale che durerà, salvo
un'interruzione, fino al 1911.
la colonia inglese dell'India è costituita in impero. 1° luglio: muore a Berna Michail Bakunin.
Thomas Alva Edison inventa il microfono a carbone. I: americano A. Graham Bell brevetta il
telefono.
Cronologia 1877
Giuseppe Verdi
20 agosto: annuncia a Piroli il fidanzamento della nipote Maria con il figlio del notaio Angiolo
Carrara. Alberto: rientra a S.Agata.
27 ottobre: riceve da Morelli il dipinto Gli ossessi.
Novembre: il Quartetto Fiorentino compie una tournée di oltre sei mesi in Austria, Italia e
Germania, eseguendo fra l'altro il Quartetto di GV (a Vienna il 7 novembre, a Trieste il 24
novembre).
14 novembre: muore a Genazzano (Roma) l'amico scultore Vincenzo Luccardi.
3 dicembre: si trasferisce con Giuseppina a Genova. -Al Conservatorio di Milano il Quartetto
Fiorentino esegue il suo Quartetto per archi.
14 dicembre: a Piroli:"non ho nulla a fare e non voglio far nulla".
1877
20 gennaio: è invitato da Ferdinand Hiller a dirigere la sua Messa al prossimo Festiva! del Basso
Reno in Colonia.
21 marzo: all'Arrivabene:"Ora è difficile poter dire se Boito potrà dare all'Italia dei capolavori! Ha
molto talento, aspira all'originalità ma riesce piuttosto strano. Manca di spontaneità e gli manca il
motivo: molte qualità musicali. Con queste tendenze si può riuscire più o meno bene in un
soggetto così strano, e così teatrale come il Mefistofele, più difficile nel Nerone!".
Primi di aprile: dietro sua autorizzazione, il Quartetto viene eseguito al Krystall Palace di Londra
da un'orchestra di 80 archi.
4 aprile ca.: si trasferisce con la moglie a S.Agata.
10 maggio ca.: parte con la moglie alla volta di Colonia.
21 maggio: dirige a Colonia la Messa da Requiem (a Piroli:"Stupenda esecuzione di masse,
meschina per parte dei quattro cantanti").
Maggio-giugno: visita l'Olanda (a Piroli: "Triste e monotona tanto nella campagna come nelle
città. Non monumenti: case parate a morto; canali orribilmente sporchi e fetenti. Si mangia male")
e il Belgio, e ammira i dipinti di Rembrandt e di Rubens.
Primi di giugno: arriva a Parigi, vi sosta per due settimane e assiste a rappresentazioni di opere di
Gounod e di Massenet e a una commedia di Sardou.
19 giugno: rientra a S.Agata.
Ottobre: scrivendo a Ricordi elogia Adelina Patti, "perfetto equilibrio fra la cantante e l'attrice.
Artista nata in tutta l'estensione della parola".
2 novembre: a Clara Maffei:"Non m'occupo affatto di musica e dopo Cologne non ho fatto altro che
fare il mestiere di Mastro Muratore. È un mestiere come un altro, che stanca, che poche volte
diverte, e fa molto arrabbiare... Ma intanto la povera gente lavora: ne ha tanto bisogno!"
21 novembre: con la moglie si trasferisce a Genova.
5 dicembre: GV ringrazia Gino Monaldi per l'invio del suo opuscolo Verdi e le sue opere.
Dicembre: trasloca al primo piano di palazzo Doria (a Hiller:"per fare meno scale ed avere un
appartamento più grande").
1878
8 febbraio: confida ad Arrivabene il suo parere sull'opuscolo di Monaldi:"È pieno d'inesattezze!"
12 febbraio: a Clara Maffei:"Povero Papa! Certamente io non sono per il Papa del Sillabo, ma sono
per il Papa dell'amnistia, e del Benedite, Gran Dio, l'Italia...[...] I: hanno accusato d'aver
indietreggiato, d'aver mancato di coraggio e di non aver saputo imbrandire la spada di Giulio II.
Per fortuna! Ammettendo anche nel '48 egli avesse potuto scacciare gli austriaci d'Italia, cosa
avressimo ora? Un governo di preti! [...] Meglio così!...Tutto quello che ha fatto di bene e di male
è riuscito ad utile del paese".
Febbraio-marzo: riceve a Genova la visita della pianista Maria Wieck, sorellastra di Clara, la
vedova di Schumann, che suona per lui.
Arte e Cultura
C. Lombroso, L'uomo delinquente.
A Parigi, sulla collina di Monmartre, viene eretta la chiesa del Sacro Cuore.
1877
4 marzo: Mosca, Bol'soj: P I. Ciajkovskij, Il lago dei cigni, balletto.
5 aprile: Parigi, Opéra-Comique: Gounod, Cinq-Mars.
7 aprile: muore a Genova Errico Petrella.
27 aprile: Parigi, Opéra: Massenet, II re di Lahore.
28 aprile: Anton Bruckner termina la Wagner-Symphonie.
Agosto: nasce la Società Orchestrale di Genova. 25 novembre: Roma,Valle: P Cossa, Cleopatra,
poema drammatico, con Intermezzi musicali di Mancinelli. 2 dicembre: Weimar: Saint-Saéns,
Sansone e Dalila. 10 dicembre: muore a Conegliano Veneto Federico Ricci.
30 dicembre: Brahms, Seconda Sinfonia.
31 dicembre: muore a Milano Alberto Mazzucato. Tolstoj, Anna Karenina, romanzo. - É. Zola,
L'ammazzatoio, romanzo.
Boito, Il libro dei versi. - G. Carducci, Odi barbare.
Mario Rapisardi, Lucifero, versi. - Lorenzo Stecchetti (pseud. di Olindo Guerrini), Postuma,
poesie.
Alessandro D'Ancona, Le origini del teatro in Italia.
H. Spencer, Princìpi di sociologia.
Don Giovanni Bosco, // sistema preventivo nella educazione della gioventù.
1878
8 gennaio: Torino, Regio: Manzotti, Sieba o La spada di Wodan, azione coreografica, musica di
Romualdo Marenco.
15 gennaio: muore a Cernobbio Carlo Blasis, coreografo e teorico della danza.
21 aprile: muore a Milano Temistocle Solera.
Giugno: al Trocadero di Parigi rassegna delle principali orchestre europee, fra cui quella della
Scala.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
1877
12 marzo: Pio IX pronuncia un'allocuzione di condanna delle principali leggi e atti del governo
italiano.
15 luglio: viene varata la legge Coppino per l'istruzione obbligatoria dei fanciulli dai sei ai nove
anni.
In Italia inizia l'inchiesta agraria da parte di una commissione parlamentare coordinata da Stefano
Jacini.
Ottobre: un colpo di stato del presidente Mac-Mahon porta al successo dei repubblicani.
Ottobre: si tiene a Bologna il primo Congresso nazionale operaio.
Scoppia una guerra tra Russia e Impero Ottomano per il predominio nei Balcani e il controllo degli
Stretti.
Nell'Africa del Sud, dopo la scoperta di importanti giacimenti diamantiferi, gli inglesi annettono la
repubblica boera del Transvaal.
In Giappone fallisce una ribellione di samurai contro l'imperatore; la casta dei samurai viene
abolita.
T.A. Edison inventa il fonografo meccanico a cilindro. Giovanni Virginio Schiaparelli delinea una
carta del pianeta Marte.
L'inglese D. E. Hughes realizza il microfono a polvere di carbone.
1878
9 gennaio: muore a Roma Vittorio Emanuele II; gli succede il figlio Umberto I.
2 febbraio: muore a Roma Pio IX; gli succede Leone XIII.
Marzo: Depretis si dimette; gli succede Benedetto Cairoli.
31 marzo: con la pace di S. Stefano la Turchia riconosce la sovranità russa sull'Armenia e sulla
Bessarabia, e la
Cronologia 1879
Giuseppe Verdi
12 marzo: a Piroli:"la miseria è molta; è cosa grave e può diventare gravissima compromettendo
anche la sicurezza pubblica. Si tratta di fame!!! [...] Se voi vedeste [...1 da noi quanti poveri, e fra
questi quanti giovani robusti, che domandano lavoro, e non trovandolo domandano la carità di un
tozzo di pane!".
Metà marzo: trascorre con la moglie un paio di giorni a Montecarlo.
19 marzo: a Clara Maffei:"Voi, proprio voi, mi consigliate a scrivere! [.. 1 Il risultato sarebbe ben
meschino. Sentirei da capo a dirmi che non ho saputo scrivere, e che son diventato un seguace di
Wagner. Bella gloria! Dopo quasi quarant'anni di carriera finire imitatore!".
6 aprile: parte da Milano alla volta di Parigi. Primi maggio: è di ritorno a Genova.
1 ottobre: viene celebrato il matrimonio di Maria Verdi con Alberto Carrara.
Fine novembre: ritorna a Parigi per visitare l'esposizione universale; ascolta all'Opera il Polyeucte
di Gounod. Quindi rientra a S.Agata.
10 dicembre ca.: si trasferisce a Genova.
1879
30 marzo: all'Arrivabene:"sono andato a sentire il Mefistofele, ed ho capito tutto di traverso". Fine
marzo: riceve una visita di Boito.
Metà aprile: parte da Genova per rientrare a S.Agata.
2 maggio: a Ricordi che insiste nel riproporre il Simon Boccanegra alla Scala con alcune
modifiche:"Ora nulla di più inutile al Teatro che un'opera mia... e poi, e poi, è meglio finire
coll'Aida e colla Messa che con un' arrangement..."
11 giugno: a Piroli a proposito dell'alluvione: "Le nostre disgrazie non sono così forti come il
Mantovano e Ferrarese, ma in ogni modo i raccolti tutti sono quasi perduti [...] Ed intanto il
Governo pensa ad aumentare le imposte, a far spese di guerre, a far Strade Ferrate non di prima necessità [alludendo al progetto di
ferrovia fra Cremona e Busseto]".
23 giugno: inizia alla Scala le prove della Messa da Requiem.
30 giugno: dirige la Messa alla Scala a beneficio delle vittime dell'inondazione del Po; rientrato
alflifitel Milan, l'orchestra della Scala, guidata da Faccio, gli dedica una serenata.
1° luglio ca.: nel corso di un pranzo Giulio Ricordi accenna a un progetto di libretto di Boito
dall'Otello di Shakespeare.
Arte e Cultura
12 luglio: Lucca, chiesa di S. Apolino: Giacomo
Puccini, Messa di Gloria.
7 ottobre: Parigi, Opéra: Gounod, Polyeucte.
Hector Malot, Senza famiglia, romanzo.
Carlo Dossi, Desinenza in '21".
Nietzsche, Umano, troppo umano.
Alessandro d'Ancona: La poesia popolare in Italia.
Tranquillo Cremona, L'edera, dipinto.
Lo scultore Vincenzo Gemito si afferma con successo
al Salon di Parigi presentando Il pescatorello. Minghetti, Stato e Chiesa.
John W. S. Rayleigh, Teoria del suono.
Viene fondato a Roma il quotidiano "Il Messaggero".
1879
1 ° gennaio: Lipsia: Brahms, Concerto per violino e orchestra.
19 gennaio: Torino, Regio: Giovanni Bottesini, Ero e Leandro, libretto di A. Boito.
1° febbraio: Vienna, Carltheater E von Suppé,Boccaccio, operetta.
6 febbraio: Milano, Scala: prima rappr. italiana del Re di Lahore di Massenet.
11 febbraio: Madrid, Real: E. Usiglio, Le donne curiose. 15 febbraio: Torino, Regio: Ferdinando
Pratesi, L'astro
degli Afghan, azione fantastica, musica di R. Marenco. 14 marzo: nasce a Ulm Albert Einstein.
20 marzo: Mosca: Ciajkovskij, Evgenij Onegin. Marzo: nasce la Società Orchestrale del Teatro alla
Scala diretta da Franco Faccio.
10 aprile: muore a Milano Bartolomeo Merelli. Maggio: Vaucorbeil viene nominato direttore
dell'Opéra di Parigi.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
sua influenza sui Balcani. La Gran Bretagna rifiuta la pace di S. Stefano; nascono dissidi fra Russia
e Austria per l'influenza sui Balcani.
Aprile: abortisce nel Matese il tentativo di un'insurrezione popolare guidata da internazionalisti.
13 giugno - 13 luglio: al congresso di Berlino viene discussa "la questione d'Oriente"; il trattato di
S. Stefano viene modificato a svantaggio della Russia; vengono confermate l'indipendenza della
Romania e della Serbia, e viene costituito il nuovo stato della Bulgaria. La Gran Bretagna ottiene
Cipro dalla Turchia, la Russia la sola Bessarabia, l'Austria l'amministrazione della BosniaErzegovina.
8 agosto: viene ucciso sul monte Labro in Toscana Davide Lazzaretti, riformatore religioso,
fondatore di una "repubblica di Dio". Il suo movimento viene represso con le armi.
Ottobre: in Germania per iniziativa di Bismarck vengono promulgate leggi eccezionali contro il
movimento socialista.
Terrorismo in Europa: attentati contro Guglielmo I di Germania e Alfonso XII di Spagna.
17 novembre: a Napoli attentato del cuoco Giovanni Passanante, repubblicano, contro Umberto I.
Bombe di aderenti repubblicani a Firenze e a Pisa.
11 dicembre: cade il governo Cairoli sostituto da Depretis.
Secondo un censimento del ministero di agricoltura industria e commercio esistono in Italia 2.091
società di mutuo soccorso.
T A. Edison inventa la lampadina a incandescenza.
Il tedesco K. Benz costruisce un triciclo con motore a scoppio.
In Inghilterra il metodista W. Booth fonda l'"Esercito della salvezza".
1879
In Italia vengono perseguitati repubblicani e socialisti, con numerose e durissime condanne.
Primi di giugno: abbondanti piogge causano una disastrosa alluvione del Po; particolarmente gravi
i danni arrecati nelle terre del mantovano e del ferrarese.
In Francia Mac-Mahon è costretto alle dimissioni.
Viene stipulata un'alleanza difensiva fra Germania e Austria in funzione anti-russa.
Fondazione del Partito Operaio Francese.
Scoppia la guerra del Pacifico fra Cile, alleato con l'Argentina, e il Perù, alleato con la Bolivia.
21 dicembre: nasce in Georgia Josif Stalin.
Karl Friedrich Benz inventa un motore a combustione interna alternativo a due tempi.
Il tedesco Georg Cantor elabora la teoria degli insiemi.
K. Fahlberg scopre la saccarina, mettendone poi a punto il primo processo di sintesi.
Cronologia 1880
Giuseppe Verdi
2 luglio ca.: Verdi riceve Boito, che gli illustra il libretto di Otello. Pochi giorni dopo Boito gli reca
lo schizzo; dopo averlo esaminato il maestro lo giudica eccellente.
5 agosto: nasce Giuseppina, figlia di Maria e Alberto Carrara.
3 settembre: GV a Filippi:"Pel momento non ho nissuna volontà di scrivere; ma domani potrei
benissimo mettermi al lavoro sia d'un'Opera, d'un Salmo, d'una Messa, E...] magari d'un'Opera
buffal... Un'Opera buffa mia sarebbe cosa divertente assai... almeno prima d'andare in scena".
4 settembre: a Ricordi, sconsigliandolo dal venire con Boito a S.Agata per discutere di Otello:"voi
siete già andato troppo oltre, e bisogna fermarsi prima che nascano pettegolezzi e disgusti. A mio
avviso, il miglior partito LI è quello di mandarmi il Poema fmito, affinché io lo possa leggere, e
manifestare con calma la mia opinione senza che questa impegni nissuna delle due parti".
3-4 ottobre: riceve la visita di Vaucorbeil; gli accorda il consenso di rappresentare l'Aida all'Opera.
19 ottobre: Carnale Saint-Saéns deplora in un articolo sul "Voltaire" che l'Opera spenda tempo e
denaro per un'opera senza avvenire come Aida; nel quadro di un progressivo deterioramento dei
rapporti italo-francesi, l'articolo suscita polemiche; le trattative del Regio di Torino per
rappresentare il Sansone e Dalila (opera ancora sconosciuta in Francia) vengono sospese in attesa
di occasione più propizia.
Primi di novembre: vengono alla luce alcune malefatte compiute da Mauro Corticelli nei confronti
di una domestica del maestro.
1 8 novembre: GV riceve da Boito il libretto di Otello.
20 novembre: a Milano per pochi giorni, discute con Boito il libretto dell'Otello; ne fa acquisto e
per il momento lo ripone in portafoglio.
2 dicembre: Boito fa atto di cessione a GV del libretto di Otello, ponendo la propria penna a
disposizione di tutte quelle modifiche che al maestro parranno necessarie.
18 dicembre: Giuseppina informa l'amica Negroni Morosini Prati dell'acquisto del libretto di
Otello:"lo comperò ma lo mise accanto al Re Lear del Somma, che dorme da trent'anni nel suo
Portafoglio, sonni profondi e non turbati. Cosa succederà di quest'Ote//o? Se sa minga.Vorrei che
Verdi potesse lasciarlo dormire come il Re Lear altri trent'anni, e poi si sentisse tanto vigore e
coraggio da musicarlo a gloria dell'arte sua".
23 dicembre: Mauro Corticelli lascia definitivamente S.Agata.
23 dicembre: GV spedisce a Ricordi il Pater noster "volgarizzato da Dante" per coro a cinque
parti.
1880
27 gennaio: spedisce a Ricordi l'Ave Maria,"volgarizzata da Dante", per voce sola e archi.
12 febbraio: parte con Giuseppina per Parigi e inizia le prove per l'Aida in francese all'Opéra;
apporta un'aggiunta ai ballabili del secondo atto.
22 marzo: dirige Aida in francese all'Opera. Viene nominato Grand Ufficiale della Legion d'onore.
5 aprile: partito da Parigi, sosta una settimana a Torino per visitarvi l'esposizione.
1 1 aprile: gli viene conferito da Umberto I il titolo di Cavaliere di Gran Croce.
12 aprile: si reca a Milano per iniziare le prove del Pater noster e dell'Ave Maria.
18 aprile: Milano, Scala: prima esecuzione del Pater noster e dell'Ave Maria, entrambi su testo da
GV ritenuto "volgarizzato da Dante"; al maestro viene conferita la cittadinanza onoraria milanese. Allo scultore
Francesco Barzaghi viene affidato l'incarico di fare una statua marmorea di GV da collocare, con
quella di Bellini, nell'atrio della Scala
accanto alle statue di Donizetti e di Rossini.
20 aprile: GV rientra a Genova. Il 4 maggio si trasferisce con Giuseppina a S.Agata. Poi torna a
Torino per visitare l'esposizione.
22 luglio: a Milano Corticelli tenta il suicidio gettandosi nel naviglio, ma viene subito salvato; GV
lo soccorrerà con un mensile.
15 agosto: ricevute da Boito le modifiche al libretto di Otello, gli propone una modifica al finale del
3° atto: un
Arte e Cultura
1° novembre: Amburgo, Stadttheater: A. Rubinstein, Nerone.
15 novembre: Napoli, Bellini: prima rappr. italiana della Carmen di Bizet.
9 dicembre: muore a Roma Emilio Angelini, primo violino e direttore d'orchestra molto
apprezzato da GV. Bedrich Smetana, La Moldava, poema sinfonico.
Ibsen, Casa di bambola, dramma. - Edoardo Ferravilla, La class di asen, commedia in dialetto
milanese. - Meredith, L'egoista, romanzo. August Strindberg, La camera rossa, romanzo.
G. Carducci, Giambi ed epodi, poesie. - Gabriele d'Annunzio, Primo vere, poesie.
G. Dupré, Pensieri sull'arte e ricordi autobiografici. Vengono scoperte le pitture preistoriche delle
grotte di Altamira in Spagna.
Viene fondato a Roma il periodico "Fanfulla della Domenica".
Politica, Società, Scienza, Scoperte
L. Pasteur scopre il principio della vaccinoprofilassi. L'inglese H. J. Lawson costruisce la prima
bicicletta a due ruote uguali, dotate di catena di trasmissione. Werner von Siemens costruisce il
primo tram elettrico.
1880
13 gennaio: Firenze, Pagliano:Auteri-Manzocchi, Stella. 21 febbraio: Venezia, Fenice: Luigi Ricci
jr: , Cola di Rienzo. 20 marzo: Milano, Manzoni: Eugenio Checchi, // piccolo Haydn, commedia.
7 aprile: muore a Parigi Marie Escudier.
Agosto: festa di Piedigrotta: Luigi Denza, Funicolì funicolà, canzone per l'inaugurazione della
funicolare del Vesuvio.
29 settembre: nasce a Parma Ildebrando Pizzetti. 5 ottobre: muore a Parigi Jacques Offenbach. 26
dicembre: Milano, Scala: Ponchielli,11 figliuol prodigo. 26 dicembre: Brahms, Ouverture tragica.
Dicembre: l'editore Sonzogno fonda il mensile "Il Teatro illustrato".
28 dicembre: Parigi, Bouffes-Parisiens: Edmond Audran, La mascotte, operetta.
C. Franck, Les béatitudes, oratorio.
Wagner completa La mia vita.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
L. Pasteur scopre il principio della vaccinoprofilassi.
L’inglese H.J. Lawson costruisce la prima bicicletta a due ruote uguali dotate di catena di
trasmissione.
Werner von Siemens costruisce il primo tram elettrico.
1880
In Francia vengono varate riforme a carattere laico e repubblicano; amnistia per i "comunardi",
scioglimento dell'ordine dei Gesuiti, si celebra per la prima volta come festa nazionale la presa
della Bastiglia; la Marsigliese diventa inno nazionale.
In Gran Bretagna cade il governo Disraeli; gli succede Gladstone.
In Inghilterra l'istruzione primaria viene resa obbligatoria.
Nell'Africa del sud i Boeri delTransvaal entrano in guerra contro gli Inglesi.
Inizia l'occupazione francese e belga del Congo. Esposizione internazionale di Parigi.
Francesco Negri realizza un apparecchio per la microfotografia e il teleobiettivo.
Il medico francese Charles Laveran identifica il plasmodio, protozoo agente della malaria.
Cronologia 1881
Giuseppe Verdi
assalto improvviso dei turchi;"il pezzo musicale vi sarebbe", ma "il Critico avrebbe molte
osservazioni a fare. L.] Sono scrupoli questi, o serie osservazioni?".
7 settembre: a Ricordi, che vorrebbe venire a S. Agata con Boito per l'Otello, Giuseppina
raccomanda pazienza: "Si può dire che Verdi è entrato alla cieca e senza volerlo in questa specie di
rete. [...] da una semplice parola lanciata col bicchiere dell'allegria alla mano è nato un libretto.
Verdi lo ha preso, e benché senza impegno l'ho più volte sentito dire, non senza malumore: lo mi
lego troppo [...] non voglio esser costretto a fare quello che non vorrei".
14 settembre: all'Arrivabene:"Ho molte case coloniche in ruina [...]. Mi sono messo in mente,
tanto che vi è tempo, di ripararle, di fabbricarne [...]. Così io faccio l'architetto, il mastromuratore, il fabbro-ferraio, un po' di tutto. [...] del perfido Jago non si parla per ora".
14 ottobre: nel ricevere una nuova versione del Finale Terzo di Otello sollecita Boito a rispondere
agli "scrupoli" manifestati nella lettera di agosto.
18 ottobre: Boito, pur non rifiutando la proposta del maestro in quanto la musica "ha una logica
sua propria", la sottopone a una serrata analisi drammaturgica osservando: "Quell'attacco dei
Turchi mi dà l'impressione come d'un pugno che rompe la finestra d'una camera dove due persone
stavano per morire asfissiate".
Metà novembre: GV con la moglie si trasferisce a Genova.
20 novembre: a Ricordi, che nuovamente insiste per dare Simon Boccanegra alla Scala, fa presente
la necessità d'avere cantanti esperti; inoltre lo spartito, "troppo triste troppo desolante", richiede
radicali modifiche, rifacendo il secondo atto. Quanto al secondo atto, chi potrebbe rifarlo? e come?
Si sovviene di due lettere di Petrarca che implora il Doge di Venezia e il Doge di Genova di non
intraprendere una guerra fratricida:"Sublime questo sentimento d'una Patria Italiana in
quell'epoca!".
24 novembre: Ricordi comunica al maestro che quanto al libretto del Simone Boito gli si è
dichiarato "pronto a fare tutto ciò che Verdi può desiderare".
2 dicembre: GV apprezza il nuovo Finale Terzo con lo svenimento di Otello; ma intanto sollecita
Boito a pensare alla revisione del libretto del Simone.
8 dicembre: Boito propone e illustra due idee per la revisione del Simone: o la scena del Senato, con
la citazione delle lettere di Petrarca, o quella della chiesa di S. Siro; ma non nasconde che il
compito è assai arduo:"ll dramma che ci occupa è storto, pare un tavolo che tentenna, non si sa da
che gamba. [...] Non trovo in questo dramma nessun carattere di quelli che ci fanno esclamare: è
scolpito! [...] V'è molto intrigo e non molto costrutto".
1 1 dicembre: o il Senato o S. Siro o far nulla; GV risponde a Boito che ragioni professionali non gli
consentono di abbandonare il progetto di aggiustare il Simone; trova stupendo l'atto di S. Siro, ma
per motivi di tempo bisogna attenersi alla Scena del Senato:"Infine tentiamo [...]. Noi non siamo
poi tanto inesperti, da non capire, anche prima, cosa sarà per succedere sul Teatro".
28 dicembre: riceve da Boito la Scena del Senato, che trova bellissima, "piena di movimento, di
color locale. con versi elegantissimi e potentissimi".
1881
8 gennaio: GV comunica a Boito i pezzi del Simone che intende cambiare o togliere, e chiede nuovi
versi per le parti da rifare.
9-17 gennaio: serrata corrispondenza fra GV e Boito per il rifacimento del libretto del Simone.
5 febbraio: GV a Boito:"Non abbiamo finito!!!!"; continua la revisione del Simone con nuovi ritocchi
al primo e al terzo atto. Allo stesso tempo Boito osserva che "ora è la quarta gamba che tentenna",
cioè l'ultimo atto.
6 febbraio: acconsente ad aggiustare anche la "quarta gamba".
9 febbraio: compie un rapido viaggio a Milano per sentire una replica dell'Emani alla Scala onde
giudicare i cantanti previsti per il prossimo Boccanegra. Rientra subito a Genova.
15 febbraio: "Non abbiamo ancor finito!"; 0V e Boito affrontano gli ultimi aggiustamenti al
libretto.
21 febbraio: 0V porta a termine la revisione del Simone. Intanto a una proposta di Ricordi per
l'allestimento della luminaria nell'ultimo atto, risponde scettico: "io non ho mai avuto la fortuna di
vedere ben montata una mia opera alla Scala... Perfino l'Aida flì meglio rappresentata in una
piccola città di Provincia, Parma, che a Milano".
24 febbraio: si reca con Giuseppina a Milano per iniziare le prove del Simone alla Scala.
Arte e Cultura
Francesco Paolo Tosti viene nominato maestro di canto della casa reale inglese.
John Hullah„Storia della musica moderna, trad. it. di A. Visetti.
Giuseppe Gabusi espone un nuovo trombone, il gabusifono.
E Dostoevskij, I fratelli Karamazoff, romanzo. - Zola, Nana, romanzo.
Paolo Mantegazza, Fisiologia del piacere.
Arnold Bócklin, L'isola dei morti, dipinto. - Federico Zandomeneghi, Place d'Anvers, dipinto.
1881
4 gennaio: Brahms, Ouverture accademica.
17 gennaio: muore al Cairo l'egittologoAuguste Mafiettc Gennaio: nasce la Società Orchestrale di
Napoli diretta da Giuseppe Martucci.
Febbraio: Romeo Orsi presenta il clarinetto a doppia tonalità (Si bem. e La).
10 febbraio: Parigi, Offenbach, I racconti d'Hoffmann. 1 1 febbraio: Milano, Scala: Manzotti,
Excelsior, ballo, musica di R. Marenco.
22 marzo: va in fiamme il teatro di Nizza; numerose le vittime.
25 marzo: nasce in Transilvania Béla Bartók.
28 marzo: muore a S. Pietroburgo Modest P Musorgskij. 30 marzo: muore a Roma l'impresario
Vincenzo Jacovacci.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
1881
1° marzo: viene assassinato lo zar Alessandro II; gli succede il figlio Alessandro III, fautore di una
politica reazionaria.
Maggio: i Francesi occupano Tunisi, e ne impongono il protettorato, suscitando la viva irritazione
del governo italiano, che inizia un avvicinamento a Prussia e Austria.
3 agosto: la Gran Bretagna riconosce l'autonomia del Transvaal.
Nuovo accordo tra Prussia, Austria e Russia sulla "questione d'Oriente".
In Francia viene introdotta la scuola primaria gratuita e laica. A Londra si tiene il congresso
anarchico.
Nel Sudan scoppia una rivolta antiegiziana guidata dal Mahdi.
Esposizione industriale di Milano.
Cronologia 1882
Giuseppe Verdi
24 marzo: Milano, Scala: prima rappr. del Simon Boccanegra nella nuova definitiva versione. 30
marzo: dopo la terza recita del Simone GV e consorte rientrano a Genova.
Marzo: Vincenzo Torelli comunica a GV la notizia della morte dell'amico Cesarino De Sanctis.
3 aprile: GV si reca per alcuni giorni a S.Agata. Il 27 torna a Milano con la moglie per visitare
l'Esposizione; quindi rientra a S.Agata.
27 maggio: all'Arrivabene alludendo all'occupazione di Tunisi.da parte dei Francesi:"Credi tu che
vorrei andare in questo momento in quel paese [Francia]? Mai!... per tutto l'oro del mondo!
Abbiamo ricevuto un gran schiaffo!".
7 giugno: a Giuseppe Perosio, che lo informa del successo di Attila a Genova:"Voi siete molto
indulgente: non crediate però che io disdegni troppo i lavori di quell'epoca. Certo che ora non li
farei, né vorrei farli in quel modo, pure...".
17 giugno: Boito lo informa d'aver ripreso a lavorare al libretto di Otello.
5 luglio: GV riceve a S. Agata una visita di Boito insieme a Faccio e a Giulio Ricordi; tema
principale dei colloqui uno scambio d'idee sull'"ultimo punto dubbioso" del libretto di Otello.
24 agosto: Boito presenta a GV una nuova stesura del Finale Terzo di Otello, con la parte lirica e
quella drammatica fuse insieme:"La figura principale del lato lirico è Desdemona, la figura
principale del lato drammatico è Jago".
27 agosto: GV risponde approvando:"Molto moltissimo bene il Finale. Quanta differenza da questo
al primo!". 30-31 agosto ca.: torna a Milano per visitare le due Esposizioni, Industriale e Artistica,
allestite ai Giardini Pubblici.
1° settembre: s'incontra con Boito; insieme vanno a visitare lo stabilimento Pelati, costruttore di
strumenti d'ottone; visita inoltre al Conservatorio l'Esposizione Musicale, dove incontra Henri
Herz, celebre pianista e costruttore di pianoforti, cui suona alcune battute di una sua composizione
che aveva suonato all'esame di ammissione al Conservatorio milanese.
24 settembre: insiste col pittore Morelli perché faccia un ritratto di Jago: "se io fossi Attore, ed
avessi a rappresentare Jago, io vorrei avere una figura piuttosto magra e lunga, labbra sottili, occhi
piccoli vicini al naso come le scimie, la fronte alta che scappa indietro, e la testa sviluppata di
dietro: il fare distratto, nonchalant, indifferente a tutto, frizzante, dicendo il bene e il male con
leggerezza ed avendo l'aria di non pensare nemmeno a quel che dice".
25 ottobre: nell'atrio della Scala di Milano si tiene la cerimonia d'inaugurazione delle statue di
Bellini e di GV.
29 ottobre: GV alla Maffei:"m'occupo di campi, di fabbriche, di terreni, e così passa la giornata
senza fare forse niente d'utile".
22 novembre: con la moglie si trasferisce a Genova.
10 dicembre ca.: in vista della ripresa del Simon Boccanegra alla Scala, si reca con Giuseppina a
Milano per risistemare l'orchestra e ridefinire la messinscena. Il 22 fa ritorno a Genova.
25 dicembre: per stimolare GV a comporre l'Otello, Ricordi ricorre all'espediente di inviargli per
Natale un panettone con sopra disegnato un moro di cioccolata.
1882
21 gennaio: rifiuta di far parte della commissione per l'arte musicale e drammatica istituita dal
ministro Baccelli, ma invia alcuni suggerimenti a Piroli, osservandogli fra l'altro (2 febbraio):"La
nostra musica, a differenza della Tedesca, che può vivere nelle Sale colle Sinfonie, negli
appartamenti coi quartetti, la nostra, dico, ha il suo seggio principalmente neiTeatri".
2 maggio: si reca a Parigi per controllare la questione dei suoi diritti d'autore dopo la morte di
Léon Escudier e per affrontare il problema della riduzione di Don Carlos con il librettista Nuitter,
il quale in realtà funge da tramite fra GV e Du Lock, i loro rapporti essendosi guastati dopo Aida.
18 maggio: parte da Parigi; sosta a Torino; arriva a S.Agata il 21.
14 giugno: informa Nuitter che nella riduzione di Don Carlos da 5 a 4 atti non è solo necessario
tagliare, ma anche modificare alcune cose; in particolare l'imbroglio del Frate "mezzo ombra e
mezzo uomo" e il duetto Posa - Filippo. da rifare completamente.
18 giugno: per la prima volta si reca alle cure termali di Montecatini con la consorte e con Teresa
Stolz, prendendo alloggio alla Locanda Maggiore. Il 10 luglio ca. rientrano a S.Agata.
Arte e Cultura
Aprile - maggio: Mostra musicale di Milano all'interno dell'Esposizione industriale.
25 maggio: il Mefistofele di Boito ritorna nella nuova versione alla Scala, e ottiene successo.
1 1 giugno: Praga, inaugurazione del Teatro Nazionale: B. Smetana, Libussa.
16-22 giugno: Milano, Congresso dei musicisti italiani: le questioni riguardano gli strumenti
d'orchestra (contrabbasso a 4 corde, corno naturale e a macchina, trombe e cornette, clarinetto,
trombone, bass-tuba) e l'unità del diapason (prevale il parere a favore del diapason a 864 vibrazioni
semplici).
22 giugno: muore a Parigi Léon Escudier.
Luglio: Carlo Collodi inizia a pubblicare a puntate sul "Giornale per i bambini" le Avventure di
Pinocchio. Storia di un burattino.
30 agosto: muore a Livorno Pietro Cossa.
24 ottobre: Roma, Valle: E. Cavallotti, Il "Cantico dei Cantici", commedia in versi.
17 novembre: Parigi, Vaudeville: Sardou, Odette, commedia.
8 dicembre: incendio del Ringtheater di Vienna, che provoca 400 vittime.
29 dicembre: esce a Trieste il primo numero del quotidiano "Il Piccolo ".
Nasce a Roma la Società del Quintetto fondata da Giovanni Sgambati.
Giuseppe Pelitti sr. costruisce il "trombone contrabbasso Verdi" dietro suggerimento del maestro.
Ibsen, Gli spettri, dramma.
A. Fogazzaro, Malombra, romanzo. - A. France, Il delitto di Silvestro Bonnard, romanzo. - Neera
(Anna Radius Zuccari), Castigo, romanzo. - Giovanni Verga, I Malavoglia, romanzo.
Guy de Maupassant, La casa Tellier, racconti.
Gemito, L'acquaiolo, scultura.
1882
10 gennaio: muore lo scultore Giovanni Dupré.
7 febbraio: Milano, Scala: Antonio Smareglia, Bianca di Cervia.
10 febbraio: S. Pietroburgo: Rimskij-Korsakov, La fanciulla di neve.
11 febbraio: muore il pittore Francesco Hayez.
18 marzo: nasce a Venezia Gian Francesco Malipiero. 14 aprile: Parigi, Opéra:Thomas, Francesca
da Rimini.
18 giugno: nasce a Oranienbaum (Pietroburgo) Igor Strawinsky.
Giugno: Arthur Pougin, Giuseppe Verdi. Vita aneddotica, con note ed aggiunte di Folchetto.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
1882
In Italia viene varata la legge per l'allargamento del voto elettorale (da 600.000 a 2 milioni di
elettori).
30 gennaio: nasce a Hyde Park Franklin Delano Roosevelt.
25 maggio: viene firmata segretamente a Vienna la Triplice Alleanza fra Germania, AustriaUngheria e Italia "per il sistema dell'ordine su basi monarchiche e contro la repubblica sociale".
2 giugno: muore a Caprera Giuseppe Garibaldi.
Giugno: agitazioni e scioperi di contadini nelle campagne della bassa parmense e del cremonese; si
invoca la repubblica.
Giugno: scoppia in Alessandria d'Egitto una violenta rivolta contro gli europei.
Cronologia 1883
Giuseppe Verdi
16 agosto: a lloito che gli comunica il desiderio manifestatogli da un critico musicale di prenotarsi
per la traduzione francese dilago, accenna alla difficoltà di tradurre il verso sciolto italiano essendo
i francesi "obbligati alla rima" e risultando quindi "quasi impossibile conservare il senso letterale,
colla frase e l'accento musicale": ma infine "perché parlare ora d'un'opera che non esiste?".
21 settembre: dopo aver ricevuto da Nuitter il progetto analitico delle modifiche da apportare al
Don Carlos, propone di sopprimere il primo atto.
23 settembre: inizia un fitto carteggio con Nuitter per il rifacimento di Don Carlos; basandosi sulla
traduzione di Maffei, GV cerca di ripristinare nel duetto Posa - Filippo il testo originale di
Schiller.
16 ottobre: decide di fare una seconda partitura di Don Carlos e si fa mandare da Ricordi copia
della partitura della precedente versione.
28 ottobre - 16 novembre: è ancora alle prese col rifacimento del duetto Posa - Filippo, che gli"dà
grandissimo pensiero". 20 novembre ca.: si trasferisce con la moglie a Genova.Affronta le
modifiche del quarto atto, ora diventato terzo.
1° dicembre: nel proporre il taglio delle prime scene del vecchio quarto atto, precisa:"In quanto a
rendere meno odiosa Eboli io sono sempre del parere che i caratteri anche i più odiosi bisogna
mostrarli al Publico come sono. Eboli non è e non può essere che una coquine!".
2 dicembre: comunica a Nuitter che la scena della Sommossa dovrà essere rapidissima "1° perché
non vi può essere interesse musicale; 2° perché sarebbe impossibile lasciare lungamente Posa
sdrajato per terra dopo aver cantato un'aria faticosissima".
7-15 dicembre: affronta le modifiche del terzo e dell'ultimo atto del Don Carlos.
20 dicembre: da qualche tempo sta facendo costruire a proprie spese un ospedale aVillanova
d'Arda; a Piroli:"i poveri ammalati di questo comunello non hanno altro ospedale che quello di
Piacenza, città distante 34 o 36 chilometri: e questi poveretti la maggior parte, muoiono per
istrada. Un giorno, parlando col Sindaco di queste miserie, dissi che avrei pensato io a costruire
qualche locale, un ricovero, qualche cosa infine per essere utile a questi infelici".
25 dicembre: a Ricordi, che gli ha inviato un panettone sormontato (con allusione a Otello) da un
moro di cioccolata... senza gambe:"Io credo invece che manchino gambe testa, torace, braccia,
tutto, tutto, tutto. [...1 ora mi occupa molto questo benedetto D. Carlos, che è osso più duro di
quello che credevo".
1883
8 gennaio: ancora alle prese con le modifiche dell'ultimo atto di Don Carlos, comunica a Nuitter di
aver terminato il primo atto.
11 gennaio: spedisce a Ricordi il primo atto del Don Carlos nella versione in 4 atti raccomandando
di tenere "ove si può, la vecchia traduzione".
26 gennaio: apporta modifiche ai versi di Eboli nella sua scena con Elisabetta e fa chiedere a
Nuitter se Du Lode è disposto a cedergli la proprietà del nuovo libretto per l'estero; intanto
spedisce a Ricordi il secondo atto.
4 febbraio: Du Lock accorda la cessione della proprietà del libretto di Don Carlos, riservandosi i
diritti d'autore per le rappresentazioni dell'opera in francese.
12 febbraio: è alle prese con la Sommossa, che intende accorciare; spedisce la prima parte del terzo
atto.
15 febbraio: è profondamente colpito dalla morte di Wagner,"una grande individualità che
sparisce! Un nome che lascia un'impronta potentissima nella Storia dell'Arte!".
19 febbraio: spedisce il quarto atto a Ricordi:"Non vi stupisca veder tolto il Coro Finale degli
Inquisitori. Non erano che note. Il Dramma non aveva bisogno né di quelle note, né di quelle
parole.Al contrario. - Portati gli avvenimenti a quel punto bisognava calar presto il sipario. [...]
Carlo V appare vestito da Imperatore!! Non è verosimile. L'Imperatore era già morto da diversi
anni. Ma in questo dramma, splendido per forme e per concetti generosi, tutto è falso [.. 1 nulla vi
è di storico, né vi è la verità e profondità Shaespiriana dei caratteri... Allora una di più, una di meno
non guasta nulla; ed a me non dispiace quest'apparizione del vecchio Imperatore!".
23 febbraio: fa sapere a Du l.ocle, tramite Nuitter, che gli è "estremamente riconoscente" e che sarà
felice di stringergli "la mano come in passato"; spedisce la seconda parte del terzo atto
concludendo così la riduzione del Don Carlos da 5 a 4 atti.
15 marzo: all'Arrivabene:"Il D. Carlos è ora ridotto in quattro atti e sarà più comodo, e credo
anche migliore, artisticamente parlando".
Arte e Cultura
26 luglio: Bayreuth: Wagner, Parsifal.
14 settembre: Parigi, Comédie: Henry Becque, I corvi, commedia.
Settembre: ad Arezzo si svolgono solenni celebrazioni del centenario di Guido d'Arezzo, con
l'inaugurazione di un monumento, l'esecuzione di un Inno di Luigi Mancinelli su versi di Boito e la
rappresentazione del Mefistofele.
Novembre: Ricordi pubblica Ideale di Tosti.
11 dicembre: Parigi,Vaudeville:Sardou,Fedora, dramma. George Ohnet, // padrone delle ferriere,
romanzo.
Carducci, Nuove odi barbare.
Gabriele d'Annunzio, Canto novo, poesie.
A Parigi il pittore Giovanni Boldini ritrae Emanuele Muzio con la bacchetta in mano, nell'atto di
dirigere.
1883
23 gennaio: muore a Parigi l'illustratore e incisore Gustave Doré.
13 febbraio: muore a Venezia Richard Wagner.
17 marzo: Milano, Scala:A. Catalani, Dejanice.
14 aprile: Parigi, Opéra-Comique: Delibes, Lakmé. Inizia alla Fenice di Venezia la tournée italiana
della compagnia di Angelo Neumann per la rappr. dell'Anello del Nibelungo di Wagner.
Aprile: l'editore Sonzogno bandisce un concorso, limitato a compositori esordienti, per un'opera in
un atto.
22 maggio: in piazza S. Fedele a Milano viene inaugurata, nel decennale della morte, una statua di
Manzoni.
25 luglio: nasce a Torino Alfredo Casella.
4 settembre: muore a Milano Carlo Tenca.
2 dicembre: Brahms, Terza Sinfonia.
13 dicembre: nasce a Vienna Anton Webern. Milano, Conservatorio: Puccini, Capriccio sinfonico.
Giovanni Verga, Novelle rusticane.
Robert Louis Stevenson, L'isola del tesoro, romanzo. Contessa Lara, Versi.
E Novati,A. Graf e R. Renier fondano il "Giornale storico della letteratura italiana".
Politica, Società, Scienza, Scoperte
17 settembre: inondazioni in Lombardia e nel Veneto; particolarmente gravi i danni provocati
dallo straripamento dell'Adige nel veronese.
16 settembre: viene arrestato l'esule triestino Guglielmo Oberdan rientrato in patria con
l'intenzione di attentare alla viti di Francesco Giuseppe.
Settembre: gli Inglesi reprimono la rivolta egiziana, occupano il Cairo e ristabiliscono il loro
protettorato sull'Egitto.
Ottobre: in Italia alle elezioni politiche si affermano le sinistre;Andrea Costa è il primo deputato
socialista.
A Milano viene fondato il partito operaio italiano.
20 dicembre: condannato a morte, Oberdan viene impiccato. Numerose proteste e manifestazioni in
suo favore.
Il governo italiano acquista dalla Compagnia di navigazione Rubattino il porto di Assab in Eritrea.
In Francia viene promulgata una legge d'indirizzo laico che statalizza l'istruzione elementare ed
esclude gli ordini religiosi dall'insegnamento.
Viene inaugurata la galleria del San Gottardo.
Il medico tedesco Robert Koch scopre il bacillo della tubercolosi.
1883
Gennaio: a Roma manifestazione repubblicana di studenti per un busto a Oberdan fatto
sequestrare dalla polizia.
14 marzo: muore a Londra Carlo Marx.
29 luglio: un terremoto nell'isola d'Ischia distrugge Casamicciola, Forio e Lacco Ameno
provocando numerose vittime. Nasce a Predappio Benito Mussolini.
Si diffondono nella Padania le cooperative di lavoro organizzate dai braccianti.
Alessandro III impone l'uso della lingua russa e l'adesione alla religione ortodossa a tutte le
regioni dell'impero.
La Romania stringe un'alleanza con l'Austria per difendersi dall'influenza russa nei Balcani.
Termina la guerra del Pacifico; il Perù, sconfitto, cede alcuni territori al Cile.
La Francia occupa il Tonchino e impone il protettorato all'Annam.
Robert Koch scopre il vibrione del colera.
Il tedesco E. Klebs scopre il bacillo della difterite. Invenzione della mitragliatrice Maxim.
26 dicembre: la Scala di Milano è il primo teatro a inaugurare un impianto integrale di
illuminazione elettrica.
Cronologia 1884
Giuseppe Verdi
24 marzo: a Ricordi: "finora non ho scritto nulla di questo Jago, o meglio Otello, e non so cosa farò
in seguito".
Aprile: compie una gita a Milano con Giuseppina. È colto da improvviso malore, ma ben presto si
riprende e affretta il ritorno a S. Agata, dove si trasferisce 1'8 maggio.
24 giugno: torna a Milano; il 26 parte per Montecatini. Durante la sosta a Milano vengono avviate
le prime trattative per rappresentare il nuovo Don Carlos alla Scala nella prossima stagione di
carnevale. Il 12 luglio parte da Montecatini; sosta qualche giorno a Firenze, dove visita la
Biblioteca Laurenziana.II 16 rientra a S.Agata.
15 agosto: a Clara Maffei:"E Casamicciola!!! quale strazio! quale immensa sventura! [...1 La carità
verrà in soccorso, ed è bene... Vi è entrato l'entusiasmo, la voga, la moda e si farà molto [...1.
Speriamo poi che i comitati, invece di distribuirne le somme ai poveri, non formino capitali alle
banche".
Ottobre-novembre: discute con Ricordi scene e cantanti per il nuovo Don Carlos alla Scala.
Primi di dicembre: si trasferisce a Genova. Il 18 si reca a Milano con la moglie per iniziare le prove
del Don C'arlos in 4 atti.
1884
10 gennaio: Milano, Scala: prima rappr. del Don Carlos nella versione in 4 atti. Il 17 rientra a
Genova con la moglie. 24 gennaio: riceve una visita di Boito; riprende il dialogo per Otello.
10 febbraio: al presidente della commissione per l'adozione di un diapason ufficiale:" vorrei che un
solo corista venisse adottato in tutto il mondo musicale. La lingua musicale è universale".
16 febbraio: muore a Napoli Vincenzo Torelli.
20 marzo: da Napoli Boito informa Ricordi:"il Maestro scrive, anzi ha già scritto buona parte del
principio del 1° atto e mi sembra infervorato".
24 marzo: una dichiarazione sfuggita a Boito nel corso di un banchetto in suo onore a Napoli, e
travisata da un cronista, raffredda improvvisamente i rapporti del poeta con GV: interrogato su
Jago che sta scrivendo per GV, Boito avrebbe espresso "rammarico di non poter essere egli il
maestro destinato a metterlo in musica".
27 marzo: l'intervista fa il giro di alcuni giornali; GV la legge e scrive subito a Faccio:"mi rivolgo a
voi, al più antico, al più saldo amico di Boito" affinché quando ritornerà a Milano gli diciate a voce,
non per iscritto, che io senz'ombra di risentimento, senza rancore di sorta gli rendo intatto il suo
manoscritto. Più essendo quel libretto di mia proprietà, glielo offro in dono qualora egli intenda
musicarlo".
19 aprile ca.: in una lunga lettera Boito manifesta a GV indignazione per il modo con cui un
giornalista ha frainteso le sue parole, così "da costruirne una frase che sta precisamente agli
antipodi del mio sentimento" e gli riferisce quali furono le sue esatte parole, così concludendo: "Lei
è più sano di me, più forte di me, abbiamo fatto la prova del braccio e il mio piegava sotto il suo, la
sua vita è tranquilla e serena, ripigli la penna [...) saprò lavorare per Lei, io che non so lavorare per
me".
26 aprile: GV accetta le spiegazioni di Boito; ma intanto la "conclusione si è, che tutto questo ha
sparso qualche cosa di freddo su quest'Otello, ed ha irrigidita la mano, che aveva cominciato a
tracciare alcune battute".
27-30 aprile: Boito ringrazia GV e ricordandosi di una scena di Jago nel 2° atto di cui non era
contento gli invia, per proprio "conforto" e "soddisfazione personale", i versi del Credo di Jago.
3 maggio: a sua volta GV ringrazia per il Credo, che trova "potentissimo e shaespeariano in tutto e
per tutto". Ma intanto la composizione di Otello è interrotta; riprenderà nel tardo autunno.
6 maggio: si trasferisce con Giuseppina a S.Agata.
10 giugno: all'Arrivabene:"ho sentito a dir molto bene del musicista Puccini [...1. Segue le
tendenze moderne, ed è naturale, ma si mantiene attaccato alla melodia che non è moderna né
antica. Pare però che predomini in lui l'elemento sinfonico! niente di male. Soltanto bisogna andar
cauti in questo. L'opera è l'opera: la sinfonia è la sinfonia, e non credo che in un'opera sia bello fare
uno squarcio sinfonico, pel sol piacere di far ballare l'orchestra".
20 giugno ca.: GV con la moglie si reca a Torino per visitare l'Esposizione. Il 22 assiste a un
concerto sinfonico diretto da Faccio; chiede di poter esaminare la partitura del Mazeppa di Liszt.
29 giugno: partito da Torino con la moglie, si reca a Montecatini.A metà luglio rientrano a
S.Agata.
27 settembre ca.: riceve la visita di Boito e Giuseppe Giacosa, suoi ospiti a S. Agata per circa una
settimana; la visiArte e Cultura
A Roma viene istituita la Galleria Nazionale d'Arte Moderna.
Il ministero italiano della guerra incarica la commissione musicale del ministero della P I. di
stabilire un diapason unico per tutte le bande e fanfare del regno.
1884
7 gennaio: Bruxelles, La Monnaie: Ernest Reyer,Sigurd.
14 gennaio: Torino, Carignano: Giovanni Verga, Cavalleria rusticana (dramma, dalla novella
omonima).
19 gennaio: Parigi, Opéra-Comique: Massenet, Manon.
15 febbraio: Mosca: Ciajkovskij,Mazeppa.
Febbraio: la commissione musicale governativa propone di ridurre il corista "francese" da 870 a
864 vibrazioni semplici.
29 aprile: muore a Hove (Inghilterra) Michele Costa. 9 maggio: muore a Roma Giovanni Prati.
.31 maggio: Milano, Dal Verme: Puccini, Le Villi.
Maggio-giugno: rassegna delle orchestre italiane all'Esposizione Generale Italiana di Torino.
26 agosto: muore a Madrid Garda Gutiérrez.
30 agosto: muore a Lesa il drammaturgo Giulio Carcano.
11 settembre: Torino, Regio: Danesi, Messalina, azione storico-coreografica, musica di C.
Giaquinto.
2 ottobre: Bologna, Comunale: L. Mancinelli, Isora di Provenza.
5 novembre: muore a Parigi la cantante Erminia Frezzolini.
Ibsen, L'anitra selvatica, dramma. Renato Fucini, Le veglie di Neri, racconti.
Xavier de Montépin, La portatrice di pane, romanzo. Matilde Serao, Il ventre di Napoli, romanzo.
- M. Twain, Le avventure di Huckleberry Finn, romanzo.
Anton Cechov inizia a pubblicare i suoi primi racconti.
Verlaine, I poeti maledetti, saggi. - C. Mendès, La leggenda del Parnaso contemporaneo.
Angelo Mosso, La paura, trattato di fisiologia.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
1884
Febbraio: la Gran Bretagna occupa in Africa orientale parte della costa somala.
14 marzo: muore a Biella Quintino Sella.
Agosto: scoppia in Italia un'epidemia di colera, particolarmente persistente a Napoli.
I: esercito italiano viene organizzato in 12 corpi d'armata e 25 divisioni; le spese militari ordinarie
e straordinarie salgono a 402 milioni di lire.
La fucilazione del soldato Salvatore Misdea suscita un'ondata di proteste contro la pena di morte.
La grande crisi agraria scuote la provincia di Mantova col movimento de "La boje!".
In Francia vengono legalizzate le organizzazioni sindacali dei lavoratori e viene approvata una
legge sul divorzio.
In Gran Bretagna una riforma elettorale concede il suffragio universale maschile.
In Africa la Germania estende i suoi protettorati sul Togo e sul Camerun.
Gaetano Mosca, Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare.
Ch. Laveran, Trattato delle febbri palustri.
Il medico tedesco A. Nicolaier scopre il batterio che causa il tetano.
Il francese H. Chardonnet inventa la seta artificiale. Viene costruita la prima linotype.
22 maggio: s'inaugura a Torino l'Esposizione Generale Italiana; e con essa il castello medievale
sulla riva del Po.
Friedrich Engel, L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato.
Jean-Martin Charcot, Lezioni sulle malattie del sistema nervoso.
Cronologia 1885
Giuseppe Verdi
ta riporta tranquillità e reciproca fiducia nei rapporti fra poeta e maestro, che riprendono a
discutere di Otello. Fine novembre: si trasferisce a Genova.
9 dicembre: informa Boito: "M'occupo, e scrivo!!"; e intanto gli chiede versi per il quartetto del 2°
atto di Otello, versi che Boito spedisce rapidamente.
1885
1° gennaio: Boito si trova a Nervi e vi resta fino a tutto marzo; gli incontri con GV, ormai avviato
a musicare l'Otello, sono frequenti.
Fine aprile: nel trasferirsi con la moglie da Genova a S.Agata, GV si ferma a Milano per farsi
estrarre cinque denti e una radice da uno specialista americano.
Aprile-maggio: riceve la visita di Amilcare Ponchielli che riferisce alla moglie:"Si parlò poi
dell'opera di Puccini, il cui genere di musica non ci piace, perché segue le pedate di Massenet,
Wagner etc. - Poi del Mefistofele di cui lodò il Duetto `Lontano lontano', il Quartetto, e certi
dettagli d'istrumentale nell'aria della prigione. Ma nient'altro, e ho capito che la fuga che finisce
l'atto delle streghe non ci piace. Non crede che Boito finirà così presto il Nerone".
28 giugno ca.: si reca con la moglie alle cure termali di Montecatini.A metà luglio rientrano a
S.Agata. 5 ottobre: comunica a Boito d'aver finito il quarto atto di Otello.
16 ottobre: riceve a S.Agata una visita-lampo di Boito e Giulio Ricordi. 27 ottobre: lavora ancora
"attorno al quart'atto".
8 novembre: a Boito - in procinto di recarsi a Vienna insieme al fisico Pietro Blaserna a
rappresentare l'Italia al prossimo congresso internazionale per l'adozione di un diapason ufficiale raccomanda una risoluzione unitaria.
Fine novembre: si reca a Milano con la moglie; ne riparte il 5 dicembre per trasferirsi a Genova.
1886
18 gennaio: a Ricordi:"m'è venuta voglia di ripassare quello che ho fatto dell'Otello... e me ne sono
spaventato per la parte del tenore. In molte e molte cose andrebbe benissimo Tamagno, ma in
moltissime altre no. Vi sono delle frasi larghe, lunghe, legate che vanno dette a mezza voce, cosa
impossibile per Lui".
21 gennaio: a Boito,infòrmandolo sugli incontri avuti con alcuni impresari:"si parla, e mi si scrive
sempre di Jago!!! Ho un bel rispondere: Otello [...]. Per parte mia poi mi parrebbe ipocrisia il non
chiamarlo Otello [...] Se Voi siete della mia opinione, cominciamo dumque a battezzarlo Otello".
18 gennaio: porta a compimento il concertato del 3° atto.
20 febbraio: si reca a Milano per sentire la Bellincioni alla Scala nel Roberto il Diavolo; assiste
anche al ballo Amor di Manzotti. Il 22 rientra a Genova.
14 marzo: Muzio a Ricordi:"Boito entrò nella stanza del Maestro proprio quando era al pianoforte
e che mi faceva sentire per la seconda volta il duetto finale del l° atto [che] ha terminato in questi
giorni".
17 marzo: insieme a Giuseppina e a Muzio si reca a Parigi, prendendo alloggio all'Hètel de Bade,
per ascoltare alcuni cantanti all'Opéra e all'Opéra-Comique in vista di Otello, in particolare Victor
Maurel, cui vorrebbe destinare la parte di Jago, e per saggiare con Du Lode la possibilità di
tradurre il libretto in francese insieme a Boito.
26 marzo: assiste all'Opéra a una replica del Cid di Massenet. Nei giorni seguenti ritorna all'Opéra
per assistere a una recita del Sigurd di Reyer con il tenore Duc e il soprano Rose Caron (sarà lei
Desdemona all'Opéra) nonché all'eArte e Cultura
1885
7 febbraio: Parigi, Renaissance: H. Becque, La parisienne, commedia.
9 febbraio: nasce a Vienna Alban Berg.
15 marzo: Londra: Sullivan,11 Mikado, operetta.
17 marzo: Milano, Scala: Ponchielli, Marion Delorme.
11 maggio: muore a Colonia Ferdinand Hiller. 22 maggio: muore a Parigi Victor Hugo. 7 luglio:
muore a Bari Nicola De Giosa.
24 ottobre: Berlino: Johann Strauss jr., Lo zingaro barone, operetta.
25 ottobre: Brahms, Quarta Sinfonia.
16-17 novembre: Vienna, congresso internazionale
per l'adozione di un diapason ufficiale: viene adottato il
corista a 870 vibrazioni semplici.
27 novembre: muore a Milano Andrea Maffei.
30 novembre: Parigi, Opéra: Massenet, Le Cid.
22 dicembre: nasce a Parigi Edgar Varèse.
C. Franck, Variazioni sinfoniche.
Fogazzaro, Daniele Cortis, romanzo. - Guy de Maupassant, Bel-Ami, romanzo. - Zola, Germinal, romanzo.
S. Lega, La popolana, dipinto.
Muore a Ginevra lo storico svizzero Marc Monnier.
A Bologna viene fondato il quotidiano "Il resto del
Carlino".
Viene fondato a Genova il quotidiano "Il Secolo XIX".
1886
16 gennaio: muore a Milano Amilcare Ponchielli.
17 febbraio: Milano, Scala: Manzotti,Amor, ballo, musica di R. Marenco.
10 aprile: Bruxelles, La Monnaie: Chabrier, Gwendoline, testo di C. Mendès.
30 giugno: Rio de Janeiro, Teatro Imperiale: Arturo Toscanini esordisce come direttore
d'orchestra dirigendo Aula.
31 luglio: muore a Bayreuth Ferenc Liszt.
Novembre: Ricordi pubblica Marechiare di Tosti e Di Giacomo.
Ibsen, Rosmersholm, dramma. - L. Tolstoj, La potenza delle tenebre, dramma.
E. De Amicis, Cuore, racconti.
Neera, Teresa, romanzo. - Robert L. Stevenson, Lo strano caso del dottor jelgll e del signor Hyde,
romanzo. Nietzsche, Al di là del bene e del male.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
1885
Eliminata la presenza inglese il Mahdi proclama lo "stato mahdista del Sudan" .
5 febbraio: l'Italia occupa Massaua in Eritrea.
Marzo-aprile: scoppiano sommosse contadine nel mantovano, nel cremonese e nel milanese che
degenerano in disordini e tumulti; vengono domate dall'esercito e dai carabinieri, con oltre 50.000
arresti e con lo scioglimento delle associazioni e delle leghe sindacali.
Scoppia una guerra tra Serbia e Bulgaria per il possesso della Rumelia.
Conferenza di Berlino per lo spartimento dell'Africa da parte delle potenze europee. Il Congo viene
riconosciuto stato indipendente sotto proprietà del re del Belgio. La Germania impone il
protettorato alTanganika. la Gran Bretagna conquista la Nigeria. La Germania stabilisce colonie
nelle isole del Pacifico.
A Bombay, in India, il partito nazionalista apre la prima sessione del Congresso nazionale indiano.
Secondo un ulteriore censimento del ministero di agricoltura industria e commercio esistono in
Italia 4.900 società di mutuo soccorso.
L. Pasteur ottiene il vaccino contro la rabbia.
Gottlieb Daimler realizza il motore a benzina.
G.W. Eastman inventa la pellicola fotografica.
Edoardo Bianchi fonda a Milano una società per la produzione di biciclette (e, più tardi, di
motociclette).
I:inglese Francis Galton rileva la diversità individuale delle impronte digitali e ne propone una
classificazione.
1886
18 aprile: dopo oltre un decennio di discussioni e di rinvii viene approvata in Italia una legge che
riconosce lo stato giuridico delle Società operaie di mutuo soccorso.
In Francia, promosso dal ministro della guerra Georges Boulanger, si afferma un movimento
nazionalista antitedesco.
La Serbia, sconfitta dalla Bulgaria, rinuncia al possesso della Rumelia.
In Gran Bretagna cade il governo Gladstone, che aveva proposto una limitata autonomia
all'Irlanda.
In Russia la politica antiebraica dello zar favorisce l'esplosione di numerosi "pogrom".
Nasce negli Stati Uniti il primo sindacato nazionale.
Nel Transvaal vengono scoperti importanti giacimenti d'oro, che determinano la penetrazione
britannica nello stato boero.
Dopo sessant'anni di guerre la Gran Bretagna annette la Birmania all'impero indiano.
Cronologia 1887
Giuseppe Verdi
sordio del tenore Juliàn Gayarre nell'Africana di Meyerbeer; si reca anche all'Opera-Comique per
ascoltare Maurel e il tenore Talazac in Zampa di Hérold.
4 aprile: a Piroli:"vado quasi tutte le sere al teatro. È una necessità!! Bisogna ch'io senta questi
giovani artisti che non conoscevo".
Primi di aprile: nel suo studio in piace Pigalle n. 11 il pittore Giovanni Boldini ritrae GV, in abito
nero, senza cappello, le mani posate sulle cosce (il dipinto sarà donato dal pittore al maestro nel
1893 dopo il successo del Falstaff, ora si trova nella Casa di Riposo per Musicisti).
9 aprile: non contento del primo ritratto, Boldini ritrae ancora GV, con il cilindro in testa e la
sciarpa al collo (questo ritratto, di cui l'autore non vorrà mai privarsi, sarà esposto all'Esposizione
universale di Parigi del 1889, alla prima Biennale di Venezia e alla "personale" di New York nel
1897).
11 aprile: GV e consorte partono da Parigi e passano per la Svizzera per vedere la galleria del S.
Gottardo. Il 13 sostano a Milano. Il 16 rientrano a Genova. Il 29 si trasferiscono a S.Agata.
24 giugno: si reca con Giuseppina alle cure termali di Montecatini. l 15 luglio rientrano a S.Agata.
13 luglio: muore a Milano l'amica Clara Maffei.
9 settembre: in procinto di spedire a Ricordi il atto di Otello e parte del 3°, scrive a Boito:"Ho
ripassato una per una le tre prime parti per vedere [...] se stavano dritte e se filano bene... Filano!!
E cosa curiosa! La parte di Jago, salvo qualche eclats, si potrebbe cantare tutta a mezza voce!".
14 ottobre: si reca a Milano per definire i preparativi per l'allestimento scenico e l'esecuzione
musicale di Otello. Il 17 rientra a S.Agata.
18 ottobre: Boito si accinge a tradurre in francese il libretto di Otello per l'esecuzione all'Opera.
24 ottobre: GV sollecita Boito, tramite Ricordi, di risolvere il problema dell'inserimento del
balletto per l'edizione francese di Otello all'Opéra di Parigi.
29 ottobre: a Boito:"Ben trovato il balletto nel second'atto". 1° novembre: comunica a Boito che
l'Otello "è finito!".
Metà novembre: si trasferisce con la moglie a Genova. Il 24 si reca a Milano per alcuni giorni;
incontra Boito e prende accordi per la traduzione francese di Otello, per la quale viene definita la
collaborazione di Du Lock. Il 10 dicembre rientra a Genova.
18 dicembre: spedisce alla tipografia di Ricordi gli ultimi due atti di Otello.
26 dicembre: Modena, Comunale: prima rappr. del Don Carlos nella versione in 5 atti, senza ballo,
con le modifiche introdotte nella versione in 4 atti.
1887
1° gennaio: muore a Roma l'amico Opprandino Arrivabene.
4 gennaio: GV arriva a Milano con la moglie per iniziare le prove di Otello con i cantanti e con
l'orchestra; prende alloggio all'Hòtel de Milan.
27 gennaio: iniziano le prove d'insieme (secondo violoncello è il giovane Arturo Toscanini). 3
febbraio: prova generale dell'Otello.
5 febbraio: Milano, Scala: prima rappr. di Otello. Il re Umberto I conferisce a GV le insegne di
Gran Croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
8 febbraio: riceve dal sindaco di Milano, Gaetano Negri, la cittadinanza onoraria milanese.
13 febbraio ca.: parte per S.Agata. L'Il marzo rientra a Genova.
19 marzo: in occasione del suo onomastico riceve da una delegazione di giornalisti un album
contenente più di trentamila firme "raccolte in tutta Italia dai signori Melzi" di Milano.
14 aprile: la traduzione in francese di Otello è terminata.
16 maggio: GV si trasferisce a S.Agata con la moglie. - 25 giugno ca.: si reca con la moglie a
Milano; il 29 partono per le cure termali di Montecatini.A fine luglio rientrano a S.Agata.
Arte e Cultura
Cesare Pascarella, Villa Gloria, poesie. - Jean Rimbaud. Illuminazioni, versi e poemi in prosa.
Daniele Ranzoni, La principessa di Saint-Léger, dipinto. - Giovanni Segantini, Alla stanga, dipinto.
Auguste Rodin, Il bacio, scultura.
Nel porto di New York viene eretta la Statua della Libertà dello scultore francese Auguste
Bartholdi.
1887
21 febbraio: S. Pietroburgo: Musorgskij, La Chovanscina (rappr. privata).
27 febbraio: muore a S. Pietroburgo Alexandr Borodin.
24 marzo: Roma,Valle: Giacosa, Tristi amori, commedia. 30 marzo: AndréAntoine fonda a Parigi
ilThéàtre-Libre.
23 maggio: muore a Napoli il tenore Gaetano Fraschini.
18 maggio: Parigi, Opéra-Comique: Chabrier, Le mi malgré lui.
25 maggio: a Parigi un incendio distrugge la Salle Favart, sede dell'Opéra-Comique, provocando
numerose vittime.
24 giugno: muore a Milano Filippo Filippi.
27 novembre: Parigi, Porte-St-Martin: Sardou, La Tosca, dramma.
28 novembre: muore a Firenze Marianna Barbieri Nini.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
La Corte Suprema degli Stati Uniti riconosce ad Antonio Meucci la priorità nell'invenzione del
telefono.
G. Daimler costruisce la prima motocicletta.
Karl Friedrich Benz costruisce la prima automobile.
1887
26 gennaio: disfatta di Dogali; il contingente italiano viene sterminato dalle truppe di ras Alula.
Luglio: si forma il primo governo di Francesco Crispi, sostenitore di una politica coloniale,
protezionistica e autoritaria.
29 luglio: muore a Stradella Agostino Depretis.
Bismarck promuove attraverso la Convenzione mediterranea un'alleanza con Italia e Gran
Bretagna, cui aderiscono Spagna e Austria, per il mantenimento dello "status quo" nel
Mediterraneo e l'integrità territoriale della Turchia.
Viene rinnovato il trattato della Triplice Alleanza.
Russia e Germania firmano il trattato segreto "di controassicurazione" per la reciproca neutralità
in caso di guerra contro un terzo paese.
La Gran Bretagna occupa in Africa orientale i territori degli attuali Kenya e Uganda.
Cronologia 1888
Giuseppe Verdi
Agosto: approva la disposizione scenica di Otello, con la prefazione di Boito.
12 settembre: si reca a Milano con la moglie per alcuni giorni. Il 14 rientrano a S.Agata.
5 ottobre: a Boito - che, in procinto di conferire con il ministro Coppino sulla riforma degli istituti
musicali gli aveva chiesto una lista di sei nomi di compositori del passato ritenuti "più adatti per
essere studiati dai giovani" - risponde indicando oltre una dozzina di nomi, in particolare
Palestrina in primis et ante omnia,Carissimi,Alessandro Scarlatti "che ha tesori anche di armonia",
Marcello, Pergolesi, Piccinni, escludendo Monteverdi perché "disponeva male le parti";
raccomanda lo studio della prosodia e della declamazione: "quando si capisce bene quello che si ha
da musicare [...] è più difficile lasciarsi forviare dalle bizzarie e stravaganze".
Metà novembre: si trasferisce a Genova con la moglie.11 21 compie una breve visita a Milano. Il
23 rientra a Genova. Il 29 si reca a S.Agata: a Villanova d'Arda sta per essere completato l'ospedale
che ha fatto costruire a proprie spese.
3 dicembre: rientra a Genova. Il 27 compie una visita di due giorni a Milano.
1888
1° marzo: il caricaturista Melchiorre Delfico gli invia un album di caricature intitolato: Otello,
impressioni.
5 aprile ca.: si reca con la moglie a Milano per alcuni giorni; assiste al terzo concerto della Società
Orchestrale della Scala.
5 maggio: parte da Genova e rientra a S.Agata.A metà giugno si reca con la moglie a Milano. Il 27
partono per le cure termali di Montecatini. L'Il luglio rientrano a S.Agata.
5 agosto: la "Gazzetta musicale di Milano" pubblica una "scala enigmatica" di Adolfo Crescentini.
12-14 settembre: GV si reca a Milano con la moglie per pochi giorni. Fine settembre: ospita a
S.Agata Boito e Giacosa.
Ottobre: a Giovanni Mariotti - promotore della trasformazione della Scuola di Musica di Parma in
Regio Conservatorio - venuto a chiedergli consiglio per la nomina del nuovo direttore, indica due
nomi: Boito (che rifiuta) e Bottesini (che accetta).
5 novembre: viene inaugurato l'ospedale di Villanova d'Arda.
Inizio di novembre: all'avvicinarsi del cinquantenario dell'Oberto la "Perseveranza" propone di
celebrare il "giubileo artistico" di GV.
9 novembre: GV a Ricordi:"Vedo che i giornali stanno parlando di un Giubileo!! Misericordial. Fra
le tante cose
inutili che si fanno al mondo, questa è la più inutile di tutte [A. Più è cosa impraticabile, ed è
un'imitazione forestiera".
Fine novembre: si trasferisce con la moglie a Genova. Il 1° dicembre ca. si recano a Milano. Il 4
rientrano a Genova.
Metà dicembre ca.: compie un'altra visita a Milano; sia questa visita che la precedente sono da
porsi in relazione con le trattative per l'acquisto di un terreno sul quale verrà costruita la Casa di
Riposo per Musicisti.
1889
14 gennaio: firma un contratto con l'architetto Camillo Boito per l'erigenda Casa di Riposo per
Musicisti.
17 febbraio: si rivolge a Boito, membro della commissione per il "giubileo artistico", perché questa
desista dai progetti avanzati: la ripresa dell'Oberto nel giorno anniversario del 17 novembre
("Figuratevi, se il nostro pubblico, con tendenze tanto diverse di quelle di 50 anni fa, potrebbe aver
la pazienza di ascoltare i due lunghi Atti dell'Oberto!") e la fondazione per sottoscrizione nazionale
di un'istituzione volta a sovvenzionare la rappresentazione della prima opera di un giovane
compositore (progetto che ritiene oneroso e impraticabile):"questo Giubileo, oltre essere
sommamente spiacevole per me, non è né utile, né pratico".
19 febbraio: alla Scala viene ripreso l'Otello con nuove scene di Zuccarelli e alcuni miglioramenti
alla messinscena del 2° atto.
Arte e Cultura
Erik Satie, 3 Sarabandes, per pianoforte.
Zola, La terra, romanzo. - Maupassant, Mont-Oriol, romanzo. - Arthur Conan Doyle pubblica il
suo primo romanzo poliziesco, Uno studio in rosso.
A. d'Ancona, Le origini del teatro in Italia.
Il medico polacco Lejzer Ludovik Zamenhof pubblica Doctoro Esperanto, saggi per l'impiego di
una lingua internazionale semplificata.
Viene fondato il quotidiano statunitense "Washington Post".
1888
7 gennaio: Napoli, Fondo: Eduardo Scarpetta. Miseria e nobiltà, commedia.
11 febbraio: Reggio Emilia, Municipale: Franchetti, Asrael.
Maggio: si apre a Bologna l'Esposizione Internazionale di Musica, di cui Boito è presidente
effettivo e GV presidente onorario.
7 maggio: Parigi, Opéra-Comique: Édouard Lalo, Le roi d'Ys.
20 maggio: la Casa Ricordi assorbe la Casa Lucca. 7 settembre: muore a Milano Tito Ricordi.
3 novembre: con decreto governativo viene approvato lo statuto che trasforma la Scuola di Musica
di Parma in Conservatorio.
22 novembre: al teatro Manzoni di Milano Eleonora Duse rappresenta Antonio e Cleopatra di
Shakespeare nella traduzione di Boito.
18 dicembre: muore a Napoli Francesco Florimo.
Rimskij-Korsakov, Sbeherazade, poema sinfonico.
Nietzsche: Il caso Wagner.
Ibsen, La donna del mare, dramma.- Johan Strindberg, La signorina Giulia, dramma.
Verga, Mastro Don Gesualdo, romanzo.
Carducci, Rime nuove. Mario Rapisardi, Epigrammi. Carlo Tenca, Prose e poesie, pubbl. postuma.
Costantino Nigra, Canti popolari del Piemonte.
1889
9 marzo: muore a Milano il commediografo Paolo Ferrari.
13 marzo: muore a Milano il baritono Felice Varesi. Muore a Parigi il tenore Enrico Tamberlick.
21 aprile: Milano, Scala: Puccini, Edgar.
26 giugno: Parigi, Opéra:Thomas, La tempesta, balletto fantastico.
7 luglio: muore a Parma Giovanni Bottesini.
18 agosto: Vienna, Hofoper: Antonio Smareglia, II vassallo di Szigeth.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
La Francia crea l'Unione Indocinese.
Galileo Ferraris scopre il campo magnetico rotante, poi applicato nell'ideazione del motore
elettrico asincrono.
Nobel inventa un nuovo esplosivo, la balistite.
1888
In Italia Crispi dà il via a una profonda riforma dell'ordinamento amministrativo sulla base di un
forte accentramento.
9 marzo: muore il Kaiser Guglielmo I; gli succede il figlio Federico III.
Tra Italia e Francia inizia la "guerra delle tariffe doganali".
15 giugno: muore il Kaiser Federico III; gli succede il figlio Guglielmo II.
Convenzione di Costantinopoli con la quale viene riconosciuta libertà di circolazione di tutte le
navi nel canale di Suez.
In Brasile l'imperatore Pedro II abolisce la schiavitù. Viene inaugurato a Parigi l'Istituto Pasteur.
L'irlandese John Boyd Dunlop costruisce il primo tubo di gomma gonfiabile (pneumatico) da
applicare alle ruote della bicicletta.
Charles Goodyear inventa il processo di vulcanizzazione del caucciù.
G. Daimler costruisce un'automobile a due cilindri.
I: industriale statunitense George Eastman produce la Kodak, prima macchina fotografica portatile
a rullo di pellicola.
1889
30 gennaio: suicidio a Mayerling del principe Rodolfo, figlio primogenito di Francesco Giuseppe.
In Abissinia muore il negus Giovanni IV; con l'appoggio italiano sale al trono il ras Menelik che
trasferisce la capitale ad Addis Abeba.
20 aprile: nasce in Austria Adolf Hitler.
2 maggio: con la "missione scioana" capeggiata da ras Makonnen viene stipulato il trattato di
Uccialli, con il quale vengono genericamente riconosciuti gli interessi dell'Italia in Abissinia.
Cronologia 1890
Giuseppe Verdi
21 febbraio: a Boito, che non assicura di mandare a vuoto il Giubileo ("il paese lo vuole"),
ribadisce:"fui, sono, e sarò sempre contrario alla celebrazione di questo Giubileo".
6 marzo: chiede a Boito di mandargli copia della "scala enigmatica" pubblicata dalla "Gazzetta
musicale di Milano": "Direte che non val la pena di occuparsi di queste inezie, ed avete ragione. Ma
che volete! Quando si è vecchi si diventa ragazzi (...1. E più credo che di questa Scala si potrebbe
fare un pezzo con parole per es. un Ave Maria".
11 marzo: informa Boito di aver armonizzato la "scala enigmatica" a quattro voci utilizzando per
due volte il testo dell'Ave Maria.
18 aprile ca.: si reca a Milano per alcuni giorni; quindi rientra a S.Agata.
Fine giugno: ritorna a Milano; procede all'acquisto di un terreno fuori Porta Magenta; in
compagnia di Boito si reca al Teatro Manzoni per una recita della Pamela nubile di Goldoni,
protagonista Eleonora Duse: in tale occasione manifesta a Boito l'antico desiderio di scrivere
un'opera comica e il suo rincrescimento per non aver potuto trovare un argomento idoneo nel
teatro di Goldoni. Da un racconto posteriore di Giulio Ricordi si apprende che Boito "nulla disse;
ma [...] tornato a casa, in quarantotto ore mise insieme di suo capo la tela di un libretto [Falstaff],
che portò subito a Verdi", ormai in partenza per Montecatini.
4 luglio: si reca con la moglie alle cure termali di Montecatini.
6 luglio: a Boito dopo aver letto il suo schizzo del Falstaff "Benissimo! Benissimo! [...] non si
poteva far meglio di quello che avete fatto Voi. Peccato che l'interesse (non è colpa vostra) non
aumenti sino alla fine. [...] Dico così per dire... e non badate a quel che dico. Ora abbiamo ben altre
cose a communicarci, onde questo Falstaff o Comari che era due giorni fa nel mondo dei sogni, ora
va prendendo corpo, e può diventare una realtà!".
10 luglio: a Boito:"Facciamo addumque Falstaff! Non pensiamo pel momento agli ostacoli, all'età,
alle malattie!", e accoglie il consiglio di Boito di tenere sulla faccenda "il più profondo segreto: [...]
nissuno deve saperne nulla!".
1 1 luglio: a Boito, che ha già apportato alcune modifiche al terzo atto di Falstaff, suggerisce di
concludere, come in Shakespeare, con i "matrimoni" .
23 luglio: rientra a S.Agata da Montecatini.
18 agosto: chiede a Boito di convincere Faccio ad accettare l'incarico di direttore del Conservatorio
di Parma, rimasto vacante dopo la morte di Bottesini; e intanto gli comunica che sta lavorando:"Mi
diverto a fare delle fughe!... Sì signore: una fuga... ed una fuga buffa... che potrebbe star bene in
Falstaff!... Ma come una fuga buffa? Perché buffa? Direte Voi?... Non so come, né perché ma è una
fuga buffa!".
Settembre: Faccio accetta l'incarico di direttore del Conservatorio di Parma.
18 ottobre: GV firma il contratto d'acquisto del terreno posto fuori Porta Magenta per costruirvi
un ospizio per musicisti.
4 novembre: riceve da Boito, in visita a S.Agata, il libretto del 1° e del 2° atto di Falstaff.
Metà novembre: si trasferisce a Genova con la moglie. Il 23 si reca a Milano per non essere
coinvolto nelle celebrazioni genovesi del suo "giubileo artistico". Il 6 dicembre rientra a Genova.
1890
15 febbraio: allarmato per le notizie sul cattivo stato di salute di Faccio, chiede informazioni a
Boito. 3 marzo: si reca per alcuni giorni a Milano. Il 7 rientra a Genova.
8 marzo: ricevuto da Boito il libretto del 3° atto di Falstaff gli invia un compenso; "Se non
arrivassi a finirne la musica, la poesia LA resterà di vostra proprietà".
17 marzo: a Boito:"il primo Atto è finito senza nissun cambiamento nella poesia; tale e quale me
l'avete dato Voi".
10-14 aprile: in un'intervista a un giornalista francese smentisce le voci di stampa secondo cui egli
si appresterebbe a comporre Giulietta e Romeo, un soggetto peraltro molto "tentatore".
15 aprile: apprende da Boito che Faccio, in disperate condizioni di salute mentale, è stato
ricoverato in un nosocomio di Monza, dove già si trova ricoverato il padre.
19 aprile: assiste al Carlo Felice di Genova a una recita dell'Orfeo ed Euridice di Gluck:"sentendolo
non ho potuto a meno di confermarmi che i Tedeschi devono restar Tedeschi, e gli Italiani,
Italiani. [...] Anche allora, epoca in cui non si faceva in teatro che della melodia, o, per dir meglio,
delle frasi melodiche, il tedesco è riuscito meglio nello
Arte e Cultura
24 settembre: muore a Parma lo scenografo Girolamo Magnani.
27 settembre: Rio de Janeiro: Gomes, Lo schiavo.
27 novembre: Berlino, Lessingtheater: Hermann Sudermann, L'onore, dramma.
Dicembre: la commissione esaminatrice del secondo concorso Sonzogno proclama vincitore Pietro
Mascagni con Cavalleria rusticana.
Gustav Mahler, Prima Sinfonia in Re magg.
Richard Strauss, Don Giovanni, poema sinfonico. Ibsen, La donna del mare, dramma. - Maurice
Maeterlinck, La principessa Malena, dramma.
G. D'Annunzio, Il piacere, romanzo. - Carolina Invernizio, Il bacio di una morta, romanzo. Jerome Klapka, Tre uomini in barca, romanzo. - Verga, Mastro don Gesualdo, romanzo. M.Twain, Un americano alla corte di re Artù, romanzo.
Carducci, Odi barbare.
Vincent van Gogh, Notte stellata e Autoritratto col capo bendato, dipinti.
Un'ulteriore indagine statistica del ministero della P I., peraltro lacunosa e imprecisa, registra in
Italia per il periodo 1887-89: 1.927 bande; 120 bande dotate di scuola di musica; 165 fanfare; 61
corali; 25 corali dotate di scuola; 80 accademie e società orchestrali; 17 cappelle; 173 scuole di
musica.
1890
3 gennaio: S. Pietroburgo: Petipa - Ciajkovskij, La bella addormentata, ballo.
8 gennaio: muore a Madrid il baritono Giorgio Ronconi.
10 febbraio: Bruxelles, La Monnaie:Reyer,Salammbó. 17 febbraio: Torino, Regio: Catalani,
Loreley.
3 marzo: Rouen: prima rappresentazione in Francia del Sansone e Dalila di Saint-Saéns.
3 maggio: Parigi, Opéra-Comique: André Messager, La Basoche.
17 maggio: Roma, Teatro Costanzi: Mascagni, Cavalleria rusticana.
21 giugno: Eisenach: Richard Strauss, Morte e trasfigurazione.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
L'Italia occupa la Somalia e ne inizia la colonizzazione. In Italia si verificano i primi fallimenti
bancari; il ministro Miceli nomina una commissione d'inchiesta.
In Italia viene promulgato il nuovo codice penale (codice Zanardelli); entrerà in vigore il 1°
gennaio 1890.
In Francia il ministro Boulanger tenta un colpo di stato, appoggiato da monarchici e clericali;
scoperto, fugge in Belgio.
14 ottobre: viene fondata a Parigi la seconda Internazionale socialista. Per iniziativa
dell'Internazionale in tutto il mondo viene celebrato il Primo Maggio come giornata di lotta dei
lavoratori per la conquista delle otto ore.
A Washington si tiene la prima conferenza panamericana; inizia la penetrazione statunitense
nell'America del Sud.
In Brasile un movimento rivoluzionario detronizza Pedro II e proclama la repubblica degli stati
uniti del Brasile.
Esposizione universale di Parigi; viene terminata la Torre Eiffel.
1890
Febbraio: in Germania viene abrogata la legge contro i socialisti; le elezioni segnano una vittoria
del partito socialdemocratico.
20 marzo: il Kaiser Guglielmo II licenzia Bismarck.
Nell'impero austro-ungarico nasce il movimento dei "Giovani Cechi", guidato da Jan Masaryk, per
la difesa dei diritti della nazione boema.
Nei Paesi Bassi la salita al trono della regina Guglielmina causa il distacco del Lussemburgo, che
si costituisce in granducato indipendente sotto Adolfo Guglielmo di Nassau.
Attraverso una Convenzione la Gran Bretagna cede alla Germania l'isola di Helgoland ottenendo
il riconoscimento della supremazia britannica in Uganda.
Cronologia 1891
Giuseppe Verdi
stromentale. [...] Non ha saputo trovare una melodia calma, larga e sentita come si doveva. Invece
frasi tormentate da modulazioni (modulazioni d'allora) e fredde".
28 aprile: si reca con la moglie a Milano per alcuni giorni; s'incontra con Boito per discutere della
situazione venuta a crearsi al Conservatorio di Parma dopo il ricovero di Faccio in nosocomio. Il 3
maggio ca. si trasferisce a S.Agata.
19 maggio: viene firmato il decreto che nomina Arrigo Boito direttore onorario del Conservatorio
di Parma, in sostituzione di Faccio "cui sarà continuato lo stipendio".
23 maggio: GV ringrazia Boito per aver accettato di supplire Faccio nella direzione del
Conservatorio di Parma."In quanto al pancione Ahi ahi! Non ho fatto nullan "
Fine giugno: GV e la moglie si recano a Milano; il 1° luglio partono per Montecatini.; a metà mese
lasciano Montecatini e rientrano a S.Agata passando per Milano.
6 ottobre: a Boito:"Ho lavorato poco, ma qualche cosa ho fatto. Mi tormentava il Sonetto del
Terz'Atto; e per togliermi questo chiodo dalla testa ho messo da parte il Second'Atto, e
cominciando da quel Sonetto, giù giù una nota dopo l'altra sono arrivato sino alla fine".
14 novembre: muore a Roma Giuseppe Piroli.
20 novembre ca.: (iV con la moglie si reca a Milano.
26 novembre: offre un pranzo alla famiglia Ricordi all'Hòtel de Milan, presenti Giuseppina e Boito;
al momento del brindisi Boito brinda alla salute del pancione. I1 segreto, gelosamente custodito
fino a quel momento, viene rivelato all'attonito editore: il maestro sta componendo il Falstaff. La
notizia della nuova opera viene resa pubblica dal "Corriere della Sera" e divulgata in tutto il
mondo.
27 novembre: muore a Parigi Emanuele Muzio.
Metà novembre: GV e la moglie nel viaggio di trasferimento a Genova si fermano per alcuni
giorni a Milano.
3 dicembre: a Gino Monaldi che gli aveva chiesto notizie del pancione: "Sono quarant'anni che
desidero scrivere
un'opera comica e sono cinquant'anni che conosco Le allegre comari di Windsor.
Ora Boito
[...] mi ha fatto una
commedia lirica che non somiglia a nessun'altra. Io mi diverto a farne la musica, senza progetti di
sorta, e non se nemmeno se finirò... Ripeto: mi diverto...".
1891
1° gennaio: a Ricordi:"Mi pare proprio che tutti i progetti sieno pazzie vere pazzie! Mi spiego. Io
mi sono messo a scrivere Falstaff semplicemente per passare il tempo, senza idee preconcette,
senza progetti, ripeto, per passare il tempo! Nient'altro!"; e a Boito:"Il Pancione non va avanti.
Sono sconcertato e distratto".
9 febbraio: si reca a Milano per condurre la moglie in cura dal prof.Todeschini. Il 7 marzo
rientrano a Genova. Aprile: riprende la composizione di Falstaff.
28 aprile: si trasferisce da Genova a S.Agata.
1° maggio: approva la deliberazione della Scala di trasformare i palchi della quinta fila in
loggione:"Il pubblico del Loggione, vale a dire quello che si lascia impressionare, e manifesta con
sincerità le sue impressioni è il pubblico vero. [...1 Il Pancione? Poveretto! Dopo quella tal
malattia di 4 mesi è smilzo, smilzo!".
24 maggio: Boito gli fa leggere il libretto del Nerone; lo trovesplendido. L'epoca è scolpita
magistralmente e profondamente".
2 giugno: scrivendo a Ricordi ritiene la Scala per il Falstaff"teatro troppo vasto per sentir bene le
parole, e per vedere i musi degli artisti".
12 giugno: a Boito:"Il Pancione è sulla strada che conduce alla pazzia. Vi sono dei giorni che non si
muove, dorme ed è di cattivo umore; altre volte grida, corre salta, fa il diavolo a quattro...".
Metà giugno: si reca a Milano con Giuseppina; dopo una sosta proseguono per Montecatini.
Ricordi dà l'annuncio ufficiale della costruzione di un "Istituto di ricovero pei musicisti vecchi e
inabili".
5-8 settembre: d'accordo con Boito, che rifiuta la direzione del conservatorio di Parma, appoggia la
nomina di Giuseppe Gallignani.
10 settembre: a Boito:"Non è vero che ho finito il Falstaff. Stò lavorando a mettere in partitura
tutto quello che ho fatto perché temo di dimenticare alcuni squarci ed impasti d'istromenti".
Ottobre?: a sconosciuto destinatario a proposito della "scienza dell'agricoltura": "Io vorrei che
questa nobilissima
Arte e Cultura
4 novembre: S. Pietroburgo, Mariinskij: Borodin, //principe Igor
8 novembre: muore a Parigi César Franck.
11 novembre: Torino, Gerbino: Marco Praga, La moglie ideale, commedia.
19 dicembre: S. Pietroburgo, Mariinskij: Ciajkovskij, La dama di picche.
Erik Satie, Tre gimnopedie, per pianoforte. Ibsen, Hedda Gabler, dramma.
Emilio De Marchi, Demetrio Pianelli, romanzo. - A. France, Taide, romanzo. - W. Morris, Notizie
da nessun luogo, romanzo.- M. Serao,ll paese di Cuccagna, romanzo.
L.Tolstoj, La sonata a Kreutzer, racconto. Annie Vivanti, Liriche.
James George Frazer, Il ramo d'oro.
In Italia comincia a diffondersi lo stile liberty ("art nouveau").
1891
22 gennaio: nasce ad Ales (Sardegna) Antonio Gramsci.
18 giugno: Parigi, Opéra-Comique:Alfred Bruneau, Le réve.
21 luglio: muore a Verona Franco Faccio.
4 ottobre: muore a Ligornetto (Canton Ticino) lo scultore Vincenzo Vela.
31 ottobre: Roma, Costanzi: Mascagni, L'amico Fritz. 10 novembre: muore a Marsiglia JeanArthur Rimbaud. Ilugo von Hofmannsthal, Gestern, dramma lirico.
Giulio Cesare Abba, Da Quarto al Volturno. Noterelle d'uno dei Mille.
Selma Lagerlik, La saga di Gósta Berling, epopea. Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray,
romanzo. - Melville termina il romanzo Billy Budd.
Pascoli, Myricae, poesie latine.
Pellegrino Artusi, La scienza in cucina o l'arte del mangiar bene.
Mosso, La fatica.
A Milano Filippo Turati fonda con Anna Kuliscioff la rivista "Critica sociale".
A Napoli Edoardo Scarfoglio e Matilde Serao fondano il quotidiano "Il Mattino".
Politica, Società, Scienza, Scoperte
In Italia entra in vigore il nuovo Codice Penale che prevede, fra l'altro, il riconoscimento del
diritto di sciopero e l'abolizione della pena di morte. Con regio decreto viene inoltre creata la
colonia italiana di Eritrea.
11 Congresso statunitense approva una legge contro i monopoli.
Con il Veloce Club Milano nasce in Italia la prima società ciclistica.
Il medico tedesco Emil von Behring scopre il principio della sieroterapia.
Il francese C.Ader riesce a compiere un breve volo su un aereo munito di motore a vapore.
A Chicago viene costruito il primo grattacielo.
Negli Stati Uniti viene eseguita la prima condanna a morte tramite sedia elettrica.
Viene fondata la società petrolifera anglo-olandese Shell.
1891
Febbraio: cade il ministero Crispi; si forma il ministero del conservatore Antonio Di Rudinì.
1° maggio: a Roma un movimento di protesta dei disoccupati, di ispirazione anarchica, degenera in
tumulti per l'intervento della forza pubblica.
15 maggio: papa Leone XIII promulga l'enciclica De Rerum novarum.
A Genova per iniziativa di Filippo Turati nasce il partito dei lavoratori italiani.
A Capolago (Canton Ticino) Errico Malatesta e E Saverio Merlino fondano la Federazione
anarchica italiana.
Al congresso del partito socialdemocratico tedesco viene adottato un programma riformista
redatto da Karl Kautsky.
A Giava l'antropologo olandese E. Dupois scopre i resti fossili del pitecantropo.
In Russia viene iniziata la costruzione della ferrovia transiberiana.
A Milano viene fondata la società elettro-meccanica Marelli.
L'americano W. L. Judson inventa la chiusura lampo (non entrerà in uso prima del 1919).
Viene ideato negli Stati Uniti il gioco della pallacanestro.
Cronologia 1892
Giuseppe Verdi
scienza fosse maggiormente coltivata da noi. Quale fonte di ricchezza per la nostra patria! Un po'
meno di musicisti, di avvocati, di medici etc. e un po' più di agricoltori".
6 novembre: a Ricordi:"Vi ringrazio della musica del [Amico] Fritz che m'avete mandato. Ho letto
in vita mia molti molti moltissimi libretti cattivi, ma non ho mai letto un libretto scemo come
questo. [...1 In quanto alla musica [...] mi sono stancato presto di tante dissonanze, di quei
rapporti falsi di modulazione, di tutte quelle cadenze sospese, di quelli inganni, e più... di tanti
cambiamenti di tempo a quasi ogni battuta 1...1. La musica sarà ad ogni modo bellissima! 1...1 ma
io sono vecchio e codino... cioè, vecchio sì, ma codino non tanto".
10 novembre ca.: si reca a Milano con la moglie; riceve le visite di Rubinstein e di Piatti. L'8
dicembre: si trasferisce con la moglie a Genova.
1892
Fine febbraio: si reca a Milano con la moglie. Il 21 marzo rientrano a Genova.
7 aprile: von Biilow scrive a GV facendo atto di contrizione per un giudizio avventato espresso
sulla Messa da requie'', alla vigilia della sua prima esecuzione:"Ebbene, illustre Maestro, ora vi
ammiro, vi amo!".
14 aprile: GV risponde a von Billow:"non è caso di parlare di pentimenti e di assoluzioni! Se le
vostre opinioni d'una volta erano diverse da quelle d'oggi, voi avete fatto benissimo a manifestarle
[...]. Del resto, chi sa... forse avevate ragione allora. [...] Se gli artisti del Nord e del Sud hanno
tendenze diverse, è bene sieno diverse..Tutti dovrebbero mantenere i caratteri propri della loro
nazione, come disse benissimo Wagner".
Aprile: termina la partitura del primo atto di Falstaff
7 aprile: si reca da solo a Milano per le celebrazioni del centenario della nascita di Rossini. L'8
dirige alla Scala la "Preghiera" del Mosè di Rossini. L'll aprile rientra a Genova.
13 giugno: affronta con Ricordi i molteplici problemi relativi all'esecuzione del Falstaff,"La musica
non è difficile, ma bisognerà cantarla diversamente dalle altre opere comiche moderne, e dalle
opere buffe antiche".
18 giugno: si reca a Tabiano con la moglie per alcuni giorni.
Fine giugno: si reca a Milano; viene fotografato da Campanari e Ferrarlo nel giardino Perego, in
via Borgonuovo dove abita Giulio Ricordi; un ritratto a mezzo busto serve al pittore Carlo Chessa
per una sua acquaforte; alcune istantanee lo ritraggono in compagnia di Boito, Ricordi, Chessa; due
istantanee - fra le più famose e diffuse dell'iconografia verdiana (erroneamente riferite al giardino
di S.Agata) - lo ritraggono insieme a Boito.
10 luglio ca.: parte con la moglie per Montecatini.A fine mese ritorna a Milano per ascoltare la
cantante
Il 1°
agosto: rientrano a S.Agata.
15 settembre: spedisce a Ricordi la partitura del terzo atto di Falstaff
18 settembre: propone l'andata in scena del Falstaff per i primi di febbraio.
Fine settembre: spedisce a Ricordi la partitura del secondo atto.
13-16 ottobre: fa una corsa a Milano per prendere le definitive disposizioni per le scene e i costumi
di Falstaff
24 ottobre: si trasferisce con la moglie a Genova, dove in novembre riceve la visita di Giosuè
Carducci e Annie Vivanti.
1° dicembre: spedisce a Ricordi la partitura del primo atto di Falstaff
21 dicembre: scrive a Ricordi perché predisponga tutto per poter iniziare le prove di Falstaff.
1893
2 gennaio: parte da Genova con Giuseppina alla volta di Milano per iniziare le prove di Falstaff.
9 febbraio: Milano, Scala: prima rappr. di Falstaff; grande successo. 2 marzo: GV e consorte
rientrano a Genova.
7 marzo: scontento di uno squarcio nel concertato finale del secondo atto di Falstaff informa
Ricordi:"Ho rifatto 6 battute, e resta accorciato il pezzo di 10 battute. Ve lo manderò domani".
8 marzo: riceve da Boldini il ritratto a olio fatto nel 1886 a Parigi.
Arte e Cultura
1892
20 gennaio: Milano, Scala: Catalani, Wally.
16 febbraio: Vienna, Hofoper: Massenet, Werther
20 febbraio: Londra, St. James: Oscar Wilde, Il ventaglio di Lady Windermere), commedia.
7 aprile: Firenze, Pagliano: Francesco Cilea, Tilda.
21 maggio: Milano, Dal Verme: Leoncavallo, Pagliacci.
6 ottobre: Genova, Carlo Felice: Franchetti, Cristoforo Colombo.
10 novembre: Firenze, Pergola: Mascagni, I Rantzau. 18 dicembre: S. Pietroburgo, Mariinskij:
Ciajkovskij, Lo schiaccianoci, balletto.
Gustave Charpentier, La vita del poeta, sinfonia-dramma. Maeterlinck, Pelléas et Mélisande,
dramma.
G. d'Annunzio, L'innocente, romanzo. - Italo Svevo, Una vita, romanzo. - É. Zola, La disfatta,
romanzo. Ada Negri, Fatalità, poesie.
Paul Cézanne, I giocatori di carte, dipinto. - Paul Gauguin, Ta Matete, dipinto.
Alfredo Ortani, La lotta politica in Italia.
G. Podrecca fonda a Roma il giornale satirico anticlericale "L'Asino".
1893
7 gennaio: Berlino, Lessingtheater: H. Sudermann, Heimat (Casa paterna), dramma.
30 gennaio: Parigi, Th. Lyrique de la Renaissance: Messager, Madame Chrysanthème.
1° febbraio: Torino, Regio: Puccini, Manon Lescaut. 26 febbraio: Berlino, Lessingth.: Gerhart
Hauptmann, I tessitori, dramma.
5 marzo: muore a Parigi Hyppolite Taine.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
1892
8 maggio: cade il governo retto da Di Rudinì; si forma il primo ministero Giolitti.
Agosto: a Genova il partito dei lavoratori italiani assume il nome di partito socialista.
Autunno: si celebrano a Genova le "Feste colombiane" per il IV centenario della scoperta
dell'America.
20 dicembre: scoppia lo scandalo della Banca Romana su denuncia del deputato socialista
Napoleone Colajanni.
In Eritrea il tenente dei carabinieri Dario Livraghi compie feroci repressioni, al limite del
genocidio.
Francia e Russia stipulano una convenzione militare. Rudolf Diesel inventa un motore a
combustione interna di olio pesante.
Viene fondata ad Atlanta la società produttrice della Coca-Cola.
In Francia fa bancarotta la società, fondata da De Lesseps, per il canale di Panama; l'iniziativa della
costruzione viene rilevata dagli Stati Uniti.
1893
19 gennaio: viene arrestato il neo-senatore Bernardo Tanlongo, direttore della Banca Romana; il
ministero Giolitti è in difficoltà.
Febbraio: Menelik denuncia alle potenze europee il trattato di Uccialli e respinge il protettorato
italiano.
Estate: 400 emigrati italiani che lavorano nelle saline di Aigues Mortes vengono selvaggiamente
aggrediti da francesi; 30 morti.Tumulti antifrancesi scoppiano a Roma e a Napoli.
Cronologia 1894
Giuseppe Verdi
18 marzo: scontento di "quella specie di mazurka che chiude la prima parte del terzo atto" di
Falstaff, medita di apportare un cambiamento.
21 marzo: di passaggio per recarsi a S.Agata sosta a Milano e assiste a una recita di Falstaff
29 marzo: a Ricordi: "Ho visto annunciato Falstaff e Manon [di Puccini] a Brescia. È un errore! I:
una ammazzerà l'altra! Date la Manon sola. Io non ho bisogno di far carriera e godo che altri
approfittino".
1° aprile: spedisce a Ricordi il cambiamento apportato alla fine della prima parte del terzo atto.
6 aprile: il Falstaff viene rappresentato al Carlo Felice di Genova, presente l'autore, con i complessi
artistici e orchestrali scaligeri.
13 aprile: parte con la moglie per Roma, prendendo alloggio all'Hàtel Quirinale.
14 aprile: viene ricevuto da re Umberto I. Dal consiglio municipale gli viene conferita la
cittadinanza romana. Invita a pranzo alcuni pochi amici, fra cui Cesare Pascarella.
15 aprile: al Teatro Costanzi assiste con Boito alla prima romana del Falstaff
15 aprile: si incontra con Eduard Hanslick che, ammirato, scrive di lui:"Qualcosa di infinitamente
mite, modesto e aristocratico nella stessa modestia, riluce nella figura di quest'uomo, che la fama
non ha reso vanitoso, gli onori non arrogante, l'età non bisbetico".
20 aprile: rientra con la moglie a Genova. Il 4 maggio si trasferiscono a S.Agata.
23 maggio: a Ricordi:"V'ho mandato stamattina le ultime note del Falstaff! Pace all'anima sua!!".
15 giugno: a Ricordi:"Il repertorio fisso da noi! col nostro pubblico è impossibile! [...] Bisogna
lasciare a ciascun paese la propria indole, e tollerare da noi talvolta gli indecenti chiassi e gli
stupidi giudizi!... [...] sotto molti rapporti le condizioni del Teatri tedeschi sono migliori,
sopratutto per la giustezza della paga, e per la pensione dopo dieci anni di servizio".
Fine giugno: si reca con Giuseppina a Milano; il 3 luglio partono per Montecatini. Agostosettembre: discute con Ricordi il progetto di dare Falstaff e Otello in francese in Francia.
2 settembre: a Ricordi in merito al successo di Falstaff a Brescia. "Io ho sempre creduto e credo
che Falstaff sia opera facilissima a rappresentarsi; e che, un po' istruiti tutti, o quasi tutti possono
eseguirla. [...] Bisogna soltanto badar molto alla parte d'Alice.Alice è la prima parte dopo
Falstaff".
Metà novembre: si trasferisce con Giuseppina a S.Agata.
8 dicembre: a Mascheroni:"Orchestra invisibile!... È un'idea tanto vecchia che tutti o almeno tutti
hanno sognato!... Anch'io vorrei nei teatri l'orchestra invisibile; ma non a metà... La vorrei
completamente invisibile! [...] Ma se l'orchestra completamente invisibile non è possibile come lo
dimostrano non solo l'Opera, [ma] moltiTeatri di Germania, e perfino Monaco e Bayreuth (ripeto
completamente) tutte le modificazioni che farete sono puerili, non hanno nulla a fare coll'arte".
Dicembre: è preoccupato per un incidente sorto fra Boito e l'editore Sonzogno a proposito di
un'opera di Frederic Cowen, che aveva minacciato di sfociare in un duello.
1894
Gennaio: protesta con Ricordi per i cambiamenti fatti apportare dal direttore dell'Opera, Gailhard,
alla traduzione francese di Otello fatta da Boito e Du Lode e da lui approvata.
21 gennaio: spedisce a Ricordi alcune correzioni apportate in Falstaff al Sonetto di Fenton e al
parlante che precede la Canzone delle Fate.
Metà febbraio: GV e consorte si recano a Milano per alcuni giorni. Il 6 marzo rientrano a Genova.
12 marzo: scrivendo a Ricordi accetta a malincuore di recarsi a Parigi per il Falstaff in francese:"a
Parigi io non conosco più nissuno, e sarei perduto come in un deserto! Più l'alloggio al mio antico
Hotel [de Bade] in cui mi trovavo come a casa mia, non è più possibile (come dite Voi tutti) e
bisognerebbe andare in quel Grand Hotel che mi è antipatico!".
14 marzo: a Boito a proposito della consuetudine di bissare "Quand'ero paggio":"In che offende
l'estetica quel piccolo squarcio? [...] È scritto bene per la voce, è istromentato leggermente; lascia
sentire tutte le parole [...] Che male c'è dunque, s'è riuscito popolare?".
Arte e Cultura
13 giugno: l'università di Cambridge conferisce la laurea honoris causa a Boito, a Max Bruch, a
Ciajkovskij e a Saint-Saéns.
6 luglio: muore a Parigi Guy de Maupassant.
16 luglio: muore a Caprino Bergamasco Antonio Ghislanzoni.
7 agosto: muore a Milano Alfredo Catalani.
16 ottobre: muore a Verona Carlo Pedrotti.
16 ottobre: S. Pietroburgo: Ciajkovskij: Sesta Sinfonia,
detta la Patetica".
18 ottobre: muore a Parigi Charles Gounod.
27 ottobre: Parigi,Vaudeville:Sardou,Madame Sans-Cine,
commedia.
6 novembre: muore a S. Pietroburgo in circostanze
misteriose Piotr Ciajkovskij.
23 dicembre: Weimar: Engelbert Humperdinck, ~sei e Gretel.
26 dicembre: alla Scala va in scena la Walkiria di Wagner in italiano.
Antonin Dvoràk, Sinfonia dal Nuovo Mondo.
Oscar Wilde, Salomè, dramma.
G. Courteline, Quelli dalle mezze maniche, romanzo. E. de Marchi, Arabella, romanzo.
C. Pascarella, La scoperta dell'America, poemetto in romanesco.
Roberto Ardigò, La scienza dell'educazione.
Lombroso, Il fenomeno psicologico di Verdi, articolo in cui l'autore, coerente con le proprie teorie,
nega al maestro la qualifica di "genio".
Nel corso di una campagna di scavi a Delfo, in Grecia, vengono ritrovate due lastre marmoree su
cui sono incisi due inni delfici, di cui uno battezzato Inno di Apollo.
1894
4 febbraio: muore a Parigi Adolphe Sax.
24 febbraio: Parigi, Odéon: Georges Feydeau - Desvallières, Il nastro, commedia.
10 marzo: Weimar: Richard Strauss: Guntram. 16 marzo: Parigi, Opéra: Massenet, Thais.
18 aprile: Colonia, Stadttheater: Nicola Spinelli, A basso porto.
10 maggio: Weimar: R. Strauss, Guntram.
13 giugno: muore adAnagni il baritono Filippo Coletti.
20 giugno: Londra, Covent Garden: Massenet, La Navanwe.
19 agosto: muore, presso Cernobbio, Giovannina Strazza ved. Lucca.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
Sommosse contadine in Sicilia e in Lunigiana, che vengono poste in stato d'assedio.
Novembre: travolto dallo scandalo della Banca Romana, Giolitti è costretto alle dimissioni; dopo la
rinuncia di Zanardelli si forma il secondo ministero Crispi. Dicembre: il col.Arimonti sconfigge i
dervisci ad Agordat. Viene istituita la Banca d'Italia.
In Inghilterra viene fondato il partito laburista indipendente.
Una insurrezione nazionalista in Macedonia rivendica
l'indipendenza dalla Turchia e l'unione con la Bulgaria. Viene inaugurato il canale di Corinto.
Negli Stati Uniti l'industriale Henry Ford costruisce la sua prima automobile.
1894
Moti insurrezionali in Sicilia (i "fasci siciliani") e in Lunigiana vengono repressi da Crispi con la
forza militare; la Sicilia viene posta in stato d'assedio.
20 marzo: muore a Torino Lajos Kossuth.
25 giugno: a Lione il presidente francese Sadi Carnot viene ucciso dall'anarchico italiano Sante
Caserio; il gesto suscita manifestazioni anti-italiane.
Luglio: il gen. Baratieri occupa Kassala.
15 ottobre: viene arrestato il capitano Alfred Dreyfus, accusato di spionaggio.
Ottobre: Crispi decreta lo scioglimento delle associazioni operaie e del partito socialista.
Cronologia 1895
Giuseppe Verdi
4 aprile: parte con la moglie per Parigi; di passaggio dalla stazione di Torino, una folla di persone
accortasi della sua presenza in treno, lo saluta con una grande ovazione, cui il maestro risponde
compiaciuto.Arrivato a Parigi prende alloggio al Grand Hòtel.
5 aprile: inizia le prove di Falstaff in francese all'Opéra-Comique, a quel tempo ospitata al Thatre
Lyrique in piace du Chàtelet.
16 aprile: prova generale di Falstaff. •
18 aprile: prima rappresentazione in francese di Falstaff all'Opéra-Comique.
29 aprile: parte da Parigi con Giuseppina, sosta a Genova, quindi rientra a S.Agata.
Fine maggio: si reca per una settimana a Milano; con Boito e Ricordi visita le Esposizioni Riunite.
L'S giugno rientra a S.Agata. Il 24 ritorna con la moglie a Milano, e di qui, dopo una settimana, si
dirige a Montecatini. Si occupa del balletto da inserire nell'Otello in francese e tempesta Ricordi
per avere informazioni su danze popolari greche, cipriote e veneziane.
10 luglio: riceve da Ricordi alcune musiche di danze antiche: "Che miseria quella musica mandatavi
da Tebaldini! Anche in quel tempo v'era ben altro ben altro! [...] Cercate cercate!"
17 luglio: parte da Montecatini e rientra a S.Agata il 19.
Agosto: compone il balletto per l'Otello in francese e il 21 lo spedisce a Ricordi accompagnandolo
con minuziose istruzioni su come dev'essere eseguito.
18 settembre ca.: si trasferisce con la moglie a Genova. Il 26 parte per Parigi (è il suo ultimo
viaggio nella capitale francese) per le prove dell'Otello in francese. Giuseppina rimane a Genova.
12 ottobre: prima rappresentazione all'Opera dell'Otello in francese, alla presenza del presidente
francese Casimir Péricr, che conferisce a Verdi la Gran Croce della Legion d'onore.
17 ottobre: partecipa con Thomas alla commemorazione dell'anniversario della morte di Gounod.
22 ottobre: lascia Parigi e rientra a Genova.
19-22 novembre: Jules Massenet gli fa visita a palazzo Doria. Il maestro lo accoglie con cordialità.
A Massenet rimane impressa l'immagine di GV,"il capo scoperto e dritto sotto il sole" che gli
mostra la città e il mare "con un gesto fiero come il suo genio e semplice come la sua bella anima
d'artista. E fu come un'evocazione di uno dei grandi dogi dell'antichità, che stende su Genova la
sua mano fatta di potenza e di bontà".
3-6 dicembre: compone Pietà Signor, su versi adattati da Boito dall'Agnus Dei, per il numero unico
di "Fata Morgana" a beneficio dei terremotati di Calabria e Sicilia.
1895
18 gennaio: sotto l'entusiastica impressione ricevuta ascoltando una rappresentazione di Falstaff a
Berlino, il giovane Richard Strauss dona a GV un esemplare della sua opera Guntram
accompagnandola con una lettera piena di ammirazione.
28 gennaio: GV si reca con la moglie a Milano per controllare i lavori della futura Casa di Riposo.
31 gennaio: progettando di comporre un Te Deum, chiede a Giuseppe Gallignani di trascrivergli
dal libro di Canto Fermo le "due cantilene"; inoltre lo prega di restituirgli le Ave Maria su scala
enigmatica, avendo intenzione di farle stampare in un ristrettissimo numero di copie (prima di
restituirle Gallignani, nel timore di una rinuncia del maestro a pubblicarle, ne trascrive copia).
17 febbraio: legge a Ricordi e a Emilio Seletti le disposizioni testamentarie relative alla Casa di
Riposo. Febbraio: fa la conoscenza di Pietro Mascagni.
9 marzo: parte da Milano con la moglie per rientrare a Genova.A fine mese si trasferiscono a
S.Agata. Aprile: inizia la composizione del Te Deum.
Metà maggio: si reca a Milano.
28 giugno: al Conservatorio di Parma vengono eseguite sotto la direzione di Gallignani, di fronte
a un ristrettissimo pubblico, le sue Ave Maria su scala enigmatica.
30 giugno: GV e consorte si recano alle cure termali di Montecatini.
Arte e Cultura
16 novembre: Napoli, Nuovo: esordio di Enrico Caruso nell'opera L'amico Francesco di Morelli.
22 dicembre: Debussy: Prélude à "L'Après-midi d'un Faune".
Nasce a Torino la "Rivista Musicale Italiana".
Carlo 13ertolazzi, El nost Milan, commedia (prima parte: La povera gent). - G. B. Shaw, La
professione della signora Warren, commedia.
A. France, Il giglio rosso, romanzo. - C. Mendes, La casa della vecchia, romanzo. - George Moore,
Esther Waters, romanzo. - Jules Renard, Pel di carota, romanzo. - Gerolamo Rovetta, La
baraonda, romanzo. 1894-96: Henryk Sienkiewicz, Quo vadis?, romanzo.
Piene Louys, Le canzoni di Bilitis,"poesie in prosa". L'attore Ermete Zacconi forma una propria
compagnia.
Viene fondata a Roma la rivista "Riforma Sociale".
1895
14 febbraio: Londra:Wilde,L'importanza di chiamarsi Ernesto, commedia.
16 febbraio: Milano, Scala: Mascagni, Guglielmo Ratcliff.
11 marzo: muore a Milano Cesare Cantù.
28 marzo: Trieste, Comunale: A. Smareglia, Nozze istriane.
5 novembre: Colonia: Richard Strauss, 'fili Eulenspiegel, poema sinfonico.
27 novembre: muore a Marly-le-Roi Alessandro Dumas figlio.
28 dicembre: i fratelli l.ouis-Jean e Auguste Lumière proiettand in pubblico il primo filmato:
l'uscita degli operai dalla fabbrica.
Scott Joplin inizia a comporre i primi ragtime. Enrico Panzacchi, Nel mondo della musica, saggi.
Carlo Bertolazzi, El nost Milan, commedia (seconda parte: I sciori).
Politica, Società, Scienza, Scoperte
1° novembre: muore lo zar Alessandro III; gli succede il figlio Nicola II, continuatore della politica
reazionaria del padre.
22 dicembre: Dreyfus viene condannato alla deportazione a vita.
Francia e Russia stipulano un'alleanza per far fronte ai contrasti con l'Austria.
Il Giappone muove guerra alla Cina per sottrarre la Corea alla sua influenza.
Il medico francese E. Roux realizza la sieroterapia della difterite.
Il tedesco E. Berliner inventa il grammofono a disco. Enrico Bernardi produce i primi esemplari
italiani di automobile con motore a combustione interna. Viene scoperto il bacillo della peste.
Il diplomatico francese Pierre de Coubcrtin promuove le Olimpiadi moderne.
Viene fondato a Milano il Touring Club Italiano.
1895
La Francia conquista il Madagascar.
Cuba si ribella alla Spagna; nonostante una dura repressione l'esercito spagnolo non riesce a
soffocare la rivolta. Si conclude la guerra fra Cina e Giappone; la Cina cede ai nipponici l'isola di
Formosa; viene proclamata l'indipendenza della Corea.
Settembre: nasce in Francia la Confederazione Generale del Lavoro che riunisce tutte le
associazioni sindacali. Scoppia la guerra fra Italia e Abissinia, alleata con Francia e Gran Bretagna.
7 dicembre: sconfitta delle truppe italiane comandate dal maggiore Pietro Toselli all'Amba Alagi
dopo eroica resistenza.
Viene fondato a Milano il partito repubblicano, erede della tradizione mazziniana.
Termina la pubblicazione (postuma) del Capitale di Marx.
28 marzo: dopo molti esperimenti utilizzando le onde elettromagnetiche, Guglielmo Marconi
approda alla rea-
Cronologia 1896
Giuseppe Verdi
19 luglio: a Giulio Ricordi che gli chiede di pubblicare le Ave Maria su scala enigmatica:"non vale
la pena di parlarne. È stato uno scherzo ed è quasi un puro esercizio scolastico" (e più tardi ad
altro destinatario:"quella non è vera musica, è un tour de force, è una sciarada").
21 luglio: rientra a S.Agata da Montecatini.
10 settembre: riceve una visita di Italo Pizzi; si parla di strumenti antichi, di antica musica greca,
dell'Inno di Apollo,
dell'orientalismo di Aida, di una visita fatta a un museo di Firenze per esaminare un flauto che
secondo Fétis era di epoca egizia e che invece risulta essere un subieu da famè (uno zufolo da
famiglio).
Ottobre: con Giuseppina si reca a Milano; alla fine del mese rientrano a S.Agata.
1896
16 gennaio: GV ritorna a Milano con Giuseppina per controllare la costruzione della Casa di
Riposo.II13 febbraio rientrano a Genova.
18 febbraio: chiede a Giovanni Tebaldini di poter conoscere un Te Deum di padre Vallotti.
21 febbraio: comincia a mettere in partitura il Te Deum.
1° marzo: riscrive a Tebaldini per il Te Deum di Vallotti osservando che questa cantica
"ordinariamente cantata nelle feste grandi solenni, chiassose o per una vittoria o per
un'incoronazione LI finisce con una preghiera E...1 commovente, cupa, triste fino al terrore!"; pertanto è curioso di sapere se Vallotti, disponendo di
un'orchestra e di un'armonia abbastanza ricca,"aveva trovato espressioni, e colori, od aveva
intendimenti diversi da molti de suoi predecessori".
26-28 marzo: compie un fulmineo viaggio a Milano.
6 aprile: rifiuta di comporre un inno su versi di Carducci per l'anniversario della liberazione di
Roma.
1° maggio: ringraziaTehddini per il Te Deum di Vallotti:"È un pezzo molto ben fatto ma non vi ho
trovato quello che cercavo". Primi di maggio: si trasferisce a S.Agata passando da Milano.
Fine maggio.: si reca a Milano da solo (Giuseppina è ammalata) per depositare in banca 400.00()
lire per l'erigenda Casa di Riposo; il 2 giugno rientra a S.Agata.
11 giugno: a Boito, dopo aver ricevuto da Tebaldini altri Te Deum:"oramai quello che è fatto, è
fatto; né io potrei dare altra interpretazione a quella Cantica".
Metà giugno: Verdi e consorte si recano a Milano per alcuni giorni.
Giugno ca.: inizia a comporre uno Stabat Mater per coro a 4 parti e orchestra.
11 luglio: ritorna a Milano con la moglie per vedere lo stato dei lavori della Casa di Riposo. Il 15
ripartono alla volta di Montecatini. Il 20 luglio rientrano a S.Agata.
Fine agosto: torna a Milano per vedere i lavori della Casa di Riposo; il 3 settembre rientra a
S.Agata.
Metà ottobre: con la moglie trascorre alcuni giorni a Milano,per vedere, fra l'altro, lo stato dei
lavori della Casa di Riposo.
20 novembre ca.: si trasferisce a Genova; le condizioni di salute di Giuseppina non migliorano.
29 novembre ca.: Umberto Giordano, fresco sposo di Olga Spatz, la figlia del proprietario dell'Iatei de Milan, si reca con la moglie a palazzo Doria per far visita a GV.
1897
Primi di gennaio: GV subisce un colpo apoplettico che gli fa perdere i sensi; soccorso dalla nipote
Maria, si rimette presto.
22 febbraio: si reca a Milano con la moglie - la cui salute, sempre più cagionevole, registra un lieve
miglioramento - per sorvegliare l'andamento dei lavori di costruzione della Casa di Riposo.
24 febbraio: concede un'intervista a Heinrich Ehrlich, che trova il maestro "quasi ringiovanito",
con il capo eretto come un militare, vigoroso come un sessantenne.
Arte e Cultura
Antonio Fogazzaro, Piccolo mondo antico, romanzo. Emilio Salgari, I misteri della giungla nera,
romanzo. Joseph Conrad, La follia di Almayer, romanzo. - Rudyard Kipling, I libri della giungla,
romanzo. - George Wells, La macchina del tempo, romanzo di fantascienza.
Paul Valéry, Introduzione al metodo di Leonardo.
Gaetano Mosca, Elementi di scienza politica. Siegmund Freud - Joseph Breuer, Studi sull'isteria.
Si apre la prima Biennale di Venezia, esposizione internazionale d'arte contemporanea.
I.. Roux fonda a Torino il quotidiano "La Stampa".
1896
26 gennaio: Torino, Gerbino: Verga, La lupa, scene drammatiche.
1 ° febbraio: Torino, Regio: Puccini, La Bohème.
12 febbraio: muore a Parigi Ambroise Thomas.
28 marzo: Milano, Scala: Giordano, Andrea Chénier.
7 giugno: Mannheim: Hugo Wolf, Der Corregidor
16 settembre: muore in Brasile Carlos Gomes.
23 settembre: muore a Poissy il cantante Gilbert-Louis Duprez.
8 ottobre: Festival di Norwich: L. Mancinelli, Ero e Leandro (in forma di cantata).
11 ottobre: muore a Vienna Anton Bruckner.
27 novembre: Francoforte: Richard Strauss, Così parlò Zaratustra.
10 dicembre: Parigi: Alfred Jarry, Ubu-re, commedia.
16 dicembre: Praga: Emil von Reznicek,Donna Diana. 25 dicembre: a Roma viene fondato il
quotidiano socialista "Avanti!".
Anton Cechov, Il gabbiano e Lo zio Vanja, commedie.
Carolina Invernizio, La sepolta viva, romanzo. - Pierre Louys,Afrodite, romanzo.
Marcel Proust, I piaceri e i giorni.
A Torino e a Milano si aprono i primi locali destinati a proiezioni cinematografiche.
In Francia viene istituito il premio letterario Goncourt.
A Bologna viene fondato il quotidiano cattolico "L'Avvenire".
1897
10 febbraio: Milano, Scala: Manzotti, Sport, ballo, musica di R. Marenco.
19 febbraio: Parigi, Opéra:A. Bruneau, Messidor
12 marzo: Bruxelles, La Monnaie: Vincent d'Indy, Fervaal.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
lizzazione del circuito oscillante aperto.
Il fisico tedesco Wilhelm Conrad Ròntgen scopre i raggi X (Un nuovo tipo di raggi).
Lo statunitense King Camp Gillette inventa il rasoio di sicurezza (sarà commercializzato a partire
dal 1901).
I fratelli Édouard e André Michelin realizzano i primi pneumatici per automobile.
Viene ideato negli Stati Uniti il gioco della pallavolo.
1896
L'arciduca Francesco Ferdinando, nipote di Francesco Giuseppe, viene nominato erede al trono.
A Londra il terzo congresso dell'Internazionale socialista decide l'espulsione degli anarchici.
1 ° marzo: disfatta dell'esercito italiano, guidato da Baratieri, ad Adua.
5 marzo: Francesco Crispi è costretto alle dimissioni; gli succede Antonio Di Rudinì.
Ottobre: con la pace di Addis Abeba si conclude la guerra fra Italia e Abissinia; l'Italia mantiene
Eritrea e Somalia, ma deve rinunciare al protettorato sull'Etiopia. La Francia proclama il
Madagascar colonia francese. Vilfredo Pareto pubblica il Corso di economia politica. Gennaio:
Guglielmo Marconi realizza la prima trasmissione di segnali radio via etere.
2 giugno: Marconi deposita a Londra il brevetto per la trasmissione telegrafica senza fili.
Anche il fisico russo A. Popov realizza la trasmissione radiotelegrafica.
Il francese Henri Becquerel scopre la radioattività naturale.
L'industriale torinese Michele Lanza costruisce la prima automobile a benzina, a due cilindri.
6 aprile: ad Atene viene aperta la prima Olimpiade moderna.
Viene fondata a Milano la "Gazzetta dello Sport".
1897
17 marzo: muore in uno scontro con le truppe abissine Vittorio Bottego.
22 aprile: a Roma il fabbro Pietro Acciarito attenta alla vita di re Umberto I.
2 maggio: la morte in carcere, massacrato dalla poliCronologia 1898
Giuseppe Verdi
16 marzo: ritorna a Genova. Ma ai primi di aprile compie una rapida corsa a Milano.
6 maggio: Verdi e consorte si recano a Milano per un breve soggiorno; il 17 si trasferiscono a
S.Agata.
1° giugno: si rassegna a far stampare le Ave Maria su scala enigmatica insieme ai tre Pezzi sacri:
Luridi alla Vergine, Stabat Mater e Te Deum.
4 giugno: informa Ricordi d'aver dimenticato a Genova la Sciarada; ma sta tuttavia trascrivendola,
cambiando qualche battuta qua e là non ricordando del tutto la prima versione: "credo che questa sia più corretta
nelle modulazioni e disposizioni di parti". Inoltre porta a termine l'orchestrazione dello Stabat
Mater.
1° luglio: si reca con la moglie a Milano per visitare i lavori della Casa di Riposo; s'incontra con
Ricordi, che insiste per fare pubblicare ed eseguire i Pezzi sacri. - Il 7 luglio partono per le cure termali di
Montecatini. Il 22 rientrano a S.Agata.
Agosto: apporta gli ultimi ritocchi ai Pezzi sacri.
1° settembre: è di passaggio a Milano, diretto a Genova, e in un incontro con Ricordi decide di
pubblicare i Pezzi sacri.
9 settembre: la salute della moglie di GV va declinando; a Ricordi:"si alza per qualche ora; la tosse
ed il catarro sono diminuite, ma la debolezza è estrema. Non mangia, e dice che non può!? È
desolante! e non si sa cosa fare".
14 ottobre: Giuseppina trova la forza per visitare a Cremona la sorella Barberina.
21 ottobre: GV spedisce le Ave Maria su scala enigmatica e il Te Deum a Ricordi per la stampa.
25 ottobre: spedisce a Ricordi le Laudi alla Vergine e lo Stabat Mater;"Finché esistevano sul mio
scrittojo li guardavo qualche volta con compiacenza e mi parevano cosa mia! - Ora non sono più
miei!! [...] È un vero dolore!"
Primi di novembre: Boito si reca a Parigi per studiare la possibilità di farvi eseguire i Pezzi sacri.
11 novembre: Giuseppina viene colta da una violenta polmonite.
14 novembre: nel pomeriggio muore in S.Agata Giuseppina Verdi Strepponi. I funerali si svolgono
a S. Agata; la salma viene provvisoriamente tumulata nel Cimitero Monumentale di Milano.
25 dicembre: GV trascorre a S.Agata le feste natalizie in compagnia di Boito.
1898
6 gennaio: GV si reca a Milano per sorvegliare la pubblicazione dei Pezzi sacri.
21 gennaio: da Parigi Boito informa il maestro di un primo accordo per l'esecuzione dei Pezzi sacri
alla Società dei Concerti del Conservatorio di Parigi.
Fine gennaio: GV limita il consenso dell'esecuzione a soli tre Pezzi, vietando quella delle Ave
Maria su scala enigmatica. l 4 marzo: parte da Milano per trasferirsi a Genova.
20 marzo: vorrebbe andare a Parigi per assistere all'esecuzione dei Pezzi sacri, ma i medici gli
vietano un così lungo viaggio; in sua vece vi sarà Boito.
29 marzo - 5 aprile: è in fitta corrispondenza con Boito per l'esecuzione dei Pezzi sacri.
7 aprile: Parigi, Conservatorio: prima esecuzione assoluta dei tre Pezzi sacri, presente Boito.
22-25 aprile: ArturoToscanini e Giuseppe Depanis si recano a palazzo Doria per consultare GV in
merito alla prossima
esecuzione dei Pezzi sacri a Torino, e averne consigli e suggerimenti; a Toscanini che gli chiede il
perché dell'intervento di una voce sola, nascosta al pubblico, alla fine del Te Deum il maestro
risponde:"E l'iimanità che ha paika dell'inferno".
26 aprile: GV si reca a Milano e vi soggiorna sino alla fine di maggio; a questo periodo risalgono
alcuni appunti del testamento olografo.
19 maggio: a proposito dei tumulti popolari milanesi soffocati a cannonate da Bava Beccaris, Boito
scrive a Bellaigue che essi non furono provocati dal caro-pane, ma per ottenere marmellata e
polenta; "siamo ancora in stato d'assedio, stato che non manca di fascino, offre innanzi tutto
l'illusione di un ritorno al medio evo. Si rientra entro
mezzanotte, non si incontrano che pattuglie, la bicicletta è scomparsa, l'automobile pure, per conto
mio sono incantato e mi sento ringiovanito di quattro secoli".
26 maggio: Torino, Salone dei Concerti dell'Esposizione Generale Italiana: prima esecuzione
italiana dei tre Pezzi sacri, diretti da Toscanini.
Arte e Cultura
3 aprile: muore a Vienna Johannes Brahms.
6 maggio: Venezia, La Fenice: Leoncavallo, La Bohème.
6 settembre: Venezia, Rossini: Smareglia, La falena.
1° ottobre: muore a Mosca il baritono Leone Giraldoni
27 novembre: Milano, Lirico: Cilea, L'Arlesiana.
28 dicembre: Parigi: Edmond Rostancl, C..'irano di Bergerac, dramma in versi.
Napoli, teatro Verdi: Salvatore Di Giacomo, 'O mese mariano, dramma.
Paul Dukas, L'apprendista stregone, scherzo sinfonico. Lorenzo Perosi, La Passione di NS. Gesù
Cristo secondo S. Marco, oratorio.
André Gide, I nutrimenti terrestri, romanzo - Bram Stoker, Dracula, romanzo.
Lev N.Tolstoj, Che cosa è l'arte?
Henri Bergson, Materia e memoria.
Emilio Girolamo Medrano fonda a Parigi il circo che porta il suo nome.
A Torino viene completata la costruzione della Mole Antonelliana.
1898
7 gennaio: Mosca: Rimskij-Korsakov, Sadko.
10 febbraio: nasce ad Augsburg Bertolt Brecht.
25 febbraio: Lipsia (rappr. privata): Frank Wedekind, Lo spirito della terra, dramma.
Primavera: esordio del baritono Titta Ruffo al Costanzi di Roma.
26 settembre: nasce a New York George Gershwin. 14 ottobre: nasce presso Mosca il Teatro
d'Arte diretto da Stanislawski e Nemirovic-Dancenko.
5 novembre: Berlino: Hauptmann, Il vetturale Henschel, dramma.
17 novembre: Milano, Lirico: Giordano, Fedora. 22 novembre: Roma, Costanzi: Mascagni, Iris.
Dicembre: Toscanini diventa direttore stabile alla Scala
di Milano.
Gabriel Fauré, musiche di scena per Pelléas et Mélisande di Maeterlinck.
L. Perosi, La risurrezione di Lazzaro, oratorio. Edoardo Di Capua scrive la canzone 'O sole mio su
versi di Giovanni Capurro.
G. B. Shaw, Il petletto wagnerita.
C. Bertolazzi, La gibigianna, commedia in milanese. Politica, Società, Scienza, Scoperte
zia, di Romeo Frezzi falsamente accusato di complicità con Acciarito provoca un'ondata di
proteste.
A Basilea si tiene il primo congresso mondiale ebraico presieduto da Theodor Herzl, nel quale
viene annunciato il programma per la costituzione di uno stato ebraico in Palestina.
La Grecia muove guerra alla Turchia in difesa di Creta; ma, sconfitta, è costretta alla pace di
Costantinopoli. Le grandi potenze europee ottengono per Creta l'autonomia sotto la sovranità
turca.
A Caltagirone Luigi Sturzo introduce il movimento della democrazia cristiana.
Antonio Labriola, Del materialismo storico.
Il fisico britannico Joseph John Thomson determina il rapporto fra la carica e la massa
dell'elettrone. Viene fondata a La Spezia la Lega Navale Italiana. Viene fondata a Torino la società
di calcio Juventus.
1898
Aprile: in varie parti d'Italia scoppiano sommosse popolari contro il rincaro del prezzo del pane.
Aprile: gli Stati Uniti intimano alla Spagna di concedere l'indipendenza a Cuba; scoppia la guerra
fra Stati Uniti e Spagna.
1° maggio: viene inaugurata l'esposizione di Torino. Proseguono proteste e scioperi; il governo
proclama lo stato d'assedio in 4 province. 6-9 maggio: i moti popolari milanesi contro il carovita
vengono repressi spietatamente dal generale Bava-Beccaris che fa sparare i cannoni direttamente
sulla folla, provocando più di 80 morti; la città viene posta in stato d'assedio; seguono gli arresti di
molti esponenti politici. Per la sua 'eroica' impresa BavaBeccaris viene ricompensato da Umberto I
con la Croce di Grande Ufficiale e la nomina a senatore.
18 giugno: dimissioni del primo ministro Di Rudinì; gli succede il generale Pelloux che imprime
una svolta autoritaria. Vengono avviati numerosi processi e condannati esponenti delle sinistre, fra
cui Turati, Andrea Costa, Lazzari, Romussi, don Albertario, la Kuliscioff, Bissolati, De Ambris.
Luglio: gli Stati Uniti si annettono lo stato delle isole Hawaii.
30 luglio: muore Otto von Bismarck.
Cronologia 1899
Giuseppe Verdi
Primi di luglio: GV parte per Milano.
1 1 luglio: insieme alla Stolz si reca alle cure termali di Montecatini. 1 ° agosto: lascia Montecatini
per rientrare a S.Agata.
13 agosto: alla notizia che il conservatorio di Milano s'intitolerà a Giuseppe Verdi scrive a
Ricordi:"Conservatorio "Giuseppe Verdi" è una stonazione! Un Conservatorio ha attentato (non
esagero) alla mia esistenza, ed io debbo sfuggirne fin la memoria".
25 settembre: a S. Agata una cameriera viene uccisa da un colpo di fucile sparato dal figlio
diciassettenne di Maria Carrara Verdi, Angiolino.
13 novembre: prima esecuzione dei quattro Pezzi sacri a Vienna, diretti da Richard von Perger,
con il battesimo ufficiale delle Ave Maria su scala enigmatica.
Primi di dicembre ca.: GV parte per Milano per un lungo soggiorno.
1899
9 febbraio: parte da Milano per trasferirsi a Genova.
18 marzo: si lamenta con Ricordi del protagonismo degli attuali direttori d'orchestra:"Quando ho
incominciato io a scandalizzare il mondo musicale co' miei peccati, vi era la calamità delle prime
Donne, ora vi è la tirannide dei Direttori d'orchestra! Male male! Però meno male il primo!!".
Metà di maggio: lascia Genova per recarsi a Milano. Primi di giugno: si trasferisce a S.Agata.
Primi di luglio: accompagnato dalla Stolz si reca direttamente alle cure termali di Montecatini.
28 settembre: dalla "Gazzetta musicale di Milano":"Giuseppe Verdi, che è sempre l'attività
personificata, passò da Milano diretto a Genova ove rimase due giorni, ritornando poi di nuovo a
Milano. Fra noi rimase quattro giorni, durante i quali prese varie disposizioni per far progredire i lavori interni del suo fabbricato fuori Porta
Magenta".
1 ° ottobre: si rivolge al ministro Baccelli per chiedere il consenso a essere sepolto, dopo la sua
morte, accanto alla moglie nell'Oratorio del Ricovero pei Musicisti in Milano.
Novembre: il Conservatorio di Parma, per iniziativa di Tebaldini, celebra il 60° anniversario della
prima opera di GV,
l'Oberto.
3 dicembre: GV si trasferisce a Milano, sempre alloggiando all'Hòtel de Milan.
16 dicembre: firma il documento che stabilisce la fondazione della Casa di Riposo per Musicisti. 25
dicembre: trascorre le feste natalizie e di capodanno a Milano tra amici.
Arte e Cultura
Parigi, Vaudeville: Pierre Berton, Zazà, commedia. - G. d'Annunzio, La città morta,"tragedia
moderna".
Henry James, Il giro di vite, romanzo. - Italo Svevo, Senilità, romanzo.
Émile Zola, J'accuse; viene riaperto il caso Dreyfus.
Paul Cézanne inizia la serie delle Bagnanti. - T Signorini, La toeletta del mattino, dipinto.
1899
14 febbraio: Londra: Oscar Wilde, L'importanza di chiamarsi Ernesto.
15 aprile: Palermo, Bellini: G. d'Annunzio, La Gioconda,tragedia.
3 giugno: muore a Vienna Johann Strauss jr.
28 settembre: muore a Schafberg il pittore Giovanni Segantini.
26 ottobre: Vienna, Carltheater: J. Strauss jr., Sangue viennese, operetta postuma.
Jan Sibelius, Finlandia, poema sinfonico.
A. Schónberg, Verklarte Nacht, sestetto per archi. Tolstoj, Resurrezione, romanzo.
Carducci, Rime e ritmi.
A Milano viene fondato il settimanale "La Domenica del Corriere".
Politica, Società, Scienza, Scoperte
10 settembre: viene uccisa a Ginevra da un anarchico italiano l'imperatrice Elisabetta d'Austria,
moglie di Francesco Giuseppe.
21 settembre: in Cina il tentativo di ammodernamento avviato dal giovane imperatore KangYuwei viene troncato da un colpo di stato della vecchia imperatrice Tzushi.
Settembre: truppe egiziane, guidate da un generale inglese, disperdono il movimento mahdista e
riconquistano il Sudan.
Dicembre: con la pace di Parigi termina la guerra fra Spagna e Stati Uniti; la Spagna, sconfitta, si
ritira da Cuba e deve cedere agli Stati Uniti l'isola di Portorico, le isole Filippine e l'isola di Guam.
Nelle Filippine il movimento nazionalista guidato da Emilio Aguinaldo proclama l'indipendenza.
Un accordo commerciale pone fine alla "guerra delle tariffe" fra Italia e Francia.
Pierre e Marie Sklodowska Curie scoprono il radio.
In Francia viene fondata la società automobilistica Renault.
Viene costruita a Paderno d'Adda la più grande centrale idroelettrica europea.
1899
25 maggio: in Italia il generale Pelloux, sostenuto da Sonnino, forma un secondo governo ancor
più reazionario e propone al parlamento leggi eccezionali per la limitazione della libertà di stampa
e di associazione; ma il colpo di stato viene bloccato dall'ostruzionismo parlamentare.Alcuni
deputati propongono una Costituente.
Giugno: le sinistre conquistano il comune di Milano; l'on. Mussi viene eletto sindaco.
Settembre: Alfred Dreyfus viene amnistiato per decreto presidenziale e reintegrato nell'esercito.
All'Aia, per iniziativa dello zar Nicola II, si tiene la prima conferenza per la pace; viene fondata la
Corte di arbitrato dell'Aia per la composizione delle controversie internazionali.
In Sudafrica inizia la guerra anglo-boera.
La Germania acquista dalla Spagna le isole Caroline, Marianne e Palau.
Novembre: in Cina ha inizio il movimento nazionale e xenofobo dei boxers.
Nelle Filippine, Aguinaldo guida un'insurrezione contro l'occupazione statunitense.
6 marzo: il chimico tedesco Dreser ottiene per la prima volta l'aspirina.
Luigi Mangiagalli, Trattato di ginecologia.
Giovanni Agnelli fonda a Torino la società automobilistica EI.A.T.
Cockran produce la lavastoviglie elettrica.
A Milano viene fondata la società di calcio Milan.
Cronologia 1900
Giuseppe Verdi
1900
1° marzo: si trasferisce a Genova.
29 marzo: a Ricordi:"Mangio poco, dormo poco, scrivo poco, e m'annojo molto! Ah l'ozio! che
orrore!".
15 aprile: trascorre la Pasqua in compagnia di Boito.
5 maggio: si trasferisce a Milano.
14 maggio: firma il proprio testamento. con il quale istituisce la 'cugina' Maria Verdi in Carrara
erede universale; fra i numerosi lasciti spiccano quelli relativi all'ospedale di Villanova d'Arda e alla
Casa di Riposo per i Musicisti, alla quale destina, fra l'altro, tutti i diritti d'autore in Italia e
all'estero.
22 maggio: riparte per S.Agata. Primi di luglio: si reca a Milano.
11 luglio: parte per le cure termali di Montecatini.A metà agosto rientra a S.Agata.
28 ottobre: d'accordo con il sindaco di Busseto,Tebaldini organizza un concerto di beneficenza con
gli allievi del Conservatorio di Parma, fra i quali Ildebrando Pizzetti. Gli allievi si recano poi a far
visita a GV nella villa di S.Agata.
12 novembre: GV riceve Tebaldini, che lo ringrazia per l'accoglienza accordata agli allievi del
Conservatorio di Parma; escono in giardino; GV osserva alcuni contadini che stanno abbattendo
una magnolia: "l'ho piantata io con le mie mani quando venni per la prima volta a Sant'Agata. Ed
ora, ingombra e profuma troppo. La faccio togliere!". Sotto i colpi d'accetta l'albero cade a
terra.Tebaldini prova una fitta al cuore:"nella vecchia pianta stroncata parvemi ravvisare il
simbolo d'una fatalità incombente!".
4 dicembre: GV lascia per l'ultima volta S.Agata in compagnia della nipote, diretto a Milano,
prendendo alloggio al solito appartamento dell'Hòtel de Milan.
22 dicembre: dà notizie di sé alla cognata Ilarberina:"non sono ammalato, ma la vita e le forze
diminuiscono di giorno in giorno".
25 dicembre: trascorre le feste natalizie in compagnia di Boito, della Stolz, di Ricordi e di pochi
amici.
1901
1 gennaio: GV trascorre il Capodanno nell'appartamento dell'Hòtel de Milan in compagnia di
Boito, Pascarella, la Stolz, il pittore Carlo Mancini e altri pochi amici.
Primi di gennaio: ha un incontro con Giordano e gli suggerisce di trasformare in opera la
commedia di Sardou Madame Sans-Géne.
18 gennaio: alla cognata Barberina:"sono da quasi quindici giorni in casa perché ho paura del
freddo!! Io sto abbastanza bene, come in passato, ma ripeto ho paura del freddo! 1...] Speriamo che
le belle giornate come questa d'oggi continuino".
21 gennaio: alle 10,30 di mattino, all'atto di alzarsi da letto, è colto da un colpo apoplettico. Il
dottore Caporali presta i primi soccorsi all'ammalato, che presenta i segni evidenti di una
emiplegia al lato destro.
22 gennaio: accorre da Montecatini il dottore Grocco; ma Boito non si fa illusioni e scrive a
Bellaigue:"il maestro sta morendo".
24 gennaio: la fine sembra imminente; al maestro, in stato d'incoscienza, viene impartita l'Estrema
Unzione. I milanesi, saputo del malore del maestro, spargono paglia sulla via Manzoni, dove
s'affaccia l'appartamento del maestro, par attutire il rumore dei tram e dei carri.
27 gennaio: alle ore 2:45 del mattino,"dopo un'angosciosa interminabile attesa se mai ripigliasse un
soffio di vita, il Grocco in lacrime si chinò sul viso immobile e baciò la fronte. Questo fu l'annunzio
della morte".
Arte e Cultura
1900
14 gennaio: Roma, Costanzi: Puccini, Tosca.
31 gennaio: Milano, Manzoni: Giacosa, Come le foglie, commedia.
2 febbraio: Parigi, Opéra-Comique: G. Charpentier, Louise.
25 agosto: muore a Weimar Friedrich Nietzsche.
Antonio Fogazzaro, Piccolo mondo antico, romanzo. Joseph Conrad, Lord fim, romanzo. - Thomas Mann, I
Bruddenbrook, romanzo.
Giovanni Pellizza da Volpedo, I/ quarto stato, dipinto.
S. Freud, L'interpretazione dei sogni.
1901
17 gennaio: Roma, Venezia, Torino, Genova, Verona, Napoli: Mascagni: Le maschere.
31 gennaio: Mosca,Teatro d'Arte: Cechov, Le tre sorelle, commedia.
10 dicembre: Torino, Alfieri: Gerolamo Rovetta, Romanticismo, dramma.
Thomas Mann, I Buddenbrook, romanzo. - Kipling, Kim, romanzo.
Viene fondata a Bari la casa editrice Laterza.
Politica, Società, Scienza, Scoperte
1900
In Italia le elezioni politiche segnano una netta sconfitta per il governo reazionario di Pelloux; gli
succede il liberale Giuseppe Saracco.
Maggio: le diplomazie occidentali inviano al governo cinese un ultimatum perché reprima la
rivolta dei boxers.
29 luglio: viene ucciso a Monza dall'anarchico Gaetano Bresci il re Umberto I; gli succede il figlio
Vittorio Emanuele III.
Agosto: una spedizione internazionale delle potenze occidentali attacca la Cina, occupa Pechino e
libera le legazioni dall'assedio dei boxers.
La Russia occupa la Manciuria.
Il fisico tedesco Max Planck enuncia la teoria dei quanti. Il fisico e chimico britannico William
Crookes isola l'uranio. Il medico austriaco Karl Landsteiner individua i gruppi sanguigni.
Il fisico Valdemar Poulsen riesce per primo a registrare la voce umana su filo magnetico.
Lo svizzero E. Brandenberger inventa il cellofan.
2 luglio: Ferdinand von Zeppelin effettua il primo volo con dirigibile ad armatura rigida.
Un frate francese, P Clément, ottiene l'agrume ibrido, noto come clementina.
Si inaugura l'esposizione universale di Parigi.
Viene fondata aTorino la prima università popolare italiana. Viene istituita la Coppa Davis nel
gioco del tennis. A Parigi si svolgono le Olimpiadi.
1901
22 gennaio: muore a Osborne in Inghilterra la regina Vittoria.
Giuseppe Zanardelli viene nominato capo del nuovo governo a orientamento liberale, con Giolitti
ministro degli interni.
Censimento generale in Italia: Li popolazione ammonta a 33.778.000 residenti.
Si intensifica l'emigrazione di italiani verso le Americhe.
14 settembre: viene assassinato da un anarchico il presidente degli Stati Uniti, William McKinley;
gli succede Theodore Roosevelt.
Le colonie inglesi dell'Australia riunite vengono costituite in dominion.
Nelle Filippine Aguinaldo viene catturato e il paese deve sottomettersi agli Stati Uniti.
Marconi realizza la prima trasmissione telegrafica fra l'Europa e l'America.
Pensieri di Verdi
sull'arte
In casa mia non vi è quasi musica; non sono mai andato in una Biblioteca musicale, mai da
un'Editore per esaminare un pezzo. Stò a giorno d'alcune delle migliori opere contemporanee, non
mai studiandole, ma sentendole qualche volta in teatro [...]. Io sono fra i Maestri passati e
presenti, il meno erudito di tutti. Intendiamoci bene, e sempre per non fare blague: dico erudizione,
e non sapere musicale. Da questo lato mentirei se dicessi che nella mia gioventù non abbia fatto
lunghi e severi studj. Egli è per questo, che mi trovo aver la mano abbastanza forte a piegare la
nota come desidero, ed abbastanza sicura per ottenere, ordinariamente, gli effetti ch'io immagino; e
quando scrivo qualche cosa d'irregolare, si è perché la stretta regola non mi dà quel che voglio, e
perché non credo nemmeno buone tutte le regole finora adottate. Forse i Trattati di Contrappunto
han bisogno di riforma. [4 marzo 1869, a Filippo Filippi]
Per quanta poca esperienza io mi possa avere, vado nonostante in teatro tutto l'anno, e stò attento
moltissimo: ho toccato con mano che tante composizioni non sarebbero cadute se vi fosse stata
miglior distribuzione nei pezzi, meglio calcolati gli effetti, più chiare le forme musicali... insomma
se vi fosse stata maggior esperienza sì nel poeta che nel maestro.Tante volte un recitativo troppo
lungo, una frase, una sentenza che sarebbe bellissima in un libro, ed anche in un dramma recitato,
fan ridere in un dramma cantato. [15 novembre 1843, a Guglielmo Brenna]
Quando ho un'idea generale di tutto il poema le note si trovano sempre. [19 agosto 1843, a
Francesco Maria Piave]
Sono stanco dei sogetti soliti. Io voglio fare una cosa che non voglio si giudichi dopo una sera è
bella è brutta... nò nò, amo che si quistioni un pezzo. [22 agosto 1846, a E M. Piave]
Leggo mal volentieri libretti che mi si mandano: è impossibile, o quasi impossibile che un altro
indovini quello che io desidero: io desidero sogetti nuovi, grandi, belli, variati, arditi..., ed arditi
all'estremo punto, conforme nuove etc. etc. e, nello stesso tempo, musicabili. [1° gennaio 1853, a
Cesare De Sanctis]
Tutto si può mettere in musica, è vero, ma non tutto può riescire d'effetto. Per fare della musica ci
vogliono strofe per fare i cantabili, strofe per concertare le voci, strofe per fare dei larghi, degli
allegri, ecc. ecc. e tutto ciò alternato in modo che nulla riesca freddo e monotono. [30 agosto 1853,
ad Antonio Somma]
E il verso, la rima la strofa? non so che dire; ma io quando l'azione lo domanda, abbandonerei
subito ritmo, rima, strofa; farei dei versi sciolti per poter dire chiaro e netto tutto quello che
l'azione esige. Pur troppo per il teatro è necessario qualche volta che poeti e compositori abbiano il
talento di non fare né poesia né musica. [17 agosto] 870, ad Antonio Ghislanzoni]
In un dramma lo stile e la lingua non valgono se non v'è azione. [...] Io musicherei colla massima
sicurezza un soggetto che mi andasse a sangue, fosse anche condannato da tutti gli artisti come
immusicabile. (25 febbraio 1854, a Giuseppina Appiani)
In teatro il lungo è sinonimo di nojoso, ed il nojoso è il peggiore di tutti i generi. (31 marzo 1854,
ad A. Somma]
Io metterei in musica anche una gazzetta, od una lettera ecc. ecc. ma il pubblico ammette tutto in
teatro fuori che la noja. [7 aprile 1856, ad A. Somma]
Ahimè! Le lungaggini producono la noia, e nulla resiste alla noia! Quando si ha la disgrazia di
essere maestri di musica bisogna avere un coraggio che è massimo, supremo: il coraggio di tagliare
anche talvolta le cose che sono buone. [11 dicembre 1885, a Opprandino Arrivabene]
Certo non bisogna scrivere esclusivamente pel tale o tale altro cantante, ma pure è necessario che
il cantante abbia capacità e mezzi atti a rendere la parte che gli si destina; un'opera male eseguita, o
fiaccamente eseguita, è come un quadro visto al bujo: non si capisce. [14 maggio l857, a Vincenzo
Torelli]
La lunga esperienza mi ha confermato nelle idee che io ebbi sempre riguardo all'effetto teatrale,
quantunque ne' miei primordi non avessi il coraggio che di manifestarle in parte. (Per esempio
dieci anni fa non avrei arrischiato di fare il Rigoletto). Trovo che la nostra opera pecca di soverchia
monotonia, e tanto che io rifiuterei oggi di scrivere soggetti sul genere del Nabucco, Foscari ecc.
ecc. Presentano punti di scena interessantissimi, ma senza varietà. È una corda sola, elevata se
volete, ma pur sempre la stessa. [...] Per l'istessa ragione preferisco Shakespeare a tutti i
drammatici, senza eccettuarne i Greci. [22 aprile 1853, ad A. Somma]
La sola cosa che mi ha trattenuto di trattare con maggior frequenza i soggetti di Shakespeare è
stata [...] questa necessità di cambiar scena ad ogni momento. Quando io frequentava il teatro era
cosa che mi dava una pena immensa, mi pareva d'assistere alla lanterna magica. [29 giugno 1852,
ad A. Somma]
La critica fa il suo mestiere; giudica e deve giudicare secondo norme e forme stabilite; l'artista deve
scrutar nel futuro, veder nel caos nuovi mondi; e se nella nuova strada vede in fondo il lumicino,
non lo spaventi il buio che l'attornia; cammini, e se qualche volta inciampa e cade, s'alzi e tiri dritto
sempre. È bello qualche volta anche una caduta in un capo-scuola". [23 dicembre 1867, a
V.Torelli]
In quanto a questo perpetuo spauracchio di decadenza che nasce ad ogni epoca fin dai tempi di
Marcello è cosa veramente da riderne. [...] Non sono io quello che devo difendere la mia epoca né
accusare le passate, ma sarebbe ben facile il dimostrare, in alcuni dei capi d'opera d'un tempo, lo
stupido convenzionalismo dei pezzi, la pedanteria dei pezzi concertati, la melodia il più delle volte
convertita in esercizi di solfeggio, l'espressione falsa, e l'istromentale duro, pesante, monotono,
senza poesia e sopratutto senza perché. Anche noi abbiamo i nostri difetti e grandi, ma è certo che
v'è meno convenzionalismo, più verità nella forma; nei pezzi d'assieme tutti hanno un linguaggio
proprio alle loro passioni (e ciò sarà anche brutto ma è un gran progresso), l'espressione è più vera,
e l'istromentale sopratutto ha un significato, uno scopo che non aveva altra volta. [30 maggio
1868, a Giuseppe Piroli]
Sembrerà strana una melodia su parole che sembrano dette da un avvocato. Ma sotto queste parole
d'avvocato, vi è un cuore di donna [Amneris] disperata ed ardente d'amore. La musica può riuscire
egregiamente a dipingere questo stato dell'animo e a dire in certo modo, due cose in una volta. È
una qualità di quest'arte mal considerata dai critici e mal tenuta dai maestri. [26 ottobre 1870, ad
A. Ghislanzoni]
In questo momento è venuto di moda di gridare e di non volere ascoltare le cabalette. È un errore
uguale a quello di una volta che non si voleva altro che cabalette. Si grida tanto contro il
convenzionalismo e se ne abbandona uno per abbracciarne un altro! [27 aprile 1872, a
O.Arrivabene]
Non ho tanto orrore delle cabalette, e se domani nascesse un giovine che ne sapesse fare qualcuna
del valore per es. del "Meco tu vieni o misera" oppure "Ah perché non posso odiarti" andrei a
sentirla con tanto di cuore, e rinuncerei a tutti gli arzigogoli armonici, a tutte le leziosaggini delle
nostre sapienti orchestrazioni. Ah, il progresso, la scienza, il verismo...! Ahi, ahi! Verista finché
volete, ma... Shakespeare era un verista, ma non lo sapeva. Era un verista d'ispirazione; noi siamo
veristi per progetto, per calcolo. Allora tanto fa: sistema per sistema, meglio ancora le cabalette. Il
bello si è che, a furia di progresso, l'arte torna indietro. L'arte che manca di spontaneità, di
naturalezza e di semplicità, non è più arte. [20 novembre 1880, a Giulio Ricordi]
Copiare il Vero può essere una buona cosa, ma Inventare il Vero è meglio, molto meglio. Pare vi
sia contradizione in queste tre parole: inventare il vero, ma domandatelo al Papà [Shakespeare].
Può darsi che Egli, il Papà si sia trovato con qualche Falstaf, ma difficilmente avrà trovato un
scellerato così scellerato come Jago, e mai e poi mai degli angioli come Cordelia, Imogene ,
Desdemona etc. etc... eppure sono tanto veri!... Copiare il vero è una bella cosa, ma è fotografia,
non Pittura. [20 ottobre 1876,a Clara Maffeil
Tutti, o quasi tutti credi tu che parlino conoscendo ed intendendo qualche cosa?... Credi tu che
tutti, o quasi tutti penetrino nelle viscere d'una composizione e comprendano gli intendimenti del
compositore? Mai e poi mai! Ma è inutile parlarne. L'arte, la vera Arte, quella che crea, non è l'arte
sdentata che ci predicano i critici, che alla fine poi non s'intendono nemmeno fra loro. Io vorrei che
mi definissero due parole che hanno sempre in bocca, melodia ed armonia! Sai tu cosa vogliono
dire?... Io non lo so davvero. [21 luglio 1874, a O. Arrivabene]
Resta a decidere [...] cosa s'intende per melodia, per armonia etc. e di tutte le altre coglionerie che
non hanno significato nissuno. Per es. se qualcuno ti dicesse che gli antichi non sapevano cosa
fosse melodia, e prima di tutti Palestrina; che nel Barbiere di Siviglia, a parte "Ecco ridente in
cielo", non vi è melodia... solfeggio sì, melodia no... cosa parrebbe a te una gran bestemmia?... [16
aprile 1873, a o. Arrivabene]
Nella musica vi è qualche cosa di più della melodia: qualche cosa di più dell'armonia: vi è la musica!
[2 settembre 1871,a O. Arrivabene]
Chi vuol essere melodico come Bellini, chi armonista come Meyerbeer. Io non vorrei né l'uno né
l'altro, e vorrei che il giovane quando si mette a scrivere, non pensasse mai ad essere né melodista,
né armonista, né realista, né idealista, né avvenirista, né tutti i diavoli che si portino queste
pedanterie. La melodia e l'armonia non devono essere che mezzi nella mano dell'artista per fare
della Musica, e se verrà un giorno in cui non si parlerà più né di melodia né di armonia né di scuole
tedesche, italiane, né di passato né di avvenire etc. etc. etc. etc. allora forse comincierà il regno
dell'arte. Un altro guaio dell'epoca si è che tutte le opere di questi giovani sono frutto della paura.
Nissuno scrive con abbandono, e quando questi giovani si mettono a scrivere, il pensiero che li
predomina si è di non urtare il pubblico e di entrare nelle buone grazie dei critici! [16 luglio 1875,
a O.Arrivabenc]
In fatto d'opinioni musicali bisogna esser larghi, e per parte mia sono tollerantissimo. Ammetto i
melodisti, gli armonisti, i secca c... e quello che vogliono ad ogni costo seccarti per bon ton.
Ammetto il passato, il presente, ed ammetterei il futuro se lo conoscessi e lo trovassi buono. In una
parola melodia, armonia, declamazione, canto fiorito, effetti d'orchestra, color locale (parole di cui
si fa tant'uso, e che il più delle volte non servono che a coprire la mancanza del pensiero) non sono
che mezzi. Fate con questi mezzi della buona musica, ed ammetto tutto, e tutti i generi. Per es. nel
Barbiere la frase
Signor, giudizio per carità
questa non è melodia né armonia: è la parola declamata giusta vera; ed è musica... Amen... [17
marzo 1882, a O. Arrivabene]
So anch'io che vi è una Musica dell'avvenire,ma io presentemente penso e penserò così anche
l'anno venturo che per fare una scarpa ci vuole del corame e delle pelli!... Che ti pare di questo
stupido paragone che vuol dire che per fare un'opera bisogna aver in corpo primieramente della
musica?!... Dichiaro che io sono e sarò un ammiratore entusiasta degli avveniristi a una condizione
che mi facciano della musica... qualunque ne sia il genere, il sistema ecc. ma musica! [...]. Sta'
tranquillo. Mi possono benissimo mancare le forze per arrivare dove io voglio, ma io so quello che
voglio. [6 marzo 1868, a o. Arrivabenej
Voi sapete come me, che vi sono di quelli che hanno buona vista, ed amano i colori franchi, decisi, e
sinceri. Altri vi sono che hanno un po' di cateratta: ed amano i colori sbiaditi, e sporchi. Sono alla
moda, ed io non disapprovo seguir la moda (perché bisogna essere del proprio tempo), ma la vorrei
accompagnata sempre da un po' di criterio e di buon senso. Dumque né passato né avvenire! - È
vero che io ho detto:" Torniamo all'antico!" Ma io intendo l'antico, che è base, fondamento,
solidità. Io intendo quell'antico che è stato messo da parte dalle esuberanze moderne, ed a cui si
dovrà ritornare presto, o tardi infallibilmente. Per ora lasciamo che il torrente straripi. Gli argini
si faranno dopo. [26 dicembre 1883, a G. Ricordi]
Il dilettantismo (fatale sempre in tutte le arti) per ismania di novità, e per moda, corre dietro al
vago, allo strano, ed, affettando entusiasmi, và ad annojarsi ad una musica straniera ch'Egli chiama
Classica, e... la Gran Musica. Perché poi Classica e Gran Musica? Chi sa!! Il giornalismo pure
(altro flagello dei nostri tempi) vanta tal musica per attirare l'attenzione, e per far credere di capire
quello che gli altri non capiscono, o capiscono meno. La folla incerta ed indecisa, tace, e corre
dietro. Malgrado questo, io non mi spavento, ripeto, convinto che quest'arte tanto artificiosa, e
strana molte volte per progetto, non sia conforme alla natura nostra. Noi siamo positivi, ed in gran
parte scettici. Crediamo poco; e non possiamo alla lunga credere alle fantasticherie di quest'arte
straniera che manca di naturalezza e di semplicità. Ora l'arte che manca di naturalezza e semplicità
non è Arte! L'ispirazione stà necessariamente nel semplice! [17 dicembre 1884, a Clara Maffei]
A me piace nelle arti tutto quello che è bello. Io non ho esclusività; io non credo alla scuola, e mi
piace il gajo, il serio, il terribile, il grande, il piccolo, etc. etc.Tutto tutto, purché il piccolo sia
piccolo, il grande sia grande, il gajo sia gajo etc. etc... Insomma, che tutto sia come deve essere:
Vero e Bello. [14 maggio 1873, a Domenico Morelli]
Ammetto la severità [del pubblico], ne accetto i fischj, alla condizione che nulla mi si richiegga
per gli applausi. Noi poveri zingari, ciarlatani, e tutto quello che volete, siamo costretti a vendere
le nostre fatiche, i nostri pensieri, i nostri delirj per dell'oro - il pubblico per tre lire compera il
diritto di fischiarci o di applaudirci. Nostro destino è di rassegnarci, ecco tutto! [...] Trista cosa il
teatro!! [4 febbraio 1859, a Tito Ricordi]
Verdi a Sant’Agata. fotografia
Non m'hanno mai sorpreso i scandali in teatro e [...] a 26 anni conobbi cosa significava pubblico.
Da quell'epoca in poi i successi non m'hanno mai fatto montare il sangue alla testa, ed i fiaschi non
mi hanno mai scoraggiato. Se ho continuato in questa malaugurata carriera si è perché a 26 anni
era troppo tardi per fare altra cosa, e perché non avevo fisico abbastanza robusto per tornare a'
miei campi. [9 febbraio 1859, a Filippo Filippi]
Questi impresari non hanno ancora capito che quando le opere non si possono dare nella loro
integrità, come sono state ideate dall'autore, è meglio non darle; non sanno che la trasposizione di
un pezzo, di una scena è quasi sempre la causa del non successo d'un'opera. Immaginati quando si
tratta di cambiare argomenti!! [1° dicembre 1851, a Vincenzo Luccardi]
Io ho sempre soddisfatti gli impegni presi con tutta coscienza: il pubblico li ha accolti egualmente
con tutta coscienza, con buoni fischi od applausi, etc. etc. Nissuno dunque ha diritto di lagnarsi, e
ripeto ancora: partita saldata. [11 marzo 1871, a Clara Maffei]
A dire il vero io son proprio poco grazioso in teatro... ed anche fuori; è perché io ho la disgrazia di
non capire mai quello che gli altri capiscono; ed appunto perché non capisco, non mi riesce mai di
profferire una di quelle parole dolci, di quelle frasi che fanno andare in solluchero tutti. [...] Tante
e tante volte ho sentito a Milano dirmi (persino quando misi in scena la Forza del destino! Tutto
dire!): La Scala è il primo Teatro del Mondo". A Napoli: Il S. Carlo primo Teatro del Mondo. In
passato a Venezia si diceva: La Fenice, il primo Teatro del Mondo. A Pietroburgo: Primo Teatro
del Mondo. A Vienna Primo Teatro del Mondo (e per questo starei anch'io). A Parigi poi l'Opéra è
il Primo Teatro di Due o Tre Mondi! [21 febbraio 1879, a Clara Maffei]
Mi vien da ridere quando leggo, o sento dire "un effetto che l'autore non s'era immaginato"! Poveri
innocenti! Per quelli che non conoscono né canto. né orchestra può darsi, ma per me non ho mai
trovato né cantante né orchestra che m'abbiano reso tutto quello che domandavo. [21 marzo 1868,
a G. Ricordi]
Nelle musiche attuali la Direzione musicale e drammatica è una vera necessità. Una volta una
prima Donna un tenore con una cavatina, un Rondò, un Duetto etc. etc. potevano sostenere
un'opera (se era un'opera); oggi no. Le opere moderne, buone o-cattive, hanno intendimenti ben
diversi! [...] Predicate il bisogno assoluto di uomini capaci alla Direzione delle musiche teatrali,
mostrate l'impossibilità dei successi senza un'interpretazione intelligente. [5 febbraio 1871, a G.
Ricordi]
Sulla divinazione dei Direttori, e sulla creazione ad ogni rappresentazione... Quest'è un principio
che conduce addirittura al barocco, ed al falso. [...] Nò: io voglio un solo creatore, e mi accontento
che si eseguisca semplicemente ed esattamente, quello che è scritto: il male stà, che non si
eseguisce mai quello che è scritto! - I.eggo sovente nei giornali d'effetti non immaginati
dall'Autore; ma io, per parte mia, non li ho mai, mai trovati. [...] Io non posso ammettere, né nei
Cantanti, né nei Direttori la facoltà di creare, che [...] è un principio che conduce all'abisso... [11
aprile 1871, a G. Ricordi]
Gli anni cominciano proprio ad essere troppi e penso... penso che la vita è la cosa più stupida, e
quello che è ancor peggio inutile. Cosa si fa? Cosa abbiamo fatto? Cosa faremo? Stringendo ben
tutto, la risposta è una, umiliante e tristissima
NULLA!
[11 ottobre 1883, a Clara Maffei]
Introduzione alle opere
di Giuseppe Verdi
Il catalogo. Ventisei sono le opere composte da Verdi nell'arco di oltre mezzo secolo di attività
dedicata al teatro in musica, dal 1836 (Rocester) al 1894 (Othéllo). Ma ventotto sono tuttavia i
titoli presenti nel suo catalogo operistico. La differenza si spiega con il fatto che due titoli
riguardano opere che il maestro adattò in seguito a un nuovo argomento con titolo
diverso:Jérusalem (1847), per la quale il maestro trasfuse gran parte della musica dei Lombardi
(1843), e Aroldo (1857), cui adattò la musica di Stiffelio (1850) con l'aggiunta di un quarto atto.
Ma revisioni fors'anche più radicali dal punto di vista sia drammaturgico che musicale Verdi operò
per altre sue quattro opere, mantenendone tuttavia il titolo originale: Macbeth (1847, 1865),
Simon Boccanegra (1857,1881), La forza del destino (1862, 1869) e Don Carlos (1869, 1884).
Ritocchi non marginali apportò anche alla musica di Traviata (1853, 1854) dopo il suo poco felice
esito alla Fenice.Altre opere furono da lui ritoccate per la versione francese all'Opéra di Parigi:Il
trovatore (Le trouvère, 1857) e Otello (Othéllo, 1894), alle quali aggiunse i ballabili, nonché Aida
(1880); solo i ritocchi a quest'ultima opera, riguardanti un ampliamento del ballo nel finale del
terzo atto, furono accolti nella versione definitiva. Inoltre compose alcune arie alternative per
Nabucco, I Lombardi, Emani, I due Foscari, Giovanna d'Arco, Attila, I vespri siciliani. Fra le opere
cui egli non ebbe bisogno di mettere nuovamente mano figurano alcuni capolavori quali Rigoletto
e Un ballo in maschera. Ventuno opere furono composte in quelli che Verdi stesso definì i suoi
"sedici anni di galera", fra il 1842 e il 1858, dal Nabucco a Un ballo in maschera. Il periodo più
intenso di questa "galera" fu il decennio che va dal 1842 al 1851; in questo periodo, precisamente
tra il 1844 e il 1847, varò fin due opere all'anno (ciò non gl'impedì di scrivere due capi d'opera
come Emani e Macbeth, per non parlare dei Due Foscari e di Attila...).
I luoghi. Sette opere scrisse per la Scala di Milano, all'inizio e in fine di carriera: dapprima
Oberto,Il finto Stanislao, Nabucco, I Lombardi, Giovanna d'Arco, quindi Otello e Falstaff, queste
due precedute dalla 'prima' europea di Aida e dalle nuove versioni della Forza del destino, del
Simon Boccanegra e del Don Carlos. Cinque opere scrisse per la Fenice di Venezia: Emani, Attila,
Rigoletto, Traviata e Simon Boccanegra; quattro per i teatri di Roma: I due Foscari, La battaglia
di Legnano, Il trovatore e Un ballo in maschera; tre per l'Opéra di Parigi:Jérusalem,I vespri
siciliani e Don Carlos (destinando all'Opéra Lyrique la nuova versione del Macbeth); due per il S.
Carlo di Napoli (Alzira e Luisa Miller) e due per Trieste (Il corsaro e Stiffelio); una per Firenze
(Macbeth), per Londra (I masnadieri), per Rimini (Aroldo), per Pietroburgo (La forza del destino)
e per Il Cairo (Aida).
I librettisti. A partire quanto meno dai Due Foscari, di molti libretti il vero autore fu, salvo i
versi, Verdi stesso, il quale preferiva valersi dapprima di uno schizzo (nel caso dei Due Foscari, di
Attila e di Macbeth preparatogli con tutta probabilità da Andrea Maffei), dal quale ricavava un
'programma' con disegnate le scene e tracciati dialoghi in prosa, che poi inviava al librettista con
l'incarico di tradurlo in versi "musicabili". Questo metodo fu da lui adottato con Piave dai Due
Foscari in poi, con Somma per Un ballo in maschera, con Ghislanzoni per Aida. I suoi librettisti
furono:
Antonio PIAZZA: Oberto (con interventi e aggiunte di Solera e, forse, di Merelli; pubblicato
anonimo). Felice Romani: Il finto Stanislao (con interventi di Solera). Temistocle SOLERA:
Nabucco, Lombardi,Giovakna d'Arco,Attila (con interventi di Piave). Francesco Maria PIAVE:
Ernani,I due Foscari, Macbeth' (con interventi di Maffei), Il corsaro, Stiffelio, Rigoletto, Traviata,
Simon Boccanegra (con interventi di Giuseppe Montahelli; quindi, per la versione definitiva, con
interventi e aggiunte di Boito),Aro/do, La forza del destino (con interventi e aggiunte di
Ghislanzoni, dopo la malattia di Piave, per la versione definitiva). Salvadore CAMMARANO:
Alzira, La battaglia di Legnano, Luisa Miller, , Il Trovatore (con interventi, dopo la morte di
Cammarano, di Emanuele Bardare). Andrea MAFFEI: I masnadieri. Alphonse ROYER e Gustave
VA£Z:Jérusalem. Eugène SCRIBE: I vespri siciliani. Antonia "SOMMA: Un ballo in maschera
(pubblicato anonimo). Joseph MÉRY e Camille DU LOCLE: Don Carlos (con modifiche e
aggiunte di Du Lode per la versione in 4 atti). GHISLANZONI: Aida. Arrigo BOITO: Otello,
Falstaff
Antonio PIAZZA: del primo librettista di Verdi (da non confondere con l'omonimoAntonio Piazza,
scrittore e drammaturgo veneziano, morto a Milano nel 1825), non si conosce molto; si sa che era
impiegato del governo lombardo e svolgeva attività poeta, di scrittore e soprattutto di giornalista.
Felice ROMANI (Genova 1788 - Moneglia, 1865) è considerato il maggiore librettista italiano
dell'Ottocento. Fu poeta del teatro alla Scala dal 1813 al 1833, quindi direttore, per volere di Carlo
Alberto, della "Gazzetta ufficiale piemontese" dal 1834 al 1849, per la quale svolse anche attività di
critico teatrale. Gli si devono tutti i libretti per Bellini, dal Pirata alla Beatrice di Tenda; scrisse
inoltre libretti per Rossini (Aureliano in Palmira, Il turco in Italia, Bianca e Faliero), per Donizetti
(Anna Bolena, L'elisir d'amore, Lucrezia Borgia), per Simone Mayr, Mercadante, Coccia, Pacini,
Meyerbeer,Vaccai e altri ancora. Il suo libretto del Finto Stanislao, composto per il maestro boemo
Adalbert Gyrowetz, risale al 1818; non si sa se Verdi si fosse rivolto all'autore, che ormai risiedeva
a Torino, per introdurvi delle modifiche; ma sembra ormai accertato che esse per la maggior parte
furono operate da Verdi stesso in collaborazione con Solera. Qualche biografo suppone che il
"distinto poeta" cui Verdi allude nel corso delle trattative per la sua prima opera alla Fenice, prima
che gli venisse suggerito il nome di Piave, fosse appunto Romani (ma avrebbe potuto essere, a
maggior ragione, Andrea Maffei). È tuttavia certo che Verdi ebbe rapporti diretti con Romani per
una cantata da eseguirsi a Milano in occasione di un convegno scientifico, intitolata Flavio Gioia,
che il maestro rinunciò a musicare per l'eccessiva lunghezza del libretto.
Temistocle SOLERA (Ferrara 1815 - Milano 1878), figlio di un patriota affiliato alla Carboneria,
studiò a Vienna. Trasferitosi a Milano, svolse attività di poeta e di compositore, facendo
rappresentare, fra l'altro, due sue opere alla Scala su libretto proprio. Nel 1845 si trasferì in Spagna
al seguito della moglie cantante e si fece impresario, diventando inoltre consigliere della regina
Isabella. Rientrato in Italia nel 1859, fu nominato "corriere segreto" fra Cavour e Napoleone III.
Fu poi delegato di polizia in Basilicata allo scopo di reprimervi il cosiddetto "brigantaggio". In
seguito rivestì l'incarico di questore in alcune città italiane (Firenze,Venezia, Bologna, Palermo).
Nel corso delle sue peregrinazioni scrisse alcuni libretti per opere che tuttavia non ebbero fortuna.
Dopo essere stato chiamato in Egitto a riorganizzarvi la polizia, si trasferì a Parigi, dove tentò
l'attività dell'antiquario e dove scrisse il suo ultimo libretto. Ridotto ormai in miseria, ritornò a
Milano, dove morì quasi ignorato.
Francesco Maria PIAVE (Murano 1810 - Milano 1876) fu il librettista che seppe interpretare,
forse meglio di altri, il pensiero drammaturgico del maestro, per il quale scrisse e versificò ben
dieci libretti. In gioventù si trasferì, a causa di traversie familiari, a Roma, dove si mise in luce
come poeta e scrittore. Rientrato a Venezia nel 1838, si impiegò come correttore di bozze nella
Tipografia Antonelli. Nell'inverno del 1843 passò al servizio alTeatro della Fenice scrivendo il suo
primo libretto per Verdi: Cromvello, divenuto Allan Cameron, poi sostituito da Emani. Il grande
successo di quest'opera e quello, a breve distanza, dei Due Foscari, proiettarono il nome di Piave
nel firmamento melodrammatico italiano di quegli anni. Verdi, sempre molto affabile nei rapporti
d'amicizia con il poeta muranese (uno dei pochissimi amici e collaboratori cui dava del tu), fu
invece esigentissimo, quasi inesorabile nei suoi confronti, sul tavolo di lavoro. Piave si sottomise
sempre al maestro con cieca fiducia:"El maestro vol cussì e mi devo contentarlo" soleva ripetere ai
denigratori (ed erano tanti!) dei suoi versi. Tenne l'impiego veneziano in qualità di direttore degli
spettacoli e di poeta fino al 1859, partecipando fra l'altro agli eventi politici del Quarantotto che
condussero all'effimera Repubblica veneziana e vestendo la divisa della Guardia
Nazionale.Trasferitosi a Milano nel 1860, ottenne con l'appoggio di Verdi, l'impiego di direttore
degli spettacoli alla Scala, incarico rinnovatogli fino al 1867, allorché, colpito da paralisi, fu
costretto a vegetare pressoché incosciente in un letto d'ospedale fino alla morte. I funerali furono
fatti a spese di Verdi, che inoltre patrocinò la pubblicazione di un Album di musiche di vari autori a
beneficio della famiglia. Oltre ai dieci libretti per Verdi, Piave ne scrisse, fra l'altro, per Pacini
(Lorenzino de' Medici,Allan Cameron), per i fratelli Ricci (il fortunatissimo Crispino e la comare),
per Mercadante, per Achille Peri.
Andrea MAFFEI (Molina in val di Ledro 1798 - Milano 1885). Fu uno dei primi amici del
compositore, che lo conobbe con tutta probabilità durante l'apprendistato all'Accademia
filarmonica diretta da Pietro Massini, di cui Maffei era membro. Nel 1832 aveva sposato Clara
Carrara-Spinelli (la quale poco più tardi aprirà il famoso "salotto Maffei"), per poi separarsene
legalmente nel 1846, avendo a testimoni Verdi e Giulio Carcano. Fu scrittore e poeta; ma il suo
nome si raccomanda alle numerose traduzioni dall'inglese (Il paradiso perduto di Milton, le
tragedie di Shakespeare, molti drammi e poemi di Byron) e soprattutto dal tedesco (il Faust di
Goethe, la Messiade di Klopstock, l'Avola di Grillparzer e tutte le tragedie di Schiller). Oltre al
libretto dei Masnadieri, collaborò con Verdi redigendo lo schizzo dell'Attila e con tutta probabilità
anche quelli dei Due Foscari e del Macbeth, al cui libretto diede il proprio contributo su esplicita
richiesta del compositore, scontento di alcuni scene versificate da Piave.
Salvadore CAMMARANO (Napoli 1801-1852). È il librettista italiano più illustre, dopo Felice
Romani, della prima metà dell'Ottocento. Discendente da una generazione di attori,
commediografi, compositori, pittori e cantanti, fu egli stesso pittore, poeta e autore drammatico. Il
suo nome si raccomanda soprattutto ai libretti; ne scrisse per Donizetti (Lucia di Lammermoor,
Belisario, Roberto Devereux , Poliuto , Maria di Rohan), per Pacini (Saffo, Buondelmonte), per
Mercadante (La vestale, Il reggente, Orazi e Curiazi), per De Giosa (Folco d'Arles).Verdi lo tenne
in grande stima, tanto che fu con lui che volle avviare il progetto del mai realizzato Re Lear.
Eugène SCRIBE (Parigi 1791-1861). Il suo nome divenne famoso in tutto il mondo come autore
teatrale: scrisse innumerevoli commedie e vaudevilles che entrarono subito nel repertorio delle
compagnie drammatiche di tutta Europa. Come librettista contribuì in maniera determinante a
fissare il canone del grand-opéra e a trasformare l'opéra-comique in un vero e proprio dramma
musicale. Fra i tanti suoi libretti - per la maggior parte composti con l'ausilio di collaboratori - si
ricordano qui, per Hérold: La sonnambula (fonte ispiratrice di Romani per l'omonima opera di
Bellini); per Boieldieu: La dama bianca; per Rossini: Il conte Ory; per Auber: La muta di Portici,
Fra Diavolo, Il filtro (anch'esso fonte ispiratrice di Romani per L'elisir d'amore), Gustavo III (che a
sua volta sarà la fonte per Verdi di Un ballo in maschera), Manon Lescaut; per Meyerbeer:
Roberto il diavolo, Gli Ugonotti, Il profeta, La stella del Nord; per Cherubini: Ali Babà; per
Halévy: L'ebrea; per Donizetti: I martiri, La favorita, Don Sebastiano, Il duca d'Alba; per Gounod:
La nonne sanglante.
Antonio SOMMA (Udine 1809 - Venezia 1865). Poeta, scrittore, giornalista e drammaturgo, visse
a lungo a Trieste, dove diresse il Teatro Grande dal 1840 al 1847 e dove fondò, con Dall'Ongaro e
altri, il giornale "La Favilla", d'ispirazione irredentista. Fra i suoi drammi si ricorda Parisina
(1835), che ebbe un periodo di fortuna sulle scene nell'interpretazione di Adelaide Ristori, di cui
Somma fu per qualche tempo copionista. Irritato per gl'interventi della censura romana ai versi di
Un ballo in maschera, non volle firmarne il libretto. A lui, dopo la morte di Cammarano,Verdi
affidò il progetto del Re Lear.
Antonio GHISLANZONI (Lecco 1824 - Caprino Bergamasco 1893). Scacciato dal seminario per
indisciplina, frequentò la facoltà di medicina all'Università di Pavia, scrivendo frattanto poesie e
racconti. Scopertasi una voce di baritono, studiò canto, debuttando a Lodi nel gennaio del 1847. Di
idee repubblicane, arrestato a Roma dai francesi e deportato in Corsica, riprese l'attività di
cantante, dapprima a Bastia e quindi in Francia, arrivando a calcare le scene del Teatro Italiano di
Parigi cantando la parte di Carlo nell'Emani. Rientrò a Milano nel 1854, ammalato di una
bronchite che gli danneggiò la voce. Dopo essere stato fischiato al teatro Carcano cessò l'attività di
cantante per darsi al giornalismo e alla letteratura, collaborando a diversi giornali e dirigendo, fra
l'altro, !'"Italia musicale" e quindi la "Gazzetta musicale di Milano". Spirito arguto e penna
brillante, acquistò subito notorietà nel mondo artistico milanese. Nel 1857 iniziò l'attività di
librettista, scrivendo testi per Gomes (Fosca e Salvator Rosa), Petrella (I promessi sposi),
Ponchielli (I lituani), Cagnoni, Catalani, e affermandosi fra i migliori librettisti del tempo per
l'accuratezza dei suoi versi. Conobbe Verdi a Milano intorno al 1845-1846, quando era ancora
cantante. Ma l'occasione di collaborare con lui verrà oltre vent'anni più tardi. Fu l'editore Ricordi a
proporre il suo nome al maestro nel 1868 per la stesura del nuovo finale della Forza del destino.
Soddisfatto della sua collaborazione, Verdi gli affidò poi la versificazione del libretto di Aida,
ricorrendo ancora a lui per alcuni versi del Don Carlo in italiano.
Arrigo BOITO (Padova 1842 - Milano 1918). Fu poeta, librettista e compositore. Aderì
giovanissimo alla Scapigliatura milanese dando inizio a un'intensa attività giornalistica a sostegno
delle proprie idee intorno alla riforma del melodramma. Nel 1865 diede alle stampe il poemetto Il
Re Orso e nel 1877 il Libro dei versi. Iniziò l'attività di librettista nel 1863 con un Amleto per
Franco Faccio, mentre stava già componendo il Mefistofele su libretto proprioil clamoroso fiasco
di quest'opera alla Scala nel marzo del 1868 sembrò frenare definitivamente l'ardore dell'artista
padovano e condurlo gradualmente su posizioni di retroguardia, segnate da un atteggiamento
sempre più conservatore. Dopo la revisione del Mefistofele, risorto a Bologna nel 1875, attese alla
composizione di una seconda opera, Nerone, progettata già in gioventù, cui si dedicherà per il
resto della vita, senza tuttavia poterla vedere rappresentata a causa dei suoi continui ripensamenti.
Compose anche il libretto di Ero e Leandro, che rinunciò poi a musicare per cederlo dapprima a
Bottesini, quindi a Mancinelli. Scrisse pochi altri libretti, tutti firmati con lo pseudonimo Tobia
Gorrio, il più notevole dei quali è quello della Gioconda per Ponchielli. Il suo nome resta legato
soprattutto alle sue raccolte poetiche, al Mefistofele e ai due libretti (questi firmati col proprio
nome) per Verdi. La sua prima collaborazione con il maestro delle Roncole era avvenuta nel 1862
con il testo dell'Inno delle nazioni per l'Esposizione di Londra. A causa di un'incauta affermazione
fatta nel novembre del 1863 durante un banchetto in onore di Faccio, da Verdi ritenuta
gravemente offen-
Verdi. Dipinto a olio di Giovanni Boldini (Parigi, aprile 1886)
siva nei propri confronti, i rapporti fra i due subirono un raffreddamento destinato a protrarsi nel
corso degli anni. Con paziente tenacia e con fine diplomazia Giulio Ricordi, che in gioventù aveva
partecipato alle battaglie artistiche di Boito, riuscì lentamente a far riavvicinare il musicista e il
poeta nel 1879 con il progetto di Otello.
Le fonti. Se si astrae dall'Oberto (le origini del cui argomento sono tuttora oscure; dal titolo
primitivo del libretto, Lord Hamilton, sembra potersi dedurre che Piazza si fosse dapprima ispirato
a una fonte inglese), dalla Giovanna d'Arco (che Solera dichiarò essere "dramma affatto originale",
solo in parte ispirato a Schiller), dai due grand oriéra Jérusalem e I vespri siciliani (entrambi
derivati da varie fonti) e dall'Aida (il cui soggetto deriva da un "programma" originale redatto da
Mariette Bey), gli argomenti dei libretti verdiani derivano in grande misura da fonti francesi
(nove); seguono le fonti inglesi (sei), quelle tedesche (quattro), e infine quelle spagnole (tre). Una
sola fonte italiana!: quella dei Lombardi. Ma ecco nel dettaglio: Alexandre Vincent Pineux-Duval:
Il finto Stanislao; Auguste Anicet-Bourgeois e Francis Cornu: Nabucco; Tommaso Grossi: I
Lombardi alla prima Crociata; Victor Hugo: Emani, Rigoletto; George Byron: I due Foscari, Il
corsaro; Voltaire: Alzira; Zacharias Werner: Attila;William Shakespeare: Macbeth, Otello, Falstaff;
Friedrich Schiller: I masnadieri, Luisa Miller, Don Carlos; Joseph Méry: La battaglia di Legnano;
Émile Souvestre e Eugène Bourgeois: Stiffelio; Antonio Garda Gutiérrez: Il Trovatore, Simon
Boccanegra; Dumas figlio: Traviata; Walter Scott:Aroldo; Scribe: Un ballo in mascbera;Angel
Saavedra: La forza del destino.
Gli interpreti. Verdi si mostrò sempre molto esigente sulla scelta degli interpreti delle proprie
opere (al punto che in occasione della Forza del destino preferì sobbarcarsi un secondo, faticoso
viaggio in Russia, pur di avere una interprete da lui ritenuta adatta alla parte di Leonora).A partire
dall'Emani fu il primo compositore a inserire nei contratti delle proprie opere la clausola con la
quale si riservava la facoltà di scegliere i cantanti dalla compagnia scritturata. Dal Rigoletto in poi
egli non segnò mai un contratto prima di sapere quali cantanti sarebbero stati scritturati.
Richiedeva cantanti che fossero buoni attori, non senza però che fosse garantito, e ciò fino alla sua
ultima opera, il primato del canto sull'azione, della voce sulla gestualità. Disse un giorno a un
cronista viennese: "sono dell'opinione che nell'opera la voce ha soprattutto il diritto di essere
ascoltata. Senza voce non vi è canto giusto". Le innumerevoli osservazioni del compositore intorno
al canto e ai cantanti disseminate nel suo sterminato epistolario riflettono le più diverse esperienze
maturate nel corso di oltre sessant'anni di ininterrotta attività artistica, un periodo incredibilmente
lungo, dall'epoca di Rossini all'alba del nuovo secolo, durante il quale Verdi ebbe a trattare con
intere generazioni di cantanti, dalla Frezzolini alla Stolz, da Guasco a Tamagno, da Ronconi a
Maurel. Scrisse per cantanti italiani e per cantanti stranieri; per voci forti e per voci deboli; per
cosiddetti `belcantisti' e per cantanti d'azione. Ma senza mai rinunciare alle ragioni del dramma e
sempre mirando a tradurre tali ragioni in canto, in espressione musicale autonoma. Ed è perciò che
nella sterminata galleria dei personaggi che animano il suo teatro non v'è carattere che assomigli a
un altro e non v'è parte che non richieda un'espressione musicale (e quindi vocale) sua propria. Ma
non per questo l'interprete deve andare oltre i confini del canto. I suoi criteri interpretativi si
possono riassumere nel consiglio dato a un suo interprete, Leone Giraldoni: "raccomando che
sieno evitati il più possibile questi rallentando che piacciono tanto alla maggior parte dei cantanti a
grande scapito del buon senso, e spesso anche dell'effetto. Che donne ed uomini cantino e non
gridino: abbino presente che declamare non vuol dire strillare. Se nella mia musica non vi sono
molti vocalizzi, non vi è per questo bisogno di mettersi le mani nei capelli, e smaniarsi come
furibondi". Varietà di coloriti, nettezza di attacco, diversità di piani sonori, spazialità della voce,
duttilità di fraseggio, dizione chiara, sempre in funzione del dramma, costituivano per Verdi una
condizione indispensabile. Si sa che egli amava le voci sfogate, in grado di raggiungere un
fortissimo da un estremo pianissimo e viceversa. Ma aveva anche un debole per interpreti di voce
non voluminosa, tuttavia penetrante e ricca di colori, come la Piccolomini, che insistentemente
volle per la parte di Cordelia nel mai realizzato Re Lear; come la Patti, che ritenne in assoluto la
migliore cantante-attrice da lui vista e ascoltata. Seppe sempre sfruttare le caratteristiche vocali
dei cantanti per i quali scriveva, ma di volta in volta piegandole alle esigenze dell'espressione
drammatica del personaggio che dovevano interpretare.Voce e vocalità non sono tuttavia la stessa
cosa. Né dalla lettura delle partiture né tanto meno dalle dichiarazioni contenute nell'epistolario
emergono elementi che in qualche misura possano accreditare il concetto, divenuto mito, della
voce verdiana. Sarebbe d'altronde un controsenso. È un termine che non significa nulla. Un flatus
vocis. Semmai nelle opere di Verdi è da tenere in massimo conto la concezione spaziale del canto
teatrale, dove ogni dimensione, in specie quella della profondità, contribuisce a connotare il
personaggio 'sonoro' e la sua funzione drammatica. Ma per questo non la voce in sé conta bensì
l'assoluto dominio dei mezzi vocali. Esistono, piuttosto, aspetti di stile vocale connessi con
l'interpretazione e con l'esecuzione che possono considerarsi peculiari del canto verdiano. Nel
corposo epistolario di Verdi si raccolgono parecchie critiche ai cantanti, anche famosi (perfino la
Malibran). Solo di due cantanti non disse che bene: di Giorgio Ronconi, "artista in tutta
l'estensione del termine", e di Adelina Patti, "cantante ed attrice meravigliosa. Un'eccezione
nell'arte". Nutrì tuttavia molta stima per interpreti quali Gaetano Fraschini (forse il cantante più
`verdiano' in assoluto, avendo cantato, finché fu in carriera, in quasi tutte le opere del maestro,
dall'Oberto alla Forza del destino) per la nettezza dell'attacco, Erminia Frezzolini per la vivacità
del canto, Filippo Coletti per l'energia del fraseggio, Teresa Stolz per l'estrema elasticità del suo
organo vocale,Victor Maurel per la sua perfetta dizione. E l'elenco potrebbe continuare.
La fortuna. Già con la sua prima opera, l'Oberto, il maestro si pose all'attenzione dei
contemporanei. Ma la sua vera popolarità comincia fra il 1842 e il 1843 con Nabucco e i Lombardi.
La maggior parte delle sue opere sin dalla prima rappresentazione riscosse successo: caloroso per i
Lombardi, i Due Foscari, Giovanna d'Arco, Attila; trionfale per Nabucco, Emani, Rigoletto,
Trovatore, Ballo in maschera, Aida. Il solo, vero e proprio insuccesso fu quello di Un giorno di
regno (più tardi ribattezzato col titolo originario Ilfinto Stanislao). Traviata e Simon Boccanegra,
benché Verdi li considerasse entrambi un "fiasco", ebbero in realtà solo un esito contrastato.
Mediocre accoglienza ebbero Alzira, Il corsaro, Stiffelio e Luisa Miller.Tutte le sue opere, a partire
da Nabucco - ma ad eccezione di Alzira, B corsaro e La battaglia di Legnano (quest'ultima a causa
delle circostanze politiche) - entrarono nel normale repertorio dei teatri e furono frequentemente
eseguite in Italia e all'estero fino all'approssimarsi dell'ultima decade dell'Ottocento. Fino al 1859
(ma a Roma fino al 1870) negli stati italiani del centro-sud, vale a dire nel Regno delle due Sicilie,
nello Stato della Chiesa e nei ducati molte sue opere furono rappresentate con libretto camuffato
dalle
varie censure, in particolare Emani, Giovanna d'Arco, Macbeth, Rigoletto, Traviata.
Quanto ai Vespri siciliani fu l'autore stesso ad approntare una versione italiana, intitolata
Giovanna de Guzman, che non incontrasse i rigori delle varie censure. Con la fine del secolo si
entra negli "anni bui" dell'opera verdiana e più in generale del melodramma italiano d'età
romantica.Verdi "progrediva", sì, con Otello e Falstaff, ma proprio questo "progresso" fece
dimenticare alla società italiana di fine secolo e oltre il Verdi degli anni giovanili e della cosiddetta
"trilogia romantica", il Verdi insomma di Emani e di Macbeth, di Rigoletto e del Trovatore. Solo il
costante favore popolare, ridotto a manifestarsi ormai solo nei teatri secondari e di provincia,
consentì all'opera di Verdi di sopravvivere ai margini di un'attività musicale ormai imperniata, nei
teatri primari, sulle opere di Wagner, di Meyerbeer, di Massenet, di Puccini, della "giovane
scuola". Alla Scala, ad esempio, nell'ultimo decennio dell'Ottocento furono date (a parte Otello e
Falstaff) solo sei recite di Rigoletto, tre di Traviata e una di Don Carlos. Al Comunale di Bologna,
la "wagneriana" Bologna, tra il 1887 e il 1912 si contano solo tre allestimenti: Rigoletto e Traviata
nel 1901 e Aida nel 1908.AI Regio di Parma, la "verdianissima" Parma, tra il 1904 e il 1911 Verdi
è presente con due soli allestimenti: Aida e Rigoletto. L'emarginazione del Verdi popolare dai
teatri primari e la scomparsa di capolavori quali Macbeth, Luisa Miller, , Simon Boccanegra, fu il
riflesso della progressiva opera di svalutazione da parte della critica di quegli anni. Quando nel
1902 si osò di riproporre alla Scala (e chi osò fu Toscanini), dopo anni di silenzio, il Trovatore, vi
fu chi trovò a ridire che un teatro prestigioso come la Scala si abbassasse a rappresentare ancora
melodrammi "da arena popolare"... Pochi anni dopo un fine cultore di musica quale Giannotto
Bastianelli non arretrò dal dichiarare che "l'arte verdiana rimase nella sostanza simile a quella dei
predecessori; arte, cioè, sempre primitiva nel contenuto sebbene spesso perfetta nella forma,
profondamente sensuale, di tinte accecanti, di un sentimentalismo un po' barocco, ma spesso franco
e sincero; arte che [...] non è destinata del tutto all'oblio, ma è meritevole di essere frammentata
da una critica spassionata e rigorosa in una specie di florilegio contenente le più belle ispirazioni
dei nostri ottocentisti". Il riscatto del teatro verdiano nasce in Germania, preparato dall'opera di
traduzione e di divulgazione di Franz Werfel e pilotato da un'opera rimasta sconosciuta alle scene
tedesche: La forza del destino, il cui trionfale successo a Dresda nel 1925 può essere considerato il
punto d'avvio della VerdiRenaissance. Fu come un'esplosione quale non si era registrata sin dai
tempi dell'Emani e del Trovatore, e che fece scrivere a un autorevole critico, nella patria di
Wagner: "Verdi per noi tedeschi è per così dire lo Shakespeare dell'opera". E mentre in Italia
ancora ci si baloccava intorno alle "sei più belle opere di Verdi", nei teatri della Mitteleuropa
capolavori quali Macbeth, Simon Boccanegra, Don Carlos entrarono nel normale repertorio
accanto alle opere di Wagner, di Mozart, di Richard Strauss, di Puccini. In Italia di vera e propria
rinascenza verdiana si può parlare solo a partire dal secondo dopoguerra, una rinascenza cauta,
quasi episodica, che si rinfranca in via definitiva solo a partire dagli Anni Sessanta e si sviluppa
attraverso la ricognizione di tutto il teatro verdiano, dalle opere dimenticate o quasi cancellate
(vedi Stiffelio) alle prime versioni di opere rifatte (vedi il primo Macbeth, vedi il primo Simon
Boccanegra).
Nota sulla melodranunaturgia verdiana. Il punto di vista da cui muove un compositore d'opera
all'atto di organizzare un'azione teatrale è alquanto differente rispetto a quello di un autore di
drammi destinati alla recitazione. In quanto musicista egli deve prefigurare il proprio materiale
entro linee di durata determinate dalla sintassi del discorso musicale e non da quella del dialogo
parlato, e deve pertanto prefissarne le dimensioni tenendo conto dei poteri di concentrazione, di
sincronia e di evocazione che sono propri del linguaggio della musica. La scelta di un argomento
d'opera è dunque in funzione di una drammaturgia soggetta alle leggi che governano la
composizione musicale. Sin dagli esordi Verdi era consapevole che nell'opera il drammaturgo
dev'essere innanzi tutto un architetto in musica e che scopo essenziale d'ogni impresa operistica è
sempre la traduzione totale dell'azione drammatica in musica. È il dramma che deve essere
posseduto dalla musica. Non viceversa. Pertanto l'interesse che in Verdi suscita un soggetto
d'opera prende sempre le mosse dalla possibilità di rinvenirvi le occasioni atte a tradurre gli effetti
in strutture musicali in movimento, compiute e autosufficienti. Riprendendo una considerazione
avanzata da Pierluigi Petrobelli, si può affermare che Verdi insegue sempre la possibilità che
"l'elemento musicale" diventi "di per sé elemento di articolazione drammatica, strumento ideale di
teatralità pura". La chiave di lettura di un soggetto d'opera avviene sempre in Verdi attraverso una
griglia di situazioni, di posizioni sceniche, di effetti teatrali che consenta di realizzare - attraverso
una concezione estremamente dialettica delle tòrme musicali - una drammaturgia interamente
posseduta dal discorso musicale. Primo risultato di questo lavoro di verifica è la concentrazione del
dramma nei suoi elementi essenziali attraverso una 'selva', una sorta di scenario in cui già viene
prefigurata la scansione musicale dell'azione drammatica, una scansione percorsa come una
corrente elettrica dal contrasto di caratteri e di situazioni. Tale contrasto risponde a quella
conflittualità dinamica, ostinatamente perseguita da Verdi, che rende possibile lo sviluppo di
strutture musicali in costante movimento. Una volta stesa la 'selva' e trovata la 'tinta musicale', il
più del lavoro per Verdi è fatto. Elemento fondamentale della griglia attraverso la quale Verdi
valuta la possibilità di un soggetto teatrale di essere tradotto in musica è costituito dalla sequenza
formale della "scena ed aria" quale era stata codificata da Rossini, quindi ripresa e sviluppata da
Bellini e da Donizetti. Applicata all'aria solistica, al duetto e al finale d'atto, la sequenza risponde al
seguente schema:
a) scena o tempo d'attacco; b) cantabile; e) scena o tempo di mezzo; d) cabaletta.
Ecco alcuni esempi nell'aria solistica, nel duetto e nel finale d'atto:
aria di Violetta nel primo atto di Traviata: a) "È strano!... è strano!..."; b) "Ah fors'è lui che
l'anima"; c)"Follie!... follie..."; d) "Sempre libera degg'io"
duetto Leonora - Conte di Luna nel quarto atto del Trovatore: a) "Qual voce!... come!... tu,
donna?"; b) "Mira d'acerbe lagrime"; c)"Conte...""Né cessi?"; d) "Vivrà!... contende il giubilo"
finale atto secondo di Aida: a)"Salvator della patria"; b) "Ma tu, Re, tu signore possente"; c) "O Re:
pei sacri numi"; d) "Gloria all'Egitto".
Verdi impiega questa formula fino all'Aida compresa, ma mai in modo meccanico al solo fine di
garantire una scansione musicale delle fasi principali di un'azione scenica. All'interno della
sequenza egli opera continue modifiche che spesso ampliano la funzione della scena d'attacco o, più
spesso, della scena di mezzo, che egli individua come elemento dinamico volto a esaltare
l'opposizione e il contrasto fra l'adagio e l'allegro, fra il cantabile e la cabaletta, fino a farle
assumere le dimensioni di brano musicalmente compiuto (come nel "Coro e Ballabile" nella scena
delle apparizioni del Macbeth, o come nel "Miserere" del Trovatore, inserito fra il cantabile e la
cabaletta dell'aria di Leonora); oppure rinuncia alla cabaletta (come nel finale primo di Luisa Miller
o come nel duetto Aida - Amonasro nel terzo atto di Aida). Elemento basilare della
melodrammaturgia verdiana è il duetto, luogo quasi sempre di scontro e di contrasto, su cui
l'intero edificio drammatico si regge spesso in maniera determinante; basti pensare ai duetti
Nabucco - Abigaille, Lady - Macbeth, Rigoletto - Gilda,Violetta - Germont, Amelia - Riccardo,
Filippo - Inquisitore,Aida - Amonasro, Otello - Jago, per citarne solo alcuni. Inoltre Verdi sfrutta
al massimo il potere di sincronia, e quindi di sintesi, consentito dal linguaggio dei suoni al fine di
concentrare azioni e sentimenti in un solo blocco musicale: vedi i terzetti dei Lombardi, di Emani,
di Attila, della Forza del destino, vedi il quartetto di Stiffelio e, soprattutto, il quartetto del
Rigoletto, unico nel suo genere. Ma vedi anche il Finale Secondo dei Vespri siciliani (il contrasto
fra il canto spezzato dei Siciliani umiliati e la cantilena dei Francesi sulla barca), il Finale Secondo
di Un ballo in maschera (lo scherno dei congiurati di contro al furore represso di Renato e allo
strazio di Amelia), il secondo atto di Otello (il contrasto fra l'omaggio canoro dei Ciprioti a
Desdemona e il dialogo fra Otello e Jago), il concertato nel secondo atto di Falstaff, prodigiosa
costruzione in cui la musica riesce a concentrare azioni e situazioni simultanee e contrastanti. E si
potrebbe continuare. È inoltre da tenere presente che Verdi tende sempre a rendere omogeneo e
compatto il discorso musicale ben al di là del pezzo chiuso, istituendo una stretta correlazione fra i
brani attraverso l'impiego delle aree tonali: ne è un esempio il nesso tonale stabilito nel Rigoletto
fra l'Introduzione (la festa nel palazzo ducale) e la seconda parte del primo atto (la casa di
Rigoletto), o, ancora, il passaggio fra la prima e la seconda scena nel primo atto di Simon
Boccanegra. A partire dal rifacimento appunto del Simon Boccanegra Verdi tende a dare maggiore
continuità al discorso musicale eliminando il pezzo chiuso, ma non dimentica tuttavia, quando
occorre, la sequenza canonica della "Scena ed Aria", sopra indicata, come dimostra la chiusa del
duetto Otello - Jago ("Sì, pel ciel marmoreo giuro!"), che presenta il carattere di una vera e propria
cabaletta, con tanto di stretta finale.
Molto altro ancora v'è da dire sulla melodrammaturgia verdiana; ad esempio sui parlanti (dove "il
motivo sta nella parte strumentale, anziché nella vocale"), sulla funzione del coro, sull'impiego
della canzone ai fini drammatici ("La donna è mobile", "Stride la vampa", la "Canzone del salice",
ecc.), sul cosiddetto "colore locale", sulla musica descrittiva (il mare, il sorgere del sole, il
temporale, la caverna, la foresta), sull'impiego di temi ricorrenti (Leitmotiv), sui registri vocali,
sulla strumentazione. Ma il presente capitolo vuole essere non un trattato di drammaturgia
musicale, bensì solo una guida introduttiva, o meglio, un primo accostamento alla conoscenza
dell'artista e all'ascolto della sua opera. Conviene dunque arrestarsi a questo accenno molto
sommario, tuttavia sufficiente a far comprendere perché la stesura dei riassunti delle sue opere sia
stata fatta sulla base non del solo libretto tout court, ma seguendo la trama ovvero la scansione dei
brani musicali di cui ciascuna opera è composta. E ciò al fine di una migliore comprensione e
soprattutto di un ascolto più consapevole. Poiché per Verdi è nella musica, cioè nell'evento sonoro,
che il dramma si esplica. Ha osservato Bruno Barili con straordinario intuito, a proposito del
Trovatore, che esso
si fa tutto al disopra del libretto, per evaporazione lirica. Il canto scavalca il testo, lo espelle, lo
distrugge: la musica fa il dramma da sé sola. La vicenda trae tutta la sua virulenza dal ritmo, e non
si può raccontarla, o spiegarla per mezzo di parole, mentre si capisce in un lampo attraverso
l'esecuzione sonora. Il barocco libretto non è che l'elemento occasionale che provoca l'esplosione, e
dietro quella ricade annientato [4. Poi, quel che è stato è stato: il libretto non esiste più. Ma c'è
l'opera viva, immortale.
Questa splendido commento vale non solo per il Trovatore, ma per tutte le opere di Verdi,
dall'Oberto al FaLstaff, per ognuno delle quali non v'è che da ripetere: la musica fa il dramma da sé
sola.
MARCELLO CONATI
Antonio Barezzi
Le opere di Verdi
Oberto conte di S. Bonifacio
Dramma in due atti [di Antonio Piazza e Temistocle Solera]
Prima rappresentazione: Milano,Teatro alla Scala, 17 novembre 1839
La fonte dell'argomento rimane tuttora sconosciuta. È infatti l'unica opera di Verdi della quale non
si è potuto finora rintracciare un precedente letterario o teatrale. Anche la genesi compositiva
rimane in parte misteriosa. Si sa che prima di rientrare a Busseto dopo aver compiuto gli studi
musicali con Vincenzo Lavi gna e aver collaborato in alcune circostanze con una Società
filarmonica da poco istituita dal maestro Pietro Massini al teatro Filodrammatici, di fianco alla
Scala, Verdi aveva ottenuto promessa dallo stesso Massini di far rappresentare una sua opera in
quel teatro. Rientrato a Busseto, nel 1836 si era accinto a rivestire di note il libretto della sua
prima opera: s'intitolava Rocester, diverrà Oberto. Quali legami vi fossero fra le due opere (la
prima su libretto del giornalista e letterato Antonio Piazza, la seconda su libretto trasformato da
Temistocle Solera) gli studiosi non sono ancora riusciti a stabilirlo con precisione. Verdi stesso
non accenna mai, nelle confidenze rilasciate negli anni della maturità intorno ai suoi esordi, a un
Rocester, limitandosi ad accennare a un libretto che, modificato da Solera, divenne l'Oberto.
Essendo improvvisamente cessata l'attività della Società diretta da Massini, Verdi tentò
inutilmente di far rappresentare la sua opera a Parma. Ritornato a Milano nell'autunno del 18.38 e
quivi stabilitosi con la famiglia nel successivo febbraio, riuscì a ottenere dall'impresario
Bartolomeo Merelli - grazie anche all'appoggio di influenti personaggi della 'Milano bene' del
tempo e a quello di due importanti cantanti, Giorgio Ronconi e Giuseppina Strepponi, cui fece
ascoltare l'opera - di farla rappresentare alla Scala. Ciò avvenne nel tardo autunno del 1839, ma
senza Ronconi e la Strepponi, per i quali l'opera era stata pensata, non essendo stati scritturati per
quella stagione (li ritroverà per Nabucco), tanto che il giovane compositore dovette 'puntare' il
ruolo protagonista, già concepito per baritono, per la voce del basso Marini. L'Oberto ottenne un
franco successo di pubblico e di critica, tanto che venne replicato fino al termine della stagione e fu
ripreso l'anno dopo. Il successo fruttò a Verdi un contratto, propostogli dall'impresario
Bartolomeo Merelli, per tre opere nuove da rappresentarsi alla Scala nelle successive stagioni
(saranno Un giorno di regno, Nabucco e I Lombardi alla prima crociata). La versione definitiva
dell'Oberto accoglie modifiche e aggiunte operate da Verdi per la ripresa alla Scala nell'autunno
del 1840 e per le rappresentazioni al Carlo Felice di Genova nel gennaio del 1841. L'opera fu data
anche a Torino, a Napoli e a Barcellona; ma ben presto superata in popolarità dalle successive
opere del compositore, da Nabucco in poi, fu pressoché dimenticata (salvo l'aria di Cuniza, Oh chi
torna l'ardente pensiero, che fu spesso eseguita nel corso dell'Ottocento, interpolata nella Luisa
Miller dai mezzosoprani che sostenevano la parte di Federica, priva di aria). Per il suo ritorno alle
scene l'Oberto dovrà attendere il nuovo secolo, a far inizio dal teatro Regio di Parma per le feste
centenarie del 1913.
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
CUNIZA, sorella di Ezzelino da Romano prima donna
Maria Shaw
RICCARDO, conte di Salinguerra primo tenore
Lorenzo Salvi
OBERTO, conte di S. Bonifacio primo basso
Ignazio Marini
LEONORA, sua figlia
prima donna
Antonietta Raineri Marini
ImELDA, confidente di Cuniza
seconda donna Marietta Sacchi
Cavalieri, Dame, Vassalli
L'azione è in Bassano nel castello d'Ezzelino e sue vicinanze
Epoca 1228
Nota storica: Ezzelino da Romano: si tratta di Ezzelino III da Romano (1194-1259); tra i principali
sostenitori di Federico II, di cui sposò una figlia, ampliò i feudi paterni impadronendosi di Verona
e di Bassano, ottenendo quindi Vicenza da Federico, e conquistando infine Padova e Treviso;
impostosi come capo del partito ghibellino e scomunicato da Innocenzo IV, fu sconfitto e
mortalmente ferito a Cassano d'Adda dalla lega guelfa comandata da Marino Della Torre; la
tradizione ne tramanda la memoria come un tiranno efferato e senza scrupoli.
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
Antefatto
Oberto, conte di S. Bonifacio, in guerra con i Salinguerra di Verona, sconfitto da Ezzelino da
Romano, loro alleato, ripara in Mantova. Sua figlia Leonora, orfana di madre e rimasta a Verona
presso una zia, sorella di Oberto, viene sedotta con promessa di matrimonio da Riccardo di
Salinguerra, presentatosi a lei sotto falso nome. Questi, innamoratosi poi della sorella di Ezzelino,
Cuniza, dal fratello lasciata nel castello di Bassano, le offre la propria mano. Ezzelino, che doveva
la signoria di Verona ai Salinguerra, approva le nozze. Leonora, conosciuta troppo tardi la verità,
accorre a Bassano nel giorno delle feste nuziali per svelare il tradimento. Vi accorre anche il padre,
Oberto, avvertito per lettera da sua sorella delle vicende di Leonora e della sua venuta in Bassano.
Qui ha principio l'azione del dramma.
1. SINFONIA. Una delle più brevi di Verdi, è in due movimenti, entrambi costruiti su alcuni temi
dell'opera: Andante (basato sul coro nuziale "Fidanzata avventurosa") e Allegro vivo.
ATTO PRIMO
Deliziosa campagna. Alla sinistra, in poca lontananza, si scorge Bassano.
2. CORO D'INTRODUZIONE. Cavalieri, Dame, Vassalli vengono a incontrare Riccardo, conte di
Salinguerra, futuro cognato del loro signore, di ritorno dalla guerra, e intonano un canto di gioia
(Di vermiglia, amabil luce): la stella che prese in cielo il volto di Amatunzia annuncia un giorno
felice; scorrano pure i fulmini di guerra per le città: la pace accompagnerà le nozze di Riccardo
protette dalla buona stella. Come si vede avanzare Riccardo il ritmo si fa vivace e il canto dei
cortigiani sempre più festoso.
3. CAVATINA. Riccardo esprime gratitudine per l'accoglienza riservatagli, pur rifiutando
generosamente un plauso dovuto più alla sposa che a lui (Questi plausi a me d'intorno). Tuttavia,
mentre il coro lo invita "dove l'attende amor", egli manifesta propositi bellicosi grazie al potere
che sta per conseguire attraverso le nozze con Cuniza, la sorella del potente Ezzelino (Già parmi
udire il fremito): già gli sembra di vedere le teste dei nemici invidiosi chinate a terra.Tutti si
avviano al castello di Bassano.
4. CAVATINA. Entra in scena Leonora; sedotta e poi abbandonata dall'ambizioso Riccardo, ella è
disperata sia per l'onore e per l'amore perduti, sia per il dolore che suo padre proverà quando ne
verrà a conoscenza. Però è certa che la vendetta che sta preparando cancellerà la vergogna. Il
sogno d'amore fiorito nella casa paterna si è dissolto nel tradimento (Sotto il paterno tetto). Ora
vorrebbe poter ritornare all'innocenza del primo giorno (Oh potessi nel mio core). Mestamente si
allontana verso l'abitato.
5. SCENA E DUETTO. Un breve preludio strumentale annuncia l'ingresso di Oberto, che ha
appreso tutta la storia da una lettera della sorella. Fa ritorno alla sua terra agitato da due
sentimenti contrastanti: la felicità di rivedere la patria natia e il dolore per dover ben presto dirle
di nuovo addio. Rientra Leonora: ha saputo delle imminenti nozze di Riccardo con Cuniza e si
propone di recarsi inosservata al castello. Alla vista del padre rimane esterrefatta. Assalita dai
violenti rimproveri di Oberto (Guardami! Sul mio ciglio vedi) ella implora commossa un abbraccio
di perdono (Padre mi strazi l'anima). Ricordando la moglie e madre morta, chiedono entrambi
aiuto al cielo per poter ottenere giustizia (Del tuo favor soccorrimi). Si sente provenire dal castello
uno squillo di tromba: Oberto ordina alla figlia di andare lassù a denunciare il seduttore; solo
allora la perdonerà. Leonora promette di ottenere la vendetta o di morire. L'abbraccio del padre
incoraggia la giovane nei suoi propositi (Un amplesso ricevi, o pentita). Insieme si avviano verso
Bassano.
Magnifica sala nel castello di Ezzelino.
6. CORO. Mentre Cuniza viene abbigliata per le nozze, dame e cavalieri esprimono ammirazione
per la sua bellezza ed esaltano le sue virtù (Fidanzata avventurosa): ella è come l'alba che rischiara
il cielo, pura come la neve che imbianca la terra Euganea; il suo sorriso è l'immagine del cielo sulla
terra.
7. SCENA E Duetto. Cuniza ringrazia, congeda il coro e viene subito raggiunta da Riccardo. Le
sembra di sognare (Il pensier d'un amore felice); tuttavia la gioia che le inonda il petto è mista a un
timore inspiegabile, come un presentimento. Riccardo le risponde con le sue certezze e le sue
promesse (Nuovo dì per te splenda sereno). La giovane si mostra infine convinta: insieme
terminano il duetto (Questa mano ornai ritorni) pensando a un solo cuore, a un'anima sola, a una
lunga vita insieme, finché morte non li separi. Ed escono di scena da porte opposte.
8. RECITATIVO. Sopraggiunge Leonora che chiede a Imelda, confidente di Cuniza, di poter
incontrare la principessa. Nell'attesa è molto agitata, perché sa che suo padre è nascosto ad
ascoltare: non vuole che la sappia tremante davanti ai suoi rivali e chiede al cielo di assisterla in
questo incontro così difficile.
9. SCENA E TERZETTO. Quando Cuniza sopraggiunge, Leonora le si presenta come figlia di un
infelice, Oberto, forse già noto alla principessa. Cuniza risponde agitata che lo conosce come
"Oberto, il nemico!". Leonora la invita a parlare sottovoce perché Oberto è nascosto nei pressi: l'ira
lo ha condotto nel castello per un atto estremo. Già le si sta avvicinando. E infatti Oberto si
presenta in scena: implora pietà non come nemico vinto ed esiliato (Se pietà sperar mi lice), ma
come padre disonorato da un vile. Cuniza è disposta a fare tutto quello che può; ma Leonora
l'avverte che se le rivelerà il fatto e il colpevole, le trafiggerà il cuore. Incuriosita e sempre più
turbata da un triste presentimento, Cuniza vuol sapere. Leonora racconta di un indegno che le rapì
tutto, pace e onore, perché sotto falso nome le promise eterno amore e poi la tradì giurando amore
ad altra donna, Cuniza, appunto. È Oberto a rivelare il nome del traditore: Salinguerra! E la verità
sta scritta sul volto di Leonora (Su quella fronte impressa); se Cuniza non crede a ciò che vede,
creda almeno allo sdegno di un padre che, disobbedendo a Ezzelino, ha lasciato l'esilio ed è tornato
armato di spada sulla terra natia per vendicare il proprio onore. Cuniza placa gli animi
promettendo aiuto e schierandosi dalla parte di Leonora, la quale si mostra dispiaciuta di recarle
tanto dolore. Ella vede che le ciglia di Cuniza sono umide di pianto; ma la giovane l'assicura che
sarà l'ultimo pianto che bagna le sue guance: ora l'ira che tormenta il suo cuore cadrà sul traditore;
analogo proposito esprimono Leonora e Oberto (Ma fia l'estremo, o misera).
10. FINALE PRIMO. Dopo aver condotto Oberto in una stanza vicina, Cuniza richiama lo sposo e
gli amici. Rivolta a Riccardo, gli indica Leonora. Per tutta risposta Riccardo, riavuto dalla
sorpresa, umilia ancora una volta la giovane già da lui sedotta, accusandola vilmente di infedeltà.
Leonora reagisce con terribile passione, ottenendo la solidarietà dell'assemblea. Oberto, che ha
udito le infami parole di Riccardo, non resiste ed esce dal suo nascondiglio, fra lo stupore dei
presenti, per difendere la figlia: il concertato a canone che segue (A quell'aspetto un fremito) lascia
intuire che egli cadrà ucciso nella sua patria; Oberto però aggiunge che con lui cadrà morto anche
il traditore. Si rivolge infine a Riccardo accusandolo di spergiuro e di viltà e affermando di saper
usare ancora la spada: è la sfida a un duello, sfida che Riccardo rifiuta per pietà della canizie
(All'onta rispondere m'udresti). Si innesta qui la stretta finale: Leonora accusa Riccardo di viltà;
Cuniza sente l'amore trasformarsi in odio per il bugiardo; Imelda e il coro chiedono al Cielo di
riportare la pace e di punire il colpevole. Su questa agitazione generale si chiude il sipario.
ATTO SECONDO
Gabinetto della principessa.
11. CORO, SCENA E ARIA. Le damigelle circondano Cuniza seduta per confortarla. Imelda le
annuncia che Riccardo vuole parlarle. Ma quell'uomo non ha nulla da dire a propria discolpa. Un
giorno quel nome le scendeva nel cuore dolcemente come la rugiada che ravviva i fiori appassiti
nella stagione estiva. Ella si abbandona per un attimo a dolci ricordi (Oh chi torna l'ardente
pensiero): come volgere ancora il pensiero ai bei sogni del primo incontro? Egli era bello nel volto,
nell'anima; le apparve lì, in quella stanza e le parlò d'amore. Un suo sguardo, un suo dolce sorriso
erano per lei vita e gioia. Ora invano le scendono in cuore: sono come preghiere su una tomba.
Ormai è deciso: Cuniza farà tutto il possibile per far tornare Riccardo al suo primo giuramento
(Più che i vezzi e lo splendore), poiché le parole di Leonora hanno su di lei più potere di qualsiasi
altra cosa e l'amicizia è un affetto santo al pari di quello dell'amore.
Luogo remoto in vicinanza ai giardini del castello.
12. CORO DI CAVALIERI. Un gruppo di cavalieri si interroga sulla mutata situazione: un bel
sogno si è dileguato e un triste velo ricopre l'astro dell'amore (Dov'è l'astro che nel cielo); la donna
tradita si consoli: in questa vita la sventura è compagna alla virtù. Il gruppo si disperde.
13. SCENA E ARIA. Arriva Oberto, e ora aspetta Riccardo: nessun rifugio può sottrarlo al duello.
Il tradimento richiede il sangue del colpevole (L'orror del tradimento); il braccio del vecchio
guerriero non è invalido, la sua spada uccide ancora. Il vecchio cada pure ucciso, se così vuole il
cielo, ma non sia oppresso dal disonore d'un delitto altrui. Il coro chiama ripetutamente Oberto:
vada tosto da Cuniza che lo ha salvato dall'ira di Ezzelino. Oberto risponde che andrà subito, non
prima però di riaffermare il proposito di vendicarsi (Ma tu superbo giovane): il destino ha in serbo
un solo giorno di vita per uno dei due; se sarà egli stesso a morire, le sue ultime parole saranno per
maledire i Salinguerra.
Giuseppina Strepponi con lo spartito del Nabucodonosor
14. SCENA E QUARTETTO. Ecco giungere Riccardo, cui subito Oberto si rivolge per invitarlo a
impugnare la spada per il duello; ma il giovane vorrebbe evitare un conflitto che ritiene ineguale.
Oberto lo schernisce, accusandolo di essere vile nelle imprese guerresche e di serbare l'eroismo
solo per quelle amorose. Riccardo, colpito nel proprio orgoglio, mette mano alla spada, ma è
fermato dal grido di Cuniza che sopraggiunge con Leonora. Le voci dei quattro personaggi si
uniscono per dare sfogo ai propri sentimenti (La vergogna ed il dispetto): Riccardo, dibattuto tra
vergogna e dispetto, si augura di essere inghiottito dal terreno; Leonora, ancora innamorata pur
sapendolo infame e traditore, non ha altra speranza che la morte; Cuniza cerca di consolarla
promettendole che farà tornare Riccardo da lei; Oberto rinnova l'accusa di viltà e il proposito di
colpirlo con la sua spada vendicatrice pari al fulmine di Dio. In un drammatico dialogare Cuniza fa
promettere a Riccardo che sposerà Leonora, mentre Oberto lo consiglia di accettare per finta e di
recarsi poi nel bosco per il duello. Nuovamente le voci dei quattro personaggi si riuniscono nella
stretta finale per esprimere ciascuno i propri sentimenti: Leonora, commossa, accetta il ritorno di
Riccardo a patto che sia pentito e sincero (Ah Riccardo! se a misera amante); Riccardo è
dispiaciuto, perché vede sul viso di lei tanto amore, ma deve onorare il suo dovere di guerriero;
Oberto persevera nell'idea fissa di lavare il disonore col sangue del traditore; Cuniza augura a
Leonora tutta la pace e l'amore che a lei saranno negati. Alla fine Oberto entra nel bosco; gli altri
si allontanano dalla parte opposta.
15. SECONDO CORO Di CAVALIERI. Entrano i Cavalieri esprimendo disappunto e
preoccupazione per il duello fra due guerrieri, che pure vengono considerati splendidi campioni di
questa terra (Ah, sventura! E dalla croce). Ma ad un tratto la musica fa capire che lo scontro è
ormai in atto: tutti corrono verso il bosco.
16. ROMANZA. Al termine di un breve, turbolento preludio strumentale entra, come inseguito da
alcuno, Riccardo sconvolto, la spada alla mano: si rende conto della gravità di ciò che ha fatto e ne
sente rimorso (Ciel che feci!). Nel delirio di una vergogna che potrà nascondere solo fuggendo gli
sembra di udire gli ultimi lamenti di Oberto morente: in atto di preghiera chiede salvezza alla
clemenza di Dio, quindi fugge.
17. SCENA E ADAGIO. Il crescendo, su un ritmo frenetico, di un altro breve preludio
strumentale sottolinea l'entrata di Cuniza e Imelda, che accorrono agitate: cercano i due uomini e
sentono nelle vene un presentimento mortale. Il coro annuncia il ritrovamento di Oberto immerso
nel sangue e di Leonora svenuta: ella, infatti, sospettando il duello, era accorsa e vi aveva assistito.
La poveretta viene condotta in scena; Cuniza, sinceramente addolorata, accoglie il suo arrivo
rassicurandola del proprio affetto (Vieni, o misera) e promettendole di mai più lasciarla. Anche il
coro accoglie la sventurata esprimendole parole di conforto.
18. SCENA E RONDÒ FINALE. Leonora è posta a sedere; Cuniza le sta vicina; tutti la
circondano. Ma lei è disperata: ha perduto tutto; ora ha perduto anche il padre: e della sua morte si
sente direttamente colpevole. Riacquistata momentaneamente la calma, racconta in breve i tragici
fatti avvenuti a Bassano (Sciagurata! a questo lido), concludendo che è stata ella medesima ad
uccidere il padre per mano del suo seduttore. Arriva un messaggero con una lettera che Cuniza
legge tremante: è di Riccardo, che è fuggito dall'Italia e che chiede perdono a Leonora, lasciandole
tutti i suoi beni e rinnovando la promessa di fedeltà come nei primi giorni del loro amore. Ma la
lettera, anziché confortare Leonora, la getta nella più profonda disperazione (Cela il foglio
insanguinato): ormai orfana, maledetta, nel suo futuro non vi è che la cella di un convento. Vede
sangue dappertutto, sente un fuoco che la brucia, in preda a violenti spasimi si augura la morte.
Sviene tra le braccia delle dame, mentre il coro implora dal cielo pietà per la sventurata.
Un giorno di regno (ii finto Stanislao)
Melodramma giocoso in due atti [di Felice Romani]
Prima rappresentazione: Milano,Teatro alla Scala, 5 settembre 1840
L'argomento, basato su una commedia di Alexandre Vincent Pineux-Duval, Le faux Stanislas
(Parigi, 1808), deriva direttamente da un libretto che Felice Romani aveva scritto per un
melodramma giocoso del compositore boemo Adalbert Gyrowetz, Il finto Stanislao, rappresentato
alla Scala nel 1818. Nonostante Verdi avesse desiderato comporre un'opera seria, come stabilito
dall'impresario Merelli, dovette tuttavia sottomettersi alla volontà dello stesso Merelli che
all'improvviso, per esigenze di cartellone, aveva necessità che egli scrivesse un'opera buffa, un
genere peraltro a quel tempo già in declino, almeno nelle forme e nei contenuti espressi dal vecchio
libretto di Romani. Il compositore intervenne sulla struttura del libretto (con la collaborazione,
forse, di Solera) operando alcuni tagli e in parte modificandolo, a cominciare dal titolo, mutato in
Un giorno di regno. È l'unica opera in cui Verdi impiega - come era ancora costume in quegli anni
in un'opera buffa (ma si trattava di un procedimento ormai datato) - il recitativo secco, vale a dire
col solo accompagnamento di cembalo e basso continuo. Verdi lavorò in cattivo stato di salute e
per di più con l'animo straziato per la repentina scomparsa della moglie Margherita, spentasi
d'encefalite il 18 giugno 1840. Ma non volle tuttavia sottrarsi all'impegno assunto. L'accoglienza
di pubblico e di critica fu disastrosa: l'opera - sul cui esito influì anche la cattiva esecuzione di
alcuni interpreti - visse una sola, infausta sera. Merelli corse subito ai ripari riproponendo
l'Oberto, cui arrise nuova fortuna. Qualche anno più tardi l'opera risorse a nuova, ma tuttavia
effimera vita al teatro in S. Benedetto di Venezia e al teatro Valle di Roma, con il titolo ripristinato
in Il finto Stanislao. Verdi, che affronterà con animo sereno gli insuccessi che gli riserverà la sua
carriera di artista (vedi Traviata; vedi Simon Boccanegra), non dimenticherà mai il fiasco di Un
giorno di regno, che resterà come una ferita aperta anche nel ricordo degli anni maturi. Scriverà
infatti a Tito Ricordi nel gennaio del 1859: `Alla Scala s'applaudì altra volta il Nabucco ed i
Lombardi; [..] tutt'insieme era tale spettacolo da non disonorare chi lo applaudiva. Poco più d'un
anno prima, però, questo stesso pubblico maltrattava l'opera d'un povero giovine ammalato, stretto
dal tempo e col cuore straziato da un'orribile sventura. Tutto questo si sapeva, ma non fu ritegno
alla scortesia. Io non ho più visto da quell'epoca il Giorno di Regno, e sarà certo un'opera cattiva,
pure chi sa quante altre non migliori sono state tollerate o forse anche applaudite. Oh se il
pubblico avesse, non applaudita, ma sopportata in silenzio quell'opera, io non avrei parole
sufficienti per ringraziarlo! ma finché ha fatto buon viso ad opere che fecero il giro del mondo, le
partite sono pari. Io non intendo condannarlo: ne ammetto la severità, ne accetto i fischi, alla
condizione che nulla mi si richiegga per gli applausi. Noi poveri zingari, ciarlatani e tutto quello
che volete, siamo costretti a vendere le nostre fatiche, i nostri pensieri, i nostri deliri per dell'oro -il pubblico per tre lire compera il diritto di fischiarci o di applaudirci. Nostro destino è di
rassegnarci".
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
IL CAVALIERE DI BELFIORE, sotto il nome di Stanislao re di Polonia
IL BARONE DI KELBAR
LA MARCHESA DEL POGGIO, giovane vedova, nipote del Barone ed amante del Cavaliere
GIULIETTA DI KELBAR, figlia del Barone e amante di
EDOARDO DI SANVAL, giovane ufficiale
IL SIGNOR LA Rocca,Tesoriere degli Stati di Bretagna, zio di Edoardo
IL CONTE IVREA, Comandante di Brest
DELMONTE, Scudiere del finto Stanislao
Cori e Comparse: Camerieri, Cameriere, Vassalli del Barone
L'epoca: 1733
La scena è nella vicinanza di Brest nel Castello di Kelbar
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
Antefatto
Stanislao Leczinski fu a intervalli re di Polonia. La sua ultima elezione avvenne nel 1833, quando
si recò a Varsavia travestito da cocchiere, affidando a un cavaliere francese, Beaufleur (Belfiore), il
compito di impersonarlo, onde far credere ai suoi nemici che egli fosse ancora in Francia.
1. SINFONIA. In un solo movimento, Allegro, è sostenuta da un ritmo scattante che predispone
all'ascolto di un'opera di genere buffo; il compositore vi riprende in nuova veste lo spunto tematico
di una sua sinfonia eseguita in un'accademia tenutasi a Busseto nel febbraio del 1838.
ATTO PRIMO
Galleria.
2. INTRODUZIONE. Camerieri e vassalli del Barone di Kelbar salutano il dì radioso in cui, alla
presenza di un sovrano, si annunciano due matrimoni, con festeggiamenti sontuosi e banchetti
strepitosi (Mai non rise un più bel dì). È un grande giorno per la casa del Barone di Kelbar: sua
figlia sta per sposare il signor La Rocca,Tesoriere degli stati di Bretagna, mentre la Marchesa del
Poggio, nipote del Barone, andrà sposa al conte Ivrea.
3. DUETTINO. Il Barone si complimenta con il Tesoriere perché egli sta per sposare un ramo
preziosissimo di un albero da cui germogliarono eroi (Ella è un ramo preziosissimo); a sua volta il
Tesoriere è convinto che l'innesto delle due famiglie darà buoni frutti."Bravo genero!" esclama il
Barone,"Gran suocero!" risponde ilTesoriere, orgoglioso d'aver per testimonio nientemeno che il
re di Polonia: cosa da segnare su pergamena!
4. SCENA E CAVATINA. Illustre ospite di Kelbar è infatti proprio il re di Polonia, Stanislao.
Delmonte, scudiero del re, annuncia che Sua Maestà si è alzata e sta per arrivare. Al suono di
squilli di tromba il coro esulta di soddisfazione. In realtà quello che si presenta è il cavaliere di
Belfiore, ufficiale del re, sotto mentite vesti per ragioni politiche.Tutti lo salutano con grande
rispetto e deferenza, ma il finto Stanislao prega tutti di trattarlo come un comune amico; informerà
anzi la Corte per l'accoglienza riservatagli. Intanto, a parte, s'immagina la meraviglia dei suoi
compagni di avventure nel vedere l'ufficiale più dissipato del reggimento assumere le pose "di
filosofo e di re" (Compagnoni di Parigi).
5. SEGUITO E STRETTA DELL'INTRODUZIONE. Quindi prega gli astanti, che ammirati per
la sua augusta presenza lo circondano per festeggiarlo, di trattarlo "come privato e amico": le
inevitabili preoccupazioni che lo scettro impone verranno più tardi (Verrà pur troppo il giorno).
6. RECITATIVO, SCENA E DUETTO. Il cavaliere chiede chi siano le spose. Il Barone fa i nomi
delle due giovani; ma quando accenna a sua nipote, la Marchesa del Poggio, al finto re sfugge
un'esclamazione di sorpresa: ammette di conoscerla per fama, e molto! Poi invita tutti a lasciarlo
solo.Temendo di essere riconosciuto dalla Marchesa si accinge in fretta a scrivere una lettera in
Polonia in cui chiede d'essere esonerato dall'incarico strategico, perché ormai il vero Stanislao
dev'essere giunto incolume a Varsavia; dovesse "regnare" ancora un giorno perderebbe l'amante.
Intanto entra tremante il nipote del Tesoriere, Edoardo: con l'animo angosciato di fronte alla
prospettiva di perdere l'amata Giulietta in favore dello zio, chiede aiuto al re offrendosi di
combattere per lui Troverò che degno io sono). Il cavaliere acconsente: potrà combattere al suo
fianco, sempre che ci sia da combattere; e lo nomina proprio scudiero. Edoardo si prostra
riconoscente. Il finto re lo rialza e gli propone di fermarsi a dormire al castello, raccomandandogli
di stargli sempre accanto: avrà così modo di rivedere Giulietta; il resto verrà. Queste parole
accendono la speranza nel cuore di Edoardo, che al culmine della gioia loda la magnanimità del
sovrano (Ricompensi amica sorte); il quale sovrano, a parte, si mostra felice di "regnare" ancora un
giorno per burlare il vecchio Tesoriere. L'incontro si conclude con doppio soliloquio su ritmo
marziale (Infiammato da spirto guerriero): Edoardo si dichiara pronto ad affrontare i pericoli della
guerra; mentre Belfiore gli prospetta un avvenire da eroe. Entrambi escono di scena.
7. SCENA E CAVATINA. Sopraggiunge la Marchesa, che, non vista, li aveva osservati da
lontano: è certa che l'uno dei due, Belfiore, sia il suo amante. Non comprende la ragione del suo
travestimento.Tanto meglio: fingerà di sposare il vecchio conte Ivrea facendo ingelosire il
cavaliere e potrà così smascherarlo. Lei ama solo Belfiore e nessun altro potrà mai aspirare al suo
cuore (Grave a core innamorato). E se Belfiore le è infedele, rinuncerà per sempre all'amore (Se dee
cader la vedova).
Giardino.
8. CORO E CAVATINA. La scena si apre con un coro di contadine e cameriere (Sì festevole
mattina) che recano fiori e frutti di augurio nuziale a Giulietta, la quale se ne sta seduta
mestamente sopra un sedile. La giovane ringrazia, ma il suo cuore soffre: ama Edoardo da morire
(Non san quant'io nel petto); le donne, notando la tristezza del suo volto, se ne chiedono il motivo.
La giovane apre loro il suo animo: non intende sposare il vecchio Tesoriere (Non vo' quel vecchio)
e invoca le gioie del primo amore, Edoardo. Le donne escono di scena.
9. RECITATIVO E SESTETTO. Sopraggiungono il padre e il promesso sposo. Kelbar ricorda a
Giulietta che deve presentarsi al sovrano. La giovane non nasconde la propria malinconia; il
Tesoriere tenta di consolarla: domani, il dì delle nozze, sarà certamente più felice. Entra il re
seguito da Edoardo, che egli presenta come proprio scudiero. Il finto Stanislao elargisce
complimenti e riconoscimenti di stima al Barone e al Tesoriere: ritenendoli esperti di guerra e di
politica, vuole consultarli su un progetto militare. Allontana lo scudiero pregandolo di far
compagnia alla "futura zia", poi stende sul tavolo una carta topografica e fa accomodare i due
gentiluomini in modo che possano volgere le spalle ai due giovani innamorati, che finalmente
hanno occasione di parlarsi. Mentre Giulietta ed Edoardo sono in dolce colloquio (Cara Giulia,
alfin ti vedo), il Cavaliere indica sulla carta la disposizione delle artiglierie sotto lo sguardo attento
di Kelbar e quello distratto del Tesoriere; e ogni tanto sorride nell'osservare l'imbarazzo di
quest'ultimo che, gettando occhiate furtive, dà in smanie nel vedere Edoardo troppo vicino a
Giulietta. Annunciata da un servo, sopraggiunge la Marchesa. Il Barone e Giulietta le vanno
incontro mentre il cavaliere imbarazzato, non potendo più scappare, si trae in disparte fingendo di
non vederla. La Marchesa, chiamata dalla cugina in difficoltà amorosa, si accosta a questa per
chiacchierare. Le due donne vengono però zittite dal Barone che le avverte della presenza del re.
La Marchesa rimane stupita nel vederlo, prende coraggio e con studiata indifferenza si avvia verso
di lui scusandosi per non aver notato prima la sua presenza. Il cuore le batte sempre più forte,
ormai è sempre più sicura che si tratta del cavalier Belfiore. Il finto re, imbarazzato e confuso,
propone di affidare le signore alle cure del suo scudiero Edoardo (Madamine, il mio scudiere); la
proposta consente ai due giovani di prolungare il loro incontro e le loro effusioni amorose; e
mentre la Marchesa pensa come smascherare il briccone, il Barone e il Tesoriere, inorgogliti per
essere diventati consiglieri del re, vantano le loro "teste tonde". Alla fine Belfiore, ritenendo
concluso il consiglio di guerra, lascia la sala con il Barone e il Tesoriere.
10. RECITATIVO E TERZETTO. Edoardo e Giulietta si avvicinano sollecitamente alla
Marchesa che passeggia pensierosa su e giù per la scena: confidano in lei per la salvezza del loro
amore. Ma la Marchesa, distratta e turbata, pur venuta per aiutarli, ora ha altro per la testa, e
infastidita dalla petulanza dei due innamorati, continua a parlare tra sé. E mentre Giulietta ed
Edoardo esprimono la delusione nel vedersi mancare il suo sostegno (Bella speranza invero), la
Marchesa in tanto imbarazzo è certa solo di due cose: che ama Belfiore e che questi l'ha ingannata.
Dichiarandosi dispiaciuti per averla infastidita i due innamorati si scusano e fanno per allontanarsi,
quando ella ricomponendosi li ferma: quel che è stato promesso va mantenuto e non farà quindi
mancare il suo aiuto: dopo tutto anche lei sa cosa è amore... Le tre voci si uniscono nella cabaletta
finale (Noi siamo amanti): armati d'amore si può vincere il destino avverso.
Galleria come prima.
11. RECITATIVO E DUETTO BUFFO. Belfiore, sempre nei panni di re Stanislao, si sta
adoperando per far fallire il matrimonio del Tesoriere con Giulietta. Alletta il promesso sposo con
il miraggio di una nomina a ministro, di un matrimonio con la principessa Ineska e della dote di un
immenso podere. Il Tesoriere coglie al volo l'offerta e mentre il finto re si allontana egli vuol
correre a disdire gli impegni precedenti. Ma ecco che il Barone si presenta con il contratto di
matrimonio in mano, pronto per le firme (Diletto genero, a voi ne vengo). A questo punto il
Tesoriere non vuole più sottoscrivere e si disimpegna dalla promessa. A tanto affronto Kelbar si
sente montare il sangue alla testa (Che sento? oh! nobili atavi miei!), ma il Tesoriere, pur
protestando riverenza al Barone, "prole magnanima di semidei", persiste nel rifiuto: il fatto è che il
re lo vuole ministro e principe. Il Barone è ancor più infuriato.
12. FINALE PRIMO. Con aria di minaccia il Barone s'avvicina allo spaventato Tesoriere, che
cerca di schivarlo. Lo insegue per afferrarlo e lo sfida a duello. Sempre più spaventato il Tesoriere
continua a correre per la scena e grida al soccorso. Accorrono subito Giulietta, la Marchesa,
Edoardo e i servitori. In breve tutti vengono messi a conoscenza dell'accaduto: il matrimonio tra il
Tesoriere e Giulietta non si farà. La Marchesa ne approfitta per proporre, a titolo di vendetta, un
nuovo matrimonio per Giulietta con un giovane di sua conoscenza. Ma il Barone rifiuta
categoricamente: sarebbe una viltà per la schiatta dei Kelbar; no, vuole un duello.
Improvvisamente appare sulla porta il finto Stanislao. Tutti ammutoliscono sotto lo sguardo
severo di colui che considerano il re; questi si avanza lentamente osservandoli a tino a uno (In qual
punto il re ci ha cólto!): il Barone non osa alzare la testa per la vergogna d'attaccar briga alla
presenza del sovrano; il Tesoriere spera che il re possa accomodare tutto; la Marchesa, Giulietta ed
Edoardo confidano nella regia autorità; mentre Belfiore intuisce che il Tesoriere ha dato la
disdetta. Alla fine il finto re chiede con tono autoritario il motivo della disputa; ed ecco che tutti si
affollano intorno a lui, ciascuno fornendo la propria spiegazione. Ma Belfiore mette tutti a tacere
con un severo rimprovero: se una delle due parti ricomincia la disputa prima della sua completa
conoscenza di causa, allora il trasgressore incorrerà nello sdegno regale.Tutti si affidano alle
decisioni della sovrana maestà (Affidate alla mente reale).
ATTO SECONDO
Galleria.
13. CORO ED ARIA. Il coro dei servitori commenta la gran confusione creata dal mancato
matrimonio; ma sono sempre state queste le abitudini dei signori, che cambiano umore come
cambiano veste (Noi felici, noi contenti): invece noi rozzi servitori abbiamo il viso aperto sia nei
giorni di festa che nei giorni di lavoro. Si presenta Edoardo; ha bisogno di sfogarsi e apre il suo
cuore alla servitù: non dispera di sposare ben presto la sua innamorata (Pietoso al lungo pianto).
La solidarietà dei servitori gli è di conforto; al suo mesto cuore non è concesso che affidarsi alla
speranza (Deh! lasciate a un'alma amante di speranza). Il coro si allontana.
14. RECITATIVO E DUETTO. Entra Belfiore con il Tesoriere e Giulietta: chiede al Tesoriere
perché il Barone si opponga alle nozze di Giulietta con Edoardo. La giovane risponde che il padre
"non ha fortuna, e il Tesorier nuota nel denaro". Se le cose stanno così, dice Belfiore, il Tesoriere
ceda al Barone un suo castello e cinquemila scudi di rendita annua. Sbiancando in volto il
Tesoriere tenta di tergiversare; ma è costretto a cedere all'insistenza del sovrano, che se ne parte
con Giulietta, lasciandolo solo a riflettere. Ma ecco che sopraggiunge lo sdegnato Barone a
chiedergli ragione della mancata promessa di matrimonio. Il Barone vuol guerra? E guerra sia.
Inizia una buffa schermaglia fra i due vecchi fatta a suon di spacconate. Avendo il Tesoriere, in
quanto parte sfidata, la scelta delle armi, il Barone gli dichiara che qualsiasi arma prenda, se lo
berrà come un uovo (Tutte l'armi si può prendere); gli ribatte il Tesoriere chiedendogli di lasciar
piuttosto detto dove vuol farsi seppellire. Sulla scelta dell'arma il Tesoriere suggerisce di porsi
entrambi a cavallo su un barile di polvere con la miccia in mano (Si figuri un barilone), e buona
notte a tutti. Figurarsi il Barone, che si vanta guerriero valente, all'udir questa proposta! No,
occorre battersi con la spada. Ma alla fine, esasperato dalla codardia del Tesoriere, il Barone decide
di farlo bastonare dai suoi servi. E mentre il Tesoriere si mostra divertito d'aver escogitato una
scappatoia per evitare il duello, il Barone dà in smanie fremendo come un vulcano (Sudo, avvampo,
smanio).
Atrio terreno chiuso da invetriata che mette al giardino.
15. DUETTO. La Marchesa è ormai decisa: vuol ridurre il cavalier Belfiore a confessare la sua
vera identità (Ch'io non possa il ver comprendere?...). In quella sopraggiunge proprio Belfiore, che
vedendo la donna intuisce i suoi sospetti e teme i suoi progetti. I due si salutano quasi con
indifferenza e conversano come fossero due sconosciuti. Forse la Marchesa pensa al Cavaliere?,
chiede Belfiore. Sì, penso a lui, ella gli risponde, e al modo di punire la sua incostanza. La
schermaglia fra i due, condotta con astuto linguaggio, fa capire all'uno che lei sta fingendo, all'altra
che lui è vicino a cascare (Io so l'astuzia fin dove giunga).
16. RECITATIVO, SCENA ED ARIA. Entra frettoloso il Barone ad annunciare alla nipote
l'arrivo del suo promesso sposo; e con altrettanta fretta si allontana. La Marchesa manifesta
l'intenzione di sposarsi subito: "E il Cavaliere?", domanda Belfiore. Oh, egli s'è preso gioco di me
fin troppo a lungo, gli risponde la Marchesa. Belfiore le fa però capire che l'amante verrà ben tosto
a disputare la sua mano. "Perché dunque non vien?" è la domanda accalorata della Marchesa. Che
venga dunque (Si mostri a chi l'adora): è disposta a perdonarlo (aggiungendo, a parte, che se
Belfiore non si scopre adesso, niente più arte di donna potrà riuscirvi). Contrariamente alle
speranze della Marchesa, il Cavaliere continua a insistere (ragion di stato ve lo costringe) nella
finzione regale. Al marziale suono di tromba accorrono i servi del Barone per informare che il
conte Ivrea si sta avvicinando con il suo seguito. La Marchesa si dispone ad andargli incontro;
potrà così dimenticare l'infedele Cavaliere (Sì, scordar saprò l'infido). Il quale Cavaliere ora
comincia davvero a preoccuparsi per il precipitare degli eventi. La Marchesa parte con la servitù.
Belfiore si allontana dal lato opposto.
17. SCENA E DUETTO. Entra Giulietta raggiante di gioia perché finalmente il padre acconsente
alle sue nozze con Edoardo. Questi sopraggiunge affannato: ha saputo che il re deve partire ed egli
come suo scudiero dovrà seguirlo. Giulietta è contrariata; e "comanda" al suo sposo di restare; e se
per Edoardo si tratta di una qti estione d'onore, che gli vieta di sottrarsi al dovere di combattere al
fianco del suo re (Giurai seguirlo al campo), per Giulietta è una questione d'amore, che gli impone
di sposarla. Edoardo la invita a riflettere; ma Giulietta - "migliore assai" del migliore dei re, come
lei stessa dice - non vuol riflettere; e anzi vuol ricorrere al sovrano, e si vedrà se ha il coraggio di
rapirle il suo Edoardo (Corro al re: saprò difendere). Il giovane la prega di desistere: il re ha ben
altri pensieri per la testa; e poi c'è in ballo l'onore... Esprimendo entrambi la speranza che l'amore
possa combinarsi con il dovere (Ah! non sia, mio ben, fallace la speranza), si allontanano insieme.
Galleria.
18. RECITATIVO E SETTIMINO. Il Barone rassicura il Conte di Ivrea che la Marchesa è
cambiata e che non pensa più al suo vecchio amore. Ella si dichiara disposta a sposare il Conte a
patto che il Cavaliere non faccia ritorno entro un'ora. Ma proprio in quel punto fa il suo ingresso il
sovrano annunciando di essere in procinto di partire per una importante ragione. La Marchesa
manifesta il proprio rincrescimento: aveva tanto sperato che egli fosse presente al suo matrimonio;
nondimeno, dispone che sia subito stipulato il contratto nuziale. Ma tra la sorpresa di tutti il finto
re ordina che il Conte Ivrea si prepari a partire con lui per segreta missione di stato. Sorpresa
generale. La Marchesa rimane confusa e come disarmata (A tal colpo preparata); a sua volta il
Cavaliere, vedendola mortificata, gongola di soddisfazione.
19. FINALE SECONDO. Giunge in scena Delmonte annunciando l'arrivo di un corriere della
Corte latore di una lettera importante. Il finto Stanislao ne intuisce il contenuto: finalmente la
commedia è finita; tuttavia prima di rivelarsi decide di rimanere ancora per un poco il re Stanislao
con il sancire le nozze di Edoardo e Giulietta, alle quali farà da testimone insieme al Tesoriere. Il
Barone non sa che dire: si piega al volere del re.Tutti innalzano evviva agli sposi. A questo punto è
giunto il momento di svelare il segreto; il Cavaliere apre la lettera e la legge: il vero Stanislao è
giunto in Varsavia sano e salvo; la Dieta si è già dichiarata in suo favore; il Cavaliere può dunque
abdicare, ricevendo come ricompensa la nomina a maresciallo. A questo punto tutti si chiedono chi
egli sia in realtà. Belfiore si rivela correndo ad abbracciare la Marchesa, che non aspettava altro. Il
Barone e il Tesoriere fanno buon viso a cattivo gioco e tutti si riuniscono (Eh! facciam da buoni
amici) per gioire della salvezza del re e per festeggiare due matrimoni. A far risparmiare "sospiri e
pianti" la burla è dunque riuscita.
Nabucodonosor (Nabucco)
Dramma lirico in quattro parti di Temistocle Solera
Prima rappresentazione: Milano,Teatro alla Scala, 9 marzo 1842
L'argomento deriva da un dramma in 4 atti di Auguste Ani cet-Bourgeois e Francis Cornu,
Nabuchodonosor, andato in scena con grande successo al Thé &re AmbiguComique di Parigi il 17
ottobre 1836 Già nel 1838 alla Scala il coreografo Antonio Cortesi ne aveva ricavato un balletto.
Dopo il fiasco di Un giorno di regno Verdi, profondamente amareggiato, si era risolto a non
scrivere più musica, rinunciando di conseguenza a musicare un libretto di Gaetano Rossi
precedentemente consegnatogli, li Proscritto, che restituì all'impresario Merelli, il quale a sua
volta lo girò al compositore austriaco Otto Nicolai. Tuttavia Merelli, che credeva nel talento del
giovane maestro bussetano, insistette perché egli scrivesse un'opera su un libretto di Solera,
Nabucodonosor, a sua volta rifiutato da Nicolai. Era l'inverno del 1841.A stimolare l'estro del
compositore fu soprattutto, come egli stesso confiderà a Michele Lessona, l'ultima scena, con la
morte di Abigaille. "Un giorno un verso, un giorno l'altro, una volta una nota, un'altra volta una
frase... a poco a poco l'opera fu composta", ma non senza interventi sulla struttura drammaturgica
da parte del compositore, che pretese da Solera la sostituzione di un duettino fra Fenena e Ismaele
con la profezia di Zaccaria, suggerendogli il Libro di Geremia. L'opera fu terminata in autunno.
Merelli avrebbe voluto rappresentarla in primavera, avendo già tre opere nuove da presentare nel
carnevale 1841-42; ma alla fine cedette alle insistenze del giovane maestro, dal "sangue bollente",
che chiedeva il rispetto degli impegni già presi. Nabucodonosor andò in scena alla Scala alla fine
della stagione di quaresima del 1842, in tempo per farne alcune recite, con scene e costumi di
ripiego. Nonostante le precarie condizioni vocali di Giuseppina Strepponi, l'esito fu trionfale. I
brani più acclamati sin dalla prima sera furono tutta la prima parte, la "Profezia" di Zaccaria
(brano comprensivo della preghiera introduttiva, "Va pensiero") e soprattutto l'invocazione finale,
"Immenso Jehova", che venne replicata a furor di popolo nelle prime due recite (avvenimento
eccezionale alla Scala in quei tempi, poiché era severamente vietata la replica di un brano, per
quanto grande ne fosse il successo) tanto che nelle recite seguenti fu sacrificata la scena finale
(morte di Abigaille) per concludere l'opera sulle note di quella invocazione. Il successo fu tale che,
ripreso il 13 agosto a inaugurazione della stagione di autunno con nuovi interpreti (Teresa De
Giuli al posto della Strepponi e Gaetano Ferri al posto di Ronconi), il Nabucco ebbe 57 repliche,
un primato alla Scala rimasto ancora oggi imbattuto. Ricorda Michele Lessona nel suo libro
Volere è potere: "Chi non ha vissuto in Italia prima del 1848, non può farsi capace di ciò che fosse
allora il teatro. Era l'unico campo aperto alle manifestazioni della vita pubblica, e tutti ci
prendevano parte. La riuscita d'una nuova opera era un avvenimento capitale che commoveva
profondissima-mente quella città fortunata dove il fatto avveniva, e il grido ne correva per tutta
l'Italia.
Il buon successo del Nabucco destò un così strepitoso entusiasmo, come non s'era veduto mai
prima. Quella notte Milano non dormì, il giorno dopo il nuovo capolavoro era argomento di tutti i
discorsi. Il Verdi era sulle bocche di tutti". Il Nabucco divenne immediatamente popolare in Italia e
all'estero, insediandosi stabilmente nel repertorio fino ai nostri giorni. "Con quest'opera confesserà Verdi anni più tardi - si può dire veramente che ebbe principio la mia carriera artistica':
Nabucodonosor è il titolo della prima rappresentazione scaligera; ben presto s'impose, fino ai
nostri giorni, la forma abbreviata, Nabucco, d'altronde già presente nel testo del libretto.
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
NABUCODONOSOR, re di Babilonia
primo basso [baritono] Giorgio Ronconi
IsMAELE, nipote di Sedecia re di Gerusalemme
primo tenore
Corrado Miraglia
ZACCARIA, gran pontefice degli Ebrei
primo basso
Prospero Derivis
ABIGAILLE, schiava, creduta figlia primogenita prima donna [soprano] Giuseppina Strepponi
di Nabucodonosor
FENENA, figlia di Nabucodonosor
altra prima donna [soprano] Giovannina Bellinzaghi
IL GRAN SACERDOTE di Belo basso Gaetano Rossi
ABDALLO, vecchio ufficiale del re di Babilonia
secondo tenore Napoleone Marconi
ANNA, sorella di Zaccaria
seconda donna [soprano] Teresa Ruggeri
Coro: Soldati Babilonesi, Soldati Ebrei. Leviti - Vergini Ebree, Donne Babilonesi Magi, Grandi del regno di Babilonia,
Popolo, ecc.
Nella prima parte la scena si finge in Gerusalemme, nelle altre in Babilonia
[Epoca: 587 a.C. circa]
Nota storica: Il personaggio e la vicenda che lo ha per protagonista si ispirano a Nabucodonosor (o
Nebukadnezar) II, figlio di Nabopolassar, re di Babilonia dal 604 al 562 a.C.; portò l'impero
neobabilonese al suo massimo splendore; promosse il commercio e l'agricoltura; conquistata una
prima volta Gerusalemme (597 a.C.), dopo una ribellione la distrusse e ne deportò la popolazione,
ponendo fine al regno di Giuda, di cui era re Sedecia (587 a.C.). Se storicamente vera è la conquista
di Gerusalemme, la conversione di Nabucodonosor alla religione di Israele, con la quale si scioglie
il dramma (vedi Parte Quarta), è puramente immaginaria, così come immaginari sono gli altri
personaggi di questa azione drammatica.
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
1. SINFONIA. Composta all'ultimo momento, essa consiste in gran parte in una sorta di riepilogo
di temi che si ascolteranno nel corso dell'opera, in particolare quello di "Va, pensiero", intonato
dall'oboe e dal clarinetto e poi ripreso dall'oboe e dalla tromba, e, per il movimento Allegro, il tema
"Dalle genti sii rejetto" nella stretta del Finale primo e il tema "Il maledetto non ha fratelli" del
Coro dei Leviti nella Parte Seconda.
PARTE PRIMA: Gerusalemme
Così ha detto il Signore. Ecco, io do questa città in
mano del re di Babilonia, egli l'arderà col fuoco
GEREMIA 300(1111
Interno del Tempio di Salomone.
2. CORO D'INTRODUZIONE E CAVATINA. La scena si apre con una musica tempestosa sulla
quale si eleva, vibrante, il canto di Ebrei, Leviti e Vergini, tutti terrorizzati per l'imminente
invasione degli Assiri guidati dal feroce Nabucodonosor, distruttore di idoli e portatore di lutti
(Gli arredi festivi). I Leviti (bassi all'unisono) implorano le vergini di levare le braccia al cielo (I
candidi veli): grazie alla loro purezza sarà più gradita la preghiera.Tutti si prostrano a terra e le
fanciulle, accompagnate dall'arpa e dai legni, invocano Dio (Gran Nume, che voli) affinché disperda
e distrugga le schiere assire sì che il popolo di David ritorni all'antico splendore. Alla fine le voci di
tutto il popolo, sostenute dall'intera orchestra, si uniscono in comune preghiera (Non far che i tuoi
figli divengano preda d'un folle). S'avanza Zaccaria, il gran sacerdote, tenendo per mano Fenena:
figlia del re assiro, ella è il "prezioso pegno" che può apportare pace; rincuora il suo popolo
ricordando Mosè e l'impresa di Gedeone (D'Egitto là sui lidi): solo fidando in Dio è la salvezza
comune; il popolo fa eco alle sue parole. Ma s'ode un rumore: è Ismaele che irrompe annunciando il
fulmineo arrivo di Nabucco. Tutti sono visibilmente impauriti. Zaccaria affida Fenena ad Ismaele;
quindi invoca la protezione del possente Dio d'Abramo, perché accenda nel suo popolo un soffio
che dia morte allo straniero (Come notte a sol fulgente). In tutti rinasce la fiducia. Il popolo si
disperde, la scena si svuota e rimangono solo Ismaele e Fenena.
3. RECITATIVO E TERZETTINO. I due giovani rievocano il tempo in cui si conobbero e si
amarono. Fenena aveva liberato Ismaele quando, giunto in Babilonia come ambasciatore, era stato
fatto prigioniero. Ora egli è pronto a infrangere i sacri doveri verso la patria per liberare la donna
amata. Sta per aprire una porta segreta quando, con la spada alla mano, entra seguita da alcuni
guerrieri babilonesi celati in vesti ebraiche, Abigaille che annuncia la conquista del tempio.
Anch'ella innamorata di Ismaele, Abigaille improvvisamente si arresta nell'accorgersi dei due
amanti e con calma forzata e amaro sogghigno li schernisce; ma improvvisamente esplode in un'ira
incontenibile minacciandoli entrambi di morte. Poi si avvicina a Ismaele e sottovoce gli promette,
in cambio del suo amore, la salvezza per il suo popolo (Io t'amaval...); ma Ismaele si sottrae alle sue
lusinghe: pensando alla libertà dei suoi, egli non sa tremare per la propria vita; intanto Fenena,
ormai convertitasi al "Dio verace d'Israello", prega per la salvezza degli Ebrei.
4. CORO. Donne ebree entrano precipitosamente in scena: Nabucco si sta dirigendo verso il
tempio trucidandone via via i difensori (LO vedeste?... Fulminando egli irrompe); sopraggiungono
Leviti e vecchi terrorizzati, quindi guerrieri ebrei disarmati che recano notizie della battaglia in
corso: le voci si sovrappongono l'un l'altra: a sottolineare lo stato d'agitazione generale e di terrore
Verdi impiega in questo brano lo stile fugato.
5. FINALE PRIMO. Abigaille s'avanza con i suoi soldati gridando "Viva Nabucco!" e subito si ode
una banda interna che intona una marcia guerriera annunciante l'arrivo del re. Ismaele informa
Zaccaria che solo un travestimento poté aprire agli Assiri le porte del tempio. Ma ormai è tardi: i
guerrieri assiri irrompono nel tempio e si spargono per tutta la scena sul ritmo della marcia
intonata dalla banda interna. Infine Nabucco appare a cavallo sul limitare del tempio. Zaccaria,
minacciando di uccidere con un pugnale Fenena, intima a Nabucco di non profanare il tempio.
Questi, con furore represso, è costretto a fermare i suoi uomini. Scende da cavallo per patteggiare
col nemico, ma sa che l'ira che è costretto a smorzare adesso scoppierà terribile tra poco (Tremin
gl'insani). Inizia a questo punto il concertato finale: Fenena invoca pietà per gli infelici, secondata
nel canto da Ismaele, che a sua volta, con Zaccaria e il popolo ebreo, chiede soccorso a Dio, mentre
Nabucco insiste nella sua minaccia di distruggere "l'empia Sionne" e Abigaille, con canto
tormentato, freme vendetta nei confronti della sorellastra. Infine Nabucco impone agli astanti di
prostrarsi in segno di sottomissione: egli non ha paura né di loro né del loro Dio; nessuno può
ormai resistergli. Zaccaria sdegnato alza il pugnale su Fenena; ma, prima che egli riesca a colpire,
Ismaele ferma il suo braccio e libera Fenena, che si getta nelle braccia del padre. A questo punto
Nabucco con gioia feroce ordina ai suoi soldati di far scempio dei vinti e di saccheggiare il tempio
(Mio furor, non più costretto). Abigaille esultante, profondamente offesa dal rifiuto di Ismaele e
ancor più dal suo generoso gesto nei confronti della sorella, vorrebbe placare il suo amore, non
pago, nel bagno di sangue del popolo ebraico. Ma intanto gli Ebrei, condotti prigionieri, invocano
sul reietto Ismaele la maledizione di Dio (Dalle genti sii reietto).
PARTE SECONDA: L'empio
Appartamenti della reggia.
Ecco!... il turbo del Signore è uscito
fuori; cadrà sul capo dell'empio.
GEREMIA XXX
6. SCENA ED ARIA. L'atto si apre con un preludio che sottolinea il carattere iracondo e
vendicativo di Abigaille, la quale entra in scena con impeto, stringendo una pergamena fra le mani
(Ben io rinvenni): dal documento ha scoperto come ella non sia la primogenita di Nabucco, bensì
figlia di una schiava. Scorno, impotenza, desiderio di vendetta: emozioni e sentimenti si
avvicendano tumultuosamente nell'animo di Abigaille. Furente d'ira, minaccia di morte Fenena,
già destinata dal padre, impegnato in battaglia, alla reggenza. Il suo sdegno si placa un attimo nel
rimpianto e nella mesta disillusione; un flauto, raddoppiato poi dal clarinetto, introduce
dolcemente il suo rimpianto del passato (Anch'io dischiuso un giorno): i tempi dell'incanto, della
speranza di trovare, giovinetta, l'amore, sono finiti per sempre. Entra agitato il Gran Sacerdote,
seguito dai Magi e dai grandi del Regno; è inorridito: Fenena manda liberi gli Ebrei; il popolo
babilonese indignato è insorto, e deposta Fenena, invoca il nome di Abigaille. Per favorire il colpo
di stato i sacerdoti hanno già sparso la falsa notizia della morte del re. Gonfia d'orgoglio, Abigaille
già si vede regina (Salgo già del trono aurato) e pensa alla vendetta: popoli interi verranno a
chiedere pietà e le figlie dei re si inginocchieranno ai piedi di una schiava.
Sala nella reggia che risponde nel fondo ad altre sale. A destra una porta che conduce ad una galleria, a
sinistra altra porta che comunica cogli appartamenti della Reggente. È sera. La sala è illuminata da una
lampada.
7. PREGHIERA. Un preludio affidato ai violoncelli prepara l'entrata di Zaccaria; egli avanza
insieme a un Levita che reca le Tavole della Legge e si sofferma a meditare su di esse (Tu sul
labbro de' veggenti): invoca Dio di parlare all'Assiria con forti accenti, sì che la sua legge risorga
sugli idoli spezzati e il tempio possa risuonare di canti a lui consacrati. Quindi entra con il Levita
nelle stanze di Fenena.
8. CORO DI LEVITI. Appena allontanatosi Zaccaria entra Ismaele: ha il compito di convocare i
Leviti dal "pontefice". Ma nel vederlo, essi si ritraggono inorriditi (Il maledetto non ha fratelli):
sulla fronte del reietto sta il marchio dell'infamia. Ismaele invoca la morte per sé; ma non c'è pietà
per chi ha tradito il suo popolo.
9. SCENA E FINALE SECONDO. Interviene Anna, sorella di Zaccaria, a salvare Ismaele dalla
furia dei Leviti, annunciando la conversione di Fenena alla religione ebraica. Entra Zaccaria per
confermare le parole di Anna. Ma sorge un tumulto: irrompe il vecchio e fedele Abdallo, tutto
affannoso, per implorare Fenena di fuggire: corre voce che Nabucco sia morto e ora il popolo
acclama Abigaille come regina. Fenena vuole accorrere in mezzo agli empi ribelli per dissuaderli;
ma è tardi: entra il Gran Sacerdote acclamando Abigaille e gridando morte agli Ebrei! Lo segue
Abigaille. Le due sorelle sono una di fronte all'altra: Abigaille reclama la corona, ma
Verdi al tempo di Nabucco (incisione, 1842)
Fenena non cede. In quello stesso istante Nabucco, aprendosi con i suoi la via in mezzo allo
scompiglio, si getta fra le due sorelle, prende la corona e, ponendosela sul capo, sfida Abigaille a
prendersela. Terrore generale. Dopo un attimo di silenzio inizia un concertato 'di stupore' che si
sviluppa a canone (S'appressan gl'istanti): s'avvicina il momento di una collera fatale che prepara
un giorno di lutto. Al colmo di un'ira superba Nabucco dichiara decaduti il dio di Babilonia, reo
d'aver indotto il popolo assiro a tradirlo, e il dio di Israele sconfitto in guerra; v'è un solo dio:
Nabucco stesso! e in un delirio di onnipotenza ingiunge a tutti di chinare il capo a terra adorando il
nuovo nume. Zaccaria con impetuoso accento lo avverte di far subita ammenda se non vuole
incappare nell'ira divina. Per tutta risposta Nabucco ordina di farlo morire, insieme al suo popolo,
davanti al proprio simulacro. Dichiarandosi ebrea, Fenena vuole seguire la stessa sorte. Con
incontenibile ira Nabucco afferra la figlia per un braccio. Ma in quel medesimo istante un fulmine
si abbatte sul suo capo. Nabucco, atterrito, sente strapparsi la corona da una forza soprannaturale;
la follia appare in tutti i suoi lineamenti: gli astanti attoniti riconoscono la vendetta divina. A tanto
scompiglio succede un attimo di silenzio. Nabucco viene sopraffatto da forze invisibili e
sconosciute che gli strappano la corona e lo scettro e lo prostrano a terra afferrandolo per i capelli
(Chi mi toglie il regio scettro); implora Fenena di aiutarlo a cacciare visioni di fantasmi con spade
fiammeggianti. Il popolo assiste muto e attonito al delirio del re. Nabucco sente ora una lagrima
bagnargli il ciglio; cerca aiuto, ma alla fine cade a terra svenuto. "Il cielo ha punito il vantator!"
ammonisce Zaccaria. L'ambiziosa Abigaille raccoglie la corona caduta dal capo di Nabucco: per lei
lo splendore del popolo di Belo non è ancora offuscato!
PARTE TERZA: La profezia
Le fiere dei deserti avranno in Babilonia la loro
stanza insieme coi gufi, e l'upupe vi dimoreranno.
GEREMIA 11
Orti pensili.
10. CORO D'INTRODUZIONE. Abigaille è sul trono. I Magi, i Grandi sono seduti ai suoi piedi;
vicino all'ara ove sorge la statua d'oro di Belo sta coi seguaci il Gran Sacerdote. Donne babilonesi,
Popolo e Soldati riempiono la scena. La marcia guerriera già udita nel Finale primo introduce
l'omaggio che il popolo assiro rivolge alla regina (È l'Assiria una regina), arbitra di guerra e di
pace.
11. RECITATIVO. Il gran Sacerdote le presenta la sentenza di morte per gli Ebrei e Fenena, che
ha tradito Belo. Abigaille si finge riluttante; ma è interrotta da Nabucco che si trascina in scena
con ispida barba e vesti dimesse; le guardie, alla cui testa è il vecchio Abdallo, gli cedono
rispettosamente il passo. È delirante: crede di trovarsi nell'aula del consiglio; si sente debole, sì, ma
tutti devono crederlo forte. Pur trattenuto da Abdallo che vuole risparmiargli l'umiliazione,
Nabucco si avvicina al trono per salire e si rivolge irato ad Abigaille, che ancora non riconosce.
Scendendo dal trono Abigaille ordina a tutti di uscire.
12. DUETTO. A Nabucco che le chiede chi sia, Abigaille risponde di essere la custode del trono:
mentre lui era ammalato, il popolo assiro ha reclamato morte per gli Ebrei; e ora gli presenta la
sentenza di condanna perché sia da lui firmata. Nabucco sulle prime tentenna incerto; ma quando
sarcasticamente Abigaille lo accusa di codardia, rompe ogni indugio: afferra la sentenza e vi pone il
suo sigillo. Abigaille esulta. E a Nabucco, che le chiede di Fenena, annunzia che essa morrà per
essersi data a un falso dio. D'altronde egli ha un'altra figlia... Nabucco è inorridito; subitaneamente
cerca in seno il foglio che attesta la nascita servile di Abigaille. Ma è Abigaille, che aveva già
previsto il gesto, a trarre dal proprio seno quel foglio da lei trafugato e a farlo violentemente a
pezzi davanti agli occhi di Nabucco. Questi è come annichilito; inutilmente con la mano corre alla
spada, e si compiange (Oh di qual onta aggravasi): "l'ombra tu sei d'un re". Di fronte a lui Abigaille
si erge superba dell'"ambita gloria": assai più vale il trono che un genitore perduto. Quanto più lui
appare sottomesso, tanto più lei è imperiosa. Un segnale di trombe proviene dall'interno: è suono
di morte per gli Ebrei, annuncia Abigaille. Nabucco reagisce chiamando le guardie: esse si
presentano, ma solo - ordina Abigaille - per condurlo prigioniero: sì, prigioniero di una schiava che
ne disprezza ormai il potere! Prigioniero!... Nabucco supplica che gli sia almeno resa la figlia; a
questa condizione Abigaille sia pur regina dell'Assiria (Deh, perdona, deh perdona). Ma invano; la
supplica del vecchio padre non fa che inasprire l'ira di Abigaille, che insulta Nabucco: non fosti
audace nel serbarmi al disonore; e ora tutti vedranno se a me non si addice il manto regale.
Nabucco viene trascinato via sotto lo sguardo trionfante della figliastra.
Le sponde dell'Eufrate.
13. CORO DI SCHIAVI EBREI, PROFEZIA - FINALE TERZO. "Super flumina Babiloniae... ci
sedemmo a piangere"... Al popolo ebreo ridotto in schiavitù non resta che il ricordo dolente e
nostalgico della patria perduta (Va, pensiero, sull'ali dorate). È il cuore dell'opera, "una grande aria
- come sembra la definisse Rossini - cantata da soprani, contralti, tenori e bassi". Nell'ampio
fluttuare ritmico della melodia risuona la tristezza di tutto un popolo che saluta le rive del
Giordano, le torri atterrate di Sionne, i destini di Gerusalemme ("di Solima i fati") e, con
prorompente scatto verso l'acuto, rimpiange l'arpa dei profeti che ora pende muta dai salici. Che
Dio ispiri un canto che dia forza al loro patimento! S'appressa Zaccaria che, severamente
rimprovera questo piagnucolare; Dio, che ora parla per sua bocca, annuncia che ben tosto l'indegna
catena sarà spezzata (Del futuro nel bujo discerno): Babilonia cadrà in rovina, in preda alle iene e ai
serpenti, sommersa dalla polvere e dal silenzio. Nulla resterà della superba città (Niuna pietra ove
sorse l'altera Babilonia); animati dal sacro fuoco di Zaccaria gli Ebrei si sentono rincuorati e si
riconoscono nelle sue parole.
PARTE QUARTA: L'idolo infranto
Bel è confuso; i suoi idoli sono rotti in pezzi
GEREMIA XLVIII
Appartamento nella reggia come nella parte seconda.
14. PRELUDIO, SCENA ED ARIA. Nabucco, seduto su un sedile, è immerso in un profondo
sopore; la musica del preludio, attraverso alcuni temi di scene precedenti ("Chi mi toglie il regio
scettro", il canto di Fenena "Padre, pietade", la marcia guerriera) lascia intuire che il suo sonno è
continuamente agitato da incubi. Si risveglia di soprassalto, tutto ansante: ancora delira, oppresso
da un sogno in cui si vedeva braccato fra le selve. Uno squillo della banda interna sembra
riportarlo alla realtà: è squillo di guerra! Or dunque la mia spada, il mio destriero... Ma è invece
uno squillo funebre, preceduto dal nome di Fenena. Il nome di mia figlia!? Sul ritmo di una marcia
funebre eseguita dalla banda interna, Nabucco s'affaccia alla loggia: vede la figlia, le mani
incatenate, che piangendo cammina tra file di soldati, mentre risuona il grido "Fenena a morte!". Il
volto di Nabucco si trasfigura; corre alle porte; trovatele chiuse, irrompe in un grido "Ah,
prigioniero io sono!". Ritorna alla loggia, guarda verso la pubblica via; quindi si tocca la fronte e,
chiedendo perdono al Dio degli Ebrei, s'inginocchia. Un dialogo fra violoncello e flauto introduce
la sua preghiera: implorando di essere liberato da tanto affanno (Dio di Giudal...), promette di
distruggere i riti i Belo e di consacrare a lui, Dio vero e onnipossente, ara e tempio. Quindi si alza e
corre ad aprire con violenza la porta; in quel mentre sopraggiunge il fido Abdallo con alcuni
guerrieri che si precipitano verso il re; ormai guarito nella mente, questi chiede una spada: per
riacquistare il trono, gli dice Abdallo; per salvare Fenena, risponde Nabucco. Lo scatto veemente
dei guerrieri (Cadranno i perfidi) anticipa lo slancio dello stesso Nabucco che, ardente d'insolita
fiamma, esorta i suoi fedeli a seguirlo (O prodi miei, seguitemi): gli empi cadranno al suolo e la sua
corona tornerà a rifulgere al sole.
Orti pensili come nella parte terza.
15. MARCIA FUNEBRE E PREGHIERA. Il Sacerdote di Belo presiede al rito sotto il peristilio
del tempio, presso un'ara espiatoria, ai lati della quale stanno in piedi due sacrificatori armati di
ascia. La scena si apre al cupo e lugubre suono della marcia funebre, eseguita da una banda interna,
che annuncia l'arrivo di Fenena, di Zaccaria e degli Ebrei condannati a morte. Essi si avviano al
patibolo scortati dai sacerdoti di Belo e dai Magi. Giunta nel mezzo della scena Fenena
s'inginocchia davanti a Zaccaria, che la incoraggia ad affrontare il martirio. La giovane sente ormai
la sua anima librarsi illuminata verso il cielo (Oh dischiuso è il firmamento).
16. FINALE QUARTO. Si sente un tumulto e il grido "Viva Nabucco!". Il Gran Sacerdote vuole
affrettare il rito. Ma Nabucco già accorre con la spada sguainata, seguito da guerrieri e da Abdallo,
e prima che i guerrieri su suo ordine possano distruggere la statua di Belo, l'idolo cade infranto da
sé. Il prodigio rende tutti attoniti. Nabucco dichiara liberi gli Ebrei e ordina che un nuovo tempio
sia eretto a Jehovah: lo ha reso demente, gli ha ridonato la pace; e ora egli ha turbato la mente di
Abigaille sì che essa si è avvelenata. Alle parole di Nabucco la pace scende nei cuori dei
presenti.Tutti s'inginocchiano per innalzare un canto di lode (Immenso Jehovah) a colui che non
ha nome (Jehovah), che dona pace e porta guerra, che fa splendere l'arcobaleno e fa vibrare il
fulmine. Il tripudio generale è turbato da Abigaille che entra in scena sorretta da due donne
babilonesi: ha ingoiato il veleno e sta per morire. Si rivolge a Fenena (Su me morente esanime)
implorando il suo perdono; quindi a Nabucco indicandogli in Ismaele l'oggetto amoroso della
sorella; infine invoca la misericordia del vero Dio implorando di non essere maledetta. Cade a terra
morta. Le ultime parole sono di Zaccaria per Nabucco: servendo a Jehovah sarai re dei re!
Margherita Barezzi, la prima moglie di Verdi
I Lombardi alla prima crociata
Dramma lirico [in quattro atti) di Temistocle Solera
Prima rappresentazione: Milano,Teatro alla Scala, 11 febbraio 1843
L'argomento è ricavato dall'episodio di Giselda nel poema epico in ottava rima di Tommaso Grossi
(Milano, 1790-1853), I Lombardi alla prima crociata, pubblicato nel 1826, una sorta di romanzo
patriottico, sul modello dellivanhoe di Walter Scott, nel quale si narrano i conflitti di una famiglia
i cui membri si riconciliano in nome di un comune ideale. Ad esso si ispira liberamente la terza e
ultima delle tre opere che Verdi aveva pattuito con Merelli dopo il successo di Oberto. La genesi
dei Lombardi è forse la meno documentata fra le opere di Verdi, stante la diuturna collaborazione
fra maestro e poeta, dimoranti entrambi a Milano, a pochi passi dalla Scala. La scelta
dell'argomento, ispirata alla spettacolarità e al frequente intervento delle masse corali, maturò nel
maggio del 1842, sull'onda del successo di Nabucco. Solera approntò un libretto in cui preghiere,
battaglie, processioni, chiostri, visioni, tradimenti, conversioni si accostano l'un l'altro entro un
percorso 'a pannelli' che richiama insistentemente la complessa struttura del grand-opéra parigino,
ma senza uno sviluppo drammatico organicamente unitario. Il maestro ne iniziò la composizione
già sul finire dell'estate del 1842. Gli aspetti religiosi dell'argomento - fra cui una processione
ecclesiastica e un battesimo - attirarono tuttavia l'attenzione dell'arcivescovo di Milano, l'austriaco
Gaisruck, che intervenne presso il capo della polizia, il barone Torresani, perché ne fosse vietata la
rappresentazione; Torresani, un melomane peraltro, propose alcune modifiche, che incontrarono
tuttavia il deciso rifiuto dell'irremovibile compositore; sua pressoché unica concessione la
sostituzione di `Ave Maria" con "Salve Maria". Alla prima rappresentazione il successo - grazie
alla trascinante interpretazione delle masse corali e dei due cantanti principali, la Frezzolini e
Guasco, e alla bravura del violinista Eugenio Cavallini che s'impose nell'esecuzione del grande
assolo, improntato ai caratteri stilistici della tecnica paganiniana, che precede il terzetto alla fine
del terzo atto - fu strepitoso e contribuì a rinsaldare la fama del giovane maestro e a valergli
l'appellativo di "papà dei cori". Oltre quattro anni più tardi, per il suo esordio sulle scene
dell'Opéra di Parigi, Verdi riutilizzerà gran parte della musica dei Lombardi su un soggetto
interamente nuovo, intitolato Jérusalem, pure ispirato alle Crociate, ma basato su uno svolgimento
più organico e coerente. Frequentemente eseguiti nel corso dell'Ottocento anche nei teatri di
provincia (dove spesso il difficile assolo per violino veniva eseguito dal flauto) e ancora saldamente
in repertorio verso la fine del secolo, I Lombardi entrarono nell'ombra all'alba del Novecento,
trascurati anche dalla Verdi-Renaissance tedesca; isolate ma importanti riprese si ebbero tuttavia a
Torino (1926/27), alla Scala di Milano (1930/31), al Maggio Musicale Fiorentino (1949). A
partire dalla stagione 1969/70 con l'allestimento del Teatro dell'Opera di Roma I Lombardi sono
tornati agli onori delle scene.
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
Atto I
Giovanni Severi
ARVINO i
primo tenore
figli di Folco signore di. Rò [Rho]
PAGANO J
primo basso
Prospero Derivis
VICLINDA, moglie d'Arvino
seconda donna Teresa Ruggeri
GISELDA, sua figlia
prima donna
Erminia Frezzolini
PIRRO, scudiero d'Arvino
secondo basso Gaetano Rossi
UN PRIORE della città di Milano secondo tenore Napoleone Marconi
Atti II-IV
ACCIANO, tiranno d'Antiochia secondo basso Luigi Vairo
ORONTE, suo figlio
primo tenore
Carlo Guasco
ARVINO, condottiero de' Crociati Lombardi
primo tenore
Giovanni Severi
GISELDA, sua figlia
prima donna
Erminia Frezzolini
SOFIA, moglie del tiranno d'Antiochia
fatta celatamente cristiana
seconda donna Amalia Gandaglia
PIRRO, rinnegato
secondo basso Gaetano Rossi
UN EREMITA (PAGANO)
primo basso
Prospero Derivis
Claustrali, Priori, Sgherri, Armigeri del Palazzo di Folco, Ambasciatori Persi, Medi, Damasceni e Caldei Cavalieri e
Guerrieri Crociati, Pellegrini, Donne lombarde, Donne dell'Harem, Vergini
L'epoca: l'anno 1097 circa
La scena: Atto I a Milano - Atto II in Antiochia e sue vicinanze - Atto III e IV presso Gerusalemme
Nota storica: I personaggi e la vicenda, tutti immaginari, si rifanno all'epoca della prima crociata,
invocatà da Pietro d'Amiens, detto Pietro l'Eremita, al grido di Dio lo vuole, perché si liberasse il
Santo Sepolcro. Consacrata da papa Urbano II a Piacenza e a Clermont-Ferrand nel 1095, la
spedizione, capitanata da Goffredo di Buglione, ebbe inizio un anno dopo e si concluse nel 1099
con la conquista, effimera, di Gerusalemme. Nell'opera il "grido di Piero" viene rievocato nella
seconda parte dell'atto 2°; e quindi ripreso alla fine dello stesso atto da Giselda, ma capovolto in
Dio noi vuole, poiché Dio venne a parlarci solo di pace e non di guerra. Nell'elenco dei personaggi
appare quello di Pirro: in lui si adombra la figura storica di Firuz, il capitano siriano che consegnò
Antiochia ai Crociati. L'azione del dramma si svolge dapprima a Milano e quindi, dopo un lasso di
alcuni mesi, in Palestina; all'inizio del terzo atto l'azione è ambientata nella "valle di Giosafat",
luogo immaginario, nella tradizione biblica, in cui avverrà il giudizio universale, identificata con la
valle di Cedron, ai piedi del monte Oliveto, a oriente di Gerusalemme.
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
ATTO PRIMO: La vendetta
La Piazza di Sant'Ambrogio. S'ode lieta musica nel tempio.
1. PRELUDIO ED INTRODUZIONE. L'opera non ha ouverture. Inizia con un breve Adagio
strumentale in cui si raccolgono brevi frasi che dapprima esprimono solennità, quindi alludono alle
fosche minacce di Pagano e al suo pentimento. Esse vengono interrotte dai bruschi accordi di una
banda interna; sulla scena sono radunati gruppi di cittadini milanesi che commentano gli
avvenimenti che si stanno preparando nella chiesa di sant'Ambrogio (Oh nobile esempio):
l'investitura del nobile Arvino quale comandante dei Crociati lombardi e inoltre la sua
riappacificazione con il fratello Pagano. Un coro di donne, uscendo dalla chiesa, chiede il perché di
tanto suono festante: i cittadini raccontano che Pagano (Quest'oggi sull'empio), colpevole d'avere
molti anni prima attentato alla vita del fratello per vendicarsi del suo matrimonio con la giovane
Viclinda, di cui Pagano stesso si era invaghito, ora è rientrato in patria dopo un periodo di esilio in
Palestina, per chiedere perdono. Riprende il suono della banda interna, ed ecco apparire la famiglia
di Folco, con Arvino in testa, che esce dalla cattedrale; ai cittadini tuttavia non sfugge nel volto di
Pagano la traccia di un furore interiore.Terminato il coro, Pagano si prostra di fronte al fratello; i
due si baciano in segno di pace. Giselda e Arvino non sanno nascondere un interiore turbamento
(T'assale un tremito!): infatti Pagano, che ha finto il suo pentimento, trama con Pirro una nuova
azione delittuosa contro Arvino, mentre il popolo, osservando i due fratelli, si augura che il bacio
di Pagano non sia quello di Giuda. Un Priore della città di Milano annuncia che i cittadini
milanesi, accogliendo il "grido di Piero", hanno deciso di inviare un contingente lombardo alla
crociata, guidato da Arvino; questi accetta il compito affidatogli e invita i presenti a stringersi in
un giuramento (All'empio, che infrange la santa promessa): tutti rispondono unanimi al suo
appello.
2. CORO DI CLAUSTRALI, SCENA,ARIA E CORO DI SGHERRI. Sta per calare la notte.
Dall'interno della cattedrale si sente provenire un breve concento d'organo sul quale s'innesta un
canto di monache che pregano (A te nell'ora infausta) affinché la pace scenda nel cuore degli
uomini. Seguito da Pirro, scivola furtivo in scena Pagano; irridendo alla preghiera delle suore
confessa tuttavia a Pirro che il suo animo non è votato al crimine; è stato un amore contrastato a
predisporvelo: l'amore per Viclinda (Sciagurata! hai tu creduto), la donna tanto impetuosamente
desiderata, per la quale la sua passione è venuta aumentando nella lontananza. Pirro lo informa che
molti uomini fidati, celati fra le piante, sono pronti all'azione. Essi gli si presentano; come Pagano
li avverte dei pericoli dell'impresa, essi lo rassicurano, spavaldi nella loro determinazione di
portare l'opera a compimento (Niun periglio il nostro seno). La ripresa del canto interno delle
monache viene bruscamente interrotta dall'esplosione d'ira di Pagano (O speranza di vendetta),
che, sostenuto dal coro degli sgherri, esprime la propria impazienza nel trarre vendetta.
Galleria nel palazzo di Folco, che mette dalla sinistra nelle stanze di Arvino, dalla destra in altri
appartamenti. La scena è illuminata da una lampada.
3. SCENA E PREGHIERA. Viclinda entra insieme a Giselda: si sente oppressa da una
inquietudine che non sa spiegare; e fa voto, qualora dovesse sopravvivere a un pericolo che sembra
sovrastarle, di recarsi a piedi nudi al Santo Sepolcro. Sopraggiunge Arvino, che invita la moglie ad
andare nelle sue stanze, ma senza coricarsi: la attende il padre Folco; poi, avvertendo un rumore di
passi, rientra guardingo nelle sue stanze. Le due donne s'inginocchiano; Giselda rivolge una
preghiera alla Madonna (Salve Maria!) attraverso una dolcissima melodia, accompagnata in
orchestra da un organico quasi cameristico. Su un breve postludio madre e figlia rientrano nelle
loro stanze.
4. SCENA E FINALE PRIMO. Su un sinistro motivo di corni entra Pirro, che sottovoce invita
Pagano a inoltrarsi: Arvino è già nelle sue stanze. Pagano non trattiene la propria gioia; ordina di
spegnere i lumi ed entra furtivamente nelle stanze del fratello. Nel frattempo, mentre in orchestra
risuona un ritmo vorticoso, si vede attraverso le vetrate della galleria un bagliore di fiamme e si
sente un fragore d'armi. Pirro esce sguainando la spada, mentre Giselda attraversa la scena
rapidamente. Pagano rientra dalle stanze di Arvino trascinando seco Viclinda che invano cerca di
opporre resistenza. Mentre l'incendio va estinguendosi, il rapitore grida alla donna di urlare più
forte, tanto nessuno l'ascolta. Ma si sbaglia, perché ecco arrivare Arvino. Di chi dunque il sangue
versato? si chiede Pagano lasciando cadere il pugnale, mentre la scena si va riempiendo di folla.
Del padre!, gli viene risposto. Tutti restano inorriditi dal gesto di Pagano (Mostro d'averno
orribile). Esplode infine l'ira di Arvino che si scaglia sul fratello per ucciderlo. Subito Giselda si
frappone: non si aggiunga delitto a delitto. Pagano fa allora per trafiggersi con la spada, ma viene
trattenuto dagli armigeri: la vita gli sarà strazio maggiore della morte.Tutti i presenti gli si
rivoltano contro (Va! sul capo ti grava l'Eterno) condannando il parricida a scontare la pena
nell'esilio perpetuo.
ATTO SECONDO: L'uomo della caverna
Sala nel palazzo d'Acciano in Antiochia.
5. CORO DI AMBASCIATORI. Molti mesi sono passati dall'azione dell'atto precedente.
Raggiunta l'Asia Minore i Crociati stanno già stringendo d'assedio Antiochia. Acciano è seduto sul
trono; dinanzi a lui stanno gli Ambasciatori. Anche soldati e popolo sono in scena; e con essi la
moglie del sultano, Sofia (segretamente convertitasi al cristianesimo), e il figlio Oronte (recante il
nome stesso del fiume che bagna Antiochia), che però non partecipano all'azione. Acciano annuncia
agli ambasciatori presso di lui convenuti che l'intera regione è invasa dai cavalieri crociati, i quali
stanno devastando i territori e compiendo stragi e rapine. Insieme agli ambasciatori invoca la
punizione di Allah per gli infedeli (Or che d'Europa il fulmine); all'invocazione si uniscono i soldati
e il popolo di Antiochia, giurando di sorgere tutti come un solo uomo contro gl'invasori. Quindi
Acciano e i convenuti escono in processione dalla sala, lasciando soli Sofia e Oronte.
6. SCENA E CAVATINA. Sofia rivela al figlio che la giovane Giselda, pur piangendo i propri cari,
lo ama sempre (e intanto, in cuor suo, spera che anche il figlio si converta). Felice della notizia,
Oronte vorrebbe trasfondere la propria gioia nel cuore di Giselda (La mia letizia infondere). La
madre gli fa tuttavia presente che egli potrà coronare il suo sogno d'amore solo abbracciando la
religione della giovane. Per tutta risposta Oronte manifesta alla madre, con sua grande gioia,
d'avere già in animo di convertirsi alla fede cristiana, a ciò indotto dall'amore per Giselda (Come
poteva un angelo) che le ha schiuso il velo della verità.
Prominenze di un monte praticabili, in cui s'apre una caverna.
7. GRAN SCENA E MARCIA DEI CROCIATI. Su una musica cupa, turbata da frementi
cromatismi, Pagano, sotto le spoglie di un Eremita, esce dalla caverna; si chiede quando si udrà il
fragore delle armi: è suo desiderio unirsi ai Crociati per emendare "un gran misfatto". Ma come
pretendere pace? Solo Dio è giusto, anche quando comanda dolore e pianto. Ma quando si udrà
l'appello "Dio lo vuole" (Ma quando un suon terribile) e la destra gelida impugnerà la spada per
liberare il Santo Sepolcro, allora l'anima potrà salire redenta al cielo. Avverte l'avvicinarsi di un
uomo in abito mussulmano; è Pirro che, richiamato dalla fama di santità dell'Eremita, chiede se
potrà ottenere perdono alle proprie colpe: ha prestato aiuto a un parricida e da codardo ha
rinnegato la propria fede. E all'Eremita, che lo invita a sperare, Pirro confida ancora d'aver avuto
in custodia le mura di Antiochia. Intanto il breve squillo di una banda interna annuncia l'arrivo
delle schiere crociate. All'Eremita non par vero: al colmo dell'entusiasmo perdona Pirro,
ingiungendogli di scontare il suo peccato con l'aprire le porte di Antiochia ai Crociati. Mentre il
suono della banda si fa più vicino, Pirro giura di aprire la notte stessa l'ingresso della città alle
truppe cristiane. Entra la banda e la scena si riempie di guerrieri crociati e di pellegrini. I: Eremita
osserva con trasporto che sono Lombardi! Spinge Pirro a rifugiarsi nella caverna; vi entra
anch'egli e ne esce con un elmo e una spada. Sul monte si distendono intanto i guerrieri crociati,
preceduti da Arvino. L'Eremita si pone l'elmo in testa e cala la visiera.
8. DUETTINO ED INNO DE' CROCIATI. Anche ad Arvino è giunta la fama di santità
dell'Eremita (Sei tu l'uom della caverna?), e ora gli si rivolge per chiedere della propria figlia,
rapita dai mussulmani; conducendolo sull'altura, gli mostra le schiere dell'esercito crociato.
L'Eremita lo
Temistocle Solera
Francesco Maria Piave
assicura che la prossima notte l'esercito accamperà in Antiochia e la figlia gli sarà restituita.
Esplode a questo punto l'inno guerriero dei crociati (Stolto Allab!... Sovra il capo ti piomba), cui
Arvino e Pagano rispondono a una voce.
Recinto dell'Harem.
9. CORO DI SCHIAVE. Precedute dal suono di una musica 'alla turchesca' le donne dell'Harem
accompagnano Giselda, che mestamente si abbandona sopra un sedile; esse irridono la sua
condizione (La bella straniera) e le danzano intorno con atteggiamenti ironici, punteggiando la
danza con parole minacciose per la sorte dei suoi. Quindi fuggono.
10. RONDÒ - FINALE SECONDO. Sorgendo impetuosamente, Giselda si rivolge allo spirito
della madre: un amore indegno di una cristiana le sta divorando il cuore (Se vano è il pregare):
spera con la preghiera di raggiungerla in cielo. Improvvisamente si odono della grida di donne che
irrompono in scena inseguite dai Crociati; con loro è Sofia, la quale informa Giselda che un
tradimento ha aperto la via ai Crociati: marito e figlio sono caduti ai suoi piedi e indica il loro
uccisore in Arvino, che sopraggiunge insieme all'Eremita. Giselda, sopraffatta dall'orrore, si copre
il volto con le mani e di fronte al padre retrocede rifiutando il suo abbraccio. Come colpita da
demenza esplode in un'accusa che declama con forza (No! no! giusta causa non è d'Iddio): no, Dio
non vuole guerra, né vendette, né uccisioni; egli ha sempre sdegnato l'olocausto della vita umana.
Arvino le urla "sacrilega!". Ma Giselda continua: sottovoce, su una sequenza di frasi cromatiche, e
con tono profetico ella prevede che un giorno torme di barbari domeranno le genti d'Europa.
Infine esplode: no!,"Dio nol vuole": egli scese fra gli uomini a parlarci solo di pace. Arvino, al
colmo dell'ira, cava il pugnale e fa per avventarsi sulla figlia; ma tutti lo trattengono col dirgli che
ella ha smarrito la ragione.
ATTO TERZO: La Conversione
La valle di Giosafat, sparsa di vari colli praticabili, fra i quali primeggia quello degli Ulivi. In lontananza
si vede Gerusalemme.
11. CORO DELLA PROCESSIONE. Cavalieri, Crociati, Donne, Pellegrini escono in processione
a capo scoperto intonando un canto alla città promessa (Gerusalem!... la grande, la promessa
città!): il canto inizia dall'interno; poi, man mano che entrano in scena, un'ampia melodia viene
dispiegata dalle voci femminili: ora che è dato di rivedere i luoghi santi, si può anche morire.
Rispondono fieramente le voci gravi dei bassi; enumerando i luoghi santificati dai vangeli,
procedono in un crescendo che sbocca nella ripresa della melodia delle donne da parte dell'intero
coro. Improvvisamente il ritmo si anima: ecco arrivare il Dio guerriero! Poi la musica si placa e le
voci invocanti Gerusalemme si perdono in lontananza.
12. SCENA E DUETTO. Compare Giselda, fuggita dalla tenda del padre; ora non ha che pensieri
d'amore per Oronte, che crede ucciso. Ma questi, che ha udito le sue ultime parole, le si presenta e
con trasporto corre ad abbracciarla. Giselda quasi non crede ai propri occhi. Il giovane le racconta
che, ferito da spada nemica, nella speranza di rivedere l'amata si è reso vile con la fuga, errando di
terra in terra e cambiando veste; ora ha tutto perduto: patria, parenti, amici, trono, la vita con
l'amata. Giselda con decisione gli dichiara di fuggire con lui e seguire il suo destino. Il giovane
tenta di dissuaderla dal proposito (Per dirupi e per foreste): egli vive fra dirupi e caverne, solo il
deserto farà loro da talamo e sarà l'urlo della iena il canto nuziale... Ma Giselda è ormai decisa;
l'amore non le impone altro consiglio che fuggire con lui. Oronte accoglie la sua decisione con
sommo trasporto di gioia. Accompagnata dall'arpa, Giselda dà tristemente addio alle tende del
campo lombardo (012 belle, a questa misera) chiedendo perdono alla madre; Oronte si associa al
suo canto affermando che pregherà lo stesso Dio di Giselda. Si ode un grido d'allarme provenire
dal campo lombardo; Giselda, spaventata, trema per la sorte di Oronte (Vieni, sol morte): mentre si
fa sempre più frequente l'appello interno dei Crociati, i due giovani si giurano fedeltà e quindi
fuggono. La scena viene suggellata dal persistente grido d'allarme.
Tenda d'Arvino.
13. SCENA ED ARIA [CON CORO]. Sono passate poche ore dalla scena precedente. Arvino è
furente nei confronti della figlia; fuggita a cavallo insieme a Oronte, sa che l'uomo della caverna la
insegue: l'avrebbe preferita morta, piuttosto che sacrilega, oh, non fosse mai nata! Su un allegro
vivacissimo irrompono alcuni Crociati con la notizia che Pagano, l'infame assassino, è stato visto
incamminarsi verso i luoghi santi; ora non può più fuggire: sia dunque tratta feroce vendetta su di
lui. Ignorando che Pagano e l'"uomo della caverna" (cioè il "santo" Eremita) sono la stessa
persona,Arvino giura di dare la caccia al fratello (Sì! del ciel che non punisce) e di ucciderlo.
Interno di una grotta. Da un'apertura in fondo si vedono le rive del Giordano.
14. PRELUDIO E TERZETTO - FINALE TERZO. Un lungo assolo di violino, caratterizzato da
un'ampia melodia che si conclude con un brano virtuosistico, introduce l'ingresso di Giselda che
sostiene Oronte ferito a morte dopo uno scontro con i Crociati di Arvino. Nell'adagiarlo sopra un
masso all'interno della grotta, Giselda appare disperata; ha bendato la ferita con le proprie vesti,
ma invano. Con impeto si rivolge contro Dio (Tu la madre mi togliesti) che gli ha tolto dapprima
la madre e ora gli sta togliendo l'uomo amato. Ma viene interrotta da una voce che con accento
tonante rimprovera il suo amore delittuoso: è la voce dell'Eremita, che si appressa a Oronte
annunciandogli nuova vita se egli cambierà fede. Sulle note di un violino solo che riprende la
melodia dell'inizio, Oronte accoglie con gioia le parole dell'Eremita e si appresta alla conversione,
conversione che l'Eremita compie con l'atto del battesimo (L'acque sante del Giordano). Ora,
esclama Giselda, il nostro amore non è più delitto davanti a Dio. Oronte è allo stremo delle forze,
ma si sente tuttavia invadere da una gioia intensa (Qual voluttà trascorrere); mentre l'Eremita
invita il morente a volgere la mente a Dio, Giselda lo supplica di non lasciarla sola; dopo averle
chiesto di bagnargli il volto del suo pianto, Oronte esala l'ultimo respiro. Giselda sviene sul suo
corpo.
ATTO QUARTO: Il Santo Sepolcro
Caverna. La scena è presso Gerusalemme.
15. VISIONE. Una scena presente nel libretto, ma non musicata, si svolge fra l'Eremita e Arvino;
mentre Giselda giace priva di sensi, l'Eremita spiega al padre d'averla trascinata nella caverna per
nasconderla alla sua ira. Arvino sembra disposto a perdonare la figlia; ma intanto chiede chi egli
sia, egli che ha visto combattere al proprio fianco facendo scudo con il suo petto agli assalti nemici.
Un giorno lo saprà, risponde l'Eremita; ma intanto preme cercare acqua per dare sollievo
all'orrenda sete che divora la fanciulla. Rimasta sola nella caverna, Giselda è sorpresa in sogno da
una visione di spiriti celesti (coro Componi, o cara vergine) che la invitano a raggiungere in cielo
un'anima da lei redenta. Alzandosi e continuando a sognare, la fanciulla chiede sia affrettata l'alba
del "giorno eterno". D'improvviso vede apparire su una nuvola, fra gli angeli, Oronte con un'arpa
in mano; non sa trattenere un grido di gioia e chiede che egli le parli. Oronte si volge a lei (In cielo
benedetto) per dirle che la sua preghiera è ora accetta a Dio e invita dunque la fanciulla ad
avvertire i Crociati lombardi di accorrere alle fonti del Siloe, dove troveranno acqua fresca per
dissetarsi. La visione sparisce.
16. ARIA. Risvegliandosi dal sogno Giselda si trova in uno stato di grande agitazione: ora alla
visione del Paradiso s'è sostituita la realtà dell'oscura caverna.Tuttavia si sente sostenuta da una
nuova forza ed erompe in un'aria di gioia (Non fu sogno!): sente risuonare in fondo all'anima la
voce amata e vede scorrere il fiume dove i Crociati potranno dissetarsi.
Le tende lombarde presso il sepolcro di Rachele.
17. CORO Di CROCIATI E PELLEGRINI. I Crociati, i pellegrini e le loro donne sono stremati
dalla sete.Tutti, all'unisono, elevano un pensiero a Dio (O Signore, dal tetto natio): ricordando
d'essere accorsi giubilanti sull'aspro sentiero in risposta all'appello di un pio, vanno con la mente ai
limpidi ruscelli e ai purissimi laghi di Lombardia, mentre ora la sete li divora senza scampo
nell'immenso arido deserto in cui si trovano.
18. SCENA. INNO DI GUERRA E BATTAGLIA. Si odono all'interno le voci di Giselda, di
Arvino e dell'Eremita che gridano: "Al Siloe! al Siloe!". Entra Giselda, ringraziando Dio per aver
esaudito le sue preghiere. La seguono l'Eremita e Arvino. Questi ordina alle schiere lombarde di
dissetarsi e subito di risalire le mura. D'improvviso risuona la squilla di Goffredo da Buglione: è
l'inizio dell'attacco finale. Gli animi si accendono e tutti irrompono in un inno bellicoso (Guerra!
guerra! S'impugni la spada): la vittoria è ormai a portata di mano. Segue fuori di scena la battaglia;
lo scontro fra le opposte schiere è descritto in musica dall'alternarsi di orchestra e di banda
interna; un lungo decrescendo, contrassegnato da un tema lamentevole che annuncia la sconfitta
dei Mussulmani, si conclude su una cadenza sospesa, preludendo così alla scena seguente.
Le tende d'Arvino.
19. SCENA, TERZETTINO ED INNO FINALE. Entra l'Eremita sorretto da Giselda e da
Arvino; per primo accorso sulle mura, ora è pieno di ferite e in delirio grida che le sue mani sono
sporche del sangue di Arvino. Giselda, con dolcezza, cerca di farlo tornare in sé. All'udirne la voce
la sua mente si rischiara; chiama la fanciulla "l'angelo del perdono" e finalmente svela la sua vera
identità: egli è Pagano! Giunto al termine dei suoi giorni annuncia che con la morte ha voluto
espiare il suo delitto '(Un breve istante); Giselda proclama che egli sta morendo "in Dio". Pagano
implora di non essere maledetto: Arvino lo abbraccia vivamente commosso. Allo stremo delle forze
chiede infine di poter vedere ancora Gerusalemme. La tenda si apre e lascia vedere le mura e le
torri della città santa con le bandiere crociate che sventolano illuminate dai raggi del sole
nascente.Tutti si uniscono in un inno di lode al Dio della vittoria e della salvezza (Te lodiamo,
gran Dio).
Ernani
Dramma lirico in quattro parti di Francesco Maria Piave
Prima rappresentazione: Venezia,Teatro La Fenice, 9 marzo 1844
L'argomento deriva dalla tragedia in versi di Victor Hugo (Besanon, 1802 - Parigi, 1885), Hernani,
rappresentata con tumultuoso esito a Parigi il 25 febbraio 1830, argomento che aveva tentato
Vincenzo Bellini; dopo averne abbozzate alcune pagine, il compositore catanese fu costretto a
rinunziarvi per l'opposizione della censura, sostituendolo con la Sonnambula. In un primo tempo
Verdi, dopo aver proposto vari argomenti fra cui Re Lear (da Shakespeare), il Corsaro e I due
Foscari (entrambi da Byron), Cola di Rienzi, Caterina Howard - si era adattato a prendere in
considerazione un libretto di un poeta esordiente, Francesco Maria Piave, ricavato da un racconto
di Walter Scott e intitolato Cromvello (poi musicato da Pacini col titolo Allan Cameron). Fu lo
stesso presidente della Fenice, poco convinto della spettacolarità di questo argomento, a suggerire
a Verdi VErnani di Hugo, suggerimento che il compositore accolse con entusiasmo, nonostante la
difficoltà di aggirare l'ostacolo della censura, trattandosi nel dramma di una congiura contro un
sovrano. Nelle intenzioni della presidenza della Fenice la parte protagonista avrebbe dovuto essere
scritta per contralto; ma Verdi, che non amò mai scrivere parti maschili per voci femminili (quasi
unica eccezione è Oscar in Un ballo in maschera, ma si tratta di un imberbe paggio) ottenne di
scrivere per tenore. L'interprete cui la parte era destinata fu costretto a rinunciare dopo la pessima
prova fatta nell'opera inaugurale della stagione, I Lombardi. Non essendosi trovato un degno
sostituto, Verdi preferì attendere l'arrivo di Carlo Guasco, scritturato per la sola stagione di
quaresima. Nel corso delle prove venne meno anche l'interprete destinato alla parte di Silva,
Vincenzo Meini, che la ritenne troppo bassa per la sua voce; Verdi fece allora scritturare un
giovanisiimo basso, Antonio Selva, dopo averlo ascoltato, su suggerimento di Superchi, al teatro in
S. Benedetto. Verdi tenne duro anche nei confronti del presidente della Fenice, scandalizzato per
un corno che suona dietro le quinte... Ma quando le cose devono girare per il verso giusto non ci
sono contrattempi che tengano. Infatti, nonostante un'esecuzione imperfetta (Guasco era
vocalmente stanco e la Loewe sembra stonasse più del dovuto), Emani ebbe un esito clamoroso. La
sua popolarità divenne pressoché immediata. Nei teatri del Regno delle Due Sicilie il libretto fu
oggetto di censura e l'opera rappresentata con titolo modificato in Elvira d'Aragona o anche Il
proscritto ossia Il corsaro di Venezia. Rimasta ininterrottamente in repertorio fino ai nostri giorni,
Ernani non ha mai conosciuto eclissi; la sua diffusione sulle scene italiane e straniere ebbe un ritmo
così fulmineo quale nessun'altra opera di Verdi fino al Trovatore. Da osservare che la cabaletta di
Silva,"1nfin che un brando vindice", non faceva parte dello spartito originale; fu composta per il
basso Ignazio Marini (che la eseguì alla Scala nel settembre del 1844) e solo in un secondo tempo
fu introdotta dall'editore nello spartito.
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
ERNANI, il Bandito
primo tenore
DON CARLO, re di Spagna
primo basso cantante [baritono]
DON RifY GOMEZ DE SILVA, Grande di Spagna primo basso profondo
ELVIRA, sua nipote e fidanzata prima donna
GIOVANNA, di lei nutrice
seconda donna
DON RICCARDO, scudiero del re secondo tenore
JAGO, scudiero di Don Ruy
secondo basso
Carlo Guasco Antonio Superchi Antonio Selva Sofia Loewe Laura Saini Giovanni Lanner Andrea Bellini
Cori: montanari ribelli e banditi, cavalieri e famigliari di Silva, ancelle di Elvira, cavalieri del re, personaggi della Lega,
nobili spagnoli e alemanni, dame spagnole e alemanne
Comparse: montanari e banditi, elettori e Grandi della Corte Imperiale, paggi dell'Impero, soldati alemanni, dame e
familiari d'ambo i sessi
La scena ha luogo: Parte I.
l(
Parte II. Parte III. Parte IV.
Nelle montagne d'Aragona
Nel castello di Don Ruy de Silva
Nello stesso castello
In Aquisgrana
In Saragozza
Epoca: l'anno 1519
Nota storica: L'argomento del dramma s'ispira all'elezione di Carlo d'Asburgo re di Spagna a
Imperatore del Sacro Romano Impero e si finge tale elezione in Aquisgrana, l'antica capitale del
S.R.I. in cui si custodiscono le spoglie del suo fondatore, Carlo Magno (nella realtà storica
l'elezione del nuovo imperatore del S. R. I. si svolse alla Dieta di Francoforte; Carlo vi fu eletto
grazie all'appoggio finanziario dei banchieri Fugger, che gli permise di comprare il voto di molti
principi elettori). Nel dramma si allude alla Lega: forse si tratta della lega dei Comuneros spagnoli,
unitisi per contrastare la politica di Carlo.
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
Antefatto
Lo sfondo storico del dramma è la Spagna del primo Cinquecento, agitata dalle ribellioni dei nobili,
soprattutto castigliani, contro la politica centralizzatrice del giovanissimo Carlo I d'Asburgo,
proclamato re di Spagna e sovrano delle Americhe nel 1516 a Bruxelles. Tre anni dopo, nel 1519,
muore Massimiliano imperatore di Germania e del Sacro Romano Impero, nonno paterno di re
Carlo. In concorrenza con re Francesco di Francia e Federico il Saggio duca di Sassonia, Carlo (il
futuro imperatore Carlo 19 ambisce succedergli nonostante l'opposizione di vari baroni
dell'impero, ai quali s'erano uniti alcuni Grandi di Spagna malcontenti di lui e associatisi in una
Lega. Fra questi Ernani, sotto il cui nome - preso da quello di un villaggio nei cui pressi si è
rifugiato - sí cela in realtà quello di don Giovanni d'Aragona, duca di Segorbia e conte di Cardona,
signore di molte terre, il cui padre era stato ucciso dal padre di Carlo e spogliato d'ogni avere.
Bandito dal regno di Spagna, Ernani, riunita una masnada di seguaci con il proposito di vendicare
la morte del padre, si dà alla macchia fra le montagne della sua terra, l'Aragona.
1. PRELUDIO. Per la prima volta Verdi assegna al brano strumentale introduttivo di una sua
opera la funzione di segnale drammatico. Il preludio inizia infatti, enunciato da trombe e tromboni
all'unisono, con il tema del "pegno di Emani": Nel momento in che Emani vorrai spento, se uno
squillo intenderà tosto Emani morirà. Al tema 'fatale' segue quello che si potrebbe definire il tema
"dell'amore", che risuonerà nel quarto atto.
PARTE PRIMA: Il Bandito
Montagne dell'Aragona. Si scorge di lontano il castello moresco di Don Ruy Gomez de Silva. E presso il
tramonto.
2. INTRODUZIONE. Sono in scena montanari e banditi, tutti seguaci di Emani, al sicuro nel loro
rifugio: alcuni mangiano e bevono, altri giocano o lustrano le armi.Tutti esaltano le virtù del vino
e il rischio del gioco (Evviva! beviam!), soli piaceri a loro rimasti. Emani si mostra su una vetta: la
mestizia del suo volto non sfugge ai banditi, che promettono di dividere con lui qualsiasi sorte;
quindi riprendono a cantare le lodi del vino.
3. RECITATIVO E CAVATINA. Discendendo dalla vetta Emani ringrazia commosso i banditi
per le loro profferte di fedeltà, e ne approfitta per confidare loro il suo amore per un'"aragonese
vergine", che però è stata chiesta in sposa dal "vecchio" Silva (Come rugiada al cespite); le nozze
sono fissate per il giorno dopo, ma egli l'ama a tal punto da morire d'affanno senza di lei. L'ardito
ribelle vuole rapirla e i suoi fidi gli assicurano che lo seguiranno: il loro pugnale gli varrà da scudo
e la sua donna diventerà la stella dei banditi. Emani esprime la propria felicità (Oh tu che l'alma
adora, vien): accanto a Elvira scorderà le proprie pene.
Ricche stanze d'Elvira nel castello di Silva. E' notte.
4. CAVATINA. Un breve preludio affidato agli archi introduce l'ingresso in scena di Elvira: ella si
augura che Silva, questo odiato vecchio che quale "immondo spettro" la persegue con le sue
profferte d'amore, non faccia ritorno e che ella possa fuggire con l'amato Emani (Emani! Emani
involami): con lui anche i luoghi più inospitali saranno un "eden di delizie". Entrano le ancelle: su
un ritmo di bolero salutano la sposa recandole ricchi doni di nozze (Quante d'Iberia giovani).
Elvira ringrazia, ma il suo animo agitato disprezza ogni dono che non le parli di Emani (Tutto
sprezzo che d'Emani); ella invoca impaziente l'arrivo dell'amato ribelle: ogni indugio è per lei
supplizio. Il suo turbamento non sfugge alle ancelle: Elvira appare loro sposa costretta e non
amante. Sempre in preda a grande agitazione, la giovane lascia la stanza seguita dalle ancelle.
5. SCENA, DUETTO, INDI TERZETTO. Don Carlo, re di Spagna, entra in incognito,
accompagnato da Giovanna, la nutrice di Elvira, cui ordina di avvisare la futura sposa di
raggiungerlo. Anche il re è innamorato della donna e freme all'idea di vedersi preferito un bandito.
Alla repentina comparsa di Elvira, egli confessa di amarla di un amore possente sin dal primo
giorno che la vide (Da quel dì che t'ho veduta), e la implora di cedere ai suoi voleri di re. La donna
risponde con fierezza d'avere nelle vene sangue d'Aragona e che nemmeno lo splendore d'una
corona potrà cambiare ciò che le detta il suo cuore. Al suo rifiuto il re l'afferra per un braccio, ma
Elvira riesce a impossessarsi del pugnale di lui e minaccia di colpirlo. Questi chiama le guardie,
mentre da un uscio segreto entra Emani furibondo. Carlo lo riconosce come ribelle al suo potere,
ma Emani lo accusa di avergli ucciso il padre: ora che lo scopre rivale in amore il suo odio per lui si
accresce. Elvira si interpone minacciando di trafiggerli entrambi con il pugnale (No, crudeli,
d'amor non m'è pegno).
6. FINALE PRIMO. Improvvisamente compare il padrone di casa, il vecchio Silva, che, vedendo
presso la fidanzata due seduttori, chiama a testimonianza del proprio disonore cavalieri e servi;
mentre Carlo si tiene prudentemente nell'ombra, Silva lamenta che la propria tarda età gli abbia
conservato un cuore giovane, ormai gelato dal disonore (Infelice e tuo credevi). Ma l'onta subita
non deve restare invendicata; esplodendo con incontenibile impeto d'ira chiede che gli venga
portata una spada per duellare (Infin che un brando vindice): la sua mano non tremerà. Ordina ai
due seduttori di uscire per il duello, quando viene annunciato l'arrivo dello scudiero del re, don
Riccardo. Appena entrato questi prende posto a fianco di Carlo, rendendogli regale omaggio. Egli,
il re! Sorpresa generale. Ha inizio il concertato "di stupore": Carlo osserva ironicamente come
Silva sembri ritornato alla ragione (Vedi come il buon vegliardo); a sua volta questi manifesta
stupore e mortificazione, mentre Emani sussurra a Elvira, confortata dalla presenza dell'amato,
che al nuovo giorno la toglierà dai suoi affanni. Silva si rivolge dolente al re; ma questi, per
toglierlo dall'imbarazzo, lo trae in disparte confidandogli che, essendo morto l'imperatore, ora si
pensa alla nomina del successore: Silva è un suddito fedele, vuole un suo consiglio. Quindi, dopo
aver annunciato ad alta voce che per la notte occuperà il castello, Carlo si avvicina ad Ernani:
indicandolo come suo fido, con gesto magnanimo invita Silva a lasciarlo partire. Inizia la stretta
del concertato: Emani reagisce: il suo proposito è sempre quello di vendicare la morte del padre
(IO tuo fido? il sarò a tutte l'ore); Elvira lo scongiura di fuggire. Intanto Carlo rivela a Silva di
aspirare al fulgore della corona imperiale; il vecchio gli assicura il proprio appoggio: chi possiede
l'amore di Iberia è ben degno di cingerla.
PARTE SECONDA: L'ospite
Magnifica sala nel palazzo di Don Ruy Gomez de Silva. Porte che mettono ai vari appartamenti. Intorno
alle pareti si vedono disposti, entro ricche cornici sormontate da corone ducali e stemmi dorati, i ritratti della
famiglia dei Silva. Presso ciascun ritratto si vede collocata una completa armatura equestre, corrispondente
all'epoca in cui il personaggio dipinto viveva. Vi è pure una ricca tavola con presso un seggiolone ducale di
quercia.
7. INTRODUZIONE. Cavalieri e paggi di Silva, dame e damigelle di Elvira riccamente abbigliate:
tutti esprimono la loro gioia per il matrimonio del loro signore (Esultiamo! Letizia ne inondi) e
magnificano la bellezza della sposa.
8. RECITATIVO E TERZETTO. Entra Silva, pomposamente vestito da Grande di Spagna;
seguito da Jago, va a sedersi sul seggiolone ducale. Giunge a corte un pellegrino che chiede
ospitalità1 L'ospitalità è sacra ai Silva, risponde il vecchio indicando i ritratti; né brama sapere
altro. Il pellegrino è in realtà Emani, venuto a rapire Elvira. S'apre una porta ed entra Elvira
abbigliata a nozze, seguita dalle ancelle. Silva presenta la sposa al pellegrino, ma questi, gettando a
terra il mantello e facendosi così riconoscere, offre in dono di nozze la taglia che pesa sulla propria
testa: inseguito dal re, Emani implora Silva di essergli consegnato, onde possa ricevere in premio
l'oro della taglia (Oro, quant'oro ogn'avido); mentre Elvira esprime grande timore per la vita
dell'amato, Silva commenta che il giovane deve aver perso la ragione. Alla fine il vecchio
orgoglioso risponde che i suoi ospiti hanno i diritti di un fratello e che l'ospitalità è sacra. Ordina
siano armate le torri del castello e, dopo aver fatto cenno a Elvira di entrare nelle sue stanze, esce
seguìto dai suoi. Su un cupo crescendo orchestrale Elvira, partito Silva, fa alcuni passi per seguire
le ancelle, poi si ferma; uscite quelle torna ansiosa da Emani, che sdegnosaménte la respinge
accusandola d'averlo illuso. La donna si discolpa mostrando un pugnale con il quale si sarebbe
uccisa durante il rito nuziale. L'ira di Emani svanisce ed egli chiede perdono per aver dubitato
della fede di lei; i due si abbracciano (Ab morir potessi adesso): ma solo affanni essi troveranno
sulla terra. Ritorna Silva; nel vedere i due abbracciati va su tutte le furie scagliandosi su di loro,
pugnale alla mano. Ma entra frettolosamente Jago, che annuncia l'arrivo del sovrano
accompagnato da un drappello di soldati. Silva ordina che si apra al re. A quest'ordine Emani
implora Silva di dargli la morte, affinché non debba essere l'odiato re, l'assassino di suo padre, a
ucciderlo; ma Silva vuole per sé la vendetta (No, vendetta più tremenda); infine fa entrare Emani in
un nascondiglio segreto, celato dietro il ritratto dello stesso Silva, mentre Elvira si ritira nelle
proprie stanze.
9. SCENA ED ARIA. Carlo entra nel castello, seguito dai suoi cavalieri; con modi bruschi chiede a
Silva perché il suo castello è armato; forse per ridestare l'idra della ribellione?... A Silva,
Verdi fotografato a Parigi da Disderi (ca. 1855-57)
che ribadisce la propria lealtà, il re annuncia d'aver vinto l'ultima torma dei ribelli; ma sa che il loro
capo si è rifugiato nel castello. Silva non nega di aver dato ospitalità a un pellegrino, ma non lo può
tradire. Reagendo con impeto, Carlo esige che il bandito gli sia consegnato: o il suo capo o quello
stesso di Silva. Al rifiuto di questi comanda che gli sia tolta la spada. Dopo aver dato ordine a suoi
di cercare il bandito in ogni angolo del castello, si rivolge di nuovo a Silva sfidandolo a resistere
alla vendetta del re (Lo vedremo, veglio audace); Silva mantiene la propria dignità: il re di Spagna
non può volere il suo disonore. Dopo aver perquisito invano il castello, i soldati del re ritornano
portando fasci di armi che depongono ai piedi del re (Fu esplorata del castello): di Emani nessuna
traccia. Elvira esce precipitosamente dalle sue stanze, seguita da Giovanna e dalle ancelle, e si
prostra al re supplicandolo d'avere pietà per il suo futuro sposo. Nel vederla Carlo si acquieta: la fa
rialzare replicando che risparmierà Silva, ma sarà lei, trattenuta in ostaggio, a seguirlo. Nell'udir
questo, Silva è colto da un'angoscia mortale: protesta, disperato, che Elvira è il suo solo conforto in
terra. Alla nuova richiesta del re di avere Ernani, il vecchio si rassegna: che Elvira lo segua. Il
sovrano prende la mano di Elvira in lacrime e le rivolge parole di amorosa passione (Vieni meco,
sol di rose): la giovane pensi ora alla gioia che l'attende. Mentre Silva, divorato dall'ira, medita
vendetta, il re parte con il suo seguito, traendo seco Elvira appoggiata al braccio di Giovanna.
10. DUETTO. Silva è rimasto solo con i ritratti dei suoi avi, in uno stato d'animo di cupo odio nei
confronti del re; poi corre a due armature che sono presso i ritratti, estrae due spade e va quindi ad
aprire il nascondiglio di Emani: vuole che il bandito si batta con lui. Questi rifiuta: non combatterò
contro un vecchio, dal quale piuttosto implora la morte purché gli sia concesso di vedere Elvira.
(Tu m'hai salvato, uccidimi). Silva gli comunica che la giovane è stata portata via con la forza dal
suo acerrimo nemico. Emani allora svela a Silva che anche il re ama Elvira. Silva è sorpreso;
chiama i suoi uomini ed Emani si offre di aiutarlo a vendicarsi del re; e qui nasce tra i due un patto
scellerato: la libertà di Elvira per la morte di Emani. Il bandito giura di rispettare il patto:
consegna a Silva un corno da caccia impegnandosi a darsi la morte quando il vecchio lo suonerà.
Sopraggiungono frettolosi i cavalieri di Silva, disarmati. Su un ritmo rapido e incalzante (In
arcione, in arcion, cavalieri), Emani e Silva indicano loro i fasci di armi che ancora giacciono per
terra e li spronano alla vendetta. Quindi tutti partono per andare a liberare Elvira.
PARTE TERZA: La clemenza
Sotterranei sepolcrali che rinserrano la tomba di Carlo Magno in Aquisgrana. A destra dello spettatore vi è
il suo monumento con porta in bronzo, sopra la quale in lettere cubitali si legge l'iscrizione KAROLO
MAGNO; in fondo una scalea che mette alla porta maggiore del sotterraneo, nel quale si vedranno anche
altri sepolcri minori; sul piano della scena altre porte conducono ad altre catacombe. Due lampade pendenti
dal mezzo spandono una fioca luce sugli avelli.
11. SCENA CARLO. La cupa atmosfera dell'ambiente sepolcrale viene sottolineata da un preludio
affidato ai soli strumenti a fiato, con melodia al clarinetto basso. Don Carlo e Riccardo, avvolti in
ampi mantelli scuri, entrano guardinghi dalla porta principale. I due, presa una torcia, esaminano il
luogo dove sta per radunarsi la Lega che cospira contro il re di Spagna, mentre altrove i principi
elettori stanno decidendo a chi andrà la corona del Sacro Romano Impero. Il re congeda il suo
scudiero ordinandogli di far sparare tre colpi di cannone per fargli sapere se è stato eletto e poi di
raggiungerlo con Elvira. Rimasto solo, Carlo pensa ai ribelli che tramano per trucidarlo;
volgendosi alla tomba di Carlo Magno contempla la vanità delle cose umane: scettri, ricchezze,
onori sono come vascelli che s'infrangono sullo scoglio della tomba e piombano nel nulla. Ripensa
ai bugiardi sogni di gioventù (Oh de' verd'anni miei): ma ora, se sarà eletto al trono dei Cesari, è
pronto a sollevarsi a volo d'aquila per rendere immortale il proprio nome nei secoli regnando con
magnanimità. Apre con una chiave la porta del monumento a Carlo Magno e vi si nasconde.
12. CONGIURA. Si schiudono le porte minori del sotterraneo e vi entrano guardinghi e avvolti in
grandi mantelli i personaggi della Lega, portando fiaccole e pronunciando la parola d'ordine
stabilita:"Ad augusta—Per angusta". Con la medesima parola entrano Silva, Jago ed Emani. Salito
su una delle tombe minori, Silva si accerta che nessuno manchi; poi, rammentando che Carlo aspira
all'impero, tra di loro votano per designare colui che dovrà ucciderlo. Ciascuno incide con il
pugnale il proprio nome su una tavoletta e la getta in un piccolo avello. Silva si appressa
lentamente all'avello, estrae a sorte una tavoletta, vi legge e pronuncia il nome del prescelto:
Emani! Il bandito accoglie con gioia l'occasione offerta dal destino: finalmente potrà vendicare la
morte del padre. Silva s'avvicina al giovane e sottovoce si propone in sua vece: gli offre in cambio
tutti i propri averi pena costringerlo, mostrandogli il corno, a morire. Ma Emani rifiuta
decisamente; Silva minaccia vendetta. Intanto i ribelli si uniscono in un giuramento: combattere
uniti per la libertà a rischio della propria vita, sperando in giorni migliori per sé e per i propri figli
(Si ridesti il Leon di Castiglia).
13. FINALE TERZO. All'improvviso si sentono all'interno tre colpi di cannone. È il segnale
richiesto da Carlo in caso di nomina. I cospiratori sono disorientati. Carlo si mostra loro sulla
soglia della tomba di Carlo Magno, sorprendendoli atterriti: essi credono nella riapparizione del
defunto imperatore. Picchiando tre volte col pomo del pugnale sulla porta di bronzo, Carlo
esclama con voce terribile:"Carlo Quinto, o traditor!". Si apre la porta del sotterraneo e, allo
squillare delle trombe, entrano sei Elettori vestiti di broccato d'oro, seguiti da Grandi che portano
su cuscini di velluto lo scettro, la corona e le altre insegne imperiali. Un ricco corteo di
gentiluomini e dame circonda il neo-eletto imperatore; fra le dame si vede Elvira, seguita da
Giovanna. Nel fondo si vedono bandiere spiegate. Riccardo, alla testa del corteo, si rivolge a Carlo,
comunicandogli la volontà degli Elettori, e gli consegna le insegne di imperatore. Carlo si scaglia
contro i ribelli, e impartisce loro una dura condanna: la scure per i nobili, la prigione per il volgo.
Emani, avanzando fieramente e vantando i propri titoli nobiliari, chiede d'essere condannato alla
scure per aver invano tentato di vendicare la morte del padre. Elvira si getta ai piedi del sovrano e
lo supplica in nome del cielo di perdonare: è virtù augusta la pietà. Nel momento supremo Carlo ha
un moto di grandezza; fissando la tomba di Carlo Magno invoca su di sé le virtù che lo fecero
grande, e prima di tutte la virtù della clemenza (O sommo Carlo): perdona a tutti, e nel vedere
Elvira ed Emani abbracciati, li dichiara sposi. Quindi rende omaggio alla memoria di Carlo Magno.
Ma in un'esplosione di gioia incontenibile tutti rivolgono l'omaggio a Carlo Quinto, auspicandogli
gloria e onore; sola voce discorde nel plauso generale è quella di Silva, che in disparte, deluso dalla
perdita di Elvira, medita vendetta. Con quest'azione di magnanimità imperiale Carlo si congeda dal
dramma.
PARTE QUARTA: La maschera
Terrazzo nel palazzo di Don Giovanni d'Aragona in Saragozza. A destra e a sinistra vi sono porte che
mettono a vari appartamenti; il fondo è chiuso da cancelli, attraverso i quali si vedono i giardini del
palazzo illuminati, e parte di Saragozza. Nel fondo, a destra dello spettatore, vi è una grande scalea che va
nei giardini.
14. FESTA DA BALLO. Da una sala a sinistra di chi guarda si sente la lieta musica delle danze
eseguita da una banda. Gentiluomini, dame, maschere, paggi e ancelle vanno e vengono
discorrendo fra loro e magnificando la felicità di Elvira ed Emani finalmente sposi e liberi (Oh
come felici gioiscon gli sposi). Ad un tratto appare una maschera dall'aspetto funesto, avvolta in un
mantello nero, che si aggira impaziente come in cerca di qualcuno.Tutti l'attorniano cercando di
penetrare il mistero, guardandolo negli occhi, che dietro la maschera sembrano riflettere le fiamme
dell'inferno; ma, dopo qualche atto di minacciosa collera, lo sconosciuto riesce a sfuggire alla
curiosità dei festanti scendendo nei giardini. Riprende l'allegra musica della danza, e dopo aver
rinnovato il canto nuziale tutti escono di scena .
15. SCENA E TERZETTO FINALE. Emani ed Elvira si mostrano venendo dalla sala delle danze:
tutto ora è silenzio e le faci si sono spente. Essi conversano gioiosi guardando il cielo stellato e
pensando al loro avvenire di sposi: ora sono uniti per sempre fino al sospiro estremo. Ma ad un
tratto s'ode un lontano suono di corno. Emani udendolo emette un grido di dolore; Elvira se ne
avvede ed è turbata. Ecco un altro suono, più vicino. Emani è stordito, e delirante esclama "È il
vecchio, è il vecchio, egli mi vuole!". Fingendo dolore per un'antica ferita prega Elvira, attonita e
confusa, di recargli un farmaco. Elvira obbedisce. Tutto ora tace intorno. Emani crede di aver
udito male, e fa per seguire Elvira. Ma ecco che compare Silva, che lo arresta mostrandogli il corno
che suggellò il patto scellerato: "Se uno squillo intenderà, tosto Ernani morirà". Il giovane implora
che gli sia almeno concesso, dopo tanti anni di sofferenze, di passare con la sposa la notte di nozze
(Solingo, errante e misero). Ma Silva è irremovibile e sordo alla pietà, e mostra al disperato Emani
una fiala di veleno e un pugnale perché possa scegliere. Emani sceglie il pugnale. Ma in quel
mentre entra precipitosa Elvira a fermare la mano dello sposo (Ferma crudele, estinguere) per poi
avventarsi furiosamente contro Silva: vuoi vendetta ora che sei presso al sepolcro? Poi si arresta e
piange. Ma Silva è inesorabile: ogni pianto è vano, Emani deve morire. Dichiarandosi fiera figlia di
un Silva, Elvira proclama l'indissolubilità del nodo nuziale che ora la lega a un giovane che ama
immensamente. Ma è proprio per tale amore, insiste crudelmente Silva, che Emani deve morire. Il
giovane, scongiurando Elvira di non piangere (Quel pianto Elvira ascondimi), le rivela il patto
scellerato che ora lo costringe a morte: la sua felicità fu solo scherno della sorte. Appressandosi
minaccioso a Emani, Silva gli rammenta il patto: con atto fulmineo Ernani si pugnala a morte,
compiendo il destino fatale. Le sue ultime parole sono per Elvira, che al massimo della
disperazione, sviene sul corpo del suo sposo, mentre il vecchio Silva esulta per aver così vendicato
il proprio onore.
I due Foscari
Tragedia lirica fin tre atti] di Francesco Maria Piave
Prima rappresentazione: Roma,Teatro Argentina, 3 novembre 1844
L'argomento - derivato dal dramma in versi, in cinque atti, di Lord George Byron (Londra, 1788 Missolungi, 1824), The Two Foscari, pubblicato nel 1821 - era stato proposto da Verdi alla
Fenice, forse dietro suggerimento di Andrea Maffei, al tempo di Emani (appena tre anni prima
Francesco Hayez, di cui Verdi era amico, aveva esposto a Brera un dipinto raffigurante l'ultimo
incontro di Jacopo Foscari con la famiglia prima dell'esilio); ma venne rifiutato in quanto
coinvolgeva antiche famiglie veneziane ancora viventi quali Barbarigo, Loredano, Contarini.
Sottoscritto nel febbraio del 1844 un contratto con l'impresario Alessandro Lanari per un'opera
nuova da rappresentarsi al teatro Argentina di Roma, il compositore ripropose l'argomento,
affidandone la versificazione a Piave. L'opera - una fra le più brevi del maestro - fu composta fra
maggio e settembre del 1844. In essa il compositore impiega alcuni motivi come reminiscenze
tematiche, a guisa di Leitmotiv. Andati in scena il 3 novembre 1844, I due Foscari riscossero un
grande successo di pubblico ed ebbero immediata diffusione sulle scene italiane e straniere,
gareggiando in popolarità con il coevo Emani. Rimasta stabilmente in repertorio per quasi tutto il
corso dell'Ottocento, alla soglia degli anni 1890 l'opera subì un periodo di eclissi, divenuto totale
per tutta la prima metà del Novecento, fatta eccezione per un allestimento tedesco a Halle nel
1929. Dopo una ripresa alla Fenice nel 1957-58 e una versione tedesca allestita a Duisburg nel
1963, i Foscari hanno cominciato ad apparire sempre più frequentemente in Italia e all'estero,
inserendosi in quel gruppo di opere cosiddette 'minori' che stanno a ridosso dei grandi capolavori.
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
FRANCESCO FOSCARI, Doge di Venezia, ottuagenario JAcopo FOscARI, suo figlio
LUCREZIA Contarini, sua moglie
JACOPO LOREDANO, membro del Consiglio dei Dieci BARBARIGO, Senatore, membro della Giunta PISANA,
amica e confidente di Lucrezia
Fante del Consiglio dei Dieci
Servo del Doge
primo basso [baritono] primo tenore prima donna basso comprimario secondo tenore seconda donna tenore
basso
Achille De Bassini Giacomo Roppa Marianna Barbieri Nini Balciassare Mirri Atanasio Pozzolini Giulia Ricci
N. N.
N. N.
Cori: Membri del Consiglio dei Dieci e Giunta -Ancelle di Lucrezia - Dame Veneziane - Popolo e Maschere d'ambo i
sessi
Comparse: Il Messer grande - Due figliuoletti di Jacopo Foscari - Comandadori - Carcerieri - Gondolieri Marinai Popolo - Maschere - Paggi del Doge
La scena è in Venezia, l'epoca il 1457
194 I due Foscari
Nota storica: Dopo essere stato membro del Consiglio dei Dieci ed esserne stato quindi a capo,
Francesco Foscari fu eletto Doge il 15 aprile 1423 in concorrenza con Pietro Loredano, padre di
Jacopo. Pochi mesi dopo Pietro e suo fratello Marco morirono avvelenati; acopo Loredano accusò
apertamente Francesco Foscari della loro morte. Foscari ebbe quattro figli: tre ne morirono; il
quarto, di nome Jacopo, accusato d'aver ricevuto doni da principi stranieri, fu condannato dal capo
del Consiglio dei Dieci, Ermolao Donato, al confino. La notte del 5 novembre 1450 Donato fu
trucidato. Anche di questo delitto Jacopo Foscari fu accusato; inutilmente torturato, fu condannato
all'esilio in Candia (oggi Creta). Cinque anni dopo, avendo invano chiesto la grazia, Jacopo Foscari
scrisse a Francesco Sforza, duca di Milano, perché intercedesse in suo favore; caduto lo scritto
nelle mani dei Dieci, Jacopo fu ricondotto in patria, nuovamente torturato e nuovamente
condannato all'esilio in Candia. In seguito un nobile veneziano, Nicolò Erizzo, in punto di morte
confessò d'essere stato egli stesso l'uccisore di Donato, scagionando così Jacopo Foscari. Rientrato
in patria ed elevato nel 1457 alla carica di Decemviro, Jacopo si adoperò per vendicarsi dei torti
subiti, tanto che il padre fu costretto ad abdicare (invano altre due volte, in passato, aveva tentato
di farlo). 11 31 ottobre 1857, udendo suonar le campane che annunciavano l'elezione del suo
successore, Pasquale Malipiero, Francesco Foscari provò così forte emozione che all'indomani
morì. - Nel dramma assume funzione protagonistica il Consiglio dei Dieci, magistratura di dieci
patrizi, eletti annualmente, istituita nel 1310 allo scopo di consolidare l'autorità del Doge e di
tutelare la quiete e la libertà dei sudditi; in casi particolari il Consiglio dei Dieci poteva aumentare
il numero dei propri membri con l'aggiunta (Zonta ovvero Giunta) di venti cittadini, sì da
costituire il Consiglio deiTrenta. Occorre anche ricordare che la delimitazione dei poteri del Doge
attraverso l'istituzione dei Dieci era diventato principio basilare della Serenissima sin dal tempo
della cospirazione di Marin Faliero. Nel libretto sono citati anche il "Messer grande" (cioè il
Bargello ossia capo della polizia), i "Comandadori" (ovvero agenti di giustizia) e un "Sopracomito",
comandante della ciurma di una galera (i còmiti erano coloro che scandivano il ritmo ai vogatori).
La seconda scena del primo atto è ambientata nel palazzo Foscari con la vista sul "Canalazzo"
(vecchio nome del Canal Grande) e sull-antico ponte di Rialto", a quell'epoca ancora in legno,
sostenuto da pali (il ponte attuale, in pietra, sarà costruito un secolo dopo, fra il 1588 e il 1591).
All'inizio del secondo atto Jacopo ha la visione del conte Carmagnola: si tratta di personaggio
storico, Francesco Bussone conte di Carmagnola che, dopo essere stato al servizio di Filippo Maria
Visconti, passò al servizio della Repubblica di Venezia, chiamatovi dal Doge Francesco Foscari nel
proposito di rafforzare il dominio della Serenissima in terraferma; nonostante la vittoria di
Maclodio nel 1427 contro il Ducato di Milano, che consentì alla Repubblica Veneziana di
annettersi i territori di Bergamo, Brescia e Crema, il Carmagnola fu accusato di tradimento dal
Consiglio dei Dieci, decapitato nel 1432 e sostituito con il Gattamelata.
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
1. PRELUDIO. Si apre con un violento tema di tutta l'orchestra all'unisono, che viene ripetuto
dagli ottoni, contrappuntati dalle agitate terzine di archi e legni. Segue un motivo melodico per
clarinetto che costituirà il tema di Jacopo Foscari; su di esso s'innesta, accompagnato dal tremolo
dei violini, un nuovo motivo, questa volta per flauto, a sua volta legato al personaggio di Lucrezia.
Esso viene interrotto da una sorda concitazione dell'orchestra da cui prende avvio un crescendo
che esplode in laceranti accordi in fortissimo: una volta ribadita la tonalità iniziale, il suono si va
placando su un persistente movimento di terzine fino a spegnersi del tutto.
ATTO PRIMO
Una sala nel Palazzo Ducale di Venezia. - Di fronte veroni gotici, dai quali si scorge parte della città e
delle lagune a chiaro di luna. A destra dello spettatore due porte, una che mette negli appartamenti del Doge,
l'altra all'ingresso comune; a sinistra altre due porte che guidano all'aula del Consiglio dei Dieci, ed alle
carceri di Stato. Tutta la scena è rischiarata da due torce di cera, sostenute da bracci di legno sporgenti dalle
pareti.
2. CORO D'INTRODUZIONE. Una musica dal suono cupo, pesantemente cromatica, disegna la
tenebrosa atmosfera nella quale i Dieci vanno raccogliendosi; come una parola d'ordine essi si
raccomandano reciprocamente "Silenzio, mistero", quel silenzio e quel mistero che sin dalle origini
avevano protetto Venezia, nata dalle onde (Qui veglia costante), e l'avevano resa potente e temuta.
Sopraggiungono Barbarigo e Loredano: controllano che il Consiglio sia al completo e se il Doge
sia arrivato: è giunto fra i primi e attende nell'aula del Consiglio.Tutti si dirigono verso l'aula per
deliberare secondo quella giustizia che rende tutti eguali, nuovamente raccomandando "silenzio,
mistero".
3. SCENA E CAVATINA. Sulla melodia del clarinetto già udita nel Preludio entra in scena,
uscendo dal carcere, il figlio del Doge, Jacopo Foscari; è condotto, fra due Comandadori, da un
Fante del Consiglio che gli ordina di attendere l'appello dei Dieci. Jacopo si appressa al verone per
contemplare Venezia e il suo mare, che la musica descrive su un tremolo di flauto; con trasporto
crescente saluta la regina dei mari. La vista della città natia (Dal più remoto esigilo) fa quasi
dimenticare il dolore patito nell'esilio. Riappare il Fante che gli ordina di presentarsi davanti ai
Dieci a dire la verità: Jacopo è terrorizzato al pensiero di affrontare lo sguardo del padre. Ma il
Fante assicura: potrà sperare pietà e clemenza. Con impetuoso scatto d'ira Jacopo fa tacere il
Fante; sa che solo odio e desiderio di vendetta alberga nell'animo dei giudici (Odio solo, ed odio
atroce): la consapevolezza della propria innocenza e quella di essere un Foscari gli danno la forza
per sopportare la sentenza. Entra col Fante e i Comandadori nell'aula del Consiglio.
Sala nel palazzo Foscari. - Vi sono varie porte all'intorno con sopra ritratti dei Procuratori, Senatori, ecc.,
della famiglia Foscart Il fondo è tutto forato da gotici archi, a traverso i quali si scorge il Canalazzo, ed in
lontano l'antico ponte di Rialto. La sala è illuminata da grande fanale pendente dal mezzo.
4. SCENA, CORO E CAVATINA. Su un tema energico degli archi entra precipitosamente
Lucrezia uscendo da una stanza, seguita dalle ancelle che cercano di trattenerla. È risoluta ad
andare da Francesco Foscari: prima che Doge egli è padre; e lei stessa, figlia di Dogi, gli è nuora:
vuole chiedere giustizia, non perdono. In un unisono agitato le ancelle cercano ancora di
trattenerla: il suo pianto è solo gioia per i nemici; solo dal cielo si può sperare giustizia. E al cielo,
inginocchiandosi, si rivolge Lucrezia con appassionata preghiera (Tu al cui sguardo onnipossente)
invocando giustizia per l'innocente e mitezza nel cuore dei giudici. Giunge Pisana in lagrime,
annunciando che la clemenza del Consiglio ha concesso a Jacopo Foscari nuovo esilio. Clemenza?
La parola è offensiva! Fremendo d'ira Lucrezia insorge (O patrizj, tremate) con veemenza
invocando la vendetta divina contro i giudici.
Sala [nel Palazzo Ducale] come alla prima scena.
5. CORO. Risuona in orchestra la cupa atmosfera dell'inizio dell'atto. Entrano i Senatori, e con essi
Barbarigo e Loredano, commentando la sentenza testé espressa: la lettera di Jacopo Foscari a
Francesco Sforza è sufficiente prova per la sua condanna all'esilio in Creta. In un allegro
vivacissimo e impetuoso, su accordi pesantemente ribattuti, i Senatori lodano l'imparzialità della
legge di S. Marco nei confronti dei colpevoli, siano essi patrizi o plebei.
Stanze private del Doge. - Vi è una gran tavola coperta di damasco, con sopra una lumiera d'argento; una
scrivania e varie carte; di fianco un gran seggiolone.
6. SCENA E ROMANZA. Su una lenta melodia arpeggiata entra il Doge Francesco Foscari e
s'abbandona sul seggiolone. Finalmente è solo. Solo? Dove non penetra l'occhio dei Dieci a spiare
ogni parola, ogni gesto, fin ogni pensiero?... Ora non può nemmeno intercedere in favore del figlio;
e anche se il ciglio non ha ormai più lagrime, l'umana debolezza lo invita a piangere sulle proprie
sventure famigliari (O vecchio con, che batti).
7. SCENA E DUETTO - FINALE PRIMO. Un servo annuncia l'arrivo di Lucrezia. Prima che
ella entri, Foscari s'impone di ricordarsi d'essere Doge prima che padre.Va incontro alla nuora che
entra sul tema precipitoso già udito in precedenza; nota che sta piangendo. E che altro le resta se
non vi son più folgori a incenerire quelle vecchie tigri dei Dieci! Foscari le ricorda di essere Doge e
dunque custode delle patrie leggi. Ma per Lucrezia sole leggi ai Dieci sono odio e vendetta! E
inveisce con crescente fremito contro il suocero (Tu pur lo sai, che giudice), che pur sapendo
innocente il figlio ha assistito impassibile alla sua condanna: chiede le sia restituito lo sposo.
Risponde il Doge chiedendo di non essere insultato (Oltre ogni umano credere): darebbe il resto
della sua vita per la libertà del figlio. Lucrezia si domanda se il padre dubiti ancora della sua
innocenza. Ma lo accusa la lettera intercettata, osserva Foscari. Sì, ribatte la nuora, ma fu scritta
solo per rivedere Venezia. Atto pur sempre delittuoso, risponde il Doge. Lucrezia si appella ai suoi
sentimenti paterni: ma il Doge, pur soffrendo come padre, non ha il potere di modificare una
sentenza. Con prorompente scatto Lucrezia chiede al suocero d'andare con lei a pregare in favore
del figlio (Se tu dunque potere non hai): se non il potere del Doge, possa almeno l'amor di padre
ottenere pietà; Foscari esprime a parte la propria impotenza (O vecchio padre misero) a salvare il
figlio da un errore involontario, e piange; Lucrezia nota le sue lagrime: esse rianimano in lei una
speranza.
ATTO SECONDO
Le prigioni di Stato. - Poca luce entra da uno spiraglio praticato nell'alto del muro. Alla destra dello
spettatore vi è un'angusta scala per cui si ascende al palazzo [Ducale].
8. PRELUDIO, SCENA E PREGHIERA. Una successione di melodie sinuose espresse da una
viola e da un violoncello introducono l'atmosfera opprimente di una delle prigioni più basse, i
"pozzi", dove non filtra luce alcuna. Jacopo, sconsolato, è seduto sopra un masso: notte!, eterna
notte! oh potesse fuggire alla vendetta dei suoi nemici! Su un'improvvisa esplosione dell'orchestra
si alza spaventato: vede sorgere di terra migliaia di fantasmi, dallo sguardo feroce, che lo
chiamano; e uno s'avanza gigantesco, recando nella mano sinistra il capo troncato e gettandogli in
volto con la destra il sangue che ne cola, come per accusarlo della propria tragica fine. Lo
riconosce: è Carmagnola! Terrorizzato, Jacopo implora da lui pietà (Non maledirmi, o prode): fu il
Consiglio dei Dieci a condannarlo a morte; e ora egli stesso si vede condannato con fraudolenta
sentenza. Alla fine, stremato, cade bocconi per terra.
9. SCENA E DUETTO. Risuona in orchestra l'energico tema che sempre distingue l'ingresso del
personaggio di Lucrezia. Ella scende precipitosamente la scala. Nel vedere lo sposo esanime crede
per un momento che gliel'abbiano ucciso e che per maggiore crudeltà le abbiano concesso di vedere
solo il cadavere. Gli si avvicina, lo tocca, sente il suo cuore palpitare. Risollevata nell'animo invita
lo sposo a posare il capo sul suo seno. Jacopo rinviene, ma è ancora delirante: crede d'avere ancora
davanti a sé lo spettro del Carmagnola. Su un vibrante crescendo di un tremolo d'archi Lucrezia
abbraccia lo sposo con grande trasporto; a quell'abbraccio Jacopo la riconosce, tuttavia teme che il
carnefice lo attenda e che la sposa sia venuta per l'ultimo saluto, mentre egli non potrà rivedere né
figli né padre. Lucrezia in lacrime gli dice che una sentenza fintamente pietosa, ancor più orrenda
della morte stessa (No, non morrai, ché i perfidi), lo vuole vivo, ma esule in una terra lontana e
lontano dai suoi, in una vita senza rassegnazione. Anche Jacopo sa che la vita dell'esule, lontano
dall'affetto dei
Verdi fotografato a Parigi da Disderi (ca. 1855-57)
propri cari, è ben più dura della morte: le lacrime della sposa sono come piombo che scende ad
appesantire la sua sofferenza. Al suono di una banda interna si sente in lontananza un canto di
gondolieri che vogano nella calma del mare. Là si ride e qui si muore, impreca Jacopo, maledicendo
coloro che lo allontanano dalla famiglia. Ma i due sposi non abbandonano la speranza di poter
insieme dividere dolore e sventura e di poter vivere, perduto ogni altro bene, nel reciproco amore
(Ah! speranza dolce ancora).
10. SCENA, TERZETTO E QUARTETTO. Avvolto in un ampio mantello nero entra nel carcere
il Doge preceduto da un servo con fiaccola. Lucrezia e Jacopo corrono verso di lui. Su una musica
dal ritmo concitato, il vecchio Foscari invita gli sposi ad abbracciarlo, con passione assicurando il
figlio d'essere ancora padre: solo il volto ha dovuto fingere rigore all'atto della sentenza; ma il suo
cuore nutre pur sempre grande amore per il figlio. Le parole del genitore sono di conforto agli
sposi. Nell'affetto paterno Jacopo scorda ogni dolore e si sente fortificato nell'affrontare il duro
esilio (Nel tuo paterno amplesso); inginocchiatosi davanti al padre, questi invoca su di lui la
protezione divina (Abbi l'amplesso estremo), mentre Lucrezia invoca, con frasi spezzate dal dolore
(Di questo affanno orrendo), che giustizia sia fatta nel giorno del gran giudizio. Tutti restano
abbracciati, piangendo. Scuotendosi, il vecchio Foscari dà l'addio al figlio, che non vorrebbe
staccarsi da lui; lo rivedrà ancora una volta, ma non come padre, bensì come Doge. Mentre Jacopo
si dispera si avverte un rumore: dalla soglia del carcere, preceduto dal Fante del Consiglio e da
quattro custodi con fiaccole, appare Loredano. Con freddezza annuncia a Jacopo che i Dieci sono
già riuniti e che una nave lo attende per tradurlo a Creta. Lucrezia vuole accompagnare lo sposo
nell'esilio; ma lo vieta, osserva Loredano, la sentenza dei Dieci. Al vecchio Foscari, che gli riserva
un'espressione ironica, Loredano consiglia saggezza... quindi ordina ai custodi di applicare la
sentenza. I due sposi abbracciano ancora una volta Foscari, ma Loredano s'interpone per dividerli.
A una sola voce Lucrezia e Jacopo si scagliano contro Loredano invocando sulla sua testa dolori e
tormenti (Ah! sì, il tempo che mai non s'arresta), e mentre il vecchio Foscari cerca invano di
trattenere il loro furore, Loredano, guardando gli sposi con disprezzo, gusta la vendetta che
finalmente cade su una schiatta che è stata funesta alla sua famiglia. Jacopo parte fra i carcerieri,
preceduto da Loredano, e seguito lentamente dal Doge, che s'appoggia a Lucrezia.
Sala del Consiglio de' Dieci.
11. Coito. Mentre risuona in orchestra il tema dei Dieci, questi, fra i quali Barbarigo, vanno
raccogliendosi: insistono sulla necessità che il giovane Foscari s'imbarchi al più presto per l'esilio;
quindi all'unisono (Non fia che di Venezia ei sfugga alla vendetta) riaffermano che egli non può
sfuggire alla vendetta dellitìcorruttibile giustizia veneziana.Tutti sono in piedi quando, sulle note
di un breve postludio, entra il Doge che, preceduto da Loredano, dal Fante e dai Comandadori e
seguito da Paggi, va gravemente a sedere sul trono. Lui seduto, tutti gli altri si siedono.
12. SCENA E FINALE SECONDO. Con dignitoso tono il Doge si rivolge ai presenti: non sa se
sia chiamato a nuovo tormento; ma la giustizia ha i suoi diritti: sarà Doge nel volto e padre nel
cuore.Tutti approvano. S'apre una porta. Entra Jacopo fra quattro custodi. Loredano consegna una
pergamena al Fante che a sua volta la dà a Jacopo. Loredano gli ordina di leggerla osservando che
la clemenza del Consiglio gli ha conservato la vita. Restituendo la pergamena Jacopo dichiara che
comunque nell'esilio morrà; quindi con agitazione si rivolge al padre: una sola parola di grazia, e
nessuno oserà negarla a chi sa d'essere innocente. Il Consiglio a una voce rammenta solennemente
che la legge non tollera di essere ingannata. Il Doge s'alza; tutti lo imitano: dichiara il giudizio
inappellabile. A Jacopo che gli chiede se mai più lo rivedrà, risponde il vecchio Foscari: "Forse in
cielo, in terra no". Mentre Loredano ordina di far subito partire Jacopo, improvvisamente si
presenta sulla soglia Lucrezia con i due figli, seguita da varie dame sue amiche e da Pisana. Con
somma sorpresa dei presenti ella si lancia contro il Consiglio accusandolo di crudeltà. Jacopo
chiama a sé i figli e li pone in ginocchio ai piedi del Doge (Queste innocenti lagrime) implorando
ancora una volta pietà; accanto a lui Lucrezia supplica i Consiglieri di cedere alla legge degli affetti
famigliari; Barbarigo stesso, commosso da quelle lagrime, esorta Loredano a desistere dalla
vendetta; ma per Loredano quelle lagrime sono come rugiada per il suo inestinguibile sentimento
d'odio verso gli orgogliosi Foscari; e mentre le dame invocano clemenza, i Consiglieri ricordano,
inesorabili, che il delitto è stato provato: la pietà darebbe solo un pessimo esempio. La cadenza
finale viene bruscamente interrotta da Loredano che insiste perché Jacopo parta immediatamente.
Quale ultimo favore questi chiede di portare con sé moglie e figli. Ma Loredano gli nega anche
questo e toglie i figli dalle braccia di Jacopo per consegnarli ai Comandadori. Con doloroso accento
il condannato supplica il padre di proteggere i figli: sa ormai di scendere presto nella tomba.
Un'esplosione corale di tutti i presenti, in cui si sovrappongono sentimenti opposti, conclude il
concertato. Jacopo parte fra le guardie, mentre Lucrezia sviene fra le braccia delle dame.
ATTO TERZO
L'antica piazzetta di San Marco. - Il canale è pieno di gondole che vanno e vengono. Di fronte si vede
l'isola dei Cipressi, ora San Giorgio. Il sole volge al tramonto.
13. INTRODUZIONE E BARCAROLA. La scena, da principio vuota, va riempiendosi di popolo e
di maschere, che entrano da varie parti.Tutto è gioia. Si sta approntando una festa: una regata di
gondole, e tutti inneggiano alla bellezza di Venezia, figlia, sposa e signora del mare. Loredano e
Barbarigo, entrambi mascherati, osservano la moltitudine commentando: ad essa non importa chi
sia Doge. Avanzando fra il popolo, Loredano ordina che si dia inizio alla regata al suono del!'
"usata canzone". Tutti vanno alla riva del mare; con i fazzoletti bianchi e con i gesti incitano i
gondolieri intonando una Barcarola (Tace il vento, è queta l'onda).
14. SCENA ED ARIA. Escono dal Palazzo Ducale due trombettieri seguiti dal Messer Grande. Lo
squillo delle trombe annuncia l'ingresso della "giustizia del Leone": il popolo deve lasciare il passo.
Ammutolito, esso si ritira tenendosi a molta distanza. Anche le gondole scompaiono dal canale,
ove si avanza una galera, su cui sventola il vessillo di San Marco. Osservando il popolo ritirarsi,
Barbarigo e Loredano si sentono più tranquilli: d'altronde il volgo manca di coraggio. Dalla galera
sbarca il Sopracomito, cui il Messer Grande consegna un foglio. Sul motivo melodico del clarinetto
che lo aveva accompagnato nel primo atto Jacopo esce lentamente dal Palazzo Ducale fra i custodi,
seguito da Lucrezia e da Pisana. Si rivolge tristemente alla moglie: d'ora in poi sarà infelice vedova
di non estinto marito; possa il vascello che lo conduce a Creta essere ingoiato fra le secche marine
o urtare in uno scoglio, più pietoso del marmoreo cuore dei giudici; ciò sarebbe preferibile a una
morte lenta. Lucrezia lo implora di vivere per lei e per ì figli; ma il viver lontano, le risponde
Jacopo, è morte; prega la sposa di essere di conforto al padre (All'infelice veglio) e di allevare i figli
nella virtù; si ricordi d'essere Contarini per nascita e Foscari per matrimonio e di non recare gioia
ai nemici con il suo pianto. Con impazienza mal trattenuta Loredano ordina al Messer Grande di
dare l'ordine della partenza; quindi, avvicinandosi agli sposi, si leva per un istante la maschera.
acopo e Lucrezia riconoscono in lui la tigre che li perseguita. Con accento pieno di passione il
giovane Foscari dà l'ultimo addio alla famiglia (Ah padre, figli, sposa); Lucrezia lo supplica di
mantenersi in vita per sé e per i figli. Tutti sono vivamente commossi alla scena del definitivo
distacco, anche Barbarigo. Solo Loredano rimane impassibile, assaporando la vendetta che scende
sull'abbominata stirpe dei Foscari. Scortato dal Sopracomito e dai custodi, Jacopo sale sulla galera.
Lucrezia sviene fra le braccia di Pisana. Loredano entra nel Palazzo Ducale; Barbarigo s'avvia per
altra strada; il popolo si disperde.
Stanze private del Doge come nell'Atto Primo.
15. SCENA ED ARIA. Risuona in orchestra per intero il tema del Doge, come nell'atto primo (n.
5).11 vecchio Foscari, in abito dogale, medita mestamente sulla partenza del figlio. Aveva quattro
figli: tre morirono nel fiore degli anni; ora il quarto è condannato a un disonorevole esilio, e nulla
ha potuto fare per salvarlo. Oh! fosse morto il giorno che gli fu posto in capo il corno dogale:
avrebbe avuto intorno a sé i figli. Giunto alla fine della vita, solo atroci affanni lo attendono. Entra
frettoloso Barbarigo recando un foglio: lo ha inviato Nicolò Erizzo in punto di morte; in esso
confessa essere stato egli stesso l'uccisore di Donato. Il vecchio Foscari prorompe in un grido di
gioia nell'apprendere la notizia che ora può restituirgli il figlio, scagionandolo da ogni colpa. Ma il
suo grido viene come strozzato dall'urlo desolato di Lucrezia che entra precipitosamente portando
la ferale notizia: Jacopo è morto di crepacuore non appena salito sulla nave. Sperava il cielo
placato, il vecchio Doge; ora non ha più figli; e cade vacillando sul seggiolone. Lucrezia sfoga il suo
dolore (Più non vive! L'innocente s'involava): forse lo sposo ha finalmente trovato giustizia in
cielo; ma attende che il vecchio padre, animato da possente desiderio di vendetta, rechi giustizia
alle tante lagrime versate. Quindi la nobildonna esce di scena.
16. SCENA ED ARIA FINALE. Entra un servo: i Dieci chiedono di parlargli. I Dieci? Che
entrino. Sul ben noto tema che li personifica, fanno ingresso i Dieci, fra i quali sono Loredano e
Barbarigo. Riponendo in capo il corno dogale, Foscari chiede il motivo della visita. Risponde
Loredano: il Consiglio e il Senato sono convinti che la tarda età e le traversie famigliari impongano
a Foscari un ben meritato riposo. Il Doge non crede alle proprie orecchie. In definitiva Loredano
dichiara che egli deve restituire ai Dieci l'anello dogale. Alzandosi impetuosamente il Doge oppone
con vigoria il proprio reciso rifiuto: già due volte in sette lustri chiese di abdicare, e non gli fu
concesso; di più: fu costretto a giurare che sarebbe rimasto Doge a vita. Un Foscari non viene mai
meno ai suoi giuramenti! I Dieci insistono perché si dimetta. Il vecchio Doge esplode in
un'invettiva contro i Dieci (Questa dunque è l'iniqua mercede): ecco il ringraziamento per chi ha
protetto la Serenissima e ne ha accresciuto la potenza; ecco il rispetto per il padre cui fu strappato
il figlio e cui ora si toglie l'onore. I presenti lo invitano a tornare alla pace degli affetti privati. Ma
quale pace? Il figlio è morto, che più resta? Rendetemi il figlio! implora Foscari. Ordina che a lui
venga l'infelice vedova. E intanto rende l'ànello: ora non è più Doge. L'anello, come d'uso, viene
infranto. Loredano fa per togliergli dal capo il corno dogale, ma con un urlo il vecchio Foscari lo
respinge: che non osi toccarlo! la sua destra ne è indegna. Egli stesso consegna il corno a un altro
Senatore, mentre un terzo Senatore lo spoglia del manto d'ermellino. Sul precipitoso tema che la
personifica entra Lucrezia: Foscari la informa che chi gli ha ucciso il figlio ora gli toglie il trono.
La invita a fuggire dal luogo. Ma è colpito dal suono della campana grande di S. Marco. Lui vivo,
salutano già il successore! Infatti, sul cupo rullare del timpano, Loredano, invano trattenuto dai
presenti che intendono rispettare il dolore di Foscari, annuncia con gioia ferina che è stato
nominato come suo successore Pasquale Malipiero. Con lugubre tono Lucrezia manifesta il proprio
accorato sdegno. Al vecchio Foscari il rintocco della campana sembra suonare a morto e
schiudergli la tomba (Quel bronzo ferale); vittima d'un odio infernale, ora è senza più figli, senza
più trono, senza più vita.Tutti sono impressionati dal suo stato di agitazione. Solo Loredano non
partecipa alla commozione generale: il suono della campana per lui è suono di tromba che annuncia
vendetta. Il rintocco della campana continua. Quel suono è morte. Il vecchio invoca per un'ultima
volta il figlio e cade morto. Loredano, in disparte, cava un portafoglio e vi scrive 'Pagato'.
Giovanna d'Arco
Dramma lirico fin un prologo e tre atti] di Temistocle Solera
Prima rappresentazione: Milano,Teatro alla Scala, 15 febbraio 1845
La genesi di quest'opera è - con quella dei Lombardi - la meno documentata fra tutte le opere di
Verdi. Non appare chiaro se la scelta dell'argomento fosse derivata da un suggerimento del
compositore o non piuttosto, come sembra più probabile, da una proposta di Solera. Comunque il
soggetto (già musicato in precedenza da altri compositori, quali, fra gli italiani, Andreozzi nel
1779, Vaccai nel 1827 e Pacini nel 1830) non deriva in linea diretta dalla tragedia di Friedrich
Schillen Die Jungfrau von Orléans, come affermato da molti studiosi. Anche se vi si accostò in
molte parti nel disegnare la figura di Giovanna d'Arco,- a quel tempo non ancora beatificata, ancor
meno santificata, bensì solo eroina (la sua canonizzazione avverrà solamente nel 1920) - Solera si
propose di fare, come egli stesso ebbe a dichiarare, "un dramma affatto originale". Verdi ne iniziò
la composizione nel tardo autunno del 1844, portandola a compimento in poco meno di quattro
mesi. Alla Scala, sin dalla prima rappresentazione (cui Verdi preferì non assistere per alcuni screzi
con l'impresario Merelli), l'opera ottenne un grande successo, grazie anche all'interpretazione di
Erminia Frezzolini, la cui affascinante figura risplendeva ancor più sotto l'armatura della
guerriera. Considerata fra le opere minori del compositore, la Giovanna d'Arco godette tuttavia di
una discreta diffusione sulle scene italiane per almeno una quindicina d'anni. Sporadicamente
riproposta in seguito in teatri secondari, l'opera - che pure contiene pagine fra le più belle del
giovane Verdi - scomparve definitivamente dalle scene dopo un'ultima ripresa avvenuta ad Alba
nel 1892. Né migliore fortuna le arrise nel Novecento: a una rappresentazione in tedesco a Berlino
nel 1941 e a una ripresa al S. Carlo di Napoli nel 1951, hanno fatto seguito rare esecuzioni, fra le
quali spicca la rappresentazione avvenuta all'Opera di Roma nel 1972.
CARLO VII, re di Francia
Antonio Poggi
GIOVANNA, figlia di
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
primo tenore prima donna primo basso [baritono] secondo tenore secondo basso
Erminia Frezzolini Poggi Filippo Colini Napoleone Marconi Francesco Lodetti
GIACOMO, pastore in Dom-Remi
DELIL, ufficiale del re
TALBOT, supremo comandante degli Inglesi
Coro: Ufficiali del re - Borghigiani - Popolo di Reims - Soldati francesi - Soldati inglesi - Spiriti eletti - Spiriti malvagi
Comparse: Grandi del regno,Araldi, Paggi, Fanciulle - Marescialli, Deputati, Cavalieri e Dame - Magistrati,
Alabardieri, Guardie d'onore
La scena è in Dom-Remi, Reims
Epoca: 1429-1431
Nota storica: Nel dramma figurano due personaggi storici: re Carlo e Giovanna. Carlo VII il
Vittorioso (1403-1461), quinto figlio di Carlo VI il Folle, fu escluso dalla successione al trono in
base al trattato di Troyes, che, siglato nel 1420 fra i re di Francia e d'Inghilterra, mirava
all'unificazione (lei due regni sotto la corona di Enrico V d'Inghilterra; alla morte del padre,
avvenuta nel 1422, si proclamò tuttavia re di Francia, ma fu incoronato a Reims solo nel 1429
grazie all'imporsi di Giovanna d'Arco ovvero la Pulzella d'Orléans, la leggendaria guerriera che
liberò il suolo francese dagli Inglesi.
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
1. SINFONIA. È in tre movimenti. Il primo di essi; caratterizzato dai brutali accordi degli ottoni
cui risponde il flauto, esprime un temporale. Il secondo movimento, equivalente a un pezzo
concertato per flauto, oboe e clarinetto, è a carattere pastorale. Il terzo movimento, in tempo
Allegro, che si apre con un lungo crescendo per culminare in un finale di carattere trionfale,
sembra quasi suggerire la trasformazione di Giovanna da pastorella a guerriera.
PROLOGO
Grande atrio in Dom-Remi che mette agli appartamenti apprestati per la corte.
2. INTRODUZIONE. Sono in scena ufficiali francesi e borghesi, divisi in due cori. Ai borghesi che
chiedono notizie gli ufficiali comunicano che Carlo è stato cacciato dal trono e che Orléans è
minacciata dagli invasori inglesi. All'unisono imprecano contro coloro che non restano entro i
confini assegnati da Dio (Maledetti cui spinge rea voglia); 'noi pure commettemmo lo stesso
peccato, e ora Dio ci punisce'.
3. SCENA, RACCONTO E CAVATINA. Delil annuncia l'ingresso del re. I presenti notano che il
suo bel volto è rattristato dal dolore. Egli viene a dare il suo ultimo ordine: fra i possenti accordi
dell'orchestra che sembrano conferire alle sue parole la forza di un pronunciamento, Carlo
comanda che un ambasciatore si rechi a Orléans per por fine alla guerra: si ripongano le spade e
sieda sul trono avito il re d'Inghilterra; scioglie i sudditi dal giuramento di fedeltà. Spiega il motivo
della sua decisione. Racconta d'essersi prostrato a terra per pregare affinché la collera di Dio cada
solo sulla sua testa, quando venne colto improvvisamente da un dolce sopore e un sogno divino gli
apparve: si trovava nella foresta, davanti a una quercia su cui era dipinta l'immagine della Vergine
(Sotto una quercia parvemi): a un tratto l'immagine parlò imponendogli di deporre elmo e spada ai
piedi della quercia. Con accento esaltato Carlo si propone ora di fregiare la propria corona di
quell'immagine e di far cessare la guerra auspicando che il piede straniero non sia pesante al suolo
francese. Vuole andare a visitare la Vergine anzi notte; ma i borghigiani tentano di dissuaderlo:
quella foresta è orrenda; essi raccontano che dopo il crepuscolo infuria la tempesta (Allor che i
flebili bronzi): là vi convengono demoni, maghi e streghe; guai all'uomo che» si fa sorprendere:
non vedrà più il mattino del nuovo giorno. Ma Carlo resta irremovibile: dove sta l'immagine della
Vergine l'inferno non ha potere, e insiste per andare a visitarla e a sciogliere il voto. La corona gli
ha portato solo infelicità (Pondo è letal martino) e vuol disfarsene; nonostante tutti i presenti
riaffermino la loro fedeltà al re, Carlo dichiara di non esserlo più e chiede quel raggio di pace che
gli doni libertà. Alla fine impone al coro un cenno e parte, mentre il coro si allontana per diverse
uscite.
Una foresta. A destra sopra una balza praticabile una Cappelletta. A sinistra sul piano avanti vi è una
quercia, al suo piede un sedile di pietra. Nel fondo si apre una caverna. Il cielo è scuro e tempestoso. Lo
squillo di una campana invita alla preghiera dei defunti.
4. SCENA. La scena si apre con una musica tempestosa simile a quella del primo movimento della
Sinfonia. Mentre il tuono si allontana Giacomo, il padre di Giovanna, esce dalla caverna in preda al
terrore: in quell'orrendo luogo non si sarebbe avventurato se non fosse ossessionato da un sospetto
letale. Mentre sopra la balza appare Giovanna che s'inginocchia davanti alla Cappella, Giacomo si
chiede, tra i fragori intermittenti della tempesta, perché mai "colei" si rechi nelle notti procellose
alla quercia dove si svolgono i riti infernali; ha essa forse venduto l'anima al demonio? Orribile
pensiero è questo per Giacomo, che in un breve arioso chiede soccorso al cielo per scoprire il vero;
quindi si ritira lentamente nella caverna per starvi di guardia.
5. SCENA E CAVATINA. Giovanna, scendendo dalla balza, osserva come la turbolenza del cielo
ben si addica all'affanno in cui versa la Francia oppressa: perché, lei donna, non può accorrere sui
campi di battaglia? forse una maglia di ferro, una spada, un cimiero le sarebbero di troppo peso? Ai
piedi della quercia, dove ogni notte riposa, la fanciulla rinnova la preghiera alla Vergine perché le
doni armi per combattere (Sempre all'alba ed alla sera); vinta dal sonno va a sedersi su una pietra
ai piedi della quercia, chiedendo perdono alla Madonna per il voto richiestole e s'addormenta.
6. FINALE DEL PROLOGO. Dalla balza scende Carlo; si dirige all'altare della Vergine, vi depone
l'elmo e la spada e s'inginocchia a pregare in silenzio, mentre il temporale si è ormai placato. Alla
sola anima di Giovanna dormiente si fa intanto sentire da lontano un coro di Demoni (Tu sei bella)
che con tono sommesso e blando, sul ritmo di un valzer scandito dal tinnire del triangolo, invitano
la fanciulla a non sprecare i suoi giovani anni e a darsi all'amore terreno. Mentre le nuvole si
diradano la foresta viene vivamente illuminata dal chiarore della luna; segue subito, sempre di
lontano, il coro degli Angeli (Sorgi! i celesti accolsero): sull'accompagnamento dell'arpa essi
annunciano a Giovanna che la sua preghiera è stata accolta; Dio l'ha scelta per salvare la Francia,
ma guai a lei se si arrenderà a un amore terreno. I due cori si sovrappongono cercando l'uno di
prevalere sull'altro. D'improvviso Giovanna si desta balzando in piedi e dichiarandosi pronta
all'impresa. Nel dire questo vede Carlo davanti all'altare, il quale le chiede chi ella sia. Giovanna
riconosce il re; dopo esser corsa alla balza per armarsi dell'elmo e della spada gli risponde
dichiarandosi guerriera (Son guerriera che a gloria t'invita); esortando il re a liberare Orléans lo
invita alla battaglia e a inalberare sull'inglese sconfitto il vessillo vittorioso della Francia. Carlo
riconosce nello sguardo di Giovanna la fiamma di Dio e si sottomette al suo comando. Non visto,
Giacomo esce dal limitare della caverna e subito riconosce il re. Né Giovanna né Carlo s'accorgono
della sua presenza. Giovanna raccomanda alla Vergine il suo gregge, la sua casa e il vecchio padre
(A te, pietosa vergine), mentre Carlo, al colmo dello stupore, crede di trovarsi di fronte non a una
creatura mortale bensì a un angelo del cielo; ma per Giacomo ora tutto è terribilmente chiaro: la
figlia si è data ai demoni infernali per un folle amore verso il re. Giovanna e Carlo s'allontanano
rapidamente. Giacomo tenta di seguirli, ma cade al suolo oppresso dal dolore.
ATTO PRIMO
Luogo remoto, sparso di rupi. In lontananza si scorge parte della città di Reims.
7. CoRo. Soldati inglesi sparsi qua e là in gruppi. Donne che piangono presso estinti, altre che
assistono i feriti. La scena si apre su una musica turbolenta in stile semi-fugato, che esprime
disordine e scompaginamento. Perduta Orléans gli Inglesi ora hanno solo un pensiero: tornare alle
proprie famiglie. Il loro comandante,Talbot, cerca di riunirli, accusandoli di viltà; essi gli
rispondono ricordandogli con quanto coraggio hanno finora combattuto (O duce, noi sempre
mirasti); non temono di lottare contro uomini mortali, ma contro una furia scatenata a che giova il
valore umano? Invano 1albot cerca di convincerli che ciò è frutto di fantasia e di paura: i soldati
rispondono d'esser venuti a combattere dei soldati, non dei demoni armati.
8. SCENA ED ARIA. Il pericolo d'un ammutinamento viene evitato dalla comparsa di Giacomo; i
capelli scomposti e i gesti dimostrano il disordine della sua mente. Viene ad avvertire che egli
consegnerà prigioniera la donna che li ha sconfitti. Giura di farlo entro sera. Lo stupore è generale.
Giacomo racconta la sua storia: egli è francese e ama la sua terra (Franco son io); ma tiene ancor
più al proprio onore: ed è quindi risoluto a combattere insieme agli Inglesi contro un re che ha
coperto d'onta il suo crine canuto. Talbot ordina di rialzare la tenda militare in luogo fortificato: in
esso, assicurano i soldati, sarà eretto il rogo per l'empia donna. Un lamento di Giacomo infonde nei
presenti un sentimento di pietà per il suo stato infelice. E in verità Giacomo è in lotta con se stesso
e cerca di dominare i propri sentimenti dilaniati fra debolezza umana e forza spirituale (So che per
via di triboli); Talbot e i soldati giurano di vendicarlo.
Giardino nella corte di Reims.
9. SCENA E ROMANZA. È stato un grande giorno di festa. Per la prima volta dopo cento anni
gli Inglesi sono stati sconfitti e ora si fanno i preparativi per l'incoronazione del re di Francia.
Fuggendo dalla frastornante atmosfera della corte, Giovanna, eroina del giorno, adornata d'elmo,
corazza e spada, s'è rifugiata nel giardino per restare sola. Ma anche qui le voci la perseguitano: nel
breve preludio strumentale, per flauto, clarinetti e oboi, risuona il canto dei Demoni. L'assale il
turbamento per un sentimento cui non osa dare nome. In fondo l'impresa è ormai compiuta, la
Francia è salva; perché dunque rimanere a corte? Il canto dei Demoni irrompe in orchestra con
forza brutale, ma viene troncato. Il pensiero di Giovanna si volge alla vita pastorale, alla capanna,
al vecchio padre (O fatidica foresta).
10. SCENA E DUETTO - FINALE PRIMO. Nel momento in cui ella decide di tornare al
villaggio, entra Carlo che le chiede di rientrare a corte dove tutti l'attendono. Ma Giovanna
risponde che Dio la richiama a casa. Con trasporto Carlo la scongiura di non partire; preferirebbe
che lei lo trafiggesse con la spada. Da lei ha avuto in dono il trono e con esso una ferita al cuore
(Dunque, o cruda): le rivela che fin dal primo giorno l'ha immensamente amata. Giovanna,
commossa, gli risponde che ora non è più l'inviata della Vergine e chiede d'essere rispettata come
prima. Carlo protesta che il suo amore è santo e puro. Giovanna si copre il volto dall'emozione. Il
ritmo incalzante dell'orchestra si fa più concitato trasformandosi in un pulsare affannoso: la
giovane sente la mente smarrirsi, non sa più resistere. Alla fine cede: confessa a Carlo d'amarlo e si
getta fra le sue braccia. D'un tratto ode le voci degli angeli che le ricordano di non accogliere un
amore terreno, e subito si scioglie dall'abbraccio. Carlo è sorpreso dal suo gesto (T'arretri e
palpiti!): il suo canto, dapprima spezzato dallo stupore, si distende infine in un'ampia melodia che
invita a un amore sereno; ma Giovanna ha ancora nelle orecchie il canto degli angeli e le sembra di
vedere fra le tenebre il fantasma del vecchio padre che la maledice. D'improvviso risuona una
marcia militare; Carlo vede gente che si appressa. Entra una delegazione guidata da Delil (Le vie
traboccano) per accompagnare Carlo alla cerimonia dell'incoronazione in cattedrale; Giovanna lo
precederà inalberando la bandiera che Delil le consegna. Ai presenti non sfugge il volto turbato
della giovane. Carlo congeda la delegazione; quindi si rivolge con dolcezza a Giovanna chiedendole
che sia lei stessa a incoronarlo (Vieni al tempio e ti consola); Giovanna rimpiange fra sé di non
esser morta sul campo di battaglia: la vita ora non le riserva che dolore. D'improvviso la sua anima
è assalita dal coro dei Demoni (Vittoria, vittoria! Plaudiamo a Satàna) che, accompagnati dalla
banda, cantano vittoria. Carlo è di nuovo sorpreso dall'atteggiamento della giovane che con
disperazione grida "Son maledetta!". Le sollecite domande di Carlo, le grida disperate di Giovanna,
il canto dei demoni si sovrappongono fra loro. Alla fine Carlo prende con trasporto la mano di
Giovanna ed esce traendola seco.
ATTO SECONDO
Piazza in Reims. Sul davanti a sinistra s'innalza la cattedrale dedicata a S. Dionigi.
11. GRAN MARCIA TRIONFALE. La scena è ingombra di popolo. Sul suono di una banda
interna si leva un plauso all'indirizzo della giovane vergine che ha redento la terra di Francia
debellando gl'Inglesi e sollevandola dal fango (Dal cielo a noi chi viene). Intanto il popolo viene
diviso dai soldati, che sostano in due ali. Cessato il canto, inizia il corteo: entrano dapprima i
suonatori, poi vengono fanciulle vestite di bianco recanti fronde, poi gli araldi, indi gli alabardieri.
Dietro a questi vengono paggi, magistrati in toga, marescialli col bastone del comando, grandi con
la spada dal pomo reale, la corona e il manto, i giudici con la verga, cavalieri e dame con l'abito
dell'ordine, deputati e quindi fanciulle che spargono fiori. Finalmente, annunciati dal suono di
campane e dallo sparo delle artiglierie, e salutati dagli evviva della folla, appaiono Giovanna con la
bandiera e il re sotto un baldacchino portato da sei baroni. Cortigiani, servitori e soldatesca
chiudono la processione. Tutti entrano nel tempio. Cessa la musica e tutto è silenzio.
12. SCENA E ROMANZA. Una sola persona rimane in scena. È Giacomo: sullo sfondo del tema
tempestoso della Sinfonia egli si dichiara non più padre bensì il fulmine di Dio crucciato.
Costernato e affranto compiange se stesso (Speme al vecchio era una figlia), povero padre costretto
a offrire in olocausto al Signore la propria figlia per sottrarla a una condanna eterna.
13. FINALE SECONDO. Si ode uno squillo di trombe provenire dal tempio; segue tosto un inno,
parafrasi del Te Deum, eseguito a cappella (Te, Dio, lodiam), concluso dal rinnovato squillo delle
trombe. La cerimonia è terminata, osserva Giacomo, e ora il corteo esce dal tempio condotto da
sua figlia che ha il volto turbato. Precedendo Carlo con la corona in testa e tutto il corteo, esce
Giovanna in stato di grande agitazione. Sembra voglia fuggire. Carlo, interpretando il suo gesto
come un atto di modestia, la trattiene perché riceva l'omaggio di tutto il popolo, che acclama con
trasporto la redentrice. Quindi Carlo annuncia che la Francia avrà ora due patroni, a ciascuno dei
quali sarà eretto un tempio: Dionigi e Giovanna. D'improvviso s'avanza Giacomo gridando alla
bestemmia. Giovanna riconosce il padre. La sorpresa è generale. Giacomo si rivolge al re: sulla
fede di vecchio e di padre egli accusa la figlia di spergiuro (Comparire il ciel m'ha stretto):
colpevole di amore terreno essa ha patteggiato coi demoni. La musica ridiventa tempestosa e la
folla arretra inorridita. Acquetatasi la musica, si apre un episodio (No! Forme d'angelo) in cui
Carlo esprime incredulità sulla colpevolezza di chi è simile a un angelo, Giacomo lotta con i propri
sentimenti paterni, la folla commenta attonita e disorientata. Su tutti si eleva, dapprima solitario e
arpeggiato dal clarinetto, il canto di Giovanna che si sottomette alla volontà divina (L'amaro
calice). Carlo chiede alla giovane di discolparsi, ma ella tace impallidendo. Quindi chiede al padre le
prove della sua accusa. Questi per tutta risposta prende la figlia per mano e per tre volte - in nome
di Dio, della famiglia, dell'anima della madre - le chiede se non sia sacrilega. Nonostante gli
appassionati appelli di Carlo, ella tace. Un improvviso tumulto orchestrale accompagnato da lampi
e tuoni semina generale terrore. Ecco la risposta del cielo! grida Giacomo. Al suo grido tutti sono
convinti che la prova è ormai manifesta: Giovanna è dunque una strega. Carlo, disperato per il suo
ostinato silenzio, le promette aiuto. Ma Giacomo ammonisce severamente il re: il solo aiuto è in
Dio; e chiama a sé la figlia piangente. La folla ora impreca contro Giovanna (Fuggi, o donna
maledetta), urlandole di uscire dalle mura della città; solo Carlo è convinto della sua innocenza. Sul
vociare della folla si leva alto il grido di Giovanna che dichiara purificata nel dolore la sua colpa
(Contro l'anima percossa) e sarà dunque lieta di portare la croce. Carlo si unisce a lei: ma ormai
non ha più potere di aiutarla. La scena si prolunga terminando fra le imprecazioni della folla.
206 Giovanna d'Arco
ATTO TERZO
Interno d'una rocca nel campo inglese. Una scala conduce a una torre, dalla quale si dominano i campi
14. SCENA E DUETTO. Giovanna, cinta di grosse catene, è abbandonata sopra un sedile: vicino a
lei s'innalza un rogo.A1 levar della tela si ode un triplice grido di sentinelle interne che lanciano
l'allarme: i Francesi! Seguono tre colpi di cannone. Quindi lo squillo delle trombe annuncia che è
iniziata la battaglia. Giovanna si riscuote; il suono bellicoso delle trombe la rende irrequieta: cinta
di catene nel campo nemico con la vista del rogo, sente crescere il rumore: vorrebbe essere sul
campo. Trovatasi rinchiusa, s'arresta immobile. A poco a poco, mentre Giacomo entra di soppiatto
e si ferma non visto a osservarla, Giovanna si rianima: come in delirio vede le legioni scontrarsi; lei
stessa incita i suoi. Poi vede il re che avventatosi come turbine sugli Inglesi ne viene tosto
circondato. Cessa la battaglia. Sconsolata, Giovanna si sente abbandonata da Dio e cade in
ginocchio; apre il suo cuore a Lui: ha amato sì un uomo, ma solo per un istante (Amai, ma un solo
istante); il suo cuore è puro e non ha più palpiti che per il Signore. Giacomo, che prima riteneva
pazza la propria figlia, ora è stupefatto: ella prega Dio! Si rende conto d'aver avuto egli stesso la
mente annebbiata. Alzandosi infiammata dalla fede, Giovanna chiede a Dio che le spezzi le sue
catene come già le spezzò a Saul [in realtà a Sansone]. Giacomo accorre a lei, liberandola dai ceppi
e chiedendole perdono. La giovane, quasi incredula, si getta fra le sue braccia chiedendo d'essere da
lui benedetta. Ponendole le mani sul capo Giacomo esaudisce la sua preghiera. Fortificata dalla
benedizione paterna (Or dal padre benedetta) è impaziente di percorrere il sentiero di guerra;
Giacomo stesso ora la incoraggia a combattere e a condurre il suo stendardo sull'ali della vittoria.
Sguainata la spada, Giovanna esce precipitosamente.
15. BATTAGLIA. Riprende il suono della musica guerresca. Salito alla torre, Giacomo guarda i
campi della battaglia; vede la figlia volare sul suo bianco destriero, apparire in cento luoghi,
liberare il re dalla mischia, riuscendo a far arretrare le turbe dei nemici. La vista viene offuscata da
un'enorme nuvola di polvere. Mentre Giacomo scende dalla torre attraverso la ringhiera, entrano
soldati francesi che annunciano la conquista della rocca.
16. SCENA E ROMANZA. Entra quindi Carlo: per la seconda volta è stato salvato da Giovanna.
Gli si presenta Giacomo invocando per sé la punizione del re. Ma Carlo perdona: Giovanna stessa
lo ha pregato di accorrere alla rocca in difesa del padre. Sopraggiunge Delil annunciando la
sconfitta degli Inglesi; ma Giovanna è morta! Silenzio generale. Giacomo nasconde il viso fra le
mani. Il re guarda mestamente i suoi. Poi s'avanza lentamente. Il suo canto diventa un lamento
(Quale più fido amico): vorrebbe rinunciare alla vita e al trono; oh, potesse nell'anima inaridirsi la
fede per fargli dimenticare il dolore.
17. MARCIA FUNEBRE.A1 grave suono di una marcia funebre avanza un mesto corteo, con alla
testa soldati francesi che con gli stendardi precedono Giovanna adagiata sulla bara. Il coro
commenta sommesso (Un suon funereo): la giovane sembra un angelo dormiente. Giacomo avverte
un gemito. Carlo nota che essa sta socchiudendo gli occhi. Mentre la musica raggiunge il culmine
trionfale della sonorità, Giovanna cerca di sollevarsi. Carlo grida al miracolo!
18. SCENA - FINALE TERZO. Giovanna si leva diritta, muovendosi come investita da una forza
soprannaturale. Riconosce Carlo, riconosce il padre. Si dichiara innocente e chiede le sia data la sua
insegna per portarla in cielo. Carlo gliela consegna. Nel riceverla Giovanna è come rapita in estasi:
vede il cielo aprirsi e la Vergine venirle incontro (S'apre il ciel); Carlo scongiura di non
abbandonare la Francia, suo padre, il suo re; Giacomo, rassegnato, chiede la benedizione della
figlia. Le tre voci s'intrecciano. Poi ancora solitaria si leva la voce di Giovanna che si sente
innalzare da una nube dorata e vede la propria corazza trasformarsi in ali. All'apoteosi finale si
aggiunge il canto degli angeli esultanti e quello dei demoni sconfitti, quindi quello di tutti i
presenti. Infine Giovanna cade. Una luce siderea si spande improvvisamente nel cielo. I soldati
abbassano gli stendardi e tutti si prostrano innanzi al glorioso cadavere.
Alzira
Tragedia lirica in un prologo e due atti di Salvadore Cammarano
Prima rappresentazione: Napoli,Teatro di S. Carlo, 12 agosto 1845
L'argomento deriva da una tragedia in versi di Voltaire (Parigi, 1694 - 1778), Alzire, ou les
Américains, rappresentata nel 1736, basata su un fatto accaduto in Perù nel XVI secolo:
l'assassinio del governatore spagnolo Gusman nel giorno delle sue nozze con una principessa Inca,
avvenuto per mano di un membro della tribù. Questa tragedia era ancora considerata a metà
Ottocento opera di esaltazione della religione cristiana contro il fanatismo idolatra dei popoli
barbari. Ben altro era naturalmente il suo messaggio: una condanna del fanatismo e
dell'intolleranza di tutte le religioni, semmai, onde dimostrare che la vera religiosità sta nell'amore
fra gli uomini: meglio essere infedeli ai propri riti pur di restar fedeli ai doveri dell'uomo, come
Voltaire dichiara esplicitamente nella prefazione al dramma. Fu lo stesso Cammarano - verso il
quale Verdi nutriva altissima stima e con il quale iniziava una collaborazione che poi avrebbe
prodotto altre tre opere, fra cui Luisa Miller e Trovatore - a proporre un argomento già musicato
in precedenza da Zingarelli (Firenze 1794), da Nicolini (Genova 1796) e da Nicola Manfroce
(Roma 1810). Nel libretto i motivi ispiratori della tragedia di Voltaire pressoché scompaiono per
lasciar invece emergere il dramma privato attraverso il confronto fra il 'barbaro' Zamoro e il
'cristiano' Gusmano, con in mezzo l'indigena Alzira. Verdi compose l'Alzira "senza nessuna fatica"
(come ebbe a dichiarare egli stesso) fra aprile e maggio del 1845, un periodo in cui fu soggetto a
frequenti disturbi alla gola e allo stomaco. Cammarano prese forse troppo alla lettera la sua
raccomandazione di "tenersi breve": l'Alzira risultò infatti l'opera più corta del maestro, tanto che
l'impresa napoletana offrì un compenso fuori contratto affinché il compositore vi aggiungesse una
Sinfonia. Alla prima rappresentazione il successo fu discreto. Migliore, ma non di molto,
l'accoglienza del pubblico romano nel successivo ottobre. Applaudita a Parma nel 1846, l'Alzira
cadde alla Scala nel 1847 ed ebbe un'unica rappresentazione. Verdi stesso, che sulle prime aveva
difeso la sua opera, si convinse che v'erano in essa difetti strutturali. Che egli poi la dichiarasse
"proprio brutta" è affermazione spesso riportata dai biografi, ma che non ha finora trovato
riscontro nei documenti. Dopo una decina di allestimenti l'opera scomparve letteralmente dalle
scene. Rimase in vita per qualche tempo la sola cabaletta di Zamoro, "Non di codarde lagrime", che
i tenori abitualmente interpolavano nel Macbeth. Dopo più di un secolo (l'ultima apparizione era
avvenuta a Malta nel 1858) l'Alzira fu ripresa all'opera di Roma nel febbraio del 1967; dopo di
allora sono seguite solo rare ricomparse (fra cui Amburgo nel 1983, Parma nel 1991).
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
ALVARO, padre di Gusmano} Governatori del Perù secondo basso Marco Arati
GUSMANO primo basso [baritono] Filippo Coletti
OVANDO, duce spagnuolo secondo tenore Ceci
ZAMORO
ATALIBA Capi di Tribù Peruviane secondo basso Michele Benedetti
ALZIRA, figlia di Ataliba prima donna Eugenia Tadolini
ZUMA, ancella di Alzira seconda donna Anna Salvetti
OTUMBO, guerriero americano secondo tenore Francesco Rossi
Ufficiali e soldati spagnuoli. Americani d'ambo
La scena è in Lima ed in altre contrade del Perù
L'epoca è verso la metà del secolo XVI
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
1. SINFONIA. Un critico dell'epoca vi rilevò "il doppio carattere selvaggiamente guerriero ed
amoroso che informa il dramma". È in due movimenti. Il primo di essi, in tempo Andante mosso,
eseguito in prevalenza dai legni, presenta un colore vagamente esotico. Il secondo movimento, in
tempo Prestissimo, introdotto da tre squilli di corno e di tromba, ha un carattere bellicoso,
addolcito a metà movimento da una patetica melodia del clarinetto, e si conclude con un tema che
sarà poi citato nella marcia trionfale degli Spagnoli a inizio del primo atto.
PROLOGO: Il Prigioniero
Vasta pianura, irrigata dal fiume Rima. L'oriente è ingombro di maestose nubi, imporporate dai raggi del
sole nascente.
2. INTRODUZIONE. Un brutale crescendo dell'orchestra sottolinea l'entrata di Otumbo alla
testa d'una tribù di Americani che trascinano Alvaro fra catene; alcuni di essi lo annodano a un
tronco, tutti gli altri gli danzano intorno gridando con accento ferocissimo un inno di guerra
(Muoia coverto d'insulti): la morte del prigioniero avvenga fra interminabili tormenti; e invocano i
fratelli caduti combattendo perché sorgano dalle tombe per assistere al supplizio.
3. SCENA, CAVATINA E STRETTA DEL PROLOGO. Mentre Alvaro, con cristiana
rassegnazione, invoca sugli indigeni il perdono di Dio, essi, alzando urli di frenetica gioia,
s'avventano su di lui, alcuni con frecce, altri con picche e tizzi ardenti. In quel mentre appare una
canoa: ne discende Zamoro. Otumbo e i suoi si gettano ai suoi piedi, increduli nel rivederlo vivo.
Zamoro nota il prigioniero; ma non vuole festeggiare la gioia del suo ritorno con il sangue.
Comanda che egli sia liberato dai legami; gli Americani eseguono. Zamoro ordina al prigioniero di
tornare fra i suoi e di raccontare loro che deve la vita a mi 'selvaggio'. Alvaro abbraccia commosso
il suo liberatore. A un cenno di Zamoro Alvaro parte, scortato da alcuni della tribù. Otumbo
esprime la propria sorpresa nel rivedere il guerriero che si riteneva morto. Ed effettivamente
morto lo ritenne l'empio Gusmano dopo la tortura inflittagli. Esplode l'odio di Zamoro per il
tiranno (Un Inca... eccesso orribile!), un carnefice che osa chiamare barbari gli Inca; e irresistibile
vola il pensiero all'amata Alzira. Al sentirne il nome Otumbo lo informa che ella è prigioniera con
il padre in Lima. Zamoro è sorpreso, ma non dispera di salvarla; e racconta che, ritornato in vita
(Risorto fra le tenebre), nell'attraversare luoghi ombrosi ha visto "mille tribù guerriere" risolute a
vendicarsi degli oltraggi perpetrati dagli Spagnoli. Tutti salutano con gioia la notizia che una
grande rivolta sta per scoppiare, e s'abbracciano con occhi scintillanti di selvaggia esultanza. La
scena culmina in un inno di battaglia all'unisono (Dio della guerra). Alla fine gli Americani
s'avviano tumultuosi, agitando nell'aria vivamente frecce, clavi ed aste.
Salvadore Cammarano
Antonio Ghislanzoni
ATTO PRIMO: Vita per vita
Piazza di Lima.
4. CORO D'INTRODUZIONE. Al lieto suono di una banda militare in scena si schierano le
milizie spagnole; gli ufficiali si radunano in crocchio. I soldati raccontano dell'arrivo di un
messaggio del re di Spagna (Giunse or or, da lido ispano); `con entusiasmo guerriero' auspicano
che esso contenga l'ordine di conquistare nuove terre americane.
5. SCENA E CAVATINA. Ad essi si rivolge Alvaro per comunicare che su disposizione regia
l'ufficio di governatore passerà a Gusmano, suo figlio. Questi dichiara che il primo atto del suo
governo sarà un accordo con l'Inca per la cessazione d'ogni ostilità. Protendendo la destra in atto
di grave giuramento Ataliba aderisce alla proposta. Gusmano gli ricorda una promessa fattagli
quale pegno di pace: d'avere in sposa sua figlia Alzira. Ataliba risponde che i tempi non gli
sembrano maturi per il matrimonio: Alzira è oppressa da una 'fatale mestizia'. Gusmano conosce il
motivo di tale incertezza: Alzira gli è contesa da un'ombra (Eterna la memoria), quella d'un uomo
ch'egli stesso ha debellato e di cui ella è ancora follemente innamorata. Ad Alvaro che gli consiglia
perseveranza e ad Ataliba che gli chiede di attendere, Gusmano oppone l'ardore di un sentimento
che non conosce pazienza ed esorta il padre di Alzira d'imporre il suo volere sulla figlia. Mentre
Ataliba parte, Gusmano dichiara che tutta la sua fama e la sua gloria non sono che polvere e cenere
senza la donna che ama (Quanto un mortai può chiedere).
Appartamento destinato ad Ataliba, nel palazzo del Governatore.
6. SCENA E CAVATINA. Su un breve preludio di violini con sordine, Zuma s'avanza
silenziosamente, seguita da altre donzelle americane; solleva una cortina, al di là della quale si
scorge Alzira addormentata su un divano; osserva la sorella, che distrutta dal pianto sembra aver
trovato un momento di quiete; le ancelle sussurrano pregando che ella trovi pace nel sonno.
Immersa in un sogno Alzira mormora il nome di Zamoro, ma subito si desta e percorre la scena
come in cerca di qualcuno. Non lo trova. Si rende conto d'aver sognato. Vede la sorella e le ancelle.
Narra loro il suo sogno (Da Gusman, su fragil barca): fuggiva da Gusmano su una canoa, quando
venne colta nell'oceano da un uragano; era sul punto d'annegare allorché, improvvisamente
sollevata da un'ombra errante fra le nubi tempestose, si ritrovò fra le braccia di Zamoro; il turbine
dell'uragano le parve la voce dell'amore. Le ancelle, impietosite, supplicano la giovane di non
vivere di sogni. Zamoro è ormai morto. In terra, risponde Alzira, ma non in cielo; egli vive
nell'astro che sfavilla nella notte (Nell'astro che più fulgido); egli è divenuto una scintilla
immortale; trasformata in luce, lei stessa ascenderà a lui per vivere un amore eterno.
7. SCENA E DUETTO. Entra Ataliba. La figlia gli va incontro, mentre Zuma e le donzelle, a un
cenno di Ataliba, si ritirano. Egli deve compiere la missione impostagli da Gusmano: costringere la
figlia a sposarlo. Alzira gli ricorda che Alvaro gli tolse il trono ma gli conservò la vita; invece
Gusmano ha tolto a Zamoro, cui era stata solennemente promessa, e trono e vita. Ataliba le fa
notare che l'ultima speranza dei popoli oppressi, privati di re e di religione, è nell'amore di
Gusmano per lei. Amore in quel tiranno? ribatte ironica Alzira. Ma a questo punto Ataliba non
ammette più obiezioni: quando il padre impone, la figlia deve ubbidire. E parte. Appare Zuma,
informando Alzira che un Inca chiede di poterla riverire. Entra lo sconosciuto: è Zamoro! (Anima
mia!). Su una musica vibrante dal ritmo affannoso Alzira, incredula alla vista del proprio amato,
indietreggia gridando al prodigio, ma subito si getta fra le sue brac-` cia; durante il concitato
dialogo Zamoro apprende con sollievo che Alzira non è ancora sposata a Gusmano. I due
innamorati rinnovano la loro promessa d'amore; caduto l'impero degli "infidi numi", non resta loro
che giurarsi fede l'un l'altro (Risorge ne' tuoi lumi).
8. FINALE DELL'ATTO PRIMO. Appare improvvisamente Gusmano, accompagnato da Ataliba
e gentiluomini spagnoli, e scorge Alzira fra le braccia di un uomo. Chiede chi egli sia: si trova di
fronte al redivivo Zamoro, che subito accusa il tiranno d'averlo privato d'ogni bene in terra, non
del cuore di Alzira. Gusmano ne ordina immediatamente l'arresto, invano trattenuto da Ataliba
che gli ricorda la pace concordata con gli Inca. Zamoro dichiara il proprio diritto a riprendersi la
promessa sposa. Come Gusmano ordina di trascinare il rivale al supplizio, Alzira si precipita
disperatamente fra i soldati e Zamoro. Questi sfida Gusmano; gli ha chiesto spesso di affrontarlo in
leale combattimento (Teco sperai combattere), ma Gusmano sa solo parlare di prigione, tortura,
patibolo; non è un guerriero, ma un carnefice! Gusmano impassibile ripete l'ordine ai soldati. Come
questi si muovono per trascinare Zamoro, entra in scena improvvisamente il vecchio Alvaro, che
subito riconosce in Zamoro l'uomo generoso che gli salvò la vita. Sorpresa generale. Alzira si
rivolge implorando pietà ad Alvaro, che chiede tosto la grazia al figlio. Ma Gusmano non recede:
Zamoro deve morire. Alvaro cade in ginocchio ai piedi di Gusmano raccontandogli l'atto generoso
compiuto da Zamoro e implorando misericordia per lui (Nella polve, genuflesso); ma Gusmano
rimane inflessibile, sebbene a disagio; e mentre da un lato Zuma e Ataliba manifestano la loro
disperazione, dall'altro Alzira lamenta che troppo breve è stata la sua felicità; Zamoro si unisce al
canto della donna amata per esprimere fiducia nella sua fedeltà. S'ode lontano, sul ritmo di una
banda, un mormorio che va crescendo a poco a poco. Entra il capitano spagnolo Ovando con la
notizia che gli Inca sono in marcia su Lima per chiedere la liberazione del loro capo Zamoro. Nella
concitazione del momento Gusmano prende una decisione: seguendo l'esempio del padre, darà una
vita in cambio d'una vita; e dopo aver ordinato alle guardie di lasciar libero Zamoro, corre fra le
braccia del padre, tuttavia ammonendo Zamoro: lo rivedrà sul campo di battaglia. Durante la
stretta del finale Gusmano promette al rivale di ritogliergli con la spada la vita che ora gli ha reso
(Trema... a ritorti fra l'armi); dal canto suo Zamoro giura a Gusmano che avrà il suo scalpo,
mentre Alzira si propone di seguire l'amato e di fargli da scudo. Ataliba e Alvaro deplorano che si
dia voce alle armi; ma Ovando e i soldati ora pensano a come affrontare l'assalto dei nemici.
ATTO SECONDO: La vendetta d'un selvaggio
Parte interna delle fortificazioni di Lima.
9. INTRODUZIONE - BRINDISI. Qua e là drappelli spagnoli sbevazzano allegramente
inneggiando alla vittoria (Mesci, mesci). D'un tratto il ritmo brutale della canzone si trasforma in
quello di una marcia funebre: si vedono, scortati da soldati spagnoli, alcuni prigionieri americani in
catene, fra i quali Zamoro, che attraversano la scena. I soldati riprendono a cantare il brindisi.
10. SCENA E DUETTO. Entra Gusmano, accompagnato da Alzira, e annuncia ai soldati la
divisione delle spoglie nemiche. Con lui è Ovando, che gli presenta la sentenza di morte per
Zamoro, accusato di ribellione. Gusmano s'avvia a un tavolo per firmarla, ma Alzira lo trattiene
implorando clemenza. Fatti uscire con un cenno Ovando e i soldati, Gusmano dichiara ad Alzira
che solo acconsentendo a diventare sua sposa potrà salvare Zamoro. A lei la scelta. Prorompendo
in lagrime la donna si getta ai suoi piedi; attraverso un canto rotto dall'emozione e punteggiato dai
passaggi lamentosi dell'orchestra (Il pianto... l'angoscia...), essa protesta che se sarà costretta allo
spergiuro la sua vita sarà comunque spenta; il pianto di Alzira provoca in Gusmano un maggiore
sdegno: ancora un indugio e Zamoro per causa sua salirà al rogo. Egli sta per firmare la sentenza
di morte, quando infine Alzira cede. Gusmano ordina immediatamente a Ovando di preparare la
festa nuziale ed esplode in un palpitante canto di gioia (Colma di gioia ho l'anima), mentre Alzira,
al massimo della disperazione, esprime la speranza di morire ai piedi dell'altare nuziale.
Orrida caverna, appena rischiarata da un raggio di luna, che vi scende attraverso un forame.
11. SCENA ED ARIA. La scena, vuota per qualche tempo, si apre su un breve preludio
strumentale, dominato dal suono grave di un serpentone che evoca l'oscurità della spelonca. Si
avanza Otumbo, guardingo, che batte su uno scudo d'oro che pende sospeso: superstiti americani
sbucano dalle parti più sinuose della caverna, dove s'erano appiattati. Otumbo comunica loro che
grazie all'oro, quel maledetto oro cagione di tanti mali, ha potuto corrompere le guardie di Zamoro
e far fuggire il prigioniero sotto vesti spagnole. Sentendo un rumore, i soldati accorrono
all'ingresso dell'antro: entra Zamoro. Mentre in orchestra risuona il motivo del preludio, tutti si
prostrano al suo incedere. Rialzatili con un cenno, Zamoro volge lentamente gli occhi, pieni di
cupa tristezza, e getta uno sguardo, come vergognandosi, all'abito spagnolo che lo riveste. I suoi
compagni cercano di confortarlo. Ma Zamoro, distrutto nell'anima, esprime la propria impotenza
(Irne lungi ancor dovrei); lui che ha sempre guardato impavido la morte in volto, ora non può più
vivere senza Alzira: l'amore rende purtroppo debole l'animo del guerriero. Otumbo gli dice che
l'ingrata Inca ormai non è più degna di lui: ella stessa si è data; non vede Zamoro in lontananza il
brillare delle faci che annunciano le nozze di Alzira con Gusmano? Con un grido selvaggio e
cacciandosi furiosamente le mani fra i capelli, mentre un tremore convulso lo assale in tutta la
persona, Zamoro esplode: la sua disperazione si trasforma in un accesso di incontenibile furore
(Non di codarde lagrime); invano trattenuto dai compagni, dichiara di partire la notte stessa per
Lima per compiere la sua vendetta.
Vasta sala nella residenza del Governatore, con logge nel fondo, dalle quali si scorge la città di Lima
illuminata; nel mezzo una tribuna, a cui si sale per tre o quattro gradini.
12. CORO D'ANCELLE. La scena è ingombra di milizie spagnole; i comandanti stanno sulla
tribuna; le ancelle di Alzira da un lato. Introdotto dal suono della banda su un ritmo di bolero le
ancelle acclamano le nozze che uniranno Americani e Spagnoli, vinti e vincitori, in una pace
duratura (Tergi del pianto, America).
13. SCENA ED ARIA FINALE. Entra Gusmano, che presenta la sua sposa alla folla riunita. Si
sente l'anima inebriata: è bello il suono della vittoria (È dolce la tromba), ma ancor più grande è la
gioia di possedere la donna amata. Dà infine ordine di cominciare il rito nuziale, mentre Alzira,
disperata, invoca d'essere inghiottita dalla terra. Le stende la mano per condurla all'altare, ma non
arriva a stringerla: un soldato s'avventa su di lui e gl'immerge un pugnale nel petto.Viene
riconosciuto: è Zamoro! Cento spade balenano sul suo capo. Ma Zamoro ormai non teme la morte:
esulti pure la traditrice Alzira alla vista del suo sangue, e impari Gusmano come si muore.
Sostenuto da Ovando e da alcuni ufficiali, Gusmano si rivolge al rivale perché apprenda ben altre
virtù: il tuo dio, Zamoro, ti ha consigliato una vendetta orribile, il mio dio m'impone di perdonare
(I numi tuoi, vendetta atroce); solo per la tua salvezza Alzira ha ceduto a me. Quindi spinge Alzira
fra le braccia di Zamoro: vivano insieme giorni d'amore. Tutti manifestano profonda commozione
per il gesto di Gusmano. Erompe a un tratto il grido disperato del padre, Alvaro; raccogliendo le
forze estreme Gusmano fa qualche passo verso di lui e si pone la mano paterna sul capo per
riceverne la benedizione. Quindi cade morto.
Attila
Dramma lirico in un prologo e tre atti - Poesia di Temistocle Solera
[completato da Francesco Maria Piave]
Prima rappresentazione:Venezia,Teatro La Fenice, 17 marzo 1846
L'argomento deriva dalla tragedia di Zacharias Werner (Kònigsberg, 1768 - Vienna, 1813), Attila,
Kiinig der Hunnen, composta nel 1808 e descritta da Madame de Staél in De l'Allemagne.
Animato da una forte avversione nei confronti di Napoleone, a quel tempo dominatore dell'Europa,
Werner volle assumere la figura di Attila a simbolo della tirannide napoleonica; nel consultare
tuttavia i documenti storici apprese che il "flagello di Dio" fu in realtà sovrano saggio e guerriero
leale, che diede leggi al suo popolo e seppe amministrarlo con giustizia: ne seguì che nella tragedia
la sua figura emerge come immagine rovesciata di Napoleone e al tempo stesso come esaltazione
del mito germanico in opposizione al corrotto mondo occidentale, cui alla fine soccombe. In tal
senso il libretto riflette abbastanza fedelmente la tragedia di Werner; e sono pertanto in errore
quegli studiosi che assegnano all'Attila verdiano un carattere risorgimentale; ben al contrario:
anche in Verdi si tratta del dramma d'un sovrano inesorabile, ma fiero e solitario nella sua lealtà,
che resta vittima degli intrighi dei "romani". Dopo aver chiesto ad Andrea Maffei uno "sbozzo"
della tragedia di Werner; Verdi aveva in un primo momento affidato la stesura del libretto a Piave,
indicandogli i punti salienti del dramma e invitandolo a leggere l'Allemagne della Staél. Per un
soggetto cui annetteva molta importanza, preferì poi affidarsi al più esperto Solera. Più esperto, sì,
ma assai meno tempestivo e puntuale di Piave. Inopinatamente partitosene il focoso Temistocle
alla volta della Spagna per raggiungervi la moglie cantante, ivi scritturata, Verdi rimase alle prese
con un libretto che, per quanto apparentemente ultimato, necessitava di ritocchi e di ulteriori
modifiche, specie nel terzo atto. Per non perdere ulteriormente tempo il compositore ritornò alla
collaborazione del più servizievole e infaticabile Piave, le cui modifiche furono peraltro approvate
da Solera su richiesta di Verdi. Già alla prima sera l'opera ottenne un grande successo, entrando
subito nel repertorio dei teatri italiani in patria e all'estero per quasi tutto il corso del secolo. Come
altre opere del periodo giovanile, l'Attila scomparve dalle scene all'alba del nuovo secolo. Ignorata
dalla Verdi-Renaissance, la rinascita dell'opera, pur lenta, ma costante, inizia a partire, in pratica,
da un allestimento effettuato al Comunale di Firenze nel dicembre del 1962.
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
ATTILA, re degli Unni primo basso Ignazio Marini
EZIO, generale romano primo basso [baritono] Natale Costantini
ODABELLA, figlia del signore d'Aquileja prima donna Sofia Loewe
FORESTO, cavaliere aquilejese primo tenore Carlo Guasco
ULDINO, giovane bretone, schiavo di Attila secondo tenore Ettore Profili
LEONE, vecchio romano secondo basso Giuseppe Romanelli
Duci, re e soldati, i.Jnni, Gepidi, Ostrogoti, Eruli, Turingi, Quadi, Druidi, Sacerdotesse, Popolo uomini e donne di
Aquileja, vergini di Aquileja in abito guerriero, ufficiali e soldati romani, vergini e fanciulli di Roma, eremiti, schiavi
La scena durante il Prologo è in Aquileja e nelle Lagune Adriatiche; durante i tre Atti è presso Roma Epoca: la metà
del secolo V [anno 452 circa]
Nota storica: La vicenda drammatica presenta tre personaggi storici. Innanzi tutto il
protagonista,Attila (395 ca. - 453), re degli Unni (popolazione di origine turco-mongolica); dopo
aver unificato le varie tribù riuscì a dominare i territori della Russia meridionale e del bacino del
Danubio sconfiggendo l'imperatore d'Oriente Teodosio II; nel 451 invase la Gallia, ma sconfitto da
Ezio ai Campi Catalaunici (località pianeggiante della Francia presso Chàlons-sur-Marne), rientrò
in Pannonia da dove iniziò la sua marcia verso l'Italia, distruggendo Aquileja. Sul Mincio (e non
nei pressi di Roma come si finge nel dramma) s'incontrò con papa Leone I Magno: la fame e le
malattie che colpirono il suo esercito lo convinsero alla pace e al ritorno in Pannonia. "Flagello di
Dio" per la tradizione cristiana, egli è tuttavia ricordato nella saga nibelungica e nei carmi
dell'Edda come monarca valoroso e saggio. Nel dramma dovrebbe avere 57 anni. Suo antagonista è
Flavio Ezio, generale romano di origine illirica (390-454); rimasto come ostaggio presso gli Unni,
strinse con loro amichevoli rapporti. Per volere di Galla Placidia gli fu affidato il comando
dell'esercito dell'Impero d'Occidente e combatté vittoriosamente contro Goti e Franchi; nel 451
(un anno prima degli avvenimenti esposti nel dramma), alleatosi con Visigoti, Burgundi e Franchi,
vinse gli Unni ai Campi Catalaunici, arrestando per qualche tempo la marcia di Attila verso l'Italia.
Nel dramma dovrebbe avere circa 62 anni. Il terzo personaggio storico, che fa una fugace ma
importante apparizione nel finale del primo atto, è papa Leone I Magno, che opportunità di
censura fanno designare nel libretto come "vecchio romano". Un altro personaggio storico non
presente nel dramma, cui allude Ezio nella prima parte del primo atto, è il "regnator d'Oriente",
cioè Valentiniano III (419-455), figlio di Galla Placidia, eletto nel 424, all'età di cinque anni, sul
trono dell'Impero d'Oriente (inetto e vizioso, accecato dalla gelosia nei confronti del generale Ezio,
lo ucciderà in uno scatto d'ira, restando a sua volta ucciso da due commilitoni di Ezio). La seconda
scena del Prologo si svolge a Rio-Alto (da cui Rialto), l'antico agglomerato di case sorgenti su
palafitte, eretto - secondo la leggenda - dagli scampati alla distruzione di Aquileja, che diverrà in
seguito la città di Venezia.
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
1. PRELUDIO. È piuttosto breve, quasi laconico; inizia con il tema sul quale i Druidi nel finale del
secondo atto pronunceranno le loro profezie e si conclude con una dolente melodia caratterizzata
dalla figura musicale del lamento.
PROLOGO
Piazza di Aquileja. La notte vicina al termine è rischiarata da una grande quantità di torce. Tutto
all'intorno è miserando cumulo di rovine. Qua e là si vede ancora tratto tratto sollevarsi qualche fiamma,
residuo di un orribile incendio di quattro giorni.
2. INTRODUZIONE. La scena è ingombra di Unni, Eruli, Ostrogoti, ecc. inneggianti ad Attila e
al dio Wodan che li hanno condotti alla scoperta del ricco suolo d'Italia (Urli, rapine, gemiti). A
poco a poco un possente re s'avanza, con il suo seguito, su un carro tirato da schiavi: è Attila che fa
il suo ingresso trionfale. Al suo passaggio tutti si prostrano. Ma Attila scendendo dal carro li fa
alzare (Eroi levatevi) e, andando a sedersi su un trono di lance e di scudi, rammenta loro la rapidità
delle sue imprese: i barbari inneggiano al loro re, ministro e profeta del dio Wodan (Viva il re dalle
mille foreste).
3. SCENA E CAVATINA. Scendendo dal trono Attila scorge un gruppo di donne risparmiate al
massacro e chiede ai suoi perché fu infranto il suo ordine di sterminare gli sconfitti. Uldino, un
Bretone schiavo di Attila, risponde che queste guerriere così mirabili nel difendere i loro fratelli
possono essere un degno tributo alla gloria di Attila. Il re è stupito.Tra queste guerriere è
Odabella, figlia del signore di Aquileia, trucidato dagli Unni, la quale con energia assicura che
santo amor di patria anima le donne italiche (Allor che i forti corrono), e se le compagne dei
barbari rimangono su un carro a piangere i loro cari, le donne italiche saranno sempre pronte alla
battaglia. Attila, sorpreso e ammirato dal coraggio e dalla fierezza della giovane, decide di
concederle una grazia. Odabella chiede una spada; il re pronto le porge la sua. Odabella coglie il
senso di un dono ambiguo con il quale l'oppressore arma l'odio dell'oppresso (Da te questo or m'è
concesso); e mentre i barbari inneggiano al valore di un re, protetto dal dio Wodan, che sa
distruggere con l'impeto di un torrente in piena e che delicato come la rugiada premia i valorosi,
Attila rimane turbato: nel suo animo coriaceo sente scendere un sentimento nuovo. Meditando
vendetta, Odabella si allontana con le altre donne.
4. DUETTO. Attila si rivolge a Uldino e gli ordina di far entrare il messo di Roma. Il popolo ha
un sussulto di sdegno, che il re placa con calma: ascoltare non vuol dire accettare. Ezio, ufficiale
romano, giunge al campo di Attila in veste di messaggero di Roma. Attila lo saluta come vecchio
amico e suo degno nemico. Ezio gli chiede bruscamente un colloquio privato. Il barbaro intima a
tutti di uscire. Appena soli, Ezio salta ogni convenevole: propone al re unno di allearsi a lui e,
approfittando della debolezza dei regnanti dell'impero d'oriente e di quello d'occidente, l'uno
vecchio e debole, e l'altro solo un ragazzo (Tardo per gli anni, e tremulo), impadronirsi di tutte le
antiche terre dell'impero romano; poi si divideranno il bottino: a Ezio l'Italia, ad Attila il mondo
intero. Attila, disgustato, disprezza con vigore la proposta del romano; con severità ammonisce
l'avversario, che pure stima valoroso combattente: laddove un eroe è disposto al tradimento, il
popolo è perduto e la stessa aria è impura, e allora sarà proprio lì che piomberà il flagello di Attila
e si manifesterà la fede di Wodan. Nel vedersi respingere il patto, Ezio si rimette i panni del
messaggero di Roma e dichiara guerra al re degli Unni in nome dell'imperatore. Con impeto Attila
promette all'avversario che sommergerà nella polvere il sonnolento impero romano (Vanitosi! che
abbietti e dormenti) e ridurrà in cenere le superbe città italiane; ma Ezio gli ricorda la sconfitta
infertagli a Chàlons. Con queste minacce di guerra partono entrambi da opposte parti.
Rio-Alto nelle lagune adriatiche. Qua e là sopra palafitte sorgono alcune capanne comunicanti fra loro per
lunghe asse sorrette da barche. Sul davanti sorge in simile guisa un altare di sassi dedicato a San Giacomo.
Più in là si scorge una campana appesa ad un casotto di legno, che fu poi il campanile di San Giacomo.
5. SCENA E CAVATINA. Un fragoroso preludio strumentale descrive la forza dell'uragano in
corso: la scena s'illumina di lampi, risuona di tuoni. Quando la tempesta si placa e le tenebre vanno
diradandosi si odono i rintocchi insistenti di una campana che suona il mattutino. Alcuni eremiti
escono dalle capanne e si avviano all'altare intonando canti di lode al Signore e Creatore che, dopo
averla suscitata, acquietò d'un soffio la tempesta (Qual notte!). Un interludio strumentale descrive
il sorgere dell'alba che a poco a poco invade la scena; gli eremiti salutano il primo raggio di sole
invitando alla preghiera. Dalle navicelle, che approdano a poco a poco, escono Foresto, uomini,
donne e fanciulli di Aquileja scampati alla strage di Attila. Foresto, cavaliere aquileiense, promesso
sposo di Odabella, interpreta la presenza delle croci e degli altari come un buon auspicio e invita i
suoi compagni ad accamparsi. Gli Aquileiensi inneggiano a Foresto, che riconoscono come loro
capo. Il giovane, ormai al sicuro sulla spiaggia, pensa alla sua promessa sposa, Odabella, schiava
dell'Unno, una sorte atroce che ben varrebbe forse la morte (Ella in poter del barbaro).Tutti
cercano di consolarlo: il sole luminoso che ora splende sembra una promessa per il futuro; ma il
pensiero di Foresto si rivolge alla patria perduta, Aquileia, divenuta un cumulo di macerie (Cara
patria, già madre e reina) e che tuttavia risorgerà, come fenice dalle ceneri, sulle onde della laguna
per rivivere ancor più superba e bella.
ATTO PRIMO
Bosco presso il campo di Attila. È notte; nel vicino ruscello bulicano i raggi della luna.
6. SCENA E ROMANZA. Sono passate molte settimane; ora Attila si trova con il suo esercito a
poche miglia da Roma. Una triste melodia di violini introduce l'ingresso in scena di Odabella che,
finalmente sola, può dare sfogo alla sua tristezza e piangere i suoi lutti. Nelle nuvole che
attraversano il cielo vede l'immagine di suo padre e poi di Foresto (Oh! nel fuggente nuvolo);
commossa da quella suggestione chiede al fiume e al vento di acquetarsi affinché possa udire la
voce dell'amato.
7. SCENA E DUETIO. Odabella sente improvvisamente dei passi. È Foresto che inopinatamente
compare: sommo stupore di Odabella che, al colmo della gioia e dell'emozione, corre ad
abbracciarlo. Ma egli la scosta: vedendola abbigliata in barbare vesti la crede traditrice e indegna
dei pericoli che lui ha affrontato per liberarla (Sì, quello io son, ravvisami), indegna della sua patria
e di suo padre. Odabella non riesce a resistere a questi accenti: ben conscia della sete di vendetta
che le cova in cuore, preferisce essere trafitta dalla spada di Foresto piuttosto che dalle sue parole.
Riesce infine a spiegarsi, e a Foresto offeso confida d'aver giurato di vendicare il suo popolo
seguendo l'esempio di Giuditta (l'eroinca biblica che salvò Israele seducendo il generale Oloferne e
decapitandolo). Foresto, commosso e dispiaciuto per aver mancato di fiducia, fa per prostrarsi ai
suoi piedi; ma la giovane lo stringe a sé e insieme i due rinnovano, all'unisono, le promesse
amorose (Oh t'inebria nell'amplesso).
Tenda di Attila. Sopra il suolo, coperto da una pelle di tigre, è disteso Uldino che dorme. In fondo alla
sinistra, per mezzo di una cortina sollevata a mezzo, la quale forma come una stanza appartata, si scorge
Attila in preda al sonno sopra il letto orientale assai basso, e coperto egualmente da pelli di tigre.
8. SCENA ED ARIA. Dopo un breve preambolo orchestrale Attila si sveglia di soprassalto e
chiama Uldino: gli narra d'aver sognato un gigantesco vecchio (Mentre gonfiarsi l'anima) che gli
afferrava la chioma e lo ammoniva a desistere dalla conquista di Roma. Il re degli Unni sembra
come paralizzato dal terrore; ma non appena Uldino gli chiede cosa intende fare, prontamente
riconquista i propri sensi e ordina, risoluto, di far riunire le sue schiere per muovere contro Roma,
sfidando, in un dialogo immaginario, lo spettro che nel sogno osava arrestarlo (Oltre quel limite
t'attendo).
9. FINALE PRIMO. In un rapido crescendo di musica marziale entrano in scena Uldino, duci, re e
le schiere dei barbari. Fra essi sono Odabella e Foresto, quest'ultimo con la visiera calata.
L'esercito radunato attende ordini. Attila lo incita alla battaglia: allo squillo delle trombe i soldati
intonano un inno di guerra (Sia gloria a Wodan). Improvvisamente al canto guerriero si
sovrappone, proveniente da lontano, un canto religioso (Vieni, le menti visita); la scena si muta in:
Il campo d'Attila.
Dalla collina in fondo si vede avanzare processionalmente, preceduta da Leone e da sei Anziani,
una schiera di Vergini e Fanciulli in bianche vesti recanti palme. La scena, sul davanti, è ingombra
dalle schiere di Attila in armi. Attila si chiede chi possano essere quegli sparuti inermi. Vergini e
Fanciulli s'avanzano cantando (I guasti sensi illumina). Il re a poco a poco si va commuovendo:
scorge alla testa di quel corteo il "bieco fantasma" del sogno. È papa Leone, che gli ripete le parole
udite nel sogno: "Di flagellar l'incarco contro i mortali hai sol. T'arretra! or chiuso è il varco;
questo de' numi è il suol". Attila trema e leva la testa al cielo sopraffatto da subito terrore. Crede di
scorgere due figure gigantesche (allusione ai santi Pietro e Paolo) che occupano tutta la volta
celeste con gli occhi di fuoco e lunghe spade fiammeggianti, le cui punte aguzze arrivano a toccarlo
(No!... non è sogno). Dominato dalla visione si prostra al suolo in segno di rinuncia.Tutti restano
sorpresi e smarriti: la visione dei fanciulli e del vecchio, e la vista di Attila inginocchiato
coinvolgono anche i guerrieri di Attila. Odabella, Foresto, Leone e il coro delle vergini lodano
Iddio, che è capace di risolvere le situazioni con eventi miracolosi come quando il piccolo David
sconfisse Golia.
ATTO SECONDO
Campo di Ezio. Si scorge lontana la grande città dei sette colli.
10. SCENA ED ARIA. Ezio, il generale romano, è solo; legge un dispaccio con il quale
l'imperatore Valentiniano gli ordina di rientrare a Roma; freme d'ira nel dover obbedire agli ordini
di un giovinetto imbelle, circondato dagli agi, più timoroso di Ezio che non delle schiere barbare. Il
pensiero del "prode guerrier canuto" va agli antichi eroi la cui gloria riempiva l'universo
(Dagl'immortali vertici); se potessero rivivere, come potrebbero riconoscere la patria nel"vil
cadavere" a cui ora è ridotta? Preceduto da alcuni soldati romani, fra cui Foresto, si presenta uno
stuolo di schiavi appena liberati da Attila, inviati a convocare Ezio presso l'Unno. Nell'accettare
l'invito Ezio congeda i soldati. Ma uno rimane: Foresto, che manifesta a Ezio l'intenzione di
avvelenare Attila approfittando di un momento di sbandamento della schiere barbare, provocato da
un segnale di fuoco, che egli farà accendere sul monte dalle truppe romane. Ezio accetta; quindi,
rimasto solo, si dichiara pronto alla guerra: saprà cadere per la patria, almeno per non vederla
decadere lentamente e fatta a brani (È gettata la mia sorte).
Campo di Attila come nell'atto primo, apprestato a solenne convito. La notte è vivamente rischiarata da
cento fiamme che irrompono da grossi tronchi di quercia preparati all'uopo.
11. FINALE SECONDO. Sono in scena Unni, Ostrogoti, Eruli, ecc. Mentre i guerrieri cantano
(Del ciel l'immensa volta), entra Attila, seguito dai Druidi, dalle Sacerdotesse, dai Duci e Re, e va
ad assidersi al posto; Odabella gli è presso in costume d'Amazzone. Uno squillo di tromba
annuncia l'arrivo di Ezio e degli ufficiali romani, tra cui Foresto, preceduti da Uldino. Mentre
Foresto si frammischia alla moltitudine, Attila invita Ezio a sederglisi accanto. Ma i druidi gli
sussurrano all'orecchio infausti presagi: lo spirito dei monti ha ululato nella notte e nuvole tinte di
sangue annunciano l'approssimarsi della tempesta. Attila respinge queste fantasie infantili e invita
le Sacerdotesse a intonare un giocondo canto conviviale. Ma il loro canto (Chi dona luce al cor?),
apparentemente lieto, è lugubre nelle parole: non un solo raggio amico penetra nelle tenebra
notturna offuscata dalle nubi e già si alza il vento e rumoreggia il tuono. All'improvviso un rapido
soffio procelloso spegne gran parte delle fiamme.Tutti si alzano per naturale moto di terrore.
Silenzio e tristezza generale (Lo spirto de' monti). Foresto corre presso Odabella, rincuorandola
con la promessa di una rapida vendetta: la tazza del veleno per Attila, complice Uldino, è già
pronta. Ma Odabella in cuor suo pensa che Attila, l'uccisore di suo padre, debba morire non per
tradimento, ma trafitto dalla sua spada. Intanto Ezio, che si è avvicinato ad Attila, gli offre l'ultima
possibilità di un'alleanza; ma il re unno rifiuta con ira. E mentre Uldino, memore della sua origine
bretone, medita di liberarsi dalla propria schiavitù e versa il veleno nella coppa destinata ad Attila,
in tutti il terrore viene scemando: la procella si è ormai allontanata e il cielo si è rasserenato.
Riscuotendosi, Attila ordina di riaccendere le torce e di riprendere le danze. Si appresta quindi a
libare in onore di Wodan bevendo dalla coppa che gli porge Uldino, quando Odabella lo trattiene
avvertendolo del veleno. Attila, furibondo, chiede del colpevole: Foresto, con fermo accento, si
autodenuncia, affermando di essere quello stesso che un dì gli strappò la corona. Attila fa per
scagliarsi contro di lui, ma subito Odabella s'interpone, e come compenso per avergli salvato la
vita chiede che a lei sola sia consentito di punire il reo confesso.Attila, compiaciuto del suo atto di
fedeltà, accetta, e come segno di gratitudine la dichiara sua sposa. Infine avverte i Romani di
prepararsi alla guerra (Oh miei prodi! un solo giorno): il re degli Unni non ha più paura di sogni e
di visioni. Nel corso del concertato Odabella implora Foresto di fuggire, assicurandogli che al
nuovo giorno avrà il suo perdono; e mentre Ezio e Uldino si appartano stupefatti - il primo
chiedendosi chi ha svelato il segreto del veleno e tuttavia ripromettendosi di debellare Attila in
battaglia; il secondo, commosso dal magnanimo gesto di Foresto che lo ha scagionato,
promettendo di essergli sempre fedele - il popolo dei barbari proclama la grandezza del re e a gran
voce lo invita a impugnare le armi contro i Romani traditori.
ATTO TERZO
Bosco come nell'atto primo, il quale divide il campo di Attila da quello di Ezio. È il mattino.
12. SCENA E ROMANZA. Entra Foresto in quello che sarà il luogo delle nozze di Attila con
Odabella. Sopraggiunge Uldino, divenuto suo fedele, che lo informa che nel campo barbaro
fervono i preparativi delle nozze del re. Foresto gli ordina di raggiungere Ezio e avvertirlo di
tenersi pronto per l'imboscata con le schiere romane al di là della foresta. Partito Uldino, il
giovane, vivamente sdegnato per il gesto di Odabella, si chiede perché la perfidia assuma volto
d'angelo (Chi non avrebbe il misero).
13. TERZETTO. Ezio arriva frettoloso dalla parte del campo romano. I soldati romani sono
pronti: i barbari saranno sterminati, proclamano insieme Foresto ed Ezio. Si ode provenire dal
campo degli Unni un dolce canto che è un inno alla bellezza di Odabella (Entra fra i plausi, o
vergine). Foresto ha un fremito di gelosia, ma Ezio lo invita a trattenere la smania per non
compromettere l'impresa. D'improvviso sopraggiunge Odabella, fuggita dal campo di Attila (Te
sol, te sol quest'anima): scorge l'amato Foresto in compagnia di Ezio e subito rassicura il giovane,
che non crede alle sue parole, di essergli rimasta sempre fedele. Intanto Ezio sollecita Foresto: ora
non è tempo di lacrime e di gelosie; si dia subito il segnale d'attacco finché il momento è propizio.
14. QUARTETTO FINALE. Sopraggiunge Attila alla ricerca di Odabella e si accorge di trovarsi
accerchiato dai tre cospiratori (Tu, rea donna); con crescente indignazione rinfaccia la loro
ingratitudine: quella di Odabella già schiava or suà sposa, quella di Foresto cui ha donato la vita,
quella di Ezio cui ha salvato Roma... Ma non c'è pietà per colui le cui nequizie hanno colmato la
misura. Odabella gli rammenta che proprio sotto i suoi occhi Attila le trucidò il padre: diventando
sua sposa sarebbe per sempre maledetta. Foresto gli ricorda che gli ha distrutto la patria, ed Ezio
gli rammenta il sangue invendicato degli oppressi. Odabella scaglia lontano la corona di sposa. Ma
ecco provenire dall'interno un grido di morte; soldati romani entrano precipitosamente in scena.
S'ode l'intenso rumore dell'improvviso assalto al campo dei barbari. Foresto si avventa contro
Attila per trafiggerlo, ma viene preceduto da Odabella, che vendica così il proprio padre. Poi
abbraccia Foresto. Attila cadendo la guarda attonito, e come il grande Cesare esclama: tu pure,
Odabella? Guerrieri romani irrompono da ogni parte annunciando che tutte le vittime di Attila
sono state vendicate!
Macbeth
Melodramma in quattro atti di Francesco Maria Piave
[con correzioni e integrazioni di Andrea Maffei]
Prima rappresentazione: Firenze,Teatro alla Pergola, 14 marzo 1847
nuova versione: Parigi,Thatre Lyrique, 21 aprile 1865
L'argomento deriva dalla tragedia di William Shakespeare (Stratford-on-Avon, 1564 - 16 16),
Macbeth, composta intorno al 1606, a sua volta ispirata alle Chronicles di Raphael
Holinshed.Verdi, che conosceva le tragedie del grande drammaturgo inglese sin dagli anni di
gioventù, da tempo desiderava affrontarle come argomento d'opera; già nel 1843 aveva proposto
alla Fenice il Re Lear. L'occasione che gli consentì di scegliere, per l'opera nuova che doveva
scrivere per la Pergola di Firenze, il Macbeth (tragedia mai sino ad allora rappresentata in Italia
dalle compagnie drammatiche, il cui repertorio shakespeariano si limitava a Giulietta e Romeo e a
Otello, già tradotte in musica rispettivamente da Rossini e da Zingarelli, Vaccai, Bellini, e
raramente comprendeva Amleto) deriva dal fatto che la compagnia di Firenze disponeva solo di
una primadonna e di un baritono di gran cartello, il che veniva a coincidere con un argomento che
non necessita di una parte importante per tenore. Lo stesso Verdi stese (con il probabile aiuto di
Andrea Maffei) lo schizzo del libretto e lo inviò a Piave perché lo versificasse. Insoddisfatto del
lavoro di Piave, chiese l'intervento di Maffei per l'aggiustamento di alcune scene. Nel corso delle
prove Verdi fu più esigente del solito; due scene in particolare considerava basilari per il successo
dell'opera: il duetto Lady - Macbeth del primo atto e la gran scena del sonnambulismo. Nonostante
il pubblico sulle prime apparisse disorientato a causa dell'elemento fantastico, l'opera ottenne
successo e ben presto si diffuse sulle scene teatrali italiane e straniere, restando in repertorio per
quasi tutto l'Ottocento (da segnalare l'abitudine dei tenori che al fine di rendere più importante la
parte di Macduff sostituivano la stretta nel quarto atto, l'"a due" con Malcom, con la cabaletta di
Zamoro nell'Alzira). Il successo dell'opera divenne subito fattore trainante per l'inserimento della
tragedia di Shakespeare nel repertorio delle compagnie drammatiche italiane, a cominciare dalla
Compagnia Lombarda di Alamanno Morelli, fino a costituire uno dei cavalli di battaglia di
Adelaide Ristori, che recitò la_ tragedia anche a Parigi e a Londra. Nel 1864, su richiesta del Thé
atre-Lyrique di Parigi, che desiderava rappresentare il Macbeth in francese, Verdi procedette a una
revisione dell'opera, ancora servendosi di Piave, introducendo brani nuovi (l'aria "La luce langue",
un balletto, il finale), sostituendone altri (il duettino "Ora di morte e di vendetta", il nuovo coro dei
profughi scozzesi, la battaglia), rifacendo interi squarci e togliendo la morte di Macbeth in scena.
La versione "francese" ebbe alcuni allestimenti anche in Italia; ma per anni vi prevalse la versione
`fiorentina". Sparito dalle scene all'alba del Novecento, il Macbeth risorse a nuova vita grazie alla
Verdi-Renaissance tedesca, a cominciare da un allestimento a Dresda nel 1928. I teatri italiani
sono giunti assai in ritardo alla riscoperta di quello che oggi viene considerato uno dei capolavori
di Verdi; è solo a partire dagli anni 1960 che esso si è gradualmente insediato nel repertorio
melodrammatico corrente. In alcune esecuzioni moderne (a partire dalla ripresa di Dresda, sopra
citata) l'opera viene fatta concludere ripristinando dalla versione del 1847 la scena della morte di
Macbeth ("Mal per me che m'affidai"), in ciò contravvenendo a un'esplicita volontà di Verdi che,
riformando il Macbeth per Parigi, volle espressamente togliere la morte in scena del protagonista
(così rispettando la tragedia originale), per sostituirvi un inno di vittoria.
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
Firenze 1847 Parigi1865
DUNCANO, re di Scozia [mimo]
MACBETH primo baritono
Felice Varesi
Ismaàl
generali dell'esercito di Duncano
BANCO primo basso
Nicola Benedetti Petit
LADY MACBETH, moglie di Macbeth prima donna
Marianna Barbieri Rey-Balla
DAMA di Lady Macbeth seconda donna
Faustina Piombanti Mairot
MACDUFF, nobile scozzese signore di Fiff primo tenore
Angelo Brunacci Monjauze
MALCOM, figlio di Duncano secondo tenore
Francesco Rossi Iluet
FLEANZIO, figlio di Banco [mimo]
Domestico di Macbeth [mimo]
Medico secondo basso
Giuseppe Romanelli
Guyot
Sicario secondo basso
Giuseppe Bertini Caillot
Streghe, messaggeri del re, nobili e profughi scozzesi, sicari, soldati inglesi, bardi, spiriti aerei, apparizioni
La scena è in Scozia, e massimamente al castello di Macbeth. Sul principio dell'Atto quarto è tra il confine di Scozia e
d'Inghilterra
Epoca: fine dell'XI secolo
Nota storica: Verso la metà dell'XI secolo il buon re Duncano successe a Edoardo il Confessore sul
trono di Scozia. Volgevano tempi difficili, perché il regno era scosso dalle rivolte dei baroni (thani)
e assalito da Danesi e Norvegesi. Duncano affidò a Macbeth il compito di riportare l'ordine.
Secondato da Banquo, Macbeth raggiunse l'intento; ma non pago di onori, osò aspirare al soglio
regale, in ciò incoraggiato dalle leggi di Scozia, in base alle quali il re, ove fosse morto senza
lasciar figli, doveva passare la corona al parente più prossimo. Duncano, già vecchio, aveva due
teneri figli, Malcom e Sivard, il primo dei quali elesse suo successore. Macbeth pensò allora di
ottenere col delitto ciò che non poteva ottenere per legge e trucidò Duncano un giorno che questi
fu ospite nel suo castello. Malcom fuggì in Inghilterra. Macbeth regnò per 17 anni. Malcom,
ottenuto da re Edoardo un esercito di uomini e secondato da Macduff, cui Macbeth aveva ucciso
moglie e figli e carpito il castello di Fife, vinse Macbeth in battaglia uccidendolo e così
recuperando il trono avito. Secondo .la leggenda gli sarebbe successo Fleanzio, figlio di Banquo,
considerato capostipite della famiglia degli Stuart, sovrani di Scozia.
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
1. PRELUDIO. È intessuto sui temi collegati alle parti più significative del dramma; si apre con il
tema delle Streghe all'inizio del terzo atto ("Tre volte miagola la gatta in fregola") suggellato da
un trillo che esprime, come spesso in Verdi, scherno e malevolenza. Prosegue con l'improvviso
scoppio degli accordi di ottoni che nel terzo atto saluta le tre apparizioni, combinato con il riso
diabolico delle "spirtali donne". E si conclude con l'ampia, toccante melodia degli archi derivata dal
preludio alla gran scena del sonnambulismo.
ATTO PRIMO
Bosco.
2. INTRODUZIONE. Tre crocchi di Streghe barbute appaiono uno dopo l'altro fra lampi e tuoni,
e si raccontano raccapriccianti magie (M'è frullata nel pensier): maledetta dalla moglie di un
navigante, una strega medita di far naufragare il marito; l'ostinata uniformità del ritmo e della
tonalità conferisce un che di fatale al canto delle "veggenti". Ma all'improvviso s'ode un rullo di
tamburo dietro la scena; nel vedere Macbeth che si avanza i tre crocchi si confondono insieme e
intrecciano una ridda (Le sorelle vagabonde) su un motivo che suona deliberatamente sguaiato e a
un tempo grottesco.
3. SCENA E DUETTO. Appare Macbeth, generale dell'esercito di Duncano, re di Scozia; con lui è
un altro generale, Banco. Scorgendo le Streghe rimangono entrambi stupiti del loro orribile
aspetto. Invitate a parlare, esse in tono profetico, su accordi di fiati a intervalli ascendenti, salutano
Macbeth tre volte: dapprima con un titolo vero che egli sa di possedere, vale a dire come sire di
Glamis; quindi con un titolo altrettanto vero, ma che egli non sa ancora di possedere, cioè come
sire di Caudore; infine con un titolo immaginario: re di Scozial... Rivolgendosi poi a Banco le
Streghe lo salutano come genitore di monarchi. Quindi spariscono con un evviva che suona a
scherno. Giungono alcuni messaggeri per annunciare a Macbeth che il sovrano ha fatto giustiziare
il signore di Caudore, e che lo ha eletto al suo posto. Macbeth resta profondamente turbato; il
secondo vaticinio delle streghe si è avverato (Due vaticini compiuti or sono): ora sente nascere in
sé un pensiero di sangue, e tuttavia s'impone di non alzar la mano rapace sulla corona promessa
nel terzo vaticinio. Non sfugge a Banco l'ambizioso orgoglio da cui Macbeth sembra animato; ma
egli ben sa che lo spirito infernale dice il vero solo per portare l'uomo a perdizione.
4. CORO DI STREGHE. STRETTA DELL'INTRODUZIONE. Non appena tutti si sono
allontanati le Streghe tornano in scena, e al ritmo convulso di una nuova ridda (S'allontanarono!),
che sembra assumere un tono di trionfo, si ripromettono di riunirsi ancora: sanno che Macbeth
ritornerà per ascoltare il loro oracolo.
Atrio nel castello di Macbeth.
5. SCENA E CAVATINA. La scena si apre con un preludio a piena orchestra dal carattere
tempestoso: sequenze ascendenti che sembrano soffi d'uragano introducono il personaggio di Lady
Macbeth in scena; sta leggendo una lettera del marito in cui egli racconta delle Streghe e dei loro
vaticini. Lady Macbeth, conoscendo la debolezza dello sposo, sa di dover intervenire per spingerlo
alla conquista del trono promesso dal terzo vaticinio: la strada della potenza è piena di delitti, e
guai per chi ha il piede dubbioso! Che Macbeth venga: non vede l'ora di accendere il suo freddo
cuore (Vieni! raffretta): il canto di Lady ergendosi verso il registro acuto, esprime un carattere
volitivo e imperioso. Entra un servo per annunciarle l'arrivo del re e di Macbeth sul calar della
sera. Duncano qui? Il destino sembra venire in aiuto di Lady, che con accento infuocato invoca i
ministri infernali (Or tutti sorgete): scenda presto la tenebra notturna a occultare il pugnale
omicida.
6. SCENA E MARCIA. Entra Macbeth per annunciare a Lady che fra poco verrà il re. Ma Lady,
che ha salutato il marito con il nuovo appellativo di Caudore, gli fa capire quale accoglienza gli si
debba riservare, opponendo alla sua titubanza un'imperiosa determinatezza. Di lontano si ode
provenire il lieto suono di una marcia villereccia (eseguita dalla banda interna); avanzandosi a poco
a poco essa annuncia l'arrivo del re. Questi attraversa la scena accompagnato da Banco, Macduff,
Macbeth, Lady Macbeth e. dal suo séguito. Quindi la musica si allontana sempre più fino a
spegnersi.
7. GRAN SCENA E DUETTO. Macbeth rientra in scena ordinando a un servo di avvertirlo della
"tazza notturna" con un tocco di campana (sarà questo il segnale dell'azione). Rimasto solo, resta
improvvisamente colpito da un'allucinazione: crede di vedere l'elsa di un pugnale insanguinato; ne
tenta la presa, ma l'arma sembra sfuggirgli. Sui movimenti striscianti dell'orchestra il suo canto,
cupo e sordo, si dipana lentamente come un serpente in agguato: nulla esiste ancora, ma l'assassino
come fantasma già si muove mentre le Streghe consumano i loro riti. Di lontano giunge il tocco di
una campana: è il segnale che chiama Duncano in cielo o all'inferno. Entra precipitoso nella stanza
dove il re riposa. Il trillo fortissimo dell'orchestra affonda rapidamente in lunghi accordi smorzati,
sui quali entra guardinga, a passo lento, Lady. Si sente un lamento. Gli fa eco il verso del gufo. Ed
ecco sulla porta apparire Macbeth, barcollante e stravolto, col pugnale insanguinato in mano.
"Tutto è finito!". Il motivo, tosto ripreso dagli archi, si snoda su un ritmo incalzante: Macbeth
s'avvicina a Lady e sottovoce le chiede se ha sentito un mormorio (Fatal mia donna! un murmure):
no, solo il canto del gufo. Improvvisamente, guardandosi le mani insanguinate, esplode: Oh vista
orribile! Tornando a parlare sottovoce dice d'aver sentito i cortigiani recitare la preghiera della
notte; avrebbe voluto egli pure recitarla, ma invano."Follie!", incalza Lady, follie che si disperdono
ai raggi del giorno. Ma Macbeth, scosso e turbato, sente una voce interna che gli dice: Glamis, hai
ucciso il sonno per sempre. Lady schernisce i suoi timori di fanciullo vanitoso che vacilla e
s'arretra. E mentre Macbeth atterrito avverte la vendetta del cielo che tuonerà su di lui le "sante
virtù" di Duncano, Lady rimane sorpresa nel constatare come l'invitto guerriero ora tremi di
paura. Ordina al marito di riportare il pugnale nella stanza del re e d'insanguinare le guardie
affinché su di loro ricada la colpa. Al suo risoluto rifiuto gli strappa di mano l'arma ed entra nella
stanza del re. Bussano forte, per tre volte, alla porta del castello. Macbeth è spaventato: si guarda
le mani lorde di sangue, imprecando: nemmeno l'acqua dell'oceano basterà a lavarle. Rientra Lady
mostrando le proprie mani, ora anch'esse insanguinate: uno spruzzo basterà a mondarle, e tutto
sarà dimenticato. Battono di nuovo. Macbeth è atterrito: vorrebbe poter cancellare il delitto, ma
Lady, con risoluta energia, lo trascina via (Vien! vien altrove, ogni sospetto). Le loro voci si
perdono in lontananza.
8. SCENA E SESTETTO - FINALE PRIMO. Entrano Banco e Macduff: questi ha il compito di
svegliare il re ed entra nella sua stanza. Su un ritmo lento (che riecheggerà nella scena del
sonnambulismo) Banco, assalito da ferali presentimenti, crede di avvertire il suono di voci
lamentose e sentir la terra tremare (Oh qual orrenda notte). All'improvviso, mentre la musica
assume un ritmo incalzante e sempre più convulso, rientra Macduff agitatissimo e inorridito: non
riesce ad articolar parola; indica a Banco la stanza del re. Banco vi entra precipitoso, mentre
Macduff chiama tutti gridando al delitto. Entrano frettolosi Macbeth, Lady, Malcom, cortigiani e
servi, chiedendo ragione dello scompiglio. In quel mentre rientra Banco annunciando con orrore
che è stato assassinato il re Duncano. Un'esplosione compatta (Schiudi, inferno, la bocca) accoglie
il terribile annuncio. Sul motivo "Tutto è finito" si sviluppa il concertato finale. Tutti esprimono
orrore (anche Lady e Macbeth) e tutti invocano la punizione divina: essa colga l'empio e gli
imprima sul volto l'immagine di Caino.
ATTO SECONDO
Stanza nel castello.
9. SCENA ED ARIA. L'orchestra riprende il motivo "Tutto è finito" con il successivo motivo
"Donna fatale, un murmure". Macbeth entra immerso in profondi pensieri, inseguito da Lady.
Ormai il destino è compiuto: Malcom, subito fuggito in Inghilterra, è accusato di parricidio,
lasciando così il trono a Macbeth. Ma questi non dimentica che le Streghe hanno profetato Banco
padre di re. Per lui e i suoi figli ha dunque egli ucciso Duncano? È forza che scorra altro sangue:
quello di Banco e di suo figlio. E subito. Macbeth esce deciso. Lady resta sola, in attesa; e ancora
una volta invoca la tenebra notturna affinché nasconda la mano che colpirà (La luce langue): un
nuovo delitto è necessario perché l'opera sia compiuta. La voluttà del trono trasporta ora Lady in
un crescente stato di esaltazione: chi fu predetto padre di re sta ora per soccombere.
Parco. In lontananza il castello di Macbeth.
10. CORO DI SICARI. Avvolti nelle tenebre notturne due gruppi di armati s'incontrano (Sparve il
sol): hanno entrambi il compito di trucidare Banco e suo figlio. A poco a poco si nascondono in
agguato fra gli alberi del parco in attesa delle vittime.
11. GRAN SCENA. Entra Banco con il figlio Fleanzio. Le tenebre infondono nel suo animo un
tristo presagio (Come dal ciel precipita): in notte simile a questa fu ucciso Duncano; immagini
terrifiche attraversano i suoi pensieri. S'inoltra col figlio nel parco, scomparendo. D'un tratto si
sente la sua voce gridare al tradimento e si vede Fleanzio che attraversa correndo la scena, invano
inseguito da un sicario. La musica si spegne in un bisbiglio sul calare della tela.
Magnifica sala [nel castello di Macbetb). Mensa imbandita.
12. FINALE SECONDO. Nella sala vi è un grande banchetto imbandito. Macbeth e Lady sono in
scena; a poco a poco entrano nobili scozzesi e dame. La musica attacca con accento che sembra
deliberatamente volgare. Macbeth e Lady recitano la parte di ospiti cortesi e generosi. Invitando
ciascuno a prendere posto, Macbeth chiede alla moglie di intonare un brindisi. Ed ella risponde con
prontezza (Si colmi il calice); il suo canto è tuttavia secco, nervoso, come di persona che stenta a
dominare il proprio isterismo. E tuttavia tutti rispondono giocondi al suo canto. Mentre il motivo
del brindisi viene ripreso come eco dall'orchestra, un sicario appare sulla porta: Macbeth lo vede e
subito gli si avvicina parlando sottovoce; nota il suo volto sporco di sangue: è sangue di Banco! E il
figlio? Fuggito! Mentre riprendono le note gioiose del banchetto, Lady nota il volto preoccupato
del marito (Fleanzio è riuscito a sfuggire all'agguato); fingendo mestizia per l'assenza del
"valoroso" Banco, Macbeth decide di sedersi in sua vece nel seggio assegnatogli. Ma, come fa per
sedersi, improvvisamente vede che su quel seggio vi è già seduto lo spettro di Banco con i capelli e
il volto insanguinati! Macbeth è atterrito e fra lo stupore generale si rivolge allo spettro, da lui
solo veduto (Di voi chi ciò fece?). Lady si scusa con gli ospiti: si tratta di un malore fugace. Ma il
marito è assalito dal terrore: perché lo spettro non parla? e può la tomba restituire al mondo gli
uccisi? Lo spettro sparisce. Lady s'avvicina a Macbeth sussurrandogli "voi siete demente!". Poi ad
alta voce, con simulata calma, lo invita a risvegliare negli ospiti la gioia. Macbeth, scusandosi,
chiede che si riprenda il brindisi. Lady non si fa pregare: lo riprende questa volta in onore
dell'"inclito Banco", e tutti partecipano al suo canto. Ma un urlo di Macbeth, che vede riapparire lo
spettro, strozza nelle gole il brindisi (Va! Spirto d'abisso): la visione di Banco, fiammeggiante di
sangue, lo sguardo fisso a lui rivolto, provoca in Macbeth un attacco isterico; no, è inutile che lo
spettro minacci; Macbeth non sa tremare di paura. "Fuggi, fantasma, fuggi!" E fa per scagliarsi
stillo spettro. Questi di nuovo sparisce. La sua scomparsa sembra ridare vita a Macbeth, che
tuttavia, scosso nella propria sicurezza, è ora costretto ad agire sotto l'influsso del vaticinio delle
Streghe; e alle Streghe si propone di ritornare, perché gli rivelino il futuro (Sangue a me
quell'ombra chiede). Solo Lady rimane imperturbabile biasimando sottovoce la viltà del marito: chi
morì non può tornare in vita. Ma in tutti ormai comincia a penetrare il sospetto; Macduff intuisce
che la Scozia è governata da una mano maledetta e in tutti nasce la convinzione che essa è ormai
diventata una spelonca di ladroni.
ATTO TERZO
Un'oscura caverna. Nel mezzo una caldaja che bolle. Tuoni e lampi.
13. CORO D'INTRODUZIONE - INCANTESIMO. Le Streghe sono già in scena che si muovono
in circolo intorno a una grande caldaja (Tre volte miagola la gatta in frega), versandovi - dopo una
triplice invocazione alla gatta, all'upupa e all'istrice - intingoli magici; per tre volte risuona il loro
canto sguaiato mentre gettano nel brodo infernale dapprima il rospo venefico, il pruno spinoso, la
radica; quindi la lingua di vipera, il pelo di nottola, il sangue di scimmia; da ultimo il dito di un
pargolo strozzato sul nascere, il labbro di un Tartaro, il cuore di un eretico. Infine, come invasate
dal demonio, si scatenano in una ridda generale.
14. BALLO. Allo squillo delle trombe la scena si riempie di spiriti, diavoli, streghe: tutti iniziano a
danzare intorno alla caldaja. Alla fine sospendono la danza e si riuniscono per invocare Ecate, la
dea della notte e dei sortilegi. Stanno per riprendere la danza, quando fra lampi e tuoni appare
Ecate.Tutti stanno religiosamente atteggiati e quasi tremanti contemplano la dea. Ecate fa capire
alle streghe che conosce l'opera loro, per la quale è stata invocata. Le Streghe indicano a Ecate la
caldaja, che essa esamina attentamente (mentre in orchestra risuona una nobile melodia di
violoncello e fagotto). Infine Ecate annuncia che re Macbeth verrà a interrogarle sul suo destino:
esse dovranno soddisfarlo. Se le visioni abbattessero troppo i suoi sensi, esse invocheranno gli
Spiriti Aerei per risvegliarlo e ridonargli vigore. Tutte stanno rispettose ricevendo i decreti della
dea. Fra lampi e tuoni Ecate scompare nell'aria. Inizia a questo punto una danza vivacissima
(Valzer). Alla fine tutte circondano la caldaja, e prendendosi per le mani l'un l'altra formano un
circolo danzando. Spiriti e diavoli si dileguano.
15. GRAN SCENA DELLE APPARIZIONI. Le Streghe si raccolgono intorno alla caldaja
menando la polta. Entra Macbeth; si arresta un istante all'ingresso per dire ai suoi soldati di
attenderlo in silenzio; quindi si rivolge alle Streghe per sapere il futuro a costo di rinnovare la
guerra fra cielo e inferno, e chiede che esso gli sia rivelato dalle potenze occulte. Il tema degli
ottoni, che aveva risuonato nel preludio, introduce la scena delle apparizioni, che le Streghe ora
invocano (Dalle basse e dall'alte regioni); il loro canto non è più sguaiato, ma è ora solenne e
profetico. All'improvviso scoppio di un fulmine sorge una testa coperta d'elmo che avverte
Macbeth di guardarsi da Macduff. Macbeth vorrebbe interrogarlo, ma l'ombra non vuole richieste.
Al rumore d'un tuono appare il fantasma di un fanciullo insanguinato; gli dice parole che lo
porteranno alla rovina: potrà essere sanguinario, feroce; nessun nato di donna potrà nuocergli. In
uno scatto di gioia ferina Macbeth giura morte a Macduff. Ancora tuoni e lampi; sorge un fanciullo
con la corona regale in testa, recante un arboscello: predice a Macbeth che sarà invincibile fino a
che la foresta di Birnam non si muova contro di lui. Macbeth a tale annuncio esplode di gioia:
nessuna foresta s'è mai mossa! Tuttavia chiede alle Streghe se la progenie di Banco regnerà. Esse
lo diffidano dal fare tale richiesta; ma egli lo vuole e fa per lanciarsi su loro con la spada, quando
improvvisamente la caldaja sparisce inghiottita dal terreno. Al suono sotterraneo di cornamuse le
Streghe per tre volte invocano le ombre di apparire. Otto re passano lentamente, l'uno dopo l'altro.
All'apparizione del primo re, Macbeth gli urla di sparire (Fuggi, regal fantasima). Via via che le
ombre appaiono e scompaiono Macbeth è colto da un terrore crescente. Da ultimo appare Banco,
con uno specchio in mano sul quale si riflette l'immagine di altri re. Macbeth lo riconosce (Oh! mio
terror! Dell'ultimo), e in un impeto d'ira irrefrenabile si avventa sullo spettro di Banco, finché,
esausto, avuto conferma dalle Streghe che i re vivranno, cade svenuto. Le Streghe, eseguendo il
comando di Ecate, invocano gli Spiriti Aerei perché ridonino "la mente al Re svenuto".
16. CORO E BALLABILE. A poco a poco scendono gli Spiriti Aerei (Ondine e silfidi, dall'ali
candide); mentre le Streghe intonano la danza, ondine e silfidi volteggiano intorno al re svenuto,
intrecciando "carole armoniche" allo scopo di confortarne i sensi. Alla fine le Streghe si dileguano
e gli Spiriti Aerei spariscono d'incanto, in un sussurro d'ali.
17. SCENA E DUETTO - FINALE TERZO. Macbeth rinviene maledicendo l'incontro con le
Streghe. Sopraggiunge Lady, sempre intenta a sorvegliare il marito. Macbeth le riferisce le
profezie delle tre apparizioni; e tuttavia la stirpe di Banco regnerà. Lady s'infuria: sia sterminata
l'iniqua razza! Accanto a lei Macbeth ritrova coraggio: sia bruciato il castello di Macduff, muoiano
la sua consorte e i suoi figli, si persegua il figlio di Banco. Le due voci si uniscono in un proposito
di morte e di strage (Ora di morte e di vendetta); lo ha decretato il fato: iniziata nel sangue, la
vendetta deve compiersi nel sangue. In un frenetico incalzare di ciechi propositi il loro canto viene
suggellato da risate isteriche.
ATTO QUARTO
Luogo deserto ai confini della Scozia e dell'Inghilterra. In distanza la foresta di Birnam.
18. CORO DEI PROFUGHI SCOZZESI. Sul rullo dei timpani un corale intonato nel registro
grave dagli ottoni introduce il coro dei profughi scozzesi che rimpiangono la terra natale (Patria
oppressa!). La figura ritmica del lamento accompagna il loro canto, un canto sommesso, come
rassegnato, ripiegato in se stesso, incapace di volo, scandito sul ritmo di una squilla che suona a
morto, che alla fine si spegne sul suono acutissimo dei violini.
19. SCENA ED ARIA. Tra i profughi è Macduff, prostrato dal dolore per la morte dei figli e della
moglie trucidati da Macbeth. Rimpiange di non aver potuto essere a loro di scudo (Ah, la paterna
mano): supplica Dio di trarlo in faccia al tiranno e, solo se questi gli sfuggirà, possa essere egli
perdonato. A suon di tamburo e al ritmo di una vivace marcia militare entra il giovane Malcom
alla testa di molti soldati inglesi. Non sa dove si trovi, ma appreso di trovarsi presso la foresta di
Birnam, Malcom ordina che ogni soldato svelga un ramo che, portato "innanzi a sé", lo nasconda; e
infine comanda di partire all'attacco. Il suo tono deciso infiamma il cuore dei profughi. Brandendo
le spade, Malcom e Macduff spronano a liberare la patria dal tiranno (La patria tradita).Tutti
rispondono compatti al grido di battaglia per salvare gli oppressi.
Sala nel castello di Macbeth, come nell'Atto primo.
20. GRAN SCENA DEL SONNAMBULISMO. Una lunga introduzione strumentale, il cui tema
aveva risuonato nel preludio dell'opera, prepara il clima nel quale sta per compiersi il dramma
finale di Lady Macbeth. Un medico e una dama attendono la sua apparizione. Ella entra
lentamente come sonnambula, portando un lume. Lo depone e quindi si sfrega le mani facendo
l'atto di cancellare qualche cosa (Una macchia è qui tuttora!): sono macchie di sangue che le
ricordano il regicidio: l'ora fatale, la viltà di Macbeth, il sangue, oh quanto sangue, di Duncano. E
queste macchie che nessun balsamo potrà mai cancellare su una pur piccola mano! E poi il ricordo
di Banco spento: chi morì non può risuscitare... Una cellula melodica in orchestra che suona come
un rantolo accompagna le ultime parole della sonnambula: a letto! Macbeth, a letto! non si può
disfare ciò ch'è stato fatto; andiamo, Macbeth; non esser codardo, andiamo... andiamo... Sulla
cadenza finale Lady Macbeth esce di scena e la sua voce si perde in lontananza su una nota
sopracuta.
Sala nel castello [di Macbeth).
21. SCENA ED ARIA. Su una violenta esplosione orchestrale che risuona come eco della battaglia
in corso, irrompe in scena Macbeth e subito inveisce contro i traditori scozzesi che si sono alleati
agli Inglesi: nessun nato di donna può nuocergli, hanno profetato le Streghe; e dunque non teme le
schiere nemiche guidate da un fanciullo (Malcom).Tuttavia non si sente più tanto sicuro; assalito
dallo scoramento, avverte la vita inaridirsi nelle vene. Giunto all'approdo della vecchiaia, non ha
più il conforto di nobili sentimenti (Pietà, rispetto, amore), né può sperare "soavi accenti" sulla sua
pietra tombale: solo la bestemmia accompagnerà la sua nenia funebre e il ricordo della sua vita.
22. SCENA E BATTAGLIA. Si sente un trasmestio all'interno e si ode un lamento di donne;
sopraggiunge la Dama di Lady:"è morta la Regina!". Con indifferenza e sprezzo Macbeth
esclama:"la vita che importa?...è il racconto d'un povero idiota". Entrano i suoi guerrieri per
avvertirlo che la foresta di Birnam si sta muovendo. Benché deluso dall'infernale presagio delle
Streghe, Macbeth non arretra: chiede corazza e spada e ordina ai suoi di correre alla battaglia: o
vittoria o morte!
Intanto la scena si muta a vista, e presenta una vasta pianura circondata da alture e boscaglie. Il
fondo è occupato da soldati inglesi, i quali lentamente s'avanzano, portando ciascuno una fronda
dinanzi a sé. In orchestra lo squillo delle trombe dà l'avvio a un brano fugato (Battaglia): il corrersi
dietro che fanno i soggetti e contrasoggetti, l'urto delle dissonanze, il frastuono strumentale
esprimono la battaglia in corso. Macduff ordina di togliere le fronde e di metter mano alle armi, e
subito accorre dove più ferve la lotta. Entra in scena Macbeth incalzato da Macduff, che gli rivela
di non essere nato di donna, perché strappato dal ventre della madre già morta. Macbeth è al
colmo dello spavento; disperatamente battendosi con Macduff esce di scena. Entrano agitatissime
donne e fanciulli scozzesi pregando per i propri uomini. D'un tratto cessa il fragore delle armi.
23. INNo DI VITTORIA - FINALE. Di lontano echeggiano grida di vittoria. Entra Malcom
seguito da soldati inglesi, i quali trascinano prigionieri i guerrieri di Macbeth; con lui è Macduff
insieme a guerrieri scozzesi e a bardi (i poeti popolari degli antichi popoli celtici). Malcom chiede
di Macbeth: Macduff lo informa d'averlo già trafitto e piegando un ginocchio a terra saluta
Malcom come nuovo re. Tutti si uniscono unanimi al saluto. Indi i bardi intonano un inno di
vittoria, accompagnandolo sulle cetre (Macbeth, Macbeth ov'è?), inno dal ritmo marziale che
sembra fugare gli incubi della notte con i suoi orrori e le sue streghe. Sull'inno dei bardi si eleva
infine, luminoso e solenne, il canto di ringraziamento delle donne (Salgan mie grazie).
I Masnadieri
Melodramma in quattro parti di Andrea Maffei
Prima rappresentazione: Londra, Her Majesty's Theatre, 22 luglio 1847
L'argomento deriva dalla tragedia in versi Die Rauber, opera d'esordio di Friedrich Schiller
(Marbach, 1759 -Weimar 1805), rappresentata con grande successo a Mannheim il 12 gennaio
1782. Cominciata a circolare in versione rabberciata su alcune scene milanesi e veneziane già in età
giacobina, ebbe poi grande fortuna in Italia dapprima attraverso un'edizione clandestina apparsa
nel 1832, quindi nella traduzione in prosa di Andrea Maffei pubblicata nel 1846 La scelta
dell'argomento da parte di Verdi maturò durante il periodo di convalescenza trascorso appunto
con Maffei a Recoaro nell'estate del 1846; il proposito era quello di destinare il dramma alla
Pergola di Firenze. Sembra che in autunno buona parte del libretto fosse già stata musicata.
Tuttavia, venuto a mancare alla Pergola un tenore della forza di Fraschini, il compositore risolse
di affrontare per Firenze un dramma di Shakespeare che gli stava molto a cuore, il Macbeth,
destinando l'argomento schilleriano a quello che può considerarsi la più antica roccaforte
dell'opera italiana all'estero, l'Her Majesty's di Londra. Verdi terminò la composizione dei
Masnadieri alcune settimane dopo essere giunto nella capitale inglese (vi era arrivato il 7 giugno,
precedutovi dall'allievo Emanuele Muzio), cioè non prima d'aver ascoltato la voce di Jenny Lind,
stella di prima grandezza nel firmamento canoro di quel tempo, cantante che il compositore
giudicò "artista in tutta l'estensione del termine", con "una agilità senza pari", ma la cui bravura di
canto secondo lui peccava "in fioriture, in gruppetti, in trilli, cose che piacevano nel secolo passato,
ma non nel 1847". Le altre parti principali furono destinate al giovane e quasi sconosciuto tenore
parmigiano Italo, Gardoni, al baritono Coletti (che Verdi aveva avuto fra i primi interpreti di
Alzira, e per il quale nutriva un'alta considerazione) e al basso Lablache, uno dei massimi cantanti
dell'epoca, ammirato sia da Rossini che da Wagner. Alla prima recita il successo fu molto caloroso,
quasi trionfale; ma nelle poche repliche che seguirono l'esito andò sensibilmente calando. Assai
migliore fortuna arrise all'opera in Italia, dove entrò subito in repertorio. Per tutto il corso degli
anni 1850 e oltre, I masnadieri gareggiarono per frequenza di allestimenti sulle scene italiane in
patria e all'estero con le opere più eseguite del compositore. Furono rappresentati anche in una
versione francese dal titolo Les Brigands (1870). Nell'ultimo ventennio dell'Ottocento le
rappresentazioni diradarono alquanto, ma l'opera non scomparve del tutto, almeno nei teatri
minori: ancora nel 1903 la si rappresentava al teatro Fossati di Milano. Dopo un trentennio di
pressoché totale silenzio, una prima timida ripresa si ebbe in Germania al tempo della VerdiRenaissance (Barmen, 1928). Ma per il definitivo ritorno alle scene attuali occorrerà attendere
l'allestimento realizzato al Maggio Musicale Fiorentino nel giugno del 1963.
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
AMALIA, orfana, nipote di prima donna Jenny Lind
MASSIMILIANO, conte di Moor, reggente primo basso profondo Luigi Lablache
CARLO figli di lui primo tenore Italo Severo Gardoni
FRANCESCO figli di lui primo basso cantante [baritono] Filippo Coletti
ARMINIO, camerlengo della famiglia reggente secondo tenore Leone Corelli
MOSER, pastore secondo basso Stefano L. Bouché
ROLLA, compagno di Carlo Moor secondo tenore Dal Fiori
Coro di giovani traviati poi masnadieri, donne, fanciulle, servi
Scena: L'azione succede in Germania [recte Boemia], al castello dei Moor e nella vicina foresta Epoca:All'inizio del
secolo XVIII; l'azione dura circa tre anni
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
1. PRELUDIO. Contribuisce a stabilire l'atmosfera del dramma. Consiste praticamente, preceduta
da un breve tempestoso avvio, in una romanza per violoncello, scritta per il celebre Alfredo Piatti,
primo violoncellista al Her Majesty's Theatre.
PARTE PRIMA
Taverna al confine della Sassonia.
2. SCENA E ARIA [CON CORO] . Carlo Moor è immerso nella lettura di un libro di Plutarco
(Quando io leggo in Plutarco); biasima il tempo che scorre imbelle. Oh, rivivesse una scintilla di
Arminio, onde far libera tutta la Germania. Dall'interno s'ode il coro di una banda di giovani "eroi
da strada" inneggianti alla vita brigantesca (Col pugnale e col bicchier). Sono i suoi attuali
compagni, che Carlo disprezza e che vorrebbe abbandonare al loro destino, pur di tornare al
castello paterno dopo aver ottenuto il perdono del vecchio padre che lo ha allontanato. Assalito
dalla nostalgia, il suo pensiero corre alle foreste della sua terra e al casto amore di Amalia, che
vorrebbe poter riabbracciare (O mio castel paterno). Parecchi giovani entrano frettolosi; con loro è
Rolla, che gli reca una lettera. Carlo gliela strappa di mano e tremante d'emozione la apre, nella
speranza che essa gli annunci il perdono paterno. La legge, sbianca in volto e fugge precipitoso
lasciando cadere la lettera. Rolla la raccoglie e ne legge il contenuto: è un messaggio del fratello di
Carlo, Francesco Moor, che lo avverte di non tornare al castello, pena l'essere rinchiuso in un
oscuro carcere; il padre lo bandisce per sempre. Carlo ritorna fieramente agitato imprecando
contro coloro che hanno respinto le sue suppliche; quindi accetta la proposta di Rolla e dei giovani
di formare una masnada e di esserne loro capo e condottiero.Tra gli evviva dei compagni egli trae
la spada e impone loro un giuramento di fedeltà (Nell'argilla maledetta). Poi tutti partono
tumultuosamente.
Franconia. Camera nel castello dei Moor
3. RECITATIVO E ARIA. Il brutale vigore del preludio introduttivo sembra voler significare
l'indole infernale del personaggio in scena, Francesco Moor, il fratello minore di Carlo. È
soddisfatto d'aver sostituito la lettera con la quale il padre concedeva a Carlo il perdono: la natura
lo fece cadetto, e sulla natura, nella persona del padre, ora vuole vendicarsi castigando il fratello.
Diritto e coscienza sono solo spauracchi per le timorate coscienze. Ora quel vecchio di suo padre
vive a stento; basta un soffio a spegnerlo. Ma se lento è il corso della natura, egli lo affretterà (La
sua lampada vitale); gli basta trovare un pugnale e nascondere la mano che lo stringe.Vede con
gioia avanzarsi Arminio. Con tono concitato gli ordina di travestirsi e di andare dal vecchio padre
con la notizia che Carlo è caduto in battaglia: certamente il vecchio ne morrà di dolore. Arminio
esita: teme di non essere creduto. Ma Francesco lo rassicura: gli fornirà una tale prova da
ingannare chiunque. Arminio parte. Francesco esulta al pensiero di diventare presto signore del
castello e prorompe in una terribile promessa di orrori (Tremate, o miseri!): finalmente si rivelerà
nel suo vero aspetto; non più gioia e riso, non più indulgenza, ma dolori e lagrime, affanni e
sospetti regneranno d'ora in poi.
Camera da letto nel castello.
4. SCENA E CAVATINA. La scena è introdotta da un preludio per flauto, oboe e clarinetto.
Massimiliano Moor è addormentato su una seggiola. Amalia si accosta pian piano e si ferma a
contemplarlo. Prega perché il suo sonno sia tranquillo; anche se ha bandito l'adorato Carlo,
tuttavia Amalia non prova risentimento nei suoi confronti. Poi come colta da un pensiero
improvviso ricorda il suo amato, il suo sguardo, il suo sorriso, i suoi baci (Lo sguardo avea degli
angeli); ma quel vortice di ebbrezza è ormai solo un sogno! L'estasi amorosa non tornerà più.
5. DUETTO. Massimiliano addormentato sogna, mormora il nome dei suoi due figli. Infine si
desta di soprassalto e vede Amalia: pensando al destino di Carlo, supplica la giovane di non
maledirlo. Ella lo rassicura. Il vecchio padre lamenta la lontananza del primogenito; caro è il
pianto all'uomo che muore, ma per lui chi piangerà? (Carlo! Io muoio). La risposta di Amalia
esprime un'ansia di morte, un anelito a spaziare nell'eternità con Carlo.
6. QUARTETTO - FINALE PRIMO. Immediatamente si presenta Francesco, seguito da
Arminio, travestito, che racconta al vecchio conte di aver visto Carlo durante la battaglia di Praga
combattere arditamente e poi cadere più volte ferito a morte. Francesco fa per avventarsi su
Arminio perché interrompa il racconto, ma Massimiliano gli fa cenno di continuare. Prima di
morire, però, Carlo gli consegnò la spada da portare a suo padre con il seguente messaggio: il
figlio che avete rinnegato morì disperato combattendo fra l'armi; la, sua ultima parola fu per
Amalia. Ignorando gli accenti disperati di Massimiliano e della giovane, Francesco mostra la spada
e legge il messaggio che Carlo vi incise col sangue: "Dal giuro, Amalia, ci scioglie la morte, sii tu,
Francesco, d'Amalia consorte". Nell'udire queste parole Amalia grida disperata: Carlo, tu non mi
amasti mai! Massimiliano invoca su di sé l'ira del cielo (Sul capo mio colpevole); ma poi si getta con
ira su Francesco, invocando che gli sia reso il figlio. Amalia cerca di consolare il vecchio,
ricordandogli che la felicità è solo in cielo. Assistendo alla scena Francesco si compiace nel vedere
il vecchio padre distrutto dall'ira e dal rimorso. Intanto Arminio, commosso dal dolore di
Massimiliano, esprime la sua vergogna. Alla fine Massimiliano ancora una volta grida di rendergli
il figlio, quindi stramazza al suolo. Amalia lo grida morto, mentre Francesco esulta: ora è lui il
signore!
PARTE SECONDA
Recinto attiguo alla chiesa del castello. Vi sorgono in disparte alcuni sepolcri gotici. In uno recente è scolpito
il nome di Massimiliano Moor
7. SCENA E ARIA. Sono passati tre mesi. Francesco ora è il padrone e vive tra festini e baldorie.
Amalia, fuggita furtiva dal banchetto, sta genuflessa innanzi al sepolcro di Massimiliano. Dopo
breve silenzio si rialza. D'improvviso l'orchestra tace, interrotta da un canto festoso che proviene
dall'interno: sono i seguaci di Francesco che inneggiano ai piaceri della vita (Godiam, ché fugaci
son l'ore del riso). Amalia è inorridita: Francesco sta tripudiando sulossa del padre! Volgendosi alla tomba pensa che Massimiliano è ora in luogo dove non può udire
l'esecrata voce del figlio snaturato. Alza gli occhi al cielo e le sembra di vedere Carlo e suo padre
uniti nella gioia, mentre lei rimane a soffrire sulla terra (Tu del mio Carlo al seno); oh, quanto
invidia l'avello di Massimiliano! Entra Arminio agitato: rivela ad Amelia che Carlo e Massimiliano
sono ancora vivi; quindi fugge senz'altro aggiungere. All'inattesa notizia Amelia dà libero sfogo
alla sua gioia (Carlo vive?...): l'universo intero ora le sorride d'amore.
8. SCENA E DUETTO. Viene raggiunta da Francesco, che le chiede perché si sia assentata dalla
festa. Per pregare sulla tomba di tuo padre, gli risponde la giovane. Ma Francesco rimprovera ad
Amalia un dolore che nasconde la sua bellezza. E si getta ai suoi piedi dichiarandosi suo schiavo in
amore e offrendole mano e cuore (Io t'amo, Amalia!); la giovane lo respinge con furore e
ripugnanza: all'infame talamo non salirà mai con Francesco. Questi tenta di trascinare con la forza
Amalia, non più per essere• sua moglie, bensì come "druda e serva". Amalia dapprima reagisce con
forza; infine, per difendersi dalla tracotante furia di Francesco, simula d'abbracciarlo e gli strappa
la spada dalla cintola minacciando di trafiggergli il cuore (Ti scosta, o malnato). Francesco
inveisce insolentendo la "vil femminetta" e a sua volta minacciandola di "catene, flagelli, tormenti".
La selva boema. Praga in lontananza mezzo nascosta fra gli alberi.
9. SCENA E CORO. Due gruppi di masnadieri appaiono ai lati opposti scambiandosi le ultime
notizie (Tutto quest'oggi le mani in mano): Rolla è stato fatto prigioniero e il giorno stesso sarà
impiccato; saputo questo, il loro capo ha giurato di vendicarsi bruciando Praga. Di lontano si vede
rosseggiare fra gli alberi una fiamma: il capo ha mantenuto la parola! Sul frastuono si levano grida
di terrore, e dagli alberi sbucano donne scapigliate con fanciulli che attraversano la scena gridando
al soccorso. Entra infine, fra la sorpresa generale, Rolla con altri masnadieri: arriva "dalla forca
dritto filato", ma non ha fiato per continuare; chiede dell'acquavite e fa raccontare dai masnadieri
entrati con lui come fu tratto salvo dal patibolo (I cittadini correano alla festa): approfittando della
festa lanciarono canapi incendiati che fecero saltare in aria la polveriera; la paura si impadronì del
nemico e grazie all'ardimento di Carlo il suo capo fu tratto dal laccio. Tutti esultano ammirati da
tale impresa. Entra Carlo, mesto e commosso: avverte la masnada che si partirà alla prossima
aurora. Rolla e i masnadieri si sparpagliano nel bosco; il loro canto si perde in lontananza.
10. RECITATIVO E ROMANZA. Rimasto solo, Carlo contempla il sole che tramonta "splendido
e grande" come la morte di un eroe. La natura è "bella e stupenda"; ma per lui il paradiso s'è
tramutato in inferno. Ha per compagni dei briganti ed egli si è ormai incatenato al crimine (Di
ladroni attorniato); reietto in terra e maledetto in cielo, sente la sua pena ancor più crudele
allorché il pensiero corre a quell'angelo di Amelia.
11. FINALE SECONDO. Rolla e i masnadieri tornano in scena per avvertire il loro capo di essere
accerchiati da mille soldati. Carlo si rifà spietato e rianima lo spirito dei compagni. Fanfare, corni e
trombe danno l'avvio a un canto di sfida e di guerra (Su, fratelli! corriamo alla pugna).
PARTE TERZA
Luogo deserto che mette alla foresta presso il castello.
12. SCENA E DuErro. Una musica dal ritmo affannoso introduce l'ingresso di Amalia, fuggita per
sottrarsi agli "artigli" di Francesco. È finalmente sola e salva. Ma il suo sollievo è di breve durata:
i suoi pensieri vengono interrotti dal lontano suono di un canto brutale di masnadieri, dalle parole
allarmanti (Le rube, gli stupri). Amalia si sente perduta: capisce di essere caduta in mano "de'
ladroni". Qualcuno si muove fra gli alberi e si sta appressando. Amalia, senza guardare, implora
pietà. Ma è Carlo, che subito la riconosce. I due volano l'uno nelle braccia dell'altro in
un'esplosione di gioia. Poi, ricordandosi d'aver appena udito un canto orrendo, Amalia si scioglie
dall'abbraccio: bisogna fuggire da quel posto. Ma Carlo la conforta; ella sarà sicura con lui (ma
intanto prega fra sé perché Amalia non sappia mai in quale abisso è caduto). La giovane racconta di
averlo creduto morto (Qual mare, qual terra); Carlo è vivamente commosso dal pianto della
giovane. In un rapido dialogo Amalia mette Carlo al corrente della nuova situazione: il padre è
morto e Francesco, nuovo signore, l'ha minacciata di morte per obbligarla a sposarlo. Malgrado gli
affanni i due gioiscono per essersi ricongiunti (Lassù risplendere più lieta); Amalia si stringe con
entusiasmo. a Carlo: lo seguirà fino alla morte. Ma il giovane sente che la loro unione si realizzerà
solo in cielo.
Interno della foresta. Sorgono, in mezzo, le rovine di un'antica rocca. È notte.
13. CORO DI MASNADIERI. Il canto che Amelia aveva udito nella scena precedente risuona ora,
preceduto da una minacciosa introduzione orchestrale, con nuova violenza: è un inno assetato di
sangue che esalta la vita dei masnadieri: stupri, incendi, assassinii non sono che un gioco per loro
(Le rube, gli stupri, gl'incendi, le morti). Il loro motto è quello di scacciare oggi la noia perché il
boia domani li strangolerà. Fieri d'essere liberi, la loro vita è dedita al piacere. Una grotta è la loro
casa, il bosco il quartiere. Una volta è la pietà di una donna, una volta la generosità di un fittavolo
a sfamarli. I lamenti dei padri uccisi, delle madri o delle spose sono musica per le loro orecchie. Poi
quando giungerà l'ora della morte coglieranno la ricompensa per le loro azioni e, innaffiate le gole
dell'ultimo vino, con un salto raggiungeranno l'altro mondo.
14. FINALE TERZO. Sopraggiunge Carlo, salutato dai compagni; subito ordina alla masnada,
essendo notte fonda, di coricarsi. La masnada obbedisce e canticchiando si addormenta. Addolorato
per aver deluso Amalia, Carlo contempla i briganti addormentati: a lui è negato il sonno. E riflette.
La vita è un cupo arcano (O vita, tenebroso mistero°. Come attirato dall'abisso dell'eternità, cava
dalla cintura una pistola per infrangere il mistero della vita. Ma darsi morte sarebbe fuggire dagli
affanni: no, meglio vivere soffrendo. E getta l'arma. Un furtivo movimento degli archi avverte che
qualcuno sta arrivando. Carlo si ritira fra gli alberi. Appare Arminio che cautamente s'accosta
all'inferriata della torre e chiama il misero abitatore, per avvertirlo che è arrivata la cena. Dal
sotterraneo risponde una voce cavernosa che invita a calare il cestino nella fossa. Arminio esegue e
fa per andarsene, quando Carlo salta fuori e lo acciuffa per le spalle chiedendogli a chi appartenga
quella voce, che continua a chiamare. Di nuovo risuona la voce da sottoterra. Arminio si divincola
e fugge. Carlo scuote le catene ed apre il cancello, e ne tira fuori un vecchio attenuato come uno
scheletro. Lo riconosce: è Massimiliano, suo padre! Con crescente stupore, senza farsi a sua volta
riconoscere, viene a sapere che il poveretto è stato sepolto vivo dal figlio Francesco. Massimiliano
gli racconta d'aver appreso da un ignoto pellegrino che il figlio Carlo era morto (Un ignoto, tre
lune or saranno); il dolore della notizia lo aveva fatto cadere in un lungo sopore. Credendolo
morto, Francesco lo fece rinchiudere in una cassa. Ma prima che il coperchio fosse chiuso, egli
emise un lamento. Scoprendolo ancora vivo Francesco ordinò che lo gettassero in quell'orrido
covo: "Troppo ei visse!". Finito il racconto, Massimiliano sviene. Carlo trae la pistola e spara un
colpo per destare la masnada. Ai compagni, balzati in piedi, addita il vecchio svenuto: sepolto vivo
da un figlio infernale, quell'uomo è suo padre! Con furia repressa da un tono solenne, giura di
trarre vendetta entro l'alba. Quindi, rivolgendosi ai masnadieri, li chiama a essere ministri di
giustizia. I masnadieri s'inginocchiano per apprestarsi al giuramento. Ponendo una mano sul capo
del vecchio svenuto, Carlo impegna solennemente sé e i compagni a diventare strumento della
vendetta divina (Giuri ognun questo canuto santo crin di vendicar!). I masnadieri giurano
(Struggitrice ira di Dio). Alla fine tutti si disperdono in tumulto. Carlo s'inginocchia innanzi al
padre.
Clara Maffei
Andrea Maffei
PARTE QUARTA
Fuga di parecchie stanze.
15. SOGNO. Francesco entra precipitoso e stravolto. È visibilmente terrorizzato: gli gridano
"Assassino!". Accorre Arminio con alcuni servi. Francesco ordina loro di condurgli il pastore.
Arminio lo vede tremante. Francesco l'afferra per un braccio: "risorgono i morti?" e lo invita ad
ascoltare il racconto di un sogno (Pareami che sorto da lauto convito): dormiva in un giardino
quando un sordo muggito lo svegliò; la terra era in fiamme, le tombe rigettavano i defunti e la
pianura era ricoperta di ossa infinite. In quel punto fu tratto sul Sinai e tre splendenti figure lo
abbagliarono. La prima, tenendo in mano un misterioso codice, esclamava: "Infelice chi manca di
fede!". La seconda, recando uno specchio, diceva:"La menzogna confondesi qui". La terza librava
una lancia gridando: "Venite, figliuoli d'Adamo". E fra i nembi tonanti il suo nome risuonava per
primo! Poi la visione di una coppa gravata di misfatti, tenuta in equilibrio da un'altra, sospesa nel
cielo, ripiena del sangue versato del divino riscatto. Quand'ecco un vegliardo distrutto per fame, e
a lui noto, prese una ciocca di capelli dalla seconda coppa e la gettò in quella dei misfatti.
Cigolando la coppa discese mentre una voce di tuono gridava: "per te maledetto l'Uom-Dio non
penò". Arminio fugge con atti di raccapriccio.
16. SCENA E DUETTO. Annunciato da poderosi squilli di ottoni si presenta Moser, il pastore.
Francesco lo ha fatto chiamare per prendersi burla di Dio o perché da Dio incalzato? Quel Dio di
cui egli nega l'esistenza - tuona il pastore - già lo sente chiedergli ragione dei suoi delitti.
Francesco gli domanda scettico: se l'anima è immortale, quali peccati possono aver provocato l'ira
del Dio di Moser? Peccati inconcepibili all'umano pensiero: il parricidio e il fratricidio. Invano
Francesco, pieno d'ira, urla al pastore di tacere. In quella entra Arminio trafelato con la notizia che
uno stuolo di cavalieri sta scendendo dal monte. In grande agitazione Francesco ordina che tutti
vadano al tempio a pregare per lui. Intanto voci in lontananza gridano che la rocca è caduta.
Francesco chiede a Moser l'assoluzione; ma questi gli risponde che solo Dio può assolverlo, non
l'uomo. E pronuncia l'anatema contro di lui (Trema iniquo! il lampo, il tuono); Francesco
s'inginocchia invocando l'Eterno per la prima e ultima volta. D'un tratto, mentre risuonano sempre
più vicine le voci che gridano "la rocca è in polvere", Francesco s'alza impetuosamente urlando che
l'inferno non si farà beffe di lui, e fugge precipitosamente.
Foresta come nell'ultima scena della parte terza. Sorge il mattino.
17. SCENA E DUETTO. La scena si apre con delicati tremoli degli archi. Massimiliano è seduto
sopra un sasso; Carlo (che egli non ha ancora riconosciuto) è al suo fianco. Il vecchio pronuncia il
nome di Francesco; non sia contro di lui la vendetta: solo per se stesso sia il castigo. Che lo spirito
di Carlo lo perdoni. Carlo commosso risponde "Ei ti perdona". Poi s'inginocchia e chiede al vecchio
di benedirlo quale suo liberatore. Ponendogli una mano sul capo Massimiliano invoca su di lui la
misericordia divina. Carlo chiede d'essere baciato. Il vecchio lo bacia come farebbe un padre con il
proprio figlio (Come il bacio d'un padre amoroso); Carlo si sente trasportato in cielo.
18. GRAN SCENA E TERZETTO - FINALE ULTIMO. Una parte dei masnadieri entra e
s'accosta a Carlo a passo lento. Carlo è atterrito dalla loro presenza. Essi gli annunciano che
qualcuno è fuggito. Carlo capisce che si tratta di Francesco e, levando le mani al cielo, ringrazia
Dio. Altri masnadieri sopraggiungono trascinando Amalia coi capelli sparsi. Amalia s'accorge di
Carlo e gli butta le braccia al collo chiedendogli aiuto. Carlo tenta di sciogliersi. La donna gli si
rivolge chiamandolo "mio sposo". Massimiliano è sbalordito. Carlo, in preda al delirio, dà in
smanie; con esplosione di rabbia chiede sia trafitta la donna, svenato il vecchio, ucciso se stesso:
"Oh fossero i vivi d'un colpo distrutti!". Si rivolge a Massimiliano rivelandosi per il maledetto,
reietto Carlo. Quindi trae la spada e s'avventa, minaccioso e terribile, sulla masnada, esecrata
ministra dell'ira celeste, per poi volgersi subitaneo verso Amalia e il padre indicando loro i
masnadieri, ladri e assassini, di cui egli stesso è il capo. Stupore universale. Dopo lunga pausa
Carlo, abbattuto, si dichiara pronto a pagare il debito alla società (Caduto è il reprobo'. Amalia,
uscita di stupore, si getta di nuovo fra le braccia di Carlo: angelo o demone, non lo lascerà mai,
qualunque sia la sua sorte. Intanto Massimiliano, anch'egli tornato alla realtà e in preda al rimorso,
invoca per sé un baratro. Sul loro canto erompe con forza il coro dei masnadieri contro lo
spergiuro Carlo: mostrando le ferite che hanno nel petto gli ricordano il solenne giuramento di
dividere la vita con loro. Amalia si rivolge a Carlo: se non può infrangere il giuramento, ch'egli
almeno la uccida come pegno d'amore. D'improvviso Carlo si rivolge alla masnada: "m'avete
offerto un capo orribile d'onta coperto... io v'offro un angelo". Ciò dicendo cava il pugnale e ferisce
Amalia a morte. Tutti accorrono verso Amelia. Carlo fugge come un disperato verso il proprio
destino.
Jérusalem (Gerusalemme)
Grand opéra in quattro atti. Poema di Alphonse Royer e Gustave Vaèz
Traduzione italiana di Calisto Bassi
Prima rappresentazione: Parigi,Thatre de L'Opéra, 26 novembre 4847
Per il suo esordio sulla maggiore scena europea, quella dell'Opéra di Parigi, regno del grand opéra
di Meyerbeen Verdi stimò di ricorrere a una sua precedente opera, fornita di sufficiente apparato
spettacolare, quale I Lombardi alla prima crociata, ma rimodellata su un soggetto interamente
nuovo, pure ispirato alle Crociate, cui i due librettisti francesi seppero conferire un percorso
drammaturgico molto più coerente rispetto a quello offerto dal libretto di Solera: la vicenda ha
inizio non appena conclusosi il Concilio di ClermontFerrand nel quale viene bandita una crociata
per liberare il Santo Sepolcro; ma in luogo dell'immaginario Arvino, capitano del contingente
lombardo, vi è la figura storica del conte Raimondo di Tolosa che con Boemondo può considerarsi
il capitano autentico della prima crociata. Per questo argomento Verdi utilizzò, trasformandola e
soprattutto raffinandola nello strumentale, gran parte della musica dei Lombardi, aggiungendovi
molti brani nuovi; inoltre, com'era dí rito in un grand opéra, inserì all'inizio del terzo atto un
balletto ovvero divertissement Da segnalare fra gli interpreti della prima rappresentazione,
accanto a Duprez (il mitico 'inventore' del Do di petto), la presenza del soprano Van
r
Gelden che a quel tempo stava perfezionandosi alla scuola di Giuseppina Strepponi.
Inoltre per la prima volta all'Opéra fu utilizzata la banda di Adolphe Sax (il famoso costruttore di
strumenti, inventore del sassofono). L'opera ebbe successo ed entrò subito nel repertorio dei teatri
di lingua francese (anche in Olanda, a Pietroburgo, in Algeri e a Tunisi, a New Orleans, a
Montreal, a Soerabaya). Sulle scene italiane, dove i Lombardi erano ormai entrati stabilmente in
repertorio, l'opera ebbe solo qualche fugace apparizione: alla Scala e a Torino nel 1851, a Venezia
nel 1854, a Verona l'anno successivo, a Vercelli nel 1858, infine all'Apollo di Roma nel 1865.
Scomparsa dalle scene all'alba del nuovo secolo, Jérusalem è stata oggetto in tempi recenti di
occasionali riprese a far inizio da quella avvenuta alla Fenice di Venezia nel settembre del 1963.
Nel gennaio del 1986 l'opera è stata rappresentata a Parma in lingua originale.
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
GASTONE, visconte di Bearn
tenore Gilbert-Louis Duprez
IL CONTE DI TOLOSA basso [baritono] Charles Portehaut
RUGGERO, fratello del conte
basso Adolphe Alizard
ADEMARO di Monteil, ambasciatore di Roma
basso Hippolyte Brémont
RAIMONDO, scudiero di Gastone
tenore Barbot
Un soldato
basso E Prévost
Un araldo
basso Molinier
L'EMIRO di Ramla
basso Guignot
236
Jérusalem
Un ufficiale dell'Emiro tenore Koenig
ELENA, figlia del conte soprano Julian Van Gelder
IsAURA
soprano Muller
Cavalieri, dame, paggi, soldati, pellegrini, penitenti, un esecutore, sceicchi arabi, donne dell'harem, popolo di Ramla
Il primo atto a Tolosa nel 1093 dopo il Concilio di Clermont. Gli altri atti quattro anni più tardi, in Palestina
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
[N.B.Tra parentesi quadre sono citati i brani analoghi dei Lombardi alla prima crociata]
1 INTRODUZIONE. Questo preludio strumentale si basa su due elementi tematici: il canto di
supplica dei monaci alla fine del terzo atto (Cum judicatur exeat condemnatus) e l'inciso melodico
che apre il terzetto del quarto atto, fra loro correlati e sviluppati sì da condensare, attraverso
l'impiego dei timbri orchestrali, le principali fasi del dramma e prepararne il clima.
ATTO PRIMO
Nel palazzo de' l conte di Tolosa. - Una galleria che serve di comunicazione tra il palazzo e la cappella
alla quale si ascende per mezzo di alcuni gradini e che si vede in tutta la sua profondità. All'esterno della
galleria, una terrazza cinge il profilo del palazzo; da questa terrazza una scala scende nei giardini, che si
lasciano intravvedere solo attraverso le cime degli alberi.
2. RECITATIVO E DUO. È notte. Al levarsi della tela Elena è presso la porta che conduce agli
appartamenti del palazzo, e Gastone nel mezzo della scena che ascolta con inquietudine. Isaura,
che veglia sul fondo, lo rassicura con un gesto. È un incontro segreto. Il conte di Tolosa con le
nozze della propria figlia con Gastone desidera riconciliare le due famiglie; Gastone odia l'uomo
che gli ha ucciso il padre in un'ingiusta guerra, ma è pronto a rinunciare alle ostilità se il conte
acconsente al matrimonio. L'alba si avvicina; occorre separarsi; in un brevissimo duo, sostenuto da
nient'altro che il suono di un corno, i due giovani si dicono teneramente addio (Addio, mio cuor,
mia vita). Gastone scende per la scala in giardino; Elena lo segue con lo sguardo. Una campana
suona l'Angelus.
3. AVE MARIA. Elena rientra in scena con Isaura, e s'inginocchia pregando per la salvezza di
Gastone (Cielo pietoso, le preci intendi ["Salve Maria"]).
4. IL SORGERE DEL SOLE. Dopo aver pregato, Elena rientra con Isaura nel palazzo del conte.
L'orchestra attacca un breve interludio che descrive, attraverso un crescendo strumentale, il
sorgere dell'alba.
5. CORO. Intanto la galleria si riempie di cavalieri e di dame che salutano il giorno propizio che
unisce due cuori rivali dando tregua all'odio (Or ecco il giorno propizio ["O nobile esempio"]): con
la fine della guerra civile la crociata chiama tutti i cristiani sotto la stessa bandiera.
6. [RECITATIVO], SESTETTO E CORO. Il conte di Tolosa esce dagli appartamenti col fratello
Ruggero, Elena e Isaura; Gastone giunge dall'esterno, seguito dal suo scudiero Raimondo e da un
gruppo di cavalieri. Il conte gli tende subito la mano in segno di pace e di fratellanza. Al canto di
dolce gratitudine espresso da Gastone si contrappone, sottolineata dal tremolo degli archi, l'ira di
Ruggero. Quindi le voci si uniscono in un canto in cui si intrecciano i timori di Elena, la felicità di
Gastone, il rodimento geloso di Ruggero, la soddisfazione del conte (Oh! come l'anima balza
serena! ["T'assale, t'assale un fremito"]). Ruggero non si rassegna a vedere Elena andare sposa a
Gastone e s'allontana infuriato alla ricerca di un braccio mercenario che serva alla sua ira. Intanto
il conte invita Elena e Gastone a inginocchiarsi davanti all'altare. Giunge Ademaro di Monteil,
l'Ambasciatore di papa Urbano; egli ha l'incarico di nominare il conte di Tolosa comandante dei
crociati francesi. Nel decidere la partenza della crociata per l'indomani il conte cede a Gastone il
proprio mantello bianco in segno di reciproca lealtà: il giovane s'inginocchia, un servo toglie il
mantello dalle spalle del conte e lo pone su quelle di Gastone. Annunciato da squilli di tromba si
eleva un canto generale, alternato da brevi episodi per terzetto a cappella, che è di esaltaziòne del
Santo Sepolcro e della sua conquista cristiana (Guerrieri del Santo, del Giusto campioni
["All'empio che infrange la santa promessa"]). Il canto sfocia in una marcia scandita dal tamburo
militare: tutti entrano nella cappella.
7.CORO DI DONNE E ARIA. Accompagnato dall'organo si ode provenire dalla cappella un canto
religioso intonato da voci femminili (Se a te nell'ora infausta). Durante il coro interno riappare in
scena Ruggero, che ascolta la preghiera in silenzio; vana invocazione, egli osserva: l'amore mi ha
reso criminale; ma per ora la collera resti celata nell'ombra e nel mistero (Del mistero il più
profondo ["Sciagurata! hai tu creduto"]). Entra un soldato: è il mercenario che Ruggero ha
assoldato per far trucidare Gastone; nessuno in Tolosa lo conosce. Assicurandogli lauta
ricompensa Ruggero conduce il soldato fino ai gradini della cappella e gli indica due guerrieri con
l'armatura dorata: quegli che porta il mantello bianco è il mio amato fratello, l'altro è il mio
nemico: colpiscilo a morte. Il soldato entra furtivamente nella cappella.
8. CORO DI BEVITORI [E CABALETTA]. Entrano soldati crociati recando coppe colme di
vino, ed elevano un canto bacchico (Mentre l'ora si avvicina ["Niun periglio il nostro seno"]): sarà
fatta strage dei saraceni e nessuna fanciulla araba potrà resistere ai loro doni, al battesimo e al
buon vino. Alla fine del coro si sente ancora per un attimo il canto religioso: i soldati indicano la
cappella ed escono con rispetto. Esplode intanto l'ira gelosa di Ruggero che attendendo il
compimento del crimine invoca lo spirito del male (Ah! vien! demonio! affrettati!); alla fine si ode
ancora il canto dei bevitori.
9. FINALE PRIMO. Si sente un tumulto, delle grida; il soldato esce dalla cappella fuggendo
pallido e sconvolto: Ruggero ritiene compiuta la sua vendetta. Dalla cappella accorre lo scudiero di
Gastone seguito da alcuni cavalieri gridando all'assassinio; alcuni soldati corrono all'inseguimento.
Esce Gastone, seguito da Elena, Isaura,Ademaro, il conte e tutto il coro. Alla vista di Gastone,
Ruggero resta stupefatto. Il conte di Tolosa, gravemente ferito, scende i gradini della cappella
sostenuto da cavalieri che lo conducono negli appartamenti. Elena sta presso il padre, in preda alla
più grande disperazione. Gastone vuole trattenerla. I soldati che hanno arrestato l'assassino
ritornano con lui, e lo gettano ai piedi di Ruggero. L'Ambasciatore pontificio gli chiede chi lo ha
pagato per uccidere: il mercenario accusa Gastone. Inorriditi, tutti puntano il dito contro di lui
maledicendolo (Mostro! spergiuro! barbaro! r Mostro d'averno orribile"» mentre, a parte, Ruggero
esprime orrore verso se stesso, ed Elena implora la giustizia del cielo: Gastone non è sacrilego.
Alla fine l'Ambasciatore pronuncia l'anatema contro Gastone: si fa consegnare la spada e lo
condanna all'esilio; ogni cristiano dovrà rifiutargli sale e pane (Fu lanciato su te l'anatema ["Va!
Sul capo ti grava l'Eterno"]).
ATTO SECONDO
Montagne di Ramla in Palestina, a poche leghe da Gerusalemme. - Una caverna presso la quale si eleva
una rozza croce. Di lontano si vede la città araba di Ramla.
10. INVOCAZIONE [E RECITATIVO]. Al levarsi della tela Ruggero, i capelli bianchi,
abbigliato in un rozzo saio e cinto da un corda, è prosternato davanti alla croce; lacerato dal
rimorso è qui giunto a piedi nudi e per tre anni ha pianto in questo deserto selvaggio; dal fondo
dell'abisso in cui si trova, vede sempre davanti a sé lo spettro del fratello, ma spera tuttavia nella
clemenza del Signore (Oh! dì fatale! Oh, eccesso!... ["Ma quando un suon terribile"]). Un
pellegrino appare sulla montagna; dopo pochi passi crolla a terra estenuato dalla fatica e dalla sete,
e chiede aiuto. Ruggero accorre, stacca una fiasca dalla cintura e gli porge da bere. Il pellegrino gli
indica altri sperduti sulla montagna e torturati dalla sete; Ruggero si allontana per soccorrerli.
11. [SCENA] E POLACCA. Due persone appaiono: sono Elena e la fedele Isaura. Fermamente
convinta dell'innocenza di Gastone, Elena ha voluto recarsi in Palestina, dove si dice che egli sia
morto, e chiedere consiglio all'eremita, venerato sia dai saraceni che dai cristiani. Le due donne si
accorgono del pellegrino. Elena quasi non crede ai propri occhi: è Raimondo, lo scudiero di
Gastone! Subito gli chiede notizie in un dialogo incalzante (Del tuo signor favella). No, Gastone,
non è morto; è prigioniero a Ramla. Elena esulta di felicità (Nella speme io m'avvaloro ["Non fu
sogno!"]); ora vuole rivederlo, a rischio della vita; ha dell'oro, e troverà bene il modo di rivedere
colui che gli è sposo davanti a Dio.
12.CORO Di PELLEGRINI. Su un tema lamentoso molti pellegrini, prostrati dalla fatica e dalla
sete, entrano a gruppi sparsi; alcuni salgono il sentiero più alto della montagna e ne ritornano
scoraggiati; guardano con disperazione l'immensa solitudine che li circonda; infine tutti si
rivolgono alla clemenza del Signore invocando la via del ritorno alla patria e alle sue fresche
sorgenti (Oh! mio Dio, dunque vano è il tuo pegno? ["O Signore, dal tetto natio"]).
13. MARCIA. Si sente debolmente di lontano il suono di una fanfara. Alcuni pellegrini raccolgono
le loro forze per salire vivacemente sulle alture e ne ridiscendono gridando con gioia: arrivano i
crociati! Al suono di un marcia guerriera alcuni cavalieri accorrono annunciando la conquista di
Ramla. Ben presto arriva l'esercito dei crociati, con la fanfara in testa, che sfila dall'alto della
montagna; alcuni prestano cure ai pellegrini malati e ai feriti.
14. [SCENA E] CORO Di CROCIATI. Alla fine appaiono a cavallo il conte di Tolosa e
l'Ambasciatore papale, circondati da paggi e da cavalieri. I pellegrini si prosternano. Il conte
ringrazia Dio per essere scampato a un assassinio. Mentre l'Ambasciatore annuncia che al nuovo
giorno apparirà Gerusalemme nel suo splendore divino, rientra Ruggero: a bassa voce i soldati
esprimono la loro devozione per l'eremita. Come lo vede, il conte implora la sua benedizione;
Ruggero, sconvolto nel rivedere il fratello, può solo chinare la testa nella polvere: alludendo a un
peccato che deve essere espiato chiede di potersi unire alla crociata. Il conte, stupito, esaudisce la
sua richiesta. Alla fine egli, Ruggero e l'Ambasciatore, all'unisono, intonano il canto dei crociati,
cui tutti si uniscono in un coro finale (Il Signor ci promette vittoria!).
La scena rappresenta la sala del Consiglio dell'emiro di Ramla.
15. ARIA. Gastone, ora prigioniero, viene introdotto nella sala, essendo stato convocato
dall'Emiro; mentre aspetta, i suoi pensieri sono per Elena, che egli sa essere vicina: spezzerà ogni
catena per rivederla e riascoltare la sua 'voce (Ch'io possa udir ancora ["La mia letizia
infondere"]).
16. [SCENA E] DUETTO. Entra l'Emiro, seguito da alcuni sceicchi e da un ufficiale: dice a
Gastone che gli ha risparmiato la vita per non attirarsi la vendetta dei cristiani; ora essi marciano
verso Ramla; questo palazzo è la sua prigione: non tenti la fuga, sotto pena di morte. MI
funzionario annuncia che una cristiana travestita da araba è stata arrestata sotto le mura; chiede
che sia uccisa. Ma l'Emiro ordina di farla entrare. È Elena! I due sposi nel rivedersi cercano di
contenere l'emozione. Interrogata dall'Emiro, Elena risponde che i cristiani non attaccheranno
Ramla finché lei sarà dentro le mura della città. Il funzionario sospetta tuttavia un complotto.
Anche l'Emiro è dello stesso avviso, e lascia soli Elena e Gastone disponendo che siano sorvegliati
onde spiare le loro mosse. I due sposi, dopo tanto tempo, possono finalmente riabbracciarsi ed
esprimersi reciprocamente tutto l'affetto; tuttavia Gastone supplica vivamente Elena di tornare dal
padre (Me, che colse un anatema). Ma per Elena il rimorso d'aver abbandonato il padre è
largamente compensato dall'aver ritrovato l'amore di Gastone (D'un padre oimè! l'imagine ["O
belle, a questa misera"]). S'ode all'interno un grido d'allarmi, seguito da tumulto; dalla finestra
Gastone vede sventolare delle bandiere crociate. Per i due sposi è il momento della fuga
(Fuggiamo!... sol morte ["Ah! vieni, sol morte"]); il loro canto sovrasta le grida interne d'allarmi.
Ma al calar della tela si trovano circondati dalle guardie.
ATTO TERZO
I giardini dell'harem.
17. CORO DANZATO. Sono trascorse poche ore. Elena è rinchiusa nell'harem dell'Emiro. Le
donne dell'harem la guardano e ridono della sua disperazione; alcune le danzano intorno, altre
sono mollemente sdraiate su dei cuscini e la canzonano (La bella cattiva).
18. BALLABILI. Entra l'emiro con il suo funzionario, accompagnato da alcuni sceicchi arabi; al
loro avvicinarsi le donne si velano e si disperdono nei giardini come volo d'uccelli. Segue un
balletto di' odalische, in quattro parti (Pas de quatre, Pas de deux, Pas solo, Pas d'ensemble) e
quindici movimenti.
19. SCENA E ARIA. Terminato il balletto, il funzionario avverte che i crociati stanno per dare
l'assalto; l'Emiro confida nell'aiuto di Allah; ma se il capo dei crociati entrerà in Ramla, riceverà la
testa di sua figlia.Tutti escono per presidiare le fortificazioni. Elena, rimasta sola, prega Dio di
liberarla (Son vani i lamenti ["Se vano è il pregare"]). Improvvisamente delle donne irrompono in
scena urlando e gridando che i cristiani sono entrati in Ramla. Elena trema per Gastone; ma
questi, nel frattempo liberatosi approfittando dello spavento che aveva invaso le sue guardie, si
precipita al suo fianco; ma trema a sua volta al pensiero di trovarsi al cospetto del padre di Elena.
Entra il conte di Tolosa, furibondo nel vedere la figlia accanto al suo presunto assassino. I cavalieri
afferrano Gastone gridando "a morte!". Sì, grida Gastone: mi sia preparato il supplizio e la cieca
giustizia sparga pure il sangue di-un innocente. Elena accorre al suo fianco, scagliandosi contro la
cieca rabbia del padre: che il suo sangue ricada su di voi (No... l'ira vostra, l'indegno insulto ["No!,
no! giusta causa non è d'Iddio"]). Ma il conte non intende ragione e respinge la figlia maledicendo
il suo amore. Mentre tutti invocano la morte per Gastone, il conte afferra Elena per le bràccia e la
trascina via.
La pubblica piazza di Ramla. Un palco addobbato di nero.
20. MARCIA FUNEBRE. Mentre il sipario rimane abbassato l'orchestra suona una marcia
funebre, in cui spicca una melodia intonata dalla cornetta. Sulle ultime battute si riapre il sipario:
Gastone viene condotto sotto scorta; dietro di lui in processione un gruppo di penitenti che porta
la sua spada, il suo elmo e il suo scudo. Una gran folla si è radunata per assistere alla sua pubblica
vergogna e all'esecuzione capitale; fra di loro i suoi compagni di crociata, guidati dal conte e
dall'Ambasciatore pontificio, cui tocca pronunciare la sentenza.
21. GRAN SCENA E ARIA. Gastone protesta la propria innocenza al cospetto di Dio.
L'Ambasciatore proclama la sua morte per l'indomani, ma oggi lo dichiara infame, privandolo di
nobiltà e di cavalierato. Gastone preferisce la morte al disonore, e si rivolge ai compagni d'arme
piangendo e implorando di non essere trattato come un infame (O miei diletti compagni d'armi).
Ma invano. Un araldo ordina che la sentenza venga eseguita. Su un ritmo funebre scandito dai
timpani, un gruppo di penitenti consegna l'elmo di Gastone al carnefice; è l'elmo di un traditore. Il
carnefice lo frantuma a un colpo simultaneo di gong e di grancassa. I penitenti iniziano un canto di
preghiera, sostenuto da un solo fagotto (Cum judicatur exeat condemnatus), sul quale si eleva il
lamento di Gastone e il canto delle donne della folla, mosse a pietà. La cerimonia si ripete altre due
volte: allorché l'araldo consegna al carnefice, nonostante la protesta del condannato, lo scudo e
quindi la spada perché siano frantumati. Infine annuncia che all'alba dell'indomani la testa di
Gastone cadrà sotto la mano del carnefice. Al sommo della disperazione Gastone implora di essere
ucciso subito (Colpite alfin! L'orgoglio mio riprendo°, mentre tutti si rivolgono alla giustizia di
Dio perché nella sua equità giudichi l'anima del condannato (Empio! Fellon! la tua condanna è
scritta).
ATTO QUARTO
La scena rappresenta il limite del campo dei crociati nella valle di Josafat.
22. CORO DELLA PROCESSIONE. Alcuni soldati vigilano l'entrata d'una tenda principale.
Ruggero contempla la lugubre valle da cui si scorge la vista di Gerusalemme: sente che la morte è
vicina. In lontananza si ode un coro: (Gerusalem!... la grande, la promessa città!): all'appressarsi del
combattimento i crociati invocano il favore di Dio. All'ingresso di Elena, che avanza in mezzo alle
donne, la melodia di un oboe prepara l'intervento dei bassi del coro che indicano il monte Oliveto
(Sovra quel colle il Nazaren piangea), il luogo del supplizio, dove un angelo porse il calice al figlio
di Dio. La processione si dilegua in lontananza, mentre una fanfara di trombe avvia l'estinguersi
delle voci coro ormai lontane nella valle.
23. [SCENA E] TERZETTO. L'Ambasciatore pontificio si rivolge all'eremita, che senza entrare
in Ramla ha voluto precedere i crociati: gli chiede l'assoluzione per un condannato a morte, quindi
prosegue per raggiungere l'armata. Elena, che è intanto misteriosamente ricomparsa rimanendo
sul fondo e ascoltando, dopo la partenza dell'Ambasciatore si avanza aspettando con angoscia che
Gastone appaia. Questi vien fatto uscire dalla tenda guidato da un soldato e finalmente rivede
Elena, che si slancia verso di lui. All'udire la voce di Gastone, l'eremita lo riconosce. Nella sua
disperazione Elena quasi impreca contro Dio (Dio, che tutto a me togliesti ["Tu la madre mi
togliesti"]). Il giovane chiede all'eremita d'essere benedetto; ma questi non può: la sua mano è
colpevole.Tuttavia Gastone insiste; ponendo fra le mani di Gastone la sua spada, la cui
impugnatura forma una croce, l'eremita lo rassicura: la giustizia divina sarà provata e la sua
innocenza rivendicata. Il suono del flauto introduce un terzetto (Non isperan o misera ["Qual
voluttà trascorrere"]): Gastone esprime la propria disperazione per la morte imminente; Elena
tenta di consolarlo invocando anche per sé la morte, mentre l'eremita rassicura che in questo
giorno la giustizia del cielo sarà appagata. Al rumore del combattimento Ruggero restituisce a
Gastone la sua armatura dicendogli: "Sii libero; ora puoi combattere per il Signore"; quindi
entrambi si precipitano nella mischia.
La tenda del conte di Tolosa.
24. LA BATTAGLIA. A sipario calato un brano per sola orchestra descrive la battaglia in corso.
25. FINALE DELL'ATTO QUARTO. Si riapre il sipario. Dal fondo della tenda si scorge il
panorama di Gerusalemme. Elena e Isaura sono in attesa dell'esito della battaglia. Con loro grande
gioia il conte entra in trionfo, seguito dall'Ambasciatore e da alcuni cavalieri che recano gli
stendardi conquistati. Da ultimo entra uno sconosciuto cavaliere col viso coperto da una celata. Il
conte, che lo ha visto compiere gesta di incredibile valore, chiede di conoscerne il nome. Per tutta
risposta il cavaliere solleva la celata: è Gastone, che ora chiede di essere giustiziato dai suoi
carnefici. In quello stesso momento entra Ruggero vacillante, mortalmente ferito. Egli confessa il
proprio crimine, chiedendo perdono al fratello e salvezza per Gastone; come ultimo desiderio
chiede di vedere ancora una volta Gerusalemme. La tenda viene aperta e, mentre i raggi del sole
illuminano i bastioni della città santa, tutti si uniscono in un inno finale (Te lodiamo, gran Dio di
vittoria).
Il Corsaro
[Melodramma in tre atti] Poesia di Francesco Maria Piave
Prima rappresentazione: Trieste, Teatro Grande [oggi Teatro Verdi], 25 ottobre 1848
L'argomento deriva dal poema The Corsair del poeta inglese Lord George Gordon Byron (Londra,
1788 - Missolungi (Grecia),1824), pubblicato nel 1814 e divenuto molto in voga presso il pubblico
italiano del tempo, tanto che nel 1826 alla Scala fu ridotto ad azione mimica e quindi nel 1831 a
Roma musicato da Giovanni Pacini su libretto di Jacopo Ferretti. Già in vista della sua prima
opera per la Fenice, Verdi aveva inserito Il corsaro fra gli argomenti su cui operare una scelta, più
tardi realizzatasi con arnani. Firmato nel 1845 con l'editore Lucca un contratto per un'opera da
rappresentarsi a Londra, il compositore ripropose l'argomento a condizione che il libretto fosse di
Piave. Procrastinato di un anno l'impegno londinese a causa della lunga malattia patita al tempo di
Attila, Verdi si decise per I masnadieri, mantenendo tuttavia il Corsaro quale argomento per
un'altra opera che s'era impegnato a scrivere per l'editore Lucca sin dall'ottobre del 1845 e che si
sarebbe dovuta rappresentare in un primario teatro italiano entro il 1849. Nel frattempo s'erano
fortemente incrinati i suoi rapporti con Lucca, a tal punto che il maestro volle sbarazzarsi al più
presto dell'impegno che aveva con lui, portando rapidamente a compimento la composizione del
Corsaro - di cui aveva già sbozzato nel 1846 alcune scene, fra le quali il duetto della prigione e il
terzetto finale - senza quasi alterare il libretto di Piave. Il 12 febbraio 1848 consegnava la partitura
completa a Lucca, autorizzandolo a farne l'uso che volesse sia della musica che delle parole. L'opera
fu destinata dall'editore al Teatro Grande di Trieste con una compagnia di gran cartello che
costituiva di per sé una garanzia per il compositore in quanto comprendeva la Barbieri Nini (che
aveva partecipato alle prime' dei Foscari e del Macbeth), il tenore Fraschini (presente alle prima' di
Alzira) e il baritono De Bassini (che aveva 'creato' la parte di Francesco Foscari). Verdi non si
mosse da Parigi, dove risiedeva, impegnato nella composizione della Battaglia di Legnano,
limitandosi a fornire alla Barbieri Nini, che gliene aveva fatto richiesta, alcune indicazioni
essenziali per l'interpretazione dell'opera. L'accoglienza del pubblico e della stampa fu molto
negativa; il commento generale fu che Trieste si attendeva da Verdi qualcosa di molto meglio.
Dopo tre sere l'opera fu tolta dal cartellone. Tuttavia Lucca accanito concorrente di quel Ricordi
che era rimasto praticamente l'unico editore di Verdi non si rassegnò facilmente al fallimento di
un'opera sulla quale aveva fatto molto affidamento, e tra il 1852 e il 1853 organizzò una serie di
rappresentazioni del Corsaro in alcuni teatri secondari, ma senza riuscire a stabilire l'opera nel
repertorio, nonostante qualche considerevole successo (in particolare nel primario teatro della
Fenice dove l'opera andò in scena a pochi giorni dalla prima' di Traviata). Dopo un'apparizione a
Lodi nel 1860 e a Oporto nel 1864, Il corsaro cadde in un totale oblio, restando ignorato perfino
alla Verdi-Renaissance tedesca, pur così provvida nel riportare in vita tante opere cosiddette
'minori' del maestro. La ricomparsa del Corsaro sulle scene risale all'allestimento fatto alla Fenice
di Venezia nel 1963. Le sporadiche riprese avvenute in seguito in alcuni teatri italiani e stranieri
hanno tuttavia dimostrato che quest'opera, pur non rientrando nel rango dei capolavori di Verdi, è
scritta con mano maestra, risultando, per l'efficacia degli aspetti drammatici e la maturità dello
stile, una delle meno invecchiate fra le sue opere del periodo giovanile.
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
CORRADO, capitano dei corsari primo tenore Gaetano Fraschini
GIOVANNI, corsaro basso Giovanni Volpini
MEDORA, giovane amante di Corrado
altra prima donna Carolina Rapazzini
GULNARA, schiava prediletta di Seid
prima donna Marianna Barbieri Nini
SEID, pascià di Corone
primo basso cantante [baritono] Achille De Bassini
SELIMO, agà [agha]
secondo tenore Giovanni Petrovich
Eunuco, nero tenore comprimario Francesco Cucchiari
Uno schiavo tenore comprimario Stefano Albanassich
Anselmo, corsaro che non parla
[mimo] N. N.
Corsari, guardie, turchi, schiavi, odalische. Ancelle di Medora.
Scena: Un'isola dell'Egeo e la città di Corone
Epoca: Il principio del secolo XIX
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
N. B. La struttura del riassunto non tiene conto del consiglio che Verdi diede alla Barbieri Nini
alla vigilia della 'prima', di dare l'opera in due soli atti, riunendo in un solo atto i primi due.
1. PRELUDIO. È in tre movimenti. Si apre con un Allegro tempestoso, che crea il clima
byroniano del dramma. L'energia sonora delle terzine in contrattempo si scarica improvvisamente
su una cadenza sospesa che introduce l'Andante. Una serie di armonie cromatiche aprono la via a
un'espressiva melodia del clarinetto (è il tema di Medora morente). Dopo un breve percorso la
melodia sfocia in un concitato Allegro conclusivo che a poco a poco si spegne sul prolungato rullo
del timpano.
ATTO PRIMO
L'isola dei corsari nell'Egeo. Seno di mare circondato da erti scogli che ne lasciano vedere l'ampiezza. Si
scorge da lontano sopra una più alta rupe scoscesa una massiccia torre quadrata di architettura bizantina.
Tra gli scogli a sinistra si vedono capanne e grotte, rifugio dei corsari. E il tramonto.
-2. CORO, SCENA ED ARIA. Corsari sparsi qua e là per la scena. Dall'interno giunge il canto
grintoso di altri corsari che inneggiano alla loro vita sui mari (Come liberi volano i venti), liberi di
cacciare ovunque le prede favorite, affrontando coraggiosamente la morte con una bandiera rossa
come scettro. Entra Corrado pensieroso; ascoltando il fiero canto dei suoi corsari, pensa al destino
che lo costringe a essere in guerra perenne con tutti gli uomini. È assai temuto, ma è anche molto
infelice. E rivolge la. mente a un fato inesorabile che gli rapì ogni bene (Tutto parea sorridere).
Entra frettoloso Giovanni, insieme ai corsari, per consegnare a Corrado una lettera pervenuta
tramite un fidato messaggero da parte del "greco esploratore". Corrado legge la lettera. Il
contenuto lo induce a ordinare ai suoi uomini di tenersi pronti per salpare in serata. Quindi si
scatena in una dichiarazione di guerra contro il Mussulmano (Sì: de' corsari il fulmine), cui si
uniscono i corsari. Alla fine Corrado si avvia alla torre, mentre i corsari si disperdono per i
preparativi.
Stanze di Medora nella vecchia torre, con verone verso il mare.
3. ROMANZA. Una dolente melodia di violini e violoncelli introduce il personaggio di Medora
che, sola in scena, attende il ritorno dell'amato Corrado. Senza lui vicino il tempo non sembra
IZ Corsaro 243
passare mai. Prende l'arpa affinché assecondi il suo canto sì che il suo lamento possa giungere
all'amato sulle ali del vento.Tetre visioni gravano sulla sua esistenza e la speranza é solo un breve
raggio di luce (Non so le tetre immagini); oppressa da una tristezza infinita, finisce per annichilirsi
giungendo a desiderare la morte.
4. SCENA E DUETTO. Sulle ultime battute entra Corrado. Sentendo le ultime parole di Medora
le chiede il motivo di tanta tristezza. Ella si giustifica allora dicendo che in assenza di lui non può
essere lieta. Il corsaro le conferma che il loro amore non morrà; ma ha bisogno
dell'incoraggiamento dell'amata per portare a compimento una pericolosa impresa. Medora tenta
di trattenerlo con parole di supplica: le notti saranno per lei lunghe veglie e il rumore del vento le
parrà un lamento (No, tu non sai comprendere); Corrado la rassicura: presto lo vedrà tornare tra i
vortici che lo porteranno direttamente tra le sue braccia, dove egli le asciugherà le lacrime, e tutto
si trasformerà in gioia. Ma intanto l'ora della partenza incalza. Medora cerca di trattenere
Corrado. Si ode un colpo di cannone: è il segnale. Medora supplica nuovamente Corrado chiedendo
pietà per le proprie lagrime: sente in cuor suo che non lo rivedrà più e che se un giorno tornerà la
troverà morta dal dolore (Tornerai, ma forse spenta); Corrado fa di tutto per rassicurarla: sarà
presto di ritorno e il dolore dell'amata si trasformerà in letizia. Il cannone tuona una seconda volta.
Corrado esce fuggendo; Medora sviene.
ATTO SECONDO
Stanza deliziosa nell'harem di Seid.
5. CORO DI ODALISCHE. Alcune odalische presentano veli trapunti e gemme a Gulnara lodando
la sua bellezza: ella è la più fulgente stella dell'harem di Seid (Oh qual perenne gaudio t'aspetta).
6. CAVATINA. Gulnara in realtà odia Seid. Per lei non è che un vile mussulmano e tutte le
gemme e gli ori non potranno mai comprare il suo amore. Il suo pensiero si rivolge al sospirato
cielo della terra natia (Vola talor dal carcere). Entra un Eunuco nero che per ordine di Seid invita
Gulnara ai festeggiamenti per l'imminente vittoria. La donna accetta, consapevole che la vita che
l'aspetta non è fatta solo di dolori: la conforta la speranza che il cielo impietosito le renda l'amore
che la infiamma (Ah conforto è sol la speme).
Magnifico chiosco in riva al porto di Corone, che si vedrà occupato dal naviglio mussulmano illuminato e
parato a festa. A sinistra dello spettatore si vedrà parte del serraglio pure splendente di luci.Alla destra vi è
una tenda con sotto le mense apparecchiate.
7. CORO ED INNO. Soldati e capitani mussulmani cantano a festa minacciando morte ai corsari
(Sol grida di festa). Entra Seid seguito da Selimo e da altri guerrieri.Tutti si prostrano. Seid esorta
i suoi sudditi alla gioia; fa squillare le trombe e invita a elevare un inno ad Allah. Egli stesso intona
il canto magnificando, sul ritmo martellante degli ottoni, la potenza del Profeta in pace e in guerra
(Salve, Allah!); a una sola voce gli risponde compatto il coro dei sudditi.
8. RECITATIVO E DUETTINO. Entra uno schiavo: annuncia l'arrivo di un Derviscio sfuggito
alle catene dei corsari, che implora di parlare a Seid. È Corrado, che sotto le mentite spoglie di un
monaco islamico, una veste con cappuccio, nasconde l'armatura di maglia di ferro e l'elmo. Egli
racconta che, fuggito dai corsari, dopo tre mesi di navigazione fu salvato da un umile pescatore;
ora chiede la protezione di Seid. Questi s'infuria contro i corsari (Di: que' ribaldi tremano)
promettendo di ridurre in cenere i loro covi; Corrado gli dice che durante la prigionia non ha
potuto vedere altro che il cielo e udire il fragore delle onde; ma sa che il riparo dei corsari è mal
custodito.
9. FINALE SECONDO. Corrado fa per partire, ma Seid gli ordina di rimanere. A un tratto un
chiarore abbagliante illumina la scena. Si grida al tradimento, mentre scoppia un brulotto: il fuoco
s'appicca alle navi, indi al serraglio. Corrado getta il cappuccio e la veste e appare armato di elmo e
di maglia di ferro; suona un corno e impugnando la spada chiama a sé i corsari; questi irrompono
sulla scena mettendo in fuga i Turchi. Dall'interno del serraglio si odono le voci di Gulnara e delle
odalische che gridano al soccorso. Ordinando di uccidere gli uomini, ma di risparmiare le donne,
Corrado corre con i suoi alla volta del serraglio e ne ritorna precipitosamente tenendo fra le
braccia Gulnara; i corsari lo seguono traendo con sé le odalische. Corrado le tranquillizza, mentre
dal di fuori si odono le voci dei Turchi che vengono all'assalto al grido di Allah. Corrado cerca di
sfuggire all'accérchiamento, ma ne è impedito dai Turchi capitanati da Seid, che entrano in scena,
sempre al grido di Allah. Anselmo e parte dei corsari riescono a fuggire; gli altri sono circondati e
vinti. Lo stesso Corrado è costretto a cedere. Seid, dopo aver ordinato che gli sia risparmiata la
vita, gli si avvicina con fare ironico e lo schernisce quale rapitore di donne; ma dopo che Corrado
gli impone di tacere, esplode incontenibile la sua ira (Audace cotanto mostrarti): il corsaro sarà
messo a morte; Corrado, per nulla intimorito, replica che dalla sua bocca non uscirà un lamento;
intanto Gulnara, guardandolo ammirata, si sente affascinata dal suo coraggio. Soldati turchi
trascinano via parte dei corsari in catene. Selimo informa il Pascià dell'esito della vittoria: molti
corsari sono stati trafitti, altri ridotti in schiavitù, altri ancora sono fuggiti. Ma Seid ordina di non
inseguirli; gli basta aver fra le mani il loro capo. Corrado mantiene il suo contegno sprezzante e
accusa Seid di perfidia. Questi gli risponde facendogli presente le torture atroci che lo
attenderanno (Sì, morrai di morte atroce); mentre Corrado resta impassibile alle minacce e i
corsari superstiti rispondono con grande fierezza agli insulti del Pascià, Gulnara e le odalische lo
supplicano di salvare la vita all'uomo che salvò la loro.
ATTO TERZO
Stanza di Seid.
10. SCENA ED ARIA. Seid è solo e pensa all'audace corsaro che osò incendiare la sua reggia e
rapire l'amata Gulnara. Poi nella sua mente di amante si affaccia il sospetto che costei non gli sia
fedele.Tormentato dalla gelosia, rammenta che Gulnara fu da lui scelta tra altre cento vergini; se il
suo amore per lei dovesse essere tradito la sua vendetta sarebbe spietata (Cento leggiadre vergini).
Per sciogliere ogni dubbio chiama Selimo e gli ordina di condurre Gulnara alla sua presenza;
inoltre comanda che il prigioniero l'indomani sia messo a morte fra le torture. Nel frattempo
prorompe in un'invettiva piena di ferocia vendicativa (S'avvicina il tuo momento): se scoprirà che
Gulnara non lo ama, egli da amante si trasformerà in tiranno.
11. DUETTO. Entra Gulnara. Seid la guarda e le si-rivolge cercando di mascherare con ironica
dolcezza i propri intenti. Le annuncia che Corrado è prigioniero e che sarà messo a morte. Gulnara
riconosce giusta la sentenza; tuttavia propone di tenerlo in vita per riscuotere la grossa taglia che
pesa sulla sua testa. Seid, nel risponderle che non lo lascerebbe libero per tutti i tesori del sultano,
intuisce che l'intenzione della giovane è quella di salvare il corsaro. Invano Gulnara tenta di
protestare; ma Seid ha già ascoltato abbastanza e ritiene ormai fondati i propri sospetti: ella ama
Corrado. La sua ira prorompe con tutta la violenza; maledicendo l'istante in cui fu salvata
dall'incendio, minaccia la giovane schiava (Sia l'istante maledetto): nel suo cuore geloso ormai
alberga solo la morte. Gulnara freme a queste parole oltraggiose e dentro di sé sente accrescere
l'odio per il tiranno e il desiderio di vendetta. Quando Seid è fuori di scena Gulnara gli lancia un
ultimo grido "Guai, tiranno!".
Interno di una torre. Di fronte una porta chiusa che mette al mare; presso ad essa un balCone con grosse
inferriate. A sinistra dello spettatore una porta con cancello che guida alle gallerie superiori del serraglio.
Da un lato è un duro giaciglio.
12. SCENA E Dumo. Corrado, carico di catene, passeggia con fare altero. Un preludio dominato
dal lamento degli archi crea un'atmosfera di cupo squallore. Il corsaro è disperato perché i suoi
ambiziosi sogni sono svaniti (Eccomi prigioniero f); il suo pensiero corre all'infelice Medora, cui la
notizia della sua morte sarebbe certamente fatale. Avesse almeno una spada! Sconsolato, si getta
esausto sul giaciglio e, vinto dal sonno, s'addormenta. Entra cautamente Gulnara: aperto il
cancello, s'avanza vestita di bianco cón in mano una lampada. Appressatasi a Corrado
amorosamente, lo contempla rammentando come egli tentasse di salvarla sottraendola per un
attimo a Seid. Corrado si desta e vede la bella odalisca che lo conforta con dolci e rassicuranti
parole. Ella gli è amica e troverà un modo di salvarlo anche se Seid ha già decretato la sua morte
(Seid la vuole). Ma il corsaro rifiuta: preferisce la morte alla viltà; e confessa d'essere lacerato da un
solo pensiero: quello di una persona amata che lo attende invano. Gulnara si rattrista nel sentire
che egli ama un'altra donna; invidia Medora con tutto il cuore e a Corrado, che la crede
innamorata del Pascià, s'affretta a dichiarare che una schiava non può amare: solo in un cuore
libero può albergare il vero amore (E può la schiava un palpito). Ma intanto occorre cercare libertà
per entrambi; con concitazione Gulnara rivela il piano di fuga: ella ha già corrotto i soldati e gli
sgherri; una nave li attenderà nel porto; quanto a Seid, ecco un pugnale, da lei celato in seno, con
cui trafiggerlo nel sonno. Ma a Corrado ripugna la proposta di usare un pugnale per uccidere un
inerme. Con appassionato tono di preghiera Gulnara tenta di convincerlo a fuggire dal carcere
(Non sai tu che sulla testa); ma il corsaro, rassegnato, chiede d'essere lasciato al proprio destino.
Gulnara è furibonda, e dopo aver schernito il corsaro per la sua viltà, fugge brandendo il pugnale
verso gli appartamenti di Seid. Il tuono rumoreggia; scoppia un fulmine. La furia degli elementi si
scatena in pochi istanti, mentre Corrado invoca su di sé il fulmine inceneritore. Altrettanto
rapidamente la tempesta si allontana. Cessa il tuono e il cielo va a poco a poco rasserenandosi.
Gulnara ritorna volgendo lo sguardo inorridita dietro di sé, cammina vacillando e cade; con voce
soffocata confessa a Corrado d'aver ucciso Seid; quindi gli si appressa piangendo: ha compiuto il
delitto per amore del corsaro; ma se questi non può amarla, che almeno fugga con lei (La terra, il
ciel m'abborrino). Di fronte al gesto di Gulnara il corsaro sente accresciuti i propri rimorsi;
commosso dalle sue suppliche promette di salvarla fuggendo con lei. Escono insieme per la porta
che mette al mare.
Spiaggia del mare come nell'atto primo. Si vede una nave ancorata.
13. TERZETTO FINALE. Un breve preludio orchestrale prepara una scena di desolazione.
Medora chiede ai corsari notizie di Corrado; ma il loro aspetto abbattuto sembra confermarle la
verità da tempo paventata: Corrado non è più. Già sente scendere nelle sue viscere la morte: ben
presto si ricongiungerà al suo amato in un altro mondo. Mentre viene esortata a sperare, alcuni
guardano verso il mare e avvistano una vela improvvisamente comparire all'orizzonte: è la nave di
Corrado. In un crescendo di sonorità, ne scende, festeggiato dai compagni, Corrado insieme a
Gulnara. Corrado si precipita ad abbracciare Medora, affrettandosi a raccontarle delle avventure in
terra mussulmana e del fortunoso salvataggio a opera di Gulnara (Per me infelice). A lei si rivolge
Medora per ringraziarla d'avergli salvato Corrado. Gulnara si schermisce, giustificando la propria
azione come gesto dettato da un amore tuttavia non corrisposto. Ma è ormai troppo tardi per
Medora, che sente la morte appressarsi. Tutti i presenti si commuovono alla vista della giovane
che sta via via perdendo i sensi. Mentre Corrado si mostra disperato, Medora, con un ultimo
sforzo chiede di poter morire sul suo seno (O mio Corrado, appressatt). La commozione è generale;
la stessa Gulnara chiede perdono al cielo, mentre Corrado impreca contro un destino che gli ha
reso la vita togliendola alla donna da lui tanto amata. Medora muore nelle braccia di Corrado.
Questi, disperato, si slancia in mare per affogarvi, mentre le ancelle portano via la salma di
Medora. Gulnara cade svenuta.
Verdi a Napoli (dipinto di Achille Scalese, 1858)
La battaglia di Legnano
Tragedia lirica in quattro atti di Salvadore Cammarano
Prima rappresentazione: Roma,Teatro di Torre Argentina, 27 gennaio 1849
L'argomento deriva da una tragedia, La Bataille de Toulouse, allora ben nota in Italia, scritta nel
1828 da Joseph Méry (Marsiglia, 1797 - Parigi, 1866), bonapartista e ardente ammiratore dell'arte
italiana; la vicenda, ambientata negli ultimi giorni della sesta coalizione (1814), era incentrata sulla
tragedia privata di tre personaggi, il tema patriottico fungendo più che altro da sfondo.
Cammarano, nel trasportare la vicenda al tempo della Lega Lombarda, s'incaricò di porre in primo
piano il tema patriottico senza sbilanciare il dramma privato, dando rilievo alle scene di massa e ai
risvolti politici, tenendo conto anche delle esigenze del compositore, che desiderava una scena col
Barbarossa, la scena in cui Rolando benedice itfiglioletto alla vigilia della' battaglia decisiva e
infine la scena finale davanti a S. Ambrogio. Concepita e composta nel clima bollente e convulso
della rivoluzione del Quarantotto, la Battaglia di Legnano - al contrario di quanto si potrebbe
ritenere - non fu solo opera d'occasione. Già il 22 luglio 1848 Verdi da Parigi aveva proposto a
Piave un libretto su un soggetto "italiano" ispirato a Ferruccio, `personaggio gigantesco, uno dei
più grandi martiri della libertà italiana". Ma il progetto, da ricavarsi dall'Assedio di Firenze di
Guerrazzi, abortì quasi sul nascere. Nel frattempo Verdi aveva accolto l'invito di Mazzini (da lui
conosciuto a Londra nel luglio del 1847) a comporre la musica per un nuovo inno di Goffredo
Mamelt Suona la tromba, ondeggiano le insegne; l'inno giunse purtroppo quando oramai la
rivoluzione era in fase di ripiegamento (d'altronde esso non presenta né nella musica né nel testo
quel carattere di schietta popolarità - pur ricercato da Verdi - in grado di competere con l'inno
Fratelli d'Italia, lanciato un anno prima). Scartato il soggetto di un Cola di Rienzo, suggerito ila
Verdi, per le difficoltà incontrate nel dargli forma drammatica, fu lo stesso Cammarano a proporre
nell'aprile del 1848 "di tratteggiare l'epoca più gloriosa della , storia italiana, quella della Lega
Lombarda" impostando la vicenda sulla stessa tela offerta da La Bataille de Toulouse di Méry.
Verdi accolse il suggerimento di Cammarano. L'opera fu dunque concepita quando sembrava che
gli Austriaci avessero lasciato l'Italia per sempre e si nutriva speranza di raggiungere l'unità
politica. Ma a causa della lentezza con cui operava Cammarano, essa fu pronta solo alla fine del
1848, quando quella speranza stava ormai svanendo. Fu tuttavia rappresentata in una Roma in cui
la rivoluzione era al culmine, una Roma abbandonata dal Papa dopo l'assassinio del ministro
riformista Pellegrino Rossi per mano di fanatici repubblicani, all'immediata vigilia della
proclamazione della Repubblica Romana guidata dal triumvirato Mazzini - Saffi - Armellini.
L'esito, manco a dirlo, fu di entusiastica accoglienza. Subito rappresentata anche a Firenze, Ancona
e Genova, l'opera scomparve dalle scene a causa delle vicende post-quarantottesche, salvo un paio
di riprese all'estero con libretto modificato in Assedio di Arlem. Dopo il Trovatore Verdi, che
credeva nei valori drammaturgici della Battaglia di Legnano, tentò di riportarla in vita
modificandone l'argomento, ma senza esito, stante l'incapacità del librettista Bardare (Cammarano
nel frattempo era morto) di stendere un libretto musicabile. All'alba dell'unità italiana (18601861)
l'opera ebbe tuttavia una decina di riprese (fra cui alla Scala e al 5'. Carlo), per poi sparire dalle
scene. Dopo una riapparizione alla Scala nel 1916 e una timida ripresa durante la VerdiRenaissance tedesca (Augsburg 1932) sull'opera scese il silenzio. Occorrerà attendere il secondo
dopoguerra (a cominciare da Parma nel 1951) per vederla ricomparire, sebbene sporadicamente,
sulle scene.
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
FEDERICO BARBAROSSA basso profondo Pietro Sottovia
I CONSOLE di Milano secondo basso Alessandro Lanzoni
II CONSOLE di Milano secondo basso Achille Testi
Il Podestà di Como secondo basso Filippo Giannini
ROLANDO, duce milanese primo basso cantante [baritono] Filippo Colini
LIDA, sua moglie prima donna Teresa De Giuli Borsi
ARRIGO, guerriero veronese primo tenore Gaetano Fraschini
MARCOVALDO, prigioniero alemanno secondo baritono Lodovico Buti
IMELDA, ancella di Lida seconda donna Vincenza Marchesi
Un Araldo
secondo tenore
Luigi Ferri
Cori e Comparse: Cavalieri della Morte - Magistrati e Duci Comaschi - Ancelle di Lida - Popolo
Milanese Senatori di Milano - Guerrieri di Verona, di Brescia, di Novara, di Piacenza e di Milano Esercito Alemanno
L'epoca: 1176 [nel mese di maggio]
Nota storica: Federico I di Hohenstaufen detto il Barbarossa (1123 ca. - 1190) ottenne da papa
Adriano V, dopo avergli consegnato l'eretico Arnaldo da Brescia, la corona di imperatore del Sacro
Romano Impero. Convinto assertore della missione universale dell'impero e della sua sacralità,
pretese la restituzione dei diritti usurpati da parte dei comuni del nord d'Italia; sceso con il suo
esercito in Italia nel 1158, rase al suolo le città ribelli: dapprima Tortona, quindi Crema e nel 1162
Milano. Per tutta risposta, secondo una tradizione peraltro non documentata, il 7 aprile 1167 si
celebrò a Pontida, località del bergamasco, su sollecitazione di papa Alessandro III, acerrimo
oppositore dell'imperatore, un giuramento fra i delegati delle varie leghe unitesi in un'unica Lega
Lombarda. La resistenza della Lega all'autorità imperiale spinse il Barbarossa a scendere
nuovamente in Italia nel 1174, trovando un alleato nel comune di Como; dopo aver invano
assediato la cittadella di Alessandria, fu sconfitto a Legnano il 29 maggio 1176 dall'esercito della
Lega Lombarda.
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
Antefatto
Arrigo, condottiero veronese, nominato ambasciatore a Milano, trova ospitalità presso il padre di Lida.
Conosce la fanciulla e se ne innamora: i due giovani si giurano eterno amore. Partito per la guerra contro
l'imperatore Federico Barbarossa, viene ferito gravemente a Susa e fatto prigioniero; a Milano giunge
notizia che egli sia morto. Frattanto Lida, per volere del padre, sposa Rolando, un fraterno amico di
Arrigo. Questi, infine liberato e rientrato a Verona, riesce a sopravvivere grazie alle cure della madre;
ripreso il comando delle schiere veronesi, accorre a Milano, nuovamente riedificata, rispondendo all'appello
delle leghe comunali.
1. SINFONIA. Si apre con un tema marziale, intonato dagli ottoni (Allegro marziale maestoso),
che costituisce - a guisa di Leitmotiv - la sigla musicale della Lega Lombarda. Il maschio carattere
del tema non si esaurisce quando viene ripreso dai legni, e anzi riesplode all'improvviso con tutta
l'orchestra per sfociare poi in un episodio lirico (Andante sostenuto), condotto dai legni, in cui
risuona un tema melanconico (che sarà poi associato all'episodio di Arrigo mentre scrive alla
madre). Un graduale crescendo conduce a un'immane esplosione, che a sua volta prepara la ripresa
del tema: essa si snoda su un accompagnamento sempre più rielaborato e termina in un pianissimo.
La seconda parte della Sinfonia (Allegro) si apre con la riproposizione del tema marziale dell'inizio;
su di esso s'innesta un nuovo tema, di carattere a un tempo brillante e militaresco, che si sviluppa
su un doppio crescendo, per concludersi infine con una lunga coda contrassegnata da un controtema (quasi un'eco della Marsigliese), di carattere marziale, che suggella il percorso musicale della
Sinfonia su un tono trionfale.
ATTO PRIMO: Egli vive!
Parte della riedificata Milano, in vicinanza delle mura.
2. CORO D'INTRODUZIONE. Da una parte della città s'inoltrano i militi piacentini ed alcune
centurie di Verona, di Brescia, di Novara e di Vercelli. La contrada è gremita di popolo, come i
soprastanti veroni, da cui pendono arazzi variopinti e giulive ghirlande. Un grido universale di
esultanza, un prolungato batter di palme e un nuvolo di fiori che cade dall'alto sulle squadre,
attesta le festevoli accoglienze ad esse prodigate. Arrigo è fra i guerrieri veronesi. Le squadre
rinnovano il giuramento fatto a Pontida nove anni prima per lottare contro il Barbarossa,
giuramento che di tanti popoli ne ha fatto uno solo (Viva Italia! Sacro un patto). Dall'alto dei
balconi rispondono le donne inneggiando all'Italia.
3. SCENA E ROMANZA. Arrigo, veronese, saluta la risorta Milano, egli, creduto morto, fatto
prigioniero, ma tornato a vita grazie alle cure della madre (La pia materna mano).
4. SCENA E ROMANZA. Si odono voci interne che a poco a poco s'avanzano (Viva Italia forte ed
una): sono le schiere milanesi, guidate da Rolando; questi è stupito nel rivedere vivo l'amico
Arrigo, che credeva caduto nella battaglia di Susa, e corre a salutarlo con grande calore,
ringraziando Dio d'avergli restituito l'amico (Ah! m'abbraccia).
5. GIURAMENTO. Uno squillo di trombe annuncia l'arrivo dei due Consoli di Milano. Alla loro
presenza Arrigo invita tutti a giurare di difendere la città col proprio sangue e di trar vendetta
dello scempio fatto dalle truppe del Barbarossa (Tutti giuriam difenderla). Quindi, con alla testa i
Consoli e seguite dal popolo, le schiere si allontanano a ritmo di marcia.
Sito ombreggiato da gruppi d'alberi in vicinanza delle fossate colme d'acqua, che circondano i muri; essi si
vedono torreggiare nel fondo.
6. CORO DI DONZEI.LE. Lida si avanza assorta in profondi pensieri; le sue donne la seguono.
Ella siede all'ombra e vi rimane estatica, con gli occhi rivolti al cielo. Le donne si stupiscono del
suo atteggiamento; poi tutte si uniscono in un canto gioioso di plauso per l'esercito della Lega
accorso in difesa di Milano (Plaude all'arrivo Milan dei forti).
7. SCENA E CAVATINA. Lida condivide il plauso delle donne; tuttavia è triste per la morte dei
fratelli e dei genitori: solo conforto al suo dolore è il pianto (Quante volte come un dono); quante
volte ha desiderato di morire! ma Dio le ha dato un figlio, e ora deve adempiere ai doveri di madre.
Improvvisamente s'indigna nel constatare l'inattesa presenza di Marcovaldo, ostaggio alemanno al
servizio di Rolando, che audacemente non le nasconde di nutrire per lei un cieco amore. Ma prima
che Lida abbia il tempo di allontanarlo, accorre frettolosa Imelda per annunciarle l'arrivo dello
sposo, seguito da Arrigo. Egli vive! Parole fatali: a Marcovaldo non sfugge lo stato di agitazione di
Lida, la quale esprime ora una gioia incontenibile nel rivedere l'amato di un tempo; non sa frenare i
palpiti del cuore: se è colpa un istante d'affetto, basti a punirla una vita di dolore (A frenarti, o cor
nel petto).
8. SCENA E DUETTO. Sopraggiunge Rolando, che presenta alla sposa il redivivo Arrigo; questi,
nel riconoscere in lei la donna con la quale un tempo s'erano giurati reciproco eterno amore, non
sa nascondere un brivido, che subito attribuisce a una vecchia ferita, ma la cui vera causa non
sfugge al bieco Marcovaldo. Memore dell'ospitalità un tempo accordata ad Arrigo "messaggier di
Verona" dal padre di Lida, Rolando a sua volta gli offre l'ospitalità della propria casa; fa quindi
allontanare le donne e Marcovaldo. Uno squillo di trombe annuncia l'arrivo di un araldo che,
allarmato, annuncia l'avvicinarsi del potente esercito imperiale; comandanti e Senato sono subito
convocati in assemblea. Rolando vi accorre precipitosamente. In tutto questo tempo Lida è rimasta
come incatenata al suolo. Arrigo le si accosta e, scuotendola d'un braccio, la apostrofa vivacemente,
ricordandole il reciproco giuramento d'amore: (È ver?... Sei d'altri?...). Lida racconta come ella
credesse Arrigo morto in guerra (Spento un fallace annunzio); rimasta orfana, senza più famiglia,
obbedì al desiderio del padre morente che la voleva sposa di Rolando. Arrigo non riesce a
trattenere una "virulenta" ironia: chissà quanto avrai pianto alla notizia della mia morte, e per
asciugare quel pianto ti sei subito sposata; ma non ricordi d'aver giurato a Dio che saresti accorsa
là dove io fossi caduto. Lida si copre il volto con le mani, non sa cosa rispondere. Arrigo, al colmo
dell'ira, l'accusa di ritorcere su altri la propria colpa: il suo amore per lei si è mutato in orrore
(T'amai, t'amai qual angelo); non resta che offrire il proprio sangue alla patria; Lida si dichiara
colpevole e chiede la punizione (Son rea, puniscimi). Ma Arrigo non intende più ragione; la
respinge ed esce velocemente.
ATTO SECONDO: Barbarossa!
Sala magnifica nel Municipio di Como. Veroni chiusi nel fondo.
9. CORO D'INTRODUZIONE. A poco a poco vanno radunandosi Duci e Magistrati che
attendono l'arrivo di una delegazione milanese in rappresentanza della lega dei comuni lombardi
per venire a patti con Como: ma ormai è troppo tardi: (Sì, tardi ed invano) l'ddio trasfuso dai padri
ai figli per "i danni mortali a Como recati" non verrà mai meno.
10. SCENA E DUETTO. Il Podestà annuncia l'ingresso di Arrigo e Rolando, messaggeri della
"baldanzosa" Lega Lombarda. Rolando informa che una nuova orda di barbari sta scendendo in
Italia attraverso i Grigioni: la valle dell'Adige lè. è impedita dalle schiere veronesi; il Barbarossa è
asserragliato in Pavia; non sarebbe dunque impresa difficile arrestare quell'orda sulle rive del lago;
dimentichiamo gli antichi rancori: abbiamo solo un nemico, l'Alemanno, e una sola patria: l'Italia. I
comaschi rispondono rammentando a Rolando il patto sottoscritto con Federico. Vergognoso
patto! ribatte Rolando: siete italiani e nel volto e nel linguaggio (Ah! ben vi scorgo), ma nelle
azioni e nei pensieri siete "barbari stranier!". Arrigo sostiene l'appello dell'amico: che la storia non
abbia a dichiararvi traditori della patria e parricidi (Oh! la storia non v'appelli).
11. FINALE SECONDO. Acerbe parole, commenta il Podestà di Como; ma Arrigo chiede una
risposta. Improvvisamente si presenta, piombato da Pavia, Federico Barbarossa: "Io darò la
risposta". Nella sorpresa e nel silenzio generali, Federico, lasciando cadere il mantello, s'avanza
fieramente verso Arrigo e Rolando: siete diventati muti?...; per i Lombardi è ormai giunta l'ora
estrema (A che smarriti e pallidi). Ma i due messaggeri milanesi non indietreggiano: non è da eroi
combattere con le ingiurie, e promettono di rivedersi sul campo di battaglia "al fiero lampo" delle
armi. L'assemblea comasca parteggia apertamente per Federico (Su te Milano già. tuona)
minacciando Milano del "fulmin punitor". Si ode un rimbombo di strumenti militari che sempre
più si approssima. Sono le "possenti squadre" di Federico; a un suo cenno vengono dischiusi i
veroni, attraverso i quali si scorgono le colline circostanti ingombre di falangi alemanne. Eccovi la
mia risposta, annuncia il Barbarossa: la caduta di Milano. No, contrattaccano Rolando e Arrigo, le
tue masnade mercenarie non vinceranno un popolo che lotta per la propria libertà né cambieranno
il destino d'Italia. Con terribile accento Federico esplode: "Il destino d'Italia son io!" e Milano due
volte distrutta sarà spavento per i ribelli. Ma Rolando e Arrigo confidano nella vittoria e in
un'Italia "grande e libera". Con grido ferocissimo tutti invocano ormai la guerra (Guerra adunque
terribile!).
Verdi al tempo di Un ballo in maschera (fotografia)
ATTO TERZO: L'infamia!
Volte sotterranee nella basilica di St. Ambrogio in Milano, sparse di recenti sepolcri: gradinata in fondo per
la quale vi si discende: una fioca lampada getta intorno qualche incerto raggio.
12. INTRODUZIONE, SCENA E GIURAMENTO. Una musica cupa, lenta, quasi minacciosa
prelude all'ingresso dei Cavalieri della Morte che scendono a poco a poco, e in silenzio; ognuno
d'essi porta una sciarpa nera ad armacollo, su cui è effigiato un teschio (Fra queste dense tenebre):
vengono a prestare giuramento. Dall'alto della scalinata appare Arrigo: anch'egli vuole far voto
della propria vita fra i Cavalieri della Morte nella guerra contro il Barbarossa. Tutti ne conoscono
il valore, e viene quindi accolto nella Compagnia. Il più anziano della Compagnia pone Arrigo in
ginocchio, ai piedi di una tomba, e lo fregia della propria sciarpa; i Cavalieri incrociano le spade sul
capo di Arrigo. Infine tutti prestano giuramento di liberare l'Italia (Giuriam d'Italia por fine ai
danni) e di cadere, prima di ritirarsi o di essere vinti, con l'arma in pugno; guai al codardo che
mancherà al giuramento: il suo nome sarà infamato per l'eternità. Lentamente i Cavalieri partono.
Appartamenti nel castello di Rolando.
13. SCENA E DUETTO. Lida s'avanza a rapidi passi; la sua fronte è pallida, lo sguardo incerto.
Imelda le chiede ragione del suo frenetico comportamento; l'ha vista scrivere, in lagrime, una
lettera. Lida nega con impeto. L'ha anche vista riporre lo scritto in seno. In seno, sì, un aspide insorge Lida in un crescente delirio - che mi avvelena le più segrete fibre (E il seno qual aspide); e
ora accusatemi: a ogni costo sono colpevole e non chiedo che di morire. E si getta convulsa sopra
una sedia. Riprende i sensi, fissa Imelda, prorompe in lagrime e s'abbandóna nelle sua braccia.
Imelda la esorta a parlare; Lida le confida che un "forsennato" ha fatto voto di morte. Arrigo? Sì,
lui. E lo scritto a lui diretto potrebbe stornare questa sciagura. Lida lo consegna a Imelda
raccomandandole che nessuno la veda andare da Arrigo. Imelda fa per uscire, ma cela rapidamente
il foglio perché sopraggiunge Rolando che l'arresta: prima di partire per la guerra vuole rivedere la
sposa e il figlio; chiede che questi gli sia condotto. Rolando è commosso, gli occhi bagnati di
lagrime, ma cerca di controllarsi. Imelda rientra col bimbo, lo depone in braccio a Rolando ed esce
veloce per l'opposto lato. Rolando abbraccia sposa e figlio; poi avverte la sposa: il cielo promette
vittoria, ma ogni vittoria è a prezzo di sangue; se egli dovesse morire lei resterà maestra di virtù al
figlio; gli ricordi che è italiano, che rispetti Dio e la patria (Digli ch'è sangue italico). Lida chiede a
Dio che sperda ogni tristo presagio. Rolando fa inginocchiare il figlio e, alzati gli occhi al cielo,
stende la destra sul suo capo per benedirlo. Quindi pone il fanciullo in braccio a Lida. Ella si ritira
col figlioletto.
14. SCENA ED ARIA. Chiamato da Rolando, entra Arrigo, che ora non cinge la sciarpa nera dei
Cavalieri della Morte. Rolando gli va incontro, osserva attentamente intorno che altri non possano
udirlo e sottovoce gli ricorda d'aver combattuto più volte al suo fianco; Arrigo rammenti che una
volta ebbe da lui salva la vita. Rolando continua dicendo, con profonda emozione, d'essere ora
marito e padre: domani prima dell'alba dovrà muoversi all'avanguardia dell'esercito; Arrigo resterà
con i Veronesi a guardia di Milano, come deciso dal Senato; stringe la mano di Arrigo
portandosela al cuore: se dovesse morire gli raccomanda sposa e figlio (Se al nuovo dì pugnando).
Arrigo pone la sua nella destra di Rolando in segno di giuramento, ma tituba nell'abbracciare
l'amico. I due si dicono addio. Arrigo esce singhiozzante e precipitoso. Rolando s'avvia per opposto
lato, e già tocca la soglia, quando si sente sommessamente richiamare. È Marcovaldo che gli
denuncia un tradimento... l'onore vilipeso... un'empia... un seduttore... E chi sono? Arrigo e Lida.
Ed ecco la prova: una lettera di Lida. Marcovaldo gli consegna lo scritto, confessando d'aver
corrotto chi lo recava (evidentemente Imelda). Rolando legge con voce tremula e
fremente:"tu,Arrigo, votato fra i Cavalieri della Morte... il mio sposo in avanscoperta contro
Federico... devo vederti prima della battaglia...te ne scongiuro in nome del nostro antico amore...".
Mentre Marcovaldo si compiace della propria vendetta, a Rolando scoppia il cuore (Ahi scellerate
alme d'inferno): il suo furore non ha limiti; ora non ha che un desiderio: vendicare il tradimento
della sposa e dell'amico spegnendoli nel sangue.
Una stanza sull'alto della torre. Ferrea porta da un lato. In fondo un verone che risponde sulle fossate delle
mura. La bruna sciarpa d'Arrigo pende dalla spalliera d'un seggio.
15. SCENA E TERZETTO - FINALE TERZO. È notte fonda. Arrigo si siede per scrivere
all'infelice madre.Tacitamente Lida s'inoltra e fissa lo sguardo sullo scritto. Alla fine, dopo aver
letto, prorompe: Vuoi morire? e osi scriverlo a tua madre? è giusto rischiare la vita per la patria,
ma non il morire a tutti costi! A che vivere, se hai cessato d'amarmi, risponde Arrigo.T'amo!
confessa Lida, t'amo! ma ora dobbiamo fuggirci e vivere per gli affetti più santi: tu per la madre, io
per il figlio; non avendo avuto risposta al mio scritto, sono qui accorsa. S'ode improvvisamente
battere alla porta e risuonare la voce di Rotando che chiama Arrigo. I due restano come fulminati.
Arrigo tosto si riprende: fa fuggire Lida sul verone, ne serra le imposte e va quindi ad aprire la
porta. Rolando entra guardando all'intorno, quindi si rivolge ad Arrigo: so che ti sei votato fra i
Cavalieri della Morte e che per riguardo non me l'hai detto; ora il tempo stringe e vengo ad
affrettarti. Ma è ancora notte, obietta Arrigo. T'inganni, gli osserva Rolando: è già l'alba. E così
dicendo spalanca il verone... Appare Lida che, cercando di dissimulare invano il suo terrore, trema
da capo a piedi; essa cerca di giustificarsi; altrettanto cerca di fare Arrigo. Ma uno sguardo di
Rolando li costringe a tacere: io non v'interrogo; perché vi discolpate? Lida cade in ginocchio ai
piedi del marito; Arrigo è come trascinato a seguirne l'esempio. Rolando con veemenza si scaglia
contro di loro (Ab! d'un consorte, o perfidi): ormai vi tengo nella polvere ai miei piedi. Ad Arrigo,
che ancora tenta di giustificarsi, Rolando impone di uscire dalla propria casa; a Lida dichiara
infranto il vincolo matrimoniale. Arrigo giura sull'innocenza di Lida; ma ormai Rolando è
scatenato: stringe l'elsa di un pugnale;Arrigo gli offre il petto, invano trattenuto da Lida. Rolando
fa per avventarsi su Arrigo sguainando la lama quando, volgendo lo sguardo alla porta, come
preso da una nuova risoluzione, a un tratto si ferma e con voce soffocata dalla rabbia si rivolge ad
Arrigo: poco sarebbe il trucidarti; avrai un supplizio ben maggiore di cento morti (Vendetta d'un
momento): mentre Arrigo invoca di essere trafitto, Lida si rivolge a Rolando dichiarandosi la sola
colpevole. Risuona all'interno uno squillo di trombe: è l'appello. Rolando, avvicinandosi alla porta,
ad Arrigo:"Tua pena sia l'infamia!" e con la rapidità di un baleno esce serrando la porta con chiavi
e catenacci. Arrigo al colmo dello spavento si slancia sulla porta, la percorre cogli occhi, la tocca
con le mani, cerca invano ogni modo di aprirla (Ah! Rolando! il ciel ne attesto); grida a Rolando
che il suo onore non fu macchiato; si rende conto che lì restando il suo nome sarebbe coperto
d'ignominia. Mentre Lida cade affranta su una sedia, Arrigo torna al verone, vede che le squadre di
Rolando già procedono e intanto echeggiano prolungati squilli di trombe. Cacciandosi le mani fra i
capelli vede avanzare i Cavalieri della Morte, fra i quali egli dovrebbe già essere. La disperazione
lo coglie: dov'è Arrigo? - diranno - ha paura di combattere? No, no, deve seguirli... Lida balza in
piedi, intuendo il gesto di Arrigo. Questi afferra la sciarpa nera e si precipita dal verone per
raggiungere i suoi compagni. Lida cade tramortita.
ATTO QUARTO: Morire per la patria!
Piazza di Milano ove sorge un vestibolo di tempio.
16. PREGHIERA. Donne, vecchi, fanciulli sono in parte nel vestibolo del tempio di S. Ambrogio,
in parte sulla via; Lida è con Imelda; tutti sono genuflessi e ascoltano le salmodie che partono
dall'interno del tempio (Deus meus, pone illos). Dopo aver avuto notizia da Imelda che Arrigo,
uscito illeso, fu visto raggiungere le squadre, Lida eleva una preghiera per la vita dello sposo e per
quella di Arrigo (Ah! se d'Arrigo e di Rolando), ma anche per la salvezza d'Italia; ora in lei parla
solo amor di patria.
17. GRAN SCENA,TERZETTINO ED INNO DI VITTORIA. Echeggia di lontano un grido di
vittoria! Tutti sorgono vivamente ansiosi. Entra il secondo Console, seguito dai Senatori e da una
gran calca di cittadini. Da Legnano giunge un messaggio: il nemico è stato sconfitto e l'imperatore
è stato sbalzato di iena dal veronese Arrigo. Si elevi dunque un inno di ringraziamento al Re dei
Re; il Console entra in chiesa con i Senatori. I cittadini si abbracciano l'un l'altro. Intanto si vedono
passare di lontano alcuni drappelli reduci dalla battaglia; e nell'aria echeggia il suono di strumenti
di guerra e il rintocco delle campane (inno Dall'Alpi a Cariddi). Improvvisamente si odono lugubri
squilli di tromba; alcuni del popolo annunciano che sta per essere portato un ferito, accompagnato
in corteo dalla Compagnia della Morte. Lida ha come un triste presagio... Entra Arrigo
mortalmente ferito e sorretto da alcuni Cavalieri della Morte; i comandanti milanesi Io seguono;
fra essi Rolando a capo chino e taciturno. Con frasi spezzate Arrigo dichiara di aver voluto esalare
l'ultimo respiro in questo luogo. Viene adagiato sui gradini della chiesa. Vede Lida. E vede
Rolando: gli chiede di potergli stringere la mano. Rolando, muto, incerto, come trascinato da un
invisibile potere, si accosta ad Arrigo; questi gli si getta al collo: giura sulla purezza del cuore -di
Lida (Per la salvata Italia). A sut volta Lida, frattanto avvicinatasi al morente, richiama Rolando
all'antica amicizia. Questi è profondamente commosso mostrando di credere all'estremo
giuramento di Arrigo: "Chi muore per la patria alma sì rea non ha!" Nella più viva commozione
Rolando stringe Lida al cuore e porge ad Arrigo la destra. Intanto entra il primo Console, seguito
da armati e'dal Carroccio trionfante. Nel vederlo,Arrigo accen" na al vessillo che lo sormonta. I
Cavalieri lo porgono ad Arrigo. Questi lo bacia, e cade morto stringendone il lembo al cuore.
Luisa Miller
Melodramma tragico in tre atti di Salvadore Cammarano
Prima rappresentazione: Napoli,Teatro di San Carlo, 8 dicembre 1849
L'argomento deriva dalla "tragedia borghese"Kabale und Liebe (Luise Millerin era il titolo
originale, poi modificato su consiglio dell'attore-impresario August Iffland), terzo e ultimo dei
drammi giovanili di Friedrich Schiller, rappresentato il 15 aprile 1784 a Mannheim con clamoroso
successo. Per i suoi contenuti - che esprimono non tanto una denuncia contro l'ingiustizia e la
violenza del potere quanto piuttosto una condanna di quel rigorismo morale della società borghese
in cui è la radice stessa della sua servitù politica - esso è considerato il testo più rivoluzionario del
teatro tedesco del Settecento. Verdi conosceva il dramma tramite la versione di Carlo Rusconi
(1844), conosceva Andrea Maffei che stava per iniziarne una nuova traduzione (vedrà la luce nel
1852) e conosceva anche la riduzione fattane da Alexandre Dumas in collaborazione con Maquet
per la scena francese, insolitamente rispettosa del dramma originale, andata in scena l' 1 1 giugno
1847 al Thé eare Historique di Parigi. La storia della composizione di Luisa Miller s'inserisce in
un momento chiave dell'evoluzione artistica di Verdi avviata alle conquiste della cosiddetta
"trilogia romantica" (Rigoletto, Trovatore e Traviata). La prima proposta di musicare il dramma
schilleriano era stata avanzata da Verdi a Cammarano nel 1846 per la seconda opera che s'era
impegnato a scrivere per il S. Carlo di Napoli entro il 1847. Rinviato di due anni l'impegno
napoletano, era lo stesso Cammarano che riproponeva l'argomento facendo pervenire al
compositore, nel maggio del 1849, il relativo "programma" con alcune modifiche al dramma
originale: l'azione viene trasportata dalla città in campagna (a vantaggio dei cori); il vecchio Miller
da musicista in pensione viene trasformato in soldato in ritiro; il personaggio di Lady Milford (che
in Schiller riveste un ruolo di aperta contestazione sociale e che Verdi avrebbe voluto "in tutta
l'estensione del carattere") ridotto a par te comprimaria non essendovi nella compagnia di canto
scritturata al S. Carlo che una sola primadonna. In agosto Verdi rientrava a Busseto da Parigi
prendendo possesso del palazzo Orlandi, da poco acquistato; in settembre lo raggiungeva
Giuseppina Strepponi:. si ufficializzava così un'unione iniziata due anni prima a Parigi. Ricevuto il
libretto completo da Cammarano il 13 agosto, Verdi ne conduceva a termine in poche settimane la
composizione. La prima sera l'opera ebbe esito contrastato, né migliorò di molto nel corso delle
prime repliche. Ciò tuttavia non impedì alla Luisa Miller di percorrere un rapido e fortunato
cammino nei teatri italiani (più di 200 allestimenti nel corso degli anni 1850) e stranieri, sì da
inserirsi stabilmente in repertorio fino alle soglie del Novecento (ultima apparizione alla Scala nel
1903, diretta da Toscanini). Dopo un'eclisse durata un quarto di secolo, l'opera risorgeva a nuova
vita grazie alla Verdi-Renaissance tedesca, a cominciare da Berlino (1927), per proseguire poi il
nuovo cammino sulle scene del Metropolitan (1929), di Torino (1933), di Leningrado (1936), di
Firenze (1937) fino a giungere ai nostri giorni inserita nel gruppo delle opere di Verdi più
frequentemente rappresentate.
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
IL CONTE DI WAITER primo basso profondo Antonio Selva
RODOLFO, suo figlio primo tenore
Settimio Malvezzi
FEDERICA, duchessa d'Ostheim, nipote di Walter prima donna contralto Teresa Salandri
WURM, castellano di Walter primo basso Marco Arati
MILLER, vecchio soldato in ritiro primo basso cantante
Achille De Bassini
Luisa, sua figlia prima donna soprano Maria Gazzaniga Malaspina
LAURA, contadina seconda donna Anna Salvetti
Un contadino secondo tenore Francesco Rossi
Damigelle di Federica, paggi, famigliari, arcieri, abitanti del villaggio
L'avvenimento ha luogo nel Tirolo, nella prima metà del secolo XVII
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
1. SINFONIA. È strettamente connessa al clima drammatico dell'opera cui è premessa.
Rappresenta per così dire 1—atmosfera morale" di una vicenda che si svolge in terra tedesca.
Costituita di un solo tempo Allegro, con tonalità d'avvio in Do minore (relativo del tono di Mi
bem. maggiore con cui l'opera si conclude), essa è imperniata su un unico tema, una cellula ritmicomelodica (che si ritroverà, variata e trasformata, in alcuni momenti dell'opera, in particolare
all'inizio dell'ultimo atto), il cui ininterrotto sviluppo riflette un procedimento compositivo
inconsueto nelle sinfonie italiane del tempo, analogo per tanti aspetti a quello delle ouvertures
dell'opera romantica tedesca, di Weber in particolare.
ATTO PRIMO: L'amore
Ameno villaggio. Da un lato la modesta casa di Miller, dall'altro rustica chiesetta: in lontananza, ed
attraverso degli alberi, le cime del castello di Walter. Un'alba limpidissima di primavera è sull'orizzonte;
gli abitanti del villaggio si adunano per festeggiare il dì natalizio di Luisa.
2. INTRODUZIONE. Già all'inizio l'impianto scenico riflette gli opposti luoghi del conflitto sul
quale si impernia la vicenda: in primo piano la casa di Miller, sullo sfondo il castello del tiranno.
Gli abitanti del villaggio e Laura elevano un canto pastorale (Ti desta, Luisa, regina de' cori) in
onore della figlia di Miller nel giorno del suo compleanno. Entra in scena Luisa accolta dal padre
Miller con parole di tenero affetto (Ecco mia figlia). Luisa è tuttavia inquieta non scorgendo fra i
presenti l'amato Carlo, nome sotto il quale si cela Rodolfo, figlio del conte di Walter. Miller,
osservando l'ansia della figlia, tenta di dissuaderla da sentimenti amorosi verso uno sconosciuto.
Luisa esprime per contro la felicità di un amore corrisposto (LO vidi, e 'l primo palpito). I
compaesani circondano Luisa per offrirle omaggi floreali, fra di essi un giovane cacciatore nel
quale Luisa subito riconosce l'amato Carlo. Ora la gioia della fanciulla è al colmo (T'amo d'amor
che esprimere). Mentre in un angolo della scena, non visto, Wurm, castellano di Walter, osserva
l'azione, tutti si associano con lieti auguri alla felicità dei due giovani innamorati, tranne Miller che
in disparte esprime il timore che la figlia possa esser vittima di un seduttore. Si ode il rintocco
della campana della chiesetta: tutti abbandonano la scena cantando ed entrano a poco a poco nella
chiesa, a eccezione di Miller. Le voci si perdono in lontananza all'interno del tempio.
_ 3. SCENA ED ARIA. Improvvisamente appare Wurm; aspirante alla mano di Luisa e furente di
gelosia, s'accosta rapidamente a Miller: vantando il favore di cui ora gode presso l'attuale signore
del luogo, Walter, si scaglia aspramente contro il vecchio, reo di non aver costretto a forza la figlia
alle nozze con lui. Miller (Sacra la scelta è d'un consorte) protesta che un padre non può essere
tiranno contro la volontà dei figli:"in terra un padre somiglia Iddio per la bontade, non pel rigor".
Wurm allora gli svela, andandosene, che l'innamorato di Luisa si cela sotto mendace aspetto: egli è
in realtà il figlio dell'altero Walter. La rivelazione scuote l'animo di Miller che si sente macchiato
nell'onore: ira e dolore invadono il suo petto (Ah! fu giusto il mio sospetto!).
Sala nel Castello di Walter, con porta in fondo.
4. SCENA ED ARIA. Entra agitato in scena Walter seguito da Wurm: questi gli ha appena
riferito del legame amoroso tra il figlio Rodolfo e Luisa. Il tiranno teme che ciò possa impedirgli di
concludere le nozze di Rodolfo con una sua amica d'infanzia, la nipote Federica, ora duchessa
d'Ostheim. Rimasto solo, accusa il figlio d'ingratitudine (e tuttavia ch'egli non sappia quanto gli sia
costata la sua felicità...): tutto farebbe per lui, ma le dolcezze dell'"affetto paterno" non fanno
breccia nel suo cuore sdegnato (Il mio sangue, la vita darei).
5. SCENA E CORO. Rodolfo si presenta al padre. Questi gli annuncia le nozze con Federica, che
sa segretamente innamorata di lui sin dalla giovinezza, nozze illustri in quanto Federica, vedova
ed erede del duca d'Ostheim, è intima amica dell'imperatrice di Germania. Rodolfo confessa di non
nutrire ambizioni; ma il padre tronca sul nascere ogni sua protesta: "son leggi i miei voleri". Si ode
una musica che annuncia l'arrivo della Duchessa con seguito di damigelle, paggi, famigliari,
arcieri.Walter trae seco Rodolfo per andare incontro alla Duchessa. Un coro (Quale sorriso
d'amica sorte) festeggia il suo arrivo. Vivamente commossa Federica si getta amorosamente nelle
braccia di Walter. Avviandosi a impartire ordini per una partita di caccia, Walter le comunica che
Rodolfo implora l'onore di parlarle.
6. SCENA E DUETTO. Federica e Rodolfo restano soli. Ella ricorda il tempo felice della prima
gioventù quando i loro due cuori stavano per aprirsi a un tenero sentimento. L'"a due"(Dall'aure
raggianti di vano splendor) si spezza in un parlante in cui Rodolfo rivela a Federica di essere
costretto da padre spietato a chieder perdono di un errore non suo: confessa di non poterle offrire
un cuore appartenente ormai ad altra donna e chiede pietà; Federica, sorpresa e turbata, gli ricorda
che "da geloso core" non può aspettarsi favore (Deh!... la parola amara perdona).
Interno della casa di Miller. Due porte laterali; una mette alla stanza di Miller, l'altra a quella di Luisa;
accanto alla prima pende una spada ed una vecchia assisa da soldato; nel prospetto l'ingresso ed una finestra,
da cui si scorge parte della chiesetta.
7. CORO DI CACCIATORI E FINALE PRIMO. Luisa è sola e muta in scena; si odono per le
montagne e le vallate circostanti grida e rimbombo di 'strumenti da caccia (Sciogliete i levrieri).
Entra Miller, si getta accasciato su una sedia (Oh padre mio!... Che fu?...); mentre il coro di
cacciatori si perde in lontananza, egli rivela alla figlia di essere tradita: Carlo è in realtà il figlio del
conte di Walter e ora si appresta a splendide nozze. La fanciulla è stupita e incredula. Aggirandosi
adirato per la stanza e trovatosi di fronte alla vecchia divisa militare, il vecchio Miller giura di
vendicare l'onore della figlia. In quel mentre appare sulla soglia Rodolfo, che ha udito le ultime
parole del vecchio (Luisa, non temer..):è vero, bugiardo fu il nome, ma non le promesse d'amore.
Pone Luisa in ginocchio ai piedi di Miller e prostrandosi anch'egli stringe nella sua la destra di lei,
solennemente giurando:"Son io tuo sposo!". Infine a Miller, che paventa l'ira di Walter sulla
propria famiglia, il giovane svela d'essere a conoscenza di un terribile segreto in grado di ridurre il
proprio padre all'impotenza. Ma ecco che il Conte in persona si presenta nella stanza di Miller (Tu,
tu, signor): armato del proprio diritto è sua intenzione di porre fine a "colpevol tresca". Rodolfo si
ribella appellandosi alla purezza del sentimento che lo lega a Luisa. Ma il Conte accusa
sprezzantemente la fanciulla di essere una "venduta seduttrice". Luisa cade fra le braccia del padre;
Rodolfo snuda la spada in atto di parricidio e tosto la ripone, così significando il proprio gesto: "La
vita mi donasti! Lo rimembra... t'ho pagato ora il dono!". Anche Miller, il vecchio soldato, insorge
contro Walter per chiedere giustizia del grave insulto. Per tutta risposta il Conte fa accorrere un
drappello d'arcieri, seguìto da molti contadini, ordinando loro di arrestare Miller e Luisa. Questa
s'inginocchia supplice ai piedi di Walter, ma il padre le impone fieramente di rialzarsi (Fra' mortali
ancora oppressa): l'innocenza non si genuflette alla superbia ma a Dio. Mentre Luisa, disperata,
implora salvezza al Signore, Walter insiste nel piegare alla propria volontà il figlio, che invece, con
l'inferno nel cuore, proclama l'indissolubilità di un nodo formato da Dio. Nel momento in cui
Walter si appresta a far eseguire l'ordine di arresto (I cenni miei si compiano) Rodolfo insorge col
ferro sguainato tentando invano di impedire che gli arcieri sottraggano Luisa. L'ira furibonda che
lo invade lo trascina dapprima a giurare al padre di seguire Luisa in carcere ("Ebbene, la segui"),
quindi di trapassarle il cuore con la spada ("Uccidila. Che tardi?"). Di fronte all'atteggiamento
irremovibile del padre, Rodolfo gioca l'ultima carta disperata (Tutto tentai... non restami), quella
del terribile segreto di cui aveva fatto cenno ai Miller: si avvicina al padre minacciandolo sotto
voce in un orecchio di svelare a tutti in qual modo egli sia giunto "ad essere conte di Walter"... ed
esce rapidamente di scena. Come folgorato dalle parole del figlio, convulso e pallido in volto più
della morte,Walter ordina che Luisa sia lasciata libera. Gli arcieri partono traendo seco il vecchio
Miller, mentre la fanciulla cade in ginocchio mezzo svenuta.
ATTO SECONDO: L'intrigo
Interno della casa di Miller.
8. INTRODUZIONE (LUISA E CORO). Gli abitanti del villaggio recano a Luisa il triste
annuncio che suo padre è stato visto trascinato in catene al carcere. La fanciulla fa per accorrere al
castello a implorare la grazia; ma ecco che alla soglia della stanza appare Wurm, che impone agli
astanti di uscire.
9. SCENA ED ARIA. Wurm comunica a Luisa che il padre, resosi colpevole di oltraggio e di
minacce al Conte, è stato condannato alla scure... essa può tuttavia salvarlo... ma a una condizione,
imposta dal Conte medesimo: dovrà, scrivere una lettera indirizzata a Wurm. Luisa, affranta per la
sorte del padre, si accinge a scrivere il foglio sottoponendosi alla dettatura di Wurm (Wurm. Io
giammai Rodolfo non amai): nella lettera essa deve dichiararsi innamorata da sempre di Wurm e
confessare di essere stata attratta da Rodolfo solo per ambizione e non per amore... Il lamento di
un clarinetto in orchestra sottolinea l'atroce dolore di Luisa, rassegnata al sacrifizio, nello scrivere
le parole dettategli dal diabolico castellano. Ma alla fine, improvvisamente insorgendo, essa si
rifiuta di firmare il foglio e in uno slancio di passione supplica Dio di non lasciarla in abbandono al
furore dei "barbari" (Tu puniscimi, o Signore) che la vogliono disonorata per salvare l'innocente
genitore.Wurm fa l'atto di ritirarsi dicendo freddamente a Luisa di ritenersi libera d'agire come
meglio crede. La fanciulla, ormai consapeyole che un suo rifiuto condannerebbe il padre a morte,
torcendosi convulsamente le mani si accosta alla tavola e firma l'infame foglio. Ma al perfido
Wurm ciò non basta (Sul capo del padre): impone a Luisa di giurare che la lettera è stata scritta da
lei spontaneamente, inoltre ingiungendole di venire al castello per mostrarsi, al cospetto della
Duchessa, innamorata di lui,Wurm... Solo in tal caso il padre sarà salvo. Luisa prorompe in un
grido di dolore (A brani, a brani, o perfido) e invoca la morte per sé, mentre Wurm esprime a parte
la speranza di stringere la sua mano.
Verdi in Russia (1861 - 1862)
Il castello: appartamenti di Walter
10. SCENA E DUETTO. Il Conte è determinato a compiere l'opera; il figlio è fuor di senno (Egli
delira), ma "esser pietoso crudeltà sarebbe". Sopraggiunge Wurm: assicura che la trama è ormai
pronta, non resta che far recapitare, da un uomo prezzolato, la lettera di Luisa a Rodolfo, e la
vittoria è certa. Non riesce però a comprendere come il Conte avesse dapprima ceduto alla
ribellione del figlio. Walter si giustifica adducendo il timore che egli possa conoscere il delitto
commesso per impadronirsi della Contea. D'altronde non per altri che per il proprio figlio egli l'ha
usurpata al cugino (L'alto retaggio non ho bramato). Con tono misterioso Wurm gli ricorda il
misfatto e cioè come un giorno gli avesse riferito una confidenza fattagli dal cugino, padrone della
contea: il suo proposito di sposarsi. Per impedire un matrimonio che avrebbe tolto l'eredità a
Walter, Wurm stesso aveva suggerito "orribil mezzo": uccidere il cugino in un agguato notturno
nella foresta per la quale egli sarebbe dovuto passare, accusando poi del delitto una masnada di
banditi. Il Conte rabbrividisce al ricordo. Ma Wurm lo calma: l'evento è ormai sepolto nei misteri
di notte eterna e tutti ritengono il cugino ucciso dai masnadieri. Non tutti! insorge il Conte: al
rumore dell'armi il figlio era accorso in tempo perché il cugino moribondo nominasse gli assassini
(Al rombo mio figlio accorse)... Wurm si sente perduto, ma il Conte gli ricorda che Satana lo ha
congiunto ai propri destini (O meco incolume sarai, lo giuro).
11. SCENA E QUARTETTO. Sopraggiunge Federica. Congedato Wurm con un cenno, Walter
rassicura la Duchessa sui sentimenti del figlio: l'amore per Luisa è ormai spento, poiché Luisa è
d'altri, e anzi ella stessa è stata condotta al castello per attestarlo. La Duchessa, stupita per la
rapidità degli eventi, si siede, cercando di ricomporsi dal suo turbamento. Walter apre una porta
segreta, donde esce Luisa accompagnata da Wurm (Presentarti alla Duchessa). Mentre Federica
con sussiego invita la fanciulla ad avvicinarsi, Wurm ricorda sottovoce a Luisa il pericolo che sta
correndo il padre. Federica, commossa dal candore della fanciulla, la interroga avvertendo che un
solo suo detto può farla sventurata o felice. Sente che ella non può mentire; prendendole la mano e
guardandola fissa negli occhi le chiede se veramente ama Rodolfo. Schiantata dal dolore Luisa
afferma di amare solo Wurm... Tuttavia, nel dubbio che la fanciulla nasconda in cuore un mistero,
Federica insiste perché Luisa dica tutta la verità. In procinto di svelare il segreto, anche Walter
insiste perché ella parli "per quanto ami il padre"... Il ricordo dell'amato genitore è lancinante per
la giovane. Gli sguardi di Walter e Wurm stanno immobili sopra di lei. Ella sente di non poter
agire diversamente se non riaffermando alla Duchessa di nutrire un solo immenso amore: e
accenna a Wurm... Federica ne trae indicibile conforto; dal canto loro Walter e Wurm non celano
la loro soddisfazione, mentre Luisa è al colmo della prostrazione (Come celar le smanie). Federica
si ritira seguita da Walter; Wurm riconduce Luisa per l'uscio segreto.
Giardino pensile del castello. Porta nel fondo che mette agli appartamenti di Rodolfo.
12. SCENA ED ARIA - FINALE SECONDO. Rodolfo viene precipitoso da un appartamento: ha il
foglio di Luisa tra le mani; un contadino lo segue. Questi gli viene narrando come Luisa lo avesse
sollecitato a recar segretamente quel foglio a Wurm (Il foglio dunque?); ma sospettando una trama
e sperando in una ricompensa egli ha risolto di consegnarlo a Rodolfo... Congedato il contadino
con una borsa di denari, Rodolfo ordina a un servo di chiamare Wurm. Infine esplode in
un'invettiva contro Luisa (Oh! fede negar potessi agl'occhi miei!...): i giuramenti, le speranze, la
gioja, tutto è menzogna, tradimento, inganno! Quando ella nelle ore dell'incantò amoroso gli
stringeva la mano e gli diceva "amo te solo", in realtà lo tradival... (Quando le sere al placido).
Sopraggiunge Wurm (Mi chiedeste?). Rodolfo gli porge il foglio di Luisa perché lo legga. Ripreso
il foglio, presenta a Wurm due pistole sfidandolo a duello mortale. Mortale per entrambi:"Meco ad
un punto solo spento cader al suolo t'è forza". Wurm, impaurito, arretra rapidamente scaricando la
pistola in aria. Al rumore dell'arma accorrono da ogni parte armigeri e famigliari. Confòndendosi
tra i sopravvenuti, Wurm sparisce. Accorre anche Walter; Rodolfo disperato cade ai suoi piedi.
Walter fa mostra di essere pentito del proprio rigore accordando al figlio il consenso alle nozze
con Luisa. Ma ora Rodolfo chiede solo compianto: Luisa lo ha tradito! Il padre lo rincuora
affermando che in tal caso la migliore vendetta è quella di condurre all'altare la Duchessa. Rodolfo
sembra acconsentire; ma in realtà egli delira dalla disperazione (L'ara, o l'avello apprestami);
dichiarando d'abbandonarsi al proprio destino, sia esso l'altare o la tomba, sente di non poter più
vivere senza Luisa.
ATTO TERZO: Il veleno
Casa di Miller. La finestra è aperta, ed attraverso di essa si vede il tempio, internamente illuminato.
13. CORO D'INTRODUZIONE. Luisa scrive presso una tavola, su cui arde una lampada; sulla
tavola medesima vi sono un cesto di frutta e una tazza colma di latte; in un canto della stanza
Laura e altre paesane mestamente contemplano Luisa (Come in un sol giorno) e osservano le
funeste impronte stampate sulla sua fronte. Laura esorta la fanciulla a ristorarsi con del cibo (O
dolce amica); ma ella rifiuta, e fra sé già medita il suicidio volando col pensiero alle "celesti
dolcezze". Osserva la chiesa illuminata e ne chiede la ragione; le contadine confuse fingono di non
saperlo: tacciono all'infelice che vi si sta apprestando il rito nuziale di Rodolfo con Federica. Dopo
una breve ripresa del coro entra, liberato dal carcere, il vecchio Miller, nelle cui braccia subito
accorre Luisa. Laura e le compagne lentamente si ritirano.
14. SCENA E DUETTO. Miller confida alla figlia d'aver appreso da Wurm quale immenso
sacrificio le è costato salvargli la vita (Pallida... mesta sei!). Mentre Luisa va lentamente alla tavola
a ripiegare un foglio appena scritto, il padre osserva in lei una calma funesta, tristemente presaga...
Chiede la ragione del foglio. Luisa prega solo che sia recato al suo destinatario. Miller guarda
fissamente Luisa, poi apre il foglio e legge; è diretto a Rodolfo; parla di tradimento, di giuramento
che non può essere infranto, di dimora dove tradimento e giuramento non hanno più alcun potere e
dove invita Rodolfo a venire a mezzanotte...A Miller cade il foglio di mano, vacilla muto di fronte
alla figlia: quella dimora sarebbe dunque... "La tomba" ella risponde... Miller inorridisce ed esplode
in un urlo di dolore. Luisa lo rincuora (La tomba è un letto sparso di fiori): la morte veste orride
forme per i colpevoli, ma è un angelo per gli innocenti. Il vecchio Miller ricorda alla figlia con
terribile accento che "pel suicida non v'ha perdono!". S'allontana raccapricciato e cade sopra una
sedia; quindi prorompe in lagrime, sorge, e stretta la figlia per mano, le dice che l'amore che un
padre ha seminato deve poter essere da lui raccolto nei suoi tardi anni; la tomba della figlia sarà
ancor prima la tomba del genitore. Luisa cede al dolore del padre, riconosce di essere colpevole, fa
a pezzi il foglio (il foglio lacero, annullo) e pentita cade ai suoi piedi. Miller la rialza e se la stringe
al seno. Insieme concordano di fuggire da un luogo così pericoloso. Luisa consiglia al padre un
breve sonno onde poter partire con la nuova aurora. Miller si avvia alla sua stanza, poi ritorna ed
abbraccia ancora una volta la figlia: sarà loro destino restare sempre insieme ramingando per il
mondo e chiedendo pane agli uomini di porta in porta (Andrem, raminghi e poveri).
. 15. SCENA, PREGHIERA, DUETTO E TERZETTO FINALE. Mentre il padre entra nelle sue
stanze a riposare, Luisa s'avvia lentamente all'opposto lato, quando la sua attenzione è richiamata
dai lenti accordi provenienti dalla chiesa. S'inginocchia per elevare una preghiera al cielo, l'ultima
preghiera nella casa dove ha finora felicemente vissuto. Intanto che è china, immersa in tacita
preghiera, un uomo avvolto in lungo mantello si è fermato sulla porta: è Rodolfo; a un famigliare
che lo segue ordina di riferire al padre che lì lo attende non appena sarà pronto il rito nuziale.
Osserva Luisa nella sua preghiera; quindi trae dal seno un'ampolla e ne versa il liquore nella tazza.
Luisa si rialza, vede Rodolfo e trasalisce. Bruscamente spiegandole sott'occhio la lettera a Wurm,
Rodolfo le chiede se ella stessa l'ha scritta... (Hai tu vergato questo foglio?). Con lo sforzo d'una
morente che proferisce l'ultima parola, Luisa, fedele al giuramento fatto, annuisce. Rodolfo
s'accascia su una sedia; accusando l'arsura che lo invade chiede una bevanda e accenna alla coppa
avvelenata. Luisa, ignara, gliela porge: Rodolfo beve e invita Luisa a fare altrettanto. Mentre Luisa
beve, Rodolfo impallidisce e volge altrove lo sguardo dicendo fra sé: "Tutto è compiuto!". Infine le
si rivolge col dire che opposti destini stanno per dividerli: altro uomo attende Luisa, altra donna
attende Rodolfo. Entrambi attenderanno invano... Il giovane percorre a gran passi la scena, si
strappa la sciarpa e la spada e le getta lungi da sé. Si sente mancare il respiro: Luisa cerca di
ristorarlo offrendogli la tazza... Ma egli reagisce al suo gesto chiamandola "infame". La fanciulla
invano protesta. Rodolfo la allontana da sé esprimendo dolorosi pensieri: come può Dio dare
sembianze d'angelo a un'anima d'inferno? E mentre Luisa si sforza di tacere, Rodolfo, al colmo
della disperazione, con voce soffocata si trova a chiedere pietà... alla fine prorompe in lagrime.
Luisa benedice il suo pianto (Piangi, piangi, il tuo dolore): esso è più giusto dell'ira; ma per Rodolfo
quelle lagrime non sono di conforto, sono stille di sangue di uomo abbandonato da Dio. L'orologio
del castello batte le ore. Rodolfo stringe Luisa per mano (Donna, per noi terribile): nell'ora
suprema vuol sapere se ella veramente ama Wurm...; guai a lei se mentisce: prima che la lampada si
spenga sarà davanti a Dio, e additando la tazza: "con me bevesti la morte". Luisa rimane come
trasognata... ma infine si rianima: la morte la scioglie da ogni vincolo, ora può dire a Rodolfo tutta
la verità. Gli narra come per salvare il padre fosse stata costretta da Wurm a scrivere quella
lettera. Rodolfo è esterrefatto: ora non sa darsi pace d'aver egli stesso ucciso l'innocente Luisa...
Cacciandosi le mani fra i capelli, e col grido terribile della disperazione, maledice se stesso, il
proprio sangue, il padre (Maledetto, maledetto il dì ch'io nacqui); invano Luisa cerca di trattenerlo
dall'inveire contro il cielo nell'ora della morte. Alle loro grida accorre Miller (Quai grida intesi?):
Rodolfo gli si confessa assassino della figlia e raccogliendo la spada fa per svenarsi. Ma Luisa lo
arresta; sente la morte serpeggiare in seno. Miller non comprende: Rodolfo gli svela che è stato il
veleno. Il vecchio si slancia verso la figlia, che annoda le braccia al collo paterno per riceverne
l'ultima benedizione (Padre... ricevi l'estremo addio). Rodolfo invoca perdono a Luisa; Miller
rimpiange il sogno crudele di un promesso incanto; Luisa protende la mano a Rodolfo ("Ah! vieni
mero... deh! non lasciarmi...") per salire con lui in cielo, e muore. Si odono voci interne. L'azione
precipita e tutto si svolge in un baleno. Entra Walter, seguito di lontano da Wurm. Entrano anche
delle donne che si fanno subito intorno al cadavere di Luisa, presso il quale è rimasto Miller in
ginocchio, immoto e pallido più del cadavere stesso. Rodolfo, scorto Wurm, rimasto sulla soglia,
afferra velocemente la spada, e lo trafigge; quindi rivolto al padre: "La pena tua... mira..." e cade
morto accanto a Luisa. Cala rapidamente la tela.
Stiffelio
Melodramma [in tre atti] di Francesco Maria Piave
Prima rappresentazione:Trieste,Teatro Grande [oggi Teatro Verdi], 16 novembre 1850
L'argomento deriva dal dramma Le Pasteur, ou l'Évangile et le Foyer di Émile Souvestre ed
Eugène Bourgeois, rappresentato a Parigi nel febbraio 1849, ma già noto in Italia alle compagnie
drammatiche col titolo Stifelius nella traduzione di Gaetano Vestri pubblicata nel 1848. Scioltosi
alla fine del gennaio 1850 dall'obbligo di una seconda opera per Napoli, Verdi cedette a Ricordi
l'opera che doveva scrivere per il S. Carlo, con l'impegno di farla rappresentare in un teatro
primario nel novembre del 1850. Intanto in maggio il compositore firmava un contratto anche con
la Fenice di Venezia. Fu in questa circostanza che nacque il progetto di Stiffelio; e fu Piave a
proporre l'argomento in vista appunto dell'opera per la Fenice. Ma per questo teatro Verdi aveva
già pensato a Le Roi s'amuse di Victor Hugo (il futuro Rigoletto); accolse invece la proposta di
Piave come argomento per l'opera che s'era impegnato a scrivere per Ricordi, il quale la destinò al
Teatro Grande di Trieste. Stiffelio fu composto tra luglio e ottobre del 1850. Alla vigilia della
prima rappresentazione esso andò tuttavia incontro a guai con la censura triestina, che, sollecitata
anche dalle proteste della locale comunità di protestanti, impose poche ma determinanti modifiche,
tali da stravolgere nel finale la situazione drammatica. Dopo la prima rappresentazione l'opera
ebbe vita breve e tormentata; ripresa a Trieste, quindi a Venezia, a Verona, a Barcellona e a Oporto
col titolo originale, fu devastata dall'intervento della censura papalina che ne modificò il libretto in
Guglielmo Wellingrode, e in questa veste rappresentata oltre che a Roma anche a Firenze, Napoli
e Palermo, ma senza fortuna. Verdi si convinse che l'opera poteva sopravvivere riscrivendola su un
argomento che fosse accetto alle censure italiane, e la trasformò in Aroldo (1857). Stiffelio
scomparve definitivamente dal giro; l'editore Ricordi addirittura ne fuse i piombi. La scoperta in
età moderna di una copia manoscritta coeva ne ha consentito la ripresa, a cominciare dal Teatro
Regio di Parma il 26 dicembre 1968 (in edizione peraltro non molto rispettosa dell'originale). La
ripresa abbinata di Stiffelio e Aroldo alla Fenice. nel dicembre del 1985 sembra aver
definitivamente consacrato quest'opera nel rango dei capolavori del genio di S. Agata.
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
STIFFELIO, ministro [pastore] assasveriano primo tenore Gaetano Fraschini
LINA, sua moglie, figlia di prima donna Marietta Gazzaniga Malaspina
STANKAR, vecchio colonnello, conte dell'impero primo baritono Filippo Colini
RAFFAELE, nobile di Leuthold tenore Ranieri Dei
JORG, altro vecchio ministro basso Francesco Reduzzi
FEDERICO di Frengel tenore Giovanni Petrovich
DOROTEA, cugini di Lina soprano Amalia Viezzoli De Silvestrini
FRITZ, servo che non parla mimo N. N.
Cori e comparse: Amici del conte e Discepoli di Stiffelio. Popolo assasveriano
Scena: Un castello del conte di Stankar in Germania [più propriamente nel Nord-Tirolo, nei pressi di Salisburgo],
sulle rive del Salzbach, e suoi dintorni
Epoca: il principio del secolo XIX
Nota storica: Il nome di Stiffelio (Stifelius) - che nel dramma copre in realtà quello di Rodolfo
costretto a nascondere il suo vero nome in quanto perseguitato per le proprie idee religiose adombra quello di Micael Stifel (1487-1567), predicatore e seguace di Lutero, transfuga in
Sassonia dopo un periodo di apostolato in Austria; ma ricorda anche quello di uno Siiffelius
seguace di un certo Miiller, forse antesignano della moderna pranoterapia. La confessione religiosa
degli "assasveriani", dissidenti luterani, di cui Stiffelio è ministro ovvero "pastore evangelico", è
pura invenzione degli autori francesi; l'appellativo è ricavato da Assasvero (Ashaverus o anche
Ahasuerus), nome che nel primo Ottocento designava l'Ebreo Errante. Nel dramma è citata la
Messiade di Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803): si tratta di un poema in esametri, diviso in
venti canti, composto fra il 1748 e il 1777.
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
1. SINFONIA. È in due movimenti,Andante e Allegro. L'Andante inizia con la citazione della
melodia del salmo "Non punirmi, Signor, nel tuo furore" nel finale del secondo atto, e prosegue
con una melodia per tromba, arricchita nella ripresa dal controcanto dei legni. L'Allegro si apre
con un tema ricavato dal coro del primo atto "A te Stiffelio un canto"; il secondo tema deriva dal
coro "Concordi qui regnino la gioia" nel finale del primo atto.
ATTO PRIMO
Sala terrena nel castello del conte di Stankar; nel fondo una porta nel centro, con finestra a sinistra dello
spettatore, un caminetto ardente a diritta. Davanti la finestra, verso la metà della scena, una gran tavola
con vari libri, tra i quali uno piuttosto grande legato in tutto lusso con fermaglio chiuso a chiave.
L'occorrente per scrivere.
2. INTRODUZIONE E RACCONTO. Jorg, seduto presso il tavolo, sta leggendo la Bibbia;
rinchiuso il libro, il suo pensiero corre a Stiffelio, che esorta a perseverare nella sua missione di
fustigatore dei nemici di Dio. Una musica allegra annuncia il ritorno di Stiffelio (il cui vero nome è
Rodolfo Miiller) da una delle sue missioni. Jorg esprime la speranza che il suo matrimonio non sia
d'inciampo allo zelo missionario. Entra Stiffelio; Lina è al suo braccio; lo seguono Stankar,
Raffaele, Federico e Dorotea che esprimono felicità per il suo ritorno. Dorotea avvisa il ministro
che un battelliere lo ha cercato. Si tratta di Valter, afferma Stiffelio, che lo aveva già consultato su
uno strano caso. E descrive (Di qua varcando sul primo albore) come questo Valter una mattina
vedesse un uomo saltar giù da una finestra nel fiume, sotto lo sguardo di una donna che sembrava
terrorizzata.
3. SCENA E SETTIMINO. Il fatto era accaduto otto giorni prima. Il fuggitivo non fu
riconosciuto, ma perse dei fogli, che il battelliere consegnò a Stiffelio. Questi trae di tasca un
portafoglio ed estrae i fogli; non vuole leggerne il contenuto; potrebbe trattarsi di colpevole tresca,
e getta alle fiamme il portafoglio: arda con esso il nome del seduttore. Lina e Raffaele traggono un
sospiro di sollievo. Stiffelio spiega il suo gesto ricordando il comandamento del perdono (Colla
cenere disperso). Alla voce di Stiffelio s'intrecciano quelle dei presenti: mentre Jorg, Dorotea e
Federico ammirano il nobile gesto di Stiffelio, Lina ringrazia il cielo d'essersi salvata,
proponendosi di non cadere più nell'errore, Raffaele le suggerisce di continuare a simulare
chiedendole inoltre un nuovo colloquio, e Stankar già sospetta di lui e medita vendetta.
4. SEGUITO E STRETTA DELL'INTRODUZIONE. Si odono grida interne: Viva Stiffelio!
Guardando dalla finestra Jorg annuncia l'arrivo di una schiera di amici e partigiani di Stiffelio che
vengono a festeggiare il suo ritorno. Essi entrano cantando le sue lodi (A te Stiffelio un canto): il
suo nome è ormai famoso in Germania per la sua opera di fustigatore del vizio e di propaganda del
Verbo divino; e mentre Stiffelio esorta gli amici a lodare Dio, Lina in disparte si sente lacerare da
un rimorso atroce; dal canto suo Raffaele, di fronte alla prospettiva di arrivare in fondo
all'avventura, soffoca ogni senso di colpa, mentre Stankar, cui non sfugge lo stato d'agitazione
della figlia, si propone di soccorrerla. Alla fine tutti partono, seguendo Stankar nelle sue stanze,
meno Stiffelio e Lina, che s'abbandona su una sedia presso la tavola.
5. SCENA ED ARIA. Rimasti soli, Stiffelio si mostra sorpreso del silenzio della moglie. Lina
supplica il marito di poterlo chiamare col dolce nome col quale l'aveva conosciuto la prima volta:
Rodolfo Múller; da allora egli è andato godendosi i piaceri del gran mondo lontano da lei. Stiffelio
le risponde che non potevano esservi piaceri senza di lei; ha visto dovunque giovani e vecchi in
schiavitù del vizio e della corruzione (Vidi dovunque gemére), ha visto la giustizia offesa e ha visto
anche donne rompere il vincolo coniugale. Vedendo Lina confusa dalle sue parole, Stiffelio
s'interrompe per assicurarla che la sua fedeltà lo conforta; guai se si scoprisse ingannato! Lina
insinua che la grandezza d'animo del marito perdonerebbe un torto fatto al suo onore. Stiffelio le
risponde che il perdono è facile a chi non è ferito in cuore. Ma s'avvede che la moglie piange ed è
tutta tremante; chiedendo la ragione del suo affanno egli le ricorda che oggi è l'anniversario del
loro matrimonio, che la madre benediceva dal cielo con il suo anello. Nel prenderle la mano nota
che al dito l'anello non c'è più! Con foga crescente egli la interroga; ma Lina non sa rispondere e
scoppiando in pianto si copre il viso con le mani. Il silenzio della moglie equivale per Stiffelio a
un'ammissione di colpa (Ah v'appare in fronte scritto): sul ritmo turbolento della musica egli
manifesta una disperazione furente: `Possa la terra inghiottirmi se mi ha colto il disonore!' Lina è
impotente a reagire. Entra Stankar per annunciare a Miiller che gli amici lo attendono; non gli
sfugge l'ira che gli sta sul volto. Promettendo a Lina di tornare, Stiffelio parte con Stankar.
6.SCENA E PREGHIERA. Lina, agitatissima, eleva una preghiera a Dio invocando perdono (A te
ascenda, o Dto clemente).
7. SCENA E DUETTO. D'impeto Lina decide di scrivere una lettera a Stiffelio, ma non riesce ad
andare oltre le prime parole. Improvvisamente entra Stankar, si avvicina silenzioso e sospettoso;
prende la lettera e legge: "Rodolfo! di voi non son più degna". Dunque i suoi sospetti erano fondati.
Con voce rotta dall'emozione Lina si giustifica affermando di non poter tacere la propria colpa.
Allora, le risponde il padre con crescente collera, Lina, non contenta di tradire Stiffelio, sarebbe
pronta a dargli morte con la vergogna e il dolore: non le basta l'infamia, ora vuol essere anche vile
(Dite che il fallo a tergere); no, ella salverà lo sposo subendo immeritatamente il suo amore. E
proprio lui, Stankar, doveva conoscere il disonore di scoprire in sua figlia un'adultera confessa (Ed
io pure innanzi agli uomini)! Invano Lina, in preda al pianto, sostiene d'essere stata complice di un
intrigo contro la propria volontà. Stankar le impone di seppellire la sua colpa nel silenzio (Or meco
venite, il pianto non vale): nessuno deve sospettare. Lina si sottomette alla volontà del genitore;
ma sa d'aver perduto per sempre l'amore dello sposo. Entrambi escono a sinistra.
'8. SCENA. Dalla parte opposta entra cautamente Raffaele; fuori dalla finestra si intravede Jorg.
Raffaele vuole un colloquio con Lina: con le spalle volte alla finestra, trae di tasca una lettera;
scorge il grande libro chiuso da un fermaglio (è la Messiade di Klopstock): con una doppia chiave
lo apre, vi inserisce la lettera e richiude a chiave il fermaglio. Jorg vede tutto, ma non il volto
dell'uomo. Entra Federico per richiedere il libro; Raffaele glielo consegna. Entrambi escono a
sinistra. Jorg scompare dalla finestra.
Sala di ricevimento nel castello, illuminata e parata per una festa.
9. CORO NEL FINALE PRIMO. Amici di Stiffelio e di Stankar, invitati a un ricevimento per
festeggiare il ritorno di Stiffelio, giungono con le loro spose introdotti da servi ed elevano un canto
di plauso al "grande oratore" (Plaudiam! di Stiffelio s'allieti il soggiorno). Da destra entrano
Stiffelio e Jorg; fra i due si svolge un dialogo serrato, mentre gli ospiti si raccolgono sul fondo
della sala sempre cantando. Dopo aver giustificato il proprio ritardo - in quanto solitamente
rifugge dalle feste mondane che spesso celano insidie amorose - Jorg rivela a Stiffelio quanto ha
appena visto, e cioè che un "signore" nascose un biglietto in un libro chiuso con fermaglio; quel
biglietto "che aspetta risposta", insinua Jorg, è strumento di una tresca! Entra frattanto anche Lina
al braccio di Stankar; quindi da sinistra ecco Raffaele con Dorotea e Federico, che ha con sé il libro
di Klopstock e che subito si mette a discorrere con Lina. Stiffelio è sorpreso dalla rivelazione di
Jorg; alla richiesta di chi sia il colpevole, Jorg gli indica colui che ha il libro, cioè Federico. Stiffelio
resta sconcertato, mentre gli ospiti avanzano dal fondo della sala attorniandolo e concludendo il
loro canto.
10. SEGUITO DEL FINALE PRIMO. Dorotea e Federico chiedono a Stiffelio se ha pensato al
sermone che terrà la sera stessa alla riunione nel tempio; il ministro risponde, fissando Federico,
che l'argomento sarà antico: il tradimento; parlerà non solo di chi vendette Gesù ai suoi nemici
(Non solo all'iniquo), ma di quanti tradiscono le leggi dell'ospitalità e del vincolo matrimoniale; su
di essi esprimerà la condanna ripetendo l'anatema del grande poeta della Messiade. Prende il libro
dalle mani di Federico per aprirlo. Ma il fermaglio è chiuso. Dorotea avverte che è Lina ad averne
la chiave. Stiffelio ordina tosto alla moglie di aprirlo; notando il suo terrore, insiste: egli sa che nel
libro è rinchiusa la condanna del traditore.
11. LARGO DEL FINALE PRIMO. L'azione improvvisamente s'arresta: tutti sono come
paralizzati dal mistero, fatale e terribile, rinchiuso nel libro (Oh qual m'invade ed agita).
12. STRETIA DEL FINALE PRIMO. Stiffelio decide di forzare il fermaglio del libro; mentre vi è
intento ne esce una lettera che cade a terra. Stankar la raccoglie; Stiffelio gli ordina di
consegnargliela. Ma il vecchio rifiuta, sostenendo che il ministro deve ignorare chi l'ha scritta e a
chi è diretta, e la riduce in brani. Al colmo dell'ira Stiffelio si scaglia contro Stankar (Chi ti salva, o
sciagurato). Lina si frappone invocando su di sé l'ira del marito. E mentre gli ospiti esprimono
turbamento alla vista di Stiffelio lacerato da un diabolico sospetto, Stankar s'avvicina a Raffaele e
sottovoce lo sfida a duello, dandogli appuntamento al cimitero; Raffaele raccoglie la sfida con
sfrontatezza. Alla fine Stiffelio e Jorg partono dalla destra; Lina e Stankar dalla sinistra; gli altri
dal mezzo. Cala la tela.
ATTO SECONDO
Antico cimitero. Nel centro è una croce con gradini; a sinistra la porta d'un tempio internamente illuminato,
a cui si ascende per grandiosa scalea; a destra più in fondo si vede il castello di Stankar; la luna piove sua
luce sulle sparse tombe ombreggiate da spessi cipressi; tra queste ve n'è una recente.
13. SCENA ED ARIA. La scena si apre su un preludio strumentale dal carattere lugubre e, a un
tempo, tempestoso. Entra Lina dal fondo, agitatissima, come trascinata da una forza invisibile; su
C)gni tomba le sembra di vedere scolpito il proprio delitto. S'aggira barcollando fra i sepolcri fino
a trovarsi di fronte all'avello della madre, presso il quale è l'appuntamento con Raffaele. Lina prega
la propria madre che dal cielo vede i suoi affanni (Ah dagli scanni eteree) ed offre le proprie lacrime
al trono di Dio; se questo non bastasse, anche la madre dovrà unirsi al suo pianto, così Iddio non
potrà negarle il perdono. Entra Raffaele frettoloso. Lei lo esorta a parlare a bassa voce: il padre è
nei pressi e il marito ha indovinato la situazione. Raffaele le risponde che dopo che Stankar ha
distrutto la prova Stiffelio sospetta di Federico. Lina, in preda al rimorso, vuole interrompere
quella relazione: ella non lo ama. Ma Raffaele si appella al suo amore. Ella insiste, e chiede la
restituzione dell'anello e delle lettere supplicandolo di fuggire. Ma Raffaele non sembra intendere
ragione. Lina disperata lo supplica un'ultima volta (Dunque perdere volete): se resta, la sua vita
sarà un eterno pianto; se fugge, su lui non cadrà la sua maledizione, malgrado proprio a lui debba
tutte le sue disgrazie.
Verdi fotografato a Parigi da Nadar (ca. 1866-1867)
14. SCENA E DUETTO. Poiché Raffaele insiste nel restare, Lina gli dichiara che dirà tutto allo
sposo. In quel punto sulla porta del tempio, appare improvvisamente Stankar avvolto in un
mantello sotto il quale cela due spade. Ha sentito la dichiarazione di Lina; con tono severo le
impone di partire; ella obbedisce. Quindi, rimasto solo con il seduttore, getta il mantello
presentando le spade e sfidandolo a un duello mortale (Scegli... Un duello?). Il giovane rifiuta di
battersi con un vecchio. Stankar inveisce contro di lui accusandolo d'infamia e di viltà; e come se
non bastasse questa accusa a fargli accettare la sfida, Stankar gli rivela di conoscere la sua vera
identità: egli non è un nobile, bensì un trovatello, figlio di padre ignoto.A tale rivelazione Raffaele
s'infuria e si precipita a scegliere una delle due spade che Stankar gli presenta; entrambi esplodono
in minacce di morte (Nessun demone, niun Dio). Quindi si battono accanitamente.
15. SCENA E QUARTETTO. Richiamato dal rumore delle armi, appare Stiffelio alla porta del
tempio: con accento autoritario ordina di cessare il duello; il luogo è sacro (Santo è il loco che sì
profanate)! I due contendenti insistono nel continuare il duello altrove. Ma Stiffelio ricorda loro di
parlare in nome di Dio: sia dimenticata l'offesa e il fratello perdoni al fratello. Ciò dicendo si
rivolge al più giovane dei duellanti, Raffaele, lo disarma e gli stringe la mano. A tale azione
Stankar non si trattiene e grida al seduttore: la mano che stringi è quella dell'uomo che hai tradito!
Stiffelio, allibito, chiede spiegazioni. Intanto dal fondo appare Lina che si precipita da Stiffelio a
chiedere grazia per Raffaele. Il gesto di Lina fa cadere il velo dagli occhi di Stiffelio: ora egli sa che
è Raffaele il seduttore! Chiede alla sposa di discolparsi (Un accento, un accento proferite); non
vorrebbe credere alla sua infedeltà, ma il suo silenzio conferma la colpa; Lina con l'animo straziato
invoca per sé la morte; Stankar, con inalterato sdegno, rinnova a Raffaele propositi di vendetta,
propositi che il seduttore accoglie con spavalderia.
16. PREGHIERA E FINALE SECONDO. Stankar dichiara a Stiffelio che non è Lina che egli deve
punire. Ma Stiffelio ormai sa contro chi deve rivolgere la propria ira; strappando la spada di mano
a Stankar, ora è lui che vuole battersi con Raffaele (Non odi un suon terribile). D'improvviso si ode
provenire dal tempio, accompagnato dall'organo, il canto dei fedeli in preghiera (Non punirmi,
Signor, nel tuo furore). Nello stesso momento sulla soglia appare Jorg che raggiunge il ministro e
lo avverte che i fratelli lo attendono al tempio per avere i confòrti della sua parola. Conforti? A
Stiffelio cade la spada di mano: come in delirio invoca che l'ira che lo invade lasci presto il posto
alla calma e si plachi l'ardore del sangue (Me disperato abbruciano); e disperatamente chiede
d'essere lasciato solo. Mentre s'ode ancora provenire dal tempio il canto dei fedeli, Jorg gli ricorda
il suo ruolo di ministro. Confuso e stordito, Stiffelio chiede a Dio di ispirare la sua parola. Ma
mentre tutti s'inginocchiano invocando pace e perdono, egli sorge impetuoso come una furia e
maledice la sposa, che cade in ginocchio ai suoi piedi. Jorg, salito sui gradini del sagrato, addita a
Stiffelio la croce, dalla quale Gesù perdonò agli uomini. La croce! Stiffelio s'avvia barcollando verso
di essa e cade svenuto sui gradini.
ATTO TERZO
Anticamera che mette a vari appartamenti. Sopra una tavola, due pistole e l'occorrente per scrivere. Una
porta a sinistra conduce alla stanza di Stiffelio.
17. SCENA E ARIA. Dopo un tempestoso preludio Stankar entra agitato leggendo una lettera con
la quale Raffaele invita Lina a seguirlo. Dunque il seduttore cerca di sfuggire alla vendetta; prende
in mano la spada, che gloriosa per tanti anni aveva cinto al fianco, e la getta a terra come
immeritevole di cingerla, gridando al disonore. E che è mai la vita senza onore? Fa per prendere la
pistola con l'intenzione di uccidersi, poi si arresta; le lagrime bagnano il suo volto ed egli scoppia
in pianto pensando alla figlia che lo ha coperto di vergogna (Lina, pensai che un angelo)
cancellando tutte le gioie che la vita riserva a un padre. Siede commosso e scrive una lettera
d'estremo addio a Stiffelio. Suggella il foglio, poi prende la pistola e la carica. In quella entra Jorg
che cerca Stiffelio, per avvisarlo di aver raggiunto Raffaele, convincendolo a tornare. Jorg entra
nella stanza di Stiffelio. Sorpreso dalla notizia, Stankar esplode in una gioia terribile: il ritorno del
seduttore gli offre ora la possibilità di portare a compimento la sua vendetta (Oh gioia
inesprimibile). Esce precipitosamente a destra.
18. SCENA. Uscendo dalla sua camera Stiffelio prega Jorg di comunicare ai fratelli che fra poco
sarà al tempio. Mentre Jorg parte, sopraggiunge Raffaele che, ricercato da Stiffelio, si dichiara
pronto a subire la sua vendetta; ma per tutta risposta il ministro gli chiede che farebbe se la sua
sposa fosse libera. Il seduttore è imbarazzato di fronte a una supposizione che ritiene assurda.
Stiffelio fa chiamare Lina e intanto conduce Raffaele in una stanza laterale così che possa ascoltare
non visto: in tal modo Stiffelio potrà sapere se al seduttore sia più cara una colpevole libertà o
l'avvenire della donna di cui ha macchiato l'onore.
19. SCENA E DUETTO. Si presenta Lina. Stiffelio le fa presente che intende partire la sera stessa
poiché Dio lo richiama in altri luoghi; le loro vie ora vanno in direzione opposta: egli servendo
Dio, ella seguendo l'uomo che ama (Opposto è il calle); ella potrà così stringersi all'uomo che ha
nel cuore. Lina è sorpresa. Ma egli rassegnato le propone il divorzio, reso possibile dal fatto che la
donna al momento delle nozze non conosceva il suo vero nome, e le consegna il documento da
firmare per porre fine al matrimonio. Lina gli risponde che s'attendeva qualcosa di fatale (Ah! Fatal
colpo attendermi); sa d'essere degna di rimprovero, ma non di disprezzo. Ma per Stiffelio le lacrime
della sposa non cancellano un disonore cui non sa rassegnarsi. D'improvviso Lina toglie di mano
allo sposo l'atto di divorzio e corre al tavolo per firmarlo. Rendendogli la carta si dichiara libera:
ora Stiffelio può ascoltarla. Il marito fa per partire, ma lei lo arresta: non allo sposo intende
rivolgersi, bensì all'uomo di chiesa; e gettandosi ai suoi piedi grida con forza: "Ministro,
confessatemi!" .Accompagnata dal lamentoso suono di un corno inglese, ella confessa al ministro
quanto Midler non aveva voluto udire: di non aver mai amato l'uomo che l'ha sedotta e disonorata
(Egli un patto proponeva), di esser stata da lui tradita, e infine di essere stata fedele al marito, che
ha sempre amato e tuttora ama. Di fronte a questa confessione Stiffelio resta sbalordito: ora egli ha
il diritto di uccidere il seduttore; si precipita verso la porta dove è celato Raffaele. Ma non è questi
che esce, bensì Stankar con la spada insanguinata in mano rivelando d'aver egli stesso ucciso
l'adultero: chi poteva rivelare il disonore ora è spento. Nel frattempo, prima che Stiffelio possa
riaversi dalla sorpresa, sopraggiunge dall'opposta parte Jorg che invita il ministro al tempio.
Questi è troppo sconvolto; ora pensa solo a fuggire da una casa infamata che è stata testimone di
disonore e di delitto (Ah sì, voliamo al tempio), ammonendo che quanto successo sia d'esempio ai
seduttori: Dio li fulminerà ; Lina, sempre oppressa dal senso di colpa per un errore involontario
che tanta disgrazia causò, invoca la clemenza di Dio. Stiffelio esce trascinato da Jorg; Una si ritira
in una stanza.
Interno d'un tempio gotico sostenuto da grandi arcate. Non si vedrà alcun altare; solamente, appoggiata a
una colonna, è una cattedra, a cui si ascende per doppia gradinata.
20. PREGHIERA. Sulle note di un preludio suonato dall'organo il popolo entra a poco a poco;
quindi ecco Federico e Dorotea; infine Lina, coperta d'un velo, che va presso la cattedra a de-stra;
finalmente Stankar da sinistra. Tutti sono in ginocchio e pregano accompagnati dall'organo (Non
punirmi, Signor, nel tuo furore) affinché il Signore disperda il velo che annebbiò le loro anime.
Stankar chiede a Dio di perdonare il suo delitto così come perdonò Davide; accanto a lui Una
confida nella bontà del Signore.
21. SCENA FINALE. Dalla destra entrano Stiffelio e Jorg, avvolti in una cappa nera; Stiffelio,
concentrato, ha con sé un libro. Mentre il coro a più riprese canta il Miserere, Stiffelio passa
accanto a Lina, dapprima senza riconoscerla. Lina si toglie il velo. Jorg nota il turbamento di
Stiffelio, che evidentemente ha riconosciuto la moglie e sente la mente confusa. Ma Jorg lo
conforta: che apra la Bibbia e il Signore lo ispirerà. Seguito da Jorg, Stiffelio sale agitato alla
cattedra per la scala a sinistra. Su suo invito apre il libro della Bibbia e con voce tremante vi legge
l'episodio dell'adultera: "Rivolto allor Gesù al popolo assemblato mostrò l'adultera che era ai suoi
piedi e così disse". A queste parole Lina cade sulla scalinata, ma egli prosegue "quegli di voi che
non peccò la prima pietra scagli" e guarda Lina che sale le scale coi ginocchi. Poi continua "La
donna perdonata si alzò!". Lina, raggiunto Stiffelio, cade ai suoi piedi. Stiffelio, ponendo la mano
sul libro, dice: "Sì. Perdonata... Iddio lo pronunziò". Tutti ripetono le sue ultime parole. Lina,
sempre in ginocchio, con le mani alzate grida "Gran Dio!".
Rigoletto
Melodramma [in tre atti]• di Francesco Maria Piave
Prima rappresentazione:Venezia,Teatro La Fenice, 11 marzo 1851
L'argomento deriva dalla tragedia in versi di Victor Hugo Le Roi s'amuse (Parigi, Théei tre de la
Comédie, 22 novembre 1832); l'esito tempestoso della prima rappresentazione indusse l'autorità
governativa a vietarne ogni ulteriore replica, avendo ravvisato in molti punti del dramma
oltraggio alla morale. L'autore intentò un processo invocando la libertà di rappresentazione
sancita dalla carta costituzionale e sostenendo il significato morale del dramma, ma perse la causa.
Dopo che la tragedia fu musicata da Verdi, Hugo tentò le vie legali per impedire la
rappresentazione di Rigoletto a Parigi appellandosi al divieto governativo di rappresentarvi Le
Roi s'amuse; anche in questo caso egli perse la causa. La sua tragedia ritornò alle scene nel 1882;
ma a quella data essa era divenuta ormai famosa in tutto il mondo con la musica di Verdi. Già nel
settembre del 1849 Verdi aveva scelto la tragedia di Hugo come argomento d'opera, affidandone il
libretto a Cammarano, che tuttavia rinunciò ritenendolo troppo pericoloso per le censure. Firmato
nel successivo aprile un contratto con la Fenice di Venezia, Verdi ripropose l'argomento a Piave
addossandogli anche il compito di ottenere il benestare preventivo della censura veneziana: "Le
Roi s'amuse è il più grazi sogetto e forse il più gran dramma dei tempi moderni. Tribolet è
creazione degna di Shakespeare!!". L'opera fu inizialmente intitolata La maledizione ("Tutto il
sogetto è in quella maledizione che diventa anche morale" aveva scritto Verdi a Piave. "Un infelice
padre che piange l'onore tolto alla sua figlia, deriso da un buffone di corte che il padre maledice, e
questa maledizione coglie in una maniera spaventosa il buffone, mi sembra morale e grande, al
sommo grande'). La composizione, iniziata nel tardo autunno del 1850 e terminata nel successivo
febbraio, fu troncata a mezzo (dopo il primo atto) dall'intervento della censura veneziana che ne
vietò la rappresentazione in via assoluta. La Fenice tentò di correre ai ripari facendo rifare il
libretto da Piave con pesanti modifiche (tolta la gobba a Rigoletto, tolto di scena il sacco con il
corpo di Gilda, ecc.) e con un nuovo titolo, Il Duca di Vendome. Di fronte al reciso rifiuto di Verdi,
risoluto, in forza del suo contratto, a sciogliersi dall'impegno, e nel timore di un processo per danni
da parte dell'impresa, la Fenice fu costretta a intervenire per addivenire a un accomodamento, che
fu raggiunto dopo lunghe trattative: mantenuta la gobba a Rigoletto, mantenuto il sacco,
trasformato il Re in un Duca di Mantova (dunque un Gonzaga, che qualche studioso ha ritenuto di
identificare nel "magnifico" e spendaccione duca Vincenzo I [1587-1612]), modificati i nomi dei
personaggi (Monterone da una località dell'aretino, Ceprano da una località del frusinate, Marullo
derivato dal Marot della tragedia e da identificarsi con il poeta Clément Marot), rifatti alcuni versi
(ad esempio "Diana o Agnese" divenuto "Questa o quella'), Verdi sacrificò, in pratica, una sola
importante scena: l'incontro di Gilda rapita con il Duca, sostituita con un'aria per tenore ("Parmi
veder le lagrime'), ottenendo in cambio di mantenere tutte le posizioni del dramma. Sulla prima
rappresentazione fiorirono alcune leggende, fra cui quella che Verdi avrebbe composto "La donna
è mobile" all'ultimo momento; è vero che egli chiese al tenore Mirate di non cantarla a casa o per
le calli di Venezia, ma la canzone era già stata composta molto tempo prima, come rivela
l'autografo dell'abbozzo. L'esito della 'prima' fu trionfale, e Rigoletto entrò immediatamente nel
repertorio internazionale, restandovi ininterrottamente fino ai nostri giorni. Non finirono però i
guai con le altre censure italiane: nello Stato della Chiesa, nel Granducato di Toscana e nel Ducato
di Modena il libretto fu trasformato in Viscardello, nel Regno delle due Sicilie, in Lionello (ma in
Clara di Perth al Teatro Nuovo di Napoli).
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
IL DUCA DI MANTOVA
primo tenore
Raffaele Mirate
RiGOLETTO, suo buffone di corte
primo basso [baritono] Felice Varesi
GILDA, di lui figlia
prima donna
Teresina Brambilla
SPARAFUCILE, bravo basso profondo Feliciano Pons
MADDALENA, sua sorella
primo contralto Anna Casaloni
GIOVANNA, custode di Gilda seconda donna Laura Saini
IL CONTE DI MONTERONE baritono Paolo Damini
MARULLO, cavaliere baritono Francesco de Kunerth
BORSA MATTEO, cortigiano tenore Angelo Zuliani
IL CONTE DI CEPRANO basso Andrea Bellini
La contessa sua sposa
seconda donna Luigia Morselli
Usciere di corte basso Antonio Rizzi
Paggio della duchessa soprano Annetta Modes Lovati
Cavalieri, dame, paggi, alabardieri
La scena si finge nella città di Mantova e suoi dintorni
Epoca: il secolo XVI
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
1. PRELUDIO. Costituisce la sintesi sonora del dramma che si sta per rappresentare; è costruito
sulla successione del tema della maledizione ("Quel vecchio maledivami") affidato agli ottoni, della
figura ritmica del pianto affidata ai violini e del ritmo della morte scandito dal cupo suono del
timpano.
ATTO PRIMO
Sala magnifica nel palazzo ducale con porte nel fondo che mettono ad altre sale, pure splendidamente
illuminate.
2. INTRODUZIONE. L'orchestra improvvisamente tace. Si apre il sipario. Folla di cavalieri e
dame in gran costume nel fondo delle sale; paggi che vanno e vengono. La festa è nel suo pieno.
Musica interna da lontano che suona motivi di danza, e scrosci di risa di tratto in tratto. Da una
delle sale s'avanza il Duca accompagnato da Borsa cui confida il proposito di portare a compimento
la sua avventura con la giovane borghese conosciuta in chiesa; essa abita in un vicolo ove ogni
notte si reca uno sconosciuto. Borsa, guardandosi intorno, fa notare la presenza di molte belle
dame. Ma il duca è attratto dalla sposa del Conte di Ceprano, la più bella. Risuona l'orchestra: il
Duca esalta la libertà come il migliore attributo dell'amore e deride, cantando una ballata (Questa
o quella), la costanza degli amanti e le smanie e le gelosie dei mariti: se attratto da una bella donna
sfiderebbe anche Argo dai cento occhi. Mentre all'orchestra subentra un gruppo strumentale di
soli archi sistemato sulla scena con suonatori in costume che eseguono un Minuetto, il Duca si
avvede della presenza della contessa di Ceprano e subito le si accosta per un'ardente dichiarazione
d'amore. Sul fondo appare Rigoletto, che osserva la scena; come il Duca e la contessa si
allontanano, e mentre la banda interna riprende le danze, egli s'accosta al marito con allusiva e
triviale apostrofe:"In testa che avete signor di Ceprano?". Il conte esce infuriato. Rigoletto esalta
la scioperata vita del Duca e subito s'allontana.Ancora l'orchestra d'archi in scena riattacca il suono
per un vorticoso Perigordino. Ma subito riprendono le danze sostenute dalla banda interna. In
quel punto entra Marullo; ha una grande notizia da dare ai cortigiani: Rigoletto, il gobbo, ha
un'amante! Allo stupore generale segue il rientro del Duca accompagnato da Rigoletto: vorrebbe
far sua la contessa di Ceprano, ma il marito lo disturba. Il gobbo cinicamente suggerisce ad alta
voce di rapirla e poi imprigionare o esiliare il marito o addirittura tagliargli la testa. Il conte di
Ceprano, che ha ascoltato, fa per avventarsi su Rigoletto, ma il buffone è salvato dal Duca che però
lo avverte di non scherzare così pesantemente: potrebbe costargli caro. Il buffone ride: sotto la
protezione del suo signore nessuno può fargli del male. Intanto Ceprano riunisce i cortigiani, che
ormai stanchi delle ingiurie del gobbo meditano vendetta, e propone loro di trovarsi armati al suo
palazzo di notte. I: orchestra si unisce alla banda e una folla di danzatori invade la sala
inneggiando ai piaceri della festa. Il crescendo di sonorità viene interrotto da una voce interna: è
quella di Monterone che viene a cercare vendetta dal Duca che gli ha sedotto la figlia. Rigoletto
chiede al Duca di parlare in sua vece. Investitosi per un momento dell'autorità ducale e usando
quindi il plurale majestatis come per un'udienza pubblica, il buffone ricorda a Monterone d'aver
egli a suo tempo congiurato contro il Duca e d'averne per contro ottenuto clemenza. Perché
dunque protestare "a tutte l'ore" per l'onore di sua figlia? A questo nuovo insulto Monterone
reagisce con rinnovato furore dichiarando al Duca che, vivo o morto, lo perseguiterà sino alla fine
dei suoi giorni; il Duca ordina di arrestarlo. Le guardie fanno per intervenire. Prima d'essere
arrestato il vecchio padre scaglia un duplice anatema contro il Duca e il suo buffone; dapprima
risponde al Duca che accanirsi contro un uomo indifeso è da vile; quindi, rivolgendosi direttamente
al buffone, lo maledice per aver deriso il dolore di un padre. La maledizione gela il sangue nelle
vene a Rigoletto, assalito da un orrore incontenibile. In un crescendo incalzante i cortigiani si
scagliano contro Monterone accusandolo d'esser venuto a turbare la festa, provocando l'ira
sovrana. Alla fine il vecchio conte parte trascinato da due alabardieri; tutti gli altri seguono il Duca
in altra stanza, mentre Rigoletto rimane come inebetito. Si cala per un istante la tela al fine di
mutare la scena.
L'estremità più deserta d'una via cieca. A sinistra una casa di discreta apparenza con una piccola corte
circondata da un muro. Nella corte un grosso ed alto albero ed un sedile di marmo; nel muro una porta che
mette alla strada; sopra il muro un terrazzo praticabile, sostenuto da arcate. La porta del primo piano dà su
detto terrazzo. A destra della via è il muro altissimo del giardino, e un fianco del palazzo di Ceprano. È
notte.
3. DUETTO. Rigoletto, chiuso nel suo mantello, appare dal fondo della via: la maledizione di
Monterone risuona nel suo animo come un incubo. Lo segue un uomo avvolto in, un grande
mantello dal quale spunta una lunga spada. Questi gli si avvicina (Signor?...Va, non ho niente):
osservando il suo fare furtivo come di chi stia sorvegliando una donna, gli si offre come sicario per
eventuali servigi. Rigoletto, che a tutta prima lo aveva preso per un ladro, gli chiede quale prezzo
per la vita di un signore e quale forma di pagamento: prezzo maggiore per un signore; una metà
prima, l'altra dopo. L'uomo lo informa che uccide sia in città che nella propria casa. Ha una
complice nella sorella: è bella e, danzando per le vie della città, attira la vittima in casa dove lui può
agire impunemente. L'uomo dichiara di chiamarsi Sparafucile, di essere straniero, Borgognone, e di
trovarsi tutte le sere appostato nella stessa via.
-.4. SCENA E DUETTO. Rigoletto indugia sulla via meditando (Pari siamo) sull'analogia tra il
bandito Sparafucile che ferisce con il pugnale e se stesso così abile nel ferire con le parole. Ma
ancora una volta lo assale un incubo: la maledizione di Monterone. Con uno scatto improvviso,
quasi a cancellarla, si scaglia contro gli uomini e la natura che lo hanno reso deforme e buffone,
negandogli la consolazione del pianto. Non gli resta che continuare a divertire il suo signore. La
sua rabbia esplode contro i cortigiani schernitori: con quale gioia li morde! poiché son essi che lo
hanno reso iniquo. Mentre si avvicina alla sua abitazione, si sente un altro uomo al pensiero della
figlia. Fa per entrare, ma ancora un volta lo assale l'incubo della maledizione di Monterone: gli
apporterà forse sventura? Scaccia il tristo presagio: è solo un folle pensiero. Da una finestra Gilda
si accorge dell'arrivo del padre; scende di corsa per corrergli incontro e si getta nelle sue braccia
(Figlia! Mio padre!). Rigoletto non riesce a trattenere un doloroso sospiro. La figlia se ne avvede e
chiede il motivo del suo turbamento; vorrebbe sapere quale sia la sua famiglia e come si chiami il
padre. Ma Rigoletto elude le domande; è solo preoccupato che la figlia non esca mai di casa, salvo
andare in chiesa. Ma Gilda insiste, e chiede di sapere almeno della madre. Al ricordo di lei si
dischiude l'animo di Rigoletto (Deh non parlare al misero): una donna ha avuto compassione delle
sue sofferenze e lo ha amato; moti, lasciandogli Gilda, il suo bene più prezioso. La giovinetta è così
commossa dalle parole del padre che il suo canto si fa singhiozzante. Quindi gli chiede nuovamente
quale sia il suo nome. Ma Rigoletto rifiuta energicamente di cedere al desiderio di Gilda; sa di
essere oggetto dell'odio altrui: alcuni lo temono, altri lo maledicono. E alla figlia sorpresa che gli
chiede dei parenti egli risponde con crescente trasporto che tutto il suo universo è riposto in lei.
L'espansione melodica si spegne su una delicata melodia dei violini: Gilda (cresciuta in campagna,
come si apprende da Hugo, affidata alle cure di una donna) chiede al padre di visitare la città, in cui
risiede ormai da tre mesi. La reazione di Rigoletto è violenta: potrebbero seguirla e rapirla pur di
disonorare un buffone. Con ordine perentorio fa accorrere la custode, Giovanna, e affannosamente
la interroga su eventuali infrazioni al rigido isolamento da lui imposto alla figlia. Da lei
rassicurato, si raccomanda che il portone sia sempre ben chiuso e la prega di vigilare sulla figlia e
di difenderne la purezza (Veglia, o donna). Gilda è intenerita dal prorompente affetto del padre e lo
rassicura che su di lei veglia dal cielo, quale angelo protettore, la madre. Intanto nell'oscurità del
vicolo appare il Duca in costume borghese, che s'avvicina alla casa di Rigoletto. Il rumore dei suoi
passi viene avvertito da Rigoletto che si precipita sulla via per osservare, aprendo per un breve ma
fatale istante la porta; ne approfitta il Duca, favorito dall'oscurità notturna, per guizzare furtivo nel
cortile e nascondersi dietro l'albero; gettando una borsa di denari a Giovanna le fa cenno di tacere.
Gilda, che si sente tormentata dai paterni sospetti, di nulla s'è accorta. Rigoletto, rientrando,
chiede affannoso a Giovanna se è mai stata seguita tornando dalla messa. Al suo diniego, ordina
che non sia aperto a nessuno, men che meno al Duca (il quale, ancora nascosto, scopre così che la
"giovane borghese" di cui s'è invaghito altri non è che la figlia del suo buffone). Rigoletto
raccomanda un'ultima volta Gilda a Giovanna, abbraccia infine la figlia e parte chiudendosi dietro
la porta, ignaro d'aver chiuso dietro di sé con l'agnello anche il lupo...
5. SCENA E DUETTO. Gilda esprime a Giovanna il rimorso per aver taciuto al padre di un
giovane che la seguiva al tempio. Ma è sentimento fugacé; la voce della fanciulla si distende
sull'arco di una melodia sospesa: il suo animo trasognato sembra cercare il volo come per inseguire
una visione cara. In uno stato d'estasi sta per proferire la parola "t'amo", quando essa viene
improvvisamente completata dal Duca che, inginocchiatosi ai suoi piedi, ha nel frattempo
allontanato Giovanna. Gilda è ora sola davanti al suo innamorato, a un tempo spaventata e attirata
dalla sua foga irruente. Con subitanee aperture all'espansione melodica il Duca incalza la fanciulla
indebolendone le ultime resistenze, fino a esprimere un'infuocata dichiarazione amorosa (È il sol
dell'anima): fama, potenza, trono sono cose fragili; solo l'amore avvicina agli angeli. Gilda cade in
estasi: nel suo tremebondo palpito si esprime la gioia di un sogno che si sta avverando. Alla
fanciulla che chiede di sapere il suo nome, il Duca risponde chiamarsi Gualtier Maldè, d'essere
studente e povero. Nel frattempo appaiono nel vicolo Ceprano e Borsa, che avevano giurato di
vendicarsi del buffone; il loro piano di vendetta mira al rapimento di quella che ritengono essere
l'amante di Rigoletto; intanto Ceprano indica a Borsa la casa del buffone. Il rumore dei loro passi
mette in agitazione Gilda, che teme l'improvviso ritorno del padre. Giovanna, pure allarmata,
accorre dalla casa: la fanciulla le affida il compito di far uscire il giovane dalla porta che dà sul
bastione. L'addio fra questi e Gilda si ripete più volte (Addio addio), in modo quasi convulso, come
si conviene a due amanti che non vorrebbero mai lasciarsi. Infine il Duca esce scortato da
Giovanna.
6. SCENA ED ARIA. Gilda resta a fissare la porta da cui è partito l'amante. Sugli arpeggi
ascendenti di un flauto la fanciulla, rapita nel suo sogno d'amore, ripete il nome dell'amato. La sua
estasi amorosa si esprime attraverso un canto spezzato (Cano nome), come un pulsare del cuore,
che esprime non solo la trepidazione amorosa, ma anche il sentimento di chi cerca di indugiare su
una visione per imprimerne nella mente le forme evanescenti. Un lungo, interminabile pedale
esprime la fissità estatica con la quale la fanciulla sembra prolungare all'infinito la gioia che la
pervade; ma in questa fissità si insinua una nota inquietante, espressa dal timbro cupo del timpano;
mentre ella sale sul terrazzo con la lanterna in mano, fuori, sul vicolo, si vanno riunendo i
cortigiani, armati e mascherati, che ammirano estasiati la sua bellezza. Gilda entra infine nelle sue
stanze ripetendo il nome dell'amato. Un lungo trillo... e la sua voce si perde in lontananza.
7. SCENA E CORO. Mentre i cortigiani si apprestano al rapimento della supposta amante di
Rigoletto, questi riappare, con fare preoccupato, dal fondo del vicolo. Ritorna alla sua casa: l'incubo
della maledizione di Monterone lo persegue come un sinistro presagio. Nell'appressarsi alla soglia
urta improvvisamente Borsa (Chi va là? Tacete... c'è Rigoletto). I cortigiani sono imbarazzati dalla
sua presenza proprio nel momento in cui stanno per rapirgli l'amante. Ceprano vorrebbe ucciderlo,
ma Borsa gli osserva che con lui vivo ci sarà più da divertirsi l'indomani. Interviene Marullo, che
gode di maggiore confidenza da parte del buffone, per risolvere la situazione: facendosi riconoscere
da Rigoletto gli dà da intendere di essere convenuti in quel luogo per sottrarre la sposa di Ceprano
in favore del Duca. Il motivo appare plausibile al buffone; ma resta tuttavia sospettoso. Per
vincerne i dubbi Marullo ricorre allo stratagemma di far tastare al buffone la chiave del palazzo di
Ceprano come prova di quanto sta dicendo. Rigoletto palpa la chiave, ne riconosce lo stemma e
trae un respiro di sollievo; decide di essere lui pure della partita: indica il palazzo e chiede d'essere
anch'egli mascherato. Gli viene affidato il compito di reggere la scala; e intanto, approfittando della
tenebra notturna, i cortigiani gli mettono una maschera cui accortamente sovrappongono una
benda che gli copra occhi e orecchie, sì da renderlo cieco e sordo. Infine lo accostano a una scala
appostata al terrazzo. Il suono dell'orchestra si spegne in un brusio, sul quale d'un tratto si stacca
sottovoce il canto burlesco dei cortigiani (Zitti, zitti, moviamo a vendetta). Frattanto alcuni
salgono al terrazzo, rompono la porta del primo piano, scendono, aprono ad altri che entrano dal
vicolo nel cortile; infine ne escono trascinando Gilda, la cui bocca è chiusa da un fazzoletto. Nel
traversare la scena ella perde una sciarpa. Da lontano si sente il grido di vittoria dei cortigiani. Gli
fa eco, ancor più lontano, il grido lamentoso della fanciulla che chiama il padre in soccorso.
Rigoletto nulla sente, causa il mascheramento. Stanco per la lunga attesa, si porta la mano agli
occhi e s'accorge della benda. La "ridevol cosa" precipita in tragedia. Sulla concitazione crescente
del ritmo orchestrale Rigoletto si strappa violentemente benda e maschera e al chiarore d'una
lanterna dimenticata riconosce la sciarpa; vede la porta spalancata, si precipita nel cortile, ne trae
Giovanna spaventata che fissa con stupore; si strappa i capelli... vorrebbe gridare, non può;
finalmente dopo molti sforzi esclama "Ah!... ah!... ah!... la maledizione!".
ATTO SECONDO
Salotto nel Palazzo Ducale. Vi sono due porte laterali, una maggiore nel fondo che si schiude.Ai suoi lati
pendono i ritratti, in tutta figura, a sinistra del Duca, a destra della sua sposa. Vi è un seggiolone presso una
tavola coperta di velluto e altri mobili.
8. SCENA ED ARIA [CON CORO]. Il Duca entra in scena agitatissimo (Ella mi fu rapita!);
racconta come un presagio interno lo avesse ricondotto alla casa della "giovine borghese" e avesse
trovato la porta spalancata, le stanze vuote. E dove ora sarà, lei così pura da spingerlo a virtù? Un
commovente moto di sincera pietà lo porta a immaginare la fanciulla piangente e spaventata
(Panni veder le lagrime). :intimità elegante ancorché superficiale del canto del Duca viene
interrotta dall'irrompere sfacciato e disordinato dei cortigiani, che si precipitano a gara per
annunciargli il rapimento dell'amante di Rigoletto e raccontargli come ciò avvenne (Scorrendo
uniti). Il Duca dapprima ascolta tra il divertito e l'annoiato; ma poi la sua attenzione si desta: la
supposta amante di Rigoletto altri non è che la sua "diletta"! Nell'apprendere dai cortigiani che la
giovane è stata condotta a palazzo, la sua gioia è incontenibile: vuole correre da lei, riaffermarle il
suo amore, rivelarle il suo vero stato (Possente amor mi chiama). Quindi esce frettoloso attraverso
la porta di sinistra.
9. SCENA ED ARIA. Dietro le quinte si ode la voce di Rigoletto che torna al suo ufficio di buffone
canterellando con represso dolore. Fra i cortigiani il solo Marullo sembra mosso a pietà per lui.
Rigoletto entra in scena cercando di mostrarsi allegro e spensierato.Viene accolto dal buongiorno
dei cortigiani, un saluto carico di ironia che non sfugge al buffone. Dopo uno sberleffo a un
provocatorio approccio di Ceprano che gli chiede se vi sono novità, riprende a canterellare
aggirandosi per la sala spiando dovunque. Stenta a mascherare la propria agitazione; i cortigiani,
avvedendosene, si limitano a un riso sommesso e contenuto, in attesa che la burla esploda. Con
simulata indifferenza si rivolge a Marullo accennando al "bel colpo" di stanotte... Marullo finge di
cader dalle nuvole: ha sempre dormito! Al che Rigoletto ironicamente risponde d'aver dunque
sognato; e riprende a canterellare. Nota a terra un fazzoletto; lo raccoglie, l'osserva: non è quello di
Gilda. Chiede del Duca: sta dormendo, gli viene risposto. Improvvisamente la scena si anima con
l'entrata di un paggio venuto a chiedere appunto del Duca da parte della sua sposa. Sulle risposte
imbarazzate dei cortigiani, che si contraddicono facendogli capire che insomma ora egli "non può
vedere alcuno", piomba impetuosa l'interruzione di Rigoletto: Gilda è dunque a palazzo! I
cortigiani non fanno in tempo a prendersi gioco del buffone e ridersi dell'amante da lui perduta,
ché questi li investe con accento terribile:"Io voglio mia figlia!". Di fronte ai cortigiani stupiti ora
non sta più un buffone, ma un padre colpito nei suoi affetti più sacri, che ora li sfida a ridere del
"bel colpo". Le parole escono come mozzate dall'ira. Corre alla porta della stanza dove ormai sa
che Gilda è rinchiusa col Duca, ma viene respinto. Su una discesa impetuosa degli archi che
s'arresta su tre violenti accordi di tutta l'orchestra, il furore di Rigoletto esplode con tutta
veemenza in un'invettiva contro i cortigiani, espressione di una rabbia e di un'acredine a lungo
repressi (Cortigiani, vil razza dannata). Ma la sua arma più affilata, la lingua, non può nulla contro
il silenzio imperturbabile di quei nobili. Si getta ancora sulla porta, che gli è nuovamente contesa.
L'impeto della musica si smorza. Si accascia spossato. E finalmente piange: ciò che gli era tolto, "il
retaggio d'ogni uom", ora gli è reso. Si rivolge a Marullo, dall'animo "gentile", il solo fra i
cortigiani che non è di nobile origine: lo supplica di rivelargli dove è stata nascosta la figlia. Le
parole si spezzano sulle labbra di Rigoletto. Ma Marullo tace: forse non ha il coraggio di dirgli la
verità. Alla fine Rigoletto, distrutto dal dolore, si rivolge a tutti i cortigiani implorando perdono e
pietà affinché gli sia ridonata la figlia, così trovando per la prima volta la via del canto spiegato.
10. SCENA E DUETTO. Gilda esce dalla stanza e si getta fra le braccia del padre. Il suo strazio è
tale che non manifesta sorpresa nel vederlo abbigliato da buffone.Tutto si svolge in un baleno.
Rigoletto è incapace di parlare. La gioia gli mozza le parole. S'avvede però che la figlia piange.
Gliene chiede il motivo. Ma Gilda vuole confessare la propria vergogna soltanto davanti al padre.
Con imperioso modo, derivantegli dall'autorità di un padre offeso nell'onore, Rigoletto ordina ai
cortigiani di uscire e comanda che sia vietato al "loro" Duca di entrare. I cortigiani lasciano
lentamente la stanza con fare divertito, rimanendo tuttavia appostati. Rimasti soli, il padre invita
la figlia a parlare. Il tono di Gilda ormai non è più quello di una fanciulla. Introdotta dal suono
dell'oboe, ella rivela l'incontro con un giovane "bello e fatale" (Tutte le feste al tempio), come se ne
innamorò e, in un drammatico crescendo, come poi fu rapita e sedotta. Rigoletto ascolta con
angoscia crescente. E anziché inveire, si esprime in un ribollire d'ira impotente, sul ritmo fremente
dell'orchestra, rivolgendosi a Dio; tutto ha egli accettato: la vergogna, l'abiezione, il disprezzo; ma
per sé, non per la figlia. Deve pur esserci un altare presso al patibolo. L'altare si è rovesciato. Ma
ora in Rigoletto prevale non la bestemmia, ma la pietà paterna. Si volge improvvisamente alla
figlia invitandola a lasciar scorrere le lagrime (Piangi, fanciulla) e ancora una volta la sua voce si
piega al canto di un'ampia melodia. La voce del padre sembra a Gilda quella di un "angelo
consolatore"; smarrita, tremante, quasi non osa credere che il padre, anziché inveire contro di lei,
le apra le braccia stringendola al cuore. Mal celando propositi di vendetta, Rigoletto comunica alla
figlia l'intenzione di lasciare l'"aura funesta" di quel luogo. Il ritmo marziale di una progressione
armonica annuncia la svolta della situazione: un usciere ordina che si schiudano le porte a
Monterone condotto al carcere. Scortato da alabardieri il vecchio conte attraversa la scena con
saldo passo; arrestandosi di fronte al ritratto del Duca riconosce con accento solenne di averlo
invano maledetto: che egli viva dunque felice. Quindi esce dalla porta di mezzo. Gli fanno eco le
parole di Rigoletto: "No, vecchio, t'inganni...". Con impetuosa mossa, la voce quasi soffocata
dall'ira, quindi con vigore crescente, Rigoletto si scatena in un desiderio sfrenato di vendicare
l'affronto subito (Sì, vendetta, tremenda vendetta). Gilda è spaventata dalla gioia feroce che brilla
negli occhi del padre e lo supplica di perdonare; nonostante tutto si sente ancor più innamorata
dell'uomo che l'ha ingannata. Ma Rigoletto non sente ragione e, rivolto al ritratto del Duca, tuona
la sua minaccia.
ATTO TERZO
Deserta sponda del Mincio. A sinistra è una casa in due piani, mezza diroccata, la cui fronte, volta allo
spettatore, lascia vedere per una grande arcata l'interno d'una rustica osteria al piano terreno, ed una rozza
scala che mette al granaio, entro cui, da un balcone, senza imposte, si vede un tettuccio. Nella facciata che
guarda la strada è una porta che s'apre per di dentro; il muro poi è così pieno di fessure, che dal di fuori si
può facilmente scorgere quanto avviene all'interno. Il resto del teatro rappresenta la deserta parte del
Mincio, che nel fondo scorre dietro un parapetto in mezza rovina; al di là del fiume è Mantova. È notte.
11. SCENA E CANZONE. Sulle note di un mesto preludio suonato dagli archi si alza il sipario.
Gilda e Rigoletto inquieto sono sulla strada. Sparafucile nell'interno dell'osteria, seduto presso una
tavola, sta ripulendo il suo cinturone, senza nulla intendere di quanto accade al di fuori. Rigoletto
interroga la figlia sui suoi sentimenti vérso il Duca: ella lo ama sempre. Invano il tempo è passato
(trenta giorni sono trascorsi dal rapimento), perché guarisse da questo amore insensato, e invano il
padre tenta ancora di dissuaderla: le dimostrerà quanto ella s'inganni; chiede solo di attendere e di
osservare: avrà così la prova dell'incostanza del suo spasimante [l'estrema concisione di questo
recitativo trascura un passaggio importante della tragedia di Hugo, dal quale si apprende che nel
frattempo la giovane era diventata di fatto l'amante ufficiale del sovrano e risiedeva a palazzo,
situazione che il buffone fingeva di tollerare onde meglio prepararsi alla vendetta]. Un veloce
disegno degli archi sottolinea l'improvviso ingresso nell'osteria del Duca, travestito da semplice
ufficiale di cavalleria. Senza indugi e con tono imperioso ordina a Sparafucile una stanza (ma "tua
sorella", secondo l'autografo) e del vino. D'un tratto l'atmosfera viene vivamente illuminata da uno
scattante ritmo di canzone che l'orchestra annuncia e poi tronca a mezzo come in attesa del canto;
subito il Duca riprende il brillante motivo per decantare la volubilità della donna, che per quanto
menzognera è pur fonte di felicità amorosa (La donna è mobile). Finita la canzone, il motivo si
trascolora in orchestra lungo un breve postludio, nel corso del quale Sparafucile rientra con una
bottiglia di vino e due bicchieri che depone sulla tavola; quindi esce sulla via per gli ultimi accordi
con Rigoletto, non senza aver prima battuto col pomo della sua lunga spada due colpi al soffitto.
12. QUARTTO. A questo segnale una ridente giovane, in costume di zingara, scende a salti la
scala. Il Duca corre ad abbracciarla e subito inizia fra i due una schermaglia amorosa (Un dì, se ben
rammentomi) nel corso della quale i due personaggi danno alle loro parole l'apparenza di un
sentimento vero; il Duca giunge perfino a dire a Maddalena di volerla sposare. Gilda, che dal di
fuori osserva attraverso una fenditura del muro con accanto il padre, sente tutto e non sa
trattenere, attraverso brevi interiezioni, una sdegnata sorpresa. Intanto la foga erotica del Duca
giunge al culmine di una vera e propria dichiarazione d'amore (Bella figlia dell'amore), che la
maliziosa Maddalena, che ben conosce le regole del gioco amoroso, accoglie incredula ridendo. In
Gilda cresce la disperazione: quelle stesse parole il Duca aveva rivolto a lei... Ma il padre la esorta
a non piangere per un uomo così vile. Quindi ordina alla figlia di prendere denaro, indossare vesti
virili e subito partire a cavallo per Verona, dove egli stesso la raggiungerà l'indomani. Gilda esce.
13. SCENA,TERZETTO E TEMPESTA. Mentre il Duca e Maddalena stanno fra loro parlando,
ridendo, bevendo, Rigoletto va dietro la casa e ritorna con Sparafucile, cui anticipa dieci scudi, la
metà del compenso pattuito; l'appuntamento è per mezzanotte. A Sparafucile, che dichiara di poter
da solo gettare il cadavere nel fiume, il gobbo vivacemente ribatte di voler compiere lui stesso
quest'ultima operazione; quindi si allontana, mentre il cielo si va oscurando e tuona. Nell'osteria il
Duca fa per abbracciare Maddalena, che si scosta nel vedere il fratello rientrare. Sparafucile
annuncia prossima la tempesta. Il Duca risolve di fermarsi per la notte, invano sollecitato da
Maddalena a partire. Il bravo gli offre la sua stanza e, prendendo un lume, s'avvia per la scala. Il
Duca lo segue, non prima d'aver sussurrato una parola all'orecchio di Maddalena che, rimasta per
un momento sola, compiange la prossima fine di un sì "grazioso" giovane. Salito nella stanza il
Duca depone il cappello, la spada, si stende sul letto, e in breve, canterellando a mezza voce il
motivo della canzone, si addormenta. Maddalena frattanto siede presso la tavola; Sparafucile beve
alla bottiglia lasciata dal Duca. Rimangono tutti e due taciturni per qualche istante e preoccupati
da gravi pensieri. Poi Maddalena si mostra turbata dalla bellezza di quel giovane; venti scudi sono
pochi per la sua vita. Il fratello con fare brusco le ordina di salire a prendergli la scala. Maddalena
sale al granaio, contempla il dormiente, ripara alla meglio il balcone e scende portando seco la
spada del Duca. Nel fondo della via compare Gilda in costume virile, con stivali e speroni, e
lentamente s'avanza verso l'osteria, mentre Sparafucile continua a bere. Lampi e tuoni si vanno
intensificando.Trascinata dall'amore la fanciulla chiede perdono al padre. Quindi si accosta a una
fessura del muro per ascoltare. Maddalena, dopo aver posato la spada sulla tavola, si rivolge al
fratello che sta frugando in un credenzone: si confessa innamorata di quel giovane, bello come un
dio, che pure l'ama, e chiede di non ucciderlo (Somiglia a un Apollo quel giovine). (E intanto Gilda,
ciò sentendo, rabbrividisce dal terrore). Ma Sparafucile per tutta risposta le butta un sacco da
rammendare: servirà per gettare il cadavere del suo Apollo. Maddalena non si dà per vinta:
immaginando che la preoccupazione del fratello siano i soldi del compenso, gli propone di uccidere
il gobbo, non appena si ripresenterà col resto del denaro. Ma Sparafucile inorridisce: è una
questione d'onore, egli è un sicario e non un bandito! Gilda segue la scena dalla strada, tremante di
raccapriccio. Maddalena è decisa a tutto: fa per salire ad avvertire il giovane del pericolo, ma il
fratello la trattiene; in fondo gli scudi fanno gola anche a Maddalena. C'è una sola soluzione: se
prima di mezzanotte qualcuno busserà alla porta, morirà al posto del predestinato. Ma la tempesta
è troppo forte, gli obietta la sorella, perché qualcuno si avventuri per via. Gilda è tentata di
sacrificarsi per salvare a un tempo l'amato e il proprio padre. Battono le undici e mezza (cinque
tocchi di campana seguiti dopo un istante da un doppio tocco d'altra campana conforme l'uso
"romano") Non resta che mezz'ora! Maddalena piange. Il suo pianto decide Gilda al sacrificio
supremo. Va alla porta bussando forte. Alla richiesta di Sparafucile la fanciulla, contraffacendo la
voce, dice d'essere un mendicante che chiede asilo per la notte. Il bravo risponde di attendere un
momento; va a frugare nel credenzone alla ricerca di un pugnale. Va quindi ad appostarsi con il
pugnale dietro alla porta. Maddalena apre, poi corre a chiudere la grande arcata di fronte, mentre
entra Gilda, dietro cui Sparafucile chiude la porta, e tutto resta sepolto nel silenzio e nel buio.
Fuori si sta scatenando la tempesta, accompagnata da continui lampi e tuoni. Alla fine la furia degli
eleménti va a poco a poco calando... ultime ffilate di vento, ultime gocce di pioggia... e la tempesta
s'allontana su una cadenza sospesa...
14. SCENA E DUETTO FINALE. Dal fondo della scena, nel silenzio più assoluto, si avanza
Rigoletto chiuso nel suo mantello. Di lontano ancora qualche lampo e qualche tuono. Da trenta
giorni il gobbo ha atteso questo momento, piangendo sotto la maschera del buffone (Della
vendetta alfin giunse l'istante). Un lampo illumina sinistramente la stamberga di Sparafucile:
l'uscio è chiuso, la mezzanotte non è ancora suonata, occorre dunque attendere qualche istante.
Solo, di fronte alla natura sconvolta dalla tempesta, il buffone s'inorgoglisce. Suona la mezzanotte.
Rigoletto s'affretta a bussare alla porta. Ne esce Sparafucile: impedendo al gobbo di entrare gli
ingiunge di attendere. Il sicario rientra e subito ritorna trascinando un sacco. Rigoletto esulta e
chiede un lume. Ma il sicario ha fretta d'intascare il resto della mercede pattuita e di gettare il
sacco nel fiume. Rigoletto insorge: vuole essere egli stesso a completare il delitto. Sparafucile
indica al gobbo un luogo lontano dove più profondo è il gorgo, lo sollecita a far presto e si
congeda. Il rombo lontano del tuono commenta il suo "Buona notte". Ora Rigoletto è solo di
fronte a quello che crede essere il cadavere del Duca (Egli è là... Morto!). Si esprime con frasi rotte
da una gioia incontenibile; finalmente può chiamare il mondo a testimone della sua impresa: aver,
egli buffone, annientato un potente. Si decide alfine a gettare il cadavere nel fiume. Fa per
trascinare il sacco quando, d'improvviso, è sorpreso dalla voce lontana del Duca, che nel fondo
attraversa la scena cantando spensieratamente il motivo della canzone "La donna è mobile". Il
gobbo s'arresta: non crede alle proprie orecchie! È buio, non riesce a vedere chi sta cantando, ma
crede di riconoscerne la voce. Quando la canzone giunge alla cadenza l'accento inconfondibile di
quella voce gli si rivela appieno. "Egli è desso", il Duca! Impreca in direzione della stamberga,
mentre la voce del seduttore si perde negli spazi notturni librandosi su una lunga nota acuta. Di
chi è dunque il cadavere nel sacco? Con fare affannoso Rigoletto corre a tagliarlo. Un lampo gli
rivela le sembianze della figlia. Ma forse è una visione, perché la fanciulla è in viaggio per Verona.
Un altro lampo gli reca l'atroce conferma: ai suoi piedi sta non il corpo del seduttore bensì quello
del suo unico bene. Si precipita verso la stamberga e picchia disperatamente alla porta senza avere
risposta. Accorre verso la figlia. A un suo debole appello s'accorge che si muove: dunque è ancora
in vita. Gilda riconosce il padre, gli indica il cuore dove è stata mortalmente colpita, e infine
confessa la propria colpa: ha troppo amato il suo seduttore e ora muore per lui (V'ho ingannato).
Rigoletto si rende conto che la vendetta è ricaduta su colui stesso che l'aveva progettata. Implora
la figlia di non morire; ma la fanciulla, che sente ormai mancare le forze, supplica il padre di
perdonare a lei e al Duca. Nel momento dell'estremo trapasso il flauto, che aveva accompagnato il
sogno amoroso della fanciulla, si ricongiunge, come per una riacquistata innocenza, alla sua voce,
che ora si libra sul moto ascensionale di un canto dolcissimo: dal cielo, vicino alla madre, ella
pregherà per lui (Lassù... in cielo). A un certo punto la tonalità si trasfigura e il canto si spegne
lentamente, troncato dalla morte. Un lungo terribile silenzio. Rigoletto chiama la figlia, ma
invano. La maledizione di Monterone si è compiuta. Strappandosi i capelli, cade sul cadavere della
figlia.
Verdi dirige !'Aida all'Opéra di Parigi ("Illustrazione Italiana", 1880)
Il Trovatore
Dramma in quattro parti. Libretto [postumo] di Salvadore Cammarano
[completato da Emanuele Bardare]
Prima rappresentazione: Roma,Teatro di Apollo, 19 gennaio 1853
L'argomento deriva dal dramma in prosa e in versi El trovador di Antonio Garda Gutiérrez
(Chiclana, Cadice, 1813 - Madrid, 1884), rappresentato con immenso successo a Madrid il l° marzo
1836. Fu proposto da Verdi a Cammarano già nel gennaio del 1851, alla vigilia del Rigoletto. In
misura ben maggiore che nelle tre precedenti opere scritte su libretto di Cammarano, Verdi
intervenne nella struttura drammatica, mirando soprattutto a salvaguardare il "carattere strano e
nuovo" di Azucena, dominato da due grandi passioni:" amor filiale e amor materno". Egli stesso ne
stese lo scenario, inviandolo a Cammarano in aprile. Il poeta napoletano lavorò al libretto molto
lentamente, sempre tenuto sotto controllo da Verdi, il quale nel frattempo, dopo il successo di
Rigoletto, veniva richiesto da numerose proposte di contratti. Firmato nel febbraio del 1852 un
impegno con l'Opéra (saranno Les Vépres siciliennes) e sottoscritto nel maggio successivo un
contratto con la Fenice (sarà Traviata), il compositore destinava Il trovatore, dopo un fallito
tentativo con il S. Carlo di Napoli, all'Apollo di Roma, dove poteva disporre di due primedonne
adatte alle parti di Azucena e di Leonora. Intanto il 17 luglio moriva Cammarano, avendo tuttavia
pressoché terminato il libretto. L'incarico di apportare gli ultimi ritocchi richiesti dal compositore
fu affidato a un suo collaboratore, Emanuele Bardare. Ulteriori ritocchi al libretto, tuttavia non tali
da alterare il dramma e il carattere dei personaggi, furono richiesti dalla censura papalina. Come il
libretto, anche la composizione subì alcuni rallentamenti. Verdi poté dedicarsi, nonostante i suoi
numerosi impegni artistici e familiari, a quella che sarebbe diventata la sua opera più popolare,
senza essere assillato da scadenze immediate. Iniziata nella tarda estate del 1851, la composizione
fu terminata negli ultimi mesi del 1852, in coincidenza con la composizione di Traviata Alla prima
rappresentazione il successo fu trionfale. Altrettanto trionfale e soprattutto rapido il suo cammino
sulle scene italiane e straniere. Nel solo 1853 ben 30 teatri diversi rappresentarono 11 trovatore.
L'anno dopo la cifra si sarebbe più che raddoppiata: oltre 65 teatri. E oltre 70 i teatri nel 1855.
Nella sola sera di S Stefano del 1854 ben 15 teatri italiani rappresentarono contemporaneamente
per la prima volta Il trovatore: il che sta a significare che, a meno di due anni dalla prima assoluta,
il mercato del lavoro operistico poteva già disporre di almeno quindici tenori in grado di affrontare
la parte di Manrico, di altrettanti baritoni per quella del Conte di Luna, di trenta primedonne per
le parti di Leonora e di Azucena, e che in pari tempo doveva essere intensificata la produzione di
un nuovo, eccentrico strumento musicale introdotto dall'autore nella partitura: l'incudine... Non
era più solo un successo. Come già per Emani, era ormai una moda. A marcare la quale concorreva
Pasquale Altavilla il famoso comico napoletano - rappresentando al San Carlino di Napoli una sua
commedia in tre atti: Na famiglia ntusiasmata pe la museca de lo Trovatore. Ben a ragione, anche
se celiando, Verdi poteva scrivere all'amico Opprandino Arrivabene nel maggio del 1862: "Quando
tu andrai nelle Indie e nell'interno dell'Africa sentirai il Trovatore': La storia del suo cammino e
della sua popolarità è storia scritta sulla punta di lancia di quel famoso "o teco" ovvero quel Do di
petto, non scritto dall'autore (ma da lui tacitamente accettato in omaggio alla regola canonica
dell'esecuzione variata nella replica di un rondò o di una cabaletta) che ha spesso (troppo spesso)
deciso le sorti di una serata. E se per Cesare Pascarella ilTrovatore è "Er pius urtra più su, la
musica più mejo", per Barili esso è "il melodramma dogmatico" i cui "quadri sono la Via Crucis del
canto italiano ".
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
IL CONTE DI LUNA baritono Giovanni Guicciardi
LEONORA
soprano Rosina Penco
AZUCENA
mezzo-soprano Emilia Goggi
MANRICO
tenore Carlo Baucardé
FERRANDO
basso Arcangelo Balderi
INES soprano Francesca Quadri
Ruiz
tenore Giuseppe Bazzoli
Un vecchio Zingaro
basso Raffaele Marconi
Un Messo
tenore Luigi Fani
Compagne di Leonora e Religiose, Familiari del Conte, Uomini d'arme, Zingari e Zingare
L'avvenimento ha luogo parte in Biscaglia, parte in Aragona
Epoca dell'azione: il principio del secolo XV
Nota: Nel racconto di Ferrando sono contenuti gli antecedenti del dramma, risalenti a quindici
anni prima ("son tre lustri" dice il Conte nel terzo atto), dai quali si apprende che il vero nome di
Manrico, fratello minore del Conte ("secondo nato"), è Garzia. L'azione ha per sfondo una guerra
civile fra opposte fazioni, a capo di una delle quali è Urgel, un proscritto, al cui seguito combatte
Manrico. Fra la parte prima e la parte seconda trascorrono alcuni mesi, durante i quali Manrico
nel corso della battaglia di Pelilla viene gravemente ferito dal Conte di Luna.
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
PARTE PRIMA: Il duello
Atrio nel palazzo dell'Aliaferia. Da un lato porta che mette agli appartamenti del Conte di Luna.
1. INTRODUZIONE. Per la prima volta Verdi rinuncia a un'ouverture autonoma. L'introduzione
orchestrale crea un clima notturno e misterioso. È infatti notte fonda. Mentre alcuni uomini
d'arme passeggiano in fondo, i familiari del Conte di Luna, di guardia al palazzo, sono sdraiati
presso la porta e stanno per assopirsi. Ferrando li richiama al loro compito, in attesa dell'arrivo del
Conte, che non ha pace, turbato dal canto di un trovatore suo rivale in amore. Essi gli chiedono
allora di raccontare ancora, per tenerli svegli, la storia di Garzia, fratello del Conte; e gli si
accostano per ascoltare meglio. Anche gli armigeri, desiderosi di ascoltare, si fanno intorno a
Ferrando. E questi racconta (Abbietta zingara). Il vecchio Conte di Luna aveva due figli. Una
mattina, all'alba, la nutrice che vegliava il secondogenito presso la culla, svegliandosi di
soprassalto, scorse un'orrenda zingara guardare il piccolo con occhio torvo. La nutrice gridò;
presto i servi accorsi allontanarono la vecchia. La zingara si giustificò dicendo che era entrata per
trarre l'oroscopo del piccolo. In realtà ella lo aveva ammaliato. Infatti di lì a poco il bimbo si
ammalò. La fattucchiera fu catturata e condannata al rogo. Ma restava in vita la figlia di lei, che
ordì una tremenda vendetta: il piccolo scomparve e di lui si trovarono solo i resti carbonizzati nel
luogo stesso in cui era stata arsa la madre. Il racconto desta il raccapriccio dei presenti. E che ne fu
del vecchio Conte? Narra Ferrando che egli morì; tuttavia convinto che il secondogenito fosse
ancora vivo, sul letto di morte fece giurare al figlio rimasto di non cessare mai le indagini. Ancora
turbati e animati alla vendetta i famigli chiedono a Ferrando se abbia mai rintracciato la zingara
infanticida e se sia in grado di riconoscerla; egli ammette di avere molta voglia di afferrarla e
spedirla all'inferno con l'anima perduta della madre; certo la riconoscerebbe. L'anima della vecchia,
però, secondo quanto si dice in giro, vaga assumendo qua e là forma di uccello notturno per
scomparire all'alba come saetta (Su l'orlo dei tetti). Ferrando aggiunge - mentre sul volto dei
presenti si manifesta un superstizioso terrore - che un servo del Conte *morì di paura dopo aver
percosso la fronte della zingara che, apparsa intorno alla mezzanotte sotto forma di gufo, lo
guardava insistentemente. Giusto in quel momento una campana improvvisamente suona a distesa
la mezzanotte.Tutti sono colti dal panico. Gli uomini d'arme accorrono in fondo; i familiari si
dirigono verso la porta.
Giardini del palazzo. Sulla destra, marmorea scalinata, che mette agli appartamenti. - La notte è inoltrata;
dense nubi coprono la luna.
2. SCENA E CAVATINA. Leonora, dama di compagnia della principessa d'Aragona, è richiamata
da Ines ai suoi doveri. Ma ella esita: non vorrebbe che passasse un'altra notte senza vedere il suo
amato. Ines le chiede incuriosita come s'accese in lei tale pericolosa scintilla d'amore. Leonora
racconta d'aver incoronato vincitore di un torneo un guerriero sconosciuto, vestito di nero, il cui
scudo era privo di stemma. Poi, scoppiata la guerra civile, egli scomparve. Finché in una dolce
notte di luna piena si udirono risuonare nell'aria silenziosa gli accordi di un liuto e la voce di un
trovatore che, come uomo che prega, cantava malinconici versi (Tacca la notte placida); in quel
canto ella udì pronunciare il suo nome; corse al verone e lo vide: era proprio lui; l'averlo
riconosciuto le diede una gioia che solo agli angeli è dato di provare. Ines è commossa dalla storia;
tuttavia quell'uomo misterioso le desta inquietudine ed ella mette in guardia Leonora da un
pericoloso amore. Ma Leonora è decisa: il suo amore per il Trovatore è indescrivibile e il suo
destino non può compiersi che al suo fianco (Di tale amor); tra sé Ines spera che ella non abbia a
pentirsi mai di un così grande amore. Le due donne entrano negli appartamenti del palazzo.
3. SCENA, ROMANZA E TERZETTO. Il Conte di Luna si avanza: tutto è silenzio; la principessa
sta dormendo; ma dalla tremola luce della lampada egli intuisce che Leonora è ancora sveglia.
Cieco d'amore fa per avviarsi alla gradinata del palazzo. D'un tratto si ode un canto provenire da
lontano (Deserto sulla terra): Solo al mondo, costretto alla guerra da un destino crudele, il
trovatore ha una sola speranza: il cuore di una donna che lo ami. E se egli potrà possedere quel
cuore, allora sarà il più grande degli uomini". Il Conte riconosce la voce: è quella delTrovatore, che
infatti avanza accompagnandosi con il liuto. Lo riconosce anche Leonora, che trepidante
accorre,andando ad abbracciare l'uomo che le si para innanzi coperto da un mantello; in quella un
improvviso raggio di luna lascia scorgere una persona, di cui la visiera nasconde il volto. Dalla
voce del Trovatore, rimasto nell'ombra, che l'accusa d'infedeltà, Leonora s'accorge dell'equivoco:
l'uomo che sta abbracciando è il Conte di Luna. Si getta ai piedi del Trovatore agitatissima,
scongiurandolo di credere all'errore, perché ella ama lui e solo lui (A te credea rivolgere). Il
Trovatore non chiede di più. Ma il Conte è infuriato e vuole sapere il nome del suo rivale. Il
Trovatore si svela: è Manrico, un seguace di Urgel e quindi un proscritto. Furioso di gelosia il
Conte invoca il sangue del rivale (Di geloso amor sprezzato). Invano Leonora lo supplica di
calmarsi, dichiarandosi la sola colpevole e chiedendo d'essere punita. Il duello è inevitabile.
Manrico è sicuro che il suo amore lo renderà invincibile e si allontana con il rivale a spada
sguainata. Leonora cade priva di sensi.
PARTE SECONDA: La Gitana
Un diruto abituro sulle falde d'un monte della Biscaglia. Nel fondo, quasi tutto aperto, arde un gran fuoco.
- I primi albori.
4. CORO DI ZINGARI E CANZONE. Azucena siede presso il fuoco, Manrico le sta disteso
accanto sopra una coltrice e avviluppato nel suo mantello; ha l'elmo ai piedi e fra le mani la spada,
su cui figge lo sguardo. Un banda di zingari, sparsa all'intorno, osserva il dissolversi delle ombre
notturne e saluta l'inizio del nuovo giorno apprestandosi al lavoro. Danno di piglio ai loro ferri del
mestiere; e al misurato tempestar dei martelli cadenti sulle incudini, or uomini or donne, e tutti in
un tempo, elevano un canto di gioia (Chi del gitano i giorni abbella) in onore della zingarella: è lei
ad abbellire la vita del gitano. Gli uomini lavorano con lena, mentre le donne versano ad essi, in
rozze coppe, del vino, che ai raggi del sole sembra brillare più vivido. D'un tratto Azucena inizia a
cantare per suo conto una canzone che attira l'attenzione degli zingari: tutti le si fanno intorno
(Stride la vampa). La canzone narra di un rogo cui il popolo s'affretta festoso levando urla di gioia;
stretta in catene viene trascinata una donna discinta e scalza; la folla inferocita inveisce contro la
vittima, mentre la fiamma, riflettendo i volti orribili della folla, si alza al cielo sinistra. Triste
canzone, osservano i gitani. Ma Azucena ribatte che essa è triste quanto funesta è la storia da cui
trae argomento. Poi, volgendo il capo verso Manrico, mormora sommessamente un'invocazione
dal giovane altre volte già udita, ma per lui ancora misteriosa: "Vendicami! Vendicami!". Intanto
un vecchio zingaro esorta i compagni a scendere verso i centri abitati per procurarsi il pane. Gli
zingari ripongono sollecitamente nel sacco i loro attrezzi e scendono alla rinfusa giù per la china,
ripigliando il loro canto (Chi del gitano), che si perde in lontananza.
5. SCENA E RACCONTO. Rimasto solo con la madre, Manrico le chiede di proseguire il
racconto. Azucena gli confida che quella che aveva cantato era la storia di sua madre, incolpata di
stregoneria da un conte malvagio che la condannò al rogo in quello stesso luogo dove ora arde il
fuoco. Mentre Manrico s'allontana con raccapriccio dalla fiamma, Azucena inizia il suo racconto
(Condotta ell'era in ceppi): in quel giorno terribile, mentre la madre in catene veniva portata al
supplizio, ella con il figlioletto in braccio cercava invano di farsi strada tra la folla. La madre,
vedendola, volle benedirla per l'ultima volta, ma gli sgherri la spinsero via pungendola con le loro
armi e insultandola con parole oscene. Alla povera donna orribilmente torturata non restò altro
che gridare alla figlia disperata "Vendicami!". Quel grido risuonò nell'animo di Azucena come eco
eterna. Fu così che riuscì a rapire il figlio del Conte e a trascinarlo sul luogo del supplizio, dove le
fiamme ardevano già pronte. Il bimbo si struggeva nel pianto e lei si sentiva il cuore dilaniato.
Quando, d'un tratto, alla mente stravolta dal dolore apparve come in un sogno la scena del
supplizio;Azucena sentiva risuonare il grido della madre "Vendicami!". Con mano convulsa afferra
il bimbo e lo sospinge tra le fiamme. Esce di delirio, mentre scompare la visione della madre, e
rinviene: resta solo il fuoco che sta distruggendo la vittima. Gira lo sguardo e in quel punto
s'avvede che il figlio del Conte è ancora vivo davanti a lei: quello che aveva bruciato era il suo
stesso figlio. Ancora rabbrividisce. E ricade sconvolta sul proprio seggio. Manrico ammutolisce
colpito d'orrore e di sorpresa. Momenti di silenzio.
6. SCENA E DtrErro. Manrico, sorpreso dal racconto, chiede dunque di chi è egli figlio; ma
Azucena frettolosamente lo rassicura imputando l'errore all'emozione. Egli è suo figlio: non lo ha
forse sempre amato di tenero amore? non gli ha forse ridato la vita, quando, accorsa alla notizia
della sua morte, gli ha curato amorevolmente le molte ferite subite nella battaglia di Pelilla?
Manrico ricorda con nobile orgoglio di essere rimasto il solo, fra le truppe sbandate, a volgere la
faccia al nemico e a combattere contro il Conte di Luna. Cadde sì; ma da prode. Azucena chiede al
figlio per quale strano sentimento egli poteva aver risparmiato il rivale ormai a terra. Manrico non
riesce a spiegarselo; ma nel punto in cui stava per trafiggerlo sentì una voce dal cielo che gli
ordinava di non colpire (Mal reggendo all'aspro assalto). Azucena gli fa notare che il rivale
tuttavia non udì quella stessa voce quando piombò su di lui ferendolo mortalmente; e dunque,
dovesse la sorte fargli incontrare il "maledetto" Conte, che immerga la lama nel suo cuore fino
all'elsa. Manrico giura di eseguire. Si sente un prolungato suono di corno: è un messo inviato da
Ruiz con un messaggio. Manrico risponde anche lui con un corno che tiene ad armacollo, mentre
Azucena, concentrata e quasi inconsapevole di quanto sta succedendo, mormora:"Vendicami!". Il
messo entra porgendo un foglio a Manrico, che questi legge ad alta voce: Castellor è stata
conquistata; per ordine del principe egli, Manrico, deve andare a vigilarne le difese; inoltre, tratta
in inganno dalla notizia della sua morte, Leonora la sera stessa prenderà il velo nel chiostro vicino.
A quest'ultima notizia Manrico, concitatissimo, ordina al messo di scendere la collina e di
approntargli un cavallo. Azucena si ridesta e, vedendo il figlio in agitazione, tenta di frapporsi. Ma
Manrico s'affretta a mettersi l'elmo e ad afferrare il mantello senza dare ascolto alla madre, che
vorrebbe trattenerlo per timore del pericolo (Perigliarti ancor languente): le sue ferite appena
rimarginate potrebbero riaprirsi; e lo supplica: "Il tuo sangue è sangue mio!". Ma Manrico si
mostra irremovibile: terra e cielo insieme non avrebbero forza per fermarlo; un solo indugio e
perderà Leonora (Un momento può involarmi il mio ben) ed egli cadrebbe spento di dolore. Si
allontana di corsa, invano trattenuto da Azucena.
Atrio interno di un luogo di ritiro in vicinanza di Castellor. Alberi nel fondo. - È notte.
7. SCENA ED ARIA. Il Conte di Luna, Ferrando e alcuni seguaci s'inoltrano cautamente,
avviluppati nei loro mantelli. Il Conte è soddisfatto d'essere giunto prima dell'inizio del rito.
Confida a Ferrando che dopo aver ucciso il rivale riteneva non esserci ostacoli al suo desiderio di
possedere Leonora; tuttavia ella è riuscita a opporne uno più grande: l'altare. Ma Leonora
dev'essere sua e di nessun altro. La luce del suo sorriso supera quella di una stella (Il balen del suo
sorriso) e il suo splendore infonde in lui un coraggio straordinario. L'amore di cui arde le parli in
suo favore e possa il suo sguardo placare la tempesta che ha nel cuore. Si ode il rintocco delle
campane del chiostro: il rito dunque s'appressa. Il Conte ordina ai suoi uomini di rapire Leonora
prima che giunga all'altare. Ferrando tenta di condurlo alla ragione, ma invano: il Conte non vuole
ascoltare e lo obbliga ad agire ordinando ai suoi di nascondersi dietro alcuni faggi.Ansioso e
guardingo, osserva dalla parte da cui deve giungere Leonora, mentre Ferrando e i seguaci
sottovoce si fanno coraggio, apprestandosi al rapimento. Intanto il Conte, in un accesso di furore,
invoca il momento fatale: nemmeno Dio può opporsi al suo amore (Per me, ora fatale). Quindi
s'allontana a poco a poco e raggiunge i suoi nascondendosi fra gli alberi.
8. FINALE SECONDO. Si ode un coro interno di Religiose: il loro canto è un invito ad
abbandonare le vane speranze terrene e a nascondersi con un velo a ogni sguardo umano (Ah!... se
l'erròr t'ingombra), allontanandosi dalle cose mondane e volgendosi al cielo. Entra Leonora, con
sèguito muliebre, accompagnata da Ines, mentre dal fondo cautamente avanza il Conte con
Ferrando e i suoi seguaci. Le amiche di Leonora piangono: non la rivedranno mai più. Ella le
conforta: il mondo per lei non ha più nessuna attrattiva; non le resta che rivolgersi a Colui che è
l'unico conforto per i sofferenti e che potrà un giorno ricongiungerla tra i beati al suo perduto
bene. Esortando le amiche ad asciugare le lacrime e ad accompagnarla all'altare, Leonora
s'incammina verso il chiostro. Ma improvvisamente il Conte si fa avanti sbarrandole la via e fa per
impadronirsi di lei, quando d'un tratto fra lui e la preda appare, quale fantasma uscito di sotterra,
Manrico. Lo stupore è generale. Leonora non crede ai suoi occhi, pensa a un sogno o a un
incantesimo; il suo cuore non può reggere a tale gioia: non sa più se è lui che è sceso dal cielo o se è
lei stessa in cielo con lui (E deggio e posso crederlo?). Il Conte irato chiede a Manrico come mai
l'inferno lo abbia rifiutato: se tuttavia vuole vivere, che fugga da lui e da Leonora. Manrico gli
risponde che, se pur mortalmente ferito, si è salvato perché soccorso da Dio, che non è mai dalla
parte degli empi. Intanto Ferrando cerca invano di placare la furia del Conte. Improvvisamente, al
grido di "Urgel viva!", sopraggiunge Ruiz con una schiera di armati in soccorso di Manrico. Questi
invita Leonora a seguirlo. Il Conte sguaina la spada per contrastarlo, ma viene accerchiato e
disarmato dagli uomini di Ruiz. Ferrando tenta di frenare il Conte, che, ormai reso impotente, è
invaso da un furore maniacale. Manrico si allontana con i suoi traendo seco Leonora, mentre il
Conte e i suoi sono tenuti a bada. Le donne si rifugiano nel cenobio.
PARTE TERZA: Il figlio della Zingara
Accampamento. A destra il padiglione del Conte di Luna, su cui sventola la bandiera in segno di supremo
comando; da lungi torreggia Castellor.
9. CORO D'INTRODUZIONE. Uomini d'arme dappertutto; alcuni giuocano, altri puliscono le
armi, altri passeggiano; ma tutti sono pronti all'imminente assalto alla rocca di Castellor (Or co'
dadi, ma fra poco). E intanto salutano i rinforzi richiesti: un grosso drappello di balestrieri che
attraversa il campo. Entra Ferrando per informare che il capitano intende attaccare, appena farà
giorno, la rocca da tutte le parti ed è certo che ci sarà un considerevole bottino. Quest'ultima
notizia incoraggia i soldati che non vedono l'ora di udire la tromba che li chiama alla battaglia per
ottenere ricchezze, vittoria e gloria (Squilli, echeggi la tromba guerriera). A poco a poco si
disperdono e il loro canto si perde in lontananza.
10. SCENA E TERZETTO. Il Conte uscito dalla tenda volge uno sguardo bieco a Castellor: è
roso dalla gelosia al pensiero che Leonora sia tra le braccia del suo rivale; ma presto, non appena
albeggi, correrà a separarli. Si ode un tumulto. Sopraggiunge Ferrando che informa il Conte di
quanto ha saputo dal capo della scorta: una zingara è stata vista aggirarsi presso l'accampamento;
ritenendola una spia gli esploratori l'hanno raggiunta e catturata. Il tumulto si fa più vicino.
Appare una donna con le mani legate, trascinata dagli esploratori e seguita da un codazzo d'altri
soldati. Il Conte le chiede dove stesse andando; ella risponde che è abitudine di una zingara
spostarsi senza una precisa meta: il cielo è il suo tetto, il mondo la sua patria. Egli allora vuol
sapere da dove venga ed ella gli risponde che fino ad allora è vissuta sulle montagne della
Biscaglia; a quel nome il Conte e Ferrando hanno un sussulto. La donna prosegue il racconto: ella
viveva poveramente, ma contenta del suo stato (Giorni poveri vivea); l'unica sua gioia era un figlio,
che però l'ha abbandonata; ed è per trovarlo che ella vaga senza meta: mai una madre provò per un
figlio l'amore che ella prova per il suo. Mentre Ferrando la scruta attentamente in volto, il Conte
le chiede se sa di un figlio di conti rapito al suo castello; egli è suo fratello e da quindici anni ne va
in cerca. Azucena si scolora in volto. Ferrando, notando il malcelato terrore della donna, riconosce
in lei la zingara che aveva commesso l'orribile delitto. Invano la povera donna tenta di negare; il
Conte è scatenato: finalmente ha messo le mani sulla donna che le uccise il fratello e ordina di
stringerle ancor più i legami. La donna urla dalla disperazione e invoca il soccorso di Manrico!
All'udire questo nome la furia del Conte non ha più freni. Azucena si dibatte e implora che le
allentino i lacci (Deh! rallentate, o barbari) predicendo all'empio figlio di iniquo genitore la
punizione che Dio riserva a chi opprime i miseri. Il Conte non bada alle minacce, egli ormai
assapora la soddisfazione di poter in un sol colpo punire Manrico con il supplào della madre, così
vendicando il proprio fratello. Ferrando e gli altri annunciano l'allestimento di una pira per la
condanna della zingara: ma non sarà il rogo l'unico suo supplizio, poiché le fiamme dell'inferno
attendono il rogo eterno della sua anima. A un cenno del Conte i soldati trascinano via Azucena.
Egli entra nella sua tenda, seguito da Ferrando.
Sala adiacente alla Cappella in Castellor, con verone nel fondo.
11. SCENA ED ARIA. Leonora e Manrico stanno per unirsi in matrimonio. Con loro è Ruiz.
Dall'esterno proviene fragore d'armi che turba Leonora. Manrico non le nasconde il pericolo:
Castellor è assediata e all'alba il nemico attaccherà; è tuttavia certo del valore dei suoi uomini, non
inferiori al nemico per valore e per coraggio. Affida per breve tempo il comando dei preparativi
bellici a Ruiz, che esce. Leonora è oppressa: quale tetra luce risplende sulle loro nozze! Manrico
cerca di consolarla: quando saranno marito e moglie egli sarà ancora più coraggioso (Ah, sì, ben
mio); ma se il destino avesse scritto la sua fine in battaglia, in quegli ultimi istanti il suo pensiero
volerà a lei e la morte sarà solo il precederla in cielo. Il suono dell'organo nella vicina cappella
accompagna un breve duettino (L'onda de' suoni mistici), in cui le voci dei due amanti, come
rasserenate, s'intrecciano con brevi frasi melodiche. Mentre s'avviano giubilanti al tempio, Ruiz
irrompe frettoloso sulla scena per annunciare che la zingara è stata catturata e che il rogo è già
pronto. Manrico, accostatosi al verone per guardare, rivela a Leonora che quella zingara è sua
madre e subito ordina a Ruiz una sortita per andare a salvarla: quel rogo orrendo sarà spento con
il sangue dei suoi carnefici (Di quella pira); era già figlio prima ancora di amarla; corre a salvarla o
a morire con lei. Leonora si sente mancare e invoca per sé la morte. Ruiz torna con uomini armati.
Manrico grida all'armi, quindi parte precipitoso, seguito da Ruiz e dagli armati, mentre all'interno
si ode un fragore d'armi.
PARTE QUARTA: Il supplizio
Un'ala del palazzo dell'Aliaferia. All'angolo una torre con finestre assicurate da spranghe di ferro. Notte
oscurissima.
12. SCENA, ARIA E MISERERE. Ruiz accompagna Leonora presso la torre dove sono rinchiusi i
prigionieri, tra cui Manrico. La donna gli ordina di lasciarla sola: non ha paura e saprà come
difendersi; e nel dir questo fissa lo sguardo su una gemma che le fregia la mano destra. Il suo
pensiero corre a Manrico, che ignora la sua presenza ai piedi della torre; e immagina che i suoi
sospiri salgano su rosee ali a portargli conforto (D'amor sull'ali rosee). Si innesta a questo punto,
scandito da una campana che suona a morto, un canto interno (Miserere d'un'alma già vicina).
Leonora rabbrividisce nel sentire questa cupa preghiera (Quel suon, quelle preci); d'un tratto dalla
torre risuona una voce accompagnata dal liuto: è quella di Manrico; la sua canzone è un addio alla
vita (Ah, che la morte ognora): sconta col proprio sangue il suo amore per Leonora. Su di lei in
scena ora convergono, con effetto stereofonico, il suono interno della campana, il Miserere da un
altro lato interno, la canzone di Manrico dal sommo della torre. .Leonora cerca di reagire allo
strazio con trasporto e disperazione: non ci fui mai sulla terra un amore più forte del suo; i loro
destini sono ormai uniti: o lei salverà la vita di Manrico anche a prezzo della propria o scenderà
nella tomba per sempre (Tu vedrai che amore in terra).
13. SCENA E DUETTO. Si apre una porta; ne escono il Conte e alcuni seguaci. Leonora si trae in
disparte e ascolta. Il Conte conferma ai soldati per l'alba l'ordine della doppia esecuzione: la
decapitazione per il figlio e il rogo per la madre. Parlando tra sé, si chiede se sta abusando del
potere conferitogli dal principe: ma a tanto lo ha trascinato la passione per Leonora, di cui, dopo la
presa di Castellor, nulla più ha saputo. Le si rivolge idealmente, quando, come invocata, Leonora
esce dal buio e si presenta a lui turbandolo. Chiede grazia per Manrico, umiliandosi ai suoi piedi
(Mira, di acerbe lagrime). Le sue preghiere tuttavia non fanno che aumentare la gelosia del Conte:
egli vorrebbe piuttosto centuplicare la morte del rivale fra mille atroci spasimi. Fa per andarsene,
ma Leonora gli si avvinghia, offrendo un prezzo per ottenere la grazia in favore dell'amato: se
stessa. Il Conte crede a un sogno. Ma Leonora insiste, stendendo con dolore la destra per
avvalorare la sua promessa: che le sia permesso di entrare nel carcere e far fuggire il suo amato;
ella sarà sua per sempre. Il Conte le impone di giurare; poi corre all'uscio della torre; vi si presenta
un custode: mentre gli impartisce un ordine sussurrandogli all'orecchio, Leonora di nascosto apre
la gemma dell'anello e ne sugge il veleno: il Conte l'avrà, ma morta. Questi torna da Leonora
annunciandole che Manrico sarà salvo. Leonora rivolge al cielo gli occhi, cui fanno velo lagrime di
gioia, e ringrazia il Signore (Vivrà!... Contende il giubilo): la sua felicità è tale che il suo canto si
spezza, scandito dai palpiti del cuore: ora non le resta che attendere la fine e poter dire a Manrico,
morendo, che egli è salvo per merito suo.Tutto pervaso dall'inattesa felicità di poter finalmente
possedere Leonora, anche il Conte si esprime con un canto spezzato, ripetendo come in delirio:
"Tu mia! Tu mia!".Alla fine chiede a Leonora di rinnovare il suo giuramento. Quindi entrano
insieme nella torre.
Orrido carcere. - In un canto finestra con inferriata. Porta nel fondo. Smorto fanale pendente alla
volta.
14. FINALE ULTIMO. Azucena giace sopra un rozza giaciglio, al suo fianco è Manrico, che tenta
di confortarla. Azucena non riesce a dormire; vorrebbe uscire da quella tomba di vivi, che le toglie
l'aria. Manrico si torce le mani per la disperazione. Ma la madre, sorgendo in piedi, gli dice di non
preoccuparsi perché i suoi nemici non potranno farle nulla: la morte ha lasciato il segno sulla sua
fronte e quando verranno a prenderla ella sarà già cadavere, anzi scheletro. D'improvviso Azucena
cade in delirio: sente arrivare i carnefici per trarla al rogo. Implora Manrico di difenderla. Egli la
rassicura. Ma ella non bada alle sue parole; è invasa dallo spavento che le incute la visione del
rogo. Il rogo! Parola orrenda! Mentre in orchestra risuona il tema di "Stride la vampa", alla mente
offuscata di Azucena ritorna la visione atroce della madre, con l'immaginé dei suoi occhi sbarrati
mentre le fiamme del rogo lambiscono i suoi capelli. La donna cade tutta convulsa fra le braccia di
Manrico, che amorevolmente conducendola al suo giaciglio la invita a dormire per ritrovare nel
sonno il riposo e la calma. Oppressa dalla stanchezza,Azucena lentamente si assopisce intonando
tra il sonno e la veglia un nostalgico canto cullante (Ai nostri monti) nel quale ella s'illude di
tornare col figlio alla loro montagne, dove potrà placidamente dormire al suono del suo liuto. Alla
fine Azucena s'addormenta. Manrico resta genuflesso accanto a lei. S'apre una porta: entra
Leonora. Manrico non crede ai propri occhi. Ella, con parole rotte dall'emozione, ma in tono
sommesso, lo informa d'essere venuta a salvarlo; facendogli fretta gl'indica l'uscita. Ma ella non
può seguirlo: deve restare. Manrico è interdetto! Leonora insiste e cerca di trascinarlo verso la
porta. A questo punto, vedendo che Leonora si rifiuta di sostenere il suo sguardo, Manrico le
chiede a qual prezzo ha potuto ottenere la sua libertà; pensa che ella si sia venduta al rivale
tradendo il suo giuramento d'amore (Ha quest'infame l'amor venduto). Leonora, offesa dall'ira
cieca e ingiusta di Manrico, si getta ai suoi piedi, supplicandolo di fuggire senza indugio.
Inaspettatamente, sulla disputa che va scemando d'intensità, si sovrappone il canto di Azucena
semi-assopita (Ai nostri monti). Intanto il veleno già comincia a fare effetto e Leonora non si regge
più. A Manrico, che in preda all'ira la maledice, la donna chiede supplicando di non imprecare:
questo è il momento dell'ultima preghiera. E cade bocconi. Manrico rabbrividisce e corre a
sollevarla. Leonora gli
rivela d'avere la morte in seno: la mano è già gelida, ma fuoco orribile è nel suo cuore. E mentre
Manrico intuisce il gesto da lei còmpiuto, ella gli chiede di pregare per lei (Pria che d'altri vivere). Entra il Conte, arrestandosi sulla soglia, appena in tempo per sentire le ultime parole di Leonora. Il veleno ha agito con insospettata rapidità. Leonora stringe la destra di Manrico in
segno d'addio, implora la grazia divina e muore. Il Conte, additando Manrico agli armati che
sono al suo seguito, ordina che sia condotto immediatamente al ceppo. Partendo fra le guardie, Manrico rivolge l'estremo addio alla madre addormentata. Improvvisamente Azucena si desta
e chiede subito del figlio. Il Conte trionfante trascina la donna verso la finestra per farla
assistere all'esecuzione. Ora la zingara può rivelargli: "Egli era tuo fratello!". Mentre il Conte resta
impietrito dall'orrore, Azucena, lasciandosi cadere ai piedi della finestra, può finalmente gridare
"Sei vendicata, o madre!".
Traviata
Libretto fin tre atti] di Francesco Maria Piave
Prima rappresentazione: Venezia,Téatro La Fenice, 6 marzo 1853
L'argomento deriva da La Dame aux camélias, "pièce mélée de chants", di Alexandre Dumas figlio
(Parigi, 1824 - Marly-le-Roi, 1895), rappresentata con strepitoso successo al Thé dtre du
Vaudeville di Parigi il 2 febbraio 1852, a sua volta ricavata dal romanzo che Dumas stesso aveva
pubblicato nel 1848.Verdi aveva sempre dimostrato un particolare rigore nella scelta dei cantanti
delle proprie opere, rigore destinato ad acuirsi ulteriormente in occasione della sua quarta opera
veneziana. I destini della Traviata saranno così strettamente legati alle vicende della formazione di
una compagnia di canto accetta al compositore da prevalere sulla scelta del soggetto, scelta decisa
in extremis, che in definitiva si rivelerà inadeguata per gli interpreti scritturati alla Fenice. Colpa
del maestro o dei cantanti?... Richiesto nel gennaio del 1852 dalla Fenice di un'opera nuova, Verdi
firmò il contratto alla fine di aprile, solo dopo aver conosciuto quale compagnia vi era scritturata,
impegnandosi a fornire il libretto entro luglio, ma con la riserva di decidere dopo il debutto della
primadonna, la Salvini Donatelli, se questa dovesse o meno agire nella sua nuova opera. Quanto
alla scelta del soggetto Verdi, intento alla composizione del Trovatore, ne incaricò Piave. La
ricerca si trascinò per tutta l'estate, ma senza risultato. Nonostante due successive proroghe
accordategli dalla Fenice, in settembre il compositore era ancora alla ricerca di un argomento. Alla
fine di quel mese Piave si recava a S. Agata con il soggetto in tasca (forse La forza del destino?); ne
stendeva il libretto ed era già in procinto di rientrare a Venezia, quando Verdi improvvisamente
s'innamorava di un altro argomento: La dame aux camélias di Dumas figlio. Piave fu quindi
obbligato a scrivere un nuovo libretto sull'argomento deciso dal maestro e recante il titolo Amore
e morte, più tardi mutato in Traviata. Sembra che Verdi ne abbozzasse le prime note già nel mese
di ottobre, mentre stava completando il Trovatore. Intanto la stagione della Fenice, dopo un
favorevole avvio, era incappata in alcuni insuccessi. Verdi, trattenuto a Roma per il Trovatore, lo
seppe troppo tardi per valersi della clausola del contratto che gli consentiva di far scritturare
un'altra primadonna. Con il libretto ancora incompleto e con la musica ancora da terminare, il
maestro tentò di sciogliersi dal contratta Impresa e teatro ,tuttavia non cedettero.Verdi si vide così
costretto a rispettare gl'impegni presi. Con una settimana di ritardo rispetto ai termini
contrattuali, si presentò a Venezia, recando seco la partitura pressoché terminata, con l'animo
oppresso da infausti presagi, che purtroppo si avverarono. Verdi giudicò l'esito della prima sera un
`asco", commentando:"La colpa è mia o dei cantanti?... Il tempo giudicherà". In realtà vero e
proprio "fiasco" non fu, poiché l'opera fu replicata per altre otto sere a teatro affollata Si trattò
comunque di un insuccesso, non però imputabile alle "forme opulente" e ancor meno alla voce della
Salvini Donatelli, la sola, anzi, a essere applaudita sino alla fine (come attestano le cronache dei
giornali e al contrario di quanto sostenuto dai biografi disinformati), bensì al cattivo stato di salute
del tenore e alla svogliatezza del baritono. Quanto ai costumi "contemporanei" si tratta di un'altra
inesattezza tramandata da biografi disattenti. Per la verità Verdi voleva che i costumi fossero "dei
tempi presente ma la Fenice, nell'intento di allontanare nel tempo un argomento
290 Traviata
scabroso che metteva in scena una cortigiana, decise diversamente, facendo risalire la vicenda "al
1700 circa". Sarà solo a fine Ottocento che si comincerà a rappresentare Traviata in costumi di
metà secolo, divenuti ormai "storici". Nonostante l'esito alla Fenice l'opera avrebbe dovuto essere
rappresentata a Roma, ma esigendo la censura papalina consistenti modifiche al libretto, Verdi ne
fece ritirare la partitura. La Traviata risorse un anno dopo a Venezia, ma non più alla Fenice bensì
al teatro in S Benedetto. Per l'occasione il maestro da Parigi (ove era impegnato nella
composizione dei Vespri siciliani) apportò alcune modifiche, in gran parte per adattare l'opera ai
nuovi interpreti.Anche di quest'opera il cammino fu rapido sulle scene italiane ed estere,
insediandosi stabilmente in repertorio fino ai nostri giorni, tanto da diventare l'opera di Verdi
forse la più amata dal pubblico internazionale. Come già Stiffelio e Rigoletto, anche Traviata fu
oggetto d'interventi da parte delle censure degli stati italiani del centro-sud, nei cui teatri fino al
1860 fu rappresentata col titolo Violetta
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
VIOLETTA VALERY prima donna
FLORA BERVOIX comprimaria
ANNINA [cameriera di Violetta] seconda donna
ALFREDO GERMONT primo tenore
GIORGIO GERMONT, suo padre primo baritono
GASTONE, visconte di Letorières secondo tenore
Barone DUPHOI. baritono
Marchese D'OBIGNY basso
Fenice 1853
S. Benedetto 1854
Fanny Salvini Donatelli Maria Spezia
Speranza Giuseppini
Carlotta Berini
Lodovico Graziani
Giovanni Landi
Felice Varesi Filippo Colini
Angelo Zuliani
Francesco Dragone
Arnaldo Silvestri
DOTTORE GRENVIL basso profondo
Andrea Bellini
GIUSEPPE, servo di Violetta secondo tenore
G. Borsato
Domestico di Flora corifeo basso
G. Tona
Commissionario corifeo basso
Antonio Manzini
Signori e signore amici di Violetta e Flora, Mattadori, Piccadori e Zingare. Servi di Violetta e di Flora, maschere, ecc.
ecc.
Scena: Parigi e sue vicinanze, nel 1700 circa
N. B. Il primo atto succede in agosto, il secondo in gennaio, il terzo in febbraio
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
1. PRELUDIO. Come già il Preludio di Rigoletto, anche questo costituisce la sintesi sonora del
dramma che si sta per rappresentare, sintesi che si racchiude nel ritratto musicale della
protagonista: Amore e. morte, giusto il titolo primitivo, voluto da Verdi. Si apre infatti con il tema
della morte di Violetta (affidato ai soli violini, lo si riudirà all'inizio del terzo atto) per poi sfociare
nel coinvolgente tema dell'amore ("Amami Alfredo"), che viene ripetuto dai violoncelli in
contrasto con il brillante controcanto dei violini, un richiamo, quest'ultimo, al carattere civettuolo
della protagonista a inizio di dramma.
ATTO PRIMO
Salotto in casa di Violetta. Nel fondo è la porta che mette ad altra sala; ve ne sono altre due laterali; a
sinistra, un caminetto con sopra uno specchio. Nel mezzo è una tavola riccamente imbandita.
2.INTRODUZIONE.
[SCENA]. Violetta, seduta sopra un divano, sta conversando col Dottor Grenvil e con alcuni
amici, mentre altri vanno a incontrare quelli che sopraggiungono, tra i quali sono il Barone e Flora
al braccio del marchese d'Obigny. Gli invitati arrivano in ritardo, ancora eccitati per essersi
intrattenuti al gioco da Flora. Violetta accoglie gli ospiti con calore e li invita a bere. Flora e il
Marchese le chiedono se il suo stato di salute le consente questi eccessi. Violetta è euforica ed
espansiva: gioia e piacere sono per lei ottimo farmaco.Tutti convengono: la gioia raddoppia la vita.
Mentre i servi sono affaccendati intorno alla mensa, su una nuova melodia degli archi entra
Gastone accompagnato da Alfredo; egli si avvicina a Violetta per presentargli in Alfredo Germont
un suo ardente adoratore.Violetta, lusingata, offre la mano al bacio del giovane. Il marchese lo
riconosce e cordialmente lo saluta. Tutto è pronto: le tavole sono riccamente imbandite e Violetta
invita gli ospiti ad accomodarsi. I posti sono occupati in modo che Violetta si trovi tra Alfredo e
Gastone; di fronte a lei siede Flora tra il Marchese e il Barone. Gastone, parlando sommessamente,
rivela a Violetta che Alfredo è infatuato di lei e che durante la sua malattia ogni giorno andava alla
sua porta per chiedere notizie. Violetta si schermisce, e su insistenza di Gastone si rivolge ad
Alfredo, che conferma imbarazzato. Violetta coglie lo spunto per provocare il Barone, che pur
conoscendola da un anno non ha mai dimostrato tanta preoccupazione. Il Barone cerca di
mascherare la sua gelosia e confida a Flora che il giovane gli è antipatico; Flora invece confessa di
provare simpatia per il nuovo venuto.
BRINDISI. Gastone si rivolge ad Alfredo, ammutolito per l'emozione; il marchese invita Violetta a
scuoterlo. Ella, invocando Ebe, la coppiera degli dei, gli versa da bere.Alfredo le risponde con
galanteria.Tutti bevono. Gastone chiede al Barone di proporre un brindisi. Questi però si sottrae
all'invito. Gastone si rivolge quindi ad Alfredo, che sulle prime ricusa; ma poi con malizia chiede a
Violetta licenza e, tra il giubilo generale, intona un brindisi alla bellezza, alla gioia fugace e,
indicando Violetta, all'amore (Libiam ne' lieti calici). Gli risponde Violetta inneggiando al piacere e
all'amore, fiore caduco. Mentre tutti si associano al canto, i due scambiano i primi approcci: ella
inneggia al tripudio, egli all'amore.
VALZER E DUETTO. L'inatteso suono di un'orchestra proveniente dalla vicina sala coglie di
sorpresa gli invitati. Violetta li invita alle danze.Tutti felici s'avviano alla porta di mezzo, quando
Violetta è colta da improvviso malore. Gli amici la circondano preoccupati; ella prova a fare
qualche passo, ma è obbligata a fermarsi e a sedere: un tremito la invade; tuttavia ha la forza di
tranquillizzare gli amici invitandoli a passare nell'altra sala.Tutti escono, meno Alfredo, che
rimane sul fondo a osservare Violetta. Mentre le danze continuano a risuonare, ella si rialza a
fatica, s'avvicina allo specchio per guardarsi e osserva il pallore del proprio volto. In quella
s'accorge della presenza di Alfredo, che con aria preoccupata le si avvicina rimproverandole la vita
che conduce: egli stesso la saprebbe curare, poiché nessuno al mondo la ama quanto lui. Questo
interessamento la sorprende: tenta di mascherare la sorpresa celiando sui sentimenti del giovane.
Ma questi le rivela di amarla da oltre un anno, allorché la vide per la prima volta (Un dì, felice,
eterea): da quel momento visse di "quell'amor ch'è palpito dell'universo", sentimento misterioso
che è a un tempo "croce e delizia" al cuore. Violetta, spaventata dall'idea di un sentimento tanto
impegnativo, nasconde il proprio turbamento reagendo con civetteria di cortigiana: confessa di
non saper amare e consiglia Alfredo di dimenticarla. Ma il giovane insiste. Per un attimo Gastone
si presenta sulla porta di mezzo come per sollecitare la presenza di Violetta alle danze, e subito
parte. Violetta propone ad Alfredo un patto: quello di rèstare buoni amici. Alfredo accetta. A
questo punto Violetta, come trascinata da un impulso interiore, trae dal seno una camelia (fiore da
lei prediletto perché privo di profumo), e la porge al giovane dicendogli, con un pizzico di malizia,
di riportarla quando sarà appassita. "Domani " chiede speranzoso Alfredo. "Ebben, domani"
risponde Violetta. Alfredo prende con trasporto il fiore. Divertita da tanta franchezza Violetta gli
chiede di ripeterle che la ama.
Alfredo fa per partire, poi torna per baciarle la mano. Infine esce di corsa, non potendo desiderare
di più.
STRETTA DELL'INTRODUZIONE. Tutti rientrano dalla sala riscaldati dalle danze: è ormai
l'alba e occorre rincasare non senza prima ringraziare Violetta per la riuscita della festa (Si ridesta
in ciel l'aurora); la godereccia compagnia si avvia al riposo per ritemprare le forze e predisporsi alle
molte gioie e ai divertimenti che la città offre.
3. SCENA ED ARIA. Rimasta sola, Violetta appare turbata, le parole di Alfredo sono ancora
impresse nella sua memoria e il pensiero di un serio amore le fa temere oscure sventure. Ma ciò
che la stupisce è lo strano sentimento di "essere amata amando" che la rende insicura. Il suo cuore
si desta all'illusione che possa essere lui l'ideale sognato, amato, atteso, che la richiama a
"quell'amor ch'è palpito dell'universo" (Ah fors'è lui che l'anima), un sentimento che pure le si era
delineato nell'animo sin da fanciulla, e proprio nei termini evocati da Alfredo: "croce e delizia al
cor". Resta concentrata un istante. Poi si scuote: "Follie! follie!". Per una giovane donna che vive in
quel "popoloso deserto" che è Parigi, non c'è scampo; l'unica possibilità è di continuare a vivere
libera e a gioire freneticamente di nuovi piaceri, fino a morire nei vortici di voluttà (Sempre libera
degg'io). Per quanto Violetta cerchi di stordirsi col canto, attraverso scale ed arpeggi
rischiosissimi, la voce di Alfredo risuona nella sua anima invitandola a quell'amore "ch'è palpito
dell'universo".
ATTO SECONDO
Casa di campagna presso Parigi. Salotto terreno. Nel fondo, in faccia agli spettatori, è un camino, sopra il
quale uno specchio e un orologio, fra due porte chiuse da cristalli che mettono a un giardino. Al primo piano
due altre porte, una di fronte all'altra. Sedie, tavolini, qualche libro, l'occorrente per scrivere.
4. SCENA ED ARIA. Una vivace introduzione degli archi sottolinea l'entrata di Alfredo in
costume di caccia, con fucile a tracolla che subito depone: per lui non v'è diletto senza Violetta;
sono ormai tre mesi da che ella ha abbandonato la città e le sue feste per ritirarsi a vivere con lui in
campagna. Il giovane è felice e si sente rinato. Da quando Violetta gli ha giurato fedeltà, il suo
giovanile ardore ha lasciato il posto a una completa felicità, tale che gli sembra di vivere in cielo
(De' miei bollenti spiriti). Entra Annina affannosa. Nel vederla in tenuta da viaggio Alfredo si
stupisce e ne chiede il motivo. La donna con malcelato imbarazzo risponde d'essere stata a Parigi
su ordine della sua signora per vendere le sue ultime proprietà; e ad Alfredo che le chiede perché
avesse finora taciuto, Annina rivela esserle stato imposto il silenzio sulla faccenda; occorrono
infatti mille luigi per sanare i debiti della loro dispendiosa vita. Alfredo, sorpreso e imbarazzato,
ordina ad Annina di tacere su questo colloquio: andrà egli stesso a Parigi per procurarsi la somma.
Annina esce. Il giovane si sente attanagliato dal rimorso per la propria condotta irresponsabile,
tutta a carico di Violetta; come svegliandosi da un sonno fanciullesco ora si propone di lavare tanta
vergogna (O mio rimorso! oh infamia!). Quindi esce precipitosamente.
5. SCENA E DUETTO. Entra Violetta con alcune carte in mano, seguita da Annina, cui chiede di
Alfredo. La domestica l'avverte che il signore è partito per Parigi promettendo di tornare entro
sera. Giuseppe entra porgendo una lettera a Violetta, che dopo averla letta scoppia a ridere'. Flora
ha scoperto il suo rifugio e'la invita a una festa per la sera stessa; ma Violetta non ci andrà, e getta
il foglio sul tavolino. Rientra Giuseppe per annunciare l'arrivo di "un signore".Violetta, credendo
trattarsi dell'uomo d'affari che attendeva, fa cenno d'introdurlo. Lo sconosciuto entra e si presenta
subito come il padre di Alfredo. Violetta sorpresa lo invita a sedersi. Con ruvido tono Germont
incolpa subito la donna d'aver ammaliato suo figlio e di esserne la rovina: per amor suo egli sta
sperperando il suo patrimonio. Violetta risentita si alza ricordando al vecchio che sta parlando a
una signora. Germont è colpito dai suoi modi. Tuttavia non demorde, accusando la donna d'essere
beneficiaria dei beni di suo figlio. Violetta risponde con fierezza: fosse vero che Alfredo voglia farle
dono dei suoi averi, ella rifiuterebbe. E nel dir questo gli mostra le carte che testimoniano la
vendita delle sue proprietà. Dopo avervi dato un rapido sguardo Germont si mostra altamente
sorpreso; addolcendo il tono, si rammarica che il passato la accusi! Violetta con trasporto afferma
che il passato non esiste più: Dio stesso lo ha cancellato con il suo pentimento. Germont è
affascinato dalla nobiltà dei sentimenti della donna. A sua volta Violetta è intenerita dal nuovo
tono di voce del padre di Alfredo. Ma questi rivela d'essere venuto a chiederle un sacrificio.
Violetta, che aveva presagito l'appressarsi di una sventura, si alza per interromperlo. Ma egli con
voce ferma le chiede di salvare l'avvenire dei suoi due figli. A Violetta, sorpresa, Germont rivela
che ha una figlia il cui fidanzato, venuto a sapere della convivenza del futuro cognato con una
cortigiana, non acconsente più alle nozze (Pura siccome un angelo); implora pertanto Violetta di
non mutare in dolore la speranza di una vergine innamorata. Violetta pensa si tratti di una
separazione temporanea e, per quanto dolorosa, la accetta. Ma Germont è venuto per chiederle di
rinunziare ad Alfredo per sempre. A questa richiesta Violetta reagisce con affannoso impeto (Non
sapete quale affetto): non ha amici né parenti, tutto il suo universo è in Alfredo, che le ha giurato
eterno amore; inoltre è malata, e vede prossima la fine. Separarsi da Alfredo? Piuttosto la morte!
Germont cerca di lusingarla dicendole che è bella e giovane: col tempo potrà rifarsi. Ma ella, quasi
offesa, ribadisce che amerà solo Alfredo. Allora Germont le ricorda che l'uomo (e Violetta, oggetto
di desiderio, lo sa benissimo) è volubile. Questa verità è come una stilettata mortale nel cuore della
giovane. Quando un giorno la bellezza svanirà - continua Germont e subentrerà la noia, quale
balsamo potrà avere un amore non benedetto dalle nozze? Che Violetta disperda un sogno fallace,
incalza Germont, e diventi piuttosto l'angelo consolatore della famiglia di Alfredo. Violetta,
annichilita dal dolore estremo, si arrende: verso la donna caduta, per quanto Iddio indulga con il
perdono, l'uomo resterà pur sempre implacabile! Piangendo si volge a Germont: sacrificherà il suo
amore, l'unico bene della sua vita, per la felicità di sua figlia (Dite alla giovine). Germont è turbato
e commosso: si rende conto della gravità del sacrificio imposto, e non trova altre parole che
invitare Violetta a piangere e a farsi coraggio. Segue un istante di silenzio. Poi Violetta chiede
come agire. Ai suggerimenti proposti da Germont ella obietta che Alfredo comunque la seguirà. Vi
è una sola soluzione, che ella tuttavia non rivela perché Germont si opporrebbe. Il figlio gli sarà
reso: che il padre accorra a suo conforto. Va al tavolo per scrivere. Poi ritorna: dovendo affrontare
tanto sacrificio chiede che almeno il padre di Alfredo la abbracci come figlia: avrà così più
coraggio. Germont acconsente. Prima di accomiatarsi egli chiede cosa possa fare per lei: in lacrime
Violetta supplica che almeno dopo la sua morte Alfredo conosca la ragione del suo sacrificio e non
maledica la sua memoria (Morrò! la mia memoria); Germont promette; un giorno ella avrà dal
cielo il premio di tanto sacrificio. Si abbracciano dicendosi più volte addio. Germont esce per la
porta del giardino.
Verdi e il notaio Carrara nel giardino della villa Paradiso a Busseto
6. SCENA. Violetta, affranta, siede e scrive un biglietto, poi suona il campanello per chiamare
Annina cui ordina di consegnare di persona il foglio. La cameriera legge la destinazione e rimane
sorpresa. Violetta le ordina silenzio e di partire immediatamente. Poi si rimette a scrivere, ma
questa volta ad Alfredo. Il lamento di un clarinetto esprime tutta l'angoscia del suo animo. Deve
comunicargli, mentendo, la fine della loro unione. Scrive e suggella il biglietto. D'improvviso
giunge Alfredo che, vedendola turbata, chiede a chi stesse scrivendo. Nascondendo la lettera
Violetta risponde agitata e confusa. Alfredo si dice preoccupato: ha ricevuto un severo scritto da
suo padre; però la rassicura: il padre l'amerà al solo vederla. Ancor più agitata e trattenendo a
stento il pianto, Violetta chiede di allontanarsi per non essere sorpresa da lui. Con frasi spezzate
dall'emozione promette che si getterà ai suoi piedi; non vivranno più divisi, "perché tu m'ami,
Alfredo, non è vero?". Alfredo chiede il motivo del suo pianto. Ma ora Violetta non piange più.
Aveva bisogno di uno sfogo. Ora gli sorride. Sarà sempre presso di lui, tra i fiori del giardino,
sempre, sempre: "amami Alfredo, quant'io t'amo... Addio". E corre nel giardino.
7. SCENA ED ARIA. Alfredo siede, apre a caso un libro, legge alquanto, quindi si alza, guarda
l'ora sull'orologio del camino: ormai è tardi, più non verrà suo padre. Sopraggiunge frettoloso
Giuseppe ad avvertire che la signora è partita in calesse e già corre a Parigi. Alfredo ritiene sia
andata ad affrettare la vendita dei suoi ultimi averi: ma sa che Annina glielo impedirà. Si vede
intanto il padre attraversare in lontananza il giardino.Arriva un messo recante un biglietto
consegnatogli da una signora in carrozza.Assalito da una strana emozione,Alfredo apre tremante il
messaggio: forse un invito a raggiungerla... Legge: "Alfredo, al giungervi di questo foglio...". Come
fulminato lancia un grido di dolore e, volgendosi, si trova di fronte a suo padre, nelle cui braccia
s'abbandona. Germont vede quanto soffra suo figlio e mentre questi, disperato, siede presso al
tavolino col volto fra le mani, cerca di confortarlo: gli parla della terra natia e delle pace che pur vi
godette (Di Provenza il man il suol) e gli ricorda anche le sofferenze patite a causa della sua
lontananza, invitandolo a tornare presto in seno alla famiglia. Ma Alfredo, al massimo della
disperazione, quasi non sente e respinge il padre; sta solo meditando vendetta. Mentre il padre lo
affretta a partire, il giovane pensa che il responsabile sia il barone Duphol, sotto la cui protezione
Violetta è tornata... Il padre tenta ancora di convincerlo a seguirlo ricordandogli la gratitudine di
sua sorella e promettendogli il perdono (No, non udrai rimproveri). Ma Alfredo non intende
ragione. Scuotendosi, getta a caso gli occhi sulla tavola: vede la lettera di Flora, la legge: ecco dove
Violetta si è recata, alla festa dell'amica! Con il proposito di vendicare l'offesa patita, fugge
precipitoso, inseguito dal padre.
Galleria nel palazzo di Flora riccamente addobbata e illuminata. Una porta nel fondo e due laterali. A
destra più avanti un tavoliere con quanto occorre per il gioco; a sinistra un ricco tavolino con fiori e
rinfreschi; varie sedie e un divano.
8. FINALE SECONDO. Flora, il Marchese, il Dottore e altri invitati entrano dalla sinistra
discorrendo fra loro. Ci sarà una mascherata, dice Flora, cui sono invitati anche Violetta e Alfredo.
Il Marchese informa che i due si sono separati; ella verrà col Barone.
CORO DI ZINGARELLE. Si ode un festoso rumore provenire da destra.Tutti corrono a ricevere
gli amici. Si presentano molte signore mascherate da zingarelle con in mano dei tamburelli che
percuotono a tempo (Noi siamo zingarelle). Alcune di loro leggono la mano a Flora e poi quella del
Marchese: non siete un modello di fedeltà, esse gli osservano. Ne nasce una schermaglia amorosa
tra Flora e il Marchese. Le zingarelle s'interpongono esortando a dimenticare il passato. I due alla
fine si stringono la mano.
CORO DI MATTADORI SPAGNUOLI. Entrano vivacemente, capitanati da Gastone, altri
signori, a loro volta mascherati da Mattadori e Piccadori spagnoli: dicono di essere venuti a Parigi
per godere la festa del bue grasso (Di Madride noi siam mattadori) e danzando raccontano la storia
di Piquillo, il gagliardo matador che per amore di una bella ritrosa in un sol giorno uccise ben
cinque tori, ottenendo in premio l'abbraccio della giovino; poi si avvicinano alle signore
promettendo che i loro cuori sono molto più miti e che a loro basta folleggiare. Gli uomini si
tolgono la maschera; chi passeggia e chi si accinge a giocare.
- SEGUITO DEL FINALE SECONDO. Improvvisamente entra Alfredo. Cerca di mostrare un
fare disinvolto. Gli chiedono di Violetta: non ne sa. Con il suo arrivo si può cominciare a giocare.
Gastone si pone a tagliare le carte, Alfredo e altri puntano. Un turbolento motivo orchestrale,
scandito su un ritmo ostinato, sottolinea l'ingresso di Violetta al braccio del Barone. Flora va loro
incontro (Qui desiata giungi). Violetta, notando l'inopinata presenza di Alfredo, crede di svenire.
Anche il Barone nota il giovane e subito impone a Violetta d'ignorarlo. Flora incuriosita fa sedere
Violetta presso di sé sul divano per avere notizie. Il Dottore si avvicina ad esse, che
sommessamente conversano. Il Marchese si trattiene a parte col Barone. Gastone continua a
distribuire le carte e Alfredo seguita a puntare. La fortuna volge in suo favore. Raddoppia la posta
di volta in volta: è sempre vincitore. Con l'oro guadagnato, promette, potrà ritornare felice in
campagna. Solo? chiede Flora. No, le risponde Alfredo con ira mal contenuta: con una tale che gli è
fuggita. Parole e tono irritano il Barone, che con malcelato astio gli si rivolge, invano frenato da
Violetta, sfidandolo al gioco. Alfredo, con tono ironico, accetta la sfida. Violetta, sempre seduta sul
divano, si sente morire. Entrambi puntano. Vince Alfredo. La posta viene raddoppiata. Alfredo
vince ancora. Mentre cresce l'agitazione intorno ai due sfidanti, il gioco viene interrotto da un
servo che annuncia pronta la cena.Tutti s'allontanano dalla porta di mezzo. Nell'uscire, parlando
piano, il Barone propone la rivincita. Alfredo accetta: al gioco che egli vorrà... La scena rimane
vuota per un istante.Torna Violetta affannata: aspetta Alfredo, da lei avvisato con un biglietto di
raggiungerla. Sul ritmo agitatissimo dell'orchestra entra Alfredo. Le sue prime parole denunciano
in lui un'ira incontrollata (Mi chiamaste? che bramate?).Violetta lo supplica di partire: il luogo è
pericoloso e trema al pensiero del Barone. Per Alfredo fra lui e il Barone è ormai una questione
mortale: forse Violetta teme di perdere d'un sol colpo l'amante e il protettore? Ma è appunto la
morte di Alfredo che ella teme! "Che v'importa della mia morte?" le risponde il giovane in tono
sempre più focoso; egli partirà solo se lei lo seguirà. Violetta rifiuta; che Alfredo dimentichi il suo
nome infamato; e poi, aggiunge, ha giurato di fuggire da lui. Alfredo incalza con le domande.
Alfine Violetta, non reggendo più a quell'interrogatorio straziante, dichiara d'aver giurato a chi ne
aveva diritto (e pensa al padre del giovane). "Fu Duphol?" esplode Alfredo. Con uno sforzo
supremo lei annuisce. Al colmo del dolore e della gelosia Alfredo si precipita furente verso la sala
per richiamare l'attenzione degli invitati. Questi rientrano confusamente. Alfredo addita loro
Violetta, che abbattuta si appoggia al tavolino: ebbene - egli dice - questa donna che voi tutti
conoscete ha dilapidato ogni suo avere per amor mio (Ogni suo aver tal femmina); ed io, cieco e
vile, ho potuto accettare questo; ma è tempo di lavare quest'onta: voi tutti siete testimoni che ora
qui io l'ho pagata. E nel dir questo getta con furente sprezzo una borsa ai piedi di Violetta, che
sviene tra le braccia di Flora e del Dottore. I: ignobile gesto di Alfredo fa inorridire tutti i presenti
(Oh, infamia orribile tu commettesti), che invitano il giovane ad allontanarsi.
LARGO DEL FINALE SECONDO. Inopinatamente si fa avanti, fra il trambusto generale, il
padre di Alfredo: con dignitoso fuoco rimprovera acerbamente il figlio, non riconoscendolo più
come tale: è degno di disprezzo chi, pur nell'ira, offende la donna. Alfredo si rende conto della
gravità del suo atto: la delusione d'amore e la gelosia lo hanno gravemente provato; non avrà più il
perdono di Violetta e, ora che ha sfogato l'ira, nel suo cuore vi è solo un atroce rimorso. Violetta
intanto ripresasi, confortata dagli amici, con un filo di voce si volge ad Alfredo: egli non può capire
quanto lei lo abbia amato né sapere a quale prezzo si è separata da lui (Alfredo, Alfredo, di questo
core); ma verrà un giorno che saprà tutto, e allora che Dio lo salvi dai rimorsi, poiché anche da
morta lei continuerà ad amarlo. Mentre tutti sono partecipi del dolore di Violetta e si fanno
attorno a lei per confortarla, il Barone s'avvicina risoluto ad Alfredo e parlandogli piano lo sfida a
duello. Alla fine Germont parte traendo seco il figlio; Violetta viene condotta in altra stanza dal
suo devoto amico il Dottore e da Flora. Gli altri si disperdono.
ATTO TERZO
Camera da letto di Violetta. Nel fondo è un letto con cortine mezzo tirate; una finestra chiusa da imposte
interne; presso il letto uno sgabello su cui una bottiglia d'acqua, una tazza di cristallo, diverse medicine.A
metà della scena una toilette, vicino un canapè; più distante un altro mobile su cui arde un lume da notte;
varie sedie e altri mobili. La porta è a sinistra; di fronte v'è un caminetto con fuoco acceso.>
9. SCENA ED ARIA. Violetta dorme sul letto;Annina, seduta presso il caminetto, è pure
addormentata. L'orchestra introduce coi soli archi ed estremamente piano la visione della scena:
risuonano all'inizio le stesse note che avevano iniziato il Preludio dell'opera e che ora introducono
una nuova melodia affidata ai soli violini. Violetta si sveglia e chiede ad Annina di aprire le
imposte. Annina esegue e dopo aver guardato nella via annuncia l'arrivo del dottore
Grenvil.Violetta tenta di alzarsi per riceverlo, ma ricade in letto; poi, sostenuta da Annina, avanza
verso il canapè; il dottore arriva in tempo per sostenerla, le misura il polso chiedendole come si
sente. La malattia la fa soffrire molto, ma ella è serena da quando ha ricevuto i conforti religiosi. Il
dottore le annuncia che la convalescenza non è lontana. Violetta sa che si tratta di una pietosa
bugia e sorride. Grenvil si congeda; accompagnato alla porta da Annina, le rivela che la tisi non
accorda a Violetta che poche ore di vita. È giorno di festa; fuori impazza il carnevale. Violetta
chiede ad Annina quanti soldi rimangono e ordina che la metà sia data ai poveri. Uscita Annina,
trae dal seno una lettera e legge con voce bassa, senza suono. La sua lettura è accompagnata in
orchestra da un violino solista che intona "Di quell'amor ch'è palpito dell'universo". La lettera è di
Germont: le racconta del duello in cui il Barone restò ferito, ma non in modo grave, e di Alfredo
che, partito per un paese straniero, ma ormai messo al corrente del grande sacrificio di Violetta,
presto tornerà a chiederle perdono. "Curatevi, meritate un avvenir migliore" è la chiusa di colui
che è stato arbitro del suo destino. Ma ormai è tardi! esclama la donna con voce sepolcrale. Si alza
a stento e va allo specchio della toilette. Contempla i segni lasciati sul suo viso dalla malattia. Il
pallore del volto sfiorito non lascia speranza. Il suono lamentoso di un oboe scandisce un respiro
fattosi ormai affannoso.Addio sogni d'amore e di felicità (Addio del passato). Con l'anima stanca,
priva del conforto di Alfredo, Violetta alla fine invoca Dio: che Egli sorrida alla traviata col suo
perdono e l'accolga nel suo seno.Tutto è finito!
10. BACCANALE. D'improvviso s'odono di lontano voci festanti: accompagnate da corni, pifferi e
tamburi, che inneggiano al "Bue grasso" (Largo al quadrupede sir della festa). Le voci si perdono
in lontananza.
11. SCENA E DUETTO. Annina riappare frettolosa; con incontenibile emozione chiede a Violetta
lo stato delle sue forze, le raccomanda di star calma. Violetta intuisce una gioia improvvisa. Su un
incalzante crescendo orchestrale la musica assume un ritmo sempre più frenetico: è Alfredo! È
tornato! Egli appare sulla soglia della porta, pallido per l'emozione. I due amanti si gettano le
braccia al collo, si abbracciano freneticamente finalmente ritrovati. Le parole corrono rapide e si
sovrappongono in uno stato d'eccitazione crescente. Egli le chiede perdono (Colpevol sono). Ella è
solo felice di riaverlo. Ciascuno di loro si proclama colpevole. Ma ora nessuno potrà più separarli.
Lasceranno Parigi per andare a vivere insieme lontani dal mondo (Parigi, o cara). Violetta vuole
recarsi subito in chiesa a rendere grazie a Dio per il ritorno di Alfredo. Nel muoversi vacilla.
È.l'emozione, dice lei. Si abbandona sopra una sedia col capo all'indietro. Alfredo, spaventato, la
sorregge. Violetta si sforza per alzarsi: è solo un malore passeggero, ma ora si sente forte. E
sorride. Ordina ad Annina di darle gli abiti. Alfredo la implora d'aspettare. Ma Violetta vuole
uscire subito. Annina le presenta una veste ch'ella fa per indossare. Ma ne è impedita dalla
debolezza. Getta con dispetto la veste e ricade sulla sedia, sotto lo sguardo angosciato di Alfredo,
che ordina ad Annina di correre a chiamare il Dottore. Gli dica, aggiunge Violetta, che Alfredo è
tornato e che vuole vivere ancora. Annina esce. Violetta si volge ad Alfredo: se il suo ritorno non è
bastato a ridarle la vita, nulla potrà ormai salvarla. Improvvisamente ella sorge impetuosa
chiedendo a Dio il perché di tanta sofferenza proprio nel momento in cui è vicina a tergere un così
lungo pianto (Gran Dio! morir sì giovine); fu dunque una follia aver armato il cuore di costanza?
Alfredo sempre più disperato cerca di calmarla e di confortarla aggrappandosi alla
speranza.Violetta s'abbatte sul canapè.
12. FINALE ULTIMO. Guidati da Annina giungono il Dottore e Germont. Questi corre da
Violetta e la abbraccia, come promesso, quale figlia. Ella è grata per averlo rivisto e si dichiara lieta
di morire tra le braccia delle persone a lei più care. Morire? Germont la osserva atterrito: la sua
anima è divorata dal rimorso; ora il "malcauto vegliardo" vede tutto il male che le ha fatto.
Violetta, intanto, aprendo a stento un ripostiglio della toilette, ne trae un medaglione e lo porge ad
Alfredo. Gli dona il proprio ritratto affinché egli possa ricordarla quando sarà morta (Prendi...
quest'è l'immagine). Inutilmente i singhiozzi del giovane tentano di impedire il così triste dono.
Mostrando quel ritratto alla donna che sposerà egli potrà dirle quanto ella lo abbia amato e come
ancora dal cielo continuerà ad amarlo pregando per la loro felicità. Invano Alfredo, al colmo della
disperazione, supplica Violetta. I presenti assistono straziati alla scena. A un tratto Violetta, come
rianimata, si alza sorridente. "È strano!", ella dice. Rinfrancata da un improvviso vigore, trasale: le
si accende per un attimo la speranza di essere tornata a vivere. "Oh gioia!". Così dicendo ricade sul
canapè. Il Dottore, dopo averle toccato il polso, ne constata la morte.
Verdi ritratto da Giovanni Boldini (Parigi, 9 aprile 1886)
I Vespri siciliani
Opera in cinque atti - Parole di Eugène Scribe e Charles Duveyrier
Prima rappresentazione: Parigi,Thatre de 1'Opéra, 13 giugno 1855
[traduzione italiana di Eugenio Caimi]
L'argomento deriva da un primitivo progetto di Scribe (Parigi, 1791 - 1861), Il duca d'Alba, un
libretto scritto nel 1838 per Halévy, passato poi, dopo la rinuncia di questi, a Donizetti, che ne
mise in partitura i primi due atti, abbozzandone in spartito gli atti seguenti, senza poterlo
terminare (completato da Matteo Salvi, il Duca d'Alba di Donizetti sarà rappresentato postumo a
Roma nel 1881). L'argomento fu da Scribe, in accordo con Duveyrier, trasportato dalla Fiandra in
Sicilia e inquadrato in un avvenimento storico: la rivolta popòlare che nel 1282 sfociò in una
guerra conclusasi con l'espulsione dei Francesi e l'instaurazione del dominio spagnolo in Sicilia.
Sul dato storico venivano innestati mito e leggenda: il mito dei Vespri siciliani, divenuto di grande
attualità in epoca risorgimentale, e la leggenda del medico Giovanni da Procida che avrebbe
organizzato il tumulto del vespro (in realtà si trovava in Spagna all'epoca della rivolta siciliana),
personaggio che, sempre in epoca risorgimentale, veniva considerato un precursore di patrioti
come Giuseppe Mazzini (era stato oggetto fra l'altro di un dramma di Niccolini e di un'opera di
Poniatowski). Il soggetto comunque rischiava di urtare il sentimento di due popoli, il francese e
l'italiano, proprio nel momento in cui la Francia di Napoleone III e il Piemonte di Cavour stavano
stringendo una salda alleanza in funzione antiaustriaca. Verdi lo sapeva bene scrivendo al direttore
dell'Opéra: "Più rifletto a questo soggetto, più mi persuado che è pericoloso. Ferisce i Francesi
perché sono massacrati; ferisce gli Italiani perché il signor Scribe alterando il carattere storico di
Procida ne fa (secondo il suo sistema favorito) un comune cospiratore con l'inevitabile pugnale alla
mano. Mio Dio! nella storia di ogni popolo ci sono virtù e delitti, e noi non siamo peggio degli
altri. In ogni caso, io sono Italiano prima di tutto, e costi quel che costi, non mi renderò mai
complice di un'ingiuria fatta al mio paese". Era la seconda volta che Verdi saliva le scene
dell'Opéra. Ma questa volta la posta era ben più grossa: per l'autore del Rigoletto e del Trovatore
si trattava di sfidare sul suo terreno quel Meyerbeer che tutta Europa da anni andava legittimando
quale successore di Rossini sul trono del teatro musicale, mettendo così a repentaglio non solo il
proprio prestigio di artista più acclamato in patria, ma anche l'eredità di una tradizione musicale,
quella italiana, considerata ormai ai margini degli sviluppi della cultura europea. Il contratto fu
firmato nel febbraio 1852. L'opera era destinata a coincidere con le manifestazioni per
l'Esposizione Universale di Parigi. Il soggetto fu fissato e accettato durante il soggiorno di Verdi
nella capitale francese (vi era arrivato a metà ottobre del 1853). Il libretto gli fu consegnato
completo nel successivo febbraio. I primi quattro atti dei Vespri furono composti tra maggio e
settembre del 1854 nel ritiro di Mandres (Seineet-Oise). Ma è solo nell'aprile del 1855 che il
compositore potrà annunciare d'aver terminato l'opera, salvo i ballabili. Le prove, iniziate il l°
ottobre 1854, furono interrotte dalla repentina scomparsa della primadonna, Sofia Cruvelli: ma si
trattò solo di una breve fuga (nel frattempo Verdi accettava di dirigere le prove del suo Trovatore
al Teatro Italiano).
Riprese in dicembre, le prove, causa la complessità della messinscena e la puntigliosa meticolosità
con cui veniva realizzata, si protrassero fino a primavera inoltrata. Poteva ben dire Verdi a un
amico:"Un'opera all'Opéra è fatica da ammazzare un toro". I Vespri ebbero successo di pubblico e
di critica (fra cui un articolo molto elogiativo di Berlioz). Verdi stesso provvide alla traduzione
italiana (peraltro pessima, affidata a Eugenio Caimi) facendo trasportare l' dzione in Portogallo col
titolo Giovanna de Guzman (tuttavia a Napoli non se ne accontenteranno e ne forniranno ben due
riscritture, rispettivamente per il Teatro Nuovo col titolo Giovanna di Sicilia e per il San Carlo col
titolo Batilde diTurenna). In questa versione l'opera fu rappresentata con successo sulle scene
italiane e straniere fino al 1859. Dopo l'unità proseguì il cammino col titolo ripristinato in Vespri
siciliani, stabilendosi in repertorio (ma con numerosi tagli, fra cui, spesso, i ballabili) per una
trentina d'anni, nonostante le difficoltà della messinscena. Dopo un periodo di silenzio, l'opera
riapparve sulle scene tedesche a partire dal 1929. Fondamentali per la fortuna attuale dei Vespri i
due allestimenti del 1951 rispettivamente al Maggio Musicale Fiorentino e alla Scala.
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
GUIDO DI MONFORTE, governatore di Sicilia per Carlo d'Angiò, re di Napoli baritono Marc
Bonnehée
IL SIRE DI BÉTHUNE uffiziale francese basso Coulon
IL CONTE VAUDEMONT basso Guignot
ARRIGO, giovane siciliano tenore Louis Gueymard
GIOVANNI DA PROCIDA, medico siciliano
basso Louis-Henri Obin
LA DUCHESSA ELENA, sorella del duca Federico d'Austria
soprano Sofia Cruvelli
NINETTA, sua cameriera contralto Sannier
DANIELI, siciliano tenore Boulo
TEBALDO, soldato francese
tenore Aimès
ROBERTO, soldato francese baritono Marié
MANFREDO, siciliano
tenore Koenig
Coro: Siciliani. Siciliane. Soldati francesi
Comparse e Corpo di ballo: Soldati francesi, sei Giovinette, quattro Paggi, Maestro di cerimonie,
Nobili d'ambo i sessi, quattro Uffiziali, due Penitenti, un Carnefice, Siciliani
L'azione è in Palermo, l'epoca il 1282
Nota storica: L'azione del dramma è immaginata all'epoca dell'insurrezione del popolo siciliano
contro la dominazione angioina, scoppiata a Palermo nella piazza di S. Spirito, all'ora del vespro
del 30 marzo 1282. Il malcontento degli isolani, causato soprattutto dalla forte pressione fiscale e
dal trasferimento della capitale da Palermo a Napoli, fu preparato da alcuni fuorusciti siciliani, tra
cui Ruggero di Lauda e Giovanni da Procida, rifugiatisi alla corte d'Aragona. L'insurrezione
palermitana diede origine alla "guerra del Vespro", che si propagò rapidamente in tutta l'isola,
preparando la strada, dopo la fuga degli Angioini, al regno di Federico d'Aragona.
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
1. SINFONIA. È in due movimenti,Adagio e Allegro. I temi sono ripresi dal corpo dell'opera.
L'Adagio è introdotto dal cosiddetto 'ritmo della morte', ripreso dal motivo dei Siciliani umiliati e
offesi nel secondo atto ("Il rossor mi coprì"); a esso si sovrappone dapprima una cellula melodica
derivata dalla salmodia dei frati nel quarto atto, quindi una distesa melodia a sua volta derivata
dall'aria d'apertura di Elena. Su un improvviso rullo di timpani l'orchestra esplode in quella che
sarà la musica della rivolta finale; l'energia vitale di questo brano sfocia in un'ampia melodia per
gradi congiunti, derivata dal duetto Arrigo - Monforte ("Mentre contemplo quel volto amato"), su
cui s'innesta un lungo crescendo. La ripresa è preceduta da uno squarcio per soli archi, a sua volta
derivato dall'addio di Elena all'amata Sicilia nel quarto atto, e si conclude con una stretta finale.
ATTO PRIMO
Il teatro rappresenta la gran piazza di Palermo. In fondo alcune strade ed i principali edifici della città. A
destra dello spettatore il palazzo di Elena. A sinistra l'ingresso a una caserma con fasci d'armi. Dallo stesso
lato il palazzo del governatore a cui sí sale per una gradinata.
2. INTRODUZIONE - CORO. Tebaldo e Roberto con parecchi soldati francesi hanno recato una
tavola dinanzi alla porta della caserma, vi siedono intorno e bevono. Siciliani e Siciliane
attraversano la piazza, formano dei gruppi qua e là, guardando biecamente i soldati francesi.
Questi cantano inneggiando alla propria patria e ricordando il premio che loro spetta quali
vincitori (A te, ciel natio). I Siciliani mormorano a mezza voce con represso furore: il canto dei
soldati suona loro come un insulto; ma non tarderà l'ora della vendetta. Intanto Tebaldo e Roberto
brindano alla gloria del loro capitano, fulmine di guerra e prediletto dai soldati. Dalla caserma
escono Béthune e Vaudemont; attraversano la piazza passando vicino a Roberto. Béthune gli
osserva, ridendo, che è ubriaco. "Sì!" gli risponde Roberto, "d'amore"; tutte le donne sono per il
vincitore: basta scegliere. L'amico lo avverte della gelosia dei Siciliani. Ma Roberto, sempre più
barcollando, gli replica che non v'è donna che resista alla vista di un cimiero. I soldati francesi
riprendono il loro canto, cui risponde sommesso quello dei Siciliani.
3. SCENA E CAVATINA CON CORI. Appare la duchessa Elena vestita a lutto; appoggiata al
braccio di Ninetta e seguita da Danieli, attraversa la piazza venendo da sinistra e si dirige verso il
proprio palazzo; ha un libro di preghiere tra le mani. È salutata con rispetto dai Siciliani, coi quali
si trattiene familiarmente in colloquio. Vaudemont, incuriosito, non nasconde a Béthune la propria
ammirazione per la bellezza della duchessa, sorella di Federico, ora ostaggio dei Francesi.
Vaudemont ricorda quanto fatale sia stata a Federico l'amicizia con Corradino lo Svevo, di cui
condivise la sorte sul patibolo; oggi la duchessa commemora quel dì doloroso. Invocando vendetta
sui Francesi, soggiunge Béthune. E non a torto, obietta Vaudemont nonostante il rimprovero del
compagno, poiché il loro capitano fu troppo spietato. Béthune saluta rispettosamente Elena e
rientra con Vaudemont nella caserma. Danieli ricorda a Elena l'anniversario funesto in cui furono
massacrati tanti patrioti siciliani; la donna, pregando a parte, volge il pensiero allo spirito del
fratello Federico, ripromettendosi di vendicarlo. Intanto all'improvviso suono di una fanfara
Roberto, completamente ubriaco, si alza da tavola chiedendo che un Siciliano sciolga una canzone
in gloria della Francia. Vedendo poi Elena, le si avvicina barcollando e con tono minaccioso le
rivolge l'invito a cantare. Ninetta con sdegno fa atto di proteggere Elena. Ma la duchessa la
trattiene e con tono di sfida, ma con calma, annuisce all'arrogante invito del francese. Roberto e
Tebaldo con i soldati hanno di nuovo occupato il posto attorno alla tavola. A poco a poco i Siciliani
si avvicinano a loro quasi circondandoli. Elena si avanza sul limitare della scena e con voce
repressa, guardando con espressione il popolo che la circonda, incomincia un canto che parla di una
nave vicina al naufragio, i cui marinai si affidano a Dio, certi del suo aiuto (In alto mare e battuto
dai venti); poi lo invita a osare, confidando nella protezione del cielo (Su coraggio, del mare audaci
figli). I Siciliani, a parte e a mezza voce, accolgono l'appello di Elena. Mentre i Francesi sono
intenti a bere, non prestando attenzione a quanto succede intorno a loro, Elena rinforza i propri
detti rinnovando l'esortazione a osare.Tutti i Siciliani si animano a vicenda. Il tono delle loro voci
s'accresce. E quando Elena invoca le armi, i Siciliani coi pugnali sguainati van sopra ai soldati
francesi. Ma un uomo appare d'un tratto sulla scalinata del palazzo del governatore. È solo e senza
guardie.
4. SCENA E QUARTETTO. È Monforte. I Siciliani nel vederlo si arrestano spaventati. Elena
non trattiene un gesto d'ira. Monforte getta uno sguardo con calma sulla turba e fa un gesto
imperioso: tutti fuggono lasciando deserta la piazza; non restano in scena che Monforte, Elena,
Ninetta e Danieli. Mentre questi fremono d'ira mal contenuta (D'ira fremo all'aspetto), Monforte,
compiaciuto dell'effetto prodotto dalla sua autorità, commenta con disprezzo la viltà dei vinti.
5. SCENA E DUETTO. - FINALE PRIMO. Giunge dal fondo Arrigo; corre verso Elena non
accorgendosi di Monforte, che al suo arrivo si arresta e gli si avvicina. Il giovane racconta alla
duchessa d'essere stato liberato per decisione dei giudici all'insaputa del crudele governatore.
Questi gli si appressa sorridente rammentandogli che proprio alla sua clemenza egli deve la
libertà. E mentre Arrigo, invano trattenuto da Elena, dichiara di voler colpire il tiranno, Monforte
con sua grande sorpresa si fa riconoscere per il governatore. Ordina a Elena e ai suoi
accompagnatori di allontanarsi. Arrigo vorrebbe seguirli, ma s'arresta a un cenno di Monforte.
Questi lo interroga sul nome suo e sui suoi genitori (Qual è il tuo nome. I1 giovane afferma di
conoscere il suo solo nome,Arrigo, di non aver conosciuto suo padre e d'aver perduto la madre or
son dieci mesi: ora spera, guardando il cielo, di raggiungerla. Monforte lo interrompe, si ricorda di
lui: è il giovane che fu educato dal duca Federico, da lui fatto giustiziare. Arrigo conferma,
dichiarandosi pronto a morire per quel grand'uomo che lo vegliò come un padre (Di giovine
audace). Monforte, fra sé, apprezza il fiero coraggio del giovane. Quindi gli propone d'arruolarsi
nel suo esercito. Ma Arrigo dichiara con enfasi di non essere un vile e rifiuta. Riacquistando la
propria freddezza Monforte avverte il giovane di dimenticare la sua clemenza, e quindi,
indicandogli il palazzo di Elena, lo ammonisce a non varcarne mai la soglia.Arrigo ne chiede il
motivo. Con tono misterioso Monforte gli ricorda che un amore infausto potrebbe essergli fatale e
gli ordina di fuggire. Arrigo afferma con forza che l'ardimento è una sua prerogativa e che non
teme le minacce di alcuno: dunque non rispetterà quel divieto. Le sue parole suscitano la vivace
reazione di Monforte (Temerario! qual ardire!), che mette in guardia il giovane dal provocare la
sua ira e ribadisce il divieto. Per tutta risposta Arrigo si lancia verso il palazzo dicendo: "Per lei
non temo morte!". "E morte avrai!" gli risponde Monforte. Arrigo entra deciso nel palazzo di
Elena; batte al portone, che gli viene aperto. Monforte lo guarda con commozione, ma senza
sdegno.
ATTO SECONDO
Una ridente valle presso Palermo.A destra colline fiorite e sparse di cedri e d'aranci; a sinistra la cappella di
S. Rosalia; in fondo il mare.
6. PRELUDIO, ARIA E CORO. Il ritmo di barcarola di un preludio strumentale introduce la
nuova scena. Due uomini arrivano in una scialuppa e guadagnano la riva; il pescatore che la
conduce si allontana. L'uomo sbarcato è Giovanni da Procida. Egli saluta la città e la sua terra
adorata giurando di dedicare la propria vita alla sua causa. Nel suo pensiero la esorta ad alzare la
fronte a nuovo splendore (O tu, Palermo); ha ramingato per paesi lontani chiedendo aiuto invano;
ma ora è tempo di sorgere a vittoria. Manfredo e parecchi compagni di Procida approdano con le
barche; altri compagni discendono dalla collina e gli fanno cerchio. A uno di essi Procida chiede di
annunziare il suo arrivo ai fidati amici; a un altro chiede di far venire Elena e Arrigo. I due
messaggeri partono; gli altri si fanno intorno a Procida; questi afferma che è giunto il momento di
agire per ribellarsi all'oppressore (Nell'ombra e nel silenzio); tutti si dichiarano pronti all'azione. Il
coro parte. Rimasto solo, Procida s'avanza verso la scena proclamandosi lieto di morire per la
salvezza della patria.
7. SCENA E DUETTO. Elena ed Arrigo vengono dalla cappella a sinistra; Procida li scorge e va
loro incontro; narra d'aver chiesto aiuti a Bisanzio e alla Spagna, e rispondendo alle richieste dei
due giovani confida l'intenzione di Pietro d'Aragona di unirsi a loro con le proprie forze, non prima
però che l'intera Sicilia da sola insorga. Arrigo ritiene che il popolo non sia ancora pronto. Occorre
comunque, osserva Procida, tentare un colpo audace. Elena propone di trarre pretesto dalla
prossima festa di nozze collettiva; il popolo accorrerà numeroso. Procida concorda osservando che
una sola scintilla basterà a far divampare un incendio; quindi, dopo aver chiesto ad Arrigo di
sostenerlo nell'azione, parte verso destra lasciando soli i due giovani. Elena chiede ad Arrigo quale
premio si attende dal suo coraggio. Questi risponde che il premio è nell'omaggio che depone ai suoi
piedi; non teme il furore del tiranno, ma trema davanti a lei. Nel dichiararle il suo amore non
chiede, da umile soldato, che di combattere e di morire per lei (Ah da tue luci angeliche). Elena,
commossa e turbata, confessa di palpitare per lui e mentalmente chiede perdono allo spirito del
fratello se ora osa aprire il suo cuore ad Arrigo. Quindi al giovane, che quasi incredulo accoglie le
sue parole, Elena fa giurare di vendicare il fratello ucciso, ed ella sarà sua.
8. RECITATIVO. Giunge Béthune, seguito da parecchi soldati, latore di una lettera del
governatore per Arrigo: è un invito a una festa da ballo. Il giovane rifiuta sdegnato. Béthune
trasforma l'invito in un ordine. Per tutta risposta il giovane estrae la spada. Ma a un cenno
dell'ufficiale, i soldati lo circondano, lo disarmano e lo trascinano via. Entra in fretta Procida;
saputo dell'arresto di Arrigo, dichiara con dolore che ciò è un nuovo ostacolo che si frappone
all'azione. Ma Elena, risoluta, afferma che il giovane dovrà tornare libero.
9. FINALE SECONDO. A questo punto, sul ritmo trascinante di una tarantella, giovani d'ambo i
sessi discendono dalle colline in abiti festivi al seguito delle dodici fidanzate. Ninetta è fra queste.
Da un'altra parte s'avanza Danieli alla testa degli sposi. A poco a poco cominciano le danze.
Manfredo e alcuni amici di Procida si avvicinano a Danieli. Questi e Ninetta s'inginocchiano
davanti a Elena, chiedendole la benedizione. A un certo punto le danze vengono interrotte da
Roberto e da Tebaldo che arrivano attraversando la scena, guidando ciascuno un plotone di
soldati. Roberto accenna ai danzatori esitanti di continuare e ordina ai soldati di rompere le fila e
di riposarsi. Questi cominciano a prendere parte alle danze, che si fanno sempre più vive e animate.
Roberto, situato con Tebaldo a sinistra, vicino a Procida, contempla lo spettacolo con curiosa
emozione. Istigato da Procida, che si professa amico sincero dei Francesi, Roberto non cela la
propria ammirazione per la bellezza delle donne siciliane. A mezza voce, con marcata intenzione,
Procida gli sussurra che ai vincitori tutto è concesso. A questo punto Tebaldo ricorda a Roberto il
ratto delle Sabine... La danza, cui si uniscono anche i soldati, va sempre più animandosi. Roberto e
Tebaldo vanno a riunirsi ai loro compatrioti. Inneggiando alla guerra e all'amore (Viva la guerra),
questi raddoppiano le loro galanti premure verso le giovani siciliane, nonostante le proteste dei
loro uomini (Su inermi tu stendi). Ad un tratto, a un segnale di Roberto, ciascuno di essi rapisce la
propria ballerina. Soldati che non ballano trascinano seco le altre giovani donzelle. Roberto si
impadronisce di Ninetta, che tenta invano di sfuggirgli. Danieli e i giovani siciliani si muovono per
riprendere le loro donne; ma i soldati mettono mano alle spade costringendo Danieli e compagni a
retrocedere spaventati e tremanti. Manfredo porta la propria mano all'elsa della spada, ma Procida
lo arresta e gli fa segno di vegliare con lui alla difesa di Elena, che è fra loro. Intanto parecchi
soldati si stanno avvicinando a lei: Procida e Manfredo mettono mano alla spada per difenderla; sta
per nascere una zuffa, quando Roberto, additando Elena, ordina ai soldati che sia rispettata e
riservata a Procida in premio dei suoi preziosi consigli. I soldati cantano vittoria con maggior
forza, facendosi beffe dei Siciliani costretti a cedere alla violenza. Quindi si ritirano conducendo
seco le donne. Cessa il ritmo della tarantella. Al tumulto succedono il silenzio e l'avvilimento.
Danieli e tutti i Siciliani, a cerchio al centro della scena, esprimono a voce bassa, repressa, su un
canto spezzato dall'ira, il rossore per l'onta subita (Il rossor mi coprì). Elena addita loro Procida
per il coraggio con il quale l'ha protetta e biasima Danieli che, timoroso, non ha saputo difendere
Ninetta. Dal suo canto Procida guarda con disprezzo Danieli e gli altri per non aver saputo
opporre resistenza. Il sentimento di tutti, incontenibile e ribollente di furore, cresce di forza fino a
raggiungere il culmine, quando, d'un tratto, sulle grida tumultuose si sente innalzarsi, proveniente
da lontano, il molle canto di una Barcarola (Del piacer s'avanza l'ora!),I Siciliani corrono alla
sponda del mare e vedono avanzarsi una barca splendidamente adorna che costeggia la
riva.Vaudemont, ufficiali francesi e nobili dame francesi e siciliane, elegantemente abbigliate,
siedono in essa. I battellieri indossano ricche livree: le dame sono adagiate su molli cuscini; alcune
tengono alle mani chitarre, altre prendono rinfreschi. Procida chiede dove vadano. Alla festa
regale, gli risponde Elena. Procida, risoluto, decide di seguirli sotto mentita veste per poter
piombare col proprio pugnale sul tiranno. Manfredo osserva che i Francesi avranno spade. "E noi
pugnale e cuore" è la risposta di Procida. E mentre il battello continua la sua marcia, sullo sfondo
della Barcarola si rinnova il canto spezzato dei Siciliani offesi: dando sfogo al dolore che brucia
loro nel petto, ora si propongono di vendicarsi con le armi in pugno.
ATTO TERZO
Gabinetto nel palazzo di Monforte.
10. PRELUDIO E SCENA. 12 scena è introdotta da un breve preludio, il cui carattere sembra
preannunciare la prossima festa. Monforte è seduto a un tavolo; pensa alla donna siciliana da lui
rapita ed amata e infine messa a morte perché ella lo odiava. Da quell'unione era nato però un
figlio che la donna gli nascose per quindici anni. Trae un foglio dal seno: è l'ultimo messaggio che
la donna gli mandò in punto di morte; in esso ella chiede di salvare il prode Arrigo, qualora fosse
minacciato di morte: è quegli suo figlio.
11. RECITATIVO E ARIA. Béthune annuncia a Monforte che Arrigo, avendo rifiutato l'invito, è
stato tratto a palazzo con la forza. Il governatore gli ordina di condurlo con rispetto alla sua
presenza. Rimasto solo, Monforte lamenta il vuoto di una vita trascorsa fra onori e ricchezze senza
l'affetto di un figlio (In braccio alle dovizie); ora egli spera di riconquistare con l'amore paterno il
figlio Arrigo e sogna un avvenire beato accanto a lui.
12. REcnwrivo E DuErro. Entra Arrigo, preceduto da due Paggi che s'inchinano e si ritirano.
Arrigo, entrando, s'accorge che tutti hanno verso di lui segni di cortesia e trova molto strano
anche il comportamento di Monforte, da cui si attende solo morte. Ma Monforte lo rassicura:
ormai egli è libero di tramare vane insidie. Non teme la morte - gli osserva Arrigo - chi combatte
un tiranno. Monforte, guardandolo fissamente, gli risponde che combattere nell'ombra col pugnale
è da vile! Quindi gli ricorda come la sua clemenza lo avesse salvato dalla condanna a morte. E fu
pietà sincera, la sua (Quando al mio sen per te parlava): non sentì forse Arrigo in quel momento la
voce del sangue? e la sua anima non palpitò per un dolore che ora gli suscita il pianto? E nel dir
questo porge al giovane la lettera della madre (Mentre contemplo quel volto amato). Arrigo la
legge, dapprima con gioia nel riconoscere le cifre materne, ma subito dopo con un fremito d'orrore
nello scoprire d'essere figlio del tiranno. Resta immobile, come annichilito; non osa guardare il
padre. E mentre questi gli rammenta il proprio potere,Arrigo pensa con dolore che Elena è ormai
per lui perduta! Monforte insiste nel richiamare su di sé l'affetto del figlio: con un solo cenno egli
potrà ottenere quanto la sua ambizione desidera. E al giovane, che chiede d'essere lasciato solo con
il suo destino, Monforte ricorda il proprio nome glorioso. "Nome esecrato!" gli risponde il figlio.
Questo rifiuto suona come un insulto mortale alle orecchie di Monforte (Parola fatale.% che
tuttavia cerca ancora di trattenerlo e di convincerlo, fino a implorarlo. Ma Arrigo non può
accettare: glielo vieta lo spettro della madre assassinata proprio da lui, Monforte, il suo carnefice!
E a lei rivolge il pensiero affinché dal cielo gli ridoni forza nel cuore (Ombra diletta che in ciel
riposi). Il padre implora ancora il suo affetto. Alla fine fa per abbracciarlo, ma Arrigo si sottrae con
impeto dalle braccia di Monforte che tenta di trattenerlo, e fugge. Monforte lo segue con lo
sguardo e con atto di dolore si allontana.
Magnifica sala nel palazzo del governatore, disposta per una festa da ballo.
Gentiluomini e dame francesi e siciliane, con maschere e senza, vanno e vengono. Entra Monforte,
preceduto dai suoi paggi e dagli ufficiali del palazzo, e va a collocarsi sopra un seggio elevato,
facendo segno a ciascuno di sedersi. Il maestro di cerimonie viene a prendere i suoi ordini e dà il
segnale per l'inizio della festa. Davanti alla Corte di Palermo si rappresenta il ballo delle Quattro
Stagioni
13. LE QUATTRO STAGIONI.
Primo ballabile: L'inverno. Entra il dio Giano che presiede all'anno. Con una chiave d'oro apre la
terra e dà vita alle stagioni. Sorge da terra un canestro coperto di ghiaccio, da cui esce la prima
stagione dell'anno, l'Inverno. Esso è impersonato da una giovine donna avviluppata entro pellicce;
dietro di lei tre giovinette con fardelli. Esse tremano di freddo. Una di loro percuote con un pezzo
di ferro una pietra che manda faville: si accende il fuoco. Le giovinette si riscaldano e invitano
l'Inverno a venire presso di loro. Ma l'Inverno rifiuta: il miglior mezzo di eccitare il calore è la
danza. La ragazza infatti si mette a danzare: dapprima un ballo vivace, quindi un elegante motivo
di valzer, infine un ritmo di polka.
Secondo ballabile: La primavera. Gli zeffiri svolazzano intorno al canestro di ghiaccio e col loro
calore sciolgono i ghiaccioli che ancora circondano il canestro. Da ogni parte sorgono mazzi di
fiori, e dal mezzo di questi fiori sorge la Primavera sotto forma di una giovinetta. Ella si
abbandona a un blando ritmo di valzer, quindi danza una mazurca, infine si scatena in un galop
finale.
Terzo ballabile: L'estate. I fiori spariscono. Il canestro si ricopre di bionde spighe. L'Estate sotto
forma d'una giovinetta sorge dal mezzo dei covoni; coglie le spighe. L'Estate e le sue compagne
vogliono ballare, ma fa troppo caldo. D'un tratto giovani Naiadi escono dal canestro con lunghe
sciarpe di velo verde, imitando le acque. L'Estate e le sue compagne si rinfrescano alle sorgenti
delle Naiadi imitando l'azione del nuoto.
Quarto ballabile: L'autunno. Salta fuori un Fauno. Spavento delle giovani bagnanti, che si
dileguano inseguite dal Fauno. Si odono suoni giulivi di lontano; il Fauno ascolta attentamente. Il
canestro si copre di frutti e di ceppi di vite. Il Fauno gira e rigira intorno al canestro e finisce col
salirvi sopra. Egli schiaccia i ceppi di vite e scopre l'Autunno con le sue compagne. Sorpresa:
appare una giovinetta che impersona l'Autunno. I suoni del sistro e dei timballi annunziano i Satiri
e le Baccanti che danno subito il via a danze molto animate. Un galop finale conclude i ballabili.
14. FINALE TERZO. Alla fine del balletto tutti i sedili, meno quelli che sono sulla predella del
trono, vengono portati via. E mentre Monforte, con due dame al fianco, procede verso una delle
sale adiacenti, la folla degli invitati eleva su uno sfondo di musica danzante un canto di lode allo
splendore delle feste regali (O splendide feste!). Quindi si disperde negli appartamenti del palazzo e
nei giardini. La scena rimane vuota per un istante, mentre continua il motivo danzante. Da destra
s'avanza Arrigo. Lo seguono Elena e Procida, entrambi mascherati, che si fanno riconoscere
dapprima con una parola d'ordine. Quindi si tolgono la maschera. Il giovane è turbato dalla loro
presenza e si mostra incerto e timoroso. Alla vista di alcuni Francesi che entrano nella sala, Arrigo
ordina agli amici di parlare in tono sommesso.Tutti e tre per non dare nell'occhio cantano sul
motivo della danza che echeggia all'interno (O splendide feste!). Le Dame e i Cavalieri entrano dal
fondo. Arrigo, Procida ed Elena restano ancora soli per un istante sul davanti della scena, mentre
prosegue dai vicini appartamenti il suono della danza. Elena e Procida rivelano ad Arrigo che la
rivolta è in atto; compagni fidati si aggirano mascherati: e mentre Elena attacca sul petto di Arrigo
un nastro di seta uguale a quello dei congiurati, Procida assicura che le forti braccia dei Siciliani
non colpiranno a vuoto e anche Monforte morirà. Il giovane è spaventato e impallidisce, ma simula
che ciò è per il timore che qualcuno ascolti. Procida si volge e, vedendo entrare Montone in mezzo
a dame francesi e siciliane, si rimette la maschera. Intanto il coro riprende il suo canto di lode alle
feste. Elena e Procida si allontanano perdendosi nella folla. Mentre le coppie danzanti passeggiano
nelle sale e i rinfreschi vengono d'intorno serviti, Monforte s'avvicina ad Arrigo, solo sul davanti
della scena. Questi avvisa il genitore di un pericolo incombente. Monforte è incredulo: si sente
sicuro nel proprio palazzo; ma si dichiara intanto felice nel sentire che Arrigo si preoccupi per la
sua vita. Arrigo mostra il nastro che distingue i congiurati e sul quale egli stesso ha giurato. Ma
con un gesto il padre glielo strappa dal petto, compiacendosi dell'orrore che i tradimenti destano
nell'animo di suo figlio: in lui dunque ferve vero sangue francese! Con calore Arrigo insiste
nell'esortare il padre a fuggire. Ma invano. Scorgendo gruppi di Siciliani che si stanno avvicinando
minacciosi, mette il padre sull'avviso. Procida circonda Monforte con i suoi e a voce bassa ordina
l'assalto. Monforte chiama i suoi soldati. Nel tumulto Elena, assetata di vendetta, precede Procida
lanciandosi per prima a ferire Montone. Arrigo si getta innanzi a lui, facendogli scudo con il
proprio petto. A tal vista Elena s'arresta e con spavento lascia cadere il pugnale. Accorsi alla voce
di Montone, i Francesi traendo le spade gli fanno corona. Volgendosi verso Béthune e Vaudemont,
Monforte ordina la morte per chiunque abbia un fregio simile a quello di Procida; ma comanda sia
salvo Arrigo, che pubblicamente ringrazia per avergli salvato la vita. L'azione s'arresta: i Siciliani
tutti esprimono sorpresa e orrore per l'atto di Arrigo; Elena, Procida e Danieli rivolgono il
pensiero alla patria perduta e maledicono Arrigo (O patria adorata). Questi si mostra esterrefatto e
lacerato dal senso di colpa: ai suoi compagni la gloria, a lui non resta che l'infamia. Al suo fianco
Monforte gli esprime gratitudine. Senza dargli ascolto Arrigo si avvicina a Elena, a Procida, agli
altri Siciliani, tentando vanamente di spiegare il proprio comportamento e implorando da loro
pietà. Ma essi lo respingono sprezzanti dandogli del traditore. Monforte cerca di consolarlo
proclamandosi suo difensore. Procida ribadisce il disprezzo verso Arrigo e lo condanna a una
doppia infamia. A un gesto di Monforte vengono trascinati via Elena, Procida e i Siciliani. Arrigo
vuol correre dietro loro, ma Monforte lo trattiene. Procida ed Elena lo respingono con disprezzo,
mentre egli tende loro le mani in atto di supplica. Oppresso, annichilito,Arrigo vacilla e cade fra le
braccia di Monforte.
ATTO QUARTO
Cortile d'una fortezza. A sinistra una stanza che conduce all'alloggio dei prigionieri. A destra un cancello
che comunica con l'interno della fortezza. Nel fondo si vede la cresta merlata d'una parte delle mura e la
porta d'ingresso custodita da soldati.
15. PRELUDIO, RECITATIVO E ARIA. Un preludio dalla massiccia orchestrazione introduce
l'atmosfera drammatica di un carcere; è basato su due temi contrastanti che, procedendo per
sequenze serrate, alla fine si placano in una coda sommessa. Su di essa Arrigo si presenta alla porta
d'ingresso: i soldati lo lasciano passare; per voler supremo di Monforte gli è concesso di visitare i
prigionieri; ordina di farli condurre in sua presenza. Un ufficiale, cui Arrigo aveva mostrato un
ordine, s'allontana uscendo dalla porta a sinistra dello spettatore. Guardando verso le prigioni
Arrigo pensa agli amici in ceppi. Egli è la cagione delle loro sofferenze e vorrebbe essere fra loro.
Ingiuriosa clemenza fu quella che gli ridiede libertà. Più della vita gli è caro l'onore. Ora viene a
discolparsi; ma vorranno vederlo e udirne le difese? Proprio nel giorno che l'amore di Elena gli
sorrideva, era destinato a perderlo; e ora non potrà avere che disprezzo dalla amata Elena (Giorno
di pianto). Gli sembra sentire dei passi. È lei, Elena, che si appresta a maledirlo. Invoca
disperatamente perdono: la morte sarà meno crudele del disprezzo della donna amata.
16. GRAN DUETTO. Elena esce dalla prigione a sinistra, condotta dall'Ufficiale, il quale le indica
Arrigo. Nel riconoscerlo si raggela. Il giovane le si rivolge supplichevole (Ah volgi il guardo a me
sereno) tentando di discolparsi e chiedendo di poter morire ai suoi piedi per essere perdonato. Ma
Elena risponde fieramente che non può perdonare.Arrigo protesta che non fu sua colpa, ma un
tremendo destino a coprirlo d'onta: infelice egli è, ma non colpevole. Con sdegno Elena gli ricorda
che fu egli stesso a fermare la sua mano vendicatrice nel momento che stava per colpire il tiranno.
"Il padre mio!" le rivela Arrigo con accento disperato. Sì, un orrendo vincolo lo ha perduto per
sempre (Nodo orribile, fatai legame); che doveva fare di fronte a un bivio crudele? Elena ha offerto
la propria vita per vendicare il fratello; egli,Arrigo, ha fatto di più: ha dato il suo onore per la vita
del padre... Elena è sconcertata dalla rivelazione che non dubita vera; il suo animo si muove a
compatimento: ma ora come sciogliersi dal-l'aborrito vincolo? Lo ha infranto l'amore, risponde
Arrigo: con l'aver reso la vita al genitore ha pagato il suo debito; ora può tornare all'odio antico
disprezzando onori e ricchezze: al padre vuole solo chiedere il dono di vivere o morire con la donna
amata. Con crescente emozione Elena confessa ad Arrigo di essere già pronta a perdonare (Arrigo!
ah parli a un core); potergli ora dire "t'amo" rende lieta la sua morte; e se la barriera del sangue si è
posta fra loro due, chiede tuttavia al giovane di serbarle fede: "Addio,Arrigo, muoio pensando a te".
Arrigo si dichiara commosso per il perdono della donna amata ed esprime la speranza di morire
con lei (È dolce raggio, celeste dono).
Boito e Verdi fotografati nell'estate del 1892 a Milano, nel giardino Perego in via Borgonuovo
17. SCENA FINALE E QUARTO. Compare Procida, scortato da soldati; mentre Arrigo si
allontana per parlare con alcuni ufficiali presentando loro l'ordine di cui è munito, Procida si
avvicina a Elena senza accorgersi di Arrigo e a bassa voce le consegna un messaggio pervenutogli
di nascosto. Elena lo apre e lo legge a mezza voce: una nave aragonese carica d'armi sta entrando
nel porto pronta ad aiutare i rivoltosi. Con accento disperato Procida impreca contro la sorte che
ora lo costringe in carcere: potesse tornare libero per breve momento! Arrigo torna dopo aver
allontanato i soldati. Procida lo riconosce e, sdegnato, chiede cosa sia venuto a fare il traditore. Il
pentimento ve lo ha condotto, assicura Elena. In quel punto entra Monforte seguito da Béthune e
da altri ufficiali. Béthune, indicando Elena e Procida, interroga il governatore sulla loro sorte.
Questi ordina per loro un sacerdote e l'esecuzione capitale. Béthune gli fa presente che il popolo
freme minaccioso. Monforte ordina che i soldati siano pronti ai posti loro destinati: al primo
accenno di ribellione seguirà la strage dei rivoltosi. Béthune s'inchina e parte. Arrigo scongiura
vivamente il padre di perdonare o di farlo morire con loro. Elena accoglie con gioia le parole del
giovane. Ma Procida respinge Arrigo: si sente offeso all'idea di morire con un traditore. Monforte
si rivolge al figlio: a te, mio sangue, toccava in sorte un simile oltraggio. Procida è
stupefatto:Arrigo figlio di Monforte! E mentre questi non capisce come Arrigo possa preferire la
morte alla gloria del regno, la rivelazione getta Procida nel massimo sconforto (Addio, mia patria):
ogni speranza di riscatto è morta ormai; gli toccherà morire invendicato. E mentre Monforte
insiste nella condanna dei ribelli, Arrigo cerca di confortare Elena, che triste e sconsolata dice
addio al fiorente suolo della patria. Si ode provenire dall'interno una salmodia: sono frati che
pregano per i condannati a morte (De profundis clamavi). Procida esorta Elena a inginocchiarsi
per pregare Dio. Mostrandogli i due inginocchiati Arrigo scongiura Monforte di sospendere
l'esecuzione. Ma questi con sdegno ricorda al figlio di essere egli stesso loro complice. Poi con
tenerezza dichiara d'essere disposto a concedere il perdono purché egli lo riconosca come padre. E
nel dir questo mostra al figlio la folla che è entrata nella fortezza, ribadendo: chiamami "mio
padre" e i condannati saranno graziati. Elena supplica Arrigo di non fado. Questi non sa che fare.
Intanto il cancello a destra si apre, lasciando vedere la gran sala di giustizia, alla quale si ascende
per parecchi gradini e in cui si vedono quattro Penitenti in atto di preghiera e alcuni soldati con
torce in mano. Sul primo gradino sta il Carnefice appoggiato alla sua scure. Monforte lo indica ad
Arrigo, assalito da crescente terrore. Due Penitenti discendono i gradini e vengono a prendere,
l'uno Procida, l'altro Elena. Si ode sempre il coro che canta De profundis, mentre il popolo che è
nel cortile della cittadella, dietro i soldati, s'inginocchia e prega; le donne implorano grazia. Elena
e Procida, preceduti dai due Penitenti. si dirigono verso la gradinata, dando l'eterno addio alla
Sicilia.Arrigo fa per slanciarsi verso Elena per seguirla, ma è trattenuto da Monforte, che si colloca
fra loro. Il Carnefice s'impadronisce di Elena; non appena ella tocca la soglia della sala di giustizia
Arrigo getta un grido: "Oh padre!". A questo grido Monforte gioisce e ordina al Carnefice di non
procedere: Elena e Procida sono perdonati. Circondati dai Penitenti e dai soldati, i due discendono
la gradinata e sono condotti vicino a Monforte che ora non si limita a un atto di clemenza, ma
impone ad Arrigo di sposare Elena: sia questo suggello d'amicizia fra due popoli rivali. Elena
reagisce d'impulso rifiutando; ma Procida a voce bassa le ordina di accettare: lo vogliono la patria e
il fratello... Monforte si rivolge al popolo: felice d'aver ritrovato un figlio, concede il perdono a
tutti. Nel segno dell'amore - egli dichiara - si apre ora un'era di pace (Risponda ogn'alma al
fremito); Elena ed Arrigo sono rapiti nell'estasi di un inesprimibile contento; ma Procida e i
Siciliani, a parte, si ripromettono di cambiare tanto giubilo in tremenda vendetta.Alla fine Arrigo
chiede al padre che le sue nozze con Elena siano celebrate all'indomani. Anzi, quest'oggi stesso gli risponde Monforte - all'ora del vespro. La decisione rende Arrigo ed Elena ancor più felici. Solo
Procida non partecipa a tanta gioia. Alla fine della ripresa della stretta, dal corpo di guardia
vengono recati bicchieri e boccali; i soldati francesi bevono con i Siciliani. Monforte s'incammina
tenendo per mano Elena ed Arrigo. Procida resta, circondato dai propri amici.
ATTO QUINTO
Ricchi giardini nel palazzo di Monforte in Palermo. In fondo gradinate, per le quali si arriva alla cappella,
dí cui si vede la cupola elevarsi al disopra degli alberi. A destra l'ingresso al palazzo.
18. CORO. Si ode tra le quinte un coro di cavalieri (Si celebri alfine tra canti); è un canto di gloria e
d'amore che annuncia la fine di tanti dolori; ad esso segue, sulla scena, accompagnato da arpa e
nacchere, un coro di giovinette che cantano in onore della bellezza della sposa (Di fulgida stella). I
due cori alla fine si sovrappongono.
19. SICILIANA. Elena in veste nuziale scende dalla gradinata del palazzo a destra. Le giovinette
le muovono incontro offrendole fiori. Elena le ringrazia (Mercé, dilette amiche) augurandosi che le
sue nozze diano serenità alla terra di Sicilia e facciano cessare le vendette. Poi congeda le donne
che si allontanano.
20. SCENA E MELODIA. Arrigo discende pensieroso dalla gradinata in fondo e va incontro a
Elena, godendo della brezza che lo accarezza in viso e del dolce mormorio del mare (La brezza
aleggia intorno); Elena è a lui vicino e promette di amarlo. Alcuni gentiluomini si presentano alla
porta del palazzo e vengono a cercare Arrigo, che a un gesto di Elena si decide a seguirli. I due
giovani si danno un breve addio. Arrigo entra nel palazzo.
21. GRAN SCENA E TERZETTO FINALE. Procida discende dalla gradinata in fondo. Con
gioia, ma con voce sommessa, esprime a Elena la gratitudine di tutti i Siciliani: il suo assenso alle
nozze ha convinto il nemico che l'orgoglio siciliano è ormai spento; tutte le difese sono state
abbandonate e ora non si pensa che ai festeggiamenti; non appena Elena avrà pronunciato il "sì" il
suono delle campane sarà il segnale del massacro. La donna esita: proprio nel giorno del
matrimonio e contro il giuramento? Procida le chiede come l'amore per il figlio di un tiranno abbia
potuto placare in lei l'odio per i Francesi. Ma Arrigo è ormai suo sposo, ed ella intende difenderlo.
Vedendo Arrigo avvicinarsi, Procida sfida la donna a correre da lui a denunciarlo. Ma Elena
inorridita non può tradire gli amici; dovrebbe forse uccidere lo sposo? Intanto Arrigo si appressa
con gioia a lei, che abbassa il capo: sventola il vessillo francese e lo squillo delle trombe risuona di
giubilo. Elena, senza rispondergli, medita a parte le parole di Procida: il "sì" nuziale, le campane, il
massacro... Oppressa da un sommo dolore ella non sa quale partito prendere. Arrigo s'avvede che
la donna trema, impallidisce, e la scongiura di parlare. A bassa voce Procida si rivolge a Elena
minacciandola di non rivelare il piano di vendetta. Elena è combattuta nell'animo e supplica lo
spirito del fratello di soccorrerla (Sorte fatali); e mentre Procida la esorta all'amor di patria
obbedendo al monito del fratello, Arrigo è tormentato dal silenzio della donna e la supplica di
guardarlo e di parlare. Dopo aver guardato un istante Procida e Arrigo in silenzio, Elena s'avanza
verso il giovane e con voce commossa gli confessa che lo spirito del fratello è una barriera troppo
alta tra loro due: ella non può sposarlo. Al grido disperato di Arrigo si contrappone quello
infuriato di Procida che vede sfumare la vendetta. Arrigo inveisce contro Elena dichiarandola
spergiura (M'ingannasti, o traditrice); non gli resta che maledirla. La donna tenta di spiegargli che
il suo amore non è mutato, mentre fra sé pensa che con il suo rifiuto sta salvando Arrigo dal
massacro. Procida intanto si scaglia contro di lei, dichiarandola traditrice. Scorgendo la
disperazione di Arrigo che vuole allontanarsi, Elena per un attimo vorrebbe spiegargli tutto. Ma
Procida a bassa voce la sfida a svelare il piano di vendetta e a tradire gli amici. No, Elena non può
tradirli, e in un impeto di passione corre da Arrigo giurandogli che l'ama, ma non può sposarlo. Il
giovane tuttavia insiste nel dichiararla spergiura. In quel mentre Monforte con tutti i cavalieri
francesi e le dame esce dal palazzo. Arrigo accorre verso di lui per dirgli che Elena, oppressa dal
ricordo del fratello, intende infrangere il nodo nuziale. Ma il governatore sa che i due si amano e,
accusandosi bonariamente di un ultimo atto di tirannia, unisce le destre dei due amanti. Mentre
Procida in piedi sugli scalini del fondo alza la mano per dare il segnale alle campane, invano Elena
tenta di sottrarsi al giuramento. Al suono della campana avvisa Monforte di fuggire. Ma questi
crede che il popolo esulti di gioia. "Di vendetta!" gli fa eco Procida. Ad un tratto questi, in piedi
sugli scalini del fondo e alzando la mano, ordina ai sacri bronzi di echeggiare. Dall'alto della
gradinata e da ogni parte accorrono i Siciliani, uomini e donne, con torce, spade e pugnali e
s'avventano sui Francesi al grido di "Vendetta! vendetta!". Procida e altri Siciliani si scagliano su
Monforte. Cala la tela.
Simon Boccanegra
Melodramma in un prologo e tre atti di Francesco Maria Piave
Prima rappresentazione:Venezia,Teatro La Fenice, 12 marzo 1857
Nuova versione [con correzioni e nuove aggiunte di Arrigo Boito]
Prima rappresentazione: Milano,Teatro alla Scala, 24 marzo 1881
L'argomento deriva dal dramma di Antonio Garcia Gutiérrez, Simón Boccanegra, rappresentato a
Madrid il 17 gennaio 1844. Fu scelto da Verdi per la sua quinta e ultima opera veneziana, il cui
contratto era stato firmato nel maggio del 1856 Non si sa come Verdi ne fosse venuto a
conoscenza; sembra probabile che Giuseppina Strepponi glielo avesse tradotto dallo spagnolo. A
Parigi, dove si trovava sin da agosto, stese il libretto in prosa affidandolo poi a Piave per la
versificazione, raccomandandogli grande cura per la messinscena (in specie per i praticabili e gli
effetti di luce) nonché, per la parte di Paolo, la scrittura di un "grande comprimario Baritono che
sia buon Attore". Stringendo i tempi e trattenuto a Parigi (dove nel frattempo s'era impegnato
all'Opéra per il Trovatore in francese, cui aggiunse un balletto) il maestro si rivolse anche alla
collaborazione del patriota e letterato Giuseppe Montanelli, esule nella capitale francese. Iniziata
in settembre, l'opera fu portata a termine a S. Agata in febbraio. Alla prima rappresentazione
l'opera ebbe fredda accoglienza, causa non ultima l'oscurità del libretto. Verdi ne battezzò l'esito
un "fiasco" al pari di quello della Traviata Il cammino dell'opera ebbe in seguito vicende alterne: al
successo di Reggio Emilia, dove Verdi stesso la pose in scena con qualche modifica, corrispose
subito dopo l'insuccesso di Firenze. Ancora successo al S. Carlo di Napoli, sotto la direzione di
Verdi. Ma ancora un fiasco alla Scala, fiasco che segnò le sorti dell'opera. Eseguita in alcuni teatri
del centro-sud d'Italia e in Spagna, l'opera praticamente uscì dal giro all'inizio degli anni 1870.
L'editore Ricordi insistette per anni presso l'autore per riportare in vita il Simone. Ma solo
nell'autunno del 1880 Verdi cedette alle sue insistenze: a quell'epoca si stava profilando una
collaborazione di Boito per l'Otello. E appunto a Boito Verdi volle affidare, quasi per saggiarne il
talento, il compito di "raddrizzare"il libretto: rifece diverse parti dello spartito aprendo il pezzo
chiuso per dare continuità al discorso musicale, conferì maggiore spessore drammatico al
personaggio di Paolo e compose un nuovo finale per il primo atto con la citazione della lettera di
Petrarca e la maledizione di Paolo. Rappresentata alla Scala con grande cura, il successo fu
indiscusso.Tuttavia non bastò a rendere l'opera popolare. Il suo cammino, lento e stentato,
praticamente si esaurì all'inizio degli anni 1890. Dopo quasi quarant'anni di silenzio, ancora una
volta per merito della Verdi-Renaissance tedesca il Simone fu riproposto all'attenzione del
pubblico e della critica, a partire dall'edizione di Vienna del gennaio 1930 nella versione tedesca di
Franz Werfel. Il successo fu tale che divenne ben presto opera di repertorio delle scene tedesche al
pari delle opere più popolari di Verdi. In Italia il cammino fu assai più lento (Roma nel 1934,
Parma nel 1936, Firenze e Bologna nel 1938). Praticamente, è a partire dal secondo dopoguerra
che il Simone si è insediato stabilmente nel repertorio dei teatri italiani. La sua appartenenza al
Verdi dei grandi capolavori è ormai oggi fuori discussione.
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
Venezia 1857
Milano 1881
PROLOGO
SIMON BOCCANEGRA, corsaro al servizio della repubblica genovese
baritono
Leone Giraldoni
Victor Maurel
JACOPO FIESCO, nobile genovese
basso
José Echeverria
Edoardo de Reszké
PAOLO ALBIANI, filatore d'oro baritono
Giacomo Vercellini Federico Salvati
PIETRO, popolano di Genova
baritono
Andrea Bellini
Giovanni Bianco
Marinai, popolo, domestici di Fiesco, ecc.
DRAMMA
SIMON BOCCANEGRA, primo Doge di Genova baritono
Leone Giraldoni
Victor Maurel
MARIA BOCCANEGRA, sua figlia,
sotto il nome di Amelia soprano
Luigia Bendazzi
Anna d'Angeri
JACOPO FIESCO,
sotto il nome d'Andrea basso
José Echeverria
Edoardo de Reszké
GABRIELE ADORNO, gentiluomo genovese tenore
Carlo Negrini Francesco Tamagno
PAOLO ALBIANI, cortigiano favorito del Doge
baritono Giacomo Vercellini
Federico Salvati
PIETRO, altro cortigianobaritono
Andrea Bellini Giovanni Bianco
Soldati, marinai, popolo, senatori, corte del Doge, ecc.
L'azione è in Genova e sue vicinanze, intorno alla metà del secolo XIV Tra il Prologo e il Dramma passano 25 anni
N. B. Nella disposizione scenica della seconda versione dell'opera (1883) l'età dei personaggi principali viene indicata
come segue:
Prologo Dramma
Simon Boccanegra
25 anni 50 anni
Jacopo Fiesco
40 anni 65 ann
Paolo Albiani
35 anni 60 anni
Pietro
20 anni 45 anni
Gabriele Adorno
30 anni
Maria Boccanegra
25 anni
Nota storica.• Simon Boccanegra fu il primo Doge di Genova. Appartenente a una famiglia illustre
(un suo avo, Guglielmo Boccanegra, era stato il primo capitano del popolo della repubblica) e
candidato del partito plebeo per il prestigio acquistatosi per aver liberato i mari di Genova
dall''african pirata" (il termine "corsaro" va inteso nel senso di comandante di bastimento armato
per la guerra di corsa). La sua elezione a Doge per volontà popolare, oltre a confermare la
vocazione marinara della repubblica, mirava a contrastare l'egemonia del patriziato di parte guelfa.
Fu eletto Doge una prima volta nel 1339 sostenuto dai capitani del popolo Raffaele Doria e
Galeotto Spinola, entrambi di parte ghibellina; costretto alla rinuncia al dogato nel 1344 ed
esiliato a Pisa, fu rieletto nel 1356. La sua morte avvenne il 13 marzo 1363 per avvelenamento nel
corso di un banchetto offerto a Sturla dal re di Cipro, Pietro Lusignano; secondo la tradizione egli
sarebbe stato avvelenato per mano del nobile genovese Pietro Malocello. Suo successore fu
Gabriele Adorno, nobile mercante di parte ghibellina. Nel dramma agisce Paolo Fiesco
appartenente a una famiglia di parte guelfa, quella dei Fieschi, che ebbe un ruolo importante nelle
vicende della politica della repubblica di Genova tra il XII e il XVI secolo. Nella scena del
consiglio viene citato "Rienzi": si tratta di Cola di Rienzo (Roma 1313-1354); sostenuto da
Francesco Petrarca, provocò in Roma una ribellione popolare contro il potere aristocratico
proclamandosi "tribuno". Inoltre si allude al "romito di Sorga" (località in Valchiusa, nella
Provenza) ovvero il cantore di Laura, la "bionda Avignonese": si tratta di Petrarca, che nel 1352,
da Avignone, scrisse al Doge Boccanegra scongiurandolo dall'intraprendere una guerra fratricida
contro Venezia; in precedenza, nel 1351, analogo appello egli aveva rivolto al Doge di Venezia,
Andrea Dandolo; entrambe le lettere, appartenenti alle Familiari, erano ben note a Verdi, che nel
1880 le suggerì a Boito per il nuovo finale del primo atto.
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
N.B. Nella versione definitiva l'autore ha sciolto i pezzi chiusi al fine di dare continuità al discorso musicale, eliminando la
numerazione dalle singole scene. Per consentire una più agevole lettura del percorso drammatico-musicale si è tuttavia ritenuto di
mantenere la scansione delle scene adottando, per la loro numerazione progressiva, la griglia contenuta nell'indice di ogni singolo
atto della versione definitiva.
PROLOGO
Nel fondo la chiesa di San Lorenzo. A destra il palazzo dei Fieschi, con gran balcone; nel muro, di fianco al
balcone, è un'immagine [della Madonna] davanti a cui arde un lanternino; a sinistra altre case. Varie
strade conducono alla piazza. È notte.
[l] INTRODUZIONE - SCENA - CORO E SCENA. Dopo un preludio orchestrale, affidato
prevalentemente agli archi e di tono sommesso, preparatore dell'atmosfera notturna, si apre il
sipario: Paolo e Pietro sono in scena, parlano fra loro a mezza voce come continuando un dialogo.
Paolo ha un piano per raggiungere il potere; a Pietro che suggerisce il nome Lorenzino l'usuraio
alla carica di Primo Abate (ovvero Doge), Paolo contropropone quello di Simon Boccanegra, il
corsaro che ha liberato il mare di Genova dai pirati africani. Dopo aver stretto la mano a Paolo,
Pietro si allontana. Rimasto solo, Paolo inveisce contro i patrizi: anch'egli, da umile plebeo, vuole
acquistare oro e potenza. Sopraggiunge frettoloso Simone; abbracciando Paolo gli chiede perché
egli lo abbia chiamato da Savona. Paolo gli propone l'elezione a Primo Abate. Simone è incredulo.
Ma Paolo insinua il nome di Maria, la donna amata da Simone. Questi con ansia ne chiede notizie.
Additando il palazzo dei Fieschi, Paolo gli risponde che la donna vi è tenuta prigioniera dal padre:
tuttavia, egli osserva, quando Simone sarà Doge chi potrà negargliela? Simone si mostra
commosso. Paolo lo informa d'aver tutto disposto per la sua elezione; solo chiede in cambio di
partecipare al potere. Simone acconsente. In vita e in morte? gli chiede Paolo. "Sia" gli ripete
Simone. S'ode gente che s'avvicina. Paolo consiglia a Simone di nascondersi. Questi s'allontana,
Paolo si trae in disparte presso il palazzo dei Fieschi. Entrano a poco a poco marinai e artigiani;
con loro è Pietro che senza indugi convoca tutti all'alba per eleggere il Doge: tutti contrari alla
nomina di un patrizio, tutti favorevoli a Lorenzino. No, è venduto ai Fieschi, ribatte Pietro. E chi
altri dunque? Paolo esce allo scoperto e pronuncia il nome di Simon Boccanegra. Il corsaro? Sì, lui.
E i Fieschi? Taceranno. Paolo chiama tutti intorno a sé e indicando il palazzo dei Fieschi dice loro
con mistero che in quella casa è tenuta segregata un'infelice (L'atra magion vedete), preda, si dice,
di visitazioni spettrali, e la sola voce umana che proviene dall'ostello sono i suoi lamenti; ma sono
ormai parecchi giorni che la sua figura non appare sul verone: le porte vengono aperte solo al
passaggio dell'altero patrizio e di notte un sinistro lume si aggira per le sale.Tutti sono inorriditi
dal macabro racconto. Ed ecco che dal palazzo si scorge il riverbero di un lume. Impauriti, tutti si
fanno il segno della croce e si disperdono in gruppi sparsi.
[2] ARIA. Da palazzo esce Jacopo Fiesco: dà l'addio all'altera abitazione ora divenuta il freddo
sepolcro della figlia Maria; impreca contro chi la sedusse: a nulla valse la sua protezione; con
l'animo lacerato dal dolore, cerca conforto pregando dinanzi all'immagine della Madonna (Il
lacerato spirito), mentre si odono lamenti all'interno del palazzo: voci di donne che piangono: "È
morta!"; voci di uomini che cantano "Miserere". Durante il postludio varie persone escono dal
palazzo attraversando mestamente la piazza e si allontanano.
[3] DUETTO. Simone ritorna in scena esultante; ora che il suo nome risuona sulle labbra di tutti
il suo pensiero è rivolto a Maria che spera diventi presto sua sposa. Un'ombra s'avvicina. È Fiesco,
che sta per entrare in chiesa e che in lui riconosce colui che lo oltraggiò seducendo e
abbandonando sua figlia: ora spera che la vendetta del cielo si abbatta su di lui (Qual cieco fato).
Simone implora pietà e lo supplica di concedergli il perdono: egli combatté per accumulare gloria,
e così meritare la fiducia di Fiesco e sposare Maria. Fiesco freddamente riconosce il valore del
corsaro; ma non dimentica le offese e irato scaglia su di lui l'anatema di Dio. Invano Simone
implora pace. Pace non sarà - dichiara Fiesco - fino a che uno di noi due non muoia. Simone gli
offre il petto chiedendogli di ucciderlo. "Assassinarti?" risponde Fiesco ritraendosi con orgoglio; e
gli propone un patto: se egli riuscirà a condurgli la bambina nata dall'unione "impura" con Maria,
egli la farà felice e il corsaro otterrà il suo perdono. Ma per Simone la cosa è impossibile: un
destino ribelle gli rapì la bimba. Racconta infatti come la piccola fosse cresciuta, mentre egli era
lontano, fra gente ostile, vegliata da una donna anziana (Del mar sul lido); un giorno facendo
ritorno a casa trovò la porta serrata, la casa muta, la vecchia donna morta e la piccola scomparsa;
fu vista vagare piangente per tre giorni; poi più nulla; da allora egli l'ha cercata, ma sempre invano.
Gli risponde Fiesco: se Simone non è in grado di esaudire il suo desiderio rendendogli la bimba,
non potrà più esservi pace tra loro. E così dicendo volge le spalle a Simone. Questi chiede ancora di
parlargli. Ma Fiesco, freddo, senza guardarlo, gli dice addio e s'allontana. Dopo pochi passi si
arresta in disparte, nell'ombra, a osservare le mosse di Simone.
[4] SCENA E CORO - FINALE. Rimasto solo, Simone impreca contro l'"implacabile" razza dei
Fieschi, meravigliandosi che da questi rettili possa essere nata Maria. Ma ora vuole vederla e
s'avvia verso l'odiato palazzo. Batte tre colpi, senza ottenere risposta. Vede però che le porte sono
dischiuse ed entra risoluto. Nell'ombra Fiesco osserva commentando: entra e troverai una fredda
salma. Simone ricompare sul balcone. Tenebra e silenzio. Stacca il lanternino dall'immagine della
Madonna e rientra. D'un tratto s'ode un grido: "Maria! Maria!". Simone esce atterrito dal palazzo:
"spaventoso, atroce sogno!". Intanto si odono voci interne che acclamano Boccanegra. Voci
d'inferno! esclama Simone. Una musica festosa accompagna l'ingresso frettoloso di Paolo, Pietro e
alcuni artigiani e marinai che accorrono ad annunciare a Simone la sua elezione a Doge. Ma questi
è affranto dal dolore e grida a Paolo: "Una tomba!". "Un trono!" gli risponde Paolo, mentre Fiesco,
che ha sentito, smania di rabbia impotente. Entra il popolo tumultuosamente con faci accese
acclamando Simone mentre le campane suonano a stormo (Viva Simon).
ATTO PRIMO
PARTE PRIMA
Giardino dei Grimaldi fuori Genò va.Alla sinistra il palazzo; di fronte il mare. Spunta l'aurora.
[5] ARIA. Son passati venticinque anni dall'azione del Prologo. Un preludio orchestrale descrive
lo spuntare dell'aurora sul mare increspato. Amelia è in scena; il suo sguardo è rivolto verso il
mare e ne ammira la bellezza (Come in quest'ora bruna): il chiarore della luna si unisce al tremolio
dell'onda come in un amplesso d'amore. Ma il fascino del mare mattutino non basta a cancellare il
ricordo della notte crudele in cui le morì la madre adottiva. Né a dimenticare - ora che è in quel
tetro, nobile palazzo, dove l'amore per la prima volta le ha sorriso - l'umile capanna in riva al mare
dove fu cresciuta. Ma intanto sorge l'alba, e non s'ode ancora l'amoroso canto che le terge il pianto.
[6] DUETTO. Ma ecco in distanza la voce di Gabriele Adorno che canta, accompagnato dall'arpa,
una serenata (Cielo di stelle orbato): come cielo senza stelle, come prato senza fiori è un'anima
senza amore. Amelia reagisce con eccitazione: è lui! Il canto si fa più vicino: se manca amore, non
valgono oro, potere e onore. La donna, sempre più animata, si fa incontro a Gabriele
abbracciandolo. Ma subito lo rimprovera per il ritardo; il giovane avanza il pretesto di gravi
ragioni di stato. A questa risposta Amelia rabbrividisce: egli sta apprestando la morte per tutti e
due; ricorda d'averlo visto varie volte in misteriosa conversazione con Andrea, il proprio tutore,
insieme a Lorenzino l'usuraio e ad altri. Gabriele la implora di tacere: il nemico è ovunque e ha
lunghe orecchie. E poi si tratta di fantasmi. "Fantasmi?" esclama Amelia. E invita il giovane a
mirare il mare: là vi torreggia Genova, là comandano i tuoi nemici (Vieni a mirar la cerula); inutile
combatterli; ripara il tuo animo nel porto dell'amore. Gabriele è affascinato da Amelia, l'immagine,
per lui, di un angelo sceso dal cielo; tuttavia le chiede di non ricercare il motivo del suo
odio.Amelia sobbalza: vede un uomo aggirarsi fra le quinte; è quello stesso che come un'ombra
ogni giorno le appare. In quel mentre entra un'ancella per annunciarle un messaggero del Doge.
Gabriele vuole uscire a vedere chi è, ma Amelia lo trattiene. Entra il messaggero: è Pietro, che
esprime alla Grimaldi il desiderio del Doge di visitare il palazzo. Amelia acconsente. Gabriele è
stupito dalla presenza del Doge. Amelia gli spiega il motivo: viene a chiedere la sua mano per un
suo favorito; sollecita dunque Gabriele ad affrettare le loro nozze: i due giovani si uniscono in un
canto per frasi che si sovrappongono, giurandosi amore oltre la morte (Sì, sì, dell'ara il giubilo).
Amelia entra nel palazzo.
[7] SCENA E DUETTO. Gabriele fa per allontanarsi, ma s'incontra in Fiesco (ora sotto il nome
di Andrea). Il giovane chiede il suo consenso alle nozze con Amelia. Fiesco non è ostile a questo
matrimonio, ma ritiene doveroso avvertire Gabriele che Amelia è di umili origini. La vera Amelia
morì in un convento a Pisa (La figlia dei Grimaldi); quel giorno stesso un'orfana, raccolta nel
chiostro, ne ereditò la cella; le fu dato il nome di Amelia Grimaldi onde impedire che l'eredità dei
Grimaldi cadesse nelle mani del Doge. Gabriele, udito il racconto, dichiara di amare l'orfana, non
l'ereditiera. Fiesco fa inginocchiare il giovane e gli impartisce la sua benedizione (Vieni a me, ti
benedico).
[8] SCENA E DUETTO. Squilli interni di trombe annunciano l'ingresso del Doge. Gabriele e
Fiesco, quest'ultimo mormorando propositi di vendetta, si allontanano. Amelia esce da palazzo con
alcune damigelle per andare incontro al Doge; questi entra dal lato opposto, con Paolo e séguito di
cacciatori. Il Doge congeda Paolo; nell'allontanarsi col séguito questi fissa languido Amelia
mormorando "Oh qual beltà!". Le damigelle si ritirano; restano soli Amelia e il Doge. Gravemente
il Doge chiede alla giovine perché i suoi fratelli in esilio non vogliano tornare in patria: forse i
Grimaldi sdegnano inchinarsi al Doge? Così dicendo porge ad Amelia un foglio: è l'atto di
clemenza che consente ai suoi fratelli di ritornare dall'esilio. A tale atto Amelia sente aprirsi il
cuore. Il Doge le chiede poi il perché di una vita così ritirata (Dinne, perché in quest'eremo);Amelia
arrossisce nel confessare di amare, ardentemente riamata, un giovane; ma vi è un perfido che mira
a lei per impadronirsi delle ricchezze dei Grimaldi. "Paolo!" azzarda il Doge. Amelia, sdegnata,
conferma; e poiché il Doge le sembra mosso da un sincero interesse per lei, gli rivela di non essere
una Grimaldi. Simone è stupito! Amelia racconta come fosse stata raccolta orfanella e cresciuta
presso Pisa da una vecchia (Orfanella il tetto umile). A Pisa? mormora Simone, assalito da un
presentimento. Amelia prosegue: in punto di morte la vecchia diede a lei bambina un medaglione
con l'immagine della madre, la baciò e la benedisse; quale triste avvenire l'attendeva in quel
momento! Simone, sempre più avvinto dal racconto di Amelia, osa appena sperare. Chiede alla
giovane se si ricorda d'aver visto qualcuno. Sì, un uomo di mare era solito visitarle. E la vecchia si
chiamava forse Giovanna? Sì, risponde ancora Amelia, mentre il ritmo musicale si va eccitando. E
il ritratto della madre consegnatole dalla vecchia non somiglia a quello che ora egli le porge? Sono
uguali! "Maria!" esclama Simone. "Il mio nome!", risponde stupita la giovane."Sei mia figlia!". In
un'esplosione di gioia i due si abbracciano. Simone contempla estatico la figlia, pieno d'emozione
per la gioia di averla ritrovata dopo tanti anni di vane ricerche: le promette che lei sarà il vivido
raggio della sua corona e che le schiuderà un paradiso di affetti (Figlia! a tal nome pa/pito);Amelia
rassicura il padre che sarà sempre al suo fianco, pronta ad asciugargli il pianto nelle ore tristi. Si
riabbracciano. Quindi Amelia parte accompagnata dal padre verso la soglia del palazzo. Questi
resta estatico a contemplarla mentre lei s'allontana, mormorando dolcemente "O figlia!". E ancora,
rimasto solo, come sognando, sospira: "Figlia!".
[9] DIALOGO. Paolo entra rapidamente e s'avvicina al Doge ansioso di conoscere la risposta di
Amelia. Il Doge bruscamente gli dice di riporre ogni speranza nei riguardi della giovane. Questa è
la sua volontà! e parte per Genova. La sua volontà? Paolo si adonta: Simone s'è forse scordato che
deve a lui il trono? Entra Pietro. Paolo lo informa che Simone gli ha negato Amelia; pertanto gli
ordina di rapire la giovane la sera stessa, quando ella è sola sul lido, e di condurla in casa di
Lorenzino; e se questi rifiutasse, gli ricordi che Paolo ben conosce le sue trame; quanto a lui,
Pietro, sarà riccamente remunerato. Entrambi escono di scena.
PARTE SECONDA
Sala del Consiglio nel Palazzo degli Abati.
[10] SCENA DEL CONSIGLIO. Durante un breve preludio cambia la scena a vista. Il Doge è
seduto sul seggio ducale; da un lato, dodici Consiglieri nobili; dall'altro lato, dodici Consiglieri
popolani. Seduti a parte quattro Consoli del mare e i Conestabili. Paolo e Pietro stanno sugli ultimi
seggi dei popolani. È presente un araldo. Simone informa che il re di Tartaria inviando ricchi doni
in segno di pace annuncia libertà di accesso alle navi liguri nel Mar Nero. Ottenuta l'approvazione,
passa ad altro più importante argomento: un messaggio di Francesco Petrarca che supplica la pace
con Venezia. Paolo non è d'accordo, sostenuto dai Consiglieri che gridano "guerra a Venezia!". Il
Doge insorge: questa è guerra fratricida! Genova e Venezia hanno patria comune.
[11] SOMMOSSA. Mentre i Consiglieri proclamano esservi una sola patria, Genova, si sente il
lontano rumore di un tumulto (coro a bocca chiusa) e si alzano alcune grida. Paolo si lancia sul
verone a osservare: le grida provengono dalla piazza dei Fieschi. Lo raggiunge Pietro. È una
sommossa, dicono allarmati i Consiglieri alzandosi. L'eco del tumulto si fa più vicino, si sente
gridare "morte! morte!". Pure il Doge corre al verone e vede Gabriele Adorno alla guida dei
cospiratori inseguito dalla plebe; accanto a lui combatte un guelfo. Fa chiamare l'araldo. Intanto
Pietro sussurra a Paolo di fuggire perché scoperto. Vedendo Paolo uscire, il Doge con tono
perentorio ordina ai Consoli del mare di sorvegliare le porte: chi fugge è un traditore! Paolo,
confuso, s'arresta. La tensione si propaga nell'aula stessa del Senato: i Consiglieri popolani
appoggiano la plebe gridando "Morte ai patrizi!". I Consiglieri nobili rispondono sguainando le
spade; altrettanto fanno i popolani. Sta per nascere uno scontro armato, mentre da fuori la folla
grida con violenza "Morte al Doge!". Simone ordina all'araldo di aprire le porte del palazzo
facendo avvertire plebei e patrizi che egli non teme minacce. Indi, con terribile accento, impone ai
Consiglieri tutti di rinfoderare le spade. Fuori si urla al saccheggio e al fuoco, quando
improvvisamente si sente squillare la tromba dell'araldo che impone il silenzio a tutti. Alcuni
istanti di muta attesa. Annunciata dal Doge irrompe in scena la folla dei popolani, uomini, donne e
fanciulli: Adorno e Fiesco entrano afferrati dal popolo che, circondando il Doge e i Consiglieri,
grida incessantemente "vendetta! vendetta!" per l'uccisione di Lorenzino. S'alza ancora possente la
voce del Doge che in tono ironico chiede se è questa la voce del popolo: un uragano da lontano, un
grido di donne da presso. Poi rivolto ad Adorno bruscamente gli chiede perché impugni la spada.
Questi risponde con baldanza d'aver trucidato Lorenzino per aver egli rapito la Grimaldi; prima di
morire rivelò che un uomo potente lo aveva spinto al crimine (e intanto Pietro avverte Paolo che è
ormai scoperto). Quindi fissando il Doge con tremenda ironia, come per accusarlo, gli dice di stare
tranquillo: Lorenzino morì prima d'aver proferito quel nome. Dopo un istante di silenzio,
d'improvviso Adorno si scaglia contro il Doge accusandolo del rapimento. I Consiglieri cercano di
trattenerlo, ma il giovane svincolandosi sta per ferire il Doge, quando viene fermato dal subitaneo
accorrere di Amelia che s'interpone fra il Doge e lui dicendo a quest'ultimo: "ferisci!". L'arrivo di
Amelia provoca stupore in tutti. La giovane, rivolta al padre, lo supplica di non infierire su
Gabriele, che nel frattempo i popolani avevano immobilizzato. Simone, addolcito dalla presenza
della figlia, cede alla sua richiesta e le chiede come fu rapita e come poté liberarsi.
[12] RACCONTO. Amelia racconta: mentre passeggiava al tramonto sul lido (Nell'ora soave), tre
sgherri la rapirono e la portarono su una nave soffocando le sue grida; quindi svenne. Quando
riprese i sensi si trovò alla presenza di Lorenzino; conoscendone la viltà ella gli disse che il Doge
era a conoscenza delle sue trame; egli, spaventato, la lasciò libera.Tutti commentano che
Lorenzino ben meritava la morte. Ma - prosegue Amelia - vi è un uomo più nefando, tuttora illeso.
E fissando Paolo che sta dietro un gruppo di persone, dice di riconoscerlo dal suo pallore. Cresce
l'eccitazione generale: tutti sollecitano di conoscerne il nome. I due gruppi dei Consiglieri,
popolani e nobili, sono sul punto di affrontarsi, i primi armati di scuri, gli altri di spade,
accusandosi reciprocamente d'aver organizzato il rapimento. Con tono possente si leva la voce del
Doge:"Fratricidir.Tutti si arrestano.
[13] PEZZO D'ASSIEME. Il Doge apostrofa patrizi e plebei accusandoli come eredi di un
insanabile odio atavico (Plebe! Patrizi! Popolo); incuranti delle imprese cui li invita il regno dei
mari, continuano a lacerarsi fra loro in famiglia: piango su voi, egli esclama, piango su questa terra
dove cresce l'ulivo; e con accento appassionato invoca pace e amore. C'è molta commozione intorno
a lui; tutti, fissandolo, si sentono calmati dalla sua voce. Anche Amelia invoca pace rivolgendosi a
Fiesco, che a parte esprime delusione per il destino di Genova in pugno a un vile corsaro, mentre
Gabriele con fervido tono ringrazia il cielo per la salvezza di Amelia. Ma nel canto generale si
insinua il dialogo fra Pietro e Paolo; Pietro esorta l'amico, dall'animo invelenito, a fuggire. Il
concertato si spegne sul dolcissimo, isolato "pace!" di Amelia.
[14] MALEDIZIONE. Ora nella sala la calma sembra tornata. Gabriele offre la propria spada al
Doge; ma questi la rifiuta rassicurando il giovane che la sua prigionia durerà una notte, il tempo di
scoprire l'intera trama.Tutto sembra finito. D'improvviso, con forza terribile, il Doge chiama
Paolo, che sbuca dalla folla allibito. Con altrettanta forza risponde l'orchestra su un unisono
suggellato da un possente trillo. Con tremenda maestà e con violenza sempre più formidabile il
Doge dichiara di rivolgersi a Paolo quale tribuno del popolo per avere un consiglio (In te risiede
l'austero dritto popolar): aiutarlo a smascherare un vile traditore che si annida nel palazzo; egli, il
Doge, sa il suo nome, è scritto sul suo volto. Lo chiama pertanto a testimone in faccia al cielo e al
Doge stesso: il manigoldo impuro sia maledetto! Quindi, cupo e terribile, con accento di comando,
afferrandogli violentemente il braccio destro, gli ingiunge di ripetere l'anatema. Atterrito e
tremante, soggiogato dallo sguardo di Simone, Paolo ripete "sia maledetto!".Tutti i presenti, che
hanno seguito con meraviglia e raccapriccio la scena, pur non comprendendo a chi il Doge volesse
alludere, ripetono "sia maledetto!", dapprima con forza, quindi pianissimo, senza voce. Paolo fugge
inorridito.
ATTO SECONDO
Stanza del Doge nel Palazzo Ducale in Genova. Porte laterali. Da un poggiolo si vede la città. Un tavolo;
un'anfora e una tazza. Annotta.
[15] SCENA E RECITATIVO. Paolo, traendo Pietro al poggiolo, gli indica i due capi della
rivolta.
Gabriele e Fiesco, e ordina di liberarli e portarli al suo cospetto attraverso una porta segreta di cui
gli consegna la chiave. Rimasto solo, è ancora scosso: è stato costretto a maledire se stesso, e l'eco
dell'anatema gli risuona nell'animo. Reietto dal Senato e da Genova, prima di fuggire vuole
vendicarsi del Doge avvelenandolo. Estrae un'ampolla e ne vuota il contenuto nella tazza, dicendo:
ora preparo il veleno, poi armo un assassino; la morte del Doge troverà sua via fra tossico e
pugnale.
[16] SCENA E DUETTO. Entrano Fiesco e Gabriele condotti da Pietro, che si ritira. Paolo si
rivolge a Fiesco (Prigioniero in qual loco): conosce il suo odio per Simone e sa tutto circa la parte
da lui avuta nella congiura guelfa; con astuzia cerca di convincerlo a uccidere il Doge nel palazzo
mentre dorme. Fiesco sdegnosamente rifiuta la proposta di un così vile misfatto. Paolo, stupito del
suo rifiuto, seccamente lo rispedisce in carcere. Fiesco parte. Gabriele fa per seguirlo, ma è
arrestato da Paolo.
[17] SCENA ED ARIA. Anche Gabriele giudica vile la proposta che ha udito fare a Fiesco. Ma
Paolo astutamente gli dice che Amelia è a palazzo e che il Doge ne sta godendo... E intanto, a
scanso di rischi, corre a chiudere la porta da cui Gabriele è entrato, dicendo al giovane: se non
ardisce il colpo già proposto a Fiesco, egli non uscirà vivo da palazzo. E parte frettoloso dalla
porta di sinistra, che si chiude dietro. Gabriele ha l'inferno nel cuore. Amelia qui! E il vecchio
Simone ne è innamorato! Già gli ha ucciso il padre; ora gli toglie l'amante! In preda a incontenibile furia gelosa, su un turbolento disegno cromatico dell'orchestra, impreca contro il
Doge: farlo morire mille volte non sarebbe mai abbastanza (Sento avvampar nell'anima).
Cessato lo sfogo violento, passa dalla furia alla commozione. E piange, chiedendo a Dio pietà per la
sua sofferenza e supplicandolo di restituirgli Amelia pura come un angelo; ché se un'ombra di
impurità oscurasse il suo candore, meglio non rivederla più (Cielo pietoso, rendila).
[18] SCENA E DUETTO. Entra Amelia dalla sinistra ed è stupita nel vedere Gabriele che
credeva rinchiuso in cella. Chiede chi lo liberò, ma egli non risponde e a sua volta chiede come
mai ella si trovi nella casa di Simone: egli l'ama. Simone, ella risponde, l'ama, sì, ma di santo
affetto, che lei ricambia. Gabriele insiste perché ella parli. Ma Amelia di più non vuol dire. Il
giovane risponde sdegnando la sua pietà (Parla, in tuo cor virgineo): vuol conoscere la verità;
invano Amelia cerca di rassicurarlo sui propri sentimenti. Il dialogo si interrompe: uno squillo di
tromba annuncia l'arrivo del Doge. Amelia, agitatissima, supplica il giovane di nascondersi: sta
rischiando il patibolo, ed ella morirebbe all'istante (All'ora istessa teco avrò morte); Gabriele, a
parte, esprime la decisione di uccidere il Doge. Alla fine Amelia riesce a trascinare il giovane a
nascondersi nel poggiolo.
[19] SCENA E TERZETTO - FINALE SECONDO. Il Doge entra leggendo un foglio. Amelia lo
vede afflitto, ma egli la rassicura. Piuttosto è lui che scorge sul volto della figlia il segno del pianto.
Ne intuisce la ragione: l'uomo da lei amato. Chiede di saperne il nome. Il più prode dei Liguri, ella
risponde:Adorno."Il mio nemico!" esclama Simone, mostrandole il nome nell'elenco dei cospiratori
guelfi. Amelia supplica: morirà con lui se non otterrà il perdono. Simone, disperato, impreca contro
il destino che gli fece ritrovare la figlia per poi essergli involata dal nemico. Ma subito si placa e
lascia alla giovane una speranza. Quindi la congeda. Lei vuol rimanere al suo fianco. Ma egli
insiste. Amelia obbedisce. Rimasto solo Simone riflette: castigare i nemici potrebbe essere segno di
paura. Ma intanto gli arde la gola; prende la tazza e beve: perfino l'acqua è amara all'uomo che
regna. La sua mente è oppressa, il sonno grava sulle palpebre. Mentre s'addormenta mormora, sul
suono acuto dei violini a punta d'arco, il nome di Amelia:
ella ama un nemico! Gabriele esce con cautela dal nascondiglio, s'avvicina al Doge e lo contempla;
è titubante, ma cerca di farsi animo col pensiero di vendicare l'ombra del padre, ucciso da Simone.
Brandisce il pugnale e sta per trafiggerlo quando entra Amelia che s'interpone rapidamente fra i
due, sussurrando agitata al giovane: vuoi dunque uccidere un vecchio inerme? non sai che egli è
incline alla nostra unione? In quel momento il Doge si sveglia. Amelia chiede al giovane di
nascondere il pugnale. Questi rifiuta. Ma Simone intuisce; si dirige verso Gabriele offrendogli il
petto e invitandolo a colpirlo slealmente. Il giovane invoca il sangue del padre. Il Doge reagisce
con ira: gli chiede chi gli ha aperto la cella, minacciandolo di farlo parlare fra le torture. Amelia
chiede pietà. A questo punto nell'animo del Doge prevale l'amore paterno: rivolgendosi a Gabriele
gli osserva d'aver ben vendicato suo padre: ora egli stesso vede involarsi la propria figlia. La
rivelazione colpisce Gabriele come un fulmine: Simone suo padre!? Divorato dai rimorsi si rivolge
ad Amelia implorando perdono, quindi a Simone dichiarandosi un assassino e chiedendo per sé la
morte (Perdon, perdon, Amelia). Mentre Amelia supplica lo spirito della madre di proteggerla e di
aprire l'animo del genitore alla pietà, Simone, nel chiedersi se perdonare o condannare, decide per
il perdono: si plachi l'odio antico e la pace regni fra i Liguri; il suo sepolcro dovrà essere l'altare
"d'amistanze italiche". Di lontano giungono voci che gridano all'armi. Amelia corre al poggiolo a
osservare. Sono i nemici di Simone, che incitano alla guerra e allo sterminio. Le voci si fanno
sempre più vicine. Simone ingiunge a Gabriele di andarsene e di unirsi ai suoi. Ma ormai Gabriele
non vuole più combattere contro il Doge. A questa dichiarazione Simone gli ordina di recare alla
folla un messaggio di pace. E mentre continua ostinato il grido dei rivoltosi, Simone promette a
Gabriele come premio di concedergli Amelia in sposa. Gabriele parte rapidamente. Sull'ultimo
grido d'all'armi cala la tela.
ATTO TERZO
Interno del Palazzo Ducale. Di prospetto grandi aperture, dalle quali si scorgerà Genova illuminata a festa:
in fondo il mare.
[20] SCENA E RECITATIVO. Il motivo della rivolta risuona in orchestra, a sipario chiuso,
sviluppandosi in un crescendo che culmina con un evviva al Doge. Si apre quindi il sipario. Un
capitano dei balestrieri restituisce a Fiesco la spada, annunciandogli la sconfitta dei guelfi. Egli ora
è libero; ma per Fiesco è una triste libertà. Mentre sta per partire s'imbatte in Paolo circondato da
quattro guardie: questi dice a Fiesco d'essere stato condannato al patibolo da Simone perché
trovato a combattere con i rivoltosi; ma Simone morrà prima di lui: un veleno lo sta divorando
lentamente e forse già lo precede nella tomba. Fiesco è inorridito. Giunge in quell'istante,
dall'interno, un canto nuziale. Paolo impreca: Gabriele sposa colei che egli aveva rapito. A tale
confessione Fiesco, sdegnato, sguaina la spada per ferirlo; poi si trattiene: la testa del rapitore è
ormai consacrata alla scure del boia... Il coro interno continua. Paolo lo ascolta con animo
disperato mentre viene trascinato via dalle guardie. Fiesco è inorridito: non è questa la vendetta
che sperava nei confronti di Simone. Ma ecco che il Doge sta arrivando. Finalmente è giunta l'ora
di trovarsi a fronte. Fiesco si ritira nell'ombra.
[21] SCENA E DUETTO. Su un tema dei corni all'unisono entra il capitano con un trombettiere;
si recano al verone. Il trombettiere suona tre squilli. Nel silenzio più assoluto il capitano si rivolge
al popolo: per ordine del Doge siano spente le luminarie e non si offendano i caduti coi clamori del
trionfo. Risuona in orchestra il tema dei corni: il capitano s'allontana seguito dal trombettiere. Su
un motivo strascicante degli archi entra Simone: le tempie gli ardono, ha il fuoco nelle vene e sente
il bisogno di respirare la brezza del mare. Lentamente si trascina al verone: lo spettacolo del mare
lo commuove. Il mare! Quanti ricordi di glorie e di estasi nel rimirarlo. Fosse egli morto nel suo
grembo! Sarebbe stato meglio, gli risponde con fermo tono una voce dietro di lui. È la voce di
Fiesco, che frattanto gli si è avvicinato. Simone, sorpreso, chiede chi sia l'intruso e, temendo un
attentato, chiama le guardie. Fiesco risponde che non vi sono sgherri. Ora stia ad ascoltarlo. Fra le
luci della festa per la vittoria - dichiara Fiesco - è scritta la sentenza di morte per Simone (Delle
faci festanti al barlume); la sua stella tramonta, la sua porpora cade in brani, e morrà da vincitore
tra i fantasmi di coloro che egli ha condannato a morte. Intanto i lumi sulla piazza cominciano a
estinguersi. Simone, stordito, crede tuttavia di riconoscere quella voce: forse risorgono dalle tombe
i morti? D'un tratto riconosce l'intruso: Fiesco! e subito ringrazia Dio che ha finalmente esaudito il
suo desiderio. Ma Fiesco, inesorabile, non gli dà tregua: come fantasma egli gli si presenta per
vendicare l'antico oltraggio. Gli risponde Simone che ora un angelo suggella la loro
riconciliazione. Fiesco rimane interdetto! Simone gli ricorda quando egli gli offerse il perdono a
condizione di condurgli l'orfanella che credeva perduta per sempre: ebbene, quell'orfanella ora gli è
resa in Amelia Grimaldi e porta il nome della madre estinta, Maria. Come fulminato da questa
rivelazione Fiesco storna il viso e, tormentato dal rimorso, piange. Simone è commosso nel vedere
le lacrime solcare il volto dell'inflessibile vecchio (Piango, perché mi parla): egli ora sente nelle
parole di Simone la voce del cielo; intanto Simone con grande dolcezza lo invita all'abbraccio e al
perdono. Ma la morte si sta avvicinando inesorabile. Fiesco addolorato confida a Simone ch'egli è
stato avvelenato da un traditore. Il Doge sente già alitare il soffio dell'eternità... Sta per giungere
Amelia. Simone vuole ancora una volta benedire gli sposi. E s'abbandona sopra una sedia.
[22] SCENA E QUARTETTO - FINALE. Entrano Amelia e Gabriele, seguiti da dame,
gentiluomini, senatori e paggi con torce. I due sposi nel vedere Fiesco sono stupiti! Simone rivela
ad Amelia che Fiesco è il padre della donna, Maria, che le dette vita. Amelia gioisce: dunque è
finito il funesto odio antico. Simone, con voce grave, commenta: "Tutto finisce, o figlia!". Amelia è
impressionata da queste parole. Il padre le dice che un grave dolore sta per colpirla: l'estrema ora è
per lui suonata; ma è felice di morire fra le braccia della figlia. Amelia (ora Maria) e Gabriele
cadono ai piedi di Simone. Questi sorge e imponendo sul loro capo le mani, solleva gli occhi al cielo
e invoca su di loro la benedizione di Dio (Gran Dio, li benedici). Maria e Gabriele supplicano
Simone di vivere per loro, mentre Fiesco commenta come il cuore umano sia fonte di interminabile
pianto. Simone chiede alla figlia di abbracciarlo. Poi chiama a sé i senatori e chiede loro di esaudire
il suo ultimo desiderio: che il serto dogale cinga la fronte di Gabriele Adorno; a Fiesco il compito
di eseguire la sua ultima volontà. Con voce quasi spenta vorrebbe ancora parlare, ma non può;
stende le mani di nuovo sul capo dei figli, mormora il nome di Maria e spira. Gabriele e Maria
s'inginocchiano davanti al suo cadavere. Fiesco si dirige al verone, seguito da senatori e paggi che
alzano le faci accese, e annuncia ai genovesi che Gabriele Adorno è il nuovo Doge. "No,
Boccanegra!!!", invoca la folla sottostante. "È morto". Una campana suona mestamente.Tutti si
inginocchiano.
Aroldo
Libretto in quattro atti di Francesco Maria Piave
Prima rappresentazione: Rimini, Nuovo Teatro Comunale, 16 agosto 1857
L'opera è un rifacimento dello Stiffelio, con l'aggiunta di un quarto atto. L'argomento è ispirato per
i primi tre atti a un romanzo di Walter Scott (Edimburgo, 1771 - Abbotsford, 1832), The
Betrothed fidanzati, pubblicato nel 1825 e già musicato da Pacini), e per il quarto atto a un altro
romanzo di Scott, The Lady of the Lake (La donna del lago, pubblicato nel 1810, e a sua volta
musicato da Rossini). Alcuni nomi dei personaggi (Aroldo, Godvino ed Egberto) furono da Piave
attinti dal romanzo di Bulwer-Lytton Harold, the Last of the Saxon Kings. La scarsa fortuna
incontrata dallo Stiffelio sulle scene teatrali e soprattutto gli ostacoli frapposti dalle censure a un
soggetto avente a protagonista un pastore protestante e per tema principale il divorzio (e da esse
trasformato in un'insulsa vicenda battezzata col titolo di Guglielmo di Wellingrode) persuasero
Verdi, fermamente convinto dei valori drammaturgici e musicali dello Stiffelio, a riscriverlo su
argomento che fosse accetto alle autorità politiche preposte alla sorveglianza dei testi teatrali,
affidando scelta del soggetto e adattamento del libretto a Piave. Oltre ad aggiungervi un quarto
atto, Verdi ritoccò lo strumentale e apportò alcune modifiche volte a conferire una maggiore
saldezza al tessuto drammatico e una più compatta organizzazione musicale. L'Aroldo riscosse
subito un buon successo di pubblico, tale da consentirgli un cammino abbastanza spedito sulle
scene della penisola e su quelle dei teatri italiani all'estero fino all'inizio degli anni 1870. In seguito
la sua fortuna decadde abbastanza rapidamente, fino a che l'opera scomparve dai cartelloni.
Ignorato fin dalla Verdi-Renaissance tedesca, rAroldo è ricomparso sulle scene con l'allestimento
del Maggio Musicale Fiorentino nel 1953. Da allora sono seguite solo sporadiche riprese, svoltesi
perlopiù all'estero, in particolare in Germania e in Inghilterra.
PERSONAGGI E PRIMI INTERPRETI
AROLDO, cavaliere sassone
primo tenore
Emilio Pancani
MINA, di lui moglie, figlia di
prima donna
Marcellina Lotti
EGBERTO, vecchio cavaliere, vassallo di Kenth
primo baritono Gaetano Ferri
BRIANO, pio solitario primo basso
G. B. Cornago
GODVINO, cavaliere di ventura, ospite d'Egberto primo tenore
Salvatore Poggiali
ENRICO, cugino di Mina secondo tenore Napoleone Senigaglia
JORG, servo d'Aroldo che non parla
[mimo] N. N.
Cavalieri crociati, gentiluomini e dame di Kenth; scudieri, paggi, araldi, cacciatori, Sassoni, paesane scozzesi
Scena, pei primi tre atti la dimora d'Egberto presso Kenth; pel quarto le sponde del lago Loomond in Iscozia
Epoca il 1200 circa
RIASSUNTO DELL'AZIONE DRAMMATICA
1. SINFONIA. È la stessa dello Stip/io, con alcuni ritocchi. In questa versione è diventata una
delle più popolari sinfonie verdiane, grazie in particolare alla melodia dell'Andante affidata alla
tromba.
ATTO PRIMO
Salotto nella dimora d'Egberto. Gran finestra nel mezzo della quale si vedranno i merli del castello. Vi sono
porte laterali, tavola coll'occorrente per scrivere, sedie, ecc. La stanza è vuota.
2. CORO D'INTRODUZIONE. La scena si apre con un canto bacchico per sole voci virili,
proveniente da una sala interna, che indica la fine di un banchetto e con il quale i compagni di
Aroldo gli danno il benvenuto; reduce dalla Palestina dove ha combattuto valorosamente contro i
Saraceni, ora egli potrà godere della compagnia della sua sposa Mina.
3. SCENA E PREGHIERA. Su un concitato preludio orchestrale Mina piomba in scena agitata:
fuggita dal convito, ella è dilaniata dal rimorso per aver tradito il marito durante la sua assenza; al
colmo della disperazione si rivolge a Dio supplicando di salvarla (Salvami tu gran Dio!).
4. SCENA E CAVATINA. Sul tema principale della Sinfonia fanno il loro ingresso Aroldo e
Briano. Aroldo nota un'insolita tristezza nel volto di Mina e ne chiede il motivo. Mina allude ai
pericoli da lui corsi in battaglia; ed egli conferma: senza l'aiuto di Briano, un solitario che lo
raccolse ad Ascalona, curandolo da una brutta ferita, egli sarebbe morto; visitando i luoghi santi
hanno giurato sulla tomba di Gesù di non separarsi più. Mina accoglie Briano come angelo
protettore della casa. Briano commosso esce. Rimasti soli, Aroldo racconta a Mina - sulla melodia
della tromba udita nella Sinfonia - come in battaglia il suo cuore non smettesse mai di pensare a lei
e, quando cadde ferito, come questo pensiero servisse a lenire il suo dolore (Sotto il sol di Siria).
Mina, sempre più oppressa dal rimorso piange.Aroldo s'accorge del suo sconforto, ne chiede
invano il motivo; quindi cerca di consolarla ricordandole la ricorrenza del loro matrimonio: dal
cielo la madre sua li benedirà. Così dicendo le prende la mano; ma vede che è priva dell'anello
nuziale. Mina sussulta sconcertata senza trovare risposta. L'animo di Aroldo s'infiamma; con ira
crescente ingiunge alla sposa di parlare: quell'anello, egli dice, è stato l'estremo dono di sua madre;
il perderlo sarebbe sventura fatale per entrambi (Non sai che la sua perdita); Mina con l'animo
accasciato non sa rispondere. Il dialogo viene interrotto da uno squillo interno della banda. Entra
frettolosamente Briano per avvisare Aroldo che gli amici lo attendono. Aroldo avverte Mina che
tornerà tosto.
5. SCENA E DUETTO. Mina, disperata, si abbandona sopra una sedia col volto fra le mani. Entra
Egberto cautamente e inosservato, e contempla la figlia. Nutre sospetti sulla sua condotta e pensa
che Godvino ne sia responsabile. Intanto Mina, scuotendosi come mossa da un impeto, prende la
penna e scrive per rivelare tutto allo sposo. Egberto s'impadronisce improvvisamente del foglio
ritenendo che sia diretto a Godvino e legge: "Aroldo! di voi non son più degna!". I suoi dubbi sono
dunque confermati. L'anziano padre avverte la figlia che il contenuto della lettera potrebbe far
morire Aroldo di disperazione. Con voce rotta dall'emozione Mina gli grida che non può più oltre
tacere la verità. Allora - le risponde il padre con crescente collera - a una spergiura è più facile
svelare la propria colpa che dare morte: non le basta l'infamia, ora vuol essere anche vile (Dite che
il fallo a tergere); no, Mina dovrà salvare lo sposo subendo immeritatamente il suo amore e
distruggendo il foglio. Mina si oppone con energia. Egberto è profondamente addolorato: proprio
a lui doveva toccare l'onta di scoprire in sua figlia un'adultera confessa (Ed io pure innanzi agli
uomini)! Invano Mina, in preda al pianto, sostiene d'essere stata complice di un intrigo contro la
propria volontà. Egberto le ordina di cessare il pianto e le impone di seppellire la sua colpa nel
silenzio (Or meco venite, il pianto non vale): nessuno deve sospettare. Mina si sottomette alla
volontà del genitore; ma sa d'aver perduto per sempre l'amore dello sposo. Escono entrambi a
sinistra.
Fuga di sale illuminate a gran festa. Nella prima vi sono mobili dell'epoca, sopra uno dei quali è un libro
chiuso da fermaglio con chiave.
6. FINALE PRIMO. Dame e cavalieri s'incontrano e si dirigono da diverse parti: per un istante
non li si vedrà che nelle sale in fondo. Godvino entra. cautamente da destra; dice di non vedere
Mina da alcuni giorni: ormai lei lo sfugge.Trae di tasca una chiave e uno scritto, tenendo sempre le
spalle volte alla destra, pone il biglietto - un messaggio per Mina - nel libro. Nel frattempo Briano
entra inosservato da destra. Godvino richiude a chiave il fermaglio del libro e quindi si confonde
tra nuovi invitati che entrano e sono raggiunti dai primi. Briano ha osserva tutta la scena; ma non
sa riconoscere il personaggio: un amico di Aroldo? Nel suo animo cresce il sospetto di una trama
contro di lui. Intanto tutti gli invitati vengono sul davanti della scena intonando un coro di letizia
per il ritorno a casa di Aroldo (Li. bello, di guerra). Alla fine del coro entra in scena Enrico
abbigliato come Godvino; stende la destra a Briano non ottenendo altra risposta che un freddo
inchino. Briano infatti sospetta di lui. Vede Enrico fermarsi a caso presso la tavola, prendere il
libro e, trovatolo chiuso, lasciarlo per andare a confondersi fra gli invitati. Per Briano il sospetto
diventa certezza. Si dirige frettolosamente verso Aroldo, che entra in quel punto, e mentre
Egberto e Mina si intrattengono con gli invitati, lo trae sul davanti della scena indicandogli il
libro: esso contiene un misterioso messaggio. Aroldo chiede chi può averlo introdotto e Briano
risponde che potrebbe essere stato Enrico. Intanto attorno ad Aroldo, che resta cupamente
concentrato, si accalca la folla degli invitati per festeggiare il suo ritorno (Per te, della croce
possente): le sue gesta saranno a lungo ricordate nelle contrade del Kenth. Poi Egberto chiede che
qualcuno narri le gesta del re Riccardo.Tutti si rivolgono ad Aroldo perché sia lui a raccontare.
Dapprima si oppone; ma pungolato dalla richiesta di Enrico, il sospetto adultero, acconsente, ma
per narrare una storia diversa: in Palestina vi fu un infame che tradì l'onore del suo ospite (Vi fu in
Palestina); egli venne scoperto mentre fissava un appuntamento con la moglie di lui per mezzo di
una lettera inserita in un libro; un vecchio amico dell'ospite svelò la tresca. Ma simile storia sta
scritta in un libro. E così dicendo prende il libro che è sulla tavola. S'accorge che è chiuso dal
fermaglio. Elena candidamente dice che ne ha Mina la chiave. Volgendosi a lei Aroldo le chiede di
aprire il fermaglio. Mina, pietrificata, esita. Notando il suo terrore Amido con ira crescente le
ripete il comando. I: azione improvvisamente s'arresta su un concertato in cui tutti esprimono la
propria agitazione (Oh qual m'invade ed agita): tutti sono come paralizzati dal mistero, fatale e
terribile, rinchiuSo nel libro. Alla fine Aroldo decide di forzare il fermaglio. Dal libro cade un
foglio. Egberto si precipita a raccoglierlo impedendo ad Aroldo di leggerlo. Questi gli impone di
renderglielo; ma il vecchio si oppone con forza e riduce il foglio in brani. Al colmo dell'ira Aroldo
si scaglia contro di lui (Chi ti salva, o sciagurato). Mina si frappone fra i due invocando su di sé
l'ira del marito. Mentre gli ospiti esprimono turbamento alla vista di Aroldo lacerato da un
diabolico sospetto, Egberto s'avvicina a Godvino sfidandolo a duello nel recinto dei sepolcri; questi
raccoglie la sfida con sfrontatezza.
ATTO SECONDO
Antico cimitero nel castello di Kenth. Nel centro è una croce con gradini; a destra la porta d'un tempio
internamente illuminato, a cui si ascende per grandiosa scalea; a sinistra più in fondo si vede il castello. La
luna fiocamente rischiara le tombe qua e là ombreggiate da secolari cipressi. Una tra quelle è recente.
7. SCENA ED ARIA. La scena si apre su un preludio strumentale dal carattere lugubre, percorso
da ritmi tempestosi. Dal fondo entra Mina, agitatissima, come trascinata da una forza invisibile: su
ogni tomba le sembra di vedere scolpito il proprio delitto; s'aggira barcollando tra i sepolcri fino a
trovarsi di fronte a quello della madre. Mina si rivolge in preghiera a lei che vede i suoi affanni
(Ah! dagli scanni eterei), e offre le proprie lacrime al trono di Dio; se questo non bastasse, anche la
madre dovrà unirsi al suo pianto, così Iddio non potrà negarle il perdono. Improvvisamente Mina
si trova appresso Godvino. Lo implora di allontanarsi dal sacro luogo. Egli le dichiara di amarla;
ma la donna gli risponde che se gli è rimasta una stilla d'onore le restituisca piuttosto l'anello.
Godvino rifiuta: è accorso per difenderla. Mina, inorridita, sente un fremito provenire dalla tomba
(Ah dal sen di quella tomba): è lo spirito irato della madre che la sta accusando; disperatamente
grida a Godvino di fuggire subito.
8. SCENA, DUETTO E QUARTETTO. Godvino freddamente risponde che vuol restare. Mina
allora gli dichiara che dirà tutto ad Aroldo. Dal fondo a sinistra si avanza Egberto, avvolto in un
mantello sotto il quale cela due spade. Ha sentito le ultime parole di Mina: con tono severo impone
a Mina di partire; ella obbedisce. Quindi, rimasto solo con il seduttore, getta il mantello
presentando le spade e sfidandolo a un duello mortale (Scegli... Un duello?). Il giovane rifiuta di
battersi con un vecchio. Egberto inveisce su di lui accusandolo d'infamia e di viltà; e, non bastasse
questa accusa a fargli accettare la sfida, Egberto gli rivela di conoscere la sua vera identità: egli
non è un nobile, bensì un trovatello, figlio di padre ignoto. A tale rivelazione Godvino s'infuria e si
precipita a scegliere una delle due spade che Egberto gli presenta; entrambi esplodono in minacce
di morte (Nessun demone, niun Dio). Quindi si battono accanitamente. Dal tempio appare Aroldo,
richiamato dal rumore delle armi. Scende dalla gradinata e nel riconoscere i due contendenti
ordina loro di abbassare le armi: il luogo sacro non sia profanato. Ma poiché i due insistono nel
duellare recandosi altrove,Aroldo dichiara di parlare in nome di Dio: giù le armi, l'offesa sia
dimenticata e che il fratello perdoni al fratello. Così dicendo s'appressa al più giovane dei duellanti,
Godvino, lo disarma e gli stringe la mano. A tale atto Egberto non si trattiene e grida al seduttore:
la mano che stringi è quella dell'uomo che hai tradito! Aroldo, allibito, chiede spiegazioni.
Sopraggiunge Mina dal fondo a sinistra, e si precipita dal marito a chiedere grazia per Godvino. Il
gesto di Mina fa cadere il velo dagli occhi di Aroldo: ora egli sa chi è il seduttore! Chiede alla sposa
di discolparsi (Che ho mentito almen mi dite); non vorrebbe credere alla sua infedeltà, ma il suo
silenzio conferma la colpa; Mina con l'animo straziato invoca per sé la morte; Egberto, con
inalterato sdegno, rinnova a Raffaele propositi di vendetta, propositi che il seduttore accoglie con
spavalderia.
9. PREGIIIERA - FINALE SECONDO. Egberto avverte Aroldo che non è Mina che egli deve
punire. Aroldo comprende che il vero colpevole è Godvino; fuori di sé dal furore strappa di mano
la spada ad Egberto e si slancia furente contro il seduttore. D'improvviso dal tempio si ode
provenire, accompagnato dall'organo, un canto religioso che invita al perdono (Non punirmi,
Signor, nel tuo furore). Ad Aroldo cade la spada di mano; in quel mentre lo raggiunge Briano, che
gli rammenta che quei canti sono un richiamo alla pietà. Aroldo come in delirio invoca che l'ira gli
dia tregua e si plachi l'ardore del sangue (Me disperato abbruciano); e disperatamente chiede
d'essere lasciato solo. Mentre riprende il canto dei fedeli nel tempio, Briano, avvicinandosi ad
Aroldo, gli ricorda con solennità il suo giuramento di crociato. Aroldo, confuso e stordito, si lascia
convincere e s'inginocchia per un momento. Poi sorgendo impetuosamente si rivolge a Mina,
negandole il perdono e maledincedola. La donna cade ai suoi piedi. Con forza Briano, indicandogli
la croce, gli ricorda che da essa Gesù perdonò gli uomini. La croce! Aroldo s'avvia barcollando
verso di essa e cade svenuto sui gradini.
ATTO TERZO
Anticamera nella dimora d'Egberto che mette a vari appartamenti. Sopra la tavola è l'occorrente per
scrivere. Una porta a sinistra conduce alla stanza di Aroldo.
10. SCENA ED ARIA. Dopo un tempestoso preludio Egberto entra pensoso e fremente leggendo
uno scritto con il quale Godvino chiede a Mina di seguirlo. Dunque il seduttore cerca di sfuggire
alla vendetta; prende in mano la spada, che gloriosa per tanti anni aveva cinto al fianco, e la getta a
terra come immeritevole di cingerla, gridando al disonore. E che è mai la vita senza onore? Fa per
portarsi al labbro un anello dal quale suggere un veleno mortale; ma s'arresta al pensiero di Aroldo
e della figlia; e scoppia in pianto pensando alla figlia che lo ha coperto di vergogna (Mina, pensai
che un angelo): ella ha così cancellato tutte le gioie che la vita riserva a un padre. Siede commosso
e scrive un biglietto d'estremo addio ad Aroldo. Suggella il foglio, poi riprende l'anello per
suggerne il veleno; ma si arresta al sopraggiungere di Briano che, nel recarsi nella stanza di
Aroldo, lo informa che il fuggitivo Godvino è stato raggiunto e ben presto sarà in questa dimora.
Briano esce. Sorpreso dalla notizia, Egberto esplode in una gioia terribile: il ritorno del seduttore
gli offre ora la possibilità di portare a compimento la sua vendetta (Oh gioia inesprimibile). Esce
precipitosamente a destra.
11. SCENA E DUETTO. Aroldo entra dalla sinistra e, cercando di dominare il furore che gli
sconvolge il cuore, siede in attesa di Godvino. Il seduttore arriva e subito dichiara ad Aroldo di
non opporsi alla sua vendetta. Ma questi gli pone una strana domanda: "Che farebbe se Mina fosse
libera?". Godvino non sa rispondere a una domanda che considera assurda. Aroldo chiama il suo
servo Jorg e gli ordina di far venire Mina; poi obbliga Godvino a entrare in una stanza laterale
perché ascolti non visto il colloquio: così Aroldo saprà se al seduttore sia più cara una colpevole
libertà o l'avvenire della donna, di cui ha macchiato l'onore. Si avanza Mina dalla sinistra con aria
rassegnata. Aroldo l'avvisa che sta per partire. Ella è sorpresa. Le nostre vie devono ormai
percorrere direzioni opposte, le dice Aroldo: egli rassegnandosi, ella stretta all'uomo che ama
(Opposto è il calle). Così dicendo le presenta un foglio con su scritto l'atto di divorzio che egli ha
già firmato. Mina nella massima disperazione implora di non essere cacciata e scoppia a piangere.
Ma per Aroldo le lacrime della sposa non cancellano un disonore cui non sa rassegnarsi.
D'improvviso Mina toglie di mano allo sposo l'atto di divorzio e corre al tavolo a firmarlo; quindi,
nel rendergli il foglio, si dichiara libera: ora Aroldo può ascoltarla. Questi, sbalordito, fa per
partire; ma lei lo arresta: non è allo sposo che intende rivolgersi, bensì al giudice (Non allo sposo,
al giudice). E vedendo che Aroldo insiste nel lasciarla, si getta ai suoi piedi implorando d'essere
giudicata. Sulla lamentosa melodia di un corno inglese, Mina confessa di aver peccato con il cuore;
ma la sua anima è pura; moglie d'altro uomo come potrebbe ella redimersi? e non capisce Aroldo
che ella ama lui e solo lui? Godvino l'ha sedotta, ingannata e tradita. A questo punto Aroldo sente
d'avere il diritto di uccidere il seduttore. Fa per andare verso la stanza, quando sulla porta compare
il vecchio Egberto, con la spada insanguinata in mano, mentre da altra porta sopraggiunge Briano.
Egberto annuncia che Godvino non è più: chi poteva rivelare il disonore, ora è spento. Egberto
esce. Briano invita Aroldo a cercare la pace nel tempio. Sconvolto dalla rapidità degli avvenimenti,
Aroldo acconsente: vuole lasciare la casa maledetta che è stata testimone di disonore e di delitto,
ammonendo che quanto successo rimanga d'esempio ai seduttori perché Dio li fulminerà (Ah sì,
voliamo al tempio); Mina, oppressa dal senso di colpa per un errore involontario che tanta
disgrazia causò, invoca la clemenza di Dio. Aroldo è trascinato altrove da Briano; Mina siede
tramortita.
ATTO QUARTO
Profonda valle in Scozia. La riva del lago Loomond si vede in prospettiva. Monti praticabili a destra e a
sinistra, dov'è un pineto presso cui una modesta casa. Cade il sole.
12. CORO D'INTRODUZIONE. Si odono lontani suoni di cornamuse e di corni che si appressano.
Quindi si sentono dalle montagne voci interne di pastori che salutano il tramonto (Cade il giorno).
Altre voci rispondono da altre parti delle montagne: sono cacciatori. Ancora altre voci da lontano:
sono mietitrici che si recano a valle annunciando la notte. Tutti scendono dalle montagne da
diverse parti e s'incontrano sulla scena ringraziando Dio per una bella giornata come questa (Sulle
roccie più scoscese). A poco a poco tutti escono di scena e le voci si perdono in lontananza.
13. SCENA E PREGHIERA A VOCI SOLE. Briano e Aroldo in eguale costume di Solitari
appaiono da una vetta a destra e scendono avviandosi alla capanna. Guardando dalla parte da cui si
udivano i felici canti Aroldo esprime il proprio tormento. La campana di un vicino villaggio suona
l'Ave Maria invitando alla preghiera. Mentre sta sorgendo la luna, Aroldo e Briano
s'inginocchiano e pregano insieme; al loro canto, privo di accompagnamento, si unisce, proveniente
dal villaggio e dalle montagne, quello del coro in lontananza (Angiol di Dio).
14. BURRASCA. È notte. La luna viene coperta da grosse nubi; si alza un vento impetuoso che
sconvolge il lago; scoppiano fulmini e si rovescia la pioggia. Una barca sta per naufragare, scossa
dall'uragano. Voci lontane gridano "Al lago! Al lago!" Gente accorre da tutte le parti per prestare
soccorso. Mentre l'uragano scoppia in tutta la sua forza, alcuni gettano una fune e tirano con
vigore; altri pregano per la salvezza dei barcaioli. Alla fine, dopo vari sforzi, appare, tirata dalla
fune, una barca mezza infranta, con la vela squarciata: vi sono Mina ed Egberto con due barcaioli.
La tempesta si va calmando, e i due viaggiatori scendono finalmente a terra, mentre la gente canta
lode al Signore per la loro salvezza.
15. SCENA, TERZETTO E QUARTETTO FINALE. Le gente consiglia i due di bussare alla
porta della capanna; vi troveranno ospitalità. Il coro esce di scena. Mina appare affranta. Egberto
la conforta indicando la casa. La donna chiede perdono al padre costretto a fuggire dopo aver per
causa sua ucciso Godvino. Il padre la rincuora e la invita a sedere su di una roccia; poi va a bussare
alla porta per chiedere asilo. Sulla soglia compare Aroldo, che dà il benvenuto all'osp
Scarica