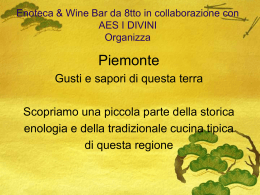Inicio T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:47 PÆgina 1 Inicio T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:47 PÆgina 2 Inicio T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:47 PÆgina 3 14 Revista de la Asociación Complutense de Dantología Año 2013 Inicio T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:47 PÆgina 4 Este número de Tenzone ha sido subvencionado íntegramente por el Departamento de Filología Italiana de la U.C.M. Números anteriores se encuentran disponibles en http://www.ucm.es/info/italiano/acd/tenzone/index.htm DIRECTORES: Carlos López Cortezo ([email protected]) Rosario Scrimieri Martín ([email protected]) Juan Varela-Portas de Orduña ([email protected]) SECRETARIA DE REDACCIÓN: Rosa Affatato ([email protected]) COMITÉ DE REDACCIÓN: Rossend Arqués (Universitat Autònoma de Barcelona): rossend_arques @yahoo.es Guido Cappelli (Universidad de Cáceres): [email protected] Raffaele Pinto (Universitat de Barcelona): [email protected] Fernando Molina (Universidad de Sevilla): [email protected] Violeta Díaz-Corralejo (Asociación Complutense de Dantología): [email protected] COMITÉ CIENTÍFICO: Cristina Barbolani (UCM), Enrico Fenzi (Génova), Ángel García Galiano (UCM), María Hernández (UCM), Natascia Tonelli (Univ. Siena). TENZONE DEPÓSITO LEGAL: M- 39482-2000; ISSN: 1576-9216 2013, nº 14 Revista anual de la Asociación Complutense de Dantología Departamento de Filología Italiana Facultad de Filología. Ciudad Universitaria 28040 Madrid Teléfono: +34 91 3945405; Fax: +34 91 3945402 Inicio T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:47 PÆgina 5 SUMARIO PRESENTACIÓN .................................................................................. 7 UMBERTO CARPI ‘Inferno’ XXXII ................................................................................ 11 MARIANO PÉRZ CARRASCO La metamorfosis de Dante como un nuevo Orfeo (‘Convivio’ II I 3) .................................................................................................. 37 CLAUDIA DI FONZO Dal ‘Convivio’ alla ‘Monarchia’ per il tramite del ‘De officiis’ di Cicerone: l’imprescindibile paradigma ciceroniano ................... 71 PIER ANGELO PEROTTI Sul valore simbolico di Virgilio nella ‘Divina commedia’ .............. 123 LUIGI PEIRONE Dal Limbo teologico al Limbo figurale di Dante ............................. 147 GIUSEPPE CIAVORELLA ‘Purgatorio’ XXXIII: profezia, missione e purificazione ................. 159 MARIANNA VILLA Tra ‘ferite’, ‘rotture’ e ‘piaghe’: percorsi e convergenze nella ‘Commedia’ ................................................................................. 205 QUAESTIONARIO DE TENZONE ............................................................. 233 NORMAS DE PUBLICACIÓN ................................................................... 239 SOBRE TENZONE ................................................................................. 243 Inicio T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:47 PÆgina 6 Presentaci n T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:47 PÆgina 7 PRESENTACIÓN Ma Virgilio n’avea lasciati scemi / di sé... Purgatorio XXX, 49 Este número 14 de Tenzone (2013) se ha convertido, desgraciadamente, en un número muy especial para todos los que componemos su Consejo de Redacción, así como para los miembros del Grupo Tenzone. El pasado 29 de julio, en un sereno, lúcido, afectuosísimo, y se puede imaginar cómo de emocionante, mensaje de despedida, redactado diez días antes de su deceso, nuestro querido amigo y maestro Umberto Carpi (Paci) nos dejaba como un último regalo –de los muchos que su sabiduría y su gran humanidad nos habían hecho en los años de compañerismo y estudios compartidos– la voluntad de que su última intervención pública, la lectura Dantis del canto XXXII del Inferno pronunciada en Bolonia el 13 de mayo de 2013, fuese publicada en nuestra revista. Nos faltan las palabras para expresar los hondos sentimientos que nos provoca esta generosa muestra de cariño, reconocimiento y cercanía intelectual por parte de quien ha sido para nosotros al tiempo luz y báculo, viento a favor y refugio. Por ello, nada mejor para expresar nuestro dolor por su muerte que el lamento de Dante por la desaparición repentina de quien hasta entonces había sido su compañero inseparable y su guía, que encabeza estas líneas. Paci –como quería que le llamasen sus amigos– no solo fue miembro entrañable del Grupo Tenzone desde su primer ludoconvegno de Galicia, sino que él mismo organizó con gran entusiasmo otros tres en diversas localidades de su querido Alto Adige. Fue sin duda uno de los más fervientes animadores del Grupo hasta el final de sus días. Si su muerte nos 7 Presentaci n T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:47 PÆgina 8 ha privado de su enriquecedora presencia y de su asombrosa mente privilegiada, sin embargo nunca podrá borrar en nosotros la huella profunda de su amistad y del ejemplo humano que nos ha legado. No es necesario insistir sobre las altas cualidades de Umberto Carpi, como persona, como investigador y universitario, y como hombre entregado a la acción política. Como investigador de la obra de Dante sus aportaciones sobre el momento histórico en que se desenvolvió este autor son imprescindibles para anclar en el espacio y en el tiempo las composiciones dantianas, para ayudar a percibir cómo en ellas se filtran las vicisitudes y las luchas políticas en que se movió y participó Dante, sobre todo durante el convulso periodo del exilio. Así, por ejemplo, vemos en su último trabajo dedicado a Le dolci rime cómo precisa el concepto de nobleza en Dante diferenciando el momento en que la canción fue escrita –en el cual la concepción dantianas de la nobleza está totalmente inserta en la lógica cultural, mercantil y política del Comune–, del momento en que Dante retorna a ella en el comentario del Convivio, diez años después –en el cual la nobleza se define y se somete a la lógica del modelo imperial, una vez que «la experiencia de un mundo carente de guía hace surgir en él un “pesimismo propositivo”, concretado en la necesidad de una jerarquía universal». No pudo estar presente, sin embargo, en el último encuentro del Grupo Tenzone dedicado a la canción Io sento sì d’amor la gran possanza, que se celebró, organizado por él mismo, el pasado mes de julio en su tierra de origen. Pero su presencia era innegable no solo por la belleza de su tierra alpina sino sobre todo por el contenido mismo de la canción, en la que una de las claves de interpretación quedaba esclarecida a través de su excelente libro La nobiltà di Dante, cuando en el capítulo primero habla del destino de la clase de los “caballeros” en la Florencia de los años noventa. En esa canción Dante propone un tipo de vida que es síntesis entre vida activa, acción, y vida contemplativa, el estudio y el amor hacia la filosofía, con la intención de ofrecer un nuevo modelo al hombre dedicado a la actividad pública en el Comune; un modelo que precisamente Umberto Carpi encarnó en su vida de entrega al compromiso político (al «servizio altrui») y de dedicación a la universidad y a la vida académica, al estudio y a la investigación histórico-literaria; un modelo que implica una 8 Presentaci n T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:47 PÆgina 9 gran generosidad, valentía y amor a la verdad. Por este motivo, es un gran honor para el grupo Tenzone haber contado con su apoyo y amistad, su aliento y entusiasmo, y que hasta los últimos momentos de su vida este proyecto fuese para él parte importante de su compromiso cotidiano. El presente número de Tenzone cuenta, pues, como artículo de especial relevancia, con la lectura Dantis del canto XXXII del Inferno llevada a cabo por Umberto Carpi en el marco de la Lectura Dantis Bononiensis (organizada por Emilio Pasquini), en la que Carpi aplica con su habitual rigor y riqueza de detalles el principio metodológico de analizar el texto a la luz de los acontecimientos políticos y sociales a los que alude y que lo condicionan, lo que sirve para proyectar luz sobre algunas de las implicaciones que la mención a ciertos personajes, aparentemente anodina para nosotros, tenía en cambio para un lector contemporáneo de Dante. Acompañan a este trabajo otras aportaciones de gran interés y relieve, comenzando con dos importantes artículos sobre el Convivio: la del profesor Mariano Pérez, de la Universidad de Buenos Aires, que estudia la identificación entre Orfeo y Dante implícita en la obra y sus consecuencias interpretativas, y la de la profesora Claudia di Fonzo, que expone con gran riqueza el trasfondo ciceroniano, especialmente del De officiis, sobre el que se contruye el tratado dantiano. Pier Angelo Perotti propone una exégesis novedosa de la figura de Virgilio, más cercana, según el autor, a una representación del Imperio que a la tradicional identificación con la razón humana. Luigi Peirone analiza el controvertido tema del Limbo dantiano, a la luz, y en contraste, con las recientes revisiones que la doctrina oficial católica sobre el tema ha realizado, marcando la diferencia entre lo que es una construcción literaria y una noción estrictamente teológica. Giuseppe Ciavorella presenta una minuciosa lectura del canto XXXIII del Purgatorio, que incide agudamente en la relación, no necesariamente pacífica, entre la purificación dantiana, que tiene un necesario componente de olvido, con su misión de poeta-profeta que debe recordar y narrar lo visto en el más allá. Marianna Villa hace un provechoso recorrido sobre algunas nociones clave pertenecientes al campo semántico de la “herida”, que nos enfrentan a la importantísima cuestión del cuerpo como asunto básico de la escatología de la Commedia y del planteamiento 9 Presentaci n T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:47 PÆgina 10 literario y filosófico de Dante. Completa el número una Quaestio textual planteada por Carlos López Cortezo acerca de Convivio III XII 13. Como se puede apreciar, presentamos al lector un nuevo número rico de sugerencias, propuestas, hipótesis, análisis e informaciones que esperamos sirva para seguir aportando al mundo de la dantística el necesario impulso para continuar la tarea que grandes maestros como Umberto Carpi nos han legado. CARLOS LÓPEZ CORTEZO ROSARIO SCRIMIERI MARTÍN JUAN VARELA-PORTAS DE ORDUÑA 10 Carpi T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:48 PÆgina 11 Inferno XXXII UMBERTO CARPI RESUMEN: Esta lectura del canto XXXII del Inferno pone de relieve las connotaciones políticas que los personajes, que se citan aparentemente de pasada, tenían para los lectores contemporáneos de Dante. Siguiendo el principio metodológico de leer los textos dantescos a la luz de los acontecimientos políticos y sociales a los que aluden y que los condicionan seguido en otros análisis, el autor muestra la profunda red de significados que se esconde en el canto, así como su estructura ferrea y “quiásmica”. PALABRAS CLAVE: Inferno, Caina, Antenora, Gianciotto, Alberti di Mangona, Camicione dei Pazzi, Bocca degli Abati, Ugolino. ABSTRACT: The present analysis of Canto XXXII of the Inferno underlines the political connotations that the characters, who are mentioned very briefly, had for the readers living in Dante’s time. The methodological principle guiding the article, as well as other analyses, is the interpretation of Dante’s texts in relation to the political and social events implied in and influencing his texts. The aim of the author is to restore the deep texture of meanings hidden in the Canto as well as its rigid and “chiastic” structure. KEY WORDS: Inferno, Caina, Antenora, Gianciotto, Alberti di Mangona, Camicione dei Pazzi, Bocca degli Abati, Ugolino. 11 Carpi T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:48 PÆgina 12 2013 1. Resteremo per un’ora1 con Dante nel gelo di Cocito, e più precisamente nella gelatina delle due zone di Caina e d’Antenora che precedono le altre di Tolomea (XXXIII) e di Giudecca (XXXIV). Ricordo questa successione perché, in realtà, i tre canti conclusivi dell’Inferno andrebbero attraversati insieme, continuativamente, come imporrebbe il compatto segmento narrativo da essi costituito: lo stesso che al centro della cantica, col blocco dei quattro canti del sabbione sotto la pioggia di fuoco (nelle cantiche successive i casi dei canti di Sordello e di Cacciaguida, per non dire del grande, particolare blocco dei canti dell’Eden, tutti poco indicati per questo tipo di lecturae, che diventano forzatamente interruptae). Vistosissima qui in tal senso, del resto, quella sorta di macro-inarcatura appunto narrativa, voglio dire l’episodio del conte Ugolino e del vescovo Ruggieri, eccezionalmente dislocato a cavallo dei due canti, che salda il nostro trentaduesimo al trentatreesimo nella medesima continuità indivisibile della distesa di ghiaccio, in cui nessun segno separa le diverse zone: «dimmi ’l perché, diss’io …», domanda Dante chiudendo il XXXII. «La bocca sollevò dal fiero pasto ... poi cominciò», risponde Ugolino aprendo il XXXIII. Distesa di sabbia infuocata, distesa di ghiaccio: in mezzo tra le due fissità (più sopra l’uniforme nevicata di fiamme cui «regola e qualità mai non l’è nova»,2 più sotto l’uniforme specchio di ghiaccio, in entrambe le quali ‒ restando invariati i contrappassi del fuoco e del gelo ‒ la gradazione delle pene è determinata dai dannati stessi, dalle rispettive possibilità di movimento nell’un caso e dalla positura nell’altro); in mezzo, dico, la varia fenomenologia caleidoscopica dei luoghi, dei peccatori, dei tormenti nel ‘cinghio’ di Malebolge e delle sue ‘dieci fosse’, nell’accidentato digradante spazio circolare raggiunto e poi abbandonato alle estremità coi due fantastici voli, prima sulla groppa di Gerione a scender giù alla base della parete di pietra ferrigna, indi nella mano di Anteo fino al fondo del pozzo estremo. Struttura topografica schizzata da Dante, appena deposto dalla ‘fiera pessima’ al piede della ‘stagliata rocca’, in uno di quei luoghi in cui par fare il punto della situazione e orientare il lettore in un percorso nient’af12 Carpi T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:48 PÆgina 13 Umberto CARPI Inferno XXXII fatto labirintico, anzi geometricamente strutturato: «Nel dritto mezzo del campo maligno | vaneggia un pozzo assai largo e profondo, | di cui suo loco dicerò l’ordigno». Sembra quasi essere questo il momento della scrittura in cui si precisa nella sua interezza la topografia generale del basso Inferno nella mente di Dante, il quale peraltro aveva già descritto nel quattordicesimo, ma ancora con qualche residua incertezza, la particolare topografia fluviale d’Averno dal gocciare delle lacrime stillanti dal Veglio di Creta a scorrer giù per i corsi di Acheronte Stige Flegetonte fino a formare nell’estremo fondo lo ‘stagno’ di Cocito, là per la prima volta nominato e annunciato: quelle lacrime, aveva avvertito, fanno Acheronte, Stige e Flegetonta; poi sen van giù per questa stretta doccia, infin, là dove più non si dismonta, fanno Cocito; e qual sia quello stagno tu lo vedrai, però qui non si conta. Qui non si conta, se ne dirà ‘suo loco’: nel mentre che viene definendo la sua pianta dell’Inferno e del tragitto che lo attende, Dante già predispone l’attesa del lettore per quel fantastico luogo terminale. Noi, per l’appunto, giungiamo nel trentaduesimo al preannunciato ‘suo loco’, in cui Dante comincia a ‘contare’ Cocito, a ‘dirne’ l’‘ordigno’. Ordigno straordinario, se si tratta del luogo (il pozzo, il ‘tristo buco’) su cui «pontan tutte l’altre rocce» nella particolare geografia infernale e se insieme si tratta, nella cosmologia tolemaica, del centro dell’universo oltre il quale «più non si dismonta»; dunque straordinaria impresa concettuale e linguistica la descrizione di questo fondo dell’Inferno ove sono dannati i peggiori tra i peccatori («Oh sovra tutte mal creata plebe | che stai nel loco onde parlare è duro», plebe parte infima e spregevole della civitas), tanto repulsivo che Virgilio, perfino nel pregare il certo non delicatissimo gigante Anteo di deporli giù nella ghiaccia, ha dovuto preoccuparsi che non gliene venisse schifo e che ‘non torcesse il grifo’: «mettine giù, e non ten vegna schifo, | dove Cocito la freddura serra». Dunque si capisce come proprio qui al limitare della ghiaccia incontriamo la più alta invocazione 13 Carpi T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:48 PÆgina 14 2013 ad Elicona prima di quella intonata in avvio del Paradiso: là troveremo invocato anche il secondo corno del monte sacro, la suprema assistenza di Apollo; qui Dante si appella solo al corno primo, quello delle Muse state capaci di muovere al suono del flauto le pietre per erigere le mura di Tebe, «sì che dal fatto» ‒ con quell’aiuto ‒ «il dir non sia diverso», cioè che il dettato dei versi corrisponda al concetto, che ‘le rime’ risultino insomma, come si conviene all’argomento, rispondenti ad un realismo comico forte, da stile ‘aspro e chioccio’ sorvegliato dal freno dell’arte, non debole da linguaggio elementare (‘babbo’ e ‘mamma’, analogamente all’insufficienza semantica che sarà in Pd. XXXIII della favella d’un bimbo «che bagni ancor la lingua alla mammella»). Per il centro dell’universo, dove siede il re infernale (vexilla regis prodeunt inferni, ricordiamo), si capisce come Dante dovesse lamentare un’insufficienza del linguaggio ad esprimere pienamente il ‘concetto’, cioè la visione e il suo contenuto di pensiero: ‘concetto’, frequente nel Paradiso soprattutto a significare ‒ come qui ‒ i limiti del linguaggio ad esprimerlo, è infatti apax nell’Inferno. Dove solo Cocito, appunto, assurge a ‘concetto’. Concetto asperrimo se in Cocito ‒ contro ogni ortodossia teologica ‒ Dante ci farà incontrare perfino anime già sprofondate lì in eterno mentre il corpo loro ancora vive in terra: negli altri luoghi, per dire d’un futuro infernale riservato a personaggi viventi nel 1300 della finzione narrativa, l’escamotage delle predizioni ovvero la mera ignoranza del dato biografico come nel caso di Venedico (e figuriamoci se Dante non sapeva che quell’eminente personaggio era morto a Bologna nel 1304-1305, proprio quando lui si trovava nella città felsinea). Cocito è davvero un luogo tutto speciale, dove troveremo raggelate nei modi e nei protagonisti del tradimento ‒ in quel buio pozzo dove regna Satana, autentico rovescio della imperiale reggia luminosa in cui ‘regge’ Dio ‒ attualità di conflitti contingenti nelle domus e nelle città, decadenza dell’epoca in cui nessuno pone più mano alle leggi, svolte storiche universali (Cristo-Chiesa, Cesare-Impero) sotto il segno negativo di Giuda e dei cesaricidi. 14 Carpi T 14:Maquetaci n 1 Umberto CARPI 09/12/2013 11:48 PÆgina 15 Inferno XXXII 2. Ecco dunque Dante che entra nella Caina di Cocito, nella sua distesa in ogni senso agghiacciante: e mi piace avvertire che per Cocito, per ciascuna delle sue quattro zone, per i traditori che le popolano, ancora ci sovvengono le eccellenti voci dell’Enciclopedia Dantesca compilate da uno dei miei maestri pisani, il sempre prezioso Emilio Bigi, che mi è caro aver l’occasione di ricordare qui con riconoscenza e rimpianto. Dell’esistenza di una non precisata Caina il Dante personaggio e i lettori già erano informati fin dal quinto canto, allorché il destino a quel luogo infernale era stato preconizzato da Francesca per l’uccisore suo e di Paolo (non dirò il loro assassino, essendo che tale per Dante, e per la giurisprudenza dell’epoca che ne prevedeva la speciale condanna alla propagginazione, era il sicario, chi uccideva su mandato altrui, dunque non davvero il caso di Gianciotto, tristo eroe d’una schiatta i cui membri, a mazzerare e a far dei denti succhio, solevano provvedere da sé). Ma quella così fatta, precoce evocazione della Caina ha dato molto da discutere: poteva Dante, in avvio della cantica e probabilmente intervenendo sull’antica stesura consegnatagli in Lunigiana dal Frescobaldi (io ho in testa che i versi per i due amanti li abbia scritti e inseriti in Casentino al tempo passionale della montanina, secondo la puntuale ricostruzione di Natascia Tonelli, mentre credo che il catalogo dei lussuriosi ‒ come quello dei megalopsicoi del Limbo ‒ stesse già nei vecchi cartoni recuperati), poteva Dante aver già tanto chiara l’intera strutturazione dell’Inferno cui si accingeva a rimetter mano, però in una prospettiva affatto nuova? E perché mai, comunque, per un delitto passionale o in ogni modo per un atto di giustizia familiare (come allora era sentito dal senso comune e dalla legge e come la stessa Francesca doveva sapere benissimo), una condanna all’improprio cerchio dei traditori? Nella nuda vicenda, a prescindere dalla pietas per gli amorosi desiri (pietas comunque diversissima, quella di Dante, dalla nostra irrimediabilmente post-romantica),3 Gianciotto era se mai il tradito, non il traditore. Violento e tirannicamente spietato quanto si voglia, però traditore no: dunque, nella logica stretta dell’episodio, destinabile piuttosto al sangue bollente di Flegetonte come uomo di sangue e di crucci che non al ghiaccio della Caina.4 15 Carpi T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:48 PÆgina 16 2013 Questi interrogativi hanno assai turbato più d’un critico, al punto da indurne qualcuno ‒ più deciso fra tutti il compianto amico Vittorio Russo (Russo 1966) ‒ a preferire la lezione Caino o Cain (pur attestata da qualche codice): scelta filologicamente respinta dal Petrocchi e insostenibile anche al mio più contenutistico parere. Credo infatti che il richiamo alla Caina per Gianciotto sia un’inserzione successiva alla prima stesura appenninica dei versi per i due amanti; e mi azzardo ad aggiungere che tale inserzione deve esser rampollata nella mente di Dante poco prima dell’approdo alla Caina: poco prima, sia nel senso del percorso come personaggio ormai giunto alle ultime bolge, sia nel senso del percorso come autore che ha ormai disegnato e ha chiara in mente tutta l’architettura infernale. Non dimentichiamo a questo proposito che entrambi i percorsi da Malebolge a Cocito (e poi di seguito i primi canti del Purgatorio almeno fino alla Valletta dei principi) furono bruciati in pochi mesi, verosimilmente a Lucca in area di influenza malaspiniana, dopo la fine di ogni speranza di ritorno concordato a Firenze.5 Pochi mesi di intensa riflessione sulle esperienze di luoghi, di persone, di avvenimenti, le esperienze vissute prima nell’Universitas blancorum in colpevole alleanza coi ghibellini, poi sotto la protezione di signori e feudatari (da Gherardo a Moroello a Guido Salvatico) legati ai ‘neri’ trattativisti; mesi in cui questi cortocircuiti politici e poetici, questi giudizi e questi collegamenti, queste condanne, tutti legati all’‘epoca’ contingente, gli si venivano via via ordinando nel disegno di un ‘sistema’ generale che si sarebbe definito una volta per tutte durante e dopo la vicenda dell’alto Arrigo. L’idea di destinare Gianciotto (ancor vivo nel 1300 della finzione narrativa ma già defunto nel momento della scrittura, sicché per i lettori d’allora la previsione veniva recepita come condanna passata in giudicato), di destinarlo ‒ dico ‒ alla Caina, io credo sia rampollata sull’onda dei duri giudizi politici e morali scagliati di seguito contro la famiglia Malatesta in If. XXVII e in If. XXVIII, rispettivamente nella descrizione della Romagna ‘tirannica’ sciorinata da Dante stesso a Guido di Montefeltro e nell’oscura predizione del mazzeramento dei due fanesi presso Cattolica pronunciata da Pier da Medicina. Nulla di più plausibile che a Dante sia 16 Carpi T 14:Maquetaci n 1 Umberto CARPI 09/12/2013 11:48 PÆgina 17 Inferno XXXII venuto in mente di coinvolgere nella condanna della famiglia riminese, oltre a Malatesta il Vecchio e al primogenito Malatestino, anche Gianciotto come traditore dei parenti, assassino infatti del fratello Paolo perché da esso lo divideva in Romagna un’aspra contesa per il dominio della contea di Ghiaggiolo e, nel Pesarese, della stessa Fano dei mazzerati. Paolo, si sa, nel 1285 aveva abbandonato anzitempo Firenze dov’era Capitano del Popolo proprio per urgenti questioni di famiglia: poco dopo risultava sinistramente dai documenti come ‘quondam Paolus’ (da notare che nel 1286 Gianciotto è già risposato!).6 Nella celebre sentenza di Francesca ‒ «Amor condusse noi ad una morte, | Caina attende chi a vita ci spense» ‒ si avverte il giudizio di Dante: secco, quasi violento suona il contrasto fra peccato d’amore fuor d’orto di ragione che trascina giù nella bufera i due amanti e la condanna a Caina per odio fraterno (odio nella Caina sempre connotato da interessi di potere, economico-ereditarî o politici). Noi andammo insieme, ad una morte, per amore e dunque la schiera di Didone; chi ci uccise (come fosse sottinteso un ‘Gianciotto invece …’) lo fece per tradimento familiar-politico, e dunque per lui la Caina come per i fratelli Alberti: ma questo è un giudizio di Dante per bocca di Francesca, di un Dante cui adesso ‒ alle soglie della Caina ‒ preme inquadrare il dramma privato da cui era stata insanguinata la domus malatestiana (le cui conseguenze ereditarie noi intravvediamo registrate dal testamento di Malatesta il Vecchio) nel contesto dei delitti politici di quei pessimi fra i tiranni di Romagna.7 La Caina, e lo stesso vale per Antenora e Tolomea, è fittamente popolata ‒ come già Malebolge ‒ da personaggi del tipo Gianciotto, tristissimi protagonisti negli avvenimenti ovvero nei luoghi, insomma nella intricata microconflittualità senza pace della recente, diretta esperienza dantesca o della storia che la ha malauguratamente preparata a partire dal momento in cui in Italia Federico imperatore aveva cominciato a subire ‘briga’, il comune di Firenze a stampare il micidiale fiorino, la Romagna a perdere cortesia, le feudalità appenniniche a sfaldarsi. Le negative contingenze dell’epoca hanno cominciato a trovare la loro ragione nella crisi storica di un sistema univer17 Carpi T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:48 PÆgina 18 2013 sale: rispetto a cui Firenze resta luogo cruciale, però non più il centro di gravitazione del mondo dantesco. 3. Centro di gravitazione ideologico, ormai abbandonata l’ideologia comunale e di pars ecclesie di matrice brunettiana ancora vigente in quei primi canti dell’Inferno d’altronde di precedente impostazione fiorentina, sta infatti progressivamente definendosi l’idea di un universalistico ordine imperiale: verso la cui piena definizione (alla quale Dante perverrà dottrinalmente con il trattato De Monarchia e poeticamente con la figuralità imperiale del Paradiso) sono state tappe fondamentali il quarto trattato del Convivio e la teorizzazione di una lingua aulica nel De vulgari, mentre altre tappe ‒ su quella via ‒ stanno per seguire nel Purgatorio fra sesto canto, valletta principesca, puntualizzazioni di Marco Lombardo, per non dire ‒ fine Inferno e inizio Purgatorio ‒ del corto circuito romano, ad alta allusività imperiale, fra Bruto e Catone. È il momento in cui, fra abbozzo dei due trattati, ultime canzoni e avvio-ripresa dell’Inferno, si viene definendo la nuova poetica dantesca. Nel contingente evenemenziale, invece, centro geografico, politico e culturale (rammentiamo almeno le triangolazioni con Moroello e Cino) è diventato tra 1306 e 1309 il microcosmo malaspiniano: certo, ormai alle spalle il Veneto di Treviso, luoghi di teatro sono anche l’Appennino casentinese e la Romagna, le cui tracce troviamo qui in Cocito pur esse assai evidenti, complementari a quelle lunigianesi. Ma il centro, diciamo così, propulsivo di questa fase è la Lunigiana di Moroello con le sue zone di influenza, Lucca in particolare, non il Casentino dei declinanti Guidi (già divenuto ‘noioso’ nella canzone montanina) e tanto meno la Romagna dei tiranni, già descritta negativamente da Dante stesso a Guido di Montefeltro e destinata al drammatico quadro di decadenza (speculare, sul versante opposto, al degrado feudale e comunale di tutto il corso d’Arno) che verrà fatto dipingere a Guido Del Duca: questo intero segmento avrà non a caso il suo punto di acme nel memorabile elogio della casa Malaspina tessuto in margine alla valletta principesca, ma già impostato nelle sue ragioni 18 Carpi T 14:Maquetaci n 1 Umberto CARPI 09/12/2013 11:48 PÆgina 19 Inferno XXXII essenziali dalla lettera accompagnatoria a Moroello della solita, cruciale canzone montanina; e si badi che le gallerie di personaggi evocati nel quinto e nel sesto della seconda cantica atterranno per lo più alla medesima area ‒ e al medesimo tormentato contesto conflittuale ‒ della platea di dannati al ghiaccio di Cocito, talvolta anzi ne completeranno la ‘narrazione’, come nel caso del conte Orso degli Alberti. Perché, anche quando fra 1307 e 1308 (nell’imminenza della stesura di questi canti) la sconfitta di Corso avrà fatto tramontare ogni speranza di rientro concordato in Firenze, l’ambiente di Dante resterà quello malaspiniano, una corte dove ha ritrovato definitivamente ‒ dopo la già positiva esperienza presso Gherardo da Camino ‒ quei mezzi economici, quel ruolo sociale, quel prestigio intellettuale, insomma quella sicurezza e quel nuovo radicamento fuori di Firenze che né la compagnia malvagia e scempia dell’Universitas blancorum, né i ghibellini feudali come i Romena e i Porciano appenninici o i Pazzi valdarnesi (tutti sulla via della rovina e tutti dannatissimi in Inferno con gran disprezzo, falsatori-brutti porci-traditori) avevano voluto e soprattutto potuto assicurargli . Ho mostrato altrove come le vicende sardo-genovesi evocate nella Tolomea di Branca Doria (già affiorate nel fitto dialogar sardo di frate Gomita e di Michele Zanche ‒ dei Malaspina parente stretto8 ‒ al bollore della pece, più avanti implicitamente alluse nella valletta purgatoriale con l’enfatizzazione dello stretto legame fra Corrado Malaspina e il Nino Visconti pisano-gallurese nonché padre della Giovanna ereditiera del conteso giudicato di Gallura); e ho mostrato come gli stessi anatemi contro Pisa e Genova scagliati rispettivamente in Caina e in Tolomea a seguito delle tremende condanne di Ugolino-Ruggieri e del suddetto Doria, anatemi contro le due città marinare altrimenti di per sé irrelati e abbastanza gratuitamente declamatorî, compongano in effetti un quadro coerente solo se ricomposti nell’ottica del punto di vista malaspinese, cioè degli interessi sardi e liguri sostenuti dalla domus di Lunigiana in un conflitto ereditario di portata europea in cui, con essi Malaspina, erano coinvolti Catalogna, Genova, Pisa, Firenze, gli Este, tutti con le rispettive alleanze 19 Carpi T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:48 PÆgina 20 2013 internazionali. E per l’appunto i Malaspina erano in fierissime contese e con Pisa e con Genova. Oggi così marginale, la Lunigiana e i suoi signori feudali ‒ ancorché potenza minore, come tale collocata nel basso della piramide principesca ‒ al tempo della dimora di Dante detenevano un ruolo significativo sia nelle vicende di Toscana (sull’asse di Pistoia e Lucca in particolare), sia nei conflitti intorno alla Sardegna allora strategicamente cruciale nel Mediterraneo: organico come fu a quel casato e a quei luoghi, Dante non poté non risentirne in tutta una fase di scrittura della Commedia, diciamo dalla calata in Malebolge (dopo aver chiuso i conti con Firenze guelfa nel sabbione ardente fra Brunetto, i tre nobili fiorentini, i banchieri-usurai, una vera climax del distacco e delle sue ragioni), fino alla valletta principesca, fino alla soglia del portone purgatoriale. Cioè prima di prender congedo da quella Tuscia da quella Romandiola da quella Lombardia, per mettersi sulla strada di Francia, quando la calata di Enrico VII e la nuova fase politica che essa avrebbe aperto erano ancora di là da venire e affatto imprevedibili. Difficile, per i lettori moderni che noi siamo, districarci tra le folle di dannati e di purganti, in questa fase di scrittura così strettamente, direi quasi agonisticamente segnata dalla partecipazione alle vicende presenti e dalla riflessione sulla storia recente post-Hohenstaufen, senza dipanare il filo aggrovigliato del percorso dantesco tra le sue venture biografico-politiche, senza distendere il filo logico dell’evolversi di una nuova poetica e di una nuova ideologia, seguendo episodio dopo episodio, personaggio dopo personaggio la scrittura militante della Commedia. 4. Chiedo venia per questa troppo lunga digressione, ma non riesco a leggere senza aver almeno tentato di orientarmi per quanto possibile nel dove, nel quando, nel perché della scrittura: ricordo ancora una volta la fondamentale osservazione di Foscolo, alle origini del moderno dantismo, esser Dante un poeta al quale l’accumulo di informazioni storiche non solo non nuoce inaridendo, ma anzi serve ad una più intensa percezione della forza poetica. E si capisce, perché quella che Luigi Russo chiamava 20 Carpi T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:48 PÆgina 21 Inferno XXXII Umberto CARPI la politicità trascendentale di ogni poesia, in realtà nella Commedia trascendentale non è, bensì affatto immanente: sicché l’assenza di notizie su un personaggio o su un episodio ne impedisce il pieno apprezzamento, vedi il caso di Pier da Medicina tra i seminatori di discordia o, qui in Caina, di Sassol Mascheroni: Dante stesso suggerisce (là per consuetudine personale, qui per fama toscana [«se tosco se’, ben sai omai chi fu»]) la rilevanza di senso in questi personaggi, rilevanza immediatamente percepibile dai lettori o uditori ‒ diciamo così ‒ in diretta, e però qualche volta interdetta non solo a noi ma ‒ per svanire della memoria ‒ già alle generazioni subito successive. Lo stesso sale delle parole di un Ciacco o di un Marco Lombardo avrebbe ancor più intenso sapore se qualcosa di certo e non solo di favolistico sapessimo intorno a queste due personalità storiche e dunque alle ragioni della scelta di Dante: il quale, suo loco, ci avvertirà (di fatto avvalorando in re il criterio foscoliano) che i dannati i purganti i beati via via fatti incontrare a lui personaggio (vale a dire prescelti da lui autore) rispondono per chiara fama a un criterio di efficacia parenetica; dunque per conseguenza, venendo meno o sbiadendosi la loro fama, se ne annullerà o attenuerà l’intrinseca pregnanza parenetico-poetica: Però ti son mostrate in queste rote, nel monte e ne la valle dolorosa pur l’anime che son di fama note, che l’animo di quel ch’ode, non posa né ferma fede per essempro ch’aia la sua radice incognita e ascosa, né per altro argomento che non paia» Pd. XVII, 136-142 Abbiamo visto come da tempo, e per ben due volte, Dante sia stato avvertito che il suo viaggio sarebbe terminato («là dove più non si dismonta») in un certo luogo detto Cocito. Ora il momento è giunto e lo stagno collettore degli altri fiumi raggiunto, però Dante personaggio ‒ mentre l’autore ha appena invocato le Muse per dire e contare quel luogo cosmologicamente cardinale ‒ non se ne rende ancora conto, si attarda a 21 Carpi T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:48 PÆgina 22 2013 riguardare indietro la parete da cui l’aveva calato Anteo («io mirava ancora a l’alto muro»). A riscuoterlo e a richiamarne l’attenzione, improvvisa, una voce di protesta («Guarda come passi»), l’invito a non calpestare «le teste de’ fratei miseri lassi». Una protesta, dunque, che gli viene su di tra i piedi e che richiama Dante, prima di guardar donde venisse quella voce, ad osservare attentamente dove egli stesso si trovi, insomma a guardarsi intorno e a cominciar a ‘dire’ e a ‘contare’ l’ordigno: un lago ghiacciato come avesse consistenza di vetro, e vetro tanto spesso da non incrinarsi nemmeno agli orli quand’anche vi fossero caduti sopra ‘Tambernicchi o Pietrapana’, cioè i monti di Tambura (lo Stamberlicchi individuato dal Torraca negli antichi testi, non mai le stravaganti vette di Schiavonia da altri escogitate) e della Pania, denotanti le Alpi Apuane: quale connotazione orografica più pertinente, tra Magra e Serchio, in un contesto di scrittura (e di ascolto) lunigianese-lucchese? E avverto che io condivido in pieno l’opinione di chi pensa che, prima della diramazionepubblicazione definitiva della cantica, già in corso di scrittura, Dante leggesse o desse via via da leggere qualche canto nei microcontesti di residenza, classico il caso dei versi ‒ come ho mostrato altrove ‒ per Paolo e Francesca in un contesto appenninico-guidesco a stretta parentela coi discendenti di Paolo. Il che comportava ‒ molti i casi in Malebolge ‒ ambientazioni, come qui il richiamo orografico alle Apuane, immediatamente percepibili dai contingenti, potenziali uditorii: allora non si davano servizi fotografici e neppure viaggi pittorici, ma solo dirette (per lo più locali) esperienze visive, ovvero una favolosa toponomastica cólta di celebri luoghi remoti, qui gli idronimi del Danubio/Danoia in Österreich/Osterlicchi ovvero del Don/Tanai sotto il freddo cielo del Nord. Questa medesima orografia apuana, del resto, se non impostata, Dante l’aveva accennata già nel ventesimo canto, fra gli indovini, dicendo dell’Aronte attergantesi al ventre di Tiresia. Aronte antico indovino etrusco, personaggio lucanéo, in Pharsalia (I, 580-587) Dante lo trova collocato fra le mura di Lucca: Arruns incoluit desertae moenia Lucae; ma noi a nostra volta, in Dante, lo troviamo spostato appunto sulle Apuane sopra Car22 Carpi T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:48 PÆgina 23 Umberto CARPI Inferno XXXII rara, con una circostanziata e pittoresca ambientazione che sembra scritta non solo avendola il poeta sotto gli occhi, ma anche per un pubblico che la conosceva bene: Aronta è quel ch’al ventre li s’atterga, che ne’ monti di Luni, dove ronca lo Carrarese che di sotto alberga, ebbe tra bianchi marmi la spelonca per sua dimora … Luni, Carrara, le cave di marmo: pertinenze tutte denotanti, con la medesima Lucca ben presente in Malebolge, Lunigiana malespinese e sua area di influenza.9 Dunque, Dante sta contemplando la distesa della Caina. Ad affiorare, nella distesa di questa prima zona di Cocito, un affollato ammonticchiarsi (stretti l’uno all’altro i due Alberti, Sassol Mascheroni ingombrante col capo la vista di Camicione, Ugolino riverso sulla nuca di Ruggieri …), dico un ammonticchiarsi di facce rese paonazze e sfigurate dal gelo (Camicione senza più orecchie «per la freddura»), rivolte verso il basso, dunque col vantaggio di poter lacrimando liberare il dolore, sollievo interdetto nella Tolomea, dove invece i volti rivolti all’insù fanno sì che le lacrime formino nel cavo orbitale ‒ ad aumentar la pena per manco di sfogo ‒ un crudele blocco di ghiaccio, la sofferenza di Alberigo dagli occhi invetriati ‒ ricordiamo ‒ e lo spietato comportamento di Dante. Già nella pece bollente dei barattieri abbiamo visto i dannati metter fuori il muso come rane, cercando di eludere il controllo dei diavoli; e come rane, ma sbattendo le mascelle a guisa delle cicogne col becco, anche qui in Caina i dannati-rana hanno il corpo sommerso e il capo fuori dal collo in su, però con un’assoluta immobilità nel ghiaccio, l’opposto del frenetico guizzare sopra e sotto delle rane impeciate. Dispute serratissime nel secolare commento, e non meno nel recente, intorno al rapporto fra diverse positure dei vari ficcati in gelatina (soprattutto delle ‘festuche in vetro’ della Giudecca), natura dei rispettivi tradimenti, gradazione della pena: ma tutto sommato 23 Carpi T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:48 PÆgina 24 2013 scarso il costrutto; e comunque inutile riassumere quanto il Bigi ha debitamente ricostruito e commentato nelle schede già rammentate. Vano cercar di integrare il testo dantesco quasi burocratizzandolo con una giustapposta regolamentazione delle colpe e delle pene, di fargli precisare quel che non precisa e che precisare non vuole: significherà pur qualcosa che a nessuna delle festuche di Giudecca Dante abbia voluto dare un nome e neppure esplicitarne la tipologia del tradimento (traditori dei benefattori? ovvero dei ‘due soli’, cioè della Chiesa e dell’Impero?); significherà qualcosa che i confini delle zone di Cocito ‒ a differenza della puntigliosa determinazione e separazione delle fosse di Malebolge ‒ restino tanto indeterminati da far aprire accanite discussioni sulla posizione stessa di Ugolino e di Ruggieri rispetto al confine fra Antenora e Tolomea, magari addirittura il primo di qua e l’altro di là. Né i traditori supremi, Giuda traditore di Cristo, Cassio e Bruto traditori di Cesare, stanno ficcati nel gelo generato dallo sbatter d’ali di Lucifero, bensì vengono fatti stritolare dalle sue fauci: come sottratti ‒ loro colpevoli di così eccezionali, non privati o locali bensì storicamente epocali tradimenti ‒ ad una lastra di ghiaccio uniforme e in sostanza uniformante al punto di ridurre i suoi estremi prigionieri a mere linee di festuca senza nome né riferimento alcuno, ben oltre la pena di irriconoscibilità personale ‒ ma non di stemma familiare ‒ irrogata agli ultimi, immobili ustionati dalla pioggia di fuoco. Alla fine, eccettuati quelli del Cristo e del Cesare peraltro fuor di gelatina, i traditori sono difficilmente graduabili, la loro è una colpa che non animalizza ma disanima e devitalizza già in vita, rendendo come di ghiaccio: e la lastra ghiacciata, il contrappasso, è per sua natura uguale in ogni punto a se stessa. Come in Paradiso sarà difficile dire il concetto delle intensificazioni di luce e del movimento di bagliori fino alla visione dell’imperatore celeste, qui al polo opposto la difficoltà sta nello spremere il concetto del gelato buio che si addensa intorno a «lo ’mperador del doloroso regno», di ‘contare’ la «sovra tutte mal creata plebe» sprofondata «nel pozzo scuro», cioè ‒ come volevo arrivar a concludere ‒ «nel loco onde parlare è duro». 24 Carpi T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:48 PÆgina 25 Umberto CARPI Inferno XXXII Ben duro, se proprio lì si poneva a Dante un serio problema, diciamo così, di storicizzazione dell’Inferno, e non tanto fra Inferno pagano e Inferno cristiano, quanto in relazione a due rotture decisive nella storia di Roma: Cesare, il suo assassinio da parte di Bruto e Cassio, l’Impero; Cristo, il tradimento di Giuda, la Chiesa. Quando Virgilio, auspice la effera, la impia, la tristis, la ‘stigia’ Erictho (altro che Maria e Lucia e Beatrice e il loro paradisiaco, cortese invito al poeta mantovano!), era stato invitato ad effettuare la sua prima discesa in Cocito e più precisamente in (quella che poi sarebbe stata la) Giudecca, tra le fauci di Lucifero aveva ben potuto vedere Bruto e Cassio da poco approdativi, non ancora Giuda. Virgilio testimone d’un assetto di Cocito (cioè di un decisivo processo storico, Impero e Chiesa) in fieri?10 5. Dicere udi’mi: «Guarda come passi; va sì, che tu non calchi con le piante le teste de’ fratei miseri lassi». Per ch’io mi volsi, e vidimi davante… Dante dunque si sente apostrofare, si volge, gira intorno lo sguardo a rendersi conto del luogo, poi si guarda ai piedi donde gli è giunta la voce: e chi vede? «Quand’io m’ebbi dintorno alquanto visto, | volsimi a’ piedi, e vidi due sì stretti, | che ’l pel del capo avieno insieme misto»: Dante apprenderà subito, non da loro ma da Camicione, trattarsi dei due fratelli Alberti di Mangona. Ma chi aveva parlato in nome dei «fratei miseri lassi»? I commenti più recenti ed autorevoli attribuiscono la voce ad un quisque dannato de illo populo, col senso ‒ per esempio Pasquini-Quaglio, ma così anche Sapegno e Bosco-Reggio ‒ di ‘noi peccatori, che pure siamo stati uomini come te, ossia tuoi fratelli’; io invece trovo più lineare (ancorché facilior) intendere che Dante, volgendosi a guardare ai propri piedi, dove aveva calpestato e donde era stato apostrofato, veda chi gli si era rivolto, cioè i due Alberti appunto «fratei miseri lassi», dunque col senso ‒ come per esempio Casini ‒ di ‘noi che nel mondo fummo fratelli’, 25 Carpi T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:48 PÆgina 26 2013 e tanto strettamente avviticchiati l’un l’altro che calpestando una testa le si calpestano entrambe. Apparentemente una minuzia: ma mi pare che l’evocazione d’una qualsivoglia nuance di fratellanza umana per bocca d’uno di questi fraterni uccisori sia incompatibile col tono generale del canto, tutto dominato dall’odio e dalla violenza fino all’esplosione del «bestial segno» di «odio sovra colui che tu ti mangi». E rancore bestiale continua a dividere questi due fratelli, la cui condanna più sofferta non sembra quella al ghiaccio, bensì il dover stare in eterno avvinti: «… ond’ei come due becchi | cozzaro insieme, tanta ira li vinse», dopo esser stati ulteriormente insieme ‘sprangati’ dal congelarsi delle lacrime per aver ‘eretto i visi’ ad osservare Dante. Non sono i due fratelli che si dichiarano, troppo impegnati a cozzare ciecamente fra loro; chi ne rivela l’identità è Camicione dei Pazzi, il quale poi seguita, diffondendosi in una vera e propria, rapida carrellata: da Focaccia a Sassol Mascheroni al congiunto Carlino ancora vivo ma di prossimo approdo a quello stagno (ancorché destinato all’Antenora in quanto traditore della Parte, non nella Caina come alcuni continuano ad equivocare). In questa sede non mi diffonderò particolarmente nell’illustrazione minuta di ciascuno dei personaggi: sia perché lo ho già fatto anni fa nel mio libro La nobiltà di Dante anche col supporto di varî alberi genealogici mirati a mostrare il fitto sistema relazionale sotteso alle selezioni dantesche, e non credo sia il caso di ripetermi; sia perché molte notizie essenziali si trovano già nei commenti antichi e moderni, benché col limite di essere concepite elencativamente, senza cogliere la coerenza dei quadri storici e politici, talvolta anche geograficamente molto circostanziati, cui queste ‘serie’ danno luogo. Appunto sui quadri complessivi mi proverò qui a richiamare brevemente l’attenzione. Di ‘serie’ nel nostro canto trentaduesimo ne incontriamo due: questa di Camicione per la Caina (che si conclude col Carlino pur esso dei Pazzi destinato all’Antenora, quasi ad introdurre la seconda zona di Cocito, alla quale infatti subito di seguito Dante trapassa), l’altra di Bocca degli Abati per i colpevoli di tradimento della patria o della Parte. Camicione, come abbiamo già accennato, appartiene alla famiglia dei Pazzi dell’alto Val26 Carpi T 14:Maquetaci n 1 Umberto CARPI 09/12/2013 11:48 PÆgina 27 Inferno XXXII darno, infeudata alla maggiore schiatta dei Guidi, insieme ai quali (in particolare, si badi bene, ai Guidi di Romena) legatissima, anzi per decenni egemone, sia nella ghibellina Arezzo prima e dopo Montaperti, sia in Casentino (proprietà dei Pazzi il castello di Gargonza primo convegno ‘bianco’-ghibellino, dei Guidi di Porciano il palazzo di San Godenzo sede del secondo, in entrambi attivamente presente Dante). Un Pazzi lo abbiamo già incontrato in Flegetonte, quel Rinieri accoppiato con l’omonimo da Corneto pur esso casentinese e padre di Uguccione, entrambi della generazione precedente a quella di Dante e per nulla affatto predoni di strada se non nella propaganda di Firenze guelfa, anzi feudatari potenti, il Rinier Pazzo addirittura vicario imperiale sotto Federico II. Dante sta facendo i conti nell’Inferno con le famiglie feudali di parte ghibellina (oltre ai Pazzi anche i Romena falsatori di moneta, quelle stesse famiglie che a suo tempo, dopo Montaperti, avevano proposto di radere al suolo Firenze, contrastate come sappiamo dal pure ghibellino e però fiorentinissimo Farinata), con quelle più coinvolte nelle agitazioni dei ‘bianchi’ e della compagnia malvagia e scempia da cui ha preso tanto radicalmente le distanze. Di schiatta violenta e tirannica (Ranieri guerreggiatore delle strade), gli odierni Pazzi degradano ad esemplari della crisi che dilania queste famiglie internamente lacerate dagli interessi (Camicione traditore di congiunti) e dei contraddittorî, opportunistici rapporti delle giurisdizioni feudali con una Firenze cui sono sempre più economicamente subalterne (Carlino traditore della Parte in quanto venditore nel 1302 alla città gigliata e battistea dello strategico castello ‘bianco’-ghibellino di Piantravigne per il prezzo dei soliti, fatali fiorini che avevano già perduto l’anima dei Romena). Del tutto contemporanea dunque, e necessariamente intricata nella attualità cronachistica dei microconflitti che dividevano le famiglie (dello stesso ignoto Sassolo sappiamo comunque essere la sua vicenda di dominio pubblico fra i toscani), l’ottica di un tipo come Camicione: ottica breve, ma utile a Dante per uno spaccato della società e del momento storico, dell’ambiente in cui sta vivendo l’esilio. Esemplare il caso dell’appena nominato Focaccia, assassino pistoiese di un parente: ma quante implicazioni, quanti sottintesi in quel semplice nome lì in Lu27 Carpi T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:48 PÆgina 28 2013 nigiana! Vanni dei Cancellieri detto Focaccia, pistoiese ‘bianco’ della città disfatta da Moroello, marito della Selvaggia Vergiolesi amata da Cino … e Cino e Moroello e Dante e la poesia erotica in quel torno di tempo.11 Geograficamente affine la Val di Bisenzio dei fratelli Alberti: ma si potrebbe obiettare trattarsi in questo caso di tragedia consumatasi una generazione innanzi. Tuttavia osservo che la vera e propria saga degli Alberti doveva risuonare ben attuale, se continuata ancora nella generazione successiva con il più giovane Orso (strettamente imparentato coi Guidi), quello salvato nella folla dei morti di morte violenta questuanti ricordo e preghiere in Pg. VI (insieme al cugino Federico Novello dei Guidi di Bagno, fratello della contessa Bianca Giovanna recente destinataria di Doglia mi reca). Un caso minore, ma a sua volta significativo, di equilibri evidentemente da soppesare nel contesto dell’attualità politica e ambientale, delle salvezze riservate a stretti congiunti di grandi dannati: FedericoManfredi, Guido-Buonconte, Ezzelino-Cunizza (non dimentichiamo che, oltre ai Guidi, gli Alberti annoveravano fra i congiunti stretti anche i da Romano, i ghiacciati Napoleone e Alessandro erano cugini primi di Cunizza, essendo quest’ultima figlia di una sorella dell’Alberto Alberti senior, non a caso fatto esplicitamente nominare da Dante come radice di quei due fratelli dei quali secondo Camicione non c’era ombra «degna più d’esser fitta in gelatina» [«la valle onde Bisenzio si dichina | del padre loro Alberto e di lor fue»]). Oggi a noi queste relazioni parentali suonano dettaglio erudito ed estrinseco, ma per Dante e per il suo pubblico esse evocavano vicende dense di significato, uno spaccato storico e una dimensione geografica integrata. Vediamo: Alberto padre dei due cozzanti becchi nella Caina aveva sposato, dando luogo a tal dannata generazione di fratricidi per causa di divisione ereditaria, una Gualdrada Guidi figlia nientemeno che della Gualdrada ‘buona’; la sorella Adelaide di quel medesimo Alberto, e dunque zia dei congelati Alessandro e Napoleone, era a sua volta andata in moglie ad Ezzelino II da Romano, matrimonio onde la beata Cunizza di Paradiso IX e l’Ezzelino III esecrabile tiranno sì in Flegetonte, però poi ‘facella’ nel cielo di Venere secondo le parole messe in bocca appunto a 28 Carpi T 14:Maquetaci n 1 Umberto CARPI 09/12/2013 11:48 PÆgina 29 Inferno XXXII Cunizza da un Dante fattosi nel frattempo filoscaligero e quindi necessariamente più benevolo con la tradizione dei da Romano di quanto fosse stato nella temperie ancora molto filoguelfa di Inferno XII (non dimentichiamo che per l’antiscaligero Mussato il parto di Adelaide nata Alberti aveva invece avuto natura dibolica). Cunizza beata ed Ezzelino tiranno o facella erano insomma cugini primi dei due Alberti e, tutti insieme, erano anche di ‘radice’ Guidi. I nomi fatti rivelare a Camicione evocano dunque una larga vicenda sistematica di crisi e di delitti familiari, generazione per generazione dalla Tuscia all’Appennino alla ‘terra prava’ rigata da Brenta Piave Tagliamento Adige. Questo Camicione dei Pazzi è un bel tipo di sfrontato senza peli sulla lingua, cui nulla sembra importare delle male notizie che Dante riporterà di lui e della sua schiatta: alla fine taglia bruscamente corto, toglie a Dante perfino il disturbo di chiedergli l’identità, «e perché non mi metti in più sermoni, / sappi ch’i’ fu’ il Camiscion de’ Pazzi; / e aspetto Carlin che mi scagioni». Su questo annuncio finisce Caina e comincia Antenora, ma Dante non se ne accorge finché, passeggiando fra le teste, non ne scalcia un’altra come gli era capitato con quelle degli Alberti, la testa cioè che Buoso da Dovera rivelerà essere di Bocca degli Abati, come del resto Dante aveva subito intuito dopo averle sentito paventare ‒ quasi estroversione d’un incubo ‒ la ‘vendetta di Montaperti’. Superfluo riassumere di nuovo qui il celebre episodio di Dante che, preso da sospetto, dischioma crudelmente il dannato per fargli confessare la sua identità: interessante invece chiederci come mai Dante, ad un’altezza dell’Inferno in cui ormai non urge più la rivendicazione fortemente guelfa ancora determinante nell’episodio di Farinata in cui pure Montaperti e l’Arbia colorata in rosso erano stati evocati come incancellabile responsabilità ghibellina, si scagli con tanta violenza contro il traditore decisivo nell’esito di quella giornata fatale. Bocca, di una famiglia Abati tradizionalmente ghibellina e legata al casato Uberti, quel giorno fatale aveva abbandonato le schiere guelfe di Firenze per raggiungere i ghibellini fuorusciti di Farinata schierati coi senesi di Provenzano Salvani e coi cavalieri tedeschi di Manfredi; in seguito aveva collaborato in Firenze col 29 Carpi T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:48 PÆgina 30 2013 regime ghibellino guidato da Guido Novello dei Guidi e dal medesimo Farinata. Un traditore dunque della patria assai più che della Parte (come invece il Gianni Soldanieri traditore dei guelfi a danno dei ghibellini nella caduta di quel medesimo regime ghibellino); e può pure darsi che Dante a quel punto volesse anche infamare il nome dei Soldanieri nel frattempo schieratisi con la pars guelfa di color ‘bianco’ e dunque numerosissimi nella compagnia malvagia e scempia dell’Universitas blancorum rimasta legata, a differenza di Dante clamorosamente ‘pentitosi’ fin da Tre donne, ai ghibellini fuorusciti e in particolare agli Uberti discendenti di Farinata. Comunque, nell’antica coscienza di parte del Dante fiorentino degli Alighieri combattenti a Montaperti quel tradimento doveva essere rimasto indelebile al di là di ogni successiva vicenda e convenienza. Bocca è tradito qui, cioè svelato nella sua identità, dal cremonese Buoso da Dovara traditore di Manfredi per danaro francese (con il concorso di un altro celebre dannato dantesco, Guido di Montfort, se è vero quanto narra Benvenuto, «uxor Caroli veniens cum Guidone de Monforte portabat secum magnam pecuniam, cum qua venenavit avaram mentem Bosii»); di Manfredi, Buoso aveva di conseguenza abbandonato il campo, lasciando libero il passaggio all’esercito di Carlo d’Angiò: Buoso (tanto peggior traditore della discendenza di Federico in quanto amico stretto di re Enzo) a sua volta svelato per ritorsione dallo stesso Bocca, che insieme elenca altri grandi traditori della medesima generazione precedente a Dante, dando luogo ad un quadro storico dell’epoca di conflitti apertasi in Tuscia e in Romandiola col declino degli Hohenstaufen: il pavese Tesauro dei Beccaria che aveva tramato col cardinale Ubaldini ‒ il Cardinale per antonomasia di Inferno X ‒ per un ritorno dei ghibellini a Firenze dopo la cacciata di Guido Novello e perciò fatto decapitare (il Beccaria era abate di Sant’Ellero, convento fortificato sulla via di accesso ai possedimenti appunto degli Ubertini, destinato pochi anni dopo nel 1267 a venir disfatto dai francesi che ne squartarono gli occupanti, una pagina nera nella storia guelfa, con ampia risonanza anche letteraria); il già ricordato Soldanieri; Tebaldello degli Zambrasi, il traditore di Faenza nel 1280, giro d’anni drammatico in Romagna tra Pagani Guidi Montefeltro Man30 Carpi T 14:Maquetaci n 1 Umberto CARPI 09/12/2013 11:48 PÆgina 31 Inferno XXXII fredi Malatesta e tutte le altre famiglie feudali o neosignorili coinvolte nel più grande quadro della sostituzione della Chiesa all’Impero per il pieno dominio della regione. In conclusione. Il canto trascorre dalla prima zona di Cocito alla seconda senza soluzione di continuità, con Dante che ‒ alla lettera ‒ ‘passeggia tra le teste’; né narrativamente si chiude, ché anzi termina avviando l’episodio di Ugolino con cui continua il trentatreesimo: però la sua struttura interna, quasi chiastica, è ferrea. Il teatro dei dannati vi si apre con la scena delle due teste degli Alberti fra loro serrate e cozzanti, vi si chiude coi «due ghiacciati in una buca» «sì che l’un capo a l’altro era cappello», rosicante cappello; fra queste due scene-madri poste in apertura della Caina e in chiusura dell’Antenora, i due quadri descritti da Camicione e da Bocca attraverso quelle ricorrenti serie di personaggi apparentemente paratattiche per elencazione e così equivocate aride anche da lettori per altri versi molto fini, in realtà ‒ se le si contestualizza ‒ ad alto tenore di semanticità e sistematicità storico-politica. Il contemporaneo quadro dei traditori di Camicione, l’ormai storico quadro dei traditori di Bocca. Mi fermo qui, lasciando alla sapienza del nostro Pasquini la prossima tappa nel ghiaccio di Cocito, dall’antropofagia di Ugolino fino alle anime già morte in vita di Alberico Manfredi e di Branca Doria. Ma non senza aver notato che la tremenda visione conclusiva di Ugolino riverso e manducante sulla nuca di Ruggieri è, per l’appunto, affatto antropofagia (non già ‘antropologica’, come per curioso ipercorrettismo il proto mi fece dire nella Nobiltà di Dante!): «come pan per fame si manduca, colui che tu ti mangi», Tideo rosicante le tempie di Menalippo. Suggerimento forte per un’interpretazione antropofagica da estendere anche al canto successivo e alla fame che poté più del dolore? Non tocca a me rispondere oggi, però voglio ricordare in conclusione ‒ a proposito di questi intrecci fra res gestae e fabula narrativa e alla loro lunga durata nella memoria storico-letteraria ‒ che quasi un secolo dopo il Sacchetti, alludendo a Gherardesca di Ugolino e a Manentessa di Buonconte spose di due Guidi danteschi (il Guido di Paradiso XVI e Guido Salvatico), le narrerà passeggianti e acre31 Carpi T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:48 PÆgina 32 Tenzone 14 2013 mente disputanti a Certomondo vicino a Poppi, il luogo della battaglia di Campaldino dove Buonconte era morto: La figliuola del conte Ugolino si volse alla compagna e disse: «O madonna tale, guardate quanto è bello questo grano e questo biado dove furono sconfitti i Ghibellini da’ Fiorentini: son certa che il terreno sente ancora di quella grassezza!». Quella di Buonconte subito rispose: «Ben è bello; ma noi potremo morire prima di fame che fosse da mangiare». 32 Carpi T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:48 PÆgina 33 Inferno XXXII Umberto CARPI NOTE Ho letto queste pagine a Bologna il 13 maggio 2013: amici e colleghi mi hanno circondato di un affetto e di un’amicizia che non posso scordare. 1 Come è stata definita in If. VI, terzo cerchio, la «greve pioggia» che «adona» i golosi. 2 Tonelli lega strettamente la ‘montanina’, in un cruciale nodo di poetica, all’episodio di Francesca (Tonelli 2010 e 2012). 3 Tommaso, molto più avanzato della corrente giurisprudenza, sosteneva nella Summa che solo il tribunale civile può mettere a morte l’adultera zelo iustitie, mentre il marito agisce livore vindicte aut odii motus, dunque dismisura di vendetta e d’odio, non tradimento. Altri hanno opinato che il tradimento fosse consistito nel non aver dato loro il tempo di pentirsi, ma la legge pretendeva che l’uccisione avvenisse proprio in actu adulterii! 4 5 Su questo fondamentale snodo biografico-politico rinvio al mio Carpi 2013. Il 1285 è anno tremendo per la Romagna senza più cortesia: oltre ai drammi di casa Malatesta anche l’eccidio perpetrato a Faenza da Alberigo dei Manfredi, punito nella Tolomea. Se teniamo conto che in Antenora troviamo il traditore Tebaldello Zambrasi (fra l’altro padre della Zambrasina così presto succeduta a Francesca, il che è notizia peregrina per noi ma doveva suonare in tutt’altro modo per i contemporanei) possiamo dire che nelle zone di Cocito si distribuisce un quadro politico romagnolo assai fosco e compatto. 6 Accenno di passata alla tesi che vorrebbe Paolo uscito di silenzio per pronunciare la battuta discussa nel testo, e in effetti in bocca a Paolo (ben consapevole del dissidio di interessi col fratello) questo riferimento alla Caina suonerebbe assai naturale. Ma mi pare che tutto il contesto voglia Paolo silenzioso e l’intera narrazione fatta pronunciare a Francesca. 7 Moglie del Corrado purgatoriale fu infatti una Orietta Spinola, che nei primi anni del Trecento testò a favore di una figlia di Michele Zanche (sorella d’un’altra andata in moglie a Branca Doria!) sposatasi con uno Spinola: Dante presso i Malaspina fece una vera immersione nei segreti sardo-pisano-genovesi (aggiungo che un nipote Corradino di questo Corrado era impegnato in un contratto matrimoniale, anche lui!, con la Giovanna di Nino Visconti). Vale la pena ricordare che 8 33 Carpi T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:48 PÆgina 34 2013 questo stesso Corrado, con la figlia Spina, sarà protagonista nel Decamerone della grande novella sesta, seconda giornata. Osservo che la prima bolgia era stata tutta bolognese: Bologna, appunto la stanza dantesca fra 1304 e 1305 prima della nuova stagione a Treviso (così presente nel quarto del Convivio) e poi soprattutto in Lunigiana. Per capire quanto fosse stata – fra ‘bianchi’ infidi alla Antelminelli e minacce filo estensi – stanza sgradevole e quale sgradevolissimo ricordo avesse lasciato, mi pare che il canto diciottesimo dei ruffiani, uno dei più sprezzanti nella Commedia, non lasci dubbi. Ne ho dato ampia lettura in Carpi 2004. 9 Rinvio ad una postilla in calce qualche ulteriore considerazione a tal proposito: sia perché queste considerazioni non furono svolte nella lettura bolognese, che tengo a lasciare nella sua integrità, sia perché portano un po’ lontano dalla specificità del trentaduesimo, i cui confini mi accorgo di aver già fin troppo forzato. 10 [È mancato il tempo a Paci per la promessa «postilla in calce» nei suoi pur operosi, e fino all’ultimo operosi, giorni: meno di tre mesi sono trascorsi da questa Lectura bolognese del 13 maggio 2013 al giorno della sua morte, avvenuta il successivo 8 agosto]. Sullo snodo pistoiese che va da Vanni Fucci a Focaccia va letto Piattoli 1934. 11 34 Carpi T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:48 PÆgina 35 Inferno XXXII Umberto CARPI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI CARPI, U. (2004): La nobiltà di Dante, Firenze, Polistampa. CARPI, U. (2013): L’Inferno dei guelfi e i principi del Purgatorio, Milano, FrancoAngeli. PIATTOLI, R. (1934): «Vanni Fucci e Focaccia dei Cancellieri alla luce di nuovi documenti», Archivio storico della letteratura italian. s. 7, XXI, pp. 100-113. RUSSO, V. (1966): «“Caina” o “Cain attende”?», in ID., Sussidi di esegesi dantesca, Napoli, Liguori, pp. 33-51. TONELLI, N. (2010): «La canzone montanina di Dante Alighieri (Rime 15): nodi problematici di un commento», Per Leggere 19, pp. 7-36. TONELLI, N. (2012): «Amor, da che convien pur ch’io mi doglia», in Dante Alighieri, Le quindici canzoni lette da diversi, II, Lecce, Pensa, 2012, pp. 255-283. 35 Carpi T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:48 PÆgina 36 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:49 PÆgina 37 La metamorfosis de Dante como un nuevo Orfeo (‘Convivio’ II I 3) MARIANO PÉREZ CARRASCO Universidad de Buenos Aires Conicet [email protected] RIASSUNTO: In Convivio II I 3 Dante espone il metodo mediante il quale le sue canzoni filosofiche debbono venire interpretate. Il brano presenta un’allegoria che caratterizza la figura di Orfeo come un «savio uomo» che, grazie al potere delle parole, sarebbe riuscito a fondare l’ordine politico facendo sì che gli uomini abbandonassero la vita selvaggia per condurre una «vita di scienza e d’arte». L’articolo propone un’interpretazione del progetto filosofico-poetico del Convivio che muove da l’identificazione allegorica tra Dante e Orfeo. Dante sarebbe appunto quel «savio uomo» che insegna qual è il vero fine dell’essere umano (la sua ‘nobiltade’), e che, grazie alla sua traduzione della filosofia in volgare rende possibile che tutti gli uomini, anche quelli che per contingenti motivi storici e sociali erano rimasti frustrati nel loro desiderio di sapere, possano ora compiere il proprio fine naturale. La proposta di lettura qui presentata si sviluppa in dialogo con André Pézard, Roger Dragonetti ed Enrico Fenzi. PAROLE CHIAVE: Convivio, filosofia, poesia, allegoria, Orfeo, Pézard, autointerpretazione. 37 PØrez:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:49 PÆgina 38 2013 ABSTRACT: In Convivio II I 3 Dante shows the method by which he will interpret his own philosophical songs. He presents an allegory that identifies Orpheus with «lo savio uomo» who by the strength of his voice would have founded the political order, making men abandon their previous wildlife and adopt a «vita di scienza e d’arte». The article proposes an interpretation of the philosophical-poetic project of the Convivio that defends an allegorical identification between Dante and Orpheus. Dante would be the wise man showing what is the true end of man (his nobiltade) and, thanks to Convivio’s translation of philosophy into vulgar, he makes possible that those men who due to contingent socio-historical reasons were frustrated in their desire to know, could now accomplish their own natural end. Our interpretation is deployed in dialogue with André Pézard, Roger Dragonetti and Enrico Fenzi. KEY WORDS: Convivio, philosophy, poetry, allegory, Orpheus, Pézard, self-interpretation. 1. La interpretación del proyecto filosófico del Convivio defendida en este artículo –a saber, que la alegoría presentada en Cv. II I 3 es una mise en abîme según la cual Dante debe ser alegóricamente identificado como un nuevo Orfeo– tuvo su origen en un malentendido. El malentendido se encuentra en unas palabras marginales de Roger Dragonetti al presentar la teoría del lenguaje poético en el De vulgari eloquentia: «Dans le Convivio (II I 3), Dante, en nouvel Orphée, se donne pour tâche d’offrir une demeure spirituelle aux Italiens en les initiant aux secrets de la parole civilisatrice» (Dragonetti 2006: 45-46). Dragonetti reenvía a una breve nota en la que André Pézard analiza detalladamente el pasaje citado (Pézard 1940a). Pero sucede que, en esa breve nota, Pézard, luego de aclarar algún problema filológico y de reconstruir una amplia panoplia de fuentes directas e indirectas, rechaza explícitamente la identificación alegórica entre Dante y Orfeo, que, sin embargo, había sido sugerida por él mismo en otro ensayo (Pézard 1940b).1 Pézard considera que la función civilizatoria que Dante atribuye a Orfeo es llevada a cabo no por el poeta –a fortiori Dante, como sugería Dragonetti–, sino por el emperador; razón por la 38 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 Mariano PÉREZ CARRASCO 11:49 PÆgina 39 Dante como Orfeo cual, si la alegoría de Orfeo tuviese un referente concreto, ése sería más bien el emperador que el poeta.2 En apoyo de la tesis de Pézard podría señalarse que tanto el Convivio (IV IV-VI) cuanto, sobre todo, la Monarchia (III XV), parecen reservar a la autoridad imperial, junto con la filosófica, la exclusiva función de velar por el cumplimiento del fin último del hombre en esta vida.3 Emperador, filósofo y papa son las tres autoridades que Dante reconoce en estas obras, y no parece haber lugar para una nueva autoridad. Sin embargo, en el Convivio el fin de la vida humana no es determinado ni por el filósofo ni por el emperador, sino por el mismo Dante, el poeta-filósofo que escribe el Convivio.4 En efecto, Dante declara que al escribir Le dolci rime d’amor se propuso «gridare alla gente che per mal cammino andavano, acciò che per diritto calle si dirizzassero», es decir que el objetivo de esta obra consiste en «riducer la gente in diritta via sopra la propia conoscenza della verace nobilitade» (Cv. IV I 9). El error acerca del sentido de la nobleza constituye la «pessima confusione del mondo», pues al pervertir el juicio –i.e., considerar como bien lo que en verdad es un mal– acaba subvertiéndose todo el orden social. Dante, en el cuarto tratado del Convivio, se propone despejar «l’errore dell’umana bontade in quanto in noi è dalla natura seminata e che “nobilitade” chiamare si dee» (Cv. IV I 7), lo cual significa que es él quien, en definitiva, señala el verdadero fin de la vida humana (Cv. IV IX 17). Podemos legítimamente preguntar, entonces, cómo es que Dante se concibe a sí mismo para adjudicarse tan alta función. Dante respondería a esta pregunta en el primer capítulo del libro segundo, donde expone cómo deben ser interpretadas sus canciones y presenta la teoría de los cuatro sentidos del texto. Al ilustrar el sentido alegórico, hace referencia a la fábula de Orfeo, a quien atribuye funciones político-civilizatorias: gracias a la belleza sensible de sus palabras, que esconden un sentido filosófico, Orfeo habría conducido a los hombres de la barbarie a la civilización, es decir, habría fundado el orden político. En este artículo procuro mostrar que la figura alegórica de Orfeo puede y debe tomarse como clave de lectura del Convivio. En esta obra, Dante se estaría presentando a sí mismo como un nuevo Orfeo, como un poeta-fi39 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:49 PÆgina 40 Tenzone 14 2013 lósofo que, al igual que el primer Orfeo, en virtud de la belleza de sus palabras puede llevar a cabo, dentro de la civilización, un nuevo proceso civilizatorio, que esta vez consiste en acercar la filosofía, considerada como un instrumento de salvación, esto es, como la vía para alcanzar el fin terrenal de la vida humana, a aquellos hombres y mujeres que, por diversos motivos, no habrían podido acceder a ella. Si se toma como clave interpretativa la figura de Orfeo, se comprenden mejor no sólo las motivaciones que condujeron a Dante a concebir el novedoso proyecto de escribir un tratado de filosofía en lengua vulgar, sino también la naturaleza de ese proyecto. Además de Pézard y Dragonetti, otros dos autores adelantaron una interpretación de Dante como nuevo Orfeo similar a la que aquí propongo. M. Dozon (1991: 71-76) habla de Dante como «nouvel Orphée et nouvel Enée», siguiendo la interpretación que Pietro Alighieri hace del descenso al infierno, quien identifica alegóricamente a Orfeo como el sapiens musicus o sapientia y a Eurídice como la bona dijudicatio o ratio: 40 [...] Orpheus, qui descendit pro Eurydice uxore sua, et ita dupliciter sonuit quod Daemones eam sibi reddiderunt. Cujus fabulam Ovidius in xo sic recitat: quod Orpheus filius Apollinis et Calliopes de Thracia summus citharista duxit in uxorem Eurydicem; quam cum Aristaeus pastor adamasset, fugiens per prata, calcato serpente interiit, et ad infernum fuit, pro qua, ut dixi, fuit Orpheus. Sed quia ipsam Orpheus retrospexit contra conventionem Daemonum antequam esset extra infernum, iterum rediit irrevocabiliter ad infernum; et Orpheus solus ascendit montem, et ibi postea feras omnes ad se sonando trahebat. Orpheus, idest sapiens musicus; Eurydice, idest bona dijudicatio. Sapientia enim adhaeret profundae dijudicationi. Et significatur Eurydice ipsa ratione, quae ratio transiens per prata, idest per voluptates hujus mundi, a serpente, idest a fallacia hujus mundi, decepta est, cum bona hujus saeculi transitoria judicat esse durabilia, et sic moritur spiritualiter et descendit ad inferos: quam ut rationem inferiorem ab inferis conditionaliter non trahit. Itam Aeneas descendit ad hunc infernum, idest cognitionem terrenorum, ut videret genitorem suum, idest Deum. PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 Mariano PÉREZ CARRASCO 11:49 PÆgina 41 Dante como Orfeo Como Orfeo y como Eneas habría descendido también Dante: «Similiter et auctor noster ad hunc talem infernum, scilicet ad cognitionem terrenorum, fingit nunc se descendisse per modum istum, ut talia per modum demonstrationis alliciat» (Pietro Alighieri 1978: 14-16). El pasaje de Pietro Alighieri tiene una gran importancia pues legitima el vínculo alegórico entre Orfeo y Dante, aunque este vínculo se establece sólo en lo que hace al descenso de Dante al infierno. Mi artículo señala que el modelo de Orfeo –siempre interpretado en términos alegóricos– se encuentra ya presente en un pasaje clave del Convivio, y que la interpretación alegórica de la función de Orfeo propuesta allí por Dante coincide con la función que Dante se atribuye a sí mismo en el Convivio. Este punto ha sido ha sido estudiado en una extraordinaria contribución de Enrico Fenzi (2002), a la que referiré al final del artículo. 2. Dante habría escrito el Convivio entre 1302 y 1308 (Corti 1983: 142145), es decir, entre los primeros años del exilio y el comienzo de la redacción del Inferno. Son años itinerantes, en los que el poeta, ya maduro, económicamente arruinado, y golpeado por los fracasos políticos, todavía no ha perdido la ilusión de retornar a su ciudad. En esta obra Dante quiere mostrar a sus conciudadanos que él no es sólo un poeta de amor y un activo político, sino un hombre de doctrina. Escribe entonces este tratado de filosofía en el que se propone mostrar que el verdadero sentido de las canciones escritas a una misteriosa dama llamada “gentil” (gentile) es de naturaleza filosófica: contra lo que indican las apariencias, no se trata de canciones de amor sino de canciones doctrinales. Hacia el final del capítulo segundo del libro primero, Dante expresa que las razones que motivaron la escritura de esta obra han sido, por un lado, el temor de ser considerado como un hombre que se deja arrastrar por las pasiones («movemi timore d’infamia»), y, por otro lado, el deseo de transmitir conocimientos y experiencias que otro no podría haber enseñado («movemi desiderio di dottrina dare»). Este doble objetivo se cumpliría al mostrar cuál es el verdadero significado de las canciones («la vera sentenza»), 41 PØrez:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:49 PÆgina 42 2013 que «è nascosa sotto figura d’allegoria» (Cv. I II 15-17). Por eso el Convivio está estructurado como un comentario de Dante a sus propias canciones. Se trata de un banquete (convivium) alegórico, donde el autor sirve el alimento (las canciones) y el pan necesario para digerirlo (los comentarios en prosa) a quienes carecen del tiempo y los instrumentos necesarios para acceder al conocimiento, ya que se dedican a actividades civiles o comerciales, y no han tenido la oportunidad de aprender el latín, es decir, la lengua en la que se transmite el conocimiento (Cv. I I 6-15). Escrito en una lengua vulgar, sin tradición filosófica, y dirigido a un público no versado en filosofía, el Convivio se presenta como una instancia de divulgación del saber.5 Una de las novedades de esta obra –sin duda no la menor– consiste en que en ella Dante traduce el saber escolástico producido originalmente en instituciones eclesiásticas y universitarias a un lenguaje y a una forma que no son los de la escolástica:6 el libro no sólo está escrito en lengua vulgar, sino que utiliza las técnicas del comentario para analizar textos poéticos en los cuales el autor comentado y el comentador coinciden (Barolini 2004 y Barański 2005). Esta breve descripción permite poner el foco sobre un punto central para la interpretación aquí sostenida: el Convivio se plantea como una obra en la que se lleva a cabo una transmisión del saber desde un sector social culturalmente dominante pero políticamente marginado (los litterati) hacia otro culturalmente marginal pero políticamente dominante (los illitterati). Esta transmisión del saber toma la forma de una translatio auctoritatis (Minnis 2009, Cornish 2000 y 2011) en un doble sentido: no sólo la transmisión de la autoridad desde una lengua culta (el latín) hacia otra lengua sin tradición filosófica y con escasa tradición literaria (el vulgar), sino también la constitución de un autor moderno7 –Dante, hasta aquí, no era más que un poeta lírico– en una nueva auctoritas (Russell Ascoli 2008). Ambos aspectos de la translatio auctoritatis son inescindibles: que este poeta vulgar llegue a convertirse en una auctoritas depende de que se demuestre exitosa su función como mediador entre quienes saben (los litterati) y quienes ignoran (los illitterati). Esta función de mediador, y, en cierto modo, de divulgador, es la que, como inmediatamente veremos, 42 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 Mariano PÉREZ CARRASCO 11:49 PÆgina 43 Dante como Orfeo Dante se atribuye explícitamente a sí mismo en el Convivio. Él es el que, sin sentarse a la mesa de la sabiduría, recoge las migajas que caen de ella, y, con esas migajas, prepara un banquete para los que viven en el hambre de la ignorancia. Esta función de mediador entre los que han accedido al conocimiento y los que no, es fundamentada gracias a una panoplia de conceptos aristotélicos. Ya el incipit del Convivio afirma el universal deseo de conocer con una cita de Alpha Maior: «Sì come dice lo Filosofo nel principio de la Prima Filosofia, tutti li uomini naturalmente desiderano di sapere» (Cv. I I 1). Pero sucede que, por razones contingentes, ese deseo no es universalmente satisfecho; y, dado que en esa satisfacción se encuentra la felicidad, que es el fin de la vida humana, la consecuencia de esa insatisfacción es que muchos hombres no pueden alcanzar el fin propio. Según la concepción aristotélica la naturaleza posee una estructura teleológica; por eso, cuando esa finalidad no puede cumplirse, la naturaleza misma se ve frustrada. El Convivio, al acercar el saber a quienes viven en la ignorancia, aparece entonces como un instrumento político-cultural clave en el cumplimiento de ese fin natural. De este modo queda justificada la función mediadora de su autor, con lo cual Dante aparece autorizado, ya que no como filósofo en sentido pleno, al menos como aquel que lleva a cabo la función política de divulgar el saber filosófico. Este planteo es expresado en un pasaje clave del libro primero, en el cual Dante explicita su posición enunciativa: Manifestamente adunque può vedere chi bene considera, che pochi rimangono quelli che all’abito da tutti desiderato possano pervenire, e innumerabili quasi sono li ‘mpediti che di questo cibo sempre vivono affamati. Oh beati quelli pochi che seggiono a quella mensa dove lo pane delli angeli si manuca! e miseri quelli che colle pecore hanno comune cibo! Ma però che ciascuno uomo a ciascuno uomo naturalmente è amico, e ciascuno amico si duole del difetto di colui ch’elli ama, coloro che a così alta mensa sono cibati non sanza misericordia sono inver di quelli che in bestiale pastura veggiono erba e ghiande sen gire mangiando. E acciò che miseri- 43 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:49 PÆgina 44 Tenzone 14 cordia è madre di beneficio, sempre liberalmente coloro che sanno porgono della loro buona ricchezza alli veri poveri, e sono quasi fonte vivo, della cui acqua si refrigera la naturale sete che di sopra è nominata. E io adunque, che non seggio alla beata mensa, ma, fuggito della pastura del vulgo, a’ piedi di coloro che seggiono ricolgo di quello che da loro cade, e conosco la misera vita di quelli che dietro m’ho lasciati, per la dolcezza ch’io sento in quello che a poco a poco ricolgo, misericordievolemente mosso, non me dimenticando, per li miseri alcuna cosa ho riservata, la quale alli occhi loro, già è più tempo, ho dimostrata; e in ciò li ho fatti maggiormente vogliosi. Per che ora volendo loro apparecchiare, intendo fare un generale convivio di ciò ch’i’ ho loro mostrato, e di quello pane ch’è mestiere a così fatta vivanda, sanza lo quale da loro non potrebbe essere mangiata. Ed ha questo convivio di quello pane degno, con tale vivanda qual io intendo indarno non essere ministrata (Cv. I I 6-11). 2013 Dante, un poeta que ha huido de la pastura del vulgo, que no se sienta a la mesa de la sabiduría, sino que recoge las migajas que caen de esa mesa, se dispone a preparar un banquete para pobres. No para pobres de inteligencia, sino para quienes viven en la pobreza del conocimiento, para aquellos hombres y mujeres a los que las necesidades de la vida han alejado de los estudios filosóficos (Cv. I I 6-11). Este banquete suministrará a los hambrientos de conocimiento el pan con que saciarse; y este pan, que es metáfora de los comentarios en lengua vulgar, alumbrará con una nueva luz a los hombres: «Questo sarà quello pane orzato del quale si satolleranno migliaia, e a me ne soverchieranno le sporte piene. Questo sarà luce nuova, sole nuovo, lo quale surgerà là dove l’usato tramonterà, e darà lume a coloro che sono in tenebre ed in oscuritade, per lo usato sole che a loro non luce» (Cv. I XIII 11-12). El sol nuevo de la lengua vulgar reemplazará al viejo sol de la lengua latina. El crepúsculo de esta lengua ha dejado «in tenebre ed in oscuritade» a muchos hombres que, en consecuencia, no pueden cumplir el fin al que están naturalmente dispuestos. Es evidente, aquí, la importancia que tiene el aspecto cuantitativo en la empresa dantesca: miles serán saciados en su hambre gracias a este 44 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 Mariano PÉREZ CARRASCO 11:49 PÆgina 45 Dante como Orfeo nuevo pan que es la filosofía vulgar. Este aspecto cuantitativo muestra el alcance político de esta obra, que busca educar a aquellos ciudadanos que ven impedido su acceso al conocimiento. La idea misma de la filosofía se ve modificada por esta tendencia popularizante propia de la lengua vulgar.8 La filosofía no es considerada por Dante una práctica exclusiva de algunos pocos hombres que se dedican profesionalmente a ella. La filosofía es ante todo «amistanza a sapienza o vero a sapere: onde in alcuno modo si può dicere catuno filosofo, secondo lo naturale amore che in ciascuno genera lo disiderio di sapere» (Cv. III XI 6, subr. prop.). Dante extiende así el concepto de filosofía hasta la comprensión de toda la humanitas. El amor natural hacia el conocimiento que –aristotélicamente– es propio de todos los hombres, hace que todos los hombres puedan ser considerados, «in alcuno modo», filósofos. El hombre que no puede desarrollar sus tendencias filosóficas, ve eo ipso impedido su desarrollo como hombre. Por eso en el Convivio la filosofía adquiere un carácter soteriológico: ella constituye una vía para que los hombres cumplan su esencia humana, y, de ese modo, se alejen de la vida bestial. Para que la filosofía pueda cumplir ese objetivo salvífico no debe presentarse bajo la forma de conceptos y argumentos puros, que en virtud de su dificultad y de su abstracción son incapaces de seducir a hombres no entrenados en los rigores de esta disciplina (Dante confiesa, en Cv. II XII 4, que él mismo experimentó esas dificultades al acercarse por primera vez a la filosofía), sino que los conceptos y los argumentos filosóficos deben presentarse vestidos con los ropajes –«le vestimenta», como veremos infra– seductores del metro, las figuras, la rima; en suma, la filosofía debe mostrarse con vestiduras poéticas. Los poemas del Convivio no tienen, pues, una función puramente decorativa: son, por el contrario, una parte inescindible del proyecto dantesco de una filosofía en lengua vulgar. Un aspecto esencial de la configuración del Convivio puede ser fácilmente soslayado, y es el hecho de que el contenido de verdad del discurso se encuentra tanto en los poemas cuanto en los comentarios filosóficos. Pero la filosofía aparece –antes que en el comentario filosófico– oculta bajo su personificación en los poemas. Aparece allí bajo la figura de esa 45 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:49 PÆgina 46 Tenzone 14 2013 dama gentil, ataviada con las bellezas sensibles propias del discurso poético. Y el caso es que el discurso filosófico propuesto en esta obra tiene el cometido de presentar a esta dama sin aquellas vestiduras poéticas, esto es, debe desnudar a la poesía de los afeites accidentales (metro, figuras, rimas), para, de ese modo, dejar expuesto el contenido racional oculto en el lenguaje poético. La filosofía dantesca, que toma la forma de un comentario a sus propios poemas, tiene la función de exponer «la gran bontade del volgare di sì», esto es, demostrar que la lengua itálica tiene la capacidad (vertù) de manifestar «altissimi e novissimi concetti convenevolemente, sufficientemente e aconciamente»: la quale [vertú] non si potea bene manifestare nelle cose rimate per le accidentali adornezze che quivi sono connesse, cioè la rima e lo tempo e lo numero regolato: sì come non si può bene manifestare la bellezza d’una donna, quando li adornamenti dell’azzimare e delle vestimenta la fanno più ammirare che essa medesima. Onde chi vuole bene giudicare d’una donna, guardi quella quando solo sua naturale bellezza si sta con lei, da tutto accidentale adornamento discompagnata: sì come sarà questo comento, nel quale si vedrà l’agevolezza delle sue sillabe, le propietadi delle sue costruzioni e le soavi orazioni che di lui si fanno; le quali chi bene aguarderà, vedrà essere piene di dolcissima e d’amabilissima bellezza (Cv. I X 12-13). La poesía presenta la bondad de la lengua vernácula9 ataviada con «le accidentali adornezze», pues la rima, el ritmo, el metro no son esenciales a la belleza natural del discurso, y pueden incluso llegar a opacar su belleza natural, que se identifica con la bondad de la lengua. Es por eso que el poema precisa de un comentario crítico que explique su contenido. El comentario filosófico aparece entonces como aquella misma dama pero desnuda –sin los ropajes de las vestiduras poéticas–, de allí que en él sea posible percibir solamente su «naturale bellezza». Esa dama, vestida o desnuda, es el lenguaje italiano, la propia lengua vernácula.10 Si a través de la prosa del Convivio será posible apreciar «la gran bondad del vulgar del ‘sì’», la lengua materna de Dante; y la bondad de la lengua –su vir46 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 Mariano PÉREZ CARRASCO 11:49 PÆgina 47 Dante como Orfeo tud– consiste en producir un discurso conceptual («altissimi e novissimi concetti [...] manifestare»); podemos concluir que a través de la escritura del Convivio Dante está queriendo elevar su lengua materna al status de una lengua filosófica como el latín, es decir, una lengua capaz de expresar la verdad «convenevolemente, sufficientemente e aconciamente», y de ese modo permitir a los hablantes de esa lengua vulgar el acceso a la filosofía, reconocida como el fin de la vida humana. En tanto comentario filosófico de textos poéticos, el Convivio participa de ambos géneros –filosofía y poesía–, que, de hecho, en el pensamiento dantesco aparecen identificados. Ya en la Vita nuova Dante considera que la auténtica poesía no puede escindirse de la filosofía. Allí señala que los que riman de un modo necio («rimano stoltamente»), sin poder dar cuenta de lo que están diciendo, no deben ser llamados poetas: Dico che né li poeti parlavano così sanza ragione, né quelli che rimano deono parlare così non avendo alcuno ragionamento in loro di quello che dicono; però che grande vergogna sarebbe a colui che rimasse sotto vesta di figura o di colore retorico, e poscia, domandato, non sapesse denudare le sue parole da cotale vesta, in guisa che avessero verace intendimento (Vita nuova XXV, 10). El trabajo de «denudare le parole» es ya en la Vita nuova, y sobre todo en el Convivio, un trabajo filosófico: se trata de dar razón, de explicar argumentativamente el verdadero sentido de las palabras poéticas. Por eso, los poetas que no pueden explicar filosóficamente sus propios poemas – esto es, explicarlos sin «figura» o «colore retorico», o como vimos en el Convivio, sin «le accidentali adornezze» del metro y la rima– no deben ser llamados verdaderos poetas. Tanto la Vita nuova cuanto el Convivio muestran que la filosofía y la poesía son dos actividades unidas hasta el punto de llegar a confundirse. Si el verdadero poeta es quien tiene la capacidad de explicar filosóficamente, mediante un «ragionamento», sus propios versos, entonces la autoridad poética y la filosófica pueden identificarse, dando lugar a esa figura que hemos llamado el poeta-filósofo, cuya autoridad coincidiría con la autoridad de Dante. 47 PØrez:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:49 PÆgina 48 2013 El verdadero poeta es, pues, en el pensamiento de Dante, un auténtico filósofo. Este ideal filosófico-poético que hace su aparición en la Vita nuova es plenamente desarrollado en el Convivio, donde además encuentra una expresión alegórica en la figura de Orfeo (Padoan 1984). La función propia de esta autoridad filosófico-poética es tanto a) política: llevar a los hombres de la barbarie a la civilización (Orfeo) y, una vez dentro de la civilitas, cumplir el tránsito de la ignorancia al conocimiento (Dante), cuanto b) filosófica: indicar el verdadero sentido de la nobleza y el fin de la vida humana. Esta figura del poeta-filósofo –alegóricamente, Orfeo– remite evidentemente al autor del Convivio. Dante, que al momento de comenzar a escribir el Convivio carece de toda autoridad, al momento de finalizarlo habría adquirido una autoridad que le es propia: la autoridad del poeta que dice la verdad acerca de la nobleza –¡la verdad acerca del fin de la vida humana!– y expresa filosóficamente esa verdad que yacía oculta en sus poemas: «Per che omai con tutta licenza e con tutta franchezza d’animo è da fedire nel petto a le usate oppinioni, quelle per terra versando, acciò che la verace, per questa mia vittoria, tegna lo campo della mente di coloro per cui fa questa luce avere vigore» (Cv. IV IX 17, subr. prop.).11 No ha sido Aristóteles (el Filósofo por antonomasia) ni Federico II (el Emperador, es decir, el poder político), quienes han encontrado y mostrado la verdad acerca de la nobleza humana, sino Dante Alighieri, el poeta-filósofo que escribe el Convivio. ¿Qué autoridad tiene ese «yo» que aparece en el posesivo («per questa mia vittoria»)?12 Ese «yo» ha sostenido repetidas veces, como hemos visto, que él no es un filósofo: no se sienta a la beata mesa de la sabiduría (Cv. I I 10), y, además, sólo ha estudiado filosofía durante treinta meses (Cv. II XII 7). Acaba de decir, sin embargo, que la opinión verdadera acerca de la nobleza aparece gracias a él. Es un giro argumentativo sutil, pero que aparece con evidencia: la verdad sobre la nobleza no la ha expresado ni el filósofo ni el emperador, sino el poeta-filósofo, que actúa como un mediador entre los que saben (los litterati) y los que viven en el hambre del conocimiento (los illitterati). Esta nueva figura concuerda con la del filósofo en lo que hace a la 48 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 Mariano PÉREZ CARRASCO 11:49 PÆgina 49 Dante como Orfeo función que debe cumplir: ambos determinan el fin de la vida humana y, en ese sentido, son consejeros del poder político. Esa concordancia no es casual. Tanto el mítico Orfeo cuanto Dante Alighieri son poetas que filosofan (Boyde 1981: 47-51), es decir, poetas cuyos versos tienen un contenido racional que puede ser expresado en prosa filosófica. Pero mientras el filósofo (paradigma de una cultura universitaria y latina) aparece distanciado de la sociedad y de la vida política más inmediata, esta nueva figura intelectual (paradigma de una incipiente cultura burguesa que se expresa en lengua vernácula) aparece íntimamente vinculada a la vida política de su ciudad. Esta función propia del poeta-filósofo es explicitada en la figura alegórica de Orfeo. Como acabamos de ver, en el proyecto filosófico diseñado por Dante en el Convivio las modulaciones del sentido pasan de los poemas (texto objeto de interpretación) a la filosofía (texto en el cual se muestra la verdad oculta en los poemas) a través de la aplicación de un procedimiento hermenéutico. Tal procedimiento, es decir, el método que se debe aplicar en la interpretación de las canciones, es expuesto en el primer capítulo del libro segundo. En los términos del banquete alegórico propuesto en el Convivio, este capítulo enseña «cómo se debe comer» («voglio mostrare come mangiare si dee»), esto es, de qué modo deben leerse las canciones para comprender su verdadero significado (Cv. II I 1). Este método consiste en la teoría de los cuatro sentidos del texto (Maierú 1999, Pépin 1970, Hollander 1969, Singleton 1950, Nardi 1944). Aquí sólo nos interesa el modo en que Dante expone el sentido alegórico, donde aparece la alegoría oculta bajo la fábula poética de Orfeo: L’altro [senso] si chiama allegorico, e questo è quello che si nasconde sotto ‘l manto di queste favole, ed è una veritade ascosa sotto bella menzogna: sì come quando dice Ovidio che Orfeo facea colla cetera mansuete le fiere, e li arbori e le pietre a sé muovere: che vuol dire che lo savio uomo collo strumento della sua voce faccia mansuescere ed umiliare li crudeli cuori, e faccia muovere alla sua volontade coloro che <non> hanno vita di scienza e d’arte; 49 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:49 PÆgina 50 Tenzone 14 e coloro che non hanno vita ragionevole alcuna sono quasi come pietre (Cv. II I 3). 2013 André Pézard (1940b: 12-13) ha señalado que la función atribuida a Orfeo en este pasaje se corresponde con el «programme annoncé» en Cv. I ix 7, donde Dante sostenía que «lo dono veramente di questo comento è la sentenza delle canzoni a le quali fatto è», y que esa doctrina tenía por objetivo «inducere li uomini a scienza e a virtù». La identidad entre Dante y Orfeo sería pues eminentemente funcional: ambos cumplirían una función civilizatoria (Fenzi 2002: 178). Dante, al enseñar –siguiendo el ejemplo de las Confesiones de san Agustín– cómo se va de una vida mala a una buena, dice que va a mostrar lo que se encuentra escondido «sotto figura d’allegoria», y que al hacer esto no sólo proporcionará un «diletto buono a udire, ma sottile amaestramento e a così parlare [es decir, alegóricamente] e a così intendere l’altrui scritture» (Cv. I II 17). El contenido de la enseñanza dantesca es claramente edificante, y consiste en señalar cuál es el fin de la vida humana. Este punto es central, pues tanto la autoridad del filósofo cuanto la del poeta consisten en definir el fin del hombre en esta vida (Cv. IV VI 6-9 y 20). A través de la interpretación verdadera –alegórica, ya que el sentido literal es una «bella menzogna»– de sus canciones, Dante enseña cuál es la bondad humana, es decir, la nobleza, y de ese modo acaba con la «pessima confusione del mondo», que justamente consiste en ignorar cuál es la nobleza o «umana bontade» (Cv. IV I 7). El proyecto filosófico de Dante en el Convivio, al transformar la palabra ficticia de lo que suena en aquello que quiere decir («volta <la> parola fittizia di quello ch’ella suona in quello ch’ella ‘ntende» (Cv. II XII 10)), no sólo muestra el camino de la virtud, sino también el fin último al cual se debe dirigir el hombre. Es en este sentido que para Dante la filosofía, «figlia di Dio, regina di tutto»,13 tiene la capacidad de otorgar la salvación, ya que actualiza la potencia última del hombre: su racionalidad. La filosofia salva al hombre de la muerte animal en la que vive –donde vive como animal pero está muerto en tanto que hombre– y lo conduce a una vida humana: 50 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 Mariano PÉREZ CARRASCO 11:49 PÆgina 51 Dante como Orfeo [È] da sapere che le cose deono essere denominate dall’ultima nobilitade della loro forma: sì come l’uomo dalla ragione, e non dal senso né d’altro che sia meno nobile. Onde, quando si dice l’uomo vivere, si dee intendere l’uomo usare la ragione, che è sua speziale vita ed atto della sua più nobile parte. E però chi dalla ragione si parte e usa pure la parte sensitiva, non vive uomo ma vive bestia: sì come dice quello eccellentissimo Boezio: “Asino vive”. Dirittamente, dico, però che lo pensiero è propio atto della ragione, per che le bestie non pensano, ché non l’hanno; e non dico pur delle minori bestie, ma di quelle che hanno apparenza umana e spirito di pecora o d’altra bestia abominevole (Cv. II VII 3-4). El proyecto filosófico de Dante consiste en traducir la filosofía a su lengua vernácula, acercarla a aquellos que viven en el hambre del conocimiento, y, por eso, no llegan a cumplir el fin de la vida humana. Dante aparece, de este modo, como un nuevo Orfeo. El primer Orfeo había conducido a los hombres del salvajismo a la civilización: al volver mansos y humildes a los crueles corazones («mansuescere ed umiliare li crudeli cuori»), Orfeo funda el orden civil o político. El segundo Orfeo extiende ese proceso civilizatorio a aquellos hombres que, debido a los cuidados civiles y familiares, habían quedado excluidos. El Convivio «sarà quello pane orzato del quale si satolleranno migliaia»; y no sólo ha de alimentar a miles, es decir, no sólo ha de saciar el hambre de conocimiento y, de ese modo, actualizar la capacidad humana de felicidad, sino que será además «luce nuova, sole nuovo», que «darà lume a coloro che sono in tenebre ed in oscuritade, per lo usato sole [il latino] che a loro non luce» (Cv. I XIII 12). En el Convivio, pues, Dante cumple la función de acercar a los illitterati el medio de salvación, el instrumento necesario para llevar una vida humana, esto es, una vida civilizada, así como la figura alegórica de Orfeo «faccia muovere alla sua volontade coloro che non hanno vita di scienza e d’arte», es decir, a aquellos hombres que no llevaban aún una vida humana («e coloro che non hanno vita ragionevole alcuna sono quasi come pietre»), pues no habían actualizado su «ultimum de potentia».14 Esta nueva función civilizatoria sólo puede ser cumplia por el mejor poeta vul51 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:49 PÆgina 52 Tenzone 14 2013 gar, que Dante, en De vulgari eloquentia, identifica explícitamente consigo mismo (el pasaje refiere a la lengua vulgar): Magistratu quidem sublimatum videtur, cum de tot rudibus Latinorum vocabulis, de tot perplexis constructionibus, de tot defectivis prolationibus, de tot rusticanis accentibus, tam egregium, tam extricatum, tam perfectum et tam urbanum videamus electum ut Cynus Pistoriensis et amicus eius ostendun in cantionibus suis. Quod autem exaltatum sit postestate, videtur. Et quid maioris potestatis est quam quod humana corda versare potest, ita ut nolentem volentem et volentem nolentem faciat, velut ipsum et fecit et facit? (Dve. I XVII 3-4) El poeta vulgar –«Cynus Pistoriensis et amicus eius», i.e., el mismo Dante– es quien afecta directamente la voluntad de los hombres («ut nolentem volentem et volentem nolentem faciat»). En consecuencia, es el poeta-filósofo, y no el puro filósofo razonador, el que es capaz de conducir a los hombres, pues él tiene la capacidad de «modificar los corazones humanos» («humana corda versare potest»), capacidad que en el Convivio Dante atribuye a «lo savio uomo» alegóricamente identificado con Orfeo, quien «collo strumento della sua voce faccia mansuescere ed umiliare li crudeli cuori». El paralelismo es por cierto muy significativo. En esa capacidad de conducción, fundada en la posibilidad de afectar de un modo directo no la razón, sino la afectividad, es decir, los “corazones”, reside la importancia política de la figura del poeta-filósofo, quien civiliza a los hombres, y al civilizarlos les otorga los medios de su salvación, los medios para actualizar plenamente su esencia humana. En el Convivio, el medio para alcanzar la salvación es la filosofía –una filosofía que es exégesis de textos poéticos–, tal como Dante expone en la explicación alegórica de la canción Voi che ’ntendendo, al final del libro segundo (es decir, en la primera ocasión en que utiliza el método alegórico expuesto al comiezo del libro segundo): 52 E là dove dice: Chi veder vuol la salute, / faccia che li occhi d’esta donna miri: li occhi di questa donna sono le sue dimostrazioni, le PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 Mariano PÉREZ CARRASCO 11:49 PÆgina 53 Dante como Orfeo quali, dritte nelli occhi dello ‘ntelletto, innamorano l’anima liberata <nelle> sue condizioni. O dolcissimi ed ineffabili sembianti, e rubatori subitani della mente umana, che nelle dimostrazioni, <cioè> nelli occhi della Filosofia apparite, quando essa colli suoi drudi ragiona! Veramente in voi è la salute, per la quale si fa beato chi vi guarda, e <si> salva dalla morte della ignoranza e dalli vizii. Ove si dice: Sed e’ non teme angoscia di sospiri, qui si vuole intendere: s’elli non teme labore di studio e lite di dubitazioni, le quali dal principio delli sguardi di questa donna multiplicatamente surgono, e poi, continuando la sua luce, caggiono quasi come nebulette matutine alla faccia del sole; e rimane libero e pieno di certezza lo familiare intelletto, sì come l’aere dalli raggi meridiani purgato e illustrato (Cv. II XV 4-5). Los ojos de esta dama que ha enamorado a Dante luego de la muerte de Beatriz, la donna gentile-Filosofía, y que ahora Dante presenta a los miles de iletrados que, por desconocer el latín, viven en el hambre humana, son causa de salvación y de felicidad («in voi è la salute, per la quale si fa beato chi vi guarda»). Así como Orfeo, mediante la dulzura de sus cantos, amansaba a las fieras y daba vida a las cosas inertes, lo cual quería decir que «lo savio uomo collo strumento della sua voce faccia mansuescere ed umiliare li crudeli cuori, e faccia muovere alla sua volontade coloro che <non> hanno vita di scienza e d’arte; e coloro che non hanno vita ragionevole alcuna sono quasi come pietre», así ahora, al concluir este libro segundo, Dante afirma que gracias a la filosofía que él mismo expone en el Convivio, el hombre «si salva dalla morte della ignoranza e dalli vizii». El libro segundo ha comenzado con la alegoría de Orfeo y concluye con la alegoría de la dama gentil-Filosofía. Ambos textos afirman que la poesía –la cítara de Orfeo y las canciones filosóficas de Dante– es portadora de una verdad tal que salva al hombre de la muerte, es decir, de la vida irracional, ya sea gracias al tránsito de la barbarie a la civilización, ya sea gracias a la enseñanza acerca del sentido de la verdadera nobleza, es decir, acerca del fin de la vida humana. 53 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:49 PÆgina 54 Tenzone 14 2013 Esta donna gentile que Dante aquí presenta está caracterizada, por un lado, como la sophia aristotélica de la Ethica Nicomaquea, y, por otro lado, como la Sabiduría salomónica: la «figlia di Dio, regina di tutto» (Cv. II XII 9), la «figlia dello Imperadore dell’universo» (Cv. II XV 12). En efecto, la filosofía que Dante quiere transmitir viene definida, al final del libro segundo, como Sabiduría (¿no es este otro indicio de que Dante puede ser identificado como «lo savio uomo», ya que es él quien transmite a los illitterati esta sapienza?). Esta simbiosis entre el modelo filosófico aristotélico y el salomónico es llevada a cabo en el libro tercero:15 Sì ch’omai qui si può dire che, come la vera amistà delli uomini intra sé è che ciascuno ami tutto ciascuno, che ‘l vero filosofo ciascuna parte della sapienza ama, e la sapienza ciascuna parte del filosofo, in quanto tutto a sé lo reduce e nullo suo pensiero ad altre cose lascia distendere. Onde essa Sapienza dice nelli Proverbi di Salomone: “Io amo coloro che amano me”. E sì come la vera amistade, astratta dell’animo, solo in sé considerata, ha per subietto la conoscenza della operazione buona, e per forma l’appetito di quella; così la filosofia, fuori d’anima, in sé considerata, ha per subietto lo ‘ntendere, e per forma uno quasi divino amore allo ‘ntelletto. E sì come della vera amistade è cagione efficiente la vertude, così della filosofia è cagione efficiente la veritade. E sì come fine dell’amistade vera è la buona dilettazione che procede dal convivere secondo l’umanitade propiamente, cioè secondo ragione, sì come pare sentire Aristotile nel nono dell’Etica; così fine della Filosofia è quella eccellentissima dilettazione che non pate alcuna intermissione o vero difetto, cioè vera felicitade che per contemplazione della veritade s’acquista (Cv. III XI 12-14). Al escribir el Convivio, Dante, poseedor de esa sabiduría que es idéntica a la filosofía («il vero filosofo ciascuna parte della sapienza ama, e la sapienza ciascuna parte del filosofo»), aparece implícitamente como el sabio que mediante sus palabras lleva vida de ciencia y de arte a aquellos que vivían en el hambre, es decir, que vivían como bestias pero estaban muertos en tanto que hombres. Esa filosofía constituye –aristotélicamente– el fin mismo de la vida humana: la «vera felicitade che per con54 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 Mariano PÉREZ CARRASCO 11:49 PÆgina 55 Dante como Orfeo templazione della veritade s’acquista». Este fin de la filosofía –que coincide con el fin de la vida humana– es análogo («sì come la fine dell’amistade vera [...] così fine della Filosofia...») al fin de la amistad, que es un fin político: lograr una convivencia racional («fine dell’amistade vera è la buona dilettazione che procede dal convivere secondo l’umanitade propiamente, cioè secondo ragione»). Este es, pues, el doble fin que se propone lograr el nuevo Orfeo/Dante: salvar a los hombres de su vida bestial y alcanzar, mediante el desarrollo pleno de la racionalidad, un buen orden político. De allí la importancia central del proyecto político presentado brevemente en Cv. IV IV-IX y que será desarrollado con más detalle en la Monarchia. El primer Orfeo, mediante la elocuencia de sus palabras, había salvado a los hombres de la vida bestial; antes de este «savio uomo» identificado alegóricamente con Orfeo, los hombres estaban muertos en tanto que hombres, y vivos sólo como bestias, pues «vivere nell’uomo è ragione usare, ragione usare è l’essere dell’uomo, e così da quello partire è partire da essere, e così è essere morto [...]. Potrebbe alcuno dicere: Come? è morto e va? Rispondo che è morto uomo e rimaso bestia» (Cv. IV VII 12 y 14). De acuerdo con la doctrina aristotélica, el hombre, al igual que todos los seres vivos, vive porque posee un alma vegetativa, siente porque posee un alma sensitiva, pero está muerto en tanto que hombre si no ejerce su actividad propia, la razón: «Così levando l’ultima potenza dell’anima, cioè la ragione, non rimane più uomo, ma cosa con anima sensitiva solamente, cioè animale bruto» (Cv. IV VII 15). El nuevo Orfeo (Dante), sintiendo misericordia hacia los que «in bestiale pastura veggiono erba e ghiande sen gire mangiando» (Cv. I I 8), mientras otros «se sientan a la mesa donde se come el pan de los ángeles» («Oh beati quelli pochi che seggiono a quella mensa dove lo pane delli angeli si manuca! e miseri quelli che colle pecore hanno comune cibo!» [Cv. I I 7]), procura saciar mediante el Convivio el hambre humana («umana fame» [Cv. I I 13]), que consiste en estar privado de la ciencia. De este modo, el poeta-filósofo del Convivio aparece como una autoridad que no sólo señala cuál es el verdadero sentido de la nobleza, sino que además 55 PØrez:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:49 PÆgina 56 2013 ayuda a los hombres a cumplir el fin propio de la vida humana: llevar una «vita di scienza e d’arte», que les permita salir de la inercia y alcanzar el pleno ejercicio de la racionalidad, pues «coloro che non hanno vita ragionevole alcuna sono quasi come pietre» (Cv. II I 3). 3. André Pézard (1940a: 15-16, n. 2) presenta algunos textos dantescos –entre los cuales se encuentra Dve. I XVII 3-4, aquí citado– que identifican al sabio con el poeta; pero no cree que este pasaje del De vulgari eloquentia pueda asociarse con el de Orfeo (Pézard 1940a: 20-21, en especial n. 14). El artículo de Pézard llama la atención sobre un problema filológico de Cv. II I 3. En su edición de 1934, Busnelli-Vandelli (ad loc.) señalan que «faria è lezione congetturale sostituita a quelle dei mss. faccia, facea, faceva, facia, tutte insostenibili e che colla stessa loro varietà attestano che anche i copisti antichi non erano soddisfatti». La adopción de una de las variantes propuestas supone modificar la atribución del sujeto «lo savio uomo». En la lección adoptada por los editores, “faria”, «lo savio uomo» no se identifica literalmente con Orfeo, sino alegóricamente; en otras palabras, «lo savio uomo» no es Orfeo, sino el sentido oculto bajo la fábula de Orfeo. No habría, pues, una determinación histórica para el sujeto «lo savio uomo». No sucede lo mismo si se adopta la variante facea. La frase quedaría «lo savio uomo con lo strumento de la sua voce facea mansuescere e umiliare li crudeli cuori, e facea [o “faccia”, como adopta Ageno] muovere a la sua volontade coloro che non hanno vita di scienza e d’arte». (Faceva, facea, facia son formas del imperfecto; según Pézard, el subjuntivo faccia sería una mala lectura de facia [1940a: 15, n. 1]). En este caso, «lo savio uomo» referiría a un personaje históricamente determinado: Orfeo, quien, en consecuencia, no sería una mera favola poetica, sino que tendría una existencia real, histórica. Esta es la variante adoptada por Pézard, que propone dos interpretaciones posibles: 1) La que han seguido Parodi-Pellegrini, que atribuye un sentido indeterminado a la expresión «lo savio uomo»: «Les éditeurs donent évidemment aux mots lo savio uomo un sens indéterminé, hors de toute actualité: 56 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 Mariano PÉREZ CARRASCO 11:49 PÆgina 57 Dante como Orfeo la allégorie veule dire que si quelque sage était vraiment inspiré de Dieu, il aurait le pouvoir d’entraîner les foules. Peut-être a-t-on vu ici une allusion aux ambitions, poétiques et morales à la fois, de Dante lui-même, pour qui savio ou saggio se confondent couramment avec poète» (Pézard 1940a: 15). 2) La que él mismo sigue, que atribuye un sentido determinado a la expresión «lo savio uomo»: «Mais il se pourrait que l’allusion fût au contraire parfaitement déterminée, et que, sous le voile de la légende, Dante visât un personnage passé, un personnage auquel il prête pour quelques instants un nom fabuleux, mais dont l’existence fut réelle, puisqu’une tradition raisonnable et ennemie du surnaturel l’atteste justement et l’oppose à la légende; un personnage don le rôle paraissait indispensable à Cicéron pour expliquer la naissance des civilisations» (Pézard 1940a: 16), y que habría llegado a Dante a través de Brunetto Latini, volgarizzatore de Cicerón. En resumen, Pézard supone que Dante habría sostenido la existencia histórica del hombre sabio fundador de la civilización, y que el mismo Dante habría juzgado que la fábula de Orfeo era una buena expresión alegórica de ese hecho histórico. En definitiva, tanto su maestro Brunetto Latini cuanto Cicerón afirmaban la existencia histórica de un primer vir sapiens y elocuente. Si esto fuera así, Dante no debería aplicar la alegoría de los poetas, sino la de los teólogos, pues se trataría de hechos históricos y no de fábulas poéticas (Hollander 1969: 38-39). Esta interpretación no contradice la que aquí propongo. Si Dante considera el texto de Ovidio como favola o como scrittura, esto no afecta mi interpretación. Lo importante en mi lectura es que, tenga una existencia real o ficticia, el personaje de Orfeo esconde una verdad, y que la verdad que esconde (esto es, su función: cumplir el tránsito de la barbarie a la civilización) coincide con la función que Dante se atribuye a sí mismo en el Convivio; aunque esa función sea llevada en otro plano, pues ya no se trata de cumplir el tránsito de la plena barbarie a la civilización, sino de hacer una litteratura para que los illitterati pasen a ser litterati, es decir, 57 PØrez:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:49 PÆgina 58 2013 pasen a llevar una vida plenamente humana. Si el texto de Ovidio fuera scrittura –esto es, tuviese un carácter histórico–, entonces esa función civilizadora habría sido históricamente cumplida por alguien a quien, en virtud de su anonimato, atribuimos el nombre mitológico de Orfeo. Si el texto de Ovidio fuera favola –esto es, tuviese sólo una realidad ficticia–, entonces Orfeo sería un símbolo que esconde un sentido moral y, en consecuencia, atemporal. Al ser una verdad atemporal, significa que «[a]ujourd’hui encore, un grand sage, un grand poète – Dante, j’imagine – pourrait par son art convertir ses lecteurs à une vie plus sainte. Seulement ce sens supplémentaire n’est pas même implicite dans notre paragraphe du Convivio» (Pézard 1940a: 20-21). Esto último apunta, claramente, contra la tesis sostenida en este artículo. En efecto, Pézard está en lo correcto cuando dice que en el parágrafo analizado no hay ningún indicio de la identidad entre Orfeo y Dante escritor del Convivio. Pero lo cierto es que en otros pasajes, así como en el proyecto filosófico de la obra, sí hay indicios de esa identidad, como él mismo había sugerido (Pézard 1940b: 12-13). Una identidad que, como he procurado mostrar en este artículo, es eminentemente funcional: Orfeo y Dante cumplen una función civilizatoria similar y complementaria. En acuerdo con la interpretación aquí propuesta se encuentra la lectura llevada a cabo por Enrico Fenzi, quien sostiene que «con la nuova proposta [la adopción de facea] scopriamo una forte corrispondenza tra la figura di Dante e quella di Orfeo, la quale investe sia i modi del rapporto lettera/allegoria, sia i contenuti» (Fenzi 2002: 177-178). Ambas figuras históricas –Dante y Orfeo– cumplirían la misma función educativa: «Orfeo, insomma, è colui che già ha fatto esattamente quanto Dante, nel Convivio, vuole fare», es decir, educar a sus conciudadanos (Fenzi 2002: 178). En este artículo he distinguido entre la función civilizatoria llevada a cabo por Orfeo y la función educativa llevada a cabo por Dante, sin poner el foco en el problema del sentido de la alegoría, asunto del cual se ocupa in extenso el artículo de Fenzi, quien llega a convertir a Orfeo en figura de Dante: «E l’esempio di Orfeo, ‘figura’ dell’autore del Convivio, è dunque importante proprio per il modo in cui racchiude il nucleo deci58 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 Mariano PÉREZ CARRASCO 11:49 PÆgina 59 Dante como Orfeo sivo dell’invenzione dantesca di un soggetto storico che agisce allegoricamente, e di un’allegoria che attraverso di lui si storicizza...» (180). Esta conclusión va más allá que la identificación funcional entre Orfeo y Dante que he sugerido en este artículo, pero ambas lecturas apoyan la idea de una metamorfosis de Dante como un nuevo Orfeo. 59 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:49 PÆgina 60 Tenzone 14 2013 NOTE 1 En ese artículo Pézard sostiene que el pasaje analizado (Cv. I IX 7) refiere a Cv. II I, es decir, a la exposición de los cuatro sentidos de la escritura en la que aparece la alegoría de Orfeo, y que, así como en I IX 7 Dante sostiene que el regalo del comentario filosófico consiste en mostrar el sentido de las canciones comentadas («lo dono veramente di questo comento è la sentenza de le canzoni a le quali fatto è»), y que esas canciones tienen por fin «inducere li uomini a scienza e virtù», así en II I 3 Orfeo, gracias a la fuerza persuasiva de su voz («collo strumento della sua voce»), aparece como aquel que hace que los hombres abandonen una vida inerte y pasen a llevar una vida de ciencia y arte: «Jusque dans certains détails d’expression, le préambule du livre II correspond au programme annoncé [en I IX 7]; ainsi Dante nous présente dans Orphée l’image du sage qui fait “mouvoir à sa volonté ceux qui n’ont point vie de science et d’art” (II I 3): c’est bien le rappel de: inducere li uomini a scienza e a virtù (I IX 7)» (Pézard 1940b: 12-13). Cf. A. Pézard (1940a: 20-21), donde sostiene que en el pasaje que analizaremos (Cv. II I 3) Dante no hace ninguna alusión al presente histórico –como sí la había hecho en De vulgari eloquentia I XVII 3-4, cf. infra, p. 22–, con lo cual la figura que cumpliría la función civilizatoria no sería ya el poeta, alegóricamente identificado con Orfeo, y a fortiori con Dante, sino el emperador: «On dirait qu’il [Dante] ne compte pas outre mesure sur la poésie, mais davantage sur la force impériale, pour améliorer l’humanité» (1940a: 21). 2 Cf. Cv. IV VI 17-20, donde Dante expone la complementariedad de ambas autoridades. Pero véase todo el arco argumentativo de Cv. IV III-IX, donde se analizan las respectivas jurisdicciones de la autoridad imperial (Cv. IV IV-V) y de la filosófica (Cv. IV VI). 3 Cf. Cv. IV I 5-10. É. Gilson (1938: 156) llevó a cabo un minucioso análisis del esquema de las autoridades en el Convivio y la Monarchia. Ese esquema aparecía a los ojos de Gilson como aporético, pues en el caso de que se produjese un conflicto de autoridades (como cuando el emperador quería definir la nobleza, algo propio de la jurisdicción del filósofo) todo el sistema se vendría abajo. Junto a su carácter aporético, este esquema dantesco de las autoridades presenta otro grave problema: ¿cuál es la autoridad de Dante al escribir el Convivio? A. Russell Ascoli (2008: 102) ha propuesto una respuesta a este interrogante, respuesta que 4 60 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 Mariano PÉREZ CARRASCO 11:49 PÆgina 61 Dante como Orfeo se encuentra vinculada a la aporía señalada por Gilson: «The aporia dantesca, the little gap between the emperor’s and the Philosopher’s domains is, presumably, the place where Dante’s own nascent authority subsists». La autoridad de Dante, según esta línea argumentativa, se encuentra explicitada en la definición etimológica de la autorità a partir de auieo (Cv. IV VI 3-4). Para lo que sigue, véase A. De Libera (1991), quien interpreta el Convivio dantesco no tanto como una obra de divulgación, como un volgarizzamento, sino como una “mediación” cultural que supone el contexto social de una vida a la vez urbana y universitaria, y que está caracterizada como un movimiento de “desprofesionalización de la filosofía”: «La déprofessionnalisation de la philosophie est donc, pour nous, ce qui signe le véritable moment de la naissance des intellectuels: un épisode qui suppose et réclame la ville [...]; un épisode qui, cependant, ne se conçoit pas sans l’université. [...] Les médiateurs de l’idéal philosophique ont parlé vulgaire, ils ont nom Dante pour l’Italie, Meister Eckart pour l’Allemagne» (1991: 12-13). En tanto que “mediador transcultural”, Dante «c’est un intellectuel total», porque ha sido él «qui a formulé en langue vulgaire le premier vrai et grand manifeste des intellectuels médiévaux: le Convivio» (1991: 24). En este artículo no he puesto el énfasis en la transmisión del conocimiento, esto es, en la volgarizzazione del saber, sobre la que llama la atención De Libera con el nombre de translatio sapientiae; aquí he subrayado otro aspecto de la transmisión del conocimiento que efectivamente lleva a cabo el Convivio, y es el aspecto de la translatio auctoritatis, es decir, la autoridad que tanto Dante cuanto su parlar materno alcanzan gracias a la prosa filosófica desplegada en el Convivio. 5 6 C. Segre (1963) sostiene que el Convivio es un «nuovo sperimento linguistico» (1963: 232) en el que Dante inventa una prosa filosófica en lengua vulgar («Nel Convivio Dante si propone di fondare, e di fatto fonda, la prosa filosofica in volgare» (1963: 237)), y que «l’armoniosa concezione scolastica dell’universo si riflette nella sintassi del Convivio, capace di racchiudere in un periodo complesso ma limpido la gerarchia degli esseri» (1963: 232). Un autor “moderno” en el sentido en que Dante utiliza esta palabra, p. ej.: «Li dolci detti vostri, / che, quanto durerà l’uso moderno, / faranno cari ancora i loro inchiostri» (Purg. XXVI, 112-114), o «non con questa moderna favella» (Par. XVI, 33). 7 Acerca de la supuesta “popularización” de la filosofía en el Convivio, véase C. Vasoli (1994: 27), quien subraya la dimensión ciudadana del Convivio, cuyo 8 61 PØrez:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:49 PÆgina 62 2013 fin consiste en «fornire, cioè, a chi vive nella “città”, la serve e la governa le idee e gli strumenti che lo indirizzino verso il supremo scopo della pace e dell’armonia civile, condizione preliminare e indispensabile affinché l’uomo realizzi la sua stessa natura». La bondad de una cosa –su bien– coincide aristotélicamente con su finalidad. El comentario dantesco mostrará que el vulgar puede expresar conceptos al igual que el latín. Como veremos, Dante sostiene que la esencia –i.e., la verdad– de toda lengua consiste en manifestar lo concebido por el hombre, de modo que, al mostrar la bontade de la lengua vulgar Dante está mostrando también su veritade, su verdad. 9 Sobre este punto, véase Dragonetti (1968: 7): «Dante est un poète de la pensée. Cela signifie que pour l’auteur du Convivio et de la Divine Comédie surtout, penser, c’est toujours méditer dans la langue en opérant sur elle selon la dictée de ses exigences profondes. Une telle opération consiste à révéler la langue à son être propre dans la splendeur du chant. Et c’est là le don de noblesse que Dante a offert à sa langue maternelle». 10 Esta conclusión hay que ponerla en relación con los capítulos de apertura del libro cuarto (I-II), y, fundamentalmente, con Cv. IV III 9-10: «Queste due oppinioni [sobre la nobleza: la del Emperador y la del vulgo] - avegna che l’una, come detto è, del tutto sia da non curare - due gravissime ragioni pare che abbiano in aiuto: la prima è che dice lo Filosofo che quello che pare alli più, impossibile è del tutto essere falso; la seconda ragione è l’autoritade della diffinizione dello imperadore. E perché meglio si veggia poi la vertude della veritade, che ogni autoritade convince, ragionare intendo quanto l’una e l’altra di queste ragioni aiutatrice e possente è». Notable, en este pasaje (que a su vez se debe poner en relación con Cv. IV VIII 4 ss.), la oposición entre verdad y autoridad. Si nos preguntamos quién y qué son los portadores de esa verdad, la respuesta aparece inmediatamente: la canción contiene una verdad que es Dante –ese verdadero poeta que, siguiendo las sugerencias de la Vita Nuova XXV, se interpreta a sí mismo– , su autor, el encargado de “hacerla aparecer” en sus comentarios («aprire per prosa»). Sobre el capítulo XXV, véase Picone (2005) y los comentarios de Pinto ad locum (Alighieri 2003). 11 La respuesta a esta pregunta constituye el tema central de los ensayos reunidos en Russell Ascoli (2008), a quien sigo en lo que hace al tema de la autoridad en Dante. El pasaje de Orfeo es estudiado en las páginas 113-114 y 117.. 12 62 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 Mariano PÉREZ CARRASCO 11:49 PÆgina 63 Dante como Orfeo La idea de que la filosofía es un don divino parece tener un origen ciceroniano. Cf. Cicerón, De legibus I, 58: «Est huius uero disputationis, Quinte, proprium, id quod expectas, atque utinam esset etiam facultatis meae! Sed profecto ita se res habet, ut quoniam uitiorum emendatricem legem esse oportet commendatricemque uirtutum, ab ea<dem> uiuendi doctrina ducatur. Ita fit ut mater omnium bonarum rerum <sit> sapientia, a quoius amore Graeco uerbo philosophia nomen inuenit, qua nihil a dis immortalibus uberius, nihil florentius, nihil praestabilius hominum uitae datum est. Haec enim una nos cum ceteras res omnes, tum, quod est difficillimum, docuit, ut nosmet ipsos nosceremus, cuius praecepti tanta uis et tanta sententia est, ut ea non homini quoipiam, sed Delphico deo tribueretur». Cf. Tusc. Disp. I, 25: «Philosophia vero, omnium mater artium, quid est aliud nisi, ut Plato [Timeo 47a] donum, ut ego [Cicerón], inventum deorum?». El motivo se encuentra también en Séneca, Ad Luc. 90, 1: «Quis dubitare, mi Lucili, potest qui deorum inmortalium munus sit quod vivimus, philosophiae quod bene vivimus? Itaque tanto plus huic nos debere quam dis quanto maius beneficium est bona vita quam vita pro certo haberetur, nisi ipsam philosophiam di tribuissent, cuius scientiam nulli dederunt, facultatem omnibus». Entre muchos otros lugares del Convivio, cf. Cv. II XV 12: «La donna di cu’ io innamorai appresso lo primo amore fu la bellissima e onestissima figlia dello Imperadore dell’universo, alla quale Pittagora puose nome Filosofia». Todos los subrayados son míos. Agradezco al profesor Antonio Tursi haberme llamado la atención sobre estos pasajes. 13 14 Tanto la función cumplida por Orfeo cuanto la llevada a cabo por Dante en el Convivio tienen un horizonte político que se pone de manifiesto si se confronta nuestra argumentación con la Monarchia. En Mon. I III Dante se propone determinar cuál es el fin propio de la humana civilitas, para lo cual se pregunta cuál es la potencialidad última (ultimum de potentia) de la humanidad entendida como un todo. En un argumento que es piedra liminar de la antropología que Dante construye en la Monarchia, señala que esta potencialidad (vis ultima) ha de ser exclusiva (propria) de la especie humana, es decir, no ha de ser compartida (participata) por ninguna otra especie: «Est ergo aliqua propria operatio humane universitatis, ad quam ipsa universitas hominum in tanta multitudine ordinatur; ad quam quidem operationem nec homo unus, nec domus una, nec una vicinia, nec una civitas, nec regnum particulare pertingere potest. Que autem sit illa, manifestum fiet, si ultimum de potentia totius humanitatis appareat. Dico ergo, quod nulla vis a pluribus specie diversis participata, ultimum est de potentia alicuius 63 PØrez:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:49 PÆgina 64 2013 illorum. quia cum illud quod est ultimum tale sit constitutivum speciei, sequeretur quod una essentia pluribus speciebus esset specificata; quod est impossibile» (Mon. I III 4-5). La clave interpretativa de este pasaje es la expresión «ultimum de potentia». “Potencia” (potentia), por oposición a acto (actus), hace referencia a la capacidad propia de una cosa. Se trata de una disposición no realizada, pero realizable. Esto explica que Dante utilice indiferentemente “vis” y “potentia”, que se encuentran unidas en el griego enérgeia. “Último” (ultimum) refiere al carácter específico de esa potencialidad. En este sentido, establece un límite, que es el límite propio de la especie cuya esencia no puede trascender la potencialidad que le es específica. De allí que –siguiendo a Gustavo Vinay (Alighieri 1959: ad loc.)– la expresión pueda traducirse también como «potencia específica» o «lo específico en relación con la potencia». Dante establece una identidad o equivalencia entre vis, ultimum de potentia y essentia. En efecto, si una potencia (vis) es participada por muchas especies, entonces no es lo propio («ultimum») de ninguna de ellas; pues aquello en lo que todas convienen no puede ser lo distintivo («constitutivum») de ninguna de ellas. En caso contrario, habría dos especies –el hombre y el caballo– que tendrían la misma esencia, lo cual es absurdo, pues si dos especies comparten la misma esencia, entonces son la misma especie. En otras palabras, si el hombre posee la misma esencia («essentia») que el caballo, entonces, puesto que toda esencia ha sido creada con vistas a una operación, ambos poseen la misma operación propia («propria operatio»), lo cual es absurdo. Esto significa que la universitas hominum o humanitas ha de tener una propria operatio que no pueda ser participada por ninguna otra especie. Sobre este razonamiento se apoya la determinación de la potencialidad última –es decir, específica– del hombre: «Non est ergo vis ultima in homine ipsum esse simpliciter sumptum, quia etiam sic sumptum ab elementis participatur; nec esse complexionatum, quia hoc reperitur in mineralibus; nec esse animatum, quia sic etiam in plantis; nec esse apprehensivum, quia sic etiam participatur a brutis; sed esse apprehensivum per intellectum possibilem, quod quidem esse nulli ab homine alii competit vel supra vel infra. Nam etsi aliae sunt essentiae intellectum participantes, non tamen intellectus earum est possibilis, ut hominis, quia essentiae tales species quaedam sunt intellectuales et non aliud, et earum esse nihil est aliud quam intelligere quid est quod sunt, quod est sine interpolatione, aliter sempiternae non essent. Patet igitur, quod ultimum de potentia ipsius humanitatis est potentia sive virtus intellectiva» (Mon. I III 6-7). Utilizo el texto de Alighieri 1965. 64 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 Mariano PÉREZ CARRASCO 11:49 PÆgina 65 Dante como Orfeo El carácter híbrido de la concepción dantesca de la filosofía ha sido señalado, entre otros, por Corti (1983: 84): «Fin qui [Cv. II XII 9 y II XV 12] potremmo benissimo essere nei territori di quella totalizzante Filosofia-Sapienza, tanto descritta e iconicamente resa in figura di regina incoronata e in trono [...]. Ma in Cv. III XI 12-14 Dante impunemente accosta la Sapienza dei Proverbi di Salomone alla specifica sofia aristotelica, sola atta a conferire sulla terra la felicità umana nella contemplazione del vero [...]. Ci si trova insomma nel Convivio di fronte non solo a due codici di comunicazione linguistica amorosa, quello delle canzoni e quello delle prose, ma in seguito allo sdoppiarsi di identità del simbolizzato a due filoni culturali, l’aristotelico e l’ecclesiastico-mistico che a questo punto fatalmente collaborano». Cf. también Nardi (1944b: 37-38) y Trovato (2003: 4042), quien coincide con Corti: «[Dante] makes a sharp distinction between these two terms, between philosophy understood as a system of natural sciences, and philosophy described as divine Wisdom, represented as donna gentile» (40). Insoslayable es la lectura de Nardi (1960: 75-83). Por último, cf. Cheneval (1998: 88-93), que discute con Corti acerca del supuesto hiato respecto de la concepción dantesca de la filosofía entre el libro III, donde, según Corti, Dante asumiría una posición cercana al aristotelismo radical, y el IV, donde Dante negaría la posibilidad de una filosofía humana (Cheneval 1998: 92-93, n. 44). 15 65 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:49 PÆgina 66 Tenzone 14 2013 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALIGHIERI, D. (1934 y 1937), Il Convivio, ridotto a miglior lezione e commentato da G. Busnelli e G. Vandelli, Firenze, Le Monnier. ALIGHIERI, D. (1959): Monarchia, testo, introduzione, traduzione e commento a cura di G. Vinay, Firenze, Sansoni. ALIGHIERI, D. (1965): Monarchia, a cura di P. G. Ricci, Milano, Mondadori. ALIGHIERI, D. (1995a): De vulgari eloquentia, a cura di V. Coletti, Milano, Garzanti. ALIGHIERI, D. (1995b): Convivio, a cura di F. Brambilla Ageno, Firenze, Le Lettere. Disponible online en Princeton Dante Project (dir. R. Hollander): http://etcweb.princeton.edu/dante/index.html ALIGHIERI, D. (2003), Vida nueva, ed. bilingüe al cuidado de R. Pinto, trad. L. Martínez de Merlo, Madrid, Cátedra. ALIGHIERI, P., (1978): Il “Commentarium” di Pietro Alighieri, nelle redazioni Ashburnhamiana e Ottobiana, trascrizione a cura di R. della Vedova e M. T. Silviotti, Nota introduttiva di E. Guidubaldi, Istituto Dantesco Europeo, Firenze, Olschki. BARAŃSKI, Z. G. (2005): «Dante Alighieri: experimentation and (self-) exegesis», en A. MINNIS, I. JOHNSON, The Cambridge History of Literary Criticism, Vol. 2: The Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 561-582. BAROLINI, T. (2004): «Autocitation and Autobiography», en H. BLOOM (ed.), Dante Alighieri, Philadelphia, Chelsea House Publishers, pp. 57-118. BOYDE, P. (1981): Dante Philomythes and Philosopher. Man in the Cosmos, Cambridge, Cambridge University Press. 66 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 Mariano PÉREZ CARRASCO 11:49 PÆgina 67 Dante como Orfeo CHENEVAL, F. (1998) : «La philosophie et le bonheur de Dante Alighieri», Studia Mediewistyczne XXXIII, pp. 79-96. CORNISH, A. (2011): Vernacular Translation in Dante’s Italy. Illiterate Literature, Cambridge, Cambridge University Press. CORNISH, A., (2000): «A Lady Asks: The Gender of Vulgarization in Late Medieval Italy», PMLA 115, 2, pp. 166-180. CORTI, M. (1983): La felicità mentale. Nuove prospettive per Cavalcanti e Dante, Torino, Einaudi. DE LIBERA A. (1991): Penser au Moyen Âge, Paris, Seuil. DOZON, M. (1991) : Mythe et symbole dans la Divine Comédie, Firenze, Biblioteca dell’Archivium Romanicum, Olschki. DRAGONETTI, R. (2006) : «La conception du langage poétique dans le De vulgari eloquentia», en ID.: Dante, la langue et le poème. Recueil d’études, Genève, Belin, 2006, pp. 45-106. DRAGONETTI, R. (1968): Dante pèlerin de la Sainte Face, Romanica Gandesia, XI, Gent-Gand, Rijksuniversiteit te Gent, Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte. FENZI, E. (2002): «L’esperienza di sé come esperienza dell’allegoria (a proposito di Dante, Convivio II I 2)», Studi Danteschi LXVII, pp. 161200. GILSON, É. (1938): Dante et la philosophie, Paris, Vrin. HOLLANDER, R. (1969): Allegory in Dante’s Commedia, Princeton, Princeton University Press. MAIERÙ, A., (1999): «‘Littera’ e ‘allegoria’», en AA.VV., Storia e poesia nella cultura medioevale, Roma, Istituto Storico per il Medioevo, pp. 138-150. MINNIS, A. (1984): Medieval Theory of Authorship, London, Scolar Press. 67 PØrez:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:49 PÆgina 68 2013 MINNIS, A. (2009): Translations of Authority in Medieval English Literature. Valuing the Vernacular, Cambridge, Cambridge University Press. NARDI, B. (1944): «Note al Convivio: I sensi delle scritture (Cv. II, I, 2 ss)», en ID., Nel mondo di Dante, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, pp. 55-61. NARDI, B., (1944b): «Le figurazioni allegoriche e l’allegoria della ‘donna gentile’», en ID., Nel mondo di Dante, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, pp. 23-40. NARDI, B. (1960): «Dal Convivio alla Commedia», en ID., Dal Convivio alla Commedia. Sei saggi danteschi, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, pp. 37-150. PADOAN, G. (1984): «Orfeo», en Enciclopedia Dantesca, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, Vol. IV, p. 192. PÉPIN, J. (1970): Dante et la tradition de l’allégorie, Montréal / Paris, Institute d’Études Médiévales / Vrin. PÉZARD, A. (1940a): «L’allégorie d’Orphée (Faria mansuescere e umiliare li crudeli cuori – II I 3)», en ID.: Le “Convivio” de Dante. Sa lettre, son esprit, Paris, Les Belles Lettres, pp. 15-26. PÉZARD, A. (1940b): «La vérité cachée (I IX 7)», en ID., Le “Convivio” de Dante. Sa lettre, son esprit, Paris, Les Belles Lettres, pp. 9-14. PICONE, M. (2005): «La teoria dell’auctoritas nella Vita nova», Tenzone 6, pp. 173-191. RUSSELL ASCOLI, A. (2008): Dante and the Making of a Modern Author, Cambridge, Cambridge University Press. SEGRE, C. (1963): «Il Convivio di Dante Alighieri», en ID., Lingua, stile e società. Studi sulla storia della prosa italiana, Milano, Feltrinelli, pp. 227-270. SINGLETON, CH. S. (1950): «Dante’s Allegory», Speculum 25, 1, pp. 7886. 68 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 Mariano PÉREZ CARRASCO 11:49 PÆgina 69 Dante como Orfeo TROVATO, M. (2003): «Against Aristotle: Cosmological Vision in Dante’s Convivio», en Essays in Medieval Studies 20, Illinois Medieval Association, pp. 31-46. VASOLI, C. (1994): «Le idee politiche di Dante dal Convivio alla Monarchia», en As relaçôes de poder no pensamento político da Baixa Idade Média. Homenagem a Joâo Morais Barbosa, Vol. I, Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 7, pp. 25-41. 69 PØrez:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:49 PÆgina 70 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 71 Dal ‘Convivio’ alla ‘Monarchia’ per il tramite del ‘De officiis’ di Cicerone: l’imprescindibile paradigma ciceroniano CLAUDIA DI FONZO Università di Trento [email protected] RESUMEN: El artículo incide en la idea de la honda influencia ciceroniana en las concepciones políticas y filosóficas de Dante, y hace un recorrido por las principales concepciones ciceronianas que han dejado su huella en la obra del florentino. Tras repasar los pasajes dantescos en que se hace explícita referencia a Cicerón, la autora se detiene en el análisis de algunas ideas clave del De officis como fuente fundamental del Convivio y del Monarchia, sin olvidar algunos pasajes de la Commedia. PALABRAS CLAVE: Cicerón, De officis, Convivio, Monarchia, útil, honesto, filosofía, política, justicia. ABSTRACT: The article stresses the idea that Cicero had a deep influence on Dante’s political and philosophical thought and it reviews the main Ciceronian concepts which left a mark on the Florentine writer’s work. After examining the passages where Dante makes explicit reference to Cicero, the author analyzes some of the key ideas of De officiis, the fundamental source of Convivio and of De Monarchia, without neglecting a few extracts from The Divine Comedy. 71 Di Fonzo:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:50 PÆgina 72 2013 KEY WORDS: Cicero, De officiis, Convivio, De Monarchia, useful, honest, philosophy, politics, justice. «humani nihil a se alienum putat» (De officiis I) «sed quoniam res humanae fragiles caducaeque sunt, semper aliqui anquirendi sunt, quos diligamus et a quibus diligamur» (De amicitia XXVII 3)1 Nel presentare una anticipazione del lavoro che sto svolgendo tra Roma Tor Vergata e Parigi VIII circa il paradigma ciceroniano entro il pensiero di Dante, vorrei partire da una considerazione lapalissiana: la giustizia non è una realtà attuale nella nostra esperienza quotidiana, ma solo e nel migliore dei casi, una tensione morale, una volontà ovvero sia l’attuarsi della «più umana» delle virtù. Desiderio naturale dell’uomo è conoscere il vero circa se stesso e il mondo che lo circonda tanto per Aristotele, quanto per Cicerone, come pure per Dante. La conoscenza del vero, precisa Dante nel quarto trattato del Convivio, è possibile grazie alla «discrezione» che risiede nella parte più nobile dell’uomo, l’anima razionale, nell’abito eligente e il suo frutto più bello è la «reverenza», là dove questa reverenza non solo è lecita ma è qualificata, conduce cioè al sommo bene; nell’abito eligente risiede la vera nobiltà, quella d’animo; all’uomo e alla sua anima razionale, nella quale Dio stesso getta il seme di nobiltà, conosciuto il vero, spetta il compito di attuare la virtù che tra tutte è la più umana, la giustizia, spetta cioè di esercitare il libero arbitrio al massimo della sua compiutezza, quando maturo perfetto e intero, reverente alle auctoritates nelle materie di competenza, è capace di volere dare a ciascuno il suo, cioè di esercitare la giustizia dalla quale discende il diritto: per Dante è un problema di intelletto, volontà e libertà dell’arbitrio (libertas maior), per Cicerone di conciliazione tra onesto e utile. Nel proseguo del presente contributo apparirà 72 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 73 L’imprescindibile paradigma ciceroniano inoltre evidente come l’endiadi «giustizia e misericordia» è già presente nella tradizione ciceroniana, quella tradizione alla quale Dante attinge nella Monarchia allorché dichiara che i pagani appellavano fortuna, quella forza che i cristiani appellano Provvidenza. Si tratta di un processo che, nell’epoca premoderna, ha riguardato la letteratura classica, con speciale riferimento a Ovidio, Virgilio e Cicerone, un processo di moralizzazione dei testi classici. All’inizio del capitolo settimo del primo libro del De officiis (I VII), e dopo aver individuato nel capitolo precedente le quattro parti che costituiscono l’intima natura dell’onesto e aver parlato della prima, cioè della conoscenza del vero, il cui desiderio è una inclinazione naturale dell’uomo («qui in veri cognitione consistit, maxime naturam attingit humanam»), Cicerone, comincia a parlare della seconda parte dell’onesto, di quell’ordine, «ea ratio», in virtù del quale la società degli uomini e la vita in comune è regolata; del cui ordine (ratio), due sono le parti: la giustizia, nella quale lo splendore della virtù è massimo, e per la quale gli uomini sono detti buoni, e la beneficenza (quella che i pagani appellano beneficenza è la misericordia dell’era cristiana) o benevolenza o liberalità che dir si voglia: «De tribus autem reliquis latissime patet ea ratio, qua societas hominum inter ipsos et vitae quasi communitas continetur; cuius partes duae: iustitia, in qua virtutis splendor est maximus, ex qua viri boni nominantur, et huic coniuncta beneficentia, quam eandem vel benignitatem vel liberalitatem appellari licet». Allo stesso modo Dante nel Convivio definisce la giustizia come la più umana tra le virtù, quella che sola risiede nella volontà: «E quanto ella è più propria, tanto ancora è più amabile; onde avegna che ciascuna vertù sia amabile nell’uomo, quella è più amabile in esso che è più umana e questa è la giustizia, la quale è solamente nella parte razionale o vero intellettuale, cioè nella volontade» (Cv. I XII 9). Alle opere filosofiche di Cicerone Dante attinge a piene mani quando scrive la sua difesa pubblica, il Convivio, rivolgendo il libello ai concittadini per muoverli a giudicare giustamente essendo stato accusato di ba73 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 74 Tenzone 14 2013 ratteria in contumacia e quindi condannato al bando dalla città di Firenze, non essendosi egli presentato presso il giudice. Alle opere di Cicerone attinge anche negli anni successivi, allorché scrive la Monarchia e la Commedia.2 A ben vedere Cicerone è citato, a partire dal primo trattato del Convivio, quello proemiale, subito dopo Aristotele, Agostino e Boezio, e nel luogo in cui Dante difende non solo l’uso del volgare, che è a vantaggio di tutti, di contro al latino, a vantaggio di pochi, ma addirittura del proprio volgare (italiano) di fronte ai volgari altrui: «Contra questi cotali grida Tullio nel principio d’un suo libro, che si chiama Libro di Fine de’ Beni, però che al suo tempo biasimavano lo latino romano e commendavano la gramatica greca, per simiglianti cagioni che questi fanno vile lo parlare italico e prezioso quello di Provenza» (Cv. I XI, 14).3 Nel capitolo appena successivo, dichiarando le ragioni generative d’amore per il volgare, nuovamente Dante ricorre a Cicerone: Dico che, sì come vedere si può che s[crive] Tullio in quello De amicitia, non discordando da la sentenza del Filosofo aperta ne l’ottavo e nel nono de l’Etica, naturalmente la prossimitade e la bontade sono cagioni d’amore generative; lo beneficio, lo studio e la consuetudine sono cagioni d’amore accrescitive. E tutte queste cagioni vi sono state a generare e a confortare l’amore che ch’io porto al mio volgare, sì come brievemente io mostrerò (Cv I, XII , 3).4 Prima di procedere è utile sottolineare il peso semantico dell’avverbio «naturalmente» usato in apertura del Convivio: «tutti gli uomini naturalmente desiderano di sapere». E ancora: «la scienza è ultima perfezione de la nostra anima, tutti naturalmente al suo desiderio siamo subietti». L’avverbio non è solo un avverbio ma è il cuore della filosofia di Aristotele e di Cicerone di cui Dante si fa collettore e rielaboratore: la fondamentale bontà della legge di natura e dei fini dalla natura impressi a tutto il creato:5 una fede nella natura che giunge dalla classicità prima che dal tomismo. 74 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 75 L’imprescindibile paradigma ciceroniano Nel prologo del De senectute e sulla bocca di Catone sin da subito è fatta professione di fede nei confronti della natura: «A quelli che non trovano nel loro spirito nessun aiuto e motivo per vivere felici, per loro ogni età è grave. Quelli che invece cercano nella loro intima essenza ogni bene, quelli non possono credere che sia un male ciò che è necessità di natura».6 Dante dal canto suo, nel capitolo nono del primo trattato del Convivio dichiara che Lo dono veramente di questo comento è la sentenza de le canzoni a le quali fatto è, la qual massimamente intende inducere li uomini a scienza e a virtù, sì come si vedrà per lo pelago del loro trattato. Questa sentenza non possono non avere in uso quelli ne li quali la vera nobiltà è seminata per lo modo che si dirà nel quarto trattato (Cv. I IX 7-8).7 Da questa concezione della natura discende quella della nobiltà d’animo. La natura, scrive Cicerone, rivela essa stessa la sua potenza, quando gli uomini esaltano in altri uomini la nobiltà di un atto che essi non avrebbero avuto la forza di compiere.8 La celebrazione che della virtù viene fatta nel De senectute, non avrebbe fondamento senza questa fiducia incondizionata nella intrinseca bontà della natura. Le circa sessanta citazioni ciceroniane che il Moore ha individuato nelle opere di Dante (Moore 1896: 258 sgg. ), sono quasi tutte riferibili alle opere filosofiche e sono tratte, per lo più, dal De officiis, dal De senectute, dal De finibus; segue il De amicitia che Dante ricorda in Cv. II XII 3 e XV 1 come l’opera che, accanto al De consolatione philosophiae di Severino Boezio, lo ha spinto maggiormente allo studio della filosofia: «E udendo ancora che Tullio scritto avea un altro libro nel quale, trattando de l’Amistade, avea toccate parole de la consolazione di Lelio, uomo eccellentissimo, ne la morte di Scipione amico suo, misimi a leggere quello» (Cv. II XII 3) Se Dante cita e traduce il De officiis nel Convivio, come pure nella Monarchia;9 nella Commedia, a giudicio del Moore, lo chiama in causa in If. XI, 23.10 75 Di Fonzo:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:50 PÆgina 76 2013 Non è casuale che Dante ricorra al De officiis, la più immanentista tra le opere di Cicerone, dedicata alla vita civile e ai doveri del cittadino, allorché egli affronta il tema della nobiltà ovvero sia nel quarto trattato: de li Offici (Cv. IV VIII 2-3; XV 12; XXIV 12 e 15). La connessione tra natura, virtù e nobiltà è infatti un nodo concettuale di ascendenza ciceroniana. Se si ragiona in questi termini si comprende anche la ragion d’essere del Catone dantesco e della memoria di Cicerone, homo novus, accanto alla genealogia mista dei sette re di Roma che Dante propone nel quarto trattato del Convivio e che Lapo da Castiglionchio riprenderà corredandola della polemica tra Cicerone e Sallustio nel merito della nobiltà, nel proemio alla epistola scritta in risposta al figlio Bernardo che gli chiedeva di conoscere quali fossero le origini della loro famiglia: nobili o plebee; epistola nella quale Lapo sostiene, in prima istanza, che meglio è nascere plebei poiché questa condizione permette addirittura di piantare per primi il seme della nobiltà e dare così lustro agli antenati come ai discendenti: si tratta di quella stessa epistola che nella seconda parte affronta poi che cosa sia la nobiltà civile secondo quando sostenuto da Bartolo da Sassoferrato, anzi volgarizzando il trattato sulla nobiltà di Bartolo contenuto nella repetitio alla l. Si ut proponitis (C. 12, 1, 1) che è un commento giuridico alla canzone Le dolci rime d’amor ch’io solea del quarto trattato del Convivio (Lapo da Castiglionchio 2005: 323-449). Anche nella Monarchia Dante cita apertamente il De officiis in due luoghi significativi: in Mn. II V 7 e 17 e in Mn. II VII 12 (in secundis Officiis) e Mn. II IX 3 (in tertiis Officiis). Il ricorso esplicito o meno a Cicerone è un fatto che non ha riscosso presso gli studiosi l’attenzione che merita. Se Dante non include Cicerone tra gli autori «qui usi sunt altissimas prosas» (Dve. II VI 7: Livio, Plinio il Vecchio, Frontino e Paolo Orosio), è solo perché quella lista comprende gli storici. Nel limbo, diversamente, Cicerone è collocato nell’alveo della «filosofica famiglia» (If. IV, 132) presieduta dal maestro di color che sanno (If. IV, 141: «Tulïo e Lino / Livio e Seneca morale») segnalato all’attenzione da una bella dieresi in apertura di verso.11 76 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 77 L’imprescindibile paradigma ciceroniano Da Cicerone viene il giudizio dantesco su Pirro. Dante fa esplicito riferimento al De officiis in Mn. II IX 8 allorché cita un frammento di Ennio citato nel De officiis I XII 38: si tratta della risposta esemplare che Pirro dà ai legati romani mandati a lui per riscattare i prigionieri: esempio di liberalità e grandezza d’animo.12 Pirro è per Dante «tam moribus Eacidarum quam sanguine generosus» (Mn. II IX 8), la sua risposta degna di un re «regalis sane et digna Aecidarum genere sententia». Dante cita verbaliter il passo di Cicerone tralasciando soltanto la seconda parte dell’ultimo verso «doque volentibus cum magnis dis» a causa del plurale pagano «dis», a giudizio di Ronconi (1970), che non si addiceva al contesto dantesco. Se ne ricava che colui che combatte per una idea di giustizia e osserva le regole della guerra ha Dio dalla sua parte. Ma il De officiis è citato a partire dal quarto paragrafo. Passi paralleli quelli del De officiis I XII 38 e di Mn. II IX 4, come avverte lo stesso Dante («Et propter hoc bene Tullius, cum de hac materia tangeret») e sui quali torneremo più avanti, con buona pace di Skinner (2001). Da queste poche considerazione nasce l’urgenza di rileggere il De officiis, e le opere filosofiche di Cicerone, per meglio comprendere le opere filosofico-politiche di Dante, in particolar modo Convivio e Monarchia e non solo. Nelle pagine che seguono ci limitiamo a rileggere alcuni punti salienti del De officiis (citiamo da Cicerone 1987) nella consapevolezza che Dante cita, legge e traduce Cicerone e lo dichiara tra le sue autorità filosofiche. Il De officiis di Cicerone, scritto nel 44 a.C., rimaneggiato nel 43 a.C. e pubblicato postumo, si articola in tre libri dedicati rispettivamente all’‘onesto’ ovvero all’etica, all’‘utile’ ovvero alla politica, e al ‘conflitto’ tra l’onesto e l’utile. Cicerone scrive sulla base delle considerazioni del filosofo greco Panezio e dello storiografo Polibio che avevano entrambi giustificato ed esaltato lo Stato romano. Poiché la restaurazione morale è fondamento d’ogni restaurazione politica, Cicerone sostiene la necessità di sottomettere l’utile all’onesto e di posporre l’utile della comunità all’utile personale in vista del bene comune cioè a dire la realizzazione della giustizia possibile: l’aequitas. 77 Di Fonzo:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:50 PÆgina 78 2013 Alcuni secoli dopo, nelle Istituzioni di Giustiniano, la giustizia è ancora identificata con un principio di ordine morale che risiede nella volontà. «E a Cicerone infatti si deve ricorrere per capire Ulpiano, benché Ulpiano sembri ridurre l’idea ciceroniana di una legge universale di ragione e di giustizia a una sorta di istinto naturale».13 Cicerone, dunque, raccoglie l’istanza da un libro, in tre libri, scritto da Panezio di Rodi (180-99 circa) e dedicato al «dovere», elaborato a Roma, nell’ambiente di Scipione Emiliano, tenendo ben presente davanti agli occhi la grande repubblica romana. Il primo libro svolgeva la dottrina generale del dovere. L’anima è dotata di due facoltà: l’istinto e la ragione. L’istinto trascina l’uomo in diverse direzioni, la ragione gli indica quel che si deve fare e non fare. La vita morale è il tentativo di disciplinare con la ragione la vita istintiva. Ci sono nell’uomo quattro istinti fondamentali: aspirazione alla ricerca del vero; aspirazione alla comunità e alla vita sociale; aspirazione alla superiorità sopra gli uomini e sopra le cose; aspirazione all’armonia e all’ordine. Tali aspirazioni, innalzate dalla ragione, si trasfigurano nelle quattro virtù cardinali: sapienza, giustizia, magnanimità, temperanza. Il secondo libro definiva la natura e il valore di ciascuna virtù: la sapienza è puro amore del sapere; la giustizia virtù sociale per eccellenza, intende non solo dare a ciascuno il suo, ma a collaborare al benessere della comunità, ossia è giustizia in senso stretto ed è beneficienza; la magnanimità, non è solo fortezza dell’animo che vince le sue battaglie interne ed esterne, ma è anche quel nobile e generoso impulso che spinge l’uomo a salire verso l’alto e a prodigarsi per il bene comune; la temperanza o moderazione è equilibrio interiore dell’anima ed è dignitosa compostezza esteriore dell’aspetto e del contegno. Il terzo libro trattava dell’utile. Posto come assioma l’inseparabilità dell’utile dall’onesto, dimostrava come dall’uomo venga all’uomo il maggior bene e il maggior male. Di qui la necessità di conciliarsi gli uomini con la benevolenza, il beneficio, la rettitudine, la dedizione al bene comune. Il vero utile dell’uomo, specialmente dell’uomo politico, è nel subordinare il proprio interesse e la propria ambizione all’interesse e all’onore della comunità. 78 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 79 L’imprescindibile paradigma ciceroniano L’opera filosofica di Panezio diviene l’orditura filosofica dell’opera di Cicerone e della sua istanza di palingenesi morale. E se Panezio, nel proemio, aveva soltanto promesso di risolvere il conflitto tra l’onesto e l’utile, Cicerone adempie alla promessa nell’ultimo libro del De officiis convinto che non esista un vero e proprio conflitto tra l’onesto e l’utile poiché tutto quanto è onesto è anche utile e nulla è utile se non è onesto.14 Basta restaurare gli antichi costumi per rigenerare il mondo. È il sogno di Cicerone come pure di molti altri poeti: «Moribus antiquis res stat Romana virisque» aveva detto Ennio. Orazio canterà nel suo «carme secolare» il compiuto ritorno di quelle virtù. Le virtù romane non sono altro che distinzioni dell’unica e indivisibile virtù e non sono altro che le elleniche virtù cardinali: la pietas che governa i rapporti tra l’umano e il divino; che adempie con scrupolosa osservanza tutti i suoi obblighi verso gli dei, i genitori, la patria; la «fides», reciproca obbligazione religiosa e morale tra gli uomini e gli dei, tra gli uomini e gli uomini: lealtà, fedeltà, onestà; e quindi reciproca fiducia e sicurezza. «Fundamentum iustitiae» la chiamerà Cicerone; la «constantia» che non ha equivalente nel mondo greco: essa è assoluta coerenza e saldezza di principi e di proposititi, e quindi incrollabile fermezza e perseveranza di atteggiamenti e di affetti nella buona e nella cattiva fortuna; la «gravitas» tranquilla e sicura coscienza del proprio valore morale che si manifesta nella dignitosa compostezza degli atti e delle parole, virtù incarnata da Catone: è la virtù del «bonus vir» e del «bonus civis», il quale, contadino soldato, adempie a tutti i doveri dello stato conscio di vivere nella e per la «res publica». Il dono che offre il libro circa i doveri si chiama humanitas. Cicerone promuove l’educazione morale del figlio Marco, così come l’autore del Convivio promuove l’educazione dei suoi concittadini; ma il vero protagonista del De officiis, come anche del Convivio, è l’uomo che emancipando se stesso, promuove il proprio bene e degli altri uomini. Tra i doveri si cintemplano quelli verso la famiglia e la divinità. La famiglia vi è riconosciuta come nucleo originario della società e d’altra parte bisogna su79 Di Fonzo:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:50 PÆgina 80 2013 perarla nella società; la divinità è insita nell'umanità e si manifesta come legge morale intrinseca. E se la Repubblica, il Catone Maggiore e il Laelio o dell’amicizia si concludono con la visione, tra pitagorica e platonica, d’una vita oltremondana che è il perfezionamento della vita terrena, ma al di fuori e al di sopra di essa, nel De officiis il destino dell’uomo si compie tutto su la terra. Unico proseguimento per coloro che l’abbiano meritato per il tramite delle virtù sociali è la gloria, cioè la riconoscenza degli uomini. Il primo paragrafo del primo libro è una sorta di proemio in cui Cicerone espone quel che si accinge a fare nella sua opera e cioè una trattazione sintetica, tra filosofia e retorica, intorno al tema del dovere. Il rapporto che Cicerone istituisce tra filosofia e retorica (intesa come pratica della persuasione in funzione politica) è di relazione: la definizione di che cosa è l’onesto e la riflessione sull’utile serve a Cicerone per risolvere l’eventuale conflitto tra l’onesto e l’utile. Cicerone sembra, così facendo, suggerire a Dante la dimensione relazionale tra la Metafisica e l’Etica che prevale e ordina tutte le altre scienze nel Convivio; dimensione relazionale che sembra essere una sintesi originale di Dante che non segue dappresso la teoria scolastica della prevalenza della Metafisica sulle altre discipline ma piuttosto quella minoritaria (ad esempio di Ruggero Bacone), e sulla quale possiamo pensare abbia influito la riflessione di Accursio e del Decreto circa il fatto che se di ‘natura’ si parla bisogna intendere ‘natura id est Deus’; così che quel «naturalmente» dell’incipit del Convivio e la naturale disposizione dell’uomo alla conoscenza è un concetto tomista ma pure va oltre Tommaso, secondo il quale la Metafisica prevale sull’Etica, in quanto se la conoscenza è «ultima perfezione della nostra anima, nella quale sta la nostra ultima felicitade» (ragionando di Metafisica), e alla quale «tutti naturalmente semo subiecti» («naturalmente» significa per legge naturale) purtuttavia è l’abito eligente che fa l’uom felice in sua operazione (ragionando sul piano dell’Etica) come è scritto nel commento ai versi 81-88 della canzone Le dolci rime d’amor ch’io solea del quarto trattato del Convivio. 80 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 81 L’imprescindibile paradigma ciceroniano Nella dedicazione al figlio Marco, Cicerone lo esorta, dopo aver fatto tesoro degli insegnamenti del maestro Cratippo nella città di Atene, a imparare l’uso migliore della lingua latina e aggiunge che «ut ipse ad meam utilitatem semper cum Graecis Latina coniunxi, neque id in philosophia solum sed etiam in dicendi exercitatione feci, idem tibi censeo faciendum (ti invito a fare lo stesso), ut par sis in utriusque orationis facultate» (De officiis I I). Cicerone dichiara di padroneggiare le due facoltà «in dicendi exercitatione / in philosophia». Nessuno dei greci è riuscito a padroneggiare allo stesso modo le due abilità: «forense dicendi / hoc quietum disputandi genus». E prosegue dicendo che non vorrebbe che la sua affermazione paresse arrogante. Pur concedendo egli a molti la scienza del filosofare, a sé egli crede di poter rivendicare ciò che è proprio dell’oratore, cioè il parlare con proprietà, con chiarezza, con eleganza, per il fatto di aver consumato, in quello studio, tutta la sua vita.15 Il matrimonio tra retorica e filosofia (genere forense e filosofico) è teorizzato splendidamente da Cicerone nel’incipit parenetico del De officiis allorché incita il figlio Marco a leggere non solo le sue orazioni, ma anche i suoi libri filosofici avendo lui, diversamente dai Greci, coltivato entrambi i generi: quello più vigoroso del foro e quello più piano e calmo del ragionamento filosofico. Un altro momento importante della riflessione ciceroniana, madre di molte considerazioni successive, è quella relativa al sommo bene. Poiché non esiste un momento che si sottragga al dovere, nell’adempimento del dovere consiste tutta l’onestà della vita, così nell’inosservanza di esso risiede tutta la disonestà.16 Dunque colui che definisce il sommo bene come disgiunto dalla virtù, e lo misuri non con il criterio dell’onestà, ma con quello del proprio vantaggio, costui, se vuol essere coerente a se stesso, e non sia diretto dalla bontà della propria indole, non potrà coltivare né l’amicizia, né la giustizia, né la liberalità: certo non può essere in alcun modo forte, giudicando sommo male il dolore, né temperante, ponendo come sommo bene il piacere: 81 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 82 Tenzone 14 2013 Nam qui summum bonum sic instituit, ut nihil habeat cum virtute coniunctum, idque suis commodis, non honestate metitur, hic, si sibi ipse consentiat et non interdum naturae bonitate vincatur, neque amicitiam colere possit nec iustitiam nec liberalitatem; fortis vero dolorem summum malum iudicans aut temperans voluptatem summum bonum statuens esse certe nullo modo potest. In questo momento e in questa questione, continua Cicerone, «io seguo principalmente gli Stoici, non già come semplice espositore, ma, secondo il mio costume, attingendo da essi, come da fonti, con piena e intera libertà di giudizio, quanto e come mi parrà opportuno».17 Poiché tutto il suo ragionamento si aggirerà intorno al dovere, è necessario, in prima istanza, definire l’essenza del dovere, cosa che Panezio aveva trascurato. Tutta la dottrina del dovere consta di due parti: l’una, teorica, che riguarda il concetto del sommo bene; l’altra, pratica, che consiste nei precetti che devono regolare la condotta della vita in ogni sua parte: «Omnia de officio duplex est questio. Unum genus est, quod pertinet ad finem bonorum, alterum, quod positum est in praeceptis, quibus in omnes partes usus vitae conformari possit» (De officiis I III). Il dovere a sua volta si divide, secondo i Greci, in dovere comune o mezzano e dovere assoluto: il dovere assoluto è l’assoluta rettitudine, mentre il dovere mezzano è quello ragionevole cioè per compiere il quale si può addurre una ragione plausibile. Tre punti si devono pertanto considerare, secondo Panezio, nel prendere un partito. Prima di tutto ci si domanda se sia onesto o disonesto a farsi, quel che è oggetto della nostra deliberazione; e appunto in questa indagine spesso l’anima si dilacera tra opposti pareri.18 Poi attentamente si riflette se l’oggetto del nostro deliberare conferisca o meno al prestigio, alla potenza, onde giovare a noi e ai nostri; e questa considerazione cade tutta nella ragion dell’utile.19 La terza specie di dubbio si ha quando pare che l’utilità a sé ci attragga e l’onestà per contro a sé ci richiami, allora l’animo nel deliberare si dilacera e produce perplessità e dubbio. 82 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 83 L’imprescindibile paradigma ciceroniano Ancora e nuovamente a nulla gioverebbe la definizione dell’onesto se non fosse l’intrinseca finalità della natura a governare le argomentazioni. Infatti, nel capitolo quarto, Cicerone scrive che la natura ha dato ad ogni essere vivente l’istinto di conservar se stesso nella vita e nel corpo, evitando tutto ciò che può recargli danno e cercando ansiosamente tutto ciò che serve a sostentar la vita: «Principio generi animantium omni est a natura tributum, ut se, vitam corpusque tueatur, declinet ea, quae nocitura videantur, omniaque, quae sint ad vivendum necessaria, anquirat et paret» (De officiis I IV). Nella natura risiede il carattere dell’uomo che è «compagnevole animale» dotato di parola. La natura, con la forza della ragione, concilia l’uomo all’uomo in comunione di linguaggio e di vita; soprattutto genera in lui un singolare e meraviglioso amore per le proprie creature; spinge la sua volontà a creare e a godere associazioni e consorzi umani. Se nel capitolo introduttivo del primo libro del Convivio, citando Aristotele (Metaph. VI I 1026a 21-32), Dante scrive: «Sì come dice lo Filosofo nel principio della Prima Filosofia, tutti li uomini naturalmente desiderano di sapere» e se l’amore di conoscenza ha per oggetto il vero e il vero il giusto e il bello cioè l'onesto, come in Cicerone, si spiega perché il quattordicesimo trattato del Convivio, mai scritto, avrebbe avuto per oggetto la Giustizia, come Dante stesso dice (I XII 12; IV XXVII 11; II I 4). La naturale tensione alla conoscenza del vero genera, a sua volta, una indipendenza che è obbedienza verso quei soli maestri che, con giusta e legittima autorità, conducano alla conoscenza del vero. La funzione del maestro è un atto di giustizia che rispetta la natura profonda dell’uomo che è quella della conoscenza del vero , almeno nella riflessione di Cicerone. La condanna che dunque Dante fa di Brunetto e della sodomia è ben lontana dalla condanna per incontinenza e riguarda piuttosto la natura e la legge di natura della quale il maestro, nell’esercizio pubblico delle sue funzioni di magister, dovrebbe essere autorevole divulgatore. Il concetto in verità è alla fine tratto da Cicerone, forse anche dal Cicerone tràdito da Macrobio. All’inizio del primo libro del commento in Somnium Scipionis di Macrobio troviamo esplicitata l’idea della connessione tra la pratica della 83 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 84 Tenzone 14 2013 giustizia e l’immortalità dell’anima che più che pervenire torna a quella giustizia dalla quale è stata informata:20 Imprimisque hominis est propria veri inquisitio atque investigatio. Itaque cum sumus necessariis negotiis curisque vacui, tum avemus aliquid videre, audire, addiscere cognitionemque rerum aut occultarum, aut admirabilium ad beate vivendum necessariam ducimus. Ex quo intellegitur, quod verum, simplex sincerumque sit, id esse naturae hominis aptissimum. Huic veri videndi cupiditati adiuncta est appetitio quaedam principatus, ut nemini parere animus bene informatus a natura velit nisi praecipienti aut docenti aut utilitatis causa iuste et legitime imperanti; ex quo magnitudo animi exsistit humanarumque rerum contemptio. L’interpretazione allegorica delle canzoni del Convivio ha inizio con il XII capitolo e muove dal tempo della morte di Beatrice, quando Dante cercò la sua prima consolazione in Boezio (De consolatione) e in Cicerone (De amicitia) riuscendo a superare gradualmente le ardue difficoltà che testi di questo tipo gli presentavano. Fu l’amore perfettissimo per la Filosofia a «levarlo dal pensiero del primo amore» e a restituirlo a vita nuova. Il commento alla canzone Amor che ne la mente mi ragiona occupa tutto il terzo trattato, dedicato alla loda della «donna gentile» cioè Filosofia. Il quarto trattato invece presenta caratteri di diversità rispetto agli altri poiché la canzone commentata Le dolci rime d’amor ch’io solea non è allegorica ma dottrinale. Dante confuta la nozione di nobiltà attribuita a Federico II nel Convivio, e a Aristotele nella Monarchia, secondo la quale la nobiltà consisterebbe in «antica ricchezza e belli costumi» sostenendo che le ricchezze non possono generare nobiltà alcuna essendo in sé vili, cioè incapaci di soddisfare il desiderio e la cupidigia d’acquisirle. Circa l’impero Dante ribadisce il fatto che a lui non si possa essere «inriverenti», ma solo «non reverenti» nella materia in cui l’imperatore non è competente, cioè trattando di filosofia; l’autorità imperiale discende infatti senza mediatori direttamente da Dio, così come è scritto nel Decreto di Graziano; perciò la natura dell’Impero Romano ha caratteri «provvidenziali». 84 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 85 L’imprescindibile paradigma ciceroniano Il Convivio si interrompe al quarto trattato molto prima di arrivare a quello conclusivo che Dante dichiara di voler dedicare alla giustizia. Il Convivio, questa è l’ipotesi corrente, sebbene imperfetto poiché non terminato, inizierà a circolare tardi così come tarda è la tradizione dei manoscritti che lo tramandano, fine del Trecento inizi del Quattrocento. La prima edizione a stampa risale al 1490. Il pensiero della Commedia spinse forse in disparte il Convivio o forse l’idea di un nuovo progetto di maggior respiro politico cominciò ad abitare i propositi di Dante esule. I due progetti, secondo l’ipotesi di Auerbach, probabilmente coesistettero nei primi anni dell’esilio e solo dopo la delusione della scrittura conviviale Dante avrebbe scelto di cimentarsi nella Commedia. Sarà forse che l’esperienza cruda e dura dell’esilio minava lo stesso impianto del Convivio che doveva terminare con un libro dedicato alla giustizia, la più umana delle virtù, in un momento in cui imperversavano le ingiustizie e le lotte di fazione tra guelfi e ghibellini, categorie che si svuoteranno sempre più di significato e si caratterizzeranno sempre di più come fazioni opposte (così scrive Bartolo da Sassoferrato nel Trattato sui guelfi e ghibellini). Non sarà piuttosto che Dante cominci a elaborare la sua riflessione sulla impraticabilità della giustizia umana (giusti son due e non vi sono intesi) in assenza delle due guide che ha come approdo la prima grande utopia politica, un imperium universale capace di comporre gli interessi particolari, più tardi rievocato da Carlo V di Spagna? Non piuttosto che il mos partium et fationum lo fa ragionare sulla necessità della tranquillitas e della pace di cui parlerà nella Monarchia prima che entrambi gli scranni, dell’imperatore e del pontefice siano vuoti? Non sarà forse che davvero aveva ragione Ernesto Trucchi a identificare in una delle tre donne la Pace, restando la prima la Giustizia naturale (Drittura), la seconda Giustizia pratica o la Legge o piuttosto, secondo l’interpretazione di Pietro Alighieri, Giustizia naturale e legale da ricomprendere sotto il giusto politico dell’Etica a Nicomaco, opera citata all’inizio del primo libro della Monarchia (Mn. I XIII 4) appena dopo la Politica (Mn. I XII 10)? Il Trucchi parafrasa così: «Canzone, imita l’uccellatore fra i Bianchi, il cacciatore di fiere tra i più feroci Neri: cerca con essi la Pace e non la tro85 Di Fonzo:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:50 PÆgina 86 2013 verai né fra gli uni, né fra gli altri. Perciò a me convenne fuggir dalla loro compagnia, farmi parte per me stesso. Essi potrebbero farmi dono di pace (...) essi potrebbero ridonar la pace a Firenze, secondo i miei costanti insegnamenti; ma non lo faranno, chè il perdonare è de’ savi, ed essi di saviezza non hanno pur l’ombra!» (Trucchi, 1937: 169-182). Sulla pace tornerà nella Monarchia a proposito della «pax augustea». Nel ripensare oggi la vexata quaestio della datazione della Monarchia, alla luce degli scavi condotti da Quaglioni (Quaglioni 2011) sulla tradizione manoscritta e alla luce dell’accertamento testuale della lezione del codice Additional 6891 della British Library, relativamente all’inciso di Mn. I XII 6, non c’è ragione di credere che Dante facesse riferimento alla terza cantica della Commedia e non piuttosto a quanto aveva scritto poco sopra nello stesso trattato, e dunque non c’è necessità di far slittare nel tempo la Monarchia. È piuttosto ragionevole collocare il suo progetto a ridosso di quello del Convivio. Il 15 agosto del 1309 Enrico VII annuncia la sua intenzione di recarsi a Roma e invia i suoi ambasciatori in Italia per preparare il suo arrivo. Enrico inizia la sua discesa nel nord Italia nel mese di ottobre dell’anno 1310, lasciando Giovanni, il figlio maggiore, a Praga in qualità di vicario imperiale. Nel mentre Enrico VII attraversa le Alpi e giunge alla pianura lombarda, Dante scrive e rende pubblica una lettera indirizzata ai governanti e al popolo di Firenze, un vero e proprio manifesto politico.21 Giustamente Quaglioni (2011), Santagata (2012) e Casadei (2013) fanno risalire la scrittura della Monarchia rispettivamente agli anni 1312 i primi due e al 1311 il terzo; davvero poco suffragata, al contrario, l’ipotesi che la collocherebbe negli ultimi anni dell’esistenza terrena del sommo poeta. Per quanto ricostruito fin qui sarebbe addirittura ragionevole pensare che il progetto della Monarchia possa essere stata la causa della non prosecuzione del Convivio, progetto troppo ambizioso che avrebbe solo dopo tredici trattati affrontato il problema della giustizia e dell’equità. E se già al principio del Convivio Dante evoca il De officiis, allorché cita la Metafisica di Aristotele e articola la sua riflessione intorno alla felicità e al desiderio di conoscenza che muove l’uomo anche quando pro86 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 87 L’imprescindibile paradigma ciceroniano pone la giustizia come la più umana delle virtù allude al paradigma ciceroniano entro il quale conosciuta l’essenza del vero non resta che compierla nella prassi etica, applicare l’onesto all’utile per raggiungere il bello che è anche giusto. Cicerone nel De officiis spiega che è esclusiva caratteristica dell’uomo l’accurata e laboriosa ricerca del vero. L’uomo, dunque, quando è libero dalle occupazioni e dagli affanni inevitabili della vita, allora desidera vedere, capire, imparare, poiché considera la conoscenza dei segreti della natura essere la via necessaria per giungere alla felicità. E di qui ben si comprende come nulla sia più adatto alla natura umana di ciò che è intimamente vero e schiettamente sincero. In Mn. I IV 2 si istituisce un parallelo importante tra l’attività della contemplazione, propria degli angeli, e quella degli uomini che sola si può realizzare in pace: Satis igitur declaratum est quod proprium opus humani generis totaliter accepti est actuare semper totam potentiam intellectus possibilis, per prius ad speculandum et secundario propter hoc ad operandum per suam extensionem. 2 Et quia quemadmodum est in parte sic est in toto, et in homine particulari contingit quod sedendo et quiescendo prudentia et sapientia ipse perficitur, patet quod genus humanum in quiete sive tranquillitate pacis ad proprium suum opus, quod fere divinum est iuxta illud «Minuisti eum paulominus ab angelis», liberrime atque facillime se habet. Unde manifestum est quod pax universalis est optimum eorum que ad nostram beatitudinem ordinantur. A questo desiderio di contemplare la verità, aggiunge Cicerone, va congiunta una certa bramosia d’indipendenza spirituale, in ragione del quale l’animo ben formato da natura non è disposto ad obbedire ad alcuno, se non a chi lo educhi e lo ammaestri nel suo interesse e lo comandi con giusta e legittima autorità. Di qui sorge la grandezza d’animo, di qui il disprezzo dei beni caduchi. E non è piccolo privilegio della natura umana razionale, così continua Cicerone nel primo libro del De officiis, il fatto che l’uomo, unico fra tutti 87 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 88 Tenzone 14 2013 gli esseri viventi, percepisce il valore dell’ordine, della decenza e della misura nelle azioni e nelle parole. L’«ordinata civilitade» è quella che specularmente Dante propone tanto per l’ordinamento cosmologico e per le intelligenze angeliche, quanto per quello politico e sociale rispettivamente nel secondo e quarto libro del Convivio. Dall’intrinseca unione di questi quattro elementi sorge quello che andiamo cercando, cioè l’onesto, il quale anche se non gode di molta fama tra gli uomini, non cessa pertanto d’essere onesto; e anche se nessuno lo loda, noi diciamo con verità che esso, per sua propria virtù è degno di lode. In De officiis I V Cicerone intesse il discorso sulle virtù cardinali e scrive: «Eccoti, o Marco, figliuol mio, la forma ideale e, direi quasi, la sembianza pura dell’onesto», quella che, se la si scorgesse coi nostri occhi, accenderebbe in noi, come dice Platone, «meravigliosi amori per la sapienza». Ma ogni atto onesto scaturisce da una di queste quattro fonti: o consiste nell’accurata e avveduta indagine del vero; o nella conservazione della società umana, dando a ciascuno il suo e osservando lealmente i patti; o nella grandezza e saldezza d’uno spirito sublime e invitto; o, in fine, nell’ordine e nella misura di tutti i nostri atti e di tutti i nostri detti; e in ciò consiste appunto la moderazione e la temperanza. Sapienza e prudenza comportano come suo proprio e special compito l’indagine e il ritrovamento del vero già per Cicerone che si fa portatore delle istanze della filosofia aristotelica contaminandole con le istanze della filosofia platonica. Le altre virtù hanno davanti a sé il compito di procacciare e mantener quelle cose da cui dipende la vita pratica. Così Cicerone descrive la sapienza nel De officiis I VI: 88 Ex quattuor autem locis, in quos honesti naturam vimque divisimus, primus ille, qui in veri cognitione consistit, maxime naturam attingit humanam. Omnes enim trahimur et ducimur ad cognitionis et scientiae cupiditatem, in qua excellere pulchrum putamus, labi autem, errare, nescire, decipi et malum et turpe ducimus» Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 89 L’imprescindibile paradigma ciceroniano [Ora delle quattro parti, in cui abbiamo diviso l’intima essenza dell’onesto, quella prima, che si fonda su la conoscenza del vero, tocca più da vicino l’intima natura umana. In verità, tutti siamo irresistibilmente trascinati dal desiderio di conoscere e di sapere; tutti stimiamo nobile e bello eccellere in questo campo]. Appena dopo Cicerone introduce la Giustizia, cioè la facoltà di dare a ciascuno il suo e far del bene al prossimo che abbiamo ricordato all’inizio di questo contributo (De officiis I VII). Fra le altre tre specie dell’onesto, la più ampia ed estesa è quella su cui si fonda la società degli uomini e, per così dire, la comunanza della vita. Due sono le sue parti: la giustizia, che ha in sé il più fulgido splendore della virtù e che conferisce agli uomini il nome di buoni; e ad essa congiunta, la beneficenza, che può anche chiamarsi generosità o liberalità. Sed iustitiae primum munus est, ut ne cui quis noceat, nisi lacessitus iniuria, deinde ut communibus pro communibus utatur, privatis ut suis. Sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut lege, pactione, condicione, sorte. [Il primo compito della giustizia è che nessuno rechi danno a nessuno, se non provocato a torto; il secondo è che ciascuno adoperi le cose comuni come comuni, le private come private. Beni privati non esistono per natura, ma tali diventano, o per antica occupazione, come nel caso di coloro che un tempo vennero a stabilirsi in luoghi disabitati, o per diritto di conquista, come coloro che si impadroniscono di un territorio per forza d’armi, o infine per legge, per convenzione, per contratto, per sorteggio] Sed quoniam, ut praeclare scriptum est a Platone [Epist. IX, p 358 A], non nobis solum nati sumus / ortusque nostri partem patria vindicat, partem amici, atque, ut placet Stoicis, quae in terris gignatur, ad usum hominum omnia creari, homines autem hominum causa esse generatos, ut ipsi inter se aliis alii prodesse possent, in hoc naturam debemus ducem sequi, communes utilitates in medium adferre, mutatione officiorum, dando accipiendo, tum artibus, tum 89 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 90 Tenzone 14 opera, tum facultatibus devincire hominum inter homines societatem. [Ma poiché come ha scritto splendidamente Platone, noi non siamo nati soltanto per noi, ma della nostra esistenza, una parte la rivendica per sé la patria, e un’altra gli amici; e poiché ancora, come vogliono gli Stoici, tutto ciò che la terra produce è a vantaggio degli uomini, e gli uomini furono generati per il bene degli uomini, affinché possano giovarsi l’un l’altro a vicenda; per queste ragioni adunque, noi dobbiamo seguire come guida la natura, mettendo in comune le cose di comune utilità, e stringendo sempre più i vincoli con lo scambio di servigi, cioè col dare e col ricevere, con le arti, con l’opera, con gli averi]. Fundamentum autem est iustitiae fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas. Sed iniustitiae genera duo sunt, unum eorum, qui inferumt, alterum eorum, qui ab iis, quibus infertur, si possunt, non propulsant iniuriam. Nam qui iniuste impetum in quempiam facit aut ira aut aliqua perturbatione incitatus, si quasi manus afferre videtur socio; qui autem non defendit nec obsistit, si potest, iniuriae, tam est in vitio, quam si parentes aut amicos aut patriam deserat. Atque illae quidem iniuriae, quae nocendi causa de industria inferuntur, saepe a metu proficiscuntur, cum is, qui nocere alteri cogitat, timet, ne, nisi id fecerit, ipse aliquo afficiatur incommodo. Maximam autem partem ad iniuriam faciendam aggrediuntur, ut adipiscantur ea, quae concupiverunt; in quo vitio latissime patet avaritia. 90 [Fondamento poi della giustizia è la fede, cioè la scrupolosa e sincera osservanza delle promesse e dei patti (...) e vorrei credere che fides sia stata chiamata così perché fit (si fa) quel che è stato promesso. Vi sono, poi, due maniere d’ingiustizia: l’una è di quelli che fanno ingiuria; l’altra di quelli che, pur potendo, non la respingono da coloro che la patiscono. Invero colui che, spinto dall’ira o da qualche altra passione, assale ingiustamente qualcuno, fa come chi mette le mani addosso a un suo compagno; ma chi, pur potendo, non ributta e non contrasta l’ingiuria, non è meno colpevole di chi abbandonasse senza difesa i suoi genitori, i suoi amici, 2013 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 91 L’imprescindibile paradigma ciceroniano la sua patria. Ed è certo vero che le ingiurie che si fanno con il proposito di nuocere, hanno spesso origine dalla paura, quando cioè, colui che medita di recar danno ad un altro, teme che, non facendo così, abbia a subir lui qualche malanno]. La parte che Cicerone dedica alla ricchezza (De officiis I VIII) ha direttamente influenzato Dante. L’idea che la cupidigia delle ricchezze sia insaziabile in quanto cupidigia di un bene che non realizza la natura e piuttosto corrompe fino alla trasgressione perversa è rintracciabile, con gli stessi toni, in Convivio IV XII-XIII. I più, scrive Cicerone, perdono ogni senso e ricordo della giustizia, quando incappano nel desiderio (in cupiditatem) dei comandi, degli onori e della gloria. Chiara dimostrazione ne ha dato di recente il temerario ardire di Gaio Cesare, che sovvertì tutte le leggi divine e umane per quel folle ideale di supremazia ch’egli s’era foggiato nella mente: Maxime autem adducuntur plerique, ut eos iustitiae capiat oblivio, cum in imperiorum, honorum, gloriae cupiditatem inciderunt (incappano). Declaravit id modo temeritas C. Caesaris, qui omnia iura divina et humana pervertit propter eum [desiderio di comando], quem sibi ipse opinionis errore finxerat principatum. E se Dante vuole dedicare l’ultimo trattato del Convivio alla giustizia, per Cicerone è un dovere combattere per la giustizia. Nel Convivio come nel De officiis la riflessione sulla giustizia in quanto atto volontario è fondamentale. Nel parlare dei filosofi che immersi nella ricerca del vero e impediti dall’amore di sapienza abbandonano proprio quelli che hanno il dovere di proteggere, sostiene che non dovrebbero neppure accostarsi alla vita pubblica, se non costretti; Cicerone aggiunge che molto più giusto sarebbe che ciò accadesse volontariamente; perché un’azione retta non è giusta se non è volontaria.22 «Aequius autem erat id voluntate fieri; nam hoc ipsum ita iustum est, quod recte fit, si est voluntarium» (De officiis I, IX).23 Infatti «Aequitas enim lucet ipsa per se, dubitatio cogitationem significat iniuriae». La giustizia risplende di suo proprio splendore; il solo dubbio implica sempre un pensiero d’ingiustizia. 91 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 92 Tenzone 14 2013 Segue un elogio della trasgressione, quando la trasgressione significa allontanamento dalla perversa consuetudine (De officiis I X): esistono circostanze in cui, quelle azioni che sembrano più degne di un uomo giusto, di quello, cioè, che chiamiamo galantuomo, si mutano nel loro contrario, come, per esempio, il restituire un deposito (anche a un pazzo furioso?), o il mantenere una promessa; e così, il trasgredire e il non osservare le leggi della sincerità e della lealtà, diventa talvolta cosa giusta. Conviene infatti riportarsi sempre a quelle norme fondamentali della giustizia che ho posto in principio: primo non far male a nessuno; poi servire alla utilità comune: «[31] Sed incidunt saepe tempora, cum ea, quae maxime videntur digna esse iusto homine, eoque quem virum bonum dicimus, commutantur fiuntque contraria, ut reddere depositum (etiamne furioso?), facere promissum quaeque pertinent ad veritatem et ad fidem; ea migrare interdum et non servare fit iustum. Referri enim decet ad ea, quae posui principio fundamenta iustitiae, primum ut ne cui noceatur, deinde ut communi utilitati serviatur. Si commettono spesso ingiustizie anche per una certa tendenza cavillatrice, cioè per una troppo sottile, ma in realtà maliziosa, interpretazione del diritto. Di qui il comune e ormai trito proverbio: estrema giustizia, estrema ingiustizia.24 Sul concetto Cicerone torna nel terzo libro del De officiis III, [xxv], 95-96: 92 III, [xxv] 95 Ergo et promissa non facienda non numquam neque semper deposita reddenda. Si gladium quis apud te sana mente deposuerit, repetat insaniens, reddere peccatum sit, officium non reddere. Quid? Si is, qui apud te pecuniam deposuerit, bellum inferat patriae, reddasne depositum? Non credo; facias enim contra rem publicam, quae debet esse carissima. Sic multa, quae honesta natura videntur esse, temporibus fiunt non honesta; facere promissa, stare conventis, reddere deposita commutata utilitate fiunt non honesta.25 Ac de iis quidem, quae videntur esse utilitates contra iustitiam simulatione prudentiae, satis arbitror dictum. III, [xxv] 96 Sed quoniam a quattuor fontibus honestatis primo libro (I, [v] 15) of- Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 93 L’imprescindibile paradigma ciceroniano ficia duximus, in eisdem versemur, cum docebimus ea, quae videantur esse utilia neque sint, quam sint virtutis inimica. Ac de prudentia quidem, quam vult imitari malitia, itemque de iustitia, quae semper est utilis, disputatum est. Reliquae sunt duae partes honestatis, quarum altera in animi excellentis magnitudine26 et praestantia cernitur, altera in conformatione et moderatione continentiae et temperantiae. Nel passo appena riportato, Cicerone discute del personaggio di Ulisse che parve attaccato all’utile ai poeti tragici greci, ma non ad Omero. Certo è che egli si finse pazzo. Il succo della questione è che la giustizia deve essere preservata anche verso i nemici. Dante cita verbaliter nella sua Monarchia questo passo di Cicerone come abbiamo già fatto notare (De officiis I XI): «Sunt autem quaedam officia etiam adversus eos servanda, a quibus iniuriam acceperis» [Vi sono poi certi doveri che bisogna osservare anche verso coloro che ci hanno offeso]. Nam cum sint duo genera decertandi, unum per disceptationem, alterum per vim, cumque illud proprium sit hominis, hoc belvarum, confugiendum est ad posterius, si uti non licet superiore. Quare suscipienda quidem bella sunt ob eam causam, ut sine iniuria in pace vivatur (...) [In verità vi sono due maniere di contendere: con la ragione e con la forza; e poiché la ragione è propria dell’uomo e la forza è propria delle bestie, bisogna ricorrere alla seconda solo quando non ci si può valere della prima. Si devono perciò intraprendere le guerre al solo scopo di vivere in sicura e tranquilla pace]. Anche la metafora delle bestie ricorre nel primo trattato del Convivio e anzi nel proemio del primo trattato. L’accumulazione di temi e immagini tra Convivio e De officiis è paradigmatica: è un problema di contesto, di paradigma di riferimento. 93 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 94 Tenzone 14 2013 Dal Convivio, cioè dagli anni dell’esilio, alla Monarchia, cioè agli anni della discesa di Arrigo VII in Italia, non è cambiato il paradigma culturale ma solo quello politico. Rileggiamo Dante, Monarchia II IX 3: Sed semper cavendum est ut, quemadmodum in rebus bellicis prius omnia temptanda sunt per disceptationem quandam et ultimum per prelium dimicandum est, ut Tullius et Vegetius concorditer precipiunt, hic in Re militari, ille vero in Officiis; et quemadmodum in cura medicinali ante ferrum et ignem omnia experienda sunt et ad hoc ultimo recurrendum; sic, omnibus viis prius investigatis pro iudicio de lite habendo, ad hoc remedium ultimo quadam iustitie necessitate coacti recurramus. Cicerone serve a Dante per legittimare l’Impero romano e le sue conquiste. Ciò che si acquisisce per duellum si acquisisce de iure. Anche la guerra ha, infatti, un suo diritto e le sue regole: un diritto militare. Cicerone si sofferma appunto sulle regole da seguirsi in guerra nel De officiis I XII 38 allorché scrive che la guerra che non ha come fine la gloria dell’impero deve essere condotta con minor asprezza.27 Dante, lo abbiamo anticipato sopra, segue dappresso il De officiis in Monarchia II IX 4 allorché palesando egli stesso l’autorità di riferimento, scrive che Pyrrhi quidem de captivis reddendis illa praeclara: «Nec mi aurum posco nec mi pretium dederitis, Nec cauponantes bellum sed belligerantes, Ferro, non auro, vitam cernamus utrique. Vosne velit an me regnare Era, quidve ferat Fors, Virtute experiamur. Et hoc simul accipe dictum: Quorum virtutei belli Fortuna pepercit Eorundem libertati me parcere certum est. Dono ducite doque volentibus cum magnis dis» Regalis sane et digna Aeacidarum genere sententia. 94 [Splendida fu davvero la risposta che Pirro diede ai nostri legati sul riscatto dei prigionieri [Ennio, Annali VIII, n.2]: «Io non chiedo Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 95 L’imprescindibile paradigma ciceroniano oro per me, e voi a me non offrirete riscatto. Noi non facciamo la guerra da mercanti, ma da soldati: non con l’oro ma col ferro decidiamo della nostra vita e della nostra sorte. Sperimentiamo col valore se la Fortuna, arbitra delle cose umane, conceda a voi o a me l’impero; o vediamo che altro ci arrechi la sorte. E ascolta anche queste altre parole: è mio fermo proposito lasciar la libertà a tutti quelli, al cui valore la fortuna dell’armi lasciò la vita. Ecco riprendeteli con voi, io ve li do in dono col favore del cielo». Parole veramente regali e degne di un Eacida]. Procede ancora Dante in Monarchia II IX 8: Unde bene Pirrus ille, tam moribus Eacidarum quam sanguine generosus, cum legati Romanorumque pro redimendis captivis ad illum missi fuerunt, respondit: Nec mi aurum posco nec mi pretium dederitis non cauponantes bellum sed belligerantes, ferro, non auro, vitam cernamus utrique. Vosne velit an me regnare Hera, quidve ferat Sors, Virtute experiamur.[...] Quorum virtute belli Fortuna pepercit eorundem me libertati parcere certum est. Dono ducite [....] L’espressione Imperii corona, che non è del latino ciceroniano, unisce nel passo dantesco due ambiti semantici e due significati: quello di premio ottenuto in un agone e quello di potere imperiale concesso da Dio, garanzia di felicità terrena. Nel proseguo dell’opera Cicerone discute della frode e della violenza (De officiis I XIII 41): Cum autem duobus modis, id est aut vi aut fraude, fiat iniuria, fraus quasi vulpeculae, vis leonis videtur; utrumque homine alienissimum, sed fraus odio digna maiore. Totius autem iniustitiae nulla capitalior quam eorum, qui tum, cum maxime fallunt, id agunt, ut viri boni esse videantur. De iustitia satis dictum. [In due modi si può fare ingiuria: o con la violenza o con la frode; con la frode che è propria dell’astuta volpe e con la violenza che è propria del leone; indegnissima l’una e l’altra dell’uomo, ma la 95 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 96 Tenzone 14 2013 frode è assai più odiosa. Fra tutte le specie d’ingiustizia, però, la più detestabile è quella di coloro che, quando più ingannano, più cercano di apparir galantuomini. Ma basti per la prima parte della giustizia]. A proposito del concetto di iniuria scriveva il Cancelli che esso è fatto risalire dai più autorevoli dantisti alle formalizzazioni del diritto romano, mentre sarebbe più congruo dire che corrisponde genericamente al significato della parola latina. Come abbiamo anticipato sopra, il Moore si rende conto per primo che l’enunciazione dei versi di If. XI, 22 («D’ogne malizia, ch’odio in cielo acquista, / ingiuria è il fine, ed ogne fin cotale / o con forza o con frode altrui contrista. / Ma perché frode è dell’uom proprio male, / più spiace a Dio») è, ancora una volta, traduzione dal De officiis (I, XIII, 41). Nardi, pur affermando in una nota marginale che Dante ha tolto la citazione dal luogo ciceroniano, aggiunge che la nozione di ‘iniuria’ sarebbe derivata da Inst. 4, 4, 2 (Nardi, 1955: 9). Non è assolutamente d’accordo con il Nardi il Cancelli poiché, egli scrive, ‘iniuria’ ha, nelle fonti giuridiche, il significato letterale «quod non iure fit». Circa la malizia Cancelli commenta che, tanto ad locum quanto a If. XI, 82 e Cv. IV XV 17, non è altro che «prava inclinazione dell’animo a mal fare, a nuocere altrui, cioè ad arrecare ingiuria «mala disposizione che non è identificabile con il dolo dei penalisti moderni, integrandosi per questi il dolo nella sola volontà dell’evento o anche della condotta». Prosegue Cicerone e parla della larghezza (De officiis I XIV), della beneficentia e della liberalitas e dei falsi benefattori che sono in verità avidi di onore: 96 Videndum est enim, primum ne obsit benignitas et iis ipsis, quibus benigne videbitur fieri, et ceteris, deinde ne maior benignitas sit, quam facultates, tum ut pro dignitate cuique tribuatur; id enim est iustitiae fundamentum, ad quam haec referenda sunt omnia» [...] «nihil est enim liberale, quod non idem iustum Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 Claudia DI FONZO PÆgina 97 L’imprescindibile paradigma ciceroniano [Bisogna anzitutto badare che la generosità non rechi danno o alla persona che si vuol beneficare, o agli altri; poi, che la generosità non sia superiore alle nostre forze; e, infine, che si doni a ciascuno secondo il suo merito: questo è il vero fondamento della giustizia, che deve informare sempre ogni precetto. [...] Non c’è liberalità dove non c’è giustizia]. E ancora (De officiis I XIV): De benevolentia autem, quam quisque habeat erga nos, primum illud est in officio, ut ei plurimum tribuamus, a quo plurimum diligamur, sed benevolentiam non adulescentulorum more ardore quodam amoris, sed stabilitate potius et constantia iudicemus. [Quanto alla benevolenza che altri abbia verso di noi, il primo nostro dovere è che più si dia a chi più ci ama; ma questa benevolenza non dobbiamo giudicarla, come fanno i giovinetti, da un certo fervor d’amore, ma piuttosto dalla sua stabilità e saldezza]. «An imitari agros fertiles, qui multo plus efferunt, quam acceperunt?» [Non dobbiamo forse imitare i campi fertili, che rendono assai più di quel che ricevono?] Per Cicerone è necessario promuovere la solidarietà umana poichè il consorzio umano è costitutivo della natura dell’uomo; per Dante l’uomo è «compagnevole animale» per natura, e vivere nell’uomo è ragione usare; il linguaggio è infine, come già diceva Aristotele, ciò che distingue l’uomo dall’animale. La filosofia aristotelica è consegnata a piene mani, accanto a quella platonica, al Medioevo per il tramite del De officiis. L’armonizzazione tra aristotelismo e platonismo è già compiuta nelle opere filosofiche di Cicerone molto tempo prima della nascita della Scuola di Chartres. Ma conviene, pensa Cicerone, risalire a monte e mostrare quali sono i principi naturali che reggono l’umano consorzio. Il primo è quello che si scorge nella socialità dell’intero genere umano. La sua forza unificatrice 97 Di Fonzo:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:50 PÆgina 98 2013 è la ragione e la parola, che, insegnando e imparando, comunicando, discutendo, giudicando, affratella gli uomini tra loro e li congiunge in una specie di associazione naturale. Ed è questo il carattere che più ci allontana dalla natura delle fiere (dei bruti): noi diciamo spesso che nei bruti c’è l’ardimento e il coraggio come nei cavalli e nei leoni, ma non diciamo che ci sia né la giustizia, né l’equità, né la bontà; perché quelli son privi di ragione e di parola (sunt enim rationis et orationis expertes) (De officiis I XVI). Questa, dunque, è la più ampia forma di società che esista, in quanto comprende e unisce tutti gli uomini con tutti gli uomini; in essa, quei beni che le leggi e il diritto civile assegnano ai privati, siano dai privati tenuti e goduti come appunto le leggi dispongono; ma tutti quegli altri beni che la natura produce per il comune vantaggio degli uomini siano tenuti e goduti dagli uomini come patrimonio di tutti e di ciscuno, così come raccomanda il proverbio greco: «Gli amici hanno tutto in comune con gli amici». E comuni sono quei beni di cui Ennio: «L’uomo che mostra cortesemente la via a un viandante smarrito, fa come se dal suo lume accendesse un altro lume ...» Il consorzio umano è organizzato per gradi (De officiis I XVII) «ut unus fiat ex pluribus». E benché ogni virtù ci attragga a sé e ci faccia amar coloro che sembrano possederla, tuttavia la giustizia e la liberalità massimamente producono tale effetto: «Et quamquam omnis virtus nos ad se allicit facitque, ut eos diligamus, in quibus ipsa inesse videatur, tamen iustitia et liberalitas id maxime efficit» E niente è più adatto a destare amore e a stringere i cuori che la somiglianza dei costumi nelle persone dabbene: quando due uomini hanno le stesse inclinazioni e le stesse aspirazioni, allora avviene che ciascuno dei due prende piacere dell’altro come di se stesso, e si avvera quello che Pitagora vuole nell’amicizia, che, cioè, di più anime si faccia un’anima sola. Tra tutte le forme di società la più importante e la più cara è quella che lega ciascuno di noi allo Stato. Cari sono i genitori, i figliuoli, cari i pa98 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 99 L’imprescindibile paradigma ciceroniano renti e gli amici; ma la patria da sola comprende in sé tutti gli affetti di tutti. E quale buon cittadino esiterebbe ad affrontar la morte per lei, se il suo sacrificio dovesse giovarle? Tanto più esecrabile dunque è la crudeltà di codesti facinorosi che con ogni sorta di scelleratezze, fecero strazio della loro patria, e nient’altro furono e sono intenti che a distruggerla dalle fondamenta. Ma, se si vuol far gerarchie per sapere a chi bisogna rendere maggiore servigio e ossequio, il primo posto va alla patria e ai genitori, ai quali noi dobbiamo la più grande reverenza; vengano poi i figlioli e tutta la famiglia, che su di noi concentra l’attenzione e in noi trova il suo unico rifugio; seguano poi i parenti che sono in buona armonia con noi, i parenti con i quali noi abbiamo in comune anche la sorte. Perciò gli aiuti necessari a sostentar la vita si devono principalmente a questi che ho nominato; (...) ma la comunanza e l’intimità del vivere, i consigli, i colloqui, le esortazioni, i conforti, talora anche i rimproveri, hanno il loro massimo vigore e valore nell’amicizia, e amicizia dolcissima è quella che affinità elettive e caratteriali congiunge: «(...) vita autem victusque communis, consilia, sermones, cohortationes, consolationes, interdum etiam obiurgationes in amicitiis vigent maxime, estque ea iucundissima amicitia, quam similitudo morum coniugavit». Dopo alcune parole spese circa le norme della beneficienza (De officiis I XVIII)28 e circa il valore dell’esperienza, Cicerone dedica il capitolo I, XIX a disquisire della grandezza dell’animo, cioè in altre parole della nobiltà: «Quocirca nemo, qui fortitudinis gloriam consecutus est insidiis et malitia, laudem est adeptus: nihil honestum esse potest, quod iustitia vacat» [Nessuno, perciò, che abbia conseguito fama di fortezza con insidie e con malizia, ha mai ottenuto una vera gloria: non c’è onestà se non c’è giustizia]. Sed ea animi elatio, quae cernitur in periculis et laboribus, si iustitia vacat pugnatque non pro salute communi, sed pro suis commodis, in vitio est; non modo enim id virtutis non est, sed est potius immanitatis omnem humanitatem repellentis. Itaque probe definitur a Stoicis fortitudo, cum eam virtutem esse dicunt propugnatem pro aequitate. (...) nihil honestum esse potest, quod iustitia vacat. 99 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 100 Tenzone 14 2013 [Ma quella grandezza d’animo, che si manifesta nei pericoli e nei cimenti, se manca di giustizia e combatte, non per il pubblico bene ma per i suoi interessi, è in difetto e in colpa; infatti ciò non solo non è proprio della virtù, ma piuttosto è proprio della brutalità, che esclude e respinde ogni gentilezza umana]. Pertanto gli Stoici ben definiscono la fortezza, quando affermano che essa è quella virtù che combatte in difesa della giustizia.(...) non c’è onestà se non c’è giustizia. Praeclarum igitur illud Platonis: «Non, inquit, solum scientia, quae est remota ab iustitia, calliditas potius quam sapientia est appellanda, verum etiam animum paratus ad periculum, si sua cupiditate, non utilitate communi impellitur, audaciae potius nomen habeat quam fortitudinis. Itaque viros fortes et magnanimos eosdem bonos et simplices, veritatis amicos minimeque fallaces esse volumus; quae sunt ex media laude iustitiae. Bellissima, dunque, quella sentenza di Platone [De rep. Pg 485 F]: «Non solo quel sapere che è disgiunto da giustizia, va chiamato furfanteria piuttosto che sapienza, ma anche il coraggio che affronta i pericoli, se è mosso, non dal bene comune, ma da un suo proprio interesse, abbia il nome di audacia piuttosto che di fortezza». «Itaque viros fortes et magnanimos eosdem bonos et simplices, veritatis amicos minimeque fallaces esse volumus, quae sunt ex media laude iustitiae» [Non vogliamo pertanto che gli uomini forti e coraggiosi siano, nel medesimo tempo, buoni e schietti, amanti della verità e alieni da ogni impostura: qualità queste che scaturiscono dall’intima essenza della giustizia]. D’altra parte, quando si è posseduti dal desiderio di sovrastare tutti, è ben difficile serbare l’equità, che è il principale attributo della giustizia. Onde avviene che gli ambiziosi non si lasciano vincere, né da buone ragioni, né da alcuna autorità di diritto e di leggi; ed ecco levarsi per lo più a vita pubblica corruttori e partigiani, che altro non vogliono se non acquistare quanta più potenza è possibile, ed essere superiori con la violenza piuttosto che pari nella giustizia. «Nullum enim est tempus, quod iustitia vacare debeat. Fortes igitur 100 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 101 L’imprescindibile paradigma ciceroniano et magnanimi sunt habendi non qui faciunt, sed qui propulsant iniuriam». Forti e magnanimi, dunque, si devono stimare non quelli che fanno ma quelli che respingono l’ingiustizia. Il capitolo successivo ancora è dedicato alla superiorità e alla libertà dell’anima (De officiis I XX) ed è un capitolo che ha profondamente inciso sul pensiero dantesco e sulla idea dell’uomo «ben tetragono ai colpi di ventura» di Paradiso XVII, 24. Si tratta di una hapax, tetragono, per cui la critica ha individuato la citazione dell’Etica di Aristotele attraverso Tommaso, Eth. Nic. Exp. I lect. XVI, n. 193 (Pasquini 1976). Dunque la fortezza dell’animo si manifesta in due modi, spiega Cicerone: il primo consiste nel disprezzo dei beni esteriori e il secondo nell’operare azioni grandi e difficili e piene di travagli. Omnino fortis animus et magnus duabus rebus maxime cernitur, quarum una in rerum externarum despicientia ponitur, cum persuasum sit nihil hominem nisi quod honestum decorumque sit aut admirari aut optare aut expetere oportere, nullique neque homini neque perturbationi animi nec fortunae succumbere. Altera est res, ut, cum ita sis affectus animo, ut supra dixi, res geras magnas illas quidem et maxime utiles, sed ut vehementer arduas plenasque laborum et periculorum cum vitae, tum multarum rerum, quae ad vitam pertinent. [In generale la fortezza e la grandezza dell’animo si manifestano principalmente in due modi: l’uno consiste nel disprezzo dei beni esteriori, posto il principio che l’uomo non deve né ricercare, né desiderare né ammirare cosa alcuna che non sia onesta e decorosa, e non deve sottostare, né ad alcun uomo, né ad alcuna passione, né ad alcun evento di fortuna; l’altro modo (ove tu sia in quella disposizione dello spirito che ora ho detto), consiste nell’operare bensì azioni grandi e soprattutto utili, ma anche straordinariamente difficili, e piene di travagli e di pericoli, come per la vita, così per molte cose che servono alla vita]. Questa parte del De officiis potrebbe fornirci elementi per escludere che il gran rifiuto di cui parla Dante non sia riferibile alla rinunzia alla ca101 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 102 Tenzone 14 2013 rica papale da parte di Celestino, e sia riferibile piuttosto alla viltà di giudicare di Pilato, pur sapendo che Dante vuole che questo luogo sia e resti indecifrabile per compiere quanto con le parole sta sostenendo: «Fama di loro il mondo esser non lassa; / misericordia e giustizia li sdegna: / non ragioniam di lor, ma guarda e passa» (If. III, 49-51).29 Cicerone condanna infatti lo sfrenato desiderio di gloria in quanto toglie la libertà dello spirito, quella libertà che gli uomini magnanimi devono conseguire e difendere con tutte le forze, quella tranquilla serenità che porta con se fermezza e soprattutto dignitosa coscienza.30 Multi autem et sunt et fuerunt, qui eam, quam dico, tranquillitatem expetentes a negotiis publicis se removerint ad otium que perfugerint. (...) His idem propositum fuit quod regibus, ut ne qua re egerent, ne cui pararent, libertate uterentur, cuius proprium est sic vivere, ut velis [Molti furono coloro che, aspirando a questa tranquillità della quale sto parlando, rinunziarono alle cariche pubbliche per rifugiarsi nella vita appartata (....) Tutti costoro non ebbero altro proponimento che quello di «vivere da re», per non aver bisogno di nulla, nè obbedire ad alcuno e godere di quella libertà, che consiste nel vivere come si vuole]. Dante corona se stesso re sulla cima del Purgatorio quando cioè è disfrancato dalle passioni ed è libero e capace di dirigersi al bene: «Non aspettar mio dir più né mio cenno; / libero, diritto e sano è tuo arbitrio, / e fallo fora non fare a suo senno: / per ch’io te sovra te corono e mitrio» (Pg. XXVII, 138-142). Nel De officiis I XXVIII trattando del decoro nella vita e nella poesia Cicerone sembra fornire a Dante la base teorica del suo pluristilismo: la teoria della convenienza. Li poeti, dal carattere dei singoli personaggi, comprenderanno quali tratti convengano a ciascuno di essi; noi invece dobbiamo conservare quel carattere che appunto la natura ci ha imposto e che, per la sua grande nobiltà, ci innalza sopra tutti gli altri esseri viventi. Perciò i poeti, nella 102 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 103 L’imprescindibile paradigma ciceroniano grande varietà dei caratteri, vedranno essi quale condotta e quale linguaggio convengano (quid conveniat et quid deceat videbunt) propriamente anche ai personaggi viziosi; noi invece non dobbiamo che osservare la legge della natura: Duplex est enim vis animorum atque naturae: una pars in appetitu posita est, quae est ορµη Γραεχε, quae hominem huc et illuc rapit (di qua, di là li mena di Inferno V), altera in ratione, quae docet et explanat, quid faciendum fugiendumque sit. [Ita fit, ut ratio praesit, appetitus obtemperet (...)]. [Due sono, scrive Cicerone, le potenze naturali dell’animo: l’una è riposta nell’istinto (i Greci la chiamano ormé cioè impulso), e trascina ciecamente l’uomo di qua e di là; l’altra risiede nella ragione, che insegna e dimostra quello che è da fare e quello che è da evitare. (Onde conviene che la ragione comanda e l’istinto obbedisce [...])] Ogni bellezza ha poi una sua specificità e perfezione relativa alla funzione e di questa specificità parlerà Dante nel Convivio, appena prima della definizione di giustizia come volontà, allorché dirà che è proprio dell’uomo l’essere barbuto, come l’essere privo di peluria è una caratteristica della bellezza femminile (Cv. I XII 8). Cicerone conclude il suo discorso (De officiis I XXXVI) dicendo che esistono due specie di bellezza: maschile e femminile: l’una ha in sé la grazia, l’altra la dignità. Dobbiamo perciò stimar la grazia propria della donna e la dignità propria dell’uomo. A questo punto Cicerone introduce il concetto per cui il costume individuale deve rispecchiare l’ordine civile e umano (De officiis I XLI). La metafora è musicale e non può passare inosservata a quanti abbiano accettato di seguirci in questo saggio di lettura del De officiis alla scoperta dell’accumulazione di motivi che popolano il paradigma dantesco: come al suono della cetra, gli orecchi dei musici avvertono anche le più lievi dissonanze, così gli uomini, se vogliono essere acuti osservatori dei vizi umani potrebbero da piccoli indizi rilevare grandi difetti. 103 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 104 Tenzone 14 2013 Ancora il cuore del discorso di Cicerone è la legge naturale, cuore della concezione dantesca della natura. Se formalmente il De officiis III V è dedicato alla conciliazione dell’onesto e dell’utile, nella sostanza è dedicato alla legge di natura impressa a tutte le cose: Detrahere igitur alteri aliquid et hominem hominis incommodo suum commodum augere magis est contra naturam quam mors, quam paupertas, quam dolor, quam cetera, quae possunt aut corpori accidere aut rebus externis. Nam principio tollit convictum humanum et societatem. Si enim sic erimus adfecti, ut propter suum quisque emolumentum spoliet aut violet alterum, disrumpi necesse est eam, quae maxime est secundum naturam, humani generis societatem. Ut, si unum quodque membrum sensum hunc haberet, ut posse putaret se valere, si proximi membri valetudinem ad se traduxisset, debilitari et interire totum corpus necesse est, sic si unus quisque nostrum ad se rapiat commoda aliorum detrahatque quod cuique possit emolumenti sui gratia, societas hominum et communitas evertatur necesse est. Nam sibi ut quisque malit, quod ad usum vitae pertineat, quam alteri adquirere, concessum est non repugnante natura, illud natura non patitur, ut aliorum spoliis nostras facultates, copias, opes augeamus. 104 [Dunque che un uomo sottragga qualcosa a un altro uomo e che a danno altrui accresca il proprio vantaggio, è cosa contraria alla natura più degli altri mali che possono capitare a causa del corpo o di eventi esterni. Un tal modo d’agire distrugge dalle fondamenta la società umana. Chi è disposto nell’animo a spogliare o far violenza ad altri per il proprio vantaggio, infrange quell’umana convivenza nella quale più fedelmente si rispecchia e si adempie la legge della natura. A quel modo che, se ciascun membro del nostro corpo immaginasse di poter essere sano e forte attirando a sé la sanità e il vigore del membro vicino, necessariamente l’organismo intero s’indebolirebbe e perirebbe, così, se ciascuno di noi si appropriasse dei beni altrui, sottraendo altrui per il proprio vantaggio, necessariamente la società umana andrebbe in rovina. In verità, che ciascun uomo preferisca acquistare per sé anziché per altri ciò che serve ai bisogni della vita, è cosa perfettamente legittima e na- Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 105 L’imprescindibile paradigma ciceroniano turale; solo che la natura non tollera che noi accresciamo le nostre sostanze, agi e potenze con le spoglie degli altri]. Proprio dopo questo discorso sulla legge di natura Cicerone parla del tiranno come di colui ch si colloca fuori dell’umanità. (De officiis III XXI). Nel trattato intorno alle leggi Cicerone si propone di spiegare l’essenza e l’origine del diritto, di esaminare le leggi da cui gli stati devono essere retti, di considerare i principi e gli ordinamenti stabiliti e codificati presso i vari popoli, ed in particolare le istituzioni giuridiche e civili del popolo romano. [I V] Egli tenta di trovare nella filosofia il fondamento della dottrina giuridica e afferma che la legge naturale, unica, irrevocabile e eterna, superiore ad ogni umana potenza e scolpita nella coscienza stessa del genere umano, è per ogni uomo il criterio della scelta tra il bene e il male, il giusto e l’ingiusto [I VI: Ea est enim naturae vis, ea mens ratioque prudentis, ae iuris atque iniuriae regula]. Questa suprema legge morale, da Cicerone identificata con la retta ragione, e solo in seconda battuta con la legge positiva, è la ratio summa insita in natura, conforme al precetto immutabile della sapienza infinita, non soggetta alla volontà e all’arbitrio degli uomini, ma fondata nell’ordine intrinseco delle cose. Essa è emanazione della mente divina. L’uomo che da Dio ha ricevuto in dono l’anima immortale ed è stato creato ad immagine di lui, tende a conseguire la perfezione attuando la propria natura razionale e dunque perseguendo la retta ragione, e di conseguenza la legge morale e perciò anche il diritto, non stabilito da governanti e giudici, ma impresso dalla natura e comune a tutti gli uomini. Ne consegue che il genere umano è nato per la giustizia [I X: «nos a iustitiam esse natos»] dalla quale discende il diritto; e che una vita ispirata ai principi del diritto rende gli uomini migliori [I XI: «recte vivendi ratio meliores efficit»] e li conduce alla perfetta virtù, fonte di ogni bene e superiore a ogni felicità che essi possano desiderare. 105 Di Fonzo:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:50 PÆgina 106 2013 E veramente felice sarà colui che, riflettendo sulla propria umanità, nel suo valore universale, conoscerà pienamente se stesso e diverrà consapevole del principio divino che è in lui [I, XXII: «sapientia duce bonum virum et, ob eam ipsam causam cernat se beatum fore»]. Senza più temere il dolore e la morte, rinunciando alle cose vili, egli celebrerà le virtù dell’uomo civile e la pietà verso Dio e come cittadino di un’unica patria e parte di una medesima società universale, nella quale tutti sono simili tra loro e soggetti ad una stessa legge, saprà sollevarsi sul mondo dei bruti ed esaltare la dignità del proprio essere. Nel secondo libro del De officiis Cicerone afferma che le leggi scritte, mutevoli e temporanee, possono essere buone o cattive, mentre la legge naturale non è frutto dell’ingegno umano né la deliberazione di un popolo, ma qualcosa di eterno che regge l’universo intero con la sapienza dei suoi ordini e dei suoi divieti [II, IV: «legem neque hominum ingeniis excogitatam, nec scitum aliquod esse populorum, sed aeternum quiddam, quod universum mundum regeret imperandi prohibendique sapientia»]. Da tale legge universale si formano i costumi, poi il diritto consuetudinario, nato dal costume, e poi le leggi della società, che divennero leggi dello stato. Il terzo libro inizia con l’elegio dei magistrati interpreti e voce stessa della legge [III, I: «magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum»] che a quella devono sottostare, come il popolo ad essi. Importante e necessario è il loro compito, se è vero che, come nell’universo i mari e le terre sono soggetti a Dio, così nello stato la vita degli uomini deve essere soggetta alle leggi. La prova di ciò è che fin dall’antichità i popoli fondarono gli stati sul principio di autorità. Ma poiché al potere monarchico, facile a degenerare nell’assolutismo, è senz’altro preferibile quella costituzione mista di cui si parla nel De re publica, egli enuncerà leggi convenienti ad un popolo ordinato a libertà, riferendole a quella forma di governo che soprattutto approva e promueve. Quindi Cicerone espone le attribuzioni particolari dei magistrati minori e maggiori riportando il formulario giuridico dell’antica legislazione romana. Tuttavia le soluzioni proposte dall’autore 106 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 107 L’imprescindibile paradigma ciceroniano tendono sempre a conservare il potere nelle mani degli otttimati. Infine Cicerone si dichiara pronto a trattare dei poteri e dei diritti dei magistrati. È con l’eposizione de potestatum iure doveva iniziare il quarto libro Delle leggi. Il trattato intorno alle leggi, scritto intorno al 52 e al 51 a.C. e rimasto incompiuto, è un dialogo tra Cicerone, il fratello quinto e l’amico Attico, ed è la prima opera giuridica in cui sia esaminata e discussa tota causa universi iuris ac legum ed in cui l’elemento giuridico abbia il suo fondamento nella filosofia, per il legislatore sola ispiratrice di principi giusti ed eterni. Platone si era occupato dello Stato e delle Leggi in due dialoghi separati; Cicerone alla dottrina dello stato perfetto (De re publica), ambientato nel passato, fa seguire la dottrina della legislazione perfetta relativa al suo presente (De legibus). Proprio in questa visione di una società migliore, amante della cultura, rispettosa delle leggi e della giustizia, e coesa grazie ai vincoli di fratellanza e nella concezione di un mondo inteso come comunità di esseri razionali, risiede il tentativo di Cicerone di conciliare l’idea dello stato a quella dell’umanità. Leggiamo quanto scritto nel De legibus I, V pur consapevoli che il pensiero di Cicerone giunge ai medievali e a Dante attraverso il De officiis e non piuttosto attraverso quest’ultima opera che stiamo considerando. Serve tuttavia a noi considerare il De legibus per capire meglio il De officiis. Nel De legibus Cicerone scrive che sarà nostro compito spiegare il fondamento del diritto e farlo derivare dalla natura stessa dell’uomo; dobbiamo esaminare le leggi, dalle quali devono essere governati gli stati, ed in seguito considerare i principi e gli ordinamenti stabiliti e codificati presso i popoli, senza tralasciare quelle che sono le istituzioni giuridiche e civili del nostro popolo: «Natura enim iuris explicanda nobis est, eaque ad hominis repetenda natura, considerandae leges quibus civitates regi debeant; tum haec tractanda, quae conposita sunt et descripta iura et iussa populorum, in quibus ne nostri quidem populi latebunt quae vocantur iura civilia». 107 Di Fonzo:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:50 PÆgina 108 2013 La legge è impressa nella natura: «(...) lex est ratio summa, insita in natura, quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria. Eadem ratio, cum est in hominis mente confirmata et confecta, lex est». Dio, creatore della natura, è naturans in Mn. II II 3 e la colpa di Babele risiede nel tentativo da parte dell’arte umana, che avrebbe dovuto seguire la natura, di superare l’arte divina, così almeno in Dve. I VII 4 e If. XI, 103-105; diversamente, io credo, in Pd. X, 10-11. Nella Monarchia ‘natura’ può occasionalmente significare Dio, ma per lo più denota l’ordine creato e Dio in quanto autore della natura è Deus naturans. Nella natura risiede una legge che è divina; sotto questo riflettore bisogna leggere e interpretare Mn. I XIV 2: «Et cum omnis talis assumptio sit otiosa sive superflua, et omne superfluum Deo et nature displiceat, et omne quod Deo et nature displicet sit malum, ut manifestum est de se (…)». Tommaso D’Aquino (Summa contra Gentiles l. 3, c. 159), dopo aver ricordato che senza la grazia divina nessuno è capace di volgersi a Dio, aggiunge, nel capitolo successivo (160), che è in potere del libero arbitrio non porre ostacolo alla grazia, ma questa capacità si riferisce a quelli che abbiano conservato integra la potenza naturale. Se l’anima si sarà piegata al male per un disordine precedente, non sarà in suo potere non porre ostacolo alla grazia. Infatti quando la mente dell’uomo è decaduta dallo stato di rettitudine è chiaro che si allontani dall’ordine del fine stabilito. Quindi quella cosa che dovrebbe tenere il primo posto nell’affetto, come ultimo fine, diviene meno amata di quella, alla quale si rivolse disordinatamente l’animo, come a fine ultimo.31 Dante ha inoltre meditato a lungo sul secondo dialogo del De finibus dove Cicerone sostiene che non sempre il sapiente è perfettamente felice di contro a quanto sostiene Catone in quel medesimo dialogo e cioè che dalla nascita ogni essere animato ha inclinazioni e pulsioni naturali che lo spingono a scegliere ciò che è conforme alla natura e respingere ciò che è contrario; quindi poi interviene la ragione a distinguere quanto deve essere ricercato per se stesso, e in tale ricerca consiste la rettitudine, che è l’unico bene. Il sommo bene si identifica, a questo punto, con la pratica dell’onestà, ovvero della virtù; il suo conseguimento è frutto di una vita 108 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 109 L’imprescindibile paradigma ciceroniano retta, cioè virtuosa, in armonia con la natura, e quindi con la ragione, che è la parte più nobile della natura umana.32 Si tratta di due dialoghi: il primo, libri I e II, si immagina avvenuto nella villa a Cuma e il secondo, libri III e IV, si finge nella villa di Lucullo a Tuscolo. Lì Cicerone incontra Marcio Porcio Catone che morirà di lì a sei anni suicida in Utica. L’argomento della discussione del primo dialogo è un esergo epicureo: «il sommo bene consiste nel piacere» di cui Torquato è il sostenitore e Cicerone il contraddittore. La confutazione di Cicerone si fonda soprattutto sulla dialettica. Altro è il piacere, altro l’assenza di dolore. (Cicerone confuta Epicuro e la sua lettera in punto di morte in De finibus II 96-100). Il sommo bene non procede dai sensi ma dalla ragione, e se esso dovesse consistere nel piacere il sapiente non sarebbe felice, perché il dolore è inevitabile, e non hanno valore i mezzi suggeriti da Epicuro per rimuoverlo (II 86-100). L’uomo è nato per più nobili aspirazioni e la stessa dignità umana si rifiuta di accettare il piacere come sommo bene (II 111-119). Interessanti sono le confutazioni che muovono dal suo spirito di Romano in ragione del quale Cicerone esalta la virtù ricordando esempi di grandi uomini del passato. Sembra che Dante abbia inteso la lezione e e in ragione della sua esemplarità ricorda Epicuro tra coloro che insieme con il corpo l’anima morta fanno.33 Lo stoicismo moderato, la proclamazione del libero arbitrio e dell’immortalità dell’anima, gli argomenti deistici della filosofia di Cicerone piacquero ai primi apologeti cristiani, che sentirono lo scrittore latino molto vicino a sé; mentre della parte negativa della sua dottrina potevano usufruire contro lo stesso paganesimo. Così Minuccio, Felice e Lattanzio utilizzano le impostazioni e i moduli stilistici ciceroniani, e con S. Ambrogio si assiste alla progressiva assimilazione della morale e dello stile ciceroniano in senso cristiano (De officiis ministrorum). A Cicerone [all’Ortensio] S. Agostino si dichiara debitore della sua stessa conversione».34 Il volgarizzatore delle orazioni di Cicerone fu per l’appunto Brunetto Latini, maestro di Dante. Anche per definire il diritto Dante invoca l’autorità di Cicerone. 109 Di Fonzo:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:50 PÆgina 110 2013 Dante entra nel dibattito circa la divisione dei due poteri, temporale e spirituale, facendosi portatore dell’istanza di divisione dei due poteri, l’uno autorevole in temporalibus, l’altro in spiritualibus, e indicando nell’imperatore l’unico principio direttivo possibile per la vita consociata, non senza presupporre la cessione di sovranità da parte del popolo che ne ha legittimato il potere legislativo.35 A Cicerone, nell’alveo della quale si sposano l’aristotelismo e il platonismo, attingerà, prima di Dante, il Corpus iuris giustineaneo. Non è finita qui: la virtù è una tensione morale che la natura stessa imprime nell’uomo al fine di condurlo al suo compimento, cioè al compimento delle sue cause finali, cioè a dire il desiderio di conoscenza ma anche l’esigenza di rendere giustizia. Anche questa bontà intrinseca della natura è un principio che, pur risalente alla filosofia greca, viene consegnato al mondo latino nelle opere filosofiche di Cicerone e che identifica la natura con il principio divino (verbi grazia nel De senectute). Graziano raccoglie questa eredità quando scrive «natura idest Deus» all’inizio del suo Decretum. La ragione scritta, canonica e civile, che si consolida quale binomio al tempo di Dante e dello ius commune, affonda le sue radici nella filosofia di Cicerone. Bisogna ripartire da questa consapevolezza per capire il dibattito dei secoli successivi tanto in relazione al concetto di nobiltà, tanto in relazione alla riscoperta dei classici. Almeno due gli interessanti riusi ciceroniani individuabili nella Commedia che rappresentano nodi concettuali e non semplici citazioni riferibili agli ergasteria ciceroniani: quando Dante contempla dall’alto dei cieli il «vil sembiante dell’aiuola che ci fa tanto feroci» (Pd. XII, 151)36 il riferimento al Somnium Scipionis è palese; e forse anche quando individua nell’amore il principio di ordinamento di tutte le cose «l’amor che move il sole e l’altre stelle» il riferimento al De amicitia è imprescindibile. Che sia dunque l’ultima terzina della Commedia, quella che proclama l’amore come l’unica forza che muove il sole e l’altre stelle, e che si ricollega all’ordinamento del Purgatorio strutturato in ragione dell’amore rivolto malamente, eccessivo o carente, tributo conclusivo a Cicerone e alla tradizione classica? Nel settimo capitolo del De amicitia, libro amato e citato 110 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 111 L’imprescindibile paradigma ciceroniano da Dante nel Convivio tra quelli usati come introibo alla filosofia, riferisce la teoria di Empedocle di Agrigento (V. sec) che nel suo poema sulla natura dichiarava l’universo essere composto dei quattro elementi (terra, acqua, aria e fuoco), aggregati dall’amore e disgregati dall’odio: «Agrigentinum quidem doctum quendam virum carminibus Graecis vaticinatum ferunt, quae in rerum natura totoque mundo constarent, quaeque moverentur, ea contrahere amicitiam, dissipare discordiam». Da Cicerone bisogna dunque ripartire per ripensare la definizione che del diritto Dante fornisce in Monarchia II V: «ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, que servata hominum servat sotietatem, et corrupta corrumpit». Carmignani37 osservava che mentre gli scolastici usavano la parola diritto come significativo di legge e consideravano la legge come comando di un superiore, non esistendo per essi il diritto da uomo a uomo, da legge obbligatoria non derivante, l’Alighieri, invece, è consapevole che esiste un diritto che si esprime nella consuetudine degli uomini prima e nella ragione poi, cioè a dire nel giusto naturale prima e legale poi. La ragione, inoltre, non avrebbe alcuna garanzia d’essere disposta al bene comune se l’uomo non fosse per natura «compagnevole animale» e se la humana civilitas non fosse altro che la realizzazione della dimensione proporzionale cioè a dire della dimensione relazionale della creatura creata in coppia dall’origine.38 L’apporto di Cicerone e della tradizione filosofica classica per suo tramite consegnata al Medioevo e a Dante, Platone compreso, è per nulla trascurabile. Una lunga serie di piccoli dettagli potrebbero ornare questo contributo; tra gli altri scelgo i passi che parlano dei Deci, i tre personaggi che in circostanze diverse salvarono la patria in pericolo. «Chi dirà de li Deci e de li Drusi che puosero la loro vita per la patria?» Cv. IV V 14 (e anche Pd. VI, 47). In Mn. II V 15-16 i Deci sono celebrati tra quanti perseguirono il bene pubblico che è fine del diritto. In questo caso alla citazione di Livio (VIII IX, X XXVIII) Dante aggiunge la testimonianza di Cicerone del De finibus II XIX 61 (vedi anche Tusc. I XXXVII 89) che ricorda tutti e tre i Deci. Livio ricorda solo i primi due (Toynbee 1902: 290). 111 Di Fonzo:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:50 PÆgina 112 2013 Per concludere mi sia concesso inoltrarmi nella terra di nessuno delle epistole di Dante e a lui attribuite: pur se ammettessimo che l’Epistola XIII a Cangrande non fosse di Dante, certo è che si tratta di un accessus filosofico alla lettura della Commedia di Dante. Ebbene proprio in questa introduzione filosofica alla lettura della Commedia affiora un riferimento a Cicerone o almeno a quel che nel Medioevo a lui si attribuiva. In Ep. XIII, 19 leggiamo che per quel che riguarda la prima parte del prologo bisogna osservare che per ottenere un buon esordio ci vogliono tre cose, come dice Tullio nella Retorica Nova, cioè che qualcuno renda l’auditor benevolo, attento e docile; e questo specialmente nel genere mirabile delle cause, come dice lo stesso Tullio: «Propter primam partem notandum quod ad bene exordiendum tria requiruntur, ut dicit Tullius in Nova Rethorica, scilicet ut benivolum et attentum et docilem reddat aliquis auditorem; et hoc maxime in admirabili genere cause, ut ipsemet Tullius dicit». A dimostrazione che non pareva per nulla peregrino ai primi esegeti, se non a Dante stesso, ricordare il nome di Cicerone nell’esordio di una introduzione alla lettura della Commedia, opera percepita dunque alla stregua di un’opera di filosofia almeno quanto lo era il De natura di Lucrezio presso i latini, ed è inutile ricordare che i Medievali non lo conoscessero. 112 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 113 L’imprescindibile paradigma ciceroniano NOTE 1 De amicitia (Cicerone 1965: 112-227, a 214). La redazione della Monarchia sarebbe da collocare intorno al 1312 sulla base delle ricostruzioni recenti. Mi riferisco ai contributi di Marco Santagata (2012) e Diego Quaglioni del quale è imminente la nuova edizione della Monarchia. Una anticipazione in Quaglioni 2011b. 2 De finibus bonorum et malorum I I (Cicerone 1988): «Scrivendo in latino ciò che i filosofi con sommo ingegno e profonda dottrina hanno trattato in greco, sapevo bene, o Bruto, che sarebbe accaduto a questa nostra fatica di incorrere in critiche di vario genere». L’undecimo capitolo del Convivio si apre con una affermazione che fa tremare le vene e i polsi ancora oggi a chiunque abbia una qualche contezza dei fatti d’Italia e della sua esterofilia programmatica: «A perpetuale infamia e depressione de li malvagi uomini d’Italia, che commendano lo volgare altrui e lo loro proprio dispregiano, dico che la loro mossa viene da cinque abominevoli cagioni. La prima è cechitade di discrezione; la seconda, maliziata escusazione; la terza, cupidità di vanagloria; la quarta, argomento d’invidia; la quinta e ultima, viltà d’animo, cioè pusillanimità. E ciascuna di queste retadi ha sì gran setta che pochi sono quelli che siano da esse liberi» (Cv. I XI 1-2). 3 De amicitia IX 154: «Quamquam confirmatur amor et beneficio accepto et studio perspecto et consuetudine adiuncta: quibus rebus ad illum primum motum animi amoris adhibitis admirabilis quaedam exardescit benevolentiae magnitudo». L’amore cioè si rafforza quando si riceve un beneficio, quando si osserva un moto di simpatia verso di noi, quando si accresce la familiarità. Queste sono le ragioni di amore accrescitive del primo moto dell’animo che accendono una straordinaria potenza d’amore. 4 Con l’aggettivo «debito» nel Convivio (ad esempio in Cv. IV XXVII 12) si determina la qualità di una cosa che si conviene quando meglio soddisfa al debito della natura, a quello cioè che la natura di questa cosa richiede per essere soddisfatta. 5 «Quibus enim nihil est in ipsis opis ad bene beateque vivendum, eis omnis aetas gravis est; qui autem omnia bona a se ipsi petunt, eis nihil malum potest videri quod naturae necessitas adferat» (De amicitia II VI 22). 6 113 Di Fonzo:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:50 PÆgina 114 2013 Senza questa fiducia nell’ordine universale della natura, a nulla gioverebbe la scienza e la conoscenza, a nulla servirebbe la virtù, né scienza e virtù condurrebbero alla felicità, quella che per Aristotele era la felicità naturale e che per Dante come per Paolo divengono fede nel fatto che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio poiché la ratio di tutto l’universo è impinta nella natura (Cv. I, I,1). 7 8 De amicitia VII 50: «Facile indicabat ipsa natura vim suam, cum homines, quod facere ipsi non possent, id recte fieri in altero iudicarent». Il De officiis I 34-38 (dai paragrafi XI-XIII con citazione indiretta di Ennio relativa alla giustizia operata da Pirro verso i nemici) è citato, tradotto e dilazionato in Monarchia II, IX nei paragrafi 3, 4, e 8. 9 Si deve a Edward Moore (1983: 3-14) l’osservazione secondo la quale Inferno XI, 23 è traduzione dal De officiis I, [xiii], 41: «The fundamental distinction of sins of violence and sins of fraud comes directly and almost verbatim from Cicero (De Officiis, I. c.13), and it is curious that Mr. Butler has not noticed this. Cicero’s words are: «“Cum autem duobus modis, id est, aut vi, aut fraude, fiat injuria; (fraus quasi vulpeculae, vis leonis videtur) utrumque homine alienissimum, sed fraus odio digna majore”. The words in parentheses are not reproduced here by Dante; but they occur in Inf. XXVII,75, where Guido da Montefeltro says: “L’opere mie / non fur leonine ma di volpe”». 10 Per quanto concerne il tributo di Dante a Seneca morale basti ricordare il nome di Santorre Debenedetti. 11 Cicerone propone ancora il giudizio circa l’onestà e la nobiltà di Pirro nel De amicitia VIII allorché paragona tra loro due nemici: Pirro e Annibale: «Pyrrho et Hannibale; ab altero propter probitatem eius non nimis alienos animos habemus, alterum propter crudelitatem semper haec civitas oderit» 12 La nozione di giustizia, scrive Diego Quaglioni appare incastonata nel frammento di Ulpiano inserito nel Digesto sotto il titolo «de iustitia et iure» tra il frammento di Paolo (Digesto 1, 1, 11), che distingue tra il diritto naturale come ius che è sempre equo e giusto e il diritto civile come espressione positiva del giusto individuabile nell’ambito di una società, e il frammento di Gaio (Digesto 1, 1, 9) relativo alla prevalenza del diritto delle genti sul diritto civile. «Il diritto naturale è quello che ogni essere animato apprende dalla natura. Infatti questo diritto non è proprio e particolare del genere umano, ma appartiene a tutti gli esseri 13 114 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 115 L’imprescindibile paradigma ciceroniano animati che sono generati e in terra e in mare ed è comune anche ai volatili» (Quaglioni, 2004: 22-24 e 30). Qualche altro spunto Cicerone può averlo avuto da Posidonio e dal suo libello intitolato Del dovere secondo le circostanze. 14 «Nec vero hoc arroganter dictum existimari velim. Nam philosophandi scientiam concedens multis quod est oratoris proprium, apte distincte ornate dicere, quoniam in eo studio aetatem consumpsi, si id mihi assumo, videor id meo iure quodam modo vindicare». (De officiis I I). 15 «Nulla enim vitae pars neque publicis neque privatis neque forensibus neque domesticis in rebus, neque si tecum agas quid, neque si cum altero contrahas, vacare officio potest in eoque et colendo sita vita est honestas omnis et neglegendo turpitudo». (De officiis I II). 16 «Sequimur igitur hoc quidem tempore et hac in quaestione potissimum Stoicos, non ut interpretes, sed ut solemus, e fontibus eorum iudicio arbitrioque nostro, quantum quoque modo videbitur, hauriemus. 17 «Triplex igitur est, ut Panetio videtur, consilii capiendi deliberatio. Nam aut honestumme factu sit an turpe dubitant id, quod in deliberationem cadit». 18 «Cum enim utilitas ad se rapere, honestas contra revocare ad se videtur, fit ut distrahatur in deliberando animus afferatque ancipitem curam cogitandi». 19 Ambrosii Theodosii Macrobii Commentariorum in Somnium Scipionis, I, 2-8, e specialmente 7-8: «idem igitur observanter secutus est in illis precipue voluminibus, quibus statum rei publicae formandum recepit. nam postquam principatum iustitiae dedit, docuitque animam post animal non perire, per illam demum fabulam quo anima post corpus evadat, vel unde ad corpus veniat, in fine operis adseruit, ut iustitiae vel cultae premium vel spretae poenam animis quippe immortalibus subiturisque iudicium servari doceret. hunc ordinem Tullius non minore iudicio reservans quam ingenio repertus est: postquam in omni rei publicae otio ac negotio palmam iustitiae disputando dedit, sacras immortalium animarum sedes et celestium arcana regionum in ipso consummati operis fastigio locavit, indicans, quo his perveniendum vel potius revertendum sit, qui rem publicam cum prudentia iustitia fortitudine ac moderatione tractaverint». 20 Segnalo in questa sede le considerazioni di Elisa Brilli circa la funzione profetico politica delle epistolografia dantesca espresse in occasione del Convegno 21 115 Di Fonzo:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:50 PÆgina 116 2013 Internazionale di Studi di Firenze (8-9 novembre 2013) dedicato a «Enrico VII. Dante e l’Italia comunale e signorile». Digesto 1,1, 10 pr. «Iustitia est costans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi» (cfr. I 1,1 pr) 22 L’aequitas di ascendenza ciceroniana prima che canonica è il criterio di ordinamento morale del Paradiso dantesco (Di Fonzo 2011: 43-52). 23 Exsistunt etiam saepe iniuriae calumnia quadam et nimis callida, sed malitiosa iuris interpretatione. Ex quo illud «summum ius summa iniuria» factum est tritum sermone proverbium. 24 Nella quaestio LVII (De iure), art. 2, laddove Tommaso confuta la tesi che sia inconveniente distinguere tra diritto naturale e positivo, dopo aver apposto l’autorità dell’Etica di Nicomaco di Aristotele a favore della distinzione delle due componenti del giusto politico, l’una naturale, l’altra legale o positiva, articolando il suo pensiero nel merito della dialettica esistente tra queste due componenti, rimanda a Cicerone del De officiis I, [v], 15 e III [xxv], 95: «Natura autem hominis est mutabilis. Et ideo id quod naturale est homini potest aliquando deficere. Sicut naturalem aequalitatem habet ut deponenti depositum reddatur: et si ita esset quod natura humana semper esset recta, hoc esset semper servandum. Sed quia quandoque contingit quod voluntas hominis depravatur, est aliquis casus in quo depositum non est reddendum, ne homo perversam voluntatem habens male eo utatur: ut puta si furiosus vel hostis reipublicae arma deposita reposcat». Cioè a dire che sebbene l’equità naturale vuole che si renda la cosa depositata al deponente ci sono circostranze in cui la volontà umana del depositante è depravata e dunque conviene non restituire il deposito per evitare che se ne faccia un uso malvagio. Cfr. Quaglioni 2004: 73. 25 2. 26 Si tratta di quella che per Dante sarà la nobiltà d’animo. Vedi anche Cv. I IX «Cum vero de imperio decertatur belloque quaeritur gloria, causas omnino subesse tamen oportet easdem, quas dixi paulo ante iustas causas esse bellorum. Sed ea bella, quibus imperii proposita GLORIA est, minus acerbe gerenda sunt». 27 «Sed ut nec medici nec imperatores nec oratores, quamvis artis praecepta perceperint, quicquam magna laude dignum sine usu et exercitatione consequi possunt, sic officii conservanda praecepta traduntur illa quidem, ut facimus ipsi, sed rei magnitudo usum quoque exercitationemque desiderat» [Come i medici, i 28 116 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 117 L’imprescindibile paradigma ciceroniano generali, gli oratori, per bene imparare che abbiano le regole della teoria non possono conseguir nulla che meriti gran lode senza l’esperienza e la pratica, così, regole e precetti, su la rigorosa osservanza dei doveri, se ne impartiscono di certo, come appunto sto facendo io, ma la vastità e la varietà della cosa richiedono anche esperienza e pratica]. Di Fonzo (2012: 51). L’ipotesi ebbe tra i sostenitori illustri Giovanni Pascoli (1952: pp. 1469-1487). Dante cita Pilato senza esprimere un giudizio morale in Mn. II XI, 5 e 6; Mn. III XIV, 5; Ep. V, 28. La connotazione negativa dell’operato di Pilato è in Pg. XX, 91 allorché Filippo il Bello è definito «novo Pilato» per non aver ostacolato Bonifacio VIII. Quest’ultimo è l’argomento di quanti sostengono che a Pilato Dante alluda in If. III, 60. 29 «Cavenda etiam est gloriae cupiditas, ut supra dixi; eripit enim libertatem, pro qua magnanimis viris omnis debet esse contentio. Nec vero imperia expetenda ac potius aut non accipienda interdum aut deponenda non numquam. Vacandum autem omni est animi perturbatione, cum cupiditate et metu, tum etiam aegritudine et voluptate nimia et iracundia, ut tranquillitas animi et securitas adsit, quae affert cum constantiam tum etiam dignitatem». [Bisogna dunque guardarsi da un desiderio eccessivo di gloria perché toglie la libertà dello spirito, quella libertà che gli uomini grandi devono raggiungere e difendere con ogni forza. Non bisogna inoltre aspirare ai poteri massimi, o, talvolta conviene non accettarli, tal altra anche deporli. Sia l’animo sgombro da ogni passione, non solo dalla cupidigia e dalla paura, ma anche e specialmente dalla tristezza, dalla allegria eccessiva e dalla rabbia, perché tu raggiunga quella serenità pacata che si accompagna alla costanza e alla dignità]. (De officiis I XX). Al capitolo successivo (XXI) Cicerone sostiene che però quelli ai quali la natura ha fornito le attitudini per governare devono cercare di ottenere le magistrature e partecipare alla conduzione della cosa pubblica. 30 Circa l’apertura alla grazia cfr. Pd. XIX, 64: «E non voglio che dubbi, ma sie certo / che ricever la grazia è meritorio/ secondo che l’affetto è aperto». 31 32 Introduzione a Cicerone (1997/v. II: 22-23). Argomento del secondo dialogo è l’etica stoica che Catone illustra a Cicerone. L’opera in questione inizia con l’immagine del bosco e della quercia; e continua dicendo che quella quercia esiste ancora nel poema Marius (poema composto da Cicerone in lode di gaio Mario di cui restano frammenti) e sempre esisterà; «l’ingegno umano la rese immortale. Non v’è infatti germoglio, che al33 117 Di Fonzo:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:50 PÆgina 118 2013 ligni tanto durevolmente per diligenza d’agricoltore, quanto quello che sia piantato dal verso di un poeta» («Nullius autem agricolae cultu stirps tam diuturna quam poetae versu seminari potest»). Segre (1953: 353-398, a 353). Con le traduzioni ciceroniane avviene l’innesto dello studio dei classici nella corrente giuridico retorica. Nell’Introduzione Segre scrive: «democrazia comunale, intensità di lotte politiche, sono fattori extraletterari che sulla letteratura ebbero effetto decisivo, strappandola alle scuole per consegnarla al popolo, caricandola di una partecipazione sentimentale e civile» (1953: 14). Le orazioni di cicerone divengono paradigmi dell’eloquenza politica per le arringhe del comune «ma intanto l’opera classica viene esaminata e tradotta con una così reverente attenzione [...] da rappresentare una novità gravida di conseguenze» (1953: 15). La Rhetorica ad Herennium pseudo ciceroniana viene usata come manuale didattico ricco di modelli epistolari. L’importanza del fattore retorico-giuridico nella storia dei volgarizzamenti ha conseguenze geografiche poiché furono in Emilia e in Toscana le principali scuole retoriche e giuridiche, ma ha anche implicazioni sulla produzione letteraria. 34 L’imperatore è garante del diritto (ius), quel diritto che in Mn. II V 1-3 è una «realis et personalis hominis ad hominem proportio, que servata hominum servat sotietatem, et corrupta corrumpit - nam illa Digestorum descriptio non dicit quod quid est iuris, sed describit illud per notitiam utendi illo si ergo definitio ista bene ‘quid est’ et ‘quare’ comprehendit, et cuiuslibet sotietatis finis est comune sotiorum bonum, necesse est finem cuiusque iuris bonum comune esse; et inpossibile est ius esse, bonum comune non intendens. Propter quod bene Tullius in Prima rethorica: semper - inquit - ad utilitatem rei publice leges interpretande sunt Quod si ad utilitatem eorum qui sunt sub lege leges directe non sunt, leges nomine solo sunt, re autem leges esse non possunt: leges enim oportet homines devincire ad invicem propter comunem utilitatem. Propter quod bene Seneca de lege cum in libro De quatuor virtutibus, “legem vinculum” dicat “humane sotietatis”» (Testo a cura di P. G. Ricci). Mi preme osservare che, in questo luogo importantissimo del suo trattato politico, Dante cita l’opera che tutto il Medioevo attribuisce a Cicerone. 35 Alfonso Traina (1980: 305-335) individua nel Somnium Scipionis di Cicerone il tramite eccellente attraverso cui giunge a Dante il topos classico del vil sembiante della terra vista dall’alto dei cieli. 36 118 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 119 L’imprescindibile paradigma ciceroniano Le considerazioni del Carmignani (1865) apparvero per la prima volta nell’edizione della Monarchia stampata a Livorno dal Torri nel 1815. Furono ristampate nel volume di Storia delle origini e del progresso della filosofia del diritto (vol. II, pp. 70-104), poi nel 1853 come apparato alla Monarchia, Torino, Società editrice della Biblioteca dei comuni italiani, 1853. Il volume era corredato anche dal ragionamento di Cesare Balbo e dalla traduzione di Ficino. Finalmente in opuscolo indipendente nel 1865, lo studioso, insieme a talune altre idee non condivisibili, sostenne l’idea che per Dante l’imperatore era «un magistrato supremo in una repubblica di più Stati indipendenti». Seguono una serie di considerazioni discutibili: Dante stabilisce una differenza razionale tra morale e diritto, individua nel diritto non una facoltà della volontà ma una nozione dell’intelletto, conferisce al diritto, in quanto nozione, un’esistenza propria, indipendente da una corrispondente obbligazione; eguaglia il diritto, per origine e titolo, alla ragione; e non concepisce il diritto che tra gli uomini aggregati in societates. 37 Gino Arias (1901: 4-6) sottolineava la distanza tra lo ius dantesco e la iustitia scolastica che si basa sulla rectitudo di cui tratta Tommaso (Summa I, q. 113, a. 3). In merito alla proportio hominis ad hominem egli sostenne che si tratta di un principio individualistico (oggetto di studio del diritto privato) posto a fondamento del vivere sociale e non anche inerente alle relazioni tra gli individui singolarmente presi e la collettività (oggetto di studio del diritto pubblico). Categorie in verità lontane dal diritto comune medievale. 38 119 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 120 Tenzone 14 2013 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ALIGHIERI D (1995a): Convivio, a cura di Franca Brambilla Ageno, Firenze, Le Lettere. ALIGHIERI, D. (1995b): Convivio, a cura di Cesare Vasoli in Opere Minori, vol. II/1, Milano-Napoli, Ricciardi. ARIAS, G. (1901): Le istituzioni giuridiche medievali nella «Divina Commedia», Firenze, Lumachi. BARTOLO DA SASSOFERRATO (1620): Bartolus a Saxo Ferrato in Secundam Codicis Partem, Venetiis, Apud Iuntas, cc. 46a- 48b. CARMIGNANI, G. (1985): La Monarchia di Dante Alighieri, considerazioni di G. Carmignani, Pisa, Nistri. CASADEI, A. (2013): Dante oltre la «Commedia», Bologna, Il Mulino. CICERONE, M. T. (1959): De legibus, a.c. di G. de Plinval, Paris, Les Belles Lettres. CICERONE, M. T. (1965): Lelio: Dell’amicizia, in Catone Maggiore, Della vecchiezza, Lelio: Dell’amicizia, testo latino, traduzione e note di Dario Arfelli, Bologna, Zanichelli, pp. 112-227. CICERONE, M. T. (1974): Delle leggi (De legibus), testo latino, traduzione e note di A. Resta Basile, Bologna, Zanichelli. CICERONE, M. T. (1987): Dei doveri (De officiis), testo latino, traduzione e note di D. Arfelli, Bologna, Zanichelli. CICERONE, M. T (1988): De finibus bonorum et malorum, I, 1 in Opere politiche e filosofiche, v. II a cura di N. Marinone, Torino, UTET. CICERONE, M. T. (1994): De officiis, a cura di Winterbottom M., Oxford, Clarendon Press. CICERONE, M. T (1997): Opere politiche e filosofiche, II, I termini estremi del bene e del male. Discussioni tusculane, a cura di N. Marinone, Torino, Utet. 120 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 Claudia DI FONZO 11:50 PÆgina 121 L’imprescindibile paradigma ciceroniano CICERONE, M. T. (2004): Dei doveri (De officiis), testo latino, traduzione e note di D. Arfelli, Bologna, Zanichelli. DI FONZO, C. (2011): «Aequitas e giustizia distributiva nel “Paradiso” di Dante», in Challenging Centralism: Decentramento e autonomie nel pensiero politico europeo, a cura di L. Campos Boralevi, Firenze, Firenze University Press, pp. 43-52. DI FONZO, C. (2012): Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica, Napoli, EDISES. LAPO DA CASTIGLIONCHIO (1753): Epistola o sia Ragionamento di messer Lapo da Castiglionchio celebre giureconsulto del secolo XIV. Colla vita del medesimo composta dall’abate Lorenzo Mehus. Si aggiungono alcune lettere di Bernardo suo figliuolo e di Francesco di Alberto suo nipote; con un’appendice di antiqui documenti, Bologna, Girolamo Corciolani ed eredi Colli a S. Tommaso d’Aquino, pp. 10-30. LAPO DA CASTIGLIONCHIO (2005): Epistola al figlio Bernardo e due lettere di Bernardo al padre, a cura di S. Panerai, in Antica possessione con belli costumi. Due giornate di studio su Lapo da Castiglionchio il Vecchio (Firenze-Pontassieve, 3-4 ottobre 2003), a cura di F. Sznura, Florencia, Aska, pp. 323-449. MOORE, E. (1896): Studies in Dante, I, Scripture and Classical Authors in Dante, Oxford, Clarendon Press. MOORE, E. (1983): Dante’s Obligations to the ‘De Officiis’ in Regard to the Division and Order of Sins in the Inferno, Cambridge, John Wilson and Son, pp. 3-24. NARDI, B. (1951): Il canto XI dell’Inferno, Roma, Signorelli [ristampe 19552, poi in Letture dantesche, pp. 193-207]. PASCOLI, G. (1902 ): «Chi sia “colui che fece il gran rifiuto”», Il Marzocco 6 e 27 luglio. PASCOLI, G. (1952): Prose, II, Milano, Mondadori, pp. 1469-1487. 121 Di Fonzo:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 122 Tenzone 14 2013 PASQUINI, E. (1976): «Tetragono», in Enciclopedia Dantesca, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. V, pp. 601. QUAGLIONI, D. (2004): La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino. QUAGLIONI, D. (2011a): «Un nuovo testimone per l’edizione della Monarchia di Dante : il Ms. Add. 6891 della British Library (Y)», Laboratoire italien 11, pp. 231-279. QUAGLIONI, D. (2011b): «“Arte di bene e d’equitade”. Ancora sul senso del diritto in Dante», Studi Danteschi 76, pp. 27-46. RONCONI, A. (1970): «Cicerone», in Enciclopedia dantesca, Roma, Istituto per l’Enciclopedia Italiana, vol. 1, pp. 991-997. SANTAGATA, M. (2012): Dante. Il romanzo della sua vita, Milano, Mondadori. SEGRE, C. (1953): «Volgarizzamenti ciceroniani di Brunetto Latini», in Volgarizzamenti del Due e Trecento, Torino, UTET, pp. 353-398. SKINNER, Q. (2001): Dell’interpretazione, Bologna, Il Mulino. TOYNBEE, P. (1902): Dante Studies and Researches, London, Methuen. TRAINA, A. (1980): «L’aiuola che ci fa tanto feroci. Per la storia di un “topos”», in Poeti Latini e Neolatini, Bologna, pp. 305-335. TRUCCHI, E. (1937): «Contributo allo studio della canzone dantesca “Tre donne”», Giornale dantesco XXXVIII, nuova serie VIII, pp.169-182. 122 Perotti T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 123 Sul valore simbolico di Virgilio nella ‘Divina commedia’ PIER ANGELO PEROTTI Vercelli [email protected] RIASSUNTO: Se il viaggio nell’aldilà di Enea ha soprattutto la funzione di esaltare Roma e il suo impero, e quello di S. Paolo di celebrare la Chiesa di Cristo, quello di Dante ha il duplice scopo – con una sorta di sintesi dei due viaggi precedenti – di glorificare entrambi, i ‘due soli’: l’Impero, rappresentato da Virgilio (uno dei suoi più grandi cantori) e la Chiesa, simboleggiata da Beatrice, che appunto guida il poeta alla visione di Dio. Virgilio non è dunque il simbolo della ragione – come sostenuto da non pochi studiosi –, ma del potere imperiale; e questa interpretazione giova anche a chiarire il senso di alcuni passi oscuri del ‘poema sacro’, per es. il ‘disdegno’ di Guido Cavalcanti, o il valore di Medusa che ‘impietra’. PAROLE CHIAVE: Virgilio, ragione, Impero, Beatrice, Teologia, Chiesa, Cavalcanti, disdegno, Medusa. ABSTRACT: If Aeneas’s travel to the hereafter has above all the function to exalt Rome and its empire, and St. Paul’s to celebrate Christ’s Church, Dante’s travel has the twofold purpose – with a kind of synthesis of the two previous travels – to glorify both of them, the “two suns”: the Empire, represented by Virgil (one of its greatest bards) and the Church, symbolized by Beatrix, who indeed guides the poet to the vision of God. So Virgil is not the symbol of the reason – as asserted by sev- 123 Perotti T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:50 PÆgina 124 2013 eral scholars –, but of the imperial power; and this interpretation is also useful to explain the meaning of some obscure passages of the “sacred poem”, for instance the “disdain” of Guido Cavalcanti, or the value of Medusa who “petrifies”. KEY WORDS: Virgil, reason, Empiry, Beatrice, Theology, Church, Cavalcanti, disdain, Medusa. 1. Uno dei problemi esegetici fondamentali che i dantisti si sono trovati ad affrontare e che – almeno in apparenza – hanno risolto, riguarda il valore simbolico di Virgilio1 al fianco di Dante, i limiti e gli scopi della sua funzione di guida attraverso l’inferno e il purgatorio, di ‘duca’, di ‘signore’, di ‘maestro’, di ‘padre’ (Inf. I, 85; II, 140; VIII, 97, 110; X, 30; etc.). Secondo la maggioranza degli studiosi, nella Divina commedia Virgilio rappresenta la ragione umana, grazie alle sue eccezionali qualità non solo di poeta, ma anche di dotto e, più genericamente, di uomo; secondo altri è il simbolo delle scienze positive, sempre in conseguenza della fama della sua dottrina. Ancora secondo gli esegeti, Beatrice rappresenta invece la teologia, le scienze divine: ecco perché Virgilio deve essere sostituito da Beatrice per l’ascesa al paradiso, dove la ragione e la scienza umana sono impotenti o insufficienti a penetrare il mistero di Dio. Virgilio, considerato anche oggi – a ragione – il più grande poeta latino (o almeno uno dei più grandi in assoluto) e uno dei capisaldi della letteratura universale, godette di una fama se possibile ancor maggiore sin dall’epoca tardo-romana e soprattutto durante il medioevo, quando gli furono attribuite anche qualità di uomo dottissimo (cfr. Inf. I, 89: «famoso saggio»; VIII, 7: «mar di tutto il senno»; X, 4: «virtù somma»; etc.), di grammatico, di filosofo, addirittura di profeta della nascita di Gesù Cristo2, soprattutto in conseguenza dell’interpretazione messianica della IV ecloga, e di mago3 o taumaturgo, nonché di spirito permeato di senso del divino, per la sensibilità religiosa che affiora da vari passi della sua opera, e segnatamente dell’Eneide.4 Tutto questo non mi sembra però sufficiente a giustificare la scelta, da parte di Dante, di Virgilio come guida per il suo viaggio ultraterreno. Se 124 Perotti T 14:Maquetaci n 1 Pier Angelo PEROTTI 09/12/2013 11:50 PÆgina 125 Sul valore simbolico di Virgilio avesse voluto scegliere semplicemente un dotto o un filosofo, avrebbe potuto – benché del poeta latino dica: «Tu sei lo mio maestro e ‘l mio autore; / tu sei solo colui da cui io tolsi / lo bello stile che m’ha fatto onore» (Inf. I, 85 ss.) – optare per Aristotele, che egli stesso definisce «maestro di color che sanno» (Inf. IV, 131), considerato il massimo filosofo e dotto dell’antichità, che (Eth. 7, 1) Dante segue per la divisione delle colpe e l’assegnazione delle pene (Inf. XI, 79 ss.) e per l’ordinamento del purgatorio secondo la teoria dell’amore (Purg. XVII, 91 ss.); anche la divisione dei cieli è aristotelica, così come lo è la teoria dell’ordine universale e dell’istinto enunciata in Par. I, 103 ss.; ancora da Aristotele deriva, attraverso San Tommaso, la teoria del merito e della grazia che distingue i cieli dall’empireo, pur formando un’unità armonica; infine, dallo stagirita prende le mosse la teoria sociale di Par. VIII, 115 ss.5 Non mi sembra peraltro ammissibile l’opinione di qualche studioso,6 secondo cui Dante avrebbe preferito Virgilio a qualche altro dotto o poeta antico per una sorta di sentimento nazionale o nazionalistico, ossia perché Virgilio era ‘italiano’ – e comunque latino –, mentre per esempio Aristotele non lo era. 2. Si può invece concordare in linea di massima con quei pochi studiosi per i quali Virgilio rappresenta «la guida terrena dell’imperatore».7 Più esattamente, credo che Dante abbia scelto come sua guida Virgilio perché egli fu il cantore di Roma, e di conseguenza l’esaltatore di quello che sarebbe stato l’Impero romano8 (Inf. II, 20: «dell’alma Roma e di suo impero»): proprio quell’Impero che, a distanza di secoli, continua a essere, secondo Dante, il fondamento della vita civile dell’umanità. Ricordiamo, infatti, che per Dante la guida temporale del mondo deve essere l’imperatore (cfr. De monarchia e la stessa Divina commedia, passim), e che il poeta, pur definito comunemente ‘guelfo bianco’ (e in effetti lo fu nei primi tempi della sua militanza politica), sembra che durante l’esilio abbia simpatizzato piuttosto per i ghibellini.9 Una spiegazione di questo genere (già proposta da Dante Gabriele Rossetti, secondo il quale Virgilio 125 Perotti T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:50 PÆgina 126 2013 è l’incarnazione dell’idea imperiale o della fazione ghibellina) contribuisce a chiarire anche alcuni aspetti del poema la cui lettura è incerta o approssimativa: per esempio la scelta dei poeti del ‘nobile castello’ (Inf. IV 88 ss.). Presso la generalità dei commentatori si legge che Dante assegnò la palma di massimi poeti dell’antichità a Omero, Virgilio, Orazio, Ovidio e Lucano perché, oltre a essere tra i più apprezzati durante il medioevo, erano quelli che egli meglio conosceva, indirettamente (Omero) o direttamente (gli altri quattro, ai quali si ispirò, o che imitò, in modo più o meno evidente): erano infatti «i poeti più cari a Dante, e tra i più letti nel medioevo, come maestri di retorica e fonti di dottrina storica, mitologica e morale» (Sapegno in Alighieri 19943: 48); è stato altresì rilevato che «è probabile che la bella scuola, di cui qui parla D., sia dovuta ad una particolare esemplificazione degli stili, secondo la poetica medievale. Infatti, Omero e Virgilio rappresentano lo stile alto tragico, cioè l’epica, Orazio satiro lo stile comico, Ovidio delle Elegie quello elegiaco (Dve. II, IV)» (GIACALONE IN ALIGHIERI 19682: 60.11 Ora, a prescindere dal giudizio moderno su due di questi poeti, Ovidio e Lucano, secondo il quale essi non sono neppure lontanamente paragonabili a Omero, Virgilio e Orazio, ritengo che ciò che è stato sin qui osservato non basti a giustificare questa preferenza di Dante; non solo, ma che Dante si sia da sé incluso come sesto nel novero di questi poeti sembra rappresentare una forma di immodestia che – per quanto Dante fosse, com’è noto, tutt’altro che umile – non solo appare stupida, ma anche fuori luogo, data la situazione in cui si manifesta. Se invece ricordiamo che questi cinque poeti cantarono tutti il potere regio (è il caso di Omero: si pensi anche soltanto all’episodio di Tersite, nell’Iliade [2, 211 ss.], o alla vendetta di Odisseo sui Proci che avevano tentato di sostituirsi a lui nel potere, nell’Odissea) o imperiale (è il caso di Virgilio, con l’esaltazione, nell’Eneide, del principato di Ottaviano; di Orazio, amico di Mecenate e dello stesso Ottaviano, per esempio con il Carmen saeculare;10 di Ovidio, con le Metamorfosi e soprattutto con i Fasti; di Lucano, con la Farsaglia, che contiene, almeno nei primi libri,11 l’esaltazione dell’imperatore), e che lo stesso Dante appartiene di diritto 126 Perotti T 14:Maquetaci n 1 Pier Angelo PEROTTI 09/12/2013 11:50 PÆgina 127 Sul valore simbolico di Virgilio a questa categoria di poeti – non solo o non tanto per quanto aveva scritto nel De monarchia, ma soprattutto per l’elogio dell’Impero che farà nella Divina commedia –, il gruppo dei sei si trova ad avere una sorta di denominatore comune, e la composizione della compagnia sembra avere una giustificazione più chiara e convincente di quella comunemente accettata; non solo, ma verrebbe meno anche la presunta immodestia di Dante, che invece si inserì in questo gruppo di poeti semplicemente perché anch’egli era o sarebbe stato uno degli esaltatori dell’Impero. 3. Se dunque Virgilio, il cantore di Roma e dell’Impero, rappresenta non la ragione o sim., ma l’idea imperiale, assume un significato diverso anche il passo di Inf. X, 28 ss. Subitamente questo suono uscìo d’una de l’arche, però m’accostai, temendo, un poco più al duca mio. Ed ei mi disse: «Volgiti, che fai? vedi là Farinata che s’è ritto: da la cintola in su tutto il vedrai». Io avea già il mio viso nel suo fitto; ed ei s’ergea col petto e con la fronte, come avesse l’inferno in gran dispitto. E le animose man del duca e pronte mi spinser tra le sepolture a lui, dicendo: «Le parole tue sien conte». dove Dante, fautore della concezione politica filo-imperiale, è spinto da Virgilio, simbolo dell’Impero, verso Farinata,12 ghibellino e cioè sostenitore dell’imperatore: il colloquio tra i due è complessivamente pacato, sereno, non certamente crudo e violento come altri, ma non perché Virgilio abbia dato a Dante il suggerimento «Le parole tue sien conte» (v. 39) – ossia ‘bada a come parli; parla saggiamente, pacatamente’13 –, bensì piuttosto perché, nonostante gli inevitabili contrasti tra le parti nella Firenze del Due-Trecento, il pensiero politico di Dante si avvicinava parecchio a 127 Perotti T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 128 Tenzone 14 2013 quello che era stato di Farinata.14 Non può sfuggire – accogliendo questa mia interpretazione del significato di Virgilio come guida di Dante – il valore simbolico di questo gesto, che invece, seguendo l’interpretazione tradizionale di Virgilio-ragione, risulterebbe banale e poco significativo, di semplice incoraggiamento nei confronti di Dante, che sembra timoroso di incontrare un avversario politico.15 4. La mia interpretazione risolve – credo in modo soddisfacente – anche la questione concernente il cosiddetto ‘disdegno di Guido’:16 leggiamo il passo (Inf. X, 52 ss.): 128 Allor surse a la vista scoperchiata un’ombra lungo questa infino al mento: credo che s’era in ginocchio levata. Dintorno mi guardò, come talento avesse di veder s’altri era meco; e poi che il sospecciar fu tutto spento, piangendo disse: «Se per questo cieco carcere vai per altezza d’ingegno, mio figlio ov’è? e perché non è teco?». E io a lui: «Da me stesso non vegno: colui che attende là per qui mi mena, forse cui Guido vostro ebbe a disdegno». Le sue parole e il modo de la pena m’avean di costui già letto il nome; però fu la risposta così piena. Di subito drizzato gridò: «Come dicesti? egli ebbe? non vive egli ancora? non fiere gli occhi suoi lo dolce lome?». Quando s’accorse d’alcuna dimora ch’io faceva dinanzi a la risposta, supin ricadde, e più non parve fora. Perotti T 14:Maquetaci n 1 Pier Angelo PEROTTI 09/12/2013 11:50 PÆgina 129 Sul valore simbolico di Virgilio La prima difficoltà che gli esegeti hanno incontrato riguarda il pronome ‘cui’ del v. 63: si riferisce a Beatrice, come sostengono alcuni commentatori,17 oppure a Virgilio, come propongono altri?18 Tralasciando le aberrazioni più o meno evidenti, dirò che fino a tempi non lontani l’interpretazione dominante era che il disdegno di Guido riguardasse Virgilio. Ma tra i moderni commentatori ha acquistato seguito l’opinione che quel disdegno riguardi invece Beatrice: Beatrice simbolo della Teologia, di cui Guido (che molto probabilmente fu anch’egli [scil. come il padre Cavalcante] epicureo) non fu certo cultore e credente. Grammaticalmente, il cui (secondo un modo latino frequente anche nella nostra poesia) assorbirebbe in sé un dimostrativo, e sarebbe un a colei cui. Io preferisco l’interpretazione tradizionale (Porena in Alighieri 19592: 104).19 L’obiezione principale – non so se già espressa da qualcuno dei numerosi esegeti che si sono occupati della questione – alla proposta di riferire il pronome ‘cui’ a Beatrice è di carattere non tanto formale, ma piuttosto logico. Per quanto riguarda il primo aspetto, vale a dire quello formale, se il pronome ‘cui’ si riferisse a Beatrice (e dunque dovrebbe valere ‘a colei che’), perché mai Dante avrebbe distaccato il pronome cui dal verbo mena ad esso strettamente connesso pel senso? creando per di più quell’ambiguità del forse, che, collocato fra il mena e il cui, non si sa alla prima se riferirlo al mena o all’ebbe? Avrebbe detto con tutta chiarezza “cui Guido vostro forse ebbe a disdegno”. Invece la collocazione un po’ anormale del forse si spiega benissimo con la cura di far intendere che il cui non dipende affatto da mena (Porena in Alighieri 19592: 105). Ricordiamo, infatti, le parole di Virgilio in Inf. I, 122-123: «anima fia a ciò più di me degna: / con lei ti lascerò nel mio partire», che indicano che ‘certamente’, e non ‘forse’, Dante sarà condotto a Beatrice e lasciato alle sue premure. 129 Perotti T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:50 PÆgina 130 2013 Ancor più forte l’obiezione di ordine logico: se è vero che il riferire a Beatrice il pronome in esame risolverebbe la questione del passato remoto ‘ebbe’ (a proposito del quale si veda infra, alla fine di questo paragrafo) – considerato che nel 1300, quando si svolge il ‘viaggio’ di Dante, Beatrice Portinari era morta da 10 anni –, è altrettanto indiscutibile che la frase, intesa in questo senso, sarebbe stata assolutamente incomprensibile per l’ascoltatore Cavalcante, perché Dante avrebbe citato con un pronome, senza nominarla direttamente, una persona (ammesso che Cavalcante la conoscesse quando entrambi erano in vita) al momento assente. In pratica, alla domanda del dannato, il poeta avrebbe risposto: ‘Non sono venuto qui da solo né per meriti miei: colui che aspetta là [e Cavalcante evidentemente può vederlo] mi conduce attraverso questi luoghi (forse) [cfr. supra] a colei [qui assente, e non identificata col nome] che (forse) [cfr. supra] il vostro Guido non apprezzò’. Infatti, se anche nella Divina commedia Beatrice in senso metatestuale simboleggia la teologia, in senso letterale è una donna, o meglio lo spirito di una donna – dato che in quel momento era morta già da tempo (cfr. supra) –, e dunque o l’indicazione a Cavalcante sarebbe stata affatto inintelligibile, oppure, supponendo che il vecchio avesse intuìto il riferimento, in senso strettamente testuale Dante gli avrebbe detto che il figlio Guido aveva avuto ‘a disdegno’ la persona reale di Beatrice, il che è assolutamente inammissibile. Questo ‘cui’ si riferisce dunque, secondo l’interpretazione tradizionale, a Virgilio: parecchi commentatori (ai quali mi associo) hanno abbracciato questa spiegazione, ma a questo punto si presenta un’ulteriore difficoltà: perché Guido disdegnò Virgilio? Guido Cavalcanti, pur parteggiando per i guelfi bianchi (ossia moderati), fu di famiglia di «guelfi accaniti»,20 e guelfo (sia pure bianco) sembra sia rimasto per tutta la vita (ma cfr. infra). Evidentemente Dante, che di Guido fu amico carissimo, conosceva bene le sue opinioni politiche – che in parte coincidevano con le proprie, considerato che anch’egli sembra essere stato, almeno sino al 1300, guelfo bianco –, e in particolare sapeva che l’amico era contrario al primato, anche se soltanto temporale, dell’imperatore sul papa, e quindi al dominio imperiale sull’umanità. Non 130 Perotti T 14:Maquetaci n 1 Pier Angelo PEROTTI 09/12/2013 11:50 PÆgina 131 Sul valore simbolico di Virgilio stupisce, dunque, che Guido avesse ‘a disdegno’ Virgilio, simbolo appunto del potere imperiale. Cadrebbe così la più comune giustificazione di tale atteggiamento di Guido, che secondo non pochi critici ‘ebbe a disdegno’ Virgilio in quanto simbolo della umana ragione consapevole delle cose divine. [...] Egli ebbe a disdegno, non curò d’ascoltare gli inviti della ragione, in quanto gli parlava ispirata dal cielo, e fidente nella forza del suo ingegno non curò d’obbedire ai decreti della religione e di piegare la fronte superba davanti a Dio (Steiner in Alighieri 1940: 94). Inoltre, mi sembrano assolutamente insoddisfacenti, per non dire assurde, altre spiegazioni, secondo cui il Cavalcanti «non amasse leggere opere scritte latinamente e che per questo non facesse più che tanto conto di Virgilio» (Scartazzini in Alighieri 1874: n. a X, 63), o secondo cui non condivise il privilegio di Dante «perché non si nutrì della poesia di Virgilio, e rimase semplice rimatore d’amore, avendo a disdegno il poeta latino» (Porena in Alighieri 19592: 105). Un altro elemento controverso di questo passo è rappresentato dal passato remoto ‘ebbe’ (v. 63), che induce Cavalcante a credere che il figlio sia già morto, mentre – come lo stesso Dante precisa poco più avanti (v. 111) – Guido è ancora tra i vivi. Vari sono i tentativi di soluzione, tutti più o meno discutibili: tra coloro che riferiscono il pronome ‘cui’ a Beatrice (cioè alla teologia), qualcuno suppone che D. avrebbe usato ebbe, sostituendo alla nozione allegorica quella della persona storica di Beatrice, venuta a morte dieci anni prima; altri ha supposto che D. abbia usato il passato remoto per dire al padre di Guido che il suo disdegno per la teologia era una cosa del tempo trascorso, per offrire a Cavalcante l’illusione che il figlio era tornato in seguito alla teologia; il Pagliaro attribuisce al nesso ebbe a disdegno (differenziandolo dal nesso ebbe in disdegno accettato da altri nel senso di avere disprezzo per qualcuno) un aspetto puntuale e ingressivo, rifiutarsi, sdegnarsi di, come quello che si integra in una proposizione infi- 131 Perotti T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 132 Tenzone 14 2013 nitiva, e quindi intende: alla quale Guido rifiutò di essere condotto, come se nel cui si nasconda, oltre al complemento di direzione, anche un infinito di verbo di moto sottinteso (Giacalone in Alighieri 19682: 150). Non minori difficoltà incontra chi riferisce cui a Virgilio, inteso – tradizionalmente – come simbolo della ragione. Ma se Virgilio è – secondo la mia proposta – simbolo dell’Impero, si intravede almeno una soluzione: si potrebbe supporre che Guido, in origine guelfo, avesse negli ultimi tempi mutato le sue opinioni politiche, accostandosi ai filo-imperiali, pur senza diventare proprio ghibellino; ma questo mutamento di pensiero, tardivo, non sarebbe stato sufficiente a consentirgli di affrontare, come Dante, il simbolico viaggio nell’aldilà. In alternativa, se Guido non modificò le sue idee politiche per tutta la vita, proporrei una spiegazione di carattere grammaticale: il passato remoto ‘ebbe’ indicherebbe un’azione iniziata nel passato e perdurante nel presente, all’incirca come il perfetto greco, ossia ‘ha sempre avuto e continua ad avere a disdegno’: anche in questo caso è evidente (anzi, lo è ancor di più) il motivo per cui Guido fu escluso dal viaggio ultraterreno con Virgilio – ovviamente da intendersi, ripeto, come simbolo dell’idea imperiale – come guida. 5. Il simbolo Virgilio-Impero può chiarire altri passi controversi o poco chiari del poema: per esempio l’episodio di Medusa che pietrifica chi la guarda, per cui Virgilio fa voltare Dante, gli fa coprire gli occhi con le mani, e per maggior sicurezza vi sovrappone le sue (Inf. IX, 52 ss.): 132 «Venga Medusa: sì il farem di smalto», dicevan tutte riguardando in giuso; «mal non vengiammo in Teseo l’assalto!». «Volgiti indietro e tien lo viso chiuso; ché se il Gorgòn si mostra e tu il vedessi, nulla sarebbe del tornar mai suso». Perotti T 14:Maquetaci n 1 Pier Angelo PEROTTI 09/12/2013 11:50 PÆgina 133 Sul valore simbolico di Virgilio Così disse il maestro; ed elli stessi mi volse, e non si tenne alle mie mani, che con le sue ancor non mi chiudessi. A mio prudente avviso, Medusa rappresenta bensì l’eresia, o il demone dell’eresia, o, più genericamente, il dubbio religioso – come afferma un certo numero di commentatori21 –, ma l’eresia e la corruzione della Chiesa stessa ai tempi di Dante, che ‘impietra’ chi a lei si rivolge. Solo Virgilio, cioè l’Impero, ossia la forza alternativa ma nello stesso tempo complementare alla Chiesa, può evitare che Dante (cioè l’umanità) sia da essa irretito: la salvezza degli uomini non deriva più dalla Chiesa – che anzi li porta alla rovina, li ‘pietrifica’ –, ma dall’Impero. Si ricordi la frase rivolta da Gesù Cristo a Pietro: «[…] tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam […]» (Mt. 16, 18):22 probabilmente Dante si è rammentato e servito di questa frase, giocando sul termine ‘pietra’ per indicare che quella Chiesa all’inizio santa, solidamente fondata sulla pietra, ora – corrotta e tralignante rispetto alle sue pure origini, e quindi eretica – è proprio essa a rendere di pietra i suoi fedeli. 6. In chiave politica si potrebbe interpretare anche la selva oscura, che indicherebbe una confusione, un traviamento politico di Dante,23 e quindi anche le tre fiere (lonza, leone, lupa) non rappresenterebbero – come molti dantisti hanno sostenuto – tre peccati capitali (rispettivamente lussuria o invidia, superbia, avarizia), ma soltanto – come la maggior parte degli esegeti ha proposto in aggiunta – rispettivamente Firenze (variegata, come il pelo della lonza, per le divisioni delle famiglie e dei partiti), il regno di Francia (si pensi a Filippo IV il Bello e allo schiaffo d’Anagni, nonché alla persecuzione contro i Templari), la Chiesa corrotta (cfr. supra § 5). Il ‘veltro’ simboleggerebbe dunque un personaggio politico, reale o soltanto ipotizzato e auspicato, che dovrebbe sconfiggere definitivamente queste tre fiere, ossia restituire la pace e la giustizia all’umanità – personaggio che però non mi sento di indicare, neppure come ipotesi, anche per non ampliare ulteriormente la già sterminata letteratura sull’argomento: su 133 Perotti T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 134 Tenzone 14 2013 questo videant doctiores. Da queste minacce politiche può salvare Dante (cioè l’umanità) – almeno temporaneamente, in attesa del ‘veltro’ – soltanto Virgilio (cioè l’Impero). 7. Ora, se Virgilio è simbolo non della ragione ma dell’Impero, Beatrice rappresenta non la teologia, ma la Chiesa e il papato: naturalmente, però, una Chiesa e un papato puri e santi, come alle origini del Cristianesimo, non certo la Chiesa corrotta e il papato invadente, arrogante e prepotente dei tempi di Dante. Il simbolo dell’Impero, Virgilio, può fare da guida al poeta fiorentino soltanto nei regni dell’oltretomba per così dire ‘terreni’ (l’Inferno e il Purgatorio), mentre per quello più propriamente ‘celeste’ (il Paradiso) è necessario l’intervento della Chiesa – la Chiesa pura, ripeto –, ossia di Beatrice, con una simmetria illustrata dalla proporzione Virgilio: Impero = Beatrice: Chiesa. Credo che si veda chiaramente che questa distinzione di ruoli corrisponde bene alla distinzione dei poteri proposta e auspicata da Dante nel De monarchia: al potere imperiale deve essere demandata la guida temporale, alla Chiesa la guida spirituale dell’umanità. La ragione vera per cui Virgilio non può essere guida di Dante nel paradiso non sarebbe dunque che Virgilio era pagano (perché nel Paradiso dantesco s’incontra più di una figura non cristiana, per es. Traiano [Par. XX, 43 ss.; 100 ss.] – guarda caso, imperatore –, Rifeo [Par. XX, 67 ss.; 100 ss.] – guarda caso, personaggio virgiliano –, oltre a rappresentanti dell’antico testamento), o che la ragione (di cui – come si è detto –, secondo la generalità dei commentatori, è simbolo) non può giungere o portare alla conoscenza e alla visione di Dio, ma piuttosto che, secondo Dante, la Chiesa ha una superiorità morale sull’Impero (cfr. De monarchia): il grado ultimo di elevazione dell’umanità può essere raggiunto soltanto grazie alla guida della Santa Chiesa. Beatrice che scende nel limbo a chiedere l’intervento di Virgilio per salvare Dante (Inf. II, 52 ss.): 134 Io era tra color che sono sospesi, e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Perotti T 14:Maquetaci n 1 Pier Angelo PEROTTI 09/12/2013 11:50 PÆgina 135 Sul valore simbolico di Virgilio Lucevan gli occhi suoi più che la stella; e cominciommi a dir soave e piana, con angelica voce, in sua favella: ‘O anima cortese mantovana, di cui la fama ancor nel mondo dura, e durerà quanto il mondo lontana, l’amico mio, e non de la ventura, ne la diserta piaggia è impedito sì nel cammin, che volto è per paura; e temo che non sia già sì smarrito, ch’io mi sia tardi al soccorso levata, per quel che ho di lui in cielo udito. Or movi, e con la tua parola ornata e con ciò ch’è mestieri al suo campare, l’aiuta sì ch’io ne sia consolata. Io son Beatrice, che ti faccio andare; vegno di loco ove tornar desìo; amor mi mosse, che mi fa parlare’. rappresenta la Chiesa («beata e bella», v. 53; «con angelica voce», v. 57) che chiede l’intervento, l’appoggio dell’Impero al suo fianco e in funzione a lei complementare – dove essa non può intervenire, cioè nella parte ‘terrena’ (cfr. supra) – per salvare l’umanità, che essa ama («amor mi mosse», v. 72). La salvezza dell’uomo dipende, secondo Dante, da due entità distinte ma complementari e, per così dire, integrate e sinergiche: l’Impero prima, la Chiesa poi, per le due sfere, terrena e divina (cfr. la teoria dei ‘due soli’ nel De monarchia): la Chiesa può esortare l’Impero a intervenire in questioni temporali (nella trasposizione poetica, l’Inferno e il Purgatorio: cfr. supra), ma non può agire direttamente; analogamente, l’Impero non può occuparsi di questioni trascendenti (nella metafora, il Paradiso: cfr. supra), riguardanti la sfera spirituale dell’uomo. 8. Il viaggio di Dante, proprio per la conciliazione tra potere temporale e spirituale da lui attuata, rappresenta, per così dire, la sintesi dei prece135 Perotti T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 136 Tenzone 14 2013 denti analoghi viaggi di Enea, precursore dell’Impero, e di San Paolo, colonna, caposaldo della Chiesa (Inf. II, 13 ss.): Tu dici che di Silvio lo parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò, e fu sensibilmente. Però se l’avversario d’ogni male cortese i fu, pensando l’alto effetto che uscir dovea di lui, e il chi, e il quale, non pare indegno ad omo d’intelletto: ch’ei fu dell’alma Roma e di suo impero ne l’empireo ciel per padre eletto. La quale e il quale, a voler dir lo vero, fu stabilita per lo loco santo u’ siede il successor del maggior Piero. Per quest’andata onde li dài tu vanto, intese cose che furon cagione di sua vittoria e del papale ammanto Andovvi poi lo Vas d’elezione, per recarne conforto a quella fede ch’è principio a la via di salvazione. Ma io perché venirvi? o chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono: me degno a ciò né io né altri crede.24 Dante è il terzo: non è Enea, non è San Paolo, ma è colui che dei due ideali propone la conciliazione, unica e vera felicità per l’umanità, e quindi il motivo e lo scopo del suo viaggio – che egli per modestia (cfr. n. 31) finge di non conoscere e di cui chiede conto – sono oltremodo evidenti e ancor più importanti, se possibile, di quelli che causarono i viaggi ultraterreni di Enea e di San Paolo. In questo sviluppo e rielaborazione del pensiero politico già esposto nel De monarchia, più ancora che nell’espressione di una concezione religiosa – in fondo ovvia, dato l’argomento del poema – consiste, a mio modo di vedere, la struttura fondamentale della Divina commedia. 136 Perotti T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 137 Sul valore simbolico di Virgilio Pier Angelo PEROTTI NOTE Della sterminata bibliografia sull’argomento, ricordiamo, in una carrellata che parte dalla fine dell’Ottocento, almeno Comparetti (1872); Ardizzone (1879); Busnelli (1919); Gemelli (1921: 144-155); Bandini (1930: 209-223); McKenzie (1930: 11-21); Auerbach (1931: 136-144); Palgen (1932: 1 ss.); Ferretti (1935); Ussani (1938: 604-610); E. Trucchi (1940); Mazzoni (1941a: 135 ss.); Pasquali (1942: 187 ss.); Rossi (1942: 112-128); Pietrobono (1944: 76-108); Casella (1947: 3 ss.); Whitfield (1949); Schoder (1948/49: 413-422); Bickersteth (1951); Sayers (1954: 54-57); Vivier (1954: 281-284; 362-377); Pézard (1957: 5-30); Getto (1959: 11-20); Guardini (1963: 47-62); Nogami (1964: 1-6); Whitfield (1965: 3-16); Nardi (1965: 42-53); Girardi (1965: 237-241); Santoro (1965: 343355); Toffanin (1967); Consoli (1967); Hollander (1968: 142-146); Vallone (1969: 14-40); Montano (1971: 550-561); Vallone (1993: 27-40); Gorni (2002); etc. 1 2 Cfr. per es. Fiammazzo (1933: 138-47); De Lubac (1964: II 2, 233-262); etc. Cfr., per es., D’Ovidio (1892: 213 ss.); Della Giovanna (1898: 134-145); Belli (1906: 5 ss.); Spargo (1934); etc. 3 4 5 6 Cfr. Silverstein (1932: 51-82); anche Perotti (1990a: 10); etc. Cfr. Siebzehner-Vivanti (1965), s. v. Aristotele, lettera f. Per esempio Comparetti (1872: 249 s.). Alla questione accenna, riassuntivamente, Siebzehner-Vivanti (1965), s. v. Virgilio, § 4. 7 8 Cfr., per es., Ricci (1965: 137-152). Non per caso il Foscolo nei Sepolcri (v. 174) definisce Dante «ghibellin fuggiasco»: cfr. Perotti (1990b: 3-7, spec. 6 e n. 5). 9 Non deve trarre in inganno il fatto che Dante definisca questo poeta con l’attributo di satiro (cfr. supra e n. 11): credo che tale appellativo sia stato qui usato in funzione puramente esornativa, ossia per indicare una delle opere più famose e più caratteristiche di Orazio: non sarebbe stato facile o possibile, del resto, qualificare in altro modo – a prescindere dalle esigenze metriche e di rima – il poeta latino. 10 137 Perotti T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 Tenzone 14 11:50 PÆgina 138 2013 Cfr. Riposati 19696: 519: «Da principio l’Imperatore gli era apparso – e lo dice chiaramente nella dedica (1, 33 sgg.) – come la più autentica espressione della romanità ed egli era giunto persino a benedire le stesse guerre civili, che avevano aperto la via al Principato di Nerone; poi le dolorose esperienze politiche smorzano i suoi entusiasmi, anzi capovolgono del tutto la sua situazione spirituale: […], si ripiega sui bei tempi della politica augustèa […]» (il corsivo è mio, per motivi fin troppo evidenti). 11 Su questo personaggio, e in generale sul canto X dell’Inferno, si vedano Aglianò (1953); Casella (1955: 35-42); Auerbach (1956: 189-221); Padoan (1959a: 12-39); Montano-Padoan (1960: 707-716); Sansone (1961); Scott (1964: 1-13); Petrocchi (1965: 261-280); Frugoni (1966: I, 261-283); etc. 12 Non sono d’accordo con quei commentatori (per esempio Porena in Alighieri 19592: 98) che interpretano «conte» nel senso di ‘chiare’ o sim. 13 Cfr. Perotti 1990b, dove sono messi in rilievo particolari di questo colloquio utili a suffragare questa mia tesi. 14 15 Ma cfr. Perotti, ibid. Sulla questione si vedano Bianchi in Alighieri 1886: 58; D’Ovidio (1901: 150-201); Mazzoni (1941b: 213-221); sintesi della questione in Pagliaro (19612: 357-380), integrato da Lucidi (1964: 203-216). A una spiegazione simile a quella da me proposta accenna Siebzehner-Vivanti (1965), s. v. «disdegno»: «fra le varie spiegazioni del motivo per cui Guido Cavalcanti spregiasse Virgilio la più attendibile mi pare la seg.: Virgilio cantando le origini di Roma imperiale, e amico di Augusto, contrastava coi concetti del Cavalcanti, guelfo accanito», che però poi in nota afferma: «Una acuta interpretazione, più attendibile della precedente, che fonda le sue premesse nello studio della filosofia e del clima spirituale a cui si ispirarono i poeti del circolo stilnovistico, e nella rigorosa interpretazione della loro poesia alla luce di questo studio, si può ricavare da quanto Mario Casella, tra i più profondi studiosi di quella età e di Dante in particolare, è venuto man mano illustrando e chiarendo sia nei suoi corsi universitari di Firenze, sia in lavori particolari […]. Tale interpretazione si basa sulla considerazione che la poetica del Cavalcanti si riduce ad un “ordine ideale”: amare la cosa per la bellezza che racchiude in sé, che in essa splende, senza desiderare altro, chiudendosi in se stessi […]. Il “disdegno” di Guido verso Virgilio è da interpretarsi quindi come insufficiente considerazione della ragione naturale da parte di Guido per amare 16 138 Perotti T 14:Maquetaci n 1 Pier Angelo PEROTTI 09/12/2013 11:50 PÆgina 139 Sul valore simbolico di Virgilio sempre se stesso attraverso l’idea»; più recentemente Pinto (2000: 97-121); Marti (2007: 389-398); etc. Per esempio D’Ancona 1913: 215 ss., spec. 218-219: «[Beatrice], nella quale il Cavalcanti non scorse quel raggio di divina luce, che Dante seppe ravvisarvi»; Chimenz (1945: 179-188); Carli (1954: 18-53); Pagliaro (19612: 357380), che parafrasa la risposta di Dante a Cavalcante: «“costui mi conduce attraverso questi luoghi da chi Guido vostro sdegnò, si rifiutò di venire”», con la conseguente precisazione semantica dell’«ebbe» (372); cfr. anche Pietrobono in Alighieri 1923: 96; Pagliaro (1967: 192-209); Sapegno in Alighieri 19943: 118; etc. 17 Per esempio Scartazzini in Alighieri 1874: n. a X 63; Del Lungo in Alighieri 1926: 92; Steiner in Alighieri 1940: 94; Nardi (19492: 93-129); Id. (1954: 4771); Porena in Alighieri 19592: 103 ss., nota finale 2 al canto X: «Il disdegno di Guido e il dolore di Cavalcante»; etc. 18 19 Di seguito il critico offre una lucida e convincente motivazione della sua preferenza, che per ragioni di spazio non ritengo opportuno riportare in questa sede. 20 Siebzehner-Vivanti (1965), s. v. «Cavalcanti»; cfr. anche supra, n. 18. Oltre al Boccaccio («la sassea e dannosa opinione» degli eretici), per esempio Porena in Alighieri 19592: 93-95, nota finale al canto IX: «Li versi strani “e il messo celeste», il quale però precisa che si tratterebbe non di eresia genericamente, ma specificamente di epicureismo; sull’argomento cfr. anche Pellegrini (1904); Busnelli (1913: 24 ss.); Santangelo (1959: 143-149); Padoan (1959b: 432-457); Id. (1959a: 12-39); Auerbach (1960: 208-213); Bacchelli (1962: 845878); Zannoni (1961: I, 275-299); etc. 21 Nell’originale greco “[…] su;ei\Pev troı, kai;ej pi;tauv th/th’/pev tra/oij kodomhv sw mou th; n ej kklesiv an […]”. 22 Si tratta quasi certamente di una coincidenza (peraltro curiosa), ma l’espressione ‘essere in sonno’, con cui nella Massoneria si indica la sospensione di un affiliato, fa pensare al verso dantesco «tant’era pieno di sonno a quel punto» (Inf. I, 11): comunque non è questa la sede adatta ad approfondire l’argomento, che ci porterebbe lontano. 23 Si noti la modestia (a meno che si tratti di ‘falsa modestia’) di quest’ultima frase, in contrasto con l’apparente presunzione (cfr. supra, § 2) manifestata in Inf. IV 102. 24 139 Perotti T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 140 Tenzone 14 2013 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI AGLIANÒ, S. (1953): Il canto di Farinata, Lucca, Lucentia. ALIGHIERI, D. (1874): La Divina Commedia, vol. I, Inferno, a c. di G. A. Scartazzini, Leipzig, Brockhaus. ALIGHIERI, D. (1886): La Commedia… dichiarata da B. Bianchi, Firenze, Le Monnier. ALIGHIERI, D. (1923): La Divina Commedia, vol. I, Inferno, a c. di L. Pietrobono, Torino, S.E.I. ALIGHIERI, D. (1926): La Divina Commedia, vol. I, Inferno, a c. di I. Del Lungo, Firenze, Le Monnier. ALIGHIERI, D. (1940): La Divina Commedia, vol. I, Inferno, a c. di C. Steiner, Torino, Paravia. ALIGHIERI, D. (19592): La Divina Commedia, vol. I, Inferno, a c. di M. Porena, Bologna, Zanichelli. ALIGHIERI, D. (19682): La Divina Commedia, vol. I, Inferno, a c. di G. Giacalone, Roma, Signorelli. ALIGHIERI, D. (19943): La Divina Commedia, vol. I, Inferno, a c. di N. Sapegno, Firenze, La Nuova Italia. ARDIZZONE, M. (1879): «I personaggi di Virgilio e di Beatrice nella ‘Divina Commedia’», in Letteratura, arte, poesia, Palermo, Tipi del “Giornale di Sicilia”, pp. 273-295. AUERBACH, E. (1931): «Dante und Virgil», Das Humanist. Gymn. 4/5, pp. 136-144. AUERBACH, E. (1956): «Farinata e Cavalcante», in Mimesis, trad. ital., Torino, Einaudi, pp. 189-221. AUERBACH, E. (1960): Lingua letteraria e pubblico, Milano, Feltrinelli, pp. 208-213. 140 Perotti T 14:Maquetaci n 1 Pier Angelo PEROTTI 09/12/2013 11:50 PÆgina 141 Sul valore simbolico di Virgilio BACCHELLI, R. (1962): Saggi critici, Milano, Mondadori, pp. 845-878. BANDINI, A. R. (1930): «Virgil and Dante and Statius», Thougth 5, pp. 209-223. BELLI, M. (1906): «Magia e pregiudizi in P. Virgilio Marone», Archivio Studio Tradizioni Popolari 23, pp. 5 ss. BICKERSTETH, G. L. (1951): Dante’s Virgil, a Poet’s Poet, Glasgow, Jackson. BUSNELLI, G. (1913): “Bullettino della Soc. Dantesca It.” 20, pp. 24 ss. BUSNELLI, G. (1919): Il Virgilio dantesco e il ‘Gran Veglio’, Roma, Civiltà Cattolica. CARLI, P. (1954): Saggi danteschi, Firenze, Le Monnier, pp. 18-53. CASELLA, M. (1947): «Le guide di Dante nella ‘Divina Commedia’», Atti e memorie dell’Accademia fiorentina di scienze morali La Colombaria, N. S. 1, pp. 3 ss. CASELLA, M. (1955): «Il canto X dell’Inferno», Studi Danteschi 33, pp. 35-42. CHIMENZ, S. A. (1945): «Il disdegno di Guido e i suoi interpreti», Orientamenti culturali 1, pp. 179-188. COMPARETTI, D. (1872): Virgilio nel Medio Evo, Firenze, La Nuova Italia [19412, a cura di G. Pasquali, rist. 1967]. CONSOLI, D. (1967): «Significato del Virgilio dantesco», in AA. VV., L’umanesimo in Dante, Firenze, Olschki. D’ANCONA, A. (1913): Scritti danteschi, Firenze, Sansoni. D’OVIDIO, F. (1892): «Dante e la magia», Nuova Antologia 3a s., 41, pp. 213 ss. D’OVIDIO, F. (1901): «Il disdegno di Guido», in Studi sulla Divina Commedia, Palermo, Sandron, pp. 150-201. 141 Perotti T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 142 Tenzone 14 2013 DE LUBAC, H. (1964): «Virgile philosophe et prophète», Exégèse médiévale II, 2, pp. 233-262. DELLA GIOVANNA, I. (1898): «Dante mago», Rivista d’Italia 2, pp. 134145 FERRETTI, G. (1935): «Dante e Virgilio dramatis personae», in I due tempi della composizione della Divina Commedia, Bari, Laterza. FIAMMAZZO, A. (1933): «Virgilio veggente cristiano?», Giornale storico della letteratura italiana 102, pp. 138-47. FRUGONI, A. (1966): «Il canto X dell’Inferno», in Nuove letture dantesche, Firenze, Le Monnier, vol. I, pp. 261-283. GEMELLI, A. (1921): «Beatrice e Virgilio», in Dante Alighieri, Milano, Soc. Editrice “Vita e pensiero”, pp. 144-55. GETTO, G. (1959): «Dante e Virgilio», Il Veltro 3, pp. 11-20. GIRARDI, E. N. (1965): «Virgilio nella poetica di Dante», in AA. VV., Dante e Roma, Firenze, Le Monnier, pp. 237-241. GORNI, G. (2002): Dante nella selva. Il primo canto della “Commedia”, Firenze, Cesati. GUARDINI, R. (1963): «La figura di Virgilio nella Commedia», in Maestro Dante, Milano, Marzorati, pp. 47-62. HOLLANDER, R. (1968): «Dante’s Use of Aeneid in Inferno I and II», Comparative Literature 20, pp. 142-146. LUCIDI, M. (1964): «Ancora sul disdegno di Guido», Cultura neolatina 14, pp. 203-216. MARTI, M. (2007): «Una mantissa ermeneutica per il X dell’Inferno (e per i vv. 62-63)», Giornale storico della Letteratura italiana 124 (vol. 184), pp. 389-398. MAZZONI, G. (1941a): «Dante e Virgilio», in Almae luces malae cruces, Bologna, Zanichelli, pp. 135 ss. 142 Perotti T 14:Maquetaci n 1 Pier Angelo PEROTTI 09/12/2013 11:50 PÆgina 143 Sul valore simbolico di Virgilio MAZZONI, G. (1941b): «Il disdegno di Guido (Inf. X, 32-63)», in Almae luces malae cruces, Bologna, Zanichelli, pp. 213-221. MCKENZIE, K. (1930): «Virgil and Dante», in The tradition of Virgil, Princeton Univ. Press, pp. 11-21. MONTANO, R. (1971): «Dante and Virgil», Yale Review 60, pp. 550-561. MONTANO, R. - PADOAN, G. (1960): «Per l’interpretazione del canto degli Epicurei», Convivium 28 (n. s. 2), pp. 707-716. NARDI, B. (19492): «L’averroismo del “primo amico” di Dante», in Dante e la cultura medievale, Bari, Laterza, pp. 93-129. NARDI, B. (1954): «Noterella polemica sull’averroismo di Guido Cavalcanti», Rassegna di filosofia 3, pp. 47-71. NARDI, B. (1965): «Tre momenti dell’incontro di Virgilio con Dante», L’Alighieri 6, pp. 42-53 (poi in Saggi e note di critica dantesca, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966, pp. 220-237). NOGAMI, S. (1964): «Dante e Virgilio», Studi Italici 13, pp. 1-6. PADOAN, G. (1959a): «Il canto degli Epicurei», Convivium 27 (n. s. 1), pp. 12-39. PADOAN, G. (1959b): «Il mito di Teseo e il cristianesimo di Stazio», Lettere italiane 11, pp. 432-457. PAGLIARO, A. (19612): «Il disdegno di Guido», in Saggi di critica semantica, Messina-Firenze, D’Anna, pp. 357-380. PAGLIARO, A. (1967): Ulisse. Ricerche semantiche sulla Divina Commedia, Messina-Firenze, D’Anna, pp. 192-209. PALGEN, R. (1932): «Die Virgilsage in die Göttlichen Komödie», Deutsches Dante-Jahrbuch 14, pp. 1 ss. PASQUALI, G. (1942): «Studi recenti su Virgilio nel medioevo», in Terze pagine stravaganti, Firenze, Sansoni, pp. 187 ss. PELLEGRINI, F. (1904): Il canto IX dell’Inferno, Firenze, Sansoni. 143 Perotti T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 144 Tenzone 14 2013 PEROTTI, P. A. (1990a): «De diis in Aeneide», Latinitas 38, p. 10 = Studi virgiliani, Vercelli, “Il Comprensorio”, p. 89. PEROTTI, P. A. (1990b): «Farinata, Dante e Pietro», L’Alighieri 31, pp. 37, spec. p. 6 e n. 5. PETROCCHI, G. (1965): «Tre postille a Farinata», Studi danteschi 42, pp. 261-280 (poi in Itinerari danteschi, Bari, Adriatica, 1969, pp. 276294). PÉZARD, A. (1957): «Les loups, Virgile et Dante», Revue des Études Italiennes 9, pp. 5-30. PIETROBONO, L. (1944): «Virgilio, l’impero e il di là», in AA. VV., Studi su Dante, Milano, Hoepli, pp. 76-108. PINTO, R. (2000): «Sensi smarriti: l’ermeneutica del disdegno in Cavalcanti e in Dante», Tenzone 1, pp. 97-121. RICCI, P. G. (1965): «Dante e l’impero di Roma», in AA. VV., Dante e Roma, Firenze, Le Monnier, pp. 137-152. RIPOSATI, B. (19696): Storia della letteratura latina, Città di Castello, Dante Alighieri. ROSSI, M. (1942): «Il Virgilio allegorico e il Virgilio poetico», in Gusto filologico e gusto poetico, Bari, Laterza, pp. 112-128. SANSONE, M. (1961): Il canto X dell’Inferno, Firenze, Le Monnier. SANTANGELO, S. (1959): Saggi danteschi, Padova, Cedam, pp. 143-149. SANTORO, M. (1965): «Virgilio personaggio della Divina Commedia», Cultura e Scuola 4, pp. 343-355. SAYERS, D. L. (1954): «Dante’s Virgil», in Further Papers on Dante, New York, Harper, pp. 54-57. SCHODER, R. V. (1948-49): «Virgil in the Divina Commedia», Classical Journal 44, pp. 413-422. SCOTT, J. A. (1964): «Politics and Inferno X», Italian Studies 19, pp. 113. 144 Perotti T 14:Maquetaci n 1 Pier Angelo PEROTTI 09/12/2013 11:50 PÆgina 145 Sul valore simbolico di Virgilio SIEBZEHNER-VIVANTI, G. (1965): Dizionario della ‘Divina Commedia’, Milano, Feltrinelli. SILVERSTEIN, H. T. (1932): «Dante and Virgil the Mystic», Harvard Studies and Notes in Philologie and Literature 14, pp. 51-82. SPARGO, J. W. (1934): Virgil the necromancer, Cambridge (Mass.), Harvard Univ. Press. TOFFANIN, G. (1967): «Dante e Virgilio», in Perché l’umanesimo incomincia con Dante, Bologna, Zanichelli. TRUCCHI, E. (1940): «Il Virgilio dantesco», in Studi su Dante, Milano, Hoepli. USSANI, V. (1938): «I viaggi di Virgilio nel sotterra», Wirtschaft und Kultur pp. 604-610 (rist. in Festschriftzum 70. Geburtstag von Alfons Dopsch, Franfurt am Main, Sauer & Auvermann, 1966, pp. 165-210). VALLONE, A. (1969): «Interpretazione del Virgilio dantesco», L’Alighieri 10, pp. 14-40. VALLONE, A. (1993): «Il canto I dell’Inferno», L’Alighieri 4 (n. s. 1-2), pp. 27-40. VIVIER, R. (1954): «Dante et Virgile», Le Flambeau 37, pp. 281-284; 362377. WHITFIELD, J. H. (1949): Dante and Virgil, Oxford Univ. Press. WHITFIELD, J. H. (1965): «Dante e Virgilio», Le parole e le idee 7, pp. 316. ZANNONI, U. (1961): «Il canto IX dell’Inferno», in Lectura Dantis Scaligera, Firenze, Le Monnier, vol. I, pp. 275-299. 145 Perotti T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:50 PÆgina 146 Peirone T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 147 Dal Limbo teologico al Limbo figurale di Dante LUIGI PEIRONE Università di Genova [email protected] RESUMEN: El artículo revisa la postura dantesca ante la presencia o no de niños no bautizados en el Limbo, así como de personas adultas que no han conocido la doctrina cristiana, para lo cual parte de las variaciones recientes en dicha doctrina por parte de la Iglesia católica. PALABRAS CLAVE: Limbo, bautismo, Catone, Rifeo. ABSTRACT: The article analyzes Dante’s attitude with regard to the absence and presence of baptized children in the Limbo as well as adults that did not know Christian doctrine. For this purpose, it starts from the recent changes to the aforesaid doctrine made by the Catholic Church. KEY WORDS: Limbo, baptism, Cato, Ripheus. Nel 1992 vedeva la luce, preso la Libreria Editrice Vaticana, il Catechismo della Chiesa cattolica, prima nel testo latino e poco dopo nella traduzione italiana, alla quale per ovvi motivi si farà qui riferimento. Si tratta di un avvenimento che va ben oltre gli interessi del semplice cattolico 147 Peirone T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 148 Tenzone 14 2013 praticante, in quanto s’inserisce in una sfera culturale che è impossibile disconoscere. Dopo il catechismo detto di Pio X (1904), la Chiesa ha fatto di nuovo sentire la sua voce in relazione anche a nuovi problemi, o a problemi che di pongono sotto l’insegna di una più pressante attualità. In realtà, mentre il catechismo detto di Pio X si presenta effettivamente sotto la veste di un catechismo tradizionale, che contiene la dottrina cristiana in forma riassuntiva e semplificata, il catechismo del 1992 si può considerare un vero e proprio manuale, sia per le dimensioni del testo (892 pagine) sia per l’approfondimento e la documentazione degli argomenti trattati; ma in realtà è stato proposto agli operatori catechistici più che ai semplici discenti. Non si tratta, come apparirà più chiaramente dal prosieguo della presente trattazione, di un particolare irrilevante, anche se neppure ha una determinante funzione in relazione ai fini qui proposti. Comunque il confronto che ora si pone, e che riveste un’importanza non indifferente, concerne la diversa presa di posizione circa la sorte dei bambini morti senza battesimo. Il catechismo detto di Pio X (100) così recita: I bambini morti senza Battesimo dove vanno? I bambini morti senza Battesimo vanno al Limbo, dove non è né premio soprannaturale né pena, perché, avendo il peccato originale, e quello solo, non meritano il paradiso, ma neppure l’inferno e il purgatorio. Nel catechismo del 1992 (1261, pp. 31-332)1 si trova invece: 148 Quanto ai bambini morti senza Battesimo, la Chiesa non può che affidarli alla misericordia di Dio, come appunto fa nel rito dei funerali per loro. Infatti la grande misericordia di Dio che vuole salvi tutti gli uomini [qui si fa riferimento in nota a I Tm 2,4] e la tenerezza di Gesù verso i bambini, che gli ha fatto dire: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedire» (Mc 10, 14), ci consentono di sperare che vi sia una via di salvezza per i bambini morti senza Battesimo, Tanto più pressante è perciò l’invito della Chiesa a non impedire che i bambini vengano a Cristo mediate il dono del santo Battesimo. Peirone T 14:Maquetaci n 1 Luigi PEIRONE 09/12/2013 11:51 PÆgina 149 Dal Limbo teologico al Limbo figurale Come di può subito constatare la differenza fra i due testi, sia nella lettera che nello spirito, è semplicemente enorme, e nel secondo di essi è implicito ma sufficientemente chiaro il disconoscimento dell’esistenza del limbo stesso dopo la discesa agli inferi di Gesù. In realtà anche prima del 1992 in qualche modo, sia pure non proprio esplicitamente, la posizione di qualche autore non era certo in inea con quanto espresso dal catechismo detto di Pio X. Significativamente Francesco Olgiati nel suo Sillabario del cristianesimo,2 che rappresenta forse il primo tentativo (almeno in Italia) di divulgazione teologica per i laici, tralascia volutamente l’argomento della sorte riservata ai bambini morti senza il battesimo. D’altra parte lo stesso atteggiamento sarà poi tenuto da Joseph Ratzinger, destinato ad assurgere al papato col nome di Benedetto XVI, in un’opera scritta con intendimenti non certo semplicemente divulgativi (Ratzinger 1977).3 In ogni caso il disconoscimento delle affermazioni contenute nel catechismo del 1904 ha avuto una ancor più decisa ed esplicita conferma in un documento pubblicato in data 19 aprile 2007, redatto da una speciale commissione teologica internazionale,4 dove si afferma fra l’altro (82 b) che «Dio non chiede cose impossibili» e che «la grazia di Dio non è limitata ai sacramenti». Ci si trova di fronte ad affermazioni addirittura rivoluzionarie (anche se perfettamente ortodosse) nei confronti di una lunga tradizione esegetica, pur non esente da oscillazioni; basti pensare alla «poena levissima» prospettata da Sant’Agostino5 e ad una situazione quasi paradisiaca prospettata (anche se non approvata) nel concilio di Trento.6 Particolarmente utile per gli studiosi di Dante, nel documento della sopra nominata commissione, è inoltre la parte dedicata alla storia della questione, dove in maniera sintetica si fanno riferimenti (anche bibliografici) di fondamentale interesse in relazione a qualsiasi indagine concernente il limbo della Divina commedia. A livello di mass-media c’è stato chi si è posto un nuovo, ipotetico problema; come sarebbe stato il poema dantesco se la posizione di Benedetto XVI fosse stata presa dalla Chiesa ai tempi dell’Alighieri.7 149 Peirone T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 150 Tenzone 14 2013 La domanda può apparire magari bizzarra, però può porci certi interrogativi e comunque a costringerci a rivedere e ripensare il testo del IV canto dell’Inferno. Un primo e chiaro punto di riferimento può essere costituito dalla voce Limbo dell’ Enciclopedia dantesca della Treccani firmata da Fausto Montanari, oltre che per il suo intrinseco valore per la sua impostazione e per la sua struttura di voce di una monumentale enciclopedia. Particolarmente interessante, preso atto della data di composizione della sintetica monografia, è l’accenno all’assenza di definizioni dogmatiche in materia nonché il rilievo dato a tre passi dell’Aquinate (anche in relazione alle considerazioni del Bottagisio (1898) letteralmente riportati. In realtà si tratta di passi che debbono assolutamente tenuti presenti come premesse necessarie all’esame del testo dantesco, e non solo quello del IV canto dell’Inferno. Non sarà quindi superfluo riportarli anche in questa sede. Il primo è il seguente (Summa teologiae, II-II q. 10 a.1):8 Si autem accipiatur infidelitas secundum negationem puram, sicut in illis qui nihil audierunt de fide, non habet rationem peccati, sed magis poenae, quia talis ignorantia divinorum ex peccato primi parentis est consecuta. Qui autem sic sunt infedeles damnantur quidem propter alia peccata, quae sine fide remitti non possumt; non autem damnantur propter infedelitatis peccatum. Unde Dominus dicit, Ioan. 15, [22]: Si non venissem, et locutus eis non fuissem, peccatum non haberent; quod exponens Augustinus dicit quod loquitur de illo peccato quo non crediderunt in Christum. Gli altri due passi, anche se non riportano nella loro interezza il testo tomistico, sono citati nella loro essenzialità senza incisi del curatore con funzione di collegamento, e pertanto qui ci si limiterà a riportare soltanto quanto di essi appare scritto nella voce enciclopedica. Ecco quanto riportato del primo di essi (De veritate, 28 a.3 ad 4): 150 Ista positio apud quosdam impossibilis reputatur, quod aliquis adultus habeat peccatum originale sine actuali. Cum adultus esse Peirone T 14:Maquetaci n 1 Luigi PEIRONE 09/12/2013 11:51 PÆgina 151 Dal Limbo teologico al Limbo figurale incipit, si quod in se faciat, gratiam ei dabitur, per quam a peccato originali erit immunis. Ed ora l’altro passo (De veritate 28 a.12 ad 2): Non est possibilis aliquem adultum esse in solo peccato originali absque gratia, quia statim cum usum liberi arbitrii acceperit, si se ad gratiam praeparaverit, gratiam habebit, alias ipsa negligentia ei imputabitur ad peccatum mortale. Sempre dal De veritate, in relazione alla qui posta, si potrebbe estrapolare anche il passo seguente: Ad primum igitur dicendum, quod non seguitur inconveniens positio quod quilibet teneatur aliquid explicite credere etiam si in silvis vel inter bruta animalia nutriatur: hoc enim ad divinam providentiam pertinet ut cuilibet provideat de necessariis ad salutem, dummodo ex parte eius non impediatur. Si enim aliquis taliter nutritus, ductum rationis naturalis sequeretur in appetitu boni et fuga mali, certissime est tenendum, quod Deus ei vel per internam inspirationem revelaret ea quae sunt necessaria ad credendum, vel aliquem fidei predicatorem ad eum dirigeret, sicut misit Petrum ad Cornelium (14 a. 11 ad 1). In realtà non è detto che Dante di S. Tommaso conoscesse anche il De veritate. Busnelli e Vandelli si rifanno a tale opera nel loro commento al Convivio (II IV 4), ma non sono seguiti da altri studiosi. Però assai meno riserve riscuote l’ipotesi di una sua conoscenza del passo citato della Summa teologiae. Comunque Dante, in contrasto con le posizioni non soltanto di S. Tommaso, nega risolutamente la possibilità di salvezza per l’adulto non battezzato, come è chiarissimamente espresso in Paradiso XIX, 70-81: ché tu dicevi: “Un uom nasce a la riva de l’Indo, e quivi non è chi ragioni di Cristo, né chi legga né chi scriva; e tutti suoi voleri e atti buoni 151 Peirone T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 152 Tenzone 14 2013 sono, quanto ragione umana vede, sanza peccato in vita o in sermoni. Muore non battezzato e sanza fede; ov’è questa giustizia che ‘l condanna? Ov’è la colpa sua, se ei non crede?”. Or tu chi se’, che vuo’ sedere a scranna, per giudicar di lungi mille miglia con la veduta corta d’una spanna? Ben note sono le eccezioni costituite da Catone e Rifeo, alle quali si accennerà in seguito, mentre Traiano si sarebbe salvato col battesimo di acqua nel corso di una risurrezione di breve durata ma bastante per il fine proposto. Dopo tutte queste premesse sarà più agevole affrontare, per l’ennesima volta il problema del limbo dantesco. Prima di tutto, secondo il pensiero comune dei teologi del tempo, dovrebbe ospitare soltanto i bambini morti senza essere stati battezzati, ma nel capolavoro dantesco essi sono quasi completamente ignorati: sono appena nominati nelle turbe “di’infanti e di femine, e di viri” (v. 30). Sarebbe troppo arduo opinare che Dante ignorasse quello che era il pensiero a quei tempi comune sull’argomento; quindi è chiaro che il suo limbo è una costruzione del suo pensiero, senza validi riscontri storici. Molto acutamente già Guido da Pisa faceva osservare:9 Sed nostra fides non tenet quod ibi sint nisi parvuli innocentes. Iste autem poeta in hac parte, et in quibusdam aliis, loquitur non theologice sed poetice. Et ideo per Infernum non Beatrix, qui typum tenet teologie, sed Virgiius eum ducit, qui tenet figuram rationis umanae. Nel passo di Guido si trova tutto l’essenziale per un’interpretazione corretta ed approfondita. Di straordinaria importanza è in particolare l’accenno alla ‘figura’ che, anche per quanto riguarda la scelta lessicale, fa pensare in certo qual modo a moderne ed innovative interpretazioni. 152 Peirone T 14:Maquetaci n 1 Luigi PEIRONE 09/12/2013 11:51 PÆgina 153 Dal Limbo teologico al Limbo figurale L’attuale disconoscimento di fatto del limbo dei bambini, se fosse stato anticipato ai tempi di Dante non avrebbe quindi modificato sostanzialmente la struttura del suo capolavoro, se pensiamo che il sommo poeta in certo senso ha preso a prestito la dimora dei pargoli innocenti per trovare un luogo dove esaltare l’opera della ragione umana, mostrandone contemporaneamente le sue limitazioni. Dal sommo poeta il limbo dei bambini è praticamente ignorato. Certo la sua fantasia avrebbe dovuto inventare qualcosa d’altro, ma solo per quanto riguarda la struttura materiale in relazione alla topografia che si riferisce alla materialità di un viaggio che ha le caratteristiche di un percorso terreno. Ma come si deve interpretare il limbo, considerato come dimora di persone illustri? O meglio la presenza e l’esaltazione di personaggi illustri, per i quali è stato appositamente costruito quel luogo secondo una logica, inoppugnabile per quanto riguarda una costruzione poetica e solo per tale motivo. Qui si preferisce partire da lontano, e fare riferimento a due emblematici personaggi, ai quali si è già di sfuggita accennato, che per la loro collocazione nell’interno del poema dantesco hanno costituito per lungo tempo un enigma esegetico: Catone e Rifeo. Per quel che riguarda Catone basti rimandare a quanto ha scritto Herich Auerbach in un suo saggio ben noto (Auerbach 1979). Si considerino in particolar modo le righe seguenti: La storia di Catone [nella Divina commedia] è isolata dal suo contesto politico-terreno, proprio come gli esegeti patristici dell’Antico Testamento facevano per le singole figure di Isacco, Giacobbe ecc., ed è diventata “figura futurorum”. Catone è una “figura”, o piuttosto era tale il Catone terreno, che a Utica rinunciò alla vita per la libertà, e il Catone che qui appare nel Purgatorio è la figura svelata o adempiuta, la verità di quell’avvenimento figurale. Infatti la libertà politica e terrena per cui è morto era soltanto “umbra futurorum”: una prefigurazione di quella libertà cristiana che ora egli è chiamato a custodire […]. (Auerbach 1979: 218) 153 Peirone T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:51 PÆgina 154 2013 Parlando di Rifeo troiano, che gode la beatitudine del Paradiso pur essendo pagano (cfr. Paradiso XX, 67-72) potrebbero fare considerazioni molto simili. Egli, iustissimus unus / qui fuit in Teucris et servantissimus aequi (Aen. II, 426-427), anche se nel poema virgiliano manca un nesso dichiarato di causalità fra la sua specifica virtù e la sua tragica morte, in qualche modo può apparire un martire della giustizia in quanto agli dei non piacque premiare la sua virtù. D’altra parte sarebbe molto arduo spiegare diversamente la sua presenza nel cielo degli spiriti giusti (cfr. Peirone 2012). Veniamo ora al Limbo, nell’invenzione poetica e strutturale dell’Alighieri sostanzialmente riservato agli «spiriti magni», ai µεγαλ ψυχοι (Forti 1965), o comunque a personaggi in qualche modo famosi dell’’antichità, ed anche del medioevo per quel che si riferisce ai musulmani. Innanzi tutto, come si può dedurre da quanto fin qui è stato espresso, il limbo dantesco è stato costruito essenzialmente in rapporto alla funzione attribuita a Virgilio, e Virgilio è innegabilmente una “figura” nel senso sopra indicato, anzi è insieme a Beatrice una delle due “figure” fondamentali ed essenziali intorno alle quali ruota tutto il poema. “Figura futurorum” era Virgilio in terra, nella sua vita di saggio però non illuminato dalla grazia divina, prefigurazione di ciò che sarà in eterno chi è stato sostenuto solo dalla ragione nel suo pellegrinaggio terrestre, ed ora nell’aldilà diventato figura adempiuta mostra l’insufficienza della ragione stessa, ma al tempo stesso mette in rilievo quanto essa sia grande di per se stessa pur non essendo sufficiente in assoluto. D’altra parte gli altri personaggi nominati, che sono i soli che contino per l’invenzione dantesca, rappresentano in certo senso un collettivo figurale che in qualche modo si affiancano e completano la figura di Virgilio. Tra l’altro solo sotto questo punto di vista si può spiegare la presenza di Cesare, altrove ricordato come peccatore sessuale. Ritorniamo ora al problema del limbo in relazione alle nuove posizioni assunte dalla chiesa cattolica. 154 Peirone T 14:Maquetaci n 1 Luigi PEIRONE 09/12/2013 11:51 PÆgina 155 Dal Limbo teologico al Limbo figurale Come si è pacificamente constatato, l’esistenza di un limbo per gli adulti, dopo la discesa del Cristo agli inferi, è sempre stato un qualcosa di estraneo alla speculazione dei teologi, ed è impossibile che Dante potesse ignorare ciò. È l’invenzione poetica e strutturale di un grandissimo poeta, che è stato prima di tutto poeta, e alle esigenze della poesia sacrifica tutto ciò che può considerarsi allotrio. Se Dante non avesse costruito in tal maniera il limbo, non possiamo sapere come avrebbe diversamente strutturato il suo poema sacro. Non possiamo certo sostituire con la nostra fantasia meschina l’«alta fantasia» del sommo poeta. Quasi certamente l’idea generale della forza della ragione umana, ed al tempo stesso della sua insufficienza nel caso di mancanza della grazia divina sarebbe stata in qualche modo espressa; altrimenti ci saremmo trovati di fronte ad un’opera totalmente diversa, anche se magari pur essa di eccelsa fattura. Pertanto non possiamo far altro che giudicare, ed ammirare l’opera alla quale «ha posto mano e cielo e terra», gustandola così com’è nella veste e nell’architettura con cui ci è stata tramandata. 155 Peirone T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 156 Tenzone 14 2013 NOTE 1 Lo stesso testo, con lievi modifiche formali, è riportato nella seconda edizione in italiano, che risale al 1999 (1261, p.. 364) . Si tenga presente che la nuova edizione in latino è del 1997. La I edizione risale al 1924. Numerose sono le ristampe della XXX edizione, Milano Vita e Pensiero, 1963. 2 L’opera è stata tradotta in italiano col titolo di Escatologia. Morte e vita eterne, IV ed., Assisi, Cittadella editrice,2005. La I ed. risale al 1979. 3 4 5 Il testo completo della relazione è facilmente reperibile su internet. C. Iul., 5 11.44. Citato nella relazione cui si è fatto riferimento, al par. 18. Cfr. Polano 1960: 842, y Pallavicino 1614: I vii 726. Può non ssere inutile ricordare pure che Monaldo Leopardi, nel suo libro Considerazioni sullo stato dei bambini morti senza battesimo, anticipa posizioni vicine a quelle attuali della Chiesa. Cfr. Vigliar 2007. 6 Cfr. l’articolo «Da Dante a Luzi, quella metafora che piace all’arte», sul Corriere della sera del 21 aprile 2007. 7 Nella voce enciclopedica non è riportato interamente, ma ne sono citate solo le parti essenziali. 8 9 Si cita da Procaccioli (a c. di) 1999. 156 Peirone T 14:Maquetaci n 1 Luigi PEIRONE 09/12/2013 11:51 PÆgina 157 Dal Limbo teologico al Limbo figurale RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI AUERBACH, E. (19797): Studi su Dante, Milano, Feltrinelli. BOTTAGISIO, T. (1898): Il Limbo dantesco: studi filologici e letterari, Padova, Antoniana. FORTI, F. (1965): «Il limbo dantesco e i megslopsicoi dell’Etica nicomachea», in Fra le carte dei poeti, Milano-Napoli, Ricciardi. PALLAVICINO, P. S. (1614): Istoria del concilio di Trento, nuovamente ritoccata dall’autore, parte prima, Roma, Biagio Diversin e Felice Cesaretti librari. PEIRONE, L. (2012): «Rifeo (Par. XX, 68)», Letteratura italiana antica XIII, pp.117-180. POLANO, P. S. (1960): Storia del concilio tridentino, IV ed., Genève, Pietro Chouet. PROCACCIOLI, P. (a c. di) (1999): I commenti danteschi dei secoli XIV, XV e XVI, a cura di Paolo Procaccioli, Roma, Lexis Progetti Edioriali. RATZINGER, J. (1977): Tod und ewiges Leben, Regenburg, Friedrich Puslet. VIGLIAR, G. (2007): «Monaldo Leopardi, il limbo e i bambini morti senza battesimo», Il lettore di provincia 138, pp. 5-18. 157 Peirone T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 158 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 159 ‘Purgatorio’ XXXIII: profezia, missione e purificazione GIUSEPPE CIAVORELLA [email protected] RIASSUNTO: Beatrice spiega a Dante il significato della visione apocalittica che ha chiuso il canto precedente: albero della giustizia divina schiantato, carro della Chiesa metamorfizzato e semidistrutto e infine trascinato lontano. Ma presto, profetizza la beata, verrà un «messo di Dio» che riporterà giustizia e pace sulla terra. Intanto ordina a Dante di scrivere, quando sarà tornato tra i vivi, tutto ciò che ha visto. Il piccolo corteo giunge, infine, presso la sorgente da cui scaturiscono i fiumi Letè ed Eunoè. Dante, che ha già bevuto l’acqua del Letè, si immerge ora nell’Eunoè e ne esce definitivamente purificato. PAROLE CHIAVE: carro, «cinquecento diece e cinque», nota, scrivi, dottrina, Eunoè, rinnovellato. ABSTRACT: Beatrice explains to Dante the meaning of the apocalyptic vision that closed the previous Canto: the tree of divine justice broken, the chariot of the Church metamorphosed, half destroyed and eventually dragged far away. Yet, as the beatified woman prophesies, a “God’s messenger” will soon arrive to restore justice and peace on earth. Meanwhile, she tells Dante to write down all he has seen as soon as he returns among the living. The small procession finally arrives at the source from where Lethe and Eunoe spring. Having already drunk the water of Lethe, this time Dante bathes in Eunoe and comes out totally cleansed. 159 Ciavorella:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:51 PÆgina 160 2013 KEY WORDS: chariot, «five hundred, ten and five», note, writest, doctrine, Eunoe, renewed. Siamo all’ultimo atto del grandioso dramma liturgico che si svolge nel Paradiso terrestre, e che ha come attori protagonisti Dante e Beatrice, come attori secondari Matelda, Virgilio e Stazio e come comparse, più o meno attive, «cento» angeli e alcune decine di figure simboliche. Un dramma che si svolge in cinque atti: nel primo, che ha funzione di introduzione, Dante arriva nell’Eden e incontra Matelda (canto XXXVIII); nel secondo, avanza la processione allegorica dei libri sacri del Vecchio e del Nuovo Testamento, con al centro il carro della Chiesa (canto XXIX); nel terzo, appare in trionfo Beatrice, che rimprovera duramente Dante peccatore e lo costringe ad una umiliante confessione, cui segue l’immersione purificatrice del pentito nel Letè (cc. XXX-XXXI); nel quarto, Dante assiste al “mistero” della «pianta dispogliata», è investito da Beatrice della missione di scrivere, «in pro del mondo che mal vive», tutto ciò che vede, e assiste alla visione apocalitica della degenerazione della Chiesa (canto XXXII); nel quinto (quello che ora esamineremo, costituito dal canto XXXIII) Beatrice rinnova a Dante il conferimento della missione poetica, profetizza la venuta di un «Cinquecento Diece e Cinque», restauratore della giustizia e della pace nella Chiesa e nell’Impero, e invita infine il pellegrino all’immersione finale rigenerante nell’Eunoè, che lo rende «puro e disposto a salire a le stelle». Quando incomincia l’ultimo canto del Purgatorio è quasi mezzogiorno: sono passate sei ore da quando Dante ha messo piede nel Paradiso terrestre (era da poco sorto il sole). La visione apocalittica è appena terminata e le sette Virtù, che hanno assistito insieme con Beatrice, Dante, Matelda e Stazio al triste spettacolo/visione della progressiva devastazione e corruzione della Chiesa, cantano in lacrime il Salmo 79 [78], che incomincia con le parole: «Deus, venerunt gentes»; e lo cantano in modo antifonale, ‘alternandosi’, cioè, nel canto dei versetti, ora le tre Virtù teologali ora le quattro Virtù cardinali. 160 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 161 Purgatorio XXXIII Giuseppe CIAVORELLA ‘Deus, venerunt gentes’, alternando or tre or quattro dolce salmodia, le donne incominciaro, e lagrimando; e Beatrice, sospirosa e pia, quelle ascoltava sì fatta, che poco più a la croce si cambiò Maria. (vv. 1-6) È una «dolce salmodia» quella cantata dalle Virtù, ma di una dolcezza dolorosa, perché le parole del salmo esprimono dolore profondo, come doloroso è stato lo spettacolo della visione apocalittica, che al salmo è in parte ispirata: Deus,venerunt gentes in hereditatem tuam. (polluerunt templum sanctum tuum, / posuerunt Ierusalem in ruinas. […] Usquequo, Domine? Irasceris in finem? […] / Adiuva nos, Deus salutaris nostri, / propter gloriam nominis tui et libera nos; / et propitius esto peccatis nostris propter nomen tuum. […] Et redde vicinis nostris […] quod exprobaverunt tibi, Domine» [O Dio, sono venute genti straniere nei tuoi possedimenti, / hanno profanato il tuo sacro Tempio, / hanno ridotto Gerusalemme in rovina. [...] / Fino a quando, o Signore? Sarai sdegnato per sempre? [...] / Soccorrici, o Dio, nostro salvatore / per la gloria del tuo nome e liberaci; / e perdona le nostre colpe per amore del tuo nome [...] / Fa’ ricadere sui nostri vicini [...] / l’oltraggio che ti hanno fatto, Signore]. Il salmo si riferisce alla conquista di Gerusalemme da parte dei Babilonesi, alla sua distruzione e alla conseguente schiavitù degli Ebrei a Babilonia; il canto del Salmo, qui nel Paradiso terrestre, è perciò un commento melodico alla visione apocalittica, terminata con l’immagine del carro della Chiesa trascinato nel folto della selva dal gigante: la Chiesa avignonese serva dei re di Francia, come il popolo ebreo fu schiavo dei re di Babilonia. Ma il canto è anche in relazione con ciò che Beatrice dirà fra poco a Dante: come il salmista invoca la vendetta di Dio sui Babilonesi e sui loro alleati (pur ammettendo le colpe degli Ebrei, dimentichi della legge del Signore), così Beatrice prometterà la venuta di un «Cinquecento 161 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 162 Tenzone 14 2013 diece e cinque, / messo di Dio», che ristabilirà la dignità della Chiesa e riporterà l’ordine e la giustizia sulla terra. Intanto, sospirando pietosa, ascolta la «dolce salmodia» delle Virtù, così trasfigurata dal dolore che Maria, ai piedi della croce, dovette mutarsi nel volto poco più di lei. Tutto il dolore del Vecchio e del Nuovo Testamento è richiamato, in pochi versi, a dare la misura della tragedia che la Chiesa e l’Europa politica contemporanea stanno vivendo. «Un gruppo gotico di iacoponica espressività», commenta Franco Lanza (1967: 1217). Ma poi che l’altre vergini dier loco a lei di dir, levata dritta in pè, rispuose, colorata come foco: ‘Modicum , et non videbitis me; et iterum, sorelle mie dilette, modicum, et vos videbitis me’. (vv. 7-12) Beatrice passa, per la terribile visione cui ha assistito e per il canto del salmo che ha ascoltato, dal dolore all’indignazione, e infine all’appassionata profezia della resurrezione morale della Chiesa. Ricordiamo che Beatrice era rimasta seduta per terra presso il tronco dell’albero della conoscenza del bene e del male, ‘innovato’ di foglie e fiori, anche durante lo spettacolo apocalittico; ora si alza in piedi accesa di sacrosanto sdegno. Sembra rivolgersi solo alle Virtù, in risposta al loro canto («rispuose»), ma le sue parole riguardano anche, anzi soprattutto, Dante, che vede, ascolta e, «ritornato di là», dovrà tutto riferire con assoluta precisione, dando testimonianza di come la realtà storica terrena, ecclesiale e politica, sia vista e giudicata in cielo. Le parole latine sono riprese fedelmente dal Vangelo di Giovanni (16, 16): Gesù annuncia agli Apostoli, durante l’ultima cena, la sua prossima morte («Modicum, et non videbitis me» [Ancora un poco e non mi vedrete]) e la sua resurrezione («et iterum modicum, et videbitis me» [e di nuovo ancora un poco, e mi vedrete]). Ma il linguaggio di Gesù non è chiaro: Egli parla «per similitudini» (in proverbiis), e i discepoli 162 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 163 Giuseppe CIAVORELLA Purgatorio XXXIII non capiscono, e glielo dicono, infatti, ma credono ugualmente. E anche Beatrice parla (e parlerà ancora) «per similitudini», usando le parole di Gesù, o un linguaggio simile a quello di Gesù; e Dante crederà, anche se non capirà, e riferirà fedelmente. Beatrice è qui, chiaramente, figura di Cristo e della Chiesa. Le sue parole qui, e soprattutto più avanti, come si vedrà, non sembrano alludere ad altro che alla speranza, anzi alla certezza di una riforma morale della Chiesa (Beatrice vede in Dio e Dante crede fermamente nelle parole di Beatrice beata, parola vivente di Dio). Ma alcuni significativi indizi (il salmo «Deus, venerunt gentes» cantato dalle Virtù, alludente all’esilio babilonese; il fatto che le parole di Beatrice siano una «risposta» al canto delle Virtù; l’allusione inequivocabile, nella visione apocalittica, al trasferimento della sede pontificia in terra di Francia [Purg. XXXII, 148-60], e quindi al lungo periodo di permanenza in quella regione, definito spesso ‘cattività babilonese’ [o ‘avignonese’] o ‘esilio babilonese’; infine il tono acceso, quasi un grido, con cui Beatrice cita le parole di Gesù), autorizzano una più precisa, e più semplice, interpretazione: la sede pontificia resterà a Roma ancora per poco, poi sarà trasferita in Provenza (1305), ad Avignone (1308); ma non resterà a lungo in terra di Francia, poi tornerà nuovamente a Roma. Ovviamente, in questa interpretazione, il trasferimento della sede pontificia è una profezia post eventum (quando Dante scrive il canto XXXIII del Purgatorio [probabilmente nel 1313] il trasferimento è già avvenuto), mentre il ritorno non lontano dei pontefici a Roma vuole essere una vera profezia, che però non si è ancora avverata, né si avvererà essendo Dante vivo: i papi ritorneranno a Roma solo nel 1377. Il Poeta trasforma in profezia la sua grande speranza.1 E che Dante possedesse in alto grado la virtù della Speranza, lo sapeva benissimo Beatrice, che nel Cielo Stellato, quando Dante sta per essere esaminato da S. Giacomo sulla seconda delle tre Virtù teologali, afferma, sostituendosi al suo «fedele»: «La Chiesa militante alcun figliuolo non ha con più speranza, com’è scritto 163 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 164 Tenzone 14 2013 nel Sol che raggia tutto nostro stuolo: però li è conceduto che d’Egitto vegna in Ierusalemme per vedere, anzi che ’l militar li sia prescritto». Paradiso XXV, 52-57 E ci piace ricordare anche le parole che Bruno Nardi scrive a proposito della convinzione di Dante che Dio avrebbe provveduto a riportare la giustizia sulla ‘terra desolata’: «E allora il sangue di Cristo fu dunque versato invano? Dio avrebbe dunque abbandonato l’umanità al suo destino, e il grande dramma cosmico dovrebbe concludersi colla vittoria dello spirito del male? L’ottimismo cristiano di Dante e la sua fede nella provvidenza gl’impedivano di pensare, non che di pronunziare, una simile bestemmia» (19902: 265-326, alla p. 271). Continuiamo con la nostra lettura. Poi le si mise innanzi tutte e sette, e dopo sé, solo accennando, mosse me e la donna e ’l savio che ristette. Così sen giva; e non credo che fosse lo decimo suo passo in terrra posto, quando con li occhi li occhi mi percosse; e con tranquillo aspetto «Vien più tosto», mi disse, «tanto che, s’io parlo teco, ad ascoltarmi tu sie ben disposto». (vv. 13-21) Si ricompone, in piccolo, il corteo, ripartendo dall’albero (tutti gli altri componenti della grande processione sono risaliti in cielo; cfr. XXXII, 8890). Dirige la piccola processione Beatrice, che dispone l’ordine del corteo: davanti stanno le sette Virtù, con in mano i sette candelabri, poi viene Beatrice, sola, in posizione centrale, seguono infine Dante, Matelda e Stazio: «quasi immagine – commenta Mario Apollonio – del ricostruirsi della Chiesa nella illuminazione dello Spirito e con la salvaguardia intellettuale della Rivelazione» (1951: 775). Dopo lo scatto di indignazione, Beatrice 164 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 165 Purgatorio XXXIII Giuseppe CIAVORELLA riacquista la serenità: ella sa, perché lo legge in Dio, che l’umiliazione della Chiesa non durerà a lungo. Non è possibile dire se i ‘passi’ (nove o dieci che siano) abbiano un significato allegorico: le congetture non sono mancate. Ci limitiamo a ricordarne due: la prima (già avanzata dal Pascoli (1952 [1904]: 1534) e riconfermata da M. Palma di Cesnola (1995: 67, ma per la datazione degli eventi citati nel canto interessano tutte le pp. 73-97) legge nei “quasi dieci passi” i quasi dieci anni che passano dalla morte di Beatrice (8 giugno 1290) all’inizio del viaggio ultraterreno di Dante (8 aprile 1300): ne sarebbe conferma la «decenne sete» di Purg. XXXII 2; la seconda vede nel numero un’allusione agli anni che intercorrono tra l’anno del trasferimento della sede pontificia in Francia (1305) e l’anno della morte di Clemente V e Filippo il Bello (1314), gli artefici (o responsabili) del trasferimento: tale congettura, avanzata da Ernesto Giacomo Parodi (1965 [1921]: 245-47) implica, ovviamente, che questo canto, ultimo del Purgatorio, sia stato composto dopo la morte dei due personaggi; il che, secondo gli studi più recenti, appare poco probabile. La prima ipotesi sembra perciò più plausibile. Sì com’io fui, com’io dovea, seco, dissemi: «Frate, perché non t’attenti a domandarmi omai venendo meco?». Come a color che troppo reverenti dinanzi a suo maggior parlando sono, che non traggon la voce viva ai denti, avvenne a me, che sanza intero suono incominciai: «Madonna, mia bisogna voi conoscete, e ciò ch’ad essa è buono». (vv. 22-30) Beatrice (la quale “sa” che Dante desidera spiegazioni su ciò che ha visto, perché «ritornato di là», dovrà riferire tutto in un poema) cerca di mettere a suo agio Dante, ancora intimidito dalla bellezza celestiale della donna, oltre che dalla severità con cui ella lo ha accolto. L’appellativo «frate» (già tante volte usato dai penitenti incontrati lungo i gironi del 165 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 166 Tenzone 14 2013 Purgatorio) è espressione della carità che unisce, nel nome di Dio, le anime salve; ma è la prima volta che Beatrice lo usa rivolgendosi a Dante. Nota Umberto Bosco nel suo commento alla Commedia: il rapporto tra Beatrice e Dante assume, già in questo canto, un carattere nuovo che rimarrà d’ora in poi costante. La donna cessa di essere la donna dello stilnovo e anche la severa rampognatrice, per diventare sollecita e amorevole ammaestratrice; Dante assume la figura d’un docile scolaro, desideroso di apprendere, anche se talvolta sprovveduto, come appare subito in questo stesso canto». Notazione certamente valida, ma che richiede forse qualche precisazione. Noi preciseremmo, per esempio, che Dante conserva, e conserverà sempre, verso Beatrice “troppa reverenza”, un atteggiamento che rassomiglia molto a quello che oggi si usa definire complesso di inferiorità (il senso di colpa, che le accuse di Beatrice avevano ridestato in lui, dovrebbe essere stato, invece, cancellato dall’immersione nel Letè; ma non sempre è così); dimostra ciò anche il «voi» con cui le rivolge (e sempre le rivolgerà) la parola (ha dato del «voi», per deferenza, anche a Farinata – che in verità sa anche affrontare «a viso aperto» – e lo darà ancora a Cacciaguida), come «a suo maggior parlando». Aggiungeremmo che Dante non può non averlo, il complesso di inferiorità: lo richiedono la situazione narrativa (Beatrice è non solo beata, e non è solo la sua ‘salvatrice’, ma è apparsa nel Paradiso terrestre fra «cento» angeli, «come Cristo» trionfante) e la psicologia del personaggio: non solo del Dante viator dell’oltretomba, ma dello stesso Dante della Vita nuova, che in presenza di Beatrice era colto da tremore, e che mai a Beatrice viva ebbe il coraggio di rivolgere la parola. I sentimenti del Dante della Commedia per Beatrice beata, insomma, non sono molto diversi da quelli del Dante della Vita nuova per Beatrice viva, ma già poeticamente ‘angelicata’: c’è sostanziale coerenza, su questo, tra il libello giovanile e il poema della maturità. Che la Beatrice della Commedia, poi, non sia più ‘la donna dello stilnovo’, 166 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 167 Purgatorio XXXIII Giuseppe CIAVORELLA era già manifesto fin dal suo colloquio nel Limbo con Virgilio (Inf. II, 52117). Ed ella a me: «Da tema e da vergogna voglio che tu omai ti disviluppe, sì che non parli più com’om che sogna. (vv. 31-33) Si direbbe che Beatrice non apprezzi la risposta di Dante: vi legge ancora il timore e la vergogna con cui egli ha ascoltato le sue severe accuse di traviamento, dopo ch’ella «di carne a spirto era salita» (Purg. XXX, 127). Un simile Dante non può scrivere tutto ‘quel che ha visto’ nello spettacolo apocalittico della devastazione della Chiesa: che non era un sogno ad occhi aperti, ma una terribile realtà storica presentata in forma visionaria e simbolica. Deve perciò ‘svegliarsi’ e ragionare, per capire veramente il dramma religioso e politico che lacera il mondo cristiano e prepararsi alla grande e difficile missione che gli è stata affidata. Né, d’altra parte, Beatrice ha finito di ammaestrarlo su ciò che ha visto: ha ancora da rivelargli cose importantissime, che dovrà riferire al «mondo che mal vive», e ha perciò bisogno di un Dante pienamente padrone di sé. Per questo lo scuote imperiosamente: «voglio». Così parlava ai profeti il Dio degli Ebrei.2 Sappi che ’l vaso che ’l serpente ruppe, fu e non è; ma chi n’ha colpa, creda che vendetta di Dio non teme suppe. (vv. 34-36) È una terzina davvero ermetica (come ermetiche sono spesso le pagine dell’Apocalisse, che Dante qui cita) e ne diamo, perciò, la parafrasi e la spiegazione: ‘Sappi che il carro («vaso») che fu rotto dal drago («serpente»), non esiste più («fu e non è»); ma coloro che sono colpevoli di ciò, credano pure che la giustizia punitiva («vendetta») di Dio è certa e presto o tardi colpirà («non teme suppe»)’. Le parole «vaso» e «serpente» richiamano le parole «carro» e «drago» di Purg. XXXII, 131-32 (che si in167 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 168 Tenzone 14 2013 seriscono nella scena ‘apocalittica’ compresa nei vv. 130-35). Il carro della Chiesa ha subìto una così mostruosa metamorfosi (Purg. XXXII, 136-47) ed è stato trascinato così lontano dalla sua vera sede (Purg. XXXII, 157-60) che si può dire che (al tempo in cui Dante vede, ascolta e scrive) non esista più agli occhi di Dio (qualcosa di simile dichiarerà S. Pietro in Par. XXVII, 23-24: «il luogo mio che vaca / ne la presenza del Figliuol di Dio»).3 L’espressione «fu e non è» è ripresa da Apoc. 17, 8: «bestia quam vidisti fuit et non est» [la bestia che hai visto fu e non è]: Dante cerca sempre un sostegno alle proprie parole profetiche nelle Scritture. Suona, però, piuttosto strana l’espressione con cui Beatrice accompagna l’annuncio dell’immancabile castigo divino: «non teme suppe». Le spiegazioni sono state diverse. I commentatori trecenteschi della Commedia fanno riferimento ad un’usanza importata dalla Grecia secondo la quale «se uno uccidea un altro, e egli potea andare nove dì continui a mangiare una suppa per die suso la sepoltura del defunto, né ’l Comune né i parenti del morto non faceano più alcuna vendetta. Ed usasi in Firenze di guardare per nove dì la sepoltura d’uno che fosse ucciso, acciò che non vi sia suso mangiato suppa» (Jacopo della Lana). Altre interpretazioni sono state avanzate da commentatori successivi (fra cui Bernardino Daniello, Guido Mazzoni, Herbert D. Austin, Francesco Torraca); la più probabile, però, è ritenuta ancora quella trecentesca del Lana. Ma il vocabolo [«suppe»] – commenta Franco Lanza – ha una sua forza sarcastica e dispregiativa sufficiente, anche senza una proiezione storica, ad inserirlo in quelle espressioni che usualmente confortano, nel linguaggio dantesco, il distacco tra la giustizia e l’empietà, l’altezza divina e la bassezza umana: simile, in tal funzione, a certe invettive dei beati che culmineranno nel “lascia pur grattar dov’è la rogna” di Cacciaguida o nella “cloaca” maledetta da San Pietro (Par. XVII 129 e XXVII 25) (Lanza in LDS 1967: 1221). 168 Non sarà tutto tempo sanza reda l’aguglia che lasciò le penne al carro per che divenne mostro e poscia preda; Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 169 Purgatorio XXXIII Giuseppe CIAVORELLA ch’io veggio certamente, e però il narro, a darne tempo già stelle propinque, secure d’ogn’intoppo e d’ogne sbarro, nel quale un Cinquecento Diece e Cinque, messo di Dio, anciderà la fuia con quel gigante che con lei delinque. (vv. 37-45) Il riferimento è ancora alla visione apocalittica (Purg. XXXII, 124-126 e 157-160). L’aquila («aguglia») è simbolo dell’Impero (come il carro è simbolo della Chiesa); il Poeta (per bocca di Beatrice) intende perciò dire che l’Impero (istituzione divina, come la Chiesa) non resterà per sempre vacante («sanza reda», ‘senza erede’). Dante, infatti, considerò l’Impero vacante dopo la morte di Federico II (1250) «non ostante che Ridolfo e Andolfo e Alberto poi eletti siano, appresso la sua morte e de li suoi discendenti» (Conv. IV III 6). Sarà vero «erede» Arrigo VII (1308-1313). Ma si tenga presente che Dante considera vacante (per indegnità di chi lo occupa) anche il soglio pontificio (cfr. Par. XXVII, 23-24, cit.). Le due massime istituzioni terrene non hanno guida. Da questa convinzione scatta la profezia del «Cinquecento Diece e Cinque». Beatrice usa un linguaggio di tipo ‘astrologico’, ma è un uso, il suo, che può essere definito strumentale, perché, dovendo essa (Dante poeta, in realtà) fare una profezia, non può non parlare «per similitudini» (in proverbiis, per usare la terminologia evangelica), come usava talvolta Gesù con i suoi discepoli. Beatrice parla ‘astrologico’ perché, al tempo di Dante, la dottrina degli influssi stellari (che, non si dimentichi, anche per i teologi avevano come causa prima Dio, donde la ‘certezza’ di Beatrice, che in Dio legge il futuro) era comunemente accettata, e compresa. Ma per i lettori del nostro tempo è forse meglio tradurre il linguaggio ‘astrologico’ dei vv. 40-45 in linguaggio corrente: ‘perché io vedo con assoluta certezza, e perciò lo rivelo a te, stelle ormai vicine a sorgere («propinque»), sicure di poter superare ogni ostacolo e ogni sbarramento («sbarro»), che ci daranno («a darne») un tempo nel quale un liberatore («un Cinquecento Diece e Cinque»), inviato («messo») da Dio, ucciderà («anciderà») la meretrice («fuia») insieme 169 Ciavorella:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:51 PÆgina 170 2013 con quel gigante che con lei commette peccato («delinque»)’. Beatrice, in sostanza, annuncia la non lontana venuta di un inviato divino (designato misteriosamente con il numero «Cinquecento Diece e Cinque», in numeri romani DXV, anagrammabili in DVX; in numeri arabi, 515), che riporterà la giustizia nella Chiesa e nell’Impero, uccidendo sia la «fuia» (la «puttana sciolta» di Purg. XXXII, 149) sia il «gigante» (il «feroce drudo» della «puttana»; Purg. XXXII, 152 e 155).4 Ci permettiamo di ricordare che era «da ciel messo» l’angelo che aprì la porta della Città di Dite, chiusa dai diavoli che non volevano far entrare Dante (Inf. IX, 85). Lo sdegno di Beatrice ricorda lo sdegno del «messo» celeste che apre la porta infernale: «Ahi quanto mi parea pien di disdegno! / Venne a la porta e con una verghetta / l’aperse, che non v’ebbe alcun ritegno» (Inf. IX, 8890). Forse non è arbitrario ipotizzare un nesso fra il canto infernale e i canti XXXII e XXXIII del Purgatorio.5 Ma l’enigma del numero «Cinquecento Diece e Cinque», al quale si è soltanto accennato, richiede un discorso un po’ lungo. La discussione sul significato da attribuire al misterioso numero con cui è identificato il «messo di Dio» incomincia già nel Trecento, con i primi commentatori della Commedia (Jacopo della Lana, l’Ottimo Commento, Pietro di Dante, Benvenuto da Imola, Francesco da Buti). Subito, nella trascrizione in cifre romane del numero 515, DXV, e nel relativo anagramma, DVX (cioè DUX), si lesse un’allusione generica ad «uno Imperadore», ovvero ad «alcuno giustissimo e santissimo Principe il quale reformerà lo stato della Chiesa e de’ fedeli cristiani» (Ottimo Commento). Solo nel Cinquecento, con il Vellutello e il Daniello, il «messo di Dio» è identificato con Arrigo VII di Lussemburgo, «uomo di grandissimo valore e pieno di singular bontade e giustizia» (Daniello). Nel Settecento Pompeo Venturi e Baldassarre Lombardi tornano a rilevare (dopo i primi commentatori del Trecento) che Dante, nell’indicare il «messo di Dio» con un numero, imita «lo stile profetico di san Giovanni nell’Apocalisse, ove il Santo indica il nome dell’Anticristo: “numerus eius sexcenti sexaginta sex” [il suo numero è seicento sessanta sei (in numeri romani: DCLXVI; in numeri arabi: 666)]» (B. Lombardi). Commenta Pietro Mazzamuto (da cui soprattutto traiamo le 170 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 Giuseppe CIAVORELLA 11:51 PÆgina 171 Purgatorio XXXIII informazioni in sintesi): «sono proposte che resteranno nella storia dell’esegesi del DXV».6 Nell’Ottocento le interpretazioni risentono spesso del clima politico risorgimentale e nazionalistico. Al ‘tedesco’ Arrigo VII viene preferito Cangrande della Scala (Niccolò Tommaseo), o addirittura Uguccione della Faggiuola. Quando Dante compone l’ultimo canto del Purgatorio, osserva il Tommaseo, Arrigo VII è già morto [in verità molti studiosi sostengono che era ancora vivo, e di questo parere siamo anche noi], mentre Cangrande, già nominato vicario imperiale, sarà capo della Lega ghibellina nel 1318. Viene anche proposta un’interpretazione neoguelfa-clericale: DXV è acrostico di “Domini Xristi Vicarius” [Vicario del Signore nostro Cristo], dove “Vicarius” è un papa; o si collega il numero «Cinquecento Diece e Cinque» con il Veltro di Inf. I, per cui DXV è acrostico di “Domini Xristi Vertagus” [Cane da caccia di Cristo nostro Signore], e si identificano Veltro e DXV. Nel Novecento i contributi più originali vengono da Robert Davidsohn (1902) e, soprattutto, da Ernesto Giacomo Parodi (1965 [1921]). Il Davidsohn ritiene che in «Cinquecento Diece e Cinque» sia da leggere una data, e precisamente il 1315, «somma dell’anno 800, nel quale ebbe luogo l’incoronazione di Carlo Magno, e del 515 del verso dantesco» (Mazzamuto): il 1315 è l’anno in cui Ludovico di Baviera è eletto imperatore, ed è anche l’anno, secondo una leggenda medioevale, in cui incomincerà una nuova fase della storia del mondo. Se si ritiene valida la proposta del Davidsohn, la data di composizione del nostro canto è da porre dopo il 1315 (o quanto meno ipotizzare una revisione del canto successiva al 1315). Il Parodi distingue nettamente tra Veltro e DXV: il primo corrisponde ad una profezia incerta e approssimata, il secondo ad un preciso personaggio storico, che non può che essere Arrigo VII, «vivo e presente» nel momento in cui Dante compone l’ultimo canto del Purgatorio, «stretto e angustiato da terribili ostacoli, ma predestinato dalla volontà di Dio e dalla santità della sua missione a trionfarne da ultimo con impreveduta facilità» (Parodi).7 E l’interpretazione del Parodi, per la rigorosa documentazione che la sostiene, è ritenuta ancora oggi la più convincente tra le moltissime avanzate in sette secoli di studi danteschi. È chiaro, però, che tale interpretazione presuppone che l’ultimo 171 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 172 Tenzone 14 2013 canto del Purgatorio sia stato composto prima della morte di Arrigo VII (24 agosto 1313), cosa non impossibile, se si accetta come data certa (come noi riteniamo), per la composizione del canto VI del Purgatorio, il mese di dicembre 1310. Più recente l’interpretazione di Robert E. Kaske, che vede nel DXV lo stesso Cristo, che ritorna sulla terra per sconfiggere definitivamente l’Anticristo e fare giustizia (in DXV sarebbero da leggere le lettere iniziali dell’espressione liturgica «Vere Dignum et iustum est», insieme con il simbolo della croce «X» [Kaske 1961: 185-254]). Andrea Battistini ritiene convincente l’interpretazione del Kaske (in L’Alighieri 29, 2007: 98-99). Nicolò Mineo (1998: 42-43) ritiene opportuno rinunciare ad identificare il DVX con un personaggio storico. Ecco che cosa scrive il critico in un suo recente saggio (premetto che per Mineo la puttana e il gigante dell’“apocalisse di Dante” raffigurano rispettivamente la Curia papale corrotta e l’Anticristo, secondo l’interpretazione che dell’Apocalisse di San Giovanni avevano data Gioacchino da Fiore e gli spirituali francescani, come Pietro di Giovanni Olivi e Ubertino da Casale): Il nostro problema a questo punto sarà non già stabilire chi possa essere il «Cinquecento diece e cinque», ma cosa questo rappresenti dal punto di vista apocalittico-escatologico. Mentre non è certo da dimostrare che la simbolizzazione nella forma del numero sia da ricondurre alla strutturazione apocalittica e sia procedimento adottato in analogia col testo giovanneo. Orbene, la figura apocalittica a cui la tradizione esegetica riconosce il compito continuato, dalla passione di Cristo sino alla fine del mondo, di combattere alla testa dei buoni contro le forze del male è l’angelo Michele, che in figura di Cristo combatterà contro l’Anticristo reale. Quest’ultimo compito anzi è quello maggiormente messo in luce nei commenti all’Apocalisse. [...] Se pertanto l’erede dell’aquila combatterà, nello spirito di Michele, e quindi di Cristo [...] contro l’Anticristo proprio, ne deriva che questo è da riconoscere nello stesso gigante. Per ultima (perché la più recente) diamo l’interpretazione di Michelangelo Picone. Questi, convinto che esista una relazione tra la profezia del 172 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 Giuseppe CIAVORELLA PÆgina 173 Purgatorio XXXIII «Veltro» (‘cane da caccia, veloce ma anche grande’), del primo canto dell’Inferno, e la profezia del «Cinquecento Diece e Cinque», dell’ultimo canto del Purgatorio, propone di individuare, nel misterioso personaggio alluso nel numero, Cangrande della Scala (individuazione peraltro non nuova, come si è già detto); e propone, nello stesso tempo, di leggere (invece che «Cinquecento diece e cinque») «cinque cento diece e cinque» (lettura che i manoscritti consentirebbero), cioè, in mumeri romani, VCXV; in questa sigla si possono leggere – dichiara Picone – «le iniziali di una frase che recita “Vicarius Canis in Christo Victoriosus”» [Cangrande Vicario Vittorioso in Cristo]. E spiega lo studioso: «Frase che non ci inventiamo noi, ma che corrisponde all’intitolazione dell’Epistola XIII, quella contenente la dedica del Paradiso a Cangrande. Dice appunto il primo comma di quella lettera: “Magnifico atque victorioso domino Cani Grandi de la Scala sacratissimi Cesarei Principatus […] Vicario generali […]» (Picone 2008: 92). In verità nell’intitolazione dell’Epistola XIII non compare il nome di Cristo («sacratissimi» è riferito a «Cesarei Principatus», e Cangrande risulta aver guerreggiato non nel nome di Cristo, ma dell’Imperatore, di cui era Vicario), ma la proposta di Picone, per la diversa e nuova lettura del numero, ci pare che meriti di essere presa in considerazione non meno delle altre. Rinunciamo ad esprimere una nostra interpretazione (ma cfr. la nota n. 5). Ci limitiamo a dire che la spiegazione data dai primi commentatori della Commedia del Trecento (fra i quali sono, è bene ricordarlo, due autori che conobbero personalmente e intimamente Dante: Pietro figlio di Dante, innanzitutto, e l’autore dell’Ottimo Commento [il notaro Andrea Lancia?], che poterono ascoltare dallo stesso Poeta l’interpretazione che essi ci hanno tramandato, e in particolare Pietro), che cioè l’“enigmatico” numero è sigla di DXV=DVX, resta, dopo tanto discutere, la sola (quasi) certezza, sulla quale la stragrande maggioranza degli interpreti non ha difficoltà a consentire. Riprendiamo la lettura del canto. 173 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 174 Tenzone 14 2013 E sappi che la mia narrazione buia, qual Temi o Sfinge, men ti persuade, perch’a lor modo lo ’ntelletto attuia; ma tosto fier li fatti le Naiade, che solveranno questo enigma forte sanza danno di pecore o di biade. (vv. 46-51) Dopo il linguaggio ‘astrologico’, il linguaggio ‘mitologico’: della mitologia degli enigmi e delle profezie, che spesso annebbia il cervello, come la stessa Beatrice avverte. Perché il linguaggio mitologico, se non si conoscono bene i miti, può essere anche meno comprensibile di quello astrologico (per rinfrescare la memoria del lettore, diamo perciò alcune spiegazioni in nota sui miti citati, tanto più che Dante commette un errore di citazione, che complica il discorso).8 Per semplificare ulteriormente la lettura delle due terzine, obiettivamente difficile, diamo anche la parafrasi dei versi: ‘E sappi che la mia profezia oscura, com’erano oscure quelle fatte da Temi o dalla Sfinge, non ti persuade, perché come quelle ottenebra («attuia») l’intelletto; ma presto i fatti che accadranno saranno («fier») essi stessi rivelatori («le Naiade»), e risolveranno questo difficile enigma senza recar danno né a greggi né a campi coltivati’. Beatrice, cioè, non chiede a Dante di sforzarsi di capire la profezia del «Cinquecento Diece e Cinque»: non sarebbe in grado di capire (in verità Dante poeta sa che i lettori del canto si proveranno a spiegare l’«enigma forte»; ed è questo, anzi, ch’egli vuole, ed è questo che inevitabilmente tenteranno di fare i lettori).9 Tu nota; e sì come da me son porte, così queste parole segna a’ vivi del viver ch’è un correre a la morte. E aggi a mente, quando tu le scrivi, di non celar qual hai vista la pianta ch’è or due volte dirubata quivi. 174 (vv. 52-57) Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 Giuseppe CIAVORELLA 11:51 PÆgina 175 Purgatorio XXXIII È rinnovato da Beatrice in questi versi il conferimento della missione poetica e profetica a Dante (cfr. Purg. XXXII, 103-105); e nello stesso tempo è imposto al Poeta di riferire con la massima esattezza ciò che ha visto e sentito: i fatti chiariranno anche ciò che ora sembra oscuro allo stesso Dante, che vede e sente. Il critico Enzo N. Girardi mette in relazione, questo momento fondamentale del “viaggio”, con il capitolo conclusivo della Vita nuova, in cui Dante accenna al progetto di composizione di un’opera poetica al cui centro sarà Beatrice. Scrive il Girardi (1989: 659): Ora, poiché l’indizio più rilevante di tale progetto costruttivo della Commedia lo si trova, com’è noto, già prima della Commedia, nel finale della Vita nuova, là dove Dante dichiara essergli apparsa una «mirabile visione, ne la quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io potesse più degnamente parlare di lei» – una visione, dunque, di cose legate a Beatrice, incentrate su Beatrice, tali da non poterne trattare se non trattando di Beatrice; sembra logico che chi muove da questo primo indizio esterno verso il poema, dovendo scegliere un punto d’arrivo che corrisponda per tema e per linguaggio a quella partenza, lo trovi proprio qui, in questa mirabile visione di cose assai più ardue e complesse di quelle della Vita nuova, comprensive dell’esperienza politica, filosofica e letteraria successiva al libello giovanile, ma tuttavia imperniate su Beatrice, interpretate da lei, e, ancora, elaborate in un linguaggio traslato e visionario che è molto simile a quello del libello stesso. Il linguaggio di Beatrice è effettivamente «traslato e visionario» per quanto riguarda il futuro: è un linguaggio profetico. Ma per quanto riguarda il passato e il presente ha la concretezza delle cose viste: quella del duplice spettacolo della «pianta due volte dirubata» e della visione apocalittica; un linguaggio simbolico, certo, ma concreto, perché fatto di figure identificabili e di atti interpretabili. E se Dante ha qualche difficoltà a capire (e dimostrerà di averle), ella è pronta a dare le spiegazioni necessarie. Aggiungeremmo una precisazione. Anche Cacciaguida e S. Pietro, 175 Ciavorella:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:51 PÆgina 176 2013 nel Paradiso, conferiranno a Dante la missione di narrare al «mondo che mal vive» ciò che ha visto in tutto il suo viaggio ultraterreno, e lo faranno, certamente, con maggiore autorevolezza e solennità, proporzionate al loro superiore prestigio gerarchico e al luogo celeste in cui si trovano; ma se Dante ha voluto che la missione gli fosse conferita per prima da Beatrice, lo ha fatto certamente per qualche motivo. Ora, noi crediamo che il motivo non possa essere che di riconoscenza; duplice riconoscenza: d’ordine poetico e d’ordine religioso. Dante riconosce a Beatrice il merito di avergli ispirato, prima, la poesia d’amore che lo ha fatto uscire «de la volgare schiera» (Inf. II, 105), e poi il grande «poema sacro», che lo porrà alla pari (ne è convinto) con i grandi poeti classici. E riconosce a Beatrice anche il merito, forse superiore al primo, di averlo salvato dalla «selva selvaggia», nella quale stava per smarrire irrimediabilmente la «diritta via». E se il «poema sacro» gli è ispirato da Beatrice, poteva non essere Beatrice a conferirgli per prima la missione poetica e profetica, le cui origini sono nella volontà di Dio? L’investitura missionaria che riceve da Beatrice ha per Dante un significato più profondo di quelle che riceverà da Cacciaguida e San Pietro. Torniamo al nostro testo, e precisamente al v. 54. Esso è la parafrasi di un aforisma del De civitate Dei XIII, 10, di S. Agostino: «nihil aliud tempus vitae huius, quam cursus ad mortem» [il tempo della vita terrena non è altro che un correre alla morte] (cfr. Purg. XX, 38-39, dove lo stesso concetto è espresso con parole diverse). Scrive Vittorio Cian: «Un verso tremendo questo, che resta la definizione più profondamente medievale e plastica, nel suo ritmo rappresentativo, della vita terrena: una corsa alla morte» (Cian 1958: 665). Beatrice ricorda in sostanza a Dante, perché lo ricordi ai vivi, che la vita terrena deve essere vissuta nella prospettiva della vita eterna. Quindi porta il discorso sulla «pianta», cioè sull’albero della conoscenza del bene e del male, intorno al quale si è svolto il ‘mistero’ rappresentato nel canto XXXII. L’espressione «or due volte dirubata» è interpretata in modi diversi; accenniamo alle due spiegazioni più accreditate (che risalgono rispettivamente ai commentatori trecenteschi Francesco da Buti e Jacopo della Lana). L’avverbio «or» – osservano i so176 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 177 Purgatorio XXXIII Giuseppe CIAVORELLA stenitori della prima spiegazione – accenna al tempo presente e sembra perciò far riferimento alla visione apocalittica appena svoltasi; l’espressione «due volte dirubata» dovrebbe allora intendersi: ‘derubata prima dall’aquila (che scendendo sul carro ruppe foglie, fiori e scorza) e poi dal gigante (che sciolse il carro dalla pianta e lo trascinò con sé nella selva)’. Se si guarda alla sintassi, questa è l’interpretazione più plausibile. Non si può non osservare, però, che l’aquila non deruba la pianta, ma la danneggia; e la distinzione è netta al v. 58. Se si guarda, invece, a tutta la rappresentazione allegorica che si svolge nel canto XXXII (e non solo alla visione) e si dà a «or» il significato di ‘a questo punto, dopo quanto hai visto qui nel Paradiso terrestre’, l’espressione «due volte dirubata» può intendersi: ‘derubata prima da Adamo (e quando la processione arriva presso la pianta, questa è ancora «dispogliata» di foglie, fiori e frutti) e poi dal gigante (che trascina via il carro legato alla pianta: e il carro era stato legato dal grifone alla pianta come cosa a lei appartenente; cfr. XXXII, 49-51)’. Questa seconda interpretazione a me sembra più convincente. Qualunque ruba quella o quella schianta, con bestemmia di fatto offende a Dio, che solo a l’uso suo la creò santa. Per morder quella, in pena e in disio cinquemilia anni e più l’anima prima bramò colui che ’l morso in sé punio. Spiega Lino Pertile: (vv. 58-63) l’albero è l’unica res che Dio creò per sé in tutto il Paradiso terrestre. Esso è dunque il segno e il simbolo del potere sovrano di Dio e allo stesso tempo della condizione subalterna dell’uomo nel creato. [...] La giustizia di Dio, dichiara Beatrice, si esprime non solo nel decretum che vieta l’“uso” dell’albero all’uomo [Genesi 2, 16-17], ma anche nella forma stessa dell’albero (Pertile 1998: 165-66). 177 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 178 Tenzone 14 2013 La «bestemmia di fatto» è il sacrilegio, e si distingue dalla «bestemmia di parola»: la prima, ovviamente, più grave della seconda. E poiché l’albero (come chiarirà fra poco Beatrice; vv. 71-72) è, simbolicamente, l’albero della giustizia divina, Adamo e il gigante (o il gigante e l’aquila, che «schianta» l’albero e il carro, il cui timone è fatto col legno dell’albero [cfr. Purg. XXXII, 51]; o, meglio ancora, Adamo, l’aquila e il gigante) hanno violato la giustizia di Dio. Adamo, secondo la Bibbia, visse 930 anni: e furono tutti anni di «pena», perché, avendo commesso il peccato originale appena sei ore dopo la sua creazione (cfr. Par. XXVI, 118-142), fu subito cacciato dal Paradiso terrestre; aspettò poi con sofferto «disio» nel Limbo per 4302 anni la Redenzione di Cristo, che lo liberò dal Limbo e gli permise di ascendere al Paradiso. Dorme lo ’ngegno tuo, se non estima per singular cagione essere eccelsa lei tanto e sì travolta ne la cima. E se stati non fosser acqua d’Elsa li pensier vani intorno a la tua mente, e ’l piacer loro un Piramo a la gelsa, per tante circostanze solamente la giustizia di Dio, ne l’interdetto, conosceresti a l’arbor moralmente. (vv. 64-72) Nell’albero edenico della conoscenza del bene e del male – ammonisce Beatrice – è da riconoscere, in senso morale («moralmente»), la Giustizia di Dio; esso è raffigurato così alto e con la chioma così singolarmente «travolta» (a forma di cono rovesciato) per significare – come spiega Benvenuto da Imola – che «scientia Dei est altissima in infinitum; revolutio autem figurat quod nullus potest ascendere vel attingere ad illam altitudinem» [la scienza di Dio è eccelsa all’infinito; lo stravolgimento della cima significa che nessuno può salire e raggiungere quell’altezza]. La scienza di Dio, e perciò anche la giustizia di Dio (che si esprime anche in proibizioni), è inarrivabile da mente umana.10 Ma Dante, nonostante tutti i segni esterni («circostanze») con cui l’albero della conoscenza del bene 178 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 Giuseppe CIAVORELLA 11:51 PÆgina 179 Purgatorio XXXIII e del male si presentava, sembra non aver capito il significato morale della proibizione («interdetto») fatta da Dio ad Adamo di cibarsi dei suoi frutti; e perciò il linguaggio di Beatrice torna severo, quasi come quando ella accusava Dante dei suoi peccati (Purg. XXX e XXXI). La severità si spiega anche con la necessità che Dante si renda ben conto dell’importanza della missione che gli è stata affidata: per compierla perfettamente il suo intelletto deve essere libero da pregiudizi terreni, la sua memoria lucida e precisa, la sua volontà determinata. Si direbbe che Beatrice voglia che Dante capisca bene ch’egli ha sì ‘lavato’ i suoi peccati, ma che la sua mente è rimasta ‘incrostata’ dagli errori della filosofia razionale, da lui seguita per anni: se vuole capire perfettamente le verità delle Sacre Scritture e gli insegnamenti dei Padri della Chiesa e dei teologi, e soprattutto se vuole eseguire bene la difficile missione che gli è stata affidata, deve liberarsi dal pregiudizio filosofico che la ragione può spiegare tutto. Per rendere più efficace il suo discorso Beatrice usa due similitudini: realistica la prima, mitologica la seconda. La prima ha come termine di paragone le acque del fiume Elsa (affluente di sinistra dell’Arno), le quali sono così ricche di carbonato di calcio che incrostano gli oggetti che vi sono immersi. Beatrice, cioè, accusa Dante di avere rivolto per così lungo tempo il suo interesse, pratico e filosofico, ai beni terreni, da cui ricavava un piacere falso ed effimero, che la sua mente è rimasta ‘incrostata’ dall’errore; conseguentemente egli è ora incapace di sollevarsi dalle verità parziali del mondo materiale alla verità suprema dello spirito: dalla filosofia puramente razionale (fondata sulle sole virtù cardinali) alla teologia (assistita dalle virtù teologali). La seconda similitudine ha come termine di paragone il mito di Piramo e Tisbe, al quale Dante aveva già accennato in Purg. XXVII, 37-39: il giovane Piramo amava Tisbe, ricambiato, ma i loro genitori ne ostacolavano le nozze; i due giovani decisero allora di fuggire, e si diedero appuntamento sotto un albero di gelso. Giunse per prima all’appuntamento Tisbe, ma la giovane, impaurita dall’apparizione di una leonessa, fuggì, lasciando cadere il suo mantello, che la belva, che aveva appena ucciso un bove, macchiò di sangue. Quando Piramo sopraggiunse, vide il mantello di Tisbe insanguinato e, pensando che la sua 179 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 180 Tenzone 14 2013 compagna fosse stata uccisa da una belva, disperato si trafisse con la spada. Tisbe, passato il pericolo, tornò indietro e trovò Piramo morente; disperata, si uccise sul corpo del compagno. Il sangue dei due giovani si sparse sulle radici del gelso, che da quel giorno produsse more rosse, invece che bianche. La morale del mito sarebbe (dico ‘sarebbe’ perché è piuttosto forzata) che, come il sangue di Piramo mutò i frutti del gelso, così il piacere dei «pensier vani» ha mutato la mente, già pura e virtuosa, di Dante. Ma perch’io veggio te ne lo ’ntelletto fatto di pietra e, impetrato, tinto, sì che t’abbaglia il lume del mio detto, voglio anche, e se non scritto, almen dipinto, che ’l te ne porti dentro a te per quello che si reca il bordon di palma cinto». (vv. 73-78) Sono versi piuttosto enigmatici, che si prestano a diverse interpretazioni; noi diamo qui la nostra: ‘Ma poiché io ti vedo indurito come pietra nell’intelletto e, oltre che pietrificato («impetrato»), anche oscurato («tinto») da quei pensieri vani, così che la luce delle mie parole ti abbaglia, voglio anche che tu le porti dentro di te, se non proprio scritte in chiari caratteri, almeno come un’immagine dipinta che ti aiuti a ricordarle, per lo stesso motivo per cui il pellegrino di ritorno dalla Terrasanta porta il bastone da viaggio («bordon») ornato di una foglia di palma’. Con l’accenno al «bordone» (il robusto bastone dal manico ricurvo del pellegrino), Beatrice intende ricordare a Dante che il viaggio che egli compie nell’oltretomba è anche un pellegrinaggio di espiazione: come il pellegrino, per voto, va a visitare la Gerusalemme terrena per vedere i luoghi dove visse e morì Cristo, così Dante, per una speciale grazia divina, ma anche per purificarsi dai suoi peccati, va a visitare, attraversando prima l’Inferno e il Purgatorio, la Gerusalemme celeste, dove Cristo trionfa (cfr. Par. XXXI, 43-45, 103-08); e come il pellegrino terreno cinge con una foglia di palma il bordone, come segno e ricordo del pellegrinaggio compiuto e del voto 180 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 181 Giuseppe CIAVORELLA Purgatorio XXXIII sciolto (la palma è pianta tipica dei Luoghi Santi), così Dante riporterà sulla terra il ricordo di tutto ciò che ha visto e sentito e, come segno della grazia particolare che Dio gli ha concesso facendogli visitare l’oltretomba ancora vivo e affidandogli un’importante missione, racconterà il suo viaggio in un poema: questo sarà, per coloro che lo leggeranno, prova della veridicità della narrazione e per lui, Dante, un richiamo continuo ad esser degno dell’eccezionale grazia che gli è stata concessa. Acuta l’osservazione di Peter Dronke (1990: 121-22) a proposito dell’«intelletto impetrato» di Dante: Mi sembra che sia difficile non interpretare le allusioni di Beatrice alla “pietrificazione” di Dante come richiami caustici al suo legame con la “bella petra”, la donna che aveva ispirato Così nel mio parlar e le altre “rime petrose”. È come se Beatrice stesse dicendo che Dante era arrivato ad appartenere a quella “petra” così profondamente da non essere più pronto ad accogliere la stessa Beatrice (Dronke, 1990: 121-22). Ricordiamo che nella «bella petra» si identifica comunemente la filosofia, al cui studio Dante si era dedicato dopo la morte di Beatrice. Ma, come abbiamo detto, le interpretazioni di queste due terzine sono diverse; ci limitiamo a riportare quella di Enzo Noè Girardi (1989: 667): Il senso insomma mi pare questo: ma poiché il tuo intelletto è fatto impermeabile come pietra e, di più, tale pietra è fatta nera come lavagna, sicché la luce, il senso delle mie parole ne vien respinto, voglio che tu le porti, se non scritte almeno dipinte su questa nera superficie per conservarle fin tanto che sarai in grado di intenderle. È il caso di far notare come l’espressione «voglio anco» richiami il «voglio» del v. 32: Beatrice intende trasmettere la propria volontà, che è volontà soprannaturale, a Dante, come faceva Dio con i profeti ebrei. Le metafore dell’«intelletto impetrato» e «tinto» riprendono le similitudinimetafore dell’«acqua d’Elsa» e di «Piramo a la gelsa». E io: «Sì come cera da suggello, 181 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 182 Tenzone 14 2013 che la figura impressa non trasmuta, segnato è or da voi lo mio cervello. Ma perché tanto sovra mia veduta vostra parola disïata vola, che più la perde quanto più s’aiuta?». (vv . 82-87) La prima terzina è la risposta di Dante alla missione affidatagli da Beatrice: l’impegno del Poeta-pellegrino a comporre la Divina commedia quando sarà tornato sulla terra (impegno che è in corso di attuazione nel momento in cui Dante scrive questi versi); in termini penitenziali, è il momento conclusivo della satisfactio operis, terzo ‘gradino’ del rito della Penitenza, dopo la contritio cordis e la confessio oris (cfr. Purg. XXXI, 91-102). Ma si noti la solennità della risposta del Poeta: la promessa di riferire fedelmente le parole di Beatrice (cfr. vv. 52-57) si configura come un voto: Beatrice rappresenta Cristo, e la promessa fatta a lei è una promessa fatta a Dio. Dante non può non mantenerla (cfr. Par. V, 19-84, dove Beatrice spiega a Dante l’importanza del voto). Ma mentre esprime solennemente la sua promessa, il pellegrino è colto da un dubbio: dovrà riferire alla lettera anche le parole che non capisce? E se gli chiedono spiegazione di quelle parole, che cosa potrà rispondere? E soprattutto: perché a volte le parole di Beatrice gli sembrano così difficili da capire, che ha l’impressione che ella parli un’altra lingua, a lui incomprensibile, di un livello molto più alto di quello dell’uomo? Dante personaggio esprime il suo dubbio usando un linguaggio metaforico, quasi nel tentativo di adeguarsi all’espressione “alta” di Beatrice: la capacità di comprendere è resa con la metafora della «veduta», la ‘vista intellettuale’, che insegue le parole che ‘volano via’, sfuggendo alla comprensione; a questa metafora si adeguano i sintagmi «più la perde» e «quanto più s’aiuta». Osserva Andrea Battistini (2007: 96): 182 Queste continue professioni di inadeguatezza […] potrebbero valere non solo come monito all’“umana gente” a stare “contenti al quia”, essendo la Ragione incapace di conoscere, mentre si è ancora in via, la Rivelazione […], ma anche come avviso agli esegeti Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 183 Purgatorio XXXIII Giuseppe CIAVORELLA a non volere chiarire pienamente il senso di una profezia che per definizione è oscura e mai completamente decifrabile. La metafora della ‘parola alata’ è antichissima, com’è noto: risale a Omero. «Perché conoschi», disse, «quella scuola c’hai seguitata, e veggi sua dottrina come può seguitar la mia parola; e veggi vostra via da la divina distar cotanto, quanto si discorda da terra il ciel che più alto festina». (vv. 85-90) La risposta di Beatrice è severa: un vero atto d’accusa. È l’ultima, e più grave, accusa che Beatrice rivolge a Dante: egli ha seguito una filosofia («dottrina») razionalistica, tutta rivolta a «pensier vani», esclusivamente mondani, e la sua mente ne è ancora come ‘incrostata’. Anche Virgilio, quando era ancora guida – ricorda il Singleton (1978: 165) – aveva parlato della sua “scola” (Purg. XXI, 33) e dei limiti ad essa imposti, più che mai evidenti ora che la guida è Beatrice: lo stesso fatto che egli abbia guidato solo fino ad un dato punto, perché “più oltre” non discerneva, sottolinea ancor meglio quelle limitazioni. A proposito di queste due terzine, si suole citare, giustamente, Isaia, 55, 8: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le mie vie sono le vostre vie, dice il Signore; perché, quanto i cieli sono più alti della terra, tanto le mie vie sono più alte delle vostre e i miei pensieri dei vostri pensieri». Nel verso 90 si allude al Primo Mobile, il cielo più ampio, più alto e più veloce; esso è anche il più distante dalla Terra, la quale, nella concezione astronomica aristotelico-tolemaica, è al centro dell’universo. Ma nel verbo «discorda» è implicato, oltre al significato di distanza, anche quello di 183 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 184 Tenzone 14 2013 contrasto: la Terra è concepita da Dante come la parte più impura dell’universo (e infatti Lucifero ne occupa esattamente il centro), così che i cieli che circondano la Terra sono tanto più nobili quanto più distanti sono da essa. E il Primo Mobile è il più distante (con l’eccezione, ovviamente, dell’Empireo, sede di Dio e dei beati). L’accusa che Beatrice rivolge a Dante ha una notevole importanza sia nella biografia culturale di Dante sia per quanto concerne la costruzione del poema. Torneremo, perciò, sull’argomento. Ond’io rispuosi lei: «Non mi ricorda ch’i’ straniasse me già mai da voi, né honne coscienza che rimorda». «E se tu ricordar non te ne puoi», sorridendo rispuose, «or ti rammenta come bevesti il Letè ancoi; e se dal fummo foco s’argomenta, cotesta oblivion chiaro conchiude colpa ne la tua voglia altrove attenta. Veramente oramai saranno nude le mie parole, quanto converrassi quelle scovrire a la tua vista rude». (vv. 91-102) L’accusa di Beatrice sembra cogliere di sopresa Dante, che dichiara di non ricordare di essersi mai allontanato da Beatrice e dalla «dottrina» da lei rappresentata, cioè dalla retta interpretazione delle Scritture; e aggiunge di non provare alcun rimorso per uno ‘straniamento’ che non ricorda.11 L’osservazione di Dante, ingenua nella sincerità della sorpresa, induce al sorriso Beatrice, che cambia atteggiamento nei riguardi del suo interlocutore; non tanto, però, da impedirle di fargli osservare (con logica sottile) che proprio dal fatto che egli non ricorda si deduce la sua colpevolezza, perché le acque del Letè (e non può non ricordare la sua immersione nel fiume) cancellano solo la memoria del peccato (cfr. Purg. XXVIII, 127-132; XXXI, 100-102): se non avesse commesso colpa, 184 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 Giuseppe CIAVORELLA 11:51 PÆgina 185 Purgatorio XXXIII Dante ricorderebbe ogni cosa. Beatrice promette infine a Dante che da quel momento si rivolgerà a lui con parole semplici, tali da poter essere comprese da un intelletto limitato, qual è quello di Dante vivo. E già in questo suo discorso, al mutato atteggiamento verso il pellegrino, corrisponde un cambiamento del registro linguistico: non più parole alte e misteriose, tali da riuscire quasi incomprensibili a Dante, ma parole del linguaggio comune, dette con tono familiare. L’ultima terzina è tutta costruita sulla metafora della ‘nudità’ della parola: una parola deprivata della luce metafisica che abbaglia l’intelletto umano e la rende inaccessibile (cfr. v. 75: «sì che t’abbaglia il lume del mio detto»). Aggiungiamo ora (come anticipato) qualche altra considerazione a quanto già detto, poiché l’argomento è importante. Cominciamo col chiederci: l’accusa che Beatrice rivolge a Dante in questi versi, è la stessa che gli aveva già rivolta, indirettamente, in Purg. XXX, 124-38, e in particolare nei versi 130-32: «e volse i passi suoi per via non vera, / imagini di ben seguendo false, / che nulla promession rendono intera»? (nei quali versi è probabile il ricordo di Conv. II XII 5-7, dove Dante parla del suo ‘innamoramento’ per la filosofia: «cominciai tanto a sentire de la sua dolcezza, che lo suo amore cacciava e distruggeva ogni altro pensiero»). Sembrerebbe di sì, è la stessa accusa, visto che Dante, in risposta (vv. 9193), afferma di non ricordare di essersi mai «straniato» da lei, che è proprio la colpa di cui Beatrice lo ha accusato. Ma perché allora ripetere la stessa accusa? La spiegazione può essere questa: l’immersione nel Letè ha cancellato in Dante il ricordo del traviamento filosofico; ma Dante deve ritornare in mezzo al «mondo che mal vive» e se non ricorda di aver già commesso un errore dottrinario gravissimo, può ricadere nello stesso errore; ed ecco allora Beatrice ‘restaurare’ il ricordo nella sua memoria. Resta, però, il problema della ‘qualità’ del traviamento di Dante, del quale sono state proposte diverse soluzioni. Per Scartazzini-Vandelli, la «scuola / c’hai seguitata» è la scuola «della scienza umana, della mera filosofia che cerca la verità di ragione, scuola che Dante ha seguitato con tanto ardore, che l’amore per la filosofia, da lui giudicata ‘somma cosa’, “cacciava e distruggeva ogni altro pensiero” (Conv. II XII 5-7), e poco egli 185 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 186 Tenzone 14 2013 curava la più alta scienza, quella delle verità rivelate, raffigurata in Beatrice». Dante, cioè, per superbia intellettuale, si sarebbe allontanato dalla fede, e ciò sarebbe dimostrato da molti passi del Convivio. Di parere non diverso è Luigi Pietrobono, per il quale «la “scuola” a cui Beatrice accenna è proprio quella che ritiene d’innalzarsi con il pensiero alla medesima altezza della parola rivelata». Non è di questo parere, invece, Michele Barbi (in Bullettino della S.D.I IX, 13), secondo il quale la colpa di cui Beatrice rimprovera Dante nel Paradiso terrestre (sia in Purg. XXX sia in Purg. XXXIII) è una sola: di aver amato più i beni mondani che Dio; e la «scuola» che ha seguitato è la povera sapienza del mondo, i «difettivi sillogismi che fanno battere in basso l’ali», l’«accorger nostro scisso», la «veduta corta di una spanna»: invece di levarsi dietro a Beatrice a conoscer ed amar «lo bene di là dal qual non è a che s’aspiri», s’era lasciato traviare dal «falso piacere» de «le presenti cose», e aveva volto «i passi suoi per via non vera, Immagini di ben seguendo false, Che nulla promission rendono intera». Per il Barbi, insomma, il peccato di Dante è stato non tanto dottrinale, quanto morale, e non ha implicato un allontanamento dalla fede. Dissente dal Barbi Étienne Gilson (1987: 95-96 e nota 13) , che scrive: In Purg. XXX Beatrice rimprovera a Dante di essere caduto là dove noi lo troviamo all’inizio della Divina Commedia, con le tre fiere, così in basso che solo la paura dell’inferno poteva ormai correggerlo; in Purg. XXXIII Beatrice lo rimprovera di aver aderito ad una «scuola» la cui «dottrina», come Dante adesso vede bene, non può seguire la sua «parola» e il cui metodo («vostra via») è tanto lontano da quello di Dio quanto la terra è lontana dal cielo. [...] Se questo non gli viene detto per ricordargli che un tempo ha contato troppo sulle forze della ragione, non si vede davvero cosa potrebbe significare. Ma il Gilson sostiene anche che l’amore per la ‘donna gentile’ (la filosofia) non venne meno nell’animo di Dante neanche dopo il suo ritorno a 186 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 187 Purgatorio XXXIII Giuseppe CIAVORELLA Beatrice (la teologia): «Vi è stata, a un certo punto, un’inversione della gerarchia di questi due amori nell’animo di Dante, e anche una temporanea dimenticanza di Beatrice, ma il ritorno di Beatrice non comportò mai l’esclusione della “donna gentile”» (1987: 95, nota 12). Il Gilson, insomma, sostiene la diversità delle accuse di Beatrice a Dante in Purg. XXX e Purg. XXXIII: colpe morali, nel primo caso, colpe dottrinali, nel secondo. A me sembra, però, che l’accenno di Beatrice alle eccezionali doti intellettive di Dante (Purg. XXX, 109-120) e all’errore da lui commesso quando «volse i passi suoi per via non vera, / imagini di ben seguendo false, / che nulla promession rendono intera» (vv. 130-32) si possa interpretare non solo come traviamento morale, ma anche come traviamento dottrinale (pur senza ipotizzare una vera caduta nell’eresia); e che quindi in Purg. XXXIII, 85-90, Beatrice non faccia altro che ribadire le accuse precedenti, perché Dante (come abbiamo detto) dovrà tornare sulla terra, per giunta investito, per volontà divina, di una missione profetica e poetica. Ritorniamo ai versi del canto. E più corusco e con più lenti passi teneva il sole il cerchio di merigge, che qua e là, come li aspetti, fassi, quando s’affiser, sì come s’affigge chi va dinanzi a gente per iscorta se trova novitate o sue vestigge, le sette donne al fin d’un’ombra smorta, qual sotto foglie verdi e rami nigri sovra suoi freddi rivi l’alpe porta. Dinanzi ad esse Eufratès e Tigri veder mi parve uscir d’una fontana, e, quasi amici, dipartirsi pigri. (vv. 103-14) Riprende la narrazione dopo il lungo e oscuro discorso profetico di Beatrice e il dialogo, piuttosto animato, fra la beata e il discepolo dalla «vista rude». È ormai mezzogiorno e il sole brilla alto e luminoso («corusco») sul 187 Ciavorella:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:51 PÆgina 188 2013 meridiano del Purgatorio, dopo essersi gradualmente spostato (secondo la concezione astronomica medievale) da oriente a occidente, da un meridiano all’altro. Ora che è quasi a perpendicolo sul monte del Purgatorio (siamo nell’emisfero sud, nell’equinozio di primavera), sembra muoversi più lentamente. Sono trascorse circa sei ore da quando Dante, poco dopo l’alba, ha messo piede nel Paradiso terrestre; fra poco, dopo che l’acqua dell’Eunoè lo avrà definitivamente purificato, «salirà alle stelle» insieme con Beatrice. E non è un caso, probabilmente, che l’ “ascensione” avvenga sei ore dopo l’arrivo nel Paradiso terrestre e a mezzogiorno. Dante aveva scritto nel Convivio che Cristo, morendo al colmo della sua vita, «l’ora del giorno de la sua morte [...] volle consimigliare con la vita sua; onde dice Luca che era quasi ora sesta quando morio, che è a dire lo colmo del die» (IV XXIII 11); e aveva aggiunto che «la sesta ora, cioè lo mezzo die, è la più nobile di tutto lo die e la più virtuosa» (IV XXIII 15). È, dunque, quasi mezzogiorno quando le sette Virtù, che, con in mano i candelabri, guidano la piccola processione, si fermano al margine di una radura, simile a quelle che si incontrano in alta montagna, dove i ruscelli, dalle acque fredde, scorrono in mezzo all’erba verde, sotto i rami neri degli alberi. Quando Dante raggiunge le Virtù, vede davanti a sé, in mezzo alla radura una sorgente, dalla quale escono, abbondanti di acque ma lenti nello scorrere, due ruscelli, che si dirigono in direzioni opposte, come fanno due amici che separandosi si salutano. Siamo nel Paradiso terrestre, e al Poeta vengono in mente i nomi dei fiumi Eufrate e Tigri, citati in Genesi 2, 10-14: «Et fluvius egrediebatur ex Eden ad irrigandum paradisum, qui inde dividitur in quattuor capita. Nomen uni Phison […] Et nomen fluvio secundo Geon […] Nomen vero fluminis tertii Tigris […] Fluvius autem quartus ipse est Euphrates» [Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiama Pison (…) Il secondo fiume si chiama Ghicon (…) Il terzo fiume si chiama Tigri (…) Il quarto fiume è l’Eufrate]. Ma forse qui, più che il passo della Genesi, Dante ha presente Boezio, De Consol. Philos. V, m. I: «Tigris et Euphrates uno se fonte resolvunt / et mox abiunctis dissociantur aquis» [il Tigri e l’Eufrate sgorgano da un’unica fonte / e presto, 188 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 189 Purgatorio XXXIII Giuseppe CIAVORELLA diramandosi le loro acque, si separano]. Ma Matelda gli ha già detto che quei due fiumi hanno nome Letè ed Eunoè (cfr. Purg. XXVIII, 127-33): il Letè lo ha già visto, e vi si è anche immerso, dunque l’altro non può essere che l’Eunoè. Resta dunque il fatto che il Poeta, pur citando indirettamente la Bibbia e Boezio, dà ai due fiumi che bagnano il Paradiso terrestre due nomi che ricordano la mitologia greco-romana, quasi a significare che la sua invenzione poetica attinge sia alla fonte cristiana sia alla fonte pagana (ricordiamo che la descrizione naturalistica del Paradiso terrestre è prevalentemente di derivazione ovidiana; cfr. Purg. XXVIII, 1-21, 49-51). Il paesaggio (e in qualche modo anche la situazione) è quello che si era presentato a Dante quando, entrato nella «divina foresta spessa e viva», era giunto sulle rive del Letè (cfr. Purg. XXVIII, 25-33): là era l’inizio del cammino nell’Eden ritrovato, qua è la conclusione del cammino. Fra poco, infatti, Dante spiccherà il volo per il Paradiso. «O luce, o gloria de la gente umana, che acqua è questa che qui si dispiega da un principio e sé da sé lontana?». Per cotal priego detto mi fu: «Priega Matelda che ’l ti dica». E qui rispuose, come fa chi da colpa si dislega, la bella donna: «Questo e altre cose dette li son per me; e son sicura che l’acqua di Letè non gliel nascose». (vv. 115-23) Beatrice è invocata nello stesso tempo come simbolo della Sapienza divina («luce») e come donna gloriosa («gloria de la gente umana»). L’enfasi della domanda può giustificarsi con la straordinarietà (la «novitate» del v. 108) del fenomeno, umanamente inspiegabile; straordinarietà che (aggiunta a quella di tutti i mirabili avvenimenti che si sono succeduti nel Paradiso terrestre) provoca in Dante non solo stupore, ma anche una momentanea amnesia, perché Dante in effetti sa, e dovrebbe perciò ricordarsi, che i due fiumi sono il Letè e l’Eunoè. Ma c’è forse dell’altro. Si svolge, infatti, nelle terzine 115-23 (con epilogo nella terzina 124-26) una 189 Ciavorella:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:51 PÆgina 190 2013 sorta di commedia degli equivoci: Dante non può (non dovrebbe) aver dimenticato le spiegazioni dategli da Matelda in Purg. XXVIII, 121-33 (perché il Letè cancella solo il ricordo del peccato); Beatrice non può non sapere che Matelda ha già informato Dante sui due fiumi e sull’unica sorgente; Matelda sa che Beatrice e Dante sanno, ma risponde a Beatrice con l’aria di discolparsi. Perché questa commediola, in cui sembra quasi che Beatrice, rinviando Dante a Matelda, voglia mettere in imbarazzo «la bella donna»? È un gioco, indubbiamente: Beatrice prende amabilmente in giro Dante, che si è rivolto a lei con tanta enfasi per chiedergli una spiegazione inutile; Matelda ha capito e asseconda Beatrice nel gioco. Alla fine, a trovarsi realmente in imbarazzo non è Matelda, ma Dante, che è costretto ad ammettere la propria amnesia, o sbadataggine, clamorosamente contraddicendo quanto lui stesso, con enfasi (è recidivo!), aveva affermato nei vv. 79-81 (e ancora Beatrice avrà amabilmente sorriso di lui). Narrativamente, la scena ha funzione di “alleggerimento” (e forse anche di autocritica: Dante Poeta costringe Dante personaggio ad ammettere, fra le altre cose – vedi confessione – la propria distrazione). Beatrice ha già tentato di mettere a suo agio Dante, ancora pieno di soggezione verso di lei, donna amata e beata, e già così severa nell’accusarlo di peccati gravi: gli ha sorriso e si è rivolta a lui con un linguaggio non più enigmatico e quasi incomprensibile (cfr. vv. 46-47, 82-84), ma con un linguaggio quasi popolare: con «parole nude» (cfr. vv. 94-102). Evidentemente Dante non ha capito, o non è riuscito ancora a vincere il proprio complesso di colpa e di inferiorità. E Beatrice ricorre allora all’ironia (in realtà autoironia del Poeta, sempre presente a se stesso); con maggior fortuna, si direbbe, perché da questo momento la narrazione procede speditamente verso il lieto fine del canto, che è anche il lieto fine di tutto il Purgatorio. Degno di nota, poi, è che per la prima volta qui viene pronunciato il nome di «Matelda»: quasi una “agnizione” finale nello stile della commedia classica. Ma a questo proposito si può aggiungere un’altra considerazione. Con la rivelazione del nome della «bella donna», che ha guidato Dante a Beatrice nel Paradiso terrestre, si scioglie un mistero (Chi è la ‘bella donna’? Qual è il suo nome?) protrattosi per sei canti. Nell’ultimo 190 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 191 Purgatorio XXXIII Giuseppe CIAVORELLA canto del Purgatorio, cioè, il Poeta (attraverso Beatrice) prima pone al lettore un «enigma forte» col numero «Cinquecento diece e cinque» e poi (quasi a compensazione del primo) ne scioglie un altro, che ha portato avanti astutamente lungo tutto il Paradiso terrestre, con tutti gli accorgimenti che la retorica gli offriva (perifrasi, soprattutto, elegantemente variate secondo le circostanze). Se lo scioglimento del mistero del nome di Matelda avviene in forma di commediola (ma il mistero dell’identità storica del personaggio resta, e resterà, irrisolto; a meno che non si voglia riconoscere che Dante, creando la figura di Matelda, abbia inteso creare un nuovo mito cristiano del Paradiso terrestre, in concorrenza con il mito pagano dell’età dell’oro, cantato da Ovidio nelle Metamorfosi, con il quale perciò Dante si confronterebbe;12 e in tal caso ogni riferimento storico del personaggio Matelda sarebbe vanificato), il «Cinquecento diece e cinque» resta davvero un «enigma forte», vero e drammatico, e tale vuole restare fino al suo inverarsi nella storia; perché quella del «DXV» vuole essere una vera profezia, in cui Dante Poeta, e cristiano convinto, crede veramente, perché «fede è sustanza di cose sperate / e argomento de le non parventi» (Par. XXIV, 64-65), e Dante è certo che Dio, prima o poi, farà giustizia di tutte le ingiustizie e nefandezze che vengono commesse sulla terra dai potenti, laici o ecclesiastici che siano. Ma riprendiamo la lettura dei versi, avviandoci alla conclusione. E Beatrice: «Forse maggior cura, che spesse volte la memoria priva, fatt’ha la mente sua ne li occhi oscura. Ma vedi Eunoè che là diriva: menalo ad esso, e come tu se’ usa, la tramortita sua virtù ravviva». (vv. 124-29) La «maggior cura» può essere stata la visione apocalittica a cui Dante ha appena assistito: Beatrice stessa l’aveva invitato a osservare lo spettacolo con grande attenzione, perché avrebbe dovuto poi riferirne «in pro del mondo che mal vive», una volta «ritornato di là»; o può essere stato 191 Ciavorella:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:51 PÆgina 192 2013 il trauma psicologico della confessione, a cui Beatrice stessa l’ha costretto. Non si può, d’altra parte, escludere che nelle parole di Beatrice ci sia una lieve ironia all’indirizzo di Dante (sarebbe intonata al sottile spirito di commedia di cui abbiamo parlato); Vittorio Cian (1958: 670), per esempio, ipotizza che l’oblio di cui parla Beatrice sia dovuto «fors’anche alla presenza di lei, che aveva turbato fino al tremore il suo spirito, come, laggiù, in terra, e come, poche ore innanzi, allorché riconobbe i “segni dell’antica fiamma”». Escluderei, invece, che si svolga in queste terzine «una scena finissima di gelosia femminile» (Pietrobono) tra Beatrice e Matelda. Si apprende, poi, dall’invito che Beatrice rivolge a Matelda, che la «bella donna» ha il compito specifico di guidare le anime, che giungono purificate nel Paradiso terrestre, all’immersione nel Letè, prima, e nell’Eunoè, dopo. Che l’Eunoè abbia la virtù di ravvivare il ricordo del bene compiuto, dopo che il Letè ha cancellato il ricordo dei peccati, è stato già detto a Dante, appunto, da Matelda in Purg. XXVIII, 127-29 (e non è certamente un caso che il Poeta rievochi quelle parole in Purg. XXXIII, 127-29, cioè esattamente cinque canti dopo: là quasi all’inizio del viaggio nel Paradiso terrestre, qua quasi alla fine; Dante ama le simmetrie). Il rito dell’immersione nell’Eunoè, che sta per celebrarsi, non fa parte, stricto sensu, del rito della Penitenza (conclusosi con l’abolitio peccati dell’immmersione nel Letè), ma ne costituisce come il naturale coronamento: è espresso, in forma rituale, il positivo effetto spirituale che l’abolitio peccati determina sul penitente. Come chiarisce Andrea Battistini (2007: 103), è lo stesso S. Tommaso a precisare che alla Penitenza segue la «revivificatio virtutum ac meritorum». Dino S. Cervigni (1989: 193) precisa ulteriormente, sempre citando S. Tommaso: «Non solo il penitente può riacquistare “aliquid maius” – una condizione superiore a quella precedente – ma può anche riottenere le opere buone compiute in stato di grazia e poi ‘mortificate’ a causa del peccato». E Dante traduce, appunto, in rito le parole di S. Tommaso: «opera prius mortificata […] recuperant efficaciam perducendi eum qui fecit ea in vitam aeternam: quod est reviviscere. Et ita patet quod opera mortificata per poenitentiam reviviscunt» [le opere prima mortificate dal 192 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 193 Purgatorio XXXIII Giuseppe CIAVORELLA peccato […] recuperano l’efficacia di condurre colui che le ha compiute verso la vita eterna: che è rivivere. E così è chiaro che le opere mortificate rivivono grazie alla penitenza] (Summa theologiae III, q. 4, a. 5). Nei versi di Dante sopravvive la parola di Tommaso: nell’invito che Beatrice rivolge a Matelda, «la tramortita sua virtù ravviva», è chiara l’eco delle espressioni «revivificatio virtutum» e «opera prius mortificata recuperant efficaciam». E l’eco perdura negli ultimi quattro versi del canto. Jacques Le Goff (1981: 404), che ha studiato in particolare la “nascita” del Purgatorio, commenta così l’immersione nell’Eunoè: «È la metamorfosi definitiva della memoria, anch’essa mondata dal peccato. Il male è dimenticato, sussiste soltanto la memoria di quanto vi è di immortale nell’uomo, il bene. Anche la memoria ha raggiunto la soglia escatologica». Ma forse si può leggere nelle parole di Beatrice e nell’immersione nell’Eunoè anche un altro significato, rapportandolo alla missione, e cioè: Dante dovrà comporre il suo poema con mente libera da ogni umano pregiudizio, ricordando solo ciò che è bene verso Dio e verso gli uomini. Come anima gentil, che non fa scusa, ma fa sua voglia de la voglia altrui tosto che è per segno fuor dischiusa; così, poi che da essa preso fui, la bella donna mossesi, e a Stazio donnescamente disse: «Vien con lui». (vv. 130-35) Sembra di capire, da questi e dai precedenti versi, una maggiore autorità di Beatrice rispetto a Matelda. Il breve episodio va però inquadrato in tutta la vicenda: il viaggio di Dante è voluto da Dio, che ha affidato a Beatrice l’incarico di organizzarlo e guidarlo; Matelda, ubbidendo in questo momento a Beatrice, ubbidisce a Dio. Non può esserci vera subalternità in cielo, se non a Dio; e Matelda è senz’altro, come Beatrice, creatura celeste. La rappresentazione in forma di commedia rientra nel realismo psicologico a cui si ispira l’intero poema. 193 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 194 Tenzone 14 2013 S’io avessi, lettor, più lungo spazio da scrivere, i’ pur cantere’ in parte lo dolce ber che mai non m’avria sazio; ma perché piene son tutte le carte ordite a questa cantica seconda, non mi lascia più ir lo fren de l’arte. (vv. 136-41) Non è qui chiarito se Dante sia immerso da Matelda nell’Eunoè, come già nel Letè, o se beva da sé l’acqua. Dalle parole di Beatrice e dal gesto di Matelda, che prende per mano Dante, si dovrebbe supporre che si ripeta il rito dell’immersione come nel fiume della dimenticanza; ma non si può non tener conto del fatto che sulla riva del Letè Dante era svenuto e che Matelda era stata costretta a trascinarlo dentro le acque del fiume, a immergergli la testa nell’onda, perché ne bevesse, e ad aiutarlo a raggiungere l’altra riva. Qui Dante è del tutto cosciente e può quindi immergersi da solo e bere l’acqua rigeneratrice, come fa Stazio: Matelda si limiterebbe ad accompagnarli sulla riva, «donnescamente». Quanto alla terzina 13941, «pare proprio che Dante avesse determinato anticipatamente la lunghezza approssimativa di ogni cantica, assegnando a ciascuna un dato numero di carte, come poi, dalla composizione di molti codici, risulta che fecero spesso gli antichi trascrittori del Poema» (Scartazzini-Vandelli). Lo «fren de l’arte», comunque, allude alle norme retoriche (di equilibrio, di simmetria, di proporzione, ecc.) che regolavano le composizioni poetiche fin dall’antichità classica. Commenta Franco Lanza (1967: p. 1231): «L’appello di Dante al lettore qui viene pòrto su un piano di affettuosa condiscendenza, come un invito alla comprensione, una scusa per il largo tratto del poema che viene contratto in sì breve spazio; […] ed è un modo discreto di associare chi legge al compito profetico che il poeta si è assunto, di farlo partecipe d’un messaggio che riguarda lui come ogni vivente». Io ritornai da la santissima onda rifatto sì come piante novelle rinovellate di novella fronda, puro e disposto a salire a le stelle. 194 (vv. 142-45) Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 Giuseppe CIAVORELLA 11:51 PÆgina 195 Purgatorio XXXIII Ricordi classici (soprattutto da Virgilio: Eneide VI, 205 ss.; XII, 788; Georg. III, 235) e biblici (soprattutto da S. Paolo: Ebrei 6, 6; Efes. 4, 23) e, come si è detto, della Scolastica, confluiscono ad arricchire il senso di questi versi conclusivi del Purgatorio. Ma il riferimento più vicino è alla «pianta dispogliata» che «si rinovella» di foglie e fiori quando il grifone lega il carro al suo tronco (Purg. XXXII, 52-60): si ripete simbolicamente per Dante personaggio il mistero della Redenzione operata da Cristo per l’intera umanità: la renovatio è pienamente attuata, il pellegrino dell’oltremondo è perfettamente riconciliato con Dio e può salire a Lui. Ma ci pare anche che nella replicazione «novelle», «rinovellate», «novella» si possa cogliere un’eco della Vita nova: come già nel libello giovanile, dopo il ritorno a Beatrice e la ‘mirabile visione’, Dante si sente rinascere a vita nuova («Incipit vita nova...»: diamo un’interpretazione un po’ diversa da quella tradizionale; più precisamente: mentre accettiamo il sintagma vita nova come titolo del “libello giovanile” (confermato del resto dallo stesso Dante in Convivio I I 16), pensiamo che Dante, con il medesimo sintagma, alluda ad un suo nuovo modo di intendere la vita, dopo la ‘mirabile visione’, sia come uomo e cittadino sia, soprattutto, come poeta), così ora, dopo aver bevuto l’acqua dell’Eunoè in presenza e per volontà di Beatrice, egli sente rinascere il proprio spirito ad una ancora più alta «vita nuova», che gli spalanca le porte del Paradiso e della «mirabile visione» di Dio. È mezzogiorno nel Paradiso terrestre, dove Dante è giunto quella stessa mattina all’alba, l’ora prima, secondo il calcolo antico-medievale. Fra poco Dante spiccherà il volo per il primo dei Cieli paradisiaci: quello della Luna. Dante, dunque, rimane nell’Eden esattamente quanto vi rimase Adamo, come lo stesso nostro progenitore affermerà in Par. XXVI, 139-42: «Nel monte che si leva più da l’onda, / fu’ io, con vita pura e disonesta, / da la prim’ora a quella che seconda, / come ’l sol muta quadra, l’ora sesta». Adamo fu cacciato dal Paradiso terrestre e non vi potè più tornare; Dante, invece, vi ritorna, grazie alla Redenzione, e vi ritorna da vivo per una speciale grazia dell’Onnipotente, che ha voluto fare di lui il poetaprofeta di una nuova era cristiana. 195 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:51 PÆgina 196 Tenzone 14 2013 NOTE Della terzina 10-12 (e di altri versi poco chiari di questo canto) è stata proposta una interpretazione piuttosto diversa da Peter Dronke. Scrive lo studioso: «Beatrice assume simbolicamente la parte di Cristo nel suo porgere la rivelazione e la redenzione a Dante. È a Dante (o alle virtù latenti in lui) che effettivamente ella si rivolge usando le parole di Cristo. Ella rimarrà in cielo ed egli dovrà tornare sulla terra per ricordare e tramandare le sue parole rivelate: in quel “poco” che Dante ha ancora da vivere non la vedrà, ma poi – come lei ha promesso – la rivedrà e starà con lei per sempre (XXXII, 101-2). Esattamente allo stesso modo, nell’episodio narrato da Giovanni, Cristo promette ai discepoli un momento di pianto seguito da un tempo in cui “io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore ne gioirà e nessuno vi toglierà la vostra gioia” ([Giovanni]16:22)» (Dronke 1990: 117). L’interpretazione del Dronke mi pare un po’ troppo ‘facile’, quasi una parafrasi dei vv. 100-02 di Purg. XXXII, che non hanno certo bisogno di spiegazione. Ho l’impressione che lo studioso non tenga conto delle parole del Salmo 79 [78] cantato dalle Virtù, parole alle quali Beatrice risponde («rispuose»), e che si riferiscono all’esilio babilonese (con evidente richiamo alla ‘cattività avignonese’ del Papa e della sua corte, chiaramente allusa nei versi 148-60 di Purgatorio XXXII). 1 Guglielmo Gorni ricorda Ezechiele 2, 6: «Come già Ezechiele (“Tu ergo, fili hominis, ne timeas eos, neque sermones eorum metuas … Verba eorum ne timeas, et vultus eorum ne formides” [‘Ma tu, figlio dell’uomo, non temerli, non aver paura dei loro discorsi… Non temere le loro parole, e non lasciarti impressionare dalle loro facce’], Dante per compiere la sua missione, deve liberarsi da ogni timore o rispetto umano» (Gorni 1990: 120). Michelangelo Picone interpreta diversamente il v. 33: «Già al v. 33 Beatrice invita Dante a passare dalla fase del sogno a quella della sua interpretazione, dalla visione avuta nel canto XXXII all’evidenziamento del senso da attribuire a quella visione» (Picone 2008: 90). 2 Totalmente diversa l’interpretazione di Michelangelo Picone, per il quale il carro non simboleggia la Chiesa, ma la poesia, e in particolare la storia della poesia di Dante, «dal libello giovanile al poema sacro della maturità, passando attraverso la drammatica esperienza dell’esilio» (Picone 2008: 81); nei vv. 34-36, sostiene il critico, «Beatrice sta […] semplicemente e coerentemente parlando della fine della poesia, dovuta all’attuale gravissima decadenza del mondo poli3 196 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 Giuseppe CIAVORELLA 11:51 PÆgina 197 Purgatorio XXXIII tico e religioso. La “vendetta di Dio”, a cui Beatrice fa riferimento al v. 36, riguarda pertanto le persone e i fatti che hanno causato l’eclisse della poesia, l’impossibilità di fare poesia in un mondo tralignato» (Picone 2008: 91). È inutile precisare che non siamo d’accordo con Picone. 4 Merita una spiegazione etimologica la parola «fuia». Il termine significa letteralmente ‘ladra’, maschile «fuio», ‘ladro’ (cfr. Inf. XXII, 90, e Par. IX, 75), probabilmente dal lat. «fur», ‘ladro’ o *«fura», ‘ladra’: la meretrice è «fuia» perché ha occupato, quasi rubandolo e comunque usurpandolo, il luogo destinato da Dio alla santa Chiesa (così che la sede pontificia è moralmente vacante). Ma per Umberto Bosco la meretrice, simbolo della Chiesa corrotta, è «fuia» perché è «una ladra del potere terreno, che spetta solo all’impero». Ma a proposito dei vv. 37-45, ritengo utile citare le parole di un grande studioso di Dante, Bruno Nardi: «Ristabilita l’universalità dell’impero, la chiesa sarà obbligata a rinunziare a ogni dominio terreno e potrà attendere in povertà ed umiltà alla sua missione puramente spirituale e ad insegnare col suo esempio agli uomini il distacco dai beni caduchi, per rivolgere tutti i suoi desideri alla beatitudine dell’altra vita. Solo così torneranno a splendere i due soli che sono necessari a rischiarare agli uomini il duplice cammino: quello della felicità terrena e quello della beatitudine celeste. […] Disgiunta la spada dal pastorale e ristabilita l’indipendenza reciproca del papato e dell’impero, la pianta edenica, dirubata una seconda volta, tornerà a rinverdire e a germogliare come al momento della Redenzione per opera di Cristo» (Nardi 19902: 278-79). Ci sia consentito di rimandare ad una nostra ‘lettura’ del canto IX del Purgatorio, dove ipotizziamo che l’angelo «da ciel messo» di Inferno IX, 85, sia figura simbolica della Divina commedia (Ciavorella 2008: 60-62). Vogliamo qui proporre l’ipotesi che anche il «Cinquecento Diece e Cinque» possa alludere alla Commedia? Non esattamente, anzi escluderemmo questa ipotesi, almeno come allusione diretta. È possibile, invece, ammettere l’allusione indiretta, accettando l’identificazione del DXV con Arrigo VII, l’imperatore che accese in Dante la speranza sia di un ritorno dall’esilio a Firenze («Se mai continga che ’l poema sacro…»; Par. XXV, 1) sia di una restaurazione della pace imperiale e cristiana nel mondo occidentale (Epistola V, indirizzata «Universis et singulis Ytalie Regibus et Senatoribus…»). Di questa speranza (di cui si fa profeta Dante attraverso l’investitura poetica conferitagli da Beatrice) si alimenta, e risuona, tutta la Commedia. E ne è come il simbolo la corona posta sul «gran seggio» della candida 5 197 Ciavorella:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:51 PÆgina 198 2013 rosa su cui siederà l’imperatore «ch’a drizzare Italia / verrà in prima ch’ella sia disposta» (Par. XXX, 133-38). Mazzamuto 19842 (ma cfr. anche Rembadi Damiani 2005). Giorgio Petrocchi, nel suo testo critico (che noi in linea di massima seguiamo, ma non qui), riporta il numero tutto in lettere minuscole. Antonio Lanza riporta il numero con le iniziali maiuscole: “Cinquecento Diece e Cinque”; soluzione accettabile, diremmo, essendo il riferimento a un nome proprio di persona non identificata (in Alighieri 19962: 530). 6 7 Nota Robert Wilson: «Se si ammette che l’aquila (v. 38), come in Purgatorio XXXII, è un simbolo dell’Impero romano, allora la prima parte della profezia (vv. 37-39) deve con ogni probabilità riferirsi a un imperatore, l’erede dell’aquila. Per Dante, nel 1300, l’erede dell’Impero è assente, dal momento ch’egli considerava Federico II come l’ultimo Imperatore romano legittimo. È possibile, allora, che la profezia si riferisca all’incoronazione di Arrigo VII a Roma il 29 giugno 1312» (Wilson 2008: 115 [traduzione nostra]). Temi, Sfinge, Naiade sono personaggi mitologici, presenti nelle Metamorfosi di Ovidio, da cui quasi certamente Dante li deriva. Alla dea Temi, figlia di Urano e della Terra, era consacrato, sul monte Parnaso, un santuario, dal quale erano emessi oracoli particolarmente enigmatici (cfr. Metam. I, 347-415: mito di Deucalione e Pirra). Sfinge era una mostruosa creatura biforme, con corpo di leone e busto di donna; appostata su una rupe lungo la strada che conduceva a Tebe (città vicina al monte Parnaso), poneva domande enigmatiche ai viandanti, e li uccideva se non sapevano rispondere; ma Edipo, figlio di Laio, re di Tebe, riuscì a dare la risposta giusta, e Sfinge, umiliata, si uccise gettandosi dalla rupe (Metam. VII, 759-65). Le Naiadi erano le ninfe delle sorgenti e dei fiumi, e anche di queste narra Ovidio; ma Dante qui le cita erroneamente, perché, avendo un testo non corretto dell’opera di Ovidio, leggeva «Naiades» invece di «Laiades» (in Metam. VII, 759-60, dove il testo corretto è: «Carmina Laiades non intellecta priorum / solverat ingeniis» [Il figlio di Laio aveva risolto l’enigma che prima nessuno aveva capito]; Dante invece leggeva: «Carmina Naiades non intellecto priorum / solvunt ingeniis»): ‘Laiade’, cioè “figlio di Laio”, era il patronimico di Edipo. Come Dante leggevano i suoi contemporanei (e tutti i commentatori della Commedia del Trecento), che, nel tentativo di dare una spiegazione plausibile del testo scorretto di Ovidio, attribuirono alle Naiadi capacità interpretative degli enigmi, immaginando anche che esse suscitassero la gelosia di Temi, perché i Tebani preferivano rivolgersi alle Naiadi, piuttosto che a lei. Quanto al v. 51, si 8 198 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 Giuseppe CIAVORELLA 11:51 PÆgina 199 Purgatorio XXXIII allude alla vendetta di Temi per la morte-suicidio di Sfinge, causata da Edipo («Naiade», per Dante): come narra Ovidio, Temi mandò contro i Tebani una belva a divorare greggi e a devastare campi coltivati (Met. VII, 759-65 e oltre). R. Wilson sente nel termine «enigma» un’“eco” della lettera di S. Paolo 1 Cor. 13, 12: «Videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem; nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam, sicut et cognitus sum» [Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa («in aenigmate», da aenigma, -atis), allora vedremo faccia a faccia; ora conosco in modo imperfetto, allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto]; e conclude: «Se si accetta almeno una qualche allusione alla lettera di S. Paolo, si aggiunge un significato escatologico al verso di Dante e si propone un approccio interpretativo che accetta una comprensione incompleta ora, insieme con una promessa di piena, diretta conoscenza quando la predizione sarà realizzata» (Wilson 2008: 120 [trad. nostra]). La proposta di lettura di Wilson ci pare accettabile. Anche qui abbiamo preferito la lettura «sappi» di Antonio Lanza a quella «forse» di Petrocchi. Scrive Lanza: «L’asserzione di Beatrice non ha nulla di dubitativo: il forse, quindi, è fuori luogo». 9 Degna di nota la precisazione di Kenelm Foster: «the notion of justice implies that of order – order in human society and in the cosmos and between cosmos and its Creator. So much is traditional (see St Thomas, Summa theol., I a, 21, I ad 3)» [la nozione di giustizia implica quella di ordine – ordine nella società umana e nel cosmo e tra il cosmo e il suo Creatore; vedi S. Tommaso Summa ecc.] (Foster 1957: 45). Questa precisazione porta ad includere, nella spiegazione di Beatrice, il riferimento alla visione apocalittica, nella quale l’ordine della Chiesa, che è espressione della volontà divina, appare sconvolto dal progressivo corrompersi delle istituzioni politiche ed ecclesiastiche. 10 Dino S. Cervigni ha chiarito, con puntuali citazioni della Summa theologiae (III, q. 89, a. 1-6), il significato teologico-penitenziale dei vv. 91-96: «È Dio che distrugge o dimentica il peccato, secondo una terminologia metaforica comune alla Bibbia, alla scolastica e anche al testo poetico dantesco. […] Primo effetto dunque della penitenza è la distruzione o dimenticanza del peccato da parte di Dio: ciò che nell’esperienza di Dante pellegrino si verifica tramite l’immersione nel fiume Letè. Vale la pena notare a questo proposito che, mentre nella Bibbia l’atto della dimenticanza viene attribuito a Dio, nella Commedia è Dante pellegrino che dimentica il suo traviamento […]: non solo importante trasferimento d’una metafora dal creatore alla creatura, ma indice anche che Dante è stato pu11 199 Ciavorella:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:51 PÆgina 200 2013 rificato del suo peccato e di ogni altro debito con esso connessso tramite l’ascesa purificante del Monte Purgatorio» (Cervigni 1989: 191). Aggiungeremmo una precisazione, per noi importante: la purificatio di Dante non è completa quando egli giunge nel Paradiso terrestre dopo l’ascesa del Sacro monte; sarà completa solo dopo il rito sacramentale della confessione (che comporta piena contritio cordis e confessio oris, alle quali Beatrice costringe il pellegrino), e dopo l’immersione nel Letè (il momento della deletio peccati, ‘cancellazione del peccato’). Salendo il Purgatorio Dante non si ‘purifica’ dei peccati (non c’è, appunto, deletio peccati, e infatti non è sottoposto, se non simbolicamente, alle pene cui sono sottoposti i veri penitenti), ma delle istintive tendenze ai diversi peccati (puniti nei vari gironi), non controllate dalla ragione. Se così non fosse, sarebbero inutili sia la confessione sia l’immersione nel Letè: non avrebbero, cioè, piena giustificazione i canti XXX-XXXI. Su Matelda personaggio e sul mito dantesco del Paradiso terrestre ci permettiamo di rimandare a una nostra recente “lettura” del canto XXVIII del Purgatorio: Ciavorella 2011. 12 200 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 Giuseppe CIAVORELLA 11:51 PÆgina 201 Purgatorio XXXIII RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ALIGHIERI, D. (19962): La commedìa, testo critico secondo i più antichi manoscritti fiorentini, a cura di A. Lanza, Anzio, De Rubeis. APOLLONIO, M. (1951): Dante. Storia della ‘Commedia’, II, Milano, Vallardi, pp. 775-777. BÀRBERI SQUAROTTI, G. (1979): «L’allegoria», in Letture classensi, VIII, Ravenna, pp. 135-160. BATTISTINI, A. (2007): «Tra memoria e amnesia. Lettura di ‘Purg.’ L’Alighieri 29, n. s., pp. 93-106. XXXIII», BELLOMO, S. (2001): «Il canto XXXIII del ‘Purgatorio’», in Lectura Dantis Turicensis, ‘Purgatorio’, a cura di G. Güntert e M. Picone, Firenze, F. Cesati Editore, 2001, pp. 503-515. BORSELLINO, N. (1991): «Visione e profezia (‘Purgatorio’ XXXII)», in ID., «Sipario dantesco. Sei scenari della ‘Commedia’», Roma, Salerno editore, 1991, pp. 72-87. CERVIGNI, D.S. (1989): «L’Eunoè o il ripristino del bene perduto», in Filologia e critica dantesca. Studi offerti ad Aldo Vallone, Firenze, Olschki, pp. 175-198. CIAN, V. (1958): «Il canto XXXIII del ‘Purgatorio’» [1936], in Letture dantesche, vol. II, ‘Purgatorio’, a cura di G. Getto, Firenze, Sansoni, 1958, pp. 657-672. CIAVORELLA, G. (2008): «‘Purgatorio’ IX: il sogno, Lucia e l’angelo portiere», L’Alighieri 31, pp. 43-76. CIAVORELLA, G. (2011): «‘Purgatorio’ XXVIII: Matelda, Critica letteraria 150, fasc. 1, pp. 3-37. CRISTALDI, S. (1988): «Dalle beatitudini all’‘Apocalisse’. Il Nuovo Testamento nella ‘Divina Commedia’», in Letture classensi 17, Ravenna, Longo Editore, pp. 23-68. 201 Ciavorella:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:51 PÆgina 202 2013 DAVIDSOHN, R. (1902): «Il “cinquecento diece e cinque” del ‘Purgatorio’» in Bullettino della Soc. Dant. Italiana IX, pp. 129-131. DAVIS, C.T. (19842): «Veltro», in Enciclopedia dantesca, Roma, Istituto per l’Enciclopedia Italiana,vol. V, pp. 908-912. DRONKE, P. (1990): «Le fantasmagorie del Paradiso terrestre», in ID., Dante e le tradizioni latine medioevali, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 97129. FOSTER, K. (1957): God’s tree. Essays on Dante and other matters, London, Blackfriars Publications, pp. 33-49. FRUGONI, A. (1972): «Il canto XXXIII del ‘Purgatorio’», in Nuove letture dantesche, V, Firenze, Le Monnier, pp. 235-253. GILSON, É. (1987): Dante e la filosofia [1939, 1953, 1972], trad. it., Milano, Jaca Book, 1987. GIRARDI, E.N. (1989): «Il canto XXXIII del ‘Purgatorio’», in Lectura Dantis Neapolitana, vol. II, ‘Purgatorio’, a cura di P. Giannantonio, Napoli, Loffredo, pp. 653-670. GORNI, G. (1990): «Cifre profetiche», in ID., Lettera Nome Numero, Bologna, Il Mulino, pp. 109-131. GRECO, A. (1981): «Il canto XXXIII del ‘Purgatorio’», in Letture della Casa di Dante in Roma, vol. II, ‘Purgatorio’, Roma, Bonacci, pp. 777795. KASKE, R. E. (1961): « Dante’s “DXV” and “Veltro”», in Traditio, XVII , pp. 185-254. LANZA, F. (1967): «Il canto XXXIII del ‘Purgatorio’», in Lectura Dantis Scaligera, vol. II, ‘Purgatorio’, Firenze, Le Monnier, 1967, pp. 12131234. LE GOFF, J. (1982): La nascita del Purgatorio, Torino, Einaudi, 1982. 202 Ciavorella:Maquetaci n 1 09/12/2013 Giuseppe CIAVORELLA 11:51 PÆgina 203 Purgatorio XXXIII MAZZAMUTO, P. (19842): «Cinquecento diece e cinque», in Enciclopedia Dantesca, Roma, Istituto dell’Enciclpoedia Italiana, vol. II, pp. 1014. MINEO, N. (1998): «Gli spirituali francescani e l’‘apocalisse’ di Dante», La Rassegna della Letteratura italiana, a. 102, n. 1, pp. 26-46. MOORE, E. (1903): «The DXV Prophecy», in ID., Studies in Dante, III Series, Oxford (rist. 1968), pp. 253-283. PALMA DI CESNOLA, M. (1995): Semiotica dantesca. Profetismo e diacronia, Ravenna, Longo, 1995, pp. 73-97. NARDI, B. (1967): «Il mito dell’Eden» [1922], in ID., Saggi di filosofia dantesca, Firenze, La Nuova Italia, 1967, pp. 334 ss. NARDI, B. (19902): «Dante profeta», in ID., Dante e la cultura medievale, Laterza, Bari, pp. 265-326. PARODI, E. G. (1921): «La data della composizione e le teorie politiche dell’‘Inferno’ e del ‘Purgatorio’», in ID., Poesia e storia nella ‘Divina Commedia’, a cura di G. Folena e P. V. Mengaldo, Vicenza, Neri Pozza, 1965, pp. 233 ss. PASCOLI, G. (1904): «Il canto XXXIII del ‘Purgatorio’», in ID., Prose, II: Scritti danteschi, a cura di A. Vicinelli, Milano, Mondadori, 1952, pp. 1525-1551. PAZZAGLIA, M. (1998): «Il ritorno di Beatrice», in ID., Il “mito” di Beatrice, Bologna, Pàtron, pp 123-151. PERTILE, L. (1998): La puttana e il gigante. Dal Cantico dei Cantici al Paradiso Terrestre di Dante, Ravenna, Longo. PICONE, M. (2008): «L’“enigma forte”: una lettura di ‘Purg.’ XXXII e XXXIII», L’Alighieri 31, n. s., pp. 77-92. PORCELLI, B. (1987): «Progressione e simmetria nella sequenza di ‘Purg.’ XXVIII-XXXIII», Studi e problemi di critica testuale 35, pp. 141155. 203 Ciavorella:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:51 PÆgina 204 2013 REMBADI DAMIANI, P. (2005): «“Un cinquecento diece e cinque”: un’ipotesi per risolvere l’“enigma forte” di Dante», Studi Danteschi LXX, pp. 103-117. ROSSI, V. (1921): «Il canto XXXIII del “Purgatorio”», in Lectura Dantis Romana, Torino, S.E.I., 1965. SINGLETON, CH. S. (1978): La poesia della «Divina Commedia», trad. ital., Bologna, Il Mulino, pp. 151-174, 291-448. WILSON, R. (2008): Prophecies and profecy in Dante’s ‘Commedia’, Firenze, Olschki. 204 Villa T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:52 PÆgina 205 Tra ‘ferite’, ‘rotture’ e ‘piaghe’: percorsi e convergenze nella ‘Commedia’ MARIANNAVILLA Università degli Studi di Milano [email protected] RIASSUNTO: L’articolo si propone di analizzare i lessemi connessi ai campi semantici delle ‘ferite’, ‘rotture’ e ‘piaghe’, alla scoperta di relazioni intratestuali tra personaggi ed episodi nell’Inferno e Purgatorio, con lo scopo di sondare la straordinaria memoria interna dantesca e gettare nuova luce su passi del poema. PAROLE CHIAVE: ferite, strazio, piaghe, seminatori di discordia, sangue, identità, vista. ABSTRACT: This paper aims to analyze the semantic field of the terms ‘rotture’, ‘ferite’, ‘piaghe’ in order to achieve a more comprehensive knowledge of Dante’s intratextual procedures at work in Inferno and Purgatorio. KEY WORDS: wounds, carnage, sores, schismatics, blood, identity, view. La rappresentazione delle colpe e delle pene dell’Inferno dantesco si ritaglia un posto peculiare nell’orizzonte medievale, nel segno di un forte 205 Villa T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:52 PÆgina 206 2013 realismo. Mediante l’invenzione dantesca del corpo aereo, generato dalla ‘virtù informativa’ (Purgatorio XXV 37-45) dell’anima razionale e perfettamente sensibile, le colpe e le pene della Commedia si imprimono in primo luogo nella ‘carne’ dei dannati portando a modificazioni ancora più significative rispetto a quanto accadeva in vita, poiché memoria, intelligenza e volontà risultano nell’al di là «in atto molto più che prima agute» (Purgatorio XXV 84 in Pinto 2004: 148), e le anime non possono più nascondere nessuna delle loro passioni (Auerbach 1971: 122). Dante rifugge, così, sia dall’astrazione concettuale di molta letteratura medievale (come il Libro de’Vizi e delle Virtudi di Bono Giamboni), evitando lunghi e astratti elenchi di vizi e punizioni, sia dal realismo grottesco e ingenuo delle raffigurazioni pittoriche del Giudizio universale o dalla produzione didattico-allegorica. La Commedia diventa allora un chiaro esempio di quanto la cultura cristiana medievale sia percorsa da tensioni e paradossi, lungi da una prospettiva eminentemente dualistica, con la rigida separazione tra tutto ciò che è spirituale dalla materialità. Se effettivamente nel Medioevo il corpo è disprezzato, condannato e umiliato, d’altro lato è proprio attraverso la penitenza corporale che si arriva alla salvezza e lo stesso Dante ‘visionato’,1 nel processo di deificatio, di avvicinamento a Dio, si vedrà modificato anche nel corpo, oltre che nello spirito (VarelaPortas 1995). Con il XIII secolo (Le Goff 2005: 25) la maggior parte dei teologi, a partire da San Bonaventura, sottolinea la valenza positiva del corpo nel mondo terreno: l’incarnazione viene vista come il riscatto dell’umanità attraverso il figlio di Dio, che, vincendo la morte, pone le premesse per la Resurrezione dei corpi. Pertanto, anche in seguito alla diffusione del ‘mito’ delle stimmati di San Francesco, le ferite vengono positivamente interpretate come sigilli della passione di Cristo. La concretezza della Commedia e la sua stessa possibilità sono allora legati all’idea della ‘resurrezione della carne’, che Dante, nello specifico, ricava dalla Bibbia e dall’Epistola di San Paolo ai Corinzi.2 Il corpo aereo, fittizio ed umbratile, riceve efficacia e realtà dal fatto che è destinato ad essere, con il Giudizio Universale, ‘rivestito’ dalla vera carne: ogni anima dannata «rivederà la trista tomba / ripiglierà sua carne e sua figura» (In206 Villa T 14:Maquetaci n 1 Marianna VILLA 09/12/2013 11:52 PÆgina 207 Tra ‘ferite’, ‘rotture’ e ‘piaghe’ ferno VI 97-98), con un’intensificazione della sofferenza fisica, secondo quanto spiega Virgilio, richiamando l’aristotelismo. I corpi aerei, nell’Inferno, sono in grado di esprimere la passione primaria del dolore mediante il linguaggio rudimentale del corpo, come i «bruti» (Convivio III VIII 1). L’al di là dantesco è allora un al di là di corpi, che in gradatio, seguendo con coerenza le leggi dell’universo, appaiono pesanti e spessi nell’Inferno, leggeri nel Purgatorio, luminosi ed inaccessibili ai sensi, se non tramite il fulgore, nel Paradiso.3 E proprio qui, nel canto XIV, attraverso il procedimento della retrogradatio la questione della condizione delle anime dopo il Giudizio Universale viene ripresa per bocca di re Salomone, presunto autore del Libro della Sapienza e del Cantico dei Cantici e portavoce, ora, della teologia cristiana, che subentra all’aristotelismo di Inferno VI. Il ‘corpo glorioso’, rivestito della carne, si troverà «in vera perfezione» e gli organi «forti / a tutto ciò che potrà dilettarne» (Paradiso XIV 59-60) saranno in grado di tollerare qualsiasi intensità di luce. Paradossalmente sono proprio le anime separate, immerse nella visione di Dio, ad attendere con ansia il corpo per completare la propria felicità: nel canto XXX del Paradiso, con il passaggio «dall’eterno al tempo», avviene l’esperienza diretta del corpo glorioso che, si badi bene, Dante non descrive mai (Chiavacci Leonardi 1988: 270). Rimandando agli studi specifici sull’argomento (Kirkpatrick 1994; Shapiro 1998; Bynum 2005a e 2005b; Gragnolati 2007) risulta ora significativo notare come il ritorno dello ‘stesso’ corpo che l’uomo aveva in vita, anche se trasfigurato e potenziato, implichi una concezione di identità come continuità spazio-temporale, pertanto solo con la ricostituzione dell’interezza ‘materialmente psicosomatica’ le anime potranno esprimere appieno la loro identità. Ecco allora che Dante si fa portavoce di una nuova concezione escatologica, affermatasi a partire del XII secolo, che non guarda più alla ricomposizione della carne, all’esperienza pienamente corporea di Inferno e Paradiso posteriore al Giudizio, ma al destino dell’anima separata e alla sua esperienza individuale ‘piena’ pur con il corpo aereo (Gragnolati-Holzhey 2003: 112-113). 207 Villa T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:52 PÆgina 208 2013 Se il corpo è ontologicamente cruciale per l’individuo,4 per la sua dimensione relazionale e anche in funzione della beatitudine eterna, risulta di grande interesse un’indagine, entro l’Inferno e il Purgatorio, sulle ferite e i tagli, segni impressi nella carne che lacerano la pelle, anch’essa importante fattore di identità, soggetta alla precarietà dell’esistenza umana. Come dimostrato da Bartoli-Ureni (2006: 20-21), Dante aveva una buona conoscenza in ambito medico-chirurgico su traumatismi e ferite da arma da taglio o punta, ricavate soprattutto dal Colligit di Averroè e dagli scritti di Taddeo sugli Aforismi di Ippocrate. Secondo la corrispondenza medievale tra la fisiologia del corpo e la topografia dell’anima, è possibile considerare la lacerazione come emblematica dell’Inferno, perché ricondurrebbe all’idea stessa del peccato come ‘rottura’ del patto con Dio. L’apertura della ferita costituirebbe allora una imago agens del vuoto e della scissione, che possono essere ‘riempiti’ solo con la pena. Nel canto XXXII del Paradiso con il termine «piaga» si intende appunto il peccato originale («la piaga che Maria richiuse e unse» v. 4), mentre con l’accezione più generica di ‘peccato’ il lemma ricorre in Purgatorio XXV 132. Nella seconda cantica la corporeità dolente dei dannati diventa invece strumento di interscambio relazionale in funzione di un «processo curativo di sofferenza» che è innanzitutto un processo «fisico», come ha messo bene in luce Manuele Gragnolati (Gragnolati-Holzhey 2003: 115-116). Le lacrime e il dolore fisico sono produttivi, perché associate al desiderio di espiazione, richiamando nel contempo l’immagine di Cristo sofferente e la possibilità di ricucire le lacerazioni. Nell’Inferno, prima ancora della matta bestialità di Malebolge, prima della demonizzazione dell’umano, l’idea della lacerazione si imprime nel lettore come emblema del peccato e della corruzione già da Semiramide, presentata nel canto quinto come «rotta» al vizio di lussuria. I lessemi «rotto-rotta», esclusivi delle prime due cantiche, sono impiegati in differenti accezioni, dalla «rotta» come ‘sconfitta’ (Inferno XXXI 16; Purgatorio XII 58; XIII 118) alla ‘rottura’ delle leggi di Dio in Purgatorio I 46, con efficace ripresa sulla sommità del monte, al termine del cammino di purificazione (Purgatorio XXX 142), fino all’interruzione dei raggi solari 208 Villa T 14:Maquetaci n 1 Marianna VILLA 09/12/2013 11:52 PÆgina 209 Tra ‘ferite’, ‘rotture’ e ‘piaghe’ a causa della fisicità di Dante, sempre nella seconda cantica, le cui implicazioni sono state analizzate altrove (Villa 2012). Nel complesso predomina, però, l’idea di ‘rottura’ connessa alla difficoltà del cammino di Dante ‘visionato’ per il percorso accidentato, tra passaggi interrotti e fenditure nelle rocce (Inferno XIV 112; XXI 114; XXIII 136, Purgatorio III 50; IV 31; IX 74; XI 2). Quest’accezione ‘concreta’ e ‘fisica’ del termine risulta significativa in relazione al personaggio di Semiramide, se si recupera la lettura di Castelvetro5 di contro a quella condivisa dalla maggior parte dei commentatori moderni e autorizzata anche dell’Enciclopedia dantesca sulla base di un ‘presunto’ «uso vivo ancor oggi» (Mariani 2005: 92), di «rotta» come ‘dedita a’. Osserva infatti il Castelvetro: «traslazione presa da un sasso, che, rotto e spiccatosi da un monte, ruina e trabocca giù nella valle senza ritegno niuno». Viene suggerita quindi l’associazione dell’idea della ‘spaccatura’ con quella dell’ ‘andare a precipizio’, per cui ‘rotta’ indicherebbe in maniera adeguata la corruzione, in senso anche ‘fisico’ di disfacimento. Notava poi il Vellutello che la lussuria ‘corrompe’ la nobile condizione dell’uomo in quella dei «brutti animali»: Fu di singolar bellezza, valorosissima in arme & di somma prudenza nel governo, ma era tanto nella libidine corrotta che bestialmente usò col proprio figliuolo; di che conoscendo esser caduta in grande & vergognosa infamia, per coprir il suo difetto, costituì in tal atto ogni licenza. Onde il Poeta dice ch’ella fu sì rotta […]. È plausibile, allora, interpretare «rotta» come ‘corrotta’ con allusione plastica al disfacimento e alla corruzione fisica. L’occorrenza infernale rappresenta un unicum del termine con questa accezione all’interno della Commedia, ma sembra già alludere alla corrispondenza tra la condizione fisica e quella interiore dei dannati, che è tipica della cantica. «Rotta» sarà infatti anche la «scheggia» di Pier delle Vigne, da cui fuoriescono parole e sangue. Nella degradazione dei suicidi trasformati in vegetali animati, privi però degli organi articolati dell’anima sensitiva, le lacerazioni inflitte dalle arpie e dalle nere cagne producono dolore ma sono anche la «fenestra» per il dolore, quindi delle aperture da cui viene emesso 209 Villa T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:52 PÆgina 210 2013 un sibilo di respiro, che sostituisce grida e parole, unito al sangue e, probabilmente, alle lacrime. Le «rotture sanguinenti», così verranno nuovamente definite a proposito di Giacomo di Sant’Andrea (Inferno XIII 132), costituiscono allora l’equivalente degradato della ferita eroica, che segnala lo spargimento di sangue come segno del valore in battaglia. Il termine «ferite» compare la prima volta in relazione al vulnus eroico degli antichi guerrieri morti in battaglia per fondare l’Impero romano: «la vergine Cammilla / Eurialo e Turno e Niso di ferute» (Inferno I 107-108). In tutte le altre occorrenze della cantica, invece, indica la punizione inflitta ai dannati, mediante vari gradi di intensità. Così in Ciampolo di Navarra: «ch’ancor mirava sua ferita» (Inferno XXII 77), la lacerazione è provocata dagli uncini, del resto già Malacoda, parlando con Virgilio, aveva usato il termine in relazione ai «raffi» dei Malebranche (Inferno XXI 87); ancora, il ladro fiorentino della terza metamorfosi viene «feruto» (Inferno XXV 105) all’ombelico fino a diventare un serpente. L’intensità maggiore è ovviamente data dall’unione delle ferite con il sangue suggerita in Inferno XI, in cui si indicano le colpe punite nel primo girone del cerchio dei violenti: «morte per forza e ferute dogliose / nel prossimo si danno» (Inferno XI 34-35). E’ significativo notare come nella raffigurazione degli ignavi il sangue fuoriesca da punture e non da ferite dovute a tagli, denotando la corruzione dell’elemento vitale che diventa nutrimento per i vermi, con una mescolanza di lacrime e sangue che verrà ripresa nel canto dei suicidi. Se la corporeità è il veicolo simbolico del rapporto tra uomo e mondo, o, nella prospettiva dantesca, di quello che è stato, la rottura come ‘ferita degradata’ è la connotazione primaria dei corpi dei seminatori di discordia, per i quali si può parlare di vere e proprie spaccature in due parti, dal momento che Dante insiste sul verbo ‘fendere’, come denuncia il contrappasso per bocca di Maometto: «E tutti gli altri che tu vedi qui, / seminator di scandalo e di scisma / fur vivi, e però son fessi così» (Inferno XXVIIII 34-35, corsivo mio). «Fessi» è dunque la condizione dei dannati, esemplificata poco sopra da Alì «fesso nel volto dal mento al ciuffetto» (v. 33): una ferita profonda, larga, una spaccatura che richiama le fenditure 210 Villa T 14:Maquetaci n 1 Marianna VILLA 09/12/2013 11:52 PÆgina 211 Tra ‘ferite’, ‘rotture’ e ‘piaghe’ delle rocce (Purgatorio IX 75; X 7), come in rapporto all’idea di ‘rottura’ sopra esaminata a proposito di Semiramide.6 Come è noto, i dannati della nona bolgia di cui sono presentati i nomi sono accostati a coppie, per la complementarietà delle piaghe. Così, a partire dal mento, la ‘fenditura’ di Alì che arriva fino alla fronte corrisponde a quella di Maometto, «rotto dal mento fin dove si trulla» (v. 24): si ingenera una corrispondenza dei lessemi «rotto» e «fesso». Inoltre l’annominatio «scisma-accisma» rimarca non solo il ruolo della ferita come imago agens della colpa specifica della bolgia, bensì l’atto stesso del ferire mediante l’arma da taglio, in un canto in cui Dante si è da subito proposto come ‘poeta d’armi’. Lungi dal vulnus che marca lo statuto eroico di un guerriero, le lacerazioni della carne sono ora temporanee e perpetue, con la ferita che si richiude durante il giro della bolgia e quindi viene nuovamente inferta. Il vulnus eroico o, nella letteratura agiografica, la ferita volutamente esibita sono invece segno di virtus o di santità, un’adaequatio al modello del Christus patiens, e finiscono per integrarsi con il corpo, conferendogli valore. Quello che interessa, nella Commedia, è invece l’atto perpetuo dell’imprimere una ferita nella carne, in un continuum ossessivo e circolare tra lacerazione e rimarginazione che riprende evidentemente il mito di Prometeo, suscitando ribrezzo e orrore in chi osserva: «Un diavolo è qua dietro che n’accisma / sì crudelmente, al taglio de la spada / […] però che le ferite son richiuse / prima ch’altri inanzi li rivada» (vv. 37-42). Il termine «ferite», un unicum nel canto, assume allora una connotazione generica, ingloba la specificità di tutte le lacerazioni della bolgia, presentate da Dante facendo ricorso a una varietà lessicale che non ha eguali. Pier da Medicina costituisce una figura di «trapasso» (Allegretti 2000: 400) tra il gruppo dei lacerati e quello dei ‘mozzi’: egli è ‘forato’ nella gola e ‘tronco’ nel naso e corrisponde a Curione, che mostra la «lingua tagliata ne la strozza» (v. 101). Dalla ‘trafittura’ si passa alla mutilazione con la «man mozza» (v. 103) del Mosca e il drammatico «capo tronco» di Bertran de Born. L’occorrenza per due volte dei soli termini «fesso» (anche nella variante «fessa») e «tronco» testimonia come le tipologie di lacerazioni si addensino intorno ai due poli delle ‘trafitture’ e delle ‘mutilazioni’, in un canto che si va 211 Villa T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:52 PÆgina 212 2013 modulando sulla chiave della giustapposizione, come ha ben mostrato Paola Allegretti (2000: 393) anche in relazione ai rapporti intertestuali con le fonti, Virgilio, in primis, e Bertran de Born (su cui si vedano almeno Allegretti 2001, Vilella 2010 e relativa bibliografia). D’altronde Alì, «fesso» nel volto, e Bertran, «tronco» nel capo, in due parti del corpo che si possono giustapporre, sono intimamente connessi al contrappasso, come si è visto ai vv. 34-36 («e tutti gli altri […] / seminator di scandalo e scisma/ fur vivi, e però son fessi») per il primo, con la corrispondenza tra vivi e morti in «fur» - «son», e come è ancora più evidente nel caso del trovatore: «così s’osserva in me lo contrappasso» (v. 142), il quale addirittura rappresenta la parodia del dogma del rapporto di filiazione tra Padre e Figlio al v. 125 (Allegretti 2000: 404-405). Inoltre la struttura chiastica che collega i due versi riferiti al ‘troncamento’ rispettivamente di Pier da Medicina e Bertran: «avea […] tronco il naso infin sotto le ciglia» (v. 65) e «’l capo tronco tenea per le chiome» (v. 121), giustappone naso, ciglia, chiome quasi a comporre ‘idealmente’ un viso umano. Qualche osservazione sulla possibile derivazione dei singoli lessemi connessi alle ferite, al di là di suggestioni e immagini che hanno ispirato Dante, dai corpi mutilati dell’Eneide, almeno con Deifobo e Pirro, a quelli di Lucano per Curione e di Bertran de Born, considerato il più grande poeta volgare delle armi (in De vulgari eloquentia II II 9) per cui si rimanda agli studi noti. Virgiliani sono sicuramente il binomio «sangue» e «piaghe» (v. 2) da Aen. II 201 («sanguine et igni»), così come il termine «tronco», soprattutto in relazione al naso di Pier da Medicina, da Aen. VI 497 («et truncas inhonesto volnere naris», in Allegretti 2000: 393, 404), dato che l’immagine dell’ipotesto è la medesima. Da Be.m platz v. 27 di Bertran de Born, come è noto, è stato coniato il verbo ‘accismare’ nel senso antifrastico di ‘acconciare’ già ipotizzato dal Vellutello e riproposto dal Crescini. Un hapax è anche il corrispettivo «dilacco», conio dantesco, con cui Maometto slabbra la ferita del diavolo (designata appunto con l’espressione «n’accisma»), da ‘lacca’ o ‘coscia’, vocaboli usati soprattutto per gli animali, e quindi, ora, in funzione degradante. Maometto viene connotato nella componente attiva di chi, adoperatosi per gli altri, 212 Villa T 14:Maquetaci n 1 Marianna VILLA 09/12/2013 11:52 PÆgina 213 Tra ‘ferite’, ‘rotture’ e ‘piaghe’ nell’Inferno si autolesiona: il suo gesto costituisce l’equivalente violento e degradato di quello con cui Manfredi mostra le piaghe, sempre nel petto, a Dante (Purgatorio III 111). Anche nel contesto dei lessemi concernenti le lacerazioni e le ferite, dunque, l’innovazione lessicale dantesca non ha paragoni a livello di quantità e varietà, né nella letteratura classica né in quella in volgare: al registro basso del canto XXVIII corrispondono parole «scarmigliate» e «lubriche» (De vulgari eloquentia II VII) ‘convenienti’ ai corpi spaccati. L’orizzonte di riferimento, allora, non può essere il linguaggio medico-scientifico, ben presente invece nel canto V del Purgatorio, bensì quello legato all’animalesco, per le ferite, e alla cucina, per le parti del corpo coinvolte («minugias», «tristo sacco», «corata»).7 In relazione al secondo tipo di lacerazioni, ovvero le mutilazioni, i termini «mozzo» e «tronco» erano già presenti entrambi, ma con intensità decisamente minore, nel canto VII dell’Inferno, rispettivamente in relazione ai prodighi che risorgeranno con i capelli tagliati (v. 57, «crin mozzi», si noti poi che nel Purgatorio l’intensità è ancora più attenuata dal sintagma «crini scemi» di XXII 46 con cui si allude ancora ai prodighi), e agli iracondi che si lacerano «brano a brano» con i denti («troncandosi», v. 114), così come lacerarono il prossimo, mentre si percuotono «non pur con mano, / ma con la testa e col petto e coi piedi» (vv. 112-113) in una furibonda lotta, che ancora costituisce il contrappasso dei dannati. La connessione tra l’arma da taglio e l’aggettivo «tronco» verrà invece recuperata e rovesciata nella valletta dei Principi (Purgatorio VIII 27) quando le spade degli angeli saranno spuntate («tronche e private de le punte sue»), e quindi incapaci di generare moncherini, perché la giustizia divina agisce attraverso vie differenti. Infine il derivativo «smozzicate», altro conio dantesco, rilancia il tema della mutilazione al principio del canto XXIX («l’ombre triste smozzicate», v. 6), sottolineandone la persistenza nella mente di Dante, e quindi del lettore, dal momento che lo sguardo del pellegrino «si soffolge» troppo sui corpi mutilati, generando la disapprovazione di Virgilio. Già Paola Allegretti (2000: 398) ha notato come gli aggettivi «tronco» e «mozzo» nella Commedia siano attribuiti anche alla scrittura e alle pa213 Villa T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:52 PÆgina 214 2013 role (si vedano Inferno IX 14 e Paradiso XIX 134). Si tratta di un’accezione metaforica ed ‘attenuata’ che, in realtà, può essere riscontrata anche in altri termini connessi alla lacerazione. E’ il caso di «piaga», che in Purgatorio XXV 30 è collegata alla metaforica del desiderio di sapere e dei dubbi che assillano Dante ‘visionato’: « […] e io lui [Stazio] chiamo e prego / che sia or sanator de le tue piaghe» (vv. 29-30) o del termine «monchi», che esprime l’ idea della mutilazione presente già nel verbo «troncare» in Inferno XIII 27-28: «se tu tronchi / qualche fraschetta […] li pensieri ch’ai si faran tutti monchi». Va notato che nella nona bolgia è assente il lessema ‘monco’, sostituito da «moncherin» (v. 104) come prodotto della mutilazione di Mosca dei Lamberti, un termine derivativo che allora può essere associato all’accrescitivo, da ‘tronco’, «troncone» (v. 141), usato per designare il busto spiccato dalla testa di Bertran de Born. Evidentemente Dante nel contesto dei seminatori di discordia ha prediletto il più brutale e fonologicamente aspro «mozzo», in linea con la violenza del canto (si vedano, affini per sonorità, «mezzul», v. 22, e «strozza», v. 101, e i rimanti «sozzo», v. 21, e «sozza», v. 105). Ma nel sogno della «femmina balba» le mani torneranno nuovamente «monche» (Purgatorio XIX 9), vale a dire ‘mozzate’ come segno dell’avaritia e dell’accidia, secondo Benvenuto da Imola, o semplicemente ‘rattrappite’, per il Buti, il Mattalia e altri commentatori moderni. Le deformità fisiche riflettono i vizi della strega / sirena, che verrà definitivamente smascherata dal gesto di Virgilio di lacerare le vesti: «fendendo i drappi, e mostravami ’l ventre: / quel mi svegliò col puzzo che n’uscia» (Purgatorio XIX 3233). Il ventre messo a nudo, come nel caso di Maometto, è rivelatore della vera natura della donna. Il «modo de la nona bolgia sozzo» è presentato attraverso il binomio «sangue» e «piaghe» (v. 2), termine, quest’ultimo, che, mediante la tecnica provenzale della ripresa, segnerà anche il trapasso all’inizio del canto successivo «la molta gente e le diverse piaghe» (Inferno XXIX 1), incorniciando l’episodio. Di fronte a tale soggetto, le ferite e i corpi lacerati in guerra, Dante sottolinea i limiti della parola umana e della memoria: «ogne lingua per certo verria meno / per lo nostro sermone e la nostra 214 Villa T 14:Maquetaci n 1 Marianna VILLA 09/12/2013 11:52 PÆgina 215 Tra ‘ferite’, ‘rotture’ e ‘piaghe’ mente» (vv. 4-5). E la lingua di Dante, che rischia il silenzio, anticipa figurativamente la lingua «tagliata ne la strozza» (v. 101) di Curione, che proprio in vita fu molto loquace («ardito», v. 102), ad indicare come qualsiasi lingua voglia intraprendere la narrazione di un al di là che supera l’esperienza umana sia destinata a fallire. Eppure Dante auctor accetta la sfida, vincendo il silenzio in una duplice direzione: nei confronti dei modelli, e il gesto di sfida è rimarcato dall’interrogativa retorica che costituisce una dichiarazione d’indicibilità paragonabile a quella dell’attacco del canto XXXII, e nei confronti del «modo sozzo» della pena, di una realtà infernale degradata e ‘iperbolica’ che la ‘lingua’ di Dante deve sforzarsi di rappresentare. La strategia iperbolica, allora, non riguarda solo la materia, ma finisce proprio per sottolineare la difficoltà di affrontarla con mezzi umani, cosicché l’attenzione è convogliata sull’abilità narrativa dell’autore e sull’eccezionalità del suo compito. E ancora, di fronte ai tagli e alle lacerazioni anche la lingua si farà ‘smozzicata’ e ‘storpiata’ non certo ‘sciolta’, come si può notare nell’esclamazione «Oh me!» di Bertran de Born nel canto, e come è ancora più evidente man mano che Dante procede verso il fondo, avvicinandosi alla lingua del Giganti, fino al silenzio in cui è immerso Lucifero. Nella Commedia, allora, il corpo non è solo l’oggetto della poesia ma diventa man mano anche il soggetto di un linguaggio che si deve fare corpo, una lingua-corpo con nuove modalità espressive, che amplia le possibilità della lingua esistente: dal corpo come oggetto di rappresentazione Dante crea il linguaggio corpo, che nella lacerazione e nella ferita del tessuto sintattico trova l’espressione più evidente. Il tema della mutilazione nel canto XXVIII dell’Inferno è introdotto attraverso l’accumulazione di soldati, romani e angioini, straziati a seguito delle sanguinose battaglie dell’Italia meridionale, rievocate «partitamente» (Ledda 2002: 92): segno che l’oggetto preciso della rappresentazione è proprio la descrizione delle ferite. Si susseguono «sangue dolente» (v. 9), «alte spoglie» (v. 11), «ossame» (v. 15), fino a quella che sarà la specificità della bolgia, le mutilazioni «qual forato suo membro e qual mozzo» (v. 19). Il binomio «sangue» e «piaghe» presuppone proprio armi 215 Villa T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:52 PÆgina 216 2013 da taglio8 che incidono il corpo e fanno uscire ‘la linfa vitale’, differenti dalle «ferze» (Inferno XVIII 35), dai «raffi» (XXI 52) o dalle unghie (XIX, 131) incontrati fino ad ora. Eppure il sangue che sporca i cadaveri, motivo primario del Sirventese di Bertrand (BdT 80, 29, v. 2 in Allegretti 2001: 13), ora diventa segno di degradazione e corruzione, implicando, accanto a sensazioni visive (v. 9 e vv. 68-69: «canna / ch’era di fuor d’ogne parte vermiglia»), anche quelle olfattive, come insegna Camporesi (1997), sensazioni che poi prevarranno nella bolgia seguente:9 l’aggettivo «sozzo» che connota il «modo» dei dannati è infatti associabile al sangue che sporca e corrompe ogni cosa, come la faccia del Mosca, «sozza» (v.105) per il sangue fuoriuscito dal moncherini. E, come ricorda DíazCorralejo (2002: 51), il sangue, per Alano di Lilla, rappresenta proprio la cruentae mentis malitia. Dante non prosegue in direzione del catalogo bellico, ma compie un passo indietro, insistendo sulle lacerazioni che semmai precedono un conflitto, attraverso i sei casi esemplari «della trista greggia» (v. 120). Il vulnus eroico, infatti, segno della violenza subita, si imprime nella pelle spesso senza rompere l’unità del corpo e lascia piuttosto una cicatrice con funzione memoriale e spesso identitaria (dalla cicatrice di Ulisse alle piaghe di Cristo, passando, nel caso della Commedia, per le piaghe dei personaggi dell’Antipurgatorio). I tagli infernali, invece, corrispettivi della ‘violenza’ provocata, rimangono sempre aperti e le ferite sono slabbrate, con la fuoriuscita dell’homo interior, il sangue, gli umori e addirittura le «minugia», in un ‘ibridismo’ tra interno ed esterno, come impurità e male, che segue altri ibridi della cantica, quello uomo-pianta e uomo-animale. E’ allora opportuno sottolineare le tre connotazioni fondamentali della rappresentazione: la precisione nelle parti del corpo interessate dai tagli, la priorità della vista tra i sensi implicati ed, infine, il bisogno di nominazione dei dannati. Sulla precisione anatomica in relazione alle «ombre triste smozzicate», oltre alla volontà di ‘collegare’ ‘paradossalmente’ personaggi ‘divisi’ secondo la logica giustappositiva già individuata, per cui Alì può essere considerato un continuatore dello scisma di Maometto, o in aggiunta al gioco di riprese e suggestioni dalle fonti, la volontà di Dante 216 Villa T 14:Maquetaci n 1 Marianna VILLA 09/12/2013 11:52 PÆgina 217 Tra ‘ferite’, ‘rotture’ e ‘piaghe’ è anche quella di rendere visive le parti del corpo che hanno determinato il peccato, nel senso che queste diventano imagines agentes della colpa e delle diverse tipologie di scissioni, come ben spiega il Landino: Questi seminatori di scandolo et di scisma sobto spetie di bene commettono fraude in danno del proximo. Ma sono tra loro differenti: infedelità, scisma, et heresia. Infedelità è opposita alla fede, et è non creder quello, che crede la fede in ogni parte et chosa. Heresia è partirsi dalla fede in alchuna parte o fare alchuno mutamento in quella. Scisma è partirsi in tutto dalla fede et dall’unione di quella. Et perchè questo è maggior che e due primi, però finge el poeta che sia punito in questa più bassa parte. Scisma adunque è divisione et separamento dell’unità della fede et della carità. Ma anchora la divisione nelle città tra parte et parte di cittadini, et anchora tra huomo et huomo, si comprende sobto questo peccato. Adunque chi ha commessa heresia nella fede è diviso tutto dal mento in giù, perché ha diviso el corpo della chiesa della quale è capo Christo, et chi ha commesso scandolo tra principi che sono capo de’ popoli, hanno le loro piaghe nel capo, et chi ha diviso e parenti hanno tagliato le mani, et quegli che hanno diviso figliuolo da padre, hanno tagliato el capo et portanlo in mano. Emblematico è il caso di Bertran de Born: Weinrich (1994: 25) ha sottolineato la valenza di imago agens del busto senza capo, un’immagine «sommamente mnemofila e suggestiva» per imprimere nella memoria il delitto e peccato astratto di ribellione che, quando coinvolga una dinastia reale, è «come la separazione di un corpo, “busto”, dalla sua testa, “capo”», secondo la nota metaforica politica del corpo come Stato. Nel caso del trovatore, poi, non si tratta solo di ferite invalidanti, ma le due parti del corpo arrivano ad agire in maniera indipendente, con il tronco che cammina e il capo che guarda e parla, generando, come già De Sanctis aveva notato, il «sublime dell’orrore». Il superamento di tutti i modelli precedenti richiede un nuovo intervento autoriale, atto a marcare la straordinarietà della visione, nel contempo rafforzata dal topos della persistenza nella memoria (Ledda 2002: 210): «Io vidi certo, e ancor par ch’io ’l veggia» (Inferno XXVIII 118). L’iniziale paura del Poeta di non 217 Villa T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:52 PÆgina 218 2013 essere creduto nel suo racconto («e vidi cosa ch’io avrei paura / senza più prova, di contarla solo», vv. 113-114) viene superata proprio in nome della veridicità della sua visione (su cui Barolini 2003: 130-131), tanto straordinaria da imprimersi nella memoria ed essere ancora viva con la stessa intensità di quando Dante ‘visionato’ ne fece esperienza. Si tratta del medesimo procedimento che coinvolge il lettore, chiamato a visualizzare a sua volta la scena, per cui l’intensità iperbolica del canto viene giustificata in quanto produttiva di imagines agentes. E, come spiega la teoria dell’arte della memoria di matrice aristotelica, la ritenzione mnemonica passa dalla vista e da ogni esperienza sensibile (cfr. Paradiso IV 40-42: «così parlar conviensi al vostro ingegno / però che solo da sensato apprende / ciò che fa poscia d’intelletto degno»). La priorità della vista sancisce dunque la veridicità del canto10 e segmenta in episodi la narrazione, ma non solo: alla vista fanno appello i dannati, che esibiscono con compiacimento le proprie mutilazioni, con lo scopo di suscitare pietà, ma nel contempo generando una mescolanza di orrore e meraviglia, ad iniziare da Maometto, la cui dichiarazione «or vedi» (v. 30), consolidata dall’anafora «vedi» nel verso successivo (v. 31), è esattamente replicata in chiusa della carrellata di personaggi da Bertran de Born («or vedi», v. 130). In entrambi i casi alla gestualità della mano non spetta solo il compito di rendere evidente la pena, coadiuvando la comunicazione verbale, ma soprattutto di porre l’attenzione sulla responsabilità personale. Così il gesto di Maometto apparentemente «redundante» (Díaz-Corralejo 2002: 45), perché l’interiorità è già visibile senza che egli allarghi ancora di più la ferita, diventa in realtà significativo a livello allegorico per mostrare il cor pravum del dannato, come suggerisce la Corralejo. Nel caso del trovatore, poi, è proprio la mano ad indirizzare la testa, a guisa di lanterna, verso Dante e Virgilio.11 E laddove manca un appello preciso alla vista, i gesti assumono un altrettanto valore eloquente con lo scopo di ‘ostendere’ le ferite.12 La mano di Pier da Medicina, appunto, mostra la lingua tagliata di Curione, ma è anche mozzata nel Mosca, segno dell’impossibilità di alcuna azione. E, si ricordi, anche Manfredi inviterà Dante a vedere la piaga «a sommo ’l petto» con la medesima espressione «or vedi» (Purgatorio 218 Villa T 14:Maquetaci n 1 Marianna VILLA 09/12/2013 11:52 PÆgina 219 Tra ‘ferite’, ‘rotture’ e ‘piaghe’ III 110-111) per potere essere riconosciuto, accompagnando presumibilmente l’invito verbale col gesto dell’indigitazione. Le ferite dei dannati della nona bolgia, tuttavia, non sono distintive, non sono portatrici di identità: ecco perché è necessario che il nome sia rivelato, dopo che la vista ha mostrato l’eterna condizione degradata. Solo il nome permette di ricostituire una ‘parvenza’ di unità, perduta per sempre a causa delle ferite-colpe. Maometto si auto-presenta, in una sorta di autoaffermazione di sé, e poi rivela l’identità del cugino, così Pier da Medicina riveste il duplice ruolo di dichiarare la propria identità, pur attraverso una «canna» «vermiglia» (vv. 68-69), e quella di Curione, impossibilitato a parlare per la lingua mozza. Differente la situazione degli ultimi due personaggi, indipendenti tra di loro ma entrambi uniti dal fatto che vogliono essere ricordati con l’atto della nominazione («ricordera’ti anche del Mosca», v. 106; «E perché tu di me novella porti / sappi ch’io son Bertram dal Bornio», vv. 133-134). Diversa sarà allora anche la reazione del pellegrino: sdegnato e violento con il primo, ai cui discendenti augura rovina e morte, generando dolore e sofferenza, e ‘indulgente’ col secondo, tanto da meritare il rimprovero di Virgilio per aver indugiato a guardare «la molta gente e le diverse piaghe» che hanno ‘inebriato’ di pianto i suoi occhi (Inferno XXIX 1-9). Risulta infine interessante insistere ancora sul termine «piaghe» in apertura del canto XXVIII, che non solo funge da collegamento con il successivo, ma getta anche ponti testuali su altre parti del poema, mostrando in maniera significativa come la costruzione complessiva del poema dantesco sia sorretta da tracce memoriali che determinano una rete di significati interconnessi e articolati, nel caso specifico intorno al tema della lacerazione13 e delle piaghe. Quest’ultimo termine, con la funzione di incorniciare l’episodio, non è assegnato a nessun personaggio della nona bolgia perché allude a segni che si imprimono nella pelle, senza l’effusione di liquido interno, e nell’Inferno ha due sole altre occorrenze, nel canto XVI al v. 10 in relazione ai sodomiti fiorentini, le cui ustioni arrecano «duol» (v. 12) in Dante ‘visionario’ e nel canto XXV ad indicare il punto in cui Buoso è stato morsicato dal serpente: da lì uscirà il fumo, 219 Villa T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:52 PÆgina 220 2013 che precede lo scambio delle due nature, umana e di rettile. Per il resto, il lessema è ricorrente nel Purgatorio, in cui è impiegato col significato generico di ‘tormento’ nel caso dei golosi (Purgatorio XXV 39) o come emblema delle discordie civili «c’hanno Italia morta» in VII 95, con un richiamo all’idea della lacerazione del ‘corpo politico’, già presente in Bertran de Born. Significative sono però le ‘piaghe’ di Dante, le sette P, ferite fisiche che devono essere ‘lavate’ in Purgatorio IX 114 e ‘spente’ in XV 80. Nella ‘carne’ di Dante, allora, è impresso un fardello suo e di tutta l’umanità: su influsso del linguaggio scritturale le piaghe acquistano esplicitamente anche il significato di ‘peccato’ e richiamano i ‘segni della storia’ impressi nel costato di Cristo, che, con le sue sofferenze, espia e lava le brutture del mondo. Ma la piaga è anche quella al petto di Manfredi, mostrata attivamente dall’anima in seguito alla richiesta di un riconoscimento che non avviene. Secondo la nota strategia dantesca degli ‘episodi paralleli’ (su cui, almeno in chiave teorica, si veda Iannucci 1984: 85-114) è possibile collegare il canto XXVIII dell’Inferno con gli episodi dei canti III e V del Purgatorio, nel segno delle ferite e delle lacerazioni.14 La piaga di Manfredi è il secondo signum impresso nella sua carne, dopo il «colpo» (Purgatorio III 108) che aveva diviso «l’un de’ cigli», turbandone il «gentile aspetto», definita da Benvenuto da Imola «turpem cicatricem»: entrambe le ferite, però, risultano insufficienti per il riconoscimento, tanto che Manfredi è costretto all’autoproclamazione onomastica. Freccero sottolinea quanto la cicatrice sia inesplicabile, dal momento che costituisce una «accidentale intrusione nella corporeità ideale dell’al di là» (Freccero 1989: 262), ben diversa, dunque, dalle mutilazioni dei seminatori di discordia, non distintive, ma impresse post mortem, a richiamare l’odiata pratica del dissezionamento di cadaveri attuata dai cerusici. Le piaghe di Manfredi sarebbero invece «ferite della storia» (Freccero 1989: 264), simboliche, che lo collegano al padre, ma che sono destinate ad essere rettificate dal sorriso e dalla rinascita purgatoriale, come le sette P per Dante: si noti, poi, che il «colpo» che ha inciso la fronte di Manfredi anticipa il «colpo» con cui verrà cancellata una delle piaghe sulla fronte di Dante (Purgatorio XXII 3). La memoria lessicale, 220 Villa T 14:Maquetaci n 1 Marianna VILLA 09/12/2013 11:52 PÆgina 221 Tra ‘ferite’, ‘rotture’ e ‘piaghe’ quindi si carica di una forte valenza semantica. Pur nella diversità di interpretazione proposta dalla Cassata Contin, che rafforza la derivazione biblica dei tagli a danno di quella rolandiana, mi sembra opportuno richiamare comunque il valore simbolico che la studiosa ascrive alle ferite, con la ‘piaga’ che ripristina l’onta del ‘colpo’ sulla fronte (Cassata Contin 2006: 120). Solo con una lettura ‘allegorica’ risulta possibile giustificare la mancata agnizione di Manfredi da parte di Dante ‘visionato’. Né la ferita né il gesto, insomma, bastano a riempire lo scambio di sguardi che presiede la situazione («volgi ’l viso» v. 104; «mi vedesti», v. 105; «or vedi», v. 110): la predominanza della percezione visiva richiama ovviamente il canto XXVIII dell’Inferno, ma l’autopresentazione di Manfredi è immediata e diretta: «Io son» (Purgatorio III 112), di contro a «Vedi come storpiato è Maometto» (Inferno XXVIII 31), dal momento che nemmeno il nome è più garante dell’identità dello scismatico, né può ricomporla, tanto profonda è la lacerazione. Da interpretare in senso ‘letterale’ sono invece le ferite delle anime nel canto V, memoria per l’eternità dello strazio che subirono prima di morire, presentate da Dante con precisione scientifica. Si tratta ora di ‘fori’ sanguinanti:15 «li profondi fori» (v. 73) per Jacopo del Cassero, mentre l’espressione «forato ne la gola» (v. 96) di Bonconte, pur riprendendo a distanza «forato avea la gola» (Inferno XXVIII 64) di Pier da Medicina, ne marca le differenze. La violenza è ora associata al mondo dei vivi, non all’al di là, per cui la ferita non è oggetto della vista di Dante: viene raccontata dall’esterno dai protagonisti, senza risentimento verso gli uccisori (vv. 83-84: «vid’io»), ma con l’insistenza dettagliata sui sintomi che hanno accompagnato la loro lenta agonia. Il ruolo del sangue è quello di richiamare gli odi e le violenze da cui le anime prendono le distanze (ricordiamo la pertinenza del sangue con le idee di violenza e lacerazione nella prima cantica), privo di quella connotazione ‘immonda’ che caratterizzava la nona bolgia infernale. Jacopo del Cassero insiste sulla potenza visiva del sangue che macchia il luogo della morte, delineando il suo itinerario dalla prima ferita al colpo mortale infertogli dai sicari: il sangue si carica allora di una valenza temporale, suggerendo l’intervallo in cui è 221 Villa T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:52 PÆgina 222 2013 avvenuto il pentimento prima dell’ultimo respiro. Significative sono poi le osservazioni di Vittorio Bartoli e Paola Ureni (2006) sulla perfetta conoscenza di Dante in merito alle differenze tra sangue venoso e arterioso, a cui farebbero riferimento rispettivamente i racconti delle due morti. Queste sono legate all’esaurirsi del sangue, inteso come liquido vitale: fuoriesce da molteplici ferite creando un «laco» (v. 84), nel primo caso, mentre da una sola, grave, ferita al collo per Bonconte, «sanguinando il piano» (v. 99) fino a lasciare solo il corpo ‘vuoto’, ridotto a puro involucro della carne («carne sola», v. 102). La morte è presentata come esaurimento del sangue, elemento vitale, in seguito a delle lacerazioni: ricordiamo che Dante ‘visionato’, per rimarcare la sua condizione, dirà di compiere il viaggio con il «sangue» e con le «giunture» (Purgatorio XXVI 57). La percezione della diversità del corpo aereo dal corpo terreno, fatto di carne e sangue, è un acquisto fondamentale dell’Antipurgatorio: un leitmotiv è infatti l’interruzione dei raggi solari da parte di Dante vivo, suscitando la meraviglia negli astanti (Villa 2012: 193-196). Duplice il risvolto: da un lato si innesta l’itinerarium di formazione di Dante personaggio, che dovrà arrivare alla consapevolezza del proprio ‘essere uomo’, dall’altro le anime purganti, ‘nell’attesa’ di intraprendere il cammino vero e proprio, sperimentano una vasta gamma di reazioni emotive, dalla paura allo stupore, utile per il progressivo allontanamento dalla dimensione terrena, verso cui sono ancora nostalgicamente protese. L’esigenza di essere riconosciute risulta primaria: «guarda s’alcun di noi unqua vedesti / sì che di lui di là novella porti» (Purgatorio V 49-50), ma non è solo funzionale ad accelerare il processo di purificazione. Quando Dante dichiara di non riconoscere alcuna anima, come era accaduto con Manfredi, subentra nelle anime il bisogno di raccontare gli ultimi istanti della propria vita anche per dare un ‘senso’ a ferite che hanno lacerato e deformato il loro corpo. Oltre al motivo della sepoltura mancata, definito dagli studiosi come il «complesso di Palinuro» (Picone 2001: 77), a collegare le tre vicende del canto V vi è la necessità di giustificare le ferite, di rievocare i dettagli che hanno generato il più grande trauma, la morte, quasi per esor222 Villa T 14:Maquetaci n 1 Marianna VILLA 09/12/2013 11:52 PÆgina 223 Tra ‘ferite’, ‘rotture’ e ‘piaghe’ cizzarla. Le ferite, per le anime purganti, acquistano valore identitario, perché sono un segno che portano con sé nell’al di là, un segno recente, che ha deturpato in maniera definitiva l’immagine di sé: ecco allora la necessità di risarcire, con le parole, quell’unità dell’io che è stata straziata. Interessa poi la risonanza memoriale: il vulnus eroico, nella tradizione, diventa oggetto di pietà e ammirazione post mortem, il mancato ritrovamento del corpo delle anime purganti qui presentate, almeno per Jacopo e Bonconte, impedisce qualsiasi risarcimento. E allora la parola di Dante giunge in loro soccorso, nel tentativo di ricucire le ‘ferite’ e le ‘lacerazioni’, individuali e storiche, di un mondo che ha perduto la diritta via. 223 Villa T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:52 PÆgina 224 Tenzone 14 2013 NOTE 1 Per la proposta dei termini ‘Dante visionario’ e ‘Dante visionato’ si veda Varela-Portas 2010: 25. Cfr. Chiavacci Leonardi 1988: 252: «La Divina Commedia di Dante è forse il solo grande testo – non teologico – che di quell’idea [scil. della risurrezione dei corpi] sia il portatore in quanto in essa ha le sue stesse radici». Si rimanda al saggio per la discussione e la bibliografia relative all’ origine «poetica» dell’idea di ‘corpo glorioso’ come doppio e verità di quello terrestre. 2 Nel Paradiso i corpi dei beati sono lucentes, descritti da Dante come «lumi», «soli», «stelle», «fulgori», «lumere», «lucerne», capaci di esprimere i propri sentimenti attraverso il movimento, in quanto ancora corpora mobilia secundum locum (Paradiso VIII 19-21; XIV 109-11; XXIV 13-18), attraverso mutamenti di colore (Paradiso XXVII 10-15; 19-21; 28-36), ed infine l’intensificarsi della luce, con il ‘fiammeggiare’ (Paradiso V 1; XVI 28-29; XVIII 25) o lo ‘sfavillare’ (Paradiso XVIII 71; XXI 41), non indagabili, dunque, in relazione ai tagli e ai segni che portano impressi. 3 Va notato, però, che nel De vulgari eloquentia (II VII 4) la parola «corpo», al pari di «femina», viene definita «lubrica, urbana et reburra», non certo illustre. 4 Il commento del Castelvetro e di tutti gli altri, indicati attraverso la sola menzione dell’autore, sono reperibili al sito www.dante.dartmouth.edu. 5 6 Valenze meno intense del verbo ‘fendere’ sono in relazione al ‘graffiare’ delle Furie (Inferno IX 49) o alle zanne con cui i cani inseguono lupa e lupicini nel sogno di Ugolino (Inferno XXXIII 36). Notava il Mattioli: «Si tratta di una descrizione esatta visivamente, ma non scientifica. Bastava aver osservato degli animali squartati nella bottega di un macellaio per notare quanto Dante descrive» (Mattioli 1965: 130). 7 Risulta significativo richiamare la significazione allegorica della spada proposta dalla Díaz-Corralejo (2002: 47): «símbolo guerrero, más concretamente de la guerra santa, símbolo del poder judicial, de la disensión, de la discordia o división, y del castigo eterno. Planos que confluyen todos ellos en Mahoma. El narrador puede haber utilizado la espada como instrumento de castigo, además de por las razones de contrapasso evidentes, para indicar, por un gesto implícito 8 224 Villa T 14:Maquetaci n 1 Marianna VILLA 09/12/2013 11:52 PÆgina 225 Tra ‘ferite’, ‘rotture’ e ‘piaghe’ de las manos, la operación decidida por el poder judicial divino, que castiga al autor de un cisma religioso que provocò varias explosiones de guerra santa, o a los autores de discordias civiles que provocaron también distintas luchas o guerras». Lasciate ferite e tagli, nella bolgia seguente si passa alla corruzione del corpo e alla puzza in relazione alla malattia. Eppure rimane un riferimento al taglio in Mastro Adamo che, oltre al ventre dilatato, ha la bocca aperta, un labbro ripiegato verso il mento, l’altro verso il naso, in una bocca squarciata (Inferno XXX 5557) dall’arsura per la sete. 9 Nel caso dei suicidi, di fronte ad una situazione altrettanto eccezionale, la vista non è sufficiente a confermare la veridicità della situazione, nonostante gli ammonimenti di Virgilio («però riguarda ben, sì vederai / cose che torrien fede al mio sermone», Inferno XIII 20-21) pertanto Dante è costretto a fare esperienza diretta ‘troncando’ un ramo, da cui fuoriescono lacrime e sangue. La lacerazioneferita, allora, è rivelatrice dell’identità del dannato, proprio perché, come afferma Barolini (2003: 131), il libro di Virgilio «è in-credibile». Il ruolo attivo di Dante non è più possibile nella bolgia dei seminatori di discordie, anche perché l’orrore delle mutilazioni allontana piuttosto il pellegrino, che evita ogni contatto con il sangue «sozzo». 10 Sottolinea la studiosa (Díaz-Corralejo 2002: 53-54): «Es el último de los gestos de este canto, en el que hemos visto que abundan, como si el narrador hubiera querido evidenciar con ellos, especialmente con los de las manos, la responsabilidad personal de llevar a cabo operaciones malvadas como el cisma o la discordia, que en el mundo presentan sólo una apariencia de actuaciones meramente políticas o de disensión en la fe, cuando en realidad proceden de un corazón depravado, como se nos muestra en el caso de Mahoma, o de ambición personal, que sería el caso de Bertrand de Born». 11 Si noti, invece, come, in altre zone di Malebolge, Dante assegni al gesto la funzione di sottolineare il degrado della condizione dei dannati, ridotti ad animali, per cui il gesto, in posizione forte e d’apertura, presenta il peccatore prima ancora delle parole e in sostituzione di esse: si ricordi la bestemmia di Vanni Fucci in apertura del canto XXV o lo spettacolo macabro di Ugolino che rode il teschio di Ruggieri, tra i canti XXXII e XXXIII. 12 Per il tema della rottura, con particolare riferimento ai raggi del sole interrotti dal corpo ‘in carne ed ossa’ di Dante nel Purgatorio si veda Villa 2012, a cui 13 225 Villa T 14:Maquetaci n 1 Tenzone 14 09/12/2013 11:52 PÆgina 226 2013 si collegano alcune delle osservazioni di seguito presentate, che in quella sede trovano una più ampia giustificazione. Altri sono, come è noto, i punti di contatto tra i due canti, secondo il principio ‘retrogrado’ che Dante impiega per creare corrispondenza tematiche e formali tra diverse porzioni testuali, per fornire una traccia memoriale, che sia da ‘stimolo’ per una lettura di «secondo grado» (Antonelli 2003: 40-41). Da un lato va sottolineata la relazione tra due personaggi ‘della stessa famiglia’‘forati’ e uccisi a tradimento: il Guido destinatario del messaggio di Pier da Medicina (Inferno XXVIII 77), ovvero Guido del Cassero, destinato ad essere gettato in mare per tradimento di Malatestino dell’Occhio, e Jacopo del Cassero, la cui vicenda, molto nota, non richiede un atto di nominazione: al personaggio del canto V del Purgatorio basta citare la Marca Anconetana. D’altro lato è significativa la presenza di ben unici sistemi di rime comuni: come ha ben dimostrato ancora Roberto Antonelli (2011), nell’impianto architettonico della Commedia le riprese ritmiche e lessicali assumono valenza semantica perché generano collegamenti a distanza tra porzioni testuali, permettendo un legame a livello di theatrum memoriae, e nel contempo arricchiscono il senso letterale. Comune ai due canti è anche la topica della meraviglia che coinvolge le anime quando si rendono conto che Dante è vivo. Se nell’Antipurgatorio l’agnizione è legata al fatto che Dante ‘visionato’ respira o proietta ombra, nell’Inferno lo stupore è la conseguenza delle parole di Virgilio, che denunciano la condizione eccezionale di Dante: «Più fuor di cento che, quando l’udiro / s’arrestaron nel fosso a riguardarmi / per meraviglia, obliando il martiro» (Inferno XXVIII 5254); rafforzato dall’atteggiamento di Pier da Medicina, che rimane ‘sospeso’: «ristato a riguardar per meraviglia» (v. 67). Nella prima cantica vengono allora sperimentate una serie di modalità espressive e di situazioni che verranno riprese a distanza e amplificate nell’Antipurgatorio, in cui diventano dei veri e propri leit-motiv (su cui rimando al mio Villa 2012: 193-210). Già nell’Inferno troviamo appunto il motivo della meraviglia e il convergere degli sguardi su Dante, per cui si crea un clima di sospensione. In questa sede basti richiamare solo: «così al viso mio s’affissar quelle / […] quasi obliando d’ire a farsi belle» (Purgatorio II 73, 75, corsivi miei); «restaro, e trasser se in dietro alquanto» (Purgatorio III 91, ma anche V 34). Infine, nell’attacco del canto XXIX dell’Inferno Dante è rimproverato da Virgilio perché si sofferma troppo a guardare «le ombre triste smozzicate» (Inferno XXIX 4-6, v.6); così in Purgatorio V 12-15 Virgilio sgrida il pellegrino per essersi lasciato distrarre dai pigri, ‘allentando’ il cammino. 14 226 Villa T 14:Maquetaci n 1 Marianna VILLA 09/12/2013 11:52 PÆgina 227 Tra ‘ferite’, ‘rotture’ e ‘piaghe’ Più intenso il riferimento a Pia de’ Tolemei, in cui Dante mette in evidenza l’ ‘effetto’ delle ferite, il disfacimento fisico: «Siena mi fe’; disfecemi Maremma» (Purgatorio V 134).L’antitesi vita-morte è ripresa dal canto VI dell’Inferno («tu fosti, prima ch’io disfatto, fatto», Inferno VI 42) ma con maggiore drammaticità nell’opposizione tra i verbi. Il tema del disfacimento è caratteristico dell’Inferno, con tre occorrenze del termine (Inferno III 57; VI 42; VIII 100); nel Purgatorio si riscontra nella predizione di Forese sulla sorte infernale del fratello (XXIV 87), infine vi è un’occorrenza nel Paradiso in relazione a «quei che son disfatti / per lor superbia […]» (Paradiso XVI 109-110). 15 227 Villa T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:52 PÆgina 228 Tenzone 14 2013 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ALIGHIERI, D. (1955): Commedia, a cura di N. Sapegno, Firenze, La Nuova Italia. ALIGHIERI, D. (1994): Commedia, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, Milano, Mondadori, reperibile al sito http//: dante.dartmouth.edu. ALIGHIERI, D. (2002): Commedia, a cura di U. Bosco-G. Reggio, vol. I: Inferno; vol. II: Purgatorio; vol. III: Paradiso, Firenze, Le Monnier. ALIGHIERI, D. (2011): Opere, vol. I, Rime, Vita Nova, De vulgari eloquentia, a c. di C. Giunta, G. Gorni, M. Tavoni, introduzione di M. Santagata, Milano, Mondadori. ALLEGRETTI, P. (2000): «Canto XXVIII», in Lectura Dantis Turicensis: Inferno, a c. di G. Güntert e M. Picone, Firenze, Franco Cesati Editore, pp. 393-406. ALLEGRETTI, P. (2001): «‘Chi poria mai pur con parole sciolte’ (Inf. XXVIII)», Tenzone 2, pp. 9-25. ANTONELLI, R. (2003): «“Memoria rerum et memoria verborum”. La costruzione della “Divina Commedia”», Criticón 87-89, pp. 35-45. ANTONELLI, R. (2011): «Come (e perché) Dante ha scritto la “Divina Commedia”», Critica del testo 14 /1, pp. 3-23. ARIÈS, PH. (1978): L’uomo e la morte dal medioevo ad oggi, Roma-Bari, Laterza. AUERBACH, E. (1971): Studi su Dante, Milano, Feltrinelli. BALFUOR, M. (1993): «“Orribil furon li peccati miei”: Manfredi’s wounds in “Purgatorio”, III», Italian Studies 47, pp. 4-17. BAROLINI, T. (2003): La ‘Commedia’ senza Dio, Milano, Feltrinelli. BARTOLI, V. - URENI, P. (2006): «La morte cruenta di Jacopo del Cassero e di Bonconte da Montefeltro (‘Purg’ V 73-102). Una nuova lettura fondata sulla scienza medica medievale», Studi danteschi 71, pp. 9-26. 228 Villa T 14:Maquetaci n 1 Marianna VILLA 09/12/2013 11:52 PÆgina 229 Tra ‘ferite’, ‘rotture’ e ‘piaghe’ Bertini Malgarini, P. (1989): «Il linguaggio medico e anatomico nelle opere di Dante», Studi Danteschi 61, pp. 29-108. BINNI, W. (1958): «Il canto III del Purgatorio» in Letture dantesche: II. «Purgatorio», a cura di G. Getto, Sansoni, Firenze, pp. 59-79. BOYDE, P. (2002): «Linguaggio del corpo e fisiologia della passione» in ID., ‘Lo colore del core’. Visione, passione e ragione in Dante, Napoli, Liguori, pp. 161-191. BUFANO, A. (2005): «Fendere», in Enciclopedia dantesca, Edizione Speciale, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol IX, pp. 27-29. BYNUM, C. W. (1995a): «Faith imagining the Self: Somatomorphic Soul and Resurrection Body in Dante’s ‘Divine Comedy’», in Faithful Imagining: Essays in Honour of Richard R. Niebuhr, a c. di S. H. Lee. W. Proudfoot and A. Blackwell, Atalanta, Ga: Scholar’s Press, pp. 83106. BYNUM, C. W. (1995b): The Resurrection of the Body in Western Christianity 200-1336, New York, Columbia University Press, pp. 291-305. CAMPORESI, P. (1975): «Carnevale, cuccagna e giochi in villa», Studi e problemi di critica testuale 10, pp. 57-97. CAMPORESI, P. (1997): Il sugo della vita: Simbolismo e magia del sangue, Milano, Garzanti. CASSATA CONTIN, A. (2006): «Le ferite di Manfredi: un’ipotesi», Giornale Storico della Letteratura Italiana 183, pp. 96-130. CERBO, A. (2001): Poesia e scienza del corpo nella ‘Commedia’, Napoli, Libreria Dante & Descartes. CHIAVACCI LEONARDI, A. M. (1988): «“Le bianche stole”. Il tema della resurrezione nel “Paradiso”», in Dante e la Bibbia. Atti del Convegno Internazionale promosso da ‘Biblia’, Firenze, 26-28 settembre 1986, a c. di G. Barblan, Firenze, Olschki, pp. 249-271. DIAZ-CORRALEJO, V. (2001): «Uno spazio inesplorato: i gesti nella “Commedia”», in “Per correr miglior acque…” Bilanci e prospettive degli 229 Villa T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:52 PÆgina 230 Tenzone 14 2013 studi danteschi alle soglie del nuovo millennio. Atti del Convegno di Verona - Ravenna, 25-29 ottobre 1999, Roma, Salerno Editrice, pp. 867-873. DIAZ-CORRALEJO, V. (2002): «Otra lectura del canto XXVIII del “Infierno”», Tenzone 3, pp. 41-57. FAVATI, G. (2005): «Ferire», in Enciclopedia dantesca, Edizione Speciale, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. IX, pp. 30-31. FRECCERO, J. (1989): Dante. La poetica della conversione, Bologna, Il Mulino. FUMAGALLI, V. (1990): Solitudo carnis. Vicende del corpo nel Medioevo, Bologna, Il Mulino. GRAGNOLATI, M. (2005): Experiencing the Afterlife. Soul and body in Dante and Medieval culture, Notre Dame, University of Notre Dame Press. GRAGNOLATI, M. (2007): «Nostalgia in Heaven: embraces, affection and identity in the “Commedia”», in Dante and the human body, a c. di J. Barnes and J. Petrie, Dublin, Four Courts Press, pp. 117-138. GRAGNOLATI, M.-HOLZHEY C. (2003): «Dolore come gioia. Trasformarsi nel “Purgatorio” di Dante», Psiche 2, pp. 111-126. GUARDINI, R. (1999): «Corpo e corporeità nella “Commedia”», in ID., Studi su Dante, Brescia, Morcelliana, pp. 221-245. IANNUCCI, A. (1984): Forme ed evento nella ‘Commedia’, Roma, Bulzoni. KIRKPATRICK, R. (1994): «Dante and the body», in Framing Medieval Bodies, a c. di S. Kay and M. Rubin, Manchester University Press, Manchester university Press, pp. 236-253. LE GOFF, J. (2005): Il corpo nel Medioevo, Roma-Bari, Laterza. LEDDA, G. (2002): La guerra della lingua. Ineffabilità, retorica e narrativa nella ‘Commedia’ di Dante, Ravenna, Longo. 230 Villa T 14:Maquetaci n 1 Marianna VILLA 09/12/2013 11:52 PÆgina 231 Tra ‘ferite’, ‘rotture’ e ‘piaghe’ MARIANI, A. (2005): «Rompere», in Enciclopedia dantesca, Edizione Speciale, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. XIV, pp. 91-92. MATTIOLI, M. (1965): Dante e la medicina, Napoli, Esi. NARDI, B. (1960): Studi di filosofia medievale, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura. NUTTON, V. (2007): «Dante, Medicine and the invisible body», in Dante and the human body, a c. di J. Barnes and J. Petrie, Dublin, Four Courts Press, pp. 43-60. PICONE, M. (1979): «I trovatori di Dante: Bertran de Born», Studi e problemi di critica testuale 19, pp. 71-94. PICONE, M. (2001): «Canto V», in Lectura Dantis Turicensis: Purgatorio, a c. di G. Güntert e M. Picone, Firenze, Franco Cesati Editore, pp. 7183. PINTO, R. (2004): «Fingo ergo sum. Elementi di teoria poetica della modernità. Lettura del canto XXVI del Purgatorio», Tenzone 5, pp. 145185. SHAPIRO, M. (1998): Dante and the Knot of body and Soul, New York, St. Martin’s Press. SUITNER, F. (2005): «Dante e Bertran de Born» in Dante, Petrarca e altra poesia antica, Fiesole, Cadmo, pp. 29-46 [1980]. VARELA-PORTAS DE ORDUÑA, J. (1995): «Sobre el arrebatamiento de Dante», Cuadernos de filología italiana 2, pp. 235-245. VARELA-PORTAS DE ORDUÑA, J. (2002): Introducción a la semántica de la Divina Commedia: teoría y análisis del símil, Madrid, Alpedrete (Madrid), Ediciones de La Discreta. VARELA-PORTAS DE ORDUÑA, J. (2010): «La doppia eterodossia di Dante Alighieri», Tenzone 11, pp. 21-32. 231 Villa T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:52 PÆgina 232 Tenzone 14 2013 VILELLA, E. (2010): «“E de fendutz per bustz tro als braiers”: sulla presenza dell’‘eredità’ di Bertran de Born nella “Commedia”», Tenzone 11, pp. 173-187. VILLA, M. (2012): «Lo sguardo dell’ “altro” e l’autoriconoscimento di Dante: un percorso nel “Purgatorio”», Tenzone 13, pp. 187-226. WEINRICH, H. (1994): La memoria di Dante, Firenze, Accademia della Crusca. YATES, F.A. (1972): L’arte della memoria, Torino, Einaudi. ZIEGLER, J. (2007): «The scientific context of Dante’s embriology», in Dante and the human body, a c. di J. Barnes and J. Petrie, Dublin, Four Courts Press, pp. 61-88. 232 Quaestionario T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:52 PÆgina 233 Quaestionario di Tenzone ¿?¿ Quaestionario T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:52 PÆgina 234 Quaestionario T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:52 PÆgina 235 QUESTIONE Nº 20 QUESTIONE: «Ché se a memoria si reduce ciò che detto è di sopra, filosofia è uno amoroso uso di sapienza, lo quale massimamente in Dio [...] È adunque la divina filosofia de la divina essenza, però che in esso non può essere cosa a la sua essenza aggiunta; ed è in lui per modo perfetto e vero, quasi per etterno matrimonio. Ne l’altre intelligenze è per modo minore, quasi come druda de la quale nullo amadore prende compiuta gioia, ma nel suo aspetto contentan loro vaghezza» (Cv. III XII 13). PROPOSTA: La fonte di Dante sarebbe questo passo dei Soliloqui di sant’Agostino: RAGIONE: Ed ora esaminiamo quale grado hai raggiunto nell’amore di sapienza. Tu desideri vederla e possederla con castissimo sguardo e abbraccio senza l’interposizione di alcun velame, nuda, per così dire, quale ella consente mostrarsi a pochissimi e sceltissimi suoi amatori. Se, tu ardessi d’amore per qualche bella donna, giustamente ella non ti si darebbe se si accorgesse che ami, oltre lei, qualche altra cosa. E ti si potrà mostrare, se essa sola non ami, la castissima bellezza della sapienza? AGOSTINO: [...] L’amore per tale bellezza può avere questo criterio di misura che non solo non la invidio agli altri, ma procuro anche che molti con me la desiderino, ad essa con me tendano, con me la posseggano e con me la godano. Ed essi mi saranno tanto più amici quanto quanto più l’amata sarà posseduta in comune (I, 13, 22)1. OBIEZIONI: Non ne conosco. SOLUZIONE: Dante si ispira alla donna-Sapienza agostiniana, erotica seppure sempre casta, per la sua Filosofia-druda del Convivio. Le due ‘donne’ coincidono infatti nel mostrare parzialmente o totalmente il loro ‘corpo’ ai suoi amanti: va notato però che nel Convivio ‘sapienza’ è il 235 Quaestionario T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 Tenzone 14 11:52 PÆgina 236 2013 corpo della Filosofia. Sul dantesco “uso amoroso di sapienza” (Cv. III XII 11-14) ho già scritto nel mio saggio «Il sesso della Filosofia. A proposito di ‘Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete’» (en Grupo Tenzone, Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete, ed. de Natascia Tonelli, Madrid, Departamento de Filología Italiana-Asociación Complutense de Dantología, 2011, pp. 133-156), ma ignorando in quell’occasione questo importante passo agostiniano che, a mio avviso, può gettare anche un po’ di luce sul cronico problema della donna-Filosofia del Convivio (la druda del passo su citato), identificata da Dante come la ‘donna gentile’ della Vita nova (Cv. II II 1). Nell’attività della donna-Sapienza dei Soliloqui, infatti, possono distinguersi due tempi: uno, esplicito, in cui si mostra nuda ai suoi «pochissimi e sceltissimi» amanti; e un altro, implicito e necessariamente previo all’altro, in cui dopo ‘averli scelti’, suscita in loro il desiderio di contemplarla nuda; un atteggiamento questo ultimo che, a mio avviso, si confà a quello della «gentile donna giovane e bella molto» della Vita nova (XXXV), la quale, affacciata alla finestra, ‘sceglie’ Dante (cfr. Cv. II II 2: «più da sua gentilezza che da mia elezione venne ch’io ad essere suo consentisse»), e lo innamora ‘mostrandogli’ la bellezza del suo volto: «Io venni a tanto per la vista di questa donna, che li miei occhi si cominciaro a dilettare troppo di vederla» (Vn. XXXVII) (cfr. Cv. II XV 7-8: «forte fu l’ora che la prima demonstrazione2 di questa donna entrò ne li occhi de lo ‘ntelletto mio, la quale fu cagione di questo innamoramento»). Per il significato di “finestra” come ‘mens contemplativa’ rimando alla mia «Presentazione» del volume del Grupo Tenzone Amor che movi tua vertù dal cielo, ed. de Carlos López Cortezo, Madrid, Departamento de Filología Italiana-Asociación Complutense de Dantología, 2011, pp. 6-7). NOTE «Nunc illud quaerimus, qualis sis amator sapientiae, quam castissimo conspectu atque amplexu, nullo interposito velamento quasi nudam videre ac tenere desideras, qualem se illa non sinit, nisi paucissimis et electissimis amatoribus suis. 1 236 Quaestionario T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:52 PÆgina 237 Quaestio nº 20 An vero si alicuius pulchrae feminae amore flagrares, iure se tibi non daret, si aliud abs te quidquam praeter se amari comperisset; sapientiae se tibi castissima pulchritudo, nisi solam arseris, demonstrabit?». A.- «[...] Quem modum autem potest habere illius pulchritudinis amor, in qua non solum non invideo caeteris, sed etiam plurimos quaero qui mecum appetant, mecum inhient, mecum teneant, mecumque perfruantur; tanto mihi amiciores futuri quanto erit nobis amata communior» (Soliloquiorum libri duo, 13.22 [PL 32]). Non va dimenticato a questo riguardo l’etimo di ‘demonstrazione’, così come che ‘demonstrare’, oltre il suo valore filosofico, significava anche «mostrarsi fisicamente manifestandosi nell’aspetto» (Tesoro della Lingua Italiana delle Origini). 2 CARLOS LÓPEZ CORTEZO 237 Quaestionario T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:52 PÆgina 238 Final T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:53 PÆgina 239 NORMAS DE PUBLICACIÓN 1. Los artículos serán originales, referidos a una investigación que verse sobre Dante y su obra, y tendrán una extensión no superior a 30 páginas tamaño A-4, con letra Times New Roman, 11 puntos, con interlineado 1,5, incluyendo notas (tamaño 10 puntos), cuadros y bibliografía. 2. El texto no llevará ningún tipo de formato ni tabuladores. Sólo se permitirán cursivas (nunca negritas) para títulos de libros y destacados. Las citas, si ocupan más de cuatro líneas, vendrán sangradas y en letra de 10 puntos. Si ocupan menos de cuatro líneas, irán como texto normal entre comillas bajas [« »]. Las comillas altas [“ ”] se reservarán para palabras con sentido trasladado y citas indirectas en español, mientras que en italiano para el sentido trasladado y las citas indirectas se usarán las comillas simples (‘ ’), quedando las comillas altas (“ “) sólo para citas dentro de citas. Las comillas bajas también se usarán en los títulos de artículos y capítulos de libros. Se usarán guiones de tipo medio (rayas) [ – ] para los incisos, y de tipo pequeño [ - ] para palabras compuestas y cifras. 3. Las notas se presentarán como notas finales. Sólo se insertarán notas para comentarios o añadidos, y nunca sólo para referencias bibliográficas escuetas. Éstas se harán en el cuerpo del texto, según el método anglosajón. Ejemplo: “En un reciente estudio (Pinto 2006: 122), se afirma que…”; o “Como afirma Pinto (2006: 122)…”. Lo mismo al final de una cita explícita. 4. La referencias bibliográficas aparecerán al final del artículo, ordenadas alfabéticamente, adecuándose a los siguientes ejemplos: ALIGHIERI, D. (2002): Rime, ed. nazionale a c. di D. De Robertis, Firenze, Le Lettere. CARDUCCI, G. (1942): «La canzone di Dante ‘Tre donne intorno al cor’», in ID.: Opere, ed. nazionale, Bologna, Zanichelli, vol. X, pp. 203251. 239 Final T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:53 PÆgina 240 MAZZONI, G. (1901): «Se possa essere il ‘Fiore’ di Dante Alighieri», in Raccolta di studi critici dedicata ad A. D’Ancona, Firenze, Barbera, pp. 657-692. PINTO, R. (2006): «Circe e la rotta di Ulisse», Tenzone 7, pp. 111-136. Nunca se hará la referencia por el editor del libro. Si se quiere citar una nota se hará así (De Robertis in Alighieri 2002: ad locum, 232). Las introducciones, prefacios, prólogos, etc., se considerarán como capítulos de libros. 5. Los artículos irán encabezados por el título, el nombre y apellido(s) del autor, la universidad o institución académica a la que pertenece, y la dirección de correo electrónico del autor. A continuación se incluirán dos resúmenes (abstracts) y dos listas con siete palabras clave (key words): en italiano y en inglés. La redacción de Tenzone traducirá los abstracts italianos al español en los artículos escritos en lengua italiana. 6. Los autores enviarán además su dirección postal y un número de teléfono, para eventuales necesidades de comunicación urgente. 7. Los artículos que no cumplan con todos los requisitos de formato y presentación podrán ser devueltos a sus autores. 8. Las fechas de recepción de artículos para cada número anual será entre el 1 de octubre del año anterior y el 1 de junio del año de publicación. El comité de redacción, a través del secretario de la revista, notificará a su autor, primero la recepción del artículo, y finalmente, antes del 15 de septiembre del año de publicación, la aceptación o no del mismo por parte del Comité Científico. En caso de no aceptación, se hará un informe de las causas de la misma. 9. La redacción de Tenzone se reserva el derecho a no enviar pruebas a los autores si las necesidades de publicación así lo exigiesen. En todo caso, dichas pruebas se enviarán en formato electrónico (Pdf). 10. Los autores tendrán derecho a un ejemplar del número. 11. El autor será el único responsable del contenido de su artículo. 240 Final T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:53 PÆgina 241 NORME DI PUBBLICAZIONE 1. Gli articoli saranno originali, riguardanti una ricerca su Dante e la sua opera e avranno un’estensione non superiore a 30 pagine formato A4, in Times New Roman corpo 11 interlinea 1,5, compresi note, tavole e bibliografia. 2. Il testo non dovrà avere nessun tipo di formato né di tabulazioni. Si permette solo la corsiva (ma non il grassetto) per titoli di libri e sottolineati. Le citazioni superiori a quattro righe andranno con il rientro e in corpo 10. Se sono inferiori a quattro righe, saranno in corpo 11 tra virgolette basse [« »]. Le virgolette basse si useranno anche per titoli di articoli e capitoli di libro. Per parole con senso traslato e citazioni indirette si useranno in spagnolo le virgolette alte [“ ”] e in italiano le virgolette semplici (‘ ’). Le virgolette alte (“ ”) si useranno in entrambe le lingue per citazioni all’interno di un’altra citazione. Si useranno trattini medi [ – ] per gli incisi e piccoli [ - ] per parole composte e cifre. 3. Le note si presenteranno a fine articolo. Si inseriranno note al pie’ solo per commenti o aggiunte, mai per meri riferimenti bibliografici. Questi ultimi si faranno nel corpo del testo, secondo il metodo anglosassone. Esempio: “in un recente studio (Pinto 2006: 122), si afferma …”; o “Come afferma Pinto (2006: 122)…”. Lo stesso alla fine di una citazione esplicita. 4. I riferimenti bibliografici appariranno alla fine dell’articolo, ordinati alfabeticamente, adegunadosi ai seguenti esempi: ALIGHIERI, D. (2002): Rime, ed. nazionale a c. di D. De Robertis, Firenze, Le Lettere. CARDUCCI, G. (1942): «La canzone di Dante ‘Tre donne intorno al cor’», in ID.: Opere, ed. nazionale, Bologna, Zanichelli, vol. X, pp. 203251. MAZZONI, G. (1901): «Se possa essere il ‘Fiore’ di Dante Alighieri», in Raccolta di studi critici dedicata ad A. D’Ancona, Firenze, Barbera, pp. 657-692. 241 Final T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:53 PÆgina 242 PINTO, R. (2006): «Circe e la rotta di Ulisse», Tenzone 7, pp. 111-136. Non si farà riferimento al curatore o editore di un testo. Se si vuol citare una nota si farà nel seguente modo: (De Robertis in Alighieri 2002: ad locum, 232). Introduzioni, prefazioni, prologhi ecc. si considereranno come capitoli di libro. 5. Gli articoli avranno come intestazione il titolo, il nome e cognome dell’autore, l’università o istituzione accademica di appartenenza e l’indirizzo elettronico dell’autore. Seguono riassunti (abstracts) e due elenchi di sette parole-chiave (key words), uno in italiano ed uno in inglese. La redazione di Tenzone tradurrà gli abstracts italiani allo spagnolo negli articoli scritti in lingua italiana. 6. Gli autori dovranno inviare inoltre il proprio indirizzo postale e un numero di telefono per eventuali necessità di comunicazione urgente. 7. Gli articoli che non soddisfino tutti i requisiti di pesentazioni potranno essere rimandati indietro. 8. Le date di ricezione degli articoli per ogni numero annuale andranno dal 30 ottobre dell’anno precedente alla pubblicazione al 30 aprile dell’anno di pubblicazione. Il comitato di redazione, attraverso il segretario, notificherà all’autore la ricezione dell’articolo e poi, prima del 15 di settembre dell’anno di pubblicazione, l’accettazione o meno dello stesso da parte del Comitato scientifico. In caso di mancata accettazione, lo si motiverà per iscritto. 9. La redazione di Tenzone si riserva il diritto di non mandare bozze agli autori se lo richiedono esigenze di pubblicazione. In ogni caso, le bozze si invieranno in formato elettronico (Pdf). 10. Gli autori avranno diritto a una copia del numero. 11. L’autore sarà l’unico responsabile del contenuto del proprio articolo. 242 Final T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:53 PÆgina 243 SOBRE TENZONE Tenzone es una revista de periodicidad anual, fundada en 2000 por la Asociación Complutense de Dantología como instrumento de comunicación científica en el campo de la dantología. Sus páginas están abiertas a todos los dantólogos, tanto de dentro como de fuera de España, y acepta trabajos en castellano, italiano y otras lenguas de amplia difusión. EDICIÓN: Asociación Complutense de Dantología. Departamento de Filología Italiana. Universidad Complutense de Madrid. CORRESPONDENCIA: Juan Varela-Portas, Asociación Complutense de Dantología, Departamento de Filología Italiana, Universidad Complutense, Ciudad Universitaria, 28430 Madrid. PÁGINA WEB: Pueden consultarse los números anteriores en http://www.ucm.es/info/italiano/acd/tenzone/index.htm (responsable Rosa Affatato). DEPÓSITO LEGAL: M- 39482-2000 ISSN: 1576-9216 MAQUETACIÓN: Juan Varela-Portas de Orduña. IMPRESIÓN: Reproducción Digital y Servicios CEMA. Tlfno: 915051498. VENTA Y SUSCRIPCIÓN: Rosa Affatato ([email protected] ) o en la dirección postal arriba indicada. PRECIOS: suscripción anual, 30 euros en España y 35 en el resto de países. 243 Final T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:53 PÆgina 244 Final T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:53 PÆgina 245 Final T 14:Maquetaci n 1 09/12/2013 11:53 PÆgina 246
Scarica

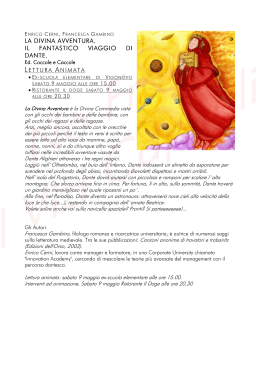




![La vita e le opere [g]](http://s2.diazilla.com/store/data/000077470_1-0bc6eda1b8dcb7194f6227736ad9e7e8-260x520.png)