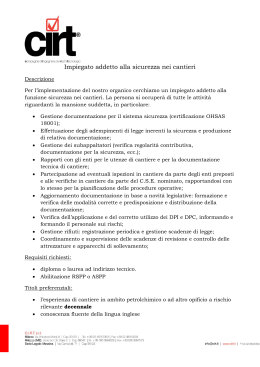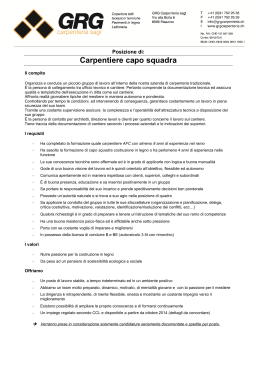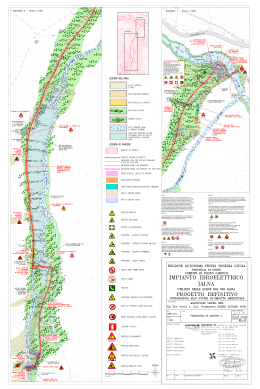Mirella Vedovetto OSSERVAZIONI, PRECEDENTI, FONTI FIDUCIARIE I PROCESSI DEL TRIBUNALE SPECIALE A VENEZIA (1931-1932) Osservazioni, precedenti, fonti fiduciarie INDICE DELLA TESI Introduzione I. UN PROCESSO 1. Le indagini 2. Gli arresti 3. Gli interrogatori 4. Due processi per un’unica attività sovversiva 5. La sentenza 6. Misure di polizia II. PROPAGANDA COMUNISTA 1. Da Parigi alle strade di Mestre 2. La circolazione della stampa 3. Alla Giudecca 4. Una tipografia clandestina a Venezia III. L’ATTIVITÀ COSPIRATIVA 1. Comunicazioni tra partito all’estero e funzionari in Italia 2. L’organizzazione comunista a Venezia 3. Cellule comuniste al Cantiere navale Breda di Porto Marghera 4. L’organizzazione comunista alla Giudecca IV. CENNI BIOGRAFICI DEGLI IMPUTATI Appendice 165 166 M. VEDOVETTO Sintesi della tesi La tesi prende in esame le indagini di polizia e il processo che portarono a individuare e reprimere un tentativo di organizzazione comunista tra il 1931 e il 1932, soprattutto nella provincia di Venezia, in un periodo in cui l’organizzazione all’estero cerca di stringere contatti e diffondere la propaganda, a partire dai luoghi di lavoro, in un paese in cui il regime ha chiuso ogni spazio di libertà. I capitoli della tesi analizzano il modo di procedere delle indagini, basate sulle “osservazioni”, ossia sul controllo a vista delle persone ritenute sospette, sul vaglio dei precedenti penali, e sui rapporti delle “fonti fiduciarie”, cioè dei confidenti di polizia. Scopo delle indagini era ricostruire una rete di relazioni: ed è questa rete che è diventata, di riflesso, oggetto d’indagine della ricerca storica. Sessantasette persone furono arrestate e subirono il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Alla fine, più della metà delle persone arrestate furono rimesse in libertà per insufficienza di prove, dopo un periodo di detenzione che andava dai due mesi a un anno. Gli altri furono condannati al confino, per periodi che variavano dai due ai cinque anni. Tutti continuarono a essere sorvegliati anche in seguito. Un secondo oggetto di indagine della tesi consiste nell’analisi della propaganda comunista, mediante opuscoli o manifestini importati da Parigi, il cui passaggio clandestino di mano in mano fa intravedere modalità e luoghi di contatto e di organizzazione – al lavoro, nelle strade, nelle osterie. In particolare viene preso in esame il tentativo di organizzazione all’interno del cantiere navale Breda a Porto Marghera. La tesi comprende infine le note biografiche dei militanti incontrati nel corso delle vicende, basate su fonti di polizia. RELATORE: Prof. Piero Brunello CORRELATORE: Prof. Alessandro Casellato ANNO ACCADEMICO: 2004-2005 Osservazioni, precedenti, fonti fiduciarie 167 INTRODUZIONE Le vicende raccontate in questa tesi si svolgono tra il 1931 e il 1932, soprattutto nella provincia di Venezia, ma anche in altre zone del Veneto. Tra agosto 1931 e marzo 1932 Aristide Martignetti inoltrò a Francesco Nudi i rapporti di cinque operazioni di polizia condotte nel Veneto che portarono all’arresto di cinque “interregionali”, com’erano chiamati i funzionari di partito mandati in Italia, e delle persone che questi contattarono. Gli arrestati, tra cui una donna, furono in tutto sessantasette e vennero denunciati al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Le accuse erano di ricostituzione del partito comunista, di partecipazione alle attività del partito clandestino, e di propaganda in suo favore; su alcuni pendevano anche tutte e tre le accuse. Il commissario Nudi era a capo del nuovo organo repressivo, l’Ovra, dipendente dal Ministero dell’Interno, creato sul finire del 1927 con lo scopo principale di combattere l’organizzazione comunista e i suoi tentativi di radicamento in Italia. Questi aspetti almeno furono prevalenti fino alla prima metà degli anni Trenta, fin quando l’attività clandestina fu più intensa. Le indagini potevano prendere il via da quelle che venivano chiamate “osservazioni”, ossia dal controllo a vista delle persone ritenute “sospette” sulla base dei loro precedenti penali e di coloro con cui entravano in contatto. Nel primo capitolo di questa tesi ho preso in considerazione uno dei quattro processi studiati e ne ho descritto le varie fasi dalle indagini, agli arresti, alle sentenze emanate nei confronti degli imputati. Nel processo che ho scelto di descrivere vennero abbinati due procedimenti penali, poiché gli imputati dell’uno e dell’altro furono ritenuti partecipi di un’“unica attività sovversiva”. Dai rapporti di Martignetti risulta evidente come il controllo da parte della polizia venisse esercitato sulla singola persona di solito da un solo agente, la cui sorveglianza poteva essere più o meno “stretta”, a seconda dell’atteggiamento più o meno “sospetto” dell’individuo. Il sorvegliato non veniva perso d’occhio nei suoi spostamenti; se prendeva contatti più di una volta con una stessa persona, anche a questa veniva affibbiato un agente; si prendeva nota dei luoghi in 168 M. VEDOVETTO cui si recava, delle vie attraversate e delle soste e, se si riusciva a captare qualcosa dei discorsi scambiati, anche qualche frase ascoltata. Ogni particolare veniva annotato, anche quelli che potevano sembrare insignificanti. Per chi seguiva le indagini dall’alto – Nudi ad esempio che poteva leggere più di un rapporto di polizia –, il singolo particolare era un tassello di un quadro più ampio dell’attività clandestina del partito. Anche per me, che ho potuto confrontare le fonti relative a più procedimenti penali, alcune note presenti nei rapporti sono state utili per ricostruire una rete di relazioni tra le persone implicate anche in processi diversi. Ho deciso di descrivere soltanto un procedimento penale perché esemplifica l’iter processuale seguito anche dagli altri. In particolare ho dedicato un capitolo proprio al processo che vide come imputati principali Luigi Orlandi e Giovanni Contavalli perché è il primo che ho consultato nella mia ricerca. È dagli incartamenti relativi a questi due processi che ho desunto i nomi che mi hanno portato a consultare i fascicoli degli altri tre procedimenti penali. Tutte le persone arrestate, la maggior parte nella provincia di Venezia, furono accusate di svolgere attività clandestina in favore del partito comunista, in particolare attraverso la diffusione di manifestini firmati dal Pcd’I. Gli arrestati, tra cui una sola donna, avevano un’età compresa tra i 19 e i 59 anni, ma prevale il gruppo di coloro che avevano tra i 24 e i 28 anni nel 1931. Tra questi, diciotto erano già noti alla polizia come comunisti prima della loro denuncia nel 1931 o 1932 poiché avevano aderito al partito dalla sua costituzione nel 1921. Quattro erano stati schedati come socialisti. Per due persone si specifica che erano passate, nel 1921, dal partito socialista a quello comunista. Uno, Antonio Fagarazzi, era schedato come anarchico. Queste persone avevano tutte più di 25 anni, e fu con alcune di loro che i funzionari di partito provenienti da Parigi presero i primi contatti. Le altre quarantuno persone arrestate, il cui orientamento politico era sconosciuto alla polizia, avevano un’età compresa tra i 19 e i 49 anni, ma prevalgono coloro che avevano meno di 30 anni. Le persone contattate dagli “interregionali” a loro volta cercavano altre persone da far aderire al movimento clandestino, rivolgendosi di preferenza agli ex compagni di partito. Infine venivano coinvolte anche persone che non avevano svolto attività politica in passato, ma erano comunque individui che già si conoscevano perché vicini di casa o colleghi di lavoro. La loro collaborazione era preziosa perché non sospetti alla polizia, e quindi erano preferiti per incarichi di tipo pratico come la stampa dei volantini, o la loro custodia. Gli “interregionali” inviati nel Veneto nell’ordine di arrivo furono: Vincenzo Bianco di Torino; Venceslao Usaj nato a Cormons, Giacomo Grai da Novara e Paolo Scarpone da Torino, che furono inviati tutti e tre assieme in Italia; infine Luigi Orlandi, bolognese. Vincenzo Bianco e Luigi Orlandi fecero in tempo, prima di venire arrestati, a prendere contatti con persone residenti nella regione. Osservazioni, precedenti, fonti fiduciarie 169 Quarantasette abitavano in provincia di Venezia: undici erano di Mestre (un paio abitavano nelle case operaie di via Pepe), Porto Marghera, Favaro Veneto, Campalto e Carpenedo; dieci abitavano nel sestiere di Cannaregio; sei a Castello; tre in quello di Dorsoduro; tre a San Polo e altri tre a Santa Croce; in nove infine abitavano alla Giudecca. Ruggero Pavanello si era trasferito da Castello alla Giudecca; Girolamo Tescari dopo aver vissuto per un breve periodo a Torino, tornato a Venezia, aveva trovato alloggio alla ex Caserma dei Gesuiti a Cannaregio, ricovero degli sfrattati. Com’è noto, i sestieri di Castello, Cannaregio, Dorsoduro e l’isola della Giudecca, zone periferiche della città di Venezia in cui si addensavano i ceti popolari, “risultavano ai primi posti in tutti gli indicatori di subalternità sociale”, ed erano state “le aree di maggior radicamento socialista prima e subito dopo la guerra”1. Sette tra le persone arrestate erano dalla provincia di Padova e otto da quella di Treviso. Tutti questi militanti, tranne due studenti universitari2, facevano lavori manuali quando potevano, ma spesso restavano disoccupati. Due erano laureati in legge e facevano praticantato presso un avvocato3. Tutti gli altri avevano frequentato la scuola elementare, la maggior parte fino alla classe terza, e non avevano proseguito gli studi. Nel periodo preso in considerazione, la disoccupazione era diffusa e anche le fonti consultate lo dimostrano. Nonostante la propaganda del regime tendesse a nascondere la crisi economica, le cose stavano diversamente: le stesse persone arrestate, durante gli interrogatori, rivelano che il tema principale dei loro discorsi era la disoccupazione, quasi per provare che non si parlava di argomenti segreti, ma alla conoscenza di tutti. Le vite di queste persone rivelano che il posto di lavoro era precario e la disoccupazione diffusa. A periodi in cui si aveva un posto di lavoro fisso se ne alternavano altri in cui ci si arrangiava facendo piccoli mestieri per i vicini o cambiando completamente tipo di occupazione. Per ognuno comunque è possibile indicare il mestiere praticato tra un periodo e l’altro di disoccupazione. Ventotto erano operai4. Tra questi, otto risiedevano a Mestre, Marghera, Campalto; diciassette a Venezia: dieci si spostavano per raggiungere ogni giorno gli stabilimenti di Porto Marghera, gli altri lavoravano alla Giudecca. Operai erano stati anche i tre “interregionali” Vincenzo Bianco, Luigi Orlandi e Paolo Scarpone per il tempo in cui avevano risieduto in Italia prima 1 A. Casellato, I sestieri popolari, in Storia di Venezia. L'Ottocento e il Novecento, II, a cura di M. Isnenghi, Roma 2002, p. 1590. 2 Carlo Vestidello studiava legge e Mario Pastrello fisica, tutti e due frequentavano l’università a Padova. 3 Erano Enrico Longobardi e Giovanni Giavi. 4 Tra questi, 15 lavoravano al cantiere navale Breda di Porto Marghera, 4 ai “Cantieri Navali e Acciaierie” alla Giudecca e 3 nella fabbrica Sava sempre a Porto Marghera. 170 M. VEDOVETTO di espatriare a Parigi, o in Russia come Bianco; Giacomo Grai invece aveva fatto il muratore, e Venceslao Usaj il meccanico. Tra le persone arrestate vi erano poi quattro muratori; tre agenti di commercio, professione sospetta alla polizia perché richiedeva molti spostamenti e quindi la possibilità di prendere contatti con persone in varie città giustificandoli con la propria professione. Tre erano falegnami. Due facevano i barbieri e quattro i baristi, quindi lavoravano in luoghi di ritrovo e in cui si scambiavano discorsi. Vi erano anche due tipografi che misero a disposizione la propria esperienza per insegnare come si stampava con i poligrafi. Infine i rimanenti quindici praticavano vari mestieri: fornaio, macellaio, elettricista, cartolaia, materassaio, tappezziere e altri ancora. Queste persone, tranne quattro che espatriarono clandestinamente in Francia risultando latitanti, vennero tutte arrestate e denunciate al Tribunale Speciale. Trentadue degli arrestati vennero rilasciati per decisione della commissione istruttoria che giudicò insufficienti le prove per sostenere le accuse. La loro detenzione preventiva andò dai due mesi a un anno. Cinque tra questi vennero comunque destinati al confino per decisione della commissione provinciale. Tredici vennero rimessi in libertà in virtù dell’amnistia emanata con decreto regio il 5 novembre 1932, in occasione del decennale della marcia su Roma5. Il decreto influì anche sulla durata del periodo di confino: coloro che erano stati condannati a due anni di confino vennero fatti rimpatriare dopo quattro o cinque mesi. Solo Antonio Scapin rimase confinato per 5 anni. L’amnistia ridimensionò, in alcuni casi, anche la durata di detenzione cui erano stati condannati, con sentenza del Tribunale Speciale, diciotto delle persone arrestate. Chi venne condannato a un anno di carcere scontò per intero la pena e furono: Cunial, Biasutto, Ferialdi, Menegazzo, Pavanello, Puggiotto e Zaccolin. Altieri, Pelizzato e Sambo, condannati a 3 anni di detenzione vennero rilasciati dopo 1 anno e 4 mesi. A Memmo e Stefani venne comminata una pena di 4 anni di reclusione ma vennero rimessi in libertà dopo 1 anno e 4 mesi dal loro arresto. Sandi venne trattenuto in carcere per 2 anni anziché 5; Orlandi per 4 invece di 9. Grai e Scarpone scontarono 2 anni e 4 mesi di carcere: il primo era stato condannato a 10, il secondo a 12 anni. Usaj tornò in libertà dopo 3 anni dal suo arresto, mentre avrebbe dovuto scontarne 12. Bianco, condannato a 11 anni e 9 mesi, venne scarcerato anche lui dopo 3 anni. Su tutte e sessantasette le persone la vigilanza della polizia continuò anche negli anni successivi alla loro scarcerazione. 5 Regio Decreto 5 novembre 1932, n. 1403 “Concessione di amnistia e indulto nella ricorrenza del I decennale” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 7 novembre 1932. Osservazioni, precedenti, fonti fiduciarie 171 L’attività che portò al loro arresto, o perlomeno quella che è possibile desumere dalle fonti processuali, fu di due tipi: la stampa e diffusione di manifestini firmati dal partito comunista, e il tentativo di ricreare organizzazioni per la ricostituzione del partito, come cellule di strada o di fabbrica. Per questo ho dedicato il secondo capitolo alla descrizione della propaganda attraverso la diffusione di opuscoli o manifestini importati da Parigi, raccontando come venivano stampati e diffusi. Attraverso il passaggio di mano in mano di un foglietto è possibile ricostruire la rete delle persone che lo ricevettero, lo lessero e lo rimisero in circolazione. In un solo caso però il racconto comincia dalla stampa e termina con la diffusione; negli altri sono riuscita a ricostruire solo pezzi di questa rete. Non credo che la frammentarietà dipenda soltanto dall’impossibilità, sulla base delle fonti che ho consultato, di reperire ulteriori informazioni: la frammentarietà del racconto rispecchia infatti quella delle relazioni tra persone ritenute avverse al regime. L’azione della polizia politica, con la vigilanza esercitata, con gli arresti e le altre misure adottate mirava a spezzare i legami tra gli individui al di fuori degli spazi organizzati dal regime: l’incontro tra due o più operai, ad esempio, destava sospetto. Spesso si ritrovavano all’osteria, oppure lungo le strade o calli dato che, come visto, molti di loro abitavano negli stessi sestieri. Alla Giudecca punto di incontro era il Campo di Marte, attorno al quale abitava la maggior parte degli arrestati residenti sull’isola. Altri luoghi di incontro e conoscenza tra gli operai erano l’ufficio di collocamento e le stesse fabbriche in cui lavoravano. Proprio una fabbrica, quella del cantiere navale Breda a Porto Marghera, e il campo di Marte alla Giudecca sono gli scenari del terzo capitolo, in cui descrivo tentativi di organizzare strutture per la ricostituzione del partito comunista. Si tratta di cellule comuniste, e sembra che ne fossero state create all’interno della Breda: almeno così comunicarono “fonti fiduciarie” alla polizia e sembrava che lo avessero testimoniato anche Bianchi e Stuppioni, operai al cantiere. In seguito però sostennero che nei verbali era stato travisato quanto avevano deposto. Infine riporto un indice dei nomi corredato di note biografiche dei militanti incontrati nel corso del racconto e di pochi altri nomi estrapolati dalle fonti. I cenni sulla loro vita sono tutti desunti dalle fonti di polizia: verbali di interrogatori, fascicoli del Casellario Politico Centrale, rapporti di polizia e, quando presenti, lettere di mogli o madri inviate al capo del governo per chiedere la scarcerazione del marito o figlio e allegate ai fascicoli processuali, oppure lettere inviate dagli espatriati alle proprie famiglie e sequestrate dalla polizia. Notizie parziali, che non rendono conto di una vita. Le informazioni sono quelle che alla polizia interessava registrare. Mentre scrivevo queste brevi note biografiche vedevo comunque emergere alcuni aspetti in comune nella vita di queste persone. La maggior parte di loro era sposata e aveva figli, altre vivevano ancora con i genitori e i fratelli. Tutti comunque avevano una famiglia, spesso numerosa, da 172 M. VEDOVETTO mantenere. Compito reso difficile non solo dalla precarietà del posto di lavoro e dal salario basso: spesso le famiglie erano ridotte alla fame anche per le misure di polizia cui veniva sottoposto chi le manteneva, e alcune dovevano ricorrere all’assistenza degli enti di beneficenza. La maggior parte delle persone coinvolte nei processi che ho descritto hanno subito più di un provvedimento di polizia, sia prima sia dopo il 1932, dal carcere al confino. Le persone “sospette” erano continuamente sorvegliate. Per loro diventava quasi impossibile creare relazioni stabili: la polizia mirava infatti a spezzare i legami creati all’esterno delle strutture di aggregazione del regime. Nelle schede del Casellario si trovano espressioni come “conduce vita appartata”, e questo era inteso come una nota abbastanza positiva sulla condotta tenuta dall’individuo; quando però si legge “partecipa alle manifestazioni indette dal regime” o “ossequiante alle direttive del regime” allora, probabilmente, la persona alla quale erano rivolte sarebbe stata radiata dal Casellario. Alcune delle persone arrestate, negli interrogatori, descrivevano la loro buona condotta assicurando che la sera, dopo il lavoro, non frequentavano compagnie ma restavano in casa. Assicuravano di non parlare di politica quando si trovavano tra di loro, ma delle condizioni dei lavoratori: l’argomento li riguardava, si sentivano autorizzati a discuterne e, tra le tante cose che negano nel corso degli interrogatori, questa è una delle poche che rivelano, quasi come giustificazione. Tutti gli interrogatori rivelano la capacità degli interrogati di negare ogni cosa, anche sotto le pressioni esercitate dagli agenti, talvolta anche di fronte a contestazioni basate su prove. Ciò che veniva usato come giustificazione è allora rivelatore di cosa loro ritenessero lecito fare o meno. Era ritenuto pericoloso parlare di “politica”. Come visto però non erano considerati argomenti inerenti la politica la disoccupazione o le difficili condizioni di vita dei lavoratori: lo diventavano quando ne veniva attribuita la responsabilità al regime. Era politica fare propaganda: e infatti tutti negarono di averne svolta in favore del partito comunista. Gli interrogati preferivano dire di non avere amicizie, di non frequentare compagnie, di rientrare in casa subito dopo il lavoro, di pensare solo a questo e alla famiglia. La ricerca di un lavoro era utilizzata da alcuni anche per giustificare l’espatrio clandestino in Francia. In molti ci andarono, alcuni vi rimasero per lunghi periodi, altri tornarono dopo poco perché la mancanza di documenti d’identità rendeva difficile la possibilità di venire assunti. Coloro che vissero in Francia spesso andavano ad abitare negli stessi quartieri dei connazionali espatriati; alcuni presero parte alle attività del partito; quelli che trovavano un lavoro, mandavano parte dei soldi guadagnati alla famiglia rimasta in Italia, quando non venivano raggiunti da moglie e figli. Alcuni piccoli dettagli fanno capire che la vita che si conduceva era all’insegna dell’economia: c’è chi tiene una capra e un orto a Mestre e chi si porta al lavoro il pasto da casa per risparmiare. Osservazioni, precedenti, fonti fiduciarie 173 Il ruolo delle donne infine appare marginale: non sembra che venissero informate dal marito sull’attività svolta. Solo in un caso una donna, Arpalice Orcali, viene portata in carcere insieme al marito. Nella loro casa avevano ospitato Vincenzo Bianco, ma lei assicurò che le era sempre stato risposto che non era affare suo sapere chi fosse quell’uomo. Irma Caburlotto, moglie di Bruno Gucchierato, svolse attività politica ma solo quando visse in Francia. Le vicende raccontate in queste pagine potrebbero suggerire altre riflessioni. Nella stampa comunista e nelle canzoni si potrebbero rintracciare ad esempio il mito dell’Unione sovietica e i temi della propaganda che il partito cercava di far arrivare da Parigi in Italia; oppure si potrebbe mettere in evidenza quanto la speranza nel futuro nella vittoria del proletariato abbia agito su operai e artigiani, ma anche su giovani intellettuali, che aspettavano la prossima crisi del capitalismo e quindi del fascismo; oppure si sarebbe potuto ricostruire la linea politica del partito, in un periodo in cui si stava trasformando. Ho preferito invece da un lato i meccanismi di controllo, di sorveglianza e di repressione messi in atto dagli apparati polizieschi del regime e dello Stato; dall’altro lato ho cercato di indagare come i militanti cercavano di dar vita a un’attività cospirativa clandestina in un contesto, com’è quello dei primi anni Trenta, segnato dalla paura (ma si potrebbe dire certezza) di finire in carcere e al confino6. La documentazione relativa ai processi presi in esame si trova conservata presso l’ACS, Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato [TSDS], bb. 375, 383, 392, 431, 432, 442, 444. 6 174 M. VEDOVETTO III L’ATTIVITÀ COSPIRATIVA 3. Cellule comuniste al Cantiere navale Breda di Porto Marghera7 Conversazioni Alla polizia politica giunse notizia che Sandi, Pavanello e Bianchi, tutti operai al cantiere Breda, svolgevano propaganda comunista in quella fabbrica non soltanto durante le ore di lavoro e nei reparti ai quali erano addetti, ma anche quando si riunivano nella mensa dello stabilimento, in un tavolo appartato, al quale prendevano posto altri operai e la sera, dopo il lavoro e in particolare di sabato, all’osteria di Cerato vicino al passaggio a livello di Mestre. Venne riferito anche che fra gli operai del cantiere era stato raccolto denaro per le vittime politiche; che nei vari reparti, nei bagni e sui battelli in costruzione per l’Unione Sovietica venivano trovati ogni giorno scritte o simboli comunisti disegnati con gesso, con vernice, o con strumenti a punta. Inoltre sembrava, ma non venne confermato, che Giorgio Sandi avesse trovato l’alloggio per l’equipaggio russo arrivato per ritirare il piroscafo “Gaga” dal cantiere, e l’avesse trovato nel caffè della zia Anna Sitran. Sempre queste “fonti fiduciarie”, confidarono che alla cerimonia per il varo Pavanello, Sandi, Bianchi e una cinquantina di altri loro compagni avevano acclamato alla bandiera sovietica issata a bordo delle imbarcazioni. Infine, era stato notato Antonio Dogà, pure lui operaio al cantiere Breda, mentre girava per lo stabilimento con disegnati sulle spalle una falce e martello in gesso. Contavalli rivelò, negli interrogatori a cui fu sottoposto, che Pavanello e Sandi una volta gli avevano confidato che all’interno del cantiere in cui lavoravano erano state organizzate delle cellule, tutte composte di “vecchi sovversivi”. Altre deposizioni vennero fatte da Ives Stuppioni, operaio da un anno alla Breda, che viveva a Mestre. Non aveva precedenti politici, però era stato visto spesso in 7 La documentazione si trova in ACS, TSDS, b. 432. La busta contiene i fascicoli del procedimento penale; gli esami testimoniali, tra cui la deposizione di Lapasin citata nel testo; i fascicoli personali degli imputati, nominati nel capitolo, con i verbali dei loro interrogatori. Osservazioni, precedenti, fonti fiduciarie 175 compagnia di Giovanni Bianchi, operaio nello stesso cantiere, anche all’esterno della fabbrica: il 9 marzo 1932, quindi, venne arrestato. Nell’interrogatorio, Stuppioni fece importanti rivelazioni sull’esistenza e sulla composizione delle cellule comuniste nello stabilimento in cui lavorava, ma in seguito, quando il giudice istruttore gli mostrò la sua dichiarazione, negò tutto, dicendo che aveva dovuto firmare, ma “soltanto ora rilevo che contiene informazioni che io non ho mai fatte”. In quel primo interrogatorio Stuppioni avrebbe deposto che nel cantiere erano state costituite tre cellule: una nel “reparto montaggio e scali”, di cui facevano parte Mario Hönl, che ne era il capo, oltre a Emilio Gasparon e a Domenico Guadagnin; la seconda nell’officina “fabbri e carpentieri”, con a capo Mario Ballarin e composta da Giovanni Tomè e altri due carpentieri di cui non sapeva il nome, ma in seguito identificati per Agostino Molin e Giacomo Sinibaldi; la terza nell’officina “meccanici” della quale conosceva soltanto uno dei componenti: Flaminio Rossetti. Avrebbe aggiunto che secondo lui il segretario di cellula nel cantiere Breda era Mario Ballarin, sia per i discorsi che gli aveva sentito scambiare con Bianchi, Pavanello e Sandi, sia perché nelle ore di lavoro si dava spesso appuntamento con Bianchi ai bagni, poiché lavoravano in reparti diversi. Di fronte al giudice, come si è detto, Stuppioni corresse queste deposizioni. Disse di non averle mai rilasciate in quella forma, e ammise solo di aver dichiarato che era sua convinzione che Giovanni Bianchi fosse capo settore del cantiere, ma di non esserne sicuro. A quell’interrogatorio aveva soltanto fatto i nomi di chi lavorava nell’officina fabbri e nell’officina montaggi e scali; aveva sì detto che in quella meccanici vi era un tornitore che lavorava accanto al tornio di Pavanello ed era molto amico di Bianchi, ma non aveva mai dichiarato che quegli operai costituivano le cellule dei rispettivi reparti. Negò poi di aver fatto il nome di Mario Ballarin e di aver parlato invece di Enrico Ballarin, il fratello, soltanto per indicarlo come uno degli operai dell’officina fabbri. Mai infine aveva detto che Domenico Guadagnin era membro di una cellula; al contrario affermò che, essendo stato di recente nominato capo operaio, si teneva per “ragione di prestigio” appartato dagli operai. Giovanni Bianchi, già schedato in precedenza dalla polizia e con esperienza di confino, è l’altro imputato che rilasciò le deposizioni più importanti sul movimento comunista all’interno del cantiere. Nel corso dei suoi interrogatori disse di sapere che Pavanello professava idee comuniste, che era già stato processato al Tribunale Speciale e sottoposto ad ammonizione per motivi politici, e che era ancora impegnato nel movimento comunista. Nell’agosto o settembre precedenti Pavanello gli aveva confidato che a Venezia era stata costituita un’organizzazione comunista che contava un comitato e dei settori, e che bisognava darsi da fare per creare un settore anche nel cantiere Breda dato l’alto numero di operai che vi lavoravano: gli aveva proposto di assumersene lui l’incarico. Bianchi gli aveva risposto che non aveva assolutamente intenzione di immischiarsi ancora in quelle faccende. Pavanello però era stato insistente, e 176 M. VEDOVETTO poi alle sue richieste si erano unite anche quelle di Sandi: gli aveva detto che se non voleva occuparsi in prima persona dell’organizzazione del movimento all’interno del cantiere, che trovasse almeno qualcuno di fidato, non sospetto alla polizia: “ma io gli risposi – raccontò Bianchi alla polizia – che non sapevo a chi rivolgermi, e che dal momento che anche lui era occupato nello stesso stabilimento avrebbe potuto personalmente vedere a chi poteva rivolgersi”. Anche Bianchi, come Stuppioni, elencò alla polizia i reparti in cui era suddiviso il lavoro al cantiere: quello dei “falegnami e modellisti”; dei “carpentieri e fabbri”; dei “meccanici”; il “reparto segheria” e quello “scalo e demolizione navi”. Ogni operaio, spiegò, svolgeva il suo mestiere in un singolo reparto, ma tutti si dovevano spostare spesso per lavorare negli scali o sui battelli. Bianchi lavorava quasi sempre all’aperto, sulle navi in costruzione per conto della Russia; Pavanello era addetto all’officina meccanici; Sandi aveva lavorato in officina e sui primi tre battelli russi; Ballarin e Tomè nell’officina fabbri e anche loro sui battelli russi. Allo stesso interrogatorio Bianchi avrebbe anche detto (ma pure lui al giudice istruttore negò di aver mai fatto simili deposizioni) che seguendo le istruzioni del partito, Pavanello aveva creato la cellula dell’officina meccanici; Sandi e Hönl quella sui battelli russi Ballarin e Tomè la cellula dell’officina fabbri; Stuppioni, Gasparon e Guadagnin quella dell’officina carpentieri. Il prefetto, nella sua denuncia, prese per buone le deposizioni rese da Bianchi sulle cellule interne al cantiere e le integrò con quelle di Stuppioni: entrambe le dichiarazioni, come si è detto, furono successivamente smentite dagli imputati di fronte al giudice istruttore. Queste rivelazioni infatti confermavano le notizie già in possesso della questura. Il prefetto escluse solo i nomi di coloro che ricoprivano cariche più alte nel partito, incompatibili con quella di membro di cellula, e indicò perciò i seguenti operai come componenti delle cellule: Mario Ballarin, Mario Hönl, Giacomo Sinibaldi, Flaminio Rossetti, Domenico Guadagnin, Agostino Molin, Emilio Gasparon, Antonio Dogà, Ives Stuppioni e Giovanni Tomè. Ballarin, indicato sia da Stuppioni che da Bianchi come membro della cellula del reparto fabbri e carpentieri, negò di farne parte, ma il prefetto non prestò fiducia alla sua deposizione e lo indicò come “sovversivo accanito e irriducibile”. Tutti dichiararono che quelle deposizioni erano false, ma a quel punto la polizia aveva in mano la lista che cercava. Dalle dichiarazioni di Giovanni Bianchi possiamo conoscere il tono delle conversazioni tra operai comunisti alla Breda. Gli era capitato per esempio di sentire Pavanello e Sandi criticare il regime fascista e affermare che “esso opprimeva il proletariato il quale aveva perduto ogni libertà, era fatto segno alla reazione e alla persecuzione mediante arresti, processi, condanne e deportazioni, che le condizioni economiche degli operai erano peggiorate con la riduzione delle paghe e con l’aumento della disoccupazione e sosteneva[no] perciò la necessità da parte degli operai di tenersi uniti e compatti per attendere l’occasione propizia per la sostituzione del Regime”. Osservazioni, precedenti, fonti fiduciarie 177 Bianchi fece alcuni nomi – Ballarin, Tomè, Hönl, Gasparon e Stuppioni – di operai che condividevano amicizia e idee con Pavanello e Sandi. Di solito si ritrovavano nella cantina dello stabilimento. Bianchi ricordava di esserci andato anche lui a bere un bicchiere di vino, e di aver partecipato ad alcune loro discussioni, esprimendo il proprio parere ma, precisò, senza mai svolgere propaganda. Aveva ascoltato Pavanello e Sandi lamentarsi che “i risultati dell’organizzazione della propaganda fossero alquanto fiacchi non solamente nello stabilimento, ma anche a Venezia”, attribuendo ciò “a timore o trascuratezza da parte dei compagni incaricati dell’organizzazione e della propaganda”. Bianchi ricordò di aver risposto che “oggi il proletariato attraversa un periodo di disorganizzazione e di demoralizzazione”, e che perciò, per quanto lo riguardava, date “le difficoltà per far fronte ai bisogni quotidiani”, non se la sentiva d’impegnarsi in un’attività politica, “specialmente in considerazione del pericolo che essa oggi presenta”. Gli altri operai concordavano con lui: erano anch’essi titubanti a impegnarsi in un’attività che poteva rivelarsi pericolosa; si parlava soprattutto della questione economica “che è quella che attualmente interessa tutti e specialmente noi operai”, ricordò Bianchi. In un interrogatorio Bianchi avrebbe affermato di aver dato istruzioni e consigli per l’organizzazione della propaganda, l’unico compito che potesse svolgere secondo le direttive del partito in quanto ex confinato. Ma al giudice assicurò di non aver mai rilasciato quelle deposizioni e disse di averle sottoscritte “perché mi trovavo in uno tale stato di depressione morale e fisica che non ebbi la forza di oppormi all’invito di firmarle, fattomi dal funzionario”. I discorsi tenuti in mensa, ribadiva al giudice, non erano di propaganda ma discussioni in cui ognuno esponeva la propria idea e si scambiavano pareri; talvolta si riprendeva a discutere la sera, dopo il lavoro, quando quegli operai si riunivano all’osteria di Cerato dove però lui, a suo dire, in due anni che lavorava al cantiere Breda era andato soltanto due o tre volte, e sempre da solo. Che il luogo di conversazioni tra gli operai comunisti fossero “la cantina” della Breda all’ora di colazione e l’osteria di Cerato finito il lavoro, è testimoniato anche dalle dichiarazioni di Stuppioni. Era lì che ci si incontrava, e ci si lamentava che il fascismo “aveva peggiorate le loro condizioni economiche e morali colla riduzione dei salari e coll’aumento della disoccupazione”. Tutti gli imputati negarono le accuse loro rivolte, affermando di non frequentare compagnie e di non partecipare ai discorsi tra operai, confermando cioè l’immagine del buon operaio voluta dal fascismo: frequentare l’osteria sì, ma solo per un bicchiere di vino; nessuna discussione politica; nessuna frequentazione sospetta; capi operai con capi operai, senza mescolanza di gradi; merenda sul luogo del lavoro; in osteria solo di passaggio, per un bicchiere di vino, sulla strada di casa; badare ai fatti propri. Ballarin, interrogato, disse che durante l’ora della “colazione” era solito trattenersi in officina per consumare il pasto che si portava da casa e quindi, anche 178 M. VEDOVETTO per risparmiare, non frequentava la “cantina” dello stabilimento. La sera, uscito dal lavoro, di solito non si fermava da nessuna parte; solo qualche volta, e soprattutto il sabato, prendeva un bicchiere di vino all’osteria di Cerato, ma ci andava sempre da solo sebbene fosse frequentata anche da altri operai del suo stesso cantiere; aggiunse che non era solito frequentare compagnie: non aveva amicizie, e quindi la sera non usciva con nessuno. Anche Tomè disse di non frequentare la mensa del cantiere; ammise solo di essere andato talvolta all’osteria di Cerato in compagnia di Ballarin, dove gli era capitato di incontrare Pavanello, Bianchi, Hönl, Gasparon, Guadagnin e Sandi. Mario Hönl ricordò di aver conosciuto Ballarin quando entrambi lavoravano in una cooperativa per lo smantellamento delle navi, e di essersi ritrovati poi al cantiere Breda. Conosceva anche Tomè, amico d’infanzia, Gasparon che aveva lavorato insieme a suo padre, e Guadagnin di cui era stato compagno sotto l’esercito e ora nel lavoro; disse di conoscere Pavanello, Bianchi, Sandi e Stuppioni “com’era naturale”, commentò, dal momento che lavoravano nello stesso cantiere, ma di non aver stretto amicizia con nessuno, e di non conoscere né i loro precedenti né le loro idee politiche. Disse che era solito pranzare sul posto di lavoro; raramente andava in mensa, oltretutto non poteva bere vino per un’operazione subita al piloro. Gli era capitato, un paio di volte, di incontrare Ballarin e Gasparon all’osteria di Cerato, ma non sapeva dire se fossero lì per “scopi politici”. Finito di lavorare rincasava “senza mai frequentare esercizi pubblici e compagnie di estranei”. Domenico Guadagnin era capo operaio nell’officina “costruzioni navali” dello stabilimento, dove lavorava anche suo padre. Proprio per la carica che ricopriva pensava di aver attirato le antipatie di qualcuno e così giustificava le accuse che gli erano state rivolte, forse “per aver dovuto adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti che mancavano del loro dovere”. Aveva per esempio dato una punizione a Ives Stuppioni e cambiato di reparto Giovanni Bianchi che forse di questo si era dispiaciuto; ma, commentò Guadagnin, il suo comportamento rientrava nelle pratiche per migliorare lo “sfruttamento delle varie abilità”. Sempre perché capo operaio, per “ragioni di prestigio e di disciplina”, disse di essersi tenuto sempre appartato dai “semplici operai” e così pranzava nella cabina dell’officina insieme al capo cantiere e talvolta insieme ad altri capi operai; la mensa quindi non la frequentava più da un anno, a meno che non fosse per bere un bicchiere di vino. Si fermava talvolta anche all’osteria di Cerato, ma mai vi si era intrattenuto con operai del cantiere. Guadagnin ammise anche di aver notato le scritte sui muri dello stabilimento, ma di non averne informato i dirigenti. Interrogato dal giudice, si giustificò dicendo che non pensava fosse compito suo denunciarle dal momento che non era tra i capi operai più anziani. Raccontò poi alcuni episodi per dimostrare quali fossero i suoi reali sentimenti e quanto fosse assurda l’accusa di appartenere al partito comunista: quando venne varato il piroscafo russo chiese un pezzo del tricolore cui era legata la bottiglia di spumante utilizzata per battezzare Osservazioni, precedenti, fonti fiduciarie 179 la nave e, sempre in quell’occasione, fu proprio lui a issare a poppa la bandiera italiana: “tali fatti ancor che di lieve importanza – disse – stanno a dimostrare quali siano i miei sentimenti e quanto sia assurda l’accusa di appartenere al partito comunista”. Emilio Gasparon aveva lavorato all’Arsenale Marittimo come calderaio per circa 25 anni, poi nel 1923 era stato licenziato per riduzione di personale; quindi aveva trovato lavoro come portinaio alla casa di ricovero israelitica, e da circa un anno lavorava al cantiere Breda. Alla polizia disse di aver notato che Pavanello e Bianchi all’ora della “colazione” andavano nella cantina dello stabilimento e che a loro si univano Tomè, Ballarin e Hönl; anche lui spesso andava alla mensa però, disse, si teneva lontano da quel gruppo e quindi non sapeva che discorsi facessero. Spesso vide che gli stessi dopo il lavoro, la sera, si ritrovavano all’osteria di Cerato a bere e discutere: pure lui ci andava, ma nemmeno qui stava in loro compagnia. Al giudice disse che, oltre a non interessarsi alle loro discussioni, non avrebbe nemmeno potuto sentire quanto dicevano perché, “a causa del mio mestiere – sottolineava – sono da vari anni affetto da sordità per cui non sempre riuscivo a distinguere le loro parole tanto più che i loro discorsi avvenivano nell’interno dello stabilimento fra il rumore causato dal lavoro e dall’andirivieni degli operai, e anche perché essendo intento al mio lavoro poco mi curavo di essi”. Nemmeno all’osteria riusciva a distinguere le loro parole infatti, commentava, certi discorsi “evidentemente non saranno stati fatti a voce alta”. Giacomo Sinibaldi ricordò di aver avuto con Stuppioni una vivace discussione sulla condizione degli operai in Francia da dove, rimasto disoccupato, era tornato nel gennaio 1931. Lui sosteneva che in quel paese gli operai godevano di un trattamento migliore che in Italia: “ma – si giustificò – non credo che per tale fatto mi si possa elevare l’accusa di essere comunista”. Disse che lui si portava il pranzo da casa e mangiava sulla banchina vicina ai battelli in costruzione su cui stava lavorando, e quelle volte che era andato all’osteria di Cerato non aveva mai incontrato altri operai. Rossetti disse di aver sì sentito Pavanello parlare in mensa delle difficili condizioni di vita degli operai e dirsi preoccupato di un possibile licenziamento, ma di non averlo mai sentito parlare di organizzazione comunista. Allo stesso modo, anche Molin alla polizia disse di frequentare la mensa del cantiere e l’osteria di Cerato in compagnia di altri operai, ma escluse che in quelle occasioni si facessero discorsi di politica. Falce e martello e navi dalla Russia Antonio Dogà, vicino di casa di Gasparon e suo garzone al cantiere, nel mese di dicembre 1931 si era lamentato con lui, piangendo, perché a sua insaputa qualcuno gli aveva disegnato sulle spalle, col gesso, una falce e martello sulla tuta da lavoro. Gasparon non aveva potuto vedere il disegno perché Dogà l’aveva già 180 M. VEDOVETTO cancellato. Dogà aveva dei sospetti su di un giovane che lavorava come “marcatempo” al cantiere. Gasparon quindi lo aveva avvicinato per chiedergli perché avesse giocato quel brutto tiro proprio a uno come Dogà che, per quanto ne sapeva, non aveva mai manifestato idee comuniste: il ragazzo però aveva negato. Disegni di falce e martello, e slogan inneggianti alla Russia, erano lo spauracchio della polizia, che cerca di individuarne gli autori, senza riuscire il più delle volte nell’intento, come dimostrano le indagini per venire a capo di manifestazioni che si diceva fossero avvenute in occasione dei lavori e poi del varo di alcune navi russe. Nel marzo 1932 venne ascoltato negli uffici della questura di Venezia Angelo Lapasin da Cannaregio, carpentiere da un anno nell’officina meccanici del cantiere Breda, iscritto al Pnf, milite della 49a Legione San Marco della Mvsn, indicato dal prefetto nella sua denuncia come “testimone importante e imparziale”. Tra le altre cose, Lapasin confermò che il gruppetto di operai su cui stava indagando la polizia si riuniva nella “cantina” dello stabilimento: si mettevano “all’ultimo tavolo in fondo che, si può dire, era sempre riservato a essi”, sicché non si poteva sentire quello che dicevano. Del resto con lui, fascista e milite volontario, non avrebbero mai parlato. Di sicuro però facevano propaganda comunista: la sera poi, alla fine del lavoro, si trovavano all’osteria di Cerato, sempre tenendosi appartati. Che fosse in atto una propaganda comunista lo si capiva dal fatto che nel cantiere venivano trovate, quasi ogni giorno, iscrizioni o emblemi di carattere comunista sui muri, nei bagni e sui battelli russi, tanto sulle fiancate che sulle paratie interne. Lapasin non era riuscito a individuarne gli autori, anche perché Pavanello e gli altri suoi compagni mai in sua presenza – e qui ribadiva la sua fedeltà al fascismo – ne avrebbero parlato. Quando si era tenuto il varo dei primi due battelli russi, Lapasin aveva assistito alla cerimonia come tutti gli altri operai, e non gli risultava che vi fossero state manifestazioni di propaganda comunista da parte del solito gruppo. Ricordò, però, che in occasione del varo del primo battello aveva notato Emilio Gasparon in compagnia di Giovanni Tomè che, indicando la bandiera sovietica issata a bordo del battello, aveva detto: “Guarda che bella bandiera! Chissà quando ritornerà!”. Quando invece era partito il piroscafo “Gaga”, lui stava lavorando in officina e quindi non aveva potuto dire se in quell’occasione si fossero verificate manifestazioni. Che Pavanello fosse comunista lo dimostrava il seguente episodio. Circa quattro mesi prima, una sera, Lapasin, come lui stesso dichiarò alla polizia, aveva incontrato Ruggero Pavanello in Rio Terrà San Leonardo nei pressi del cinema “Italia”. Pavanello sembrava ubriaco e l’aveva invitato a bere un bicchiere di vino. Lapasin era in compagnia di un operaio del cantiere Breda, di cui non ricordava il nome, ed entrambi avevano seguito Pavanello in un’osteria vicina. Pavanello allora aveva chiesto a Lapasin perché si mostrasse ostile nei suoi Osservazioni, precedenti, fonti fiduciarie 181 confronti, e Lapasin aveva risposto di non aver mai fatto nulla per fargli pensare che lo fosse. Allora Pavanello gli aveva domandato: “perché non diventi dei nostri?”. Lapasin aveva fatto un gesto di meraviglia e rabbia, e Pavanello aveva continuato dicendo che sarebbe potuto diventare un “compagno” pur continuando ad appartenere al partito fascista e indossare la divisa di milite nazionale: non se ne sarebbe pentito. Tanta era la collera di Lapasin, che l’amico con cui stava era dovuto intervenire per trattenerlo ma Pavanello, ubriaco, continuava a rassicurarlo che avrebbe potuto ugualmente indossare la divisa di milite nazionale e che avrebbe pensato lui a ricompensarlo. Offeso da quelle parole, alla fine Lapasin si era lasciato trascinare fuori dall’osteria e con l’amico si era allontanato senza più dar retta all’ubriaco. Il giorno dopo l’aveva incontrato di nuovo al cantiere, ma non gli aveva detto nulla di quanto accaduto la sera precedente per evitare qualsiasi altra discussione. Aveva però chiesto all’operaio che aveva assistito alla scena di parlare con Pavanello per fargli capire quanto “imprudente e sconveniente” fosse stato il suo comportamento, e ne aveva informato il capo squadra della Mvsn, Antonio Saba. Dopo quell’incidente Pavanello si era mostrato freddo e riservato nei confronti di Lapasin. Sugli emblemi di falce e martello alla Breda, la polizia approfondì le indagini, senza però venirne a capo, come si è detto. Al cantiere Breda erano stati costruiti quattro battelli per conto della Russia. Stuppioni disse che sulle loro pareti, durante la costruzione, erano state fatte iscrizioni “inneggianti al comunismo e ingiuriose per il regime”. Le aveva viste con i suoi occhi. Raccontò che quando venivano cancellate per ordine dei capi operai venivano immediatamente rifatte, va a sapere chi fossero gli autori. Negò invece che durante il varo del battello russo “Gaga” si fossero tenute dimostrazioni alla vista della bandiera sovietica issata a prua, di cui la polizia aveva avuto notizia. Se ci fossero state, disse, se ne sarebbe di sicuro accorto perché lui era fra gli operai che si trovavano in coperta. Ammise però che, siccome era distante dagli operai che assistevano al varo, non poteva sentirne gli eventuali commenti. Bianchi invece dichiarò di non aver visto scritte comuniste all’interno del cantiere, e di non averne nemmeno sentito parlare. Il giorno del varo del piroscafo russo “Gaga” lui si trovava a bordo di un altro battello, sul quale si trovava pure Travan, capo dell’ufficio “mano d’opera”, che aveva fatto scendere a terra tutti gli operai e salire due Militi Nazionali con l’incarico di vigilare sugli operai. Bianchi, sbarcato, si fermò dietro al palco delle autorità, da dove aveva assistito alla cerimonia. Non aveva sentito nessuno acclamare alla bandiera russa ma, a causa della “ressa e confusione”, non era riuscito a vedere né Pavanello né Sandi. Guadagnin, il capo operaio, aveva sì notato “iscrizioni sovversive e ingiuriose” su muri e pilastri dell’officina: ma disse che sui battelli russi non ne erano state fatte, forse perché sugli stessi su cui lui lavorava vi erano anche due operai conosciuti da tutti come fascisti. Il giorno del varo si era seduto con la famiglia sul 182 M. VEDOVETTO palco delle autorità e non si era accorto di nessuna manifestazione comunista. Dopo il varo del “Gaga”, raccontò, era stata messa in vendita una cartolina con una foto del piroscafo e lui ne aveva comprata una “senza pensare che ciò potesse costituire un’affermazione politica, per il fatto che a bordo figurava la bandiera sovietica”, lì per lì almeno non gli venne in mente: oltretutto la bandiera, nella fotografia, non era nemmeno appariscente, e tutti se ne facevano dare una copia, ma “palesemente a scopo di ricordo” e niente più.
Scaricare