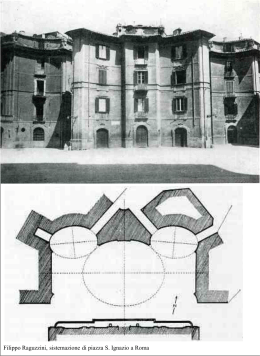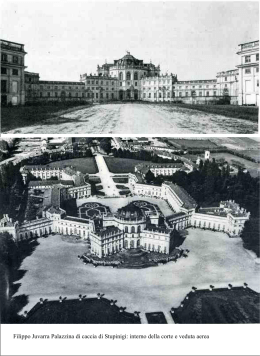unità 5 L’età di Calvino e Filippo II Riferimenti storiografici 1 Nel riquadro il dipinto di Pieter Bruegel il Vecchio intitolato Nozze contadine (Vienna, Kunsthistorisches Museum): si notano in primo piano i piatti a base di cereali, ampiamente coltivati in questo periodo. Sommario 1 2 3 4 5 6 Il ruolo dell’argento nel commercio con l’Oriente La rivoluzione dei prezzi Progetti di Riforma cattolica e di Controriforma nell’Italia del Cinquecento L’attività del Sant’Uffizio in Italia I Paesi Bassi contro lo Stato moderno La discussione sul diritto alla ribellione nel Tardo Cinquecento F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 7 8 9 10 11 Povertà e vagabondaggio nel Cinquecento L’arte al servizio della fede nel cattolicesimo del Cinquecento Verso Lepanto L’attacco contro l’Inghilterra: gli obiettivi di Filippo II La posizione politica di Jean Bodin 1 Il ruolo dell’argento nel commercio con l’Oriente UNITÀ 5 Per commerciare con l’Oriente era indispensabile possedere argento, visto che i mercanti indiani e cinesi volevano essere pagati in metallo prezioso e non erano interessati ai prodotti delle industrie europee. Per tutto il Cinquecento, però, non fu difficile, per gli europei, procurarsi l’argento, in virtù dei grandi giacimenti scoperti dagli spagnoli in Messico e in Perù. L’ETÀ DI CALVINO E FILIPPO II 2 Missionari a parte, gli europei andarono in Oriente fondamentalmente per commerciare e sino alla fine del diciottesimo secolo ebbero abbastanza senno per capire che le conquiste territoriali non rientravano nelle loro possibilità. Le conquiste tentate dagli europei furono limitate, salvo alcune eccezioni, ad isole e a porti destinati a fungere da basi per le loro attività commerciali. Consci del fatto che la loro superiorità tecnologica e militare consisteva nei loro galeoni armati, gli europei si accontentarono per quasi tre secoli di limitare il loro controllo al mare e alle zone costiere. Quando si spinsero per la prima volta in Estremo Oriente, gli europei furono attratti principalmente dalle spezie; ma non occorse loro molto tempo per rendersi conto che numerose altre merci offrivano eccellenti opportunità di profitto: così il rame del Giappone, le cotonate dell’India, la seta e i tappeti della Persia, la seta, le porcellane e (dopo la fine del Seicento) il tè della Cina. Il punto dolente era costituito dal fatto che gli europei non avevano quasi niente da offrire in cambio dei prodotti orientali. Dalla Rivoluzione Industriale in poi, ci si è abituati a dare per scontata la superiorità occidentale in fatto di tecnologia e produzione e riesce difficile immaginare una situazione in cui l’Oriente aveva molto da offrire sia in termini di materie prime che di prodotti finiti, mentre l’Occidente aveva ben poco da offrire che interessasse le genti dell’Asia. Eppure questa era esattamente la situazione prevalente nei secoli sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo. I velieri armati di cannoni permisero agli europei di dominare gli oceani, di annientare la navigazione e il commercio musulmani nell’Oceano Indiano e di accaparrarsi gran parte del commercio interasiatico. Fornendo argento giapponese alla Cina, rame giapponese alla Cina e all’India, chiodi di garofano delle Isole delle spezie all’India e alla Cina, manufatti di cotone indiani all’Asia sudorientale, tappeti persiani all’India gli europei fecero grossi guadagni e il reddito derivato dalla attività di intermediazione servì loro per pagare parte delle importazioni in Europa di prodotti asiatici. Ma quel reddito non era sufficiente e la parte di gran lunga più importante delle importazioni dell’Asia dovette essere pagata con massicci trasferimenti di metalli preziosi dall’Europa all’Asia. Masse di argento in forma di reales o pezzi da otto coniati a Siviglia, di dollari messicani, di ducatoni d’argento coniati in Italia, di corone francesi e di talleri olandesi anno dopo anno presero la via delF.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 l’Asia. Gli europei potevano disporre d’argento in abbondanza grazie alla favorevole bilancia commerciale dell’Europa nei confronti delle Americhe. Se si prescinde dal commercio relativamente limitato che attraverso le Filippine si svolgeva tra l’America spagnola e l’Estremo Oriente, si può ragionevolmente affermare che a quel tempo il commercio intercontinentale consistette essenzialmente in un’ampia corrente di argento che si muoveva verso est dalle Americhe all’Europa e dall’Europa all’Asia, e in un vasto flusso di beni che muovevano in direzione opposta: prodotti asiatici che prendevano la via dell’Europa e prodotti europei che prendevano la via delle Americhe. Il deficit della bilancia commerciale tra l’Europa e l’Asia lo si poteva, per così dire, toccare con mano. Individui come van Linschoten osservando i velieri che salpavano per le Indie vedevano che «non hanno che un carico leggero, composto unicamente di qualche barile di vino e di olio e di piccoli quantitativi di merce; all’infuori della zavorra e dei viveri per l’equipaggio non trasportano altro, perché quel che soprattutto si spedisce alle Indie sono i reali da otto». Alla fine del Cinquecento un mercante fiorentino riferiva che il solo Portogallo e la Spagna inviavano in Cina più di 1 500 000 scudi all’anno. Quanto attendibile sia questa valutazione nessuno può dire, ma per i secoli diciassettesimo e diciottesimo disponiamo di dati più abbondanti e più precisi e questi indicano concordemente che l’argento era la principale merce europea esportata in Asia. In Europa questa situazione suscitava imbarazzo e preoccupazione e diede vita ad accesi dibattiti e a numerose pubblicazioni. Tanto in Inghilterra che in Francia le Compagnie che praticavano il commercio con le Indie Orientali furono ripetutamente attaccate e accusate di mettere i loro egoistici interessi al di là e al di sopra dell’interesse pubblico, di prosperare a spese della ricchezza e della potenza nazionale. Su un piano più concreto furono fatti ripetuti tentativi per migliorare la situazione. In Inghilterra il governo ordinò che almeno un decimo del carico di ogni nave diretta alle Indie fosse composto di «derrate, prodotti o manufatti del regno». La Compagnia Inglese delle Indie Orientali fece di tutto per inserirsi nel commercio di Nanchino e altre città della Cina settentrionale, nella speranza che la rigidità del clima nordico potesse favorire uno spaccio considerevole dei manufatti inglesi di lana. Tuttavia, questi e simili tentativi fallirono miseramente. I mercanti europei esaminarono anche la eventualità di esportare quadri e objets d’art, ma l’arte occidentale era fortemente legata ai soggetti religiosi e, come Richard Cocke scrisse dal Giappone, i popoli asiatici non avevano alcun interesse per le scene bibliche. «Essi stimano maggiormente un foglio di carta col disegno di un cavallo, una nave o un uccello che non una preziosa nostra pittura. Né alcuno darà sei denari per quel bel quadro della conversione di San Paolo». Dopo aver tentato senza successo di vendere quadri tradizionali, la Compagnia Olandese delle Indie cercò di vendere stampe che avessero «un richiamo umano più generale, come una collezione di nudi o altre illustrazioni poco decenti», ma anche questi sforzi d’immaginazione non riuscirono ad ottenere risultati apprezzabili. Verso il 1701 il Consiglio della Compagnia delle Indie Orientali scriveva agli uffici di Londra: «Non sappiamo cosa consigliare alle vostre Eccellenze di inviare in questi luoghi (Cina), perché gli indigeni non apprezzano altro che l’argento e il piombo; e probabilmente se tutto il resto delle vostre merci fosse gettato a mare, il carico di ritorno non sarebbe inferiore di molto». C.M. CIPOLLA, Tecnica, società e cultura. Alle origini della supremazia tecnologica dell’Europa (XIV-XVII secolo), il Mulino, Bologna 1990, pp. 71-73 UNITÀ 5 Quale strategia coloniale scelsero le potenze europee che si sforzarono di penetrare in India, in Cina e in altre zone dell’Asia? Spiega il ruolo svolto dal «commercio di intermediazione» nel meccanismo degli scambi tra Europa ed Estremo Oriente. In quale direzione si muoveva nel Cinquecento l’argento? E in quale direzione, invece, si muovevano i manufatti lavorati? RIFERIMENTI STORIOGRAFICI 3 F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 2 La rivoluzione dei prezzi UNITÀ 5 I contemporanei considerarono l’inflazione che investì l’Europa nel Cinquecento come una conseguenza del massiccio arrivo di metalli preziosi dalle Americhe. Oggi, però, si tende a vedere nell’aumento demografico la causa principale dell’aumento dei prezzi. L’ETÀ DI CALVINO E FILIPPO II 4 L’inflazione è un fenomeno economico che investe qualunque società che non abbia un’economia naturale primitiva. Allorché nel Cinquecento e agli inizi del Seicento gli storici scoprirono questo fenomeno, lo chiamarono, con una qualche esagerazione, «rivoluzione dei prezzi», contrapponendolo al lungo periodo di prezzi costanti o addirittura cedenti del Basso Medioevo. Per coloro che vivevano nel XVI secolo, tale rivoluzione non fu immediatamente percepibile: i prezzi, specialmente i prezzi dei prodotti alimentari, fluttuavano entro margini assai ampi, sia stagionalmente sia in base all’andamento del raccolto; la spinta ascendente generale, per tutto il secolo, fu soltanto del 2 o 3 per cento per anno; ma, a partire da circa la metà del Cinquecento – da Palermo a Stoccolma, da Londra a Novgorod [in Russia, n.d.r.] – l’aumento cumulativo dei prezzi divenne evidente. All’inizio del Seicento in Inghilterra, i prezzi all’ingrosso dei cereali erano, in media, circa cinque volte superiori a quelli degli ultimi decenni del Quattrocento; in Francia erano aumentati più di sette volte, e nella Spagna meridionale ancora di più. Parve dapprima che l’inflazione fosse imputabile alla malvagità di alcuni: teologi e predicatori tuonavano contro i monopolisti e gli usurai; le diete tedesche incolpavano i Fugger e le altre grandi compagnie commerciali. […] Ma venivano date anche spiegazioni più sottili dell’inflazione persistente. I teologi dell’università di Salamanca negli anni intorno al Cinquecento furono i primi a individuare una relazione tra le importazioni spagnole di oro e di argento e l’aumento dei prezzi: «Nei paesi nei quali vi è una scarsità di denaro – scriveva Martin de Azpilcueta Navarro – tutte le merci, persino il lavoro e la fatica degli uomini, vengono ceduti a minor prezzo che non là dove il denaro è abbondante. Così vediamo, sulla base dell’esperienza, che in Francia, dove il denaro è più scarso che in Inghilterra, il pane, il vino, il panno e il lavoro valgono molto meno (che in Spagna). E anche in Spagna nei tempi in cui il denaro era più scarso, le merci e il lavoro erano venduti a minor prezzo che dopo la scoperta delle Indie che invase il paese di oro e di argento. La causa di ciò è che il denaro ha più valore dove e quando è scarso che dove e quando è abbondante». Azpilcueta e i suoi colleghi anticipavano così la famosa teoria quantitativa della moneta. La spiegazione che questa offriva della rivoluzione dei prezzi, tuttavia, fu accettata quasi universalmente grazie ad un opuscolo pubblicato nel 1568, la Response de M. Jean Bodin aux paradoxes du Seigneur de Malestroit [Risposta di Jean Bodin ai paradossi del Signor di Malestroit, n.d.r.], da un funzionario della zecca francese, il quale sosteneva che l’aumento dei prezzi era, più che reale, apparente, e era dovuto alle successive riduzioni del fino [la quantità di metallo pregiato, n.d.r.] della moneta. […] Fu facile tuttavia a Bodin, famoso tra i suoi contemporanei soprattutto come giurista e teorico politico, dimostrare che i prezzi in Francia erano saliti molto più di quanto sarebbe avvenuto se non vi fosse stata nessun’altra causa diversa dalla riduzione del contenuto di fino. In Inghilterra, dopo due successivi e, alla fine, riusciti tentativi di riconiazione, i prezzi ancora continuavano a salire. In altri paesi, come la Spagna – quando Bodin scriveva – la moneta non aveva subìto alcuna alterazione, anche se in quest’ultima tale fenomeno avrebbe raggiunto punte estreme dopo il 1597. Bodin perciò, sostenendo che si doveva addebitare all’importazione dell’oro e dell’argento americano l’aumento dei prezzi europei, giungeva alle stesse conclusioni dei professori di Salamanca, anche se, pare, indipendentemente da loro. […] Tuttavia, la teoria di Bodin sulla rivoluzione dei prezzi […] ha recentemente subìto attacchi violenti e decisivi. Per quanto riguarda la Spagna abbiamo troppe prove che dimostrano come gran parte dell’argento che giungeva a Siviglia venisse di nuovo rapidamente esportato in pagamento delle importazioni, per la paga e gli approvvigionamenti delle truppe all’estero, e per rimborsare i prestiti dei banchieri tedeschi e genovesi al governo spagnolo. […] Ma, fenomeno ancor più importante, i prezzi delle diverse merci non aumentarono mantenendo invariati i rapporti relativi, come ci si sarebbe aspettato in un’inflazione meramente monetaria; si verificarono infatti aumenti veramente notevoli per quanto riguarda i prodotti agricoli, specialmente cereali e lana, mentre i manufatti aumentarono soltanto di circa la metà. Dunque, se è assurdo sostenere che l’argento americano non ebbe alcun effetto inflazionistico in Spagna e nell’Europa occidentale, è pur vero che non fu la sola, e forse, neppure la più importante causa dell’aumento dei prezzi. H.G. KÖNIGSBERGER, G.L. MOSSE, L’Europa del Cinquecento, Laterza, Roma-Bari 1983, pp. 32-37 A chi fu attribuita inizialmente, dai contemporanei, la causa dell’aumento dei prezzi? Quali furono i settori a subire maggiormente l’aumento dei prezzi? F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 L’Italia cattolica vide contrapporsi due progetti alternativi di risposta alla sfida protestante. La prima strategia faceva capo al cardinale Gian Pietro Carafa, fautore di un’inflessibile repressione; la seconda era disposta al dialogo dottrinale con i luterani e a intraprendere un radicale ripensamento dell’organizzazione ecclesiale, ponendo al centro la Sacra Scrittura. [La realtà religiosa italiana vide] il progressivo delinearsi di due diversi orientamenti, dapprima paralleli e solidali e poi via via divergenti, l’uno mirante a una riforma della Chiesa finalizzata soprattutto a una più efficace lotta contro l’eresia, l’altro disponibile invece a trarre spunto dai conflitti e dalle fratture religiose in atto per un confronto aperto e ironicamente flessibile con le dottrine della Riforma. Il primo trovò la sua guida indiscussa nel nobile napoletano Gian Pietro Carafa, discendente da un’aristocratica famiglia cardinalizia, fondatore, insieme con san Gaetano da Tiene, dei teatini, che presero appunto il nome dalla sua diocesi di Chieti (in latino Theates). […] Le sue ambizioni alla porpora [al titolo di cardinale, n.d.r.] (poi concessagli nel ’36) rivelano in realtà la lucida consapevolezza che tale linea intransigente avrebbe dovuto muovere da posizioni di potere e dotarsi dei necessari strumenti operativi, primo fra tutti quel supremo tribunale del Sant’Ufficio romano, formalmente istituito nel luglio del ’42, da lui caparbiamente voluto e preparato negli anni precedenti e poi diretto con estrema severità e al di fuori di ogni controllo papale, fino alla sua elezione alla tiara [fino all’elezione a papa del Carafa stesso, n.d.r.] nel 1555. Più complesso e variegato il secondo gruppo, fortemente caratterizzato da un’impronta veneta, maturato tra le aule dell’università patavina [di Padova, n.d.r.] e i circoli umanistici raccolti intorno a un letterato di prestigio quale Pietro Bembo (cardinale dal ’39) e a un personaggio di grande statura e autorevolezza quale Gasparo Contarini. […] Vale la pena di soffermarsi brevemente sulla figura del vescovo di Verona Gian Matteo Giberti, in passato potente uomo di curia, datario di Clemente VII e artefice primo della disastrosa politica antimperiale che aveva condotto alla tragedia del ’27 [il sacco di Roma, n.d.r.], ma anche sempre più consapevole dell’esigenza di un’incisiva riforma, come attestano i suoi vincoli di amicizia e di stima con il Carafa. Fuggito avventurosamente da Roma all’indomani del sacco volle abbandonare per sempre la corte papale e ritirarsi nella sua diocesi di Verona al fine di promuovervi un’opera di capillare restaurazione morale e disciplinare: vero e proprio archetipo del vescovo esemplare post-tridentino, residente presso la sua cattedrale e sollecito nel provvedere al governo del sistema beneficiario [relativo all’assegnazione dei benefici ecclesiastici, le terre che fornivano rendite finanziarie al clero, n.d.r.], a una predicazione fondata sui testi evangelici, alle visite pastorali e all’emanazione delle costitu- zioni diocesane, alla riforma di monasteri e conventi, all’istruzione dei fedeli, alla tutela dell’autorità episcopale e dei diritti ecclesiastici, al controllo della vita religiosa del gregge a lui affidato e alla guida dei sacerdoti, richiamati ai loro compiti di cura d’anime. […] Chiamato a misurarsi con i gravi abusi del clero e con la sua complessiva inadeguatezza ad affrontare i compiti che tale impegno richiedeva, il Giberti dovette anzitutto dotarsi dei mezzi necessari (tra cui una stamperia destinata a fornire gli strumenti biblici, patristici e catechistici di quella svolta religiosa) e circondarsi di collaboratori dotati di litterae et boni mores [competenze culturali e buoni costumi, n.d.r.] all’altezza della situazione. Di qui il confluire a Verona […] di numerosi ecclesiastici e intellettuali particolarmente sensibili alle esigenze di riforma […]. L’intrecciarsi di uno sforzo riformatore chiamato ad affrontare la drammatica crisi dell’istituzione ecclesiastica e della vita religiosa collettiva con un’attività di studio e di riflessione aperta al confronto con le grandi questioni teologiche sollevate dalla Riforma protestante contribuisce a spiegare come proprio nell’ambiente veronese, sullo sfondo di progressive divergenze e tensioni con le prospettive intransigenti del Carafa, finissero coll’emergere orientamenti dottrinali sempre più difficilmente compatibili con l’ortodossia ufficiale. […] Nel corso delle sue lezioni sulle lettere paoline, poi pubblicate a Venezia nel ’36 e destinate a lasciare un segno profondo sui collaboratori del Giberti che ebbero modo di ascoltarlo, il van Kampen [l’ebraista fiammingo Johann van Kampen, chiamato a Verona dal vescovo riformatore, al fine di offrire una migliore comprensione delle Scritture, n.d.r.] parlava apertamente di giustificazione per fede e di predestinazione. Tutto ciò contribuisce a spiegare come nel febbraio del ’46, all’indomani della prima riunione del Tridentino, sempre fanaticamente desideroso di acquisire meriti denunciando a Roma prelati sospetti di eresia, il vescovo Grechetto non esitasse a scagliarsi con aspre parole contro «quella mala semenza del episcopo di Verona morto». A quanto sembra, del resto, lo stesso Giberti avrebbe espresso vivo apprezzamento per opere come il Summario de la santa Scrittura, che volle divulgare nella sua diocesi giudicandolo «libretto molto utile per que’ poverelli che non intendono latino», e come il Beneficio di Christo, che ebbe modo di leggere manoscritto poco prima della morte, avvenuta alla fine del ’43. Una morte che lo sottrasse a quegli incipienti sospetti di eresia […] che ne avrebbero poi appannato l’immagine esemplare di «gloria et honore dell’ordine episcopale», nella quale non tarderà infatti ad essere sostituito da san Carlo Borromeo. M. FIRPO, Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento. Un profilo storico, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 106-111 Che cosa era il «Sant’Ufficio romano»? Spiega l’espressione «vero e proprio archetipo del vescovo esemplare post-tridentino». F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 UNITÀ 5 Progetti di Riforma cattolica e di Controriforma nell’Italia del Cinquecento 5 RIFERIMENTI STORIOGRAFICI 3 4 L’attività del Sant’Uffizio in Italia UNITÀ 5 Mentre in altre regioni d’Europa, rimaste fedeli a Roma, il compito di reprimere il dilagare dell’eresia venne assunto direttamente dallo Stato, in Italia venne riorganizzato il tribunale dell’Inquisizione. Nei diversi Stati italiani, esso operava in stretta collaborazione con le autorità, che però a volte cercavano di evitare le esecuzioni in pubblico, per evitare tumulti e proteste. L’ETÀ DI CALVINO E FILIPPO II 6 [Nei primi anni di attività del Sant’Uffizio in Italia] la questione dominante a cui si dovette rispondere fu quella del rapporto tra la violenza e il Vangelo, tra l’uso della forza e le questioni di fede. In via teorica, l’armamentario tradizionale dei teologi aveva pronti gli argomenti per rispondere: ma non si trattava di condurre soltanto una discussione fra teologi di mestiere. La repressione dell’eresia acquistava rapidamente caratteri di grande ampiezza e così pure la protesta e la reazione delle coscienze offese. I teologi si affannarono a spiegare, scendendo anche sul terreno della polemica in volgare, le loro ragioni: gli eretici si debbono bruciare, scrisse il francescano Giovanni da Fano, così come si brucia il mal seme della zizzania quando si raccoglie il frumento. […] Ma la contestazione più dura fu quella mossa dalle vittime, che opposero alla giustizia dell’Inquisizione la parola del vangelo: e forse la formulazione più netta di questo argomento fu quella del fabbro friulano Ambrogio Castenario, secondo il quale «non si trovava mai nel testamento novo che Iddio habbi ordinato che si facci morir alcuno per la sua fede». Davanti a questo fuoco di fila di accuse, l’istituzione inquisitoriale appare inflessibile e come arroccata nelle sue certezze. La stessa predilezione per le esecuzioni pubbliche sembra dimostrare che non si aveva paura di esibire spettacoli di morte ed esempi di martirio. Eppure, ben si sapeva che quegli spettacoli erano pericolosi e avevano effetti ambigui: terrorizzavano, certamente – e in questo erano in sintonia con i meccanismi della giustizia penale dell’epoca e con la sua dura pedagogia dei supplizi – ma, a differenza di quella, offriva allo sguardo delle folle non dei ladri e degli assassini puniti per i loro delitti bensì uomini che avevano scelto di morire per le loro idee. Erano spettacoli odiosi; del resto, le cronache medievali raccontavano di inquisitori aggrediti e uccisi, di folle tumultuanti in favore di condannati per eresia. E bastava leggere i verbali dei processi per scoprire che gli imputati desideravano avere quella occasione per manifestare le loro idee. Lorenzo Vex, un luterano processato a Venezia nel 1566 affermò «che mal volentiera el moreria in l’acqua salsa [gli sarebbe dispiaciuto di essere annegato in mare, n.d.r.], perché el non saria visto: ma che vorria esser brusato in piazza, perché el diria tanto che’l si saveria [avrebbe parlato pubblicamente e quel che avrebbe detto si sarebbe risaputo, n.d.r.]». Quel desiderio non si realizzò. Ma altri ci riuscirono. Il calzolaio Girolamo Venier, condannato a leggere la sua abiura nel duomo di Udine la domenica 15 aprile 1544, lesse invece buona parte di un testo in cui rivendicava le sue idee e protestava contro la violenza che lo aveva piegato, dichiarandosi «vinto per assedio in quel modo che si vincono le città et castelli per fame»; poi cercò di fuggire, mentre la folla gridava: «Scampa via, scampa via». […] Un sistema penale – non solo ecclesiastico – fondato sulle pene esemplari e terrificanti si rivelava rischioso e controproducente quando si trattava di reati d’opinione: la testimonianza di fede del condannato, i suoi discorsi alla folla, perfino la semplice elencazione delle sue eresie potevano aprire orizzonti nuovi e pericolosi ai presenti. Non c’erano vie d’uscita: e in genere l’istituzione ecclesiastica si mostrò fiduciosa nell’effetto di orrore e di esecrazione che ci si attendeva dalla descrizione delle eresie condannate. I giudici più scrupolosi si preoccupavano di aggiungere, al termine delle sentenze, delle esortazioni ai presenti a dimenticare quelle opinioni che avevano sentito condannare. A. PROSPERI, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Einaudi, Torino 1996, pp. 163, 168-170 Che differenza esisteva tra l’esecuzione di un “eretico” e quella di un delinquente comune? Quale effetto intendeva raggiungere la Chiesa nel fare eseguire pubblicamente la condanna di un eretico? F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 La rivoluzione dei Paesi Bassi fu un fenomeno complesso, dettato da varie cause complementari. Il fattore religioso giocò un ruolo importante, ma all’inizio molti nobili che appoggiarono la ribellione erano cattolici, non riformati. In questi aristocra-tici, la motivazione principale che li spinse all’azione era il desiderio di opporsi allo Stato moderno, che Carlo V e Filippo II avevano cercato di imporre nei loro territori, cancellando antiche tradizioni e libertà consolidate, che assegnavano alle varie comunità privilegi ed esenzioni che nessuno voleva vedere cancellati. Nella ricca Repubblica delle Sette Province [le province del Nord, cioè Groning, Frisia, Olanda, Utrecht, Overijssel, Gheldria e Zelanda, n.d.r.], invidiata da tutte le altre nazioni per il suo commercio internazionale, non esisteva un’autorità che cercasse di regolamentare con ordini e prescrizioni il diffuso spirito d’iniziativa. […] Ciò che permise agli olandesi di dominare nel commercio internazionale non fu dunque un’organizzazione commerciale o una teoria economica progredita. Al contrario, si può dire che essi trassero giovamento proprio dalla mancanza d’ingerenza statale. […] A dare ai Paesi Bassi la loro potenza fu […] il fatto che l’organizzazione rimase ferma a quelle forme estremamente limitate che nel medioevo si compendiavano nella parola libertà: cioè autonomia di ogni più piccola unità, rigorosi divieti all’interno della propria cerchia, massimo boicottaggio degli estranei, ma niente imposizioni da parte di un’autorità centrale. […] La rivolta contro il governo spagnolo fu una rivoluzione conservatrice, e non poteva essere altrimenti. Gli innovatori, riformatori, modernizzatori e sovvertitori consapevoli erano, a quel tempo, non i rivoltosi ma i governi legali. Le nuove energie politiche di quel periodo, anche nel caso dei Paesi Bassi, venivano dal centralismo e assolutismo monarchico, il quale o aveva già vinto, come in Francia, Spagna e Inghilterra, o si stava rafforzando a spese degli Stati Generali del tardo medioevo. Quando, attorno al 1400, i duchi di Borgogna s’impadronirono dei Paesi Bassi, questa consapevole tendenza a concentrare e sfruttare pienamente tutta la potenza statale era ancora agli inizi. Il primo obiettivo per i principi, da Filippo l’Ardito a Carlo il Temerario, consisteva sempre nel dare al governo una base un po’ più solida in ciascuna delle varie province […]. Ma le cose cambiarono completamente quando Carlo V si trovò a dominare sui Paesi Bassi accresciuti della Frisia, della regione di Groninga, della diocesi di Utrecht e della Gheldria. […] Successivamente però, il figlio di Carlo V, troppo spagnolo, non capì che questo importante e ricco territorio che andava dal Lussemburgo alla Frisia, e che nel suo insieme era ancora noto soprattutto col nome di Borgogna, poteva essere retto secondo i nuovi principî soltanto se lo si riconosceva come una unità autonoma in seno al consorzio degli stati occidentali e se si rispettava veramente la sua autonomia. Questo era inconcepibile per la Madrid di Filippo II. La conseguenza fu l’insurrezione. Il governo spagnolo si avventurò in esperimenti finanziari come la decima, senza preoccuparsi minimamente di vedere se i provvedimenti si adattavano alla struttura economica olandese. Poi provò delle riforme che in sé e per sé erano ottime, come l’unificazione del diritto penale, ma senza tener conto che nei Paesi Bassi tutto il concetto di diritto e di legge era ancora legato a quello medioevale di privilegio, cioè a un concetto che contrastava con qualsiasi centralizzazione, anche con la migliore. […] La vittoria significò nelle Province Unite non solo supremazia della fede protestante, ma anche conservazione (contro le tendenze politiche dell’epoca) dell’autonomia cittadina e dell’amministrazione provinciale secondo il vecchio sistema degli stati [le assemblee che riunivano i delegati dei vari ceti di una città o di una regione; il re non poteva prendere alcuna decisione, soprattutto in materia fiscale, senza il loro parere favorevole, n.d.r.], nonché la continuazione di un sistema economico che sebbene antiquato sotto molti rispetti, pure era intimamente legato a quella struttura politica. La Lega di Utrecht, in linea di principio, non era che un’alleanza militare per proseguire la lotta – unendo le forze – sino a una felice conclusione. Solamente il primo articolo, dove si dichiara che la Lega è permanente, accenna a finalità più ampie. Ma quante alleanze e quanti patti sono stati dichiarati eterni nella storia del mondo e poi non hanno retto alla prova! La Lega non aveva tra i suoi obiettivi la libertà e l’autonomia politica, e tanto meno venne costituita come libero stato. Solo le circostanze la resero tale, ed era inevitabile che nella pratica si rivelasse incapace di raggiungere un così grande scopo. La base su cui ci si era uniti era una concezione medioevale della libertà che non bastava certo per costruire un nuovo stato. L’unanimità che richiedeva per quasi tutte le decisioni importanti era un criterio tipico del medioevo; il criterio della maggioranza stentava ancora ad affermarsi. Nel primo medioevo, infatti, si partiva dall’idea che nelle scelte e nelle decisioni d’importanza tutti i consiglieri dovessero essere d’accordo (o, se si vuole, fingere d’essere d’accordo), ritenendosi che in ultima istanza fosse lo Spirito Santo a ispirare la giusta scelta. Ma nell’esercizio di una direzione statale moderna, pretendere l’unanimità significava soltanto impedire al potere esecutivo centrale di essere veramente efficiente. Ancor più deleteria doveva rivelarsi col tempo la mancanza di un qualsiasi mezzo per superare i punti morti, quando il dibattito tra le correnti opposte si arenava, o per costringere la minoranza a piegarsi al volere della maggioranza. Essendo uno strumento statale così difettoso, non fa meraviglia che proprio quegli articoli della Lega che miravano a unificare realmente l’amministrazione – per esempio l’articolo che prevedeva un sistema fiscale comune – restassero sempre lettera morta. J. HUIZINGA, La civiltà olandese del Seicento, Einaudi, Torino 2008, pp. 18-25, trad. it. P. BERNARDINI MARZOLLA Spiega l’espressione «rivoluzione conservatrice». Spiega le due espressioni «unificazione del diritto penale» e «centralizzazione». Qual era il sistema decisionale tipico del Medioevo? Quali difficoltà provoca al governo di uno Stato moderno? F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 UNITÀ 5 I Paesi Bassi contro lo Stato moderno 7 RIFERIMENTI STORIOGRAFICI 5 6 La discussione sul diritto alla ribellione nel Tardo Cinquecento UNITÀ 5 Le guerre civili verificatesi in Francia spinsero molti intellettuali a condannare severamente la figura del ribelle, accusato di portare discordia e caos all’interno dei regni. In questo contesto, Guglielmo d’Orange, leader della rivolta dei Paesi Bassi, difese il proprio operato con vigore, consapevole del fatto che il suo stesso onore di nobile e di gentiluomo era in pericolo. L’ETÀ DI CALVINO E FILIPPO II 8 [La forza di convinzione del Miroir des Rebelles di Daniel Drouin] si basa sul proposito di trarre conclusioni generali dall’esperienza particolare della Francia; o meglio, di stabilire una stretta connessione tra il giudizio sull’esperienza francese e la condanna generale e teorica della ribellione. Il fenomeno è considerato in un panorama che va dalla storia ebraica all’Europa cristiana medievale e moderna, attraversando il mondo greco e gli imperi persiano, romano, turco; è in questa dimensione di storia universale che si può cogliere pienamente il significato delle vicende trentennali della Francia, con le quali il panorama si conclude. «È a voi, mia nazione francese – scrive Drouin – che ho voluto parlare in questo libro. […] Con quale argomento, con quale pretesto continuate a resistere a mano armata contro la Corona? In verità non ne avete alcuno e non ci fu mai al mondo una ribellione più immotivata della vostra». Il giudizio che domina il panorama storico generale e la ricostruzione delle vicende più recenti è il destino fallimentare della ribellione e la ineluttabilità del castigo. Secondo Drouin è qui, in questa inevitabile e costante conclusione, il segno della volontà divina di sostenere il potere legittimo, anche quando appartiene a re pagani e idolatri […]. «Dio sta sempre dalla parte della legittimità»: il libro vuole dare, attraverso il tema del fallimento, un supporto storico alla teoria sull’origine del potere regio, che è il punto di riferimento comune e fondamento teorico positivo di tutta la campagna controrivoluzionaria. […] In quanto azione promossa e ispirata dalla nobiltà […] la ribellione appariva come violenza particolaristica, ingiusta difesa di arcaici privilegi contro l’interesse generale della nazione e contro l’equilibrio politico e sociale garantito dalla monarchia. Era qui, nel suo contenuto retrogrado, il fondamento principale della sua debolezza. Qualunque azione rivoluzionaria, inoltre, poteva raggiungere una certa efficienza soltanto a condizione di basarsi sul sostegno popolare, che in effetti i Grandi ribelli avevano sfrenatamente sollecitato e organizzato nel corso delle guerre civili. Questa operazione demagogica era considerata il più nefando attentato contro il vivere civile e contro la società, perché significava dare spazio allo scatenamento di istinti brutali ed alle barbarie, e, nello stesso tempo, era segno di velleitarismo [sforzo inutile, perché condannato al fallimento, n.d.r.] e insensatezza perché nulla poteva essere più fragile e illusorio del sostegno popolare, inevitabilmente destinato a venir meno nel breve periodo. […] Per quanto fossero numerosi i punti di contatto con le guerre di religione in Francia, e particolarmente con il ruolo che svolse qui l’estremismo religioso e politico e con le spinte centrifughe e particolaristiche che operavano all’interno del paese, il caso della contemporanea rivoluzione dei Paesi Bassi ertta diverso. […] Il caso di Guglielmo d’Orange doveva apparire come l’eccezione che conferma la regola. Nel suo panorama politico europeo del 1638, Henri de Rohan avrebbe notato, in modo significativo, che Guglielmo era stato «il solo in un secolo ad avere avuto l’onore di fondare uno Stato». Guglielmo d’Orange pubblicò la sua Apologia in risposta al bando con cui Filippo II lo dichiarava ribelle, «perturbatore della quiete della Cristianità e specialmente dei Paesi Bassi» e prometteva un premio cospicuo e addirittura un titolo di nobiltà a chi lo avesse, come «peste pubblica», levato dal mondo. Anche Guglielmo, nel respingere l’accusa, faceva appello alle tradizioni costituzionali (all’originario contratto tra sovrano e sudditi) dei territori che formavano i Paesi Bassi, senza giungere quindi all’affermazione di un concetto universale di indipendenza e di nazionalità. Ma mentre negli altri testi rivoluzionari cinquecenteschi le tradizioni costituzionali si identificavano con privilegi e poteri della nobiltà, considerata come interprete e rappresentante esclusiva della nazione politica, egli le concepiva in modo più ampio, come diritti e libertà di tutto l’insieme della comunità. Anche nel campo religioso, la sua rivendicazione di libertà non significava il sostegno della esclusiva pratica confessionale dei suoi correligionari. In nome di questo patriottismo Guglielmo rifiutava la «servitù assoluta» che la Spagna voleva imporre ai Paesi Bassi; sulla stessa base respingeva il tentativo, fatto nel bando di Filippo II, di attribuire la sua ascesa politica all’uso demagogico e strumentale del tumulto popolare e di collocare la sua azione nel quadro della tradizione anarchica e particolaristica del ribellismo nobiliare. «La Spagna – diceva Guglielmo agli Stati Generali delle Province Unite – vuole privarvi intieramente dei vostri antichi privilegi e delle vostre libertà, per disporre di voi, delle vostre donne e dei vostri figli, come fanno i suoi ministri dei poveri Indiani o per lo meno dei Calabresi, Siciliani e Milanesi, senza ricordare che i nostri paesi non sono paesi di conquista, ma per la maggior parte sono patrimoniali o si sono dati volontariamente, e sotto buone condizioni, ai predecessori di Filippo II». Ribelli, infedeli e spergiuri – continuava Guglielmo, attaccando una parte della nobiltà dei Paesi Bassi – sono quindi quei signori che avendo la preminenza politica e la funzione di comando militare non si oppongono a chi calpesta i diritti e le costituzioni del loro paese. R. VILLARI, Il ribelle, in ID. (a cura di), L’uomo barocco, Laterza, Roma-Bari 1998, pp. 116-124 Con quale segno la volontà divina, secondo Daniel Drouin, dimostra di disapprovare le ribellioni? Chi era, per Guglielmo d’Orange, il vero sovversivo che distruggeva l’ordine fissato dalla tradizione? F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 Nella seconda metà del Cinquecento si ebbe un notevole aumento del pauperismo e della mendicità. Per fronteggiare questo problema sociale, i principali stati d’Europa decisero di non affidare più ai privati il compito di assistere i bisognosi, ma di assumersi tale incarico direttamente, nel tentativo di distinguere i veri poveri dagli imbroglioni. Nessun altro secolo è stato tanto consapevole del problema della povertà come il Cinquecento, in cui tutti gli osservatori concordavano nell’affermare che il numero dei poveri e le difficoltà da essi create non erano mai stati così grandi. Nel 1587 Sisto V deplorava in una bolla il comportamento dei vagabondi («Riempiono di lamenti e di grida non solo i luoghi pubblici e le case private, ma perfino le chiese; fanno nascere timori e incidenti; vanno in giro come animali selvatici, senz’altra cura che la ricerca di cibo»); Juan Luis Vives biasimava i mendicanti che invadevano le chiese mentre i fedeli erano in preghiera («Si fanno largo tra la gente riunita, sfigurati dalle piaghe, emanando un lezzo insopportabile»); secondo il cronista Pierre de l’Estoile, nel 1596 a Parigi «la folla dei poveri nelle strade era così fitta da impedire il passaggio». In molte città dell’Europa occidentale almeno un quinto della popolazione era formato da indigenti. Nel 1551 il 17 per cento della popolazione di Troyes era inclusa nella categoria dei mendicanti e vagabondi, che però non comprendeva i bisognosi domiciliati stabilmente nella città; negli stessi anni a Lovanio i poveri erano il 21,7 per cento, a Leida circa il 40 per cento e a Bruxelles il 21 per cento. A Segovia nel 1561 era classificato così un sesto della popolazione, senza contare i vagabondi; a Bergamo nel 1575 su 20000 abitanti i poveri erano il 35 per cento, ma in questa categoria erano compresi solo «i vecchi, i malati e i minori di 15 anni» a Exeter e a Leicester al tempo di Elisabetta metà della popolazione viveva al di sotto della «linea della povertà». La miseria era dunque una caratteristica innegabile delle città, dove i disoccupati abbondavano; ma sarebbe errato considerarla come un fenomeno esclusivamente urbano, e molti poveri erano originari delle campagne. [...] I poveri senza fissa dimora furono sempre guardati con sospetto e apprensione, anche quando non erano così numerosi come a Troyes nel 1551. Essi affluivano nelle città in cerca soprattutto di lavoro, di ricovero e di assistenza: in un documento del 1569 si affermava che la beneficenza aveva attirato a Londra «un gran numero di vagabondi, furfanti, sbandati e oziosi, oltre che di poveri, storpi e malati». Ben presto si cominciò a pensare che non fosse opportuno prestare a tutti i bisognosi un aiuto indiscriminato. I vagabondi erano malvisti sia perché oziosi, sia perché rappresentavano una minaccia per l’ordine sociale: erano gente senza radici e senza occupazione, estranei alla comunità che li ospitava, in una parola erano «diversi». Nel 1582 un magistrato del Kent, William Lambard, si scagliava contro «i vagabondi e i mendicanti senza fissa dimora che infettano e corrompono il mondo coi loro furti, l’ubriachezza, la prostituzione, la procreazione di [figli – n.d.r.] illegittimi, gli omicidi e infiniti altri misfatti». Naturalmente molti di questi vagabondi cercavano solo di procurarsi da vivere. L’emigrazione di mera sussistenza, in aumento nel XVI secolo, era strettamente connessa col ciclo agrario: testimonianze relative all’Inghilterra degli anni dopo il 1570 mostrano che la mobilità era massima al termine della mietitura (agosto-settembre) e al tempo della semina (marzo-aprile). A differenza dei tradizionali migranti stagionali, che si trasferivano d’estate nelle zone di mietitura, ma tornavano in autunno ai loro villaggi, i nuovi migranti erano spesso degli sradicati, come quel Nicholas Lawrence, nativo dell’isola di Thanet, che dichiarò di essere «un povero bracciante, che oggi vive in un luogo e domani in un altro». [...] Le leggi, in base al presupposto che i disoccupati fossero tali per volontà propria, li trattavano duramente, come si può vedere da un decreto emanato nel 1544 nei Paesi Bassi, in cui si ordinava che fossero mandati alle galere «tutti i briganti e i vagabondi che non fanno altro che angariare la povera gente, andando di villaggio in villaggio e da una fattoria all’altra a chiedere l’elemosina, spesso con minacce, e passando la notte in taverne, fienili e luoghi simili; la loro miseria non deriva dai mali della guerra o da altre cause legittime, ma soltanto dal loro carattere riottoso e dalla loro indolenza, nel senso che non hanno nessuna voglia di guadagnarsi la vita lavorando». H. KAMEN, L’Europa dal 1500 al 1700, trad. di G. SCATTONE, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 179-182 Quale giudizio esprimevano sui poveri, le persone di alto livello sociale, nel Cinquecento? In quali provvedimenti pratici si espresse la loro valutazione? F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 UNITÀ 5 Povertà e vagabondaggio nel Cinquecento 9 RIFERIMENTI STORIOGRAFICI 7 8 L’arte al servizio della fede nel cattolicesimo del Cinquecento UNITÀ 5 Mentre il calvinismo rifiutava le immagini sacre, il cattolicesimo ne fece un uso sempre più marcato nei propri luoghi di culto, concependo l’arte come uno strumento capace di affascinare i fedeli e di tenerli legati alla Chiesa di Roma. L’ETÀ DI CALVINO E FILIPPO II 10 [Grazie ai nuovi ordini religiosi sorti nel Cinquecento], la Chiesa si salvò, e poté guidare da Roma una delle più straordinarie rivoluzioni dall’alto che la storia conosca. Diresse la battaglia in modo riflessivo. La civiltà che essa propagò – poco importa il nome – fu una civiltà di combattimento, e la sua arte un mezzo, un mezzo in più. Si tratta, in realtà, d’un’arte che appartiene alla propaganda. In certo qual modo, con i suoi lati buoni e cattivi, è un’arte guidata dall’alto. A Rubens come a Caracciolo, al Domenichino come a Ribera o a Zurbarán o a Murillo, dei religiosi accorti, dei teologi chiesero l’esecuzione di quadri da essi composti in spirito; salvo poi a rifiutarli, se l’esecuzione sembrasse loro difettosa. Contro il protestantesimo, nemico dei templi sontuosi e delle immagini, la Chiesa volle coscientemente costruire le più belle case di Dio sulla terra, immagini di Paradiso, lembi di cielo. L’arte è un mezzo potente per combattere e istruire. Un mezzo per affermare, mediante la potenza dell’immagine, la santità immacolata della madre di Dio, il valore efficace dei santi, la realtà possente dell’eucarestia, il primato di San Pietro, un mezzo per trarre argomento dalle visioni e dalle estasi dei santi. Pazientemente esaminati, pazientemente insegnati, temi iconografici identici circolano così in tutta l’Europa. Se il barocco forza la nota, se ha il gusto della morte, della sofferenza, dei martiri presentati con un realismo senza debolezze, se sembra abbandonarsi al pessimismo, al desengano spagnolo del secolo XVII, ciò dipende dal fatto che esso vuole e deve provare, che ricerca il particolare drammatico che colpisce e fa effetto. È un’arte ad uso dei fedeli, che si vuol convincere e trascinare, ai quali si vuole insegnare con l’azione una sorta di verismo, l’esattezza di tanti dogmi contestati: quelli del Purgatorio o dell’Immacolata concezione. Arte teatrale e consapevolmente teatrale: il teatro non servì forse d’arma da guerra ai gesuiti, specialmente nella conquista della Germania, in un tempo, aggiungiamolo, in cui esso aveva dappertutto i suoi diritti, le sue compagnie ambulanti, ben presto le sue scene fisse? F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, trad. di C. PISCHEDDA, Einaudi, Torino 1976, pp. 881-882 Con quali finalità venne usata l’arte dalla Chiesa cattolica, nel Cinquecento e nel Seicento? Che cosa significa l’affermazione secondo cui «L’arte è un mezzo potente per combattere e istruire»? Spiega che cosa significa la seguente affermazione: «Il barocco (...) è un’arte ad uso dei fedeli (...) Arte teatrale e consapevolmente teatrale». F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 Lo storico Fernand Braudel ha definito la battaglia di Lepanto una “vittoria senza conseguenze”, poiché essa non segnò una vera svolta nei rapporti di forza tra cristianità e Islam. Il brano che segue illustra la complessità delle relazioni internazionali e delle pressioni che si contrapposero alla corte dei sultani nei decenni che precedettero la battaglia. Nel 1566 scomparve il grande Solimano. L’Occidente tirò un sospiro di sollievo; qua e là vi furono anche manifestazioni di gioia. Eppure, un velo di mestizia sembrò offuscare quel prevedibile giubilo. Era venuto meno uno dei protagonisti della storia del secolo, un uomo politico e un sovrano che aveva saputo affascinare anche l’Occidente: che continuamente aveva parlato di lui, ne aveva imitato immaginificamente i fasti e i costumi nelle sue feste e nei suoi apparati, lo aveva ammirato, lo aveva perfino a più riprese ritratto. Lo stesso Tiziano aveva dipinto ben tre volte la sue effigie, fondandosi su immagini che gli erano state messe a disposizione e sforzandosi d’interpretarle. Paolo Giovio lo aveva lodato come pio e magnanimo. Fu soprattutto grazie a Solimano e al suo mito occidentale –alimentato da Montaigne, da Bodin, da Charon – che si fondò l’idea diffusa della giustizia, dell’ordine, della potenza severa e inesorabile dell’impero turco, parallela a quella della sua temibilità in guerra e della crudeltà dei suoi costumi. I molti viaggiatori cinquecenteschi francesi in Oriente non risparmiavano elogi nei confronti del Gran Turco che governava le sue genti in pace e giustizia. Si onorava la «pace turchesca» da lui imposta al suo impero: un’espressione d’onore, evidentemente ispirata alla pax romana, per quanto non mancasse chi ne sottolineava il carattere tirannico e feroce. L’imponente macchina da guerra ottomana era comunque ancora in moto. Il nuovo sultano Selim II (15661574), sistemate sia pur provvisoriamente le cose sul fronte balcanico-danubiano con la pace di Adrianopoli del 1568, tornava a investire con foga e da più versanti lo scacchiere mediterraneo. In un paio d’anni i cristiani persero infatti, a ruota, Tunisi (occupata nel 1569 da UlujAli succeduto al defunto Dragut come governatore di Algeri), e Cipro, conquistata dagli infedeli fra il luglio del 1570 e l’agosto dell’anno successivo, quando la piazzaforte veneziana di Famagosta si arrese. La perdurante intesa con i francesi rendeva più efficace l’offensiva turca. Come accolse l’Occidente la morte di Solimano? Quali fattori determinarono l’alleanza tra Spagna e Venezia? F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 Si dispiegava intanto, presso il sultano, l’attività politica e diplomatica d’un uomo geniale: Giuseppe Nasi, esponente autorevole degli ebrei spagnoli esuli a Istanbul e nelle altre città dell’impero ottomano. Mentre il vizir Mehmet Sôqüllü insisteva affinché si proseguisse la guerra contro la Spagna per il controllo dell’Africa settentrionale e magari si riprendesse quella contro l’impero per l’Ungheria, il Nasi caldeggiava invece un conflitto contro Venezia: e aveva intensificato la propaganda in tal senso dopo che, nel 1566, il sovrano turco lo aveva investito duca di Nasso e di altre isole dell’Egeo. Egli organizzava intanto attorno a Tiberiade delle colonie ebraiche chiamandovi gli ebrei espulsi dall’Italia. Se nella sua politica nordafricana il sultano seguiva le indicazioni del suo vizir, non trascurava certo i consigli del suo amico ebreo. Il 25 marzo del 1570 erano difatti arrivate a Venezia le richieste turche relative alla resa di Cipro. La Serenissima – che, dopo la Prévesa, aveva sino ad allora evitato di compromettersi in un’esplicita alleanza in funzione antiturca con la Spagna per non esser coinvolta nelle questioni nordafricane – dovette rivolgersi accorata, ora, all’unico che sembrava disposto a fermar gli ottomani: Filippo II. La Spagna cristiana – scossa da uno sbarco dei maghrebini in Andalusia, seguito dalla rivolta dei moriscos di quella regione tra 1565 e 1570 – rispose entusiasta. Cipro seguiva come sappiamo il suo destino: cadeva Nicosia il 9 settembre del 1570, cadeva Famagosta il 5 agosto del 1571: quattro giorni più tardi il fratellastro del Rey prudente, Giovanni d’Austria – il vincitore dei moriscos andalusi –, sbarcava a Napoli; e poco più d’un mese più tardi una flotta ispano-veneto-papale salpava da Messina. L’Occidente fu investito dalle notizie relative a Cipro, che sortirono però un effetto opposto a quel che i turchi – seminando al loro solito il terrore attraverso una crudeltà sapientemente ostentata – avevano immaginato. Il racconto del martirio inflitto al comandante veneziano di Famagosta, Marcantonio Bragadin, che lo aveva sostenuto con impavido stoicismo, fece presto il giro della Cristianità: e concorse a provocare proprio quel che l’abile gran vizir Mehmet Sôqüllü aveva fatto fin allora il possibile per evitare, l’alleanza tra Spagna e Venezia. F. CARDINI, Europa e Islam. Storia di un malinteso, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 234-235 UNITÀ 5 Verso Lepanto 11 RIFERIMENTI STORIOGRAFICI 9 10 L’attacco contro l’Inghilterra: gli obiettivi di Filippo II UNITÀ 5 Filippo II era profondamente religioso, ma anche capace di soppesare tutti i rischi di un’impresa militare. Il suo obiettivo principale, secondo alcuni studiosi, era di infliggere una dura lezione alla regina Elisabetta I, al fine di costringerla a interrompere i contatti politici con i ribelli protestanti dei Paesi Bassi e di obbligarla a togliere ogni appoggio e sostegno ai corsari inglesi che saccheggiavano le navi spagnole cariche d’argento, nell’Atlantico. L’ETÀ DI CALVINO E FILIPPO II 12 Indipendentemente dai suoi piani di guerra, quali erano gli obiettivi che Filippo II si proponeva di conseguire con il progettato attacco all’Inghilterra? Per lungo tempo la storiografia inglese ha privilegiato la tesi secondo la quale il re spagnolo non si proponeva nulla di meno della conquista dell’Inghilterra, del rovesciamento di Elisabetta – magari anche della sua esecuzione – e del ristabilimento del cattolicesimo in Inghilterra, come del resto il piano di Zúñiga [Juan Zúñiga, uno dei più autorevoli consiglieri politici di Filippo II, n.d.r.] indicava a chiare lettere. Coloro che parteciparono alla campagna dell’Armada, da una parte e dall’altra, sembrarono condividere in larga misura questa opinione. Più di recente però l’orientamento degli storici in merito è in parte cambiato. Certo, Filippo detestava il protestantesimo con tutte le sue forze e nulla gli sarebbe stato più gradito che vederlo schiacciato definitivamente, in Inghilterra come altrove; ma egli era anche abbastanza realista da capire quali fossero gli interessi concreti suoi e del suo regno. Come aveva scritto a Farnese, si rendeva conto del fatto che i cattolici inglesi erano ormai una minoranza perseguitata e ininfluente, e che restaurare pienamente il cattolicesimo in quel paese era ormai una causa persa. Non gli sfuggiva che, quand’anche gli fosse riuscito di sbarcare in Inghilterra e detronizzare la regina, si sarebbe poi trovato di fronte a una resistenza popolare irriducibile che avrebbe rappresentato un drenaggio insostenibile sulle risorse umane e finanziarie del suo impero. Quanto si era rivelato difficile – e alla lunga sarebbe stato impossibile – domare la rivolta olandese era un esempio più che eloquente di quale sarebbe stata l’enormità di un simile compito in un paese più vasto e popoloso, che per di più era un’isola. E poi quanto a lungo un’occupazione spagnola dell’Inghilterra sarebbe stata tollerata dalle altre potenze europee, a cominciare dalla Francia? C’era poi un altro fattore da considerare: se infatti Elisabetta fosse stata, in qualsiasi modo, eliminata, a succederle sul trono sarebbe stata Maria Stuarda, cattolica, sì, ma anche mezza francese, e che era anzi già stata regina consorte di Francia nonché legatissima alla ultrapotente fazione dei Guisa. Maria gli doveva della gratitudine: ma fino a che punto la gratitudine può prevalere sulle considerazioni politiche? Bel risultato sarebbe stato di abbattere i Tudor e i protestanti per favorire l’eventualità che suo padre, Carlo V, gli aveva raccomandato di temere più di ogni altra, una stretta alleanza fra Francia e Inghilterra! F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 Quella di Filippo II era una mente complessa e capace di analisi sottili. Alla sua leadership si può rimproverare di aver voluto decidere tutto dal suo piccolo studio all’Escorial senza rendersi conto di persona delle situazioni: non solo egli non parlò mai direttamente ad Alessandro Farnese [principe reggente nei Paesi Bassi spagnoli, che avrebbe dovuto unire le proprie forze a quelle dell’Armada, n.d.r.] durante tutto questo periodo, ma non visitò mai neppure la sua flotta in allestimento a Lisbona. Anche la sua esperienza di guerra era limitata e la strategia che aveva alla fine prescelto soffriva senza dubbio una scarsa aderenza alla realtà. Ma non gli si può negare la capacità di aver soppesato attentamente i rischi che correva né di aver saputo valutare con realismo il conto dei benefici e delle perdite che potevano derivare da un’impresa. E questa capacità non gli venne certo meno in questa occasione. L’analisi dei programmi e delle azioni porta a ritenere che Filippo avesse in mente due tipi di obiettivi, anche intercambiabili, che potevano essere alternativamente privilegiati in funzione degli eventi: gli obiettivi massimi e quelli minimi. Gli obiettivi massimi erano senza dubbio realizzare lo sbarco in Inghilterra e giungere fino a Londra: ma questo non significava necessariamente l’eliminazione di Elisabetta e del suo regime. In queste condizioni e con la sua bandiera che sventolava sulla Torre di Londra, con ogni probabilità Filippo sarebbe stato disposto a una pace a condizioni per lui vantaggiose, ma non del tutto devastanti per la regina. Queste condizioni avrebbero compreso la rinuncia alla guerra di corsa e alla pirateria, il ritiro delle truppe dalle Fiandre e la cessazione del sostegno ai ribelli nonché la libertà di culto per i cattolici in Inghilterra. Probabilmente vi si sarebbe aggiunto il pagamento di una indennità di guerra e magari il ritiro delle guarnigioni inglesi dall’Irlanda, oltre alla garanzia del controllo di qualche fortificazione nella stessa Inghilterra: ma Elisabetta e il protestantesimo inglese sarebbero sopravvissuti «buoni per un altro giorno» e l’esercito spagnolo sarebbe stato ritirato dal paese. Del resto, il protestantesimo era ormai una componente dell’Europa e, al di fuori dei propri territori, Filippo non si era mai proposto concretamente l’obiettivo di sradicarlo del tutto. Naturalmente gli eventi bellici hanno poi una logica loro propria che può portare a far cambiare gli obiettivi iniziali: ma questo è un altro problema. Nel 1586 e anche nel 1588 gli obiettivi massimi del re erano più o meno quelli. I due più importanti erano certamente la cessazione degli attacchi inglesi al commercio e alle coste spagnole, obiettivo che era anche quello più sentito dalla società spagnola nel suo insieme, e la cessazione del sostegno inglese ai ribelli olandesi. La libertà di culto per i sudditi cattolici di Elisabetta era certamente un obiettivo importante, ma complementare. Se questi erano gli obiettivi massimi, l’obiettivo minimo irrinunciabile era senza dubbio farla finita con gli attacchi inglesi per mare. Ma questo si poteva perseguirlo anche per altra via che non fosse lo sbarco in Inghilterra e perfino l’invio dell’Armada. Si poteva cioè intimidire gli inglesi a tal punto da indurli a intavolare trattative di pace con la sola minaccia dell’attacco diretto e dello sbarco. Questo poteva essere ottenuto tanto facendo apparire nella Manica una grande flotta in assetto di guerra, con relativo accompagnamento di trasporti sui quali fosse imbarcato un corpo di spedizione, quanto al limite senza necessariamente che questa partisse: bastava che si sapesse che essa era in allestimento. Proprio per questo motivo però era indispensabile che i preparativi fossero credibili. […] Non vi era alcun dubbio sul fatto che inviare l’Armada nella Manica avrebbe rappresentato un drenaggio di risorse quasi insopportabile. Non sfuggiva al re che, una volta dato l’annuncio della costituzione della flotta per attaccare l’Inghilterra, egli non poteva desistere dall’impresa senza ottenere almeno il suo obiettivo minimo, e cioè la fine degli attacchi inglesi per mare, pena una gravissima perdita di prestigio all’estero e anche all’interno. Costi vi sarebbero quindi stati comunque: ma sfruttare l’elemento deterrente rappresentato dall’Armada senza dover necessariamente combattere avrebbe almeno consentito di ridurli. Fu per questo che Filippo esitò fin quasi alla fine prima di impartire ai suoi capi militari gli ordini definitivi. A. MARTELLI, La disfatta dell’Invincibile Armada. La guerra anglo-spagnola e la campagna navale del 1588, il Mulino, Bologna 2008, pp. 144-148 UNITÀ 5 A giudizio dell’autore, Filippo II può essere definito «fanatico», cioè determinato a lottare a qualunque costo, pur di riportare il cattolicesimo in Inghilterra e nel resto d’Europa? Quali erano gli obiettivi massimi di Filippo II? E quali, invece, gli obiettivi minimi? Qual era il principale motivo di rancore della società spagnola, nei confronti degli inglesi? Il re era sensibile a questo problema? Vi era sintonia tra il sentire del re e quello della società spagnola? RIFERIMENTI STORIOGRAFICI 13 F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 11 La posizione politica di Jean Bodin Per Jean Bodin, l’autorità dello Stato dev’essere conservata a qualunque costo, pena il caos e l’anarchia. Da un lato, egli attacca i ribelli calvinisti, che giustificano la rivoluzione, ma dall’altro ritiene che la tolleranza religiosa sia indispensabile per il mantenimento dell’ordine politico. UNITÀ 5 A La stabilità dello Stato come obiettivo politico primario primo sottotitolo L’ETÀ DI CALVINO E FILIPPO II 14 Bodin non pretende affatto di accantonare il grande valore duraturo dell’uniformità religiosa. L’intera questione delle religioni rivali viene introdotta nel corso della discussione e a mo’ d’esempio dei pericoli della «sedizione e del fazionalismo». Egli inizia ammettendo che nulla è più importante per «conservare in vita gli Stati nel loro ordinamento», giacché serve a fornire «il fondamento primo del potere» e della forza dello Stato. Qualunque cosa Bodin fosse stato disposto ad affermare e scrivere in privato, pubblicamente, nelle sue dottrine, affermò sempre la necessità di non accettare il diritto naturale alla tolleranza delle minoranze religiose. Egli insiste al contrario che siccome «le dispute in materia religiosa» tendono più di qualsiasi altra cosa «ad apportare l’eversione degli Stati, occorre proibirle per certo con leggi inviolabilissime», cosicché una religione la quale «si regge sul consenso comune», non sia di nuovo «messa in discussione». Questi sentimenti sono tuttavia accompagnati da una percezione riluttante eppur assolutamente chiara del fatto che, rappresentando le religioni rivali una fonte talmente potente di discordia, laddove non possano essere soppresse, esse devono essere tollerate. Bodin cita la situazione del suo tempo, in cui il consenso e l’accordo della nobiltà e del popolo verso una nuova religione sono divenuti «così potenti che sarebbe impossibile o per lo meno ben difficile distruggerli senza mettere a rischio lo Stato». «In questo caso i principi più saggi hanno preso l’abitudine di fare come quei piloti (timonieri, n.d.r.] prudenti che si abbandonano alla tempesta sapendo bene che resistere ad essa provocherebbe solo un naufragio generale». Bodin sottolinea immediatamente quale lezione si deve trarre da questa similitudine: è necessario riconoscere «tutti i collegi, corpi e comunità di qualsiasi tipo» che non possono essere eliminati senza porre in pericolo o distruggere lo Stato. La prima ragione per accettare questa conclusione è, secondo Bodin, che, pur avendo il governo il dovere di sostenere l’unità religiosa, ciò non può alterare il fatto che «la salute e il benessere dello Stato» devono rimanere «la cosa principale rispettata dalla legge». Dove si scopre che l’ordine è in conflitto con l’uniformità religiosa, si deve sempre trattare come suprema priorità il mantenimento dell’ordine. B La polemica contro i monarcomachi calvinisti primo sottotitolo Bodin vide chiaramente come suo principale compito ideologico quello di attaccare e sconfessare nei Sei libri la teoria ugonotta della resistenza, che egli era giunto a considerare il maggior pericolo alla possibilità di restaurare una monarchia ben ordinata in Francia. Questo fine F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 fondamentale emerge molto chiaramente nelle prefazioni programmatiche aggiunte alle edizioni successive della sua grande opera. Bodin esterna il suo estremo orrore perché vede «i sudditi armarsi contro i principi», scritti sediziosi [che incitano alla rivolta armata, n.d.r.] «pubblicarsi come fiaccole per l’incendio degli Stati» e il popolo «con lo spettro della tirannide ribellarsi al potere di quei re che sono dati alla stirpe umana per divino consiglio». Ripetutamente Bodin indica che è sua intenzione rispondere a questi «uomini pericolosi», i quali con il pretesto della libertà popolare «eccitano i sudditi alla ribellione contro i loro prìncipi naturali, aprendo la porta a quella anarchia ch’è peggio di qualsiasi tirannide del mondo, sia [perfino della, n.d.r.] la più aspra». La risposta di Bodin ai rivoluzionari ugonotti è diretta e inflessibile: nessun atto pubblico di resistenza di un suddito contro il legittimo sovrano può essere mai giustificato. […] L’attacco di Bodin alla teoria e alla pratica della rivoluzione ugonotta ci porta al cuore delle dottrine positive enunciate nei Sei libri in quanto ci conduce alla discussione della sovranità, considerata da Bodin «il punto principale e più necessario per la comprensione della natura di uno Stato». Se un governante non è «sovrano in assoluto», «è senza alcun dubbio lecito» da parte dei suoi sudditi resistergli e «procedere contro il tiranno per via di giustizia». Ma dovendo essere il fine fondamentale del governo quello di assicurare non già la libertà, bensì l’«ordine», qualsiasi atto di resistenza di un suddito contro il suo governante va completamente bandito nel nome della conservazione della fragile struttura dello Stato. Bodin è quindi tratto dalla logica del proprio impegno ideologico a sostenere che in qualsiasi società politica vi deve essere un sovrano assoluto, nel senso che egli comanda ma non è mai comandato, e quindi non può essere mai legittimamente contrastato da nessuno dei suoi sudditi. Tale conclusione è enunciata per esteso nel Libro I, Capitolo VIII, intitolato Della sovranità. Bodin inizia definendo la sovranità come «quel potere perpetuo e assoluto che è proprio dello Stato». Fa poi capire chiaramente che nel caratterizzare il sovrano come «assoluto», egli ha in mente soprattutto una cosa: perfino quando le sue ordinanze non sono mai «eque ed oneste», «al suddito non è lecito contravvenire alle leggi del suo principe» o opporsi in altri modi «col pretesto dell’onestà e della giustizia». In breve, il sovrano è per definizione esente dalla resistenza armata, poiché «sovrano è chi non riconosce nulla superiore a sé all’infuori di Dio». Sono così state già completamente gettate le fondamenta per la successiva creazione del «grande Leviatano», visto [dal filosofo inglese Thomas Hobbes, che pubblicò la sua opera principale, Leviathan, nel 1651, n.d.r.] come «Dio mortale», a cui «sotto il Dio immortale dobbiamo la pace e la difesa». Q. SKINNER, Le origini del pensiero politico moderno, II. L’età della Riforma, il Mulino, Bologna 1989, pp. 363-364, 409-413 Tra mantenimento dell’ordine e uniformità religiosa, qual è la priorità per Bodin? Come si deve porre il suddito nei confronti di ordinanze sovrane che non sono «eque ed oneste»?
Scaricare