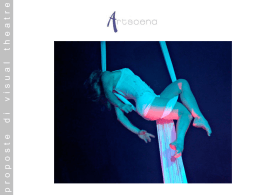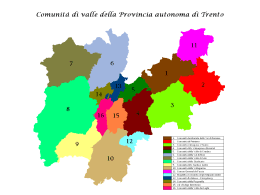Entroterra di Ponente, modi di vivere, modi di abitare. INTRO Guardando da lontano, nel lungo orizzonte, lo sguardo prende subito di mira ciò che è diverso dalla natura. Infatti è attirato dalle costruzioni umane, apparizioni sempre straordinarie, nel senso che non appartengono alla successione ordinaria del paesaggio (morfologia, vegetazione, coltivi, ecc...). Mentre accade questo fenomeno dello sguardo, interpretabile come un buon segno verso l’umanità, ci sono posti nei quali i paesi che tanto hanno attirato l’attenzione sembrano mimetizzarsi e rientrare nella natura da cui si erano separati. Questo accade nel Ponente ligure. L’arte di mostrarsi e l’arte di mimetizzarsi appartengono ai principi fondamentali dell’architettura, i quali principi, quando vengono infranti, producono la brutta arte di rimanere troppo esposti e sempre in bella vista, come succede alle brutte costruzioni, incapaci di nascondersi. Il brutto, infatti, non viene accettato né dalla natura né dal nostro sguardo e rimane senza riparo e remissione come chi non appartiene a nessuno. Nel corso di questo piccolo viaggio di studio, diffidando del concetto di spontaneità in architettura e dubbiosi sull’esistenza di antichi piani regolatori, abbiamo cercato di capire la formazione Prima Tappa Pontedassio Se uno vi dicesse che il paesaggio bisogna andarselo a cercare, come minimo rimarrete perplessi. Eppure guardatevi intorno: è quasi tutto coperto da villette, da pa-lazzi, da stabilimenti, da supermercati e da strade so-stenute da alti muraglioni. Cosa è successo? Il pae-saggio dov’è? Niente paura. Se c’è una cosa che non bisogna prova-re di fronte al paesaggio maltrattato è la paura, la qua-le , a sua volta, genera l’indifferenza, una forma di cecità provvisoria per non vedere le cose brutte. Invece di non vedere le cose brutte la cosa da fare è perdonarle. Il perdono è il modo giusto per non rifiuta-re tanti angoli di mondo che noi abbiamo manomesso. Se siamo in grado di perdonare la bruttezza riceviamo un premio grandissimo: saremo in grado di trovare il bello che si è nascosto qua e là, come insegui-to, ma che resiste, bellissimo, nei posti più strani. Mai vista una palma meravigliosa in una discarica di calcinacci dell’edilizia? Non vedete che il cielo è splendente anche dietro un brutto palazzo? Non sono esercizi facili. Quelli di Pontedassio ci perdoneranno se abbiamo tirato in ballo queste idee mentre andiamo proprio a Pontedassio. Niente paura. Tra Oneglia e Pontedassio si trova la fascia critica dello sviluppo della Valle Impero. I concetti di bello e di brutto valgono poco in questi casi. Il bello è in movimento e, ogni tanto, quando si imbatte male, pren-de una brutta cera. E’ in questi casi che noi dobbiamo im-parare l’arte di guardare, di capire i tempi della storia e, alla fine, l’arte di perdonare. Quest’ultima non è un’arte qualun-que, che accetta tutto quello che capita. E’un’arte sopraffina, che va a cercare il bello dappertutto e, state sicuri, lo troverà. Pontedassio è al confine , dove il paesaggio antico si me-scola con la modernità industriale. E’ proprio qui che noi possiamo fare i nostri esercizi di lettura, andando a trova-re l’antico alfabeto della bellezza. Solo così riusciamo vedere le pietre del vecchio ponte, un limone che sbuca dal muro, qualche alto cipresso, muri di case lavorati come una superficie scolpita. Ve-dete che è vero? Il perdono è stato premiato. Se avete fatto bene i primi esercizi, adesso tutto fila lascio. Troverete gli angoli giusti, che vi ripagano con generosità. Sentirete che l’antico paesaggio è ancora vivo sotto l’oppressione di troppi muri e di troppi tetti. Siccome siete voi che l’avete scoperto, lui vi sorriderà. A questo punto l’avete meritato e lui vi prenderà letteralmente per mano e vi condurrà dove quasi tutto è intatto, dove i secoli sono vivi come fosse ieri. Meravigliosi relitti vi accoglieranno, uliveti che hanno visto passare tante vite umane, e tutto ciò si fa sentire, perché avete trovato l’anima. Questo è il mestiere del turista. Diano Arentino In queste valli così morbide che si chiamano Valli del Dianese, i paesi hanno nome e cognome. Sembrano persone che appartengono a una famiglia. Il cognome è Diano e i parenti sono tanti: Diano Marina, Diano San Pietro, Diano Castello, Diano Arentino. Perfino le frazioni dei comuni hanno nome e co-gnome, come fossero nipotini: Diano Borello, Diano Borganzo, Diano Roncagli. Sembra che effettivamente si tratti di una famigliola, messa com’è in un ambiente rilassato e pacifico, una specie di grande culla, al riparo di un monte imperioso, affilato come un becco che infatti si chia-mava, in antico, Scortegabecco. Alcuni sostengono che questo nome così efficace abbia a che fare con una pianta frequenti in questi posti, il profumato lentisco, che in dialetto si chiama proprio così. Il monte, ufficialmente, porta il nome di Pizzo D’Evigno e ci fa capire qual è il carattere di questa Ligu-ria, dolcissima e mite, ma che si impenna, all’improvviso, mostrando antichi spettacoli, le bianche os-sa geologiche, come dire che la bella Riviera ha una madre antica e montanara. La rapidità con cui si passa dai crinali ventosi, meravigliosamente poveri e tuttavia ricchissimi di rarità bota-niche, alle conche grasse e coltivate al centimetro, dove c’è il basilico e i campi di rose , è soltanto una delle suggestioni che questo territorio ci offre. Qui è bello cercare le cose minute e le sorprese non manche-ranno: si scopre come i contadini liguri siano straordinari nel ricavare campi artistici dove appena si può stare in piedi, come si scoprono storie innumerevoli di arte umile e raffinata, chiese romaniche e barocche, pale d’altare, belle statue di Madonne. In fondo, lontano, c’è il mare di Diano Marina, San Bartolomeo e Cervo. Chi è laggiù, lungo le belle spiagge, difficilmente non è attirato da questi monti che promettono segreti esclusivi, cose uniche, visioni che solo la lontananza custodisce. Seconda Tappa Cesio Cosa c’entra Cesio con Ranzo? Cosa li accomuna? Il modo più facile per capirlo è prendere un compasso. Il perno del compasso lo mettiamo a Pieve di Teco e adesso apriamo le due gambette, non troppo: una corrisponde alla Valle Impero che termina a Imperia; l’altra corrisponde alla Valle Arroscia che termina ad Albenga. Cesio è sulla prima gambetta e Ranzo è sul-la seconda, quasi alla stessa altezza. In mezzo c’è un grande triangolo dove siamo già stati: le Valli del Dia-nese. Ecco risolto il mistero. Le due gambette del compasso ci dicono che, nel ponente, le valli sono fatte a ventaglio, annodate in alto, verso i monti, e divaricate in basso, verso il mare. La via comoda segue le gambette del com-passo, per esempio la famosa Statale 28; la via poetica invece va di traverso, sui crinali che separa-no una valle dall’altra, e trova i segreti migliori di questa terra alla luce del sole, ma capace di na-scondersi in posti remoti. Di bello a Cesio c’è soltanto la bellezza. Strana faccenda. Innanzitutto da lì si può capire l’olivicoltura ligure, come se i contadini del passato avessero percorso palmo a palmo tutta quella terra impervia, esplorando con le mani la temperatura, le ore di sole, le pendenze, le vene dell’acqua. Dove l’istinto e l’esperienza dicevano di sì’, là nasceva l’uliveto. E’ così che vediamo gli uliveti dispersi co-me macchie d’argento scuro tra la ruggine dei bo-schi invernali, querce e castagni. Cesio è il posto adatto per grandi lezioni all’aperto. Non c’è biso-gno che abbia grandi monumenti. Messo com’è, al balcone della Valle Impero, ha davanti più cielo che terra. Più che guardare a se stesso, Cesio guar-da tutto il resto, una virtù rara, che merita un pellegrinaggio. Ranzo L’attraversata da Cesio a Ranzo è possibile. In ge-nere, però, vince il principio che ha insegnato l’arte ai geografi: il corso dei fiumi ci indica do-ve tracciare le strade più comode. Anche questa volta sarà così. Dalla Valle Impero si scavalca a Colle San Bartolomeo e scendiamo per la Valle Arroscia fino a Ranzo. Dal puro guardare lontano, qui siamo invitati a guardarci intorno. Non siamo più aggrappati all’osso della montagna, sia-mo arrivati in una conca dove si è depositata la pin-guedine dei campi , terra coltivata come un giardino, vigne, orti. Si sente che laggiù in fondo c’è Albenga, capitale dei vasetti di erbe aromatiche, risalite in tante coltivazioni lungo la valle. Ranzo è un paese di strada, nel senso che la strada della Valle Arroscia ci passa in mezzo, spingendolo un po’ verso il fiume e un po’ verso la collina. Ranzo capoluogo sembra avere generato una famiglia numerosa di bor-gate bianche, sparpagliate sulla sponda al sole. Vuole dire che siamo in una terra che ha dato da mangiare a tanta gente, terra popolosa oltre che de-vota a guardare le chiese, gli oratori e i campanili che sbucano dopo ogni curva, là dove c’è un gruppo di case. Anche le chiese sono bianche. Intonaci e decori barocchi coprono a volte antiche murature di pietra come se, un bel giorno, fosse arrivato un col-po d’aria gentile, una devozione affettuosa, che ha rivestito di stucchi e accenni d’oro altari e facciate. Perfino San Pantaleo, massimo monumento, sa essere severo e civettuolo. A Ranzo è nato il pittore Pietro Guido, il più noto rappresentante ligure di una squadra di pittori, i quali, nel millecinquecento, hanno scaldato con i loro colo-ri, dal Piemonte alle valli di Nizza, tante chiese e santuari di montagna. Terza Tappa Borgomaro Non è la prima volta che succede: la cultura a volte ci porta fuori strada. La questione, in questo caso, è divertente e complicata, in quanto a portarci fuori strada è proprio una strada, la notissima statale 28 del Col di Nava. E’ un bel caso. Uno pensa che la valle del torrente Impero segua questa strada, dritta verso nord. Invece il torrente, quasi all’insaputa, fa una bella curva dopo Chiusavecchia e risale per una valle che la cultura della viabilità ha reso laterale. Questo è il potere delle strade diritte! Noi comunque svoltiamo e seguiamo il fiume e la sua antica strada tortuosa, la quale non ci porta a perdere nell’intrico di valli e monti, in quanto, a lungo andare, ci porta in Valle Argentina, meta superba, o nell’alta Valle Arroscia, che non è da meno. I malintesi suoi nomi non sono ancora finiti, perché invece che Valle Impero questa si chiama Valle del Maro. Chi ci vuole confondere le idee? Tutto si spiega quan-do veniamo a sapere che il termine Maro riguarda un ra-mo dei Conti di Ventimiglia che governavano da queste parti. Adesso possiamo andare tranquilli a Borgomaro, nella Valle del Maro, dove scorre il torrente Impero che nasce lassù, dal Monte Grande, luogo famoso di lotte par-tigiane. Finalmente un po’ d’ordine! A Borgomaro vale la pena fermarsi. Si sente subito che questa è la valle delle acque, come testimoniano perfino i numerosi lavatoi, veri monumenti, i quali, non si sa per-ché, e più ancora delle fontane, esprimono una particola-re devozione all’acqua, della quale esaltano la purezza, la musica continua, il sentore di vita in movimento. L’acqua ha attirato frantoi e mulini e, anche adesso che le loro grandi ruote sono ferme, sembra che il loro gocciolare sia ancora nell’aria, come l’odore delle olive spremute. Siamo capitati giusti. Questa è la Valle dell’Impero. Come spesso in Liguria, i fondovalle ricavano il proprio fascino dall’ombra, dal suolo profondo, dove tutto il buono sembra essere disceso dai monti che infatti sono rimasti spogli, pieni di vento, spirituali. A guardare bene, in alto, questa è una valle di gran-di e famosi pascoli, con le caselle di pietra a secco, primordiali, che insegnano l’origine della volta e dell’arco. In paese le volte e gli archi di pietra si pre-sentano evoluti, esperti nelle soluzioni architettoniche, per cui l’intera valle risulta un bel libro di lettura, dai principi elementari ai calcoli raffinati. Aurigo Ci vuole poco per entrare in un altro mondo. Basta andare ad Aurigo, a due passi, dove dal-la poesia dell’acqua si passa alla poesia dell’aria. Aurigo ha il dono del sole, dall’alba al tramonto. Può sembrare strano, ma dove c’è lo splendore della luce, gli uomini hanno costruito i ripari per l’ombra, come dimostrano tutti i paesi della Liguria montana, con vicoli che sembrano grotte artificiali, forse in memoria di ripari antichissimi, modelli di difesa e di raccoglimento. Un esempio insigne di come la luce si sposa con lo scuro l’abbiamo nella chiesa di Sant’Andrea, accanto alla quale, candidamente intonaca-ta, si erge un meraviglioso campanile di pietra colore del ferro, robusto e incerto, come i primi passi di un bambino che non cadrà, ottimo ma-nuale per muratori che non ci sono più. Quarta Tappa Chiusanico A Chiusanico troverete ciò che vi aspettate, ma anche il suo contrario. Vi attende una sorpresa, che è il motivo di ogni viaggio. Per scoprire di che si tratta dovete prestare attenzio-ne a tanti piccoli indizi, sparsi per il paese. Potete iniziare visitando la chiesa di Santo Stefa-no: sul sagrato a risseu (il mosaico a ciottoli bianchi e neri tipico di Genova) sono disegnate delle caravelle, con la fatidica data 1492. Ma che c’entra l’America con Chiusanico? Entrate in municipio e la spiegazione sarà più vicina: vi attende infatti un busto in terracotta di Cristoforo Colombo. Se ancora non avete risolto il rebus, è meglio che usiate i piedi anziché la testa: andate direttamente in via Colombo, al n. 8. Una piccola targa vi fornirà la risposta: quella è la casa dove nacque lo scopritore delle Indie Occidentali. Come ogni storia che si rispetti, anche in questo caso ci vuole una buona dose di fiducia e immaginazione. Perché in giro per il mondo ci sono tante case native di Colombo: a Genova, a Cogoleto, a Cuccaro Monferrato, a Piacenza, a Terrarossa, a Bettola. Altri storici e linguisti lo fanno nativo della Spagna e forse anche marrano e forse an-che sefardita. Vera o falsa che sia, la storia di Cristoforo Colombo da Chiu-sanico è comunque divertente. Si può immaginarlo bambino, mentre guarda il mare da lontano, uno spicchio blu all’orizzonte con i monti innevati alle sue spal-le. Possiamo vederlo salire di corsa lungo un sentiero fino a Torria e fermarsi a contemplare il fondovalle, fingendo di trovarsi sulla tolda di una nave. Il Colombo di Chiusanico non è né scienziato, né navigatore, né mercante. Il Colombo di Chiusanico è un esploratore sognante e il suo mare è uno spazio di libertà, fanta-sia e speranza, perché questo è il mare per chi vive nelle valli. Ora voltate le spal-le alla leggenda e dedicate la vostra attenzione a Chiusanico: ammirate le sue belle case di pietra, gli oliveti sparsi dappertutto, il santuario della Madonna della Visitazione e lo splendido dipinto su questo tema di Domenico Piola. Prima di partire, però, volgete gli occhi improvvisamente verso il mare: talvolta acca-de che l’antico blu indichi la direzione dei sogni. Chiusavecchia Di Chiusavecchia corre l’obbligo di parlare, non fosse altro per colmare un vuoto. La bellezza del paese, infatti, è ingiustamente trascurata. Anche le “bibbie rosse” del viaggiatore, quelle guide im-ponenti che richiedono più tempo per leggerle che per guardarsi intorno, non ne fanno praticamente menzione. Sarà forse per que-sto che a Chiusavecchia hanno dedicato una via ad un miste-rioso “poeta pellegrino”. Approfittando del vantaggio di non sape-re chi fosse, ci si può divertire ad immaginarlo. Noi ce lo figuriamo con una mantella nera, un berretto rotondo di feltro e un robusto bastone di castagno, buono per camminare ma anche per offendere e difendere. Girava per i paesi della valle Impero e dell’Arroscia, accompagnato da un cane un po’ randagio e un po’ bastardo. Si guadagnava il pane, facendo poesia a se-conda dell’occasione: per matrimoni, feste laiche e sacre, compleanni, fidanza-menti e magari pure funerali. Ma cosa avrà cantato di Chiusavecchia, il nostro aedo? Noi scommettiamo che avrà raccontato dei mulini, quelli ad ac-qua,invece di quelli a vento. Avrà messo in poesia gli ulivi che sono dappertutto da queste parti, come una ossessione, come una benedizione, al punto che c’è pure un santuario dedicato alla Madonna dell’Uliveto. C’è da credere che abbia cantato anche della pietra locale, che da queste parti fa belle le case, le terrazze, i ponti. Al suo posto noi avremmo cantato anche della bella chiesa parrocchiale di San Biagio e di San Francesco di Sales, in stile barocco e con il suo bel campani-le a cipolla, ma chissà se avrà fatto in tempo. Questa insomma, la nostra propo-sta. Ma adesso tocca a voi, trovare la vostra poesia di Chiusavecchia. D’altra parte è risaputo che la bellezza è negli occhi di chi la guarda. Quinta Tappa Dolcedo Vasia Dolcedo non si visita, Dolcedo si legge. Dovete sfogliarne le pagine, come se aveste sotto gli occhi un piccolo, intelligente e denso manuale di architettura. E’ un piccolo compendio dell’arte di costruire dell’entroterra, con le sue “cose grandi” e i piccoli trucchi del sapere artigiano. Troverete il topos dei caruggi, stradine strette tra le case e spesso coperte, che fanno somigliare i paesi dell’entroterra a fortezze o alverari. Alzando gli occhi scoprirete l’estetica della praticità nei loggiati ( detti “altane”), aperture ad arco utilizzate come essiccatoi ma capaci di dare “respiro” alle abitazioni. A Dolcedo, che è un paese di fiume, l’architettura dialoga con l’acqua. Per capirlo basta dare un’occhiata alla “Palazzata”, l’insieme di case a schiera unite senza soluzione di continuità, che si affaccia sul Prino, quasi a contemplarlo. E prestate attenzione ai cinque ponti che collegano le diverse frazioni, tra cui il Ponte Grande, con la sua unica arcata a sesto acuto. Opera “grande” è certamente la chiesa di S. Tommaso, la più vasta e ricca dell’intera valle, in stile barocco, progettata da uno dei tanti architetti della dinastia Marvaldi, che nel XVII secolo erano gli architetti di “grido” della zona in fatto di edilizia religiosa. Dato che l’architettura è, anche, una sorta di testimonianza, pensate com’era Dolcedo nel 1600: si contavano allora ben 4.000 abitanti. Contrappunto armonico di tanta arte aulica dell’edificare sono le piccole ingegnosità del costruire, per scopi agricoli o civili. Tra queste vi consigliamo di andare a cercare le prëe garbe, le pietre bucate, che servivano da supporto per i pali. Le prëe garbe, poste in posizioni aggettanti, costituivano una sorta di aggancio e venivano usate per molteplici scopi: per inserire i pali dei vitigni, per tirare una rete negli uliveti, per i pergolati delle case patrizie. Testimonianza del genius loci di Dolcedo sono anche i casô, costruzioni rettangolari in pietra caratterizzate da tra arcate centrali sulle quali poggiavano le piccole travi di quercia che sorreggevano il tetto di ardesia. I casô, che ospitavano le greggi brigasche, costituiscono un umile simbolo della capacità adattiva dell’architettura all’ambiente, perché consentivano di realizzare alti tetti pur non avendo a disposizione il legname adatto allo scopo, che era sostituito dalla pietra, da queste parti molto abbondante. Di Vasia, più che dire, abbiamo da domandare. Anche questa, se ci pensate, è un modo per offrirvi un aiuto per il vostro viaggio. In questo caso, al posto delle risposte, trovate delle domande. Il che, se un po’ vi darà disturbo, vi costringerà anche all’attenzione e all’arte di interrogare. Dato che non vogliamo tirare troppo la corda, meglio partire dalle questioni semplici. La prima domanda sorge spontanea ed è molto evidente: perché quel campanile? Sì, proprio quello della chiesa di S.Antonio Abate che vi si para subito davanti agli occhi. Noi abbiamo, forse, scoperto che è dell’inizio dell’Ottocento e che il suo costruttore fu un capomastro svizzero di nome Monti. Ma sul perché l’abbiano fatto così alto – misura 49 metri, il più alto della valle – non abbiamo trovato nessuna risposta. Il consiglio allora è di provare ad interrogare la gente del posto, perché di sicuro qualcuno avrà una spiegazione, magari legata alla vanità del capomastro, o forse allo scioglimento di un voto, o forse ad una questione di “campanilismo”. Se avete trovato la vostra risposta e se la sfida vi appassiona, saliamo di livello. Le domande a dire il vero sono tante e dipendono tutte dal dipinto “La sacra famiglia” di Antoon Van Dyck. A noi risulta che 1624 il celebre pittore fiammingo dipinse questo famoso quadro su rozza tela, donandolo alla chiesa di Sant’Anna di Vasia. Se avete voglia provate a scoprire se è vero (perché alcuni lo attribuiscono al suo collaboratore Jan Roos) e provate anche a chiedere dove si trova adesso (perché a noi risulta che sia stato trasferito nella chiesa di Moltedo). Soprattutto provate a chiedere che diavolo ci facesse da queste parti un pittore tanto affermato e frequentatore delle corti europee e perché abbia deciso di regalare ad una sperduta chiesa il suo dipinto. L’ultima domanda è quella più infida, perché in apparenza più facile ma in realtà decisiva. Provate a chiedere perché l’olio di queste parti è così buono. Ma non preoccupatevi se non trovate risposta: solo l’assaggio vale da solo tutto il viaggio. Sesta Tappa Pietrabruna “Sentieri di pietra”. Così potrebbe chiamarsi questa tappa di Olioliva continua. Che la pietra sia protagonista lo preannuncia anche il nome che avete sotto gli occhi: Pietrabruna, che pare debba il suo nome proprio al colore dei sassi con cui è stata edificata. D’altronde la pietra con il passare degli anni e dei secoli si è nobilitata. E’ diventata il simbolo di un sapere artigiano che ha saputo adattare il suo fare alle condizioni economiche e alle caratteristiche dell’ambiente. Questa notorietà si deve, in parte, al suo diventare inattuale. Solo quando si è smesso di costruire le case e i ponti e le chiese con i sassi ci si è resi conto della bellezza e dell’intelligenza di questo edificare con semplicità. Si potrebbe anche dire che i sassi sono diventati belli con il cemento, che li ha sostituiti quasi per intero nell’edilizia. Tutto ciò darebbe un senso anche alla bruttezza di tante costruzioni degli anni ’60 e ’70, che proliferano anche in questa lembo di Liguria: sarebbero come l’ombra che mette in risalto la luce in certi violenti quadri caravaggeschi. Comunque non preoccupatevi, perché a Pietrabruna troverete più che altro segni di bellezza. Di pietra è la chiesa di S. Gregorio, edificata nel XII secolo. E’ in stile romantico che, se ci pensate, è quello che meglio si adatta ad essere edificato con i sassi, che ne esaltano la semplicità e sobrietà della trama. Pure di sassi sono molte case e palazzi, come già tante altre nei dintorni.Più specifici sono invece i portali in ardesia sormontati da bassorilievi ed epigrafi: andate a cercarli, perché non ne troverete molti altri esempi altrove (Taggia e Triora permettendo). Il percorso “petroso” non è però sufficiente per conoscere Pietrabruna. Dovete cercare da voi il sentiero invisibile dei profumi e dei fiori. Potete scegliere l’itinerario nostalgico, evocato dalla lavanda, che qui fu, per lungo tempo, una delle coltivazioni principali. Oppure potete incamminarvi lungo sentieri più attuali, cercando i colori degli anemoni e dei ranuncoli che in molti coltivano da queste parti Taggia Per Taggia non è facile trovare un perché. Non per mancanza, ma per eccesso. Forse è d’obbligo partire dalle taggiasche, per spiegare il motivo del viaggio. Quindi va bene partire dalla chiesa romanica di Santa Maria del Canneto, eretta tra il X e il XII sec. Li accanto troverete un uliveto storico, simbolo dell’introduzione da parte dei benedettini della coltura dell’ulivo nel Ponente Ligure e testimonianza di una delle più riuscite sintesi della regola dell’ “ora et labora”, su cui si fonda la vita monastica dell’ordine. L’altro motivo del viaggio è, anche qui, la pietra. In particolare l’ardesia, che in antico era il materiale per eccellenza dei portali della Liguria. Fate un giro per il centro storico per apprezzare la qualità degli scalpellini che per secoli si sono alternati nel lavorare questa pietra nera, resistente e liscia al tatto come un velluto. Girando per Taggia potete comprendere a fondo l’intima natura contrastata di questo entroterra, in cui luce e ombra sempre si alternano. Così in natura, dove il chiarore che viene dal mare lotta con l’oscurità di oliveti e boschi, così nelle città, in cui i borghi si stringono, si ritorcono su se stessi e si vestono a nero per sfuggire agli eccessi di una luminosità che toglie profondità e rilievo. Sempre di pietra , ma non di ardesia, è il ponte medievale a 16 arcate che attraversa il torrente Argentina: anche questo vale, quasi da solo, il vostro viaggio. L’ultimo motivo è quello più importante. Anche questo è legato ad un ordine, questa volta quello dei Domenicani, che qui hanno costruito nel XV secolo uno dei conventi più belli e importanti di tutta la Liguria. Il linguaggio, ancora una volta, è quello dell’assenza e della presenza. Di ciò che resta e di ciò che è stato e viene evocato. L’eleganza della facciata della chiesa a conci bianchi e neri e la raffinatezza delle opere d’arte (del Canavesio e dei Brea) raccontano del passato glorioso di Taggia che, grazie all’attività di questo convento, fu per tre secoli il centro culturale e artistico della Riviera di Ponente. D’altra parte, per capire a fondo la bellezza di quest’alternarsi di pieni e di vuoti che è la storia e la natura dell’entroterra, è sufficiente che passiate nel convento e che passeggiate all’ombra della luce sotto le colonne di pietra nera del chiostro del XV secolo. Settima Tappa Badalucco Castellaro Questa tappa vorremmo dedicarla al narrare più che al viaggiare. All’arte del raccontare, che tesse tra loro cose diverse e fatti distanti. Alla letteratura, che rende tangibile l’incredibile e che rende inutile distinguere il vero dal falso. Di cose rare e di racconti strambi, infatti, ne incontrerete parecchi, visitando Badalucco e Ca-stellaro. Può capitarvi, per iniziare, di incontrare i saraceni, mentre gustate lo stoccafisso di Badalucco preparato con specifica e rinomata ricetta locale. Perché un’antica leg-genda narra che proprio le scorte di stoccafisso permisero agli abitanti del paese di resistere al lungo assedio dei saraceni e di passare al contrattacco. L’epica guerresca è d’altronde ben radicata da queste parti. Ne sentirete gli echi visi-tando i ruderi del castello di Campo Marzio, fortificazione bizantina sorta presumibilmente su antichi ruderi romani. Il mito locale, posto sul confine tra cronaca e favola, racconta che in questi boschi nel II secolo a.C si svolsero le battaglie decisive tra popolazioni liguri e i romani, al termine delle quali tutta la Liguria di Ponente passò sotto l’orbita romana. Anche il centro storico di Badalucco sembra costruito apposta per farsi racconto. Tra le “cose notevoli” del paese ci sono, infatti, le cinque antiche porte del borgo fortificato e i due ponti so-pra il torrente Argentina. Le cinque porte sono al-trettanti punti di vista diversi per conoscere il paese, sono cinque incipit diversi per intraprendere un percorso di scoperta. E così i due ponti che servono, anche, per collegare le storie diverse che il paese stesso vi invita ad inventare. Non preoccupatevi se, di solito, non siete capaci di invenzione. Qui a Bada-lucco è facile trovare ispirazione. Potete prendere spunto dai tanti artisti che qui hanno disseminato, lungo la strada, opere d’arte ed intuizioni. Qui infatti troverete streghe arrampicate sui palazzi, come nel murale che vi in-vitiamo ad cercare. Altrove saranno le ceramiche, appese nel museo e nel-le vie del paese, a scatenare la vostra immaginazione. Fate però attenzione al racconto che inventate, perché narrando può anche capitare di equivocare. Ne sanno qualcosa Umberto Eco e suo “figlio” Baudolino. In quel romanzo ricorreva infatti il nome “badalucco”, per indicare, in dialetto alessandrino, una persona sciocca. Da queste parti se ne sono accorti e anche un poco, giocosamente, ri-sentiti. Così hanno scritto al semiologo nazionale chiedendogli cortese-mente di rettificare, il che è prontamente avvenuto … Affinché non sia mai più detto spregiativamente che quel tizio è un “badalucco”! A Castellaro hanno eretto un santuario all’arte di nar-rare. Il santuario, in realtà, è dedicato alla Madonna di Lampedusa. Vi chiederete il perché di Lampedusa e rice-vendo risposta capirete anche il nesso con la letteratura. Secondo la leggenda iniziò, infatti, a Lampedusa l’incredibile avventura di Andrea Anfosso, capace di fuggi-re dalla prigionia saracena e di fare ritorno via mare a Ca-stellaro. Se già il felice compimento della vicenda profuma di letteratura, perché sarebbe stato catturato negli anni sessanta del millecinquecento e avrebbe fatto ritorno a casa ai primi del seicento, le modalità del viaggio entrano di diritto nella pura leggenda. Anfosso avrebbe attraversa-to millecinquecento miglia di mare con una imbarcazione ricavata intagliando un tronco e sarebbe scampato alle navi lanciate al suo inseguimento usando come vela un dipinto della Madonna, che il Signore gli avrebbe fatto apparire di fronte agli occhi a Lampedusa, per indicargli mezzi e modi della fuga. Fatto salvo il diritto (e forse il dovere) della fede di credere l’incredibile, la vicenda di Anfosso ha molto da insegnare sulla forza del narrare. Intanto perché il santuario, nato sulla base di questa leggen-da, esiste realmente, come reali sono furono gli sforzi degli abitanti di Ca-stellaro per erigere questo monumento alla buona fede. Poi perché ricorda la capacità del racconto di assimilare verità e finzione, narrando del tor-mento per gli atti di pirateria dei saraceni, degli scontri tra genti e religioni. Infine perché questa leggenda è il simbolo della forza dell’invenzione, che sulla base di pochi fatti sa ri-costruire un mondo: la tela del santuario, in effetti, sembra proprio essere originaria di Lampedusa. Adesso che avete imparato la forza della narrazione, visitando Castellaro provate anche voi a ri-costruirvi un vostro mondo e una vostra, personale, leggenda. Magari partendo da “Don Antonio”, romanzo patriottico di Giovanni Ruffini in parte ambientato presso il Santuario di Castella-ro. Ma questa, si sa, è ancora un'altra storia … Baiardo Ottava Tappa Ceriana Ceriana è una paese invisibile, anche se osser-vandolo non ve ne accorgerete. Direte che, al contrario, è fatto con solide mura, con un impianto a chiocciola di stampo medioevale, da cui affiora an-cora la roccia arenaria su cui il paese è edificato. E citerete a testimonianza il vostro viaggio tra viuzze e mulattiere, lungo il quale avete incontrato le sue chiese e i suoi oratori. Eppure la bellezza, a volte, è invisibile agli occhi. E’ il caso di Ceriana, che è il “paese del canto.” I pro-tagonisti di questo canto sono i cori, la cui storia è legata ai festeggiamenti della Madonna della Villa. Nel paese si contano sei cori, ognuno con u-no stile di canto e una composizione particolare. Hanno un vasto reperto-rio, che spazia dai canti sacri e profani cerianesi e ponentini, alle laudi e agli antichi inni dell’ufficio latino, ai “Miserere”, ai più tipici canti "D'osteria" sino ad arrivare alle filastrocche delle voci bianche. Ma la musica a Ceria-na è anche la Banda Musicale che fu fondata nel 1882 e che accompagna le ricorrenze civili e religiose del paese. Se tornerete in occasione di una delle feste liturgiche, scoprirete im-provvisamente anche i colori nascosti di Ceriana: sono i neri, verdi, rossi e azzurri delle mantelline che identificano l’appartenenza alle antichissime confraternite. Le confraternite presenziano alle feste con il loro stendardo, le torce e le croci, ma rappresentano anche un punto di riferimento essenziale per l'organizzazione di feste profane e sagre gastro-nomiche. Baiardo è un paese di fantasia. Almeno ci piace pensarlo così, come una sorta di riscatto dello spirito dal terribile terremoto che nel 1887 fece tanti danni, in parte an-cora visibili. La fantasia si esprime nella “festa della barca”, un rituale unico in tutto il Ponente e che destò l’attenzione anche di Italo Calvino. La festa rimanda ad una leggenda amoro-sa dal finale tragico, che vede coinvolti tre giovani figlie del conte di Baiardo e altret-tanti giovani pisani. Della storia non vo-gliamo raccontarvi troppo, per non togliervi il piacere di ascoltarla dalla gente del luogo. Ma vi consigliamo di anda-re a vederla, nel periodo pentecostale, per stupirvi del grande pino spo-glio piantato nella piazza principale, per ammirare le ragazze in costu-me che a girotondo cantano i loro tre canti, d’amore, nostalgia e dolore. Di fantasia è anche il personaggio più noto di Baiardo, quell’Antonio Rubino 1880-1964 diventato celebre disegnatore di fumetti. Rubino, con il suo stile liberty e floreale, collaborò dapprima con i giornali di trincea che nella prima guerra mondiale dovevano offrire conforto e svago ai soldati al fronte. In seguito lavorò per il Corriere dei Piccoli, inventando una trentina di personaggi, concepiti e disegnati co-me fantocci, tra i quali il più celebre è forse Quadratino. Fu anche autore di tre cartoni animati: il paese dei ranocchi, crescendo Rossiniano e i sette colori Nona Tappa Perinaldo Perinaldo lo capisci con gli occhi rivolti verso il cielo. Se ti metti in ascolto scoprirai che tutto il paese parla da secoli con i pianeti e con le stelle. Tra i tanti, ha una speciale relazione con Saturno. Attorno al gigante gassoso ruota una sonda, lanciata dalla Nasa nel 1997, che ha percorso tre miliardi e mezzo di km per arrivare a destinazione. Cassini è il nome della sonda e questo è il segreto che la unisce al nostro piccolo paese. Gian Dome-nico Cassini, nato nel 1625 a Perinaldo, fu infatti un astronomo illustre. Svelò misteri legati agli anelli di Saturno e alla Grande Macchia Rossa di Giove. In paese, nel castello di Maraldi, trovi ancora la “camera dell’astronomo” dove trascorse la giovinezza, il museo cassiniano che ne racconta la vita e le scoperte e un piccolo ma attivissimo osservatorio astronomico a lui dedicato. Un giusto riconoscimento per una famiglia che per tre generazioni, a partire da Gian Domenico fino ad arrivare al pronipote, diresse l’osservatorio astronomico di Parigi. Guarda le stelle, ma non dimenticarti del sole. Lo devi guardare attraverso il foro gnomonico della Chiesa della Visitazione. Li c’è una meridiana a camera oscura, che consente rilevazioni sul movimento apparente del sole e sull’eclittica. L’hanno costruita di recente i perinaldesi ed è stata completa-ta nel 2007. Anche questa è dedicata ai Cassini, rifacendosi a quella realiz-zata da Gian Domenico a San Petronio a Bologna e quella costruita nel 1702 a Santa Maria degli Angeli a Roma da suo nipote Filippo Maraldi. Queste meridiane antiche servirono per provare il movimento della terra intorno al sole. La meridiana della Visitazione ti ricorda che un paese lo conosci solo con gli occhi della memoria. Perinaldo lo conosci con lo sguardo rivolto a terra. Ci trovi infatti dei carciofi insoliti, privi di spine e con una decisa sfumatura violetta. Sono i cugini del “violet” provenzale e la leggenda vuole che le piantine d’oltralpe siano state portate qui direttamente da Napoleone, di passaggio nel 1796. Unici per aspetto e area di coltivazione, sono stati eletti a presi-dio Slow Food e sono celebri per croccantezza, profumo e delicatezza Castelvittorio. A Castelvittorio puoi osservare l’arte della guerra. Sun Tzu però non c’entra nulla. C’entra invece una tra-sformazione, per una volta gentile, imposta dal tempo. Castelvittorio nasce infatti nel medioevo come borgo fortificato, in posizione strategica sulle direttrici per la Francia e per il Piemonte. Smarrita lungo i secoli la va-lenza militare, la collocazione sulla collina e i vicoli stret-ti, alti e coperti sono diventati segni di notevole bellez-za. Da difensivo il genius loci si è fatto creativo, con l’adozione di alcune soluzioni insolite e brillanti. Davvero originale è, ad esempio, il riutilizzo come sedili dei capi-telli di ardesia nera della vecchia chiesa. E altrettanto estrosa è la costruzione, nettamente separata dalla chiesa, della torre campa-naria, che termina in una cupola a cipolla con i colori di Arlecchi-no. Diventato amante dell’arte dell’invenzione, Castelvittorio si è rega-lato nel passato un crocefisso ligneo del Maragliano, collocato nella parrocchiale di Santo Stefano. Il più scenografico degli scultori barocchi genovesi, famoso per sue opere lignee, trova nelle pieghe ritorte dei vicoli di questo paese una sua perfetta collocazione. E se ancora non conoscete l’ Anton Maria Maragliano, questa visita può essere l’occasione per iniziare una lunga frequentazione. In tutta la Liguria e il Basso Piemonte sono disseminate infatti sue sculture, presepi e soprattutto le im-perdibili casse e crocefissi processionali. Ottava Tappa Dolceacqua Anche se la centoseiesima canzone del Petrar-ca (“chiare e fresche e dolci acque”) nulla ha a che fare con il toponimo, Dolceacqua è poesia fatta paese. E, come accade per i versi, per esse-re compresa richiede il suo tempo. Per visitarla occorre quindi partire da fermi, seduti all’aperto in uno dei bar del borgo antico adagiato ai piedi del castello. In mano, più che la penna, vi consigliamo di tenere un bicchiere del famoso Rossese di Dol-ceacqua, primo Doc della Liguria. Questo vino ros-so rubino, dal sapore corposo e dal profumo fra-grante, è infatti il migliore compagno per il vostro percorso di scoperta. Dalla vostra comoda postazione noterete subi-to che Dolceacqua, con la sua compiuta bel-lezza, si presta bene all’indugiare dello sguar-do. L’aveva già capito Monet, passato da queste parti nel 1833 in compagnia di Renoir. Del suo passaggio restano tre quadri che, in fondo, hanno lo stesso soggetto, anche se ritratto con inquadra-ture differenti: quel ponte a schiena d’asino che ancora oggi potete osservare e che l’impressionista francese definì, giustamente, co-me un gioiello di leggerezza. Ora che avete rilassato mente e cuore potete iniziare ad inoltravi per le vie strette di Terra (il nome dell’antico borgo). Anche qui vi raccoman-diamo un andamento lento, un po’ per godere i piccoli dettagli dei vicoli stretti (gli archetti pensili, i passaggi coperti, ecc …) un po’ per non stancarvi eccessivamente, dato che il paese si arrampica sulla collina tracciando cerchi concentrici e di-segnando percorsi labirintici. Ma se vi perde-te, non dovete preoccuparvi: anche smarrirsi, da queste parti è un esercizio di poesia. Apricale La tentazione della gerarchia è un vizio irresi-stibile. Il discorso vale anche quando si parla del-la bellezza, della quale si dovrebbe apprezzare la varietà, piuttosto che dedicarsi ad esercizi di tas-sonomia. E tuttavia non c’è turista che nel suo gi-rovagare rinunci all’innocente piacere di stilare la sua personale classifica dei luoghi più amati. Ri-nunciando in un sol colpo alla diplomazia e all’ipocrisia, abbiamo perciò deciso di dichiarare cosa realmente pensiamo di Apricale: è lui il mo-dello, è lui il più bello. Sapendo che, come ogni questione inerente il gu-sto, conta più la sensazione che la ragione, pro-viamo però a proporvi qualche motivazione a sup-porto della nostra preferenza. Anzitutto assegniamo un bel 9 all’aspetto. Ci piace, in particolare, la conservazione pressoché perfetta dell’originario impianto medieva-le, con il castello sulla cima e le case che scendono a gironi concen-trici lungo il crinale. Il 10 invece lo riserviamo per il portamento. Di Apricale, infatti, ci piace il modo di “andare”. Ci hanno sedotto le tante erte e le scalinate strette, le rampe a gradoni, i passaggi coperti, le piccole piazzette e i vicoli dall'andamento irregolare. Un voto speciale, almeno un 8, anche alla “presenza” e alla “prontezza”. Apricale infatti non si è “seduto” sulla propria bellezza. Nel tempo ha saputo rinnovarsi ed inventare forme nuove di seduzione. Negli ultimi decenni ha stretto in affettuosi abbracci artisti nazionali e internazionali, allestendo mostre importanti e ospitando prestigiose rappresentazioni teatrali all’aperto. Come ogni seduttore che si rispet-ti, Apricale ha ricevuto regali e omaggi: è per questo che trovate i murales sulle facciate delle case e le pitture e le scultu-re ad impreziosire il castello e gli angoli del borgo.
Scarica