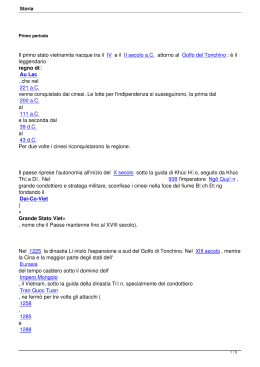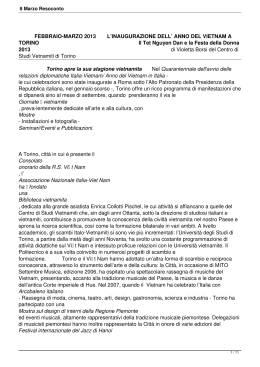NICO IVALDI TRAMONTO SUL FIUME DEI PROFUMI Diario di un viaggio in Vietnam Breve introduzione In questo libro racconto il viaggio che ho compiuto in Vietnam nel 1989. E’ il diario fedele di quei giorni, costruito sugli appunti che andavo prendendo giorno per giorno nei posti più incredibili: in barca, per strada, sui cyclo-pousse (i risciò vietnamiti), nelle pagode, in albergo. Agli appunti iniziali, al mio ritorno in Italia, ho aggiunto ben poco, proprio per non disperdere l’originale freschezza di quelle note. Così mi è successo, mentre completavo la stesura di questo libro, di provare le stesse emozioni, gli stessi stati d’animo, le medesime sensazioni che avevo provato mentre visitavo questo Paese. Per chi scrive, è già una grande soddisfazione. Il lettore non si attenda da questo libro una storia del Vietnam, nè una ricostruzione della guerra contro gli americani. Per scrivere queste cose è necessaria una competenza del Paese che io, onestamente, non possiedo. E poi: come pretendere di scrivere un libro sul Vietnam dopo solo un mese di permanenza? Un servizio giornalistico su questo come su qualsiasi altro paese del mondo si può fare anche quando si è rimasti un’ora, se in quell’ora si sono viste cose interessanti: un libro specifico è tutta un’altra cosa. Ad ognuno il suo mestiere. Io mi sono limitato a osservare e a descrivere luoghi, sensazioni, persone e situazioni con curiosità e voglia di saperne di più. Prima di chiudere questa breve introduzione, sento l’obbligo di ringraziare alcune persone, che elenco in ordine assolutamente casuale: Zana e Giovanni Carello, che hanno promosso con entusiasmo la pubblicazione di questo libro, il ricavato della vendita del quale sarà devoluto all’Unifam (Unione contro la fame nel mondo) per il finanziamento di progetti di solidarietà nel Terzo Mondo; mio figlio Davide e mia moglie Marina, che hanno pazientemente sopportato certi inevitabili sbalzi d’umore del sottoscritto durante la lavorazione del libro; mio padre, che ha impreziosito questo lavoro con i suoi disegni; mia madre, che sicuramente mi farà una gran pubblicità. Infine, un ringraziamento particolare al dott. Furio Colombo, che è stato di una cortesia unica a ritagliarsi un poco di spazio in mezzo ai suoi mille impegni per leggere il manoscritto e arricchirlo con un suo commento. Buona lettura. Nico Ivaldi Primavera 1997 2 Nota di Furio Colombo Caro Nico Ivaldi, la conosco solo da queste pagine. Ma nel leggere il suo diario di un viaggio in Vietnam - il Vietnam di oggi, tanti anni dopo la guerra - mi rendo conto di avere un debito con lei. Con la sua rivisitazione piena di attenzione a un Paese che amo, mi ha aiutato a districare la mia memoria privata e personale di quei volti, quei nomi, quei luoghi, dalla vastità e dal peso della memoria collettiva che è stata costruita da milioni di ore di immagini delle televisioni del mondo, finchè in Vietnam ci sono stati sangue e morte. Come accade nei mezzi di comunicazione di massa, dopo l’ultima esplosione e l’ultima strage, si spengono le luci della televisione, le telecamere se ne vanno e resta solo silenzio. Resta un immenso vuoto, come il cratere di un vulcano spento. Di tutto ciò che è stato vissuto, patito, narrato e testimoniato non c’è più niente. Il niente di un mondo destinato a vivere senza memoria. Le sono grato perchè ha ignorato il vuoto dei Media, e nel farlo si rivolge a chi non ha mai saputo nulla del Vietnam, ma anche a quelli, come me, che sentivano la propria esperienza personale impastata con il blocco sempre più grigio e remoto della memoria collettiva che se ne sta andando. Le immagini e le emozioni di anni che dovrebbero essere, nel loro amore e terrore, “indimenticabili”, sembravano svanire nella nebbia del niente. Nella sua narrazione amorevole e scrupolosa ho trovato il senso dei luoghi, il suono dei nomi, tra cui ho viaggiato e vissuto tra la fine dei Sessanta e l’inizio dei Settanta, ho rivisto paesaggi, sentito rumori e ritrovato, limpida, l’evocazione di minimi gesti, aromi e colori che esistono solo nel Vietnam. Ho rivisto certe sere di pace, molto dopo il tramonto, molto prima della notte, in cui il tempo dei villaggi sembra sospeso, i racconti affidati agli 3 occhi, la continuazione della vita e persino della Storia, garantita dai molti vecchi e dai molti piccoli che ti si mettono intorno e sembrano, come te, in attesa. Ho rivisto, in Hanoi, il viso del bambino che fissa il cielo mentre scoppia l’abbaglio della prima esplosione, le corse verso i tombini-rifugio. La foresta, le grotte, la forma magica delle montagne, stranamente colorate d’azzurro, mi sono tornate in mente insieme con quel continuo rumore di acqua che scorre. Sembra un dono della natura, ma il più delle volte è il frutto di fatiche disumane nascoste, come si nasconde la paura, il dolore. Una strana grazia resta il volto del Vietnam. Le ho detto le ragioni del mio debito. Mi lasci aggiungere la speranza che altri, più giovani, vogliano leggere, vogliano sapere, e decidano di partecipare all’impegno volontario per il Vietnam vero e magico, doloroso e bellissimo che lei racconta. Torino, 12 gennaio 1997 4 Prologo In volo sopra la Storia Nel mese di agosto del 1989, mentre il decrepito Iliyushin sovietico, decollato da Berlino Est, traversava le pianure russe, sorvolava i cieli dell’Asia sovietica, e sostava per rifornimento a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, non immaginavo certo che quello sarebbe stato il mio ultimo viaggio nell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Il comunismo era ad un passo dal disfacimento come un castello di sabbia tanto nelle periferie - Germania Est, Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia - quanto al centro del Grande Impero Rosso. E noi, quel momento epocale lo stavamo vivendo inconsapevolmente. Nel grande terminal dell’aeroporto di Tashkent, città islamica dalla storia bimillenaria, i ritratti dei padri della patria sovietica, Lenin, Stalin, Breznev, giganteggiavano - ancora per poco - sui muri disadorni. I soliti ritratti: la pelata di un Lenin luciferino, i baffoni di un rassicurante Stalin, le sopracciglia cespugliose di Breznev. Come tanti fantasmi infreddoliti e semiaddormentati, abbiamo vagato davanti alle vetrine polverose e tristi dei negozietti (chiusi) di pettini e souvenir, in un’alba gelida e cupa. Abbandonati come fagotti sulle poltroncine della sala d’attesa, abbiamo poi bevuto piccoli bicchieri colmi di salatissima e tiepida acqua di Vichy disposti su un carrello a tre piani spinto da un addetto dell’aeroporto. Qualcuno della nostra comitiva, stretto nel suo giubbottino, concentrava la sua attenzione sul via vai di guardie dai tratti di campagnoli orientali, che a loro volta ci guardavano non si capiva bene se per controllarci oppure per semplice curiosità. Solide donne uzbeke di mezza età ramazzavano con incredibile vigoria i pavimenti, mentre, accanto a loro, indifferenti a tutto e a tutti, chiacchieravano a voce alta cinque anziani carichi di medaglie della seconda guerra mondiale, che tintinnavano come i ciondoli di un lampadario ad ogni minimo movimento. 5 Siamo ripartiti con grandi tremori e scossoni. Sotto di noi, a dodicimila metri di quota, scivolano i maestosi altipiani del Tibet: vederli dall’oblò, é come osservare con un microscopio la pelle vecchia e grinzosa della terra. Dopo avere goduto della bellezza di questo panorama, ho provato a socchiudere gli occhi e ad immaginare altri spettacoli della natura, dei quali, in questo viaggio, come mi auguravo, avrei sicuramente beneficiato. E’ così che mi sono addormentato. Al mio risveglio, l’aereo volteggiava su una grande distesa di risaie, su mucchi di capanne e di alberi sul ciglio dell’acqua, sulle spirali dei fiumi che si spandono nelle paludi e lasciano riflessi abbaglianti, sulle teste dei contadini chini sui campi. C’era tutto, in quel ritaglio di vita: l’acqua, il cielo, l’uomo, gli animali. C’era il Vietnam. 6 1 Nel Nord Vietnam. L’eterno dopoguerra di Hanoi “Hai mai visto un popolo che smette di crescere? Hai mai visto un popolo che smette di spingersi avanti? Tu, piccolo, cresci nel tempo vietnamita, tu scavi trincee nel profondo di te, tu costruisci il paese nel tuo cuore. In quella trincea sotterra l’odio feroce e il frutto che nascerà, piccolo, sarà l’amore” (Strofa di una canzone studentesca vietnamita) 7 Il ponte sul Fiume Rosso Lo sbarco all’aeroporto “Noi Bai” di Hanoi avviene sotto gli occhi di un ometto dall’aspetto dimesso, la camicia azzurra aperta sul davanti, le ciabatte ai piedi, il borsello a tracolla: Dang Sung. Sung tiene bene in vista sul petto il “pass” azzurro di riconoscimento: è una delle guide in forza alla Vietnam Tourism, l’ente turistico di Stato vietnamita. Ha ventinove anni, parla inglese e russo e sulla gamba destra porta ancora il ricordo di una bomba americana. Sung fa gli onori di casa in quello che più che un aeroporto internazionale sembra una stazioncina ferroviaria di campagna d’altri tempi, un po' deteriorata, povera, deserta. Prima di questo aeroporto, tutto in muratura, progettato dai giapponesi, c’erano delle baracche militari, vecchie e mal ridotte. Ma in pochi anni anche il nuovo edificio ha assunto l’immagine del vecchio. Vetri sporchi, condizionatori inservibili, banconi dove avvengono perquisizioni minuziose, porte chiuse e cento piccoli divieti. I poliziotti addetti al controllo dei passaporti ci accolgono con rigida cortesia, ma anche con grandi sorrisi, e attendono che compiliamo, accucciati per terra, in un angolo del salone ingrigito dal tempo, i formulari doganali. Le giovani guardie, chiuse nelle loro verdissime divise con la piccola stella rossa cucita sul petto, e gli altri viaggiatori vietnamiti, ci osservano con occhi accesi dalla curiosità. Mi sento come un insetto sotto vetro. Fuori, il cielo è basso, l’aria è calda e l’umidità si appiccica alle mani. Raggiungiamo Hanoi città dopo una quarantina di chilometri percorsi a bordo di un pulmino azzurro di fabbricazione russa e dopo aver attraversato un ponte gigantesco, il 8 ponte del Drago, il più lungo del sud-est asiatico, un viadotto teso con un balzo di chilometri di cemento armato e ferro sopra le risaie del Fiume Rosso. Dal finestrino, i monti all’orizzonte sono di un blu appannato. Il sole, nascosto dietro le nubi, non dà ombre, è come un’alba diffusa e dilatata lungo tutto l’arco del giorno. Spiccano i verdi muri delle case di campagna, circondate da minuti e rigogliosissimi frutteti, alberi di banane e di mango. Nelle risaie si scorgono donne curve e con le gambe completamente affondate nell’acqua. Il ponte del Drago è il simbolo dei grandi cambiamenti degli ultimi anni: costruito dai cinesi, al tempo dell’”amicizia” con i vietnamiti, abbandonato dopo la rottura con Pechino nel 1979, ricominciato dai russi, è un’opera interminabile ma utile.. Interminabile perché eternamente in riparazione. Utile perché senza un ponte che sostituisca quello abbattuto dagli americani, l’attraversamento del delta del Fiume Rosso sarebbe un’impresa estenuante, a causa delle risaie e dell’acqua che invade tutto. Sung, in piedi accanto all’autista taciturno e ombroso, che zigzaga fra lo scomposto flusso di biciclette, dice con orgoglio che il ponte ha due corsie, una per la ferrovia e l’altra per il traffico normale. Guardiamo fuori dal finestrino, ma non vediamo altri mezzi a quattro ruote se non grossi camion made in URSS e qualche Volga di rappresentanza, di quelle che attendono gli ospiti illustri all’aeroporto. Il traffico cosiddetto “normale” si esaurisce qui. Poi biciclette, biciclette, nient’altro che biciclette. Se dovessi sintetizzare con una sola frase il Vietnam, direi: gente in bicicletta. Credo che in nessun’altra parte del mondo questo mezzo di trasporto assuma tanta importanza quanto in Vietnam (mi chiedo: nessuno ha mai pensato di dedicare un monumento alla bicicletta vietnamita?). Qui, con le biciclette si trasporta di tutto, dai tini alle fascine di legna, ai sacchi di riso, ai barilotti di semi, fino ad arrivare agli animali, alle gigantesche gerle (e non solo una, ma fino a quattro, due ai lati, una davanti e una dietro), ai bambini, ad intere famiglie di quattro persone. 9 Per tutta la giornata, l’onda inarrestabile delle due ruote fruscia velocissima ai lati della ferrovia, sollevando un cicaleccio leggero che si snoda misteriosamente sotto la foresta dei cappelli a cono, e lascia intuire là sotto un sommesso dialogo di saluti, scampanellate, sorrisi. Abbiamo preso alloggio nel più grande e moderno hotel di Hanoi (uno dei quattro della città), appena fuori dal centro, l’hotel “Thang Loi”, che significa La Vittoria. L’albergo, donato allo Stato vietnamita da Fidel Castro per celebrare la vittoriosa rivoluzione di popolo, affonda le sue palafitte di cemento nell’acqua color caffelatte del grande lago dell’Ovest, è avvolto da alberi di ogni tipo e ha, purtroppo, un aspetto già fatiscente. Nella sua piscina sguazzano robuste valchirie tedesco-orientali, che gonfiano l’acqua con poderose bracciate. Sono le hostess dell’Interflug, la compagnia di bandiera della DDR con la quale abbiamo viaggiato. I piloti tracannano generose sorsate di “Saigon”, una bibita a base di cocco e alcool, e frullati freschi di papaia al bar dell’hotel e sulla terrazza, dove tira un vento tiepido. Le nostre valigie si ammonticchiano disordinatamente nella hall, c’è confusione, i turisti premono perché la signorina alla reception si decida ad assegnare le camere. Alcuni inservienti dell’hotel stazionano come falchetti dalla parti di valigie e borsoni, nell’attesa che i possessori facciano loro un cenno. Sotto, nel lago pieno di ninfee, alcuni bambini raccolgono lumache acquatiche nere in grandi ceste. La riva è coperta da una vegetazione lussureggiante nella quale si intravedono dignitose casette con piccoli imbarcaderi e piccole barche. Da qui, dalla nostra stanza, Hanoi è poco più che un puntino coperto dal fogliame e dalle prime luci del tramonto. 10 Hanoi di notte Dopo la cena e il saluto del direttore del “Thang Loi” ai turisti italiani, ho scritto questi appunti allungato pigramente sul letto della mia camera. Ho perso una decina di minuti nel tentativo di fare funzionare l’impianto di ventilazione e nel riavvolgere la lunghissima zanzariera bianca che pendeva a cascata sopra il letto. Il condizionatore funziona a tratti, con un rumore di ventola incrinata, le lamelle per dirigere il getto dell’aria non sono regolabili perché legate con la corda, altrimenti cadrebbero. La luce è rotta. Non mi va di lamentarmi perché conosco i tantissimi problemi di questo Paese. La mia indulgenza mi premia perché improvvisamente il condizionatore riparte sia pure con grande agitazione, traballamenti e rumori vari. Sarebbe piaciuto, a me e a mia moglie, un’accaldatissima Marina, che mi ha seguito anche in quest’avventura dopo le peregrinazioni turche e israeliane, lasciarci andare al sonno, ma Sung ce lo ha simpaticamente impedito: ha “deciso” di sua iniziativa di andare nel centro di Hanoi a festeggiare il nostro arrivo. Tempo mezz’ora e questo oceano di pace e silenzio che è Hanoi, capitale della Repubblica Socialista del Vietnam e città antichissima (fu capitale del primo Stato vietnamita già nel 1010, con l’inizio della dinastia Ly) ci ha conquistati con il suo fascino decadente e la sua solitudine lunare. Per apprezzare Hanoi - mi aveva consigliato prima di partire per il Vietnam un amico milanese - bisogna essere dei contemplativi, bisogna accettare di fare un balzo nello spazio-tempo, perché Hanoi è una città inconsueta nella sua straordinaria armonia tra struttura urbana e ambiente naturale. La mancanza di denaro le ha permesso di mantenere le forme e il decoro di capitale ex coloniale, arricchita dalla spontaneità di un popolo fra i più sorridenti e gentili di tutto l’Oriente. 11 Le case di Hanoi non conoscono il cemento armato, sono fatte ancora di mattoni, e il verde, muschioso, umido, rigoglioso, le ricopre, le circonda, le coccola. I nomi delle vie Via della Seta, Via dei Panieri, Via dei Lampioni, Via dei Tamburi - sottolineano una concezione arcaica e poetica della vita. Il tempo, i grandi mutamenti della società nell’ultimo secolo, l’hanno condannata ad una svagata umiltà e ad un dolce declino bohemien che piace forse più a noi occidentali che agli stessi vietnamiti. Lungo i boulevards alberati di scuola Haussmann (l’urbanista che ridisegnò il volto della Parigi ottocentesca) si allineano palazzine liberty. Eccoli, stagliarsi davanti a noi, scenografici, con grandi spazi davanti ad esaltarne l’antica imponenza di centri del potere, i palazzi della “grandeur” francese, del governatore del Tonchino e quello del governatore di tutta l’Indocina. Sung è prodigo di spiegazioni di carattere storico, ma evita consapevolmente di parlare dell’aspetto di questi edifici, deteriorati e cadenti. D’altronde il Vietnam, soprattutto dopo la guerra contro gli americani, ha avuto ben altre priorità che non la cura di questo gioiello urbanistico che è Hanoi, i cui abitanti, tre milioni di persone in tumultuosa crescita, vivono in una città a suo tempo concepita per mezzo milione di anime. Tutti l’uno sull’altro, in 2,4 metri quadrati a testa (il che significa che una famiglia di quattro persone ha a disposizione una stanza di 10 metri quadrati), nei pochi stabili costruiti e in quelli vecchi continuamente rimaneggiati, dai cui balconi sono stati ricavati stanzini col tetto di lamiera. Il problema degli alloggi ha suggerito rimedi peggiori del male, e distrutto ogni nostalgia estetica: penso ai quartieri “moderni” per operai e tecnici alla periferia della città, casermoni che, secondo una regola già consolidata in quasi tutti i paesi comunisti, hanno iniziato, il giorno dopo la loro costruzione, un processo di rapida fatiscenza. 12 Vagabondiamo senza meta per le strade di Hanoi - lungo viali perennemente verdi, dove alberi spesso giganteschi hanno tronchi contorti percorsi di liane e radici indurite spinti dalla curiosità di mettere il naso nelle migliaia di botteghe che, anche la sera, popolano la città. Lumini da cimitero segnalano la presenza di questi piccolissimi negozi. In molte case, le bacchette di incenso bruciano davanti all’immaginetta del Budda o sugli altarini di famiglia, dove si perpetua il ricordo degli antenati. Qualcuno prega, qualcun altro si limita a sperare che accada qualcosa. In ogni via, in ogni strada di Hanoi, arde una vita sorprendentemente intensa, eppure silenziosa, serena, quieta. Acquattati sotto gli alberi, i venditori offrono birra cinese con sciroppo, strane zuppe, stecche di dolcissime mandorle. Le porte e le finestre, che danno su locali stretti e profondi, sono aperte. Su panche, su stuoie stese al suolo, stanno distesi o accovacciati donne e bambini, vicino a piccole lampade. Una famiglia intorno ad un tavolino chiacchiera placidamente muovendo i bastoncini sui piatti di riso. Un giovanotto in canottiera è piegato su un disegno tecnico: chissà, forse diventerà un ingegnere. I ciclisti circolano a frotte nelle strade a lampioni spenti e si perdono in una tenebra uniforme e impenetrabile. Gli innamorati si sfiorano appena, pudichi, come vuole il costume riservato della gente vietnamita, sulle rive del lago della Spada Restituita (Hoan Kiem), immobile come una miniatura laccata, uno dei simboli di Hanoi. La Pagoda che sorge su un isolotto del lago Hoan Kiem conserva una leggenda del XV secolo. Narra la storia che un proprietario terriero, di nome Le Loi, aveva deciso di insorgere contro i dominatori Ming. Inviò messaggeri in tutto il paese alla ricerca di uomini coraggiosi, cavalli, elefanti da guerra. I rinforzi tardavano e mentre Le Loi se ne stava in meditazione sull’isolotto, una grande tartaruga d’oro uscì lentamente dalle acque portando sul dorso una spada che lanciava lampi. Le Loi capì che gli dei erano con lui: vinse la guerra. Il Vietnam era libero, e la grande tartaruga tornò un giorno a riprendersi la spada. 13 Ho visto ragazzi poco più che sedicenni scendere in pista in uno dei dancing all’aperto (non sono molti a Hanoi, e tutti ricopiano fedelmente le atmosfere delle italiche balere degli anni Sessanta), dove le orchestre intonano musiche vietnamite imbastardite dal rock americano. Quando il pick-up del giradischi si abbassa per l’ultima volta, sono da poco passate le dieci: è l’ora di chiudere, il Vietnam non si può permettere un simile consumo di luci. E poi, come recitano i solenni slogan del Partito, il Paese non può tollerare che i giovani l’indomani si presentino a scuola o al lavoro stanchi e assonnati, storditi da quelle musiche indiavolate che odorano di Occidente lontano un chilometro. Cronache di ordinaria povertà “Da mangiare, soltanto una ciotola di riso scotto e lo stomaco a turno geme, urla e brontola.” Sono lontani i tempi in cui Ho Chi Minh, incarcerato in Cina senza neppure saperne il perchè, scriveva questi versi. Eppure c’è ancora più di uno stomaco, tra la sua gente, che, cinquant’anni dopo, continua a gemere, a urlare e a brontolare. Il Vietnam è infatti oggi uno dei quattordici paesi più poveri della Terra, con un reddito pro capite di cento dollari l’anno. Può garantire ai suoi figli meno di 1600 calorie a testa al giorno (per vivere sono necessarie 2200 chilocalorie al giorno) e carne una volta al mese. Il latte non si può fornire a tutti, ma solo ai bambini appena nati e alle loro madri. Anche il riso, alimento primario, è insufficiente, a causa di periodiche inondazioni e siccità e di gravi carenze nel sistema di raccolta e di distribuzione. Quello che manca qui è il potere di acquisto per tutti gli strati della popolazione. Infatti lo scarto tra il reddito minimo e quello massimo, tra l’apprendista e il ministro è 14 molto ridotto: il contrario non sarebbe tollerabile in una società così povera. Lo stipendio medio di un insegnante è di dieci dollari al mese (dodicimila lire), così come quello di un funzionario statale, dodici quello di un medico (quattordicimila), tredici la pensione di un ex ambasciatore (quindicimilalire). Così, scatta la corsa al doppio e anche triplo lavoro: c’è chi fa maglioni, chi alleva animali, chi consegna pacchi a domicilio, chi si ingegna comunque, anche con traffici più o meno legali, e una piccola corruzione, impalpabile ma onnipresente come la polvere nell’aria. Per le pochissime statistiche in circolazione, il Vietnam era praticamente dato per morto alla fine del 1986 (inflazione al 900%, debito estero di oltre sei miliardi mezzo di dollari, il 25% di disoccupati), quando un flebile soffio di perestrojka bussò alla porta del VI Congresso del Partito Comunista del Vietnam, forse il più rosso dei partiti rossi e certamente uno dei più granitici, testardi, inaffondabili gruppi dirigenti della sinistra mondiale. La perestrojka in salsa viet si chiama “Doi moi” ed è nata come risposta alla crisi terribile di un Paese commercialmente strozzato dall’embargo internazionale deciso dagli Stati Uniti (che non hanno ancora pagato i danni di guerra), come ritorsione dell’invasione vietnamita della Cambogia, avvenuta nel 1978 con l’aperto sostegno dell’Unione Sovietica e in sfida palese alla Cina, il Nemico di sempre. Una vendetta politica che ha chiuso al Vietnam le frontiere di tutto il mondo e, soprattutto, lo ha fatto passare tragicamente di moda, cancellandolo per anni dalla memoria collettiva di quello stesso Occidente che ne aveva fatto una bandiera antimperialista. Il nemico interno della “Doi moi” è la burocrazia di un Partito Comunista connotato da una serie di privilegi che avevano scandalizzato l’opinione pubblica, e che aveva commesso enormi errori nel suo dirigismo economico tali da disincentivare la produzione 15 e provocare l’indignazione popolare o la disaffezione delle masse nei confronti dello Stato. Il rinnovamento del Partito ha portato al vertice personalità più aperte e pragmatiche che hanno rinnegato il furore ideologico e cominciato a fare i conti con la realtà. Abbandonata l’assurda ambizione di “rieducare” il Sud capitalista e occidentalizzato, omologandolo al grigiore del Nord, oggi si assiste ad un processo inverso, nel quale la strada dell’unificazione sociale del Paese passa per un socialismo che non disdegna gli investimenti stranieri, la piccola iniziativa privata, i programmi di sviluppo turistico, il rispetto della libertà individuale e di stampa, la valorizzazione in tutti i campi di personalità che il clima postbellico aveva emarginato e addirittura perseguitato. Il nostro arrivo in Vietnam coincideva con questo mutamento di situazione. Biciclette e caschi verdi Le otto del mattino. Immersi nel lago fino alla cinta, i soliti bambini sono già alla ricerca delle lumache. Affondano il braccio, si bagnano il viso, la testa e poi estraggono trionfanti il frutto del loro lavoro. Ce n’è uno che è completamente nudo e quando si accorge della mia faccia che lo spia dalla camera d’albergo, si inabissa sotto l’acqua alla ricerca di un luogo che lo metta al riparo da sguardi indiscreti. Tentiamo di buttare giù la colazione vietnamita: tè e una minestra con carne di bue, riso, cotta con germogli di soia e con giallo d’uovo e insaporita con foglie di menta, coriandolo, pepe e ginepro. Tentiamo, ma senza successo. Ripieghiamo sulle banane., verdi e succose. Oltre a Dang Sung, l’hotel ospita altre due guide: Ho Thi e Hieu. Il primo mi sembra quello con la maggiore autorità personale: cammina e si siede con simpatici movimenti dinoccolati all’americana. Passa da una grande euforia a un controllato formalismo, 16 soprattutto davanti alla vociante comitiva di russi che gli é stata affidata. Hieu pare una ragazzina del liceo e invece ha da poco compiuto trent’anni. Ha i modi affabili e quando parla, cosa che non disdegna affatto, finisce di solito per restare senza fiato. Ha un viso ovale non bello, ma molto espressivo e sincero. Parla benissimo il francese e fa da guida ai gruppi francofoni. Scendiamo nelle vie di Hanoi, dove da almeno tre ore é già scattata la battaglia giornaliera per la sopravvivenza (i vietnamiti si mettono presto in movimento, tra le cinque e le sei del mattino). A poco a poco, la metropoli dei poveri si sgranchisce, si anima, si scalda. Una moltitudine biblica di ciclisti dilaga nelle vie già abbrustolite dal sole. Rumore di ruote sull’asfalto e voci simili a cinguettii. C’è un poliziotto in divisa bianca, armato di tanta buona volontà, che si sforza di dare un ordine a quel traffico scomposto, onnidirezionale, dove ognuno va per la sua strada, perché qui la parola precedenza non esiste in nessun vocabolario. Ma è tutto inutile, nessuno lo ascolta. E allora gli conviene risalire sul marciapiede e mettersi al riparo dal sole sotto uno striminzito albero. Dice Sung che i vietnamiti più “ricchi” (lui stesso ha usato questo eufemismo) si notano subito per via della marca della loro bici: se è di fabbricazione cecoslovacca e ha il cambio ha otto velocità, significa che il proprietario è un capo o almeno uno “che se la fa coi capi.” Dal torrente di bici, in questo paesaggio stradale senza cartelli pubblicitari, senza strisce pedonali, senza semafori, senza automobili, vedo spuntare i bei volti asciutti, intrepidi, delle ragazze tonchinesi. Pedalano tenendo il busto eretto e il mento alzato e scandagliano con lo sguardo la folla alla ricerca di un po' d’attenzione. Sono vestite semplicemente: una casacca bianca o di altro colore, larghi pantaloni neri di satin, sandali. Qualcuna ha le mani fasciate da lunghi guanti bianchi e, all’apparenza, lussuosi. 17 La centralissima Via della Seta è un ottimo punto d’osservazione per vedere, spiare i vietnamiti in un qualsiasi giorno della loro esistenza. Qui, per poco non mi travolgeva il vecchio e arrugginito e lentissimo tram grigio e rosso (l’unico di Hanoi, che collega, quando ce la fa, la periferia con il centro), il quale, in un travagliato slancio d’orgoglio, riesce a compiere il miracolo di dividere in due il mare dei ciclisti, scampanellando con insistenza. Il tram trasporta una folla fitta e silenziosa, tanti gruppi di una diversità sorprendente. Vi sono stipate donne dei villaggi con lo sguardo tranquillo, immerse nei loro pensieri, bambini vestiti di panni avanzati, ragazzi con grandi caschi verdi dondolanti sulla testa, e operai e altra gente comune. Il tram avrà settant’anni, fu costruito dai francesi e da allora nessuno l’ha più degnato di un restauro. Lo vedo ansimare, cigolare, sferragliare; nelle curve devono sporgersi almeno due passeggeri per rimettere a posto la puleggia che puntualmente si stacca dal filo. Eppur si muove. Miracolo. Nella garrula e colorata babele di Via della Seta e delle altre strade, fioriscono i mercatini improvvisati. Non esistono marciapiedi di Hanoi dove non si incontrino piccole officine ambulanti o semplici banchetti per la riparazione delle biciclette, per il gonfiaggio delle gomme, per il taglio dei capelli, per il rammendo dei vestiti, per la vendita delle sigarette o dei fiori, dei lumi a petrolio, dei caschi di tela e di altre poverissime cose. E poiché in Vietnam non si butta via niente - anzi, tutto si ricicla - esistono addirittura le stazioni di rifornimento per le penne biro, che vengono riempite con professionalità e pulizia a poco prezzo. Alla Banca Nazionale del Vietnam cambiamo i nostri dollari per un cospicuo e ingombrante pacchetto di dong, la moneta locale. Le banconote sono avvolte in strisce ricavate da giornali e sono tutte usurate. Per ogni dollaro abbiamo ricevuto 4500 dong. I tagli sono diversi, ma da ogni biglietto spunta il pizzetto imbiancato di Ho Chi Minh, pure presente in un gigantesco ritratto sulla facciata della banca e su molti mura della città. 18 In Vietnam non esiste moneta metallica, ma solo banconote. Osservo le cassiere della banca: contano i soldi e poi riportano i totali a penna su grandi fogli di carta già scritta da una parte. Non vedo calcolatrici. Né tantomeno computers. Gli impiegati sono sbracciati, con camicie a quadri, nessuno porta la cravatta, ovviamente (sai il caldo!). Appena fuori dalla banca, improvvisamente mi si getta davanti un autista di cyclopousse, quel triciclo a pedali con la poltroncina che fa da taxi, versione meccanizzata del vecchio risciò. E’ un uomo dall’età indefinibile, senza l’ombra di un pelo sul viso, il casco coloniale dei vietcong calato sugli occhi, la parlata francese fluida e chiara. Sulla visiera, un nome, scritto con la biro blu: THONG. L’uomo fa in tempo ad offrirmi ad un prezzo per me convenientissimo alcuni volumi illustrati sul Vietnam e sull’artigianato locale, un attimo prima che un poliziotto-bambino, su ordine di Sung, senza troppi complimenti, lo allontani con una brusca strattonata. Per quel giorno, con i turisti , Thong ha chiuso. Non mi è piaciuto il comportamento della mia guida, anche se credo abbia avuto i suoi buoni motivi per intervenire. Gli chiedo spiegazioni, ma Sung sembra voler sottrarsi alla mia domanda. Dirotta la mia attenzione verso un industriale trevigiano, sostenendo che dovrei conoscerlo solo perché é italiano (ma Sung sa quanto è grande l’Italia?). Insisto, finché Sung mi spiega che a Hanoi è vietato importunare i turisti. Ma non mi stava importunando, replico, stava solo vendendo dei libri. Gli stessi libri li puoi trovare in qualsiasi libreria, ha chiuso la discussione Sung. E poi Hanoi, ha aggiunto il mio amico, non è come Saigon: là è tutto diverso, é tutto permesso. Sarà poi vero? 19 Buon riposo, zio Ho Lentamente, quasi impercettibilmente, si muove il lungo serpente di folla davanti al mausoleo di Ho Chi Minh, sulla piazza Ba Dinh, dove, il 2 settembre del 1945, il capo vietnamita lesse il proclama d’indipendenza che cominciava con queste parole (tratte dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America): “Tutti gli uomini sono stati creati uguali. Sono stati tutti dotati dal Creatore di certi diritti inalienabili, tra cui la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità”. Per rendere omaggio al padre della patria (il cui nome significa “Colui che illumina”) giungono qui ogni giorno cinquemila vietnamiti da tutti gli angoli del Paese. Composti e silenziosi, coi vestiti della festa, le donne col capo coperto, attendono tranquillamente il loro turno per entrare nel mausoleo sotto un sole che brucia. Sfilano con le braccia lungo i fianchi, come vuole la tradizione, dimostrando un commovente sentimento di affetto e gratitudine per Ho Chi Minh. La coda è lunga almeno quanto quella davanti al mausoleo di Lenin, a Mosca sulla Piazza Rossa. A noi turisti non è consentito incolonnarci come tutti i vietnamiti. Corsia preferenziale, più rapida, che ci fa non poco vergognare di fronte agli altri poveretti. Posiamo su un tavolino telecamere e macchine fotografiche: ordini superiori. Saliamo i pochi gradini di una scalinata di marmo nero, al fondo della quale si arriva in un’ampia sala dove le spoglie imbalsamate del rivoluzionario riposano sotto una speciale campana di vetro leggermente interrata. La temperatura è mantenuta appositamente attorno ai zero gradi, ma ci viene detto che ogni notte, grazie ad un congegno automatico, il catafalco viene calato in una cantina a quaranta gradi sotto lo zero: meraviglie della tecnica. Sostiamo non più di quindici secondi davanti al corpo imbalsamato di Ho Chi Minh, morto nel 1969, giusto vent’anni fa. Mi sembrano quindici secondi lunghissimi, 20 interminabili. E’ qui davanti a me, questo incredibile personaggio che ha resuscitato una nazione, edificato uno stato, condotto due guerre che furono le guerre degli oppressi. Lo vedo così fragile che pare sopravviva soltanto per forza d’immaginazione, nel fuoco della lotta di un popolo altrettanto esile e frugale e stoico quanto lui. Lo zio Ho (Bac Ho), come viene chiamato familiarmente dai vietnamiti, indossa un completo chiaro e ha le braccia distese lungo i fianchi. I capelli candidi sono pettinati all’indietro, la fine e rada barba caprina sembra quasi evaporare dal mento. Un piccolo riflettore irraggia un tenue riflesso di porpora sulle mani e sul volto smagrito, dai lineamenti delicati. Ho Chi Minh, quando era ancora in forze, aveva detto pubblicamente che, alla sua morte, bisognava evitare grandi funerali “per non sciupare il denaro e il tempo del popolo”, e che lui voleva essere cremato, sperando che la pratica dell’incinerazione si diffondesse nel Paese perché gli pareva una pratica “buona dal punto di vista igienico e che permette di economizzare la terra”. Invece, l’ufficio politico del Partito Comunista, sostenendo che la cremazione sarebbe stato un atto irreparabile, una grave perdita per il Paese, e che il corpo dello zio Ho avrebbe dovuto essere sempre visibile, non rispettò il suo desiderio. La ragione di stato aveva prevalso. Ha scritto un giornalista sovietico: “Visto da lontano, il mausoleo con i suoi tetti e le venti colonne che lo sorreggono, fa pensare a un fiore di loto sullo sfondo azzurro del cielo.” Sarà. Ma i contadini in processione che aspettano pazienti il loro turno per vedere la salma di Ho, sono abituati a vivere nelle risaie e nelle foreste sul fiume. Conoscono il bambù, il riso, la manioca, il cocco e i pompelmi rosa. In quella costruzione di marmo lucido, costruito con la consulenza dei sovietici, forse non vedono nessun fiore di loto, ma solo uno squallido cubo di marmo. E hanno ragione. 21 Ho Chi Minh sembra venirci incontro nella casa che sorge accanto al mausoleo, una capanna tutta in legno profumato, con pochi mobili di raffinata semplicità. Due stanzette, un tavolo, molti libri: ecco il rifugio del Saggio. Qui il vecchio capo trascorse gli ultimi anni della sua tumultuosa esistenza. Sono rari i turisti ammessi a visitare questo luogo (noi, per fortuna, siamo stati fra questi), che dice invece molto dell’uomo e di quello che faceva, leggeva, sapeva, pensava. E’ qui che si capisce che se Ho Chi Minh si fosse limitato a vincere la guerra avrebbe avuto lo stesso il suo mausoleo, ma non sarebbe salito su mille altarini domestici. Perché lui, che poteva esprimersi da intellettuale marxista e francofono, parlava invece per massime e metafore, come il vecchio, umile uomo che era e che sempre rimase. Perché aveva bisogno di sentirsi in campagna e in quella casa invitava nugoli di bambini a chiacchierare con lui tutte le domeniche, come un buon vecchio nonno. Perché curava con tenerezza le piante e lo stagno e non dimenticava mai di dare da mangiare alle carpe, quelle carpe simbolo del contadino che conosce soltanto l’acqua grigia e bassa della risaia, che non può alzare la testa per vedere il cielo perché anche la sua tomba sarà là, in mezzo alle piantine del riso. Bambini del Vietnam Spesso la gente vietnamita ci guarda a bocca aperta, mentre passeggiamo oppure mentre noi osserviamo loro e tentiamo di fotografarli. Sento che i vietnamiti si godono la nostra presenza e che vederci per loro è un’esperienza piacevole. La maggioranza delle persone non ci dice nulla. Ci guarda, ci addita, poi parla di noi con i suoi vicini. Ha detto Sung che l’osservazione fatta più spesso da chi ci vede passeggiare si riferisce alla nostra statura. E perché, mi sono chiesto, non al nostro abbigliamento, al 22 nostro ridicolissimo equipaggiamento di videocamere e macchine fotografiche con sofisticati obiettivi? Quando non fa più tanto caldo, prima del tramonto, vado a passeggiare spesso per conto mio in città, cercando di stabilire un rapporto con le occhiate che la gente mi lancia, godendomi le ambiguità della mia identità, protetto dal fatto che non parlo il vietnamita e posso soltanto restituire le occhiate e sorridere. Credo proprio che i bambini siano la parte essenziale del paesaggio umano del Vietnam. E’ molto bello vederli mentre mi vengono incontro, in silenzio, mentre mi tirano i peli delle gambe, o si attaccano ai calzoni, cercando un dito o la mano, guardando in su seri, attenti, con quegli occhioni grandi, ma con grande fiducia. I più sfacciati si mettono in posa, le mani sui fianchi, lo sguardo studiato come se recitassero in un film e attendono una foto-ricordo che non riceveranno mai. Indossano vestitini di stoffa semplice, magari ricavati da altri vestiti dismessi dai fratelli più grandi. Qualcuno è scalzo, altri trascinano ciabattine marroni, uguali nella fattura e nel modo di alzare la polvere. I bimbi vietnamiti sorridono senza capire nulla delle nostre parole, e poi si radunano in cerchio come per stabilire una strategia di dialogo con lo straniero particolarmente disposto nei loro confronti. E’ un confabulare serio, il loro, interrotto da risa improvvise, come non trattenute. E’ capitato che qualche bambino abbia steso la mano nel gesto di chiedere caramelle, gomme da masticare, biro colorate, portachiavi, o qualsiasi altro oggetto che porti scolpito, indelebile, il marchio dell’”esotismo” occidentale.. In questi casi ci viene la tentazione - e lo facciamo anche - di regalare qualcosa, non certo per un rigurgito tardo-coloniale, quanto per stabilire in qualche modo un contatto, garantirsi razioni supplementari di sorrisi, una forma come un’altra per comunicare. Forse, per conoscersi meglio. 23 Una sera, sulle rive del Lago della Spada Restituita, abbiamo regalato ad un bimbo scalzo una penna biro, ma Sung, irritato dai comportamenti dei bambini, ormai accorsi a frotte intorno a questa specie di poverissimo albero della cuccagna, ha esclamato disperdendoli: “Non hanno bisogno di nulla!” , mostrando di temere che la dignità vietnamita ne venga in qualche modo compromessa. Sung, quella volta, è parso molto orgoglioso di essere un’avanguardia comunista che si è assunta la responsabilità del bene del popolo e di educarlo ad essere sempre dignitoso, e anche se gli abbiamo detto - mentendo - che i bambini sono così in tutto il mondo, lui è parso irremovibile, e con il braccio alzato, ci ha condotti oltre. Nel Tempio della Letteratura Sotto un vento improvviso, caldissimo, che spazza le cartacce e le foglie e sembra rallentare per un attimo la fiumana di biciclette per le vie di Hanoi, Sung ci conduce una mattina a visitare uno dei più bei templi della capitale: il Tempio della Letteratura. A ben pensarci, nessuno altro popolo ha avuto l’audacia di consacrare un tempio al genio astratto della Letteratura. I vietnamiti (che hanno un’autentica venerazione per tutto ciò che è fatto con la carta) sì, e che tempio. Attraversiamo un grande muro di cinta bianco, poi passiamo sotto un alto e rosso portale, infine sotto un altro portale, anch’esso rosso, perché questo è il colore tradizionale della nobiltà e della grandezza. Il Tempio è dedicato a Confucio, ed è stato costruito nel 1070, all’epoca in cui la città si chiamava Thang Long (solo nel 1400 prenderà il nome attuale) ed ospitava la prima università vietnamita per il reclutamento e la formazione dei mandarini. Vediamo delle stele, erette su tartarughe di pietra (la tartaruga è uno dei quattro animali sacri vietnamiti, con il dragone, il liocorno e la fenice) sulle quali per dieci secoli 24 sono stati incisi i nomi dei laureati, che per secoli hanno formato l’élite dello Stato feudale. Coloro che non superavano le prove, venivano immersi, per qualche secondo, nell’acqua chiara del laghetto centrale. Sotto i frangipani, ma un po' dovunque, lavorano dei ragazzi, si scambiano appunti di scuola, si ripetono a vicenda la lezione. In fondo, sotto la cupola dell’edificio centrale, delle studentesse in architettura stanno compiendo delle rilevazioni. Alcuni bambini stanno facendo il bagno nei due stagni rituali. Confucio è morto da molto tempo, ma questo luogo, a lui dedicato, sembra vivo, tanto è bello e depositario di saggezza. Vi sarei rimasto per giorni e giorni. In cyclo-pousse Gli autisti di cyclo-pousse sono una delle attrazioni di Hanoi. Piroettano con consumata perizia fra bambini che giocano, ceste di frutta, vecchine col bilanciere in precario equilibrio, riuscendo ad evitare perfino le pozzanghere e gli altri pazzi come loro. Stanno appollaiati alle spalle del passeggero sul sellino della bicicletta che spinge il carrozzino. Pedalano e parlano, chinandosi fino a sfiorare i capelli del trasportato. Si sente sul collo il loro fiato affannoso, e l’odore di certi condimenti, maledettamente piccanti. Ti parlano di tutto, per quel poco che riescono a dire in inglese. Ti chiedono da quale paese provieni, non considerando mai l’italiano tra i possibili visitatori del Vietnam. Ti chiedono se sei francese, inglese, o, tutt’al più, americano. Non ti possono scambiare per russo perché dicono che i russi vestono male e che le loro donne sono grasse e sformate. Gli interessa molto conoscere il tuo nome e, quando glielo hai detto li senti sforzarsi per ripeterlo nel migliore dei modi: “Nico, Nico, Nico”. 25 Altre volte ti chiedono una sigaretta, quasi tremando di gioia quando gliela sporgi all’indietro. Molti autisti di cyclo-pousse sono curiosi di sapere se sei sposato e, soprattutto, quanti figli hai. Non riescono a capire come da noi, in Occidente, a trent’anni si possa ancora essere signorino o signorina. E allora vai a spiegare loro tutti i nostri problemi, il lavoro, la casa, i divertimenti; vagli a dire che il nostro è un mondo a parte, e che siamo noi ad aver perso i giusti valori e non loro. Ma non tutti gli autisti di cyclo-pousse sono loquaci. Se ti capita (e ti capita) di imbatterti in quello silenzioso, immusonito, contrariato, ecco che il tuo city-tour si trasforma in una passeggiata meno divertente. Buona solo per scattare foto. Soldatini con i sandali Ieri, nella tarda mattinata, si è messo a piovere. E’ stata la prima pioggia tropicale alla quale ho assistito dal momento del mio arrivo in Vietnam. Senza lampi, nè tuoni, è venuta giù all’improvviso, fitta e densa come nebbia. Le strade si sono riempite presto di pozzanghere grandi come crateri, ma il traffico su due ruote non ha subìto il minimo rallentamento. Chi era di corsa (come può esserelo un vietnamita, persone solitamente tranquille) per andare al lavoro o recarsi ad un appuntamento non si è minimamente preoccupato di questa lavata calda, e ha proseguito imperterrito la sua corsa. Sopra qualche cicylo-pousse sono state montate tettoie di plastica colorate, mentre lunghe coperte di nylon azzurro coprivano le gambe dei passeggeri. Mi trovavo in una grande camera circolare negli uffici della Vietnam Tourism, sobriamente arredata con grandi manifesti che illustravano, in technicolor, le bellezze naturali del Paese: le pagode di Hué, i fiordi della baia di Halong, le montagne di Dalat, definita la Svizzera del Vietnam. 26 In un’altra stanza, Sung aveva finalmente risolto il mistero di una valigia di un mio amico che si credeva definitivamente smarrita all’aeroporto di Hanoi il primo giorno. La valigia era finita per sbaglio nel deposito bagagli, sepolta in mezzo ad altre. Sung è arrivato in compagnia di una deliziosa e altissima impiegata della Vietnam Tourism che si è scusata per l’inconveniente e mi ha pregato di consegnare la valigia al mio amico (all’appello mancavano comunque due paia di scarpe!). Sulle rive increspate del lago, proprio di fronte alla stanza in cui mi trovavo, è transitato un camion di militari, dal quale è sceso un soldatino che si è diretto in tutta fretta contro il muro di una casa per fare la pipì. A vedere questo giovanotto affondare i sandali con disinvoltura nell’acqua, mi è venuto alla mente un filmato francese che avevo visto alla televisione prima di partire per il Vietnam. Le immagini riprendevano i soldati di Hanoi mentre si addestravano, attraversavano i fiumi, aiutavano i contadini a raccogliere il riso, costruivano dighe, imparavano a guidare i nuovi jet inviati dai sovietici. Commentava lo speaker: “Oggi l’esercito è formato da un milione di uomini. Ci sono famiglie che hanno anche quattro figli sotto le armi e villaggi dove l’arruolamento ha raggiunto quattro abitanti su dieci. Trentacinque anni di guerra hanno lasciato tracce.” E’ difficile sapere se ancora oggi è il fucile che comanda al Partito e al suo milione e settecentomila iscritti, oppure se la psicosi dell’accerchiamento e della difesa è diventata la logica unificante dei due poteri. Una lingua musicale Seduto in un locale all’aperto - sopra la mia testa un vecchio paracadute americano è stato utilizzato come parasole - mi sono messo a sfogliare una copia del quotidiano locale, “Nguoi Hanoi”, che ho appena acquistato in una bottega. 27 Due operatori americani stanno preparando un servizio sulla Hanoi di Ho Chi Minh, che manderanno in onda nel 1990, in occasione del centesimo anniversario della sua nascita. Uno di loro ha una barba chiara e fluente e i capelli legati con un nastrino. Indossa un’incredibile camicia fatta con gli scampoli di altre camicie dai colori vivaci. Negli Stati Uniti un capo del genere è capace di costare una cinquantina di dollari. Alcuni vietnamiti, da come la guardavano, sembrava non avessero mai visto niente di più colorato in tutta la loro vita. Il giornale ha sedici pagine di carta ruvida, quasi gialla. E’ composto ancora a caldo, con il piombo, ma la resa è pessima, forse a causa della non ottima qualità dell’inchiostro. Poche, sfuocate, le riproduzioni fotografiche. Ci sono alcuni disegni elementari e perfino una vignetta del Forattini vietnamita, che ironizza sulla piaga della corruzione. Due pagine sono dedicate alle poesia e alla pubblicazioni di brevi novelle. Della serie “I Grandi viaggi”, ecco un reportage su Tahiti e la Polinesia, impreziosito da alcune fotografie della solita fattura. Non capisco un acca di vietnamita, eppure mi incuriosisce questa lingua, anche a vederla scritta (in un articolo del “Nguoi Hanoi” comparivano i nomi di O’nixt Ho-Minh-Uay, Uylio m Secxpia e Ghi Do Mopatxang, e mai più avrei immaginato si riferissero a Ernst Hemingway, William Shakespeare e Guy de Maupassant!). Mi spiega Duong Thi, una simpatica studentessa che collabora con la casa editrice “Editions en langues etrangères”, che quella vietnamita è una lingua monosillabica, fluida e morbida, costruita su cinque diversi toni che annebbiano quasi i confini fra canto e parola, poiché corrispondono alle note della scala della musica tradizionale. A seconda del tono, il suono cambia significato, diviene di fatto un’altra parola. Ad esempio, ma può voler dire tante cose: fantasma (tono neutro), ma (tono grave), guancia e madre (tono acuto), nuovo germoglio di riso (tono forte) e tomba (tono interrogativo). 28 Una sera prima di cena, nella hall del “Thang Loi”, ho avuto un’altra breve lezione di lingua vietnamita dal dottor Tran Quang Huy, dell’Associazione di amicizia Vietnam-Italia. Mi ha spiegato, il dottor Quang Huy, tutti i quindici significati della parola io, che varia a seconda della persona alla quale ci si rivolge. Il termine io di fronte ad un superiore oppure ad un anziano, è diverso da quello che si usa quando si parla con un amico o con una persona più giovane. Un maestro con i suoi scolari non dice io, ma si riferisce a se stesso con l’espressione “il maestro”. Nella lingua vietnamita - ha aggiunto il dottor Quang Huy - non esiste ne il tu ne il lei: il discorso si svolge sempre in terza persona. Ad esempio: “Io dico all’onorevole signore”, oppure: “Io dico al compagno”. Il marito si rivolge alla moglie come alla “sorella minore”, la moglie chiama il proprio marito “fratello maggiore”. Ancora oggi in campagna il bambino non viene sempre chiamato con il suo vero nome, per timore degli spiriti che potrebbero nuocergli o anche rapirlo, pertanto si usano soprannomi. La tendenza ad evitare i nomi può portare a questa cerimonia, che il dottor Quang Huy ha reso molto bene in francese con un’eloquente mimica: La moglie grida verso la risaia: - Chi chiama e chi è chiamato? Il marito risponde: - Chi è quello che chiama? La moglie, di rimando: - Quello che chiama e al quale qualcuno risponde. Il marito domanda: - Chi risponde? E la moglie: - Quello che è chiamato dalla moglie. Hanoi, Natale 1972 Molto spesso, passeggiando per Hanoi, ho cercato di immaginarmi come potesse presentarsi agli occhi di un visitatore la città straziata dai bombardamenti dei B-52 nel 29 Natale del 1972. Bambini in fuga per le strade, le grida delle donne, il fuoco, la polvere, le case sventrate. Ho tentato di pensare a come si vivesse a Hanoi in quel tragico dicembre, mentre i bombardieri americani sganciavano quarantamila tonnellate di bombe sul territorio densamente popolato di Hanoi e Haiphong, e nel nostro Occidente si costruivano presepi e si addobbavano gli alberi di Natale. Ho tentato, ma non ci sono riuscito. Le strade, i templi, le botteghe, l’operosità e la gentilezza della gente, i bambini: Hanoi sembra un tale panorama di pace e serenità immutabile da secoli, e non si riesce ad immaginare neppure lontanamente, un simile sconquasso, breve ma catastrofico. Ha scritto Furio Colombo in un suo memorabile réportage sul Vietnam che “c’era un silenzio teso nel mondo, in quei giorni. Quella guerra stava cambiando e aveva cambiato il destino di tutti, la qualità della vita, il senso di stare al mondo, i fatti normali e banali di tutti i giorni, le prospettive del futuro, il rapporto - persino quello più personale e più intimo con i nostri bambini, in case lontane e ‘sicure’.” Nel dicembre del ‘72, Sung aveva dodici anni: fu in quei giorni che una scheggia impazzita piovuta in casa, mentre lui era nascosto sotto la finestra, gli fratturò la gamba destra. Sung ha rievocato con me quei brutti momenti durante una passeggiata sulle rive del lago della Spada Restituita. Le facce della gente che si calava nei rifugi, delle madri piangenti che vegliavano i propri bambini, accovacciati nei luoghi più impensati. Lo sguardo calmo e vuoto di chi continua a vivere, mentre intorno la morte ha arato e spazzato via tutto ciò che significa la vita. I visi febbrili, lucidi di fatica, di sonni cattivi, la polvere della guerra. Tutto questo vive ancora nella memoria di Sung. Sung mi mostra alcuni tombini dei rifugi antiaerei: sono ancora lì, nelle strade di Hanoi, al loro posto. “Durante la guerra - dice - erano aperti ai due lati e quelli più grandi 30 avevano l’apertura di cemento che scendeva subito molto in profondità. Solo che oggi sono ormai inservibili, e la gente, quando passa, non ci fa più caso.” Beviamo una Coca-Cola seduti sull’erba. Sung ricorda la sua casa, in quei giorni: ricorda la luce gialla della lampadina che pendeva dal soffitto crepato, una stanza con le finestre sfondate e la coperta a far da chiusura contro il vento gelato. Sua madre e le sue sorelle indossavano due o tre giacche di tela una sull’altra per resistere al freddo. Un cappello di paglia, largo e spesso, serviva a riparare dalle schegge, se la bomba non era troppo vicina. Quando usciva di casa, dopo i bombardamenti, Sung vedeva i crateri delle bombe, sentiva le grida dei feriti, vedeva il sangue dei morti. Per lui e la sua famiglia, come per mille altri vietnamiti, la giornata cominciava con un lavoro minuto e fervido di ricerca nella polvere, nei buchi, nelle macerie. Tutti cercavano, sollevavano, trasportavano, scavavano. Nessuno era abbastanza bambino per essere escluso dal portare qualcosa, abbastanza vecchio per farsi lasciare indietro, abbastanza fragile per non caricarsi il suo peso. Le ore in cui gli americani non bombardavano, ricorda Sung, erano calme, come gli intervalli fra le crisi acute di un male brutto. Il mio amico parla senza guardarmi, fissa lo specchio chiaro del lago, ogni tanto sorseggia una goccia di Coca. Dice che una delle cose che gli sono rimaste più impresse di quei momenti era la voce della radio. Una voce quasi incessante che rimbalzava da un altoparlante all’altro, da un transistor all’altro, fra le campagne e i villaggi. Sentiva la radio parlare anche nel buio, nelle strade deserte, sulle distese di distruzione: erano esortazioni, appelli, discorsi politici che lui non capiva, oltre che informazioni pratiche, notizie sul continuo pericolo. L’incoraggiamento non erano le parole pronunciate, ma il fatto che esisteva una voce e che continuava a parlare. Quella stessa voce ha annunciato la fine della guerra e Dang Sung ricorda che, in quello stesso momento, il suo migliore amico, suo coetaneo, moriva dopo un’agonia 31 durata una settimana. Dice che la guerra per lui è finita quando, dopo mesi, il ricordo dell’amico spirato si è fatto meno vivo e sentito, solo allora. Non quando la radio ha dato la notizia e la gente ha fatto festa. “Perché in questo paese - mi ha ancora detto con gli occhi lucidi - non è ancora venuto il momento di festeggiare qualcosa.” Guerra e pace a Hoa Binh Hoa Binh (che vuole dire “pace”) è un borgo che si allunga mollemente ai piedi delle montagne, ad un’ottantina di chilometri a sud-ovest di Hanoi. E’ abitato da almeno un migliaio di russi che lavorano alla costruzione della centrale idroelettrica. Ci sono molti poliziotti che si aggirano per la cittadina: pare non gradiscano la presenza di stranieri che curiosano dalle parti della grande diga. Ci sono molte case in costruzione, a Hoa Binh, e un mercato vivacissimo. Comincia qui la regione dei Muong, la più numerosa di quelle minoranze (e sono tante in Vietnam: più di sessanta) che fanno del Paese uno stato “multinazionale.” I Viet costituiscono il 90per cento della popolazione totale, ma si valutano sui 4 milioni gli allogeni, di origine cino-tibetana (come i Meo, i Mung, i Thay) o austral-asiatica (Muong, Jarai, Mon-Khmer), che abitano altopiani e montagne. Il destino del Vietnam moderno infatti si è spesso giocato non soltanto sulle terre, ma nel profondo della vita di queste tribù, che hanno dato alla guerriglia popolare antifrancese combattenti coraggiosi come Chu Van Tan, per esempio, diventato il secondo generale dell’esercito popolare di Ho Chi Minh e Giap. Quello stesso Vo Nguyen Giap, soprannominato “Napoleone rosso” che il 7 maggio 1954, a Dien Bien Phu, nella regione di un’altra minoranza al confine con il Laos, i Thay, con un capolavoro di strategia militare, aveva segnato per sempre il destino del corpo di spedizione coloniale francese. 32 Oggi il generale Giap, guerrigliero per caso (“Ero un professore di storia abituato a maneggiare la penna, non la spada”, ama dire quando viene intervistato, poche volte, per la verità) ha settantasette anni e in Vietnam è un mito, secondo soltanto a Ho Chi Minh. Dopo i francesi ha sconfitto gli americani: eventi grazie ai quali Giap è tuttora considerato la più grande mente strategica del dopoguerra. Il suo popolo lo chiama “il vulcano sotto la neve”, perché dietro un’apparenza fredda e imperturbabile nasconde un ardore senza limiti che è riuscito ad infondere in milioni di vietnamiti, un ardore che si è rivelato più forte del napalm e dei B-52. Vive a Hanoi in una villetta non distante dal mausoleo di Ho, accanto ad un parco lasciato appositamente selvatico, come si conviene ad un uomo che ha avuto per casa la giungla. Nei pressi della villetta c’è un piccolo lago immobilizzato nella morsa dei fiori di loto e abbellito da decine di vasi da cui penzolano i rami delle orchidee che i comandanti del Fronte di Liberazione del Vietnam del Sud coglievano nella foresta e inviavano al loro leggendario comandante. Ogni orchidea è il ricordo di un accampamento nella boscaglia, di una marcia notturna sulla pista di Ho Chi Minh che alimentava di uomini e mezzi i combattenti del Sud. Sono trascorsi molti anni da quei giorni e le orchidee, con il loro aspetto macilento, paiono testimoni di un tempo lontano. Così come il generale Giap (che in vietnamita significa “corazza”), dalla liscia faccia ovale da bonzo in meditazione, ultimo protagonista vivente di un’epopea straordinaria per il popolo vietnamita; quel Giap che, ancora oggi, quando parla dello zio Ho, abbassa il tono della voce, i suoi occhi vagano lontani e a tutti i suoi interlocutori suole dire con commozione: “Peccato che lei non l’abbia conosciuto: lo zio Ho era una persona dall’animo gentile, umile, con un amore enorme per la gente, il popolo: voleva liberare gli uomini di tutto il mondo.” 33 Abbiamo impiegato più di due ore per giungere a Hoa Binh. Abbiamo attraversato paesi che sembrano tutti uguali: Ha Dong, Chruong My, Xuan May, Ky Son. Per un lungo tratto abbiamo seguito il corso del Song Da, o Fiume Nero, che è forse il più bello fra tutti quelli che fanno del Vietnam una sconfinata sagra delle acque. Il Song Da spiega le sue anse in un teatro di montagne, di color bronzo dorato più che nero, di una larghezza che ne fa un’ideale via d’acqua a dimensione umana. E’ sulle sue rive che - dicono i vietnamiti - si vorrebbe fondare la casa dei sogni: tra il cielo, la roccia e la risaia che costeggia. Il nostro pulmino arrancava per le strade tortuose e malandate. Nulla ricordava un itinerario di guerra. Sembrava piuttosto di sfogliare una collezione di stampe orientali, con le montagne avvolte nella nebbia, le grandi case di legno sulle palafitte, le risaie, le cascate. Per queste mulattiere i patrioti vietnamiti spingevano con forza le loro biciclette, che trasportavano fino a 350 chili di roba, munizioni e viveri per lo più, e percorrevano quaranta chilometri al giorno in queste condizioni. Quelle due ruote sgangherate, rinforzate con pezzi di bambù, rappresentavano l’unico loro mezzo di trasporto. Per queste strade impossibili è nato l’orgoglio militare dei vietnamiti. Eccoci dunque nel paese dei Muong. I Muong sono un popolo che costituisce un caso a sè. Il dialetto Muong si parla ma non si scrive, non è più praticato. Anche nella scuola di Hoa Binh non lo si insegna più. Questo villaggio, così incassato fra i monti, dà l’impressione dell’isolamento e della lontananza dal potere centrale. Vengo a sapere che ci sono molte persone, qui, che hanno imparato il vietnamita a dieci, dodici anni e che, per miracolo, conoscono il nome del primo ministro. Siamo stati ospiti di una famiglia nella sua graziosa casa di legno decorato, costruita su palafitte lungo il corso di un torrente. Nella “zona ospiti” ci è stata offerta della dolcissima grappa di riso che abbiamo aspirato da cannucce ricurve che emergevano da 34 un’anfora. Tutto intorno, era un’aggressione festosa di bambini, con i piccoli che cercavano di issarsi sulle spalle dei più grandi, curiosi di poter osservare proprio da vicino questi strani “marziani”. Capre e maiali circolavano liberamente attorno a noi. Abbiamo consumato il pranzo a Hoa Binh, in un ristorante gestito da personale rigorosamente Muong. La cameriera indossava il caratteristico costume nero con fiori rossi ricamati sulla casacca, e parlava nel dialetto locale che perfino il nostro interprete occasionale ha stentato a capire. Niente turbante, sulla testa della cameriera, ma il più pratico non a forma di cono. Fuori dal finestrino del pulmino che ci riportava in hotel, osservavo il pacifico esercito di donne che trotterellavano sotto il peso dei panieri agganciati in equilibrio ad una canna che poggia sulle spalle. Quando il carico è troppo pesante, collocano di sbieco il bilanciere di bambù, portato all’altezza della nuca, con il collo piegato. Sotto simili pesi, non si riesce a marciare al passo, bisogna trottare al ritmo del bilanciere. Gli uomini, loro, utilizzano più spesso la famosa bicicletta con le asticelle, un carrettino che i vietnamiti chiamano “Ho Chi Minh”. Le donne intanto continuano a usare le spalle, anche se il padre della patria ammoniva: “Bisogna liberare le spalle.” E Hoang Tung, intellettuale vietnamita, ha scritto ispirandosi a Mao: “Le donne sorreggono più della metà del cielo. Svolgono le mansioni più dure, accettano tutto. E gli uomini, egoisti, vogliono molti figli. Il nostro cuore sanguina quando vediamo le nostre mogli lavorare in quel modo!”. Duello sul ponte. Verso Haiphong La lunga colonna di vecchi camion, di autobus, di jeep militari, sozzi di fanghiglia e dalle vernici sbiadite, è ferma sul ponte sul Fiume Rosso. Il nostro autista, Tran, è più 35 nervoso del solito. Suona come un dannato quel suo clacson sfiatato. Possibile che non veda, poco più in là, il cantiere aperto? Dal finestrino del nostro pulmino incolonnato spunta la mano di una giovane che ci porge un pompelmo bianco, appena sbucciato. La ragazza ha il cappello a cono legato al collo con un nastrino rosso. E’ molto bella: i capelli neri e brillanti le scendono lungo la schiena, fino alle anche. Gli occhi, che tiene ben alti, esprimono al tempo stesso innocenza, grazia, dolcezza, stupore infantile. La pelle è ambrata e lucente. La colonna si muove. Il pulmino ha un sussulto. Tran sterza bruscamente, supera con rabbia due o tre camion che ci stavano davanti, affonda le ruote nel terriccio umido fino a trovarsi fianco a fianco con un automezzo militare che non ha nessuna intenzione di lasciarci passare. Gli occupanti sono soldati che non dimostrano più di sedici anni. Ci fissano e sogghignano. Uno di essi strappa la buccia di un’arancia e poi addenta il frutto con insana voluttà. Il loro autista finge di non accorgersi della nostra presenza e così rischiamo una collisione fra specchietti retrovisori. Tran lancia qualche insulto al suo indirizzo, imballa il motore e il pulmino si spegne. Non è una novità: gli anni sulla carcassa di quel vecchio residuato bellico (quasi 200.000 chilometri) cominciano a pesare. Infine, Tran trova il varco giusto. I militari smettono la prova di forza e ci troviamo adesso davanti a ben quattro camion. Un successone. Ora Tran sorride. Siamo diretti a Haiphong, 150 chilometri a nord di Hanoi, terza città del Vietnam per numero di abitanti e principale centro industriale del Nord. Haiphong, secondo porto del Vietnam, divenne famoso all’epoca dei bombardamenti americani per l’abilità con la quale i vietnamiti modificavano i missili made in URSS e colpivano gli aerei yankee. 36 Lasciare Hanoi vuol dire toccare con mano quella che è stata la più assillante delle preoccupazioni dei governanti vietnamiti: le vie di comunicazione. Il già citato ponte sul Fiume Rosso, pur costantemente bombardato, riparato, ricostruito, rinforzato, costituisce ancora oggi il solo cordone ombelicale fra Hanoi e il resto del Vietnam. Di tutti gli altri ponti, seicento e più, che si devono attraversare per raggiungere Saigon, millesettecento chilometri a sud, non ce n’è uno che non abbia subito le medesime disavventure. Sono stati tutti riparati con mezzi di fortuna: assi di legno, tronchi. E la ferrovia? Eccolo, il treno, che ci affianca su un rialzo della strada, mentre ci troviamo di nuovo incolonnati. Sui vagoni di legno verde è stipata una folla ammassata perfino sulle piattaforme aperte e seduta sui finestrini. Questo treno - che attraversa la più celebre strada ferrata del sud-est asiatico, la linea imperiale, meglio conosciuta come “Transvietnamita” - è divenuto, nelle sue epiche traversate, il simbolo della vita e della miseria, della bellezza e dell’inferno di tutto un Paese. Parte ogni tre giorni da Saigon per raggiungere, dopo 52 ore di estenuante tragitto e 1729 chilometri di calore e polvere, Hanoi. Alla fine della guerra, nel 1975, il 60% dei binari era fuori uso, ma venne ricostruito a tempo di record nel giro di due anni. Per questo motivo i vietnamiti considerano il “treno della riunificazione” (così è chiamato oggi ogni convoglio che fa la spola fra Saigon ed Hanoi) un motivo di orgoglio nazionale e un simbolo dell’unità del Paese. Poco importa che le vecchie locomotive diesel a vapore di fabbricazione sovietica abbiano un passo piuttosto lento (50 km. l’ora): considerando i deragliamenti, i bufali e i veicoli che si fermano sulle rotaie, le inondazioni e i tifoni, si può dire che il solo fatto che i treni continuino ad andare in Vietnam sia un vero miracolo di ingegneria. Verso le dieci, consumiamo una rapida colazione (banane e tè) a Hai Duong, un ex villaggio destinato a morire nell’anonimato finché i cinesi nel 1965 non hanno pensato 37 bene di impiantarvi una fabbrica di ceramiche. E così Hai Duong è diventato celebre in tutto il Vietnam. Per le strade c’è il solito movimento di carretti e biciclette stracariche di gerle colme di verdure e foglie. Ho visto uomini anziani rintanati come cani solitari e silenziosi all’ombra delle loro capanne. In una baracca di legno e lamiera ci siamo dissetati con una noce di cocco appositamente aperta per noi. A mezzogiorno Haiphong proietta il suo aspetto di città fantasma. Dalla strada principale si vedono stabilimenti industriali, fabbriche di vetro e di mattoni, cementifici, forni da calce. Giungiamo a destinazione dopo quattro ore di viaggio. Sostiamo qui giusto il tempo di pranzare nell’hotel “Huu Nghi” , nel centro città, proprio accanto ad un deposito di birre cinesi, attorno al quale c’è un gran movimento di camion e manovali. Sul banco della reception ci sono un gigantesco calendario russo con soggetti cosmonautici e mazzi di chiavi delle camere sparpagliati. Gruppi di gechi - quelle lucertoline assolutamente inoffensive che acchiappano insetti - vigilano sui muri nella loro classica posizione di attesa. Traggo da un portariviste un opuscolo turistico dai toni piuttosto patriottici: “Oggi Haiphong é una delle città più attive e creative nella costruzione del socialismo e nella difesa dello Stato socialista. Gli abitanti di Haiphong stanno impegnando tutte le loro risorse per costruire la città e farla divenire un porto moderno con un’industria e un’agricoltura sviluppate, un centro di import-export, turismo e servizi, e, al tempo stesso, una fortezza inespugnabile contro l’invasione straniera.” (Quale, ormai?). C’è pochissimo tempo per vedere la città di Haiphong, - che detiene, credo, un record mondiale: è infatti attraversata da ben sedici fiumi - ma quel poco è sufficiente per riportare a casa impressioni non proprio positive. Mi ha colpito l’elegante teatro municipale sulla piazza intitolata ai martiri di Dien Bien Phu. C’é una montagna di rifiuti davanti ad un 38 caseggiato completamente sventrato, che pare fresco di bombardamento; e un negozio di souvenir per turisti che qui c’entra come una Rolls Royce sulle rovine di Macchu Picchu. Eppure Haiphong gronda storia. La città ha sempre fatto barriera contro gli eserciti e le flotte di tutte le dinastie cinesi. Qui i contadini e i pescatori venivano a raccogliersi per le guerre e le insurrezioni contro i signorotti nel XVII e XVIII secolo. In questo porto i francesi eressero nel 1837 la loro prima cittadella. E fu sempre Haiphong l’ultima testa di ponte della Francia quando, nel 1954, imbarcò le sue truppe bastonate dai guerriglieri di montagna. Proprio nel porto di Haiphong ci siamo resi conto di come esso sia il ritratto puntuale di un Paese che non riesce ad amministrare la pace, a lavorare in una condizione normale. Le navi attendono settimane prima di essere scaricate, e poi la merce resta all’aperto abbandonata sotto l’acqua e il sole perché chi deve venire a ritirarla non trova i camion. Il porto è davvero un cimitero di containers arrugginiti e sfondati. Così, secondo indiscrezioni dei responsabili del porto stesso, quasi la metà di quello che arriva qui viene perduto. Ripartiamo da Haiphong diretti ad Halong, luogo-cartolina del Vietnam. Un bambino con una camicia che gli penzola dai pantaloni corti e larghi, attende il segnale convenuto per aprire il cancello: stiamo per imbarcarci sul “bac”. Il “bac” è in Vietnam il mezzo più comune per attraversare i fiumi. E’ una parola derivata dal francese. Nella buona sostanza, si tratta di un enorme barcone che un rimorchiatore, agganciato alla sua fiancata, sospinge da una riva all’altra. Nel giro di pochi secondi il “bac”, che dovrà traghettarci oltre il fiume Cam, è stracarico di gente e mezzi: contadini con le loro ceste e i panieri, giovani a bordo di una Lambretta, una jeep con tre soldati, ragazze in bici. 39 Il nostro pulmino ha rischiato di non farcela a salire sul “bac”, spintosi troppo nell’acqua. Alcuni di noi sono saliti a piedi (forse per mancanza di fiducia nei confronti di Tran?). Tutti stretti, gli uni contro gli altri, abbiamo sentito il calore trasformarsi, in certi momenti, in un qualcosa di appiccicoso, un gigantesco e umido impasto di carne, braccia, bocche: corpi che sembrano risucchiarci e soffocarci. Ci sono tre bambine che si scambiano francobolli ancora attaccati al frammento della lettera. E c’è una vecchia che offre ghiaccioli, dal poco probabile colore marrone, avvolti in uno strofinaccio che secoli fa doveva forse esser bianco. Un ragazzino osserva quasi sgomento, come noi, un’enorme chiazza d’olio vomitata dal rimorchiatore. Il getto è denso e crea nell’acqua torbida lo stupefacente effetto cromatico della goccia di caffè nero nel cappuccino senza schiuma. Poco dopo, attraversata una stretta striscia di terra chiusa da basse montagne, siamo pronti per un nuovo imbarco per superare il Bach Dang, il Fiume Bianco. Sung è sceso dal pulmino ed è andato a confabulare con un tizio terribilmente ossuto e bianco in volto. Che cosa avranno mai da dirsi? Si imbarca pure una fiammante Toyota Crown nera, una vera auto di lusso, con i sedili in pelle e varie cartine del Vietnam appoggiate sul cruscotto. In piedi, accanto al cofano, due giovani inglesi di Brighton - dove c’è la spiaggia dei ricchi - bianchissimi biondissimi, sorriso largo e denti grandi. Ci raccontano di aver affittato l’auto a Hanoi, e nel pacchetto erano inclusi pure una guida e un’autista, a disposizione per tutta la durata del loro viaggio. Con poco più di quattro milioni sono rimasti in Vietnam una ventina di giorni, compresa una puntata veloce (ma molto proficua, sogghigna uno dei due) in quel di Bangkok. Saluteranno il Vietnam dalla baia di Halong. Il Bach Dang ha l’aspetto di un larghissimo estuario, l’acqua chiarissima sembra non scorrere ed è percorsa da giunche dalle tipiche vele quadrate che si muovono lentamente. 40 Risbarchiamo. La Crown nera chiede strada e ci sorpassa con una strombazzata. I due inglesi ci salutano. Gradatamente la campagna piatta scompare, l’acqua comincia a circondarci. Ecco il mare: la baia si apre su una spiaggia lunga e sabbiosa ricca di palme e di pini, silenziosa e intatta. C’è una nebbiolina appena impercettibile, il mare è solcato dalle vele gonfie dei sampan. Siamo a Bay Chay, nella regione carbonifera di Quang Ninh, che copre il 90% delle riserve vietnamite. Ai tempi dei francesi, migliaia di uomini della campagna circostante furono condotti a lavorare nelle miniere e furono proprio quelle intollerabili condizioni di sfruttamento che li portarono in seguito a ribellarsi al giogo dello straniero. Qui la Cina è davvero vicina, cento chilometri dal confine. Partì da qui, dal golfo del Tonchino, l’inutile crociata americana per il “contenimento” del comunismo nel sud-est asiatico. Halong, l’ottava meraviglia del mondo Passeggiamo sul triste lungomare di Bay Chay. Non c’è anima viva ad eccezione dei soliti commercianti: venditori di carburante in taniche chiare e occasionali “miscelatori” di strane bibite, in capanne coperte da frasche. L’albergo nel quale pernottiamo è una grande costruzione bianca, in stile coloniale, con ampia terrazza e vista sulla baia. Il personale dell’albergo sembra essersi volatilizzato. Spunta solo un giovanotto pimpante che dice di essere il responsabile. Ci guida nelle nostre camere, e quando arriva a quella mia e di Marina, si accorge di non avere preso la chiave. Attimi di tensione. “Torno subito,” dice. Quel “subito” diventano cinque e poi dieci minuti. Poi un quarto d’ora Ritorno nella hall in cerca del giovane. Sparito. Mi siedo su di una poltrona e ammiro gli splendidi poster appesi alle pareti: raffigurano la spettacolare successione di 41 isole, pare più di tremila, e scogli che fanno della baia di Halong, secondo i vietnamiti, l’ottava meraviglia del mondo. Un panorama che ha fatto poeta anche un disincantato giornalista come Jean Lacouture: “.....questa selva di isola affollate di barche con le vele a farfalla dalle ali brune, questo lago marino del colore del cielo su cui ondeggiano ciuffi di cotone a forma di nuvole.....” Halong significa “là dove il drago si posò”. Secondo una leggenda, il drago celeste abbandonò il suo antro nella montagna e scese verso il mare buttandosi in queste acque. Le torsioni della sua coda scavarono crepacci giganteschi nel suolo e quando, finalmente, si tuffò nel mare, l’acqua si precipitò a riempire le vallate, lasciando così emergere i tremila isolotti. Il sogno svanisce con il sopraggiungere del giovanotto, sorridente, in possesso della chiave. Non ho nessuna voglia di chiedergli spiegazioni per l’attesa, in Vietnam è bello imparare a risolvere gli imprevisti con un bel sorriso stampato sulle labbra. Così ho fatto quel giorno, come per tutto il resto del viaggio. Improvvisamente, sento una grande animazione fuori della nostra stanza. Esco sul piano, mi affaccio alla finestra: urla, insulti, bestemmie in romanesco. Vedo Sung nel piccolo parco che circonda l’albergo, accovacciato nella tipica posizione dei vietnamiti: ridacchia. Nello spazio di un secondo si materializza davanti ai miei occhi la scena alla quale avevo assistito nel secondo imbarco: il parlottare sommesso e discreto con il tizio magrissimo, poi il “bac” che parte quasi subito, e Sung che dimostra con un sorriso grande la sua soddisfazione. Mi ha poi spiegato Sung che gli è bastato infilare un pacchetto di Marlboro nel taschino del camiciotto del manovratore del “bac” per farci partire in anticipo sull’orario. Cosicché siamo arrivati prima dell’altro “bac” che trasportava, tra gli altri, un gruppetto di romani. I quali, buoni ultimi, sbarcati a Bay Chay, hanno avuto la sgradita sorpresa di 42 trovarsi alloggiati in un altro hotel, del quale Sung conosceva la fama: aria condizionata rotta, docce impraticabili, water luridi. A noi é andata bene. Fin troppo, se si fa eccezione per la frugalissima cena (pastina in brodo, gamberetti fritti e banane verdi a volontà) e per il via vai di rane e insetti vari e qualche timido scarafaggio che ogni tanto transitavano per la nostra stanza. Ma quelli, chi poteva prevederli? La mattina seguente ci siamo imbarcati su una panciuta nave russa, la “Mosca”, in una giornata nebbiosa che sembrava volerci nascondere apposta l’incanto di questi picchi rocciosi in piedi sull’acqua, di queste piccole montagne che hanno scavati, al loro interno, antri profondi da isola del tesoro. Davanti a noi, il Mar della Cina si spalancava nella sua dolce e incomparabile grandezza, e pareva perdersi dietro l’orizzonte rarefatto dalle nubi. Abbiamo navigato tra un isolotto e l’altro e tra una grotta e l’altra dai nomi più incredibili (Tunnel della Dogana, Grotta delle Meraviglie, Isola della Grande Scimmia, Isola della Sorpresa, Isola delle Mammelle) con il timore di perderci, come in un grande labirinto marino. La Grotta della Vergine deve il nome, secondo la leggenda, a una giovinetta figlia di pescatori che, essendo così poveri da non poter acquistare una barca, ne avevano noleggiata una da un ricco del paese. Ma, al momento di pagare, poiché non avevano il denaro necessario, avevano dovuto acconsentire a cedergli la mano della loro unica figlia. La quale, non essendosi mai rassegnata a vivere con quell’uomo, che aveva tentato di convincerla prima con le buone maniere e poi con le bastonate, era stata infine abbandonata in quella grotta, dove era morta di fame. Un pescatore aveva trovato il suo corpo e nel punto in cui lo aveva sepolto, era sorta una roccia con l’immagine della fanciulla, in ricordo del suo penoso sacrificio. 43 Di tanto in tanto, incontravamo qualche sampan con le vele spiegate, con pescatori intenti a intrecciare qualcosa, forse reti per la pesca. Non so quanti altri luoghi al mondo riescano a sprigionare una tale bellezza remota e dolcissima: nelle forme, nei colori, nel profumo intenso di mare e di pini, il solito odore vegetale d’acqua che è diffuso in tutto il Vietnam, ma molto più forte, permeato di salino. Profumo di mare intatto, come i pesci d’argento che vedo guizzare nelle reti. La traversata è stata tranquilla fino al momento in cui il maltempo e lo scatenarsi della pioggia non ci hanno costretti ad invertire la rotta. Solo a quel punto, forse a parziale compensazione della nostra amarezza per l’interruzione forzata della navigazione, è entrato in funzione il bar della nave, offrendo a tutti bibite e tè. Il comandante ci ha spediti tutti in coperta, sinceramente preoccupato di non farci prendere acqua. Ha smesso di piovere quando siamo ritornati a terra, ma ormai il fascino dei fiordi di Halong se n’era andato. Due giorni dopo, imbarco da Hanoi per Danang. Gli aerei, in Vietnam, partono tutti ad orari fissi: le sei del mattino. Che significa alzarsi almeno alle tre. Al check-in osservo un tizio: sale su una scala reggendo fra le mani un grande cartello. Non senza sforzo, lo appende al muro, come se fosse un quadro. Lo posiziona con una certa precisione e mentre scende dalla scala, leggo DANANG, la destinazione del nostro volo. Dove manca l’elettronica, in Vietnam, arriva sempre la mano dell’uomo. L’imbarco avviene secondo un rituale che fa riflettere sul concetto di egualitarismo e democrazia dei governanti di Hanoi. Prima vengono chiamati tutti i passeggeri con il boarding pass giallo, che é quello rilasciato ai russi; poi s’imbarcano i possessori della carta rossa, che viene data, ovviamente, ai dirigenti comunisti locali; quindi è la volta dei tagliandi blu che sono riservati ai signor nessuno; e infine i verdi, per gli stranieri. 44 Una volta a bordo anche l’aereo - che riassume nella sua patetica e disgraziata condizione la povertà del Vietnam - è diviso in quattro sezioni separate da porte che vengono tenute ben chiuse: ognuna delle caste deve stare nel suo scomparto. Bravi i piloti vietnamiti, vorrei proprio dirlo. Un po' troppo spericolati, a dire il vero (si sa, anni e anni di guerre hanno lasciato il segno). 45 2 Sul 17° parallelo. A Danang e a Hué “Dimenticherai fatiche e sofferenze Davanti a queste montagne e colline Che chiudono le verdi risaie Dove il fiume si distende, spada piantata in pieno cielo Dove le barche scivolano e ascoltano il canto dei pescatori Qui é Hué Ti addormenterai sotto le carezze del vento Su di un cuscino di nuvole” (Antico canto vietnamita) 46 Il “bordello” dei marines Un’ora di volo, e la malinconica tranquillità di Hanoi è già dimenticata. Siamo sbarcati a Danang (la francese Tourane) ventiquattro anni dopo i marines, che qui erano venuti con ben altre intenzioni. Erano uomini decisi, con le divise in ordine e i bazooka impugnati come racchette da tennis: erano le prime truppe inviate dal Pentagono. Ben presto, gli americani a Danang diventeranno dodicimila. Alla fine del 1967, più di mezzo milione di soldati americani si troveranno sul suolo vietnamita: la cosiddetta “escalation” aveva raggiunto il punto più alto. Ad accoglierli, sulla spiaggia bianca, c’erano bellissime ragazze del luogo con corone di fiori e grandi cartelli: WELCOME, MARINES. “E’ stato un bel giorno - ci dice una donna di una cinquantina di anni che afferma di essere stata testimone di quello sbarco - Dicevano che venivano a proteggerci dagli attacchi dei comunisti del Nord. Erano buoni e gentili, giocavano con i bambini, e tutti qui eravamo contenti.” Nessuno, o pochi, immaginavano che cominciava proprio quel giorno, sulla splendida costa, la sconfitta americana in Vietnam. Ancora oggi la grande base di Danang, soprannominata un tempo “bordello dei marines”, conserva un aspetto imponente e desolato. Da questo aeroporto, al momento della ritirata del 1975, decollò un Boeing 727 americano sul quale erano riusciti a stiparsi trecentotrenta soldati sud-vietnamiti, il doppio dei passeggeri abituali. Tutto intorno all’aeroporto, una fascia di tre chilometri di terreno brullo colpisce la nostra attenzione: è quella che un tempo veniva chiamata “zona di tiro libero”, dove si sparava, senza chiedere l’autorizzazione, su qualsiasi cosa si muovesse. Abbiamo percorso chilometri di strada per arrivare nel centro di Danang superando capannoni e magazzini chiusi, che sembravano disfarsi lentamente assieme alle merci. 47 Ogni tanto, tra palme stentate e giardini arsi, compariva una figura in divisa. All’ingresso della città, c’è un distributore della Esso completamente inservibile. Manca tutto, ma è rimasta l’insegna. L’edificio è recintato di filo spinato. Filo spinato anche sul muro di una scuola. Sembra che qui esista un culto morboso per conservare i segni della guerra, anche quelli che potrebbero essere facilmente cancellati. Danang mi è sembrata la periferia degradata di una qualsiasi metropoli europea. Un deposito immenso di materiale arrugginito, che i vietnamiti, con la loro geniale inventiva, prima o poi troveranno sicuramente il modo di riciclare. Nessuna città vietnamita, neppure Saigon, è stata deformata, gonfiata, drogata dalla guerra quanto Danang, passata da 30.000 abitanti dei tempi della colonizzazione francese a 2 milioni nel 1973. Dagli ultimi rapporti ufficiali americani durante la guerra: “I quattro quinti della superficie urbana di Danang sono occupati da installazioni governative, molto spesso militari. La popolazione civile è quindi ammassata in spazi angusti e poco salubri, in ragione di più di otto persone di media per alloggio. Nove abitazioni su dieci non beneficiano della raccolta delle immondizie. Per fortuna, i vietnamiti non ne producono molte. La città sta per soffocare sotto il proprio peso, e non potrà sopravvivere se continuerà ad estendersi.” Il consiglio è stato rigorosamente seguito e, finita la guerra, Danang si è data un assetto più modesto, da cittadina di provincia, piuttosto “laida e triste”, secondo il compilatore di una guida turistica francese del 1986, con poco più di trecentomila abitanti Pranziamo nel ristorante dell’hotel “Phuong Dong”, dove alcuni commensali italiani, nostalgici del Chianti e del Grignolino, hanno scovato del vino bulgaro, che qui pare essere molto ricercato e apprezzato. Un gruppo di cinque hippies tedeschi staziona davanti all’albergo. Posteggiato un poco più in là, un pulmino Toyota di color beige, che i cinque devono avere noleggiato. 48 Una biondina sciatta e trascurata legge un romanzo di Hermann Hesse. Nella hall, nascosti da un enorme sofà e da un ancora più grande ventilatore, quattro giapponesi giocano a dama, alternando grasse risate a corpose bevute di birra cinese “Wanlipijiu”. Che fare a Danang? Dissetarsi con un succo di papaia in qualche locale oppure trastullarsi sulla piazza del teatro, magari assistendo alle evoluzioni pallonare di una decina di emuli di Maradona, la cui foto con la maglia del Napoli campeggia sui poster di un paio di bar? O magari intrattenersi con uno smilzo cinese, da molto tempo residente in Vietnam, il quale, quando trova un turista che gli da ascolto, parte in quarta con un discorso già preparato a tavolino e che suona pressappoco così: “Il Vietnam ha bisogno di denaro e di aiuti, di molti aiuti per non rimanere strozzato dalla crisi economica. Aiutate il Vietnam, europei ricchi. Voi potete.” E’ sempre così, il cinese smilzo. Chi tenta di ascoltarlo, dopo qualche minuto non ne può più della sua parlata mezza francese e mezza cinese, e lo liquida regalandogli un pacchetto di sigarette oppure offrendogli una birra. Ma quello che dice è pura, purissima verità. Al posto dei locali al neon dove i marines trovavano svago, ci sono negozi di abbigliamento, sartorie che esibiscono vestiti in vendita a prezzi proibitivi - due o tre salari di un funzionario medio - piccoli caffè con musiche occidentali, qualche dancing all’aperto. Quella sera ho notato una insolita animazione dentro una piccola casa: una decina di persone, gli occhi fissi come ipnotizzati, uno addosso all’altro, assistevano ad una “telenovela” da un unico televisore sistemato sopra un mobiletto che mi è parso fragile. Proprio come in Italia, trentacinque anni fa, ai tempi di “Lascia o raddoppia”, quando attorno ad un solo televisore, in casa di qualcuno o in un locale pubblico, si radunavano molti spettatori che non possedevano ancora l’apparecchio. 49 Mi ha spiegato Sung - il cui zio, fratello di sua madre, lavora al Centro di produzione televisiva vietnamita, “Dai truyen hinh Viet nam”, una specie di RAI - che la tivù, in molte zone del Vietnam, è ancora vista come un oggetto magico che attira gli sguardi e la curiosità di tutti. Il direttore generale della tivù di Stato gestisce un budget annuale di poco meno di due miliardi, pressappoco lo stesso di una piccola emittente locale italiana, compresa la pubblicità. Fare una televisione decente con così pochi fondi non è possibile. E allora, anche in questo settore, ci si arrangia. In attesa che il satellite sovietico venga utilizzato per la trasmissione in tutto il Paese, i tecnici della sala registrazione della Rai vietnamita a Hanoi doppiano la sera tardi le trasmissioni della giornata; a mezzanotte un fattorino corre alla posta e spedisce venti videocassette ai centri tv di tutto il Paese. A Saigon e a Danang arrivano il giorno dopo, visto che sono le uniche due città con l’aeroporto, negli altri centri più tardi. E’ un sistema complicato perché ciascuna provincia si è dovuta comprare un trasmettitore e ha dovuto attrezzare degli studi per poter trasmettere programmi non stantii. C’è una storiella che circola a questo proposito. Un tizio proprio di Danang va in vacanza a Hanoi. Passa le sue serate davanti al televisore. Torna nella sua città e, cinque giorni dopo essere ritornato a casa, vede il telegiornale con gli stessi servizi e le stesse notizie che aveva visto tre settimane prima nella Capitale. Dall’Unione Sovietica arrivano i telegiornali registrati che i vietnamiti traducono e rimandano in onda con i sottotitoli. Dalle ambasciate italiane, francese, inglese, tedesca e da quelle dei paesi socialisti arrivano videocassette con le registrazioni di avvenimenti di vario genere: incontri di calcio, concorsi di bellezza, documentari. Così si costruisce un palinsesto che non sarà il massimo dell’originalità, ma permette a tanti vietnamiti di conoscere un po' di mondo. 50 Storia dei misteriosissimi Cham Se il Vietnam fosse il Far West, i Cham sarebbero i suoi indiani, ha scritto qualcuno. Misteriosa popolazione, che annoverava pirati, mercanti, medici e artisti sofisticati in continuo contatto culturale e commerciale con India, Giava e Sumatra (stanziata nell’antico regno di Champa originariamente a nord di Huè e poi sempre più a sud a partire almeno dal IV secolo d.C.), i Cham furono gradualmente sterminati, con una innumerevole serie di battaglie, dalla pressione dei loro terribili vicini: i Khmer a ovest e i Viet a nord. Prima che cadesse la loro capitale Vijaia (l’odierna An-Nhon) nel 1471 segnando il crollo definitivo del regno Champa, che nel 1822 sarebbe stato annesso alla monarchia vietnamita, i Cham, catturati e trasferiti come schiavi alle corti vietnamite, riuscirono a trasmettere agli invasori le loro cognizioni di architettura, scultura, musica, medicina. Di loro non resta più molto: il museo a Danang, una comunità di qualche decina di migliaia di persone che vive dispersa sulle montagne e i santuari di My Son e Dong Chuong. Il professor Tran Ky Phuong è il conservatore del museo Cham - e autore di una infinità di pubblicazioni, dispense e articoli sui Cham. E’ di sangue Cham per parte di madre. Lo raggiungiamo un pomeriggio nel suo ufficio, una baracca buia e spoglia: lui è là, un tutt’uno con volumi, quaderni e carte geografiche. Il professore è un intellettuale minuscolo, raffinato e dai modi squisiti, buon conversatore in inglese, sulla quarantina. Ci spiega che da ormai quindici anni studia i Cham e dice di aver trascorso sui monti di My Son mesi interi, nella stagione del sole e in quella delle piogge, per studiare, fotografare, catalogare quei grandiosi templi. Chiunque transiti per Danang non può pensare di andarsene senza aver prima conosciuto questo professore e visitato il suo 51 museo (una costruzione senza pareti, tutta vetrate e colonnati), ricco di trecento statue, frontoni e altari provenienti da My Son e da altre zone del regno Champa. Nel nostro programma di viaggio era già stabilita un’escursione sull’altopiano di My Son, culla della civiltà Cham, ma qualcuno della nostra comitiva non se l’è sentita di affrontare i molti disagi previsti dallo spostamento (e pure la presenza di cobra, paventata da qualcuno, e di mine nei dintorni del sito archeologico di My Son avevano influito non poco sulla scelta di starsene ancora per un giorno a crogiolarsi al sole sulla splendida sabbia di Danang). Così siamo partiti in quattro. Sessanta chilometri di strada asfaltata, altrettanti di terra battuta, tra scossoni e i continui sballottamenti del pulmino che sprofondava in enormi buche del terreno. Abbiamo costeggiato larghi filari di banani, superato villaggi lindi, grandi aie di cooperative, goduto della quiete che addolcisce la vita di questi luoghi lontani e sperduti. La strada si arrestava a un villaggio, oltre il quale avremmo dovuto procedere su una jeep e poi a piedi. Infine, dopo un trekking di cinque chilometri sotto un sole impietoso, superando spuntoni di rocce e petraie, lungo un sentiero diretto a sud verso il Monte del Dente di Gatto, così chiamato per la sua forma che ricorda appunto il dente di un gatto, siamo giunti a My Son. Il professor Tran Ky Phuong ha portato con sé la sua ultima creatura: un libretto di un centinaio di pagine, scritto in vietnamita e in inglese, che illustra il sito di My Son, con il corredo di fotografie ed eleganti disegni che riproducono i tesori di questa Angkor Vat vietnamita. Ogni tanto lo sfoglia, quasi cercasse un’ispirazione, l’attacco per un discorso. Lo spettacolo di My Son è di quelli che mozzano il fiato: davanti a noi si ergono le torri-tempio dei Cham, costruite tra il IV e il XIII secolo, testimoni di una splendida, millenaria civiltà artistica, la più longeva del sud-est asiatico (la civiltà di Angkor Vat visse soltanto tre secoli). Alcune sono ancora miracolosamente in piedi, altre in rovina; di altre ancora spunta solo il perimetro emergente dalla vegetazione. E poi sacrari, tesori, piramidi 52 a sezione rettangolare, torri di mattoni tenuti insieme da un misterioso collante, mura spesse, decorazioni in arenaria intorno ai portali e sulle steli, sculture di stile indiano, contorte danzatrici, leoni, elefanti, immagini di Siva. In un pronao, c’era un grosso, abnorme fallo, tozzo come un pentolone, adagiato nell’incavo di una piattaforma quadrata, anch’essa simbolo inverosimile. Un sacerdote versava acqua lustrale da un solco della piattaforma; i fedeli la sorbivano augurandosi un futuro di fertilità e longevità. Il professore ha poi voluto sottoporre una nostra amica, Laura, alla lettura del volto, un’antichissima tradizione dei Cham. Si tratta di risalire alla sua storia personale e quindi alla formulazione del suo futuro. Abbiamo seguito il rito magico attraverso la porta del tempietto rimasta socchiusa, raccolti entro una piccola macchia d’ombra. Gesti misteriosi sul viso della ragazza, ondeggiare delle teste, movimenti delle braccia. Tornata fra noi, l’abbiamo vista visibilmente scossa, ma anche commossa e piacevolmente stupita: quale avvenire le avrà mai presagito l’esile professor Tran Ky Phuong? Laura non ha mai voluto rivelarcelo. La furia dei B-52 si è abbattuta anche su questi luoghi così carichi di antiche suggestioni. La grande foresta tropicale di My Son é stata aggredita chimicamente dagli americani: in parte carbonizzata con il napalm, in parte avvelenata a morte, isterilita con gli erbicidi. Si calcola che, nella zona, gli americani abbiano sganciato oltre un milione di bombe. Nelle grotte buddiste Gli americani chiamavano “montagna di marmo” questo luogo di pellegrinaggio buddista, non lontano da Danang, ma per i vietnamiti è rimasta la “montagna dei cinque 53 colori”, cioè dei cinque elementi costitutivi dell’universo: il fuoco, il legno, l’acqua, la terra e il metallo. Vi si arriva dopo aver percorso una marea di scalini scolpiti nella pietra e dopo aver evitato la moltitudine di commercianti che agitano davanti ai nostri occhi bastoncini d’incenso, oggetti in marmo e piccoli Budda in legno. Questa è una montagna impervia, selvaggia, ricca di anfratti nascosti che servirono come nascondiglio per i vietcong che contendevano agli americani la piazzaforte di Danang: proprio qui furono scritti col sangue alcuni dei capitoli più feroci della guerra. Guidati da un anziano monaco buddista, siamo entrati in fila indiana in una piccola fenditura poco più alta e più larga di un uomo. Abbiamo poi seguito per un buon tratto un cunicolo. Ci siamo calati con cautela per una trentina di gradini scavati nella roccia, finché il cunicolo è sboccato in un’ampia caverna, detta Monte dell’Acqua: ci sentiamo esseri minuscoli e inutili sprofondati nella grande pancia buia. Sulla volta c’è un cratere aperto da una bomba americana, attraverso cui filtra una luce velata che rischiara l’interno. Una ventina di gradini più in basso, sorgono tre piccole pagode, attraverso i cui pilastri s’intravedono altre statue, bassorilievi e altari. Dalla cima la vista è stupenda: si domina l’intera baia con la grande spiaggia bianca. Spezzoni di roccia escono come iceberg dalla baia color smeraldo. E’ difficile resistere alla tentazione di un tuffo in quello splendido mare. Sung l’ha capito e nel primo pomeriggio ci ha condotti sulla spiaggia dalla finissima sabbia bianca. Il litorale è deserto e riesce difficile immaginare l’animazione di ventiquattro anni prima. Accanto a noi, tre ragazzi coreani sono distesi al sole e ogni cinque minuti tirano giù una sorsata gigantesca da una bottiglia di Bourbon. Stentano a scrollarsi di dosso le invadenti, piccole venditrici di oggetti-ricordo. Il mare è pulito e l’acqua calda. Le onde, impetuose. Sung è rimasto sul pulmino a finire di leggere un romanzo di Cronin. Al fresco, sotto la pineta, a due passi dal bar. 54 Sul Colle delle Nuvole Alle due di un pomeriggio, ad un’ora che invita più ad una siesta in riva al mare che non ad uno spostamento, ci mettiamo in viaggio verso Hué. Sono 110 i chilometri che dividono Hué da Danang. Percorriamo la strada nazionale numero 1, che durante la dominazione francese si chiamava strada coloniale numero 1, costruita sulle tracce della strada dei mandarini, che in origine era poco più che una pista. Poco fuori Danang, un cimitero militare segue la strada per un paio di chilometri: disteso, grossa macchia lunare su un terreno bianco argenteo di salina. Poi, di tornante in tornante, attraverso una macchia mediterranea verde e bruna, la strada prende a salire per le alture che segnano la divisione geografica fra Nord e Sud Vietnam, il 17° parallelo, sorta di cortina di ferro orientale, fino al Colle delle Nuvole, enfasi mandarina per un passo di montagna a strapiombo sul Mar della Cina. Sempre incappucciato di nubi dai colori cangianti, esso merita pienamente il suo nome in ogni ora del giorno e spicca, la notte, per i candori che la più piccola falce di luna è sufficiente a far brillare. Sostiamo una decina di minuti nell’unico posto di ristoro aperto. Proprio di fronte a questa baracca, c’è un vecchio forte coloniale francese, abbandonato e circondato da reticolati. Gli autisti di camion sgangherati, i cofani aperti come grandi bocche, versano acqua nei radiatori fumanti, che non smettono di dissetarsi. Chi può si riposa appoggiando la testa sul volante. Una corriera scarica un gruppo di giovanissimi vocianti, che sembrano studenti in gita. Ben presto, la catena annamitica (l’Annam è la regione di centro) penetra nel mare con speroni rocciosi che circondano piccole pianure. Entriamo nella provincia di Binh Tri 55 Tien, la zona in cui il Paese, dall’incredibile forma di un cavalluccio marino, si assottiglia fino a una larghezza di cinquanta chilometri. Talvolta la strada sale o scende per pendii gonfi d’alberi bassi e di pascoli coperti di fiori, alle volte corre in pianura. Infine costeggia il mare, spiagge bellissime costellate di capanne di pescatori piantate sotto boschetti di alberi di cocco, ed entra a Huè, la vecchia capitale imperiale, città di poeti e musicisti. Le ragazze di Hué Per le strade di Huè camminano contadini con i lunghi abiti tradizionali, gli stessi che si vedono nelle foto ingiallite del tempo in cui l’imperatrice usciva dal palazzo su una portantina. Vedo pedalare le ragazze di Huè, le ragazze più belle di tutto il Vietnam. Le vedo pedalare senza fretta, scortate da una lunga chioma scura che si srotola dietro a loro, spesso fino al sedere, si solleva e svolazza quasi con gli stessi fremiti del lembo della loro tunica bianca che ondeggia al di sopra del portabagagli. Non mi è bastata questa prima immagine delle ragazze più belle del Vietnam. Le ho attese fuori dell’albergo “Huong Giang” (uno dei due della città), dove avremmo passato la notte, sulle mitissime sponde del Fiume dei Profumi, che deve il nome ai petali di fiori particolarmente profumati che l’acqua trascina con sé lungo il suo corso. Le ho osservate mentre camminavano, e ho avuto l’impressione che non toccassero il suolo, ma che appoggiassero i piedi su un cuscino di nuvole. Mentre le guardavo, abbassavano gli occhi, per timidezza o per una sorta di civetteria tipicamente femminile. Ragazze di quattordici, quindici anni portavano gonne larghe, bianche o grigie, sapientemente pieghettate, a nascondere il ginocchio. Sembravano figure fuori dal tempo, immagini dolci di un mondo che era e che non tornerà più. 56 Huè è l’unica città d’arte del Vietnam, una parentesi poetica tra il nord austero e spesso fanatico e il sud inquinato dagli usi occidentali. Era poco più di un villaggio, immerso nella quiete dolcissima e un po' sonnolenta delle verdi acque del suo fiume, quando una dinastia di signorotti, i Nguyen, rovesciò nel 1802 la dinastia imperiale dei Le, che risiedeva a Hanoi, e trasferì a Huè la capitale del Regno. Tutta la poesia del Vietnam è racchiusa qui, in questa pace beata e fuori dal tempo. Nel corso dei secoli molti poeti hanno magnificato le bellezze di Huè. Come Cao Ba Quat, vissuto tra il 1809 e il 1853, che ha composto “Attraversando una mattina il Fiume dei Profumi”: “Montagne e colline chiudono le verdi risaie Il fiume si distende, spada piantata in pieno cielo Le barche scivolano, e ascoltano i canti dei pescatori Sulla riva, una coppia di uccelli, le zampe ripiegate, dorme La strada impolverata si allunga, senza fine, i miei occhi sono abituati a seguirla La nostalgia del villaggio lontano mi opprime il cuore Sogno di poter frustare il cavallo del ritorno Sul ponte, cavalli e carrozze passano e ripassano Tutto questo mi è estraneo Mi piacerebbe soltanto Addormentarmi sotto le carezze del vento, su un cuscino di nuvole.” Poco prima di cena, avevo interrotto la doccia, magnetizzato dal tramonto scivolato leggero sul Fiume dei Profumi. Sull’acqua, alcuni pescatori in sampan accarezzavano mollemente il remo e avanzavano, sullo sfondo del tramonto, uno di quei tramonti belli fino allo stucchevole come se ne vedono in Oriente, una specie di immenso bagliore che dal rosso stinge al violetto. Altri pescatori erano accovacciati dentro cesti rotondi di giunco, con in testa il cappello a cono: pescavano allineati. Il sole pieno vagava un poco all’orizzonte sopra il mare. Poi è calato, fino a scomparire. 57 Mai, la guida di Huè, una splendida madre di quarantadue anni, indossa un bellissimo ao dai (la casacca lunga fino al ginocchio con il colletto alla coreana e due spacchi che partono dai fianchi) verde chiaro, pantaloni bianchi e, in testa, il copricapo a cono. Un nastro rosa le infiocchetta il volto. Ha gli occhi profondi come il silenzio e un sorriso che pare dipinto. Sono da poco trascorse le otto del mattino, ma l’aria qui intorno è già molle e untuosa. Il Vietnam raffinato, pigro, amoroso, quello dei poeti e delle concubine, sopravvive non solo a Huè ma anche nei suoi più immediati dintorni, in quella pianura ondulata attraversata da un meandro del Fiume dei Profumi, che accoglie le tombe degli imperatori Nguyen, edifici tondeggianti di un grigio perfetto, arroccati su poggi erbosi, e il palazzo imperiale, la cittadella proibita e la Pagoda della Dama Celeste. “Tomba” in Vietnam è una parola ingannevole. Prendiamo la tomba di Tu Duc, ad esempio, l’imperatore che, per avere massacrato dei missionari francesi, fu costretto, pur restando imperatore, a sottomettersi al protettorato della potenza coloniale: un’umiliazione peggiore di qualsiasi punizione fisica. E’ vero che la tomba di Tu Duc è un palazzo funerario, ma è così superbo che costituirebbe una bellissima abitazione anche per un vivo. E’ formato da una processione di edifici separati da superfici d’acqua, da spazi di pietra, da gradini, da giardini, in un’alternanza di ombre fitte e di luci. La struttura architettonica e molti elementi decorativi richiamano i templi cinesi. Il clima tropicale ha purtroppo corroso legno e ceramiche e stinto i colori. E anche qui, ovunque è passata la mano dei ladri. Ha scritto Pham Quynh, uno dei più famosi scrittori vietnamiti ed ex Ministro della pubblica istruzione: “Questa tomba fonde in sé tutti i colori del firmamento e le sfumature dell’acqua: riassume le alte montagne, le fitte foreste e il vento che soffia fra le foglie. Questa tomba è il lavoro paziente ed ispirato di un artista desideroso di colorare la campagna per svegliare 58 l’anima in attesa, librandosi nel silenzio di questo triste luogo o sussurrando sulla cima di un pino solitario”. Qui non si ha voglia di camminare in fretta. Scendiamo i piani della tomba di Tu Duc lasciandoci quasi vincere dal sonno pesante di questi stagni dove muoiono i fiori di loto. I letterati di Huè amavano andare a zonzo per queste colline dove vegetano gli steli, oppure di notte in sampan sul fiume, a cercare ispirazione per creare poesie che le loro donne avrebbero poi recitato. Il passo di Mai è leggero e cadenzato. Ora, senza neppure essercene accorti, siamo come sospesi nel tempo di fronte al Palazzo della Pace Profonda, la residenza imperiale. Qui abitò l’ultimo re del Vietnam, Bao Dai, il “principe playboy”, e la sequenza di pagode e colonne non può non farci pensare all’”Ultimo Imperatore” di Bernardo Bertolucci. Da qui, nel 1945, Bao Dai si affacciò per annunciare al mondo la sua abdicazione. Il Vietnam entrava, con qualche anno di ritardo, nel ventesimo secolo. La cittadella di Bao Dai doveva essere simile alla Città Proibita di Pechino, con mura lunghe dieci chilometri a rinchiudere palazzi e templi. Ma, a differenza della corte pechinese, fu costruita in una trentina d’anni: troppo pochi per curare tutti i dettagli. Cosicché, oggi a due secoli di distanza, la cittadella è decrepita, oltre che danneggiata dalle battaglie contro i francesi e da quattro settimane di feroci combattimenti che si scatenarono su Huè dalla fine di gennaio del 1968, durante l’offensiva del Tet (il capodanno lunare vietnamita). “Huè se ne va - scriveva Oriana Fallaci in una delle sue tante, memorabili corrispondenze di guerra - sbriciolata in calcinacci.” Sotto le bombe dell’aviazione americana, che spianò i quartieri popolari della città, le donne di Huè elevarono il loro canto al cielo: “Se andate al Nord Dite allo zio Ho Che il cuore di Huè è rimasto intatto.” 59 Di intatto qui è rimasta anche la spettacolare tomba di Khai Dinh, un monumentale sacrario di pietra grigia con uno schieramento di guerrieri in marmo sulle scalinate. Sullo sfondo, una gigantesca statua di Budda, forse la più alta del Vietnam, sovrasta il paesaggio sottostante. Il sole è molto caldo. Come calda è la mano che mi passa sul braccio una vecchia donna con la pelle del viso che pare squamarsi, strato dopo strato, come pagine di un antichissimo libro. Porta una casacca viola, che l’avvolge come un sacco. E’ scalza, tutta piegata su se stessa. Il bastone su cui si appoggia mi pare un supporto molto ma molto precario. Mormora qualcosa a me incomprensibile, mentre, con un braccio, indica la torre ortogonale della Pagoda Tien Mu, altrimenti detta Pagoda della Dama Celeste, che sorge proprio sulla riva del fiume. Sopraggiunge Mai anticipando quello che avrebbe dovuto dirci di lì a poco. Dice che la pagoda fu costruita nel 1601 ove sorgeva un tempo un antico tempio Cham e la cui creazione, secondo le leggende del luogo, sarebbe stata predetta da una signora, apparsa agli abitanti di Hué, vestita di una tunica rossa e di un paio di pantaloni verdi. Ecco ciò che forse aveva voluto dirmi la donna scalza e antica. Dietro la pagoda sta il convento buddista. Nei portici che circondano il cortile riposa un grande Budda di bronzo che ride. Monaci frettolosi passano accanto a noi. Huè è il centro del buddismo vietnamita e soprattutto lo è stato negli anni ‘60, quando i monaci si opposero al violento tentativo di cattolicizzare il Paese avviato dai feroci fratelli Diem, dittatori-fantocci di Washington. Simbolo della protesta dei monaci di Huè è la Austin azzurra degli anni ‘30 conservata in una rimessa retrostante la pagoda - a bordo della quale il monaco Thich Quang Duc l’11 giugno del 1963 si era fatto trasportare a Saigon e qui si era cosparso di 60 fuoco, per protestare contro l’eccidio di una folla di buddisti da parte della polizia di Diem. Sulla lucidissima limousine è posta la foto dell’autoimmolazione che ha riempito le copertine dei giornali di tutto il mondo. Un gesto costato alla dittatura sud-vietnamita più di una battaglia perduta. 61 3 Il Sud. A Saigon, la città del peccato “Spesso mi prende un desiderio struggente di tornare a Saigon, la Saigon del mio primo viaggio. E sogno quelle palme verdi, quelle strade affollate di cappelli a cono, quei camion militari, quei risciò, quel caldo pesante che ti addormenta come un misterioso languore e in una ritrovata saggezza. Nella mia esistenza, Saigon è affondata come un coltello”. (Oriana Fallaci, “Niente e così sia”) 62 Yankee, whisky & droga Le note di “Guantanamera” in vietnamita ci giungono nette, vibranti, da una radio appoggiata sul bancone di un negozio del duty-free dell’aeroporto saigonese di Than Son Nhut. Immagini di un passato neppure troppo lontano si affollano nella mia mente non appena vedo i ricoveri degli aerei e i fabbricati bassi di quest’aeroporto che fu base americana Saigon ci accoglie così, alle sei di un mattino livido, dopo un volo di 700 chilometri da Danang. Lo so che dovrei chiamarla Ho Chi Minh Ville, il nome con il quale la città é stata ribattezzata dai comunisti vincitori. Saigon non è un nome infamante, è solo il nome del fiume che attraversa la città. Ma per molti, in Vietnam come all’estero, Saigon significa dissolutezza, corruzione, vizio, disperazione. Tuttavia a me pare che il cambiamento del nome sia un esorcismo per separare la città dal suo passato (un po' com’è successo nella nuova Russia di Eltsin, che ha ribattezzato Leningrado con il nome di San Pietroburgo: qualcuno riesce a chiamarla con il nuovo nome?). Per cui continuerò a chiamarla Saigon.. Ci prende un consegna una nuova guida, Nguyen Canh Hoà. E’ un ragazzotto dagli occhi infossati, di bassa statura, capelli tagliati a spazzola, nerissimi. Ha trentacinque anni, per dieci anni ha insegnato la lingua inglese, veste con gusto (camicie stirate, pantaloni di gabardine, scarpe di cuoio rossiccio) e non abbandona mai una borsetta da fotografo “Canon”, nella quale conserva non so che. Ogni tanto, Hoà si spazzola le scarpe ed esibisce qualche timida, imprecisa parola in italiano. E’ un vietnamita ricco, e non lo nasconde. 63 Mentre il pulmino che ci ha raccolti si fa largo nelle vie dell’ex città coloniale, quasi fendendo i banchi di afa, Saigon torna ad essere ai miei occhi la città decadente, tragica, irresistibile, viva, seducente, corrotta e corruttrice per visitare la quale qualsiasi giornalista avrebbe dato, all’epoca, dieci anni della sua vita. Saigon dista da Hanoi millesettecento chilometri: una distanza sufficiente per sbarcare in un altro pianeta. Perché il Sud del Vietnam è un altro pianeta, separato al Nord da trent’anni di guerre, di diversi regimi politici, ed è composto da etnie differenti. A Hanoi si parlava del Sud con un misto di paura e di disagio. C’era come il timore di essere contaminati da un mondo che emana ancora un fascino, anche se sinistro. I rigorosi funzionari del nord non vanno volentieri nella Babilonia del Sud. C’è ancora troppo odore di imperialismo: realmente e metaforicamente. Al Sud sopravvive un mondo che non ha, nel bene come nel male, nessuna voglia di scomparire. Saigon, nei ruggenti anni Sessanta, viveva tutta intorno alla rue Catinat, il viale degli antichi splendori coloniali, per metà bordello - tutta bar senza sonno e taverne odorose di sesso e spinelli - e per metà Via della Quiete, dove potevi scegliere se spendere mezz’ora in una bottega antiquaria o in una libreria internazionale. E lì, nel mezzo, a segnare la linea di demarcazione tra le due anime del vecchio boulevard, la candida mole dell’hotel Continental, il castello dei destini incrociati, dove capitava di incontrare un pittoresco campionario di umanità: l’inviato di guerra e la puttana, lo spacciatore di droga e l’avventuriero. Sulla veneranda terrazza di questo glorioso carrozzone munito di condizionatori d’aria che sferragliavano come elicotteri, Oriana Fallaci scrisse pagine di “Niente e così sia” e Graham Greene vi aveva ambientato, qualche anno prima, alcune pagine di un romanzo divenuto celebre, “Un americano tranquillo”. 64 A cento metri dal Continental, maestoso come una transatlantico, si ergeva il Rex, che ospitava la sala stampa e il circolo ufficiali dell’esercito americano. Lassù, nella grande terrazza del quinto piano, tra verdi pergolati e gabbie di bambù a forma di pagoda, i GI (i soldati USA) consumavano le umide notti tropicali in compagnia di delicate bellezze orientali. Agganciare una ragazza era uno scherzo: bastava scendere nella hall e schioccare le dita. Loro erano lì, abbordabili, in t-shirt e jeans attillati, pronte a scambiare qualche ora d’amore per un pugno di dollari. Saigon era a quell’epoca una città in vendita, ossessionata dall’avidità, inconsapevole della catastrofe imminente. Una città che bruciava un miliardo di dollari l’anno. Un emporio dove trovavi di tutto, la ricchezza sfacciata e i mendicanti, i mutilati e gli orfani, il whisky e la droga, la vita e la morte. Il mercato nero era una piovra onnivora che trangugiava ogni sorta di generi, dai preservativi ai fucili. Negli anni “americani”, più di un milione di persone erano affette da malattie veneree; impazzavano la tubercolosi, il colera, le epatiti e il tifo, i drogati erano stimati sul mezzo milione. Per le strade di Saigon circolavano non soltanto veicoli militari di ogni specie, ma anche Chevrolet, Chrysler, Mercedes, Volkswagen, Triumph e dappertutto giravano uomini bianchi in camicie sportive e pantaloni di tessuto ingualcibile. Nei mercati indigeni, di merce vietnamita c’era ben poco, forse i fiori, qualcosa da mangiare e i fuochi d’artificio. Venditori ambulanti e bambini offrivano sigarette americane e bottiglie di Johnnie Walker e Black & White. Grandi avvisi fuori dai saloni di vendita proponevano fuoriserie americane: “CONSEGNA QUI O NEGLI STATI UNITI - FACILITAZIONI DI PAGAMENTO”. Poi, è venuta la “Grande Rieducazione Socialista”. La nuova parola d’ordine per Saigon era: rigenerazione. Il regime di Hanoi scelse una linea morbida, quella di evitare lo scontro, provvedere ai bisogni più immediati, curare 65 le ferite più profonde. Ma in quali condizioni! Una strada che richiede anni e anni a uno Stato robusto diventa impraticabile per un organismo malato. Peccato che, nel loro fideismo rivoluzionario, i comunisti abbiano commesso l’errore di smantellare tutto, il lecito e l’illecito, il vizio come la virtù. Al punto che oggi Saigon dà l’impressione di una città improvvisata, senza identità, che vive di espedienti e dove la caccia al dollaro rimane lo sport preferito e il dong carta straccia. Ma se non ci si ferma alla superficie, se si ha voglia di lasciarsi risucchiare nel vortice della città, dopo poche ore ci si accorge che, malgrado lo sventolio delle bandiere rosse, qualche traccia della “swinging Saigon” è rimasta qua e là. Agli incroci senza semafori, il traffico delle bici e delle motociclette forma un groviglio assordante e inestricabile come negli anni americani, assicurano i bene informati. Dalle finestre del centrale hotel “Què Huong”, dove siamo alloggiati, a due isolati dal consolato francese, si vede spuntare perfino qualche sgangherata Mercedes. Se poi si dà un’occhiata alle botteghe intorno al “mercato dei ladri”, ci dice il giovane con radi baffetti alla reception, sembra proprio di essere in Occidente. Dal caviale alle videocassette, dal whisky al profumo, dalle macchine fotografiche ai televisori giapponesi, qui c’è tutto il campionario del consumismo di casa nostra. Niente a che vedere con i magazzini tristemente vuoti di Hanoi. Saigon si presenta oggi come il ponte verso l’Occidente. Il governo - o meglio, il malgoverno filo-americano - qualcosa le ha lasciato in eredità: piccoli sussulti imprenditoriali sparsi, dinamismo, un diffuso desiderio di ricominciare. Oggi Saigon più che lavorare, traffica, come quasi tutto il Vietnam, ma ha un modesto bacino industriale localizzato a Bien Hua (metallurgia, cemento, tessili), un piccolo artigianato che dal 1986 ha ripreso a respirare (telai, legno scolpito, lacca), un ceto 66 intellettuale che, dopo essere stato estromesso da qualsiasi responsabilità, e “rieducato” con metodi più o meno spicci, spera di rientrare nel sistema circolatorio del Paese. I voli settimanali che collegano Saigon alla Thailandia (l’Occidente” più prossimo) sono sei, mentre nell’86 ve n’era uno soltanto. L’affaticata capitale del Sud viene tenuta d’occhio dai mercati stranieri (Giappone, Hong Kong, Singapore). Gli ottimisti giurano che, salve brusche inversioni di tendenza, la posizione geografica, il porto e il prevedibile sviluppo faranno di Saigon la Bangkok dell’anno Duemila. Nel frattempo, la gente si arrabatta e spera, riciclando ogni pezzetto di metallo avanzato dalla guerra, come se tutto fosse finito ieri. Quante persone vi abitano nessuno lo sa più, tre milioni, forse quattro: da molti anni non c’è tempo di censirli. E il numero è aumentato, dalla fine della guerra, con il ritorno dei reduci della Resistenza dalle foreste (nessuno li chiama mai vietcong, che suona settario perché significa “viet comunisti”, mentre il movimento anti-americano è stato molto più ampio e generalizzato), l’arrivo di masse di miserabili affluite in città dalle montagne e dal delta del Mekong, e di gruppi di profughi cambogiani scampati ai macelli del sanguinario Pol Pot. Scene di vita quotidiana Nel primo pomeriggio Hoà ci accompagna nella Saigon degli odori e delle curiosità. Il mercato Ben Thanh, con la sua caratteristica torre dell’orologio, è un significativo spaccato di vita quotidiana dell’ex capitale del Vietnam del Sud. Il mercato coperto accoglie centinaia di banchi, separati da un corridoio strettissimo che non permette il passaggio di più di una persona per volta. In certi punti in cui il corridoio si allarga improvvisamente, si rischia di infilare comicamente i piedi in qualche pentolone dove bollono verdure e pesce. Le venditrici sono dispettose nell’invitarci a 67 vedere i loro banchi, perché sanno bene che, girandoci ora a destra, ora a sinistra, rischiamo di perdere l’orientamento. C’è un odore di spezie e pesce essiccato che non dimenticherò tanto facilmente. Nella strada, il mercato si colora magicamente: i colori della frutta e delle verdure esposte sui banchi sono una gioia per gli occhi. I mercanti sono tutti accovacciati o seduti in terra con il loro cesto di frutta o il loro mucchietto di verdure, a pochi centimetri dalle ruote dei veicoli in corsa. Silenziosi sotto il sole, indifferenti sotto il folle scroscio di pioggia tropicale che pare non scomporre né alcune vezzose signorine intente a sistemarsi i cappelli con nastri colorati, e neppure due vecchi scheletrici, che stanno concludendo il loro misero “pho”, la zuppa di pasta, legumi e pollo. Mi sposto di una ventina di metri ed entro in una polverosissima e buia e piccola libreria antiquaria. Il libraio si lascia cadere compiaciuto in fondo al naso le lenti spesse come fondi di bottiglia, mentre intona chi sa quali accordi con la chitarra. La mia visita lo ha colto di sorpresa. Gli chiedo di mostrarmi tutti i libri fotografici sul Vietnam, su Saigon e su Ho Chi Minh. L’uomo si guarda intorno con le mani appoggiate sul bancone. Mi rendo conto di avere sconvolto i suoi piani da come osserva ora me, e i miei abiti, ora gli scaffali che traboccano di volumi. Ma non dovrebbe avere difficoltà ad accontentarmi. Dapprima estrae da uno scaffale alcuni pacchetti di vecchie cartoline illustrate scolorite e accartocciate come se fossero state sempre esposte al sole. Poi, scantona goffamente dietro un vecchio armadio adibito a libreria e comincia ad estrarre, magia delle magie, volumi destinati ad un inevitabile pensionamento. Dalla pila cartacea presto accumulatasi sul tavolo, restano, alla fine del mio lavoro di scelta, tre volumi: un grandioso affresco della vittoriosa rivoluzione, con immagini crude e impressionanti dei bombardamenti su Hué, Danang e Haiphong: una ricostruzione per immagini di 35 anni di vita vietnamita, colto dall’obiettivo nel rituale di gesti e atti 68 quotidiani; infine, l’epopea del Grande Vecchio, lo zio Ho, raccontata in un’opera di grande formato, costituita da quaranta tavole fotografiche che ripercorrono gli anni dal 1920 al 1957. Soddisfatto per il triplice acquisto, rovescio nelle mani tremolanti del libraio il solito pacchetto di dong da 1000 e 5000. La sua felicità è palpabilissima e si manifesta con l’offerta di una sigaretta (marca “Khanh-hoi”, fortissime, mi dirà un amico intenditore) e infine in una stretta di mano decisa, in netto contrasto con la gracilità del fisico. Mentre sto per uscire, il libraio mi blocca sulla porta: “Ha visto Vo An Ninh?”. Non so chi sia, rispondo. “E’ il più famoso fotografo del Vietnam. E’ appena uscito da qui. Guardi qua”, mi dice traendo da un quaderno alcune immagini ingiallite di foreste di bambù e fiori di loro che sembrano scattate migliaia di anni fa. “Sono foto di Vo An Ninh, belle, no?” Una di queste foto ritrae un vecchio con lunghi e bianchi capelli che gli piovono sulle spalle. “E’ lui, quello”, fa col dito il libraio. “E’ Vo An Ninh”. Ogni mattina, appena sorge l’alba, mi racconta il libraio, Vo An Ninh, inforca la sua bicicletta e, malgrado i dolori ad una gamba per un vecchio incidente e gli ottantaquattro anni che porta con gioviale disinvoltura, percorre una ventina di chilometri esplorando palmo a palmo Saigon e i suoi immediati dintorni. Quando un dettaglio lo colpisce, Vo si blocca di colpo e tira fuori dalla sacca la sua vecchia Zeiss Ikon col soffietto. Non mi è stato possibile rintracciarlo, il vecchio Vo An Ninh. Credo di avere perso qualcosa. E’ malato, molto malato in questo periodo, mi ha confessato sottovoce, chissà poi perché, il libraio. E visto che ormai era in vena di confidenze, mi ha detto che prima di morire, Vo vorrebbe visitare Parigi ancora una volta. “Pensi che se Vo fosse vissuto a Parigi per tutta la sua vita, il nostro Paese avrebbe perso un pittore, un grande pittore.” Pittore, ha detto il libraio. Proprio così. 69 Il nostro albergo non ha la storia del Rex o del Continental. E’ un palazzone alto e chiaro, con molti piani e un’esistenza anonima. Davanti alle vetrine della sua modesta boutiques, si attardano tutte le sere alcuni uomini d’affari thailandesi. Non lontano dal bancone della reception, c’è una porta dalla quale di tanto in tanto filtrano luci psichedeliche e spunta qualche minigonna: è la discoteca. Le nostre uscite serali, a Saigon, seguono itinerari prestabiliti che anche i bambini del quartiere imparano presto a conoscere. Infatti, non facciamo in tempo a scendere la scalinata dell’albergo, che queste piccole creature dagli abiti laceri e senza le scarpe ai piedi, ci si buttano incontro ripetendo all’infinito una triste litania: “Give me money, please. Give me money, please”, dammi dei soldi, per piacere. Sia che noi li si accontenti, sia che si faccia finta di nulla, giunto ad un certo punto della strada, il gruppetto di piccoli fa improvvisamente marcia indietro, come se fosse giunto al limite della zona di questua loro assegnata. Ed attaccano altri mendicanti, questa volta uomini storpi, vecchie grosse, e poi i soliti venditori di monete di zinco e rame del periodo indocinese. “Compra, amico - mi dice un vecchio sdentato, mentre tenta di infilarmi sotto il braccio una raccolta di banconote con l’effigie di Ho Chi Minh. E quindi, anch’egli all’improvviso, giunto ad un certo incrocio, si volatilizza nel buio della sera. Raggiungiamo la posta centrale poco prima della chiusura. Accanto al palazzo della posta, ci fermiamo per qualche minuto ad osservare la cattedrale gotica di Notre-Dame, che domina la via Dong Khoi. Costruita più di cento anni fa, la cattedrale di Saigon spicca, oltre che per la sua maestosità, anche per la caratteristica facciata di mattoni rossi. Nel vasto salone della posta, si respira un’atmosfera di altri tempi, alla quale qui a Saigon non eravamo abituati. Il salone è molto grande, elegante. Gli impiegati, nascosti dietro i grandi vetri dei loro sportelli, scrivono a mano su grossi quaderni a righe o a quadretti, come gli scolari di De Amicis. I ventilatori appesi al soffitto hanno lunghe pale e si mettono in moto faticosamente, quasi arrancando, come se avessero bisogno di tempo 70 per raggiungere una velocità utile. Il silenzio che predomina qui ha dell’irreale: parlano più gli occhi vispi e penetranti dello zio Ho, in un gigantesco dipinto all’ingresso del palazzo. La donnina delle pulizie raccoglie gli ultimi granelli di polvere dai banconi, mentre a poco a poco altri sportelli vengono oscurati e gli impiegati, raccolte le loro sacche, se ne tornano a casa. Siamo venuti qui per acquistare francobolli e affrancare, visto che ci siamo, le cartoline da spedire ai nostri amici e parenti. Quest’ultima operazione, apparentemente banale in qualsiasi altro paese del mondo, qui in Vietnam nasconde notevoli insidie. Innanzitutto, i francobolli vietnamiti sono spesso molto grandi e le cartoline molto piccole: cosicché trovare lo spazio per scrivere l’indirizzo del destinatario è una bella impresa. Poi, i francobolli vietnamiti non sono gommati e allora è necessario approfittare dei vasetti di colla di riso già predisposti dagli impiegati e incollare i francobolli. Già, ma senza pennello, come si fa? Semplice, si usa il dito, ma bisogna fare in fretta, perché al primo spiffero d’aria che filtra nel salone, il francobollo diventa un coriandolo che si deve rincorrere. Infine, l’ultima motivazione per la quale è molto difficile far pervenire all’estero una cartolina spedita dal Vietnam, è il costo dell’affrancatura. Non che sia alto, per carità. Soltanto che l’inflazione galoppante rende, ogni giorno che passa, inutilizzabile un certo taglio, cosicché bisogna integrarlo con francobolli di altri tagli con il bel risultato di tappezzare tutta la cartolina di francobolli. Qualche impiegato ci propone, in cambio di una piccola mancia, di occuparsi della questione lasciandogli il pacchetto di cartoline. Confidiamo nella sua pazienza per far felici madri e zie. Le nostre “notti brave” nella “lussuriosa” Saigon vivono la loro ingloriosa fine in uno dei tremila bar che animano le vie del centro. Molti di questi bar non sono visibili dalla 71 strada. Bisogna introdursi sotto grandi pergolati e lì scoprire che le flebili luci che si intravedono appartengono ai locali pubblici. Ci sediamo ad uno di questi tavolini. Nell’attesa che qualcuno venga a raccogliere le ordinazioni, mi diverto con buona dose di sadismo, lo ammetto, ad osservare i camerieri, una folla di lillipuziani frenetici, terrorizzati dalle urla del padrone del bar che li indirizza ora ad un tavolo ora ad un altro. Il padrone sta curvo sul blocchetto delle ordinazioni seduto su una specie di trespolo illuminato dalla luce di una candela: scrive con frenesia, il volto cattivo, teso. Quando apre bocca, urla come un ossesso. Alle sue urla rispondono le urla dei piccoli camerieri: afferrano il conto, lo portano al cliente, riscuotono il denaro, tornano al trespolo, infilano il conto su una punta di ferro, poi corrono al banco, versano altre bibite nei bicchieri e le portano ai tavoli, sempre di corsa, sempre sbagliando, spesso disperandosi per i rimproveri del padrone. Uno di questi buffi camerieri piomba all’improvviso al nostro tavolo. Ha le mani sudate, e mi viene spontaneo raccomandargli di darsi una calmata. Segna su un pezzo di carta le nostre ordinazioni dopo averle ripetute in un linguaggio che mescola inglese, francese e vietnamita: due caffè, una limonata, un gelato alla papaia, un’aranciata. Quindi, lo vediamo sparire nelle tenebre. Frattanto, accanto a noi le coppie di fidanzati tubano con una discrezione che ha del claustrale. Dopo una decina di minuti il cameriere ritorna verso di noi. Ho smarrito il foglietto, dice, potreste ripetere tutto? Riscriviamo tutto. Una nostra amica ne approfitta, in buona fede, per variare la propria ordinazione, non immaginando di peggiorare la situazione. Pronti, il cameriere riparte. L’attesa si fa spasmodica. Infine, quando ormai buona parte delle coppiette si è eclissata per continuare altrove le proprie effusioni, il cameriere ritorna al nostro tavolo, tutto sudato e nella sua incomprensibile lingua, dice più o meno così: Sono spiacente, ma mi dicono che non abbiamo il gelato, né il frullato e neanche bibite, ma solo tè e caffè, che cosa facciamo? 72 29 aprile 1975 Molti di noi hanno un sussulto, mentre il pulmino della Vietnam Tourism si ferma davanti all’ex ambasciata americana. Anche se ora il bianco edificio è diventato la tranquilla sede dell’ente di stato petrolifero, è pur sempre emozionante trovarsi di fronte ad uno dei simboli del crollo yankee in Vietnam. Era il 29 aprile 1975. Mentre i comunisti colpivano l’aeroporto di Than Son Nhut con i loro razzi, gli americani misero in atto il più vasto piano di evacuazione mai eseguito. Nell’arco di diciotto ore, andando avanti e indietro tra Saigon e la portaerei, una flotta di settanta elicotteri della marina prelevarono mille americani e quasi seimila vietnamiti dalla capitale ormai sconvolta. Accompagnata la moglie, ripiegata la bandiera, l’ambasciatore Graham Martin salì sul tetto dell’ambasciata per essere imbarcato su un elicottero. All’alba del 30 aprile, con le sue strade deserte, vuota e spettrale Saigon aspettava i comunisti. Quello stesso mattino, le colonne di vietcong puntarono sulla guarnigione militare governativa, si impadronirono dei quartieri generali della polizia, della stazione radio e di altri centri vitali. Uno squadrone corazzato, sopraggiunto da nord, passò per rue Hong Trap Tu e svoltò a sinistra verso Thong Nhut boulevard per poi giungere di fronte al palazzo presidenziale di Van Thieu (si dice dopo aver comicamente smarrito la direzione giusta ed essersela fatta indicare da una smagrita e sgomenta ragazzina in pigiama, che non aveva mai visto in vita sua un soldato delle Forze di Liberazione). Mentre i carri armati attraversavano l’ampia cancellata d’ingresso ed entravano nel grande parco del palazzo presidenziale, uno dei soldati salì di corsa per le scale ed issò sulla balconata la bandiera rossa e gialla dei vietcong. 73 Toccò al colonnello Bui Tin dettare le condizioni della resa e consegnare alla storia un messaggio di pacificazione: “I nostri uomini stanno soltanto festeggiando. Non dovete temere. Tra i vietnamiti non ci sono né vincitori né vinti. Soltanto gli americani sono stati battuti. Se siete dei patrioti, considerate questo come un momento di gioia. La guerra per la nostra patria è finita.” Dopodiché Bui Tin scese nel parco e passeggiò dietro il palazzo. Si sdraiò sull’erba a guardare il cielo. Il suo cuore finalmente esultava. Il sontuoso palazzo di tre piani, residenza di Van Thieu, presidente della Repubblica del Vietnam del Sud, ultimo governo-fantoccio, è ora davanti a noi, nel suo stile imperial-kitsch di orribile gusto. Non è certo un museo - come dovrebbe essere - ma un palazzo pronto per essere rimesso in uso, come se aspettasse domani un nuovo capo del governo. Scrivanie, tavoli, sedie, gabinetti di studio e di ricevimento, sale di riunione (impreziosite da arazzi, quadri, mosaici, tende di velluto rosso), sale da pranzo, da ballo, le cucine: è tutto ancora in perfetto ordine, pavimenti lustri, senza una macchia, mobili senza polvere. Nel suo sottosuolo c’è un labirinto di tunnel, a prova di attacco atomico. Computer, sofisticati impianti di radio trasmissioni, carte geografiche, telefoni: tutto il necessario per decidere, dirigere e controllare le operazioni militari. Hoà cerca di non tradire la soddisfazione che certo prova, lui comunista del Sud, nel condurci nel palazzo-simbolo della disfatta americana. Ma gliela si legge negli occhi. Poi, ha come un soprassalto mentre, con il dito puntato, ci indica il Thong Nhut boulevard, che vide sfilare, come già ricordato, i soldatini del Nord che andavano a riprendersi la patria perduta. Vista da qui, la storia sembra finita solo ieri. 74 Nel Museo dei Crimini di Guerra Chi non ricorda quella foto che ha fatto il giro del mondo, dove si vede una giovanissima e piccola contadina-guerrigliera vietnamita in pigiama con il cappello a cono, che tiene sotto il controllo del fucile con la baionetta inastata un gigantesco pilota di B-52 americano? Da quella foto sono stati tratti più di un dipinto - nei quali la ragazza è resa ancora più piccola di quanto non sia nella realtà, per ragioni propagandistiche - uno dei quali è posto all’ingresso del Museo dei Crimini di Guerra. Fino a non molto tempo fa, la dicitura esatta era: Museo dei Crimini di Guerra Americani. Poi, qualche turista americano si dev’essere sentito offeso e il Museo ha preso il nuovo nome. Tuttavia, la sostanza del discorso non cambia, se leggo l’opuscolo che mi viene dato all’ingresso: “IMMAGINI DEI CRIMINI COMMESSI DAGLI IMPERIALISTI AMERICANI DURANTE LA GUERRA D’AGGRESSIONE CONTRO IL VIETNAM”. Nelle sale, buie, si affollano, appiccicate su pannelli che stentano a reggere il peso degli anni, le immagini delle guerre combattute dai vietnamiti contro i francesi, gli americani, i cinesi, i cambogiani. Prigionieri, fosse comuni, cadaveri allineati, esodi di massa, deportazioni: ci sono tutti i terribili ingredienti che caratterizzano conflitti di grandi proporzioni. C’é pure una ghigliottina a cui i francesi ricorrevano per punire gli “agitatori” negli anni ‘30. Ma ancora più realistiche sono le prigioni in cui venivano rinchiusi gli oppositori del regime di Van Thieu, le famigerate “gabbie di tigre”. Sono ancora lì, visibilissime, crudelmente vere, a ricordarci la fine di migliaia di donne, bambini, uomini, costretti a vivere in condizioni disumane dentro queste piccole celle, a volte anche in venti dentro una cella, sotto la calura estiva; oppure persone sole, perché non si potessero scaldare, esposte ai rigori dell’inverno. Nutriti con poltiglie di vermi, sabbia, sale, infine del putrido 75 brodo. Bersagli di sacchi di calce che venivano rovesciati loro in testa per punizione dai guardiani. Nel piccolo parco che circonda il museo sono esposti i feticci della guerra contro gli USA: carri armati, elicotteri, un autoblinda, chiusi in un recinto di filo spinato per impedire che i turisti - come pare sia già successo - ne amputino delle parti. Ma in tutto il Vietnam, carcasse di autoblinde, aerei, armi e veicoli sono ancora lì, abbandonati, a testimoniare l’ampiezza del cataclisma abbattutosi sul Paese. Su un tronco dell’arteria tra Huè e Dong Hoi, la “strada senza gioia” resa celebre dall’omonimo libro di Bernard Fall, l’evidenza della carneficina è ancora oggi insopportabile: cimiteri militari da ogni parte, torrette di carri T34, T54 e M48 che giacciono di traverso sulle strade dissestate; basi aeree bombardate a tappeto ancora con le loro piste distrutte; dune cosparse di scatole di munizioni vuote. Se molti di questi “reperti” fanno bella mostra di sé davanti ai musei, altri sono stati sapientemente riciclati dai vietnamiti, gente ingegnosa e pratica. (Pare che con il semplice bambù, i vietnamiti riescano a fabbricare una quantità straordinaria di cose: case, ponti, impianti d’irrigazione, impalcature, pali per il trasporto, tazze, pipe e mobili). Razzi arrugginiti, camion, cannoni e carri armati sono diventati tubi, travi metalliche, placche e lingotti d’acciaio e ghisa. Quasi tutti gli utensili (pettini, portacenere, raggi per le biciclette) contengono oggi questi materiali. C’è alluminio di elicottero nei ventilatori e negli apparecchi televisivi, acciaio di cannone nelle travi delle case, ferro di scatolame nei giocattoli, pneumatico di camion nelle scarpe. Per migliaia di chilometri, i reticolati sono stati usati per i recinti del bestiame. Alcuni prodotti del riciclaggio sono perfino esportati in Giappone. Tenendo conto della consistenza degli stocks, l’attività di recupero potrà proseguire per almeno altri 76 quindici anni. E non è certo priva di rischi. Lungo la celebre linea McNamara, dove ebbero luogo terribili combattimenti, c’erano alla fine della guerra diciassette milioni di razzi inesplosi. Il loro riutilizzo è costato duemila morti e parecchi mutilati. Un dramma in tempo di pace “Avete tutto il tempo che volete, ma attenzione: occhio al portafogli!” Hoà è lapidario mentre impartisce questa raccomandazione, secca come una frustata, a noi turisti che ci apprestiamo ad inoltrarci nella giungla di video registratori, impianti hi-fi, radiostereo, macchine per scrivere, walkmen, frigoriferi, ventilatori, calcolatrici, orologi che popolano il celebre Mercato dei Ladri. Questo mercato si guadagnò il nome durante la guerra, quando i nuovi prodotti rubati dagli spacci militari americani. i famosi “Px”, venivano rivenduti qui. Un nostro amico è già partito alla caccia dei cronometri russi, precisissimi quanto incredibilmente economici. Ne acquisterà otto! Camminando per le strade intorno al mercato, qualcuno rivede la Napoli del secondo dopoguerra, la Napoli degli sciuscià di Rossellini, nei suoi aspetti più vivi e anche più sinistri; sui marciapiedi e agli incroci ritroviamo le stesse bancarelle, le stesse valigette appoggiate su treppiedi di legno dove bambini smagriti vendono biglietti della lotteria e sigarette. Anche sfuse, se si vuole. C’è un grande parcheggio delimitato da una corda, per custodire le biciclette e, ad ogni angolo di strada, c’è un meccanico pronto a ripararle con la pompa, il catino, un elmetto rovesciato e la scatola degli attrezzi. Ognuno di questi meccanici senza officina arriva a guadagnare anche dieci volte quello che guadagna un funzionario statale. Ci sono molte storie sulle forature collettive che colpiscono i saigonesi alla fine di un banchetto o dopo aver visto un film al cinema. 77 Al Mercato dei Ladri ci siamo divisi in gruppetti. Hoà ha accettato di accompagnare il sottoscritto e altre tre persone. La nostra guida ci ha portati a visitare i banchi dove si possono ancora trovare - giura - giacconi, giubbotti, camicie, calzoni, armi appartenute ai soldati americani. Altri banchetti, spacciano per originali gli stessi indumenti, made in Taiwan. Con noi c’è Mario, sessantasei anni, gioviale vicentino, testa taurina su un corpo che pare una quercia, superbo bevitore e nemico giurato del caldo tropicale. Curiosa come noi fra i banchi del mercato, senza risparmiare commenti in dialetto all’indirizzo di alcune belle commesse. Nonostante le raccomandazioni ricevute da Hoà, Mario tiene il portafogli nella tasca dei pantaloni, ben visibile. Borbotta: “Che ci provino a toccarmi”. E’ un attimo: un ladro in bicicletta, velocissimo, gli sfila il portafogli e tenta la fuga. Mario lo blocca, lo agguanta per il collo con certe grandi mani contadine, toste. Il ladro lascia cadere il bottino, che Mario velocemente raccoglie. Poi riesce a sgusciare dalla stretta micidiale del grosso veneto. Al quale resta in mano la bicicletta del mancato ladro, ormai mescolatosi alla folla che popola il mercato. Mentre sono fermo davanti al pulmino con Hoà, vedo arrivare Mario con la bicicletta portata a mano. Trema tutto, farfuglia qualcosa, stenta a reggersi in piedi. E’ questione di secondi: non facciamo in tempo a raccomandargli di calmarsi, che il poveraccio si piega su se stesso, si affloscia come un canotto sgonfio, crolla, gli occhi vitrei. E’ l’inizio del dramma. Hoà capisce al volo la situazione. Insieme a lui, all’autista e ad una nostra amica, medico anestesista, spingiamo Mario dentro il pulmino. Tremila occhi di vietnamiti forse abituati a cose ben peggiori - sono sgranati lì, attorno al malato, pronti a raccontare ad amici e parenti la notizia dell’anno. Via, di corsa verso il pronto soccorso. Tre piccole infermiere, insaccate entro camici bianchi più grandi di loro, a malapena riescono a sollevare una gamba del malcapitato. 78 Finalmente, con l’aiuto di altri infermieri, Mario viene issato sulla barella. Il personale medico e paramedico è lodevole per impegno, disponibilissimo, sollecito. Una giovane dottoressa sentenzia con lapidaria brutalità: paralisi della parte destra del corpo. Mario non rinviene. La bocca è piegata in una smorfia. Non c’è altra scelta: dev’essere subito trasferito nel più attrezzato ospedale di Saigon, il “Cho Ray”. L’impatto con l’interno dell’ospedale è per me dirompente: accanto al tavolino dell’accettazione - dove tre infermiere e un medico occhialuto si passano dei fogli a vicenda - c’è tutta un’umanità dolente, ammassata senza ordine, straziata, abbandonata come un sacchetto delle immondizie. Che attende: una visita specialistica, delle cure, forse una stanza. C’è un giovane che sembra un indiano, occhi chiarissimi, cerchiati, steso sulla barella col petto nudo: ha un buco in gola grosso come una moneta. C’è una vecchia donna assistita da un’altra più giovane: ha la gamba destra fratturata e l’osso che sporge come un uncino. C’è ancora tanta altra gente che piange, urla, si dimena, soffre. Tutti aspettano qualcuno o qualcosa. Chissà per quanto. Mario, pur nella disgrazia, può ritenersi fortunato: ha avuto l’unica camera del secondo piano (gli altri malati sono sistemati nella camerata) con l’aria condizionata, due sedie e un letto americano a manovella degli anni Cinquanta. Sarà perché è straniero, e allora va trattato con un occhio di riguardo, oppure per il senso di ospitalità che caratterizza il popolo vietnamita? Ben presto ci rendiamo conto delle tragiche condizioni sanitarie di questo Paese: le siringhe per le flebo, come quella infilata nel braccio di Mario, non vengono mai buttate via dopo l’uso, ma semplicemente lavate e asciugate con uno straccio che noi usiamo per spolverare i mobili. Mancano le siringhe, i guanti di gomma, i disinfettanti, il materiale radiologico, le flebo, le garze, gli anestetici (qui l’anestesia non sempre è praticata, sopperiscono erbe 79 medicinali), gli antibiotici, i cardiotonici, i bisturi, per non parlare degli strumenti di laboratorio e di ricerca. Qui a Saigon c’è uno dei due ospedali specialistici (l’altro è a Hanoi) per la cura del cancro: meno di seicento posti-letto per un paese lungo duemila chilometri! Mario è seguito con curiosità, ma anche premura, da alcune infermiere. Ora ha ripreso conoscenza, capisce ciò che gli si dice, ma non riesce a parlare. Mi stringe con forza la mano con il braccio rimasto illeso, ma per l’altro non c’è nulla da fare: è morto. Si alternano i medici, ora un dottore con il quale conferiamo in inglese, ora una dottoressa con cui c’intendiamo in francese. I medici vietnamiti godono di grande rispetto e credito presso i loro colleghi stranieri: per questo sento che Mario è in buone mani. Passiamo la notte con Mario, Hoà ed io. Buttiamo giù nervosamente pane e banane, e beviamo Coca-Cola. La notte sembra non finire mai. A tratti si riesce a dormire, e quando non si dorme la causa è dei lamenti strazianti di uomini e ragazzi in agonia, nudi, avvolti solo per pudore con un asciugamano bianco sotto la pancia, legati con le braccia al letto, che si dimenano in maniera incontrollata, e a volte nell’indifferenza di qualche infermiera. Accanto alla stanza di Mario, ma nella camerata, c’è una bimba di otto anni, Wai, in coma per una caduta dal terzo piano di casa. Ha picchiato la testa e non riesce a riprendere conoscenza. E’ come un uccellino ferito. Il papà, un uomo brizzolato sui quarantacinque anni, è disperato: sua moglie, un medico che adesso si trova negli Stati Uniti per un corso di aggiornamento, non sa ancora nulla, e lui non intende avvisarla per non spaventarla. Ma Wai non accenna a migliorare e allora bisognerà pure prendere una decisione. Ci facciamo coraggio a vicenda, io e il padre di Wai. L’indomani mattina, Mario riceve la colazione: una tazza di acqua calda con del latte condensato. Il Vietnam è un paese così povero che ai neonati, per esempio, viene 80 somministrata solo acqua di riso, con il risultato che qui la mortalità infantile è ancora elevatissima, intorno al dieci per cento. Alle sette meno venti viene Marina a darmi il cambio. Nel frattempo, cerchiamo di attivare tutti i canali possibili per organizzare un sollecito rientro di Mario in Italia. Smuoviamo le acque dell’Ambasciata italiana a Hanoi, dove gli addetti parevano intorpiditi dall’afa tropicale: Sì, faremo, ci attiveremo. “Dovete attivarvi subito, non c’è tempo da perdere!”, urlo nella cornetta all’attaché dell’ambasciata, abituato a ben più tranquilli ozi ministeriali. Ci mettiamo in contatto con l’Europe Assistance e con la nostra agenzia di viaggio. Telegrafiamo al sindaco del paese di Mario. Di più, francamente, non sappiamo che cosa fare. La piccola Wai intanto non ha ancora ripreso conoscenza. Per via nasale, le viene somministrato un pasticcio liquido di latte condensato e molta acqua. E’ tutta cosparsa di tubi, sonde, cannule, fleboclisi. La testina è sempre avvolta in un’ampia fasciatura che le copre quasi gli occhi. Il padre abbozza per la prima volta un sorriso e, prima ancora che io gli domandi notizie della piccola, s’informa sulle condizioni di Mario. A tarda sera, mentre lascio l’ospedale, scorgo il padre di Wai a capo chino, gli occhi fissi sul lettino. I nostri sguardi s’incrociano, l’uomo fa un gesto terribile con la mano: un segno della croce sul capo della piccola. No, non è possibile che sia morta. E’ molto grave, mi dice un’infermiera, non sappiamo se ce la potrà fare. Però è ancora viva, e per questo non si deve perdere la speranza. La sera mi trova spossato. Mi piazzo in poltrona, nella hall dell’albergo, e mentre sfilano alla tivù le immagini della “Piovra”, quella con ancora il commissario Cattani, mi addormento. 81 Cholon Penso continuamente a Mario e attendo di ora in ora che venga rimpatriato. So che è in buone mani. Hoà ha chiesto ad una sua collega della Vietnam Tourism di assistere il malato, le avrebbe pagato lui il disturbo. Quel pomeriggio, di ritorno dal quartiere cinese di Cholon, ho saputo che finalmente Mario aveva ricevuto la visita di un funzionario della nostra ambasciata, il quale gli stava cercando un posto sul primo volo per Parigi con l’Air France. Ho tirato un grande sospiro di sollievo. Durante quelle concitate giornate, mi sono tenuto spesso in contatto con i medici, i quali mi hanno rassicurato sulle sue condizioni. So che ci vorrà del tempo, ma so anche che Mario è forte come un toro e ce la farà. Tre giorni dopo, Mario partirà per la sua cittadina. Siamo stati a Cholon, la Chinatown di Saigon, la Shanghai vietnamita, il quartiere abitato dagli “hoas”, la minoranza cinese, settecentomila persone, detentrice di un potere mercantile molto forte, ridottasi notevolmente di numero dopo l’esodo forzato del 1978, in seguito alle tensioni di frontiera fra il Vietnam e la Cina. Molti di loro, accusati di essere delle quinte colonne di Pechino, fuggirono allora su imbarcazioni di fortuna, diventando spesso vittime degli attacchi di pirati, respinti dall’uno all’altro porto. Questi profughi rappresentarono un terribile spettacolo per il mondo e un prezioso materiale di propaganda contro il Vietnam, presentato come l’oppresso che diventa oppressore. Durante la guerra contro gli americani, Cholon era una città nella città, il centro del piccolo capitalismo selvaggio nascosto nel ventre di Saigon, dove si trafficava in oro e il dollaro si moltiplicava con lo strozzinaggio. Non c’era bisogno di polizia per tenere l’ordine 82 a Cholon. La legge di Cholon era il racket e chi sgarrava finiva dritto, e con un coltello nella schiena, nei gorghi fangosi del fiume Saigon. La vita intensa di Cholon si fermò nel febbraio del ‘68, quando gli Skyriders americani la ridussero per la gran parte in cenere. Dov’erano le strade, restarono solo distese di terra carbonizzata. Fiamme apocalittiche si alzarono al cielo divorando case, capanne, sampan ancorati sul fiume. Dopo la Liberazione, anche l’anarchica Cholon ha dovuto subire la palingenesi rieducativa e ha perso i suoi mafiosi, le sue fumerie d’oppio, le sue sale da gioco, i suoi bordelli e tutto il suo fascino sinistro. Per i cartografi, Cholon è sicuramente il quartiere più indecifrabile, un labirinto dalle invenzioni urbanistiche uniche. Una, per cominciare, è la zona chiamata Ban Co, che significa “scacchiera”, con riferimento alla scacchiera vietnamita in cui ogni quadrato è attraversato da due diagonali. E un’altra è il cosiddetto sur, con cui vengono spesso indicati gli indirizzi di Cholon. Il numero civico di un abitante, ad esempio, mi spiega Hoà, può essere enunciato o scritto così: 47/22/3 (che si legge 47 sur 22 sur 3), e via proseguendo fino a un massimo di cinque sur. Significa che bisogna portarsi alla strada indicata e percorrerla fino al numero 47. Da queste parti dovrebbe trovasi un viottolo, o una strada minore, senza nome preciso, che si deve imboccare fino a raggiungere il numero 22. Nelle vicinanze del 22 si suppone quindi l’esistenza di una terza diramazione, più o meno sommariamente indicata, dove si trovano almeno tre case, l’ultima delle quali corrisponde all’inquilino che si sta disperatamente cercando da giorni. E se non c’è e lascia detto di ripassare, peggio per chi lo cerca. 83 Nonna Dai Come tutti i porti del mondo, anche quello di Saigon non è consigliabile visitare la sera. Hoà ci dice che è l’unico luogo della città in cui se ci si avventura si rischia il portafogli e anche la gola (brr....). Ma adesso per fortuna è un tardo pomeriggio senza sole e l’unico rischio che corriamo è di essere assaliti dalle solite torme di mendicanti che sbucano all’improvviso sulla banchina offrendoci cartine di Saigon, sigarette, chewinggum. Sulla riva, si staglia la possente figura del “Floating Hotel” (l’hotel galleggiante) il primo albergo vietnamita costruito con capitali stranieri, per la precisione di Singapore, una chicca veramente esclusiva e caruccia anche per le nostre tasche. Sull’altro lato della Piazza degli Eroi è stato da poco inaugurato lo Shaky Club, ottima birra e ottimo cibo, dice chi c’è stato, una joint venture tra un’altra società di Singapore e il Ministero della Cultura vietnamita. Attraverso le porte spalancate sui vicoli della Dong Khoi si intravedono interni di case angusti e affollati di bambini, letti di bambù, fornelli a kerosene. Nelle piccole botteghe d’antiquariato pregiate specchiere francese del tardo Ottocento si mescolano a foto di Rambo incorniciate. Durante l’occupazione francese, questa era la Via della Pace, che si faceva ammirare per le sue boutiques di lusso, i caffè come la “Rotonde” e la “Taverne alsacienne”, i suoi bei palazzi e per una generale atmosfera frivola. “Madame arriva subito, intanto accomodatevi.” La ragazzina in ao dai con arabeschi, scarpette ricamate, cipria e rossetto che apre il cancello del ristorante immerso nel buio, si scusa con un sorriso. Da una porta socchiusa filtra la figura di una donnina vestita di chiaro, con un grande scialle rosso sulle spalle, i capelli grigi pettinati con cura. Entriamo. 84 C’è una minuscola sala da pranzo in cui sono allineati quattro tavolini e un tavolo più grande. Servizi da tè cinesi e bacchette di avorio ingiallite dal tempo. Le pareti presentano un unico tipo di tappezzeria: libri. Sono tanti: volumi rilegati in pelle, codici, raccolte di leggi, tutti con le copertine scure, tutti coperti da un dito di polvere. La donnina ci viene incontro, affabile. Si chiama Madame Dai. Il suo ristorante si chiama “La Bibliotheque” ed è sistemato nel suo vecchio studio di avvocato. Nonna Dai, come la chiamano i bimbi del quartiere, è stato un personaggio famoso nel periodo del precedente regime. Appartenente ad una famiglia dell’alta borghesia, laureatasi in diritto a Montpellier negli anni ‘50 (ora di primavere ne ha sessantadue) è diventata avvocato e si è poi dedicata alla politica. Senatrice nel governo fantoccio, è stata osservatore alla conferenza di pace di Parigi e, dal 1969, capo della delegazione del Vietnam del Sud all’Unione Interparlamentare di Vienna. Quando Saigon cade, i nuovi governanti, pur mostrandole rispetto, le fanno capire che dovrà cercarsi un altro mestiere, che lei con la politica ha chiuso. “Dal momento che so cucinare, mi sono inventata un nuovo mestiere e ho trasformato il mio studio in ristorante”, dice mentre è tutta intenta a servire le portate agli altri commensali. Da allora, l’ex studio professionale è diventato uno dei luoghi più frequentati dagli europei di passaggio a Saigon. In queste dignitose stanze, a due passi dalla Cattedrale, sono entrati e usciti diplomatici, giornalisti, funzionari ONU, scrittori, musicisti, artisti. E anche semplici turisti. Nel tavolo accanto al nostro c’è un giapponese con due giovani inglesi. Più in là quattro tedeschi, con barbe unte e spinose. Un anziano francese che assomiglia molto a Charlie Chaplin sorseggia con gli occhi socchiusi la sua tazza di tè. In una bacheca di mogano chiaro, Madame Dai conserva quel che resta delle preziose porcellane Tang di famiglia. Ci mostra con orgoglio un catalogo di Christie’s in cui figurano alcuni dei suoi vasi. 85 Non è per niente facile farla parlare di argomenti che non siano la cucina, o l’arte. Ci dice, quasi sottovoce, di avere evitato l’internamento in un campo di rieducazione. E’ tutto quello che riusciamo a farle dire di argomento politico. Dà il meglio di sé con i suoi piatti. Gustiamo una zuppa di gamberetti e asparagi, un’aragosta con salsa rosa e del pollo con i funghi. Ci consiglia certi vini francesi davvero ottimi. E’ un personaggio interessante, Madame Dai, una donna vivace e combattiva. Si da un gran da fare per aiutare il prossimo. Si è battuta per far costruire una scuola per bambini abbandonati e orfani. Il comune di Saigon le ha fornito le aule, ma lei deve pensare al reclutamento degli insegnanti. Segue gli anziani, organizzando per loro corsi di ginnastica, di musiche corali e di letteratura. Alla fine della cena, ci sottopone il libro d’oro del suo ristorante. Ci si può scrivere solo un semplice pensiero con il proprio nome, oppure, ancor meglio, lasciare un’offerta per la sua scuola. Ogni pagina reca un timbro a secco delle autorità. Sopra la mia dedica, leggo di sfuggita alcuni versi di Prévert di una coppia di parigini e un saluto a Madame Dai e a tutto il Vietnam da parte di una comitiva di svedesi. Ripensando a quando, alla mia domanda se avrebbe voluto lasciare il Vietnam per raggiungere i suoi figli che vivono uno in Canada e l’altro negli Stati Uniti, la donna rispose “no, non me ne andrei mai da qui, neppure per un giorno”, annoto sul libro d’oro una frase tratta da “Il lago in fiamme. Storia della guerra in Vietnam” di Frances Fitzgerald, che ho portato con me in questo viaggio: “Durante l’evacuazione di un villaggio nella provincia di Quang Nam da parte delle truppe vietnamite, un vecchio si rifiutò di partire: ‘Devo restare qui, per occuparmi di questo giardino. Devo custodirlo per il mio nipotino. Se parto, anche le tombe dei miei antenati saranno inghiottite dalla foresta. Dove volete che trovi il coraggio per andare via?’”. 86 Sul delta del Mekong “Mia madre mi dice a volte che mai, in tutta la vita, vedrò fiumi belli come questi, grandi, selvaggi come il Mekong e i suoi bracci che scendono verso gli oceani, distese d’acqua che spariscono nelle profondità degli oceani....” (Marguerite Duras, L’amante) Siamo diretti a My Tho, che qualche poliglotta della domenica ha pronunciato all’inglese: mai tu, in una paesaggio di tombe in mezzo alle risaie, di oche petulanti in mezzo alla strada, di chiatte attraccate sul fiume, di ponti ora costruiti dai francesi, ora dagli americani. My Tho l’attraversiamo soltanto, ed è un peccato perché forse avrebbe meritato qualche attenzione di più. Ci troviamo nella provincia di Tien Giang, una regione famosa per le sue coltivazioni di orchidee e ricca di alberi da frutto, il cui profumo è percepibile nell’aria: aranceti, alberi di mango, banani, palme da cocco. Il Mekong finisce qui la sua lunga corsa durata ben 4500 chilometri, che lo ha portato a bagnare gli altipiani del Tibet, la provincia cinese dello Yunnan, Luang Prabang nel Laos, Phnom Penh in Cambogia, per poi gettarsi in questa parte del Vietnam, dove sfocia infine nel Mar della Cina Meridionale. Il percorso su quella che avrebbe dovuto essere una motolancia è soporifero, monotono. Abbiamo da bere delle enormi noci di cocco. Il delta del Mekong è tutto pieno di canali. Si succedono piantagioni di caucciù, risaie e giardini fino all’estremità della penisola che ogni anno le alluvioni del Mekong, spingono più avanti nel mare: qui si entra nel mondo ancora quasi vergine della mangrovia (una formazione vegetale tropicale). La guida per quest’escursione è un gran parlatore, con un accento yankee da fare invidia perfino a Reagan ed è fissato per tutto ciò che è a stelle e strisce. Approdiamo infine nella piccola isola di Khu Thoi Son, troppo deliziosa per non rischiare di finire nelle grinfie di qualche club turistico affamato di esotiche novità. L’isoletta è poco estesa, ma in quello spazio ristretto vivono cinquemila anime che dispongono di una scuola elementare e di un ospedale. Rinfrescati dagli spicchi di pompelmo offertici da una famiglia che abita 87 in una delle tipiche abitazioni con il tetto di foglie, ci lasciamo troppo presto alle spalle questo piccolo mondo tropicale, popolato di gigantesche palme da cocco, pesci e da una natura bizzosa e ribelle. Riattraversiamo gli stretti canali che separano risaie colme d’acqua, assistiamo alla raccolta di noci di cocco grandi come palloni di calcio, ci gustiamo questo squarcio di paradiso primitivo, attraversato da una luce solare che fende le foglie degli alberi e sprofonda nella placide acque del fiume. Più tardi siamo in estatica ammirazione davanti alla pagoda buddista Vin Tranh, maestoso complesso che conta ben sessantadue statue di Budda e altri motivi ornamentali in bronzo. All’interno, un bonzo in tunica gialla, accetta offerte in denaro dai turisti. Sull’altare, tanta frutta per il Budda. Fuori del complesso, gruppi di bambini premono rumoreggiando contro le inferriate per attirare la nostra attenzione. Pranziamo al ristorante “Trung Luong”, all’aperto, nascosto sotto un tetto di foglie (accanto ad un ponticello che diresti dipinto), dove abbiamo consumato la polpa del pesce-elefante, servita, secondo la ricetta classica, su di un foglio di carta di riso inzuppato di una salsa fermentata, il nuoc nam, mescolata con dell’altro pesce comune. Questa specialità va mangiata con le mani, tutti insieme, magari pensando a quel famoso detto vietnamita che recita: “Nel cibo come nella Morte, si coglie la fratellanza del Genere Umano.” Figli di Platoon Scooter giapponesi e Guzzi si sorpassano a vicenda in un vorticoso intrico di ruote sulla piazza Lam Son di Saigon. I giovani cavalcano con sicurezza piccole cilindrate; alle loro spalle premono le ragazze, dai jeans attillati e dal trucco pesante. 88 Poco più in là un gruppo di uomini facoltosi, forse giapponesi o coreani, in camicia e cravatta e completi di lino scuro, con le ventiquattr’ore, scivolano con pesantezza dagli scalini dell’hotel “Doc Lap” (Indipendenza), l’ex Caravelle, l’albergo più “francese” della città, eredità rimasta ben radicata nella scortesia che gli impiegati della reception dimostrano nei confronti degli anglofoni. Le umide sere di Saigon le consumiamo nel non fare nulla, perché anche questo fare nulla è uno strato di colore in più che si aggiunge al nostro affresco della città. Passeggiamo e osserviamo. E presto scopriamo che anche in un gran bazar qual è Saigon, non è difficile scovare le ultime vittime della tragedia della guerra, coloro che gli altri vietnamiti chiamano “bui doi”, la polvere della vita. Sono i cosiddetti “figli di Platoon”, i ragazzi e le ragazze che i GI hanno abbandonato nelle strade del Vietnam negli anni della guerra crudele. Si riconoscono subito: pelle nera e tratti orientali, capelli biondi e occhi a mandorla, lineamenti granitici in corpi sottilissimi, quasi diafani. Sono odiati da tutti, perché sono l’involontaria testimonianza vivente che le donne vietnamite sono andate a letto con gli americani.. Saranno almeno 20.000 in tutto il Vietnam. Si chiamano Linh, Phuong, Mai, Tien. Vagano senza meta per le strade, bivaccano nei parchi, guidano cyclo-pousse oppure chiedono la carità agli incroci. Sporco souvenir della guerra, sono malvisti perfino dagli altri mendicanti, perché riescono più facilmente a commuovere gli occidentali con le tasche piene di dollari. Ma la maggior parte di loro preferisce ammazzare le giornate davanti alla sede del “Foreign Relations Service Department”: qui si deciderà il loro destino. Accarezzano infatti un unico sogno: emigrare in America, la loro Terra promessa, il loro Eldorado, il grande paese del dollaro, della musica rock e dei palazzi alti fino al cielo. Fino allo scorso anno ne partivano 250 al mese, ora solo 40. 89 Quei cento metri di marciapiede sono il loro limbo, la loro piccola repubblica indipendente, il loro regno dell’illusione. Sono ragazzi perduti, questi “amerasiatici”. Ma basta poco per conquistarli: una sigaretta, un sorriso, una pacca sulle spalle. Intanto, dall’altra parte dell’Oceano, moltissimi “bravi” padri di famiglia (Jack, Jim, Tom) nelle loro graziose casette con prato, cani e bambini, tremano all’idea che gli piombi addosso, vent’anni dopo, un bel figliolone con gli occhi a mandorla, magari concepito in una notte d’amore dopo settimane di estenuanti missioni di rastrellamento nella giungla. Divertimento a poco prezzo Tutti qui, nonostante i tanti problemi, hanno il diritto e il bisogno di ridere, anche quelle giovani madri, anche quelle vecchine minute, dall’aria delicata ma non fragile, con i capelli d’argento raccolti sulla nuca, anche i loro figli e i loro nipoti che applaudono con compostezza il prestigiatore che si sta esibendo sul palco del teatro municipale di Saigon. Ci siamo infilati nel teatro perché abbiamo trovato il portone spalancato e nessuno ci ha fermati. Neppure la maschera, un ometto grassoccio e rubizzo, che certo, per via dell’aspetto, non dev’essere vietnamita. La sala è piena. Qualche famigliola si è addirittura portata la cena: frittelle di riso, frutti. Intere generazioni ridono in perfetta sincronia, come se ubbidissero ad un comando prestabilito. Li sollecita le evoluzioni, alquanto goffe, di un tizio sui trampoli, che prima amoreggia con una tizia pure sui trampoli e poi subisce il suo soffocante abbraccio e finisce per ruzzolare in terra. Poco prima, qualche numero elementare di un illusionista aveva tenuto i presenti con il fiato sospeso. Si trattava di fare sparire un uovo, non la piramide di Cheope, ma nella sala la tensione si tagliava con il coltello, la si avvertiva negli sguardi impietriti verso il mago, nelle mani intrecciate in grembo, negli “Ohhhhh” ripetuti. 90 Poi, la liberazione, nel momento della riapparizione dell’uovo, gli applausi a palme aperte e i bambini sollevati per aria come quando sfila il papa in piazza San Pietro. E infine la chiusura dello spettacolo, con il pubblico sfollante che ci guardava come se fossimo marziani. Non era la prima volta e non sarebbe stata l’ultima. Un infinito “day after” Andiamo con Hoà, una mattina, nella campagna fuori Saigon, a Thanh Da. Il solito velo opaco di calura avvolge l’ex capitale del Vietnam del Sud, mentre l’attraversiamo. Il pulmino, guidato da Anh, fila via verso la campagna. Per strada, incontriamo qualche arrugginito camion russo che caracolla veloce, sollevando pietrisco e fanghiglia. E poi i carretti del fitto traffico quotidiano che attraversa silenzioso tutto il Vietnam. File interminabili e tranquille di bambini scrutano con attenzione il nostro mezzo, molto pulito, mentre le madri lavorano con i piccoli legati sulla schiena e i vecchi vanno a riposarsi aspirando furtivamente una boccata dalla pipa di canna. Sfila come in una processione davanti a noi, questo Paese incredibile, in cui tutti sembrano troppo giovani e acerbi, incapaci, con quelle piccole ossa, di reggere i pesi. Vengono avanti ondeggiando, questi piccoli, coraggiosi vietnamiti, con la regolarità della pioggia, dell’acqua, dei fatti della natura. Tutti camminano con lo stesso passo, come se si muovessero nel tempo, non da un luogo all’altro, in una misteriosa trasferta di secoli, fra guerre medievali e migrazioni senza fine. Il lavoro in risaia, ecco la scena classica del Vietnam, il “leitmotiv” di questo Paese timido, bagnato, verde, che ha formato una natura dolce e benigna, un’arte minuta, e piccole facce nitidamente disegnate. Le donne, con lunghi gambali di tela, per proteggersi dalle sanguisughe, e col viso coperto da ampi fazzoletti, per mantenere chiara la 91 carnagione, secondo i locali canoni della bellezza, curano le pianticelle di riso, mentre file di bufali trascinano in tondo gli aratri di legno con cui i contadini smuovono il fango. Con un secchio, uno travasa l’acqua da una risaia all’altra, senza scomporsi: dalla strada spunta solo il copricapo femminile, tondo e a punta. In mezzo a questo lavoro, lento e ripetitivo, ecco gruppi di ragazzi intenti a pescare gamberi e pesci con ceste e piccole bilance, immersi nell’acqua a volte fino ai fianchi. Superiamo la campagna, dove i defolianti americani e il micidiale “Agente Orange” hanno fatto terra bruciata, in senso figurato, purtroppo. E’ un “day after” che non sembra finire mai. Secondo le statistiche del Pentagono, piovvero complessivamente sulle foreste, le acque e gli abitanti del Vietnam centrale e meridionale, settantadue milioni di litri di defolianti, contenenti centocinquantasette chilogrammi di diossina. Fu la più grande e crudele guerra chimica della storia. Crudele perché, a differenza dei gas asfissianti lanciati dagli eserciti austro-tedeschi nella prima guerra mondiale, gli erbicidi prodotti dalla Dow Chemical (il colosso mondiale del settore) non si limitarono a fare dei morti o degli invalidi; l’Agente Orange penetrò nel seme stesso dell’uomo, e continua ad agire, anche adesso. Nel 1971 la rivista americana “Physics Free Press” pubblicava un terribile atto di accusa (in Italia ripreso solo da “il manifesto”) contro tutti quegli studiosi che si erano messi al servizio di Washington per pianificare un genocidio diventato anche ecocidio: “Chimici e biologi di varie specialità hanno messo a punto defolianti ed erbicidi. Medici e fisiologi hanno provato gas tossici ed incapacitanti. Meteorologi e geofisici hanno studiato sistemi per la produzione di piogge ed alluvioni. Matematici ed esperti di elettronica hanno sviluppato programmi e calcolatori idonei a massimizzare la capacità distruttiva dei bombardamenti. Oftalmologi ed ingegneri hanno perfezionato un laser che emette fasci di luce capaci di bruciare, a distanza e definitivamente, gli occhi dei vietcong. Psicologi hanno elaborato per l’esercito metodi di selezione e di preparazione di soldati adatti a questo tipo di guerra. Altri scienziati hanno prodotto microbombe a forma di caramella capaci di frantumare la mandibola di un bambino senza ucciderlo.” 92 ***** Ai lati della carreggiata, il riso è sparso in lunghe strisce: bici e moto lo sbramano passandoci sopra. Quando si preannuncia il temporale monsonico, il riso viene ammucchiato e ricoperto, per poi venire ridisteso non appena è cessata la pioggia. Sostiamo ora a Thu Dan Mot, dopo aver percorso una trentina di chilometri, per fare acquisti in una fabbrica di lacche. Hoà dimostra di aver ben capito la psicologia di alcuni turisti, che smaniano dalla voglia di perdere delle mezze ore alla ricerca del quadretto migliore da regalare alla mamma o alla fidanzata: andrà meglio un quadretto con i pescatori, o uno con i fiori, uno con i bufali o con i contadini? Assistiamo alla preparazione di un quadretto da parte di artigiane disponibilissime a illustrarci le fasi del loro lavoro, anche se a qualcuno di noi non importa nulla sapere che, per ogni quadretto, sono stati necessari ben dodici strati di lacca, e che, ad esempio, le tinte sono ottenute con l’utilizzo di sostanze particolari come i semi di ortensia per il giallo, frammenti di gusci d’uovo per il bianco più puro mentre gusci di lumache e molluschi sono alla base del blu e del viola. Vasi, pietre laccate, scacchiere, vassoi e paraventi si accumulano, in un baleno, nelle borse dei famelici turisti. Hoà è soddisfatto perché il pubblico ha gradito. Anche questo è marketing. Una volta eliminati dong superflui dai portafogli, risaliamo sul pulmino per poi ridiscendervi dopo nemmeno un paio di chilometri. Qui c’è un parco con il bar, tavolini all’ombra delle palme da cocco, una pagoda rossa che spicca come un garofano in mezzo ad un campo di gladioli. Alcune ragazze, seminascoste dal fogliame, sorseggiano un succo di cocco. Accettiamo l’offerta, fattaci da un ragazzo, di una breve escursione in battello sul fiume Saigon. Qualcuno di noi arriccia il naso: ma saremo sicuri su quell’imbarcazione? Scafo malandato, toppe di ferro che coprono gli acciacchi degli anni a prua, un interno che 93 pare dover imbarcare acqua da un momento all’altro. Siamo noi i diffidenti oppure non ci siamo ancora abituati ai miracoli di questo Paese poverissimo eppure vitalissimo? All’atto pratico, il battello si dimostrerà sicuro, anche se, oltre i tre passeggeri (noi siamo in sei) affiora qualche problema legato alla portata. Ma non c’è da preoccuparsi, dice il capitano di lungo corso, al quale, a giudicare dall’alito, eccessivamente forte e liquoroso, starebbe meglio il grado di capitano .... di lungo sorso! La città sotto terra A meno di quaranta chilometri da Saigon, Cu-Chi è stata per lungo tempo il simbolo della resistenza nel Sud. Era un paradiso in terra, prima del settembre 1965, una regione prospera, con i suoi alberi da gomma, le sue risaie, i suoi orti, e le sue colture. Poi, quel paradiso è diventato un inferno. I B-52 si sono scatenati in terribili raids, i bulldozer hanno rasato a zero gli alberi da gomma e gli orti, i defolianti e gli erbicidi sono stati rovesciati a fiumi, dagli elicotteri si sparava perfino sui cespugli di bambù. L’orizzonte era striato da altissime colonne di fumo nero che salivano in linea retta nel cielo limpido. Più tardi, tra il ‘67 e il ‘68, la popolazione rientrava a piccoli gruppi e riprendeva a coltivare qua e là qualche fazzoletto di terra. Di nuovo rappresaglie, ricerca di vietcong, obici e carri armati. I contadini vivevano in rifugi di fortuna. Finché più nulla si muoverà. Gli americani non vedevano più partigiani. Ma la resistenza continuava ad oltranza nella regione. Ma dove? Da chi era rifornita? Di che cosa viveva? La risposta è sotto i nostri piedi: minuscoli sotterranei scavati nel terreno a partire dalla fine degli anni ‘40, quando il nemico era francese, dove migliaia di persone hanno vissuto, dormito, pregato. E combattuto. Dice la guida, Nguyen Quang Tiep, un veterano della guerra anti-francese e antiamericana, che ha vissuto a Cu-Chi per tutta la durata del conflitto - ma quasi sempre in 94 superficie, addetto alla preparazione di trappole -, che i vietcong, essendo molto magri, potevano sopravvivere sotto terra e nella giungla con un chilo di riso alla settimana. Non solo: erano in grado di rimanere ore ed ore sott’acqua servendosi di canne di bambù svuotate. Inoltre erano abituati ai pericoli della giungla. Forse è proprio per queste qualità straordinarie che questi piccoli guerriglieri hanno vinto la guerra contro l’esercito tecnologico che preparava i combattimenti trasferendo nella foresta ogni genere di comfort, dalle bistecche alle Coca-Cola, per soldati in gran parte demotivati. Cu-Chi era una vera e propria città sotterranea lunga 350 chilometri di cunicoli, con scuole, dormitori, cucine, depositi di viveri e di armi. Le stanze venivano illuminate con lampade a petrolio. L’aria arrivava da alberi scavati all’interno o da cunicoli mascherati da cespugli in superficie. Anche gli accessi erano mimetizzati e una delle uscite portava direttamente al letto del fiume Saigon con un ingegnoso sistema di chiuse. C’erano anche falsi ingressi che si rivelarono trappole micidiali. Chi vi si imbatteva, poteva finire trafitto da frecce o saltare su una mina. I vietcong vivevano sotto terra di giorno e uscivano la notte per incursioni nell’ex capitale. Inutilmente gli americani cercarono di localizzare la città sotterranea. Quando riuscivano a distruggere alcuni chilometri di tunnel, la “città” si era già modificata come una lucertola cui si taglia la coda. Invano il generale William Childs Westmoreland, comandante supremo delle forze americane in Vietnam, aveva creato un corpo speciale, quello dei “green rats” (topi verdi), composto di soldati di piccola taglia addestrati per quel genere di combattimento, i quali penetravano nei cunicoli, facendosi precedere da un’ondata di gas tossici. Sono sceso in uno di questi sotterranei (alto un’ottantina di centimetri e largo non più di trentacinque) camminando carponi per venti metri, vincendo con difficoltà un senso potente di claustrofobia, attanagliato dalla paura di non uscire più vivo all’aria aperta, di 95 rimanere schiacciato sotto il peso del terreno. L’apertura del cunicolo era di quaranta centimetri per quaranta, nascosta fra i bambù e mascherata da due metri di terra. Mentre mi muovevo entro quella stretta apertura, guidato dal reduce che faceva luce con una torcia di legno, toccando il meno possibile il terreno per una naturale avversione, mi veniva naturale pensare al sacrificio di questa gente, di questi contadini, che, come talpe, lavorando la notte, hanno scavato chilometri su chilometri di corridoi, adattandosi a vivere per giorni interi sdraiati o seduti, mai in piedi. Finita la guerra, la città sotterranea è stata parzialmente distrutta. Davanti all’ingresso è stato costruito un piccolo museo, che contiene l’incredibile mappa delle gallerie e dei nascondigli che il nostro reduce ci descrive minuziosamente. Accanto alla mappa vietnamita, c’è la mappa americana, o meglio, la ricostruzione approssimativa che fecero gli esperti americani dei cunicoli dai quali i guerriglieri vietcong uscivano la notte per colpire gli obiettivi nemici, secondo la tattica del “mordi e fuggi”, con incursioni rapidissime, sabotaggi, trappole micidiali, oltre al sacrificio personale di kamikaze, capaci di lanciarsi dentro un elicottero pieno di soldati con addosso una bomba. Il reduce apre le braccia sconsolato: “Qui la vegetazione è morta, chissà quando ricrescerà?” La guerra forse ha lasciato tracce eterne in questa natura dolce e tenera violentata dagli uomini. Ancora segnali di guerra lungo la strada che, nel tardo pomeriggio, abbiamo ripreso per Saigon. Bambini seminudi giocavano, ma non alla guerra, accanto ai resti di un elicottero abbattuto: salivano sulle ali del velivolo e poi si buttavano giù con un balzo, sorridenti per l’impresa compiuta. Si sono ormai abituati all’idea di questi strani parcogiochi, dove invece che altalene e scivoli, ci sono carri armati, elicotteri e mortai. Ci siamo fermati a visitare il cimitero di guerra di Cu-Chi, dove troneggia un grandioso monumento in marmo dedicato ai martiri della Rivoluzione. Una simbologia 96 cara al comunismo tropicale, balcanico (Albania), centroamericano (Cuba) ed est europeo (URSS). Nel camposanto deserto, dove l’afa è pesante e le mosche volano fastidiose sopra le oltre cinquemila tombe, c’è solo un vecchio uomo, con la camicia fuori dai pantaloni, il colletto sdrucito: prega davanti ad una tomba. Ci avviciniamo, e l’uomo ci chiede di fotografare quella tomba. Un desiderio che non ci costa nulla esaudire. Sulla tomba c’è scritto un nome e un cognome e una data: Pham Van Co, morto il 28 luglio 1966. Il vecchio ora sorride con le lacrime agli occhi, poi ci stringe la mano e ritorna alla sua bicicletta. Incrociamo un funerale buddista che, per i colori vivissimi delle corone di fiori e i canti intonati, ricorda più una festa che un rito funebre. Il nostro autista tenta di farsi strada, poco elegantemente, con un paio di strombazzate, ma alla fine è Hoà, preceduto da un gruppetto di oche, che scende dal pulmino e ottiene lo spostamento dalla strada del corteo. Più avanti, il monsone rovescia fiumi di acqua grigia e compatta. Superiamo biciclette e moto con appesi enormi grappoli di galline vive e maiali a zampe in su. Il sole si alterna alla pioggia e quando l’acqua scende più violenta, anche i vetri del pulmino si appannano ed è necessario fermarsi qualche minuto. Alcuni bambini si gettano a piedi uniti nelle ampie pozzanghere ai margini della strada, rotolandosi nel fango e ingaggiando lotte. Una volta “lavati” li attenderanno le madri e le sorelle davanti alle baracche per la rituale spidocchiatura. ***** 97 Saigon è inebriante sotto questi scrosci di acqua grandi come onde. Riusciamo ad aprirci un varco tra le Volga sfondate e qualche malcapitato cyclo-pousse che rientra precipitosamente alla base. Qualche “imprudente” venditore di monete, davanti al nostro albergo, svolge i suoi tesori dalla custodia di nylon, ma è intelligente a capire al volo che la giornata di pioggia non è propizia per il “business”. Non ci resta, per ingannare il tempo nell’ultimo pomeriggio che trascorriamo in Vietnam, che fare un giro nella libreria internazionale di Saigon. E’ curioso che là dentro non esista una sola cartina del Vietnam, mentre gli ambulanti, dieci metri più in là, ne hanno molte copie. Questa libreria è stata invasa da libri sovietici dopo la firma del trattato di amicizia fra Vietnam e Unione Sovietica del novembre ‘78: opere illustrate sui tesori dell’Ermitage, libri fotografici su Mosca, vita di Lenin per immagini, dizionari di cirillico. Acquisto una vecchia pianta di Huè e faccio incetta di spilline di Ho Chi Minh, quadretti con la sua immagine e medagliette della Gioventù Comunista vietnamita, che nessuno regolarmente compra. Ritornando in albergo, l’autista di cyclo-pousse mi ha proposto di trascorrere qualche ora d’amore con disponibili minorenni: “nice, nice”, belle, belle. “Ten dollars”, dieci dollari per togliersi la paura. Ha quasi lasciato cadere la domanda dall’alto, come se si trattasse di un qualsiasi argomento di conversazione, infilato fra un “Where do you come from?” (Da dove vieni?) e un “Are you married?” (Sei sposato?). Nell’”offerta” del giovane, col berretto mimetico e il viso tutto butterato, non ho notato alcuna forzatura, né il desiderio impellente di combinare l’incontro. Lui ferma il cyclo e mi indica un vicolo: è li che mi porterebbe. M’immagino, chissà perché, tante baracche a più piani, una sopra l’altra, a coprire la vista al cielo, con piccole porte e piccoli ballatoi; mi pare perfino d’intuire tutti i rumori, le parole, i brusii, i fruscii, i respiri e i sospiri, e poi di sentire l’odore di talco, di fumo, di profumi occidentali, di pipì, di 98 cibo. E m’immagino ancora bambine con trucchi pesanti, l’aria innocente, un velo di tristezza nei loro occhi. Ma se quel posto non dovesse piacermi, aggiunge il mio amico del cyclo, lui conosce delle case lungo i binari della ferrovia, proprio così, a pochi centimetri dalle rotaie, “non aver paura, amico”, dice ridendo e mostrando grandi denti gialli. Tutto come vent’anni fa, penso. Sarà forse diminuito il numero delle “girls” (anzi, lo é certamente) ma il fenomeno della prostituzione minorile resta. Sarà ancora vero che i ricchi e vecchi cinesi di Cholon strapagano la verginità delle ragazzine perché sono convinti di ringiovanire e di essere più virili? Mi rendo conto adesso quanto sia difficile per un europeo giudicare il costume asiatico. A Saigon la prostituzione è qualcosa di diverso che nelle grandi capitali occidentali. Non solo è una necessità, ma anche una sfida, una condanna, forse al di fuori delle valutazioni etiche. In particolare, non tocca chi affronta con maggiore fortuna e col privilegio della dignità la vita quotidiana. Poche ragazze agiscono scientemente per lucro, poche sono volgari, moltissime conservano ancora, oggi, un’incredibile innocenza. Sono anch’esse vittime innocenti di una tragedia, la guerra, che, da un’età tribale, ha proiettato tutta la società vietnamita nel purgatorio del 2000. Dimenticare il Vietnam? Addio, “Saigon la douce”, come la chiamavano i francesi. Addio, Vietnam. Ce ne andiamo. Pur essendo mattino prestissimo, Hoà ha preteso che tutto il personale dell’hotel venisse a salutarci. In questo schieramento di piccoli, giovani vietnamiti della generazione nata durante gli sconvolgimenti della guerra, con le mani lungo i fianchi, come soldatini 99 sull’attenti, i visi sinceramente dispiaciuti, ho rivisto tutta la gentilezza, la bontà, la serenità di questo popolo. Parto con il cuore gonfio di tristezza perché vorrei ancora restare in Vietnam. Chi lo sa il perché, forse perché ho imparato ad amarlo, e come tutte le cose che si amano o si sono amate avrei voluto anche capirlo. La sera prima della partenza avevo conosciuto un francese sulla sessantina, elegante nel suo completo di lino beige, mezzo uomo d’affari e mezzo mercante d’arte. Gli avevo confidato il mio stato d’animo e la mia leggera inquietudine. Il francese mi aveva guardato, aveva spento sotto il tacco della scarpa la sigaretta e aveva alzato gli occhi al cielo. Poi mi aveva detto che, pur essendo stato in Vietnam quattordici volte negli ultimi venti anni, di questo Paese lui non aveva mai capito nulla. Come potevo, io, avere la presunzione di arrivare dove lui aveva fallito? “Non ci pensi più al Vietnam, amico mio”, aveva concluso il francese, prendendomi sotto braccio e rientrando in albergo. “Lo dimentichi.” Non ci sono mai riuscito. 100 101 BREVE CRONOLOGIA 939 a.C. Fondazione dello Stato vietnamita indipendente. 1009-1225. Dinastia dei Ly. 1225-1400. Dinastia dei Tran. 1427-1789. Dinastia dei Le. 1802. Dinastia degli Nguyen, ultima dinastia reale. 1858. Penetrazione militare francese nel porto di Danang. 1862. La Corte Imperiale di Hué cede alla Francia Saigon. Nelle campagne del Vietnam meridionale si sviluppa la resistenza alla colonizzazione francese. 1882. Le truppe francesi occupano Hanoi ed impongono il protettorato sul resto del Vietnam. 1890. Nasce Nguyen Tat Tan, il futuro Ho Chi Minh. 1900. Fino ai primi anni del secolo si sviluppano numerose sommosse spontanee che verrano poi inglobate nei movimenti patriottici. 1920. Al Congresso di Tours, Ho Chi Minh aderisce al Partito Socialista francese. 1930. Fondazione del Partito Comunista indocinese. 1936-1939. Varie sommosse politiche guidate dal Partito Comunista. 1941. Fondazione del Fronte Viet Minh. 1944. Vo Nguyen Giap assume il comando del primo nucleo dell’esercito di liberazione del Vietnam. 1945. L’occupazione giapponese, in seguito alla sconfitta francese da parte dei nipponici, prelude alla disgregazione dell’apparato coloniale. Nell’agosto scatta l’insurrezione in tutto il Paese. Il 2 settembre viene dichiarata l’Indipendenza. Nasce la Repubblica Democratica del Vietnam. Il 23 settembre i francesi scatenano la guerra di riconquista. 1954. Gli americani intensificano il loro aiuto ai francesi. Il 7 maggio a Dien Bien Phu i vietnamiti sconfiggono definitivamente i francesi. Alla conferenza di Ginevra il Paese viene diviso in due tronconi: a nord del 17° parallelo, la Repubblica Democratica del Nord, a sud, zona d’occupazione francese. 1955. Gli Stati Uniti subentrano alla Francia nel controllo del sud del Vietnam, dove installano un regime anticomunista con capitale Saigon. 1960. Fondazione del Fronte Nazionale di Liberazione, che raggruppa tutte le forze guerrigliere del sud. 1961. Gli Stati Uniti insediano a Saigon un proprio comando militare. 1964. Iniziano i bombardamenti americani. 1968. Offensiva del Tet: si affermano le forze dell’esercito popolare vietnamita. 1969. Muore Ho Chi Minh.. 1970. E’ la guerra totale: il conflitto si estende all’intera Indocina. 1973. Firma degli accordi di Parigi che prevedono il ritiro delle forze americane, la cessazione delle ostilità e la riunificazione del Paese. Il presidente sudvietnamita Van Thieu prosegue tutavia la guerra. 1975. Il 30 aprile Saigon viene liberata dalle forze del FNL. 1976. Il Paese, unificato, si costituisce in Repubblica Socialista del Vietnam. 1979. Il Vietnam invade la Cambogia. Per ritorsione, la Cina invade le province settentrionali vietnamite. 1985. Tensione cino-vietnamita. Offensiva contro la guerriglia cambogiana. 1986. VI Congresso del Partito Comunista. 1989. Ritiro delle truppe vietnamite dalla Cambogia. 102 Indice Nel Nord Vietnam. L’eterno dopoguerra di Hanoi Prologo. In volo sopra la Storia Il ponte sul Fiume Rosso Hanoi di notte Cronache di ordinaria povertà Biciclette e caschi verdi Buon riposo, zio Ho Bambini del Vietnam In cyclo-pousse Soldatini con i sandali Una lingua musicale Hanoi, Natale 1972 Guerra e pace a Hoa Binh Duello sul ponte. Verso Haiphong Halong, l’ottava meraviglia del mondo Sul 17° parallelo. A Danang e a Hué Il “bordello” dei marines Storia dei misteriosissimi Cham Nelle grotte buddiste Sul Colle delle Nuvole Le ragazze di Hué Il Sud. A Saigon, la città del peccato Yankee, whisky & droga Scene di vita quotidiana 29 aprile 1975 Nel Museo dei Crimini di Guerra Un dramma in tempo di pace Cholon Nonna Dai Sul delta del Mekong Figli di Platoon Divertimento a poco prezzo Un infinito “day after” Dimenticare il Vietnam? . Breve cronologia 103 L’AUTORE Nico Ivaldi è nato a Torino - dove risiede - nel 1958. Si è laureato in Lettere Moderne nell’Ateneo torinese con una tesi su Felice Govean, uno dei fondatori della “Gazzetta del Popolo”. Ha lavorato come cronista alla “Gazzetta del Popolo” e collaborato a “Stampa Sera” con inchieste sul mondo della cultura torinese. Ha pubblicato articoli su molte altre riviste a diffusione nazionale. Sta preparando un altro libro tratto dagli appunti dei suoi viaggi nel continente europeo. Giacomo Ivaldi, l’autore dei disegni, è nato a Torino, dove ha sempre svolto la sua attività aritstica. Pittore paesaggista e ritrattista, si è cimentato anche nella scultura e nel disegno pubblicitario, senza peraltro trascurare tutte le possibilità espressive offerte dalla lavorazione del legno e dei metalli. . 104
Scaricare