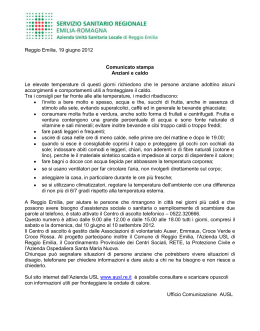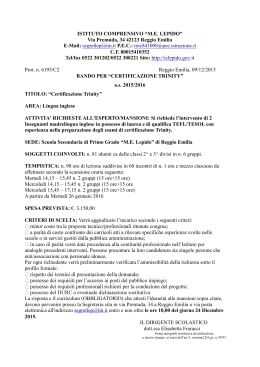(1,1) -1- 102765_RS_110_cop.indd 04/11/10 10:16 R I C E R C H E S RS T O R I C H E RS RS Anno XLII RICERCHE STORICHE Direttore Ettore Borghi N. 110 ottobre 2010 Rivista semestrale di Istoreco (Istituto per la storia della Resisistenza e della Società contemporanea in provincia di Reggio Emilia) Direttore Responsabile Carlo Pellacani Coordinatore di redazione ed editing Glauco Bertani Comitato di Redazione: Michele Bellelli, Lorenzo Capitani, Mirco Carrattieri, Alberto Ferraboschi, Alessandra Fontanesi, Benedetta Guerzoni, Marzia Maccaferri, Fabrizio Montanari, Francesco Paolella, Ugo Pellini, Massimo Storchi, Antonio Zambonelli Direzione, Redazione, Amministrazione Via Dante, 11 - Reggio Emilia Telefono (0522) 437.327 FAX 442.668 http://www.istoreco.re.it e.mail: [email protected] Cod. Fisc. 80011330356 Foto di copertina: Dollmann, il primo a sinistra con la camicia bianca, durante un incontro tra ufficiali probabilmente in un locale dell’ex GIL, in via Gorizia a Reggio Emilia (data presunta fine 1944 inizi 1945) (Fototeca Istoreco) Prezzo del fascicolo numeri arretrati il doppio Foto sfondo sezioni: Impiccagione di sei indigeni. Immagini di questo tipo circolarono in modo semiufficiale tra i soldati italiani durante la guerra in Etiopia (Fototeca Istoreco) € 13,00 Abbonamento annuale € 20,00 Abbonamento sostenitore € 73,00 Abbonamento benemerito € 365,00 Abbonamento estero € 50,00 I soci dell'Istituto ricevono gratuitamente la rivista I versamenti vanno intestati a ISTORECO, specificando il tipo di Abbonamento, utilizzando il Conto Corrente bancario BIPOP-CARIRE n. IT05J 02008 12834 000100280157 oppure il c.c.p. N. 14832422 La collaborazione alla rivista è fatta solo per invito o previo accordo con la redazione. Ogni scritto pubblicato impegna politicamente e scientificamente l’esclusiva responsabilità dell’autore. I manoscritti e le fotografie non si restituiscono. Stampa GRAFITALIA – Via Raffaello, 9 Reggio Emilia Tel. 0522 511.251 Fotocomposizione ANTEPRIMA – via Gramsci, 104/f Reggio Emilia Tel. 0522 271.185 Editore proprietario ISTORECO (Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Reggio Emilia) Registrazone presso il tribunale di Reggio Emilia n. 220 in data 18 marzo 1967 Con il contributo della Fondazione Pietro Manodori Indice Editoriale Valerio Onida, «Com-memorare», Fare memoria insieme. Reggio Emilia, 25 aprile 2010 5 Memorie/Testimonianze Lorenzo Capitani a cura di, Renzo Bonazzi e il ’68 a Reggio Emilia 13 Massimo Storchi a cura di, Special operation executed di Mike Lees, prima parte 18 Realino Ferretti a cura di, Orlando Ferretti, il mio diario. Campagnola Emilia, ricordi della Liberazione 44 Documenti Massimo Storchi (a cura di), Dr. Eugenio Amonn, Lugano, via Loreto 10. Tre lettere di Eugene Dollmann a Dino Prandi (1952-1968) 53 Francesco Paolella, Maria Bertolani Del Rio. La Colonia-scuola «A. Marro» di Reggio Emilia e il regime fascista 58 Biografie Bruno Grulli, Un «piper» scozzese tra i partigiani reggiani. Vive in Scozia il suonatore di cornamusa che partecipò all’attacco di Botteghe 67 Mario Frigeri, Gismondo Veroni. Una biografia 74 Flavio Parmiggiani, Giuseppe Moruzzi: un ricordo personale 101 Didattica Lorena Mussini a cura di, «Les chemins de la memoire», Villa Emma (NonantolaItalia)-Maison D’Izieu (Lione-Francia) 108 Salvatore Trapani, Auschwitz e la sua memoria 125 Note e rassegne Benedetta Guerzoni, Disincanto africano 129 Nicola Mai, Remo Cantoni e l’impegno politico-culturale 138 Nilde Iotti. A dieci anni dalla scomparsa, una breve bibliografia 148 Carlo Pellacani, Omaggio ai caduti dell’Egeo e alle vittime dell’eccidio di Cefalonia (a cura dell’Associazione marinai d’Italia) 152 Sandro Chesi, Sandro Spreafico. I cattolici reggiani dallo Stato totalitario alla democrazia 154 Recensioni Glauco Bertani (a cura di), Indice analitico «RS-Ricerche Storiche» 100-109 194 3 Editoriale Festa della Liberazione. 65° anniversario «Com-memorare», fare memoria insieme Reggio Emilia, 25 aprile 2010 Valerio Onida* Siamo qui per commemorare la Resistenza e la Liberazione, dopo 65 anni. «Com-memorare», cioè fare memoria insieme. Ma che vuol dire fare memoria insieme di eventi di 65 anni fa? Di un’epoca cioè in cui la maggior parte di voi non erano ancora nati, altri più vecchi (come chi vi parla) erano sì già nati, ma hanno vissuto quegli eventi da bambini, e solo pochi ormai portano di essi un ricordo personale da adulti? Vuol dire, credo, tre cose essenziali: • 1 – non dimenticare; • 2 – ritrovare e rinsaldare in noi la consapevolezza del significato profondo di un evento, dell’eredità che da esso proviene e del suo valore; • 3 – ribadire la coscienza che si tratta di un patrimonio comune, cioè appartenente non a una parte o una frazione, ma all’intera comunità: è per questo, fra l’altro, che la commemorazione è indetta e promossa dal Comune, l’istituzione di base che tutti ci riunisce e ci rappresenta. Anzitutto, non dimenticare. Nella storia degli uomini la memoria, personale e collettiva, è essenziale per dare senso al nostro vivere e al nostro agire. Noi siamo ciò che attraverso il nostro passato, personale e collettivo, si è costruito nel tempo; dimenticare il nostro passato vorrebbe dire smarrire il significato di ciò che siamo oggi, qui e ora, e la direzione del cammino che ci attende. Si ringrazia il professor Onida per aver gentilmente acconsentito alla pubblicazione di questo intervento in occasione del 65° anniversario della Liberazione di Reggio Emilia, il 25 aprile 2010. * 5 Certo, la memoria può essere ed è anche un peso, con i suoi carichi di dolore, di frustrazioni e di lutti che spesso e per molti porta con sé: e gli eventi che oggi commemoriamo sono anche eventi dolorosi e luttuosi. Ma elaborare questo peso per trasformare anch’esso in lezione per il futuro è il nostro compito: per questo diciamo che la storia è maestra della vita. Abolire od oscurare la memoria, anche se fosse possibile (e non lo è) come «resettare» una memoria elettronica nel nostro computer, non ci renderebbe migliori ma ci farebbe perdere una parte consistente e importante del nostro essere. Secondo punto: fare memoria, ma a quale fine? Noi commemoriamo la Resistenza e la Liberazione non tanto come fatti storici per così dire «neutri», mere evenienze, ma come eventi che hanno espresso ed esprimono un contenuto di valore, qualcosa che essi miravano a darci e che ci hanno dato. In questo senso, trattandosi di eventi di un passato sempre più remoto, parliamo di eredità, cioè di un patrimonio che ci è stato donato e trasmesso da coloro che ne sono stati i protagonisti diretti e dalle circostanze in cui essi hanno operato. E qual è l’eredità che ci è stata lasciata dalla Resistenza e dalla Liberazione? Si tratta, all’evidenza, di un’eredità politica, come politici sono gli eventi che ricordiamo: un cambiamento di sistema di governo, una rinnovata indipendenza nazionale dopo i tragici eventi della dittatura e della guerra. Ma «politica» in un senso alto, non cioè come eredità di una particolare opinione o di uno schieramento o di un partito contro un altro, bensì come un nucleo di valori e di principi destinato a costituire la base della convivenza nella nostra comunità, la base della nostra Repubblica. Certo, come ogni guerra, anche quella partigiana e di liberazione ci parla di forze in lotta fra di loro, di conflitto armato, di violenza delle armi da una parte e dall’altra, di vincitori e di sconfitti. Ma l’evento del quale parliamo, come il grande evento epocale e planetario in cui esso si inserisce costituendone un episodio, e cioè la seconda guerra mondiale, ha questo di caratteristico: esso non ci parla fondamentalmente – come invece tante guerre del passato – di un confronto e di uno scontro fra nazioni o fra potenze (da questo punto di vista l’Italia è fra le nazioni sconfitte, nonostante il parziale e tardivo cambiamento di fronte): ma dello scontro finale fra diverse ed opposte concezioni dell’ordine politico, fra quello che il Presidente americano Roosevelt chiamò il «nuovo ordine di tirannia» e una concezione dell’ordine politico basata sui principi del costituzionalismo, libertà, eguaglianza, giustizia. L’eredità della Liberazione non è dunque solo o tanto la fine di un’occupazione militare straniera (cui peraltro un’altra se ne è necessariamente sostituita pro tempore) quanto la fondazione di un ordine fondato su quei principi. Questo e il nuovo ordine costituzionale. È per questo che la più genuina espressione dell’eredità in questione è proprio nella Costituzione: perché è la Costituzione che esprime in forma compiuta e articolata il nucleo essenziale di valori e di principi della nostra convivenza politica, per la cui affermazione la Resistenza si è realizzata. 6 Il significato primo e originario delle costituzioni scritte è proprio questo. Quando i coloni americani, più di due secoli fa, vollero consacrare la loro conquistata indipendenza dalla madrepatria britannica, in apertura della loro Dichiarazione di indipendenza affermarono che quando un popolo scioglie i preesistenti legami politici e dà vita a un nuovo ordinamento, «un giusto riguardo alle opinioni del mondo» richiede che se ne dichiarino esplicitamente le ragioni, e si enuncino le «verità di per sé evidenti» su cui si intende costruire il nuovo ordine. Nella Resistenza italiana, come è noto, erano presenti e convivevano programmi politici diversi e contrapposti (sia pur solo genericamente elaborati), che fin da subito, e nel tempo successivo, si sono sviluppati, confrontati, si sono trasformati o hanno ceduto il posto ad altri programmi sopraggiunti. Ma la specifica eredità della Resistenza, quella che oggi siamo chiamati a confermare e rinsaldare, non si identifica in alcuno di quei programmi, bensì nel nucleo di principi su cui si fonda la Costituzione. In questo senso i valori e i principi della Resistenza non sono nemmeno solo valori e principi nazionali, specificamente italiani. I valori e i principi del costituzionalismo hanno costituito il terreno comune su cui si è realizzato l’ingresso dell’Italia, uscita dal periodo della dittatura fascista, nella famiglia degli stati costituzionali. Celebrare gli eventi di quel tempo vuol dire dunque per noi rinsaldare la consapevolezza della centralità, per la nostra convivenza civile, dei valori consacrati nella Costituzione: eguale dignità di ogni persona umana; libertà e diritti inviolabili; doveri inderogabili di solidarietà; giustizia sociale; potere politico basato sul consenso e fondato e limitato dalla Costituzione. E poiché i valori costituzionali sono certo consacrati in istituzioni stabilite e in regole acquisite e garantite, ma sono anche un programma permanente che richiede continua attuazione, il rischio vero, per noi oggi, è quello di allontanarci, più o meno consapevolmente, da queste radici, magari inseguendo particolari interessi individuali o di gruppo o di categoria o perfino di popolo, dimenticando che i valori su cui ci fondiamo sono valori esigenti, che richiedono continua fedeltà e coerenza di condotte. In questo senso l’eredità di cui parliamo è anche fonte di responsabilità per ognuno di noi. Responsabilità di non disperdere il patrimonio che ci è stato trasmesso, di non lasciarlo deperire, di rinnovare quotidianamente la tensione finalistica, la fedeltà agli obiettivi di fondo che esso ci richiede. Quando la Costituzione afferma che è «compito della Repubblica» costruire una società in cui libertà e eguaglianza crescano, in cui si realizzino pieno sviluppo della persona, di ogni persona, e partecipazione, non parla di doveri di qualcun altro o solo di chi esercita autorità: parla di compiti comuni ad ognuno di noi. La Costituzione ci parla, certo, di diritti, ma anche di doveri, che sono i diritti degli altri. Ecco perché l’eredità della Resistenza è per tutti noi anzitutto un programma permanente e una fonte permanente di responsabilità. 7 Terzo punto. Ho parlato di memoria e di eredità. Rispetto ad un evento come la Resistenza ci possono essere e ci sono memorie individuali o familiari diverse, anche opposte. Ma quella che qui celebriamo è una memoria collettiva, un’eredità che non appartiene a questa o quella parte, a questo o a quel gruppo, ma appartiene a tutti, perché è un’eredità di valori comuni. I valori costituzionali sono per definizione valori comuni, appartenenti all’intera collettività: essi esprimono le ragioni e i criteri di fondo che fanno di un popolo, di una multiforme presenza collettiva in un determinato luogo e in determinato tempo, una comunità politica, cioè un insieme che ha qualcosa che la unifica. Nessuna parte di questo insieme, nessun gruppo, nessun partito può dunque vantare diritti esclusivi o primogeniture sulla Costituzione, «casa di tutti» per definizione. Certo, alle origini della Costituzione, come di ogni vicenda umana, ci sono state divisioni e anche scontri. Il processo costituente ha dovuto superare ostacoli e dissensi. Ma il consolidarsi dell’esperienza costituzionale – e quella della Repubblica italiana è una esperienza consolidata – comporta proprio che ciò che all’inizio può essere nato su un terreno di divisione, nel tempo diventa segno e strumento di unità. Perché i valori che la Costituzione esprime sono valori tendenti all’unità: eguaglianza, diritti e doveri di tutti, solidarietà. Ed è ciò che si esprime anche nella «geografia» del potere istituzionale. In democrazia la divisione e il confronto sono fisiologici. Ma le istituzioni, che pure offrono il quadro e gli strumenti del confronto e della divisione – si pensi ai meccanismi elettorali e parlamentari – hanno e devono conservare anche una loro capacità di esprimere e rappresentare l’unità. Nel nostro sistema ciò è reso particolarmente visibile dall’esistenza di ruoli istituzionali espressamente rivolti a questo fine. Basta pensare al Presidente della Repubblica, che per Costituzione ha il primo e fondamentale compito di «rappresentare l’unità nazionale» (art. 87 della Costituzione). Non è senza significato che nella prassi repubblicana si sia teso sin dall’inizio, e sempre finora, a sottolineare questa caratteristica della prima magistratura dello Stato, anche con la scelta di personalità che presentassero il più possibile connotati unificanti, piuttosto che di personalità percepite come «divisive», espressione di una parte contrapposta ad altre. Non è vero che in democrazia l’unico criterio di legittimazione delle istituzioni sia il principio di maggioranza. Il principio di maggioranza regge l’ordinario esercizio del potere politico: ma le «funzioni di unità» sono essenziali, tanto più, quanto più la politica quotidiana tende ad esasperare le divisioni. Ecco perché, sia detto per inciso, non mi pare che, nella odierna realtà italiana, sia saggio ipotizzare trasformazioni costituzionali che si risolverebbero nella scomparsa o nell’indebolimento, a livello istituzionale, di queste funzioni di unità (come quella di un Capo dello Stato garante di unità) attraverso l’esa- 8 sperazione del principio di maggioranza. Per queste stesse ragioni, del resto, ogni eventuale revisione della Costituzione – testo che esprime al massimo livello esigenze unitarie – dovrebbe passare attraverso procedimenti decisori non fondati sul semplice criterio di maggioranza. Per usare le parole di un costituente, le eventuali revisioni non possono attuarsi «in forza di una leggina deliberata quasi di sorpresa e con una maggioranza fittizia ed effimera, ma solo in forza di un atto solenne, che sia espressione sicura della maggioranza del popolo italiano», e – aggiungerei io – di una maggioranza ampia e concorde. La Costituzione ha rappresentato fin dall’inizio, e per i decenni trascorsi, un potente fattore di unità del paese. Evitiamo in ogni modo che si perda o si indebolisca questa funzione. La Resistenza, che oggi celebriamo, si è sviluppata e manifestata in un contesto che per un verso componeva ad unità forze e programmi diversi, ma per altro verso ha comportato il prevalere di una parte della società italiana in conflitto con un’altra (non a caso i protagonisti si chiamavano partigiani). Tuttavia ciò non è in contraddizione con quanto ho detto circa la funzione di unità propria della Costituzione: perché gli ideali per i quali la guerra di liberazione è stata combattuta e vinta – ideali di libertà, eguaglianza, democrazia, giustizia – esprimevano ed esprimono non interessi o vedute particolaristiche, ma l’intento di fondare su basi più alte l’unità della comunità nazionale. Così che, a distanza di decenni, può ben dirsi che anche la Resistenza è patrimonio unitario del paese. Anzi, poiché i valori e gli ideali da essa espressi, e confluiti nella Costituzione, sono valori e ideali di ispirazione universale – quelli che nello stesso periodo di tempo hanno ispirato la ricerca di un nuovo ordine internazionale e l’aspirazione all’affermazione dei diritti umani «ovunque nel mondo» – possiamo dire che si tratta di un patrimonio che va al di là degli stessi confini della nazione. Perciò esso si offre, allo stesso modo, come base della convivenza anche per i nuovi abitanti della nostra terra giunti qui, e spesso qui stabilmente insediati, venendo da altre nazioni, alla ricerca di lavoro e di migliori condizioni di vita. Per loro, come per noi, i valori essenziali della Costituzione – incentrati sull’eguale e inviolabile dignità di ogni persona – costituiscono il patrimonio di una umanità che ci accomuna, condivisibile e condivisa pur nella differenza delle lingue, delle culture e delle tradizioni. Questa è del resto la caratteristica dei valori umani più profondi: di essere naturalmente espansivi e diffusivi, al di là delle persone e dei gruppi che storicamente li affermano e li promuovono, ma non ne sono i gelosi possessori o i titolari esclusivi. Voglio terminare citando le parole di un vostro grande concittadino, protagonista della Resistenza e della Costituente, Giuseppe Dossetti. Egli pronunciò queste parole in chiusura di un suo elevato e ispirato intervento in Assemblea, il 21 marzo 1947, rievocando un episodio e un incontro della sua esperienza partigiana. 9 Dossetti parlava di una persona che presumibilmente era, e sarebbe stato se fosse vissuto ancora, un suo avversario politico. Quasi due anni fa – disse – il giorno di Pasqua del 1945, sull’Appennino reggiano. Prima delle luci dell’alba, venivamo svegliati dall’annuncio che truppe … tedesche e fasciste avevano rotto una parte del nostro schieramento sul Secchia. Incominciava così una giornata di Pasqua, che fu giornata di duri combattimenti … [Alla fine] la vittoria. Ma la sera fu triste. Proprio una delle ultime fucilate aveva colpito Elio, il nostro vice comandante di brigata. Era venuto alla nostra brigata da formazioni garibaldine … Era ferito mortalmente … Credetti così di dovergli dire che la vita era ormai finita per lui e di dovergli chiedere che egli consapevolmente la offrisse per noi: perché tutti diventassimo più buoni, più fedeli alla bandiera che servivamo, più disposti a immolarci come lui per il rinnovamento d’Italia. Bastarono poche parole perché egli comprendesse ed assentisse, e con gli ultimi esili sforzi della voce confermasse ciò che gli avevo chiesto. E noi presenti giurammo allora, di fronte a un sacrificio così grande e così consapevole, che avremmo sempre sentito e osservato l’impegno che esso importava per noi. Questo è l’impegno – concludeva Dossetti – con il quale oggi vi parlo. Esso … dice a tutti che dobbiamo avvertire la presenza e il gemito del nuovo mondo che sta sorgendo e che dobbiamo inchinarci su questo mondo nuovo, con religioso rispetto, perché in nulla venga menomato e tradito i messaggio e il compito che i nostri morti ci hanno lasciato. Questo è anche il nostro rinnovato impegno di oggi. 10 Valerio Onida, in piazza Martiri 7 luglio durante la manifestazione del 25 aprile 2010 Memorie Testimonianze Renzo Bonazzi e il ’68 a Reggio Emilia Note da una intervista a cura di Lorenzo Capitani Un breve profilo L’avvocato Renzo Bonazzi è morto il 1° aprile 2010, all’età di 85 anni. Sindaco di Reggio dal 1962 al 1976, è stato, poi, eletto senatore per due legislature nelle liste del pci, di cui è stato dirigente provinciale. Ha aderito poi al pds, ai ds e infine al pd. Subentrò al sindaco Campioli nel 1962 e seguì l’iter processuale e le conseguenti vicende politiche dei fatti relativi al luglio 1960. Bonazzi è stato un sindaco molto apprezzato. Uomo di cultura e di grande apertura intellettuale, è stato tra i fondatori del Circolo del cinema e della cultura negli anni Cinquanta. Il suo lavoro ha fatto crescere un’intera generazioni di intellettuali. Ricordiamo anche che era membro del Comitato direttivo di Istoreco e di molti altri sodalizi culturali e politici. Istoreco si sente impegnato a promuovere iniziative nel prossimo futuro per valorizzare il lavoro di Renzo Bonazzi, una tra le personalità più stimate e ascoltate della città. 13 Per diversi anni, negli ultimi tempi, durante il periodo estivo, sulle spiagge familiari dei Lidi ferraresi, ci siamo trovati con Renzo e Marisa a passare le nostre giornate, un po’ pigramente, tra il mare cortese del Lido di Spina, le folle chiassose degli Estensi, i richiami più sapienti delle terre di Ravenna. L’amicizia di una vita con Alessandro Carri e la sua paziente consorte Mafalda era all’origine di queste occasioni, che permettevano a Renzo di coniugare la sua nota passione per il mare con i tempi più dilatati della lettura e della riflessione e con belle serate di buona cucina. Ho potuto conoscere così, ancora più da vicino, una persona, prima ancora che un uomo politico, che non si stancava mai di informarsi, di esprimere le proprie idee, di confrontarsi anche con le posizioni più lontane. Senza dubbio mosso da profonde proprie convinzioni, Renzo ha mantenuto un rapporto sempre fermo con il partito popolare di massa, anche dopo le traversie seguite alla fine del pci. Comprendeva certe debolezze degli ultimi passaggi, ma rifuggiva da ogni tentativo di separazione da una storia che voleva vivere fino in fondo. Ripercorrere l’esperienza politica e amministrativa di Renzo Bonazzi sarà un impegno a cui la ricerca dei prossimi anni non potrà certo sottrarsi. In questa sede mi piacerebbe segnalare un passaggio di questo lungo itinerario, che ritengo abbia avuto un significato particolare in un uomo politico che, sin dai primi anni Cinquanta, è chiamato a svolgere un’importante funzione pubblica. Mi riferisco alla stagione dei nuovi movimenti, dal ’68 ai primi anni Settanta, caratterizzata da una profonda ansia di cambiamento che attraversa la società, le culture, le istituzioni. Com’è noto, proprio Bonazzi finirà per rappresentare simbolicamente la speranza di un rinnovamento, facendo di Reggio un centro di straordinaria vitalità, ben presto oggetto di interesse nazionale e internazionale. Una stagione felice, sia pure tra tante contraddizioni, che consentì alla nostra città di scoprirsi capace di investimenti sul futuro e di uscire da una dimensione un po’ angusta di piccola provincia. Lo stesso Bonazzi ne ha parlato in un suo preziosissimo saggio realizzato per l’Istituto Banfi1 e ora quegli anni hanno trovato un primo pregevole inquadramento storico, pur con qualche imprecisione e incompletezza, in un recente lavoro di Antonio Tricomi2. R. Bonazzi, Le iniziative degli Enti locali a Reggio Emilia negli anni Sessanta e la nascita dell’Istituto Banfi, in Istituto Antonio Banfi, Annali 2, 1988. 2 A. Tricomi, Cultura e politiche culturali a Reggio e in Emilia, L. Baldissara (a cura di), Tempi di conflitti, tempi di crisi. Contesti e pratiche del conflitto sociale a Reggio Emilia nei «lunghi anni settanta», l’Ancora, Napoli-Roma 2008. 1 14 Nelle tante conversazioni estive non di rado tornavamo a parlare di quegli anni e di ciò che avevano lasciato in noi. Quanto contasse questo riferimento culturale e politico l’ho potuto constatare anche nel corso di una lunga intervista che ho avuto la possibilità di realizzare con Renzo, in preparazione di una pubblicazione sui sindaci del dopoguerra, dal 1945 al 1976. Buona parte di quel dialogo, che si fece ben presto fitto ed intenso, è rintracciabile in quel testo, il cui carattere stringato e divulgativo tuttavia non ha consentito di riprendere integralmente quanto registrato3. Ecco perché, in segno di omaggio e di affettuoso ricordo, mi piace riportare in questa sede un brano di quella intervista, dedicato al ’68. Si tratta di rapidi pennellate, con le quali Renzo voleva trasmettermi certo qualcosa di più di semplici informazioni su una stagione irripetibile. Come se parlarne, in un caldo pomeriggio estivo lontano nel tempo, potesse comunque consentirci di respirare quel clima. E la tradizionale lucida razionalità dell’argomentare a volte complesso di Renzo, sembrava rivestirsi di una imprevista leggerezza. Intervista a Renzo Bonazzi Lido di Spina, agosto 2008 Come parleresti del ’68 a Reggio Emilia? Come presenteresti Reggio e le sue varie anime? Dovrei parlare in primo luogo di quanto avvenne nelle scuole, anche se in modo un po’ ritardato rispetto al contesto nazionale. Si cominciava davvero a respirare un’aria nuova, il cui segno distintivo mi sembrava la forte denuncia dell’autoritarismo in tutte le sue forme. L’educazione, la cultura più tradizionale, le diverse espressioni artistiche, la cultura scientifica: nulla sembrava sfuggire agli interrogativi che mettevano in crisi gli antichi paradigmi. Anche l’esperienza che prendeva forma nelle nostre scuole materne poteva in qualche modo risentire di quel clima. Così si aprirono nuovi spiragli per nuove esperienze. Non sapevamo bene forse la direzione su cui stavamo procedendo, ma sentivamo che tutto era finalmente in movimento. La mia impressione proprio su Reggio è che avvertivamo un fervore che aveva radici lontane e sofferte: le giornate del ’60. Dopo quella nuova «rivolta democratica», prevalentemente giovanile, con tutto ciò che seguì, finalmente 3 L. Capitani, Da Campioli a Bonazzi: la sfida del governo, l’avventura del cambiamento. Appunti per un nuovo racconto delle vicende politiche e amministrative del Comune di Reggio Emilia (1945-1976), in aa.vv., Sindaco una scelta di vita. Città e sindaci della provincia di Reggio Reggio Emilia dal 1945 al 1975, Progetto Editoriale Giuliana Lusuardi, Correggio 2009. 15 in noi si faceva largo un convincimento: la stagione dell’egemonia centrista poteva dirsi esaurita. Nuove generazioni si affacciavano all’impegno politico, nei movimenti giovanili, nelle proteste operaie, nelle sperimentazioni culturali. Si poteva guardare con più fiducia all’appuntamento di un consolidamento e di una qualificazione del nostro sistema democratico. Poi molte spinte vennero assorbite, altre si spensero, ma nulla fu uguale a prima. Vorresti citare qualche episodio memorabile? Mi piace ricordare il rapporto con gli studenti. Quando mi capitava, ed era già una grande novità, di parlare con loro della politica, della amministrazione, del ruolo centrale di un Comune, mi sembrava di vivere in un altro mondo rispetto a quello tradizionale dei Consigli comunali. Quando penso al ’68, penso soprattutto alle assemblee con i giovani, a Dario Fo che si diverte a provocare la cultura «alta», ma richiedendo una attenzione più profonda allo stesso gesto teatrale, al Living che si ferma a Reggio, scandalizzando i benpensanti, ma dimostrando nei fatti la vitalità di un teatro che si fa nel mondo reale, che diventa mondo reale, e ti interroga. Penso al pubblico che protesta anche per le tante sperimentazioni e a quello invece che in esse trova un nuovo alimento. Penso ai muri che cadono, alle celle reali e metaforiche che si aprono. Quando penso al ’68, penso alla domanda di libertà che in esso si esprimeva. E alle risposte non sempre adeguate della politica. Ma la città era divisa? Senza dubbio. Una città divisa nettamente in due. Da una parte un’anima resistente ad ogni minimo cambiamento, specie nelle relazioni sociali. L’espressione di questa anima era rappresentata dal più importante imprenditore reggiano, Achille Maramotti, con il quale il conflitto raggiunse toni aspri per la sua pervicacia nel non voler riconoscere il sindacato e il suo ruolo autonomo. Si arrivò addirittura alla presenza del Sindaco in fabbrica in appoggio ad alcune sacrosante richieste dei lavoratori sui metodi e i tempi del lavoro. Dall’altra un’anima sperimentale che, anche tra tante ingenuità, ci chiedeva di procedere con coraggio sulla strada intrapresa. Ricordo una grande cena con Rafael Alberti, che, sulla collina della Fola, ci invitava alla fantasia e alla creatività. Ci lasciò, tra gli altri ricordi, disegni di fiocchi di neve, nei quali si potevano leggere mille mondi diversi. Comunque, anche nei contrasti, Reggio era una città viva, tesa al cambiamento, desiderosa di misurarsi con il futuro. Forse c’era qualcosa in tutto questo che poteva assomigliare ad una forzatura «illuministica». Alcuni me lo hanno sempre rimproverato. Poche strade e troppa cultura, mi si diceva in qualche assemblea. Replicavo che non c’è miglior strada della ricerca e della cultura perché una comunità possa sentirsi vitale e non ripiegata su se stessa. 16 Quanto alla cultura e al ruolo del Comune? Dovrei parlarti in primo luogo di uomini, di persone che davvero ci hanno cambiato. Inutile ricordarti il ruolo di Loris Malaguzzi, che dimostrò la possibilità di lavorare per rinnovare i rapporti con l’infanzia, con una educazione libera e rispettosa dei mille linguaggi con cui entriamo in contatto sin dalle prime esperienze di vita. Penso a Campos Venuti e Piacentini in materia di pianificazione urbanistica. Penso a giovani intellettuali che cercammo con pazienza per dare volti nuovi e futuro dignitoso alle nostre più consolidate istituzioni, come Giancarlo Ambrosetti e Armando Gentilucci. Un investimento che si rivelò particolarmente felice, nonostante le tante diffidenze iniziali. Penso a personaggi straordinari nella poesia, nell’arte e nella musica, come Corrado Costa, come il suo amico Spatola, come Luigi Pestalozza, con il quale prese il via l’esperienza di Musica e Realtà. Indimenticabili i concerti di quelli che diventeranno i protagonisti assoluti della musica italiana, come Claudio Abbado o Maurizio Pollini, nei quartieri, nelle fabbriche, nei teatri aperti a un nuovo pubblico. Penso alla sfida di affidare la direzione del teatro pubblico ad una persona determinata ma lontana dai tradizionali circoli intellettuali, come Guido Zannoni. E fu il decollo del Municipale. Una felice congiuntura: persone diverse, ma spinte da un non comune dinamismo e capaci di rovesciare in un attimo, in improvvise accelerazioni, le più pigre consuetudini. Non sono mancate incomprensioni, ma la città cresceva. Grazie alle nuove e alle «antiche generazioni», quelle che non temevano di sbagliare. Chi dovrà occuparsi di quegli anni a queste persone, come a molte altre che qui non ho il tempo di ricordare, dovrà dedicare attenzione e rispetto. 17 Michael Lees, Special operation executed Nel paradiso dei folli, un ufficiale di Sua Maestà sulle montagne reggiane con un’intervista a Osvaldo Salvarani Aldo a cura di Massimo Storchi Introduzione Nel 1986 usciva presso l’editore William Kimber il volume Special operation executed di Michael Lees, in cui l’autore, già ufficiale in servizio presso il soe (Special operation executive) raccontava la propria esperienza di ufficiale di collegamento presso le formazioni partigiane prima in Serbia e poi in Italia (Piemonte ed Emilia) fra il 1943 e il 1945. Un’autobiografia di grande interesse non solo per il punto di vista del narratore (un ufficiale incaricato di operare in contesti di lotta «irregolare») ma anche, e soprattutto, per il ruolo che il capitano Lees ebbe nelle vicende della Resistenza reggiana dal dicembre 1944 alla fine di marzo del 1945. La sua esperienza con la Divisione «Reggiani» (come Lees denomina le formazioni reggiane sull’Appennino), si snoda fra il difficile inverno 1944-1945 quando, dopo il proclama Alexander, le Brigate si trovarono ad affrontare le necessità non solo della lotta armata ma anche, e soprattutto, quelle della sopravvivenza in condizioni invernale di grande difficoltà, e l’attacco a Villa Rossi del 27 marzo 1945 che Lees pianificò e condusse di persona (rimanendo gravemente ferito nello scontro). La scelta di non smobilitare né di trasferire uomini oltre le linee in attesa dell’offensiva primaverile fu una decisione che, seppur condivisa all’interno del Comando unico e del CLN, rappresentò certamente una sfida davvero impegnativa nel contesto di quei mesi. Solo grazie all’appoggio delle popolazioni montanare e all’organizzazione logistica (che fu in grado di trasferire dalla pianura alla montagna ingenti quantità di generi alimentari) fu possibile non solo sopravvivere ma mantenere attiva – e migliorare – la capacità offensiva delle formazioni partigiane. 18 La narrazione di Lees non riconosce la realtà di quei mesi difficili e applica gli schemi militari maturati nell’esperienza precedente in Serbia, a fianco delle formazioni cetniche del generale Mihailovič, alla realtà reggiana giudicata, con ben poca generosità, simile al «paradiso dei folli». Come spesso accade nelle narrazioni autobiografiche la tendenza dell’autore è quella di un marcato egocentrismo e in più tratti del racconto il protagonismo dell’ufficiale britannico sembra oscurare ogni altra figura di comando. Anche per questo è parso opportuno pubblicare nella medesima occasione l’intervista, realizzata dal curatore nel 1996, a Osvaldo Salvarani Aldo, Capo di stato maggiore del Comando unico, che puntualizza e sottolinea alcune debolezze e imprecisioni dei ricordi del capitano britannico. Va comunque ricordato come il libro, che ancora attende una traduzione integrale in italiano, sia dedicato al caporale Bert Farrimond, telegrafista di fiducia di Lees e a «quei tanti italiani nelle fila della resistenza e a quei civili ai quali devo la mia fuga e la mia vita». In questa prima parte si pubblicano i primi due capitoli dedicati all’attività di Lees nel reggiano (capitolo 15-Arrival in Emilia: Fool’s Paradise e capitolo 16-Reggiani regroup) al prossimo numero di «rs» i rimanenti due capitoli (capitolo 17-Sizing up Botteghe/Albinea e capitolo 18-The grand Finale). «Lees io l’ho conosciuto bene ed era un tipo…» Intervista a Osvaldo Salvarani Aldo (Montecavolo, 28 agosto 1996) Che giudizio dà del testo del capitano Lees? L’ho letto con grande interesse e spero che presto possa essere tradotto in italiano, magari con delle note e delle osservazioni. Ma il racconto di Lees rispecchia la situazione della Resistenza reggiana nell’inverno 1944-1945? Mi sembra che Lees pecchi un po’ di protagonismo e certi suoi giudizi, ad esempio quello su Monti [Augusto Berti], siano poco simpatici, il suo è un punto di vista, oltretutto, che è stato ricostruito dopo molto tempo, così ricorda certe cose e ne dimentica molte altre. Monti era un buon ufficiale, molto disponibile e serio. Lees io l’ho conosciuto bene ed era un tipo… del resto per essere nei soe non si poteva essere dei militari qualunque, anche se la mentalità del militare di professione si vede bene, e si vedeva anche allora… Un esempio? Non dico fosse tutto sbagliato però si doveva rendere conto della situazione che era molto difficile, lui ci descrive come se fossimo quasi in vacanza, 19 ma basta vedere le perdite, i morti che abbiamo avuto per capire che le cose erano diverse. Basta leggere i diari delle Brigate per sapere che la nostra attività era continua. Mi ha dato proprio fastidio come lui descrive la ritirata di fronte al grande rastrellamento invernale: per essere un esercito di volontari quello che abbiamo fatto è stato anche troppo, ci siamo ritirati e non sbandati e quasi senza perdite (e lui questo almeno lo ricorda). Quattordici caduti davanti a migliaia di tedeschi all’attacco. Ci eravamo preparati e abbiamo messo in pratica i nostri piani. Abbiamo tenuto i tedeschi in movimento per dieci giorni senza che riuscissero mai a prenderci. Avevamo imparato la lezione dell’estate quando davvero eravamo impreparati e l’attacco tedesco ci aveva davvero messo a terra. Ci siamo mossi in condizioni terribili, la neve era alta anche un metro e mezzo, siamo riusciti a tenere gran parte delle armi, i garibaldini poi erano poco equipaggiati per l’inverno, tante armi era bloccate dal gelo e abbiamo avuto un bel po’ di congelati, altro che buoni scarponi! Del resto in altri passaggi Lees si contraddice, visto che ricorda come i garibaldini fossero piuttosto scalcinati come equipaggiamento. Per me quella ritirata è stata un successo, tanto che poi siamo tornati sulle nostre posizioni in un paio di settimane. Non si può dimenticare che i partigiani sapevano cosa fare e, nei limiti di una guerra irregolare, siamo riusciti a farlo. Sembra che Lees se ne scordi, una cosa strana perché ricordo che, subito dopo, si complimentò con noi. Comunque basta leggere la ricostruzione precisa che fa Franzini di quei giorni per capire come sono andate davvero le cose. E la questione dei lanci? I materiali com’erano distribuiti? Lees è stato onesto e riconosce che c’erano stati dei problemi, lui poi capisce che era importante che tutti i partigiani fossero equipaggiati bene, questo ci ha fatto risparmiare tante discussioni e tante liti che c’erano state, quando invece l’ufficiale che c’era prima aveva fatto delle scelte diverse. E sa, per noi gli inglesi, gli alleati, erano fondamentali, non potevano rompere con loro. E poi Lees dimentica una cosa fondamentale, quello che era successo in novembre, il proclama Alexander... Quando vi aveva invitato a tornare a casa d’inverno… Si figuri! Tornare a casa! In altre zone hanno fatto passare il fronte per diminuire gli effettivi, dare due pasti al giorno non era una cosa facile con l’inverno alle porte. Noi invece abbiamo deciso di rimanere lì, tutti d’accordo, Marconi è stato subito deciso e con lui anche Miro e Carlo. I montanari sono stati bravissimi e poi siamo riusciti a far arrivare la roba dalla pianura, abbiamo fatto uno sforzo incredibile. Ma cosa potevamo fare, andare a casa? Non eravamo in vacanza… 20 Ma non sembra, secondo Lees, che aveste problemi di vitto… Mi sono arrabbiato quando ho letto la storia del suo pranzo, quando è arrivato! Me lo ricordo bene quel pranzo, quasi abbiamo digiunato per fare bella figura, per far vedere che lo accoglievamo bene, e lui ha pensato che fossimo nell’abbondanza, gli abbiamo offerto anche il Sassolino che poi gli è piaciuto tanto! Del resto la sua prima impressione è che fossimo dei selvaggi… Racconta il suo arrivo con molto humour inglese, i partigiani come selvaggi intorno al pentolone… Questa cosa poi di inventarsi la Divisione «Reggiani»… mah, forse lui aveva capito così e poi fa anche un po’ di confusione con la nostra organizzazione, quando lui arriva la 145ª Brigata ancora non c’era, l’abbiamo fatta noi dopo per difendere la centrale di Ligonchio, la mia impressione è che lui sia arrivato senza ordini precisi e abbia un po’... improvvisato, poi ha trovato il suo obiettivo e le cose sono andate meglio… Ma avete avuto scontri? Contrasti? No, scontri proprio no, Lees era un tipo… Wilcockson era più duro e settario, Lees era più un uomo d’azione, gli piaceva lo scontro, le questioni politiche gli erano estranee. Fece delle ottime cose organizzando la squadra di Gordon [Glauco Monducci], i «Gufi neri» e preparando l’attacco di Villa Rossi, però non è che fece tutto da solo… A Villa Rossi c’erano anche i nostri garibaldini e i russi perché avevamo capito subito che era un’operazione importante, per questo scegliemmo gli uomini migliori e lasciammo le sap solo in funzione di appoggio. A lui interessava l’attacco, noi avevamo la preoccupazione delle conseguenze, la zona era abitata, anche per questo mandammo i nostri uomini migliori, ricordo sempre Gianni Farri fra gli altri, e in divisa… Posso chiederle una cosa personale? Come mai lei non è mai citato da Lees, eppure lei era il Capo di stato maggiore… Mah, forse avrà pensato che non fossi importante… L’attacco di Botteghe fu un successo anche se proprio Lees fu ferito… Certo la cosa fu un successo ma la ritirata riuscì bene proprio perché c’eravamo noi ad avere organizzato utilizzando gap e sap, Lees e Gordon feriti attraversarono il territorio occupato e furono messi in salvo... Comunque lei è d’accordo con la pubblicazione dei capitoli tratti dal libro di Lees? Assolutamente, però sarebbe bene pubblicare insieme anche i nostri documenti, per chiarire bene come andarono le cose. 21 Secchio, 1945 – Da sinistra, il maggiore Wilcockson, il capitano Lees, il caporale Bert Farrimond e Carlo (don Domenico Orlandini) comandante delle Fiamme Verdi 22 Michael Lees (1921-1993) Nato da famiglia con tradizioni militari fu educato nel collegio cattolico di Ampleforth. Allo scoppio della guerra, dopo un periodo nel Dorset Yeomanry fu inviato in India nella Brigata paracadutisti, da qui trasferito in Egitto per essere destinato a tornare poi in Gran Bretagna agli inizi 1943. Cercando l’azione a tutti i costi entrò nel soe1 (Special operation executive) al Cairo. Nell’agosto 1944 sposò Gwendolen Johnson. Nel corso della sua attività come ufficiale nel soe operò in Serbia, dove collaborò per sette mesi con i Cetnici, e poi in Piemonte per tornare in Italia alla fine del dicembre 1944 dove rimase con le formazioni partigiane reggiane fino al suo ferimento nell’attacco di Villa Rossi del 27 marzo 1945 (Operazione Tombola). Tornato alla vita civile nel 1950 venne assunto da un gruppo internazionale (con interessi in Argentina e Africa Orientale) come dirigente. Nel 1971 le ferite di guerra lo costrinsero a ritirarsi in Irlanda dove divenne allevatore e coltivatore e dove viveva parte dell’anno (mantenendo la sua casa nel Dorset) fino alla sua morte. Nel 1949 ha ricevuto la Cittadinanza onoraria di Reggio Emilia e nel 1985, Il soe ebbe origine da una serie di organismi creati dal mi6 (il servizio segreto britannico) immediatamente prima dello scoppio del conflitto, destinati alla propaganda in territorio nemico e a svolgere azioni «coperte». Dopo l’inizio del conflitto il soe agì in rapporto con il Comando supremo britannico per azioni di commando in territorio nemico, mentre ebbe rapporti più difficili con il Foreign office (ministero degli Esteri) e con il mi6. In continua evoluzione organizzativa nel corso del conflitto, arrivando ad essere organizzato in quindici sezioni operative (per ognuno dei paesi in cui operava) la sede del Comando fu a Londra in Baker Street 64 (da qui il soprannome di «gli irregolari di Baker Street») con diversi comandi locali (quello del Cairo si occupava dei Balcani, quello di Algeri della Francia meridionale). Il Comando del Cairo divenne dalla metà del 1944 responsabile di tutto il settore Mediterraneo. Altri Comandi locali erano a Ceylon e persino negli usa per collaborare con fbi e oss. Alla fine del 1943 il soe stabilì una sua base a Bari per l’attività nei Balcani, utilizzando l’aeroporto di Brindisi come base operativa sia per le azioni verso Balcani e Polonia che per quelle sull’Italia occupata. Il personale del soe era composto da militari regolari britannici (ma anche canadesi), da militari dei paesi occupati sfuggiti ai nazisti e da collaboratori reclutati «in loco» indispensabili per la loro conoscenza del terreno. Dopo la fine della guerra, nonostante la disponibilità di una rete diffusa utilizzabile in funzione antisovietica, il governo Attlee decise lo scioglimento del soe che avvenne, ufficialmente, il 15 gennaio 1946. Gran parte del personale tornò alle sue precedenti attività civili mentre una parte di agenti «operativi» passò alle dipendenze del mi6. 1 Bibliografia M.R.D. Foot, The Special Operations Executive 1940-1946, Pimlico 1999. W. Mackenzie, The Secret History of SOE, Special Operations Executive 1940-1945, bpr Publications 2000. 23 insieme a Roy Farran, quella di Albinea. Nel 1985 fu chiamato a far parte come membro onorario del sas2 Regimental association. Capitolo 15 L’arrivo in Emilia: il Paradiso dei folli3 Era il dicembre 1944. Dopo poche settimane passate a casa, ricevetti ordini di rivolgermi a un certo recapito di Londra dove, così mi fu detto, avrei ricevuto altre informazioni. Dopo aver vagato attraverso un labirinto di corridoi senza trovare nessuno che sapesse qualcosa di me o del mio futuro, arrivai nell’ufficio di un colonnello dall’aspetto campagnolo che aveva firmato la mia lettera di richiamo. Mi offrì una scatola di sigarette piuttosto costose e mi sorrise dietro a un voluminoso pacco di documenti che riconobbi essere il mio dossier personale. «Deve tornare subito in Italia – disse – non so perché ma hanno chiesto il suo rientro immediato». «Per una missione, Sir?». «Credo proprio di sì», rispose mentre sorridendo si alzò per aprirmi la porta. Mi presentai al mio Quartier generale in Italia alla vigilia di Natale. Erano tutti presi dalle festività e nessuno sembrava particolarmente interessato a me, ma alla fine riuscii a cavar fuori l’informazione che non sarei dovuto partire prima di una settimana e che nel frattempo potevo starmene in un campo sosta dove avrei potuto incontrare altri membri della mia futura squadra. Il campo era vicino a Brindisi. Girammo per un bel po’ per strade sterrate fino ad arrivare a una fattoria circondata di pioppi. Appena il camion ci scaricò in cortile un tizio che se ne stava tutto tranquillo all’ombra si fece avanti per vedere chi fosse arrivato. Riconobbi subito Farrimond. Aveva una storia interessante da raccontare. Mi spiegò che pochi giorni dopo che li avevo lasciati a Pino, Temple aveva organizzato un grande attacco su Alba, una città seconda solo a Torino per importanza in quella zona e 2 sas (Special air services). Il principale corpo di Forze speciali, attivo ancora oggi nell’esercito britannico, nacque nel 1941 quando volontari britannici condussero attacchi dietro le linee nella Campagna del nord-Africa. Fino alla fine della guerra i sas condussero operazioni in tutta l’Europa occupata. Dopo la guerra i membri del sas sono stati impiegati in varie parti del mondo dalla Malaysia (1951) all’Irlanda del Nord, fino all’intervento a Londra nel 1980 contro l’ambasciata iraniana quando liberarono 26 ostaggi catturati da terroristi. Negli ultimi anni i sas hanno operato nella ex-Jugoslavia a caccia di criminali di guerra in Bosnia e come supporto agli attacchi aerei nato nel Kosovo, in Iraq e Afghanistan. Attualmente i sas sono organizzati su tre reggimenti. Il motto del corpo è «Who dares Wins» (Chi osa vince). 3 Traduzione a cura di Massimo Storchi. 24 un centro di filofascisti. L’attacco aveva avuto successo e Alba era stata presa. Infuriato dalla sfrontatezza di questa azione, il nemico aveva radunato grosse forze e, usando tanks e divisioni da montagna, aveva spinto i partigiani sulle colline intorno Marsiglia. Poi, attaccando anche da sud, aveva tagliato ai partigiani la via di ritirata verso le montagne. Durante questo attacco Temple era stato ucciso. Farrimond era stato fortunato, si era nascosto e il campo di aviazione era stato completato prima dell’offensiva e, su sua richiesta, un aereo era stato inviato a raccoglierlo poche ore prime che il nemico prendesse l’aeroporto. Gli chiesi cosa cosa avesse fatto dal suo ritorno. «Sto aspettando ordini, sir». «Vuoi tornare al nord?», gli chiesi. Ci pensò un attimo: «Dipende da cosa devo fare». Il mio operatore radio era già stato designato ma potevo sempre far cambiare tale incarico. Conoscevo Farrimond come un buon operatore e un tipo affidabile. Per me era meglio scegliere qualcuno che conoscevo e di cui potessi fidarmi. «Vuoi venire con me, Bert?». Tacque per un momento. «Verrò con lei, sir, se devo andare con qualcuno, ma è un po’ che non sono in missione. Quando si parte?». «Fra una settimana, più o meno. Non voglio una risposta subito, pensaci e fammelo sapere domani». Farrimond venne da me quella stessa sera e mi disse che accettava la mia offerta. Natale passò come un giorno qualsiasi. Con tante cose cui pensare la festa sembrava inutile e fui felice quando le festività finirono e potei trovare qualcuno con cui iniziare a discutere della missione. Eravamo destinati a rilevare la Missione che era stata attiva per sei mesi e che necessitava di un periodo di riposo. Aveva operato sulle montagna a ovest di Bologna solo poche miglia dietro il fronte. Dovevamo essere paracadutati di giorno su un obiettivo qualche miglia a est, dove un ufficiale che era lì già da qualche mese ci avrebbe fornito di guide per raggiungere la nostra destinazione. Dovevo organizzare e rifornire una formazione partigiana nota come Divisione Reggiani. Dovevamo organizzare sabotaggi, soprattutto lungo le strade vicine al fronte, fornire informazioni sulla linea del fronte e preparare e organizzare i partigiani in vista dell’offensiva di primavera. Mi piaceva molto questo incarico. Operando vicino al fronte saremmo stati sempre in azione e avremmo dovuto lavorare a stretto contatto con le truppe alleate. Una base avanzata per rifornimenti aerei era stata dislocata nei pressi di Firenze. Questo ci avrebbe garantito rifornimenti adeguati e, se fosse stato necessario svolgere lanci in pieno giorno, le truppe partigiane erano in numero considerevole per non correre troppi rischi. Uno sguardo alla mappa mi confermò che quelle montagne erano alte e ripide – ideale per una tattica di guerriglia – e da parecchi punti di vista le 25 possibilità sembravano davvero buone. Poiché sapevo poche parole di italiano, mi fu dato un interprete, un giovane italo-canadese che si chiamava Lizza. Dopo qualche giorno passato a raccogliere il nostro materiale e provare le attrezzature radio, partimmo in volo per la nostra base presso Firenze. Eravamo in lista per essere lanciati il giorno seguente ed ero molto preso ad imparare tutte le istruzioni del comando che avrebbe seguito la nostra missione sia per i rifornimenti che per i collegamenti. Mi incontrai con l’ufficiale incaricato di seguire la nostra missione e con piacere scoprii che anche lui aveva svolto missioni operative dello stesso tipo prima di venir inchiodato dietro a una scrivania. Speravo che questa esperienza gli avrebbe dato una visione realistica dei nostri problemi e, nonostante le sue maniere troppo educate e la stretta di mano umida e flaccida, avrebbe capito tutto e ci sarebbe stato di grande aiuto. L’uomo «sul campo» biasima sempre un po’ quelli che rimangono alla base, spesso ingiustamente e ogni volta recrimina di essere stato abbandonato. Questo si capisce facilmente, perché vive in un suo piccolo mondo, coi suoi problemi urgenti che mettono tutto il resto in secondo piano. Spesso si trova in situazioni scomode e pericolose e ha molto tempo per far ingrandire le lamentele. D’altra parte, l’uomo «alla base» molto spesso diventa troppo vincolato alle regole burocratiche e così relega in secondo piano le domande di rifornimento e materiali, giudicate come reazioni isteriche di chi si trova in situazioni meno comode della sua. Gli agenti in territorio nemico troppo spesso sono considerati solo come puntini sulla carta geografica e come pedine da usare per soddisfare le ambizioni personali. Ci svegliarono alla cinque. Il cielo era velato e un vento gelato soffiava da nord. Ero grato alla mia calda tuta da volo mentre andavamo verso l’aeroporto. I nostri materiali erano stati imballati e caricati la notte precedente. Avremmo volato su un Dakota, insieme ad altri due aerei uguali che portavano altro materiale allo stesso obiettivo. Salendo sull’aereo pensai com’era diversa quella partenza dalle altre volte. A Brindisi e nel deserto c’era sempre stata un’atmosfera drammatica, una strana tensione che ci prendeva. In un modo fatalistico lo spalancarsi del portello dell’Halifax era stato simbolico, come un passaggio verso un altro mondo. Ma oggi, seduto comodamente in un seggiolino di volo, guardando attraverso il finestrino al forte riverbero del sole sulla pista, mi sentii come se stessi partendo per una vacanza per passare la mattinata. Senza tensione o eccitazione, pensavo solo a cose di nessun conto. In volo, arrivando sul mare, attraversammo di nuovo la costa a sud di La Spezia. Lampi intermittenti da una collina sopra la città, rivelava la posizione di una batteria antiaerea leggera che scaricava inutilmente contro di noi i suoi colpi. In perfetta formazione e senza cambiar rotta, navigavamo tranquillamente verso le montagne. Due Mustang dei quattro della nostra scorta che ci avevano accompagnato ruppero la formazione e scesero a colpire le batterie, 26 facendoli pentire dell’iniziative avventata. Sotto di noi, a destra, sbuffi bianchi di fumo segnavano i colpi sopra alle cime dei monti. Volavamo a zigzag, per provare il percorso e per seguire l’andamento del suolo. Spesso la neve copriva le cime più alte, centinaia di piedi più alte dell’aereo, finché attraversammo la cresta più alta e potemmo vedere chiaramente in distanza la grande pianura e il fiume Po. D’improvviso una voce gridò «ci siamo!» e guardando attraverso il portellone vidi una serie di punti rossi sul terreno innevato sotto a noi. Mentre la scorta girava in cerchio sopra di noi, i Dakota affondarono verso il basso in strette virate e in formazione «in linea». I punti rossi aumentavano, finché si rivelarono come paracadute stesi sul terreno, col foro centrale che mostrava la neve. Altre piccole figure divennero uomini che correvano intorno alla zona di lancio o stavano fermi facendo segni verso di noi. Appena l’equipaggio fissò le cinghie di sicurezza e sistemò i pacchi lungo il portellone, controllai il mio paracadute e sistemai la borsa legata alla gamba. Questa borsa pesava circa sessanta libbre [28 chilogrammi] (e conteneva tutti i miei effetti personali), aveva un sistema di sgancio veloce se avessi dovuto lasciarla andare legata a un cavo di una decina di metri dalla mia cintola appena il paracadute si fosse aperto. Facemmo tre passaggi per lanciare il materiale. L’equipaggio lavorò duro per allineare i pacchi vicino al portellone così che con uno spintone precipitò tutto l’intero carico nell’esatto momento in cui passavamo sul terreno sottostante. Quando tutto il materiale fu sganciato, muovendomi goffamente per il peso del materiale legato alla gamba, mi misi davanti al portellone con Farrimond e Lizza proprio dietro. Tenendomi alle cinghie del cavo che univa il paracadute all’aereo, controllai bene il perno per assicurarmi che fosse proprio fissato bene. Il pavimento sobbalzò appena l’aereo virò, riassestandosi lentamente. Poi quell’inconfondibile suono come il battito d’ali di un piccione che si posa mi avvisò che i motori stavano calando e la luce rossa lampeggiava sulla parete. Il rosso passò al verde. Spingendomi con entrambe le mani mi slanciai con la gambe fuori facendo una capriola indietro appena la coda dell’aereo mi passò come un lampo sulla testa. Il paracadute si aprì con uno strappo tirando indietro la mia testa così che potei vedere la seta soffice spiegarsi come crema. Era un materiale eccezionale e mi feci una nota mentale che dovevo tenerne da parte un pezzo per farci un foulard per Gwen. Mi piegai sulle ginocchia e sganciai il pacco lentamente cosicché non potesse scivolar via. Sentii una voce dall’alto: «Stai cercando di prendere un...» ma non capii il resto, con il peso in più della borsa, scendevo più velocemente degli altri. La terra si stava avvicinando in fretta. Sfilai con la mano il gancio e lo tirai con forza verso la spalla. Un gruppo di uomini a terra, gesticolando e saltando quà e là intorno a un paracadute rosso come cannibali intorno al pentolone, si sparpagliarono su un lato e sentii il grido da sopra appena il mio pacco 27 urtò terra. Appena mollai le cinghie i miei piedi urtarono i rami di un albero e traballando caddi a terra. Stavo nel greto di un ruscello circa venti yarde dal piccolo campo dove erano stati messi i segnali. Bert e Lizza erano caduti sugli alberi ma con l’aiuto dei partigiani riuscimmo a tirarli giù senza danni. Seppi subito che la missione inglese era in un villaggio che potevamo vedere in lontananza a circa mezzo miglio. Un partigiano in divisa, con i gradi di tenente dell’esercito italiano, si offrì di accompagnarci. Eravamo sul lato meridionale di una larga vallata che scendeva verso il fiume. Rumori di spari segnalavano la zona del fronte oltre il versante lontano dei monti a sud. C’era poca neve intorno e i sentieri che percorrevamo erano pieni di fango. Nella vallata c’erano villaggi popolosi e case di contadini scure qua e là sui versanti. Il sentiero verso il villaggio era percorso da contadini coi loro muli che si dirigevano verso la zona del lancio. Subito dopo una svolta del sentiero ci venne incontro un tizio alto. Aveva occhiali spessi e portava un «tommy gun»4 era, ovviamente, inglese. «Come va – ci chiamò – sono Wilcockson. Mi dispiace che non ci fosse nessuno ad accogliervi ma nessuno ci ha detto che dovevate arrivare con il lancio». Rimasi sorpreso nel sapere che la base non li aveva informati e spiegai chi eravamo e quali erano i nostri compiti. Wilcockson diede ordine di raccogliere i nostri materiali e ci accompagnò al suo comando. Wilcockson stava a Gova, un paesino di soli duecento abitanti. In tempo di pace era stata un località turistica per gli sport invernali e poteva vantare due alberghi che ora erano usati come quartier generale della missione e dei partigiani. Appena vidi la comoda stanza, il letto morbido e il bagno pensai che se anche la mia zona era come quella di Wilcockson quella guerriglia partigiana sarebbe stata proprio una pacchia! Bert era entusiasta da poter lavorare con la corrente elettrica che del resto serviva quasi tutti i villaggi intorno. Informai Wilcockson delle ultime novità del comando ed egli ci spiegò la situazione locale. Il suo compito era di ufficiale di collegamento con un reparto partigiano chiamati i «Modenesi» che controllavano il territorio a sud della città di Modena. La Divisione «Reggiani», con cui dovevo operare io, era affiancata a quella e prendeva il nome dalla città di Reggio circa una sessantina di chilometri a nord-ovest di Bologna. Fui lieto di sapere che il comando dei «Reggiani» era a sole cinque ore di marcia da Gova, così che potevo arrivarci in meno di una giornata di cammino. «E dove sono le truppe nemiche più vicine?» chiesi. «La pianura ne è piena, naturalmente – mi rispose – ci sono anche dei presidi lungo la strada statale. Quello più vicino è a un paio di ore di marcia da qui». 4 Nomignolo attribuito al fucile mitragliatore Thompson. 28 Erano troppo vicini per pensare a dei lanci di giorno. «Ma allora sanno certamente le posizioni partigiane e dei lanci di armi e materiali. Mi meraviglio che se ne stiano buoni senza far niente». In risposta Wilcockson tirò fuori la mappa per farmi vedere che i presidi erano così dispersi che non sarebbero riusciti a concentrarsi in nessuna località a meno di tre ore di cammino. «Non preoccuparti del nemico, ogni tanto mandano qualche pattuglia della Brigata nera ma i partigiani li fanno scappare ogni volta e loro non hanno abbastanza truppe per un attacco in grande. Non abbiamo avuto guai per mesi». Avevo già sentito simili parole ma ero l’ultimo arrivato e non replicai. «Bene, cerca di far star sveglie le tue pattuglie stanotte, sono allergico ai tedeschi e ogni volta che arrivo io sembra che in giornata arrivino sempre a far guai!». Facemmo i nostri piani dopo un eccellente pranzo. Decisi di visitare la mattina dopo il comando della Divisione «Reggiani» per stabilire il nostro comando, lasciando per il momento Farrimond a Gova a collaudare le sue attrezzature radio. Una volta stabiliti i contatti radio con il comando mi avrebbe raggiunto. Non ero eccessivamente impressionato dai partigiani che avevo visto sul campo di lancio e attorno al villaggio. Trasandati in apparenza, pochi sembravano avere il fisico del ruolo come quelli che avevo incontrato nell’Italia del nord. D’altra parte erano numerosi e ben armati e se erano sopravissuti tanto tempo su quei monti dovevano essere almeno ben organizzati. Mi chiedevo quando sarebbe finito il bel tempo. Con poca neve sul terreno potevano essere abbastanza mobili. Il problema sarebbe venuto con la neve alta. Wilcockson mi spiegò che la Divisione «Reggiani» era formata da quattro Brigate: tre comuniste e una dell’ala destra dei democratico-cristiani, un gruppo chiamato «Fiamme Verdi». Mi sembrava una strana combinazione, ma lo scontro politico da quelle parti era abbastanza fiacco e sembrava che in pratica tutto funzionasse a dovere. Il comandante era un ex colonnello dell’esercito che si faceva chiamare Monti [Augusto Berti]. Wilcockson lo giudicava una persona piacevole ma piuttosto facilona. Ad affiancarlo al comando per controllare le brigate comuniste c’era Eros [Didimo Ferrari], un commissario politico. Fui sbalordito nel sentire che Monti poteva contare su un comando di oltre cinquanta persone per gestire una Divisione con duemila unità di effettivo; sembrava piuttosto maldestro e inutile un comando simile per una formazione di guerriglia. Quella notte a Gova, nel mio hotel, ripensavo alla situazione certo non facile in cui ero capitato: eravamo circondati da nemici. Il lancio era stato così perfetto e comodo e ora ce ne stavamo ad ascoltare le novità bevendo dell’ottimo vino del luogo, che Wilcockson aveva accumulato in una cantina ben fornita. Un cameriere in giacca scura e grembiule bianco apparecchiava per cena, mentre parlavamo di questioni ben lontane dalla situazione attuale. 29 Mentre raccontavo a Wilcockson della mia partenza dall’Inghilterra, Bert era impegnato in un’accanita discussione con l’altro operatore su questioni di football e Lizza chiacchierava in italiano con l’altro interprete. La cena che fu servita dalla cameriera fu eccellente: spaghetti serviti con vino e formaggio grattugiato, carne di manzo, una frittata fatta con vero burro. Il Marsala, che aveva preceduto la cena, fu seguito da un brillante vino rosso e, per finire, aprimmo una bottiglia di Sassolina (sic) della cantina di Wilcockson. È un liquore forte di anice, fatto a Sassuolo, una cittadina lì vicino. Tolti i piatti, benedicemmo la fortuna che ci aveva condotti in quel paese dell’abbondanza dove potevamo farci un pranzetto migliore che in qualunque altro luogo dei territori già liberati. Quando mi svegliai e aprii la finestra, vidi che le mie previsioni erano giuste: l’inverno s’era preso la sua rivincita. Folate furiose di neve battevano contro le persiane e formavano croste ghiacciate, nascondendo alla vista anche le case più vicine. Mi vestii ben pesante e scesi per vedere cosa si poteva fare. La porta principale dell’albergo era bloccata e cercai un’altra uscita, con la neve e il ghiaccio che mi battevano in faccia capii che non era una bufera passeggera ma una tormenta che poteva durare giorni. La neve era già alta quasi un metro e qualche capanna era già nascosta dai cumuli che il vento ammucchiava contro. Ogni movimento era impossibile e Wilcockson, suggerì di rinviare il mio giro dai «Reggiani». Ero impaziente e dopo aver atteso fino alle dieci per vedere se la bufera fosse calata, partii con una guida. Lottammo per circa mezz’ora, dandoci il cambio per far la traccia sul sentiero, affondando fino alle cosce nella neve polverosa. Alla fine, dopo aver passato i primi rilievi, la guida mi disse che non sapeva più continuare e, non senza rabbia, mi resi conto che dovevamo tornare indietro prima che anche le nostre tracce scomparissero. Quando arrivammo all’hotel i nostri abiti erano inzuppati e ghiacciati da sembrare pezzi rigidi di cartone. Passammo il resto della giornata seduti davanti al fuoco. Nessuna pattuglia uscì, nessuna staffetta arrivava, ma era chiaro che nessuno con quel tempaccio avrebbe potuto far niente altro. Farrimond aveva preso contatto con il Comando, seduto ben comodo con le radio sul tavolo, era di ottimo umore e ripeteva che quello era il tipo di lavoro adatto a lui. Ero d’accordo anch’io ma dubitavo che sarebbe continuato molto, una volta che avesse smesso di nevicare. La mattina dopo il sole filtrava attraverso la finestra ancora chiusa. Il cielo limpido sul bianco accecante della neve fresca era uno spettacolo magico. Mi vestii in fretta, feci un’enorme colazione con uova e pancetta e presi la mia roba pronto a partire. Eravamo fortunati perché dei contadini avevano già aperto il sentiero ma, anche camminando sulle loro tracce, si faceva una bella fatica ed ero in difficoltà a dovere tenere un passo troppo corto per i miei gusti. Ci fermammo solo una volta ma ci volle quasi tutta la giornata per 30 arrivare al Comando del colonnello Monti a Febbio. Questo era un villaggio molto più in alto di Gova, infilato sotto le montagne che lo chiudevano da tre lati. A parte la strada che avevamo fatto la sola altra via era un sentiero verso un passo stretto fra le montagne dietro al villaggio, un passaggio impossibile se non per sciatori in gamba. Il colonnello aveva stabilito il comando nella canonica, una casa larga e solida di sasso al margine dell’abitato. Dalle stanze aperte sentii ticchettio di macchine da scrivere e voci femminili, c’era un aria da uffici commerciali più adatta a un’industria che a un comando che doveva essere mobile come quello di un’unità partigiana. Monti era sulla cinquantina, alto e di buon aspetto. Un po’ stempiato, aveva modi educati e voce tranquilla ma non sembrava avere quella forte personalità che ci vuole per comandare truppe irregolari. Dopo i saluti gli chiesi di raccontarmi qualcosa della sua Divisione, i risultati in passato e i piani per il futuro. «Come sapete abbiamo quattro Brigate, tre Garibaldi e una dei democraticocristiani. Ogni brigata ha da quattrocento a cinquecento uomini. A parte una brigata attiva sulla strada statale 63 sono tutte concentrate qui intorno». «Che difesa avete preparato?», chiesi. Rispose con la medesima tranquillità: «Oh, siamo al sicuro; il sud è protetto dalle montagna che adesso sono intransitabili, meno che in un punto, Civago, dove abbiamo un forte presidio. Il nostro lato orientale, dove eri stamattina, è protetto dai modenesi. Le Fiamme Verdi tengono tutti i passaggi sul Secchia verso il nord e i Garibaldini controllano gli accessi alla strada 63». Non conoscendo la zona non feci commenti e, seguendo le sue spiegazioni sulla carta, ascoltai tutto quanto. Mi disse che avevano avuto una buona quantità di materiali dal mio predecessore, ma solo armi di piccolo calibro. C’era bisogno adesso di armi più pesanti – mortai e mitragliatrici di medio calibro – oltre che abiti e cibo. Fui sorpreso da quello che chiedeva perché sapevo le quantità dei materiali consegnati e, a parte i lanci, la Divisione occupava uno staff per il comando di oltre sessanta persone per trovare cibo in zona. La zona era potenzialmente ricca, i tedeschi avevano fatto ben poco e non sembrava esserci un gran bisogno di aiuto esterno. Quando chiesi delle azioni di sabotaggio, Monti si mostrò in imbarazzo. Cercò di cambiar discorso parlando del lavoro di informazioni e di propaganda, compreso il giornalino che il Commissariato distribuiva ogni settimana. Pressato da domande più esplicite dovette ammettere che nei mesi passati erano state fatte poche azioni, cercò scuse, alcune ridicole, ma scoprii che, a parte l’inattività in passato, i partigiani non avevano piani stabiliti per il futuro in vista dell’offensiva di primavera. Quella sera incontrai i comandanti della Divisione «Reggiani». Miro [Riccardo Cocconi], il comandante in seconda, comunista, era un tipo tranquillo ma di carattere fermo; come molti dei suoi colleghi che avevo incontrato, non si 31 staccava mai da un pesante giaccone di cuoio. Marconi, un medico massiccio e vigoroso con una gran barba nera, che aveva fatto un buon lavoro nei primi tempi a favore dei prigionieri inglesi fuggiti. Eros, il commissario politico, non portava un nome appropriato, era un ometto bruttino e piccoletto, sebbene serio e sincero nei suoi ideali. Pedro, il furiere, un tizio che che non mi fece una buona impressione, probabilmente del tutto a torto. Il tipo più inconsueto era il comandante della Brigata democratico-cristiana, un prete cattolico, don Carlo (sic)[don Domenico Orlandini]. Questi era salito in montagna subito dopo l’armistizio e aveva combattuto sin da allora. Aveva attraversato due volte le linee per sollecitare aiuti degli alleati alle sue formazioni e ogni volta era tornato al suo posto di comando. Si diceva che avesse avuto somme in denaro dal Papa con cui era in rapporto prima che gli alleati liberassero Roma. Era riservato, quasi timido, la miglior pubblicità per il clero che io abbia mai incontrato. A prima vista questi partigiani sembravano aver tutto: uomini, armi, l’ambiente a favore, facile da difendere ma abbastanza vicino alle linee di comunicazioni nemiche per poterle tartassare con azioni efficaci. Tutto sembrava al meglio ma avevo la sensazione che sotto sotto ci fosse qualcosa di sbagliato. Quegli uomini stavano in montagna per viverci, non per combattere. L’inattività poteva essere capita se avessero preparato piani di battaglia per quando il momento fosse opportuno. Chiedere ancora armi quando non usavano quelle che già avevano; chiedere cibo quando il territorio poteva dar loro ciò di cui avevano bisogno; volere equipaggiamento – un lusso in una guerra irregolare; tutto ciò dimostrava la loro mentalità di tenere le posizioni, senza infastidire troppo il nemico, per paura del prezzo da pagare. Sentii che questo era l’esempio tipico di cosa succede quando la guerriglia riceve aiuti dall’esterno e non deve più combattere per ogni arma o per ogni pezzo di pane. Gli abbondanti rifornimenti alleati avevano fatto nascere un atteggiamento di sufficienza nei partigiani e mi chiedevo cosa potessi fare per cambiare la situazione. Per rompere la loro apatia ci voleva uno scossone. Lo ebbero, non da me, ma dal nemico e prima di quanto temessi. Capitolo 16 I Reggiani si riorganizzano Partii per Gova al mattino presto con don Carlo (sic), che tornava alla sua brigata a Costabona, un villaggio sulla mia strada, così accettò di accompagnarmi per darmi altre informazioni sulla zona. Era un’altra giornata splendida e il sentiero ben tracciato facilitava il cammino, nonostante ci fossero cumuli di neve ovunque. Ci fermammo spesso così potevo controllare col binocolo 32 quello che Carlo mi spiegava. Il Cusna era dietro a noi con il largo stendersi del suo dorso interrotto da alberi e qualche casa. A sinistra il Prampa copriva la curva della Strada 63 che circondava il suo lato più lontano. Di fronte, oltre Villa Minozzo, un borgo bruciato due volte dai tedeschi in estate, il Secchia piegava verso Castelnovo Monti, una cittadina con un presidio: «Quanti uomini ha?», chiesi. «Circa trecento uomini di solito», rispose Carlo «ma sembra che un battaglione della Brigata Nera sia arrivato stanotte». «Perché stanno rinforzando il presidio?». «Chissà, potrebbero essere diretti al fronte ma di solito i fascisti non sono destinati alla prima linea». Carlo non sembrava preoccupato da questo fatto e continuava a spiegare altri punti interessanti e fummo sorpresi quando, arrivati a Costabona, trovammo Wilcockson in mezzo alla strada con tutte le nostre attrezzature radio e materiali già caricate su un mulo. «Hallo, stai andando a casa o cos’altro?». Wilcockson ci fissò sbalordito: «Buon Dio, non sapete nulla? I jerries [nomignolo dato dagli inglesi ai tedeschi] hanno attaccato i modenesi la scorsa notte e quelli si sono squagliati e sono corsi a nascondersi. Hanno occupato Gova stamattina e ce la siamo battuta appena in tempo. Porti iella! Sei arrivato ed è finita la pace!». Le notizie erano una tale sorpresa che ci volle qualche minuto perché mi rendessi conto della situazione. I modenesi si erano rintanati e avevano lasciato il lato orientale scoperto. I giorni seguenti dimostrarono la fragilità del comando di Monti. Il panico regnava sovrano e la resistenza dei partigiani era caotica. Il nemico premeva da Gova marciando senza ostacoli verso le posizioni garibaldine a est. Contemporaneamente la Brigata nera attaccava attraverso il Secchia da Costabona e sciatori austriaci piombavano giù, aggirando Civago, all’improvviso su Febbio. Come avevano fatto i modenesi anche i garibaldini abbandonarono la lotta e si dispersero, alcuni riprendendo gli abiti civili e dirigendosi verso la pianura, altri attraversando la ss 63. Anche noi ci ritirammo il giorno seguente da Costabona. Fu una ritirata da incubo. Il servizio informazioni aveva cessato di esistere, non sapevamo quanto il nemico fosse penetrato nelle nostre linee, così dovevamo evitare le strade principali e lottare con la neve alta dei sentieri. Attraversammo il Secchia all’imbrunire e come se la situazione già non fosse abbastanza critica un mulo decise che non sarebbe mai entrato in acqua. S’inchiodò senza speranza, cercai di smuoverlo salendogli in groppa e urlando a tutta forza. Non servì a nulla, mi caricai del materiale e attraversai il fiume. Arrivai sull’altra sponda e sentii i suoi ragli simili a risate mentre se ne stava ancora immobile a guardarci arrancare. 33 Il nemico per fortuna fece un grosso errore. Non chiusero completamente l’accerchiamento e così, nonostante fossimo lenti e appesantiti dal carico riuscimmo ad attraversare la statale che era stata lasciata libera. I nostri abiti scuri sulla neve alla luce della luna ci rendevano bersagli perfetti, lenti com’eravamo sarebbe bastato un paio di jerries con una mitraglia a stenderci tutti. Per fortuna non incontrammo nessuno e dopo una scarpinata di venti ore raggiungemmo il versante più sicuro dove Monti e i suoi si erano già rifugiati seguendo un’altra strada. A Ranzano, dove mi fermai, incontrai il gruppo del comando, erano male in arnese e ufficiali e soldati si trascinavano con le armi imballate sui muli. Molti erano azzoppati dal gelo, per questo non potevano accampare scuse, visto che avevano buoni scarponi e calze di ricambio. Il solo lampo di luce in quell’armata demoralizzata erano le staffette che, a differenza dei loro compagni, erano pronte ed efficienti, senza traccia di stanchezza. I giorni seguenti realizzammo la situazione. I «Reggiani» come divisione non esistevano più; alcune unità minori si erano sciolte ed erano tornate a casa. Ma, a sorpresa, la maggior parte era sfuggita all’attacco senza danni ed era dispersa in varie zone, anche verso le colline. Il centro di rifornimento aveva smesso di funzionare ed era una conclusione scontata che il nemico avrebbe scoperto e distrutto i depositi che ci eravamo lasciati alle spalle. Anche il servizio informazioni era fuori uso perché sin dal primo giorno dell’attacco il nemico aveva bloccato tutte le strade e nessuno poteva più né entrare né uscire dalla zona. In un quadro così nero c’era un lato positivo. I partigiani non avevano avuto grosse perdite e un rapporto non confermato riferiva che le Fiamme verdi, prima di essere spazzate via da est avevano inflitto grosse perdite alla Brigata nera. Non c’erano notizie di don Carlo ma nessuno se ne preoccupava perché tutti erano convinti che sapesse badare a se stesso alla perfezione. In fondo non mi dispiaceva, a dire il vero, che quel rovescio fosse arrivato così presto. Il nemico aveva impiegato un’intera divisione e potevano usare ancora quella forza per una seconda ondata. L’attacco doveva essere stato programmato in anticipo e fatto scattare non appena la neve aveva immobilizzato i partigiani. Visto che un attacco di queste proporzioni aveva richiesto un grosso sforzo di pianificazione e organizzazione, ero sicuro che avremmo avuto almeno un mese, se non due per raccogliere le forze in vista della primavera. Avevo in testa di mettere insieme un’unità di guerriglia a modo mio, sull’esperienza di quanto avevo fatto in Jugoslavia e sulle Alpi marittime. Sarebbe stato difficile modificare la vecchia organizzazione, che sembrava buona ma attualmente fiacca, ma, ora che il nemico l’aveva distrutta per conto mio, potevamo ripartire da zero e, per la prima volta, con abbondanza di scorte e armi. Già sapevo che Monti era consapevole di non essere all’altezza del compito e ora che avevano bisogno davvero del mio aiuto, ero certo che potevo 34 condurli secondo i miei piani. Per fortuna i partigiani italiani, a differenza dei loro colleghi jugoslavi, erano ben consci dei loro limiti militari e ben felici di poter avere con loro un ufficiale inglese. Ebbi un lungo colloquio con Monti, per spiegargli che volevo avere parte attiva nella riorganizzazione delle forze partigiane, come nell’ideazione e conduzione delle azioni di sabotaggio. Con molto tatto feci capire che non ero soddisfatto del comando, che giudicavo poco dinamico e che, mentre lui rimaneva come comandante e si sarebbe occupato solo delle cose burocratiche, io avrei preso in mano il resto. Monti, a sorpresa, fu d’accordo con me. Mi spiegò che c’erano molti fra i garibaldini che volevano sostituirlo con Miro e da quel momento fummo alleati perché l’ultima cosa che avrei voluto era avere Miro come comandante. Era un tipo intrattabile con forti idee comuniste, la sola distrazione che era essenziale evitare. Dopo due settimane dall’attacco, con la tipica mancanza di fantasia teutonica, i tedeschi rastrellarono tutta la zona, bruciando e saccheggiando alcuni villaggi, senza neppure pensare ad inseguirci o a tenderci una trappola sulla via del ritorno. In quelle giornate non rimanemmo con le mani in mano. Farrimond era occupato a spedire elenchi di materiale che ci serviva – esplosivi in gran parte – mentre io mi davo da fare per organizzare una squadra di sabotatori e un mio servizio di informazioni. A comandare questa squadra chiamai Gordon [Glauco Monducci], un ufficiale dello staff di Monti. Era stato in un reparto degli alpini ed era ben allenato alla guerriglia in montagna, era forte, intelligente e attivo, e dimostrò di essere un’ottima scelta. Gli diedi una lettera di incarico e gli ordinai di andare in giro fra le unità disperse e di tornare solo quando avesse trovato i quaranta migliori elementi della Divisione. Questi uomini dovevano essere equipaggiati a puntino con il materiale del prossimo lancio e avrebbero dovuto essere addestrati a compiere ogni tipo di sabotaggio. Una volta pronti avrei inviato ciascuno di loro presso gli altri reparti per addestrare a loro volta dei sabotatori per poter contare su gente addestrata quando la necessità l’avesse richiesto. Diedi incarico a un partigiano di nome Kiss [Giulio Davoli] di organizzare il servizio di informazioni. Dio solo sa perché avesse scelto un nome di battaglia così inconsueto. Kiss aveva circa trent’anni ed era abbastanza insignificante di aspetto salvo che per un paio di occhi grigi molto penetranti. La voce monotona e le maniere discrete ne facevano un perfetto capo-spia. Preferii mettere in piedi un mio servizio di informazioni, nonostante già funzionasse quello delle brigate che riferiva regolarmente sulle attività nemiche in città e sulle strade, per essere più autonomo e per poter a mia volta verificare le informazioni che arrivavano. Kiss aveva vissuto a Reggio prima della guerra e aveva ancora molti contatti in città. Era stato preso due volte dai tedeschi ed era sempre riuscito a farla franca, così conosceva molto bene i loro sistemi. Iniziò così a prendere contatti con elementi fidati sia in città che in località poste sulle strade principali. 35 Queste ultime, infatti, erano un obiettivo importante per identificare quantità e tipo dei veicoli in transito, le insegne delle unità nemiche, e ci consentiva con sufficiente facilità di avere un quadro preciso dei movimenti da e verso il fronte che diventava un bagaglio di informazioni di primaria importanza per i nostri. Le nostre informazioni servivano a controllare quelle dei partigiani che, anche se abbondanti in quantità, erano spesso imprecise. Kiss insisteva sulla necessità di usare solo ragazze come corrieri perché gli uomini erano troppo esposti al rischio di essere presi in un rastrellamento o per essere inviati in campi di lavoro, mentre il fascino femminile, oltre che utile per strappare informazioni, poteva essere utile a superare sospetti e situazioni difficili. Non fece fatica a convincermi perché già mi ero accorto che le poche partigiane che avevano incontrato valevano ognuna una dozzina di uomini. Nelle settimane seguenti del resto più volte avrei sottolineato il loro coraggio che qualche volta sconfinava nell’incoscienza, come accadde a Pavullo. Quella volta, infatti, successe che fummo avvisati di identificare con urgenza dei reparti nemici che erano stati segnalati in quel posto, un paese vicino alla linea del fronte. In senso stretto quel paese non era nemmeno nella mia zona ma in quella di un altro ufficiale dislocato coi modenesi, comunque visto l’urgenza della cosa io chiamai Kiss e gli dissi di mettersi subito in movimento. Ventiquattr’ore dopo due ragazze tornarono con tutte le informazioni che avevo richiesto e che subito trasmisi alla base, fatto questo mi dimenticai della questione. Tre giorni dopo mi arrivò una lettera spiritosa del mio collega nel modenese sul fatto che, a parte il fatto che non avesse obiezioni che noi spiassimo i «suoi» tedeschi, visto che così le informazioni potevano essere confrontate, il problema era che l’azione delle nostre informatrici aveva scatenato l’intelligence tedesca. Le nostre brave ragazze, infatti, per risparmiare tempo, non erano andate attraverso i soliti informatori, ma avevano semplicemente fermato i soldati tedeschi per strada per sapere notizie e dettagli sulle loro unità e attività! Mentre aspettavo che il nemico si ritirasse mi chiedevo dove fossero finiti i nostri che si erano rifugiati a Ranzano. Erano in gran parte garibaldini, visto che le Fiamme Verdi se ne n’erano andate verso la pianura, ed erano molto scontenti della spartizione del materiale arrivato con i lanci. Sembrava che il mio predecessore avesse scelto di vivere con don Carlo (sic) e avesse scelto le zone di lancio lì intorno. I garibaldini erano convinti che le Fiamme Verdi, che avevano la responsabilità dei campi di lancio, avessero imboscato la metà della roba prima di dividerla con loro. La stessa spartizione, secondo loro, era chiaramente ingiusta visto il rapporto delle brigate di tre a uno a loro favore. Questa storia era confermata anche dal fatto che i garibaldini erano più scalcinati visto anche le armi vecchie che si portavano dietro. Monti ammise che qualche Fiamma Verde aveva anche quattro paia di scarponi e quattro unità di corredo mentre i garibaldini spesso erano quasi scalzi. La questione aveva provocato screzi non piccoli fra le unità. Comunque fossero le idee politiche, 36 era essenziale che la distribuzione fosse equa, perché un movimento di guerriglia, comunque composto, potesse dare il meglio. Il giorno prima di andarcene da Ranzano, arrivò Gordon con un primo gruppo di una ventina di uomini che, sebbene malmessi e poco equipaggiati, mi sembrarono abbastanza in gamba. In particolare uno mi sembrò un tipo tosto e adatto ad essere il vicecomandante. Era un tizio piccolo e magrolino di nome Rubens che aveva passato un anno prima della guerra come cameriereportiere in una taverna a Parigi. Un altro, siciliano, era stato preso dai fascisti e portato al loro comando per essere interrogato, ma li aveva sorpresi e, svincolandosi dai torturatori, era saltato da una finestra al secondo piano, riuscendo a salvarsi miracolosamente senza un graffio. La brutalità del trattamento aveva lasciato il segno perché il suo unico desiderio era quello di vendicarsi. Divenne un ottimo sabotatore. Gordon, in qualche modo, aveva trovato armi per tutti i suoi uomini, compreso due bren. Questo mi tranquillizzò perché non avremmo avuto lanci prima di tornare nella nostra zona, cosa che ora potevamo fare visto le informazioni che Kiss aveva ricevuto dalle sue staffette: la zona ormai era libera da pattuglie e truppe nemiche. Il ritorno fu tranquillo. Erano passate tre settimane dalla nevicata, i sentieri erano battuti e si andava bene. Avvicinandoci alla SS 63 ci aspettavamo guai da un momento all’altro mentre procedevamo col mulo in mezzo al convoglio con sopra le nostre radiotrasmittenti. Avevo lasciato il comando a Gordon e facevo anch’io il passeggero sul mulo ma fui impressionato da come Gordon impiegò i suoi bren per garantirci un attraversamento sicuro della strada statale. Fu un azione impeccabile. Tornati nella nostra zona mi sentii elettrizzato all’idea che ora potevamo incominciare a far sul serio. Nel primo villaggio sotto Castelnuovo fummo scambiati per fascisti e fu divertente vedere l’imbarazzo della gente che, dopo aver gridato «Viva il Duce!», capì chi eravamo davvero. Dagli stessi abitanti ci fu confermato che, mentre rimaneva la forte guarnigione di Castelnovo, la zona intorno era libera, salvo qualche pattuglia che però non ci faceva certo paura. Ci dirigemmo verso Costabona, dove speravo di incontrare Carlo e forse Luigi [Pio Montermini], uno dei comandanti garibaldini. Sulla strada feci una nuova conoscenza che si rivelò poi un buon amico. Stavamo marciando quando c’imbattemmo in una pattuglia di uomini che portavano la stella rossa delle brigate Garibaldi. In un terribile italiano chiesi informazioni sulla situazione in zona quando si avvicinò un tipo veramente strano. Non era altissimo ma aveva due spalle ben piantate, parlava adagio appoggiandosi a una lunga piccozza. Un paio di occhi azzurri mi gardavano dietro gli occhiali su un viso arrossato e con la barba lunga. Dopo avermi ascoltato mi parlò in un inglese un po’ pedante ma ottimo, forzando le parole con una voce un po’ nasale. «Come va, signore? Posso presentarmi? Sono Fritz [Franz] Snapper, già tenente della riserva dell’Esercito olandese». Quasi scoppiai a ridere. Avevo incontrato gente di tutti i paese ma un olan- 37 dese così non me lo sarei aspettato davvero: «Come diavolo sei finito qui?», chiesi. Il tenente Snapper si drizzò ben bene per sembrare un po’ più alto: «Ho l’onore, signore, di essere aggregato da alcuni mesi alla divisione “Reggiani”, per così dire, a titolo onorario». Era troppo, mi misi a sedere nella neve torcendomi dalle risa. Fritz sembrava invece imperturbabile. «Sei talmente buffo! Piantala di farmi ridere! Posso avere l’onore di aggregarla alla mia missione a titolo onorario?», gli chiesi. I suoi grandi morbidi occhi grigi si riempirono di lacrime. «Questo, signore, è un onore che accetto con il più grande piacere». A Costabona trovai Carlo reinsediato e con un colpo di fortuna anche Luigi e Ramis [Brenno Orlandini], i comandanti garibaldini. Questi ultimi avevano passato le ultime settimane sulle colline, dormendo all’addiaccio nei boschi di giorno e strisciando di notte nei villaggi. Era chiaro che Carlo, nella sua maniera tranquilla, non aveva mai lasciato la zona. Rifugiandosi in borghese presso il parroco del luogo, si era fatto passare come suo servitore quando i tedeschi avevano perquisito la canonica. Arrivai al momento giusto, perché le truppe si stavano ritirando e Luigi, Ramis e Carlo stavano mettendo insieme i primi piani di azione in assenza di Monti e del suo staff. Lavorammo insieme fino a sera e riuscii a ripartire prima di notte. Avevo scelto come base un paesino chiamato Secchio, fra Costabona e Febbio, in posizione centrale e a meno di un’ora di cammino dal comando di Carlo a Costabona e da quello di Luigi a Minozzo. Ramis operava in stretto contatto con Luigi così potevo tenermi in contatto anche con lui e, attraverso il Comando di Divisione che doveva tornare a Febbio (a due ore di cammino) speravo di riuscire a mettere insieme un sistema di segnalazione per poter trasmettere i messaggi più urgenti. Secchio era poco più che un gruppetto di case arrampicate su per una valle di un affluente del Secchia. Un buon sentiero portava oltre il torrente verso Gova e la zona tenuta dai modenesi che era a poco più di tre ore di marcia. La vallata portava verso Febbio, annidato sotto al Cusna con una zona protetta e aperta di fronte a quella adatta per la zona dei lanci. Era una zona proprio giusta e con qualche lavoro di difesa sarebbe stata una perfetta base partigiana. Carlo mi accompagnò a Secchio e mi presentò al prete don Pedro (sic) [don Pietro], un ometto timoroso, ma un buon patriota. Nonostante si rendesse conto del pericolo si offrì di ospitarci finché non avessimo avuto una casa a nostra disposizione. Sua madre, che lo assisteva, era una dolce vecchietta che presto ci trattò tutti come suoi figli, badando ai nostri bisogni con la massima cura. Gordon sistemò i suoi uomini in una casa che era stata la scuola del villaggio, mentre Kiss mise al sicuro le sue staffette alloggiandole in un casale a poche centinaia di metri dal paese. Ero stato fuori con Bert per sistemare le antenne della nostra radio tra la canonica e il campanile della chiesa, quando 38 tornai in casa trovai due preti impegnati in una scena poco consona alla Bibbia. Era seduti in sala da pranzo e sul tavolo tenevano due bicchieri di vino e la bottiglia. La bottiglia era quasi vuota e don Pedro se ne stava in piedi, la faccia bianca di rabbia e urlava ai due che ridevano come matti. Temendo di poter interrompere il discorso fra quelli chiesi a Carlo in francese perché don Pedro facesse quella sfuriata. «Beh, la scorsa estate quando di armi ce n’erano poche abbiamo preparato un campo di lancio per la mia brigata qui, vicino al villaggio. Don Pedro era entusiasta di avere un comando partigiano e poichè il lancio fu fatto di notte, mandò dei suoi parrocchiani a portar via i contenitori e riuscirono a prendere sei mitragliatori bren. Ha organizzato un piccolo gruppo di parrocchiani e quelli hanno cominciato a tendere imboscate ai mezzi nemici sulla strada per Reggio. Per caso i miei uomini una volta li hanno visti e li hanno pedinati. Com’era facile prevedere per uomini non addestrati sono finiti contro una pattuglia nemica, se la sono vista brutta e hanno tagliato la corda gettando via le armi. Pedro si è salvato dalla cattura perché le Fiamme Verdi sono intervenute e, dopo averlo arrestato, l’hanno portato al mio comando dove gli ho dato una lavata di testa per aver portato via delle armi. Ci rimase molto male perché era consapevole del suo fallimento come capo-partigiano». Per finire questa storia, ne sentii delle altre sullo stesso Carlo. Lasciava sempre da parte il suo ruolo di partigiano per dire la messa per i suoi uomini la domenica. Un giorno, come era solito fare, era sull’altare con la pistola sotto la sua tunica, quando entrò in chiesa una staffetta per avvertire che i fascisti stavano arrivando. Con una calma degna di Drake, rimandò la staffetta e, rivolto ai fedeli, diede incarico di formare un pattuglia per far fronte al nemico. Detto questo, finì di dir messa prima di riassumere il comando dell’azione. Questa era la stoffa dei preti di montagna, ci furono tutti amici e alcuni davvero si resero utilissimi. Un altro che incontrai, don Vasco [Casotti] di Febbio aveva un rifugio segreto costruito nella canonica dove tenne nascosto per mesi prigionieri fuggiti mentre in paese c’erano i tedeschi. Cercai di fargli accettare un rimborso per le spese che aveva avuto per ospitarli ma non volle altro che un paio di paracadute di seta da distribuire ai poveri del paese. Il nemico ci diede la tregua di un mese che ci serviva e alla metà di febbraio la Divisione era già operativa. Appena Monti tornò chiesi subito un incontro per proporre il mio piano di creare una piazzaforte nella vallata fra Secchio e Febbio per lanciare attacchi alle vie di comunicazione del nemico. Decidemmo di occupare un territorio ampio come quello che era stato prima dell’attacco, eccezion fatta per il versante orientale che stavolta sarebbe stato protetto dalle nostre unità e non più dalle truppe modenesi. Ogni unità fu assegnata a una zona con l’ordine di preparare difese fisse lungo il proprio perimetro di difesa così da non impegnare tutte le risorse al primo attacco, qualora il nemico avesse sfondato. Dovevamo essere in grado di resistere dando tempo alle altre unità di riorganizzare la difesa. In questo modo potevamo contare 39 anche su uomini per azioni di sabotaggio, senza intaccare la struttura di base. A ogni unità venne poi assegnata un tratto di strada su cui compiere imboscate e sabotaggi. Nonostante la dura opposizione di Monti io richiesi che il quartier generale di Febbio fosse ridotto della metà degli effettivi, rendendo fra l’altro le brigate autonome per gli approvigionamenti. Questo era fra l’altro un incentivo visto che il cibo e il vino migliore era in pianura dove avrebbero dovuto combattere per guadagnarselo. In cambio io promisi di fornire armi pesanti per la difesa e cibo e abiti per gli uomini. Per organizzare la zona dei lanci di Febbio misi insieme un gruppo di una cinquantina di uomini provenienti da ogni brigata. Questo ci avrebbe assicurato dalla scomparsa di contenitori e una più equa distribuzione del materiale. Per coordinare queste operazioni Monti mise Scalabrino [Ettore Scalabrini], un meraviglioso vecchio individuo che aveva passato 17 anni in America come minatore. A parte il suo bastone, del quale era giustamente fiero, devo dire che non ho mai capito una parola del suo pseudo-inglese che parlava correntemente. Da parte sua non accettò mai il mio italiano né la presenza dell’interprete cosicché comunicavamo soltanto con le intonazioni della voce e con le espressioni del viso e devo dire qualche volta con buoni risultati! Alla prima occasione lo informai che se fosse sparito un solo contenitore lo avrei fatto fucilare. Rimase imperturbabile a questa minaccia ma lo sentii poi dire che molta gente sarebbe stata fucilata prima che sparisse anche un solo paio di calzini. Aveva ragione. La mattina ero ancora in marcia verso la zona di lancio quando apparvero gli aerei sul Cusna e iniziarono a girare in tondo. Appena i paracadute si aprirono scoppiò un fuoco d’inferno di mitragliatori, fucili e quant’altro tutt’attorno. Pensando che il nemico avesse rotto da Civago e avesse architettato un’imboscata perfetta corsi a perdifiato su una collinetta per capire meglio cosa stesse succedendo. Appena arrivato in cima sentii un fischio e il fuoco cessò all’improvviso. Poi una figura grigia e scarna arrivò in mezzo allo spiazzo di lancio dove i contenitori erano dispersi quà e là. Quel bel tipo aveva disposto i suoi uomini tutt’intorno al campo e senza avvertire nessuno prima aveva dato l’ordine di sparare a tutto spiano pour décourager les voleurs (in francese nell’originale) [per spaventare i ladri]. Al suo ordine smisero di sparare rimanendo in posizione mentre lui controllava ogni contenitore arrivato. Allora e solo allora iniziò la raccolta del materiale. Questo sistema, seppure un po’ costoso in munizioni, diede buoni risultati. Nei due mesi successivi di lanci non perdemmo più un contenitore. Da parte mia il presidio di Secchio stava venendo su bene. Gordon ora poteva contare su quaranta uomini, tutti perfettamente equipaggiati, addestrati e disciplinati. Sezioni di questa squadra erano già andate nelle varie brigate e l’imboscata al primo convoglio la settimana precedente era stata un successo. Se tutto fosse continuato a filare liscio le squadre avrebbero potuto assalire il nemico in settori differenti ogni notte. Anche Kiss aveva fatto un gran bel lavoro. Aveva numerosi agenti in città 40 e nei paesi più grossi, tutti impegnati a compilare rapporti che le staffette ritiravano a intervalli regolari. Queste staffette non erano meno di venticinque e tre di esse stavano sempre presso la nostra base. In questo modo ci arrivavano tante informazioni che spesso dovevo star sveglio fino all’alba per leggere tutto e per stendere dei rapporti condensati da far trasmettere da Farrimond all’alba. Da parte sua Bert era soddisfatto di poter lavorare con la corrente elettrica a disposizione senza i guai delle batterie da ricaricare. Pochi giorni dopo il nostro arrivo a Secchio e prima che le cose diventassero impegnative si lamentava, scherzando, di aver pochi messaggi da trasmettere, poco dopo si pentì di aver scherzato quando fu costretto a lavorare anche quattordici ore al giorno per codificare e trasmettere messaggi. Per nostra fortuna però ci trovavamo in condizioni ideali, comodi e con la pancia piena. Fritz Snapper si occupava del passaggio delle staffette delle linee: il servizio aveva base a Civago da dove i corrieri partivano per seguire un percorso contorto e difficile per aggirare le linee tedesche e arrivare a quelle alleate. Le guide non erano partigiani e lavoravano solo per denaro, volevano più di due sterline per portare un messaggio a Firenze o per guidare qualcuno attraverso le linee. Considerato che spesso facevano viaggi accompagnando fino a un centinaio di persone, non era un affare da poco. Si poteva poi inviare un corriere speciale per messaggi veloci al prezzo di venti sterline altrimenti i messaggi aspettavano a Civago per la regolare spedizione bisettimanale. Fritz era in buoni rapporti con le guide e lo usavo per controllare che tutto filasse liscio. Era in effetti un vera sopresa pensare di mettersi comodi, nell’Europa occupata, a scrivere una lettera in assoluta tranquillità e sapere che sarebbe arrivata al mio comando dopo quattro giorni. Il nemico aveva uno schieramento sulla linea del fronte a maglie molto larghe. Le guide conoscevano bene la dislocazione di ogni unità e dei campi minati. La loro preoccupazione maggiore era il maltempo, lontani da ogni rifugio in caso di bufera la situazione poteva diventare molto critica. Fritz si rendeva utile anche negli interrogatori. Parlava tedesco e francese, oltre che olandese, inglese e italiano e spesso lo usavo per interrogare i prigionieri che le brigate mi mandavano prima di chiuderli nel carcere di Febbio. Era molto bravo, faceva domande minacciose ai poveri prigionieri, spaventati a morte per essere stati presi dai partigiani. Nonostante gran parte dei prigionieri, in gran parte soldati di truppa tedeschi, fossero gente un po’ tonta e ignorante, tutti quanti parlavano e spesso ci hanno dato anche notizie utili. Fritz era poi un tipo incredibile: era affascinante nei modi e con una grande capacità di apprendere, ma aveva anche tratti di grande semplicità al limite dell’ingenuità, come aveva dimostrato raccontandoci la sua vicenda personale, credibile solo dal suo racconto. Era iniziato tutto in Olanda nel 1940, dopo che i tedeschi avevano invaso il paese e l’esercito si era sbandato. Allora Fritz aveva vissuto qualche mese da civile, cercando di «dar fastidio», come diceva, ai tedeschi insieme ai suoi amici del movimento clandestino. Presto però quel- 41 le azioni non gli bastarono più e pensò di fuggire in Inghilterra dove si stava riformando l’esercito olandese. Così, insieme a un amico, si diresse verso la Svizzera dove arrivò senza difficoltà. Una volta arrivato, però, si trovò bloccato perché i pochi voli diretti in Inghilterra portavano persone importanti e non certo uno qualunque come lui. Dopo un anno il denaro finì e allora gli venne in mente un’idea un po’ folle, quella di attraversare l’Italia e di unirsi alle truppe inglesi che combattevano al sud. Una notte, così, senza documenti né mappe, attraversarono il confine vicino al Sempione. Il piano fallì perché nel loro entusiasmo i due non tennero in conto il fatto di non sapere neppure una parola di italiano! Come se fossero ad aspettarlo, fu preso dalla polizia fascista e accusato di essere una spia. L’accusa cadde solo perché il giudice si convinse che gli alleati non potevano essere tanto fessi da spedire spie che non sapessero neppure una parola d’italiano. Così Fritz scampò la fucilazione ma fu internato in un campo che fu preso dai tedeschi dopo l’8 settembre. A quel punto Fritz andò dal comandante tedesco e gli raccontò del suo odio per gli italiani e dell’entusiasmo che provava per i tedeschi. L’ufficiale ci cascò e lo lasciò libero. Per dimostrare i suoi sentimenti l’olandese scappò subito in montagna. In preparazione del ruolo da giocare nella offensiva di primavera ormai prossima, avevo incaricato Kiss di trovare informazione su tutti i possibili bersagli interessanti nel nostro raggio di azione. In particolare mi interessava un comando, posto a Villa Spadoni, ai margini della pianura reggiana. Avevamo avuto vari rapporti su quel comando ma tutti contradditori e, a parte che fosse un comando importante, non ne sapevamo molto di più. Gordon aveva reclutato nella sua squadra un paio di tedeschi che avevano disertato ed erano uomini ben addestrati e disciplinati. Sarebbero stati molto utili quando avessimo attaccato garantendo ai nostri sabotatori una copertura sicura per ingannare il nemico. Un giorno uno dei due torna da una missione portando un giovane sergente austriaco che voleva unirsi a noi. Questo tipo, Hans, era stato in servizio con la 4a Divisione paracadutisti a Bologna. Sembrava abbastanza interessante ma non ero particolarmente interessato a lui finché, mentre ci raccontava la sua storia, ci disse che aveva disertato da Villa Spadoni, dove era in servizio con un carro armato. Hans era molto preciso a fornirci informazioni: Villa Spadoni era un comando di artiglieria con un colonnello in comando. Era certo un buon obiettivo ma secondo lui c’era in zona un comando molto più importante, forse un Comando d’Armata, di cui però non sapeva altro perché i tedeschi, temendo attacchi partigiani, si cautelavano con grande cura. Messo in agitazione mandai Kiss e, passategli le informazioni di Hans, gli ordinai di concentrarsi solo su quel bersaglio. Ero seduto al nostro tavolo di lavoro, il sole filtrava attraverso le imposte sulle spalle di Bert che stava iniziando a scrivere il messaggio in arrivo: «Prego informarci sulla possibilità di usare unità...». Qualcuno bussò alla porta e Kiss entrò: 42 «Mi scusi, sir, ho le informazioni che voleva». Questa sì che era una buona notizia! «Bravo, come hai fatto?», gli chiesi. Kiss mi fece un gran sorriso: «Una delle nostre staffette è un gran bel pezzo di ragazza». Sorrise con un’espressione romantica negli occhi. «È una che ci sa fare, ieri sera è tornata da un incontro con l’ufficiale del presidio di Castelnovo che le ha raccontato la cosa». Mi passò un foglio: C’è un importante comando a Villa Rossi a Botteghe. È il Quartier generale del 273° Corpo e coordina i Comandi della XIV Armata. Lì risiede il generale Feurstein. La scorsa settimana c’è stata una visita di Graziani. Bert attirò la mia attenzione a quanto aveva finito di scrivere, decodificando il messaggio appena arrivato: «Prego informarci sulla possibilità di usare unità SAS da paracadutarsi nella vostra zona per azioni di sabotaggio a linee di comunicazione». Guardai i due messaggi, poi strappai un modulo e scrissi solo: «Ottima idea. Mandateci quanti più uomini potete». «Spediscilo subito, Bert». (continua) La copertina del libro 43 Orlando Ferretti, il mio diario Campagnola Emilia, ricordi della Liberazione «In conclusione, a questa data 11 dicembre ’78 Alberto Lodini si trova libero…» a cura di Realino Ferretti Premessa La presente testimonianza costituisce solo uno stralcio di un più ampio lavoro scritto da mio padre che, pur non avendo completato il regolare ciclo di studi elementari e quindi provando una naturale avversione per il racconto scritto, ha tuttavia desiderato fortemente lasciare una piccola traccia scritta di quella che è stata la sua esperienza terrena (soprattutto nei periodi 1938-1939 anni di duro lavoro di emigrante in Germania e nei venti mesi della guerra di liberazione). Anche per non togliere nulla della sua appassionata narrazione ho deciso di riportare, senza alcuna variazione, il racconto nella sua elementare e a volte sgrammaticata prosa. Orlando Ferretti nasce a Campagnola Emilia il 7 aprile 1913, è il secondo di sei fratelli; il padre, Pietro, lavora alle dipendenze di un proprietario terriero del luogo e nel frattempo organizza, assieme ad altri, una cooperativa bracciantile di cui poi diverrà presidente (la madre era Carmelina Montanari). Nel 1924, all’età di 11 anni, Orlando è costretto ad abbandonare la scuola (è in quarta elementare) a causa della morte del padre. Diventa così il «capofamiglia» e viene impiegato nella cooperativa nella quale operava il padre. Questa occupazione continua per alcuni anni fino a quando il fascismo non scioglierà la cooperativa in quanto di chiara ispirazione socialista. A questo punto, perso il lavoro, non restava altro da fare che cercare occupazione presso qualche piccolo coltivatore diretto del paese come bracciante. I tempi erano durissimi, la miseria nera; per darne la misura mi è sempre bastato sentire (e quante volte mio padre me l’ha detto) che per mangiare, la famiglia di Orlando doveva aspettare che la famiglia del dottor Bigi , il farma- 44 cista del paese, terminasse la cena. Ci si sfamava, quindi, con ciò che restava su quella tavola! Questa condizione miserevole è durata per parecchi anni. Nel 1938, a seguito di accordi tra Mussolini ed Hitler, si presenta la possibilità di emigrare in Germania. Mio padre, assieme ad alcuni compaesani, come molti altri italiani decide di partire. La zona loro assegnata è nei pressi di Hannover, per la precisione ad Ueltzen; si trattava di fare lavori agricoli, principalmente la raccolta di patate. Gli anni 1938-1939 sono stati di duro lavoro, ma anche anni di soddisfazione in quanto il loro datore di lavoro, un grande proprietario terriero, trattava questi emigranti con giustizia attenendosi scrupolosamente, agli accordi pattuiti dai due paesi. A dicembre del 1939 mio padre è rientrato in Italia e quindi è stato subito arruolato. Dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale è stato inviato in Jugoslavia e qualche mese dopo fatto rientrare in Italia ed assegnato ad una compagnia che operava nel porto di Genova col compito di proteggere le navi provocando sbarramenti fumogeni. L’otto settembre 1943 si trova sempre nel porto di Genova; come tanti altri ha gettato la divisa militare ed indossato abiti civili e si è incamminato verso casa. Durante quel periodo a Genova si è ammalato gravemente (per questa ragione riceverà un pensione di guerra) e così i venti mesi che porteranno all’aprile 1945 li passerà a casa a Campagnola . Prenderà solo indirettamente parte alla guerra di liberazione sapendo che il fratello Efrem ed una sorella, Dolores, erano rispettivamente nelle formazioni partigiane operanti nel parmense il primo e, come staffetta nel reggiano, la seconda. Finita la guerra nel 1946 la famiglia Ferretti (una anziana madre e sei fratelli) si troverà a gestire una cooperativa di consumo (un caffè ed un negozio di generi alimentari). La cooperativa di Campagnola nei cinque anni successivi fino al 1951, anno in cui la gestione passa in altre mani, registrerà lusinghieri successi di bilancio arrivando ad essere la prima cooperativa di consumo della provincia. Dopo il 1951 Orlando riuscirà ad impiegarsi, come operaio, alla Landini-trattori di Fabbrico dove resterà fino al 1973, anno del suo sessantesimo compleanno e quindi del pensionamento. Il resto della sua vita (è morto il 24 settembre 2001 ad 88 anni) è trascorso a Campagnola, dove non ha mai smesso di attendere ai piccoli lavori domestici, attorniato dall’affetto dei suoi cari e confortato dalla presenza dei suoi adorati cinque nipoti. Il giorno 3 aprile 1945 ha mitragliato in piazza a Campagnola, erano le 13 pomeridiane, io mi trovavo in campagna da Pignagnoli Ferdinando, il mio datore di lavoro, proprio a quell’ora fu ferita a morte con una pallottola la signorina Colli Laura, morì pochi giorni dopo, precisamente il 9 aprile ’45. La lotta di Liberazione incominciava a diventare molto pesante, poiché i 45 fascisti sentivano l’acqua alla gola, i partigiani avevano acquistato la simpatia della popolazione, direi anche da parte di coloro che avevano nei primi tempi incoraggiato o finanziato la guerra, perché il popolo era stanco dei bombardamenti e le rappresaglie la espropriazione [sic, gli errori sono nell’originale] di tutti i suoi prodotti. Si sentiva già odore di liberazione, però la lotta in quei giorni era sempre più dura e rovente. Mia sorella Dolores che era staffetta partigiana, la sera del 14 aprile ’45 mi avvertì che il giorno seguente, 15 aprile, ci sarebbe stato un rastrellamento a Campagnola. Ricordo bene quel periodo e quella notte, non riuscivo a dormire. Mi alzai che erano le due di notte quel maledetto 15 aprile 1945 mi misi alla finestra della mia camera da letto, mi sembrava di sentire chiacchierare nel paese, in possibile, c’era il coprifuoco, di notte non si poteva uscire di casa, c’era il pericolo della morte. Uscii dalla mia camera da letto, andai in fondo al corridoio, c’era una finestra per assicurarmi se era verità che ci fossero persone fuori a quell’ora. Pochi minuti dopo sentii avvicinarmi da una persona, era Bellesia Pierino. Dialogando, pure lui mi diceva che non riusciva a dormire, senza sapere che alla mattina c’era un rastrellamento. Certe notizie non si poteva manifestarle. Io lo sapevo perché mia sorella era partigiana, c’erano le spie da ambo le parti, perciò era pericoloso parlare. Infatti, anche lui sentiva chiacchierare nel paese, mi diceva se erano partigiani perché lui non li aveva mai visti. Io non risposi sempre con la paura del compromesso. Non credevo che fossero fascisti, e non potevo dire: «sono partigiani», preferii il silenzio, perché il giorno dopo poteva dire inconsciamente: «Orlando a detto che erano partigiani», questa frase poteva essere trasportata da una spia fascista, poteva crearmi seri guai. Dopo un periodo Pierino che era in maglietta sentì il freddo, mi disse torno a letto. Andai alla finestra della mia camera da letto, erano le tre di notte mi sembrò di vedere nel buio due militi armati che camminavano per strada, li vidi a ritornare indietro, con stupore mi accertai che erano fascisti. Subito diedi l’allarmi ai miei colleghi alla Casa bianca abitavano in 17 famiglie. Eravamo in sette disposti ad uscire di casa e scappare in campagna, ma purtroppo era già tardi. Noi sette pericolosi per essere braccati abbiamo pensato di nasconderci in solaio con fascine contro all’uscita, con la speranza che mai più trasportavano le fascine per scoprirci. Mia sorella Dolores ci avrebbe avvertiti se i fascisti fossero entrati in casa sbattendo le finestre della camera da letto che si trovavano sotto al solaio dove eravamo nascosti. Dopo pochi minuti di silenzio si sentì sbattere le finestre. Si sentivano delle voci che salivano le scale, infatti, arrivarono su nel solaio. Bruschi Abramo, Codogni Camillo, Bompani Afro, Bellesia Pierino, Zulini Francesco, Lugli Andrea, e il sottoscritto Ferretti Orlando. Noi sentivamo tutto quello che dicevano, insistevano che uscisse Pierino, però i fascisti non sapevano che eravamo in sette nascosti dietro le fascine, compreso Pierino. Però senza che 46 nessuno parlasse, Pierino uscì dal buco. Noi sentimmo, si sentiva una voce che chiedeva la carta di identità, poi subito un’altra, «allontanati che le carte gliele do io», si sentì un colpo di pistola, le grida del padre e della sorella di Pierino che erano presenti compresa mia sorella. Fecero scendere le scale di corsa a Pierino, con una pallottola nei polmoni; fatta la prima scala stramazzò a terra. Il padre s’avvicinò per sollevarlo ma quel fascista che gli aveva sparato ordinò al padre di allontanarsi dicendo che era un partigiano e che doveva continuare a scendere le scale di corsa da solo. Con quell’episodio tutti seguirono Pierino al paese, la casa si liberò dai fascisti armati. Piano piano, uscimmo dal solaio, erano le ore nove chi scappò in campagna, che si nascose di nuovo, io andai dal mio datore di lavoro a nascondermi, mi seguiva mia sorella Dolores. Andai sul fienile, Dolores mi coprì con delle balle di paglia. Pensando un ritorno dei fascisti, Dolores conosceva il mio nascondiglio involontariamente si tradisse, pensai di cambiare nascondiglio, andai entro all’abbeveratoio delle mucche, era pieno di acqua. Ma quell’epoca l’acqua era troppo fredda che non riuscii a resistere. Uscii di nuovo, fu la volta di una botte sporca del pozzo nero. Dopo pochi minuti sentii pronunciare il mio nome, era un certo Zulini Rinaldo che mi annunciava le Brigate nere, così si definivano i fascisti, avevano portato via mia sorella Dolores, perché non mi sono presentato io, solo la mia presenza poteva liberare Dolores. Il mio nome venne fatto perché Iolanda era incinta, hanno chiesto chi era stato a mettere incinta, Zulini fece il mio nome, ecco l’arresto di Dolores, (pensa, Realino, mi hai dato grattacapi fra virgolette prima di nascere, intendiamoci scherzo). Venni a casa trovai mia madre disperata, senza esitare mi cambiai perché ero tutto sporco, partii per dare il cambio a mia sorella Dolores. Seguito da mia madre a distanza, perché non volevo che venisse con me. Mi presentai al comando fascista per dare il cambio a mia sorella. Fecero uscire dalla prigione mia sorella e mi fecero entrare. Ricordo benissimo che mia sorella non voleva lasciarmi, io la pregai di andarsene a casa, fra l’altro io sapevo che lei era staffetta, perciò molto pericolosa se l’avessero riconosciuta. Entrai in prigione, guarda caso trovai Marzi Geminiano e il figlio Gino, mio suocero e cognato, perché sposai Marzi Iolanda, in più trovai in prigione un certo Lodini dove io prestai servizio come lavoratore agricolo all’età di 15 anni. Restammo in prigione poche ore, in quel periodo di detenzione, spalancarono le porte della prigione, ci presentarono un certo Morellini Selvino che io conoscevo bene, nato a Campagnola, tutto sporco di sangue perché l’avevano torturato, le dissero, trova fuori un partigiano in questi prigionieri, altrimenti sai cosa ti spetta. Per tutta risposta disse: «questi sono tutti lavoratori, brava gente», chiusero 47 la porta della prigione portando con se Selvino. Erano circa le ore 16 del pomeriggio 15 aprile ’45 si apre di nuovo la porta della prigione, ci fanno uscire tutti e quattro, si portano al comando che si trovava in Comune, ci fanno attendere davanti alla porta del comando per entrare uno alla volta, venne la volta mia, entrai, mi chiese il nome il comandante e la carta d’entità. Stavo sfilandola dal portafoglio quando il comandante che mi interrogava me lo strappò di mano. Osserva tutti i documenti, mi disse: «tu dovresti essere militare», non feci in tempo a rispondere, che una voce che io non vidi, rispose di no. Ancora oggi penso che questa voce fosse un fascista di Campagnola che conosceva bene la popolazione, e perciò restava nascosto per non farsi conoscere. A mia presunzione il «no» voleva dire lasciatelo libero, e il «sì» arrestatelo. Quelli che arrestavano li mettevano su per le scale del Comune chiudevano il cancello, con la presenza dei fascisti armati, sicché non potevano scappare. Il comandante appena mi disse che potevo andare, volevo fare i passi normali, ma il piede appena toccava a terra, non so il perché, subito si alzava. Mai in vita mia ho riscontrato tale agitazione. Appena fuori dal Comune, non avevo ancora attraversato la piazza, un militare mi chiamò, gli andai incontro, allungò la mano consegnandomi la patente di guida. Dalla fretta di uscire non ho raccolto tutte le mie cose. Arrivo a casa, imparo che Bellesia Pierino è stato fucilato ai margini dell’ospedale Baccarini. Ferito su nel solaio hanno fatto correre al comando dei fascisti, senza dubbio l’avranno interrogato, e poi con due militi armati lo avranno portatato ai confini dell’ospedale. Sul cancello dell’ospedale c’era il dottore di nome Zocco attendere, era un forestiero. I due militari arrivati al cancello dell’ospedale il dottore disse (sempre a voce di popolo): «Avete bisogno di me?» Risposta: «Ci pensiamo noi a curare questo ferito». Sono arrivati ai confini della recinzione dell’ospedale e lo hanno fucilato. La medesima sorte toccò anche a Salati Secondo. Però Salati fu fucilato in fondo al recinto del parco di Conti; un’altra esecuzione fu fatta sempre la medesima giornata, quel maledetto 15 aprile 1945, la terza esecuzione fu eseguita all’altezza del caseificio di Fontanesi. Il disgraziato era un militare sbandato che tentava di raggiungere la propria casa a piedi, si chiamava Piron. Mentre si stava parlando di ciò che era successo in quella brutta giornata, abbiamo imparato che le Brigate nere erano partite da Campagnola con i tutti i fermati alla volta di Reggio. Ero molto spaventato, non ricordo chi portò a casa Pierino morto. Sempre a voce di popolo, poi in seguito si riscontrò la verità, i fascisti dovettero lasciare i prigionieri di Campagnola a Bagnolo, perché altri fascisti che avevano rastrellato altri paesi e fatte altre rappresaglie si erano scontrati con i partigiani, perché stava scendendo la sera. I partigiani diedero il contraccolpo, quale zona del contrattacco non lo so, e tanto meno i risultati. 48 Appena buio, poco prima del coprifuoco, è stato detto il Santo rosario per il povero Pierino adagiato sul letto. Finito il rosario, spariti tutti, ognuno si è chiuso a chiave nella propria camera da letto. Ricordo che sono andato nella camera da letto di mia madre assieme a tutte le sorelle. Eravamo in una camera unica, eravamo tutti terrorizzati perché si temevano altre rappresaglie. Non dimenticherò mai quella notte, perché mi sono trovato in piedi a mezzanotte, senza accorgermene, nel profondo sonno. Al mattino, del 16 aprile, mi accorsi che il giorno prima non avevo mangiato. In quei giorni l’esercito tedesco, ridottissimo, combatteva a Cassino [sic] contro agli americani nostri alleati, l’esercito tedesco dovette ritirarsi. La ritirata passava da Campagnola, il giorno 22 aprile 1945. Era una domenica, non si poteva uscire di casa. In quel giorno mi trovavo alla finestra nella mia camera da letto osservando la ritirata. Cerano quattro apparecchi che mitragliavano i mezzi corazzati dei tedeschi in ritirata. Questa battaglia si svolgeva sotto ai miei occhi. Era un pomeriggio. La colonna dell’esercito tedesco in ritirata veniva da Carpi diretta a Guastalla. I quattro apparecchi mitragliavano a bassa quota la colonna tedesca. Molti mezzi si incendiavano, venivano abbandonati, e gli occupanti scappavano per la campagna. Quando gli apparecchi si abbassavano i tedeschi le sparavano con la rivoltella, mi trovavo in un punto che potevo osservare bene senza pericolo. Dall’alto dove mi trovavo si vedeva bene: c’era un fumo, il vento soffiava da nord a sud, sembrava un gigantesco argine di fumo senza fine. Erano le 17 del giorno 22 aprile 45, poche ore dopo scendeva il buio, non si vedeva più nessuno, perché in questa zona c’erano cartelli in legno tedesco, «zona infettata dai partigiani (Achtung)». Quella sera andai a letto presto. Il mattino del giorno dopo mi alzai di buonora e trovai tre militari italiani che dormivano sotto il portico di casa. Io non dissi nulla, dormivano. Penso che fossero tre militari sbandati, erano a piedi, perché non circolava alcun mezzo. Penso volessero raggiungere la properia casa. Durante il giorno si vedevano molti soldati tedeschi a piedi chiedevano di Guastalla. Al dopo pranzo di quel giorno sono andato al paese, curioso come tutti di vedere la ritirata. Oramai si sentiva aria di armistizio. Erano le 14 del giorno 23 aprile, mi trovavo vicino alla fontana del Comune, vidi un camioncino tedesco carico di militari armati, e un cannoncino trainato dal mezzo. Passavano a velocità abbastanza sostenuta infilavano la strada per Novellara, diretti a Guastalla per potere passare il Po. Poco dopo passò una motocicletta a grande velocità con due partigiani armati che inseguivano il camioncino dei tedeschi. La gente tutta riversata in piazza si domandava cosa stesse succedendo, perché oltre alla motocicletta dei partigiani seguiva una camionetta militare degli alleati armati, agenti di colore mescolati con dei bianchi figli di italiani residenti in America, che ciò si imparò dopo, che operavano in Italia. 49 Dopo poco tempo si vide a ritornare indietro il camioncino dei tedeschi tutti disarmati, con le mani dietro alla schiena legate con filo di ferro, senza camioncino. Erano quei tedeschi in ritirata, fecero sette morti a Canolo sparando sulla popolazione che inneggiava sulla fine della guerra. A testimonianza del fatto si trova una lapide, nel centro di Canolo, con tutte le foto dei colpiti a morte, tuttora, al punto dove sono stati colpiti. Erano gli ultimi giorni della lunga guerra. I tedeschi della strage furono acciuffati e non si sa la fine che hanno fatto. Questo giorno, se ben ricordo, dovrebbe essere stato il giorno 22 aprile ’45. Il giorno successivo davano la caccia ai fascisti. Partigiani e alleati americani assieme solo per tre giorni, ci fu carta bianca per la popolazione di vendicarsi dei fascisti. Il comando alleato, gli americani, proibirono spargimento di sangue, oltre alla data stabilita. Continuava la caccia ai fascisti, venivano messi in prigione, processati per direttissima, in special modo quelli che avevano fatto rappresaglie o torture e taluni capi che fecero fare fucilazioni. Non ricordo la data, ma il primo processo svolto a Reggio ci sono andato in bicicletta, perché mancavano i mezzi di trasporto. Ero presente in aula, quando fecero le accuse contro a un tenente, un sergente e altre tre camice nere. Erano dei specialisti nel torturare partigiani e staffette. Al processo cerano i torturati, che precisavano le torture ricevute. L’aula era gremita, c’erano gli altoparlanti installati nelle diverse piazze, sicché uno poteva seguire il processo restando fuori dall’aula. Io non mi accontentavo se non vedevo gli imputati, perciò facevo sacrificio per entrare in aula. Se ne sentivano di tutti i colori. Due ragazze che i fascisti arrestarono perché erano staffette partigiane. Il presidente del tribunale le interrogò alla presenza dei torturatori e a un certo punto fece sgombrare l’aula perché le ragazze dovevano fare vedere le cosce tutte graffiate dai cani oltre alle torture subite. Credo che in quel processo, il tenente Pilati, così si chiamava, e il sergente siano stati condannati alla fucilazione. Ritornando agli ultimi giorni della guerra in Italia i tedeschi si concentravano a Guastalla per passare il Po, siccome anteriormente avevano fatto saltare il ponte, per strumentalizzazione belliche, tentavano di passarlo a nuoto o con balle di paglia oppure tavole di legno, ma il Po è un fiume di rapina erano più quelli che annegavano che quelli che riuscivano ad attraversarlo. In pochi giorni, grazie ai partigiani e agli alleati, sparirono tutti i tedeschi e i fascisti. Il 25 aprile 1945 fu dichiarato l’armistizio. C’era chi manifestava gioia, per la fine della guerra, e altri che piangevano, non sapendo dove si trovavano i loro congiunti, purtroppo la maggior parte doveva ancora tornare, e purtroppo molti non tornarono mai più. I capi della repubblica di Salò, tutti fascisti, si rifugiarono presso il comando alleato. Quando i partigiani chiedevano uno di questi capi fascisti, per portarli sui loro misfatti, glieli davano, a condizione di non torcerli un capello, loro ne erano responsabili. 50 Ricordo che un certo Lodini Alberto nativo di Campagnola faceva parte della repubblica di Salò, perciò un capo fascista tanto più comandante della piazza di Campagnola quel maledetto 15 aprile 1945. Fu ucciso Bellesia Pierino, Salati Secondo e Piron. I partigiani fecero richiesta al Comando alleato per portarlo a vedere il misfatto del 15 aprile, che lui senz’altro conosceva bene. Glielo consegnarono, lo fecero inginocchiare davanti alla lapide dei tre martiri, però era protetto dai partigiani, armati, nessuno lo poteva toccare. Molte persone seguivano questi raffronti di parole se ne sentivano di tutti i colori, ricordo solo una: «A Lodini gli facciamo il funerale prima di morire». In conclusione, a questa data 11 dicembre ’78 Alberto Lodini si trova libero. 51 Documenti Dr. Eugenio Amonn, Lugano, via Loreto 10 Tre lettere di Eugene Dollmann a Dino Prandi (1952-1968) a cura di Massimo Storchi Il primo incontro fra Dino Prandi1 e il colonnello Dollmann (Ratisbona, 8 agosto 1900-Monaco di Baviera, 17 maggio 1985) avvenne nel settembre 1943 quando l’ufficiale tedesco, di passaggio a Reggio e su indicazione di Alcide Spaggiari che l’aveva accompagnato in una breve visita turistica al centro della città, si recò alla Libreria Nironi e Prandi di via Crispi alla ricerca di un volume di Clelia Fano. Qualche mese dopo, stabilitosi ormai nella Villa Brazzà alla Roncina2, Dollmann tornò (questa volta in divisa da colonnello delle SS e accompagnato da due pastori tedeschi) in libreria alla ricerca di altri volumi (questa volta la Figlia di Iorio di D’Annunzio). La sua richiesta non potè essere esaudita da Prandi, ma l’occasione per un nuovo incontro era solo rimandata. Fra la fine di novembre e gli inizi di dicembre 1944 la questura e l’upi (Ufficio politico investigativo) della gnr misero a segno un duro colpo alla struttura clandestina reggiana con l’individuazione e l’arresto di alcuni membri del Comando piazza (il braccio militare del cln provinciale). Finirono nel carcere dei Servi e sotto le torture fasciste a Villa Cucchi Angelo Zanti (Amos), Carlo Dino Prandi (1915-2004), figlio di Giacomo (Nino) e nipote di Gino (1904-1970), titolare della libreria «Nironi e Prandi», fondata nel 1926 da Giacomo Prandi e Arturo Nironi e che fu, durante il fascismo, l’unico luogo libero in città di incontro fra intellettuali e antifascisti (per questo ebbe il nome scherzoso di «farmacia»). La famiglia Prandi era di salde radici socialiste e lo stesso Nino era stato arrestato nel 1941 per le sue idee politiche. Si veda: Come si viveva a Reggio Emilia sotto l’occhio vigile dell’ovra, in «Ricerche Storiche» nn.17-18, 1972, pp. 91-112. 2 Sul soggiorno e l’attività a Reggio Emilia di Dollmann si veda: U. Pellini, Il colonnello delle SS Eugen Dollmann a Reggio Emilia in Almanacco nn. 38-39/giu-set. 2002, pp. 133-151; M. Storchi, Quando Dollmann chiese scusa ai partigiani, «RS-Ricerche Storiche», n. 83/1997, p. 60. 1 53 Calvi di Coenzo (Mariani), Luigi Ferrari (Pellegrini), capitano Adriano Oliva (Martini), Gino Prandi (Barra) e Alfeo Fontana3. Successivamente processati dal tribunale militare furono tutti condannati a morte4. Nella riunione del 9 gennaio 1945 presso la Militärkommandantur di Parma, per diretto intervento di Dollmann, fu decisa la sospensione della pena per Calvi, Ferrari e Prandi e la fucilazione del solo Zanti (avvenuta il 13 dello stesso mese)5. Pochi giorni prima Dino Prandi si era recato a Villa Brazzà per incontrare nuovamente Dollman, recandogli, come pretesto, la copia de La figlia di Iorio. L’incontro fu amichevole e Dollmann garantì il proprio interessamento. Prandi, Calvi e Ferrari furono successivamente trasferiti dalle carceri reggiane prima a quelle di Parma, sotto il diretto controllo tedesco (Dollmann non nutriva alcuna fiducia negli alleati fascisti) e poi presso il Comando tedesco ss di Verona, dove furono liberati il 28 aprile 1945. Da qui, a piedi, poterono rientrare a Reggio. Dino Prandi e Dollmann rimasero in contatto anche dopo la fine del conflitto, l’attività professionale e la riconoscenza del primo, la passione bibliografica del secondo furono gli elementi principali di questo rapporto. Le lettere che si pubblicano (grazie alla cortesia di Paolo Prandi, figlio di Dino) testimoniano di questo rapporto. Nella prima, del gennaio 1952, Dollmann è ancora costretto a firmarsi «Eugenio Amonn» («per evitare inutili sensazioni introno a un così stupido mito che si ha creato… al mio nome») e risiede a Lugano, in attesa di rientrare – come avverrà – nella sua Monaco dove trascorrerà il resto della sua vita. Il tono è cordiale, Dollmann si dice impegnato nella stesura della seconda parte delle sue memorie (probabilmente quel Libero schiavo uscito in Italia solo nel 1968) e si raccomanda a Prandi di recare un saluto ai Conti Spalletti ai quali lo legava una solida amicizia, maturata negli anni del suo soggiorno romano. Nella seconda lettera, del luglio 1968, mentre conferma l’interesse al classico catalogo della Libreria Prandi annuncia la propria partecipazione alla trasmissione della rai, dedicata alle vicende del 25 luglio 1943 e chiede «una qualche bella stampa… di Reggio… non avendo nessun ricordo del mio mai dimenticato soggiorno a Reggio». Nell’ultima lettera, successiva di un mese, Dollmann conferma la sua figura di impegnato scrittore di memorie e promette, in occasione di una sua prossima visita a Reggio (mai compiuta) di cui ricorda i «lontani giorni felici-infelici di allora!». Per le vicende legate all’arresto, processo e condanne ai membri del Comando Piazza si veda: G. Franzini, Storia della Resistenza reggiana, Edito a cura dell’anpi Reggio Emilia3, Reggio Emilia 1982, pp.403-404 e 495-504. 4 Secondo la testimonianza di don Prospero Simonelli, Dollmann apprese della notizia del processo ai sei antifascisti proprio da Nino Prandi nella Libreria dov’era spesso in visita. Si veda: P. Simonelli, Seguendo un processo in «Il Volontario della Libertà» 25 aprile 1946. 5 Il verbale della riunione è riportato in: Franzini, Storia della Resistenza reggiana, cit., p. 836. 3 54 Lugano, via Loreto 10* 17.1.1952 Gentile Signor Prandi, pocchi [sic] giorni fa, mi consegnava il mio amico di Basilea il suo graditissimo pensiero col quale mi avete fatto veramente una grande piacere. Non solo per i vostri – e, ahimè così ben ricordati cataloghi che anche a Basilea, nella città di Erasmo di Rotterdam hanno suscitato ammirazione ma anzitutto per i vostri amichevoli e gentili pensieri con i quali avete ricordato i tempi passati. Tempi, ai quali io, nonostante tutto che accadeva dopo, mi ricorderò sempre con piacere e con gratitudine e certamente in questi pensieri non sono dimenticati le varie ore trascorse fra i vostri libri e nella Vostra compagnia, ore lontane dalla guerra e dei suoi orrori. Ho sentito con vero piacere che a casa Sua tutto sta e tutto va bene e sono contentissimo che anch’io, come gentilmente Vi siete ricordati, ho potuto attribuire se bene in cosi piccola parte, a questo stato di cose. Ho ritrovato qualche vecchio ricordo, preso una volta da lei, fra i vostri cataloghi e con nostalgia penso dove saranno andati finire tutti i miei tesori bibliofili della Villa. Spero, quando il tempo futuro lo permetterà, e venendo una volta a Reggio, di trovare ancora presso di Lei il magnifico D’Annunzio e la sua Figlia di Jorio che per lunghe sere invernali mi tenne così buona compagnia. Le sarei molto grato se di tanto in tanto mi volete inviare i vostri cataloghi ed altre vostre pubblicazioni però – la provvidenza è la madre della sapienza – indirizzate a: Dr. Eugenio Amonn, Lugano, via Loreto 10. Ormai anche il Vostro così splendido indirizzo a Basilea non può fare più male, ma è sempre meglio ancora evitare inutili sensazioni intorno a un così stupido mito che si è creato – e voi lo sapete bene veramente senza la mia collaborazione – al mio nome. Personalmente sto bene ed ho molti progetti, ho viaggiato nuovamente molto e sto scrivendo la seconda parte delle mie memorie dal 1945 in poi. Se state in contatto coi Conti Spalletti, me li salutate per favore, per Lei e tutta la Sua famiglia anche da parte mia tutto il bene per questo anno così decisivo ed ancora sentiti ringraziamenti del Suo Eugenio Amonn *Gli errori sono nell’originale Monaco di Baviera, il 1 VII 1968 16 Fürstenstrasse Gent.mo Signor Prandi, tornato dal Medio Oriente d’un lungo viaggio, trovo al mio ritorno la Sua graditissima lettera ed il bel catalogo e mi affretto di ringraziarla per ambedue. 55 Mi piace che si interessa del mio nuovo libro e sentirei ben volentieri il suo giudizio a lettura finita. Ho sentito con molto piacere che Lei, Sua famiglia ed anzitutto Suo zio stanno bene e che tutto procede soddisfacentemente. Il 29 luglio la “RAI” farà una grande trasmissione sul 25 luglio e la liberazione di Mussolini, dove parteciperò anch’io e forse sarà interessante per Lei. Ancora una cosa: trovando una volta una bella stampa o qualche cosa del genere di Reggio, le sarei assai grato di volermelo mandare a mie spese, non avendo mai nessun ricordo del mio mai dimenticato soggiorno a Reggio. Passando per queste parti, non mancherò i vederLa; per oggi La saluto insieme con tutta la Famiglia Cordialissimamente Suo Eugenio Dollmann 8 München 2-16 Fürstenstrasse 14 VIII 1968 Gentile Signor Prandi, anzitutto, colle dovute scuse per il ritardo i miei ringraziamenti sinceri per la monografia sul “Tricolore” e sugli altri libretti, ricordandomi tutto con tanto piacere agli [sic] lontani giorni felici-infelici di allora! Ho letto tutto con molto interesse e vero piacere, commosso per il Suo gentile pensiero! Sono ben contento che Le ha piaciuto il mio libro, purtroppo nel momento non ho più un esemplare qua a Monaco, ma appena arrivata una nuova spedizione certamente non mancherò di inviarle un esemplare con dedica personale! Nei prossimi tempi “Lo Specchio” credo che porterà dei articoli miei che forse potrebbero interessarla. Sto scrivendo molto-ha letto forse “L’Europeo” in circostanze del 25 luglio 1943? Sicuramente, o nell’inverno prossimo o in primavera verrò in Italia e non mancherò di passare per Reggio Emilia, visitandola e riparlando di tante cose del passato! Per oggi, raccomandandomi ai Suoi, rimango con i miei più cordiali saluti Suo Eugenio Dollmann 56 Dollmann, il primo a sinistra con la camicia bianca, durante un incontro tra ufficiali probabilmente in un locale dell’ex gil, in via Gorizia a Reggio Emilia (data presunta fine 1944 inizi 1945) (Fototeca Istoreco) 57 Maria Bertolani Del Rio Colonia scuola «Antonio Marro» (Reggio Emilia)1 a cura di Francesco Paolella Il lettore troverà nelle prossime pagine la trascrizione di un resoconto, pubblicato nel 1927 da «Maternità ed Infanzia», bollettino dell’onmi (l’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, fondata appena due anni prima)2. Il testo è dedicato ai primi anni di vita di una istituzione medico-pedagogica, la Colonia-Scuola «Antonio Marro», creata nell’ambito del manicomio reggiano del «San Lazzaro»3. A firmarlo è stata Maria Bertolani Del Rio, psichiatra del manicomio e responsabile della Colonia-Scuola dagli inizi e fino a oltre la seconda guerra mondiale. Qui ci basterà segnalare soltanto qualche aspetto della vita di quella istituzione, che ha rappresentato per lungo tempo una realtà importante nel panorama sanitario ed educativo reggiano e, soprattutto, un dispositivo capace di mettere in pratica idee e progetti assai diffusi e radicati nella classe medica (psichiatrica in particolare) della prima metà del Novecento. In primo luogo, il convitto rispondeva a una esigenza ben precisa: curare ed istruire bambini e ragazzi, di entrambi i sessi, «deficienti intellettuali» ed «anormali del carattere», ma che fossero comunque passibili di emendazione: Pubblicato in «Maternità ed Infanzia», II, 5 (1927). Cfr. M. Minesso (a cura di), Stato e infanzia nell’Italia contemporanea. Origini, sviluppo e fine dell’onmi 1925-1975, Il Mulino, Bologna 2007. 3 Sul «Marro» cfr.: V. Fornaciari, J. Kasper, F. Paolella, La storia della Colonia-Scuola «Antonio Marro» dell’O.P. «San Lazzaro» di Reggio Emilia in «Servizi Sociali Oggi», 14, 1 (2009); F. Paolella, Un esperimento di profilassi sociale negli anni del fascismo. La Colonia-Scuola «Antonio Marro» di Reggio Emilia in Politiche di selezione. Numero monografico della «Rivista Sperimentale di Freniatria», di prossima pubblicazione. 1 2 58 con un periodo di osservazione, lo psichiatra (e, in seconda battuta, anche le insegnanti) doveva selezionare i soggetti che potessero migliorare nelle condizioni psico-fisiche, nella condotta, nell’apprendimento. In una formula, occorreva sottrarre i «deficienti» dalle «insidie del mondo», per renderli capaci di tornarvi dopo aver acquisito capacità lavorative. Questo convitto aveva appunto l’obiettivo primario di insegnare facili lavori manuali; di più, la disciplina del lavoro rappresentava essa stessa il più efficace strumento correttivo a disposizione di medici ed educatori. Pur presentandosi come «casa gioiosa», e nonostante il tono «umanitario» che domina anche in questo resoconto, il «Marro» era invece a tutti gli effetti un reparto del «San Lazzaro». In questo senso, ogni ambito della vita nella colonia (orari, disciplina, attività) proveniva necessariamente dal potere della direzione psichiatrica. E, come si diceva, la selezione degli ammissibili dipendeva in prima istanza dallo «sguardo medico». Un’ultima notazione è infine necessaria per contestualizzare questo scritto: in diverse occasioni i medici del «San Lazzaro» (la Bertolani del Rio, ma anche Giuseppe Guicciardi, allora direttore del manicomio) hanno sottolineato l’«assonanza» non casuale fra il progetto del «Marro» e le contemporanee politiche fasciste per l’infanzia4. In effetti anche questa Colonia-Scuola era presentata come dispositivo di «difesa sociale» e di «profilassi morale», e ciò in un senso molto ampio: se, da un lato, si voleva appunto porre rimedio all’abbandono da parte delle istituzioni mediche e scolastiche dei bambini con carenze intellettive e caratteriali, dall’altro lato, sullo sfondo rimaneva la precisa esigenza di individuare preventivamente e «normalizzare» tutti quei soggetti che, anche solo potenzialmente, avrebbero potuto rappresentare un pericolo, avvicinandosi alla delinquenza o essendo «traviati» (spesso si citava infatti il problema della prostituzione minorile). Origini e organizzazione La Colonia-Scuola A. Marro, annessa all’Istituto Psichiatrico di S. Lazzaro presso Reggio Emilia, è stata inaugurata il 15 giugno 1921 ed è destinata ad accogliere fanciulli, maschi e femmine, dai cinque ai sedici anni, anormali dell’intelligenza e del carattere, tutti emendabili in grado maggiore o minore. Ideata dal Direttore dell’Istituto Prof. Giuseppe Guicciardi, che ne tracciò gli scopi, ne diresse i lavori, ne stabilì l’organizzazione, ne curò tutti i particolari, «Una delle maggiori soddisfazioni di chi dedica la propria opera alla Colonia Scuola è di notare la perfetta corrispondenza di questa alla Legislazione fascista, che, come nessun’altra, si è preoccupata dei problemi dell’assistenza dell’infanzia» (M. Bertolani del rio, Il primo decennio della Colonia Scuola «A. Marro» in «Rivista Sperimentale di Freniatria», LXV, 1931, p. 649). 4 59 ebbe dall’On. Amministrazione del Pio Luogo e dalle Provincie di Reggio e di Modena ogni favore ed appoggio. La Colonia, circondata dall’aperta campagna, occupa un’ampia villa con annessi fabbricati e confina con la periferia dell’Istituto e con esso è in comunicazione immediata con viabilità interna. Alla villa si accede anche direttamente dalla città, così da lasciare l’impressione di una certa indipendenza, pur essendo la Colonia non altro che un reparto del grande Istituto, da cui infatti attinge per tutti i servizi generali. Due edifici nettamente separati sono adibiti a dormitori, refettori, laboratori e luoghi di soggiorno per i bambini e le bambine, mentre si pratica la coeducazione vigilata dei due sessi nella scuola, negli esercizi del canto, nelle passeggiate, nell’intervento ai divertimenti. Il personale di assistenza diretta degli alunni è tutto femminile. Alla sorveglianza di esso vigila insito una capo-sezione, e all’andamento generale dei servizi è preposta l’Ispettrice dell’Istituto. Una famiglia di custodi cura la manutenzione del giardino e dell’orto. Tre maestre, abilitate pure all’insegnamento della ginnastica educativa, impartiscono le loro lezioni nelle ore antimeridiane di ogni lunedì, mercoledì e sabato. Il martedì e il venerdì mattina sono dedicati al canto e alla ginnastica ritmica, sotto la direzione di una maestra di musica. Il giovedì mattina gli alunni ricevono dal cappellano dell’Istituto l’insegnamento religioso, che si ritiene utile a rafforzare i freni morali. Nelle ore pomeridiane del lunedì e del giovedì alcuni di essi si addestrano nel disegno e nella pittura sotto la guida di un esperto maestro. I pomeriggi tutti dei giorni feriali sono occupati nei vari laboratori: i maschi lavorano presso il sarto, il calzolaio, la canestraio; le bambine attendono alla calza, al cucito, al ricamo e sono adibite ai piccoli telai e alla macchina per le maglie. Inoltre i maschi coltivano a gruppi l’orto, e le bambine compiono a turno le varie faccende domestiche. Scopo dell’Istituzione Dato il ceto in prevalenza popolare che ospita la Colonia e considerata la media dello sviluppo intellettuale degli alunni, lo scopo dell’istituzione viene automaticamente tracciato verso il raggiungimento di risultati eminentemente pratici. Accanto all’istruzione elementare e all’educazione necessaria per una vita sociale dignitosa assume la massima importanza l’insegnamento professionale. Ecco perché nella Colonia è sempre in maggior sviluppo l’apprendimento dei lavori manuali e intorno al sarto, al calzolaio, al canestraio e alla maestra dei lavori femminili si raccoglie un forte nucleo di bambini e bambine. 60 Scelta dei soggetti Perché il nostro programma possa divenire realtà evitando un eccessivo e sproporzionato lavoro educativo, è necessario che i ragazzi accolti nella Colonia siano tutti suscettibili di emendamento. Devono quindi costituire un aggregato per quanto è possibile non troppo eterogeneo. Chi presiede alla Colonia ha sempre avuto di mira di evitare gli elementi «buoni soltanto a far numero»: tuttavia non si è mancato di accogliere in osservazione soggetti che lasciavano sia pure un’incerta speranza di buona riuscita finale. Nella diagnosi medica dei soggetti ci atteniamo possibilmente alla classificazione proposta dal De Sanctis nel suo recente Trattato di Neuropsichiatria infantile, il libro più completo e moderno che sull’argomento possiede la letteratura medica internazionale. L’esperienza ci ha insegnato che alcuni gruppi di malati – per non rompere l’armonia e l’ordinamento della Colonia – devono essere in linea generale esclusi. Tra questi vi sono gli epilettici, purché non si tratti di soggetti ad accessi molto rari ed in cui non si manifestino equivalenti psichici che rivestano una certa gravità. Un altro gruppo che noi – dopo una abbastanza vasta esperienza – abbiamo dovuto escludere è costituito da quelli che presentano gravi perturbamenti del carattere come postumi di encefalite epidermica. Esiste ormai una abbondante letteratura sui disturbi psichici che tale affezione lascia frequentemente nei bambini. La personalità di questi malati muta profondamente. Torpidi, apatici intellettualmente, in loro affiorano e si affinano istinti perversi. Essi divengono lamentosi, petulanti, piagnucolosi, a tratti aggressivi ed impulsivi, capaci di ogni più stolida azione, spessissimo cleptomani, mentre l’affettività subisce alternative di esagerazioni e di ottusità assoluta. Tali gravi perversioni del carattere – che ricordano quelle che sono state osservate in alcuni individui che hanno riportate lesioni dei lobi prefrontali – non sono suscettibili di alcun miglioramento con nessun mezzo di cura, come hanno dimostrato pure fra noi Ruata, Pellacani, Bolsi, ecc. Anche più vana appare l’opera emendativa rivolta a questi soggetti quando si pensi che i disturbi hanno un andamento progressivo, che nessuna terapia vale ad arrestare. Esclusi così in linea generale due gruppi di malati, che per alcuni sintomi hanno anche punti di contatto, esclusi a priori i gravi cerebropatici, gli audiomutismi idiotici, gli idioti mongoloidi, ecc., noi abbiamo discretamente limitata la nostra azione onde efficacemente svolgerla secondo il prestabilito programma. 61 Assistenza medica Il compito del medico preposto alla «Colonia-Scuola» è duplice, in quanto è diretto a rilevare, seguire e correggere le manifestazioni somatiche e quelle psichiche. Alla necessità di conoscere esattamente o di curare i disturbi dei due più importanti organi sensoriali, la vista e l’udito, si è sopperito richiedendo periodicamente l’opera illuminata di due consulenti specialisti, il dott. Bruno Pellegrini, oculista, e il prof. Gino Merelli, otorinolaringoiatra. Le eventuali alterazioni morfologiche e le attitudini costituzionali in un adulto possono essere ben poco influenzate perché esse sono ormai una condizione fissa, definitiva. In situazione molto migliore si trova invece il medico di fronte al bambino, perché la morfologia e la costituzione di questo sono ancora in corso di evoluzione. Non occorre addentrarci nel fitto e ipotetico intreccio che, specialmente per opera di Kretschmer, si va delineando sui rapporti costituzionali somaticopsichici. A me basta ricordare quale importanza pratica dal punto di vista educativo possa avere la constatazione in un bambino di uno stato ipotiroideo, di una costituzione linfatica, con vegetazioni adenoidi, di manifestazioni rachitiche con sintomi di spasmofilia, ecc. Principalissimo fra i problemi che si affacciano durante questo studio metodico dei soggetti è la ricerca dell’eziologia dei disturbi che essi presentano. Col progredire delle nostre conoscenze noi vediamo che molti fatti furono attribuiti alla così detta «degenerazione», che furono interpretati come «arresto di sviluppo», o come «ritorni atavici», sono semplicemente l’espressione di un processo patologico. Questo può consistere in un insulto meccanico, in una alterazione del circolo ecc., ma il più spesso è di natura infiammatoria, di origine infettiva. Esiste poi un gruppo a parte di deficienti con malformazioni grossolane: lussazione congenita dell’anca, ectromelia, miosite ossificante progressiva con brachidattilia, megaencefalia ecc.) nel quale non è aggredibile il fattore dannoso che ha agito sulla struttura scheletrica e ha minorato l’intelligenza. Non meno interessante dello studio somatico e neurologico dei piccoli allievi è quello delle manifestazioni che chiamerò psichiatriche in stretto senso. La maggior parte degli ospiti, che sommano attualmente a novanta, è costituita da deficienti intellettuali di tutte le possibili gradazioni, da epilettoidi compulsivi, da instabili, ma accanto a questi compaiono soggetti che presentano quadri meno frequenti nell’età infantile. Così p. es. una bambina di dieci anni microsomica e e con una lussazione congenita dell’anca, potrebbe servire di paradigma scolastico per la dimostrazione della frenosi maniaco-depressiva iniziatasi a 5 anni. Alcuni soggetti, in prevalenza femmine, sono stati accolti presentando le note più chiare e conclamate di isterismo: accessi convulsivi, mendacio, bisogno di richiamare in ogni modo su di sé l’attenzione altrui, ec- 62 cessive manifestazioni sentimentali, ecc. Quasi a dimostrare l’importanza della terapia suggestiva e dell’influenza dell’ambiente in tali casi, ho avuto il piacere di veder scomparire in breve tempo tutti i sintomi più clamorosi e in primo luogo le convulsioni, poi ho visto i malati subire un rapido adattamento alla nuova disciplina e divenire ottimi allievi. La terapia deve quindi essere psichica, medicamentosa e fisica. Per quest’ultima bagni, docce, applicazioni elettriche, cure di sole possono essere largamente usate. Per tutti poi è obbligatoria la ginnastica per la quale è stata creata una spaziosa palestra dotata dei principali apparecchi atti a sviluppare muscoli ipotrofici, a rieducare movimenti goffi o disordinati. Assistenza educativa Perché l’opera del medico approdi a buoni risultati, i nostri soggetti necessitano di una oculata, continua sorveglianza ed assistenza. Nessuno dei loro atti – sia pure semplice ed istintivo – deve sfuggire al controllo ed alla critica di chi è preposto alla loro educazione. È quindi problema di massimo valore la scelta del personale che li assiste e li guida in tutte le vicende della loro giornata. L’assistenza educativa mira pure ad un duplice scopo: intellettuale e morale. Maestre, assistenti, operai assumono in grado diverso in doppio difficile compito e devono perciò essere reclutati fra persone che abbiano speciali requisiti ed attitudini. La nostra Colonia – dopo un periodo di assestamento purtroppo lungo e faticoso – ha raggiunto alfine una sistemazione molto soddisfacente. L’orario stabilito, al quale si è già accennato, permette un alternarsi piacevole di occupazioni da parte dei bambini e consente il cambio a brevi intervalli del personale che assume così il proprio lavoro con energie non logorate da prolungate fatiche. Le maestre studiano singolarmente i soggetti ed impartiscono lezioni a piccoli gruppi ed anche individuali. La scuola è provvista di abbondante materiale pedagogico secondo i metodi ortofrenici più noti. Dopo cinque anni di esperienza le maestre hanno però adottato per norma didattica di seguire i programmi scolastici per fanciulli normali, frazionando e diluendo nei singoli casi quelle parti che riescono di più difficile comprensione. Ogni anno i bambini che hanno svolto un determinato programma vengono presentati come privatisti a sostenere gli esami delle pubbliche scuole di Reggio. Sinora i risultati finali sono stati sempre soddisfacenti. A lato della scuola è sorta una piccola biblioteca che va lentamente arricchendosi di libri, giornaletti, pubblicazioni illustrate. Per farci un concetto esatto della capacità di apprendere e dei progressi fatti dai singoli allievi, è stato istituito il diario mensile. Ogni alunno cioè possiede 63 un apposito quaderno nel quale alla fine di ogni mese deve scrivere, o sotto dettatura o spontaneamente. In quest’ultimo caso anche maggiormente quello che lo ha impressionato in quel periodo di tempo. Da questi componimenti soggettivi affiorano talvolta idee più complesse di quanto si poteva supporre e sentimenti lodevoli, frutto degli insegnamenti impartiti. Riguardo ai mestieri è lasciata per quanto è possibile libera la scelta. Avviene così che i ragazzi si applicano volentieri e traggono maggiore profitto. Nei laboratori i più esperti ed i più anziani di essi sono indirizzati ad aiutare i più deficienti ed i più piccini. Nelle donne è l’istinto della maternità che entra in gioco e l’aiuto reciproco non si lascia molto desiderare. Fra i maschietti la mutua cooperazione è più tardiva, ma raggiunge talora gradi lodevolissimi. Il senso dell’altruismo, che si cerca di sviluppare in essi con ogni mezzo, è stato spinto talvolta ad episodi commoventi. Per citarne uno, dirò come un giorno, in città, assistendo a una pubblica festa, alcuni dei nostri ragazzi scorgessero un loro ex-compagno. Chiamatolo, lo salutarono con espansione e lo costrinsero ad accettare tutto il poco denaro che avevano nei loro borsellini. Né abbiamo trascurato di instillare praticamente il senso del risparmio. Per ogni alunno è stato creato uno speciale libretto della locale Cassa di Risparmio. Il provvedimento fu accolto da tutti i bambini con grande gioia e con molte promesse, poi fedelmente mantenute. Merita speciale menzione un episodio significativo che di tanto in tanto si ripete da parte di un ragazzo. È questi, o per meglio dire, era questi un instabile che per le gravi anormalità del carattere i parenti furono costretti a ricoverare sette anni addietro nell’Istituto psichiatrico di San Lazzaro. Sorta la Colonia nel 1921, il ragazzo vi fu trasferito. Subito dopo il maestro di disegno si accorgeva della non comune abilità dell’allievo, il quale oggi, dopo quasi sei anni di degenza in Colonia – oltre che essere notevolmente migliorato di carattere ed avere fatto soddisfacenti progressi nella scuola e nel laboratorio del sarto – dipinge quadretti ad olio e ad acquarello che suscitano la sorpresa di chi li osserva. Ora questo ragazzo, evidentemente dotato di un talento parziale, occupa talvolta la sua ricreazione nel disegnare e nel dipingere per conto suo, avendo a sua disposizione materiale di sua proprietà. Ciò che egli eseguisce trova poi modo di vendere e quasi tutto il ricavato porta gelosamente a noi, perché sia depositato nel suo libretto. Esempio incoraggiante di ciò che possa raggiungere un’opera continua e paziente di educazione. Così, dopo quasi un sessennio di funzionamento della Colonia, a noi sembra di aver raggiunto un ordinamento che, per quanto lungi dall’essere perfetto, ci consente di sperare in sempre maggiori risultati finali. Però dopo così pochi anni di vita dell’Istituzione ci è permesso di prendere in considerazione soltanto frutti limitati del nostro lavoro. Non è possibile assurgere a giudizi di ordine generale e formulare statistiche. Queste verranno quando, dopo parecchi anni, si moverà nella libera vita un numero sufficiente ragguardevole di 64 antichi ospiti della Colonia. Così pure i risultati scientifici, che dal metodico studio biologico e psicologico dei soggetti potranno essere tratti, necessitano di un forte nucleo di osservazioni e di un lungo periodo di sedimentazione. È fatta però eccezione per i casi più interessanti, che hanno costituito oggetto di lavori a parte. Per ora ci basta di potere asserire che la «Colonia-Scuola» è una istituzione vitale, che corrisponde effettivamente ad una necessità sociale e che può compiere una benefica funzione umanitaria. 65 Biografie Dal Cusna a Botteghe di Albinea La vicenda reggiana del piper David Kirkpatrick Bruno Grulli La battaglia combattuta nelle ville Calvi, Rossi e Viani presso Botteghe di Albinea durante la notte del 27 marzo 1945, oltre che essere stata uno degli episodi salienti e più brillanti nella epopea resistenziale reggiana, costituì un singolare avvenimento per la partecipazione ad essa di un suonatore (piper) di cornamusa scozzese (bagpipe-pipe) che indossava il caratteristico gonnellino. Si tratta di un caso unico, per quanto ci risulta, in tutta la storia partigiana. L’operazione fu voluta dal comando alleato nell’intento di colpire uno dei più importanti obbiettivi nemici dell’Alta Italia e cioè la 5a sezione del comando tedesco che aveva sede David Kirkpatrick nel 1945 (arnelle tre ville albinetane ed il cui Ufficio inforchivio famiglia Kirkpatrick per mazioni era direttamente collegato con Berligentile concessione Matteo Inno. Si pensava inoltre che potesse esservi alcerti) loggiato il comandante supremo Kesserling1. In previsione del definitivo attacco alla Linea Gotica si valutò anche l’impatto morale e psicologico che avrebbe avuto sui tedeschi il sentirsi gli alleati già alle porte delle città della via Emilia. Per questo si volle che al combattimento partecipasse una cornamusa scozzese per 1 G. Franzini, Storia della Resistenza Reggiana, anpi, Reggio Emilia 1966, pp. 634-638. 67 siglare la paternità dell’attacco. Sull’avvenimento venne realizzato dalla rai nel 1969 un servizio televisivo2. Gli uomini, appartenenti allo Special air service britannico, e il materiale per l’operazione vennero paracadutati in più lanci alle pendici del monte Cusna già dal 4 marzo, data di inizio della cosiddetta «Operazione Tombola». La frequenza e la quantità dei lanci ha dato spazio nelle testimonianze e nelle relazioni a comprensibili divergenze sulle date, sugli orari e sui luoghi degli avvenimenti3. Per ultimo venne comunque lanciato, il 24 marzo, il suonatore di cornamusa David Kirkpatrick. Romolo Fioroni (Franco, 1928-2010) delle Fiamme Verdi, che assistette a quel lancio, affermò che le cornamuse erano due e che si preoccuparono subito di recuperarne il contenitore anch’esso paracadutato4. Il piper venne in un primo momento scambiato per una donna a causa del suo gonnellino poi destò la curiosità degli abitanti di Case Balocchi suonando la cornamusa e «tutti i bambini gli andavano dietro...». Il paracadute venne in seguito usato per fare un vestito da sposa. Passando per Castiglione e Governara Kirkpatrick raggiunse Secchio che era in quel periodo la base della missione inglese guidata dal capitano Michael Lees. Gli anziani di Secchio ricordano che quando arrivò suonò la cornamusa nello spiazzo di fronte alla chiesa5. Alla sera, nella canonica di Secchio, si consumò una cena offerta dagli ufficiali inglesi; Kirkpatrick, secondo l’usanza scozzese, suonò la cornamusa durante la cena circolando attorno alla tavola imbandita quindi pernottò in una casa del paese6. La preparazione dell’azione era stata accurata e meticolosa; gli uomini che vi parteciparono vennero scelti tra i migliori elementi delle formazioni partigiane reggiane e tra coloro che avevano dimostrato maggior ardimento7. Alla missione inglese vennero aggregati oltre i partigiani appartenenti alla 26a e 145a Brigate «Garibaldi» e ai «Gufi neri» guidati rispettivamente da Gianni (Giovanni Farri, 1921-1991), Antonio (Nello Mattioli, 1922-1998) e Gordon (Glauco Monducci, 1923-2007), un gruppo di soldati russi fuggiti dai campi di internamento ed i paracadutisti britannici. Complessivamente un centinaio di uomini comandati dal maggiore Roy Farran (1921-2006). Un documentario televisivo sull’attacco di Albinea, in «RS-Ricerche Storiche», n. 7-8/1969, pp. 133-34, pag. 175. 3 G. Giovanelli, Fiamme Verdi, La Nuova Tipolito, Felina 2002, nota 17 a p.323. 4 Testimonianza di Romolo Fioroni del settembre 1999, confermata nel 2006 a Paolo Simonazzi. 5 Si vedano M. Incerti, Il parà con il kilt e la cornamusa…, in «Carlino Reggio», 13 agosto 2010 e id, Col mio paracadute quella ragazza fece l’abito di nozze, in «Il Resto del Carlino», 12 agosto 2010. 6 Testimonianza di Bruno Gimpel dell’1 settembre 2010. 7 Si vedano L’ardita azione di Botteghe descritta da un ufficiale inglese, in «Il Nuovo Risorgimento», 26 marzo 1950 e L’attacco di Botteghe, in «Il Nuovo Risorgimento» del 27 marzo 1950. 2 68 Giovanna Quadreri (Giorgio), nata nel 1928 a Marola, accompagnò il gruppo degli inglesi, David ed altri aiutanti locali, circa quaranta persone, da Secchio a Montelago di Valestra. Partirono dopo la mezzanotte da Secchio, percorsero la costa destra sopra il Secchiello, lasciarono sulla sinistra Vogno e Cerrè Marabino, passarono per Predolo, Rondinara, Cavola e attraversarono il ponte sul Secchia; quindi passarono per Colombaia per arrivare a Montelago dopo le ore 12 del 25 marzo. Tutto a piedi, per mulattiere e sentieri, evitando di entrare nei borghi. Dopo quella sgambinata si riposarono ma già nel pomeriggio il piper Kirkpatrick suonò la cornamusa nella villa dove erano acquartierati8: era stato arruolato per suonare e ovunque poteva lo faceva per rimarcare la presenza alleata. Incerti Amabile, partigiano di Baiso (1923-2005), affermò di averlo visto dalle parti di Villaprara ma sicuramente all’epoca della intervista ci fu confusione con Valestra: «al gh’iva la vèsta e al suneva la piva… e la gente si meravigliava nel vedere quel giovane in sottana che suonava»9. Il 25 marzo tutti gli uomini erano già concentrati a Valestra. Base di partenza della operazione, il borgo sembrava una grande caserma. «Nel pomeriggio si cantava La brigata Garibaldi10 e l’eco di questa canzone … rispondeva nell’aria come un suono giulivo di campane nel dì di festa…». Proveniente da Montelago alla testa di un gruppo di paracadutisti arrivò anche Kirkpatrick suonando la cornamusa e destando la curiosità dei presenti: «un suono strano, come proveniente dall’aldilà ci scuote all’improvviso… una melodia così dolce e nello stesso tempo così strana… uno di quei famosi scozzesi in sottanino che sta soffiando a pieni polmoni nella cornamusa…»11. L’effetto della bagpipe di Kirkpatrick fu di stupore non solo per Monducci ma anche per le popolazioni locali. Da Villa (borgo distante meno di un chilometro da Valestra) udirono quel suono e «pensarono che i partigiani facessero una festa; quando corsero a Valestra si meravigliarono nel vedere questa gente col gonnellino, fu una sorpresa…»12. In alcune testimonianze raccolte la bagpipe venne chiamata «la piva», probabilmente per la sua struttura e per il suono stridulo simile a quello della estinta cornamusa locale, la cui memoria era forse ancora presente nell’immaginario della gente ma non come strumento guerriero. «Quel soldato con la sottana soffiava dentro una piva… e mentre suonava gli altri tutti dietro...»13. Testimonianze ed informazioni di Giovanna Quadreri del 13 settembre 2010. Si vedano B. Grulli, Un piper scozzese tra i partigiani reggiani, in «Notiziario anpi», n. 7-8/2010 e Testimonianza di Amabile Incerti raccolta a Baiso il 7 marzo 1983. 10 G. Monducci, Gufi, brigata alleata e Garibaldini uniti combattono e vincono, in «Il Volontario della Libertà», nn. 32/33/34/35, 29 luglio 1945-5/12/, 19 agosto 1945. 11 Si vedano G. Monducci, …e vennero i giorni del Gufo Nero, Bertani, Cavriago 1995, p. 117, e id, Gufi, brigata alleata e Garibaldini uniti combattono e vincono, cit. 12 Testimonianza di Pellegrino Montecchi (Valestra, classe 1935) raccolta il 13 agosto 2010. 13 Testimonianza di un anziano (allora circa ottantenne) raccolta nell’aprile 1982 a Valestra. 8 9 69 Lo stupore dunque non fu solo per la bagpipe ma per quello scozzese in kilt che la suonava mentre procedeva. Al loro passaggio alcuni bambini si erano nascosti dietro le siepi14 ma un po’ in tutta la zona ricordavano quelle scene, forse anche con un po’ di timore15. Era Farran che dava importanza alle parate con la cornamusa. Tra le 19 e le 22 (come premesso le testimonianze sono a volte contrastanti) il battaglione completo mosse da Valestra e, dopo una faticosa ed insidiosa marcia notturna al «chiaror di Luna»16, raggiunse tra le 4 e le 6 del mattino la Ca’ del Lupo sopra Vezzano. Dopo le pesanti marce fecero finalmente una lunga sosta in quel luogo. Alle 23 calarono attraverso il Più Bello fino a Botteghe dove, alle 1.30 del 27 marzo il centinaio di arditi attaccò di sorpresa il comando tedesco a Villa Calvi e Villa Rossi. Kirkpatrick partecipò all’azione ma non fu lui a lanciare l’attacco come forse avrebbe voluto Farran17. La cosa fu quasi concomitante perché «ai primi spari aveva già gonfiato il sacco…»18. «Fu una battaglia cruenta … si combattè col pugnale e col calcio del mitra per non colpire i compagni vicini…»19 e «in mezzo a questa sarabanda di scoppi e di urla si levava il suono di una zampogna scozzese che accompagnava l’azione dei paracadutisti inglesi…»20 e «nel frastuono della battaglia: ma che odo? Sto forse delirando… pare impossibile ma è il suono della zampogna che ho già udito a Valestra… lo scozzese col sottanino ci ha seguiti anche nell’attacco… ed ora sta correndo tra le due ville…» come ricordava Monducci dopo che era stato ferito21. Livio Piccinini aveva accennato a due suonatori22 ma fu il medesimo Kirkpatrick che passò da villa Calvi a villa Rossi come confermato da Farran23. Il piper era stato arruolato nell’High land infantry regiment ma venne richiesto negli ultimi giorni da Roy Farran in considerazione dell’effetto morale che avrebbe avuto sui tedeschi24. Testimonianza di Vincenzo Ugoletti del marzo 2001 e testimonianza del signor Beretti (all’epoca bambino) raccolta nell’aprile 1982 a Valestra. 15 Testimonianze ed informazioni di Giovanna Quadreri del 13 settembre 2010 e testimonianze varie raccolte a Cavola e Valestra il 21 dicembre 1981. 16 Si veda Monducci, …e vennero i giorni del Gufo Nero, cit., pp. 118-119. 17 R Farran, L’attacco di Botteghe, trad. italiana a cura di Graziella Galeazzi, in «Ricerche storiche», n. 25/1975, p. 58, (Id, Operazione Tombola, Collins, Londra 1960). 18 Testimonianze di Nello Mattioli raccolte dai figli Antonello e Tiziano nel 1993/94. 19 L’ardita azione di Botteghe descritta da un ufficiale inglese, in «Il Nuovo Risorgimento», 26 marzo 1950. 20 L’attacco di Botteghe, in «Il Nuovo Risorgimento», 27 marzo 1950. 21 Monducci, Gufi, brigata alleata e Garibaldini uniti combattono e vincono, cit. 22 Testimonianza di Livio Piccinini del settembre 1981. 23 Farran, op. cit., cit pag. 58. 24 M. Lees, Special operation executed, in Monducci, …e vennero i giorni del Gufo Nero, cit., p.143. 14 70 Già a Secchio si erano dileggiati sulla presenza di questo suonatore in basco e gonnellino25 e anche a Valestra «si era ironizzato su di lui… io e Taras ridevamo nel pensare che noi partigiani conducevamo una guerra ben diversa, non con psicologie così raffinate26... ma quando cominciò a suonare in battaglia sotto il tiro nemico anche i partigiani rimasero impressionati. Tra i tedeschi si creò il panico perché ben sapevano che con la cornamusa c’erano gli uomini votati alla morte…»27. «Erano terrificati dalle sue note solenni e terribili lanciate nell’aria…»28. Nello Mattioli, che era posizionato vicino a David Kirkpatrick, disse: «quel suonatore fu per noi una vera sorpresa… i garibaldini reggiani non avevano mai visto una cosa simile ed in un primo momento si era sorriso perché si riteneva che in battaglia lo schioppo contasse di più di una piva… ma dopo l’inizio della battaglia si resero conto che aveva un peso non comune nell’attacco, che il suo contributo era notevole perché aveva intimorito i tedeschi ed aveva fatto diminuire il loro volume di fuoco… più tardi si disse che un soldato con la piva valeva di più di uno con lo schioppo…»29. «Durante l’attacco si vedeva ogni tanto tra le fiammate delle armi la sagoma di Kirkpatrick che avanzava, egli infatti si era esposto molto quindi si era piazzato dietro un albero accanto ad una mitragliatrice che sparava direttamente su villa Calvi probabilmente inviato là dallo stesso Farran. Insomma il suonatore fu molto coraggioso ed il suono della cornamusa si udiva nonostante il frastuono della sparatoria»30. Sul fianco destro del piper, che «appariva come una figura sempre molto vicina al suo comandante…», stavano gli attaccanti riparati dagli anfratti del terreno31. Kirkpatrick suonò fino verso la fine del combattimento per incitare gli attaccanti32, sappiamo che intonò spesso Higland Laddie33, un classico delle bande militari scozzesi34 finché una pallottola di rimbalzo perforò l’otre della bagpipe rendendola inutilizzabile35 ma lui sopravvisse, si mise al riparo in un fossato quindi si sganciò verso il Crostolo assieme agli altri. Ibidem. Testimonianze di Nello Mattioli raccolte dai figli Antonello e Tiziano nel 1993/94. 27 Testimonianza di Livio Piccinini del settembre 1981. 28 A. Alpi, Notte di fuoco e di sangue ad Albinea, in «Reggio Democratica», 27 marzo 1946. 29 Testimonianze di Nello Mattioli raccolte il 10 agosto 1981. 30 Ibidem. 31 Testimonianze di Nello Mattioli e Livio Piccinini dell’ottobre 1987, Testimonianza di Giovanni Farri del marzo 1983. 32 Testimonianza di Giovanni Farri del marzo 1983. 33 Higland Laddie è ascoltabile in tanti video diffusi nel Web. 34 Farran, op. cit., p. 58. 35 Testimonianza di Giovanni Farri del marzo 1983; A. Farri, Quella notte di marzo a Botteghe di Albinea, in «Notiziario anpi», nn. 5/6, luglio 2010. 25 26 71 L’azione durò circa un’ora ed alle 2.30 era già finita con successo. Tra le forze alleate caddero tre inglesi e otto restarono feriti (Lees e Monducci compresi) mentre i tedeschi riportarono diverse decine di caduti ed innumerevoli feriti, il Comando, l’Archivio e l’Ufficio Cartografico dati alle fiamme e distrutti36. I fascisti tesero a minimizzare il fatto e sulla loro stampa scrissero di ben otto morti e moltissimi feriti tra i nemici37. I garibaldini reggiani non parlarono con Kirkpatrick, in primo luogo per problemi di lingua, ma anche per i rapporti di diffidenza esistenti con la missione alleata che preludevano già ai tempi della guerra fredda38. Parte del distaccamento, dopo la battaglia, ripiegò su Ca’ del Lupo e dopo una marcia a tappe forzate raggiunse Valestra. Al ritorno dalla missione vittoriosa, nonostante la stanchezza, gli uomini si disposero incolonnati per tre ed al suono della cornamusa sfilarono per il paese. Questa volta però la gente applaudiva e i bambini correvano ai lati del suonatore. A Valestra Farran sperava che in lontananza i tedeschi li udissero perché sapessero che il battaglione era già in zona franca39. Come avrà fatto Kirkpatrick a disporre di una cornamusa funzionante dopo che l’otre era stato bucato da un proiettile? Riuscì forse a ripararla (cosa abbastanza complessa) durante la spericolata e sfiancante marcia di ripiegamento o ne aveva una di scorta40? Si vuole che il suono della cornamusa avesse contribuito a salvare la popolazione di Albinea da una feroce rappresaglia in quanto i tedeschi credettero di trovarsi di fronte l’esercito alleato e non brigate partigiane41. Dopo l’attraversamento del Secchia il distaccamento si ricongiunse con le Fiamme Verdi a Cavola. Come egli stesso confessa nel suo discusso diario42 Farran arrivò più stremato degli altri e dovettero trasportarlo su un cavallo43. Il distaccamento alleato partecipò in seguito ai combattimenti di Ca’ Marastoni e di Monte della Castagna per poi ricongiungersi a Sillano con le forze alleate44. Monducci, Gufi, brigata alleata e Garibaldini uniti combattono e vincono, cit. Dure perdite partigiane ad Albinea, in «Il Solco fascista», 28 marzo 1945. 38 Testimonianze di Nello Mattioli raccolte il 10 agosto 1981, Testimonianze di Nello Mattioli e Livio Piccinini dell’ottobre 1987. 39 Farran, op. cit., p. 58. 40 Testimonianza di Romolo Fioroni del settembre 1999, confermata nel 2006 a Paolo Simonazzi; Grulli, Un piper scozzese tra i partigiani reggiani, cit. 41 Si vedano Diario di Don Ugoletti del 27 marzo 1945, in Villa Rossi 50° Anniversario, a cura del Comune di Albinea e Associazione Pro Loco Albinea, 1995 e M. Incerti, Col suono della cornamusa evitò la strage nazista a Villa Rossi, in «Carlino Reggio», 15 luglio 2010. 42 Si vedano B. Gimpel, La missione inglese presso i partigiani reggiani, in «Ricerche storiche», n. 40/1980 e L. Casali, La relazione ufficiale inglese su Botteghe di Albinea, in «Ricerche Storiche», n. 44-45/1981. 43 Farran, op. cit., p. 58. 44 Si vedano G. Franzini, Storia della Resistenza Reggiana, anpi, Reggio Emilia 1966, pp. 634-638, e Gimpel, La missione inglese presso i partigiani reggiani, cit., p. 84. 36 37 72 Dopo la sfilata di Valestra però le tracce del nostro piper si perdono e nessuna cornamusa suonò nelle battaglie successive, probabilmente venne inviato in altre zone45. Nemmeno a Sillano, per quanto ci risulta, si ha memoria di passaggi di cornamuse in quei giorni46. Di Kirkpatrick non si seppe più nulla, gli ambienti storiografici locali se ne disinteressarono e non ne conoscevano nemmeno il nome e l’età e se fosse ancora vivo. Solo nel 1982 l’opuscolo «La piva dal carner» dedicò due paginette alla sua vicenda reggiana47. Dopo un anno di ricerche il giornalista Matteo Incerti lo ha rintracciato nel giugno del 2010 e, tramite il figlio Lee, lo ha intervistato. David Kirkpatrick è ancora vivo, nato nel 1926 aveva all’epoca 19 anni. Oggi ne ha 84 e vive in Scozia a Girvan, un piccolo villaggio di pescatori sulla costa occidentale. Ha un brutto ricordo della guerra. I ricordi di quella terribile notte a Botteghe se li è portati per tutto il dopoguerra e non ne ha mai voluto parlare prima di oggi: «una cosa tremenda, morirono tanti giovani, vidi bruciare vivi dei tedeschi dentro una delle ville, la guerra è orrenda…». Minatore prima della guerra al ritorno dal fronte si è sposato e ha avuto quattro figli. In un primo tempo ha nuovamente lavorato in miniera sempre presso Girvan poi in una fabbrica di lavorazione di alghe. Ha continuato a suonare la cornamusa per tutta la vita ed i suoi figli ne hanno conservato la tradizione48. 45 46 47 48 Testimonianze di Giovanni Farri e Glauco Monducci del novembre 1981. Testimonianze di anziani di Sillano del 20 dicembre 1981, confermate il 21 agosto 2010. BG, Piper & Brigata Garibaldi, in «La Piva dal Carner», n. 17/1982. M. Incerti, Tutta la vita ho avuto gli incubi di quella notte, in «Notiziario anpi», n. 7-8, 2010. 73 Luglio 1943-aprile 1945 Gismondo Veroni Una biografia Mario Frigeri Il 25 luglio 1943 Gismondo Veroni era sergente furiere della Divisione «Messina», stanziata a Metkovich (Croazia). L’annuncio della destituzione di Mussolini fu accolta con gioia dalla maggior parte dei suoi commilitoni, ma il successivo annuncio radiofonico del maresciallo Badoglio, nominato dal Re al posto del duce, ne raggelò le speranze di una rapida conclusione della guerra da parte dell’Italia. I soldati, convinti che la continuazione guerra a fianco dell’Asse avrebbe inevitabilmente portato alla sconfitta, cercarono di instaurare un dialogo con gli ufficiali della divisione per convincerli a far cessare le ostilità. Veroni fu uno di quelli che si espose maggiormente e, per questa ragione, subì una denuncia per offese alla patria e minacce ai superiori. Grazie all’aiuto di un amico, il sergente Bortesi, gli ufficiali che lo avevano denunciato, i quali volevano forse liberarsi di un «piantagrane», decisero di mandarlo in licenza. Veroni tornò a Reggio Emilia il 30 agosto 1943 e, appena giunto nella sua Rivalta, prese immediatamente contatto con gli amici del pci clandestino. Da loro venne a sapere che, il 3 settembre, Attilio Gombia era tornato da un incontro con Luigi Longo a Roma con l’ordine di riorganizzare il partito, per renderlo funzionale alla lotta armata contro gli occupanti tedeschi. Fino a quel momento il partito si era limitato alla sola opposizione politica non armata e 74 non aveva ancora iniziato a combattere militarmente i nazifascisti, come già succedeva nel resto dell’Europa occupata dalle truppe di Hitler. Nei pressi di Montecavolo. 9 Settembre 1943 Dopo la notizia dell’armistizio1, i dirigenti del pci clandestino si riunirono, il pomeriggio del 9 settembre nelle campagne di Montecavolo, per decidere come comportarsi di fronte all’occupazione tedesca. Alla riunione parteciparono: Scanio Fontanesi, Armando Attolini, Ferdinando Ferrari, Alcide Leonardi, Osvaldo Poppi, Gismondo Veroni, Spero Ghidoni, Sante Vincenzi, Arrigo Nizzoli, Cesare Campioli, Gaetano Chiarini, Silvio Fantuzzi, Celso Giuliani e Attilio Gombia. Gombia informò subito i presenti delle direttive impartitegli da Luigi Longo in merito all’inizio della lotta armata2. Vi erano però numerosi dubbi su come andasse organizzata. Su questo aspetto si rivelarono decisive le esperienze di Cesare Campioli nel Maquis francesi e di Veroni in Croazia, dove le truppe d’occupazione da tempo stavano combattendo contro i guerriglieri di Tito3. In base ai loro consigli si decise che, per dare inizio alla lotta armata, occorreva: • recuperare le armi e munizioni abbandonate dal Regio esercito; • prendere contatto, comune per comune, con persone di sicura fede antifascista allo scopo di reclutare i quadri dirigenti del nascente movimento partigiano; • trovare case sicure (quelle che verranno poi chiamate «case di latitanza») dove nascondere i ricercati, curare i feriti e gli ammalati e immagazzinare armi, munizioni e viveri; • contattare medici ed infermieri per avere un minimo di assistenza medica e per procurare medicine ed articoli sanitari; • iniziare a selezionare piccoli nuclei armati da usare per combattere i fascisti pronti a schierarsi di nuovo con i tedeschi, e in particolare colpire i lori capi4. Per mettere in pratica questi cinque punti, il pci clandestino decise di dar vita al «Comitato militare», che divenne il braccio armato del partito. Furono scelti per farne parte: Alcide Leonardi (D’Alberto), Gismondo Veroni (Tito poi Bortesi poi Franchi), Osvaldo Poppi (Davide) e Ferdinando Ferrari (Marte)5. G. Magnanini, Il regime Badoglio a Reggio Emilia. 25 luglio-8 settembre 1943, Teti, Milano 1999. G. Franzini, Storia della Resistenza Reggiana, anpi Reggio Emilia, Reggio Emilia 1966, p. 13. 3 Ibidem. 4 Ivi, p. 15. 5 G. Veroni, Considerazioni sui Cervi, in «Ricerche Storiche», nn. 38-39/1979, pp. 117-121. 1 2 75 I primi contatti Didimo Ferrari, militante comunista di Campegine da poco liberato dalle carceri e dal confino, informò Veroni che in quel paese Aldo Cervi, l’organizzatore della cena in piazza del 27 luglio per festeggiare la caduta del duce, stava formando una banda armata composta dai suoi sei fratelli e da numerosi militari alleati evasi dopo l’armistizio che i Cervi avevano ospitato. Veroni era dell’idea che la Resistenza reggiana fosse ancora troppo impreparata per iniziare la lotta armata e che fosse quindi necessario evitare azioni avventate, le quali avrebbero prodotto come unico risultato quello di attirare l’attenzione delle truppe d’occupazione tedesche. Il rischio era quello di essere eliminati ancor prima di iniziare a combattere. Decise quindi di incontrare Aldo Cervi per dissuaderlo dal compiere azioni improvvisate. Da Sesso, insieme a Didimo Ferrari, si recò a Campegine dove questi gli presentò un compagno locale e amico di Aldo, Tommaso Bertani, che a sua volta lo accompagnò a Casa Cervi. Lungo la strada, Bertani informò Veroni che Aldo e i suoi uomini avevano già iniziato a compiere raid in zona con un auto sottratta ai fascisti, durante i quali mostravano le loro armi dai finestrini del veicolo. Durante l’incontro Veroni espose le decisioni prese dal Comando militare sull’inizio della lotta armata, ma Aldo gli rispose che lui e i suoi erano già pronti a combattere e non avrebbero atteso gli ordini, né del Comando né di chiunque altro. Veroni si limitò a controbattere: «State sottovalutando il pericolo a cui vi esponete», dopodichè tornò a Reggio Emilia per riferire a D’Alberto. Prima di partire raccomandò a Tommaso Bertani di organizzare i partigiani locali ma di evitare contatti con la famiglia Cervi per non metterli in pericolo6. In montagna Quindici giorni dopo l’incontro con Aldo Cervi a Campegine, D’Alberto ordinò a Veroni di recarsi in montagna insieme a Davide. Otello Salsi, un compagno di Cervarezza, aveva segnalato l’insediamento in zona di una banda armata, le cui incursioni nei dintorni stavano allarmando la popolazione locale. Fu lo stesso Salsi ad accompagnare Veroni e Davide a Cervarezza e, una volta giunti a destinazione, li fece incontrare con gli uomini della famigerata «banda». Erano Aldo Cervi ed i suoi uomini, i quali volevano imitare le bande partigiane di Tito sui monti della Jugoslavia. Veroni, che aveva visto all’opera le bande partigiane di Tito, cercò di spie- 6 Ibidem. 76 gare ad Aldo e ai suoi uomini che in Jugoslavia il territorio montano era molto diverso dall’Appennino reggiano: più boscaglia, meno centri abitati, strade quasi inesistenti o che passavano per profonde vallate e pertanto adatte per preparare imboscate al nemico. Ma Aldo e i suoi, in particolare Dante Castellucci, risposero accusando di «attendismo» Veroni, Davide, e tutto il Comitato militare reggiano. Terminato senza esito l’incontro, Veroni e Davide tornarono in città per riferire di quanto accaduto a D’Alberto e al responsabile del partito Angelo Zanti (Amos). A fine ottobre vi fu un cambiamento nel Comitato militare: Vivaldo Salsi (Montanari) subentrò a Davide, spostatosi nel modenese. D’Alberto informò Veroni che Aldo era tornato in pianura ed era quindi necessario un incontro per tentare nuovamente di ottenere un accordo. Veroni, pur pessimista sulle possibilità di accordo, concordò, ancora attraverso la mediazione di Bertani, un incontro a Campegine. Veroni propose nuovamente ad Aldo di integrare i suoi uomini con elementi coraggiosi e politicamente preparati, ma Aldo gli rispose che poteva contare su un numero sufficiente di combattenti e che essi, in merito alla preparazione politica, erano ben orientati perché istruiti personalmente da lui. Aldo sostenne con Veroni che era sua intenzione iniziare la guerriglia colpendo il nemico tanto in pianura quanto in montagna, usando gli uomini che da tempo aveva addestrato e preparato militarmente e politicamente. Secondo Cervi non c’era bisogno di altre forze, tanto meno di quelle che lui considerava «attendiste». Veroni manifestò il suo dissenso verso una lettura «giacobina» della realtà, perché la battaglia, secondo lui, si sarebbe preannunciata molto lunga. Per affrontarla era necessario costruire una forte organizzazione e non affidarsi allo «spontaneismo». Ma Aldo Cervi, come si vedrà, non accettò i suggerimenti di Veroni. Si limitò a rispondere: «Arrivederci, vienimi a trovare ancora». Nascono i gap Nei primi giorni del novembre 1943 giunse da Bologna Ilio Barontini7 per incontrare il gruppo di Veroni. Egli era un reduce della guerra di Spagna, aveva organizzato i guerriglieri del negus in Etiopia e combattuto nelle file del Maquis in Francia. Dall’alto della sua esperienza militare suggerì, come unica strategia possibile per affrontare i nazifascisti in mancanza di una forza armata organizzata, di colpire direttamente i vertici del rinato partito fascista. Uno de- 7 Su Ilio Barontini si veda: F. Baldassarri: Un garibaldino del ’900, Teti Editore, Milano 2001. 77 gli obiettivi poteva essere il federale provinciale l’avvocato Giuseppe Scolari. Veroni, già da qualche tempo, aveva reclutato un piccolo nucleo di uomini desiderosi di iniziare a combattere militarmente i tedeschi e i fascisti, i quali andarono poi a formare il primo nucleo della futura Brigata gap. Tra questi vi erano: Rino Soragni (Muso), Emore Silingardi (Mario), Lorenzo Gennari (Fiorello), Arrigo, Orfeo Becchi (Gaeta) e Lorenzani. Questi uomini pedinarono per diversi giorni il federale Scolari, sulla strada che questi percorreva alla sera dall’ufficio all’abitazione, e, una volta individuato il punto più favorevole all’attacco, comunicarono a Veroni di essere pronti. Attacco al Federale Quando Veroni comunicò a D’Alberto che i suoi gap erano pronti a catturare o uccidere il federale, questi gli ordinò di sospendere l’azione perché aveva assegnato la missione ad Aldo Cervi e a i suoi uomini. Di fronte alla comprensibile richiesta di spiegazioni da parte di Veroni sul perché di questa scelta, D’Alberto gli rispose che si trattava dell’ultimo tentativo per inglobare Aldo e la sua banda nelle file della Resistenza organizzata dal Comitato militare8. La sera del 13 novembre 1943, Aldo e i suoi tentarono di catturare il Federale ma, a causa della loro impreparazione e scarsa conoscenza dei luoghi, l’attacco fallì9. L’autista dell’avvocato Scolari riuscì, con una spericolata manovra, a sfuggire all’assalto, mettendo in salvo il gerarca. La rimozione di D’Alberto La decisione di affidare ad Aldo Cervi l’incarico di catturare il Federale, costò a D’Alberto la rimozione dal ruolo di comandante del Comitato militare. Il responsabile del pci clandestino, Gaetano Chierici (Lemmi), lo inviò a Parma e lo sostituì con Veroni stesso10. Nel suo nuovo incarico, assunto il nome di battaglia di Franchi, Veroni continuò a mantenere i contatti con Aldo Cervi. Considerandolo in imminente pericolo, lo invitò alla massima prudenza. Le forze armate della rsi, infatti, in particolare la gnr (Guardia nazionale repubblicana) e la sua polizia, l’upi, al comando del capitano Pilati, sotto la pressione del federale si erano messe alla ricerca degli attentatori11. Veroni, Considerazioni sui Cervi, cit., pp. 117-121. Ibidem. 10 G. Veroni, Azione partigiana. Racconti di tempi difficili, Libreria Rinascita, Reggio Emilia 1975, pp. 49-51. 11 Documento Prefettura R.E. Prot. 21035 in Archivio Istoreco Reggio Emila (d’ora in poi AISTO), b. 14/C, fasc. 6. 8 9 78 Ma Aldo non ascoltò nemmeno questa volta i consigli di Veroni e la sera del 21 novembre si mise di nuovo in azione: con sei uomini, a bordo di due auto, si recò a Fabbrico per compiere una rapina a casa dei fratelli Landini (i proprietari della locale fabbrica di trattori) allo scopo di autofinanziarsi. Sulla via del ritorno, in uno scontro con una pattuglia di carabinieri, una delle auto forò uno pneumatico e dovette essere abbandonata. Nella fretta di abbandonare il veicolo, uno degli uomini di Aldo smarrì il portafoglio con i documenti personali. «Il mattino seguente – così narra nella sua ricostruzione di quei tragici giorni Gismondo Veroni – incontrai Aldo a Mancasale e, conosciuto l’accaduto, lo invitai ad andarsene immediatamente da Campegine»12. La cattura dei Cervi. 25 novembre 1943 Aldo, pur mostrandosi preoccupato, ritenne però che la situazione non fosse così allarmante. Sottovalutò il nemico. Un nutrito reparto della gnr reggiana, all’alba del 25 novembre 1943, circondò casa Cervi intimando la resa. Dopo uno scambio di colpi, i fascisti incendiarono il pagliaio posto sopra la stalla e anche l’abitazione rischiò di andare a fuoco. Messi alle strette, gli assediati si arresero13. Alcide Cervi con i suoi sette figli e Quarto Camurri furono inviati a Reggio Emilia mentre i militari alleati e Dante Castellucci, che riuscì a spacciarsi per francese grazie alla buona conoscenza della lingua maturata nella sua esperienza di emigrato, furono condotti a Parma14. I gap entrano in azione In base agli ordini di Ilio Barontini impartiti durante la sua visita a Reggio Emilia, il Comitato militare decise di mettere in campo i gap per effettuare i primi attacchi ad esponenti di spicco del rinato partito fascista. Nel tardo pomeriggio del 15 dicembre 1943, in via Prati Vecchi, strada per Cavriago, i gap tesero un agguato al seniore della milizia Giovanni Fagiani che con la figlia stava rientrando da Reggio Emilia. L’ufficiale rimase ucciso e la figlia gravemente ferita. Il capo della Provincia Enzo Savorgnan15, appresa la morte del seniore Veroni, Considerazioni sui Cervi, cit., pp. 117-121. Quattro prigionieri catturati in una casa colonica, in «Il Solco fascista», 26 novembre 1943. 14 A. Cervi, R. Nicolai (a cura di), I miei sette figli, Editori riuniti, Roma 1956 p. 143. 15 Sulla figura di Savorgnan si veda F. Giannantoni, Enzo Savorgnan, Capo della Provincia di Varese. Settembre 1944-aprile 1945, «RS-Ricerche storiche» 97/2004, p. 7. 12 13 79 Fagiani, fece arrestare una quarantina di persone e minacciò di farle fucilare per rappresaglia. Dispose, infine, la loro liberazione ma emise un decreto in cui si avvertiva che, in caso di nuovo attentato, la rappresaglia sarebbe stata inevitabile16. Il tentativo di far evadere i Cervi da parte del cugino Massimo Cervi Massimo Cervi, cugino dei Fratelli, dopo aver visitato gli arrestati prese contatto con uno dei carcerieri per verificare possibilità di fuga. Verificato che, in occasione delle festività natalizie ormai prossime, i controlli sarebbero stati allentati vista l’assenza di alcuni secondini, Massimo decise allora di aspettare quella sera per mettere in atto l’evasione. Un incidente tecnico impedì però la realizzazione del piano: il motore dell’automobile, che avrebbe dovuto utilizzare per raggiungere il carcere e caricare gli evasi, non si mise in moto. Massimo decise allora di rimandare alla festività successiva, cioè l’ultimo dell’anno, in cui si sarebbero verificate le stesse condizioni di assenza del personale della notte di Natale. L’uccisione di Davide Onfiani. 27 dicembre 1943 Nonostante l’ordinanza del capo della Provincia, il Comitato militare decise di continuare le azioni e, tra gli obiettivi da colpire, indicò lo stesso Savorgnan, oltre al federale Scolari, al comandante della gnr Wender e ai segretari federali comunali, il cui compito era reclutare vecchi e nuovi fascisti per rimpinguare le forze armate della rsi al servizio dei tedeschi17. Uno degli obiettivi era il segretario del pfr di Correggio Quirino Codeluppi detto Nacio. Nel tentativo di colpire quest’ultimo tuttavia si verificò probabilmente uno scambio di persona: l’informatore locale del Comitato militare, anziché indicare il segretario del pfr a colui che doveva effettuare l’attentato, indicò il segretario comunale Davide Onfiani. L’attentatore, informato del fatto che Onfiani tutte le sere saliva sul treno locale Bagnolo-Correggio per tornare nella sua casa a Correggio, lo aspettò in stazione e lo uccise. Attentato al Seniore della Milizia, in AISTO, b. 14/C, fasc. 6. Si vedano Veroni, Azione partigiana. Racconti di tempi difficili, cit., p. 63 e Franzini, op. cit., p. 67. 16 17 80 Nel municipio di Bagnolo venne decisa la rappresaglia Il corpo di Onfiani fu portato in Municipio dove, da Reggio, arrivarono Savorgnan, Scolari e Wender18. Giunse anche il figlio di Davide Onfiani, avvisato dell’accaduto da Savorgnan. A quest’ultimo, Scolari e Wender comunicarono che, per vendicare il padre, stavano preparando una rappresaglia contro noti detenuti antifascisti. Il figlio di Onfiani si oppose ma non fu ascoltato. I tre, tornati a Reggio, ordinarono al I seniore della milizia Silvio Margini di preparare, come rappresaglia per l’uccisione di Onfiani, l’esecuzione dei fratelli Cervi e di Quarto Camurri per l’alba del giorno dopo. Il seniore Margini tentò di dissuaderli o perlomeno di limitare il numero dei giustiziati al solo Aldo Cervi, capo riconosciuto della banda, ma i tre si mostrarono irremovibili. È probabile che il principale promotore dell’iniziativa fosse l’avvocato Scolari che, dagli interrogatori dei Cervi, aveva scoperto il loro coinvolgimento nel tentativo di catturarlo e ucciderlo il 13 novembre. Gennaio 1944 Dopo l’uccisione dei sette fratelli Cervi e di Camurri, il Comitato militare e il suo braccio armato, i gap (emanazione militare del pci clandestino), vennero criticati dagli altri partiti antifascisti che, con varie motivazioni, si erano dichiarati contrari – per il momento – a iniziare la lotta armata. Il Comitato Militare bloccò del tutto, o quasi, le operazioni dei gap, per dedicarsi all’organizzazione del movimento resistenziale con l’obiettivo di farsi trovare con forze sufficienti per affrontare la lotta armata in primavera. Ma il 27 gennaio 1944 a Villa Minozzo, in seguito a scontro a fuoco nella sua canonica, venne arrestato il parroco di Tapignola don Pasquino Borghi, con l’accusa di aver ospitato la banda dei Cervi e i militari alleati evasi. Il 30 gennaio 1944, don Pasquino Borghi ed altri otto antifascisti, su decisione, ancora una volta del capo della Provincia Savorgnan, vennero portati al poligono di tiro di Reggio per la fucilazione19. Febbraio 1944 Dopo la fucilazione di don Pasquino Borghi, la cui unica colpa fu di aver seguito i dettami che la fede gli imponeva, cioè aiutare il prossimo, ospitando la banda di Aldo Cervi, anche altri partiti antifascisti, come la dc e quella Franzini, op. cit., p. 75. Il tempo e la vita di don Pasquino Borghi (Albertario). Celebrazioni del 100° della nascita e del 60° della fucilazione, Atti del Convegno, Bibbiano 2003, Istoreco, Reggio Emilia 2004; S. Fangareggi, Un prete nella Resistenza: Don Pasquino Borghi, Aliberti, Campagnola Emilia 2004. 18 19 81 parte del partito socialista che sino ad ora si era schierata con gli attendisti, si convinsero a collaborare fattivamente con il Comitato militare organizzato dal pci20. Marzo 1944 Sulle montagne dell’Appennino reggiano-modenese agivano piccole bande partigiane, di cui facevano parte un gruppo di uomini che sin dall’autunno del 1943 erano agli ordini del sassolese Giuseppe Barbolini, a cui si erano uniti il cavriaghese Emilio Niccioli, poi Osvaldo Poppi (Davide). Il 20 marzo 1944, in un rastrellamento nelle zone di Monchio, Susano e Costrignano e Cervarolo, un reparto della divisione «Hermann Göring» fece quasi 150 morti. Le vittime erano tutte civili inermi, compreso il parroco di Cervarolo don Pigozzi. Dal carcere dei Servi, dove erano detenuti in due diverse circostanze, riescono a fuggire Didimo Ferrari e Reclus Malaguti. I due si rifugiano in montagna, prendendo i nomi di Eros e Benassi, presto raggiunti da Riccardo Cocconi (Miro). Dal Comitato militare al Comando piazza. Aprile-maggio 1944 Nell’aprile 1944, con l’inserimento ufficiale degli altri partiti antifascisti nella lotta di Resistenza, si decise di sciogliere il Comitato militare e di dar vita ad un organismo in cui fossero rappresentati tutti i partiti. Nacque così il Comando piazza. La prima riunione si tenne a casa del conte Carlo Calvi a Villa Cadè e vi parteciparono: Angelo Zanti (Amos), Gismondo Veroni (Franchi), capitano Adriano Oliva (Martini), generale Mario Roveda (Stani), Luigi Ferrari (Pellegrini), Risveglio Bertani, oltre al padrone di casa conte Carlo Calvi (Mariani)21. La rsi chiama alla leva le classi 1923-1924-1925. Maggio 1944 Nel maggio 1944 la rsi, allo scopo di ricostruire il suo esercito per poterlo affiancare ai tedeschi nella guerra contro gli angloamericani, chiamò alle armi i nati nel 1923, 1924, 1925 e quei militari dell’ex Regio esercito che, sfuggiti alla cattura e alla deportazione in Germania dopo l’8 settembre, si erano nascosti Ivi, p. 102. Si vedano L. Tiso, Angelo Zanti (Amos), Tipografia popolare, Reggio Emilia 1955, p. 28 e Franzini, op. cit., p. 116. 20 21 82 presso parenti ed amici. La maggior parte di questi giovani preferì prendere la via dei monti ed unirsi ai partigiani che, nella zona dell’Appennino a cavallo delle province di Reggio Emilia e Modena, avevano dato inizio alla lotta armata contro i presidi della rsi posti nei comuni montani. In breve tempo fu liberata una vasta zona che comprendeva i comuni di Montefiorino, Prignano, Frassinoro e Polignano nel Modenese e Toano, Villa Minozzo e Ligonchio nel Reggiano. Il 18 giugno 1944 quel territorio prese il nome di «repubblica di Montefiorino»22. La liberazione di Roma e lo sbarco angloamericano in Normandia avevano rappresentato un grande incentivo per la Resistenza nei territori italiani ancora occupati dai nazifascisti. Mentre sulle montagne reggiane e modenesi si stava costituendo, come già detto, la «libera repubblica di Montefiorino»23. Nella pianura reggiana intanto erano entrate in azione la 37a Brigata gap e la 77ª Brigata sap, posizionate fra la via Emilia ed il Po, e la 76a Brigata sap, posizionata tra la via Emilia e la zona pre-collinare. I compiti assegnati alle brigate 77a e 76a erano principalmente la raccolta di armi, munizioni ed equipaggiamenti militari da inviare in montagna ai settemila giovani che difendevano la repubblica di Montefiorino. A questo scopo furono saccheggiati vagoni con forniture militari destinate ai soldati nazifascista nelle stazioni di Rubiera e Reggio Emilia e vennero disarmati quei militari tedeschi o della rsi che percorrevano in piccoli gruppi il territorio Reggiano o erano di stanza in presidi isolati. I sappisti avevano l’ordine di evitare, se possibile, di uccidere o ferire i militari attaccati per evitare rappresaglie alla popolazione locale. La 37a gap nel giugno 1944 Gli ordini impartiti ai gap erano sostanzialmente diversi. A essi competeva l’organizzazione e l’azione negli attentati contro gli aderenti, sia civili che militari, al pfr. Il pfr nella provincia di Reggio Emilia contava su un discreto numero di sostenitori. Tra questi, alcuni aderirono per conservare il posto di lavoro o continuare a usufruire di quelle agevolazioni di cui avevano approfittato durante il Ventennio mentre altri, specialmente gli ex squadristi che dopo gli anni ruggenti del 1921-25 erano stati messi da parte, aderirono per rifarsi di quelli che consideravano torti subiti. C’era inoltre un certo numero di persone che 22 E. Gorrieri, La Repubblica di Montefiorino: per una storia della Resistenza in Emilia, Il Mulino, Bologna 1966, Franzini, op. cit., p. 134. 23 Franzini, op. cit., p. 174. 83 aveva deciso di aderire al pfr perché considerava un tradimento la decisione del Re di destituire il duce e di passare nel campo alleato. Come vennero scelti gli obiettivi? Il Comando dei gap ragionò così: «Sono più pericolosi per la Resistenza i fascisti cattivi o i fascisti buoni?». Per «cattivi» deve intendersi coloro che partecipano e comandano uccisioni, torture, rastrellamenti e stretta collaborazione con i tedeschi; per fascisti «buoni» invece si intende coloro che cercano di dialogare con la Resistenza continuando i contatti con le persone che sanno coinvolte nel movimento resistenziale ed operando affinché si evitino inutili spargimenti di sangue da entrambe le parti. Il comando gap, secondo chi scrive, decise che i fascisti «buoni», per la Resistenza, erano più pericolosi di quelli «cattivi», perché non spingevano la popolazione a schierarsi con la Resistenza. Così con il mese di giugno 1944, iniziarono gli attacchi ai fascisti «più in vista»: i gap uccisero il dottor Azzolini, un medico capitano della gnr che aveva conservato un ottimo rapporto con il professor Pasquale Marconi, ne aveva favorito la liberazione quando l’arrestarono con l’accusa di essere in contatto con i partigiani, ma era di sicuro presente durante la strage di Cervarolo del marzo 1944. L’11 giugno era stato ucciso il dottor Vercalli e poi ai primi di luglio del dottor Vezzosi. Questo modo di operare fu criticato dai membri della dc e pli del Comando piazza sempre contrari alle soluzioni estreme24. La fine della repubblica di Montefiorino. 29 luglio-3 agosto 1944 La pianura padana era diventata, nel luglio del 1944, fondamentale per l’economia di guerra tedesca. Le industrie che non erano state distrutte dai raid dei bombardieri alleati continuavano a produrre attrezzature militari, mentre la fiorente agricoltura era in grado di fornire carne e cereali per le truppe. Il maresciallo Kesselring, comandante in capo delle truppe tedesche in Italia, cercò di frenare il più possibile l’avanzata angloamericana con l’obiettivo di bloccarla con una linea difensiva, come i tedeschi avevano già fatto a Cassino. Il comandante tedesco individuò questa linea nella dorsale appenninica tosco-emiliana da Rimini a Carrara. Questa era una barriera naturale difficilmente superabile ma, perché fosse in grado di resistere efficacemente all’avanzata alleata, era necessario mantenere libere e utilizzabili le ferrovie che, passando per la pianura padana e il passo del Brennero, collegavano i monti con la Germania25. Grazie a spie infiltrate a Montefiorino, il comando del maresciallo Kesselring fu informato dell’arrivo della missione britannica, del lancio di armi 24 25 84 Ivi, p. 189. Ivi, p. 215 e segg. e munizioni immagazzinate in attesa dell’arrivo di un consistente reparto di paracadutisti della Divisione italiana «Nembo» e della preparazione di un aeroporto di fortuna a Frassinoro dove far atterrare rifornimenti e rinforzi26. I nazifascisti non potevano correre il rischio di trovarsi un notevole contingente nemico, per di più munito di un aeroporto dove ricevere rinforzi, alle spalle della loro linea difensiva. Il controspionaggio tedesco riferì che i parà sarebbero dovuti atterrare il 2 o il 3 agosto. Per prevenire il loro arrivo i germanici fecero convergere sulla zona di Montefiorino numerose truppe, supportate da blindati e artiglieria, da quattro zone diverse e, all’alba del 29 luglio 1944, diedero via all’attacco. Tra i difensori della repubblica partigiana solo cinquecento o seicento uomini erano adeguatamente addestrati ed amati, mentre tutti gli altri erano militarmente impreparati e, in gran parte, disarmati. Gli inglesi, di fronte all’assalto tedesco, preferirono distruggere le armi immagazzinate anziché distribuirle e rischiare che finissero in mano nemica. Quei pochi che erano in grado di affrontare lo scontro tentarono inizialmente una vana resistenza ma, sopraffatti dai tedeschi, furono costretti a ritirarsi. Degli altri seimila, una parte fu uccisa e fatta prigioniera mentre la maggioranza si divise in piccoli gruppi e riuscì ad aggirare lo schieramento tedesco per nascondersi in alta montagna o tornare in pianura. Il 3 agosto era tutto finito27. Operazione «Anvil» ed arresto dell’offensiva alleata contro la Linea gotica, agosto 1944 Dopo lo sbarco in Normandia il fronte italiano era diventato d’importanza secondaria. Gli angloamericani, compreso che l’unico modo per far terminare la guerra in Europa era annientare la Germania, decisero che il fronte occidentale aveva la precedenza su tutte le altre operazioni militari. Iniziò così l’operazione «Anvil», uno sbarco massiccio di uomini sul suolo francese. Per questa missione furono impiegate le migliori divisioni della VIII armata americana dell’VIII armata britannica. Le divisioni stanziate in Italia si trovavano in una situazione di stallo, logorate dallo sfondamento del fronte a Cassino e Anzio e dall’inseguimento delle Divisioni tedesche in Toscana, Umbria e Marche. Necessitavano di nuovi uomini e mezzi, ma questi erano tutti dirottati verso l’offensiva in Francia. 26 27 Ivi, p. 235 e segg. Ivi, p. 244 e segg. 85 Testimonianza di Gismondo Veroni. Villa Sesso, estate 1944 Nell’estate del 1944 si costituì il Comando centrale provinciale delle brigate con la funzione di tenere in contatto le brigate sap stanziate in pianura con il Comando unico delle brigate sap sull’Appennino reggiano. Furono designati dal Comando piazza a far parte del Comando centrale provinciale: Gismondo Veroni (Franchi) nel ruolo di comandante; Bruno Cattini (Zenith), commissario; Ettore Barchi (Pezzi), vice comandante; Antonio Basini (Sacchi), vice comandante; Gabbi (Roberto), intendente generale. Avevano a loro disposizione come staffette: Dimma Rossi (Lina), Ovilde Vecchi (Ines), Albina Fontanesi (Adriana) e Varo Paterlini (Rova). Era necessario trovare una sede per il Comitato centrale provinciale nelle vicinanze di Reggio, in modo da facilitare i contatti con il Comando piazza e il cln. Fu scelta Villa Sesso, una frazione del Comune di Reggio Emilia, per la sua posizione strategica: dista soli tre chilometri dal centro della città; è attraversata dalla statale 63 Reggio-Guastalla; ha allacciamenti stradali con Cavazzoli, Campegine, Villa Argine e Bagnolo; era attraversata anche dalla linea ferroviaria Reggio Emilia-Boretto. Franchi inoltre conosceva perfettamente la zona grazie alla parentela con le famiglie Davoli e Montecchi, residenti nel fondo «Vialato», e pertanto sapeva che la stragrande maggioranza della popolazione locale simpatizzava per il movimento di Liberazione. Il Comitato centrale provinciale si stabilì a casa Davoli-Montecchi. In un vicino campo di granoturco venne scavato un rifugio da usare in caso di emergenza e nelle case dei Miselli e dei Catellani furono creati depositi sotterranei di materiali vari, anni e munizioni. Casa Manfredi divenne luogo di riunione dei dirigenti del pci clandestino e del cln provinciale, oltre che luogo di raduno per i giovani che volevano aggregarsi alle brigate sull’Appennino. Essi, seguendo l’argine del torrente Crostolo che passava nelle vicinanze di Casa Manfredi, potevano giungere fin sui monti. Per evitare azioni che potessero attirare l’attenzione dei reparti della rsi in zona, la Resistenza aveva impartito ordini affinché non si compissero attentati contro esponenti nazifascisti locali. sap, Il colonnello Augusto Berti (Monti) Con la fine della repubblica di Montefiorino, si ebbero mutamenti radicali nell’organizzazione delle formazioni partigiane sull’Appennino reggiano-modenese: da un unico comando si passò a due Comandi distinti: quello reggiano, con Miro comandante ed Eros commissario, e quello modenese, guidato da Armando, Barbolini, Davide e Nardi. 86 I modenesi erano in contatto con una missione militare alleata statunitense, mentre i reggiani con una britannica; fu questa missione che fece scoppiare una grave crisi nella zona montana controllata dai partigiani reggiani. I britannici ritenevano il comunista Riccardo Cocconi (Miro) militarmente non all’altezza del suo incarico e ne chiesero la sostituzione con un ufficiale del Regio esercito a loro scelta. Proposero il colonnello Augusto Berti, un parmense che aveva frequentato l’Accademia militare di Modena e da accademista aveva fatto esercitazioni sul campo nella zona tra fra le province di Reggio Emilia e Modena, maturando una buona conoscenza del territorio. La missione britannica comunicò al Comando piazza che nel caso in cui le formazioni montane reggiane non avessero accettato il colonnello Berti, avrebbero sospeso a tempo indeterminato l’invio di armi, munizioni, viveri e denaro. Il Comando piazza inviò in montagna Gismondo Veroni con l’incarico di organizzare un incontro con Miro, Eros e con comandanti e commissari di Brigata e di distaccamento. All’incontro, passato poi alla storia come quello del «fico diplomatico» (visto che le discussioni furono svolte nei pressi di una pianta nei pressi della canonica di Poiano) presero parte oltre a Miro, Eros e i vari comandanti e commissari, anche Carlo (don Domenico Orlandini), Franceschini (professor Pasquale Marconi) e altri esponenti partigiani della dc. Veroni informò i convenuti dell’ultimatum posto dai britannici: «Niente colonnello Berti, niente aviolanci». I due giorni successivi furono segnati da scontri e accuse reciproche fra la fazione di Eros e Miro e quella di Carlo e Franceschini. Veroni capì che le brigate «Garibaldi» non volevano assolutamente un comandante imposto dalla Missione britannica. Carlo e Franceschini intendevano creare una propria formazione partigiana, con partigiani di estrazione cattolica, autonoma dalla brigate «Garibaldi» di cui non approvavano certi atteggiamenti e metodi, sia verso le popolazioni montane che nei confronti dei nazifascisti28. Fu allora decisivo l’intervento di Osvaldo Salvarani (Aldo), Capo di stato maggiore delle brigate «Garibaldi», che rivolto ai presenti disse: Credo che in passato ci siano state delle debolezze, delle lacune, ma ritengo che non vi sia stata obiettività in molti giudizi e che i fatti vengono strumentalizzati per avvalorare le tesi delle due parti. Perciò per il bene del movimento penso sia necessario trovare al più presto possibile una soluzione accettabile a tutti, anche se non soddisferà completamente gli uni e gli altri. Aggiungo che abbiamo bisogno di formazioni forti, ben inquadrate, disciplinate ma invito tutti a ricordare che i nostri Soldati, i nostri Partigiani, sono dei volontari a cui non si può imporre una disciplina ma si deve far capire della loro importante funzione per la liberazione 28 Veroni, Azione partigiana. Racconti di tempi difficili, cit., p. 127 e seg. 87 del nostri paese da tedeschi e fascisti. Ci saranno da superare molte avversità perciò è indispensabile creare la fiducia e la tranquillità in tutti. Ben venga un nuovo Comandante se servirà a questo scopo, ben vengano formazioni con diverse colorazioni politiche se avranno lo scopo di non contrastarsi le une con le altre ma invece di emularsi per disciplina e coraggio29. Le sensate parole di Aldo furono accolte favorevolmente da entrambe le parti e si decise quindi di istituire un comando generale denominato Comando unico con Augusto Berti Monti come comandante generale, Eros come commissario generale, Miro e Franceschini come vice comandanti e Aldo come capo di stato maggiore. Fu inoltre creata una nuova Brigata, le «Fiamme Verdi», con Carlo nel ruolo di comandante30. I rifornimenti alle brigate montane, agosto-settembre 1944 Gismondo Veroni, dopo aver risolto il problema del comando delle brigate montane, contattò immediatamente la missione militare britannica per richiedere la ripresa degli aviolanci, il cui blocco non aveva più ragione di esistere dopo l’accettazione di Monti da parte delle formazioni partigiane Reggiane. Tuttavia, in quel momento, gli aerei abitualmente utilizzati per rifornire i partigiani italiani erano impegnati in un ponte aereo per rifornire di armi e munizioni i polacchi dell’Armja Krajova, che erano insorti a Varsavia nel tentativo di liberare la loro capitale dai tedeschi. Era perciò necessario, per poter riprendere i rifornimenti in Italia settentrionale, attendere il ritorno alle basi militari di Foggia degli aerei americani impegnati a paracadutare armi e munizioni al Maquis francese che appoggiavano lo sbarco alleato nel sud della Francia. Veroni, tornato in pianura, fece rapporto al Comando piazza del nuovo assetto del Comando delle brigate montane, il quale fu approvato, e riferì le informazioni avute dalla missione britannica in merito ai rifornimenti. Il Comando piazza lo incaricò di intensificare l’invio di tutto ciò che era necessario ai partigiani sui monti, utilizzando tutto il personale che riteneva indispensabile poiché i rifornimenti avevano la precedenza assoluta su qualsiasi altra operazione. Esistevano due linee per far arrivare i rifornimenti dalla pianura ai depositi delle brigate montane. La prima partiva da Reggiolo e, passando per Correggio, San Martino in Rio, Rubiera, Scandiano e Casalgrande, arrivava a Viano e Baiso. La seconda partiva da Brescello-Boretto e, costeggiando la sponda destra del fiume Enza, passava vicino a Praticello, Sant’Ilario, Montecchio, Bibbiano, San Polo, aggirava Ciano e arrivava a Ramiseto e Castelnovo ne’ Monti31. 29 30 31 88 Ivi, p. 139. Ivi, p. 143. G. Veroni, Il rifornimento, in «Ricerche Storiche», n. 40/1980, p. 85. Linea di rifornimento Est I rifornimenti – Il Militär Kommando 108 – Il Colonnello ss Eugenn Dollmann – Villa Spalletti – Tenente Werner Müller - Distaccamento partigiano di San Donnino di Liguria Nell’Italia Settentrionale erano stanziati ben 800.000 militari tedeschi. 350.000 erano posti a difesa della linea gotica mentre gli altri erano assegnati soprattutto ai litorali ligure e veneto, con compiti anti-sbarco, e nelle città industriali di Piemonte, Lombardia e Veneto. Se le truppe insediate in pianura potevano rifornirsi depredando le campagne dell’oltre Po, quelle sulla linea gotica dovevano essere rifornite da un apposito ente Tedesco denominato Militär Kommando. Per le province di Parma e Reggio Emilia era competente la Militär Kommandandantur 1008, con sede a Parma. Gli ufficiali della mk 1008 si rivolsero, per organizzare i rifornimenti, al colonnello delle ss Eugenn Dollmann. Questi, dopo aver abbandonato Roma e Firenze, era arrivato a Reggio Emilia, dove scelse come sua residenza villa Ottavi (zona Roncina, periferia ovest di Reggio Emilia). Il colonnello, uomo di profonda cultura umanistica che negli anni Trenta aveva vissuto a Parma per compiere ricerche sulla famiglia Farnese, spiegò ai suoi interlocutori che sin dal 150 ac gli eserciti di Roma si rifornivano di carne fresca, insaccati, grano e farro in Emilia. Precisò inoltre che nelle province di Parma e Reggio Emilia vi erano importanti aziende agricole dedite all’allevamento di suini e bovini, industrie agro-alimentari per la produzione di conserve, insaccati e macelli per la fornitura di carni fresche e surgelate. Dollmann aveva ricavato queste informazioni da un documento del luglio 1944, redatto dall’Istituto zootecnico provinciale di Reggio Emilia e fattogli recapitare dal servizio informazioni tedesco, in cui si precisava che, da un recente censimento effettuato nei 35 comuni della pianura e della pedecollina sotto controllo germanico, nelle stalle e nelle porcilaie reggiane si contavano ben 140.000 bovini e 80.000 scrofe. Il rifornimento. Il conte Spalletti Il colonnello Dollmann si impegnò con la Militärkommandantur 1008 a trovare una soluzione accettabile in tempi brevi. Nella sua permanenza a Roma, il colonnello aveva conosciuto un nobile reggiano, il conte Antonio Spalletti, e dopo l’8 settembre 1943 ne aveva fatto rilasciare da Kappler la moglie, che era stata arrestata perché monarchica. Dollmann pensò che era giunto il momento per farsi ricambiare il favore. Convocò il conte a Villa Ottavi (il conte e la moglie, dopo aver lasciato Roma, erano tornati nella villa della loro tenuta a San Donnino di Liguria nel Comune di Casalgrande) e lo esortò a sfruttare le sue conoscenze personali per contat- 89 tare i proprietari delle aziende agricole più importanti, gli industriali, i conservieri e i produttori di insaccati e carni per invitarne alcuni in rappresentanza a un incontro con il colonnello tedesco. Il conte Spalletti, grazie alle sue conoscenze, poté in breve comunicare a Dollmann che un rappresentante degli agrari ed uno degli industriali erano pronti ad incontrarlo. La riunione ebbe luogo a Villa Spalletti. Il colonnello minacciò i rappresentanti che, in caso di mancata collaborazione da parte di agrari ed industriali, avrebbe provveduto direttamente al sequestro di animali e attrezzature per inviarle in Germania; la stessa sorte sarebbe poi toccata ai dipendenti delle aziende, ai quali sarebbero stati annullati i permessi che li esentavano dalla chiamata alle armi o dai lavori della «Todt», l’organizzazione tedesca che realizzava le linee di difesa sulla Linea gotica. Gli interlocutori si dichiararono disponibili a rifornire l’esercito tedesco vendendo i loro prodotti al prezzo di costo, ma chiesero in cambio il permesso di poter continuare a vendere le eccedenze ai loro abituali clienti residenti in Piemonte, Lombardia e Liguria; chiesero inoltre permessi permanenti affinché i mezzi delle aziende potessero circolare indisturbati, senza subire sequestri da parte di militari tedeschi o della rsi. Il colonnello accettò queste condizioni. Il rifornimento. Il tenente Werner Müller Conclusa la trattativa, il conte Spalletti venne incaricato dal colonnello Dollmann di fare da supervisore per suo conto al consorzio degli agrari e industriali. Il conte accettò, ma chiese al colonnello una scorta, per proteggerlo durante il perfezionamento degli accordi con le aziende e la percorrenza di zone infestate da partigiani, e l’insediamento a villa Spalletti di un presidio militare permanente. Il colonnello inviò a Villa Spalletti il tenente Müller con quaranta militari tedeschi. Il Distaccamento partigiano di San Donnino di Liguria La tenuta Spalletti si trovava sulla linea di rifornimento Rubiera-Viano-Baiso. L’arrivo dei quaranta soldati tedeschi rendeva il passaggio in zona, anche se compiuto in ore notturne, particolarmente pericoloso, specialmente se si dovevano condurre in montagna animali vivi. Il muggito di una mucca o di un vitello poteva attirare l’attenzione dei militari. Fortunatamente uno dei responsabili del locale distaccamento partigiano, Afro Masoni, lavorava come operaio della tenuta Spalletti. Masoni iniziò a frequentare il tenente Müller e scoprì che questi era austriaco e che dopo cinque anni di guerra ne aveva piene le tasche di Hitler. Rassicurato da queste informazioni, Masoni informò l’ufficiale tedesco dei 90 problemi che la presenza tedesca a villa Spalletti causava al passaggio notturno dei rifornimenti destinati alla montagna. Müller gli propose un accordo: lui avrebbe fatto in modo di trattenere i suoi uomini, di notte, dentro la villa; in cambio i partigiani locali e quelli di passaggio non avrebbero effettuato alcuna azione offensiva contro di lui e i suoi uomini. Stretto il patto, Masoni chiese al tenente: «Perché il colonnello Dollmann ha assicurato il conte Spalletti e la sua casa alla sua protezione?». Müller lo informò del ruolo rivestito dal conte Spalletti nella raccolta dei rifornimenti da inviare ai militari stanziati sulla Linea gotica e della conseguente necessità che ad esso fosse assicurata ogni protezione possibile. Il rifornimento. Masoni e Folloni Masoni capì l’importanza dell’informazione ottenuta dal tenente Müller sul ruolo del conte Spalletti e la riferì immediatamente a Sereno Folloni (Molteni), vice commissario della V zona (Scandiano). Molteni, appresa la notizia, si recò immediatamente a Reggio Emilia per riferirla al Comando piazza che, a sua volta, convocò Gismondo Veroni e il suo vice Ettore Barchi (Pezzi). Quest’ultimo era un democristiano che era stato affiancato a Veroni in base agli accordi fra i partiti dopo la costituzione del Comando piazza, con cui Franchi collaborò sino alla Liberazione in buona armonia. Dopo la riunione montana sotto il «fico diplomatico» una nuova patata bollente fu scodellata nelle mani di Veroni. Questi ragionò con Pezzi per trovare una soluzione a un problema che si mostrava di difficile soluzione. Sabotare aziende agricole e industrie infatti poteva avere conseguenze funeste sia per il movimento di Liberazione che per l’economia reggiana in generale. Innanzitutto significava far perdere il posto di lavoro agli operai e, quindi, far saltare la copertura ai partigiani che erano con loro. Inoltre vi era il rischio che alla fine del conflitto il patrimonio zootecnico, specialmente quello bovino che per generazioni i reggiani avevano pazientemente selezionato per produrre il formaggio «grana», andasse distrutto. Grazie a Molteni e Masoni, Veroni e Pezzi riuscirono a contattare il tenente Müller e conoscere l’identità dei due rappresentanti degli agrari e degli industriali. Ottenuto un incontro con loro, Veroni e Pezzi conclusero un patto che in gran parte risolse i problemi dei rifornimenti di denaro e viveri in cui si dibatteva la Resistenza reggiana: gli agrari avrebbero versato alla Resistenza una sorta di «tassa» proporzionale agli ettari di superficie delle aziende; gli industriali avrebbero fornito loro insaccati, conserve, carne congelata e fresca; i caseifici grana e burro32. M. Frigeri, Finché c’è guerra… Economia e guerra civile a Reggio Emilia. Luglio 1944-aprile 1945. Appunti di ricerca, in «RS-Ricerche Storiche», n. 103/2007, p. 106 e segg. 32 91 Linea di rifornimento Ovest I sap incaricati del disarmo dei presidi della gnr e delle bn in pianura, l’incendio di Casa Cervi da parte dei militi del presidio di Praticello e le loro interferenze sulla linea di rifornimento nella parte della Valle dell’Enza fra i comuni di Brescello e Sant’Ilario. Uno dei metodi utilizzati dai partigiani per procurarsi armi, munizioni ed equipaggiamenti era quello di disarmare i presidi fascisti sparsi in pianura. La tattica consolidata prevedeva la cattura di uno o più militi quando questi uscivano dal presidio per pattugliare il territorio o per bere un bicchiere di vino all’osteria, dopodiché li si costringeva a farsi aprire la porta del presidio. Penetrati nell’edificio i partigiani, se non trovavano – come di norma – resistenza, si limitavano a disarmare i militi prendendo anche divise, calzature, coperte e tutto ciò che poteva essere loro utile. Infine ai militari si intimava di tornarsene a casa e di non rientrare nei ranghi della rsi. Ma non sempre queste azioni andarono a buon fine. A Reggiolo, nel settembre 1944, il Toscanino (il commissario dei gap Aldo Ferretti) e alcuni partigiani locali cercarono di catturare due militi usciti dal presidio, ma questi opposero resistenza alla cattura e ferirono il Toscanino. I partigiani reagirono uccidendo i due fascisti. Il giorno dopo il federale Ferri arrivò a Reggiolo, circondò il paese, catturò quattro persone e le fucilò. Anche a Campagnola si verificò un fatto grave. I partigiani locali al comando di Gramsci (Lino Battini), con la complicità del commissario prefettizio locale, che da tempo era passato nelle file della Resistenza, riuscirono a penetrare nel presidio ed a disarmare i militi. Dopo essere stati privati anche dei loro indumenti, i fascisti furono rimessi in libertà33. Ma evidentemente qualcuno di loro aveva riconosciuto il Battini e il giorno dopo vennero arrestati il fratello ed il padre di Gramsci. Li fucilarono e la loro casa data alle fiamme34. L’incendio di Casa Cervi. Annientamento del presidio rsi di Praticello Quando, nel novembre del 1943, i militi della RSI incendiarono il fienile per costringere alla resa i Cervi e i loro uomini, anche l’abitazione venne parzialmente danneggiata. Le donne e i bambini furono costretti ad abbandonarla e farsi ospitare da parenti ed amici. Grazie all’aiuto della gente del luogo tuttavia, A. Ferretti, Ricordi e lotte antifasciste, Libreria Rinascita, Reggio Emilia 1971, p. 153. L. Bellesia, A. Boccaletti, Un padre, un figlio, un olocausto, in R. Cantoni (a cura di), Una scelta difficile. Trentasei memorie e riflessioni sulla Resistenza, Dea cagna, Montecavolo 1995, p. 37 e segg. 33 34 92 la casa fu resa nuovamente abitabile in tempi brevi e il vecchio Alcide, sua moglie Genoeffa, nuore e nipoti poterono tornare nella loro casa. Ma alle soglie dell’inverno, nel novembre 1944, i militi fascisti del presidio di Praticello costrinsero prima i Cervi a sgomberare la casa e poi la incendiarono. Athos, il responsabile per la Resistenza nella zona di Praticello, incontrò Veroni a Sesso e lo informò dell’accaduto. Gli comunicò inoltre che i responsabili dell’incendio e la guardia comunale del paese stavano cercando informazioni atte a contrastare l’afflusso di rifornimenti dalla bassa reggiana ai monti lungo la linea di rifornimento Ovest, quella della valle dell’Enza. Veroni inviò subito un reparto di gap al comando di Lino Battini (Gramsci). I partigiani, con la collaborazione di Athos e dei partigiani locali, catturarono due militi all’osteria e li costrinsero a farsi aprire la porta del presidio, dove catturarono gli altri quattro. Infine andarono a prendere, nella sua abitazione, la guardia comunale Cagnolati. Nell’identificare i militi, uno dei gap che aveva partecipato al disarmo del presidio di Masone riconobbe Golinelli, milite già disarmato e messo in libertà ma a cui era stato intimato di non tornare più nei ranghi della rsi. Questo fatto, e forse un tentativo di ribellione di uno dei prigionieri, scatenò una sparatoria nella quale Cagnolati e i sei militari fascisti furono uccisi. Forse influì il fatto che Lino Battini, quando catturò i militi del presidio di Campagnola, si era limitato a disarmarli lasciandoli incolumi, mentre il giorno dopo i fascisti gli uccisero padre e fratello35. Ingiusto biasimo Praticello, 7 novembre 1944. Un centinaio di militi della rsi circondano Praticello, arrestano 31 persone e ne fucilano tre. Gli altri arrestati vengono portati a Reggio Emilia e Parma. Alcuni giorni dopo, Veroni, Pezzi e l’addetto al servizio informazioni Bruno Cattini (Zenith) furono convocati in una villetta in viale Risorgimento dove abitualmente si riuniva il Comando piazza. All’incontro erano presenti: Stani, Mariani, Toti, Martini, Pellegrini e Barra. Stani prese subito la parola per rimproverare Veroni di quanto era accaduto a Praticello, sostenendo che l’attacco al presidio e la successiva uccisione dei militi e della guardia comunale avevano scatenato una feroce ritorsione sulla popolazione locale, con tre fucilati e 31 arrestati. Intervenne poi Mariani per sottolineare l’inutilità del gesto, che aveva portato all’annientamento di un presidio lontano da ogni via di comunicazione e di scarsa importanza militare. Fece poi notare che fra i 31 arrestati figuravano tre donne di Parma parenti di 35 Ferretti, Ricordi e lotte antifasciste, cit., p. 164 e segg. 93 Stani, una delle quali era la moglie, precedentemente sfollate in zona. Toti per il momento tacque, mentre Martini e Pellegrini cercano di mediare. Prese allora la parola Veroni per respingere le critiche. Prima di tutto insinuò esplicitamente che, se non fossero stati coinvolti parenti stretti di membri del comandante del Comando piazza, nessuno avrebbe obiettato qualcosa alla scelta di compiere questa operazione. Replicò poi alle critiche di Mariani sulla scelta dell’obiettivo sostenendo, come responsabile dell’invio dei rifornimenti in montagna, che il presidio di Praticello aveva una grande importanza strategica trovandosi linea di rifornimento che costeggia l’Enza. A suo parere era necessario impedire ad ogni costo tutte le interruzione ai rifornimenti, soprattutto dopo la sospensione degli aviolanci da parte degli Alleati36. Ingiusto biasimo Pertanto, secondo il parere di Veroni, si doveva eliminare il presidio di Praticello, che era una spina nel fianco della linea di rifornimento Brescello-San Polo. Inoltre quei militi si erano resi protagonisti di un fatto particolarmente odioso: avevano cacciato di casa i superstiti della famiglia Cervi, incendiandone di nuovo la casa. Veroni terminò affermando che alcuni rappresentanti del Comando piazza ragionavano come i cosiddetti «benpensanti», i quali si guardavano bene dall’interferire con fascisti e tedeschi nell’attesa che la guerra finisse. Dopodichè salutò i presenti e uscì seguito da Pezzi e Zenith. Il giorno dopo Veroni ebbe un incontro con Toti a Sesso. Saltini gli rimproverò il modo in cui aveva lasciato la riunione e, pur approvandone le argomentazioni, gli suggerì di sottostare alle decisioni della maggioranza dei componenti del Comando piazza per evitare di provocare ulteriori spaccature fra le parti. Infine gli comunicò che per il momento lui, Pezzi, Zenith e Gramsci erano sospesi dalle loro funzioni37. Messaggio radiofonico del Maresciallo Alexander. Arresto di alcuni componenti del Comando piazza. Nuovo Comando piazza Il 13 novembre 1944, il generale Alexander, comandante delle forze armate alleate in Italia, annunciò con un messaggio radiofonico che l’offensiva angloamericana, che era ripresa alla fine di settembre, era sospesa a causa del maltempo che aveva reso inagibili le vie di comunicazione dietro le linee e 36 37 94 Mattinale 8 novembre 1944, in AISTO, b. 14C, fasc. 2. Veroni, Azione partigiana. Racconti di tempi difficili, cit., p. 155 e segg. impediva all’aviazione alleata di appoggiare le truppe a terra. Invitava quindi i partigiani a nascondere armi e munizioni e aspettare l’offensiva prevista per la primavera38. Il colonnello Dollmann, approfittando della situazione, cercò allora di stipulare una tregua con la Resistenza reggiana, ma sia le brigate in montagna che quelle in pianura decisero di continuare la lotta armata. Di fronte al rifiuto della proposta di tregua, Dollmann scatenò contro la Resistenza reggiana gli agenti dell’upi al comando del maggiore Tesei che, tra il 28 novembre e il 2 dicembre, arrestò Angelo Zanti (Amos), ufficiale di collegamento fra il Comando Nord Emilia e le formazioni reggiane, e i componenti del Comando piazza Martini, Pellegrini, Paolo Davoli (Sertorio), Mariani e Barra. I componenti del Comando piazza scampati alla cattura abbandonarono Reggio in cerca di un luogo sicuro: Stani e Virgilio Camparada (Sandro) si ritirarono in montagna. Cesare Campioli (Marzi), l’avvocato Vittorio Pelizzi (Fossa) e Camillo Ferrari (Bianchi) si nascosero a casa di amici. Domenico Piani fuggì a Bologna. Il Comando piazza che si era costituto all’inizio della lotta armata non esisteva più. Nel dicembre 1944 si ricostituì il nuovo Comando piazza: Vittorio Saltini (Toti) assunse la direzione e ne ridusse drasticamente il numero dei membri: Eaco Catelli (Vinci), presto sostituito da Walter Sacchetti (Lari), per il pci; Ivano Curti (Paolo) per il psi; infine Giuseppe Dossetti (Serra) per la dc39. Toti assume le cariche di Commissario generale del Comando piazza e segretario provinciale del pci clandestino Una delle prime decisioni del nuovo comandante fu quella di reintegrare, nei rispettivi incarichi di responsabile e vice responsabile della sezione militare del Comando piazza, Gismondo Veroni e Pezzi. Questi, a loro volta, richiamarono in servizio Lino Battini (Gramsci)40. Come si è detto precedentemente, era necessario incrementare l’invio di viveri in montagna. Veroni e Pezzi compirono, con la complicità dei proprietari, delle vere e proprie razzie di carne fresca e surgelata dai macelli, di insaccati dai salumifici, di burro e formaggio grana dai caseifici. Parte di quei viveri fu distribuito anche alla popolazione della pianura, ridotta alla fame a causa del razionamento dei beni di prima necessità imposto dalla guerra. 38 39 40 Franzini, op. cit., p. 426 e segg. Ivi, p. 432. Ivi, p. 403 e segg. 95 Ma proprio in quel periodo, tra il 16 e il 22 dicembre, una delle basi partigiane più efficienti fu annientata dalle milizie fasciste. La sera del 16 dicembre 1944 un forte reparto della Brigata nera, su ordine del capo della Provincia Giovanni Caneva, piombò su Sesso e perquisì diverse case del circondario. In una di esse sorprese quattro giovani che ascoltavano Radio Londra. Furono portati in un campo vicino e fucilati41. Le case Manfredi e Miselli, le basi più importanti – dove erano immagazzinate armi, munizioni e viveri da destinare sia ai partigiani in pianura, in preparazione dell’insurrezione generale, sia alle brigate della montagna – non furono fortunatamente individuate. Veroni ordinò di non reagire. Gran parte delle armi trafugate nelle stazioni di Rubiera e Reggio Emilia erano ancora a Villa Sesso o nel cimitero di Cavazzoli ma, finché gli agenti del nemico rimanevano in zona, non si potevano trasferire altrove. La sera del 19 dicembre, invece, alcuni partigiani travestiti da militi della gnr, si recarono a Villa Sesso a casa dell’ex segretario locale del pnf, Umberto Orlandini, e gli chiesero se era stato lui l’autore della soffiata che aveva portato all’arresto e alla fucilazione dei quattro giovani la sera del 1642. La strage di Villa Sesso, 16-20 dicembre 1944. Altri ostaggi il 21 L’Orlandini, credendoli militi fascisti, confermò di essere l’informatore della Brigate nere. Avuta la conferma, i falsi militi uccisero lui, le sue due giovani figlie e tre vicini di casa. Fu un atto inutile ed irresponsabile, che attirò su Villa Sesso una rinnovata attenzione da parte delle milizie fasciste. Questa volta arrivò in paese la gnr e gli agenti dell’upi, la polizia investigativa comandata dal maggiore Tesei. Questi, dopo aver raccolto le necessarie informazioni, piombarono in casa dei Manfredi e dei Miselli. Li arrestarono, li portarono nei locali della cooperativa di consumo e qui li torturarono con un ferro da stiro bollente per costringerli a rivelare i luoghi dov’erano nascoste armi e munizioni. Furono fucilati i cinque Manfredi, i due Miselli e altre sette persone accusate di essere partigiani o collaboratori della Resistenza. Era il 20 dicembre 1944. Ma la strage non era finita. Il giorno dopo, quattro persone fermate a caso nei dintorni mentre transitavano per strada dirette a Reggio Emilia per lavoro, furono anch’esse uccise43. Frigeri, Finché c’è guerra… Economia e guerra civile a Reggio Emilia, cit., p. 106 e segg. Franzini, op. cit., p. 452 e segg.; A. Zambonelli, Cronaca di una guerra civile. L’eccidio di Villa Sesso: 17-21 dicembre 1944, «Ricerche Storiche» n. 74-75/1994, p. 5 e segg. 43 Ivi, p. 506 e segg. 41 42 96 Cambiamenti nei Comandi delle brigate partigiane in pianura. Uccisione di Vittorio Saltini (Toti) e della sorella Vandina, gennaio 1945 Tra la fine dicembre e i primi giorni di gennaio, Toti apportò alcuni cambiamenti nei ruoli di comando delle brigate di pianura: alla 77a sap furono assegnati Guerrino Cavazzoni (Ciro) come comandante, Renato Bolondi (Maggi) e Egidio Baraldi (Walter) come commissari; alla 76a sap Paride Allegri (Sirio) come comandante, Talino Fiaccadori (Ribin) e Mario Simonazzi (Azor) come vice comandanti, Lino Battini (Gramsci ora Tom) come commissario; alla 37a gap Alfredo Casoli (Robinson) come comandante, Aldo Ferretti (Toscanino) come commissario. Per ragioni logistiche, Sirio era stanziato nella zona di Cavriago, Ribin a Viano-Baiso, Azor ad Albinea e Tom a Scandiano. Azor, oltre che vice comandante della 76a e responsabile della IV zona, fu incaricato da Veroni di riscuotere le somme di denaro che, in base all’accordo stipulato con i rappresentanti degli agrari, era dovuto al cln. Il 25 gennaio 1945 Toti cadde in un agguato preparato dagli uomini della gnr. Il doppio incarico di segretario del pci e comandante del Comando piazza, costringeva Toti a muoversi continuamente e quasi sempre senza scorta. Quella sera si stava spostando da Correggio a San Michele di Bagnolo, dove il giorno dopo doveva presiedere una riunione dei Comandi della bassa reggiana. Lungo il tragitto decise di recarsi dal fratello Adalgiso a Fosdondo, senza sapere che da tempo la gnr sorvegliava la casa. Per Toti non ci fu scampo. Lo stesso giorno i fascisti uccisero anche la sorella di Toti, Vandina. Arrigo Nizzoli (Lino) segretario provvisorio del pci clandestino della provincia di Reggio Emilia. La lettera, datata 12 febbraio 1945, di Veroni alla federazione del pci reggiano La nomina a segretario provvisorio del pci provinciale di Arrigo Nizzoli, da tempo collaboratore di Toti per i contatti con i commissari politici delle brigate partigiane in montagna, fu, dopo la morte di Vittorio Saltini, una scelta quasi obbligata. Gli altri esponenti del partito decisero di rimandare alla fine del conflitto un’ulteriore riorganizzazione dei quadri dirigenti e, in particolare, la nomina del segretario provinciale. Nizzoli, nel periodo in cui aveva fatto da vice a Toti, aveva compreso qual era il potere che il segretario del pci aveva tra le file della Resistenza reggiana e intuì quanto l’importanza di questo ruolo sarebbe aumentata ancor di più nel dopoguerra. Decise allora di inserire nei posti chiave del movimento resistenziale persone a lui legate, sostituendo i comandanti e i commissari in carica, 97 senza tuttavia preoccuparsi di consultare il responsabile militare del partito, cioè Gismondo Veroni. Il 12 febbraio 1945, in un rapporto alla federazione provinciale del pci, Veroni denunciò la situazione che si era venuta a creare dopo le decisioni del segretario politico in merito alle questioni militari. Fece presente che, mentre il defunto Vittorio Saltini, oltre a essere un buon politico, era dotato anche di una buona capacità in campo militare, l’attuale segretario dimostrava con le sue attuali decisioni di essere totalmente digiuno di conoscenze belliche. Veroni fece infine notare che, se il precedente segretario era sempre stato disponibile a discutere sulle decisioni da prendere, il nuovo prendeva non accettava contestazioni alle sue decisioni. Veroni e Pezzi furono rimossi da responsabili militari del Comando piazza e il 17 marzo 1945 fu loro assegnato il comando di una brigata di nuova costituzione, la sap Montagna, composta in massima parte da partigiani con scarsa esperienza. La zona di competenza della nuova brigata era quella di CarpinetiBaiso, adibita soprattutto a trasportare i rifornimenti da Rubiera per la 145ª e la 26ª Brigata44. L’attacco tedesco del 21 marzo 1945 Veroni aveva appena preso il comando della Brigata sap della montagna quando, il 21 marzo 1945, forze armate tedesche iniziarono un rastrellamento nella zona di Viano e Baiso. In previsione dell’offensiva primaverile alleata, i tedeschi erano intenzionati a ripulire le retrovie del fronte. A corto di munizioni e sotto il fuoco dalle mitragliatrici e dai mortai, i partigiani della 76a furono costretti a ritirarsi sul crinale Valestra-Carpineti. Tuttavia Veroni e gli uomini della Brigata sap Montagna, Garibaldini e Fiamme Verdi, riuscirono a fermare l’offensiva. I combattimenti continuarono per alcuni giorni nelle zone limitrofe ma, il quattro aprile, l’attacco tedesco fu definitivamente respinto. Era ormai imminente l’offensiva alleata di primavera che avrebbe portato alla liberazione di Reggio Emilia il 24 aprile 1945, permettendo il ritorno di Gismondo Veroni nella sua casa di Rivalta. Isonzo Rota, Mario Simonazzi (Azor) Due validi collaboratori di Veroni non ebbero la fortuna di poter festeggiare 44 G. Veroni, Rapporto dattiloscritto alla Federazione provinciale del AISTO, b. 12/B, fasc. 2. 98 pci, 12 febbraio 1945, in la Liberazione. Isonzo Rota, intendente del macello Prati di Sabbione, aveva permesso con le sue informazioni ai partigiani di impossessarsi e dirottare in montagna un autotreno di carne congelata destinata a Milano. Elementi della banda Pelliccia, al servizio dei tedeschi, travestiti da partigiani prelevarono Rota e lo uccisero a un centinaio di metri da casa45. Mario Simonazzi (Azor), vice comandante della 76a sap ed esattore delle somme dovute dagli agrari al cln, scomparve misteriosamente il 21 marzo 1945 sulla strada che da Viano va a Baiso. I suoi resti furono ritrovati in località Casa del Lupo nell’agosto 1945. Azor era stato scelto nel ruolo di esattore da Veroni perché, grazie alla sua neutralità politica, era decisamente adatto a trattare con persone, gli agrari reggiani, che diffidavano degli uomini di sinistra. Venne identificato l’uccisore, ma il mandante rimase ignoto46. Veroni e Nizzoli Arrigo Nizzoli, nel dopoguerra riuscì a farsi confermare segretario del partito comunista reggiano. Durante il suo mandato si verificarono in provincia di Reggio Emilia una serie di omicidi definiti «eccellenti». Furono uccisi: l’ingegner Vischi, il capitano Mirotti, il sindaco di Casalgrande Farri, Ferioli e il parroco di San Martino Piccolo don Pessina. Arrigo Nizzoli fu trasferito prima a Parma e poi nel ferrarese, dove rimase sino alla morte. Personaggi citati con i loro nomi «di battaglia» Gismondo Veroni (Tito-Bortesi-Franchi), Scanio Fontanesi (Giuliani), Armando Attolini (Dario-Scapini), Ferdinando Ferrari (Marte), Alcide Leonardi (D’Alberto), Osvaldo Poppi (Davide), Sante Vincenzi (Mario) Arrigo Nizzoli (Lino), Cesare Campioli (Marzi-Ugo), Gaetano Chiarivi (Lemmi-Scuri) Silvio Fantuzzi (Pietro-Neri), Celso Giuliani (William), Attilio Gombia (Ascanio), Didimo Ferrari (Eros-Duri), Aldo Cervi (Gino), Tommaso Bertani (Tom), Otello Salsi (Gino) Dante Castellucci (Facio), Vivaldo Salsi (Montanari-Tancredi), Ilio Barontini (Dario), Rino Soragni (Athos-Muso), Emore Silingardi (Mario), Testimonianza del maresciallo Gioia, (maggio 1945), in AISTO, b. 9/H, fasc. 2. M. Storchi, Sangue al Bosco del Lupo. Partigiani che uccidono partigiani. La storia di Azor, Aliberti, Reggio Emilia, 2005. S. Folloni, Una zona, una Resistenza. Storia della resistenza nella V zona (Reggio Emilia). Scandiano, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Viano, 1985. 45 46 99 Lorenzo Gennari (Fiorello), Possidio Lorenzani (Fiero), Orfeo Becchi (Gaeta), don Pasquino Borghi (Albertario), Giuseppe Barbolini (Barbolini), Emilio Niccioli (Orlando), Reclus Malaguti (Benassi), Riccardo Cocconi (Miro), Angelo Zanti (Amos), cap. Adriano Oliva (Martini), gen. Mario Roveda (Stani), Luigi Ferrari (Pellegrini), conte Carlo Calvi (Mariani), Pasquale Marconi (Franceschini), col. Augusto Berti (Monti), don Domenico Orlandini (Carlo), Osvaldo Salvarani (Aldo), Afro Masoni (Bovo), Sereno Folloni (Molteni) Ettore Barchi (Pezzi), Aldo Ferretti (Il Toscanino-Werter), Lino Battini (Gramsci-Tom), Bruno Cattini (Zenith), Gino Prandi (Barra), Paolo Davoli (Sertorio), Virgilio Camparada (Sandro), Vittorio Pelizzi (Fossa), Camillo Ferrari (Bianchi), Eaco Catelli (Vinci), Walter Sacchetti (Lari), Giuseppe Dossetti (Serra-Benigno), Ivano Curti (Paolo), Antonio Basini (Sacchi), Enrico Gabbi (Roberto), Guerrino Cavazzoni (Watt-Ciro), Renato Bolondi (Maggi), Paride Allegri (Sirio-Atomo), Talino Fiaccadori (Ribin), Mario Simonazzi (Azor-Salardi), Alfredo Casoli (Robinson). 100 Giuseppe Moruzzi Un ricordo personale Flavio Parmiggiani Ricorre quest’anno il centenario della nascita di Giuseppe Moruzzi che è stato certamente il più grande scienziato italiano nel campo della neurofisiologia e degli studi sul cervello del secolo scorso. Cent’anni fa. Giuseppe Moruzzi nasce a Campagnola il 30 luglio 1910 da Giovanni Moruzzi e Bianca Carbonieri, figlia primogenita di Luigi Carbonieri e Carolina Prampolini. Il legame tra Giuseppe Moruzzi e la mia famiglia comincia proprio cent’anni fa: infatti mio nonno materno, Merzi Fiorigi, compare come teste nel suo atto di nascita (vedi all. 1). Mio nonno era custode e «factotum» della villa Carbonieri di Campagnola. Il padrone, Luigi Carbonieri, aveva sposato Carolina Prampolini, di illustre famiglia reggiana con vaste proprietà a Rubiera e a San Faustino. La famiglia Carbonieri viveva d’inverno a Modena nel palazzo di corso Umberto I (oggi corso Canalgrande), proprio di fianco al Teatro Comunale, e passava la lunga estate nella villa di Campagnola dove aveva tante proprietà terriere; la famiglia possedeva anche altre ville di campagna, come la sontuosa villa di Lesignana di Modena e quella di Magreta. Nella villa di Campagnola e tra i famigliari e i parenti il piccolo Giuseppe sarà sempre chiamato familiarmente Peppino. Ancora nel 1987, nel necrologio scritto per l’«Italian Journal of Neurological Sciences (“Portrait of a friend”)», il professor Macchi dell’Università Cattolica si rivolgeva al vecchio maestro e amico appena scomparso con queste parole: «Dear Peppino do you remember…». Mio nonno Fiorigi e la moglie Adalgisa avevano la gestione completa della villa Carbonieri; come era costume allora, lavoravano entrambi per i padroni 365 giorni all’anno. Tra la nascita dello zio Gilberto (1898) e quella della zia Emma (1914), la nonna Adalgisa ebbe quindici gravidanze e dodici figli nati; di questi, tre morirono bambini o neonati e nove, sette sorelle e due fratelli, diventarono adulti e tra questi nove c’era mia madre Ida. Per qualche strano motivo non meglio spiegato, quasi tutti i figli di Fiorigi nacquero in inverno. 101 Succedeva così che ogni anno, quando i padroni tornavano a Campagnola per l’estate, trovavano che era arrivato un nuovo bambino. La signora Carolina si lamentava col marito perché la famiglia del custode diventava sempre più pesante da mantenere ma Luigi le diceva: «Porta pazienza Carolina, sarà la nostra servitù di domani». Infatti, alcune sorelle di mia madre passarono diversi periodi a servizio dei Carbonieri, in particolare una, la zia Lara, trascorse tutta la sua vita, da 14 anni fino alla morte a 96 anni, a servizio della famiglia di Laura Carbonieri, figlia ultimogenita di Luigi, sposata all’avvocato Bianchi, di Reggiolo ma residente a Modena di cui fu anche podestà. Ricordava mia madre che il padrone era molto buono: alla fine di ogni anno, nonostante i nonni avessero lavorato tutto l’anno per i padroni, facendo i conti, per via di una famiglia così pesante, risultavano sempre a debito; il padrone allora tirava una riga sulla pagina e cancellava tutti i debiti. Bianca e il figlio Peppino passavano lunghi periodi d’estate nella villa di Campagnola. Mia madre ricordava come le sue sorelle litigassero per avere la possibilità di «spupazzare» o, come si direbbe oggi, baby-sitterare il piccolo Peppino, che era un bambino buonissimo, quando questi non era accudito dai famigliari. Circa quarant’anni fa. Nel settembre 1969, studente di Fisica a Milano, stavo lavorando alla mia tesi di laurea presso un istituto del cnr ospitato presso l’Istituto di fisiologia dell’università. Proprio quel settembre era rientrato a Milano il professor Baldissera che aveva passato un anno presso l’Istituto di neurofisiologia di Goteborg (Svezia), dove aveva studiato le caratteristiche di scarica dei motoneuroni spinali. Saputo che c’era un giovane fisico laureando in istituto, venne a parlarmi e mi propose di studiare con lui un modello matematico di motoneurone che servisse a spiegarne le modalità di scarica; accettai la sua proposta e questo segnò il mio ingresso, come biofisico, nel campo della neurofisiologia. La mia tesi di laurea riguarda appunto un modello di motoneurone, il lavoro di tesi sarà pubblicato, circa un anno dopo la laurea, sulla prestigiosa rivista «Brain Research», autori Baldissera, Gustafsson, il ricercatore svedese che aveva collaborato agli esperimenti in Svezia, e io stesso; sarà il mio primo articolo su rivista internazionale. Tra il 1970 e il 1974 vinsi per quattro volte una borsa di studio per partecipare ai corsi della «International School of Biophysics» che si tenevano presso il Centro «Ettore Majorana» a Erice (Trapani). A Erice strinsi amicizia con alcuni colleghi fisici che lavoravano all’Istituto di biofisica del cnr di Pisa. I colleghi pisani stavano studiando le caratteristiche di scarica indotte da stimoli luminosi nell’occhio laterale del Limulus. Quando videro il lavoro della mia tesi pubblicato su «Brain Research», mi invitarono a Pisa a fare un seminario per presentarlo. L’avviso del mio seminario doveva essere stato affisso nei diversi istituti dell’università di Pisa perché, mentre stavo per cominciare la mia presentazione, scorsi in una delle ultime file della sala il professor Moruzzi. Che uno scienziato del calibro del professor Moruzzi si fosse scomodato per venire 102 a sentire il seminario di un giovane borsista cnr, certo mi sorprese; c’era però un altro motivo: io sapevo delle sue origini campagnolesi e pure lui sapeva delle mie, credo che in occasione di un incontro delle famiglie di Bianca e Laura Carbonieri la zia Lara gli avesse parlato di un nipote che lavorava nel campo della neurofisiologia. Finito il seminario ci intrattenemmo a parlare a lungo, il professor Moruzzi si informò sugli studi che stavo facendo e mi invitò per l’indomani, era un sabato, a visitare l’istituto da lui diretto. Visitare l’Istituto di fisiologia di via San Zeno, quasi appoggiato alle antiche mura di Pisa, fu davvero un’emozione (Benigni avrebbe detto: «è come per un falegname entrare nella bottega di San Giuseppe»). Il professor Moruzzi mi accompagnò a visitare i diversi laboratori e mi spiegò gli esperimenti che in essi venivano condotti. Passammo poi palazzina prefabbricata ad un piano, sistemata nel grande giardino dove si trovavano alcuni istituto della facoltà di Medicina. La palazzina ospitava l’Istituto di neurofisiologia del cnr, anche questo diretto dal professor Moruzzi, dove lavoravano i colleghi del cnr; tra questi, il professor Maffei, attuale presidente dell’Accademia nazionale dei Lincei, ed Anna Fiorentini, un fisico anche lei come me (ma molto più brava di me) passata alla neurofisiologia. La visita si concluse nella famosa biblioteca dell’Istituto, ricchissima di libri e riviste specializzate. Scoprii che vi era disponibile anche la collezione della rivista «Biophysics», traduzione americana della rivista russa «Biofizika» su cui venivano pubblicati i lavori di un gruppo formidabile di scienziati detti il «Gruppo di Mosca» (Gelfand, Gurfinkel, Orlowski, ecc.). Il Gruppo di Mosca lavorava nell’Istituto per i problemi della trasmissione dell’informazione dell’Accademia delle scienze sovietica, in questo caso trattava della trasmissione dell’informazione dal cervello ai muscoli per eseguire i movimenti. Gli scienziati del Gruppo di Mosca erano stati pionieri negli studi sul controllo motorio e sulla locomozione animale, ed erano ancora leader mondiali in questo campo pur avendo ridottissimi rapporti con i centri di ricerca occidentali. A quel tempo, lavorando su problemi di controllo motorio, trovavo spesso citati i loro articoli, ma non ero ancora riuscito a leggerne uno perché non sapevo che esistesse in Italia una biblioteca abbonata alla rivista «Biophysics». Da quella volta non ebbi più problemi, mi bastava telefonare alla bibliotecaria dell’Istituto di Pisa per ricevere qualche giorno dopo le fotocopie. L’ultima volta che incontrai di persona il professor Moruzzi fu nel settembre del 1975, a Monaco di Baviera, in occasione del I Congresso della European neuroscience association (ena); casualmente ci trovammo al tavolo delle iscrizioni nello stesso momento. Ci riconoscemmo subito e, espletate le formalità di iscrizione, ci sedemmo a chiacchierare nella grande hall del Centro congressi. In quel periodo stavo cominciando a prendere contatti per andare a lavorare in America per un anno, gli parlai di questo progetto e degli studi che stavo facendo con il professor Baldissera. Controllando il contenuto della borsa che ci avevano appena consegnato all’atto dell’iscrizione, trovammo un 103 volumetto che conteneva il programma del congresso, i riassunti di tutte le comunicazioni che sarebbero state presentate ed un elenco dei partecipanti, con istituto di affiliazione e data e luogo di nascita; ci fece sorridere scoprire che Campagnola Emilia (Italy) risultava il luogo di nascita con il più alto numero di partecipanti, ben due! A quel primo congresso dell’ena, il professor Moruzzi era stato invitato a tenere la Opening lecture; ricordo che la sua relazione fu tutta incentrata sulla necessità, ormai ineludibile per l’avanzamento delle conoscenze sul cervello, di uno sforzo interdisciplinare che vedesse coinvolte competenze diverse come quelle di medici, biologi, fisici, ingegneri, ecc. Quei concetti suonarono ovviamente come musica per le mie orecchie. A sottolineare il profondo contributo dato dal professor Moruzzi alle neuroscienze e per celebrarne la vita e il lavoro come grande scienziato, nel 1980 la European neuroscience association istituì la «Moruzzi Lecture», che da allora si tiene in occasione di ogni congresso annuale. Nella primavera del 1978, avendo vinto una borsa di studio nato-cnr, partii per un soggiorno di studio, che sarebbe durato due anni, presso il Laboratory of neurophysiology dell’Università dell’Alberta (Canada) diretto da un grande scienziato, il professor Richard Stein. Nel novembre di quell’anno si tenne a St. Louis il congresso annuale della American society for neuroscience. Il professor Stein invitò tutti i suoi cinque collaboratori di quel periodo a partecipare al congresso di St. Louis, dove si svolse anche il simposio congiunto della ibro (International brain research organization). Il titolo del simposio ibro di quell’anno (il primo si era tenuto a Pisa nel 1961 organizzato proprio dal professor Moruzzi) era The reticular formation revisited, per celebrare i trent’anni di un articolo fondamentale di Moruzzi e Magoun del 1948 sulla formazione reticolare. Correva voce che, per quel lavoro basilare del 1948, il professor Moruzzi fosse stato per diversi anni nella lista dei candidati al premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia. Oggi. Quest’anno, 2010, ricorre il centenario della nascita di Giuseppe Moruzzi, e numerose sono le celebrazioni per ricordare l’anniversario. Ha cominciato l’Accademia nazionale dei Lincei, di cui Moruzzi è stato socio ordinario per molti anni, con una manifestazione il 13 maggio (vedi all. 2). L’Università di Pisa ha celebrato sabato 19 giugno con un convegno «Oltre la scienza. L’opera di Moruzzi come promotore di cultura a 100 anni dalla nascita». Nella villa Agostini Venerosi della Seta, a Corliano (Pisa), dal 22 al 26 giugno, si è svolto il convegno internazionale: «From Carlo Matteucci to Giuseppe Moruzzi: two centuries of European Physiology». A satellite of the 15th Annual Meeting of the International Society for the History of the Neurosciences. 104 Atto di battesimo del professor Giuseppe Moruzzi datato 31 luglio 1910. Padrini Carbonieri dott. cav. Luigi e Carbonieri Anastasia per Maddalena Moruzzi. Ha officiato monsignor Anselmo Mori. L’atto certifica che Giuseppe Moruzzi è nato “in paese (Casa Carbonieri)” Il programma del convegno dedicato a Moruzzi Didattica Les chemins de la memoire Villa Emma (Nonantola-Italia)-Maison D’Izieu (Lione-Francia) a cura di Lorena Mussini «Per noi parlare con i giovani è sempre più difficile. Lo percepiamo come un dovere e insieme come un rischio: il rischio di apparire anacronistici, di non essere ascoltati. Dobbiamo essere ascoltati: al di sopra delle nostre esperienze individuali siamo stati collettivamente testimoni di un evento fondamentale ed inaspettato, non previsto da nessuno. È avvenuto contro ogni previsione; è avvenuto in Europa … è avvenuto, quindi può accadere di nuovo, questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire». Primo Levi, I sommersi e i salvati Presentazione del progetto1 Progetto realizzato dall’Istituto superiore «Matilde di Canossa», Reggio Emilia. Collaborazioni: Fondazione Villa Emma, Maison d’Izieu, Comune e Provincia di Reggio Emilia, Istoreco, Istituto storico di Modena, Istituto «A. Cervi», Comunità ebraica, Associazione amici del Canossa. A.S. 2009/2010 Classe 5ª B Liceo linguistico Progetto pluridisciplinare: Italiano – Francese – Storia – Storia dell’Arte Docenti coinvolti: Antonella De Nisco, Daniele Longo, Lorena Mussini, Sonia Ruozzi, Regine Saugier Ringraziamenti. Le docenti e le allieve che hanno realizzato il progetto qui presentato desiderano sinceramente ringraziare le referenti per la didattica dei due Istituti storici di Reggio Emilia e di Modena, Alessandra Fontanesi e Giulia Ricci, perché hanno sostenuto fin dalle prime battute l’idea del progetto e la sua realizzazione. Un particolare grazie ai due direttori dei luoghi della memoria prescelti, Fausto Ciuffi per Villa Emma e Stephanie Boissard per la Maison d’Izieu, per la premura, la gentilezza e la professionalità con cui hanno accolto ed accompagnato il gruppo classe nel percorso di studio e nella visita ai luoghi. Infine, un grazie a quanti, dentro e fuori la scuola, hanno contribuito alla realizzazione del progetto, in particolare tutte le componenti scolastiche, Preside, collaboratori, genitori e colleghi che hanno avuto fiducia nelle nostre idee e che hanno sostenuto il nostro modo di lavorare sul tema della Shoah, dando credito ed attenzione alle produzioni elaborate dalle ragazze nel corso dell’anno scolastico. 1 109 Il progetto è nato da un nucleo originario di lettura e rielaborazione di un testo memoriale francese sulle storie dei ragazzi della Maison d’Izieu, attorno al quale si è via via strutturato, col contributo di diversi docenti del Consiglio di classe e di diversi enti e soggetti, un percorso pluridisciplinare di storia/ memoria, teatro ed elaborazione artistica che, curvando alcuni argomenti fondamentali delle diverse discipline coinvolte sul tema della Shoah, ha focalizzato l’attenzione degli studenti sulle vicende tragiche vissute dai ragazzi della Maison d’Izieu intrecciate, in modo opposto e complementare, a quelle dei ragazzi di Villa Emma. L’orizzonte nel quale si inscrive questo lavoro pluridisciplinare è dunque lo sterminio degli ebrei d’Europa, passaggio difficile, doloroso, ma ineludibile, per un percorso formativo rivolto agli studenti che rilegga la storia del Novecento promuovendo anche una riflessione sui temi del razzismo, della costruzione del pregiudizio e del consenso, sulle persecuzioni eseguite fra le connivenze e l’indifferenza della popolazione oppure, al contrario, sul coraggio e la scelta di chi non ha interrotto, dopo le leggi razziali, i legami di affetto, di amicizia, di sostegno o solidarietà. Aspetti che si ricollegano ai temi della responsabilità individuale e collettiva, della scelta, dell’impegno civile, della solidarietà. 110 Osservazioni preliminari Interrogarsi sul come fare memoria ed affrontare il discorso della Shoah con le giovani generazioni, oggi, significa tener conto di un dato generale inconfutabile: a partire da una legge dello stato italiano (Legge Colombo-De Luca, n. 211, 20 luglio 2000) che istituiva la Giornata della memoria, indicandone anche la data, 27 gennaio, e definendo la questione della memoria dello sterminio antiebraico come tema di riflessione collettiva, l’ultimo decennio è stato contraddistinto da un proliferare di iniziative, commemorazioni istituzionali e pubbliche, ritualizzazioni collettive e individuali che pongono ormai molteplici questioni che vanno dalla credibilità di tali rielaborazioni, alla loro efficacia per costruire una memoria collettiva, alla capacità della nostra società di interrogare se stessa al presente «Ovvero di saper intravedere nel passato, anche prossimo, che andiamo ad indagare, non solo le domande o le inquietudini, ma anche le remore, le autocensure che mettiamo nel presente»2. D’altra parte, l’ipertrofia delle iniziative e delle proposte sulla Giornata della memoria stimolano una sua monumentalizzazione e trivializzazione, come Mosse ha già sottolineato per la memoria dei caduti del primo conflitto mondiale e il pericolo latente, ma non tanto, è che anche per la Shoah l’operazione di museificare la storia tradisca un bisogno collettivo di allontanarne la memoria. Cioè l’esatto opposto di quello che ci si proponeva. È vero che oggi c’è una coscienza diffusa, in gran parte della popolazione, della sinistra realtà dello sterminio, come l’uso metonimico di Auschwitz nel parlare comune attesta; ma è ugualmente vero che non altrettanto diffusa è la consapevolezza che affrontare la storia del genocidio ebraico richiede di indagare la storia politica, culturale, civile, della società europea e, per noi, italiana. «Il genocidio ebraico è un evento che ha comportato la distruzione fisica di milioni di individui per mezzo di una macchina persecutoria che colpiva gli inquilini della porta accanto. Quindi la memoria di questo atto riguarda tutti noi. È l’evento strutturale in cui noi europei abbiamo conosciuto le nostre “potenzialità” … Il Giorno della Memoria riguarda un pezzo di storia culturale dell’Europa con cui il nostro continente ha iniziato a confrontarsi con ritardo e spesso con disagio»3. In realtà, mai come in questo decennio si è parlato di Auschwitz e mai come in questo decennio assistiamo, in campo politico, sociale, culturale ed anche educativo, a derive di xenofobia, a spinte pericolose di razzismo, a rigurgiti di revisionismo e, a volte, a conati di insofferenza anche verso la Shoah. Ovviamente fra i due fenomeni non intercorre un nesso di causalità diretta, ma il problema esiste. La ritualità commemorativa o la lezione morale non permettono di comprendere il crimine e, per insegnanti ed educatori, 2 3 D. Bidussa, Dopo l’ultimo testimone, Einaudi, Torino 2009, p. 41. Ivi, p.10. 111 muoversi sul terreno della istituzionalizzazione della memoria della Shoah deve accompagnarsi alla consapevolezza che il 27 gennaio deve essere, per gli studenti, solo una tappa di un percorso di studio e di approfondimento dei fattori politici, culturali ed ideologici che hanno reso possibile «questo crimine contro l’umanità eseguito sul corpo del popolo ebraico», come lo definisce Hannah Arendt. La domanda fondamentale che guida la riflessione dell’educatore riguarda allora l’universalità di questo crimine e la figura della vittima, evitando il rischio della sacralizzazione. Il problema allora è: come fare per insegnare un argomento simile e fare in modo che tutti noi, in quanto esseri umani, ci sentiamo coinvolti come tali? Questa è la sfida educativa che la Shoah ci pone. E qui l’esperienza didattica ci induce a sostenere apertamente che l’emozione, che pure è impossibile evitare, deve essere trattata con prudenza, deve essere contenuta, ricondotta in percorsi di studio che evidenzino la matrice culturale del nazismo nel sincretismo di correnti di pensiero, elementi ideologici e politici già presenti nel panorama europeo di inizio Novecento. Deve essere compensata da un insegnamento politico della Shoah, nel senso che va esplicitato ai giovani il legame diretto fra questo orrore e ideologie mortifere e sradicatrici. Lo slogan, l’impatto emotivo non possono, in nessun caso, essere il filo conduttore per insegnare la Shoah alle giovani generazioni. Quindi, come insegnanti ed educatori ci siamo posti il problema di praticare strade diverse e ricercare strategie educative e didattiche innovative che riuscissero a tener uniti il rigore della conoscenza storica all’impatto emotivo che l’ascolto delle testimonianze e la visita ai luoghi comportano. Prima osservazione: la Shoah va collocata su uno sfondo storico costituito da molti elementi che definiscono una complessità di fattori che ci induce a superare la spiegazione monocausale del genocidio, cioè l’antisemitismo come elemento decisivo, e ci spinge invece ad allargare il campo di indagine ad aspetti cruciali delle strutture sociali ed economiche delle società degli anni Trenta, come delle sovrastrutture politiche, culturali ed ideologiche presenti e sedimentate da tempo nelle stesse. Gli esiti recenti di molte ricerche documentarie e storiografiche, riprendendo un filone di ricerche già inaugurato dalla Arendt, da Bauman e da Todorov, inseriscono il genocidio ebraico, oltre che nella aberrante ideologia eugenico-razziale del nazismo, anche nelle strutture stesse del sistema organizzativo, burocratico e produttivo della nostra società tecnologica ed industriale. E, a questo proposito, molte possono essere le piste di lavoro, ad esempio la questione della responsabilità degli esecutori materiali dello sterminio, quindi l’analisi della macchina burocratica nazista e degli apparati industriali e produttivi, come lo studio di Daniel J. Goldhagen4 mostra molto bene. Oppure il problema del coinvolgimento diretto di «Uomini comu- 4 D.J. Goldhagen, I volonterosi carnefici di Hitler. I tedeschi comuni e l’Olocausto, ed. tedesca 1996, trad. it. Mondadori, Milano 1997. 112 ni», tedeschi e non, secondo l’efficace definizione di Christopher Browning5, per il quale larghi strati della società di tutti gli stati occupati dalla Germania nazista risultano coinvolti nella prassi dello sterminio, una collaborazione più o meno volontaria al progetto genocida di centinaia di migliaia di uomini comuni, con livelli di iniziativa autonoma e di ferocia insospettabili. Uomini «normali», protagonisti come manovalanza dello sterminio ebraico che vede coinvolti ucraini, baltici, croati, polacchi, ecc. Filone di studi destinato, negli anni a venire, a maggior sviluppo, sia per i nuovi fondi documentari affiorati dopo il crollo dei sistemi comunisti sia per le lacune effettive che tuttora persistono in questo campo di ricostruzione storica. Altre importanti piste di lavoro possono essere lo studio di altri genocidi, l’indottrinamento ideologico, l’uso della propaganda, la formazione del consenso, l’esercizio della violenza collettiva e sistematica, insieme al tema dei «giusti», cioè di chi ha saputo, in qualche forma, opporsi al conformismo e alla sopraffazione. La sfida didattica ed educativa che la Shoah ci pone dunque è di respingere, sempre e comunque, la spiegazione dello sterminio ebraico come una delle tante tragedie delle guerre. Seconda osservazione: la Shoah va «stemperata» in una prospettiva di lungo periodo che, a partire dalle leggi razziali del 1935 in Germania e del 1938 in Italia, porti a riflettere come essa sia il punto culminante di un processo di sistematica e progressiva emarginazione della popolazione ebraica che ha inizio con le leggi razziali, perché lì si compie il primo atto di una spoliazione dei diritti, per poi proseguire fino all’annullamento della stessa vita delle persone, in un crescendo che scandisce come tappe fondamentali, la morte civile prima, l’internamento, la deportazione e la distruzione di massa poi (Endlosung cioè soluzione finale). Allargare l’ottica sulle leggi razziali significa sottolineare che in Italia, ad esempio, la persecuzione iniziata nel 1938 da parte dello stato fascista italiano: «violentò gli uomini, le donne, le loro identità, le loro coscienze, i rapporti sociali, i loro affetti – come scrive Michele Sarfatti – La maggioranza degli altri italiani si abituò progressivamente a vivere senza gli ebrei, senza conoscere gli ebrei, senza sentire l’obbligo di rispettare gli ebrei … Mentre la separazione si trasformava da programma in realtà, gli ebrei divenivano sempre più soli e l’Italia sempre più ariana e antisemita»6. Proprio sul razzismo culturale e ideologico di cui era imbevuta la cultura, la politica e la società dell’Europa di fine Ottocento e dei primi del Novecento C. Browning, The Path to Genocide. Essays on the emergence of the Final Solution, New York 1992, trad. it. Verso il genocidio. Come è stata possibile la «Soluzione Finale», il Saggiatore, Milano 1998. 6 M. Sarfatti, Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi, Einaudi, Torino, pp.42-43. 5 113 e sull’antigiudaismo cristiano che, pur non avendo legami di continuità con l’antigiudaismo pagano, alimenta tuttavia, specie a partire dall’XI secolo d. C., un forte senso di rifiuto e di ostilità verso l’ebreo, insiste molto Georges Bensoussan per spiegare che l’antisemitismo di Hitler, già fortemente presente nel Mein Kampf, raccoglie, amplifica e potenzia numerosi aspetti già presenti nel panorama ideologico e culturale dell’Europa di allora, sottolineando come l’ideologia nazista presenti un sincretismo incredibile, coerente ed esplosivo, di elementi preesistenti sul piano ideologico, religioso, culturale e politico della Germania di inizio Novecento7. Terza osservazione: lo studio della Shoah va incardinato sulla dimensione della storia locale e delle storie familiari e personali. «Nel Giorno della memoria noi non c’interroghiamo dunque sui sopravvissuti o sui testimoni diretti, ma su noi stessi, venuti dopo, e che da quell’evento siamo stati segnati,qualunque sia il nostro rapporto individuale e familiare con esso. Sia che siamo figli delle vittime, dei carnefici o di quella ampia fascia di zona grigia, di mondo degli spettatori che si trova in mezzo»8. L’individualità, l’identità è stata tolta alle vittime dello sterminio. Un’operazione fondamentale è ridare voce, carne, sangue, identità, nome alle vittime della Shoah. Peraltro, la materialità delle cose e delle persone è una risorsa straordinaria per i ragazzi sul piano della memoria e della costruzione del sapere storico. La vicenda personale di una vittima avvicina le due dimensioni: quella dell’individualità, della vita quotidiana e comune, a quella della tragedia sovrapersonale che incombe e travolge, inghiottendo nel nulla, milioni di individui senza nome. Rispetto ad altri conflitti etnici ed altri genocidi c’è, in questo come per altri aspetti, una specificità dello sterminio degli ebrei: una sistematica, ossessiva cancellazione dei nomi, delle identità, dei corpi e di ogni traccia possibile di milioni di persone. Osserva in tal senso Bidussa: «Auschwitz sancisce un altro meccanismo di distruzione del corpo, in cui è prevalente il dato simbolico accanto a quello sistematico della distruzione. Lì risiede la sua modernità e il fatto che parli a noi vivi»9. La Shoah, dunque, è anche la distruzione delle tracce dello sterminio. Anche nella lingua tedesca non si parla mai di sterminio. Si parla di azione, di soluzione finale, di reinstallazione della popolazione. Già la Arendt aveva definito la lingua del nazismo «eloquenza del diavolo», proprio per questa attenuazione del male, del negativo, dell’orrore. 7 G. Bensoussan, Israele un nome eterno. Lo Stato d’Israele, il sionismo e lo sterminio degli ebrei d’Europa, trad. it. UTET, Torino 2009. 8 Bidussa, op. cit., p. 11. 9 Ivi, p. 10. 114 La questione del silenzio e dell’incomunicabilità Eppure, ad un certo punto di ogni percorso di conoscenza individuale, di costruzione della memoria storica deve intervenire, anche, il silenzio della meditazione, il raccoglimento della commozione e del pudore di fronte ai racconti dei testimoni, l’elaborazione che ogni coscienza deve fare quando si confronta con il «Male assoluto». Di fronte a questa «frattura a livello di civiltà» – Zivilisationsbruch – come bene la definisce Dan Diner10 nella sua valenza più universale, ognuno di noi è chiamato a una responsabilità storica e civile di trasmetterne la conoscenza alle giovani generazioni ma, nello stesso tempo, sente la fatica e la difficoltà della rappresentabilità della Shoah, i limiti della strumentazione dello storico rispetto alla comprensione di un evento che pone interrogativi che toccano direttamente le sfere antropologica, metafisica e religiosa. Non ci sono scorciatoie o versioni edulcorate, effetti speciali: è un viaggio nelle profondità insondabili dell’animo umano in cui albergano bene e male, che ognuno di noi deve compiere nella propria interiorità e da cui riemergere, conservando brandelli di verità e parole o sguardi e storie di persone che più hanno lasciato il segno. «Se la storia è una catena di generazioni – dice lucidamente Elena Loewenthal – la Shoah sta fuori da ogni storia, perché fra chi è stato laggiù e chi è venuto dopo si stende un abisso nero, immenso, d’incomunicabilità. Loro erano laggiù. Noi che siamo venuti dopo, no. Un muro invalicabile ci separa per sempre da quel dolore e da quella morte»11. Un silenzio che non è assenza di parole, ma che proviene dalla distanza fra narrazione, rievocazione responsabilità. Uno spazio vuoto che separa il dicibile dall’incidibile, il non rappresentabile dal rappresentabile, il sopportabile dal non sopportabile e che sfocia spesso nella vergogna e nel senso di colpa. Scrive Elie Wiesel parole durissime: «La lezione dell’Olocausto, se ce n’è una, è che la nostra forza non è che illusoria e che in ciascuno di noi c’è una vittima che ha paura, che ha freddo, che ha fame. Il Talmud insegna all’uomo di non giudicare mai un amico finché non si troverà al suo posto. Ma per voi gli ebrei non sono amici; non lo sono mai stati; è perché non avevano amici che sono morti. Allora, imparate a tacere»12. D. Diner, «Zivilisationsbruch»: la frattura di civiltà come epistemologia della Shoah, in Storia della Shoah, vol. I, UTET, Torino 2005. 11 E. Loewenthal, Ma oggi sto zitta, perché ho sempre paura del fantasma in «La Stampa», 20 gennaio 2005. 12 E. Wiesel, L’ebreo errante, La Giuntina, Firenze 1983, p.179. 10 115 Opzioni metodologiche e didattiche Il progetto, grazie alla collaborazione degli istituti storici e al contributo degli esperti dei due luoghi di memoria, ha supportato la rielaborazione creativoespressiva con un approccio storico e memoriale rigoroso ed approfondito, per evitare che l’impatto emotivo assorbisse ed esaurisse l’incontro con queste vicende. Oppure per attenuare il rischio che risultasse prevalente la complessità delle questioni storiche che definiscono il quadro storico generale in cui la Shoah si inserisce rispetto alla attività laboratoriale e alla gestualità concreta in cui si sono tradotte le azioni di rielaborazione individuale e collettiva. Pertanto: studio ed approfondimento storiografico sempre collegato ai laboratori storici e creativo-espressivi. Un’altra metodologia importante di lavoro è stata quella di inserire sempre i racconti memoriali e le testimonianze in una ricostruzione di quadri storici più ampi e complessi, saldamente ancorati alle metodologie proprie della ricerca storica e agli esiti più significativi dei dibattiti culturali più recenti. Infine, una risorsa preziosa di lavoro è stata quella di integrare lo studio e l’approfondimento fatto con gli esperti (analisi delle fonti, visite guidate ai luoghi e incontro con i testimoni) con momenti individuali e Maison d’Izieu 116 collettivi di rielaborazione e riflessione su quanto ascoltato o visto e con altri momenti e spazi significativi di libera e autonoma produzione creativo-espressiva da parte delle allieve. Anche allo scopo di costruire una memoria attiva, si sono ripercorse le storie personali dei protagonisti, con un uso partecipato, consapevole e interattivo delle testimonianze e dei luoghi. Le fasi e le attività del progetto Il progetto si è svolto dall’inizio dell’anno scolastico fino al termine delle lezioni, impegnando docenti e allieve sia in ore di lezioni curricolari, al mattino, sia in ore pomeridiane di laboratorio, studio e rielaborazione artistica e teatrale delle storie dei ragazzi di Villa Emma e della Maison d’Izieu, con alcuni momenti particolarmente significativi che sono stati parte integrante del progetto: • Convegno di studi/Voci recitanti-Istituto Magistrale Reggio Emilia, aula magna «F. Pardo», 27 gennaio 2010; • Visita Fondazione Villa Emma-Nonantola (MO), 17 febbraio 2010; • Viaggio/visita Musée de la Resistance et de la Déportation- Lione(Francia), 8 aprile 2010; • Visita Maison d’Izieu-Ain (Francia), 9 aprile 2010; • Restituzione finale del progetto/Voci recitanti- Istituto Magistrale-Reggio Emilia, aula magna «F. Pardo», 28 maggio 2010. 117 Francese: Daniele Longo, Regine Saugier Lettura, analisi e rielaborazione del romanzo di Philippe Grimbert, Un Secret. Il percorso narrativo, in lingua francese, ha permesso di affrontare la triplice esperienza dell’autore che affronta il concetto di memoria familiare e personale e il problema della rimozione di eventi emotivamente devastanti. Rappresentazione teatrale, in lingua francese e italiana, Les chemins de la memoire, a cura di D. Longo e R. Suagier, liberamente tratto da Les Enfants d’Izieu, di Roland Causse e da Anni in fuga-I ragazzi di Villa Emma, di Josef Indig Ithai. Questo spettacolo teatrale, attraverso un processo rielaborativo della nostra memoria locale, ha messo in comune due vicende e due luoghi geograficamente lontani e ridato voce ai loro protagonisti, ragazzi, adolescenti e bambini, affinché la collettività potesse interiorizzare il significato della loro esperienza. Particolarmente toccanti, nella rappresentazione teatrale interpretata dalle ragazze, le storie di Villa Emma e della Maison d’Izieu hanno fatto riaffiorare alla memoria collettiva le vicende di ragazzi perseguitati allo stesso modo, ma che, circostanze diverse ed una diversa solidarietà umana, hanno condotto verso destini opposti. Storia dell’arte: Antonella De Nisco La realizzazione del Sipario/Rideau Il sipario 118 Il progetto ha previsto la realizzazione di un manufatto simbolico, un sipario di significative dimensioni (massimo centimetri 150x180) in tessuto di cotone grezzo. Il sipario, solitamente un drappo scorrevole che divide il palcoscenico di un teatro dalla sala degli spettatori, diventa, nel nostro progetto, un oggetto artistico realizzato in due parti identiche composte da strisce di stoffa strappate e ritessute. La scelta del bianco e del nero e del semplice cotone grezzo è simbolica, come quella dell’intreccio delle strisce strappate che riportano i nomi dei ragazzi, allacciati in orizzontale e in verticale da un destino e una storia tristemente comune. I due lembi tessili sono identicamente formati da 73 strisce strappate in verticale (i sopravvissuti di Villa Emma), intrecciate con 54 strisce strappate in orizzontale (le vittime di Izieu). Le strisce strappate recheranno, dipinte in nero, i nomi dei/delle ragazzi/e ebrei ritessute dalle nostre allieve. La classe sarà invitata a realizzare un oggetto semplice che, simile ad un arazzo, può essere sospeso o appeso. Sipario/rideau come piccolo segno metaforico, un gesto creativo che completa il progetto di storia, di letteratura e di rielaborazione teatrale in francese e diventa simbolo concreto di riflessione storica in ricordo delle persone. Il manufatto, in duplice copia, è stato usato come: • fondale/oggetto per una lettura a più voci e per la rappresentazione teatrale prevista in lingua francese e italiana; • fotografato per diventare un eventuale manifesto o cartolina nella Giornata della memoria (27 gennaio 2010/ricordo delle persone, del momento storico e del nostro impegno a non dimenticare); • donato come omaggio/ricordo dell’iniziativa e delle attività svolte dalla nostra scuola a Villa Emma e alla Maison d’Izieu. Storia contemporanea/memoria: Lorena Mussini Il percorso di storia ha previsto lo studio della Shoah a partire dalle leggi razziali del 1935 in Germania e del 1938 in Italia, con esame di documenti e filmati. Proprio la conoscenza storica ci ha permesso di superare l’idea preconcetta e un po’ ingenua che il fascismo italiano sia un totalitarismo «alla buona», relegando la responsabilità dello sterminio degli ebrei al «tedesco cattivo», stereotipo speculare all’altro «degli italiani brava gente» che si sono piegati alla feroce logica antisemita dei nazisti, specie nell’ultima fase del conflitto. Lo studio delle leggi razziali fasciste del 1938 ha evidenziato una prassi persecutoria consolidata ed una legislazione restrittiva molto capillare, sicuramente più minuziosa e dettagliata, in alcuni passaggi normativi, di quella tedesca (ad esempio: tutto il pacchetto normativo sulla scuola firmato dal ministro Bottai) fino alla collaborazione sistematica, da parte degli apparati politici e 119 militari del fascismo e di parte della società civile, nel rastrellamento e nella deportazione degli ebrei. Storicamente, dunque, è un falso che gli italiani siano stati per lo più spettatori che protagonisti della Shoah, più vittime che carnefici. Ci sono responsabilità dirette di tanti italiani che furono disponibili a consegnare ai tedeschi gli ebrei residenti nel paese, compresi i propri concittadini; che li scortarono sui treni diretti a Fossoli, campo di raccolta e transito, che collaborarono per inviarli a morte certa nei campi di sterminio. Così, come tanti scelsero invece di aiutare, essere solidali o almeno non compiere un atto di delazione. Come a Nonantola, in cui un intero paese, caso unico, pur intuendo e sapendo, mantenne una cortina di silenzio; mentre parecchie persone aiutarono direttamente i ragazzi di Villa Emma a nascondersi e poi a fuggire. Solo a questo si deve la loro salvezza. Altri aspetti della Shoah studiati ed approfonditi sono stati: le varie fasi dello sterminio, cronologia e processo storico, problematizzati in modo tale da mostrare i fattori contingenti come degli elementi di coerenza, oltre alla rapidità e alla concomitanza dello sterminio, secondo l’ipotesi di Hilberg13. Inoltre, utilizzando alcune pagine di Hannah Arendt, tratte dalla Banalità del male e dalle Origini del totalitarismo, comprendere che le caratteristiche di questa macchina mostruosa del Male si inscrivono nei tratti di efficienza burocratica e moderna razionalità industriale della realtà della Germania negli anni Trenta. Tratti comuni alla società industriale dell’Occidente, così efficiente e spesso indifferente verso lo sterminio di massa. Comprendere che il totalitarismo si basa appunto su ideologia e terrore e che pertanto, ogni totalitarismo è connesso al genocidio, in quanto crimine contro la pluralità degli esseri umani e quindi contro l’esistenza umana in sé. Ancora, per il filone memoriale sono state analizzate pagine significative tratte da Se questo è un uomo e da I sommersi e i salvati di Primo Levi, alcuni brani da Anni in fuga. I ragazzi di Villa Emma a Nonantola, di J. Indig Ithai e un passo tratto da E la parola ebreo divenne insulto: dialogo sulla memoria con Vittorio Foa, di Rosetta Loy, comparso sull’«Unità» del 10 giugno 1997. Lezioni introduttive alle storie dei due luoghi (Villa Emma e Maison d’Izieu) sono state curate da Alessandra Fontanesi di Istoreco, con particolare riguardo per la storia comparata Italia/Francia. In particolare in Francia per il periodo compreso fra il 1940, anno dell’occupazione della Francia da parte dei tedeschi, il collaborazionismo del nuovo stato francese, la Francia di Vichy, fino al 1944; per l’Italia dall’anno della svolta, cioè il 1943 e l’occupazione nazista dell’Italia settentrionale e la costituzione della rsi, fino al 1945. 13 R. Hilberg, La distruzione degli Ebrei d’Europa, Einaudi, Torino 1995. 120 Italiano: Sonia Ruozzi Il Bisogno del ricordo Era, il dopoguerra, un tempo in cui tutti pensavano di essere dei poeti … C’erano allora due modi di scrivere, e uno una semplice enumerazione dei fatti, sulle tracce di una realtà grigia, piovosa, avara, nello schermo di un paesaggio disadorno e mortificato; l’altro era un mescolarsi ai fatti con violenza e delirio di lacrime,di sospiri convulsi, di singhiozzi. Nell’uno e nell’altro caso non si sceglievano più le parole; perché nell’un caso le parole si confondono nel grigiore, e nell’altro si perdevano nei gemiti e nei singhiozzi14. Letture per un incontro individuale con la storia Letture finalizzate ad analizzare il rapporto dell’autore con la storia, nell’ottica del ricordo. Passi tratti da: Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny; Primo Levi, Se questo è un uomo; Elsa Morante, La Storia; Josef Indig Ithai, Anni in fuga. I ragazzi di Villa Emma a Nonantola. I percorsi del progetto Tale percorso progettuale ha avuto come esiti tre momenti particolarmente significativi: 1. Il primo, il gemellaggio ideale con la Maison d’Izieu e Villa Emma di Nonantola, luoghi con storie analoghe, ma con esiti completamente diversi: felice, nel caso dei 73 ragazzi di Villa Emma che si sono tutti salvati, tranne uno. Tragico, nell’altro caso: i 54 ragazzi della Maison d’Izieu sono stati tutti deportati e sterminati, tranne uno. Fattivamente queste due vicende complementari e opposte sono state tradotte nel linguaggio segnico di un Sipario-Rideau, fatto di 73 strisce di cotone, con i nomi dei protagonisti di Villa Emma, intrecciate alle 54 strisce coi nomi dei ragazzi d’Izieu. Ogni striscia dunque porta trascritto un nome e quel nome, trascritto con pazienza dalle ragazze, diviene azione rievocativa, gestualità che restituisce identità a ragazzi cui questa fu strappata, concreto omaggio memoriale che si oppone, nel presente, alla cancellazione del nome di allora, prima e fondamentale tappa nel processo di disumanizzazione compiuto nei lager, come lucidamente ricorda Primo Levi. Lungo l’arco di molti mesi si è sviluppato 14 N. Ginzburg, Lessico Familiare, Einaudi, Torino 1963, pp. 165-166. 121 un percorso di approfondimento e di studio della Shoah, delle storie dei due luoghi, uniti da un gemellaggio ideale in questo percorso memoriale compiuto dalle allieve. Le visite ai luoghi e le attività di laboratorio storico con studio di documenti e filmati sono state predisposte e curate dalle due referenti degli Istituti storici di Reggio Emilia e Modena (Alessandra Fontanesi, Giulia Ricci) e dai direttori dei due luoghi di memoria, dottor Fausto Ciuffi per Villa Emma, M.me Stephanie Boissard per la Maison d’Izieu. 2. Il secondo, elaborazione di uno spettacolo in lingua francese e italiana, presentato il Giorno della Memoria, nell’aula magna dell’Istituto Canossa, il 27 gennaio 2010. Lo spettacolo si è concretizzato in un racconto a più voci che ha riprodotto, in lingua francese e italiana, le fasi più salienti delle due storie. Più articolato, dinamico e concitato quasi il flusso narrativo delle storie d’Izieu, perché assemblato sulla base di un’opera già esistente, Les enfants d’Izieu, e perché ha voluto restituire voce, sangue, emozioni, pensieri a quei ragazzi deportati e quasi subito inghiottiti dalle camere a gas. Mentre la trama recitativa delle storie dei ragazzi di Villa Emma si è articolata in modo più pacato, lineare e discorsivo, modulata sul fluire dei ricordi di Joseph Inding, ebreo croato in fuga che, a soli 21 anni diventa il Villa Emma, Nonantola (MO) 122 maestro e il tutore di tutti i ragazzi di Villa Emma. 3. Il terzo, la visita ai luoghi compiuta con la supervisione degli esperti, il 17 febbraio 2010 Villa Emma, l’8 e il 9 aprile 2010 il Museo della Resistenza e della Deportazione a Lione, in Francia e la visita alla Maison d’Izieu. L’incontro, anche fisico, con il luogo che ha accolto ed ospitato le vicende ha ampliato, se possibile, l’impatto emozionale; ma ha anche affinato, approfondito le conoscenze e i contenuti storici e memoriali acquisiti. Anche i luoghi, se interrogati in modo opportuno, parlano, narrano e trasmettono storie e questa esperienza, così particolare, l’hanno potuta sperimentare tutte le allieve che hanno partecipato alle visite, sia a Nonantola sia a Izieu. Osservazioni conclusive Il progetto è risultato piuttosto impegnativo, ma molto coinvolgente ed interessante. Per le nostre allieve sicuramente un’opportunità di formazione e di crescita straordinaria. Per noi docenti è stato un percorso di ricerca-azione che 123 ha consolidato e confermato l’efficacia di alcune strategie didattiche ed educative che si riconducono all’attività laboratoriale, alla visita ai luoghi, all’uso di fonti scritte e orali (testimonianze) per supportare gli studi e gli approfondimenti storiografici. Ma si può dire che questo progetto si è spinto oltre, ha voluto far oltrepassare alle allieve la soglia di una fruizione passiva ed automatica della testimonianza, spingendo ogni partecipante a diventare protagonista del percorso memoriale, esse stesse testimoni ormai di seconda/terza generazione, perché i testimoni di prima generazione stanno ormai scomparendo. Oggi ci troviamo già in questa prospettiva, nella necessità cioè di favorire nelle nuove generazioni giovani testimoni che siano «portatori» attivi del ricordo e della memoria di vicende, di protagonisti, di luoghi. Anche le elaborazioni artistiche e teatrali prodotte dalle allieve sono state un risultato importante nel processo di costruzione di una memoria attiva, perché hanno contribuito a rafforzare il senso della partecipazione, della solidarietà, hanno dato spessore all’ etica della responsabilità e delle scelte individuali. Sono state il segno concreto dei giovani di oggi verso i giovani di allora, cui è stato dato in sorte quel tempo e quel destino. Per riprendere idealmente un discorso interrotto allora, riallacciare il filo di quei pensieri e di quelle storie individuali e trasmetterlo a noi e a quelli dopo di noi. 124 Auschwitz e la sua memoria Salvatore Trapani* Dal 15 al 20, dal 22 al 27 febbraio e dal 1° al 6 marzo 2010 si sono svolti tre Viaggi della Memoria ad Auschwitz. Grazie alla collaborazione di tante persone, collaboratori di Istoreco ed amici esterni, istituzioni, fondazioni, associazioni e cooperative il nostro progetto ha potuto dare questa opportunità a circa mille reggiani. Il Viaggio della Memoria con le sue iniziative collaterali è nato dieci anni fa per dare l’occasione allo «studente-cittadino» che sta finendo il percorso scolastico di studiare anche fuori dalle aule la storia con i suoi importanti capitoli della guerra, della deportazione e della Resistenza. Per vedere con i propri occhi. Il «Viaggio della Memoria» 2010 è stato un progetto impegnativo ma bellissimo, il progetto sulla storia contemporanea più vasto del mondo scolastico reggiano ed un vero e proprio evento culturale cittadino. Comunemente chiamato «Viaggio della Memoria» è molto di più di una visita di un campo di concentramento: la preparazione con numerose conferenze e testimonianze, un viaggio di studio con intense visite guidate, la elaborazione al ritorno a Reggio Emilia con gruppi di lavoro, laboratori e iniziative pubbliche. L’approccio cercato in tutte le fasi del progetto del «Viaggio della Memoria» è certamente lo studio della Storia, ma include anche l’attenzione alla dimensione umana delle singole storie ed un impegno culturale che parla alla nostra vita di oggi. Un progetto che non si limita ad osservare il passato, ma che vuole includere il presente. (Matthias Durchfeld) Nato a Catania si è laureato sull’«Arte dell’olocausto». Vive a Berlino, lavora come giornalista e scrittore e collabora da sette anni con i Viaggi della Memoria di Istoreco. * 125 L’edizione 2010 dei viaggi della memoria, organizzati da Istoreco si è appena conclusa. Circa mille scolari emiliani, da differenti istituti, hanno fatto visita al museo dell’ex campo di sterminio Auschwitz/Birkenau, alla ricerca delle prove storiche, in nome di una memoria italiana purtroppo labile. Non perché il nostro Paese sia scevro di memoria o di memori. Ma sono le poche cellule benigne di un tessuto organico incancrenitosi, davanti agli esiti di quei fenomeni, a causa di un bendaggio annodato con forza. E a bendaggi stretti, segue inevitabile la cancrena... Quel nodo però non è frutto di una svista, è voluto. E per questo ci resta una memoria agonizzante. Con un rammarico in più: l’amarezza di un’Italia, che ha perso l’occasione di guarire, di maturare compatta in una nazione. L’Italia continua a restar divisa davanti alle fasi storiche più critiche della sua società, incapace di farsene una ragione. Perché? Per presunzione, per la mancata accettazione di un fatto ineluttabile: noi siamo stati parte integrante di quella violenza. Se riuscissimo ad accettarlo potremmo maturare, evolverci, capire che non bisogna sempre sedersi dalla parte dei vincitori, per vincere. Per il rifiuto di questa evidenza, ci troviamo a navigare in difficili acque. E non è la crisi economica. Quella purtroppo c’è, con i suoi effetti devastanti in ambito sociale. È l’evoluzione civile, che purtroppo non è avvenuta, che non è decollata. L’esempio sta nel confronto con la Germania. Era il 1978 quando in Germania Auschwitz assurse agli onori della cronaca grazie al film americano Olocausto sulla storia – romanzata – della famiglia Weiss. Così che milioni di tedeschi – soprattutto giovani – ne furono sconvolti. Le loro domande assillanti erano rivolte a genitori e insegnanti e costrinsero la vecchia generazione a confrontarsi con i crimini che, da allora, sarebbero stati per sempre collegati al nome di Auschwitz. È a partire da questa data che tutti i fenomeni di rimozione della memoria sono falliti. La fabbrica di morte di Auschwitz, costruita per sterminare, come insetti nocivi, senza lasciar tracce, la più grande quantità di uomini con la massima economia di spazio, tempo e mezzi, è sinonimo dei crimini nazisti durante il fascismo europeo. Ma da noi in Italia Olocausto non è arrivato? Certo, ed ebbe altrettanti spettatori. Appunto, noi italiani guardammo sconvolti a ciò che solo la Germania fu in grado di fare. Nel polverone delle accuse, però ci siamo subito messi tra gli accusatori. Bastava guardare alla Germania per differenziarci: distrutta, con interi quartieri di città rasi al suolo, denigrata e divisa in quattro spicchi dagli alleati e poi dal muro sovietico. Noi invece eravamo illesi. Doveva esserci per questo un motivo plausibile. Le ferite sanguinanti tedesche, non ebbero un corrispettivo italiano. Le nostre città sono state risparmiate, i nostri beni culturali ristrutturati e non persi nelle rappresaglie alleate; non abbiamo vissuto decenni tra le macerie della guerra; una generazione intera, non si è consumata, come in Germania, prona tra le macerie a mani nude, per riottenere i mattoni da ricostruzione nel confronto con l’incubo nazista e i suoi esiti. La violenza 126 postbellica è stata appunto risparmiata agli italiani. Noi ci eravamo arresi, con Badoglio e l’armistizio; abbiamo dimostrato di essere «brava gente», un popolo ravvedutosi. E invece ci è mancata la lezione. E qualunque voce contraria a questa evidenza è stata messa a tacere con la stigma di pessimista. I responsabili fascisti di quelle vergognose violenze, fatte con i nazisti, non erano tra gli aguzzini a Norimberga, ma nel nuovo Parlamento democratico. Ci siamo dati l’alibi di uno statuto speciale, che continua ad avere i suoi drammatici effetti ancora oggi. L’Italia è stata invece il pavimento delle camere a gas e dei crematori. La civiltà rinascimentale, barocca, simbolista e poi decadente ha dato fuoco alle fornaci, alla fine di un atavico progress di violenze definite ineluttabili. Noi con il nostro razionalismo culturale, abbiamo fondato quel principio di necessità sfociato nel radicalismo della ragione strumentale, che ha condotto Hitler stesso a prendere le sue decisioni. Il nazismo non si è inventato nulla, ma è stato il frutto di secoli di cultura europea, con l’Italia antico centro culturale e di bellezze al posto di comando. Così la civiltà positivista tedesca messasi sul piede di guerra in Europa ha trovato in Mussolini e negli italiani volontari attivi, anelanti alle grandezze del passato. È dietro a quegli aneliti che giorno e notte bruciavano i crematori. La civiltà del bello pur di crederci ha nascosto e nasconde il lato più brutale dietro una maschera tranquillizzante. Il rifiuto di questa evidenza continua a creare danni gravi in Italia. Invece l’accettazione delle responsabilità tra i tedeschi ha prodotto la ricostruzione di un Paese e l’avvio di una grande evoluzione civile. Le minoranze perseguitate di allora, hanno oggi un posto di diritto nella società tedesca e un ruolo determinante nel tessuto politico e economico del Paese. Non si tratta più di guardare al passato per capire, ci basta guardare al nostro presente nazionale, che ha rifiutato l’evoluzione che nasce da ogni presa di coscienza. Con esiti al dir poco imbarazzanti: le ronde, la caccia agli immigrati a Rosarno, il negato matrimonio civile agli omosessuali, il rifiuto di creare luoghi della memoria e l’abbandono irresponsabile di quelli esistenti. E non è mai troppo tardi. Basterebbe incominciare col chiudere scusa. 127 Note e Rassegne Disincanto africano Le fotografie di Gino Cigarini durante la guerra d’Etiopia Benedetta Guerzoni Una guerra sovraesposta In occasione della quinta edizione di Fotografia Europea il Polo Archivistico del Comune di Reggio Emilia e Istoreco hanno allestito la mostra fotografica Disincanto africano. Le fotografie di Gino Cigarini durante la guerra d’Etiopia. Dal tema della manifestazione fotografica, l’incanto, è nata l’idea di esporre le fotografie del reggiano Cigarini (Castelfranco Emilia, 1912) secondo due filoni principali: l’incanto stesso – inteso come fascinazione per l’esotico e come «avventura fascista a lieto fine» della guerra di conquista coloniale – e il disincanto, ovvero la scoperta della guerra nella sua quotidianità e nei suoi orrori, lontani dalla propaganda e dall’eroismo di maniera. L’esposizione è stata quindi organizzata selezionando il materiale fotografico, organizzandolo poi secondo i due assi portanti, per mostrare anche quanto la collezione stessa fosse già coerente con essi. Si tratta infatti di temi che ben descrivono, da un lato, lo spirito che animava chi nell’esercito partiva, spesso per la prima volta, con la macchina fotografica. E dall’altro, la forza della fotografia e il desiderio di documentare la guerra al di là della propaganda, sia per documentare ma soprattutto per conservare una memoria personale degli avvenimenti vissuti in prima persona. La collezione, donata a Istoreco dagli eredi di Cigarini, raccoglie circa 900 fotografie di origine diversa, di cui almeno 550 della guerra d’Etiopia: scatti dello stesso Cigarini, sia come operatore della 14ª squadra cinefotografica dell’8° reggimento genio, sia come privato, fotografie di propaganda prodotte e distribuite per l’esercito, serie fotografiche in commercio all’epoca della guerra, e fotografie scattate da altri, come quelle in cui posa sorridente con i compagni di unità1. La guerra d’Etiopia fu il banco di prova della nuova società di massa fascista. Un diluvio di immagini, simboli e parole inonda la vita degli italiani. Canzonette popolari, cinegiornali, esposizioni museali, quaderni e materiale scolastico, stampa illustrata, saggistica. E fotografie. Cartoline, serie fotografiche, album di propaganda, materiali per i soldati. Si assiste quindi a uno sforzo mediatico senza precedenti, di pari passo con lo sviluppo proprio delle strutture totalitarie dedicate al sistema dei media. È del 1935, infatti, la creazione del ministero per la Stampa e la propaganda, che Questa e altre immagini qui citate sono visibili sul sito internet di Istoreco: http://www. istoreco.re.it cliccando sulla voce «Archivio Fotografico». 1 129 Il manifesto della mostra accentra in modo definitivo la politica culturale del regime con uffici per la stampa, la cinematografia, la musica e il teatro, oltre a quelli specifici per la propaganda politica2. Ma la guerra di Etiopia è anche la prima in cui i soldati italiani partono, spesso, con la propria macchina fotografica. Questo porta a una produzione privata di proporzioni inedite, che documenta la vita quotidiana dei soldati, oltre a una tipologia spesso clandestina di immagini di violenza efferata che si affianca alla produzione ufficiale, seriale e omologante. Gino Cigarini è un giovane soldato del genio quando, nell’ottobre del 1935, arriva in Africa orientale. Egli fa parte di quella struttura di servizio foto-cinematografico dell’esercito che, in occasione della guerra d’Etiopia, per la prima volta mobilita una sezione cinematografica, sedici squadre fotografiche, sedici squadre telefotografiche, più un reparto Luce militarizzato (il «Reparto africano»). Immagini pubbliche e private, dunque, di celebrazione e di un’Africa «nel cassetto», portate a casa da molti soldati semplici. Il rito dell’album fotografico dei ricordi fu tra i più diffusi simboli della conclusione dell’esperienza africana, oltre ogni narrazione Cfr. M. Begozzi, Il Ministero per la stampa e la propaganda, in A. Mignemi (a cura di) Immagine coordinata per un impero. Etiopia 1935-1936, Gruppo Editoriale Forma, Torino 1984; e S. Mannucci, La fotografia strumento dell’Imperialismo fascista in http://www.storiaxxisecolo.it/ fascismo/fascismo17e.htm. 2 130 imposta degli eventi. Si tratta del momento di massimo consenso per il regime, e la memoria di quella guerra ancora oggi ne gode: dopo le pubblicazioni e i dibattiti degli ultimi decenni, sulla vera natura politica e militare di quelle vicende, la guerra d’Etiopia è ancora presente nella memoria collettiva degli italiani come un momento di successo internazionale, di benessere, nonostante le sanzioni, le ristrettezze, le atrocità commesse, che hanno subito una vera e propria rimozione. 1 Incanto L’incanto, l’esotismo, il senso di avventura e di affermazione del fascismo: tutti elementi presenti nella collezione fotografica di Gino Cigarini, che ben rende l’idea di quale fosse l’immaginario italiano legato alla terra d’Africa, un immaginario che aveva radici nelle esperienze coloniali dell’età liberale. Ed è proprio da lì che si ripartì per la nuova produzione di immagini e simboli di propaganda che caratterizzeranno la «pedagogia imperiale» del fascismo. 1.1 Un’altra Africa, la stessa Straniamento ed esotismo: il sentimento degli occidentali che per la prima volta arrivano in Africa nella prima parte del Novecento è lo straniamento, e l’esotismo il suo contraltare, l’elemento che riesce a riequilibrare quella sensazione di diverso, lontano, ignoto. Un esotismo che si traduce, nelle immagini in mostra, in fascinazione per la natura africana, per i paesaggi immensi e sterminati, primordiali, e per una popolazione con una storia millenaria, la cui religiosità di matrice cristiana eppure «diversa» crea un misto di attrazione e familiarità. Le fotografie di paesaggio, le vedute, e quella di documentazione etnografica si iscrivono in una tradizione estetica di lungo corso e, all’epoca della guerra d’Etiopia, sono già da tempo parte di quell’immaginario coloniale che per molti versi si può definire europeo. Fa parte dell’immaginario esotico anche quel senso di avventura che rende unica un’esperienza collettiva come quella della guerra di conquista: la pubblicità dell’epoca, a proposito delle macchine fotografiche, sottolinea proprio questo aspetto nei suoi slogan. Ma l’esotismo è anche una forma di violenza, quando, invece di accogliere in sé la ricchezza della realtà variegata che incontra, la riduce ad alcune categorie di riferimento, appiattendola: nel caso della fotografia, su due dimensioni. La fotografia, nata per riprodurre fedelmente e oggettivamente la realtà, è fin dalla sua invenzione uno degli strumenti di maggiore successo nel formare l’idea a cui deve aderire ciò che non si conosce, e che quindi fa paura3. 3 Cfr. fra i tanti L. Gervereau, Les images qui mentent. Histoire du visuel au XX siècle, Seuil, Paris 2000. 131 Adua, 30 gennaio 1936 – Panorama Fotografia come stereotipo, modello: ecco il guerriero abbigliato e armato senza quella «tecnologia» civilizzatrice che il fascismo si pregerà di portare in quelle terre; ecco Adua come un ammasso di capanne, selvaggia e immobile nel tempo; ecco l’esotismo della «venere nera» africana. Uno dei capisaldi della comunicazione visiva della guerra d’Etiopia, che riprende una tradizione coloniale occidentale di ottocentesca memoria, è l’immagine della donna di colore come simbolo della conquista e della violenza che implica, della generosità e dell’abbondanza del nuovo impero coloniale nei confronti del soldato vincitore. Dalla forma «borghese» e rassicurante del madamato di epoca liberale, si passa con il fascismo alla «purezza della civiltà latina» e alle leggi razziali, con l’auspicio di una rigida separazione dei sessi, tanto che persino la famosa canzone Faccetta nera fu censurata, dopo la fine della guerra, per l’implicita allusione alla conquista sessuale dell’Africa, luogo di sensualità sfrenata e selvaggia, di corpi esposti e, quindi, offerti. Il nuovo punto di vista fascista è che la donna di colore può essere solo prostituta: l’immagine della donna e il modo in cui cambia, restando comunque e sempre oggetto sessuale, è quindi il simbolo del passaggio che il fascismo opera dalla coscienza coloniale e imperialista a quella più esplicitamente razzista4. Cfr. S. Palma, L’Italia coloniale, Editori Riuniti, Roma 1999; E. Bini, Fonti fotografiche e storia delle donne: la rappresentazione delle donne nere nelle fotografie coloniali italiane, in http:// www.sissco.it/fileadmin/user_upload/Dossiers/Foto_e_storia/Lavori_in_corso/fotografia_ storia_donne.doc. 4 132 1.2 Un’avventura fascista Da un punto di vista mediatico, l’intervento in guerra è ampiamente organizzato: l’esercito e le amministrazioni civili dell’Africa Orientale aprono uffici stampa congiunti ad Asmara e a Mogadiscio per accogliere i giornalisti italiani e stranieri e per fornire documentazione fotografica e giornalistica oltre al supporto logistico. Saranno le uniche agenzie autorizzate dal ministero della Propaganda, per mantenere un controllo totale sulla forma e i contenuti della comunicazione. Al termine del conflitto gli uffici vengono chiusi e se ne apre uno ad Addis Abeba; si passa in questo modo da strutture di guerra a strutture di occupazione e a una «esportazione» stabile di un canale di comunicazione unico e omologante. Durante il conflitto vigeva infatti il divieto di pubblicare foto con il nome dell’autore per agevolare l’omologazione del messaggio e il controllo dei contenuti. Con questa esperienza bellica, la guerra si dota di un nuovo linguaggio, e soprattutto di un nuovo linguaggio visivo: la pervasività della propaganda è tale che spesso, infatti, anche le memorie di guerra private si giovano di una narrazione visiva a tappe fisse, ormai introiettate e fatte proprie, parte dell’esperienza individuale. Inoltre, i soldati ricevono un’ampia gamma di materiali di propaganda, segnale della trasformazione della guerra nella società industriale: pubblicistica, cartoline, serie fotografiche, che spesso si mescoleranno con le raccolte e gli album privati. Il viaggio segnato dal passaggio nel Canale di Suez, tra Oriente e Occidente, civiltà e barbarie, familiarità ed esotismo, avventura; e i tentativi di fascistizzazione dell’Africa, un’Africa che il regime sognava di omologare ai riti e ai simboli del fascismo, da quelli marziali e imperiali a quelli della vita quotidiana: il saluto romano, le uniformi scolastiche, le insegne militari. Ma l’Africa è anche ignoto, pericolo, violenza e ferocia, e su questo agisce l’immaginario creato dal fascismo: è l’immagine dell’eroe virile e sbruffone che, beffandosi del pericolo e anzi con il sorriso, tiene tra le braccia la carcassa dell’animale feroce (e, solo in quanto tale, esotico). Sono immagini per i soldati, per il fronte interno, per dimenticare quelle della ferocia e della violenza imposta alle popolazioni, che vedremo. Tutto il materiale di propaganda, e in particolare le fotografie, costituì un precedente e creò un vero e proprio filone autonomo nell’ambito della rappresentazione fascista della guerra, seppur di volta in volta declinato con alcune differenze a seconda dei diversi obiettivi militari e politici, come dimostrano i successivi «album» del Luce (per esempio in occasione della guerra in Albania5). 2 Disincanto La storia coloniale italiana, la pubblicistica, i giornali illustrati, e anche la 5 A. Mignemi, La campagna militare in Etiopia del 1935-36 e l’occupazione dell’Albania nell’archivio dell’Istituto Luce, in , in «Ieri Novara Oggi», n. 1 (nuova serie), pp. 67-88. 133 produzione letteraria, oltre alla propaganda politica del fascismo, hanno prodotto quella mitizzazione dell’Africa come terra di conquista che, come abbiamo visto, dà luogo a una enorme produzione di immagini, negli ambiti più diversi. Tale produzione coinvolge anche i soldati come interpreti diretti della memoria e della documentazione. 2.1 L’Africa nel cassetto I soldati al fronte scattano fotografie: mai si ripeterà una tale produzione privata in ambito bellico6. Una vera e propria Africa nel cassetto. Queste immagini documentano la vita del campo e tutto ciò che esula dalla vita militare, il tempo libero, la celebrazione di festività e riti religiosi. Si tratta di immagini che, come capita spesso in questi casi, sembrano opporsi a quelle pubbliche, ufficiali: immagini che vogliono ristabilire una precaria normalità, immagini di quiete, di momenti vuoti, a volte forse inconsapevolmente ironiche, come quelle che vediamo a proposito del generale Maravigna, piccolo generale del grande impero fascista, o quella del rito religioso celebrato con le armi puntate. I soldati vogliono immortalare i ricordi di quell’esperienza che è anche la loro, al di là della guerra fascista, della propaganda. Lo fanno per i loro cari rimasti a casa, ma anche per se stessi: per esempio negli album, come strumento di legittimazione e di memoria costruita secondo un discorso articolato in un racconto visivo, per ribadire la propria soggettività, la stessa di quell’esperienza che viene vissuta come parte della propria vita di individui, oltre che come soldati e italiani, su cui incombe la propaganda fascista. Un’esperienza in cui l’esotismo ha un ruolo importante nel segnare il tratto individuale: ognuno ha l’opportunità di concretizzare le avventure salgariane, di divenire eroe in prima persona, uscire dall’anonimato per dire «c’ero anch’io». Esiste comunque una reale difficoltà di discrimine tra foto pubbliche e private, in quanto la pervasività della propaganda impone anche al singolo forme e contenuti omologati e uniformi. È però chiaro che la produzione di fotografie private aumenta mano a mano che cresce la delusione per l’avventura africana: «la tentazione di scrivere la propria avventura era assai forte in tutti e crebbe in misura proporzionale alla delusione cui andarono incontro in molti. Il rito dell’album fotografico di ricordi fu infatti, per migliaia di soldati, la più diffusa conclusione dell’avventura africana»7. 2.2 Vittime, violenza, atrocità La documentazione della violenza della guerra in Etiopia, nelle foto dei nemici 6 A proposito della produzione privata e in particolare della memorialistica cfr. N. Labanca, Una guerra per l’impero. Memorie della campagna d’Etiopia 1935-1936, il Mulino, Bologna 2005. 7 A. Mignemi, Lo sguardo e l’immagine. Le fotografie come documento storico, Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 129. 134 uccisi, militari e civili massacrati per ritorsione, così come in quelle dei cadaveri italiani, riguarda sia serie clandestine tollerate dalla propaganda, sia immagini «ufficiali», conosciute e, in parte, divulgate all’interno dell’esercito. Naturalmente si tratta di un uso molto diverso: le immagini dei nemici uccisi, prigionieri, impiccati, che vediamo nella collezione di Gino Cigarini, sono una forma di esorcismo della violenza, ormai tristemente nota a chi conosce la storia del Novecento. La fotografia introduce allo scandalo dell’orrore, non all’orrore in sé, non rappresentabile: una sorta di uso ipocrita dell’immagine che nasconde male la realtà della guerra, ma che aiuta a sopravvivere8. Eppure, sul piano politico queste immagini hanno anche un altro significato: possono essere viste come quell’estetizzazione e celebrazione della morte, della violenza e della guerra che è uno dei tratti più distintivi del fascismo, nell’ambito della creazione di quel nuovo linguaggio della guerra di cui abbiamo visto altri esempi. Le foto di atrocità sui nemici, un altro retaggio del colonialismo liberale, celebrano la guerra come medicina e come igiene del mondo; all’epoca l’effetto che si voleva ottenere era l’esclamazione: «Giustizia è fatta!», in particolare per le foto che ritraggono i ribelli morti per impiccagione. Si tratta di un tipo di immagine molto presente in questo tipo di collezioni, prodotta in serie per l’esercito, come una macabra celebrazione e quindi legittimazione della missione civilizzatrice dell’Italia fascista. In generale, infatti, furono migliaia le fotografie di questo tipo trovate nelle tasche dei militari caduti prigionieri alla fine dell’impero coloniale, nel 1941. Fotografie di produzione privata ma dal contenuto pubblico e politico. Di tutt’altra natura l’uso delle immagini di atrocità e massacri contro militari e civili italiani ed indigeni: una manipolazione pubblica e politica che si avvaleva anche dell’uso di voci incontrollate per ampliare la spirale di una violenza efferata nelle ritorsioni, per giustificare la propria posizione sulla scena politica internazionale e in particolare di fronte alla Società delle Nazioni. Se l’Italia viola la convenzione di Ginevra del 1929, utilizzando armi chimiche come ritorsione contro i ribelli, lo fa perché le foto documentano le atrocità del nemico9. È quindi necessario intervenire per salvare le popolazioni indigene innocenti, con una guerra che in quest’ottica diventa difensiva. Una manipolazione tipica della guerra moderna che in questo caso si basa sull’assunto razzista largamente condiviso per cui la mentalità di guerrieri prevede le forme di violenza più efferate e ingiustificabili, mentre l’Italia fascista porta la civilizzazione (eppure molte fotografie mostrano i soldati italiani che, sguardo ammiccante in macchina, ostentano parti del corpo del nemico come trofei di guerra). Ecco allora le immagini di atrocità del nemico pubblicate sulla stampa italiana, negli album e come serie fotografiche per l’esercito, come quella in cui si vedono due Cfr. A. Mignemi, Immagini per il soldato e il soldato fotografo, in A. Mignemi (a cura di) Immagine coordinata per un impero. Etiopia 1935-1936, cit., p. 193. 9 G. De Luna, Il corpo del nemico ucciso. Violenza e morte nella guerra contemporanea, Einaudi, Torino 2006, pp. 91-95. 8 135 uomini girati di schiena che espongono i segni della violenza abissina (la fotografia dei due di fronte fu pubblicata in copertina su «L’Illustrazione Italiana» del 12 aprile 1936). Conclusioni Dopo la fine della guerra d’Etiopia, Gino Cigarini tornò al fronte a partire dal gennaio 1942: in Croazia con il 6° reggimento genio, nell’80ª compagnia telegrafisti. Ma dopo l’8 settembre fu catturato dai tedeschi a Trieste e rinchiuso come prigioniero militare in diversi campi di concentramento in Germania fino alla fine della guerra, quando rientrò alla vita civile. La sua collezione arriva a Istoreco nel 2008 ed è subito chiaro l’interesse del materiale, innanzitutto perché si riscontra la pubblicazione di alcuni degli scatti in titoli di rilievo10. Inoltre, la collezione è particolarmente completa ed esaustiva nell’illustrare 10 A. Mignemi, Si e no padroni del mondo, Etiopia 1935/36. Immagine e consenso per un impero, Istituto storico di Novara, Novara 1982. 136 tematiche diverse: quelle private e individuali, con la produzione di materiale che idealmente costituisce quell’album che tantissimi riportarono dalla guerra africana; ma anche quelle della propaganda e della produzione diretta (essendo Cigarini parte di quella «macchina» di propaganda a cui abbiamo accennato), specchio della politica e del più generale clima dell’epoca. Una collezione, quindi, degna del lavoro, tuttora in corso, di riordino e valorizzazione che ha come obiettivo l’identificazione il più possibile precisa di ogni scatto, attraverso il riscontro con la stampa dell’epoca, le pubblicazioni sull’argomento e gli archivi fotografici nazionali, quali quelli dell’Istituto Luce di Roma. Ciò allo scopo di distinguere le immagini scattate da Cigarini rispetto per esempio alle serie per i soldati e a quelle commerciali. Si tratta in sostanza di una collezione che ben si inserisce in quell’ambito di ricerca storica attraverso il materiale iconografico, e fotografico in particolare, come ha dimostrato l’interesse di un esperto del calibro di Adolfo Mignemi. L’interesse del fondo Cigarini è infine dimostrato dall’inserimento nel progetto Returning and Sharing Memories per una «restituzione di memoria», relativo al periodo dell’occupazione coloniale italiana dell’Africa orientale, 1935-1941. Al progetto, coordinato dal professor Paolo Bertella Farnetti dell’università di Modena e Reggio Emilia, hanno aderito anche storici dell’Africa e del colonialismo italiano tra cui Alessandro Triulzi dell’università di Napoli «L’Orientale» e Matteo Dominioni dell’università di Torino. Un lavoro che, pur iniziato su scala locale e con materiali privati, rappresenta un primo importante tentativo di affrontare il passato coloniale italiano e la sua memoria, nonostante le tante difficoltà che, nel nostro Paese, si riscontrano su questo argomento11. A. Triulzi, Displacing the colonial event. Hybrid Memories of Postcolonial Italy, in «Interventions», Vol. 8, Issue 3, november 2006, pp. 430-443. 11 137 Remo Cantoni e l’impegno politico-culturale Nicola Mai* «Studi Filosofici»: la rivista (1940-1949) Remo Cantoni nasce nel 1914 a Milano e proprio a Milano porta a termine i suoi studi universitari fino a diventare – dopo varie docenze presso altre università italiane quali Pavia e Cagliari – ordinario di Filosofia morale presso la stessa Università che gli diede i natali. Fu allievo di Antonio Banfi, esponente di punta della «scuola milanese»1, punto di riferimento per quel campo della ricerca filosofica orientata alla polemica con l’idealismo, lo spiritualismo cattolico e l’irrazionalismo dominante nella cultura italiana della prima metà del Novecento. Questa «battaglia» filosofica e culturale, dalle implicite connotazioni politiche, ebbe come arma principale la rivista «Studi Filosofici» fondata dallo stesso Banfi; espressione di un vero e proprio orientamento filosofico, tra le pagine della rivista si discutevano apertamente alcune delle maggiori correnti di filosofia contemporanea ancora scarsamente conosciute in Italia, dalla fenomenologia al neo-positivismo, dal pragmatismo deweyano all’esistenzialismo. E proprio per il fatto di essere sorta come strumento di polemica, di libera diffusione culturale e per la pluralità d’interessi che il folto numero d’intellettuali aderenti esprimeva con la stesura degli articoli, differiva da tutte le altre riviste italiane dell’epoca. Banfi poteva, infatti, contare sulla collaborazione e sui contributi di studiosi, filosofi, artisti e intellettuali di ogni genere e di alto profilo tra cui Enzo Paci, Giulio Preti, Giovanni Maria Bertin, Dino Formaggio, Galvano Della Volpe, Ludovico Geymonat e Remo Cantoni ovviamente. Quest’ultimo, dopo la discussione della sua tesi di laurea (1938) con Antonio Banfi come relatore, Il lavoro che qui presentiamo è tratto dall’ultimo capitolo della tesi di laurea di Nicola Mai La Filosofia e il quotidiano. A proposito di Remo Cantoni, discussa nel marzo 2009 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna. Il saggio non ha l’ambizione di compiere un’analisi esegetica accurata e approfondita dell’esperienza strettamente filosofica di Remo Cantoni, ma vuole tentare di aprire uno spiraglio di luce sul filosofo milanese e, soprattutto, di riflesso sul suo tempo. Cantoni, infatti, non s’impegnò unicamente nel campo filosofico, ma va anche ricordato per il suo ruolo nella politica, nei dibattiti letterari, estetici, sociali, culturali e morali della propria epoca. Una proposta, insomma, per ricordare il filosofo milanese che ha lasciato un’impronta sottile, tuttavia indelebile, nella cultura e nella società milanese e nazionale tra i primi anni Quaranta e il periodo post-bellico. 1 Per un approfondimento sulla «scuola di Milano» vedi F. Papi, Vita e filosofia. La scuola di Milano. Banfi, Cantoni, Paci, Preti, Guerini e Associati, Milano 1990. * 138 in primis divenne assistente alla cattedra di Storia della Filosofia di cui lo stesso Banfi era titolare presso la Statale di Milano e in secondo luogo divenne redattore capo del progetto «Studi Filosofici». Rivista trimestrale fondata nel 1940 dal filosofo di Vimercate2 fu da lui diretta per tutta la durata della sua pubblicazione, fino al 1949. Nelle Parole d’introduzione3 pubblicate sul primo numero di «Studi filosofici», riportanti la firma della Redazione, per cui senza tema di sbagliare si può affermare anche del Cantoni stesso, viene svelata l’ambizione che la rivista sente di poter perseguire: restituire alla filosofia quel suo primitivo carattere scientifico e razionale lontano da qualsiasi schematizzazione o prospettiva metafisica e parziale; la filosofia deve confondersi con ideologie pratiche, comprendere la vita e trovare le soluzioni nel senso non esclusivamente teoretico, ma realistico delle concrete circostanze, diventando così volontà consapevole della propria relatività e del rischio della propria affermazione. La filosofia quindi riconosciuta come processo d’infinita costruzione che, nell’amore e nel coraggio della verità del filosofo, trova la propria intenzione edificante. Ma nella rivista viene soprattutto difeso il principio della storicità del sapere filosofico, da non confondere con l’abbandono della tradizione ogni qualvolta si presenti un momento difficile; al contrario ciò che va ricercato è il rinnovamento del valore e del senso di continuità nella storia del pensiero. Furono perciò numerosi i numeri speciali con rassegne e recensioni dedicate alla filosofia internazionale, riprendendo in esame spesso i giudizi sui grandi filosofi classici nel caso in cui ne fosse riscoperto il valore speculativo nella problematica contemporanea. La rivista non voleva apparire né come una mera raccolta eclettica di saggi filosofici e storici, né come lo strumento di un particolare indirizzo sistematico. Piuttosto ambiva a battere il cammino per tutte quelle ricerche e analisi critiche volte a chiarire, pur mantenendo la differenziazione delle loro forme e delle loro direzioni, la posizione della filosofia allontanandola dall’irrigidimento dogmatico e dalla contaminazioni di generici e dannosi valori spirituali. Sospesa dal regime fascista nel 1944, la rivista riprese le pubblicazioni col numero di gennaio-marzo del 1946 riaffermando con maggior energia quei principi e quel programma d’indipendenza speculativa che le erano stati da guida nei primi difficili anni di vita e che lo saranno fino alla chiusura definitiva, avvenuta per divergenze politiche sorte tra i principali collaboratori. Problemi su cui non ci soffermeremo, perché quello che interessa qui è evidenziare, invece, alcuni aspetti del clima culturale, sociale e politico della Milano di quegli anni. Vimercate è il paese natale di Antonio Banfi (Vimercate, 30 settembre 1886-Milano, 22 luglio 1957). 3 Parole d’introduzione, in «Studi Filosofici. Rivista trimestrale di filosofia», prefazione di Eugenio Garin, a cura del Centro Antonio Banfi, Arnaldo Forni Editore, Bologna 1972, (I ed. 1940, pp. 1-3). Tutti i numeri della rivista sono stati raccolti e ristampati in quattro volumi dall’editore Arnaldo Forni nella suddetta opera nel 1972. 2 139 La «Casa della Cultura» e «Il Politecnico»4 Proprio negli anni della crisi e della svolta, quelli attorno al 1945 per intenderci, Milano fu il nucleo di una serie di attività culturali, in genere, e filosofiche in particolare. Dopo il ventennio fascista, in cui la cultura veniva per ultima fra le manifestazioni di civile umanità, dopo la milizia, lo sport e la devozione al regime, la prima idea di una sede ad essa riservata, di una vera e propria «Casa» per la cultura, senza attributi di partito o di tendenza ma retta esclusivamente dalla libertà di pensiero e di comunicazione, era sorta nella mente di Antonio Banfi. Da sempre aveva improntato le proprie lezioni, nonché la propria vita all’antifascismo: fu tra i firmatari della risposta al «Manifesto degli intellettuali fascisti»5; sul finire del 1941 entrò in contatto con l’organizzazione clandestina del partito comunista italiano al quale aderì; dopo l’8 settembre prese direttamente parte all’organizzazione della Resistenza. Costretto al silenzio e all’isolamento, e come tanti ad una vita intellettuale «clandestina», troverà il modo di uscirvi precisamente il 4 maggio 1945: data in cui si costituì un «Fronte della Cultura», il cui unico scopo era quello di trasferire nel mondo della cultura lo spirito e l’attività della Resistenza. La riunione del 4 maggio in casa Banfi, la prima non segreta, vide come partecipanti e membri del comitato promotore: Remo Cantoni, Elio Vittorini, Giansiro Ferrata e Riccardo Bauer, chiamati a discutere l’indirizzo, lo scopo e l’organizzazione del «Fronte» stesso; di certo non mancò anche l’appoggio del cln lombardo. Prendendo spunto dallo scambio di battute di quella riunione, riportate in parte da Carlo Montaleone nel suo lavoro monografico su Remo Cantoni6, risulta evidente che le domande ricorrenti dei partecipanti riguardavano il pubblico a cui avrebbe dovuto rivolgersi l’operato del «Fronte»: alle persone o ai partiti? Ai crociani, ai liberali, o solo ai socialisti, ai comunisti, agli azionisti? Mentre Vittorini metteva in primo piano la priorità logico-temporale della dittatura del proletariato e quindi, insieme a Ferrata, puntava ai marxisti e all’ala della sinistra, Cantoni avrebbe accolto chiunque, anche se ex fascista, ovviamente solo se in grado di dimostrare di essere progressista, tendente cioè ad un ideale di cultura che non fosse astratta e apolitica, in breve che non fosse una cultura pura, fuori dalla storia e dalla società. Banfi non si pronunciò, forse per paura della possibilità di troncare e far fallire il progetto sul nascere. Tuttavia, nella primavera del 1946 il progetto banfiano, tanto Per maggiori approfondimenti sul tema vedi in Parte I: La stampa, sez. Riviste mensili, il capitolo dedicato alla Filosofia a cura di Guido Neri; e in particolare il capitolo Politica, Sociologia, Storia, nella fattispecie R. Crovi (a cura di), Il Politecnico, in Milano com’è. La cultura nelle sue strutture dal 1945 ad oggi. Inchiesta, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 1962. 5 Qui s’intende il «Manifesto degli intellettuali antifascisti», nel quale si denunciava la violenza e la soppressione della libertà di stampa da parte del regime. Pubblicato da Benedetto Croce in risposta al «Manifesto degli intellettuali fascisti» redatto nel 1925 da Giovanni Gentile. 6 C. Montaleone, Cultura a Milano nel dopoguerra. Filosofia ed engagement in Remo Cantoni, Bollati Boringhieri, Milano 1996. 4 140 discusso nell’anno precedente, si concretizzò: venne inaugurata la «Casa della Cultura», che aveva come presidente Ferruccio Parri, vicepresidente Banfi, e illustri consiglieri, tra cui Giulio Einaudi, Alberto Mondadori, Raffaele de Grada e Remo Cantoni. Il nuovo circolo, ancora oggi in attività, divenne subito il più frequentato centro culturale della città di Milano. Aperto a tutti gli intellettuali era diventato un luogo di sincero, reale dibattito e incontro: situazione irrealizzabile durante il regime. Le associazioni culturali più disparate trovarono nella «Casa» gli spazi per potersi riunire e organizzare iniziative di vario genere: dalle conferenze ai corsi, dalle proiezioni ai convegni, dalle letture ai concerti. Nel giro di nemmeno due anni si fecero avanti i primi segni di una crisi, anche l’unità del «Fronte della cultura» si era incrinata: l’accordo sul piano esclusivamente antifascista non aveva più forza sufficiente per garantire una coesione, ferita dalle numerose differenze ideologiche che si andavano delineando. Cominciava così una lotta, senza compromessi, tra i diversi orientamenti e soprattutto tra i numerosi partiti. La «Casa della Cultura» dovette cedere, caratterizzandosi come centro di dialogo della sinistra laica e socialista, e soprattutto del partito comunista che scelse d’imboccare la strada della compattezza ideologica rifiutando così qualsiasi convivenza con scuole o impostazioni politico-culturali divergenti. Nel 1951 poi «trasferitasi nella nuova e definitiva sede di via Borgogna 3, si costituisce legalmente in associazione avente per statuto lo scopo di promuovere e coordinare l’attività culturale e artistica e di favorire i rapporti fra quanti, sia privati o associazioni o enti, si occupano di problemi culturali ed artistici, offrendo loro un accogliente centro di ritrovo, di consultazione e di studio, che agevoli gli scambi intellettuali fra Milano e gli altri centri italiani, e fra l’Italia e l’estero…»7. Dalla riunione del 4 maggio 1945 in casa Banfi non si voleva soltanto creare un «Fronte della Cultura», che sarebbe sfociato nella fondazione della «Casa della Cultura», ma dare vita ad una nuova rivista, strumento necessario per divulgare le idee, i progetti del «Fronte», e in grado di rimediare alla sospensione, da parte del regime fascista negli ultimi due anni della guerra, della già affermata rivista «Studi Filosofici». L’idea della rivista, durante l’organizzazione della Resistenza milanese, divenne per lo stesso Banfi assillante e, assieme al fisico e partigiano Eugenio Curiel (ucciso dai «repubblichini» poco prima della Liberazione), pensò d’intitolarla «Nuovo Politecnico», prendendo spunto dal «Politecnico» fondato nel 1839, sempre a Milano, da Carlo Cattaneo. Banfi premeva affinché la rivista non ritardasse ulteriormente l’approdo alle stampe, ma come fare senza aver prima superato alcune delle controversie presentatesi tra i collaboratori in seduta di riunione? Era forse questo il problema su cui Banfi così silenzioso quel 4 maggio, come abbiamo sopra accennato, rifletteva? Fu allora Vittorini a prendere le redini della discussione intorno alla rivista. Dopo pochi mesi, esattamente il 29 settembre 1945, in veste di direttore fece uscire il primo G. Veronesi (a cura di), Casa della Cultura, via Borgogna 3, in Milano com’è. La cultura nelle sue strutture dal 1945 ad oggi, cit., p. 705. 7 141 numero del settimanale, stampato a colori e in formato quotidiano, «Il Politecnico» edito da Giulio Einaudi. Con la parola «politecnico» Vittorini intendeva evidenziare un interesse per tutte le tecniche cioè per tutte le attività culturali che si adoperano per la ricerca della verità e non per la sua predicazione. Il settimanale si occupava dei problemi dell’attualità, a qualsiasi campo appartenesse; entrava in un rapporto dialogico con tutti coloro che sentivano la necessità di conoscere e apprendere, utilizzando un linguaggio che rendesse accessibile a tutti qualsiasi problema. La cultura, secondo Vittorini, doveva partecipare attivamente alla rigenerazione della società e per farlo doveva immedesimarsi con le classi lavoratrici, facendo proprie le loro aspirazioni; per fare questo era necessario che la cultura fosse a stretto e continuo contatto con le «masse». Vittorini vide nel progetto «Il Politecnico» lo strumento attraverso cui, mentre gli intellettuali ponevano al centro delle loro discussioni e dei loro studi i problemi della cultura, con l’obiettivo di una rigenerazione sociale, tutti i lavoratori potevano prendere atto e partecipare all’elaborazione dei problemi culturali in vista dello stesso fine. La rivista perciò si rivolgeva ad un pubblico vastissimo, dagli operai agli intellettuali; lo scopo era quello di riunire le collaborazioni di persone di varia provenienza ideologica per divulgare quella cultura europea che era stata soppressa dal fascismo, ricavandone un’azione politica che avesse come oggetto della lotta l’uomo stesso e non esclusivamente l’ideologia. Dal 6 aprile 1946 la rivista continuò la pubblicazione in formato ridotto e con cadenza mensile. Ma la caratteristica che più di tutte emerge nella prospettiva umanistica di Vittorini, ed è alla base del nuovo indirizzo del «Politecnico», riguarda il deciso rifiuto del metodo dell’utilizzazione della cultura da parte del potere politico, ovvero il rifiuto della prassi politica perentoria e funzionale che spesso non tarda a divenire conservatrice, dogmatica, fino a rifiutare la storia. A Vittorini, marxista e comunista, non importava di far politicamente comodo o meno al pci, l’unico suo obiettivo era il rinnovamento della cultura italiana. Questa precisazione che riportò sulla «sua» rivista provocò un’aspra polemica, sul rapporto politica-cultura, con Palmiro Togliatti. Vittorini sosteneva che la cultura, in quanto verità, non si sviluppa e muta solo grazie ai cambiamenti concreti del mondo, ma nella misura in cui non si soddisfa e cristallizza in possesso e sistema. Inoltre osservava come politica e cultura fossero due attività distinte anche se non perfettamente: ‹‹quando una di esse è ridotta a non avere un dinamismo suo proprio, e a svolgersi, a divenire, nel senso dell’altra, sul terreno dell’altra, come sussidiaria o componente dell’altra, non si può non dire che lascia un vuoto nella storia. La cultura che perda la possibilità di svilupparsi in quel senso di ricerca, che è il senso proprio della cultura, e si mantenga viva attraverso la possibilità di svilupparsi in senso di influenza, cioè in senso politico, lascia inadempiuto un compito»8. Vittorini definiva «Il Politecnico» una rivista «indipendente di sinistra», mentre Togliatti puntava sulla cultura come espressione della lotta politica e del partito. Questa polemica determinò la decisione di Vittorini di uscire dalle fila del 8 R. Crovi (a cura di), Il Politecnico, cit., p. 175. 142 pci, nonché la chiusura immediata della rivista, che avvenne nel dicembre 1947. Nei pochi anni di vita del «Politecnico», anche Cantoni, collaboratore di spicco della rivista di Vittorini, elaborò il proprio personale umanismo critico-storico attraverso l’esame della condizione dell’uomo, sostenendo quella funzione liberatrice della filosofia non elitaria, ma aperta alle altre componenti culturali e scientifiche, in particolare quelle antropologiche. Cantoni, al pari di Vittorini, s’impegnò nella progettazione di una cultura capace di liberarsi definitivamente dalle catene di un passato recente impregnato di idealismo, ma soprattutto ebbe a cuore le sorti di un paese che per venti anni aveva subito vessazioni morali e materiali. Banfi e Cantoni: la rottura Facciamo il punto della situazione. È finita la guerra e a Milano i progetti portati avanti da Banfi e dalla sua scuola sembrano destinati al naufragio. La «Casa della Cultura», in concomitanza con la chiusura del «Politecnico», assume una fisionomia più improntata alla politica che alla cultura. Solo «Studi Filosofici», dopo la ripresa delle pubblicazioni, come dicevamo interrotte dal regime nel 1944, sembra essere risorta più forte di prima e capace di continuare su di una impostazione critica e speculativamente indipendente. Purtroppo presto anche quell’equilibrio ritrovato nella redazione del periodico s’incrina. Il fattore decisivo che scatenò la rottura definitiva tra Cantoni e il suo «maestro» fu la recensione9, uscita su «Studi filosofici» per mano di Cantoni, a un libello10 antiesistenzialista scritto dal allora responsabile del settore cultura del partito comunista francese Jean Kanapa. Il libello, fortemente polemico, faceva il verso al ben più famoso scritto sartriano11, a parere del Nostro era una vera e propria dichiarazione di guerra all’esistenzialismo, poiché inteso come coscienza di una classe borghese decadente e cattolica. La soggettività tanto difesa dall’esistenzialismo veniva difesa dal Cantoni nel momento in cui non si creasse una interiorità viziosa e sofferta o diventasse giudizio sommario, dogmatico, sempre astratto e moralistico, incapace di qualsiasi forma dialettica. «Difendere una certa forma di solitudine non vuol dire costruire il senso della vita sulla solitudine, o opporre la solitudine alla moltitudine, bensì non distruggere quei valori dell’intimità, della riflessione, della meditatività che possono, in ultima analisi, risolversi in un arricchimento individuale che è, anche, un arricchimento collettivo»12. Se gli esistenzialisti avevano creato intorno a sé una retorica intimista, occorreva sempre guardarsi dalla retorica opposta. Perciò, se nel primo caso R. Cantoni, Recensioni, in «Studi Filosofici. Rivista trimestrale di filosofia», Arnaldo Forni Editore, Bologna 1972, n. IX, 1948, pp. 167-71. 10 J. Kanapa, L’Existentialisme n’est pas un humanisme, Editions sociales, Paris 1947. 11 J.P. Sartre, L’Existentialisme est un humanisme, Editions Nagel, Paris 1946. 12 R. Cantoni, Recensioni, in «Studi Filosofici. Rivista trimestrale di filosofia», cit., p. 169. 9 143 non s’intendono i valori obiettivi e sociali creando intorno a sé il vuoto; nel secondo caso si dissolve la persona nel continuum di una ragione impersonale, in una storicità metaindividuale. Ad ogni modo Cantoni riconosceva, così come lo stesso Kanapa, un accento di nichilismo nella formula che racchiudeva l’essenza dell’esistenzialismo: «scegli quello che vuoi, basta che tu scelga, pur che la tua scelta sia autentica». Al capogruppo del partito comunista francese sembrava che la libertà esistenzialistica si risolvesse in un impegno senza continuità, senza responsabilità storiche, un impegno espresso esclusivamente da un’enfasi verbosa e da una declamazione inconsistente; in somma l’engagement esistenzialista sembrava appartenere al mondo in cui si parla piuttosto che al mondo in cui si vive. Se Cantoni si trovava ad essere sostanzialmente d’accordo con il giudizio di Kanapa quale fu la vera ragione della polemica scatenatasi in seguito? In effetti Cantoni concordava con l’impostazione generale di quelle 126 pagine scritte dal politico francese, il quale però più volte confuse la ricerca critica con la semplice libellistica, difetto che il filosofo milanese identificava nella confusione tra due momenti distinti della socialità: politica e cultura. La convergenza tra politica e cultura, la loro dialettica, non deve risolversi in una massiccia e acritica identificazione. Insomma Cantoni non ha intenzione di affermare, contraddicendo Kanapa, una piena autonomia della cultura, perché nulla è autonomo nel mondo dove tutte le cose sono in una rete d’infinite relazioni; piuttosto cerca di definire un confine tra la politica culturale e la politicità della stampa di partito, dei parlamenti o delle lotte sindacali. È soprattutto dalla lezione di Gramsci che Cantoni ha imparato l’essenziale distinzione tra teoria e prassi, tra cultura e politica13. Gramsci aveva in mente un nuovo tipo d’intellettuale o «filosofo democratico» la cui personalità storica fosse caratterizzata dal rapporto attivo tra lui e l’ambiente culturale che voleva modificare, di modo che i rapporti tra intellettuali e popolo non si riducessero a semplici rapporti di ordine burocraticoformale, trasformando così il gruppo degli intellettuali in una casta, in un sacerdozio. Cantoni, anche se iscritto al partito comunista, venne accusato d’irrazionalismo per aver dileggiato la lotta dei compagni francesi contro l’esistenzialismo; venne accusato anche Banfi d’indifferenza ideologica per non aver vigilato abbastanza sia sul suo collaboratore Cantoni, sia sui saggi pubblicati sul periodico di cui era direttore. Queste accuse, avanzate dalla direzione del partito comunista nel settembre 194814, suggerirono a Banfi una lettera destinata a Cantoni, ci dice Montaleone, per indurlo a non fare passi troppo avventati e a non prendere decisioni drastiche nei confronti del partito15. Cantoni dopo aver meditato a lungo la strada da seguire inviò una lettera16 di risposta a Banfi, datata 4 settembre 1949, non per scusarsi e nemmeno per abiurare R. Cantoni, Antonio Gramsci e le responsabilità della cultura, in «Studi Filosofici. Rivista trimestrale di filosofia», cit., pp. 137-164. 14 Montaleone, op. cit., p. 234, nota 33. 15 Ivi, p. 119. 16 Riportata integralmente in Ivi, pp. 163-68. 13 144 il passato o la «qualifica» di comunista, ma per chiarire definitivamente la propria posizione. «Non ho affatto cambiato convincimenti politici, non ho la minima intenzione di nuocere al Partito; desidero, per quanto sta in me, continuare a lavorare in una direzione che ritengo utile al comunismo, né la mia azione sarà “anticomunista” come tu scrivi, per il fatto che non sono più tesserato …»17. Cantoni era pronto ad assumersi tutte le sue responsabilità, nel caso ce ne fossero state. Egli riconosceva al partito il merito della promozione dei condivisibili valori di civiltà e progresso racchiusi nell’ideale comunista, ma si trovava in disaccordo sul fatto che quei valori fossero appannaggio esclusivo del partito, e che al di fuori di esso non fosse creduto possibile alcun contributo alla loro realizzazione. Cantoni aveva avuto il coraggio di ribellarsi al partito, senza temere di essere considerato un «individualista», un «indisciplinato» o, addirittura, un «disertore», come lo considerò invece il suo maestro. Continua nella lettera: «Le mie dimissioni, caro Banfi, non sono un errore, una debolezza, né una “diserzione”, come ti è piaciuto definirle. Disertore è chi passa nel campo nemico o chi si rifiuta di assolvere a un suo dovere. Io non ho fatto né l’una né l’altra cosa. Se si toglie il fatto “cultura”, io sono solidale con l’azione politica e economica del partito comunista»18. È proprio la politica culturale del partito, e non il partito in quanto tale, ad avere un impatto negativo sul pensiero di Cantoni; le armi della cultura, secondo il parere del filosofo milanese, venivano usate in modo ingenuo da funzionari (intellettuali) incapaci di operare senza una costante tutela politica, tanto che gli s’insinuava nell’animo l’idea che il loro lavoro, ogni qualvolta non fosse dedicato a fini immediati e contingenti, politici insomma, non potesse considerarsi serio e utile. Lo spirito critico e il senso storico venivano così imbavagliati e assumevano connotazioni sempre più verbali, polemiche, enfatiche e retoriche; ecco allora che continuava: «Credo … che le creazioni del pensiero, dell’arte e della cultura in genere siano opere di uomini, non certo distaccati dalla storia e dalla società, ma pur sempre esistenti individualmente e personalmente responsabili del loro operato. Vi sono uomini per i quali l’appartenenza a un organismo istituzionale, come il Partito, agisce come stimolo e controllo. Ve ne sono altri, diversamente conformati, che messi a un regime disciplinare, per quanto legittimo, si sentono inaridire e divengono improduttivi»19. Siamo certi che Cantoni s’includesse in quest’ultima tipologia di uomini; insofferente a qualsiasi aut aut rigido e perentorio, prese la decisione in armonia con la propria personalità, la propria individualità, senza dover rendere conto a nessuno che non fosse se stesso. 17 18 19 Ivi, p. 163. Ivi, p. 165. Ivi, p. 163. 145 Cantoni e «Il pensiero critico» Banfi non resse alle accuse avanzate dalla dirigenza del partito comunista e, per evitare di esporsi nuovamente al pericolo di esse, decise di abbandonare la direzione della rivista «Studi Filosofici». La posizione assunta da Cantoni nei confronti della politica culturale comunista fu decisiva nella rottura di quell’autentico equilibrio interno alla redazione del periodico, mai messo in discussione nonostante vedesse la partecipazione di personalità intellettuali tra loro differenti. Banfi chiese20 al redattore capo, amico e allievo da quasi vent’anni, di non far apparire il proprio nome nel numero che stava per uscire; al che Cantoni rispose che la rivista era indissolubilmente legata al nome del suo maestro e che senza di lui non era possibile continuarne la pubblicazione. A conferma di quanto Cantoni credesse nel ruolo sociale e culturale che poteva rivestire una rivista, nell’ottobre 1950 fondò un nuovo trimestrale: «Il pensiero critico». Il periodico riprendeva il titolo della collana che il Nostro dirigeva per l’editore Mondadori, presso il quale dal 1947 era responsabile della sezione filosofica, sociologica e psicologica. Nonostante «Il pensiero critico» fosse caratterizzato da un interesse più spiccato nei confronti della letteratura, in particolare quella contemporanea inglese e americana, possiamo dire che rappresentò la giusta continuazione di «Studi filosofici». Cantoni mantenne come collaboratori alcuni dei colleghi conosciuti durante l’esperienza della rivista banfiana: Enzo Paci, Giulio Preti, Dino Formaggio; molti anche i nuovi tra cui Paolo Rossi, Renato Solmi, Franco Fortini, Fernanda Pivano, Galvano Della Volpe, Carlo Tullio Altan. Mantenne anche quel distintivo approccio trasversale e multidisciplinare alle sollecitazioni culturali, trovando una reale concretizzazione in una proposta editoriale ricca e complessa. Anche il sottotitolo della rivista che riportava come frase «Problemi del nostro tempo» riecheggiava il sottotitolo di «Studi Filosofici» che analogamente recitava «Rivista trimestrale di filosofia contemporanea» o anche «Problemi di vita contemporanea». Quello di Cantoni fu un periodico capace di formare una cultura non esclusivamente filosofica, in grado di allargare i propri orizzonti in un’Italia appena uscita dal secondo conflitto mondiale. «Il pensiero critico» rifuggiva quindi qualsiasi tipologia d’impostazione specialistica tanto che i confini disciplinari, dalla filosofa alla letteratura, dalla sociologia all’estetica, dai temi sociali a quelli antropologici, furono caratterizzati da una certa fluidità e permeabilità. L’identità della rivista si espresse anche attraverso una specifica organizzazione, che rimase invariata fino al 1962, anno della chiusura ma non della definitiva estinzione. Essa, infatti, confluì nella «Rivista di filosofia» (1963) la cui redazione, dopo un breve periodo trascorso a Milano, venne trasferita a Torino sotto la direzione di Norberto Bobbio e Nicola Abbagnano. Al progetto aderirono, come sempre, Giulio Preti, Enzo Paci e Remo Cantoni, anche se 20 Ivi, p. 235, nota 33. 146 quest’ultimo vi pubblicò solo tre saggi. Diventato professore ordinario presso l’università di Milano si dedicò fino al 1978, anno della sua scomparsa, a disegnare un quadro nuovo del contesto culturale e filosofico di un’Italia proiettata sullo scenario degli anni Sessanta e Settanta. Se si rileggono i contenuti dei suoi scritti di quegli anni notiamo che per Cantoni tutta la cultura, nella sua valenza umanistica e scientifica, aveva bisogno di assumere un carattere critico tale da presupporre una distinzione netta tra il razionalismo metafisico (che si risolve nella contemplazione vuota di significati) e l’irrazionalismo. Esisteva, secondo Cantoni, una via intermedia tra questi due indirizzi di pensiero, e la individuò nella ragionevolezza dell’umanismo critico-storico: l’uomo, con tutte le sue contraddizioni storiche, veniva posto al centro della speculazione filosofica mediante la rilettura e il recupero del criticismo e del materialismo storico; non si accontentava della funzione contemplativa della filosofia. Cantoni, attraverso una scelta di vita radicale, ma sempre destinata ad un impegno civile, ci ha dato una lezione di libertà. Egli continua a ricordarci che quando il clima ideologico diventa asfissiante, viene sottratto spazio al rapporto tra cultura e individuo; spazio indispensabile per maturare una responsabilità che sia innanzitutto consapevolezza del proprio compito intellettuale: una consapevolezza che deve mantenersi autonoma, ma mai aliena alle dinamiche della politica dominante. È proprio quell’onestà intellettuale e quel senso della misura che scorgiamo nell’impegno divulgativo di Cantoni; lo sforzo del dialogo con il grande pubblico, direttamente e senza pretese, ci ha offerto un’analisi sobria e acuta dell’epoca in cui viveva: un «esercizio» di filosofia antropologica. 147 Dicembre 1999-dicembre 2009 Nilde Iotti A dieci anni dalla scomparsa Nel corso dell’anno si sono svolte diverse manifestazioni e giornate di studio dedicate all’opera e alla figura di Nilde Iotti nel decennale della sua scomparsa, con la partecipazione di storici, studiosi e personaggi politici che ben conoscevano il suo percorso politico e umano. Presentiamo di seguito una brevissima biografia, curata da Katia Romagnoli su www.anpi.it, per meglio poter comprendere le scelte che segnarono la vita della Iotti. A seguire una bibliografia di base per approfondire la conoscenza della vita e del lungo e tortuoso percorso politico compiuto dalla prima donna Presidente della Camera dei Deputati (a cura di Lella Vinsani). Leonilde (chiamata da tutti Nilde) Iotti, nacque a Reggio Emilia il 10 aprile 1920. Il padre, un deviatore delle Ferrovie dello Stato, attivista nel movimento operaio socialista, perseguitato poi, durante il regime fascista, a causa del suo impegno sindacale, nonostante le disagiate condizioni economiche, nelle quali versava, iscrisse la giovane figlia all’Università cattolica di Milano, perché come spesso ricordò Nilde, citando le sue parole: «È meglio stare con i preti, che con i fascisti». «Per anni indossai il cappotto rovesciato di mio padre», dichiarò la Iotti in alcune interviste, ritornando con la memoria ai tempi della sua giovinezza, della povertà, dei tanti sacrifici compiuti dai genitori, che desideravano che lei studiasse per diventare «qualcuno». Rimasta orfana di padre nel 1934, Nilde riuscì a proseguire gli studi perché la madre, in un periodo in cui le donne, per la legge fascista erano relegate al focolare domestico, iniziò a lavorare. Durante la frequenza della facoltà di Lettere alla Cattolica di Milano, per Nilde iniziò un travaglio ideologico, che la allontanò dalla fede cattolica, ritenuta assolutista ed intollerante. «Al credo, perché assurdo, dissi razionalmente no». Con l’adesione dell’Italia alla seconda guerra mondiale, Nilde, sostenuta dall’esemplare lezione di vita lasciatagli dal padre, s’iscrisse al pci. Dal 1943 si segnalò dapprima come porta-ordini, uno dei ruoli più significativi e pericolosi assunti dalle donne, durante la Resistenza, attraverso il quale i partigiani tessevano la fitta rete di intrecci politici, che portarono l’Italia alla liberazione dall’occupazione nazifascista. Il suo impegno fra i partigiani della città natale, le consentì poco più che ventenne di essere designata responsabile dei Gruppi di difesa della donna, struttura attivissima nella guerra di Liberazione. Il primo di questi organismi fu costituito a Milano nel novembre del 1943 da alcune esponenti di spicco dei partiti che affluirono nel Comitato di liberazione nazionale, dopo la firma dell’armistizio, mentre i tedeschi assediavano le campagne e le città del 148 nord Italia, compiendo efferati rastrellamenti di civili, impegnati nella lotta contro il fascismo. I Gruppi di difesa della donna e di assistenza ai combattenti della Libertà, da Milano, si estesero su tutto il territorio italiano ancora occupato, perseguendo l’obiettivo di mobilitare, attraverso un’organizzazione capillare e clandestina, donne di età e condizioni sociali differenti, per far fronte a tutte le necessità, derivate dalla recrudescenza della guerra. Tali gruppi operativi femminili si segnalarono, durante la Resistenza, attraverso la raccolta d’indumenti, medicinali, alimenti per i partigiani e si adoperarono per portare messaggi, custodire liste di contatti, preparare case-rifugio, trasportare volantini, opuscoli ed anche armi. Come si è detto, Nilde Iotti ricoprì, dal 1943, il ruolo più emblematico, ma anche più rischioso, che molte partigiane dei gdd esercitarono, quello di porta-ordini. Victoria de Grazia, nel suo volume Le donne nel regime fascista, definisce la staffetta come «l’eroina della Resistenza: porta-ordini e persona di fiducia, è il vero jolly della guerra partigiana». Da responsabile del gdd di Reggio Emilia, Nilde si fece interprete di quella coscienza civile e politica, che le donne, dopo secoli di esclusione dalla vita pubblica e dopo vent’anni di dittatura fascista, solo durante il periodo bellico, iniziarono a manifestare. Infatti, gli studi compiuti sulla Resistenza italiana conferiscono ampio risalto al ruolo, non secondario, che i Gruppi di difesa della donna ebbero nel promuovere l’emancipazione femminile. Dopo il Referendum del 2 giugno 1946, grazie al quale per la prima volta le donne italiane esercitarono il diritto di voto e furono così «considerate, dal punto di vista politico, cittadine a pieno titolo», come sottolinea Miriam Mafai, la ventiseienne Nilde Iotti fu mandata in Parlamento. «Robusta, alta, i capelli sciolti sulle spalle, il manifesto desiderio di imparare a fare il deputato», secondo la descrizione del suo portavoce alla Camera Frasca Polara, Nilde conobbe Palmiro Togliatti, capo carismatico del pci, in un ascensore di Montecitorio. Da questo incontro seguì una relazione sentimentale, che seppe resistere a tutti gli attacchi, soprattutto all’interno del Partito, perché Togliatti era già coniugato con un figlio e, all’epoca, aveva 53 anni. Nilde, dapprima come semplice deputato, poi come membro dell’Assemblea costituente, attraverso la sua sensibilità e la sua cultura istituzionale, diede prova di uno spiccato talento politico. Ella stessa definì quella nell’Assemblea costituente, come «la più grande scuola politica, a cui abbia mai avuto occasione di partecipare, anche nel prosieguo della mia vita politica». Nilde entrò a far parte anche della «Commissione dei 75», alla quale fu assegnato il compito di redigere la bozza della Costituzione repubblicana, da sottoporre al voto dell’intera Assemblea. Come si è già ricordato, i 556 componenti dell’Assemblea costituente, in rappresentanza del popolo italiano, si riunirono per la prima volta il 25 giugno 1946 per nominare il Capo provvisorio dello Stato (venne eletto Enrico De Nicola) e per designare i 75 membri rappresentativi di tutta l’Assemblea. Dopo circa sei mesi di attività, la Commissione dei 75 sottopose il proprio progetto costituzionale all’intera Assemblea che, nel corso di quasi tutto il 1947 discusse, integrò, modificò, articolo per articolo la bozza iniziale. Solo il 22 dicembre 1947 venne approvato, a larghissima maggioranza, il testo definitivo della Costituzione che, una volta promulgato dal Capo Provvisorio dello Stato, entrò in vigore il 1° gennaio 1948. 149 Il ruolo svolto nell’ambito della Costituente, a favore dei diritti delle donne e per le famiglie, segnò profondamente l’impegno che Nilde profuse nella sua attività parlamentare, condotta ininterrottamente, per 53 anni, con rigore, costanza e semplicità. Di grande risalto ed attualità si presenta la relazione sulla Famiglia, che Nilde predispose nel 1946, in qualità di membro della «Commissione dei 75». In essa l’onorevole Iotti, auspicando il superamento dello Statuto albertino con una nuova carta costituzionale, che si occupi dei diritti della famiglia, del tutto ignorati dal predetto Statuto, ormai obsoleto, peraltro disapplicato durante i vent’anni di regime fascista, invita l’Assemblea a voler regolare con leggi il diritto familiare. Caposaldo della nuova Costituzione deve essere dunque il rafforzamento della famiglia: «L’Assemblea costituente … deve inserire nella nuova Carta costituzionale l’affermazione del diritto dei singoli, in quanto membri di una famiglia o desiderosi di costruirne una ad una particolare attenzione e tutela da parte dello Stato», scrive Iotti a tal proposito. Altro elemento nevralgico della relazione in esame riguarda la posizione della donna: «Uno dei coniugi poi, la donna, era ed è tuttora legata a condizioni arretrate, che la pongono in stato di inferiorità e fanno sì che la vita familiare sia per essa un peso e non fonte di gioia e aiuto per lo sviluppo della propria persona. Dal momento che alla donna è stata riconosciuta, in campo politico, piena eguaglianza, col diritto di voto attivo e passivo, ne consegue che la donna stessa dovrà essere emancipata dalle condizioni di arretratezza e d’inferiorità in tutti i campi della vita sociale e restituita ad una posizione giuridica tale da non menomare la sua personalità e la sua dignità di cittadina». Se pensiamo che alla vigilia della seconda guerra mondiale il femminismo storico era stato spazzato via, insieme a tutti i partiti politici e a tutte le libertà (di pensiero, di stampa, di organizzazione, ecc…), se consideriamo, inoltre, che la politica sociale di Mussolini prevedeva che «il lavoro costituisce per la donna non una meta, bensì una tappa della sua vita, da risolversi, prima possibile, con il rientro nell’ambiente domestico», la relazione della Iotti, scritta quando le donne italiane si erano appena affacciate sulla scena politica, si propone come tentativo molto coraggioso di svecchiamento e di rinnovamento democratico. Un occhio di riguardo viene posto da tale relazione sull’emancipazione, che può derivare dal lavoro; la nuova Costituzione pertanto dovrà assicurare il diritto al lavoro «senza differenza di sesso». Altro elemento, oggetto di studio, da parte della giovane parlamentare e che rappresenterà, nel corso delle successive legislature, uno degli impegni politici di maggiore rilievo, concerne l’annosa questione dell’indissolubilità del matrimonio. Nilde manifesta la propria contrarietà ad inserire nella Costituzione il principio dell’indissolubilità «considerandolo tema della legislazione civile». Infine, la Relazione focalizza la propria attenzione sulla maternità, non più intesa come «cosa di carattere privato», bensì come «funzione sociale» da tutelare. Uno degli articoli di maggiore impatto innovativo della proposta costituente, riguarda il principio dell’uguaglianza giuridica dei coniugi. Questi ultimi hanno eguali diritti e doveri nei confronti dei figli (per la loro alimentazione, educazione ed istruzione). Ricordiamo che il Codice Penale (c.d. Rocco dal nome del penalista che lo curò), entrato in vigore nel 1942, concepiva le donne come «beni», sui quali il padre prima ed il marito poi, esercitavano assoluta 150 autorità. Forte dell’esperienza maturata nella Costituente, Nilde proseguì la propria missione politica a favore dei diritti delle categorie più disagiate (le donne in primo luogo), sia in Parlamento, sia all’interno del pci, dove ottenne pieno riconoscimento solo dopo la morte di Togliatti. Nel corso di mezzo secolo, vissuto all’interno delle istituzioni repubblicane, Nilde fu promotrice della legge sul diritto di famiglia del 1975, della battaglia sul referendum per il divorzio (1974) e per la legge sull’aborto (1978). Dal 1979 al 1992 ricoprì la carica di Presidente della Camera, segnalandosi per grande capacità di equilibrio, di mediazione e di saggezza. Nel 1993 ottenne la presidenza della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali. Nel 1997 venne eletta vicepresidente del Consiglio d’Europa. Con quello stile fatto di rigore e di eleganza, che tanto colpì Togliatti, al punto da suggerire ai deputati comunisti: «Imparate da Lei!», Nilde si distinse anche con la richiesta di dimissioni dal Parlamento, per motivi di salute (18 novembre 1999). Il 4 dicembre 1999 la «Signora della Repubblica» esce di scena in punta di piedi… Bibliografia (in ordine cronologico): Giannetto Magnanini, Ricordi di un comunista emiliano, Teti, Roma 1979 Guido Gerosa, Le compagne, Rizzoli, Milano 1979 Massimo Caprara, Ritratti in rosso, Rubettino, Catanzaro 1989 Liano Fanti, Nilde Iotti, Camunia, Milano 1991 Gianni Corbi, Nilde, Rizzoli, Milano 1993 Massimo Storchi (a cura di), Nilde Iotti, Comune di Reggio Emilia, 2000 Sergio Barbero, Il Migliore e la Dama Rossa, Spoon River, Torino 2002 Leoncarlo Settimelli, La ragione e il sentimento. Ritratto di Nilde Iotti, Castelvecchi, Roma 2009 Fiorella Imprenti e Claudia Magnanini (a cura di), Nilde Iotti. Presidente. Dalla Cattolica a Montecitorio, prefazione di Giorgio Napolitano, Biblion Edizioni, Milano 2010 A cura della Camera dei Deputati sono stati pubblicati: Iotti, Discorsi parlamentari, 2 voll., Roma 2003 Nilde Iotti. Una donna della Repubblica, Roma 2004 151 Omaggio ai caduti dell’Egeo e alle vittime dell’eccidio di Cefalonia A cura dell’Associazione marinai d’Italia Carlo Pellacani Dal 16 al 23 maggio 2010 la sezione reggiana dell’Associazione marinai d’Italia ha realizzato un viaggio in Grecia cui ha partecipato una trentina di soci e simpatizzanti, giunti anche da altre città italiane e dalla Spagna. L’iniziativa si è articolata in tre momenti specifici: l’omaggio alle 53 vittime reggiane dell’affondamento del piroscafo «Principe di Savoia» avvenuta per iniziativa dell’esercito austriaco l’8 giugno 1916, a quaranta miglia da Otranto al traverso di Punta Linguetta che delimita a ovest il golfo di Valona; visita ai luoghi ove si è consumato l’eccidio della Divisione «Acqui» da parte dell’esercito tedesco nel corso dell’ultimo conflitto mondiale e commemorazione dei reggiani colà deceduti con la deposizione di una corona d’alloro sul monumento che ricorda l’evento; visita all’incrociatore pesante «Gheorghios Averoff», costruito nei cantieri Orlando di Livorno, e al cacciatorpediniere «Velos» il cui equipaggio, ammutinatosi durante una sua missione a Napoli quando i colonnelli presero il potere in Grecia, non ha fatto ritorno in patria ottenendo dall’Italia il riconoscimento dei rifugiati politici. Oltre a questi momenti storico-rievocativi, il viaggio in Grecia ha permesso la visita a monumenti e siti archeologici, propiziata dalla stagione particolarmente favorevole. L’omaggio ai soldati reggiani deceduti per l’affondamento del piroscafo «Principe di Piemonte» nel 1916 corona l’attività di ricerca che ha permesso di identificarne il luogo e l’evento che ne ha determinato la morte. Il lancio di una corona di fiori in mare aperto, negli stessi luoghi ove avvenne il siluramento austriaco, costituisce la prima commemorazione ufficiale dell’evento, resa ancor più solenne dalla recita della preghiera del marinaio e dalla lettura dei nomi dei militari finora identificati. Assieme al presidente dell’Associazione Gianni Casoli, Amos Conti (che ha effettuato le ricerche nell’ambito del progetto «Albi della memoria» di Istoreco) ha finalmente offerto adeguata memoria ai soldati reggiani cui finora era attribuita l’indistinta attribuzione di «caduto nell’Egeo». Si tratta di una ricerca non conclusa, in quanto potrebbero evidenziarsi altri reggiani tra i passeggeri del piroscafo italiano, ma rappresenta comunque un esito a lungo atteso da parte delle famiglie alle quali non era mai stata indicato l’evento che ha causato il decesso. Oltre a questo momento commemorativo, il viaggio prevedeva la visita ai luoghi ove si è consumato, nell’isola di Cefalonia, l’eccidio dei componenti la Divisione «Acqui». È un episodio che presenta tuttora una lettura controversa sotto il profilo storico, ma che ha interessato più di seimila militari italiani trucidati senza pietà per non essersi piegati all’invito a collaborare con le truppe tedesche, divenute nemiche dopo l’armistizio 152 dell’8 settembre 1943. La dettagliata visita ai luoghi interessati, ove sussistono ormai scarse tracce dei fatti di quel periodo, si è conclusa con la commemorazione davanti al monumento che è stato eretto nei pressi di Argostoli e con la citazione dei nomi degli undici reggiani di cui è documentata la morte in quei luoghi nei giorni dell’8 e 9 settembre 1943 (Ludovico Barbieri di Reggio Emilia, Decimo Fontanesi di Reggio Emilia, Sergio Ganassi di Campagnola Emilia, Nando Giovanardi di Campegine, Oliviero Ruozzi di Reggio Emilia) e del 21 e 22 settembre 1943 (Germano Casarini di Correggio, James Casini di Campegine, Rolando Incerti di Bibbiano, Antonio Neri di Rubiera, Enzo Rabitti di Albinea, Bruno Serperi di Castelnovo ne’ Monti). A Cefalonia, com’è noto, si sviluppò anche una pervicace resistenza contro le preponderanti forze tedesche, non meno rilevante anche se infruttuosa per la disparità di forze in campo. Non meno avvincente è stata la visita alle due navi che documentano, alla fonda nel porto del Pireo, la lotta contro la dittatura militare in Grecia negli anni Settanta del secolo scorso, anni non troppo lontani ma che sembrano ormai appartenere ad una fase storica dimenticata. Il gruppo italiano è stato accolto con calorose attestazioni d’amicizia ed ha potuto approfondire aspetti della storia italiana e greca che rivela molte connessioni. Il viaggio in Grecia, splendidamente organizzato dall’Associazione marinai d’Italia, costituisce dunque un’importante occasione per il risarcimento del sacrificio di un nutrito gruppo di reggiani, ai quali spetta l’onore di una memoria imperitura e l’impegno di uno svelamento delle motivazioni del loro sacrificio. 153 Sandro Spreafico I cattolici reggiani dallo Stato totalitario alla democrazia Sandro Chesi Un corpus imponente Con l’uscita in volume autonomo di una «Guida alla consultazione» (con indici vari), Sandro Spreafico ha definitivamente concluso la sua monumentale opera: I cattolici reggiani dallo Stato totalitario alla democrazia. Si tratta di circa seimila pagine di grande formato, articolate in cinque volumi, l’ultimo dei quali snodato in due tomi di uguale consistenza. Un’opera da far tremare «le vene e i polsi», ma che è frutto della caparbia determinazione dell’autore, dote che unita all’intelligenza ci ha dato (oltre ai citati volumi) una ricca serie di studi storici, che raramente è dato di incontrare come frutto di una sola persona. Tra questi è necessario citare i primi due volumi di una trilogia, già usciti da tempo, cioè nel 1979 e nel 1982 La chiesa di Reggio Emilia tra antichi e nuovi regimi. Essi esaminano acutamente ed esaurientemente le vicende della nostra chiesa locale a partire dalla rivoluzione francese, per arrestarsi alla «inutile strage» della prima guerra mondiale. Rimaneva e non è ancora stato dato alle stampe, il terzo volume, che avrebbe dovuto abbracciare la densa storia che ha visto una ancor più drammatica seconda guerra mondiale, il tramonto delle dittature europee del XX secolo e un ruolo inedito dei cattolici. Mi sono chiesto come mai il professor Spreafico abbia imposto a se stesso questa lunga battuta d’arresto: credo però che una spiegazione più che plausibile possa essere data. Posto di fronte a un’enorme quantità di materiali, parte dei quali già noti ed esaminati dagli studiosi, a fianco di altri noti, ma inesplorati, ed altri ancora da ricercare, percorrendo piste sconosciute, è quasi certo che egli abbia pensato a un lavoro propedeutico al volume ultimo della trilogia di cui abbiamo parlato: raccogliere, snidare, con abilità di segugio della storia, tutto ciò che potesse servire per ricostruire un disegno storico il più possibile esauriente di gran parte del secolo che abbiamo da poco lasciato alle spalle. La ricerca è stata largamente fruttuosa e anche generosa, in quanto egli ha raccolto per sé stesso, ma anche messo a disposizione di tutti gli studiosi, un materiale enorme e di varia natura, parte del quale, senza il suo intervento, sarebbe andato molto probabilmente perduto. I cinque volumi presentano anche un altro pregio: sono razionalmente strutturati. Ciascuno ruota attorno a un nucleo tematico che richiama i problemi storiografici 154 connessi; si apre, di solito, con una introduzione (e le varie introduzioni unificate costituirebbero già di per sé una interessante narrazione e una altrettanto coinvolgente analisi storica); segue una ricca sezione iconografica, con interessanti ragionate didascalie, e subito dopo si apre la corposa terza sezione documentaria, dove sono raccolte interviste di protagonisti, fonti archivistiche mai utilizzate, carteggi epistolari, pubblicistica varia, memorie. Ne è uscita, insomma, una interessante antologia, che ha richiesto all’autore circa 25 anni di lavoro: un lunghissimo periodo che da un lato è stato utile per incominciare a lasciare decantare, almeno in parte, periodi turbolenti, pieni di passioni contrastanti, favorendo una analisi storica il più possibile obiettiva e, d’altro lato, grazie alla ricchezza dei materiali e alla ampiezza e profondità delle riflessioni, trasformando «una città di provincia – come scrisse Campanini presentando il primo volume – in un prezioso osservatorio dal quale gettare lo sguardo assai più lontano». I cattolici dal non expedit al ruolo di protagonisti nel XX secolo… In tal modo, anche se non siamo ancora in possesso dell’ultimo saggio della trilogia, dopo aver preso conoscenza dell’humus dei cinque volumi in cui affonderà le sue radici, possiamo veramente considerare questo intero corpus come uno dei contributi più pregevoli per lo studio del ruolo che i cattolici italiani hanno assunto nel XX secolo. Essi, infatti, passarono da uno stato di marginalità nella vita del nostro paese a uno stato di protagonismo, garante della riconquistata libertà e di uno Stato democratico e sociale, pur ancora incompiuto, ma sufficiente per uscire dagli egoismi dello Stato liberale dell’Ottocento. Fu questo passaggio, che vide i cattolici per la prima volta direttamente coinvolti con funzioni di guida della vita pubblica italiana, che suscitò l’interesse degli storici: di qui uscirono importanti saggi di autori di diversa formazione culturale, da Iemolo a Spadolini, da De Rosa a Candeloro, solo per citarne alcuni. Fu un filone storico-culturale che risentì anche del magistero pontificio di altissime figure di pontefici, come furono Leone XIII, Pio XI, Pio XII, in difesa dei valori più alti e della pace in Italia e nel mondo. …nel crogiuolo di una storia, di mille storie contrapposte o in dialogo È in questa scia, in questo terreno che diventa sempre più fertile, che si inserisce la fatica di Spreafico con autorevolezza, in quanto pur dando vita a una storia locale, da studioso completo qual è, mostra l’inevitabile intreccio che esiste tra storia patria e storia nazionale. Nello stesso tempo, però, egli mette in luce una situazione singolare dei cattolici reggiani rispetto a quella dei cattolici di tante altre città. Mentre, infatti, dalla scena stanno uscendo le oligarchie liberali e vi stanno progressivamente irrompendo le masse popolari, egli definisce il volto di un cattolicesimo reggiano minoritario, che 155 deve misurarsi con sottili, astute forze antagoniste. Emerge, però, che lo scontro non lo fiacca, ma lo agguerrisce, lo rende orgoglioso dei propri stendardi e della propria fede, incarnato in figure sia umili, come in tanti membri e piccoli dirigenti di opere cattoliche, sia grandi, come i Cottafavi, i Tesauri, i Cassoli, i Riccò, fino ai Lari, padre e figlio, e alle più giovani generazioni della Resistenza e del dopoguerra. Ma non solo. I cattolici reggiani... dice il titolo di questa grande antologia; ed è sicuramente questa la tesi centrale e unificante dei volumi, ma è una tesi mai priva di una o più antitesi: sono infatti presenti anche tutte le forze che interagiscono col mondo cattolico e addirittura ognuna di esse presenta i propri conflitti o rapporti interni; sono rapporti dialettici tra forze, gruppi, persone ben connotate ora in contrapposizione, ora il dialogo. Ne esce la sintesi di una società non sonnolenta, ma vivace come poche. I nuclei tematici di ciascun volume sono facilmente desumibili dai sottotitoli di ciascun volume. Il primo recita: I giorni e le opere del Fascismo: “terza via” o Leviatano di terracotta?; il secondo: Davide senza fionda: il laicato cattolico dalla opposizione bloccata al collateralismo conflittuale; il terzo: Dal collateralismo conflittuale al riscatto cruento: quale sacerdozio?; il quarto: Battezzati in armi: cristiani nelle tagliole della storia; il quinto: Il difficile esordio: “uomini nuovi” e “uomini vecchi”. Sono titoli accattivanti nella loro ricchezza di analogie, nella loro sapiente costruzione. Ma chi non si ferma ai titoli vede (e ci soffermiamo soltanto su alcuni esempi) che il fascismo da una parte costituisce lo sfondo necessario in cui si muove il cattolicesimo locale, dandoci però nuovi strumenti interpretativi, cogliendo, nel gioco politico interno, il contrapporsi di fascisti della prima ora a una nuova giovane classe di gerarchi emergenti. Nello stesso tempo l’obiettivo inquadra sempre meglio la piccola parte di clero filofascista che pensa a una cattolicizzazione del fascismo dall’interno, mentre il «grosso» di clero e laici, costituiscono le forze obbedienti dell’intransigentismo, in cui confluiscono ex popolari, membri di cooperative bianche, di casse rurali… a cui si opporranno – e ne parleranno altri volumi – alcune voci dissenzienti, tra cui i contestatori della «Plebe». Allo stesso modo testimonianze, fotografie, documenti danno vita alla dialettica tra cattolici intransigenti, che lottano contro lo scippo prampoliniano che tenta di estrapolare dalle pagine del Vangelo un Cristo in veste socialista, protagonista della famosa Predica di Natale di Camillo Prampolini. L’Azione cattolica, quindi, dovrà tentare di arginare la fuga dalla fede, minata prima dal razionalismo liberale e in seguito da un socialismo anticlericale che scivolerà inevitabilmente in gran parte nel massimalismo comunista. Per cui quando si tratterà della Resistenza non verranno focalizzate soltanto le prime incertezze che renderanno inquiete alcune anime cattoliche sull’uso della violenza, ma si cercherà di dare una visione il più possibile completa, esaminando non solo ruolo e tesi dei partigiani cattolici, ma anche quelle dei comunisti inquadrati nelle brigate garibaldine e anche dei repubblichini, con il triste contorno di vendette, di efferate stragi, di delitti, che hanno reso la guerra, già di per sé detestabile, un ripetuto riaffiorare di barbarie; e poco importa che alcuni le abbiano rifiutato e altri attribuito il nome di guerra civile: barbarie rimane e rimarrà, anche se non mancarono, fortunatamente, pagine di 156 sacrifici durissimi, di generosità, di eroismo, di amore veramente eccezionali. Rimarrà pure nitido, nelle pagine di Spreafico il ricordo dei due vescovi, Brettoni e Socche, che tentarono di arginare i terribili guasti cercando di riattizzare il flebile lume della ragione là dove sembravano soverchiare istinti brutali. Davanti ai nostri occhi scorre un’intera galleria di personaggi grandi e piccoli, di ogni estrazione. E man mano che la narrazione e la documentazione proseguono, emerge l’inevitabile giudizio dell’uomo e dello storico Spreafico, che guarda con il maggior distacco possibile, ma anche con la maggiore adesione possibile alla verità storica, al periodo denso di idee e di fatti verso cui confluisce la sua fatica. Alla sete di vendette, ai propositi di coloro che volevano «tenere calda la canna del loro mitra», alla politica dei «pugni chiusi», delle «bocche cucite», delle «epurazionieliminazioni» egli oppone il «riscatto cruento» (emblematico nella fucilazione di don Pasquino Borghi e nell’agguato mortale a don Pessina), le parole di dolore, di amore e perdono di due madri (di un membro del plotone di esecuzione di don Borghi e della madre del sacerdote), le affermazioni di due grandi resistenti cattolici: Marconi e Dossetti. Di fronte a un capo partigiano, che durante la Resistenza accusava di tradimento chi si opponeva ad esecuzioni da lui decretate senza concedere un minimo di difesa, Dossetti, che protestò, in seguito, anche contro pestaggi di democristiani della montagna, rispondeva con le famose parole «Vorrei dare il mio indirizzo ai suoi partigiani, perché a Reggio Emilia, se c’è un traditore da colpire, quel traditore sono io…»; e con altrettanta decisione Marconi affermava: «noi difendiamo i diritti della persona umana, nei fascisti, nei comunisti, nei ladri, negli innocenti…»; e poco più tardi Giorgio Morelli moriva ad Arco di Trento (colpevole perché cercava mandanti e sicari dell’amico Azor) senza parole di condanna per nessuno, ma soltanto chiedendo l’«Imitazione di Cristo». Spreafico non dimentica neppure le assurde proposizioni del razzismo condannate dal vescovo Brettoni, la fucina di idee che divenne la biblioteca capitolare, grazie a monsignor Tondelli, la ricchezza di una letteratura di profonda spiritualità, prima ancora che teologica, che fu per molti cattolici l’alimento principale, quando essi furono chiamati nel secondo dopoguerra a una ricostruzione morale, non meno importante di quella materiale, per risorgere dalle rovine. Come fare storia Spreafico sa fare storia e sa che cosa è storia. Ce lo dimostrano le molte pagine da lui scritte e ce lo ha dimostrato anche una relazione da lui recentemente tenuta nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario della Deputazione di storia patria su «La conoscenza storica come problema». Sa che non si tratta di «ciottoli accatastati» ma di un grande numero di tessere che vanno riscoperte e composte in un grande mosaico che dev’essere il più possibile aderente all’originale, anche se (allontanandosi sempre più da noi questo originale), la personalità dell’artista – in questo caso dello storico – è ineliminabile e il disegno, se 157 lo storico non è sufficientemente distaccato o se è condizionato da un sistema politico o da una cultura dominante, rischia di essere deformato. Il giudizio comunque dello storico non può essere avalutativo, deve «trovare le forze per spremere tutte le sue capacità di verità, deve snidare gli idoli», che la vita colloca lungo le strade; «non semina disperazione, ma speranza». Anche perché lo storico si può caricare di singolari responsabilità: c’è, infatti, nell’opera di ogni storico un risvolto pedagogico. «Con la storia – diceva Spreafico in quella sua lezione sopra citata – posso educare al senso civico, alla rivolta, al terrorismo: la storia non è disciplina innocua fatta da eunuchi … ci carica di responsabilità pesanti, ma anche entusiasmanti». Quale uomo? Non voglio chiudere queste brevi note senza soffermarmi un attimo su un aspetto, piccolo nella grande mole dell’intera opera, ma per me rilevante: che ci riporta a un giudizio pronunciato da un protagonista, che diceva a un suo amatissimo maestro di spiritualità: «Ci avete educato alla vita di preghiera, di carità e ve ne serberemo immensa gratitudine, ma non ci avete educato a capire, in tempo, il Fascismo». Io credo che una educazione all’antifascismo anche solo rivolta a una parte dei giovani e uomini, che affollavano in quei tempi le canoniche e gli oratori, non avrebbe potuto rimanere segreta e sarebbe stata controproducente: avrebbe riprovocato molto probabilmente, e più duramente, la repressione fascista del 1931 e avrebbe risospinti cattolici fuori dalla vita dello Stato, perché mai il fascismo avrebbe accettato una opposizione, anche se non violenta, ma rivolta alla educazione della gioventù, di cui voleva il monopolio. Riprova ne è che le opposizioni al fascismo finirono per essere nuclei sparuti, costretti o all’esilio o alla clandestinità. La cosiddetta «interiorizzazione» invece con l’irrobustimento della vita interiore fatta di meditazioni della Parola, della vita di preghiera e di carità, inattaccabile e sfuggente per il regime, fu a mio parere il fatto più rilevante di una «cultura di opposizione “altra” nel ventennio»: essa, infatti, poteva raggiungere sia antifascisti sia molti aderenti alle organizzazioni fasciste e persino membri della Milizia; soprattutto disegnava un tipo di uomo posto su binari diversi da quelli posati dalla «mistica fascista»: non l’uomo dell’impero o l’uomo della «razza pura» ma l’uomo Cireneo, del servizio o l’uomo Cristo, che dà la propria vita per gli altri, l’uomo che invita alla pace e non alla guerra. Lo si vide (e ce ne possiamo rendere conto oggi, con molta chiarezza, dopo quasi settant’anni) appena incominciata la parabola discendente delle fortune fasciste, ancora perdurando la guerra e subito dopo, quando fu necessario esprimere una nuova classe dirigente. Nei volumi di Spreafico compaiono, infatti, figure, nella Prima repubblica, di protagonisti e di gregari di solida statura morale e spesso di alta statura culturale, manageriale e politica, tanto che viene da chiedersi se l’oggi sa restare a quell’altezza, anche se la risposta diventa difficile per il pericolo sempre presente di essere laudatores temporis acti. 158 Spreafico, comunque, ci ha dato un’opera unica e preziosa. Sono convinto che poche città possono disporre di un contributo analogo. Praticamente, quando sarà uscito anche il terzo volume della trilogia di cui già abbiamo parlato, Reggio potrà disporre di una completa, accurata e penetrante storia contemporanea della Chiesa reggiana. Credo che la nostra provincia, gli studiosi, la diocesi debbano essere felici di avere espresso uno storico che ha dotato la sua città di una simile opera. 159 Recensioni A. RAGAZZI, Dalla vecchia Reggio al mondo nuovo. Economia, società e primo socialismo a Reggio Emilia, a cura di Alberto Ferraboschi e Olga Ragazzi, Diabasis, Reggio Emilia 2010, pp. 184, 18 euro Dalla vecchia Reggio al mondo nuovo. Economia, società e primo socialismo a Reggio Emilia, 1886-1901, è il titolo del volume che Amleto Ragazzi ha dedicato alla sua città, offrendo un validissimo contributo per la conoscenza della medesima e del movimento politico – il socialismo prampoliniano – cui si dedicò per tutta la vita. Ragazzi (1886-1972), era nato da famiglia di condizioni modeste. Giovanissimo pittoredecoratore-stuccatore, aveva sviluppato qualità politiche e amministrative di grande spessore: diverrà ben presto un dirigente socialista ma – nel periodo pre-fascista – anche e soprattutto un promotore di società di mutuo soccorso, un cooperatore e un collaboratore del giornale di Prampolini, «La Giustizia». Noto per essere stato l’artefice, assieme a Manlio Bonaccioli, del cosiddetto almanacco del movimento operaio e socialista, sorvegliato speciale durante il fascismo, Amleto Ragazzi, aderì alla Resistenza e nel dopoguerra fu consigliere comunale oltre che presidente rispettivamente della Colonia «Luigi Roversi», della Croce Verde e del Consorzio cooperativo ferrovie reggiane. Scritto tra gli anni Cinquanta e i Sessanta e poi pubblicato per merito di Istoreco (attraverso Diabasis) a distanza di mezzo secolo, quest’ultimo volume (utilissimo per gli studiosi di storia locale) è rigidamente suddiviso in due parti che recano due titoli esplicativi; la prima è Attività commerciali, industriali, artigiane nella vecchia Reggio e nel suo suburbio, la seconda Dall’alba del socialismo alla Camera del lavoro. Il periodo, per ambedue, lo si evince dal titolo generale dell’opera, va dal 1886 al 1901. Ragazzi mette cioè in rapporto l’esame minuzioso della vecchia città, già in corso di una prima trasformazione (ma alla vigilia di cambiamenti ben più radicali), con un resoconto sullo stato delle organizzazioni proletarie e del nascente partito socialista reggiano, cioè con quegli organismi che realizzeranno in larga misura, il «mutamento». Il volume esce a ottantacinque anni dal precedente scritto a quattro mani con il maestro Bonaccioli ma a differenza dell’altro, quest’ultimo non è, o non esclusivamente, un’opera sui prodromi socialisti a Reggio Emilia; è, invece, soprattutto, un’indagine storica e insieme sociologica, rigorosa ed illuminante sulla Reggio di fine Ottocento, redatta da un testimone d’eccezione. E appunto con questo suo lavoro di testimonianza l’Autore mostra quanto siano lontane le elucubrazioni teoriche astratte dal socialismo prampoliniano. Definito dai suoi detrattori, di destra e di sinistra, «topografico», «miope» e «difensivo», esso fu tuttavia straordinariamente incisivo ed efficace. La teoria per i prampoliniani discendeva dall’analisi oggettiva della società e dall’intento di cambiarla. Essa si basava non già sull’idea di una trasformazione palingenetica cruenta ma su quel «buon senso comune», cioè su una versione popolarizzata del positivismo laico, evoluzionistico e razionalista che a Reggio veniva divulgata dai socialisti in forme e contenuti facilmente comprensibili alle masse. In sostanza Ragazzi presenta un sorprendente affresco della 160 città, colta negli anni cruciali dell’ultimo quarto dell’Ottocento, dal 1886, data del primo sciopero dei muratori ma anche data di nascita del periodico «La Giustizia», al 1901, anno di fondazione della Camera del lavoro. In questo torno di tempo, il disagio sociale se non la miseria conclamata, la facevano ancora da padroni. In effetti la città e la provincia erano caratterizzate da un’arretratezza diffusa: da cittadina ducale, Reggio, si era trovata ad essere all’improvviso capoluogo di provincia, coi problemi gravissimi di un territorio che gli Estensi avevano per alcuni secoli volutamente mantenuto in condizioni di subalternità economica rispetto al Modenese. Anche l’agricoltura, nella seconda metà dell’Ottocento, era molto arretrata. Soltanto i profitti «senza investimenti» premevano ai proprietari reggiani i quali per salvaguardare i propri interessi ritenevano di doversi unicamente preoccupare di garantire l’ordine sociale ed economico esistente. Come ha giustamente notato Alberto Ferraboschi, la carenza di una solida funzione d’avanguardia da parte della borghesia locale produsse nell’ultimo quarto del secolo la nascita di attività economiche alternative e in particolare quel cooperativismo classista di matrice socialista riformista, cui Ragazzi dedica qualche puntuale ed interessante accenno nella seconda parte del libro. Non sono però le annotazioni storico-politiche – che poco aggiungono all’attuale stato degli studi sul movimento operaio reggiano – a caratterizzare questo lavoro, ma le scrupolose descrizioni di Reggio nel periodo considerato, a destare maggiore interesse. Il libro, infatti, è già stato notato, altri non è se non una minuziosa indagine sulla «vecchia città» che, oltre a presentare un’ordinata elencazione di tutti gli esercizi commerciali, le imprese economiche, i luoghi di culto, di ritrovo, i mercati, ecc., è anche la fotografia dei mali sociali che l’affliggevano. Si tratta in sostanza di una litania di dati apparentemente pedissequa e in parte ragionieristica, che tuttavia, lo rileva anche la co-curatrice Olga Ragazzi (nipote dell’Autore): disegnano «con umana partecipazione, un quadro sociale ed economico di Reggio ai limiti della sopravvivenza». È un’indagine cruda e tuttavia ricca di aspetti anche minuti della vita della città che – è ancora Olga Ragazzi a notarlo – «non si risolve però in fredde note statistiche di dati e numeri…» ma affascina il lettore proprio perché rimanda con immediatezza ed un’incredibile quantità di nomi e di toponimi, oggi in gran parte dimenticati, alle peculiarità di un territorio ormai radicalmente trasformato (una curiosità: i titolari del ristorantePizzeria Giardino confermano, ad esempio, la derivazione del loro esercizio dall’antico Caffè del Giardino che, Ragazzi lo ricorda, alla fine dell’Ottocento era l’unico locale pubblico nelle adiacenze di Porta Castello). C’è, più in generale, un richiamo oltre che alla modestia produttiva, alle carenze urbanistico-abitative e conseguentemente socio-sanitarie della «vecchia Reggio», carenze che riflettono limiti annosi essendo la città ancora intralciata dalla sua antica soggezione alla capitale ducale (Modena) ed in cerca di una identità che proprio nell’ultimo quarto di secolo cominciava ad assumere contorni più definiti, grazie a qualche raro esponente illuminato della borghesia (Ulderico Levi) ma soprattutto in virtù dell’intelligente e tenace lavoro organizzativo e politico dei socialisti. Anzi, proprio a partire dall’ultimo quarto dell’Ottocento, la modernizzazione della vita economica e sociale reggiana inizierà a portare il segno inequivocabile del partito di Camillo Prampolini. Lui, i suoi uomini e la loro opera, la condizioneranno 161 al punto che nemmeno il fascismo riuscirà a cancellare tutte le sue realizzazioni e il loro «metodo», il riformismo, influenzerà addirittura le cellule comuniste reggiane la cui tendenza «prampoliniana» – come ha notato Giuseppe Prestipino nell’ultimo numero del «Calendario del Popolo» – influirà e non poco sulla politica nazionale del pci. Notevole peraltro era stato il contributo dei «socialisti reggiani» per la nascita del socialismo nel nostro Paese. Lo ha notato anche Del Bue nel primo volume della sua opera più recente, ricordando che il 22 percento dei delegati al Congresso fondativo del psi di Genova erano reggiani, che nel 1890 su quattro deputati socialisti la metà erano di Reggio, che nel 1913 Vergnanini, forte dell’esperienza maturata in questa provincia venne chiamato a Roma per dirigere la Lega nazionale delle cooperative, che all’inizio del Novecento i socialisti reggiani costruivano la prima ferrovia cooperativa (la Reggio-Ciano), per non dire delle municipalizzazioni e di tutte le altre conquiste politico-amministrative, sindacali, economiche e sociali. Se tutto questo è vero, evidentemente qualcosa di buono, di valido in sé, di originale, c’era. Pertanto, in questa fase di abulia politica della sinistra, in parte legata ancora ad ideologie e partiti del tardo Ottocento, alcuni aspetti del riformismo socialista e segnatamente di quello prampoliniano, di cui Ragazzi è espressione, potrebbero essere forse riconsiderati in questa nuova complessa e per certi versi drammatica fase della globalizzazione. Se tutto questo è vero, lo è, evidentemente qualcosa di buono, di valido in sé, nel cosiddetto «metodo reggiano» c’era. È indubitabile che da allora i tempi sono radicalmente mutati. Tuttavia, alcuni aspetti del riformismo socialista e segnatamente di quello prampoliniano, di cui Ragazzi è espressione, potrebbero essere forse riconsiderati in questa nuova fase della globalizzazione. Rispetto alla crisi del fordismo cioè del posto fisso e a tempo pieno, con le sue rigidità e le sue forme di tutela, la condizione attuale post-industriale ha paradossalmente più punti in comune con l’eterogeneità ottocentesca che con l’omogeneità taylor-fordista, moderna o industriale che dir si voglia. Nella visione «difensiva» prampoliniana, sul sindacalismo conflittuale ha sempre prevalso la tendenza all’autorganizzazione economica, alla solidarietà di gruppo, all’associazione in cooperative che si coordinano e competono nell’ambito dell’economia capitalistica. D’altronde il socialismo di Camillo Prampolini, più che sulla socialdemocrazia tedesca, che pure egli considerava un esempio positivo dal punto di vista dell’organizzazione del partito, si fondava su criteri legalitari, solidaristici, umanitari, localistici e fortemente autogestionari, valori, crediamo, utili ancor oggi per una riflessione sul futuro della nostra società di fronte alle grandi sfide del mondo moderno. Giorgio Boccolari G. NOTARI, Hai un cuore forte, puoi correre, Novecento Editino Consulta librieprogetti, Reggio Emilia 2010-pp.119, 12 euro A. PINOTTI, M. BARLETTAI, I racconti del ribelle, Tipografia San Martino, San Martino in Rio 2010, pp. 145, 10 euro Può accadere che il nostro dialetto d’origine gallo-celtica, dialetto che sta ormai morendo essendo oggi ormai esclusivo patrimonio soltanto delle generazioni anziane, 162 sia più ricco della nostra lingua italiana. Nel dialetto infatti esiste sia il termine muntanar per definire l’abitante della montagna, e cioè l’italiano «montanaro» derivante dal latino muntanus ed esiste anche il termine piandsan per definire l’abitante della pianura. Ma in italiano al dialettale piandsan corrisponde il vocabolo «pianigiano» che però tutti i vocabolari definiscono terminologicamente desueto. Tutto quanto premesso per rilevare che il sottotitolo Autobiografia di un partigiano montanaro che affianca il titolo del libro di Giacomo Notari, Hai un cuore forte, puoi correre dovrebbe corrispondere ad un altrettanto possibile sottotitolo Autobiografia di un partigiano pianigiano da affiancare al titolo del libro di Avio Pinotti e Monica Barlettai I racconti del ribelle. I due saggi autobiografici hanno un sostanziale parallelismo: la prima parte con l’infanzia e gli anni giovanili in famiglia; la seconda parte con lo scoppio della guerra e la partecipazione alla Resistenza; la terza parte con l’impegno politico nel Partito comunista che vedono Notari impegnato nel settore cooperativo e come pubblico amministratore e Pinotti invece dapprima nelle lotte sindacali nelle campagne, sia dei nostri mezzadri sia in Puglia e in Abruzzo e successivamente negli impegni di lavoro, anche come imprenditore in proprio. Notari nasce in una piccola borgata della montagna reggiana in un contesto tradizionale ove la Parrocchia è il solo centro sociale e in particolare nasce e vive in una famiglia di coltivatori diretti proprietari di non molte biolche tra terreno coltivo e bosco. Il lavoro dei campi non occupa totalmente il padre che si ingegna anche come muratore. Pinotti nasce nella campagna fertile di San Martino in Rio in pianura e in una grande famiglia di mezzadri; poi il padre si divide dai fratelli per condurre in proprio, ma sempre come mezzadro, un podere nella campagne di Correggio. Sotto il profilo dell’entità del reddito famigliare quello di una famiglia mezzadrile di un podere di pianura era superiore a quello di un modesto proprietario coltivatore diretto di montagna; sul mezzadro però gravava il proprietario-padrone con il suo 50 percento a cui si aggiungevano le regalie, altre prestazione a favore della famiglia del proprietario e soprattutto la totale gestione della vendite dei prodotti agricoli che il proprietario si arrogava. Il plurisecolare contratto di mezzadria alla metà del secolo scorso era ormai alla fine; era stato temperato dal Lodo De Gasperi e poi dal Lodo Moro che limitarono dal 50 percento al 42 percento la parte dei proprietari che con difficoltà accettarono queste riforme. Ed ecco che in questo contesto sociale matura la prima «ribellione» del giovane Pinotti ed anche l’incomprensione nei confronti di suo padre che lo accettava e che accettava anche il regime fascista, pur non essendolo, come accettava le regole e le pratiche religiose della Chiesa che il «ribelle» Pinotti accomunava al regime fascista. Pinotti, più anziano di tre anni nei confronti di Notari, viene arruolato di leva nel Regio esercito un mese prima della data dell’armistizio dell’8 settembre 1943. Contravvenendo al comandante fascista del suo battaglione con altri soldati reggiani lo abbandona e rientra fortunosamente a casa. Gustoso è il fatto dello scambio dei suoi vestiti militari con uno «spaventapasseri» da cui prende i poveri e stracciati vestiti. Nel marzo del 1944 risponde alla chiamata alle armi della rsi, ma poco dopo diserta e con altri compagni si porta al ponte di San Pellegrino sul Crostolo per raggiungere in mon- 163 tagna i partigiani garibaldini cui si aggrega con il nome di battaglia Athos, frutto di una giovanile lettura dei Tre Moschettieri. Partecipa al non riuscito attacco del 24 maggio al presidio gnr di Villa Minozzo ed al successivo riuscito blocco dei Granatieri della rsi al Ponte della Governara. Con lo sbandamento delle formazioni partigiane a seguito della massiccia rappresaglia tedesca dei primi di agosto rientra nella sua pianura, ivi svolgendo una rischiosa e intensa attività partigiana, diventando anche comandante di una brigata. Intenso e commosso è il ricordo di due amici partigiani: uno morto e l’altro amputato di una gamba perché colpiti da «fuoco amico»: c’era infatti tra i partigiani un’insufficiente preparazione all’uso delle armi. Da rimarcare è l’incarico affidato a Pinotti di interrogare, e se del caso giustiziare, don Bonibaldoni, parroco di Quara, in quanto «sospettato di collaborazione con i fascisti». Si trattava, nel caso, di un incarico basato su di un grave pressappochismo di informazioni in quanto don Bonibaldoni era un antifascista, aveva salvato una famiglia di ebrei milanesi si da meritarsi in futuro di essere riconosciuto dallo Stato di Israele come «Giusto tra le genti». La chiamata in causa sul problema del comandante Walter si concluse, a lieto fine, con un abbraccio tra due «cavriaghini doc» come erano don Bonibaldoni e Walter. Quanto a Notari si trovò negli anni 1944-45, a diciotto anni, a dover decidere da che parte stare: e sceglierà quella giusta, ma con le modalità più rischiose: si arruola con un amico come milite della rsi al fine di indurre gli altri arruolati alla diserzione e a passare con i partigiani: diventando però il compito sempre più rischioso, una volta trasferito da Scandiano a Como, diserterà e con un fortunoso viaggio ritornerà nei suoi monti per combattere con i partigiani garibaldini assieme al fratello maggiore Giuseppe che, purtroppo, cadrà in combattimento. Conclusa la loro partecipazione alla Resistenza, è naturale e conseguente che sia Notari che Pinotti continuino il loro impegno sociale e politico, e ciascuno nell’ambito della realtà sociale e politica in cui sono maturati. Ed ecco Pinotti guidare le lotte dei mezzadri contro un padronato che non accetta i nuovi tempi politici e che rifiuta l’applicazione delle riforme introdotte dai nuovi tempi al contratto di mezzadria: sono lotte accese e violente che porteranno a scontri con le forze di polizia ed anche a vicende giudiziarie in sede penale. E poi l’impegno organizzativo nel pci, anche con presenze in regioni del meridione dove le «organizzazioni dei lavoratori languono». Notari invece rimane nella sua montagna sia organizzando il pci con le difficoltà ivi derivanti da un consistente elettorato a favore della dc sia impegnandosi come dipendente della Federazione delle cooperative, ma prevalente e rilevante sarà il suo impegno come pubblico amministratore sia come assessore della Giunta provinciale con lo speciale incarico di seguire la zona montana. E poi nel 1970 conquista alla sinistra il Comune di Ligonchio, già alla dc sin dal 1946, e ne sarà confermato Sindaco sino al 1983. Se gli impegni pubblici assorbono completamente le giornate di Notari, Pinotti invece nel 1954 è dipendente molto attivo della scia (Società commercio industria agricola), un’azienda consistente fondata con capitali che venivano dai prestiti dei contadini comunisti. La scia tra contrasti e discussioni, che vedono Pinotti tra i contrari, si «privatizza» nella g&g di Gibertoni e Giovanardi, iscritti sì al pci, ma imprenditori in proprio. Rimarrà nella nuova società con funzioni innovative nella pubblicità dell’azienda 164 e nel marketing con i paesi dell’Est europeo, ma nel 1960 diventerà imprenditore in proprio. Ma pur fra tanti impegni la giovanile partecipazione alla Resistenza terrà sia Notari che Pinotti sempre iscritti all’anpi. Notari ne diventerà nel 2002, per scelta unanime, Presidente provinciale della importante sede di Reggio Emilia, carica che ricopre con immutato consenso ancor oggi. Pinotti, che confessa che l’anpi è la sua seconda famiglia, è presidente della sezione comunale di Correggio che apre come iscritti anche ai giovani, rendendola per iniziative la più attiva della provincia. Nell’ambito di questo suo appassionato ruolo si scontrerà duramente con Otello Montanari, allorché nel 1990 questi lancerà una vera e propria campagna all’insegna dello slogan «Chi sa, parli!», slogan di successo e che ebbe notorietà nazionale. Il contrasto finirà nelle aule dei tribunali in sede penale, ma Pinotti ne uscirà giustamente assolto perché la Costituzione protegge il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Sia però consentito a questo recensore manifestare il proprio consenso alla sostanza dell’iniziativa di Montanari, più che alla forma e alle modalità dallo stesso utilizzate. Non si può negare che all’indomani del 25 Aprile 1945, e non solo a Reggio Emilia, si verificò un eccesso di giustizialismo nei confronti di persone più o meno coinvolte con il passato regime fascista e ci furono anche veri e propri delitti politici che continuarono sino a tutto l’agosto 1946. Fu grave, e lo è tuttora, la vera e propria damnatio memoriae di tenere segreti i loro luoghi di sepoltura sì da indurre una nobile figura di resistente, quale è stato Osvaldo Salvarani, a dare precise disposizioni, purtroppo rimaste inascoltate, ai comandi locali della polizia partigiane di consentire ai famigliari il recupero delle salme dei giustiziati. Se Osvaldo Salvarani fosse stato ascoltato a suo tempo non ci sarebbe stato bisogno dello slogan di Otello Montanari. Mi piace richiamare e condividere quanto scritto in proposito dallo storico Giorgio Vecchio nel commento alla recente ripubblicazione della «Nuova Penna»: «La storia della Resistenza è ancora ben lungi dall’essere scritta in modo definitivo e convincente. Applicarsi a questo tipo di ricerca con grande libertà di spirito e ampi orizzonti nella ricerca di fonti e testimonianze significa oggi compiere non solo un’attività scientificamente necessaria, ma anche un’operazione di evidente rilievo culturale e civile, convinti che quella stagione, pur tra errori, complicità e deformazioni di ogni genere, abbia comunque rappresentato uno dei momenti più alti della nostra storia nazionale. E convinti che mettere in evidenza «il male» della Resistenza sia il modo migliore per farne risaltare «il bene di fronte ad ogni interessata demolizione». In conclusione c’è un’assonanza finale degna di nota nei due libri di ricordi di Notari e Pinotti: la loro bella storia d’amore coniugale, e successivamente anche famigliare, tuttora felicemente in atto: tranquilla e pacifica sin dall’inizio quella di Notari con Elsa di Ligonchio mentre più contrastata dalle rispettive famiglie, ma comunque a lieto fine, quella di Pinotti con Marina di Correggio da lui rinominata in Lilia. Entrambi i volumi sono arricchiti da un completo corredo fotografico, ed anche documentale-politico per il lavoro di Pinotti. È soprattutto emotivamente coinvolgente quello delle vecchie, ed al tempo rare e costose, foto di famiglia e di guerra. Danilo Morini 165 G. BERTANI, M. CARRATTIERI (a cura di), Voltare pagina: il giornalismo reggiano dopo la Liberazione (1945-1951). In ricordo di Giorgio Morelli «Il Solitario», rs-Libri, Reggio Emilia 2010, pp. 132, 10 euro Il convegno Voltare pagina: il giornalismo reggiano dopo la Liberazione (19451951), organizzato da Istoreco, anpi e alpi-apc, svoltosi nella nostra città due anni fa e dedicato alla figura di Giorgio Morelli Il solitario diviene, con la pubblicazione degli atti a cura di Glauco Bertani e Mirco Carrattieri, opera di consultazione preziosa non solo per gli addetti ai lavori ma per tutti coloro che vorranno approfondire un tema scarsamente indagato ma non per questo meno degno di attenzione. Nel momento in cui l’Italia riacquista la propria libertà e si appresta a costruire il proprio cammino verso la democrazia repubblicana si registrano sanguinosi episodi, regolamenti di conti, vendette personali che nulla hanno a che fare con la Resistenza. Una delle vittime di questo oscuro periodo è Giorgio Morelli Il Solitario giovane partigiano e giornalista cattolico che con grande coraggio ed impegno civile partecipa all’esperienza dei «Fogli Tricolore» all’indomani della vicenda armistiziale e poi è animatore instancabile della «Nuova Penna». Se sulla vicenda umana di Mario Simonazzi Azor lo storico Massimo Storchi si è impegnato in una ricerca approfondita e coinvolgente altrettanto non possiamo dire del Solitario. A questo proposito appaiono condivisibili le parole di Mirco Carrattieri: «L’auspicio è che la vicenda di Giorgio Morelli possa essere un tassello di una “piccola grande storia” quella del nostro territorio e della sua identità, che Istoreco intende condurre al di fuori dei settarismi e al di là del provincialismo». La limpidezza morale e civile del giornalista ragazzino Giorgio Morelli non oscura ma anzi illumina vieppiù il pluralismo delle esperienze, il più delle volte improntate a vivace volontarismo, giornalistiche maturate nella nostra città e provincia nell’immediato dopoguerra. Glauco Bertani illustra in modo mirabile il vissuto della stampa partigiana dal «Garibaldino» al «Partigiano» passando in rassegna con particolare cura «Il Volontario della Libertà» ed il progressivo modificarsi del contesto politico sempre più influenzato dal clima della guerra fredda e della sempre più aspra contrapposizione ideologica. Michele Bellelli ripercorre la storia di «Reggio Democratica» organo del cln locale, la sua impostazione, un’analisi dei redattori delle rubriche ed il rapporto con i propri lettori. La completezza e la ricerca di una sintesi di una esperienza così spontanea, generosa e multiforme trovano nei significativi contributi relativi ai diversi filoni ed orientamenti ideali e politici: Roberto Scardova per la stampa comunista, Mauro Del Bue per quella socialista, Marzia Maccaferri per la parte cattolica ed Ercole Camurani per la stampa liberale, repubblicana ed azionista. Last but not least Massimo Storchi disegna, da par suo, il panorama del movimento fascista reggiano uscito dal primo dopoguerra, le sue evoluzioni con particolare riguardo alla questione giovanile. Mario Monducci 166 G. BERTANI (a cura di), Fabbrico, un paese cooperativo. Storia e memoria della cooperativa di consumo 1885/2009, Ricerca di Lorenzo Reggiani e Mauro Poletti. Edizioni Diabasis, Reggio Emilia 2009, pp. 126, 13 euro Questo libro è un saggio di storia locale che mostra il complesso intreccio dei rapporti tra cooperative, sindacati, partiti politici e autorità pubblica dalla fine dell’Ottocento a oggi. La prima parte consiste di un’introduzione che delinea la storia politica italiana dall’Unità fino alla Grande Guerra e di un capitolo che riporta le alterne vicende della cooperativa di consumo di Fabbrico e più tardi della cooperativa provinciale (CoopReggio), interprovinciale (Coop Nordemilia) e infine interregionale (Coop Consumatori Nordest). Viene ripercorsa l’intera storia della cooperativa di consumo di Fabbrico e la sua evoluzione dalla sua creazione a oggi, prima in un chiuso ambiente provinciale che man mano si apre all’esterno; tutta questa prima parte è corredata da un ricco apparato di note, che, oltre alla bibliografia, contiene numerose citazioni documentarie. Nello specifico, sono sottolineati alcuni elementi di particolare interesse: innanzitutto sono descritte in dettaglio le origini della cooperazione, i violenti contrasti con l’autorità pubblica, i ripetuti tentativi di far cessare l’attività dell’azienda, la stessa nascita della cooperativa come società di resistenza contadina. In secondo luogo, si riferisce dello sviluppo cooperativo sotto i governi Giolitti all’inizio del Novecento, e la sfortunata vicenda del Magazzino consortile (o Consorzio) che intendeva riunire sotto il centro acquisti delle cooperative di consumo l’intero movimento cooperativo provinciale. Inoltre, l’autore cerca di ricostruire l’andamento della cooperativa e in generale del movimento durante il regime fascista, arrivando alle seguenti e un po’ paradossali conclusioni: se da un lato il fascismo controllava direttamente i consorzi e le organizzazioni centrali cooperative, molti socialisti continuavano a operare all’interno dei singoli spacci, che, essendo gestiti liberamente, continuavano a svolgere la loro funzione di centri sociali delle frazioni. Infine, vengono messi in evidenza i cambiamenti strutturali nella cooperazione del secondo dopoguerra: dal banconiere a percentuale al dipendente a stipendio fisso, dai piccoli spacci sparpagliati ai grandi supermercati, dalle cooperative suddivise nelle frazioni alla grande cooperativa interregionale. Notevole è anche il paragrafo finale del capitolo, dedicato al Teatro Pedrazzoli e all’influsso della cooperativa di Fabbrico sulla cultura del paese, che grazie al teatro, costruito nel 1954 con fondi e forza lavoro della cooperativa, ha potuto avere ospiti come Dario Fo e Cesare Zavattini. Segue una seconda parte che contiene numerose testimonianze sotto forma di interviste, realizzate da Lorenzo Reggiani a testimoni di varia estrazione: da soci fedeli, a personalità politiche passate e presenti, fino a figure dirigenziali come il Presidente di Coop nordemilia Renzo Testi. Si tratta di rielaborazioni di interviste sostenute in periodi diversi e che rappresentano opinioni diverse all’interno della comunità locale. Di particolare rilevanza sono le annotazioni dei vari testimoni sui valori cooperativi, sui prodotti a marchio Coop, sui cambiamenti di gestione e sulle politiche cooperative come l’introduzione del prestito sociale. Queste annotazioni ci aiutano a capire sia come questi provvedimenti venivano decisi dall’amministrazione, sia come venivano recepiti dalla base sociale. Le annotazioni di maggiore rilevanza riguardano proprio il 167 progetto di fusione nella cooperativa provinciale CoopReggio: se da un lato il dirigente Renzo Testi la definisce «Una decisione drastica ma del tutto necessaria per restare competitivi», dall’altro il negoziante di uno degli spacci di Fabbrico ricorda i contrasti con i soci che non volevano rinunciare al negozio sotto casa che veniva chiuso perché in perdita da anni. Infine, l’ultima parte contiene una serie di fotografie che aiutano a contestualizzare la realtà in cui le vicende avvenivano. Ci sono anche le foto, particolarmente curate, di preziosi documenti dell’inizio del secolo, tra cui lo statuto iniziale, la relazione dell’Esposizione di Milano del 1906, gli elenchi dei soci del 1936. Le fotografie sono per la maggior parte relative a momenti di celebrazione (un carnevale negli anni Sessanta, il centenario della cooperativa nel 1985, la visita di una scolaresca), con l’eccezione di alcune foto d’epoca della vecchia sede della cooperativa, una delle quali compare anche sulla copertina del libro. In conclusione, il libro narra la storia del successo di un’azienda, che da umili origini in un piccolo paese della Bassa reggiana è diventata una grande azienda a livello nazionale, ma ha conservato e ha saputo trasmettere i valori propri del movimento cooperativo. Questa storia viene raccontata nella prima parte da un punto di vista prettamente storico, con note e bibliografia; nella seconda parte attraverso le testimonianze di persone che hanno vissuto la realtà storica dagli anni Sessanta in avanti; infine, attraverso le immagini dei documenti e delle attività della cooperativa nel paese. Corrado Secchi R. GUARNIERI, Le radici e le ali. La cgil nella scuola, nell’università e nella ricerca dal 1944 al 2010, Edizioni Conoscenza, Roma 2010, pp. 436, 25 euro Si legge con grande emozione, per chi è interessato alle vicende della scuola italiana e alle sue relazioni con la cultura e la politica di un Paese come il nostro che deve attendere gli anni Sessanta per un significativo innalzamento del livello medio di istruzione e un forte sviluppo della scolarizzazione, il lavoro curato da Romeo Guarnieri. Si tratta della prima organica ricostruzione delle vicende che hanno portato alla nascita e al rafforzamento della cgil-scuola, oggi approdata ad una denominazione che personalmente continuo a ritenere un po’ burocratica e infelice di Federazione lavoratori della conoscenza (flc). La prima storia di un tentativo coraggioso, e senza dubbio riuscito, di dar vita ad un sindacalismo confederale dei lavoratori della scuola, attraverso il superamento delle prevalenti esperienze autonome o corporative, eredità scomoda e complessa degli anni Cinquanta. La posta in gioco si è rivelata sin dai primi passi della cgil-scuola, non a caso situati nelle tumultuose vicende del ‘68 italiano, ben più alta di una semplice questione di organizzazione sindacale. Basi pensare agli esiti del primo Congresso costitutivo del sns-cgil (17-20 dicembre 1970), con la scelta strategica di una contrattazione, basata su una visione della scuola libera dai vincoli dell’autoritarismo fino allora prevalente. Nonostante le disillusioni che oggi ci segnano, con gli interrogativi profondi sullo stesso futuro della formazione in Italia, non si può non ricordare lo slancio che si av- 168 vertiva anche nelle parole, magari ingenue, che venivano utilizzate. Infatti, come ricorda giustamente Guarnieri, «il principio ispiratore del rapporto di lavoro diviene la volontà di realizzare una scuola quale comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile (Art. 1 del decreto delegato 416)». Il lavoro nella scuola, in linea del resto con il dettato costituzionale, come qualcosa di ben più importante di una mera trasmissione di antichi saperi, ma come impresa educativa sempre sottoposta alla verifica di solide relazioni con il mondo che alla scuola guarda e che dalla scuola tanto pretende. Ecco perché la cgil: i lavoratori della scuola con i lavoratori delle altre categorie, che dovevano per primi esser coinvolti in una visione riformatrice di ampio respiro. Quegli stessi lavoratori, magari combattivi e decisi nelle aziende per difendere i propri diritti, ma supini e piegati davanti ai cancelli della scuola di fronte al «latinorum» del primo burocrate di turno. A quel primo Congresso seguirono le epiche battaglie sul territorio, la vicenda delle 150 ore, primo importante tentativo di inserire la scuola nella contrattazione delle categorie industriali, i «decreti delegati», grande cornice riformatrice discussa e discutibile, con cui ancora oggi comunque facciamo i conti. Ma anche momenti più difficili, di ripiegamento, di rincorsa dei fenomeni contingenti, del precariato che diviene la grande spia di un disagio profondo. Impossibile qui soffermarci sull’insieme di questa storia. Scopo di questa breve nota solo quello di invitare alla lettura di un lavoro assai utile, anche perché ha potuto contare sulla consultazione di importanti materiali di archivio, in buona parte facenti capo alla Camera del lavoro di Reggio Emilia. Infine due piccole sottolineature. La prima riguarda un interrogativo con cui chi lavora nella scuola è abituato a confrontarsi. La presenza sindacale di tipo confederale riesce ancora oggi a svolgere un ruolo di primo piano, sulla base di una visione «alta» della scuola? Di fronte cioè agli antichi e ai nuovi problemi di un sistema scolastico, che rischia un pauroso abbassamento di qualità oltre alla riproduzione di amplissime disuguaglianze, avrà il sindacalismo confederale la forza di ripensare se stesso e di reagire, con convinzione ed efficacia, alla critica velenosa e in gran parte infondata di essere uno dei fattori della crisi di credibilità della scuola? La seconda, infine, riguarda un invito a ricordare quanto questa storia sia legata alla nostra città, che ha dato un contributo davvero notevole in termini di idee, di iniziative, di persone, di dirigenti nazionali, alla battaglia per un sindacalismo scolastico confederale dal profilo autenticamente riformatore. Lorenzo Capitani A. GIUSTARDI, Disegnava aerei. 19 novembre 1942-28 luglio 1943, Edizioni Teorema, Reggio Emilia 2010, s.i.p. Otto mesi nella vita un ragazzo di sedici anni, Osvaldo Notari, otto mesi di lavoro nella grande fabbrica delle Officine «Reggiane». Un sogno, disegnare aerei, che diventa realtà, una realtà che può significare un’intera vita, non solo per Osvaldo ma per tutta 169 una famiglia che vede in quel ragazzo anche la speranza di un futuro migliore. Otto mesi che finiscono un mattino di fine luglio 1943, davanti ai cancelli chiusi della fabbrica i colpi di pistola e le raffiche di mitraglia fermano per sempre Osvaldo, sedici anni, e altre otto vite. Caduto il fascismo che aveva voluto la guerra, si voleva solo festeggiare la pace che sembrava prossima. Ma la guerra doveva continuare, oltre quelle vite fermate davanti a un cancello chiuso. Il sangue che correva sull’asfalto e il temporale a lavare, a cancellare l’accaduto. Osvaldo non ebbe neppure un funerale, non fu neppure concesso ai suoi di incontrare altri padri, altre madri di quelle vittime per scambiare e vivere insieme quel dolore comune. Un assassinio di stato, compiuto quasi in segreto. Poi la storia sarebbe andata avanti e in quella guerra tanti altri come Osvaldo sarebbero stati uccisi. Quella stessa fabbrica, che doveva essere il futuro per tanti ragazzi, sarebbe finita sotto le bombe. Osvaldo rimase un nome, ricordato una volta l’anno d’estate, una lapide su un muro. Annamaria Giustardi riprende quella storia, quella vita di un ragazzo di sedici anni e la ricostruisce con l’affetto e la dolcezza che le viene non solo dal personale coinvolgimento in quella storia ma con la capacità di racconto che ha già dimostrato in altre occasioni (Bambino d’inverno, Marsilio, 2003). Si unisce il recupero di materiali d’archivio sulla vita, costretta e sorvegliata, in una grande fabbrica militarizzata, con la quotidianità della Reggio di quei mesi di guerra, di una famiglia fra le tante impegnata nella quotidiana lotta per la sopravvivenza. Troppo spesso la ricostruzione storiografica si deve arrestare sulla soglia delle singole esperienze, Disegnava aerei riesce felicemente a superare questo limite, la narrazione diventa il racconto fatto dallo stesso Osvaldo, nella sua fragilità, nei suoi entusiasmi, nelle sue paure che riflettono i mesi difficili di una guerra ormai persa, di una realtà attorno che diventa sempre più complessa. La caduta del fascismo accelera e moltiplica le difficoltà, ci si agita, si fanno manifestazioni, ma un ragazzo di sedici anni che voleva solo disegnare aerei come può immaginare che la storia passerà proprio dalla sua fabbrica, che passerà su tanti come lui, uccisi in quella mattina di luglio? La notizia dell’eccidio si fece strada presto in città, la ricerca affannosa del padre, l’arrivo all’ospedale. Osvaldo era già in una cassa di legno, da poco prezzo. Il segno del colpo che l’aveva ucciso era chiaro, definitivo. Il dolore che dovette rimanere in silenzio, il prezzo pagato dalla famiglia per uno strazio che non poteva essere urlato. Ogni morte ha anche un «dopo» e Annamaria Giustardi lo ricostruisce con delicatezza ma anche con il desiderio legittimo di restituire giustizia a quel dolore che rimase silenzioso a segnare nel profondo le vite di chi rimase. Alla fine del racconto Osvaldo non è più solo il ragazzo che disegnava aerei ma ha recuperato tutta la sua complessità di persona, dal ruolo di vittima torna a quello di protagonista della vicenda non solo sua personale ma di quella di tante persone. Disegnava aerei interpella con discrezione ma con fermezza anche la nostra attenzione alla vicenda storica, riportando l’obiettivo sull’umanità ferita, sulla dissipazione del genere umano che ogni guerra, ogni atto di violenza, rappresenta. Ci sollecita ad una riflessione sui ritardi e le pigrizie della ricerca su tanti aspetti della nostra vicenda storica, quella delle «Reggiane» fra le tante, dove troppo spesso l’accettazione di una visione mitologica dei fatti, pur in parte giustificata da contesti e scenari ormai 170 trascorsi, ha ridotto il nostro punto di vista a quello di freddi e parziali osservatori, distogliendo lo sguardo dalla umanità delle singole persone, ridotte a semplici nomi su una lapide sempre più corrosa dal tempo. Massimo Storchi A. CASOLI, Contavamo i cavalli bianchi, Bastogi Editrice, Foggia 2010, pp. 268, 22 euro Antonio Casoli ha l’età di chi era bambino durante la seconda guerra mondiale. Adolescenza e maturità vissute in quella parte di Reggio comunemente designata con le espressioni «fuori porta Castello» o «San Pellegrino», magari con ulteriori specificazioni: la «Rotonda», la «Montata», la «Rosta», e simili. A questi luoghi e al suo tempo egli ha dedicato un’accurata operazione di recupero della memoria, di cui è risultato questo volume, a proposito del quale le ormai impronunciabili parole «territorio» e «gente» possono tornare in uso con una certa pertinenza di significati. Bussando a molte porte e ottenendo significativi contributi (ricordi personali e familiari, fonti iconografiche, interviste e collaborazioni direttamente ospitate) Casoli ha proceduto all’identificazione (fisica e antropologica) di un territorio di prima e seconda periferia e della comunità che lo ha popolato, dalla fine della guerra alla ricostruzione, agli anni del boom e dei mutamenti nella vita materiale (le opere e gli svaghi) sino all’avvento delle seconde e terze generazioni, incapaci di leggere sotto l’attuale dimensione urbanistica la stratigrafia di un passato tanto diverso, eppure non tanto lontano. La mappa morfologica e storica del territorio è accurata. Innanzi tutto le acque visibili (il Crostolo) e quelle sottratte alla vista (il canale di Secchia). Poi l’asse viario principale (da viale Umberto I alla Baragalla sino a Rivalta) con le sue diramazioni a est e ovest. Tracce del passato ducale, percorsi obbligati nei viaggi da e per la montagna. Ed è quello che resta, mentre l’intensa edificazione ha cancellato ogni traccia di una realtà agricola insospettabile per chi è venuto dopo: poderi, famiglie padronali e mezzadrili (di cui è data rassegna in un’accurata appendice) a cinque minuti di cammino dal ring reggiano e da una delle porte d’accesso al centro storico. E non attività residuali, ma quelle che danno maggiore sostanza alla tradizione agricola della provincia: la stalla, la vigna (non a caso, in stretta prossimità, trovavano posto la produzione del vino e la stagionatura del formaggio). Di pari interesse è il rilievo della fitta rete di imprese piccole o micro che, per la loro stessa natura (servizi alla persona, commercio, produzione di liquori e confetture), incontravano un’utenza di prossimità anche minuta, famigliare, e venivano perciò a costituire luoghi di incontro e di cemento comunitario. E senza dubbio la consistenza di questa comunità, capace di guardare avanti negli anni del riscatto dopo il fascismo e la guerra, spiega il successo di una grossa addizione come il quartiere Giardino (1955), con la rapida assimilazione della sua varia e abbastanza «interclassista» popolazione, fra i «vecchi» della zona. Col Giardino – un esempio delle potenzialità realizzatrici di una Repubblica agli albori nel campo dell’edilizia popolare, purtroppo non attuate poi in proporzione all’aumento della ricchezza complessiva – negli stessi anni veniva ad investire e valorizzare il quartiere un altro impegnativo intervento pubblico: il nuovo ospedale, inizialmente sorto 171 per la munificenza di Alfredo e Durante Gallinari e per qualche anno rimasto allo stato di struttura incompiuta. Mai stata sacca periferica isolata, la zona venne così a trovarsi fra le più note e «visitate» della provincia. Va precisato che, pur nella sua accuratezza documentaria, il libro non è uno studio professorale. La sua ricca aneddotica ne fa una lettura attraente, specialmente grazie alla icastica evocazione di tante figure e famiglie per molti versi degne di memoria. A questo pregio si aggiunge un occhio particolarmente esercitato nel riconoscimento e nella descrizione dei molti aspetti della cultura materiale, particolarmente rilevanti per fissare i caratteri di un’epoca di transizione dai vecchi ai nuovi mestieri. (eb) M. DEL BUE, Storia del socialismo reggiano. I Dalle origini alla Prima Guerra Mondiale, Graphic & Graphic, Montecchio (RE) 2009, pp. 597, 25 euro È un periodo fecondo per la storia del socialismo reggiano: i prodotti del Comitato nazionale per la valorizzazione della figura di Camillo Prampolini; i lavori di Giorgio Boccolari e Nando Odescalchi; ora questo bel volume di Del Bue. Il 150° della nascita di Prampolini, ma anche la forte rivalutazione storica del riformismo, concorrono a questo importante recupero, che valorizza uno dei grandi patrimoni politici e culturali della città. Da sempre cultore di storia, già autore di notevoli studi sul psi del dopoguerra e ultimamente di una fortunata «biografia parallela» di Prampolini e Menada, Del Bue avvia con questo volume una ambiziosa ricostruzione del socialismo reggiano dalle origini ad oggi, con l’obiettivo di far emergere «una bella storia» (così nell’introduzione). Una storia «di idee e di azioni», come più volte ci ricorda l’autore, che intende il movimento socialista in senso unitario e coerente, ma ampio e complesso, al di fuori dell’ufficialità e dell’ortodossia, con anzi una particolare attenzione per le contaminazioni, gli sviluppi originali, gli spunti anticipatori. Il libro è prima di tutto una biografia collettiva della classe dirigente socialista, che ci fa sfilare davanti una galleria di personaggi più o meno noti, descritti da Del Bue con la consueta abilità: non solo Prampolini (la cui vicenda viene ripercorsa nel dettaglio), ma anche i suoi principali collaboratori (da Vergnanini a Roversi, ma anche gli «allogeni» Soglia e Zibordi, o i «transfughi» Artioli e Borciani), fino ad arrivare ai singoli segretari locali. Ci sono poi i grandi nomi del panorama nazionale (particolare attenzione viene dedicata a Costa, Turati, Labriola, Mussolini); i «compagni di strada» anarchici e radicali; ma anche storie da film come quelle di Angelo Umiltà o Luigi Parmeggiani. C’è poi la storia delle organizzazioni socialiste: quelle politiche, dai gruppi internazionalisti (di cui si ricostruisce l’articolata galassia) al psi (che proprio al congresso reggiano del 1893 assume la definizione di «socialista»); ma anche quelle economiche (i sindacati e le cooperative), gli enti locali, i giornali. Tra l’altro sono accuratamente tematizzate le differenze interne al mondo provinciale, tra città e campagna, pianura e montagna, Enza e Secchia. Ma c’è soprattutto, in sottofondo, una storia di Reggio Emilia tra Otto e Novecento, nel momento cioè in cui la nostra città è il «punto nero» d’Italia e il riformismo pram- 172 poliniano la «Mecca del socialismo». Il testo, pur assai voluminoso e documentato, è di piacevole lettura, non solo per l’oggettivo interesse delle vicende narrate, ma anche per le doti dell’autore, la cui facilità di scrittura e la cui brillantezza d’ingegno trovano qui ampie conferme. Si sente peraltro il forte coinvolgimento di Del Bue in una storia di cui si sente anch’egli parte: nella rivendicazione delle origini risorgimentali del socialismo; nell’insistenza sul tema dell’etica laica; nella contrapposizione del modello reggiano e quello sovietico. Ma anche, curiosamente, quando tra tanti (meritati) elogi per il socialismo nostrano, si prende la libertà di criticarlo per l’insensibilità verso lo sport e il teatro, da sempre sue grandi passioni. Certo per una storia «scientifica» servirebbe forse un ampliamento di orizzonti, magari in chiave comparativa; bisognerebbe uscire dalla storia interna, per confrontarla con quella delle altre correnti ideali e delle altre forze politiche; sarebbe opportuno tener conto degli sviluppi più recenti della politologia. Ma Del Bue aveva obiettivi di alta divulgazione e ci pare che da questo punto di vista abbia ottenuto risultati notevoli. È auspicabile che egli riesca a proseguire il lavoro che si è prefisso (un secondo volume sul periodo 1918-1956 ed un terzo fino al 1994), anche dovendo affrontare periodi meno gloriosi per la storia del socialismo reggiano; e soprattutto che sulla scia del suo esempio, e grazie ai materiali in corso di archiviazione presso il Polo di via Dante, sia possibile sviluppare compiutamente una storia dei partiti politici reggiani. Mirco Carrattieri G.L. BASINI, L. SEGRETO, Credito Emiliano 1919-2010. Dalle radici agricole alla diffusione nazionale, Editori Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 620, 45 euro. Forma e sostanza. In questi due sostantivi si riassume l’essenza dell’unica banca reggiana che, mantenendo la propria identità ed autonomia nell’arco di cento anni di attività, ha saputo sviluppare l’area di influenza sino a essere presente su tutto il territorio nazionale. Su questa vicenda è stata realizzata una ponderosa ricerca a cura di Gian Luigi Basini e di Luciano Segreto, professore emerito di Storia economica all’Università di Parma il primo e docente di Storia della finanza all’Università di Firenze il secondo. Al di là delle importanti indicazioni sulla nascita, sullo sviluppo e sulle modificazioni di questa istituzione bancaria reggiana (sorta nel 1910 con la denominazione di Banca agricola commerciale di Reggio Emilia per iniziativa di Igino Bacchi Andreoli e di una trentina di esponenti della ricca borghesia locale), il lavoro consente un approfondimento sulle storia del Novecento, addentrandosi in aspetti e in collegamenti che consentono di meglio comprendere i fatti. La storia di una banca è comunque importante per il suo ruolo determinante nello sviluppo territoriale, ma in questo caso lo è ancor di più in quanto la Banca agricola commerciale ha gradualmente interessato tutta la provincia (dedicandosi soltanto dopo gli anni Ottanta ad operazioni che interessavano ambiti diversi) e ha mantenuto per molti anni la leadership incontrastata nell’amministrazione dei depositi della clientela. La sua presenza capillare, destinata principalmente alle attività agricole e alla tra- 173 sformazione dei prodotti dell’agricoltura – con un’attenzione speciale alla produzione e commercializzazione del formaggio parmigiano-reggiano e alla lavorazione delle carni suine e bovine – costituisce un aspetto qualificante di una storia dalla quale non è possibile prescindere per comprendere e valutare gli accadimenti del Novecento. L’iniziativa di Igino Bacchi Andreoli fu un atto coraggioso perché sfidava in modo esplicito un plotone di dieci banche e di sedici Casse rurali che erano già presenti sul territorio, ma non fu un atto temerario: contando sulla propria esperienza di assessore e di sindaco del Comune di Reggio nonché di presidente della Provincia, «aveva individuato le prospettive di una struttura bancaria diversa dalle esistenti che, al di fuori di ogni interesse di parte, poteva andare incontro alle crescenti esigenze dell’agricoltura, del commercio e dell’industria di una provincia ancora troppo arretrata e, nello stesso tempo, garantire agli azionisti privati adeguata soddisfazione alle loro esigenze di investimento». Il sogno di Bacchi Andreoli è stato condiviso da Riccardo Modena e da ventinove investitori, tra i quali una qualificata rappresentanza di ebrei e di esponenti della massoneria locale. Si tratta di «persone superiori per cultura, moralità e censo» (come Banca d’Italia definirà i soci fondatori della Banca agricola commerciale di Reggio Emilia quasi trent’anni dopo), in grado di accaparrare le simpatie degli interpreti della fase di sviluppo economico che stava interessando il territorio reggiano. L’iniziativa si caratterizza fin dall’inzio per un’idealità «demo-liberale» e per una forte dotazione di mezzi propri che consentiranno alla banca di mantenersi relativamente indenne dalle pressioni politiche e di intervenire con autorevolezza nei processi di sviluppo dell’economia locale anche nelle fasi più difficili del regime fascista e della ricostruzione postbellica. Diretta da Riccardo Modena e da Alfonso Terrachini negli anni turbolenti e difficili della prima guerra mondiale, della grande crisi del 1929 e della seconda guerra mondiale, la banca supera i momenti drammatici della depressione e della guerra senza ricorrere ad aiuti esterni, rappresentando un riferimento determinante per le imprese e per gli agricoltori, soprattutto dopo l’incorporazione – negli anni Trenta – della Banca scandianese e della Banca dell’agricoltura. I rapporti con il regime costituirono un banco di prova determinante per la banca. Il presidente Aldo Bacchi Andreoli (figlio del fondatore Igino) dovette allontanarsi da Reggio perché accusato di favorire la lotta partigiana, mentre il direttore Alfonso Terrachini riparò a Como inseguito dalle censure di parte avversa (tanto che subì un processo di epurazione, da cui uscì assolto per l’intervento di importanti esponenti della lotta di Liberazione). Gli anni della ricostruzione trovano la banca in prima fila nell’assistenza all’economia locale, meritandosi anche qualche richiamo non troppo velato da parte di Banca d’Italia per l’appoggio ad alcune ditte in evidente difficoltà finanziaria. Il rapporto con il movimento cooperativo e con la piccola e media imprenditoria, ma anche con il settore terziario, costituisce un carattere distintivo dell’azione della Banca agricola commerciale. Superata la fase più tribolata della ricostruzione, la banca dovette affrontare la delicata successione alla tumultuosa ma decisiva gestione di Alfonso Terrachini, durata ben trentacinque anni. Fu un parto difficoltoso, che presuppose ben dodici anni di gestazione, tanti quanti furono gli anni occupati da due direzioni interlocutorie quali quelle di Gaetano Mascheroni e di Natale Grossi. Alla fine, nel 1975, la scelta 174 cadde su un manager lombardo, Franco Bizzocchi, che vantava ascendenze reggiane per parte di padre. Fu una decisione che consentì di recuperare il ritardo che la banca aveva accumulato nel corso degli anni Sessanta e Settanta, quando la Banca agricola commerciale di Reggio Emilia aveva condiviso a pieno titolo il percorso di crescita e di sviluppo dell’intera comunità, partecipando attivamente alle fasi di produzione del reddito e all’assunzione di nuove logiche imprenditoriali, ma aveva tralasciato di aggiornare la propria struttura interna e la definizione di una strategia operativa. A partire dal 1975, la nuova direzione della banca dà avvio ad un processo di crescita culturale e professionale che, nell’arco di pochi mesi, cambia radicalmente la fisionomia della Banca agricola. Come è stato scritto, «l’immissione in dosi massicce di personale giovane, preparato, motivato, fu una autentica molla per far compiere alla banca quel balzo da tempo atteso e ormai indispensabile». E per coloro che furono protagonisti di quella stagione si trattò di un’esperienza indimenticabile. È impossibile sintetizzare, in questa sede, gli interventi che si sono realizzati nell’arco di venticinque anni, tanto quanto è durata la direzione di Franco Bizzocchi, prima con la presidenza di Enrico Ferrari, poi di Antonio Triglia e infine di Giorgio Ferrari. Si tratta di tasselli di un mutamento radicale che sfocia nel cambio di ragione sociale, interpretando nella forma ciò che nella sostanza sta avvenendo da mesi. Banca agricola commerciale di Reggio Emilia diviene così Credito emiliano, e più brevemente Credem. La banca, ancora saldamente in mano a 24 famiglie reggiane che detengono poco più di un terzo delle azioni, esplicita un cambiamento che pare sconfessare una scelta localistica che aveva trovato evidenza nella particolare impostazione grafica della ragione sociale della banca alla fine degli anni Settanta. In effetti è alle porte un salto dimensionale, sia nella diffusione delle azioni «oltre i confini di operatività tradizionale», sia nella presenza in altre aree nazionali. La banca, con Franco Bizzocchi nelle vesti di amministratore delegato-direttore generale e l’industriale Achille Maramotti quale vicepresidente, si appresta a realizzare «uno sforzo che non ha paragoni nella storia del sistema bancario degli ultimi decenni», ovvero l’applicazione di regole di qualità nel fare credito al di fuori del contesto in cui sono nate, ed in particolare nel Sud d’Italia. L’operazione determina la dimensione nazionale della banca reggiana, sulla quale s’innesta la fase espansiva del decennio che è alle nostre spalle, aprendo spiragli su una storia che ha mutato gli interpreti (Adolfo Bizzocchi è il nuovo direttore generale, vicepresidente non è più Achille Maramotti) e che ha strategie in corso di definizione per una realtà che si prospetta complessa e avvincente per una «banca tradizionale, commerciale, domestica, che si muove in un contesto interregionale e ha una grande prudenza nella gestione dei crediti». Ancora una volta, a conferma dell’unitarietà del percorso di sviluppo della banca reggiana, la forma e la sostanza sono i parametri di riferimento. Carlo Pellacani Una città, tanti bambini. Memorie di una storia presente, Reggio Children, Reggio Emilia 2010, pp. 264, 26 euro Reggio Children è – formalmente – una srl che ha lo scopo di valorizzare a livel- 175 lo internazionale l’idea pedagogica legata alle scuole comunali e ai nidi di Reggio Emilia e, nel contempo, di favorire quegli scambi culturali che sono all’origine stessa di tale esperienza. In se stessa riflette il carattere collettivo delle conquiste maturate all’interno delle scuole reggiane, storicamente frutto di un intreccio virtuoso di scelte amministrative, di partecipazione sociale, di buone pratiche non cristallizzate in canoni fissi, ma rivolte alla continua (ri)scoperta del bambino come continente mai del tutto esplorato. Non sorprende dunque che questo volume, che compie una accurata rassegna di quella storia – a partire dalle sue radici e senza trascurare le sue proiezioni sul futuro – faccia leva su una molteplicità di voci: amministratori comunali, storici, grafici, pedagogisti, insegnanti, tante figure «che c’erano» e che fecero. Insomma, in modo invero singolare, Reggio Children (nome collettivo) è, insieme, autrice ed editrice dell’opera. Che è poi il catalogo della mostra storica che porta lo stesso titolo. Un progetto globale molto ben riuscito, che nell’espressione «una storia presente» riecheggia il titolo della ricerca condotta a suo tempo da Istoreco e sfociata in un volume a cura di Lorenzi, Canovi e Borghi. Ma qui l’intento didattico-esplicativo compie un passo avanti, consentendo usi plurimi: per l’aggiornamento professionale, per una riflessione civile, per sapere di più su Reggio nel mondo di ieri. Che si tratti di «memorie» – si veda il sottotitolo – non è detto a caso. Quello della memoria è infatti un tema cardinale per gli storici e gli studiosi sociali, per lo più esaminato nella forma dell’opposizione memoria divisa/condivisa. Ma il guaio peggiore per la memoria è l’essere labile, confusa, frammentaria. Oppure di isolare i fatti dai contesti. Cosa che trova un efficace antidoto nelle strutture della mostra e del catalogo, che situano un rilevante aspetto locale di storia culturale e civile nel quadro della grande storia, culturale e civile, del Novecento. Che è poi un modo di evitare di cadere nel gioco equivoco di esaltare i successi del prodotto autoctono, frutto di un particolare genius loci. Se c’è un merito, in questo e in molti altri campi, della città di Reggio è quello dell’uscita dal guscio, del captare le grandi voci e le importanti suggestioni che vengono da più ampi orizzonti: dall’internazionalismo socialista del primo Novecento, alla Resistenza antifascista e alla cultura politica del costituzionalismo democratico. E, nel campo delle idee, la sensibilità alle grandi correnti della pedagogia, della psicologia, delle neuroscienze, delle avanguardie artistiche (gli anni della costruzione delle scuole dell’infanzia sono quelli di «Musica e Realtà», dell’Istituto Banfi, del rinnovamento della cultura psichiatrica, della presenza in città del «Gruppo 63» e del Living Theater, per fare solo qualche esempio). Questa nota non può concludersi senza esprimere l’amaro rimpianto perché uno dei più assidui co-autori del progetto, e sindaco in anni irripetibili, il compianto Renzo Bonazzi, non abbia potuto vedere il pieno compimento del lavoro. (gb) C. DE MARIA (a cura di), Andrea Costa e il governo della città. L’esperienza amministrativa di Imola e il municipalismo popolare. 1881-1914, Diabasis, Reggio Emilia 2010, pp. 189, 30 euro Nel 2010 ricorre il centenario della morte di Andrea Costa, padre nobile del socialismo italiano. Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Imola per ricorda- 176 re l’illustre concittadino, Carlo De Maria ha realizzato una mostra storico-documentaria con i materiali conservati nella Biblioteca comunale e ha curato il relativo catalogo. Scevra da intenti puramente celebrativi, l’opera rappresenta un importante contributo alla ricerca storica. Basata su un’accurata ricerca archivistica e bibliografica, essa indaga infatti aspetti della vita di Costa affrontati marginalmente dalla storiografia del movimento socialista, concentrata soprattutto sul coinvolgimento dell’imolese nelle vicende di interesse nazionale e internazionale. La mostra esplora innanzitutto la dimensione privata di Costa, approfondendo aspetti spesso trascurati dagli studiosi come i rapporti interpersonali, la formazione culturale e i viaggi. L’attenzione di De Maria si focalizza però prevalentemente sul ruolo svolto dal celebre socialista all’interno della realtà comunale di Imola. Più precisamente, le tematiche su cui si sofferma maggiormente l’autore sono, da una parte, il rapporto tra Costa e il mondo dell’associazionismo popolare locale e, dall’altra, l’esperienza pionieristica dell’amministrazione comunale di Imola – primo comune italiano a essere guidato da una giunta democratico-socialista – nella costruzione di un sistema di welfare municipale. La figura di Costa diventa quindi il filo conduttore di un viaggio tra le difficili condizioni delle classi popolari di fine Ottocento e l’originale esperienza del municipalismo popolare. Il lavoro di De Maria non è però, come potrebbe sembrare da questa descrizione, un mero studio di storia locale. La raffigurazione di un quadro dettagliato dell’esperienza socialista imolese rappresenta, al contrario, il punto di partenza per un’analisi di ampio respiro sulle peculiarità del socialismo italiano ed europeo negli anni precedenti alla Rivoluzione d’ottobre e all’avvento dei fascismi. Il «laboratorio imolese» è, infatti, un vero e proprio antesignano di tutti i casi di socialismo municipale che si registrano a inizio Novecento in Italia, tra i quali non si deve dimenticare quello di Reggio Emilia. La realtà del comune romagnolo diventa quindi, nelle intenzioni dell’autore, un vero e proprio esempio paradigmatico del carattere plurale e decentrato della sinistra europea di fine Ottocento e inizio Novecento. L’immagine del socialismo che emerge dalla mostra è quella di un universo politico policentrico, che non conosce ancora quel controllo rigido sull’ideologia e sull’azione delle singole realtà locali che le segreterie dei partiti politici novecenteschi imporranno negli anni successivi. Per usare le parole di Pino Ferraris, è un mondo la cui ricchezza consiste «nel pluralismo delle idee e nelle diversità delle scuole». Focalizzare l’attenzione sui singoli casi comunali non è quindi soltanto una scelta dettata dal desiderio di esplorare aspetti trascurati dalla storiografia nazionale, ma anche e soprattutto un approccio necessario per giungere alla corretta comprensione dell’intero fenomeno. Con questa mostra dunque, De Maria restituisce pienamente alla dimensione locale quell’importanza che le è propria nella ricerca storica del mondo socialista delle origini. Oltre che un utile strumento per comprendere il fenomeno del socialismo municipale, la mostra si rivela infine un’occasione per riflettere su alcune problematiche del mondo di oggi. Temi come welfare, cittadinanza e autonomia – che ricorrono più volte tra le pagine del catalogo – rimangono, infatti, a oltre cent’anni dalla scomparsa di Costa, di grande attualità nella politica italiana e internazionale. Marco Marzi 177 M. PANARARI, L’egemonia sottoculturale. L’Italia da Gramsci al gossip, Einaudi, Torino 2010, pp. 145, 16,50 euro Accade sempre più spesso, nella surreale Italia di oggi, di ascoltare una risposta come quella che Mario Borghezio, europarlamentare della Lega Nord, ha dato a Lilli Gruber in chiusura della trasmissione televisiva Otto e mezzo, venerdì 17 settembre 2010. All’auspicio della giornalista di riaverlo come ospite, magari per presentare un suo libro, Borghezio ha ribattuto, alludendo con malcelato vanto a sé e ai suoi compagni di partito: «noi è già tanto se sappiamo leggere e scrivere. Siamo umili operai della politica!». Se poi vogliamo parlare di «società civile», ecco un frammento di dialogo, ascoltato a Reggio Emilia, in una via del centro, davanti a un esercizio commerciale. Dice un cittadino italiano, alludendo agli evasori fiscali: «tanto non rubano mica a noi poveracci... rubano allo Stato!» Gli risponde un cittadino dagli evidenti tratti somatici orientali: «dove pensi che li vada a prendere, lo Stato, i soldi delle tasse, se non da noi poveracci?». Se questi sono i frammenti di una «sottocultura» diffusa nel nostro Paese, giunge allora propizio il volume L’egemonia sottoculturale, pubblicato per i tipi di Einaudi da Massimiliano Panarari, saggista, consulente di comunicazione pubblica e politica e docente di Analisi del linguaggio politico presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. L’intento che Panarari intende raggiungere con questo libro è ambizioso: spiegare le origini politiche e ideologiche di questa sottocultura, descriverne i meccanismi e la genesi, anche risalendo a precedenti illustri quali i gruppi situazionisti e il cosiddetto postmoderno, infine suggerire alla sinistra un percorso politico e culturale per affermare un’egemonia diversa e meno manipolatrice. Cercheremo di verificare se e quanto questo intento sia stato raggiunto. L’assunto da cui parte Panarari è chiaro: dopo una lunga marcia nel deserto, la destra è riuscita, a partire dalla fine degli anni Settanta del Novecento, a conquistare progressivamente il potere in Occidente e mettere così in discussione le conquiste e le garanzie sociali che la sinistra dava ormai per acquisite. Alla base di questo progetto vi sarebbe l’ideologia neoliberale, da intendersi non come prosecuzione del liberalismo classico, ma come «una sua lampante e innegabile “perversione”» (p. 5), tanto da meritarsi la definizione di «neoliberalesimo» attribuitale dal sociologo Luciano Gallino. Lo strumento di questa affermazione politica ed economica neoliberale sarebbe, per Panarari, l’aver costruito una nuova egemonia culturale, basata sulla creazione di un potente immaginario popolare, atto a rafforzare e rendere benaccetti alle classi sociali meno abbienti gli stili di vita e i privilegi delle classi dominanti. Il primo capitolo del volume è dedicato alla definizione e contestualizzazione della nozione gramsciana di «egemonia», fatto che già rende meritorio il lavoro di Panarari, in un quadro come l’attuale in cui l’opera di Antonio Gramsci – uno dei più importanti e originali pensatori italiani del secolo XX – è notoriamente studiata più all’estero che in Italia. Panarari rilegge le nozioni gramsciane di «direzione», basata sul consenso, e «dominio», basato sulla sopraffazione, alla luce della contesa egemonica fra sinistra e destra giocatasi, in Italia e non solo, dalla metà del Novecento in poi. Il partito comunista italiano e un più ampio fronte progressista, avevano in effetti messo in atto nel secondo dopoguerra la teoria gramsciana dell’egemonia, basata sulla costruzione 178 di un universo culturale alternativo da parte degli intellettuali «organici» alle classi lavoratrici. Basti pensare a riviste quali «Rinascita» e «Il Politecnico», case editrici come Einaudi, Editori riuniti, Feltrinelli, oltre alla libera iniziativa di singoli intellettuali e correnti di pensiero. Questa egemonia, rileva Panarari, fu forte ma limitata ai professionisti della cultura – scrittori, giornalisti, insegnanti, artisti, ecc. – e se crebbe fino agli anni Ottanta del Novecento, presto si arrestò e retrocesse, davanti alla nuova «filosofia popolare» del disimpegno e del riflusso. Nel secondo capitolo l’autore esamina invece gli strumenti messi in campo dalla destra per affermare una propria egemonia culturale: la televisione commerciale, la globalizzazione dei processi economici e culturali, certe categorie del postmoderno. In questo processo, niente affatto casuale, Panarari parte dalle analisi di pensatori quali Michel Foucault, che ha parlato di istituzione totale come lato oscuro della modernità, per definire la televisione lo strumento perfetto «per diffondere pensieri debolissimi e condizionamenti fortissimi» (p. 24). Il Nostro ci dà anche una data di nascita di questa televisione moloch, l’11 ottobre 1983, quando la trasmissione comica Drive in fu diffusa per la prima volta dall’emittente Italia 1, contrapponendosi simbolicamente alla televisione «pedagogica» della rai e di Ettore Bernabei. Erano quelli gli anni, ricorda Panarari, dell’egemonia politica di Bettino Craxi e della nascita dell’impero economico e commerciale di Silvio Berlusconi. Craxi, da modernizzatore quale si definiva, investì in modo massiccio su televisione e giornali e su un sistema radiotelevisivo misto pubblico/privato. Sulle basi poste dall’uomo politico socialista s’innesterà l’impero mediatico di Berlusconi, destinato, dopo il terremoto di Mani pulite, a diventare l’erede politico dello stesso Craxi. Con Craxi prima e Berlusconi poi, chiosa Panarari, «il fil rouge ... dell’anticomunismo continua a dipanarsi, senza soluzione di continuità, dagli anni Ottanta sino ai giorni nostri, in un Paese di “lunghe durate più lunghe”, per quanto concerne i cicli politico-economici, di quanto accada nel resto dell’Occidente» (p. 32). Affermazione degna di attenzione, perché solo una comprensione profonda degli avvenimenti politici che hanno interessato l’Italia dal 1978 al 1993, potrebbe permetterci, crediamo, di cogliere nella dovuta luce gli avvenimenti successivi e l’interminabile «anomalia» italiana che è ancora sotto i nostri occhi. Il postmoderno chiamato in causa da Panarari come elemento dell’egemonia neoliberale è, in effetti, una galassia talmente ampia da rischiare di perdercisi. Gli elementi messi però in evidenza sono la crisi della «grande narrazione» e delle identità «forti», con lo svilupparsi parallelo sia di un «pensiero della differenza», «ironico, irenico e sincretistico», sia di complementari e preoccupanti fenomeni, quali xenofobia, rivendicazioni identitarie, fondamentalismi religiosi. L’esplosivo cortocircuito fra neoliberalismo e immaginario collettivo genera, in una società quanto mai frammentata, la netta prevalenza di un solo settore: quello dell’economia, che ricompone l’unità perduta sul piano delle immagini, «le quali – scrive Panarari – danno agli individui ciò che manca nelle loro esistenze reali» (p. 58). Dopo i primi due capitoli introduttivi, l’autore dedica gli altri cinque a un’approfondita disamina degli strumenti dell’egemonia sottoculturale in Italia: rotocalchi e trasmissioni televisive giudicati emblematici in quanto «armi di distrazione di massa». Il primo a essere messo sotto i riflettori è il giornalista Alfonso Signorini, direttore di «Chi» e «Tv Sorrisi e Canzoni», definito da Panarari il vero intellettuale organico al si- 179 stema politico-mediatico di Berlusconi. Panarari sottolinea la funzione forte dei media guidati da Signorini verso «la presentizzazione assoluta, la cancellazione della memoria e l’ossessione dell’arricchimento finanziarizzato e short term che guidano il neoliberalismo» (p. 44). Anche la contaminazione fra gli argomenti trattati, all’ordine del giorno in questi rotocalchi, è vista da Panarari come emblematica di «quell’abbattimento della distinzione dei generi e dei registri che identifica ... uno dei pilastri dell’egemonia sottoculturale» (p. 50). Secondo oggetto dell’analisi di Panarari sono Antonio Ricci e le sue trasmissioni. Il nostro autore sottolinea come, sebbene questi sia giudicato dalla sinistra «uno dei nostri», abbia però messo la sua cultura al servizio dell’egemonia sottoculturale neocapitalista. Trasmissioni come «Le Iene» e «Striscia la notizia» sono, a detta di Panarari, esempi di «infotainment 2.0», cioè commistioni di informazione e intrattenimento, contrabbandate come «servizio pubblico», ma destinate in realtà a un ruolo di «populismo mediatico». Ecco emergere nuovamente i contenuti dell’Internazionale situazionista, sebbene rovesciati politicamente di segno. Queste trasmissioni, infatti, ostentano un atteggiamento ludico e scanzonato, da carnevale perenne, insistono su parodia e ironia ma, avverte Panarari, sono solo apparentemente dalla parte della «gente», mentre in realtà si tratta di strumenti molto potenti dell’egemonia sottoculturale dei ceti legati alla nuova economia neocapitalistica. Nel capitolo quinto è la volta di Maria De Filippi, «arbitra» elegantiarum della neo-Italia, come recita il sottotitolo, ironica definizione che sintetizza il punto di vista dell’autore. De Filippi, erede non degna – a detta di Panarari – di Raffaella Carrà, ha imposto nelle sue trasmissioni, Amici e Uomini e donne, un’«estetica» in cui ogni cosa è sopra le righe e i «valori» veicolati sono l’avvenenza fisica, l’incultura, la visione tradizionale del rapporto uomo/donna, insieme a un grande spazio dato a un’assertività e un’emotività non filtrate. Panarari si rifà al celebre film di Adrian Lyne Flashdance (1983) per osservare che «il messaggio, allora come oggi, è rimasto lo stesso: altro che rivoluzione, il membro della working class o dell’underclass si riscatta, rigorosamente da solo e per via individuale (e magari già che c’è, non lesinando qualche colpo sotto la cintola al concorrente), ballando, cantando, recitando, facendosi protagonista della società dello spettacolo» (p. 86). Non poteva mancare l’attenzione ai reality show e alla loro «Ur-valletta» Simona Ventura. Endemol, spiega Panarari, è il network mondiale – con partecipazione di Mediaset al 33 percento e della banca d’affari Goldman Sachs – che ha elaborato e lanciato il format di reality come Il Grande Fratello, forte di trenta edizioni nazionali. Questa multinazionale, osserva Panarari, si candida gramscianamente ad «agenzia del simbolico», per passare «dal nazionalpopolare al globalpopolare» (p. 93). Il meccanismo del reality è basato sull’avventura e su situazioni che stimolino la curiosità morbosa dello spettatore; gli interpreti sono spesso semplici «caratteristi» che recitano «esperienze di vita» tratte dal copione degli autori. «Questa è, in buona sostanza – conclude Panarari –, fiction» (p. 97), ma una fiction che, nell’epoca del crollo delle ideologie e di ogni risposta totalizzante alle domande dell’uomo, propone esempi da imitare, «esperienze eccezionali» da prendere a modello. L’ultimo capitolo è dedicato ai talk show e in particolare a Porta a Porta di Bruno Vespa, trasmissione in cui si respira intimità col potere e dove il potente di turno – 180 che appartenga alla maggioranza o all’opposizione – è sempre messo a proprio agio. Queste trasmissioni si reggono, secondo Panarari, grazie alla tecnica dello storytelling, l’arte di raccontare storie, che è oramai divenuta «la forma postmoderna della propaganda» (p. 110). Anche a Porta a Porta, dove sempre più spazio viene concesso a temi non politici, quali il gossip e la cronaca nera, si pratica il già ricordato abbattimento delle barriere fra i generi, con lento e inesorabile slittamento dall’informazione all’infotainment. «Sempre meno info – commenta Panarari – e sempre più entertainment: il segreto dell’equilibrio (scusate, dello squilibrio) alchemico, è tutto qua. Intrattenere, e non dare da pensare» (p. 111). A tutto questo, si aggiungano una spruzzata di «opinionisti» tuttofare dalle dubbie competenze, l’illusione demagogica del «televoto» e il gioco è fatto. L’Epilogo (quasi) ottimista del libro di Panarari è dedicato alla pars construens, a ciò che la sinistra dovrebbe fare per intaccare l’egemonia sottoculturale della destra. Come ha scritto Carlo Freccero, citato da Panarari, la sinistra ha disperso un patrimonio culturale fatto di decenni di riflessioni sul ruolo della televisione e, dopo la caduta del Muro di Berlino, è rimasta solamente legata all’economia, mentre «la destra conquistava la dimensione dell’immateriale e dello spettacolo» (p. 125) e Berlusconi si accaparrava case editrici, emittenti private e la maggiore casa di produzione cinematografica del Paese. Dunque la sinistra, sostiene Panarari, dovrebbe evitare la falsa alternativa fra «apocalittici e integrati», ma ripensare linguaggio e contenuti della televisione, recuperare la nozione di servizio pubblico e rimettere in auge l’idea solo apparentemente obsoleta di «pedagogia di massa». Il risultato potrebbe essere la rinascita nei cittadini, non più solo spettatori e consumatori, di un nuovo spirito critico; lo sviluppo di un reale pluralismo, con network televisivi anche orientati a sinistra; il ripristino di una sfera pubblica e di un’idea di informazione e democrazia degne di questo nome. Per fornire un quadro complessivo della fatica di Panarari, diremo che il suo volume ci sembra prestarsi a una duplice lettura, sul piano politico e sul piano culturale, strettamente intrecciati fra loro. Sul piano politico, lo scenario descritto da Panarari è senz’altro affascinante e ricco di utili spunti, ma ci sembra doveroso aggiungere la considerazione che, se la destra neoliberale ha costruito un nuovo immaginario così ben delineato, lo ha fatto perché ciò corrispondeva a un preciso disegno politico ed economico e tale disegno, mutatis mutandis, ci sembra altrettanto necessario per una sinistra che si prefigga, non solo di competere con la destra sul piano dell’egemonia, ma di sostituirla nella direzione del Paese con una politica che, finalmente, riporti all’ordine del giorno i temi delle libertà, dei diritti e doveri e della giustizia sociale, tanto a lungo messi in sordina dall’inutile «blablà» dei servi sciocchi del potere. Anche sul piano più strettamente culturale, possiamo affermare che i connotati e gli effetti dell’egemonia sottoculturale della destra sono esaurientemente e brillantemente descritti, svelando alcuni dei numerosi meccanismi «illusionistici», cui il pubblico televisivo è quotidianamente sottoposto. Stupisce in parte l’assenza in bibliografia di due opere italiane che, a nostro avviso, hanno in un passato recente dato un utile contributo al tema in oggetto. Parliamo dei volumi di Raffaele Simone, La Terza Fase. Forme di sapere che stiamo perdendo (Laterza, Roma-Bari 20033) è di Claudio Giunta, L’assedio del presente. Sulla rivoluzione culturale in corso (Il Mulino, Bologna 2008), 181 solo per affermare che forse il terreno su cui lavorare è, almeno in parte, già dissodato. Infine, crediamo vada superata la distinzione, presente con insistenza nelle posizioni della destra italiana degli ultimi quindici anni ma, ci sembra, sposata anche nel testo che qui presentiamo, fra cultura «di destra» e «di sinistra». È solo la polemica politica di breve respiro ad applicare queste etichette. Per limitarci al secolo che ci ha preceduto e senza negare la complessità del tema, è utile e possibile chiedersi se – per esempio – Thomas Mann, Benedetto Croce, Norberto Bobbio fossero di destra o di sinistra? Se cultura è sinonimo di analisi critica della realtà, fiducia nel confronto, salvaguardia della memoria e ricerca di nuove frontiere, allora l’intellettuale onesto sarà sempre il «sale della terra», non chierico al servizio del potente di turno, ma voce critica nei confronti di qualunque potere. Il libro di Panarari propone una disamina metodica, spietata, illuminante e illuminista della ormai autoreferenziale società dello spettacolo in cui siamo immersi e in particolare della televisione. Ha il merito di parlare chiaro e chiamare le cose con il loro nome. Si legga per esempio a p. 46, dove si parla di «“democrazia (o demagogia) della fama” come surrogato (molto conveniente) della giustizia sociale». Forse nascono anche da qui alcune acide recensioni che il libro ha ricevuto su importanti organi di stampa nazionali. Altre qualità possiamo riconoscere a questa utile guida al nostro oscuro presente. Tra una strizzatina d’occhio al linguaggio «pop» e un uso – a nostro avviso eccessivo – degli incisi fra parentesi, vi si respira un’aria genuina d’intelligenza e di libertà, oltre a un’eco delle cinque qualità che Italo Calvino attribuisce nelle Lezioni americane alla buona letteratura fonte di conoscenza. Scusate se è poco. Roberto Marcuccio F. LORETO, L’unità sindacale (1968-1972 ). Culture organizzative e rivendicative a confronto, Ediesse, Roma 2009, pp. 400, 18 euro C’è stato un tempo in cui il sindacato ha rappresentato in Italia, per milioni di persone, la principale speranza di rinnovamento sociale e di allargamento degli spazi di democrazia, partendo dai luoghi di lavoro per investire la società nel suo complesso, rendendo credibile e possibile la prospettiva delle riforme «di struttura», da molti auspicate e ben poco realizzate. Questo tempo racconta Fabrizio Loreto in L’unità sindacale (1968-1972). L’unità sindacale è un’aspirazione antica, che ha sempre incontrato nella storia italiana ostacoli molto forti, di natura ideologica, politica e di impostazione dell’attività sindacale. Loreto ripercorre le tappe di «avvicinamento» rispetto al periodo in cui l’unità organica è apparsa un obiettivo perseguibile e non solo proclamato e auspicato, cioè gli anni dal 1968 al 1972. Il ’68 è un angolo di osservazione privilegiato, secondo l’autore, per lo studio della storia del movimento sindacale, perché in quell’anno si afferma in modo netto la «anomalia» del sindacato italiano in quanto soggetto politico autonomo, con proprio programma di cambiamento dell’intera società e non solo delle condizioni economi- 182 che e normative sui luoghi di lavoro. Questo avviene per l’incontro che si realizza nei territori tra movimenti degli studenti e operai, prolungando la mobilitazione collettiva ben oltre quell’anno. Per l’autore l’anno degli studenti – il ’68 – e l’anno degli operai – il ’69 – vanno esaminati come un unico «biennio rosso», per la contaminazione tra soggetti, forme e luoghi del conflitto. Il risultato di questo complesso incontro è un allargamento dei diritti di cittadinanza nel paese, producendo la fine del dispotismo padronale in fabbrica e l’introduzione di elementi di moderno stato sociale. Nel ’68 il sindacato è all’inizio anche oggetto di contestazione, poi, specie dall’autunno, diviene protagonista della contestazione, fa propria la novità dei delegati e dei consigli di fabbrica e si assiste ad una accelerazione della conflittualità di lavoro, non tanto per la quantità di ore di sciopero, ma per la qualità dei contenuti rivendicativi, per le forme di lotta, per gli esiti contrattuali. A livello nazionale, attraverso un itinerario non facile i sindacati trovano una posizione comune sul problema della riforma pensionistica e previdenziale che porta il 14 novembre al primo sciopero unitario dopo il 1948. Seguono le mobilitazioni contro le gabbie salariali, superate a inizio ’69. Da qui inizia la storia del movimento sindacale come soggetto politico, tratto peculiare del «caso italiano». Il momento alto del «biennio rosso» è l’autunno dei contratti del ’69, preceduto nello stesso anno dai congressi delle Confederazioni con al centro i temi dell’autonomia e dell’unità. Le acli proclamano la fine del collateralismo con la dc e la libertà di voto, la fim cisl conclude il cammino degli anni Sessanta passando «dall’associazione alla classe». La cgil nel congresso di Livorno, superando resistenze persistenti nella componente comunista (si teme il «disarmo politico» della classe operaia), fa la scelta dell’incompatibilità tra cariche politiche e sindacali, accettando di compiere un passo fortemente sollecitato dalla cisl. Tutto questo mentre dai primi mesi dell’anno si afferma rapidamente nelle fabbriche la figura del delegato di reparto, e le piattaforme rivendicative per i rinnovi contrattuali sono definite in modo nuovo, in particolare ad opera delle federazioni dei metalmeccanici: pochi e selezionati obiettivi, coinvolgimento di massa attraverso le assemblee di tutti i lavoratori, continuità della lotta durante le trattative; prevale tesi degli aumenti uguali per tutti, si prevede la costituzione di organismi unitari di base per coordinare le sezioni sindacali ed eleggere delegati di reparto. La vertenza contrattuale, che si apre a settembre, arriva dopo 1500 accordi aziendali del ’68 e seicento nel ’69 e per l’autore «chiude un ciclo irripetibile della storia italiana, non soltanto sindacale, nel quale la democrazia, intesa come larga partecipazione dei cittadini alla vita sociale, economica e politica del paese e come autodeterminazione delle condizioni di vita e di lavoro, visse una stagione di estensione e consolidamento. A essere messo in discussione fu soprattutto il meccanismo autoritario di funzionamento della fabbrica fordista; per questo, le lotte dei metalmeccanici travalicarono ben presto la pur rilevante questione salariale per divenire lotte per il potere e per la libertà nei luoghi di lavoro». Durante l’«autunno caldo» le Confederazioni elaborano una vera e propria politica delle riforme, che prende avvio dalle problematiche della casa e dell’edilizia. Il primo momento di visibilità della strategia delle riforme è lo sciopero generale del 19 novembre. 183 Se l’autunno contrattuale rappresenta il punto alto del biennio, col 1970 per l’autore comincia una fase differente, nella quale mentre si diffondono anche fuori degli ambiti strettamente sindacali le novità che vengono dal mondo del lavoro, compaiono e pesano sempre più le resistenze e le reazioni. Come ricorda Bruno Trentin, dopo l’autunno caldo comincia la battaglia per la diffusione dei delegati e per costruire il sindacato dei consigli, unità sindacale e nuovi strumenti di rappresentanza divengono inseparabili. I meccanici mettono in campo, dopo il rinnovo contrattuale, circa trentamila delegati e duemila consigli di fabbrica, e spingono le altre categorie industriali. L’ascesa del sindacato pare per un certo tempo irresistibile e influenza sempre maggiormente il livello politico. I primi mesi del 1970 vedono l’approvazione dello Statuto dei lavoratori, l’introduzione dell’istituto costituzionale del referendum, la prima elezione dei consigli regionali. L’azione sindacale si mantiene alta, attraverso la contrattazione aziendale, mentre con le mobilitazioni sulle riforme di struttura il sindacato ha ormai assunto il ruolo di agente politico. A fine marzo le Confederazioni elaborano per la prima volta un piano organico di riforme della politica economica e sociale basato su cambiamento del «meccanismo di sviluppo», con potenziamento dell’intervento statale. Si prevedono interventi su spesa pubblica, tariffe, prezzi, servizi sociali, e si individuano i quattro pilastri dell’intervento riformatore: riforma fiscale, politica della casa, riforma sanitaria, politica dei trasporti. Inizia la fase della «supplenza sindacale», il sindacato assume un inedito potere politico, apre col governo la «vertenza per le riforme», che si protrae per circa due anni, con assemblee e lotte generali, si afferma un «Sindacalismo avanzato in un paese arretrato» (Turone). Ma il 1970 vede anche la comparsa prepotente della reazione e di segni opposti. Nei mesi successivi si manifesta a pieno la «strategia della tensione», con gli attentati ai treni, culminata con la bomba di piazza Fontana, compare la «maggioranza silenziosa», inizia la «rivolta» di Reggio Calabria. Nel sindacato si manifestano in modo crescente le ostilità e le resistenze verso unità organica, soprattutto ad opera della componente socialdemocratica della uil e in alcune categorie della cisl. È lo stesso ruolo politico del sindacato che evoca le resistenze e le ostilità da parte di chi ancora non si era reso ben conto della presenza ingombrante del nuovo protagonista. Dalla crisi del governo Rumor del luglio Settanta, a fronte del giudizio negativo delle Confederazioni sulla disponibilità ad una politica di riforme, fino alle elezioni del 1972, le prime anticipate nella storia della Repubblica, determinate dalla crisi definitiva della formula del centro-sinistra, che mostrarono un elettorato sostanzialmente fermo sugli equilibri preesistenti, con l’elemento di rilievo dell’avanzata dell’esterna destra del msi e l’arretramento del psiup. Il movimento degli anni precedenti non pare aver inciso in modo significativo sugli equilibri politici. Alle elezioni anticipate segue il governo Andreotti che ripropone la formula politica del centrismo, recuperando il partito liberale ed escludendo i socialisti. Tra ’70 e ’72 si chiude rapidamente anche la prospettiva dell’unità organica. La Federazione unitaria, che chiude di fatto la vicenda dell’unità, rappresenta qualcosa di più della semplice unità d’azione, ma «qualcosa di molto meno rispetto alla rifondazione unitaria del sindacato» . 184 L’analisi di Loreto si diffonde poi, nell’ultima parte del testo, nella ricerca delle ragioni di più lunga durata per le quali il progetto dell’unità organica non si compì, collocate in tutto l’arco della storia dell’Italia repubblicana. L’analisi si sviluppa attorno a tre filoni: le culture e i comportamenti delle classi dirigenti nei confronti dell’unità sindacale e il rapporto tra ambiti nazionale e internazionale; i comportamenti dei partiti nei confronti della prospettiva dell’unità sindacale; le culture presenti nell’ambito del complesso panorama del movimento sindacale italiano. Per l’Autore quest’ultimo punto assume un rilievo particolare nell’arrestarsi del processo verso l’unificazione organica, portandolo a sviluppare la riflessione fino ai nostri anni. Il libro di Loreto si occupa quindi di un momento particolare della storia italiana, non solo per il rilievo di primo piano assunto per la prima volta dal sindacato che diviene protagonista politico, ma anche per la effettiva portata straordinaria di quell’esperienza. Straordinaria anche perché può essere vista come tentativo di superare, nel pieno del «secolo delle ideologie», proprio le gabbie ideologiche di riferimento di quelle componenti culturali e politiche che avevano dato vita al movimento operaio e sindacale italiano. Superare le ideologie che pure erano state costitutive dell’origine delle organizzazioni sindacali nelle loro diverse ispirazioni ideali, in quanto schemi attraverso i quali fornire una visione del mondo già definita nei suoi tratti di fondo. Un superamento tentato con la costruzione di un movimento che si basa su nuovi strumenti di democrazia, attraverso i quali costruire consenso e legittimazione da definire e ridefinire continuamente, non dati come acquisiti proprio per la certezza e la forza dei riferimenti ideologici, ma basandosi sulla capacità di miglioramento delle condizioni di lavoro e di libertà dei lavoratori, cioè sulla democrazia e il progresso. Forse il progetto era «troppo straordinario», proprio perchè fuori e oltre alcuni tratti di fondo di quel secolo e per questo fuori tempo perché troppo avanti rispetto al suo tempo. Resta comunque, accanto al lavoro di analisi e comprensione delle ragioni del mancato successo, il grande fascino di un progetto che parve per alcuni brevi anni aver trovato le gambe per camminare ed affermarsi. Romeo Guarnieri E. CARNEVALI, P. PELLIZZETTI, Liberista sarà lei! L’imbroglio del liberismo di sinistra, Codice edizioni, Torino 2010, pp. 131, 14 euro Lo si legge col gusto di chi ha tra le mani un pamphlet, per la pungente ironia con cui sono infilzati i suoi bersagli, ma l’argomento è serio e per certi versi drammatico: il progressivo assoggettamento culturale della sinistra italiana ed europea a un certo liberismo, nel quadro di una più generale abdicazione del Politico nei confronti dell’Economico (in concreto: degli attori politici istituzionali nei confronti di un martellante battage accademico al servizio dei grandi potentati finanziari, delle loro lobby, dei foraggiatissimi «pensatoi»). Una resa incondizionata, frutto di una complessa strategia i cui atti preparatori stanno già negli anni Settanta e la cui (resistibile?) ascesa si compie nell’ultimo trentennio. Ripercorrerne la storia, seguendo anche la linea tracciata da S. Halimi (il Grande balzo all’indietro, già segnalato su queste pagine), significa dare sostanza al collaudato adagio (prudenza vuole che se ne tacciano le 185 fonti) secondo cui le idee dominanti sono le idee della classe dominante. Spesso i pamphlet hanno un mandante, magari non dichiarato. Dal canto loro Carnevali e Pizzetti giocano a carte scoperte: fra i loro mandanti si trovano liberisti d’antan (Luigi Einaudi, Ernesto Rossi), capi di stato all’altezza dei momenti difficili (Franklin Delano Roosevelt), il presunto padre del laissez faire incondizionato (A. Smith) e ovviamente colui ne aveva decretato la fine (J. M. Keynes). Il tema del libro (l’esposizione di un autentico dramma) impone poi la presenza della figura del villain: F. Hayek, M. Friedman fra gli economisti, R. Nozick, L. Stauss fra i filosofi (apologeti dell’avidità come valore e negatori della corrispondenza di un qualsiasi contenuto reale alla parola «società»). L’occhio degli autori è rivolto principalmente al cortile di casa nostra, ma il quadro complessivo di riferimento riguarda tutto l’Occidente, e prende luce da un’attenta analisi del cuore ideologico del (neo)liberismo massimalista. In sintesi: Wall Street e Chicago University, le fonti di ispirazione dei nostrani Brambilla che «hanno sciacquato i panni nel Potomac». Per queste ragioni sarebbe consigliabile iniziare la lettura a ritroso, dal capitolo 7 – significativamente intitolato La fine del mondo, a Wall Street – e dal capitolo 6, che restringe il campo alla situazione italiana (Il liberismo NON è di sinistra). In quest’ultimo sono illustrati i successi ottenuti da una pattuglia monocorde di suggeritori (il duo Alesina-Giavazzi, Michele Salvati, Franco Debenedetti…) nel fomentare l’avanzata di una «sinistra moderna, in grado di darsi un valido programma di riforme: occupare lo “spazio ideologico” della destra». Da qui una cascata di conseguenze, che hanno indubbiamente eroso le capacità di un’opposizione efficace (e identificabile) alla destra populista e mediatica: dall’incapacità di prevedere, sulla base di una propria analisi critica dell’attuale capitalismo finanziario, la catastrofe imminente, alla illusoria visione di una flessibilità del lavoro «buona», dall’allegra privatizzazione dei «monopoli naturali», alla sottovalutazione del potenziale criminogeno dei «robber barons» nostrani (vedi la proposta di Fassino, ministro della giustizia nel secondo governo Amato, di depenalizzare i «reati finanziari, inclusa la bancarotta fraudolenta»). Ciliegina sulla torta, l’affanno per andare ad occupare il mitico Centro, premessa per la candidatura nelle liste del centro-sinistra di figure rappresentative della destra industriale più intransigente. Quello che s’è detto non deve far pensare, però, ad un lavoro disinvoltamente giornalistico, né ad un’analisi mirata soltanto a denunciare i limiti delle persone. Esso presenta, al contrario, una serie di robusti argomenti, distribuiti su una gamma molto differenziata di livelli (cosa che induce il lettore a concludere che non si tratti tanto di un’opera letteralmente a quattro mani, ma piuttosto di un ben riuscito patchwork, amalgama di singoli contributi dei due autori). A livello epistemologico viene discusso un difetto costitutivo delle «scienza» economica: la pretesa di conformarsi alle scienze fisiche, come fondamento della presunzione di dar vita a un sapere capace di previsioni esatte. Tutto ciò in base all’assunzione delle capacità autoregolative del mercato e della razionalità (e adeguata informazione) dei vari soggetti che vi operano. Su questo terreno le obiezioni sono facilitate dalle clamorose smentite storiche che hanno direttamente colpito anche recenti premi Nobel della «triste scienza». Ma l’atto di fede sulla «naturale» tendenza del mercato 186 all’equilibrio è dura a morire, essendo condizione necessaria per pretendere lo Stato minimo e negare valore a qualsiasi politica economica «costruttivista», e specialmente ai keynesiani interventi sulla domanda. Persino di fronte ad evidenti congiunture di carattere recessivo. Al Politico non resterebbe che rassegnarsi alla regola che viene riassunta nell’acronimo tina (there is no alternative). Un altro ordine di considerazioni riguarda la contraddizione fra le dichiarazioni liberiste di principio e la pratica concreta di decisivi aiuti politici alla formazione delle grandi fortune industriali e finanziare. Per quanto riguarda l’Italia la cosa è nota: la collaudata formula «privatizzare i profitti e socializzare le perdite», cara a Ernesto Rossi, è norma costante nel consentire alle grandi fortune private di stare a galla nei tempi difficili e di prosperare con le vacche grasse. A questa constatazione ovvia, ma che comunque è bene non dimenticare, gli autori aggiungono un pizzico di perfidia: l’assoluta mancanza di chiaroveggenza da parte di presunti giganti dell’imprenditoria (VittorioValletta, Giovanni Agnelli, Alberto Pirelli, Vittorio Cini), scettici sulla possibilità di sviluppo dei telefoni negli anni Trenta e del personal computer nei Sessanta! Ma anche il cuore dell’Occidente non scherza, solo che si pensi all’importanza della spesa militare nella formazione del pil statunitense, agli intrecci politica-affari non solo nell’era Bush, ma anche in quella dell’«ulivista americano» Bill Clinton. Per non parlare dei continuo andirivieni delle stesse persone dai grandi consigli di amministrazione al governo federale, e ritorno. Sotto questo profilo è sintomatico del disorientamento della dirigenza del nostro centro-sinistra l’innamoramento per il partito democratico americano, frutto dell’incapacità di andare oltre la crosta superficiale, per mettere a nudo una realtà che venne a suo tempo liquidata da uno che se ne intende (Gore Vidal) con una definizione forse un poco enfatica: «negli usa esiste un solo partito della proprietà privata, con due ali destre, la repubblicana e la democratica». Sul piano della politica politicante la più rilevante conseguenza di questa dominanza ideologica (neo)liberista è l’attacco sistematico al Pubblico, servizi o patrimoni che siano. Alla denigrazione sistematica e alle reiterate accuse di sperperi ingiustificati fa riscontro una prospettiva di liquidazione, di marginalizzazione, di svendita. Insomma, la progressiva riduzione di ogni cosa e di qualsiasi attività alla natura di merce, cui viene a soggiacere sempre più un lavoro salariato privo di tutele contrattuali e normative. Mentre la forma-azienda assurge, nei discorsi e nella prassi, a ideale regolativo della organizzazione politica. Ettore Borghi G. LIGUORI, La morte del pci, manifestolibri, Roma 2009, pp. 191, 20 euro 10 ottobre 1990: «Occhetto presentava alla Direzione del pci la sua Dichiarazione d’intenti, il nuovo nome (Partito democratico della sinistra, pds) e il nuovo simbolo (una quercia con alla base il solito simbolo del pci, in piccolo). Subito dopo, senza aspettare il dibattito e ignorando le obiezioni che gli venivano da più parti, si recava in una sala stampa gremita e ripeteva davanti agli operatori dei media la presentazione». Una procedura che «già prefigurava quel “partito leggero”, leaderistico, d’opinione, massmediatico», paventato dagli esponenti del «fronte del no», ma visto con favore 187 da quanti, dentro o fuori dal partito, miravano al superamento dell’anomalia italiana rispetto alla presunta forma «normale» delle democrazie occidentali. Essendo condizione primaria per tale normalizzazione l’accoglimento nell’Internazionale socialista e l’avvio del complessivo sistema istituzionale verso un bipartitismo non più imperfetto. Al confronto appare in sordina l’evento che, per certi versi e almeno superficialmente, viene considerato l’esordio di tutto il processo di trasformazione. Domenica 12 novembre 1989: sede non ufficiale e non pubblicizzata anticipatamente (un raduno di ex partigiani nel quartiere della Bolognina), parole significative, ma generiche sulla necessità di «impegnarsi in grandi trasformazioni», presenza solo di due giovani cronisti (ansa e «Unità»), altrettanto generica dichiarazione ai medesimi sull’imminenza di «grandi cambiamenti e innovazioni in tutte le direzioni». Alle vicende che stanno fra quelle due date Guido Liguori dedica un’analisi serrata, che rende conto del dibattito interno e delle più interessanti voci esterne che si pronunciarono a favore o contro quella che, comunque vista, appariva una scelta di campo le cui implicazioni eccedevano il pur importante significato simbolico del cambiamento di nome e del progressivo allontanamento dall’uso di un linguaggio «di classe». Perché erano in gioco, secondo l’Autore, la sopravvivenza o la fine della «forma-partito-di-massa in Italia», con la conseguente, possibile «desertificazione della politica come partecipazione». Insomma, ciò che più distingue questo lavoro dalle ormai numerose ricostruzioni disponibili della storia ultima del pci è un pesante giudizio sull’attualità, l’amara constatazione che «oggi tutta la sinistra appare disastrata, quasi inesistente nel panorama politico italiano», per l’evidenza empirica che, nel suo divenire altro, il pci di allora ha dato avvio a esiti, «come tutti possono vedere», tutt’altro che felici. Da qui la necessità di dare ampio spazio alle «dinamiche soggettive che hanno portato a quell’esito», non soggiacendo alla presunta ineluttabilità deterministica degli eventi, per far luce sulle scelte e sulle loro motivazioni, sulle pressioni culturali che avevano progressivamente fatto sbiadire, agli occhi di molti, l’immagine di una forza antagonista rispetto alla società esistente e quella di un partito diverso. Sulla rinuncia, infine, a rivendicare come patrimonio da difendere la «funzione nazionale» svolta storicamente dal partito di Togliatti e Gramsci (non va dimenticato che il pensiero gramsciano è terreno peculiare delle ricerche dell’Autore). Ed è questo impegno che porta a considerare lo stesso evento Bolognina anche (o soprattutto) come punto di arrivo, dunque a far emergere: a) la speciale natura del pci (il suo avere «nome e cognome») all’interno del comunismo mondiale; b) le luci e ombre della conduzione di Berlinguer; c) il cambiamento di orizzonte generato dalla crescente affermazione dell’ideologia neoliberista a partire dalla metà degli anni Settanta. È indubitabile, per Liguori, che dal dopoguerra in poi il partito guidato da Togliatti – nella forma di «partito di massa e non solo di quadri» – avesse un carattere democratico e nazionale. Un partito-comunità fatto di un «intreccio di relazioni, solidarietà e grumi di vissuto condivisi nel tempo», dove già a metà degli anni Cinquanta la visione culturale di Gramsci aveva avuto il sopravvento sulla matrice marxista-leninista di marca sovietica: «Togliatti realizzò una politica di ispirazione gramsciana nei limiti in cui gli era consentito nel mondo di Jalta, ma seppe anche fare del pci un partito protagonista della costruzione della democrazia post-fascista in Italia». La domanda 188 che segue inevitabilmente è allora: quando e come si arrivò ad una formazione altra, in cui l’asserito valore primario dell’unità e la pratica del centralismo democratico mal dissimulavano la sostanza di un aggregato di indirizzi anche molto divaricati negli obiettivi e nelle strategie? Il punto focale viene dunque ad essere il cruciale passaggio dai Settanta agli Ottanta, gli anni di Berlinguer e della «questione morale», di cui Liguori illustra in modo convincente il valore politico, la presa sui fenomeni storici di fondo, dunque l’impossibilità di liquidarla come moralismo astratto o come semplice riflesso della personale sensibilità dell’uomo Berlinguer. Si stava determinando un’alleanza dc-psi (il futuro caf) come riflesso italiano di una situazione internazionale in cui «si diffondevano ideologie antidemocratiche, “decisioniste” o della “governabilità”, che guardavano con fastidio alla democrazia e alla domanda di partecipazione». Tutte premesse per condurre ad una possibile degenerazione del sistema politico, coi partiti trasformati in «macchine di potere e di clientela». Né del resto il psi poteva ritenersene del tutto immune. A livello strutturale molto era cambiato con gli anni: la gestione del potere locale come matrice di un «partito degli amministratori troppo tendente al compromesso», l’avvento di quadri portati a vedere la politica come sbocco lavorativo, un funzionariato assurto a posizioni di responsabilità dopo un curriculum in cui scarso peso ormai veniva ad assumere la formazione mediante le «scuole di partito». Senza dimenticare la forza attrattiva del psi craxiano, che induceva gli esponenti della destra interna a fare dell’unità coi socialisti la propria bandiera in polemica con Berlinguer. Il cui «sforzo prometeico» doveva fare i conti con limiti teorici e realizzativi. La morte repentina del leader – 11 giugno 1984 – lascia perciò sospesa la questione se, magari attraverso un appello alla società e ai movimenti, sarebbe stata possibile «la rifondazione di un progetto comunista adeguata all’Occidente». Abbandonato quel tentativo, iniziava la fine del pci, l’agonia degli Ottanta sino alla «morte non inevitabile, ma annunciata». Della successione di eventi, si è detto, Liguori traccia un quadro molto ricco di figure e di idee, senza appesantimenti. Una scena con tanti attori, le cui voci sono riferite col rispetto dovuto alla gravità e alla complessità del tema. Di questa lettura si potranno giovare in primo luogo quanti, mentre le vicende si svolgevano, le hanno seguite dall’esterno, come più o meno interessati spettatori (anche se Stendhal ci ha mirabilmente insegnato che non sempre lo stare nel cuore di importanti fatti storici rappresenta la migliore collocazione per comprenderli). Ancor più se ne potrebbero giovare quelli che sono venuti dopo, quelli – come nota ironicamente l’Autore – per cui picci suona «personal computer» e nient’altro. Un partito forte di un milione e mezzo di tesserati (reali), capace persino di mobilitare intorno a sé un dibattito culturale di inimmaginabile ampiezza, antagonista (almeno in prospettiva) al sistema esistente eppure votato dal trenta percento e oltre degli elettori, apparirebbe loro, per dirla col linguaggio appropriato, «roba di un altro pianeta». Ettore Borghi 189 E. GENTILE, Né stato né nazione. Italiani senza meta, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 110, 9 euro Emilio Gentile, già autore di un ponderoso studio sull’evoluzione del senso di identità nazionale degli italiani a partire dell’Unità, propone un’analisi dissacrante della convinzione comune circa la fiducia nel sistema democratico e l’orgoglio patrio. La diagnosi di Gentile non è ottimista. Essa trova fondamento nel presupposto – peraltro desunto dalle affermazioni di Massimo D’Azeglio – che gli italiani sono «i peggiori nemici dell’Italia unita», sconfessando l’interpretazione che attribuiva allo storico ottocentesco l’individuazione della necessità di «fare gli italiani» dopo che l’Italia era stata fatta con l’avvenuta unificazione. Si è trattato di una sintesi assolutoria per gli italiani, che non corrisponde al pensiero del D’Azeglio. «Gli italiani c’erano già – scrive Gentile –, ma erano i peggiori nemici di se stessi perché rimanevano gl’Italiani vecchi di prima dell’Unità», non modificando le abitudini e le convinzioni che avevano acquisito nel corso di secoli di lotte fratricide e di disuguali processi di crescita civile e sociale. Chi aveva confidato che la positiva conclusione delle battaglie per l’indipendenza e per l’Unità potesse significare l’assunzione di un nuovo modello di relazioni e il recupero di un senso di dignità nazionale, è rimasto deluso. E tale stato di cose si è ulteriormente aggravato con il trascorrere degli anni, tanto da farci trovare oggi a doverci confrontare con l’oblio della nazione, cioè l’idea di nazione ridotta a «vuoto simulacro, portato sulla scena per esigenze di copione, ma incapace di suscitare negli italiani ideali, sentimenti ed emozioni condivise». La ricostruzione dei passaggi che hanno portato alla situazione attuale evidenzia una condizione irreversibile. Maturata nel corso dei 150 anni che ci separano dall’Unità, la crisi si è accentuata per la «sclerosi di un sistema politico rimasto per decenni bloccato mentre la società tumultuosamente cambiava». Giungendo a delegare la definizione di questo aspetto della vita nazionale a «una coalizione della quale fa parte un partito, la Lega Nord, nato col proposito di disunire l’Italia perché non crede nell’esistenza di una nazione unica dalle Alpi alla Sicilia». Ma l’unico problema non è soltanto nella coalizione di governo: «l’apparato dello Stato appare in tutte le sue strutture un edificio con profonde crepe, e in molte parti percolante», per cui il popolo ha finito per perdere «la fiducia nella democrazia e si afferma un orgoglio nazionale che non contempla né onore né dignità». Gentile documenta – ricorrendo anche all’apporto di storici contemporanei come Giulio Bollati, Norberto Bobbio, Rosario Romeo e Renzo De Felice – lo svolgersi di questo percorso storico-culturale e definisce «fuochi fatui» le riviviscenze di orgoglio patrio che si sono manifestate negli anni Ottanta, in quanto ritiene che ad essi ha fatto seguito l’irruzione della Lega e la rapida adesione a propositi di divisione nazionale che configgono apertamente con gli ideali risorgimentali e con la lotta di liberazione dal nazi-fascismo. È un retaggio antico, afferma Gentile: tutte le feste di celebrazione dell’unità nazionale sono state occasione di divisione, a partire dal 1911 fino al 1961. Lo storico è ancora più drastico: anche i valori della Resistenza sono stati dispersi dalla guerra fredda e si è allargato un «oblìo della nazione» che pare portare alla fine dell’Italia unita in 190 quanto pare essersi consolidata «una decadenza che potrebbe diventare irreversibile». Le previsioni che gli Italiani siano senza meta, in netta controtendenza rispetto all’evolversi delle democrazie più evolute, lasciano perplessi, così come non genera speranze la constatazione che «un popolo sottoposto a un continuo ripensamento della propria identità, finisce per perderla o per diventare schizofrenico». L’ultima chance è nel recupero dei valori identitari che portarono i nostri avi a lottare nel periodo risorgimentale e nella lotta di liberazione poi, trovando la forza di debellare la crisi di fiducia nello stato e di recuperare un senso civico, con una nuova e diffusa partecipazione popolare alla politica. Un nuovo Risorgimento, dunque. Difficile e complesso da realizzare a 150 dall’Unità d’Italia, ma necessario per determinare una svolta nella cultura e nella prassi di vita collettiva che possano tutelare le nuove generazioni. Saremo capaci di tanto? Secondo Emilio Gentile la risposta è scontata e, tenendo conto dei fatti storici, purtroppo negativa. Ma l’Italia ha dimostrato di poter conseguire risultati apparentemente impossibili, quando matura una convinzione comune. Carlo Pellacani F. LOPES, E se l’Africa scomparisse dal mappamondo?, Armando Editore, Roma 2009, pp. 430, 33 euro La prima constatazione che nasce spontanea, leggendo la ponderosa opera di Filomeno Lopes, è di vivere una condizione di profonda ignoranza circa le vicende del continente africano, e più precisamente circa gli ultimi cinquecento anni della storia e della cultura di una terra che è comunque la culla dell’umanità. Per chiunque non viva in quella realtà (nella sua complessa e variegata sfaccettatura), ma anche per gli stessi abitanti di quell’area, il costo di questa diffusa carenza di conoscenza evidenzia il livello di considerazione della cultura occidentale d’ogni tempo. È una «svalutazione» che nasce dall’esigenza di affermare, per ragioni di convenienza, la logica di potere che ha caratterizzato ogni scelta politica e culturale del mondo occidentale nei confronti dell’Africa, a partire dalle valutazioni di filosofi importanti come Hegel e Nietzsche. Per il mondo occidentale l’Africa sembra non disporre di «oggetti e attributi in grado di far parte a pieno titolo della natura umana, e quando ciò avvenga, tali oggetti e attributi sono considerati di minor valore, meno importanti e di qualità inferiore». La natura elementare e primitiva dell’Africa diviene, così, l’universo per eccellenza di ciò che è incompleto, mutilato e non concluso. «E la sua storia è ridotta ad una serie di regressi allo stato di natura, la storia di un continente che va ancora in cerca dell’umanità», dice Lopes. Con il risultato di fornire un’immagine irreale dell’Africa, «opposta a ciò che è». Già da queste affermazioni emerge il taglio del lavoro di Lopes, e la denuncia esplicita di un uso distorto della storia, nonché di un’inqualificabile leggerezza degli Stati industrializzati nel considerare l’apporto dell’Africa alla costruzione del loro sviluppo economico e sociale. A queste valutazioni, frutto di una ricerca ampiamente documentata che delinea un percorso culturale che non si è arenato in lotte tribali o nello spazio angusto di collusioni di potere, Lopes aggiunge la proposta di quel progetto di «Rinascimento 191 africano» che era stato illustrato a Parigi nel 1948 da Cheikh Anta Diop e che è stato al centro degli incontri di Johannesburg del 1998. In quell’occasione, come aveva già fatto Nelson Mandela nel 1994, è stato sancito che «il XXI secolo deve essere il secolo del Continente africano», consentendo a quest’ultimo di conoscere «una nuova alba vitale», grazie all’assunzione piena, libera e responsabile della propria eredità storica, spirituale e culturale. È un passaggio importante, perché presuppone una riflessione filofosica e un’azione politica che consentano agli africani di «conoscere dall’interno i loro punti di forza e le loro debolezze», affermando «con maggior forza di non subire ciò che si è convenuto di chiamare globalizzazione, ovvero la negazione delle società, dei popoli e delle nazioni africane», partendo dalla terra come luogo di socializzazione e di produzione sociale, culturale e politica. Il popolo, in quest’ottica, è il vero protagonista storico della nuova stagione dell’Africa e può segnare la fine della reiterata falsificazione della storia che è stata adottata finora. L’appello di Lopes (giovane e affermato studioso che proviene da Guinea Bissau e che lavora di diversi anni a Roma presso Radio Vaticana) prende le mosse dalla consapevolezza del pericolo di implosione che attualmente attanaglia l’Africa intera, vittima di una recrudescenza di turbolenze e di violenze che sembrano trarre fondamento nei Programmi di aggiustamento strutturali elaborati dal Fondo mondiale e dalla Banca mondiale e che paiono confliggere con la ricerca di una soluzione definitiva del problema della povertà. Lopes si confronta con la realtà e propone un esame di coscienza a quanti chiedono ancora oggi di non considerare l’Africa. «Se l’Africa scomparisse dal mappamondo, come si evolverebbero le politiche di immigrazione dei Paesi europei? E quale giustificazione potrebbe darsi alla perdita di un patrimonio di cultura e tradizioni unico al mondo?» Gli interrogativi non restano senza risposta, perché Lopes, con misurata sensibilità, sollecita una rinascita della comunità africana che si attui facendo leva sulle proprie forze, più che sugli aiuti esterni. E propone un risarcimento storico e politico dell’evoluzione culturale e civile di un popolo cui dovrebbero essere riservate adeguate opportunità di sviluppo. Carlo Pellacani L. PAGGI, Il «popolo dei morti», La Repubblica italiana nata dalla guerra (19401946), Il Mulino, Bologna 2009, pp. 309, 24 euro Il saggio di Leonardo Paggi ricostruisce la nascita della Repubblica italiana da un punto di vista fino ad ora poco studiato, quale l’effetto dei bombardamenti angloamericani sulla popolazione civile e le loro conseguenze morali e sociali. La tesi portante è che gli italiani abbiano cominciato a maturare il definitivo distacco dal regime fascista quando questi proclamò di fatto la propria impotenza a proteggere le popolazioni urbane dalle incursioni aeree nemiche. L’ordine di Mussolini di sfollare le città venne visto come il segno più evidente dell’incapacità dello Stato fascista di garantire la condizione minima, basilare, sine qua non, perché lo Stato stesso possa esistere: garantire la vita dei propri cittadini. Per rimarcare questa condizione di azzeramento della 192 vita sociale e pubblica italiana, un vero e proprio «si salvi chi può», viene proposto il paragone con il modello britannico dove mai, nemmeno nei periodi più intensi della battaglia d’Inghilterra, il Governo decise di svuotare le città ed anzi più intensi che mai furono gli sforzi fatti per proteggere la popolazione. Protezione intesa non solamente come difesa fisica dagli attacchi aerei della Luftwaffe, ma anche come mantenimento, nei limiti del possibile naturalmente, delle condizioni di vita anteguerra. Una situazione resa possibile anche dall’intimo convincimento della popolazione britannica di combattere un conflitto giusto, la guerra di una democrazia contro una dittatura. La Resistenza viene vista come momento fondante della nuova democrazia italiana e viene analizzata attraverso fonti generalmente poco sfruttate in tal senso, vale a dire gli archivi comunali che raccolgono le testimonianze di un popolo che piano piano riprende coscienza di sé e dei suoi diritti nel reclamare aiuto per se stesso e giustizia e ricordo per i morti, senza distinzione fra caduti partigiani, morti nei bombardamenti o trucidati dai nazifascisti. La rinascita dello Stato avviene grazie al «popolo dei morti» (come lo definì Calamandrei), ossia grazie al tributo di sangue che l’Italia pagò alla seconda guerra mondiale e che divenne «la più importante fonte di legittimazione della rinata democrazia italiana ed europea». Michele Bellelli 193 Indice analitico «RS-Ricerche Storiche» dal 100 al 109 a cura di Glauco Bertani* Avvertenza: il presente indice analitico non comprende Atti e attività dell’Istituto né le recensioni. NB: La prima cifra corrisponde all’anno di pubblicazione, la seconda al numero della rivista, la terza al numero di pagina. PREFASCISMO – Politica – Società – Economia FERRABOSCHI ALBERTO, Le radici del modello reggiano. Società e politica a Reggio Emilia nel secondo Ottocento, 2007/103/131 –, Il «bardo» della montagna reggiana Gian Lorenzo Basetti e la democrazia radicale tra Otto e Novecento, 2008/106/9 MONTANARI FABRIZIO, Cento anni fa moriva Louise Michel, 1830-1905, 2005/100/136 MORATTI ALFIO, 1987. Garibaldini reggiani in Grecia. Una pagina di storia cittadina, 2009/107/81 FASCISMO/ANTIFASCISMO – Politica – Società – Economia BELLELLI MICHELE, Introduzione – «Dagli Arditi del popolo all’ANPPIA. Per una storia dell’antifascismo reggiano», 2007/104/7 –, Come muore una democrazia – ID, 2007/104/29 –, Una nazione al guinzaglio – ID, 2007/104/41 –, (a cura di), Documenti – ID, 2007/104/95 BONINI ELISA (a cura di), «Fui accusato di organizzazione comunista…». Intervista a Carlo Porta presidente dell’ANPPIA di Reggio Emilia – «Dagli Arditi del popolo all’ANPPIA. Per una storia dell’antifascismo reggiano», 2007/104/68 CARRATTIERI MIRCO, La guerra civile spagnola tra memoria e storia Saggio bibliografico, 2008/105/55 * Si ringraziano per la collaborazione Marco Marzi ed Elena Tedeschi. 194 FOLLONI DAVIDE, In Spagna sognando l’Italia – «Dagli Arditi del popolo all’ANPPIA. Per una storia dell’antifascismo reggiano», 2007/104/57 GIANOLIO ALFREDO, Fortunato Belloni e l’attualità dell’antifascismo, 2008/105/47 MONTANARI FABRIZIO, Vittorio Cantarelli. L’anarchico reggiano che organizzò un attentato a Mussolini, 2006/102/161 I numeri delle persecuzioni subite dal 1919 al 1943 – «Dagli Arditi del popolo all’ANPPIA. Per una storia dell’antifascismo reggiano», 2007/104/75 PAOLELLA FRANCESCO, Berneri in Spagna tra guerra e rivoluzione, 2006/102/147 PIGNEDOLI CLEONICE, L’Archivio della Direzione didattica di Castelnovo ne’ Monti. Eccoli i miei scolaretti… I registri scolastici degli anni 1942-43 e 194344, 2009/108/91 PONZETTA RAFFAELE, In difesa dell’ordine costituito: breve storia e funzioni della polizia in Italia dall’Unità alla fine della seconda guerra mondiale – «Dagli Arditi del popolo all’ANPPIA. Per una storia dell’antifascismo reggiano», 2007/104/10 RIATTI ADRIANO, RIATTI PAOLO, L’auto «made in Reggio». Utopia od opportunità perduta?, 2009/108/127 GUERRE COLONIALI, GUERRE MONDIALI BOLOGNESI DAVIDE, Traiettorie di vita attraverso la scrittura: due epistolari di contadini reggiani dispersi sul fronte russo (II parte), 2005/100/67 BONFRESCHI LUCIA, Lettere di un intellettuale-resistente: Raymond Aron a La France Libre durante la seconda guerra mondiale, 2005/100/182 CONTI AMOS, Gli aerei del duce cadono… ma non si dice!, 2008/105/79 CONTI AMOS, MORATTI ALFIO, 8 giugno 1916. L’affondamento del «Principe Umberto» Strage di soldati reggiani rivelata grazie agli «Albi della memoria», 2008/106/47 FANTINI LUCA, Dalla parte di Francisco Franco.«Volontari» reggiani nella guerra civile spagnola, 2009/109/52 FERRABOSCHI ALBERTO, La Grande guerra raccontata in tre libri, 2006/101/189 MORATTI ALFIO, 1° marzo 1896. I reggiani alla battaglia di Adua, 2008/105/99 RESISTENZA/GUERRA DI LIBERAZIONE – Occupazione tedesca – Repubblica sociale italiana DURCHFELD MATTHIAS, GOVI ANNALISA, Gombio 1944. «Haben dich deine Eltern so erzogen?». Due donne fermano la strage nazista, 2009/107/99 PIGNEDOLI CLEONICE, Gli internati slavi a Castelnovo ne’ Monti, 2006/102/99 ROMANI GIANFRANCO, Il timbro tedesco. Quando Cesare Campioli sfuggì alla Cattura, 2009/109/127 195 RESISTENZA/GUERRA DI LIBERAZIONE – Politica – Società – Economia ANCESCHI GIUSEPPE, Radici e piante della Resistenza italiana, 2008/105/187 FRIGERI MARIO, Finché c’è guerra… Economia e guerra civile a Reggio Emilia luglio 1944-aprile 1945 Appunti di ricerca, 2007/103/106 RESISTENZA/GUERRA DI LIBERAZIONE – Fatti militari – Vita partigiana BELLELLI MICHELE, Fabbrico. Una battaglia che non s’aveva da fare?, 2006/102/127 – (a cura di), Le liberazioni. Tre testimonianze in «diretta», 2007/103/150 BERTANI GLAUCO, CONTI AMOS (a cura di), 62° della Liberazione. Le foto della Liberazione di Reggio Emilia, 2007/103/143 MATTIOLI RODOLFO, Tre ragazzi uccisi. L’eccidio di Gavassa, Reggio Emilia 22-23 aprile 1945, 2008/106/101 STORCHI MASSIMO (a cura di), Dossier Cernaieto. La cattura e l’uccisione del presidio GNR di Montecchio 22-24 aprile 1945, 2007/104/123 DOPOGUERRA – Società – Politica – Economia BELLELLI MICHELE, Scacco matto alle Reggiane, 2007/103/49 – (a cura di), Ricostruzione postbellica: la polizia economica partigiana Intervista a Fernando Cavazzini Toni e Brenno Orlandini Ramis, 2007/104/155 –, 1946 e dintorni, La ricostruzione a Reggio Emilia, 2006/102/141 CAMURANI ERCOLE, Tracce reggiane di Luigi Einaudi: Arturo D’Aversa. L’economia reggiana nella Relazione della Banca d’Italia nel 1946, 2009/107/7 CANTONI SERENA, «Concueste poche righe», due famiglie reggiane migranti tra Castelnovo Sotto e l’Argentina, prima parte, 2009/108/29 –, «Concueste poche righe», due famiglie reggiane migranti tra Castelnovo Sotto e l’Argentina, seconda parte, 2009/109/5 CARRATTIERI MIRCO, Ricostruire la Ricostruzione: bipolarismi, triangoli rossi e… teste quadre, 2007/103/9 COOKE PHILIP, Da partigiano a quadro di partito: l’educazione degli emigrati politici italiani in Cecoslovacchia, 2006/101/9 GUARDASONI GIAN FRANCA, Breve storia del CIF a San Martino in Rio, 2007/103/100 GUARNIERI ROMEO, 1945-1946. L’economia reggiana in alcuni documenti, 2009/107/66 –, La politica comunista dopo la guerra di liberazione: nel governo locale, nell’economia e verso i ceti medi, 2005/100/43 MAGNANINI GIANETTO, 1945-1946. Reggio Emilia nel contesto della ricostruzione. Alcune riflessioni sull’economia reggiana, 2009/107/59 MENABUE FEDERICA, I primi passi dell’associazionismo femminile a Reggio Emilia: l’esperienza di UDI e CIF negli anni della Ricostruzione, 2007/103/78 SALVINI ELISABETTA, Dalla Resistenza alla Ricostruzione. Il lungo maternage delle donne reggiane, 2007/103/62 196 SOLIERI FABRIZIO, Criminalità comune e vita quotidiana a Reggio Emilia dopo la liberazione (1945-1946), 2007/103/88 DOPOGUERRA – Storia – Storiografia BUSANI VALDA, Le ragioni e le modalità della ricerca. (Postfazione contenuta in V. Busani, «C’era freddo dentro il cuore di tutti...», ricerca sui fatti del 1° gennaio 1945 a Scandiano e ad Arceto, Scandiano 2008), 2008/106/147 CARRATTIERI MIRCO, 07-07-07: Perché «commemorare» non significhi «imbalsamare», 2007/104/187 CASALI LUCIANO, Terrorismo fascista, 2008/106/153 CONTI AMOS, I fratelli Cervi. Sepolti in segreto e riesumati dalle bombe, 2007/103/11 –, Un’altra conferma sul caso «Gelindo Cervi» La testimonianza di Pierino Beggi, 2007/104/145 –, La fantomatica sentenza di condanna a morte dei fratelli Cervi. Ecco la prova che non fu mai scritta, 2008/105/165 MACCAFERRI MARZIA, La stampa cattolica di Reggio Emilia, 1945-1951. Nuovo intransigentismo o pedagogia democratica?, 2009/108/9 PAOLELLA FRANCESCO, Il problema delle fonti nella ricerca sulla deportazione dall’Italia, 1943-1945. Museo della Deportazione di Prato, 7-8 dicembre 2005, 2006/101/179 –, «Rastrellati e deportati». La repressione antipartigiana e l’internamento nei Konzentrationslager. Istituto storico di Parma, 8-9 maggio 2006, 2006/102/183 TAURASI GIOVANNI, Modena nel difficile dopoguerra. Appunti su storiografia e fonti inedite, 2007/103/41 VILLA ROBERTO, La Costituzione italiana e il contributo reggiano, 2005/100/167 MEMORIE – BIOGRAFIE BARAZZONI RENZO, In memoria di Gaetano Arfè (1925-2007), 2007/104/4 BECCHI MICHELE, Theobaldo Antonio Kopp. Il partigiano Guglielmo, 2009/108/109 BELLELLI MICHELE, Luigi Spoto: un eroe nascosto?, 2007/103/140 BOCCOLARI GIORGIO, Un Archivio «che parla tanto di lui». La documentazione cartacea e multimediale di Cesare Zavattini, 2008/106/67 CAMURANI ERCOLE, Il Presidente e il Cappuccino. I rapporti tra Luigi Einaudi e padre Placido da Pavullo, 2008/105/9 CATTANI CESARE, Fermo Ognibene prima del comando del battaglione «Picelli», 2007/104/111 FONTANESI ALESSANDRA, SQEUU. Intervista ad Andrea Talmelli, 2009/108/150 FRIGERI MARIO, Il caso Disteso: la mancata rivolta dei carabinieri contro Salò. Rapporto su una ricerca in corso, 2006/101/39 GRAPPI HERMES, Osvaldo Salvarani, «Un socialista weberiano», 2008/106/119 197 MORETTI ANDREA, Il caso Piron. Voci di un cippo partigiano, 2005/100/129 MORINI DANILO, Attivo Resistente. In memoria di Ermanno Dossetti, 2008/105/5 PAOLELLA ANDREA, «Io e Giovannino Guareschi: due emiliani internati militari in Germania». Intervista a Gaetano Montanari, 2008/106/91 PELLINI UGO, Temistocle Testa, 2006/101/45 –, Giuseppe Cancarini Ghisetti. Il partigiano combattente dei servizi segreti, 2008/105/37 VERGALLI TERESA, Claudio Truffi, un reggiano trapiantato per l’Italia. Un percorso di vita, 2006/101/65 DIDATTICA BORGHI BEATRICE, DONDARINI ROLANDO, Insegnare storia con efficacia e qualità rinnovate in tempi di crisi e di involuzione del sistema scolastico, 2009/109/159 CAPITANI LORENZO, L’anno della Costituente, 2005/100/157 CAPITANI LORENZO, FONTANESI TIZIANA, MONTANARI PAOLA, PARTESOTTI BRUNETTA, Progetto in rete. La costituzione della cittadinanza, 2009/109/174 CICCIU’ LOREDANA, Piccola-grande storia della Resistenza. Un’esperienza didattica, 2009/107/155 DURCHFELD MATTHIAS, Intervistiamo… la nostra storia. I Ragazzi di Vezzano, 2008/106/125 FERRETTI MARIA ASSUNTA, Interrogare un popolo di statue. Itinerari didattici sui monumenti di rilevanza storica, 2005/100/145 FONTANESI ALESSANDRA, Ora che siamo a Reggio Emilia. Percorsi di cittadinanza attiva per cittadini migranti attraverso feste e ricorrenze, 2007/104/167 –, Quando la «piccola» storia racconta quella «grande». ERA-European Resistance Archive (Archivio Europeo della Resistenza), 2007/104/171 –, Le attività didattiche di Istoreco a.s. 2007-2008, 2008/106/143 –, Come insegnare la storia della Shoah? Una riflessione sul contenuto, sul metodo e sulla formazione dei formatori, 2008/106/131 –, Relazione attività didattiche Istoreco a.s. 2008-09, 2009/108/181 GUERRA LUIGI, Educazione al patrimonio e alla cittadinanza nella formazione del docente di storia, 2009/109/167 MORANDO MARIA PAOLA, ZAGATTI PAOLA, Istoreco in viaggio. «Trieste fascistissima» e «Lubiana italiana» giovedì 4-domenica 7 dicembre 2008, 2007/107/145 MORINI MAURIZIA, Agli studenti direi…, 2005/100/161 MUSSINI LORENA, Un tempo nel tempo. Sassuolo e le trasformazioni del ’900. Giornata di studi. Sassuolo 29 maggio 2005, 2006/101/103 –, La storia insegnata tra problemi e prospettive L’esperienza del laboratorio di didattica della storia Sassuolo-distretto scolastico n. 19-Rete istituti superiori, 2007/103/161 198 –, Reportage da una giornata di studi «Mettiamo in agenda una nuova politica per la storia! Riflessioni e proposte sul curricolo verticale», Modena 6 novembre 2006, 2007/103/172 EBRAISMO CAMPAGNANO GIULIO, Una traversata sciistica. Un ebreo in fuga dai nazisti, 2009/109/142 CATELLANI ANGIOLINO, Giorgio Finzi. Un Ebreo triestino-campagnolese nella temperie dell’ultimo conflitto mondiale, 2007/107/129 –, Giorgio Finzi, Kaddish per zia Clotilde, 2009/108/161 PAOLELLA FRANCESCO (a cura di), Intervista. Da un incontro con Piero Terracina, deportato ad Auschwitz-Birkenau, 2007/103/177 –, Su Liana Millu: deportata, scrittrice, moralista, 2008/105/179 –, Antisemitismo italiano di Stato, 2008/106/27 EDITORIALI BORGHI ETTORE, Riflessioni su un anniversario, 2008/106/5 CARRATTIERI MIRCO, in ricordo di Franco Boiardi, 2009/108/5 MAGNANINI GIANNETTO, Prospettive di lavoro, 2005/100/7 STORCHI MASSIMO, Un altro 25 aprile, 2006/101/5 ETA’ REPUBBLICANA BONAZZI RENZO, La costruzione del sistema Emilia, 2008/105/149 BORGHI ETTORE (a cura di), L’autonomia al lavoro: comune e infanzia. Intervista a Loretta Giaroni su Scuole e nidi comunali, 2006/101/57 CAPITANI LORENZO (a cura di), «Vado al Moro» Documenti e testimonianze, 2008/106/113 –, Vado al «Moro» 2. Perché il II liceo scientifico si chiama così. Interviste a Gino Molini e Ignazio Vignali, 2007/107/139 GRAPPI ENZO, Immigrazione, flessibilità del lavoro e lavoro nero. Il nuovo profilo sociale di Reggio Emilia, 2006/101/147 PAOLELLA ANDREA, Luciano Serra: Pasolini come me lo ricordo. Intervista al poeta e scrittore reggiano, 2008/105/155 –, Libero Riva. Due anni nell’Agro Pontino, 2007/107/121 –, Ivan Bondi. Quel che ricorda un reggiano del Vajont. Intervista, 2009/108/137 PAOLELLA FRANCESCO (a cura di), Il «San Lazzaro» e il movimento antimanicomiale italiano. L’esperienza reggiana. Intervista a Christian De Vito, 2009/109/149 RICCO’ GIAN FRANCO, «Modello emiliano»: lavoro e coesione sociale a Reggio Emilia, 2006/101/161 RINALDINI TIZIANO, Militanza, violenza e politica attraverso e oltre gli anni Settanta. Una riflessione, 2008/105/131 ARGOMENTI INTERNAZIONALI 199 FERRETTI ALESSANDRA, La costituzione spirituale della Repubblica federale tedesca, 2005/100/188 FRATTINI GIULIA, Legittimazione e potere, il sistema DDR. L’antifascismo di Stato e le pratiche di legittimazione del potere nella Repubblica democratica tedesca, 2006/102/171 ILARI MASSIMILIANO, La giustizia di Franco. La repressione franchista e il movimento libertario spagnolo (1939-1951), 2007/104/180 ATTI CONVEGNI «MEUCCIO RUINI e le radici della Costituzione repubblicana», Reggio Emilia, 19 novembre 2005, Atti del convegno – 2006/102/5-79 – ZAMBONELLI ANTONIO, Meuccio Ruini (1877-1970), 2006/102/5 – BOJARDI FRANCO, Meuccio Ruini tra Belle époque e Italia repubblicana, 2006/102/9 – MARCUCCIO ROBERTO, L’archivio Meuccio Ruini presso la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, 2006/102/13 – FERRABOSCHI ALBERTO, Meuccio Ruini e la vita politico-amministrativa a Reggio Emilia nell’età giolittiana, 2006/102/29 – CARRATTIERI MIRCO, Tra impegno ed evasione Meuccio Ruini storico, 2006/102/51 – CAMPANOZZI SIMONE, Meuccio Ruini. Il pensiero politico e giuridico di un padre della Costituzione, 2006/102/79 VARIE BELLELLI MICHELE, L’album del marinaio Fernando Notari. Una nuova acquisizione per la fototeca di Istoreco, 2009/108/121 –, La X flottiglia Mas. Alcune brevi note, 2009/109/181 BELLU’ FRANCESCA, Ecolinguistica dell’italiano negli Stati Uniti. Dinamiche del processo di perdita linguistica tra gli emigrati italiani nel territorio statunitense, 2006/101/169 BERTANI GLAUCO, Indice analitico. RS dal 1° fascicolo al n. 99, 2005/100/217 BORGHI ETTORE, Una disputa settembrina, 2008/106/159 CARRATTIERI MIRCO, RileggendoSi. Appunti per una storia lunga cento numeri, 2005/100/13 CONTI AMOS, Gli Albi della Memoria: le tecnologie informatiche, supporto essenziale per la ricerca storica e per la conservazione attiva della memoria, 2006/101/119 In difesa della libertà di stampa, 2009/108/181 PAOLELLA FRANCESCO, Camus in rivolta. La separazione da Sartre, 2005/100/176 PELLACANI CARLO, Arte e design nel mondo diviso (A margine di una mostra al MART di Rovereto), 2009/109/187 –, Classificare, pensare, escludere. Un importante seminario di formazione per 200 docenti, 2009/109/188 STORCHI MASSIMO, La Memoria della città-Polo Archivistico Un progetto per la comunità reggiana del XXI secolo, 2006/101/139 201 (1,1) -1- 102765_RS_110_cop.indd 04/11/10 10:12 All’interno: Valerio Onida, «Com-memorare», Fare memoria insieme. Reggio Emilia, 25 aprile 2010 Lorenzo Capitani a cura di, Renzo Bonazzi e il ’68 a Reggio Emilia Massimo Storchi a cura di, Special operation executed di Mike Lees, prima parte Realino Ferretti a cura di, Orlando Ferretti, il mio diario. Campagnola Emilia, ricordi della Liberazione Massimo Storchi (a cura di), Dr. Eugenio Amonn, Lugano, via Loreto 10. Tre lettere di Eugene Dollmann a Dino Prandi (1952-1968) Francesco Paolella, Maria Bertolani Del Rio. La Colonia-scuola «A. Marro» di Reggio Emilia e il regime fascista Bruno Grulli, Un «piper» scozzese tra i partigiani reggiani. Vive in Scozia il suonatore di cornamusa che partecipò all’attacco di Botteghe Mario Frigeri, Gismondo Veroni. Una biografia Flavio Parmiggiani, Giuseppe Moruzzi: un ricordo personale Lorena Mussini a cura di, «Les chemins de la memoire», Villa Emma (Nonantola-Italia)Maison D’Izieu (Lione-Francia) Salvatore Trapani, Auschwitz e la sua memoria Benedetta Guerzoni, Disincanto africano Nicola Mai, Remo Cantoni e l’impegno politico-culturale Sandro Chesi, Sandro Spreafico. I cattolici reggiani dallo Stato totalitario alla democrazia Recensioni Glauco Bertani (a cura di), Indice analitico «RS-Ricerche Storiche» 100-109 € 0 ,0 13 ISSN: 0035-5070
Scarica