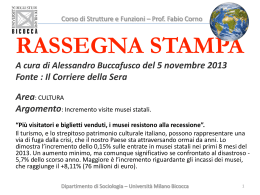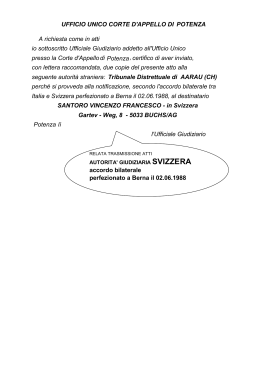Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère Association des Amis du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère I Musei della seconda guerra mondiale nelle Alpi occidentali tra passato e futuro 23, 24, 25, 26 NOVEMBRE 2005 TORINO/GRENOBLE Articolato in sei sedute consecutive, il convegno si è svolto in due tempi: • 23-24 novembre a Torino, presso il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà. • 25-26 a Grenoble, presso la Maison des Sciences de l’Homme, nel campus universitario. Sedi del Convegno TORINO 23-24 novembre Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà Palazzo dei Quartieri Militari Corso Valdocco, 4a (angolo via del Carmine) GRENOBLE 25-26 novembre Maison des Sciences de l’Homme-Alpes 1221 Avenue Centrale Domaine universitaire 38400 Saint-Martin-d’Hères 2 A sessant’anni dalla fine del secondo conflitto mondiale tre Paesi della regione alpina occidentale, l’Italia, la Francia, la Svizzera, mettono a confronto la rispettiva elaborazione della memoria di quegli eventi e le forme della sua rappresentazione. Dal confronto risultano realtà molto diverse: in Francia, dove si riscontra una fitta presenza di musei della Resistenza e della Deportazione, già da tempo è stato posto il problema del loro futuro e delle loro trasformazioni, dopo la fine dell’“era dei testimoni”. In Svizzera si supplisce in questi ultimi tempi, con frequenti e pregevoli mostre documentarie, a quella che può essere definita una “lacuna della memoria”. In Italia, dove i rari musei della Resistenza hanno sempre avuto vita stentata, si assiste in questi ultimi anni ad un infittirsi di iniziative, che mettono a frutto l’esperienza di ricerca e di formazione didattica degli Istituti storici della Resistenza e della società contemporanea. In tutte queste realtà ci si deve confrontare con i problemi legati al futuro di musei, centri di documentazione e luoghi di memoria dedicati alla Resistenza, alla Deportazione e più in generale alla storia della Seconda guerra mondiale: problemi di rinnovamento dei contenuti e delle forme di comunicazione, nonché di disponibilità politica ed economica dei governi e delle comunità locali. Intorno a questi interrogativi è stato organizzato il convegno internazionale che ha avuto luogo dal 23 al 26 novembre a Torino ed a Grenoble. In collegamento con queste sessioni, il 13 e 14 dicembre 2005 si è svolto a Modena il seminario Luoghi per la memoria, luoghi per la storia a cura dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Modena. Sono state discusse, in tre sessioni, le esperienze di valorizzazione dei luoghi di memoria della Seconda guerra mondiale realizzate in alcuni Paesi europei, con un’attenzione specifica alla loro valenza formativa e alla promozione del territorio e delle culture locali. 3 TORINO 23-24 novembre 2005 1. LA POLITICA DELLA MEMORIA (E DELL’OBLIO) 2. RAPPRESENTAZIONI E IMMAGINI NEI MUSEI 3. NUOVE MEDIAZIONI 4 TORINO 23-24 novembre 2005 Seduta inaugurale mercoledì 23 novembre Ore 9 Intervengono: Gianni Oliva, Assessore alla Cultura della Regione Piemonte Valter Giuliano, Assessore alla Cultura della Provincia di Torino Fiorenzo Alfieri, Assessore alla Cultura della Città di Torino Antonio Monticelli, coordinatore del progetto Interreg Memoria delle Alpi/Mémoire des Alpes 1. LA POLITICA DELLA MEMORIA (E DELL’OBLIO) mercoledì 23 novembre, ore 9,30 In che modo si è fondata la conoscenza storica della Seconda guerra mondiale in ciascuno dei tre Paesi delle Alpi occidentali: Francia, Svizzera, Italia? Questa prima domanda mira a porre in luce i differenti approcci storiografici ed i rapporti fra storiografia e uso pubblico della storia. Presiede Claudio Dellavalle, Università di Torino, presidente dell’Istituto piemontese per la SAtoria della Resistenza e della società contemporanea Musei e uso pubblico della storia Giovanni De Luna, docente di storia contemporanea, Università di Torino La memoria della seconda guerra mondiale in Francia Philippe Barrière e Gil Emprin, docenti di storia, incaricati del Servizio educativo del Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère Pausa caffè Politiche della memoria e rappresentazione della storia nazionale nell’Italia unita Massimo Baioni, docente di storia contemporanea, Università di Siena La memoria della seconda guerra mondiale nella Confederazione Elvetica Claude Hauser, docente di storia contemporanea, Università di Friburgo (Svizzera) Discussione 5 Philippe Barrière et Gil Emprin - La memoria della Seconda Guerra mondiale in Francia Introduzione: possibili approcci e scelta della sintesi. Esistono varie possibilità per l’approccio di questo tema, tutte interessanti, di cui ognuna possiede la propria logica: 1) si potrebbe iniziare con l’ispirarsi del lavoro teorico dei sociologi (Halbwachs, il primo, e Namer) e dei filosofi (il primo dei quali è sicuramente Ricoeur), raggiunti, tardivamente è vero, dagli storici (Wahl per il primo convegno, Nora e i Luoghi… e Rousso, per la sua Syndrome de Vichy) e i politologi (Marie-Claire Lavabre), che confrontano le proprie analisi per definire i campi di competenza della memoria e della storia, quindi per esaminare i rapporti, spesso conflittuali che intrattengono queste due istanze di interrogazione del difficile passato della 2° guerra mondiale; 2) si potrebbe invece scegliere la cronologia pura, che sonderebbe le grandi tappe della costituzione di una memoria, vista soprattutto dal punto di vista dello Stato, principale ordinatore di questa memoria storica nazionale; 3) l’ottica tipologica potrebbe essere un altro approccio, con una duplice domanda: quali sono i grandi tipi di memoria, che plasmano dei discorsi particolari, ogni volta singolare, su un passato storico comune, quello della “situazione storica estrema” (Tzvetan todorov) quale è stata per i Francesi la Seconda Guerra mondiale; quali sono i vettori di queste memorie plurime– e tra questi vettori, ovviamente, i musei?; 4) quarta possibilità: l’approccio politico, che porrebbe un’altra domanda, quella importantissima della strumentalizzazione delle memorie della 2° Guerra mondiale, ossia delle risorse che procurano ai concorrenti politici della seconda parte del novecento francese, nello scontro tra due pretendenti al monopolio memoriale, che sono lo stato gollista ed i suoi intermediari, e il PCF ed i suoi intermediari. Ma è l’oggetto stesso di questo convegno ad orientare questa breve presentazione, la cui ambizione è chiaramente la sintesi. Per noi si tratta di provare ad esprimere, in modo critico naturalmente, le singolarità nazionali francesi prima di confrontarle con altre. A questo titolo, vogliamo, Gil ed io, mettere in luce le peculiarità (non diciamo le eccezioni!) francesi. I – Attori di memoria. A grandi linee si possono discernere quattro gruppi di attori che, ad un titolo che ognuno di loro ritiene evidentemente legittimo, intendono partecipare alla costruzione della rappresentazione, diciamo “culturale” per rimanere sufficientemente generici, della Seconda Guerra mondiale. A) Il primo di questi attori è lo Stato, ben inteso, che forte dei suoi legali intermediari (la Giustizia, la Pubblica Istruzione, il monopolio dell’informazione audiovisiva, ecc.), riesce a farsi sentire per primo, ma non come unico. Per lo stato repubblicano, si tratta – ed è questa una costante che si ritrova sul periodo relativamente lungo che dura tutto il “secondo novecento” francese – di un triplice obiettivo: deve affermare la propria preminenza in materia di decifrazione dell’evento (ad esempio è lui a stabilire il calendario commemorativo, sforzandosi di privilegiare la continuità e di avvicinare l’11 novembre all’8 maggio, in un’ottica nazionale per non dire nazionalista), vuole conservare il monopolio nell’impartire le lezioni storiche che bisogna trarne (in particolare grazie agli insegnanti che devono fidarsi delle Instructions Officielles che il ministero pubblica per insegnare quel periodo; ricordarsi che la storia del regime di Vichy, nella sequenza della Seconda Guerra mondiale, fa parte del programma di storia dei licei nel 1961-1962 e nel 1966 per le 5° ad esempio) e di severo inquadramento dei vettori e supporti di memoria (il 23 aprile 1966 – data della Giornata nazionale del ricordo della Deportazione – e non è un caso, viene ufficialmente inaugurato il « musée de la Résistance Dauphinoise », a Grenoble: il museo di Grenoble fa quindi ben parte di questo “un quarto circa” di musei che vengono creati fra il 1954 ed il 1979 e si piazza vicino ad importanti realizzazioni tutte segnate dal sigillo dello stato, come il musée de l’Ordre de la Libération di Parigi, quello di Besançon oppure il Centre Jean Moulin di Bordeaux). 6 B) La seconda voce proviene da un gruppo di attori che chiamerei volentieri attori sociali. I partiti politici (primus inter pares, il PCF, che dispone di una forza quasi altrettanto importante dello stato gollista, con però in meno il potere di stato; questo punto dei rapporti tra questi due mastodonti merita per altro uno sviluppo, tanto il confronto nella connivenza struttura la memoria francese della 2° Guerra mondiale), i sindacati, le associazioni naturalmente, le Chiese (le “forze vive” della Nazione per dirlo in fretta), ma anche delle personalità che intervengono a proprio nome, individui con una statura pubblica riconosciuta, compongono questa nebulosa che, diversamente dallo stato, non può esprimersi con una sola voce. Queste voci, al proprio posto a seconda della tematica che li caratterizza (politica, sociale o morale), ritengono di avere anch’esse da dire sulla vicenda ed i loro propositi fanno pienamente parte del processo di codificazione memoriale. La popolazione – intendo dire l’opinione – è tanto più portata ad ascoltarle che considera i possessori di queste voci come degli “opinion leaders” tradizionalmente incaricati di spiegarle il mondo. Simultaneamente, risuona, talvolta frammentario ma essenziale, l’eco della voce delle associazioni di ex combattenti e deportati. Le numerose associazioni che sono nate alla Liberazione sono spesso di categoria e spessissimo categoriche. Esse continuano ad essere al tempo spesso luoghi del ricordo con una socievolezza molto particolare (nel senso di posti riservati dove delle persone che hanno vissuto la stessa esperienza possono ritrovarsi nel nome di un patrimonio che solo esse condividono), e degli attori di memoria incaricati di difendere un’eredità di memoria “contro” un presente che per definizione è evolutivo e dimentico. Conosciamo tutti questa figura tipica dell’ex resistente/deportato/testimone che in qualche moda “presentifica” la memoria tramite i propri ricordi personali. C) Terza categoria, gli attori professionisti, ossia quelli di cui il mestiere è quello di proporre al pubblico un discorso sulla guerra costruito secondo le proprie aspirazioni. Penso innanzitutto agli storici (si conosce il peso di alcuni studi, di cui Laurent Douzou ha recentemente ricordato l’importanza: il libro di Robert O. Paxton, all’inizio degli anni ‘70, naturalmente, ha contato perché La Francia di Vichy è innovatore in tre modi – sguardo statunitense esogeno; utilizzo degli archivi tedeschi; dimostrazione della Collaborazione volontaria di Vichy. La storiografia fu cambiata per sempre. Ma gli storici non sono gli unici al lavoro. Non dimentichiamo le istituzioni culturali, musei e memoriali della guerra, di cui si conosce, ma ne parleremo in questi quattro giorni, la frequentazione e il peso sociale. Infine, anche se non è di certo il minore di questi “professionisti”, i media audiovisivi, onnipresenti, “onnidicenti”, onnipotenti, anche se varia il loro registro espressivo (Vedi i film, documentario di qualità anche se molto orientato per Il dolore e la pietà, e Shoah, di Lanzmann, che impone il termine Shoah per qualificare il genocidio degli Ebrei d’Europa; fizione di qualità anche se orientata anch’essa per Lacombe Lucien e Arrivederci ragazzi, di Louis Malle; ma anche servizi e fictions sul modo alla moda del docu-dramma delle grandi reti televisive – Vedi gli improbabili Jean Moulin che di recente hanno invaso il piccolo schermo). Ciascuno di questi attori principali vive una particolare attesa nei confronti dell’”oggetto” Seconda Guerra mondiale e ha quindi un diverso discorso. Per farla breve, per lo stato si tratta di dire la legge ed il diritto; per le associazioni di ex, di difendere un discorso della fedeltà, attraverso un sovra-investimento memoriale talvolta problematico; per gli storici al contrario, di costruire un sapere ed una riflessione razionali; per i musei di attrarre pubblico; per i media di fare audience... II - L’evoluzione dei rapporti storia/memoria della Seconda Guerra mondiale tra il 1944/45 e i giorni nostri è oggigiorno ben segnata, grazie a numerosi lavori; ricordiamo rapidamente i principali tempi di questa genealogia memoriale, con alcuni riferimenti cronologici: A) il tempo della memoria della Seconda Guerra mondiale esiste… prima ancora che questa finisca. Una delle maggiori preoccupazioni dei resistenti, quale che fosse il loro orientamento politico, era di pensare all’organizzazione della memoria del combattimento durante lo stesso, di utilizzare il passato per vincere la battaglia presente e di inserire questo episodio in una lunga storia nazionale decisamente eroica (riferimenti a Valmy, al 14-18, alla Rivoluzione, agli 7 Allobroges; es. del 11 novembre 1943 a Grenoble, ecc.); questo periodo dura la durata della 2° Gm; B) la concorrenza nell’intesa (resistenti molto maggioritari e al potere, posto della Francia nel mondo, visione nazionalistica della storia) tra de Gaulle e i comunisti che considerano la memoria della guerra e particolarmente della Resistenza come un serbatoio a cui attingere la propria legittimità politica (il primo resistente contro il mito del partito dei 75.000 fucilati); questo periodo dura dal 1945 al 1968, con delle crisi e periodi di remissione ovviamente, che non abbiamo tempo di analizzare oggi; C) il fenomeno di ritorno del bilanciere (o come si passa da una visione eccessiva dei Francesi tutti resistenti– il famoso “esistenzialismo”– alla visione altrettanto oltranzista ma esattamente opposta di una Francia codarda, popolata da bastardi e collaborazionisti); questo periodo è quello degli anni ‘70 e ‘80 e della moda del “vade retro Satana” (che segue i primi tentativi di riabilitazione di Vichy, che ebbero poco successo pubblico: Aron e i crimini dell’”epurazione selvaggia”, Rémy e la teoria della “spada e dello scudo”, l’ADMP : Pétain = Verdun e non Montoire, ecc.) come l’ha denominata Pascal Ory in particolare; D) l’irrompere della memoria della Shoah (lavoro paziente di Klarsfeld + Shoah di Lanzmann) e le sue conseguenze nel cambiamento di prospettiva della memoria generale della Seconda Guerra mondiale, ora adombrata dalla tardiva presa di coscienza (i processi per crimini contro l’umanità degli anni ‘80 e ‘90) ma definitiva del peso del genocidio e delle responsabilità francesi nel suo svolgimento (Chirac nel 1995). Questo fenomeno è sicuramente in parte alla base del successo sociale sorprendente del 60° anniversario della Liberazione (2004) e del 60° anniversario della scoperta dei campi (2005), di cui possiamo testimoniare per la situazione di Grenoble e della Francia; gli anni ‘90 e fino a quando?; E) il passaggio – che forse si sta operando in questi primi anni del XXI secolo– ad un'altra ossessione di memoria, quella delle guerre di decolonizzazione: l’Algeria, nuova sindrome? III La storiografia di fronte al peso delle memorie A) Una storiografia sotto influenza: 1944 – anni ‘70 In questo contesto di memorie dominanti, pesanti perché strumentalizzano i fatti, era difficile scrivere una storia scientifica. Eppure, fu una preoccupazione immediata, fin dal 1944 per il Governo provvisorio della Repubblica Francese (GPRF) riunire i fondi documentari sull’occupazione e la liberazione. La Commissione di storia dell’Occupazione e della Liberazione della Francia (CHOLF) facente capo al Ministero della pubblica istruzione, inizia a lavorare sulla Resistenza, mentre il Comitato di Storia della Guerra creato nel 1945 sotto l’autorità della presidenza del Consiglio, riunisce fondi di vari ministeri. Ne fanno parte storici rinomati: Pierre Renouvin, Lucien Febvre, Henri Michel. Dalla fusione di questi nasce il Comitato di Storia della Seconda Guerra Mondiale (CHGM) nel 1951 e la Revue d’histoire de la 2èm GM.. Henri Michel scrive il primo “ Que sais-je “ sulla Resistenza nel 1950. Però il lavoro meticoloso e utile del CHOLF e del CHGM è un lavoro di accumulo di dati, spesso effettuato dai corrispondenti dei dipartimenti. Non viene fatta molta sintesi, perché è sotto pressione da parte di gruppi e di “grandi testimoni”. Non si è potuta fare opera di divulgazione, quando si era ad esempio stabilito con molta precisione i numeri e le condizioni dell’epurazione. E’ più utile oggi,per rileggere il periodo (utile per la mostra ‘maquis’ ad esempio.) Questo lavoro è rimasto soffocato sotto il peso dei grandi testimoni (i libri di Yves Farge nel 1946, Guillain de Bénouville, le Memorie di De Gaulle nel 1954) delle polemiche, delle memorie concorrenti. La storiografia della deportazione subisce le stesse pressioni: i lavori del Centre de Documentation Juive Contemporaine (CDJC), nato a Grenoble nell’aprile 1943, sono rimasti confidenziali, mentre erano già molto avanzati (1955 Joseph Billig sul Commissariat aux Questions juives) Gli anni ’60 sono gli anni del consenso esistenzialista, con Jean Moulin al Panthéon, musei della Resistenza, Concorso scolastico 8 B) Verso la fine della sindrome: 1973-2005 1 : avanzate storiografiche venute dall’esterno e una nuova ricerca francese la "rivoluzione“ storiografica di Robert Paxton il cui libro pubblicato nel 1973, lo sguardo decentrato di uno statunitense che non ha vissuto il periodo, l’utilizzo degli archivi tedeschi per studiare i rapporti tra Vichy e la Germania, permette di mostrare che il collaborazionismo non è stato subito, ma chiesto da Vichy. Philippe Burrin, storico svizzero, prosegue con l’investigazione della società francese sotto vichy (la nozione dell’“accomodarsi”) L'irrompere della memoria della deportazione degli Ebrei lancia nuove ricerche storiche che fanno apparire la distinzione fra campi di concentramento e campi di sterminio (Olga Wurmser-Migot) Gli storici francesi si liberano dalla pesantezza della memoria: apertura degli archivi nel 1979, integrazione del Comité d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale in un laboratorio del CNRS, l'Institut d'Histoire du Temps Présent (IHTP) nel 1980. Nuovi studi ne risultano: "Vichy ed i Francesi", la Francia degli anni neri, il Partito Comunista dal 1938 al 1941… 2 : i miti infranti il rinnovo storiografico infrange antichi miti e rilancia polemiche e dispute, ma fa scoppiare alcuni ascessi: Rimessa in discussione della memoria comunista (l'appello del 10 luglio 1940, la domanda di riedizione di l'Humanité…) finalmente ammessa da storici comunisti (Bourderon, Martelli) - fine del mito pétainista della "spada", del "buon Pétain" e del "cattivo Laval" riscoperta dell’antisemitismo francese, del collaborazionismo amministrativo. (vicende Leguay, Bousquet, Papon) 3 : lo storico, arbitro dei conflitti di memoria Negli anni ‘90, ci sono nuovi interessi di memoria, che implicano quindi delle opposizioni durevoli fra ciò che oppone e che si potrebbe chiamare (utilizzando un termine coniato da JeanMichel Chaumont ) la concorrenza delle vittime (parleremo di questo anche sabato). Citiamo tre esempi per dire le antiche divisioni che continuano e quelle nuove, recentemente apparse e che raccontano inedite pretese. Antichi fronti: deportati politici contro deportati razziali (85.000 deportati politici contro 75.000 ebrei); nuovi conflitti: zingari (172 via Malines), omosessuali (repressione penale), neri nei campi nazisti) Indipendentemente dalla natura e dall’età di queste concorrenze, dimostrano due cose, secondo noi: l’impossibilità ultima di fondere, nel senso fisico di questo termine, le memorie in una memoria unica ed unanime, per dirla tutta, nazionale, come lo stato cerca sempre di fare; la necessità di un discorso obiettivo, laico potremmo dire sul passato, distante dalle cappelle memoriali. Ma gli storici hanno ripreso la mano sottolineando e analizzando questi obiettivi (Rousso) e queste memorie: nel chiarire il concetto, lo storico diventa l’arbitro delle rivendicazioni memoriali: perché la memoria è legata alla fedeltà, ed è alla verità che lo storico lavora. Ne deriva una domanda sociale di storico arbitro: consultato come esperto per i dibattiti, commissioni scientifiche, allestimento di luoghi della memoria, di musei, film documentari ma anche, e i problemi sono altri, nei processi (Touvier, Papon) In definitiva, si assiste in Francia ad un acquietamento, un consenso globale che si è potuto osservare nelle commemorazioni del 2004 e del 2005: testimoni e politici sono ora in fase col discorso degli storici, le dispute di memoria sembrano scemare. C) Nuovi cantieri per gli storici Tre sembrano importanti: 1) il ritorno alla storia: 9 - dovere di memoria = dovere di storia; Cf. Rousso : “Il dovere di memoria non è che un involucro vuoto se non deriva da un sapere” - storia positivista - storia sociale e culturale (IHTP) - storia … della memoria. 2) il ritorno alla Grande Guerra, attraverso nozioni operatrici: - “Brutalisation and Trivialisation”: la Prima Guerra mondiale, vera matrice della seconda? - E l’ideologia? 3) la storia comparativa, recente preoccupazione, di cui peraltro testimonia questo convegno: - triplice articolazione: locale/nazionale/internazionael/« regione » (le Alpi). Le problematiche di storia culturale ed antropologica sono molto interessanti in questi nuovi ambiti geografici. Massimo Baioni – Politiche della memoria e rappresentazione della storia nazionale nell’Italia unita Il mio intervento sarà un po' laterale rispetto al fuoco tematico del convegno. Ma spero che le ragioni risulteranno abbastanza chiare e plausibili. E' noto che la guerra civile che nel 1943-45 contrappose i gruppi della Resistenza ai militanti fascisti della Repubblica sociale italiana fu anche una aspra contesa che investì i simboli, gli uomini, gli eventi della storia nazionale e in particolare del Risorgimento. Da una parte la Repubblica sociale mise in atto un recupero, sistematico quanto vano, delle memorie patriottiche ispirate ai numi tutelari del repubblicanesimo - da Mazzini a Mameli alla repubblica romana -, che potevano essere brandite contro la monarchia, accusata del «tradimento» dell'8 settembre; dall'altra, uniti nella lotta contro il nemico «nazifascista», i partigiani avviarono la costruzione della più solida immagine della Resistenza come «secondo Risorgimento», destinata a conoscere una lunga fortuna nella storia dell'Italia repubblicana e a trovare una traduzione anche sul versante delle rappresentazioni museali. L'aggancio al Risorgimento rifletteva il bisogno di nobilitare la Resistenza, stabilendo un rapporto stretto con il mito fondativo dell'Unità nazionale e con l'insieme dei suoi simboli di maggiore potenza evocativa. Questa soluzione fu tutt'altro che scontata, come credo alcuni relatori avranno modo di ricordare nel corso di questo convegno, e fu condizionata dalle molte esigenze della lotta politica. Un complesso intreccio di sedimentazioni del passato e di istanze innovative sembra dunque contraddistinguere l'uso pubblico della storia patria e le forme della sua rappresentazione negli anni della ricostruzione dell'identità nazionale. Ma proprio per questa sua specificità, il caso italiano richiede di essere affrontato secondo una lettura di lungo periodo, che tenga conto delle immagini e delle rappresentazioni del Risorgimento elaborate e diffuse dopo il 1861. In che modo erano entrate a far parte di una politica della memoria che mirava a legittimare le istituzioni e a fare del mito del Risorgimento uno dei canali privilegiati. della pedagogia patriottica? Quali tensioni e polemiche il richiamo al Risorgimento aveva alimentato tra le diverse formazioni politiche, innescando una dialettica tra miti ufficiali e miti di opposizione? E ancora: quali mutamenti la Grande Guerra provocò nella ridefinizione dell'immaginario risorgimentale e quali tragitti esso conobbe durante il ventennio fascista? Muovendo il discorso da questi interrogativi, vorrei cercare di evidenziare come la riflessione sui miti e sulle rappresentazioni (anche museali) del Risorgimento nell'Italia liberale e nell'Italia fascista sia un passaggio fondamentale per comprendere tappe, percorsi e caratteri delle politiche della memoria che investirono la Resistenza all'indomani del 1945, nel contesto della nuova Italia repubblicana. Scontando inevitabili semplificazioni, intendo sviluppare alcune riflessioni intorno a tre punti essenziali, nei quali mi pare di potere riconoscere le componenti che attraversano come un filo rosso il variegato utilizzo della memoria del Risorgimento e le sue rappresentazioni nelle diverse 10 stagioni dell’Italia contemporanea. l) sul versante della memoria per così dire "ufficiale", il ricorso alla categoria della "continuità", che ritma il puntuale recupero del Risorgimento in tutti i momenti cruciali della storia italiana. 2) Le narrazioni egemoni erano però inscritte in una cornice tutt'altro che compatta e omogenea. Anzi, e qui tocchiamo un secondo aspetto ricorrente, il Risorgimento e i suoi miti furono il terreno di aspri conflitti di memorie, configurando un universo di simbologie e di rituali che spingevano alla rivendicazione di identità altre, antagoniste rispetto a quelle ufficiali. 3) Infine, ultimo punto che toccherò rapidamente ma che si ricollega a quello che ho appena ricordato, il rapporto ondivago tra identità nazionale e identità locale, che offre alcuni spunti non trascurabili per leggere il confronto sul Risorgimento e la sua traduzione sul piano della politica della memoria e della rappresentazione della storia, inclusa la sua espressione museale. Claude Hauser – La memoria della Seconda Guerra mondiale in Svizzera Parlare della memoria della Seconda Guerra mondiale in Svizzera significa sicuramente evocare un prima e un dopo. Il “prima” è una visione di quel periodo che ha dominato nella società elvetica fino all’inizio degli anni ‘90, visione dovuta maggiormente agli ambienti politici e militari che hanno governato il paese che non ai professionisti della storia. Una memoria ufficiale del conflitto, lusinghiera per la Svizzera e per gli Svizzeri, largamente improntata all’auto-celebrazione, si è imposta durante la guerra fredda, presentando un paese e dei cittadini dal comportamento senza macchia, anzi eroico per la generosità e lo spirito di solidarietà nei confronti delle vittime della guerra. Frutto di una costruzione deliberata e ragionata, in funzione di obiettivi politici, economici e militari che vedremo oltre, questa memoria ufficiale - l’ “insieme delle immagini e degli stereotipi legati alla guerra e percettibili pubblicamente” (van Dongen) - è stata poco a poco integrata da una maggioranza della popolazione. Largamente e metodicamente diffusa ed insegnata, si è mischiata ai ricordi direttamente vissuti ed alle esperienze personali della generazione della mobilitazione (“quelli della mob”), fino a velarli o deformarli. In definitiva, ispirandosi ampiamente ai miti fondatori del paese, questa politica della memoria ha fatto apparire un’immagine della Svizzera che sembra un trittico quasi sacro: Æ un paese resistente, sia grazie al ruolo del suo esercito che a quello del suo governo (immagine destinata all’interno, per aumentare la coesione del paese) Æ uno Stato umanitario e generoso, solidale delle tragedie che avvenivano e aperto ai profughi (immagine destinata ad essere proiettata verso l’estero soprattutto!) Æ una comunità vigile e saggia, che non è mai stata tentata dagli estremismi, né di sinistra né di destra, e ha saputo preservare la propria coesione sociale. (van Dongen) Intralciati nel loro lavoro sulle fonti, talvolta perfino sottoposti a censura, qualche volta influenzati loro stessi dalla “vulgata storiografica”onnipresente, i professionisti della Storia non hanno potuto o saputo far assumere al paese il passato negativo della collettività di appartenenza (Grosser) durante quel lungo periodo. Sarà necessario attendere che venga fortemente rimesso in causa il passato prossimo che hanno vissuto la Svizzera e gli Svizzeri in seguito alle vicende dell’”oro nazista” e dei “fondi ebraici senza eredi” che sono emerse nel 1995, per discernere una svolta annunciatrice del “dopo”. Prima limitato ad una controversia politico-diplomatica, per via del forte interesse dei media - che rispondeva ad una domanda sociale – questo dossier a base storica si è rapidamente esteso, all’insieme della società civile. Col risultato che è stato sotto l’influenza di forti pressioni esterne, in un clima teso di “memoria sottoposta ad inchiesta giudiziaria” (Rousso), che la Svizzera ha dovuto affrontare una nuova lettura del proprio passato durante il Secondo conflitto mondiale. Talvolta vissuto come un “psicodramma nazionale”, questo processo di ritorno del represso, generatore di un dibattito che ha fatto riemergere molti ricordi, privati o comuni, rivela, secondo lo storico Jean-François Bergier (che presiedette i lavori della Commissione Indipendente di Esperti Svizzera-Seconda Guerra mondiale), il risultato di un “processo” interno simile a quelli della psicanalisi. Nella sua maggioranza, la società svizzera ha sentito la necessità di prendere coscienza di questo periodo della sua storia sotto tutti gli aspetti, di demistificarlo e di abbandonare l’idea del “Sonderfall”, questa eccezionalità elvetica che a lungo volle fare del paese un isola felice 11 protetta dal cielo in mezzo all’Europa ed al mondo. Si vede qui l’importanza della dimensione identitaria, propria di ogni dibattito sulla memoria, sia essa personale o collettiva (Ricoeur). Nel 2001-2002, dopo 5 anni di lavori e senza aver oltrepassato il budget stanziato dalle autorità federali, la Commissione Bergier presentò il rapporto finale, di 25 volumi per un totale di circa dieci mila pagine. I lavori non pretendono di avere totalmente innovato o rivoluzionato la storiografia: stese in un voluminoso rapporto di sintesi, le conclusioni hanno soprattutto confermato e precisato elementi già conosciuti, ma troppo poco diffusi nell’opinione pubblica, e di conseguenza mal integrati nella memoria collettiva. Nel leggere il rapporto di sintesi colpisce il fatto che da un lato il contesto dell’epoca in Svizzera, fatto di timori e di un sentimento di insicurezza largamente mantenuto dagli eventi alle frontiere e dalle propagande, non è stato minimizzato nell’analisi globale. E neanche gli orientamenti generali di un’opinione elvetica essenzialmente legata ai valori democratici ed ostile al nazismo, in particolare nella Svizzera tedesca. Riprendendo i termini impiegati da Jean-François Bergier in un bilancio successivo alla pubblicazione dei lavori della CIE, questa ha soprattutto portato sfumature, contrasti ed arricchito l’immagine comunemente accettata della Svizzera durante la guerra, in particolare stabilendo una distinzione chiara fra le scelte politiche della Svizzera ufficiale e le opzioni maggioritarie di una pubblica opinione talvolta poco o male informata. (Bergier Porr). Un po’ come un restauratore d’arte che cerchi di liberare una vecchia foto dei numerosi ritocchi o aggiunte cosmetiche destinati ad abbellirla, il gruppo di storici della Commissione Indipendente di Esperti (CIE) ha fatto emergere in piena luce, dando loro maggiore rilievo, con termini pesati e talvolta incisivi, i lineamenti poco lusinghieri del ritratto della Svizzera in armi: Æ in primo luogo la questione dei profughi, a forte valenza emotiva. Le autorità di allora scelsero in effetti di praticare una politica di asilo molto restrittiva, molto più restrittiva di quanto non lo imponessero le condizioni politico-militari o la situazione socio-economica del tempo di guerra. Hanno pesato molto per il potere i sentimenti xenofobi ed un antisemitismo latente che rappresentano un contro-valore costante nella Svizzera del primo terzo del novecento, sotto la pericolosa influenza degli Stati autoritari vicini. Così, mentre la memoria collettiva aveva esaltato l’accoglienza in Svizzera di militari francesi e polacchi sconfitti durante l’estate del 1940, o quella di bambini vittime del conflitto in guisa di riscatto umanitario nel contesto della Liberazione, la realtà storica ha questa volta messo in luce le circa 20.000 persone rifiutate alle frontiere, in particolare gli ebrei perseguitati che trovarono la porta chiusa nelle cupe ore dell’estate 1942. Æ altro argomento sensibile, quello della cooperazione economica con i paesi dell’Asse. L’espressione “Business as usual “ impiegata dallo storico Daniel Bourgeois ben traduce l’orientamento generale di una maggioranza di imprese elvetiche i cui dirigenti hanno privilegiato, da buoni discepoli del liberalismo, il profitto e gli affari con i padroni del momento. Dissimulati a lungo sotto il pretesto “nazionale e spirituale” di uno spirito di resistenza e di una preparazione militare efficace, i principali e veri argomenti della neutralità preservata apparivano clamorosamente frantumati. Æ infine, la questione delicata, ancora più direttamente e concretamente legata alla memoria, della restituzione dei beni delle vittime dopo la guerra. Questa questione ha potuto essere analizzata e spiegata nei dettagli grazie al lavoro scientifico dei collaboratori della CIE, che hanno finalmente avuto accesso alle fonti bancarie e a quelle dell’economia privata. Parallelamente, le valutazioni cifrate stabilite dalla Commissione Volcker, incaricata di ritrovare i beni ebrei lasciati con negligenza senza eredi negli istituti finanziari elvetici, hanno permesso di ripristinare infine una giustizia che aveva un peso sociale e simbolico per numerose vittime del nazismo o per i loro discendenti. Le condizioni di possibilità di una politica memoriale Se questo approccio e questi risultati tutto sommato critici hanno riscontrato numerose opposizioni, e provocato un vasto dibattito identitario in Svizzera, è proprio perché durante quasi mezzo secolo, una politica della memoria è riuscita a dominare e segnare la mente di almeno due generazioni, e allo stesso tempo a intralciare lo sviluppo della storiografia elvetica sul Secondo conflitto mondiale. Il successo di questa politica memoriale che si impose rapidamente e durevolmente è legato al contesto della Guerra fredda nascente. Nata dalla volontà di far fronte alle ideologie totalitarie degli 12 anni 1930, la Difesa nazionale spirituale, questo “patriottismo di guerra votato alla difesa dell’indipendenza e dell’identità svizzera”, avrà fin dal 1948 come principale bersaglio l’URSS e il comunismo, considerati come la nuova principale minaccia per la Confederazione. L’anticomunismo si risveglia tanto più facilmente poiché le elite dirigenti del paese, traumatizzate dal ricordo dello choc sociale degli scioperi del novembre 1918, hanno considerato con diffidenza l’interesse crescente, verso il 1942/43, di gran parte dell’opinione svizzera nei confronti di una Russia comunista che viene allora percepita come un avversario valoroso ed efficace del nazismo e latore di un futuro migliore sul piano sociale (Lasserre). Nel primo dopoguerra, la diplomazia elvetica, guidata dal consigliere federale Max Petitpierre, che pure non si può definire filoamericano, prova a ridare nuovo lustro alla propria immagine e far capire agli Stati Uniti che la politica di neutralità può anche servire loro d’efficace “copertura” nel nuovo contesto della guerra fredda. Allineando discretamente la Svizzera dietro la NATO (adesione all’Organizzazione europea di Cooperazione economica, che rappresenta, insieme al piano Marshall, uno strumento del “containment” americano di fronte all’Unione Sovietica sul continente europeo. Quindi firma dell’accordo Hotz-Linder nel 1951, che sottoponeva di fatto il commercio estero svizzero al blocco imposto dagli Americani ai paesi dell’Est), i diplomatici elvetici vogliono dimostrare che il loro paese non costituisce un punto debole nel sistema di containment che gli Stati-Uniti mettono in opera in Europa. Le recenti ricerche dello storico Sacha Zala hanno mostrato che in quel contesto di tensione, del dopoguerra, la Svizzera ufficiale ed ufficialmente neutrale ha reclamato dagli Alleati occidentali che venga riconosciuta ma senza rivelarla pubblicamente, la propria posizione non neutrale durante la Seconda Guerra mondiale, con l’idea che possa continuare ad impegnarsi dietro la NATO, pur continuando ad apparire come un paese ufficialmente non impegnato nel conflitto Est-Ovest. Nel concreto, si trattava in particolare di non rivelare troppo in fretta, negli anni 1950, le trattative segrete di alleanza difensiva condotte tra il generale Guisan e lo Stato Maggiore francese nel 1940, per far fronte ad un eventuale attacco tedesco della Svizzera da nord. Sotto l’apparenza di una neutralità ufficiale e mistificata, la Confederazione sperava quindi di proseguire col sostegno discreto ma efficace del campo occidentale nel caso molto temuto di un attacco sovietico in Europa. L’inizio della Guerra fredda, le scelte occidentaliste della politica estera svizzera e gli interessi politico-economici convergenti di Svizzera e Stati Uniti ebbero così l’effetto di neutralizzare fin dal 1948 i violenti e ripetuti attacchi che lanciarono gli Alleati anglosassoni fin dagli ultimi mesi del conflitto, contro la posizione elvetica durante la guerra. Una memoria a dominante “grigio-verde” La Svizzera e gli Svizzeri non hanno conosciuto la guerra sul proprio suolo, ma l’hanno fortemente temuta. Eppure quando il conflitto ebbe fine e la guerra fredda stava per instaurarsi, le autorità politiche e militari misero l’accento su una versione militarizzata della memoria elvetica. L’idea era di far perdurare nei cittadini l’immagine rassicurante di una efficace neutralità armata e di una istituzione militare necessaria, anche sul piano interno dove rappresenterebbe un elemento importante per la coesione del paese (slogan e simbolo del cittadino-soldato sempre tenuto vivo). Questo orientamento conferisce rapidamente un colore grigio-verde alla memoria elvetica del conflitto. Si esprime, ad esempio, attraverso monumenti simbolici specifici. Costruiti su una triade “luogo-oggetto-persona”, i principali luoghi della memoria del periodo di guerra, molto rappresentati in una letteratura patriottica-militare del ricordo che fiorisce dopoguerra sono: Da un lato la ridotta alpina e i suoi molteplici fortini costruiti nella roccia granitica, simbolo di una nazione che vuole essere a maggioranza resistente, e il soldato di fanteria con gli sci, “guardiano dei colli” d’altro lato la frontiera elvetica, le linee di fortificazione che dovevano impedire l’accesso del territorio ai blindati (i famosi “toblerones” Rif: studio sugli sbarramenti) e la sentinella che veglia giorno e notte sul paese. Guardando al calendario elvetico di commemorazioni legate al conflitto, notiamo anche che, fino a pochissimo tempo fa, è stata la mobilitazione generale del paese, e quindi l’inizio del conflitto, ad essere celebrata, e non l’armistizio. Sono soltanto due anni che la Confederazione si è associata 13 alla giornata dedicata alla memoria della Shoah ed incoraggia le scuole a ricordare quest’evento nelle lezioni di storia. E’ interessante ricordare le principali tappe dell’instaurarsi di questa memoria molto militaresca della guerra in Svizzera. Queste tappe si confondano largamente con il destino della figura carismatica che per una maggioranza di Svizzeri, incarna il principale ricordo della guerra: il capo dell’esercito, Henri Guisan, nominato generale dall’Assemblea federale il 30 agosto 1939. Prima tappa: l’immediato dopoguerra. L’8 maggio 1945, il generale Guisan trasmette un messaggio con un tono molto paterno e volontariamente “vicino” ai cittadini-soldati. Due idee primeggiano in questo discorso: quella che il paese è stato salvato dalla Provvidenza e dallo spirito di resistenza del suo esercito; e quella che occorre essere vigili nel futuro e rimanerlo, mantenere un esercito forte il cui principale pilastro è ormai rappresentato da una generazione che deve mostrare la strada: “quelli della mob”. Durante l’omaggio alla bandiera, cerimonia organizzata dallo Stato Maggiore e Guisan, il 19 agosto 1945, la patria è glorificata e l’immagine del cittadino-soldato esaltata: si inizia anche una selezione nella memoria militare del conflitto insistendo sui due atti giudicati eroici dell’esercito fra il 1939 ed il 1945: il rapporto del Grütli (il 25 luglio 1940, Guisan raduna segretamente tutti gli ufficiali superiori sul prato mitico dei fondatori della Confederazione, al Grütli (sulle rive del Lago dei 4 Cantoni), per fargli prestare giuramento al paese) e la strategia del Ridotto nazionale, che fu adottata nell’estate 1940 per concentrare la maggior parte dell’esercito nel ridotto alpino organizzato intorno alle basi fortificate di Saint-Maurice, del Gottardo e di Sargans. In questo modo, Guisan sottolinea lo spirito di sacrificio, la volontà e il morale dei cittadini-soldati durante il servizio attivo: questo spirito prevarrà nell’avvenire e avrà la meglio su ogni discussione strategica o storica intorno al conflitto, giudicata prematura. Un anno più tardi, il 24 giugno 1946, Guisan consegna alle Camere federali il proprio rapporto sul servizio attivo (in realtà redatto in gran parte dal suo aiutante di campo Bernard Barbey) che fa dell’autore il principale guardiano e vettore di questa memoria militarizzata. Guisan auspica con insistenza in particolare una riforma dell’istituzione militare per adeguarsi alle esigenze del futuro. Le divergenze interne ed altre rivalità dello Stato Maggiore sulle grandi opzioni strategiche o posizioni ideologiche durante la guerra sono cancellate e gli effetti collaterali della strategia del Ridotto sulle popolazioni dell’Altopiano svizzero, abbandonate al nemico in caso in invasione, nemmeno evocati. L’opinione pubblica nella stragrande maggioranza, concesse la propria fiducia al generale ed al suo rapporto. Le critiche di alcuni colonnelli, spesso di estrema destra o gelosi dell’aura di Guisan, non furono molto ascoltate e non intaccarono l’immagine “esistenzialista” dell’esercito e del generale. Usando pienamente del proprio carisma, nel momento in cui la sua popolarità è al massimo e si riflette nel successo che ottiene nelle numerose comparse in pubblico davanti a società militari, culturali o sportive, Guisan ama allora auto-proclamarsi un padre della patria, sensibile alla coesione sociale del paese quanto agli affari militari. Mette la propria gloria al servizio degli sforzi consentiti dagli ambienti militaro-patriottici (Esercito e Focolare e il Riarmo morale) con l’obiettivo di imporre l’immagine di un paese generoso e solidale con i vincitori che hanno pagato caro il proprio impegno. Ad esempio, Guisan sostiene una grande azione di solidarietà svizzera (con il giornale Le Tocsin) per ricostruire il villaggio martire di St-Gingolph, alla frontiera franco-svizzera la cui popolazione ha subito terribili rappresaglie da parte delle SS nel 1944 e il cui destino simbolizza in Svizzera Romanda tanto la barbarie nazista quanto la resistenza francese. Il mito dell’esercito salvatore del paese emerge nettamente di questo primo appuntamento della Svizzera con la propria storia nel primo dopoguerra. Questo mito si svilupperà durante la guerra fredda, come testimonia la coreografia della morte di Guisan nel 1960, che suscita una vivace emozione nel paese. Organizzato da un collaboratore vicino a Guisan, Samuel Gonard, il funerale del generale è uno spettacolo militare, con numerose truppe (circa un migliaio di soldati), le bandiere e gli stendardi dell’esercito nonché i rappresentanti della Commissione di difesa nazionale, cervello militare elvetico che si presenta in quel momento come il principale bastione di fronte alla minaccia sovietica giudicata onnipresente. Portato al rango di figura quasi religiosa al quale viene votato un culto, il generale fu allora trasformato in mito. La sua tomba divenne un vero e proprio luogo di memoria, dove si viene in pellegrinaggio da ogni dove. Dieci anni dopo la sua scomparsa, un « Centre général Guisan » fu creato nella sua ex proprietà di Verte-Rive per 14 perpetuare il suo ricordo. Così, letteralmente congelata dall’atmosfera della guerra fredda, questa versione militarizzata della memoria del conflitto dominò la scena fino alla caduta del Muro di Berlino, nonostante qualche fessura apparsa alla fine degli anni 1960, con le contestazioni di una nuova generazione antimilitarista. Nel 1989, gli cittadini svizzeri sono chiamati a pronunciarsi sull’iniziativa “Per una Svizzera senza esercito” lanciata dal Gruppo per una Svizzera Senza Esercito (GSSA), che sorprendentemente raccoglie circa il 40% di opinioni favorevoli. In questo contesto politico teso, l’operazione “Diamante”, destinata a commemorare il 50° anniversario dell’inizio della mobilitazione, ed organizzata con la partecipazione delle società di ufficiali svizzeri e la riattivazione delle reti sociali degli “ex della Mob”, è destinata a suscitare polemiche e controversie. Gli oppositori ritengono che i 6 milioni di franchi stanziati per l’occasione dal Parlamento federale servono innanzitutto alla promozione dell’esercito. Nello spiegare il mantenimento della neutralità, la manifestazione tiene in poco conto le vittime del conflitto, non menziona il rifiuto dei profughi ebrei e trascura il ruolo del commercio estero e delle consegne di armi. In quanto ai pochi eroi della resistenza umanitaria elvetica come Paul Grüninger e Gertud Kurz, che fecero passare il confine ai profughi, dovranno ancora attendere (il 1995 per il capo della polizia di Saint-Gall) per uscire dal purgatorio ed essere riabilitati. Se le grandi linee di un dibattito di fondo su questo periodo del passato svizzero appaiono alla svolta degli anni 1990, non è soltanto per via degli sconvolgimenti politico-strategici in Europa. Tra il 1984 ed il 1989, la figura e il ruolo idealizzati del generale Guisan sono stati demistificati, non senza polemiche, dai lavori storici di Oscar Gauye, responsabile dell’Archivio federale svizzero, quindi di Willy Gautschi, autore della prima biografia seria e non agiografica del generale. La memoria collettiva è allora raggiunta da una memoria storica del conflitto che, ormai più libera di esprimersi, suscita anche maggior risonanza nelle nuove generazioni, meno influenzate da una politica ufficiale del ricordo ormai senza più fiato. Quando lo Stato controlla la storia e la memoria… La politica della memoria della Svizzera ha progredito a colpi di rapporti ufficiali, la cui redazione, spesso provocata da pressioni esterne, ha lasciato soltanto poco spazio ad una storiografia indipendente e critica. Questa, strettamente controllata dalle autorità federali che tengono a mantenere ad ogni costo una neutralità elevata a rango di mito, è praticamente stata “intralciata” per tre decenni, per riprendere i termini dello storico Sacha Zala: accesso all’archivio vietato, censura imposta, ed si comprende quindi facilmente che sia tramite ricerche ed analisi effettuate in altri paesi che maggiore luce è potuta filtrare attraverso una nebbia - o delle interferenze storiografica sistematicamente mantenuta. Ogni volta si è prodotto un fenomeno di azionereazione, rivelatore della posizione “difensiva” adottata da quello che si è preso l’abitudine di chiamare “il riccio elvetico”. 1954: il quinto tomo dei Documenti diplomatici tedeschi svela la responsabilità diretta delle autorità elvetiche nell'apposizione, nel 1938, del segno distintivo « J » (Jude) sui passaporti degli ebrei tedeschi ed austriaci al fine di poterli facilmente identificare e respingere. 1957: un rapporto richiesto dal Consiglio federale al giurista Carl Ludwig conclude abbastanza prudentemente che “è fuori dubbio che una politica più liberale in materia di ammissione avrebbe avuto come risultato di mettere innumerevoli persone al riparo dallo sterminio”. 1961: sequestrati dagli Alleati, i Documents on German Foreign Policy, sono pubblicati sotto la responsabilità di un gruppo di storici indipendenti, e rivelano in particolare il segreto della cooperazione militare franco-svizzera, conosciuta con il nome degli accordi della Charité-surLoire, dove Guisan aveva negoziato prima della guerra un eventuale sostegno della Francia in caso di attacco contro la Svizzera. E’ uno dei pilastri fondatori politici ed identitari del paese ad essere questa volta preso di mira, ed è in effetti col titolo “Storia della neutralità svizzera, quattro secoli di politica estera elvetica” che Edgar Bonjour, professore di storia a cui è stato aperto l’archivio di stato in via del tutto eccezionale, pubblica i risultati del suo rapporto sulla politica estera del paese tra il 1939 e il 1945. La cosa del resto non fu priva di difficoltà e indugi, poiché il “rapporto Bonjour” venne pubblicato soltanto nel 1970, e non integralmente, sotto la pressione di un’opinione pubblica che non comprendeva le reticenze del Consiglio federale (Friedrich Traugott Wahlen in particolare) a volerlo conservare allo stato di documento interno. Sarà necessario attendere la revisione del regolamento dell’Archivio federale in 1973 perché l’accesso ai documenti riguardanti la Seconda Guerra mondiale sia facilitato e generalizzato. La fine di questo periodo di “glaciazione storiografica” corrispose agli ultimi tentativi dei “guardiani della 15 memoria ufficiale” di intralciare i lavori degli storici limitando l’accesso alle fonti. Il professor Georg Kreis, che esegue una ricerca all’inizio degli anni 1970 sulla vicenda della Charité-sur-Loire, farà con successo un ricorso al Consiglio federale per rimuovere l’interdizione di consultare dei documenti del DMF sui rapporti militari franco-svizzeri tra il 1936 e il 1941, che gli era stata imposta (1974 : Auf den Spuren von La Charité). Questi limiti imposti alla storiografia spiegano perché gli studi critici sul passato della Svizzera durante la guerra provengano prima da ambienti giornalistici o da saggisti, meno sorvegliati e meno intralciati. Possiamo citare il libro impegnato e molto critico di Jean-Baptiste Mauroux, cronista letterario svizzero in Francia, intitolato Du bonheur d’être Suisse sous Hitler (1968), che fu mal accolto in Svizzera, ma ripubblicato con grande successo più di 30 anni dopo. Quanto al giornalista Alfred A. Häsler, sottolineò le cupe pagine della politica di asilo svizzera, molto restrittiva in particolare verso i profughi ebrei: pubblicato nel 1967, il suo libro corrisponde ad un momento di presa di coscienza generale dell’orrore dell’Olocausto, legata al processo Eichmann (1961). L’irrompere di questa memoria ebrea del conflitto provocherà alcune prese di coscienza nella generazione della Mob, certo ancora limitate, delle responsabilità svizzere legate alla politica d’asilo condotta durante la guerra. Il libro di Häsler sarà adattato per lo schermo da Markus Imhoof en 1981, e la scrittrice Yvette Z’graggen ne trarrà un romanzo pubblicato nel 1982 (Les années silencieuses – Gli anni silenziosi). Verso la metà degli anni ‘80 alcune opere di sintesi iniziano a rimettere in discussione la storiografia dominante, e propongono una rivalutazione globale del passato nazionale durante l’ultima guerra. E’ principalmente il capitolo che Hans Ulrich Jost dedica al periodo delle due guerre (1914-1945) in la Nouvelle Histoire de la Suisse et des Suisses, molto provocante e critico, che sarà ampiamente mediatizzato e provocherà reazioni molto nette, oltre gli ambienti specialistici (1983). Nulla di sorprendente quando si sa che per Jost, che poteva utilizzare le ricerche di Daniel Bourgeois sulle relazioni diplomatiche fra il Terzo Reich e la Svizzera (1974) o i lavori di Peter Utz sui traffici dell’oro nazista effettuati dalla Banca Nazionale (1980), questa ricerca rivelava “i contorni perlomeno torbidi di una storia ancora intrisa di immagini edulcorate o di patriottismo perverso” (ego-storie). Nonostante tutto, la forza di penetrazione di queste elaborazioni storiche è stata sminuita dal profondo radicamento, nell’identità nazionale, di una triade di valori – neutralità, umanitarismo, democrazia – largamente diffusi dalla politica ufficiale della memoria. Si capisce quindi tanto meglio che sia nella redazione del rapporto Bergier che nelle ricerche pubblicate in questi ultimi dieci anni, si trovi presso gli storici svizzeri una volontà di instaurare un dialogo scientifico con le generazioni che hanno vissuto il conflitto, in particolare tentando di riabilitare il valore del ricordo, della testimonianza, del destino individuale esemplare di un vissuto comune o collettivo. Le conclusioni del rapporto Bergier indicano in particolare che “era ora dopo 50 anni e due generazioni, di ritrovare la realtà di un età prima che siano scomparsi tutti quelli che la vissero”. Non si può in effetti parlare di una “storia vissuta”, una “memoria collettiva” contro una “memoria storica” intesa come la ricostruzione sapiente e professionale del passato (Rousso, p. 21). Lo si potrebbe credere se ci si fidasse di alcuni libri particolarmente polemici pubblicati con il preciso obiettivo di contestare gli insegnamenti del rapporto Bergier: il libro di Jean-Pierre Richardot Une autre suisse e soprattutto quello del Gruppo di lavoro « Histoire vécue » intitolato La Suisse face au chantage (La Svizzera di fronte al ricatto). Lo storico e il testimone devono piuttosto ricercare il dialogo e lavorare insieme, senza animosità. Il mestiere del primo, naturalmente, serve ad esercitare una “funzione correttiva o terapeutica” rispetto ai ricordi del secondo, ma lo storico deve anche conoscere i meccanismi della memoria e la loro importanza nel rapporto passato/presente/futuro che vive ogni persona o comunità se vuole esercitare al meglio il proprio ruolo e la propria funzione critica nella “conquista di una giusta distanza rispetto al passato” (Ricoeur) che è il suo principale obiettivo. A questa condizione soltanto, i suoi lavori potranno essere accettati e riconosciuti dai testimoni-attori e dalla società civile. Hanno lavorato in questo senso i responsabili del progetto Archimob, che hanno proposto di rivisitare la storia della Svizzera durante la guerra con 555 testimonianze filmate e registrate, scelte per la loro ricchezza e rappresentatività. Archimob e la mostra “L’Histoire c’est moi, 555 versions de l’histoire suisse” (La Storia sono io, 555 versioni della storia svizzera” non sono un nuovo “monumento” che celebri la memoria di una generazione mal compresa. Le fonti orali raccolte e costitutive di una memoria 16 collettiva sono varie e rappresentative di una gran variétà sociale. Le persone sollecitate per testimoniare sono non solamente quelle della generazione della Mob, nella sua componente militare, ma anche quelle delle vittime del conflitto, profughi, ebrei in particolare, passati per la Svizzera, per esserne cacciati o esservi accolti, oppure persone che hanno vissuto in Svizzera dopo essere sopravissute alla Shoah. Le loro testimonianze danno una nuova dimensione alla percezione storica degli eventi dell’ultima guerra vista dalla Svizzera. Rimesse in prospettiva dagli storici, danno maggior spessore e meno fessure allo specchio delle realtà della guerra così com’è stata vissuta dai contemporanei. Conclusione: memoria publica, memoria personale, storia: verso la riconciliazione? Per finire, occorre interrogarsi sul modo in cui la memoria ufficiale del conflitto in Svizzera si è poco a poco sovrapposta ai ricordi personali della generazione che ha vissuto il conflitto. Il processo è simile a quello che descrive brillantemente Umberto Eco nel romanzo “La misteriosa fiamma della regina Loana”, dove l’eroe, colpito da amnesia in seguito ad un trauma accidentale, può soltanto più attivare una memoria libresca fatta da una molteplicità di ricordi e citazioni tratti da quello che lo scrittore chiama la “memoria semantica” o memoria pubblica. Eccessiva in lui, domina senza discussioni la sua memoria episodica, costruita a partire dai suoi ricordi e sensazioni personali, e che si sforza di ritrovare con l’aiuto dei suoi cari. Il parallelo con la “generazione della mobilitazione” in Svizzera è qui illuminante: coloro che hanno vissuto il secondo conflitto mondiale all’interno delle frontiere protettrici della Svizzera neutrale non hanno certamente subito un trauma violento, portatore di amnesia. Però il processo rapido e costantemente mantenuto negli anni del dopoguerra da una Svizzera ufficiale che voleva rapidamente ricostruire il passato prossimo a suo vantaggio ha potuto agire come un rullo compressore della memoria e seppellire sotto una quantità enciclopedica di documenti di ogni tipo le contraddizioni o le sfumature proprie di ogni memoria individuale. La memoria pubblica ha anche fatto uso dei moderni mezzi di propaganda per forgiare le memorie dei bambini che hanno vissuto la guerra in Svizzera ed assicurare così un “passaggio di testimone” senza soluzione di continuità, da una generazione alla successiva, garanzia del perpetuarsi di questa versione ufficiale e dominante della storia del paese. Il libro, ma anche l’immagine, e soprattutto il film, hanno così contribuito all’onnipresenza di questa memoria semantica per la gioventù del primo dopoguerra. Facciamo l’esempio dell’accoglienza in Svizzera dei bambini vittime del conflitto durante e soprattutto alla fine della guerra. Nel celebre libro bianco che il DPF intende pubblicare nel 1945 al fine di facilitare il rientro della Svizzera sulla scena internazionale in grande stile, lo scrittore Maurice Zermatten conclude il proprio articolo con un richiamo al ricordo riconoscente verso un paese che ha salvato tanti bambini: questi dovrebbero ricordare “quando saranno uomini, della pace benefica e dolce che offriva loro un paese risparmiato”. Questi appelli dalle risonanze molto politiche saranno in effetti accolti. I vari episodi positivi dell’accoglienza dei bambini vittime della guerra saranno così incisi nelle coscienze dei bambini svizzeri che li hanno visti o li hanno frequentati alcuni mesi durante il conflitto. Dal popolarissimo giornalino per bambini Fip-Fop, progettato e gestito dalla Nestlé, ai libri di letteratura per giovani che si moltiplicano alla fine del conflitto su questo tema dell’infanzia rifugiata in Svizzera durante la guerra (Théo le petit réfugié, Heidi grand’mère e soprattutto Marie-Louise la petite française), sempre e ovunque domina lo stesso messaggio: quello di una Svizzera accogliente, unita in uno stesso slancio di solidarietà umanitaria simboleggiata dalla Croce Rossa, Soccorso ai bambini e le azioni intraprese alla fine della guerra. Il durevole mantenimento di questo mito della Svizzera, terra d’asilo spiega lo choc ed il sentimento d’incomprensione provato da un gran parte della generazione di bambini svizzeri cresciuta in questa atmosfera, quando il velo di questo memoria ufficiale si strappò e fece apparire le mancanze e i limiti della politica svizzera del Rifugio, anche verso alcuni bambini vittime del conflitto come gli Ebrei. Per capire bene questo fenomeno, occorre anche tener conto del vissuto individuale della guerra per i bambini svizzeri, più particolarmente quelli che vivevano ai confini del paese. Quando si ascoltano le testimonianze raccolte dall’associazione Archimob, quando si leggono i ricordi d’infanzia pubblicati da tanti attuali settantenni, colpiscono due forti immagini di questa infanzia “alle frontiere della guerra”. La prima è quella di un “infanzia rubata”, soprattutto 17 presente in ambiente rurale dove i bambini devono svolgere buona parte dei lavori agricoli, ravvivata dallo specchio teso a questa generazione della guerra da quella successiva, l’infanzia dorata degli anni ‘60. Come accettare senza frustrazione, rivolta o rifiuto, di aver sacrificato la propria infanzia per un paese che ha chiuso le proprie porte ai più poveri e perseguitati, cercando di tirarsi d’impiccio, di fronte ai nazisti prima, poi di fronte ai vincitori … ? La seconda immagine che domina i ricordi dei bambini svizzeri, in particolare di frontiera, è quella di un’infanzia allegra, che approfitta di alcuni irregolarità sociali intervenute nel sistema educativo in seguito alle “mobs” e alle vicende del conflitto (allerta, profughi accolti nelle scuole, ecc.). In effetti, la prossimità del conflitto e la mobilitazione della società toccano anche il mondo dell’infanzia, che riproduce fin nei giochi più o meno pericolosi i combattimenti. Certamente pittoresca da evocare, la memoria di questa “guerra dei bottoni” ha potuto vacillare di fronte all’ampiezza delle sofferenze evocate e alle responsabilità elvetiche, dimostrate negli anni 1990-2000. Nell’ambito di un dibattito mediatico passionale che non sempre ha distinto ruoli e responsabilità (Svizzera ufficiale, esercito, popolazioni, opinion makers …), tali ricordi hanno talvolta fatto nascere sentimenti di colpevolezza assunti oppure hanno contribuito a far rifiutare la storia rivisitata dai professionisti della Commissione Indipendente di Esperti Svizzera-Seconda Guerra mondiale. Eppure, sono tanti i giovani attori-testimoni della guerra che hanno dimenticato, comprensibilmente viste le ricostruzioni memoriali del dopoguerra, che loro stessi o chi li circondava avevano protestato, emesso critiche quando furono chiuse le frontiere svizzere o aperte in maniera selettiva o opportunistica. Le recenti ricerche dimostrano la riprovazione delle popolazioni di frontiera quando le autorità federali chiusero le frontiere nell’estate 1942, oppure la loro irritazione di fronte agli ostacoli posti da queste stesse autorità per impedire contatti tra gli abitanti svizzeri e i profughi temporanei francesi, anche nel momento della Liberazione. L’analisi storica permette di risvegliare alcuni aspetti di questa memoria personale, nascosta sotto le pesanti macerie della memoria pubblica, e può riuscire a riconciliare una maggioranza con una memoria del conflitto più vicina alla realtà di quanto non lo fossero le ricostruzioni del dopoguerra. 18 2. RAPPRESENTAZIONI E IMMAGINI NEI MUSEI mercoledì 23 novembre, ore 14,30 In che modo si sono costruite le memorie collettive della Seconda guerra mondiale nelle tre aree delle Alpi occidentali e in quali realizzazioni (mostre, musei, luoghi di memoria...) questa memoria si è manifestata? Considerate nella prospettiva storica, le differenze dei contesti e delle forme permettono di valutare le specificità di ogni situazione. Presiede Gianni Perona, Università di Torino, direttore scientifico dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia (INSMLI) La difficile costruzione di una memoria della Resistenza italiana: le prime mostre 1945-1955 Adolfo Mignemi, storico, curatore della mostra “Un’immagine dell’Italia, Resistenza e ricostruzione” dell’INSMLI L’eco in Francia delle mostre sulla Resistenza italiana del 19451946 Olivier Forlin, docente dell’Università Pierre Mendès France, Grenoble, collaboratore del Centro di ricerca della storia dell’Italia e dei Paesi alpini (CRHIPA) Musei della Resistenza e politiche della memoria: il caso dell’Emilia Romagna Claudio Silingardi, direttore dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea, Modena Pausa caffè La comunicazione per immagini nei musei della Resistenza e della Deportazione in Francia Jean-Jaque Fouché, professore di filosofia e gornalista, direttore dell’Institut La Maison de la Culture, ispettore generale al Ministero della Cultura, capo progetto per la creazione della Mémoire d’Oradour-sur-Glane La Confederazione svizzera durante la guerra attraverso le mostre Christian Luchessa, storico, collaboratore dell’Istituto di Storia delle Alpi (IsAlp), Università della Svizzera italiana, Lugano Discussione 19 Adolfo Mignemi - La difficile ricostruzione di una memoria della Resistenza italiana: le prime mostre 1945-1949 La costruzione di un immaginario visivo organico della Resistenza data dai giorni stessi della Liberazione. Il suo progetto è percorso da componenti spesso contrastanti ed eterogenee di carattere politico, culturale ed economico. Esse vanno dall’esigenza di affermare il ruolo, se non il primato, dell’esperienza politico-militare delle formazioni partigiane e dei comitati di liberazione nell’intera vicenda della guerra sviluppatasi in Italia dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, alla necessità di trasformare gli attori di quel conflitto in soggetti politici o meglio nei protagonisti della ricostruzione nazionale intesa come vera e propria transizione ad un’altra Italia. Anche l’anima di queste spinte era sicuramente composita, andava dalle aspirazioni rivoluzionarie totali al rinnovamento democratico delle modalità di rappresentanza politica, dal semplice ripristino delle libertà fondamentali al mutamento istituzionale. Accanto a questo conflitto politico culturale tra il “vento del Nord” e “Roma centro del potere” – che, per altro, percorreva non solo le forze espresse dalla lotta antifascista ma lo stesso neofascismo di Salò e movimenti come il “partito dei senza partito” di Guglielmo Giannini – vi sono anche i più immediati interessi materiali dei produttori di immagini, ovvero delle pietre indispensabili alla costruzione dell’edificio dell’“immaginario”. Alla fine della guerra si riattivano i canali delle agenzie fotografiche internazionali e vi sono gli Alleati che stanno facendo incetta di quanto più possibile documentazione visiva dei mesi di guerra. Nonostante l’uso massiccio fatto dalla propaganda fascista e nazista di immagini nel corso del conflitto, esso non ha delegittimato né la fotografia né la ripresa cinematografica e in un contesto di mutamenti radicali, in particolare il crollo del fascismo e della Germania nazista, anzi tutto questo ha ridato una nuova vitalità e prodotto un diverso interesse della gente verso le immagini: per trovare conferme (è veramente accaduto! Si pensi al commercio delle immagini di piazzale Loreto a Milano), certezze (la dimensione reale della guerra al di fuori dell’ambito di immediata e diretta conoscenza. Si pensi alla realtà dei bombardamenti) e raffronti (misurare il dolore altrui, il tenore di vita di chi non è stato coinvolto dalla guerra). I fotografi professionisti nei giorni della liberazione si sono messi a riprendere ogni cosa e a renderla disponibile ai giornali che sempre più numerosi, a partire dalle pubblicazioni illustrate, stanno riprendendo ad affollare le edicole, esposti accanto a morbosi fascicoletti stampati da editori improvvisati che promettono anche attraverso le immagini di rivelare le reali cause di quanto accaduto. Sembra un paradosso ma l’immagine diviene in questa fase uno strumento di razionalizzazione e rimozione, di elaborazione del lutto. La forte dose di retorica di cui riesce a dotarsi questo processo di costruzione di un immaginario visivo della Resistenza consente di contenere il doloroso impatto con le immagini inquietanti dei cadaveri martoriati, per quanto ricomposti nelle bare, che rappresentavano la gran parte della documentazione visiva della resistenza scattata tra l’autunno 1943 e i primi mesi del 1945. E’ utile riflettere almeno sommariamente sui caratteri della documentazione fotografica prodotta in quell’arco di tempo e ripercorrere in termini essenziali quella vicenda. Le peculiarità della Resistenza furono la riservatezza, la solidità dei rapporti interni, la necessità di rendere ottimali i rapporti con la realtà esterna alla banda partigiana, l’efficacia dell’azione, l’emblematicità del gesto. Come tradurre ciò in immagini? I primi problemi da affrontare erano di tipo militare e politico: la fotografia non doveva compromettere ed esporre al rischio della rappresaglia nemica né persone né luoghi. I secondi erano di tipo professionale e tecnico: si trattava di disporre di capacità tecniche adeguate e di mezzi, in particolare di reperire materiali che non era facile trovare, per ottenere i quali era talvolta indispensabile affrontare rischi elevati rispetto all’utilità di ciò che si sarebbe realizzato ovvero qualche immagine fotografica che non avrebbe di fatto accresciuto l’efficacia delle azioni compiute. 20 L’atteggiamento dei comandi partigiani fu pertanto in generale di scarsa attenzione verso le potenzialità dell’uso della fotografia nella guerra che si stava combattendo, almeno fino alla fine dell’inverno 1944-45. Fu allora che nella certezza della prossima conclusione della guerra si venne a creare un’ampia disponibilità di operatori professionisti nel campo della produzione di immagini che offrivano i propri servigi, le proprie attrezzature e i materiali indispensabili ai vari gruppi partigiani. La fotografia, in altre parole, iniziava ad essere presente non caratteri di episodicità ma in forma sistematica nell’ora della resa dei conti., Ci si avvide che si erano dimenticati almeno quindici mesi di guerra e, soprattutto, l’intero processo di maturazione politica che aveva portato i primi nuclei di sbandati, spesso aggregati unicamente dal desiderio di vedere terminare in fretta la guerra, in protagonisti della rinascita nazionale. Un percorso di crescita che aveva coinvolto sempre più non solo i gruppi armati ma ampi settori della società civile, divenuti protagonisti di processi che mandavano all’aria, solo per fare due esempi, ruoli sessuali e gerarchie generazionali, scardinando vecchi modelli comportamento. Anche dal punto di vista della rappresentazione dell’iniziativa militare l’episodicità della presenza della macchina fotografica tra le bande partigiane, protrattasi a lungo nel tempo, sfumava le differenze geografiche di una guerriglia che si era sviluppata in modi diversi non solo da una regione all’altra ma spesso di valle in valle. La presenza di fotografi professionisti tra le fila partigiane nelle ultime settimane di guerra portò a moltiplicare gli episodi di ricostruzione di alcuni episodi significativi o almeno emblematici (l’agguato, l’organizzazione della banda ecc.) rendendo credibili tentativi già fatti in precedenza di restituire situazioni eccezionali che avevano dato luogo, nella maggior parte dei casi, a maldestre messe in posa più grottesche e ridicole che verosimili, sicuramente intelleggibili solo dalla memoria dei protagonisti fotografati. La macchina fotografica con questi tentativi professionali di ricostruzione si impegnava a far uscire le istantanee dalle dinamiche del gruppo per tradurle in una lingua comune. Fu in un certo senso la scoperta che la fotografia poteva consentire di “rivelare” ciò che per ragioni di sicurezza era stato a lungo nascosto. Se questi furono i principi ispiratori della documentazione fotografica dell’ultima fase della guerra, quali furono nella realtà i risultati? L’incalzare degli eventi travolse i fotografi che finirono per rappresentare con un numero elevatissimo di immagini le ultime convulse fasi del conflitto, scambiando una ripetitiva serie di episodi per una intera, articolatissima vicenda. La dimensione puramente militare, e poi la cosiddetta “resa dei conti”, prese con prepotenza il sopravvento, lasciando sullo sfondo le varie articolazioni sociali della lotta di resistenza, testimoniata unicamente dalle folle che presenziano sempre più ai singoli episodi ripresi dai fotografi senza particolare intenzionalità o con la volontà di dar voce a scelte politiche, come fino a qualche settimana o mese prima si riprendevano le manifestazioni del regime. Si pensi a piazzale Loreto a Milano, o ai processi e alle sfilate dei collaborazionisti condotti tra ali di folla al luogo dell’esecuzione (Santi e Maffei a Carpanedo, Farinacci a Vimercate, Starace e Barzaghi a Milano, Solaro a Torino ecc.) tutte immagini costruite per essere analizzate esclusivamente per il primo piano mai per le presenze sullo sfondo e per i comportamenti che esse rendevano evidenti e che, con il senno di poi, come è puntualmente avvenuto. sarebbe stato facile definire “bestiali” e “inquietanti”. In quegli ultimi giorni di guerra, quando ci si propose di ricostruire episodi, ad esempio la distribuzione di volantini o il sabotaggio, lo si fece in forma stereotipata e quasi sempre reclutando i protagonisti tra chi si trovava a portata di mano, curando i dettagli e l’apparenza, come ogni ripresa fotografica professionale richiede. Si pensi alle innumerevoli belle ragazze tutte promosse “staffette” o “combattenti” o ai più brutti e cenciosi dei prigionieri inesorabilmente destinati ad incornare i ruoli più odiosi del nemico come in una grottesca caricatura. Il trionfo del luogo comune, d’altro canto, fu praticamente inevitabile e la necessità, come avremo modo di vedere, sembrò crescere anche a conflitto terminato. Le vicende della Resistenza furono fotografate, oltre che dal mondo partigiano, da fascisti, da tedeschi e da operatori alleati. Ed anche su queste produzioni è opportuno soffermarsi brevemente. 21 Furono sguardi diversi l’uno dall’altro, tutti profondamente connotati dalle ideologie ma soprattutto dalle culture di origine. Lo si percepisce in particolare osservando le immagini realizzate dai fotografi Alleati, un esercito composito per nazionalità e culture, dalle quali emerge senza difficoltà il lavoro dell’operatore cresciuto riprendendo le realtà contadine e tra queste il mondo delle campagne europee più povere o le grandi colture statunitensi, oppure districandosi fra le architetture antropologiche metropolitane, oppure nei rigidi schemi della discriminazione razziale dei possedimenti coloniali. Le ideologie dominano soprattutto gli scatti degli operatori tedeschi e fascisti, ma non solo. Il lavoro degli operatori Alleati riflette assai di frequente lo spirito della produzioni di immagini legata alle campagne di documentazione del New Deal, quella democrazia gridata e piena di contraddizioni che fa una fatica estrema, ad esempio, a capire quanto strava accadendo nell’Italia della Resistenza al punto che assai diverse, quando non antitetiche appaiono le immagini prodotte dai fotografi al seguito degli eserciti e da quelli, non molti, aggregati alle missioni Alleate che raggiungono le formazioni partigiane e ne condividono l’esperienza, almeno per brevi periodi di tempo. La produzione neofascista ha comunque peculiarità che è opportuno richiamare. Le milizie di Mussolini stavano non solo combattendo una guerra ma si sforzavano di costruire una legittimità e una credibilità alla Repubblica sociale. Nonostante l’ampia disponibilità di mezzi, di uomini e dell’esperienza degli apparati di propaganda trasferiti da Roma al nord, essi finirono per rinunciare a rappresentare la progettualità politica, limitandosi – forse anche per l’eccessiva frammentazione delle formazioni armate, tutte puntualmente dotate di operatori cine-fotografici – a dare spazio soprattutto all’azione militare e guerresca. Tutta la pubblicistica illustrata del dopoguerra, curata in particolare da Pisanò, evidenzia questa scelta e non solo per il limite imposto dal progetto editoriale che intendeva una storia delle forze armate della Rsi. Basta, per convincersi di ciò, gettare uno sguardo alla produzione istituzionale del Luce per scoprire la scarsa omogeneità dei materiali realizzati, la sovra rappresentazione di realtà assai poco significative, l’egemonia delle divise e delle armi rispetto alla superficiale e minimale documentazione della società civile e della vita quotidiana colta, in proporzione con maggiore attenzione da parte degli operatori militari tedeschi (si pensi alla documentazione sulle “città aperte”, sulle retrovie ecc.) per quanto, come già si diceva, in ossequio a rigidi schemi ideologici di racconto della realtà dell’occupazione del territorio italiano. Come già si diceva nel dopoguerra la rappresentazione fotografica della Resistenza vive nuove determinati stagioni. Nel 1945, a sostegno di uno sviluppo della politica ciellenistica, che trovava la sua più organica espressione nel governo Parri, è il momento delle mostre per far conoscere all’Italia intera quella lotta. Poi, successivamente, nel 1946 l’impegno divulgativo è rivolto all’esterno dei confini nazionali: sono i mesi dell’avvio della conferenza per il trattato di pace che impegnava i governi De Gasperi a rappresentare di fronte ai Paesi vincitori la difficili posizione dell’Italia, prima paese aggressore, poi dal 1943, grazie proprio alla Resistenza, paese schierato contro la Germania hitleriana e la Repubblica neofascista di Mussolini. La scelta di strumenti divulgativi quali appunto le mostre, destinate a fornire una sintesi compiuta di ciò che avevano rappresentato politicamente la guerra partigiana e la Resistenza, impose la costruzione di un modello narrativo per immagini e numerose semplificazioni. Scomparve la specificità territoriale, divenne prioritaria l’azione militare e tutto ciò che si poteva tradurre in cifre significative: quanti morti? quante azioni? quanti mezzi nemici distrutti? ecc. Le coscienze mutate non sono soggette ad essere quantificate e ancor meno risultano facilmente rappresentabili. Come pretendere che una dimessa scrivania in uno stanzone vuoto del municipio di Domodossola evochi adeguatamente quaranta giorni di sforzi per dare un governo ad una zona libera? Come non essere tentati dall’idea di attribuire ad una certa zona quell’immagine “vera” di un sabotaggio ad una linea ferroviaria scattata altrove? I binari venivano minati e fatti brillare quotidianamente in cento luoghi diversi sempre (o quasi) allo stesso modo, con analoghe procedure. A Parigi quell’immagine si trasferì da Cureggio, in Piemonte, all’Emilia, probabilmente perché una didascalia manoscritta aveva suggerito ad un frettoloso lettore anzicché la piccola località nel 22 Novarese il grosso centro di Correggio in provincia di Reggio Emilia. O forse, più semplicemente – e il caso di altre immagini sembrerebbe confermarlo – la somiglianza dei nomi è solo casuale perché si doveva dare comunque una testimonianza visiva dei ripetuti sabotaggi ferroviari nella zona: che importava se nell’immagine erano ritratti Gaetano Colombo “Frisè”, e con lui Renzo Cerri “Bis” e Pompeo, tutti contemporaneamente ripresi da una cinepresa le cui sequenze faranno bella mostra di sé in Giorni di gloria, il documentario per eccellenza della lotta partigiana firmato da Mario Serandrei e prodotto nell’estate 1945. A sessanta anni di distanza, si è ricorsi alla stessa immagine, nel percorso espositivo del piccolo museo della Resistenza di recente allestito ad Ornavasso, a pochi chilometri da Cureggio, poichè essa ben si adattava a rappresentare i sabotaggi a cui aveva partecipato Paolo Stefanoni, caduto a Candoglia il 10 luglio 1944. Nella ricollocazione geografica e temporale dell’immagine mutano ovviamente anche i nomi dei protagonisti che ora sono, oltre a Paolo Stefanoni, il “capitano Ugo”, “Ferruviè” e Benedetto Alberini “Dett”. Vi è anche una esplicitamente dichiarata volontà di piegare alle esigenze della comunicazione i documenti visivi. Quando nel gennaio 1949, ad esempio, la mostra della Resistenza allestita dal Cvl per Bordeaux viene proposta a Novara in occasione della “Giornata della Resistenza”, indetta per il 23 gennaio, e Remo Muratore ne cura l’integrazione con materiali locali relativi alla guerra partigiana e con i pannelli della mostra dedicata ai Convitti scuola della Rinascita per partigiani, che era stata esposta a Praga nei mesi precedenti, uno dei pannelli propone l’immagine dell’interrogatorio alla caserma della Brigata nera “Ettore Muti” di due partigiani. La fotografia, molto nota, era stata esibita anche come prova d’accusa durante il processo ad Alceste Porcelli e altri della Brigata nera avvenuto nei mesi precedenti. Nella mostra allestita a Novara essa viene proposta accompagnata dal seguente testo: «Ma costava caro: molto caro, quando si era presi. Si cominciava così, con le frustate sul viso e si terminava nella tortura più inumana. Qui vediamo solo il braccio del “maresciallo” che cominciava così l’interrogatorio. Chi sarà? Il maresciallo Cau? Quello che ancora oggi per incarico di Scelba applica orrende sevizie si partigiani? [Il maresciallo Silvestro Cau era il comandante della stazione dei Carabinieri di Castelfranco, in Emilia, accusato di aver estorto con la violenza numerose testimonianze contro i partigiani della zona, nel dopoguerra durante le indagini sul cosiddetto “triangolo della morte”. NdR] Non importa sapere chi è, tanto Scelba l’avrà già trovato e gli avrà dato un incarico di fiducia nella Celere! Notate lo sguardo dell’altro prigioniero che attende, è uno sguardo in cui l’orrore delle sevizie è unito all’odio e alla determinazione di resistere. Questi uomini non parlavano allora! S’immagini, Ministro Scelba se riuscirà a piegarli adesso!?!» Le esemplificazioni potrebbero accumularsi numerose. Ma è indispensabile guardare con maggior attenzione alla scelta degli strumenti divulgativi dell’immaginario visivo della Resistenza che vengono utilizzati a partire dall’estate 1945. Come si è detto non era assolutamente semplice anche nell’Italia del 1945 spiegare e far conoscere la Resistenza. Allo scopo di realizzare una comunicazione precisa, capace di trasmettere compiutamente l’idea che “il prezzo pagato dal popolo italiano è stato alto” e che la vicenda resistenziale aveva dimostrato le sue ritrovate e rinnovate capacità civiche e di maturità politica, si erano dedicati fin dalle prime settimane successive alla conclusione della guerra alcuni tecnici che disponevano di una considerevole esperienza professionale di lavoro grafico ed avevano sviluppato negli anni precedenti una attenta e avanzata riflessione critica sulle potenzialità informative di strumenti quali le esposizioni temporanee, cui il fascismo aveva fatto ampio ricorso. Tutti inoltre avevano alle spalle una diretta esperienza della vicenda partigiana. E’ ad essi che si deve la grande e importante stagione della produzione di mostre dedicate alla resistenza ed alla ricostruzione che si aprirà nell’estate del 1945. A poche settimane dalla liberazione, Milano ospita la prima mostra sulla Resistenza. E' la Mostra della liberazione aperta all'Arengario il 7 luglio 1945, organizzata dalla redazione milanese de "l'Unità" e allestita da Gabriele Mucchi, Albe e Lica Steiner con la collaborazione di Mario De Micheli, Duilio Morosini, Ernesto Treccani, Luigi Veronesi, tutti militanti comunisti che avevano partecipato alla lotta clandestina. La mostra, ricca di fotografie, documenti, dati statistici e stampa clandestina, si rivolge ovviamente alla cittadinanza ma è allestita senza dimenticare gli "occupanti" alleati per i quali sono appositamente compilate didascalie in inglese. 23 Composta da circa 23 pannelli, essa offre una ricostruzione non retorica degli eventi dei venti mesi di guerra partigiana. Una piccola sezione di pittura completa la mostra con quadri di Fiorenzo Tomea, Renato Birolli, Gabriele Mucchi, Giuseppe Ajmone, Ernesto Treccani, Renato Guttuso e altri. All’uscita ai visitatori, circa 50.000, viene chiesto di esprimere il proprio parere sull’esposizione. Dal punto di vista dei contenuti il percorso è molto essenziale. Si presenta la vicenda delle brigate garibaldine prendendo le mosse dall’esperienza del lavoro politico clandestino comunista negli anni del regime. In modo significativo la mostra era aperta dalla frase pronunciata da Antonio Gramsci ai giudici del Tribunale speciale: «Verrà giorno in cui voi porterete l'Italia alla catastrofe, e allora toccherà a noi comunisti salvare il paese». Le immagini e i materiali sono quasi tutti realizzati nell’area del Piemonte orientale ed a milano ma essi vengono sempre riproposti in forma emblematica e simbolica. Massiccio il ricorso alle fotografie realizzate dai professionisti, in particolare il nucleo che intorno a Carrese avrebbe dato vita a “Publifoto” e quello che operava con Farabola. Invano si cercherebbero nel percorso espositivo elementi contestuali generali: il fascismo, le sue scelte politiche e le forme dell’antifascismo, le altre nazioni. Eppure – viene spontaneo osservare – Steiner era nipote di Giacomo Matteotti, una delle figure simbolo del martirologio antifascista; egli era stato anche commissario politico in una formazione partigiana che non era garibaldina. Dal canto suo la moglie Lica Covo aveva perso il padre, ebreo, nei massacri sulle sponde del Lago Maggiore nel settembre 1943; così Gabriele Mucchi, a loro stretto da una intensa amicizia, che a sua volta aveva scattato nella casa della famiglia Covo, a Mergozzo, una serie di fotografie delle stanze devastate e saccheggiate dai nazi-fascisti che costituiscono uno dei documenti visivi più intensi relativi a quelle vicende. Con grande rigore – e si può comprendere anche con grande travaglio, in particolare per Albe e Lica – viene scelto di dare priorità alla semplicità del percorso ottenendo, in tal modo, la più elevata incisività della comunicazione: chi siamo, cosa abbiamo fatto, cosa vogliamo. Il rigore linguistico grafico ottenuto componendo in una sorta di collage stampe fotografiche semplici, che sarebbero potute finire in un album di famiglia e che solo una lettura superficiale potrebbe scambiare per subalternità ideologica, rimarrà ineguagliato in tutte le mostre analoghe allestite in quei mesi in altre città dell’Italia settentrionale. La Mostra della liberazione è esposta anche a Genova (9-29 settembre 1945) a Palazzo Ducale, integrata da una seconda parte riguardante Genova e la Liguria organizzata dall'Anpi. Sempre in ambito lombardo, in occasione del primo congresso dei Cln provinciali dell’Alta Italia (Milano, 30-31 agosto 1945) il Cln Lombardia apre, all’Arengario di Milano, la Mostra della ricostruzione organizzata da Emilio Sereni e realizzata ancora una volta da Albe e Lica Steiner. Sul piano dei contenuti la mostra, articolata su 20 pannelli, documenta nella prima parte la lotta armata dando ampio risalto all’opera dei Comitati di liberazione: dall’organizzazione clandestina, all’insurrezione e all’avvio della ricostruzione. La comunicazione è essenziale, fondata sul continuo confronto e sulla contrapposizione dualistica: positivo/negativo, passato/presente, guerra/pace ecc. «25 aprile Cln / 25 luglio Badoglio» contrappone il primo pannello, «Ieri il mitra: oggi la scuola e il lavoro» titola uno degli ultimi. La «nascita della nuova democrazia», rappresentata dai Cln che compongono la «concordia dei partiti», è sintetizzata da un susseguirsi calibrato di richiami: come nasce un Cln, cosa faceva in clandestinità, cosa fa ora, la sua attività quotidiana, il Cln come iniziativa di base, il suo adeguarsi alle diverse realtà nella fabbrica, nel paese, nel quartiere ecc., ed ancora «Epurare per costruire». In questo nuovo allestimento il linguaggio grafico diventa vera e propria ricerca formale: le immagini sono linguaggio e la forma verbale diviene a sua volta costruzione visiva. Totalmente diverso rispetto a quello della precedente mostra esso diviene a sua volta un vero e proprio modello copiato infinite volte negli anni successivi da molti, soprattutto le strutture espositive realizzate con tubi Innocenti, quelle impiegate per realizzare i cantieri, in realtà già impiegate nella mostra precedente, che ora sono scelte per creare spazi e volumi, evocando volutamente il cantiere simbolico della Ricostruzione. Se ci si sposta da Milano a Torino, il 4 agosto 1945 viene inaugurata la Mostra artistica dei partigiani della Langa, allestita alla Galleria Cigala, organizzata dal Fondo di solidarietà nazionale e realizzata da Felice De Cavero, Rino Anzi e Albino Tovagliari, tutti ex partigiani. La 24 documentazione fotografica è fornita da De Cavero, fotografo professionista, già responsabile della stampa e propaganda della 14ª brigata Garibaldi; una sezione della mostra è destinata a disegni, acquerelli, tempere di argomento partigiano. Lo schema contenutistico ha la stessa essenzialità della mostra milanese della liberazione ma di essa manca il rigore e la coerenza stilistica della linea grafica. La fantasia artistica di De Cavero valorizza però abilmente la territorialità della vicenda partigiana al punto che nei mesi seguenti, la mostra viene ampliata e assume carattere regionale, diventando la mostra della Resistenza in Piemonte; la rappresentazione poi si arricchisce di nuova documentazione, giungendo a formare ulteriori sezioni tra cui quelle riguardanti le relazioni tra Resistenza italiana e francese e la partecipazione dell’esercito alla guerra di liberazione.. La mostra viene esposta, su richiesta delle autorità francesi e delle associazioni di italiani in Francia, a Grenoble (3-14 ottobre) e a Nizza (16-25 novembre), poi a Genova (17-26 gennaio 1946), Alessandria (9-17 febbraio). Sullo specifico tema della partecipazione delle Forze armate alla guerra di liberazione dal 25 agosto al 9 settembre 1946 si tiene a Torino anche la Mostra dell’esercito. L’intenso percorso di riallestimenti avuto nel tempo dalla mostra torinese della Resistenza esaurisce, in un certo senso, le sue potenzialità comunicative. Pertanto in occasione del primo anniversario della liberazione di Torino, nell’aprile 1946, si decide di creare un nuovo allestimento della mostra della Resistenza in Piemonte. L’iniziativa è di Franco Antonicelli, presidente del Cln regionale e la realizzazione è curata da Eugenio Gentili Tedeschi che si avvale della collaborazione di Riccardo Moncalvo e di Domenico Riccardo Peretti Griva per la parte fotografica e di Alessandro Galante Garrone per la preparazione dei testi. La mostra è allestita a Palazzo della Cisterna, con materiale molto semplice: pannelli di compensato ricoperti di cartone ondulato per sostenere documenti e fotografie e un soppalco, realizzato con tubi Innocenti, per la sezione destinata alla consultazione, da parte dei visitatori, dei documenti, della stampa clandestina e della letteratura partigiana. L’intento è dichiarato: documentare senza amplificazioni e senza retorica le esperienze e le sofferenze della lotta di liberazione e quanto il Piemonte ha saputo fare per la conquista della libertà. Questo intento è simbolicamente rappresentato dall’ingrandimento fotografico dell’immagine di un partigiano caduto, ripetuta più volte a ricoprire l’intera parete, affiancata da dati con il numero dei caduti e da una grande carta del Piemonte con le indicazioni delle diverse zone partigiane. Il discorso espositivo si apre con il richiamo ai primi caduti dell’antifascismo italiano e agli inizi dell’antifascismo a Torino, per passare subito dopo al 25 luglio, all’8 settembre e alla guerra partigiana vera e propria. La mostra, diversamente da altre dello stesso periodo, si completa con l’esposizione, su tavoli collocati nelle diverse sale, di strumenti propri della guerra partigiana: mine stradali, fucili mitragliatori, mitragliatrici, bazooka, chiodi a tre punte, timbri e documenti falsi; la sala ove sono allestiti i pannelli riferiti alla cooperazione alleata è sovrastata da un paracadute semiaperto e, accanto alla documentazione del processo Perotti, è collocata la sedia utilizzata per la sua fucilazione. Con materiali analoghi sono organizzate negli stessi mesi mostre anche in alcune città europee ad opera esclusivamente delle comunità italiane presenti in quei paesi. Ad Amsterdam, ad esempio, su iniziativa del Circolo ricreativo italiano, è allestita nel marzo 1946 la mostra del partigiano italiano, formata da circa 100 fotografie, alcune delle quali di agenzia (Publifoto) altre trovate nella sede della Muti a Milano. Considerato l’esito positivo della prima mostra della Resistenza in Piemonte, e dei suoi allestimenti in Francia, era nel frattempo nato il progetto di organizzare una Mostra della Resistenza italiana da esporre a Parigi in occasione della Conferenza della pace (Ecole des Beaux Arts, 14-26 giugno 1946). L’iniziativa viene promossa dal Comando generale del Cvl, dal Fondo di solidarietà nazionale e dall’Anpi con il sostegno del Governo e dei ministeri della Guerra e dell’Assistenza post bellica, in accordo con il Comité national de la Resistance française. Inaugurata all'indomani della proclamazione della Repubblica italiana alla presenza di Leo Valiani, Giancarlo Pajetta, Giustino Arpesani e di Louis Saillant, presidente del Conseil national de la Résistance, la mostra è realizzata da Lodovico Belgioioso, Eugenio Gentili Tedeschi, Mario De Micheli, Gabriele Mucchi e 25 Remo Muratore. Albe e Lica Steiner non partecipano al progetto in quanto stanno preparandosi a lasciare l’Italia per il Messico. Le annotazioni stese da Gabriele Mucchi in vista della mostra di Parigi chiariscono molto bene l’intreccio di problematiche tecniche che ci si trovò ad affrontare: «3) La mostra […] non conviene che sia troppo pesante e gonfia di materiale, altrimenti il pubblico non la segue […]. 4) Sono da evitare pitture e disegni, dove questi non abbiano un eccezionale valore documentario e un eccezionale valore artistico. 5) E’ da ricercare invece un’attrattiva nella composizione dei pannelli, in alcune suggestive disposizioni d’allestimento, purché si resti decisamente lontani da qualsiasi retorica, specialmente dalle retorica della fu Mostra della Rivoluzione Fascista. 6) Tenuto conto che la mostra va all’estero e che il suo scopo è di mostrare quale è stato il concorso dell’Italia alla lotta in Europa contro il nazifascismo, e quanto ha fatto per liberare sé stessa, ritengo non sia possibile tenere un criterio di rappresentanza delle varie regioni, o formazioni, o reparti, o CLN, ma piuttosto un criterio unitario-storico-propagandistico. (Una emozionante fotografia di un fatto avvenuto in una modesta formazione dovrà essere preferita a una banale fotografia anche se fornita da una formazione importantissima). 7) Ritengo piuttosto sia necessario dare importanza a statistiche e a grafici che posano fornire alla stampa dati importanti sulle nostre forze, sul numero dei caduti, sui prigionieri inglesi salvati ecc. (tener conto che la mostra, a Parigi, dev’essere inaugurata nei giorni del congresso per la pace). 8) Da evitare energicamente, appunto per il carattere nazionale-storico-propagandistico della mostra, ritratti di martiri, di caduti, di comandanti ecc. se non per i personaggi più importanti e per i nomi che possono avere forte risonanza all’estero. 9) Da scartare nomi ed esaltazioni di singoli reparti o persone. 10) Dosaggio dei cimeli. Inutile p.e. bidoni, paracadute, armi ecc., oggetti notissimi anche dalla resistenza francese: metterei invece p.e. il mitra col fiocco rosso che giustiziò Mussolini, impressionanti strumenti di tortura, una radio clandestina che abbia servito a comunicazioni con l’estero ecc.». L'esposizione si avvale di fotografie, grafici, documenti, in lingua francese, che illustrano l’azione svolta dal popolo, dai partigiani, dai soldati contro l’oppressione fascista e l’occupazione tedesca. I materiali sono montati su circa 160 pannelli più un enorme plastico dell’Italia settentrionale con la dislocazione delle forze partigiane nella primavera 1945. A differenza delle esposizioni precedentemente descritte questa volta sono affrontati i temi dei caratteri del regime fascista e della realtà economica nazionale italiana. Non sono tuttavia affrontate le responsabilità della monarchia – e ciò per ovvie ragioni essendo stata realizzata la mostra mentre era ancora in corso la vicenda referendaria istituzionale che sarebbe stata conclusa dal voto del 2 giugno 1946 – né le campagne coloniali o la legislazione razziale. Il fascismo è rappresentato come espressione classista, finanziato dell’alleanza tra i grandi proprietari terrieri e i capitalisti della grande industria. Del regime si sottolinea continuamente il ricorso alla violenta repressione del dissenso, ai caratteri di Stato liberticida, all’impegno nell’indottrinamento delle nuove generazioni attraverso l’uso degli apparati scolastici. Della società italiana si evidenziano la miseria crescente e diffusa, gli arricchimenti speculativi ma al tempo stesso il mantenersi vitale di una opposizione antifascista che nella guerra di Spagna manifesta nuovamente la sua capacità di organizzare una risposta di lotta incisiva al fascismo. Sarà proprio questa vicenda e l’inizio della guerra mondiale, di cui non si approfondiscono tuttavia i caratteri e le responsabilità, a far crescere anche quella fronda intellettuale giovanile che tanto contributo darà all’iniziativa nuova dei partiti antifascisti ricostituitisi e stretti da un patto d’azione comune stipulato nel 1942. A partire da questa nuova alleanza aumenta anche la mobilitazione operaia nelle fabbriche resa sempre più manifesta dal numero crescente di scioperi. Ampio spazio ha poi, nella ricostruzione delle vicende resistenziali realizzata dalla mostra, il contributo offerto dalle forze armate sia al momento dell’armistizio sia poi con la costituzione di reparti combattenti in Jugoslavia ma soprattutto in Italia ove si giungerà a costituire con il contributo degli Alleati il Corpo italiano di liberazione. 26 La ricostruzione di queste vicende giunge anche ad eccessive enfatizzazioni che rischiarono addirittura di provocare un incidente diplomatico a causa del modo di rappresentare quanto accaduto in Corsica dopo l’8 settembre 1943. L’allestimento parigino venne riproposto a Zurigo (4-19 gennaio 1947), Basilea (25 gennaio-2 febbraio), Ginevra (8-16 febbraio), Roma (dicembre), Napoli (15-30 giugno 1948), Torino (17 settembre-6 ottobre 1948) e, secondo un progetto poi non realizzatosi, avrebbe dovuto essere portato a Londra, New York, Buenos Aires e Rio de Janeiro. Nel 1953 la mostra dopo essere stata allestita a Milano fu affidata dal CVL alla custodia definitiva del Museo del Risorgimento. Verso la fine del 1946, su invito del Centre action de défense emigrès in Bordeaux, organizzatore di una “Esposizione della Resistenza europea” viene allestita una Sezione italiana destinata alla mostra di Bordeaux (prevista per il 14 dicembre 1946) con documentazione in lingua francese. Lo spazio limitato messo a disposizione dell’Italia obbliga il Comando generale del Cvl a una nuova elaborazione del materiale selezionato per Parigi e a contenere la mostra in dimensioni molto minori (circa 80 pannelli) che includono anche una parte riguardante la ricostruzione. Gli ottanta pannelli della mostra di Bordeaux vengono allestiti in tutta fretta, avendo a disposizione pochissimi giorni, affidandosi alla intensa partecipazione e conoscenza dei temi da sviluppare e alle straordinarie capacità creative delle persone a cui veniva chiesto di realizzare il percorso espositivo. Di questo gruppo conosciamo con certezza solo due nomi: Remo Muratore e Italo Pietra. Al primo si deve in tutta probabilità gran parte della preparazione dei pannelli, al secondo il lavoro sui testi, con una sinergia che si ritroverà successivamente al momento della realizzazione del volume bilingue, italiano e francese, La Resistenza italiana, edito dal Corpo volontari della libertà nel 1949, ampliando l’opuscolo stampato due anni prima. Muratore, originario di Chieri, si era formato a Milano ove aveva lavorato, dal 1938 al 1941, presso lo studio Buggeri realizzando vari importanti lavori con Xanti Schawinsky, Max Huber, Albe Steiner, Luigi Veronesi e Erberto Carboni. Dal 1943 al 1945 aveva partecipato attivamente alla lotta partigiana nell’Oltrepò pavese. Italo Pietra era originario di Godiasco nel pavese. Con il nome di battaglia “Edoardo” aveva partecipato alla resistenza anch’egli nell’Oltrepò, divenendo prima ispettore delle brigate garibaldine, poi comandante delle diverse divisioni della zona. Nella preparazione della mostra destinata a Bordeaux, come già si diceva, viene fatto un ampio uso della documentazione predisposta per la precedente di Parigi ma i pannelli finiscono per risultare, sia sul piano dei contenuti sia dal punto di vista tecnico, assai diversi. Nonostante si disponesse solo di una manciata di giorni si era provveduto alla ricerca di nuove immagini e documenti, in particolare relativi alla ricostruzione – tema che nella mostra di Parigi era assente – e alla riscrittura totale dei testi. Dal punto di vista tecnico le immagini vengono ristampate e impaginate sui pannelli, i titoli e talvolta alcuni testi sono tracciati e colorati a tempera, ma la ulteriore, vera grande novità è rappresentata dalla scelta dei materiali di supporto: non più pannelli pesanti e di grosso formato sopra i quali i materiali talvolta rischiavano di perdersi, ciascuno dotato di un supporto poco maneggevole, bensì snelle tavole in masonite nelle quali le immagini e i documenti si susseguono con un ritmo serrato di narrazione, ciascuna dotata di una perforatura standard per fissarle a parete o per consentire di unirle, pannello a pannello, con semplici anelli di connessione. Quando il 12 dicembre 1946 Remo Muratore e Italo Pietra partono alla volta di Bordeaux con loro viaggiavano tre o quattro casse di solida struttura ma modesto peso che nulla hanno in comune con le 51 casse del peso complessivo di nove tonnellate e mezzo necessarie al trasferimento della mostra di Parigi. Il percorso espositivo progettato per Bordeaux risulta praticamente dimezzato rispetto a quello realizzato a Parigi. Esso vede i curatori costretti a rendere essenziale la comunicazione, con una notevole riduzione dei testi e con l’eliminazione di larga parte del percorso argomentativo. Si finisce così per accentuare sia il ruolo delle tematiche presenti sia, all’interno di esse, il peso delle reticenze e delle omissioni. Si puntò a colpire l’attenzione quasi esclusivamente con elementi di assoluta sintesi, con dati, statistiche o grafici. 27 Il tema delle vicende storiche del ventennio di dittatura fascista, da cui aveva preso avvio l’allestimento della precedente mostra di Parigi, vede l’assenza di una riflessione sul fascismo come regime. Esse vengono ricondotte alle vicende di un dittatore circondato da un manipolo minoritario di violenti e criminali rinunciando, nuovamente, a sottolineare le responsabilità storiche della monarchia, i caratteri reazionari di massa assunti dal regime, le politiche di discriminazione razziale praticate, le mire di espansionismo imperialista, le responsabilità nello scatenare il secondo conflitto mondiale. Delle guerre fasciste condotte a partire dal 1935 non vi è traccia, così neppure della guerra di Spagna, che nella precedente esposizione parigina era invece ampiamente richiamata; lo stesso avversario della guerra partigiana è individuato nel “crucco nazista”, mentre nella precedente mostra era sempre, in modo più accorto, denominato “tedesco”. Le responsabilità collettive risultano dunque totalmente azzerate e, di conseguenza, viene ad essere enfatizzato il ruolo dell’esercito e delle forze armate. Anche i caratteri generali della lotta di resistenza sono ricondotti ad uno schematismo quasi riduttivo. Nonostante l’Esposizione di Bordeaux non sia stata poi effettuata, la mostra allestita per l’occasione è stata presentata in diverse città italiane e straniere: Berna, Lucerna, Lugano, Milano, Praga, Novara (dal 22 gennaio 1949 per alcune settimane), Pisa (settembre 1949). L’impegno di grafici ed architetti impegnati nella realizzazione di tutte queste mostre non può ovviamente essere disgiunto dal dibattito che si stava svolgendo in quei mesi, e che li vedeva spesso protagonisti, intorno alla figura dell’intellettuale ed al ruolo della cultura. “Una nuova cultura”, come l’avrebbe definita Elio Vittorini dalle colonne del primo numero de “Il politecnico”, la rivista progettata dal punto di vista grafico e della comunicazione da Albe Steiner, il grafico che aveva realizzato la mostra della liberazione e quella della ricostruzione a Milano nell’estate del 1945. «Non più una cultura che consoli nelle sofferenze, ma una cultura che protegga dalle sofferenze, che le combatta e le elimini»: così si apriva quell’editoriale che tracciando le linee programmatiche della nuova rivista assumeva i caratteri di un vero e proprio manifesto: «Di chi è la sconfitta più grave in tutto questo che è accaduto? […] se il fascismo ha avuto modo di commettere tutti i delitti che questa cultura aveva insegnato ad esecrare già da tempo, non dobbiamo chiedere a questa cultura come e perché il fascismo ha potuto commetterli? […] l’insegnamento di questa cultura non ha avuto che scarsa, forse nessuna influenza civile sugli uomini. Essa ha predicato, ha insegnato, ha elaborato principii e valori, ha scoperto continenti e costruito macchine, ma non si è identificata con la società, non ha governato con la società, non ha condotto eserciti per la società […]. Potremo mai avere una cultura che sappia proteggere l’uomo dalle sofferenze invece di limitarsi a consolarlo? Una cultura che le impedisca, che le scongiuri, che aiuti a eliminare lo sfruttamento e la schiavitù, e a vincere il bisogno, questa è la cultura in cui occorre che si trasformi tutta la vecchia cultura. La cultura italiana è stata particolarmente provata nelle sue illusioni […]. Io mi rivolgo a tutti gli intellettuali italiani che hanno conosciuto il fascismo. Non ai marxisti soltanto, ma anche agli idealisti, anche ai cattolici, anche ai mistici […]. Occuparsi del pane e del lavoro è ancora occuparsi dell’“anima”. Mentre non volere occuparsi che dell’“anima” lasciando a “Cesare” di occuparsi come gli fa comodo del pane e del lavoro, è limitarsi ad avere una funzione intellettuale, e dar modo a “Cesare” (o a Donegani, a Pirelli, a Valletta) di avere una funzione di dominio “sull’anima” dell’uomo. Può il tentativo di far sorgere una nuova cultura che sia di difesa e non più di consolazione dell’uomo, interessare gli idealisti e i cattolici, meno di quanto interessi noi?». Ciò che si crea intorno alle mostre è un colossale laboratorio carico dell’entusiasmo, della gioia e della vitalità giovanile di questi intellettuali, nonché delle irrequietezze generazionali di chi aveva fatto l’esperienza della resistenza. Tale laboratorio, da un lato, definisce l’immagine visiva della resistenza che verrà come tale riproposta per numerosi decenni, dall’altro, costituisce una esperienza di raccolta della documentazione della lotta partigiana che, a sua volta, consentirà la costituzione e la nascita degli archivi storici della resistenza a partire da Torino nel 1945, da Genova nel 1947 e da Milano poco dopo fino alla nascita in questa stessa città dell’“Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia” nel 1949 ad opera di Ferruccio Parri. 28 Rispetto alla prima, in particolare, va rilevato che la necessità di fornire una informazione visiva ampia e incisiva, perseguendo al tempo stesso gli obiettivi della massima semplificazione e della essenzialità si tradussero, da un lato, nella scelta di immagini che finirono per ripetersi mostra dopo mostra divenendo uno stereotipo, dall’altro nell’inizio della moltiplicazione degli errori di attribuzione a luoghi, persone ed eventi dovuti ora a involontarie imprecisioni, ora all’opportunismo di dover documentare situazioni di cui non esistono fotografie, oppure per compiacere il probabile fruitore dell’immagine. Vi fu poi l’ampio coinvolgimento nella riproduzione tecnica dei materiali e nella raccolta della documentazione visiva, soprattutto dei momenti della liberazione e del dopoguerra, dei fotografi professionisti delle agenzie (Publifoto, Farabola ecc.) che, se arricchivano dal punto di vista estetico-formale la qualità delle immagini esposte, introdussero però logiche documentali assolutamente non scientifiche, bensì commerciali. E’ principalmente a questi fotografi che si deve l’avvio parallelo di una distribuzione – soprattutto a periodici e alle prime pubblicazioni saggistiche illustrate – dei materiali originali della resistenza privi – spesso volutamente per aggirare possibili pagamenti di diritti – di indicazioni precise. Questa pratica nel tempo ha prodotto la generalizzata perdita di identità delle fotografie che solo di recente, dopo varie decine di anni si è iniziato, con estrema fatica essendo scomparsi nel frattempo molti utili testimoni, a studiare ed a sottoporre ad edizione critica. Sul piano politico l’intera vicenda evidenzia una coesione tra i rappresentanti delle forze partitiche che avevano dato vita all’esperienza dei Cln che superò le prove delle divisioni e contrapposizioni di quegli anni e che andrebbe più ampiamente indagata. Le mostre stesse rappresentano con evidenza un percorso di progressiva restrizione degli spazi politici pienamente e interamente condivisi. A distanza di decenni dalla loro realizzazione risulta evidente come, al di là della rilevanza documentale dei materiali sul piano storico, sia indispensabile riflettere intorno all’analisi della progettualità e delle finalità comunicative del percorso che la mostra ha voluto sviluppare. In altre parole significa cogliere, da un lato, il disegno scientifico in tutta la sua ampiezza, dall’altro e, al tempo stesso, alla luce di tutti gli evidenti limiti che gli organizzatori si imposero, il tipo di rappresentazione che delle vicende della lotta di resistenza italiana si intendeva dare al mondo intero nel momento in cui si andavano definendo gli accordi di pace ed i nuovi assetti ed equilibri internazionali. L’Italia era stata, tra il 1940 e il 1943, un Paese aggressore, corresponsabile dello scatenamento del secondo conflitto mondiale, accanto alla Germania nazista e all’impero nipponico. Dopo l’armistizio del settembre 1943, si erano viste, al suo interno, significative fasce della popolazione insorgere di propria iniziativa, impugnando le armi per combattere l’occupazione tedesca e il progetto politico delle forze neofasciste che, all’ombra delle bandiere naziste, tentavano di ripristinare nel Paese il governo della dittatura spazzata via dalla sua stessa crisi interna nel luglio precedente. «L’importanza di una lotta di liberazione – scriveranno, proprio Muratore e Pietra, a cominciare dal risvolto di copertina del volumetto La resistenza italiana – non si può giudicare dalla misura del vantaggio militare che gli eserciti alleati ne hanno ricevuto. Anche la lotta di liberazione francese e la lotta di liberazione jugoslava perdono parecchio della loro importanza se giudicate sulla base del loro apporto allo sforzo bellico degli eserciti alleati. E la lotta di liberazione italiana, malgrado le sue decine di migliaia di caduti, diventa di un’importanza irrisoria se giudicata su simile base. E’ fuori dubbio che se anche non ci fosse stata nessuna lotta di liberazione italiana gli eserciti alleati avrebbero vinto lo stesso. La differenza sarebbe stata solo di tempo. Essi avrebbero vinto sei mesi più tardi. Ma se non vi fosse stata nessuna lotta di liberazione, cioè nessuna lotta partigiana, essi non sarebbero stati degli eserciti liberatori; sarebbero stati degli eserciti semplicemente conquistatori». Va poi ricordato che negli stessi giorni della fine del 1946, in cui veniva realizzata la seconda mostra della Resistenza italiana e si predisponeva il volumetto che avrebbe accompagnato la sua circolazione e quella dei pannelli allestiti per l’esposizione di Parigi, i rappresentati del popolo italiano, democraticamente eletti dopo oltre venti anni di soppressione delle libertà, iniziavano a scrivere la carta costituzionale, documento fondamentale per la vita democratica che il Paese si avviava a vivere, riversando in essa lo spirito e gli sforzi di quel percorso di liberazione. 29 Olivier Forlin - La risonanza delle mostre sulla Resistenza italiana in Francia. La difficile costruzione di una memoria della Resistenza italiana in Francia (dal 1945 agli anni ‘50) Analizzeremo la conoscenza in Francia della Resistenza italiana nel dopoguerra e la costruzione di una memoria di questa lotta clandestina dal 1945 agli anni ‘50, attraverso l’accoglienza fatta in Francia alla mostra dedicata alla Resistenza piemontese (Mostra partigiana) presentata a Grenoble ed a Nizza nell’ottobre 1945 e attraverso la mostra sulla Resistenza italiana presentata a Parigi alla primavera del 1946. Gli obiettivi degli organizzatori di queste mostre erano molteplici: far conoscere in Francia la lotta clandestina italiana e la partecipazione degli Italiani alla liberazione del proprio territorio ed alla lotta contro il nazi-fascismo; cancellare il ricordo del fascismo. Nella prospettiva della conferenza per il trattato di pace fra Italia e Alleati (che si riunirà a Parigi l’estate ‘46), si trattava di creare una corrente di opinioni favorevole all’Italia, e più in generale, di favorire un reinserimento rapido dell’Italia nel nuovo equilibrio internazionale. Quale fu la risonanza di queste mostre nell’opinione francese, vista da un lato nella stampa quotidiana delle regioni di Grenoble e di Nizza e, dall’altro lato, nei periodici nazionali? Tutti i messaggi che gli organizzatori volevano diffondere furono recepiti? Quale fu la risonanza delle mostre sulla costruzione di una memoria della Resistenza italiana in Francia? Esistono altri vettori che permisero di far conoscere la memoria della lotta clandestina italiana? I. Le reazioni alla Mostra partigiana nella stampa della regione di Grenoble nell’ottobre ‘45 Una reazione entusiastica La mostra, inaugurata il 3 ottobre 1946, ricevette un’accoglienza molto favorevole. Tanto più che l’inaugurazione della Mostra fu segnata dalla presenza di partigiani, il cui capofila depose una corona sulla tomba di suo figlio ucciso durante i combattimenti ai fianchi delle FFI. La stampa, e in particolare i periodici comunisti (Le Travailleur alpin) o vicini al PC (Les Allobroges), ma anche giornali con diversi orientamenti politici come Le Dauphiné libéré e Le Réveil, segnalarono il gesto e ricordarono l’impegno degli Italiani nella lotta armata, i sacrifici, i rapporti stabiliti fra i movimenti della resistenza da una parte all’altra della frontiera alpina, la solidarietà nata da questi contatti, la fedeltà allo spirito della Resistenza e all’ideale di libertà... La mostra, incarnazione della Resistenza italiana, si fece il portavoce di un Italia antifascista e democratica e costituì una tappa nel rinnovarsi dell’amicizia franco-italiana. Oltretutto, l’Italia era sul punto di rientrare nel novero delle nazioni democratiche. Obiettivi non raggiunti Ciononostante, gli obiettivi degli organizzatori di cancellare la memoria del fascismo per sostituirla con quella di una Italia partigiana non furono del tutto raggiunti su scala nazionale. La Mostra di Parigi a maggio 1946 non fu assolutamente citata nella stampa nazionale (il vaglio di quotidiani come Le Monde e L’Humanité si è rivelato vano). Soltanto un articolo pubblicato sulla rivista comunista Europe, alla fine del ‘46, evocò la mostra, firmato da Maria Brandon-Albini, un’intellettuale antifascista italiana esiliata in Francia nel 1936, che partecipò alla Resistenza in Francia e vi si installò. Brandon-Albini si lamenta del debole eco provocato dalla mostra e, oltre questo, del fatto che la Resistenza italiana sia disconosciuta in Francia. Al contrario, alcune settimane più tardi, durante le negoziazioni del trattato di pace, le reazioni furono di estrema diffidenza verso l’Italia, per non dire anti-italiane, quando l’Italia protestò contro l’attribuzione alla Francia dei due comuni alpini di Tenda e Briga. La stampa nazionale francese evocò il ricordo delle aggressioni fasciste, la “pugnalata alle spalle” del giugno ‘40 ; si riparlò di una vicenda di mitragliamento dei Francesi da parte dell’aviazione italiana durante l’esodo ; si ricordò la responsabilità del popolo transalpino nel sostegno al fascismo e la perennità del regime. Le rivendicazioni francesi furono considerate legittime. Hubert Beuve-Méry, direttore di Le Monde, ad esempio, redasse editoriali piuttosto severi nei confronti delle forze nazionaliste italiane che protestavano contro la Francia. Non risparmiò neanche Alcide De Gasperi che anch’egli, aveva espresso la sua contrarietà all’attribuzione alla Francia dei due comuni. BeuveMéry gli rimproverò di strumentalizzare il nazionalismo ed il malcontento italiani per fini di politica interna e si dichiarò scandalizzato dal suo atteggiamento (editoriale del 30 giugno - 1° luglio ‘46). 30 La corrispondenza del direttore di Le Monde con Maurice Vaussard, un italianista e collaboratore occasionale di Le Monde, traduce una posizione simile: Beuve-Méry minimizza il ruolo e l’importanza della Resistenza italiana e critica maggiormente ancora, l’atteggiamento dei responsabili transalpini. [cf. luglio 1945: Maurice Vaussard si stupisce, in una lettera a Hubert Beuve-Méry che questi abbia tagliato l’articolo edito in Le Monde dove faceva riferimento a propositi del suo amico Luigi Sturzo; la risposta di Beuve-Méry fu questa: « E’ proprio perché mi sembrava che don Sturzo desse uno spazio eccessivo alla Resistenza italiana che ho soppresso quel passo. Credo che si possa fare una politica amichevole verso l’Italia pur senza dare una risonanza eccessiva al ruolo pur sempre ristretto degli antifascisti» (Lettera di H. Beuve-Méry a M. Vaussard, del 18-07/1945] Alla fine dell’estate del 1946, Beuve-Méry confidò ancora a Vaussard il suo relativo malumore nel confronto degli Italiani: « Ho visto parecchi Italiani in questi ultimi tempi; i migliori tra di loro hanno delle reazioni assai strane» (lettera di H. Beuve-Méry a M. Vaussard, del 5 settembre 1946). Il tono e gli argomenti erano analoghi negli articoli del corrispondente permanente di Le Monde a Roma, Jean d’Hospital. Dal canto loro, gli intellettuali legati al PCF diventarono più veementi verso l’Italia. Fu Aragon, allora responsabile del prestigioso Comité national des Écrivains (CNE), organizzazione nata nella clandestinità, che rispose ai responsabili italiani nel luglio 1946 in Les Lettres françaises [« Après le Congrès des Écrivains. Amica Italia », Lettres françaises, n° 116, 12 luglio 1946]: Attaccò con virulenza i nazionalisti italiani, nonché gli antifascisti, e rimproverò ad alcuni di loro di essersi associati alle proteste dei primi, come Toscanini che aveva annullato un concerto in Francia. Toscanini accusava quest’ultima di indebolire la giovane democrazia italiana e di favorire l’irrobustirsi dei nostalgici di Mussolini con l’annessione dei comuni alpini. Opponendosi agli argomenti degli antifascisti, Aragon affermò che l’Italia, anche governata da oppositori del fascismo, doveva pagare per i crimini del defunto regime, ritenne che « il prezzo di Tenda e Briga è modesto per questo», e suggerì ai democratici italiani di prendersela non con la Francia, ma col regime mussoliniano. Chiaramente, con l’occasione della vicenda delle frontiere alpine, si risvegliava il risentimento per i discorsi anti-francesi degli anni ‘30 e per l’aggressione di giugno 1940: « Gli scrittori francesi, [che però ben si guardano di giudicare a questo riguardo il popolo italiano nel suo insieme, il quale ha saputo nel 1943 riprendere al nostro fianco la lotta contro il nemico comune], non possono però dimenticare che non tanto tempo fa, in Italia, non erano semplici rettifiche di frontiera ad essere reclamate a gran voce, ma Nizza, ma la Savoia, ma la Corsica, ma la Tunisia. L'Italia ha fatto la guerra con il fascismo, i suoi soldati hanno saccheggiato, ucciso, devastato il nostro suolo. Questo deve essere pagato, e per l’avvenire comune della Francia e dell’Italia. Tenda e Briga sono un prezzo modesto per il crimine di quelli che, se fossero stati vincitori, ci avrebbero strappato Nizza, la Savoia, la Corsica, la Tunisia ». Analoghi sentimenti furono espressi dalla stampa di Grenoble; il tono era ancora più duro nei quotidiani nizzardi. A Nizza, l’accoglienza della Mostra nell’autunno del ‘45 suscitò meno entusiasmo che non nel Delfinato, e le reazioni anti-italiane furono più vivaci nella primavera del ‘46 che nella regione di Grenoble. Un settimanale di Nizza, L’Ergot, creato da un gruppo di resistenza gollista, adottò una linea molto italofoba. Queste differenze fra le reazioni delle opinioni di Nizza e Grenoble dipendevano da vari fattori [Vedi Ralph Schor, « L’image des Italiens dans les Alpes-Martimes (1938-1946) »]: l’emigrazione italiana era meglio integrata nel Delfinato che nelle Alpi marittime, dove le tensioni fra Francesi ed emigrati italiani erano vivaci alla fine degli anni 1930; il ricordo dell’occupazione italiana (nov. 1942 - sett. 1943) era meno dolorosa a Grenoble che a Nizza, dove le rivendicazioni irredentistiche italiane avevano segnato la popolazione locale. Infine, dopo l’8 settembre 1943, a Grenoble ci furono delle organizzazioni antifasciste come i CLN e l’Unione delle Donne Italiane che contribuirono a far conoscere la Resistenza transalpina e ad accreditare l’idea della solidarietà franco-italiana forgiata nella lotta clandestina. Ad ogni modo, malgrado le mostre del 1945-1946, le reazioni anti-italiane mostrano che la Resistenza italiana era disconosciuta in Francia nel dopoguerra; anche se non era ignorata da 31 alcuni settori dell’opinione o in alcune regioni, il suo ricordo stentava a controbilanciare la memoria dolorosa del fascismo e delle aggressioni. II. I motivi del disconoscimento della Resistenza italiana in Francia Si possono addurre vari motivi per rendere conto della disconoscenza della lotta clandestina italiana in Francia. Alcuni sono congiunturali e sono legati al fatto che le truppe francesi che combatterono in Italia furono avvicendate a Firenze, e non penetrarono quindi nel centro-nord dove la Resistenza italiana si manifestò maggiormente a partire dall’inverno 1944-45. Altri motivi rimandano agli interessi politici francesi ed allo stesso tempo alle rappresentazioni dominanti verso l’Italia: la Francia cercò di minimizzare la partecipazione italiana alla Resistenza, perché il mantenere l’Italia nel campo dei vinti, sminuirla in quanto potenza di minor rango, permetteva di valorizzare il rango della Francia, in un momento in cui questa tentava di ritrovare e riaffermare il proprio ruolo di grande potenza. Questo atteggiamento permise di legittimare le pretese territoriali sull’Italia: il GPRF fece occupare la Valle d’Aosta nel maggio 1945, prima di essere costretto ad evacuare la regione sotto la pressione degli anglosassoni. Quindi le autorità francesi reclamarono le rettifiche della frontiera alpina. L’occultamento della partecipazione italiana alla lotta clandestina era anche l’espressione di un paternalismo politico e di sentimenti accondiscendenti verso l’Italia. Nel testo citato in precedenza, Aragon si attribuisce il “diritto”, dice, di denunciare le posizioni nazionalistiche degli antifascisti italiani; per legittimare le proprie critiche, egli invoca le campagne d’Italia di Napoleone che avrebbero portato oltre le Alpi i principi della libertà; e quindi accusa gli antifascisti transalpini che se la prendono con la Francia, di voler colpire la libertà. Il disconoscimento della Resistenza transalpina infine, era l’espressione della pregnanza di una memoria dolorosa del fascismo, delle rivendicazioni di Mussolini, dell’aggressione del giugno 1940. Questi sentimenti, ovvi nella stampa di destra nazionalista, erano anche presenti nei periodici del PCF la cui linea oscillava dalla solidarietà antifascista nata dalla Resistenza al nazionalismo di cui il partito si fece il portavoce nel dopoguerra. Dal popolo italiano ci si aspettava un esame di coscienza, l’espressione di una colpevolezza; e quando i rapporti si fecero più tesi fra i due paesi a proposito delle frontiere alpine, questi sentimenti diventarono di ostilità verso l’insieme degli Italiani, antifascisti compresi. Evidentemente, le idee ed immagini che le mostre tentarono di diffondere in Francia fecero fatica a controbilanciare una serie di idee e di rappresentazioni che erano altrettanti ostacoli alla costruzione di una memoria della Resistenza transalpina in Francia. III. La costruzione di una memoria della Resistenza italiana in Francia grazie agli intellettuali e alla cultura A partire dal 1946-47 tuttavia, alcuni intellettuali elaborarono una memoria decisamente diversa del fascismo e della Resistenza italiana e tentarono di far conoscere in Francia allo stesso tempo la lotta clandestina transalpina e le sofferenze vissute da una parte del popolo italiano durante la guerra. Gli intellettuali di sinistra francesi sedotti dall’Italia Erano gruppi poco numerosi, tra i quali si annoveravano gli intellettuali marxisti indipendenti del partito comunista, in particolare quelli che gravitavano intorno a riviste come Les Temps Modernes diretta da Sartre, o Esprit di Emmanuel Mounier. Altri erano membri del PCF, ma ai margini dell’apparato del partito perché la loro relativa autonomia era difficilmente compatibile con la disciplina esatta dalle autorità comuniste; il gruppetto informale detto della « rue Saint-Benoît » che intorno a Marguerite Duras radunava Robert Antelme, Dionys Mascolo oppure Edgar Morin, nonché parte di coloro che animavano il settimanale Action (gli stessi, con anche Claude Roy, Dominique Desanti...), avevano le stesse opinioni. Sedotti dalle forze politiche della sinistra transalpina, il PCI che ritenevano più flessibile della controparte francese, o il partito d’Azione che sembrava loro innovatore, dai dibattiti ideologici che animavano gli ambienti dell’intellighenzia di sinistra, in particolare quelli che si svilupparono intorno ai pensieri di Gramsci, Vittorini o Gobetti, 32 attratti infine dal rinnovo letterario e cinematografico sotto il segno del neorealismo, instaurarono dei rapporti con gli omologhi italiani e si aggregarono alle loro reti. Le testimonianze sulla guerra e la Resistenza Questi intellettuali pubblicarono in Francia dei servizi sull’Italia nuova, dove intervistavano i capifila della Resistenza e dell’antifascismo, evocarono il loro combattimento fin dal periodo fra le due guerre, il loro esilio, spesso in Francia, ricordavano la lotta armata e rendevano loro omaggio. Sottolineavano pure, come ad esempio René Maheu in Les Temps Modernes alla primavera del 1946 [« Italie nouvelle ou les incertitudes de la liberté »], Georges Adam in Les Lettres françaises (di cui è allora il redattore capo) allo stesso periodo [« Le levain dans la pâte »], o Mounier in Esprit all’inizio del 1948 [« Lignes de force d’un personnalisme italien »], il martirologio italiano quando si rendevano sui luoghi di memoria della repressione nazifascista: le fosse Ardeatine furono frequentemente citate, così come piazza Nettuno a Bologna dove erano esposte le foto di partigiani caduti, mentre Torino venne dichiarata capitale della lotta clandestina. Nelle pagine dei periodici, pubblicavano testimonianze dirette di Italiani sulla prova della guerra e sulle vicende della resistenza. In effetti, in Italia apparve la tendenza da parte di alcuni gruppi intellettuali, a pubblicare documenti grezzi, testimonianze in presa diretta (diari, lettere, racconti di vita...) sul conflitto e la Resistenza, sugli itinerari sotto il fascismo e durante la clandestinità: preoccupazioni che erano quelle della redazione della rivista milanese diretta da Elio Vittorini, Il Politecnico, e quelle della squadra di Società, basata a Firenze ed animata da Cesare Luporini e Romano Bilenchi. Gli intellettuali francesi legati a quegli ambienti riprodussero a loro volta questi documenti nei propri periodici, come la redazione dei Temps Modernes che dedicò un numero speciale all’Italia nel 1947 [n° 23-24, agosto-settembre] che molto deve a Vittorini ed ai suoi amici. E’ un importante volume per la conoscenza della nuova Italia in Francia. Una delle tre sezioni, intitolata “Guerra” era costituita da alcune di queste testimonianze. Una è il racconto del massacro da parte dei Tedeschi degli uomini del paese di Civitella della Chiana presso Firenze (scritto da una donna del paese diventata vedova, fu elaborato da Romano Bilenchi e Marta Chiesi); un’altra è la narrazione di Giacomo Debenedetti, scrittore e critico romano, del rastrellamento degli Ebrei di Roma dai nazisti il 16 ottobre 1943; una terza testimonianza racconta le esecuzioni di giovani partigiani dalla milizia fascista. Diversi testi, spesso racconti o lettere di intellettuali, testimoniano l’impegno degli Italiani nella Resistenza: un documento anonimo racconta l’attentato di via Rasella contro soldati tedeschi (come rappresaglie, i tedeschi massacrarono più di 330 civili italiani alle fosse Ardeatine); è riprodotto il diario di Bruno Fanciullacci, intellettuale fiorentino impegnato e morto nella lotta clandestina, così come la lettera che Giaime Pintor scrisse a suo fratello Luigi la vigilia del giorno in cui entrò nella lotta armata dove anch’egli avrebbe lasciato la vita. Infine, anche se non è inserito in questa sezione, ma nella successiva intitolata “Crisi”, l’estratto dell’autobiografia di Franco Fortini dove ricostituisce il percorso che lo condusse dal fascismo di sinistra della propria giovinezza alla lotta armata nei ranghi socialisti, è apparentato ai precedenti testi. Così, con un atteggiamento identico a quello di alcuni periodici transalpini, Les Temps Modernes non pubblicarono analisi sapienti sulla resistenza firmate da storici o politici, ma testimonianze dirette, forti, che suscitavano una vivace emozione. Gli intellettuali francesi di sinistra attinsero altresì alla letteratura ed al cinema italiani e pubblicarono nelle proprie riviste dei passi di opere di finzione (romanzi, novelle, croniche...) sulla Resistenza, nonché numerose critiche di libri e film sullo stesso tema. La cultura neorealista, vettore della conoscenza della Resistenza e del martirio italiano L’accoglienza delle opere letterarie e cinematografiche neorealiste da parte degli intellettuali francesi di sinistra fu entusiasta. Ora, gran parte di queste opere trasmettevano un antifascismo culturale, o vertevano sul conflitto, le sofferenze del popolo italiano e la Resistenza, come Conversazioni in Sicilia di Vittorini, colorato di antifascismo culturale, e, dello stesso autore, Uomini e no, romanzo della Resistenza lombarda, o alcune opere di Vasco Pratolini ambientate nei quartieri fiorentini durante la guerra (Il Quartiere). I film sulla lotta clandestina di Rossellini (Roma città aperta, Païsa), Vergano (Il sole sorge ancora), Lattuada (Il bandito), De Santis (Caccia tragica), attrassero anch’essi tutta l’attenzione di numerosi intellettuali. Queste opere mostrano un popolo vittima del fascismo, che aveva sofferto la guerra con dignità, un popolo resistente e 33 coraggioso. In questo modo le rappresentazioni degli Italiani elaborate dagli intellettuali condussero a dissociarli dal fascismo e permisero di rinnovare profondamente l’immagine degli Italiani in Francia. Georges Sadoul, comunista storico e critico del cinema scrisse nella rivista Europe, nell’aprile 1950, che « a quanto si dice Roma città aperta, che mostra al mondo la Resistenza italiana, ha fatto, perché questo paese non venga confuso col fascismo, più di quanto non possano fare cento discorsi di cento ministri». Ed ecco ciò che scrisse nel 1952 a proposito della letteratura neorealista a sfondo sociale, Robert Bosc, critico della rivista gesuita Études: « Non credo che si possa leggere uno o l’altro dei romanzi di cui abbiamo parlato senza provare un sentimento di durevole amicizia per un popolo così coraggioso e così sincero. Nel campo del cinema, è facile constatare che i grandi film italiani proiettati in Francia del 1945 hanno contribuito – più di tutti quanti i patti -, a distruggere il risentimento che allora esisteva fra i due paesi. Ci rallegriamo di vedere tradotte numerose opere letterarie che appartengono alla stessa scuola neorealista. Serviranno anch’esse a riavvicinare i nostri paesi ed aiuteranno i Francesi e gli Italiani a meglio capirsi, stimarsi ed amarsi » [R. Bosc, Études, febb. 1952]. Una memoria della Resistenza italiana viene progressivamente costruita in Francia a partire dal 1946-1947; però riguarda essenzialmente le elite culturali ed alcuni rappresentanti del mondo politico, solitamente di sinistra, anche se l’articolo di Robert Bosc indica che il processo di conoscenza della Resistenza transalpina tende a diffondersi ad una parte almeno dell’intellighenzia moderata o di destra a partire dall’inizio degli anni cinquanta. Ma con la guerra fredda, si costruisce anche una memoria tronca e selettiva Le premesse della costruzione e della diffusione di una memoria tronca della Resistenza e del fascismo possono essere individuate in alcuni film del movimento neorealista che tendono a cancellare il fascismo o, comunque, l’idea di un sostegno popolare che ricevette il regime, il consenso che seppe instaurare. Con l’avvento della guerra fredda, gli intellettuali comunisti francesi ripresero e diffusero la vulgata comunista della Resistenza italiana imposta a partire dal 1947-48. Essa si articolava intorno all’idea di un popolo che ha resistito in massa, o almeno che condivideva in massa lo spirito della Resistenza, come affermava Jean Noaro, intellettuale comunista ed italianista, in una critica del romanzo di Renata Vigano da lui tradotto per le Éditions sociales (legate al PCF), L’Agnese va a morire (testo pubblicato in La Pensée, 1953). In effetti, egli ritiene che « c’è stata una resistenza del popolo italiano che merita di essere meglio conosciuta »; oltre, specifica che « questa resistenza del popolo italiano era iniziata fin dall’avvento del fascismo» e che « un popolo intero ha lottato; ha anche avuto il particolarissimo merito di sbarazzare l’umanità di un Mussolini, e ciò in maniera definitiva e senza appello. Questo sollevamento raccolse in un vasto fronte nazionale i proletari, i borghesi, gli operai, i contadini e gli intellettuali ». Allo stesso tempo, le testimonianze in presa diretta ed altri documenti grezzi scomparirono dalle pagine delle riviste francesi, perché gli intellettuali che pubblicavano questi documenti in Italia furono richiamati all’ordine da Togliatti fin dalla fine del 1946 (è questo il caso della redazione di Società che si vide imporre intellettuali “controllori” in particolare Emilio Sereni, futuro responsabile della commissione intellettuali del PCI), quindi nel 1947-48 (Togliatti e Alicata criticavano allora Vittorini e la redazione del Politecnico poiché ritenevano avesse un contenuto troppo eclettico); molti di loro, in effetti, provenivano dal fascismo: formati dal regime nel corso degli anni trenta, difensori di un fascismo di “sinistra”, passarono a poco a poco nell’antifascismo alla fine del decennio e durante la guerra, percorsi di cui testimoniano i loro documenti. In quel momento però, la direzione del PCI voleva imporre l’idea che il fascismo fu un fenomeno che non aveva ricevuto l’appoggio del popolo né quello degli intellettuali. La costruzione di una memoria della Resistenza italiana in Francia avvenne progressivamente a partire dal 1946-1947. Le mostre del 1945 e 1946 che circolarono in Francia ebbero un impatto su scala locale e regionale, come nella regione di Grenoble, ma poca risonanza a livello nazionale. E’ quindi necessario riportarsi alle iniziative di alcuni gruppi di intellettuali di sinistra attratti dall’Italia, sedotti dalle forze politiche e ideologiche della sinistra italiana, che intesserono rapporti con i colleghi italiani, per capire il processo di diffusione della memoria della 34 lotta clandestina italiana. Amanti della cultura neorealista, a partire dalla critica che fecero di film e libri, elaborarono delle rappresentazioni favorevoli del popolo italiano e contribuirono a diffondere la conoscenza della Resistenza. Tuttavia, questo movimento non toccò l’opinione pubblica nel suo insieme. Per altro, con la guerra fredda, si passò rapidamente verso una memoria che si allontanava dalla realtà storica. O questa memoria lasciava troppo spazio all’idea di una partecipazione popolare massiccia alla lotta clandestina, mito che verrà smentito in particolare da Renzo De Felice; oppure, ed è il caso in buona parte della destra e della massa dell’opinione, la Resistenza italiana rimase disconosciuta, se non ignorata. Claudio Silingardi - Musei della Resistenza e politiche della memoria: il caso dell’Emilia Romagna Lo scorso anno la Regione Emilia-Romagna ha approvato il proprio statuto: nel preambolo si afferma che la Regione «si fonda sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e sugli ideali di libertà e unità nazionale del Risorgimento e si basa sui principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dall’Unione europea […]». Una dichiarazione impegnativa ed esplicita, soprattutto nella prima parte, che conferma quanto la Resistenza abbia fatto e faccia parte dell’identità collettiva della regione, nonostante siano passati sessant’anni dalla lotta di liberazione. Oggi in Emilia-Romagna sono presenti più di una ventina di musei dedicati alla Resistenza e alle vicende della seconda guerra mondiale (in particolare la deportazione), ed alcuni importanti luoghi di memoria diventati luoghi per la memoria (e per la storia). Siamo inoltre alla presenza di un reticolo di associazioni (in primo luogo quelle partigiane), fondazioni, istituti storici della Resistenza che si occupano di questi temi, in una relazione positiva con il protagonismo giocato dagli enti locali nel mantenere viva questa memoria. Partendo da questi dati di fatto, che rendono evidente una specificità emiliano-romagnola nel quadro nazionale, la relazione intende fissare in primo luogo i caratteri essenziali dell’esperienza resistenziale nella regione, e le modalità di costruzione di una nuova identità regionale che, a dispetto delle semplificazioni operate da sociologi ed economisti, si è venuta definendo attraverso percorsi non sempre lineari. Saranno poi presi in esame i momenti e le modalità di costruzione di questa ‘grande narrazione’, esaminando sia il rapporto tra politiche della memoria e lotta politica e sociale, sia le diverse declinazioni che questa ha avuto sul piano concreto, ad esempio nell’edificazione di centinaia di cippi e monumenti, nelle iniziative celebrative, nella ricerca storica, nella produzione artistica per arrivare infine alla costituzione dei musei storici. Momento centrale della relazione è l’approfondimento delle ragioni che portano ad una nascita tardiva ma al tempo stesso così articolata dei musei dedicati alla Resistenza. Per fare questo saranno presi in esame – nell’ambito di una riflessione più generale sul caso italiano – alcuni casi concreti: il Museo dei fratelli Cervi di Gattatico, il Museo monumento al deportato politico e razziale di Carpi, il Museo della Repubblica partigiana di Montefiorino e il Museo della battaglia del Senio di Alfonsine. Al tempo stesso sarà posta attenzione ad alcuni luoghi di memoria fondamentali, in particolare Monte Sole (strage di Marzabotto) e il campo di transito di Fossoli (deportazione). La relazione si soffermerà poi sulle potenzialità che questa realtà regionale – si potrebbe parlare di un vero e proprio “museo diffuso” della seconda guerra mondiale, della Resistenza e della deportazione – mantiene e può esprimere, dei tentativi di consolidamento dei musei messi in atto in questi ultimi anni (soprattutto in direzione del rafforzamento del legame con il territorio), ma anche delle difficoltà di coordinamento e di gestione e della mancanza di una strategia complessiva a livello regionale, che penalizza le possibilità di evoluzione futura di questo sistema museale. Jean-Jacques Fouché - La comunicazione tramite l’immagine nei musei della Resistenza e della Deportazione in Francia. Delle immagini della Seconda Guerra mondiale – fisse con la fotografia ed animate con il cinema – appaiono alle udienze (20-11-1945 / 1°-10-1946) del Tribunale militare internazionale di Norimberga che giudicò i “grandi criminali di guerra nazisti”. La sala “600” del tribunale della città 35 era stata allestita dai servizi americani per permettere proiezioni e servire da studio fotografico. La chiusura del periodo di guerra implicava un’apertura su una nuova era; la dimostrazione tramite l’immagine doveva, oltre la scomparsa dei testimoni, contribuire a mantenere la veridicità dei loro racconti. Ogni anno, il festival Visa pour l’image riunisce a Perpignan foto-giornalisti del mondo intero. Vi si presentano delle “storie in immagine” di cui molte costituiranno gli archivi di domani. Un numero fuori serie di Le Monde (novembre 2005) dedicato all’anno 1945 asserisce che “l’immagine non è un’illustrazione ma un elemento essenziale di comprensione della storia”. Significa forse che è stato definitivamente definito lo statuto dell’immagine in quanto documento comprovante? Chiaramente non è così e il dibattito, che si aprì fin dall’alba della filosofia greca, prosegue. Due recenti mostre hanno provocato animati dibattiti e veri e propri conflitti: - la prima, in Germania, sul tema dei crimini commessi dalla Wehrmacht tra il 1941 ed il 1944 in Unione sovietica. Utilizzava anche delle fotografie scattate dai soldati e recuperate negli album di famiglia; vi fu un dibattito sull’autenticità di alcune fotografie e gli organizzatori furono costretti a revisionare la mostra, che proseguì il suo itinerario con un nuovo catalogo interamente rivisto. - la seconda, in Francia nel 2001, era intitolata “memoria dei campi”, e mostrava, fra tanti documenti, quattro fotografie della resistenza polacca ad Auschwitz; a sollevare obiezioni– con una tonalità molto polemica – fu il regista del film Shoah, Claude Lanzmann, (direttore della rivista Les Temps Modernes) ed i collaboratori della rivista. Per difendere la pubblicazione delle quattro foto prese dall’interno di un forno crematorio a Birkenau, Georges Didi-Huberman pubblicò un bellissimo testo: Images. Malgré tout (Immagini. Malgrado tutto) (Parigi, Ed. de Minuit, 2003, 235 p.). Il libro inizia in questo modo: “Per sapere, bisogna immaginarsi. Dobbiamo tentare di immaginare ciò che fu l’inferno di 1944. Non invochiamo l’inimmaginabile. (...)”. Le memorie dei testimoni e le immagini formano le fondamenta dei musei della Seconda Guerra mondiale; non possiamo quindi evitare di rimettere queste fondamenta in discussione. Sono pertinenti, efficaci? I musei sono dei conservatori di memorie oppure il sapere che comunicano può essere una provocazione ad immaginare le situazioni, ordinarie, inedite o eccezionali vissute dagli attori, i testimoni e le vittime? Oltre all’opportunista “dovere di memoria” spesso invocato dai politici e della sua evoluzione ragionata in “dovere di storia”, non si dovrebbe anche aggiungere la necessità di immaginare? In maniera molto naturale, i musei dedicati alla storia della Seconda Guerra mondiale concedono ampio spazio agli archivi visivi oltre alle collezioni di oggetti e di documenti. (il tutto costituisce gli “expôts” nel senso del corso di museologia di Georges-Henri Rivière). I documenti “immagini” vengono sempre rispettati? Le fotografie esposte devono essere sistematicamente documentate ed accompagnate da una didascalia: una legenda riportante informazioni sulla data, il formato, il luogo, la situazione del fotografo e il credito dell’immagine. Questa regola minimale di deontologia effettivamente non è sempre rispettata. Innanzitutto perché la fonte può essere sconosciuta da coloro che, nonostante ciò, diffondono le immagini. Non è raro trovare, nelle fototeche di grandi musei o nelle agenzie specializzate, fotografie senza didascalia o con riferimenti errati. (Fototeca del IWM a Londra, una foto senza didascalia: in una via di una città di provincia francese, una bella e giovane donna bionda, pistola in mano, è circondata da uomini con caschi e uniforme disparati. Insieme guardano una cartina. Gli uomini sono deferenti verso la giovane donna che li può comandare; è una foto dell’attrice e resistente Sylvia Monfort durante la liberazione di Chartres nell’agosto 1944! Sembra che non siano state scattate foto delle impiccagioni a Tulle il 9 giugno 1944, eppure non è raro trovare immagini d’impiccagioni a Pascevo, periferia di Belgrado nell’aprile 1941, attribuite appunto a Tulle). Senza l’apparato critico che la completa, una foto diventa inutilizzabile. Però l’assenza di didascalia è talvolta imposta dall’allestimento delle immagini sui pannelli: manca lo “spazio” e le foto sono spesso rilavorate o riquadrate. Queste operazioni trasformano il documento. Da una ventina d’anni a questa parte, le immagini sono state forse ancor più sottoposte ad imperativi estetici, architettonici, scenografici e grafici. 36 Gli interventi di rinnovamento realizzati dagli enti locali o dai musei associativi della Resistenza e della Deportazione, hanno spesso conferito un’autorità preponderante agli scenografi rispetto ai conservatori. La creazione, sempre su iniziativa degli enti locali, di nuovi allestimenti dedicati alla memoria di particolari eventi ha accentuato questa tendenza (ad esempio: la strage di Oradour o i “malgré nous” di Alsazia Mosella, oppure la mostra permanente nell’antico spazio, incompiuto, dei congressi nazisti a Norimberga). Con argomentazioni di natura finanziaria, ma anche di comunicazione e di pedagogia, i committenti prestano maggiore attenzione ai direttori lavori che non agli storici. Architetti e scenografi concepiscono il proprio intervento come la produzione di un’opera d’arte. Essi immaginano un edificio e la relativa scenografia creando un’immagine che per prima si presenterà ai visitatori. (Esempi). L’edificio è la prima immagine che colpisce il visitatore. La direzione lavori impone un’estetica, per rispettare la propria idea di quale sia della missione dell’edificio. In questo modo, attribuisce un significato al contenuto tramite l’immagine del contenente. Gli “allestimenti della memoria” e i musei rinnovati propongono la messa in scena di un racconto illustrato da immagini e confortato da documenti di archivi e oggetti. La costruzione del racconto e il suo controllo sono la più grande difficoltà del dibattito fra gli attori-testimoni-vittime e gli storici. I politici locali intervengono in questo dibattito, prendendo logicamente le parti dei propri elettori, e possono quindi ridurre l’intervento degli storici “memorie torbide” (una formula di Pierre Laborie). Malgrado i suoi contributi scientifici, il suo sapere dovuto allo studio degli archivi, la sua padronanza della storiografia, la posizione del ricercatore diviene fragile. Influenzato dagli “uomini dell’arte”, il racconto del museo o del memoriale tende a riprodurre contenuti “già memorizzati” (una formula di F. Raphaël). Vi sono molteplici esempi dello scostamento fra quello che il racconto del museo traspone del “senso comune” e le rettifiche che andrebbero fatte a partire dagli archivi. Ricordiamo che la memoria collettiva trattiene ciò che valorizza una comunità ed occulta le fonti critiche. Quali immagini per quale impiego? Vi sono due tipi di immagini: da un lato le fotografie, film ed altri documenti d’archivio, e dall’altro, le visioni prodotte dall’immaginazione (immaginario di un artista, di un fotografo, di uno scenografo...). Segnaliamo brevemente gli oggetti che fanno immagine (l’oggetto-icona), ad esempio la bicicletta, presente in varie mostre temporanee di musei che simboleggia i pericoli nei quali incorrevano le staffette della Resistenza. Una fotografia vale per la propria fedeltà a riprodurre una realtà passata e scomparsa. Ma una foto è sempre allo stesso tempo una copia ed una rappresentazione. Talvolta è il prodotto di una ricostituzione: la famosissima immagine di Evgueni KhaldeÏ, della bandiera sovietica sul tetto del Bundestag nel maggio 1945, è una messa in scena, oltretutto modificata per essere diffusa (uno dei soldati indossava diversi orologi!). Questo falso archivio esprime meglio di ogni altro documento la vittoria delle forze sovietiche a Berlino: possiede l’aura della immagine vera. E’ quindi diventata un’icona. Vale a dire un’immagine riconosciuta dal senso comune, uno dei simboli che significano la vittoria sui nazisti. Impossibile stabilire una distinzione fra la veridicità dell’istantaneo, che si suppone essere direttamente nel vivo del soggetto, e la posa: entrambe sono ugualmente vere. I musei espongono delle icone di cui possiamo definire il repertorio, notando che esso è relativamente limitato malgrado la quantità di documenti disponibili. Le immagini più frequentemente stereotipate della “salita del nazismo in Germania”, delle SS, della resistenza, del collaborazionismo... illustrano un racconto quasi minimalista, basato sul “già memorizzato”. Un’immagine è sempre la conseguenza di una scelta. La sua realizzazione corrisponde ad una strategia ed alle intenzioni di un autore (di fatti è più una produzione culturale che non la copia più o meno realista di una realtà). L’impiego che se ne fa in una mostra la integra in una nuova strategia che non ha legami con quella della sua produzione. L’immagine deve soddisfare la logica di significato del museo e i criteri tecnici organizzativi formulati da colui, scenografo o grafico, che la mette su un pannello. Questo condizionamento, che può provocare un rinnovato interesse, è 37 comunque un’estetizzazione differente e supplementare dell’estetica dell’immagine stessa (La valorizzazione di un’immagine può effettuarsi solamente in rapporto col suo studio critico). Il visitatore vede prima il pannello nella sua globalità: titoli, sottotitoli e “blocchi” di testi o di immagini, non una determinata fotografia in particolare. Ogni immagine si iscrive nell’ambito di un dispositivo materiale ed estetico che associa vari elementi “visualizzabili” (titoli, testi, immagini) (Un dispositivo è un allestimento - un ‘bricolage’ – di tecniche e di significato). Tramite la proprio grafica, il pannello è portatore di significato, più di ognuno degli elementi che lo costituiscono. Il visitatore è invitato a considerare vari livelli: prima quello globale del pannello, quindi quelli delle immagini o di altri documenti, talvolta divenuti talmente secondari da passare inosservati. Ci sarebbero quindi vari “livelli di lettura” possibili, dalla vaga attenzione alla meticolosa lettura. Il dispositivo tradizionale del pannello conserva il faccia a faccia e la distanza fra i visitatori (mantenuti davanti) e ciò che è esposto. (Esempio del Centre d’Oradour). Un altro dispositivo invece, propone un’integrazione dei visitatori nell’immagine stessa: non sono più “davanti agli expôts” ma “dentro”. Questa “messa in situazione” dei visitatori si rivolge al loro immaginario, con l’intento di provocare emozioni ed empatia verso gli attori o le vittime di una situazione drammatica. Da oltre quindici anni, l’Imperial War Museum di Londra propone delle simulazioni delle trincee della Grande Guerra o dei bombardamenti del Blitz di Londra. Il visitatore evolve in uno spazio costruito e riceve informazioni (sonore, visive e delle vibrazioni) provenenti dall’allestimento. La tecnica (coordinamento di effetti visivi con movimenti prodotti da cilindri), adattata dei simulatori di volo usati per l’addestramento dei piloti viene impiegata nei parchi di divertimento. Questa evoluzione delle scenografie nelle mostre segue quella del teatro quando, opponendosi alla “distanza” privilegiata nell’estetica di Brecht, i registi integrano gli spettatori nello spazio di recitazione. Una forma di partecipazione è compresa nel dispositivo, concepito per suggerire quello che attori o testimoni hanno potuto vivere o subire. (Esempio con le immagini del Memoriale; Schirmeck). La scenografia fa l’immagine. La prima difficoltà che si erge in questo tentativo di provocare l’immaginario ci sembra provenga dalla poca credibilità di scene necessariamente costruite nel rispetto delle norme di sicurezza attuali per il pubblico. La stazione ed il vagone ricostituiti per evocare le evacuazioni dell’agosto 1939, non sono “giusti”; i corridoi della linea Maginot sono puliti e senza odori! Il realismo della scena è limitato dalle obbligazioni di sicurezza legate all’accoglienza dei visitatori. Ci sarebbe poi un’altra difficoltà, di ordine deontologico o etico: fino a dove ci si potrebbe spingere nel costruire il falso per provocare l’emozione e l’empatia dei visitatori? Ricostituire un vagone della deportazione con la paglia, gli odori di putrefazione, di urina e di escrementi? (Esiste un autentico vagone della deportazione al Museum fur Verckehr und Technick di Berlino; benché pulito, suscita l’emozione). Dov’è il limite da non oltrepassare? Sarebbe forse la ricostituzione di una camera a gas? Verrebbe attraversata dai visitatori? I musei associativi o privati che propongono accumulazioni di oggetti ed immagini sono in via di sparizione. (Non sarebbe il caso di conservarne qualcuno tale e quale per studiare la strumentalizzazione delle memorie? Il musée associatif de la Résistance et de la Déportation de Tulle, quello privato di Mr La Picirela a Vassieux-en-Vercors). I musei rinnovati e i nuovi allestimenti utilizzano delle immagini integrate in due dispositivi di esposizione. Il primo dispositivo può essere chiamato “comunicazionale”. Si tratta di un allestimento, di una “impaginazione” su pannelli (la maggior parte delle volte completati da vetrine) di testi, immagini e suoni in funzione di un racconto. Il faccia a faccia del visitatore con gli “expôts” conserva una certa distanza critica nonostante l’estetizzazione più o meno forte che subiscono per il loro condizionamento. Il secondo dispositivo può essere definito “fusionale”, perché i visitatori sono inclusi nello spazio riservato agli expôts. Piazzato in mezzo al dispositivo, il visitatore viene invitato ad identificarsi con gli attori-testimoni o con le vittime. Il dispositivo fusionale ricerca l’adesione dei visitatori ai racconti di drammi e di azioni eroiche. Gli aspetti drammatici suscitano la compassione e l’empatia. Non 38 sono più condizionati solo gli expôts, ma anche i visitatori inclusi nelle scenografie. La distanza critica viene ridotta, soppressa in taluni casi. In entrambi i modelli, il dispositivo estetizza gli expôts, ciò che include le immagini fisse o animate, comprendendole nell’estetica immaginata dallo scenografo o l’architetto. Per concludere, ci si può soltanto augurare che un dibattito tra i committenti (in genere i politici locali), ed i responsabili organizzativi (architetti e scenografi), permetta di conservare il rigore scientifico indispensabile per i musei della Seconda Guerra mondiale. Auguriamoci il dibattito, riprendendo una formula di Jacques Hainard, affinché i musei della Resistenza e della Deportazione siano, come qualunque altro museo “uno spazio critico (…) dove ognuno può interrogare ed interrogarsi”. Bibliografia: Gueissaz (Mireille) et Wahnich (Sophie) Dir.: Les musées des guerres du XX° siècle: lieux du politique? (Tumultes, N° 16, avril 2001, éditions Kimé); Le Dispositif; entre usage et concept; (Hermes, N° 25, CNRS Éditions, 1999); Deleuze (Gilles): “Qu’est-ce qu’un dispositif”; in Deux régimes de fous, (éditions de Minuit, Paris, 2003, p. 316 et s.); Collectif, direction GHK: derrière les images, (Musée d’ethnographie de Neuchatel, 1998); Raphaël (Freddy) et Herberich-Marx (Geneviève): “Le musée provocation de la mémoire, dans Éthnologie française (N° 1, 1987); Le parti pris du document. Littérature, photographie, cinéma et architecture au XX° siècle; (Communications, N° 71, Paris, éditions du Seuil, 2001); La Shoah: images témoins, images preuves, (Les cahiers du Judaïsme, N° 15, 2003); Visa pour l’image, Actes du colloque du 14ème Festival international du photojournalisme Perpignan, septembre 2002, (Images Évidence, Chagny, 2003). 39 3. NUOVE MEDIAZIONI giovedì 24 novembre, ore 9 La presenza relativamente recente di professionisti della ricerca e della museografia nelle istituzioni interessate ha permesso d’instaurare strategie che promuovano nuove forme di rappresentazione. Si cercherà di individuarle attraverso alcune esperienze, tentate soprattutto a Torino e a Grenoble, mostrando in particolare il raccordo fra questi esperimenti e il territorio. Presiede Ivo Mattozzi, Università di Venezia La rappresentazione della Deportazione nei musei italiani Patrizia Dogliani, docente di storia contemporanea, Università di Bologna Il museo diffuso: la città, il territorio. L’esperienza di Torino Daniele Jalla, presidente dell’ICOM per l’Italia, coordinatore dei servizi Museali della Città di Torino Il rapporto fra ricerca e comunicazione nel museo. Riflessioni su un’esperienza Ersilia Alessandrone Perona, direttrice dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” Pausa caffè Allestimenti multimediali nei nuovi musei della Resistenza italiani Franco Rolle, architetto, Studio N!03 Considerare il territorio Jean-Claude Duclos, conservatore del Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère Discussione 40 Ersilia Alessandrone Perona - Il rapporto fra ricerca e comunicazione nel museo. Riflessioni su un’esperienza A confronto con la Francia, la diffusione e l’ affermazione dei musei della Resistenza in Italia possono essere definite in generale “deboli”, per le ragioni storiche e soprattutto politiche che vengono analizzate nelle due prime sessioni del convegno. A queste ragioni, si possono aggiungere le voci identità e generazioni, che sono fortemente connesse tra loro. Negli attori-testimoni l’ affermazione della propria identità di Resistenti (o deportati, o internati) corrisponde a un’ esperienza di vita oltre che alla volontà di trasmettere dei valori: essa ha pertanto una consistenza che in genere è difficile scalfire. Ciò ha prodotto in passato molte frizioni fra partigiani di appartenenze diverse, fra partigiani e deportati, fra partigiani e internati militari, le quali hanno sostanzialmente impedito loro di esercitare complessivamente il peso politico necessario per ottenere una rappresentazione a livello nazionale. Non è un caso che l’ unico terreno sul quale l’ intesa è stata tempestiva ed efficace, sia Stato quello della commemorazione dei caduti (mentre molto più contraddittorio e tardivo è stato il riconoscimento delle vittime civili). La presenza di musei a livello locale nel Centro e nel Nord Italia, peraltro molto disuguale,corrisponde pertanto ai diversi incroci fra le identità in grado di Affermarsi e il consenso politico corrispondente. L’ affermazione identitaria forte non ha condizionato solo la nascita dei musei ma anche la loro fruizione. Il passaggio dall’ emissione alla ricezione dei messaggi affidati al museo, infatti, non è scontato. In questo processo entrano in gioco sia le sensibilità di ciascuna generazione (si pensi al rapporto di contestazione-appropriazione della Resistenza fatto dai giovani del ’68), sia i mutamenti dei quadri sociali della memoria che possono alterare in modo radicale la ricezione: «Nel mondo nuovo di opportunità fugaci e di fragili sicurezze, le identità vecchio stile, non negoziabili, sono semplicemente inadatteо», ha scritto Barman. La mediazione degli storici, l’ introduzione di nuovi linguaggi nella rappresentazione museale ha ottenuto il contrasto, ma non l’ha risolto del tutto. Mutando i contesti, tramontando la generazione degli attori-testimoni, è ancora possibile rappresentare in un museo un periodo storico ritenuto fondativi dalle istituzioni e dal consenso di una grande parte della società italiana? La ricezione cercherà di rispondere a tale quesito, sulla base delle esperienze compiute in questo campo dall’ Istituto piemontese per la storia della Resistenza. Franco Rolle - Allestimenti multimediali nei nuovi musei della Resistenza italiani Negli ultimi anni gli orientamenti allestitivi in materia di musei, in particolare di quelli a carattere storico, hanno legato la trasmissione della memoria e della conoscenza storica con l’ interattività e la flessibilità. Le nuove tecnologie favoriscono infatti una fruizione più attiva e partecipata del visitatore. L’ integrazione di sistemi tradizionali con allestimenti multimediali permette di creare ambienti di grande suggestione e dal forte potere evocativo. In particolare la progettazione di “ ambienti video “ immersivi e interattivi (allestimenti che utilizzano videoproiezioni su pareti o altri supporti scenografici che circondano il visitatore e lo immergono in una particolare atmosfera) permette di stabilire un contatto diretto tra il visitatore e l’ avvenimento rappresentato e apre un mondo di possibilità che alla parola scritta o al singolo reperto sarebbero negate. Accanto all’ esigenza di avvicinare il visitatore su un livello emozionale l’ interattività e la multimedialità permettono di mantenere e sviluppare un necessario percorso divulgativo-didattico di approfondimento dei contenuti. Jean-Claude Duclos - Considerare il territorio Nel 1957, quando forniva la propria consulenza per la programmazione del Musée de Bretagne, Georges Henri Rivière, scrisse « Due temi s’impongono verso i quali devono tendere le rappresentazioni museali: il tempo e lo spazio intorno ad un determinato territorio ». Fu allora 41 che il territorio cominciò ad essere veramente preso in considerazione nei musei. Eppure sarà necessario attendere l’inizio degli anni ‘70, e la messa in pratica del concetto di ecomuseo perché la raccomandazione di Georges Henri Rivière venga pienamente applicata. Laddove nascono degli ecomusei, nello spazio rurale francese all’inizio, quindi nel Quebec, in Catalogna, in Norvegia o in Portogallo, le motivazioni sono simili. Ovunque, si tratta di sottrarsi alla dipendenza di un potere troppo forte, di ricercare per se stessi e sulle basi di una storia e di un’identità proprie, le condizioni della riconoscenza e la capacità di agire per conquistare una nuova autonomia. Così queste esperienze danno largo spazio alla nozione di ‘abitante esperto’, nata dalla decolonizzazione. Come disse il filosofo Davidson, è la “riconoscenza dell’altro come un pari cognitivo”. In effetti, si considera che coloro che vivono una realtà e l’incarnano sono portatori di conoscenze altrettanto degne di interesse e proficue che quelle degli esperti e dei libri. Ed è in quello stesso momento, insieme al territorio, che la memoria fa il proprio ingresso nel museo. In effetti, è proprio negli ecomusei che appaiono per la prima volta i consigli scientifici composti in pari numero di abitanti rappresentativi e di ricercatori patentati. “La comunità nella sua interezza – dice Hugues de Varine nel 1973 a proposito dell’esperienza dell’ecomuseo di Le Creusot – costituisce un museo vivente, il cui pubblico si trova in permanenza all’interno. Il museo non ha dei visitatori, bensì degli abitanti”. Definito finora dall’edificio che lo contiene, il museo, in queste nuove esperienze, si dilata fino allo spazio del territorio, quello della popolazione che serve. Viene così aperta una nuova via con queste esperienze, protese verso la museografia del tempo e dello spazio con la partecipazione della popolazione a fare da motore, l’interdisciplinarità come strumento e lo sviluppo come obiettivo. Anche se gli ecomusei non ne faranno tutti la dimostrazione, questo approccio rimane attuale, in particolare in Francia, nei nostri musei detti “di società” e, in alcuni altri luoghi del mondo, grazie agli adepti di quella che viene ancora chiamata “la nuova museologia”. Ed è questo stesso approccio che abbiamo applicato a Grenoble all’inizio degli anni 1990, per il caso del museo della Seconda Guerra mondiale che ci veniva chiesto di realizzare o, per meglio dire, di trasformare. I nostri partner – ex combattenti, resistenti, deportati e le loro associazioni – si convinsero abbastanza in fretta che fosse preferibile riferirsi al territorio dell’Isère, ai luoghi, agli eventi ed alle persone che parteciparono lì alla storia del periodo. Questo modo di procedere non era un limitarsi, tanto più che fu, e rimane sempre, facile ricollegare le vicende locali alle loro risonanze nazionali ed internazionali. Privilegiare le realtà territoriali permetteva anche di evitare di fare un ennesimo museo della Seconda guerra mondiale. Permetteva altresì, interpretando questa sequenza storica a partire dalla memoria locale dei luoghi e delle persone, di renderla più vicina, più viva e quindi più facile da comunicare. Quindi, come nei primi ecomusei, abbiamo instaurato un consiglio scientifico composto per metà di ex resistenti e deportati e per l’altra metà di archivisti e storici del periodo. Un programma di raccolta di fotografie e di ricordi, tramite la registrazione audio e da qualche tempo, video, ci ha permesso di comprendere poco per volta il territorio del dipartimento dell’Isère. Mentre a partire da questi materiali mettevamo in opera una museografia del tempo e dello spazio dei vissuti della Seconda Guerra mondiale nell’Isère, abbiamo incontrato i nostri colleghi dell’Istituto di storia della Resistenza del Piemonte. Anch’essi usavano le stesse strategie, dove forse erano arrivati in modi diversi. Quando scoprii la Guida per la memoria, di Ersilia Perona per la città di Torino, ebbi la sensazione che ci avevano preceduti. Constatando che la memoria dei luoghi, malgrado le lapidi commemorative era diventata illeggibile e che però occorreva continuare a decifrare lo spazio urbano, come un palinsesto, gli autori di questa guida, come degli archeologi, hanno restaurato la comprensione di questo spazio rivelandone ognuno degli strati. Di modo che, restituita nelle parti della guida dedicate successivamente alla Torino delle leggi razziali, della guerra, della resistenza, della deportazione e della liberazione, in relazione diretta con le tracce che sussistono in sito, la geografia della città contribuisce a rendere intelligibile la successione delle vicende che fanno la storia del periodo della guerra. La vera e propria stratigrafia proposta da 42 questa guida mi parve costituire un’alternativa così efficace ai tentativi di lettura dei monumenti ed altre iscrizioni, talvolta sul punto di sparire, che feci di tutto finché non ne abbiamo fatto una simile per Grenoble. Abbiamo avuto la possibilità di realizzare il progetto nel 2004, con il 60° anniversario della Liberazione. Fu intitolato « Grenoble en Résistance ». Con quasi 12.000 copie vendute, il successo fu tale che le Editions du Dauphiné libéré ci invitarono a proseguire. L’anno successivo abbiamo pubblicato « L’Isère en Résistance », con più di 8.000 esemplari venduti. In questi volumi, i luoghi, gli edifici, le vie, le frazioni, i paesi e quello che vi è successo sono oggetto di altrettanti articoli, segnati su una cartina, e raggruppati per ognuno dei periodi degli anni della guerra. Quando nel marzo 2002 Gianni Perona ci propose “di riprendere tutta la materia, per cogliere non soltanto i rapporti che uniscono necessariamente la condotta della guerra da parte dei militari di tutte le potenze coinvolte, ma anche il complesso gioco delle resistenze passive ed attive, armate e non armate”, cioè di studiare la Seconda Guerra mondiale su scala territoriale delle Alpi, si distingueva una nuova mediazione. Nuova perché nessuno, nessuno storico aveva ancora preso le Alpi come oggetto di studio della guerra. Per altro, osserviamo che questo approccio recentissimo si riallaccia alla recente presa di coscienza della realtà europea. “Francia, Italia e Svizzera – prosegue Gianni Perona – si buttarono nella guerra o in una neutralità armata, forse senza prevedere quanto la crisi avrebbe colpito una rete di frontiere molto delicata, che da secoli si trova al centro di ogni rimaneggiamento politico del sistema europeo”. Il tempo e lo spazio, la memoria ed il territorio. Per la ricerca come per la sua rappresentazione, sia essa museografica o meno, i campi rimangono validi, tanto più che i dati non cessano di evolversi. Rimane il dubbio di sapere se potremo continuare a lungo a spiegare le realtà di oggi alla luce dei fatti della Seconda Guerra mondiale o se, con la memoria che si spegne, non si tratterà magari soltanto più di storia. Non è assicurato che i musei strettamente dedicati a quel periodo storico sopravvivano a questa evoluzione. 43 ORGANIZZAZIONE Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” Via del Carmine, 13 10122 Torino Tel. 011 4380090 / Fax 011 4360469 [email protected] www.istoreto.it Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère 13, rue Hébert 38000 Grenoble Tel. + 33 04 76423853 / Fax + 33 04 76425589 [email protected] www.resistance-en-isere.fr Association des Amis du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère 14, rue Hébert 38000 Grenoble [email protected] Con il patrocinio di
Scarica