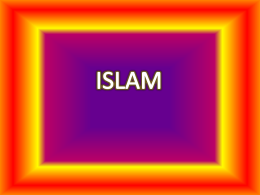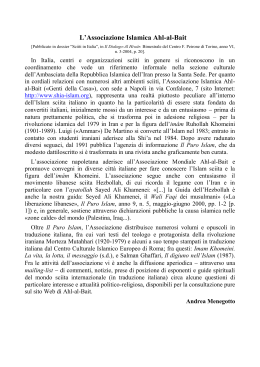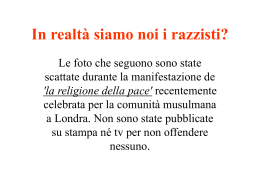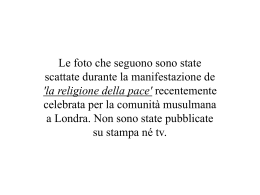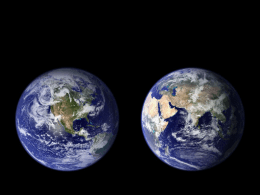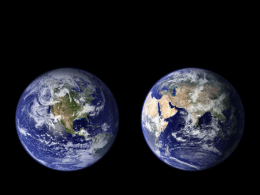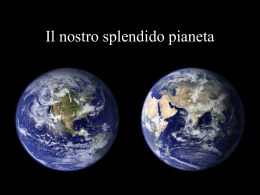ISTITUTO DI STUDI POLITICI "S. PIO V" ROMA D. CELLAMARE, R. ANGIUONI, M.E. GATTAMORTA L'ISLAM RADICALE IN AFRICA A CURA DI DANIELE CELLAMARE PREFAZIONE DI GIANLUIGI ROSSI EDITRICE APES 2012 Indice Prefazione di Gianluigi Rossi 1. Il diritto che discende da Allah di Daniele Cellamare 2. Il dibattito sul ruolo dell’islamismo di Daniele Cellamare 3. L’occidente del mondo arabo di Roberto Angiuoni 4. L’ombra lunga del fondamentalismo di Daniele Cellamare 5. I percorsi frammentati dell’islamismo di Maria Egizia Gattamorta 6. La periferia dell’Islam di Maria Egizia Gattamorta Appendice Nota sui criteri di trascrizione usati. Per agevolare la lettura del testo è stato scelto un sistema di trascrizione dei termini arabi e africani facilmente comprensibile. Le lettere enfatiche, così come le lunghe e gli apostrofi, che rendono indistintamente differenti accezioni del termine, non sono state evidenziati. Termini noti e diffusi in Occidente – quali ulama, imam, mufti, etc. – non recano segni diacritici. Sempre al fine di agevolarne la lettura, i termini inseriti nel testo conservano quasi sempre la forma singolare anche dove sarebbe necessario il plurale (shahid anziché shudada, faqih, anziché fuqaha, etc.) Prefazione La creazione di sistemi coloniali stabili, negli anni tra le due guerre, aveva contribuito a favorire un atteggiamento più comprensivo nei riguardi delle culture africane – prima ritenute insolite ed esotiche – per incoraggiare in epoca più tarda un’attenzione crescente al grande tema dell’unità continentale. Questi studi hanno assunto dignità scientifica e stimolato quindi l’interesse per le complesse ed articolate culture, favorendo in larga misura una serie di ricerche sulla sua storia e sugli sviluppi delle istituzioni socio-politiche. Dopo i primi riconoscimenti dell’africanismo sul piano storiografico – ad opera del nigeriano K. Onwuka Dike per i suoi studi sul delta del Niger nel 1956 – è stato rovesciato il consueto approccio eurocentrico e il capovolgimento di prospettiva permette un più approfondito studio sulla storia del continente, proprio alla ricerca di quei valori e quelle fonti, che – per la loro assenza – avevano in passato negato qualsivoglia evoluzione della cultura africana. Riuscendo a distinguere gli ambiti di analisi dell’africanismo da quelli dell’orientalismo – che godeva già da prima di un certo rispetto accademico – queste ricerche hanno saputo dare adeguate risposte alla crescente considerazione internazionale del continente africano e dei suoi soggetti che, nella maggioranza dei casi, stavano diventando gli attori della propria storia e non più semplici oggetti della dominazione coloniale. Considerando quindi questi soggetti come protagonisti dei propri destini politici, i nuovi studi – proprio come questa Ricerca – ravvisano con forza la necessità di svincolarsi da quella diffusa atmosfera intellettuale che ha lungamente ostacolato l’approccio corretto alle realtà africane, per proporre una metodologia più complessa, in grado di elaborare una valenza di interesse internazionale nell’ambito del moderno africanismo. Questo approccio metodologico, nato negli anni Cinquanta, è stato incoraggiato senza dubbio dalla riscoperta delle fonti e dei documenti della storia africana – più numerosi di quanto si supponesse – e dalle fonti europee mai prima utilizzate, come gli archivi delle compagnie commerciali, delle società missionarie e delle amministrazioni coloniali. Parimenti, si è ravvisata subito la necessità di dare rilevanza a fonti e influenze non africane, rappresentate – come nel caso specifico – dalla cultura islamica e araba, coniugando le nuove metodologie con un approccio diretto all’attualità degli eventi e alle loro complessità nel contesto sociale, in ogni caso riconducibili al loro potenziale non utilizzato. Il Sahel e il Sudan, ma in definitiva tutto il continente, sono stati attraversati da vigorosi processi di espansione dell’islamismo e hanno prodotto nuove ed interessanti esperienze politiche. Queste ultime, a loro volta, hanno incoraggiato l’esplosione di una serie di jihad locali, intese come manifestazioni di un movimento di riforma che mirava a mettere in discussione la tradizionale strategia di compromesso tra i mussulmani e gli animisti, il principale elemento di resistenza politico-religiosa dell’islamizzazione. Con l’intensificarsi della penetrazione coloniale, si è ridotta l’ostilità degli animisti e si sono aperti quei nuovi percorsi commerciali – regolari e sicuri – che hanno favorito i contatti tra comunità islamiche indipendentemente dalla loro distanza. Scopo di questa ricerca è appunto quello di interpretare le conseguenze della colonizzazione per coniugarle con la multiforme e variegata realtà islamica, ancora in bilico tra le tendenze moderate e le derive dell’ortodossia, ovvero quelle militanti più aggressive. Le due guerre mondiali hanno di fatto dato impulso al processo di decolonizzazione: la prima con l’incitamento alla lotta di liberazione mutuata dalla rivoluzione russa e la seconda, con la guerra fredda, al movimento dei non allineati. Questi fattori sono riusciti ad esercitare, sia in seno alle Nazioni Unite che nell’opinione pubblica internazionale, la pressione necessaria per giungere all’indipendenza. Insieme al tentativo di elaborare un socialismo arabo, con il presidente egiziano Nasser, nei paesi sub sahariani si è cercato di sviluppare una sorta di passaggio da una comunità di villaggio primitiva a quella di un villaggio socialista, come in Nigeria e nello Zimbabwe, a sicura testimonianza del fermento di una ideologia in continua dilatazione. Il dibattito, parallelamente, vedeva contrapporsi gli esponenti del socialismo arabo – che si sforzavano di dimostrare che quella forma politica e sociale di governo era in piena consonanza con i principi del Corano – e gli avversari che non si stancavano di ricordare che le riforme agrarie e le nazionalizzazioni andavano contro il diritto di proprietà, e pertanto contro le norme coraniche a cui ogni buon mussulmano avrebbe dovuto attenersi. In ogni caso, tutti questi modelli – dal nazionalismo arabo a quello di stampo liberale e democratico ereditato dai colonizzatori europei e sino al panarabismo nasseriano – elaborati da intellettuali reduci da scuole occidentali e così percepiti dalle popolazioni, hanno progressivamente lasciato spazio all’ideologia islamica, intesa come modello di giustizia e di organizzazione della società, l’unica in grado di definire una diversa e più marcata identità culturale. La speranza di tornare ad essere protagonisti della storia continua però a suscitare preoccupazione in molti analisti occidentali, che vedono in ciò una potenziale minaccia sul piano ideologico ed economico, paventando la totale incompatibilità tra islam e democrazia. Le recenti rivolte arabe sembrano suggerire però che non sono ancora cambiate, nella loro sostanza, le cause della crisi, oggi più direttamente imputate alla classe dirigente, autolegittimatasi come unica garante dello sviluppo sociale e politico della popolazione. Il radicalismo islamico, in questo studio analizzato nelle sue componenti più significative, continua a trovarsi al centro dell’attenzione mediatica per le cruenti tensioni da cui è attraversato, svelando all’esterno l’esistenza di numerosi ed energici movimenti di militanza. Ci piace però pensare che il ricorso al terrorismo equivale piuttosto ad una dichiarazione di impotenza, sia per chi lo pratica – per la sua incapacità di utilizzare strumenti più idonei a suscitare la solidarietà dell’opinione pubblica internazionale – sia per chi lo subisce, presumibilmente costretto a riconoscere che l’aver costretto l’avversario a questa scelta non sia stato il modo migliore di gestire il conflitto. Di contro, l’islam militante riesce però a produrre una seria alternativa ai governi e alle opposizioni, proponendo sul piano sociale, e su quello politico, soluzioni che appaiono credibili ad una quota crescente di elettorato, nel tentativo di coniugare il rifiuto di una dipendenza tecnologica e scientifica dall’Occidente con una via di islam politico. Attraverso un’indagine approfondita delle situazioni storiche che maggiormente hanno contribuito alla formazione di questi processi evolutivi, la Ricerca concorre alla maggiore comprensione di quella che viene comunemente indicata come la rinascita islamica, o meglio quel complesso intreccio di fattori e processi religiosi, sociali, politici ed economici che hanno partecipato alla produzione di questo oscuro e inquietante arco di islam radicale. Gianluigi Rossi Capitolo Primo Il diritto che discende da Allah Daniele Cellamare Il dibattito sull’islam radicale è aperto da alcuni decenni. In un primo tempo, l’era islamica sembrava aver soppiantato gli anni della decolonizzazione ispirandosi ad ideologie più familiari alla cultura occidentale, quali il nazionalismo e il socialismo. In anni più recenti, invece, gli studiosi (in particolare Gilles Kepel) hanno parlato di declino, se non di fallimento, dell’islam politico, che sarebbe riuscito ad afferrare il potere solo in pochi casi. Il potere nel mondo mussulmano si è lasciato però conquistare dall’islam e cerca di utilizzarlo ai propri fini, ma la vicenda – pur avendo tutte le apparenze di uno scontro tra civiltà – sembra in buona parte non essere soltanto politica. In quella che viene considerata come l’area politica più fragile del globo (i tre grandi istmi mediterranei), caratterizzata da un gran numero di formazioni statali di diversa natura, sembra che sia ancora oggi costretta a pagare per le ripartizioni territoriali decise nelle capitali europee all’inizio del secolo scorso. Percepite come cicatrici ancora brucianti, le frontiere geometriche ed astratte ereditate dall’epoca coloniale mal si conciliano con la confessione islamica, intesa come comunità di credenti che non contempla al proprio interno l’idea di alcun confine rigido, rappresentandosi piuttosto come un insieme di entità socio-politiche piuttosto flessibili, o meglio inserite in un contesto per definizione in movimento e in espansione. L’islam quindi non ammette per sua natura un quadro preciso – di cui i confini sono la cornice – al cui interno vengono esercitate le sovranità statali di tipo occidentale, ma preferisce basare la propria identità sull’elemento religioso, relegando ad un piano inferiore il valore della relazione con un determinato spazio (ritenuto invece fondante nella cultura occidentale). Sulla scia del ritiro degli europei, la stessa comunità islamica è stata investita al suo interno nel conflitto tra stati e tribù – o meglio tra comunità e culture periferiche – con il duplice paradossale risultato di lasciare stati senza popolo e popoli senza stato. La questione del Sahara occidentale, così come lo chiamano le maggiori organizzazioni internazionali, è ancora aperta. Riconosciuta da alcuni stati con il nome di Repubblica araba sahrawi democratica (Rasd), ha proclamato la sua indipendenza nel febbraio del 1976, per opera dei nomadi mauri del Fronte Polisario (qualche ora prima del ritiro ufficiale della Spagna) ma in forte contrasto con le rivendicazioni del Marocco. Secondo le autorità di Rabat, la porzione di deserto in questione – che si affaccia sull’Atlantico subito a sud dell’arcipelago delle Canarie – costituisce il naturale prolungamento dello stato marocchino, e va quindi riconosciuto come sua parte integrante. Al contrario, il Fronte Polisario si richiama al principio della intangibilità delle frontiere fissate in epoca coloniale e reclama – sostenuto principalmente dall’Algeria – l’indipendenza del territorio. La singolarità della situazione è sottolineata dall’esistenza di un muro costruito dal Marocco nella metà degli anni Ottanta che, composto da terrapieni e campi minati, attraversa in diagonale per circa 250 chilometri la quasi totalità dello spazio conteso, inibendo al governo sahrawi il controllo dei due terzi superiori del paese, i soli dotati di autentiche città. Anche il caso dei tuareg – il cui ambito risulta frammentato tra l’Algeria, la Libia, il Mali e il Niger – è ascrivibile a queste contingenze, lì dove le aspirazioni nazionali sembrano avviarsi verso un più completo stadio di organizzazione politica. Il prestito più pericoloso che l’islam continentale abbia mai fatto a quello mediterraneo è il radicalismo, inteso nella sua versione di veicolo della solidarietà panislamica e antinazionalista, una versione che da decenni influenza la vita politica degli stati nord africani. Imposto con vigore dall’Arabia Saudita alla fine degli anni Sessanta contro il modernismo laico di Nasser e dell’algerino Bumedien (ma rilanciato in forma ancora più incisiva dalla rivoluzione iraniana del 1979) il radicalismo riflette la risposta più estrema al principale problema che oggi l’islam ha di fronte: quale forma di organizzazione politica assumere all’interno del mondo mussulmano in cui esso rappresenta uno dei più energici e formidabili agenti di mutamento? I governi dell’Africa mediterranea hanno risposto, nel 1989, con la proclamazione dell’Unione del Maghreb Arabo e con l’obiettivo di creare un comune spazio politico-economico tra Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania, cercando di superare la contesa relativa del Sahara occidentale e le rivendicazioni delle minoranze berbere. Anche se i cinque paesi sono caratterizzati da regimi differenti sul piano ideologico, politico ed economico (dal regno del Marocco al regime militare della Mauritania) con il Grande Maghreb si è cercato di sostituire le rivalità interne con la cooperazione regionale, aprendo la strada verso una determinazione complessiva degli spazi politici, o meglio verso la costituzione di insiemi, più o meno grandi, per i quali l’identità degli interessi economici si fonda sull’identità culturale (solo qualche giorno prima della proclamazione dell’Unione maghrebina, anche l’Egitto, l’Iraq, la Giordania e lo Yemen si erano uniti nel Consiglio di Cooperazione Araba, mutuato sull’esempio di quello del Golfo). Nel territorio islamico le fratture sono molto più evidenti verso il centro che non verso la periferia, che risulta decisamente più compatta, e verso tale risultato convergono le due fondamentali differenze di natura geopolitica che oppongono il Maghreb al cuore del Mashrek: la maggiore stabilità delle frontiere (le più antiche) e la maggiore omogeneità religiosa della popolazione, rendendo quindi di difficile individuazione i comportamenti aggreganti e le nuove tendenze coesive nel corpo centrale dell’islam. In ogni caso, il nuovo islam mediterraneo, proprio nella sua effervescenza, mostra indubbi segni di risveglio della propria personalità culturale e – di conseguenza – tenta di individuare la propria collettiva potenzialità politica. La mappa degli incidenti scoppiati dopo l’11 settembre 2001 segnala che i paesi coinvolti nelle violenze sono quelli dove alcune forze politiche hanno cercato di pilotare la questione per rafforzarsi e destabilizzare il regime (la violenza è stata strumentalizzata dai movimenti radicali che respingono con forza la presenza occidentale, sia essa americana che europea). Anche se, in apparenza, non esiste un fenomeno più aberrante della violenza praticata in nome della religione, in realtà essa costituisce piuttosto una norma che un’eccezione storica, tragicamente confermata dal nostro tempo, anche se con modalità – come quelle dello stragismo suicida di origine islamica – che la cultura occidentale avrebbe difficilmente potuto concepire. Secondo Jan Assmann 1 il monoteismo, con la sua concezione di Dio unico, ha instaurato un concetto di verità esclusiva, collegato ad una rivelazione che riduce le verità di tutte le altre religioni al rango di aberrazioni e di menzogne da perseguitare, e di conseguenza agli infedeli non viene concessa altra alternativa alla conversione o alla eliminazione. Nell’antico mondo politeistico, la violenza era motivata da ragioni di potere e di sovranità, ovvero 1 Jan Assmann, nato in Germania nel 1938, insegna Egittologia all’Università di Heidelberg ed è l’autore di Non avrai altro Dio, pubblicato da Il Mulino nel 2007. Altre opere pubblicate in Italia sono La memoria culturale (Einaudi, 1997), Mosè l’egizio (Adelphi, 2000), dove inaugura un nuovo tipo di indagine, la “semantica culturale”, più attenta al rilievo che i fatti assumono nella rappresentazione della memoria, piuttosto che nella storia, e “Potere e salvezza” (Einaudi, 2002). da ragioni politiche anziché da questioni di verità, o meglio di adesione o meno ad un’ortodossia divina. Il cristianesimo, così come l’ebraismo, sarebbe diventato più tollerante per via di un processo di secolarizzazione contestuale con lo sviluppo di tutta la civiltà occidentale. A tale processo, l’islam sarebbe invece rimasto estraneo, arrestandosi ad una fase arcaica, per ragioni che non sembrano solo di carattere storico o culturale, ma essenzialmente religiose (incasellato in una sorta di integralismo che investe tutti gli aspetti della vita e dell’esperienza). L’intellettuale inglese Martin Amis 2 accusato sovente di islamofobia, sostiene invece che una seria analisi delle dinamiche del fondamentalismo (e delle violenze ad esso collegate) deve svincolarsi dalle riflessioni sulle colpe, passate e presenti, dell’Occidente, pena la perdita di lucidità e forza per contrastare il fenomeno di fronte all’orrore fondamentalista ogni discorso sulle responsabilità storiche delle ex potenze coloniali decade, sono tutte scuse per nascondere la vera colpa del nostro tempo: incapace di vedere il male, l’Occidente continua a distogliere lo sguardo, mentre l’epidemia porta al delirio dell’antiamericanismo e al terrore pianificato in Europa. Per altri intellettuali, invece, al-Qaeda sta perdendo terreno in quasi tutti i paesi mussulmani e il fondamentalismo islamico è votato al medesimo destino, perché ovunque sia stato messo alla prova – dalla Nigeria al Sudan – le popolazioni si sono ben presto disamorate delle sue attrattive. Anche se la maggior parte degli islamici – radicali o meno – non sono ancora riusciti a trovare risposte adeguate ai problemi della modernità in grado di soddisfare le legittime aspirazioni dei popoli mussulmani, i gruppi radicali trovano crescente sostegno all’interno delle loro comunità, anche se vengono da molti analisti considerati come forze reazionarie e retrive che potrebbero ostacolare lo sviluppo dei loro paesi. Per l’intellettuale Fareed Zakaria (L’Occidente e il nemico, «Newsweek», 2010) l’islam radicale ha conquistato una vasta base di consensi nel mondo mussulmano per tutta una serie di motivi complessi, primo tra tutti il mancato sviluppo dei paesi mussulmani, sia sotto il profilo politico che economico in tutta la regione del nord Africa, gli Stati Uniti e le altre potenze occidentali appoggiano dittatori laici che dichiarano di voler combattere forze di opposizione islamiste. In cambio, però, questi governanti hanno fatto ben poco per promuovere vere riforme, rafforzare le istituzioni statali e diffondere la trasparenza in politica. La decolonizzazione è stata in effetti un processo troppo rapido, dettato dalle esigenze politiche delle vecchie potenze coloniali piuttosto che dalla maturità delle loro stesse colonie. Una recente storiografia ha evidenziato come i nuovi stati si siano in effetti rivelati in breve tempo come creazioni artificiali, spesso etnicamente eterogenee e prive di una qualsiasi architettura politica e amministrativa. Secondo Sergio Romano («Corriere della Sera», 5 dicembre 2007) la guerra fredda ebbe il tragico effetto di far piovere sul continente africano i capitali con cui ciascuno dei due blocchi cercò di comperare la fedeltà dei governi locali […] e la fine della guerra fredda ebbe l’effetto, non meno tragico, di rendere evidente la precarietà dei regimi africani. Poco più di due secoli fa gli intellettuali liberali hanno cominciato a credere che l’Occidente avesse imboccato una strada a senso unico verso la democrazia moderna e laica e che le altre società – una volta imboccato lo stesso percorso – l’avrebbero inevitabilmente seguito. Anche se gli sviluppi si sono dimostrati diversi dall’ipotesi iniziale, è stata conservata una sorta di 2 Martin Amis, nato ad Oxford nel 1949, ha vinto nel 1973 il Somerset Maugham Award ed ha pubblicato numerosi libri tradotti in italiano. Tra le raccolte di saggi, è stato tradotto nel 2009 Il secondo aereo. 11 settembre: 2001-2007, edito da Einaudi. tacita fede nel processo di modernizzazione e i ritardi sono stati attribuiti, con diverse valenze, a circostanze attenuanti come il colonialismo, l’ignoranza o la povertà. Una convinzione questa che ha condizionato il modo di vedere la teologia politica – soprattutto nella sua forma islamica – come una sorta di atavismo che richiederebbe piuttosto analisi di tipo sociologico che non un serio impegno intellettuale (nella cultura mussulmana le istituzioni politiche sono concepite dal punto di vista dell’autorità divina e della redenzione spirituale, contrariamente a quella occidentale). La chiave della grammatica e della sintassi della teologia politica – per evitare che il tentativo di comprendere l’islam più radicale risulti addirittura paralizzante – va piuttosto ricercata proprio nella sua presenza nella vita intellettuale occidentale fin dentro il secolo XX, dopo che era riuscita a dismettere il paradigma medioevale e trovato le sue ragioni moderne per cercare ispirazione politica nella Bibbia. Percepita come una visione illuminata, la moderna teologia politica era stata quindi accolta da coloro che avevano a cuore le sorti della democrazia liberale, anche se dopo la Prima guerra mondiale la piega apocalittica ha permesso agli “uomini nuovi”, ansiosi di abbracciare il futuro, di produrre giustificazioni teologiche alle più ripugnanti ideologie totalitarie. Quindi questo tipo di approccio non è ascrivibile ad una sola cultura o religione, ed è sempre a disposizione di chi cominci a guardare al legame divino tra Dio, l’uomo e il mondo, nel tentativo di trovarvi l’unico ordine politico legittimo. La teologia politica, quindi, rimane destinata ad essere continuamente adattata alle circostanze e ad essere rilanciata in qualunque momento, anche di fronte a forze apparentemente irresistibili, come quelle della modernizzazione, della secolarizzazione e della democratizzazione. In definitiva, chi ha creduto che la legge di Dio fosse destinata a governare l’umanità, ha seguito un istinto antico, inevitabilmente desinato a sfidare la democrazia e la tolleranza. Anche se solo dopo la Seconda guerra mondiale i principi della moderna democrazia liberale si sono radicati pienamente nell’Europa continentale, la sfida della teologia politica non accenna a placarsi, con il suo carico di minacce, sia politiche che fisiche. L’intellettuale americano Mark Lilla – in un articolo apparso nel 2008 sul «New York Times» con il titolo Dio e i terroristi – ritiene che la retorica politica occidentale deve molto ai movimenti settari protestanti del secolo XVII, vibranti di energia messianica, e che solo grazie ad una forte struttura costituzionale la teologia non ha mai seriamente messo in crisi la legittimità di fondo delle istituzioni. Quando la discussione sul fondamentalismo islamico e sul messianismo politico affronta il problema delle cause sociali – come il miglioramento delle condizioni materiali o lo spostamento dei confini politici – in realtà cade in una trappola intellettuale, quindi o presumiamo che la modernizzazione e la secolarizzazione alla fine ne avranno ragione, oppure la affrontiamo come una minaccia esistenziale incomprensibile. Sulla stessa sponda sembra porsi anche l’intellettuale americano Benjamin Barber3 chiedendosi se l’islam – nella sua accezione più ampia, e quindi non solo quello radicale o salafita – sia o meno una religione refrattaria alla democrazia, alla libertà, al pluralismo e alla modernità, intese nelle caratteristiche dei valori liberali. Il fondamento alla base del concetto di scontro di civiltà formulato da Huntington – secondo il quale Occidente ed Oriente sarebbero impegnati in uno scontro violento per la sopravvivenza – sembrerebbe di fatto sempre presente nella politica in generale e nei media occidentali in particolare e, di conseguenza, quando ci si interroga sulle origini del radicalismo 3 Nato negli Stati Uniti nel 1939, Benjamin Barber, docente all’università del Maryland, è autore del volume Guerra santa contro McMondo (Tropea, 2008). Ha partecipato ad Istanbul a numerosi seminari di Reset-Doc, un’associazione per il dialogo tra le culture. nella misura in cui l’islam è fondamentalista, la religione lo è anch’essa in molti luoghi, perché nella nostra epoca di laicità la religione è sotto assedio e il fondamentalismo è più di ogni altra cosa una reazione alla religione sotto assedio. Secondo molti analisti, la crescente applicazione della sharia nella maggior parte dei paesi islamici è dovuta ad una serie di fattori concomitanti, primo tra i quali l’esigenza dell’Arabia Saudita di svolgere un ruolo guida in virtù della diffusione del wahabismo nei paesi a maggioranza mussulmana e sunnita (è il paese che maggiormente finanzia la costruzione di moschee e la penetrazione di personale religioso con scopi didattici e divulgativi). Inoltre, anche il ruolo dei movimenti islamici radicali contribuisce alla diffusione di una cultura orientata al dogma islamico che assicura la soluzione dei problemi in cambio dell’osservanza scrupolosa del Corano. Grazie a cospicui finanziamenti, questi gruppi radicali sono in effetti molto attivi tra la popolazione, promuovendo scuole, dispensari medici e aiuti e sostentamenti ai poveri. Rispondono quindi concretamente al malessere sociale e all’insoddisfazione causati dalla miseria e dalla corruzione, o meglio dalla più generale incapacità di gestione da parte dei governi. Secondo l’esperto di islam Samir Khalil 4 la semplicità con cui il messaggio coranico arriva alle popolazioni più disagiate è dovuta alla capacità di manipolazione del testo del Corano, dove vengono estrapolate singole frasi dal contesto storico per giustificare società patriarcali e per dare fondamento religioso alle prevaricazioni dei gruppi più intransigenti. In questi termini, la rivendicazione della fedeltà all’islam sembrerebbe quindi un ottimo alibi per conquistare o gestire il potere pubblico, a sicuro complemento della diffusa mancanza di istruzione. Il termine sharia è l’abbreviazione di Shari’at-Allah, che letteralmente significa la via di Dio. Come è noto, le sue fonti principali sono il Corano e la Sunna, ovvero la tradizione che raccoglie gli hadith, i detti attribuiti a Maometto. Il fondamento e il soggetto ultimo del diritto islamico è quindi Dio, la cui volontà – espressa appunto nella sharia – determina i diritti e i doveri dei singoli e della collettività, risultando pertanto superiore a qualsiasi normativa stabilita per mera iniziativa umana. L’applicazione integrale delle disposizioni della sharia – non solo in materia di diritto familiare, ma anche penale – rappresenta la principale rivendicazione dei gruppi radicali islamici che la considerano l’unico ed effettivo antidoto ai problemi delle società mussulmane, che sono di fatto decadute proprio per essersi allontanate dagli insegnamenti trasmessi da Allah attraverso il Profeta, ma anche l’unico rimedio efficace alle contraddizioni insanabili in cui versano le comunità occidentali. In ogni caso, la sharia conquista nuovi spazi: anche fuori dal continente africano, in molti paesi mussulmani la sharia è applicata secondo precisi riferimenti alla costituzione, in particolare in Arabia Saudita Iran, Yemen, Afghanistan e Iraq5. In Somalia, il parlamento provvisorio, con un voto all’unanimità, approva il 18 aprile 2009 l’adozione della sharia. Il voto ratifica la decisione del governo di unità nazionale che aveva stabilito l’adozione della legge coranica il 10 marzo dello stesso anno. 4 Il gesuita Samir Khalil, titolare di cattedra alla Saint Joseph University di Beirut, è considerato un esperto di questioni islamiche di fama internazionale. L’intervista è stata rilasciata a Giorgio Paolucci e pubblicata sul «Corriere della Sera» del 5 maggio 2009. 5 In Arabia Saudita la sharia viene applicata più rigorosamente che in altri paesi e il Corano stesso è considerato la costituzione dello stato. L’esecuzione delle pene previste avviene in pubblico, come il taglio della mano per i ladri, la decapitazione per gli assassini e la lapidazione per le adultere. Nelle città, la polizia religiosa veglia sul rispetto del codice di abbigliamento islamico. In questo caso, la decisione sembra dettata dalla volontà di soddisfare alcuni stati arabi che sostengono finanziariamente il nuovo esecutivo. Sia il presidente Sharif Ahmed che il premier Omar Abdirashid Alì Harmake avevano espresso la loro piena disponibilità ad applicare la sharia nel paese dopo aver incontrato sei leader religiosi provenienti da Arabia Saudita, Qatar, Kuwait e Sudan, che stavano mediando tra governo ed opposizione. In Algeria un progressivo abbandono di ogni prospettiva laica si registra, con continue concessioni alle letture più retrive, come il nuovo regolamento dei culti non islamici. Secondo una recente indagine condotta dal quotidiano locale “Liberté”, circa il 60% dei maschi algerini è contrario alla soppressione della poligamia che, pur se poco praticata, continua ad essere prevista dal Codice della famiglia, ispirato alla sharia6. In Nigeria, a partire dal 2000, dodici stati della Federazione hanno introdotto la sharia e riconosciuto ai loro tribunali religiosi il diritto di dirimere le questioni penali. Sino ad allora, i tribunali esercitavano la competenza soltanto in materia di matrimonio o di controversie tra mussulmani in cui le parti abbiano acconsentito a ricorrere ad essi. In Sudan, il tentativo di introdurre la sharia è stato all’origine di una lunga guerra civile. Indipendentemente dalla recente creazione dello stato del Sud Sudan, l’accoro di pace firmato il 5 gennaio 2005 tra il governo e l’Esercito Popolare di Liberazione del Sudan – anche se ne limitava l’applicazione al territorio del nord, abitato in prevalenza da mussulmani – tentava di estendere la legge islamica a tutto il paese. In Egitto, sin dal 1980 e sotto il mandato di Sadat, i principi della sharia sono diventati “la fonte principale della legislazione” egiziana, e un più “una fonte principale della legislazione”. Inoltre, è stato anche stabilito – per decisione della Corte costituzionale – che “qualsiasi legge contraria all’islam è contraria alla Costituzione”. Uno degli aspetti più significativi dell’islam è sicuramente la sua morale sociale, ovvero la dottrina sociale della religione, posto il suo carattere positivamente normativo piuttosto che orientativo, di regolamento per l’azione sociale piuttosto che di componente per la formazione della coscienza pubblica. La tesi corrente che vuole nell’islam la coincidenza tra religione e comunità, o meglio tra religione e stato (l’islam come compenetrazione strutturale di religione e di vita socio-politica) è oggi autorevolmente contestata. Il politologo francese Olivier Carré preferisce ipotizzare nel fenomeno una “ortodossia deviante” e il sociologo delle religioni, Enzo Pace, individua invece uno “stereotipo” di mito collettivo (un ricorrente luogo comune). Si tratterebbe quindi di una tesi prevalentemente divulgativa, e di fatto infondata, propria della volgarizzazione dell’argomento. La sovrapposizione sostanziale tra din, dunya e dawla (religione, società e stato) non sarebbe quindi materialmente presente, ma si potrebbe invece configurare come un’offerta politica dell’islam ai potenziali convertiti, o meglio ai fedeli per la “riunificazione del temporale e dello spirituale”. Secondo il politologo francese Olivier Roy, una delle questioni cruciali che la cultura occidentale non riesce a penetrare sino in fondo è proprio il rapporto tra religione e potere politico, la base della statualità islamica, perché non è sufficiente dire che l’islam è la religione di stato, occorre invece parlare di statualità islamica, in quanto la sharia definisce la natura e la struttura dello stato stesso […] per introdurci a capire, richiamiamo due principi direttivi. Il primo è che la religione si mantiene e si fortifica nella misura in cui la coesione di gruppo, asabiyya, cementa unitariamente il gruppo e il potere, mulk, fa vivere e protegge la sharia. Il secondo principio riguarda la dinamica stessa della sharia 6 Sul quotidiano è stata anche pubblicata una vignetta satirica intitolata “Ormai i processi saranno tutti in arabo” ed il boia aggiunge “Anche le pene!” e in particolare le modalità stesse della sua realizzazione. La sharia deve essere realizzata pienamente, deve trovare accoglienza incondizionata, proprio perché è la legge di Dio. La mancanza di successo è la sconfitta di Dio e il fallimento della recitazione e della testimonianza del predicatore. La distribuzione della materia in sistema religioso, sistema politico e sistema giuridico viene quindi operata soltanto per essere adattata a criteri occidentali (E. Nallino, Enciclopedia italiana) ma dal punto di vista islamico la dogmatica, la morale, il diritto privato e molta parte del pubblico (il sistema fiscale, il diritto di guerra, il processuale e il penale) formano essenzialmente un tutto unico che, scaturito dalle medesime fonti sacre, porta il nome complessivo di sharia. Sempre secondo Nallino, la sharia è divisa dai mussulmani in due sezioni, la prima riconducibile, secondo la teologia cattolica, ad una sorta di foro interno del credente (l’attività della mente e del cuore, o meglio dogmatica e morale individuale) e la seconda avente per oggetto gli atti esterni verso Dio, ossia le pratiche di culto, i rapporti giuridici con gli altri uomini e alcune norme di condotta (chiamata fiqh, vocabolo intraducibile ma riconducibile a “diritto mussulmano”, e a sua volta divisa in ibadat, pratiche del culto, e muamalat, modo di agire verso gli altri). Il fatto che Dio sia quindi l’unico legislatore avrebbe prodotto una sorta di impotenza legislativa nei califfi e nei loro successori, che si sono limitati a far applicare, ma talvolta anche ad integrare, la Legge sacra, definendo questa integrazione attraverso una fictio iuris, denominata syisa (linea di condotta) e relegata in campo amministrativo. Il risultato di questo processo fu la diffusione, in pratica in tutto il mondo mussulmano, di una duplice forma di amministrazione della giustizia, una di tipo religioso, esercitata dal qadi, che si atteneva scrupolosamente alla sharia, e l’altra laica, esercitata da autorità politiche sulla base della consuetudine, dell’equità e dell’imparzialità (ma talvolta anche dall’arbitrio) delle norme governative e, in epoca più moderna, sulla base dei codici. Ma anche a fronte di una ridotta rilevanza politico-giuridica, la legge religiosa rimane comunque la struttura essenziale per l’organizzazione islamica della società, anche se nei paesi arabi ha fortemente ridotto la possibilità dei cittadini non mussulmani di vedere i propri diritti equiparati a quelli degli altri abitanti. Di fatto, la sharia ratifica, o promuove, quella consuetudine storica del mondo islamico che viene chiamata la “confessionalizzazione della società”: ogni membro della società mussulmana è identificato innanzitutto in funzione della religione professata. Per tale ragione la “Gente del Libro” (cristiani ed ebrei), pur avendo la libertà di seguire la propria religione e il proprio statuto personale (riguardante il matrimonio, la discendenza, il testamento, le donazioni e talvolta anche l’eredità) dipende tuttavia da tribunali speciali autonomi, detti appunto “confessionali”, che sono controllati dalle autorità governative mussulmane. Poiché i membri non mussulmani non partecipano alla più ampia ideologia islamica dello stato, non possono quindi pretendere di raggiungere i gradi più alti delle cariche pubbliche e, talvolta, anche nelle determinazioni più significative nel mondo del lavoro. Quanto alla tipologia dei mussulmani di fronte al rapporto religione-stato, padre Robert Caspar, un missionario in terra d’Africa, distingue tra mussulmani di ambiente popolare, mussulmani di cultura religiosa (tradizionalisti o riformisti), mussulmani modernisti di doppia cultura (islamica ed occidentale) e mussulmani fondamentalisti. Oltre all’origine storica del termine fondamentalismo (proveniente dal mondo protestante, così come il termine integralismo da quello cattolico), l’accezione del vocabolo viene ricondotta alla cultura occidentale per favorirne la comprensione per analogia 7. 7 Marie Thérèse Urvoy, docente di islamologia presso l’Institut Catholique e l’Institut Supérieur de Théologie des Religions di Tolosa sostiene che il fondamentalismo si può trovare in qualunque religione, ma “un fondamentalista cristiano potrà fare riferimento solamente a fatti di tradizione; potrà irrigidirsi su certe pratiche religiose o entusiasmarsi per l’ordine cristiano medioevale, ma non potrà mai richiamarsi ad un testo fondatore. Al contrario, un ebreo o un mussulmano hanno nei loro stessi testi sacri un insieme di prescrizioni che danno la sensazione di disporre materialmente di un manuale, che basta applicare. Con applicare intendo la messa in pratica di precetti concreti ed immediati, dati letteralmente, e questo non è il caso del Vangelo”. Il fenomeno comunemente noto come fondamentalismo islamico deve essere invece ricondotto ad una forma storicamente determinata della rinascita islamica, dopo un lungo periodo di decadenza culturale, politica e religiosa, marcata per molti paesi islamici dalla dominazione coloniale europea. I nuovi movimenti collettivi si incaricano di dare voce ad una profonda esigenza di identità, o meglio rimanere mussulmani, in n mondo che cambia rapidamente, senza rinunciare ai tratti originari della propria cultura di appartenenza. Marcando territori e spazi urbani, così come gesti quotidiani e regole di condotta, il sistema di credenze creato dall’islam aderisce profondamente nel tessuto sociale, nella ricerca spirituale di un modello e di uno stile di vita capace di guidare le nuove generazioni (non solo esperienza religiosa, l’islam è anche una complessa forma di sapere, teologico e giuridico al tempo stesso, al servizio della costruzione della città terrena). La rinascita islamica si pone quindi come un fenomeno moderno – almeno secondo le categorie storiografiche occidentali – inteso come espressione di rottura e riscatto nei confronti del colonialismo europeo. La rimozione dell’islam come elemento fondativo dei nuovi stati-nazione sorti dalla caduta dell’impero ottomano – e la diffusione delle ideologie di matrice occidentale, nazionaliste o socialiste – è considerato uno dei fattori scatenanti del fondamentalismo islamico contemporaneo. L’ideologo di punta del radicalismo islamico è Sayyd Qutb (1906-1966) e la sua opera costituisce il riferimento teorico di tutti i gruppi che trovano nel radicalismo la matrice essenziale della fede. Secondo Qutb, il mondo mussulmano era ripiombato nel corso del tempo nello stesso stato di ignoranza religiosa che il Profeta aveva trovato alla Mecca all’inizio della sua predicazione (nel linguaggio di Qutb si tratta del trionfo delle potenze del male). La jihad diventa quindi il necessario ricorso alla violenza, valutata come una forma di ascesi purificatrice e teologicamente fondata. I seguaci sono invitati a battersi innanzitutto contro il nemico interno – costituto da governi ritenuti empi perché portatori di valori del tutto incompatibili con la fede islamica – e poi per la diffusione del messaggio di Allah nel mondo. Prima di Qutb, Abd al-Rahman ibn Muhammad Ibn Kaldun8 aveva già chiaramente indicato la strada. In assenza di un profeta, una comunità religiosa ha bisogno di qualcuno che se ne prenda cura e la possa costringere a comportarsi secondo la legge rivelata. Questo qualcuno fa in qualche modo le veci del profeta, in quanto bada a che siano rispettati gli obblighi da lui imposti. Inoltre, in ragione della necessità di un governo politico per ogni organizzazione sociale umana, gli uomini hanno bisogno di chi sia capace di perseguire il loro bene, impedendo loro, anche con la forza, di fare ciò che loro può nuocere. Questa persona è il sovrano. Ora, nella comunità islamica, la guerra santa è un dovere canonico, a causa del carattere universale dell’islam, e dell’obbligo di convertire tutto il mondo, volente o nolente che sia. Ecco perché potere temporale e potere spirituale sono in questo caso confusi: il sovrano può dedicarvi le sue forze contemporaneamente. Le altre comunità religiose non hanno questo carattere ecumenico, e la guerra santa non è per esse un dovere canonico, se si eccettua il caso della legittima difesa. Ciò comporta che i capi di queste religioni non si occupino di politica. Il potere regale presso queste comunità appartiene ai suoi titolari, che l’hanno ottenuto per caso, e in ogni modo senza rapporto con la loro fede. Regnano per necessario effetto dello spirito di clan (nella cui natura è pure la ricerca del potere) e non perché debbano vincere le altre nazioni, come è il caso dell’islam. Devono solo confermare la propria religione tra i loro sudditi. 8 Storico e filosofo dell’Africa del nord (Tunisi, 1332 – Il Cairo,1406), è considerato il sociologo della società araba e berbera. Il brano è tratto dalla sua opera principale, Prolégomènes historiques, Commission Libmaise pour la Traduction des Chefs-d’oeuvre, Beyrouth, 1968. Capitolo Secondo Il dibattito sul ruolo dell’islamismo Daniele Cellamare 1. L’integralismo religioso – nella sua più ampia accezione del termine – viene sostanzialmente riferito ad un suo preciso orientamento politico, ovvero all’opportunità di fornire le linee direttive dell’azione politica e dei fondamenti stessi delle attività sociali ed economiche, in ogni caso ispirate alla propria linea dottrinale. Questa concezione ispiratrice tende ad uniformare – senza eccezioni o compromessi – qualsivoglia manifestazione dello Stato e dei suoi cittadini, coniugando i precetti religiosi con l’ordinamento societario. Il tentativo – spesso costante nel tempo – di rivendicare l’applicazione più rigorosa e completa dei principi della dottrina, ha favorito l’eliminazione del pluralismo ideologico e al tempo stesso ha determinato la volontà di applicazione, rigida e totale, di quei principi comuni in grado di amalgamare la sfera religiosa con quella politica. In particolare, nel più vasto movimento ideologico dell’integralismo islamico, tale applicazione trova nella sua stessa valenza storica (din wa dunya, ovvero “religione e mondo”) la necessità di coniugare, con perseverante costanza, gli aspetti sacri e profani dell’esperienza umana, a sicuro suggello del completo inserimento nel sistema islamico. Questo tipo di integralismo – che sostiene con forza l’applicazione della legge islamica basata sul Corano e sulla Sunna – è stato spesso assunto come sinonimo di fondamentalismo ed ha recentemente acquisito, pur nella sua genericità, un riferimento diretto all’agire violento per la promozione dell’ideologia di base. Risorto in epoca recente nel secolo XX (in Egitto, con il movimento della Fratellanza Mussulmana), l’integralismo islamico ha raggiunto la maggiore risonanza internazionale con la rivoluzione islamica in Iran (Ruhollah Khomeyni), laddove il sistema di vita cittadino si è integrato con la rigida applicazione dei dogmi della fede professata. Il legame indissolubile tra i precetti religiosi e l’ordinamento societario è diventato la chiave di lettura della din wa dunya, ovvero la necessità di non riservare l’espressione della fede esclusivamente alla propria attitudine personale, ma piuttosto nella obbligatorietà di rivolgere il comportamento concreto del fedele verso l’esterno, dalla famiglia al mondo9. Da un punto di vista esclusivamente ideologico, il fondamentalismo islamico nasce come reazione alla marginalizzazione della religione di Allah e - adottando principi di assolutismo e infallibilità delle Sacre Scritture - tenta di effettuare una rigida selezione tra gli aspetti della tradizione che intende difendere e quelli che invece rifiuta nel segno di una modernità non condivisa. Oltre la distinzione – tipicamente occidentale – tra religione e politica, l’islamismo militante intende 9 I due diversi aspetti possono essere separati, solo ed esclusivamente, in presenza di un grave ed imminente pericolo per il fedele. Il ricorso all’espediente della dissimulazione della fede (taqiya), più diffuso tra gli sciiti, è in questo caso legittimamente ammesso. ristabilire l’ordine ideale della Città di Dio, con l’applicazione della legge islamica (sharia), interpretata in senso rigoroso e radicale, ma anche con accentuati riferimenti proprio all’attivismo militante del credente. Quindi anche la definizione di islam militante – o meglio di islam radicale – risulta appropriata se riferita alla necessità di rispondere alle esigenze di una umma dilaniata dal confronto con una modernità che viene considerata estranea – se non ostile – ai valori immutati dell’islam. Nonostante una tradizione ininterrotta di studi esegetici (ijtihad), la spinta dell’islam radicale degli ultimi decenni ha proposto una nuova interpretazione della perduta autenticità islamica che – rivalutandosi con il ritorno alle radici della fede – ripudia qualsiasi forma di moderazione, sia nelle gerarchie religiose che nei poteri statuari degli stessi regimi islamici, considerati complici di un Occidente agnostico che ne assicura – direttamente o attraverso canali occulti – la mera sopravvivenza politica. Storicamente, sin dopo la fine della Prima guerra mondiale, la penetrazione delle idee occidentali nel mondo mussulmano, considerate eccessivamente moderne, venne contrastata con l’applicazione della sharia, così come qualunque tentativo di instaurare sistemi giuridici contrari alla tradizione religiosa. Il “movimento di risveglio”, meglio identificato con il termine salafita, mira quindi a risollevare l’islam dallo stato di decadenza, politica e culturale, in cui sarebbe caduto, ovvero un nuovo programma di modernizzazione della religione islamica che ben presto si è trasformato in una ideologia rivoluzionaria affatto rispettosa delle autorità tradizionali. La scuola di pensiero sunnita della Salafiyya (da salaf al-salihin, ovvero “i pii antenati”) intendeva inizialmente rivelare le radici della modernità nella civiltà islamica, identificando nelle prime tre generazioni di mussulmani dei secoli VII e VIII (Sahabi, i compagni di Maometto, Tabihun, la generazione successiva, Tabi al-Tabin, coloro che vengono dopo i seguaci) i presupposti storici di un riformismo islamico (islah) con le spiccate caratteristiche di un movimento culturale, se non addirittura politico10. Nella seconda metà del secolo XX, il termine salafita ha invece assunto una diversa connotazione – anche se non sovrapponibile alle diverse ideologie che nel tempo lo hanno strutturato – rinunciando al confronto ideologico con le esperienze occidentali per identificarsi con gli ambienti islamici più conservatori. Pur marcando una precisa volontà di dare vita ad una nuova interpretazione delle Sacre Scritture (in chiave di autentica tradizione islamica, e quindi facendo ricorso allo strumento della ijtihad), il movimento ha rivisitato le nuove fattispecie giuridiche secondo un ritorno alle fonti espresse dalla stessa osservanza dei dettami del Corano e dalla purezza della tradizione etico-giuridica (hadith) della Sunna. In altri termini, il salafismo ha finito per riproporre una lettura del Corano non più in termini esegetici, bensì impostandone la sua valenza in una accentuata chiave di anti-modernismo. Associato oggi alle espressioni più radicali dell’islamismo, il movimento salafita diviene più facilmente identificabile con la corrente fondamentalista wahabita, ovvero con l’indagine rigorosa per l’accertamento del comportamento lecito o meno, con i valori dell’islam, da parte del consenso dei dotti (ijma). Sotto un profilo strettamente esegetico, il consenso delle scuole giuridiche (madhahib) e degli esperti giurisperiti (fuqaha) – elaborato con il ricorso alla logica, alla linguistica e alle numerose tradizioni prodotte nella sterminata arena dell’ambiente religioso – deve ottenere il consenso di una più ampia maggioranza in grado di aggregarsi e di validarne la cogenza legale. 10 Tre studiosi della Sunna: Ahmad ibn Hanbal (780-855), Ibn Taymiyya (1263-1328) e Muhammad ibn Abd alWahhab (1703-1792) hanno ricevuto il titolo onorifico di Shaykh al-Islam, in qualità di modelli esemplari di virtù religiosa. Almeno sino a quando non verrà modulato un diverso consenso in grado di adeguare il responso alle mutate esigenze della società islamica. Il sostantivo-aggettivo salafita rappresenta dunque l’aspetto più complesso di una diffusa volontà di dare corso ad una nuova ijtihad del Corano e della Sunna – laddove il fedele è in ogni caso autorizzato a dare una interpretazione anche personale dei Testi Sacri – e per questo motivo gli attivisti militanti, ovvero coloro che predicano il ritorno ai tempi d’oro dell’islam, preferiscono chiamarsi islamiyyun (per l’appunto islamici) a sicura testimonianza del privilegio concesso. Di diversa natura sembra invece delinearsi il percorso del wahabismo11 di iniziale formazione giuridica e teologica della scuola di Ahmad ibn Hanbal, ma sostanzialmente ispirato ad una riforma religiosa per un ritorno al rigore originale del Corano. Considerato una delle espressioni più significative del conservatorismo islamico, questo movimento non condivide però, con il più generale fondamentalismo del secolo XX, la disobbedienza al potere politico costituito, indipendentemente da chi lo detenga. Per la sponda conservatrice, infatti, il ruolo delle autorità islamiche deve in ogni caso essere rispettato e solo in casi estremi è consentito il ricorso alla forza (la guerra civile non è ammessa) e la dichiarazione di apostasia per un governante mussulmano. Anche se di fatto questo atteggiamento si è sovente tradotto in acquiescenza di fronte al potere costituito, la maggior parte delle scuole teologiche e giuridiche non accetta il carattere populista del fondamentalismo e non riconosce la legittimità di chi vorrebbe sostituire le autorità politiche costituite con leader carismatici e popolari. Ma il sistema degli ulema – i dotti che detengono, anche in un contesto religioso privo di clero, un sapere superiore a quello delle masse dei fedeli – è spesso controllato dallo stato, favorendo in questo modo la naturale tendenza ad erigersi a sostegno e guardia dell’ordine costituito. È comunque innegabile la forte influenza esercitata dal wahabismo sul movimento fondamentalista contemporaneo e sulle spinte socio-filosofiche che intendono proporre un modello islamico alla guida dei nuovi equilibri internazionali. Ostili ad ogni interpretazione personale (ray) dei giurisperiti islamici, le teorie di Wahhab guardano con sospetto alle formule politiche occidentali fondate sulla democrazia, considerata un’ipotesi di governo non compatibile con i precetti dell’islam, così come le devianze del sufismo e le consuetudini religiose (pratiche preislamiche) accusate di inquinare la devozione dei veri credenti. In particolare, i teorici del fondamentalismo – proprio su ispirazione dottrinale wahabita – conservano un atteggiamento di spiccata diffidenza nei confronti dei movimenti di ispirazione sufi presenti nel continente africano (nello specifico, i muridi senegalesi). Secondo questa prospettiva, la confraternita sufi è responsabile di aver introdotto una pericolosa innovazione nel primitivo messaggio coranico, e di aver accettato – con atteggiamento apolitico, quindi passivo – le prevaricazioni del neocolonialismo e della modernità occidentale. Di contro, le attuali correnti sufi non sembrano condividere il più generale fondamentalismo islamico (in questo caso associato al terrorismo), preferendo alla mistica dell’azione salafita quella tradizionale della via interiore. Al tempo stesso, però, non sembrano neanche in grado di coltivare un “sufismo politico”, ovvero un tentativo di congiunzione tra la tradizione sufi e la modernità, seppur selettiva. Il radicalismo islamico trova quindi compiuta espressione nella prospettiva di una guida politicoreligiosa di tutto il mondo islamico – e non solo sunnita – che sembra attraversare trasversalmente le correnti più disparate, unite da una sorta di nostalgia dell’antico califfato, o quanto meno nella 11 Muhammad ibn Abd al-Wahhab (al-Uyayna, Nayd, 1703 – Dariyya, Riyad, 1792). Il movimento wahabita, fondato sull’unicità di Dio e sull’osservanza rigorosa del Corano, costituisce l’elemento formativo e l’ideologia ufficiale dell’Arabia Saudita, in virtù del patto stipulato tra Wahhab e la famiglia al-Saud nel 1744. critica alla realpolitik dei governanti dei paesi islamici. Sulle modalità di attuazione, invece, divergono le posizioni, accumunate nel dibattito sulla liceità degli interventi, ovvero sull’opportunità di perseguire gli obiettivi politici con il ricorso all’uso della forza (con obiettivi civili e/o militari). In questo difficile contesto, si innesta, con aspra determinazione, anche il contrasto tra il fondamentalismo e il nazionalismo islamico, pur variabile nelle sue espressioni locali. Anche se i movimenti nazionalistici – in questo caso è lecito parlare di “islam nazionale” – traggono la propria identità nelle più antiche radici islamiche, il percorso storico ha tuttavia evidenziato una certa predisposizione alla laicizzazione della vita politica (adozione di sistemi legislativi che non coincidono con la sharia) suscitando le reazioni talvolta violente dei movimenti più radicali. Anche la stessa ispirazione occidentale dei nazionalisti (quasi sempre di natura socialista) ha contribuito alla progressiva perdita dell’ideale del “califfato politico” per affermare la volontà di costituzione di un moderno Stato islamico, capace anche di impugnare le armi per mere rivendicazioni territoriali o – addirittura – per conquistare un’egemonia regionale. Per il movimento fondamentalista si tratta di un’interpretazione, e di un progetto, assolutamente non condivisibile, laddove non esiste nel Corano alcun richiamo alla differenza tra le nazioni, bensì la sola umma, la comunità universale dei credenti di Dio. Nell’ambito di un comune obiettivo di re-islamizzazione delle società, sembrano delinearsi due diversi atteggiamenti culturali, identificabili come radicale il primo e tradizionalista il secondo, in ogni caso riconducibili a diverse strategie per la costruzione di un soggetto islamico unitario. Se per il primo si tratta di una islamizzazione dall’alto, ovvero l’acquisizione immediata della titolarità del potere politico, per il secondo il fenomeno deve invece scaturire dal basso, con una paziente opera di diffusione sul territorio della cultura islamica (le idee fondamentaliste – necessarie per il consenso politico del futuro Stato – devono penetrare nel mondo studentesco, lavorativo ed intellettuale). Nel variegato mondo del fondamentalismo, se queste divisioni non sono accentuate per via della condivisione del fine ultimo – le alleanze si configurano spesso, anche se temporanee – le divergenze ideologiche sembrano invece scontrarsi, con maggiore facilità, con i problemi politici, nazionali e regionali, dando talvolta vita ad alleanze che, pur concettualmente impossibili, raggiungono vette di pericolosità proprio a causa della loro spiccata asimmetria. 2. L’estrema eterogeneità del gruppo degli sahaba (i compagni di Maometto, che avendo preso parte, a vario titolo, al trionfo della nuova fede costituivano l’originaria comunità mussulmana) provoca una considerevole divergenza di opinioni nei campi più disparati, dalle semplici modalità di osservanza del culto sino alla stessa designazione – in effetti, particolarmente complessa – della nuova guida della comunità dopo la morte del Profeta. Pur condividendo che la successione non dovesse comportare alcuna esigenza di particolari qualità profetiche – il sigillo era stato già apposto sulla profezia rivelatrice – sono piuttosto le modalità di elezione del nuovo capo spirituale a creare profondi contrasti all’interno della comunità dei compagni. La repentina e affatto condivisa elezione di Abu Bakr – avvenuta nelle ore immediatamente successive alla morte di Maometto, mentre i familiari erano ancora impegnati nei preparativi delle cerimonie funebri – suscita le prime divergenze sui criteri selettivi (e non sul nome del prescelto) che a loro volta originano una tendenza favorevole al criterio basato sul merito da una parte, ed un diverso orientamento, più restrittivo, dall’altra, o meglio la diretta discendenza carnale dal Profeta (la figlia Fatima era andata in sposa ad Alì, cugino di Maometto, e questa coppia era stata ritenuta da alcuni – anche per via della doppia parentela di Alì con il Profeta – la più naturale linea genealogica per la successione). Il cosiddetto partito (shi’a) di Alì raccoglie anche il favore di coloro che avrebbero preferito, in ogni caso, un diverso svolgersi degli eventi, sebbene accumunati nella presunta lesione dei diritti politici inferta alla famiglia del Profeta, prima ancora che nel mancato riconoscimento di natura spirituale. Anche se la cultura islamica non ha mai operato sino a questo momento una distinzione netta tra eresia o scisma, la sconfitta del movimento sciita – che giunge sino al confronto armato con la parte avversa – traccia i primi contorni di una impostazione dottrinale diversificata. La mancata realizzazione del legittimo ruolo di guida – a cui la comunità mussulmana (umma) era tenuta, secondo la volontà del Profeta, a prestare assoluta obbedienza – così come una lunga serie di torti subiti, spingono la componente sciita verso una concezione sempre più sacrale della figura dell’imam (attesa messianica), ovvero della guida per diritto divino, superando quindi l’originaria lotta politica per rivolgersi piuttosto, con maggiore entusiasmo religioso, verso una visione più cosmica e trascendente. L’iniziale e contenuta dissidenza del movimento esplode però durante il califfato di Uthman, accusato di favorire, in maniera eccessivamente sfacciata, i componenti della propria famiglia (Omayyadi) a sicuro svantaggio delle nuove fila di convertiti che vanno ad ingrossare le forze militari di Kufa, il principale campo della regione irachena. Per i giovani ed entusiasti sostenitori dell’islam costituiscono quindi elemento di scandalo i privilegi concessi all’aristocrazia di Medina – che tanto era stata avversa al Profeta – e la protesta si identifica con la difesa di quei diritti, adesso non solo politici, ma anche religiosi, che erano stati negati alla famiglia di Maometto. Partito da Kufa, il malcontento si estende anche in Egitto (oltre che in Arabia e Siria), lì dove si innestano le componenti più pure – ma anche più combattive – dello spirito religioso islamico del primo periodo. Con la morte per assassinio del califfo Uthman, il più alto rappresentante della famiglia omayyade (Muawiya, governatore della Siria) scatena un aperto conflitto contro i seguaci di Alì, accusati di essere – in ogni caso – i responsabili morali di quel crimine così grave. Le lotte che seguono si concludono con la sconfitta degli sciiti (molti di loro si rifiutano però di fare ricorso alle armi) e il partito di Alì, anche se diventa più esiguo nel numero, rafforza la sua determinazione nella ricerca del riscatto politico (le maggiori istanze di giustizia e rigore vengono, ma solo in questa fase, assorbite dagli intransigenti kharagiti12). Rispetto al più vasto mondo sunnita, lo sciismo imamita rappresenta il maggiore gruppo della dissidenza islamica. La preferenza accordata al termine di imam – preferito a quello di califfo, in qualità di elemento maggiormente caratterizzante – ha favorito la denominazione di “quelli dei dodici” (duodecimani), ovvero la serie di imam riconosciuti come legittimi. I primi tre califfi, precedenti ad Alì e riconosciuti dall’ortodossia sunnita, vengono quindi considerati degli usurpatori, e di conseguenza l’epiteto preferito dai loro avversari diventa “coloro che ripudiano” (in senso meno dispregiativo, viene usata anche la denominazione di alidi). I fautori di Alì concordano nel ritenere che la volontà di Allah e del Profeta, nel riconoscere il cugino e il genero come legittimo successore, è stata espressa più volte e in maniera equivocabile, anche se questi segnali sono stati ignorati dalla maggioranza della comunità13. 12 In seguito, alcune tra le principali sette di questo movimento, come i sufriti e gli ibaditi, perdono l’originario estremismo e si diffondono maggiormente nell’Africa del Nord – Tripolitania e Algeria meridionale – oltre che nell’isola di Zanzibar. 13 In particolare, lo hadith al-thaqalayn (“il detto dei due beni preziosi”), secondo il quale il Profeta avrebbe dichiarato: “lascio fra voi due beni preziosi; il Corano e le Genti della mia Casa. Essi non si separeranno sino al giorno del giudizio”. Inoltre, una quarantina di versetti coranici farebbero riferimento all’eccellenza di Alì (anche senza farne direttamente il nome) e alcuni detti del Profeta (hadith) lo indicherebbero apertamente come il legittimo successore. Dopo la morte di Alì, la rinuncia del figlio maggiore Hasan ad esercitare i suoi diritti di successione apre definitivamente la strada all’affermazione degli Omayyadi, un gesto che successivamente i sunniti elogeranno come un dignitoso atto di responsabilità, ovvero nel convincimento oggettivo di evitare una lotta impari con i più potenti rivali. Il nuovo califfo Muawiya inaugura la dinastia – destinata a governare l’islam per quasi un secolo – con contrasti particolarmente duri nei confronti della famiglia di Maometto e nella corrente sciita si rafforza il convincimento che l’atto di abdicazione di Hasan sia stato solo il risultato di un ennesimo e scaltro inganno del nemico omayyade. Con la morte di Muawiya, il califfato passa nelle mani del figlio Yazid, ma il fratello minore di Hasan (Husayn, divenuto adesso il capofamiglia) rifiuta di riconoscere questa successione e riesce ad aggregare le speranze dei fedeli sciiti in qualità di nipote diretto del Profeta. Il fatto di sangue avvenuto a Kerbala nel 680 – riconosciuto come la nascita della shi’a – è sicuramente l’episodio che maggiormente inciderà sulla sua storia successiva14. Dopo questa tragedia, i discendenti del Profeta evitano di incoraggiare qualsivoglia contestazione politica (o militare) e scelgono invece una vita del tutto ritirata, dedita alla devozione e all’insegnamento religioso. La ripresa del malcontento sciita trova invece sponda favorevole con gli Abassidi, impegnata a rovesciare la dinastia omayyade e quindi in grado di canalizzare tutte le correnti vicine allo sciismo – alcune anche clandestine – per la restaurazione dei diritti usurpati alla discendenza del Profeta. Anche se gli alleati sciiti contribuiscono al successo della dinastia (al-Suffah, primo sovrano della famiglia viene proclamato califfo a Kufa nel 750), la nuova dirigenza teme il coagularsi di una ulteriore ribellione all’ordine costituito e prende marcatamente le distanze dai seguaci di Alì, arrivando ad effettuare una sorveglianza speciale ai discendenti diretti del Profeta, anche se scevri da qualunque coinvolgimento negli avvenimenti politici. In uno stato di semi prigionia – in un campo della città di Samarra, in Iraq – l’undicesimo discendente di Alì e Fatima, Hasan al-Askari, muore nell’anno 874 e diventa successore il figlio – a tutti sconosciuto – Muhammad al-Mahdi (il guidato), tenuto nascosto nei sotterranei di Samarra per sfuggire alla sorveglianza degli Abassidi, ma sottratto miracolosamente alla vista degli uomini nello stesso anno della morte del padre. Il numero degli imam riconosciuti da questa corrente maggioritaria – appunto quella imamita – si ferma quindi a dodici, anche se in seguito l’esatta successione tra i vari imam sarà oggetto di ulteriori divisioni. Al di là dell’effettiva discendenza dell’undicesimo imam – è lecito ipotizzare che la comunità sciita, priva di sbocchi politici, avesse inteso ricorrere ad un espediente per minacciare gli Abassidi con la presenza di un oppositore occulto, e quindi più temibile – la scomparsa (ghayba) dell’imam diventa un vero e proprio dogma teologico. Un dogma in grado di trasformare la figura del custode della segreta sapienza – ma in questo caso è meglio identificarla come guida – in colui che è atteso, ovvero colui che alla fine dei tempi porrà fine al suo lungo occultamento per ripristinare l’ordine cosmico. Ma anche la guida finale dell’umanità – figura apocalittica vicina alla corrente sunnita, con modalità diverse – è il resurrettore (al-qa’im), chiamato ad annunciare il momento finale 14 Gli abitanti di Kufa convinsero Husayn – nipote del Profeta, ma anche terzo imam per gli sciiti – a prendere il potere in qualità di legittimo capo dei mussulmani. Sulla strada verso l’Iraq, nella località denominata Kerbala, Husayn e la sua tribù vennero accerchiati dalle truppe del califfo Yazid ed annientati dopo essere stati affamati per giorni, senza che arrivassero da Kufa gli aiuti promessi. Presso gli sciiti – che dopo questo episodio si considerano i perseguitati per la vera fede – sono tenuti in altissima considerazione sia Alì (venerato con il titolo di Wali Allah, amico di Dio) che i suoi due figli avuti da Fatima: Hasan e Husayn. La profonda impressione per la tragedia di Kabala è ancora molto viva e continua ad ispirare poemi, elegie e drammi liturgici. Il sepolcro di Alì a Negef e quello del figlio Husayn a Kerbala sono importantissime mete di pellegrinaggio. dell’avventura umana, e quindi anche il signore del tempo. L’occultamento del mahdi, con la sua evidente portata messianica, deve il suo successo all’opera del primo grande teologo imamita – Abu Sahl al-Nawbakhiti – che riesce a produrre una delle caratteristiche più peculiari del movimento sciita, riconosciuta come articolo di fede da tutti gli imamiti (secolo X). La vera rinascita culturale dell’imamismo si realizza però con le produzioni letterarie di carattere teologico e filosofico della scuola di Isfahan in Iran (in particolare, Muhammad Baqir Maglisi, nella seconda metà del secolo XVII) che – oltre ad accentuare la lotta per la realizzazione messianica di un regno di giustizia – genera anche motivi di dissidenza all’interno dello stesso imamismo e non più soltanto contro i secolari rivali sunniti. La tradizionale dissimulazione sciita (taqiyya), vissuta come un atteggiamento quietistico – se non addirittura passivo – viene sostituita con una militanza più attiva, ritenuta fondamentale per riproporre le istanze non più derogabili dello sciismo. In particolare, la figura dell’imam – con il superamento delle implicazioni politiche già esaminate – assume una maggiore dimensione spirituale in qualità di capo della comunità, ovvero di autorità religiosa in grado di illuminare la condotta degli uomini sulla via più corretta da seguire. Conservando in linea generale le connotazioni originarie del califfo sunnita (capo dei credenti e custode della legge) l’imam sciita acquista una spiccata valenza spirituale che subordina necessariamente quella temporale. Gli imam sono quindi i depositari della scienza divina e, conseguentemente, gli unici interpreti qualificati del Corano, soni i discendenti del Profeta: il Profeta stesso, i dodici imam e Fatima, immacolati e provvisti di infallibilità (isma). Anche il Testo sacro riveste per gli sciiti lo stesso valore sostanziale attribuito dai sunniti, la sua validità viene messa in discussione per via di una alterazione (tabdil) esercitata all’epoca di Uthman per epurare le parti che maggiormente si richiamavano alla missione di Alì e della sua famiglia. Solo tramite l’intervento degli imam – esercitato per pura ispirazione spirituale – gli sciiti attribuiscono maggiore validità all’interpretazione simbolica del Testo, ricondotto con ermeneutica propensione dal senso letterale al significato più spirituale (ta’wil). La divisione tra senso esteriore (zahir) e senso interiore (batin) racchiude in pratica la stessa centralità dello sciismo e più volte è stata proprio la causa di insanabili fratture sviluppatesi all’interno del movimento. In effetti, l’estrema necessità di salvaguardare lo spirito del Libro di Allah ha spesso sottomesso – sino a farla sparire del tutto – la lettera del testo, con un’interpretazione talvolta eccessivamente allegorica, e condannata con il termine di batiniyya, pura interiorità. Più pragmatica risulta invece l’elaborazione dei criteri adottati per determinare l’autenticità degli hadith, riconducendo l’attendibilità delle narrazioni solamente a quelle riferite da Alì o dai membri della famiglia del Profeta15. Inoltre, sono riconosciuti come valida fonte scritturale anche gli stessi insegnamenti degli imam, facendo lievitare le raccolte di hadith a livelli di gran lunga superiori di quelle correnti tra i sunniti. Le caratteristiche così marcate dell’ermeneutica sciita hanno favorito la concezione che i semplici fedeli non possano quindi avventurarsi liberamente nelle diverse interpretazioni del Corano, lasciando all’imam l’unica effettiva possibilità d’interpretazione fedele delle Sacre Scritture. La principale scuola teologico-giuridica dell’imamismo – conosciuta come quella degli akhbari – legittima questa impostazione e limita l’uso del Corano alla sola recitazione liturgica, riservando ai resoconti degli insegnamenti impartiti dagli imam l’unica fonte di elaborazione (in contrapposizione, la scuola degli usuli che propugna invece un uso più disinvolto dell’investigazione delle fonti). 15 Di conseguenza, viene molto ristretta la validità dei resoconti attribuiti agli altri compagni e negato il fondamento legale del consenso (igma) di questi ultimi. Interessante, infine, sotto un punto di vista dottrinale, l’evoluzione della pratica della dissimulazione (taqiyya), storicamente imposta ai fedeli per sfuggire alle persecuzioni ma non praticata dalla corrente sunnita (e fortemente condannata dal kharagismo). Consentendo al fedele di dissimulare il proprio sostegno alla famiglia di Alì – e quindi di comportarsi esteriormente con tale prudenza da giustificare anche lo spergiuro – la taqiyya assume nel tempo diversa valenza, sottraendosi ai condizionamenti delle circostanze per connaturarsi con lo stesso esoterismo della shi’a, ovvero identificandosi con il kitman (riserbo, segretezza), il segreto iniziatico che non può essere rivelato – e tantomeno condiviso – ai profani (gli imamiti accentuano la distinzione tra mussulmani ed infedeli, considerando questi ultimi come impuri ed imponendo l’abluzione nel caso di contatto fisico). Le differenze giuridiche – più di quelle rituali – tra i sunniti e gli sciiti vengono quindi marcate sull’atteggiamento tenuto di fronte sia ai fatti politici che religiosi, vissuti entrambi con inconciliabile adesione sin dall’inizio della loro storia. Con la nascita dei movimenti sciiti estremisti (ghulat, esagerati) – considerati come le più antiche forme di dissidenza religiosa e contraddistinti da estrema segretezza e parzialità delle fonti – si afferma il movimento dell’ismailismo, sicuramente il più significativo tra i movimenti scismatici16. Ricomparsi improvvisamente nella seconda metà del secolo IX, gli ismailiti si propongono come un movimento di vasta portata rivoluzionaria in grado di affermarsi, nel giro di pochi decenni, in quasi tutta l’Africa del nord, oltre che in Persia, nella penisola arabica e persino in India. Le correnti più influenti, ovvero quelle che riescono ad ottenere uno straordinario successo religioso e politico, sono quelle dei càrmati e dei fatimidi (sommariamente accumunati dai sunniti e dagli imamiti con il nome di batiniyya). I càrmati propagandano idee ugualitarie e comuniste – pur auspicando una società iniziatica e chiusa – e disprezzano tutte le istituzioni sociali, arrivando a contestare le stesse prescrizioni formali dell’islam ortodosso. Le profonde tendenze radicali del movimento (nel 930 i càrmati si impadronirono della Mecca ed asportarono la “pietra nera”, utilizzata dai loro capi come poggiapiedi durante le funzioni fisiologiche) trovano comunque espressione compiuta nel Bahrain – senza riuscire a trovare altrove adeguata sistemazione – e lo stato indipendente, di tipo comunitario ed egualitario, sopravvive sino all’anno 1077. I fatimidi rappresentano, a loro volta, un’ulteriore e consistente spaccatura nello sviluppo dell’ismailismo. Riuniti intorno alla figura di Ubayd Allah – che si dichiara discendente di Fatima, la figlia del Profeta17 e alla guida del movimento ismailita – non attendono più il ritorno di un capo assente (scomparso) ma proclamano la continuità della linea degli imam, che dopo Ismail si sono regolarmente succeduti. Sostenendo quindi di essere l’imam legittimo, Ubayd Allah provoca la scissione dei càrmati – che si mantengono fedeli all’attesa di quello scomparso – ed entra in conflitto aperto con le dottrine ismailite, attribuendo continuità storica ad una linea che si riteneva interrotta (ad un ciclo di occultamento, dawr al-satr, dove gli imam esistono, anche se nascosti, segue un ciclo di 16 Con il termine di ismailiti – anche se gli interessati preferiscono definirsi con il nome di da’wa (appello, propaganda) – si identificano coloro che, alla morte di Gafar al-Sadik, ritennero come suo legittimo successore in qualità di imam il figlio Ismail. 17 Il nome di fatimiyya, fatimidi, è stato attribuito dagli avversari, sia sunniti che imamiti, probabilmente con intenti dispregiativi. manifestazione, dawr al-kashf, dove si esterna effettivamente il loro potere). La tribù berbera di Kutama, nelle montagne dell’Algeria orientale, viene conquistata dalla prospettiva di una ribellione sia politica che religiosa (la propaganda è opera di Abu Abd Allah) ed elegge Ubayd Allah a capo di una vasta insurrezione che lo porta a fondare un grande stato ismailita nel 909, con sovranità su tutta l’Africa del nord, a occidente dell’Egitto, e con il titolo di al-Mahdi. L’estensione massima dei confini si realizza verso la fine del secolo X, con la conquista dell’Egitto e l’edificazione della città del Cairo (al-Qahira, la dominante), al centro di un rinnovato – ma questa volta internazionale – movimento culturale. Con i califfi del Cairo le pratiche del culto e la normativa giuridica tornano a svolgere un ruolo fondamentale, oltre ad intraprendere una politica ben diversa da quella in precedenza condotta dai movimenti scismatici. Oltre allo scarso interesse per la diffusione delle loro dottrine, i sovrani del Cairo mostrano anche una sostanziale tolleranza nei confronti degli altri mussulmani e una ancora minore tendenza al proselitismo (le masse rurali rimangono tradizionalmente fedeli al credo sunnita ma non vengono perseguitate, così come i cristiani e gli ebrei godono di molti vantaggi, sino ad assumere importanti cariche amministrative e politiche). Con la fine dell’impero fatimide nella madrepatria africana – con la deposizione dell’ultimo rappresentante nel 1171 per opera di Saladino – la storia dell’ismailismo successivo si riconduce ad una complicata sequenza di scissioni che finiscono per polverizzarla. Con l’Egitto riconquistato dai sunniti, rimangono fedeli ai califfati fatimidi soltanto i mustali (il nucleo principale si sposta in Arabia meridionale e in India) che a loro volta subiscono la scissione dei nizariti (l’ulteriore derivazione dei khojas raggruppa alcuni adepti in Africa orientale) e dei bohora, una corrente sciita autonoma che pur avendo le sue radici nei fatimidi, non appartiene al ramo dei nizariti, bensì a quello dei mustali. Il complesso fenomeno della mistica islamica – non certo riconducibile alla mistica occidentale, ma piuttosto ad una tendenza squisitamente interiore dell’islam, definita dal termine tasawwuf – non solo trova difficoltà nella stessa etimologia18, ma si afferma solo nel secolo IX per indicare con certezza coloro che si dedicano con particolare intensità alle discipline spirituali. Inizialmente avversata da tutte le correnti teologiche – a causa dell’esaltazione della virtù dell’amore, maggiormente celebrata rispetto alla stessa valorizzazione dell’obbedienza – questa corrente preferisce fare riferimento alla pietà religiosa coltivata dal Profeta anziché sviluppare l’insegnamento impartito nel periodo di permanenza a Medina. Le componenti più rigidamente “letteraliste” della cultura araba – da sempre sospettosa verso dottrine non considerate ortodosse – denunciano con forza l’estraneità del sufismo rispetto allo spirito originario dell’islam, condannando altresì la religiosità strettamente ascetica, percepita come distacco dal mondo e quindi con una forte propensione alla rinuncia. Partendo dal presupposto che una corrente così spiritualmente sofisticata deve necessariamente avere un’origine straniera (implicito pregiudizio di fondo da parte dei sunniti) viene sottolineato l’influsso del monachesimo cristiano d’Oriente, se non addirittura dello gnosticismo e delle antiche religioni persiane. In realtà, il sufismo – che ha trovato il suo alimento iniziale proprio nella meditazione del Corano e nell’insegnamento del Profeta – viene considerato un genuino prodotto dell’islam, e proprio le sue radici ne giustificano pienamente la nascita e lo sviluppo (nella primitiva comunità mussulmana le dimensioni della vita religiosa erano intimamente connesse: la definizione delle norme giuridiche, la speculazione sui principi dogmatici e la disciplina del perfezionamento spirituale). Anche se la tensione ideale del sunnismo rimane l’unico tentativo di conciliazione delle varie 18 Nei primi testi islamici viene riferita al sostantivo suf (stoffa di lana grezza), ovvero al materiale usato per confezionare le vesti indossate dai primi asceti. Successivamente, e con maggiore frequenza, viene proposta la derivazione dal termine safa (purezza) o dal sostantivo suffa (portico), che richiama una categoria di pii e poveri personaggi che il Profeta aveva ospitato appunto sotto un portico. componenti dell’islam, la complessa articolazione dei differenti aspetti del vivere religioso genera la nascita di raggruppamenti autonomi, sempre meno permeabili tra di loro e talvolta addirittura ostili. Con l’insegnamento di al-Hasan al-Basin (Kufa, Basra e Baghdad), i temi principali dell’evoluzione diventano quelli del distacco dalle mondane vicissitudini, dell’accettazione – gioiosa, con fiducioso abbandono – di Allah e dell’amore spirituale, sino a diventare superamento della dimensione umana individuale e meditazione metafisica (al-Gunayd). La successiva tendenza a marcare una maggiore distinzione tra le categorie dei profani e degli iniziati (dominio esteriore e dominio interiore) deve probabilmente ricercarsi nel più intenso conflitto – tra le teorie sufi e i dottori della legge – scatenato da al-Husayn ibn Mansur al-Hallag con il suo scandaloso proclama (“io sono il Vero”) che provoca la prima profonda spaccatura nella comunità mussulmana. Il rapporto privilegiato che lega invece i fedeli al loro Signore – walaya, amicizia o protezione, ma anche santità – è costituito da santi che, provvisti di un loro Sigillo posto sotto un’egida divina, agiscono – e meditano – per conto di Dio. L’identificazione di una temibile eresia si realizza invece con la dottrina del wahdat al-wugud (l’unicità dell’essere) ad opera di Muhyi i-din ibn Arabi gli inizi del secolo XIII, ovvero con la negazione della differenza tra Dio e le cose (le cose non possiedono un essere proprio perché solo Dio è il vero unico). Anche se il consenso alla dottrina di Arabi, tra molte obiezioni, si consolida nel tempo, la recente spinta del radicalismo islamico riapre la discussione con particolare vigore19. La pluralità di tendenze che ha sempre caratterizzato il sufismo sin dalle sue origini – ogni maestro produce esperienze spirituali personali – consente comunque (e forse paradossalmente) a questo ramo dell’islam di mantenere una maggiore coerenza interna – il quadro di riferimento è comune – così come di evitare il trionfo assoluto di una specifica scuola a detrimento delle altre. Oltre alla pratica individuale – nei confronti del maestro, che rappresenta la realizzazione piena delle possibilità interiori, il discepolo deve osservare la adab, le buone maniere, con i caratteri di una vera e propria normativa – un ruolo altrettanto rilevante viene attribuito ai riti effettuati in comune dai discepoli, riunioni che prevedono, oltre all’invocazione collettiva, l’ascolto di poesie e l’esecuzione di musiche e danze (sicuramente gli aspetti più appariscenti della pratica, ma condannati dai dottori della legge per gli effetti talvolta sensuali ed inebrianti). Gradualmente, ma in particolare dal secolo XIII, la forte spinta associazionistica del sufismo trasforma le semplici e libere comunità di fedeli in ordinamenti strutturati, con statuti e regole, ma in particolare con dettagliati obblighi rituali e indicazioni precise sui comportamenti degli aderenti. La gerarchia a carattere piramidale delle confraternite (lo shaikh, l’ultimo anello di una catena che risale al Profeta, impartisce in qualità di capo della comunità insegnamenti teorici e pratici ai discepoli, a loro volta divisi tra esperti e novizi) deve obbedire a motivi di estrema praticità – dal numero elevato di aderenti all’ampia estensione geografica – e di conseguenza assume maggiore importanza la figura del khalifa, il vicario, delegato dallo shaikh alla guida dei discepoli, anche se spesso in deciso contrasto con il maestro, sino a modificarne le dottrine e le pratiche di appartenenza20. Nell’Africa settentrionale, la confraternita in grado di esercitare un’esclusiva superiorità sul 19 Il parlamento egiziano, agli inizi del 2000, ha sospeso la pubblicazione di un’edizione critica de “Le illuminazioni della Mecca” (“al-Futuhat al-makkiyya”), considerata l’opera maggiore di Arabi, anche se il provvedimento è stato in seguito annullato. 20 Questa è considerata la causa dell’estrema prolificazione degli ordini e delle confraternite in tutto il mondo mussulmano. Nell’Egitto contemporaneo ne sono riconosciuti quasi un centinaio, anche se alcuni di essi rappresentano solo minime varianti locali rispetto alle confraternite maggiori originarie. Maghreb e in buona parte dell’Egitto è senza dubbio la Shadhiliyya del marocchino Hasan alShadhili e del discepolo Abu Abbas al-Mursi (1250-1280). Tra gli ordini orientali più antichi, la Mawlawiyya del poeta turco Galal al-din Rumi, invece, ha il merito di rendere popolari i “dervisci roteanti” in Occidente – il metodo basato sulla danza estatica – anche se la diffusione della confraternita non supera l’area di origine (quella dei dervisci è una danza rituale altamente emblematica, e di profonda spiritualità, che rappresenta una delle più intense espressioni della mistica islamica21). Ispirato da una visione di un islam aperto e tollerante, il maestro Mevlana introduce nelle cerimonie religiose la danza e la musica, a sicuro sconcerto dei teologici ortodossi, poco inclini ad accettare vistose espressioni dottrinali, considerate inoltre così vicine al paganesimo. Diffuse in tutto l’impero ottomano, le confraternite mevlevi utilizzano la danza per raggiungere un’estasi che permette una sorta di comunicazione divina (Ataturk considerò gli ordini dei dervisci un ostacolo al cammino del popolo turco e vennero banditi nel 1925, con l’esproprio dei monasteri e la loro trasformazione in musei. Successivamente consentite, le confraternite celebrano ogni anno, il 27 dicembre, la commemorazione di Mevlana con una cerimonia estremamente spettacolare). Senza dubbio, le confraternite (turuq, singolare tariqa) favoriscono sì la diffusione del sufismo, ma riescono anche ad elaborare una profonda dedizione alla pratica dell’islam – da parte di grandi masse di fedeli – esercitando una forte influenza sulla vita sociale, ovvero sulla morale, sugli usi e sulla stessa educazione della società islamica. Profondamente radicate nel tessuto sociale islamico, queste confraternite si pongono, pur nella loro complessità, a baluardo difensivo dell’islam durante la penetrazione straniera22 e solo un vasto movimento di riforma (neosufismo, secolo XVIII) tenta una collocazione storico-politica più adeguata nel processo evolutivo delle dottrine sufi, in particolare nel riformismo che mira a combattere le devianze e a ripristinare i valori più puri del sufismo. Se la scuola del marocchino Arabi al-Darqawi si limita a criticare l’eccesso di attivismo politico, l’algerino Ahmad al-Tigani si pone piuttosto come elemento in grado di marcare decisamente il distacco dal passato, arrivando a contestare la legittimità della trasmissione di insegnamento da maestro a discepolo e riservando la fonte di ogni magistero spirituale al solo Profeta. Considerata un’opera di restaurazione particolarmente energica – caratterizzata da atteggiamenti rigidi con incursioni nella vita politica, in aperto contrasto con le autorità – la Tiganiyya viene interpretata come distintivo segno di fondamentalismo e riesce ad espandersi con facilità nella sua area di origine, l’Africa occidentale, sino a raggiungere ampi consensi nella zona sub-sahariana, dove ancora oggi la sua presenza si fa sentire con particolare incisività. Sulla stessa sponda, l’ultimo grande riformatore, Ahmad ibn Idris della città di Fez, si avvicina decisamente alle proposte del fondamentalismo wahabita, con cui condivide le ampie riserve per l’eccessiva venerazione dei santi, il rifiuto categorico di ogni forma di consenso che non sia quello dei compagni del Profeta e la ferma determinazione ad uniformare le pratiche e i comportamenti di tutte le popolazioni mussulmane. La confraternita da lui fondata (Ahmadiyya Idrisiyya) trova ampia diffusione e si arricchisce con due illustri discepoli, Muhammad Uthman al-Mirghani e Muhammad ibn Alì al-Sanusi, a loro volta fondatori della Mirghaniyya e della Sanusiyya. 21 La tradizione racconta che il filosofo turco Celaleddin Rumi (chiamato Mevlana, la nostra guida), attraversando il quartiere degli orafi della città di Konya, in Anatolia, si sia lasciato ispirare dal tintinnio ritmato dei martelli che lavoravano l’oro e che, con le braccia allargate, abbia iniziato a roteare su se stesso come in una danza. 22 Alcune confraternite raggiunsero un tale potere, a causa della straordinaria venerazione di cui godeva la guida spirituale, da costituire dei piccoli stati, con la trasmissione ereditaria del potere, il controllo del consenso popolare e addirittura con il reclutamento di un esercito. Accomunate da uno spiccato carattere militante e da una forte presenza nelle vicende politiche, la prima confraternita crea una sorta di potentato in Eritrea e la seconda – più conosciuta con il nome della famiglia, i senussi – si oppone con forza al colonialismo italiano, arrivando, dopo il Secondo conflitto mondiale, a costituirsi in monarchia ufficiale e riconosciuta. Sono le èlite urbane, nel corso del secolo XIX, ad individuare nell’islam delle confraternite un fattore di decadenza della civiltà islamica, ovvero il sintomo di una frammentazione (periferica) della cultura, riferita ad autorità locali e agli inevitabili processi di clientelismo ad esse legati per via della tradizionale fratellanza di sangue. In effetti, la civiltà islamica si è espressa – nei suoi momenti più significativi – con l’identificazione di uno stato forte, strutturato in una capitale (cultura di matrice urbana) e con una serie di province periferiche, non autonome, sulle quali irradiare i riferimenti legislativi, culturali e religiosi. Dalle confraternite quindi deriva la degenerazione dell’islam (il riformismo mussulmano lo definisce “il ripiegamento dell’islam su se stesso”) e gli intellettuali vengono chiamati a riconquistare la grandezza dell’islam (lo spazio politico della città-modello). La centralizzazione dello stato – e la coscienza urbana, eminentemente politica – servono a superare il sintomo di debolezza dello stato-nazione, che ha permesso alle confraternite di decentralizzare la cultura islamica e di diffonderla localmente. Parimenti, il misticismo delle confraternite viene percepito come una forma arcaica di religiosità, e quindi un ostacolo alla modernizzazione. All’associazionismo delle confraternite, che rappresentano il plurale e il diversificato della società, si oppone il pensiero teologico dogmatico della scuola hanabita (Ibn Taymiyya e Ibn Abd alWahhab) basato su un islam forte, uno stato dirigista e un accentuato formalismo gerarchico (il riformismo mussulmano, islah, trova il suo fondamento nella tradizione profondamente legata ad un hadith del Profeta: “la mia comunità non si riunirà mai su un errore”). Dal piano teologico, la condanna delle confraternite si sposta su quello politico (secolo XX) con la pesante accusa di collaborazionismo con il potere coloniale (alla vigilia dell’indipendenza dell’Algeria vengo chiuse le sedi della confraternita Isawiyya). Alla convergenza tra il movimento riformista e quello laicista – a cui corrisponde un massiccio esodo rurale verso le capitali – le confraternite tentano di recuperare il ruolo (anche antropologico) dell’identità, inserendosi nella vasta trasformazione economica e sociale che il pensiero nazionalista genera. La loro sopravvivenza – assicurata dal rapido cambiamento e dal trasferimento nelle città – permette anche la trasformazione in partiti politici, così come avvenuto in Libia e in Sudan. 3. Se il mondo intero – nei suoi aspetti più variformi – rappresenta effettivamente l’ultima frontiera, il terreno della rivalsa non è più nei termini del dar al-harb (quello perduto e da riconquistare, in opposizione al dar al-islam, quello mussulmano) e l’identificazione della controparte acquisisce le connotazioni più diverse, dall’elemento crociato a quello sciita, se non quando apostata. Questo atteggiamento – spesso identificato con il termine di jihad globale – tende a definire ed a contrastare i processi di democratizzazione (politica ed economica) attuati dall’Occidente nei confronti dei paesi arabi e mediorientali. Percepiti come un tentativo, costante nel tempo, di assicurare la sopravvivenza ai regimi filooccidentali – a sicuro deperimento delle istante sociali e spirituali delle popolazioni – rappresentano per l’islam radicale il mezzo più efficace per riordinare e riproporre le tradizionali istanze che nel passato avevano coeso la cultura araba. Quindi non deve stupire se il terreno è diventato anche quello mussulmano – e forse più di altri – proprio a causa delle maggiori e più efficaci risposte in grado di elaborare persuasive modalità di aggregazione. Si tratta quindi di contribuire a creare una nuova umma, una sorta di raggruppamento virtuale dei fedeli, in grado di abbattere le barriere legate all’identità nazionale e al tempo stesso di accrescere il divario, peraltro già esistente, tra i governi e le società arabe. Inoltre, il supporto logistico e finanziario fornito dall’Occidente aveva contribuito in maniera determinante alla sconfitta dei movimenti islamici in Algeria, in Marocco, in Tunisia e in Egitto, aggravando i fenomeni di corruzione dei dirigenti legati all’amministrazione pubblica e favorendo, nel contempo, una manipolazione geopolitica della regione, ovvero legittimando il ruolo strategico dei movimenti islamici più radicali come unici ed indiscussi difensori della tradizione coranica. Oltre ad ergersi a difesa della corruzione materiale introdotta dall’Occidente, questi movimenti hanno anche usufruito della liberalizzazione delle telecomunicazioni effettuata da molti paesi nordafricani (2005-2006), con il vantaggio di allargare la rete dei contatti e di ampliare, di conseguenza, l’attività di proselitismo. In effetti, è lecito anche ipotizzare un’ulteriore decisione strategica, ovvero l’opportunità di essere sempre meno legati ad una sola base territoriale solida per le operazioni internazionali, rendendo affatto indispensabile consolidare una presenza costante in un solo ed unico paese. Secondo molti analisti, infatti, i movimenti più radicali hanno già creato, nel continente africano, strutture sicure di comando e controllo. L’indebolimento dei confini fisici e burocratici tra gli Stati favorisce un’attività transfrontaliera sempre più accentuata e al tempo stesso – oltre a mettere a repentaglio l’intesa tra la dirigenza araba e l’Occidente – costringe al dibattito sul più generale ruolo svolto dall’islam nelle vicende politiche regionali. Così come già accaduto durante il periodo della Guerra Fredda e l’occupazione sovietica dell’Afghanistan, possono anche oggi gli islamisti costituire una forza legittima? Di contro, la frammentazione dell’implicito patto stipulato tra i governanti arabi e le classi dirigenti occidentali, sembra aver favorito un facile terreno di coltura proprio per lo stesso islam radicale. In una congiuntura storica particolarmente delicata – ovvero nel periodo in cui molti governi nordafricani iniziavano a prendere in considerazione l’opportunità di abbattere le rigide barriere erette dal panarabismo per aprire le porte ai flussi di beni, servizi e informazioni della globalizzazione – le marcate ed incisive presenze integraliste nella regione hanno indotto gli stessi paesi ad innalzare a loro volta nuove barriere, sia a protezione della sovranità dello Stato, sia al fine di garantirne meglio la legittimità. Una difficile ricerca di equilibrio della propria identità che deve anche fare i conti con la funzione stessa dello stato mussulmano moderno, proprio l’aspetto più critico che il radicalismo intende mettere in discussione, svolgendo il ruolo di strenuo lottatore per la difesa della religione prima e del benessere sociale poi. Il divario tra i governanti arabi, sempre più impegnati nel contrasto alle attività terroristiche, e le popolazioni – in ampia misura religiose e tradizionaliste – sembra allargarsi progressivamente e irrimediabilmente, facendo riaffiorare, nei rapporti stato-società del mondo arabo, analoghe tensioni a quelle registrate all’epoca delle lotte nazionaliste tra nazione araba e stato arabo. Inoltre, questa nuova formula di panislamismo radicale sembra avere a disposizione risorse maggiori di quelle possedute dal panarabismo, anche se disposte in maniera caotica e talvolta (apparentemente) frammentaria. Ma perché in terra mussulmana? E con quali rapporti con gli altri fedeli? Da un punto di vista storico-religioso, l’islam considerato classico (esteso sino al secolo XVI, il decimo secolo dell’ègira) comincia ad assumere una sua peculiare natura di esclusivismo dottrinale con l’insorgere di numerose scuole giuridiche – particolarmente rigide – che non riescono ad elaborare una casistica legale orientata ad una corretta fattispecie religiosa, ma sembrano piuttosto preoccupate di rielaborare sterilmente i principi del dogma e di screditare le posizioni assunte dalle altre. Secondo l’affermazione esclusiva della propria dottrina, queste scuole cercano di imporsi come l’unico apparato possibile per la migliore comprensione delle nuove esigenze sociali (e quindi di come vivere correttamente l’islam) minando però quell’unità sostanzialmente omogenea che era sempre riuscita ad adattarsi alle nuove circostanze che di volta in volta si erano proposte. Si assiste quindi, in questo periodo, ad una mutazione significativa – e per certi aspetti irreversibile – della storia dell’islam, segnata sino a questo momento da una considerevole capacità di difesa collettiva dei principi fondamentali, pur essendo in grado di adattarsi alla coesistenza di punti di vista molteplici e di elaborare nel contempo una risposta efficace alle vicissitudini storiche. Con il passaggio dal secolo X all’XI, si è sentita più forte l’esigenza di un rinnovamento (tagdid), ovvero della necessità di assicurare la sopravvivenza della fede islamica nelle condizioni sempre più critiche che si andavano palesando: la disgregazione politica e morale in cui versava la maggioranza del mondo mussulmano23. Anche se lenta e progressiva, questa è la fase in cui è possibile scorgere i segni di una nuova concezione dell’islam, o meglio dove l’intellettualità islamica viene chiamata ad affrontare – in maniera più critica rispetto al passato – le sollecitazioni della storia. La necessità di questo rinnovamento – la restaurazione dei valori più autentici dell’islam di fronte alla perdita delle certezze del passato – produce, in linea di massima, due diverse correnti storiche. Sebbene unite nella comune e severa condanna delle categorie religiose barricate ad esclusiva tutela dei privilegi acquisiti, la prima tendenza – identificabile con la denominazione di intransigenti – propone un ritorno alle fonti primarie dell’islam (Corano e Sunna) già sufficienti per esorcizzare i pericoli della decadenza dei costumi, mentre la seconda – denominata dei tolleranti – è pronta ad accettare le dottrine oramai consolidate nel tempo, limitando la critica ai soli eccessi, o abusi, che alcuni sviluppi hanno inevitabilmente generato. Se la prima corrente trae la sua forza unicamente dalla parola del Corano e dal messaggio del Profeta, la seconda ribadisce il ruolo fondamentale del consenso (igma), riconosciuto come lo strumento che ha sempre permesso all’islam – nel corso della sua storia – di adeguarsi a modificazioni e sviluppi. All’inizio della sua era moderna, l’islam sunnita subisce quindi – per la prima volta – un forte influsso di protofondamentalismo, che non riesce più ad emarginare al suo interno, così come già avvenuto nel passato con il rigorismo dei kharagiti o lo scisma degli sciiti, pur avendo le scuole affermato con forza l’impossibilità, da parte di mussulmani, di emarginare altri mussulmani come miscredenti. Venuto meno quindi ogni tentativo di neutralizzare tale radicalismo, proprio una scuola – quello neo-hanabita di Ahmad Ibn Taymiyya – riesce a contrastare energicamente qualsivoglia forma di accomodamento, esortando inoltre la giurisprudenza ad una interpretazione sempre più letterale, e inflessibile, della legge di Dio. All’alba del secolo XVIII – con la riproposta organica della dottrina di Ibn Taymiyya – il nascente movimento wahabita propone ancora una volta il ritorno radicale alle origini come unico strumento in grado di affrontare – e risolvere – le devianze dottrinali e morali che l’impero ottomano non era in grado di arginare. Anche se il tenore estremamente rigido di questa dottrina suscitò a lungo nel mondo islamico il timore di un fanatismo che non poteva essere accettato di buon grado dalla mentalità sunnita tradizionale, gli insegnamenti di Wahhab trovarono ampia risonanza proprio sull’atteggiamento da tenere nei confronti degli altri mussulmani. Confermata la condanna ortodossa dei movimenti kharagiti e di quelli sufi (colpevoli di diffondere una devozione popolare troppo prossima all’idolatria), questa scuola riesce ad imporsi come l’unica dottrina in grado di condannare compiutamente i movimenti che pretendono di rappresentare l’islam autentico (tacciando di infedeltà gli altri credenti) ma ben presto si rivela come un’ideologia settaria subito pronta – prima fra tutte – a scomunicare proprio quei mussulmani che praticano la fede 23 Con l’idea di rinnovamento, si intende comunemente accettato l’ingresso dell’islam nella sua era moderna, con l’inizio del secondo millennio dell’ègira, indicativamente in corrispondenza del mese di ottobre dell’anno 1591. islamica senza condividerne le idee fondamentali. Interessante qui notare che il wahabismo – pur essendo considerato per lungo tempo un movimento scismatico al pari di altri – non può essere collocato oggi tra le eterodossie dell’islam. Sotto un profilo strettamente dottrinale, questo movimento trae origine dalle principali scuole sunnite – al contrario dei kharagiti e degli sciiti – e anche se non le rappresenta pienamente, sembra affermarsi piuttosto per una corretta interpretazione dei Testi Sacri, anche se parziale e talvolta esasperata. Ma il successo di questa corrente deve piuttosto essere ricercato nella sua capacità di abolire la logica delle differenziazioni tra i mussulmani, che proprio le scuole giuridiche – in ragione dei loro forti contrasti – avevano contribuito ad alimentare. In altri termini, il wahabismo si presenta sulla scena del mondo islamico come una scuola capace di semplificare – e quindi di rendere più accessibile alle masse – l’islam stesso, ovvero di guidare i fedeli verso pratiche di comportamento universali e ben comprensibili. A questo indirizzo ha dato forte impulso la pubblicistica (responsi giuridici semplificati, libretti ed opuscoli) avvicinandosi con studiato approccio agli strati più popolari della comunità islamica, comunemente estranei alle complesse elaborazioni delle scuole tradizionali. Resa più complicata nel recente passato – a causa dello spiccato conservatorismo delle autorità governative arabe – questa attenta opera di propaganda sul territorio ha ricevuto oggi forte impulso dalle recenti tecnologie informatiche, permettendo di raggiungere in questo modo le masse dei fedeli indipendentemente dalla loro adesione alla nazione/stato di appartenenza. La più recente costruzione dottrinale della Salafiyya (Rashid Rida, 1865-1935), intesa anch’essa come rifondazione dell’islam, si oppone tenacemente non solo agli influssi delle altre dottrine, ma anche a qualsivoglia forma di occidentalizzazione – in questo caso intesa come imitazione servile di innovazioni contrarie allo spirito originario dell’islam – e al cosiddetto islam parallelo: la mistica islamica e le confraternite (turug). Tra i numerosi movimenti che si richiamano al salafismo, trovano autorevole collocazione sia quello del fondamentalismo di Hasan al-Banna che quello del riformismo (islah) che prese piede nei paesi del Maghreb in generale e nell’Algeria coloniale in particolare (Ibn Badis, fondatore dell’associazione degli ulema di Algeria). Per i riformisti algerini è necessario porre rimedio alla crescente degenerazione dell’islam opponendosi ai regimi corrotti (fasida) e riproponendosi nella condizione di una purezza fondatrice (gahihyya), corrispondente all’ordine culturale originario. Il più recente fondamentalismo sunnita – che l’islam sciita ha classificato come cultura politica del sunnismo – a partire dalla fine degli anni Ottanta ha evidenziato che i nuovi attori principali dell’islam contemporaneo non sono più gli studiosi delle scuole – responsabili delle incertezze manifestate davanti alla storia e alla sua evoluzione – bensì i militanti di un islam esclusivamente politico, o meglio rivoluzionario, in grado cioè di spezzare i vecchi legami e di segnare il tramonto definitivo del mondo tradizionale. Agevolato dall’assenza istituzionale di un clero dogmaticamente legittimato, il nuovo islam della contestazione sembra contrastare con forza l’ingresso nella modernità occidentale, proponendo la asabiyya, una sorta di fratellanza di sangue o spirito di gruppo, in grado di superare la molteplicità delle situazioni politiche, economiche e culturali tipiche di ciascun paese mussulmano. Ma anche la strategia dei movimenti fondamentalisti subisce mutamenti significativi. Di fronte all’insuccesso politico di gruppi al-Gihad e Takfir wa Higra in Egitto – che si proponevano la conquista del potere al vertice, così come accaduto in Iran – la nuova tendenza mira piuttosto a costruire progressivamente, dal basso, una nuova società islamica, mirando soprattutto ai gruppi sociali più disagiati e deculturati. Utilizzando anche gli opportuni canali della solidarietà e dell’associazionismo, il nuovo messaggio non si limita a bollare i valori occidentali (la modernità) come estranei alla cultura locale, ma imprime il primato dell’etica islamica su tutti gli altri aspetti dell’esistenza umana, non disgiunto dall’induzione di un forte senso di colpa (oltre che di effettiva emarginazione) per il fedele che abbia intenzione di allontanarsi dalla prassi rituale tradizionale. Quindi un processo di reislamizzazione accumunato nel rifiuto dell’Occidente secolarizzato, così come testimoniato dalla produzione ideologica dei leader del nuovo movimento (Rashid Ghannouchi in Tunisia, Abbasi Madani in Algeria e Haasan Turabi in Sudan) oltre ad alcuni tentativi di costruire una sinistra islamica (Hasan Hanafi in Egitto e un gruppo di intellettuali tunisini della rivista «15/21»). In ogni caso, l’islamismo radicale si afferma – al di là delle connotazioni eversive dei gruppi algerini – nell’area del Maghreb agli inizi degli anni Novanta e ancora oggi non sembra essere riuscito a risolvere il dilemma (per certi aspetti etimologico) tra la volontà di potenza e la ricerca di nuovi significati in grado di identificare in maniera più compiuta le aspirazioni politiche e sociali dei fedeli. Con l’emergere della questione islamica – quindi non solo in Occidente, ma prima ancora nei diversi paesi mussulmani – il riferimento ad una identità, etnica o religiosa, diventa il presupposto fondamentale per la costruzione di un nuovo ordine politico, sia nelle dinamiche delle relazioni internazionali che nelle questioni relative all’inserimento delle popolazioni islamiche nei territori occidentali. Il radicalismo, a sua volta, si pone come costruttore di un nuovo ordine, questa volta mondiale, contrapposto a quello dell’Occidente che impone una visione totalitaria, e tenta di coniugare politica e mistica utilizzando l’accattivante linguaggio religioso per rendere invalicabile il passaggio da una cultura all’altra. Ma occultando al tempo stesso le tematiche relative ad una possibile costruzione di uno spazio democratico, percepito come sempre più urgente dalle giovani popolazioni maghrebine. Infatti, anche se si registra una sostanziale diversità di opinioni tra chi ritiene che l’islam debba costruire una relazione privilegiata con la politica (il gruppo di al-Qaeda ribadisce continuamente il richiamo alla sharia) e chi invece, escludendo l’islam dalla visibilità pubblica e riconducendolo alla sfera privata, considera la democrazia e la religione assolutamente compatibili. Tra le due diverse tendenze sembra invece delinearsi l’assenza di un apparato culturale (riflessioni sui mutamenti in corso) che costruisca un solido rapporto tra l’entità religiosa e le vicende che il mondo mussulmano è destinato ad attraversare nel prossimo futuro. Questo spazio, che alcuni analisti hanno identificato con il malessere psicologico giovanile, lascia all’islam radicale la possibilità di coniugare – anche se in maniera forzosa – il senso di emarginazione, dovuto alla modernità non sempre condivisa, con un nuovo orizzonte culturale che progressivamente sembra assumere le connotazioni di un più marcato ed aggressivo islam politico. Bibliografia 1. C. Lo Jacono, I cosiddetti fondamentalismi islamici, «Parolechiave» n°3, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Roma 1993. 2. K.F. Allam, L’islam globale, Rizzoli, Milano 2002. 3. B. Etienne, L’islam radicale, Rizzoli, Milano 1988. 4. M. Campanini, Il pensiero islamico contemporaneo, Il Mulino, Bologna 2005. 5. M. Richard, The Society of the Muslim Brothers, Oxford University Press, London 1969. 6. W. Laquer, Storia del terrorismo. Rizzoli, Milano 1978. 7. W. Laquer, Il nuovo terrorismo, Corbaccio, Milano 2002. 8. C. Baffoni: I grandi pensatori dell’islam, Edizioni Lavoro, Roma 1996. 9. A. Bausani, L’islam, Garzanti, Milano 2001. 10. G. Kepel, Jihad, ascesa e declino, Storia del fondamentalismo islamico, Carocci, Roma 2004. 11. A. Spataro, Fondamentalismo islamico. L’islam politico, Edizioni Associate, Roma 1996. 12. M. Introvigne, Osama bin Laden. Apocalisse sull’Occidente, Elledici, Leumann. Torino 2001. 13. M. Introvigne, Fondamentalismi, Piemme, Torino, 2004. 14. G. Hamilton, L’islamismo, Il Mulino, Bologna 1970. 15. R. Guolo, Il partito di Dio. L’islam radicale contro l’Occidente, Guerini e Associati, Milano 1994. 16. R. Guolo, Avanguardie della fede, l’islamismo tra ideologia e politica, Guerini e Associati, Milano 1999. 17. R. Guolo, Il fondamentalismo islamico, Laterza, Bari 2002. 18. R. Pezzimenti, Il pensiero politico islamico del ‘900. Tra riformismo, restaurazione e laicismo, Rubbettino, Catanzaro 2006. 19. L. Bonante, Terrorismo internazionale, Giunti, Firenze 2001. 20. American Academy of Arts and Sciences, Fundamentalism Project,. 5 volumi editi tra il 1991 e il 1995. 21. F. Burgat, Il fondamentalismo islamico, Edizioni Sei, Torino 1995. 22. E. Pace, Sociologia dell’islam, Carocci, Roma 2004 23. T. Ramadam, Il riformismo islamico, un secolo di rinnovamento mussulmano, Edizioni Città Aperta, Troina (En) 2004. 24. B.M. Scarcia, Il mondo mussulmano. Quindici secoli di storia, Carocci, Roma 1998. 25. M. Mahmood, Mussulmani buoni e cattivi; la guerra fredda e le origini del terrorismo, Laterza, Bari 2005. 26. A. Jarach, Terrorismo internazionale. Gruppi, collegamenti, lotta antiterroristica,. Vallecchi, Firenze 1979 27. Y. M. Choueri, Il fondamentalismo islamico: origini storiche e basi sociali, Il Mulino, Bologna 1993 28. F. Burgat, Il fondamentalismo islamico, Edizioni Sei, Torino 1995. 29. J. L. Esposito, Guerra santa? Il terrore nel nome dell’islam, Edizioni Vita e pensiero, Milano 2004. 30. R. Gunaratna, Inside al-Qaeda. Global network of terror, Columbia University Press, New York 2002. 31. O. Carrè, Mistique et politique. Lecture rèvolutionnaire du Coran par Sayyd Qutb, Frère Musulman radical. Edition du Cerf, Paris 1984. Capitolo Terzo L’occidente del mondo arabo Roberto Angiuoni 1. La mamlaka, ovvero il mondo dominato dall’islam, rimase – sino all’inizio dello scorso millennio – esclusivamente e saldamente legata all’Oriente. Anche se conquistato definitivamente nel secolo XI, il Maghreb è stato sempre considerato come una sorta di appendice della più vasta cultura islamica, o meglio uno spazio geografico composto da un comune fondo etnico di popolazioni di origine non araba24. I berberi – diffusi anche in Libia, in Mauritania e nel territorio del Sahara occidentale – anche se in effetti sono stati in grado di tenere testa a tutte le invasioni provenienti dal mare (dai fenici ai romani e ai vandali), si sono però arresi di fronte alla prima e unica invasione proveniente da terra: appunto quella araba. E anche se raramente sono riusciti a formare unità politiche durevoli (con l’islamizzazione hanno raggiunto la loro maggiore epoca di indipendenza con la formazione dei grandi stati degli Almoravidi e degli Almohadi), l’accentuato particolarismo dei gruppi locali ha sempre ostacolato tale processo di stabilizzazione, favorito anche, in epoca mussulmana, dalla spiccata tendenza soprannazionale dell’islamismo. Con una struttura sociale basata sulla famiglia patriarcale – ma con la presenza di un antico matriarcato nella regione del Rif – hanno sempre fatto ricorso ad una sorta di istituzione democratica per lo sviluppo sociale (la gemmaa, il consiglio dei capi famiglia) anche se ben presto trasformatasi in una oligarchia dominata da notabili e da anziani delle famiglie più autorevoli25. Sotto la dominazione romana conservarono cultura e costumi propri e la stessa conversione al cristianesimo, pur accettata, venne marcata con l’adesione all’egualitario scisma donatiano26, come forma di opposizione al potere imperiale di Roma e della sua religione ufficiale. Anche la successiva e rapida conversione all’islam espresse con chiarezza una diffusa insofferenza, 24 Nota nell’antichità con il nome di Barberia, l’attuale regione del Maghreb – denominata anche Africa Minore – comprende i monti dell’Atlante e le pianure costiere di Marocco, Algeria e Tunisia. Per il geografo mussulmano Ibrahim al-Istakhri (secolo X), si tratta semplicemente della “manica del vestito” e per Ibn al-Faqih addirittura della “coda dell’uccello mondo […] e la coda è davvero ciò che vi è di più sporco”. 25 Al ceppo berbero vanno accostati anche i tuareg del Sahara e i Senhaga della Mauritania. Pur essendo oscura la provenienza geografica dei berberi, alcuni studiosi hanno ipotizzato una matrice berbera anche per i Guanci, popolazione delle isole Canarie oggi estinta. 26 Con il termine donatismo si indica lo scisma della chiesa africana che prende il nome da Donato di Cartagine. La sua importanza storica risiede, tra l’altro, nell’avversione all’impero romano e nell’accoglienza del risentimento delle popolazioni oppresse. In particolare, i donatisti espressero la loro ferma convinzione che un vero cristiano non potesse addivenire ad accordi con le autorità civili. e la dottrina comunemente abbracciata fu quella kharagita27, percepita come la confessione islamica più intransigente e puritana e, per certi aspetti, più affine alla dottrina donatiana. In ogni caso, a sicura manifestazione di accentuata avversione nei confronti dell’autorità centrale del califfo, di Damasco prima e di Baghdad poi. Ancora più determinante sembra essere stata la scelta di abbandonare il kharagismo a favore dell’eterodossia sciita, ovvero di quel particolare credo che per tutta la storia dell’islam ha sempre agito come un vero e proprio contropotere. Anche quando venne ristabilita l’ortodossia sunnita (Almoravidi), le popolazioni del Maghreb aderirono, coerentemente con la loro tradizione, al rito malikita, ovvero a quello più rispettoso del territorio e dei suoi insediamenti, in altri termini alle autonomie locali, pur conservando nella sfera religiosa molti elementi del primitivo animismo mescolati alla dottrina islamica28. Nella storia di queste popolazioni, quindi, la commistione tra elemento religioso e potere politico sembra riconducibile ad eredità storiche già radicate prima della conquista araba, così come il dinamico intreccio tra potere centrale ed elemento locale, caratterizzato – anche in questo caso – da un particolarismo religioso vissuto in decisa opposizione all’autorità centrale. Tale commistione – per certi aspetti ancora tipica delle regioni del Maghreb – è rimasta una costante della storia dell’Africa del nord, palesando una notevole coerenza e continuità dalla fase preislamica sino al più recente seguito, ovvero la fondazione dei moderni Stati subito dopo il Secondo conflitto mondiale. Anche dopo la fine dei grandi imperi coloniali, l’identità di queste popolazioni oscilla tra la valorizzazione del legame nazionale e quello religioso, secondo un delicato processo ancora in cerca del proprio equilibrio. La storia dell’Africa del nord – così come la quasi totalità del mondo islamico – obbedisce ad una evoluzione contraddistinta da un periodo preislamico di prosperità, da una successiva fase medioevale di “beduinizzazione” e infine da una insorgenza della cultura sedentaria su quella nomade in epoca moderna. In particolare, la ristrettezza delle vallate e l’esiguità delle fasce pedemontane delle regioni maghrebine hanno fortemente condizionato – o meglio impedito – la formazione di larghe unità politiche, mentre le regioni pianeggianti e costiere sono state il nucleo dell’organizzazione territoriale. In prima analisi si riscontra quindi una sorta di opposizione duale tra la pianura e la montagna. La prima destinata all’agricoltura permanente e al ruolo di area urbana, quindi politicamente più forte – ma anche votata alle invasioni esterne – e la seconda dedita invece alla conservazione del quadro 27 I kharagiti (kharijiti) costituiscono una delle correnti più antiche dell’islam. I seguaci del quarto califfo Alì causarono una scissione – durante la battaglia di Siffin nel 657 – delusi dal fatto che il califfo si rimettesse alla sentenza arbitrale di Adrun anziché affidarsi al giudizio divino delle armi. Si qualificano orgogliosamente come “coloro che vanno in battaglia”, in contrapposizione ai qa’idun, “coloro che rimangono a casa”. Sostenitori di rigide norme etiche, dichiarano fuori dalla religione islamica chiunque incorra in un peccato grave e ritengono che il califfato dovrebbe essere affidato – attraverso il voto della comunità – all’uomo moralmente più integro, indipendentemente dalle sue origini. Attualmente i kharagiti contano circa un milione e mezzo di seguaci e vivono soprattutto nelle oasi dell’Africa settentrionale. 28 Con il termine di malikiti vengono identificati i seguaci della scuola fondata dall’imam Malik ben Anas (710795) che seguono pedissequamente la tradizione di Medina. Attualmente i malakiti raggiungono la ragguardevole cifra di 160 milioni e sono diffusi sia in Africa settentrionale (Algeria, Marocco, Tunisia, Sudan e Alto Egitto) che centrale. Per quanto riguarda gli elementi pre-islamici, il più diffuso è quello della bàraka (letteralmente “benedizione”), la forza soprannaturale e benefica che emana – secondo la tradizione popolare, spesso degenerante in superstizione – da persone ritenute sante o da oggetti e luoghi considerati sacri. Il contatto, anche indiretto con tali persone, oggetti o siti, farebbe fruire di un benefico influsso salutare. culturale ed economico autoctono, e quindi più isolata rispetto ad ogni innovazione proveniente dall’esterno. In particolare poi, le regioni del Maghreb sono caratterizzate da un terzo elemento distintivo: l’area del deserto e della steppa, lasciata al crescente dominio del bellicoso nomadismo, pastorale e guerriero. Ad eccezione dell’Egitto, si può quindi ricondurre la storia dell’Africa settentrionale a questa espressione di triplice contrasto strutturale, i cui effetti sembrano ancora oggi risultare decisivi per interpretare le dinamiche socio-politiche dell’intera regione. Con l’arrivo dei primi conquistatori mussulmani, il processo di arabizzazione del Maghreb resta limitato alle regioni orientali (dove trova sostegno nel quadro urbano), mentre il deserto e le aree più secche degli altopiani interni del Marocco e dell’Algeria conservano il primato della vita nomade. Le regioni maghrebine centrali ed occidentali restano quindi sostanzialmente berbere (pastori e coltivatori, nomadi e seminomadi) mentre il Marocco atlantico si conferma – insieme alla vallata dello Chelif – la roccaforte della vita rurale sedentaria. Nell’area del Maghreb l’organizzazione spaziale islamica rimane incentrata sull’esistenza di una dinastia, che si identifica con la presenza di una capitale, e le zone di effettivo controllo restano in genere limitate alla pianura circostante, o meglio al patrimonio agro-alimentare. Questo diventa il bled-el-wakhzen, il “paese del fisco”, ovvero il territorio effettivamente sottomesso, con le tribù locali che ne rappresentano il braccio secolare, lo strumento di difesa dell’autorità governativa. Oltre questo spazio, si estende il bled-es-siba, la “terra dell’insolenza”, cioè dell’anarchia e della dissidenza, il cui ambito include, quasi essenzialmente, il dominio montano. L’effettiva sovranità sul territorio è quindi parziale – è massima al centro e sfuma verso la periferia – e il governo centrale non riesce ad esercitare il monopolio assoluto della forza, costretto a coesistere con focolai di potere, lì dove è minima la sua possibilità di controllo (al contrario, il grado di autonomia delle autorità subordinate è direttamente proporzionale al loro grado di perifericità). Di conseguenza, il meccanismo del funzionamento statale non obbedisce – se non in misura molto limitata – al principio dell’identità tra formazione statale e unità territoriale, e lo stesso assetto dello stato si fonda sul mutuo riconoscimento tra due poteri distinti: quello centrale e quello locale. Nel complesso, l’Africa del nord è una delle poche regioni del mondo dove la colonizzazione europea ha avuto molto tempo a disposizione per introdurre le strutture necessarie allo sviluppo di un’economia moderna29. Ma la colonizzazione ha essenzialmente realizzato – attraverso la vendita delle terre demaniali, gli espropri e i sequestri – un colossale trasferimento fondiario di oltre tre milioni di ettari in Algeria, più di un milione in Marocco e settecentosettantamila in Tunisia (dai coltivatori locali ai nuovi contadini francesi). In totale, meno di quarantamila famiglie di immigrati si sono divise più di quattro milioni e mezzo di ettari, pari ad un quinto dell’intera superficie coltivabile del Maghreb, i terreni più fertili e meglio provvisti di acqua. In Algeria, l’estensione delle aziende di proprietà europea superava i centoventi ettari ed ammontava a più del decuplo di quelle locali, oltre ad occupare la quasi totalità del Sahel ad occidente della capitale, ovvero le terre sino ad allora destinate in buona parte al pascolo estivo 29 Il dominio francese è durato in Algeria più di centotrenta anni (dal 1881 al 1956) e in Marocco poco più di quaranta (dal 1912 al 1956). Il controllo italiano sulla Libia dal 1911 al 1942. Quello inglese sul Sudan – da solo o in condominio con l’Egitto per oltre ottanta anni (dal 1870 al 1955) e sullo stesso Egitto dal 1914 al 1922. delle greggi provenienti dal sud, causando – di conseguenza – la crisi delle pratiche di transumanza e – di riflesso – delle attività di allevamento degli ovini. Insieme alla pastorizia si registra anche la decadenza delle forme di nomadismo e ai pastori si impone la scelta di una migrazione interna verso le pianure, rafforzata dal bisogno crescente di manodopera delle nuove industrie estrattive e delle imprese impegnate nella costruzione delle infrastrutture, specialmente strade e opere idriche, e nell’edilizia urbana (un’altra migrazione, anche se di minore entità, si registra verso le montagne, tradizionale e storico rifugio dal potere centrale). Intorno agli anni Trenta si assiste alla notevole e brusca accelerazione del ritmo di crescita della popolazione (la cosiddetta “urbanizzazione patologica”), così come alla rovina dell’artigianato locale, incapace di contrastare la concorrenza dei prodotti industriali di importazione. Si intensifica quindi l’esodo delle campagne verso le città, ma queste ultime non sono ancora in grado di offrire posti di lavoro sufficienti e tantomeno servizi adeguati alla domanda (le prime bidonville sorgono ad Algeri nel 1936, e in tutta l’Algeria la popolazione urbana raddoppierà in meno di vent’anni). L’inurbamento maghrebino segna il culmine in corrispondenza degli ultimi anni della dipendenza e dei primi dell’indipendenza: nella prima fase la città rappresenta un rimedio all’insicurezza delle campagne (tormentate anche dai combattimenti) e nella seconda un’opportunità di alloggio e di lavoro dopo la partenza degli europei. Sono proprio questi gli anni dove giunge a compimento quel gigantesco, e spesso doloroso, rimescolamento delle culture e delle etnie, sino a questo momento separate, se non addirittura contrapposte. Il fenomeno mette fine alla logica del particolarismo e segna l’inizio di una diffusa presa di coscienza dell’identità, tra nazione, territorio e stato, ma più che altro nei termini del loro complesso carattere unitario. Questa difficile identità sembra ancora attendere nell’Africa mediterranea una sua concreta e compiuta realizzazione e si trova oggi rimessa in discussione, sopravanzata da ampi e comprensivi progetti di costruzione politica. 2. E’ il régime du sabre (il “governo della spada”) che dal 1834 apre una lunga stagione di violenze e stupri, di profanazione di moschee e di saccheggi indiscriminati delle ricchezze artistiche dei territori algerini. Sono i trentaquattromila uomini della monarchia francese di Luigi Filippo, la potente Armée d’Afrique guidata dal generale de Bourmont. Una presenza militare che è necessario incrementare appena l’afflusso dei coloni francesi (i pieds noir, attratti dal basso costo della manodopera locale per impiantare commerci e piccole industrie) supera le centomila unità, per il controllo di solo una piccola parte del più vasto territorio algerino. E diventano anche centomila gli uomini della Armée d’Afrique (un terzo dell’intero esercito francese) impegnati dal 1839 al 1847 a contrastare i guerriglieri di Abd el-Qader in una lunga e difficile campagna per la conquista dell’Algeria settentrionale. La Seconda Repubblica francese dichiara la “Colonia Algeria” parte integrante del territorio francese e con Napoleone III – spinto dalla personale ambizione di diventare Roi des Arabe – il controllo militare diventa più pressante. La sconfitta subita dalla Francia ad opera della Prussia nel 1871 favorisce una massiccia migrazione di alsaziani e lorenesi, facendo lievitare la presenza dei coloni e causando, di conseguenza, una recrudescenza delle attività guerrigliere anticoloniali. Anche questa volta la risposta di Parigi è affidata a rigide misure poliziesche: due milioni di coloni francesi devono essere assolutamente difesi da oltre quattro milioni di algerini mussulmani. L’applicazione di nuove norme nel Codice Penale – viene introdotto il reato di “insolenza” e i sospettati possono essere trattenuti in prigione per cinque anni prima di avere un regolare processo – contribuisce a mantenere le due comunità sempre più separate e contrapposte tra di loro. Ma oramai l’influenza francese si è estesa su tutto il Maghreb e la sua estromissione, militare e politica, diventa sempre più difficile. Durante la Seconda guerra mondiale è l’Algeria ad ospitare la sede del “Governo Provvisorio della Francia Libera” nel 1942 e due anni più tardi anche il “Comitato Francese di Liberazione Nazionale”, presieduto dal generale De Gaulle. Ma il vento delle aspirazioni di libertà e di indipendenza che soffia durante il conflitto raggiunge anche il nazionalista algerino Ferhat Abbas, favorendo l’ispirazione necessaria per il suo “Manifesto del Popolo Algerino”, una chiara denuncia dei privilegi riservati alla minoranza bianca a danno di una maggioranza araba, tenuta in umilianti condizioni di emarginazione. Anche se le prime e sanguinose sommosse nell’Algeria orientale scoppiano nel 1945, la data storica dell’inizio della vera e propria insurrezione contro la “madrepatria” francese è il 1° novembre del 1954. La guerriglia algerina è ormai ben organizzata, sia sotto il profilo militare che quello politico: al Front de Libération Nationale, il famoso Fln, spetta il compito politico-strategico della lotta, alla Armé de Libération Nationale (Aln), il suo braccio armato, compete la realizzazione degli attacchi contro gli obiettivi militari, ed al Mouvement Algérien Nationale (Mna) è affidato il compito di reclutare gli operai algerini residenti in Francia per sostenere attivamente la causa indipendentista. Arriva dal Cairo, in radiodiffusione, il primo appello del Fronte di Liberazione alla lotta nazionale per “il ripristino dell’Algeria sovrana, democratica e sociale, nel quadro dei princìpi dell’Islam”, ma quello che realmente costituisce l’effettiva forza del movimento di liberazione è la capillare attività svolta sul territorio. Anche se indiscussa, la profonda infiltrazione del movimento nelle associazioni professionali – in special modo nelle istituzioni studentesche e nelle organizzazioni femminili – rimane ancora oggi oggetto di studi e di varie interpretazioni il ricorso all’uso della “violenza programmata” nelle complesse fasi della lotta di liberazione. Anche se, sotto un profilo puramente storiografico, è stata accettata l’ipotesi di una “risposta proporzionata” alla dichiarazione di ostilità pronunciata dal ministro degli Interni Francois Mitterand: “l’unica trattativa possibile è la guerra”, rimane tuttavia di difficile comprensione le motivazioni che hanno spinto il Fln ad effettuare – dopo attacchi portati esclusivamente ad obiettivi militari e governativi francesi – la strage di civili perpetrata nella località di Philippeville nell’agosto del 1955. Il comandante della regione di Constantine decide infatti – ma non è dato sapere se in via autonoma o di concerto con i vertici della lotta armata – di alzare il tiro: centoventitre morti tra donne, bambini ed anziani. La reazione francese è oggettivamente sproporzionata: nella dura rappresaglia perdono la vita oltre milleduecento maquisard (guerriglieri), ma secondo il Fln i caduti per mano della polizia e dell’esercito superano i dodicimila. Gli avvenimenti che hanno preceduto l’inizio della “Guerra di Algeria” (1954-1962) sono comunque importanti per comprendere la sanguinosa spirale di violenza che ha caratterizzato gli anni della conquista dell’indipendenza. Le prime insurrezioni armate contro il governo coloniale francese scoppiano nelle regioni dell’Aurès e della Cabilia, subito dopo la deliberazione del primo ministro francese, Pierre MendèsFrance, in merito alla concessione di piena autonomia interna alla Tunisia (1954, e due anni più tardi l’indipendenza). Con il nuovo premier francese Edgard Fauré – alla guida di una coalizione di radicali di destra ed ex-gollisti – la situazione diventa ancora più difficile durante la prima discussione sulla “questione algerina” affrontata in sede Onu, dove l’atteggiamento di Parigi è categorico: “la Francia rifiuta qualsiasi interferenza delle Nazioni Unite”. Nel 1956, dopo l’ulteriore concessione della Francia all’indipendenza del Marocco, l’aereo che trasporta, proprio dal Marocco all’Algeria, alcuni importanti esponenti del Fln viene dirottato dai caccia francesi ed uno dei capi storici, Ahmed Ben Bella, viene arrestato insieme ad altri leader nazionalisti algerini. L’intenzione è quella di decapitare il pericoloso e sempre più agguerrito “Esercito di Liberazione del Maghreb” ed al tempo stesso accontentare la corrente della “destra coloniale”, già messa a dura prova dalle concessioni di indipendenza per la Tunisia ed il Marocco. A complicare la già difficile situazione interna della Francia arriva il fallimento dell’intervento franco-inglese in Egitto nel 1956 (per rappresaglia alla nazionalizzazione del Canale di Suez) e la contemporanea costituzione ad Algeri del “Comitato di Salute Pubblica”, composto da cittadini francesi aderenti alle frange più intransigenti dell’estrema destra (in grado di organizzarsi anche in associazioni clandestine per i loro ratonnades, che anche se letteralmente significa “acchiappa il ratto”, in effetti vuol dire “ammazza l’arabo”). Anche gli ufficiali francesi di istanza in Algeria, sotto la guida del generale dei paracadutisti Jacques Massu – un veterano della Seconda guerra mondiale che ha combattuto al fianco di De Gaulle – si schierano a favore di un’azione militare più marcata nei confronti dei ribelli, in aperto contrasto con il governo di Parigi che sta inutilmente tentando un faticoso compromesso con il Fronte di Liberazione Nazionale algerino. Solo pochi anni prima, però, Mendès-France aveva dichiarato all’Assemblea nazionale di Parigi che i reparti algerini fanno parte della Repubblica francese. Sono stati francesi a lungo e sono irrevocabilmente francesi […] fra loro e la Francia non ci può essere alcuna secessione immaginabile. La situazione diventa particolarmente critica quando si diffonde in Francia (maggio 1958) la notizia che alcuni reparti di paracadutisti francesi sono arrivati in Corsica con il preciso intento di sbarcare sul territorio continentale e “prendere in mano la situazione”. Il presidente Coty – forte dell’appoggio popolare e di un vasto consenso parlamentare – decide di richiamare in campo il generale Charles De Gaulle, nominandolo primo ministro (con procedura eccezionale) in data 1° giugno 1958. Sulla scrivania del generale ci sono due grossi problemi: la soluzione dell’Algeria e la riforma della costituzione. La nuova costituzione (ottobre 1958) suggella la nascita della V repubblica – con un regime di tipo presidenziale e un notevole rafforzamento dell’esecutivo a discapito del potere parlamentare – e definisce la libera “comunità francese”, di chiara ispirazione al già collaudato Commonwealth britannico. Il 21 dicembre del 1958 De Gaulle viene eletto presidente della Repubblica e della Comunità Francese, che occupano complessivamente una superficie di oltre dieci milioni di chilometri quadrati (all’incirca l’estensione dell’Europa a metà degli anni Cinquanta) con oltre ottanta milioni di abitanti. L’antico impero coloniale francese si trasforma quindi in uno stato federale, all’interno del quale le colonie e gli ex-possedimenti possono beneficiare – oltre che di una considerevole autonomia interna – anche dell’appoggio e della tutela francese per la soluzione di problemi di difesa militare, economici e di politica estera. Ma la nuova “Unione Francese” non lascia ancora spazio alla spinosa questione algerina: “i dipartimenti dell’Algeria e del Sahara sono parte integrante della madrepatria”, ovvero della Francia, così denominata in tutti i documenti ufficiali dell'epoca. Il Fln ha nel frattempo realizzato una struttura politico-militare in grado di contrastare le attività repressive di Parigi e di condizionare – negli anni a venire – la formazione e gli elementi costitutivi del futuro stato islamico di al-Jazz’ir. Approfittando del fatto che molti pieds noirs delle aree interne vendono le loro proprietà per cercare rifugio e protezione ad Algeri (dove vige lo stato di emergenza a tutela dei coloni) il Fln ottiene il controllo delle zone rurali che si estendono nelle regioni di Aurès, nella Cabilia, nelle montagne intorno a Costantine e nell’immediata periferia meridionale delle strategiche città di Algeri ed Orano. Ed è proprio in queste zone che la Armata Nazionale di Liberazione stabilisce un effettivo sistema amministrativo militare, in grado di raccogliere i fondi necessari alla lotta, di organizzare la logistica, di assicurare i rifornimenti alimentari ed ovviamente, di reclutare gli uomini per la causa indipendentista (anche in questo caso l’azione politico-militare del Fln/Anl è caratterizzata dall’uso della “violenza programmata” per il controllo capillare del territorio conquistato). Anche se il comando iniziale viene affidato esclusivamente ad ufficiali mussulmani provenienti dai quadri regolari dell’esercito, gli atti di violenza contro i connazionali – sospettati di collaborazionismo, se non quando di tradimento – sono particolarmente atroci. Così come per i soldati francesi catturati, anche per loro sono previste punizioni esemplari che vanno dalle mutilazioni alle “morti rituali”, praticate con efferata crudeltà. Anche il mancato supporto agli uomini delle forze rivoluzionarie (rifiuto di collaborazione o di copertura) viene punito con la morte. Soltanto durante i primi due anni di lotta è stato stimato che i guerriglieri abbiano ucciso oltre seimila mussulmani e circa mille uomini di diversa etnia, tutti algerini, e senza alcuna distinzione relativa all’età ed al sesso. Quindi un clima di terrore e di violenza, giustificato soltanto dalla missione islamica di convertire la popolazione mussulmana alla guerra contro l’invasore francese occidentale, prima ancora che si palesino le caratteristiche religiose della guerra santa. E sono sempre i vertici mussulmani della lotta di liberazione ad organizzare – con gradualità, ma anche con efficacia – una sommersa attività civile, che spazia dalla celebrazione dei matrimoni sino alla costituzione di un pur elementare apparato di giustizia civile e penale. Sotto il profilo politico, l’organizzazione è ancora più matura. Nel settembre del 1956 il Fln ha deciso di consolidare e rafforzare il progetto politico e militare con la creazione del “Consiglio Nazionale della Rivoluzione Algerina” (Cnra, Conseil National de la Révolution Algérienne) composto da 34 membri, e con il “Comitato di Coordinamento ed Esecuzione” (Cce, Comité de Coordination et d’Exécution) con cinque membri che rappresentano l’esecutivo, a cui viene affidato il compito di esercitare una debita pressione diplomatica non solo sul governo francese, ma anche sui membri “comunisti ed arabi” delle Nazioni Unite. Anche l’Armata di Liberazione, il braccio armato di questa complessa e sofisticata organizzazione politica, ha raggiunto livelli ragguardevoli: equipaggiati con armi francesi (ma vengono segnalate anche armi leggere americane e tedesche) i quarantamila uomini della Anl sono ormai una forza di combattimento ben organizzata e disciplinata. Sono state anche messe a punto precise tecniche di guerriglia, che prevedono imboscate e raid notturni – evitando sempre uno scontro diretto con le truppe francesi – contro accampamenti militari, commissariati di gendarmeria, uffici postali, aziende agricole e sistemi di trasporto e comunicazione. Le basi di acquartieramento e di addestramento sono in genere conventi e santuari abbandonati (o requisiti) lungo i confini con il Marocco e la Tunisia e contribuiscono ad accrescere il “reclutamento occasionale”, ovvero la partecipazione di guerriglieri part-time per singole operazioni militari, dove le stime in proposito ci indicano la presenza variabile di guerriglieri irregolari tra le diecimila e le venticinquemila unità. Ed è proprio questo il motivo per cui Parigi è costretta ad inviare in Algeria altri quattrocentomila uomini (tra di loro anche la famosa Legione Straniera) e ad arruolare circa centosettantamila algerini mussulmani – quasi tutti volontari – rimasti fedeli alla madrepatria. Vengono inviate anche truppe avio-trasportate (reparti dotati di maggiore mobilità per gli interventi nelle zone montagnose) e varie unità navali lungo la costa mediterranea per intercettare eventuali approvvigionamenti alle attività ribelli provenienti dall’estero. Interessante qui annotare l’attività svolta dalla “Sezione Speciale Amministrativa” (Sas, Section Administrative Spécialisée) creata nel 1955 per stabilire sul territorio un contatto diretto con la popolazione algerina lealista. Conosciuti come képis blues (berretti blu), gli ufficiali di questa sezione speciale riescono a reclutare circa centocinquantamila volontari (harkis) algerini mussulmani che riusciranno a diventare un importante strumento di contro-insurrezione (salvo essere poi dimenticati dalla Francia al momento dell’indipendenza dell’Algeria). Dall’inizio della battaglia di Algeri del 30 settembre del 1956, sino al temuto colpo di stato del 24 maggio 1958 (il generale De Gaulle viene eletto dal parlamento solo quindici ore prima dell’operazione “resurrezione”) gli avvenimenti sono sanguinosi e drammatici, dal bombardamento dei villaggi sospetti, all’uso della tortura ed alla reclusione di due milioni di algerini nei campi di concentramento. Nel gennaio del 1960 e nell’aprile del 1961, due pericolosi putsch vengono tentati contro De Gaulle (i militari si sentono traditi dalla nuova costituzione) e solo il carisma del generale e l’atteggiamento diviso dell’esercito evitano il peggio, mentre la potente ed agguerrita Oas (Organisation de l’Armée Secrète) continua a spargere morte e devastazioni con la sua attività “contro-terroristica”. Bisogna aspettare il 3 luglio del 1962 prima di vedere la bandiera bianca e verde con la mezzaluna rossa sventolare sulla vecchia fortezza della kasba di Algeri. Il governo algerino è stato a lungo controllato dalle Forze Armate, così some spesso succede nei paesi che hanno dovuto organizzarsi militarmente per il riscatto dell’indipendenza dal regime coloniale. In politica estera, i rapporti con la Francia migliorano subito dopo la crisi del 1976 – durante la quale l’Algeria si oppone alla divisione del Sahara ex spagnolo da parte del Marocco e della Mauritania – anche se rimangono molto tesi quelli con Rabat. Gli algerini approvano (1986) la nuova “Carta Nazionale”, adottata dal congresso straordinario del Fronte di Liberazione nazionale, per integrare la costituzione e liberalizzare il sistema economico. Le elezioni del 1987 – su liste uniche del Fln – portano all’assemblea popolare nazionale novantacinque deputati, in larga parte tecnici e professionisti con l’età media di quarantacinque anni. L’anno successivo scoppiano le proteste di piazza contro il caro vita ma vengono duramente represse dall’esercito (cinquecento morti) e la nuova costituzione del 1989 dichiara legali altri partiti oltre al Fln, e tra questi il Fronte delle Forze Socialiste (Fss) di Ait Ahamed, il Movimento per la Democrazia in Algeria (Mda) di Ben Bella e il Fronte di Salvezza Islamico (Fis), fondato nel marzo del 1989 dagli imam Abassi Madani e Alì Benhadj. Contemporaneamente, prendono vita altri quaranta partiti e tornano in patria numerosi esiliati, lasciando occasionalmente sperare in una nuova stagione democratica. L’iniziale impronta socialista e non-allineata, con le caratteristiche di un intransigente politica antiimperialista (Ben Bella, Boumedienne e Bandjedid sono tutti espressione dell’Armata Nazionale Popolare a cui si deve la nazionalizzazione delle industrie di base, la creazione di fattorie cooperative e lo sviluppo degli scambi con l’Europa dell’est) viene quindi sostanzialmente modificata nel 1989 in seguito alla nuova costituzione che decreta, tra le altre cose, appunto la fine del sistema socialista a partito unico. Questo nuovo ordinamento costituzionale – resosi necessario dopo le rivolte di piazza del 1988, conosciute con il nome di cous cous – delimita anche i nuovi poteri dell’esercito, confinandoli entro funzioni istituzionali democratiche, ovvero la difesa della sovranità nazionale e l’integrità territoriale del paese, differentemente da quello che recitava l'articolo 82 della precedente costituzione del 1976: “l’esercito nazionale, strumento della rivoluzione, partecipa allo sviluppo del paese ed alla costruzione del socialismo”. Sul malcontento della popolazione – il Fondo Monetario internazionale subordina ulteriori crediti ad un severo piano di rientro del debito che si traduce in ulteriori aumenti di prezzi dei generi alimentari essenziali – il Fronte Islamico di Salvezza ottiene la maggioranza assoluta nelle elezioni municipali del 1990 e viene accusato di provocare rivolte e scontri di piazza (i due fondatori del partito vengo arrestati nel 1991). Sempre nello stesso anno, il Fis vince il primo turno delle elezioni politiche anticipate – boicottate dal 42% della popolazione – e per bloccare la vittoria islamica (gennaio 1992) le forze armate intervengono dichiarando fuori legge il Fis e annullando il voto popolare (i dirigenti del partito vengono arrestati). Anche se probabilmente non ci troviamo di fronte ad una e vera propria dittatura militare, è innegabile che durante la sanguinosa lotta civile che ne è scaturita, il potere politico-decisionale è rimasto saldamente nelle mani delle forze armate, ma dovremmo dire della Anp (“Armata Nazionale Popolare”), il frutto della trasformazione dell’Armata di Liberazione subito dopo l’indipendenza. Ma l’intervento dell’esercito in una così delicata fase politica del paese trova tuttavia, secondo molti storici, una sua giustificazione. Già dal giugno del 1991 i drammatici e sanguinosi scontri tra la polizia e gli integralisti islamici (il Fis arriva a minacciare la guerra santa contro l’esercito algerino) costringono il primo ministro Ahmed Ghozali a proclamare lo stato di assedio, e quando nel primo turno delle elezioni del 26 dicembre il Fis ottiene il 47,50% dei voti, il potere viene assunto dallo “Alto Comitato di Stato” (15 gennaio 1992, presieduto da Mohamed Boudiaf, assassinato dopo appena cinque mesi) che dopo aver arrestato il leader del Fis, Abdelkader Ahchani, decreta lo stato di emergenza (9 febbraio 1992) e pone fuori legge il Fronte Islamico di Sicurezza. All’interno delle moschee viene vietata qualunque attività non religiosa, ma oramai la fiamma fondamentalista dilaga in tutto il territorio e prende il via una lunga serie di ripetuti attacchi contro l’esercito e le forze di sicurezza: la sanguinosa guerra civile, che farà registrare oltre 100.000 vittime, è appena scoppiata. Il “Gruppo Islamico Armato” (Gia) – espressione dell’integralismo islamico più intransigente – si rende responsabile di sanguinose esecuzioni contro intellettuali algerini, donne occidentalizzate, giornalisti e stranieri. Nel 1994 – dopo che le forze di sicurezza riescono ad uccidere il capo del Gia, Djaafar el-Afghani, ed il generale Liamine Zéroual viene nominato presidente della repubblica – iniziano le trattative per un progetto di pace con la prospettiva di nuove elezioni. Nel novembre dell’anno successivo, le elezioni presidenziali vedono confermato il presidente Zéroual con il 61% dei voti (svoltesi correttamente secondo gli osservatori delle Nazioni Unite) ma boicottate dal Fis per protesta contro i massicci attacchi portati dall’esercito contro le presunte basi dei fondamentalisti islamici nel mese di marzo. Le elezioni del 1997 vengono vinte dal Rnd, “Raggruppamento Nazionale Democratico” del generale Liamine Zéroual, seguito dal gruppo islamico moderato Hamas, organizzato nel Movimento della Società per la Pace (Msp). Il parlamento rende operativi numerosi provvedimenti “arabizzanti”, come un più ampio uso ufficiale della lingua araba, suscitando però le dure contestazioni dei cabili, la popolazione berbera delle regioni montuose dell’Atlantide. La guerra civile continua con una agghiacciante sequenza di massacri perpetrati dal Gia contro la popolazione civile di interi villaggi e con la macabra contabilità di quasi mille morti nella sola estate del 1997. Bisognerà aspettare il 1999, con le dimissioni di Zéroual per motivi di salute e la vittoria di Abdelaziz Bouteflika alla presidenza30, ottenuta con l'appoggio dei militari (73,8% dei voti, con il solito sospetto di brogli) per assistere alla rinuncia della lotta armata da parte dell’Esercito Islamico di Salvezza, il braccio armato del Fis, ancora fuori legge (l’annuncio del suo scioglimento verrà dato nel gennaio del 2000). Le assicurazioni del nuovo presidente sono importanti: amnistia per coloro che non si sono macchiati di omicidio e di stupro (approvata successivamente con un referendum popolare) ed un serio progetto di pacificazione nazionale. Ma il nuovo millennio si apre ancora nell’incertezza politica e sociale del paese. Le varie amnistie portano alla liberazione di numerosi militanti islamici e continuano le violenze dei Gruppi Islamici Armati e del Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento (Gspc), oltre alle rivolte dei cabili. Nel mese di gennaio il governo annuncia che circa l’80% dei combattenti islamici ha deposto le armi e si è arreso, ma nel mese di dicembre – durante il ramadam – numerosi assalti contro i villaggi nelle aree meridionali dell’Algeria provocano duecentocinquanta morti, dando il via a quel fenomeno che è stato definito il “terrorismo residuale” e che ancora oggi, per certi aspetti, insanguina il paese. Nelle elezioni parlamentari del 2002 lo storico Fnl supera il partito presidenziale Rnd e i gruppi a forte caratterizzazione islamica si confermano – con il Movimento della Riforma Nazionale – la seconda forza del paese (nel nuovo governo di Alì Benflis entrano cinque donne). Anche se con la nuova costituzione non sono ammessi i partiti politici la cui ideologia si richiami alla razza o alla religione (quindi i partiti islamici dovrebbero essere ritenuti fuori legge) l’islam è comunque considerato la religione di stato, con il divieto di pratiche religiose contrarie alla moralità mussulmana. Interessante qui annotare che ancora oggi viene comunque segnalata, presso alcuni reparti militari, la figura del “commissario politico” dove – non trovando più alcuna giustificazione nell’originale ruolo sovietico di controllo dell’ideologia politica – è più probabile che le funzioni di questo ufficiale siano riconducibili al dar el-ifta, l’istituzione religiosa creata dal governo di Algeri nel 2003 per fornire “indicazioni e prescrizioni” in materia di fede. Nel gennaio del 2006 viene diffusa la notizia (dall’agenzia Interfax) che l’Algeria acquisterà 30 Alle elezioni presidenziali dell’aprile del 1999 si presentano cinquanta candidati. Solo sette nomi arrivano sulle schede e sei si ritirano alla vigilia della consultazione per protesta contro i brogli. armamenti militari dalla Russia per un valore di 7,5 miliardi di dollari31. Dopo la visita di Vladimir Putin in Algeria (la prima di un presidente russo dopo cinquant’anni) nel marzo del 2006 viene firmato l’accordo che prevede anche un complesso schema finanziario per la cancellazione di parte del debito contratto dall’Algeria nei confronti dell’Unione Sovietica e riconducibile alla cifra indicativa di 4,74 miliardi di dollari. Al di là della sicura soddisfazione del governo di Mosca (i principali clienti, Cina ed India, stanno diversificando i loro fornitori) i dati relativi alla quantità ed al tipo di armamenti non sono mai stati ufficialmente confermati. Indicativamente, si parla di 36/40 Mig-29, di 20/28 Su-30, di almeno otto sistemi missilistici di difesa aerea (S-300MPU2 Favorit, ultimo aggiornamento del S-300, con gamma da 200 chilometri) e di circa 40 carri armati T-90, oltre ad altre forniture, sempre militari e mai specificate. L’entità e la tipologia dei nuovi armamenti lascia perplessi molti analisti. I Mig-29 in questione sono presumibilmente del modello Smt (alcune fonti ci indicano che potrebbero essere ben quarantanove) e sei esemplari del modello Ubt, simile al modello Smt, ma di derivazione dal Mig-29Ub, da addestramento e con doppio sedile. Il Mig-29Smt, identificato come “Prodotto 9.17”, è l’ultimo aggiornamento del famoso Mig-29, un sofisticato multiruolo da oltre Mach 2 che, nei primi anni del 2000, viene annoverato in servizio in ventuno Forze Aeree, oltre ad essere l’unico aereo russo adottato dalla Nato, dopo che la Luftwaffe tedesca ne ha incorporato gli esemplari in forza nell’ex Repubblica Democratica32. Molti osservatori (e tra questi la “Federazione degli Scienziati Americani”) riconoscono che l’attuale Mig-29 – Fulcrum nel Codice Nato – è potenzialmente migliore della “Aquila F-15” e del “Falco F-16”, ma sempre al di là delle capacità operative di volo acquisite dai singoli piloti. Il carro armato T-90 rappresenta l’ultima generazione del già collaudato carro russo T-72 da cui riprende l’intero schema di insieme (il T-72 è probabilmente il carro armato più prodotto al mondo) ed è considerato il mezzo di combattimento più competitivo rispetto ai carri in dotazione alla Nato, anche se oggettivamente sotto-potenziato rispetto a quelli occidentali di ultima generazione33. 31 Per comprendere meglio l’entità della cifra in questione è bene ricordare che la Russia – secondo esportatore di armi al mondo dopo gli Stati Uniti – vende ogni anno armi per un valore complessivo di 5 miliardi di dollari, e l’ultima importante commessa è stata acquisita nel 2000 dall’India per un valore di 3,3 miliardi di dollari. 32 Monoposto e con una apertura alare di 11,36 metri, alle iniziali due turbo-ventole Tumansky R-33D (ciascuna con una spinta da Kg. 8.300) il modello Smt ha preferito due R-43D in grado di aumentare la singola spinta a Kg. 9.800, sempre con post-bruciatore. Anche l’iniziale autonomia di volo è stata aumentata sino a Km. 2.100 con l’aggiunta di ulteriori serbatoi, così come è stato potenziato il carico di armamento (Kg. 4.500), nel modello base costituito da 6 piloni alari per l’alloggiamento dei missili Aa-10/11, oltre ad un cannone da 30 mm. Potenziato anche il raggio di azione del radar NO19Mp Zhuk, con ampia capacità di mappatura terrestre e controllo dei missili guidati aria-terra. Infine, anche arricchito il display del Cockpit con due visori a grandi dimensioni Mfd (multi-funzione), a colori e con cristalli liquidi. 33 Con un armamento sussidiario di lanciarazzi e mitragliatrici, il T-90 conserva il suo cannone da 125 mm e tre uomini di equipaggio. Caratteristiche importanti rimangono l’affidabilità e la robustezza, potendo resistere all’attacco contemporaneo di due razzi anticarro sparati da differenti posizioni. Interessante la scelta motoristica, che prevede un motore diesel semplice ed economico (diesel poli-combustibile da 12 cilindri ed 850 Hp) al posto della turbina, consentendogli di raggiungere una velocità massima di 70 chilometri orari – agevolata dal peso relativamente impegnativo di 46,5 tonnellate – ed un’autonomia di 550 chilometri. Basso e profilato come da tradizione sovietica Per quanto riguarda le altre possibili forniture è stato ipotizzato l’acquisto dei mezzi corazzati leggeri da ricognizione (“T2”, di produzione congiunta tra Russia e Bielorussia) equipaggiati con mitragliatrice automatica da 30 mm, lanciagranate e razzi anticarro ed antiaereo34. Non si tratta quindi di un normale aggiornamento della capacità operativa delle forze armate algerine – effettivamente non più rinnovate dalla fine degli anni Novanta – ma piuttosto di un armamento di dimensioni eccezionali, ancora più insolito se operato in un contesto pacificato come viene considerato quello dell’area mediterranea. Le agenzie di intelligence occidentali – che hanno tutte segnalato la notizia relativa agli armamenti algerini – non hanno elaborato alcuna teoria riguardo all’interpretazione ed all’analisi dei dati significativi in essa contenuti. Come prima considerazione, però, deve essere valutata la difficoltà principale interna del paese, ovvero quel “terrorismo residuale” del quale è stato già fatto cenno. Pur considerando sconfitto il Gia, il Gruppo Islamico Armato – o meglio la seconda generazione degli ex-combattenti algerini rientrati dall’Afghanistan verso la fine degli anni Ottanta – oramai ridotto a poche centinaia di guerriglieri nascosti in villaggi sperduti e con scarsa capacità operativa, non va invece sottovalutato il ruolo giocato dal “Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento”, conosciuto con la sigla Gspc. Questi uomini, figli del Fronte Islamico di Salvezza ed accesi avversari del Gia, hanno già favorito l’espansione del terrorismo islamico in una buona parte dell’Africa settentrionale. Anche se, come il Gia, non sembrano godere del pieno consenso della popolazione algerina, questi fondamentalisti possono disporre di una forza attiva stimata in oltre duemila uomini e di sofisticati armamenti e mezzi di comunicazione. Oggetto di particolare attenzione da parte delle agenzie di intelligence occidentali (sembra che il Gspc intenda opporsi alla pacificazione del Darfur e creare inoltre conflitti locali in Guinea, Senegal, Liberia, Sierra Leone e Costa d’Avorio, da dove in effetti cominciano ad arrivare i primi segnali di tensione) questo gruppo integralista è anche al centro delle attenzioni del Pan Sahel Iniziative (Psi), un preciso programma voluto dal governo di Washington – in accordo con l’Algeria, la Liberia, la Nigeria ed il Niger – per potenziare nell’intera regione le attività coordinate di natura militare, di polizia, di antiterrorismo e di intelligence. La collaborazione con i vari governi sembra dare un decisivo impulso favorevole, tanto da impegnare gli Stati Uniti con satelliti e sistemi di elint puntati sulla regione. Questa situazione sembrerebbe quindi essere sotto controllo, o meglio non in grado di giustificare i nuovi armamenti algerini, specialmente se si considera il loro mix, più adatto ad un impegnativo confronto terrestre che non per un’attività di contrasto anti-insurrezionale. (l’altezza è di soli 226 centimetri) è stato oggetto di un’importante commessa da parte dell'India nel 2000 – oltre 300 carri completi di accessori e parti di ricambio, buona parte dei quali prodotti in loco su licenza – anche questa volta dopo una visita di Vladimir Putin a Nuova Delhi. 34 Costruiti con tecnologia Stealth (ovvero quasi invisibili ai radar) risultano in grado di raggiungere la velocità di 100 chilometri orari e di rimanere sufficientemente silenziosi. Ma la vera potenzialità del mezzo consiste nella possibilità di montare un aereo da ricognizione non pilotato che permetterebbe di ampliare considerevolmente l’attività di intelligence tattica, ovvero la capacità di spingere in profondità le zone di osservazione e di controllo. Sembrerebbe quindi l’armamento ideale per fronteggiare le possibili insidie costituite dalle lunghe e desertiche frontiere dell’Algeria, che oltre tutto aveva già dimostrato un certo interesse per il T2 sin dal 2001, in occasione della sua presentazione ufficiale, insieme all’Egitto ed agli Emirati Arabi Uniti. Sotto un profilo strettamente strategico, i vicini scomodi dell'Algeria sono la Libia ed il Marocco, ed anche se con quest'ultimo una breve guerra di confine del 1976 ha messo in luce le difficoltà dell'Anp, non sembra che esistano oggi effettive minacce militari tra i due paesi. In ogni caso, il Marocco ha un esercito più numeroso, ma l'Algeria può contare su una superiorità in termini di artiglieria e mezzi corazzati e l'aeronautica marocchina schiera la tecnologia americana numericamente inferiore a quella sovietica dell'Algeria. La Libia può invece vantare, in termini numerici, una superiorità nell'aviazione e nella marina – rispetto all'Algeria ed al Marocco – ma rimane significativamente inferiore nella struttura globale dell'esercito. Quindi anche in questo caso sembra raggiunta una sorta di parità strategica. Nei nuovi armamenti algerini potrebbero essere inclusi, come accennato, i nuovi “T2” in grado di controllare le lunghe frontiere del paese. Già dal 1993 (circa 27.5 milioni di abitanti) la popolazione algerina è concentrata sulla fascia costiera – lunga circa 100 chilometri – con la densità media che scende rapidamente dal nord al sud, lasciando in pratica deserte ampie zone a ridosso del Sahara, teoricamente vulnerabili ad un attacco marocchino proveniente da ovest (che potrebbe avere grandi vantaggi nelle vie di comunicazione più rapide con il confine del paese, unica alternativa alla difesa naturale costituita dalle montagne dell'Atlante). Anche con la Libia i problemi di frontiera nel sud-est potrebbero difficilmente essere risolti: è una zona isolata dal resto del paese ed il collegamento è assicurato da un'unica strada che raggiunge la città di confine di Edjeleh, e che potrebbe diventare a sua volta una facile preda in considerazione della superiorità delle divisioni meccanizzate libiche. Nell'estremo sud non può oggettivamente essere ipotizzata alcuna seria minaccia: la distanza e la desertificazione dell'area – anche se un problema per l'Algeria – rappresentano un ostacolo insormontabile per il Mali ed il Niger. Inoltre, un accordo sulla frontiera con la Mauritania è stato già firmato nel 1985 dopo tre anni di trattative. Con la Tunisia non esistono reali motivi di pericolo. Anche qui un contrasto ventennale sui confini è stato definito nel 1983, e la ridotta consistenza delle forze armate tunisine non ha mai realmente impensierito lo stato maggiore di Algeri35. Gli armamenti algerini non sembrano riguardare il settore navale, ma in ogni caso il Mediterraneo rappresenta un elemento strategico anche per l’Algeria. Già dal 2001 l'Alleanza Atlantica ha in piedi un progetto denominato “DM” (“Dialogo Mediterraneo”) con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, la Mauritania, il Marocco e la Tunisia. Il comune denominatore è la sicurezza del mare e sotto questa bandiera si sono schierati anche Israele (2005) e Russia (2006) con programmi ed esercitazioni congiunte, oltre all’auspicio congiunto di una sorta di partenariato tra i paesi coinvolti, che metta in evidenza non solo l'importanza del recente accordo Nato-Russia, ma anche la valenza politica di “vedere allo stesso tavolo i ministri di Israele e di paesi arabi”. 35 Quando, nel 1985, la Libia ha tentato di provocare la Tunisia (violazione dello spazio aereo, minacce e movimenti di truppe) l'Algeria non ha esitato a schierarsi apertamente a favore della Tunisia lungo tutta la zona di frontiera. Il presidente Bouteflika palesa all’esterno le migliori intenzioni (la “Carta per la Pace e la Riconciliazione Nazionale”, il riavvicinamento agli Stati Uniti, l’attenzione per la nuova immagine internazionale del paese e la legge sugli idrocarburi, 22 maggio 2005, che apre le porte agli investimenti delle società straniere) ma il suo stato di salute lascia seriamente perplessi gli osservatori internazionali. L’ultima generazione di generali, che ha conservato una sorta di monopolio sulle maggiori attività economiche, non chiarisce le sue intenzioni, ovvero la condivisione della politica presidenziale o piuttosto il recondito desiderio di conquista del potere decisionale. I generali Larbi Belkheir (ex consigliere personale di Bouteflika), Khaled Nezzar (ex ministro della Difesa) e Mohamed Lamari (ex capo di Stato Maggiore dell’esercito) sono spesso oggetto di critiche, come quelle rivolte da Abdul Qadeer Shareef (cattedra di Scienza e Tecnologia all’università di Ajman): i militari si comportano come se fossero al di sopra della giurisdizione delle istituzioni civili […] come se non dovessero mai rispondere a nessuno del loro operato. Ma le critiche si rivolgono anche verso la Russia, accusata di esercitare una forte pressione in tal senso. E’ comunque fuori discussione l’intensa attività di marketing svolta negli ultimi anni dalla potente Rosoboronexport – la società dedicata alle esportazioni dell’industria bellica russa, a forte controllo statale – che sta esercitando un ruolo da protagonista proprio nelle aree del Medio Oriente e del Nord Africa. A fronte del calo delle vendite verso i principali clienti (Cina e India) la Russia sta spostando la sua attenzione proprio su queste aree considerate favorevoli, essendo già riuscita ad accaparrarsi importanti commesse anche dalla Siria, dalla Giordania, dalla Libia, dallo Yemen, dal Sudan e dagli Emirati Arabi Uniti. E’ un tipo di politica che viene considerata aggressiva, e la conferma arriva dalla Sofex (Special Operations Forces Exhibition) una mostra di grande interesse proprio per i mercati del Medio Oriente e dell’Africa del Nord, tenuta in Giordania dal 27 al 30 Marzo del 2006. Pur essendo dedicata ad armamenti ed equipaggiamenti innovativi per le operazioni delle forze speciali, la Rosoboronexport decide di presentare in questa occasione gli ultimi e sofisticati sistemi d’arma: sistemi di difesa aerea, sistemi di propulsione a razzo, sistemi d’arma navali, veicoli corazzati ed elicotteri. Quindi l’obiettivo potrebbe essere proprio quello di riconquistare – prima sotto il profilo militare e dopo quello politico – la vecchia leadership esercitata dall’ex Unione Sovietica, messa in crisi dall’offerta di tecnologia militare lanciata sui mercati proprio dalle nuove repubbliche, come l’Ucraina e la Polonia, in un certo qual modo entrate in una pericolosa orbita di “protezione occidentale”. Un’altra importante chiave di lettura potrebbe essere ricercata nel settore degli idrocarburi, che costituisce oltre il 50% delle entrate del governo di Algeri. Al quinto posto per le riserve di gas naturale ed al quindicesimo per quelle petrolifere, l’Algeria è al centro dell’attenzione sia da parte della Russia che degli Stati Uniti d’America. La strategia americana nell’area (abbiamo già accennato alla cooperazione nelle attività antiterroristiche) mira anche al controllo delle fonti energetiche del più ampio Golfo di Guinea, che potrebbe fornire il 25% dell’intero consumo petrolifero di Washington. Gli accordi stipulati con l’Algeria, la Nigeria, la Liberia ed il Niger puntano anche all’inserimento della tormentata repubblica dell’Angola, che aggiunta agli altri stati rappresenta un’area capace di fornire il 10% delle risorse petrolifere mondiali. La Russia, primo produttore al mondo di gas, ha scoperto da poco che le sue esportazioni in Europa possono essere “strangolate” dalle nuove repubbliche confinanti – la guerra del gas con l’Ucraina ha fatto registrare una fragile tregua solo agli inizi del 2006 – ed ha deciso di rivolgere le sue attenzioni verso nuovi progetti, che vanno dall’iniziale costruzione di gasdotti europei (attraverso il Mar Baltico per raggiungere direttamente la Germania e con il Blue Stream sino al terminale turco di Ceyhan) per finire nel nuovo asse energetico Algeria-Russia. Con due importanti aziende già presenti in Algeria – la Lukoil nei campi petroliferi e la Stroitransgas nella progettazione dei gasdotti – la Russia è adesso in grado di assicurarsi una posizione strategica sul mercato internazionale del gas. L’Algeria è in effetti un grosso deposito di materie prime, che per essere lavorate hanno però bisogno di tecnologia avanzata. E’ quindi necessario acquistarla dall’estero, e il prezzo da pagare, per gli analisti algerini, è la mancata emancipazione politica e sociale del paese. In realtà, il ministro degli Esteri algerino, Abdul Bedjaoui, subito dopo la famosa e storica visita di Vladimir Putin ad Algeri del marzo del 2006 ha dichiarato che la Russia ha contribuito sostanzialmente allo sviluppo delle forze armate algerine in termini di armamenti e di addestramento […] ed il settore delle risorse naturali fornisce un’arena reale per l’associazione tra i nostri paesi […] le aziende algerine e russe svilupperanno la loro cooperazione sul mercato del gas e potrebbero anche accedere insieme in altre regioni del mondo. L’Algeria è anche un importante punto di snodo del traffico di droga che dal Marocco – ma anche da altri paesi – raggiunge l’Europa. A questa attività illecita si intrecciano il traffico di armi e le attività collegate al terrorismo islamico. Secondo Abdelmalek Sayeh, direttore generale dell’Ufficio Nazionale per la lotta contro la droga e la tossicodipendenza (Onldt) le indagini dei servizi di sicurezza hanno stabilito in maniera inequivocabile i legami tra i narcotrafficanti, il contrabbando di armi, il riciclaggio di denaro, l’immigrazione clandestina e il terrorismo: in Algeria esiste una connessione tra queste reti e un’intensa attività di questi trafficanti si è registrata nei paesi del Sahel. Inoltre, l’Algeria corre seriamente il rischio di trasformarsi da paese di transito a paese consumatore di sostanze stupefacenti. Alla fine del 2008, alle tonnellate di droga sequestrate (oltre diciotto) si devono aggiungere ben 900.000 compresse di psicofarmaci e 22 chilogrammi di cocaina (la percentuale di merce di transito raggiunge appena il 40%). La regione occidentale del paese è quella maggiormente interessata dal traffico (48 percento) e al secondo posto le città di Algeri e Blida (il Marocco è considerato uno dei più grandi produttori di cannabis, coprendo il 60% della produzione nazionale). Ogni anno vengono condannate quasi ventiduemila persone, tra trafficanti e tossicodipendenti, e circa il 10% dei consumatori ha un’età compresa tra i dieci e i quindici anni e l’80% tra i sedici e i trentacinque. Con un budget di tre miliardi di dinari algerini (oltre 35 milioni di euro), viene lanciata una politica nazionale di lotta alla droga e alla tossicodipendenza che prevede – tra il 2008 e il 2009 – l’apertura di quindici centri di recupero, cinquantatre centri di intermediazione per le cure esterne e centottantacinque cellule di accoglienza e di orientamento (il più ampio programma di lavoro – Mednet, lanciato già nel 2006 – prevede la cooperazione di altri paesi: Libano, Marocco, Tunisia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo). Sin dal 2005 ha preso consistenza in Algeria – e con un aumento costante – il fenomeno degli harraga (letteralmente “chi brucia”, in senso più ampio “chi brucia le frontiere”), i giovani che lasciano il paese su piccole barche da pesca di 4/5 metri (boté) per raggiungere l’Europa36. 36 Nel 2008 i guardiacoste algerini hanno intercettato quasi cinquecento persone e ripescato una cinquantina di Con un costo stimato tra i 100/150.000 dinari a persona (1.000/1.500 euro), i giovani algerini fuggono il “male di vivere”, o meglio la totale mancanza di prospettive che caratterizza la loro generazione. Secondo Mohammed Kouidri, docente nella facoltà di Scienze Sociali di Orano, quello degli harraga sta diventando il modello di una buona parte della gioventù algerina: all’inizio si pensava che fosse la miseria a spingerli a partire, ma in realtà è soprattutto il sogno di un altro modo di vivere […] qui i giovani vivono con molti divieti e la destinazione europea viene sublimata dai canali televisivi occidentali. Pochi giorni prima delle lezioni presidenziali del 2009 la giornalista francese Florence Beaugé traccia sulle pagine del quotidiano «Le Monde» un quadro, per certi aspetti sconfortante, della società algerina, sfiduciata dalla politica, orientata verso tendenze conservatrici e con una grave crisi di identità. Secondo l’autrice, la spinta conservatrice in atto minaccia la libertà delle donne e contribuisce alla regressione della mentalità – approccio sociale – della gioventù algerina (nel 2000 il 27% degli algerini era favorevole all’uguaglianza dei sessi ed oggi la percentuale raggiunge appena il 16%, così come la metà della popolazione era pronta ad eleggere una donna alla presidenza contro appena un terzo nelle recenti consultazioni). Anche un altro rapporto, redatto ad Algeri dall’autorevole Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant et de la femme, conferma questa tendenza. Con la notevole eccezione della Cabilia, tutte le regioni dell’Algeria sembrano toccate da un’ondata retrograda: in materia di eredità, un algerino su tre è favorevole ad una spartizione su base paritaria tra fratelli e sorelle, mentre pochi anni prima era uno su due. Nel campo lavorativo, solo due algerini su dieci sono favorevoli al fatto che le donne lavorino e in materia di abbigliamento sette persone su dieci auspicano che tutte le donne, ragazze comprese, portino il velo islamico (hijab). Secondo l’avvocato Nadia Ait Zai, fondatrice del Centro, le donne algerine “pagano il prezzo di dieci anni di pressione islamista”. Esiste quindi un legame tra la regressione e la delusione causata dal fallimento del Fronte Islamico di Salvezza (Fis) nel suo tentativo di prendere il potere: la popolazione non spera più in una soluzione collettiva, si accontenta di credere ad una salvezza individuale, attraverso il ripiegamento verso un islam di tendenze salafite. In effetti, nel paese si registra la chiusura di molte enoteche e le attività commerciali hanno la tendenza a serrare i battenti all’ora della preghiera, capitale compresa. Aumenta anche il numero degli algerini di confessione cristiana perseguiti in giudizio per “proselitismo in ambiente mussulmano”, così come diventa sempre più diffuso l’uso del velo e la frequenza devota nelle moschee. Particolare fenomeno è anche quello dell’improvviso entusiasmo per il pellegrinaggio alla Mecca. La maggior parte di questi fedeli è però costituita da nuovi ricchi che lo praticano, secondo il sociologo Nacer Djabi, “per una religiosità di facciata, spesso ipocrita, dove l’apparenza prevale sulla sostanza”, ovvero verso un islam considerato come valore rifugio in un paese in crisi di identità. E proprio sulla grave crisi di identità che stanno attraversando gli individui di sesso maschile pone l’accento il rapporto presentato dal Centre de recherches en anthropologie sociale et culturelle di Orano. Superati dalle ragazze nella corsa ai diplomi ed al successo personale, e destabilizzati dalla disoccupazione, gli algerini si ritraggono nella loro ultima roccaforte: i costumi. corpi senza vita. La direttrice del Centro, Nouria Benghabrit-Remaoun, sostiene che le zawiya (le scuole e i conventi delle confraternite religiose) non sono mai state così frequentate nel corso dell’ultimo decennio e questo perché “il potere ha sistematicamente combattuto l’ascesa di figure o di correnti capaci di rappresentare la società civile” lasciando spazio a consuetudini e comportamenti ispirati fortemente all’islam. Said Benmerad, docente dell’università di Algeri e membro del Centre National d’études et d’analyses pour la population et le développement, aggiunge che “i giovani algerini sono in realtà strattonati da tutte le parti e sono alla ricerca di modelli islamici positivi”. In effetti, l’età media del paese è di ventisette anni (con oltre il 75% della popolazione sotto i 30 anni) quindi con una scarsa conoscenza – storica e politica – sia della lotta per l’indipendenza dalla Francia (1962) sia della guerra civile che ha diviso il paese per oltre un decennio (2000). Dopo il lungo dominio francese, durato oltre un secolo, i governi algerini che si sono succeduti hanno sempre cercato di forgiare un’identità nazionale scevra da qualsiasi influenza occidentale e il parallelo processo di “arabizzazione” forzata ha generato una forte diffidenza verso le imprese straniere e i loro investimenti nel paese (anche la lingua inglese, considerata appartenente ad una cultura estranea, è stata ignorata nelle scuole e nelle università, persino nelle discipline commerciali o legate alle attività di marketing). I sospetti verso il capitalismo occidentale e le sue diramazioni politiche divennero più intensi nel corso della guerra civile, quando sia i ribelli islamici che i governi eletti cercavano di accreditare le proprie credenziali nazionalistiche per ottenere il sostegno della popolazione. Il risultato, però, è stato quello di far crescere intere generazioni di algerini circondate dalla violenza e senza la possibilità di avere le conoscenze politiche ed economiche necessarie per sfuggire a questa situazione di disagio. Secondo Nabila Ramdani, giornalista premiata con l’European Muslim Woman of Influence Award del 2010, le amministrazioni algerine non sono riuscite a creare una solida infrastruttura sociale entro cui far fiorire un sistema democratico e la conseguenza è che in Algeria, pur essendo uno dei paesi più giovani al mondo, i giovani non sono qualificati per competere nel mondo moderno […] le giovani generazioni sono state educate per essere buoni algerini e buoni arabi, non per contemplare l’idea di raggiungere il successo all’interno dell’economia globale […] quando il nostro isolato sistema economico comincerà a collassare non avremo alcuna possibilità di fuga e questo fomenterà frustrazione e rabbia. Mentre il presidente Abdelaziz Bouteflika apre un tavolo di consultazioni (gennaio 2011) sui prezzi degli alimenti di base (farina, olio da cucina e zucchero, raddoppiati nel corso di un solo mese) la situazione nel paese diventa particolarmente tesa37. Il presidente algerino – secondo molti osservatori locali e internazionali – si concentra in maniera eccessiva sul taglio delle tasse e dei dazi doganali sulle importazioni, ovvero nella ricerca di una soluzione a breve termine per fronteggiare la crisi e le rivolte di piazza. In realtà i problemi del paese hanno radici più profonde: la mancanza di lavoro, di servizi pubblici e di case a prezzi accessibili, insieme ad un sistema di istruzione scadente e la forte impennata dell’inflazione. Sebbene in Algeria vi sia abbondanza di gas naturale e di petrolio (durante i dodici anni di governo 37 Azzedine Lebza di diciotto anni, la prima vittima dei disordini di piazza, muore colpito da un proiettile della polizia ad Ain Lahdjel (a circa 250 miglia a sud-est di Algeri) e un altro manifestante, Akriche Abdel-Fattah di trentadue anni, perde la vita a Bou Smail (a circa trenta miglia dalla capitale). Solo nel corso del mese di gennaio del 2011 aumenta considerevolmente il numero delle vittime e il numero degli arrestati supera il migliaio. di Bouteflika il paese ha incassato più di seicento miliardi di dollari) ampie fasce della popolazione vivono in assoluta povertà nelle gigantesche baraccopoli alla periferia delle grandi città. La giornalista algerina Ghania Mouffok, esperta in questioni arabe, pubblica sul quotidiano «ElWatan» un articolo dove denuncia che già nel corso del 2010 – ovvero l’anno precedente la cosiddetta primavera araba – i servizi della polizia nazionale hanno registrato nel paese ben 11.500 sommosse, manifestazioni pubbliche e raduni di piazza, rispondendo alle istanze con “colpi di manganello, granate lacrimogene e cariche di blindati” (questa attività repressiva viene chiamata dai giovani algerini con il nome di azraine, il diavolo). La giornalista continua sostenendo che coloro che ci governano e che gestiscono 150 miliardi di dollari di riserve in valuta estera abitano in un altro paese. Militari e civili, membri delle oligarchie che saccheggiano il paese, vivono in prigioni dorate, le loro spiagge sono private, i loro ristoranti sono club esclusivi, il loro quartieri sono chiusi da barriere di ferro e cemento. Tutto il paese è frammentato dai posti di blocco, posti di blocco della polizia nelle città e posti di blocco militari e della gendarmeria nelle campagne […] non si sa più chi assedia chi. (in effetti, nei quartieri delle città considerati più a rischio ci sono almeno tre commissariati di polizia, numerosissime telecamere di sorveglianza e una fitta rete di poliziotti in abiti civili chiamati hnoucha, serpenti). Dopo le rivolte in Tunisia, Egitto e Libia nel marzo del 2011, l’Algeria ed il Marocco38 vengono in effetti toccati solo marginalmente dalle proteste di piazza. Secondo il giornalista James Badcock, direttore dell’edizione in lingua inglese del quotidiano «El Pais» di Madrid e articolista su questioni nordafricane per il «Daily Star», le redini del paese sono tenute da un esercito forte e da un apparato di forze di sicurezza che, allenate all’esperienza della violenza di strada (in special modo nella regione della Cabilia) riescono a contenere le rivolte e di conseguenza evitano di far lievitare il numero di vittime tra i manifestanti. Al contrario dell’Egitto e della Tunisia, l’esercito algerino non gode della stessa stima tra la popolazione e la sua immagine è stata offuscata dalle atrocità della guerra civile, contribuendo a percepire i vertici militari come detentori delle segrete chiavi dell’influenza politica e delle sue indebite ricchezze. Inoltre, i piccoli passi verso la riconciliazione compiuti dal presidente Bouteflika (parziale rilassamento della legislazione di emergenza, nuovo schema di assistenza per i mutui e la promessa di costruire nuovi alloggi a prezzi accessibili) sembrano in grado di contenere le sponde più intransigenti dei rivoltosi, anche se non mancano le critiche per non essersi rivolto alla nazione – che segue con apprensione le rivolte tunisine ed egiziane – con un discorso rassicurante. A meno di un anno dalla rielezione di Bouteflika per la terza volta (14 aprile 2009) le intenzioni governative sembrano quelle di consolidare il regime e di utilizzare – solo in misura ridotta – le entrate dovute all’eccezionale aumento dei prezzi di petrolio e gas per soddisfare le pressanti richieste sociali e stimolare gli investimenti nelle infrastrutture39, anche se le poche riforme economiche non si sono ancora tradotte in prosperità sociale. 38 I raduni dei manifestanti nelle città marocchine per sollecitare le attese riforme non hanno oggettivamente dato l’impressione di un ampio momento di rivolta. Re Mohammad VI, in qualità di “guardiano ereditario” del progresso democratico del paese, sembra ancora poter contare su un solido sostegno popolare. 39 Secondo le cifre ufficiali, tra il 2004 e il 2009 il governo ha speso 120 miliardi di dollari per alloggi, ferrovie e autostrade, oltre che per alzare gli stipendi di base per gli impiegati pubblici e per il periodo 2009-2015 ha in programma di spendere altri 150 miliardi di dollari. Il regime rimane l’attore principale con i suoi tre partiti – il Fronte di Liberazione Nazionale, il Raggruppamento Nazionale Democratico e il Movimento della Società per la Pace, moderatamente islamico – e l’Algeria non si presenta quindi in maniera dissimile dalla maggior parte dei paesi arabi, che hanno realizzato riforme politiche spesso incomplete (sotto pressioni sia interne che internazionali) e che hanno cambiato solo superficialmente i sistemi politici, senza alterarne affatto l’essenza40. In modo particolare pesa il silenzio del presidente circa le numerose accuse di corruzione dilagante nelle istituzioni pubbliche (tra queste la compagnia petrolifera statale Sonatrach, cuore pulsante dell’economia algerina) e negli stessi membri del governo (Chakib Khali, ministro dell’Energia e molto vicino al presidente, e Amar Ghoul, ministro dei Lavori Pubblici, entrambi accusati di aver accettato tangenti), permettendo in questo modo all’esercito – l’altro principale detentore del potere – di guadagnare terreno politico e consensi41. Le uniche voci che promettono riforme sostanziali arrivano dall’ex primo ministro Mouloud Hamrouche (da giovane ha combattuto nella rivoluzione e ha partecipato alle elezioni del 2009), ma la sua piattaforma riformista – liberalizzazione politica ed economica – deve ancora ricevere un consenso esplicito da parte dell’esercito (ironicamente definito dalla stampa algerina come il decision-maker). Ma anche da Benbitour Ahmad, un teocrate esperto in questioni economiche (è stato primo ministro di Bouteflika dal 1999 al 2000) che promette radicali cambiamenti interni, così come dall’attuale primo ministro Ahmed Ouyahia (ha guidato il governo per tre volte ed è il nome più frequente come candidato alla presidenza) che può contare sulla benedizione dell’esercito ma non certo sulla benevolenza della popolazione, a causa di un certo numero di politiche sociali impopolari, la dissoluzione di istituzioni economiche statali, il licenziamento di molti impiegati pubblici e l’arresto di alcuni funzionari accusati di corruzione, ma subito rilasciati. Esattamente dieci anni prima delle rivolte (il 13 gennaio del 2000) entrava in vigore la legge sulla Concordia Civile, ovvero la “grazia per amnistia” concessa a oltre seimila combattenti dell’Esercito Islamico di Salvezza, il braccio armato del Fronte, che avevano impugnato le armi contro il governo centrale e sotto il comando di Madani Mezrag agli inizi degli anni Novanta. La politica del perdono – con l’adesione della popolazione, sollecitata ad esprimersi attraverso un referendum – ha permesso ai criminali (il termine veniva usato nel lessico ufficiale) di trasformarsi in pecore smarrite (nuova designazione ufficiale) e di lasciare i gruppi armati salafiti per ritrovare la retta via all’interno della società algerina. Cinque anni più tardi (settembre 2005), il suffragio universale viene ancora richiesto per trasformare la legge sulla Concordia civile in una Carta per la Riconciliazione nazionale e da quel momento gli eventi che hanno scosso il paese negli anni Novanta vengono qualificati come tragedia nazionale, con l’apertura di risarcimenti sia per le vittime dirette (insorti e militari) che per quelle collaterali (civili e scomparsi). Vengono rimessi in libertà più di duemiladuecento islamici, giudicati e condannati per atti di 40 Mahmoud Belhimer, giornalista e scrittore algerino, nel suo articolo apparso su «Arab Reform Bullettin» il 2 aprile 2011. 41 Sembra che la corruzione sia anche la causa della morte del direttore della Sicurezza nazionale, Alì Tounsi, ucciso nel suo ufficio il 25 febbraio 2011 da un dipendente sotto inchiesta per aver accettato tangenti. terrorismo, e oltre trecento combattenti del Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento (Gspc) depongono volontariamente le armi. Anche se il netto miglioramento della situazione generale (in termini di sicurezza) è ascrivibile alla Riconciliazione nazionale – la scoperta dei covi e la forte limitazione dei gruppi armati – essa viene però indicata da molti analisti come la causa principale della radicalizzazione del movimento islamico. In ogni caso, l’insurrezione islamica nel Maghreb – ovvero l’insieme delle operazioni dei gruppi che si richiamano all’islamismo radicale – scoppia nel 2001 e si estende rapidamente non solo nel Maghreb ma anche nel Sahel e in tutta l’Africa occidentale. Due anni più tardi gli Stati Uniti, insieme all’Algeria (l’alleato regionale) lanciano il cosiddetto “secondo fronte”, ovvero la caccia nel Sahel e nel Sahara meridionale agli islamisti provenienti dall’Afghanistan che qui hanno trovato rifugio e protezione. La nuova guerra al terrore provoca enormi danni alle popolazioni della regione ed alimenta sentimenti di rabbia e frustrazione verso l’occidente, contribuendo alla instabilità politica dell’intera area (golpe del 2005 in Mauritania, ribellioni Tuareg in Mali e Niger, rivolte nell’Algeria meridionale e crisi politica del Ciad). Secondo molti analisti, questa offensiva è anche la causa della distruzione dei mezzi di sostentamento delle popolazioni (in particolare l’industria turistica) ed ha provocato la crescita di comportamenti repressivi da parte dei governi, spingendo le nuove generazioni verso il contrabbando o l’emigrazione forzata. Sempre nel 2003, il Gruppo Salafita prende in ostaggio trantadue turisti nel Sahara algerino, tenendoli prigionieri in due gruppi separati, a distanza di circa trecento chilometri l’uno dall’altro. L’esercito algerino riesce a liberare uno dei due gruppi e l’altro, che trova rifugio nel Mali, viene rilasciato dopo il pagamento di cinque milioni di euro. L’anno successivo, le forze algerine e maliane dichiarano di essere riuscite a stanare il Gruppo Salafita dal Mali e di averlo inseguito sino al massiccio del Tibesti, in Ciad, e di aver ucciso quarantatre terroristi dopo una battaglia durata tre giorni. Sembra che sia però riuscito a fuggire il loro capo, Saifi Amari, chiamato aberrazak, il parà, per via del suo passato da paracadutista nelle forze regolari algerine. Sposato con tre donne del Mali, Amari sarebbe sì riuscito a far perdere le sue tracce, ma sarebbe anche finito nelle mani dei ribelli del Ciad e riconsegnato alle autorità algerine – dove era stato già condannato all’ergastolo in contumacia – dopo una mediazione sostenuta dalla Libia42. Il Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento conduce un nuovo attacco ai danni della base militare di Lemgheith (2005), in territorio mauritano al confine con l’Algeria e il Mali, provocando la morte di quindici soldati. Per tutta l’Africa occidentale il 2005 è comunque l’anno più critico. il Gruppo Salafita di Abdelmalek Droukdel decide di stringere un’alleanza con l’organizzazione di Osama bin-Laden e si ribattezza “al-Qaeda nel Maghreb islamico” (Aqmi), affiancando al nuovo nome anche una nuova strategia. Abdelmalek Droukdel (alias Abu Husab, alias Abdel al-Wadoud) sostiene di aver ricevuto la piena approvazione da parte di bin-Laden e riesce a raccogliere nel nuovo gruppo una quarantina di sigle 42 L’apporto statunitense in questa operazione militare, inizialmente smentito, è stato successivamente ammesso dal Dipartimento di Stato e quantificato in un centinaio di soldati, un velivolo di supporto e un cario di equipaggiamenti, forniti all’esercito del Ciad. minori, raggiungendo la considerevole cifra di millecinquecento uomini alle sue dipendenze. Cura personalmente l’addestramento degli estremisti, mantiene i rapporti con gli islamici radicali della Tunisia e del Marocco, invia dozzine di volontari in Iraq e stabilisce una forte presenza in Mauritania, Niger e Mali, oltre alla stretta collaborazione con l’Egitto e la Libia. Il nuovo polo di aggregazione può anche contare sulla presenza di un pericoloso raggruppamento fondamentalista di matrice salafita, il Combat and Call Brigade (che ha mutato il nome in “Organizzazione di al-Qaeda per i paesi del Maghreb arabo”) con un pesante passato di terrorismo alle spalle, e sul Gruppo Islamico Combattente Marocchino (Gicm), associato a numerosi attacchi terroristici (Casablanca nel 2003, Madrid nel 2004, con centonovantuno vittime e circa duemila feriti, e ancora Casablanca nel 2007). Negli anni 2006 e 2007, i rapporti delle agenzie di intelligence occidentali riportano che il 33% degli estremisti islamici giunti in Iraq provengono dall’Africa settentrionale (principalmente dal Maghreb e dall’Egitto) e che le presenze degli islamici radicali nell’area, ma anche nel continente, si stanno moltiplicando: nel deserto del Sahara i miliziani di al-Qaeda stanno preparando un’importante base logistica, nel Senegal uno sceicco radicale sostiene di poter contare su novemila guerriglieri armati e minaccia attentati contro gli interessi occidentali, in Sierra Leone il traffico di diamanti è controllato dagli islamici radicali vicini ad al-Qaeda, in Mali gruppi vicini ad Osama binLaden controllano alcune banche, in Costa d’Avorio scoppiano violenti scontri tra mussulmani e cristiani, in Nigeria, oltre a scontri analoghi, ben dodici stati della federazione hanno deciso di adottare la shiaria, in Sudan gruppi islamici vicini al governo minacciano di attaccare le truppe delle Nazioni Unite se dovessero schierarsi in Darfur, in Somalia sono numerosi i campi di addestramento per i guerriglieri che minacciano la guerra contro l’Etiopia e in Sud Africa viene sgominata una cellula terroristica che progettava attentati su larga scala. Al-Qaeda si trasferisce in Africa. L’arco dell’islam radicale (la definizione è del giudice francese Jean-Louis Bruguière) è sotto la guida degli estremisti algerini ed al loro fianco si schierano i combattenti del Marocco, della Tunisia, dell’Egitto e della Libia, oltre ai numerosi guerriglieri che provengono all’Africa subsahariana. L’area del Sahel – la poverissima striscia desertica all’estremo sud dell’Algeria, del Senegal, della Mauritania, del Mali, del Burkina Faso, del Niger, della Nigeria, del Ciad e del Sudan – diventa paradossalmente la prima fonte di finanziamento degli estremisti radicali: contrabbando di sigarette, automobili rubate e traffico di alcolici, naturalmente con la forte disapprovazione delle frange idealistiche islamiche. Le fonti di intelligence occidentali riferiscono che, dopo una breve fase iniziale, questi gruppi non partecipano più in prima persona alle attività di contrabbando, ma si limitano a regolare un regime di tassazione sui traffici. In particolare, un forte tributo di passaggio viene chiesto ai trafficanti di droga del Sud America, che utilizzano questa via preferenziale per raggiungere l’Europa, via Marocco e Libia. A capo dell’organizzazione, Abdelmalek Droukdel, a sua volta responsabile di due compagnie (katiba) che conducono vita nomade per sviare i sospetti. I capi delle due compagnie sono Abdelhamid Abu Zeid e Amokhtar Belmokhtar (soprannominato Monsieur Marlboro) e possono contare su una rete di alleati e giovani fiancheggiatori per arrivare indisturbati (non in prima persona) ai luoghi frequentati dagli occidentali e preparare i rapimenti a fini di lucro. Subito dopo il viaggio di Abdelmalek Droukdel nel Maghreb (primavera del 2007), dove si riuniscono in uno sperduto villaggio del Marocco i rappresentanti di tutti i gruppi fondamentalisti, un video43 del nuovo ed indiscusso capo apre una stagione di attentati e violenze: 43 Il video viene trasmesso da «al-Sahab», la società di produzione mediatica dei talebani con sede a Quetta, in i mujaheddin verranno impiegati in operazioni di martirio per combattere gli stati apostati, gli ebrei e i crociati […] le caserme delle forze di sicurezza, gli uffici governativi, i funzionari pubblici e i luoghi dove sono presenti gli stranieri, siano essi diplomatici, uomini di affari o turisti. In Marocco (11 marzo 2007) Abdelfattah Randi si fa esplodere in un internet caffè di Casablanca e la polizia arresta (dopo solo dodici giorni) una decina di attentatori, scoprendo che si tratta di giovani benestanti. Durante le indagini si scopre un complotto ai danni dell’industria del turismo (la terza fonte di guadagno del paese, pari al 10% del Pil) con attentati ad Agadir e Marrakesh, oltre a navi da crociera, europee ed americane, alla fonda nel porto di Casablanca. Nell’area denominata Kidal (nel territorio del Mali, ma al confine con Niger e Algeria) dove è molto attivo un traffico di armi, di contrabbando di sigarette e di merci di ogni tipo – schiavi compresi – vengono arruolati dalle autorità algerine e maliane tremila tuareg per combattere la presenza terroristica nella regione. Si tratta di tuareg raggruppati nella Alleanza Democratica per il Cambiamento e sotto il comando di Ahmed Agbibè, equipaggiati ed armati dai due paesi sponsor e grazie alla mediazione dell’ambasciatore algerino del Mali. Sempre nel 2007, un nuovo video – a nome del gruppo radicale “I Seguaci del Profeta nel Sahara, la Terra di Coloro che portano il Velo” e girato nella regione di Adrar, in Mauritania – lancia minacce non solo contro i governi di Algeria e Marocco, ma anche contro la Spagna e la Francia. L’obiettivo dichiarato è la riconquista dell’Andalusia (Siviglia, Granada, Cordova). Anche dal Madagascar (febbraio 2007) arrivano segnali inquietanti: trenta uomini armati assaltano la villa di Jamal Khalifa e dopo aver rubato denaro, pietre preziose e diversi computer, lo uccidono senza un motivo apparente. Per le agenzie di intelligence degli Stati Uniti, (Robert Mueller, direttore della Fbi) Khalifa è il cassiere della jihad islamica. Ha incontrato Osama bin-Laden nel 1997 all’università di Jeddah (il primo studia biologia e il secondo economia) e dopo gli studi sposa la sorella dell’amico, Sheikha. Le due famiglie, entrambe saudite, possono contare su ingenti disponibilità economiche e dopo aver seguito le lezioni di Abdullah Azzam – il leader religioso palestinese – Jamal e Osama decidono di partire insieme per l’Afghanistan. Sotto inchiesta in Giordania, Jamal Khalifa finanzia gli islamisti radicali nelle Filippine e stringe amicizia con il leader egiziano Abu Hafs. Arrestato in California nel 1995, viene misteriosamente espulso in Giordania e, probabilmente, questo paese lo consegna all’Arabia Saudita che lo rimette in libertà. Associato a Ramzi Youssef e Khaled Mohammed (gli attentatori dell’11 settembre 2001) e al piano Bojinka (che prevedeva la distruzione contemporanea di dodici aeroplani americani) viene arrestato dai sauditi subito dopo l’attentato alle Torri gemelle. Liberato anche questa volta, torna ai suoi lucrosi affari (una miniera di diamanti e numerosi ristoranti a Jeddah) prima di essere ucciso in circostanze misteriose nella sua villa in Madagascar. Ma perché in Africa? La risposta viene dallo sceicco Abu Azam al-Ansari, l’ideologo dell’islamismo radicale internazionale, che trasmette nel 2007 un nuovo e lungo video: la grande debolezza e la corruzione dei suoi governi facilitano il movimento e l’organizzazione delle azioni dei nostri militanti, senza timore di essere scoperti […] quel continente presenta occasioni Pakistan. Oltre all’emittente, la società dispone di una rete clandestina di webmaster in grado di eludere la sorveglianza degli Stati Uniti. Il responsabile è Adam Gadhan (nato in California e soprannominato Azzam l’americano) ma di lui non si hanno più notizie dal 2007. operative migliori rispetto ai paesi con intelligence più solide […] le frontiere africane sono più permeabili ed esiste un’enorme quantità di armi e materiale bellico più facile da ottenere e ad un prezzo più economico che in qualsiasi altro luogo del pianeta […] le decine di conflitti armati che sconvolgono l’Africa producono molti individui pronti a sacrificarsi per la santa causa […] l’Africa è una miniera d’oro per la jihad e la vicinanza del Maghreb all’Europa ci permetterà di spostarci rapidamente per attaccare gli infedeli. In Algeria, i primi attentati – realizzati dopo la storica fusione dei gruppi integralisti – sono ad opera di kamikaze che prendono di mira il palazzo del governo e la direzione della polizia giudiziaria, confermando che la guerriglia islamica (quindici anni dopo la sua apparizione) ha deciso di adottare lo stesso modus operandi di al-Qaeda, già collaudato in Iraq e Afghanistan. Nel 2007 viene compiuto un attentato all’emiro Mustapha Kartali (una bomba nella sua auto gli tronca la gamba destra), l’uomo che era stato il leader del Gruppo Islamico Armato e che aveva aderito all’amnistia di Bouteflika (prima di entrare nel Gia aveva militato nelle file del Fronte Islamico di Salvezza). La responsabilità dell’attentato viene attribuita a Abu Musab Abdelouadoud, il nuovo capo di alQaeda nel Maghreb Islamico che si vanta di scegliere gli obiettivi da colpire senza consultarsi con Osama bin-Laden (in effetti, sembra che al-Qaeda non eserciti alcun controllo sulle brigate combattenti algerine). Proprio in Algeria si assiste però alla prima scissione tra il gruppo principale e l’ex capo della cellula sahariana, Abdelkader ben-Messoud (alias Musab Abu Daoud) che crea una nuova frangia ispirata ad Antar Zouabri, indiscusso capo del Gia ed autore di sanguinosi attentati tra il 1996 ed il 2002. Anche nella cosiddetta Area 5 (la regione algerina del Sahara) si verificano condizioni analoghe. Dopo anni di scontri tra l’ala oltranzista di Abuzid Abdelhamid e il gruppo di Mokhtar Belmokhtar (alias Khaled Abu Abbas, che si arrenderà alle autorità algerine nel gennaio del 2007) prevale la corrente di Abdelhamid e si rende responsabile dell’attentato dell’11 aprile del 2007 (trentatre morti e duecentoventisei feriti). Uno degli organizzatori dell’attentato, Sidali Rachid (alias Alì Diss), viene ucciso durante un’operazione di rastrellamento della polizia insieme al suo braccio destro, Nour Mohammed ed altri cento terroristi. In ogni caso, la Riconciliazione nazionale non viene messa in discussione dai nuovi attacchi, nonostante i numerosi detrattori che si oppongono a qualunque concessione offerta alle forze negative (il termine viene preso in prestito dalla popolazione ruandese, che qualifica in questo modo i responsabili del genocidio). Solo dopo poche ore da un tentativo di attacco kamikaze nei suoi confronti (Batna, settembre 2007), il presidente Bouteflika si affretta a rassicurare i notabili della città: “l’opzione della Riconciliazione è irreversibile”. Le ripercussioni economiche durante il “decennio nero” furono pesanti. L’economia algerina registrò perdite superiori ai 20 miliardi di dollari e molti progetti di ampio respiro vennero fermati per ragioni di sicurezza (l’aeroporto e la metropolitana di Algeri, l’autostrada chiamata est-ovest, il passante ferroviario degli altopiani e molti altri). La riduzione della violenza favorì il riavvio dei cantieri e riaprì le porte ad un ambizioso piano di investimenti pubblici (oltre 200 miliardi di dollari in dieci anni), ma permise anche il reinserimento sociale di circa 6.500 combattenti e la liberazione di oltre 2.500 prigionieri islamici. Sostenuta da una schiacciante maggioranza (più del 90% della popolazione si è espressa favorevolmente), la Riconciliazione nazionale rimane ancora oggi una realtà complessa e di difficile interpretazione. Anche se ci sono state vendette contro i pentiti (sembra che oltre duecento islamici siano stati uccisi dai vecchi compagni), questa legge “suggerisce alla società di accettare senza riserve il reinserimento di persone colpevoli di atti particolarmente barbari, difficili da perdonare e dimenticare44”. Per agevolare il loro reinserimento sociale, molti islamisti evitano di rientrare nelle città o nei villaggi di origine e preferiscono rifugiarsi nell’anonimato dei grandi agglomerati urbani, dove non sono conosciuti i violenti trascorsi (ma anche per la difficoltà di ritrovare il vecchio impiego nelle aziende, che nel frattempo – proprio a causa della guerra civile – hanno chiuso i battenti o hanno cambiato attività). “La maggior parte di loro si è riciclata nell’economia sommersa, già assalita e governata dai loro maestri, gli emiri” e l’unico settore attentamente sorvegliato dallo stato è quello dell’istruzione, da sempre il più importante serbatoio dei militanti islamici, dove “i pubblici poteri si mostrano vigili e impediscono il ritorno dei pentiti nelle scuole, nei licei e nei collegi”, provocando però lo sdegno degli anziani capi islamici (tra di loro, Madani Mezrag denuncia la mancanza del rispetto degli impegni da parte dello stato). L’economia sommersa consiste nelle reti islamiche di riciclaggio di denaro sporco – rimaste sempre attive – per avviare i nuovi affari, dalla semplice bancarella di frutta e legumi sino alle più redditizie attività commerciali legate all’importazione e alla distribuzione di opere religiose (dal Cairo e da Damasco), in ogni caso domini incontrastati del proselitismo religioso. Anche se i militanti pentiti non beneficiano di alcun aiuto finanziario da parte del governo, le famiglie dei terroristi caduti hanno invece diritto a forme di compensazione e secondo Merouane Azzi, responsabile della sezione “riconciliazione” all’interno della Corte di Algeri, il costo totale di queste operazioni supera i 12 miliardi di dinari, pari a circa 120 milioni di euro: “più della metà dei cinquantamila dossier di richiesta di risarcimento sono state vagliate, ma venticinquemila non offrono diritto ad alcun indennizzo da parte dello stato, almeno secondo la legge”. Gli indennizzi riguardano anche le famiglie degli scomparsi, vittime delle forze dell’ordine. Su settemila casi censiti, ben 6.450 hanno ricevuto una indennità di 700.000 dinari (circa 7.000 euro) per ogni persona scomparsa, ma circa cinquecento famiglie hanno rifiutato l’offerta per proseguire i loro sit-in settimanali per reclamare a gran voce la verità sui loro congiunti. Le autorità algerine hanno invece abbandonato alla loro sorte le vittime della tragedia nazionale che si sono battute per la repubblica, ovvero i patrioti civili che hanno impugnato le armi contro gli islamici radicali (senza uno status sociale) e i funzionari e diplomatici rimasti vittime degli attentati. Nel maggio del 2009 – durante la dichiarazione della sua politica generale davanti al parlamento – il primo ministro Ahmed Ouyahia, presenta le scuse a questa categoria di vittime e promette una rapida valutazione delle loro rivendicazioni (sei mesi più tardi, il 18 dicembre 2009, un centinaio di “dimenticati” della Riconciliazione si radunano a el-Mouradia e la maggior parte di loro è sulla sedie a rotelle). Gli Stati Uniti proseguono nella politica di rafforzamento della loro presenza nell’Africa settentrionale e nei paesi confinanti con il Sahara. Il presidente Bush aveva già annunciato (6 febbraio 2007) la creazione della United States Africa Command (Africom) – il cui settore era precedentemente subordinato al Comando delle forze 44 Dichiarazione dell’avvocato Mohamed Nadir Bouacha, riportata dal giornalista Cherif Ouazani nell’articolo Algeria: la riconciliazione dieci anni dopo, apparso sul quotidiano «Dar al-Hayat» il 12 febbraio 2011 e pubblicato a Londra. americane in Europa – per aggiungersi agli altri comandi già preesistenti, lo “European Command, il “Central Command” e il “Pacific Command”. Oltre alla determinazione di Washington ad entrare in competizione con le altre potenze per le ricchezze del continente, la decisione viene presa dopo il duplice attacco alle ambasciate americane di Nairobi e Dar es-Salaam, ovvero per il moltiplicarsi dei pericoli che corrono gli interessi americani nel continente (ambasciate e compagnie commerciali). Alla guida del Comando viene posto il generale William Ward, già vice comandante dello “European Command”, con sede a Stoccarda, e profondo conoscitore della regione africana e dei suoi problemi. L’amministrazione americana aveva deciso, nel 1983, di includere l’Africa sotto il comando europeo per via del fatto che la maggior parte dei paesi erano ex colonie europee ed avevano quindi conservato stretti rapporti politici e culturali con le vecchie potenze coloniali. Se quindi la maggior parte dei paesi africani era sinora legata agli europei, specialmente per l’addestramento e la formazione dei quadri militari (oltre che per l’acquisto di armi e munizioni), l’arrivo degli Stati Uniti rappresenta un elemento di concorrenza e un tentativo di ridimensionamento dell’influenza esercitata da questi ultimi, specialmente dopo il declino dell’influenza militare russo-cubana nel continente, in particolare in Angola e Mozambico, e la costante crescita della presenza cinese (il segretario americano alla Difesa, Robert Gates, dichiara che la costituzione dell’Africom “consentirà agli Stati Uniti un approccio più efficace e coerente al continente africano rispetto all’approccio attuale, che altri non è che un retaggio della guerra fredda”). L’area di intervento dell’Africom – composto da circa mille uomini distribuiti in tre comandi secondari – include tutto il continente africano, con l’eccezione dell’Egitto (che dipende dal Central Command) e di alcune isole dell’Oceano Indiano e compito dell’organizzazione è quello di presiedere all’applicazione dei programmi legati alla sicurezza e alla stabilità del continente, ma in particolare nell’Africa del nord e nella regione del Sahara. Tra i principali programmi rivestono maggiore importanza quello relativo all’addestramento delle forze di peacekeeping (African Contingency Operations Training and Assitance Program, Acota), quello di addestramento e formazione militare internazionale (International Military Education and Training Program, Imet) e il programma di lotta all’Aids (President’s Emergency Plan for Aids Reliefs) con un bilancio che supera i diciotto miliardi di dollari per un periodo di cinque anni. Pur senza avventurarsi nella costruzione di basi permanenti nella regione, tale politica prevede l’offerta di aiuti di vario genere agli eserciti dei paesi alleati nella guerra al terrorismo, aiuti che prevedono anche l’organizzazione di manovre militari su vasta scala (all’inizio di ogni stagione estiva) con le forze armate di una decina di nazioni africane, evitando quindi di ricorrere alla concentrazione di truppe americane sul territorio dei paesi considerati amici. Secondo il generale William Ward – comandante della United States Africa Command – quella di al-Qaeda nell’Africa del nord è una minaccia reale ed è quindi sua intenzione cooperare militarmente con i paesi della regione per fronteggiare questa emergenza, possibilmente con una serie di accordi “a lungo termine per garantire una maggiore stabilità nel continente”. Dopo aver presenziato alle manovre congiunte delle forze armate tunisine (base militare di Bizerte, maggio 2008) il generale Ward si reca in Marocco per condurre una serie di colloqui sulla cooperazione sia militare che di intelligence, ma nell’agenda del suo viaggio non è prevista una tappa ad Algeri. L’Algeria aveva infatti informato gli americani di non essere intenzionata ad ospitare la sede dell’Africom sul suo territorio45 e la scelta si era quindi orientata verso la Mauritania, ma anche in 45 questo caso era stata respinta dopo un duro scontro tra il governo ed i suoi oppositori (i leader dell’opposizione si erano recati direttamente dal presidente Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi per dissuaderlo sull’iniziativa con minacce di scioperi, manifestazioni e proteste). In ogni caso, circa duecento marines statunitensi arrivano nella cittadina di Atar (a nord della Mauritania, nel giugno del 2008) per una missione ufficialmente umanitaria, ovvero con l’obiettivo di sostenere l’esercito mauritano in operazioni di soccorso e cura dei malati. Gli analisti americani ritengono che la minaccia, islamica e terroristica, sia ormai destinata ad aumentare e che si sia aggravata con le vicende somale e la guerra nel Darfur, oltre che a causa del moltiplicarsi delle controversie e dei conflitti fra i paesi della regione. In effetti, la diffusione della presenza salafita nell’Africa settentrionale nel corso degli ultimi anni ha prodotto una lunga scia di attentati: dall’ attentato suicida nel 2002 contro la sinagoga di elGhriba (nell’isola tunisina di Djerba, con la morte di ventidue persone, tra cui quattordici turisti tedeschi) sino all’attacco all’ambasciata israeliana di Nouakchott (la capitale della Mauritania) all’inizio del 2008. In Africa orientale46 la politica statunitense si è tradotta nell’ampliamento della base americana a Gibuti (che ospita milleottocento uomini, oltre alla presenza di unità navali al largo del Corno d’Africa) e in quella settentrionale ed occidentale con la costituzione dell’Africom. L’annuncio del Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento di aver aderito alla rete di al-Qaeda sembra che sia stato l’elemento determinante per favorire la collaborazione dei paesi del Sahara con gli Stati Uniti, che a loro volta creano la Trans-Sahara Counter Terrorism Partnership (Tsctp) con la partecipazione dei capi di stato maggiore di Algeria, Marocco, Tunisia, Mauritania, Niger, Mali, Ciad, Senegal e Nigeria (la Libia decide di rimanere fuori). Il desiderio della Nigeria di entrare nell’organizzazione, nonostante la sua lontananza dal Sahara, viene presentato – ed accolto dagli Stati Uniti – a causa della rapida affermazione delle correnti islamiche radicali nella variegata e complessa realtà etnica e religiosa del paese (gli Stati Uniti, in occasione della creazione della Tsctp, stanziano per i paesi che aderiscono, una cifra che oscilla tra gli 80 e i 90 milioni di dollari). La nuova partnership aveva già avuto il suo battesimo con le manovre militari congiunte nel giugno del 2005 (in Senegal, con la denominazione di Flintlock 2005) e si sono successivamente trasformate in un appuntamento annuale, con l’obiettivo americano di aiutare e sviluppare le capacità degli eserciti locali per contrastare le attività del fondamentalismo islamico in prima persona, senza ricorrere ad un intervento diretto delle truppe di Washington. La cosiddetta vision americana formulata dal comando supremo nel 2003 – la protezione degli Stati Uniti dalla minaccia terroristica non comincia dal territorio nazionale ma dalle sorgenti del terrorismo stesso, in Africa e in Asia – è quindi alla base di questa strategia che mira ad impedire alle organizzazioni fondamentaliste di trovare rifugi sicuri nel Sahara, o meglio in quelle regioni che i governi centrali non riescono a controllare. Il presidente Bouteflika, sollecitato sull’argomento, aveva però dichiarato al giornale spagnolo «Abc» che il suo paese non aveva ricevuto alcuna proposta dagli americani in questo senso, e quindi non si rendeva necessario dare una risposta, affermativa o negativa che fosse. 46 Fazul Abdullah Mohammed – uno dei terroristi più ricercati al mondo – ha ricevuto, direttamente da Osama bin Laden, il compito di organizzare le strutture terroristiche in Africa orientale. Responsabile degli attentati del 1998 in Kenya e Tanzania, Fazul è stato il finanziatore e l’addestratore dei gruppi al-Shabaab in Somalia. Sembra che sia stato ucciso, casualmente, ad un posto di blocco vicino a Mogadiscio. Secondo numerosi giornalisti, sia algerini che tunisini (e tra di loro Rashid Khashana, corrispondente per il quotidiano «Dar al-Hayat») la crescente influenza militare degli Stati Uniti nell’Africa settentrionale determina però una forte impennata di sentimenti ostili verso gli americani, aumentando vertiginosamente le tensioni tra i governanti e le popolazioni. Inoltre, proprio queste tensioni possono essere sfruttate dai gruppi islamici radicali “per giustificare la loro presenza e per assicurarsi nuovi sostenitori”. Agli inizi del 2009, a preoccupare gli analisti occidentali47 c’è anche il pericolo di una contemporanea e complessa successione (dinastica) dei quattro governanti del nord Africa: il libico Muammar Gheddafi, il tunisino Zine al-Abedin ben Alì, l’egiziano Hosni Mubarak e l’algerino Abdel Aziz Bouteflika. In particolare, il fratello del presidente algerino, Said Bouteflika, è collegato ad un movimento popolare che “potrebbe alla fine servire come base per il suo tentativo di successione”. In realtà, la legittimità del regime è fondata sulla guerra di indipendenza e sul ruolo di custode svolto dalla presidenza, e Said non sembra possedere, agli occhi dell’opinione pubblica, questo particolare carisma. Se piuttosto la successione dinastica venisse considerata una seria minaccia per l’ordine repubblicano, questa situazione potrebbe rafforzare “la percezione che l’esercito ha di se stesso come custode dello stato”, inducendolo quindi ad intervenire. Un serio elemento di contrasto tra i paesi del nord Africa è piuttosto l’Unione del Maghreb Arabo (Uma): a vent’anni dalla sua nascita (17 febbraio 1989) questo organismo internazionale è sempre rimasto lettera morta. Descritta come un progetto che avrebbe risvegliato le economie del Maghreb, l’Unione non è in realtà riuscita a promuoverne lo sviluppo e costituire un blocco maghrebino in grado di confrontarsi con gli altri blocchi regionale e di soddisfare le aspettative delle popolazioni. Secondo Amel Moussa48, l’Unione “vive la paralisi ancor prima di aver conosciuto la palpitazione e la vita che le era stata pronosticata al momento di annunciare la sua nascita”. Il Consiglio della presidenza – che detiene il potere di prendere le decisioni – non si riunisce in effetti dal 1994 e dei pochi accordi firmati (appena ventisette) soltanto sei sono entrati nella fase di attuazione nell’arco di due decenni, e tra questi l’accordo per la creazione di un istituto di credito maghrebino per gli investimenti e il commercio estero e per lo scambio dei prodotti tra i paesi dell’Unione. Sembra comunque che la causa principale della paralisi dell’organismo sia da attribuire al contrasto tra l’Algeria e il Marocco sulla questione del Sahara Occidentale, ostacolo insormontabile anche per la convocazione del vertice maghrebino a cinque, che riunisce i leader del Grande Maghreb Arabo (Algeria, Libia, Tunisia, Marocco e Mauritania). Secondo Rabat, l’Algeria ostacola il cammino dell’Unione perché appoggia il diritto di autodeterminazione del popolo saharawi, al contrario del Marocco che vorrebbe invece lavorare ad 47 Wolfram Lacher, analista dei paesi del Nord Africa presso la società di consulenza «Conrol Risks», e autore dell’articolo I figli emergenti dei moribondi regimi del Nord Africa del 12 gennaio 2009. 48 Amel Moussa, giornalista tunisina, nel suo articolo L’Unione del Maghreb Arabo nel suo ventesimo anniversario, apparso sul quotidiano «Sharq al-Awsat», il 19 febbraio 2009. Moussa è anche una famosa poetessa e le sue opere sono state tradotte in numerose lingue, italiana compresa. un progetto di autogoverno allargato (anche se il problema del conflitto del Sahara occidentale è attualmente di competenza delle Nazioni Unite, le sue pesanti implicazioni continuano a dominare le relazioni tra i due paesi). Anche l’atteggiamento tenuto da Muammar Gheddafi (in occasione dell’inaugurazione dei lavori della decima sessione del Consiglio presidenziale del raggruppamento dei paesi del Sahel e del Sahara, settembre 2008) non contribuisce a favorire lo sviluppo dell’Unione, perché secondo il leader libico l’organizzazione “non esiste, non è nulla, è solo una menzogna”. Altri analisti invece puntano il dito contro il disaccordo nato sul progetto di “Unione per il Mediterraneo” annunciato dal presidente francese Nicolas Sarkozy. Una timida accoglienza è stata espressa dalla Tunisia, dal Marocco e dalla Mauritania, mentre la Libia ha subito rifiutato l’adesione e l’Algeria ha invece espresso una serie di riserve e condizioni (secondo Amel Moussa, si tratta di un’occasione persa e “ciò che ha deluso le elite e i popoli del Maghreb è stato il disprezzo mostrato dai loro leader nei confronti del progetto, ed il fatto che essi non lo hanno trattato come un ‘estrema priorità della regione, pur con tutti i problemi economici e di sviluppo, gli spaventosi tassi di disoccupazione e il fenomeno dell’emigrazione clandestina”). In realtà, le tensioni nel Vicino Oriente forniscono all’Algeria, ma anche agli altri paesi arabi, un serio motivo per esprimere le loro reticenze a proposito del progetto, che li raggrupperebbe insieme allo stato ebraico. Prima della riunione del mese di luglio del 2008 – dove è stata confermata la presenza del primo ministro israeliano Ehud Olmert – i responsabili arabi si preoccupano, forse in maniera eccessiva, che la coreografia del summit non dia l’impressione di una normalizzazione dei rapporti con Israele. Ma la freddezza di Algeri nasce anche dall’atteggiamento tenuto da Parigi. Il presidente francese ha presentato la sua idea di Unione per il Mediterraneo in Marocco – in occasione del discorso pronunciato a Tangeri e a Rabat il 23 ottobre 2007 – deludendo le speranze delle autorità algerine che contavano su un riequilibrio delle posizioni francesi in merito al Sahara occidentale (la scelta del paese è stata infatti molto criticata). Inoltre, Parigi ha offerto la co-presidenza dell’Unione all’Egitto e alla Tunisia la sede del segretariato. Secondo il giornale «Le Quotidien d’Oran», il tergiversare del presidente Bouteflika davanti alla proposta, criticato da alcuni diplomatici francesi, è in realtà un modo di far pagare a Sarkozy la “sua politica di sotterranea ostilità nei confronti dell’Algeria, adottata sin dal suo arrivo all’Eliseo”. Secondo alcuni analisti occidentali, le cause del frazionamento – e del mancato sviluppo – dei paesi del Maghreb è da ricercarsi nella cronica incapacità di trasformazione dei sistemi politici. La rivista «Newsweek» (marzo 2009) definisce gli stati arabi come “l’ultima roccaforte del rifiuto del mondo”, ovvero la mancata realizzazione di una effettiva rivoluzione democratica a causa di un errato modello di stato in via di modernizzazione, che ha invece condotto ad una frattura sempre più profonda tra lo stato e la comunità. In particolare, l’Algeria era stata indicata – in un rapporto delle Nazioni Unite elaborato alla metà degli anni Settanta – come uno dei pochissimi paesi arabi in grado di raggiungere i livelli dei paesi europei. Ma le illusioni di un effettivo progresso si infransero rapidamente quando il paese diventò ostaggio della corruzione e della guerra civile, alimentando la frustrazione sociale (innalzamento dei tassi di disoccupazione ed emigrazione, aumento degli indici di suicidi e di criminalità). Le élite dei paesi arabi non sembrano possedere un’ideologia propria – e neanche un’ideologia nazionale, di sviluppo o di modernizzazione – ma piuttosto una spiccata tendenza a ritenere validi solo i loro apparati e la loro efficienza come organi di controllo e di dominio. Secondo l’analista arabo Burhan Ghalioun, nei regimi arabi abbiamo assistito al passaggio da programmi socialisti a programmi di stampo liberista senza che si sia avvertita la necessità di cambiare il governo o le persone […] la struttura dittatoriale è diventata implicita, cominciando a chiedersi come prolungare la propria sopravvivenza senza interrogarsi invece sulla propria legittimazione, e questo, alla luce della realtà araba attuale, è ciò che ha condotto l’evoluzione di molti paesi arabi ad un punto morto. La pressione a lungo esercitata dagli Stati Uniti per la “strategia di coesione” contro l’intensa e potenziata attività di al-Qaeda nella regione maghrebina ottiene i primi risultati significativi nel giugno del 2010, ovvero quando si intensificano i rapporti con il governo algerino, in definitiva il maggior beneficiario dell’Africom (anche se l’amministrazione di Washington è ancora riluttante a fornire all’esercito algerino un sostegno militare diretto e un equipaggiamento sofisticato). La forza di al-Qaeda nel Maghreb Islamico, alimentata da numerose nuove cellule e dai ribelli tuareg, è adesso in grado di controllare ampie zone del deserto e rappresenta una seria minaccia alla sicurezza dei paesi della regione. Ma per l’analista Usama Butt (autore del volume Pakistan Quagmire, pubblicato in Gran Bretagna) la militanza di Aqim non rappresenta niente di nuovo, bensì “la conseguenza dell’interrotta guerra civile algerina, l’unica novità consiste nella sua propagazione nella regione”. Negli anni successivi all’indipendenza il Maghreb non è mai stato una regione autonoma, ma solo governato da regimi autocratici e laici che hanno visto nell’islam solo una forma di arretratezza culturale. La secolarizzazione coatta della società algerina si sarebbe interrotta con la vittoria islamista negli anni Novanta se non fosse intervenuto l’esercito per salvare la democrazia (espressione usata da quasi tutti i quotidiani francesi per commentare la vicenda). Usama Butt ritiene anche che, eliminando dalla società qualsiasi espressione legata all’islam, il regime algerino – così come gli altri governi laici del Maghreb – ottenne “quello che i poteri coloniali francesi avevano solo potuto sognare, ovvero un genocidio culturale e una totale occidentalizzazione del blocco regionale”. Se quindi agli islamici – che godono di un ampio sostegno da parte della società algerina – viene preclusa ogni via politica, le fazioni radicali al loro interno potrebbero facilmente guadagnare terreno. I cablogrammi del Dipartimento di stato americano riguardanti l’Algeria – divulgati da Wikileaks verso la fine del 2010 – lasciano chiaramente intendere che quando si tratta di sicurezza in Africa del Nord e nella regione del Sahel, il principale interlocutore è l’Algeria. Le rivolte scoppiate nel paese vengono attribuite all’aumento dei prezzi dei generi alimentari e probabilmente influenzate dai tumulti generati in Tunisia, ma rimane indiscussa la competenza algerina nel contrastare il ramo regionale di al-Qaeda (le forze di sicurezza algerine sono considerate le più esperte in materia di antiterrorismo per via dell’esperienza maturata nel contrasto ai militanti islamici negli anni Novanta). Quello che invece preoccupa l’amministrazione di Washington sono il livello di corruzione e la paralisi politica del paese, senza contare la forte sperequazione con i pochi privilegiati che beneficiano degli ingenti introiti provenienti dai giacimenti di combustibili fossili presenti nel paese, quindi possibile causa di futura instabilità. In uno dei cablogrammi diffusi, viene commentata la creazione, su iniziativa di Algeri, di un’organizzazione di quattro stati (oltre all’Algeria anche il Mali, la Mauritania e il Niger) per cooperare contro al-Qaeda nel Maghreb con la condivisione di informazioni di intelligence e di risultati investigativi. Il vice segretario americano alla Difesa, Vicky Huddleston, avrebbe dichiarato al suo omologo algerino che “Washington riconosce la leadership algerina in Africa e la sua esperienza nella lotta al terrorismo e apprezza gli sforzi compiuti per rendere l’area del Sahel più sicura e impedire al terrorismo di radicarsi nei paesi vicini”. In particolare, non si esercita alcuna pressione per includere le forze statunitensi nel comando congiunto di Tamanrasset (il nome è quello dell’avamposto nel deserto algerino dove si sono tenuti gli incontri tra gli alti funzionari dei governi del Sahel) ma piuttosto si propone un piano per incrementare i voli di ricognizione e si propone di offrire il contributo americano per la partecipazione più attiva degli altri governi regionali (interessante qui notare che non viene criticata l’Algeria per aver escluso il Marocco dall’iniziativa, così come non ci sono lamentele per la freddezza che gli organi di sicurezza algerini hanno riservato alla proposta di inserire i governi europei nell’alleanza contro al-Qaeda nel Maghreb). L’accettazione da parte degli Stati Uniti della supremazia regionale algerina viene confermata in un altro cablogramma inviato dal rappresentante americano a Bamako (Mali), dove si fa riferimento alla necessità di rassicurare l’Algeria su quelli che sono gli obiettivi dell’assistenza militare americana all’esercito del Mali, con l’intenzione di “consentire la gestione delle molteplici minacce alla sicurezza del nord, e di non lanciare l’esercito del Mali in qualche donchisciottesca campagna contro i tuareg”. Così come avviene per le più ampie questioni legate al terrorismo islamico, anche nel ciclico conflitto tra il governo di Bamako e i ribelli tuareg nell’arido Mali settentrionale, i funzionari americani dimostrano di essere fermi sostenitori della linea algerina (l’Algeria è ansiosa di guidare un’operazione internazionale contro i fondamentalisti islamici proprio nel Mali settentrionale, dove è stata segnalata una forza di diverse centinaia di militanti islamici, in gran parte algerini e mauritani, concentrati in quelle remote aree di territorio non governate dall’autorità centrale). Ma tutto questo senso di sicurezza svanisce quando si affrontano gli affari interni dell’Algeria. I diplomatici americani – ma anche i loro interlocutori locali – non sono in grado di sapere quale sarà il destino del paese dopo le dimissioni (per motivi di salute) o la morte del presidente Abdel Aziz Bouteflika (l’unica certezza viene dalla consapevolezza che neanche il presidente, benché rieletto per tre volte, è in grado di allentare il controllo dell’esercito sulle istituzioni del paese). Alcune fonti dell’ambasciata americana ad Algeri riferiscono che le forze armate algerine non si fidano del presidente e che la corruzione all’interno del clan di Bouteflika49 ha generato un conflitto basato su interessi economici privati in cui sono coinvolti numerosi alti ufficiali dell’esercito. In un altro dispaccio, invece, si legge che molti contatti dell’ambasciata ritengono che il presidente Bouteflika non sia particolarmente corrotto, ma che siano i suoi fratelli, Said e Abdallah, ad essere particolarmente avidi. 3. Dopo la sfortunata guerra del 1948, condotta insieme ad altri paesi arabi contro lo stato di Israele, l’antica dinastia fondata da Mohammed Alì nel secolo XIX viene estromessa dal paese dal colpo di stato del 1952, guidato dal generale Mohammed Naguib che costringe re Farouk ad abdicare. Nasce la Repubblica Araba di Egitto ed il generale Naguib assume le cariche di presidente e di primo ministro, sino alla comparsa del colonnello Gamal Abd el-Nasser sulla ribalta della scena 49 Un esponente dell’opposizione ha soprannominato il clan del presidente Bouteflika “la gang di Tikrit”, con riferimento agli ex collaboratori di Saddam Hussein. L’espressione è stata usata in uno dei cablogrammi americani. politica del paese50. Alla morte di Nasser nel 1970, gli succede il vice presidente Anwar Sadat che tenta di liberare il Sinai riaprendo nel 1973 le ostilità contro Israele insieme alla Siria – la guerra dello Yom Kippur – ma anche questa volta senza raggiungere i risultati desiderati51. Tra il 1977 ed il 1979 il presidente Sadat si reca prima in visita a Gerusalemme e successivamente firma con il primo ministro israeliano Begin un trattato di pace che permette all’Egitto il recupero graduale del Sinai (1982), che mette fine ad una guerra trentennale e che ristabilisce le relazioni diplomatiche tra i due paesi. Ma il mondo mussulmano non sembra apprezzare la nuova politica estera del Cairo (dopo la firma del trattato, l’Egitto viene escluso dalla Lega Araba sino al 1989) ed il 6 ottobre del 1981 – lo stesso anno in cui l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina compie duecentoquarantotto azioni terroristiche contro bersagli israeliani – Sadat viene platealmente assassinato nel corso di una parata militare da un gruppo estremista islamico (le prime valutazioni degli analisi attribuiscono l’attentato prima al gruppo della Jihad Islamica e successivamente alla Fratellanza Mussulmana), e gli succede il vice presidente Hosni Mubarak52. Gli anni Novanta sono contraddistinti dall’inasprimento delle tensioni politiche e sociali della corrente fondamentalista islamica – due falliti attentati a Mubarak, uno in Etiopia ed uno al Cairo – dopo la posizione assunta dall’Egitto in merito alla decisione di sostenere le Forze Alleate contro l’Iraq nella guerra del Golfo (1991), sino ai sanguinosi attentati contro i turisti occidentali nei pressi di Luxor (1997). Come successore designato di Sadat, il nuovo presidente ha la necessità di sostenere il processo di pace con Israele ed al tempo stesso si adopera per migliorare l’immagine dell’Egitto nel mondo arabo, considerata compromessa da un accordo quantomeno prematuro nei confronti di Tel Aviv. Pur conquistando il rispetto da parte di molti paesi occidentali, negli anni Novanta Mubarak attua una dura repressione contro il terrorismo fondamentalista e contemporaneamente conduce una parallela e sotterranea islamizzazione del diritto interno egiziano, alla ricerca di una necessaria ed indispensabile coesione nazionale (il sistema giudiziario, per esempio, combina elementi della Common Law britannica, dei Codici napoleonici e della legge coranica). Ma i problemi di stabilità del nuovo presidente devono fare i conti con una opinione pubblica egiziana che manifesta, sempre con maggiore insistenza, uno spiccato sentimento di ostilità verso l’amministrazione di Washington. Anche durante l’imponente esercitazione Bright Star svoltasi in Egitto nell’ottobre del 2001 – che ha costituito il più grande concentramento di forze multinazionali con compiti non operativi, per 50 Quando nel 1956 Nasser annuncia la nazionalizzazione della Compagnia del Canale di Suez, scatena l’intervento armato di Francia, Regno Unito ed Israele. Le truppe con la Stella di Davide occupano la penisola del Sinai e la Striscia di Gaza, già parte della Palestina ed in amministrazione all’Egitto dal 1948. Solo una perentoria azione delle Nazioni Unite, con il preventivo accordo degli USA e dell’URSS, costringe Israele a ritirarsi, sino al nuovo conflitto del 1967 – la guerra dei Sei Giorni – dove le truppe di Tel Aviv riconquistano il Sinai e la Striscia di Gaza. 51 Anche se l’Egitto può contare sul supporto di un contingente aereo sovietico, Israele riesce ad attraversare il Canale ed a conquistare la città di Suez. Una serie di successivi accordi (1974 e 1975) prevedono il ritiro dell’esercito israeliano dalla sponda occidentale del Canale e la presenza di un contingente militare egiziano lungo una porzione di territorio sulla sponda orientale, così come la cessione da parte di Israele di alcune aree petrolifere del Sinai. 52 Il generale Mohammed Hosni el-Sayed Mubarak, classe 1928, viene dall’Aeronautica Militare ed ha frequentato la Scuola di Guerra di Frunze in Russia. E’ stato capo di Stato Maggiore nel 1969 e comandante in capo dell’Aviazione egiziana nel 1972 (si deve a lui la riorganizzazione dell’arma aerea prima della guerra del 1973) sino alla nomina di vice presidente avvenuta nel 1975. attuare le procedure comuni di combattimento e verificare la interoperabilità dei vari comandi – la stampa egiziana ha preferito mantenere un basso profilo. Nonostante la presenza di 70.000 soldati di dieci diversi paesi (anche l’Italia con 1.200 uomini) il presidente Mubarak non ha potuto ignorare la forte opposizione interna e la stessa visita effettuata dal comandante delle Operazioni in Afghanistan (il generale americano Tommy Franks) ha fatto registrare alcune critiche ai bombardamenti in atto sul territorio di Kabul, considerati dall’opinione pubblica egiziana come un più generale attacco all’islam. Ed anche quando nel 2003 gli Stati Uniti organizzano a Camp Lemonier (una vecchia base della Legione Straniera a Gibuti) il comando della Combined Joint Task Force Horn of Africa per le operazioni di contrasto al terrorismo nel Corno d’Africa, Mubarak non esita a manifestare le sue perplessità – l’area è storicamente sotto la sfera di influenza del Cairo – obiettando l’appoggio dato dagli Stati Uniti ai ribelli secessionisti del Sudan meridionale, lì dove gli equilibri della regione potrebbero essere compromessi ai danni dell’Egitto, preoccupato per le sorti del prezioso contributo naturale costituito dal Nilo. Ma la politica internazionale intrapresa dal presidente non intende effettuare pericolosi scostamenti: nel 2002 i rapporti commerciali con gli Stati Uniti superano i 4 miliardi di dollari, senza contare un altro miliardo che da Washington raggiunge direttamente il Cairo sotto forma di aiuti militari. Inoltre, l’Egitto è adesso inserito in un gruppo di paesi che in ambito Nato vengono identificati con la sigla di Mediterranean Dialog (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Marocco, Mauritania e Tunisia) ed all’Italia è stata affidata la leadership nei contatti preferenziali con le autorità politiche e militari egiziane53. Nel 2003 viene anche ipotizzato l’allargamento della Nato – secondo i vertici dell’organizzazione le maggiori minacce vengono proprio dal Medio Oriente – per un più stabile equilibrio geo-strategico dell’area, e tra i paesi candidati emerge proprio il nome dell’Egitto. La proposta, almeno sotto un profilo puramente tecnico, non è priva di fondamento. A fronte di quasi un milione e mezzo di soldati (Alleati europei e Canada) soltanto 55.000 uomini sono effettivamente operativi – e quindi proiettabili fuori area – ed al tempo stesso sono quasi tutti impegnati in missioni internazionali di peace-keeping: l’Alleanza ha bisogno di uomini e l’esercito egiziano può contare su quasi mezzo milione di soldati (nel 2003: esercito 71%, aeronautica 25 e Marina 4, con spese militari pari al 2,7% del Pil nazionale)54. L’anno successivo si apre un dibattito simile anche in sede Onu, in occasione dei lavori iniziati per una possibile riforma dell’organizzazione. Il mondo arabo – ma in questo caso è più corretto parlare di oltre un miliardo di mussulmani non rappresentati – preme alle porte del Consiglio di Sicurezza, dove i cristiani (nell’accezione più ampia del termine) possono contare su quattro seggi ed il quinto è ad esclusivo appannaggio del mondo cinese. Anche se l’Arabia Saudita potrebbe avere il prestigio necessario, l’Egitto – così intensamente impegnato nelle operazioni militari a fianco delle potenze occidentali – sembra entrare a pieno titolo 53 Grazie a precisi accordi bilaterali, l’Italia può adesso contare su ampie aree per l’addestramento – insufficienti sul nostro territorio – per i reparti meccanizzati e corazzati, al fine di migliorare le specifiche tecniche d’arma, con la relativa connotazione operativa, sempre nell’ambito di esercitazioni congiunte con l’esercito egiziano (tra le più importanti, la Brigata Pinerolo nel 2002 e la Brigata Garibaldi nel 2004). 54 Alle dipendenze del ministero degli Interni sono attivi due corpi paramilitari, le “Forze Centrali di Sicurezza” (duecentocinquantamila uomini equipaggiati anche con veicoli corazzati e mortai) e la “Guardia Nazionale” (sessantamila uomini equipaggiati con armamento leggero), mentre sono organizzate sotto il ministero della Difesa (agli ordini del generale Mohamed Hussein Tantawi) le “Forze di Protezione Nazionale” (sessantamila uomini), le “Forze di Frontiera” (ventimila uomini) e le “Forze di Protezione Costiera” (duemila uomini per la sicurezza delle installazioni pubbliche lungo il litorale e le attività di lotta al contrabbando). nella rosa dei candidati. Ma il paese è stretto da una parte dall’offensiva politico-militare di Washington contro i regimi autoritari del Medio Oriente e dall’altra dalla recrudescenza degli attentati terroristici. Nell’Ottobre del 2004 i fondamentalisti islamici colpiscono l’Hotel Hilton a Taba – sul Golfo di Aqaba – che ospita numerosi clienti israeliani per le ultime celebrazioni del Sukkot (la “Festa dei Tabernacoli”) ed insanguinano anche altre tre località turistiche sul versante egiziano del Mar Rosso. A distanza di pochi mesi, lo spaventoso attentato nella zona più affollata di Sharm el-Shéik provoca quasi un centinaio di vittime. Anche se Mubarak è riuscito a ricucire la frattura tra l’Egitto ed il mondo arabo dopo gli accordi di pace con Israele – ed a porsi in una posizione privilegiata tra i paesi dell’area ed il mondo occidentale – non è bastato un cauto dialogo con l’opposizione moderata per assicurare al paese quel processo di democratizzazione necessario a garantirne la stabilità interna. Pur godendo di un vasto consenso popolare – Mubarak è diventato un personaggio influente dopo la buona prova dell’esercito durante la guerra del 1973 – a fronte della intransigente opposizione al fondamentalismo islamico, il presidente ha affiancato un rigido controllo sia sulle Forze Armate che sui Servizi Segreti, sulle emittenti televisive e radiofoniche, così come sull’intera economia del paese. Dopo ventiquattro anni di potere indiscusso, le piazze del Cairo – sino ad oggi importante palcoscenico per le manifestazioni contro Israele, gli Stati Uniti e la guerra in Iraq – si affollano per le democratiche richieste di riforme politiche e sociali. Sventolano le bandiere dei riformisti del partito Kifaya (“Basta!”), degli intellettuali del “Centro Kaldum” e quelle dei progressisti del partito Wafd, ma quando nelle centrali piazze di Ramsis e di Tharir scendono i Fratelli Mussulmani – la maggiore forza di opposizione del paese, vietata dal 1954 ma tollerata da molti anni – dal quartier generale della polizia, nella vicina Piazza Lazoghly, escono migliaia di uomini in tenuta anti- sommossa e dopo una violenta repressione con decine e decine di arresti, disperdono il corteo e riportano la tranquillità nelle turbolente strade del Cairo (in altri termini, l’Egitto sceglie la repressione contro la lettura intransigente del Corano e contro il rigore wahabita). I Fratelli Mussulmani sono il più antico movimento politico islamico del mondo arabo – fondato in Egitto nel 1928 da Hassan al-Banna – che ha iniziato l’attività di terrorismo conducendo azioni violente e sanguinarie contro il governo di re Faruk. Quando il “Consiglio del Comando Rivoluzionario” di Nasser decide l’istituzione di uno stato secolare, quindi assolutamente non islamico, la Fratellanza viene accusata dell’attentato ai danni del presidente nel 1954 e la repressione è durissima: migliaia di militanti arrestati, sei dirigenti condannati a morte e la pena dell’ergastolo per il leader Hassan al-Hudaybi. Anche l’ala più moderata dell’organizzazione viene bandita dal paese, ma molto più probabilmente rimane offuscata dalla grande popolarità di Nasser e della sua vincente ideologia panaraba. Ma la sconfitta militare egiziana nella guerra del 1967, e quindi la crisi del secolarismo panarabo, riapre le porte per il ritorno della Fratellanza sulla scena politica egiziana. Accusati ancora una volta di complicità nell’assassinio del presidente Sadat nel 1981, i Fratelli Mussulmani restano nella lista nera delle organizzazioni fuori legge, anche se nel tempo sembrano ammorbidire le loro posizioni politiche: si battono sì per la nascita di uno stato islamico, ma oggi intendono farlo attraverso autentici strumenti democratici. Mubarak, in un certo qual modo, sembra accettare il nuovo orientamento e tollera che sedici candidati della Fratellanza – formalmente indipendenti – siano eletti in parlamento nelle elezioni del 2000, favorendo in questo modo, però, la principale voce di opposizione al suo regime. Nel 2005 il leader Mohammad Ahmed Akef dichiara su «Al Jazira» di rinunciare all’instaurazione di uno stato islamico (ipotesi considerata inverosimile da molti analisti), di accettare il riconoscimento dei “Fratelli Copti”, di condannare la violenza e di promettere la sua collaborazione con il governo del Cairo, senza dimenticare – fatto decisamente insolito per un movimento islamico di opposizione – l’approvazione della parità dei diritti tra uomo e donna. Il Dipartimento di Stato americano preme per l’avvio di procedure democratiche in tutto il Medio Oriente, ed in particolare chiede all’Egitto un allentamento delle redini del potere ed un minimo di riconoscimento delle forze di opposizione (nell’intervento del segretario di Stato, Condoleezza Rice nel 2005, tenuto presso l’American University del Cairo si chiedono riforme democratiche ed affermazione dello stato di diritto). Ma i Fratelli Mussulmani, sin dai tempi della diaspora, hanno dato vita a numerosi movimenti estremistici e paramilitari in tutto il mondo arabo, diventando il simbolo del radicalismo religioso contro la libertà e la democrazia dell’intero continente. Le frange più intransigenti hanno intuito i limiti dell’ideologia fondante di al-Banna (la mancanza di un apparato militare e l’ambiguità nelle prospettive di assunzione del potere politico) ed hanno trovato maggiore ispirazione nell’ideologo Sayyd Qutb, distintosi per aver sviluppato una teoria decisamente rivoluzionaria per la confessione sunnita. Secondo Qutb, il vero credente ha il diritto di destituire i governi illegittimi – dal punto di vista dei principi islamici – usando lo strumento della jihad, sostenuta da martiri ispirati e disposti al sacrificio pur di promuovere l’autorità di Allah sulla terra. Ed anche se la dirigenza egiziana è riuscita negli anni a creare una organizzazione efficiente e ben diffusa nella città del Cairo – il primo movimento islamico a base urbana capace di inserirsi in un difficile tessuto sociale, con servizi medico-ospedalieri, assistenza sociale ed istituti educativi – sopravvive all’interno del movimento un’ala dura alimentata dai giovani militanti di ultima generazione, accesi sostenitori della sharia ed animati da feroci sentimenti antioccidentali. La confraternita politico-religiosa fondata in Egitto nel 1928 da Hassan al-Banna – al-Ikhwan almuslimun, i Fratelli Mussulmani – invoca il ritorno all’osservanza integrale del Corano e di tutta la tradizione islamica, in qualità di fondamento unico di qualsivoglia manifestazione della vita privata e pubblica55. Pur lottando sin dall’inizio contro l’influsso dell’Occidente, la Fratellanza non intende respingere a priori i progressi della scienza e della tecnica, ma piuttosto perseguire un ordine sociale e una giustizia equidistanti sia dal capitalismo che dal comunismo. Ostile comunque alla Gran Bretagna, il gruppo entra in contatto con l’Asse (1940) e affianca al movimento di base un’organizzazione terroristica segreta – tra le vittime anche primi ministri egiziani nel 1945 e nel 1948 – che causa però l’eliminazione diretta dello stesso al-Banna, nel 1949, ad opera di agenti speciali egiziani. Pur avendo contribuito alla caduta di re Faruk nel 1952, le spiccate concezioni teocratiche portano il gruppo ad entrare in aperto contrasto con il nazionalismo laico di Nasser e dopo gli attentati falliti nei suoi confronti (1954 e 1966) l’organizzazione viene dichiarata fuori legge56. Accusati dell’assassinio del presidente Sadat nel 1981 – i Fratelli operano clandestinamente in Egitto e in Siria – vengono duramente repressi ed entrano in conflitto, sempre negli anni Ottanta, anche con il leader libico radicale Gheddafi. I gruppi collegati alla Fratellanza Mussulmana, con la comune radice integralista islamica, si diffondono in molti paesi arabi e intensificano gli attentati e le azioni terroristiche anche contro istituzioni e cittadini stranieri (i Fratelli entrano nel parlamento egiziano, nel 2000, ma anche in 55 Per Hasan al-Banna, la creazione del movimento è tesa al rinnovamento popolare – e di dinamica sociale – necessario ad eliminare dall’islam la decadenza che lo opprime per restituirne dignità e identità. 56 Il disaccordo tra Nasser e la Fratellanza, nel più ampio scontro tra nazionalisti e fondamentalisti, nasce in seguito alle diversità di opinioni sul ritiro delle truppe inglesi. Negoziato per il presidente, doveva invece essere affrontato con il ricorso alle armi per i Fratelli Mussulmani. quello giordano e pachistano). Sayyd Qutb, membro ed ideologo della Fratellanza, viene considerato la chiave di volta di una dottrina che vede nel tacito compromesso stipulato tra i poteri locali dei paesi colonizzati e le forze dominanti europee, l’origine del radicalismo islamico contemporaneo (l’opposizione al nemico occidentale non è più ipotizzabile in termini democratici, ma deve essere perseguita con la jihad). Considerato il padre della jihad militante, Qutb (1906-1966) è inizialmente un acceso sostenitore del nazionalismo egiziano per avvicinarsi, solo successivamente, alla religione islamica, intesa come valida alternativa spirituale ai modelli di vita occidentali che l’Egitto inizia – consapevolmente o meno – ad adottare. L’ignoranza religiosa (jahiliyya) – nella sua più ampia accezione del termine – diventa la causa principale della sofferenza dei popoli arabi e l’adesione alla Fratellanza viene vissuta come alternativa politica e sociale al capitalismo e al socialismo reale, considerati inadeguati alla soluzione del problema57. Lo “stato islamico” si raggiunge solo con un impegno individuale – un dovere, per ogni fedele, che non ammette scusanti – e con la piena adesione al messaggio coranico: qualsiasi regime in cui si applichi la legge islamica, è un regime islamico, quale sia la forma e la sua denominazione, e qualsiasi regime in cui non si applichi questa legge non è riconosciuto dall’Islam, anche se è diretto da un collegio religioso mussulmano, o se porta un titolo mussulmano. L’obbedienza dei soggetti è condizionata e limitata esclusivamente dal compimento o non dal compimento della legge islamica da parte di colui che comanda. Non vi è altra condizione che l’equità nell’esercizio del governo e nell’obbedienza a Dio. Inoltre, la guida suprema di questo modello ideale deve essere un leader carismatico che gode di speciali predilezioni divine (amir) e che si avvale di una consulta di saggi in grado di suggerire pareri – o meglio di suffragare scelte – ogni qualvolta se ne presenti la necessità (shura, principio della consultazione). L’ideologia nazionalista non è più quindi sufficiente a soddisfare l’esigenza di giustizia sociale che le popolazioni arabe invocano, e solo l’organizzazione islamica – differente nei suoi fondamenti da tutte le altre – è in grado di salvaguardare il supremo bene religioso trasmesso alla comunità: si basa sul fatto che la hakimiyya [la sovranità] appartiene solo ad Allah. Egli solo fa le leggi. Tutti gli altri ordinamenti politici sono fondati sul principio di una sovranità esercitata dall’uomo che può legiferare. Tali fondamenti sono opposti tra loro e non possono quindi essere equiparati. Infatti, l’ordinamento islamico non ha nulla di simile con nessun altro ordinamento e lo si può definire solo attraverso la sua particolare qualità di ordinamento islamico. Non è compito del ricercatore, nel momento in cui presenta l’organizzazione islamica, avvicinarla o paragonarla a qualsiasi altro ordinamento, sia del passato, sia del presente. Il tentativo di trovare delle somiglianze o di stabilire dei paragoni – oltre al fatto di essere superficiali e parziali – o di stabilire delle identità solo per alcuni elementi e non sull’essenza dell’ordinamento globale, non rafforzano in alcunché l’islam. Il vero modo di presentare le cose consiste nel rendere conto dei fondamenti della religione nella loro essenza, con la piena convinzione che tali fondamenti sono perfetti, che si accordino o no con le altre organizzazioni politiche. Il solo tentativo di difendere l’ordinamento islamico attraverso la sua somiglianza agli altri ordinamenti testimonia un senso di fragilità. Un ricercatore deve conoscere la religione per quello che è e basare le sue ricerche alla luce delle sue verità interne. La verità assoluta appartiene solo a Dio – custodita segretamente nella sua mente – e le teorie 57 Durante la permanenza in prigione, dal 1954 al 1964, compone un poderoso commentario del Corano (“All’ombra del Corano”), la cui sintesi viene proposta con il titolo di “Pietre miliari”, che si afferma rapidamente come il breviario dell’islam radicale rivoluzionario. Arrestato nuovamente per il complotto contro Nasser, viene condannato a morte nel 1966. scientifiche si basano solo su congetture, ipotesi e calcoli approssimativi, dato che l’uomo conosce solo quel minimo sufficiente per vivere sulla terra, avendolo Dio liberato dal pesante compito di creare leggi incerte. Il mondo si divide in due tipi di società, quella islamica e quella jahilita (il termine jahiliyya indica il periodo di ignoranza dominato dalle forze del male prima della rivelazione divina concessa al Profeta). Il mondo moderno è jahilita, comprese le comunità mussulmane dirette da falsi governi islamici: “la comunità mussulmana è già da tempo scomparsa dall’esistenza, è andata in frantumi sotto il peso di quelle false leggi e usanze che non hanno alcuna relazione, neanche remota, con gli insegnamenti islamici”. Il compito di promuovere la resurrezione della comunità spetta all’avanguardia militante, pronta a mettersi in marcia proprio nel cuore della jahiliyya per “iniziare il movimento di rinascita in qualche paese mussulmano”, esempio significativo del futuro dominio dell’islam sul mondo. Questa è la grande opportunità per l’avanguardia della fede (militanti e combattenti), ovvero quella minoranza virtuosa che – maturato il sapere religioso – combatte per i diritti di Allah sulla terra. La base teorica per una collocazione contemporanea della dottrina classica della jihad – compresa l’elaborazione dottrinale del pensiero militare mussulmano sulla guerra – trova quindi il suo fondamento e tenta di elaborare la sua piena legittimazione non solo come strategia unica del movimento, ma anche in qualità di esclusiva arma politica in grado di combattere il governo infedele e risolvere compiutamente la ricostruzione dell’ortodossia istituzionale. E’ ancora necessario risolvere però la degenerazione islamica (la mentalità mussulmana è asservita al liberalismo occidentale) con la “guerra santa contro rinnegati ed apostati”58 diretta contro i governi mussulmani che hanno tradito i principi della legge islamica. La guerra, compreso il suo drammatico peso costituito da morti, feriti e prigionieri, non deve destare preoccupazione perché “non si avranno mai delle perdite umane nei ranghi dei mussulmani sinceri, poiché i martiri della fede non muoiono, ma dimorano nella comunità e nell’esercito mussulmano e hanno su di essi un’influenza permanente”. Il partito combattente concepito da Sayyd Qutb risponde quindi pienamente al fallimento dell’atteggiamento moderato assunto dai sostenitori della “grande jihad”, ovvero la risoluzione pacifica della crisi dei valori dell’islam – obiettivo considerato irraggiungibile dal radicalismo – per porsi come unico elemento qualificato per operare il cambiamento della popolazione araba. Il calcolo di Mubarak sembra essere semplice e pragmatico. Pressato da Washington, agli inizi del 2005 annuncia la “Primavera del Cairo”, ovvero le elezioni presidenziali a suffragio diretto e la scarcerazione del maggiore dissidente laico, Ayman Nour, a capo del partito filo-liberale al-Ghad (“il Domani”) che si era visto privare, nel giro di mezz’ora, della sua immunità parlamentare con l’accusa di aver falsificato cinquanta firme per una richiesta ufficiale di riforme sociali. Ma quando i Fratelli Mussulmani scendono in piazza, Mubarak adotta la linea dura per dimostrare a Washington che – pur avendo effettuato le concessioni politiche richieste – la Fratellanza rimane un pericoloso focolaio di proteste e di disordini, quindi deve essere considerata motivo di seria preoccupazione anche da parte della Casa Bianca. In realtà il presidente conosce bene i suoi alleati americani e non dimentica di ricordare loro quello che è avvenuto in Algeria nel 1991 – quando il “Fronte di Salvezza Islamico” vinse le elezioni con una maggioranza importante ed i militari furono costretti a sospendere il voto, iniziando una drammatica stagione di repressioni e di stragi da entrambe le parti – e pertanto il messaggio arriva 58 L’apostasia è considerata un reato particolarmente grave, che prevede la perdita di tutti i diritti, compreso quello alla vita, e la dannazione eterna. “come può mai Iddio guidare degli uomini che hanno respinto la Fede dopo averla accettata […] la loro ricompensa sarà che essi si trarranno addosso la maledizione di Dio, e degli angeli e degli uomini in genere”. Corano, 3: 86-89. forte e chiaro: attenzione, se si vota vincono i fondamentalisti. L’amministrazione di Washington non rimane certo insensibile a questo campanello di allarme e quando la stessa Condoleezza Rice si recherà al Cairo nel gennaio del 2007 per incontrare il ministro degli Esteri egiziano, Ahmed Aboul Gheit, non farà più riferimento al rafforzamento dello stato di diritto, ma si limiterà a lodare il contributo offerto dall’Egitto alla politica estera americana in Medio Oriente. Mubarak ha scoperto le sue carte: la partita democratica è cautamente iniziata, ma le forze fondamentaliste – specialmente quelle che ambiscono ad una dittatura religiosa – devono rimanere fuori. E quando l’importante giornale saudita «Arab News» – per voce del suo direttore, l’analista politico Khaled al-Maeena – invita l’Egitto a dare una possibilità democratica ai Fratelli Mussulmani (“sono cambiati molto rispetto al passato […] oggi sono percepiti come l’unica forza che combatte la corruzione e la povertà e che si oppone all’ingerenza straniera […] dovrebbero essere messi alla prova”) a Mubarak viene offerto un ulteriore sostegno politico alla sua tesi: non sono forse i Fratelli attirati proprio nella sfera ideologica del wahabismo? Ed un appoggio politico fornito dall’Arabia Saudita non è a sua volta una forma di ingerenza sospetta in uno stato sovrano che cerca in tutti i modi di combattere il terrorismo islamico in nome di un secolarismo ormai consolidato nel tempo? Ma Mubarak deve far fronte anche ad un’altra minaccia, per certi aspetti ancora più difficile da gestire: nel 2005 si verificano cambiamenti importanti nelle società dei paesi arabi. Le emittenti televisive trasmettono le elezioni politiche in Afghanistan ed in Iraq, in Marocco ed in Giordania vengono applicate le quote di presenze femminili e le donne del Kuwait protestano per il diritto al voto. Il successo ottenuto dal nuovo partito politico guidato dal giovane avvocato Ayman Nour – borghese, liberale e laico – sembra porsi come una seria alternativa al Partito Nazionale Democratico, la formazione politica del presidente. In pratica, Mubarak vede minare le basi del suo stesso potere e la sua tesi (“o noi o gli integralisti islamici”) viene percepita adesso come una sorta di ricatto politico. Le Forze Armate gli sono fedeli, l’intelligence è sotto stretto controllo, le minacce esterne non costituiscono certo un problema, e quindi Mubarak deve giocare la sua partita sul piano politicocostituzionale. Anche se è alla guida del paese dal 1981, il presidente vuole ottenere il suo quinto mandato consecutivo, pur avendo raggiunto la ragguardevole età di settantasette anni ed uno stato di salute che desta forte preoccupazione tra i suoi collaboratori e gravi perplessità tra gli osservatori occidentali. Per la prima volta nella storia della Repubblica Araba di Egitto, Mubarak è il primo presidente che non ha nominato un suo vice, con il rischio di creare un vuoto di potere in caso di scomparsa o di inabilità (l’Egitto ha sempre avuto una sorta di successione automatica tra il presidente ed il suo vice) e questa situazione crea una sicura diffidenza tra i diplomatici e gli analisti stranieri. Il presidente della Repubblica, in base all’articolo 76 della Costituzione, viene eletto con una procedura piuttosto insolita. Il parlamento viene chiamato a scegliere, con maggioranza assoluta, un unico candidato da sottoporre al giudizio popolare per la nomina definitiva e per la durata in carica di sei anni. L’elettorato attivo può solamente esprimere un voto favorevole o contrario, anche se si è sempre ottenuto un consenso plebiscitario. Ed in questo caso, con circa il 90% dei seggi in parlamento del Partito Nazionale Democratico, non si ravvisano certo segni di preoccupazione e Mubarak può permettersi il lusso di conquistare la rielezione sfidando anche altri candidati. Il presidente accetta che possa presentarsi al giudizio degli elettori qualunque candidato che venga sostenuto da almeno il 10% del parlamento (emendamento costituzionale approvato con referendum il 26 maggio 2005). Ed è così che, solamente sotto un profilo strettamente formale, inizia la prima competizione per le elezioni presidenziali. Mubarak ottiene l’88,6 % dei consensi (il partito ha messo a disposizione per la campagna elettorale il suo imponente apparato) sugli sfidanti Ayman Nour (7,6 %) e Nomaan Gomaa, capo dello storico partito Wafd. Naturalmente, non mancano le critiche: Nour lamenta la mancanza di pari opportunità e Gomaa chiede la ripetizione del voto affermando di essere stato soggetto a limitazioni di varia natura. Inoltre, non sono pochi gli osservatori internazionali che manifestano grosse perplessità sulla correttezza delle elezioni. Anche se l’affluenza alle urne ha fatto registrare un ridotto 23 % (hanno votato 7 milioni di egiziani su 32 aventi diritto) rimane indiscussa la volontà del popolo egiziano di affidarsi ad un capo carismatico – il culto della personalità è un tratto caratterizzante – che sia in grado di guidare il paese con autorità, prestigio e fermezza. In ogni caso, la prima manifestazione di democrazia, anche se in uno stile tutto egiziano, sembra iniziare a fiorire. Secondo la Costituzione del 1971 (articoli 180-183) le Forze Armate egiziane “appartengono” al popolo e sono chiamate a difendere il paese non solo per quanto riguarda il territorio e la sicurezza nazionale, ma anche per proteggere le conquiste socialiste raggiunte dalla società egiziana. Sempre in base alla Costituzione – l’Egitto è una “Repubblica araba con un sistema democratico socialista” – il presidente, eletto con un mandato di sei anni, è anche a capo dell’esecutivo. La difesa della patria è considerata un “sacro dovere” ed il comando delle Forze Armate è affidato al presidente della Repubblica che esercita i pieni poteri con il solo ausilio del “Consiglio di Difesa Nazionale”, il principale organo consultivo in materia di sicurezza nazionale. Anche se istituito dalla stessa Costituzione, in realtà questo Consiglio viene convocato molto raramente, rimanendo di fatto il potere decisionale nelle mani del presidente e del ministro della Difesa. Non a caso, i quattro presidenti della Repubblica – dopo la caduta della monarchia nel 1952 – e più precisamente Naguib, Nasser, Sadat e Mubarak, provengono tutti dalle Forze Armate, considerate dalla stessa opinione pubblica egiziana come la più importante fonte di alimentazione per la classe dirigente del paese. Con un numero di militari attivi vicino al mezzo milione, quello dell’Egitto è considerato il più forte esercito della regione – nel 2005 le spese militari hanno raggiunto il 3,5% del Pil – che pur non essendo membro della Nato, rimane un importante alleato militare e strategico (è l’unica nazione araba a possedere satelliti spia) e la sua leadership sul continente africano gli consente di porsi come interlocutore privilegiato per la fornitura di assistenza ed addestramento anche in altri paesi. Con la leva obbligatoria al diciottesimo anno di età e per la durata di tre anni, ogni anno i giovani che raggiungono l’età per il servizio militare sono quasi un milione e la disponibilità annuale sfiora la ragguardevole cifra di venti milioni di adulti tra i diciotto ed i quarantanove anni. In virtù dell’importante ruolo esercitato dal presidente della Repubblica – anche il controllo sul ministero della Produzione Bellica e sul Consiglio Nazionale per gli Approvvigionamenti Militari – si può oggettivamente parlare di un elevato grado di militarizzazione del paese. Oltre alla struttura di comando al vertice, è di rilevanza strategica anche la “Organizzazione Araba per la Industrializzazione” – un consorzio a forte connotazione egiziana – che attraverso la progettazione e la fabbricazione di sistemi per la difesa, ha come obiettivo dichiarato l’autonomia operativa dall’Occidente. Inoltre, l’Egitto è uno dei più grandi produttori di armi. Secondo alcuni esperti occidentali, nella località di Leopolis, nelle vicinanze dell’aeroporto internazionale del Cairo, esiste una struttura di produzione militare (dalle bombe a mano ai carri armati, sino ai missili di media gittata) considerata una delle più grandi al mondo, per dimensioni e tipologia diversificata di produzione bellica. Quindi una politica militare di alto profilo che tende a premiare le aspirazioni della dirigenza egiziana (la leadership nel mondo arabo) attraverso il ruolo delle Forze Armate, non solo un efficace mezzo di politica interna, ma innanzitutto il più potente strumento di politica internazionale del paese. Al ministero degli Interni risponde la prima delle forze speciali creata negli anni Ottanta per la lotta al terrorismo, la Hostage Rescue Force con base nel sud del Cairo e con circa cento uomini addestrati per il contrasto alle attività terroristiche urbane in collaborazione con la polizia metropolitana. La seconda squadra – le informazioni al riguardo sono molto ridotte – è denominata “Unità 333” e dovrebbe contare su cinquanta uomini alle dipendenze dirette dell’esercito. La terza “Unità 777” (conosciuta anche come Al-Sa’iqa o Forza Thunderbolt) è considerata quella più importante. Addestrata dagli Stati Uniti sin dal 1981, questo reparto aviotrasportato è composto da circa trecento uomini ed ha raggiunto solo negli ultimi tempi livelli qualitativi di un certo rilievo. Posto oggi sotto il comando dell’esercito (Army Command) ed allenato periodicamente insieme alla Delta Force, sembra che abbia compiuto sconfinamenti illegittimi per la cattura di elementi estremistici della Fratellanza Mussulmana. L’attività di intelligence è organizzata in tre settori principali che rispondono al nome dei “Servizi di Sicurezza Generale” (con riporto diretto alla presidenza della Repubblica), dei “Servizi Segreti” (alle dipendenze del ministero della Difesa) e della “Direzione Generale per le Indagini di Sicurezza” (Gdssi, sotto il controllo diretto del ministero degli Interni e responsabile, con un’attività spesso considerata troppo intransigente, della complessa ed articolata sicurezza nazionale). Dopo il pugno di ferro voluto da Nasser – ventimila prigionieri politici, controllo sulle riunioni politiche ed anche sulle discussioni pubbliche – la Gdssi è rimasta screditata dall’assassinio del presidente Sadat (con le accuse di incapacità o complicità indiretta) per riacquistare prestigio e reputazione solo con l’avvento di Mubarak. Incaricata della sorveglianza dei rappresentanti dell’opposizione, dei giornalisti, dei diplomatici stranieri e degli attivisti politici sospettati di attività sovversive, nel 1986 questa unità è stata accusata di torture ai danni degli estremisti islamici catturati e quaranta ufficiali sono stati sono stati rinviati a giudizio per quattrocentoventidue accuse di torture ai danni dei membri dell’associazione terroristica al-Jihad. Dopo due anni di indagini, il tribunale del Cairo ha assolto tutti gli imputati, ma pur riconoscendo l’effettivo utilizzo di pratiche inumane, non è stato in grado (o non ha ritenuto opportuno) di ricondurre la responsabilità diretta delle efferatezze agli ufficiali incriminati. In ogni caso, la Gdssi è l’unico organismo autorizzato alla lotta contro la sovversione politica e la sua organizzazione sembra essere ben infiltrata nei partiti politici, nei mezzi di informazione, nei sindacati, nelle aziende pubbliche ed addirittura negli apparati governativi. Ma chi sono i veri nemici delle istituzioni pubbliche egiziane? La al-Jihad (“guerra santa”) è un’organizzazione di militanti islamici che si sono separati negli anni Settanta dalla Fratellanza Mussulmana (contestando il rifiuto dell’uso della violenza) per dare vita ad una attività armata contro la minoranza copta in particolare e le istituzioni governative in generale (durante la presidenza Sadat). Al di là della capacità di organizzare attentati sanguinari e complotti antigovernativi, la sua pericolosità è costituita essenzialmente dalla capacità di fare proseliti tra le file dei militari egiziani. Fortemente ostacolati dall’intelligence e dalle forze speciali (i leader storici sono stati quasi tutti arrestati) i nuovi membri di ultima generazione della “guerra santa” hanno dato vita sin dai primi anni Novanta ad una nuova formazione denominata “Avanguardia dei Conquistatori”, considerata la frangia più determinata ed intransigente dell’intera organizzazione. Il “Gruppo Islamico” nasce invece dal movimento studentesco egiziano, anch’esso separatosi dalla Fratellanza Mussulmana alla fine degli anni Settanta. Dopo un’alleanza politica con la “guerra santa” (il nemico comune è il governo) durata sino alla metà degli anni Ottanta, gli “studenti” del Gruppo Islamico hanno iniziato la loro attività di capillare proselitismo nelle classi più povere della capitale e nei villaggi rurali dell’Egitto meridionale, diventando presto il punto di riferimento, militare ed organizzativo, di una trentina di organizzazioni islamiche minori sparse sul territorio. Sulla base di questa nuova forza, il Gruppo Islamico si è dimostrato particolarmente aggressivo e pericoloso, suscitando una dura azione repressiva da parte del governo, con l’eliminazione fisica di molti dei suoi membri più importanti. In particolare, sembra che l’attentato di Luxor del 1997, dove hanno perso la vita cinquantotto turisti stranieri, sia stato organizzato da militanti del Gruppo addestrati in Afghanistan con la collaborazione delle forze talebane. Anche se nel 1977, subito dopo la strage, sei leader storici del movimento – incarcerati al Cairo – hanno lanciato l’appello per un cessate il fuoco unilaterale (rifiutato anche da Mubarak) la nuova dirigenza si è dissociata dalla dichiarazione di politica sociale ed ha cercato di ricompattare i gruppi di guerriglieri per riprendere la lotta armata. Un altro movimento estremista è quello della “Rivoluzione Egiziana”, non legato alla Fratellanza Mussulmana ma finanziato da Khaled Abdel Nasser, il figlio dell’ex presidente. Pur essendosi reso responsabile dell’omicidio di due cittadini israeliani (1985) e di due ufficiali americani (1987), questo movimento non sembra avere molto seguito tra la popolazione per via della totale assenza di una matrice ideologica, sia essa politica che religiosa. L’arresto dei suoi membri più significativi è avvenuto alla fine degli anni Ottanta – con particolare enfasi da parte dei mezzi di comunicazione – e sembra che le relative condanne abbiano seriamente incrinato la forza e la pericolosità dell’intera organizzazione. La Fratellanza Mussulmana – che si presenta adesso sulla scena politica del paese con un nuovo passaporto ideologico – sembra aver consolidato la sua posizione di rifiuto a porsi come entità di interposizione tra il popolo ed il potere, nella convinzione di poter costituire un valido strumento per il raggiungimento di uno stato islamico. Ma il rafforzarsi delle posizioni geopolitiche e strategiche degli stati teocratici (Iran e Sudan) e la indisponibilità di Mubarak a qualunque tipo di trattativa, sembrano aver indotto i Fratelli Mussulmani a ricercare con maggiore determinazione la loro specificità culturale e religiosa. Anche se la Fratellanza Mussulmana mantiene il controllo delle organizzazioni professionali e sindacali del paese e può contare sull’appoggio dell’establishment finanziario e commerciale – è percepita come una associazione segreta, borghese ed esclusiva – questo movimento rimane l’unico in grado di poter catalizzare le sfide islamiche che provengono dalle regioni meridionali, lì dove le arretrate condizioni economiche e culturali favoriscono il terreno migliore per le inclinazioni integraliste. In ogni caso, l’opinione pubblica egiziana ritiene – al di là delle specifiche politiche – che la Costituzione del 1971 sia stata modificata sin troppe volte, e solo per essere sottomessa agli interessi del presidente e del suo regime. Di fatto, l’appello di Ayman al-Zawahiri lanciato nei primi mesi del 2006 (“portiamo la jihad in Africa”) è stato subito raccolto dal “Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento”, che dopo aver fatto giuramento di sottomissione ad Al Qaeda – secondo fonti di intelligence francesi e spagnole – ha raccolto sulle montagne algerine i militanti islamici armati per creare una vera e propria piattaforma logistica. L’obiettivo è quello di addestrare gli uomini e di esportare la lotta nei paesi dell’Africa del Nord (e l’Egitto è considerato “eccessivamente” laico) in ossequio alle direttive dell’ideologo Abu Azam alAnsari: “l’Africa è una miniera d’oro per la jihad […] la vicinanza all’Europa ci permette di spostarci rapidamente per attaccare gli infedeli”. L’unico appello per fermare la violenza di al-Qaeda – inascoltato – viene lanciato dal fondatore della jihad egiziana, Imam Abdul Aziz al-Sharif e dal fratello del numero due di al-Qaeda, Mohammed al-Zawahiri, entrambi detenuti nelle prigioni del Cairo. Già durante le elezioni presidenziali del 2005, Mubarak decide di affidare al figlio Gamal il processo di innovazione democratica del Paese, affidandogli al tempo stesso – una sorta di prova generale – il delicato compito di organizzare e condurre la prima campagna elettorale a suffragio diretto. Diventato in poco tempo la principale personalità in campo politico, Gamal Mubarak gode di un ampio consenso popolare (figlio secondogenito del presidente ma anche il prediletto della consorte Suzanne, il giovane erede non ha ancora raggiunto il quarantacinquesimo anno di età ed ha una passione sfrenata per le auto veloci e gli abiti di lusso) e dopo un master in “Amministrazione di Impresa”, conseguito all’università americana del Cairo, ed un lavoro presso la Bank of America (il Cairo e Londra), Gamal fonda la società di investimenti «Medinvest» ed arriva a controllare un patrimonio stimato in 100 milioni di dollari. Dopo la vittoriosa elezione del padre nel 2005, Gamal Mubarak viene nominato vice segretario generale del Partito Nazionale Democratico e con l’aiuto di giovani tecnocrati inizia la modernizzazione delle strutture economiche e finanziarie del paese, considerate cristallizzate sin dai tempi di Sadat. Nonostante il presidente Mubarak abbia continuato negli anni a consolidare la sua alleanza con Washington (in trent’anni gli Stati Uniti hanno elargito, sotto varie forme, oltre 60 miliardi di dollari) il giovane Gamal sembra assumere un atteggiamento politico più attento agli interessi del paese che non alla collaborazione storica con il Dipartimento di Stato americano. Agli inizi del 2006 si fidanza con la figlia di el-Gammal – una potente famiglia di costruttori – e poiché il nome della giovane donna è Khadija, come quello della prima moglie di Maometto, i Fratelli Mussulmani leggono nella scelta della futura moglie un rispettoso omaggio alla tradizione mussulmana ed iniziano a vedere nell’erede un nuovo e possibile alleato. Il 19 settembre del 2006, in una dichiarazione ufficiale, Gamal Mubarak critica apertamente la politica americana in Medio Oriente ed annuncia – a sorpresa – la sua intenzione di verificare attentamente l’ipotesi della opzione nucleare. In realtà, l’Egitto possiede un vecchio progetto che ha interrotto nel 1986 dopo la disastrosa sciagura di Chernobyl, bloccando i lavori della centrale atomica di el-Dabaa (Alessandria) e le sperimentazioni del “Centro Nazionale di Ricerche Atomiche” (il Cairo) che avevano portato il paese al livello più alto nel mondo arabo, destando forti preoccupazioni nello stato di Israele. Nel marzo del 2007, un documentario trasmesso dalla televisione israeliana sulla guerra dei Sei Giorni (dal 5 al 10 giugno del 1967, combattuta tra Israele ed un’alleanza di paesi arabi, Egitto, Siria, Giordania e Iraq, scoppiata a causa del blocco imposto dall’Egitto alle navi israeliane nel Golfo di Aqaba) viene interpretato dall’Egitto come una ammissione di colpa nella strage di centinaia di prigionieri di guerra. Nonostante le smentite del regista, Ron Edelist (si trattava di una squadra di terroristi palestinesi inquadrati nelle Forze Armate egiziane durante un regolare scontro a fuoco) l’allora comandante dell’unità speciale Shaker (“Mandorla”) viene accusato di strage dalla stampa egiziana: “quarant’anni fa ha ordinato l’eccidio di 250 prigioni di guerra, ha le mani sporche del nostro sangue”. Il comandante dell’unità, dal 1967 al 1970, è Binyamin Ben-Eliezer – l’ex ministro della Difesa di Tel Aviv ed oggi ministro delle Infrastrutture, un generale di origine irachene che parla perfettamente l’arabo e che viene tenuto in grande considerazione dal presidente egiziano e dal capo dell’intelligence del Cairo. Ma il risentimento della popolazione egiziana viene subito cavalcato dai media e dai parlamentari della Fratellanza Mussulmana: i primi inducono il ministro degli Esteri egiziano a convocare l’ambasciatore israeliano, Shalom Cohen, ed i secondi minacciano di “sgozzarlo nel cortile se prova a mettere piede qui da noi”. E si spingono anche oltre, arrivando a chiedere il ritiro dell’ambasciatore egiziano da Tel Aviv, il blocco degli accordi di Camp David, l’interruzione delle intese per la cooperazione economica ed attraverso la voce di Salama al-Ruqi – parlamentare indipendente del Sinai – anche l’uso delle armi: “l’unico modo per risolvere la situazione è dichiarare lo stato di guerra!”. Al ministro Ben-Eliezer, che ha programmato una visita al Cairo per discutere le importazione di gas naturale, non rimane che cancellare l’incontro. Anche se la guerra dei Sei Giorni ha registrato la perdita di ventunomila soldati dell’alleanza araba, di quarantacinquemila feriti e di seimila prigionieri (contro settecentosettantanove soldati israeliani caduti, oltre duemila feriti e quindici prigionieri) il presidente Mubarak cerca di spegnere l’incendio e sicuramente non dimentica che le esportazioni israeliane verso l’Egitto hanno raggiunto nel 2006 i 126 milioni di dollari americani (contro i 29 del 2004) e che l’Egitto ha venduto ad Israele beni per 77 milioni, rispetto ai 29 realizzati nel 2004. E quindi, se non si può ritenere legittima la preoccupazione costituita dallo stato di Israele – il suo valore del nucleare è solo quello di una deterrenza finale – è più accreditabile l’ipotesi che l’ostinata determinazione dell’Iran a costruire un arsenale atomico condizioni pesantemente, in chiave antisciita, i governi della regione. La popolazione dell’area è quasi totalmente sunnita ed il timore della crescita militare e dell’invadenza regionale dell’Iran sciita spinge questi paesi ad un istintivo meccanismo di difesa: l’Algeria ha annunciato di voler riprendere il suo programma avviato nel 1985 e poi interrotto, la Libia ha svelato di voler riprendere il programma iniziato segretamente e persino il Marocco ha avviato trattative con società americane per la costruzione di moderni reattori nucleari. L’Arabia Saudita, la Giordania, gli Emirati Arabi ed il Kuwait, a causa dell’alleanza strategica con gli Stati Uniti, hanno già formalizzato la richiesta al direttore della Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, l’egiziano Mohammed el-Baradei (per il ministro degli Esteri saudita, Saud alFaisal, questo percorso deve avanzare “in maniera aperta, legale ed ufficiale”). Lo Yemen, l’Oman ed il Bahrein sono semplicemente in lista di attesa, così come lo sono la Turchia e la Siria del giovane Bashar Assad. Quindi Gamal Mubarak non solo prende le distanze dal nazionalismo (laico ed autoritario) del padre, ma alza il tiro e sembra pronto anche ad irritare l’alleato americano pur di strappare un applauso agli islamisti del Cairo. Gli analisti ritengono che verranno costruiti, nonostante le pressioni contrarie degli Stati Uniti, dai tre ai dieci reattori nucleari. La tesi ufficiale è quella di una scelta per la ricerca e lo sviluppo di una fonte di energia civile (quelle alternative richiederebbero quasi cinquant’anni di tempo) per soddisfare le necessità del paese. Come già esaminato, il presidente Mubarak non ha mai nominato un suo vice (per molti analisti un precedente pericoloso) e quindi non è praticabile al momento alcuna successione automatica. Ed anche se l’opinione pubblica egiziana non ha gradito il modello siriano (Bashar Assad ha preso il posto del padre Hafez e l’Egitto non è una monarchia ma una repubblica) il giovane Gamal sembra essere l’unica figura di prestigio in grado di raggiungere la massima carica del paese. Il vero problema consiste nel fatto che Gamal Mubarak non è un militare. Tutti i presidenti della Repubblica Araba d’Egitto provengono dalle Forze Armate e forse il paese non è realmente pronto a vedere per la prima volta un civile a capo dello stato. Con riferimento alle considerazioni svolte sull’importanza che ricopre l’esercito come elemento determinante per la formazione della classe dirigente, è possibile ipotizzare che le scelte di Mubarak (l’assenza di un vice e l’inizio delle riforme costituzionali) preludano in realtà all’avvio di una strada maestra per la successione del figlio. Anche se al momento il giovane Gamal è considerato il vero leader politico del paese, esiste in effetti un candidato ideale che risponde al nome di Omar Suleiman, il capo dei servizi segreti egiziani. Una figura autorevole che gode di prestigio nel mondo arabo e di simpatie dell’Occidente – oltre ad un largo consenso all’interno del paese – mutuato dai complessi negoziati condotti con particolare abilità con i gruppi armati palestinesi nel difficile percorso di pace con lo stato di Israele. Nella primavera del 2007 il parlamento egiziano – dove il partito del presidente Mubarak domina incontrastato – approva con trecentoquindici voti favorevoli e centotrentaquattro contrari, ben trentaquattro emendamenti alla Costituzione presentati dal governo ed ispirati ad una “profonda riforma democratica”. Gli emendamenti, aspramente criticati dall’opposizione e dalle organizzazioni per i diritti umani, vengono sottoposti al popolo egiziano per il voto referendario (anche in questo caso è possibile solo accettarli o respingerli in blocco) in data 26 marzo 2007. Il giorno prima della votazione si registrano numerosi incidenti durante le manifestazioni di protesta e solo un massiccio intervento della polizia, con numerose cariche e l’arresto di centinaia di manifestanti, riesce a riportare l’ordine nelle piazze del Cairo. In una sorta di limbo mediatico – con poca risonanza sulla stampa europea e quasi nessuna su quella americana – il presidente Mubarak ha oggettivamente posto il sigillo della dittatura militare sul paese ed ha inflitto un duro colpo alle libertà civili ed ai diritti umani. Gli emendamenti all’articolo 179 della Costituzione (“stato di polizia”) prevedono la formalizzazione – in legge costituzionale – delle leggi speciali introdotte durante il regime Sadat ed inasprite subito dopo il suo assassinio, anche se l’opinione pubblica egiziana sperava di vederle attutite, se non addirittura abrogate, sin dalla loro istituzione nel lontano 1981, ovvero quelle leggi di emergenza e “transitorie” che hanno da sempre accompagnato la presidenza Mubarak. Ogni cittadino può essere arrestato e detenuto senza limiti di tempo, ed anche processato dai tribunali militari, così come la polizia viene autorizzata ad effettuare perquisizioni ed intercettazioni senza mandato della magistratura nelle inchieste contro il terrorismo. Le comunicazioni (dal telefono alla posta, ma anche telematiche) non costituiscono più un diritto inviolabile, così come le abitazioni private e la privacy personale: in nome della lotta al terrorismo si giustifica la soppressione dei diritti dei cittadini e per Amnesty International si tratta del “peggior colpo ai diritti umani” che sia mai stato vibrato in Egitto dalle leggi speciali del 1981. L’articolo 5 vieta di creare partiti politici con base o orientamento religioso e l’articolo 62 chiude definitivamente la strada alla Fratellanza Mussulmana: nessun indipendente può candidarsi alle elezioni, dopo che i Fratelli – proprio da indipendenti – erano riusciti a conquistare un quinto dei seggi nelle legislative del 2005, e quindi a costituirsi come unica forza di opposizione organizzata. Le reazioni del leader Essam al-Aryan sembrano trovare fondamento: è iniziata la trasformazione della repubblica in monarchia di fatto e gli emendamenti preparano la strada per il figlio del presidente Mubarak. Vittima dell’articolo 88 è invece la magistratura, secondo alcuni analisti responsabile di aver sfidato apertamente le Forze di Sicurezza che impedivano agli elettori (anche con le armi) di votare in seggi elettorali dove il Partito Nazionale Democratico risultava particolarmente debole. Dopo essersi anche opposta ai brogli delle elezioni del 2005, la magistratura si vede estromessa dalla responsabilità (e dalla garanzia) sulla correttezza del voto ed al suo posto viene istituita una commissione governativa “indipendente” per monitorare la validità delle votazioni. Per Nassar Amin, il direttore del Centro Arabo per l’Indipendenza dei Magistrati, questo è il “colpo finale alla nostra democrazia”. Per tutta l’opposizione – da quella islamica a quella laica – la revisione della Costituzione è in realtà un vero e proprio colpo di stato (“la morte di ogni libertà personale”) ed oltre cento parlamentari lasciano l’aula per organizzare un sit-in di protesta: “vogliamo avere la coscienza pulita, che sia il solo Pnd a rispondere di questa vergogna davanti al popolo”. La televisione di stato, che trasmette abitualmente tutte le sezioni di lavoro, evita di mostrare i seggi vuoti del parlamento. Ma il giorno del referendum popolare si avvicina (26 marzo 2007) e per le strade del Cairo sono numerosi i camioncini che girano con l’imponente fotografia del presidente Mubarak che, via megafono, impartisce il suo suggerimento alla popolazione: “Votate sì, per il bene dei vostri figli e il vostro futuro”. Ma per chi riesce ad evitarli, ci pensa la televisione di stato a diffondere con metodicità il messaggio del raìs: si tratta di riforme democratiche che incoraggiano l’attività dei partiti, che pongono fine allo sfruttamento della religione, a comportamenti illeciti e proteggono la patria dal terrorismo. L’opposizione riesce a far sentire la sua voce solo con comizi ed appelli pubblici (molto di più possono gli sms sui telefoni cellulari) e l’invito è quello di boicottare il referendum, anche se il prezzo da pagare è l’arresto di sei membri di al-Ghad, nei loro uffici, e di tredici attivisti durante l’organizzazione di una protesta popolare. Nel giorno del referendum il governo ha dato disposizione di trasportare i dipendenti pubblici alle urne e centinaia di pullman li hanno prelevati dalle aziende tessili del delta del Nilo, sino ai più remoti impianti petroliferi di Suez. E con il 20% dell’affluenza popolare (meno del 5% per gli osservatori indipendenti) ed il 75,9% dei consensi, le riforme di Mubarak si impongono nella vita politica e sociale del paese. Le accuse di un referendum truccato sono numerose, e tra queste l’autorevole voce del Consiglio Nazionale per i Diritti Umani, una organizzazione riconosciuta dallo stato e diretta da Boutros Ghali, l’ex Segretario generale delle Nazioni Unite: i dipendenti pubblici sono stati costretti a votare, i registri nei seggi elettorali non sono accurati, ad alcuni osservatori è stato impedito di avvicinarsi ai seggi ed un certo numero di responsabili del voto ha compilato personalmente molte schede. Accuse gravi che si uniscono al coro delle proteste del Circolo dei Giudici, del movimento Kifaya, dell’ex premier Aziz Sedqui, del poeta dissidente Ahmad Negm e, naturalmente, dei Fratelli Mussulmani. L’importante ed autoritaria riforma costituzionale di Hosni Mubarak, oltre ad aggravare la già precaria condizione dei diritti umani, di fatto legalizza la difficile situazione in cui si trovano migliaia di detenuti politici nelle prigioni egiziane. Oltre alla denuncia di Human Rights Watch (l’arresto di Muhammad al-Sharqawi, un blogger di venticinque anni arrestato, torturato e sodomizzato dalla polizia di stato), quella di Amnesty International (aprile 2007) è particolarmente dura: l’Egitto è il centro internazionale della tortura – anche per conto di altri stati – ed il teatro di sistematiche violazioni in nome della sicurezza nazionale, ed i detenuti, contro i quali non è stata nemmeno formulata un’accusa precisa, ammontano a diciottomila e sono sepolti in prigione da più di dieci anni. Il governo ha immediatamente respinto tutte le accuse, dichiarandosi “profondamente offeso”, ed ha confermato che sul fronte dei diritti umani il paese sta compiendo “reali e continui progressi”. Ma il giorno prima del rapporto ufficiale di Amnesty International dieci membri dei Fratelli Mussulmani vengono arrestati senza apparenti motivi (Mubarak ha oggi un formidabile alibi per mettere gli avversari politici fuori gioco). Per molti osservatori, questa intransigenza – al di là dell’opportunità politica – non costituisce effettivamente il cardine di una lotta al terrorismo e la militanza islamica sembra proporsi con la connotazione democratica del consenso popolare. Il timore condiviso da alcuni analisti risiede proprio nella eccessiva preclusione alle vie democratiche, che potrebbe indurre, così come in altre situazioni già accaduto, ad una recrudescenza delle attività terroristiche, alimentando appunto l’ipotesi dell’unica strada percorribile per la determinazione delle proprie specificità religiose. Anche se la stampa internazionale ha dato alla notizia scarso rilievo, un ulteriore emendamento alla Costituzione riserva al primo ministro il diritto di rilevare la carica presidenziale in caso di morte o di inabilità del presidente. Quindi non esiste più l’obbligo di nominare un vice – con i problemi che se sarebbero derivati se la scelta fosse caduta direttamente sul figlio – ma la successione diventa automatica con la seconda carica politica del paese, indipendentemente dall’uniforme e dalla designazione precostituita di un vice presidente. Ma sulla strada del figlio Gamal – ormai lastricata di prestigio politico – manca qualcosa di importante per il più ampio progetto volto a fare di quest’uomo il naturale successore alla presidenza del padre: il matrimonio. Nella cultura egiziana, dove l’età media maschile per l’addio al celibato è intorno ai venticinque anni, una carica di prestigio rimane imprescindibile dal radicato concetto di famiglia, tradizionalmente considerato come segno di maturità personale e di prestigio sociale. Se l’opinione pubblica egiziana non è ancora pronta per un presidente senza le mostrine del comando, non lo è senz’altro per accettare questa carica senza una first lady. Il futuro “erede al trono” decide di prendere moglie il 4 maggio 2007, proprio il giorno del settantanovesimo compleanno del presidente, e subito dopo la fine dei lavori della “Conferenza Internazionale per la Stabilizzazione dell’Iraq”, tenuta a Sharm el-Sheikh, la perla egiziana del Mar Rosso. Anche se il vero contratto matrimoniale era stato già firmato la settimana prima nel Club dell’Aviazione di Heliopolis al Cairo (davanti alla massima autorità del mondo sunnita, il grande imam Mohammed Sayyed al-Tantawi, autore delle critiche più aspre al discorso di Benedetto XVI a Ratisbona, e come testimone dello sposo proprio il capo dell’intelligence, Omar Suleyman) la festosa celebrazione del matrimonio con la bella, giovane e ricca Khadija el-Gammal, avviene nella villa presidenziale di Sharm el-Sheikh, con migliaia di invitati – importanti e segreti – ma sicuramente senza la partecipazione di Condoleezza Rice che riparte subito dopo la conclusione del vertice (tra gli intellettuali del Cairo circola una battuta che riassume l’evento con malcelata ironia: “il regalo di nozze? L’Egitto!”). Ma gli interrogativi degli analisti non sono pochi, e tra i più importanti è legittimo segnalare che presumibilmente Gamal Mubarak non conosce profondamente il suo paese (e questa limitazione è vista come una grave lacuna politica) e che la sua giovane età non gli permetterebbe di comprendere sino in fondo le complesse tradizioni della cultura e della politica egiziana. Ma se ci troviamo realmente di fronte ad una definitiva trasformazione del vecchio regime socialista in un moderno sistema regolato dall’economia di mercato (ma impermeabile alle istanze democratiche) la partita deve ancora essere giocata dai militari. Ed inoltre, con la sua prossima configurazione, l’Egitto è pronto a contrastare le sfide che si stanno minacciosamente addensando, sempre con maggiore frequenza, proprio nell’Africa del Nord? Il drammatico appello lanciato da al-Qaeda non è rimasto inascoltato. Sin dall’inizio del 2007 una serie di sanguinosi attentati ha sconvolto l’intera regione, seminando sulle coste del Mediterraneo morti e feriti tra la popolazione civile. Alle porte di Tunisi (gennaio 2007) si è combattuta una vera e propria battaglia tra la polizia ed una cellula jihadista che stava progettando una serie di attentati contro le ambasciate (Usa e Gb), gli alberghi di lusso ed i siti turistici più importanti. A Casablanca (marzo 2007) tre kamikaze si fanno saltare in aria per sfuggire alla cattura – erano provvisti di cinture esplosive – durante un tentativo di contrasto alle numerose cellule terroristiche clandestine individuate dalla polizia marocchina. Ma l’attentato più grave si registra ad Algeri (aprile 2007) con una spaventosa esplosione causata da un kamikaze in automobile ai danni del palazzo del governo, nel cuore della città, seguita subito dopo da altre due autobomba scagliate contro una caserma della polizia, Bab Ezzouar, lungo la strada che conduce all’aeroporto: 30 morti ed oltre 220 feriti, con il marchio – e la rivendicazione – di al-Qaeda, che usa la nuova sigla di “al-Qaeda nella Terra del Maghreb Islamico”. I media europei e statunitensi – al di là dell’enfasi giornalistica sugli attentati – hanno dedicato poca e scarsa attenzione ai recenti sviluppi del paese, così come le istituzioni democratiche deputate a questo tipo di analisi ed elaborazione degli scenari a breve e medio termine. Il problema del nucleare – o meglio, la sua connotazione strategica – potrebbe infiammare l’orgoglio nazionale egiziano, già messo a dura prova dalla superiorità politica e militare di Israele e dell’Iran, ed anche se il presidente Mubarak si è sempre opposto allo sviluppo delle armi di distruzione di massa, rimane l’interrogativo sull’atteggiamento della nuova dirigenza voluta dal figlio Gamal. Il forte deficit economico raggiunto con gli Stati Uniti potrebbe spingere il Cairo a raccogliere le allettanti offerte che arrivano dalla Russia e dalla Cina e al tempo stesso non è chiaro quale sarà il ruolo della Fratellanza Mussulmana dopo l’estromissione dalla vita politica del paese. Il Dipartimento di stato americano sembra essere distratto da problematiche particolarmente complesse (il pantano iracheno, le difficoltà incontrate in Afghanistan, l’ingerenza della politica iraniana, e la perdurante instabilità in Libano ed in Palestina) che hanno presumibilmente convinto Washington ad elaborare una dottrina fondata su posizioni difensive, lì dove le priorità non sono più costituite dalla diffusione della democrazia nell’area mediorientale, bensì dal consolidamento della stabilità (quella residua) ancora presente nella regione. Il 25 gennaio del 2011 prende il via la rivolta popolare egiziana. Durante la “giornata della collera” – sulla scia di quella che in Tunisia ha portato alla caduta del presidente Zine el-Abidine Ben Ali – si infiammano le piazze delle città del Cairo, di Alessandria, di Suez, di Poro Said e di Assuan. Piazza Tahrir, nel centro della capitale, si riempie di quasi ventimila manifestanti e diventa il luogo simbolo della protesta contro il regime. Gli scontri con le forze di sicurezza sono subito molto violenti e le prime notizie parlano di poliziotti e manifestanti uccisi. Il coprifuoco viene imposto ad Alessandria (dalle ore 23.00 alle 06.00 del mattino) e subito dopo anche nelle altre città, ma i manifestanti lo ignorano e costringono – nonostante un fitto lancio di lacrimogeni e l'impiego di idranti e blindati – le forze di polizia a ritirarsi. Le autorità egiziane intimano ai provider locali di rendere impossibile l'accesso ai social network (Twitter e Facebook), diventati la principale arma degli attivisti per organizzare le proteste. Anche i telefoni cellulari smettono di funzionare in tutta l'area intorno al Cairo e viene oscurato il canale delle notizie di «al-Jazeera» (Mubasher), da sempre in aperto conflitto con il governo egiziano. I manifestanti incendiano la sede del partito di governo, il Partito Nazionale Democratico, e la compagnia di bandiera Egypt Air annuncia la sospensione di tutti i voli, nazionali ed internazionali. Mentre imprenditori e personalità politiche vicini al regime lasciano il paese a bordo di aerei privati, i manifestanti marciano sul ponte Qasr al-Nil e raggiungono piazza Tahrir, dove cercano di assaltare gli uffici della televisione di stato dopo essere riusciti a ribaltare alcuni mezzi della polizia schierati per bloccare il corteo. L'ex capo dell'Agenzia internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), l'egiziano Mohammed elBaradei, arriva al Cairo accolto da una folla di simpatizzanti e dichiara pubblicamente di essere pronto a guidare il delicato processo di transizione del paese (fermato dalla polizia, viene condotto agli arresti domiciliari). Subito dopo la tradizionale preghiera del riposo settimanale islamico, le violenze esplodono con maggiore intensità e centinaia di migliaia di persone marciano compatte verso il palazzo del presidente ad Heliopolis. Nel frattempo, Hosni Mubarack, durante un discorso trasmesso dalla televisione di stato, dichiara che non ha intenzione di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali ed annuncia l'avvio di riforme politiche ed economiche, rimanendo però al potere per gestire personalmente la fase di profonda transizione che intende attuare. Poche ore più tardi, i fedelissimi di Mubarak, a dorso di cavalli e cammelli, irrompono in piazza Tahrir e si scontrano con gli oppositori del governo (l'Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Navi Pillay, riferisce alla stampa che nelle proteste in corso hanno già perso la vita oltre trecento persone). Due milioni di manifestanti invadono il centro del Cairo durante la “domenica dei martiri”, in ricordo delle vittime delle violenze governative, e chiedono l'immediata destituzione del presidente Mubarak. Nel nord della penisola del Sinai, a circa 70 chilometri dalla Striscia di Gaza, esplode il gasdotto che rifornisce Israele e Giordania. Le fiamme vengono domate con la chiusura delle valvole di flusso – non ci sono vittime – e il governatore della regione, Abdel Wahab Mabrouk, avanza l'ipotesi che si tratti di un atto di sabotaggio ad opera di terroristi. L'impianto, che si trova a qualche centinaio di metri dall'aeroporto locale, è già stato oggetto in passato di attacchi mirati: nel 2008 i membri di una tribù beduina della penisola hanno cercato di farlo esplodere in segno di protesta contro il governo egiziano, accusato di una violenta forma di discriminazione nei loro confronti. Il vice presidente, Omar Suleiman, apre il dialogo con tutti i partiti di opposizione e tenta di concordare l'avvio di una serie di riforme istituzionali, proponendo la formazione di due commissioni indipendenti. In risposta, i sindacati proclamano una giornata di sciopero generale ed a Suez incrociano le braccia anche alcuni lavoratori della Compagnia del Canale. Dopo decine di giorni di protesta, il presidente del Partito Nazionale Democratico, Hossan Badrani, e il premier Ahmed Shafiq, annunciano per la prima volta che il presidente Mubarak potrebbe dimettersi, ma nonostante questa dichiarazione le manifestazioni di piazza continuano sempre più numerose. Si dimettono solo i vertici del partito, compreso il segretario generale Safwat al-Herif, fedelissimo del presidente, e il figlio del rais, Gamal. La crisi in Egitto costa a Wall Street la più grave perdita dal mese di novembre del 2010 e la Borsa di New York chiude con tutti gli indici in rosso (la perdita si manifesta quando i network americani fanno scorrere le drammatiche immagini degli scontri e dopo alcune ore si registra anche un forte calo dell'euro sul dollaro). In un primo tempo, il Segretario di stato americano, Hillary Clinton, afferma che il governo Mubarak “è stabile e sta cercando soluzioni per rispondere alle legittime necessità della popolazione” e l'inviato speciale per l'Egitto, Frank Wisner, si associa nel confermare la necessità che il presidente debba “rimanere al potere per pilotare i cambiamenti”. Ma dopo l'intensificarsi della rivolta, il portavoce della Casa Bianca, Robert Gibbs, dichiara che il malcontento degli egiziani “ha raggiunto un punto di ebollizione” e che gli Stati Uniti sono pronti a rivedere la politica di aiuti nei confronti del Cairo. I dati ufficiali del Dipartimento di stato fissano a 1,3 miliardi di dollari l'anno i finanziamenti militari americani, e nel campo dell'assistenza civile l'agenzia Usaid ha erogato, dal 1975 sino all'inizio del 2010, aiuti di vario tipo per un importo totale di 28 miliardi di dollari. Anche il Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, chiede alle autorità egiziane di “rispettare la libertà di espressione ed associazione”. Per il New York Times si stanno svolgendo trattative segrete tra l'amministrazione di Obama e i vertici militari egiziani “per cogliere l'occasione” di far uscire dal paese il presidente, senza farlo decadere ufficialmente dal suo incarico. Agli inizi di marzo, l'Alto Consiglio Supremo delle Forze Armate egiziano – che ha assunto la guida del paese – accetta le dimissioni del premier Ahmed Shaqif, personalità politica considerata troppo vicina a Mubarak, ed incarica Essam Sharaf di formare un nuovo governo. In realtà, il Consiglio intende predisporre con urgenza un governo di transizione che garantisca la stabilità dell'Egitto almeno sino alle prossime elezioni, sia esse parlamentari che presidenziali. Sharaf, un docente universitario di ingegneria, aveva già guidato il ministero dei Trasporti ma, nonostante le sue dimissioni dal dicastero e la sua presenza in piazza Tahrir con i manifestanti, le proteste della popolazione continuano perché anche lui viene considerato una figura già troppo compromessa con il presidente Mubarak. Il primo banco di prova per il nuovo premier sono i servizi di sicurezza. I manifestanti chiedono una seria riforma di questi apparati, considerati da sempre il braccio forte del presidente. Un corteo “pro-democrazia” di circa duemila persone viene però attaccato da squadre di uomini in abiti civili che, secondo alcune testimonianze, sono armati di coltelli e di piccoli ordigni per disperdere la folla. In risposta, i manifestanti prendono d'assalto il ministero dell'Interno e il quartier generale dell'Amin al-Dawla – la polizia segreta egiziana, nel palazzo di Madinat al-Nasr, alla periferia del Cairo – per cercare le prove dei crimini commessi dalla polizia di regime nel tentativo di reprimere le proteste. Anche se Sharaf, durante un comizio tenuto proprio a piazza Tahrir, promette una rapida riforma degli apparati di sicurezza, assicurando che nel futuro saranno ad esclusivo servizio dei cittadini, le proteste non si placano. I militari circondano gli uffici del ministero degli Interni e sbarrano la strada ai manifestanti. Oltre a numerosi check-point e un fitto cordone di soldati, vengono anche schierati sei carri armati (la folla viene dispersa a colpi di calci di fucile e sparando munizioni a salve). Diverso comportamento, però, viene tenuto dai militari nei confronti della sede della polizia segreta. I manifestanti riescono a superare i cancelli del famigerato palazzo della Amin al-Dawla, considerato il luogo delle celle segrete e delle torture inflitte ai prigionieri politici, e a raccogliere documenti e fotografie che testimoniano gli spaventosi abusi di potere. Un piccolo contingente dell'esercito interviene solo più tardi e conduce i manifestanti fuori dall'edificio in maniera pacifica. Anche se tutte le persone vengono identificate e perquisite – per evitare che i documenti compromettenti escano dalla sede – le prove raccolte riescono comunque ad arrivare il giorno dopo su varie piattaforme di internet. Anche se molti documenti erano stati probabilmente già distrutti, il materiale raccolto potrebbe risultare determinante per i capi d'accusa nei futuri processi ai vertici della polizia segreta (nel frattempo, è già iniziato il processo contro il potente Habib al-Adli, l'ex ministro degli Interni accusato, tra l'altro, di detenzioni illegali e torture). I militari continuano però a presidiare il ministero degli Interni in maniera sempre più serrata (due carri armati vengono posti all'interno della struttura e viene estesa l'area dei controlli, con l'interdizione del traffico automobilistico e con la limitazione dell'accesso dei pedoni al minimo indispensabile). In questo caso, sembra che i soldati vogliano tutelare i documenti presenti all'interno dell'edificio ed infatti alcuni testimoni, che abitano nelle zone limitrofe, parlano di decine di uomini in abiti civili che escono dal cancello nord del ministero con borse voluminose e di un intenso via vai di piccole camionette della polizia. I manifestanti, in ressa davanti ai cancelli principali, vengo attaccati dai cosiddetti baltaghi, gli uomini assoldati per creare caos e disperdere la folla. In realtà, sembra che si tratti di elementi in borghese della Amin al-Dawla, che – in questa circostanza armati di pistole ed armi bianche – iniziano a lanciare pietre contro la folla in fuga. E questa volta interviene anche l'esercito ai danni dei manifestanti. I militari sparano a salve e rincorrono le persone in strada, arrestandone alcune e trascinandole sui furgoni della polizia. Le testimonianze dei presenti non lasciano dubbi sul trattamento inumano riservato a queste persone, percosse brutali e urla raccapriccianti, segnalando in modo particolare la delusione popolare nei confronti del comportamento dell'esercito in questa occasione (in effetti, durante i primi morti e i primi violenti arresti effettuati alla fine di gennaio, i responsabili erano soltanto poliziotti e mai soldati). Il motto sino ad oggi lanciato dai manifestanti, al-sha'abwa al-gheishyidwahda (“il popolo e l'esercito uniti mano nella mano”), scompare definitivamente dalle dimostrazioni di piazza. Gli episodi accaduti al ministero degli Interni hanno minato la fiducia nelle istituzioni militari e secondo alcuni analisti il comportamento contraddittorio e inaffidabile tenuto dall'esercito rischia effettivamente di lacerare quel tessuto sociale che lo aveva sempre sostenuto, al di là dell'importanza simbolica che oggettivamente riveste il ministero degli Interni. La composizione del nuovo esecutivo, nominato dall'Alto Consiglio Supremo delle Forze Armate, e che include Nabil al-Araby al ministero degli Esteri, potrebbe rivoluzionare la politica mediorientale del Cairo e creare gravi problemi allo stato di Israele. Anche se la Casa Bianca non commenta ufficialmente questa svolta, il “Washington Post” riporta un'intervista rilasciata da Mustafà Kamel al-Sayid, docente di Scienze Politiche all'università del Cairo. Secondo il professore, quella di al-Araby, pur essendo una figura autorevole nel contesto politico egiziano, non è sicuramente in linea con la politica pro-israeliana attuata dal presidente Mubarak. Il nuovo ministro, infatti, non ha mai nascosto le sue perplessità sul sostegno egiziano fornito allo stato sionista e il quotidiano americano conclude l'articolo temendo che, oltre ad un sterzata filo palestinese, si possa realizzare una temuta apertura di contatti diplomatici con l'Iran, oltre al rafforzamento delle relazioni con la Siria e gli Hezbollah libanesi. In definitiva, dalla valutazione di questo importante segnale l'amministrazione americana ritiene che il nuovo Egitto non potrebbe più essere quell'alleato affidabile che è stato durante tutta la presidenza Mubarak, timore questo fondato anche sui larghi consensi dell'opinione pubblica egiziana tributati al ministro al-Araby. In realtà, il percorso di rifondazione democratica dell'Egitto presenta, in questa delicata fase di transizione, dei punti poco chiari. I militari hanno assunto il comando politico del paese, ma il “Comitato 25 gennaio” – quello che raccoglie i movimenti che hanno gestito le manifestazioni di piazza Tahrir – non sembrano intenzionati ad accettare un nuovo paese con i soldati al potere. Per i più moderati, invece, i militari hanno sicuramente contribuito a creare il nuovo assetto: hanno sciolto il parlamento, nominato un nuovo governo più rappresentativo delle istanze della piazza, di fatto arrestato Mubarak, e hanno elaborato otto proposte di riforme della costituzione da sottoporre a referendum popolare. Ma proprio sugli emendamenti costituzionali si accentrano le critiche più dure dell'opinione pubblica. Durante la stesura delle proposte, i militari avrebbero consultato soltanto Amr Moussa, il segretario generale della Lega Araba, e i Fratelli Mussulmani, ignorando completamente i rappresentanti popolari del “Comitato 25 gennaio”. In effetti, il Consiglio Supremo non ha mai incontrato, o promesso di incontrare, la “nuova opposizione” e il comitato ristretto che ha elaborato gli emendamenti costituzionali, composto da cinque persone, era formato da quattro militari e un rappresentante dei Fratelli Mussulmani. La società civile comincia a sospettare che questo rapporto tra istituzioni militari e la Fratellanza Mussulmana sia pilotato con il solo obiettivo di andare velocemente alle urne e creare un cortocircuito nel processo politico di ricomposizione del paese. Oltre al mancato negoziato ufficiale tra i militari e i partiti politici, l'opinione pubblica reclama ancora a gran voce l'abolizione della legge di emergenza (sospesa ma non abolita) e la riforma degli apparati di sicurezza, responsabili della repressione e ancora effettivamente operativi, sia al Cairo che nel resto del paese. Quando si arriva, il 19 marzo 2011, al primo referendum popolare indetto da oltre cinquant'anni, la popolazione egiziana si reca alle urne ed esprime il suo gradimento (77,2%) sulle modifiche costituzionali che hanno, tra l'altro, il compito di aprire la strada alle elezioni parlamentari e presidenziali. In questo modo si assicura, a chi verrà democraticamente eletto, la possibilità di condurre i cambiamenti del paese e di redigere una nuova carta costituzionale. Ma l'ombra dei Fratelli Mussulmani aleggia anche su queste consultazioni. L'istituzione islamica Dar el Iftaa, che emana le temute fatwa ed è considerata la principale interprete della sharia, ha reso noto – attraverso il gran muftì egiziano Ali Gomaa – che la sua posizione è perfettamente equidistante tra il parere favorevole e quello contrario agli emendamenti. Anche se la dichiarazione sul voto non è troppo chiara, lo è invece sull'articolo 2 della Costituzione, quello che fa riferimento alla sharia come fonte di diritto per la popolazione egiziana, ovvero il fondamento politico, giuridico e religioso dell'Egitto (quello, non potrà mai essere toccato). Un nuovo corteo si snoda nel centro del Cairo e raggiunge prima il palazzo della televisione di stato e, dopo una sosta a piazza Tahrir, anche quello del parlamento. Questa volta i motivi della protesta sono svariati. Primo fra tutti, la nuova legge approvata dal governo (ma non ancora ratificata dal Consiglio Supremo delle Forze Armate) che prevede sino ad un anno di carcere per chi organizzi o partecipi alle proteste di piazza, ma anche a scioperi, marce e sit-in, oltre ad ammende particolarmente salate, dai 3.000 ai 60.000 euro. Si tratta di una norma molto controversa, ma il governo Sharaf difende il bisogno di tornare alla normalità e teme che l'ondata di scioperi che ha travolto il paese possa causare anche il collasso dell'economia egiziana. Parallelamente, il ministro del lavoro, Ahmad Hassan al-Borai, rilascia un'intervista all'agenzia internazionale Aki-Adnkronos e lancia un grido di allarme. Il tasso di disoccupazione, che oscilla tra i 7 e i 10 punti percentuali, tocca oggi punte preoccupanti tra i giovani laureati, assestandosi intorno al 45%. Secondo il ministro, il problema risiede nella mancanza di offerte di lavoro, causata dalla crisi economica che ha travolto l'Egitto dopo la rivolta del 25 gennaio 2011. Il folto gruppo di economisti e giovani uomini politici legati a Gamal Mubarak era riuscito ad introdurre alcune riforme legate alle liberalizzazioni, ma oggi sono invece indicate dall'opinione pubblica come una delle principali cause della crisi finanziaria che attanaglia il paese, con la conseguente fuga dei capitali e degli investitori. In effetti, la stessa popolazione sembra divisa tra chi vuole tornare alla propria quotidianità (al grido di istikrar, il ritorno alla normalità) e chi percepisce che la strada per un vero cambiamento sociale è appena iniziata (con lo slogan adalaigtima'iyya, giustizia sociale). Ma durante l'ennesimo corteo si lanciano appelli minacciosi anche contro il Consiglio Supremo, accusato di non aver ancora avviato i processi contro Hosni e Gamal Mubarak, ma anche contro il segretario del partito Safwat al-Sherife e gli alti membri del regime. Sotto accusa anche i vertici direttivi della televisione e della radio egiziane, colpevoli di aver contribuito alla campagna governativa a favore di Mubarak e di aver ignorato le legittime richieste dei manifestanti. Nel corteo, anche la giovane Unione Indipendente dei Sindacati, alla quale hanno aderito molti lavoratori, organizzati in unioni di categoria, dopo le forti limitazioni delle libertà sindacali imposte dalla Federazione dei Sindacati egiziani, controllata dal regime. Il braccio di ferro tra i dimostranti e i militari è appena iniziato. Ai primi del mese di aprile, il giornale arabo al-Quds al-Arabi riporta a chiare lettere l'ultimatum lanciato dal movimento del “Comitato 25 gennaio” e dalla “Coalizione dei Giovani della Rivoluzione”, per la difesa dei diritti umani: “diamo al Consiglio Supremo delle Forze Armate una settimana di tempo, al massimo, per ripulire le istituzioni del paese dagli uomini di Hosni Mubarak”. Il messaggio è molto chiaro: i manifestanti chiedono alla giunta militare al potere di destituire tutti i fedelissimi di Mubarak dai posti di responsabilità, altrimenti verrà ripresa la lotta, e questa volta ancora più cruenta. Anche il richiamo ai fedelissimi è di facile interpretazione: sotto processo devono andare, oltre all'ex presidente e i suoi familiari, anche il segretario del partito di governo (il Partito Nazionale Democratico) Safwat al-Sherife, il presidente del parlamento Fathi Surur e il direttore dell'ufficio presidenziale, Zakkaria Azami. In realtà, il sospetto che l'ombra della restaurazione si stia allungando sul futuro del paese è concreto. I militari hanno sottoposto a referendum un numero limitato di emendamenti costituzionali, che non intaccano di certo l'essenza del vecchio regime, e tanto meno garantiscono l'evoluzione democratica dei processi in atto. Inoltre, il giorno dopo il referendum, una “dichiarazione costituzionale” dei militari ha di nuovo modificato gli emendamenti appena approvati, introducendo elementi della vecchia Costituzione, ritenuti ancora utili. Secondo alcuni analisti si è trattato di un vero e proprio colpo di mano per assicurare alla giunta al potere il privilegio di controllare sempre più a lungo il processo politico. Non si sarebbe quindi trattato di un referendum popolare, bensì di un referendum politico per legittimare il processo di transizione avviato e gestito dai militari, desiderosi di ritrovare la legittimazione del ruolo storico che hanno sempre avuto nel paese (ma tutto questo a discapito delle rivendicazioni dei movimenti popolari). Anche il ruolo giocato dai Fratelli Mussulmani non è ancora chiaro. Sembra che fossero d'accordo con i militari per non cambiare la precedente legge elettorale, ma questo solo per avere la possibilità di registrarsi con un nuovo partito – il “Partito dello Sviluppo e della Democrazia” – che ufficialmente non è fondato su una base religiosa. La Fratellanza è riuscita a costituire, nel tempo, una rete sociale, politica ed economica che ha finito per inserirsi a pieno titolo nel tessuto sociale egiziano e i timori dei giovani rivoltosi è che si sia creato un nuovo blocco politico-sociale tra i militari, la borghesia e gli estremisti islamici. Nella sua villa nei pressi di Sharm el Sheikh nel Sinai meridionale, dove si è ritirato dopo essere stato costretto a dimettersi l'11 febbraio, Hosni Mubarak viene raggiunto dai primi capi di accusa: corruzione e appropriazione indebita. Ma il procuratore del Sinai, Abdullah al-Shazli, indaga anche sul ruolo avuto dall'ex presidente e dai suoi due figli – Alaa e Gamal – nella dura repressione dei moti di piazza, in particolare riguardo all'ordine di sparare sulla folla. Mubarak è formalmente in stato di arresto, anche se il comunicato stampa parla di una misura cautelare della durata di due settimane, senza chiarire se il provvedimento sia stato disposto per evitare l'inquinamento delle prove o per scongiurare il pericolo di fuga. Ormai Mubarak è alle strette. La Corte di Assise del Cairo accoglie la richiesta del procuratore generale Abdel Meguid Mahmoud e congela i conti dell'ex presidente, così come quelli della moglie e dei due figli, anche se rimane sconosciuto l'ammontare dei fondi congelati. A metà del mese di aprile, Mubarak – che ha raggiunto la rispettabile età di ottantadue anni – viene colto da infarto alla notizia dell'arresto dei suoi due figli, condotti nel carcere di al-Tor, nella periferia del Cairo. In realtà, l'ex presidente aveva già avuto un precedente, ma non gravissimo, infarto durante l'interrogatorio del procuratore al-Shazli, ed era stato ricoverato nell'ospedale internazionale di Sharm (questa volta, invece, viene portato d'urgenza prima nel reparto di terapia intensiva – protetto da un massiccio servizio d'ordine – e subito dopo con un elicottero militare nel più attrezzato ospedale di Islamiya, sul Golfo di Suez). Nel frattempo, le indagini dei giudici proseguono e i nuovi capi d'accusa sono, oltre all'appropriazione indebita di denaro pubblico, anche abuso di potere e complicità nell'assassinio dei manifestanti. Per la prima volta nella storia del mondo arabo, un presidente della Repubblica viene messo agli arresti e indagato dalla magistratura ordinaria. Adesso la questione è quella relativa al processo che deve essere sostenuto, o meglio se ci sarà un vero processo ai danni di Mubarak e come sarà condotto. Il timore più diffuso tra gli attivisti è che, come tutte le iniziative adottate dal Consiglio Supremo, anche questa sia arrivata in ritardo. L'ex presidente avrebbe in effetti avuto tutto il tempo (due mesi) per sistemare o nascondere i documenti più compromettenti, senza calcolare la possibilità di occultare all'estero le immense ricchezze sottratte alla popolazione egiziana. I quotidiani arabi legati ai movimenti di piazza ritengono che vada fatta chiarezza sul ruolo avuto dai militari sino ad oggi. Il Consiglio Supremo potrebbe infatti aver agito in parte sotto la pressione delle proteste, ma anche per difendere gli interessi politici ed economici del paese. Il potente generale Mohamed Tantawi è stato ministro della Difesa del governo Mubarak e la maggior parte delle cariche oggi presenti nel Consiglio rivestono il ruolo assegnato loro dall'ex presidente. Ancora una volta, è forte il sospetto che la famiglia Mubarak e i loro alti funzionari possano sì avviarsi sulla strada del tramonto, ma che il regime che li ha sempre sostenuti non è stato ancora rovesciato, e che forse non lo sarà mai. Oramai sembra diffuso anche il convincimento che esercito e polizia siano sempre stati alle strette dipendenze del regime, il primo come apparato di controllo repressivo, il secondo a salvaguardia del clientelismo e della corruzione. Il generale Ismail Muhammad Othman rilascia un comunicato che sembra confermare i timori dell'opinione pubblica: gli organi di stampa egiziani hanno adesso l'obbligo di informare, e di ottenere il permesso, del “Direttorato Militare per l'Informazione” prima di pubblicare qualsivoglia notizia relativa alle Forze Armate. Anche la nuova politica estera egiziana muove i suoi primi passi. Il ministro Nabil al-Araby annuncia ufficialmente dall'emittente televisiva al-Jazeera che l'Egitto “prenderà misure importanti per alleggerire il blocco di Gaza”, definendo vergognosa la precedente decisione di chiudere il valico di Rafah, l'unico punto di ingresso nella Striscia di Gaza non controllato da Israele. Secondo il ministro, si tratta di venire incontro alle esigenze del popolo palestinese, lasciando che passino da e per Gaza tutte le persone che lo desiderino e tutti i beni che si ritiene opportuno far transitare. In precedenza, il passaggio era stato aperto solo in rare occasioni e sempre per scopi umanitari, ma la nuova decisione sembra contrastare con gli accordi firmati nel 2005 tra gli Stati Uniti, Israele, Egitto e Unione Europea, che incaricavano gli osservatori di presidiare costantemente gli accessi al valico. Ancora una volta è il Washington Post a lanciare l'allarme. Su indicazioni del ministro al-Araby, giudice e giurista di grande fama, i diplomatici egiziani stanno anche cercando di riallacciare i rapporti con l'Iran e le aziende egiziane di stato vengono invitate a rivedere i contratti stipulati con Israele, considerati troppo vantaggiosi per la controparte. Si affaccia sulla scena internazionale un nuovo nazionalismo che, invece di trovare sponde diplomatiche tra le parti, intende rilanciare la propria autonomia decisionale, approfittando dello scetticismo della maggioranza egiziana nei confronti degli Stati Uniti in generale e di Israele in particolare. Oltre alla Siria in fiamme e la Libia in dissesto, il governo di Tel Aviv deve adesso confrontarsi con l'artefice del cambiamento della politica estera egiziana, in grado di ridefinire gli equilibri geopolitici della regione (lo scenario, al momento, si sta rivelando ben più complesso e pericoloso della questione palestinese). Ai primi di maggio viene firmato al Cairo l'accordo di riconciliazione tra le due più importanti fazioni palestinesi, Hamas e Fatah, chiudendo la drammatica pagina delle divisioni e dei conflitti. Sotto l'ala protettrice dei servizi egiziani, il capo dell'ufficio politico di Hamas, Khaled Meshaal, e il leader di Fatah, Abu Mazen, siglano l'accordo di riconciliazione e aprono la strada alla nascita di un governo unitario di transizione. Le dichiarazioni dei due leader si fanno più baldanzose: Abu Mazen coglie l'occasione per invitare Israele a sospendere la costruzione degli insediamenti ebraici e Meshaal approfitta per lanciare il solito proclama contro lo stato sionista: Adesso l'unica battaglia dei palestinesi è contro Israele, e il nostro obiettivo è la piena sovranità dello stato palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, con capitale a Gerusalemme, senza insediamenti, senza concedere nemmeno un centimetro di terra e senza rinunciare al diritto al ritorno dei profughi. Tel Aviv aveva già fatto sapere, in precedenza, che non ha alcuna intenzione di negoziare con Hamas – considerata un'associazione terroristica che non riconosce lo stato sionista – e che Fatah deve adesso scegliere tra la pace con Hamas o quella con Israele (anche il commento ufficiale del premier Netanyahu è in linea con l'atteggiamento del governo: “E' un colpo tremendo per la pace e una vittoria per il terrorismo”). L'intenzione palestinese è adesso quella di chiedere all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il riconoscimento unilaterale di uno stato indipendente e nel frattempo non si contano i gesti simbolici promossi da Hamas nella Striscia di Gaza. Viene riaperta la televisione «Palestine Tv» – controllata da Fatah e chiusa nel 2007, dopo la vittoria elettorale del movimento islamico nelle elezioni e la cacciata di tutte le altre fazioni, Fatah compresa – si lasciano sventolare le bandiere gialle di Fatah, si possono ammirare le insegne prima bandite e si permette a molti membri del partito di Abu Mazen di mostrarsi e parlare pubblicamente. Nel frattempo, al Cairo, nel giorno del compleanno di Mubarak (il 5 maggio, per ottantatre anni di età) i sostenitori dell'ex presidente si scontrano con gli oppositori e chiedono che non venga processato. Se i primi chiedono rispetto per un uomo che ha guidato il paese per tanti anni, i secondi chiedono invece che venga giustiziato per aver ordinato l'uccisione di molti manifestanti. Gli scontri, che hanno causato decine di feriti, si sono svolti a colpi di pietre sino a quando non è intervenuto l'esercito per riportare l'ordine in città. Ma il problema palestinese è ancora aperto e questa volta è il ministro degli Esteri egiziano a rilasciare una dichiarazione al Washington Post. “Stiamo facendo pressioni su tutti i nostri alleati, e sugli Stati europei, affinché tutti riconoscano lo stato palestinese” (si tratta però della creazione di uno stato entro i confini del 1967, quelli definiti dagli accordi di Camp David). Il ministro egiziano ha anche affrontato, ma in maniera laconica, il problema dei rapporti diplomatici con l'Iran, congelati da oltre trent'anni: “l'Egitto ha voltato pagina nelle relazioni con ogni paese del mondo, e se mi chiedessero se tra questi figuri l'Iran, risponderei di si”. Al Cairo proseguono i processi contro la vecchia classe dirigente (l'ex ministro del Turismo, Zoher Garana, viene condannato a cinque anni di reclusione con l'accusa di aver venduto a prezzi stracciati i terreni sulle rive del Mar Rosso per l'edificazione di complessi turistici). Anche per Mubarak viene stilata una nuova accusa, quella di aver venduto gas ad Israele a prezzi ridotti in cambio di “commissioni” finite direttamente nei conti correnti dei figli (l'ex presidente si trova ancora in ospedale – ma viene ugualmente interrogato – e il procuratore Abdelmajid Mahmoud rinnova per altre due settimane la sua custodia cautelare). Anche sul fronte politico, gli sviluppi della Fratellanza Mussulmana non si fanno attendere. Un esponente della Fratellanza, Abdel Moneim Abouel Fotuh, annuncia, oltre la prossima formazione di un partito autonomo di stampo riformista, anche la propria candidatura alle presidenziali, in qualità di indipendente, per raccogliere i voti dei conservatori e dei moderati. Poiché quello di Fotuh sarebbe il terzo partito tra quelli fondati da personalità di spicco dei Fratelli Mussulmani, viene immediatamente espulso dalla dirigenza della Fratellanza, che si affretta a dichiarare che l'unico partito ufficiale è quello di “Libertà e Giustizia”, con il leader Mohammed Moursi. In realtà, secondo la stampa egiziana, buona parte dei giovani, così come dei moderati, sono pronti a seguirlo, nonostante le sue posizioni moderate riguardo alle donne, ai copti ed al ruolo della legge islamica nella nuova Costituzione. Le tensioni all'interno del Paese hanno adesso anche il volto degli scontri interreligiosi. Già ai primi di marzo i cristiani avevano protestato per il rogo di una chiesa, avvenuto ad Atfih, e per l'assalto dei mussulmani salafiti durante la loro manifestazione. Gli incidenti avevano causato la morte di dieci persone e i mussulmani avevano giustificato il loro operato adducendo il caso di una giovane cristiana, sposata ad un religioso copto, che sarebbe sparita dopo la sua conversione all'islam (la stessa motivazione usata in passato da al-Qaeda per giustificare le stragi contro i cristiani in Iraq). Gli scontri sarebbero avvenuti in diversi quartieri del Cairo, provocando anche il ferimento di cinquanta persone, ricoverate in sei diversi ospedali della capitale. A metà del mese di maggio, scoppiano nuovi disordini tra i mussulmani e i cristiani copti, causando la morte di ottanta persone e il ferimento di altre decine di manifestanti. I cristiani – radunati davanti alla sede della televisione di stato, al Cairo, in un sit-in di protesta per la morte di quindici fratelli di fede uccisi agli inizi di maggio nel quartiere di Imbaba – vengono attaccati da un gruppo di una cinquantina di islamici con fucili da caccia e bombe molotov. Il tragico bilancio della giornata arriva dopo uno scontro violento che vede anche numerose macchine date alle fiamme. Solo l'intervento della polizia, con lancio di lacrimogeni, riesce a disperdere i manifestanti e a riportare la calma nel quartiere. Il papa copto, Shenuda III, interviene per chiedere ai fedeli di interrompere la manifestazione di protesta (che dura da nove giorni), ma segnala anche la presenza di molti infiltrati islamici tra le fila dei cristiani. Vanno avanti anche le indagini sull'ex presidente Mubarak. I militari smentiscono ufficialmente le voci ricorrenti che parlano di un'amnistia al deposto rais in cambio della restituzione dei beni indebitamente accumulati. Sembra anche che Mubarak sia disposto a chiedere perdono al popolo egiziano e a restituire tutto l'ingente patrimonio sottratto alle casse dello stato, ma anche in questo caso non arriva alcuna conferma da parte del Consiglio Supremo. La notizia viene considerata plausibile, visto che la moglie Suzanne è stata scarcerata dopo aver accettato di restituire allo stato 24 milioni di lire egiziane (pari all'incirca a ventiquattro milioni di dollari americani). Il Consiglio Supremo si affretta però a dichiarare che la notizia è sicuramente falsa, che chi la diffonde lavora contro gli interessi del paese, che i militari non interferiscono nelle indagini della procura e che Mubarak e i due suoi figli rimangono in stato di detenzione. Verso la fine di maggio viene formalizzata l'accusa di aver ordinato alla polizia di aprire il fuoco sui dimostranti durante le rivolte, con il conseguente rinvio a giudizio. Secondo il sito egiziano Youm7, sono stati rinviati a giudizio anche il figlio Alaa e l'uomo d'affari Hussein Salem, molto vicino all'ex presidente (secondo la legge egiziana, Hosni Mubarak, se le accuse a suo carico venissero confermate, rischierebbe la pena capitale). Secondo un rapporto pubblicato dall'organizzazione Amnesty International, la brutale repressione delle autorità egiziane contro il movimento popolare di piazza Tahrir avrebbe causato la morte di 840 persone e il ferimento di altre numerose migliaia. Inoltre, molti civili sarebbero stati ingiustamente arrestati e sottoposti al giudizio dei tribunali militari, calpestando i diritti fondamentali della persona. Gli analisti che seguono con apprensione le vicende egiziane concordano tutti nel ritenere che le autorità avranno molto da fare per ripristinare la fiducia nelle istituzioni, oramai percepite come un implacabile strumento di repressione. Il 27 maggio 2011 viene proclamato il secondo “venerdì della collera”. Gli organizzatori di questa manifestazione nazionale intendono contestare l'ipotesi di grazia per l'ex presidente Mubarak (le voci sono nate dopo che si è avuta conoscenza del suo precario stato di salute) e reclamare a gran voce un processo pubblico e trasparente. Ma prima ancora della manifestazione, il portavoce del movimento, Inji Hamdy, rilascia un duro comunicato che esprime critiche accese contro il Consiglio Supremo delle Forze Armate. Le accuse riguardano, tra l'altro, di non aver rispettato le richieste dei manifestanti e di aver preso decisioni in totale autonomia, senza alcuna consultazione con le altre forze politiche. Inoltre, viene anche denunciato il vertiginoso aumento degli arresti e dei processi militari contro i civili. Tra le richieste c'è anche quella di rinviare le elezioni parlamentari – e di conseguenza anche quelle presidenziali – sino a quando non verrà raggiunto tra le parti un comune accordo sulle modalità di voto. Infine, viene anche richiesta la formazione di una commissione specifica per iniziare i lavori su una nuova Costituzione e il totale allontanamento di tutti i leader del vecchio regime dalle istituzioni pubbliche. I manifestanti del secondo “venerdì della collera” si radunano in piazza Tahrir e avanzano le loro richieste: giustizia per le oltre ottocento vittime della repressione e un processo rapido per l'ex presidente e il suo staff politico. Ma anche, ancora più importante, la formazione di un Consiglio presidenziale civile e un'Assemblea costituente. Ancora una volta, l'ombra dei Fratelli Mussulmani si allunga sulle proteste. I membri della Fratellanza e le formazioni integraliste salafite avevano deciso di boicottare questa giornata (i motivi non sono chiari) ma la frangia più giovane del movimento decide invece di scendere in piazza e unirsi alle migliaia di manifestanti che affollano le strade del centro del Cairo. Mohammed Moursi, il leader dei Fratelli, nonostante la posizione ufficiale assunta per il boicottaggio della manifestazione, non rilascia alcun comunicato. A questo importante appuntamento risultano però assenti le Forze Armate egiziane. Con uno stringato comunicato stampa fanno sapere che – per evitare possibili scontri con i manifestanti – hanno deciso di non presidiare la zona (in alternativa, le limitazioni al traffico e l'accesso alla storica piazza vengono controllati dai nuovi e ben organizzati Comitati popolari). Ma i sospetti dell'opinione pubblica sul comportamento tenuto dai militari vengono alimentati ancora una volta. Durante una delle tante manifestazioni tenute nel mese di marzo, diciassette giovani donne erano state arrestate proprio a piazza Tahrir dai soldati che presidiavano la zona. Le donne denunciarono di essere state picchiate, colpite con scariche elettriche, minacciate con pesanti accuse di prostituzione e costrette a subire test di controllo sulla verginità. Le autorità militari rigettarono le accuse, ma un altro rapporto di Amnesty International confermò le violenze subite dalle donne nelle caserme dell'esercito. Alla fine di maggio un generale egiziano – che ha chiesto di mantenere l'anonimato – conferma durante un'intervista rilasciata alla «Cnn» americana che le donne arrestate erano state costrette a subire controlli sulla verginità, dopo essersi accampate in piazza Tahrir insieme ad alcuni uomini. Il generale, pur ammettendo le gravi responsabilità dell'accaduto, difende comunque l'operato dei militari, sostenendo che i test erano stati effettuati nella prigione militare dove erano state rinchiuse affinché non potessero sostenere di “essere state molestate sessualmente o violentate” dai soldati. Nella iniziale rivolta egiziana è sicuramente mancata una vera regia organizzativa e si può quindi, presumibilmente, dedurre che la spinta propulsiva sia stata essenzialmente popolare, con forti connotazioni laiche e spontanee. Poiché non si è ancora delineata nell'organizzazione del movimento popolare una struttura capace di sostituirsi validamente a quella del regime di Mubarak, il paese corre oggettivamente il rischio di vedere emergere – in maniera sotterranea e forse anche ambigua – la cosiddetta seconda linea della vecchia oligarchia del potere politico. Anche il movimento della Fratellanza Mussulmana – che probabilmente sino ad oggi aveva rinunciato alla sua radicalizzazione in cambio di un malcelato permesso di infiltrarsi nel tessuto sociale – potrebbe oggi rivendicare un ruolo politico più determinante. Infine, anche se gli eserciti dei paesi arabi sono storicamente considerati come la colonna del secolarismo e del nazionalismo, sembra che i militari egiziani siano invece determinati a pilotare non solo la fase di transizione, ma anche lo stesso futuro politico. Le Forze Armate egiziane costituiscono in effetti un sistema sofisticato e ben organizzato, e non solo militare, ma anche industriale ed economico. L'istituzione, infatti, possiede oltre ad una importante struttura produttiva (armamenti, materiali di supporto e logistica), anche una estesa attività industriale per alcuni beni di largo consumo (elettronica e farmaceutica) e forti interessi nello sviluppo immobiliare nelle aree di maggiore interesse turistico. Oggi le variabili sembrano quindi essere ancora troppo numerose e poco omogenee, in attesa che si trovi la capacità di coagulare le forze politiche e militari nella prospettiva di un futuro patto di coesione nazionale, in modo da garantire all'Egitto il suo naturale e strategico ruolo negli equilibri del mondo arabo. La monumentale moschea di al-Azhar (“la splendente”) ospita il più antico luogo di culto del Cairo islamico contemporaneo, l’istituto accademico religioso dell’islam fondato alla fine del secolo X dai Fatimidi come centro assoluto del sapere teologico sciita. Due secoli più tardi, l’università di al-Azhar passò sotto l’autorità sunnita e dopo aver sviluppato – anche se con alterne vicende – gli studi di teologia e diritto, ottenne nel 1872 il privilegio di conferire titoli. Nel 1930 i dipartimenti furono riorganizzati e divisi in tre aree di conoscenze – teologia coranica, giurisprudenza e lingua araba – e nel 1961 la moschea e l’università vennero poste sotto il controllo diretto dello stato che istituì anche nuove facoltà (medicina, ingegneria, economia e agraria). Venne concesso alle donne – che sino a quel momento potevano solo frequentare corsi periodici – il diritto di accedere ai corsi dell’università, anche se con aule e alloggi separati da quelli degli uomini. Gli iscritti all’università – ammessi senza discriminazioni di razza o nazionalità – devono però essere di fede islamica e sono tenuti a frequentare le lezioni a tempo pieno (provenienti da circa sessanta paesi diversi, gli studenti studiano la cultura islamica, la sharia, il Corano e le sue interpretazioni dottrinali). L’università conta circa centomila iscritti e costituisce la più alta istituzione teologica dell’islam sunnita nel mondo, in grado di formare teologi (ulama) e specialisti in diritto mussulmano (mufti) – che possono emettere pareri giuridici (fatwa) – ma anche capi spirituali (imam). Il grande imam di al-Azhar viene nominato dal presidente egiziano ed ha, oltre ad un importante ruolo di guida spirituale, la possibilità di emettere pareri che influenzano gli orientamenti religiosi e politici dei fedeli islamici. Le infinite dispute ideologiche che si svolgono all’interno dell’università riguardano essenzialmente la possibilità di una rilettura esegetica del Corano, i cui esiti sono destinati ad influenzare, inevitabilmente, il complesso universo mussulmano. Proprio il rovesciamento epistemologico compiuto da Sayyd Qutb nella nuova interpretazione del Corano ha aperto la strada al radicalismo islamico e creato le condizioni necessarie per l’aggregazione di movimenti collettivi a base religiosa e politica. La Fratellanza Mussulmana, che ha superato per prima il mero piano dottrinale della teoria, ha prodotto i gruppi estremisti di al-Jihad e di Jamà-at Islamiyyad, ritenuti responsabili dell’assassinio del presidente Sadat il 6 ottobre 1981. Secondo Salam al-Faraj, esponente di spicco della jihad islamica egiziana, la lotta doveva spingersi sino allo “sterminio dei leader infedeli che predicano, digiunano e pretendono di essere mussulmani e che non hanno ancora trovato coloro in grado di sopprimerli con l’ordine di Dio Onnipotente”, lì dove uccidere il nemico diventa un obbligo di fede che i giureconsulti hanno volutamente posto in oblio anziché esaltarne la missione purificatrice. L’ulema palestinese Abdallah Azzam, anche lui figura di primo piano nella storia dell’islam radicale egiziano, ha organizzato e coordinato la partecipazione araba alla guerra in Afghanistan negli anni Ottanta. Al contrario di quanto ipotizzato da Sayyd Qutb, Azzam propose un’avanguardia con una base più solida, o meglio una base territoriale sulla quale i giovani mussulmani potevano ricevere un’adeguata educazione alla jihad ed introdusse anche un nuovo – e di più semplice comprensione – elemento per distinguere una società islamica da un’altra non islamica: se la sovranità è attribuita a qualcuno diverso da Allah, sia essa la nazione, lo stato o il partito, la società non può considerasi islamica. Al-Zawahiri, considerato l’ideologo di al-Qaeda, si uniì ai Fratelli Mussulmani all’età di quattordici anni ma nel 1990 dedicò un libro alla confraternita (“La mietitura armata”), accusando i dirigenti di aver trasgredito ai principi fondamentali dell’islam per accettare il gioco politico della democrazia, con la necessaria e implicita accettazione della legittimità del potere costituito. 4. L’ondata di proteste e di rivolte che ha recentemente interessato il Maghreb – “piccolo e grande59” – ha acceso i riflettori del mondo anche sulla realtà marocchina e sulla sua specificità nel contesto africano (la “peculiarità marocchina”). L’apparente tranquillità della “bella addormentata del Maghreb” non deve indurre gli osservatori occidentali a sottovalutare quel che è accaduto negli anni e accade oggi entro i confini marocchini Come ha osservato Aboubakr Jamai, editore di «Le Journal Hebdomadaire» di Casablanca, il Marocco ha avuto nell’ultimo decennio un ritmo di crescita robusto e ha goduto di sostanziosi investimenti nelle infrastrutture. Ma questo non ha impedito l’innalzamento dei tassi di disuguaglianza e povertà nel paese, come una crescita della disoccupazione giovanile, e l’assestamento dell’aspettativa di vita, del livello medio d’istruzione e un reddito nazionale procapite attorno a parametri tutt’altro che positivi. Per dare un’idea, nei paesi classificati dall’Onu per indice di sviluppo il Marocco figura alla 114ma posizione, molto più in basso, ad esempio, della Tunisia rivoluzionata che è all’81mo posto. 59 Il Maghreb è l'area più a ovest del Nord Africa che si affaccia sul mar Mediterraneo e sull’Oceano Atlantico e che comprende gli Stati di: Marocco, Algeria e Tunisia, più il Sahara Occidentale che oggi è sotto occupazione marocchina. Questi Stati hanno dato vita, nel 1989, all’ “Unione del Maghreb Arabo” (conosciuta come “grande Maghreb”) che abbraccia anche la Libia e la Mauritania. Secondo un’analisi presentata l’11 maggio del 2011 dall’ Haut-Commissariat au plan (Hcp) il tasso di disoccupazione è passato dal 13,4% al 9,1%, ma è cresciuta a dismisura la precarizzazione del lavoro tanto da vanificarne il miglioramento. Solo il 20% dei lavoratori dispone di un sistema di sicurezza sociale (il 32% nelle realtà urbane e il 4,5% nelle aree rurali). Inoltre i due terzi dei lavori offerti oggi sono precari e circa due salariati su tre lavorano senza contratto: il risultato è che solo il 20% della popolazione attiva beneficia della copertura sanitaria. Tra le persone occupate solo l’11% ha un diploma di scuola superiore e tra i giovani con età quindici-ventiquattro anni la disoccupazione è al 17,6% e sale al 31,3% nelle aree urbane. Il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito che in Marocco, come in altri paesi non produttori di petrolio, vi sono rischi sulla crescita economica per la diminuzione degli investimenti e dei flussi turistici. Per il 2011 le previsioni di crescita di Rabat sono superiori al 4%, ma non bastano perché il deficit pubblico è in crescita e potrebbe limare ulteriormente le spese per lo sviluppo. Sebbene la monarchia “liberale” di Mohammed VI sia riuscita a contenere le proteste e ad impedire che i settori giovanili più sfiduciati approdassero verso lidi estremistici, ci sono stati vari accenni di rivolta negli ultimi anni e nel giugno del 2008 un’intera città, quella di Sidi Ifni, si è sollevata contro il governo. Nel Paese è ancora forte un grosso sentimento di sfiducia verso la politica (basti pensare che nelle elezioni del 2007 hanno votato solo il 35% degli aventi diritto) e le manovre economiche del governo. A Rabat quasi ogni giorno lavoratori, disoccupati e studenti, si ritrovano in piccole dimostrazioni davanti ai palazzi governativi. Il 26 settembre 2011 circa ottomila persone hanno partecipato ad una manifestazione indetta a Casablanca dal “Movimento 20 febbraio60”, cui ha aderito anche il Pjd (Partido de la Justicia Y el Desarrollo). Azzedine Akesbi, professore all’Istituto di agronomia di Rabat, ha lamentato l’assenza della libera concorrenza economica, una politica finanziaria destinata a favorire solo i grandi gruppi vicini alla monarchia e l’inefficacia della politica agricola. L’innalzamento a livello mondiale del prezzo dei prodotti e la debolezza locale del potere di acquisto fanno sì che l’incertezza dei marocchini circa il proprio futuro aumenti e li renda più insicuri. Nel Paese vengono denunciate inoltre una fortissima corruzione a livello locale, con un giro di tangenti impressionante nel settore immobiliare (l’associazione internazionale contro la corruzione, Trasparency International, posiziona il Marocco all’85esimo posto nel mondo, mentre la Tunisia è al 59esimo), il restringimento della libertà di stampa e una vasto lavorio di censura contro le opposizioni democratiche. Il governo ha pensato bene di favorire la nascita del “Partito per l’Autenticità e la Modernità” (Pam), fondato nell’agosto del 2008 da Fouad Ali al-Himma, ex vice ministro degli interni e stretto amico del re, al fine di limitare l’avanzamento dei partiti islamici (come la seconda forza del paese, il partito di Giustizia e Sviluppo) senza intromettersi patentemente nella conduzione del partito, ma questa operazione potrebbe avere un orizzonte limitato. Parallelamente, il governo del re Mohammed VI, in un discorso alla Nazione del 9 marzo 2011, ha lanciato la nuova costituzione marocchina (approvata a luglio con uno straordinario –e sospetto98% di si) anche al fine di anestetizzare la ribellione dei giovani ed impedire il contagio della primavera araba. La costituzione prevede una “regionalizzazione avanzata” – col conferimento ai presidenti dei 60 Il movimento 20 febbraio è nato nel 2011 in via spontanea come espressione della mobilitazione di giovani studenti e disoccupati contro la nuova costituzione marocchina e la crisi economica. Il movimento ha posizioni al momento molto confuse sia sugli obiettivi da perseguire sia sulle prossime forme di protesta. Le rivendicazioni più condivise propongono l’abolizione del potere dinastico a vantaggio di una monarchia parlamentare sul modello inglese o spagnolo, mentre una minoranza chiede apertamente il passaggio al sistema repubblicano. Quel che unisce apparentemente i manifestanti è una idea generica di democrazia e di rivoluzione, sul modello delle esperienze egiziane e tunisine. consigli regionali del potere esecutivo al posto dei governatori e dei wali – la parità d’accesso tra uomini e donne ai ruoli elettivi e alla gestione degli affari regionali, il rafforzamento dei “meccanismi di moralizzazione della vita pubblica, la costituzionalizzazione delle istanze incaricate della buona governance, dei diritti umani e della protezione delle libertà”. Nondimeno, è ancora il re a nominare il primo ministro (art. 46, a condizione che egli sia un membro del partito con il maggior punteggio alle elezioni parlamentari); è il re che nomina i ministri sulla base delle raccomandazioni del primo ministro (art. 47); sempre e solo il re può destituire i ministri (art. 47) e di fatto il governo. Il re dirige il consiglio dei ministri (art. 48), rimanendo quindi ancora il capo del ramo esecutivo del governo. È il comandante delle forze armate (art. 53), nomina il personale militare (art. 53), approva le candidature alla pubblica amministrazione attraverso la sua presidenza del consiglio dei ministri (art. 48), nomina e accredita gli ambasciatori (art. 55), firma e ratifica i trattati internazionali (articolo 55, con condizioni). Si rivolge al parlamento senza che questo abbia diritto di replica (art. 52), presiede la sessione di apertura di ottobre del parlamento (art. 65) e può sciogliere le camere (art. 51). Approva le nomine dei giudici (art. 57), può concedere la grazia (art. 58), presiede il consiglio superiore della magistratura (art. 56), il consiglio della sicurezza nazionale (art. 54) e può dichiarare lo stato di emergenza (art. 59). In sostanza, il re mantiene quasi tutte le sue vecchie prerogative e il controllo sul parlamento. Benché la costituzione sia stata approvata da quasi tutta la popolazione, non si può escludere che il bluff governativo esca presto in superficie, destando ancora più rabbia tra i giovanissimi e i disoccupati. Un malcontento che presta benissimo il fianco alla propaganda islamista radicale e che potrebbe consolidare le sue posizioni antigovernative. Per capire da dove nasce il legame tra islam e Marocco e quali siano le varie anime dei mussulmani in questa terra è necessario tornare indietro negli anni. Gli arabi partirono alla conquista del Nord Africa nella prima metà del secolo VII, ovvero nei premi decenni della rivelazione islamica. Al tempo il Marocco era compreso nella Mauritania Tingitana romana, che era dominata dal disordine e non aveva una religione condivisa: le genti abbracciavano culti naturisti, tradizioni animiste, riti pagani e confessioni tribali. Nel 647 d.C. il governatore d’Egitto, Abdullah Ibn Saad, condusse una battaglia contro i bizantini a Ifriqia (Tunisia) e nel 681 Oqba ibn Naafi Al Fihri attraversò buona parte dell’Africa settentrionale spingendo il suo cavallo fino alle acque dell’Atlantico (“il mare di tenebre”). Nel 703 d.C. Musa ibn Nosseyr s’impadronì del Paese e provò a convertire all’islam tutto il popolo berbero, ma il Marocco restò lo stesso in uno stato d’incertezza e caos fino al 788. Da quell’anno al 985 in Marocco regnarono gli Idrisidi, che presero il loro nome dal sultano Idris I. Idris ibn Abd Allah fece risalire le sue origini ad Ali ibn Abi Talib e sua moglie Fatima, figlia del profeta Maometto e il suo regno rappresentò il primo stato islamico autonomo del Marocco. Suo figlio, Idris II, sviluppò l’area del Fez e la trasformò nella sua reggia e capitale del regno. Fez divenne di lì a poco il centro dell’islamizzazione e dell’arabizzazione del Nord Africa. Con Muhammad (828-836) il regno fu frammentato in diversi piccoli stati nel nord del Marocco, prima di essere riunificato sotto Yahya IV (904-917). Gli scontri con i Fatimidi (che fu la dinastia sciita ismailita più importante della storia dell’islam) e la fuga da Fez nel 926 distrussero la dinastia, che lasciò spazio nel 985 al principato dei Maghrawa. Sotto il regno idriside, prese piede il madhhab malikita61 dell’esegeta mussulmano, giurista ed 61 La scelta del rito malikita, a detta degli studiosi, spiega la longevità dell’islamismo in Marocco: esso si basa sulle tradizioni e gli usi locali dei primi seguaci del Profeta (sunna), procedendo per analogia (qiyas) e utilizzando criteri sussidiari quali la valutazione del bene comune. Questa ortodossia (la più conservatrice, invero, tra le scuole giuridiche sunnite) mette l’atto religioso al di sopra del temporale ed è centrata sulla coesione della comunità (umma), sulla responsabilità del credente, sulla consultazione (choura) tra i dotti, sull’adattamento alla realtà nel rispetto della tradizione e dell’ortodossia, differentemente dal rito hanafita che è imperniato sull’opinione e sull’interpretazione razionale delle fonti. esperto di fiqh sunnita, Malik ibn Anas (ibn Malik ibn Amr al-Asbahi), sponsorizzato dal giurista e teologo Assad ibn-al Furat, “successore dei successori” del profeta Maometto. Nel 1055 iniziò la dinastia berbera, proveniente dal Sahara, degli Almoravidi, i “conquistatori riformisti”, che restarono al potere fino al 1147. In ordine, nel 1035 Yahya bin Ibrahim, capo berbero della tribù Judala, di ritorno dal pellegrinaggio alla Mecca, decise di convertire il suo popolo ai precetti dell’islam. Due anni più tardi, Abd Allah ibn Yasin, capo spirituale ed ideologo malikita, rilevando la mancanza di una buona conoscenza dell’Islam in Maghreb, cominciò a porre le basi dottrinali del movimento almoravide. Fondò così un ribat (convento fortificato) nell’isola di Tidra, in Mauritania e nel 1055 conquistò la città marocchina di Sigilmassa. Yusuf ibn Tashfin succedette a Ibn Yasi, morto in combattimento, e in qualità di primo sovrano almoravide fondò Marrakech nel 1060. Tra il 1063 e il 1082 lavorò per unificare il Marocco e l’Algeria occidentale, fondando il regno di Tlemcen. In seguito, s’impegnò coi principi arabi di Spagna (“i re delle Taifa”) a combattere contro Alfonso VI di Castiglia, che riuscì a sconfiggere a Sagrajas nel 1086. Nel giro di pochi anni, divenne padrone di tutta l’Andalusia. A succedergli fu Ali ibn Yusuf ibn Tashfin, che si scontrò subito con i principi cristiani e coi berberi Almohadi. Dopo di lui, Tashfin ibn Ali’ morì cadendo in un precipizio mentre fuggiva da una battaglia ad Orano e gli ultimi due re Almoravidi non fecero che accelerare la caduta della dinastia, che lasciò spazio, nel 1147, agli Alhomadi che conquistarono Marrakech. Gli Almohadi (“affermatori dell’unicità di Dio”), dinastia di berberi, governarono sul Maghreb e sulla Spagna mussulmana fino al 1269. Arrivarono al potere con Ibn Tumart, ma fu Abd al Mu’min ad impadronirsi di Marrakech e a diventare “comandante dei credenti”. Egli dotò il paese di una flotta imponente, di una rete di strade e di una prima vera amministrazione centrale. Condusse la guerra contro la Spagna e unificò l’Africa del Nord che divenne la prima potenza mediterranea su terra e mare. Il suo impero, con la presa di Cordova nel 1148 e di Granada nel 1154, comprendeva l’insieme del Maghreb e il Bilad al-Andalus occidentale. Abd al Mu’min impose il principio di ereditarietà dinastica, sicché suo figlio, Abu Ya’qub Yusuf, potè succedergli alla sua morte nel 1163. Il figlio di quest’ultimo, Abu Yusuf Ya’qub al-Mansur (“reso vittorioso da Dio”) allargò il dominio almohadita su tutta la Spagna islamica, infliggendo nel 1195 una dura sconfitta ad Alfonso VIII di Castiglia nella battaglia di Alarcos. Circa tre lustri dopo (16 luglio 1212), gli stati cristiani di Spagna (Castiglia, León, Aragona e Navarra) e del Portogallo riuscirono a battere i mussulmani nella battaglia di Las Navas de Tolosa. Iniziò così l’inesorabile declino degli Almohadi, che persero Cordova nel 1236, Valencia nel 1238, Siviglia nel 1248 e infine Marrakech che passò ai Merinidi nel 1269. La dinastia dei Merinidi, berberi provenienti dal Nord del Sahara, durò fino al 1465. Nel secolo XIV i Merinidi (“i grandi costruttori”) tentarono di estendere il loro dominio sulla penisola iberica, riuscendo a riconquistare Gibilterra e una parte dell’Andalusia, prima di cadere contro i cristiani nella Battaglia di Tarifa (1340) che li costrinse ad abbandonare la penisola iberica. I cristiani riconquistarono alcune località della costa, approfittando della morte del re merinide Abu Inas Faris e del conseguente indebolimento della dinastia. Una famiglia di visir, i Banu Wattas o Wattasidi, esautorò definitivamente i Merinidi, sostituendosi a loro nell’esercizio del governo ed assumendo i pieni poteri sulle regioni dell’attuale Marocco. I Wattasidi governarono dal 1465 al 1511: la loro fu essenzialmente un’azione di resistenza passiva contro i cristiani e di salvaguardia dell’indipendenza. Sotto i wattasidi, peraltro, aumentarono gli scambi commerciali con l’Europa, a scapito di una relazione economica e politica più stretta con gli altri popoli del Sahara. Nel 1511 arrivarono al potere i Saadiani, la cui dinastia restò al governo del Marocco fino al 1666. Sotto di loro, il Marocco visse una nuova fase di crescita ed espansione: essi riconquistarono Marrakech nel 1525 che tornò ad essere la capitale del paese. Sotto Mohammed ash-Sheikh, I Saadiani cacciarono i cristiani da Agadir, da Safi e Azemmour (nel 1541) e nel 1578 si difesero strenuamente contro i portoghesi in una delle battaglie più sanguinose del sedicesimo secolo. I portoghesi provarono a riprendersi le città di Agadir, Safi, Azemmour e Mogador, non avendo conservato altri domini in Marocco al di fuori delle piazzeforti di Tangeri, Ceuta e Mazagan. La “battaglia dei tre re” (così denominata perché morirono tre sovrani: Sebastiano I “il desiderato” di Portogallo, Mohammed e l’aspirante sovrano marocchino Moulay Abdelmalek Es-Saadi, zio di Mohammed) svoltasi a Ksar el Kebir, si risolse in una carneficina e nella sconfitta dei portoghesi, che rinunciarono alle proprie ambizioni coloniali e furono annessi dalla Spagna di Filippo II. Lo stesso giorno della vittoria sui portoghesi, salì al potere in Marocco Abou el Abbas Ahmed detto El Mansour (il vittorioso), quinto figlio di Mohammed, una delle figure più apprezzate della storia marocchina e del tardo Rinascimento. Grazie alle ricchezze sottratte ai portoghesi e alle quantità ingenti di oro raccolte in svariati missioni africane (Sudan, su tutte) el Mansour rinnovò completamente il Marocco rendendolo un paese ammirevole sotto diversi punti di vista. El Mansour rinforzò l’esercito, sviluppò l’artigianato e l’agricoltura, corroborò i rapporti commerciali con l’Europa, avviò una nuova politica di amministrazione statale e creò il grande palazzo di El Badi, a Marrakech. Tuttavia, i suoi continui investimenti e sperperi, volti a garantirgli forte immagine e consenso, prosciugarono velocemente le casse dello stato marocchino. La stessa conquista del Mali orientale (“la campagna Songhai”), avvenuta il 16 ottobre 1590 grazie ad un esercito di quarantamila uomini si risolse trenta anni dopo in una ritirata, visti gli alti costi della dominazione e il conflitto con il popolo locale. El Mansour morì di peste nel 1603 e fu sostituito da Abu Maali Zidan e da Fares Abou Abdallah. Nel 1666, con la conquista del Fez da parte di Mulay Rashid, salirono al potere gli Alawiti o Alawidi: una dinastia sunnita62 che vantava (e vanta tuttora) una discendenza dal Profeta per il tramite della figlia Fatima e del cugino Ali, suo consorte. Questa ascendenza sceriffale ha consentito agli alawiti di sopravvivere al colonialismo e di restare al potere fino ai nostri giorni. Il sultano più famoso del Marocco fu proprio l’alawita Mulay Ismail, fratello di Mulay Rashid, che regnò dal 1672 al 1727 e fondò l’impero degli sceriffi. Ismail strappò diversi porti africani agli europei, respinse gli assalti ottomani e le resistenze delle tribù non allineate, ottenne il controllo delle vie del commercio del Sahara, costruì Meknes (che divenne capitale del regno), eresse delle fortezze all’interno delle grandi città ed estese la sua autorità fino al Senegal. Con la morte di Ismail, il Marocco versò in un profondo disordine per diciotto anni, causato da numerose faide intestine che provocarono financo la perdita di un terzo del territorio. La pace tornò nel 1757 sotto Sidi Mohammed Ben Abdallah, noto per aver riconosciuto per primo l’indipendenza degli Stati Uniti. Egli fondò Essaouira, liberò Mazagan dall’occupazione portoghese e proclamò l’apertura del paese al commercio estero. Il suo successore, Mulay Sliman, riportò di nuovo in crisi il Marocco, che rallentò il commercio con l’Europa, interruppe la politica marittima e fu colpita da terribili epidemie. Dello stato di debolezza interna al Marocco approfittarono subito le potenze straniere: il sostegno dell’impero degli sceriffi all’emiro algerino Abd el-Kader provocò l’intervento militare della Francia nel 1844 e della Spagna nel 1859-1860. La sconfitta del Marocco di fronte alle tre potenze occidentali venne sancita dal Trattato di Tangeri (1844) e dall’Accordo di Tetuan (1844). Moulay el Hassan provò a mantenere in vita il potere sceriffale, unificando le tribù dell’Alto Atlante, e modernizzando il paese, ma nel frattempo il Marocco si indebitava sempre più con le banche. 62 Gli alawiti marocchini si distinguono dalla setta sciita alawita cui appartengono, tra gli altri, i Siriani (con la famiglia Assad). Alla conferenza di Algeciras del 1906 si decise di nominare la Francia e la Spagna come mandatarie della Banca di Stato del Marocco. Un anno dopo, in seguito all’omicidio di alcuni cittadini europei, i francesi occuparono Casablanca e nel 1909 la Spagna intraprese la conquista militare del Rif. Nel 1911 il nuovo sultano Moulay abd el-Hadif chiese l’aiuto dei francesi per liberare Fez, occupato da tribù ribelli: l’intervento francese costò ai marocchini la firma del Trattato di Fez, il 30 marzo 1912, che assegnava alla Francia il protettorato sul paese e garantiva nominalmente al Sultano le sue prerogative di sovranità, lasciando tuttavia il controllo della giustizia, degli esteri, della difesa e della finanze ad un Residente Generale, la cui controfirma era necessaria per ogni dahir (editto del re). Il protettorato francese era diviso in sette regioni: tre civili (Casablanca, Rabat e Oujda), tre militari (Fez, Meknes, Agadir) ed una mista (Marrakesh). In quelle militari, l’amministrazione era retta dai funzionari degli Affaires Indigènes e in quelle civili dai Contrôleurs civils. Pochi mesi più tardi, col Trattato di Madrid (27 novembre 1912) fu creata una zona d’influenza spagnola (comprensiva di Rif, Tarfaya e Ifni) dove l’amministrazione civile e militare era retta da un Alto Commissario, mentre il Sultano era rappresentato da un Khalifa, scelto comunque da Madrid. La Germania, che nell’estate precedente era arrivata quasi alle armi con la Francia per la crisi di Agadir, riconobbe il protettorato francese in cambio di concessioni territoriali ai tedeschi in Congo. Nel frattempo, Moulay abd el-Haif abdicava in favore del fratello Moulay Yousef ben Hassan. Rabat divenne capitale del Marocco, su decisione del generale Lyautey, nominato nel 1912 residente generale. Al tempo stesso, ebbe luogo la riorganizzazione amministrativa del Marocco che di fatto fu diviso in tre zone d’influenza: Tangeri (città internazionale), protettorato francese (a Rabat, dove risiedeva il sultano), protettorato spagnolo (a Tétouan, dove risiedeva un califfo nominato dal sultano). Negli anni a seguire e fino alla metà degli anni Trenta, scoppiarono rivolte in tutto il Marocco, sia contro i francesi sia contro gli spagnoli. Nel 1920 alcune tribù del Rif (guidate da Abdelkrim El Khattabi) in rivolta ebbero la meglio su quindicimila soldati spagnoli, dando sì origine alla Repubblica del Rif indipendente. Negli anni Trenta la crisi internazionale scatenò proteste anche in terra marocchina e il rinvigorimento delle opposizioni nazionalistiche, che nel 1937 (secondo alcuni, nel 1944) si organizzarono nel partito dell’Istiqlal o hizb al-Istiqlal (Partito dell’Indipendenza) di Allal al Fasi e Ahmed Balafrej: un’organizzazione nazionalista e panaraba che mirava all’indipendenza dalla Francia e alla costituzione del “Grande Marocco”. L’Istiqlal puntava inoltre al recupero della Canarie, del Sahara Occidentale, della Mauritania, di parte del Mali e del sud-ovest dell’Algeria. Il suo bacino militante risiedeva nelle città e nelle campagne e partendo da una base di 100.000 sostenitori arrivò nel giro di tre anni a circa un milione di affiliati. L’Istiqlal ottenne rapidamente anche il sostegno della componente araba della società marocchina e del nuovo sultano, Mohammed V (al secolo Sidi Mohammed ben Yusef), salito al trono dopo la morte del padre Yousef ben Hassan. Di lì a poco, scoppiò la Seconda guerra mondiale, con la conseguente occupazione tedesca della Francia nel 1940 e con la creazione dell’armata della Francia Libera di De Gaulle in Africa e lo sbarco alleato in Marocco nel 1942. Nel 1944 venne proclamato il manifesto dell’Indipendenza e nel 1947, nella città internazionale di Tangeri il sultano si pronunciò pubblicamente a favore dell’indipendenza. La richiesta non fu ben accetta, tanto che si registrò una crisi tra le autorità del protettorato e i nazionalisti e Mohammed V fu costretto ad abbandonare il Paese. La Francia poco dopo subì l’onta della sconfitta in Indocina e la rivolta in Algeria: conflitti che permisero a Mohammed V di tornare in patria (novembre 1955) per vedere riconosciuta prima dalla Francia e dopo dalla Spagna la definitiva indipendenza del Marocco (2 marzo 1956). Il 7 dicembre 1955 si era formato un Gabinetto di coalizione guidato dal Primo Ministro M’Barek Bekkai e costituito da venti partiti, di cui nove dell’Istiqlal, sei del Parti Démocraticque de l’Indépendance (Pdi), partito di intellettuali e grandi commercianti guidato da Mohamed Hassan Ouazzani, e cinque indipendenti. Mohammed V, subito dopo l’indipendenza, si mise all’opera per consolidare l’autonomia marocchina e lanciò politiche importanti nel campo della scolarizzazione, dello sviluppo energetico, del lavoro, della difesa militare e delle relazioni internazionali, con l’adesione alla Lega Araba (1 ottobre 1958). Con il dahir del 2 giugno 1961, l’impero sceriffiano diventò un “Regno arabo e mussulmano” e Mohammed V re anziché sultano. Nell’ottobre del 1957 l’Istiqlal ostacolò la formazione del Mouvement Populaire (sostenuto dalla popolazione rurale berbera) attirando su di sé gli strali delle altre forze di governo, che si dimisero in blocco, e circa un anno dopo arrivò a controllare l’intero governo, riuscendo ad eleggere Ahmed Belafrej come primo ministro. Conseguentemente furono chiusi tutti i giornali del Pdi e arrestati i leader del Mouvement Populaire. Alla fine del 1958 scoppiò una rivolta nell’ex protettorato spagnolo del Rif, dove le popolazioni berbere lamentavano la totale occupazione dei posti di governo da parte del partito nazionalista e di funzionari locali incapaci financo di comunicare in berbero o spagnolo (parlavano sono in arabo o francese) e la cattiva gestione delle politiche agricole. L’esercito inviò nel Rif circa ventimila uomini (Forces Armées Royales) guidati dal principe Moulay Hassan per reprimere crudelmente la sommossa. Nello stesso periodo, Mohammed V costituiva un nuovo governo, col radicale Abdallah Ibrahim che sostituiva Belefrej nel ruolo di primo ministro, in risposta agli scioperi di massa organizzati dal sindacato Umt (Unione Marocaine du Travail). L’ala sinistra dell’Istiqlal, guidata da Ben Barka, rimasta esclusa dal nuovo esecutivo, decise di formare prima la “Confederazione Nazionale dell’Istiqlal” (non una scissione, non una corrente, ma una sorta di frazione dell’Istiqlal) e dopo, a rottura avvenuta, l’Union National des Forces Populaires (Unfp) il cui segretariato fu composto da uomini del Mouvemente Populaire, del Pdi e della organizzazione segreta Munuzzama al-Sirriyya. Il 29 maggio 1960 si tennero le prime consultazioni elettorali dal giorno dell’indipendenza. Le elezioni, gestite in modo anomalo e pasticciato (risultarono candidati perfino dei minorenni), diedero la maggioranza all’Istiqlal col 40% dei consensi e il 23% dei voti all’Unfp. Poco prima di morire (per una banale operazione al naso) Mohammed V mise a punto una costituzione, che fu promulgata da suo figlio, il nuovo re Hassan II, nel 1962, e fu sospesa nel 1965 (quando venne proclamato lo stato d’emergenza) a causa di una sollevazione popolare per la crisi economica, fino alla proclamazione della nuova costituzione nel 1972. La Costituzione ottriata del novembre 1962 (approvata con referendum dal 99,56% dei votanti e promulgata il 7 dicembre 1962) fu sostenuta dall’Istiqlal e dal Mouvemente Populaire, ma non dall’Unfp che stigmatizzava l’accentramento dei poteri nelle mani del re. I cittadini marocchini ebbero sì la possibilità di rinnovare la bai’a63 e di legittimare il potere monarchico. Da quel momento in poi, tutti i successivi preamboli delle differenti costituzioni del regno qualificarono il Marocco come uno stato mussulmano, che contempla l’Islam come religione ufficiale (la cui riforma è vietata) garantendo al tempo stesso la libertà di culto. Nella costituzione del 1962 il re assurse a “comandante dei fedeli” (amir al-mu’minin), nel rispetto della tradizione islamica e alawita, ovvero a capo della comunità mussulmana, a guida (imam), rappresentante del Profeta tenuto ad ottemperare alla legge religiosa e a preservare l’integrità della 63 La bai’a è l’atto del riconoscimento, ovvero una base contrattuale contemplata dal Corano, attraverso la quale il popolo presta atto di sottomissione a ciascun nuovo re come autorità spirituale e temporale, in cambio dell’impegno del monarca a mantenere la pace, l’ordine pubblico, la giustizia e il rispetto dell’Islam. fede. In questo senso, stato e religione si fusero e la figura del monarca acquistava autorevolezza sia giuridica che religiosa. Nello stesso testo si contemplava, inoltre, il multipartitismo (art. 6) che alcuni videro come un’importante concessione democratica, altri come un’operazione volta a frammentare l’opposizione. La Corona ed i suoi diritti costituzionali divennero ufficialmente ereditari e si potevano trasmettere per via ereditaria ai figli maschi: una norma che numerosi ulema ritennero contraria ai principi islamici. Il re nominava e revocava il primo ministro e i ministri in generale (art. 24), presiedeva il Consiglio dei ministri, promulgava le leggi e le poteva sottoporre a referendum, nominava ed accreditava gli ambasciatori, firmava e ratifica i trattati, poteva sciogliere la Camera dei Rappresentanti (art. 27), comandava le Forze Armate Reali e il Consiglio Superiore della Magistratura (art. 33). il Re poteva inoltre dichiarare lo stato d’emergenza (état d’exception) dopo aver consultato i presidenti delle Camere ed indirizzato un massaggio alla nazione (art. 35). Il potere legislativo era attribuito ad una Camera dei Rappresentanti, eletta per quattro anni a suffragio universale e da una Camera dei Consiglieri (Majlis al-Mustacharin), eletta per due terzi in ogni prefettura e provincia da un collegio composto da membri delle Assemblee delle prefetture, di provincia e dei consigli comunali, mentre i restanti due terzi dalla Camera di Commercio ed Industria, dalla Camera dell’Agricoltura e dai rappresentanti sindacali. Il Majlis al-Mustacharin veniva eletto per sei anni ed era rinnovabile per metà ogni tre. L’iniziativa legislativa, oltre che naturalmente ai due rami del Parlamento, spettava anche al primo ministro. Il potere giudiziario era indipendente dal potere legislativo ed esecutivo, mentre il Consiglio Superiore della Magistratura era presieduto dal re e dal ministro della Giustizia, come vicepresidente. Un’Alta Corte di Giustizia giudicava i membri del governo responsabile di crimini commessi durante l’esercizio delle proprie funzioni, mentre una Camera Costituzionale vigilava sull’elezione dei membri del Parlamento e sui referendum. L’iniziativa di revisione della Costituzione apparteneva sia al primo ministro che al Parlamento e doveva essere votata dalla maggioranza assoluta di quest’ultimo ed era valida solo dopo l’approvazione di un referendum popolare. Grazie a questo assunto squisitamente marocchino, Hassan II riuscì a governare lo stato con pugno di ferro e con quella forza di cui necessitava il Marocco nei primi anni d’indipendenza. Il sistema veniva a reggersi dunque su tre pilastri fondamentali: l’islam, l’integrità territoriale e l’autorità sacra e inviolabile del monarca (che si estende anche ai suoi editti – dahir) riconosciuta dal popolo. Il politologo Mohammed Tozy (1999) spiegava che: il sistema è caratterizzato da una doppia tensione che neutralizza tutte le velleità di trasformazione radicale. Si tratta in primo luogo del radicamento di una cultura autoritaria che tocca tanto la monarchia quanto la classe politica; e, in secondo luogo, della centralità della religione nel suo dispositivo di legittimazione e di costruzione di un controprogetto di società. Tra il 1962 e il 1964, Hassan ripropose la politica espansionistica del “Grande Marocco”, entrando in conflitto con l’Algeria e creando una tensione tra i due paesi che resta vivida ancora oggi. Il Marocco era interessato ad alcune zone di frontiera con il Sahara (Béchar e Tindouf), cui la Francia teneva in modo particolare vista la ricca presenza di petrolio nell’area e la possibilità di sfruttarla per gli esperimenti nucleari64, ragione per la quale si scontrò con l’Algeria nella “guerra delle sabbie”, terminata con il cessate il fuoco del 20 febbraio 1964. Nei primi mesi del 1965 ebbero inizio i cosiddetti “anni di piombo”: il 23 marzo del 1965 gli studenti di Casablanca, Fez e Rabat, insieme con gli abitanti delle bidonville manifestarono contro il governo che proibì agli studenti maggiori di quindici anni, provenienti dalle classi meno abbienti, di 64 Il 13 settembre 1960 la Francia aveva fatto esplodere la sua prima bomba atomica nella stessa zona. proseguire gli studi. Il governo sedò la rivolta nel modo più brutale: mitragliò i manifestanti da un elicottero, provocando circa 1.500 morti (per Hassan II furono solo 70). Per il clima di tensione creato dagli studenti e per tante altre proteste annunciate a livello locale, il sovrano decise, come già indicato, di sospendere la costituzione e di governare da solo. Al contempo, provò a ricucire lo strappo con Ben Barka, che però non tornò mai dall’esilio: il 29 ottobre 1965 l’ex leader della sinistra Istiqlal fu rapito e torturato a morte nei pressi di Parigi. La nuova costituzione del Marocco (20 marzo 1970) rendeva apparentemente democratica la svolta autoritaria di Hassan II: veniva creato un parlamento monocamerale eletto in parte a suffragio universale e in parte da rappresentanti municipali vicinissimi al governo. Questa costituzione fu riformata il 15 marzo 1972, ma le modifiche non intaccarono l’accentramento del potere nelle mani del sovrano. Hassan subì, a questo punto, due tentativi di colpo di Stato e un attentato tra il 1971 e il 1972 per opera di cospiratori militari che si erano ispirati agli “ufficiali liberi” egiziani e libici. Questi tentativi fallirono e gli attentatori-golpisti furono giustiziati dopo processi sommari. Il 15 agosto 1974 il sovrano mobilitò l’esercito marocchino per invadere l’ex Sahara spagnolo (Sahara occidentale). Mentre il popolo saharawi rivendicava (e rivendica tuttora) il diritto inalienabile all’autodeterminazione su un territorio che prima della dominazione spagnola non aveva conosciuto sottomissione, i giuristi marocchini sostenevano che il Sahara facesse parte del Bled es-Siba, i cui abitanti avevano riconosciuto l’autorità religiosa del sultano e che quindi appartenesse al Marocco. La Spagna reagì inviando la flotta davanti alle coste atlantiche e costringendo Hassan II alla ritirata, anche se il sovrano non smobilitò i ventimila uomini ammassati lungo le frontiere con il Sahara. Nel settembre 1975 l’Onu riconobbe il diritto del popolo saharawi all’autodeterminazione, sostenendo parimente che avesse innegabili legami storici sia con il Marocco che con la Mauritania. Ma Hassan II ritenne la sentenza dell’Onu favorevole al Marocco ed invitò tutta la popolazione ad entrare pacificamente nel Sahara occidentale: ebbe così inizio la “Marcia Verde” (6 novembre 1975), che coinvolse circa 530.000 uomini, che marciarono muniti di Corano e di ritratti di Hassan II. I “volontari” ottennero il sostengo dell’opposizione marocchina, della Mauritania, dall’Olp palestinese e di quasi tutti i paesi arabi. I militari spagnoli abbandonarono il territorio non perché manchevoli di forza ed uomini per affrontare i marocchini –per quanto il numero di uomini arruolati da Hassan fosse realmente impressionante- ma per la malattia di Franco che sarebbe morto di lì a poco (20 novembre 1975). Il 14 novembre 1975, con l’Accordo di Madrid, Spagna, Marocco e Mauritania stabilirono l’amministrazione comune del Sahara sino al 28 febbraio 1976, data in cui il territorio sarebbe stato diviso tra il governo marocchino e quello mauritano. Il 12 gennaio 1976 l’ingresso delle truppe marocchine e mauritane nel Sahara occidentale scatenò la reazione decisa dei sahariani e la proclamazione, da parte loro, della “Repubblica Araba Saharawi Democratica” (Rasd). Nel 1979 i marocchini furono attaccati e sconfitti nella città di Tan-Tan, nonostante godessero del sostegno francese. Nel luglio 1980 ben ventitre stati riconobbero la Rasd, fino agli ottanta attuali (nessuno in Occidente), sebbene i saharawi non abbiano mai ottenuto l’effettiva indipendenza. Dal 1991 è in atto una tregua vigilata dall’Onu che ha istituito la Missione delle Nazioni Unite per il Referendum nel Sahara Occidentale (Minurso). Il compito della Minurso era anche quello di organizzare un referendum sullo status definitivo del Sahara Occidentale che non è mai stato effettuato. Nel 2004 la durata della missione Onu fu prorogata per consentire l’esame di una nuova proposta di pace, ma nel frattempo continuarono le proteste e le manifestazioni, come quella – significativa e pacifica- svoltasi nel 2010 a Gdeim Izik, nei pressi di El Aium, capitale dei Territori Occupati. Come ha ribadito Abdel Kader Taleb Omar, primo ministro della Rasd, in una recente intervista 65, i 65 L.Attanasio, Abbandonati da tutti, i saharawi sono pronti a riarmarsi, intervista ad Abdel Kader Taleb Omar, Limes on line, 4/10/2011. sarahawi chiedono a gran voce un referendum per l’autodeterminazione, negato categoricamente dal Marocco. Il primo ministro ha nel contempo paventato la formazione di soggetti politici più radicali in Sahara: Dobbiamo trovare fatti, non più parole, per convincere la popolazione. Io ho finito le parole e temo che possa nascere una sorta di Hamas saharawi al nostro interno e che questa fazione possa prevalere. e non ha salutato positivamente le innovazioni costituzionali di Mohammed VI, caldeggiando un timido sostegno ai movimenti di protesta contro il sovrano: Non voglio qui esprimere un parere a riguardo, saranno i cittadini marocchini, i vari movimenti di protesta come il “20 febbraio” a dire se garantirà maggiore democrazia. Il punto è molto semplice: la Costituzione non potrà cambiare le sorti del nostro popolo perché noi non apparteniamo al Marocco, nessun diritto internazionale riconosce il Sahara Occidentale come proprietà marocchina. Nel 1979 la vittoria khomeinista in Iran, da un lato, entusiasmò diversi gruppi islamisti e giovani studenti, dall’altro spaventò Hassan II che temeva una immediata ricaduta interna, anche a fronte del fatto che lo shah Mohammad Reza Pahlavi aveva trovato riparo proprio in Marocco. Nel 1980, il re fece emanare dagli ulema una fatwa che condannava come anti-islamica la rivoluzione khomeinista e contemporaneamente diede ordine di costruire a Casablanca una moschea (la Moschea Hassan II), la seconda più grande al mondo dopo quella della Mecca. Con quest’operazione, ricorrendo ad una severa repressione e a condanne a morte contro diversi gruppi islamisti (come “Giustizia e Carità” e la stessa Istiqlal), Hassan riuscì a congelare il quadro politico e religioso del suo paese. Nel 1981 Hassan II cedette alle richieste del Fondo Monetario Internazionale e conseguentemente aumentò i prezzi dei generi di prima necessità. Ne scaturì un’insurrezione popolare (“Rivolta di Casablanca”) che lasciò una pesante scia di sangue in Marocco fino agli inizi degli anni Novanta, quando venne istituita la “Commissione per la Verità e Riconciliazione” per investigare sui crimini commessi nel corso del conflitto interno. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta il sovrano intensificò i rapporti con la Libia (strinse un’alleanza con Gheddafi il 13 agosto 1984), con l’Arabia Saudita, con Israele (in segreto)66 e con gli Stati Uniti. Questo rapporto privilegiato con l’Occidente non provocò grandi reazioni, fino alla seconda guerra del Golfo, quando Hassan II inviò milleduecento soldati in Arabia Saudita per liberare il Kuwait invaso da Saddam. Questa scelta fu contestata dalla popolazione che diede vita, il 14 dicembre 1990, a dimostrazioni in quasi tutte le città del regno e che andarono avanti per tutta l’estate. Fu così che Hassan, il 4 settembre 1992, ideò una nuova Costituzione fondata sui principi universali dell’uomo, su alcuni cambiamenti alle prerogative del primo ministro e della Camera dei Rappresentanti, sulla creazione di un Consiglio costituzionale che vigilava sull’applicazione e la stessa costituzionalità delle leggi. Dal 1994 in poi, Hassan II, al fine di tessere rapporti commerciali con l’Europa (e per consolidare la sua alleanza con gli Stati Uniti) adottò una politica interna più tollerante e liberò circa duemila oppositori politici. Il 13 settembre 1996 venne adottato con un referendum una nuova Costituzione che rafforzò i poteri del Parlamento e riportò il bicameralismo in Marocco. Venne istituita una Camera dei Rappresentanti (Majlis al-Nawab) con trecentoventicinque membri eletti per sei anni a suffragio universale diretto e rinnovata di un terzo ogni tre anni (art.36-37); una Camera dei Consiglieri (Majlis al-Mustacharin), con duecentosettanta membri di cui 3/5 eletti in ogni regione da un collegio elettorale composto da rappresentanti delle collettività locali e 2/5 eletti in ogni regione da 66 Israele fornì al Marocco armi sofisticate per la lotta alla guerriglia ed assistenza tecnica per combattere la siccità. membri scelti dalle camere professionali ed a livello nazionale dai rappresentanti dei salariati (art.38). Fu l’ultimo lascito di re Hassan II che morì il 23 luglio 1999. Suo figlio, Mohammed VI, al secolo Sidi Mohammed, fu intronizzato il giorno stesso. I nuovi equilibri della corona e gli attentati terroristici di Casablanca del 2003, quando dodici kamikaze provocarono quarantacinque morti, hanno reso in questi anni ancora più complesso il quadro dei rapporti tra lo stato e le organizzazioni islamiste. A tal proposito, è utile sottolineare che se la monarchia alawita è riuscita a domare le opposizioni, a coinvolgerle nell’attività governativa e perfino ad annientarle, non ha nel contempo risolto il problema dell’islam radicale e superato i difficili rapporti con le organizzazioni mussulmane, anche se apparentemente lontane da propositi terroristici. Sotto Hassan II, comparvero i primi veri gruppi organizzati di stampo islamista (alcuni scomparsi, altri ancora attivi) che criticarono duramente la dinastia alawita. Nel 1969 Abd al-Karim Muti fondò il gruppo islamico radicale al Shabiba al-Islamiyya (Gioventù Islamica). Pur essendo la prima organizzazione islamica del Maghreb, nasceva in ritardo rispetto a tanti altri movimenti africani dello stesso lignaggio, a partire dal movimento pionieristico dei Fratelli Musulmani in Egitto, fondato nel marzo del 1928 da Hasan al-Banna. Questo nuovo soggetto non arrivò subito allo scontro con gli alawiti, che piuttosto cercavano il confronto e la collaborazione coi mussulmani più radicali in un’ottica di fronte unico contro la sinistra radicale e i movimenti panarabi. La normalizzazione dei rapporti governativi con la sinistra radicale e l’apertura del fronte sahariano provocarono un allontanamento del governo dalla Gioventù Islamica, che iniziò a criticare Hassan II per la sua politica imperialistica ed antisionista fino alla fuga all’estero di Muti, accusato dell’assassinio del giornalista Omar Benjelloun. Nell’ottobre 1981 dalla Gioventù Islamica uscì la corrente (più moderata) della Opción Islámica che nel 1995 si trasformò in Alternativa Civilizada. La professoressa Paloma Gonzáles del Miño dell’Universidad Complutense de Madrid distingue due fasi dello sviluppo politico dell’Islam nel paese: una prima fase -che va dai primi anni Settanta alla metà degli anni Ottanta- caratterizzata dalla lenta, progressiva penetrazione del movimento islamista nella società e una seconda –che va dalla metà degli anni Ottanta ai nostri giornicaratterizzata da comportamenti eterogenei della corona, fatti di tolleranza, repressione e politiche contraddittorie. L’anno che fa da spartiacque nella storia dell’islam nazionale è in realtà il 2003: gli attentati organizzati dai kamikaze della bidonville di Sidi Moumen (per conto di Salakia Jihadia, un ramo del “Gruppo islamico combattente marocchino” – Gicm – affiliato ad al-Qaeda ed eterodiretto da alZarqawi) hanno distrutto la tesi dell’ “eccezione marocchina” e hanno provato che l’autorità religiosa del monarca non può più fare da scudo contro il fenomeno dell’islam radicale. In particolare si sono palesate l’incapacità della dinastia di trascendere e superare le divisioni (claniche, confessionali, regionali, politiche), la difficoltà governativa nel promuovere una politica realistica e coerente e l’incapacità di annullare o sintetizzare le pluralità politiche presenti nella società. L’inserimento obbligato e accelerato del Marocco nel sistema di alleanze occidentali e nella lotta contro il terrorismo internazionale ha maggiormente acuito la scissione degli alawiti dagli altri settori dell’islamismo marocchino. Parimenti, il tentativo di Mohammed VI, successivo ai fatti di Casablanca, di riprendere il controllo del quadro religioso nazionale attraverso una legge antiterroristica e la proclamazione della “fine dell’era della negligenza” è risultato ai più una mera operazione di propaganda e addirittura un azzardo grossolano, a fronte dell’abilità degli estremisti mussulmani di crescere e rafforzarsi proprio laddove si restringono gli spazi democratici. Invero, il movimento islamico marocchino non è mai stato un fenomeno compatto e omogeneo (quindi facile da studiare ed eventualmente colpire) ed è mutato a seconda dei tempi e degli obiettivi politici che le organizzazioni mussulmane e la corona si erano posti di volta in volta. Sommariamente, i movimenti islamici marocchini si dividono in tre categorie: i gruppi radicali che non escludono di ricorrere alla violenza e alla jihad per raggiungere i propri obiettivi e che hanno relazioni più o meno strette con le centrali del terrore di stampo qaedista; settori più pragmatici, inseriti nel contesto istituzionale, come il Partito Giustizia e Sviluppo; un’associazione-movimento, che fa categoria a sé, come Giustizia e Spiritualità di Abdessalam Yassine che contesta la legittimità religiosa della monarchia alawita, condanna la violenza, non partecipa alle elezioni politiche e rifiuta la forma partito. Il jihadismo marocchino si può dividere, a sua volta, in due macrocorrenti: il wahabismo, di stampo saudita, rappresentato da Mohammed Ben Abderrahmane al Maghraoui, che nel 2008 ha lanciato una fatwa con la quale dichiarava legale il matrimonio delle bambine dai nove anni in su, e la salafya jihadia cui appartengono organizzazioni come la Recta Vía e il “Gruppo Islamico Combattente Marocchino” (Gicm). Il wahabismo ha una lunga storia di penetrazione in Maghreb, ma nei fatti è sempre stato un movimento marginale, tanto più in Marocco dove l’islam ha sempre avuto connotati nazionalisti. Non a caso, il suo ingresso in Marocco non si giustifica con un movimento “dal basso” o con operazioni o con l’adesione di singoli clan, ma come una operazione gestita “dall’alto” da parte dei governi marocchini. Gli alawiti, infatti, hanno sfruttato i sauditi sia per ragioni squisitamente economiche (è notoria la ricchezza d’idrocarburi da parte dell’Arabia Saudita e, quindi, la facilità con la quale può comprare alleanze) sia per questioni di utilitarismo politico-religioso, in quanto dal wahabismo stesso gli ultimi sovrani marocchini hanno attinto la fortissima strumentalizzazione dell’ideologia al fine di legittimare la propria sovranità. È da aggiungere che l’Arabia Saudita, come già spiegato, aiutò in modo rilevante il Marocco nelle prime fasi della guerra in Sahara, costruendo i muri difensivi del deserto (Ruiz Miguel, 2003). L’uomo che è ritenuto responsabile della legalizzazione del wahabismo nel Paese è, nella fattispecie, l’ex ministro del terzo governo Lamrani (1992-1994) Abdelkader M’Dagri Alaui, che ritenendo inevitabile l’espansione islamica nel paese tentò una politica d’integrazione. Passando al salafismo jihadista, il Gicm è un gruppo sunnita, affiliato ad al-Qaeda, che trae origine nella guerriglia afghana degli anni Ottanta. È emerso nel 1990 ed è composto da reclute marocchine addestrate nei campi armati in Afghanistan. Il Gicm è ritenuto responsabile, dalla Cia e dal governo marocchino, degli attacchi a Casablanca nel 2003, degli attentati dell’11 marzo 2004 a Madrid e alla stazione di Atocha (che causarono circa centonovantuno vittime e duemila feriti), degli attacchi a Casablanca del marzo-aprile 2007 (un kamikaze saltò in aria in un internet caffè alla periferia della città, nel sobborgo di Sidi Moumen, provocando un morto e quattro feriti). Il presunto fondatore del Gicm, Saad Houssaini, è stato catturato nel 2007 dalla Brigata Antiterrorista Marocchina, dopo gli attentati di Casablanca, e la sua fuga in Iraq è stata favorita da Abu Musab al-Zarqawi e da una cellula di al-Qaeda attiva in Germania. Il Gicm è stato bandito in tutto il mondo dal Comitato 1267 delle Nazioni Unite poco dopo l’attentato alle Torri Gemelle (gli Usa considerano il gruppo come un’organizzazione terroristica dall’11 ottobre 200567). Il gruppo -storicamente attivo in Marocco, Algeria, Mauritania, Sahara occidentale (che ha difeso contro il Marocco), Europa occidentale, Afghanistan e Canada- si sarebbe sciolto nel 2007, ma è molto probabile che i suoi uomini siano tuttora attivi in altre organizzazioni terroristiche. Alla seconda categoria (organizzazioni islamiste inglobate nelle istituzioni) appartiene il Partido de la Justicia y el Desarrollo (Pjd), il più importante partito di opposizione nel Parlamento marocchino. È presente nelle istituzioni dal 1997, anno in cui questa sigla prese forma dall’unione di diverse formazioni islamiste con il Movimiento Popular Constitucional y Democrático di AlJatib. 67 Capitolo 8, Foreign Terrorist Organization, Country Reports on Terrorism 2005, Dipartimento di Stato, 30 aprile 2006. Il Pdj è stato il terzo partito più votato nel 2002 68 e nel 2007 ha superato tutti gli altri partiti in termini di preferenze e percentuali di voto, pur restando all’opposizione. Il suo presidente è, dal 2007, Saadeddine Othmani. Il Pjd è uno dei partiti islamici più anomali della storia africana: raccoglie un numero copioso di militanze femminili, si professa moderato69, fa un’opposizione dura e senza sconti alla dinastia alawita (attualmente capeggia le proteste contro la nuova Costituzione e dà supporto al “Movimento 20 febbraio”), ma è guardato con sospetto dall’Occidente dal giorno degli attentati di Casablanca, sebbene non sia stata mai provata la sua partecipazione e i suoi dirigenti abbiano condannato l’accaduto in più di un’occasione. La storia del nocciolo duro del Pjd, Yamaa Al-Islah at Tawhid, si divide in quattro tappe: dal 1982 al 1984 il movimento lavorò in clandestinità; dal 1984 al 1992 Yammaa Al-Islah si frammentò (tatticamente) in più associazioni; dal 1992 al 1996 iniziò il lavoro di riorganizzazione e riunificazione; dal 1997 ad oggi vi è stata la formazione e la costruzione del nuovo partito Pjd. La presentazione alla elezioni fu un fatto straordinario, ma non esclusivo nella storia istituzionale marocchina: già alle elezioni del 1993 si presentarono candidati islamici indipendenti che però non ottennero alcun seggio. Oggi il Pjd lotta pubblicamente ed istituzionalmente contro la corruzione governativa e la disparità sociale, è favorevole ad un’ “applicazione progressiva e razionale della sharia”, si oppone alla politica complessiva di Mohammed VI, ma non mette in discussione l’islam di stato e l’elevazione del sovrano a Comendador de los Creyentes. Il partito critica il governo sulla politica estera, in particolare per l’alleanza con gli Usa e le relazioni con Israele, ma sul piano interno mantiene un profilo riformista e difende l’applicazione della mudawana70 sulla quale la monarchia ha costruito la sua immagine e l’azione modernizzatrice. Il Pjd è tuttora diviso in due livelli (di qui le accuse di doppiezza e camaleontismo politico): la funzione politica e istituzionale è affidata, come detto, ai quadri e alla sigla stessa del Pjd, il lavoro “sociale e di base” (e quindi l’azione di proselitismo o dawa) del partito è rimandato a sotto-gruppi di movimento raggruppati nel “Movimento per l’Unità e la Riforma” (Mur): una struttura apparentemente indipendente ma che in realtà è legata a filo stretto con i vertici del partito. Questa doppiezza è il vero punto critico del Pjd, perché da un lato scontenta la base, sempre più insofferente per il “governismo” del partito e per la sua azione contraddittoria e deideologizzata, dall’altro spaventa il governo e gli analisti più attenti ai fenomeni di trasformismo islamista, che temono i nefasti effetti di quella che il politologo francese Olivier Roy ha definito come “logica della banalizzazione”. Vale la pena riportare qui una sintesi della considerazione di Roy a proposito di questi fenomeni: Quello che traspare dietro la crisi dell’islamismo non è il ritorno di ideologie precedenti (nazionalismo arabo o laicismo di tipo kemalista), anch’esse in crisi, ma una deideologizzazione, di cui i discorsi sulla società civile e il patto politico sono dei sintomi piuttosto che delle alternative. 68 Il risultato acquista ancora più importanza se si considera che il Pjd non si presentò in tutto il territorio nazionale. Nella stessa occasione, il Pjd denunciò brogli elettorali. 69 I dirigenti del Pjd per marcare la rottura con il radicalismo degli anni passati hanno più volte ribadito che “il cambiamento della società marocchina non può intervenire che gradatamente, nella fattispecie con l’insegnamento e l’educazione di massa, all’interno di un partito politico autorizzato”. 70 La mudawwana è la raccolta di testi giuridici o codici di legge di un paese. Riguarda, in particolare, le raccolte organiche di testi giuridici scritti da singoli esperti di diritto islamico sullo statuto personale e il diritto di famiglia. In un certo senso, la banalizzazione dell’islamismo segna la vittoria della reislamizzazione: il fatto che l’impronta dell’Islam sulle società musulmane (almeno nelle apparenze, per esempio nell’abbigliamento) sia oggi molto più forte rispetto a trent’anni fa, è un effetto dell’islamismo? Non se ne può essere così certi perché, inversamente, si può notare che questa banalizzazione dell’Islam genera proprio il fenomeno in contrapposizione a cui l’islamismo si definiva: la comparsa di uno spazio laico, non nel senso di “non religioso”, ma nel senso che questa reislamizzazione (essa stessa confusa, diversificata e contraddittoria) è contrassegnata dal rifiuto del politico: avviene al di fuori dell’ordine politico, ridotto allora alla sua logica propria, sottolineando l’impossibilità della “totalizzazione” sociale che è uno dei tratti caratteristici dell’islamismo 71. All’ultima categoria di organizzazioni (le più complesse e imponderabili) appartiene il movimento islamista Justicia y Caridad, la cui base ideologica è il prodotto di una commistione di mahadismo, sufismo e jerifismo72. Justicia y Caridad è considerato il partito islamico più forte e radicato del Marocco, nonostante non partecipi alle elezioni e sia enormemente sottovalutato a vantaggio dell’istituzionale Pjd. Il movimento è stato fondato dallo sceicco Abdessalam Yassine, leader carismatico che ha vissuto tra carcere e arresti domiciliari trenta anni della sua vita ed è considerato il teorico islamico più importante e influente del Marocco. Per diversi anni ha indicato ai suoi seguaci la strada da seguire non soltanto citando il Corano, ma raccontando anche i sogni e le apparizioni di Maometto al suo cospetto. Yassine era un ex funzionario del ministero della Pubblica Istruzione che, sotto Hassan II, propagandava l’instaurazione in Marocco di un stato islamico, in opposizione al sovrano che considerava troppo sensibile ai valori (e agli interessi) dell’Occidente e inadatto a svolgere il ruolo di capo di governo e comandante dei fedeli. Da giovane era stato un sostenitore di Sayyid Qutb ed ha sempre considerato gli stati non retti sulla legge coranica come stati empi, sostenendo con forza il ritorno al califfato, al sistema di Stato introdotto dal profeta Maometto e, mutatis mutandis, dall’Iran negli anni della rivoluzione. Nel 1974 Yassine indirizzò una lettera che superava le cento pagine dal titolo El islam o el diluvio nella quale invitava provocatoriamente il sovrano a pentirsi per i suoi peccati e a ritornare sulla strada dell’islam. Hassan II non uccise Yassine per non scatenare una guerra religiosa in Marocco, ma fece subito rinchiudere il suo accusatore in un manicomio, dal quale Yasin uscì solamente nel 1979. In un raro momento di libertà, Yassine fondò l’associazione Ousra al-Jamma (come comitato di beneficenza), dalla quale nel 1983 nacque la al-Jamaa che riscosse notevole successo nel proletariato urbano. La fondazione di Justicia y Caridad (o al-Adwal-Ihsan) è datata intorno al 1988 e il portavoce attuale è Fathallah Arsalan. Come aveva fatto con Hassan II, Yassine inviò un memorandum alquanto duro e sferzante a Mohammed VI, all’atto della sua incoronazione, che per sua fortuna non provocò un’immediata reazione del re. Justicia y Caridad è tollerato dal governo, ma è a tutti gli effetti un partito illegale. Non solo perché rifiuta la partecipazione elettorale, ma perché a differenza del Pjd non riconosce Mohammed VI come comendador de los creyentes , pur dichiarandosi un movimento non violento. 71 O. Roy, Global Muslim, Le radici occidentali del nuovo Islam, Feltrinelli, Milano, 2003. 72 Il jerifismo è la dottrina del sufismo che si richiama a El Yazuli come capo spirituale e al jerife (discendente di Maometto) Abu Abdallah Mohammed Es Saiidi. Intorno alla metà del 1400 raggiunse i 12.000 affiliati e scelse la strada della jihad. L’azione del movimento risulta imperniata su tre assi: propaganda religiosa, intervento politico, azione sociale. L’elemento dell’educazione è molto sentito e d’altronde Yassine, in qualità di ex ispettore scolastico, ha sempre considerato l’istruzione come un volano per la conversione all’Islam e per la diffusione delle sue idee. Si spiega così l’intervento di Giustizia e Carità nelle università, dove ha conquistato la militanza di studenti molto noti per la loro aggressività e intolleranza contro gli studenti di sinistra e i giovani meno sensibili alle tematiche islamiche. Questi stessi studenti hanno conquistato quasi completamente l’ “Unione Nazionale degli Studenti del Marocco”, che era in origine un movimento di sinistra vicino alla “Unione socialista delle forze popolari” e ai marxisti-leninisti di Al Amame e del “movimento 3 marzo”. Negli ultimi tempi la soglia di attenzione del governo su Justicia y Caridad è cresciuta notevolmente: il governo sta procedendo a controlli e operazioni di polizia mirati per indebolirlo e ottenere informazioni, anche a fronte dell’intervento di quest’organizzazione nel “movimento 20 febbraio”. Tuttavia, Justicia y Caridad ha recentemente deciso di mitigare la sua azione di lotta e disturbo, aprendo parzialmente al re sulle modiche della costituzione e dichiarando superato il richiamo al modello di stato iraniano. Nel frattempo, il movimento si rafforza tra i più giovani e allarga le sue maglie nel resto del mondo: ha seguaci in Francia, Belgio, Paesi Bassi e Stati Uniti. La figlia di Yassine, Nadia, tiene regolari conferenze in Europa. Un raid della polizia marocchina, effettuato nei locali del movimento nel maggio 2006, ha svelato che il movimento ha circa centomila iscritti e più di trentamila sostenitori. Ma non è affatto azzardato ipotizzare che la crisi economica, da un lato, e le sirene della primavera africana dall’altro, abbiano moltiplicato il numero dei suoi affiliati e simpatizzanti, nonché i suoi legami con organizzazioni estremiste di altri paesi (in particolare, Sudan, Egitto e Giordania). Il fatto che il Pjd appaia ai settori più ideologizzati del movimento studentesco e giovanile un partito colluso col potere corrobora ancora di più la tesi secondo la quale “Giustizia e Carità” continuerà a rappresentare un problema sia per il Marocco sia per l’Occidente. In conclusione, la disaffezione della popolazione dal carisma di Mohammed VI, la corruzione del sistema di potere marocchino e l’incipiente aria di crisi che si respira per le strade del paese, aprono spiragli seri di propaganda per i gruppi radicali e non è garantito che il governo saprà rispondere con gli strumenti giusti a questo nuovo scenario. Al contempo, la frammentazione dei gruppi islamici in centinaia di comitati caritatevoli, gruppi studenteschi, partiti e associazioni culturali, con estrazioni culturali e religiose le più varie e diversificate, non permettono più operazioni di “semplificazione” dall’alto o tentativi di dialogo efficaci e duraturi con l’opposizione. A fronte di questo quadro, la possibile e devastante ascesa dell’islam radicale va considerata, anche nella “bella addormentata” del Marocco, come un problema serio e stringente da affrontare. 5. Muhammad ibn Alì al-Senussi (1792-1859), studioso algerino di origine marocchina e appartenente ad un’antica famiglia dell’aristocrazia araba della Spagna, aderisce profondamente alle idee di riforma puritana che si vanno agitando nel mondo islamico e dopo il suo rientro dalla Mecca (1843) si stabilisce in Cirenaica (nell’impero ottomano non esisteva la Libia e il suo territorio si componeva di due province distinte, la Tripolitania e la Cirenaica, amministrate da due funzionari imperiali, rispettivamente nelle città di Tripoli e Bengasi). Nel 1843 al-Senussi fonda la sua prima rete di zauie – monasteri che fungono contemporaneamente da ostelli per i viaggiatori, magazzini per le merci, piccoli centri urbani e tribunali – nella regione del Gebel Akhdar e questo permette alla Cirenaica di godere di una certa indipendenza sino alla conquista italiana ad opera del generale Graziani agli inizi degli anni Trenta. Intollerante e violentemente ostile verso i cristiani, la confraternita dei senussi stabilisce il suo centro a Giarabub (1855), in un’oasi che funge da punto d’incontro delle carovane del deserto libico, a trecento chilometri a sud di Tobruk, e riesce ad estendere rapidamente la sua influenza in tutto il Sahara orientale (dopo la morte del fondatore, la sua opera continua con il figlio maggiore, Ahmed al-Mahdi, e poi con il nipote Ahmed al-Sharif). Giarabub diventa il centro spirituale e culturale della congregazione religiosa e, rispetto alla Tripolitania, l’impero ottomano deve quindi accettare in Cirenaica una sorta di parziale condivisione del controllo del territorio con la potente confraternita. I senussi conducono prima una guerra contro la Francia, ai confini del sud tunisino, e poi contro l’Italia, che ha occupato la parte costiera della Libia dopo la guerra italo-turca del 1911-1912 (nel 1918 il capo della congregazione si rifugia a Costantinopoli). Ultimata la pacificazione della Libia, l’Italia occupa l’oasi di Cufra (1931) e pone fine alla potenza senussa. Durante la Seconda guerra mondiale, l’Inghilterra tratta però con i senussi della Cirenaica e promette che il loro paese non sarebbe ricaduto sotto l’autorità italiana. Solo alla fine della guerra viene implicitamente riconosciuta la differenza tra i territori di Tripolitania e Cirenaica, ovvero quando i ministri degli Esteri italiano ed inglese (Carlo Sforza e Ernest Bevin) tentano di trovare un accordo per la spartizione del paese: all’Italia la Tripolitania, alla Gran Bretagna la Cirenaica e alla Francia le regione occidentale del Fezzan (il progetto non si realizza perché l’Unione Sovietica chiede a sua volta l’amministrazione di un pezzo di territorio nord africano e gli Alleati, per evitare un insediamento sovietico, preferiscono creare un regno di Libia sotto il trono dell’ultimo discendente dei senussi). Nel 1949, quindi con il consenso britannico, la Cirenaica viene costituita in regno mussulmano ereditario a favore del capo della confraternita, Mohammed Idris el-Nadhi el-Senussi, che diviene re di Libia nel 1951 (Idris fissa la sua residenza a Tripoli, ma il centro religioso e culturale rimane a Bengasi, dove costruisce nel 1955 il palazzo reale di al-Manar). L’indipendenza della Libia – dopo decenni di colonialismo italiano ed un periodo di occupazione militare franco-britannica dal 1943 al 1951 – viene decisa dalle Nazioni Unite nel 1949 e diviene affettiva solo alla fine del 1951 con re Idris I, l’emiro della Cirenaica. Nel 1953 la Libia firma con il Regno Unito un trattato di alleanza che concede alla corona inglese alcune basi militari in cambio di imponenti aiuti finanziari. Nello stesso anno, il paese aderisce alla Lega Araba e nel 1955 all’organizzazione delle Nazioni Unite. Ma la scoperta del petrolio (1958) modifica sostanzialmente la situazione economica della Libia e provoca la caduta della monarchia senussita e della sua struttura feudale, diventata oramai anacronistica. La giunta militare guidata dal colonnello Muammar al-Qaddafi (Gheddafi, classe 1942) con un colpo di stato nel 1969 si impadronisce del potere, depone il sovrano e governa il paese attraverso un Consiglio Rivoluzionario (facendo così pagare a re Idris, secondo molti storici, l’atteggiamento neutrale assunto durante la guerra dei Sei Giorni tra Israele e i paesi arabi). Da monarchia costituzionale, la Libia si trasforma in repubblica e senza assumere alcuna carica politica, Gheddafi si attribuisce il potere supremo quale “guida della rivoluzione”, dopo aver abolito le elezioni e gli schieramenti partitici. La nuova Libia si allinea alle tendenze più intransigenti del panarabismo: le basi anglosassoni vengono evacuate, 20.000 italiani vengono espulsi ed i loro beni confiscati (1970), la British Petroleum viene nazionalizzata ed inizia l’integrale arabizzazione della cultura, dell’educazione nazionale e dell’amministrazione pubblica. In nome della “terza via” – destinata a sostituirsi al capitalismo ed al socialismo – Gheddafi appoggia con fermezza la resistenza palestinese e si oppone a qualsivoglia compromesso con lo stato di Israele, sino ad entrare in contrasto con la stessa organizzazione di Yasser Arafat per la supremazia della lotta militare contro lo stato ebraico. Nel 1977, con la nuova riforma costituzionale, il paese cambia il nome in “Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista” ed assume il Corano come legge fondamentale dello stato, ovvero con le precise connotazioni di una repubblica popolare, socialista ed islamica. Il popolo esercita la sovranità attraverso duemilasettecento rappresentanti scelti dai “congressi popolari di base” che a livello nazionale si riuniscono nel “Congresso Generale Popolare” e che a sua volta elegge gli organi del potere esecutivo: il Segretario generale ed il Comitato generale del popolo. I membri di questo comitato svolgono le funzioni dei ministri, inizialmente venti, e successivamente ridotti a cinque nel 2000: esteri, giustizia, finanze, informazione e petrolio. Il Segretario generale svolge i compiti di capo del governo ed il leader Gheddafi ricopre la carica – de facto – di capo dello stato. Sempre nel 1977, la Libia si scontra più volte con l’Egitto lungo le frontiere ed inizia un violento contenzioso con il Ciad, accusato di aver occupato alcuni stabilimenti di uranio. La disputa viene risolta solo nel 1994 grazie all’intervento di un tribunale internazionale e lo stesso anno la Libia sostituisce il calendario occidentale con quello lunare dell’islam, adottando la sharia sia nel campo penale che in quello civile. Pur nei limiti di una difficile unificazione interna, la Libia non riesce ad esprimere una politica estera conforme e durevole. Tutti i progetti diplomatici più importanti – dalle fusioni con l’Egitto, il Sudan e la Tunisia, così come quello con l’Algeria e la Tunisia insieme – naufragano molto spesso prima ancora di arrivare al tavolo delle trattative. Ergendosi a campione dell’islam, Gheddafi lancia spesso operazioni di destabilizzazione contro alcuni regimi con cui era stato amico (oltre l’Egitto, anche la Tunisia) ed i rapporti con l’Occidente sono soggetti a gravi tensioni: tra il 1979 ed il 1980 si registrano a Tripoli saccheggi e devastazioni nelle ambasciate di Stati Uniti e Francia. Ma le misure di austerità imposte alla Libia dopo la recessione provocata dalla crisi del mercato del greggio nei primi anni Ottanta, aumentano il già critico dissenso all’interno del paese. Dopo arresti, destituzioni ed anche esecuzioni ai danni di alcuni ufficiali libici – per la nuova Libia, le forze armate sono solo un “esercito popolare” – nel 1984 viene effettuato il primo serio tentativo di impossessarsi di una caserma di Tripoli. La repressione interna è spietata, così come sono sempre più numerose le eliminazioni degli oppositori del regime libico in esilio. Sul piano della politica internazionale, Gheddafi sottoscrive con l’Unione Sovietica un accordo di collaborazione economica, commerciale e tecnico-scientifica. Nel 1985 il paese viene accusato di aver appoggiato attacchi terroristici in Europa (Roma e Vienna), di pesanti coinvolgimenti con i gruppi rivoluzionari armati in Egitto e Siria e di aver organizzato l’attentato in una discoteca in Cisgiordania dove perdono la vita tre persone, tra cui un militare americano. Anche se Gheddafi condanna le uccisioni indiscriminate di vittime innocenti – ma è pronto a scatenare una guerra in tutto il Mediterraneo se la Libia viene attaccata – per l’agenzia ufficiale libica «Jana» si tratta di “atti eroici”. In seguito alla dichiarazione unilaterale da parte della Libia sulla territorialità delle acque del golfo della Sirte – rivendicata da Tripoli oltre le dodici miglia marine, contrariamente alle leggi ed alle consuetudini internazionali, e definita la “linea della morte” – i rapporti con gli Stati Uniti e con la Gran Bretagna diventano particolarmente tesi. Nel 1981 due caccia americani, decollati dalla portaerei Nimitz, abbattono due veivoli dell’aeronautica militare libica e due anni più tardi altri caccia libici vengono intercettati dagli F-14 americani e costretti a rientrare alla base. La tensione con gli Stati Uniti (presidente Ronald Reagan) si inasprisce nel 1986. Durante un’esercitazione aeronavale della VI flotta americana nel golfo della Sirte, due motovedette libiche, che si avvicinano pericolosamente alle forze statunitensi, vengono affondate. La Libia reagisce lanciando sei missili contro gli F-14 in sorvolo sul golfo (senza riuscire ad abbatterli) e gli stessi aeroplani intercettano e distruggono la batteria missilistica responsabile dell’attacco. Il giorno dopo gli Stati Uniti conducono altri attacchi contro le basi missilistiche libiche ed affondano altre due motovedette di Tripoli. L’esercitazione americana si conclude il 27 marzo del 1986 senza ulteriori incidenti. Ma solo nove giorni più tardi, nella discoteca La Belle di Berlino Ovest, frequentata da personale americano, una violenta esplosione causa il ferimento di oltre duecento persone (tra cui sessantasette soldati americani) e la morte di un sergente degli Stati Uniti e di una giovane donna turca. Secondo le agenzie di intelligence occidentali, la responsabilità dell’attentato è di matrice libica. Washington decide di rispondere con l’operazione denominata Eldorado Canyon, che prevede la distruzione di cinque importanti obiettivi: la base navale di Sid Bilal, gli aeroporti militari di Tripoli e Bengasi, una base missilistica in Cirenaica e la caserma di Bal al’Aziziyyah, dove abitualmente risiede Gheddafi con la famiglia. Partiti dalla base britannica di Lakenheat, diciotto cacciabombardieri F-111 compiono un lungo volo sull’Atlantico – per non invadere lo spazio aereo di Francia e Spagna che non hanno concesso l’autorizzazione – e si danno appuntamento sui cieli del golfo della Sirte con sedici caccia A-6 decollati dalle portaerei America e Coral Sea in navigazione nel Mediterraneo. Dopo i bombardamenti si contano trentasette morti – tra cui la figlia adottiva di Gheddafi, Hanna di sedici mesi – e novantatre feriti tra cui la moglie del colonnello e due dei suoi figli. Lo stesso giorno la Libia replica con il lancio, contro l’isola di Lampedusa, di due missili Scud che non raggiungono il bersaglio e cadono in mare a due chilometri dalla costa. L’obiettivo, secondo Tripoli, è la base di ascolto americana Loran C, occupata da una piccola guarnigione che era stata rafforzata solo qualche giorno prima da un contingente di marines americani. Gheddafi definisce l’Italia nemico “numero uno” e minaccia gravi misure militari se continuerà ad essere la base degli attacchi americani contro il suo paese. Il presidente del Consiglio dei ministri italiano, (Bettino Craxi) indirizza a Tripoli una nota di protesta e diffida la Libia dal compiere altri atti del genere, pur riservando un giudizio molto severo sull’operazione americana. Sul piano politico, la Libia riceve forme di solidarietà esplicita soltanto dall’Unione Sovietica e da alcuni paesi che aderiscono al movimento dei non allineati. Alle continue minacce verbali del colonnello Gheddafi di rappresaglie contro i paesi dell’Alleanza atlantica, Washington annuncia la rottura delle relazioni diplomatiche e commerciali con Tripoli; congela gli averi presso le banche americane (oltre un miliardo di dollari); dispone la proibizione del traffico aereo ed il blocco sulle importazioni di petrolio. Il consiglio della Lega Araba condanna le sanzioni e le minacce ai danni della Libia. Durante la guerra del Golfo contro l’Iraq per la liberazione del Kuwait nel 1991, Tripoli non partecipa alla forza multinazionale contro Saddam Hussein e sempre agli inizi degli anni Novanta, le Nazioni Unite impongono sanzioni al paese (risoluzione 748 del 1992, embargo alla Libia) per il suo rifiuto di collaborare sugli attentati aerei alla Uta (Nigeria, 1989, centosettanta vittime) ed alla Pan Am (Scozia, 1998, duecentosettanta vittime tra cui centottantanove americani) dove sono coinvolti agenti libici accusati di aver piazzato gli ordigni esplosivi sugli aeromobili. Solo nel 1999 la Libia consegna alla Corte internazionale dell’Aja due sospetti attentatori della Pan Am (nel 2001 l’ufficiale dell’intelligence libica, Abdel Basset Alì al-Meghsi, viene giudicato colpevole) e si impegna a risarcire le famiglie di entrambi i disastri aerei per un importo indicativo di 4 milioni di dollari per unità familiare. All’interno del paese, Gheddafi avvia una politica di privatizzazioni e di aperture agli investitori stranieri europei, nonostante la grave tensione esplosa nel 2000 a causa della presenza di oltre due milioni di lavoratori africani, addetti ai lavori più umili, ma sicuramente mal visti dai giovani libici afflitti da un crescente e drammatico tasso di disoccupazione. Nel 2003, le Nazioni Unite dichiarano decadute le sanzioni precedentemente imposte e dopo nove mesi di trattative segrete con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, Gheddafi annuncia (19 settembre 2003) la sospensione della produzione di armi nucleari, chimiche e biologiche, lì dove sono compresi anche i missili a lungo raggio – limitandone la portata a soli 300 chilometri – con grande soddisfazione dello stato di Israele, oramai fuori gittata. L’anno successivo, dopo aver accertato – attraverso ispezioni dirette dei siti libici – l’avvenuta rimozione delle armi non convenzionali e lo smantellamento dei missili Scud, Washington revoca l’embargo commerciale e ristabilisce, anche se solo formalmente, le relazioni diplomatiche con Tripoli. I componenti essenziali del programma militare nucleare (e segreto) della Libia – anche se ancora ad un livello di sviluppo molto ridotto – vengono trasportati nel laboratorio nazionale americano di Oak Ridge nel Tennessee. In realtà, la rinuncia di Gheddafi ad alimentare l’eversione ed a produrre armi di distruzione di massa rappresenta l’unica via disponibile, sia per risanare l’economia fortemente compromessa dalle sanzioni (gli integralisti islamici continuano a provocare disordini soffiando sul malcontento popolare dovuto all’embargo) sia per uscire dall’isolamento nel quale è stato confinato dalla comunità internazionale. Tripoli invita anche gli altri stati mediorientali ad intraprendere la stessa strada ed incassa la piena solidarietà dell’Egitto sotto lo sguardo attento di Washington. Anche l’Unione Europea segue l’esempio americano: sempre nel 2004 – dopo l’impegno libico di risarcire anche i familiari delle vittime di un attentato ai danni della discoteca di Berlino nel 1986 – la Ue revoca l’embargo sulle armi e sul materiale militare.73 Dopo aver inaugurato il nuovo corso delle relazioni internazionali libiche, con la rinuncia alle armi di distruzione di massa e l’accettazione delle ispezioni previste dal protocollo aggiuntivo al trattato di non proliferazione nucleare, Gheddafi sembra aver intrapreso anche “azioni coperte” per riallacciare i rapporti con lo stato di Israele. Il colonnello smette di indossare la divisa e per alcuni anni scompare dalla scena internazionale. I suoi delegati ratificano a Vienna nel 2004 il trattato internazionale per la messa al bando di tutti gli esperimenti internazionali (Ctbt, centosettanta paesi). Ma sempre nel 2004, proprio mentre la Libia appare più conciliante, la fondazione Gheddafi – la potente istituzione presieduta dal figlio Seif al-Islam al-Gheddafi – annuncia di aver richiesto agli Stati Uniti un indennizzo per le vittime (secondo Tripoli, quarantuno morti e duecentoventisei feriti) delle incursioni americane contro Tripoli e Bengasi. Agli inizi del 2006, il consolato italiano di Bengasi viene attaccato ed incendiato da gruppi di manifestanti che reagiscono duramente alle dichiarazioni italiane. 74 La “guida della rivoluzione” autorizza nella seconda città della Libia un’imponente manifestazione contro le vignette satiriche apparse in Danimarca, ma per i giovani libici il vero bersaglio si trasforma nel diavolo crociato rappresentato dall’Italia e che ha acceso la miccia con il suo intervento polemico in televisione. La manifestazione ben presto non è più sotto controllo e tra i dimostranti che conducono l’assalto contro il consolato italiano ci sono anche uomini armati. La protesa si trasforma presto in vera e propria guerriglia – come poche volte si era vista in Libia – e la polizia riceve l’ordine di sparare contro quel gruppo di dimostranti che ha manifestato l’intenzione di uccidere i nostri diplomatici asserragliati all’interno dell’edificio. Dopo tredici morti, decine di feriti e numerosi arresti, finisce la cronaca della giornata. Ma a distanza di pochi giorni la televisione libica ed un dispaccio dell’agenzia «Jana» trasmettono il discorso pronunciato da Gheddafi durante un raduno di rappresentanti governativi a Sirte: l’obiettivo della manifestazione di Bengasi era l’uccisione del console italiano e della sua famiglia. 73 La decisione viene presa su richiesta del governo italiano, interessato a fornire alla Libia aerei e motovedette per prevenire l’immigrazione clandestina. 74 Il casus belli sono le magliette raffiguranti le caricature di Maometto esibite dal ministro delle Riforme Istituzionali, Roberto Calderoli. Secondo il colonnello, la matrice dell’odio dei giovani libici – rivolto esclusivamente contro l’Italia e non associato alla questione delle vignette satiriche – va ricercata nel risentimento nutrito dalla popolazione, sin dal 1911, verso l’occupazione coloniale italiana, aggravata dal nostro rifiuto di risarcire il paese per le sofferenze patite. A coronamento delle esternazioni, anche chiare minacce: se le richieste di indennizzo non vengono subito esaudite, non sono esclusi ulteriori attacchi contro i nostri connazionali o le nostre sedi diplomatiche in Libia. In realtà, gli osservatori occidentali più attenti forniscono sulla manifestazione di Bengasi uno scenario ben diverso. Alla vigilia dell’assalto al consolato italiano, viene distribuito tra la popolazione di Bengasi un volantino scritto in arabo (“per l’offesa che abbiamo ricevuto nei confronti del Profeta, voi avete un appuntamento con un’esplosione degna della vostra offesa”) e firmato dalla “Organizzazione alQaeda di Bengasi” che incita gli islamisti a rinnovare gli attacchi contro l’Occidente sulla scia di quelli di New York, Madrid e Londra. Il potente ed organizzato apparato di sicurezza libico probabilmente sottovaluta il rischio di alQaeda, anche se non ignora che esiste sin dal 2005 in Cirenaica, tra le montagna che circondano la cittadina di Derna, una filiale dell’organizzazione, vero e proprio covo dell’estremismo islamico. Il gruppo affiliato all’internazionale del terrore porta il nome di “Gruppo Islamico Combattente Libico” ed è guidato da due leader del jihadismo internazionale. Il primo si chiama Abu Laith, detto “il libico”, ed oltre ad essere l’emiro del gruppo è al tempo stesso il comandante militare di alQaeda nella zona di Khost in Afghanistan.75 Il secondo è Adb al-Ghaffar ed il suo quartier generale è a Zahedan, in Iran, dove mantiene i collegamenti con le altre organizzazioni terroristiche. Oltre alle attività internazionali (riescono ad arruolare in Libia circa cinquecento volontari per combattere in Iraq sotto le insegne di al-Qaeda) entrambi condividono la battaglia per la sovversione del governo libico. Anche se i servizi segreti di Tripoli riescono ad arrestare oltre un centinaio di affiliati, il Gruppo Islamico può sempre contare su un gran numero di giovani libici (ma anche egiziani, palestinesi e sudanesi) che soffrono per la mancanza di lavoro e per la diffusa corruzione, senza contare gli oppositori storici del regime: il “Fronte di Liberazione” e la rete degli imam radicali nelle moschee di Bengasi. Tra i diecimila dimostranti della manifestazione contro l’Italia, il gruppo di assalto ai danni del nostro consolato viene guidato da un centinaio di giovani (libici e stranieri) ben addestrati militarmente e tutti provenienti dalla cittadina di Derna. Forse Gheddafi, per la prima volta, si rende effettivamente conto di quanto possa essere devastante l’estremismo islamico, esploso proprio ai danni della sua Jamahiriya. Il primo ministro (Shukri Ghanem, riformista) viene sostituito da Alì Mahmoud al-Baghdadi, espressione della vecchia guardia conservatrice, ed al tempo stesso si riapre il dialogo con i Fratelli Mussulmani – bloccato da otto anni – con l’improvvisa ed inaspettata liberazione di centotrenta membri della Fratellanza, con la firma del giovane e diplomatico Seif, il figlio di Gheddafi. Quindi per il colonnello – secondo alcuni analisti italiani – il passato coloniale e la mancata riparazione dei danni di guerra sono in realtà soltanto un tentativo di ricomporre l’unità e la coscienza nazionale. In effetti, a causa delle forti autonomie che caratterizzano i diversi clan tribali, una chiara identità nazionale non è stata mai raggiunta (forse, paradossalmente, si è realizzata sotto il periodo coloniale italiano) e quindi Gheddafi è spesso costretto a cavalcare il malessere sociale utilizzando un anticolonialismo strumentale per cercare di comporre il nazionalismo libico. Anche storicamente, il colonnello ne ha fatto un uso spregiudicato subito dopo la conquista del 75 La zona di Khost è la stessa dove sino alla fine del 2005 hanno operato i soldati italiani e proprio Abu Laith è considerato il responsabile degli assalti alla caserma Salerno dei nostri alpini e paracadutisti. potere, nel tentativo di strappare alla grande congregazione religiosa della senussia l’egemonia esercitata su un paese di pastori e beduini e privo di una struttura sociale e politica. Quando gli islamisti si impadroniscono della manifestazione, Gheddafi non può certo ammettere che la sua leadership viene minata da gruppi appartenenti al suo paese (ed al mondo mussulmano) e si rifugia nell’anticolonialismo italiano: di conseguenza, se il suo potere è insidiato, la minaccia può venire solo dalle colpe dell’Occidente. Gheddafi non dimentica certo quello che è accaduto in Algeria agli inizi degli anni Novanta (la sanguinosa guerra civile) e deve necessariamente accreditare la sua figura come quella di un leader patriottico, ovvero l’unico in grado di garantire la sicurezza e la difesa della Libia, contro un’ondata religiosa in grado di travolgerlo con relativa facilità. E la richiesta di indennizzo per i danni coloniali è probabilmente solo un gioco al rialzo. In realtà l’Italia ha già saldato nel 1951 il suo debito con la Libia (sono stati versati cinque milioni di sterline e cedute a re Idris tutte le strutture pubbliche) ma Gheddafi ha sconfessato quello storico accordo internazionale ed ha richiesto un “simbolico gesto riparatore”. Nel 1984 non si è raggiunto un compromesso sul numero dei posti letto di un ospedale che doveva essere costruito dall’Italia – cento offerti contro i milleduecento richiesti – e nel 2002 sono stati offerti 63 milioni di euro per la costruzione di un’autostrada tra Tripoli e Bengasi. Ma dopo l’assalto al consolato italiano, le richieste di Gheddafi diventano faraoniche: l’autostrada deve essere lunga 1.700 chilometri, dalla frontiera tunisina a quella egiziana, ed il costo stimato è adesso di 3,5 miliardi di euro. Nella primavera del 2006 il Segretario di stato americano, Condoleeza Rice, annuncia la cancellazione della Libia dalla lista nera degli Stati “sponsor del terrorismo”. La rottura ufficiale tra i due paesi risale al 1980, quando Washington (presidente Jimmy Carter) decide la chiusura dell’ambasciata americana attaccata da violente proteste popolari. Ma con l’arrivo della bella stagione, si ripropone con forza il problema del traffico clandestino di esseri umani nel Mediterraneo. Quando Abdulati Alobidi, il viceministro libico degli Esteri con delega agli Affari Europei, incontra a Roma il nostro ministro degli Interni (Giuliano Amato) ed il Commissario europeo (Franco Frattini), l’atteggiamento verso l’Italia è ambiguo e la posizione verso l’Europa è intransigente. Nei primi sei mesi del 2006 a Lampedusa arrivano oltre dodicimila clandestini e quasi tutti provengono da Zwara, il porto a sud delle coste libiche. L’alto funzionario di Tripoli contesta all’Unione Europea la decisione unilaterale di pattugliare il mare della Libia (progetto Frontex) per arginare il fenomeno: “la Libia non accetterà mai il pattugliamento del mare all’interno dei propri confini. Per combattere l’immigrazione clandestina, l’Europa deve darci mezzi e apparecchiature adeguate”. Anche per quanto riguarda la possibilità di inviare una forza di polizia internazionale ai confini libici con gli altri stati africani – Tripoli si è spesso lamentata di essere costretta a sorvegliare oltre 4.000 chilometri di frontiere terrestri – Alobidi non prende neanche in considerazione questa ipotesi. Nelle mani del Commissario europeo viene consegnata invece una lista di richieste (elicotteri, fuoristrada attrezzati per il deserto, visori notturni e motovedette) necessarie alla Libia per fermare i clandestini: “questa è la collaborazione che vogliamo, aiuto logistico e di intelligence per combattere i trafficanti”. Per ribadire con forza l’unica strada percorribile per avviare una forma di collaborazione, Alobidi comunica ufficialmente la decisione del suo governo di non partecipare al vertice di Malta (6 luglio 2006) che avrebbe dovuto fissare i tempi e i modi dei controlli marittimi per fermare i clandestini. E durante la conferenza stampa tenuta a Tripoli dopo il suo rientro da Roma, il viceministro libico degli Esteri definisce anche il punto della situazione con l’Italia. Quando gli viene fatto notare che alcuni osservatori internazionali accusano la Libia di ricattare l’Italia chiedendo un grande gesto di riconciliazione come la costruzione di un’autostrada che attraversa tutto il paese, la risposta è, ancora una volta, categorica: “non c’è alcun ricatto perché la decisione è già presa, l’autostrada si dovrà fare. Questo lo hanno accettato tutti i governi che si sono succeduti in Italia, compreso quello attuale”. E per quanto riguarda il risarcimento alle imprese italiane, la risposta è, ovviamente, soltanto possibilista: “Dobbiamo solo stabilire la cifra. Alla fine troveremo un accordo su tutto, compreso il rientro in Libia dei vostri connazionali”. Il Viminale è stanco delle continue richieste di Gheddafi: “con lui non trattiamo più, adesso intervenga l’Europa”. L’urgenza è quella di ottenere il via libera al pattugliamento delle coste libiche per bloccare la partenza di migliaia di esseri umani. Se le motovedette schierate dall’Unione Europea non possono controllare il confine marino a ridosso delle coste libiche, questo vuol dire – restando in acque internazionali – rendere molto più difficile e rischioso respingere o soccorrere le imbarcazioni clandestine cariche di disperati in cerca di salvezza. Ma il programma prevede anche la pianificazione di una politica di sviluppo sia in Libia che in Egitto, oltre che in Tunisia e Marocco. Quindi l’Italia decide di non essere più l’interlocutore privilegiato della Libia che “pretende non soltanto la cessione dei mezzi e delle apparecchiature per monitorare la costa, ma anche la costruzione di un’autostrada ed una serie di altri investimenti in territorio africano”. Adesso dovrà essere l’Europa (o meglio le imprese europee) ad impegnarsi in progetti più importanti che consentano di offrire lavoro e sviluppo alle popolazioni nordafricane, unica strada percorribile per la qualità della vita, indispensabile per arginare i drammatici viaggi della speranza. In Libia, l’ingresso degli arabi è consentito senza l’obbligo del visto, ma è sufficiente dimostrare di avere la disponibilità di almeno 500 dinari (circa 350 euro) con la sola eccezione degli egiziani – molto più numerosi – a cui viene richiesto un contratto di lavoro per varcare la frontiera. A causa di questa politica panaraba, le stime dell’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (Iom, con sede anche a Tripoli) parlano di quasi due milioni di stranieri presenti in Libia, metà dei quali clandestini e per Tripoli, una pressione migratoria così imponente non è più sopportabile. Mentre viene ipotizzata una sorta di sanatoria per chi dimostrerà di poter trovare un’occupazione anche stagionale – se la Libia decide di alleggerire i controlli, per l’Italia l’ondata migratoria potrebbe assumere dimensioni più che allarmanti – Gheddafi ed il figlio Seif litigano sui grandi temi di democrazia e corruzione. In occasione del trentasettesimo anniversario della rivoluzione verde il leader Gheddafi risponde alle accuse del figlio – indicato come suo successore alla guida del paese – che gli rimprovera la mancanza di democrazia a beneficio di una “mafia corrotta di funzionari che tenta di ostacolare le riforme”. Per il colonnello il potere deve restare al popolo libico e quelli che intendono cambiare il sistema devono essere considerati come veri e propri nemici della rivoluzione: “dobbiamo essere pronti ad uccidere i nostri nemici se rialzano la testa”. Anche se le critiche del figlio sono indirizzate a quei dirigenti pubblici che si comportano “come se fossero i proprietari dello Stato che amministrano”, per Gheddafi il progetto politico della Libia rimane corretto, rivoluzionario ed inviolabile: “libertà e sovranità a tutto il popolo, potere e ricchezza a tutto il popolo”. Probabilmente gli strali del colonnello non vogliono colpire direttamente il figlio – piuttosto metterlo in guardia – bensì i due massimi esponenti dell’opposizione (Muhammed Salen Buswir e Ramadan Abu Zakus) da poco rientrati in Libia dopo un periodo di esilio e diventati buoni amici del giovane delfino. La Libia accetta anche di ricevere alcuni investigatori della nostra polizia (ufficiali di collegamento italiani sono già presenti) per cooperare nella formazione di una task-force libica appositamente costituita per incrementare le operazioni di controllo lungo la costa76. Operazioni di monitoraggio che i libici dimostrano già di saper condurre con abilità quando si tratta 76 Dopo l’estate del 2006, il ministro italiano dell’Interno riavvia il “dialogo tecnico” con la Libia per il contrasto all’immigrazione clandestina. Tripoli accetta di inviare in Italia un ufficiale di collegamento con l’incarico di fare squadra insieme agli investigatori del Servizio Operativo Centrale della Polizia di Stato contro i mercanti del traffico umano. di individuare i pescherecci di Mazara del Vallo. Proprio mentre sono in corso le trattative tra i due paesi, una motovedetta libica blocca il “Mediterraneo Primo” a venti miglia dalla costa e costringe l’equipaggio a far rotta nel porto di Darnah. In piena crisi con il nostro paese, le attenzioni di Gheddafi sono piuttosto rivolte ad ottenere soldi dai risarcimenti internazionali. Da Sirte, sua città natale, dichiara con malcelata soddisfazione che “la Coca Cola e la Pepsi sono in realtà africane. Le sostanze che utilizzano provengono da piante del nostro continente. Devono risarcirci”. Nell’autunno del 2006 alcuni ministri e sottosegretari dell’Unione Europea riuniti a Tripoli per la “Conferenza Ministeriale Africana-Unione Europea sull’Immigrazione e lo Sviluppo” vengono improvvisamente caricati su due pullman verdi e condotti a vedere gli edifici devastati dai bombardamenti del 15 aprile 1986 dai caccia americani che colpirono la città alle due di notte con l’intento di uccidere la “guida della rivoluzione”. Dopo la visita guidata alle macerie rimaste come crudele testimonianza – una sorta di mausoleo – i funzionari possono essere ricevuti da Gheddafi nella tenda montata al centro della caserma Bab alAzizia. Il colonnello è adesso pronto ad offrire la sua collaborazione all’Europa (sempre a patto che si realizzino subito gli aiuti allo sviluppo) e dopo aver messo in guardia i rappresentanti europei dal pericolo dell’esplosione demografica dell’Africa, conclude ricordando i danni causati dal colonialismo nel suo continente: “restituite all’Africa le ricchezze e le materie prime saccheggiate ai nostri paesi”. Quando si tratta di ricevere la delegazione italiana (Giuliano Amato e Massimo D’Alema) alla presenza di Abdulhafed Gaddur, l’ambasciatore libico accreditato al Quirinale, Gheddafi apre la palazzina presidenziale situata al centro della sua caserma fortificata. Come sempre, in primo piano ci sono le compensazioni richieste dalla Libia per i danni causati dalla guerra e dal colonialismo, e soltanto dopo i crediti vantati dalle industrie italiane (circa 600 milioni di dollari) e dalle famiglie italiane cacciate nel 1970 dalla Libia (3 miliardi di euro requisiti, ed ancora oggi, il 7 ottobre, si celebra la “giornata della vendetta”). Ma questa volta sul tavolo del contenzioso c’è anche il piano dell’ENI per dieci miliardi di euro (nel 2006 l’import italiano, soprattutto di petrolio e gas, è cresciuto del 56,81%) e viene concordato un primo tratto di quella famosa autostrada, che nel frattempo ha superato la lunghezza di duemila chilometri. Per quanto riguarda l’obiettivo italiano di una “concessione, senza discriminazione, dei visti ai profughi italiani”, si vedrà. L’Italia assicura nuovi mezzi per il controllo delle frontiere (motovedette e moduli per i campi di permanenza dei clandestini) e la Libia si dichiara favorevole al progetto Frontex – con il comando affidato a Malta e Italia – e richiede che il controllo delle piste del deserto sia a totale carico dell’Unione Europea. Ma questa disponibilità è per Tripoli soltanto un orientamento di massima. Il 2007 si apre con nuove provocazioni: uno scarno comunicato del governo libico annuncia che “il Comitato Rivoluzionario ha deciso di erigere una statua di Saddam Hussein in piedi accanto ad Omar al-Mukthar sul patibolo”. La Libia proclama tre giorni di lutto nazionale dopo la morte del dittatore iracheno, cancella tutte le celebrazioni pubbliche per la festa mussulmana del sacrificio (eid ul-adha) e le bandiere sugli edifici governativi vengono esposte a mezz’asta. Omar al-Mukthar, insegnante di Corano, era a capo della confraternita dei senussi e si oppose strenuamente all’occupazione italiana della Libia. Dopo quasi vent’anni di sanguinosa guerriglia, la resistenza venne domata ed il “leone del deserto” fu impiccato per volere del generale Graziani nei pressi di Bengasi il 16 settembre del 1931. E lo stesso giorno della commemorazione religiosa, Gheddafi incassa le lodi del Vaticano. In occasione di un incontro interreligioso tenuto a Tripoli, vengono invitate le comunità cristiane con i loro pastori, ed il vescovo cattolico (Giovanni Martinelli) ringrazia il colonnello per aver concesso ai cristiani che vivono in Libia “di poter liberamente praticare il loro credo”. Per sigillare l’esperienza di fraternità in un paese mussulmano, il vescovo recita il Padre Nostro in arabo. Ma le stravaganze di Gheddafi non sono finite. Quando si reca ad Addis Abeba per il summit dell’Unione Africana (29 gennaio 2007) arriva con quindici automobili al seguito, trasportate con appositi aerei cargo. Ai controlli della dogana etiopica – sfarzo ed egocentrismo non passano inosservati – vengono scoperte due valigie piene di pepite d’oro. Per gli imbarazzati diplomatici libici, si tratta di “un regalo del nostro leader ai Capi di Stato africani” (dichiarazione riportata dal quotidiano etiopico «Capital») ma probabilmente ci troviamo di fronte ad uno degli innumerevoli progetti internazionali a cui Gheddafi sembra essere particolarmente affezionato. Il quartier generale dell’Unione Africana è attualmente ad Addis Abeba ed il colonnello non ha mai nascosto il suo desiderio di attuare almeno una divisione dell’organizzazione in due aree geopolitiche, naturalmente trasferendo a Tripoli la parte più consistente. La proposta libica non è ovviamente all’ordine del giorno e non sembra che possa essere seriamente presa in considerazione, lì dove le problematiche più importanti (arabi, africani, Darfur, Somalia e presidenza dell’Unione) rappresentano le priorità politiche e sociali per lo sviluppo dell’intero continente. Con l’obiettivo di coinvolgere il colonnello nella lotta al terrorismo, gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna si contendono ricchi contratti di forniture alle forze armate di Tripoli. Rimasto saldamente al potere – dopo i bombardamenti di Ronald Reagan e l’inserimento nell’asse del male da parte di George W. Bush – Gheddafi potrebbe diventare uno strategico partner militare degli Stati Uniti. Oltre alla necessità di rafforzare uno schieramento amico intorno all’area mediorientale, Washington teme l’indebolimento (anche fisiologico) del regime di Hosni Mubarak in Egitto e tenta di consolidare la sua presenza politica e militare nell’Africa del nord. Una nuova base nel continente potrebbe permettere agli Stati Uniti di controllare con maggiore attenzione le crisi che si profilano nel Darfur ed in Nigeria, senza contare quelle già esplosive in Somalia e nel Corno d’Africa. Infine, la Libia rappresenta il decimo paese al mondo per le riserve di petrolio, e la possibilità di contrastare l’invadenza di Pechino nella regione potrebbe aver indotto Washington ad accelerare i tempi del riavvicinamento. Il responsabile libico per gli Affari americani (Ahmed Said Fituri) si reca a Washington per discutere di collaborazione militare ed economica. Gli Stati Uniti prevedono di aprire a breve la loro ambasciata a Tripoli e probabilmente intendono includere la Libia nella Trans Sahara Counter Terrorism Partnership, l’accordo che riunisce i paesi africani nel contrasto all’avanzata islamista, sempre più attiva nella regione (la Libia potrebbe ospitare anche le basi americane nel prossimo African Command con la prevista sede in Marocco). Anche Londra si offre di addestrare l’esercito libico e di sostituire i jet di Tripoli (Mig e Mirage) con i più moderni Ef-2000 Tifone. Ma anche la Francia sta facendo la corte alla Libia ed i più economici Rafale sembrano essere interessanti (3,2 miliardi di dollari per 18 esemplari). Gli Stati Uniti rilanciano e propongono caccia F-16 usati in cambio di basi militari, incluso Wheelus Field, l’aeroporto a soli sette chilometri da Tripoli e già utilizzato dagli americani sino al 1970. Ma secondo gli analisti americani, Gheddafi non è realmente così allineato con l’Occidente. Si lamenta di aver ricevuto troppo poco in cambio della rinuncia al programma nucleare ed alle armi di distruzione di massa, ed al tempo stesso aderisce alla lotta contro il terrorismo internazionale (“l’epoca delle ostilità è finita”). Ma allora, perché vengono liberati sessanta membri del “Gruppo Islamico Combattente Libico”, così legato ad al-Qaeda? Anche all’interno del paese, la sua credibilità non è ai massimi livelli. Decide di assoldare giovani tuareg per formare una milizia personale ai suoi ordini (il regime, dopo quaranta anni di dittatura, è fortemente esposto al rischio di traumatici cambiamenti) e nonostante le promesse di ingaggio – lauti guadagni, borse di studio e residenza libica a chi aderisce – gli ex padroni del Sahara disertano l’appello e non si presentano al campo di addestramento di Oubari, nel sud della Libia. Gli uomini blu, che vivono tra le rocce del massiccio dall’Air e tra le dune di Temet, nel nord del Niger, non si fidano del colonnello libico. Dopo l’ultima visita del nostro ministro degli Esteri nell’autunno del 2006, Massimo D’Alema si reca in Libia nella primavera del 2007 per una “visita di carattere informale”, dopo che i rapporti tra Roma e Tripoli sembrano essersi raffreddati. La prolungata chiusura dell’ambasciata a Roma, ufficialmente per lavori di ristrutturazione – così come lo smantellamento dei consolati di Roma e Milano – alimentano questa tesi. Il nostro ministro decide di trascorrere in Libia le vacanze pasquali con il recondito obiettivo di incontrare il leader Gheddafi e di ristabilire quel clima collaborativo che sembra essersi interrotto (l’ambasciata libica è chiusa da oltre un mese ed anche il consolato di Palermo ha interrotto le sue attività). Alla fine l’incontro avviene e dopo un’ora di riunione sotto la solita tenda nella caserma Bab alAzizia, D’Alema si limita a dichiarare alla stampa che deve riferire al presidente del Consiglio la natura delle consultazioni. La Farnesina smentisce una crisi diplomatica e di conseguenza fioccano le indiscrezioni. Sembra infatti che al ministro libico degli Esteri (Abd al-Rahman Shalgam) sia stato proposto un piano di investimenti e cooperazione – senza escludere la realizzazione di almeno un tratto dell’autostrada – che prevede cospicui contributi per la costruzione di ospedali, scuole ed infrastrutture. Oggettivamente, proprio quello di cui la Libia ha realmente bisogno.77 Infine, sembra anche che la mancata adesione della Libia al progetto Frontex – almeno per il momento – sia subordinata all’assicurazione che l’Italia svolga la sua parte con l’Unione Europea per soddisfare le richieste di Tripoli. Secondo la Farnesina si tratta di normali visite diplomatiche, ma l’agenzia libica «Jana» usa toni trionfalistici. Il nostro ministro avrebbe assicurato che il governo italiano è pronto al finanziamento dell’autostrada, offerta “al popolo libico nel quadro dei risarcimenti per il periodo coloniale italiano”. Sarebbe quindi stato raggiunto un accordo per voltare pagina, ovvero un “pacchetto di misure” dove sono inseriti anche i risarcimenti per le imprese italiane e quelli per gli italiani espulsi dal suolo libico.78 Ma Gheddafi non è ancora soddisfatto. Poco dopo l’incontro con il nostro ministro, parlando al Congresso del Popolo (il parlamento), annuncia che per risolvere il problema dei libici esiliati in Italia e fatti prigionieri durante il periodo coloniale, “intende proporre all’Italia di iniziare ad analizzare il Dna di tutti gli italiani” per sapere con certezza quanti (e quali) siano i figli dei libici esiliati che oggi vivono nella nostra terra. Si tratta di un problema che Gheddafi non hai mai dimenticato di sollevare e che segue la plateale dichiarazione di qualche anno prima dell’agenzia libica «Jana»: “gli abitanti delle isole Tremiti sono di origine libica al 100%”. Ma perché le Tremiti? Nel 1911 e nell’anno successivo furono deportati tremila libici in alcune località italiane (Tremiti, ma anche Ustica, Ponza, Favignana e Gaeta) e nelle isole pugliesi centinaia di libici morirono di stenti e di colera. Nel marzo del 2004 – proprio subito dopo gli incidenti ai danni del nostro consolato di Bengasi – nell’isolotto di San Nicola è stato ultimato un cimitero per dare sepoltura a quattrocentocinquanta di questi deportati. Si tratta di una struttura di 77 Inoltre, poco prima di questo incontro, una delegazione italiana di piccole e medie imprese, guidata dal sottosegretario al Commercio internazionale Mauro Agostini, ha trattato in Libia importanti progetti nei settori dell’agroindustria, del turismo e dell’energia. 78 Il capitolo più clamoroso rimane quello dell’autostrada: seguendo il tracciato della via Balbia (dal nome del governatore, Italo Balbo) il percorso supera in lunghezza l’autostrada del Sole nel tratto da Reggio Calabria a Milano. La stampa italiana si interroga sull’opportunità di costruire un’autostrada di queste dimensioni in un paese dove le infrastrutture sono ancora così carenti, e si chiede anche perché non è stata realizzata con gli enormi proventi delle risorse petrolifere di cui il regime dispone (una commissione congiunta avrà il compito di verificare che tutti gli aspetti dell’intesa vengano rispettati). Nel frattempo, l’ambasciata libica a Roma rimane chiusa e l’ambasciatore viene richiamato a Tripoli. legno, metallo e pietra che si richiama all’arte islamica.79 Seif al-Islam al-Gheddafi (il cui nome significa “la spada dell’islam”), di trentacinque anni, è il primo figlio della seconda moglie di Muammar al-Qaddafi. Nella sua visita a Roma nell’estate del 2007 tende una mano all’Italia e dichiara che il suo paese è pronto ad un accordo storico. Intende portare il padre nella nostra capitale per firmare un trattato di amicizia che chiuda definitivamente con il passato (però, prima le compensazioni) e poi apra la strada ad una nuova collaborazione, con un rinnovato regime sulle tassazioni, sul commercio, sulla pesca e sulla sicurezza (prima di lasciare Roma dichiara anche che l’Eni contribuirà con il governo italiano al finanziamento per l’autostrada). Il capo di stato maggiore dell’aeronautica libica decide di invitare a Tripoli il nostro omologo, il generale Vincenzo Camporini: oltre alla formazione dei piloti e dei tecnici militari, il tema principale dell’incontro è la cooperazione nelle attività di Sar (Search & Rescue) che prevedono esercitazioni congiunte anche con altri paesi del Mediterraneo, nel quadro della iniziativa 5+5. Questo forum, iniziato con gli incontri periodici tra i ministri degli Esteri e dell’Interno, si è successivamente allargato alla Difesa con l’obiettivo di arrivare ad una larga alleanza militare tra le due sponde del Mediterraneo. I paesi europei sono l’Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo e Malta. Quelli africani sono la Libia, l’Algeria, la Tunisia, il Marocco e la Mauritania. Quindi una sorta di Nato euro-araba che sembra avere lo scopo di stabilizzare legami e rapporti che attualmente risultano però poco convincenti. I programmi in ambito militare sono ambiziosi: una “Scuola per colonnelli” a Parigi nel 2008, un “Centro di Analisi Strategica” a Tunisi (per gli analisti, un avamposto per studiare il terrorismo islamico in nord Africa) ed un istituto per lo sminamento e le tecniche degli artificieri a Tripoli. Oltre alle esercitazioni aeronavali congiunte, si stanno preparando i protocolli d’intesa sulla Protezione Civile e sulla difesa del mare dall’inquinamento. Infine, è anche prevista la vigilanza comune, aerea e satellitare, contro l’immigrazione clandestina (la Libia, insieme alla Tunisia, si è detta pronta a partecipare anche all’interscambio dei dati sul traffico del naviglio mercantile nel Mediterraneo). Le novità arrivano invece per la Francia, proprio il paese europeo che più di tutti si è battuto a favore dell’intervento della Nato contro il regime di Gheddafi nella primavera del 2011. Il presidente Nicolas Sarkozy, ricevuto a Tripoli sotto la solita tenda, stringe con Gheddafi un importante accordo di cooperazione per il nucleare civile. La Francia fornirà alla Libia un reattore in grado di assicurare l’approvvigionamento di acqua potabile desalinizzando l’acqua marina. Ma sul tappeto ci sono altre intese: oltre alla collaborazione nei campi della ricerca scientifica e tecnica, sono in agenda accordi sulla difesa e sulla sicurezza, così come importanti progetti comuni sugli armamenti. Ma il giorno dopo, sulla prima pagina del quotidiano tedesco di estrema sinistra «Die Tageszeitung» appare un’immagine poco rassicurante di Gheddafi, con la barba non rasata ed i capelli lunghi, con gli occhiali scuri ed un’enorme spilla nera a forma di Africa, dello stesso colore della sua camicia sotto l’abito bianco. E vicino la fotografia, il titolo: “Vendereste un reattore nucleare a quest’uomo?”. Il mondo politico di Berlino condanna unanimemente la scelta del presidente francese e il viceministro tedesco degli Esteri (Gernot Erler) dichiara che in questo modo il rischio di proliferazione atomica aumenta vertiginosamente “proprio mentre la comunità internazionale è impegnata in un confronto con l’Iran sul nucleare, Sarkozy offre un reattore a quel Gheddafi che 79 Nato dalla collaborazione tra il comune di San Nicola e l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente con sede a Roma, il progetto del cimitero è stato interamente finanziato dalla Farnesina con 40.000 euro. L’Italia ha anche investito sinora oltre due milioni di euro per finanziare le ricerche ed organizzare i convegni sulle condizioni ed i trattamenti riservati ai libici in Italia durante il periodo coloniale. fino al 2003 – per sua stessa ammissione – stava cercando di dotarsi della Bomba”. Ma oramai il meccanismo si è messo in moto: una settimana più tardi la Libia firma con la Francia un primo contratto per l’acquisto di missili anticarro Milan – Nibbio in francese – per un valore di 168 milioni di euro (la dichiarazione viene rilasciata dal figlio di Gheddafi durante un’intervista concessa a «Le Monde»). Oltre a questa fornitura, si prevedono anche la costruzione di una fabbrica di armi e manovre militari integrate. Un altro contratto, per il valore di 128 milioni di euro, è stato concluso per un sistema Tetra di comunicazioni radio criptate, ma questa volta le polemiche scoppiano anche in Francia. Nell’imbarazzo di una situazione così delicata, il ministro francese degli Esteri smentisce l’esistenza di un simile accordo ma il portavoce dell’Eliseo (David Martinon) laconicamente aggiunge: “immagino che sia vero”. Ma dopo le prime smentite francesi, arrivano le conferme dal governo di Tripoli.80 In definitiva, si tratta pur sempre dei primi accordi di armamenti firmati da un paese europeo dopo la soppressione dell’embargo sulla vendita di armi alla Libia nel 2004. Ma questo non è il solo round messo a segno da Gheddafi. Il 16 ottobre del 2007 la Libia, insieme al Vietnam, entra ufficialmente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con un seggio non permanente per il biennio 2008-2009. L’ex nemico degli Stati Uniti entra così nel massimo organo decisionale del palazzo di vetro ed il suo voto sarà quindi decisivo nella risposta che le Nazioni Unite dovranno dare alle grandi crisi internazionali. La Libia torna a sedere nel Consiglio di sicurezza dopo un’assenza di vent’anni (per il Vietnam è la prima volta) con il beneplacito di Washington che negli ultimi quindici anni aveva bloccato per ben due volte la scalata di Tripoli all’organizzazione. Per il dipartimento di Stato americano “Vietnam e Libia sono molto ansiosi di riprendere i rapporti commerciali con l’Occidente e non faranno nulla per mettere in pericolo tali relazioni”.81 Ma proprio nel momento di maggiore avvicinamento all’Europa (Italia e Francia in testa) Gheddafi chiude le porte agli europei. La Musica, nave da crociera della compagnia italiana Msc, entrata nel porto di Tripoli per far partecipare i suoi duemilacinquecento passeggeri ad una visita guidata della città, ha dovuto prendere il largo e fare rotta verso Messina. Gli agenti della dogana si sono rifiutati di accettare sul suolo libico europei con passaporti privi della traduzione in arabo. Con un decreto a sorpresa, Tripoli ha infatti reintrodotto una norma (abolita nel 2005) che impone la traduzione in arabo delle generalità segnate sul passaporto e i problemi non sono stati pochi. Poiché l’obbligo di traduzione per i cittadini europei (e non solo per quelli dell’Unione) vale anche per uscire dal paese, molti voli internazionali sono ripartiti senza i loro passeggeri. La Farnesina ha successivamente chiarito che è necessaria una traduzione effettuata dalla questura italiana e che va sottoposta all’ambasciata libica a Roma al momento della richiesta del visto. Nonostante tutto, Tripoli continua la sua ascesa sul palcoscenico internazionale. Tra gli invitati alla conferenza di pace per il Medio Oriente (Annapolis, 27 novembre 2007) spiccano i nomi della Libia e della Siria. Ma questa volta l’atteggiamento disinvolto del leader 80 Arrivano anche le conferme della Eads, il gruppo franco-tedesco che costruisce i Milan tramite la controllata Mbda (Finmeccanica partecipa al consorzio Mbda per il 25%, il restante 75% è ugualmente diviso tra Eads e BAe System). 81 Proprio in quei giorni per l’Italia si conclude a Tripoli un importante accordo del valore di 28 miliardi di dollari, circa 20 miliardi di euro. L’intesa raggiunta dall’Eni (Paolo Scaroni) con la società libica di stato Noc (Shukri Ghanem) rafforza e prolunga di venticinque anni gli attuali contratti per la produzione di petrolio e di gas, assicurando all’Italia una maggiore sicurezza energetica sul fronte degli approvvigionamenti. L’Eni – che è presente in Libia dal 1959 – si conferma al primo posto tra gli operatori stranieri ed oltre a massimizzare la produzione dei giacimenti storici, intende avviare una nuova campagna di perforazioni sul territorio libico. libico non sfugge ad al-Qaeda. In un messaggio audio diffuso via internet della durata di ventotto minuti (dal titolo Serrare i ranghi), Ayman al-Zawahiri invoca la guerra santa contro gli interessi occidentali in Nord Africa. In particolare, definisce Gheddafi un nemico dell’islam e dopo averlo chiamato “cane” e “servo degli Stati Uniti”, si rivolge al popolo libico esortandolo a seguire l’esempio di Omar al-Mukhtar. La conclusione del messaggio è per le tutte popolazioni dell’area: “unitevi contro i vostri tiranni come Gheddafi, Ban Alì, Bouteflica e Muhammed VI”. Ma la “guida della rivoluzione” non si lascia intimorire ed annuncia che alla fine dell’anno si recherà nei principali paesi dell’Europa mediterranea. A Parigi, Madrid e Lisbona giungono le richieste per l’istallazione di un tendone per accogliere il colonnello, ma alla Farnesina non arriva alcun dispaccio (secondo gli analisti italiani il nostro paese è ancora sotto giudizio). Gheddafi arriva a Parigi con un corteo di un centinaio di automobili e viene accolto con tutti gli onori riservati ad un importante capo di stato. E le prime polemiche francesi arrivano proprio sull’accoglienza offerta a Gheddafi: pur essendo numerosi i paesi che fanno affari con lui, la stampa di Parigi si chiede come mai sia proprio la Francia a riceverlo come un grande leader mondiale. Gheddafi torna in visita a Parigi per la prima volta dal 1973 e viene ospitato per cinque giorni nell’Hotel Marigny, a pochi passi dall’Eliseo, quel principesco palazzo in cui i presidenti francesi alloggiano abitualmente i capi di stato stranieri in visita ufficiale. Ma la vera nota di colore è la gigantesca tenda beduina montata nel giardino del Marigny per ricevere gli ospiti illustri che verranno a rendergli omaggio (a Parigi piove ed è meglio dormire nella suite presidenziale). Ma le polemiche sulla visita di Gheddafi non si limitano alle accuse rivolte dalla stampa e dagli esponenti dell’opposizione (“è un terrorista in visita di stato”). Anche all’interno del governo, i dissapori sono tangibili. Il ministro francese degli Esteri (Bernard Kouchner) adducendo impegni di lavoro, diserta la cena ufficiale organizzata all’Eliseo per il leader libico. Ma la vera stilettata arriva da Rama Yade. Trent’anni, senegalese e mussulmana, questa giovane donna è la titolare del dicastero dei Diritti Umani (dipende dal Quai d’Orsay, quindi dal ministro degli Esteri) e non si lascia sfuggire l’occasione che vuole Gheddafi a Parigi proprio il 10 dicembre, ovvero nel giorno in cui la Dichiarazione universale delle Nazioni Unite sui diritti umani compie sessant’anni. In un’intervista rilasciata al «Parisien» – e riportata da tutta la stampa occidentale – attacca duramente l’ospite così ingombrante: “il colonnello Gheddafi deve capire che il nostro paese non è uno zerbino su cui un dirigente, terrorista o no, può venire ad asciugarsi i piedi del sangue dei suoi misfatti”. Ma nell’agenda del presidente Sarkozy ci sono impegni ben più importanti e dopo la partenza di Gheddafi annuncia trionfalmente che l’incontro è servito a formalizzare accordi commerciali e forniture di tecnologia per dieci miliardi di euro, molti di più di quelli previsti inizialmente (quanto basta per sdoganare l’intera Libia e non solo il suo leader). Oltre al già promesso impianto nucleare, anche armi per l’esercito, airbus civili e i caccia militari Rafale, un prodotto dell’industria francese che sino a quel momento non aveva trovato alcun acquirente al mondo. Nel frattempo, sul sito mediorientale «Arab on-line» viene riportata una frase di Gheddafi pronunciata prima di lasciare Tripoli: “visiterò dieci stati europei, ma non l’Italia […] esistono problemi bilaterali tra i nostri paesi”. Anche a Madrid, Gheddafi si dimostra generoso. Dopo aver richiesto, ed ottenuto, che l’ultima sera della sua permanenza di quattro giorni venisse allietata da un’esibizione di flamenco, rilascia promesse di lucrosi affari. Al premier spagnolo José Luis Rodrìguez Zapatero ed al suo ministro degli Esteri, Miguel Angel Moratinos, il colonnello assicura un’importante “piattaforma” per i nuovi affari delle imprese spagnole in Libia ed in Africa, e la stima prevista raggiunge i dodici miliardi di euro. Anche se la tenda beduina viene ugualmente montata, l’accoglienza in Spagna, per onori e sfarzi, è pari a quella francese, ma senza le code polemiche. Oltre alla Moncloa, il palazzo del governo, si aprono anche le porte della Zarzuela, la residenza di re Juan Carlos di Borbone, che riserva a Gheddafi lo stesso riguardo che ha avuto poche settimane prima per Bill Clinton. L’Italia deve aspettare prima il rientro di Gheddafi a Tripoli e poi la fine del 2007. Quattro anni dopo l’inizio delle trattative viene siglato l’accordo per contrastare l’immigrazione clandestina: Tripoli ha finalmente accettato il pattugliamento delle coste libiche. Il protocollo d’intesa – sette punti – viene firmato, naturalmente a Tripoli, tra il ministro libico degli Esteri (Abdurrahman Mohamed Shalgam) ed il ministro italiano dell’Interno (Giuliano Amato). Sul modello di quello albanese, l’accordo prevede squadre miste italo-libiche per il controllo di quei tratti di costa che vedono abitualmente partire i mercanti di schiavi. Ma per convincere il colonnello Gheddafi, gli sforzi dell’Italia non sono stati pochi. Nel testo del protocollo viene definito che i pattugliamenti saranno organizzati con sei unità navali cedute temporaneamente dall’Italia (successivamente sostituite da altrettanti mezzi consegnati in via definitiva). I mezzi imbarcheranno equipaggi misti e la direzione delle attività sarà affidata ad un ufficiale libico, coadiuvato in seconda da un ufficiale italiano. L’Italia cede alla Libia sei unità navali della Guardia di Finanza, tre guardacoste classe “Bigliani” e tre motovedette classe “V.5000”. Oltre alle navi, l’Italia si impegna ad effettuare l’addestramento e la formazione del personale di polizia e degli ufficiali e piloti che a bordo di elicotteri e motovedette si occupano della ricerca in mare. Roma invierà a Tripoli anche cinque fuoristrada allestiti per il deserto (con apparecchiature satellitari gps ed impianti radio), strumenti con tecnologia avanzata per l’individuazione di documenti falsificati, sistemi di comunicazione satellitare e computer. E’ sempre l’Italia che interviene – e mette a disposizione di Tripoli – un finanziamento di due milioni di euro dell’Unione Europea (Roma partecipa con 700.000 euro) per mettere a punto il progetto di rimpatrio volontario per gli sfollati entrati in Libia dai paesi limitrofi. Ed è sempre l’Italia ad organizzare i voli interni africani necessari per riportare a casa i clandestini. L’impegno a concedere altri fondi italiani ed a farsi garante nei confronti dell’Unione Europea per la consegna di ulteriori mezzi e finanziamenti, ha coronato l’accordo. Naturalmente, la costruzione dell’autostrada è parte integrante del patto. L’abilità negoziale di Gheddafi si è sempre trincerata dietro la via Balbia (che riassume il periodo coloniale e l’autostrada così intensamente voluta) e quindi non ha realmente permesso una qualsivoglia forma di reale collaborazione per risolvere i problemi di uno stato che ha oggettivamente fatto molto poco per il suo sviluppo, ed ancora meno per il livello di vita della sua popolazione che sino alla recente rivolta del 2011 ha sofferto di infrastrutture da paese sottosviluppato (quando i rapporti con l’Italia hanno attraversato momenti di crisi, i nostri analisti concordano nel valutare che gli sbarchi dei clandestini sono stati intensificati). La rivolta contro il regime di Gheddafi nella primavera del 2011, che ha provocato l’intervento della coalizione a guida Nato, ha generato la fuga di decine di migliaia di profughi sub sahariani verso Agadez, in Nigeria. Un volta attivo crocevia commerciale nel centro del Sahara, la città di Agadez si è trasformata in un centro di raccolta di migranti africani in fuga dalla guerra e dalle violenze in Libia, con una affluenza – nell’estate del 2011 – superiore a settantamila persone, a bordo di camion resi disponibili dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e da diverse ambasciate dell’Africa occidentale che hanno mediato con le autorità libiche per garantire un viaggio sicuro (i profughi arrivano da Sebha, una città della Libia meridionale e vengono accolti in quattro campi allestiti dall’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati). Il presidente nigeriano, Mahamadou Issoufou, dichiara alla «Bbc» la sua preoccupazione per il crescente numero di rifugiati, destinato a salire ulteriormente per la fuga di migliaia di persone anche dalla incerta situazione della Costa d’Avorio. Nonostante le lamentele riguardo all’aumento della criminalità, i residenti di Agadez sembrano mostrare comprensione nei confronti dei libici, anche se la città è invasa dalla comunità tuareg del Niger che ha mantenuto uno stretto rapporto di collaborazione con Gheddafi. In effetti, nel corso degli anni, il leader libico ha contribuito a risolvere diverse ribellioni dei tuareg, la più recente delle quali reclamava a gran voce una maggiore quota derivante dai profitti delle miniere di uranio nella regione. Nel 2009, Gheddafi ha anche presieduto ad un accordo di pace che ha garantito l’amnistia per quattromila ribelli tuareg, chiedendo il disarmo in cambio di posti di lavoro, anche se Saidou Kaocen Maiga, il portavoce degli ex combattenti, ha sempre dichiarato che molti di loro sono ancora disoccupati e che per questo motivo hanno accettato l’offerta di combattere in Libia contro il regime per 1.000 euro al giorno. La situazione rimane però confusa. In alcuni campi organizzati nella parte occidentale della Libia, sembra infatti che numerosi africani sub sahariani siano stati attaccati da simpatizzanti dei ribelli libici, scambiati per mercenari, con decine e decine di morti. In realtà, il conflitto per il patrimonio della Libia e per i suoi enormi depositi nelle banche occidentali (stimati in duecento miliardi di dollari) si muove in parallelo con un altro conflitto – per certi aspetti più aspro – per i vertici del potere all’interno del paese e che ha luogo tra gli islamici e i liberali. Se da un lato molti analisti concordano sul fatto che l’intervento militare della Nato a favore dell’opposizione non sia avvenuto solo per motivi umanitari ma anche per ragioni commerciali, dall’altro, però, l’inasprirsi delle divisioni tra l’ala liberale libica e l’ala degli islamici rappresentata dagli sceicchi Abdel Hakim Belhaj (comandante del consiglio militare di Tripoli) e Ismail Alì Salabi (comandante del consiglio militare di Sirte e Bani Walid) minaccia seriamente di indebolire la legittimità del Consiglio nazionale transitorio (Cnt) agli occhi del popolo libico e rischia nel contempo di mettere in pericolo la riconciliazione nazionale del paese82. In realtà, gli islamici costituiscono la maggioranza schiacciante dei ribelli libici e al loro interno non sono pochi gli intransigenti che ritengono che il Cnt li abbia trattati come elementi inferiori della rivolta, e che non abbia attribuito loro la quota di incarichi ministeriali e governativi che avrebbero meritato all’interno del Consiglio direttivo, una sorta di consiglio ministeriale responsabile della gestione degli affari del paese. Oggettivamente, i liberali laici – che per la maggior parte erano stati alti funzionari del passato regime o che avevano vissuto in Occidente – sono riusciti ad accaparrarsi i più alti incarichi e vengono accusati di aver trattato con arroganza i comandi islamici sul campo, che a loro volta hanno offerto in sacrificio, negli scontri con l’esercito libico, un alto numero di vittime su tutto il territorio. Lo sceicco Alì Salabi – considerato il padre spirituale di tutti gli islamici libici e membro dell’Unione internazionale dei dotti mussulmani, guidata da Yusuf al-Qaradawy, sorprende gli interlocutori quando accusa pubblicamente (12 settembre 2011) i membri del Consiglio direttivo di voler derubare il popolo libico e chiede al presidente del Consiglio, Mahmoud Jibril, di dimettersi per “lasciare ai libici ed alle vere forze patriottiche del paese di costruire il futuro della Libia”. In particolare, attacca anche i simboli stressi del liberalismo laico, come Mahmoud Shammam (responsabile dell’informazione), Alì Tarhouni (responsabile delle risorse energetiche e finanziarie) e Abdel Rahman Shalqam (consigliere del presidente) accusandoli di monopolizzare le decisioni legate al settore economico e sanitario, oltre che agli altri settori relativi ai servizi. Inoltre, la valenza dell’attacco di Salabi cresce di importanza se si considera il fatto che viene pubblicato nelle prime pagine di «Aljazeera.net», il sito che si trova a Doha, la capitale del Qatar, ovvero il paese che ha maggiormente sostenuto la rivolta libica. Secondo gli analisti, si tratta di un vero e proprio messaggio rivolto dal Qatar al Consiglio 82 L’ala liberale libica, che ha richiesto l’intervento della Nato, è stata anche accusata dagli islamici di aver corteggiato lo stato di Israele utilizzando il filosofo francese Bernard Henry Lévy, noto per la sua stretta amicizia con il premier Benjamin Netanyahu e con il ministro della Difesa, Ehud Barak. Nazionale Transitorio, accentuato dal fatto che la televisione «Libya Tv» – finanziata proprio dal Qatar – ha sempre ignorato gli islamici durante le sue trasmissioni sulla rivolta. Le manifestazioni che seguono alle dichiarazioni dello sceicco Alì Salabi – organizzate a Tripoli con la partecipazione di alcune centinaia di liberali – vengono considerate un fenomeno insolito che potrebbe aggravare la situazione (la distinzione) e accentuare gli scontri tra gli islamici e i liberali. Il segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, mostra di parteggiare per i liberali ed esprime i timori dell’Alleanza nei confronti degli islamici (intervista rilasciata al quotidiano britannico «Daily Telegraph» in data 14 settembre 2011) palesando il rischio che la Libia cada nelle mani degli estremisti islamici se non viene costituito, il più presto possibile, un solido governo stabile. Secondo il quotidiano «al-Quds al-Arabi» (editoriale del 15 settembre 2011) il Consiglio Nazionale Transitorio ha commesso gravi errori ma il principale è stato quello di comportarsi con arroganza e prepotenza non solo nei confronti degli islamici – che hanno sopportato il peso maggiore della rivoluzione contro il deposto regime dittatoriale – ma anche nei confronti dei paesi vicini, Algeria ed Egitto, accusati di appoggiare Gheddafi, e persino nei confronti della superpotenza cinese. L’articolo continua con l’accusa rivolta ad alcuni membri del Consiglio che si sono spinti ad usare un linguaggio razzista non solo nei confronti dei libici di colore, ma anche nei confronti degli africani in generale, con il pretesto che il deposto dittatore aveva utilizzato alcuni di loro come mercenari. Questa mentalità, che denota superbia e arroganza, e istigazione ai danni dell’altro, e che si contraddistingue per l’emarginazione di alcune forze libiche che hanno compiuto enormi sacrifici per rovesciare il regime dittatoriale di Gheddafi sui campi di battaglia, difficilmente potrà guidare il paese, fondare uno stato democratico con una magistratura imparziale e indipendente, o porre le basi di una riconciliazione nazionale che realizzi le aspirazioni di milioni di libici all’interno di uno stato fondato sulle istituzioni, sull’uguaglianza e sui buoni rapporti con i paesi vicini. L’editoriale si conclude portando ad evidente esempio della tesi il fatto che la maggior parte di questi paesi, ed in particolare l’Algeria, il Niger, il Mali e il Ciad , così come altri venti stati africani con il testa il Sud Africa, sono ancora riluttanti a riconoscere il Consiglio Nazionale Transitorio. I leader dei paesi del Sahel africano lanciano un allarme riguardo alle possibili ripercussioni negative della guerra in Libia sulla più generale situazione della regione, già duramente provata negli ultimi anni da una furiosa ondata di operazioni terroristiche dell’islamismo radicale, trasformandola in uno dei principali focolai di violenza nel mondo. Gli analisti hanno di fatto segnalato che molte armi sofisticate – tra cui anche complessi sistemi missilistici antiaerei – sono penetrate nella regione sia intenzionalmente attraverso i resti delle milizie di Gheddafi, compresi i mercenari africani sub sahariani, sia attraverso le recenti e fiorenti attività del lucroso contrabbando di armi. Sin dalla sua ascesa al potere nel 1969, il leader libico ha sempre desiderato occuparsi dei settori del Sahel e del Sahara, avanzando una serie di iniziative politiche per unire la regione sotto la sua leadership. L’ultima di queste iniziative è stata la creazione di un’organizzazione regionale denominata “Raggruppamento Sin-Sad” (in arabo le lettere sin e sad sono le iniziali delle parole Sahel e Sahara) finanziata e supervisionata direttamente da Gheddafi. In particolare, per la regione del Sahel si intende quel vasto spazio che si estende dal sud dell’Algeria (anche con propaggini nel Marocco meridionale) sino al Sudan, che comprende la Mauritania, il Mali, il Niger e il Ciad. Questa regione, nonostante la molteplicità delle sue componenti etniche e culturali, costituisce un’unità storica ed antropologica che si estende su una superficie di otto milioni di chilometri quadrati ed è imperniata su una fertile componente fluviale (i fiumi Senegal, Niger e Ciad) situata al centro di vaste estensioni desertiche e collegata da percorsi che risalgono all’era medioevale, per una rete commerciale carovaniera che unisce il Sudan occidentale alle città del nord Africa, ma anche per una via per i pellegrini diretti ad oriente e quindi un importante ponte per gli scambi culturali tra l’occidente islamico e l’oriente arabo.83 La regione del Fezzan, nel sud della Libia, appartiene allo spazio del Sahel che include il cosiddetto “paese dei tuareg” e le tribù arabe vicine, negli stati dell’Africa occidentale (Mali, Niger, Ciad e Burkina Fasu). Sempre a questa regione appartiene anche il Darfur, strettamente legato al Ciad centrale. Questi paesi, da sempre considerati tra i più poveri del mondo, negli ultimi anni hanno suscitato l’interesse internazionale a causa di fenomeni di vasto impatto politico, quali la scoperta di ingenti ricchezze minerarie e petrolifere (destinate ad aprire nuovi orizzonti economici), la trasformazione della regione in un teatro di primo piano nelle reti di contrabbando (compresi il narcotraffico e il trasferimento di mano d’opera clandestina) e l’intensificarsi delle operazioni terroristiche che prendono di mira i turisti e gli occidentali residenti nella regione (dopo l’affiliazione ad al-Qaeda del Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento e il trasferimento nel deserto del Sahel). Secondo il ricercatore algerino Alì Bensaad, le reti del terrorismo e del crimine organizzato hanno adottato gli stessi percorsi nel deserto e si sono basate sugli stessi canali tribali tradizionali, mentre i deboli stati della regione sono incapaci di controllare piste che non conoscono confini ufficiali e che sono sotto il controllo dei gruppi tribali che ne hanno ereditato il dominio. Anche se si può ritenere che i gruppi terroristici e le bande del crimine organizzato non controllino effettivamente il territorio, è indubbio che siano in grado di trarre importanti vantaggi dalle soffocanti crisi economiche e sociali che vivono questi paesi, emarginati dai percorsi dello sviluppo e della modernizzazione. Secondo l’accademico mauritano Sayyed Wild Abah, autore di diversi saggi sui problemi legati alla trasformazione democratica, ciò a cui la regione sta assistendo attualmente è la rovina dei fragili stati nazionali del Sahel sotto il peso delle lotte intestine concentrate nei focolai beduini del deserto (la regione di Azawad nel Mali, Agadez nel Niger e il Darfur nel Sudan), laddove si concentrano le ricchezze naturali che suscitano la competizione strategica tra le grandi potenze internazionali, cosa che non fa altro che complicare le problematiche e le sfide geopolitiche e di sicurezza per questi paesi […] non vi è dubbio che gli ultimi eventi libici abbiano aggiunto nuove sfide a questo panorama già di per sé esplosivo. Il Sahel è oggettivamente legato a doppio filo con i focolai di tensione nel Corno d’Africa attraverso la disgregata area somala e molti analisti concordano nel ritenere che il nuovo “stato talebano” potrebbe essere replicato in diverse zone del Sahel e del Sahara.84 83 In questa regione sono stati fiorenti alcuni imperi islamici che estesero la loro influenza al nord e al sud: lo stato del Mali, l’impero del Ghana, lo stato degli Songhai e quello degli Almoravidi. Al loro interno vennero fondate antiche città come Touat, Chinguetti, Walata e Timbuktu, che per secoli sono riuscite a conservare un’importanza religiosa e scientifica. 84 Analogamente, la linea della crisi del Sahel è a sua volta collegata, attraverso il ponte del Corno d’Africa, al focolaio di tensione dello Yemen, ovvero al timore della formazione di un “triangolo di minacce” i cui lati si uniscono nell’Africa occidentale ed orientale, e nel sud-ovest della penisola araba. I crescenti segnali di una militarizzazione della rivolta popolare e delle pressanti richieste separatiste del sud lasciano temere una disgregazione dell’unità yemenita e la nascita di un altro “stato talebano” nel governatorato di Abyan, sulla costa del Mare Arabico, considerato uno dei centri più attivi di al-Qaeda. Sebbene lo scenario di una disgregazione della Libia non sembra al momento ipotizzabile, è pur vero che alcune organizzazioni salafite hanno invitato i fedeli a creare emirati islamici nella Libia orientale, qualora dovesse inasprirsi la disputa politica che infuria tra i ribelli riguardo all’identità ed all'ispirazione religiosa del nuovo stato. Inoltre, le ripercussioni della secessione del Sud Sudan suscitano profonde preoccupazioni sul futuro di un modello di stato africano multietnico e multireligioso e il presidente del Ciad, Idriss Deby, dichiara con amarezza che “la regola di rispettare i confini politici ereditati dal colonialismo ha costituito in passato l’unica garanzia per la sopravvivenza delle entità statali africane, in gran parte artificiali”. L’ambasciatore della nuova Libia a Roma, Abdulhafed Gaddur – intervistato da Maurizio Caprara per il «Corriere della Sera» il 21 ottobre 2011, il giorno dopo la notizia della morte di Gheddafi – rassicura invece sul futuro del nuovo paese circa la sicurezza della Tripoli liberata ed affidata ad Abdel Hakim Belhaj, un estremista islamico passato per il carcere di Guantanamo. Per l’ambasciatore Gaddur “adesso tutta la Libia è liberata, ci sarà un governo provvisorio e prenderà in mano tutto, compresa la sicurezza della capitale”. 6. L’Islam è la religione di stato della Tunisia, dove il 98% dei cittadini è sunnita e di rito malikita. La parte restante di popolazione si divide tra mussulmani kharagiti, una percentuale minuscola di sufi, cristiani ed ebrei (in parte sovvenzionati dal governo). Il governo controlla e sovvenziona le moschee e, nella persona del presidente, nomina il Gran Mufti. Una legge del 1988 stabilisce che, fatta eccezione per le festività e i momenti canonici di preghiera, le moschee devono restare chiuse. L’educazione religiosa islamica è obbligatoria nelle scuole pubbliche e la sharia viene applicata in alcuni casi di diritto della famiglia. Benché la Tunisia sia nota per un’applicazione laica e duttile del Corano, i matrimoni interconfessionali (tra mussulmani e cristiani) sono spesso vietati od osteggiati. L’impronta laica dell’islam tunisino affonda il suo pensiero negli studi di Ibn Kaldun (1332-1346) che fissò le fondamenta dei cosiddetti movimenti di risveglio distinguendo sia il doppio modello culturale della umma e asabiyya (spirito di corpo e di gruppo, indipendente dalla religione) sia i distinti ruoli del Califfo (sottomesso alla sharia) e del malik (colui che esercita il potere): Nel momento in cui va a perdersi lo spirito guerriero e governa il gruppo dominante, l’asabiyya non ha più ragione d’essere e il vecchio sistema, svuotato di ogni energia viene trascinato alla rovina. Egli, quindi, ha per primo assunto la concezione del gioco della passione umana, che trascende la vita dell’individuo, ma su cui il singolo può far leva per costruire la sua sorte e quella del gruppo col quale possiede un vincolo naturale85. Il rinnovamento dell’islam tunisino passa poi per Khayr ed-Dhin (1822-1890), noto come Hayreddin Pasha, tra i protagonisti della modernizzazione nazionale, che invitò gli ulema ad interpretare in modo più adeguato la loro missione temporale e i suoi concittadini a valutare con imparzialità le usanze degli europei sostenendo che è un principio dell’islam cercare la conoscenza. Questi esempi fanno dell’islam tunisino un’eccezione politica nel mondo mussulmano, quantunque il rinverdirsi del salafismo e le spinte radicali della “primavera araba” mettano in discussione la prosecuzione di questa tradizione pacifica. La penetrazione islamica in Tunisia risale al secolo VII: con la presa del potere di Abu Bakr a Hijaz, 85 L. el-Houssi, Il concetto di laicità nell’Islam tunisino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Padova, a.a. 2000-2001. il migliore amico di Maometto e con la nascita del primo califfato islamico iniziarono le prime incursioni arabe in Africa. Nel periodo del califfato degli Omayyadi (661-750), Oqna Ibn Rafaa entrò in Tunisia, che al tempo era una realtà all’avanguardia nelle infrastrutture urbane, agricole e commerciali (eredità delle dominazioni fenicia e romana) ove stabilì la capitale dell’Ifriqiya86, che chiamò Al Qayrawan (“campo militare”), l’odierna Qayrawan. Al Qayrawan divenne in poco tempo uno dei centri urbani più importanti dell’intero Nord Africa islamico. La popolazione indigena, composta principalmente da berberi e nomadi, fu convertita alla religione mussulmana, non senza problemi: i berberi organizzarono più di una rivolta contro gli arabi, come quella della regina Khaina (di religione ebraica) che, partendo dai monti dell’Aurès (a nord-est dell’Algeria) si pose a capo di un’alleanza di tribù indigene di religione ebraica e resistette ai mussulmani per circa dieci anni, prima di essere catturata ed uccisa. Nel 698 gli omayyadi presero anche Cartagine accelerando l’islamizzazione della Tunisia, che affidarono alle cure dei governatori locali. Di lì in avanti, si spostarono in Marocco, in Spagna (le cui terre conquistate chiamarono al-Andalus) ed in Francia, sino ad arrestare la propria avanzata nel 732 quando l’esercito arabo-berbero-andaluso di Abd al-Rahman ibn Adb Allah al-Ghafiqi subì una dura sconfitta (“il lastricato dei martiri”) ad opera dell’esercito franco di Carlo Martello, maggiordomo di palazzo dei re merovingi, nella battaglia di Poitiers. Dal 750 al 1517 gli Abbasidi presero il comando del movimento islamico, concentrando la loro azione a Baghdad (al tempo, capitale dell’islam) e affidando la Tunisia al comandante Ibrahim Ibn al-Aghlab, che fondò la dinastia degli Aglabiti. Gli Aglabiti si spinsero fino all’Italia meridionale e in Sicilia, ove conquistarono Mazara e Palermo (831). Parimenti mantennero in Tunisia una stabilità politica invidiabile, crearono infrastrutture ed opere di pubblica utilità (ponti, cisterne, canali) e la moschea di Sousse. Sul finire del secolo IX il dominio degli Aglabiti, indebolito dalle frequenti rivolte delle tribù berbere, subì l’attacco dei seguaci di Abu Abdullah ash-Shii fautore della dottrina sciita fatimita. La capitale Kairouan fu conquistata così come l’intera regione. Le nuove capitali divennero prima Mahdia, fino al 972, poi Il Cairo (al-madinat al-qahira), fondata proprio dai Fatimidi a ridosso dei precedenti insediamenti arabi di Fustat, al-Askar e al-Qata’i. L’Ifriqiya passò intorno al 970 sotto il controllo degli Ziridi, che governarono per conto dei Fatimidi fino al 1148, quando arrivarono alla rottura con gli sciiti. Gli Ziridi persero il dominio dell’Algeria, che divenne indipendente nel 1014 e furono attaccati dalla tribù dei Beni Hiala (o hilaliani) che devastarono l’Ifriqiya, poi dagli Almohadi provenienti da Spagna e Marocco. La Tunisia s’impoverì rapidamente: le aree più fertili e civilizzate - come Kairouan - caddero in disgrazia e le coste divennero preda, di lì a poco, dell’attacco dei Normanni. La resistenza alle prime incursioni dei Normanni di Ruggero II di Sicilia non durò a lungo: i Normanni s’impossessarono di tutti i porti vicini alla Sicilia, da Tripoli a Tunisi. Contemporaneamente, i sunniti Almoravidi, già padroni di Andalusia, Portogallo e di una parte di Senegal e Mali, si scontrarono in Marocco con gli sciiti Almohadi. Questi ultimi conquistarono Marrakesch nel 1147 e nel giro di dieci anni l’intero Maghreb, che pur diviso regione per regione in svariati califfati, si ritrovò unito per la prima e ultima volta nella storia. La Tunisia fu affidata ai marocchini berberi Hafsidi dal 1207, che separarono la Tunisia dal resto del Maghreb nel 1236. La città di Tunisi divenne in questo periodo la più grande città dell’Africa settentrionale, dopo il Cairo, e un ricco polo commerciale, con i suoi suks e attività d’artigianato all’avanguardia. Allo stesso tempo, si affermò in Tunisia il pensiero di Ibn Kaldun, padre della sociologia del mondo arabo-islamico. 86 Ifriqiya è il nome che gli arabi invasori dettero alla vecchia Provincia Africa, istituita da Roma e mantenuta dai Bizantini. Coincideva con l’attuale Tunisia, una parte di Algeria e l’est della Cirenaica. Nel 1453, sotto il sultano Mehmet II (Maometto II) il conquistatore, i turchi ottomani conquistarono Costantinopoli facendo cadere l’Impero Romano d’Oriente. Nell’arco di un secolo, s’impadronirono anche di Tunisi costringendo gli Hafsidi ad allearsi con il re Carlo V di Spagna e ad affidarsi al comandante genovese Andrea Doria: scelta obbligata ma fatale, in quanto i tunisini non accettarono di sottostare ad un impero e ad un comandante cristiani. Ottomani e spagnoli si contesero a lungo il possesso del territorio tunisino fino a quando, nel 1574, la Tunisia divenne una provincia dell’Impero Ottomano. I Turchi non furono particolarmente oppressivi coi tunisini, garantendo loro un lungo periodo di prosperità e un certo grado di autonomia politica. Gli Ottomani, mettendo fine al califfato, introdussero in Tunisia il sultanato ed affidarono, nel 1705, il potere ad un bey (capo reggente) di nome Hussein Ben Ali: nacque così la dinastia husseinita (l’unica vera dinastia tunisina prima dell’indipendenza) che regnò fino al 1957. In questi anni la Tunisia recuperò il proprio peso commerciale, abolì la schiavitù, lanciò importanti opere pubbliche (strade e acquedotti) creò la propria bandiera e promulgò, nel 1861 – sotto Muhammad es-Sadok Bey – la prima costituzione del mondo arabo. Ma lo sperpero eccessivo del denaro, la debolezza del bey, gli intrighi dei ministri Mustafà Khaznadar e Mustafà Ben Ismail, mortificarono il paese e portarono la Tunisia sull’orlo del disastro economico. Nel 1869, sotto Sadok Bey, il paese s’indebitò gravemente – fino alla bancarotta – dovendo parimenti accettare prestiti finanziari, e quindi l’ingerenza politica, delle potenze europee. Francia, Inghilterra e Italia87, nel tentativo di mettere le mani sulla Tunisia, crearono subito una “commissione finanziaria internazionale” per risollevare il paese dalla grave crisi in cui versava. Delle tre potenze, fu la Francia a vincere questa partita: con un accordo segreto tra i transalpini e la Gran Bretagna, nel 1879, la Francia ottenne il benestare inglese sul controllo della Tunisia e i britannici il lasciapassare francese per l’assoggettamento di Cipro. Due anni dopo, i Francesi partirono dall’Algeria – sua colonia dal 1830 – e con un pretesto invasero il territorio tunisino. Il 12 maggio 1881 col Trattato di Bardo (Al Qasr as Sa’id) venne ufficialmente instaurato il protettorato francese sulla Tunisia, in base al quale il bey fu costretto ad affidare ogni potere nel settore degli affari esteri, della difesa e dell’amministrazione al residente generale di Francia. Le Convenzioni della Marsa dell’8 giugno del 1883 sancirono l’amministrazione diretta francese, col bey che perdeva tutta la sua autorità. Per l’Italia, che non aveva ancora colonie e mirava ad espandersi in Africa del nord, il protettorato francese fu un’onta terribile (si è parlato di “schiaffo di Tunisi88”): non solo vedeva sfumare la possibilità di dominare uno dei suoi obiettivi strategici, ma assisteva inerme anche all’inizio della “dominazione informale” inglese sull’Egitto. La Francia sviluppò l’infrastruttura tunisina costruendo strade, ferrovie, miniere e collegamenti tra Tunisi-LaMarsa, Algeri-Tunisi e Sousse-Kairouan; circa centomila emigrati italiani si riversarono nel paese e contribuirono alla sua civilizzazione. Ma col trascorrere degli anni si sviluppò nei tunisini un forte senso di nazionalismo: questo 87 L'Italia aveva siglato un trattato con la Tunisia l'8 settembre 1868 per una durata di ventotto anni, per regolare il regime delle capitolazioni. L'accordo internazionale garantiva alla Tunisia diritti, privilegi e immunità concesse a diversi stati preunitari italiani. Gli italiani di Tunisia conservavano la loro nazionalità d'origine e non dipendevano che dalla giurisdizione consolare in materia civile, commerciale e giudiziaria, ma non in materia immobiliare, in cui, tuttavia, era riservata al console l'applicazione delle sentenze pronunciate dai tribunali del bey. L'uguaglianza civile assicurava agli italiani la libertà di commercio ed un vero e proprio privilegio d'extraterritorialità per i loro stabilimenti. In materia di pesca e navigazione, beneficiavano dello stesso trattamento dei tunisini. Infine, il bey non poteva modificare i dazi doganali senza consultare preventivamente il governo italiano. 88 Pirandello scrisse in proposito: “Intanto guardate: Tunisi è là! (…) E ci sono i francesi là, che ce l’hanno presa a tradimento! E domani possiamo averli qua, in casa nostra, capite?” (L.Pirandello, I vecchi e i giovani – 1913, pubblicato a Milano, Mondadori 1992). sentimento si coagulò prima nel “Movimento dei Giovani Tunisini”, formatosi nel 1907, poi nel partito indipendentista Hizb al-Hurr al-Dasturi o Destour (Costituzione), fondato nel 1920 dallo sceicco Abd al Aziz Téalbi (Talabi). Il Destour mirava alla costituzione di uno stato a struttura liberale (con l’elezione di un’assemblea a suffragio universale), alla parità di diritti tra francesi e tunisini, all’affermazione dei diritti democratici e delle libertà proprie delle democrazie occidentali. Con la deportazione del fondatore e la repressione operata dai Francesi, il partito divenne illegale (1933), ragione per la quale si scinderà in due formazioni: il Vecchio Destour (partito conservatore che non denunciava il protettorato francese, ma mirava a riformarlo) e Neo Destour (1934-1964), un soggetto progressista e conseguentemente indipendentista che rivendicava l’abbattimento del dominio francese. I capi del Neo Destour furono Mohammed El Materi e Habib Bourguiba. Quest’ultimo fu confinato, all’inizio negli anni Trenta, nel sud del paese insieme con gli altri militanti e nel 1938 fu imprigionato in Francia per cospirazione contro la sicurezza dello stato. Passata la Francia sotto il regime di Vichy, alleato dell’Italia, Bourguiba mostrò una notevole lungimiranza nel rifiutare l’appoggio di Mussolini alla sua causa e lanciò un appello per sostenere le truppe alleate (8 agosto 1942). Bourguiba pagò questa scelta con un nuovo arresto da parte dei nazisti, ma nel 1944, con la conquista dell’Africa del nord da parte degli alleati, tornò in libertà. La fine della guerra non portò all’immediata autonomia della Tunisia, che – oltre a soffrire la permanente occupazione francese – continuava a versare in uno stato di profonda crisi, con una disoccupazione alle stelle, deficienza di energia elettrica, blocco della produzione agricola e uno sfruttamento della manodopera a livelli schiavistici. Nel 1946 i tunisini si affidarono alle Nazioni Unite per ottenere aiuti e indipendenza, ma i riscontri non furono positivi. La stessa Francia, che pur aprì a negoziati con Bourguiba e Salah Ben Youssef (panarabo e più radicale di Bourguiba), tentennò sulle richieste del Neo Destour. Solo il 31 luglio 1954 Pierre Mendès-France si decise a riconoscere unilateralmente l’“autonomia interna” della Tunisia e la formazione di un governo temporaneo con la partecipazione di tre membri del Neo Destour. Questa prima decisione venne confermata il 3 giugno 1955 in un apposito trattato e portò alfine all’indipendenza totale della Tunisia in data 20 marzo 1956. Fatta eccezione per il porto strategico di Biserta, che tornò alla Tunisia solo nel 1963, i tunisini riprendevano il controllo del proprio territorio e potevano così eleggere un’assemblea nazionale costituente con Bourguiba presidente. Il 25 luglio 1957 veniva proclamata la Repubblica e Bourguiba, ufficialmente dall’8 novembre 1957, ne diventava il nuovo presidente (confermato nel 1959, nel 1964 e nel 1969). Bourguiba promosse riforme importanti, come quelle dell’insegnamento, e promulgò il “Codice dello statuto personale”. L’islam diveniva religione di stato, ma nella statuizione dei diritti civili e familiari Bourguiba non accettò condizionamenti: nel giro di poco tempo fu vietata la poligamia, riconosciuto il diritto di voto alle donne, proibito l’uso dell’hijab nelle scuole, tollerato il divorzio e legalizzato l’aborto (1965). Le scuole divenivano pubbliche e non più coraniche (anche se lo studio del Corano restava al centro dell’insegnamento) e i tribunali, prima divisi nel doppio regime di coranico e civile, si trasformavano in corti giudiziarie civili. Dal 1964 al 1970 Bourguiba, sotto l’influenza del sindacalista e ministro delle finanze Ahmed Ben Salah (poi condannato ai lavori forzati), varò la “fase socialista” e una serie di riforme agrarie che si rivelarono fallimentari. Contemporaneamente, il Neo Destour si trasformò in “Partito Socialista Costituzionale” o “Partito Socialista Desturiano”, mentre quattro anni più tardi (gennaio 1968) nacque l’“Associazione di salvaguardia del Corano” (embrione dell’odierno Ennahda) che si dichiarò ostile al laicismo di Bourguiba e al Codice dello Statuto personale e si rifaceva ai Fratelli Mussulmani. Chiusa l’esperienza socialista, Bourguiba decise di governare la Tunisia con piglio più autoritario: nel 1974 s’impose come presidente della repubblica a vita. Negli anni successivi normalizzò i rapporti con Israele, passò la gestione dell’economia al ministro liberale e filoamericano Hédi Nouira, e nel famoso “giovedì nero” (26 gennaio 1978) represse duramente i tunisini scesi in piazza per lo sciopero generale proclamato dall’Unione Generale dei Lavoratori Tunisini. Nel 1978 Bourguiba criticò gli accordi di Camp David – abbandonando la sua politica di distensione con Israele – in maniera tale che la Tunisia divenne sede della Lega Araba (nella quale era entrata il 10 gennaio 1958) e dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Sul piano dell’organizzazione militare: Bourguiba operò in funzione di una netta distinzione tra le forze armate e la politica, di fatto estraniando queste ultime in modo quasi assoluto dal sistema istituzionale centrale e rendendole sì un elemento di potere del Presidente, ma non un centro di interessi autonomi. Il Presidente avocò a sé le prerogative del controllo e dell’esercizio, delle nomine e dell’organizzazione, al fine di verticalizzare ed irrigidire la linea di comando, senza tuttavia coinvolgere l’apparato militare nella più ampia dimensione istituzionale del paese. L’ossessione di Bourguiba era rappresentata dal modello nazionalista panarabo di Nasser in Egitto e plasmò le forze armate quindi in modo speculare al modello egiziano, epurandole dagli attivisti politici e religiosi e plasmando una gerarchia legata da un vincolo di natura personale con il Presidente. In modo particolare, Bourguiba impedì alle forze armate di assumere alcun ruolo nel sistema economico, rendendole anzi strettamente dipendenti dal potere centrale e soprattutto da quello Presidenziale, e quindi particolarmente fedeli alla linea gerarchica89. Ma il declino di Bourguiba era dietro l’angolo: le difficoltà economiche del paese - causate da corruzione, clientelismo, siccità, inflazione, rialzo del dollaro - costrinsero Bourguiba, da un lato, ad aprire al pluralismo dei partiti (nel 1983 furono legalizzati il “Movimento dei Democratici Socialisti” e il “Movimento di Unità Popolare”), dall’altro a soffocare nel sangue tutte le rivolte spontanee che si susseguirono una dietro l’altra fino alla fine della sua esperienza politica. Partecipe di quelle rivolte era il radicalismo islamico, rappresentato dalla vecchia Associazione di salvaguardia del Corano trasformatasi in “Movimento della Tendenza Islamista” (6 giugno 1981) e poi (febbraio 1989) in Hizb al-Nahda (Ennahda, “Movimento della Rinascita”) con Rashid Ghannouchi innalzato al ruolo di emiro. Il partito, nato e sviluppatosi nelle moschee del paese, affondava le sue radici nei movimenti delle università tunisine e si riconosceva nella rivoluzione iraniana. L’islam politico in quegli anni penetrava nelle università e nelle scuole mescolandosi ai socialisti/marxisti e miscelando i suoi propositi in formule propagandistiche semi-progressiste e anti-sistema. Con la formazione del “Movimento della Tendenza Islamica”, i mussulmani radicali uscirono allo scoperto, scontrandosi direttamente con Bourguiba, ma formando al contempo (come accadde per “Giustizia e Carità” in Marocco) svariate associazioni di beneficenza e comitati di quartiere per allargarsi a macchia d’olio sul territorio e mantenere quella “mimetizzazione” che era stata la sua fortuna negli anni della gestazione. Il ministero dell’Interno ha rifiutato più volte di “registrare” il movimento come organizzazione legale e nel 1981 arrestò centosette militanti del Mti tra cui lo stesso fondatore Ghannouchi (condannato a undici anni di prigione). Gli arrestati furono amnistiati tre anni più tardi, ma nel 1987 (in seguito alle rivolte di Sousse e Monastir) Ghannouchi venne condannato al carcere coi lavori forzati a vita e due militanti del Mti Mehrez Boudagga e Boulbeba Dekhil - furono impiccati l’8 ottobre 1987. Uno dei vecchi leader di Ennahda, Kerker Salah, ha rivelato che Ennahda, infiltratasi nell’esercito, aveva organizzato un colpo di stato per l’8 novembre 1987: 89 N.Pedde, La variabile delle forze armate, in Speciale Crisi Egitto e Tunisia, «Difesa e Interesse Nazionale», 7 febbraio 2011. http://www.interessenazionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/Speciale-DIN_Crisi-in-NordAfrica_07_FEB_2011.pdf I sostenitori del Mti avevano preparato un colpo di stato, previsto per l’8 novembre. Questa decisione fu adottata dall’Ufficio politico del movimento islamista [...] Non avevamo altra scelta [...] Il governo ci aveva dichiarato guerra90. Ghannouchi ha dichiarato nel 1994: Quanto al tentativo [di colpo di stato] militare, si trattava d’altro che di un’iniziativa volta a fare fronte ad un regime che aveva dichiarato di volere sradicare il movimento. [...] Il piano è stato progettato al di fuori del movimento e in assenza della maggior parte delle sue istituzioni, anche se alcuni elementi della direzione vi hanno preso parte. Nel 1987 Bourguiba fu deposto per senilità, col “colpo di stato medico” del generale Ben Ali che, avvalendosi dell’art.57 della Costituzione, si fece nominare primo ministro e poi presidente (1989). Ben Ali si presentò come naturale successore di Bourguiba, benché si guardasse bene dal presentarsi in pubblico con lui, tanto che Bourguiba fu confinato nella sua città natale di Monastir e sorvegliato da una équipe medica onde evitare che danneggiasse l’immagine del nuovo presidente (e scatenasse contro di lui le opposizioni). In luogo del vecchio “Partito socialista desturiano” fu fondato, il 27 febbraio 1988, il “Raggruppamento costituzionale democratico” (Rcd) che ha dominato il panorama politico tunisino fino al 9 marzo 2011, data del suo scioglimento per mano della Corte di Cassazione. Intanto, il partito Ennahda, che aveva firmato il “Patto Nazionale” di Ben Ali e voleva profittare dell’annunciata apertura del governo alle forze islamiche (che durò molto poco: nel giro di pochi Anni Ben Ali arrestò circa ottomila persone, tra le quali militanti mussulmani e vari attivisti di associazioni islamiste), otteneva alle elezioni parlamentari dell’aprile 1989 circa il 14,5% dei voti91, ma il risultato non fu mai considerato valido. I dirigenti di Ennahda furono accusati di destabilizzare il paese, allorquando decisero di organizzare e sostenere manifestazioni a sostegno dell’Iraq coinvolto nella prima guerra del Golfo. La loro posizione si aggravò ulteriormente quando fu dimostrato il coinvolgimento nell’incendio della sede di Bab Souika del Rcd, che causò la morte di una persona. Per questo ed altri motivi, nell’agosto del 1992 circa duecentosessantacinque militanti di Ennahda furono condannati ad almeno venti anni di carcere; Ghannouchi, punito con l’ergastolo, fuggì in Algeria e in seguito a Londra. Ben Ali, padrone incontrastato della scena politica, rafforzava intanto i suoi poteri: abolì il mandato di presidente a vita – stabilendo un tetto massimo di due mandati consecutivi - ma si presentò come unico candidato alle elezioni del 1994 e del 1999. Nel 2002 eliminò il limite dei mandati, ma parimenti s’impegno a dar luogo ad elezioni “plurali e trasparenti”. I partiti avversari non ottennero alcun spazio nei media, ragione per la quale alle elezioni parlamentari del 2004 il Rcd ottenne l’87,7% dei voti e alle presidenziali Ben Ali ottenne il 94,5% dei voti validi. Il 25 ottobre del 2009 il presidente Ben Ali è stato rieletto, per la quinta volta, con un plebiscito dell’89,62% dei voti. Dieci anni prima il presidente aveva deciso di graziare circa seicento detenuti di Ennahda, che per rilanciarsi puntarono sull’appoggio delle associazioni per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle forze di sinistra. Proprio con il “Partito Democratico Progressista” e il “Partito Comunista dei lavoratori tunisini”, l’Ennahda costruì il movimento per le libertà civili, noto come “Movimento del 18 ottobre”. L’11 aprile 2002 la Tunisia fu scossa da un terribile attentato: nella sinagoga di Djerba scoppiò una bomba, che causò la morte di diciannove persone (quattordici tedeschi, quattro tunisini e un 90 N.Beau e J.P. Tuquoi, Notre ami Ben Ali, La Découverte, Parigi, 2002, p.41. 91 In realtà, la percentuale ottenuta da Ennahda si aggirò intorno al 30%. francese). L’attentato, rivendicato da al-Qaeda come una risposta alle violenze ebraiche, portò al varo di una straordinaria legge antiterrorista. Non ci sono stati in seguito altri episodi rilevanti di azione terroristica, fatta eccezione per i duri scontri di Tunisi nel 2007, quando le forze di sicurezza islamiste si scontrarono con alcuni salafiti vicini ad al-Qaeda au Maghreb islamique (Aqmi) arrivati dall’Algeria e penetrati nella zona desertica del sud ovest del paese. Benché fosse evidente il legame tra Aqmi e questi terroristi, l’attacco fu rivendicato dallo sconosciuto gruppo islamico “Unificazione e guerra santa”. Nell’occasione morì Lassad Sassì, capo della cellula di Aqmi in Tunisia, un terrorista che soggiornò anche in Italia – a Milano – fino al 2000. Si è anche sospettata un’infiltrazione di “Unificazione e guerra santa” nelle forze armate tunisine, ma quest’ipotesi non ha trovato riscontro. Un anno dopo, il 22 febbraio 2008, l’Aqmi rapì nel deserto della Tunis al-amiqa (la Tunisia profonda) due turisti austriaci, trasferendoli successivamente in Algeria. Nel maggio 2011 la polizia ha arrestato inoltre, a Remada nel governatorato di Tataounione, a 130 chilometri dal confine con la Libia, un algerino ed un libico – Abou Muslum e Abou Batin vicini all’organizzazione al-Qaeda per il Maghreb (Aqmi) – trovati in possesso di una cintura esplosiva che intendevano usare per un attentato suicida. Nel mese di settembre la polizia ha fermato nella zona desertica nove automezzi attrezzati per lanciare razzi e trasportare munizioni, che provenivano ancora una volta dall’Algeria. Stando a fonti occidentali, nella circostanza sarebbero morte circa sei persone. Molti analisti temono che l’instabilità della Libia e la nuova democratizzazione della Tunisia possano, in effetti, trasformare l’intera area in un porto franco del terrorismo e la Tunisia in un ponte di comunicazione tra i gruppi radicali di Algeria e Libia. Ma le vere preoccupazioni, per Ben Ali e il governo di Tunisi, iniziarono nel 2008, non sul versante terroristico, ma su quello delle ribellioni popolari.. Nella città di Redeyef, nel gennaio del 2008, in seguito a un concorso pubblico, presumibilmente truccato per ottanta posti di lavoro presso la Cfg, la Compagnie des fosfates de Gafsa, i disoccupati della città occuparono la sede regionale dell’Ugtt (Union Générale Tunisienne du Travail) considerata correa del misfatto, rivendicando subito la solidarietà di alcuni parti del sindacato stesso e di fasce della società civile locale e nazionale. La prima vittima della rivolta mineraria è Hisam Bin Giddu, che muore fulminato a Tabeddit nel tentativo di bloccare, insieme ad altri manifestanti, gli impianti della Cpg laddove è la polizia, secondo i manifestanti, ad aver causato la sua morte, riallacciando la corrente proprio nel momento in cui il ragazzo si aggrappava ai cavi92. Il 15 agosto 2010, nella città di Ben Guardane, alla frontiera con la Libia, venne chiusa la dogana di Ras el-Jedir, da dove passavano le vetture tunisine cariche di merce di contrabbando. La città, che vive di questa forma di illegalità, si ribellò scontrandosi con le forze dell’ordine. Pochi giorno dopo, la frontiera venne riaperta. L’Ambasciata italiana a Tunisi, in un rapporto del 2009, ha descritto così la situazione tunisina: Secondo un rapporto dell’Ambasciata italiana a Tunisi, l’Italia risulta il secondo Paese investitore, per un ammontare complessivo di 680 milioni di dinari (350 milioni di euro) nel 2009, in gran parte concentrati nel settore energetico. Il numero di imprese italiane registrato dalle autorità tunisine, escluso il settore energia, è di circa 700 unità, con oltre 55.000 addetti. Gli investimenti italiani spaziano dal settore tessile ai trasporti, dalle costruzioni alle banche. Tutti i grandi nomi sono presenti. Benetton, Eni, Ansaldo, Fiat, Todini, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit e Intesa San Paolo. La Tunisia offre alle imprese l’opportunità di beneficiare di un generoso sistema di off-shore, delocalizzando la propria produzione e fatturando il proprio business in loco, ed evitando dunque di pagare tasse in Italia. Nonostante questi investimenti, la Tunisia è un paese che però 92 L. Declich, Tunisia, la Rivoluzione Modello, in «Limes», n.1/2011, p. 290. soffre di sacche di povertà, spesso concentrate nelle zone centro-occidentali e nord-occidentali 93. La Tunisia s’incendia sul serio a partire dal 17 dicembre 2010, quando Mohamed Bouazizi, un laureato che si era adattato a venditore ambulante abusivo di frutta e verdura nella città di Sidi Bouzid, acquista una tanica di benzina e si dà fuoco di fronte al palazzo del governatore locale, morendo per ustioni pochi giorni dopo. Causa scatenante del drammatico gesto è stata la confisca delle merci da parte della polizia, che a detta di alcuni testimoni l’avrebbe anche molestato e picchiato. Già pochi mesi prima, nel marzo 2010, nella zona di Monastir un altro venditore ambulante, Abdesslem Trimech, si era dato fuoco perdendo la vita. Il gesto di Bouazizi ha esaltato subito buona parte del Paese che è scesa in piazza per denunciare il forte tasso di disoccupazione (circa il 15% del paese non lavora e, tra questi, il 72% è composto da giovani tra i quindici e i ventinove anni), il rialzo dei prezzi di prima necessità (pane, farina, zucchero, latte), la corruzione della polizia e l’indifferenza delle autorità. Secondo il nostro Istituto Nazionale per il Commercio Estero: I tassi di crescita fino ad oggi annunciati non hanno potuto ridurre la disoccupazione e soprattutto quella dei giovani che ha raggiunto una percentuale di più del 30%. Questo fatto è la conseguenza del dualismo eccessivo tra gli insediamenti stranieri nei poli tecnologici ed il resto dell’apparato produttivo (è l’origine delle differenze regionali), dell’inefficienza dei sistemi di formazione e di orientamento, del fallimento dei meccanismi dell’innovazione e della creazione d’impresa, e dell’insufficienza del dinamismo del sistema bancario [...] Si stima che il debito pubblico in percentuale rispetto al Pil raggiungerà più del 49% contro il 42,3% previsto94. Conseguentemente le proteste si sono allargate a macchia d’olio in tutta la Tunisia e i manifestanti hanno rivolto la propria rabbia direttamente contro Ben Alì e i suoi collaboratori, colpevoli a dir loro del soffocamento della libertà d’espressione, del bavaglio alla stampa e del clientelismo dilagante nel paese. In proposito, bisogna ricordare che: Ben Ali conferisce un ruolo essenziale ai mezzi di comunicazione di massa, seguendo l’esempio del predecessore Habib Bourguiba. Egli mantiene un controllo totale della stampa e delle radio, mezzi di propaganda per promuovere l’immagine di un leader competente, progressista e di grande successo. Le immagini e le affermazioni di Ben Ali sono una presenza costante sulle prime pagine della stampa e metà delle notizie serali nei programmi delle emittenti pubbliche «Tv7» e «Canale 21» riportano incontri, impegni e iniziative del presidente. L’emergere di alcune stazioni radio e di televisioni indipendenti nel corso degli anni sembra migliorare lo scenario, ma le regole del gioco rimangono immutate: nessuno spazio a opinioni divergenti; criticare le cariche istituzionali è tabù, denunciare la corruzione del governo è un suicidio. Molti giornali internazionali («Le Monde», «Liberation», «Le Figaro», «Al-Quds Alarabi») che cercano di denunciare la corruzione del governo, gli abusi contro i diritti umani e il deficit democratico del Paese, vengono progressivamente censurati95. Sul fronte della corruzione, un ruolo chiaro e controverso l’ha giocato Leila Trabelsi, seconda 93 E. Santi, La Rivoluzione tunisina: origini e prospettive, in «Rivista di Studi Politici», trimestrale dell’Istituto di Studi Politici “S.Pio V”, n. 2/2011, Anno XXIII, aprile-giugno 2011, p. 130. 94 C.Olivia, Tunisia, Breve nota politico economica, Istituto nazionale per il commercio estero, Tunisi 2011. http://www.ice.it/informazioni/newsletter/web/2011_Giugno/tunisia.pdf 95 E. Santi, La Rivoluzione tunisina: origini e prospettive, cit., pp 129-130. moglie di Ben Ali, la donna più odiata del paese, coinvolta con servizi segreti tunisini e libici, amante di alti funzionari prima di diventare la favorita del presidente Ali. In Francia nel 2009 le venne dedicato un intero libro, scritto dai giornalisti francesi Nicolas Beau e Catherine Graciet, intitolato “La reggente di Carthage”. Stando ai media tunisini e francesi, la reggente, scappando dal paese nel 2011, avrebbe portato con sé circa 1.500 lingotti d’oro fatti uscire in tutta fretta dalle casseforti della banca centrale. Un peso apparentemente importante nell’ispirazione della rivolta lo ha avuto Wikileaks. Secondo la rivista «Foreign Policy», ad esempio, gli scoop di Assange sono diventati il catalizzatore del risentimento popolare e sono stati “sia un grilletto che uno strumento per la rabbia politica”. Per queste ragioni la Tunisia potrebbe essere considerata “il primo stato spinto sull’orlo del precipizio da Wikileaks96”. Per l’analista Emanuele Santi, L’operazione Wikileaks rappresenta un altro passaggio chiave nel preparare il Paese alla rivoluzione. I documenti diplomatici pubblicati nel dicembre 2010 mostrano a chiare lettere il punto di vista della diplomazia americana riguardo al regime di Ben Ali. Si tratta di un punto di vista molto severo che mette in evidenza come la politica tunisina sia troppo concentrata e dipendente dalla figura del presidente, come la libertà di espressione sia limitata, la corruzione regni sovrana e i problemi sociali siano veri. La visione americana è riassunta in uno dei passaggi in cui si evidenzia come “Da molti punti di vista, la Tunisia dovrebbe essere un alleato vicino agli Stati Uniti. Ma non lo è. Mentre condividiamo alcuni valori fondamentali e il Paese si sta sviluppando a ritmi sostenuti, la Tunisia ha grossi problemi. Il presidente Ben Ali sta invecchiando, il suo regime è sclerotico e non vi è un chiaro successore. Molti tunisini sono frustrati. Molti tunisini si lamentano della mancanza di libertà politica e sono arrabbiati per sua moglie, la corruzione, la disoccupazione e le disparità regionali. L’estremismo rappresenta una minaccia costante […] Il risultato: la Tunisia è un Paese turbato come anche i nostri rapporti97”. Il 17 dicembre Ben Ali è a Dubai in vacanza con la famiglia e snobba le manifestazioni. Non si rimette in viaggio per la Tunisia, se non tre giorni dopo, quando l’eco della rivolta raggiunge le città di Biserta, Ben Guerdane, Jendouba, Tunisi, Sousse, Kairouan, Sfax, Zarzis, Jerba. Nei giorni dell’8 e 9 gennaio i manifestanti passano all’attacco: a fronte dell’uso di bombe molotov e dell’inasprimento della contestazione, la polizia decide per la repressione della protesta, ricorrendo a cecchini sui tetti e all’uso armi che mietono venticinque morti. La contestazione passa così dalle città periferiche a Tunisi: il 10 gennaio scendono in piazza professionisti, sindacalisti, studenti e disoccupati che si appellano al cambio di governo e bruciano i ritratti di Zin el-Abidin Ben Ali. Il presidente, fino a quel momento renitente ad intervenire, pronuncia immediatamente un discorso alla televisione nazionale «Tv7» nel quale promette trecentomila posti di lavoro ai manifestanti e al contempo condanna i contestatori tacciandoli di terrorismo e complicità con gli stranieri: Bande di persone a volto coperto hanno attaccato la scorsa notte sedi istituzionali in diverse città del Paese. Si tratta di bande pagate e comandate da entità straniere con l'obiettivo di colpire il Paese. Si diffonde nel frattempo la notizia del rapimento di un giornalista e sul web compaiono immagini delle repressioni avvenute a Thala, Regueb e Kasserine; la polizia spara proiettili di gomma ai funerali delle vittime delle precedenti manifestazioni, scuole e università chiudono. I sindacati dichiarano sciopero generale e la rivolta continua nonostante la repressione sia sempre più dura. 96 E. Dickinson, The First Wikileaks Revolution?, foreignpolicy.com, 13 gennaio 2011. http://wikileaks.foreignpolicy.com/posts/2011/01/13/wikileaks_and_the_tunisia_protests? sms_ss=twitter&at_xt=4d2fbd11812912cc,0 97 E. Santi, La Rivoluzione tunisina: origini e prospettive, cit., p 134. Mohamed Ghannouchi passa alle contromisure e il 12 gennaio annuncia la sostituzione di Rafiq Belhaj Kacem, ministro dell’Interno, che ne paga le spese, con Rafiq Belhaj Kacem. Questa decisione non basta a fermare gli scontri e Tunisi diventa il teatro principale degli scontri. Il governo chiede a Rachid Ammar, capo di stato maggiore, di reprimere nuovamente la rivolta, ma lui e l’esercito restano neutrali, intervenendo solo per difendere i punti sensibili. Le proteste e gli scontri continuano ormai in tutto il paese e ci sono ancora vittime. Ben Ali sente la pressione dei manifestanti e decide di pronunciare (13 gennaio 2011) uno straordinario e anomalo discorso in arabo tunisino nel tentativo di riavvicinarsi al popolo. Sostiene di aver compreso lo spirito dei rivoltosi e le loro ragioni di protesta, condanna l’uso delle armi nella repressione e promette di arrestare e punire i responsabili; dichiara di avere commesso degli errori perché mal consigliato e mal informato sullo stato reale del paese, promette libertà di stampa e di espressione, libertà della rete e della democrazia. Sorprendentemente, annuncia elezioni anticipate entro sei mesi e promette di farsi da parte in occasione delle elezioni presidenziali del 2013. Ma l’inganno dura poche ore: la sera stessa le squadre antisommossa passano alle misure dure e il giorno dopo mietono feriti a Thala e un morto a Tunisi. Il 14 gennaio si arriva alfine al momento della svolta: circa sessantamila persone si radunano di mattina in piazza Mohamed Alì per dirigersi subito dopo verso il palazzo del ministero dell’Interno. In avenue Habib Bourguiba echeggiano cori durissimi contro il presidente Ben Ali e tutti chiedono le sue immediate dimissioni Il primo ministro Mohamed Ghannouchi, dopo aver decretato lo stato di emergenza, appare in televisione alle 18.30 e annuncia – col benestare del Consiglio costituzionale – la fine dell’era Ben Ali, durata ben ventitre anni. Ghannouchi assume la guida del potere, con un direttorio formato da sei persone Il presidente della Camera, Fouad Mebazaa, secondo le previsioni della costituzione tunisina, diventa presidente supplente. Nel pomeriggio dello stesso giorno, Ben Ali ha abbandonato il paese, arrivando in Arabia Saudita, dopo essersi visto opporre un rifiuto di protezione da Malta e Francia, e l'avvertenza da parte dell'Italia che non gli sarebbe stato permesso di atterrare. Su di lui pende un mandato di cattura internazionale. Immediatamente prima della sua partenza, Ben Ali ha ordinato al capo della sicurezza presidenziale, generale Ali Sériati, di attuare la cosiddetta politica della terra bruciata; già la sera del 14 gennaio sono cominciati i primi attacchi armati. Si trovano così una di fronte all’altra le milizie di Ben Ali, desiderose di riprendere il potere tramite un colpo di stato, e l’esercito che pur ha dichiarato la propria neutralità nello scontro in atto. Gli incidenti intorno al palazzo presidenziale di Cartagine provocano circa settantotto morti e novantaquattro feriti. Nonostante la destituzione di Rachid Anmar – che si era rifiutato di sparare sui manifestanti e aveva insistito perché Ben Alì si dimettesse – dal suo incarico, le truppe hanno continuato a fraternizzare con i manifestanti e a combattere le milizie dell’ex presidente. Nello stessa giornata del 14 febbraio una delegazione di ufficiali ha raggiunto Ben Ali per comunicargli il rifiuto dell’esercito di agire contro il popolo tunisino. È utile ricordare, a tal proposito, le caratteristiche essenziali della difesa tunisina: Le forze armate della Tunisia, costituite nel 1956, sono composte da un organico di circa 36.000 uomini, di cui 27.000 in forza all’esercito, 4.000 all’aeronautica e circa 5.000 alla marina. A queste si aggiungono ulteriori 12.000 uomini delle forze paramilitari della Guardia Nazionale. Le forze armate sono ancora basate sul sistema della leva obbligatoria, che i cittadini di sesso maschile sono chiamati ad adempiere (con eccezioni per permessi di studio e lavoro, e sempre più per nepotismo) al compimento del ventesimo anno d’età. Circa 27.000 giovani prestano servizio ogni anno per dodici mesi, nelle forze armate tunisine, mentre sono circa 8.500/9.000 i militari (ufficiali e sottufficiali) in servizio permanente. Di questi, il 60% è in forza all’esercito ed il restante 40% equamente distribuito tra marina ed aeronautica. Le forze armate costituiscono un buon indicatore per la comprensione delle diseguaglianze economiche e sociali del paese. I coscritti sono in larga misura provenienti dalle aree centrali e meridionali del paese, mentre tra quelli della fascia costiera e del nord e ben più rilevante l’incidenza dei permessi di rinvio o dei congedi. La gran parte degli ufficiali è invece riconducibile geograficamente alle aree più sviluppate del paese, e tra loro non pochi sono espressione del sistema di potere dell’establishment98. Dopo la dichiarazione di stato d'emergenza, l'esercito si è fatto carico dell'ordine pubblico non solo proteggendo i punti sensibili ma intraprendendo una vera caccia alle milizie presidenziali. Dalla parte delle forze armate tunisine si schierano anche gli Stati Uniti. La popolazione tunisina, dal canto suo, si organizza in un comitato di autodifesa per affiancare l’esercito sia nella lotta al golpismo del presidente sia per arrestare le azioni vandaliche e distruttive cui si erano votati diversi settori del movimento, che avevano saccheggiato negozi, assaltato banche e preso di mira anche piccoli esercizi commerciali. Il 17 gennaio Ghannouchi presenta un nuovo governo di unità nazionale, riservando però diversi posti di prestigio a esponenti del vecchio regime, che mantengono la Difesa, il ministero dell’Interno e quello degli Esteri. Sgomenti per questa scelta, i tunisini tornano in piazza e Ghannouchi e Mebazaa decidono di dimettersi dal Rcd presidenziale; il 20 gennaio la decisione è emulata dal resto dei ministri del governo ad interim che portano così il comitato centrale del Rcd alla dissoluzione. Intanto il giovane blogger Slim Amamou, uno dei principali volti della protesta, viene nominato sottosegretario alla gioventù e allo sport. Il 18 gennaio torna in Tunisia, dopo anni di esilio, Marcef Manzouki, leader del partito fuorilegge “Congresso per la Repubblica”. Rachid Ghannouchi, a differenza degli esponenti Hizb al-Tahir (un’organizzazione politica panislamica e genericamente salafita) che propugnano il ritorno al califfato e l’assunzione di un islamismo più radicale, si dichiara favorevole ad un accordo con le opposizioni, a competere democraticamente con le altre forze e a combattere la fanatizzazione ideologica del movimento di protesta. Hamadi Jebali, segretario generale di Ennahda, prova a conquistare la fiducia dell’occidente incontrando a Washington i senatori John McCain e Joseph Lieberman. Oggi al-Nahda si dichiara vicina al partito islamico-conservatore turco Akp (“Partito per la Giustizia a lo Sviluppo”, di Recep Tayyp Erdogan) e non rinnega il suo legame storico coi Fratelli Mussulmani e gli studi di el-Banna e Qutb. I suoi oppositori in Tunisia lo hanno definito come “portatore di uno Stato ideologico fondato sul Corano e non sui principi della democrazia”, mentre loro si definiscono come veri e unici protettori dell’islam in quanto principale religione del paese. Pochi giorni prima, il 27 gennaio, il ministro degli esteri, Kamel Morjane, si è dimesso e il primo ministro ha annunciato un rimpasto di governo senza esponenti del vecchio regime. Un mese più tardi, dopo che un corteo è degenerato in scontri con la polizia che hanno provocato la morte di cinque persone, Mohamed Ghannouchi si dimette da primo ministro e al suo posto viene nominato Beij Caid Essebsi, già ambasciatore tunisino in Germania, una figura di basso profilo giudicata adatta per governare un periodo di transizione. Il 26 aprile i vertici dell’Rcd vengono banditi dalle elezioni per l’assemblea costituente, mentre il 20 giugno Ben Ali e sua moglie vengono condannati in contumacia a trentacinque anni di carcere per furto e possesso illegale di denaro contante e gioielli. In estate destano scalpore le dichiarazioni di Rachid Ghannouchi, capo di Ennahda, che nel corso di un’intervista rilasciata a «Sabah el khir ya Mas» (“Buongiorno Egitto”) parla di “califfato per la nuova Tunisia” come “obiettivo ultimo” del suo partito. Ai primi di ottobre, inoltre, circa duecento militanti salafiti hanno attaccato la sede principale 98 N.Pedde, La variabile delle forze armate, cit. dell’emittente televisiva «Nessma» e incendiato la casa del presidente Nabil Karoui, reo di aver trasmesso sulla sua rete «Persepolis», il cartoon franco-iraniano della regista Marjane Satrapi che racconta la storia di una giovane emancipata in fuga dall’oscurantismo degli ayatollah. Il film è ritenuto offensivo nei riguardi dell’islam. Contestualmente, i fondamentalisti islamici protestano per il divieto imposto alle ragazze che indossavano il niqab d’iscriversi all’università: gli integralisti attaccano così le forze dell’ordine con pietre, bastoni e coltelli. Anche in questo clima, è partita la campagna elettorale per l’elezione dell’Assemblea costituente, una competizione cui hanno preso parte circa centocinque organizzazioni. Il Consiglio nazionale ha stabilito la parità uomo-donna alle elezioni, ha dato il voto ai tunisini residenti all’estero, ha sancito l’ineleggibilità di membri del regime che hanno ricoperto responsabilità istituzionali e ha scelto un sistema elettorale di carattere proporzionale (con liste plurinominali) che di fatto ha permesso anche ai partiti minori di avere una rappresentanza (un rappresentane ogni sessantamila votanti). I risultati delle elezioni del 23 ottobre 2011 (cui ha partecipato circa il 70% degli aventi diritto) ha consegnato l’Assemblea nella mani di Ennahda che gestirà questa fase transitoria, che comprende anche la definizione di una nuova Costituzione, fino alle prossime elezioni. In questo quadro, la scelta di abolire la polizia segreta – con Ennahda che è al potere e con la Libia e l’Algeria che sono particolarmente esposte all’influenza terroristica – pone seri interrogativi circa la stabilità della Tunisia e la sua sicurezza interna. Sul piano economico va annotato che: anche se la rivoluzione tunisina non è stata, come molti mezzi di comunicazione hanno erroneamente riportato, una “guerra del pane”, la ripresa economica e la lotta contro la disoccupazione soprattutto nelle zone “calde”, dove è nato il movimento rivoluzionario, rappresentano infine un’altra chiave di volta nella costruzione della nuova Tunisia. Le regioni di Sidi Bouzid, Gafsa, Kef e Kasserine hanno dei ritardi strutturali che necessiteranno anni di investimenti per essere colmati. La stagione turistica […] si prospetta assai problematica, con stime che prevedono un calo del 50% dei ricavi nel settore. La gestione della “congiuntura economica” risulterà dunque di importanza capitale per mantenere la pace sociale necessaria per una transizione politica. La lotta alla corruzione giocherà inoltre un ruolo importante per ristabilire la fiducia degli investitori e di una grande comunità tunisina residente all’estero che attende il momento per tornare in un Paese nuovo, per portare nuove energie e risorse in maniera onesta e trasparente99. Il giornalista Lorenzo Declich spiega che: a fronte di un iniziale declassamento della Tunisia da parte delle agenzie di rating, sono molti gli operatori internazionali che scommettono sul futuro economico del paese: l’abbattimento dell’impero dei Trabilsi (il clan familiare della moglie di Ben Ali), pur avendo rappresentato un colpo all’affidabilità del sistema paese ha infatti rimosso un filtro attraverso cui dovevano passare tutte le azioni desiderose di metter piede a Tunisi […]Le grandi aziende nazionali e internazionali hanno dunque compreso che la Tunisia di oggi può essere una grande occasione d’affari. Un esempio è l’iniziativa di marketing «16 giugno 2014» promossa dal Memac Ogilvy Label Tunisie in collaborazione con Mindshare, Adbuzz, Access to E-Business e con la partecipazione di NessmaTV […] A rafforzare l’attrattiva economica della Tunisia post-Ben Ali arriva poi la recente decisione del G8 di Deauville di istituire un fondo di 35 miliardi di dollari per aiutare la «primavera araba». Tra gli investitori esteri più attivi figurano i paesi del Golfo (impegnatisi per 10 miliardi di euro, secondo quanto riferito dal presidente francese Nicolas Sarkozy) e in particolare il Qatar, il cui protagonismo spazia dal sostegno a Tunisi nel contesto dell’emergenza umanitaria ai confini con la Libia fino all’«investimento in nuovi progetti tesi a 99 E.Santi, La Rivoluzione tunisina: origini e prospettive, cit., pp 137-138. rafforzare lo sviluppo tunisino». Tuttavia, non è tutto rose e fiori. Il 19 gennaio l’agenzia di rating Moody’s declassava la Tunisia (da Baa2 a Baa3) e ne peggiorava l’outlook da stabile a negativo. E se nella Tunisia del 2010 i sindacati erano organizzazioni fantoccio nelle mani del potere dittatoriale, oggi un sindacato rinnovato, protagonista della rivoluzione, può rappresentare un grosso problema per quegli imprenditori che, pur pagando pegno a Ben Ali, potevano poi contare sull’assenza di vertenze contrattuali […] Gli italiani hanno da tempo una politica di incentivi su scala principalmente regionale, con il coinvolgimento di banche e organizzazioni economiche nazionali a vocazione internazionali, come Sace, Simest e Confindustria. Quest’anno il ministro degli Esteri Franco Frattini ha aperto un «tavolo Tunisia» (17 febbraio) con il ministro dell’Industria e della Tecnologia tunisino, presentando un pacchetto di aiuti per «cinque milioni di euro immediatamente disponibili, ai quali se ne aggiungeranno altri 13. Sommando le nuove linee di credito si arriva a 73 milioni di euro per sostenere il settore privato» ha dichiarato Frattini100. L’avanzamento elettorale e politico in Tunisia del partito islamico al-Nahda (Ennahda) ha aperto un dibattito rilevante nel paese – e in Occidente – sui rischi legati alla stabilità del Maghreb e sulla possibile deriva dell’Africa occidentale verso l’estremismo religioso. I leader di Ennahda, pur accettando “le regole del gioco democratico” e respingendo le accuse di estremismo, hanno più volte fatto riferimento nei propri interventi pubblici “al ritorno del califfato”. Interessato a questo dibattito, il magazine online «Italnews.info»101 ha pubblicato nel febbraio 2011 la lettera aperta di un utente della rete, che ha usato il nickname di Skander BB, indirizzata ad Ennhada e pubblicata (in francese) in un forum di uno dei principali provider tunisini che ospitano discussioni su questo argomento. “Noi Tunisini, e generalmente i popoli arabi islamici, per quindici secoli siamo purtroppo rimasti delusi dai nostri politici e dai nostri capi spirituali. Le guerre sanguinose scoppiate per la successione del Profeta e le altre che seguirono, anche tra gli Omayyadi e gli Abbasidi in nome della difesa del vero Islam, sono una vivida testimonianza degli abusi che può provocare le pericolosa miscela tra politica e religione. La storia islamica è ricca di eventi di grande sofferenza per le popolazioni arabo-islamiche. La religione usata per scopi politici è pericolosa, purtroppo, e prima o poi condanna ad una settaria deriva di guerra civile. Questa miscela evoca in un gran numero di mussulmani un giustificato spavento. L’individuo, nella società religiosa dell’Iran o dell’Arabia Saudita, è considerato nella migliore delle ipotesi un oggetto, una “cosa” che funziona e non pensa. Le derive dittatoriali, le sottomissioni, le emarginazioni, la tortura, l’esilio e così via, vengono effettuate ancora in nome dell’Islam ed è lo sport preferito dei leader arabi e mussulmani. Anche nelle società che non hanno dichiarato apertamente la loro appartenenza religiosa a questa politica, l’individuo non ha alcuna libertà, senza alcun rispetto. In tutti i Paesi mussulmani i governi stanno al potere e perpetuano il loro dominio solo e grazie ad una base di fedeli religiosamente indottrinati e disposti a sacrificarsi per il leader spirituale. Per il vero Mussulmano, la mancanza del dibattito politico è considerata un dovere o addirittura un requisito assoluto. La sottomissione ai leader politici o spirituali è un obbligo divino. La critica e la discussione sulle decisioni è completamente assente dalla sfera pubblica. Chiunque osi discutere o criticare un capo politico o spirituale è considerato un traditore e ne paga il prezzo con la sua vita. A coloro che hanno la memoria corta, a coloro che non conoscono la storia politica dell’Islam, quelli che parlano del “periodo d’oro dell’Islam” come un periodo di pace e prosperità sociale, 100 L.Delich, Tunisia Prove tecniche di futuro, in Limes 3/2011, pp.280-282. 101 http://www.italnews.info/2011/02/24/lettera-aperta-ai-leader-del-partito-islamico-ennahdha/ ricordo le molte differenze economiche e politiche nate da guerre fratricide e movimenti religiosi, che continuano ancora oggi. In nome dell’Islam, il mondo arabo-islamico, nonostante il suo periodo di massimo splendore, non aveva che brevi periodi di pace. La gara per il potere e troni dei principi e di guide spirituali durante questo “periodo d’oro” fu tale che la gente di quel tempo ha vissuto le stesse sofferenze e le paure di noi oggi. Chi ha osato contraddire, contrastare il principe o il leader spirituale, compresi gli intellettuali e gli scienziati, erano al meglio imprigionati o costretti all’esilio. L’impiccagione e la decapitazione nello spazio pubblico è stata la macchina per raffreddare qualsiasi ardore politico o intellettuale. La generosità dei principi nei confronti dei loro sostenitori era lo strumento per eccellenza per dividere e conquistare. Questo ci ricorda dolorosamente di pratiche ancora in corso nei nostri Paesi arabo-islamici. Signori del Partito Ennahdha, noi apprendiamo dell’arrivo nella nuova Tunisia di un partito politico che fonda la sua dottrina sul fattore religioso: la storia di Paesi arabi islamici ha dimostrato l’incompatibilità tra religione e politica nell’Islam. La storia ha dimostrato che si tratta di una fonte di oppressione per i popoli. La storia ha dimostrato che si tratta di una fonte di settarismo e di instabilità. La storia ha dimostrato che una volta che il fattore religioso ha invertito il meccanismo delle libertà individuali e politiche, che la riduzione di una società in tutta la sua complessità nella convinzione religiosa è pura e semplice ignoranza. La storia ha anche dimostrato che “l’età d’oro” dell’Islam si è avuta grazie a pochi leader musulmani che hanno permesso ad intellettuali e scienziati, arabi e non, di parlare e di vivere liberamente, senza vincoli politici né religiosi. Illustri leader di Ennahdha, chiedo la grazia e l’onestà intellettuale di essere lungimiranti, di non lasciare per molto tempo che le vostre ambizioni politiche vi facciano dimenticare l’essenziale: l’interesse nazionale e il benessere di un intero popolo. Invito la vostra base ad affrontare le sue dissonanze intellettuali ed evitare al nostro Paese nuove sofferenze. La miscela del fatto religioso con il fatto politico è una vera e propria confusione di generi. La base del suo partito, come d’altronde tutte le basi di partiti in tutto il mondo, non ha alcuna capacità intellettuale e la prospettiva necessaria per fare ciò. Il vostro riferimento alla religione mussulmana che è anche la nostra religione è legittimo. D’altronde, la nostra Costituzione, il nostro Codice civile e tutte le nostre attuali pratiche sociali e politiche, sono basate su di esso. Evitate di far credere ai vostri sostenitori di essere i custodi del vero Islam. L’Islam è nobile. L’Islam è universale. L’Islam è per tutta l’umanità. I suoi valori sono degni di qualsiasi società fino alla fine dei tempi. La sua data di nascita non è quindici secoli, che risale alle origini del mondo. L’Islam non è nato per essere in conflitto con ogni messaggio, ogni dottrina. È nato per illuminare coloro che cercano la verità in un ambito individuale e personale. Per finire vorrei dire al Signor Ghannouchi che l’onestà intellettuale deve essere una delle grandi qualità del politico mussulmano. Un discorso vero e autentico è del tutto coerente con i valori che lo producono. Nel Tuo caso, ho l’impressione che le cose siano confuse. Dal momento del tuo ritorno sulla scena politica e da quando hai cominciato a prendere la parola, i tuoi discorsi politici stanno sempre di più scendendo dalla dottrina ufficiale verso quella pubblicata apertamente sul tuo sito. Ciò dà l’impressione di parlare un doppio linguaggio. Potresti chiarire i seguenti punti: - i Suoi simpatizzanti e la base del partito demonizzano la laicità, che è semplicemente la separazione del fatto religioso da quello politico. La laicità non rifiuta alcuna credenza, nel caso l’Islam. La laicità rispetta tutte le credenze sia religiose sia politiche. Perché non prova ad illuminare i Suoi simpatizzanti sul concetto di laicità e le sue varie scuole? Una base di sostenitori illuminata è la garanzia della perennità e del successo di qualsiasi movimento politico o altro, non crede? - Lei dice che il Suo non è un partito religioso e vorrei crederlo. Ma il sito del Suo partito mostra apertamente la sua linea politica religiosa. Può spiegare questa contraddizione? O è un fatto prettamente congiunturale? - Lei dice di non coltivare il culto della personalità, di essere contro ogni deriva di questo tipo e che è a favore di una Repubblica parlamentare in cui solo le persone elette governano. Le rispondo al riguardo che in base a ciò che fa, io avrei paura a votare per il Suo partito oggi. La base del Suo partito è in una pericolosa deriva politica. Essa La considera un capo spirituale unico ed infallibile, come Khomeini. Il culto della personalità attorno alla Sua persona è già in atto. Questo ci ricorda a noi che non apparteniamo ad Ennahdha e che abbiamo pagato un prezzo alto per la libertà, ricordi terribilmente dolorosi. D’altronde Lei ne ha avuto la Sua parte. Allora è pronto a dare l’allarme anche dentro il Suo partito per fermare il culto della personalità di questa macchina diabolica? E’ pronto a inquadrare e salvare il Suo partito da un trend pericoloso? E’ sicuro che questa dottrina adottata attualmente di miscela di generi (secondo il Suo sito) sia in grado di coesistere pacificamente in uno spazio democratico, libero da qualsiasi dottrina religiosa? Come garantirebbe la non deriva settaria e religiosa della Sua base alle prossime elezioni? - Lei dice che il Suo partito è per il rispetto e la consacrazione dell’uguaglianza nella differenza di tutti, siano esse religiose, intellettuali o altre. Che Lei rifiuta l’alienazione di tutti i tipi. A guardare il Suo sito, mi sembra che il Suo partito sia aperto solo a coloro che condividono le vostre convinzioni. La scelta di scrivere il Vostro sito solo in lingua araba è un esempio ed è una scelta esplicita di esclusione. Coloro che non appartengono alla cultura araba non hanno posto nei vostri piani per le nuove politiche in Tunisia? In un mondo in cui le chiavi di successo economico e sociale sono in Inglese e Francese, stranamente si escludono queste due lingue principali dal Suo discorso politico; perché? Vorrei ricordare che i Mussulmani che parlano arabo sono una minoranza nel mondo mussulmano e non abbiamo bisogno di parlare l’arabo per essere un buon mussulmano. Il più grande Paese mussulmano, l’Indonesia, non parla arabo, la Turchia non più, ecc. D’altronde l’Arabo, così come la lingua francese, non è la lingua del Tunisino. Tutti noi, Voi compreso, parliamo Tunisino. La scelta della lingua araba è una scelta politica che ci è stata imposta. Perché non dare lo status di lingua nazionale al Tunisino?”. 7. Posizionata strategicamente tra il Nord Africa e l’area sub-sahariana, la Mauritania102 vive un contesto del tutto particolare in cui persistono ancora oggi tensioni etniche e razziali all’interno delle comunità arabe – suddivise tra Beydane (i cosiddetti “White Moors”) e Haratine (conosciuti come “Black Moors” o “schiavi liberati”) – e africane locali (Haalpulaar, Soninke e Wolof). Il 100% della popolazione è mussulmana sunnita. Tra i fattori che comportano un delicato equilibrio, certamente grande importanza è da ascriversi al fatto che sin dall’indipendenza (ottenuta nel 1960 dalla Francia) si è sviluppato un contrasto tra una linea di “islamizzazione e arabizzazione forzosa”103 imposta dall’alto che ha spinto le dottrine salafite verso una tendenza più moderata. Questa dialettica – ancora non risolta – ha comportato l’alternanza tra il supporto all’imam come Bouddah Ould Bousseyri e Mohammed Salem Ould Addoud, la promozione di centri studi islamici con una visione radicale o la creazione di moschee (grazie al finanziamento dei partner del Golfo) e tendenze più avanzate di apertura verso l’esterno 102 Sezione a cura di Maria Egizia Gattamorta. 103 Anoual Boukhars, The Challenge of radical Islam, «Terrorism Monitor» vol.3, Ottobre 2005, http://www.jamestown.org/programs/gta/terrorismmonitorgta/ (registrate più o meno negli anni 1991-1993 e 2002-2004). In questo quadro complesso appare fondamentale la figura del presidente Maaouya Ould Sid' Ahmed Taya. Primo ministro tra il 1981 ed il 1984, autore di un golpe militare nel dicembre 1984, capo dello stato dal gennaio del 1992 all’agosto del 2005, Ould Taya si è distinto negli anni al potere per aver promosso una linea ferma contro i gruppi militanti islamici e le organizzazioni clandestine, per aver voluto un avvicinamento agli Stati Uniti ed al campo occidentale, per essersi schierato contro il dittatore iracheno Saddam Hussein (precedentemente considerato un fedele alleato). Nonostante queste scelte fossero state considerate in modo critico all’interno dello Stato (che si configura ufficialmente come Repubblica Islamica), l’elemento determinante che ha fatto scatenare i movimenti islamici ed il malumore popolare è stato lo stabilimento di relazioni diplomatiche con Israele nell’ottobre 1999. Gli attentati ed i complotti pianificati dai gruppi radicali islamici nel 2003 e nel 2004 sono stati utilizzati abilmente dal potere centrale per reprimere ogni forma di dissenso e l’opposizione in generale. Secondo un report del 2005 redatto dal think thank International Crisis Group104, il governo di Ould Taya avrebbe “gonfiato” la minaccia del terrorismo islamico per assicurarsi il supporto dei partner occidentali (tanto più dopo l’11 settembre 2001) e per minimizzare agli occhi dell’opinione pubblica internazionale sia i problemi connessi alla corruzione dilagante che la riduzione delle libertà individuali. Con tale affermazione non si vuole però disconoscere la presenza sempre più incisiva in questi anni di cellule del “Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento” (Gspc, successivamente trasformatosi in “al-Qaeda nel Maghreb Islamico” – Aqmi) che riescono a cogliere proprio il malcontento della popolazione locale ed attirarsi le simpatie delle frange estreme dei gruppi islamici, arruolando numerosi giovani. Il golpe che ha portato alla caduta del regime di Ould Taya il 3 agosto 2005, promosso dal “Consiglio Militare per la Giustizia e la Democrazia” guidato dal Colonnello Ely Ould Mohamed Vall ha ricevuto una forte critica internazionale (concretizzatasi in un primo tempo nella sospensione dall’organizzazione continentale dell’Unione Africana) controbilanciato da un forte sostegno popolare, esausto del clima di repressione instaurato dal regime precedente. Le prime mosse della nuova autorità – come ad esempio l’amnistia per i prigionieri politici, il ritorno in patria degli oppositori mandati in esilio da Ould Taya, la creazione di una Commissione Nazionale Elettorale, la pianificazione di un referendum costituzionale nonché l’organizzazione di consultazioni generali nel breve periodo – hanno alimentato le speranze per un cambiamento sostanziale della scena politica nazionale. L’elezione di Ould Cheikh Abdellahi nel marzo 2007 è stata vissuta come la concretizzazione di un percorso democratico. Il nuovo presidente tuttavia ha mostrato alcune gravi carenze che hanno determinato un rapido allontanamento dalla scena politica. L’incapacità nel gestire le controversie interne delle formazioni politiche locali, la debolezza nel promuovere una manovra macroeconomica atta ad affrontare il rialzo di prezzo dei generi alimentari, la mancata risposta agli attacchi terroristici di Aqmi, il perdurante utilizzo di forme di nepotismo ed autoritarismo hanno favorito il 6 agosto 2008 le condizioni per un nuovo golpe militare incruento guidato dal generale Mohamed Ould Abdel Aziz. La deposizione di un rappresentante civile ed il ritorno di una equipe militare è stata applaudita da una folla esultante nelle strade di Nouakchott, impaurita dagli ultimi attacchi di “al-Qaeda nel Maghreb Islamico” (ad Aleg e Al Ghalawiya nel dicembre 2007 e quello del febbraio 2008 proprio nella capitale mauritana contro l’ambasciata israeliana). Nonostante l’isolamento internazionale causato dalla presa di posizione da parte di Stati Uniti, Unione Europea, Unione Africana ed Istituzioni finanziarie internazionali (che hanno sospeso aiuti ed esteso sanzioni di vario tipo pur di ottenere la normalizzazione politica ed il ritorno dell’estromesso presidente Abdullahi), la giunta ha cercato di promuovere iniziative di sviluppo e soprattutto dei “gesti di apertura” con le parti politiche contrarie. In tal senso deve essere letto l’annuncio nel gennaio 2009 104 Islamist terrorism in the Sahel: fact or fiction?, Crisis Group, «Africa Report» n. 92, Marzo 2005, http://www.crisisgroup.org/ di consultazioni presidenziali per il maggio successivo, inteso quale segnale di dialogo. L’ostilità ed il boicottaggio delle elezioni da parte delle formazioni dell’opposizione ha allarmato la comunità internazionale che è intervenuta facendo pressione su Abdel Aziz e i gruppi minori per riallacciare i contatti con il gruppo militare al potere. Solo grazie alla mediazione senegalese è stato raggiunto un accordo a Dakar agli inizi di giugno per posporre le elezioni nel luglio 2009 e formare un governo di unità nazionale durante il periodo di transizione. Il voto del 18 luglio ha coinvolto dieci protagonisti tra i quali è emerso come vincitore al primo turno Ould Abdel Aziz con il 52,64% delle preferenze. Degli altri candidati solo Ould Belkheir e Ould Daddah hanno ottenuto una quota superiore al 5% dei suffragi, raggiungendo rispettivamente il 16,2% ed il 13,6%. In occasione dell’assunzione dell’incarico il 5 agosto 2009, il Presidente Abdel Aziz ha garantito di focalizzare l’attenzione sulla minaccia terroristica, sempre più pressante sul paese. In questa direzione è stata adottata il 5 gennaio 2010 una legge antiterrorismo105 che ha ampliato i poteri del governo per controllare in modo più pervasivo ed efficace coloro che sono sospettati di essere collegati a gruppi terroristi locali. Fondamentale è stato poi il rafforzamento delle forze armate e dei servizi di intelligence per contrastare la minaccia salafita e vigilare sui traffici illegali connessi (droga, tabacco, armi), facilitati dai confini porosi dello spazio saheliano. Gli attacchi crescenti sul suolo mauritano – contro rappresentanze diplomatiche straniere, pattuglie militari o cooperanti europei – ma ancor più i richiami rivolti dai leader di Aqim e replicati dai responsabili di al-Qaeda106 nei confronti dei locali al fine di un sollevamento generale contro un governo “colpevole di alto tradimento dei valori islamici” hanno manovre drastiche a livello interno e hanno favorito il coinvolgimento in attività regionali. Gli incontri sempre più frequenti dei Capi di Stato Maggiore e dei responsabili dei Servizi di Intelligence di Algeria, Mali, Mauritania e Niger (come ad esempio nell’aprile e nel settembre 2010)107 evidenziano un impegno corale innovativo. Tuttavia diversi osservatori notano che per essere incisiva, l’azione dovrebbe includere Chad, Libia e Marocco, superando vecchie gelosie ed antagonismi di area108. Indicativa di cosa potrebbe comportare una collaborazione rafforzata tra gli attori dell’area è stata l’azione condotta dall’esercito e dall’aviazione mauritani contro le milizie di al- Qaeda nel Maghreb Islamico nella Foresta Wagadou (nord-ovest del Mali, 24-25 giugno 2011). Sebbene non sia chiaro 105 La Mauritanie se dote de nouvelles lois antiterroristes, 02.01.2010, http://www.rfi.fr/contenu/20100102-mauritanie-dote-nouvelles-lois-antiterroristes La législation antiterroriste en Mauritanie suscite un débat http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/features/2010/01/13/feature-01. Si ricorda tuttavia che il Consiglio costituzionale nel marzo 2010 ha respinto alcuni articoli della legge antiterrorista che avrebbero comportato, tra l’altro, l’incarcerazione dei minori ed il prolungamento della durata della detenzione preventiva da parte della polizia a quattro anni. Al riguardo vd Le Conseil constitutionnel mauritanien rejette certaines parties de la législation antiterroriste, 09.03.2010. http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/features/2010/03/09/feature-01 106 Il riferimento è a Ayman Al Zawahiri, numero due di al-Qaeda. 107 New Sahel-Saharan joint military command opens in Algeria, 22.04.2010. http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2010/04/22/feature-01 Shared north African anti-terror intelligence centre planned, 30.09.2010. http://www.english.rfi.fr/node/49781 108 Nonostante il pericolo di Aqim, Algeria e Marocco non riescono a superare i vecchi attriti e collaborare fattivamente per contrastare le azioni delle cellule terroriste. se l’esercito del Mali abbia partecipato o meno all’offensiva in cui sono morti una quindicina di combattenti di Aqim ed in cui una decina di guerriglieri sono rimasti feriti, è intuibile una previa informazione o quanto meno un “placet” per l’operazione da parte del governo di Bamako. Tale azione – nonchè la gestione della notizia – è stata molto discussa da parte dall’opposizione mauritana (ad esempio Mohammed Moustapha Ould Bedreddine e Ahmed Ould Daddah) che ha paventato un effetto negativo sulla guerra al terrorismo e ha criticato la mancanza di un’informazione ufficiale nei confronti del pubblico, vittima di “pettegolezzi” della stampa. In occasione del secondo anniversario del suo arrivo al potere, il 5 agosto 2011 il Presidente Abdelaziz ha ribadito di non essere pronto a subire il diktat del terrorismo. Per tale motivo abbiamo rafforzato le nostre capacità militari in numero, qualità e quantità […] la Mauritania ha moltiplicato da trecento a quattrocento le sue capacità logistiche e rinforzato la qualità dei suoi armamenti109. Secondo gli esperti di settore la questione dell’estremismo islamico in Mauritania deve essere colta nella giusta prospettiva, poiché non sembra innato ma riceve piuttosto un supporto limitato dal basso. Bibliografia P. González del Miño, El movimiento islamista en Marruecos. Entre la institucionalización y el asociacionismo, «Revista Cidob d’Afers Internacionals», num. 93-94, aprile 2011, pp. 33-51. J.Antonio Macías Amoretti, El pensamento político marroquí contamporáneo. Islam y democrazia en Abd al-Salam Yasin y Muhammad u Muhammad Abid al-Yabri, Casablanca-GranadaOxford, 2007. Hassan II, La mémoire d’un Roi. Entretiens avec Enric Laurent, Plon, Parigi, 1993. 109 Mauritanie : le président Ould Abdelaziz refuse le "diktat du terrorisme, 06.08.2011 http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20110806150924/ S. Kirhlani, El movimento islamista marroquí, «Redacción Pueblos», 2 giugno 2005. A. Agostinelli, Rivolte, ora tocca al Marocco?, «Espresso online», 17 febbraio 2011 A. Yasin, La senda profética: educación, organización y avance, in www.yassine.net. M. Tozy, El fin de la excepción marroquí. El islamismo de Marruecos frente al reto del salafismo, in «Afkar/Ideas», n.1, dicembre 2003. M.Tozy, Monarquía e Islam político en Marruecos”, Ediciones Bellaterra, 2000. Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Reino de Marruecos, 47/2010, luglio 2010. M. López Belloso, El integrismo islámico en Marruecos, in «Trabayos y ensayos», numero 1, gennaio 2005. - L. El Houssi, Il concetto di laicità nell’Islam tunisino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Padova, a.a. 2000-2001. - E. Santi, La Rivoluzione tunisina: origini e prospettive, in «Rivista di Studi Politici», trimestrale dell’Istituto di Studi Politici “S.Pio V”, n. 2/2011, Anno XXIII, aprile-giugno 2011, p. 130. - L. Declich, Tunisia, la Rivoluzione Modello, in «Limes», n.1/2011 - L.Declich, Tunisia, prove tecniche di futuro, in «Limes», n.3/2011 - R. Burgat, L'Islamisme au Maghreb, Karthala, Parigi 1988. - Tunisie: Habib Mokni, le MTI, l'islam et le pouvoir, «Les Cahiers de l'Orient», n°7, troisième trimestre 1987. - N. Beau e J.P. Tuquoi, Notre ami Ben Ali, Parigi, La Découverte, 2002. - Speciale Crisi Egitto e Tunisia, «Difesa e Interesse Nazionale», 7 febbraio 2011. - Mauritanie: le président Ould Abdelaziz refuse le diktat du terrorisme, «Jeune Afrique», 06.08.2011. http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20110806150924/ - A. Boukhars, The Challenge of radical Islam, «Terrorism Monitor» vol 3, Ottobre 2005, http://www.jamestown.org/programs/gta/terrorismmonitorgta/ - W. Ramzi, New Sahel-Saharan joint military command opens in Algeria, «Magharebia», 22.04.2010, http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2010/04/22/fe ature-01 - Shared north African anti-terror intelligence centre planned, «Rfi», 30.09.2010, http://www.english.rfi.fr/node/49781 - M.Y.O.A. Wedoud, Le Conseil constitutionnel mauritanien rejette certaines parties de la législation antiterroriste, «Magharebia», 09.03.2010, http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/features/2010/03/09/feature01 - La Mauritanie se dote de nouvelles lois antiterroristes, «Rfi», 02.01.2010, http://www.rfi.fr/contenu/20100102-mauritanie-dote-nouvelles-lois-antiterroristes - M.Y.O.A Wedoud, La législation antiterroriste en Mauritanie suscite un débat, «Magharebia», 13.01.2010, http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/features/2010/01/13/feature01 - Islamist terrorism in the Sahel: fact or fiction?, International Crisis Group, Africa Report n. 92, Marzo 2005, http://www.crisisgroup.org/ - C. Jourde, Sifting through the layers of insecurity in the Sahel : the case of Mauritania, «Africa Security Briefing», no.15, Settembre 2011, http://africacenter.org/wp-content/uploads/2011/09/AfricaBriefFinal_15.pdf - I. Fakir e C. Boucek, Mauritania: 2009. Year in review, «Med 2010», Iemed, 2010, http://www.iemed.org/ - Mauritania’s goals in its struggle against al-Qaeda, «Al Jazeera Centre for Studies», 25 Luglio 2011, http://www.aljazeera.net/mritems/streams/2011/7/26/1_1076198_1_51.pdf Capitolo Quarto L’ombra lunga del fondamentalismo Daniele Cellamare 1. Nel Sudan, il paese più vasto dell’Africa prima della scissione, convivono venticinque milioni di abitanti suddivisi in seicento gruppi etnici, che parlano oltre cento lingue diverse. Il nord è mussulmano e il sud (il 30% della popolazione) è animista e cristiano. La divisione geografica del Sudan in una parte settentrionale – che comprende tradizionalmente anche il centro e l’ovest – ed in una parte meridionale, corrisponde indicativamente alla distinzione etnica tra l’elemento arabo mussulmano e l’elemento africano della popolazione. Il nord, arabo ed islamizzato, appartiene sotto il profilo culturale all’area medio-orientale mentre il sud, popolato da tribù pagane di razza negroide e nilotica, appartiene alla struttura etnico sociale africana. I niloti sono una delle grandi famiglie etniche in cui si dividono i neri africani, localizzati principalmente nel bacino dell’alto Nilo e le popolazioni più diffuse vivono proprio nella repubblica del Sudan, anche se oggi si tende a restringere l’accezione del termine niloti per indicare i due gruppi più importanti (Luo e Dinca-Nuer) e quello minore, dove sono più accentuati gli influssi camitici (Niloto-Camiti). Tra le popolazioni di lingua araba del nord si distinguono, essenzialmente per il modo di vita, le popolazioni cittadine, gli allevatori nomadi di bestiame e di cammelli, e gli agricoltori che vivono in comunità rurali. Tra Atbara e la catena montuosa che fiancheggia il Mar Rosso, vive la popolazione dei beja, mentre la regione situata tra Assuan e Dongola è abitata dai nubiani, i primi abitanti del nord, oggi profondamente mussulmani dopo la lunga presenza degli arabi nell’area. L’altopiano del Kordofan meridionale è abitato dai nuba, popolazione montanara negroide di diverse origini. Le regioni del Bahar al-Ghazal, nel Sudan meridionale, sono abitate da tribù nilotiche, e le principali sono le denka, le sciluk e le neur. Nelle “regioni equatoriali”, sempre nel Sudan meridionale, si trovano i Nilo-amiti, che per lingua e civiltà differiscono profondamente dai niloti, così come l’ultimo gruppo della popolazione del sud, gli zanda, stabiliti sull’altopiano di Ironstone. L’area dei monti Nuba (nel centro geografico del paese) non è assistita dalle autorità governative e più di due milioni di persone vengono sistematicamente ignorate, o meglio, pur essendo in maggioranza mussulmani, i nuba sono oggetto di sterminio etnico da parte del governo di Khartoum. Su queste montagne cinquantadue tribù differenti – che discendono dagli schiavi sfuggiti alle carovane arabe nei secoli scorsi, hanno dato origine ad una serie di comunità legate da uno spirito di tolleranza e coesione tra diverse culture e fedi religiose che non sembrano avere uguali in Africa. Sulle montagne Nuba si moltiplicano però i famosi e sinistri “campi della pace” del governo sudanese (in realtà si tratta di veri e propri campi di concentramento) dove i militari del regime praticano lo stupro come pulizia etnica e i giovani addestrati nei campi vengono poi impiegati dalle truppe governative per reprimere i ribelli del sud. Anche se la regione dei monti Nuba è molto florida, i rastrellamenti, i villaggi bruciati e le razzie di bestiame hanno ottenuto l’effetto di distruggere l’economia rurale e quindi di spingere la popolazione verso le città del nord. Il Sudan – o più precisamente Beled-es-Sudan, il “paese dei neri” – assume le connotazioni di unità politica solamente nel 1820, quando l’egiziano Mohammed Alì Pascià, viceré sotto la sovranità turca, invia le sue truppe nelle regioni situate al di là della frontiera meridionale dell’Egitto e quella vasta area rimane per sessanta anni sotto la dominazione del Cairo – e quindi nominalmente sotto quella turca – e sottoposta ad un’amministrazione corrotta e dispotica. Per le regioni del sud si spalancano le porte della lucrosa tratta degli schiavi e tra i mercanti di esseri umani che percorrono le aree meridionali il più importante di tutti, conosciuto con il nome di Zobeir, viene nominato governatore di Bahr el-Ghaza e nel giro di un anno riesce ad imporre la sua autorità anche nella regione del Darfur. Cinque anni più tardi, sotto il governo di Alì Kurchid, il Sudan esce da un duro regime di amministrazione militare – e da un rigido sistema fiscale – per avviarsi verso la sua prima unificazione. La capitale Khartoum viene fondata intorno ad un accampamento militare egiziano e l'Inghilterra inizia a manifestare il suo interesse sul controllo del Nilo, in chiave di contenimento dell'espansione francese nell'area. Il generale inglese Gordon, governatore della Provincia dell'Equatore (1877-1879) stronca prima una rivolta nel Darfur e poi lotta strenuamente contro il traffico di schiavi, ma l'intrusione europea nella regione provoca un forte risentimento nella popolazione di fede mussulmana, aggravato dalla presenza di numerosi missionari cattolici. Nel 1880, il leader religioso Mohammed Ahmed – conosciuto con il nome di mahdi, colui che libera il mondo dal male – si pone a capo di una insurrezione popolare che dopo quattro anni di aspri combattimenti riesce a sconfiggere le truppe anglo-egiziane inviate a reprimere gli insorti. Ahmed conquista anche la capitale Khartoum e riesce a catturare, e ad uccidere, il governatore Gordon, prima di diventare il padrone del paese e di sfidare gli eserciti anglo-egiziani. Il nuovo stato viene edificato su basi teocratiche e, nonostante la morte di Ahmed, riesce a sopravvivere sino al 1898, ovvero sino a quando non viene abbattuto il regime mahadista per mano di lord Kitchener, con un vero e proprio massacro perpetrato ad Omdurman e con un successivo accordo di amministrazione congiunta anglo-egiziana nel paese. La frontiera settentrionale del Sudan viene fissata al 22° parallelo a nord dello Uadi Halfa e dopo un incidente a Fascioda, sul Nilo Bianco, tra l'Inghilterra e la Francia, si perviene ad un accordo definitivo: Parigi riconosce l'egemonia di Londra sul Nilo e lascia la regione in mano alla Corona. Anche se l'amministrazione inglese sviluppa la rete di irrigazione, quella ferroviaria e crea il nuovo scalo di Port Sudan sul Mar Rosso, nel 1924 nasce un movimento nazionalista – diffuso maggiormente negli ambienti militari – che arriva, al culmine di una serie di sanguinosi attentati, ad assassinare il governatore generale inglese. Dopo la Seconda guerra mondiale i nazionalisti egiziani reclamano l'annessione del Sudan all'Egitto, ma all'interno del paese la popolazione è ancora divisa tra l'unione con il Cairo e la completa indipendenza. Re Faruk d'Egitto forza la mano e dopo aver abrogato unilateralmente la convenzione con l'Inghilterra si proclama re del Sudan. Solo il colpo di stato anti monarchico del 1952 in Egitto apre la strada al diritto di autodeterminazione del Sudan, che diventa repubblica indipendente il 1° gennaio del 1956, con il riconoscimento ufficiale della Gran Bretagna e dell’Egitto. Lo stesso anno, con una parvenza di legalità e di rispetto per i diritti umani, viene accolta dalle Nazioni Unite la domanda di ammissione del nuovo stato ed alla fine del 1956 – accettata all’unanimità dal Consiglio di sicurezza – viene ratificata dall’Assemblea generale. Il Sudan entra a far parte anche della Lega Araba, del Fondo Monetario Internazionale, dell’Unesco e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Ma il paese non sembra ancora pronto per le istituzioni parlamentari ispirate al modello britannico e nel 1958 il comandante supremo delle forze armate, generale Ferik Ibrahim Abboud, con un colpo di stato militare ordina lo scioglimento del parlamento, di tutti i partiti politici e la soppressione della costituzione. L’organo costituzionale principale diventa il Consiglio supremo delle forze armate, composto da un ristretto numero di membri, prima tredici e successivamente solo undici. A questi alti ufficiali vengono affidate le più importanti funzioni del governo, suscitando il malcontento dei generali esclusi dal consiglio e nel 1959 un primo tentativo di colpo di stato viene duramente represso. Ma i problemi del giovane Stato africano non sono ancora finiti. Primo fra tutti, il violento antagonismo tra le regioni nere del sud (cristiane ed animiste) e quelle mussulmane del nord, i due terzi della popolazione, che detengono di fatto tutto il potere del paese, anche se tra i mussulmani vi sono feroci rivalità religiose (in modo particolare tra la setta mahadista e quella khatmia). Con la crisi del Medio Oriente, scatenata nel 1967 dalla guerra dei Sei Giorni, il governo sudanese di Mahgub si schiera tra gli avversari più intransigenti di Israele e si avvicina – sia militarmente che economicamente – ai paesi socialisti. Un colpo di stato di giovani militari, nel 1969, porta al potere il colonnello Jaafar Nimeiri che, nonostante un forte orientamento iniziale a sinistra, entra in conflitto con il partito comunista quando decide di istituire un regime a partito unico sul modello dell'Egitto di Nasser. I comunisti si rifiutano di sciogliere il partito e tentano di conquistare il potere (1971) ma Nimeiri riesce a riprendere il controllo della situazione con l'aiuto egiziano e dopo la condanna a morte dei leader della rivolta diventa capo della repubblica grazie ad un plebiscito. Con l'appoggio delle masse rurali mussulmane porta avanti una politica moderata (prende le distanza dall'Urss) e riesce a mettere fine alla lunga guerra civile tra il nord e il sud, concedendo alle sei province meridionali uno statuto di larga autonomia. Un nuovo tentativo di colpo di stato – nel 1976, durante il quale perdono la vita oltre settecento persone – viene sventato da Nimeiri e il governo rompe i rapporti con la Libia di Gheddafi, accusata di averlo favorito. Anche con l'Urss l'allontanamento si fa più marcato, a favore dell'Egitto e dell'Arabia Saudita. In politica interna viene accentuato uno stretto controllo sulle attività del governo, dell'esercito e del partito unico, l'Unione Socialista Sudanese, suscitando un diffuso malcontento che sfocia in una grave protesta studentesca ed operaia. Nel 1983 il regime diventa ancora più autoritario e per la prima volta si assiste ad una spiccata caratterizzazione islamica, con l'imposizione della sharia in tutto il paese. La forte pressione esercitata dai partiti religiosi non conduce solo all'introduzione della legge islamica, ma favorisce anche l'abolizione del Trattato di Autonomia per le regioni del sud, di religione cristiana ed animista. Il comandante dell'esercito, colonnello John Garang, diserta dalle file regolari e forma il “Movimento per l'Esercito Popolare di Liberazione del Sudan” (Spla) e in poco tempo si assicura il controllo di quasi tutte le regioni meridionali. La crisi economica e la carestia, unite alla dura repressione di ogni dissenso, favoriscono l'ennesimo colpo di stato (1985) ma questa volta il Comitato Militare di Transizione riesce a destituire Nimeiri ed il suo posto viene preso dal generale Abdel Rahman Sewar el Dahab, ex braccio destro del deposto presidente. Le prime elezioni su base pluripartitica, dopo diciotto anni, vengono vinte dal “Partito Umma”, guidato da Sadek el-mahdi, discendente del capo spirituale dell'islam sudanese, diventato primo ministro con una politica estera fortemente orientata verso l'Urss e la Libia. All'interno del paese deve affrontare i guerriglieri dell'Esercito di Liberazione di Garang che effettuano numerosi attentati terroristici contro le postazioni governative. Viene dichiarato lo stato di emergenza, ma le nuove proteste contro l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità favoriscono un altro golpe militare che rovescia il regime del mahdi, mette al bando i partiti e sospende la costituzione. Nel 1986 si svolgono le prime elezioni democratiche ed il governo legittimamente eletto viene deposto nel 1989 da un altro colpo di stato militare guidato da Omar Hassan Ahmad al-Bashir (che diviene contemporaneamente capo di stato, del governo e del Consiglio della Rivoluzione per la Salvezza Nazionale), con i partiti politici messi al bando (lo trasformerà in governo civile solo nel 1993). Amnesty International lancia la sua prima accusa di pulizia etnica contro l’etnia nuba. Nel 1998 entra in vigore la nuova costituzione basata sulla legge islamica (la sharia viene imposta a livello nazionale e quindi anche sulle regioni meridionali popolate da africani di diversa confessione) e l’anno successivo il presidente al-Bashir scioglie di nuovo il parlamento e dichiara lo stato di emergenza. Ma secondo molti osservatori, il vero cervello del nuovo regime è invece Hassan Tourabi, il leader nazionalista del Fronte Nazionale Islamico (Nif), a cui si attribuiscono la forte impronta di fondamentalismo belligerante, i conflitti per motivi di confine con la maggior parte degli Stati vicini, l'introduzione della sharia in tutto il Paese e la presunta complicità nel tentato assassinio del presidente egiziano Hosni Mubarak nel 1995. Il processo di pacificazione è lungo e complesso. Un primo tentativo di unificazione nazionale effettuato dal “Comitato di Mediazione”, composto da Etiopia, Eritrea, Kenya e Uganda (sotto la bandiera dell’Igad, la Inter-Governamental Authority for Development) nel 1994 non raggiunge gli effetti desiderati, così come la firma dell’accordo preliminare di pace nel 2002. A complicare la situazione, l’ingresso delle truppe ugandesi nel Sudan meridionale nel 2003 – con il consenso di Khartoum – per distruggere le basi dei ribelli ugandesi, anche al costo della vita di centinaia di civili sudanesi africani. Ma in Uganda la situazione è altrettanto incandescente. Dal 1988, anno della sconfitta militare della fazione antigovernativa di Alice Lakwena, nel nord del paese i miliziani dell’ “Esercito di Resistenza del Signore”, guidati dal visionario Joseph Kony, reclutano bambini-soldato e riducono le bambine in schiavitù sessuale. L’intento dichiarato dei miliziani è la destituzione del presidente Yoweri Museveni e l’istituzione di una legge che imponga il rispetto dei principi dell’Antico Testamento. Il Sudan allenta i legami storici con l'Egitto, appoggia l'Iraq di Saddam Hussein durante la guerra del Golfo (1990-91) e si avvicina all'integralismo khomeinista dell'Iran teocratico (con il presidente iraniano Rafsanjani viene firmato un accordo di cooperazione militare). Nel 1998 aerei militari americani bombardano una fabbrica di Khartoum accusata di produrre gas chimici e Washington si oppone fortemente all'ingresso del Sudan, in qualità di membro temporaneo, nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In quello stesso anno vengono scoperti nelle regioni del sud giacimenti petroliferi di notevole importanza (duecentomila barili al giorno, ma con una potenzialità pari al doppio in pochi anni) e il controllo su quest'area diventa prioritario per il governo centrale. Inizia una feroce repressione con raid aerei – contro obiettivi civili dichiarati covi terroristici – e con l'evacuazione della popolazione che vive nelle zone date in concessione alle compagnie petrolifere straniere. Inoltre, il 30 giugno del 1998, entra in vigore una nuova costituzione basata interamente sulla legge islamica. Nelle elezioni del 2000, boicottate dai partiti dell'opposizione, il presidente Bashir viene rieletto per altri cinque anni e rinnova lo stato di emergenza proclamato l'anno prima. La forte islamizzazione del paese, esasperata dal conflitto civile che registra la drammatica contabilità di oltre due milioni di morti, pone il Sudan in contrasto sempre più accentuato con gli Stati Uniti, che accusano Khartoum di dare supporto e protezione al terrorismo internazionale. Dal 2001 iniziano i primi tentativi per garantire il cessate il fuoco nelle regioni meridionali e quattro anni più tardi si firma in Kenya il primo accordo, il Comprehensive Peace Agreement, con il quale si propone un referendum per votare l'indipendenza delle regioni del sud. Già dai primi anni Ottanta, le difficili condizioni economiche del paese avevano alimentano la guerra civile tra i ribelli del sud ed il governo centrale guidato dalla popolazione del nord. In realtà, la guerra civile ha origini più antiche. Scoppiata con la proclamazione dell’indipendenza (1956) è stata guidata dal movimento Anya Nya sino al 1972 e dal 1983 dall’Esercito Popolare di Liberazione del Sudan (Spla, Sudan People’s Libaration Army) agli ordini del colonnello John Garang de Mabior. A firmare l'intesa tra il governo islamico e il “Movimento Popolare di Liberazione” sono il vice presidente sudanese Alo Osman Mohamed Taha e il capo dei ribelli del sud, John Garang. I punti principali dell'accordo sono: la fine del conflitto, la formazione di un governo di coalizione, la decentralizzazione del potere con la concessione dell'autonomia delle regioni del sud, l'unificazione dell'esercito e la suddivisione al 50% delle entrate del petrolio tra governo centrale e Sudan meridionale, oltre alla possibilità di votare l'eventuale secessione. Ma per Khartoum la partita in gioco ha una posta alta: il governo vede i gruppi africani come una seria minaccia alla sua leadership araba e gli africani rivendicano i mancati proventi che derivano dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e minerarie presenti nella loro regione. Nel Sudan occidentale sono stati scoperti estesi giacimenti di petrolio molto pregiato (leggero ed a bassissimo tasso di zolfo) e dal 1999 il paese è diventato il secondo esportatore dell’intera area subsahariana dopo la Nigeria, ed il settimo produttore del continente africano. La prima fase dei nuovi colloqui di pace si conclude nel gennaio del 2004 a Naivasha (Kenya) con la firma di un accordo tra il governo di Khartoum ed i ribelli dello Spla, lì dove è risultato determinante il contributo offerto dagli Stati Uniti e dai paesi occidentali che hanno sempre sostenuto la composizione pacifica della controversia. Le basi dell’accordo sembrano soddisfare le parti: i trecentomila barili di greggio estratti giornalmente, con un utile stimato in oltre due miliardi di dollari annui, possono diventare ottocentomila entro il 2010 se si creano le condizioni necessarie per la stabilità politica connessa con le attività industriali. Gli introiti vengono ripartiti nella misura del 50% tra le parti, per un periodo di sei anni, a decorrere dalla definitiva cessazione delle ostilità. Trascorso tale termine, un referendum popolare potrà scegliere il futuro della regione meridionale, tra la permanenza nella repubblica sudanese e la autodeterminazione amministrativa. Il 9 gennaio 2005 a Nairobi (in Kenya, proprio perché il ruolo del presidente Mwai Kibaki è stato particolarmente incisivo) viene firmato l’accordo di pace tra il governo sudanese (vice presidente Alì Osman Taha) e l’Esercito Popolare per la Liberazione del Sudan (John Garang) alla presenza del Segretario di stato americano, Colin Powell, e di numerosi rappresentanti dei governi occidentali. E dopo quasi cinquanta anni di guerra civile tra il nord arabo e mussulmano ed il sud africano e cristiano-animista (due milioni di morti ed oltre quattro milioni di rifugiati), nel mese di settembre del 2005, Nafie Alì Nafie, vice presidente del National Congress, annuncia al mondo intero la formazione del primo governo di unità nazionale tra il nord ed il sud del paese. L’esercito viene unificato – o meglio viene definito l’impiego delle rispettive forze armate in modo congiunto o separato – e John Garang rientra a Khartoum, dopo ventidue anni di guerriglia, portato in trionfo da oltre un milione di manifestanti, per assumere la carica di primo vice presidente del Sudan. La grande manifestazione di piazza spaventa la dirigenza militare-islamica del paese ed il National Congress ordina alla televisione di stato di non riprendere in diretta l’arrivo di Garang in aeroporto ed organizza il pranzo di benvenuto non al palazzo presidenziale, e neanche in parlamento, bensì nella sede del partito. Il messaggio è chiaro: il National Congress e lo stato sono la stessa cosa. Il partito al potere dal 1989 (grazie al colpo di stato di al-Bashir) è il National Islamic Front (Nif) con la presenza di una forte componente araba e mussulmana di estrazione moderata, che mal sopporta il pugno di ferro islamico voluto dalla sua fazione più oltranzista, appunto il National Congress. Con l’arrivo di Garang nelle più alte istituzioni dello stato, le differenze tra le due fazioni sembrano accentuarsi. In ogni caso, Garang rimarrà alla vice presidenza solo per tre settimane, per morire precocemente in un incidente aereo il 1° agosto del 2005. Quindi la situazione non è certo pacificata. Inoltre, già dal 1995 una coalizione di fazioni, fuoriuscite dallo Spla, e raggruppate nella National Democratic Alliance, ha aperto un nuovo fronte nel nord-est del Sudan, utilizzando basi logistiche in Eritrea. Ed a complicare la situazione interna, anche l’enorme campo profughi di Mayo, alle porte di Khartoum, che ospita dal 1981 quasi mezzo milione di persone fuggite dal sud: un miserabile villaggio di fango e paglia privo di acqua, luce e fognature. Dal 2002 non arrivano più i fondi delle organizzazioni internazionali (tre dollari al giorno per persona) ed il governo sudanese, avido di terreni sui quali allargare la capitale, con sistematica cadenza invia le sue ruspe per abbattere ogni volta almeno una decine di capanne. Mentre il Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, rincorre con ottimismo la rapida conclusione della tormentata vicenda dell’unità nazionale, il Sudan Liberation Army Movement (Slam) – un gruppo armato costituitosi nel 2003 – lancia feroci accuse contro il governo di Khartoum: la provincia occidentale del Darfur è volontariamente trascurata dalle autorità centrali, sia sotto il profilo economico che sotto quello assistenziale. Gli scontri armati tra i ribelli del Darfur e le forze governative hanno già provocato tremila vittime (per la maggior parte civili) e circa centomila profughi sconfinati nel vicino Ciad. Il risanamento economico e politico del paese – dopo essere passato attraverso la difficile ed incompleta pacificazione del sud – deve adesso fare i conti con il nuovo problema emerso con prepotenza, la ribellione del Darfur. Già dall’inizio del 2003, il “Fronte di Liberazione del Darfur” (Fld) – guidato dall’avvocato Abdel Wahid Mohamed Nur e formato dai Comitati di Autodifesa dei villaggi di etnia fur nel Jebel Marra – è insorto contro il governo centrale con l’appoggio di altri gruppi etnici della regione. Con l’allargamento del consenso tribale del territorio, il Fronte prende il nome di “Esercito di Liberazione del Sudan” (Sla, Sudanese Liberation Army) e si allea con il “Movimento per la Giustizia e l’Uguaglianza” (Jem, Justice and Equality Movement), impegnato nel nord della regione. La reazione del presidente al-Bashir è spietata: le milizie arabe filo-governative janjaweed conducono la distruzione sistematica dei villaggi, delle riserve di acqua e dei generi alimentari, insieme a saccheggi, violenze carnali ed uccisioni indiscriminate. Solo nei primi sei mesi del 2004 le vittime superano le decine di migliaia e le migrazioni forzate registrano oltre un milione di profughi in campi improvvisati sul confine con il Ciad, dove i sopravvissuti muoiono per fame e malattie. Ma gli janjaweed e le truppe regolari sudanesi arrivano anche ad attraversare le frontiere per attaccare i campi dei rifugiati, nonostante le dure proteste del generale Idriss Déby, il presidente della repubblica del Ciad. In assenza di un vero accordo politico tra governo e ribelli, il presidente al-Bashir sottoscrive un nuovo cessate il fuoco della durata di quarantacinque giorni (N’djamena, 8 aprile 2004), in realtà la terza tregua in sei mesi, dove la richiesta più urgente degli insorti e delle organizzazioni internazionali – il disarmo degli janjaweed – viene puntualmente disattesa. Per Khartoum si tratta pur sempre di un “affare interno, tutt’al più regionale” e sulla scia di questa politica si pongono i paesi dell’Africa del nord. Per il libico Gheddafi è un “conflitto tribale” e quindi non è ipotizzabile alcuna interferenza non africana, e la Lega Araba e l’Organizzazione della Conferenza Islamica non rilasciano alcuna dichiarazione al riguardo. Ma l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, al termine di una missione di inchiesta nel Darfur, conferma la gravità dello scenario, “crimini di guerra e crimini contro l’umanità”, e l’Unione Europea decide di supportare l’Unione Africana (con uno stanziamento di 12 milioni di euro) per la costituzione di una missione di monitoraggio nella regione. E’ prevista una missione di dodici mesi con l’impiego di centoventi osservatori ed una forza di protezione composta da duecentosettanta militari, con il solo compito di difendere la sicurezza del contingente. Il Commissario europeo allo sviluppo ed agli aiuti umanitari, Poul Nielson, convince il G8 (Londra, 11 giugno 2005, riunione nella quale viene firmato l’accordo per la cancellazione del debito pubblico nei paesi più poveri) ad approvare uno stanziamento di altri 6 milioni di euro – oltre ai 20 milioni già previsti per gli aiuti al Sudan – ed includere un piano di addestramento di una forza di cinquantamila militari destinati alle missioni di pace in Africa, per lo sviluppo previsto nell’arco di cinque anni. Nel luglio del 2004 un primo gruppo di osservatori internazionali dell’Unione Africana si stabilisce in un’enorme villa nel quartiere residenziale di Khartoum per monitorare il rispetto del cessate il fuoco faticosamente raggiunto, e trecento soldati del Rwanda e della Nigeria arrivano nel Darfur il mese successivo. Nonostante l’Unione Africana sia sempre stata considerata una organizzazione estremamente prudente – secondo molti analisti sempre timorosa di assumere posizioni sgradite ai governi africani – un rapporto stilato dai suoi funzionari contiene durissime accuse contro gli janjaweed, anche se “non è stato provato che l’esercito regolare sudanese combatta al fianco dei miliziani arabi”. La denuncia – diffusa da un dispaccio «Reuters» e trasmessa dalla «Bbc» – riguarda le atrocità commesse dalle milizie arabe contro le popolazioni nere africane, che non si limitano a saccheggiare le capanne e ad incendiarle, a violentare le donne e ad ammazzarle insieme ai loro uomini dopo aver rapito i bambini, ma nello stesso mese di luglio, avrebbero prima incatenato e poi bruciato vivi gli abitanti dello sperduto villaggio di Ehda. Nel rapporto viene anche sottolineato che “l’attacco al villaggio è giunto inaspettato e non è stato provocato”. Un’altra denuncia che si aggiunge alla lunga lista di rapporti analoghi stilati dalla Ocha (l’agenzia che si occupa della tutela dei diritti dell’uomo), dal World Food Programme (“cominceremo a lanciare il cibo dagli aerei in quelle zone dove non si riesce proprio ad arrivare”), da “Medici Senza Frontiere” (“i soldati governativi respingono chiunque si avvicini ai campi profughi”) e da Terre des Hommes (“gli aiuti umanitari sono stati bloccati per settimane e sbloccati solo grazie alle pressioni internazionali”). Ed è grazie proprio alle pressioni internazionali che al piccolo contingente di osservatori dell’Unione Africana si aggiunge un gruppo di osservatori militari, composto per la maggior parte da americani. E’ il congresso degli Stati Uniti, in un documento approvato il 23 luglio 2004, a definire per la prima volta la tragedia del Darfur con il nome di “genocidio”. George W. Bush e Colin Powell decidono di abbandonare la dizione di “catastrofe umanitaria” poiché la definizione stessa di genocidio permetterebbe in sede Nazioni Unite l’intervento multinazionale in via automatica. Delusa dall’atteggiamento intransigente del governo del Sudan – alla proposta di Londra di inviare un contingente militare per creare corridoi umanitari, Khartoum ha risposto che “non tollereremo ingerenze nella nostra politica interna” – la Casa Bianca concorda con Kofi Annan l’intimidazione di disarmare le milizie arabe e prepara una bozza di risoluzione che prevede la condanna del comportamento del governo, il divieto di viaggiare per i suoi funzionari e l’embargo alla vendita di armi. Già dal 2003 il Sudan ha iniziato una massiccia politica di armamenti (dagli arsenali dell’ex Unione Sovietica, grazie alla mediazione del trafficante Victor Bout) con l’acquisto di aerei, elicotteri, cannoni, fucili automatici e mine anti-uomo. Anche se Khartoum ha ripetutamente negato di appoggiare i miliziani arabi, sono altrettanto numerosi i documenti raccolti da Human Rights Watch dove “i funzionari governativi ad alto livello sono implicati nel reclutamento e nell’addestramento delle milizie filo-governative”, così come quelli presentati da Polyanna Truscott, coordinatrice di Amnesty International per il Darfur, dove le accuse al governo sudanese riguardano gli stupri condotti dagli janjaweed come parte di una deliberata politica di pulizia etnica: “quando sono sistematici non possono essere addebitati a singoli miliziani indisciplinati”. Le organizzazioni internazionali sono quindi compatte nel riconoscere le atrocità organizzate dal governo centrale e sono anche loro in attesa che le Nazioni Unite parlino apertamente di genocidio, l’unico termine che secondo lo statuto dell’organizzazione permetterebbe l’invio automatico delle truppe per bloccarlo con la forza. Al governo di Khartoum non è probabilmente riuscito il tentativo di porre fine al conflitto con la forza in tempi brevi (per poi presentare il fatto compiuto alla comunità internazionale) ed il suo progetto di islamizzare il paese non trova più un fronte compatto a sostenerlo. Oltre al fatto che nella regione sono presenti tribù di confessione mussulmana – e quindi non si tratta più di eliminare esclusivamente i nemici della vera fede – all’interno delle autorità centrali ci sono correnti che fomentano i disordini del Darfur per favorire il collasso dell’intero processo di pace raggiunto recentemente nel sud. Inoltre, gli ufficiali dell’esercito regolare originari del Darfur si sono rifiutati di bombardare i villaggi della regione ed il rischio di ammutinamento di larghi settori delle forze armate è drammaticamente concreto. Il 30 luglio del 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite approva con tredici voti favorevoli e due astensioni – il Pakistan e la Cina – la risoluzione sul disarmo delle milizie del Darfur entro trenta giorni, e minaccia sanzioni nel caso di inadempienza. Anche questa volta l’atteggiamento di Khartoum è intransigente: respinge immediatamente la richiesta e proclama la mobilitazione “politica e strategica”, facendo palesare ufficialmente dure reazioni ad ogni interferenza straniera. Da Parigi, il presidente Chirac ordina al contingente francese in Ciad (duecento soldati) di portarsi ai confini del Sudan e di organizzare trasporti aerei per un intervento umanitario. La risoluzione – promossa da Francia, Germania, Spagna, Romania e Cile – è passata solo dopo che gli Stati Uniti hanno eliminato dal testo la parola “sanzioni”, sostituendola con “minaccia della interruzione di tutte le attività economiche e diplomatiche nei confronti di Khartoum”, così come previsto dall’articolo 41 della carta delle Nazioni Unite, anche se la mancata adempienza all’ultimatum prevede “gravi conseguenze”. Anche un'ulteriore concessione è stata concordata per agevolare il governo sudanese. Le milizie devono essere sì disarmate e rispondere alla giustizia, ma le forze armate del Sudan – benché accusate di plateale protezione – vengono esentate da qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Ancora una volta la reazione di Khartoum è provocatoria. Non solo rifiuta integralmente la risoluzione, ma annuncia che “tratterà in maniera appropriata tutti i soldati stranieri che metteranno piede nel Sudan”. E come chiaro segno di sfida, vengono liberati immediatamente quarantanove leader dell’opposizione islamica – precedentemente imprigionati – per “unificare il fronte interno”. Anche davanti alla tragedia umanitaria, che il palazzo di vetro ha definito la più grave al mondo, Khartoum alza la posta e lancia messaggi inquietanti. Le reazioni all’interno del paese sono abbastanza omogenee. Daffi Khateeb, Segretario generale del ministero dell’Informazione, assicura che “abbiamo fatto e stiamo facendo tutto quanto è possibile per disarmare gli janjaweed”, e dichiara che sono stati inviati in Darfur tremilacinquecento poliziotti ed infine aggiunge che la colpa della crisi umanitaria è dei ribelli che non vogliono partecipare ai colloqui di pace. Anche se il governo sudanese “si sente offeso”, l’opinione comune è che le risoluzioni non aiutino a risolvere la catastrofe. L’avvocato Ghazi Suleiman, presidente del Gruppo sudanese per la difesa dei diritti umani, ritiene che la radice del problema vada ricercata nel fatto che il Darfur è stato scelto come campo di battaglia dagli integralisti islamici. Da una parte i governativi guidati dal presidente al-Bashir e dall’altra parte i ribelli, vicini ad Hassan al-Turabi, leader del fondamentalismo sudanese. Secondo Suleiman, la popolazione del Darfur è stata il nucleo del National Islamic Front (Nif), il partito religioso mussulmano che con il colpo di stato del 1989 “ha cancellato la democrazia in Sudan”. Quando il Nif ha subito la divisione politica al suo interno in due fazioni (l’ala moderata ed il National Congress), le tribù del Darfur si sono schierate e divise, ed oggi le milizie janjaweed “sono da una parte e dall’altra”. Alfred Taban, il direttore del quotidiano «Khartoum Monitor» – finito in carcere una decina di volte per atteggiamenti antigovernativi – ritiene che la responsabilità delle stragi sia imputabile ad entrambe le parti: “Non è questione di buoni e cattivi. Se si inaspriscono gli animi con azioni sbagliate, si rischia di peggiorare la situazione. Occorre obbligare le due parti a sedersi al tavolo dei negoziati”. In realtà, il problema non consiste nelle possibili sanzioni, bensì nella richiesta delle Nazioni Unite di disarmare le milizie arabe filo-governative per porre fine ad una strage effettivamente riconosciuta. L’oggettiva difficoltà del governo risiede nel fatto che oltre il 40% dell’esercito regolare ha le sue origini nel Darfur e di conseguenza le simpatie sono rivolte ai guerriglieri. Secondo gli analisti, se i miliziani a cavallo fossero smobilitati, tutta la regione cadrebbe immediatamente nelle mani dei ribelli ed il regime di Khartoum ne sarebbe tragicamente travolto. Di diverso orientamento è la posizione dell’Unione Europea . Subito dopo la risoluzione delle Nazioni Unite, Pietre Feith – inviato speciale dell’Alto rappresentante per la politica estera di Bruxelles, Javier Solana – guida in Darfur un team di esperti con l’incarico di stilare un rapporto sulla situazione. Anche se la missione concorda nel ritenere che i massacri sono stati commessi in modo graduale e che i villaggi sono stati bruciati su larga scala, la situazione generale “non può essere rappresentata come un genocidio”. Inoltre “esistono dubbi concreti sulla volontà del governo di proteggere la popolazione civile […] e gli janjaweed a volte sembrano agire in modo indipendente, altre volte come forze di sicurezza del governo” (conferenza stampa del 7 agosto 2004). Tra le misure prese in considerazione dall’Unione Europea, Feith sottolinea soprattutto l’invio di agenti da affiancare alle forze dell’ordine sudanesi: “abbiamo proposto che corpi di polizia dell’Ue siano dispiegati nella catena di comando delle forze sudanesi” (ma per entrare in vigore, tale misura deve essere approvata all’unanimità dal Consiglio Affari Generali dell’Unione Europea) per concludere che la crisi in Darfur è “tanto politica quanto umanitaria”. Dura la replica di Bill Frist, leader della maggioranza repubblicana al senato degli Stati Uniti, nella sua conferenza stampa tenuta a Nairobi dopo una visita ufficiale in Sudan: “quello che sta accadendo in Darfur è genocidio. Non concordo con le valutazioni fatte dall’Unione Europea”. Secondo Frist, il governo centrale ha il potere di mettere fine alle stragi contro i civili e le milizie janjaweed “non solo sono sostenute dal governo, ma sembrano esserne il braccio armato”. Parallelamente, Washington (Adam Ereli, portavoce del Dipartimento di stato) manifesta apprezzamento per le recenti dichiarazioni di Khartoum, ovvero per l’impegno preso per creare “zone cuscinetto” nel Darfur per favorire le forniture di cibo ed acqua ai civili. Ma secondo il nostro sottosegretario agli Esteri, Margherita Boniver, sicuramente no; al ritorno da una missione in Sudan – dove ha incontrato il ministro degli Affari umanitari sudanese ed ha effettuato una visita nella cittadina di Nyala in Darfur – ha dichiarato che “la situazione, invece di migliorare, peggiora sotto tutti i profili, da quelli che riguardano i negoziati a quello umanitario a quello politico” (22 dicembre 2004). Lo stesso giorno, gli elicotteri delle forze sudanesi radono al suolo una serie di villaggi intorno alla città di Nyala, per riprendersi le basi dalle quali i guerriglieri del Sudan Liberation Army li avevano sfrattati poche settimane prima. La situazione per le organizzazioni internazionali diventa insostenibile. Dopo i continui e ripetuti attacchi ai convogli umanitari e le incursioni ed i saccheggi nei villaggi, Save the Children decide di ritirare dal Darfur tutti i suoi trecentocinquanta uomini (quattro operatori sono appena stati uccisi) e Médecines sans Frontières denuncia l’assassinio di un suo collaboratore e la sparizione di altri ventinove operatori. Il coordinatore umanitario dell’Onu – Manuel Aranda da Silva, del Mozambico – definisce il Darfur “una bomba ad orologeria”. Una notizia apparsa su un giornale italiano («Il Foglio», 28 settembre 2004) accresce le preoccupazioni degli osservatori: secondo diverse agenzie americane di intelligence, viene segnalata la presenza in Sudan di unità militari siriane di esercito ed aeronautica dotate di bombe ed artiglieria armate con aggressivi chimici. Queste armi, messe a disposizione delle forze sudanesi, avrebbero già ucciso centinaia di civili nei villaggi del Darfur abitati da africani. L’impiego di aggressivi chimici permette a Khartoum di seminare il panico tra la popolazione della regione, favorendo l’esodo verso il Ciad, mentre Damasco ha l’opportunità di testare le proprie armi di distruzione di massa e di far fare esperienza ai suoi reparti specializzati. All'inizio del 2005 sono soltanto due le istituzioni internazionali presenti in Sudan con missioni militari: le Nazioni Unite (Unamis, United Nations Advance Mission in Sudan) e l'Unione Africana (Amis, African Mission in Sudan). Con la nuova risoluzione 1590 del 24 marzo 2005, il Consiglio di sicurezza stabilisce che la missione in Sudan, diventata Unmis, sia composta da diecimila militari, da un'adeguata componente civile e da settecentoquindici unità di polizia. Poiché l'Unione Africana deve incrementare la sua presenza da duemiladuecento uomini ad oltre settemilasettecento, la Nato decide di definire con l’Unione Africana il supporto logistico necessario per l'incremento del contingente: trasporto aereo di migliaia di peacekeeper africani, addestramento di centinaia di ufficiali dell'Unione e sistema di comunicazioni a disposizione delle varie unità. Un abile compromesso che vede gli Stati Uniti supportare lo sforzo della Ua sotto la discreta vigilanza della Nato ed al tempo stesso un indiretto riconoscimento delle esigenze di un importante soggetto politico africano. Ma la Nato deve pur conservare un basso profilo. In definitiva, si tratta di una sua espansione strategica e di una indiretta minaccia al prestigio delle Nazioni Unite, e l'alto ufficiale dei marines a capo dell'organizzazione militare dell'Alleanza – generale James Jones – si affretta a dichiarare che un intervento della Nato in Darfur, anche se alcuni leader internazionali hanno fatto pressione in tal senso, rimane da escludere. La situazione nel Darfur continua a peggiorare. Nell'area nord-occidentale un feroce attacco senza precedenti degli janjaweed (letteralmente i “diavoli a cavallo”) contro i campi profughi di Aro Sharow e di Gosmeina registra l'ennesima strage contro civili indifesi già costretti a vivere in situazioni drammatiche e decimati da fame e malattie (da fonti ufficiali Nazioni Unite, Ginevra 29 settembre 2005). E sempre le milizie di etnia araba e di confessione mussulmana si macchiano ancora le mani con il sangue dei civili neri e cristiano-animisti del villaggio di Madayum, sconfinando oltre il confine del Ciad per un'operazione di pulizia etnica e di razzia del bestiame (da fonti militari del Ciad, N'djamena, 29 settembre 2005). Anche il confine orientale del Sudan con l'Eritrea si sta infiammando. Dopo oltre dieci anni di scontri di basso livello, i ribelli dell'Estern Front (dove sono confluiti il Beja Congress ed il Rashaida Free Lions) lanciano una violenta ed organizzata offensiva contro le truppe governative di Khartoum con l'appoggio di Asmara e dello Jem, il Justice and Equity Movement che si batte anche per il Darfur. Teatro degli scontri è la città di Tokar, a soli 120 chilometri a sud di Port Sudan sul Mar Rosso, e la popolazione beja – circa quattro milioni – rivendica l'iniqua divisione delle risorse e la marginalizzazione politica e sociale dell'intera regione. Ma è pur sempre il Darfur a destare le maggiori preoccupazioni della comunità internazionale e dopo una violenta ripresa degli scontri nell'estate del 2005 (stato di emergenza in Sudan e coprifuoco a Khartoum dopo la morte in un incidente di elicottero di John Garang, il leader degli ex ribelli del Sudan People's Liberation Movement, vicepresidente del Sudan da sole tre settimane. Al suo posto arriva il successore Salva Kiir, il nuovo vice presidente del Sudan) le Nazioni Unite decidono di evacuare a scopo precauzionale una buona parte del personale che opera nell'area occidentale della regione. L'accordo di pace siglato in Nigeria (Abuja, 5 maggio 2006) non viene sottoscritto da tutte le parti in causa. Secondo lo Jem ed una fazione minoritaria dello Slm, le proposte di Khartoum non sono ancora soddisfacenti. Sulle stesse posizioni si attestano anche altri gruppi minori che sono riusciti a reclutare uomini tra i rifugiati esasperati dai continui attacchi dell'esercito regolare e delle milizie filo-governative (nell'area meridionale del Darfur in alcuni campi profughi sono stati sequestrati – in diverse occasioni – numerosi soldati della forza di pace dell'Unione Africana per protestare contro la mancata protezione delle donne e dei bambini). Tra questi gruppi, la coalizione più organizzata è quella del Nrf, il National Redemption Front che – con il probabile aiuto di Tripoli – riesce a dimostrare una buona capacità di combattimento infliggendo pesanti sconfitte ai regolari sudanesi. Per ora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è riuscito solo ad imporre le restrizione dei traffici e della libertà di circolazione per quattro persone ritenute responsabili di ostacolare i tentativi di dialogo tra le parti in Sudan (generale Mohamed Alhassan, comandante dell'aviazione; Adam Yacub Shant, comandante dell'Esercito di Liberazione; Gabril Abdul Kereem Badri, comandante del Movimento Nazionale per la Riforma e Shaikh Husa Hilal, capo della tribù julul nel Darfur settentrionale). Kofi Annan rilancia la sua proposta di un contingente di peacekeeping – migliore equipaggiamento e mandato più incisivo – sotto la bandiera delle Nazioni Unite: ventimila militari e funzionari di polizia internazionale per avvicendare i settemila uomini dell'Unione Africana che vedono scadere il loro mandato alla data del 30 settembre 2006. Per la sua risposta, il presidente sudanese Omar Hassan al-Bashir sceglie la platea più significativa. Durante il vertice dei paesi non allineati (Cuba, 16 settembre 2006) dichiara con ostentato orgoglio che “non vogliamo che l'Onu torni in Sudan ad alcuna condizione [...] respingiamo la decisione del Consiglio di Sicurezza” senza dimenticare di sottolineare che gli accordi economici stretti con la Cina, il Pakistan, l'India e la Malaysia potrebbero permettere al suo paese di sopravvivere a qualsiasi sanzione, esattamente così come Cuba ha resistito ad oltre quaranta anni di sanzioni americane. In realtà, il presidente teme che i contingenti delle Nazioni Unite possano svolgere indagini – ed arresti – contro le autorità locali coinvolte nelle operazioni di pulizia etnica, così come auspicato dalla Corte penale internazionale per i reati di genocidio e crimini contro l'umanità. Il Darfur sta infiammando tutta la regione. Una guerra senza confini che dilaga nel Ciad e nella Repubblica Centrafricana, contagiata dall'immunità che viene di fatto accordata agli janjaweed, e quindi a tutte quelle bande irregolari arabe che, per diversi motivi, si sentono liberi di riaffermare la loro superiorità sulle minoranze etniche e religiose. Secondo Esam Elhag, portavoce del gruppo Sla, il governo di Khartoum ha anche reclutato fondamentalisti giunti in Sudan da tutto il mondo islamico (anche da Afghanistan ed Iran) organizzando il loro campo base a Saraf Omra, vicino a Kabkabia nel Darfur settentrionale. In effetti, Osama bin Laden – che fu ospite del governo di Khartoum sino alla fine degli anni Novanta – ha già chiamato a raccolta i suoi estremisti per combattere gli interessi occidentali in Sudan, ed anche se risulta improbabile la formazione di una vera e propria forza di miliziani in grado di contrastare la presenza delle Nazioni Unite (l'appello è stato lanciato con questo obiettivo) non è da escludere l'infiltrazione di numerosi integralisti stranieri all'interno del paese. Ai primi di ottobre del 2006 viene ritrovato nella periferia di Khartoum il corpo, decapitato, di Mohamed Taha, il direttore del giornale filo-governativo «al-Wifaq». Pur essendo membro della setta islamica dei Fratelli Mussulmani, Taha aveva subito la grave accusa di blasfemia a causa della sua inchiesta sulla genealogia del Profeta, avendo sostenuto la tesi che il padre di Maometto avrebbe portato un nome legato agli idoli pre-islamici. La sua decapitazione sembra essere una firma inequivocabile. In Etiopia, nel suo discorso di apertura al summit dell'Unione Africana, il nuovo Segretario generale delle Nazioni Unite – Ban Ki-Moon – chiede con forza che venga approvata la decisione di inviare immediatamente nel Darfur un contingente misto di caschi verdi (la nuova denominazione dei peacekeeper africani) e di caschi blu. Questa volta Khartoum – insieme alla Lega Araba – lascia intendere che potrebbe esserci un consenso di massima, anche se le condizioni poste circa la operabilità sul territorio sono molto limitate: solo logistica e comunicazioni, ma un piccolo passo in avanti sembra essere stato compiuto (Addis Abeba, 29 gennaio 2007). La situazione in Darfur continua però ad essere drammatica. Secondo un rapporto di Amnesty International le autorità governative continuano a sferrare attacchi aerei contro obiettivi civili e Russia e Cina forniscono armi a Khartoum violando l'embargo imposto dalle Nazioni Unite. Mosca e Pechino si affrettano a smentire, ma un altro rapporto delle Nazioni Unite riferisce che il governo sudanese è addirittura arrivato a dipingere i suoi aerei militari con i colori delle Nazioni Unite per nascondere il trasporto di armi. Per il presidente George W. Bush la situazione non è più sostenibile. Dopo aver imposto sanzioni unilaterali contro il Sudan (dopo quelle del 1997 per l'assistenza concessa a bin Laden) un duro monito viene pubblicamente lanciato ad Omar Hassan al-Bashir: è ora di abbandonare l'ostruzionismo e di accogliere i caschi blu dell'Onu in aiuto alle truppe dell'Unione Africana [...] il popolo del Darfur ha sofferto troppo a lungo per mano di un governo complice di attacchi, assassinii e stupri contro civili innocenti. A favore di nuove sanzioni si esprimono anche Regno Unito e Francia, e mentre Ban Ki-Moon è alle prese con la spinosa questione sul comando della forza congiunta, Liu Guijn – l'inviato cinese in Africa – ribatte che Pechino è contraria ad una nuova risoluzione: “solo lo sviluppo economico del Sudan potrà portare alla pace”. Ma il fronte compatto delle autorità sudanesi sembra essersi incrinato. Il 12 giugno 2007 l'agenzia «Reuters» diffonde la notizia che il Sudan è pronto ad accettare una forza di pace ibrida composta da militari dell'Unione Africana e dell'Onu. Unica condizione è che il contingente previsto (ventitremila uomini) sia composto esclusivamente da militari africani. Ma forse c’è un regista dietro le quinte. Anche se da tempo gli analisti occidentali avevano puntato il dito contro Pechino, il cambiato atteggiamento della Cina durante la conferenza di Parigi (25 giugno 2007) ha confermato la diretta dipendenza dello stato africano al colosso orientale. La Cina, sino ad oggi uno dei principali ostacoli alla cooperazione internazionale per il Darfur, acquista il 60% del petrolio prodotto dal Sudan ed ha sempre impedito che si raggiungesse un accordo sulle sanzioni contro Khartoum (gli analisti concordano che il cambiamento di rotta potrebbe essere interpretato nella necessità di una nuova immagine internazionale in previsione delle Olimpiadi del 2008). Già sotto accusa per la ferrovia che collega la Cina con il Tibet, per i danni provocati al sistema idrico del fiume Mekong e per continue forniture di armi al governo del Sudan, Pechino non può permettersi il lusso di prestare il fianco ad ulteriori critiche delle cancellerie occidentali e della stampa internazionale. E subito dopo la promessa di non esercitare il diritto di veto, il generale Martin Luther Agwai (ex capo di stato maggiore delle forze armate nigeriane) prende il comando dell'Amis ed inizia a lavorare con Rodolphe Adada (ministro degli Esteri della repubblica del Congo) il rappresentate politico della missione Onu-Ua in attesa che decolli il nuovo importante progetto. E alla fine, dopo oltre duecentomila morti e due milioni di sfollati, viene approvata all'unanimità la risoluzione 1769 che istituisce la missione Unamid (United Nations African Union Mission in Darfur), la più ampia e più costosa (2,6 miliardi di dollari nel primo anno e 1,4 nei successivi) operazione di peacekeeping sotto le bandiere multicolore delle Nazioni Unite: è il 31 luglio del 2007. L'ultima e complessa stesura – presentata inizialmente da Gran Bretagna (Gordon Brown) e Francia (Nicolas Sarkozy) è stata esposta ai rappresentanti dei quindici paesi del Consiglio di sicurezza. (l'Italia – attuale membro non permanente del Consiglio per il biennio 2007-2008 – si è associata successivamente alla proposta). Dopo una laboriosa trattativa (sono stati corretti sostantivi, aggettivi, dettagli e virgole) anche la Cina, la controparte più tenacemente critica, accorda il suo consenso. Il documento autorizza l'invio di ventiseimila uomini tra militari ed agenti di polizia ai sensi del capitolo VII della carta delle Nazioni Unite, ovvero quello che definisce i casi di “azione necessaria” (l'autorizzazione all'uso della forza) per l'autodifesa del personale delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana. L'obiettivo è quello di assicurare la libertà di movimento per gli aiuti umanitari, ma la parte più significativa è costituita dall'intento di “proteggere i civili minacciati dalla violenza”. La pressione esercitata dalla Cina ha purtroppo ottenuto la cancellazione dal testo originale del diritto delle forze delle Nazioni Unite di sequestrare le armi illegali, sostituito dall'autorizzazione a “tenerle sotto controllo”, così come è stato eliminato qualunque riferimento alle milizie degli janjaweed e qualsivoglia accenno alla minaccia di sanzioni. La composizione della missione ibrida, sotto il controllo congiunto Onu-Ua, è stata definita in maniera piuttosto burocratica: 19.555 soldati, trecentosessanta osservatori militari, diciannove unità composte da centoquaranta agenti di polizia ed una componente di 3.772 civili. La parte preponderante della missione deve essere fornita dai paesi africani, ma viene previsto un contributo extracontinentale nell'ipotesi che la prima opzione non venga raggiunta. Gli Stati Uniti non inviano truppe ma si limitano ad un consistente aiuto finanziario ed alla collaborazione del trasporto del personale (le motivazioni umanitarie hanno avuto il sopravvento sulle pressioni esercitate dalle grandi corporation petrolifere, escluse dallo sfruttamento petrolifero). La Cina ed il Pakistan si impegnano ad inviare medici ed ingegneri mentre il Ghana, il Senegal, il Kenya ed il Benin raddoppiano i loro contingenti già presenti nella regione del Darfur. L'Egitto e la Nigeria concordano l'invio di seimila soldati. Le prime parole pronunciate dopo il voto dal Segretario generale Ban Ki-Moon sono improntate alla massima soddisfazione: “è un'operazione storica senza precedenti”. Ma non trascorrono ancora tre mesi e la violenza torna ad esplodere. Una base delle forze dell'Unione Africana (Haskanita, nella zona orientale del Darfur) viene attaccata da un gruppo di miliziani con trenta veicoli armati. L'identità degli aggressori non viene stabilita con certezza (tra ribelli o milizie governative) ma il bilancio è drammatico: vengono uccisi dieci caschi verdi e trenta di loro feriti, sette in modo grave. Il campo viene saccheggiato e completamente distrutto e alla fine dell'incursione altri cinquanta militari non rispondono all'appello. Terminata la stagione delle piogge, la fame e le malattie continuano a mietere le loro vittime. La regione è un gigantesco lager dove i civili vengono usati come ostaggi sia dai ribelli africani che dalle milizie arabe. Gruppi di banditi e di sciacalli, senza controllo, si lanciano in razzie e stupri. I bambini rapiti vengono venduti come schiavi nella capitale. Continua lo stato di emergenza e ad aggravare la situazione l'ingresso di truppe regolari ugandesi – con il consenso del governo di Khartoum – nel Sudan meridionale per distruggere le basi dei ribelli ugandesi rifugiatisi in quella regione di confine. La sanguinosa operazione militare costa la vita a centinaia di persone, compresi civili sudanesi. Nel frattempo si aggrava la situazione anche nel Darfur. I contingenti inviati dall'Unione Africana, meno di trecento uomini inviati per proteggere gli osservatori internazionali e la popolazione della regione non riescono ad “imporre la pace” e dopo decine di migliaia di morti e più di un milione di rifugiati, gli Stati Uniti cominciano a parlare per la prima volta di genocidio. In effetti, un resoconto dell'Onu spiega all'opinione pubblica internazionale che le milizie arabe e i temuti janjawwed, appoggiati dal governo centrale, stanno sistematicamente uccidendo gli abitanti dei villaggi con il supporto dell'aviazione militare (“pulizia etnica”). Washington chiede al Consiglio di Sicurezza dell'Onu una risoluzione che preveda dure sanzioni contro il governo di Khartoum, accusato di appoggiare le milizie janjawwed nonostante l'accordo con il segretario Kofi Annan per il loro disarmo. Lo Stato dell'Africa nord-orientale, lungo il corso iniziale del Nilo, era il paese più grande del continente africano prima del referendum che si è tenuto nel gennaio del 2011. La regione semi-autonoma del sud decide infatti di separarsi dal nord e di dare vita ad uno stato indipendente. Il presidente Bashir viene incriminato dalla Corte Penale Internazionale (4 marzo 2009) per crimini contro l'umanità, commessi proprio nel Darfur, e viene chiesto il suo arresto. Dopo numerose manifestazioni di piazza a sostegno del presidente, nel paese ritorna una calma apparente. Il tanto atteso referendum per l'indipendenza del sud si svolge dal 9 al 15 gennaio 2011 ed ai primi di febbraio vengono resi noti i risultati ufficiali: il 98,83% della popolazione si è espressa a favore della secessione (nel sud, quattro milioni di votanti su dieci milioni di abitanti). Dopo ventidue anni di guerra civile con il nord – con più di due milioni di morti e quasi tre milioni di sfollati – la regione semi-autonoma del sud si avvia ad essere uno stato sovrano ed indipendente. Anche se il nuovo nome non è stato ancora deciso, il probabile “Sudan del Sud” sarà la 54° nazione dell'Africa e la 193° del mondo. Mentre i giornali locali esaltano la vittoria schiacciante del referendum (“quelli che non hanno votato a favore si sono semplicemente sbagliati nel mettere il segno giusto sulla scheda”) la popolazione si raduna in festa, tra canti e tamburi, nella città di Juba – la città principale e la futura capitale del sud – intorno al mausoleo di John Garang, lo storico leader della ribellione contro il governo centrale. Il presidente Omar Bashir sottoscrive a Khartoum l'atto di riconoscimento ufficiale della votazione favorevole proclamata a Juba e quando raggiunge la sede del Partito Nazionale del Congresso annuncia formalmente – in un discorso trasmesso dalla televisione di Stato – di accettare il risultato e di rispettare la scelta dei sudanesi del sud. Nella cerimonia ufficiale tenuta nella capitale, il presidente, tra sorrisi e complimenti, stringe la mano al suo ex nemico Kiir e gli assicura “rispetto e sostegno”. Il mondo intero tira un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo di una reazione violenta del governo alla decisione presa sulla secessione, nonostante l'accordo firmato nel 2001. Il futuro presidente del sud, Salva Kiir, risponde sulla stessa lunghezza d'onda e tranquillizza tutti dichiarando che verranno tenuti ben saldi i legami tra i due paesi, “perché non possiamo essere nemici”. Da Washington il presidente americano Barack Obama si congratula con il popolo del sud Sudan e afferma che gli Stati Uniti sono “lieti di annunciare l'intenzione di riconoscere il nuovo Stato”. Anche dall'altra parte del mondo, il portavoce del ministro degli Esteri cinese, Hong Lei, dichiara di rispettare “la volontà e la scelta del popolo sudanese”. Entro il 9 luglio 2011 – data ultima per l'entrata in vigore dell'indipendenza – i dirigenti del nord e quelli del sud dovranno accordarsi per definire tutti i dettagli, compresa la fondamentale delimitazione delle nuove frontiere. Ma il cauto ottimismo delle dichiarazioni ufficiali non rassicura del tutto gli osservatori internazionali. La prima voce stonata è quella del fratello del presidente, Mohamed Hassan Bashir, che assume una posizione ben differente dalle esternazioni precedenti. Pur affermando che i sudanesi del sud avevano il diritto di procedere alla secessione, aggiunge che “presto potrebbero pentirsi di questa scelta”. Si tratta di un riferimento diretto ai gravi problemi che affliggono il sud, come la mancanza di infrastrutture, l'analfabetismo e l'impreparazione della classe dirigente, sino ad oggi impegnata solo nella lunga guerra civile. Nell'intervista, rilasciata il giorno stesso della notizia sull'esito del referendum, il fratello del presidente lamenta la cattiva immagine che la stampa occidentale utilizza per denigrare il suo paese: “il Sudan è diverso da quello presentato dai media occidentali [...] e subisce da tempo un costante attacco che risponde ad un preciso disegno politico occidentale. Per noi è molto difficile riuscire a reagire a questa potenza di fuoco mediatica”. Anche sulla tormentata regione del Darfur le sue opinioni si discostano dai resoconti ufficiali degli osservatori internazionali e delle Nazioni Unite. La questione del Darfur è stata presentata in modo totalmente diverso dalla realtà [...] si è semplicemente trattato di una guerra civile tribale. Tutto è cominciato per l'attacco di un gruppo di ribelli a forze di polizia, postazioni dell'esercito e a siti civili come gli ospedali. Qualsiasi governo, di qualunque parte del mondo, avrebbe reagito [...] abbiamo provato in tutti i modi a trattare con loro pacificamente [...] le bande dei ribelli, dopo ogni attacco, tornavano a rifugiarsi nei popolosi villaggi e questo ha provocato la morte di civili, vittime innocenti del fuoco incrociato. Sui timori di una forte islamizzazione del paese, Mohamed Hassan Bashir lancia invece messaggi tranquillizzanti. Le leggi islamiche saranno applicate, ma continueremo a chiamarci Repubblica del Sudan. Dopo l'indipendenza del sud, il 98% degli abitanti del Sudan saranno mussulmani e [le leggi islamiche] le applicheremo con moderazione e non saranno valide per i non mussulmani [...] nelle nostre strade si possono vedere ragazze non velate passeggiare tranquillamente, senza alcun problema. In ogni caso, un voto elettorale non sembra sufficiente per fare del Sud Sudan uno stato indipendente a tutti gli effetti. Sul tavolo delle negoziazioni in corso tra nord e sud pesa il tema della condivisione dei proventi petroliferi, con i ricchi giacimenti presenti soprattutto nelle regioni meridionali, ma sino ad oggi gestiti interamente da quelle settentrionali. Il pericolo è quello che la secessione possa riaccendere il conflitto sul controllo delle riserve petrolifere. L'appartenenza della regione di confine di Abyei, dove si trovano i pozzi d'oro nero, non è stata ancora decisa. Un referendum locale, per stabilirne l'appartenenza, è stato rimandato sine die. In quest'area si concentra non solo l'80% delle riserve petrolifere dell'intero paese – con l'oleodotto di Port Sudan e le raffinerie gestite dal nord – ma anche gas naturale e miniere d'oro. Nei giorni successivi al referendum il combustibile è misteriosamente scomparso dalla città di Juba e questo episodio, anche se limitato, ha fatto temere che il nord volesse mettere in ginocchio il sud prima ancora che cominciasse a muovere i primi passi. La situazione, già difficile, è aggravata dall'atteggiamento dell'esercito sudanese. Le unità di stanza nelle regioni meridionali – proprio nell'area di Abyei – non intendono consegnare le armi e si rifiutano di muovere verso settentrione. Nel mese di gennaio del 2010, proprio quello del referendum, sono scoppiati sanguinosi scontri con le forze irregolari del sud che hanno lasciato sul terreno oltre cento morti e costretto centinaia di persone ad un esodo forzato. Anche nel Darfur si sono riaccesi gli scontri. I combattimenti tra le truppe governative e i gruppi armati di opposizione – intorno all'ospedale del ministero della Salute – hanno provocato la fuga di settemila persone che si sono rifugiate nei campi vicino alla città di Shangil Tobaya. Il pericolo temuto dal nord è sicuramente dovuto alla possibilità che l'indipendenza del sud possa incoraggiare altri movimenti separatisti, primo fra tutti quello delle popolazioni cristiane ed animiste del Darfur. Un altro grave problema che deve essere ancora affrontato è quello del debito pubblico. L'ammontare totale del paese supera i trentasei miliardi di dollari ed è sicuro che nessuno dei due stati vorrà accollarsi il debito per intero. Su richiesta di entrambe le parti, una società svizzera è stata incaricata di eseguire una perizia tecnica nell'ambito della più generale separazione di beni e debiti (“attivi e passivi”) oltre che sulle complicate questioni bancarie e monetarie. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, e l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Catherine Ashton, danno il benvenuto al nuovo stato ma gli analisti non nascondo le loro preoccupazioni: potrà un paese tormentato dalla guerra civile, da milioni di profughi, dalle rivalità tribali, dalla siccità, dalle epidemie e dalle emergenze alimentari resistere in maniera pacifica allo strappo di una secessione così importante? Il 9 luglio 2011, dopo un conflitto brutale che ha costretto almeno un milione di sudisti ad abbandonare le proprie case per sfuggire alla guerra (molti sono finiti al nord, dagli odiati nemici mussulmani) nasce il Sud Sudan. Dopo essersi adattati a fare i lavori più umili, i profughi tornano nel porto fluviale di Juba, la nuova capitale, con la speranza di interrompere il ciclo mortale della violenza e della povertà (nel nuovo stato un bambino su tre è gravemente malnutrito, i tassi di mortalità materna sono i più alti al mondo e l’analfabetismo è una condizione normale). Ma il nord, nonostante le promesse, non vuole perdere il controllo dei pozzi di petrolio al confine tra i due paesi e invade la contea di Abyei (contesa e ricca di giacimenti), costringendo le popolazioni africane di dinka nkok a scappare. Viene bombardato anche il Sud Kordofan, un’altra regione contesa, abitata dai nuba, neri ma in maggioranza mussulmani, che hanno partecipato alla guerra di secessione con il Sudan People’s Liberation Army. Anche in un’altra regione, il Blue Nile, si segnalano incursioni delle forze del nord Sudan, accusate di sobillare gruppi ribelli del sud per combattere contro il nuovo governo (ai capi locali vengono promessi ricchi premi in denaro in cambio della loro lealtà a Khartoum). Anche se la Cina continua a fornire armi e sostegno politico a Bashir – ancora ricercato dal Tribunale penale internazionale per crimini contro l’umanità e genocidio commessi dalle sue truppe in Darfur – molti analisti concordano nel ritenere che Pechino dovrebbe adesso esercitare pressioni in favore di un confine smilitarizzato e di una distensione che faciliti i suoi interessi petroliferi anche nel Sud Sudan. Secondo Talal Salman, giornalista libanese ed editore del quotidiano «al-Safir», la vera difficoltà del nuovo stato nasce dalla mancanza di una pregressa storia indipendente, dall’assenza di una struttura economica e di una organizzazione sociale definita. La partizione del Sudan ha avuto luogo accidentalmente, proprio mentre la regione araba è sconvolta, da oriente a occidente, da rivolte popolari che chiedono la caduta di regimi fatiscenti i cui leader dispotici rifiutano di accogliere le rivendicazioni dei loro popoli […] il Sudan, con la sua composizione demografica multiforme e diversificata, potrebbe non rappresentare il modello ideale di Stato centrale arabo, soprattutto tenuto conto della sua sterminata superficie e dall’assenza di mezzi di trasporto e di comunicazione, dell’arretratezza e della povertà […] gli apparati amministrativi non sono in grado di raggiungere le regioni più remote del paese e le sue popolazioni dai molteplici idiomi e dalle etnie in reciproco contrasto, con le sue tribù di origine africana che non hanno alcun legame con l’identità araba e spesso neanche con quella islamica. In effetti, i rapporti fra queste componenti sembrano essersi fermati a prima dell’indipendenza, fondati essenzialmente sul commercio e localizzati nei pascoli del sud, con i confini dettati dai limiti stessi delle estensioni delle tribù. Il paese ha conosciuto la religione cristiana solo nelle recente epoca coloniale e nonostante una più ampia accezione del termine di “stato cristiano”, la maggioranza della popolazione conosce – e pratica – solo gli antichi culti e le divinità tramandate oralmente dagli antenati, quindi senza alcun legame apparente con le religioni monoteistiche. Con la secessione del sud, lo stato originario del Sudan perde un quarto dei suoi cittadini e un terzo della sua superficie, oltre perdere tra il tra il 70% e l’80% delle sue risorse petrolifere, il 60% del suo bilancio e il 90% della valuta estera. Sarà quindi necessario, e non solo sotto un profilo meramente politico, stringere una serie di accordi che permetta al sud di fare affidamento su Port Sudan per le esportazioni di petrolio. Il confine di demarcazione è attualmente la più lunga frontiera tra due paesi del continente, stimata intorno ai 2.000 chilometri, ma i problemi dei movimenti al suo interno costituiscono la maggiore fonte di preoccupazione. Ci sono milioni di meridionali al nord che – trattati come veri e propri stranieri – perdono i posti di lavoro e i diritti concessi prima dell’indipendenza, anche se i sudanesi stanziati nel sud – in misura molto minore – sono stati rassicurati dal nuovo governo non solo sulla possibilità di rimanere, ma anche con la concessione del diritto di cittadinanza. Oltre ai problemi già esposti, il Sud Sudan deve fronteggiare i pericoli della milizia di opposizione ugandese, la al-Rab Army, e delle milizie armate del sud con cui lo Splm non è stato in grado di raggiungere un accordo (con le accuse di sostegno dirette al partito del Congresso nazionale del nord). Inoltre, è necessario provvedere alla rimozione di centinaia di migliaia di mine per facilitare il reinsediamento degli sfollati e dei rifugiati. Senza contare la creazione di ospedali, strade, ponti e infrastrutture per l’acqua potabile, così come le opportunità di lavoro e la formazione delle risorse umane per agevolare la coesistenza tra i vari gruppi presenti nel paese, con la loro immensa diversità tribale, culturale, religiosa, politica ed anche militare. Anche il precario rapporto tra le dirigenze dei due paesi, o meglio la mancanza di fiducia reciproca, lascia perplessi gli osservatori internazionali. L’escalation militare registrata nella regione di Abyei ha portato alla decisione internazionale di dispiegare quattromiladuecento soldati etiopici in base al capitolo VII della carta delle Nazioni Unite (quindi forze in missione di combattimento) ed entrano in discussione gli accordi per dispiegare forze internazionali anche lungo l’intero confine tra nord e sud, oltre che per assorbire gli elementi dello Splm ancora presenti nel nord e di risolvere le controversie nel sud Kordofan e nel Nilo Azzurro. Gli accordi, raggiunti ad Addis Abeba, sono stati definiti dai membri del partito di governo di Khartoum che si sono opposti, come Nifasha 2, dal nome dell’accordo di pace sudanese che venne firmato nel 2005 nella città di Nifasha in Kenya, ovvero sottolineando le sofferenze e i sacrifici che secondo loro il nord ha patito, per una inutile condivisione del potere dettata elusivamente dalle richieste provocatorie del sud. Anche se in un primo momento il presidente Bashir aveva respinto gli accordi firmati dl suo vice Nafie Alì Nafie e li aveva duramente criticati durante un sermone del venerdì in una moschea di Khartoum, dopo un viaggio d Addis Abeba – ma secondo gli analisti dopo che erano emerse alcune fratture nelle file del partito di governo, lasciando intravedere la possibilità di una coalizione antigovernativa – avrebbe invece dato le istruzioni necessarie per attuarli. Il pericolo paventato, quindi, consisterebbe nella possibilità di trasformare il paese, o meglio le contese regioni di frontiera, in una sorta di Kashmir sudanese. Le dirigenze dei due paesi sono in effetti alle prese non solo con i problemi del fronte interno (le difficoltà di gestione della complessità etnica e religiosa) ma anche con le difficili alleanze esterne per esercitare pressioni uno contro l’altro: il sud accusa il nord di sostenere le milizie dell’opposizione e il nord accusa il sud di finanziare i gruppi del Darfur che si oppongono al regime. Gli attori regionali e internazionali potrebbero quindi giocare un ruolo determinante in questo complesso scenario, anche se la comunità internazionale è schierata contro il presidente Bashir per le accuse mosse dalla Corte penale internazionale. La guerra tra i due paesi, infine, non sembra ipotizzabile proprio a causa delle reciproche dipendenze dal petrolio, lasciando quindi escludere un conflitto di lunga durata, ma allarma invece gli analisti la possibilità di un probabile scenario caratterizzato da una situazione né di guerra e né di pace – ma ugualmente catastrofico – che potrebbe prosciugare le risorse, e le poche energie, dei due paesi attraverso piccole ed asimmetriche guerre per procura. 2. Attualmente i fedeli mussulmani costituiscono la maggioranza dei cittadini nell’Africa Orientale e, quindi, negli stati membri dell’Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo110. L’Islam è la religione 110 L’autorità Intergovernativa per lo Sviluppo (Intergovernmental Authority on Development – Igad) è un’organizzazione internazionale politico-commerciale formata dai paesi del Corno d’Africa e nata nel 1986 nell’ambito delle Nazioni Unite. Attualmente ha sede a Gibuti. Nella fattispecie, sei Paesi dell’Africa Orientale (Gibuti, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Uganda) si sono riuniti nel gennaio del 1986 per sollecitare l’Onu a trovare una soluzione politica e un’istituzione intergovernativa capaci di far fronte alle siccità ricorrenti, al degrado ecologico e ai gravi disastri naturali che avevano colpito tra il 1974 e il 1984 l’intera regione del Corno d’Africa. Di qui, la nascita dell’Igadd (Autorità Intergovernativa per la Siccità e lo Sviluppo) a cui nel 1993, al momento della sua indipendenza, si è unita l’Eritrea. Il 18 aprile 1995, ad un vertice straordinario dei capi di Stato dell’Igadd tenutosi ad Addis Abeba, si è deciso di rivitalizzare l’Autorità e di estendere la cooperazione fra i suoi membri oltre gli obiettivi della sicurezza alimentare e della tutela del territorio. Per questo motivo, con gli accordi del 21 marzo e del 25 novembre 1996, è nata l’Igad che si è riproposta di perseguire i seguenti obiettivi: sicurezza alimentare e protezione ambientale; prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti; affari umanitari e sviluppo infrastrutturale. L’Eritrea, dal 2007 in poi, ha più volte annunciato la sua fuoriuscita - illegittima per l’Igad- dal suddetto organismo intergovernativo, causa il conflitto in Somalia e l’occupazione di territori, considerati eritrei dal governo di Asmara, da parte dell’Etiopia (si veda, in particolare, il comunicato del Ministero degli Affari Esteri eritreo datato 3 febbraio 2010). più diffusa nell’insieme degli Stati del Corno d’Africa, che comprende la Somalia, l’Etiopia, l’Eritrea e Gibuti, con un territorio pari a quasi due milioni di chilometri quadrati. L’ultimo censimento condotto in Etiopia nel 1994 ha mostrato una realtà religiosa interna a maggioranza cristiana (col 50% di ortodossi, il 10% di protestanti e circa l’1% di cattolici), con una presenza mussulmana consistente che si avvicinava al 33% della popolazione. Nuovi studi indicano una crescita esponenziale dei mussulmani devoti, tale da raggiungere la maggioranza della popolazione. Questo risultato si è ottenuto non solo per le vie ordinarie della propaganda religiosa, ma anche e soprattutto attraverso la pratica del matrimonio poligamico, la moltiplicazione delle nascite nelle famiglie mussulmane, i matrimoni tra mussulmani e cristiani, che hanno visto nella maggior parte dei casi la conversione all’Islam da parte del coniuge femminile cristiano. Ai cristiani, invece, è stato vietato sia il matrimonio poligamico, per ovvie ragioni di dottrina, sia il matrimonio con persone di fede diversa. L’uso cristiano volto a controllare le nascite ha ulteriormente contribuito a ribaltare il rapporto tra il numero dei fedeli delle due confessioni. A tal proposito, appare oggi anacronistica e superata la definizione dell’Etiopia come “isola di cristianità in un mare di Islam”, tanto più se si guarda alla nuova penetrazione islamica e ai trascorsi storici dei mussulmani nella stessa area. Più appropriato e aderente alla realtà è parlare dell’Etiopia come un “museo di culture e credenze religiose111”, dove l’Islam ha avuto una funzione e un’influenza sociale tutt’altro che marginali. Mentre il Cristianesimo ebbe i suoi albori in Etiopia già nel 330 d.C., quando re Esana lo innalzò a religione ufficiale112, le prime tracce dell’insediamento islamico nell’area si rivengono nel 615 d.C., cinque anni dopo l’inizio della predicazione pubblica di Maometto, quando i muhajirun113 si spostarono nel Regno di Axum114, in fuga dalla persecuzione dei Quraysh alla Mecca. Sebbene fosse dell’avviso che “l’Abissinia non è territorio di jihad”, Maometto si rivolse così ai suoi seguaci: se andate in Abissinia troverete un re (nejashi) sotto il cui regno nessuno è perseguitato. È un regno di giustizia in cui Dio vi farà trovare sollievo da quanto state soffrendo. I muhajirun riuscirono a convertire all’islam re Ashama ibn Abjar, uno degli ultimi sovrani di Axum, quantunque la teorizzazione di quest’adesione sia contestata da diversi storici (nondimeno, sembra appurata l’originalità della sua corrispondenza con lo stesso profeta). Per diverso tempo, cristiani e mussulmani convissero negli stessi territori in maniera pacifica. I fedeli cristiani, radicati in Etiopia già da tre secoli, accolsero i seguaci di Maometto con una tolleranza e un rispetto che sorpresero gli stessi mussulmani. Con il passare degli anni la penetrazione mussulmana in Etiopia attraverso il Mar Rosso continuò a crescere. Il regno di Axum perse la sua influenza sul Mar Rosso e sulle aree circostanti e con il 111 La definizione è di Carlo Conti Rossini, storico del Corno d’Africa. 112 Fonti storiche attendibili, riportate nei lavori del monaco, teologo e storico cristiano Tirannio Ruffino (345410 d.C), confermano quest’evento. Tuttavia, l’ottavo capitolo degli Atti degli Apostoli racconta che il Cristianesimo si diffuse in Etiopia subito dopo che un ministro della Regina Candace si fece battezzare da San Filippo (secolo I a.C.). 113 I Muhajirun erano i mussulmani della prima ora (inclusi nei Sahaba o Compagni del Profeta) che si mossero con Maometto dalla Mecca attraverso Yathrib per la leggendaria hijra (ègira o emigrazione). 114 Il Regno di Axum (o Aksum) fu un importante regno commerciale situato nell'Africa centro-orientale, che crebbe a partire dal periodo proto-axumita nel IV secolo a.C. e raggiunse l'apice della sua potenza e ricchezza verso il I secolo d.C. Axum cominciò a declinare nel VII secolo . Il regno di Axum si estendeva attraverso zone dell'odierna Eritrea, dell'Etiopia, dello Yemen, dell'Arabia Saudita meridionale, della Somalia occidentale, del Gibuti e del Sudan settentrionale. declino del regno e il sollevarsi di alcuni gruppi etnici pagani, l'Etiopia piombò nell'epoca più buia della sua storia. Si tornò alla normalità con l’ascesa della dinastia Zagwe nel secolo XII: crebbe ulteriormente la cultura cristiana, ma al contempo si aprì la strada al consolidamento dei sultanati mussulmani in Etiopia. Un parziale freno all’ascesa mussulmana a detrimento dei cristiani d’Etiopia (al tempo isolati perché dipendenti dal lontano Patriarcato d’Alessandria) fu posto dall’imperatore Gebre Mesquel Lalibela115, che dopo aver visto Gerusalemme in un’apparizione provò a rinverdire la fede cristiana e a ricreare la “Terra Santa”, costruendo undici chiese scavate nella roccia della città di Roha. Con la restaurazione della dinastia salomonica116, Chiesa e Stato unirono le proprie forze nella difesa della fede cristiana ed ogni tentativo di attacco a quest’ultima in Etiopia fu combattuto militarmente. Cionostante, dalla città di Harar (Etiopia orientale), dove si radicò la Qadiriyya117, e le coste somale settentrionali, fra i secoli XIV e XV venne sferrata la prima offensiva legittimata come jihad, rivolta contro i miscredenti abissini dell’altopiano. I mussulmani, comandati da Sa‘d alDon, furono però sconfitti dall’imperatore Yishaq. Circa un secolo dopo, l’Etiopia visse uno dei momenti più drammatici della sua storia. Nella prima metà del secolo XVI, il nuovo sultano di Harar, Ahmad ibn Ibrihim al-Ghazi, noto in aramico come Grayné o Gragne (“il mancino”), per conto del Sultanato Adal118 e dei turchi ottomani, attaccò gli altopiani abissini settentrionali con truppe somale ed afar, sperimentando financo l’uso dei cannoni. Questa campagna è storicamente conosciuta come la conquista dell'Abissinia o Futuh Al Habash. Ahmad, proclamatosi imam, sconfisse gli Etiopi nella “battaglia di Shimbra Kuree” nel 1529 e prese il controllo dei ricchi altipiani etiopi. Nel 1541 i portoghesi, che avevano interessi nell’Oceano Indiano inviarono in Etiopia quattrocento moschettieri; ciononostante, nell’agosto del 1542 le forze del “mancino” riuscirono a sconfiggere e ad uccidere il comandante portoghese Cristóvão de Gama. L’imperatore etiope Galawedos e i portoghesi lanciarono a quel punto una vittoriosa controffensiva: nella Battaglia di Wayna Daga , nei pressi del lago Tana, nel febbraio del 1543, Ahmad perse la vita. Gli etiopi successivamente riconquistarono l'altopiano Amhara e recuperarono le perdite contro Adal. Ma la minaccia d’islamizzazione dell’altopiano fu solo rinviata di qualche secolo, anche perché dal secolo XVI in poi l’Etiopia cristiana adottò una politica distensiva nei confronti dell’islam. Se è vero che il culto islamico non si poté esprimere che per vie private, essendo di lì in avanti impraticabile e illegale la manifestazione pubblica di un credo ostile al cristianesimo, è altrettanto importante sottolineare che i neosufi riuscirono, dal secolo XIX in poi, ad esercitare una funzione 115 Gebre Mesqel, noto come Lalibela -che in lingua agau significa "le api riconoscono la sua sovranità”- è stato un imperatore d’Etiopia e membro della dinastia Zagwe. È venerato come santo dalla Chiesa ortodossa etiopica. 116 Intorno al 1270, Yekuno Amlak depose l'ultimo re della dinastia Zagwe e fondò un nuovo regno e una nuova dinastia. Questa nuova linea dinastica rivendicava la discendenza diretta dal biblico Re Salomone, ed è nota come dinastia salomonica. L’Impero Etiope controllava un territorio che comprendeva le regioni di Tigrè, Amhara e Shewa. 117 Fondata da Abd al-Qadir al-Gilani, la Qadiriyya è la più antica e radicata confraternita mistica del mondo islamico. Prese piede in Maghreb, Andalusia, Asia Minore, Arabia, Iraq e si affermò, in terra etiope, ad Harar nel secolo XV secolo come tariqa ufficiale. 118 Stato mussulmano multietnico, situato nel Corno d’Africa, che controllava la gran parte di Somalia, Etiopia, Gibuti ed Eritrea e aveva relazioni e scambi economici con i Paesi in Africa, Vicino Oriente, Europa ed Asia. di “intermediazione islamica” col potere, ma anche di di punto di riferimento costante per i fedeli, attraverso le confraternite di Aḥmadiyya, Ḫatmiyya, Rasidiyya, la Ṣaliḥiyya e la Dandarawiyya119. Tafarì Maconnèn, meglio noto come Hailé Selassié (“Potenza della Trinità”), capo della Chiesa Ortodossa etiope Tewahdo, dal canto suo, concesse ampia libertà ai mussulmani. L’opera di liberalizzazione dell’impero voluta da Hailé Selassié – i consigli municipali nel 1945, la nuova costituzione del 1955 e le prime elezioni a suffragio universale nel 1957 – ebbe maggiore efficacia subito dopo il tentativo di golpe militare del 1960, ad opera del principe ereditario Asfa Wassen Asserate, producendo un chiaro orientamento che mirava a realizzare una moderna forma di monarchia costituzionale. Oltre ad una larga influenza esercitata negli affari politici e diplomatici africani120, l’imperatore riformò di nuovo la costituzione nel 1966, concedendo al primo ministro la facoltà di scegliere i ministri e rafforzando i poteri del governo a discapito stesso della massima autorità istituzionale. Nel 1967, fu concessa una più larga autonomia amministrativa alle province che non riuscì tuttavia a contenere le rivolte popolari e studentesche (1968-1969) scoppiate in Eritrea e accumunate al malcontento degli ufficiali inferiori (sottopagati) e alle critiche sulle incertezze del governo nel prestare soccorso alle vittime della carestia. L’avanzamento democratico e diplomatico del paese (vi fu un considerevole scambio di ambasciatori con i paesi occidentali) non permise comunque all’Etiopia di uscire da uno stato di profonda arretratezza. Le critiche popolari si incentrarono sulla rigida divisione in caste della società (l’elemento religioso mussulmano ebbe, in questo periodo, una notevole influenza) e sull’accentramento del potere nelle mani della ristretta nobiltà e della chiesa ortodossa. Il “Comitato di Coordinamento delle Forze Armate” mise sotto tutela Hailé Selassié e nonostante la promessa di una più evoluta monarchia costituzionale, nel 1974 l’imperatore fu deposto e arrestato. Alla sua morte, l’anno successivo, il “Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio” (Derg) abolì la monarchia e proclamò la repubblica, pur essendo attraversato da forti rivalità tra le varie fazioni politiche sulla nuova forma di governo e sulle proposte per uscire dalle gravi difficoltà economiche. La rivoluzione d’impronta socialista avviata dal Consiglio Provvisorio venne però interrotta nel 1977 da un nuovo putsch militare che, eliminato il capo dello Stato Tafari Bante, portò alla testa del Derg il colonnello Hailé Mariam Menghistu, sostenuto dall’Urss brezneviana. Menghistu non esitò ad attuare una durissima e indiscriminata repressione contro gli esponenti del passato regime (anche verso i militari appartenenti alla sinistra politica dissidente, ovvero i membri dell’Ethiopian People Revolutionary Party, che aveva inizialmente appoggiato la rivolta contro il Negus Neghesti – Re dei Re – Giovanni IV) e una persecuzione altrettanto dura contro i membri della Chiesa etiopica, tra cui il Patriarca Theophilos, e le tribù nere di origine ebraica. Nel frattempo, l’Etiopia accolse consiglieri e aiuti militari da Cuba, dallo Yemen del Sud e dalla Repubblica Democratica Tedesca, trasformando ogni soldato dell’esercito in un membro del partito comunista, pur essendo il governo militare fortemente impegnato a reprimere le forze della guerriglia non solo in Eritrea, ma anche in Ogaden e nel Tigray. Involontariamente, la stretta repressiva di Menghistu sulle opposizioni e sui fedeli produsse un rinnovamento spirituale sia tra i mussulmani che tra i cristiani. Mentre la guerriglia aveva paralizzato le istituzioni governative, soprattutto nel nord del paese, cristiani e mussulmani unirono le proprie forze in un'opera di soccorsi e aiuti. Proprio in Ogaden, nel 1977 l’Etiopia subì l’invasione somala, capeggiata da Siad Barre che nella 119 Queste confraternite s’ispiravano direttamente al pensiero del mistico mussulmano marocchino Aḥmad ibn Idris . 120 Selassié fu guida politica e spirituale dell’ “Organizzazione dell’Unità Africana” (Oau), nata nel 1963 con sede ad Addis Abeba e sostituita nel 2002 dall’Unione Africana. lotta contro Meghistu per l’accaparramento della regione agitò, senza successo, anche dei miliziani di estrazione islamica. Nondimeno, quegli stessi miliziani islamici formarono negli anni successivi (a partire dagli anni Ottanta), un movimento radicale tuttora esistente e monitorato dall’intelligenza internazionale: al-Ittihad al-Islami (“Unione Islamica”), oggi sospettata di contiguità con al-Qaeda per il tramite di rappresentanti del Congresso Somalo delle Corti Islamiche. Nel biennio 1984-1985, il paese venne colpito da una carestia di vastissime proporzioni che portò alla morte di quasi otto milioni di persone. Stremato dalle rivolte, dal collasso economico del paese, dalla siccità su larga scala e dal problema dei rifugiati, il regime venne deposto da una coalizione di forze ribelli, il “Fronte Rivoluzionario Democratico del Popolo Etiope” (Fdrpe) nel 1991. Menghistu fuggì in Zimbabwe, presso il suo amico Robert Gabriel Mugabe, dove tuttora risiede e lavora come consigliere sulla sicurezza121. Ad Addis Abeba prese il potere il leader tigrino Meles Zenawi, capo del Fronte Rivoluzionario Democratico del Popolo Etiope, e ad Asmara Isaias Afewerki, leader del “Fronte Popolare di Liberazione Eritreo” (Eplf)122 che guidò l’Eritrea verso l’indipendenza nel 1993. I primi veri scontri di carattere politico, diplomatico, territoriale e religioso, interessanti i nuovi governi, scoppiarono nel 1995, allorquando il governo somalo si acconciò a sostenere il “Fronte di Liberazione Oromo” in Etiopia e il governo di Zenawi, a sua volta, offrì il suo appoggio al Sudan People’s Liberation Movement ostile a Khartoum. In quel periodo, ovvero nel 1996, era di stanza in Sudan Osama bin Laden, rappresentante supremo di al-Qaeda. Nel 1998, come noto, iniziò uno scontro tra Etiopia ed Eritrea per il controllo della città di Baddamé (Badme). Il conflitto terminò nel 2000 con l’accordo di Algeri, con una nuova mappatura dei confini, con migliaia di profughi (circa 350.000) e danni stimati in tre miliardi di dollari. Nel 2001, Girma Wolde Giyorgis sostituì Negaso Gidada alla presidenza della repubblica di Etiopia e le Nazioni Unite schierarono osservatori nei territori eritrei occupati dalle forze di Addis Abeba, mentre i due governi liberarono i rispettivi prigionieri di guerra. L’anno successivo l’Etiopia si schierò al fianco degli Stati Uniti nella guerra contro l’Iraq, scatenando sanguinosi conflitti etnici a Gambela, che provocarono la morte di duecentocinquanta persone e la fuga precipitosa in Sudan di un migliaio di esuli. Le elezioni del 2005 segnarono una tappa importante nel cammino politico del paese. Il “Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiopico” di Zenawi, pur risultando vincitore su scala nazionale, perse quasi tutti i seggi nell’area di Addis Abeba, attribuiti alla “Coalizione per l’Unità e la Democrazia” (Cud), provocando nella capitale una situazione di grande tensione. Le manifestazioni scoppiate all’università furono represse dall’esercito con decine di feriti e centinaia di arresti, mentre la Commissione elettorale si vide costretta a rinviare la pubblicazione dei risultati. Oltre ad un inasprimento delle attività di guerriglia nell’Ogaden (gli scontri tra gli uomini di etnia oromo e i somali si allargarono anche nella zona dell’Ahman), le tensioni con l’Eritrea si fecero più tese e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite decise di prorogare i termini della missione incaricata di tracciare il confine tra i due paesi dopo la guerra iniziata nel 1998. Il conflitto provocò più di settantamila vittime e oltre un milione di sfollati (quasi centomila civili eritrei furono espulsi dall’Etiopia e il governo di Asmara allontanò più di diecimila residenti di 121 Nel 2006, la Corte Suprema dell’Etiopia ha giudicalo Hailé Mariam Menghistu, dopo dodici anni di processo, colpevole (in contumacia) di genocidio e crimini contro l’umanità. L’accusa ha provato la sua diretta responsabilità nelle violenze – uccisioni e torture – ai danni degli oppositori politici. Il verdetto del 2007, che aveva inflitto l’ergastolo all’imputato, venne modificato l’anno successivo in condanna a morte, sempre in contumacia, insieme ad altri diciotto dirigenti del regime. 122 Il gruppo è nato nei primi anni Settanta, scindendosi dal “Fronte di Liberazione Eritreo”; oggi porta il nome di “Fronte Popolare per la Democrazia e la Giustizia”. nazionalità etiope, con le rispettive confische delle proprietà), e aprì un contenzioso incessante sulla definizione dei confini. Una Commissione internazionale, la “Commissione Confini”, si mise al lavoro lungo una zona smilitarizzata di frontiera, profonda venticinque chilometri, sotto il controllo della Unmee, la missione di pace delle Nazioni Unite per l’Etiopia e l’Eritrea (quattromila caschi Blu). Il centro del contenzioso fu l’assegnazione del villaggio di Badammè, di scarso valore strategico ma di alto contenuto politico (sempre amministrato dall’Etiopia, era diventato durante la guerra il simbolo stesso del nazionalismo di Addis Abeba) che le Nazioni Unite assegnarono all’Eritrea, senza il riconoscimento dell’Etiopia123. La difficile situazione dell’Ogaden e la crisi in Somalia aggravarono la situazione. L’Etiopia accusò l’Eritrea di appoggiare i ribelli separatisti del “Fronte di Liberazione Nazionale dell’Ogaden” (Onlf), la regione etiope abitata da popolazioni di etnia somala, e di offrire aiuto e assistenza logistica alle Corti islamiche che governavano a Mogadiscio. Di contro, l’Eritrea accusò l’Etiopia di non rispettare le decisioni della Commissione internazionale sui confini, di causare una grave crisi umanitaria nell’Ogaden e di praticare inaccettabili interferenze in Somalia. Per molti analisti, la noncuranza occidentale nei confronti dello spietato regime di Meles Zenawi (dalla repressione interna al contrasto violento in Ogaden) ha trovato una sua giustificazione nella garanzia di stabilità offerta dall’Etiopia nei confronti del dirompente fondamentalismo islamico nelle zone di frontiera e in particolare di fronte al caos dilagante in Somalia. Nel 2006 il governo etiope e il governo federale di transizione somalo avviarono un conflitto (dalle terribili conseguenze) per sottrarre il controllo della Somalia all’ “Unione delle Corti Islamiche” e al blocco terroristico islamico che comprendeva, sotto la longa manus di Al-Qaeda, forze come l’ “Alleanza per la liberazione della Somalia”, al-Shabaab, Ras Kamboni Brigades, Jabhatul Islamiya e Muaskar Anole. Agli inizi del 2007 un commando di uomini armati attaccò un accampamento nella regione di Hamad Ela, nel deserto della Dancalia e al confine con la frontiera eritrea, e sequestrò cinque cittadini europei (quattro britannici ed una donna italiana). Nella regione, inospitale a causa di una depressione simile a quella del Mar Morto, era stata segnalata la presenza di diverse bande di predoni, ma anche di piccoli gruppi di ribelli che rivendicavano l’indipendenza della regione Afar – abitata dall’etnia afar, una delle tribù più antiche dell’Africa che vive tra Etiopia, Eritrea e Gibuti – attraverso un braccio armato denominato Afar Revolutionary Democratic Union (Ardu), già responsabile del rapimento di nove turisti italiani nel 1995. Inoltre, era stata segnalata la presenza di ribelli etiopici sostenuti – armati e finanziati – dal governo di Asmara. Sembra infatti che questi gruppi armati siano riusciti ad entrare in Etiopia attraverso la Somalia, per azioni di sabotaggio sul territorio etiopico, quando Asmara poteva contare su una forte presenza militare durante il governo delle Corti islamiche124. Secondo un leader afar – Ismail Alì Sero, governatore della parte della regione controllata dall’Etiopia – il sequestro degli occidentali era avvenuto ad opera dei ribelli dello Ethiopian People Patriotic Front, un gruppo organizzato e finanziato dal regime di Asmara in chiave anti-etiopica e molto attivo nell’area (in effetti, lo stesso Meles Zenawi aveva riconosciuto che alcune precedenti azioni di sabotaggio erano state condotte da questo gruppo armato). Anche le Nazioni Unite avevano espresso qualche perplessità (Michele Montas, portavoce della 123 La Commissione fece ricorso alla cartografia messa a disposizione dalla Gran Bretagna – che aveva colonizzato il Corno d’Africa fin dai primi del Novecento – e dall’Italia, in possesso della documentazione sull’Abissinia e sull’intero periodo coloniale. 124 Secondo i testimoni del sequestro, il gruppo armato e gli ostaggi si erano diretti a piedi verso il confine con l’Eritrea, probabilmente per raggiungere la base militare di Arat, nel distretto di Wema . Unmee) sostenendo che le autorità eritree avevano imposto, solo qualche giorno prima del sequestro, nuove restrizioni ai movimenti dei caschi blu nella zona (recentemente ridotti da 2.500 a 1.700 uomini) con il divieto di alzare in volo gli elicotteri per il controllo dell’area. Secondo gli ultimi rapporti delle Nazioni Unite (2006-2007) il regime di Asmara ha inoltre aiutato i fondamentalisti islamici di Mogadiscio con l’invio di armi, ufficiali e soldati. Quando avvenne la liberazione degli ostaggi (dopo quasi due settimane, ma senza le otto guide etiopiche rimaste nella mani dei rapitori), l’Eritrea prese subito le distanze dal rapimento degli occidentali. Secondo il sito ufficiale del governo di Asmara («Shabait»), la responsabilità andava ricercata nel gruppo di opposizione afar al regime di Addis Abeba – Afar Revolutionary Democratic Unity Front – e gli europei sarebbe stati tenuti in ostaggio in territorio etiopico, prima di essere trasferiti in Eritrea per la sola liberazione. A soli pochissimi giorni dal rapimento, in Etiopia si verificò un altro sanguinoso attacco ai danni di un campo petrolifero di una compagnia cinese. Un gruppo armato di circa duecento uomini assaltò il campo per le ricerche petrolifere (Zhongyuan Petroleum Exploration Bureau di Pechino) vicino a Jijiga, a circa seicento chilometri da Addis Abeba, nella desertica regione sud-orientale dell’Ogaden. Nella battaglia con le truppe governative rimasero uccisi sessantacinque etiopici e nove cinesi, ma vennero anche rapiti altri sette cinesi ed un numero imprecisato di lavoratori locali. Con un comunicato inviato alla stampa italiana125, il gruppo del “Fronte Nazionale di Liberazione dell’Ogaden” (Onlf) rivendicò l’incursione: Più volte abbiamo avvertito che non permetteremo ai regimi etiopici e a qualsiasi compagnia di sfruttare le risorse minerarie che appartengono al nostro popolo […] i cinesi erano già stati avvisati ma il consigliere del primo ministro etiopico, Bereket Simon, accusò l’Eritrea di essere la reale organizzatrice del grave atto terroristico. Nell’arida regione dell’Ogaden – abitata dall’omonima tribù somala – si era già combattuta nel 1977 una guerra tra i somali, guidati da Siad Barre, e gli etiopi comandati da Hailè Mariam Mengihstu, causando l’insorgenza dei primi gruppi islamici che combatterono nel nome di Allah contro i nemici cristiani. Una sorta di guerra parallela 126 a quella in corso nella vicina Somalia, combattuta tra il Governo federale di transizione somalo – aiutato dall’esercito etiopico – e i gruppi ribelli che fanno capo al clan hawiye e ai resti dei miliziani islamici aiutati dagli eritrei con armi e finanziamenti. Nell’estate del 2008 la repressione dell’esercito etiopico fu particolarmente cruenta. L’associazione umanitaria Human Rights Watch denunciò una serie di atrocità commesse dalle truppe di Addis Abeba nella caccia ai ribelli, con torture, stupri e esecuzioni sommarie di migliaia di persone, non solo ai danni dei guerriglieri, ma anche nei confronti dei membri delle tribù di appartenenza, compresa la distruzione totale dei villaggi di Labiga, Dameerey, Qamuuda e Laasoole, ampiamente documentata dalle immagini satellitari127. Sebbene le relazioni tra cristiani e mussulmani siano ancora buone, segni di insoddisfazione si sentono da entrambe le parti. La comunità cristiana si sente in un certo senso inerme di fronte alla sempre maggior espansione dell'Islam, mentre la comunità mussulmana lamenta innanzitutto i comportamenti del governo e la scarsa autonomia riconosciutagli. Le tensioni tra le due comunità sono cresciute in questi ultimi anni. Qualche anno fa 125 M. A. Alberizzi, «Corriere della Sera», 25 aprile 2007. 126 Solo nello stesso mese dell’attacco, negli scontri avevano perso la vita duecentoqurantasette soldati etiopici e trentotto ribelli. 127 Le autorità etiopiche impedirono ai giornalisti e alle organizzazioni non governative di recarsi nell’Ogaden. il sindaco di Addis Abeba è stato rimosso dal suo incarico perché accusato di aver agevolato la creazione di 80 luoghi di culto per i mussulmani. Il fatto ha dato origine a fenomeni di tensione e violenza in entrambe le comunità della capitale e di altre città. Zenawi, dal canto suo, conduce da tempo una lotta strenua contro i già citati mussulmani oromo (negando loro anche l’accesso alle pubbliche funzioni e all’Università) e il “Fronte Islamico di Liberazione dell’Oromia” (Filo), e contemporaneamente contro gruppi indipendentisti di dubbia natura come il “Fronte di Liberazione dei Sidana” (Fls), il “Fronte di Liberazione del Gambela” (Flg), il “Fronte Unito dei Patrioti Etiopici” (Fupe), il “Fronte di Liberazione degli Afar” (Fla). La partita con queste fazioni non si gioca solo sul piano della sicurezza, ma anche sul piano squisitamente economico. La gestione delle risorse idriche, nel caso di specie, e dei bacini dei fiumi Uebi Scebeli e Giuba rinfocola di continuo le tensioni con i fondamentalisti e coi governi di Somalia e Kenia. I mussulmani, dal canto loro, riescono a influenzare i settori più bassi e indigenti della popolazione attraverso operazioni commerciali mirate, come la distribuzione di nastri e video in cassetta (contenenti la lettura del Corano) destinati agli analfabeti e con l’attività di stampa legata ai giornali «Hikma» (Saggezza), «Imman» (Fede) e «Bilal» (era il nome di uno dei primi schiavi convertiti all’Islam). Se è vero che non registriamo in Etiopia una presenza granitica e organizzata di cellule terroristiche vicine ad al-Qaeda128 o ad altri gruppi estremisti, come avviene in Sudan e Somalia, parimenti non è da escludere che i problemi di carattere confinario, la questione delle nazionalità, la cattiva distribuzione del potere possano rappresentare un humus ideale per la propaganda terroristica e per una penetrazione più incisiva in Etiopia di forze legate al mondo islamico radicale. In Eritrea, la popolazione è divisa quasi a metà tra mussulmani a nord, specialmente nelle aree costiere, e cristiani a sud e sull'altopiano. Geograficamente, l’Eritrea è un punto d’incontro tra frontiere, essendo situata tra il Mar Rosso e il fronte arabo della penisola, confinando con la valle sudanese del Nilo ed estendendosi in parte sugli altopiani del Nord Etiopia. La contiguità con queste aree ha avuto ed ha tuttora una forte influenza sulle sorti del Paese, che infatti è un crogiuolo di culture e contaminazioni religiose. La scuola shaafita (il madhhab fondato dal palestinese al-Shafi’i) fu introdotta in Eritrea, per lo più da pellegrini yemeniti, prima che nelle altre regioni. La scuola malikita (il madhhab ispirato all’opera di Anas ibn Malik, rappresentante dei dotti di Medina), dominante nel Sudan pre-turco, piantò le sue radici nelle pianure occidentali, mentre la scuola hanafita (il madhhad che si rifà alla figura di Abu Hanifa al-Numan), introdotta ufficialmente dagli Ottomani, prese piede nelle pianure orientali e nell’altopiano del Nord. L’Islam interessò la regione eritrea fin dalla sua diffusione in Hijaz nel secolo VII, quando alcuni arabi del califfato omayyade occuparono le isole Dahlak fuori dalla costa di Massaua, creando una delle prime realtà sotto influenza islamica dell’Africa orientale. Nei secoli XII e XIII l’arcipelago delle Dahlak divenne la sede di un emirato indipendente guidato da sultani che si occupavano di traffici lucrativi con Egitto, India, Etiopia e Yemen. L’acme dell’islamismo nel Corno d’Africa e in Eritrea si raggiunse a partire dal secolo XV, con l’esperienza del sultanato di Adal e la jihad del già citato “mancino” Ahmad bin Ibrahim al-Ghazi. Dal 1557 al 1865 furono gli Ottomani ad occupare Massaua e a realizzare nella regione diverse moschee, tombe e santuari, imponendo la scuola hanafita come rito legale e ufficiale. Ancora più importante per lo sviluppo dell’islamismo in regione furono gli avvenimenti del secolo XIX, quando partì un’ondata di rinnovamento e riforma religiosa in tutto il mondo islamico, con l’espansione dell’imperialismo egiziano e la diffusione dell’Islam in tutto il Nord-est africano. La realtà islamica eritrea si rafforzò col declino del potere centrale etiope nell’Era dei Principi e fu attraversata tra il secolo XVIII e XIX dal cosiddetto revivalismo islamico, una serie di movimenti 128 Fonti occidentali rivelano che in Etiopia, come in Kenya e Somalia, le reti terroristiche sfruttano il sistema informale hawala per riciclare denaro sporco ed effettuare transazioni anonime. che nacquero come risposta all’occidentalizzazione del mondo mussulmano e al conseguente indebolimento dell’impero turco. In Eritrea come in Etiopia furono le confraternite sufi a rivitalizzare la vita religiosa e politica, attraverso gli ordini della Qadiriyya e della Shadhiliyya. I sufi s’impegnarono a riformare l’Islam coinvolgendo nel loro progetto anche i non-mussulmani e i settori sociali meno rappresentati ed economicamente più arretrati. Un nuovo flusso di mussulmani si diresse verso l’Eritrea durante il regno etiope dell’Imperatore Giovanni IV, devoto cristiano tigrino, che espulse i mussulmani tigrini dalle loro case costringendoli all’emigrazione. Ma fu il colonialismo italiano a plasmare e condizionare in modo rilevante la storia dell’islam nella regione e a raggruppare le diverse culture in un’unica area. Sotto il governo italiani, i mussulmani divennero circa il 60% della popolazione, occupando quasi 4/5 di territorio (soprattutto in pianura), mentre i cristiani di lingua tigrina arrivarono a costituire il 40% degli abitanti stanziati esclusivamente in altopiano, insieme con piccoli gruppi convertiti all’islamismo, noti sotto il nome di giaberti. Queste due entità – cristiano copta da una parte, mussulmana “eterogenea” dall’altra- restarono divise in forme non conflittuali per diverso tempo. Nel primo periodo coloniale, invero dall’occupazione di Massaua nel 1885, l’Italia fu attenta a rispettare i costumi e le tradizioni religiose locali, assumendo un atteggiamento manifestamente neutrale; tuttavia col passare del tempo gli italiani concessero sovvenzioni alle moschee, finanziarono i leader delle comunità mussulmane, lasciando agli stessi piena autorità in campo giuridico e consuetudinario. In particolare, furono i mussulmani di Massaua a godere dei benefici maggiori, perché considerati come la comunità più civile, evoluta e democratica tra le società della colonia. L’azione italiana si distinse sostanzialmente in tre fasi: la prima caratterizzata da una strategia di conquista, dalle politiche mussulmane del Governatore Martini129 e dalla risposta alla minaccia mahdista130; la seconda comprese la conquista della Libia e i primi studi approfonditi sul mondo islamico; l’ultima fu la fase fascista che vide l’Italia teorizzare, in un’ottica antifrancese e antinglese, le virtù del “potere mussulmano” al fine di fomentare l’instabilità regionale e conquistare arabi e mussulmani agli obiettivi imperialistici mussoliniani. L’Italia provò a stimolare una forte coscienza eritreo-mussulmana che funzionasse da riferimento centrale per la politica imperiale del regime nella regione. In tal senso, s’inserì la nomina di alAzhar (al Mukhtar Ahmad Umar) come Gran Mufti eritreo e quindi come faro della comunità coloniale mussulmana. Sotto l’amministrazione militare britannica, l’Islam eritreo visse uno dei suoi momenti più fecondi: si moltiplicarono i centri religiosi islamici ed aumentò il numero stesso dei fedeli mussulmani (fino a superare il mezzo milione). Nel dicembre 1946, a Keren, nacque la “Lega indipendentista mussulmana” (al-rabita al-islmiyya al-iritriyya), che si ripropose apertamente di creare una nuova grande identità mussulmana eritrea attorno ad uno Stato libero e di stampo confessionale. Dello stesso avviso fu Sheikh Ibrahim AlMukhtar, già nominato Gran Mufti dagli italiani, che s’impegnò in prima persona nella causa indipendentista eritrea e nella resistenza al dominio etiope; nel periodo dell’ “Amministrazione Militare Britannica” (Bma) si fece promotore della riforma dei tribunali islamici e delle procedure 129 Il Martini si preoccupò in particolar modo di portare a Keren, per le più varie ragioni, un rappresentante della discendenza del Profeta, sostituendo il cadi Daud Mobammed con Mobammed Hascem el-Morgani, al fine di controbilanciare l’influenza sulle popolazioni musulmane del filo inglese Said Alì Morgani. Martini vietò anche la presenza in Eritrea di attività missionarie cristiane. 130 Era il mahdismo anticoloniale legato alla figura del sudanese Mohammed Ahmed Mahdi che lanciò la sfida dello stato teocratico islamico, contro il potere egiziano ed inglese. giudiziarie in tutto il territorio. Tra il 1941 e il 1952 vennero aperti più di una dozzina d’istituti religiosi islamici, in particolare ad Asmara, Massaua, Hirgigo, Keren, Mendefera, Aqurdat e negli altri villaggi. Fiorirono in quel periodo associazioni e istituzione islamiche come il “Consiglio Supremo Islamico” (al-Majlis al-islami al-ali), l’ “Associazione dei giovani mussulmani” e il “Fronte degli Ulama” (Jabhat al-ulama), tutti fondati nel 1946-1947. L’Amministrazione britannica istituì l’arabo come lingua ufficiale alla stessa stregua del tigrino e come materia d’istruzione. Comparvero i primi articoli sulla storia e la religione islamica, sull’emigrazione e il pellegrinaggio. Questo contribuì, da un lato, ad amalgamare una realtà mussulmana diversificata e frammentata e a rafforzare l’identità nazionale; dall’altro, a produrre i primi scontri tra cristiani e mussulmani che si verificarono, infatti, nel 1949 e nel 1950. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò il 2 dicembre 1950 una risoluzione che fece dell’Eritrea un’unità autonoma sotto la sovranità della corona etiopica. Conseguentemente, dal 1952 al 1962, la presenza islamica in Eritrea subì un vistoso arretramento: gli Etiopi vietarono la propaganda islamica e nel 1954 arrestarono gli editori del giornale «Sawt al-Rabita». Un anno dopo, Ibrahim Sultan, uno dei fondatori della Lega Musulmana e leader del Fronte Democratico Eritreo, fu accusato di diffamazione ai danni di un funzionario sudanese e processato. Nel 1957 l’arabo e il tigrino furono sostituiti dall’amarico come lingua ufficiale, cessarono i finanziamenti alle moschee e iniziarono discriminazioni in campo educativo e religioso. L’Eritrea subì un’onta terribile, che s’inserì in un quadro di forte cambiamento in tutto il nord-est africano e in Medio Oriente131. In questo contesto, esuli eritrei diedero vita al “Movimento di Liberazione Eritreo” (Elm), nato nell’Aprile del 1958 a Port Sudan, e al “Fronte di Liberazione Eritreo” (Elf) che nacque al Cairo nel luglio 1960132. La lotta eritrea, in quella fase, fu rappresentata dalla figura di Uthman Salih Sabbi che aderì all’Elf alla fine del 1961 e lavorò strenuamente per la liberazione eritrea in un quadro federale laico e panarabo. Hailé Selassié, per tutta risposta, abrogò l’accordo federale e annesse coartatamente l’Eritrea all’Etiopia; nel 1964 nominò Asrate Ras Kassa come endarase (rappresentante dell’imperatore) nella provincia appena annessa. Lo status giuridico dei tribunali islamici eritrei venne abrogato, i tribunali furono ribattezzati come qadi councils e al centro dei sigilli ufficiali venne inserita una croce. Con la rivoluzione etiope del 1974 e l’istituzione del Derg sotto Menghistu, il panorama politico per i mussulmani eritrei peggiorò: il “Fronte di Liberazione del Popolo Eritreo” (Eplf) fu il primo obiettivo della repressione del nuovo regime. I leader della Khatmiyya ripararono a Kassala, nel 1975, altri scelsero il Sudan sottoponendosi all’influenza wahhabita e salafita. Nel 1982 nacquero il “Fronte Islamico Nazionale per la Liberazione dell’Eritrea” (Jabhat at-tahrir al-wataniyya al-islamiyya al-iritriyya) e L’ “Avanguardia Islamica” (ar-Ruwwad al-muslimin). Nel 1988 i due movimenti si fusero nel “Movimento Eritreo della Jihad Islamica” (Harakat al-jihad alislami al-iritri), che nel 2003 prese il nome di “Movimento per la Riforma Islamica dell’Eritrea”. Negli stessi anni, venne fondato il “Movimento Islamico di Salvezza dell’Eritrea” (Mise), che rivendicava l’abbattimento del regime eritreo con l’instaurazione di un califfato mussulmano in tutto il Corno d’Africa. Allo stesso tempo, la guida della lotta secessionista eritrea passò dal “Fronte di Liberazione Eritreo al Fronte Popolare di Liberazione Eritreo” di Afewerki, fautore al tempo di un nazionalismo 131 La rivoluzione di Nasser nel 1952, l’indipendenza del Sudan nel gennaio del 1956 e l’onda vibrante del panarabismo che dilagò in tutto il Medio Oriente, furono gli esempi più emblematici di tale cambiamento. 132 In questo senso, la fondazione del “Fronte di Liberazione Nazionale” algerino il 1 novembre 1954 rappresentò un modello importante di riferimento politico per tutti i movimenti indipendentisti africani e non. ostinato e irriducibile, che chiuse ogni apertura all’ipotesi di una federazione con l’Etiopia. Per dieci anni le forze secessioniste eritree e tigrine restarono sulla difensiva. Passarono all’attacco solo dopo le terribili grandi carestie del 1984, 1987 e 1989, che misero in ginocchio il regime del Derg e tutto il paese etiope. Con l’appoggio di Usa ed Arabia Saudita, il Fple, allora stretto alleato del “Fronte Tigrino Popolare di Liberazione” di Meles Zenawi, riuscì nel 1991 a conquistare Asmara e a prendere il controllo dell’Eritrea. Dal 1993, anno del referendum e dell’ufficializzazione dell’indipendenza, in poi l’Eritrea riguadagnò l’autonomia statuale e per i mussulmani si aprì un nuovo scenario, fatto di lenti ma progressivi passi in avanti nel radicamento della fede islamica. Tornò in auge la figura del Mufti (dal 1992, Shaykh al-Amin Uthman al-Amin, ad Asmara) e furono restaurate le corti della sharia, i consigli waqf, i comitati haij and umra, vennero riaperte le scuole e gli istituti religiosi. L’Arabia Saudita mise a disposizione finanziamenti e supporto logistico per la costruzione di moschee in tutto il paese (ad Asmara sono trenta), ma l’influenza wahabita arrivò anche dal Sudan. Il tigrino e l’arabo furono considerati entrambi lingue di lavoro dello Stato; uno Stato che, almeno sul piano ufficiale, si professò laico e promise di non intervenire nelle scelte religiose individuali. Il 12 maggio del 1998, come sopra accennato, l’esercito eritreo sferrò una massiccia offensiva, occupando le località di Badrue e Shiraro, in una zona amministrata dall’Etiopia ma “dentro il confine coloniale eritreo”, secondo Afewerki. La guerra dilagò nel settore centrale all’area di Zalambessa e nel settore orientale a quella di Bure. Nel febbraio 1999, con l’offensiva su larga scala denominata Sunset, l’esercito eritreo fu costretto a ritirarsi dalla piana di Badrue. L’Etiopia sferrò nel maggio 2000 una nuova poderosa offensiva su tutta la linea del fronte, ed occupò Barentu e Tesseney, sul fronte occidentale, e Tsorona e Sanafé sul fronte centrale. Il 18 giugno del 2000, dopo che l’Onu aveva decretato l’embargo sulle armi per entrambi i paesi, l’Eritrea accettò di sottoscrivere il cessate il fuoco che mise fine a quei combattimenti ma non alle tensioni tra i due paesi. Qualche anno prima, il 5 dicembre del 1994, l’Eritrea aveva rotto le relazioni diplomatiche col Sudan. L’accusa che Afewerki aveva mosso al Sudan, oltre quella centrata inizialmente su una pretestuosa disputa confinaria, fu il sostegno offerto dal Fronte Nazionale Islamico sudanese alla guerriglia islamica eritrea. I Sudanesi, dal loro punto di vista, accusarono gli eritrei di sostenere la guerriglia antisudanese concentrata nelle regioni orientali. Di lì a poco, Asmara ospitò (giugno 1995) un congresso dei leader delle opposizioni sudanesi, tra cui anche ribelli darfuriani, ai quali fornì l’appoggio allo scopo dichiarato di rovesciare il governo centrale di Khartoum. Le relazioni diplomatiche tra i due Stati, in seguito, si riallacciarono, malgrado il governo eritreo non avesse cessato di dare man forte alle forze ostili a Khartoum, come i guerriglieri dell’Eastern Front. Sul fronte squisitamente interno, la minaccia islamica in Eritrea non sembra un problema all’ordine del giorno. Il già citato Harakat al-Jihad al-Islami al-Eritrea, il “Movimento Eritreo della Jihad Islamica” (noto anche come “Movimento Abu Sihel”, “Jihad Islamica Eritrea”, “Movimento Eritreo per la Riforma Islamica”, Harakat al Khalas al Islami, “Movimento Islamico di Salvezza”) nasce da fusioni ed alleanze eterogenee, tanto pacifiche quanto dedite all’organizzazione della lotta armata. Pur puntando all’Eritrea come principale terreno di lotta, ha basi in Etiopia e in soprattutto in Sudan133. È difficile capire quanto consistente e radicato sia questo Movimento, che abbraccia dissidenti politici e gruppi non necessariamente votati al radicalismo islamico, e che risulta, però, alquanto disomogeneo e disorganizzato. Sembra preferire, piuttosto, la via dell’opposizione politica scevra da attacchi terroristici di una certa entità: l’obiettivo di molti resta quello di garantire alla popolazione mussulmana una maggiore 133 Il Movimento è guidato da Shaikh Khalil Mohammed Amer. rappresentanza politica nel Paese, piuttosto che condurre una guerra santa contro i “crociati cristiani” o l’Occidente. Tuttavia, gli Stati Uniti lo hanno inserito nella lista dei gruppi affiliati ad al-Qaeda, ma è certo che solo gli esponenti più radicali hanno qualche legame con quello che resta dell’organizzazione del defunto Osama bin Laden. Il “Movimento Eritreo della Jihad Islamica” ha dichiarato di essere responsabile di una serie di attacchi avvenuti nel corso del 2003, ovvero imboscate alle forze armate eritree, costate la vita a quarantasei militari e lo scoppio di una bomba in un hotel della cittadina di Tesseney, in prossimità del confine con il Sudan. L’Eritrea fa inoltre parte, insieme con Kenya, Somalia, Sudan, Gibuti, Etiopia e lo Yemen, della cosiddetta coalizione dei volenterosi (la coalition of willingness134) a guida americana nella lotta contro il terrorismo. Ciò sembra non bastare al governo eritreo che lamenta una scarsa attenzione per la sua causa a vantaggio dell’Etiopia, i cui rapporti con gli Stati Uniti appaiono più stretti e fidati. Il fronte somalo sembra essere la cartina di tornasole di questo sistema di alleanze. A livello logistico l’Eritrea è stata scalzata da Gibuti, dove gli Stati Uniti hanno costituito, a Camp Lemonier, la propria base per la gestione delle operazioni della Combined Joint Task Force – Horn of Africa. Un elemento che gioca a favore dell’opposizione interna all’Eritrea e che indebolisce indubbiamente la politica sulla sicurezza di Afewerki sempre centrata sulla necessità di stanare alQaeda e di sostenere gli alleati occidentali. 3. Gli Afar o Dàncali-Dànachili135 sono un gruppo etnico nomade del Corno d’Africa, composto da circa 150.000 individui, presente principalmente nel deserto della Dancalia, nella regione di Afar (istituita nel 1995) in Etiopia (circa il 2% della popolazione totale), nella punta meridionale dell’Eritrea e a Gibuti (stanziati al Nord, sono 1/3 della popolazione). Gli Afar sostengono di essere discendenti del figlio di Noè e praticano l’Islam, cui si convertirono attorno al secolo X sotto la pressione dei mercanti arabi. Gli Afar sono organizzati in clan familiari e in classi: gli Asaemara (“rossi”), che sono i nobili più potenti e vivono lungo la costa e gli Adeimada (“bianchi”), che sono lavoratori e vivono sulle montagne Mabla. Anche se i mussulmani hanno il permesso di sposare quattro donni, i matrimoni Afar sono solitamente monogami. Le ragazze possono sposarsi già all’età di dieci anni; i matrimoni si stringono solitamente tra cugini di primo grado, in particolare tra un uomo e la figlia della sorella di suo padre. La divisione della comunità Afar in più aree e regioni ha causato, negli anni, non pochi conflitti e tensioni all’interno del Corno d’Africa. Come ha sottolineato Yasin Mohammed Yassin 136, il 134 La coalizione dei volenterosi è una formula politica atta a descrivere quel sistema di alleanze costruito prevalentemente dagli Usa al fine di intervenire militarmente (e per fini umanitari) in quegli scenari che non prevedono un intervento di peacekeeping dell’Onu, su mandato del Consiglio di Sicurezza. Questa formula è stata usata probabilmente da Clinton, per la prima volta, nel 1994 circa una possibile operazione militare contro la Corea del Nord, ma è con Bush e l’intervento in Iraq che viene usata con forza, riuscendo a coinvolgere dai 46 ai 49 Paesi. Quest’ultima coalizione si può considerare sciolta dai primi di gennaio del 2010, quando il comando delle operazioni in Iraq è passato alla Multi National Force Iraq (Mnf–I). 135 L’accezione di Dàncali, pur in voga mediaticamente, è considerata offensiva dagli Afar. 136 Y. M. Yassin, Political history of the Afar in Ethiopia and Eritrea, in «Afrika Spectrum» n.42, Giga Institute of rapimento di cinque europei e una dozzina di etiopi nella depressione della Dancalia nel 2007 ha attirato i media internazionali su un problema, quella dell’Afar Land, rimasto per lungo tempi ai margini della cronaca mondiale e che nasce molto prima di quest’episodio137. La regione del Corno e le aree in cui risiedono gli Afar rappresentano un punto di snodo fondamentale per i traffici commerciali (e petroliferi) tra Africa e Medio Oriente. Nello specifico, il fatto che i pastori Afar, tutti di fede islamica, vivano esattamente sulle coste dell’Africa Orientale alimenta non poche paure circa il possibile inserimento nell’area dei gruppi del terrorismo islamico138, stante anche la povertà estrema e la frustrazione che caratterizzano questa comunità. Anche se gli Afar non sono facilmente suscettibili di idee estreme promosse da organizzazioni come AlQaeda, vi è la possibilità, se l’emarginazione e la dominazione persistono e le situazioni socioeconomiche continuano a peggiorare, che le persone diventeranno così disperate che gli elementi dell’estremismo religioso otterranno un certo sostegno tra gli Afar 139. La terra abitata dagli Afar è nota come “culla delle origini umane” e per l’abbondanza di risorse naturali. Gli arabi lavorano da secoli per esercitare un’influenza dominante nella zona, gli occidentali tengono alla sicurezza della regione per il passaggio del petrolio attraverso Bab-elMandeb, gli israeliani puntano strategicamente all’area come base navale, gli Usa monitorano il territorio per la prevenzione del rischio terroristico. Dopo la Seconda guerra mondiale, le terre degli Afar furono suddivise in diversi governatorati generali; nel 1961 l’Afar Land fu divisa nei quattro governatorati generali di Hararge, Shoa, Wallo e Tigray. Nel 1961 e nel 1963 cinquantacinque capi tribù trovarono un accordo circa la formazione di un’unità autonoma gestita dagli Afar, con la promozione di una petizione da presentare all’Imperatore etiope, per il tramite dello sceicco Yasin Mohamoda. Ma circa un anno dopo, i dignitari, gli anziani, i capi tribali e leader religiosi convenuti ad Addis Abeba non diedero seguito al suddetto proposito. Nel 1965 alcuni studenti Afar si organizzarono nella Afar Students Association (Asa) che coinvolse decine di giovanissimi e contribuì alla nascita dell’ Afar Koborih Angoyya (Aka) al Cairo il 2 novembre 1972. Il movimento provò a coinvolgere nella sua azione, con scarsi risultati, sia il sultanato di Aussa (Awsa) che il generale Ahmed Suleiman e Siad Barre in Somalia. Nel novembre 1974, mentre il Derg uccideva sessantuno ministri imperiali e diversi funzionari militari, il sultanato di Aussa mobilitò i giovani Afar riformisti contro la nuova riforma agraria. Il giorno dopo l’esilio del Sultano Ali-Mirah Hanfere, il 3 giugno 1975, suo figlio contribuì alla fondazione del “Fronte di Liberazione Afar” (Alf) che si scontrò violentemente col Derg. Il regime uccise migliaia di giovani, ragione per la quale un pezzo consistente dell’Alf riparò in Somalia, mentre altri militanti si diedero ad operazioni di guerriglia isolata. Un’ultima battaglia interessò il Derg e gli Afar nel 1976 quando le forze governative guidate da Habib Mohamed Yayyo lanciarono un’operazione militare contro gli Afar in un luogo chiamato Do’oroita. Più tardi, il Derg si convinse circa la necessità di trattare con l’Aka -che nel frattempo si African Affairs, Amburgo, 2008. 137 Il movimento Qfar Ugugumo già tre decenni fa si era sollevato in armi contro l’intrusione del “Fronte di Liberazione del Popolo Tigray” (Tplf) nelle terre degli Afar. 138 Si teme la ripetizione di quanto avvenuto con al-Itihaad-al-Islamiya (Aiai), l’ala somalo-orientale di al-Qaeda, che è cresciuta negli ultimi anni proprio attirando a sé i settori più disperati e marginali della popolazione somala. 139 Y.M.Yassin, Ivi, p. 2. era trasformato in “Movimento Nazionale di Liberazione Afar” (Anlm)- e di concedere agli Afar l’agognata autonomia politica e unificazione. L’Anlm riuscì ad organizzare una Conferenza “panafarica” nella città di Gewane, nel periodo dell’8-15 aprile 1977, nella quale si riunirono più di cinquecento persone in rappresentanza di cinque regioni. La risoluzione della conferenza condannò la politica amministrativa dell’Etiopia (paese bollato come “prigione di nazioni e nazionalità”) e le tendenze separatiste e nazionalisticoetiopiche di alcuni settori Afar. Il Derg non poteva offrire una soluzione immediata al problema e quindi promise d’istituire un organo responsabile del governo che avrebbe studiato dettagliatamente una soluzione per la “nazione Afar”: nacque così l’ “Istituto per lo Studio delle Nazionalità Etiopi”, le cui ricerche e raccomandazioni furono tuttavia sistematicamente ignorate dal Derg. Nel 1988 fu istituita un’amministrazione autonoma Afar nella regione di Assab, che comprendeva circa il 60% dell’Afar Land. Molti salutarono l’iniziativa come un importante passo in avanti per la causa Afar, per altri si trattava di un tentativo disperato da parte del regime di concentrare i ribelli in una sola zona al fine di allontanarli dalle regioni autonome di Eritrea. Con la fine del regime del Derg nel maggio 1991, la regione autonoma Assab venne sciolta e il Fronte di Liberazione Afar col figlio del sultano, Ali Mirah, riconquistarono la scena politica. I leader dell’Alf parteciparono alla Conferenza di Pace di Londra (27-28 maggio 1991), che aveva lo scopo di mediare la fine della guerra civile etiope, insieme con l’ultimo primo ministro del regime etiope, Tesfaye Dinka Yadessa140, Isaias Afewerki (Eplf- Eritrean People’s Liberation Front), Zenawi (Tplf- Tigray People’s Liberation Front) e Lencho Letta del “Fronte di Liberazione Oromo”, e poi alla Conferenza nazionale di Addis Abeba del 1-5 luglio 1991, in qualità di alleati dell’Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front-Eprdf. L’8 dicembre 1991 il Consiglio regionale Afar elesse Habib Ali Mirah, figlio del Sultano, come presidente di regione 141, col beneplacito dell’Arabia Saudita (dove aveva trovato riparo la famiglia di Ali Mirah nei primi anni del Derg) e del Tigray People’s Liberation Front (Tplf, filo albanese), la cui ala di sinistra si era spesa più di tutti per la costituzione di un’area sotto l’effettivo controllo degli Afar. Tuttavia, le tensioni tra Alf e Tplf, già iniziate venti anni prima 142, riesplosero rapidamente. Il Tplf non nascondeva, infatti, di voler creare una regione Afar sotto la sua giurisdizione, per il tramite di un governo posticcio che avrebbe modellato a sua immagine e somiglianza. Nel 1994 il Tplf riuscì a disintegrare effettivamente l’Alf e addirittura a dividere i due figli di Ali Mirah, Hanfare e Omar che formarono due partiti diversi ed opposti l’uno all’altro. Nell’agosto del 1995 Hanfare diventò presidente del nuovo governo regionale, ma al tempo stesso l’Organizzazione democratico popolare Afar (Apdo143), un fantoccio in mano al Tplf, ottenne la 140 Tesfaye Dinka Yadessa, di etnia Oromo, fu Ministro degli Affari Esteri e primo ministro di Etiopia, nonché membro di spicco del regime di Menghistu Haile Mariam. Era considerato come uno dei membri più moderati del regime di Menghistu, stante anche il suo ruolo di mediazione tra il Derg, da un lato, e il “Fronte di Liberazione Popolare Eritreo” (Eplf) e il “Fronte di Liberazione Popolare del Tigray” (Tplf), dall’altro. 141 La regione non riuniva ancora tutti gli Afar in una sola area, escludendo, tra le altre, le terre eritree in cui Afar rivendicavano un insediamento storico. 142 L’Alf lamentava l’intenzione del Tplf di annettere l’Afar Land e di farne una provincia auto amministrata in una regione dominata dai tigrini. Per questo ed altri motivi, Afar e Tplf si scontrarono militarmente nel 1978 a Berahle (quindici morti tra gli Afar) nella battaglia noto come “mercoledì di guerra”. Il Tplf rinunciò ai suoi propositi di disintegrazione dell’Alf solo verso la fine degli anni Ottanta e l’inizio del 1990, non disponendo di un interlocutore altrettanto valido nel campo Afar e vivendo vieppiù un periodo di sbandamento, stante il crollo mondiale del marxismolenismo cui si rifaceva. 143 maggioranza dei seggi. Un anno dopo il consiglio regionale licenziò Hanfare e lo sostituì con un ex miliziano del Tplf, Ismail Ali Siro, giudicato surrettiziamente più democratico e competente del suo predecessore. Contestualmente i tigrini tentarono, da un lato, un negoziato con gli Afar del nord 144 e, dall’altro, un’operazione offensiva nei confronti dell’organizzazione Ugugumo145 (rivoluzione). La maggior parte dell’Alf del nord (ribattezzata Afar National Liberation Front – Anlf) prese parte al governo regionale e alla coalizione responsabile dell’ Afar National Democratic Movement (Andm). Sul fronte Ugugumo, invece, il Tplf decise di imprigionare il leader Muhyafin Miftha, arrestato prima a Gibuti, poi estradato in Etiopia. Successivamente, in cambio del cessate il fuoco, fu adottato un atteggiamento più cauto nei confronti dell’Ugugumo che, non essendo stato completamente distrutto, è tuttora libero d’agire nelle terre Afar e, in generale, in tutto il Corno d’Africa. In realtà, la storia di Ugugumo e delle sue appendici è complessa e in continua evoluzione. Noto anche come Arduf (Afar Revolutionary Democratic Union Front), Ugugumo fu rifondato nel 1993 come una coalizione di tre organizzazioni Afar: l’Arduu (Afar Revolutionary Democratic Unity Union), fondata nel 1991 e guidata da Mohamuoda Ahmed Gaas (o Gaaz), l’Afar Ummatah Demokrasiyyoh Focca (Audf) e l’Afar Revolutionary Forces (Arf). Gaas fu eletto segretario generale nel 1995, ma rifiutò la carica a vantaggio di Miftha. Nel marzo 1995, Arduf fu coinvolta nel rapimento di turisti italiani nella Afar Land, con conseguente campagna militare etiope contro il gruppo, coordinata con il governo eritreo. Gli scontri avvennero in località Dallol, al margine del grande Piano del Sale nella Dancalia settentrionale, e coinvolsero anche membri dell’Apdo, bollati come traditori da Ugugumo e colpiti direttamente nelle loro case e proprietà. Nel giro di poche settimane venne bloccato tutto il traffico sulle rotte del commercio carovaniero, con conseguente scarsità di cibo in tutta l’area. Nel 1997 ripartirono i tentativi politici di riconciliazione, con la creazione di una Conferenza Afar, ma andarono tutti a vuoto. Il 5 giugno 1998, con l’inizio della guerra tra Eritrea e Etiopia e l’attacco della città di Alitena146 da parte dell’Eritrea, Mohamuoda Gaas decise di rilasciare una dichiarazione unilaterale di cessate il fuoco con le forze governative. L’Arduf si riconciliò col governo etiope per ridurre al minimo le vittime civili nella regione e condannò gli attacchi del governo eritreo. Nel luglio 2003 Arduf entrò a far parte della neonata coalizione Uedf 147, in opposizione alla L’Apdo era un’organizzazione di Afar creata dai tigrini apropria immagine e somiglianza tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta per contrastare la resistenza dell’Alf. Prima ancora, portava il nome di Tigray Afar Democratic Organization (Tado): i suoi militanti erano giovanissimi in cerca d’istruzione o ragazze in fuga dalle proprie famiglie perché contrarie ai matrimoni combinati. La Tado si trasformò in Apdo non per ragioni di rinnovamento, ma per eliminare il richiamo compromettente al Tigray dalla sigla. 144 L’Alf del Nord fu una grande organizzazione armata, più radicale dell’omonima frangia meridionale, creata nel 1979 dallo sceicco Ahmed Hussein Mussa, ex funzionario Anlm uscito polemicamente da quest’ultima per il suo avvicinamento al Derg nel 1976. Si trasformò qualche anno dopo in Anlf-Fronte di Liberazione Nazionale Afar. Nel 1983 Mussa, Salih Abdilla, Ahmed Ibrahim e Villi Ahmed Mohammed tennero una conferenza in Yemen per lanciare la proposta dell’unificazione degli Afar in Etiopia e la creazione di un solo centro operativo. Negli anni successivi crearono un fronte comune anti-Derg con l’Eplf. 145 Nato in Somalia e in seno all’Anlm negli anni Settanta, il fronte rivoluzionario Ugugumo (Rivoluzione) fu rifondato nel 1981 dai giovani Afar che abbandonarono il “Fronte di Liberazione eritreo” e organizzarono una milizia in Etiopia, col sostegno del Derg, per combattere i tigrini e le forze dell’Eplf. 146 Nella città di Alitena vive la gente Irob, un’etnia di agricoltori cristiani, strettamente correlati agli Afar linguisticamente. 147 L’ Uedf (United Ethiopian Democratic Forces) è una coalizione di diversi partiti etiopi d’opposizione, coalizione di governo Eprdf (Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope). Il 20 settembre 2003, in un comunicato risoluto e violento, invitarono i governi eritreo ed etiope a non inviare funzionari di stato o anche semplici cittadini nella regione Afar per “compiere atti illegali e di brigantaggio contro il nostro popolo”. E aggiunsero: Lasciate che il mondo intero sappia che Arduf ribadisce la sua posizione come ha fatto nel 1990, 1991, 1993 e 2000 , che non è solo contro l’atto illegale di dividere il nostro popolo Afar e la delimitazione del nostro suolo sotto forma di demarcazione tra Etiopia ed Eritrea, ma è pronto a rendere inefficace qualsiasi altro esercizio di demarcazione. Nel 2006 Mohamoda Gaas abbandonò definitivamente la causa dell’Arduf (ma era già in rotta con l’organizzazione da circa dieci anni) ed entrò nel governo divenendo viceministro del turismo. Ali Salih Hudale, altro quadro storico degli Ugugumo, aveva fondato un anno prima un partito moderato dal nome di Anrdf (Afar National Revolutionary Democratic Front). Un’altra scissione dell’Arduf fu l’Anmdg (Afar National Movement for Democracy and Good Governance) di Rashid Salih, Mohammed Thayb e Mohammed Osman. L’Anmdg tentò di collaborare con l’Eprdf, ma il fallimento di quest’iniziativa ne compromise l’esistenza e ne causò lo scioglimento. Sul versante eritreo, gli Afar si opposero ai confini coloniali disegnati dall’Italia, che apparivano loro come un recinto artificiale tra fratelli, al contrario dei leader tigrini dell’Eritrea che rivendicavano di avere poco in comune con i loro “parenti” dall’altra parte del fiume Marab. Per questo motivo, nel marzo 1949, alla conferenza delle Nazioni Unite riunita a New York, Fitawrari Yasin Mohamoda votò per la federazione dell’Eritrea con l’Etiopia. Tuttavia, gli Afar non furono del tutto estranei alla lotta d’indipendenza dell’Eritrea: a metà degli anni sessanta si unirono al “Fronte di Liberazione Eritreo” (Elf), istituito dagli studenti Beni Amer (Amir) 148 con il sostegno delle famiglie Mirgani di Kassala. Furono, in particolar modo, i mussulmani Afar della costa orientale ad abbracciare la causa di Uthman Salih Sabi, nonostante l’Elf mirasse apertamente a controllare la linea costiera popolata dagli Afar. Di conseguenza, nel 1967 i combattenti Afar dell’Elf chiesero di operare solo all’interno delle loro zone storiche per fermare gli abusi tigrini e le vessazioni ai danni della popolazione dancalica. Questa situazione portò allo scoppio di un conflitto armato, tutto interno all’Elf, tra gli Afar e gli abitanti delle pianure tigrine, nella quale questi ultimi furono sconfitti e quindi emarginati fino agli inizi degli anni Settanta. Nel frattempo, Salih Osman Sabe e Hiruy Tadla Bayru formarono un nuovo movimento chiamato “Fronte di Liberazione del Popolo” (Plf) che nei primi anni Settanta si trasformò in “Fronte Popolare di Liberazione Eritreo” (Eplf). Il giovane Eplf, dominato dai tigrini cristiani dell’altopiano, approfittò della disputa tra Afar e Elf per mobilitare le proprie forze in Dancalia. La composto dalle organizzazioni: Oromo National Congress, Ethiopian Social Democratic Federal Party, Southern Ethiopia People’s Democratic Coalition, All-Amhara People’s Organization and the Ethiopian Democratic Unity Party. Ne fanno parte anche: Arduf, All-Ethiopia Socialist Movement (Meison), Ethiopian Democratic Union-Tehadiso, Ethiopian National United Front, Ethiopian People Federal Democratic Unity Party (Hibrehizb), Ethiopian People’s Revolutionary Party, Gambela People’s United Democratic Front, Oromo People’s Liberation Organization (OploIbso) e Tigrean Alliance for Democracy. Collabora saltuariamente con la coalizione d’opposizione più forte (Cud – “Coalizione per l’unità e la democrazia”), ma persegue una politica sostanzialmente autonoma. Ha partecipato alle elezioni generali del 15 maggio 2005, ottenendo 52 seggi nel Consiglio dei Rappresentanti del Popolo (Cfr). Alle elezioni regionali svoltesi nell’agosto dello stesso anno, ha ottenuto 105 seggi su 537 nell’assemblea della regione Oromia, un seggio in Harari e 37 dei 348 seggi nella Snnpr (Southern Nations, Nationalities, and Peoples Region). Nel luglio 2008, l’Uedf, insieme con Oromo Federalist Democratic Movement, Somali Democratric Alliance Forces e Union of Tigrians for Democracy and Sovereignty (anche conosciuta come Arena), ha fondato il Ethiopian Democratic Unity Front o semplicemente Medrek, una nuova coalizione di partiti d’opposizione. 148 Beni-Amer (Amir) è un gruppo misto etnico formatosi nel secolo XIV con l’unione delle genti Benja, tigrine e Biher-tigrine. Occupano i confini tra la valle del Barka in Eritrea e la zona di Kassala nel Sudan orientale. massiccia affluenza di giovani cristiani tigrini nell’Eplf portò nuove divisioni, quindi una scissione e la formazione di una nuova coalizione chiamata Elf-Plf. Nel 1980, gli Afar condussero una nuova battaglia vittoriosa contro L’Elf spingendoli fuori dalla Dancalia una volta per tutte. L’Elf subì un attacco simile prima dal Derg, poi dal Tplf unito all’Eplf, che lo costrinsero a riparare velocemente in Sudan e ad accettare il definitivo declino politico. Ma gli Afar restavano comunque un problema per tutte le organizzazioni eritree, che continuavano a vedere negli Afar una minaccia per la lotta d’indipendenza dall’Etiopia. Si susseguirono per tutta la durata degli anni Ottanta omicidi e repressione a danno dei dancali, ma ciononostante gli Afar riuscirono a difendere la propria regione e a rafforzare nel loro popolo un sentimento di unità, fratellanza e di “orgoglio Afar”. Nel maggio 1991, con la caduta del Derg e la nascita dello Stato eritreo, cambiò drasticamente la situazione. L’Eplf affermò la sua egemonia sulla etnie minoritarie, fino al punto di cambiare i nomi dei villaggi Afar in tigrino. L’Epld, che nel terzo congresso svoltosi ad Asmara nel febbraio 1994 mutò il suo nome in “Fronte Popolare per la Democrazia e la Giustizia” (Pfdj), divise ulteriormente la regione della Dancalia nel quartiere di Zoba Sud e nel Northern Red Sea Zoba, affidando l’autorità amministrativa ai tigrini. Il governo eritreo procedette ad un’assimilazione forzata e sostituì addirittura l’alfabeto latino degli Afar, usato da decenni in tutto il Corno d’Africa, col ge'ez149. Il governo di Asmara condusse un ulteriore attacco militare contro i movimenti politici Afar e contro gli Ugugumo insieme con il Tplf e l’amministrazione di Gibuti. Prima del conflitto EritreaEtiopia, il governo eritreo aprì un ufficio consolare per monitorare la situazione di Ayssata, al tempo capitale della regione di Afar in Etiopia, costringendo i movimenti dancali ad emigrare in Yemen e nella stessa Gibuti. Proprio in Etiopia avevano trovato riparo giovani Afar di Beku’Buye (guidati da Osman Mohammed Derder), Hal-Hal (guidati da Mohammed Hussein), Murayum Sagem (guidati da Sahlu Gumhed Sahlu), Abe (leader Ahmed Humad Igahel). Questi giovani provarono a contattare alcuni funzionari Tplf a Mekele per convincerli a sostenerli nella lotta contro il governo di Asmara. I contatti risultarono vani, fino al 1997 quando il Tplf fornì agli Afar un aiuto militare, logistico, politico e finanziario per combattere l’Eplf. Di conseguenza un coordinamento provvisorio di queste forze, guidato da A.Osman Maer, il 17 ottobre 1998 fondò ad Abala il gruppo politico noto come Red Sea Afar Democratic Organization (Rsado). L’anno successivo aderirono al movimento diversi giovani che studiavano all’Ethiopian Civil Service College, tra cui spiccò uno studente al secondo anno di economia, Ibrahim Harun, che divenne prima vicepresidente del Rsado, poi presidente. Di lì a poco, il Rsado avviò attacchi –sporadici- di guerriglia in diverse località della regione Dancalia dell’Eritrea, anche se dovette rinunciare dopo l’accordo di pace di Algeri del 2000 all’assistenza del governo etiope. Nel 2003, il Rsado è entrato per la prima volta nell’ “Alleanza Democratica Eritrea”, un’associazione ombrello per tutte le opposizione eritree, che nacque a Khartoum il 26 gennaio 1998, chiarendo i propri propositi di autodeterminazione, il diritto alla secessione e la volontà di allargare il fronte di lotta alle organizzazioni radicate in Etiopia. Nel 2009 il Rsado, che nel frattempo ha guadagnato proseliti in Etiopia come in Eritrea ed è accettato in Etiopia come un movimento “federalistico” legittimo (tanto da ottenere una trasmissione radiofonica di mezz’ora per tre giorni alla settimana ad Addis Abeba) si è unito all’Eritrean Salvation Front (Rsf, che definisce l’amministrazione di Afewerki come una delle più grandi prigioni africane) per colpire il governo di Asmara. Rsado, che è una delle tredici opposizioni al Fpd, ha effettuato negli ultimi anni decine di attacchi in diverse città eritree. Nel novembre 2009 ha distrutto un sistema radar militar e ha attaccato un 149 Il ge'ez (gheez o geez) è una lingua semitica, oggi estinta, parlata nell'Impero d'Etiopia fino al secolo XIV. Attualmente è ancora usata come lingua liturgica della Chiesa ortodossa etiopica ed eritrea, dagli etiopi di religione ebraica (falascià) e dalla Chiesa cattolica etiope. Anticamente veniva parlata nella provincia del Tigré. campo militare governativo, in un luogo chiamato Sanafi, al centro di Akale Guzay, uccidendo circa duecentottantacinque soldati e raccogliendo nove fucili d'assalto Kalashnikov, un’arma Rpg e una mitragliatrice pesante. In sostanza, il “caso Afar” resta più che mai aperto. Sebbene non esista un partito che unifichi tutte le varie fazioni dancale e renda le rivendicazioni secessioniste di questo popolo un problema stringente per i governi eritreo e somalo, è altrettanto vero che la frustrazione accumulata negli anni dagli Afar, i metodi terroristici dei suoi gruppi più radicali e la contiguità degli stessi con alcuni settori dell’islamismo fondamentalista yemenita e arabo, rappresentano un rischio in più per la stabilità del Corno d’Africa, già colpito dall’eterna tensione tra Eritrea ed Etiopia e dalla drammatica situazione politica in Somalia. 4. Gli Oromo150 (Il potente, in ge’ez) sono uno dei più importanti gruppi etnici dell’Africa. Si trovano in Etiopia (a sud del Tigray e ai confini con la terra degli Afar), nel nord e nel sud del Kenya (Lamu Island) e in alcune zone isolate della Somalia 151. Sono circa trenta milioni di persone e rappresentano il gruppo etnico più forte in Etiopia, raggiungendo circa il 34,49% della popolazione secondo un censimento del 2007. La loro lingua è la oromo (nota anche come oromiffa, afaan oromoo, galligna o gallinya), una delle lingue cushitiche parlate nell’Africa del nord e in Africa orientale. Gli Oromo sono divisi in circa dodici diversi gruppi etnici, che sono i: Welega, Macha, Tulama, Wollo, Ittu, Ania, Afran Qallo, Nole, Babille, Jarso, Ársi o Arússi, Borana. Questi ultimi (borana significa “genti del mattino”, da boru-aurora) vivono nel sud della regione Oromo e nel nord del Kenya, sono fieri ed orgogliosi guerrieri152 e si considerano l’etnia primogenita, il popolo più antico del gruppo Oromo, non corrotto dalla modernità. Attualmente sono pastori seminomadi che si muovono fra il bacino del Giuba e le terre del Konso, ma sono stimati anche come bravi ingegneri e idraulici. Le religioni degli Oromo sono quelle sunnita (il 44,3% in Oromia), cristiano ortodossa etiope (41,3%) protestante (8,6%), la tradizionale waaq153 (4,2%) ed altre, minoritarie, come i Testimoni di Geova (circa l’1,6%). Per quanto la storia e l’attività politica degli Oromo siano strettamente legate al Corno d’Africa, questa comunità ha buoni rapporti con l’Arabia Saudita, sia per motivi di carattere geografico sia per la presenza, nel regno saudita, dei luoghi sacri dell’Islam 154. Alcuni sceicchi wahhabiti sono perfino riusciti ad imporre, nonostante la forte resistenza degli Arsi, centinaia di matrimoni endogamici e tra cugini all’interno della comunità Oromo, che pur vieta 150 Gli Oromo sono noti anche come Galla; questo termine oggi è in disuso in quanto considerato dispregativo. 151 Vi sono circa duecentomila Oromo anche in Yemen. 152 Un adagio dei Borana recita: “Chi non ha ucciso nessuno non è degno di sposarsi”. 153 Nella religione tradizionale Oromo esiste un dio supremo, detto Waka o Waaq, che crea e regola l'esistenza di ogni essere vivente e non vivente, esiste in ogni cosa, e mantiene l'ordine cosmico. 154 La Mecca (Makkah-la Benedetta), Medina (la Radiosa), e la Moschea di Al-Aqsa di Gerusalemme sono i tre luoghi più importanti per i fedeli mussulmani e si trovano tutti nel Regno saudita. l’unione tra membri dello stesso clan come rischio per la stabilità dei rapporti interpersonali, del tessuto sociale e della gerarchia interna alla stessa comunità. Al tempo stesso, i wahhabiti hanno provato a vietare loro il culto dei santi e, in particolar modo, la venerazione di Shaikh Hussein 155 e il pellegrinaggio (muuda) alla tomba del Santo nella zona di Bale nella regione Oromia. In effetti, gli Oromo sono sempre stati tra i popoli più esposti all’influenza dell’islam e degli islamici presenti nell’area: l'attuale regione del sud-est Oromo era un paese di sette principati islamici, meglio conosciuto in Siria e in Egitto come il “paese di Zeila”. Tra questi figuravano regni come Bali, Sharka, Arababini e Dawaro. L’islam ha inoltre irradiato la città di Harar (con una ricca presenza di Oromo) e, in subordine, il santuario di Sayh Husayn nel Bale. Quando Ahmad ibn al-Ghazi partì alla conquista dell’Etiopia, le comunità degli Oromo, Somali e Afar, spesso in conflitto l’una con l’altra 156, riuscirono a governare più o meno unite in quasi tutto il Corno d’Africa. Al termine della jihad, quando i mussulmani e i cristiani si trovarono in uno stato di grande debolezza, prese slancio la grande migrazione degli Oromo. Diversi sottogruppi del popolo, tra i quali gli Arsi, i Bale e i Nole, si spostarono, intorno alla metà del secolo XVI, nelle zone rurali157 dell’Etiopia orientale e sudorientale ove i mussulmani avevano già lasciato le proprie orme. Lo spostamento nelle zone di cultura Sidama 158, tradizionalmente lontana dall’islam, avrebbe dovuto comportare il declino della propaganda e dell’identità mussulmana. L’islamismo oromo riuscì, invece, a sopravvivere (U.Braukamper, 1977) mescolandosi alle religioni popolari e alle manifestazioni culturali. La gran parte degli Oromo mussulmani mantennero vieppiù in vita fra di loro quelli che erano i costumi e le regole sancite dalla Seera (le leggi Oromo). Lo storico U.Braukamper ha definito questa pratica come “sopravvivenza medievale islamica” e ha sostenuto che queste sacche di resistenza hanno stimolato il processo di reislamizzazione della regione. Nei primi decenni del secolo XIX salirono alla ribalta le monarchie oromo degli Enarya, Goma e Guma. L’oromo Ras Gobena Dacche guidò lo sviluppo dell’Etiopia moderna e l’assimilazione di più territori entro i confini etiopi, unendo il suo esercito di Shewa Oromo con le milizie di Menelik II. Quando Menelik fuggì, nel 1865, dalla fortezza di Maqdala dell’imperatore Tewodros, Gobena fu tra i primi ad aiutarlo e a sottomettersi al suo potere. Ottenuto il sostegno tra i vari clan oromo, guidò le forze militari di Menelik II al sud e all’ovest. Poco prima di morire, nel 1880, l’esercito di Gobena sconfisse le milizie di Sidma e Gurage, quest’ultime comandate dal mussulmano Hassen Inijamo. Non tutta la comunità approvò la sua politica nazionalista, ovvero il tentativo di 155 Lo sceicco Hussein introdusse l’islam tra le genti Sidama, intorno al secolo XIII e compì, secondo gli Oromo, diversi miracoli. 156 Gli Oromo e i Somali erano sovente in competizione per la conquista delle terre più ricche di risorse e, in specie, di acqua dolce. 157 Nelle realtà più arretrate dello stato etiopico cristiano, precisamente in quelle rurali, gli islamici erano riusciti a guadagnare il sostegno dei pastori e dei contadini presentandosi come l’alternativa degli oppressi al regime degli habesha. 158 I Sidama sono un gruppo etnico del sud dell'Etiopia presente nella Snnpr (Southern Nations, Nationalities, and People's Region) d’Etiopia. Parlano il Sidaamu-afoo, che secondo il censimento nazionale del 1994 era la lingua madre del 99,5% di questo gruppo etnico. La maggioranza dei Sidama è di fede protestante (66,8%), gli altri sono mussulmani (7,7%), cattolici (4,6%) e cristiani ortodossi (2,3%). sottomettere i vari gruppi etnici dell’Etiopia ad un potere unico centralizzato. Un veterano della resistenza oromo dichiarò, infatti, un secolo più tardi: Si noti quando gli Amhara occuparono il nostro paese con l'aiuto degli imperialisti europei nel 18851891, molti dei nostri sono stati massacrati. Poi i sopravvissuti sono stati assegnati come schiavi per i coloni che divisero le nostre terre tra loro. Ricordate che saccheggiarono e distorto il nostro legame storico, come è ampiamente noto, che hanno violato la nostra dignità, fino a chiamarci i Galla sporchi. Vi rendete conto di quante volte è stata negata la giustizia nei tribunali di diritto? Voi, mussulmani, la vostra religione è stata denigrata e non è stata condivisa l'uguaglianza con i cristiani. Innumerevoli crimini che non sono stati commessi dai colonialisti europei sui popoli africani sono stati perpetrati su di voi. Siete stati schiacciati per 80 anni 159. In effetti, se prima dell’ascesa di Menelik II il popolo oromo viveva libero e si autorganizzava col sistema gadaa (un complesso ordinamento politico basato sulla stratificazione sociale), sotto il nuovo imperatore milioni di Oromo furono massacrati o venduti come schiavi. Parimenti, diverse compagnie inglesi saccheggiarono le miniere dell’Oromia. Ciononostante, Oromo di discendenza pura e mista entrarono a far parte della nobiltà etiope senza smarrire la propria identità. In particolare, il nipote più giovane di Menelik II, Iyasu V, noto anche come Lij Iyasu, figlio del comandante e nobile oromo Mikael di Wollo (convertitosi al cristianesimo), fu imperatore d’Etiopia dal 1913 al 1916, ma senza corona in quanto fu scomunicato dalla Chiesa ortodossa etiope con l’accusa di essersi convertito all’islam160. Di etnia mista, ma Oromo per linea paterna, fu Haile Selassie, imperatore dal 1930 al 1974, quantunque fosse considerato un Ahmara161, grazie alla discendenza regale dalla nonna paterna che gli permise di salire al trono imperiale. Selassie non fu mai accettato come un punto di riferimento dalla comunità oromo, in quanto sotto di lui fu consolidato il sistema feudale e schiavistico a danno degli stessi oromo, così come, a causa del suo benestare, gli inglesi riuscirono a saccheggiare il cotone dell’Oromia. Anche l’esperienza coloniale italiana fu carica di contraddizioni e non soddisfò pienamente gli Oromo. Gli uomini di Mussolini tentarono di conquistare questo popolo, che conoscevano grazie al lavoro di missionari e ricercatori, ergendosi a liberatori dal potere imperiale abissino: abolirono l’amarico, imposero l’italiano e l’oromo e in alcune zone diedero la terra ai contadini sottraendola ai latifondisti amarici. Ma gli Oromo, ritenendo di essere strumentalizzati, si sollevarono in più di una circostanza contro gli italiani. Col ritorno di Selassié, alleato del blocco occidentale nel Corno d’Africa, tantissimi Oromo tornarono alla schiavitù e i loro prodotti furono confiscati e venduti ai paesi stranieri (come il caffè, esportato in Usa). Anche per questo motivo, i contadini Oromo si unirono alle manifestazioni studentesche, contribuendo alla destituzione di Selassié nel 1974. Ma il regime del Derg e di 159 G.Tareke Etiopia, Potenza e protesta: rivolte contadine nel ventesimo secolo, Cambridge University Press, Cambridge, 1991. 160 Iyasu morì nel 1935 in circostanze misteriose. Tuttora non è conosciuto il luogo della sua sepoltura. Una voce che persiste fino ad oggi è che l'imperatore Haile Selassie ordinò alle sue guardie di ucciderlo. Altri sostengono sia morto per cause naturali. 161 Gli Amhara o Amara sono un gruppo etnico dell'Etiopia centrale, di cui fanno parte circa 23 milioni di persone, cioè il 30,2% della popolazione etiope secondo i più recenti censimenti del 1994. Parlano l'Amarico, la lingua ufficiale dell'Etiopia e dominano la vita politica ed economica. La loro religione predominante per secoli è stata il cristianesimo, con la Chiesa etiope, monofisita, a giocare un ruolo centrale nella cultura del paese e del gruppo etnico amarico. Gli Amhara ereditarono la religione e la tradizione monarchica da Axum, così come hanno fatto i Tigrini. Menghistu che gli succedette non fu certamente meno ostile agli Oromo: nonostante il richiamo al socialismo e all’autodeterminazione dei popoli, il governo rosso – espressione di una elite amarica – negò di fatto alle minoranze qualsiasi diritto all’autonomia. Menghistu attuò la riforma agraria per contenere rabbia (e fame) dei contadini, ma al contempo deportò milioni di Oromo. Fu così che iniziarono a lottare contro i marxisti-leninisti di Menghistu, il “Fronte di Liberazione Eritreo” (anch’esso vicino alle posizioni di Mosca e Cuba), i Somali, i Tigrini e gli stessi Oromo. Quest’alleanza depose il regime militare nel 1991: molti Oromo, fuggiti e allontanati dall’Etiopia negli anni di governo del Derg, tornarono a casa pieni di speranze. L’attività religiosa, prima rigidamente controllata dallo stato, venne liberata dal controllo diretto degli apparati repressivi del potere centrale. Il proselitismo, la propaganda, l’attività culturale e le cerimonie di ciascuna confessione iniziarono a svolgersi senza grosse restrizioni di sorta. Grazie a questa nuova situazione, l’Islam riuscì a portare avanti un’intensa attività di proselitismo in Etiopia e fra gli Oromo. Da quel momento, le diverse comunità islamiche etiopiche hanno cercato di porre le basi per un più saldo radicamento nelle aree già islamizzate, proponendosi, inoltre, come un attore dinamico e cosciente dei nuovi processi culturali e politici in fieri nell’Etiopia del post-Derg e aprendo prospettive nuove e inusitate per tutti i musulmani dell’intera area dell’Africa orientale. In un clima nuovo di tolleranza religiosa, correnti di pensiero veicolanti una interpretazione complessiva dell’Islam che si presenta come sintetica, sistematizzata, universalmente valida (e quindi moderna) e, al tempo stesso, sacralizzata dal voler essere espressione della semplice e immutabile purezza dei primordi della religione, si sono affacciate in Etiopia, come ovunque altrove nel mondo islamico162. Subito dopo la caduta del regime, i mussulmani si votarono ad una poderosa produzione letteraria a stampa e ad un’intensa attività editoriale, che portò alla nascita di un copioso numero di testate periodiche e riviste islamiche specializzate. Non si trattava più di un lavoro rapsodico, clandestino e in lingua amarica, ma di una letteratura tradotta dall’arabo alle lingue locali, della ristampa di opere arabe in lingua originale, di testi diretti sia ai mussulmani più colti sia ai semplici credenti. Una parte di questa fiorente produzione letteraria fu pubblicata proprio in afan oromo (o oromiffa) sì garantendo la diffusione di una lingua che per tantissimi decenni era stata patrimonio di una ristretta cerchia di persone. Per qualche tempo le gerarchie tigrine ed oromo riuscirono perfino a governare insieme, mantenendo vivido il dialogo con gli eritrei che nel frattempo diventavano indipendenti. Ma tra il 1992 e il 1995 riprese piede il tentativo di marginalizzare e reprimere l’autonomismo oromo. Una politica, quella messa in atto innanzitutto da Zenawi, che radicalizzò ulteriormente quella che era l’organizzazione più forte ed organizzata della comunità Oromo 163: l’Olf, il “Fronte di Liberazione Oromo”. L’Olf fu fondata nel 1973 dai nazionalisti oromo che propugnavano l’autodeterminazione del loro popolo contro la “dominazione coloniale abissina”. L’Olf ha cambiato spesso posizione circa gli “obiettivi finali” della sua attività: ha più volte alternato rivendicazioni apertamente secessionistiche 162 A.Gori, Brevi note e osservazioni su alcune recenti pubblicazioni islamiche etiopiche in lingua oromo, «Quaderni del Dipartimento di Linguistica-Università di Firenze», n.18, 2008, pp 199-220. 163 Nella storia del Corno d’Africa innumerevoli sono stati i gruppi e i clan impegnati a difesa degli Oromo. Quelli più conosciuti, sono: Mecha e Tulama Self-Help Organization (fondato nel gennaio del 1963 e sciolto dal governo nel novembre 1966; oggi porta il suo nome un gruppo di beneficenza sospettato di terrorismo), Olf (di cui sopra), Oromo Federalist Democratic Movement (Ofdm), United Liberation Forces of Oromia (Ulfo), Islamic Front for the Liberation of Oromia (Iflo), Oromia Liberation Council (Olc), Oromo National Congress (Onc, oggi affermato come OPC). Altrettanto nota è la Oromo Peoples' Democratic Organization (Opdo), organizzazione socialdemocratica fondata nel 1989 e parte integrante, nel 2011, dell’Eprdf di governo. È accusato dagli altri partiti (e dall’Olf) di essere un fantoccio nella mani di Zenawi. con appelli più moderati alla collaborazione delle minoranze etniche entro una federazione di popoli etiopici con pari diritti. Dal governo etiope è considerata come un’organizzazione terroristica. L’Olf ha uffici a Washington e Berlino, dove dirige alcune trasmissioni radiofoniche. Ha agito dal 1992 ad oggi in netta opposizione a Zenawi, che considera come nemico della causa oromo alla stessa stregua del vecchio Menghistu. Sebbene la costituzione etiope riconosca il diritto di autodeterminazione di tutti gli stati, l’Olf ritiene che l’attuale governo sia l’espressione del dominio tigrino e quindi causa d’instabilità fra i popoli (come dimostra, a loro giudizio, la tensione con l’Eritrea). L’Olf si macchiò già nell’aprile del 1991 del terribile massacro del Bodeno. In quella circostanza morirono circa centocinquanta civili ahmara: alcuni di questi furono addirittura costretti a gettarsi da un dirupo. L’Olf a distanza di qualche tempo provò ad addebitare l’accaduto al Tplf, ma risulta confermata la loro esclusiva responsabilità in questa azione sanguinaria. Nel dicembre del 1991, invece, l’Olf attaccò gli stessi Oromo e i coloni Amhara nella zona di Arsi: secondo Human Rights Watch, nel massacro di Arba Guugu, meglio noto come “la strage nascosta di Oromo e mussulmani in Arsi” furono uccisi circa centocinquantaquattro uomini, quasi tutti amhara (cristiani e mussulmani); altri quarantasei uomini furono assassinati nei pressi di Hararghe. Nel 1998, l’Olf uccise circa duecento persone (alcuni sostengono duecentosedici, altri centottantasette) al confine tra Etiopia e Kenya, a Bagalla. Il casus belli (pretestuoso) fu il pascolo non autorizzato sui terreni borana da parte della tribù Degodia, sottoclan dei somali Hawiye. La maggior parte delle vittime furono donne e bambine, circa cinquantadue ragazze furono addirittura rapite. Nonostante il governo keniota abbia condannato il gesto e denunciato l’azione dell’Olf, si sospetta che fosse corresponsabile dell’accaduto viste le sue continue tensioni col governo etiope e col suo esercito (costituito da tantissimi Oromo lealisti che sembrano non avere scrupoli nel reprimere i loro stessi simili). Secondo i media kenyoti, l’Olf avrebbe ucciso altri centoquarantadue civili, nei primi mesi del 1998, nel Distretto Wajir. Di fronte a tutto ciò, non mancarono le ritorsioni del governo. Il 17 aprile del 2001, ad Addis Abeba, nel corso di una manifestazione studentesca che richiedeva la rimozione di un preside legato al regime, quarantacinque giovani oromo furono uccisi, centinaia di ragazzi vennero feriti e duemila arrestati (fonte Bbc). Nel corso del 2003, furono uccisi circa duecentotrenta Oromo che manifestavano per l’autodeterminazione (fonte Amnesty International). Nella primavera del 2004, centinaia di studenti Oromo, che avevano chiesto l’organizzazione di uno spettacolo sulla cultura Oromo, furono espulsi dall’università, dopo notti di pestaggi ed orrori. Di qui la fuga in Kenia di cinquecento e più studenti tra i quattordici e i venti anni. Fu così che, un anno dopo, circa un mese prima delle elezioni etiopi del 2005, il “Fronte di Liberazione Oromo” uccise circa quattrocento persone. Le vittime non furono i consueti avversari politici, ma Oromo vicini al governo. Il “Fronte di Liberazione Oromo” è attraversato ancora oggi da un dibattito molto intenso al suo interno sulle tre opzioni dell’autonomia, indipendenza, integrazione rispetto allo stato etiope e alle altre comunità. L’impressione è che non sarà tanto il dibattito interno, quanto il contesto esterno e generale del Corno d’Africa a determinare una volta per tutte quale sarà la sua politica e chi, tra i cristiani e i mussulmani, prevarrà alla guida dell’Olf. Fatto sta che al momento l’Olf e il governo nazionale continuano a combattere l’uno contro l’altro164 e a scambiarsi pesanti accuse165. 164 Recentemente l’Olf ha dichiarato che si opporrà strenuamente alla nuova legge del governo, che intende negare la Carta d’Identità alle etnia somale, eritree e oromo per garantire la sicurezza nazionale contro l’azione di questi gruppi (fonte: http://www.oromoliberationfront.org) 165 L’Olf ha recentemente accusato il governo etiope di essere responsabile delle esplosioni del settembre 2006 ad Il “Fronte di Liberazione Oromo” non sembra collegato alle frange più estreme del mondo militante islamico, ma nel 2006 è stata denunciata, da vari media africani, la sua collaborazione con l’Unione delle Corti Islamiche. Lo stesso gruppo di monitoraggio delle Nazioni Unite sulla Somalia, nella relazione dell’ottobre 2006 al Consiglio di Sicurezza, ha dichiarato che l’Olf stava combattendo dalla parte delle Corti. L’Olf, in un comunicato del 2 maggio 2007, ha rigettato completamente l’accusa, rimarcando la sua ferma intenzione di non intromettersi negli affari degli altri stati e aggiungendo che “vede chiaramente il terrorismo come un pericolo e minaccia per la pace e si unisce alla comunità internazionale nella lotta contro l’estremismo e il terrorismo”166. Tuttavia, prima e durante la guerra civile in Somalia del 2006, l’Olf era sospettato di collaborare direttamente con al-Ittihad e con gli islamici eritrei per la destabilizzazione dell’Etiopia e della Somalia. Alcuni militanti Olf prigionieri in Somalia hanno ammesso sia il proprio addestramento in Eritrea sia la collaborazione con al-Qaeda. Alcuni di loro sarebbero stati reclutati dall’Olf in Yemen, attraverso campagne radiofoniche mirate. Nel 2007, la Corte distrettuale Usa ha incarcerato un sostenitore dell’Olf, Sisaye Dinssa, residente a Dallas, con l’accusa di contrabbando di danaro, trasporto di stupefacenti e materiale informativo sul suicidio col cianuro, sul nucleare e sull’anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle. Prescindendo, dunque, dalle dichiarazioni del governo etiope, che ha tutto l’interesse ad eliminare una forza d’opposizione e a screditarla agli occhi della comunità internazionale, l’Olf resta comunque un’organizzazione ambigua. Appare quindi giustificata l’attenzione dell’occidente su un gruppo che ha un recentissimo passato e (probabilmente) un presente fatto di stragi ed attentanti e che ha sfruttato al massimo quella che il professore Alan Dershowitz chiama l’ “aritmetica della morte”. Nonostante la presa di distanza dal terrorismo e le rivendicazioni più o meno moderate, l’Olf sembra disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Magari perfino a dialogare più attivamente e organicamente, come dimostra il caso somalo, con i settori più oltranzisti e violenti del mondo islamico. 5. Il Kenia è un paese a maggioranza cristiana: il 45% della popolazione è di fede anglicana e quacchera (il più grande gruppo di quaccheri in una sola nazione) e il 35% è di fede cattolica. L’islam rappresenta circa l’11% della popolazione, ed è distribuito nel paese secondo questo articolato schema: - nella provincia nord-orientale del Kenya vivono circa seicentomila persone di etnia somala, in maggioranza mussulmane. La loro identità etnica supera quella religiosa, ragione per la quale non hanno mai cercato l’unità d’azione o una qualche forma di collaborazione con gli altri mussulmani kenyoti; - alcune comunità mussulmane vivono lungo la costa, dove i mussulmani sono circa la metà della popolazione. È stata una delle zone più instabili e ribelli della storia kenyota dall’inizio del secolo XX; piccole minoranze mussulmane sono presenti in tutto il resto del paese, soprattutto a Nairobi, ma non giocano un ruolo determinante nella vita politica e religiosa del Kenya; aderiscono al credo islamico svariati immigrati asiatici, provenienti dall’India e dal Pakistan; recentemente a questi immigrati si sono aggiunti centinaia di mussulmani provenienti dalla - Addis Abeba che hanno ucciso tre persone. L’attentato era stato addebitato dal governo a due organizzazioni oromo, ma Wikileaks ha comprovato responsabilità dirette del Goe (Government of Ethiopia) nella preparazione dell’attentato e nell’eliminazione dell’attentatore. 166 http://oromiatimes.multiply.com/journal/item/501 Somalia. Questi immigrati hanno scelto il Kenya -in alcuni casi- per mere ragioni di disperazione (la Somalia è in preda alla guerra civile e alla carestia), e –in altri casi- per destabilizzare il paese o riorganizzare la lotta in Somalia (molti di loro sono vicini ad alShabab). Dal punto di vista dell’articolazione interna al credo islamico, i mussulmani sono così caratterizzati: 1) la grande maggioranza dei mussulmani indigeni del Kenya appartiene agli ordini sufi della Qadiriyya (perlopiù somali) e della Ibadiyya (arabi). Sono particolarmente radicati nelle zone rurali; 2) altrettanto importanti e radicati sono gli appartenenti al movimento del “riformismo islamico” (noto anche come “Modernismo islamico” o Nahda – Rinascita), abbracciato dagli arabi presenti nelle grandi città; 3) gli asiatici praticano quasi tutti il credo sunnita hanafita; 4) poche migliaia di mussulmani aderiscono alla Ahmadia, una setta esoterica mussulmana che ha pubblicato la prima edizione del Corano in swahili, ma che è considerata eretica dalla maggior parte dei fedeli islamici; 5) una piccola minoranza di mussulmani kenyoti aderisce allo sciismo, dividendosi quasi equamente tra ismailiti e duodecimani. Negli anni, questi gruppi si sono più volte frammentati e, talvolta, scontrati su questioni sostanzialmente banali, come accade in occasione nel Ramadan in merito all’avvistamento della luna. Ciononostante, la diffusione di una vasta gamma di istituzioni religiose, l’esistenza di moschee, madrase, confraternite sufi e di un sistema giudiziario autonomo (il qadis) non solo ha unito i mussulmani, ma ha inibito conflitti e rotture insanabili tra le varie comunità. Le altre religioni diffuse sono l’induismo, l’animismo, il sikhismo, il gianismo e il credo di baha’i. Le etnie in cui è divisa la popolazione sono circa settanta e appartenengono alle famiglie linguistiche dei bantu, nilotici, paranilotici e cusciti. Le etnie più numerose sono i bantu kikuyu (21% della popolazione), i bantu luhya (14%), i bantu jamba (11%) i nilotici luo (13%) e i paranilotici kalenjin (11%). Questo “meticciato” religioso non ha prodotto, nei secoli, scontri rilevanti tra le diverse confessioni, e soprattutto non ha posto l’una contro l’altre le realtà cristiane e mussulmane del paese. Negli ultimi decenni, e in particolare dagli attentati alle ambasciate americane di Nairobi e Dar es Saalam (Tanzania) del 7 agosto del 1998, questo equilibrio si è spezzato ed è parsa ai più evidente la presenza marcata del salafismo e la rilevante esposizione del Kenya alla penetrazione entro le proprie terre del terrorismo qaedista. Prima del 1998, infatti, al-Qaeda era un’organizzazione di fatto sconosciuta nel continente africano167 e, in particolare, in Kenya. Bin Laden e i suoi, dall’inizio dell’invasione sovietica in Afghanistan e, in particolar modo, dalla fine anni Ottanta fino ai due attentati, hanno concentrato i propri sforzi organizzativi nel lavoro di addestramento dei miliziani, al fine di formare cellule specializzate negli attacchi di vasta portata e sotto-cellule da distribuire sui territori asiatici, arabi ed europei. Gli attentati in Kenya rappresentarono, insomma, il passaggio di al-Qaeda dalla pianificazione alla attuazione della guerra santa. In più, gli attacchi segnarono un mutamento delle operazioni, da difensiva sul territorio mussulmano ad offensive in territorio nemico. A differenza della resistenza in Afghanistan, da Nairobi in poi, al-Qaeda ha concentrato il grosso delle sue energie nell’azione spettacolare in terre ostili (o, semplicemente, contro governi ostili) e nel reclutamento esteso e decentralizzato a carattere squisitamente messianico. 167 L’attentato al World Trade center del 1993, che ha preceduto gli attentati di Nairobi e Dar es Salaam, non è stato collegato direttamente ad al-Qaeda ma semplicemente al gruppo di cospiratori formato da Ramzi Yousef, Mahmud Abouhalima, Mohammad Salameh, Nidal Ayyad, Abdul Rahman Yasin e Ahmad Ajaj. Un altro elemento introdotto dagli attentati alle ambasciate americane, riguarda il modus operandi di alQaeda: d'ora in avanti si moltiplicheranno gli attentati simultanei. Gli attentati di New York, di Casablanca, di Istanbul, di Madrid e di Londra sono un esempio del nuovo approccio caratterizzato dalla riproducibilità tecnica. Si tratta nella pratica di far apparire l'attentato non come frutto di una casualità, di un caso fortuito o di una situazione particolarmente propizia, ma l'esito di un processus industriel contrôlé de bout en bout, prévisible et reproductible. La concentrazione temporale degli attacchi (amplificata dai media, il cui utilizzo rappresenta una delle caratteristiche fondamentali di al-Qaeda) è il simbolo dell'onnipresenza e del superpotere dell'organizzazione 168. Gli attacchi avvennero lo stesso giorno (nella ricorrenza dell’arrivo delle truppe americane sul suolo saudita durante la prima guerra del Golfo) e quasi alla stessa ora, intorno alle 10.45 locale. Il più violento e distruttivo fu quello di Nairobi: l’esplosione fu udita a oltre trenta chilometri di distanza, l’ambasciata e gli edifici circostanti furono letteralmente spazzati via dagli ordigni, i morti furono duecentododici e i feriti quattromila (a Dar es Salaam si contarono undici morti e ottantacinque feriti). Nella fattispecie, i morti furono quasi tutti civili e africani (morirono solo dodici americani), a riprova che quella di al-Qaeda è stata perlopiù una dimostrazione di forza e una mera provocazione ai danni dei non mussulmani. L’azione in Kenya e Tanzania fu pianificata nel 1993, quando al-Qaeda affidò la gestione delle operazioni ad Ali Abdul Mohamed Saoud169 e ad un esperto di computer. La squadra disponeva di un appartamento a Nairobi, fornito di un laboratorio per sviluppare le fotografie di sorveglianza. Le tecniche di sorveglianza e l'equipaggiamento impiegato per le comunicazioni, comprendevano videocamere che arrivavano dalla Cina ed erano distribuite in Germania. Nel gennaio del 1994, bin Laden ricevette il rapporto di sorveglianza, completo di diagrammi preparati dagli specialisti di computer. Il rapporto fu esaminato da Osama e dai più alti livelli della commissione 168 E. Loi, La storia di al-Qaeda: attacco agli Usa, http://www.storiain.net/arret/num139/artic4.asp 169 Ali Abdul Mohamed Saoud (1952) è una delle personalità più ambigue e controverse del mondo islamico radicale. Fonti statunitensi ed israeliane sostengono abbia lavorato sia per la Cia sia per la jihad islamica (egiziana e qaedista) con atteggiamenti tipici del doppiogiochista . L’agente speciale dell' Fbi Jack Cloonan l’ha definito “il primo allenatore/maestro di Bin Laden”. Dopo una carriera da maggiore nell’unità di intelligence dell’esercito egiziano (dal quale fu cacciato per sospetto fondamentalismo), Saoud ha lavorato negli Usa come traduttore di al-Zawahiri, che al tempo girava per le moschee della California alla ricerca di fondi per la resistenza all’invasione sovietica dell’Afghanistan. Al-Zawahiri incoraggiò Saoud a infiltrarsi nei comandi statunitensi, cui quest’ultimo si presentò però fin da subito in qualità di disertore. Per conto della Cia, nel 1984, raccolse informazioni presso una moschea (vicina ad ambienti hezbollah) sita in Amburgo (Germania) dove invero dimostrò tutta la sua inaffidabilità. Inseritosi nella moschea, provò a tradire l’intelligence americana e a passare dalla parte degli hezbollah. Ma svelò maldestramente il lavoro di spionaggio e i suoi nuovi propositi ad elementi della moschea infiltrati anzitempo dalla Cia. Poco più tardi, diventò un cittadino americano sposando, dopo sole sei settimane di fidanzamento, una donna californiana. Si arruolò nell’esercito Usa e dopo poco tempo divenne sergente istruttore presso il John F. Kennedy Special Warfare Center and School di Fort Bragg (Carolina del Nord), dove tenne corsi di cultura araba. Partì più volte in missione per l’Afghanistan, ove millantò un certo successo nell’uccisione di sovietici. Sfruttando al massimo le informazioni, l’addestramento e il materiale ricevuti nell’esercito americano, tenne dei veri e propri corsi di jihad a terroristi di stanza negli Stati Uniti, come Osama bin Laden e Ayman al Zawahiri. Perlustrò più di un’ambasciata statunitense in Africa (come ha fatto con quella kenyota) per preparare al meglio gli attentati del 1998. Attualmente è detenuto a Karachi e collabora in qualità d’informatore col governo statunitense. militare di al-Qaeda, Banshiri 170 e il suo sostituto, Mohammed Atef 171 (Abu Hafs al-Masri). La conclusione a cui arrivarono fu che l'ambasciata americana di Nairobi era l'obbiettivo più semplice, perché più facile da colpire con una macchina riempita di esplosivo. La cellula in Kenya dovette superare molti ostacoli, dovuti in parte al ritardo tra la preparazione e l'effettiva esecuzione dell'attentato. Uno di questi, nell'agosto del 1997, rischiò di annullare l'operazione. La cellula keniota, infatti, entrò nel panico perché un quotidiano londinese, «Daily Telegraph», riportò che Madani al-Tayyib (o Sayed Tayb al-Madani, NdR), formalmente a capo della commissione finanziaria di al-Qaeda, stava fornendo delle informazioni importanti ai sauditi e questi ultimi a loro volta le stavano comunicando alle autorità americane e britanniche. Nello stesso momento, componenti della cellula africana vennero a sapere che agenti statunitensi e kenioti stavano ispezionando la residenza keniana di Wadi al-Hage, e che il suo telefono era stato intercettato 172. Questo non arrestò la preparazione dell’attacco agli Stati Uniti e gli attentatori continuarono ad acquistare bombe, mezzi di trasporto e case ove studiare le mosse tattiche e costruire gli ordigni. Il 7 maggio 1998 Atef inviò un fax all’ufficio di bin Laden a Londra nel quale era contenuta una nuova fatwa, sostenuta da sceicchi stanziati in Afghanistan, ove annunciava e giustificava la guerra santa contro i nemici dell’Islam e, quindi, gli Stati Uniti d’America. Due settimane più tardi, bin Laden ribadì il contenuto della fatwa in un’intervista alla Abc. Il primo agosto, gli elementi della cellula non direttamente coinvolti nell'attentato lasciarono l'Africa. Quelli rimasti iniziarono l'assemblaggio della bomba. Bin Laden e il resto della leadership di al-Qaeda lasciarono Kandahar per rifugiarsi nella campagna, aspettandosi una risposta americana. Nel frattempo le rivendicazioni furono faxate agli uffici di al-Qaeda e a quelli del Jihad islamico egiziano di Baku con l'ordine di trasmetterle al giornale «Al-Quds al-Arabi». Una proclamava la formazione dell'Esercito islamico per la liberazione dei due luoghi sacri, mentre le altre due, una per ciascuna ambasciata, annunciavano che gli attacchi erano stati compiuti da un battaglione dell'Esercito islamico. 173 170 Abu Ubayda al-Banshiri fu un terrorista egiziano e uno dei capi più rispettati di al-Qaeda. Era alla guida di alQaeda in Africa, prima di morire annegato nel Lago Vittoria (1996), causa incidente del suo traghetto. 171 Mohammed Atef fu per anni il capo militare di al-Qaeda, benché il suo nome sia rimasto sconosciuto negli anni. La sua morte nel 2001 ha rappresentato il primo successo degli Usa nella battaglia al terrorismo. Ha prestato servizio nell’aereonautica militare egiziana per due anni, prima di diventare membro del gruppo Egyptian Islamic Jihad e combattente in Afghanistan, ove ha conosciuto prima al-Zawahiri e poi bin Laden. Si è occupato, negli anni, delle operazioni in Sudan e nello stesso Afghanistan e ha presentato diversi piani ad al-Qaeda per rovesciare il governo iraniano e Musharraf in Pakistan. A detta degli Stati Uniti, addestrò in Kenia dei miliziani somali che parteciparono alla battaglia di Mogadiscio del 1993. Morto al-Banshiri, prese il suo posto, nonostante le perplessità degli altri qaedisti, liquidati però da bin Laden: “Atef sapeva della Jihad quando la maggior parte di voi non era ancora nata" . Il 4 novembre 1998 gli Stati Uniti emanarono un mandato di cattura per Atef. Nel 1999 venne processato in contumacia da un tribunale egiziano, che lo condannò a sette anni di prigione per la sua attività nella Eij. Dopo il bombardamento al cacciatorpediniere Uss Cole nel porto di Aden (2000), i dirigenti di al-Qaeda si separarono l’uno dall’altro per ragioni di sicurezza e Atef si rifugiò a Kandahar (raggiunto in seguito da bin Laden). Nel gennaio 2001, a Kandahar, la figlia di Atef sposò il figlio diciassettenne di Osama bin Laden e pochi mesi più tardi (prima dell’attacco alle Torri Gemelle) si schierò con Osama contro il mullah Omar, (forse) ostile ad un nuovo attacco agli Stati Uniti. Dopo l’11 settembre, si aprì la caccia ufficiale e risoluta degli Usa ad Atef, che alfine morì in seguito ad un bombardamento Usa sulla sua casa a Kabul (ma c’è chi sostiene sia morto in seguito ad un raid terrestre). Nel 2006 apparve in un video che dimostrava il suo coinvolgimento nella pianificazione degli attentati del 2001. 172 E. Loi, La storia di al-Qaeda: attacco agli Usa, http://www.storiain.net/arret/num139/artic4.asp 173 Ibidem Ebbe così luogo il primo attentato di al-Qaeda contro gli Stati Uniti e, di fatto, contro il continente africano. Un attentato che accese i riflettori del mondo sull’organizzazione di Bin Laden (che pur si divise sulla legittimità di quest’azione 174) e che dimostrò la vulnerabilità dell’Africa orientale di fronte all’avanzata terroristica. L’islam ha preso piede in Kenia grazie alle migrazioni dei popoli arabi, come i somali, e degli asiatici, in particolare indiani, stabilitisi in Africa orientale per ragioni di natura commerciale. Il sultanato di Oman corrose progressivamente il potere dei portoghesi, che si erano scontrati per certo anni con la resistenza della gente swahili - discendenti dei primi arabi yemeniti mescolati con le tribù locali -e si ritirarono dopo la caduta di Fort Jesus. Gli omaniani conquistarono le coste del Kenya (area essenziale per le comunicazioni con Tanzania e Mozambico), spostando poi la capitale da Mascate a Zanzibar (1983), parte dell’odierna Repubblica Unita di Tanzania. Il sultano di Zanzibar estese i suoi traffici anche nelle zone interne del Kenya, alla ricerca di avorio e schiavi, ma anche per reclutare fedeli. Intorno alla metà del secolo XIX s’intensificò la presenza degli europei, e in particolare dei britannici, che spartirono il controllo dell’area con i tedeschi (agosto 1855) e il sultano di Zanzibar. Al sultano restò solo il dominio di una stretta striscia di terra lungo la costa e i tedeschi ottennero il territorio a sud della frontiera che andava dal lago Vittoria fino alla costa, passando vicino al monte Kilimangiaro (sostanzialmente, ottennero la Tanzania), gli inglesi si presero il territorio a nord. Insieme con gli inglesi arrivarono in Kenya diversi missionari anglicani che contribuirono alla diffusione del cristianesimo nel paese. La Compagnia imperiale dell’Africa orientale inglese amministrò il territorio ad ovest del lago Vittoria (1888), ma dimostrandosi incapace nel lavoro di amministrazione costrinse il governo inglese a creare prima il protettorato formale dell’Africa orientale (1895) poi a trasformare il Kenya in una vera e propria colonia della corona (1920). Molti coloni venivano dal Sudafrica, mentre altri venivano da Paesi europei. I coloni introdussero varie forme di lavoro forzato, alle quali la popolazione locale reagì con risentimento. Nel 1904, il governo locale introdusse la politica di confinare gli africani nelle riserve. Nello stesso tempo, un grosso numero di lavoratori arrivò dall’India, che era una colonia dell’Impero britannico, per costruire la ferrovia e favorire il commercio. Col passare del tempo gli indiani, che erano diventati un popolo numeroso, chiesero di partecipare alla vita politica del territorio. che, nel 1920, era diventato la colonia del Kenya. La creazione della colonia produsse ostilità di tipo razziale. La legislazione relativa alla proprietà della terra favorì i coloni. Gli africani furono privati della loro terra e confinati in riserve, mentre una precisa linea politica (“la regione muntuosa ai bianchi”) limitò la proprietà della migliore terra arabile ai soli europei. Queste ed altre tensioni influenzarono lo sviluppo dello scenario politico. 175. Nondimeno, i mussulmani non diedero particolari problemi ai coloni inglesi, fatta eccezione per le ripercussioni locali della rivolta lanciata dal Mullah “pazzo” Mohammed Abdile Hassion in Somalia. Gli inglesi, nonostante mantenessero il pugno di ferro sull’amministrazione generale del Kenya, badarono bene a non frammischiare i mussulmani ai cristiani e a non interferire troppo con i costumi locali. Allo stesso tempo lasciarono ai mussulmani l’autonomia sull’amministrazione interna alla comunità e il controllo dei waqf e delle madrase. Prima dell’indipendenza, in effetti, il radicalismo etnico del paese ha sempre prevalso sul conflitto 174 Alcuni esponenti di al-Qaeda ritennero che un attentato così feroce – con poche vittime americane e scagliato in un luogo lontano dai centri del potere occidentali – fosse completamente inutile e nocivo ai fini della vittoria contro il “mondo democratico”. 175 G. Caramazza, Kenya, la Terra dello Struzzo, «misna.org», gennaio 2011. interconfessionale, che per ragioni storiche (e forse per l’abilità degli inglesi) non ha trovato la sua ragion d’essere in Kenya. I mussulmani kenyoti assorbirono nella propria cultura usanze tipiche della religione tradizionale africana, teoricamente incompatibili con la dottrina islamica, come la credenza nelle stregoneria, pratiche tribali di guarigione e l’uso cerimoniale dei tamburi. Al contempo, varie credenze islamiche furono inserite nelle pratiche delle religioni indigene. Tra i cristiani e i mussulmani s’istaurò un originale sincretismo, riscontrabile, ad esempio, nella comune valorizzazione della figura di Gesù, Issa figlio di Maria per i mussulmani. A combattere la colonizzazione pensò il gruppo etnico dei kikuyu, che a differenza dei masai (compensati dai britannici con la concessione di alcune terre) videro subito negli inglesi gli espropriatori delle proprie ricchezze e “coloro che avrebbero portato la carestia e il pianto”. A tal proposito il saggio Moro wa Kebiro sosteneva: “non permettete che passino accanto alle vostre case, perché subito le vorranno”. I kikuyu si opposero strenuamente agli inglesi dal 1880 al 1900 e dopo di loro si ribellarono i nadi (dal 1895 al 1905), i Giriama (nel 1913-1947) e le donne contro il lavoro forzato in Muranga (nel 1947). Dall’etnia kikuyu provenivano la gran parte dei ribelli Mau-Mau che intrapreso una lotta dura e cruenta176 contro i colonizzatori (e contro i kukuyu ostili all’insurrezione) che insanguinò il Kenya dal 1952 al 1960. I capi della rivolta si organizzarono in una società segreta nella quale si prestava giuramento e si dichiarava di lottare per ripristinare lo statu quo precedente alla colonizzazione. Prima della straordinaria sedizione dei Mai Mau, fu creata l’ “Associazione dei giovani kikuyu” (1921) che fu la prima organizzazione a difendere i diritti dei kenyoti e rappresentò l’embrione dell’ “Associazione centrale dei kikuyu” capeggiata da Jomo Kenyatta, cui si ispirarono i Mau Mau negli anni del conflitto. Kenyatta lottò per il diritto alla terra, l’accesso all’istruzione, il rispetto delle tradizioni africane e per portare rappresentanti kikuyu nel consiglio legislativo (dominato dagli inglesi e comprensivo di una minoranza d’indiani), prima di partire per Londra ove restò – con brevi apparizioni in Kenya per circa quindici anni. Il 20 ottobre 1952 il governatore Baring dichiarò lo stato di emergenza: il giorno dopo (“operazione Jock Scott”) furono arrestati Jomo Kenyatta e altri centottanta presunti leader Mau nella città di Nairobi. Con una serie di amnistie (concesse e revocate), l’aumento dei salari urbani e un programma di riforma agrario, la repressione si allentò e nel 1960 si raggiunse la fine del conflitto. Una conferenza parlamentare svoltasi nel gennaio dello stesso anno stabilì l’apertura del collegio legislativo ai kenyoti e l’accettazione del meccanismo “una testa, un voto”. Kenyatta fu scarcerato il 14 agosto 1961 e divenne così il leader ufficiale del Kanu (“Unione nazionale africana del Kenya”): il movimento a capo del quale guidò la delegazione kenyota alla prima e seconda Conferenza di Lancaster a Londra. Alle elezioni del maggio 1963 il Kanu (indipendentista moderato) batté il Kadu (“Unione democratica nazionale del Kenya” che sosteneva una politica federalistica non ostile agli inglesi) e conquistò ottantatre seggi su centoventiquattro. Il 1 giugno 1963 Kenyatta divenne primo ministro del governo autonomo del Kenya, sotto la supervisione di un Governatore generale che rappresentava in loco il Capo dello Stato, Regina 176 I Mau Mau uccisero circa milleottocento persone tra i civili africani (la maggior parte dei quali proprio kikuyu), duecento soldati e civili britannici e trentadue nelle file dei Mau Mau. Gli inglesi uccisero circa 5000 civili, tra ribelli e semplici indigeni. Ma i Mau Mau si distinsero per l’uso sistematico della tortura, della mutilazione e dell’avvelenamento a danno dei kikuyu. Gli inglesi condannarono i loro nemici e una buona parte di cittadini sfuggiti alle deportazione di massa, dell’isolamento in campi recintati col filo spinato, al lavoro coatto. Elisabetta II. Il 12 dicembre 1963 il Kenya ottenne l’indipendenza e le elezioni nello stesso anno elevarono Jomo Kenyatta alla presidenza della repubblica. Il 1 giugno 1964 Kenyatta divenne capo dello Stato, capo del governo e comandante delle forze armate. Il nuovo leader chiese agli inglesi di non abbandonare il territorio e sorvegliare la transizione verso l’indipendenza effettiva. Kenyatta stabilì un forte controllo del paese, mantenne giustappunto le leggi oppressive del governo coloniale, lasciò svariati funzionari inglesi nei vecchi posti di comando ed escluse dall’assegnazione delle terre gran parte dei combattenti Mau Mau. Parimente, incluse nel suo governo ministri provenienti dalle varie tribù e realizzò importanti riforme economiche che permisero la modernizzazione e l’industrializzazione del paese. Dal 1963 al 1967 Kenyatta dovette affrontare la rivolta degli shifta177 (banditi), un conflitto di stampo secessionista animato da un’etnia del distretto della “Frontiera del Nord del Kenya” (Nfd) che rivendicavano l’istituzione di una “Grande Somalia”. L’etnie somale del Nfd178 (insieme con i Borana Oromo e Sakuye) soffrirono un isolamento eccezionale e un forte senso di frustrazione sotto il dominio degli inglesi, che staccarono la zona dal resto del Kenya con tanto di controllo serrato ai confini (1926-1934). Pochi giorni prima della concessione dell’indipendenza formale alla Somalia, gli inglesi annunciarono l’unificazione delle aree somale in una regione amministrativa, ma dopo la dissoluzione delle ex colonie britanniche in Africa orientale la Gran Bretagna concesse il controllo del Nfd ai nazionalisti kenioti, nonostante gli abitanti della frontiera del nord avessero espresso la propria volontà – in un plebiscito informale – di aderire alla nuova repubblica somala. Amareggiati per la mancata realizzazione della promessa autodeterminazione, l’etnia somala si organizzò nel “Partito popolare progressista della Provincia del Nord” (Npppp) e iniziarono a lottare contro il governo, che non solo non soddisfò le loro richieste ma adottò dure misure repressive (stragi di massa), la detenzione preventiva e la pena di morte per possesso non autorizzato di armi da fuoco. Seguirono attriti e scontri tra l’esercito del Kenya e gli insorti somali del “Movimento di Liberazione del Distretto della Frontiera del Nord” (Nfdlm), che costrinsero il governo kenyota ad un accordo (1964), di scarso successo, con l’imperatore etiope Haile Salassie. L’Unione Sovietica, su richiesta del governo somalo, finanziò gli insorti con circa trentadue milioni di dollari, grazie ai quali questi ultimi riuscirono a produrre ed installare diverse mine antiuomo. Dopo quattro anni di conflitto, il presidente dello Zambia, Kenneth David Kaunda decise di mediare i colloqui di pace tra il primo ministro somalo Mohamed Egal e Kenyatta. I colloqui si conclusero col cessate il fuoco ufficiale (ma le schermaglie continuarono per altri due anni) sancito col Memorandum of Understanding – memorandum di Arusha - che tuttavia Siad Barre denunciò nel 1969. Nel 1966, Kenyatta fu rieletto senza avversari, col Kadu praticamente sciolto e il Kanu trasformatosi in partito unico dominato dall’etnie kikuyu-luo. Con una riforma costituzionale del 1967 ampliò notevolmente i suoi poteri e negli anni successivi iniziò a perseguitare i suoi avversari con arresti ingiustificati e mezzi non ortodossi (alcuni 177 Il termine shifta (o scifta) veniva usato in Africa orientale e nell’area del Corno per indicare chi conduceva una vita da ribelle, bandito, fuorilegge e si opponeva alle istituzioni ufficiali. Negli anni della decolonizzazione, questa denominazione (o epiteto) è stata usata per riferirsi agli indipendentisti e secessionisti di varia natura, e addirittura per biasimare i semplici criminali. Diversi signori della guerra e imperatori etiopi furono infatti shifta prima di diventare abbastanza potenti da imporsi a loro volta come autorità. Fra questi si possono citare gli imperatori d'Etiopia Teodoro II e Giovanni IV. 178 L’Nfd oggi comprende la provincia nord-orientale del Kenya e i distretti di Marsabit, Moyale e Isiol. oppositori morirono in sospetti incidenti d’auto). Alle elezioni del 1969, Kenyatta bandì l’ultima organizzazione ufficiale rimasta in circolazione, il Kpu (guidata dal suo ex vice presidente, Jaramogi Oginga Odinga) e un anno dopò prestò di nuovo giuramento per un altro mandato. Fu rieletto presidente nel 1974 dopo nuove elezioni-farsa e morì quattro anni più tardi, a Mombasa. Il suo posto fu preso dal vicepresidente Daniel Toroitich arap Moi detto Nyayo (“le orme” in swahili, perché seguiva le orme di Keniatta), ex leader del Kadu che aveva sfidato Kenyatta nei primi anni dell’indipendenza. La sua elezione fu duramente osteggiata dalla mafia kiambu, un piccolo gruppo di persone kikuyu del distretto kenyota del Kiambu. Come il suo predecessore, Nyano stabilì buoni rapporti con l’Occidente e tenne sotto smacco il paese, controllando draconianamente il Kanu per anni e combattendo ogni forma di apertura al socialismo e di avvicinamento sovietico179. Il 1 agosto 1982 un gruppo di soldati dell’aeronautica kenyota, guidati da Ezechia Ochuka, tentò un colpo di stato contro il presidente, ma l’operazione fallì clamorosamente grazie al rapido intervento delle forze lealiste dell’esercito e della polizia. Moi profittò dell’occasione per epurare le fila del partito e del governo dai fedelissimi di Kenyatta tacciati di tradimento - per condannare a morte Ochuka, per modificare la costituzione e stabilire de jure il partito unico di stato. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta esplose il disagio delle università e dei college. Sorsero movimenti di protesta di accademici e studenti, all’interno dei quali s’infiltrò la polizia segreta, che costrinse così diversi movimenti d’opposizione ad organizzarsi in modalità segreta. Nacquero gruppi come Mwakenya. Pambana (la lotta), Mpatanishi (l’arbitro) , e Umoja (“unità”– fondata a Londra da Ngugi wa Thiong’o). Mwakenya, che ha mutato il nome in Pambana e Mpatanish, fu un movimento spontaneo, semisocialista, fondato da ricercatori universitari ma radicato anche tra i contadini kukuyu di Nakuru e Nyeri. I suoi leader rimasero sconosciuti, tanto che si è pensato ad una struttura priva di una vera gerarchia e sostanzialmente fragile, a dispetto dei timori del governo. Nell’organizzazione si entrava per giuramento, come accadeva nei Mau Mau. L’ala più conosciuta di questo movimento fu Ukenya Mwakenya, fondata a Londra da Yusuf Hassan (da cui si dissociarono familiari e amici) insieme con elementi appartenenti alla comunità somala di Garissa, una città della Provincia del nord-est kenyota. Questi movimenti furono ridotti al silenzio senza grossi sforzi, ma consigliarono al governo – caduto il Muro e finita la guerra fredda – di ripristinare il multipartitismo, come era nei desiderata dell’ambasciatore statunitense Smith Hempstone. D’altronde le stesse potenze straniere, che avevano tollerato la repressione politica come misura necessaria per bloccare la diffusione del marxismo in Africa, non potevano più voltare la faccia dinanzi all’uso così evidente e crudo della violenza da parte del governo. Alla prima elezione (1992), Moi fu eletto presidente e il Kanu ottenne la maggioranza dei seggi in parlamento, ricorrendo a brogli e sfruttando la divisione dell’opposizione. Ma ancora una volta, prima e dopo le elezioni, il paese fu sconvolto dalla violenza: nella valle del Rift i miliziani controllati dal governo attaccarono le comunità kikuyu e incendiarono le loro case. Stessa cosa avvenne nel 1997: Moi fu confermato presidente, ma i governi occidentali chiesero riforme costituzionali per democratizzare realmente il paese e il Fondo Monetario Internazionale sospese i prestiti. Aldilà della risposta formale a queste richieste, Moi prescindette continuamente da comportamenti democratici, permettendo truffe di ogni tipo, inquinando la giustizia, comprando i capi locali e cooptando alcuni di questi nell’amministrazione pubblica in modo più che discutibile: La magistratura nel 2000 ed il parlamento nel 2001 sostanzialmente dissolsero l’Autorità kenyana contro 179 “Non c’è spazio per i comunisti in Kenya”, annunciò il suo vice Mwai Kibaki nei primi mesi del governo Moi . la corruzione e bloccarono la creazione di una nuova autorità con un mandato simile. Tra i 132 casi di corruzione sui quali l’autorità stava allora indagando ci fu lo scandalo Goldenberg, che da solo sottrasse ai fondi pubblici 430 milioni di dollari. Il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale confermarono la sospensione dell’aiuto che era stata precedentemente imposta al Paese 180. Nel 2002 si presentò il problema della successione a Moi, che non poteva ricandidarsi per il terzo mandato. Moi sostenne la candidatura del figlio di Kenyatta, Uhuru, e contemporaneamente si propose come presidente anche il figlio dell’ex vicepresidente Jaramongi Oginga Odinga. Il Narc (National Raimbow Coalition, cioè “Coalizione Nazionale Arcobaleno”), già Napk (“Partito di Alleanza Nazionale del Kenya”), un cartello delle opposizioni democratiche, candidò Emilio Mwai Kibaki del Partito democratico, che fu sostenuto alfine da Odinga e da sei ministri di Moi che abbandonarono il Kanu. Il 27 dicembre 2002, quasi a sorpresa (tutti temevano un golpe di Moi), Kibaki vinse le elezioni, assicurandosi centoventicinque seggi sui duecentodieci elettivi, nell’entusiasmo generale. Nondimeno, i kenyoti rimasero presto delusi dall’azione di Kibaki. Il presidente promise nuove terre a chi ne abbisognava, ma di fatto assegnò migliaia di ettari ai privati con accordi sospetti: Nel marzo 2006, la polizia fece irruzione negli uffici del quotidiano «The African Standard», il giornale fu chiuso e le trasmissioni della rete televisiva della stesso gruppo furono bloccate. Un’irruzione fu fatta anche contro Ktn, che era allora la più popolare rete televisiva. La disputa con i media continuò anche nel 2007, anno in cui dovevano svolgersi le nuove elezioni181. Ciononostante, Kibaki ottenne nei primi anni di governo la fiducia di buona parte del mondo occidentale. La decisione di rendere gratuita l’istruzione primaria, che agevolò l’ingresso nelle scuole di due milioni di studenti in più rispetto al passato, ottenne il plauso di Bill Clinton, che incontrò Kibaki nel 2005 nel corso di un viaggio ufficiale in Kenya. Proprio nel 2005 Kibaki lanciò il testo provvisorio di una nuova Costituzione (meno innovativa di quanto il popolo kenyota si aspettasse) che però fu respinta da un referendum nel novembre dello stesso anno. Questo sconfitta portò Kibaki a formare, il 23 novembre 2005, una nuova squadra di governo 182 (“il Nuovo Governo Nazionale”, Ngn), ma ad annuncio avvenuto sedici ministri e viceministri rifiutarono l’incarico. Poco prima delle elezioni del 2007, Kibaki sponsorizzò la nascita del “Partito di Unità Nazionale” (Pnu), una coalizione che abbracciava partiti come Kanu, Narc-Kenya, Ford Kenya, Ford-Popolo, Partito Democratico, Shirikisho e il Napk. Il Pnu ovviamente propose la rielezione del presidente Kibaki, l’opposizione si divise tra il “Movimento democratico arancione” di Odinga (Odm) e il “nuovo Odm” di Kalonzo Musyoka. Le elezioni, avvenute in un nuovo scenario di guerra etnica, furono caratterizzate da brogli da ambo le parti: ad un terzo dell’elettorato non fu permesso di votare ed entrambi i candidati ricevettero più voti di quelli realmente espressi dalla popolazione. Ufficialmente vinse Kibaki per una manciata di voti, seguito subito dopo dall’Odm di Odinga che ottenne la maggioranza dei seggi in parlamento. Il giuramento di Kibabi (30 dicembre 2007) diede l’abbrivo ad un’escalation di violenza etnica inaudita che produsse circa millecinquecento morti e cinquemila sfollati. 180 G.Caramazza, Kenya, la Terra dello Struzzo, «misna.org», gennaio 2011 181 G.Caramazza, Kenya, la Terra dello Struzzo, cit. 182 Queste le parole pronunziate da Kibaki: “A seguito dei risultati del referendum, è diventato necessario per me, come Presidente della Repubblica, di riorganizzare il mio governo per renderlo più coeso e più capace di servire il popolo del Kenya”. Per fermare il nuovo massacro, l’Unione africana inviò il presidente del Ghana John Kufuor a mediare, mentre il presidente ugandese Museveni trattò personalmente con Kibabi e Odinga. Alla fine fu l’ex segretario generale dell’Onu, Kofi Annan a convincere Odinga e Kibabi a trovare un accordo (28 febbraio 2008): l’Odm entrò al governo e Odinga divenne primo ministro. Il rapporto è proseguito con continui alti e bassi, ma la stabilità del governo e l’equilibrio politico tra le massime cariche della repubblica resta ancora una chimera. In questo quadro, nel maggio 2010 il Parlamento ha varato una nuova costituzione, che ha ottenuto nell’agosto dello stesso anno l’approvazione del 67% degli aventi diritto al voto, oltre quattro milioni di voti su poco più di sei milioni di elettori. Con la nuova “legge fondamentale”, il Kenya resta una repubblica presidenziale, ma il parlamento guadagna potere diventando bicamerale, attraverso la creazione di una camera alta composta da sessanta membri in rappresentanza delle quarantasette contee del Paese. Parimenti, sono state istituite una Corte Suprema composta da cinque giudici e una Commissione giudiziaria indipendente per sorvegliare sulla nomine ai vertici dello Stato. Per la prima volta nella storia del Kenya, è stata introdotto la doppia cittadinanza e l’ottenimento di una nuova cittadinanza non significherà la perdita di quella kenyota. Restano in piedi gli elementi costituzionali contro i quali si è attivato il mondo cristiano: l’articolo 26, comma quattro - che ribadisce l’illegalità dell’aborto, ma che lo tollera per “trattamenti di emergenza” riguardanti la salvaguardia della vita e della salute della madre - e l’articolo 24, comma quattro - che affida la risoluzione delle controversie in materia di diritti, status personale, matrimonio, divorzio ed eredità riguardanti i mussulmani ai tribunali di diritto islamico, incorporati nel sistema giuridico dello stato. Nel 2012 i kenyoti saranno chiamati alle prime elezioni generali successive al varo della Costituzione. Kofi Annan, presidente dell’App (Africa Progress Panel183), ha recentemente incontrato esponenti cristiani, indù e mussulmani per ottenere garanzie circa il mantenimento di un ambiente favorevole a consultazioni trasparenti e pacifiche. Sul fronte della politica estera, resta alta la tensione con le Corti Islamiche e al-Shabab che sta colpendo ripetutamente il Kenia con attentati e sequestri di persona 184, al fine di destabilizzare il governo e arrestare il coinvolgimento del governo Odinga-Kibabi nella guerra somala. Già nel 2010 il governo keniota ha dovuto fronteggiare migliaia di persone (in buona parte di etnia somale) scese in piazza per partecipare alla protesta del Muslim Human Rights Forum (Mhrf) contro l’estradizione in Giamaica dell’imam anglo-giamaicano Sheik Abdullah al-Faisal, un predicatore razzista – già attivo in Gran Bretagna – che ha invitato i suoi seguaci ad uccidere gli ebrei, gli indù, i cristiani e gli americani. Dietro le proteste del Mhrf si nascondeva, a detta dei kenyoti, l’ombra lunga di al-Shabab. Il 16 ottobre 2011 l’esercito kenyota ha invaso la parte meridionale della Somalia con blindati ed elicotteri, in risposta ai nuovi attacchi dei mussulmani vicini ad al-Qaeda: la guerra tra il terrorismo islamico somalo e la repubblica kenyota si preannuncia ancora lunga. Alla vigilia dell’indipendenza e alla fine del secondo conflitto mondiale –in particolare, dalla fine degli anni Cinquanta in poi- i mussulmani iniziarono a rivendicare la propria autonomia e a formare i primi movimenti indipendentisti. Nel 1956, Il movimento mwambao (swahili autonomi) si organizzò nel “Fronte dei Mwambao 183 L’Africa Progress Panel è costituito da un gruppo di persone autorevoli che monitorano e incoraggiano il progresso degli stati africani. È stato istituito sulla scia del vertice G8 di Gleneagles, tenutosi nel luglio 2005. 184 Nei primi giorni del mese di ottobre 2011 una donna francese di sessantasei anni, malata di cancro e paraplegica è stata prima sequestrata, poi torturata, infine uccisa dagli uomini di al-Shabaab. Uniti” (Muf), una coalizione ombrello di gruppi mussulmani che temevano l’assimilazione, rivendicavano la proprietà delle terre e agognavano l’unificazione con Zanzibar. Ma il primo – vero - tentativo di organizzazione collettiva dei mussulmani fu posto in essere nel 1968, con l’ “Unione nazionale dei mussulmani del Kenya” (Nukem), guidata da due giovani membri del governo Kanu vicini ai paesi arabi come l’Arabia Saudita e la Libia. Nel 1973 nacque il “Consiglio supremo dei mussulmani del Kenya” (Supkem), sotto l’egida del governo che lo riconobbe come unica rappresentanza legittima della popolazione mussulmana. Il Consiglio ebbe più successo del Nukem (nel 1996 affiliò circa 150 organizzazioni mussulmane) ma non riuscì a gestire i disordini del 1992-1994 e del 1998. Nella storia dei partiti islamici del Kenya annoveriamo anche il Mcc (“Consiglio consultivo mussulmano”), l’ “Associazione degli studenti mussulmani dell’Università di Nairobi”, la “Fondazione Islamica”, l’ “Organizzazione Mussulmana Istruzione e Welfare”. Con l’istituzione del sistema multipartitico, si formò il Ipk – “Partito islamico del Kenya” –che organizzò le contestazioni del 1992 per denunciare il mancato inserimento dei mussulmani nelle istituzione governative e pubbliche, l’indifferenza del governo per le aree abitate dai mussulmani, l’esclusione di fatto delle etnie islamiche dalle scuole e le scarse opportunità di lavoro. La tensione raggiunse il picco a Mombasa, quando furono arrestati diversi esponenti di Ikp e sette imam. I sostenitori di Ikp si risolsero ad attaccare direttamente gli edifici pubblici, ragione per la quale subirono una punizione esemplare dal governo. Quando il Ikp passò nelle mani del giovane sceicco Khalid Balala si radicalizzò fino al punto di chiedere la destituzione del presidente Moi e di scadere nella guerra verbale con i cristiani (che lamentavano l’insorgere del pericolo islamico). Il governo reagì formando un’organizzazione islamica moderata, l’Uma (“Musulmani Uniti d’Africa”), come contrappeso all’Ipk. Ipk e Uma iniziarono a sfidarsi a colpi di fatwa, promettendo l’uno la morte dei leader dell’altro partito, e di epiteti razzisti (gli esponenti di Uma si ritenevano dei veri africani “neri” a dispetto dei vili “marroni” arabi dell’Ipk). Lo scontro produsse altresì la fuoriuscita dall’Ipk di Balala che formò un’organizzazione – estremista quanto marginale – dal nome di “Fronte della Salvezza Islamica”. Nel 1994, sotto l’influenza del movimento Tabligh (“movimento di propaganda”, d’ispirazione indiana e pakistana), si registrarono dei disordini nella regioni costiere, istigati da giovani mussulmani puritani, che portarono alla messa al bando delle bevande alcoliche. Nel 1997 si diffusero nuove violenze nelle regioni costiere, con un bilancio di oltre un centinaio di vittime e con la migrazione di circa centomila persone, secondo i dati raccolti da Human Right Watch. In diversi casi furono lo stesso governo e le forze di polizia ad aiutare le giovani milizie del Kanu nelle reazione contro i ribelli. Queste furono assistite perfino da un “guaritore tradizionale”, Swaleh salim bin Alfan, che s’impegnava a rendere i giovani “invisibili e invulnerabili” attraverso riti d’iniziazione e cerimonie simili a quelle dei Mau Mau. Alcuni di questi miliziani indossavano divise che combinavano simboli religiosi propri dell’islam con emblemi caratteristici delle religioni tradizionali. Ma questi episodi sembrarono addirittura irrilevanti o folkloristici meno di un anno dopo, quando il fantomatico “Esercito islamico di liberazione del Kenya” (agenzia di al-Qaeda) si macchiò del criminoso attentato di Nairobi. Quell’episodio – apparentemente indipendente dalle tensioni religiose ed etniche interne al Kenya – costrinse le autorità locali a considerare un problema fino a quel momento indifferente ai kenioti: il radicalismo islamico. Si è notato nel corso degli anni che le comunità islamiche, votate fino a pochi anni prima al sufismo più pacifico, iniziavano ad avvicinarsi pericolosamente al wahhabismo. Un avvicinamento originato dalla presenza di Ong islamiche e associazioni di beneficenza finanziate dall’Arabia Saudita e dagli altri stati del Golfo; dalla costruzione sempre più celere e diffusa di moschee e madrase, finanziate dagli stessi paesi arabi, all’interno delle quali veniva chiaramente predicato il wahabismo stesso; dai continui “viaggi di studio” dei giovani in Arabia Saudita. Non a caso, dopo gli attacchi alle ambasciate statunitensi, le autorità keniote decisero di chiudere cinque Ong: Mercy Relief International Association, al-Haramein Foundation, Help African People, International Islamic Relief Organisation, Ibrahim bib Abd al Aziz al-Ibrahim Foundation e Rabitat al-Islam, tutte sospettate di aiutare finanziariamente i terroristi. L’allarme crebbe ancora di più quando il fantomatico “Esercito della Palestina”, un gruppo che ha poi dichiarato di aver agito in difesa della Palestina nell’anniversario della sua divisione, ha rivendicato l’autobomba fatta esplodere dinanzi all’ Hotel Paradise di Mombasa (frequentato abitualmente da turisti israeliani) e il lancio di due missili Stinger contro un aereo di linea appena partito dall’aeroporto di Mombasa. Il secondo attentato fallì, ma l’autobomba causò tredici morti (tra cui due bambini israeliani) e ottanta feriti. In conclusione, quest’insieme di eventi, unito all’escalation di violenza generata dall’infiltrazione di al-Shabab nel territorio kenyota e al malcontento dei mussulmani della costa e della provincia nordorientale del paese, ci spiegano che il radicalismo islamico è “storia presente” del Kenya e fanno legittimamente temere che il terrorismo abbia ancora forti potenzialità di diffusione nell’area. 6. La Repubblica Unita di Tanzania è nata nel 1964, con la fusione di Tanganica (Tanzania continentale) e Zanzibar. Circa il 99% degli abitanti della terraferma è di origine africana (il 95% di questi appartiene all’etnia bantu, suddivisa a sua volta in circa centotrenta tribù) e il restante 1% abbraccia etnie asiatiche, europee ed arabe. A Zanzibar prevalgono arabi, africani ed etnie miste. Secondo recenti indagini della Cia, i cristiani sono indicativamente il 35% della popolazione (metà cattolici, metà protestanti) i mussulmani circa il 33% e i seguaci delle religioni tradizionali rappresentano intorno al 30% degli abitanti. Nell’arcipelago di Zanzibar i mussulmani sono nettamente dominanti: circa il 99% degli abitanti ha scelto la fede islamica, contro l’1% dei cristiani. Nel 2009, uno studio dello statunitense United States Bureau of Democracy, Human Rights and Labor ha suggerito invece che circa il 62% della gente di Tanzania sia di fede cristiana, il 35% mussulmana e il 3% di altre religioni. La storia dell’islam nella regione parte già dagli albori del primo millennio, quando i commercianti persiani e arabi si stabilirono lungo la costa orientale della Tanzania e parallelamente nell’Africa centrale, nelle isole Comore, in Madagascar, nei Grandi Laghi e in Zimbabwe, favorendo la nascita della lingua e della cultura swahili, frutto della commistione di elementi bantu, africani e arabi. Ad arabi e persiani si deve, tra i secoli XIII e XV 185, la costruzione di vere e proprie città-stato sulla costa e sulle isole di Zanzibar e Kilwa così come lo sviluppo di un fiorente commercio nell’area (come oro e avorio) diretto diverse le Indie. Il vero controllo della Tanzania, però, restava nella mani delle tribù bantu 186, che stabilirono 185 E’ il cosiddetto periodo shirazi, che prende il nome dai sultani che regnavano sulle numerose città-stato arabe della regione e che nella maggior parte dei casi si ritenevano discendenti di famiglie aristocratiche della regione di Shiraz, in Persia. 186 Il matrimonio dei coloni arabi e persiani le con donne bantu determinò la nascita di nuove genti: i sawahila (i relazioni con l’Arabia Saudita e il Golfo Persico adottando l’islam nei nuovi centri urbani. Le zone interne non fiorirono come la costa, penalizzate dal commercio transfrontaliero, e al tempo stesso non subirono i processi di conversione religiosa tipici dei nuovi centri urbanizzati. Negli anni che seguirono l’esplorazione di Vasco de Gama, furono i portoghesi a conquistare gran parte della costa dell’Africa orientale. Una colonizzazione, quella portoghese, che la popolazione nativa non subì in modo passivo, ma che destò anzi la ribellione dei bantu, più volte repressi nel corso dei secoli. I portoghesi lasciarono il posto, nel secolo XVIII, al sultanato di Oman che costrinse i lusitani a spostarsi progressivamente fuori dalla regione. All’inizio del 1813, Sayyd ibn Said, sultano dell’Oman, stabilì il suo comando sulle isole della costa dell’Africa dell’Est. Nel 1828 conquistò Mombasa e nel 1840 trasferì la capitale del suo regno a Zanzibar, contribuendo in modo significativo allo sviluppo della zona attraverso la creazione di rotte commerciali che mettevano in comunicazione le zone interne del lago Tanganica e dell’Africa centrale con l’Estremo Oriente. Fu in questo periodo che Zanzibar divenne una delle capitali della cosiddetta rotta orientale della tratta degli schiavi africani. Gli arabi introdussero anche la produzione di chiodi di garofano, che valse a Zanzibar e ad alcune isole vicine l'appellativo di “isole delle spezie”. Il commercio richiedeva scambi e rapporti con l’interno, quindi si costituirono nuovi porti lungo la costa, come punti di partenza per le rotte verso l’entroterra che portavano alla regione dei Grandi Laghi. I governanti omaniti dello Zanzibar, nondimeno, non cercarono di diffondere l’islam verso l’interno, ma fu piuttosto a causa della diffusione degli schiavi convertiti e di alcune tribù, in particolare quelle che si trovarono a stretto contatto con il commercio. Mentre gli esploratori si spingevano nell'entroterra continentale, i diplomatici e i politici europei (più di tutti i britannici) stringevano i primi rapporti con il sultanato di Zanzibar. Grazie alla pressione inglesi, intanto, il sultano alleviò la condizione di schiavitù e nel 1876 vietò formalmente la tratta di schiavi. Intorno al 1884 i tedeschi presero il controllo del moderno Tanganica attraverso la German East India Africa Company (Doag), la società tedesca dell’Africa dell’est, e nel giro di due anni conquistarono una cintura costiera di dieci miglia che era appartenuta al sultanato di Zanzibar. Nel 1890 il Regno Unito firmò con l’impero tedesco il trattato di Helgoland-Zanzibar, con il quale la Germania rinunciava al sultanato di Wituland, riconosceva il dominio inglese su Uganda, Sudan e la costa del Kenya e s’impegnava a non interferire nelle relazioni fra il sultanato di Zanzibar e il Regno Unito. La Germania otteneva in cambio l’arcipelago di Helgoland, il dito di Caprivi e il controllo della costa intorno a Dar es Salaam. Il dominio europeo e la fine del commercio degli schiavi portarono al rafforzamento del commercio e alla più generale pacificazione. Il Tanganica divenne il punto di riferimento per le transazione e le attività commerciali dell’Africa dell’est e persino dell’Africa centrale. I tedeschi costruirono ferrovie, strade e città, introducendo nuovi tipi e tecniche di coltivazione. La costruzione delle ferrovie contribuì anche al rafforzamento delle comunicazioni tra gli islamici (a Ujij, sul lago Tanganica, veniva aperto un importante centro islamico) agevolati dal fatto che i tedeschi li utilizzavano come funzionari di polizia, soldati ed insegnanti. Ma anche i tedeschi non esitarono a reprimere le rivolte locali, schiacciando prima i ribelli del popolo hehe-guidati da Mhwawa, tra il 1891 e il 1894, e di nuovo nel 1898, e poi la popolazione stanziata nella zona del fiume Rufiji, che si opponeva al lavoro forzato nelle piantagioni di cotone. Nel 1905 a ribellarsi fu il popolo matumbi, guidato da Kinjikitile Ngwale, la cui protesta si estese da Dar es Salaam ai monti Uluguru, nella valle di Kilombero, fino alle sponde settentrionali del lago Malawi. costieri). Nel 1907 scoppiarono anche le proteste del popolo ngoni e dei maji maji – forse il primo esempio di lotta nazionalista sorto in Tanzania – ma anche qui i tedeschi intervennero con durezza causando circa centoventimila vittime tra gli africani. Dopo le aspre battaglie della Prima guerra mondiale, come quella volta a conquistare la città di Tanga il 4 novembre 1914 (il primo grande evento della guerra in Africa, che vide soccombere gli inglesi contro le sparute forze degli ascari tedeschi), la Lega delle Nazioni assegnò al Regno Unito il mandato per amministrare l’ex Africa Orientale Tedesca, Tanzania compresa. La colonia, che manteneva la capitale a Dar es Salaam, fu affidata all’amministratore britannico Sir Horace Archer Byatt e fu ribattezzata nel 1920 col nome di “Tanganica”. Gli inglesi non avviarono una dominazione basata sull’assimilazione e sulla linea dura di comando, ma promossero la nascita delle istituzioni locali, delle prime organizzazioni africane, e sostennero l’ingresso dei tanzaniani negli organi legislativi e amministrativi. L’islam, in questa fase, non possedeva ancora una sua specifica identità e autonomia e nelle zone interne del paese si era spesso confuso con le tradizioni tribali già esistenti (per esempio, la credenza in un solo Dio si univa al culto e all’adorazione degli antenati). In generale, si può quindi sostenere che in quel periodo le tradizioni bantu rappresentavano il sottostrato culturale di quelle popolazioni, formando invece le tradizioni islamiche la sovrastruttura che si ergeva sopra di esse. È il motivo per cui il radicalismo islamico, che già condizionava altre aree del continente qui in Tanzania, faceva fatica e svilupparsi ed a penetrare in profondità. Tuttavia, anni dopo, le autorità coloniali inglesi riferirono che nelle zone dell’Africa orientale sotto controllo tedesco, come in Tanganica, vi era un non meglio specificato movimento in via di sviluppo che mirava a coniugare una visione dell’islam panafricana (suscitando di conseguenza una maggiore vigilanza, negli anni Venti e Trenta, al fine di impedire pericolose commistioni tra elementi bantu e islamici). Anche se sulla costa e nelle isole di Zanzibar, Lemu e Pemba, i mussulmani avevano sviluppato una maggiore caratterizzazione ideologica e religiosa, il loro sguardo era piuttosto rivolto verso la penisola araba che non verso l’interno del continente. Gli arabi e gli indiani che qui si erano stanziati, utilizzavano l’islam come una sorta di scudo protettivo contro le influenze africane e in particolare contro coloro che non potevano rivendicare discendenze di tipo persiano, arabo o indiane. Proprio gli indiani, ad esempio, non adottarono la cultura swahili e tantomeno si sposarono con gente swahili, conservando gelosamente i propri riti e pregando solo nelle proprie moschee. Rispetto alla cooptazione dei tanzaniani all’interno degli organi amministrativi inglesi, va sottolineato che i britannici distinsero tra arabi, swahili e africani, affidando ai primi gli incarichi di maggiore rilievo, ai secondi delle funzioni meno importanti e ai terzi ruoli di basso prestigio. Sicuramente questo sistema accentuò sentimenti razzisti ed arrivò a marcare la distinzione stessa tra i fedeli mussulmani, tanto da adottare la separazione delle moschee swahili da quelle africane. Contemporaneamente, gli inglesi avevano sponsorizzato al massimo le prime scuole, fin dai primordi del loro intervento in Africa, grazie anche al lavoro dei missionari cristiani e nel 1929 l’ordine dei benedettini aveva più di settecento insegnanti solo nei villaggi della Tanganica del Sud. Nelle comunità mussulmane, mandare i propri figli a queste scuole era considerato al pari di un tradimento (e un peccato). Il mandato al Regno Unito fu confermato anche dopo la Seconda guerra mondiale, su decisione delle Nazioni Unite in data 13 dicembre 1946. Come in altri paesi, pochi anni dopo videro la luce le prime spinte indipendentiste e le prime organizzazioni nazionaliste. Nel 1954, Julius Nyerere – un maestro di scuola, nonché uno dei due soli tanzaniani ad aver ricevuto un’istruzione universitaria all’estero – fondò il Tanganyika African National Union (Tanu), il primo vero partito dell’indipendenza tanzaniana. Il Tanganica divenne formalmente autonomo nel maggio del 1961, e pienamente indipendente il 9 dicembre dello stesso anno, quando Nyerere fu eletto primo ministro. La nuova nazione venne accolta come repubblica nel Commonwealth un anno più tardi. Il 9 dicembre del 1963, due anni dopo la dichiarazione d'indipendenza, anche Zanzibar raggiunse la sua sovranità, formandosi come monarchia costituzionale sotto il governo del sultano. Il primo governo fu formato dal “Partito Afro-Shirazi” (Afro-Shirazi Party, Asp) che, come nel caso del Tanganica, era stata la principale forza politica a guida della transizione verso l'indipendenza. Il 26 aprile 1964 Tanganica e Zanzibar si unirono a formare la Repubblica Unita di Tanganica e Zanzibar (United Republic of Tanganyika and Zanzibar), ribattezzata Tanzania il 29 ottobre, ma nella costituzione della nuova repubblica Zanzibar mantenne un elevato grado di autonomia rispetto alle autorità centrali. Nel 1977, sotto la spinta di Nyerere, il Tanu e l'Asp si fusero in un partito unico, il Chama Cha Mapinduzi (Csm) ovvero il “Partito della Rivoluzione”. L’indipendenza della Tanzania cambiò in parte le condizioni dei mussulmani, ma non in maniera tale da costringerli alla coesione. Se da un lato i nazionalisti sospettavano dei mussulmani (ritenendoli troppo legati alle influenze non africane e, segnatamente, ad una prospettiva di matrice arabo-islamica) dall’altro concessero invece una certa autonomia nel campo economico e sulle questioni di culto. Come accadde in Kenya, furono rispettati, e mantenuti in vigore, i tribunali islamici. Nel contempo, i mussulmani continuarono a dividersi tra di loro, in particolare tra sciiti (indiani) e sunniti. Questi ultimi faticavano ad accettare la fiducia che gli investitori arabi nutrivano nei primi (gli arabi destinavano agli sciiti ingenti somme di denaro e prestiti per attività commerciali) e mal sopportavano il fatto che gli sciiti controllassero le piantagioni e il mercato all’ingrosso senza coinvolgere le altre comunità mussulmane. Gli sciiti tanzaniani, profondamente classisti e chiusi nei confronti delle altre culture, disprezzavano gli swahili e si opponevano fortemente ai matrimoni misti, specie se si trattava di unirsi con donne africane non arabe. Nella comunità sciita si distinsero gli ismailiti, che presto risultarono tra i gruppi meglio organizzati nel paese. Furono, tra i mussulmani, quelli più coesi e attivi nella formazione di aziende, infrastrutture e scuole di standard europeo, che istituirono come alternativa alle scuole tradizionali coraniche. Il ruolo dominante svolto è ancora oggi riscontrabile nelle opere più importanti, come gli ospedali, le industrie, i siti storico-culturali, le compagnie assicurative e i grandi hotel gestiti dalla Aga Khan Foundation-run a Dar es Salaam. Al nord-est del paese vivevano invece i somali, quasi tutti di credo sunnita-shafiita, maggiormente concentrati nella costruzione di una “Grande Somalia”. A Zanzibar e Kilwa si stabilirono le prime comunità sufi: la Qadiriya fu abbracciata dai mussulmani di Zanzibar, la Shadiliya da quelli di Kilwa. La politica di Nyerere e del Tanu-Ccm fu caratterizzata dal tentativo di riformare profondamente la società tanzaniana, sradicando il retaggio lasciato dal colonialismo sul piano economico, politico e culturale, e tesa a riscoprire la tradizione africana in chiave socialista. Il progetto culturale e politico di Nyerere prese il nome di Ujamaa (in swahili “famiglia estesa”) e aveva il suo principale manifesto nella “dichiarazione di Arusha”, su cui si basava, in parte, la costituzione della Tanzania stilata nel 1982 e modificata nel 1984. Il Ccm aveva la funzione di guida di questa transizione e governò per diversi decenni in regime strettamente monopartitico, dedicando parte delle sue risorse alla diffusione della cultura dell’ ujamaa nelle scuole. L'ujamaa identificava nel villaggio rurale, con proprietà collettiva dei mezzi di produzione, l'unità fondamentale della società e dell'economia del paese, anche se quest’ideologia rappresentava una strana miscela di marxismo maoista e di cristianesimo umanista. Obiettivo di Nyerere era quello di portare la Tanzania all'autosufficienza, rifiutando l'ingresso del paese nelle logiche di mercato internazionali proprie del modello occidentale. L'ujamaa rappresentava comunque uno degli esempi più eclatanti e tipici di socialismo africano, e poneva in contrapposizione la Tanzania con il vicino Kenya, che preferì abbracciare, subito dopo l'indipendenza, la logica del capitalismo internazionale. Nyerere vinse le prime elezioni presidenziali nel 1962, anche se attraverso intimidazioni e perquisizioni della polizia contro i suoi avversari. E a guerra fredda iniziata, Nyerere scelse di mantenere le sue relazioni sia con i membri del “Patto di Varsavia” sia con i “paesi non allineati”. Nello stato corporativista, che forgiò personalmente, tutti i gruppi d’interesse (organizzazioni femminili, giovanili, religiose, etniche e sindacati) furono controllati direttamente dal governo, e i leader e membri di queste organizzazioni divennero una sorta di funzionari di stato. L’idea che sottostava al corporativismo di stato era che tutti i gruppi dovessero essere rappresentati, ma sempre e solo sotto il controllo governativo, almeno sino a quando quest’ultimo non si fosse evoluto – “con l’abnegazione di tutti i cittadini” - verso una struttura più democratica. Di conseguenza, l’apparato militare fu strettamente collegato sia alla macchina statale sia a quella del partito, i soldati, infatti, potevano anche coprire la posizione di ministri e deputati, viceministri e funzionari di partito. Questa comunione tra stato, esercito e partito fu sviluppata anche per impedire operazioni golpiste, come quelle tentate nel 1968-1969. Nyerere aveva l’abitudine di creare commissioni presidenziali ogni volta che si riteneva necessario congelare o cancellare dei problemi: queste commissioni si pronunciavano a priori sulle singole questioni che interessavano i cittadini, per cercare solo dopo il sostegno del popolo, a fatto compiuto. I tanzanesi era liberi di dibattere, localmente, sulle questioni che avevano più a cuore, ma le lagnanze sulle attività del governo potevano essere espresse solo in presenza di funzionari governativi. Le elezioni politiche locali avevano solo una valenza simbolica: i candidati erano sempre due e dello stesso partito. La scheda delle elezioni presidenziali prevedeva un si al presidente (accompagnato al suo volto) e un no, inserito in un riquadro vuoto e grigio. O meglio, si poteva scegliere tra un si, legato al volto del presidente e un no, inserito in riquadro grigio vuoto. L’apparato di sicurezza della Tanzania era fortemente pervasivo (caratteristica conservata nel tempo), sebbene il controllo delle persone fosse meno opprimente rispetto agli stati sovietici (ai cittadini si chiedeva anche di agire come occhi e orecchie dello stato). Nel 1970 Nyerere lanciò un programma di ritorno coatto alla terra: l’85% delle popolazione rurale fu costretta a lasciare le case e i villaggi per inserirsi nelle settemila comunità rurali dello stato. Nel 1979 l'Uganda di Idi Amin tentò di invadere la regione tanzaniana di Kagera, ma la Tanzania respinse l'offensiva e proseguì invece con l'invasione dell'Uganda. L'esercito tanzaniano avanzò in Uganda con il sostegno degli esuli ugandesi oppositori di Amin, riuniti nell' “Esercito di liberazione nazionale” dell'Uganda. Questa coalizione conquistò la capitale ugandese, Kampala, l'11 aprile dello stesso anno, e costrinse Amin alla fuga e all'esilio. Nel 1985 Nyerere passò il governo del paese al numero due del Ccm, Ali Hassan Mwinyi, che nel 1990 sostituì Nyerere anche come segretario del partito. Sotto il governo di Mwinyi vennero messe in atto le riforme necessarie a consentire elezioni democratiche multipartitiche, che ebbero luogo per la prima volta nell'ottobre del 1995. Le elezioni furono vinte a larga maggioranza dal Ccm, che elesse alla presidenza il proprio candidato, Benjamin William Mkapa, il 23 novembre. I risultati delle successive elezioni politiche del 2000, nuovamente vinte dal Ccm, furono contestati dall'opposizione, e la tensione politica sfociò in una serie di scontri fra la polizia e i dimostranti a Zanzibar, nel gennaio del 2001. Ancora il Ccm risultò vincitore nella consultazione del dicembre 2005, con l'elezione dell'attuale presidente Jakaya Mrisho Kikwete. La Tanzania è ufficialmente uno stato secolare, garantisce la libertà di confessione ma non tollera partiti di natura religiosa. La scelta sulla presidenza sembra invece ruotare tra mussulmani e cristiani: Nyerere, il primo presidente della Tanzania, era un cristiano; il suo successore, Ali Hassan Mwinyi, era mussulmano, Mkapa, di nuovo cristiano, e il presidente Kikwete mussulmano, ed è la stessa logica a muovere la composizione dei governi, anch’essi equilibrati tra mussulmani e cristiani. Nelle scuole, anch’esse sotto il controllo dello stato, il sistema tiene conto delle quote per rappresentare tutti i gruppi tribali, etnici e religiosi. Sotto il suo regime, Nyerere creò il “Consiglio supremo dei Mussulmani in Tanzania”, conosciuto con l’acronimo Bakwata (Baraza Kuu Waislamu Watanzania) al fine di rappresentare, unificare e controllare tutti i mussulmani del paese. Ufficialmente, aveva il compito di promuovere gli interessi mussulmani nella legislazione, nell’istruzione e negli affari religiosi della Tanzania. Bakwata non è però riuscita a dar voce ai diritti dei mussulmani nel paese, ma il suo contributo è stato essenziale per ottenere il sostegno dei mussulmani durante le elezioni. Bakwata ha perso, nel corso degli anni, la residua legittimità che le era stata elargita e nel tempo è finita con l’essere accusata di pesanti coinvolgimenti nella corruzione del governo. Sotto il regime Neyrere fu istituito a Dar es Salaam anche il Council of Muslim elders (consiglio degli anziani mussulmani) ed ogni qualvolta Neyrere intendeva fare un annuncio importante cercava di incontrare personalmente i saggi del consiglio per ottenere il sostegno necessario, che veniva puntualmente corrisposto, sia per ingraziarsi il governo, sia per guadagnare autorità tra gli stessi mussulmani. L’apertura economica degni anni Ottanta comportò che alcuni gruppi ottenessero privilegi maggiori rispetto agli altri e questo dislivello portò tensione tra le correnti mussulmane, ma soprattutto generò scontri tra cristiani e mussulmani, scoppiati sovente anche nelle piazze. Negli anni Novanta, con la nuova apertura democratica del paese, la tensione sul fronte mussulmano aumentò considerevolmente. Nel 1992 il governo annunciò che per ridurre la spesa pubblica la gestione della sanità e dell’istruzione sarebbe stata trasferita alla chiesa cattolica, e in risposta a questa decisione un gruppo fondamentalista, il Council for The Promotion of the Koran in Tanzania (il Consiglio per la promozione del Corano in Tanzania, meglio conosciuto come Balukta, acronimo swahili di Baraza la Uendelezaji wa Kuran Tanzania) occupò i quartieri generali del suo rivale Bakwata, considerato un fantoccio cristiano nelle mani del governo. In seguito a questa azione dimostrativa il gruppo islamico fu messo fuorilegge. Il suo leader, lo sceicco Shaykh Yahya Hussein, ripiegò sulla propaganda di strada ed iniziò ad utilizzare una retorica sferzante e provocatoria contro Bakwata e il governo durante i sermoni nella moschea centrale di Daar Es Saalam. Nell’aprile del 1993 il gruppo islamico organizzò manifestazioni di piazza, distrusse macellerie di proprietà cristiana (perché vendevano maiale) e attaccò perfino alcuni ritrovi frequentati da cristiani. Lo sceicco venne arrestato, con altri quaranta esponenti del suo partito, e con l’accusa di voler distruggere il sistema tanzaniano per instaurare uno stato basato sulla sharia. Poco più tardi, riuscì a fuggire nello Swaziland, mentre un altro leader del Balukta, lo sceicco Shaykh Kassim Bin Jumaa, restò in custodia cautelare, fino alla sua sospetta morte per ipertensione nel gennaio del 1994. Balukta fu bandito, nonostante si siano successivamente registrati dei tentativi, da parte del governo, di reintegrare alcuni suo membri all’interno della compagine Bakwata. Nel 1998, un gruppo mussulmano chiamato Khidmat Da’wat Islamiyya (Service for Islamic Propagation) nel corso di alcune preghiere pronunciate nella moschea di Daar es Saalam proferì slogan minacciosi contro i cristiani. Ne derivarono violenti scontri di piazza che causarono diversi morti e l’arresto di un centinaio di persone. Il governò asserì che i responsabili degli scontri erano stranieri provenienti da Arabia Saudita, Iran, Libia e Sudan e dopo averli identificati decise di espellerli dal paese. Un tanzanese, Khalfan Khamis Mohammed, o meglio un terrorista già sotto osservazione del governo americano per altri episodi, rimase coinvolto nell’attentato di Dar Es Salaam del 7 agosto 1998. Mohammed era nato in una delle isole della Tanzania e si era trasferito a Daar Es Salaam per raccogliere danaro in vista della sua partenza per l’Afghanistan. Nel 1995 fu rispedito in Tanzania – come copertura gestiva una pescheria – con il compito di organizzare il trasporto dei componenti delle bombe e trovare una casa sicura per costruire il dispositivo dinamitardo. In seguito all’intervento degli Stati Uniti in Afghanistan, in Tanzania si moltiplicarono le manifestazioni in favore di Osama bin Laden, non tanto come esponente di al-Qaeda, quanto come simbolo della tenace resistenza agli Stati Uniti. È difficile stabilire con precisione, invece, la natura e le finalità dell’organizzazione segreta Simba wa Mungu (Leone di Dio), responsabile degli attentati alla moschea di Mwembechai a Dar es Salaam (13 febbraio 1998) nei quali morirono quattro mussulmani. Il suo fondatore, lo sceicco Ponda Issa Ponda, fu accusato nel 2002 di aver organizzato attentati contro cittadini stranieri e di essere un mussulmano corrotto, di aver condotto attacchi a mano armata contro moschee moderate e di aver incendiato un bar turistico nella città di Stone Town ( Mji Mkongwe, Zanzibar). In risposta alle accuse, fu organizzata una manifestazione speciale in difesa di Ponda da un gruppo denominato, per l’appunto, Ponda Group. La polizia intervenne con lacrimogeni e spari per disperdere i manifestanti e il bilancio finale della manifestazione fu di due morti –un poliziotto e un civile – e di cinquantatre arresti. Otto delle persone arrestate, tra cui Shaykh Ponda e Shaykh Mussa Kanducha, furono accusate dell’omicidio del funzionario di polizia, ma in seguito le accuse a loro carico caddero, anche se nel 2003 Ponda tornò in carcere, con l’accusa di tessere accordi con i terroristi di Kenya e Burundi. Secondo le analisi prodotte dagli analisti americani, la presenza di un partito islamico sponsorizzato dal governo ha indubbiamente agevolato la deriva estremista. Benché il terrorismo islamico sia alquanto debole nel paese, il fatto che le istituzioni siano considerate corrotte, che la povertà estrema interessi circa la metà della popolazione e che i paesi vicini – come il Sudan e la Somalia – siano tutt’altro che pacifici, potrebbero rendere la Tanzania un terreno ideale per il reclutamento degli islamici radicali. Se l’estremismo mussulmano ha destato preoccupazione nella vecchia Tanganica, ancora di più hanno impressionato il governo tanzaniano e l’Occidente gli avvenimenti nell’isole di Zanzibar. Quando il Tanganica ricevette l’indipendenza dai britannici, l’isola di Zanzibar era dominata da un’aristocrazia araba che schiacciava la minoranza shirazi. Gli africani, al tempo, rappresentavano circa il 77% della popolazione, gli shirazi circa il 7% e gli arabi il 17%. Questi ultimi, però, monopolizzarono i vertici decisionali e la gestione delle piantagioni agricole che costituivano uno dei fondamenti dell’economia. Le tensioni elettorali e la violenza esistevano nell’arcipelago Zanzibar già dalle prime elezioni che avvennero quando la colonia era ancora britannica, nel luglio 1957. Alle elezioni, il “Partito Afro-Shirazi” (Asp), un partito radicale di destra che rappresentava i residenti africani di Zanzibar, non ottenne alcun seggio rispetto ai partiti che rappresentavano interessi pro-arabi, pro-swahili e pro-britannici. Le elezioni del 1961 si risolsero in un pareggio e quindi furono ripetute sei mesi più tardi. Dopo quel voto, diversi partiti formarono una coalizione contro l’Asp, che ottenne soltanto dieci dei ventisei seggi in palio, nonostante avesse vinto tutti i ballottaggi con il 49,9 % dei voti. Seguirono accesi scontri tra gli arabi e le popolazioni native, accusate dai primi di intimidazione e voto doppio (quando le isole ricevettero l’indipendenza dai britannici, nel dicembre del 1963, erano governate da questo tipo di coalizione). Un mese più tardi, un immigrato dell’Uganda di nome John Okello portò avanti un colpo di stato violento contro il governo e il sultanato, rovesciandoli entrambi. La maggior parte della popolazione araba di Zanzibar fu massacrata o espulsa e fu stabilito un Consiglio rivoluzionario dello Zanzibar composto da membri dell’Asp guidato da Abeid Karume. Neyriere concluse un act of union con Karume nell’aprile del 1964, creando la moderna Tanzania, ma questa fu una decisione che la maggior parte della popolazione dello Zanzibar non ha mai accettato. Nel 1972, Karume venne assassinato e sostituito da Aboud Jumbe, ma questo episodio suggerì al governo di rafforzare la struttura statale e i partiti Asp e Tanu vennero unificati nel Ccm. Nuove tensioni, benché non eccessivamente violente, avvennero di nuovo nel 1992, quando Zanzibar annunciò la sua adesione all’ “Organizzazione degli Stati Islamici” (Oic), di cui non faceva parte la Tanzania, e questa decisione causò un tale scompiglio nei media della Tanzania e nel parlamento da costringere Zanzibar a ritirare la domanda. Quando furono legalizzate le elezioni multipartitiche, il “Fronte Civico Unito” (Cuf) di Seif Shariff Hamad ottenne una buona visibilità in Zanzibar (aveva il suo quartier generale nell’isola islamica di Pemba) e rivendicò la separazione delle isole dal Tanganica, suscitando una forte irritazione del governo centrale. Da quel momento, Il Cuf divenne il principale avversario elettorale del Ccm. Nel 1995, il candidato del Ccm, Salmin Amour, fu dichiarato vincitore con il 50.2% dei voti, ma le elezioni non furono considerate né eque e né regolari per evidenti brogli amministrativi. Conseguentemente, l’assistenza internazionale allo sviluppo venne interrotta e la maggior parte degli stranieri che lavoravano nell’isola abbandonarono il paese. Negli anni successivi le tensioni si acuirono e nel 1997 una chiesa cattolica a Zanzibar fu distrutta da un’esplosione. Le elezioni del 2000 a Zanzibar videro un distacco minimo tra i candidati, vicini l’uno all’altro, ma il candidato del Ccm, Amani Abeid Karume, figlio del primo capo di governo dopo il colpo di stato, fu dichiarato vincitore. In reazione, nel gennaio del 2001 il Cuf organizzò numerose manifestazioni di protesta. Nell’isola di Pemba, la polizia rispose con la forza e Human Rights Watch riferì di almeno trentacinque morti, seicento feriti, scontri a fuoco, pestaggi e abusi sessuali. Dopo questa violenza Cuf e Ccm avviarono un dialogo per mettere fine ad una crisi che durava da troppo tempo, ma le tensioni sembrarono ugualmente perdurare. Anche le elezioni del 2005 furono accompagnate di nuovo dalle accuse di voto doppio, di registrazione abusiva di non residenti e di soldati stranieri, al fine di impedire la vittoria dell’opposizione. Nel contempo, venne anche avanzato il sospetto che i membri dell’opposizione avessero fatto deliberatamente circolare delle schede finte. Poco dopo, esplosero di nuovo delle violente proteste perché al Cuf venne impedito di utilizzare delle strutture dello Zanzibar per una manifestazione, così come era stato invece permesso al Ccm, e gli scontri che precedettero le elezioni si conclusero con diciannove feriti. Nel serrato duello finale, Karume fu proclamato di nuovo vincitore. Queste storiche tensioni, politiche culturali, unite al fatto che le isole di Zanzibar non hanno vissuto la stessa crescita e lo stesso sviluppo del Tanganica, preoccupano notevolmente i governi inglesi e statunitensi, che temono fortemente l’influenza sull’arcipelo degli islamici salafiti provenienti dal Sudan e dall’Arabia Saudita. Gli Stati Uniti sostengono anche che l’Arabia Saudita finanzi lo Zanzibar con circa un milione di dollari all’anno, per costruire madrase, moschee, e centri islamici in tutto il paese. Inoltre, proprio da queste isole provenivano due pericolosi terroristi di al-Qaeda: Khalfan Khamis Muhammad, coinvolto nell’attentato alle ambasciate statunitensi, e Qaed Sanyan al-Harithi, ucciso nel 2002 in Yemen. Un gruppo attivo a Zanzibar, considerato tra i più pericolosi, è Jumuia ya Uamsho na Mihadhara (“Associazione della Rinascita e della Propagazione della Fede”, Arpif), conosciuto popolarmente come Uamsho, di matrice saudita. Ha prodotto una vasta letteratura e numerosi video per l’addestramento alla jihad in Afghanistan ed è responsabile della morte di diversi esponenti del secolarismo tanzaniano che si opponevano alla sharia. Questo gruppo ha anche protestato con forza contro l’influenza esercitata dall’Occidentale sull’isola attraverso i canali turistici, molto attivi nella regione, ed è responsabile di numerosi attacchi contro le chiese cattoliche ed altri obiettivi sensibili. Su pressione di Uamsho, slogan anticristiani sono diventati prevalenti su riviste, quotidiani, pamphlet e perfino utilizzati sui vestiti delle persone. Per contrastare l’arrivo di occidentali nell’area, gli islamici radicali hanno minacciato gli stabilimenti turistici dello Zanzibar e in particolare hanno promesso di colpire i proprietari dei locali che non si rifiutano di servire bevande alcoliche e alimenti incompatibili con la fede mussulmana. Uamscio è diretta dallo sceicco Azzani Khalid Hamda, il cui obiettivo dichiarato è di il trasformare Zanzibar in un paese guidato dalla sharia e il suo progetto prevede anche che i residenti non mussulmani dell’isola ( l’1% della popolazione) si convertano all’islamismo. Oltre agli attentati, uno dei metodi usati dallo sceicco radicale è quello di rapire giovani donne cristiane (minorenni) per convertirle con la forza alla religione mussulmana, o inviandole di nascosto nei paesi arabi (negli ultimi anni è stata denunciata la scomparsa di decine di queste donne). Nonostante la leggera evoluzione verso la democrazia da parte del governo centrale, Zanzibar resta sicuramente uno dei più punti più critici della regione a causa della spiccata presenza di islamici radicali. 7. Nel 1949 le Nazioni Unite approvano l’indipendenza della ex colonia italiana con il nome di “Territori della Somalia”, e con l’unione dell’ex protettorato britannico del Somaliland, nel 1960, nasce la Repubblica della Somalia. Meno di dieci anni dopo, il 21 ottobre del 1969, la giunta militare guidata dal generale Maxamed Siyaad, meglio conosciuto con il nome di Siad Barre, prende il potere con un colpo di stato e la Somalia cambia il suo nome in Repubblica Democratica della Somalia: uno stato socialista che procede rapidamente allo scioglimento dei partiti politici ed alla nazionalizzazione delle più importanti attività economiche. Alla guida di un Consiglio Supremo Rivoluzionario e con l’aiuto di finanziamenti sovietici e cinesi, il presidente Barre cerca di superare le divisioni tribali della popolazione somala (i nomadi ne costituiscono ancora il 65%) e di combattere il diffuso analfabetismo presente sull’intero territorio. Vengono installate basi missilistiche sovietiche sulla costa dello strategico Golfo di Aden (successivamente smantellate), e sfruttando la crisi etiopica del 1977, le truppe regolari di Mogadiscio appoggiano i ribelli somali nella provincia dell’Ogaden, da lungo tempo impegnati contro il governo di Addis Abeba. Ma l’intervento diretto dell’URSS e di Cuba, che si schierano al fianco dei militari al potere in Etiopia, e le riserve manifestate dalla comunità internazionale verso un paese aggressore, isolano politicamente e militarmente la Somalia, che si ritira dall’Ogaden nel 1978, senza abbandonare tuttavia il sostegno alla guerriglia locale contro l’odiata Etiopia. La nuova Costituzione (1979) riafferma con forza la solidarietà somala con i “movimenti di liberazione”, provocando di conseguenza un enorme afflusso di rifugiati politici ai quali si uniscono migliaia di contadini colpiti da una gravissima siccità. Nel 1980 i rifugiati ammontano a circa 1.200.000 (un abitante su quattro) a fronte di una popolazione già duramente provata dalla guerra e dalla crisi economica. Il presidente Barre, preoccupato soprattutto di superare l’isolamento internazionale, stringe forti legami con la Cina Popolare (aiuti militari ed economici). Non sembra preoccuparsi invece dell’unità nazionale e tantomeno della gravissima crisi alimentare che attanaglia il paese, e che solo gli aiuti dell’Onu riescono in parte a mitigare (un rapporto delle Nazioni Unite nei primi anni Ottanta pone la Somalia tra i paesi più poveri al mondo). Nonostante il rinnovo dello stato di emergenza (verrà revocato solo nel 1982) il Movimento Nazionale Somalo (Mns) continua la sua politica di opposizione al regime dittatoriale e dopo aver respinto il progetto di una costituzione democratica, nel 1991, i gruppi armati del “Congresso dell’Unità Somala” e del “Movimento Patriottico Somalo” entrano a Mogadiscio e costringono Siad Barre alla fuga. La nomina non ufficiale del nuovo presidente Ali Mahdi (clan degli abgal) viene subito contestata dal generale Farah Aidid (clan degli aberghedir) iniziando in questo modo una sanguinosa lotta civile tra fazioni contrapposte per il controllo della città di Mogadiscio, una città ormai semidistrutta, allo stremo delle forze e priva di una qualsiasi istituzione pubblica efficiente. Mentre l’etnia issak proclama la secessione delle regioni del Nord (Somaliland, governato con legge islamica e non riconosciuto dalla comunità internazionale) il generale Barre tenta invano nel 1992 la riconquista di Mogadiscio, ma deve riparare in Kenya dopo la sconfitta ad opera delle milizie di Aidid, oramai organizzate e ben consolidate nella capitale. Per sedici anni la Somalia rimane priva di un governo effettivo, mentre una guerriglia violenta e sanguinosa tra i gruppi tribali ed una carestia di dimensioni bibliche, in un territorio già ridotto alla fame, uccidono oltre mezzo milione di abitanti. La situazione oramai insostenibile – il vortice di violenza impedisce anche alle organizzazioni umanitarie di operare – induce il Consiglio di Sicurezza dell’Onu a disporre nel 1992 l’invio di ottocento caschi blu (Unosom I) ma il perdurare della crisi spinge il Consiglio (Risoluzione 794) a dare mandato ad una coalizione a guida Usa (Restore Hope) per ritornare nel 1993 (Risoluzione 814) ad un comando diretto dell’Onu sulle forze presenti in teatro (Unosom II). Le Forze di Pace riescono a stabilire un minimo d’ordine sul territorio e consentono la ripresa dei soccorsi alla popolazione, ma l’ambiente rimane così ostile (avvengono sanguinosi attentati di sospetta matrice terroristica legata ad Osama Bin Laden) che non si realizza alcun cambiamento di rilievo nella complessa situazione etnico-politica della Somalia. Dopo il ripiegamento degli ultimi contingenti (1995) il paese ritorna preda dell’aspro conflitto tra i signori della guerra, ancora Farah Aidid e Ali Mahdi, che si proclamano entrambi presidenti della nuova Repubblica somala. Mogadiscio è divisa in due dalla “linea verde”, il confine territoriale tra le milizie di Aidid e quelle di Mhadi, diventati clan sanguinari dediti al saccheggio, alla razzia ed alla violenza indiscriminata nei confronti della popolazione civile. Nonostante gli assalti portati spesso ai danni di convogli, anche scortati, il contingente internazionale riesce a svolgere molti interventi umanitari di aiuto ed assistenza alla popolazione. Solo dopo una sanguinosa serie di attacchi contro gli uomini della coalizione, nel 1994, i contingenti della missione Onu lasciano il territorio della Somalia. Quattro anni più tardi, dopo scontri e violenze tribali, anche la regione nord orientale del Puntland dichiara la sua autonomia, seguita negli anni successivi da altre regioni somale (Bari, Nugaal e Mudug) che costituiscono governi separati, ma sempre su base tribale, senza manifestare un più ampio progetto politico verso l’indipendenza o verso la ricostruzione di uno stato unitario. Le accese rivalità dei frammentati e sanguinari clan locali ostacolano il primo tentativo di riconciliazione nazionale (Gibuti, 1999) sostenuto dall’Onu, dalla Ue, dalla Lega Araba e dalla Igad, l’Inter Governamental Autorithy Development, l’autorità intergovernativa per lo sviluppo, o meglio un ente di cooperazione regionale composto da Etiopia, Eritrea, Gibuti, Kenya, Somalia, Uganda e Sudan. Il governo transitorio del presidente ad interim (Abdigassim Salad Hassan, ex vice primo ministro di Barre nel 2000) non viene riconosciuto dai signori della guerra che costituiscono un organismo governativo parallelo (“Consiglio di Restaurazione e di Riconciliazione della Somalia”, Srrc) e riprendono la lotta armata. Nel 2004 – dopo una debole tregua tra i leader delle varie fazioni in lotta – nasce un Parlamento transitorio che inaugura la prima legislatura del paese dopo tredici anni di completa anarchia. Dopo due anni di lavori della “Conferenza di Riconciliazione” (si è aperta ad Eldoret in Kenia il 15 ottobre 2002 e si è conclusa a Nairobi il 29 agosto 2004) viene firmata una Costituzione federale ed il nuovo parlamento (duecentosettantacinque membri selezionati dai capi clan partecipanti) elegge con centottantanove voti favorevoli il capo dello Stato somalo, l’ex colonnello Abdullahi Yussuf Ahmad. Anche lui è un capo tribale – ma secondo Washington si tratta un ex signore della guerra – e ricopre parallelamente la carica di presidente del Puntland, un terzo del territorio somalo. All’età di settanta anni (soprannominato “il lupo”, ma in realtà sposato con quattro figli e nonno per tre volte) si trasforma in uomo politico: Mi sono formato in Italia, alla Scuola di Fanteria di Cesano, poi a Mosca, alla Scuola di Guerra. Diventato ufficiale dell’esercito somalo, venni chiamato dal generale Barre a partecipare al suo colpo di stato. Rifiutai: una scelta pagata con sei anni di carcere, dal 1969 al 1975 […] ma quando nel 1977 lanciò la guerra contro l’Etiopia, mi nominò comandante del fronte meridionale. In nove mesi penetrai nel territorio etiopico per 350 chilometri. Malgrado ciò, la Somalia venne sconfitta. Fu allora che alcuni miei ufficiali tentarono di rovesciare la dittatura. Il colpo fallì e dovetti riparare a Nairobi. Ma io avevo dato inizio alla guerra civile in Somalia e da allora continuo senza sosta a combattere. Anche se fortemente sostenuto dall’Etiopia, il presidente rimane in esilio in Kenya (Nairobi) così come il nuovo governo nazionale ed il suo primo ministro Alì Mohammad Gedi, un veterinario ed ex accademico di Mogadiscio. Interrogato sul criterio adottato per la scelta del premier, il neo presidente ha risposto che “ero un migiurtino ed ora sono un somalo, ma essendo io un darod, il capo del governo doveva essere un hawiya”. Anche se Mogadiscio è ormai ridotta ad un cumulo di macerie dopo quindici anni di battaglie quotidiane tra le milizie rivali, il nuovo premier decide di recarsi nella capitale per preparare il terreno al rientro del suo governo in Somalia. Il 3 maggio 2005 convoca la popolazione nello stadio comunale per un saluto ufficiale e subito dopo l’inizio del suo discorso una potente granata esplode tra la folla: quindici morti e decine di feriti. Nel complesso ed ambiguo mosaico degli oppositori, si distingue anche il ministro della Sicurezza, Kanyare Afrà, che – pur facendo parte dell’esecutivo – secondo fonti di intelligence occidentale gestisce invece un immenso traffico di droga (dall’Oriente verso l’Europa e gli Stati Uniti) utilizzando a proprio vantaggio gli aeroporti ed i porti somali fuori da ogni tipo di controllo statale. Inoltre, il presidente Yussuf è appunto un migiurtino, del nord della Somalia, e pur avendo le simpatie degli Stati Uniti e dell’Etiopia, non gode di altrettanto favore nella città di Mogadiscio. Ma pur di permettere il suo rientro a Mogadiscio, l’Unione Africana e la Igad si dichiarano pronti ad inviare un contingente militare (l’Uganda mette subito a disposizione duemila uomini) senza includere però l’Etiopia, considerata dall’Egitto e dall’Eritrea in grado di esercitare “un’influenza troppo forte” sulla Somalia. Tra le voci dell’opposizione suona anche quella del leader integralista islamico di quarantadue anni, sheik Sharif Ahmed: Guerra Santa contro il governo se si azzarda a mettere piede in Somalia e Guerra Santa anche contro le truppe straniere che oseranno venire qui a proteggerlo. Il governo di transizione si deve accontentare di Baidoa, una cittadina dell’entroterra collinare, a 250 chilometri ad ovest di Mogadiscio. Con tre diverse offensive, sferrate dal febbraio al giugno del 2006, le Corti islamiche diventano padrone di Mogadiscio, della sua regione, il Benadir, e di buona parte del territorio somalo. E’ in effetti sorprendente la rapidità con cui circa ottomila combattenti islamici a bordo di centinaia di tecknike (i camioncini pick-up di fabbricazione giapponese dotati di armi pesanti) mettono in fuga i miliziani dei signori della guerra (Mussa Sudi, Qanyare Afrah, Bashir Rage e Omar Finish, tra i più importanti) e fanno sventolare sugli edifici della capitale i loro drappi neri con le scritte in arabo che inneggiano al Profeta. Denominati al-shabab (gioventù), sono quasi tutti giovani islamisti radicali provenienti dai paesi asiatici. A loro si uniscono i religiosi e i fondamentalisti somali, gli oppositori del Governo di transizione ma anche bande di alcuni signori della guerra che aderiscono con opportunistico entusiasmo al progetto del nuovo califfato. Anche i finanziamenti non mancano. Le Corti islamiche – federate in una Unione che raggruppa ideologicamente sia gli integralisti legati ad al-Qaeda che i religiosi moderati che si rifanno all’ideologo egiziano Sayyed Qtub, fatto impiccare da Nasser nel 1966, e gli islamici somali che non manifestano simpatie per l’intrusione di elementi esterni – possono contare sull’aiuto della Casa Reale saudita, degli Emirati Arabi e di numerosi sceicchi arabi del Golfo, oltre che su alcuni ricchi e potenti “commercianti” somali che vedono nelle milizie islamiche un malleabile strumento di accondiscendenza per i loro traffici illeciti. Il controllo sulla vita economica del paese – in realtà gli affari più lucrativi – è assicurato da un fondo monetario di rotazione di tutte le forze islamiche internazionali e dall’agenzia che opera i più importanti trasferimenti monetari – al-Barakaat – attiva nei settori delle telecomunicazioni, dell’import-export, delle derrate alimentari e dei materiali da costruzione. Al-Barakaat è un’organizzazione finanziaria sorta nel 1991 che gestisce, oltre all’unica banca operante in Somalia, anche il servizio postale e una società di telecomunicazioni. Opera attraverso una rete di fiduciari sparsi in tutto il mondo – circa seimila soci e intensi rapporti con grandi gruppi internazionali – ed è stata inserita nella lista nera delle aziende messe al bando nell’ambito del programma americano di lotta al terrorismo perché accusata di essere tra i finanziatori di al-Qaeda. Inoltre, le Corti possono contare anche sul “sistema tributario” islamico, ovvero sul prelievo fiscale organizzato ai danni dei suk somali, le attività commerciali già in precedenza selvaggiamente vessate dal racket delle milizie delle tribù locali. Il flusso di armamenti, nonostante l’embargo, giunge in Somalia via mare dallo Yemen – leader storico del commercio regionale di armi – e per via aerea dall’Eritrea, in chiave – anch’essa storica – di opposizione alla Etiopia e favorevole al Governo di transizione. Secondo la «Bbc» inglese (luglio 2006), anche aerei imponenti, come due Ilyushin 76, possono atterrare sul territorio controllato dalle Corti per scaricare ottanta tonnellate di armi e decine di consiglieri militari eritrei senza che alcuna voce si alzi per una condanna della violazione dell’embargo e della pesante ingerenza di Asmara nell’aiuto ad una organizzazione di forte ispirazione islamica ed in aperto conflitto con il Governo di transizione somalo, riconosciuto dalla comunità internazionale. La popolazione somala, molto probabilmente per porre fine alle violenze, alla corruzione e all’impunità degli affaristi corrotti, così come alle angherie dei signori della guerra, sembra accogliere benevolmente i combattenti di Allah ed accetta – forse di buon grado – anche l’imposizione della legge islamica. La maggior parte delle scuole viene chiusa e i bambini, subito arruolati, vengono equipaggiati con armi leggere e bardati con vistose cartucciere. Quelle rimaste aperte prevedono, secondo i nuovi regolamenti della sharia, classi separate tra maschi e femmine. Alle bambine viene imposto il velo blu. Per le donne somale – da sempre amanti degli sfarzosi abiti di mousseline colorata – è riservato il rigore del velo nero mussulmano in tinta unica (niqab, a completa copertura del corpo con la sola eccezione del volto scoperto), che ha preso il posto del tradizionale e colorato jelbaab (che lasciava scoperto viso e braccia), oltre alla più rigida segregazione sessuale. La nuova “polizia dei costumi” vieta la danza e chiude le sale da ballo ed i cinematografi, così come impedisce di guardare la televisione (comprese le partite di calcio), di ascoltare musica occidentale, di celebrare matrimoni che contengano nella cerimonia canto o danze e di fare uso del khat (erba anfetaminica), un leggero stimolante molto diffuso tra i giovani. Dopo un raid contro la sede della Radio dell’Africa Orientale (a nord di Mogadiscio, definitivamente chiusa) e contro Radio Jowar (nel centro di Mogadiscio, costretta a non trasmettere più musica ma solo la diffusione del Corano, la dottrina islamica e i notiziari ufficiali), le Corti islamiche emettono una fatwa di condanna a morte (17 ottobre 2006) contro i membri della Commissione Nazionale per la Musica della Somalia, affiliata all’Unesco (otto membri, tra cui tre donne, che riescono a riparare fortunatamente in Kenya subito dopo il responso giuridico). La sentenza viene giustificata con la citazione del versetto V, 33 del Corano: In verità la ricompensa di coloro che combattono Iddio e il Suo messaggero, e si danno a corrompere la terra, è che essi saranno massacrati o crocefissi, o amputati delle mani e dei piedi dai lati opposti, o banditi dalla terra: questo sarà per loro ignominia in questo mondo e nel mondo a venire avranno immenso tormento. Pur non essendoci nel Corano un divieto esplicito della musica e del canto, questa interdizione sembra fare riferimento ad alcune precedenti fatwa emesse da teologi wahabiti, come il muftì dell’Arabia Saudita, Abdelazi Bib Baz che sentenziò: la parola ma’azif si riferisce al canto e agli strumenti musicali. Il Profeta ci ha detto che alla fine dei tempi arriverà un popolo che permetterà queste cose, così come permetterà l’alcol, l’adulterio e la seta. Questo è uno dei segni della profezia, tutto ciò è accaduto. Il hadith [il detto] indica che gli strumenti musicali sono haram [proibiti] e condanna coloro che dicono che sono halal [leciti], così come condanna coloro che ritengono che l’alcol e l’adulterio siano leciti. Chiunque ritenga che il canto e gli strumenti musicali siano leciti, mente e commette un peccato grave 187. Anche gli alcolici vengono messi al bando e nella cittadina di Bulo-Buti i nuovi mullah arrivano a minacciare di morte chiunque non rispetti la regola islamica delle cinque preghiere quotidiane. Le Corti confiscano le abitazioni dei signori della guerra (ville, appartamenti e locali fortificati) e nei loro filmati di propaganda mostrano alla popolazione il livello di corruzione raggiunto dal precedente “regime”: bottiglie di whisky scozzese, gin di fabbricazione etiopica e lattine di birra, insieme a video cassette e a riviste occidentali. Yussuf Indhadde, uno degli sceicchi più importanti dell’Unione, si affretta a dichiarare con austera solennità che “tagliare una mano, una gamba, flagellare o giustiziare un criminale per punire un reato è perfettamente legale” . Nato nel porto di Marka, a sud di Mogadiscio (che adesso controlla interamente) e già militare sotto l’ex presidente Barre – i suoi uomini hanno avuto un ruolo importante nella battaglia di Mogadiscio – quando arriva al potere è un ricchissimo uomo d’affari di quarantotto anni, che gestisce ufficialmente l’importazione dei redditizi camioncini giapponesi pick-up. 187 A Kabul, durante il regime dei talebani, nel dicembre del 2002 venne distrutta la maggior parte degli strumenti musicali esistenti. In realtà, è stato inserito in un rapporto dell’Onu come il maggiore trafficante di armi della Somalia e le sue esternazioni intendono giustificare l’operato delle Corti: “è la popolazione che ci ha chiamati perché facessimo cessare furti, sequestri e racket”. In effetti, i “santoni” (la definizione è stata usata dal premier Gedi per indicare i fondamentalisti islamici) riescono ad imporre e garantire un pur minimo ordine sociale: meno furti, meno esazioni e minore rischio di perdita degli averi e della vita in cambio di una totale obbedienza alla legge del Corano. Nell’estate del 2006 la tensione tra le Corti islamiche ed il Governo transitorio sale vertiginosamente. Violando l’impegno di non aggressione siglato a Khartoum (firmato dalle parti ai primi del mese di luglio, due settimane prima dell’attacco) i miliziani delle Corti prendono possesso di Bur Hakaba, una città a soli sessanta chilometri da Baidoa, la sede provvisoria dell’amministrazione governativa ad interim. Secondo le opinioni dei corrispondenti occidentali, i miliziani si sarebbero mossi dopo aver ricevuto l’ordine preciso di imporre la legge coranica su tutta la regione, e la città di Bur Hakaba sarebbe caduta, con relativa facilità, per via della diserzione della guarnigione governativa – di etnia digrilmirifle – che si sarebbe unita alle Corti islamiche. A difesa della città di Baidoa dovrebbero trovarsi circa tremila soldati di etnia migiurtina (la stessa regione del presidente Yussuf, a nord del Corno d’Africa), oltre ad un presunto contingente di soldati etiopici (il ministro dell’Informazione di Addis Abeba, Berhane Hailu, ha fatto sapere che il suo paese è pronto ad invadere la Somalia per proteggere l’amministrazione di Yussuf, l’unica riconosciuta a livello internazionale). Mentre si inaspriscono gli scontri, adesso a soli quaranta chilometri da Baidoa, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite autorizza la costituzione – esclusivamente da parte di paesi africani – di una Forza di Pace da inviare in Somalia con il compito di proteggere il Governo Federale di Transizione Nazionale e promuovere le trattative con le Corti ed i Tribunali islamici. Ma il nuovo leader delle Corti, e presidente del Consiglio Supremo islamico in Somalia, il colonnello sheikh Hassan Dahir Aweys – che ha sostituito il più moderato sheik Sharif Ahmed, adesso a capo dell’esecutivo – rigetta la proposta del Consiglio di Sicurezza adducendo che non è ipotizzabile la presenza di truppe straniere in Somalia, anche se africane o mussulmane. Aweys è il fondatore del gruppo fondamentalista al-Ittihat e da circa trent’anni dichiara pubblicamente che il suo sogno è quello di trasformare la Somalia in un califfato con la stretta applicazione della legge coranica (è lui alla guida dell’ala oltranzista delle Corti). Nel settembre del 2001 è stato fotografato mentre guidava i manifestanti che inneggiavano all’attacco delle Torri gemelle di New York, con indosso una maglietta raffigurante il volto di Osama bin Laden. Considerato dall’intelligence americana come il braccio operativo di al-Qaeda in Somalia, è stato inserito nell’elenco dei terroristi internazionali stilato dall’Onu. Sharif Ahmed svolge invece il ruolo di primo ministro, anche se di un esecutivo molto ristretto, e sembra riflettere un atteggiamento più conciliante, avendo preso le distanze dagli al-shabab, i giovani che rappresentano invece l’ala più intransigente del movimento, quello di Aweys. I due leader delle Corti islamiche appartengono a differenti cabale (gli aggregati etnico-sociali delle genti islamizzate fuori dall’Arabia, in particolare in Africa settentrionale e Somalia), Aweis è un aer e Ahmed un abgal, anche se devono tenere conto dei rapporti e delle alleanze tribali attualmente in atto tra le loro genti. In ogni caso, il finanziatore dell’islamismo radicale che le Corti rappresentano in Somalia è Abukar Omar Addane, un anziano uomo d’affari (viene indicato come il collettore di tutti i finanziamenti di al-Qaeda nel Corno d’Africa) diventato leader indiscusso del gruppo, anche se costretto su una sedia a rotelle a causa di un incidente. Il fragile Governo di transizione è oramai asserragliato a Baidoa, sotto stretto assedio delle Corti islamiche, e gli scontri si trasformano in violenti combattimenti. La difesa del presidente Abdullahi Yussuf è assicurata, oltre che da un contingente governativo, dalle truppe etiopiche (alcune migliaia per gli osservatori, ma solo poche centinaia di consiglieri militari armati per Addis Abeba) ed il 12 dicembre 2006 il Consiglio dei Tribunali islamici lancia un ultimatum all’Etiopia: via le truppe dalla Somalia entro sette giorni o “questo sarà il giorno del Giudizio per gli etiopici e segnerà la loro distruzione”. Lo spettro di una guerra diretta – adesso il governo etiope riconosce ufficialmente la presenza di truppe in territorio somalo – si sta rapidamente materializzando. Dopo un ennesimo attacco portato alla periferia di Baidoa, le truppe etiopiche – appoggiate dagli Stati Uniti e in un certo qual modo spalleggiate anche dall’Unione Africana – decidono di intervenire (in realtà, l’esercito etiopico entra in Somalia su richiesta del Governo di transizione somalo, attraverso il passo di Fer Fer, il posto di frontiera sulla vecchia strada imperiale italiana che collegava Mogadiscio con Addis Abeba). Per la stampa e l’opinione pubblica araba si tratta di una guerra a connotazione religiosa, tra un paese filo-occidentale e cristiano e un altro mussulmano, fortemente legato al mondo arabo islamico. Ma le motivazioni sono sostanzialmente diverse: il governo di Addis Abeba teme fortemente il contagio dell’estremismo islamico e si decide per l’intervento solo dopo una espressa richiesta del Governo di transizione somalo, la sola autorità riconosciuta dalla comunità internazionale e quindi in grado di lanciare un simile appello. L’Unione Africana riconosce all’Etiopia, in effetti, il diritto di difendere la propria sovranità minacciata dalle mire espansionistiche delle Corti islamiche (che intendono realizzare la Grande Somalia) e le Nazioni Unite si astengono dal condannare l’azione militare di Addis Abeba, auspicando nel contempo una pacifica soluzione politica (non si ravvisano quindi gli estremi di una violazione del diritto internazionale). Anche se buona parte dell’esercito etiopico è composta da elementi mussulmani (e l’armamento quasi interamente sovietico), la recente intesa tra l’Etiopia e gli Stati Uniti non sembra incidere sulle politiche di fondo o sulla condotta delle operazioni, probabilmente nella convinzione di una guerra estranea ai modelli di neo-colonialismo sinora conosciuti (Somalia ed Etiopia sono entrambi paesi poveri, senza petrolio o risorse naturali: il reddito pro-capite per la Somalia è di 600 dollari e per l’Etiopia 800). Inoltre, un rapporto delle Nazioni Unite dell’inizio del 2006 ha denunciato la presenza in Somalia di migliaia di terroristi islamici provenienti da Libia, Eritrea, Yemen e Siria – sin dal 1998 – subito dopo gli attentati rivendicati da al-Qaeda ai danni delle ambasciate Usa a Nairobi in Kenya e Dares-Salaam in Tanzania (la Somalia sembra essere diventata la nuova base del terrorismo islamico poiché diversi capi di questa organizzazione vivono ormai stabilmente a Mogadiscio). Tra gli elementi maggiormente pericolosi vengono segnalati Adan Hashi Aeru – uno dei leader più oltranzisti, guerrigliero responsabile di numerosi attentati contro le truppe americane durante l’operazione Unosom, oltre ad aver capeggiato la distruzione del cimitero italiano di Mogadiscio per trasformarlo in un campo di addestramento, ed oggi alle dirette dipendenze di Osama Bin Laden dopo un training operativo tra i talebani – e Abu Talha Assudani (alias “il sudanese”) incaricato di reclutare uomini da utilizzare contro gli interessi occidentali in Somalia ed in Africa, ed inoltre anche lui responsabile della profanazione del cimitero italiano della capitale, ristrutturato dai nostri soldati nel 1993 durante l’operazione “Ibis188”. Secondo gli analisti occidentali, la nuova alleanza del terrore – trafficanti di droga ed integralisti islamici – è oramai stabilmente radicata a Mogadiscio, dopo essere stata costretta ad abbandonare Kabul con la forza. Un rapporto delle Nazioni Unite del 2006 dichiara che le Corti vengono armate – in violazione dell’embargo internazionale – da Gibuti, Egitto, Eritrea, Iran, Libia ed Arabia Saudita, oltre che dalla milizia sciita libanese Hezbollah. In effetti, dalla fine del 2005 si registra in Africa una crescente influenza del wahabismo saudita: in Algeria continuano le attività del Gruppo Islamico Armato e del Gruppo Salafita per la predicazione e il combattimento; in Nigeria la maggioranza degli stati settentrionali adotta la sharia, costringendo alla fuga migliaia di cristiani, e sono da poco usciti allo scoperto i membri del gruppo clandestino Black Taliban; in Malawi gli integralisti alzano sempre di più la voce contro la forte presenza occidentale; in Sudan, dove l’islam è religione di stato, dopo una lunga guerra civile nelle regioni cristiane, il Darfur è insanguinato dagli scontri tra le milizie arabe e gli autonomisti; in Egitto, le località turistiche continuano ad essere obiettivi del terrorismo islamico, mentre i Fratelli Mussulmani raddoppiano la loro rappresentanza parlamentare e continuano le attività dei gruppi armati Jamaa Islamiya, al-Tawid e Jihad Islamica; in Tanzania, nell’isola di Zanzibar, opera il gruppo clandestino Bismillahi (letteralmente, “in nome di Dio”) che chiede l’introduzione della sharia e del Consiglio nazionale mussulmano; in Kenya, oltre ad un partito islamico non autorizzato, è attiva la fazione radicale Subken, che organizza manifestazioni a favore di Osama bin Laden a Nairobi e Mombasa; in Uganda, il gruppo estremista Tabligh (con ramificazioni tra i guerriglieri della Allied Democratic Forces) si rende responsabile di numerosi attentati; in Sud Africa sono invece attivi piccoli gruppi estremisti che cambiano continuamente le proprie sigle per sviare le indagini delle autorità; nell’area sub-sahariana (Marocco, Mali, Niger e Ciad), infine, è stata segnalata la presenza di predicatori radicali che si spostano di paese in paese, anche in questo caso per sfuggire ai controlli governativi. Il commentatore politico Sergio Romano attribuisce invece agli Stati Uniti la responsabilità dei finanziamenti ai signori della guerra e il conseguente rafforzamento degli integralisti in Somalia: le prime manifestazioni di fanatismo islamico risalgono all’intervento in Afghanistan da parte delle truppe Nato dopo l’11 settembre, quando al-Qaeda, privata del suo santuario talebano, cercò di riorganizzarsi altrove e riuscì a trovare qualche punto di appoggio nella vecchia colonia italiana. Fatta la diagnosi, il medico di Washington ha deciso che la cura del malato esigeva il rafforzamento degli anticorpi, vale a dire il finanziamento di quelle signorie feudali che si erano installate in Somalia dopo il crollo dello stato, all’inizio degli anni Novanta, ed erano riuscite a spartirsi, dopo una furibonda guerra civile, le magre risorse del territorio. Se i signori della guerra erano decisi a contrastare la strategia di alQaeda, il realismo suggeriva agli Stati Uniti di sceglierli come alleati e aiutarli a combattere 189. Ma per quanto riguarda la dirigenza e il finanziamento delle Corti islamiche, la situazione è ancora più complessa. 188 Martedì 18 gennaio 2005 bande di miliziani locali hanno completamente distrutto il cimitero italiano con la giustificazione che non potevano essere accettati nel paese cimiteri che non fossero esclusivamente islamici. Le testimonianze del reporter della «Bbc» inglese furono raccapriccianti: tombe divelte, lapidi distrutte e centinaia di resti mortali dei nostri defunti sparsi sul terreno ed oggetto di gioco e di scherno da parte dei bambini somali. 189 S. Romano, Quando la cura Usa non funziona. In Somalia, come in Afghanistan, e in Iraq, la politica americana rinforza gli integralisti, «Panorama», 22 giugno 2006. Anche se non confermato, alcuni analisti avrebbero indicato la presenza a Mogadiscio di due emissari di Teheran incaricati di barattare armi sofisticate in cambio di uranio. L’importanza della partita in gioco è stata enfatizzata dalla definizione data da Ayman al-Zawahiri, l’ideologo di alQaeda che alla fine degli anni Novanta ha affidato ad alcuni integralisti egiziani il compito di alimentare il fonte africano usando le teste di ponte in Kenya e nel Corno d’Africa: “la Somalia è la guarnigione meridionale dell’islam”. Il sostegno al movimento islamico locale si è sviluppato sia con un intervento diretto – l’invio di uomini nella nuova legione straniera islamica – che con una rete logistica molto attiva, nei paesi della regione e nello stesso Occidente. Dopo l’intervento etiopico e la fuga di numerosi guerriglieri (ottobre 2006), le autorità dello Yemen annunciano la cattura di un alto numero di stranieri accusati di aver sostenuto con armi e finanziamenti le Corti islamiche, e tra questi quattro europei e tre australiani. In particolare, due fratelli gemelli australiani sono figli di Abdul Rahim Ayub, importante esponente della Jemaa indonesiana e veterano della guerra in Afghanistan. La moglie, Rabia Hutchinson, è particolarmente legata a Walid al-Masri, uno dei più alti dirigenti di al-Qaeda, ed ha diretto un ospedale sotto il regime dei talebani, con un riporto diretto ed esclusivo ad al-Zawahiri. In Canada, le autorità di polizia scoprono un traffico di armi in favore delle milizie islamiche, ed in particolare per il gruppo somalo al-Ittihad. Le navi cargo, che fanno scalo anche in alcuni porti italiani del mar Tirreno (la Spezia e Livorno), trasportano armi e munizioni raccolte in Canada e Svezia prima di raggiungere il Corno d’Africa. Inoltre, decine di giovani somali – che avevano ottenuto asilo politico – tornano in massa nel paese di origine al fianco delle Corti islamiche, rispondendo all’appello di un altro cittadino canadese, Abdullah Alì Afrah, conosciuto con il nome di “aspro”, in ricordo del suo passato di venditore ambulante di aspirine. Sull’altro versante, invece, la stampa americana («New York Times», 7 aprile 2008) riferisce che – nonostante le pressioni fatte da Washington sulle Nazioni Unite per imporre un embargo ancora più stretto contro la Corea del Nord, impegnata nei test atomici – gli Stati uniti hanno di fatto permesso una vendita segreta di armi all’Etiopia, in chiave di urgente contrasto alle Corti islamiche. Il 21 luglio del 2006 le Corti islamiche dichiarano la guerra santa (jihad) contro l’Etiopia – durante un’intervista rilasciata da Hassan Daher Aweis alla radio somala «Horn Afrik» – e poco dopo viene lanciato un appello a “tutti i combattenti islamici del mondo” (sempre da Aweis, ma dalla sua città natale di Dusa Mareb, capoluogo del Mudug, dove si trova per coordinare la nuova organizzazione sociale, strettamente islamica) per prendere parte alla guerra santa in Somalia, con l’obiettivo di creare un califfato islamico internazionale, ovvero la riunificazione con trecentocinquantamila somali presenti nelle regioni di confine con l’Etiopia, il Kenya e Gibuti. I corrispondenti della stampa internazionale, da Nairobi, riferiscono di manifestazioni e cortei della popolazione di Mogadiscio a favore delle Corti islamiche che – dopo la preghiera del venerdì e galvanizzata dall’appello alla guerra santa – è scesa in piazza per inneggiare alla pace che gli islamici sono riusciti ad imporre dopo il nefasto periodo dei signori della guerra, percepiti dai somali come alleati degli Stati Uniti (un corteo di oltre cinquecento veicoli ha attraversato la capitale con i clacson spiegati sino a tarda sera). In effetti, la progressiva crescita dei Tribunali islamici – la forza politica e religiosa che applica rigorosamente la legge mussulmana – riveste agli occhi della popolazione il merito di aver sottratto i cittadini alla tirannia dei signori della guerra e di aver restaurato alcuni servizi fondamentali, anche se si tratta di un islamismo radicale vicino alla corrente wahabita e strettamente legato ad alQaeda190. 190 Secondo Annamaria Gentili, docente di Storia dei Paesi Afro-Asiatici all’Università di Bologna, si registra in Alla fine di luglio del 2006 quattromila soldati etiopici, duecento carri armati e decine di mezzi blindati entrano in territorio somalo e rompono con facilità l’assedio di Baidoa, costringendo i miliziani islamici ad una “ritirata strategica” (nella città di Gode, la capitale dell’Ogaden, le forze americane sono presenti con un piccolo contingente militare, dotato di aerei ed elicotteri, per monitorare la situazione). Contemporaneamente, con raid aerei mirati, vengono bombardati l’aeroporto internazionale di Mogadiscio e quello militare di Baledogle, dove affluiscono armi, munizioni e combattenti stranieri che hanno risposto all’appello della jihad somala. Ma sprovviste di un esercito effettivo e di una forza contraerea, le Corti ripiegano disordinatamente verso Mogadiscio, dove si teme la creazione di una roccaforte islamica – sicuramente più difficile da conquistare – anche se il portavoce del Governo di transizione, Abdimahran Dinari, non sembra ravvisare questo pericolo: Quando tutto sarà finito, entreremo pacificamente a Mogadiscio. Ma non ci vendicheremo, anzi, offriamo l’amnistia ai miliziani che abbandoneranno le armi. Dello stesso tenore sono le espressioni usate dal premier etiopico, Menes Zewari: Noi non vogliamo Mogadiscio e presto ci ritireremo. L’offensiva in corso ha l’obiettivo di eliminare le forze del terrorismo internazionale; in particolare gli Eritrei che le appoggiano e le sostengono. In breve tempo i soldati etiopici diventano ventimila e l’aviazione utilizza costantemente i suoi caccia (Sukhoi 27 e Mig 23) per la copertura delle truppe in avanzamento e, nonostante le assicurazioni di Zewari, la presenza etiopica diventa ogni giorno sempre più ingombrante (le forze armate di Addis Abeba sono considerate tra le più potenti in Africa). Sulla base di una richiesta presentata dal Qatar, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite cerca un compromesso per il ritiro delle truppe etiopiche (prematuro per gli Stati Uniti e la Gran Bretagna) ed anche l’Unione Africana rivede le sue posizioni iniziali: attraverso il suo Segretario generale, Alpha Oumar Konaré, chiede l’immediato ritiro dei soldati di Addis Abeba. Ma i carri armati etiopici sono già entrati a Mogadiscio e si schierano a difesa dell’aeroporto internazionale (il grosso del contingente, carri compresi, rimane attestato fuori città) mentre i soldati somali regolari pattugliano la zona del porto marittimo. La temuta battaglia per la capitale non c’è stata e le truppe islamiche rimaste – dei ventimila miliziani se ne contano solo poche migliaia dopo l’offensiva etiopica – si ritirano verso Chisimaio (Kismaayo) dove il potere è ancora in mano al gruppo fondamentalista guidato dallo sceicco Hassan Turki, l’ideologo di al-Ittihat, universalmente riconosciuta come la succursale somala di al-Qaeda. L’opinione pubblica internazionale, che segue con attenzione i numerosi resoconti che arrivano dalla Somalia, si chiede come mai non si sia combattuto a Mogadiscio, nonostante i forti timori espressi dagli analisti e dai corrispondenti della stampa estera. Secondo le dichiarazioni rilasciate da Sharif Ahmed alle agenzie occidentali, si tratta di un ripiegamento voluto dalla dirigenza islamica: “ce ne siamo andati per evitare bombardamenti a tappeto, dal momento che le forze etiopiche stanno perpetrando un genocidio ai danni del popolo somalo”. Al di là della forzata esagerazione sulla realtà della guerra in corso (le perdite subite dalla Corti Africa orientale, ma anche occidentale, una “crescente presenza economica e di proselitismo dei Paesi del Golfo: moschee non tradizionali, attività economiche, aiuti allo sviluppo”. C. Zecchinelli, Il radicalismo mussulmano può espandersi comunque e destabilizzare la regione, «Corriere della Sera», 27 dicembre 2006. islamiche ammontano a tremila caduti e cinquemila feriti, oltre a centinaia di vittime civili ed altrettanti profughi ammassati sui barconi diretti in Yemen) molti miliziani islamici – per la maggior parte giovani e ragazzi prelevati dalle botteghe e dalle scuole e costretti a combattere – si sono tolti la divisa degli integralisti per ritornare alle loro attività originarie o per arruolarsi con i vecchi signori della guerra che hanno ripreso, rapidamente, il controllo della capitale (alcuni di loro, tra cui Abdi Qabbdid e Abdi Nur Wal, hanno ricevuto imponenti rifornimenti di armi dagli etiopici per combattere le Corti). In effetti, tra i primi ad entrare in città c’è proprio il famigerato generale Aidid che con il suo nutrito gruppo di guerriglieri guida i nuovi saccheggi nelle ville e nei palazzi – che sino a ieri ospitavano i leader integralisti – e si impadronisce dei punti strategici (strade principali, piazze e crocevia) per riprendere il controllo del territorio che gli era stato usurpato, con l’aiuto di suo figlio Hussein, subito nominato ministro dell’Interno. Anche se la maggioranza della popolazione di Mogadiscio sembra accogliere la notizia della fuga delle milizie islamiche con gioia e soddisfazione, non mancano tuttavia le perplessità – e le proteste – per un nuovo governo completamente sconosciuto agli abitanti, ovvero per il controllo della capitale che, in un certo qual modo, le Corti avevano assicurato (il timore più significativo è dato dal possibile ritorno di un periodo di violenze e soprusi che avevano contraddistinto il precedente regime dei signori della guerra). Mentre l’esercito del Governo di transizione e gli alleati etiopici si insediano nella ex ambasciata degli Stati Uniti, il premier Gedi ritorna a Mogadiscio (29 dicembre 2006) scortato da un convoglio di ventidue veicoli (di cui sei dotati di armi pesanti e con oltre cento uomini tra le forze lealiste e quelle etiopiche) e annuncia che verrà imposta la legge marziale per tre mesi “per porre fine all’anarchia e ristabilire la sicurezza.” Il generale somalo Nur Galal – che aveva contribuito a rovesciare la dittatura di Siad Barre – cerca di riprendere il controllo della città e riesce a convincere le truppe etiopiche a rimanere attestate fuori da Mogadiscio per legittimare l’ingresso degli esponenti del Governo di transizione (ma soprattutto per evitare incidenti con la popolazione), facendosi anche garante della difesa del cimitero italiano, diventato il quartier generale delle milizie integraliste al-shabab. Il problema politico della presenza dell’Etiopia in territorio somalo è di particolare rilevanza. La lotta per il potere è stata in effetti decisa da un intervento militare esterno, come se la Somalia fosse adesso – di fatto – sotto il protettorato del suo potente e bellicoso vicino settentrionale. Anche se per il governo di Addis Abeba potrebbe risultare difficile spingere in profondità, e nel tempo, la sua offensiva militare – lo sforzo per portare e sostenere le truppe in linea non è stato indifferente ed è anche necessario presidiare con attenzione, in questo momento delicato, il confine con l’Eritrea – agli occhi dell’opinione pubblica somala il presidente Yussuf ed il premier Gedi potrebbero apparire come burattini manovrati dall’Etiopia, o meglio non godere di quella considerazione che rimane, nel bene o nel male, riservata alle Corti islamiche che si sono battute con le sole forze a disposizione, conservando quel prestigio sociale che la sconfitta non ha compromesso, ma forse ha addirittura accresciuto. Nelle more di una situazione così delicata, il governo di Addis Abeba non contribuisce certo a creare un’immagine più trasparente dell’operazione: perché non vengono rivelati i nomi dei quattro generali che hanno guidato e coordinato l’intervento militare in Somalia? Durante la conferenza stampa rilasciata dal premier somalo Meles Zenawi (28 dicembre 2006) è stato mantenuto il riserbo più assoluto sull’identità dei generali che hanno vinto la guerra lampo contro le Corti e che hanno organizzato i campi di addestramento per i soldati del Governo di transizione, con particolare attenzione alle tecniche antiguerriglia. Sembra inoltre che questi generali siano oggi impegnati nella caccia ai guerriglieri che combattono in Etiopia contro il regime (con i gruppi Oromo Liberation Front e Ogaden People’s Liberation Front) e che hanno le loro basi in Somalia, per lo più proprio a Mogadiscio, così come nella ricerca e nella cattura degli eritrei che sono scesi in campo al fianco delle Corti islamiche. I nomi non vengono svelati poiché probabilmente si tratta di ufficiali tigrini, e questo potrebbe costituire un certo imbarazzo sia in Etiopia – dove il governo viene accusato di essere composto soltanto da tigrini, pur costituendo questi ultimi una piccola minoranza pari al 7% – ma anche nella stessa Eritrea, dove i tigrini rappresentano il 52% della popolazione. Ma il dubbio diventa più sostenuto sulla possibile appartenenza religiosa degli ufficiali, ovvero sul timore che si tratti di elementi non mussulmani. In questo caso le Corti islamiche avrebbero ragione nel dichiarare – così come hanno fatto – che si è trattato di una crociata contro i fedeli dell’islam. Ma per gli analisti la preoccupazione maggiore nasce sulla fine delle Corti islamiche, ovvero sui loro spostamenti e sull’eventuale rivalsa che potrebbero organizzare dalle nuove sedi logistiche. I miliziani delle Corti sono tornati nella loro base storica, sull’isola di Ras Kambon, davanti alle coste somale di Chisimaio, anche se molto più vicina al confine con il Kenya. Disorientate per la sconfitta subita, le Corti non sembra ancora in grado di riorganizzarsi prontamente, ma appaiono piuttosto preoccupate di intavolare delle trattative che evitino l’arresto e la condanna dei suoi leader rimasti nelle mani del Governo di transizione. Al di là delle dichiarazioni congiunte (“Siamo stati sconfitti ma non abbiamo perso la guerra. Anzi, faremo quello che abbiamo promesso di fare: colpiremo ovunque e ci ritireremo. Fino a quando tutti i blindati e i carri armati etiopici saranno cacciati dal paese”) le milizie islamiche si sono divise in tre diversi gruppi. Secondo le indicazioni raccolte dall’intelligence occidentale, il primo gruppo, fedele ad Hassan Turki, decide di rimanere a Ras Kambon per organizzare la guerriglia promessa (l’isola viene ribattezzata Tora Bora in omaggio alle catene montuose afgane dove aveva trovato rifugio Osama Bin Laden durante i bombardamenti americani nella guerra contro i talebani). Il secondo gruppo, legato all’intransigente sceicco Hassan Dahir Aweys, sceglie invece la clandestinità nella regione della bassa Shabelle, fitta di montagne e di boschi, deciso a preparare ed organizzare la “resistenza” terroristica al nuovo regime somalo. Il terzo gruppo, composto dai fedeli del moderato Sharif Ahmed, cerca di riparare in Kenya e di chiedere asilo politico. Ma il governo di Nairobi ha già schierato migliaia di militari e di poliziotti lungo i suoi 1.500 chilometri di confine – senza contare il massiccio pattugliamento delle coste – fedele alle dichiarazioni rilasciate dal primo ministro alla stampa internazionale: si all’accoglienza dei profughi, no all’ingresso degli integralisti islamici. Dopo le esternazioni del presidente somalo Yussuf (“gli Stati Uniti hanno il diritto di agire da soli per colpire i terroristi ovunque essi si trovino”) la portaerei americana Dwight D. Eisenhower (alla guida di altre tre navi da guerra per operazioni di intelligence ed anti-terrorismo) si sta lentamente avvicinando nella zona dopo aver salpato le ancore dalla base americana di Manama in Bahrain, mentre dalla base militare americana di Gibuti un Ac-130 Spectre (denominato la “cannoniera volante”) ha iniziato a rullare i motori. Gibuti è dal 2003 la base della Task Force americana (“Camp Le Monier”, circa 1.600 uomini) e nel Bahrain è di istanza la V Flotta americana (circa millecinquecento uomini) per la più ampia missione di “individuare, ostacolare e sconfiggere i gruppi di terroristi transnazionali che operano nella regione”, secondo una direttiva emanata subito dopo l’11 Settembre 2001 (Donald Rumsfeldt, Segretario alla Difesa) nella più ampia strategia del Pentagono nelle operazioni di contro-terrorismo su scala globale. Secondo il «New York Times» (13 Gennaio 2007), Washington aveva già fornito la collaborazione della Cia (supporto di intelligence senza intervento diretto) ai signori della guerra per ostacolare l’avanzata delle Corti islamiche, ma dopo il fallimento dell’operazione le competenze sarebbero passate direttamente al Dipartimento della Difesa, che adesso – scoperti finalmente i covi dei terroristi – deve collaborare con il governo di Mogadiscio e quello di Nairobi per cercare di catturarli. L’8 gennaio del 2007, quattro bombe a guida laser lanciate dallo “Spectre191” annunciano ufficialmente il ritorno degli Stati Uniti in Somalia dopo la disastrosa esperienza di Restore Hope del 1993. Le bombe colpiscono le località di Hayo e di Badmadow (Ras Kambon) mentre elicotteri americani (quasi sicuramente della Delta Force) attaccano Bankajirow e Badel, tutte le località dove hanno cercato rifugio i miliziani islamici in fuga da Mogadiscio. Secondo fonti del Pentagono, rimangono uccisi tre terroristi appartenenti al gruppo di al-Qaeda e super ricercati dalle intelligence occidentali (Abdullahi Mohammed Fazul, delle isole Comore; Abu Tacha del Sudan e Alì Saleh Naban, del Kenya), insieme ad altri dieci terroristi considerati però meno importanti (gli attacchi americani, anche se autorizzati e difesi dal presidente somalo, vengono però criticati dal nuovo segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, e dall’Unione Europea). Le Nazioni Unite autorizzano la formazione di un contingente di forza di pace composto da paesi africani per contribuire alla stabilizzazione della Somalia, ma la partita è adesso in mano al presidente keniota Mwai Kibaki ed al premier etiopico Meles Zenawi, ed entrambi i governi concordano nell’accelerare i tempi di realizzazione delle truppe di peacekeeping. L’Etiopia, già criticata per il suo intervento militare, dichiara che lascerà la Somalia entro breve tempo (ma non desidera che i suoi sforzi militari vengano vanificati da una recrudescenza terroristica) ed il Kenya – con la grave preoccupazione della presenza di integralisti islamici lungo il suo confine – riceve il mandato dell’Unione Africana per il coordinamento di tutta l’operazione (oltre ad avere la presidenza di turno della Inter Governmental Agency for Development, Igad). Anche se gli analisti ritengono che le modalità e i tempi a disposizione siano troppo limitati (sono necessari non meno di 8.000 uomini) le maggiori incognite provengono proprio dai paesi africani. L’Uganda ha già inviato (1° marzo 2007) un battaglione logistico a Baidoa con il compito di organizzare il dispiegamento del contingente militare dell’Unione Africana e sono in arrivo altri 1.500 soldati ugandesi oltre a ottocentocinquanta nigeriani, insieme a reparti del Ghana e del Burundi. L’Angola ha offerto la sua disponibilità, ma il Sud Africa, la Tanzania e la Nigeria sono ancora titubanti. Accertato l’assenso favorevole del Malawi – mentre il Mozambico è impegnato nella preparazione di un contingente da inviare in Darfur, nell’ambito della missione Amis – il totale previsto di ottomila uomini sembra però al momento irraggiungibile, anche a causa della conclamata mancanza di fondi dell’Unione Africana per il finanziamento della missione. Da registrare, quantomeno, le buone intenzioni del presidente ugandese, Yoweri Musaveni: anche se i suoi uomini non hanno il compito di disarmare le milizie islamiche, “rimane fermo il dovere di difendere il governo somalo e l’impegno di ricostruire ed addestrare l’esercito e la polizia”. 191 L’AC-130 Spooky – un quadrimotore ad elica derivato dal C-130 Hercules – è in grado di produrre una potenza di fuoco impressionante: cannone Bofors da 40 mm (120 colpi al minuto), mitragliatrice Gau-4 Vulcan da 20 mm (1.800 colpi al minuto), cannoncini da 7,62 mm e lanciamissili Howitzer da 105 mm. Lungo 29,8 metri, ha un’autonomia di 2.407 chilometri (circa 8/10 ore di volo), tredici uomini di equipaggio e può trasportare sino a dieci tonnellate di armamenti e munizioni, oltre a radar sofisticati (di navigazione e con indicatori di obiettivi in movimento, per la visione notturna e per seguire la traiettoria dei colpi sparati) e con un centro di controllo per la precisione del tiro, con strumenti per la visione a raggi infrarossi e sensori per la protezione da missili offensivi. Le truppe ugandesi (in treni e navi speciali da Kampala a Mombasa e poi a Mogadiscio) trovano l’appoggio dei soldati somali già schierati sul terreno per evitare incidenti con la popolazione e i temuti scontri con le milizie islamiche (l’obiettivo a breve termine è anche quello di riportare a Mogadiscio il governo legittimo e le sue istituzioni politiche ed amministrative). Nonostante tutto, non sono pochi gli analisti che nutrono forti dubbi sulla reale possibilità delle forze africane di portare pace e sicurezza, ed è ancora tutta da verificare la capacità di controllo del territorio e la stessa stabilità politica del Governo di transizione. Dopo la fuga delle Corti, i combattimenti a Mogadiscio riprendono tra i miliziani antigovernativi – adesso un miscuglio di guerriglieri islamici, sbandati, miliziani del clan hawiya, ma anche decine di arabi, così come è arabo il nome che li identifica, muqawamah, resistenza – che si oppongono al tentativo delle forze lealiste di disarmarli. Questi gruppi, però, riescono ad abbattere un aereo cargo Ilyushin bielorusso (tre missili terra-aria, quasi sicuramente forniti da Asmara), appena decollato dall’aeroporto di Mogadiscio – dopo aver scaricato generatori elettrici e materiale logistico destinato alle truppe ugandesi del contingente di pace dell’Unione Africana192– oltre ad un elicottero da combattimento etiopico (Mi-24) causando la morte di quattro membri dell’equipaggio. Secondo fonti della Croce Rossa, si tratta della battaglia più feroce combattuta a Mogadiscio negli ultimi quindici anni (centinaia di morti e altrettanti feriti giacciono per le strade, mancano viveri e acqua, la popolazione è afflitta da un’epidemia di colera e dissenteria, in città vengono usate le armi pesanti e quindicimila persone scappano disordinatamente del centro abitato). Un tentativo di accordo tra l’esercito etiopico e gli anziani della tribù hawiya – che insieme a quelle abgal, habergidir e aer sono le maggioritarie nella capitale – non viene raggiunto a causa del rifiuto dei somali di consegnare al colonnello Gebre – il comandante delle truppe di Addis Abeba – nove miliziani islamici, accusati di atti di terrorismo. Si tratta di Fazul Harun Abdallah e di Saleh Alì Naban, accusati dell’assalto alle ambasciate USA nel 1998 e inseriti dall’Fbi nell’elenco dei “most wanted”. Ma anche di Abu Taha al-Sudani, uno dei finanziatori dei gruppi islamici somali collegato ad alQaeda, e di Hassan Turki, fondatore nel 1977 del gruppo fondamentalista al-Ittyat al-Islam. Infine, i giovani capi degli al-shabab, Adan Ashi Aeru e Ahmed Abdi Godane, addestrati in Afghanistan sotto i diretti comandi di Osama bin Laden, e Ibrahim Aji Jama al-Afgani, combattente in Kashmir e rientrato in Somalia agli inizi degli anni Novanta, insieme a Issa Osman Issa, coinvolto nell’attentato all’Hotel Paradise a Mombasa nel 2002. Di fronte al dilagare delle violenze in Somalia, gli Stati Uniti decidono di inviare una delegazione guidata dal vice sottosegretario alla Difesa, Ryan Henry, per costruire in Africa una base – o meglio un centro di comando – che coordini tutte le operazioni nel continente: raccolta di informazioni, addestramento di unità locali, pronto intervento e aiuti umanitari (Africom). Durante la visita nell’Africa del Nord, la delegazione – nonostante le prospettive di investimenti e posti di lavoro – non riesce a trovare alcun paese pronto ad accogliere l’iniziativa, incassando il rifiuto di Marocco, Algeria, Mali, Libia ed Egitto (e quindi rimane operativa solo la Trans Sahara Counter Terrorism Partnership). Nell’estate del 2008 – i ribelli islamici conquistano Chisimaio – si riaffacciano i miliziani di alshabab, nati dalle ceneri delle Corti islamiche e guidati da Hassan Turki (ma con la presenza di 192 Nella forza di pace africana, autorizzata dalle Nazioni Unite, è presente solo il contingente ugandese, avendo deciso la Nigeria, il Benin e il Burundi di rimandare – a data non definita – l’invio dei militari. mujaheddin yemeniti, afghani e arabi, finanziati dalla pirateria somala). Attraverso una campagna di terrore (diciassette rapimenti e almeno venicinque omicidi mirati in pochi mesi) prendono di mira i cooperanti delle agenzie Onu e delle organizzazioni non governative, con l’obiettivo di impedire la distribuzione di cibo alla popolazione e gestire in proprio tutto il meccanismo degli aiuti, in modo da guadagnare consenso attraverso una capillare rete di supporto sociale193. I fondamentalisti accusano le organizzazioni di fare proselitismo per i cristiani e di seminare “una distruttiva influenza occidentale”. Nella compagine islamica si verificano ulteriori fratture. Uno degli uomini più oltranzisti dello scenario somalo, sheikh Hassan Mhadi – comandante la brigata Khalid bin Walid che ha conquistato Chisimaio, la seconda città della Somalia a cinquecento chilometri a sud della capitale, imponendo alla popolazione misure restrittive molto severe, basate sul terrore – prende le distanze dal suo vice, sheikh Mustafà Alì Anod. Il motivo del contendere è l’atteggiamento da tenere nei confronti degli altri gruppi di ispirazione islamica: l’ “Unione delle Corti”, considerata troppo moderata e divisa a sua volta in due diversi organizzazioni. La prima, guidata da sheikh Sharif Shek Ahmed e stanziata a Gibuti, e la seconda – più oltranzista – capeggiata dal leader sheikh Hassan Daher Aweis, che risiede ad Asmara. Una volta scartata definitivamente l’ipotesi di trovare un accordo con l’ala più moderata (Sharif Shek Ahmed), Hassan Mahdi esclude anche qualunque contatto con l’ala oltranzista (Hassan Daher Aweis), accusata di aver scelto l’esilio in Eritrea al posto della militanza attiva. Durante una riunione della shura, il parlamento che governa Chisimaio, le dichiarazioni di Hassan Mahdi prospettano la scelta di una linea più rigida degli stessi oltranzisti delle Corti: I loro capi sono rinnegati. Hanno scelto come esilio l’Eritrea che collabora con Israele ed è arrivato al punto di concedere ai sionisti una base logistica. Dunque sono nemici anche loro. Noi restiamo autonomi e indipendenti, e non risponderemo a nessuno delle nostre lotte. Il suo vice, Mustafà Alì Anod, dissente su questo tipo di scelta e viene cacciato dal parlamento con un voto all’unanimità. L’Unione delle Corti islamiche dislocate a Gibuti (Uic-D) lottano contro gli Etiopici – ma al tempo stesso aprono trattative per definire una data per il ritiro delle loro truppe dalla Somalia – e vogliono introdurre una sharia applicata senza disumano rigore. Il resto delle Corti, organizzato ad Asmara (Uic-A) non intende trattare con il Governo di transizione sino a che i loro alleati di Addis Abeba non avranno ritirato le truppe. I vertici militari della Uic-A sono invece in Somalia, e primo tra tutti il vecchio colonnello Hassan Turki, considerato il vero ideologo dell’islamismo radicale somalo, che – pur mantenendo un profilo molto basso – opera nel sud del paese e mantiene i contatti con al-Qaeda. Un altro comandante di rilievo è il bellicoso Muktar Robow (alias Abu Mansur), impegnato in azioni di sabotaggio contro gli etiopici a Mogadiscio. 193 Il 3 agosto 2008 una bomba esplode nel viale principale di Mogadiscio, Maka al-Mukarama, causando la morte di una trentina di donne che stavano facendo pulizie in strada, nel quadro di un ampio programma dell’agenzia non governativa Adra che prevede la distribuzione di cibo (grano ed olio) in cambio di immondizie. Si è probabilmente trattato di una ritorsione proprio per colpire le donne che hanno aderito al programma, organizzato per evitare che venissero piazzate degli ordigni esplosivi nelle montagne di rifiuti ammassate nelle strade della città (poche settimane prima, alcune donne avevano infatti trovato tra i rifiuti alcune mine, subito disinnescate dagli artificieri etiopici). Oltre alla brigata Khalid bin Walid – che opera anch’essa nel sud del paese – viene segnalato un altro gruppo con la denominazione di Harat Ras Kamboni, il promontorio al confine con il Kenya dove gli islamici hanno costruito una potente base militare, fatta di bunker, capannoni e magazzini nascosti nella foresta e nei cunicoli sotterranei. A Chisimaio la legge islamica viene applicata, se possibile, con maggiore rigore rispetto al resto del paese. Hassan Mahdi arriva ad ordinare la morte della giovane donna Aisha Ibrahim Dhuhulow, per mezzo della lapidazione, accusata di adulterio. Durante l’esecuzione, svoltasi nella piazza principale di Chisimaio alla presenza di migliaia di persone, scoppiano tafferugli con alcuni parenti che cercano di salvare la ragazza e durante una breve sparatoria perde la vita anche un bambino (un leader degli estremisti si è scusato e l’ha definito un “danno collaterale”). La ragazza è stata sepolta sino alle spalle e per tre volte è stato interrotto il lancio di pietre per estrarla dalla terra e verificare se fosse ancora viva (per la sharia la lapidazione deve avvenire con “sassi di media grandezza, né troppo grandi da causare la morte istantanea, né troppo piccoli da risultare inoffensivi”). Prevista per gli adulteri (principalmente donne, ma anche uomini), questa pena può essere teoricamente inflitta solo se la colpa è provata da quattro testimoni oculari – ritenuti attendibili – oltre alla pubblica presenza, ritenuta indispensabile, dell’uomo con cui la colpevole ha avuto rapporti sessuali (tutti elementi che sono mancati nell’esecuzione di Chisimaio, dove la ragazza è stata ritenuta colpevole senza alcun processo e trasportata in piazza coperta da un velo verde e una maschera nera). Il giudice, sheikh Hayakalah, dichiara agli spettatori della piazza – ma anche in collegamento con Radio Shabelle – che questa nostra sorella ha ammesso il suo peccato: le abbiamo più volte chiesto di ritirare la confessione, ma lei ha insistito ed ha persino detto di essere felice di venire punita in base alla legge islamica. Solo successivamente, si è venuto a sapere che in realtà l’adultera lapidata era una bambina di tredici anni, rapita e stuprata da tre uomini (probabilmente di al-shabab) mentre si recava dal campo profughi di Dhagahbur, in Etiopia, a Mogadiscio in visita all’anziana nonna. La notizia dell’esecuzione accende il dibattito sui giornali e sui siti internet del mondo islamico – già in corso da tempo – sull’effettiva legalità islamica della lapidazione. Nel Corano non vi è menzione diretta di questa pratica – contemplando soltanto una serie di frustate per gli adulteri – ma un hadit (detto) attribuito al Profeta sembra essere alla base di questa consuetudine194. Secondo Ahmed Ibrahim Mohammed, deputato al parlamento somalo e presidente della commissione per gli Affari costituzionali e federali, la legge penale somala prevede al massimo un anno di reclusione per le adultere, una pena leggera, e comunque esclude la pena di morte. La nostra Costituzione si ispira alla legge coranica solo per quelle parti che riguardano l’eredità, il mantenimento dei figli e il sostegno economico della moglie in caso di divorzio. Per il resto è una legge laica. Certo, non ci possono essere norme che vanno contro il Corano, ma il nostro testo sacro non obbliga a lapidare tutte le adultere. 194 I pochi paesi che prevedono la lapidazione (Arabia Saudita, Nigeria, Yemen, Pakistan e Iran) non la utilizzano – di fatto – da alcuni anni (decretando moratorie sostanzialmente rispettate), con la sola eccezione del Pakistan. Il governo di Mogadiscio – adesso guidato da Nur Adde – registra forti divergenze con il presidente Abdullahi Yussuf, accusato dal primo ministro di tollerare, se non incoraggiare, omicidi e regolamenti di conti (il premier rimane però inspiegabilmente, al suo posto e si dimettono cinque ministri, subito rimpiazzati). In ogni caso, il presidente Abdullahi Yusuf annuncia le sue dimissioni (dicembre 2008) davanti al parlamento riunito a Baidoa, rimasta una delle poche città ancora sotto controllo governativo. Dopo quattro anni decide di lasciare l’incarico – perché “la Somalia è paralizzata e non c’è modo di unificarla” – e di ritirarsi nella regione natale del Puntland, al nord del paese. In realtà, le Nazioni Unite ravvisavano già da tempo nella sua figura un serio ostacolo alla riappacificazione dei clan in lotta e parlano adesso di un “nuovo inizio” per il futuro politico del paese. La situazione rimane però molto delicata: il gruppo intransigente degli al-shabab ha conquistato quasi tutto il territorio (l’epiteto più morbido riservato al presidente è “vergognoso”) e le truppe di Addis Abeba – entrate in Somalia proprio per difendere il Governo di transizione dagli attacchi delle milizie islamiche delle Corti – decidono di ritirarsi. L’inviato delle Nazioni Unite per la Somalia, Ahmedou Ould Abdallah, dichiara che “spetta adesso ai somali, dopo il ritiro dei soldati etiopici assicurare la pace e la stabilità del paese” mentre una folla festante accoglie la notizia e invade le piazze della capitale. La sicurezza passa ora alle sole forze governative e a quelle della missione Amisom – autorizzate dall’Onu nel 2007 – anche se potrebbero unirsi le milizie mussulmane sciite, in previsione di un complesso accordo in tal senso. L’elezione a nuovo presidente, avvenuta a Gibuti nel febbraio del 2009, di sheikh Sharif Ahmed – l’islamico moderato a capo dell’esecutivo delle Corti islamiche nel 2006, dopo la conquista di Mogadiscio – suscita la violenta opposizione degli al-shabab che lo bollano immediatamente con il termine di “traditore”. Spaccato il debole fronte tra il moderato Sharif Ahmed e il fondamentalista Hassan Daher Aweis (il nuovo presidente è stato votato da un parlamento misto, composto da laici e religiosi moderati, e con l’appoggio determinante di Addis Abeba e di Washington), le milizie al-shabab al comando di Aweis mettono a ferro e fuoco Mogadiscio (tra di loro viene individuato anche il terrorista comoriano Fazul Harun Abdallah, ricercato per gli attentati del 1998 contro le ambasciate statunitensi, mentre il kenyota Ahmed Salim Swedan risulta ucciso in Pakistan). In occasione dell’elezione del nuovo presidente, anche il leader di al-Qaeda, Osama bin Laden, trasmette un messaggio su internet – dal titolo “Combattete, campioni della Somalia” – per attaccare l’islam moderato che sembra prevale in Somalia: la guerra che da qualche anno infuria sulla vostra terra è una guerra tra l’islam e la crociata internazionale […] questo genere di presidenti sono un surrogato dei nostri nemici, la loro autorità è nulla e vuota a priori, ed essendo Sharif uno di loro, deve essere detronizzato e combattuto. Il quindicesimo tentativo di formare un governo somalo funzionante, dall’inizio della crisi nel 1991, è quindi visto dagli estremisti islamici – sia locali che internazionali – come un tentativo di conquista del paese da parte dell’Occidente e i capi di al-shabab si affrettano ad assicurare che gli attacchi nei confronti degli stranieri e dei civili somali “che cooperano con gli infedeli, non avranno fine sino a quando questo governo rimarrà al potere”. Le operazioni delle organizzazioni non governative sul campo, che tentano di portare alimenti e beni di prima necessità alle vittime della peggiore crisi umanitaria del mondo (dall’inizio della ribellione islamista, sono stati uccisi più di sedicimila civili, circa un milione di persone ha lasciato le proprie case e tre milioni di somali dipendono dagli aiuti umanitari) trovano continui ostacoli da parte degli integralisti islamici, dai rapimenti del personale agli attacchi dei convogli. Il primo ministro somalo, Omar Abdirashid Alì Sharmarke, nel tentativo di rafforzare la sicurezza del personale umanitario ordina alle agenzie di registrarsi presso il governo: A nessuna organizzazione sarà permesso di lavorare nella capitale Mogadiscio o in qualsiasi altro posto della Somalia senza l’approvazione del governo […] abbiamo bisogno di sapere dove portano avanti le loro attività e in che modo stanno aiutando la popolazione […] se lo staff umanitario viene colpito in qualche modo, il governo somalo sarà considerato il principale responsabile. La battaglia per il controllo di Mogadiscio comincia con un massacro ad opera dei caschi blu dell’Africa Union Mission in Somalia (Amisom). Una bomba piazzata sul ciglio della strada esplode al passaggio di un convoglio di truppe ugandesi e i soldati reagiscono sparando all’impazzata sulla folla: 32 civili uccisi e decine di feriti. Nel frattempo, le milizie di al-shabab conquistano la città di Giohar (Jowahr) a circa novanta chilometri dalla capitale, ma devono anche incassare un duro colpo a causa della defezione di uno dei comandanti più impegnati, anche se non nuovo a repentini cambi di fronte. Lo sceicco Yusuf Mohammed Siad – soprannominato inda ‘adde, occhi bianchi – dopo una burrascosa riunione con gli anziani del suo clan (composto da habergidir e aer) decide di consegnare il suo cospicuo arsenale al governo somalo. In risposta, Hassan Turki – si è scoperto che il suo vero nome è Shek Hassan Abdallah Hersi – che controlla con i suoi guerriglieri il sud della Somalia, decide di trasferire i miliziani da Ras Chiamboni a Mogadiscio, per dare man forte agli al-shabab, temporaneamente ridotti di numero. Ma tra di loro – ammesso per la prima volta da un portavoce ufficiale – si registra la presenza di numerosi combattenti stranieri, compresi alcuni italiani195. In effetti, un kamikaze straniero – di carnagione chiara – a bordo di un camion uccide sei agenti di polizia e un civile facendosi esplodere davanti ad una caserma di Mogadiscio. Secondo la polizia somala si tratta di uno dei trecento jihadisti, quasi tutti arabi, giunti di recente nella capitale per sostenere le milizie al-shabab. Sull’altro fronte, Abdullhai Farah – leader spirituale dei sufi che fanno capo alla moschea di alQadria, a nord di Mogadiscio, costretto a scappare in Somaliland per le minacce di morte ricevute dopo che le milizie di al-shabab avevano occupato la vicina moschea di al-Idayha – decide di abbandonare la consueta tranquillità per scagliarsi contro le milizie oltranziste islamiche: gli shabab vogliono trasformare la Somalia in un campo di concentramento, travisando la legge coranica e applicandola per la loro convenienza politica. I miei ragazzi a Mogadiscio, per la prima volta da quando è scoppiata la guerra civile, hanno imbracciato i fucili. In tutta la Somalia le sette sufi – tradizionalmente pacifiche nella ricerca di un’esperienza diretta con Allah – si ribellano agli integralisti e al loro braccio armato, dopo la devastazione delle loro moschee e la profanazione delle tombe sacre. A loro si uniscono anche gruppi di tradizionalisti ortodossi – compresi i seguaci laici e pacifisti di Ahlu Sunnah Waljama – stanchi di subire le violenze degli uomini di al-shabab. Di contro, l’intransigente leader delle Corti, Hassan Daher Aweis – rientrato in Somalia dopo 195 Secondo Yussuf Hassan, stringer del «Corriere della Sera» a Mogadiscio, ci sarebbero appunto degli italiani, senza però sapere se si tratta di mussulmani naturalizzati o cittadini italiani convertiti all’islam. M. A. Alberizzi, Somalia, gli integralisti avanzano. Con loro islamici italiani”. «Corriere della Sera», 18 maggio 2009. l’esilio volontario in Eritrea e già a capo dell’ala oltranzista – riceve a sorpresa la cancellazione del suo nome dall’elenco americano dei terroristi, probabilmente a causa dell’opportunità concessa da Washington per partecipare ad eventuali negoziati di pace. Aweis, che ha già raggruppato intorno alla sua figura carismatica i fondamentalisti più accesi con il nome di Hezb al-Islam, non sembra però propenso a posizioni più moderate: Chiedo a Sharif Ahmed di abbandonare la sua autoproclamata carica di presidente, allo scopo di salvare le vite dei somali, noi non abbiamo un vero governo somalo, ma dei burattini stranieri che si proclamano responsabili della Somalia. Nessun paese al mondo accetterebbe un governo imposto dall’esterno, i somali sono quindi liberi di respingerlo. Secondo molti analisti occidentali, i fondamentalisti non intendono accettare il nuovo Governo – compresa la proposta di varare la sharia come legge costituzionale – perché l’obiettivo è piuttosto quello di raggiungere il potere attraverso una campagna di terrore, con l’appoggio del governo eritreo, una dittatura tra le più dure di tutta l’Africa, che fornisce armi e addestramento ai miliziani islamici più radicali196. L’estrema gravità della situazione spinge il presidente del parlamento somalo – Aden Mohamed Nur – a lanciare un appello ai “paesi vicini” (giugno 2009) per l’immediato invio di soldati per fronteggiare la feroce ribellione dei fondamentalisti islamici. Gli fa eco il capo della commissione dell’Unione Africana (Ua), Jean Ping, che ritiene legittimo il diritto del governo somalo di chiedere sostegno ai paesi membri della Ua per “l’aggressione perpetrata da formazioni armate, anche con appoggi esterni, contro la popolazione e il governo di Mogadiscio”. L’Unione Africana è presente in Somalia – in particolare nella capitale – con circa quattromilatrecento uomini, ma il loro mandato non prevede però il contrasto militare alle azioni dei ribelli islamici, ma esclusivamente il ricorso alle armi per la semplice autodifesa. L’Etiopia, interpellata per un altro eventuale intervento in Somalia, si affretta a dichiarare che invierà le sue truppe oltre il confine solo in presenza di un mandato internazionale (anche se alcuni testimoni riferiscono che truppe etiopiche sono già stanziate nella zona di Beledwyne, in territorio somalo). Ad appoggiare la richiesta del governo interviene anche il Segretario generale dell’Organizzazione della Conferenza Islamica (Oci), Ekmeleddin Ihsanoglu, che ritiene “inevitabile che la comunità internazionale intervenga immediatamente per appoggiare il Governo e ristabilire l’ordine nel paese, e ad alleviare le sofferenze di civili innocenti”, esortando i cinquantasette membri dell’Organizzazione – la Somalia ne fa parte – ad aiutare il presidente Sharif Ahmed, possibilmente con nuove e più efficaci regole di ingaggio. La risposta dei ribelli somali non si fa attendere. Il portavoce delle milizie di al-shabab – sheikh Alì Mohamud Rage – replica minacciando i paesi confinanti in caso di intervento armato: “noi lanciamo un avvertimento ai paesi vicini: se voi volete che i vostri soldati tornino in una bara, allora mandateli sul nostro suolo”. A fronte della gravità della situazione, gli Stati Uniti decidono di fornire armi e munizioni al governo somalo per combattere la ribellione degli estremisti islamici (Ian Kelly, portavoce del Dipartimento di Stato americano), mentre le milizie di al-shabab si scontrano duramente con il gruppo autonomo – ma filogovernativo – degli Ahlu Sunna Waliamàa, i seguaci del misticismo sufi, considerati apostati dagli integralisti radicali. 196 Oltre ad armi leggere e pesanti, le milizie islamiche ricevono da Asmara cinque carri armati T55 di produzione sovietica, ma sono difficili da pilotare e i carristi eritrei organizzano corsi accelerati per i guerriglieri. Mogadiscio subisce pesanti bombardamenti e gli islamisti arrivano ad attaccare la “chilometro 4”, la base militare dell’Amisom (le forze di pace dell’Unione Africana che adesso contano 4.300 uomini tra ugandesi e burundesi) ed estendono i combattimenti anche a ridosso del palazzo presidenziale di Sharif Ahmed. Il “Comitato per la Sicurezza Congiunta” (Jsc) – composto da membri dell’Ufficio politico per la Somalia delle Nazioni Unite, dell’Amisom, della comunità internazionale e del governo, oltre che dai commissari di polizia e dai capi delle agenzie di intelligence – si riunisce precipitosamente per elaborare nuove e più efficaci strategie per migliorare la sicurezza del paese. Ma la crisi non fa che aggravarsi e gli scontri si intensificano nei quartieri meridionali della capitale, dove si fronteggiano gli estremisti di Harakat al-Shabaab Mujahideen con i moderati del gruppo sufi di Ahlu Sunna Waljamàa. A peggiorare la situazione delle forze governative, la morte improvvisa di alcuni soldati burundesi dell’Amisom, a causa di una misteriosa malattia, e il ricovero in ospedale di una ventina di loro che accusavano gli stessi sintomi. Anche se il presidente Ahmed impone definitivamente la sharia come unica legge per il paese, i leader di al-shabab non depongono le armi perché è loro intenzione introdurre una versione ancora più dura ed intransigente (due ex poliziotti somali, accusati di aver venduto informazioni in cambio di denaro, vengono bollati come “nemici di Allah” e decapitati nella pubblica piazza con grande risonanza mediatica). Secondo gli analisti americani, in aiuto dei fondamentalisti sono arrivati dall’estero un migliaio di miliziani, tra afghani, pachistani ed arabi, ma anche combattenti con passaporto americano, canadese ed europeo (italiano compreso) e il Segretario di stato americano, Hillary Clinton, lancia un duro attacco contro l’Eritrea, colpevole di aiutare i ribelli somali e di “incendiare” l’intera regione del Corno d’Africa. Subito dopo, l’intelligence americana mette a segno un duro colpo per la dirigenza di al-Qaeda in Africa. Con l’operazione Celestial Balance le forze speciali statunitensi riescono ad uccidere a Barawe, nel sud della Somalia, Alì Saleh Nabhan, il responsabile di una strategica cellula africana molto attiva tra Tanzania, Kenya e Somalia. Nato in Kenya, all’età di trent’anni Nabhan era partito volontario per l’Afghanistan nel 1998 e dopo solo tre anni era diventato istruttore nei campi di addestramento di al-Qaeda. Sposato con tre mogli e appoggiato dai suoi referenti in Pakistan (con Abdullah Fazul aveva partecipato agli attentati di Nairobi, Dar el-Salaam e Mombasa) era riuscito a conquistare una posizione di rilievo, arrivando a controllare decine e decine di militanti di origine somala cresciuti in Occidente (svedesi, britannici ed americani). Dopo aver tentato di eliminarlo con un attacco di missili cruise sparati da un sottomarino (il terrorista era però riuscito a fuggire), i Navy Seals sono riusciti ad intercettare il corteo di automobili che lo scortava sulla strada di Barawe e dopo aver bloccato gli automezzi lo hanno ucciso insieme a quattro miliziani afghani, tre somali e Alì Fidow, un dirigente di al-shabab (le forze speciali hanno portato via il cadavere del terrorista per eseguire il test del Dna e per privare “il nemico delle spoglie del martire”). Dopo aver promesso vendetta per l’uccisione del leader (“assaggerete la nostra risposta”) gli integralisti piazzano due autobomba nel quartier generale dell’Amisom a Mogadiscio – nel super protetto aeroporto della capitale – causando la morte di almeno nove persone e due peace-keepers (tra i militari, perde la vita il colonnello burundese Juvenal Niyonguruza e rimane ferito il comandante in capo delle forze di pace, il generale ugandese Nathan Mugisha). Nella città di Chisimaio, interamente controllata dagli integralisti, il gruppo al-shabab realizza un quiz radiofonico che mette in palio un fucile d’assalto Ak-47, due granate e una mina anticarro (i vincitori ritirano il premio in mezzo ad una folla festante) mentre uno dei comandanti, Mohamed Alì Shuqul, annuncia la conquista della città di Afmadow, nella Somalia meridionale – ormai quasi interamente nelle mani degli islamisti radicali – dopo aver anche sbaragliato i rivali del gruppo Izbu al-Islam, considerati troppo teneri rispetto all’applicazione della sharia e costretti a fuggire a piedi verso la frontiera keniota. A Mogadiscio, un fondamentalista che indossa abiti e scarpe femminili, con il volto completamente coperto dal niqab, riesce ad introdursi nella sala dell’hotel Shamo (a duecento metri dall’incrocio K-4, quello che delimita la zona della capitale controllata dai miliziani islamici dal settore ancora in mano al governo) dove è in corso la cerimonia per il festeggiamento per la laurea in Medicina dei giovani neo-dottori dell’università di Benadit. Data l’importanza dell’evento (in Somalia mancano medici, infermieri, farmaci, strumenti chirurgici e plasma) partecipano anche il preside della facoltà di Medicina e cinque ministri in carica. L’esplosione del kamikaze provoca la morte di ventidue persone (perdono la vita il ministro della Salute, Alì Aden Qamar, quello dell’Interno, Ahmad Abdullah e quello dell’Istruzione, Ibrahim Addow, anche leader delle Corti moderate). Anche il Puntland – la regione semi-autonoma al nord della Somalia, rimasta relativamente tranquilla – viene sconvolta da una serie di assassinii commessi contro le autorità. I soldati governativi danno il via ad un’offensiva militare contro i ribelli islamici di sheikh Mohamed Said Atom, un noto trafficante di armi legato al gruppo al-shabab, e riescono ad intrappolare le forze nemiche sulle montagne Galgala – asserragliate agli ordini del comandante militare Abdikarin Ahmed Beynah – aprendo un nuovo fronte nella già complessa crisi somala. La Commissione europea di Bruxelles decide di destinare altri 47 milioni di euro per finanziare le operazioni di peace-keeping della missione Amisom, ritenuta “cruciale per prevenire un ulteriore crollo significativo della sicurezza della Somalia” (dal 2007 al 2010, l’Amisom ha potuto contare su un finanziamento complessivo della Unione Europea pari a 142 milioni di euro). Ma le forze degli al-shabab si sono già concentrate nel campo di addestramento di Maslah, alla periferia di Mogadiscio, per svolgere un breve addestramento prima di una nuova offensiva contro la capitale (dopo un leggero rinforzo di soldati ugandesi, le truppe dell’Amisom possono adesso contare su seimila uomini). Durante una seduta dell’Assemblea – per discutere della crisi del governo guidato dal premier Omar Sharmarke, nel luglio del 2010 – il parlamento somalo viene bombardato dai colpi di mortaio dei ribelli di al-shabab, causando decine di vittime. Le truppe del contingente africano rispondono bombardando il mercato di Bakara, base degli islamisti radicali. A distanza di un mese, un gruppo di uomini armati – tutti identificati come miliziani di al-Qaeda di diversa provenienza197 – irrompe nell’hotel Muna, in uno dei pochi quartieri di Mogadiscio controllati dai governativi, e uccide trentadue persone, tra cui sei membri del parlamento somalo e quattro funzionari del governo di transizione, oltre a clienti e inservienti al lavoro. Il portavoce di al-shabab, sheick Alì Mohamud Rage, rivendica l’assalto, pianificato da tempo, e 197 Nei primi giorni di febbraio del 2010, il gruppo islamico di al-shabab ammette, per la prima volta, di essere allineato alla rete internazionale di al-Qaeda. Sino a questo momento, la dirigenza del gruppo aveva sempre respinto le accuse mosse dagli Stati Uniti, negando qualunque coinvolgimento con l’organizzazione terroristica globale. Nell’ultima dichiarazione, invece, si annuncia che “la jihad nel Corno d’Africa deve essere condotta in linea con la guerra santa internazionale guidata da al-Qaeda”. annuncia l’inizio di una vasta offensiva “contro gli invasori cristiani e il governo apostata”. L’assalto segue di una trentina di giorni un altro attentato compiuto a Kampala, in Uganda (due bombe con settantasei morti e decine di feriti), anche questa volta attribuito a miliziani di al-Qaeda come ritorsione per l’invio di truppe in Somalia. Pochi giorni prima, la polizia antiterrorismo keniota aveva arrestato a Mpeketoni (sull’isola di Lamu, ai confini con la Somalia) dodici persone in possesso di esplosivi, istruzioni per fabbricare bombe e detonatori, mappe e dettagliati piani di attacco contro obiettivi nella capitale. Tra gli arrestati – arrivati dalla Somalia con un motoscafo veloce preso in affitto – figurano tre cittadini della Tanzania e nove del Kenya, che avrebbero probabilmente rivelato, durante gli interrogatori, la localizzazione dei loro complici a Malindi. A distanza di pochi giorni vengono arrestati anche Suleiman Abdul Hamid, un importante leader radicale – catturato da una task force di agenti appartenenti a diverse nazionalità, non rivelate – e tre ugandesi che confessano di aver ricevuto un addestramento militare (esplosivi compresi) in Somalia. I due principali leader politici somali, il presidente Sharif Ahmed e il presidente del parlamento, Sharif Hassan Aden, decidono di estendere di un anno il mandato del governo e del parlamento (rimandando le elezioni politiche all’agosto del 2012). L’accordo – sottoscritto alla presenza del presidente dell’Uganda, Yoweri Museveni, e dell’inviato delle Nazioni Unite in Somalia, Augustine Mahiga della Tanzania – prevede le dimissioni del primo ministro, Mohamed Abdullah Farmayo. Il nuovo premier, Abduweli Mohamed Alì, presenta la compagine di governo formata da diciotto nuovi ministri, ma secondo la televisione araba «al-Jazeera» i contrasti tra le parti, circa la distribuzione dei ministeri, non sono state superate (Asha Osman Aquil, una donna appena nominata a capo del dicastero per “Donne e Famiglia” viene rapita dagli al-shabab a Balad, nella regione di Shabelle, a trenta chilometri dalla capitale). Nell’estate del 2011 le Nazioni Unite diffondono i primi dati sulla carestia che ha colpito le regioni meridionali della Somalia (controllate dagli islamisti) dove oltre due milioni di persone rischiano la fame (quasi quattro milioni nel Corno d’Africa), e la presenza di al-shabab viene indicata come una delle circostanze che contribuisce ad aggravare la crisi. Il portavoce del gruppo, Alì Mohamud Rage, si affretta ad accusare le Nazioni Unite di aver diffuso dati esagerati e di politicizzare la crisi, sostenendo che la presa di posizione dell’Onu è “totalmente, al 100 %, una propaganda sbagliata e priva di basi”. Per permettere la distribuzione degli aiuti, Washington annuncia che potrebbe lasciar cadere le sanzioni anti-terrorismo imposte alle milizie islamiche, con il solo obiettivo di venire incontro alle estreme necessità dettate dalla siccità che ha colpito il Corno d’Africa (solo per pochi giorni, i gruppi islamici permettono la distribuzione degli aiuti, ma solo sotto pagamento di un tributo, e di conseguenza le organizzazioni non governative potrebbero subire sanzioni penali per aver accettato di finanziare, anche se involontariamente, le milizie islamiche). Anche il governo somalo si impegna a varare un’amnistia per i combattenti islamici che decidono di abbandonare la lotta e consegnare le armi, attraverso un comunicato ufficiale rilasciato dal primo ministro Abduweli Mohamed Alì, che annuncia la creazione di un’unità di forze speciali per monitorare le aree che verranno sottratte alle forze islamiche. In realtà, le milizie stanno gradualmente abbandonando la città di Mogadiscio (ne controllavano più del 50%) e sembra che, anche in questo caso, il grosso delle forze si sia diviso in tre diversi gruppi, diretti a sud, ad ovest e a nord del paese. In una video conferenza organizzata dalla capitale, l’inviato delle Nazioni Unite per la Somalia, Augustine Mahiga, spiega che la decisione potrebbe essere stata presa per via dell’esaurimento del sostegno finanziario, sino ad oggi assicurato da donazioni private che arrivavano dai Paesi del Golfo, venute a mancare a causa delle rivolte che interessano tutta l’area. Aggiunge inoltre che la milizia di al-shabab, benché indebolita dai ridotti finanziamenti e da lotte intestine di potere, potrebbe riorganizzarsi e diventare ancora più pericolosa, abbracciando strategie di stampo qaedista, ancora più distruttive. Le Nazioni Unite, nel luglio del 2011, dichiarano lo stato di carestia della Somalia (l’ultima volta era stato dichiarato ufficialmente nel 1993, due anni dopo l’inizio della guerra civile) e il rapporto indica che complessivamente dodici milioni di persone nel Corno d’Africa hanno estremo bisogno di “assistenza d’emergenza”, mentre il numero dei somali che hanno bisogno di assistenza umanitaria è salito da due a quasi quattro milioni negli ultimi sei mesi, a causa di una combinazione letale di forte instabilità politica, di grave siccità e di aumento dei prezzi delle derrate alimentari198. La crisi della Somalia ha ripercussioni drammatiche su tutta le regione, in particolare in Kenya ed Etiopia, ovvero nei paesi che accolgono il maggior numero di sfollati ed a loro volta colpiti dalla siccità (la crisi è anche aggravata dall’estrema scarsità di risorse dei paesi limitrofi). Le stime dell’organizzazione non governativa Save the Children199 evidenziano che più della metà della popolazione nelle zone colpite della Somalia è costituita da bambini: “sono due milioni quelli che soffrono le conseguenze più terribili della grave crisi alimentare e per un milione di loro c’è il rischio concreto di perdere la vita” (Ben Fot, direttore di Save the Children in Somalia). Nel campo profughi di Dadaab, nell’area a nord-est del Kenya, trovano accoglienza oltre quattrocentomila rifugiati e l’affluenza giornaliera oscilla tra millecinquecento e tremila profughi. Aperto nel 1991 per ospitare somali, etiopici e sudanesi, il campo di Dadaab si divide in tre sezioni – Hagadera, Dagahaley e Ifo – e la registrazione del flusso migratorio è assicurata da ufficiali del governo kenyota oltre che da funzionari dell’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (Acnur). Un altro rapporto di Amnesty International evidenzia invece una situazione altrettanto drammatica relativa al lungo percorso che devono sostenere i rifugiati e le loro famiglie per raggiungere il campo profughi (costretti a camminare per oltre un mese, senza mangiare, con le donne e le bambine soggette a violenza e spesso attaccati dalle iene). Oltre al trasporto illegale degli sfollati, compiuto da autisti di automezzi senza scrupoli per raggiungere il confine con il Kenya – i militari esigono il pagamento di un pedaggio e chi non è in grado di pagare finisce preda dei trafficanti di organi – il rapporto denuncia l’estensione dei crimini di guerra a bambine e bambini. Arruolati con la forza ad un’età inferiore ai quindici anni da parte di gruppi armati islamici, viene negato loro l’accesso all’istruzione e sono le maggiori vittime durante gli attacchi indiscriminati 198 Secondo la classificazione della sicurezza alimentare (Persone in stato di insicurezza alimentare; Stress; Crisi; Emergenza; Carestia), per lo stadio di carestia viene usato il parametro della morte di due bambini al giorno su 10.000 persone. Le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite hanno stilato un rapporto dove la morte dei bambini ha raggiunto la spaventosa cifra di otto ogni 100.000 persone. 199 La coalizione di organizzazioni non governative italiane denominata “Agire” (Action Aid, Amfer, Avsi, Cesvi, Coopi, Cisp, Intersos, Vis e Save the Children) può vantare una presenza radicata e un’attività di lungo periodo nelle aree colpite dalla siccità. contro le aree densamente popolate. Per Michelle Kagari, vicedirettore di Amnesty International per l’Africa, la crisi umanitaria che ha colpito i bambini in Somalia è anche la conseguenza del fatto che negli ultimi due anni gli alshabab hanno impedito l’accesso agli aiuti (il titolo del rapporto è “Sulla linea del fuoco. Bambine e bambini sotto attacco in Somalia”, giugno 2011). Inoltre, il rapporto riferisce che gli islamici, oltre ad aver imposto severe limitazioni al diritto allo studio, vietano l’insegnamento di alcune materie e usano le scuole per indottrinare i bambini e farli partecipare ai combattimenti. Utilizzando metodi sempre più minacciosi per reclutare i fanciulli – compiendo raid e rapimenti nelle scuole e nei luoghi pubblici – le milizie offrono anche denaro e telefonini per accattivarsi le simpatie dei piccoli (alcuni di loro, intervistati da Amnesty International, hanno riferito di insegnanti uccisi durante gli assalti compiuti nelle scuole e di bambine obbligate a sposare i miliziani). Il rapporto si conclude con un’amara constatazione sulla drammatica situazione degli adolescenti somali: Se sei un bambino in Somalia rischi la vita in ogni momento, puoi essere ucciso, reclutato e spedito al fronte, punito dagli al-shabab perché ti hanno trovato mentre ascoltavi musica o indossavi vestiti sbagliati, costretto ad arrangiarti da solo perché hai perso i genitori o puoi morire perché non hai accesso alle cure mediche. Bibliografia J.Miran, A Historical Overview of Islam in Eritrea, Wash, Bellingham, Usa, 2005. S.Bruzzi, Jihad, Sudi e colonialismo in Africa sub.sahariana. Il caso della Hatmiyya in Eritrea, Phd in Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell’Asia e dell’Africa, Università degli studi di Cagliari, 2010. M. Ghebreghiorghis, Molti re, poche guerre e una lunga convivenza, in Nemici sconosciuti. Al Qaida e gli altri: cosa sappiamo davvero del nuovo terrorismo”, «Oasis» n.3, 2006. Etiopia ed Eritrea. Sviluppi di situazione, Cesi per Senato della Repubblica, 2006. C.C.Rossini, Storia d’Etiopia, Roma, Seam, 1999. M. Guglielmo, Chi comanda in Ogaden?, in «Limes on line», Rubrica Gees, Corno d’Africa, 27-10-2010. M.Guglielmo, Al Qaida in Africa: dall’11 settembre ad oggi, in «Limes on line», Rubrica Gees, Corno d’Africa, 10-01-2011. A.Rabasa, Radical Islam in East Africa, Rand, Project Air Force, 2009. S. J.Hansen, A. Mesøy, The Muslim Brotherhood in the Wider Horn of Africa, Nibr 2009. F. Martini, Il Diario Eritreo, I, Firenze, 22 gennaio 1898. K.F.Allam, C.Lo Jacono, A.Ventura, Islam, a cura di Giovanni Filoramo, Milano, Laterza, 2007 B.Lewis, Le origini della rabbia musulmana, Mondadori, Milano 2010. U.Caimpenta, L’impero abissino, Edizioni Aurora, Milano, 1935. - Y.M. Yassin, Political history of the Afar in Ethiopia and Eritrea, in Afrika Spectrum 42, Giga Institute of African Affairs, Hamburg, 2008. - D.Y.Mohamoda, The predicament of the Afars in Ethiopia and Eritrea, unpublished paper presented at ‘Peace Building and the Role of the Afar People’s Conference, Sweden, Dicembre 2001. - D.Y.Mohamoda, The rise and fall of the Sultanate of Aussa with particular reference to the regime of Ali Mirah, Addis Ababa University, BA thesis, Department of Political Science and International Relations, 1985. - A.H. Gnamo, Islam the orthodox Church and Oromo nationalism (Ethiopia), in «Cahiers d'études africaines», n.165, 2002. - M.Hassen, The Oromo of Ethiopia, A History, 1500-1865, Cambridge University Press, Cambridge, 1990. - A.Gori, Brevi note e osservazioni su alcune recenti pubblicazioni islamiche etiopiche in lingua oromo in «Quaderni del Dipartimento di Linguistica-Università di Firenze» n.18, 2008. Etiopia: la lotta degli Oromo, Un secolo di resistenza per la sopravvivenza e la libertà, Associazione Bilisummaa. G.Tareke, Etiopia, Potenza e protesta: rivolte contadine nel ventesimo secolo, Cambridge University Press, Cambridge, 1991. - B. Møller, Political Islam in Kenya, Danish Institute for International Studies, «Working Paper» n. 22, Copenhagen, 2006. - M.Jodi Vittori e K.Bremer, Islam in Tanzania and Kenya: Ally or Threat in the war on terror?, U.S. Air Force Academy Colorado Springs, El Paso Country Colorado, 2009. - T.Hays e S. Theimer, Egyptian agent worked with Green Berets, bin Laden, in «Jerusalem Post», 31 dicembre 2001. - L.Williams e E. McCormick, Al Qaeda terrorist worked with Fbi, «San Francisco Chronicle», 4 novembre 2001. - E. Loi, La storia di al-Qaeda: attacco agli Usa. http://www.storiain.net/arret/num139/artic4.asp - K.Dawoud, Mohammed Atef, «The Guardian», 19 novembre 2001. - Department of the Treasury, Specially Designated Nationals List, 20 aprile 2009 - M.Ressa, Seeds of Terror: An Eyewitness Account of Al- Qaeda Newest Center of Operations in Southeast Asia, The Free Press, 2003. - G.Caramazza, Kenya, la Terra dello Struzzo, «misna.org», gennaio 2011. - G.Arnold, Kenyatta and the politics of Kenya, Londra, Dent, 1974. - J.A. Winder, The Rise of a Party-State in Kenia: from “Harambee” to Nyayo”, Università della California, Berkeley, 1992. - A.Tundo, Il Kenya dice si alla nuova Costituzione, «it.peacereporter.net», 05/08/2010. Capitolo Quinto I percorsi frammentati dell’Islam Maria Egizia Gattamorta 1. L’Africa Occidentale conta oggi più di centoquaranta milioni di individui di religione mussulmana. La loro presenza varia considerevolmente da stato a stato: si passa dal 100% della popolazione in Mauritania al 12,2% in Liberia. Una realtà sicuramente disomogenea -come si comprende più chiaramente dalla tabella riportata di seguito- che comprende paesi a maggioranza islamica come il Senegal (94%), il Mali (90%), la Sierra Leone (60%), il Niger (80%), la Nigeria (50%), il Burkina Faso (60,5%), il Chad (53,1%), la Guinea (85%), il Gambia (90%), la Guinea Bissau (50%) o con consistenti minoranze, come la Costa d’Avorio (38,6%), il Ghana (15,9%), il Benin (24,4%) ed il Togo (20%). La presenza mussulmana nell’Africa occidentale ha radici storiche lontane. A differenza di altre regioni, la diffusione della confessione islamica, non è stato l’effetto di una conquista militare, bensì di intensi rapporti commerciali e successivamente culturali, tra l’Africa mediterranea e le regioni immediatamente a sud del Sahara. Decisiva è stata la conversione all’islam delle tribù berbere in Nord Africa sotto la dinastia degli Almoravidi, in quanto queste hanno sempre costituito l’attore principale degli scambi tra le due sponde del deserto del Sahara. Questo interscambio commerciale è sempre stato vivo dall’alto medio-evo all’età contemporanea e consisteva essenzialmente di traffici gestiti da carovane di nomadi che si avventuravano nelle vaste aree desertiche per vendere al sud, abbigliamento, cavalli, sale, armi, suppellettili di ottone e acquistare avorio, oro, pelli, ma anche schiavi e prodotti agricoli. Le principali rotte commerciali dal Nord Africa all’Africa occidentale, che risalgono ai primi secoli della storia dell’islam, intorno al nono secolo, erano sostanzialmente tre: 1. una occidentale da Sijilmasa (Marocco meridionale) fino a Awdaghast, l’attuale sito archeologico di Tegdaoust nella Mauritania meridionale e da lì verso il regno del Ghana nella regione tra il fiume Senegal ed il fiume Niger; 2. una orientale da Jabal Nafusa (nell’attuale Libia occidentale vicino al confine tunisino), attraverso il Fezzan e l’oasi di Kawar fino alla regione del lago Chad nell’area controllata dal regno di Kanem, islamizzato dalla dinastia Sayfawa nel decimo secolo; 3. una rotta centrale da Tahart (Algeria) via Warghla (Algeria) verso il Niger. Nei secoli successivi molte altre rotte commerciali si svilupparono trasversalmente includendo aree più meridionali come le città Hausa di Kano e Katsina in Nigeria200. Dall’undicesimo secolo le conversioni alla religione mussulmana hanno coinvolto le classi dirigenti e le dinastie al potere, a cominciare dai regnanti degli stati del Sahel (Regno Takrur nell’area del fiume Senegal o il re della dinastia Zuwa a Gao (Mali). 200 John Hunwick, West Africa, Islam, and the Arab World, Markus Wiener Publishers, Princeton, 2006. Oltre al commercio e all’influenza politica, l’Africa settentrionale e più in generale il mondo mussulmano, hanno avuto un fortissimo impatto di tipo culturale. Tra il decimo ed il diciottesimo secolo l’Africa occidentale ha visto una proliferazione di centri di studi islamici tra i quali Timbuktu, che ha rappresentato la manifestazione più evidente del fenomeno. La lingua araba divenne la lingua colta usata in letteratura e negli studi giuridici e sotto l’influenza di accademici provenienti dall’Africa del Nord si sono formate importanti linee di pensiero, dagli austeri assertori del rispetto della sharia, alle dottrine mistiche dei sufi. Con l’arrivo delle potenze coloniali il prolifico rapporto tra Africa occidentale ed Africa del Nord si è tuttavia interrotto, sia sotto il profilo economico, che politico-culturale. L’introduzione del cash crop in Africa occidentale ha consegnato il commercio alle grandi compagnie anglo francesi con i flussi di merci diretti verso la costa. Analogamente in Africa del Nord l’interscambio veniva diretto verso le metropoli europee. Attraverso la creazione di frontiere artificiali, le potenze coloniali scoraggiarono i movimenti interni, non soltanto attraverso il Sahara, ma anche trasversalmente tra paesi dell’Africa occidentale. L’istruzione, in gran parte controllata dai missionari, ottenne grandi risultati soprattutto nelle zone costiere del Golfo di Guinea con il proselitismo cristiano. Nell’azione per diffondere il credo cristiano, grandi sforzi furono posti in una politica denigratoria verso l’islam e gli arabi, tacciati di schiavismo verso la popolazione nera, con l’intento di frenare la diffusione della religione mussulmana e incentivare le conversioni al cristianesimo. Le amministrazioni coloniali, per rafforzare il controllo del territorio, non hanno mancato tuttavia di mantenere buoni rapporti con strutture sociali e poteri locali di religione islamica, con diverse conseguenze che variano da paese a paese. In Nigeria del Nord, ad esempio, l’amministrazione coloniale inglese indebolì l’influenza culturale delle fratellanze sufi, e diede nel periodo immediatamente precedente all’indipendenza, carta bianca a Ahmadu Bello, autorevole leader musulmano. Questo favorì clan più tradizionalisti che di fatto esclusero dalla vita politica locale (Nigeria del Nord) gli intellettuali laici occidentalizzati e non musulmani. Al contrario in Senegal, i francesi riuscirono ad avvantaggiarsi dell’appoggio politico delle società dei sufi, conosciute per il loro approccio più pacifico e distante dalla militanza islamica violenta, una scelta che ha modellato gli equilibri politici anche successivamente all’indipendenza di quel paese. Le radici molteplici dell’islam dell’Africa occidentale, la loro interazione con situazioni locali disomogenee, hanno fatto si che la realtà islamica della regione sia estremamente composita e soltanto un’analisi per ogni singolo paese può consentire una valutazione su quanto il radicalismo possa realmente svilupparsi e in che maniera possa influenzare gli equilibri politico strategici dell’area e le politiche di sicurezza. Le preoccupazioni da parte di molti analisti per il proselitismo sciita, dopo la rivoluzione iraniana, non sembrano per ora avere avuto conferma nei fatti, anche perché l’attivismo ed i fondi degli acerrimi avversari degli sciiti – ovvero i gruppi wahabiti sunniti, finanziati dall’Arabia saudita – hanno costituito un freno insormontabile al proselitismo dell’islam politicizzato appoggiato dagli iraniani. Tuttavia i gruppi islamici rigoristi sunniti costituiscono essi stessi, con la loro retorica a favore della sharia, da imporre a tutti i cittadini, un pericolo per il pluralismo sociale e religioso, con effetti devastanti sulla tenuta degli attuali equilibri politico sociali in vari paesi, un fenomeno particolarmente evidente nella Nigeria del nord.. Attualmente, se si esclude il caso particolare della Nigeria con il gruppo terroristico di Boko Haram e con le numerose organizzazioni radicali, si è portati ad escludere che vi siano consistenti forze endogene in Africa occidentale, portatrici degli ideali del radicalismo islamico armato. Nella zona del Sahel l’unico movimento militante islamico con rilevanza internazionale e che rientra nella galassia del terrorismo globale è “al-Qaeda nel Maghreb Islamico” (Aqim), che non nasce da dinamiche politiche ed inter-etniche autoctone, ma bensì è di provenienza algerina. Negli anni successivi, l’impegno in Iraq e una consistente attività in Algeria hanno costituito le principali attività operative del movimento. Tuttavia a partire dal 2008, le gravi sconfitte del terrorismo in Iraq, gli ostacoli per una penetrazione in Europa, le difficoltà riscontrate in Algeria nonché le gravi difficoltà finanziarie, le pressioni interne ed internazionali hanno spinto Aqim a dirigere le proprie operazioni verso sud, nel Sahel ed in particolare in Mauritania, Mali e Niger. Chiaro sull’argomento, si rivela un approfondimento di Andrea Plebani: Questi territori, per estensione, posizione, conformazione geografica, condizioni socioeconomiche e debolezza delle istituzioni statuali sono divenuti la principale area di azione del movimento (Aqim) guidato da Droukdal, assumendo una rilevanza eccezionale non solo sotto il profilo logistico, ma anche dal punto di vista operativo e finanziario […]. Tali aree costituiscono vere e proprie zone grigie al di fuori del controllo delle forze di intelligence e di sicurezza internazionali e rappresentano il luogo ideale dove Aqim potrebbe rinascere, riconfermando la sua rilevanza all’interno dello scenario jihadista internazionale. La peculiari caratteristiche geo-politiche e socio-economiche delle province meridionali algerine e delle aree settentrionali di Mali, Mauritania e Niger aggiungono ulteriori dimensioni alla tradizionale categoria dei black spot che le rendono particolarmente adatte alle strategie di Aqim. Esse godono infatti di condizioni socio-culturali e di sicurezza ideali per le cellule qaediste, oltre a presentare dimensioni spaziali estese e una conformazione geografica particolarmente ostile201. Le preoccupazioni che gruppi provenienti dall’estero, come in quest’ultimo caso possano innestarsi nelle dinamiche politiche locali e sfruttare altre forme di radicalismo politico-religioso sembrano tuttavia molto fondate, soprattutto se gli sviluppi socio-politici locali sono caratterizzate da forti conflittualità e diffusa povertà. Nella collezione di saggi curati da William F.S. Miles (Political Islam in West Africa: State-Society Relations Transformed) si ha la conferma della profonda diversità delle situazioni in Africa occidentale. Gli autori, esperti dei singoli paesi analizzati (Gambia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, e Senegal) esaminano il diverso tasso di islamizzazione della vita politica di ciascun paese, fattore derivante da un diverso rapporto tra religione e politiche interetniche. Le conclusioni del lavoro, che a tutt’oggi sembra rappresentare il più approfondito studio sulle potenzialità del radicalismo islamico in Africa occidentale, indicano che vi è un indubbio risorgere dell’islam politico nella regione202. La forte interazione tra religione e politica sembra inoltre minacciare in molti paesi le tradizioni laiche degli stati post-coloniali. Pefino le confraternite religiose, che avevano costituito in passato un fattore di stabilità negli equilibri dei nuovi stati africani, non mancano oggi di promuovere istanze favorevoli ad un’islamizzazione delle dinamiche politiche. Secondo gli autori dello studio citato sono in crescita i sentimenti antioccidentali e la promozione di visoni del mondo legate alle linee di pensiero più rigoriste ed arcaiche come i forti contenuti contro la parità di genere. Al di là delle cause specifiche che stanno determinando questo sviluppo dell’islam politico, che variano da paese a paese, vi sono elementi comuni che sembrano facilitarne il processo. In buona sostanza si tratta della debolezza delle compagini statali ed amministrative in tute le sue forme. Le poor governance, che si associano a condizioni di povertà diffusa, costituiscono fattori che sono stati presenti in Africa occidentali da sempre. Si tratta di problemi che tuttavia non hanno mai avuto una risposta. Dopo l’indipendenza e nel corso degli anni Settanta fino all’inizio degli anni Ottanta la soluzione ai gravi problemi economico-sociali dell’Africa nera era sembrata essere quella della costruzione di una società socialista, istanza che è fallita proprio sul versante economico. Quello 201 Andrea Plebani, Geo-politica di al-Qa’ida nel Maghreb islamico (Aqmi), in Adriana Piga e Roberto Cajati (a cura di), Niger – problematiche sociopolitiche, risorse energetiche e attori internazionali, CeMiSS, 2011. 202 William F.S. Miles (a cura di), Political Islam in West Africa: State-Society Relations Transformed, Lynne Rienner, 2007. che è seguito con l’imposizione di ricette neo-liberiste, insieme alla promozione di istituzioni democratiche e rappresentative, pur con qualche parziale successo, non ha avuto un impatto diffuso, né in termini di sviluppo economico, né in termini di partecipazione sociale. Vaste aree dell’Africa occidentale, fuori dal controllo dello stato, sembrano in questa situazione particolarmente permeabili a chi promuove un rifiuto di quella modernità di matrice occidentale, che non ha fornito soluzioni concrete e visibili per la vita di tanti africani che continuano a vivere in condizioni di insicurezza economica e sociale. Per questi motivi oggi l’illegalità diffusa, la debolezza delle istituzioni statali, l’elevata corruzione e la delegittimazione dei governi costituiscono terreno fertile per l’inserimento di gruppi terroristici nell’area. Fino ad ora, gran parte dei conflitti inter-etnici e dei disordini locali non hanno assunto una spiccata connotazione ideologica anti-occidentale come in Nigeria, Sudan, Somalia o nel Medio Oriente. Tuttavia il pericolo di una contaminazione ideologica e di una radicalizzazione politica in paesi con grandi porzioni di abitanti o minoranze consistenti di religione mussulmana, dietro la spinta del diffuso malessere sociale, esistono. Già oggi molte organizzazioni islamiche si sostituiscono alle carenti strutture statali, in molti paesi dell’area, fornendo assistenza sociale ai diseredati e perfino sicurezza ai cittadini in aree dove gli apparati di polizia governativi, o perché insufficienti, o perché corrotti dalla malavita organizzata, non espletano le funzioni proprie. Il radicalismo islamico, basato sulla riscoperta degli antichi valori di probità, sull’inflessibilità etica e sull’essenza alternativa rispetto ai valori di modernità di matrice occidentale, può diventare particolarmente attraente in determinate circostanze. 2. La Nigeria costituisce un importante banco di prova della capacità del suo sistema politico di incanalare le profonde divisioni religiose in un percorso di dialogo basato sui principi democratici, consentendo la pacifica convivenza di gruppi sociali con istanze molto distanti tra di loro. Se si guarda agli eventi dell’ultimo decennio, i segnali appaiono tuttavia allarmanti vista la radicalizzazione dello scontro e la diffusa violenza interreligiosa. La Nigeria è una repubblica federale, retta da un sistema democratico, suddivisa a grandi linee tra un nord a maggioranza mussulmana ed un sud a maggioranza cristiana. Nel sud vi sono minoranze mussulmane tra gli yoruba che tuttavia tradizionalmente, per via della vicinanza alla comunità cristiana, hanno un credo a carattere eclettico, che li distingue nettamente dalle impostazioni dei sunniti puritani del nord203. Sussistono anche delle minoranze scite che, al pari dei wahabiti, sono rigoristi e si rifanno a Komeini e ad una militanza fortemente politicizzata, cosa che ha provocato numerosi scontri nelle regioni centrali e settentrionali della Nigeria204. A complicare il quadro, concorre la sussistenza di consistenti minoranze cristiane nei governatorati del nord e la localizzazione di gran parte delle risorse energetiche, petrolio e gas, nella parte meridionale del paese (in particolare gli stati del Delta, di Bayelsa e di River). Il sistema federale prevede un meccanismo di compensazione dei proventi dell’industria estrattiva, ma questi non sono sempre considerati soddisfacenti dalle parti. Lo stato federale è molto debole nella sua capacità del controllo del territorio, tanto che nel sud (dove lo scontro interreligioso è quasi assente), si registra una violenza endemica, soprattutto nell’ 203 Falola, Toyin, Violence in Nigeria: The crisis of religious politics and secular ideologies, Rochester, University of Rochester Press, 386 p. (1998). 204 Miles, William F.S., Religious pluralisms in Northern Nigeria, Nehemia Levtzion and Randall L. Powels (eds), The history of Islam in Africa, Athens, Ohio University Press, (2000) area del Delta del fiume Niger. Qui operano numerose milizie armate il cui intento principale è di natura economico-finanziaria, anche se alcuni gruppi cercano di legittimarsi con istanze di tipo politico, soprattutto sui temi legati alla proprietà ed il controllo delle risorse da parte delle popolazioni autoctone e sulla condanna del rapporto stretto tra istituzioni governative e multinazionali straniere. Le milizie del Delta del Niger hanno a più riprese rapito dipendenti delle compagnie petrolifere a scopo di estorsione e hanno condotto vere e proprie azioni militari contro gli impianti petroliferi, che nei casi più gravi hanno influito in modo significativo sull’esportazione energetica nigeriana. Questi gruppi, tra i quali il più noto è il Mend (Movement for the Emancipation of the Niger Delta), si stanno rafforzando considerevolmente grazie al furto quantitativamente rilevante del petrolio attraverso il bunkering, che viene imbarcato e venduto clandestinamente. Si tratta di operazioni molto complesse, che richiedono un’organizzazione estremamente articolata con ramificazioni negli apparati governativi. Non sono infatti mancati negli ultimi anni arresti eccellenti, correlati alle attività di esportazione illegale di petrolio. L’entità del fenomeno è di difficile valutazione e le stime variano tra il 10% ed il 35% della produzione nigeriana. Stime prudenti calcolano gli introiti di questi traffici pari ad una quota di circa un miliardo di dollari all’anno. Le milizie del Delta del Niger, oltre ad essere coinvolte in varie tipologie di traffici illegali (come ad esempio il traffico di armi o di droga), forniscono i propri servizi a politici locali, un fenomeno inquietante che contribuisce ad incrementare il caos generale. In questo contesto, le compagnie petrolifere occidentali – così come le classi abbienti nigeriane – fanno un esteso uso di corpi di polizia privati che si sovrappongono agli apparati di sicurezza statali, sempre più inefficienti e screditati. Questo modello caratterizzato da violenza diffusa, debolezza degli apparati di sicurezza, ampie sacche di corruzione e iniquità nella distribuzione del reddito, in aree a forte presenza mussulmana – dove si sono sviluppate organizzazioni legate al radicalismo religioso – può diventare una miscela esplosiva. Nel nord del Paese, successivamente all’indipendenza (1960), il risorgere di istanze islamiche a carattere eminentemente politico, con diffuse istanze radicali, è stato largamente influenzato da accademici religiosi istruiti in Arabia Saudita, che hanno iniziato a propagandare con successo l’approccio di un islam più austero e puritano di tipo wahabita. Con il declino del peso politico delle elite mussulmane del nord, dopo le elezioni del cristiano Obasanjo nel 1999 alla presidenza nigeriana, il nesso religione-politica ha assunto una forza maggiore. La presidenza di Obasanjo ha infatti determinato una progressiva emarginazione dai centri di potere civili e militari delle classi dirigenti mussulmane del nord, posizioni che queste avevano ricoperto negli ultimi quarant’anni di storia del paese. La prima reazione è stata quella di una serie di successi elettorali di figure vicino ad una concezione dell’islam più rigorista. A partire dall’indipendenza, i gruppi legati ad una concezione wahabita dell’islam, avevano promosso l’idea di reintrodurre la sharia nel nord mussulmano. Il nuovo governo nigeriano aveva infatti interrotto l’azione dei tribunali penali basati sulla legge islamica garantiti dall’amministrazione coloniale britannica. Questo sistema venne sostituito nel nord con una corte di appello di tipo islamico, che avrebbe dovuto garantire i diritti dei credenti. La soluzione, fissata nella costituzione del 1979, non soddisfò affatto una consistente parte delle èlite islamiche del nord che avrebbero voluto una piena applicazione della sharia. Il sistema del 1979 prevedeva anche una rete di tribunali inferiori di ispirazione islamica, ma le decisioni finali erano prese da una corte d’appello federale “laica”. E’ interessante notare che a differenza di altre regioni e stati africani, la lotta per imporre la legge islamica, non era soltanto appannaggio di società religiose, ma il frutto di rivendicazioni esercitate direttamente dai governatori. Le istanze di rigorismo religioso sono rappresentate in Nigeria all’interno della rete istituzionale del nord, sia civile che militare (a reminiscenza del periodo coloniale). Soltanto nell’ottobre 1999 uno stato del nord, lo stato di Zamfara, è riuscito a reintrodurre la sharia. Nel corso degli anni successivi la legge islamica è stata adottata in altri 11 Stati su un totale di 36, in alcuni di essi in modo parziale. Il supporto da parte della maggioranza mussulmana alla legge islamica è peraltro facilmente spiegabile, non soltanto dalla perdita di potere reale delle èlite del nord successivamente alle elezioni di Obasanjo, ma da una reazione al lassismo dilagante dei costumi, alla diffusa corruzione, all’incremento delle disuguaglianze sociali, al deterioramento delle condizioni di sicurezza e a tutto ciò che viene visto come contaminazione culturale proveniente dall’occidente. La forza e la diffusione dell’islamismo radicale è confermato anche da alcuni sondaggi condotti dal Pew Global Research Centre, nell’ambito del Pew Global Attitudes Project205. I mussulmani della Nigeria risultano essere i più favorevoli ad al-Qaeda con una percentuale del 49% nel 2010, contro il 3% dei libanesi, il 18% dei pakistani e il 20% degli egiziani. Parimenti, ancora nel 2010, il 48% dei musulmani nigeriani dichiaravano di aver fiducia in bin Laden, contro il 3% dei libanesi, il 18% dei pakistani e il 19% degli egiziani. L’applicazione della sharia, anche se non nei modi estremi dell’Arabia Saudita, del Pakistan o dell’Iran, ha naturalmente provocato una forte reazione, non soltanto dei gruppi cristiani ed animisti, ma anche di chi, pur di religione musulmana, ritiene che essa sia un fattore di profonda divisione del paese, che potrebbe portare ad una frattura dell’unità nazionale. Quel che è certo, è che le tensioni inter-religiose sono cresciute esponenzialmente negli ultimi dieci anni. Uno dei maggiori centri di tensione è la città di Jos, insieme ai centri urbani di Kano e Katsina. In queste ultime due località si è sviluppato un movimento radicale, gli Izala, che si aggiunge alla vasta panoramica del radicalismo nella Nigeria settentrionale, ma che va citato anche per la sua influenza oltre confine, vale a dire nel paese vicino, il Niger. Jama’t Izalat al Bid’a Wa Iqamat as Sunna (“Società per la rimozione dell’innovazione ed il ripristino della Sunna”), noto appunto come Izala o Yan Izala, è stata fondata nel 1978 da Idriss Ismaila a Jos, nello stato di Plateau in Nigeria. Izala è un movimento anti-sufi, istituito per combattere il tradizionalista sincretismo dell’islam africano. Sulla base dei precetti coranici che il movimento ritiene risalire alle origini dell’islam, questo sembra più piegato a combattere le supposte deviazioni tra musulmani che contro gli infedeli. Oggi Izala si sta diffondendo oltre confine, non soltanto in Niger ma anche in Chad206. Le determinanti della violenza sono molteplici e costituiscono una miscela spesso difficilmente distinguibile tra il fattore etnico, quello religioso, il difficile rapporto tra comunità indigene e migranti, nonché conflitti per l’uso della terra. I gruppi maggiormente coinvolti negli scontri sono i cristiani Berom ed i mussulmani Hausa e Fulani, anche se, altri su scala minore, concorrono ai numerosi episodi di violenza. Il ruolo delle milizie armate non è sempre decisivo nello scatenarsi della violenza, pur contribuendo spesso ad una sua radicalizzazione. In occasione delle elezioni il tasso di disordini di strada tende ad aumentare di intensità, come è avvenuto nell’aprile 2011, confronto elettorale che è stato peraltro giudicato equo e corretto dagli osservatori internazionali. La sconfitta di Muhammadu Buhari il candidato di religione mussulmana, ex militare, originario del nord, contro il cristiano Goodluck Jonathan, ha scatenato una lunga serie di scontri in numerose città della fascia centrale e settentrionale, animati da bande giovanili esasperate anche dalle condizioni economiche. Nelle ultime consultazioni, in cui le èlite mussulmane associate al partito di governo hanno visto ridotto il loro spazio, sembra che il ruolo di piccoli gruppi armati organizzati sia stato determinante207. 205 Pew Global Research Centre, http://www.pewglobal.org/2011/05/02/osama-bin-laden-largely-discreditedamong-muslim-publics-in-recent-years/ 206 B. F. Soares, R. Otayek (eds.), Islam and Muslim Politics in Africa, New York, Palgrave 2007, pp. 177ss. ; O. Meunier, Dynamique de l’enseignement islamique au Niger, le cas de la ville de Maradi, Paris, L’Harmattan, 2000, pp. 176 ss. 207 Al di là dei singoli episodi correlati con gli eventi elettorali, gli scontri tra militanti e polizia e tra comunità cristiane e musulmane, innescate spesso da piccoli incidenti, si sono moltiplicati talvolta con conseguenze gravissime. Tra febbraio e maggio 2000, ben duemila persone sono rimaste uccise a Kaduna (capitale dell’omonimo stato). Non da meno sono stati gli scontri di Jos (capitale dello stato di Plateau), avvenuti nel 2001 che hanno provocato la morte di più di mille persone. Più recentemente nel marzo 2010, sempre nello stato del Plateau, nel villaggio di Dogo Nahawa (abitato soprattutto da contadini stanziali di religione cristiana e di etnia Berom), un gruppo di locali è stato attaccato da pastori nomadi di religione mussulmana dell'etnia Fulani con un bilancio superiore ai cinquecento morti. Si calcola che dal 1999 ad oggi più di quindicimila persone siano state uccise in scontri di origine etnica e religiosa. La diffusa aggressività non può essere attribuita semplicemente alle istanze rigoriste religiose. L’adozione della sharia è stato il frutto di scelte democratiche da parte di governatori eletti dai cittadini. La violenza interreligiosa sembra essere piuttosto il modo in cui in Nigeria tendono a scaricarsi le tensioni sociali, che nel sud non coinvolgono gruppi religiosi opposti, bensì bande armate con intenti economico finanziari. Non mancano peraltro “meccanismi di accomodamento” tra le varie istanze che siano di tipo etnico religioso o legate alla spartizione delle risorse finanziarie. Se tali meccanismi fino ad ora non sono riusciti a frenare gli scontri tra comunità, hanno senz’altro impedito una disintegrazione di un paese di centocinquantacinque milioni di abitanti, formato da duecentocinquanta distinti gruppi etnici e linguistici. I suddetti “congegni” si basano sulla capacità delle èlite di raggiungere accordi di massima su questioni fondamentali, su di una rete molto importante di associazioni della società civile, ma anche da un sistema politico democratico, che pur tra limitazioni ed insufficienze, ha migliorato di molto il suo funzionamento negli ultimi anni. Il sistema degli equilibri resta fragile, ma sembra poter reggere fintantoché le organizzazioni di militanti radicali più strutturate e con legami internazionali, restano in qualche modo circoscritte e non ottengono un supporto di massa. Ci si riferisce sostanzialmente ai gruppi di Boko Haram (detti anche “talebani nigeriani”), KalaKato, Darul-Islam, Ahmadia Movement, Garika Shi’a Salafiya (Izala), che hanno poco in comune se non la stessa matrice islamica, un atteggiamento anti-sistema e la scelta di azioni armate. Particolare attenzione è stata rivolta dai media locali ed internazionali proprio a Boko Haram. Il moltiplicarsi nell’ultimo semestre di attacchi terroristici rivendicati dal gruppo radicale islamico di Boko Haram negli Stati federati nord-orientali nigeriani (Borno, Yobe, Jigawa, Katsina, Bauchi, Kano) e nella stessa Abuja, ha obbligato i responsabili governativi e le Agenzie dell’Intelligence a confrontarsi con le sfide crescenti per la sicurezza del Paese. Seppur emerso nel 2002 il gruppo conosciuto anche come Jama’atul Ahl-Sunnati Lil Dawa’ati wal Jihad ed identificato con il nome di “talebani nigeriani”, solo recentemente è stato percepito come un vero pericolo nazionale, nei cui confronti è necessario predisporre una strategia mirata di lungo periodo. La setta, che crede negli insegnamenti del Corano e nella Sunna e rifiuta l’educazione nonché i valori occidentali, ha come obiettivo l’imposizione di una islamizzazione forzosa della Nigeria. Pur avendo perso il leader fondatore, Ustaz Mohammed Yusuf , nel luglio 2009 e pur non avendo una strutturazione precisa, il movimento ha intensificato recentemente le operazioni contro obiettivi sia civili che militari ed ha ampliato il suo raggio d’azione. Come evidenziato nella tabella riportata al termine di questo approfondimento, Boko Haram indirizza la sua violenza contro determinate categorie: rappresentanti/strutture militari e della polizia, banche, mercati, pub all’aperto e bar, docenti universitari, chiese e predicatori islamici non violenti. In tal modo il gruppo cerca di seminare il panico tra la popolazione e di rendere il paese ingovernabile. Peter M. Lewis, Nigeria: Assessing Risks to Stability, «Center for Strategic and International Studies» (Csis), Washington, 2011. Si possono individuare due fasi nello sviluppo della sua identità: la prima dal 2002 al luglio 2009 in cui gli aderenti hanno fondato campi e scuole sul modello afghano, si sono trasformati in un fenomeno urbano e sono arrivati ad un confronto diretto con la polizia e l’esercito; la seconda, iniziata nel luglio 2009, in cui il terrore si è allargato alle zone centrali, in cui la setta è passata alle tecniche di attacchi suicidi ed ha alzato il target degli obiettivi (come ad esempio il quartier generale della polizia ad Abuja e gli uffici delle Nazioni Unite, rispettivamente il 16 giugno ed il 26 agosto 2011). Pur non essendo facile monitorare Boko Haram e trovare un filo logico nelle sue attività, analisti di prestigiosi think thank e di organizzazioni non governative attive nella tutela dei diritti dell’uomo 208 sono concordi nel dire che i radicali utilizzano l’elemento religioso ma rispondono in realtà all’insoddisfazione del ceto medio e delle classi meno abbienti nei confronti dell’ingiustizia sociale, della corruzione, della poor governance, della povertà, della disoccupazione dilagante tra i giovani. Goodluck Jonathan non ha saputo dare fino ad oggi risposte soddisfacenti al malessere generalizzato, né come vice presidente in tandem con il Presidente Uamu Yar’adua (il quale aveva come priorità la pacificazione nelle regioni del Delta del Niger), né come Acting President dal febbraio 2010 (perché ha dovuto affrontare le divisioni interne del People’s Democratic Party e convincere l’elettorato delle sue capacità), né tantomeno nei primi cento giorni di presidenza (in cui si è preoccupato di attorniarsi di uomini del gruppo etnico Ijaw o di esponenti del sud della Nigeria, piuttosto che offrire posti a esponenti del Nord e placare il malcontento degli Stati settentrionali). Il capo dello stato ha reagito agli ultimi attacchi di Boko Haram licenziando nei primi giorni di settembre il suo counterterrorism adviser ambasciatore Zakari Ibrahim e sostituendolo con il generale Sarkin Yakin Bello (già responsabile dell’Operation Restore Hope nel Delta del Niger). Numerose sono state le promesse per programmi volti a favorire i giovani imprenditori e le assicurazioni riguardanti la differenziazione delle attività produttive nigeriane (tramite un rilancio dei reparti non-oil) ma sfortunatamente non sono seguiti gesti concreti immediati, capaci di rispondere all’alienazione registrata nelle regioni del nord. Per quanto concerne il “duplice approccio” basato sull’amnistia al gruppo ed il rafforzamento della sicurezza nell’area, illustrato nel mese di giugno del 2011 dal vicepresidente Namadi Sambo, esso si è ridotto esclusivamente allo schieramento di ventimila uomini nelle “zone più calde” (Borno, Kaduna, Plateau, Bauchi, sulle linee di confine tra Benue e Nasarwa, nonché sulle frontiere tra Benue e Taraba). L’ipotesi dell’amnistia (risultata vincente per i ribelli del Delta del Niger) supportata dal governatore del Borno, Kashim Shettima, è stata scartata – o quanto meno per il momento accantonata – perché avrebbe dimostrato la debolezza dell’amministrazione e l’avrebbe messa nelle mani di altri gruppi irredentisti presenti sul territorio. Anche il tentativo di mediazione affidato all’ex presidente Olusegun Obansajo per promuovere un dialogo con Babakura Baba Fugu (cognato del defunto Mohamed Yusuf) è fallito per l’uccisione di quest’ultimo il 17 settembre 2011 ad opera di Boko Haram, perché non riconosciuto ad agire in sua vece. Molti si chiedono se la presenza dei militari possa essere una soluzione risolutiva per la stabilità e la sicurezza dei cittadini ma tale misura appare soddisfacente solo in via temporanea. In realtà, quello che serve è un approccio olistico, capace di affrontare le vere cause che si nascondono dietro la formazione della setta radicale e non considerare solo l’epifenomeno della violenza. L’amministrazione Jonathan dovrebbe mostrarsi convincente nel promuovere allo stesso tempo riforme socio-economiche e piani di investimento per infrastrutture pubbliche, linee-guida vincolanti il comportamento delle forze dell’ordine e misure punitive della corruzione di pubblici funzionari, dovrebbe far crescere una classe politica credibile e responsabile209. 208 Ad esempio, International Crisis Group, Council on Foreign Relations, Institute for Security Studies (Iss), Centre for Strategic and International Studies (Csis), Human Right Watch. 209 Council on Foreign Relations ed ISS- African Security Review. In realtà molti dubitano sulle capacità del Presidente (che è stato sempre visto come un uomo di basso profilo, catapultato sulla scena politica solo da una serie di avvenimenti fortuiti) ma soprattutto sulla reale volontà politica del gruppo dirigente di promuovere un processo complesso e articolato. Le sfide che la Nigeria deve affrontare sono numerose e diventano ogni giorno più grandi. Come sottolineato dalla stampa locale210, il peggioramento della sicurezza “ha polverizzato l’economia dello stato. Il deterioramento della situazione nel nord-est ha comportato un esodo dei cittadini da Maiduguri, la svalutazione del mercato immobiliare, la fuga verso le regioni nordoccidentali ma soprattutto ha indotto gli investitori stranieri a modificare i piani per gli investimenti (come accaduto di recente per un gruppo di operatori tedeschi impegnati nel settore del cemento). Preoccupanti sono poi i “collegamenti” di Boko Haram: il ritrovamento di armi e le tecniche adoperate nelle operazioni sono prove inconfutabili di un pericoloso supporto esterno, di contatti con gruppi terroristici, in particolare Al Qaeda. Fonti della sicurezza nigeriana ritengono che la setta stia attuando una strategia diversiva, in un cui un’ala si concentra sulle rimostranze locali e si propone a sostegno dei diritti delle minoranze, un’altra ala cerca di sviluppare relazioni con i movimenti radicali dell’Afghanistan, della Somalia, dell’Algeria. Altri timori riguardano possibili alleanze dei radicali islamici con gruppi militanti del Delta del Niger. In tal senso devono essere lette le interviste rilasciate dal “generale” Prince Melenge e dal “generale” Gunlift Akpoebi (due ex combattenti del Delta) al settimanale indipendente «National Daily»211. Gli ex ribelli hanno minacciato un’unione di forze con i radicali perché il governo non ha ancora provveduto al pagamento degli indennizzi concordati. Se l’avvertimento si concretizzasse verrebbe messa a serio rischio la stabilità di quello che è considerato il gigante dell’Africa occidentale. In tale contesto, inevitabilmente sono chiamate in causa le agenzie della sicurezza. Ad oggi, tuttavia, esse hanno mostrato un grave ritardo nel reperimento di informazioni sul terreno (vale a dire non ha funzionato o ha funzionato poco il filtro con gli abitanti delle regioni maggiormente colpite dal fenomeno Boko Haram) ed hanno rivelato una deplorevole incapacità nel prevenire gli attacchi terroristici. A ciò si aggiunga che l’attentato realizzato al quartier generale della Polizia ad Abuja il 16 giugno 2011, è stato un segnale chiaro dell’abilità dei talebani nigeriani di colpire nel cuore del sistema ma soprattutto ha messo in luce pericolose infiltrazioni dei criminali all’interno della struttura. DATA 2002 EVENTI COLLEGATI A BOKO HARAM Ustaz Mohammed Yusuf fonda a Maiduguri (Stato del Borno) il gruppo Jama’atul Ahl-Sunnati Lil Dawa’ati wal Jihad conosciuto come Boko Haram (comunemente tradotto come L’educazione occidentale è un peccato). L’obiettivo è di fare della Nigeria uno Stato islamico ed imporre la legge islamica in tutto il paese 210 Newswatch Online, The Boko Haram killings, 25.07.2011-01.08.2011. 211 National Daily, Siege of Terror: ex Niger Delta militants threaten mayhem over unpaid allowances, n.19, 25.09.2011 24-31 dicembre 2003 7 gennaio 2004 Boko Haram attacca la stazione di polizia ed occupa alcuni edifici pubblici a Geidam e Kanamma (Stato di Yobe). La polizia libera gli edifici uccidendo diciotto uomini e arrestandone una dozzina Sette membri di Boko Haram sono uccisi e tre arrestati da alcuni vigilanti a Damboa (Stato del Borno) giugno 2004 Quattro membri di Boko Haram uccisi da alcune guardie mentre cercavano di fuggire dalla prigione di Damaturu (stato di Yobe) settembre 2004 Le milizie di Boko Haram attaccano le stazioni di polizia a Bama e Gworza (Stato del Borno) ed uccidono sei persone. Le forze di polizia rispondono alla violenza eliminando ventiquattro componenti della setta. I militanti fuggono in Cameroon e Niger Boko Haram attacca un convoglio di sessanta poliziotti in un’imboscata a Kala-Balge , vicino al confine con il Ciad. ottobre 2004 2004 Ustaz Mohammed Yusuf Kanamma (Yobe State) 2005-2008 Boko Haram recluta uomini e raccoglie risorse, restando nelle retrovie 22 febbraio 2009 Il governatore dello Stato di Bauchi impone il coprifuoco a Bauchi, dopo violenti scontri che hanno causato undici morti, ventotto feriti e distruzione di abitazioni e chiese Scontri con la polizia a Bauchi, perché i membri del gruppo si rifiutano di rispettare la legge che impone il casco ai conducenti di motorini. Negli incidenti la Polizia uccide trentanove membri della setta, ne ferisce quindici, ne arresta centosettantasei. Nei giorni successivi si verificano scontri violenti negli Stati di Bauchi, Kano, Yobe e Borno Morte di Ustaz Mohammed Yusuf mentre era sotto la custodia delle forze dell’ordine. I membri Boko Haram accusano la polizia di aver ucciso il loro leader con un’esecuzione extra-giudiziale mentre le forze dell’ordine affermano di averlo ucciso mentre tentava la fuga Arresti di aderenti a Boko Haram. Scoperto un campo di Boko Haram a Biu (220 km a sud di Maiduguri) 26 luglio 2009 30 luglio 2009 3 agosto 2009 posiziona il campo base "Afghanistan" a 1 ottobre 2010 Scoppio di due ordigni esplosivi ad Abuja nelle vicinanze delle aree in cui sono organizzati i festeggiamenti ufficiali per il 50mo anniversario dell’Indipendenza. Il Mend – Movement for the Emancipation of the Niger Delta – rivendica gli attentati ma inizialmente ci sono forti dubbi sulla responsabilità degli incidenti. 9 ottobre 2010 Bashir Kashara (esponente religioso wahabita che aveva criticato la dottrina di Boko haram) viene ucciso a Maiduguri 24 dicembre 2010 28 dicembre 2010 28 gennaio 2011 Lo scoppio di alcune bombe a Jos (stato di Plateau) causa trentadue vittime e settantaquattro feriti in gravi condizioni. Boko Haram rivendica la responsabilità dell’operazione Gli attacchi di Boko Haram a Maiduguri (stato del Borno) provocano la morte di tre persone e l’esplosione di una bomba a Jos (stato del Plateau) causano sei vittime Boko Haram uccide Modu Fannami Gubio (candidato dell’Anpp – All Nigerian Peoples Party – per il governatorato dello stato del Borno) 8 febbraio 2011 13 marzo 2011 1 aprile 2011 Abu Suleiman (uno dei leader di Boko Haram) in un’intervista alla «Bbc» pone delle condizioni per interrompere gli assassinii nel Nord: dimissioni di Ali Modu Sheriff (governatore del Borno), restituzione al gruppo della Moschea a Maiduguri e ritiro immediato dei soldati da Maiduguri Imam Ibrahim Ahmed Abdullahi (predicatore non violento, che ha espresso più volte un parere contrario a Boko Haram) è ucciso mentre entra nella moschea di Maiduguri Sospettati aderenti a Boko Haram attaccano la stazione di polizia a Bauchi 9 aprile 2011 Esplosione in un centro elettorale a Maiduguri 15 aprile 2011 Attacco ai danni dell’ufficio della Commissione Elettorale Nazionale Indipendente ed uccisione di alcune persone. Le forze dell’ordine sospettano che l’autore degli incidenti sia il gruppo di Boko Haram Un esponente religioso mussulmano è ucciso a Maiduguri da due attentatori sospettati di appartenere a Boko Haram 20 aprile 2011 22 aprile 2011 Boko Haram compie operazione alla prigione di Yola (stato di Adamawa) e libera quattordici prigionieri 25 aprile 2011 Boko Haram fa esplodere tre bombe a Maiduguri 9 maggio Boko Haram rifiuta offerta di amnistia fatta da Kashim Shettima (nuovo governatore dello stato del Borno) 19 maggio 2011 L’esplosione di tre ordigni a Lagos Street (Maiduguri) provoca la morte ed il ferimento di alcuni poliziotti e soldati. La polizia sospetta che Boko Haram sia responsabile dell’attentato Settanta membri sospettati di appartenere a Boko Haram attaccano il quartier generale della Polizia e una Banca a Damboa (80 chilometri a sud di Maiduguri) Scoppio di tre bombe a Zuba (Abuja), Zaria e Maiduguri. Bilancio di tredici morti e trentatre feriti. Boko Haram rivendica l’operazione 27 maggio 2011 29 maggio 2011 30 maggio 2011 Esplosioni nella caserma dell’esercito di Shadawanka a Bauchi (stato di Bauchi) e a Maiduguri (stato del Borno) 31 maggio Esplosione a Baga Road (Maiduguri) 31 maggio 2011 Uccisione di Abba Anas Ibn Umar Garbai El-Kanemi (fratello del sultano del Borno, Alhaji Abba Kyari Umar Garbai) a Maiduguri 6 giugno 2011 Membri di Boko Haram uccidono l’esponente religioso Ibarhim Birkuti, fuori dalla sua casa di Biu (duecento chilometri da Maiduguri) 7 giugno 2011 Tre esplosioni a Maiduguri nelle vicinanze della Chiesa Cattolica di St Patrick, nella circoscrizione di Gwange e al Kano Motor Park 16 giugno 2011 Una bomba esplode all’interno del quartier generale della Polizia a Abuja 20 giugno 2011 Un gruppo armato attacca una stazione di polizia ed un banca a Kankara (stato di Katsina). Muoiono sette persone, tra cui cinque poliziotti. 26 giugno 2011 Esplosione di un ordigno esplosivo in un bar a Maiduguri – venticinque vittime 27 giugno 2011 Assalto armato all’ufficio del Nigeria Customs Service (Ncs) a Maiduguri – due vittime e tre feriti 3 luglio 2011 Incidente in un pub all’aperto a Maiduguri – venti morti 9 luglio 2011 Non meno di trenta persone muoiono negli scontri a Maiduguri tra membri appartenenti a Boko Haram e la polizia 10 luglio 2011 Scoppio di una bomba fuori la chiesa All Christian Fellowship di Suleja (Niger State) 12-15 luglio 2011 Scontri a Maiduguri ed inizio della fuga della popolazione locale 2 agosto 2011 Varo ufficiale della “Commissione sulle sfide alla sicurezza nel nordest” (detta anche “Commissione Galtimari”), che non ha mandato di mediazione ma di studio delle motivazioni che hanno portato una crescente insicurezza nell’area nordorientale. La Commissione è composta dall’ambasciatore Usman Galtimari, dal senatore Bala Mohammed (ministro del Territorio della Capitale Federale), da Emeka Wogu (ministro del Lavoro e della Produttività), dr. Bello Haliru Mohammed (ministro della Difesa), dal senatore Ali Ndume, dal colonnello Musa Shehu (in pensione), da Joe Kyari Gadzama (San) e da Abdullahi Shehu (segreteria del Governo Federale). Scoppio di una bomba a Maiduguri – due vittime 4 agosto 2011 12 agosto 2011 Il religioso Liman Bana è ucciso a Ngala (Stato del Borno) da alcuni esponenti di Boko Haram 18 agosto 2011 Nella versione online del Nigerian Standard appare un messaggio dell’imam Abubakar Shekau (uno dei leader di Boko Haram) in cui viene offerta solidarietà ad al-Qaeda e viene fatta una minaccia agli Usa. Uomini armati di Boko Haram attaccano due stazioni di polizia e due banche a Gombi (Stato di Adamawa). L’incidente provoca la morte di sedici persone , tra cui sette poliziotti Attacco agli uffici delle Nazioni Unite ad Abuja – ventitre vittime e ottanta feriti 25 agosto 2011 26 agosto 2011 1 settembre 2011 Scontro a fuoco tra membri di Boko Haram e la polizia nell’Adamawa state. 4 settembre 2011 Due membri di Boko Haram uccidono nell’area di Zinnari (Maiduguri), il 55enne religioso Malam Dala 12 settembre 2011 I responsabili dell’Università di Ibadan confermano di aver ricevuto minacce da Boko Haram circa esplosioni di bombe tra il 12 ed il 17 settembre 12 settembre 2011 13 Settembre2011 17 settembre settembre 2011 26 settembre 2011 28 settembre 2011 1 ottobre 2011 3 ottobre 2011 Boko Haram attacca una stazione di polizia e una banca a Misau (stato di Bauchi) . Negli scontri a fuoco muoiono sette persone, di cui quattro poliziotti Boko Haram organizza un’imboscata a Maiduguri in cui muoiono quattro soldati , dopo un raid militare che ha portato all’arresto di quindici militanti della setta. Assassinio di Babakura Fugu (cognato di Mohammed Yusuf) a distanza di due giorni da un incontro con ex presidente Olosegun Obasanjo. Boko Haram lo ha accusato di aver cercato una mediazione ed aver tratto a suo nome con l’ex capo dello stato. National Daily pubblica la minaccia da parte di alcuni esponenti del Mend di allearsi con Boko Haram perché il governo di Abuja non ha pagato entro agosto gli indennizzi concordati Commissione Galtimari presenta il suo report finale al governo federale nigeriano . I dati non sono stati resi pubblici ma è trapelato che la Commissione ha auspicato il dialogo, la formazione di una nuova Commissione allargata con ampi poteri per gestire le criticità collegate con Boko Haram. Esplicitamente la Commissione ha criticato l’incapacità mostrata dalle Agenzie preposte alla sicurezza. Il Governatore dello Stato del Borno, Kashim Shettima, annuncia l’arresto di uno dei capi di Boko Haram e di altri cinque aderenti al gruppo (senza specificarne i nomi) Festeggiamenti di basso profilo per il 51mo anniversario dell’indipendenza della Nigeria per timore di attacchi da parte di Boko Haram. A Bulabulin Garnam (periferia di Maiduguri) rimangono uccise due persone a causa dello scoppio di un ordigno esplosivo Boko Haram uccide tre persone nel Baga Market di Maiduguri 16 ottobre 2011 Modu Bintube (membro del Parlamento dello stato del Borno) è ucciso a Maiduguri da alcuni membri della setta di Boko Haram 22 ottobre 2011 Alhaji Zakariya Isa (giornalista della «Nigerian Television Authority», ritenuto un “informatore” del governo) è ucciso a Maiduguri da alcuni membri appartenenti al gruppo radicale di Boko Haram Assalto a due banche (First Bank e KeystoneBank Ltd) e uccisione di un ispettore di polizia a Saminaka (stato di Kaduna) da parte di un gruppo di militanti di Boko Haram Un ufficiale della polizia sopravvive ad un attentato compiuto nel quartiere di Bulunkutu a Maiduguri da tre membri di Boko Haram 23 ottobre 27 ottobre 2011 Fonti: raccolta articoli da «allafrica.com», «Irin News», «Un News Service», «Bbc», «Reuters Africa», stampa nigeriana («Vanguard», «Daily Champion», «Daily Trust», «Leadership», «This Day») 3. Il Mali può essere ben definito la “culla dell’islam” in Africa occidentale. Questa religione ha iniziato a diffondersi nel paese dal secolo XI e Timbuktu divenne fin dagli albori, uno dei principali centri di studio e di preghiera della regione. Situata a nord del fiume Niger, nel bordo meridionale del deserto del Sahara, questa città, è stata fin dal quinto secolo un importante centro carovaniero. Questa sua funzione di snodo commerciale ha favorito il suo crescente ruolo di elaborazione teorica e di terminale di una considerevole migrazione intellettuale proveniente dal nord Africa. Nel 1325 il sultano del Mali, Mansa Musa, ordinò la costruzione della Grande Moschea dopo un viaggio alla Mecca sotto la supervisione del docente Andaluso Abu Ishaq al-Sahili. Tra il XIV ed il XVIII secolo a Timbuktu si sviluppò una notevole produzione di studi islamici, parte dei quali frutto del lavoro di accademici autoctoni, come la tribù Masufa, molto attiva nella zona fin dal tempo degli Almoravidi. Oggi, l’islam in Mali è noto per il suo approccio moderato, che ha consentito lo sviluppo di un sistema democratico fin dagli anni Novanta. Non a caso il Mali, con una costituzione che garantisce il carattere laico dello Stato, è tra i pochi paesi a maggioranza mussulmana in Africa, a ricevere un rating di paese libero da Freedom House212. La grande influenza esercitata dalla setta sufi della Qadiriyya, ha certamente contribuito a controbilanciare le dottrina wahabita e l’appoggio, che soprattutto l’Arabia Saudita, l’Iran e la Libia, hanno fornito ai movimenti islamici più rigoristi. L’altro fattore limitante dell’integralismo, è il forte sincretismo tra islam e culti tradizionali africani, che continuano a sopravvivere nella cultura maliana. Nonostante che lo stato del Mali abbia sempre adottato un approccio laico, il ruolo della religione ha un suo peso politico. Come sostengono alcuni studiosi, i vari regimi che si sono succeduti dall’indipendenza ad oggi, hanno guadagnato in legittimità politica proprio grazie all’appoggio dei leader religiosi213. Recentemente si sono registrati segnali che indicano – secondo alcuni analisti – un possibile mutamento del quadro maliano. Le correnti wahabite, di fronte ad un evoluzione culturale nei centri urbani (soprattutto tra i giovani che guardano all’occidente come modello ispiratore), sembrano più propensi a fissare dei paletti in difesa dell’islam ortodosso più rigorista. Nella capitale Bamako, l’imam Mahmud Dicko, influente direttore della radio islamica della capitale e presidente dell’ “Alto Consiglio Islamico del Mali” (Haut Conseil Islamique Malien-Hci) ha lanciato da tempo i suoi strali contro l’ex presidente Alpha Oumar Konarè (in carica dal giugno 1992 al giugno 2002) per l’impoverimento del paese, causato a suo dire dalla politica di strette relazioni con gli Stati Uniti. I suoi sermoni sono tutti indirizzati contro l’Occidente che vuole propagandare i propri come valori universali e che interferisce negli affari interni maliani, sovvenzionando le organizzazioni laiche della società civile. Mahmud Dicko è intervenuto in modo incisivo nel corso del dibattito parlamentare sul codice di famiglia ed è riuscito ad ottenere importanti modifiche, anche senza snaturare l’insieme di norme essenzialmente laiche. Quando la legge è stata approvata nel 2010, ha contribuito ad organizzare una grande manifestazione a Bamako, che ha visto la partecipazione di più di cinquantamila persone. Di fronte alle proteste da parte di numerosi rappresentanti mussulmani, che rifiutavano l’idea della parità tra uomo e donna nel nuovo codice di famiglia, il presidente Amadou Toumani Tourè ha deciso di sospendere l’applicazione della legge. L’approccio di Dicko, come di tanti altri esponenti wahabiti, tuttavia sembra restare prudente. Alla domanda posta da un giornalista sulla sua posizione sulla sharia, Dicko ha risposto: “Je me bats pour ma religion, mais il serait prématuré d’appliquer la charia au Mali ", aggiungendo poco più tardi “Je suis musulman, je ne peux pas m’opposer à l’instauration d’une république islamique, 212 Per maggiori informazioni, http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=1 213 V. Le Vine, Mali: Accommodation or Coexistence?, in William F.S. Miles (a cura di) Political Islam in West Africa: State-Society Relations Transformed, Lynne Rienner, 2007. mais je suis très bien dans ce pays laïque214 ». Un atteggiamento ambivalente largamente condiviso dai musulmani tradizionalisti, anche nel laico Mali, che può tuttavia suscitare qualche preoccupazione alla luce di altre profonde debolezze del paese. Da un punto di vista economico-sociale la percentuale di popolazione che vive in condizioni di povertà è ancora molto elevata, con un alto tasso di polarizzazione dei redditi e una pervasiva corruzione. La capacità dello stato di fornire servizi pubblici resta bassa, sugli standard dei paesi più poveri. La vastità del territorio e la lontananza dai centri urbani delle aree a bassa densità di popolazione, rende le politiche di rafforzamento dei servizi pubblici estremamente problematiche. Questi fattori, affiancati allo scarso controllo del territorio, soprattutto nell’area desertica del nord, possono costituire un elemento di rischio elevato. Il Mali peraltro ha già sperimentato rivolte armate nella sua periferia. Dopo l’accordo con i ribelli tuareg nel 1991 ed un decennio di pace, la zona settentrionale del paese tra il 2006 ed il 2009 – nonostante un accordo di massima nel 2008 – ha vissuto intensi scontri armati tra i tuareg e le forze governative, culminati con l’attacco di una base militare governativa nel 2008. Soltanto nel 2009 le forze governative sono riuscite a distruggere la principale base del North Mali Tuareg Alleance for Change guidata da Bahanga, che si è rifugiato in Libia. Per esperienza di altri paesi che hanno sperimentato ribellioni violente dei nomadi, come il Niger, il pericolo di una saldatura tra spezzoni sconfitti dei tuareg e la nuova minaccia qaedista di provenienza straniera, sono molto attuali. Proprio in Mali Aqim ha iniziato ad operare nel 2008, grazie anche all’esistenza di legami di sangue tra esponenti qaedisti e gruppi di tuareg operanti in aree specifiche (e in special modo nella regione maliana del Kidal) ed ha permesso all’organizzazione terroristica di penetrare più facilmente nel tessuto sociale locale e di contare sulla protezione riservata a membri dello stesso clan familiare. Una delle prime azioni di un certo rilievo da parte di Aqim è stata il rapimento di quattro turisti europei, uno dei quali decapitato nel 2009 in seguito al rifiuto del governo britannico di rilasciare un terrorista. Nel luglio 2009 Aqim ha attaccato un convoglio militare uccidendo un ufficiale superiore e trenta soldati governativi. Successivamente si sono susseguiti una serie di rapimenti di altri cittadini occidentali ed il governo maliano ha accettato di fatto la trattava con Aqim per ottenere il rilascio di alcuni di questi. Aqim utilizza inoltre il territorio maliano per sviluppare traffici illegali verso l’Africa del nord con finalità di autofinanziamento. Nonostante l’ impegno da parte del governo del Mali di combattere il terrorismo qaedista, la scarsità di mezzi e di risorse ha impedito di raggiungere visibili successi. Il governo degli Stati Uniti ha fino ad ora stanziato consistenti finanziamenti per migliorare l’efficacia del sistema di sicurezza del Mali e dei paesi limitrofi, proponendo la Pan-Sahel Initiative (Psi, 2002-2004)215 e poi la Trans-Sahara Counterterrorism Initiative (Tscti, programma lanciato nel 2005 con le esercitazioni Flintlock 2005)216, di cui si daranno maggiori dettagli nell’approfondimento relativo al Niger. In ambito regionale, il Mali ha partecipato alla creazione del Joint Command Center a Tamanrasset (Algeria) nell’aprile 2010, insieme a Mauritania, Niger ed Algeria, per coordinare le forze e contrastare l’azione di Aqim. 214 M.Meunier, in Mahmoud Dicko, l'imam qui casse le code de la famille, «Jeuneafrique.com», 14/10/2010. 215 Della Psi facevano parte Mali, Mauritania, Niger e Chad. 216 La Tscti ha coinvolto nelle esercitazioni oltre ai quattro partner della Psi, anche Algeria, Marocco, Tunisia, Nigeria e Senegal. 4. Paese con una maggioranza musulmana, pari all’80% della popolazione, il Niger è composto da varie etnie: 56% Hausa, 22% Derma-Songhai, 8,5% diTuareg, 8% di Fulani 4% di Kanuri. La composizione etnica è importante in quanto fornisce la misura di quanto il Niger possa essere influenzato dalla vicina Nigeria, avendo in comune per una larga parte di popolazione, la lingua hausa. La vita politica nigerina è stata da sempre influenzata dal fattore religioso. Tanto che la classe intellettuale laica di educazione francese, è stata di fatto esclusa in passato dall’alta burocrazia e dalle cariche politiche. Come afferma Adriana Piga: Durante diversi decenni si è rivelato quasi impossibile ambire ad incarichi politici di rilievo per la frazione non islamica della società nigerina. Ancor di più, ogni dichiarazione pubblica, secondo la consuetudine, iniziava con la recitazione della testimonianza di fede, la shahada, e soprattutto durante la fase pre-elettorale ogni tipo e modello di propaganda politica veniva infiorettato ad hoc da numerosi versetti coranici funzionali alle specifiche finalità politiche. Importantissima la veicolazione dell’islam attraverso molteplici media, dal giornale islamico «As-Salam» fino alle innumerevoli trasmissioni radiofoniche a sfondo islamico. Indubbiamente nessun partito politico nigerino si può permettere di non tenere conto dell’importanza che riveste l’Islam nelle sue molteplici dimensioni, sia nel mondo rurale che nell’universo urbano in tutto il Niger217. Il panorama dell’islam nigerino è complesso e composito, come peraltro quello della maggioranza dei paesi dell’Africa occidentale. Anche in questo Paese movimenti rigorosi di ispirazione wahabita si affiancano a gruppi religiosi quietisti della tradizione propria africana. Tra i gruppi più intransigenti si osserva una gamma variegata tra chi, tutto sommato è pronto ad accettare l’idea di vivere in un paese con una costituzione essenzialmente laica e chi invece vorrebbe spingere per uno stato confessionale, dietro l’esempio dei vicini governatorati della Nigeria del nord. Se si guarda alla composizione delle sette vicino ai sufi ed al tradizionalismo africano, innanzitutto possiamo osservare la presenza nelle aree rurali dei cosiddetti Mallam, marabutti che spesso non conoscono né la lingua araba né quella francese, ma che godono ancora di una certa influenza sui ceti popolari non istruiti. Di maggior peso sono le confraternite sufiste della Qadiriyya e della Tijaniyya. Per quanto riguarda invece le associazioni islamiche più inflessibili, paradossalmente esse hanno conosciuto un grande sviluppo nel corso dei progressi del sistema democratico, a partire dalla “Conferenza Nazionale Sovrana” del 1991, mentre precedentemente erano state tenute a freno dai governi autoritari. Grazie agli spazi di espressione e di libertà democratica inaugurati dalla Conferenza Nazionale Sovrana, si svilupperà una miriade di associazioni islamiche di stampo tradizionalista come l’Afi, l’Association pour la Fraternité Islamique, l’Arfi, Association pour le Rassemblement et la Foi Islamique, o ancora la Fondation Amar Taleb e islamiste a carattere fondamentalista, come l’Adini-Islam e la Gongouniyya.218 Il panorama di queste associazioni, pur avendo un tratto comune nella critica verso il sufismo africano, è piuttosto variegato, in relazione al loro grado di vicinanza al radicalismo religioso. Ad 217 A.Piga, La deriva anti-democratica di Tandja nel 2008-2009 e la risposta dell’opposizione. Islam, classe militare e società civile a confronto in Adriana Piga e Roberto Cajati (a cura di), Niger – problematiche sociopolitiche, risorse energetiche e attori internazionali, CeMiSS, 2011. 218 Ibidem esempio l’Association Nigérienne pour l’Appel et la Solidarité Islamique, Anasi, è essenzialmente un’associazione apolitica e incentrata, sia sulla difesa dei diritti umani, che sulla difesa ad oltranza dell’unità nazionale del Niger. Al contrario, associazioni come l’Association pour la Diffusion de l’Islam au Niger (Adini-Islam), disciolta nel 2000, ma che continua le attività di proselitismo in maniera non ufficiale, si richiama ai principi più radicali, a favore della reislamizzazioe integrale della società. Questi movimenti manifestano un’aperta ostilità verso le componenti laiche e francofone della società nigerina ed una critica aperta contro l’influenza culturale occidentale nel paese. In particolare essi si sono mossi con forza per frenare l’approvazione del codice di famiglia essenzialmente laico e talvolta hanno manifestato in forme violente. Dopo l’11 settembre 2001 il governo nigerino, con il pretesto di combattere il terrorismo, ha esercitato forte repressione verso le organizzazioni più estremiste. Un dato preoccupante è l’influenza che stanno esercitando, anche attraverso i mass media le organizzazioni radicali islamiche della vicina Nigeria. Negli ultimi anni i flussi commerciali con il paese confinante si sono incrementati notevolmente ed è proprio nella classe dei commercianti hausa che si annidano molte simpatie verso il fondamentalismo. Uno dei movimenti più temibili è quello Izala, di stampo salafita, che rivendica apertamente la creazione di uno stato teocratico. Nel nord del paese, il Niger è esposto alle stesse problematiche già citate per il Mali. L’area è stata teatro di lunghe rivolte dei Tuareg, organizzati nel Mouvement des Nigériens pour la Justice (Mnj). L’accordo concluso al termine dei tumulti però non sembra aver soddisfatto le rivendicazioni dei nomadi, quanto piuttosto placato alcuni leader locali con delle piccole concessioni anche di carattere pecuniario. Questa situazione di malcontento, che persiste, potrebbe favorire una saldatura tra elementi locali ed Aqim, attivo piuttosto liberamente nel deserto, come avviene in Mali. Negli ultimi anni, si sono susseguiti attacchi alle forze armate nigerine e rapimenti di cittadini occidentali, in alcuni casi finiti in maniera cruenta. Per rafforzare le capacità locali di controllo e difesa del territorio è stata promossa dall’amministrazione statunitense la Pan-Sahel Initiative (Psi). Tale iniziativa ha coinvolto Chad, Niger, Mali e Mauritania in programmi di addestramento per le forze armate nel 2003 e 2004 con un budget iniziale di 8,4 milioni di dollari americani. Successivamente – per il periodo 2005-2008 – tale programma è stato ampliato ad Algeria, Marocco, Nigeria, Senegal e Tunisia, ed è stato ribattezzato Trans-Sahel Counter Terrorism Initiative (Tscti). La prima esercitazione della Tscti, Flintlock 2005 (6-26 giugno 2005), ha riscontrato un buon successo tra i partecipanti sia perché ha permesso loro di apprendere nozioni di tattica, sia perché li ha incoraggiati a rispondere congiuntamente alle sfide regionali. Il training, che ha avuto luogo sul terreno di Algeria, Senegal, Mauritania, Mali, Niger e Chad, ha accresciuto la capacità dei paesi coinvolti nel frenare flussi illeciti di armi, di beni e traffico di esseri umani. Gli sforzi per rafforzare le politiche di sicurezza del Niger possono controbilanciare nel breve periodo la minaccia dei gruppi integralisti che operano nel deserto, ma difficilmente sono in grado di contribuire a rafforzare la stabilità politico sociale a livello nazionale. Sarà utile ricordare ad esempio che il Niger è il secondo stato più povero dell’Africa e che, come gran parte degli attori della regione, soffre di elevati livelli di corruzione, servizi sociali praticamente inesistenti ed una profonda frattura tra realtà urbana e aree rurali e desertiche. Unico elemento positivo in questo quadro desolante è la recente evoluzione politica ed istituzionale. Il 18 febbraio 2010 un colpo di stato ha rovesciato il regime corrotto e autocratico del presidente Mamadou Tanja. Il Consiglio Supremo per la Restaurazione delle Democrazia guidato dal maggiore Salou Djibo, si è subito impegnato ad organizzare elezioni libere entro un anno. Nell’ottobre del 2010 è stata approvata la nuova costituzione con referendum popolare con il 90% dei voti a favore. Questa si basa sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo, richiamandosi apertamente allo stato di diritto. Il carattere laico della costituzione è confermato dall’articolo, 8 titolo I, che vieta la costituzione di partiti politici basati sulla religione. Le elezioni del gennaio 2011 sono avvenute nel pieno rispetto delle regole democratiche, con tanto di dibattito televisivo tra i due contendenti, Mahamadou Issoufou del Nigerien Party for Democracy and Socialism (Pnds) e Seini Oumarou del Movement for the Development of Society (Mnsd). Nel mese di marzo del 2011 il nuovo presidente Issoufou (58% dei suffragi) ha nominato Brigi Rafini, un politico Tuareg di Agades come primo ministro. Issoufou, figura carismatica, sembra tenere molto alla coesione sociale del paese, un fattore chiave per contrastare la deriva del radicalismo islamico. Il nuovo governo ha lanciato in questa ottica un ambizioso piano di rafforzamento del settore agricolo per assicurare la sicurezza alimentare e ha dato la priorità al rafforzamento dei servizi sociali nelle zone rurali. 5. Il Senegal viene spesso preso ad esempio dalla letteratura come paese a maggioranza islamica (94% della popolazione) in cui la religione – lungi dal creare ostacoli allo sviluppo democratico – ha rivestito un ruolo attivo nelle interazioni socio-politiche. Nel far ciò, il credo religioso ha favorito l’instaurarsi di dinamiche che hanno contribuito all’equilibrio sociale ed alla stabilità politica. Nonostante tale realtà di base, alcune tornate elettorali non hanno goduto piena legittimazione popolare e ciò ha portato a parlare di “regime semi-democratico” senegalese. La suddetta affermazione deve essere però vagliata alla luce del risultato delle urne. In occasione delle elezioni del 1978 (vinte da Leopold Sedar Senghor) e di quelle del 1983 (vinte da Abdou Diouf) si è registrato un onesto confronto delle opposizioni, sebbene il risultato finale fosse prevedibile. Le elezioni del 1988 nelle quali il partito socialista di Diouf venne riconfermato al potere furono invece molto contestate e scatenarono reazioni estremamente violente della piazza, tanto da costringere lo stesso Diouf a promuovere una serie di riforme. Tali riforme però portarono ad una cambio di leadership soltanto nel 2000, a causa dell’inesperienza dell’opposizione. Il nuovo partito al potere, il Parti Démocratique Sénégalais guidato da Abdoulaye Wade, dopo un primo periodo di consenso deve affrontare un fortissima opposizione che ne vuole l’estromissione nelle elezioni del 2012. Sono in molti a temere che le consultazioni possano svolgersi in maniera non corretta e possano scatenare nuovamente la violenza del 1988, o – ancor peggio – ricreare la situazione di violento confronto che si è avuto recentemente in Costa d’Avorio. Anche se la democrazia in Senegal non sembra pienamente matura, non si può ignorare che il paese goda di mass media tra i più liberi dell’Africa e di una società civile (costituita anche da forti organizzazioni religiose) che partecipa al processo politico in maniera corale. La società – nel rispetto ed in collaborazione con le istituzioni – difende un pluralismo di idee che possono confrontarsi alla luce del sole, senza che queste debbano essere rappresentate da gruppi armati o sette che fanno sistematico uso di violenza. La componente laica e filo occidentale della società senegalese (rappresentata soprattutto dagli intellettuali) può esprimersi liberamente senza suscitare indignazione né ostracismi da parte dei gruppi religiosi. Questo quadro non è tuttavia necessariamente immutabile, soprattutto alla luce dell’evoluzione registrata negli ultimi anni all’interno del mondo musulmano internazionale. In questo contesto, lo status quo rappresentato nell’ambito religioso senegalese di confraternite sufi in armonia tra di loro ed in ottimi rapporti con il potere, sembra destinato a subire delle incrinature. Il Centre for Strategic and International Studies (Csis) di Washington nell’enumerare i vari possibili fattori di instabilità del Senegal cita 219, oltre alla questione del confronto elettorale nel 219 L. A. Villalon, Senegal: Assessing Risks to Stability, Centre for Strategic and International Studies (Csis), Washington, 2011 2012 (considerato sicuramente l’elemento più determinante), anche le tensioni interreligiose e la preoccupazione per il crescente ruolo della religione nella politica nell’era della democrazia. Tale fattore di rischio, valutato come debole nell’immediato, se associato al fattore economico-sociale nel lungo periodo, merita un’attenzione particolare. Le debolezze strutturali dell’economia senegalese e l’ultima evoluzione del quadro economicosociale sono alla base di queste preoccupazioni. Qualsiasi governo possa essere scelto l’anno prossimo, il paese si troverà ad affrontare notevoli difficoltà dovendo diversificare l’economia in presenza di limitate risorse di base, dovendo provvedere ad una popolazione in crescita e assorbire l’incremento delle nuove generazioni istruite con delle aspettative ben precise, dovendo affrontare una diffusa povertà urbana. Le organizzazioni religiose hanno generalmente fornito un appoggio alle istituzioni per ricomporre i contrasti, avendo come obiettivo quella della coesione sociale. Nel far questo, un ruolo chiave lo hanno ricoperto i vari ordini Sufi che rappresentano un centro di riferimento per almeno l’85% della popolazione220. Com’è noto queste, fin dall’epoca coloniale hanno costituito un fattore di stabilità politica del Senegal. Le tre principali organizzazioni sono: la Mouridiya, la Tijaniyya e la Qadiriyya. La Mouridiya è un ordine originario del Senegal, fondato da sheik Ahmadu Bamba (1853 - 1927) e formatosi durante l’occupazione coloniale, nell’ambito del gruppo etnico maggioritario dei Wolof. Tale confraternita è molto coesa ed organizzata centralmente. La Tijaniyya è di origine nord africana e si è diffusa in tutta l’Africa occidentale. I suoi discepoli sono più numerosi di quelli della Mouridiya sono frazionati in varie famiglie religiose. Essa è stata introdotta in Senegal nel 1835 da El-Haj Sheik Omar Tall (1799-1864) ed al giorno d’oggi vi aderiscono oltre il 51% dei mussulmani locali. La Qadiriyya vanta una lunga storia, essendo stata fondata nell’undicesimo secolo, ma gode di un peso relativo sia per il profilo quantitativo di adepti sia per la capacità dei Marabutti di far sentire il loro peso politico. Gli ordini sufi sono sottoposti ormai da alcuni decenni ad una serrata critica da parte di gruppi cosiddetti “riformisti” che incarnano le nuove istanze internazionali del “political islam”. Questi ultimi, inizialmente ispirati dalla rivoluzione fondamentalista iraniana, sono rappresentati da leader educati nel mondo arabo e molto contrari nei confronti dei processi di occidentalizzazione 221. Tra di essi si ricordano le organizzazioni, come la Jamatou Ibadou Rahmane, l’Associations des Etudiants de l’Universite de Dakar e l’Organisation pour l’Action Islamique, presenti soprattutto nei centri urbani e nelle Università. Il loro rimprovero verso il sistema dei marabutti sufi muove dall’idea che l’ortodossia islamica si è in qualche modo alterata dal contatto con le culture autoctone africane. Per il momento il seguito su cui possono contare queste associazioni radicali è molto limitato. Tuttavia la loro influenza culturale sta penetrando all’interno delle stesse compagine Sufi. Nella lotta per esercitare maggiore influenza all’interno delle confraternite e nell’ambito della lotta intergenerazionale, alcuni giovani leader sufi hanno iniziato ad abbracciare molti elementi del rigorismo islamico ed hanno formato dei gruppi militanti come quello di Hizbut Tarquiyyah (all’interno della Mouridiya) o di Dahiratoul Moustarchidine wal Moustarchidati (nell’ambito della Tijaniyya). Particolarmente organizzati e con un peso politico da non sottovalutare sono i Moustarchidine wal Moustarchidati, descritti spesso dai media occidentali come “il segnale della nascita del fondamentalismo islamico in Senegal”. Questo movimento, fondato negli anni Ottanta da Moustafa Sy, cosmopolita e colto, nipote del fondatore dei Tijan, ha avuto un certo seguito tra i 220 Ibidem 221 D. Dickson, Special Report: Political Islam in Sub-Saharan Africa The Need for a New Research and Diplomatic Agenda, United States Institute of Peace, 2005. giovani istruiti dei centri urbani222. La reazione dell’establishment sufi e delle istituzioni senegalesi, ad eccezione di un breve periodo di repressione, è stata quella di instaurare un linea di contatti pacifici con queste organizzazioni. Secondo molti osservatori, questi movimenti, con una decisa tendenza al radicalismo, sono stati in qualche modo “anestetizzati” da questa capacità del sistema paese del Senegal di scegliere la strada del dialogo piuttosto che quella dello scontro politico223. 6. Il Chad – situato a ridosso dell’Africa del Nord e del deserto del Sahara – condivide con gli altri paesi del Sahel la storia della penetrazione culturale mussulmana nel Medio Evo e l’influenza che questa ha avuto sugli assetti regionali. La percentuale attuale della popolazione di religione islamica, pari al 53,1%, è inferiore a quella di Niger (80%) e del Mali (90%), tuttavia tale presenza risulta regolarmente suddivisa sui quattro quinti del territorio, in particolare nel nord del paese. Il Chad ha vissuto una storia post-coloniale all’insegna di governi autocratici ed autoritari, registrando una forte instabilità tanto nelle aree centrali quanto in quelle periferiche. Gli esecutivi che si sono succeduti negli ultimi cinquanta anni hanno dovuto affrontare varie ribellioni armate, legate al controllo del potere ed alla distribuzione delle risorse tra diversi gruppi etnici. La religione ha giocato quasi sempre un ruolo secondario e talvolta soltanto strumentale ai conflitti civili. Sul territorio vivono poco meno di duecento gruppi etnici, tra i quali i principali sono i Sara (27,7%), gli Arabi (12,3%), Mayo-Kebbi (11,5%) 224. I Sara sono i più numerosi e vivono nella regione meridionale; essi hanno avuto il maggior peso politico tra il 1960 (anno dell’indipendenza) ed il 1979 (anno della creazione di un governo di coalizione, in cui i gruppi etnici del nord assunsero un’influenza determinante). Il contrasto tra il nord mussulmano ed il sud prevalentemente cristiano sembra essersi limitato all’ambito politico e non essersi riversato nel reparto militare. Uno dei motivi di contenzioso è, ad esempio, il sistema educativo per il quale la componente mussulmana vorrebbe un’accentuazione dell’orientamento religioso in senso islamico a scapito dell’attuale approccio prevalentemente laico. L’islam chadiano è costituito prevalentemente dal misticismo sufi e ciò ha ridotto il rischio di contrapposizioni violente in nome della religione. La confraternita alla quale aderiscono la maggior parte dei musulmani chadiani è la Tijaniyya, che incorpora in maniera sincretica molti elementi dell’animismo tradizionale africano. Soltanto una piccola minoranza di mussulmani viene considerata dagli osservatori e dallo stesso governo del Chad come fondamentalista. La figura di maggior rilievo in tale ambito è quella dell’imam Mahamadou Mahamat (conosciuto come sheikh Faki Suzuki), che opera a N'Djamena. Per le sue attività di proselitismo e per i suoi sermoni molto accesi ed estremistici, è stato messo agli arresti domiciliari tra il 1998 e il 1999. Nel 2002 lo stesso “Comitato Superiore per gli affari islamici dello stato” ha accusato Mahamat e l’imam Haroun Idriss Abou-Mandela, di predicare 222 Leonardo A. Villalon, Sufi Modernities in Contemporary Senegal: Religious Dynamics between the Local and the Global, in Martin Van Bruinessen and Julia Day Howell (acura di), Sufism and the “Modern” in Islam, I.B. Tauris, 2007. 223 A.Thurston, Why is Militant Islam a Weak Phenomenon in Senegal?, Institute for the Study of Islamic Thought in Africa (Isita), Buffet Center, 2009. 224 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cd.html contro la Tijaniyya, instillando odio interreligioso ed interetnico. In tal senso non può essere sottovalutata la crescita delle attività di predicatori itineranti provenienti dal Sudan, dall’Arabia Saudita e perfino dal Pakistan che spesso fomentano ostilità e rancore tra i gruppo locali.225 I pericoli per la stabilità del paese tuttavia non sembrano derivare nel breve periodo tanto da queste manifestazione di attività religiose ortodosse, quanto piuttosto dagli sviluppi in corso nelle zone nord-occidentali. Queste regioni – importante snodo di scambio tra il nord Africa islamico e l’Africa sub-sahariana – sono state da anni trascurate dal governo centrale che si è concentrato sulle aree di forte instabilità ai confini con il Sudan. Ora, a causa della vicinanza con il Niger e la Nigeria settentrionale vi è un forte rischio di contaminazione per quel che riguarda i traffici illegali connessi ad organizzazioni terroristiche. Il riferimento è alle attività di Aqim e di Boko Haram, organizzazioni che negli ultimi anni hanno fatto sentire la loro influenza226. Il tessuto socio-economico di tale spazio presenta da questo punto di vista una forte vulnerabilità. La cessazione delle attività militari dei due movimenti ribelli Mouvement pour la Democratie et le Developpement (Mdd) e Mouvement pour la Democratie et la Justice au Tchad (Mdjt), ha lasciato comunque una scia di controversie locali e di istanze insoddisfatte. A ciò si aggiunge un’endemica conflittualità tra comunità diverse, soprattutto tra pastori nomadi e agricoltori stanziali. La parallela bassa capacità di governance locale da parte delle autorità centrali, che di fatto ignorano il deterioramento delle condizioni sociali della regione, costituiscono tutti fattori in grado di favorire la diffusione del dettame fondamentalista e il radicamento sul territorio delle organizzazioni citate. Se si considera inoltre che una delle più evidenti mancanze di governance riguardano il sistema giudiziario locale, non sarebbe certamente una sorpresa se l’applicazione della sharia diventasse una rivendicazione nei prossimi anni. Il governo del Chad fino ad ora ha mostrato una marcata insensibilità alle necessità ed alle istanze economico-sociali della regione nord-occidentale, come dimostrato in occasione delle inondazioni del 2010 che hanno devastato la città di Faya Largeau e più in generale dei fenomeni di siccità che mettono regolarmente a rischio la sicurezza alimentare di buona parte delle popolazioni settentrionali. 7. Se l’islam ha avuto un’ampia diffusione nei paesi del Sahel e nella Nigeria del Nord fin dal secolo XI (con i primi contatti addirittura nel secolo IX), tale fenomeno si è manifestato ben più tardi nei paesi costieri dell’Africa occidentale e nel Burkina Faso, paese senza sbocco al mare e collocato a nord di Costa d’Avorio, Ghana, Togo e Benin. Tra i paesi costieri a maggioranza mussulmana, si trovano la Guinea Conakry (85%), il Gambia (90%) e la Guinea Bissau (50%). In Guinea Conakry la maggior parte della popolazione islamica è sunnita di tradizione malikita o appartiene agli ordini sufi della Qadiriyya e Tijania. Vi sono anche minoranze Ahmadiyya, movimento fondato in India nel 1889, considerato eretico da gran parte dell’islam. Dopo l’indipendenza del paese (1958), il leader Sekou Touré (mussulmano marxista), cercò inizialmente di scoraggiare l’islamizzazione del paese, anche se negli anni Settanta, per rafforzare il suo potere in declino iniziò una politica di collaborazione con le istituzioni religiose. Fin da allora il rapporto tra governo e comunità islamica è stato collaborativo e senza scosse di particolare rilievo. 225 E. P. Lipton, Religious freedom in Africa, Nova, 2002. 226 International Crisis Group, Chad's North West the next high-risk area, Africa Briefing n.78, febbraio 2011. Anche in Gambia la maggior parte dei mussulmani sono sunniti, sebbene sia entrata in vigore nel paese un sistema diffuso di associazioni guidate da marabutti nello stile sufi e sopravvivano pratiche tribali ed animiste che si mescolano alle prassi islamiche ortodosse. La popolazione di religione islamica musulmana ha ormai raggiunto il 90% del totale, sia per effetto dei grandi sforzi di proselitismo nel corso del secolo XIX, sia per un certo favore da parte delle autorità coloniali britanniche. Se l’islam politicizzato non sembra costituire un problema, non sono mancate nel paese tradizioni fondamentaliste. Tra il 1850 ed il 1901 dietro l’effetto della campagna puritana di alcuni leader jiadisti, come Maba Diakhou e Foday Kabba Dumbuya, contro i comportamenti poco ortodossi dei leader musulmani, si verificarono le Soninke-Marabout Wars considerate una vera e propria guerra civile. I marabutti erano “sacerdoti” ed insegnanti mussulmani, mentre i soninke erano i capi tribali mandinka. Questi ultimi, pur essendo nominalmente mussulmani mantenevano intatte molte tradizioni animiste tradizionali e praticavano stili di vita e rituali giudicati immorali, come l’uso di sostanze alcoliche. Il conflitto persistente (costituito soprattutto da quelli che oggi si definirebbero “scontri a bassa intensità” ) creò in quel periodo spostamenti rilevati della popolazione in Gambia e considerevoli sacche di profughi. In Guinea Bissau dove il rapporto tra mussulmani ed il resto della popolazione è più bilanciato, sia il governo che la società, si attengono ad un atteggiamento tollerante verso i vari credo religiosi. I mussulmani – più numerosi tra i Fulani ed i Peul – vivono nel nord del paese. Unico episodio di intolleranza religiosa si è riscontrato nel 2005 tra islamici e appartenenti alla minoranza Ahmadiyya, risolto con il divieto di praticare questa forma di eresia mussulmana. I suoi seguaci sembrano essersi convertiti in maniera volontaria alle pratiche sunnite. Per quanto riguarda gli altri tre paesi costieri dell’Africa occidentale – vale a dire il Benin, il Togo ed il Ghana – la religione mussulmana rappresenta soltanto una rilevante minoranza rispettivamente pari al 24,4%, 20%, e 15,9% della popolazione. In tutti e tre, non sono in corso tensioni politiche di matrice religiosa. La libertà di culto è garantita dalla costituzione e le comunità di religione islamica forti nel nord dei tre stati non professano ideologie antagoniste. Ognuno di essi ha specifiche caratteristiche che lo distingue dai vicini: ad esempio il Ghana, a differenza degli altri attori dell’Africa occidentale, non ha forti comunità sufi, ma ospita una consistente rappresentanza di sciiti che ha raggiunto il milione di persone, in gran parte commercianti libanesi. In tutta l’area esaminata è difficile individuare dinamiche interreligiose che possano potenzialmente determinare il nascere di correnti fondamentaliste. Qualche debole segnale può forse essere riscontrato in Benin dove, secondo uno studio di Galilou Abdoulaye, nel nord del paese, le nuove generazioni di intellettuali tendono ad assume in maniera crescente posizioni vicine all’intransigenza wahabita con forti accenti anti-occidentali. I motivi di queste nuove tendenze vanno ascritte alla crescente frustrazione delle nuove generazioni per la doppia emarginazione: la prima deriva dall’esclusione dalle èlite nella società del Benin e la seconda dall’emarginazione all’interno della stessa comunità islamica dove le vecchie generazioni continuano a controllare le leve del potere. A questi fattori si aggiunge l’influenza culturale del wahabismo internazionale e l’inserimento di queste nuove generazioni con posizioni rilevanti nel sistema educativo “arabizzato” finanziato dall’Arabia Saudita e Kuwait 227. Questo fenomeno che vede le nuove generazioni “arabizzate” escluse dalle leve del potere del paese e dalla leadership sociale, che rivendicano la loro appartenenza al “riformismo islamico” di tipo integralista, è presente anche in Burkina Faso. Anzi, in questo paese sembra che esso assuma una diffusione ed una forza maggiore che in Benin. In Burkina Faso dove si registra una popolazione mussulmana del 60,5%, il processo di islamizzazione è stato relativamente recente a differenza di Mali, Niger o Nigeria del Nord. In altri termini ciò significa che la tradizione mussulmana è meno radicata storicamente nel tessuto sociale. Dall’epoca precoloniale l’etnia dominante Moose, anche quando alcuni suoi sovrani si erano 227 G. Abdoulaye, Islam au Benin, Lit, 2007 convertiti all’islam, ha sempre preferito frenare l’impatto del credo religioso per non minacciare l’ordine tradizionale. L’amministrazione coloniale francese, a differenza di quanto fece in altre colonie, evitò di sviluppare scuole mussulmane e di appoggiarsi sulle èlite islamiche, preferendo puntare sui capi tribali tradizionali che in Burkina erano appunto i Moose. In questo quadro l’insegnamento islamico e la formazione dei quadri amministrativi locali restava dunque laica o basata sulle scuole missionarie. Soltanto dopo la Seconda guerra mondiale nacque un movimento di reazione per affermare l’insegnamento coranico e vennero costituite le prime madrase. Queste scuole, erano finalizzate ad impartire un insegnamento in lingua, così da diffondere non soltanto il credo religioso ma la cultura e le tradizioni del mondo arabo. Nonostante il fatto che il sistema di insegnamento fosse nettamente inferiore da un punto di vista tecnico a quello delle scuole pubbliche laiche e missionarie228, le madrase hanno conosciuto una crescita esponenziale. Un fattore importante di questa diffusione delle scuole coraniche è stato naturalmente l’apporto finanziario di paesi come l’Arabia Saudita e il Kuwait. Interessante notare che tale crescita riflette anche l’incremento della popolazione di religione mussulmana che è passata dal 10% al 60% degli abitanti del Burkina Faso. La cultura arabo-islamica, riservata in passato ad una minoranza di letterati, ha conosciuto così un’ampia diffusione. Il movimento dei “nuovi mussulmani” o dei “riformisti arabizzati” ha come obiettivo il ritorno all’umma delle origini, purificando l’islam dalle distorsioni e false credenze che le sono estranee; come i salafiti, ritengono di essere i veri interpreti del Corano e della tradizione; sono ovviamente critici verso le distorsioni dell’islam africano dominato dalle confraternite sufi. Il rinnovamento religioso per recuperare l’ortodossia perduta si affianca a una forte attenzione al settore sociale e politico; i “giovani riformisti” ostili alla cultura occidentale non rifiutano la modernità, ma la reinterpretano alla luce dei dettami rigoristi della tradizione wahabita. Questo movimento giovanile è molto fiero della propria identità linguistica araba e dell’ambiente culturale locale229. Da un punto di vista delle prospettive politiche, è evidente che in Burkina Faso la diffusione di questo movimento giovanile che presenta caratteri soprattutto di tipo culturale, può essere una fonte di preoccupazione. Questo soprattutto se si tiene conto che gli esponenti di questo movimento appartengono a strati assimilabili alla piccola borghesia intellettuale emarginata, non soltanto dalle èlite occidentalizzate al potere, ma anche dall’establishment mussulmano delle vecchie generazioni. 8. Se i paesi del Sahel per la loro storia, gli equilibri politici interni e la conformazione geografica hanno suscitato negli ultimi anni crescenti preoccupazioni tra gli analisti occidentali che seguono il fenomeno jihadista, vi sono altri protagonisti dell’Africa occidentale che richiedono una buona dose di attenzione, pur in una situazione molto diversa. Questi sono: la Sierra Leone, la Costa d’Avorio e la Liberia. In questi tre stati la presenza radicale non deriva da importanti movimenti dell’islam politico autoctoni, bensì da minoranze soprattutto sciite con forti contatti con l’estero. Per quanto riguarda il rapporto tra religione e politica, i tre paesi hanno comunque dinamiche molto diverse tra di loro. La Sierra Leone con un 60% di popolazione mussulmana, dopo una lunga guerra civile (marzo 228 In Burkina si dice comunemente che le madrase “vanno bene per l’aldilà mentre le scuole europee servono per guadagnarsi il pane sulla terra”. 229 R. Otayek, L’affirmation élitaire des arabisants au Burkina Faso, in R.Otayek, Le radicalisme islamique au dud diu Sahara, Karthala, 1993. 1991- gennaio 2002), vive una difficile fase di ricostruzione con il supporto della Gran Bretagna e delle Nazioni Unite. La religione non ha mai costituito un fattore di instabilità, nonostante la rapida crescita del credo islamico successivamente all’indipendenza (1961). Al contrario, in Costa d’Avorio – dove il 38,6% di popolazione professa la religione islamica – le componenti wahabite hanno un certo peso nelle dinamiche politico-sociali del paese, anche se si tratta di piccole minoranze. Talvolta si sono verificate forti tensioni tra questi gruppi tradizionalisti e la più vasta area dei mussulmani; tensioni che si sono prodotte anche tra i gruppi più tradizionalisti ed “arabizzati” ed i riformisti che seguono una dottrina che riconcilia l’islam tradizionale e la modernità. Dalla fine degli anni Novanta ad Abidjan ed in particolare nel campus universitario di Cocody, si è assistito ad un forte incremento delle attività di proselitismo delle componenti sunnite più tradizionaliste e di gruppi salafiti. Sotto l’influenza di colleghi stranieri, come ad esempio giovani teologi istruiti in Arabia Saudita e in Kuwait o studenti della Nigeria settentrionale, alcune minoranze si sono espresse in varie maniere anche con azioni di militanza politica che hanno causato forti agitazioni, come quando un gruppo di studentesse han rifiutato di togliere il velo prima degli esami universitari. Interessante notare che durante gli anni della presidenza Gbagbo si è registrata una convivenza e tolleranza religiosa tra cristiani e mussulmani, ma dopo l’avvento di Alassane Dramane Ouattara, in molti dubitano che la presidenza possa garantire un simile equilibrio per i prossimi anni. In Liberia il peso dell’islam è ancora più ridotto, pari al 12,2% della popolazione totale. Questa minoranza, in gran parte sunnita alla quale si aggiungono frazioni sciite, è presente tra i gruppi etnici Mandingo, Vais e Fulah. I mussulmani mandingo hanno subito una vera e propria persecuzione durante la guerra civile per motivi prevalentemente di invidia sociale, essendo questi in gran parte membri della business community. I contrasti interreligiosi sono tuttavia il riflesso di quelli interetnici, che si manifestano in forme violente soprattutto in relazione alla distribuzione delle risorse o dei diritti di proprietà fondiaria. Il fatto che l’islam sia in qualche modo marginalizzato, in un paese a maggioranza cristiana, implica necessariamente che ci possano essere reazioni basate su tematiche religiose, soprattutto tra quei gruppi influenzati da studenti istruiti in Kuwait o Arabia Saudita. Il pericolo di una radicalizzazione può crescere più che altro per effetto del forte sviluppo di associazioni fondamentaliste cristiane che favoriscono dinamiche basate sulla contrapposizione con le minoranze mussulmane. Tali sviluppi negativi sono potenzialmente possibili nelle aree rurali a maggioranza mussulmana, dove l’ortodossia sunnita si è espressa di volta in volta. La tendenza al rispetto dei principi più tradizionalisti ed ortodossi in alcune ristrette comunità musulmane è sempre stata presente in Liberia: si ricorda, ad esempio, che nel 1989 il governatore Fulah nel distretto di Sinoe, applicò in varie occasioni punizioni corporali basate sulla sharia per reprimere l’uso di alcolici o la promiscuità, suscitando prese di posizioni molto dure da parte delle autorità centrali del paese. In conclusione in Sierra Leone, in Liberia o in Costa d’Avorio non sembra imminente un coinvolgimento o un collegamento delle frange tradizionaliste islamiche al movimento radicale globalizzato. Tuttavia la debolezza delle istituzioni statali e la corruzione generalizzata sono fattori che creano condizioni favorevoli all’organizzazione di traffici illegali. In questo ambito alcune minoranze, come la comunità libanese sciita in Costa d’Avorio, che supera i centomila individui, ma anche quella meno numerosa in Sierra Leone e Liberia, ha costituito una vera e propria rete di traffici soprattutto di diamanti. Fin dagli anni Ottanta e Novanta i commercianti libanesi attraverso il commercio dei diamanti hanno costituito un’importante fonte di finanziamento per organizzazioni fondamentaliste come Amal e Hezbollah230. Successivamente numerose analisi hanno portato a collegare le organizzazioni libanesi attive nei tre 230 Meib Staff, Hezbollah and the West African Diamond Trade, Middle East Intelligence Bulletin, vol. 6, no. 6-7 giugno 2004, www.meib.org/articles/0407_12.htm paesi dell’Africa occidentale direttamente a network terroristici ed al-Qaeda. In altri termini si è sviluppata un’organizzazione triangolare di fund raising tra comunità sciite africane, movimenti fondamentalisti libanesi e il network globale sunnita per finanziare attività terroristiche con i proventi dei citati traffici illeciti attivi non soltanto in Liberia Costa d’Avorio e Sierra Leone, ma anche in Africa centrale ed Africa sud orientale come in Tanzania231. Secondo uno studio di Ricardo Laremont e Hrach Gregorian, i militanti di al-Qaeda, Abdullah Ahmed Abdullah, Ahmed Khalfan Ghailani (arrestato in Pakistan il 25 luglio 2004), e Fazul Abdullah Muhammed utilizzavano contatti libanesi per organizzare operazioni di acquisto di diamanti e di riciclaggio di denaro in Sierra Leone dal 1998 al 2001. Questi soggetti sono stati addestrati da Abu Ubadiah al-Banshiri e Wadih El Hage (segretario personale di Osama bin-Laden) per commerciare in diamanti nel West Africa. AlBanshiri e El Hage precedentemente avevano commerciato in diamanti e altre gemme preziose in Kenya e Tanzania dal 1993 al 1997. Al loro arrivo in Sierra Leone, Abdullah, Ghailani e Muhammad sono entrati in contatto con Aziz Nassour (un avido supporter di Amal e principale mercante di diamanti per Mobutu Sese Seko) e il cugino di Nassour, Samih Ossaily, noti trafficanti di diamanti per Amal e Hizbullah. Nell’ottobre 1998 El Hage mandò in West Africa Abdullah, Ghailan e Muhammad per vendere diamanti con l’obiettivo di finanziare le attività terroristiche di al-Qaeda. E’ provato che dal 1998 al 2001, al-Qaeda ha raccolto milioni di dollari dalla vendita di diamantu collaborando con la rete esistente libanese per rendere il traffico possibile.232 E’ difficile sapere se queste attività abbiano avuto un seguito anche negli ultimi anni, poiché mancano informazioni provenienti da fonti aperte. L’assenza di notizie potrebbe essere attribuito alla cessazione delle operazioni, ma anche allo scarso controllo e alla quasi completa libertà in cui possono muoversi i trafficanti nelle aree africane. In altri termini, i traffici illegali collegati al terrorismo potrebbero proseguire all’insaputa delle autorità e delle strutture di sicurezza dei paesi esaminati. 9. La ventata di cambiamento che si è verificata in Nord Africa, le rivolte promosse dal basso che hanno fatto deviare – più o meno pacificamente – il percorso stabilito dai regimi al potere in Egitto e Tunisia e che invece con la violenza hanno sovvertito il regime libico, inducono a chiedersi se sia possibile “trasportare” tali esperienze anche nella vasta area a sud del Sahara. È lecito aspettarsi una “primavera africana” anche nella regione occidentale africana? Se sì, in quale lasso di tempo? Ci sono in alcuni paesi in particolare le condizioni che hanno portato ai fenomeni di piazza Tahrir? Dietro possibili nuovi scenari ci possono essere gruppi radicali islamici? Quale l’elemento indispensabile per riprodurre l’effetto Tunisia? Sono domande non indifferenti che invitano ad una lettura approfondita del quotidiano dei paesi africani, spesso bypassato dai mass media italiani o ritagliato ad hoc sulla base di chiavi di lettura 231 D.Farah, Report Says Africans Harbored Al Qaeda Terror Assets Hidden in Gem-Buying Spree, in «Washington Post», 29 dicembre 2002; D-Farah, Blood into Stones, Broadway Books, New York, 2004; G.Campbell, Blood Diamonds, Westview Press, Boulder 2002 232 R.Laremont e H. Gregorian, Political Islam in West Africa and the Sahel, in «Military review», GennaioFebbraio 2006; Global Witness For a Few Dollar$ More: How Al Qaeda Moved Into the Diamond Trade, Global Witness, Aprile 2003 francesi ed inglesi. Risalta immediatamente che al di sotto della fascia sahariana mancano dei fattori strutturali essenziali per un cambiamento di potere. In primis non c’è un alto tasso di alfabetizzazione delle classi giovanili come nella regione settentrionale del continente; non c’è in alcuni casi, o comunque è limitato in altri, un accesso ad internet; è assente, o comunque in nuce, una classe media sviluppata; c’è un alto numero di etnie che detta le regole del gioco politico nazionale. Le folle che hanno animato le proteste di Tunisi e del Cairo erano composte da studenti e universitari che richiedevano un lavoro o comunque un cambiamento delle regole nel mondo lavorativo e da giovani donne che rivendicavano un ruolo differente nella società. I diversi gruppi reclamavano la libertà di scegliere rappresentanti nazionali, al di fuori di liste blindate in cui c’èra -solo apparentemente - una pluralità di formazioni ma in cui -di fatto- un partito unico dominava la scena politica. Questi ragazzi erano padroni dei mezzi informatici e utilizzavano twitter e facebook per organizzare i loro incontri e raduni di piazza, dimostrandosi padroni delle tecnologie dell’era globale. E’ la fascia di età compresa tra i venti e i trenta anni quella che si confronta con un quotidiano fatto di rinunce, con una situazione economica che non ha contribuito a creare ma che deve subire, con una disoccupazione crescente. C’è poi l’ultimo fattore da non sottovalutare: in Tunisia ed Egitto non sono presenti tutti i gruppi etnici che animano la realtà al di sotto del Sahara. Ciò ha favorito negli ultimi mesi una reductio ad unum, permettendo di esprimere indifferentemente la propria voce. L’assenza nell’area subsahariana di un alto tasso di alfabetizzazione, di un diffuso accesso ad internet, di una classe media sviluppata ed infine la presenza di un numero eccessivo di etnie sono elementi che rendono difficile realizzare nel breve periodo “una primavera africana”. Qui, pur essendoci una grande voglia di cambiamento e stanchezza per i regimi che sono stati ancorati al potere nelle ultime due-tre decadi, le forze di opposizione non sanno contrapporsi in modo compatto al partito dominante. Quanto accaduto in Benin, Burkina Faso e Senegal tra il febbraio ed il maggio 2011 può essere preso ad esempio del contesto africano occidentale. In Benin si sono svolte delle manifestazioni a Cotonou per protestare contro le modalità in cui era stata gestita la fase prima del voto presidenziale (le consultazioni si sarebbero dovute svolgere il 27 febbraio, sono state rinviate una prima volta al 6 marzo ed infine si sono tenute il 13 marzo). L’opposizione ha contestato la vittoria di Boni Yayi che avrebbe ottenuto il 53,13% delle preferenze ma nulla è riuscita a fare per dimostrare le irregolarità del voto. Nulla hanno potuto fare anche le formazioni minori nelle elezioni legislative del 30 aprile, ottenendo solo trenta degli ottantatre seggi del parlamento nazionale. Più delicato è stato il caso del Burkina Faso. Il 20 febbraio 2011 è morto a Koudougou il giovane studente Justin Zongo in seguito alle percosse in un commissariato locale. Le motivazioni di quanto accaduto sono rimaste poco chiare. I giovani hanno manifestato in alcune città di provincia (Koudougou, Poa, Koupéla, Ouahigouya, Pouytenga); si sono chiuse scuole e università; diversi attivisti sono stati fermati dalle forze dell’ordine. Chrysogone Zougmoré, presidente del Mouvement Burkinabe des Droits de l'Homme et des Peuples (“organizzazione non governativa per la tutela dei diritti dell’uomo”) è stato chiamato a testimoniare il 10 marzo in una gendarmeria della capitale perché ritenuto responsabile di aver incoraggiato le manifestazioni Il 14 aprile è stato poi il turno dei militari che si sono ammutinati nella capitale Ouagadougou e sono usciti dalle caserme nell’est del Paese esprimendo la loro insoddisfazione nei confronti del presidente Blaise Compaoré e del trattamento riservato loro. Questa, secondo la stampa locale, è stata una delle crisi più gravi registrate dall’avvento al potere di Compaoré (1987). Nel caso del Senegal, la protesta nelle strade di Dakar si è fatta sentire il 23 ed il 27 giugno 2011. La popolazione ha espresso il suo malcontento nei confronti di un progetto di legge elettorale che nelle consultazioni del febbraio 2012 agevolerebbe il presidente Abdoulaye Wade ed il suo entourage (in particolare il figlio Karim Wade, considerato il “delfino” pronto per l’incarico di vice) e per la mancata erogazione di energia elettrica per oltre settantadue ore. Partiti dell’opposizione, associazioni della società civile e gruppi di giovani hanno denunciato la deriva del potere e sono riusciti a far ritirare il progetto. La nascita del “Movimento 23 giugno” ha rappresentato il punto più alto della protesta. La disponibilità al dialogo mostrata dal presidente in carica, dopo il discorso ufficiale del 14 luglio è stata giudicata piuttosto una sfida nei confronti dell’opposizione e di quanti intendono manifestare il loro malessere. Wade ha dimostrato di porsi al di sopra delle istituzioni, di avere la massima fiducia in se stesso e nella sua vittoria. I temi più caldi –quali la disoccupazione, il rialzo dei prezzi dei generi alimentari, i problemi di energia – non sono stati affrontati in modo appropriato. La promessa di creare un “Alto consiglio per l’impiego e la formazione” non ha placato gli animi e non ha soddisfatto i bisogni urgenti del popolo. E’ evidente che nei tre casi suddetti – Benin, Burkina faso e Senegal – non c’è stata una pressione di movimenti radicali islamici a coadiuvare le proteste. Bibliografia The World Factbook CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ E.P. Lipton, Religious freedom in Africa, Nova 2002. A. Galilou, Islam au Benin, Lit, 2007. R. Otayek , L’affirmation élitaire des arabisants au Burkina Faso, in René Otayek Le radicalisme islamique au Sud du Sahara, Karthala, 1993. Hezbollah and the West African Diamond Trade, Middle East Intelligence Bulletin, Meib Staff, vol 6, n. 6-7, giugno 2004, www.meib.org/articles/0407_12.htm F.Douglas, Report Says Africans Harbored Al Qaeda Terror Assets Hidden in Gem-Buying Spree, «Washington Post», 29 dicembre 2002. F. Douglas, Blood into Stones, Broadway Books, New York, 2004. G. Campbell, Blood Diamonds, Westview Press, Boulder 2002. R. Laremont e H. Gregorian, Political Islam in West Africa and the Sahel, in «Military review» January-February 2006. Global Witness, For a Few Dollar$ More: How Al Qaeda Moved Into the Diamond Trade, Global Witness Aprile 2003, http://www.globalwitness.org/library/few-dollar-more-how-al-qaedamoved-diamond-trade https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mi.html International Crisis Group, Chad's North West the next high-risk area ,Africa Briefing n.78, February 2011, http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/chad/B78-chadsnorth-west-the-next-high-risk-area.aspx J. Hunwick, West Africa, Islam, and the Arab World, Markus Wiener Publishrs, Princeton, 2006. W. Thornberry e J. Levy, Al Qaeda in the Islamic Maghreb, Csis, Settembre 2011. http://csis.org/publication/al-qaeda-islamic-maghreb A. Plebani, Geo-politica di al-Qa’ida nel Maghreb islamico (Aqmi), in Piga A. e Cajati R. (a cura di), Niger – problematiche sociopolitiche, risorse energetiche e attori internazionali, CeMiSS, 2011. W.F.S. Miles, Political Islam in West Africa: State-Society Relations Transformed, Lynne Rienner, 2007. T. Falola, Violence in Nigeria: The crisis of religious politics and secular ideologies, Rochester, University of Rochester Press, 386 p. (1998). W.F.S. Miles, Religious pluralisms in Northern Nigeria, in Levtzion N. and Powels R. L. (eds), The history of Islam in Africa, Athens, Ohio University Press, (2000). Osama bin Laden Largely Discredited Among Muslim Publics in Recent Years , Pew Global Research Centre, 2 maggio 2011, http://www.pewglobal.org/2011/05/02/osama-bin-laden- largely-discredited-among-muslim-publics-in-recent-years/ B. F. Soares e R. Otayek R. (edited by.), Islam and Muslim Politics in Africa, New York, Palgrave 2007. O. Meunier, Dynamique de l’enseignement islamique au Niger, le cas de la ville de Maradi, Parigi, L’Harmattan, 2000. P. M. Lewis, Nigeria: Assessing Risks to Stability, Center for Strategic and International Studies (Csis), Washington, 2011, http://csis.org/files/publication/110623_Lewis_Nigeria_Web.pdf National Daily, Siege of Terror: ex Niger Delta militants threaten mayhem over unpaid allowances”, 19-25.09.2011, http://www.nationaldailyngr.com/ Newswatch Online, The Boko Haram killings, 25.07.2011-01.08.2011. http://www.newswatchngr.com/index.php? option=com_content&task=view&id=3344&Itemid=26 V. Le Vine, Mali: Accommodation or Coexistence?, in. Miles William F.S (a cura di) Political Islam in West Africa: State-Society Relations Transformed, Lynne Rienner, 2007. M. Meunier, Mahmoud Dicko-L'imam qui casse le code de la famille, http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2596p018.xml0/ , 14/10/2010 Piga A., La deriva anti-democratica di Tandja nel 2008-2009 e la risposta dell’opposizione. Islam, classe militare e società civile a confronto, in A. Piga e R. Cajati (a cura di), Niger – problematiche sociopolitiche, risorse energetiche e attori internazionali, CeMiSS, Roma, 2011. Villalón L. A., Senegal: Assessing Risks to Stability, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Washington, 2011, http://csis.org/files/publication/110623_Villalon_Senegal_Web.pdf D. Dickson, Special Report: Political Islam in Sub-Saharan Africa The Need for a New Research and Diplomatic Agenda, United States Institute of Peace, Washington, Maggio 2005, http://www.usip.org/publications/political-islam-sub-saharan-africa-need-new-research-anddiplomatic-agenda A. L. Villalón, Sufi Modernities in Contemporary Senegal: Religious Dynamics between the Local and the Global, in Van Bruinessen M. and Howell JD (a cura di), Sufism and the “Modern” in Islam, I.B. Tauris, London-New York, 2007, http://www.apnaorg.com/books/english/sufism-modern-islam/sufism-modern-islam.pdf A. Thurston., Why is Militant Islam a Weak Phenomenon in Senegal?, Institute for the Study of Islamic Thought in Africa (Isita), Buffet Center, 2009. http://www.cics.northwestern.edu/documents/workingpapers/ISITA_09-005_Thurston.pdf O. Kane et JL Triaud (sous la direction de), Islam et islamismes au sud du Sahara, IremamKarthala, MSH Parigi, 1998. R. Otayek (sous la direction de), Le radicalisme islamique au sud du Sahara, Karthala-MSHA, Paris, 1998. H.D. Hassan, Islam in Africa, «CRS http://www.fas.org/sgp/crs/row/RS22873.pdf Report for Congress», Maggio 2008 A. Piga e R.Cajati (a cura di), Niger – problematiche sociopolitiche, risorse energetiche e attori internazionali, CeMiSS, Roma, 2011. US Department of State-Office of the Coordinator for Counterterrorism, Country reports on terrorism 2010, Washington, Agosto 2011 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ Capitolo Sesto La periferia dell’Islam Maria Egizia Gattamorta 1. La comunità di religione islamica rappresenta l’1,5 % della popolazione del Sud Africa (circa quarantanove milioni di persone), secondo i dati riportati dal World Factbook della Cia, ed è principalmente concentrata nell’area di Western Cape (nella regione sud occidentale) dove il 6,5%7% della popolazione è mussulmana. Una percentuale minima ma significativa, che si ricollega ad una presenza storica (l’islam arrivò in Sud Africa nel secolo XVII ed il primo gruppo giunse dall’odierna Indonesia), si lega ad un cambiamento sociologico post-apartheid, si connette agli eventi internazionali della rivoluzione islamica iraniana ed al post-11 settembre 2001. Dopo il crollo delle Twin Towers ed il varo della “lotta al terrore”, numerosi esperti di settore hanno messo in allerta i responsabili politici sudafricani circa i collegamenti tra gruppi radicali islamici locali ed il network di al-Qaeda ed hanno evidenziato i rischi di violenze nelle aree più degradate, date le difficili condizioni economiche interne, le differenze sociali e i ripetuti atti di xenofobia ai danni di stranieri. Il Sud Africa è considerato area periferica del radicalismo islamico, tuttavia è anche percepito come un “ponte”, o meglio un “territorio di passaggio”che ha filtrato operazioni finanziarie della rete creata da bin-Laden nell’ultimo quindicennio. Cape Town, Durban, la provincia di Eastern Cape e Pretoria hanno registrato i movimenti di diversi esponenti riconducibili ad al-Qaeda. A testimonianza di ciò si ricorda che la moschea di Pretoria è stata luogo di preghiera di alcuni ricercati, come ad esempio Farhad Ahmed Dockrat 233, ritenuto nel gennaio 2007 dal Dipartimento del Tesoro e dai servizi di intelligence americani un finanziatore indiretto dell’Al Akhtar Trust, fondo afghano destinato ai militanti di al-Qaeda. Altro nome noto all’amministrazione Usa è anche quello di Junaid Ismail Dockrat, cugino di Farhad, accusato di reclutare sudafricani e poi inviarli in Pakistan ai fini dell’indottrinamento qaedista tramite il contatto con Hamza Rabi’a (noto responsabile di al-Qaeda). Se questi sono i due nomi più eclatanti, non si possono dimenticare quelli dei terroristi stranieri che sono stati arrestati sul territorio (ad esempio Khalfan Khamis Mohamed, arrestato a Cape Town nel 1999 per gli attentati alle ambasciate americane in Tanzania e Kenya nel 1998) e dei militanti del network radicale trovati in possesso di passaporti sudafricani all’estero (come per es. Ihsan Garnaoui arrestato nel gennaio 2003 all’arrivo in Germania; Ibrahim Tantoush arrestato in Indonesia nel novembre 2003; Haroon Rashid Aswat arrestato in Zambia nel luglio 2005; Mohammed Gulzar arrestato in Gran Bretagna nel luglio 2006 e accusato di aver pianificato atti di terrorismo il mese successivo; Rashid Rauf, arrestato dalle autorità pakistane nell’agosto 2006, Fazul Abdullah Muhammad ucciso a Mogadiscio nel giugno 2011). Per arginare la pratica della vendita di documenti (un passaporto falso costa all’incirca 80 dollari americani), dal 2009 sono state introdotte delle nuove regole al Dipartimento competente del Ministero degli Interni,sono state rafforzate le misure per contrastare le pratiche di corruttela dei pubblici funzionari e sono state avviate collaborazioni sia con la polizia che con i servizi di intelligence. Nell’ultimo quarantennio, gli elementi radicali islamici sudafricani hanno coagulato le loro forze 233 Si ritiene che Farhad abbia dato più di 400.000 rand nel 2001 (corrispondenti a 62.900 dollari americani) ad un rappresentante talebano del Pakistan, cifra che è stata poi trasmessa all’al-Akhtar Trust. E’ stato inoltre messo in prigione in Gambia per sospette attività terroristiche. intorno ad alcune organizzazioni specifiche nate come punto d’incontro di .interessi religiosi, culturali e politici. Nel dettaglio si ricordano: - Muslim Youth Movement of South Africa (Mym): nato nel dicembre 1970 a Durban come organizzazione per lo più culturale che risponde ad un bisogno dei giovani mussulmani di esprimere la loro personalità e crescere all’interno della società sudafricana. I primi responsabili sono Abu Bakr Mahomed (presidente), Mahmud Moosa (vice presidente), Moosa Randeree (segretario del movimento). Dal 1974 inizia a trasmettere il proprio messaggio attraverso la pubblicazione mensile «Al Qalam». Nel 1986 gli uffici vengono trasferiti a Cape Town. In questo periodo inizia la seconda fase in cui il Mym si propone di partecipare alla lotta politica. Non molto attivo tra il 1994 ed i primi anni 2000, solo dal 2010 gli organizzatori hanno pensato ad una ristrutturazione e a tal fine hanno organizzato un evento per rilanciare le attività. - Qibla Mass Movement: movimento anti-apartheid, creato negli anni Ottanta e strettamente collegato agli ideali della rivoluzione iraniana. Qibla ha promosso tre progetti: la formazione dell’Islamic Unity Convention (Iuc) nel 1994, organizzazione in cui hanno partecipato duecentocinquanta gruppi; la preparazione delle componenti più estremiste del Pagad (ad esempio la G-Force); il controllo di «Radio 786» della Islamic Unity Convention; Tra gli esponenti di spicco, si distingue la figura di Achmad Cassiem riconosciuto da alcuni come il leader indiscusso di Qibla. Presidente dell’ Islamic Unity Convention, Cassiem ha combattuto l’apartheid da quando aveva quindici anni e a diciassette anni è stato imprigionato a Robben Island. - People Against Gangsterism and Drugs (Pagad) Due sono gli elementi che spingono alla nascita del Pagad nel dicembre del 1995: il clima ideologico creato da Qibla e l’alto livello di criminalità nel Western Cape. La studiosa Anneli Botha, individua tre anime all’interno del gruppo: 1) “populisti moderati e cittadini preoccupati”; 2) “estremisti islamici ed infiltrati di Qibla”; 3) “trafficanti di droga interessati ad utilizzare il Pagad come copertura per proteggere i loro affari”. Nei primi anni il Pagad si è mosso sul fronte anticrimine, tra il 1998-1999 ha diretto la sua attenzione verso il personale degli uffici preposti alla sicurezza, e nel 2000 ha colpito ristorante e luoghi pubblici di ritrovo. - People against Prostitutes and Sodomites (Papas) - Muslims against global oppression (Mago) Organizzazione radicale islamica, che tra i suoi responsabili ha annoverato Moain Achmad. Il gruppo, ritenuto responsabile dell’attentato al Planet Hollywood di Cape Town nell’agosto 1998, si è sempre professato contrario nei confronti della politica americana e britannica verso il mondo islamico. In occasione della visita del primo ministro Blair in Sud Africa nel gennaio 1999, un suo esponente aveva minacciato un’operazione terroristica che poi non è stata portata a termine. - Muslims against illegitimate leaders (MAIL) - Al Jamah Formazione politica nata nel 2007, con l’intenzione di supportare gli interessi musulmani in Sud Africa e promuovere la sharia. Nelle elezioni del 2009 ha ottenuto lo 0,15% di preferenze. Interessante notare la posizione di Al Jamah rispetto alle vicende libiche del febbraio-settembre 2011. Il partito ha espresso una totale solidarietà nei confronti del leader Muammar Gheddafi, uomo che si è distinto per il suo attivismo nei confronti delle problematiche continentali. Nel mese di agosto, Al Jamah ha pubblicato sul sito un avvertimento rispetto all’eventuale uccisione del colonnello, percepita come una macchia nei confronti di tutti gli africani. Mentre alcuni esperti ed operatori dell’intelligence hanno sottolineato la possibilità di una presenza strutturata di al-Qaeda in Sud Africa, tracciando un percorso storico ed un’evoluzione del processo, altri hanno rivelato l’inconsistenza di alcuni elementi e non li hanno considerati segnali attendibili234. Per quanto concerne le amministrazioni, il timore palesato in diverse occasioni era quello dell’inserimento del network qaedista nel tessuto sociale sudafricano (per il reperimento di materiale e di adepti, ma anche per transazioni finanziarie). In tale operazione, i seguaci di binLaden avrebbero abilmente sfruttato l’insoddisfazione delle classi più disagiate, le difficoltà per l’inserimento dei giovani nel mondo lavorativo e il senso di esclusione della popolazione locale convertita all’islam dalle agenzie specializzate e dalle charities finanziate dai paesi del Golfo. In ciò sarebbero stati favoriti dalla presenza di strutture come il Pagad e Qiblah nate spontaneamente per rispondere a problemi locali e volte a richiamare ad una correttezza dei costumi, non timorose di attaccare obiettivi occidentali in loco. In occasione dei campionati mondiali di calcio del 2010 si è molto temuto per operazioni contro obiettivi sensibili e contro strutture sportive predisposte per gli eventi. Per prevenire vere e proprie stragi sono stati approntati dei mezzi di controllo su tutta l’area, è stata potenziata la sorveglianza ed il personale locale è stato affiancato da team stranieri. In particolare, è stato fatto un training a quarantaquattromila agenti di polizia aggiuntivi, l’Interpol ha inviato duecento esperti di supporto e sono stati spesi 90 milioni di dollari americani per nuovi equipaggiamenti. I terroristi hanno optato per una strategia out of area, come dimostrato dal duplice attentato a Kampala (Uganda) durante la finale dei mondiali di calcio l’11 luglio 2010. Rivendicati dal movimento radicale somalo degli al-Shabaab, i kamikaze hanno causato la morte di settantaquattro persone ed il ferimento di decine di persone. In tale modo è stato dato un duplice segnale: è stato punito lo sforzo del governo ugandese di assistenza di truppe in ambito Amisom ed è stata dimostrata una capacità di azione indiretta. Ad oggi i problemi del Sud Africa sembrano concentrarsi maggiormente su una dicotomia interna al partito dell’African National Congress (Anc). L’attenzione è tutta puntata sulla contrapposizione tra il presidente in carica Jacob Zuma ed il leader della Lega giovanile dell’Anc, Julius Malema. L’atteggiamento populista di quest’ultimo, la promozione di politiche di nazionalizzazione sembrano focalizzare l’attenzione dei locali. E’ da vedere se proprio nella distrazione generale, possa crearsi un terreno fertile per la proliferazione di nuove cellule utilizzabili in operazioni in altri teatri continentali. In tal senso, i partner americani ed europei, attraverso Africom oppure il finanziamento della formazione delle forze di sicurezza locali e regionali, tramite la brigata regionale Sadcbrig (in ambito African Standby Force) dovrebbero continuare ad accompagnare il processo di crescita del management locale della sicurezza. 2. Inserita in un punto strategico dell’Oceano Indiano in cui si raccordano le linee di comunicazione del mondo asiatico con quelle dello spazio africano, l’isola del Madagascar presenta un quadro della sicurezza molto particolare. Il rischio di instabilità è alto dal punto di vista interno, a causa della 234 Tra i primi ci si riferisce ad Anneli Botha e Hussein Solomon, tra i secondi il riferimento è ad Annette Hubschle e Iqbal Jhazbhay. crisi politica scaturita con l’estromissione dal potere di Marc Ravalomanana nel marzo 2009 e la successiva ascesa di Andry Rajoelina. Tale “sconvolgimento politico” ha comportato un peggioramento della situazione economica e delle condizioni di vita locali, un tasso crescente di criminalità diffusa, un controllo ridotto da parte dei servizi dell’ordine e della sicurezza. Sebbene sia bassa la minaccia diretta del terrorismo internazionale nel paese, si teme la debolezza dell’autorità centrale nel controllare transazioni finanziarie sospette, come anche la sua incapacità a vigilare su commerci illegali di vario tipo (in particolare narcotraffico e gemme preziose). Grave si è dimostrata in diverse occasioni l’incompetenza delle forze addette alla sorveglianza di personaggi sospettati di avere un collegamento con al-Qaeda, ricercati dall’Interpol, dalla Cia e dalle agenzie di intelligence europee. La creazione di strutture specifiche presso il ministero degli Interni ed il varo nel luglio 2008 dell’unità specializzata nel contrasto al riciclaggio di denaro, Samifin (Sampan-draharaha Malagasy Iadiana amin'ny Famotsiam-bola)235 non hanno portato risultati concreti perché limitati dalla riduzione del budget nazionale. Anche se in Madagascar non sembra sussistere il pericolo del radicalismo in quanto tale, né la percentuale ridotta della popolazione che professa la religione islamica (7% su un totale di 21 milioni di abitanti) dimostra tendenze estremistiche, tuttavia esiste un “rischio indiretto”. Due eventi hanno infatti destato qualche sospetto per possibili connessioni con il terrorismo internazionale. Il primo riguarda l’uccisione di Muhammad Jamal Khalifa (cognato di Osama bin-Laden) il 30 gennaio 2007 nel villaggio di Sakaraha ed il secondo si riferisce alla notizia pubblicata sul quotidiano «Midi Madagasikara» di Antananarivo nel febbraio dello stesso anno, circa la “possibile presenza” di Fazul Abdullah Muhammad236 nella città di Majunga (nord-ovest dell’isola malgascia). Poco chiare sono apparse le circostanze dell’omicidio di Khalifa: il fatto che nella casa dove viveva sono scomparsi gioielli, computer e denaro, che l’operazione è stata portata a termine da un commando di venti-trenta uomini, che proprio pochi giorni prima della sua morte l’Interpol avesse inoltrato notizie sul suo conto ai servizi americani, ha indotto a credere che l’azione fosse mirata e che ci fosse un movente ben preciso. Amico di bin- Laden dal 1977 (i due si erano conosciuti mentre frequentavano l’università di Jedda); impegnato in Afghanistan per combattere l’invasione sovietica (negli anni Ottanta); conosciuto dalle autorità giudiziarie della California, della Giordania, dell’Arabia Saudita e delle Filippine per coinvolgimenti con gruppi terroristici; collegato con pericolosi criminali internazionali (oltre a bin-Laden, si fanno i nomi di Ramzi Youssef e Khaled Sheikh Mohammed)237, considerato il finanziatore di gruppi come Abu Sayyaf (gruppo separatista islamico operante nelle Filippine), coinvolto nel commercio di pietre preziose in Madagascar, Kalifa di certo continuava ad agire nell’ombra nonostante si fosse – almeno apparentemente – distanziato dalla linea dello “sceicco del Terrore”. La notizia della sua uccisione ha indotto a credere che il Madagascar rientrasse tra i paesi utilizzati da al-Qaeda per promuovere operazioni illecite nell’ambito del commercio di rubini e smeraldi, così come i paesi del West Africa sono stati utilizzati per il traffico di diamanti. La presenza segnalata di Fazul Abdullah Muhammad – uno dei terroristi più ricercati a livello 235 Per informazioni sulla Samifin: http://www.samifin.gov.mg/samifin/ 236 Fazul Abdullah Muhammad membro di al-Qaeda operante nell’area orientale africana, è stato ucciso nel giugno 2011. 237 Si ricorda che Ramzi Youssef è stato coinvolto nel primo attentato al World Trade Center nel febbraio del 1993 in cui morirono sei persone e ne rimasero ferite un migliaio; Khaled Shik Mohammed è considerato una delle menti degli attentati dell’11 settembre 2001 alle Twin Towers. internazionale, protagonista delle operazioni nelle regioni orientali africane – in un villaggio sperduto dell’isola, a distanza di pochi giorni dall’assassinio di Kalifa, ha fatto inoltre pensare che ci fosse un possibile raccordo tra i due esponenti del gruppo terroristico; che il Madagascar costituisse un punto per il reclutamento di giovani simpatizzanti con la causa jihadista, pronti ad andare a combattere in Somalia; che a nord e a sud della capitale, Antananarivo, vi fosse una struttura capace di garantire il libero movimento di esponenti qaedisti. 3. Secondo i dati riportati dal World Factbook della Cia238, il 13% della popolazione è mussulmana su un totale di quasi sedici milioni di abitanti. La nascita della comunità si fa risalire ai movimenti dei commercianti arabi provenienti dalle coste orientali che stabilirono un controllo sulle aree del Lago Malawi agli inizi del secolo XIX ed influenzarono le popolazioni locali (ad esempio la comunità dei Yao, posizionata nella zona meridionale del lago). Lo studioso David Bone (docente di Università del Malawi, Dipartimento di studi religiosi)239 riporta che ulteriori stimoli si ebbero con la diffusione dei principi delle confraternite sufi della Qadiriyya e della Shadhiliyya, introdotte nei primi anni del secolo successivo. In tale contesto, un contributo determinante per lo stabilimento dell’islam è stato dato dagli asiatici che si insediarono man mano sul territorio e che promossero la costruzione di moschee e madrase. Nonostante l’impegno, le comunità islamiche non fecero un grande numero di adepti (sulla base di un censimento del 1931, i mussulmani registrati erano l’8,4%), ostacolate dall’attività di missionari protestanti che proponevano scuole e davano nozioni di inglese, permettendo in tal modo alle popolazioni un lento e graduale avvicinamento alla presenza coloniale britannica.240 L’avvento dell’indipendenza nel 1964 portò cambiamenti profondi nel Malawi, primo fra tutti la fine “del matrimonio tra educazione e religione”, fortemente voluto da quello che sarebbe divenuto il protagonista per un trentennio della scena politica nazionale, Kamuzu Banda 241, leader del Malawi Congress Party, Mcp. Nonostante il controllo ferreo esercitato dall’esecutivo, proprio in questo momento i giovani mussulmani iniziarono un lento processo che avrebbe portato al revival islamico degli anni Ottanta. La creazione della Muslim Association of Malawi (Mam), sponsorizzata dal Sud Africa e dai mussulmani asiatici, promosse la creazione di nuove moschee e borse di studio per giovani credenti. Ciò favorì il contatto diretto con le comunità religiose del Sudan, Pakistan e Arabia Saudita, ma soprattutto l’accostamento all’ortodossia islamica. 238 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mi.html 239 D.Bone, Malawi’s Muslim Communities in their Local and Global Context, http://www.sharia-in-africa.net/pages/publications/malawis-muslim-communities-in-their-local-and-globalcontext.php 240 Si ricorda che intorno al 1870 iniziarono attività di missionari scozzesi. Il primo console britannico inviato nell’area risale al 1883 e gradualmente da tale data iniziò il controllo della grande potenza europea. Nel 1889 venne formato lo Shire Highlands Protectorate e nel 1891 venne creato il British Central African Protectorate. 241 Si ricorda che Hastings Kamuzu Banda fu Primo Ministro dal 1964 al 1966 e poi Capo dello Stato dal 1966 al 1994. Banda instaurò un regime autoritario e promosse un controllo vigile di tutte le attività dei musulmani ed i contatti con paesi islamici. La partnership della Mam con l’African Muslims Agency (Ama, l’organizzazione caritatevole con sede in Kuwait, volta alla promozione dell’islam attraverso gli insegnamenti del Corano) 242 portò una nuova consapevolezza delle comunità islamiche ma anche una diversa loro percezione da parte degli altri gruppi presenti sul territorio. La costruzione di nuove moschee e scuole, la pubblicazione di documenti e testi sacri in lingua inglese o dialetto locale colse di sorpresa tutta la collettività del Malawi. Esponenti politici e rappresentanti religiosi guardarono con sospetto questa nuova consapevolezza e assertività da parte della comunità islamica. Anche i membri della confraternita della Qadiriyya espressero il loro timore, poiché vedevano messa in pericolo la loro posizione a causa dei giovani riformisti. L’elezione di un presidente mussulmano, Elson Bakili Muluzi (rappresentante dello United Democratic Front, Udf), nel 1994 mise fine ad anni di cattiva gestione e registrò inevitabilmente un rafforzamento della comunità islamica, anche se la collettività cristiana restava predominante. Un segnale di apertura venne dato, tra l’altro, dal lancio di un mensile islamico, «Al Muslim» nonché dalla promozione della Qadiriyya Muslim Association of Malawi e di gruppi finanziati dall’estero che miravano a promuovere progetti educativi. A questa prima fase della presidenza Muluzi, risalgono i contatti avviati con la Libia, la Malesia, il Kuwait, gli Emirati Arabi Uniti e il Sudan che si concretizzarono in scambi di visite ed elargizione di fondi da parte dei ricchi donatori del Golfo (il riferimento è al prestito di 315 milioni da parte del Kuwait Development Fund). David Bone sottolinea quattro “incidenti” avvenuti negli anni della presidenza Muluzi (1994-2004) che coinvolsero la comunità islamica del Malawi, come soggetto attivo o passivo. Il primo avvenne nell’agosto 1998 quando la Muslim Association of Malawi promosse una fatwa contro ogni sorta “di propaganda anti-islamica, nei confronti del governo, dei partiti, dei media, dei gruppi della società civile e di tutte le moschee” […] volta a promuovere un “early warning contro ciò che i suoi autori percepivano come una diffamazione continua e uno stereotipo negativo dell’islam e della comunità mussulmana da parte di oppositori politici e di buona parte della stampa”243. Il secondo incidente riguarda la campagna elettorale del 1999, in cui si verificarono degli attacchi a delle moschee nel nord del Malawi e vennero rase al suolo proprietà nel sud del paese: la mancanza di una risposta chiara da parte della polizia e la reazione poco partecipe della chiesa locale comportò un senso di frustrazione da parte della comunità islamica che si sentì colpita e non adeguatamente protetta dallo stato. Il terzo episodio in cui i mussulmani si sentirono “marginalizzati” coincise con il tentativo di cambiare i testi scolastici della scuola superiore focalizzati sullo studio della Bibbia con studi riguardanti le religioni principali del paese, vale a dire cristianesimo, islam e religioni tradizionali africane. Sebbene l’iniziativa fosse stata avviata nel 1978 sotto la presidenza Banda, il fatto che il ministero dell’Educazione fosse gestito da un rappresentane mussulmano indusse la comunità cristiana a credere in una cospirazione e a reagire in modo così forte da spingere il presidente Muluzi ad abbandonare il progetto. Tale scelta accrebbe il senso di sfiducia, di impotenza e di esclusione da parte dei credenti islamici. Il quarto evento che coinvolse la comunità mussulmana del Malawi rientra nella war on terror promossa dagli Stati Uniti dopo l’11 settembre 2001. Il 22 giugno 2003, nell’ambito di 242 Il fondatore dell’Ama è Abd al-Rahman Hamoud al-Sumait . Dopo aver condotto studi medici a Baghdad e Liverpool è stato molto attivo nella promozione di associazioni specialistiche in Canada, Kuwait, Zanzibar e Kenya. Avendo riscontrato nei Fratelli Mussulmani dell’area sub sahariana una scarsa conoscenza del Corano e dell’ortodossia islamica, Al-Sumait ha focalizzato l’attenzione proprio su tale area. La sua linea è proposta nel documento The Relief Propagation Organizations (Direct Aid International – African Muslim Agency) (al-Mu’asasat al-Khayriyyah alDa’wiyyah: Jam'iyyat al-Awn al-Mubashir – Lajnat Muslimi Ifriqya). 243 David Bone, op. cit. un’operazione congiunta della Cia e dell’intelligence nazionale vennero arrestati a Blantyre (nel sud del Malawi): Fahad Al Bahli (di nazionalità saudita, direttore della succursale malawiana del Registered Trustees of the Prince Sultan Bin Aziz Special Committee on Relief), Ibrahim Habaci (di nazionalità turca, direttore esecutivo della Bedir International High School), Arif Ulusam (di nazionalità turca, proprietario del ristorante Take Away), Mahmud Sardar Issa (sudanese, direttore dell’Islamic Zakaat Fund), Khalifa Abdul Hussein (kenyota, insegnante nella locale Islamic Mission) con l’accusa di essere coinvolti nel finanziamento di operazioni di al-Qaeda nel continente. L’operazione venne giustificata con degli warnings da parte di addetti alla sicurezza di Stati Uniti e Gran Bretagna secondo cui sarebbero state imminenti delle operazioni terroristiche nell’area orientale africana. In quell’occasione la stampa locale ricordò che Herman Jay Cohen (assistant secretary alle questioni africane tra il 1989 ed il 1993) nell’ambito del programma Straight Talk Africa di «Voice of America Tv» il giorno dopo gli attacchi alle Twin Towers aveva accusato il governo di Lilongwe di aver garantito “un passaggio sicuro ed il tappeto rosso” agli autori degli assalti alle ambasciate americane in Kenya e Tanzania del 1998. I cinque arresti e la poca chiarezza sull’intera gestione dell’evento causarono la protesta della comunità islamica che accusò il proprio governo di aver ceduto a pressioni americane e di aver consegnato gli uomini catturati sul proprio territorio alla Cia, biasimando contemporaneamente la debolezza della Muslim Associaton of Malawi per non saper proteggere i credenti islamici. L’intervento della polizia che seguì nei giorni successivi represse il dissenso con gas lacrimogeni e metodi violenti. Alla fine di luglio venne data notizia della deportazione dei cinque prigionieri in Zimbabwe e poi in Sudan dove vennero rilasciati non essendo state riscontrate prove a loro carico. In tale delicato frangente, si sovrapposero le dichiarazioni ufficiali: il presidente Muluzi in un primo momento esaltò il contributo del proprio paese alla war on terror e parlò di un’operazione congiunta con Washington, poco dopo l’ambasciatore americano Roger Meece negò un coinvolgimento del proprio governo nel trasferimento dei cinque sospetti. Da quanto riportato brevemente si deduce che la comunità islamica del Malawi è rimasta isolata per molto tempo sia dalla famiglia mussulmana nel suo complesso sia dal processo nazionale, a causa di una molteplicità di fattori: certamente per difficoltà di comunicazione ma anche per aspetti tipici del contesto nazionale del Malawi. In questo ultimo secolo, i mussulmani locali si sono sentiti marginalizzati – se non ostracizzati – dalla maggioranza cristiana in diverse occasioni. Ciò li ha portati talvolta a reagire con forza e a rimarcare nelle piazze il proprio dissenso. A parte le dichiarazioni dell’assistant secretary americano Herman Jay Cohen e l’arresto dei cinque stranieri sospettati di essere collegati al network di al-Qaeda, nel giugno 2003 (poi rilasciati a distanza di un mese), ha recentemente destato sospetto una notizia apparsa sul sito di «Nyasaleaks.com» il 4 settembre 2011 244. Secondo quanto appreso da un cablogramma ufficiale, nel campo rifugiati di Dzaleka in Malawi tra i rifugiati somali si sarebbe nascosto almeno un membro del gruppo terrorista somalo di al-Shabaab. Dopo un primo tentativo di trasferimento in Etiopia, i rifugiati sono stati trasferiti in Tanzania. Tale circostanza, da un lato dimostra che i terroristi somali cercano di confondersi tra le folle di disperati che cercano rifugio in altri paesi africani, dall’altro evidenzia l’allerta delle autorità di Lilongwe su possibili movimenti interni di esponenti radicali e la disponibilità a partecipare alla war on terror internazionale. È arduo tuttavia interpretare questi segnali e trarne come conseguenza a senso unico una connessione tra il Malawi ed il terrorismo internazionale di matrice islamica. Le stesse proteste del 20-21 luglio 2011 a Blantyre e Mzuzu, che hanno indotto taluni osservatori a 244 http://www.nyasaleaks.com/2011/09/04/the-malawi-government-might-have-detained-a-person-linked-to-thenotorious-al-shabab-somali-terrorist-group-according-to-a-leaked-cable/ parlare di una versione nazionale della “primavera araba”, non sono il frutto di istanze radicali bensì l’espressione di un malcontento generale nei confronti del presidente Bingu Wa Mutharika 245, della politica economica del suo governo, del deterioramento delle condizioni di vita e della crescente repressione politica. Le ultime manifestazioni sono state represse violentemente dalle forze dell’ordine 246, autorizzate dal capo dello stato a “utilizzare qualsiasi misura per reprimere i dimostranti”: ciò indicherebbe che non è possibile – almeno nel breve periodo – una concertazione, o quanto meno, una dialettica tra le forze sociali ed il governo centrale del Malawi. Bibliografia American Foreign Policy Council’s, South Africa, «World Almanac of Islamism», http://almanac.afpc.org/South-Africa. Bone D, Malawi’s Muslim Communities in their Local and Global Context , «Sharia Debates in Africa», http://www.sharia-in-africa.net/pages/publications/malawis-muslim-communities-intheir-local-and-global-context.php https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mi.html A member of Al Shabab Somali terrorist group might have been detained in Malawi, «Nyasaleaks», http://www.nyasaleaks.com/2011/09/04/the-malawi-government-might-have-detained-aperson-linked-to-the-notorious-al-shabab-somali-terrorist-group-according-to-a-leaked-cable/ The World Factbook Cia, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ M. Terdman, Al-Qaeda Inroads in Southern Africa, Global Research in International Affairs (Gloria) Center , The project for the research of islamist movements (Prism), African Occasional Papers , Volume 2 (2008), n.1, marzo 2008), http://www.e-prism.org/ 245 Il presidente Bingu Wa Mutharika al potere dal 2004. Inizialmente apprezzato dalla comunità internazionale per l’accorta politica agricola che aveva portato buoni risultati in Malawi, in questi ultimi anni è stato fortemente criticato per la poca trasparenza della gestione e per i metodi autoreferenziali, tanto dai donors occidentali che dagli operatori interni. 246 Secondo quanto riportato dalla stampa locale, negli scontri che sono seguiti nel luglio 2011 ci sono stati duecentocinquanta arresti, quarantaquattro feriti e diciotto vittime. M. Terdman, Factors Facilitating the Rise of Radical Islamism and Terrorism in Sub-Saharan Africa, Global Research in International Affairs (Gloria) Center , The project for the research of islamist movements (Prism), Volume 1 (2007), Number 1, Marzo 2007, http://www.eprism.org/ M. Terdman M., Islam in Africa newsletter, Global Research in International Affairs (Gloria) Center , The project for the research of islamist movements (Prism), Volume 1 (2006), Number 3 , Luglio 2006, http://www.e-prism.org/ Solomon H, Playing Ostrich: Lessons Learned from South Africa’s Response to Terrorism, «Africa Security Brief», Gennaio 2011. Botha A., Why al-Qa’eda seems to prefer South African passports, International Crime in Africa Programme, Iss Pretoria Office , http://www.polity.org.za/ , Giugno 2011. Botha A., “Pagad: a case study of radical Islam in South Africa, «Terrorism Monitor», vol. 3 issue 17, 14 settembre 2005. Szrom C., Does al Qaeda Threaten the World Cup? Assessment, Context, and Implications for Understanding of the al Qaeda Network”, http://www.criticalthreats.org/africa/does-al-qaedathreaten-world-cup-assessment-context-june-7-2010 , 7 giugno 2010. Holt A. , South Africa in the war on terror, «Terrorism Monitor», Volume: 2 Issue: 23, 1 dicembre 2004. Schmidt M. Islamic terror is not a problem for South Africa – an interview of Iqbal Jhazbhay Saturday Star, November 2004, http://www.iol.co.za/news/politics/islamic-terror-is-not-aproblem-for-sa-1.227451 Firsing S. South Africa’s role in the United States-led war against Islamic extremism, 23.07.2011, http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/07/23/south-africas-role-in-the-united-states-ledwar-against-islamic-extremism/ D. Hanson, Al Qaeda in South Africa, 26 maggio, 2007, http://www.americanthinker.com/2007/05/alqaeda_in_south_africa.html Forest James J.F., Al Qaeda’s Influence in Sub-Saharan Africa: myths, realities and possibilities, in Perspectives on terrorism- A journal of the Terrorism Research Initiative, September 2011, vol 5, issues 3-4 , http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot «The Star Online», http://www.iol.co.za/the-star «Sabc 3 Tv», http://www.sabc3.co.za/ «Sapa», http://www.sapa.co.za/ «The Sunday Independent», http://www.iol.co.za/sundayindependent «Voice of the Cape Online», http://www.vocfm.co.za «Al Jamah», http://aljama.co.za/ TABELLA “Presenza di credenti mussulmani in Africa” PAESE NORD AFRICA Algeria POPOLAZIONE TOTALE APPARTENENZA RELIGIOSA 34.994.937 (Luglio 2011 stime) Mussulmani Sunniti (religione di stato) 99%, Cristiani ed ebrei 1% Egitto 82.079.636 (Luglio 2011 stime) Mussulmani (maggior parte Sunniti) 90%, Copti 9%, altri Cristiani 1% Libia 6.597.960 (Luglio 2011 stime) Mussulmani Sunniti (ufficiale) 97%, altri 3% Marocco 31.968.361 (Luglio 2011 stime) Mussulmani 98,7%, Cristiani 1,1%, Ebrei 0,2% Mauritania 3.281.634 (Luglio 2011 stime) Mussulmani 100% Tunisia 10.629.186 (Luglio 2011 stime) Mussulmani 98%, Cristiani 1%, Ebrei e altri1% AFRICA OCCIDENTALE Benin 9.325.032 (Luglio 2011 stime) Cristiani 42,8% (di cui Cattolici 27,1%, Metodisti 3,2%, Protestanti 2,2%, altro 5,3%), Mussulmani 24,4%, altri 32,8%(2002 censimento) Burkina Faso 16.751.455 (Luglio 2011 stime) Mussulmani 60,5%, Cattolici 19%, Animisti 15,3%, Protestanti 4,2%, altro 0,6%, niente 0,4% Capo Verde 516.100 (Luglio 2011 stime) Cattolici e Protestanti Costa d’Avorio 21.504.162 (Luglio 2011 stime) Mussulmani 38,6%, Cristiani 32,8%, indigeni 11,9%, niente 16,7% (2008 stime) note: la maggior parte degli stranieri (lavoratori migranti) sono Mussulmani (70%) e Cristiani (20%) Gambia 1.797.860 (Luglio 2011 stime) Mussulmani 90%, Cristiani 8%, credenze locali 2% Ghana 24.791.073 (Luglio 2011 stime) Cristiani 68,8% (Carismatici/Pentecostali 24,1%, Protestanti 18,6%, Cattolici 15,1%, altro 11%), Mussulmani 15,9%, tradizionale 8,5%, altro 0,7%, niente 6,1% (2000 censimento) Guinea 10.601.009 (Luglio 2011 stime) Mussulmani 85%, Cristiani 8%, credenze locali 7% Guinea Bissau 1.596.677 (Luglio 2011 stime) Mussulmani 50%, credenze locali 40%, Cristiani 10% Liberia 3.786.764 (Luglio 2011 stime) Mali 14.159.904 (Luglio 2011 stime) Cristiani 85,6%, Mussulmani 12,2%, Tradizionale 0,6%, altro 0.2%, non dichiara 1,4% (2008 censimento) Mussulmani 90%, Cristiani 1%, credenze locali 9% Niger 16.468.886 (Luglio 2011 stime) Mussulmani 80%, altro 20% (incluso credenze locali e cristiani) Nigeria 155.215.573 (Luglio 2011 stime) Mussulmani 50%, Cristiani 40%, credenze locali 10% Senegal 12.643.799 (Luglio 2011 stime) Mussulmani 94%, Cristiani 5%, credenze locali 1% Sierra Leone 5.363.669 (Luglio 2011 stime) Mussulmani 60%, Cristiani 10%, credenze locali 30% Togo 6.771.993 (Luglio 2011 stime) Cristiani 29%, Mussulmani 20%, credenze locali 51% AFRICA CENTRALE Cameroun 19.711.291 (Luglio 2011 stime) Credenze locali 40%, Cristiani 40%, Mussulmani 20% Repubblica Centrafricana 4.950.027 (Luglio 2011 stime) Credenze locali 35%, Protestanti 25%, Cattolici 25%, Mussulmani 15% Congo 4.243.929 (Luglio 2011 stime) Cristiani 50%, Animisti 48%, Mussulmani 2% Gabon 1.576.665 (Luglio 2011 stime) Cristiani 55%-75%, Animisti, Mussulmani meno di 1% Guinea Equatoriale 668.225 (Luglio 2011 stime) nominalmente Cristiani, di cui predominanti i Cattolici, pratiche pagane Repubblica Democratica del Congo 71.712.867 (Luglio 2011 stime) Sao Tomé e Principe 179.506(Luglio 2011 stime) Cattolici 50%, Protestanti 20%, Kimbanguisti 10%, Mussulmani 10%, altro 10% (incluso sette sincretiche e credenze locali) Cattolici 70,3%, Evangelici 3,4%, Avventisti 1,8%, altro 5.1%, niente 19,4% (2001 censimento) Tchad 10.758.945(Luglio 2011 stime) Mussulmani 53.1%, Cattolici 20,1%, Protestanti 14,2%, animisti 7,3%, altro 0,5%, sconosciuto 1,7%, atei 3,1% (1993 censimento) AFRICA ORIENTALE Burundi 10.216.190 (Luglio 2011 stime) Cristiani 67% (di cui Cattolici 62%, Protestanti 5%), credenze locali 23%, Mussulmani 10% Djibouti 757.074 (Luglio 2011 stime) Mussulmani 94%, Cristiani 6% Eritrea 5.939.484 (Luglio 2011 stime) Mussulmani, Copti, Cattolici, Protestanti Etiopia 90.873.739 (Luglio 2011 stime) Ortodossi 43,5%, Mussulmani 33,9%, Protestanti 18,6%, tradizionali 2,6%, Cattolici 0,7%, altro 0.7% (2007 Censimento) Kenya 41.070.934 (Luglio 2011 stime) Protestanti 45%, Cattolici 33%, Mussulmani 10%, credenze locali 10%, altro 2% nota: gran parte di kenyoti sono cristiani, ma sono numerosi quelli che seguono religione islamica e credenze locali Rwanda 11.370.425 (Luglio 2011 stime) Somalia 9.925.640 (Luglio 2011 stime) Cattolici 56,5%, Protestanti 26%, Avventisti 11,1%, Mussulmani 4,6%, credenze locali 0,1%, niente 1.7% (2001) Mussulmani Sunniti Sudan 45.047.502 note: compresa la popolazione del Sud Sudan (pari a 8.260.490); (Luglio 2011 stime) Mussulmani Sunniti, piccole minoranze cristiane Sud Sudan 8.260.490 (secondo censimento controverso del 2008; numero reale potrebbe essere di 9,28 milioni) (2008) Animisti, Cristiani Tanzania 42.746.620 (Luglio 2011 stime) Terraferma - Cristiani 30%, Mussulmani 35%, credenze locali 35%; Zanzibar – più del 99 % Mussulmani Uganda 34.612.250 (Luglio 2011 stime) Cattolici 41,9%, Protestanti 42% (Anglicani 35,9%, Pentecostali 4,6%, Avventisti del Settimo Giorno 1,5%), Mussulmani 12,1%, altro 3,1%, niente 0,9% (2002 censimento) AFRICA AUSTRALE Angola 13.338.541 (Luglio 2011 stime) Credenze locali 47%, Cattolici 38%, Protestanti 15% (1998 stime) Botswana 2.065.398 (Luglio 2011 stime) Cristiani 71,6%, Badimo 6%, altro 1,4%, non specificato 0,4%, niente 20,6% (2001 censimento) Lesotho 1.924.886 (Luglio 2011 stime) Cristiani 80%, credenze locali 20% Madagascar 21.926.221 (Luglio 2011 stime) Credenze locali 52%, Cristiani 41%, Mussulmani 7% Malawi 15.879.252 (Luglio 2011 stime) Mozambico 22.948.858 (Luglio 2011 stime) Namibia 2.147.585 (Luglio 2011 stime) Cristiani 82,7%, Mussulmani 13%, altro 1,9%, niente 2,5% (2008 censimento) Cattolici 28,4%, Mussulmani 17,9%, Zionisti Cristiani 15,5%, Evangelici Pentacostali 10,9%, Anglicani 1,3%, altro 7,2%, niente 18,7% (2007 censimento) Cristiani 80%-90% (Luterani almeno il 50%), credenze locali 10%- 20% Swaziland 1.370.424 (Luglio 2011 stime) Sud Africa 49.004.031 (Luglio 2011 stime) Zambia 13.881.336 (Luglio 2011 stime) Cristiani 50%-75%, Mussulmani 24%-49%, credenze locali 1% Zimbabwe 12.084.304 (Luglio 2011 stime) Sincretici (in parte cristiani, in parte credenze locali) 50%, Cristiani 25%, credenze locali 24%, Mussulmani e altro 1% Zionisti 40% (credenze indigene mescolate con culti cristiani), Cattolici 20%, Mussulmani 10%, altro 30% (incluso Anglicani, Baha'i, Metodisti, Mormoni, Ebrei) Zionisti Cristiani 11,1%, Pentecostali/Carismatici 8,2%, Cattolici 7,1%, Metodisti 6,8%, Olandesi riformati 6,7%, Anglicani 3,8%, Mussulmani 1,5%, altri Cristiani 36%, altro 2,3%, non specificato 1,4%, niente 15,1% (2001 censimento) Fonti: Cia ,The World Factbook, 2011, https://www.cia.gov/
Scarica