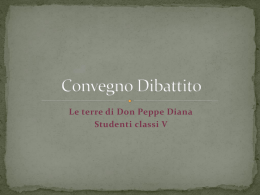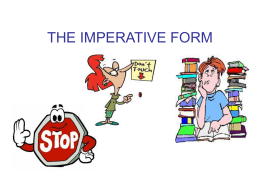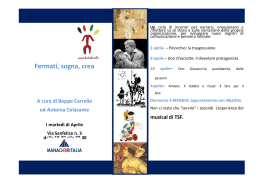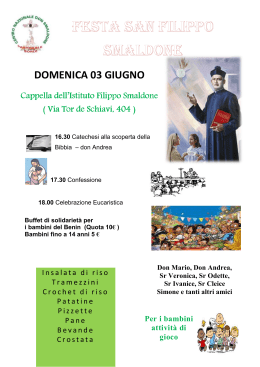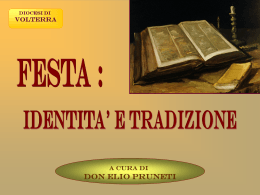Data e Ora: 21/11/09 21.55 - Pag: 49 - Pubb: 22/11/2009 - Composite Giornale di Brescia 49 Domenica 22 Novembre 2009 Cultura&Spettacoli Il vescovo di Baghdad «Il dramma? Incapaci di riconciliazione» L Rolando Anni, poi, ha ricostruito la figura di don Vender quale «prete degli sfollati», precisando, però, che dal ’45 al ’74 egli è stato per la comunità parrocchiale di Santo Spirito molto di più. Partendo dalle tracce archivistiche disseminate specie presso l’archivio parrocchiale e presso quello della Camera di Commercio bresciana, Anni ha ripercorso il periodo in cui don Vender è stato presidente della Cooperativa Edile Quartiere Sfrattati e ispiratore della Cooperativa Corale di San Vincenzo. Don Giacomo, ha sottolineato Anni, è stato animato senza sosta da carità, giustizia e speranza, tradotte nella vita di ogni giorno nella ricerca di un lavoro sicuro e di una casa per i suoi parrocchiani. A conclusione del convegno è giunta la testimonianza della ex parrocchiana di Santo Spirito Elisabetta Rietti, carica di nostalgia e struggimento. Le sue parole, ricche di emotività, non hanno fatto velo alla comprensione del personaggio e della sua opera, anzi l’hanno resa ancor più vera. a riconciliazione in Iraq «o sarà frutto di solidarietà e ragione, o non sarà». Il cammino che si prospetta è difficile nella frammentarietà del Paese ripiombato nelle contrapposizioni tribali. Mons. Jean Sleiman, vescovo di Baghdad, affida la speranza a un impegno di lungo periodo, nell’Iraq che «ha bisogno di aiuto per liberarsi di un retaggio culturale: il dramma di oggi è l’incapacità di una riconciliazione». Su questo tema mons. Sleiman è intervenuto l’altra sera ad un partecipato incontro della Cooperativa cattolico-democratica di cultura nella sala Bevilacqua dei Padri Filippini della Pace. Libanese di origine maronita, carmelitano scalzo autore di studi di spiritualità e di scienze sociali, è arcivescovo di Baghdad dei Latini dal 2001: fautore del dialogo, con il libro «Nella trappola irachena» ha lanciato un appello alla riconciliazione nazionale autodeterminata. Presentato dalla presidente della Ccdc Paola Paganuzzi, il suo intervento è stato preceduto da uno sguardo sulla situazione odierna dell’Iraq a cura di Riccardo Redaelli, docente in Cattolica e coordinatore di un programma italiano di cooperazione scientifica con il sistema universitario iracheno. I cristiani sono presenti nel Paese da tempi lontanissimi: erano un milione e 800mila negli anni ’80, oggi sono ridotti a 400mila e l’esodo continua, in questo «Paese di profughi, verso l’esterno e al suo interno». Al tempo della dittatura e delle sanzioni internazionali in Occidente «si vedeva un solo tipo di violenza». Al Qaeda ne ha fatto «una vetrina mediatica» da sfruttare, fino al 2007, quando i capi tribali sunniti hanno tolto l’appoggio all’organizzazione terroristica e gli Usa hanno rafforzato la presenza. C’è più sicurezza, ma non sono migliorate le condizioni politiche, mentre dilaga la corruzione nell’apparato statale e, dopo il passaggio del controllo militare alle forze irachene, gli attacchi sono di nuoMons. Jean Sleiman vo aumentati: «La violenza fa comodo a tanti, in vista delle elezioni di gennaio». L’Iraq ha alle spalle una storia di violenze, osserva mons. Sleiman, «il dramma dei cristiani e delle altre minoranze era già in germe: la guerra ha rimesso a fuoco la dinamica strutturale di questa società eterogenea. Il regime l’aveva gestita, ma non l’ha rinnovata. Alla sua caduta sono riapparse le tribù, come attori politici e la tribù vuol dire che non c’è persona, non c’è libertà, responsabilità, volontà di andare oltre. Il fondamentalismo in poco tempo è diventato una maniera di pensare: è il rifiuto dell’altro e la verità non ha posto». Restano «le ferite della storia, mai affrontate nella verità». Incidono gli effetti di «una modernità entrata in maniera aggressiva nella società tradizionale, che prova frustrazioni nuove». Non manca l’intelligenza, ma viene degradata a furberia, perché «la ragione non arriva ad avere il suo ruolo», mentre la religione strumentalizzata diventa fanatismo. I cristiani, presenza millenaria, hanno perso il legame con il loro Paese, si rifugiano nelle tende dei profughi. «La paura non era così grande sotto il regime - osserva il vescovo -, ma la verità era spesso impossibile e oggi c’è una riconciliazione da fare con la verità, con il coraggio, con la speranza. Con Saddam c’era ordine, ma uccideva gli animi. Impauriti sotto Saddam, i cristiani sono disincantati dopo Saddam: in certe aree hanno subito persecuzioni, in altre soffrono per la pressione psicologica, in qualche isola si coesiste, con la condivisione di gioie e dolori nei matrimoni e nei funerali. Al nord i rifugiati non riescono ad inserirsi nell’ambiente curdo, all’estero le famiglie sono divise». In questo Stato che è «un insieme di staterelli, non c’è un denominatore comune». Il primo passo dovrebbe essere l’accettazione dello Stato, come unico arbitro e detentore di armi. La riconciliazione ha bisogno di un progetto, il concetto di potere è un fatto culturale e un aiuto si può dare con gli scambi culturali. «Ci vuole pazienza», dice mons Sleiman. Elena Pala Elisabetta Nicoli DON VENDER Il «combattente» dello spirito Un convegno in Cattolica ne ha ricostruito la poliedrica biografia, dagli anni del Seminario all’impegno tra i soldati al fronte, dall’antifascismo all’azione come «parroco degli sfollati» N on lasciatevi ingannare dal titolo, «Don Giacomo Vender: fonti per una biografia». Quello organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, dall’Archivio storico della Resistenza bresciana in collaborazione con il Dipartimento di Scienze storiche e filologiche nella giornata di ieri, ospitato nella Sala della Gloria dell’ateneo di via Trieste in città, non è stato il semplice seminario riservato agli addetti ai lavori che si limita - come recita il titolo - ad illustrare le fonti archivistiche utili a ricostruire la biografia di un personaggio. È stato molto di più. Un’appassionata biografia Primo, per la «normale eccezionalità» del personaggio cui era dedicato l’incontro, don Giacomo Vender (Lovere, 1909-Brescia 1974). Seminarista e sacerdote nella relazione di Lucia Signori dell’Archivio Storico Diocesano, tenente «Cravatta azzurra» sul fonte dei Balcani e prigioniero del regime fascista tra il 1944 e il 1945 nell’intervento di Inge Botteri dell’Università Cattolica, «parroco degli sfollati» nel contributo di Rolando Anni (sempre dell’Università Cattolica), infine straordinario pastore d’anime ed eccezionale «comunicatore» del Vangelo nella rievocazione commossa e commovente di Elisabetta Rietti della Parrocchia di Santo Spirito. Secondo, per il respiro dei vari interventi. I relatori hanno, infatti, mostrato al vivo alcuni modi di fare storia trasmettendo una contagiosa passione di ricerca che ha avuto il suo punto d’avvio in un imprescindibile scavo archivistico, sistematico e approfondito, come ha sottolineato il professor Mario Taccolini, moderatore del seminario. Passione si diceva, perché i vari relatori hanno sì trattato la materia con il distacco e il rigore propri del ricercatore professionale ma, al tempo stesso - per riprendere un’espressione di Henri Marrou - con un evi- volontà. Un sacerdote disponibile nei confronti dente «amor platonico», senza il quale il biogra- dei commilitoni al fronte, forse un po’ «ostinafo mai riuscirebbe a capire le ragioni profonde to» - come don Giacomo stesso si definisce del suo biografato. ma, ha sottolineato Signori, «altrettanto aperArchivio del Seminario diocesano e Archivio to e generoso all’azione dello Spirito». storico diocesano sono state le fonti da cui ha Molteplici sono stati gli archivi sondati da Inattinto Lucia Signori sviluppando alcuni «pas- ge Botteri per ricostruire gli anni della seconda saggi della vita di guerra mondiale don Vender legadella biografia di ti vuoi alla sua don Vender. La formazione in Sestudiosa ha riperminario vuoi al corso sia la storia suo essere sacerdel protagonista dote». Queste le sia le vicende affitipologie docuni di altri cappellamentarie analizni militari (sopra zate: dalla corritutte, quella di paspondenza della dre Giulio Bevilacmadre con i paqua). dri carmelitani di In particolar Adro alle lettere modo, ha illustraaccompagnatoto gli anni trascorrie di don Giovansi da don Vender ni Martinazzoli prima sul fronte di Lovere, dalle croato (tra il lupagelle scolastiglio 1940 e il giuche del ginnasio gno 1943) con il e dei successivi 73˚ Reggimento studi di teologia fanteria, le cosidai giudizi disciplidette «Cravatte nari. Infine, la corazzurre», poi sul rispondenza con fronte francese al Don Vender medaglia al valor militare e il vescovo Giacinseguito del 2˚ Regto Tredici relatigimento Cavallenel corteo per i caduti delle Fiamme Verdi va al periodo che ria (tra il giugno e corre dal seconil settembre do conflitto mondiale agli anni ’60. 1943). Don Giacomo è un giovane cappellano In questa conversazione a distanza, emergo- che non si accontenta di operare nelle retrovie, no alcuni tratti caratteristici della personalità ma vuole stare in prima linea con i suoi commidi don Vender: l’irruenza, l’esuberanza, l’impe- litoni. gno profuso nel superamento dei propri limiti, È il mediatore, ha precisato Botteri, «tra l’aula sincerità, il buon cuore, la costante forza di torità e il soldato, tra le esigenze di vita di guer- ra e quelle della vita civile tanto lontana per i soldati in trincea quanto sempre presente». È, anche, negli anni della Resistenza, l’autore dell’opuscolo «Un verso dell’inferno dantesco e lo spirito dell’inferno fascista», edito in allegato al famoso foglio clandestino «Il Ribelle» e firmato con lo pseudonimo «Sancio Empörer». Di non facile lettura né a portata di ogni lettore, l’opuscolo - ha auspicato Botteri «sarebbe da studiare con approfondita attenzione», non solo perché «contiene la lucida posizione di don Vender sul fascismo, il suo spirito combattivo e per nulla quiescente», ma anche perché restituisce allo studioso la formazione culturale e letteraria di don Giacomo. Il «prete degli sfollati» Il Lotto bresciano si fa «Capolavoro per Milano» Va in mostra al Museo diocesano ambrosiano l’Adorazione dei pastori della nostra Pinacoteca C on la sua religiosità devota e turbata, con la sua ansia di penetrazione psicologica, la sua trepidazione per gli affetti della vita domestica e per le sacre conversazioni calate nelle umili stanze, Lorenzo Lotto (Venezia 1480 ca. - Loreto 1556) fu viandante-pittore colto, irrequieto e sofisticato, coinvolto intimamente nella profonda crisi religiosa, culturale ed economica dell’Italia del primo ’500: si sottolinea talvolta anche la sua affettuosa ironia, che risponde proprio all’esigenza di una parlata più naturalistica, confidenziale, che porta ad introdurre anche nelle opere sacre, dove si preoccupò pure di «retrar poveri», certo «sermo humilis» tipico della predicazione. La grandezza di Lotto è proprio negli istanti quotidiani, fatti entrare «alla pari» in pittura, e nella capacità di interpretare i misteri della psiche, così da essere anche il vero inventore del ri- L’Adorazione dei pastori di Lotto, 1530, va a Milano tratto borghese (e celebrativo dei valori della famiglia in ritratti coniugali). Già Berenson nella monografia del 1895 rivendicò la modernità di Lotto tra colpi di luce audaci come colpi di teatro, ombre vaganti, colori preziosi come succhi d’erbe e fiori, a interpretare già non tanto l’uomo pubblico, quanto l’uomo privato, introspettivo. Lotto fu attento agli impulsi che la «devotio moderna», d’intima preghiera, aveva dettato all’evocazione dal vero nella pittura nordica, ben documentata in area veneto-padana. La confidenziale presenza di persone e cose, di moti e affetti quotidiani risalta anche nella bellissima «Adorazione dei pastori» o «Natività» della nostra Pinacoteca Tosio Martinengo (chiusa per lavori), che domani sarà presentata al Museo Diocesano di Milano, all’insegna di «Un capolavoro per Milano», a cura di Paolo Biscottini ed Elena Lucchesi Ragni, dove resterà fino al 17 gennaio (ore 10-18, chiuso lun., € 8 col museo, il martedì € 4, catalogo Silvana Editoriale, info 0289420019). Il restauro che negli anni scorsi (per le mo- stre in Pinacoteca collegate al ciclo goldiniano dello Splendore dell’arte) ha restituito la morbida tessitura di lume-colore crepuscolare del dipinto (mosso però da strepitosi acuti acidi e affilati o viceversa da tremolii delicati e sussurri cangianti), ha permesso di orientare definitivamente anche la secolare questione della datazione, ora certa per la riemersa firma «L. Lotus 1530» in basso al centro, sul bordo della cesta che accoglie il Bambino, e della destinazione a devozione privata. La scena mostra due pastori - si ipotizzano i committenti - introdotti da due angeli riccioluti a rendere omaggio a Gesù nella cesta, vegliato da Maria orante inginocchiata e da Giuseppe. Il Bambino afferra il muso dell’agnello in dono, a preconizzare la Passione evocata anche dal telaio a croce della finestra della capanna. Il dipinto è dalla fondazione nella nostra Pinacoteca, nel lascito del conte Paolo Tosio che l’acquistò tra l’agosto 1824 e il gennaio 1825 dall’antiquario bergamasco Giovanni Querci della Rovere (con cui avviò, con questo, una lunga serie di acquisti). L’antiquario tramandò che era stato dipinto per i Conti Baglioni di Perugia (e uno studioso ancora 10 anni fa «identificò» nei pastori Braccio II e Sforza figli di Grifonetto Baglione), ma già nel 1826 il Brognoli nella sua guida alle raccolte bresciane, scrisse che erano raffigurati i fratelli Gussoni (nel primo ’500 un cavalier Gussoni è registrato a Venezia, ma nel regesto dei beni della casata non risulta questo Lotto). In ogni caso, ora la data riscoperta ha riportato l’esecuzione della tela al soggiorno veneziano del pittore rientrato da Bergamo, ed alla committenza devozionale privata. Davvero la «sacra conversazione» di tradizione veneziana è calata nella contemplazione mistica della più umile quotidianità, la luce reale fatta «medium» di eventi spirituali, a cui molto dovranno anche i nostri bresciani, specie Moretto e Savoldo. Ma il Longhi indicava qui anche uno dei «precedenti» del Caravaggio del calmo, dolce «Riposo nella fuga in Egitto». Fausto Lorenzi
Scarica