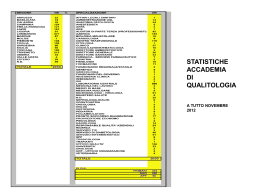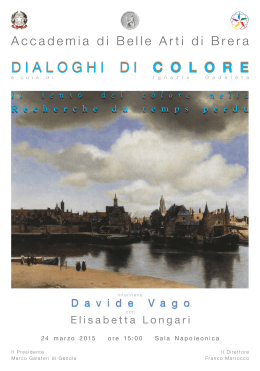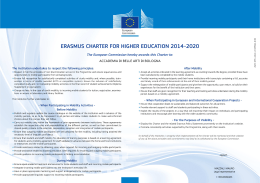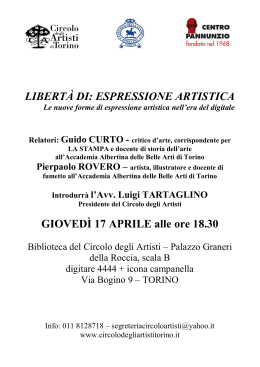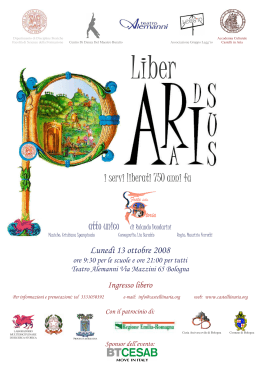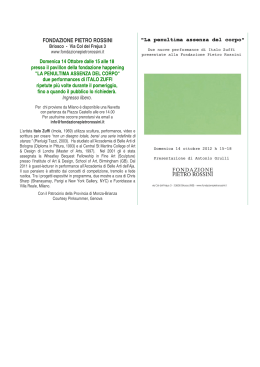TRIMESTRALE DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, IDEE, TESTIMONIANZE, PROGETTI, DIDATTICA, RECENSIONI, MOSTRE, NOVITÀ. ANNO 2010 - N°6 - EURO 6,00 Redazionale: COME SARÁ LA NUOVA ACCADEMIA DI BRERA Maestri storici: TOTI SCIALOJA Testimonianze: EUGENIO CARLOMAGNO ALBANO MORANDI BRUNO CECCOBELLI MARCO TIRELLI Docenti artisti: PAOLO ROSA TULLIO BRUNONE GABRIELE GIROMELLA RADU DRAGOMIRESCU MARCELLO CINQUE Accademia di Sassari: ANTONIO BISACCIA Accademia di Bari: PRE-VISIONI Ex studenti: MOIRA RICCI Ex docenti: GUIDO BALLO FRANCESCO LEONETTI Fondazione Maimeri: GIANNI MAIMERI Recensioni Sostieni Academy! con pubblicità e abbonamenti per il nuovo anno anche individuali, ognuno potrà ricevere la rivista comodamente a casa propria. contattaci scrivendo a: [email protected] versamento su c/c postale n°89424840 REDAZIONALE Distruggere l’Accademia di Brera Intervista a MICHELANGELO PISTOLETTO La sua esperienza all’Accademia di Vienna Intervista a DANILO ECCHER Direttore della GAM di Torino Intervista a ENZO INDACO Presidente dell’Accademia di Catania PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI Accademia di Catania Intervista a MARTINA CORGNATI Docente all’Accademia Albertina di Torino Intervista a NICOLA MARIA MARTINO Artista e Direttore dell’Accademia di Sassari Intervista a ALESSANDRO GUERRIERO Designer e Presidente della NABA, Milano UNICREDIT & ART L’esperienza con l’Accademia Albertina Una mostra GIUSEPPE MARANIELLO Ex studenti MICHELE GIANGRANDE Redazionale: ECCO LA NUOVA ACCADEMIA DI BRERA! Maestri storici: TOTI SCIALOJA Testimonianze: EUGENIO CARLOMAGNO ALBANO MORANDI BRUNO CECCOBELLI MARCO TIRELLI Docenti artisti: PAOLO ROSA TULLIO BRUNONE GABRIELE GIROMELLA RADU DRAGOMIRESCU MARCELLO CINQUE Accademia di Sassari: ANTONIO BISACCIA Accademia di Bari: PRE-VISIONI Ex studenti: MOIRA RICCI Ex docenti: GUIDO BALLO Fondazione Maimeri: GIANNI MAIMERI Recensioni TRIMESTRALE DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, IDEE, TESTIMONIANZE, PROGETTI, DIDATTICA, RECENSIONI, MOSTRE, NOVITÀ. ANNO 2010 - N°5 - EURO 6,00 TRIMESTRALE DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, IDEE, TESTIMONIANZE, PROGETTI, DIDATTICA, RECENSIONI, MOSTRE, NOVITÀ. ANNO 2010 - N°4 - EURO 6,00 oppure bonifico bancario intestato a: Editrice L’Immagine srl UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA - MOLFETTA IBAN: IT 36 Z 03002 41560 000010242187 Redazionale: C’É UN’ITALIA ROVESCIATA CHE.. Maestri storici: LUCIANO FABRO Testimonianze: GIANNI CARAVAGGIO PIETRO COLETTA HIDETOSHI NAGASAWA Sulla Scultura: ACHILLE BONITO OLIVA Patrimonio storico: LA PINACOTECA ALBERTINA DI TORINO N.A.B.A. MILANO L.A.B.A. BRESCIA Docenti: GIULIO DE MITRI GABRIELE DI MATTEO BARBARA TOSI Sul Restauro: DUILIO TANCHIS Fondazione Maimeri: TRATTATO SULLA PITTURA Ex studenti dell’Accademia di Roma Recensioni Sommario ragionato di Elisabetta Longari Il numero 6 è “caldo” non soltanto perché è quello estivo ma soprattutto perché fa il punto sull’annosa questione della sede dell’Accademia di Brera che, risolta egregiamente sulla carta (Brera spostando molti corsi nella nuova destinazione assumerebbe la fisionomia di un campus), attende però un finanziamento adeguato per diventare realtà, e, poiché, come si sa, il denaro non cresce sugli alberi e purtroppo di questi tempi è vero anche che gli investimenti pubblici e privati sulla formazione culturale stanno calando in modo esponenziale, non ci resta che incrociare le dita e fornirci di amuleti speciali e potentissimi. Pubblichiamo una “chicca” relativa al tema precedentemente esposto: un intervento di Ado Franchini che ricorda e mostra come un progetto datato 1935 e firmato dai migliori architetti razionalisti lombardi, se fosse stato realizzato, avrebbe salvato “capra e cavoli” mentre avrebbe dotato la città di un edificio di grande efficacia funzionale e purezza estetica (la vita in generale è costellata di occasioni mancate). Toti Scialoja è il maestro su cui concentriamo la nostra attenzione, ospitando una lettura critica di Barbara Drudi e il ricordo di alcuni tra i suoi allievi. Un altro grande maestro scomparso di recente cui si rende qui omaggio attraverso il ricordo di un’allieva di talento (Fausta Squatriti) è Guido Ballo, studioso appassionato del futurismo come della realtà contemporanea in cui agiva da acuto “occhio critico” (nella biblioteca dell’Accademia di Brera si conserva il suo archivio, fondamentale strumento di consultazione e di studio per chi si dedica soprattutto all’approfondimento degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta). Uno spazio è stato dato alla Scuola di Nuove Tecnologie di Brera, delle cui problematiche parlano Paolo Rosa, Tullio Brunone e Riccardo Notte, “vivaio” che ha già regalato al mondo dell’arte diverse figure di spicco tra cui qui presentiamo Moira Ricci. Mentre registriamo la vivacità dell’Accademia di Catanzaro e il cambio di direzione dell’Accademia di Sassari, Anna Maria Amonaci “legge” criticamente il Teatro di figura di Gabriele Giromella e proseguiamo, come di consueto, a ospitare segnalazioni e recensioni d’interesse “accademico”. Buona lettura e arrivederci al prossimo numero. Iniziativa editoriale adottata come progetto dall’Accademia di Brera A A DEMY OF FINE ARTS NUMERO 6 / Estate 2010 SEDE Viale Stelvio, 66 20159 Milano tel. 02 87388250 fax 02 6072609 [email protected] DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Cugusi DIRETTORE Gaetano Grillo VICE- DIRETTORE Elisabetta Longari REDAZIONE Gaetano Grillo Elisabetta Longari Alessandro Gioiello GRAFICA E PUBBLICITÀ Marcella Renna 3397880296 EDITRICE L’IMMAGINE SRL Zona Industriale Lotto B/12 70056 Molfetta (Ba) Italy FOTOLITO E STAMPA L’IMMAGINE AZIENDA GRAFICA SRL Via Antichi Pastifici Lotto B/12 - Z.I. 70056 Molfetta (Ba) Italy tel. +39.0803381123 fax +39.0803381251 www.limmagine.net [email protected] SOMMARIO *Tutte le collaborazioni si intendono a titolo gratuito ACADEMY OF FINE ARTS Iscritto al Tribunale di Trani n.3/09 Fondato da Gaetano Grillo HANNO COLLABORATO* Anna Maria Amonaci Ruxandra Balaci Tullio Brunone Bruno Ceccobelli Maurizio Coccia Giustina Coda Pino Di Gennaro Barbara Drudi Ado Franchini Albano Morandi Sergio Nannicola Riccardo Notte Stefano Pizzi Paolo Rosa Fausta Squatriti Marco Tirelli 1 02 Redazionale di Gaetano Grillo 05 La nuova Brera a Brera, 1935 07 Maestri storici: Toti Scialoja 11 Maestri storici, testimonianze: E. Carlomagno, A. Morandi, B. Ceccobelli, M. Tirelli 15 Docenti/Nuove Tecnologie: P. Rosa, T. Brunone, R. Notte 21 Docenti: Gabriele Giromella, Radu Dragomirescu, Marcello Cinque 30 Accademia di Sassari: un nuovo direttore, Antonio Bisaccia 32 Accademia di Bari: Pre-Visioni 34 Contributi: Stefano Pizzi, Sergio Nannicola, Pino Di Gennaro 39 Ex studenti: Moira Ricci 41 Ex docenti: Guido Ballo 43 Fondazione Maimeri: Gianni Maimeri 46 Recensioni In copertina: Accademia di Brera Foto di Vito Giacummo L’UNICA RIVISTA PERIODICA RIVOLTA ALLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, AI DOCENTI, AGLI STUDENTI E A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE. Foto Ranuccio Bastoni L’ACCADEMIA DI BRERA LASCIA UNA PARTE DELLA SEDE STORICA MA QUADRUPLICA IL SUO SPAZIO! di Gaetano Grillo redazionale 2 L’accordo La critica Il 19 luglio 2010 forse rimarrà una data storica per l’Accademia di Brera ma anche per Milano e per il sistema accademico nazionale. In quella data, infatti, al Comune di Milano, alla presenza del Sindaco Moratti, dei Ministri La Russa, Bondi e Gelmini, nonché del Commissario Resca, è stato firmato il protocollo per il via libera all’espansione dell’Accademia e della Pinacoteca di Brera; la prima si espande fuori dal quartiere, la seconda occupa gli spazi lasciati liberi dalla prima. Si tratta di un compromesso che giunge dopo una faticosissima transazione iniziata diversi anni orsono quando il Sindaco di Milano, Letizia Moratti era Ministro dell’Istruzione e dell’Università. Allora si pensò di edificare la nuova Accademia di Brera in un’area della Bovisa, accanto al Politecnico, progetto poi abbandonato per varie ragioni e sostituito da un accordo firmato nel 2008 dal Presidente dell’Accademia, l’editore Gabriele Mazzotta; accordo che prevedeva il trasferimento negli spazi della Caserma Mascheroni. Ne è seguita una stagione di continui attacchi mediatici nei confronti dell’Accademia, finalizzati a recepire frettolosamente quell’accordo che, però, era fortemente penalizzante per la nostra istituzione poiché conteneva condizioni che avrebbero portato inevitabilmente alla perdita dell’identità e del prestigio della nostra Accademia. Alcuni mesi orsono il Governo ha nominato Mario Resca a Commissario Straordinario per Brera e quest’ultimo ha trattato con l’attuale direttore, Gastone Mariani che ha tenuto il polso fermo e ottenuto un risultato finalmente adeguato al sacrificio che ci è stato pressantemente richiesto e al quale l’Accademia ha risposto con unanime senso di responsabilità benché con dolore e senza condividere il progetto generale. Vediamo in sintesi quello che avverrà: l’Accademia di Brera cederà alla Pinacoteca le aule del Cortile Napoleonico (con la condivisione del Salone Napoleonico), cederà l’ex Chiesa di Santa Maria e altri spazi compreso quelli affacciati sull’orto botanico per un totale di circa diecimila metri quadri mentre conserverà tutto il quadrilatero centrale e le aule del lato nord dell’edificio sino all’ingresso da via Fiori Oscuri. In cambio la nostra Accademia si espanderà in una grande area compresa fra via Mascheroni e via Mario Pagano, un’area di ventunomila metri quadri coperti, quindicimila metri quadri di parco e il diritto di prelazione su un terzo lotto di quattromila metri attualmente destinato a mensa. Il Ministro La Russa ha detto: “Quello che non è riuscito a fare Napoleone, non è detto che invece non riesca al Ministro Bondi e al Ministro Gelmini, con l’aiuto del Sindaco Moratti”. Peccato che con la sua sottile formazione culturale non sapesse che il complesso di Brera non era nato per essere un grande museo ma l’esempio eccellente della cultura illuminista che voleva la convivenza delle arti (Accademia e poi Pinacoteca), delle lettere (Istituto Lombardo delle Lettere), delle scienze (Orto Botanico e Osservatorio Astronomico) della memoria (Biblioteca Braidense). Questo progetto di museificazione (alla Louvre), del quale è stato incaricato l’architetto Mario Bellini, prevede la copertura del cortile con una grande vetrata, il riordino della collezione esponendo parte del patrimonio che giace nei depositi e il solito book-shop, caffetteria e gadgets per turisti fast food. L’obiettivo sarebbe quello di raggiungere per l’EXPO 2015 il milione di visitatori ma con un investimento previsto di cento milioni di euro che sono ancora da trovare. Viene spontanea una domanda: ammesso e non concesso che sia centrato l’obiettivo in concomitanza dell’Expo, cosa sarà di Brera quando la città tornerà alla sua vita normale, tendenzialmente modesta dal punto di vista turistico? Sarà in grado la Pinacoteca di Brera con il suo solo patrimonio e senza un contesto storico urbano come può esserlo quello di Firenze, Venezia o Roma, ad attrarre molti visitatori l’anno? Oppure il quartiere imploderà perdendo quell’autentica vivacità e identità che gli hanno conferito nel tempo la presenza degli artisti, di milioni di giovani studenti che l’hanno frequentato, galleristi, intellettuali, mercanti, collezionisti? Non sarebbe stato più opportuno trovare soluzioni per continuare a far convivere l’Accademia e la Pinacoteca espandendosi sì ma all’interno del quartiere? Perché non si è pensato di aggregare alla Pinacoteca i più adeguati spazi della Biblioteca Braidense, che sono già attigui e allo stesso livello del primo piano? La Braidense conta pochissimi visitatori, occupa un grande spazio e spostare il patrimonio librario sarebbe costato meno che spostare un’Accademia che conta tremilacinquecento studenti, quasi cinquecento professori e poi personale di segreteria, ausiliario e tutto l’indotto che ne consegue. Perché non riconsiderare il bellissimo progetto per la nuova Accademia di Brera firmato già nel ’35 dagli architetti Figini, Pollini, Lingeri e Terragni? Si trattava di una nuova costruzione all’interno dell’orto botanico. L’autocritica L’Accademia di Brera, nel decennio scorso, avrebbe potuto fare una scelta di campo diversa, ovvero puntare sul contenimento delle iscrizioni, evitare la proliferazione di troppi corsi, concentrarsi sull’eccellenza del servizio formativo e consolidare il prestigio specifico in ambito artistico che le viene riconosciuto da molto tempo. In verità la Legge di Riforma 508/99 aveva messo le basi per la trasformazione delle Accademie in Università ma come accade puntualmente nel nostro Paese, a buone intenzioni con corrispondono buoni provvedimenti tanto che invece di investire in questa direzione lo Stato ha cominciato progressivamente a tagliare i fondi lasciando le accademie, come si suol dire, in “braghe di tela”. L’Accademia di Brera, prima e più di tutte le altre, ha cercato di accelerare il processo di riforma adeguando la sua offerta formativa e puntando sull’ampliamento di corsi sino ad avere un incremento d’iscrizioni che ha sfiorato i quattromila studenti con il più alto tasso d’internazionalizzazione, più di qualsiasi altra Facoltà Universitaria. Questo successo ha naturalmente aumentato la necessità di avere ulteriori spazi da dedicare alla didattica iniziando a pensare all’ampliamento della sede con soluzioni più vicine all’idea di un campus dotato di laboratori efficienti, ampi e luminosi, di spazi espositivi interni ed esterni, nonché di grandi aule ad anfiteatro per le lezioni frontali. L’Accademia di Brera ha inseguito con convinzione il modello universitario staccandosi sempre più da quello dell’Accademia tradizionale soprattutto nella scelta dei nuovi Corsi che hanno guardato meno all’arte e piuttosto alla moda, al design, alla comunicazione, Ecco come sarà in futuro! L’Accademia di Brera ha dimostrato di essere responsabile e sensibile alle pressanti richieste che sono giunte in particolare dal Ministero dei Beni Culturali, dal Comune di Milano e dalla Pinacoyeca di Brera. Pur non condividendo l’obiettivo del progetto e pur essendo stata oggetto di campagne diffamatorie mirate a screditare il suo prestigio, ha accolto con apertura mentale la nuova fase interlocutoria avviata dal Commissario Mario Resca. Un’istituzione intelligente come l’Accademia di Brera non si è caparbiamente arroccata su posizioni intransigenti di mera conservazione ma ha saputo trattare per realizzare un salto di qualità verso una didattica adeguata alle nuove istanze dell’arte, della formazione artistica, culturale, della ricerca e della produzione. Come sarà in futuro l’Accademia di Brera? Si amplierà e si estenderà sull’asse che collega via Brera a via Mascheroni passando per la Basilica di Santa Maria delle Grazie, il Cenacolo di Leonardo da Vinci, sino ad affacciarsi sul nuovissimo e avveniristico quartiere di City Life, già in costruzione. A Brera resteranno molte aule, tutto il quadrilatero centrale, la condivisione del salone Napoleonico con accesso dal Cortile, resterà il Palazzetto della Fondazione Lombardi e Croce, resterà la sede della ex Chiesa di San Carpoforo, spazi che saranno adeguatamente ristrutturati, in particolare San Carpoforo che costituisce una enorme risorsa potenziale. Nei nuovi spazi di via Mascheroni (ventunomila metri quadri coperti più quindicimila di parco, più la prelazione su un terzo lotto di quattromila metri quadri coperti)1 ci sarà il grande ampliamento dell’Accademia di Brera con il suo nuovo Museo dell’Accademia dove troveranno finalmente posto tantissime opere d’arte di pregevole valore, oggi temporaneamente depositate in varie sedi di Milano. Sostanzialmente stiamo parlando di uno spazio quattro volte maggiore a quello di cui oggi dispone l’Accademia senza parlare di un’altra pregevolissima gemma: l’Isola Comacina (sul lago di Como), una gemma che l’Accademia di Brera si accinge a valorizzare al massimo dopo tanti anni di abbandono. Questo sarà il futuro di una istituzione storica importante che ha un cuore antico ma una mente fresca e pronta a riprogettarsi per i prossimi cento anni. Sarà un’Accademia di Brera molto più grande, molto più efficiente e molto più bella ma…. Il Commissario Resca riuscirà a trovare i finanziamenti? Cosa accadrebbe se cadesse il Governo? Sarà veramente questo il nostro futuro? 1 Si veda Paola D’Amico, in “Corriere della Sera”, 20 luglio 2010 3 redazionale Foto Vito Giacummo alle nuove tecnologie ecc. Si è trattato di una scelta di campo che sarebbe stata profetica e veramente vincente se non fosse avvenuta in Italia, peccato che la Legge 508/99 è stata tradita nel suo impianto poiché è mancata la volontà dei Governi che si sono succeduti in questi undici anni ad applicarla pienamente. Oggi abbiamo un’Accademia di Brera che ha ereditato tutti i mali dell’Università e ha perso tutto il fascino della vecchia identità. Il modello del tre più due è risultato un fallimento sia da noi sia nelle altre Facoltà e mentre si torna a riconsiderare il quinquennio per ridare solidità formativa a quanto è stato sino ad ora frammentato, si fa strada l’ipotesi che bisognerebbe riformare la riforma poiché la sua estenuante fase di sperimentazione ha evidenziato la sua precoce obsolescenza. Sarebbe stato bello poter conservare nella sede storica i corsi storici e portare tutti i nuovi corsi nei nuovi spazi con strutture adeguate a una didattica supportata dalla tecnologia. Così non sarà poiché il processo in corso non è controvertibile ma nella sede storica si potrà ospitare la didattica di secondo livello, i master, i dottorati di ricerca ecc. Inutile piangere sul latte versato ed è molto meglio, ora, progettare una nuova Accademia di Brera che abbia il cuore nella sua sede originaria ma le braccia e la mente in un luogo finalmente idoneo a svolgere un lavoro didattico all’altezza dei nostri tempi e con l’ambizione che da sempre contraddistingue questa istituzione. 4 redazionale Evidenziato in arancione la superficie che resta nella sede storica e in giallo la condivisione della Sala Napoleonica Entro il tracciato rosso la nuova grande area dove sorgerà il Campus Brera La nuova Brera a Brera, 1935. Il progetto razionalista per la nuova Accademia di Brera. 5 Di Ado Franchini Si tratta del progetto di nuova edificazione che nel febbraio 1935 il Ministero della Educazione Nazionale e il Presidente dell’Accademia Rino Valdameri affidarono a quattro dei più valenti giovani dell’architettura moderna italiana: Luigi Figini e Gino Pollini (milanesi, classe 1903)) con Pietro Lingeri e Giuseppe Terragni (comaschi, classe 1894 e 1903), tutti ex allievi architetti dell’Accademia o del Politecnico di Milano. Il loro lavoro partiva dal presupposto, sostenuto con forza dal Presidente Valdameri, di mantenere l’Accademia a Brera, ma trasferendola in un nuovo edificio moderno ed efficiente da costruirsi nell’area dell’orto botanico del palazzo (di proprietà demaniale), dopo che nel 1932 una tromba d’aria ne aveva quasi distrutto completamente la vegetazione. I progettisti presentano nell’estate del 1935 un progetto che copre 3600 mq dei 6500 dell’orto botanico: si tratta di un edificio a ponte, lungo 120 metri e composto da due corpi di fabbrica paralleli lunghi sollevati dal suolo a m.5,40, per mantenere la visione unitaria del giardino e per permettere una estesa sistemazione a verde anche al piano terreno. Nella relazione si sottolinea la ricerca di “..una vera e propria compenetrazione del nuovo palazzo con il verde circostante.” Il modello di studio ci dà una chiara visione della potenza e dell’energia dell’edificio nel suo complesso. Per garantire la massima trasparenza, pareti vetrate racchiudono solo alcune zone del piano terra, che contengono atrio e scale di accesso e anche alcune aule speciali. L’edificio più basso e slanciato, alto solo 8 metri contiene la biblioteca, le sale espositive, l’aula di storia dell’arte, un giardino pensile per esposizioni di scultura, ed è accessibile e aperto anche al pubblico. L’edificio principale delle aule, alto sei piani, ha un impianto molto semplice ed efficace, diviso in tre fasce parallele: a nord le aule dell’Accademia e il Liceo Artistico, illuminate da una grande vetrata continua a tutt’altezza, al centro il sistema distributivo verticale e i cavedii di ventilazione, a sud i percorsi di distribuzione orizzontale, con una facciata più chiusa e compatta, tagliata da finestre a nastro continue e lunghe come l’intero edificio. L’altezza interna dei piani varia in relazione alle esigenze dei tipi di aula e di laboratorio, e questa varietà di ambienti è leggibile dall’esterno nel fronte vetrato nord, divenendo così il tema dominante della facciata e dell’impianto architettonico, con i suoi sottili rapporti armonici e con la visione dei “meccanismi” interni che consentono di utilizzare le migliori condizioni di illuminazione e di flessibilità degli spazi. La risposta a quello che già allora si rimproverava alle antiche sale del Palazzo di Brera, ma che “.... per masse architettoniche e per qualità del materiale costruttivo, vetro acciaio, pietra...” avrebbe potuto reggere al confronto con la storia, configurandone anzi la continuità e la naturale evoluzione. Un edificio così potente e sollevato dal suolo richiede una struttura snella proprio come quella di un ponte, e infatti il progetto dei quattro trentenni lombardi propone un telaio in acciaio, con travi reticolari che hanno (un passo da 24 metri a terra e di 12 m agli altri piani, per ridurre al minimo gli appoggi e far letteralmente volare la struttura sul giardino. Il progetto è di grande valore innovativo e ha forti elementi di qualità documenti storici Lo spostamento dell’Accademia dal suo antico palazzo, opera del Richini e del Piermarini sulla struttura dell’antico convento degli Umiliati e poi dei Gesuiti, è un problema che tra breve compirà i suoi primi 100 anni. E’ dal 1913 infatti, che si discute e si tentano soluzioni diverse, senza successo e con grande dispendio di energie e di proposte, ma soprattutto con reiterate polemiche, sterili autodistruttive e senza effettivi risultati concreti. Penso che sia utile sapere che proprio per Brera, nel quinquennio 1935-1940, prese forma uno dei più interessanti progetti del Razionalismo italiano, che per diverse e italiche ragioni non trovò la possibilità di essere realizzato, portandoci oggi, settantacinque anni dopo, a dover discutere ancora animatamente sul tema dello spostamento dell’Accademia dalla sua storica sede originaria, voluta da Maria Teresa d’Asburgo nel 1776 “...per sottrarre l’insegnamento delle Belle Arti ad artigiani e artisti privati, e per sottoporlo alla pubblica sorveglianza e al pubblico giudizio”. BRERA 1935 documenti storici 6 sia tecnico-strutturale che distributiva e trova eguali in pochi progetti di quegli anni, non solo in Italia ma in tutta Europa. Il risultato architettonico e plastico, d’avanguardia e di alto livello qualitativo, e potrebbe senza dubbio essere firmato oggi da qualche grande nome dell’architettura contemporanea. Ma è qui che, come oggi, interviene il sistema italico dei veti e delle trame che comincia subito a lavorare per frenare opportunità e slanci verso il futuro. Nonostante l’approvazione del progetto da parte di Mussolini in persona, al quale Valdameri e gli architetti si erano rivolti direttamente per avere sostegno nel dicembre 1935, il sistema del sottopotere professional-burocratico nazionale riesce a bloccare l’iter del progetto per anni. Il Genio Civile, preposto alla realizzazione delle opere pubbliche, di concerto con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Consiglio Superiore delle Belle Arti (nel quale dominavano Piacentini e gli accademici romani) e la Soprintendenza ai Monumenti con il parere della Commissione edilizia locale, bocciano il progetto con varie e diverse giustificazioni, (le sanzioni contro l’Italia, il costo dell’acciaio, il calcolo statico non adeguato agli standard dell’epoca, il luogo non adatto, la “modernità” non italiana, ecc) e impongono la ricerca di una soluzione più modesta e riduttiva, con plauso vittorioso della stampa governativa e locale che vede con malanimo sempre crescente l’architettura non allineata alle forme auto celebrative del regime. Forti tensioni si scatenano nel gruppo di lavoro e nel 1938 un nuovo progetto di dimensione ridotta e fortemente banalizzata viene preparato da Lingeri, Figini e Pollini, che si adeguano ai condizionamenti convinti che “...prima si debba fare il palazzo e poi le polemiche ...”, accettando il compromesso di un’architettura autarchica e sottomessa alla volontà dell’apparato fascista. Giuseppe Terragni si rifiuta di firmare questa versione e ne propone un’alternativa che per quanto dimensionalmente ridotta, non rinnega il progetto originario e ne salva il senso, lo spirito moderno e l’elegante integrazione tra corpi di fabbrica complementari. E’ il tempo delle grandi polemiche tra architettura libera e l’architettura di regime, che va sempre più decisamente verso una censura diretta contro ogni forma di modernizzazione e di internazionalizzazione della cultura architettonica, nella quale tanti giovani come Terragni avevano creduto e lavorato. Marcello Piacenti e gli accademici dominano ormai il panorama dell’architettura italiana con il cinismo e la forza che il potere politico ora concede loro e il tempo di un’architettura rivoluzionaria e generosa è finito. E’ tempo di guerra e di distruzione, di parole d’ordine e di violenza e non c’è più spazio per un’arte che non sia di sostegno alla dittatura e ne incarni la romana prosopopea. Il progetto viene accantonato e Terragni, ormai senza lavoro, decide di partire volontario per la Russia, facendo la cosa più irrazionale per un razionalista moderno come lui. Tornerà nel 41 per morire all’improvviso nel ’42, a 39 anni, con la mente e l’anima frantumata dall’orrore della guerra e dai sensi di colpa per una fede, quella fascista, che lo aveva tradito nella sua arte e nella vita. Dopo la Guerra Lingeri, Figini e Pollini tenteranno di riprendere il progetto per portarlo alla realizzazione, ma i tempi sono cambiati, l’Italia ha altri obiettivi che non hanno bisogno di una nuova Accademia di Brera. Ma ancora oggi quel progetto ci dice che antico e nuovo possono coesistere, possono parlarsi e convivere, e che solo l’ottusità delle menti e dei tempi oscuri, allora come oggi, non riesce a vedere ciò che è possibile e ciò che è saggio e utile. *Ado Franchini è architetto e dal 1995 è docente di Progettazione Architettonica presso il Politecnico di Milano, facoltà di Architettura. Ha pubblicato saggi e articoli su quotidiani e su riviste specializzate italiane e tedesche di architettura e urbanistica, oltre a cataloghi di seminari ed esposizioni. Vive e lavora a Milano dove dal 1983 svolge attività professionale nel suo studio ADM Architettura, occupandosi di progettazione architettonica, urbanistica, restauro, interior design. Fra i vari progetti ha realizzato nel 2010 il Parco Scientifico Tecnologico Como Next, in provincia di Como. 7 Marte, 1991, cm 170x230, vinavil su canapa, coll. privata TOTI SCIALOJA maestro e… allievo all’Accademia di Belle Arti di Roma “Amato” maestro, attivo all’Accademia di Belle Arti di Roma dal 1953 al 1983 come docente, e dal 1983 al ’85 come direttore, Toti Scialoja era, si sa, pittore e poeta: un intellettuale con un ruolo da protagonista nella cultura artistica italiana. Ma per molti, e soprattutto per i giovani artisti “in erba”, era qualcosa di più. Lui, a differenza di altri, si dedicava con passione e intelligenza anche all’insegnamento: un punto saldo di riferimento per chi aveva deciso di seguire l’incerta strada dell’arte. Tanto per essere chiari: Toti Scialoja, professore all’Accademia era già allora- oggi forse ancor di più- entrato nel mito. Nell’ambiente dell’arte romana nessuno dimentica il “passaparola” tra i giovani studenti di qualche anno fa: si devono seguire i corsi di Scialoja per “diventare un artista”. La fama delle qualità didattiche di Scialoja era tale che, pensate, un giorno un giovane cinese, iscitto all’università per stranieri di Perugia, si presentò all’Accademia dichiarando di voler diventare “allievo di SCialoja”! Purtroppo per lui era tardi. Toti aveva già lasciato la cattredra ed era passato a ricoprire l’incarico di Direttore. Li Xiang Yang, questo il nome del giovane cinese, divenne poi per qualche anno assistente di Scialoja. Per Toti l’insegnamento aveva una connotazione particolare, quasi ‘paterna’: lui che nella vita aveva deciso di non avere figli, vi ritrovava la gioia particolare del ‘dare’, dell’offrire agli altri anche senza aver nulla in cambio, proprio come un padre. Scopriva questo con il suo tipo speciale di insegnamento che andava ben oltre le poche ore della didattica imposta dall’istituzione. Ma rimaniamo per un istante nel “mito”, e vediamo come si presentava il “maestro”. Ad una prima occhiata la sua biografia ci sembra aderire in pieno alla cosiddetta “Leggenda dell’artista”, a quell’insieme di verità e mistero, che appartiene alla nostra tradizione culturale e che ha radici così profonde e lontane da perdersi sino nell’antico Egitto. Una leggenda biografica che Scialoja amava rinnovare spesso nei suoi racconti, arricchendola di aneddoti curiosi ma molto significativi. Episodi, questi, che lo potessero inserire a buon diritto nella genealogia della stirpe “artistica”. Autodidatta, secondo uno dei topoi più diffusi dalla tradizioneautodidatta era stato Lisippo nel racconto di Plinio il Vecchio – Scialoja non aveva frequentato nessuno scuola d’arte, né tanto meno l’Accademia. Si era avvicinato al mondo della pittura spontaneamente, senza le regone precise di alcun maestro. Si aggiungeva poi alla sua biografia un altro “luogo letterario” tra i più ricorrenti: la scoperta del talento in età assai precoce, quasi infantile. Ricordate Giotto, giovinetto, che disegna la pecora sul sasso? Anche a Scialoja piaceva ricordare così la sua infanzia: “ Ho iniziato a dipingere molto giovane, ero quasi bambino, andavo a Villa Borghese con la mia tavolozza, la tela, il cappello di traverso, facevo maestri storici Di Barbara Drudi maestri storici 8 ‘il pittore’ […] un simpatico pittore che stava lì un giorno mi disse: << Bravo, sei un pittore>>”. E ancora, sempre nella scia della tradizione delle “vite d’artista”, si trova in Scialoja la scoperta casuale del suo talento da parte di un maestro. Ci torna in mente Cimabue che, fermatosi “tutto maraviglioso” (Vasari) davanti alla pecora tanto verosimigliante disegnata da Giotto, chiese al pastorello se voleva andare a imparare il mestiere da lui in bottega. Qualcosa di analogo sembra che capitò anche a Toti: un giorno, seduto al tavolino con alcuni amici artisti, prese a disegnare una copia da un quadro di Dalì; Corrado Cagli, lì presente, con entusiasmo gli disse: “ […] tu sei un pittore, perché hai fatto questo disegno senza mai staccare la matita dal marmo (il tavolino) e hai un segno interessante”. Non starò a soffermarmi sul fatto se sia vero o meno che il “pittore nato” si riconoscerebbe dalla spontanea capacità di disegnare “senza mai staccare la matita…”, come sembra pensasse Cagli, o da qualche altra bizzarria. Tutto questo ha pure il suo fascino, ma è mito, appunto. Quale è invece la storia? La storia mi appare di tutt’altro tipo: Scialoja apparteneva alla Tradizione, sia pittorica che sociale. Era senza dubbio parte di quella comunità che ritiene l’arte trasmissibile, che ha fiducia nell’insegnamento come mezzo di comunicazione per la creatività. Meticoloso nell’analisi dei dipinti, fin quasi alla pignoleria, perdutamente innamorato della Pittura, che lui considerava un’arte sensuale, Scialoja non smise mai di riferirsi a modelli, e di rileggere in senso sempre nuovo la tradizione. Allora, se ribaltiamo la situazione, e guardiamo Scialoja non più solo come maestro, ma come un “anello” di una interminabile catena, lunga quanto la storia stessa dell’uomo, la prospettiva cambia di molto. In questa lunga catena Toti, come ogni altro artista, appare avere un “prima” e un “dopo”, annoverando quindi nel suo percorso non solo allievi ma anche maestri. È allora legittimo chiedersi: quali sono stati i maestri di Scialoja? Lui, autodidatta- ma che praticava con tanta passione e generosità intellettuale l’insegnamento dell’arte- che maestri aveva guardato? “Ho avuto per Giorgio Morandi e conserverò sempre, una particolare devozione”- aveva scritto negli anni cinquanta- “La sua opera è stata esemplare nel nostro Paese. È la pittura del mio primo Maestro, del mio più amato Maestro”1. La storia dei maestri d’elezione di Scialoja, o dei suoi ‘precursori’ sempre scelti e mai subiti- per dirla con Borges- comincia molto lontano, cioè quando Toti è ancora un pittore figurativo e definisce il suo amore per Van Gogh e Soutine. L’espressionismo delle opere di questi anni, il segno insistito fino allo spasimo, denunciano chiaramente la loro fonte d’ispirazione. “Il mio modello era Van Gogh, mitizzato sulle quadricromie”2 Il tocco minimo del segno che fa lievitare la forma e torna su se stesso, ossessivo, viene così spiegato in alcuni appunti di Scialoja che illustrano il suo modo di procedere creativo di quegli anni: “quello che io chiamavo ‘l’ebollizione luminosa’, l’ingigantirsi e venire avanti come bolle nella luce-maschera. Abbaglio della pittura di Ensor- così mi pareva nel 1938-40 […] la frantumazione plastica e luminosa, il modellatore per punti e linee di Van Gogh […] i frammenti di meteria in torsione: torce di materia vivente che divampano in Soutine […] la tempesta dei contorni i Kokoscka”3. Sul finire degli anni quaranta però, Scialoja comincia a ricomporre il segno espressionista in stesure più quiete: nei suoi quadri le campiture si accostano in un gioco tenue e calibrato di ton sur ton. Sembra che la furia giovanile si plachi in una più ponderata e matura definizione del concetto di “spazio pittorico” e di cromatismo. Nel 1948 era cominciata infatti la grande ammirazione per Morandi, che Scialoja conobbe anche personalmente. La pittura del maestro bolognese incarnava per Toti l’imprescindibile idea del “tono” cromatico. Quell’idea costante e mai del tutto abbandonata: neanche molto più tardi, nelle grandi opere di gestualità “tutta offerta” e vitale dipinte negli anni ottanta. Ma, nel giro di pochi anni, al sorgere del 1950, l’insoddisfazione di Scialoja per la pittura figurativa – retaggio del passato- , lo induce ad esplorare nuovi territori e ad imboccarla strada, del resto assai 1 Giuseppe Appella, Vita, opere, fortuna critica, in Toti Scialoja. Opere 1955-1963, catalogo della mostra, Verona, Galleria dello Scudo, 1999, p. 133. 2 Catalogo della mostra, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 1991, p. 23. 3 Roma. Toti Scialoja, Giornale di pittura, inedito, Fondazione Toti Scialoja, 9 affollata, di una rivisitazione del cubismo. Con l’idea che proprio da lì si dovesse ripartire per concepire la nuova spazialità dell’opera. “L’argento e il grigio mentale della natura morta di Braque del 1911. Un balsamo grammaticale, una chiarezza che addizionandosi risuscita”4. Attraverso una attenta rilettura del cubismo, comincia dunque al principio degli anni cinquanta la transizione verso la pittura “astratta”, a cui Toti approderà nel 1954. Nel 1955 infatti, Scialoja si può considerare un pittore completamente astratto. Il segno dinamico e fluido si muove ormai autonomo rispetto alla “rappresentazione” della forma riconoscibile e, agile, prende vita sulla superficie. Negli inchiostri così come nelle tempere il pennello sui avvia a definire le tracce e le campiture di una nuova concezione dello spazio pittorico: bidimensionale, astratto, esito formale di una gestualità “automatica”, scoperta e condivisa con molti artisti di quegli anni. Scialoja ha scelto di nuovo i suoi ‘precursori’. Incantato dai labirinti filamentosi di Pollock, sedotto dagli organismi fluttuanti di Gorky, 4 Toti Scialoja, Giornale di pittura, Parigi 1954, inedito, Fondazione Toti Scialoja, Roma. Toti individua nella emergente pittura dell’espressionismo astratto americano il riferimento a lui necessario nella nuova strada intrapresa. Bellissime pagine scriverà infatti sulla pittura di Arshile Gorky, forse l’artista americano da lui più amato. “Tanto io ho prediletto Gorky”ha dichiarato Toti in un’intervista- “che quando insieme ad Afro e Colla facemmo due numeri di Arti Visive, di cui un numero doveva essere dedicato a me, io mi trassi in disparte in favore di Gorky, obbiettando che in Italia non esistevano monografie dell’artista ed era più importante far conoscere la sua arte”. Ancora un gesto di generosità intellettuale che si può accostare all’insegnamento, cioè alla forza di chi è disponibile a rinunciare a qualcosa che soddisfa la propria vanità, in favore di un arricchimento culturale destinato a tutti. Scialoja ci fa apparire la pittura di Gorky come un “traboccare dello spirito distillato dal dolore personale”, in cui “il colore e la forma si caricano di fantomaticità umana”. Per Toti si annulla in Gorky ogni intercessione estetica: si tratta di pittura insanguinata e interiorizzata. “La prima emozione che si riceve da una tela di Gorky è simile a quella che potrebbe recarci una scritta segreta e leggerissima, un colore maestri storici Per Willem de Kooning, 20.3.1997, cm 204,5x205 vinavil su tela, coll.privata Verona Irritazione, 1957, cm 108x93, vinavil su canapa, coll privata maestri storici 10 tutto offerto, tutto affiorato sulla superficie”5. E ancora sulla pittura di Pollock e di de Kooning, parole dedicate alla forza espressiva del loro segno libero e incisivo “Pollock non fa che percorrere con il segnocolore, avanti e indietro, tutta la superficie della tela, per gremirla, come inebriandosi di una continua riprova”6. Tanto si sentiva un “pittore espressionista”, aderente all’atteggiamento creativo degli action painters che un giorno Toti ebbe a rivelare a Giuseppe Appella di aver cercato sempre nella pittura “qualcosa che trascende la pittura stessa […] che la pittura possa essere simbolo dell’uomo in toto, dell’uomo intero […]”. Arrivando a concludere: “Nella pittura americana ho ritrovato me stesso”7. Avere dei maestri, scegliere degli artisti che lo guidassero, quasi come gli spiriti degli antenati, non significava tuttavia per Scialoja, imitazione pedissequa, manierismo. Le sue scelte spaziavano dalla pittura figurativa all’astrattismo, dall’antico al contemporaneo prediligendo di volta in volta quello che sentiva più consono al suo momento creativo. Individuando nella pittura di “quelli prima di lui” l’intuizione profonda che aveva permesso di rendere tangibile il pensiero, di rendere forma e colore l’immagine mentale. Nel giugno del 1955 scriveva: “ Ho scoperto ora la grandezza, l’attualità folgorante di Degas. Il colore deve avere una risuonanza interna (il colpo di una lastra di metallo) ma apparire prosciugato, opaco di materia, senza effusione”8. Ogni modello contiene un travisamento da parte di chi lo guarda. Potremmo dire dunque che il maestro non è quello che ti tocca in sorte, ma è quello che ti scegli. “Cézanne aveva insegnato semplicemente questo: che la linea tracciata per descrivere la curva della collina vale in se stessa, senza riguardo alla collina. […] La mia pittura fa cenno semplicemente a questo: una linea, una pennellata, non cerca relazione con un’altra linea […] ma vive del rapporto con te, che la tracci, tu, soggetto temporale […]”9. 5 6 7 Toti Scialoja, Giornale di pittura, Editori Riuniti, Roma 1991, p. 45. Toti Scialoja, op. cit., 1991, p. 13. Giuseppe Appella, Colloquio con Scialoja, in Scialoja. Opere 1955-1963, catalogo della mostra, GIbellina, Museo Civico, Edizioni La Cometa, Roma 1985. Toti Scialoja tenne il suo primo corso all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 1953. Vincitore di un concorso per un incarico straordinario di Scenotecnica, conserverà la cattedra fino all’anno accademico 1956/57, passando poi, dall’insegnamento di scenotecnica, al corso di Bianco e Nero. Quest’ultimo veniva inteso non tanto come Grafica, quanto più specificamente come disegno e pittura. Nel 1960 Scaloja lascerà l’Accademia in seguito alla decisione di traferirsi a New York, ma vi farà ritorno, con la cattedra di Scenografia, alla fine del decennio dopo un lungo soggiorno a Parigi. Il suo insegnamento durerà fino al 1982 seguito da tre anni di direzione dell’Accademia. Come nelle antiche botteghe d’arte Scialoja preferiva lavorare lui stesso in classe, definendosi “maestro di mestiere e non di stile”. Realizzava alcuni “lavori” proprio davanti agli studenti, spiegando ad ogni passaggio l’intervento tecnico che gli consentiva di mettere in atto l’intenzione, il progetto mentale. Scialoja si poneva come esempio di un certo modo di intendere e vivere la pittura, e l’arte in generale. Il suo modo di insegnare non era quello di distribuire precetti e regole, o di trasmettere un metodo indiscutibile. Sembrava aderire a quell’idea espressa da Harold Rosenberg per cui “l’arte è modo speciale di pensare”. Amava poi parlare degli artisti più attuali, e fu tra i primi, nel 1958, ad occuparsi in classe del New dada americano. Invitava gli studenti a comprendere ed imitare il metodo di “stampaggio” e di collage adoperati da Robert Rauschemberg, suscitando grande impressione tra i suoi allievi: in particolare su Kounellis e Pascali. La tecnica del “collage”, dapprima insegnata e poi fatta propria, fu largamente adoperata da Scialoja nelle sue opere a partire dalla seconda metà degli anni sessanta: corde, giornali, merletti costituirono il suo primo repertorio materico. Queste materie andavano a sostituire il ritmo ripetuto delle impronte, accostandosi sulla tela in successioni temporali. Tuttavia con il passare del tempo e mutata la situazione storica, anche la “materia” viene abbandonata e la pittura di Toti si avvia ad una modificazione sostanziale: gli inserti ritmici si irrigidiscono in rettangoli e quadrilateri, lasciando il posto ad un linguaggio più geometrico. Accostamenti cromatici di strisce dipinte su carta di giornale – da lui definite “quantità” – e incollate sulla tela e sulla carta divennero allora la sua scelta espressiva. Più raccolto e meditato rispetto all’espressionismo della pittura precedente, il lavoro artistico degli anni settanta sembra infatti meno partecipato: del resto molto del tempo a disposizione di Toti veniva speso per l’Accademia, sia come energie fisiche che psichiche. E in più erano gli anni della sua consacrazione a poeta; un nuovo impegno creativo che lo coinvolgerà al punto da fargli lasciare un po’ in disparte la pittura. Ma, nel 1982, un nuovo maestro si affaccia prepotentemente nell’immaginario visivo di Toti: Francisco de Goya. Ancora un maestro antico, nelle cui opere Toti ravvisa una pennellata energica e strutturante, una pennellata che da sola è in grado di costruire la forma espressiva. I personaggi-spettri della “pittura nera”, quei volti affioranti dall’ombra, riescono a catalizzare la sua attenzione e a risvegliare il suo inesausto espressionismo, avviando un’ultima e vitalissima fase di pittura. A Goya sono dedicati i titoli di alcune opere di quest’ultima produzione: Primo San Isidro, Secondo San Isidro e via così. Dunque non solo Toti Scialoja maestro ma anche i maestri di Toti SCialoja, quegli artisti da cui egli ha saputo trarre linfa vitale per il suo percorso creativo. Del resto la passione che lo coinvolgeva nella scoperta di maestri sempre nuovi era la stessa che permeava tutta la sua esistenza artistica e dunque anche le sue lezioni in Accademia. Accanto al lavoro artistico vero e proprio non dimentichiamo infatti che Scialoja teneva avvincenti lezioni teoriche. Partendo dal teatro arrivava ad affrontare temi della letteratura, della poesia e della storia dell’arte, seguendo sempre il preciso svolgimento di un pensiero. Un pensiero risorgente, fatto di interrogativi, di pause, di cadute improvvise, quasi fosse un monologo teatrale. Durante le sue lezioni dunque ogni problema riguardo all’arte- fosse teorico o tecnico- veniva da Toti ogni volta scoperto, reinventato, riassaporato, seguendo la convinzione che ogni valido insegnamento consistesse non nel “far sapere”, ma nel “far sentire”. Nel “far vivere” profondamente ad ognuno l’esperienza creativa. 8 Toti Scialoja, Giornale di pittura, giugno 1955, inedito, Fondazione Toti Scialoja, Roma 9 Toti Scialoja, op. cit., 1991, p. 147. *Estratto del testo per la mostra “Omaggio a Toti Scialoja” Galleria Il Segno, Roma, dicembre 2007 11 Eugenio Carlomagno è stato allievo di Toti Scialoja all’Accademia di Belle Arti di Roma. A Cura di Barbara Drudi Quali sono i ricordi più vividi che hai dei tuoi anni come allievo di Toti Scialoja? fuori, condurre ad amare l’arte, i suoi diversi linguaggi e le sue infinite realizzazioni. I miei ricordi legano Toti Scialoja in particolare ad un libro IL CORVO di Edgar Allan Poe che il maestro lesse un periodo in cui frequentavo l’Accademia di Belle Arti di Roma. Era sempre vestito in modo accurato ed elegante e movendo con grazia le mani, sembrava quasi dipingesse nell’aria quello che ci leggeva,… piano piano, dalla forza delle sue parole e dalla sua lettura accurata nasceva una specie di scenografia virtuale in cui si materializzava il corvo, la stanza, i rumori e i suoni delle parole. Era una specie di fascinazione collettiva, profonda, come tutte le sue lezioni. Quanto contano i “maestri” in Accademia? Secondo Scialoja l’arte non si può insegnare, quello che si può insegnare è “l’amore per l’arte”, sei d’accordo? Pensi che questa idea sia valida ancora oggi? L’arte non è fatta solo e soltanto di codici prefissati o definiti ma anche da quel mondo particolare che appartiene al singolo soggetto che si propone come artista. Anche le Accademie svolgono continuamente questa pedagogia: educare, nel senso originario di estrarre, portare Sono importantissimi. Il loro ruolo è fondamentale nel suggerire percorsi e spunti; quando s’instaura tra maestro ed allievo un canale di comunicazione quasi individuale, allora il maestro riesce a far emergere quelle particolari soggettività dell’allievo che poi consentiranno di affermarsi autonomamente. L’educazione all’Arte, l’apprendimento e la conoscenza di tutti i suoi linguaggi, vecchi e nuovi, è la fase intermedia per la realizzazione dell’opera d’arte. Il maestro Scialoja aveva questo grande pregio: insegnarci l’amore per l’arte anche grazie alla sua capacità di trasmissione e di comunicazione. Nel suo orizzonte di vita (che si intravvedeva durante le lezioni) nelle sue scelte linguistiche o pittoriche, nei suoi dubbi e nei suoi pensieri c’era sempre spazio per un rapporto vero con gli allievi che proprio per questo diventava fecondo. *Barbara Drudi è docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Belle Arti de L’Aquila maestri storici / testimonianze Breve intervista a Eugenio Carlomagno, Direttore dell’Accademia dell’Aquila. 12 maestri storici / testimonianze Grande Cammino di Santiago, 2006, nastro adesivo e cera su ready-made Conversazione tra Albano Morandi ed Elisabetta Longari Hai studiato all’Accademia di Roma alla fine degli anni Settanta. Scialoja: diresti due o tre cose che sai di lui, per favore? Inizio nel 76 (ottobre) e scopro un nuovo mondo. L’incontro con Scialoja è folgorante, non è un insegnante che spiega la scenografia, ma un grande attore, un poeta che recita il mondo e le cose del mondo, siamo tutti ammaliati dal suo modo di fare. La metodologia con cui ci avvicina allo studio dello spazio passa per la scoperta della pittura del novecento e in particolare per l’informale: Burri, Afro, Capogrossi, …, quello che lui chiamava lo spazio bidimensionale astratto, il metodo che utilizzo oggi con i miei studenti risente moltissimo della sua lezione. Poi i pomeriggi passati nel suo studio di Piazza Mattei, 10 dove, dopo aver visto gli ultimi lavori inchiodati al pavimento di legno, ci dissetava con whisy e soda a volontà. Non pensare che fosse così naturale e facile, la mia classe di scenografia, partita nel 76 con oltre 40 iscritti è finita nel 1980 credo con 5 persone. Ma anche Alberto Boatto… Anche con Alberto si è creata subito una buona intesa, si andava a vedere le mostre e poi a cena al “Grottino” dietro campo de fiori, bisognava prima dimostrare un grande attaccamento allo studio, altrimenti nessuna confidenza. Scialoja è stato il sentimento, Boatto il Pensiero. Che rapporto avevi con i Transavanguardisti? Com’era la città dal punto di vista della vita artistica? Che ricordi hai? Schifano, Boetti, Mattiacci… li vedevi? Roma in quegli anni era straordinaria o forse erano solo gli occhi meravigliati di un ragazzino che veniva dalla provincia lombardo veneta. Alberto Boatto ci portava a lezione gli artisti suoi compagni di starda. Ricordo con grande piacere l’incontro con Alighiero Boetti e con Matiacci. Boetti l’ho rivisto raramente, mentre Eliseo e il suo lavoro li ho frequentati più assiduamente. È strano, rifletto solo ora quanto sia stato importante il lavoro di Alighiero Boetti sulla mia formazione artistica. In che senso? L’ironia leggera e sottile, “amo l’ironia perché è l’unico ingrediente che fa digerire al mondo contemporaneo la spiritualità”, sono le parole di Alighiero pubblicate su un delizioso libretto stampato da un piccolo editore della mia città.È proprio all’insegna della leggerezza e dell’ironia che ho impostato il mio percorso artistico alla ricerca di una contemporaneità proposta in forma antiretorica e anticelebrativa. Il concetto della “non scelta”, Boetti diceva in relazione alle “mappe”: “non ho scelto niente nel senso che il mondo è fatto come è e non l’ho disegnato io.” Questo ragionare attorno all’emergere di un’idea base, di un concetto in cui far confluire prepotentemente l’imprevisto scompigliando le regole e lasciando ampio margine al caso fa sì che tutto il resto non sia più da scegliere ma venga di conseguenza. È un po’ come il concetto di “disponibilità” di cui Parla Federico Fellini: “…Le prime due settimane delle riprese sono un viaggio pieno di contraddizioni. Destinazione ignota […] in seguito ho l’impressione di non essere più io a dirigere il film, è il film a dirigere me, il film sa benissimo dove andare. Allora cerco di restare disponibile, di accettare le scoperte del viaggio.” Anche Boetti non vuole scegliere ma lasciare che sia il contesto a scegliere “ il mio problema infatti è di non fare scelte secondo il mio gusto ma di inventare dei sistemi che poi scelgano per me.” È un po’ quello che succede a me con le installazioni fatte con gli oggetti trovati su cui intervengo non prevaricandoli ma cercando, con il mio lavoro, di mettere in evidenza le potenzialità estetiche insite nella cosa stessa.È concettualmente un modo di vedere il mondo attraverso la struttura del campionario piuttosto che attraverso la tavolozza, come direbbe Alberto Boatto.Nel mio operare più recente poi è entrato prepotentemente un concetto che Boetti ha sempre frequentato, quello di delegare rimanendo se stessi. L’operare degli altri diveniva il suo operare, operazione più da regista che da artista visivo tradizionalmente inteso, è quello che sta succedendo sempre più frequentemente al mio lavoro. Torniamo alla domanda di partenza… Non ho mai amato particolarmente il lavoro degli artisti della transavanguardia, salvo alcune cose di Enzo Cucchi, ma ricordo perfettamente la prima mostra di Sandro Chia vista alla Galleria di Giuliana De Crescenzo con i compagni dell’Accademia e con Giovanna Dalla Chiesa, che allora era l’assistente di Boatto, in cui, dopo mesi di visite a mostre di opere fotografiche o oggettuali vedevamo ripresentato il disegno (anche se era ancora un disegno raffreddato dal processo progettuale). Ricordo perfettamente che al ritorno in aula riferii a Giovanna l’interesse che aveva suscitato in me questo tentativo di riprendere il rapporto con le avanguardie storiche e con i mezzi della pittura precedente alla seconda guerra mondiale. Era il 1978 e la transavanguardia non era ancora nata. Come sei arrivato all’installazione su parete, a “frammentare” l’unità del dipinto e a utilizzare oggetti? È stato un processo assolutamente naturale, a me sembrava fosse l’unica possibilità di evolvere il pensiero che Scialoja ci aveva trasmesso attraverso lo studio e la comprensione dello spazio, ma mi sbagliavo. La prima volta che mostrai a Toti i lavori ad acquarello su carta di riso strappata e poi ricomposta direttamente sulla parete( ero molto fiero di quel lavoro nato alla fine dell’ultimo anno di accademia e nell’estate successiva )lo feci arrabbiare fuori misura. Dopo di allora restammo molto tempo prima di riappacificarci. Ero molto convinto di quel lavoro che esposi anche alla Librogalleria Giulia (Alberto Boatto aveva mostrato i lavori a Mario Quesada che subito li espose) dove Fabrizio D’Amico li vide e mi invitò alla Quadriennale dell’86. L’insegnamento di Scialoja puntava a costruire delle persone in grado di pensare uno spazio, qualunque esso fosse, dentro e fuori dal teatro, nello spirito delle ricerche teatrali d’avanguardia che le cantine romane offrivano. Erano i tempi di Carmelo Bene e di Leo De Bernardinis, di Memè Perlini, il Living Theatre era accampato a Roma, Grotowski e Barba venivano spesso in tournée. Questo concetto di spazio dialogante divenne per me un pensiero costante, l’opera non era finita in se ma solo in rapporto allo spazio che la conteneva. Riguardando alcuni tuoi lavori passati sento un retrogusto alla Borges e alla Queneau, o sbaglio? Trapelano da atmosfere e da titoli… Le letture di Borges e Beckett, Queneau e Calvino sono state per me linfa vitale. Più di qualsiasi testo di estetica o di storia dell’arte. L’uso delle parole che si scontrano, creano un incidente di percorso e formano nuovo senso: l’eterotopia mi ha insegnato che due cose sommate non danno semplicemente un risultato algebrico. *Albano Morandi è direttore artistico e docente di Scenografia alla L.A.B.A. di Brescia 13 Questa foto è il ricordo di una cena voluta dagli allievi di Toti il 16 dicembre del 1993 (data del suo compleanno) alla trattoria “Pommidoro” a San Lorenzo. Tra di loro Kounellis, Nunzio, Marco Tirelli, Gianni Dessì e molti altri Un Maestro: Toti Scialoja Di Bruno Ceccobelli All’epoca in cui studiavo all’Accademia di Belle Arti a Roma tra 1973 - 77 leggevo molta di filosofia Zen, e uno dei primi curiosi Koan più consono allo spirito ”rivoluzionario” del tempo era: <<Se maestri storici / testimonianze Foto di Claudio Abate trovi un maestro uccidilo>>. Contemporaneamente facevo ricerche esoteriche, ove i segreti dei misteri piccoli o grandi, passavano esclusivamente da maestro ad allievo. Due scuole di pensiero che potrebbero apparire superficialmente contrarie, infatti, in oriente, la filosofia (il pensiero riflessivo) più spesso si manifesta con dei paradossi. Comunque è sicuramente vero, sia per l’occidentale che per l’orientale che, se s’incontra un signore che si pubblicizzi maestro e magari a pagamento, per prudenza occorre sicuramente evitarlo e cioè ucciderlo, dimenticarlo. Uccidere un maestro potrebbe però voler dire tradirlo, digerirlo e superarlo; ma prima deve accadere l’eccezionalità di trovare vero un maestro. Io m’incontrai in Accademia con un certo gruppo di studenti accorti e decisi a prendersi sul serio per diventare, in fretta, bravi artisti. Gli stessi che oggi fanno capo alla nuova generazione romana di via degli Ausoni, nel quartiere di S.Lorenzo. Noi, giovani svegli, prima di iscriverci ai corsi accademici, indagammo su quali professori risultassero più proliferi nello sfornare artisti valenti. Un solo professore aveva le carte in regola ed era Toti Scialoja, era un vero grande astrattista conosciuto nel mondo che aveva frequentato i più grandi artisti europei e americani, nonché ottimo poeta, colto e raffinato letterato. Serbavamo in memoria che nel giro di circa quindici anni d’insegnamento erano passati sotto la sua regola (perché di regola si trattava), artisti del calibro di: Pascali, Kounellis, Gino De Dominicis, Giosetta Fioroni, Stocchi…. per le nostre convinzioni erano artisti meritevoli più che sufficienti per scegliere il suo corso di scenografia, e a completare la sua aurea, due donne importanti legate alla sua intimità, Titina Maselli e Gabriella Drudi. Ecco, come ricordo la regola di quello che per me era il mio Maestro: primo, puntualità alle lezioni e ascoltare possibilmente senza intervenire (come nella scuola Pitagorica), secondo, rispettare tutte le consegne che erano frequenti, ogni quindici giorni circa. Ma anche se avessimo voluto intervenire, sarebbe stato quasi un sacrilegio, perché era come interrompere una partitura sinfonica, sì, perché Toti sapeva come incantare il suo uditorio, soprattutto se c’erano giovani e ricordo, negli anni, numerose ancelle e vestali vicino al maestro. Aveva una voce stentorea, con modulazioni alte e basse, a seconda della necessità emozionale degli argomenti, gesticolava con abilità, a volte, nei momenti più filosofici dei suoi discorsi, restava a lungo in silenzio e poi improvvisamente scoppiava in una risata omnicomprensiva e nei momenti nervosi aveva delle impuntature molto simpatiche. Negli anni che seguirono, dopo la scuola, continuammo a frequentare Toti nelle sue esposizioni o feste sempre con lo stesso calore e rispetto. Nel suo ottantaquattresimo compleanno organizzammo una festa agli Ausoni, nel mio studio c’erano tutti gli affezionati degli anni passati, dopo mangiato, con insistenza gli chiedemmo una conclusiva lezione, si mise a parlare con molta lentezza, ma con molta concisione, ricapitolando tutti i suoi ideali e sogni di una lunga vita dedicata ai “gesti” artistici, io mi commossi immediatamente perché compresi, solo in quell’istante, che molti dei miei pensieri sull’arte, che da molto tempo scrivevo e dichiaravo in giro per il mondo, erano dovute esclusivamente alle sue esaltanti frasi. Pochi giorni dopo coniai questo nostrano Koan: <<Sono allievo che sollievo!>> Toti Scialoja è stato pittore, poeta e soprattutto grande maestro. Di Marco Tirelli Sulla sua altezza come poeta e pittore ci sono le sue opere a dirne ma che maestro è stato, se gli artisti che sono usciti dalla sua Scuola, tra i quali il sottoscritto, sono così differenti tra loro e soprattutto da lui stesso? Forse proprio questa è stata la sua sottile grandezza. Scialoja ci ha insegnato ad essere noi stessi ma soprattutto che l’arte è una continua, rigorosa, sofferta ricerca del senso intimo delle cose e delle profonde ragioni del nostro stare al mondo. Seminatore sempre in cerca di terreni fertili. Spesso ripeteva che forse si può sopravvivere senza l’arte, ma una volta che si è toccati dal “sacro fuoco” non se ne può più fare a meno. Toti è stato il piroforo di un fuoco acceso nella notte dei tempi, forse lo stesso che Prometeo rubò agli dei; ce lo ha consegnato e se ne è tornato lassù. Voglio immaginare che ora sia una di quelle stelle che si dice essere morte, ma la cui luce arriva a indicarci ogni volta la rotta da seguire. maestri storici / testimonianze 14 Marco Tirelli, Senza titolo, 2009, Tempera su tela cm. 234,5 x 181 ALESSANDRO RUSSO Galleria Antonio Battaglia via Ciovasso, 5 - 20121 Milano T/F 0236514048 [email protected] www.galleriaantoniobattaglia.com PAOLO ROSA 15 Studio Azzurro, Museo Laboratorio della Mente: il Tavolo Sonoro nell’area denominata Dimore del Corpo, 2008 Percorso multimediale permanente situato nell’ex Ospedale Psichiatrico Santa Maria della Pietà di Roma. Laboratori del sensibile della sapienza del terzo millennio, o meglio, dove si formano i nuovi saperi e chi ne detiene la maggior conoscenza. Subito scopriremmo come siano mutate le condizioni di riconoscibilità disciplinare, di condensazione dell’esperienza, di trasmissione dell’informazione. Per chi s’illude ancora, come insegnante, di poter esibire la sua conoscenza del mondo a un pubblico di allievi sprovveduti e desideranti, basta ricordare a ciascuno di essi quante volte gli sia capitato di chiedere ad un giovane studente il funzionamento di un dispositivo, la procedura per una applicazione, il significato di un termine sconosciuto o la modalità di connessione di un cavetto misterioso. Oppure, per andare oltre il tecnico, chiedere le conseguenze di un social network, le ragioni di un blog o di un idioma da sms. Basta ricordare di quante volte gli sia capitato di domandarsi come si sta configurando (uso questa definizione consapevolmente) una realtà che sfugge dalle categorie classiche e di trovare risposta improvvisa nella proposta di un suo studente o in un suo inedito atteggiamento. Quante volte si sia dovuto affidare ai suoi giovani interlocutori per fruire di un aggiornamento spicciolo, quotidiano legato ad una dinamica complessa e in continua ed esponenziale evoluzione. Basta riconoscersi in questa semplice constatazione per capire come il rapporto docente-studente debba rigenerarsi in uno scambio di conoscenze e anche di esperienze, che occorre ammettere essere bi-direzionale. Anzi tridimensionale se alle due componenti citate volessimo aggiungere quella dell’habitat in cui questo scambio avviene. Occorre dunque partire da lì, dalla consapevolezza che non ti trovi davanti e intorno una forza inerte ma viceversa una parte attiva e fondamentale per calare la propria esperienza dentro una realtà percepibile e condivisibile da tutti. Occorre attivare la massima capacità d’ascolto, di dialogo, di sperimentazione comune per docenti / nuove tecnologie Occorre domandarsi se in questi anni non si sia persa un’occasione straordinaria per ridisegnare radicalmente i modi di insegnamento, le attitudini e le relazioni dell’apprendimento, approfittando dell’esplosiva e inesorabile introduzione di nuove tecnologie e di nuovi linguaggi nel panorama delle nostre vite. Ci siamo resi conto tutti di come lo scenario intorno a noi sia mutato, come i nostri comportamenti, i modi del comunicare, la costruzione d’immaginari siano determinati dal rapporto intrinseco con i dispositivi e i sistemi che dipendono dalle tecniche digitali. Di come i ritmi, le abitudini, la socialità siano filtrati dai grandi sistemi comunicativi e di come i processi di globalizzazione abbiano avvicinato distanze, mescolato culture, insidiato identità millenarie e profilato nuove riconoscibilità. Eppure il sistema educativo, il più grande e organizzato dispositivo di creazione di intelligenze, nonché di anticorpi utili ad ostacolare le forme degenerative di queste novità, non si è smosso granchè da un impianto che risale ormai ad un paio di secoli fa: quando si andava in carrozza, non c’era elettricità, si comunicava con la penna a inchiostro la vita media delle persone era intorno ai quarant’anni e le aule convergevano sull’autorevole presenza della cattedra. Un sistema talmente vecchio e indifendibile che anche i politici oggi hanno buon gioco a smantellare pezzo dopo pezzo per dare spazio a canali di formazione (o meglio forgiazione) affidati a media invasivi e adattati per distillare sottilmente i modi di “stare al mondo”. Se qualche timido passettino è stato fatto per inserire alcuni contenuti adeguati, per istituire scuole o corsi che invitano ad un aggiornamento, poco emerge invece sul lato delle metodologie d’insegnamento e sui modelli relazionali. Mentre, è proprio lì che si potrebbe iniziare per riattivare una linfa virtuosa, un’energia forte e capace di dare il passo alla velocità del cambiamento sociale. Senza pensare che sia troppo esagerato, si potrebbe cominciare cercando di immaginare i contorni Studio Azzurro, Tavoli - Perchè queste mani mi toccano - videoambientazione interattiva. “Oltre il villaggio globale”,Triennale di Milano, 1995 docenti / nuove tecnologie 16 poter creare le condizioni di un laboratorio di crescita e d’invenzione reciproca. Detta in modo diretto: occorre che l’insegnante impari ad apprendere dai suoi studenti. Solo così potrà godere del rispetto che gli è dovuto per il tempo che porta addosso. Intendo il tempo della stratificazione della conoscenza, dell’esperienza nel corso della vita, della memoria che detiene, degli approfondimenti che ha fatto, degli errori, delle incertezze e dei risultati che ha prodotto. Solo così potrà ritrovare l’autorevolezza che distingue nettamente il suo ruolo, insostituibile anche in una dinamica paritetica e restituisce peso alle sue parole e valore alla sua figura. Solo così egli potrà osare un giudizio di valore che in qualche modo possa essere interpretato più che come una sentenza sul già fatto, come un’espressione in relazione ai fatti della vita cui lo studente si troverà davanti al termine del suo percorso. Una vita al futuro perciò, che impegna le due parti a prefigurare una società prossima densa di valori e in continuo cambiamento. Tutto questo prefigura una modalità più laboratoriale che cattedrattica, più esplorativa che dogmatica, che lega la conoscenza ad una pratica continua, che sperimenta cose e relazioni. Le stesse relazioni che compongono quell’habitat in cui tutto ciò accade. Quando mi riferisco all’habitat alludo ad un ecosistema che si deve generare nel luogo dell’insegnamento, una fertilità d’atmosfera che si compone delle disponibilità reciproche, come abbiamo detto, ma anche di una qualità fisica dello stare assieme nel medesimo luogo e tempo. Uno spazio elaborativo dove si avvertono palesemente i segni del divenire, delle idee che scaturiscono, delle visioni che prendono forma. Un “laboratorio” aperto e in questo non assimilabile alle vecchie scuole di “maestri”, chiuse nelle loro certezze e convinzioni, nelle loro matrici e nelle loro riproduzioni. Mi rimane sempre nella mente una visita a Jamas, l’istituzione più importante del Giappone dedicata alle Arti dei Media. Accanto a studi attrezzati e aule efficienti risaltava l’importanza di un grande open space, suddiviso in modo molto semplice in una sessantina di micro studi, che gli studenti gestivano autonomamente come propri, seppur in una dimensione fortemente condivisa, un’area franca ma assolutamente congrua con lo sviluppo didattico d’insieme. Al pari della condivisione del lavoro, la condivisione del riposo. Che si svolgeva in una magnifica distesa di tatami, uno spazio silenzioso e di penombra meditativa, contrasto preciso alla vitalità degli ambienti precedenti. Un’effervescenza ritmica e armonica che si differenzia radicalmente dalla cultura dei corridoi, praticata dai nostri studenti e anche da qualche nostro insegnante. Un’atmosfera intensa che mi rimbalza anche ad un più antico viaggio fatto a Mosca alla storica scuola di cinema del Vgik, la scuola di Sergeji Eisestein e dei maggiori autori russi. Mi impressionò a quel tempo l’aula di montaggio, un enorme salone fitto di moviole dove almeno un centinaio di futuri montatori si stava esercitando al suono meccanico dei motori di trascinamento dei rulli. E qualche passo più in là in un altro ambiente, questa volta al suono di un brano classico, un gruppetto di ragazzi, maggior parte uomini vestiti con un improbabile tutina aderente, danzava con discreta leggerezza. “Scuola di danza?” chiesi al mio accompagnatore. “No, di regia” mi rispose. Atmosfere, magari non riproducibili, ma perché non sforzarsi di trovare la nostra via, il nostro habitat appunto. Credo che di elementi da mettere in gioco ne avremmo parecchi. Certo, in questa divagazione, si manifesta chiaramente il mio riferimento alle scuole che trattano i valori dell’arte. E’ la mia esperienza e potrebbe apparire parziale e limitata rispetto al complesso mondo della formazione. Tuttavia mi vengono da sottolineare due fattori che possono rendere questa riflessione più generale. Il primo è che la mutazione cui alludevo in apertura si sviluppa su una dimensione “sensibile” stravolta rispetto a ciò che conoscevamo. Oggetti, distanze, tempi, presenze fanno capo a percezioni radicalmente cambiate. In questo processo stiamo perdendo la nostra concezione di realtà oppure se si vuole essere più positivi stiamo assumendo nuove sensibilità di una Studio Azzurro, La Fortezza delle Emozioni – percorso multimediale permanente. Particolare dell’installazione Occhi di luce.Forte Belvedere Gschwent, Lavarone (Tn) 17 nelle scelte dei giovani, non è certo perché in esse trovano le fila di un collocamento al lavoro, ma forse, e su questo c’è davvero da riflettere, perché esse potenzialmente possono offrire gli strumenti per la creazione del lavoro, non solo nel settore della ricerca artistica, ma in mondo che richiede grande attitudine all’immaginazione e all’invenzione e che avrà sempre più bisogno di intelligenze visionarie per uscire dalle numerose emergenze da cui è afflitto. Sono tutte buone ragioni per non perdere l’occasione. Paolo Rosa docenti / nuove tecnologie realtà che si è resa complessa e svariata nella sua forma del visibile e dell’invisibile. Le arti si occupano proprio di sensibilità, si rivolgono al mondo del sentire, razionale ed emozionale, si riferiscono ai sensi propri ma anche al sentire comune. Quindi sono l’ambito adeguato per costruire esperienze fondamentali per dare forma e cultura a questo spostamento. La società dovrebbe puntare su questi “laboratori del sensibile”, investire massicciamente sulle sue sperimentazioni. Inoltre, ed è il secondo fattore, se queste scuole, accademie, licei, hanno un significativo indice di gradimento TULLIO BRUNONE docenti / nuove tecnologie 18 Detournement Venice, Palazzo Albrizzi - Venezia - 2010 Installazione interattiva - Computer/Video/Software/Specchio La gran semplificazione introdotta dai media comunica al pubblico la sensazione che i problemi siano anche facili da risolvere in tempi brevi . A. Arbasino È nell’esperienze del Laboratorio di Comunicazione Militante, intorno agli anni settanta, che troviamo le origini della questione teorica sulla quale si sono fondate una serie di operazioni ed interventi che hanno avuto, nella visione critica, analitica ed attiva di tale laboratorio , anticipazione di ciò che in seguito sarebbe divenuta la consapevolezza che gli strumenti che stavano apparendo nel panorama sociale e politico, avrebbero determinato un radicale e profondo mutamento nel complesso dell’elaborazione e dell’uso delle immagini nel sistema di comunicazione. Cioè che tale mutamento non avrebbe più funzionato come semplice arricchimento della strumentazione espressiva nello scenario della produzione artistica e della comunicazione, ...bensì che i sistemi espressivi che le nuove tecnologie proponevano, stessero aprendo una fase rivoluzionaria, con in prospettiva lo scardinamento e la modifica radicale del sistema della comunicazione, cancellando progressivamente, e sostituendoli, i criteri estetico/ linguistici, filosofici e sociali con la logica delle nuove immagini e del nuovo complessivo sistema che si stava prefigurando. La necessità e la logica della moltiplicazione dei riferimenti, la velocità di diffusione, l’incrocio dei territori e dei linguaggi, la diffusione sempre più capillare e personalizzata delle possibilità di auto produrre immagini, filmati e oggetti multimediali, ne sono la conseguenza. Da queste origini il lavoro si è vieppiù indirizzato nella convinzione che la sua natura stessa. non potesse prescindere da un profondo radicamento con il suo essere politico e sociale Da queste brevi considerazioni risulta evidente che la complessità del lavoro nel suo insieme, oltre all’attenzione rivolta al concetto di comunicazione, si pone mettendo in discussione i modi e i tempi tradizionali di realizzazione dell’arte. Infatti, il tema della comunicazione, nell’ottica dell’utilizzo in maniera prioritaria del mezzo digitale, del computer e del video come strumento di disapprovazione della pratica artistica tradizionale, crea un effetto di collegamento e di scomposizione capace di guidare l’esperienza artistica oltre se stessa e di darle una possibilità mediale per indagare in maniera analitica il proprio territorio. Questo passaggio tende anche a disconoscere drasticamente quanti si sono mossi sull’euforia dell’immagine digitale, simulando un trasferimento delle regole pittoriche classiche dell’iperrealismo nel mondo dell’immagine mediale, è in gioco invece un discorso più complesso: non si tratta più di perlustrare uno spazio ambiente elettronico tramite delle protesi tecnologiche, ma di con-venire con una ibridazione dello spazio fra corpo e macchina. Tale innesto riesce a gestire gli universi paradigmatici dell’immersione diretta nei luoghi della memoria, dove lo strumento tecnologico è stato superato da se stesso e dove l’ipotesi si è catapultata in una pratica interna all’oggetto stesso, dell’immagine e della sua spazialità. S’immerge sotto la superficie dell’immagine, per compiere una gestione diretta delle proprie attività, legate all’osservazione del mondo naturale che è lì a scontrarsi e ibridarsi con quello artificiale offerto dalla tecnologia. Si parla di proiezione fisica e quindi di corporalità diretta in grado di scoprire l’anima della rappresentazione, i dettagli dell’esistente più che il generico essere. Aspetto proveniente e innestato da quell’esperienza, il rapporto con la produzione e la partecipazione sociale, la profonda connessione apertasi fra le esperienze produttive e la possibilità di essere operatori nell’apertura di una disponibilità strumentale dallo smisurato potenziale proposto dalla commercializzazione e dall’abbattimento dei costi delle attrezzature produttive, per cui chiunque è messo nelle condizioni di produrre e realizzare. L’apertura delle conoscenze e delle esperienze per le quali vi è lo slittamento straordinario da consumatore/osservatore a produttore, in grado di possedere i meccanismi e gli strumenti, apre a sua volta e genera una nuova ipotesi, la relazione fra creatività e creazione, nella definizione di produzione istintiva o di invenzione unica del progetto. Ci troviamo dunque in un territorio dove la socializzazione dei mezzi di produzione è stata uno dei punti fondamentali nell’esperienza degli anni settanta. Dove l’aspetto laboratoriale è stato uno dei momenti qualificanti della ricerca artistica in generale, che gradatamente si è trasformato e trasferito attraverso un lavoro di elaborazione e di sviluppo nella struttura didattica, originando le premesse di quello che poi sarebbe divenuto elemento determinante nella impostazione degli schemi che hanno dato origine con altri collaboratori provenienti da quelle esperienze, al nucleo di base originario della scuola di Nuove tecnologie dell’arte dell’Accademia di Brera. *«Nel XXI secolo è necessario mettere in discussione il mòodo di creare l’immaginario esteriore ed interiore, il significante ed il significato delle cose ed il nostro modo di rappresentarlo non come una volontà in atto, ma come fatto concreto, un luogo dove interagiscono metamorfosi possibili senza scindere l’aspetto tecnico da quello poetico...». Tullio Brunone *Com. Scientifico Scuola Nuove tecnologie dell’Acc. Di Brera. (A.Balzola, G.Baresi, T.Brunone, E. Quoghi, M.Folci, G.Pedote, P.Rosa.) Verso una coevoluzione delle arti e delle scienze Se fondere le due culture Bisogna a mio parere partire dalla constatazione che viviamo in un universo che è in sé inconcepibilmente creativo, e questa creatività si riflette in tutti i domini e a tutte le scale di osservazione. Forse, la parte più esaltante di quest’epoca di tumultuose trasformazioni sta proprio nel fatto che il mondo intero è per la prima volta testimone in diretta della forza pulsante di siffatta incontenibile creatività: la quale precede e supera tutti gli schemi. In altre parole, ciò che viene creato, ciò che sorge dalle matrici, è quasi sempre assolutamente unico nel suo genere, e irripetibile. Per questo motivo si assiste da qualche tempo a un fenomeno singolare, poiché sembra quasi che la fiaccola della creatività sia passata nelle mani del più veloce tra i tedofori, rappresentato dalla scienza nel suo complesso. In un certo senso oggi la scienza supera e precorre l’arte. Non è forse un’opera d’arte la cellula artificiale creata da Craig Venter? Non dubito che questa straordinaria invenzione avrà una ricaduta impressionante nella pratica artistica, nel senso che è impossibile che essa non suggerisca ipotesi, percorsi creativi, cortocircuiti. C’è quindi sempre una ricaduta delle tecnologie, di tutte le tecnologie e di tutte le scienze. Ma vanno fatte due precisazioni: non esistono le scienze “al plurale” e le tecnologie “al plurale”. Esistono, certo, le specializzazioni, anzi esse crescono con il fiorire della complessità. Però, tutti i settori della ricerca appartengono allo stesso universo di fenomeni, sono sfaccettature di una stessa manifestazione globale, il che può sembrare a prima vista nebuloso, ma non lo è, se si considera la nozione di universo “non ergodico”. Secondo: se si studia l’immaginario che precede e prepara l’attuale civiltà, e se si sottopone questo immenso materiale all’analisi 19 docenti / nuove tecnologie Di Riccardo Notte comparativa, e se infine si considera il testo (nel senso di qualunque reperto culturale) come impronta che struttura la progressiva formazione di miti, di aspettative, di concezioni generali di idee universali quali la “vita”, la “macchina”, il “mondo”, l’”evoluzione”, l’”uomo” etc. , ci si accorge molto in fretta che i pilastri delle attuali ricerche scientifiche o tecnologiche emergono dalle sorgenti dell’immaginazione creatrice, per usare un’espressione bergsoniana. L’immaginazione precede e prepara qualunque realizzazione, anche tecnologica. Questo asserto si oppone a ogni ipotesi di determinismo tecnologico . Vale invece il principio della reciproca fecondazione o ancor più dell’autofecondazione. L’immaginazione e le scienze “dure” si comportano in un certo senso come quelle specie di invertebrati ermafroditi in cui una sola gonade funge per ambedue i sessi; nel senso che basta una minima innovazione teorica o tecnica ed ecco che su di essa, se le condizioni di sviluppo sono favorevoli, si innesta una immensa matrice inventiva che coinvolge tutte le arti, ma prima di ogni altra la letteratura, perché essa è narrativa e pertanto si riallaccia alla funzione primaria della comunicazione, ovvero all’oralità. Se torniamo all’esempio della cellula artificiale intesa come opera d’arte, ebbene esiste un famoso testo del 1962, scritto non a caso da uno scienziato con la collaborazione di uno scrittore, in cui si immagina la costruzione del DNA artificiale per mezzo e sulla base dell’hardware e del software, insomma via computer, ovviamente alieno. Questo romanzo è A come Andromeda, dell’eminente astrofisico Fred Hoyle e di John Elliot, libro poi trasposto in uno sceneggiato televisivo di successo. In realtà, le idee seminali sono perfino precedenti e in parte affondano le loro radici nella letteratura fin de siècle. Ma il computer che progetta il DNA sintetico (in forma di una sublime bellezza femminile – autentica Galatea biomeccanica) è una vera novità, se si pensa che nel ’62 il modello teorico di Watson e Crick, basato sulle indagini fisico-chimiche di Rosalind Franklin, aveva appena nove anni e la prima conferma sperimentale appena quattro! Il fatto che la penna sia stata impugnata da uno scienziato, non è insignificante. Se si esplora la letteratura si resta sbalorditi dalla quantità e dalla qualità delle menti scientifiche che si sono cimentate in un genere considerato di evasione, ma che di evasione non è, perché è in realtà di prefigurazione, di esplorazione dei “possibili adiacenti”, per dirla con Stuart Kauffman. È come se la scienza nel suo complesso sentisse urgentemente il bisogno non tanto di comunicare (sarebbe banale, e poi esistono agenzie specializzate che sanno farlo benissimo) ma soprattutto di scandagliare con la libera immaginazione il ventaglio delle possibilità accessibili in quel determinato momento storico. Però, sia chiaro, ciò non è prerogativa degli scienziati. Se esiste un campo di convergenza delle più svariate intelligenze questo è proprio l’interzona fantastica e terribile dell’immaginazione. La quale fa paura. Anche perché mette in gioco elementi di rottura, non di ricomposizione. Mi viene in mente quanto scrive Federico Gustavo Pizzetti, docente di Istituzioni di Diritto pubblico alla facoltà di Scienze Politiche di Milano. Pizzetti si occupa delle relazioni tra le neuroscienze e il diritto, materia di grande attualità. Egli definisce “paradosso dell’alieno” il fatto che le neuroscienze stanno avvicinandosi al punto in cui sarà possibile in un certo senso “ristrutturare” varie funzioni cerebrali superiori. A quel punto sorge un dilemma: chi decide per chi? Posso io, soggetto e oggetto dell’intervento, decidere sulla base della mia attuale personalità tutto ciò che riguarderà la vita di un “sé” completamente diverso dal mio? Di un “sé” alieno? Bel dilemma. Però, a ben vedere, il paradosso dell’alieno è esportabile in tutti i settori, e non a caso lo stesso Fred Hoyle lo usò come metafora di quel processo di radicale ripensamento del concetto stesso di “vita” che sarebbe derivato dal connubio tra l’informatica e la biologia. Questo tema ci porta dritto a considerare le spinte e le resistenze ai mutamenti. Le trasformazioni provocano instabilità e spunta sempre un largo fronte di resistenza a ogni instabilità. Esemplare, oltreché relativamente recente, resta l’instabilità introdotta dalle tecnologie informatiche, il cui epifenomeno è il web. Ne feci a suo tempo esperienza. Quando alla fine degli anni Ottanta iniziai a occuparmi delle relazioni tra l’arte, le tecnologie informatiche e il Media System scoprii con sorpresa un fronte di resistenza pazzesco. Nessuno mi dava credito, anche se le fonti erano di prima mano, perché attraverso un canale docenti / nuove tecnologie 20 diretto seguivo quanto si discuteva negli Usa. Solo dopo oltre un anno d’incessanti perorazioni, esortazioni e preghiere riuscii a pubblicare nel marzo 1991 sulla rivista “Mass Media” un lungo saggio sulle realtà virtuali e sui primi esiti dell’Internet. Però sotto la voce “azzardi”. Non mi ero reso conto che lo stesso standard del sistema di comunicazione di quel tempo reagiva emettendo “anticorpi” all’ipotesi di un’innovazione che ne avrebbe scombussolato gli assetti, come poi è accaduto. È un esempio fra i mille del “paradosso dell’alieno” di Pizzetti. Si avverte a pelle che dietro l’angolo si cela un alieno “mostruoso”, “incomprensibile”, imprevedibile; e si reagisce col sistema delle sabbie mobili. Il che è inutile, perché l’innovazione trova le sue vie. Infatti, passano manco dieci anni ed ecco che “virtuale” diventa sinonimo di “banale”. In realtà ogni società , ogni civiltà prepara il suo “alieno”. Però la novità risiede nell’accelerazione, già evidente in tutto il secolo scorso, ma mai così pressante come al giorno d’oggi. Due o tre lustri sono bastati a rivoltare come un guanto i paradigmi dei tre o quattro decenni precedenti. Infatti il crollo dei blocchi, la globalizzazione della finanza e la pervasività del mercato mondiale vanno di pari passo con la rivoluzione del web, la robotica o la post-genomica. E sfido chiunque ad affermare in coscienza che ci si è davvero adattati al nuovo. Eppure, non siamo ancora emersi alla superficie dell’ultimo oceano che già si annunciano altre, più ampie e ancor più accelerate rivoluzioni. Questo ci porta a considerare una questione delicata ma centrale: che ruolo svolgono le istituzioni (che come dice la parola stessa “stanno”, non si muovono)nella rivoluzione perenne dei rapporti? Questo problema investe anche un’istituzione così flessibile come l’Accademia di Belle Arti. Però, per quanto flessibile (suo valore aggiunto spesso trascurato), essa è sempre un’istituzione, perciò soggetta a recepire, spesso traumaticamente, più che a governare, il processo di trasformazione, almeno in Italia. Se si torna al settore che ho scelto come esempio, ebbene si registra anche nell’attardatissima Italia un fronte di sperimentazione avanzata nei domini della bioarte e della nanoarte, campi apparentemente distanti ma in realtà convergenti. Ma non mi risulta una ricezione degli stessi domini da parte dell’istituzione accademica. Un po’ meno attardati lo si è in altri settori, al confine tra la comunicazione e l’arte. Però, anche in questi casi, con l’idea che sia l’istituzione a reggere il vessillo, mentre nella realtà essa regge la candela che illumina fiocamente attori sociali che trovano altri percorsi per esprimere quanto vibra nell’aria. Come superare tale punto morto? Non c’è che una soluzione: aprirsi. * Riccardo Notte è docente di Antropologia culturale presso l’Accademia di Brera, a Milano, dal 1997. Dalla fine degli anni ’80 inizia a studiare le ricadute sociali, politiche e culturali delle nuove tecnologie di comunicazione, pubblicando su questi argomenti i volumi Millennio virtuale (Roma, 1996), La razza stellare (Roma, 1999), La condizione connettiva (Roma, 2002), You, Robot. Antropologia della vita artificiale (Firenze, 2005), Machina ex Machina (Roma, 2008). È stato redattore del bimestrale «Mass Media», storica rivista di studi sulla comunicazione, che ospitò la prima riflessione organica apparsa in Italia sul fenomeno emergente dell’Internet. Modi del sentire parlare, 2008 Studio Azzurro, Museo Laboratorio della Mente: Parlare nell’area denominata Modi del sentire. Percorso multimediale permanente situato nell’ex Ospedale Psichiatrico Santa Maria della Pietà di Roma GABRIELE GIROMELLA Il teatro di figura come scultura ‘aperta’ Di Anna Maria Amonaci ha approvato l’attivazione del biennio specialistico all’interno del medesimo dipartimento di Scenografia). Si tratta di un laboratorioofficina, quello che ha attivato Giromella, ispirandosi ai cantieri medievali, frutto di apporti collaborativi costanti, “fatti di tanti saperi, di ricerca, di sperimentazioni”(1), teso a riconsegnare all’oggi un genere espressivo confinato dal dopoguerra nella cerchia delle attività per l’infanzia; nella certezza che il teatro di figura, recuperato storicamente, possa offrire “un ampio spettro di comprensione delle cose”, per via del suo “vasto ed eclettico linguaggio metaforico”(2), tanto da emozionare un pubblico ben più ampio ed eterogeneo di quello attuale. Con Giromella mi sono incontrata di nuovo, stimolata dalla sorpresa ricevuta, per capire meglio ciò che lo spinge a dedicarsi in pieno a questo genere teatrale; quale nesso, insomma, vi ritrovi con la scultura, tenendo conto tuttavia che l’interesse per la marionetta è stato un fenomeno costante nelle sperimentazioni di avanguardia del Novecento. In ambito teatrale Gordon Craig, nel primo decennio del secolo, in consonanza delle ricerche astratte, teorizzò la sostituzione dell’attore con la «supermarionetta», affinché fosse reso a pieno il valore della levità in uno spazio tutto mentale, tradotto con la semplificazione delle scene per rappresentare sul palcoscenico puri stati d’animo. Penso poi a Tadeusz Kantor, che di Craig colse tutto il portato, al suo utilizzo negli anni Settanta di manichini dai volti di cera gravanti sulle spalle degli attori in La classe morta, a significare il peso e insieme il valore del passato per il riscatto dell’immaginazione. Quanto agli artisti visivi, rammento Fortunato Depero e il suo uso di marionette, secondo l’ottica futurista di dinamismo, al posto di attoriballerini in Balli plastici (1918). Nell’ambito performativo anche Dennis Oppenheim si è avvalso della loro esile consistenza per misurarsi con i concetti di “dematerializzazione” e di “metamorfosi”, come nelle istallazioni Theme for a Major Hit e Attempt to Raise Hell, entrambe del 1974, dove “le marionette simulano i movimenti dell’artista”(3). Riguardo più in generale all’impiego di manichini e di pupazzi: i primi – com’è noto – connotano stilisticamente le opere surrealiste, rappresentando paradigmi di silenzi oltreumani; i secondi, quali metafore dell’uomo svuotato di senso, sono assai in uso nel tempo corrente. Esemplari appaiono le geniali ironie corrosive che vertono al tragico di Maurizio Cattelan. Ma l’attenzione di Gabriele verso i personaggi inanimati del teatro di figura – non soltanto burattini, marionette, figurine di carta – mi pare scaturisca da motivazioni di natura direi più intima, mirata a suscitare emozioni, toccando le corde degli affetti, piuttosto che attenta ad 21 docenti Fine giugno 2010. Brera in clima di esami con i corsi terminati da poco: qua e là qualche studente, ancora meno e di fretta i colleghi. Mi aggiravo per i corridoi alla ricerca dell’aula, anzi del laboratorio di Giromella, per chiedergli informazioni sulla modalità di iniziative culturali dell’Istituto. L’ho conosciuto oltre un decennio fa all’accademia di Carrara, dove si è formato scultore, ma in quel tempo vi insegnava anatomia artistica. In seguito ci siamo rivisti a Milano. Sempre gentile col suo accento triestino, ha mantenuto l’aria un pochino spiritata che ricordo di allora. Riguardo alla sua didattica a Brera, mi ero fatta idea che fosse di indirizzo meramente tecnico, stando anche a quanto dicono gli allievi sulla bontà delle pratiche di mestiere che acquisiscono presso il suo laboratorio. E poi l’avevo visto quasi sempre affaccendato in mezzo a cavi elettrici, fari e faretti, strutture di metallo e così via. Con scarso entusiasmo, in prospettiva di un incontro su questioni logistiche, sono entrata allora nella stanza. Ho aperto anzi la porta quasi con noia, una noia però più generale e di lungo corso, dipesa da un senso di monotonia rispetto per esempio a gran parte dei soliti fatti artistici odierni che lasciano in fondo l’uggia del ‘già visto’. Al primo colpo d’occhio mi è parso un ambiente laborioso, con diversi studenti prossimi a un bancone pieno di oggetti, su cui spiccavano, fra libri e materiali plastici, coloratissimi burattini in costruzione. Teste di legno e di argilla, stoffe, carte, nastri erano sparsi intorno; una folla altrettanto colorata di pupazzi e figurine si intravedeva dalle grandi sporte semiaperte degli armadi a muro che testimoniano della passata vita conventuale di Brera. Forse nell’aula di Giromella era ubicata la cambusa del refettorio. A ridosso della porta, in bella vista, catturava l’attenzione una fila gremita di marionette pendente da un’alta impalcatura. Colpivano in particolare i volti di quei pupazzi: Arlecchino, Pulcinella e gli altri personaggi della commedia dell’arte si succedevano dinoccolati accanto a Cenerentola, Don Chisciotte, il Diavolo, principi, turchi, ballerine; vicine, dondolavano ancora altre marionette, per lo più vestite nell’esuberante foggia seicentesca, ma anche con panni del nostro tempo, come quella di un milite dal volto sparuto di ragazzo. Un insieme rutilante di attori muti dai grandi occhi incisivi. Così ‘veri’ mi sono apparsi quei fantocci dalle smorfie accentuate! Tutti quanti erano lì a richiamare emozioni sopite, nel loro essere parodie dei caratteri umani. È seguito un incontro davvero inaspettato: Giromella e il suo collaboratore, Pietro Marchese, mi hanno parlato del laboratorio del teatro di figura, attivato nel 2003 nell’ambito dell’offerta formativa della Scuola di Scenografia (è di pochi giorni la notizia che il CNAM accademia docenti di catania 22 attivare energie sensoriali o cerebrali, in riga con le sperimentazioni di avanguardia. Sperimentazioni che trovano origine nella concezione modernista dell’«Uomo nuovo», la cui struttura, aveva scritto Lázló Moholy-Nagy nel 1925, “è la sintesi dei suoi apparati costitutivi, dalle cellule agli organi più complessi”(4). Pertanto all’arte veniva affidato il compito di attivarli fino “ai limiti delle loro facoltà biologiche”, attraverso la produzione di “nuovi rapporti [...] tra i fenomeni ottici, quelli acustici ed altri fenomeni conosciuti e ancora sconosciuti, e di farli assimilare in misura sempre maggiore agli apparati funzionali”(5), al fine di giungere alla resa massima di questa ‘macchina’, organicamente perfetta. Un altro registro interpretativo riguardo al fare artistico mi pare si avverta da parte di Giromella, anche in un suo scritto sul teatro di figura, dove già dalla scelta delle parole appassionate, traspare un diverso modo di intendere la funzione stessa della forza dell’arte. Una forza – mi ha detto di recente – che sia “evocativa e veicolo di trascendenza”, capace “di esorcizzare il ‘male’ per via della stupefazione, della meraviglia, di intensità espressive, colme di affetti”, attivando, in una “dimensione di ritualità, la comunicazione ‘aperta’, ossia quel senso di mutazione e di rinascita, proprio dell’opera rigeneratrice”. Un teatro a cui egli affida il compito – ha scritto – “di far emergere dall’oscurità la bellezza della metafora dell’uomo, il senso poetico, il significato simbolico, la comprensione del sacro”(6). Un brano intenso, pieno di sentimento per comunicare il significato dell’atto teatrale, ossia offrire una visione coinvolgente, quella dello “spettacolo”, appunto. Per cui il “linguaggio deve rimanere limpido, comprensibile, emozionale non semplicistico né ridotto né banale, (giacché) la sua grandezza sta nel poter raggiungere tutti i livelli di comprensione dell’essere umano”(7). E a fronte di operazioni che ‘congelano’ il teatro di figura, inserendolo nei repertori di folclore del passato, il più delle volte confinate ai circuiti formativi per l’infanzia, egli si appella al potere evocativo dell’opera da trasmettere all’oggi: “L’artificio si consuma, non si conserva – prosegue il testo –, va celebrato, vissuto nel luogo del mistero, perché esso rinnovi il suo ciclo vitale di energia e di emozione; in questo modo la poesia si libera e passa vibrante su chi riceve il segreto messaggio”(8). Nella seconda conversazione Giromella mi ha raccontato che al teatro di figura è approdato riflettendo su “come poter esprimere a pieno la mutevolezza, la trasversalità, il senso del divenire”, nella volontà di dare forma a opere ‘aperte’. D’accordo con Arturo Martini, sul limite della statuaria come «lingua morta»(9), essa gli rappresenta, nella sua finitezza di oggetto concluso, una sorta di “cesura, di arresto, rispetto alla comunicazione piena”, a differenza della terracotta che permette, grazie alla duttilità della materia, usata magari nella quantità minima necessaria al bozzetto, di esprimere intimità profonde “con immediatezza e sincerità”. Sull’argilla facilmente si imprimono quei gesti minimi, ogni volta unici, come “l’impronta lasciata dal polpastrello”, per esempio, seguendo con maggiore velocità il flusso del sentire, “secondo un andamento progressivo che è poi quello del racconto”. E ancora: “L’argilla per la sua semplicità è veritiera, subisce trasformazioni che si impressionano e si cristallizzano col fuoco; essa è come la vita dell’uomo, adattabile alle mutazioni degli eventi che, succedendosi, infine la determinano”. Proprio questo senso di “apertura, ben più che con la duttilità dell’argilla”, egli l’ha avvertito attuabile attraverso “la mobilità dell’atto teatrale” – mi ha detto –, chiarendo il passaggio dalla scultura. Un atto teatrale che sia innanzitutto “rappresentazione di spazi interiori, dove, con l’apporto tecnico necessario, unificante la magia della luce e il portato musicale, si dia pieno svolgimento allo stupore e alla meraviglia. A fronte dei rischi ghettizzanti dei pensieri unici, il teatro di figura, grazie all’infinita possibilità espressiva che possiede, può comunicare invece totale trasversalità, proprio per la varietà di scelta dei suoi diversi elementi ‘recitanti’: dalle marionette, ai burattini, alle figure del teatro delle ombre, di quello ‘su nero’ e dell’oggetto, fin’anche ai mimi e ai ballerini. La cui eventuale entrata nella scena è intesa alla stregua degli oggetti inanimati”, cioè semplici corpi, funzionali ad arricchire la suggestione dello spettacolo. “Della scultura – ha precisato poi – “respingo fortemente due cose: la prima l’autoreferenzialità dell’oggetto, che richiede un’infinita produzione di scarto prima della sua messa a punto. Intendo che per creare uno dei tanti pezzi esistenti al mondo, devi violentare la materia, sia essa roccia, pietra o marmo. La purezza è essenzialità, e necessita di pochissime cose. La scultura corre il rischio di una super produzione di oggetti sui quali l’artista appone la firma, tramutandoli in feticci ambiti dal Mercato. L’altro aspetto che della scultura mi dà il senso di limite, è la violenza spesso arrecata al contesto ambientale, perché il più delle volte, la sua collocazione non tiene di conto del rapporto con lo spazio circostante. Da ciò viene meno quella fruibilità che sarebbe il fine stesso della scultura, una fruibilità data dalla perfetta integrazione dell’opera nello spazio che l’accoglie, al fine di restituire un sentimento di appartenenza a chi il luogo infondo lo vive”. Riguardo alla formazione, gli ho chiesto poi quali maestri avessero concorso alla messa a punto dei suoi stilemi espressivi. Così lui: “Nonostante quanto abbia detto sulla scultura, fino dai primi del Novecento si sono poste le basi affinché essa toccasse corde più intime, che non 1 Presentazione dell’«Associazione Teatrino Girò», opuscolo a cura di G. Giromella, 2009, p. IV. “L’associazione si è costituita nel marzo 2001 a Fosdinovo (Massa Carrara), allo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza artistica, in particolare agendo in due specifici settori: quello della produzione di spettacoli per il teatro di figura e quello della formazione di una compagnia di teatro popolare dialettale”. 2 Ibidem. 3 Comunicato stampa (Paola C. Manfredini Studio) della mostra Dennis Oppenheim. Materia Interchange. Opere 1968-1974, a cura di A. Fiz, Galleria Fumagalli (5giugno-20 novembre), Bergamo, 2010. 4 L. Moholy Nagy, Pittura fotografia film, a cura e traduzione di A. Negri, Scalpendi, Milano 2008, vol. I, p. 56. 5 Ibidem. 6 Le frasi riportate sono tratte dal comunicato di G. Giromella, letto in occasione dell’incontro I patrimoni del Teatro di Figura: necessità della conservazione, tutela della memoria, opportunità dello studio, Giornata di studio promossa dall’Università degli Studi di Bergamo e dalla Fondazione Benedetto Ravasio (lunedì, 14 dicembre 2009), Auditorium del Collegio Sant’Alessandro, Bergamo. 7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Il riferimento è allo scritto di A. Martini, La scultura lingua morta, uscito nel 1945, ripubblicato a cura di E. Pontiggia, La scultura lingua morta e altri scritti, Abscondita, Milano 2001. 23 docenti adempiere a funzioni quasi del tutto celebrative. Penso a Medardo Rosso, capace di tradurre sensibilità epidermiche per via di una materia mutevole, a seconda delle vibrazioni della luce, come la cera. Una luce che dà vita alla forma. Le sue cere, infatti, si animavano con la luce, per meglio rendere il valore della leggerezza, abbattendo il peso della materia. È proprio nell’impiego della cera, per il suo potenziale di mutevolezza che avverto nell’opera di Medardo Rosso il senso della comunicazione”. “Intendi dire, Gabriele – gli ho chiesto – che la plasmabilità della cera per te acquista significato di ‘apertura’, ovvero quel potenziale comunicativo che tu cerchi nell’atto teatrale? E lui: “Appunto, giacché il teatro rappresenta lo spazio vitale, dove può avvenire massimamente il momento dell’incontro”. Se Medardo Rosso lo induce a riflettere sulla materia ‘plasmabile’ con la luce, a Fausto Melotti Gabriele si ispira per il “senso di levità” che affiora dagli scenari dei suoi teatrini, dove gli “spazi, organizzati secondo metrica musicale”, traducono precisioni ideali esaltanti la sinuosità delle forme. Egli rimanda infine a Depero per “l’apporto della tecnica e della meccanica, in chiave di produzione seriale, a fronte della pratica del mestiere”. Sono dunque tre le coordinate direzionali nella ricerca di Giromella: l’attenzione alla luce, che determina il divenire dello spettacolo in opera ‘aperta’; il riferimento alla precisione della metrica musicale, per la progettazione e l’ordinamento delle scene; il tenere ben presente il portato tecnico, affinché, con la riunione del tutto: valori luminosi, musicali e tecnici, si attualizzi il senso dello spettacolo che in fondo è la resa ‘plastica’ di un “percorso metaforico e mentale”. Di più: è la messa in atto di un’apertura comunicativa totale, così che, con l’immaginazione accesa, il sentimento di libertà apra l’anima al canto. Allora comprendo la levità provata alla vista, lì per lì, di quell’insieme variopinto di pupazzi dai panni sgargianti, appesi ai fili o montati su buffi manicotti, in attesa di animarsi nello spazio dei sogni. *Gabriele Giromella è docente di Teatro di Figura all’Accademia di Belle Arti di Brera *Anna Maria Amonaci è docente di Storia dell’Arte e della Fotografia all’Accademia di Belle Arti di Brera Senza Titolo, 2010, installazione, materiali diversi, dimensioni ambiente docenti 24 RADU DRAGOMIRESCU RADU DRAGOMIRESCU, UNA QUASIRETROSPETTIVA1 Segno e disegno della dolce morte Bucarest, giugno 1998 Di Ruxandra Balaci Principio vitale, trasforrnativo della Vita stessa, la “buona”,”dolce”, “cara” Morte6, dall’ala fugace - un funebre paradossalment delicato, (Allegro funebre ma non troppo...) è percepibile nel volo degli oiseauxscheletri, nelle fronde, onde, nubi, nella nebbiolina misteriosa, avvolgente, quasi simpatica...7 Una “monografia dell’oscurità leggera”, la dimensione serena del notturno. (“Cette obscure clarté qui tombe des etoiles”, Anselm Kiefer). ...Nigredo e albedo (anche come metaforiche polarità del disegno...) Nei disegni, come anche nelle installazioni o negli oggetti-sagome, le aure di muffe e gas evanescenti dileguano - estompando contorni e concetti - subentrando l’eterico, lo svanimento del trapasso l’indefinibile fantasma inavvertito, fragile ma possente, presente ovunque in natura8. (Dans la mort il y a la vie, d’une écrasante fragilité...) Vi è suggerita la mobilità dell’immutabile. Materie acquose-aeriformi colano lentamente, generando trasparenze squisite, ma anche opacità o atmosfere soffuse (“Velo d’aria”). Agenti argentei, cenere o artificiosamente colorati spariscono nell’Athanor, nell‘esoterico Graal 9 ancora segno di deperizione, risoluzione e trasformazione. A un certo punto il lavoro stesso può anche (deve) sparire, ritualmente volendo. L’iconografia con la quale Dragomirescu opera cela una sorta di bizzarro iconoclasmo: il personaggio umano è quasi sempre “velato”, nascosto, o parzialmente occultato; sagoma, angelo-fantasma, pupazzo-mummia inquietante, sussiste come segno generico per la specie, non come entità individualizzata10. L’apparenza è, al massimo, quella di un’effigie, alter ego impersonale (I Gemelli), oppure spoglia di un archetipo (Ellie). La presenza di altri esseri, piante, animali è metonimica per la supposizione eudemonica del New Age come comunione universale (highest degree of integration in nature). Come esempi: il daino, la colomba, ma soprattutto il leprotto. Quest’ultimo - Re della palude - una specie di gynn lunatico, possibilmente, un muto alter ego11, è, ancora, taciturne pulsion de vie, sottolineandone la velocità. Spirito vitale ed erotico, può anche nascondere il complementare thanatico; lo scorrere bisbigliato della vita e il sussurro del vento nella palude. Egli pure ode l’inudibile, è inafferrabile ed invisibile... Nell’Iconologia del Ripa, alla quale è interessante rimandare per certi aspetti iconografici, citando l’antica autorità egizia, la Lepre è anche segno di solitudine. Solitudine benefica, fonte di studio, possibilità di mantenersi candido e puro12. Altri elementi iconografici con connotati cosmogonici e mistagogici riprendono un simbolismo archetipale arricchito di nuances e significati personali. A questo esempio le piccole sfere o il cerchio, manierismo onnipresente, rimandano all’atomo princeps costituente la materia, al vuoto, primordiale, roteante, fonte di mondi e di vita (nel Ripa la forma circolare o il globo sono simboli d’eternità). Congruenti alle stelle nella notte, indicanti le testoline degli scheletri-oiseaux13. Oppure l’arco celeste o arcobaleno (ovviamente simbolo d’aria nell’Iconologia) sposa forse la definizione New Age - “reminder of a bridge that once existed between Henven and Earth and was accessihle to all people.” Come pure sembra sposasse occultamente, la materia ed il significato globale di quest’opera un’altra definizione New Age legata alla nozione di Deepening - “reclaiming the dark the fertile Earth where the hidden seed lies unfolding, the unseen power that rises within us, reclaiming all the lost parts of ourselves” (Starhawk). Finalmente, un motivo-chiave, che rifugge ad un’accezione superficiale, ma che si evidenzia alla lettura più accorta, è la Croce. La Croce, simbolo eccelso di Morte e Resurrezione, compimento 25 docenti Poetico, rappresentativo e simbolico, peccando forse per un eccesso di erudizione, il lavoro di Radu Dragomirescu contiene come pervadente metafora quella della Morte, percepita parimente come vita della Natura e cangiante interregnum, come decomposizione (alchemica) e trasformazione degli elementi, come notturna riflessione sull’Essere e sul Tempo. Si partiva da “installate” Nature Morte2 (anni’70-80) - vanitas clamando la deposizione della materia fiorente - grandi tavoli imbanditi recanti frutta, agrumi e fronde (con varianti le teche di vetro cubiche o ampie superfici cosparse di terra) - “o pus lentI” che marcivano, macchiavano, defluivano gas, essiccavano finalmente, svanivano nella realtà, lasciando macchie, tracce, ombre... E mentre svanivano vi si ritrovavano, soavemente configurate, impronte fantasmatiche, equivalenti delle “suprasensibili” proiezioni platoniche, nei disegni. L’Opera si produceva con evidenza, illustrando la complessità del processo di degrado, di deperizione, del morire nel reale e del risorgere “altrove”. Pourissement materiale e sublimazione proiettiva/ideale3. Fotografie e acquerelli, schizzi delle installazioninature morte, di trasposizioni di queste, di dettagli o di frammenti macrotizzati sono serviti come strumentazione investigativa per la finale, sofisticata elaborazione del disegno. Scarno, non estraneo da trame geometriche di tipo rinascimentale, il disegno di Dragomirescu è stato qualificato come “altamente innaturale (...) una schizofrenia tra naturale e artificiale” (Mauro Panzera) o come “scheletro” e “cenere” (Bonito Oliva). Non è un disegno ortodosso, anche se lo potrebbe sembrare ad una superficiale ricognizione, giacché nutre un doppio paradosso: da un canto la negazione della propria funzione accademica - il disegno è pittura, affresco, installazione, work in progress; da un altro canto, la negazione della propria sostanza: seppure appariscentemente scarno ed esile, quasi immateriale, è invece, di fatto, assai denso, palpabile, addirittura “costruito”, lavorato in strati orizzontalmente sovvraposti di grafite4. I disegni sono autonomi o parti integranti delle installazioni, piccoli, medi o notevolmente grandi, su tela preparata, carta intelata, calco, legno, evanescenti ma esibiti ovunque, insinuati e pervadenti allo stesso tempo. Talvolta vengono occultati, sovvraposti da altri, continuando a esistere; il non mostrare mai tutto, il non spiegare mai tutto, l’intuito ineffabile preso come regola d’intesa, come “frequenza d’ascolto” implica esoterismo, iniziazione, il saper guardare... Secondo l’opus alchemicum ma anche secondo Beuys: “Un’opera è tanto più notevole quanto meno la si comprende. Quanto meno è comprensibile tanto più è giusta. L’arte non è fatta per essere compresa.” 5 La non-definizione sotto apparenze di esattezza, la dileguazione del senso in tenue sfumature della forma... ...udire l’inudibile, vedere l’invisibile, toccare l’intangibile... sembrano essere gli esiti dell’arte di Dragomirescu. ...cogliere la leggerezza (grafica) della Morte sotto la (disegnata) peau de l’oeuvre. La Morte sembra non-drammatica, non-angosciante; senza il pathos dell’irreversibile, è trasformazione armonica, ciclica, naturale della natura in Natura. ...il 13 del Tarot, il solve et coagula del rito alchemico; panthanatisme, morte e vita come alternativa e complemento. Sotto il segno della trasformazione - il lento, spettacolare marcire dissolutivo-risolutivo... L’o pus lento è il bacio lieve, soave della Morte positiva: “Death process of dissolving ourselves to become more harmonious on another level” (Michio Kushi). 26 docenti Senza Titolo, 2010, installazione, materiali diversi, dimensioni ambiente più opera a parete (Ho freddo, tanto freddo, 2010, grafite su tela, 97 x147 cm) dell’universale ciclicità, memento mori e pegno del mito dell’Eternel Retour. Ed è questo, forse, il senso fondamentale dell’opera di Radu Dragomirescu... The paradoxical permanence of transience.. . Note 1) “Quasiretrospettiva” informale, perché vi si ritrovano le principali tappe del suo percorso artistico, qualché in parte liberamente interpretate: certi lavori, rifacendosi a tappe anteriori, sono inventati sul e per il posto - il Museo Nazionale d’Arte di Bucharest. Inoltre è questa la prima presentazione ampia di Radu Dragomirescu in Romania, sua terra d’origine, dopo 25 anni di assenza. 2) Originanti nelle nature morte napoletane, ma epurate, portate verso una risoluzione astrattizzante, una “razionalizzazione” e un’artificiosità ricercata, equiparando un’astrazione teorica del discorso visivo. Le teche cubiche con frutta e agrumi in putrefazione (che ricordano anche i Kondensation swurfel di Hans Haacke) richiamano alla mia attenzione soprattutto un reperto del Museo di Capodimonte, la Grande Fiorera di mogano Empire, con un elemento centrale una teca di vetro semisferica contenente frutta falsa; R. D. ha trascorso a NapoIi, a Capodimonte appunto, i primi anni del suo soggiorno in Italia, prima di stabilirsi a Torino. Non per niente a caso gli influssi e l’empatia dell’artista con le “alchemiche” Napoli e Torino, le due città italiane di forte tradizione esoterica. L’adottiva razionalità, tipicamente subalpina, fusa alla vocazione mistico-esoterica - particolare per Torino, punto di riferimento per la Cristianità e centro magico, vi si ritrovano, in R. D. assieme ad un pervadente sentimento di comunione con la natura. 3) È da vedere l’ispiratissimo testo di Mauro Panzera, nel cat. di R. D.: Dove (Solitario Sole), Loggetta Lombardesca, Ravenna, l996: “L’immagine di Dragomirescu è il punto esatto del passaggio tra una vaporizzazione e una mineralizzazione” (...) “L’immagine si forma tra vapori e minerali”.. Citerei anche le annotazioni estremamente pertinenti sulla cromatica: “La sua tavolozza è altamente innaturale. teorica. Il nero, il bianco, l’argento, ora il rame a mosaico. E i pochi colori impiegati sono sommamente artificiali, anche nei loro reciproci contrasti e stridori. Si direbbe che i colori di Dragomirescu, come i suoni che le sue orecchie captano, viaggiano a frequenze improbe per l’orecchio umano. E di ascolti sono disseminate le sue immagini (...) ogni sua immagine è uno spazio d’ascolto...” 4) La critica si sofferma notevolmente sulla tipologia del disegno di R. D. v.: A. Bonito Oliva, A. D’Avossa, M. Panzera, F. Poli, T. Trini, M. Vescovo. L’aspetto “cenere”, nero-argenteo, grafite dei disegni va considerato anche come riflesso della ceramica nera antica. Non è da trascurare la formaziene archeologica dell’artista, implicante, ovviamente, un determinato tipo di cultura visiva e una mentalità particolare riguardante la deperizione, la memoria. la temporalità. 5) J. Beuys: Arte e politica, in “Flash Art”, marzo ‘97. 6) Fu dedicata alla Cara Morte una mostra organizzata da Tommaso Trini, nel ‘78, presso il Chiostro di Voltorre a Gavirate, con Luciano Fabro, Marisa e Mario Merz, R. D. Inoltre, in Italia. vi si ritrovano, anche se rari, santuari dedicati alla Buona Morte. 7) Nebbia chiara, tenue, sempre presente nell’atmosfera attorniante le colline ad Aramengo, dove l’artista risiede (a questo proposito è da vedere il testo di Piero Cavellini, dell’84, Il racconto delle Colline nere). 27 Senza titolo, 2009, installazione dimensioni ambiente, Abazia Santa maria di Vezzolano * Radu Dragomirescu nasce a Roseti (Romania) il 7 giugno 1944. Nel 1973 si stabilisce definitivamente in Italia. Frequenta l’università di arti plastiche N. Grigorescu di Bucarest diplomandosi nel 1969. Partecipa agli scavi archeologici sulla costa del Mar Nero, nella città di Costanza (Tomis), Mangalia (Calatis) e a Ischia con la guida dell’archeologo rumeno Vasile Canarache negli anni dal 1960 al 1965. Viene invitato a Parigi (anno 1968) alla 6A biennale internazionale della gioventù ed ottiene il gran permio. Nel 1972 riceve il premio per la grafica dell’unione degli artisti rumeni. Nel 1984 viene invitato alla Biennale di Venezia - Aperto 1984. Vasto è il panorama di esposizioni personali e collettive: 1971 Edimburgh Richard De Marco Gallery - 1977 Quadriennale di Roma - 1977 Galleria La Salita -1979 Milano Galleria dell’Ariete, Genova Galleria Forma - 1980 Kyoto Municipal of Art, Modena Galleria Emilio Mazzoli - 1981 Wroclaw Museo di Architettura - 1990 Valencia Galleria Pasqual Lucas - 1982 Genève Galerie Marie Louise Jeanneret - 1982 Torino Galleria Tucci Russo - 1983 Ravenna Loggetta Lombardesca,1983 Brescia Galleria Piero Cavellini - 1984/1985/1987/1988 orino Galleria Eva Menzio - 1986. Ravenna Pinacoteca Comunale - 1988 Bucarest Museo Nazionale d’Arte della Romania - 1990 Torino Galleria In Arco - 1991. Alicante Centro Eusebio Sempre Palazzo Gravina - 1992 Warrenpoint (Northern Ireland) Narrow Water Gallery - 1993 Ravenna Pinacoteca Comunale Santa Maria delle Croci - 2001/2004 Torino Paolo Tonin Arte Contemporanea - 2001 Asti ex Chiesa di San Giuseppe - 2002 Cuneo Fondazione Peano - 2003 Moncalieri Foderie Teatrali Limone - 2005 Firenze ex Chiesa di San Carlo dei Barnabiti - 2008 Firenze Accademia delle Arti del Disegno - 2009 Abbazia di Vezzolano - Radu Dragomirescu è titolare di Pittura all’Accademia diTorino. docenti 8) Sulla “natura insondabile e oscura” v. T. Trini: L’Arte sulla Terra. Note su Dragomirescu (‘78), ma anche l’articolo di G. Verzotti: La Natura e la Morte (‘83). 9) Che una tradizione vuole sotterrato nel basamento della Grande Madre a Torino. Con riferenze al Graal v. il cat. di R. D. per la personale all’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Venezia, 1995-96: E o Silenzio e anche la mostra al Narrow Water Castle (1992). 10) v. Verso il Paradiso, personale di R. D. alla Galleria Arco Multipli, Torino, 1990, cat. a cura di Sergio Bertaccini. 11) Autoritratto con lepre e stelle è un rarissimo esempio di personaggio individualizzato. Come alter-ego funzionano pure I Gemelli, segno zodiacale dell’artista, questa volta doppio impersonale, senza volto; facendo una digressione: la sagoma dei Gemelli ripete, per una strana specie di coerenza formale interna, quella delle primissime Colline di cera del ‘74, più tardi delle Caveme, ampiamente commentate da Bonito-Oliva nel cat. del ‘79. 12) È da considerare l’inflazione odierna (Iudica e non) del motivo della lepre, del coniglio e l’inserimento di Dragomirescu nella serie degli artisti che lo sfruttarono: cominciando sempre da Beuys, passando per Koons e Flanagan, fino all’Errotin le vrai lapin di Catte!an, per citare i molto noti. 13) Si veda sempre il Ripa per la figurazione analoga del Crepuscolo della sera. Marcello Cinque 28 Costa Paradiso, 2009, cm 190x150x85, gomma spugna e guaina liquida Qualcosa di nuovo (anzi di antico) docenti di Maurizio Coccia Quando, anni fa, vidi alcuni lavori di Marcello Cinque, la prima cosa che mi venne in mente fu una poesia di Giovanni Pascoli. Si trattava de L’aquilone, di cui ho parafrasato l’incipit per dare il titolo a queste brevi note (“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, / anzi d’antico...”). Il presente scritto, quindi, è l’occasione per approfondire quell’accostamento, all’apparenza tanto stravagante. Perché, obiettivamente, accostare due autori tanto diversi, è perlomeno singolare. Ma andiamo con ordine. Per cominciare, verifichiamo gli eventuali punti di contatto sul piano – diciamo così – della concezione creativa. Le opere di Cinque, effettivamente, sembrano ispirate da uno stupore quasi infantile. La meraviglia del mondo è per lui un quotidiano rinnovarsi, sì che, nel suo lavoro, possiamo parlare di “scoperta” e non di “invenzione”, di qualcosa che già esiste nella realtà. Chi ha studiato nei miei stessi, lontani anni, lo sa. Si tratta della famigerata “poetica del fanciullino”. Un’interpretazione che mescola elegiaco amor mortis e misticismo, Melodramma e Positivismo. Però, quella definizione che, seppur stiracchiata, poteva adattarsi a Pascoli, sicuramente è fuorviante per Marcello Cinque. Per capire la differenza bisogna rifarsi alla sua biografia, più che allo stile. Quel portato d’ingenuità, di facile trasporto emotivo, di intuizione irrazionale, non può appartenergli. Perché essere napoletani non è una condizione dello spirito. Ma è il risultato di un formidabile percorso di adattamento. In quel tipo contesto, intelligenza, malizia, autocontrollo, prontezza di riflessi fanno la differenza. Bene. Il secondo aspetto da considerare, in questo passo a due fra Pascoli e Cinque, potrebbe essere quello delle rispettive caratteristiche formali. Vediamo l’esempio de L’aquilone. Questa lirica, in sintesi, è un’esaltazione della giovinezza. Soprattutto della leggerezza che la caratterizza. Attraverso una metafora, quella del volo, che inserisce nel dettato qualche ambizione di sinestesia. Anzi. Di più. Il ricorso a particolari strumenti retorici, in certi passi sfiora addirittura l’onomatopea. Par di sentire, tra i versi, il frusciare delle corde, il garrire dei tessuti. Anche la ricerca di Marcello Cinque parte da un repertorio di forme organiche, attinte dalla natura. Nei lavori più recenti, sembra persino volerla sovvertire, la natura. Per creare un microcosmo personale, dove le regole fisiche sono contraddette e si scompaginano i rapporti A questa omologazione (che fa dell’anonimato stilistico se non un valore almeno una premessa metodologica), Cinque risponde tornando invece a componenti grezze, sia materialmente che concettualmente. Ispirandosi cioè ad un’iconografia naturale, e manipolando materiali “primari”, aspira a conciliare tradizione artistica e ricerche della moderna industria. Originalità e qualità manifatturiera del prodotto artistico. Ecco la chiave. Il punto di intersezione che, forse, mi ha fatto scattare l’associazione fra i nostri due protagonisti. Lo slancio sperimentale di Pascoli, all’inizio del XX secolo, si risolveva nella tensione tra fissità strutturale e rinnovamento stilistico della poesia italiana (e lo testimonia la sua influenza sui movimenti letterari successivi). Anche per Marcello Cinque – fatte le debite proporzioni – comporta uno sforzo di mediazione tra patrimonio storico e innovazione tecnologica. Tra immaginario quotidiano e istanze di assoluto. Tra Nuovo e Antico. Appunto. 29 *Marcello Cinque è artista e docente di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Sassari *Maurizio Coccia è docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Sassari e direttore del Centro per l’Arte Contemporanea Palazzo Lucarini di Trevi. Muschio bianco, 2007, 40x60 cm, gommaspuna e guaina liquida Forma 1, 2007 diametro 50x30 cm, gommaspugna e guaina liquida docenti fra peso e volume. Tuttavia, l’uso del monocromo, e l’evidente trasposizione del “segno” nella terza dimensione, testimoniano di una tensione verso l’astratto, più che verso il reale. Marcello Cinque modella l’anima in metallo di sculture “tattili”. Nascono così corolle di fiori alieni, morbide coste mediterranee, vulcani nani, coralli. Ultimamente, queste forme embrionali hanno preso ad assemblarsi. I profili languidamente si intrecciano. Assumono l’aspetto di sontuosi panneggi. O di stalattiti. O ancora, di vortici e irruenti fenomeni meteorologici. Però l’aspirazione mimetica è più una concessione ad un innato buon gusto, che un’esigenza rappresentativa. Mi sembra di capire che a Marcello Cinque non interessa proporci una versione dell’Eden aggiornata ai tempi della sintesi chimica. Piuttosto è un discorso attinente alla dimensione linguistica del fare artistico. L’attuale panorama internazionale, infatti, presenta soluzioni che prelevano i materiali da un campionario di forme, immagini, concetti già esistenti. Questi poi, vengono rielaborati e metabolizzati in una sorta di ready-made globale (e globalizzato), disinvoltamente, senza ansie di primogenitura o autorialità Antonio Bisaccia 30 Foto di Salvatore Ligios All’Accademia di Sassari c’è un nuovo direttore accademia di sassari A cura di Elisabetta Longari Chi è Antonio Bisaccia? Credo di essere il meno adatto per rispondere a questa domanda, anche perché bisognerebbe intendersi su cosa vuol dire “conoscersi”…. Detto questo, proverò ad abbozzare un breve ritratto. Presupponendo esistente il mio “soggetto empirico”, descriverò soltanto uno dei tanti “soggetti funzionali” che attiviamo nel corso della nostra vita sociale. Innanzitutto nasco in un’altra grande isola, la Sicilia, che mi ha dato l’opportunità di conoscere Leonardo Sciascia, lettore dei miei primi e inediti racconti, negli anni del liceo. Cresco, dunque, con l’idea che la letteratura e poi il cinema dovessero necessariamente affondare in me i loro artigli. Laureato al primo DAMS di Bologna (dove ancora insegnavano docenti del calibro di Eco, Nanni, Squarzina, Maldonado, Barilli, Fabbri, Volli, etc…), ho -da subito- la ventura di poter tenere dei seminari di Estetica presso l’Università della stessa città sin dal 1993, grazie alla generosa disponibilità intellettuale del Prof. Luciano Nanni e di tutta l’atmosfera anceschiana che vi si respirava. E’ da allora che ho cominciato a pubblicare volumi sul rapporto tra il cinema e le altre arti. Ricordo, tra gli altri, Effetto Snow -Teoria e prassi della comunicazione artistica (Costa&Nolan), con il quale ho vinto il prestigioso premio “Filmcritica- Umberto Barbaro” e Punctum Fluens (Meltemi). Ho, inoltre, collaborato, con quotidiani e riviste. La collaborazione più strutturata è stata quella con la storica rivista Parol-Quaderni d’arte e di epistemologia, realizzata nell’ambito dell’insegnamento di Estetica dell’Università di Bologna. Vice-direttore della stessa sin dal 2000, dal 2009 ne ho avuto in affidamento la Direzione. Ultimo dettaglio, non utile a tutti ma irrefutabile: ho 46 anni. Hai scelto di insegnare a Sassari senza essere sardo, perché? Non si sceglie di insegnare in un luogo in virtù di un diritto di nascita o di residenza! Semplicemente accade. Come accade ad altri colleghi che insegnano a Milano e non sono milanesi e così via. Ecco, diciamo che l’essere sardo non era tra i requisiti richiesti. Erano richiesti, piuttosto, i titoli artistico-culturali e professionali. In ogni caso, in questi anni ho capito che è un assoluto privilegio insegnare in Sardegna, dove il senso del possibile sposa una cultura tra le più intriganti e dove la macchina raffinata della percezione trascrive, balisticamente, il sentimento materico della visione. Quale è stata la tua esperienza in tutti questi anni in Accademia? Quest’anno inizio il mio quattordicesimo anno qui a Sassari. Sono arrivato in Accademia con molte aspettative e alcune di queste sono state deluse. Ma, tra le delusioni, si è fatta sempre viva l’ossatura semantica che sostanzia la ricerca. Ovvero quella ferma e non meccanica intenzione di rendere visibile ciò che è semplicemente celato. Provenendo da un ambiente universitario, ci ho messo qualche tempo a capirne le logiche e i meccanismi. A volte, l’esperienza del limite e dell’isola ha permesso di interrompere e decostruire tutte quelle condizioni di fondo e afone che non avrebbero portato verso circuiti accademici virtuosi. La mia esperienza è stata, dunque, di grande operosità e crescita. Cosa pensi della riforma? Dell’idea di riforma penso un gran bene, in generale. Penso meno bene se guardo alla legge di riforma 508/99. E’ davanti agli occhi di tutti il suo essere una scatola ancora vuota o, meglio, uno scheletro da rimpolpare, con i suoi regolamenti ancora latitanti: sebbene qualcosa si sia fatto sugli ordinamenti didattici. Manca ancora la fondamentale emanazione del D.P.R. sul “Regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché per il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico”, ovvero almeno il 50% della macchina Accademia. L’idea di fondo è da apprezzare, ma molte cose sono state tralasciate con troppa leggerezza: ad esempio, lo stato giuridico ed economico della docenza, ad oggi ancora relegata nell’area del famoso “ruolo ad esaurimento”. Ecco perché qualche anno addietro fondai il C.N.E.G.E.D (Comitato Nazionale Equiparazione Giuridico Economica Docenti: www.cneged.org). All’inizio avemmo un’attenzione inaspettata da parte del Ministro Moratti, che c’inviò una lettera in cui sostanzialmente sottolineava che il rapporto d’impiego contrattualizzato dei docenti ed assistenti delle Accademie di Belle Arti non può essere assimilato a quello non contrattualizzato dei docenti universitari, di cui all’art.3, comma 2 del D.Lgs 165/2001. Ciò posto, un’equiparazione giuridica ed economica non può essere effettuata a livello amministrativo, ma richiede un intervento legislativo. In tale direzione, negli anni, si sono susseguiti vari disegni di legge bipartisan: ma nessuno ha mai lasciato gli spazi ristretti delle varie commissioni cultura di Camera e Senato. Diviene, ora, necessario riprendere in mano le fila del Cneged per richiedere a gran voce ciò che i sindacati non possono chiedere per noi: la decontrattualizzazione. Come dovrebbe essere l’Accademia nel tuo immaginario ideale? Una domanda difficile, soprattutto per via del mio immaginario! Comunque penso che l’Accademia dovrebbe imparare molte cose dal passato. E “imparare” non vuol dire conservare. L’idea di metodo non invecchia mai, ma spesso si è accecati dal nuovismo a tutti i costi. A costo di togliere ossigeno anche allo stesso nuovo. Due parole dovrebbero essere fondamentali per la poetica dell’Accademia: ricerca e produzione. Se ricerca e produzione artistica vanno a braccetto, quel luogo può essere chiamato Accademia. Purtroppo, invece, notiamo spesso la dirompente conversione alla “maniera”: che è il modo principe per uccidere le Accademie. L’Accademia di Sassari, in tal senso, e per via della sua giovane età anagrafica (20 anni), non si adagia e sfrutta la sua mancanza di tradizione a totale vantaggio di una sensibile concrezione percussiva dell’immagine. Martino ha fortemente criticato questa riforma ed è stato contestato per la sua posizione in difesa della specificità, tu cosa ne pensi? Le sue sono sempre state critiche costruttive e pochi hanno capito che non si esce dalla specificità. Essa è la chiave di volta del sistema Accademia. Uscire dalla specificità sarebbe come uscire dal linguaggio. E’ l’eterna lotta tra “nomos” e “caos”. E Martino ha sempre scelto l’esemplarità del “nomos” senza lasciarsi sfuggire le seduzioni del “caos”. In tutto questo, specificità non vuol dire “recinto”. E’ su La Sardegna rivendica da sempre l’Accademia nel suo capoluogo: Cagliari, ti sembra giusto che quella città sia sprovvista almeno di una succursale? La nostra rivista, tramite Gaetano Grillo, che pure è stato dieci anni fa vicedirettore da voi in Accademia a Sassari, un anno fa si è molto attivato presso il Comune di Cagliari per questa causa. Il Comune, con un testo congiunto fra maggioranza e opposizione ha deliberato la richiesta di una succursale, sei a conoscenza della cosa? La Sardegna che conosco io è, invece, molto fiera di avere l’Accademia a Sassari. La storia la conoscono anche le pietre. L’allora Presidente Cossiga la volle qui, nella sua città natale. E solo dopo tanti anni ho capito il perché. Qualche anno addietro fui promotore, insieme al Consiglio Accademico, di una richiesta per aprire una sede decentrata a Iglesias, nel cagliaritano. Anzi, a dire il vero, fummo noi disponibili a una richiesta del comune di Iglesias e della provincia di Carbonia Iglesias. Comune e provincia deliberarono la loro disponibilità di spazi e disponibilità economica. Qui a Sassari ci fu una levata politica degli scudi. Ci ritrovammo innanzi a un’antica “dialettica” tra Sassari e il sud della Sardegna, tanto che i politici locali gridarono allo “scippo”. La cosa durò qualche mese finché non si capì che i tempi non erano maturi e, soprattutto, che il famoso D.P.R. sul riequilibrio del sistema, citato prima, non aveva visto la luce. In quello schema di D.P.R. è segnato anche come normare eventuali corsi decentrati. E finché non ci sarà, sarà impossibile pensare a eventuali allargamenti sul territorio di quest’Accademia. Fatta questa premessa, non posso che essere d’accordo con lo sviluppo del sistema-accademia in Sardegna, che non necessariamente deve passare per Cagliari, pur non escludendola. La strada intrapresa, da qualche anno, dagli enti locali sassaresi è quella di formare un forte polo artistico-culturale, in sinergia con Università e Conservatorio, che dovrebbe avere il suo dato visibile soprattutto negli spazi del restaurando ex-Mattatoio , del Museo dell’Arte del Novecento e del Contemporaneo presso il Convento del Carmelo, e del Museo Masedu qui a Sassari. Questa linea, che affianca la nostra idea di un Politecnico delle Arti, è senz’altro condivisibile: il Nord Sardegna come polo di attrazione per l’area dell’alta formazione artistica e musicale. Arrivando al punto, sono a conoscenza della nuova delibera del comune di Cagliari, ma non ne conosco i dettagli. Ovvero, non so se il Comune abbia intenzione di aprire un’Accademia privata, comunale, o se abbia intenzione di attivarsi per avere un’Accademia Statale. Nel primo caso, noi nulla possiamo fare se non assistere all’apertura di un’ennesima Accademia privata. Nel secondo caso, nulla il Comune di Cagliari potrà fare se non passando attraverso l’Accademia di Sassari, come previsto dallo schema di D.P.R. E, formalmente, l’Accademia di Sassari non ha ricevuto alcun cenno. Sulla questione se mi sembra giusto che Cagliari sia sprovvista almeno di una succursale, potrei dire che non si tratta di scuola dell’obbligo, in cui la dislocazione sul territorio è la priorità assoluta. Più che un diritto potrebbe essere un’opportunità, ma diversa dall’attuale azione di politica culturale di quest’Accademia. Quali sono i programmi per questo nuovo corso? Questo nuovo viaggio dell’Accademia di Belle Arti di Sassari non può che essere quello di sempre, con una spinta davvero consistente verso la sperimentazione e l’internazionalizzazione. Se posso sintetizzare le circa 50 pagine di programma che mi ha portato all’elezione, posso dire che l’Accademia di Sassari avrà sempre più un atteggiamento glocal. Non il territorio come feticcio, ma come strumento per focalizzare le inquadrature di altri spazi e di altre rappresentazioni del mondo. La direzione da intraprendere è racchiusa nella formula scritta sul nostro sito (www.hdemiass.org): Arte, Tradizione e Nuove Tecnologie. 31 accademia di sassari Che significa essere Direttore di un’Accademia fortemente caratterizzata dalla direzione dell’artista Nicola Maria Martino che è stato un riferimento forte per tanti anni a livello nazionale; quale è stato il vostro rapporto? A questa domanda potrò rispondere meglio dopo che avrò fatto l’esperienza da Direttore. Posso però adesso affermare che molto ho imparato sulle Accademie da Nicola Maria Martino, che ha forte il senso dello Stato e dell’Istituzione. Ho collaborato con lui come consigliere accademico e poi come consigliere d’amministrazione e nessuno può negargli una lucidità tecnica e giuridica non comune. Per ciò che concerne la sua Direzione didattica e artistica, non posso che sottolineare il suo fermo intendimento a difesa delle cosiddette “Scuole” tradizionali e l’altrettanta ferma intenzione a non ostacolare le nuove tecnologie dell’arte (con aperture, ad esempio, di laboratori di animazione digitale, di aule ipermediali, etc…). Non è un caso che da un lato la nostra Accademia abbia avuto grandi riconoscimenti oggettivi (leggasi premi etc…) e dall’altro sia stata la prima Accademia cablata in Italia, e forse ancora l’unica totalmente cablata. La mia Direzione, probabilmente, avrà nei contenuti e nello stile un’altra impronta, com’è fisiologico che sia; ma, senza dubbio, conserverò di quell’eredità consistente il dna utile allo sviluppo dell’Accademia. quest’ambiguità, mai risolta, che hanno contestato Martino, ovvero sulla lettura restrittiva della specificità: che è, invece, una sorta di correlativo oggettivo delle opportunità che le Accademie dovrebbero raccogliere. 32 PRE-VISIONI Maria Santarcangelo Una mostra della Scuola di Decorazione dell’Accademia di Bari curata da Giustina Coda, Paolo Lunanova, Alfonso Pisicchio e Giuseppe Sylos Labini. accademia di bari Di Giustina Coda Il nutrito gruppo di giovani presenti nella mostra propone micro e grandi storie, in ragionate dipendenze dal passato e in forti consapevolezze delle suggestioni pittoriche del presente. E’, il loro, un dialogo singolare col proprio tempo, un banco di prova, su cui, tra diverse istanze, riassumono i molteplici linguaggi della espressioni artistiche, liberi di affiancare e verificare tradizioni e di declinare visioni già pronte per il futuro. Con vivacità e ingegno, con linguistica libertà di esecuzione, con originali testimonianze di tecniche e materiali diversi, dalle tele alle carte, ai legni, agli acquerelli, agli acrilici, lo spazio è occupato con proposte e formule che attestano lo studio, la ricerca e la riflessione sul grande patrimonio della cultura artistica. Allo spettatore è sempre richiesta una aperta interpretazione e partecipazione per immagini che spesso non hanno un solo e unico senso di lettura, ma accendono l’immaginazione in intense impressioni visive, temporali, spaziali e conducono a un vivo coinvolgimento sulle contraddizioni che caratterizzano la contemporaneità. Tutte le opere, che si distinguono in differenza di espressioni, inclinazioni, esperienze e sensibilità, conservano, tuttavia, un peculiare accordo nell’approccio sperimentale e nell’attualità e originalità del messaggio culturale attivando una serie di effetti relazionali per trovare corrispondenze e sistemi di confronto. Liberi da schemi precostituiti, non vincolati da alcun condizionamento, mettono in mostra il loro lavoro con grande disponibilità perché solo così è possibile trovare una identità per dialogare e trovare se stessi. Il gusto della citazione, recuperato in un reticolo di forme minute e raffinate, quasi ossessivamente ripetute nella eleganza di colori e segni e nella finezza dei motivi decorativi di sapore klimtiano, associa le opere di Schena e Di Leonardo. Diversamente Santarcangelo combina i suoi arabeschi nostalgici con brani del Picasso più noto, in un felice contrappunto tra la propria vitalità e quella del grande artista, mentre Zambetta “copia” Pollock alla ricerca della propria cifra artistica, inserendo nell’ opera una domanda per se stessa, in uno stretto rapporto di tensione esistenziale, che nello stesso tempo diventa risposta per lo spettatore. A ricerche di tipo neo-concettuale, a operazioni sul linguaggio, Volpicella affida la sua opera, consegnando poi questo compito alla declinazione di rosa-ae. Storie di natura tradotte nella leggerezza dell’acquerello, per Abiusi e Alterio. Percepiscono accenti e segnali dal mondo animale e vegetale ricreando efficaci vibrazioni cromatiche, la prima fissando con la macchina fotografica le variazioni della corteccia di un albero restituite in pennellate nel manto di una zebra, l’altra circoscrivendo i contorni immobili di una foglia. Bisceglia ascolta il brusio del silenzio, trasportato sulla tela con una materia bianca e ovattata, mentre nel grande acrilico di Piccolo appare un universo armonico di gocce di colore libere nello spazio a simulare immagini sbiadite di ricordi mediterranei. Il gruppo formato dalle due sorelle, Marzulli con Linzalata e Tarantini costruisce una scenetta ispirata alle fiabe attraverso un giocoso percorso che mette insieme parole, segni, figure e colori “a volontà”.Un fine uso del pastello ad olio permette a Campanelli di trasformare la materia di una pietra preziosa in pura evanescenza di luce, la forma in instabili riflessi coloristici, mentre, con la stessa tecnica, Colucci racconta il difficile rapporto col mondo: la difficoltà di comunicare, di relazionarsi con gli altri non arresta o impedisce la libertà del pensiero. Mariangela Volpe Marinella Porcelli 33 espressione della donna di oggi, statuaria e immensa quanto pudica e nascosta sotto pesanti e preziosi abiti, quella di Porcelli è solo evocata da un impalpabile velo bianco, leggera e poetica installazione creata come uno spazio-riparo. Una famiglia di bruchi di stoffa colorata divengono la forza sinestetica di una memoria latente trasmessa dai molteplici tessuti: un’unica vita nel racconto di tante stoffe. Ancora una volta Bagliato sceglie l’ironia più leggera e sofisticata per confrontarsi con le possibilità e le condizioni dell’uomo. La scultura di Vitucci occupa lo spazio andando al di là di forme concrete e riconoscibili, in una cadenza immaginativa che dà all’opera una plastica solidità. Travalicano ogni realtà, in una rivalsa fantastica, gli acquerelli di Miccolis. In una dimensione straniante la figura umana s’identifica nel colore e si consuma in una libertà immaginativa raggiungendo una cadenza favolistica. L’astratta decorazione nera nella costruzione di Manfredi accompagna il lento movimento dello spettatore in un coinvolgimento visivo provocando un’illusione e una instabilità percettiva di sapore optical. Volpe smembra un corpo umano in sei cubi ubbidendo, da una lato, ad una tradizionale lezione figurativa, dall’altro riproponendo la stessa immagine in pixel diligentemente e accuratamente realizzati con minuscole pennellate. Una forza vitale e una fugace sensazione di magia ritroviamo nell’opera di Mangini che rifugge da ogni forma immediata e individuabile a favore di una disposizione astratta del colore di gusto quasi minimalista. Il tessuto pittorico di De Gennaro si organizza lineare nella sfera luminosa degli ocra e degli azzurri, in un impulso cromatico che si libera sulla superficie. Il grande ritratto di Zenzola è un divertente omaggio al proprio maestro, una spiritosa caricatura che rivisita in chiave ironica un’alta tradizione pittorica. Nell’installazione di Carriero sono tracce della dignità dell’uomo, echi di frantumazione di vita umana e di storia tragica: i colori, le etichette, le valigie rimandano e sostanziano un percorso di memoria orribile. Da un processo di mentalizzazione prende corpo il gran dio orientale di Di Vincenzo, metafora di una abbondanza e una ricchezza che può diventare fatale per l’uomo. accademia di bari Si animano, in sorprendenti slanci di sapore matissiano, le figure di Scaringella. Un brillante e innaturale cielo d’Africa accoglie, in una festa di colori, improbabili oggetti, piante e animali, sorpresi nella assoluta fissità di una luce artificiale. E, nella danza, si liberano anche le due figure di Lisi, in un movimento continuo e flessuoso che arriva a coinvolgere lo stesso supporto. Il versante ludico è attraversato dalle opere di Spagnoletta che, in quattro piccoli quadretti, ricrea una atmosfera infantile e insieme gustosamente ironica e accattivante. Crea personaggi fumettistici che spuntano da macchie di colore e che fanno riflettere sul linguaggio delle immagini di massa. Anche Zingaro usa la figuratività fumettistica dimensionando lo spazio e ritagliandolo secondo un ordine in cui comprime volti di attori e attrici famosi, super-donne o super-uomini, scandendo un tempo indefinito, simbolo della vita. Attenta alla poetica dell’infanzia, Schiavone racconta di bambini prigionieri del nuovo mondo incapaci o ormai impossibilitati a vivere una esistenza semplice e incontaminata. Il dittico di Carrieri ha un preciso valore autobiografico: mostra i suoi oggetti e i suoi vestiti, se stessa, in maniera aperta, come si fa nei Social Network, li raduna, li confonde e li azzera sotto lo smalto bianco e poi ne esprime tutto il dolore per la separazione. La riscoperta della materia caratterizza l’opera di Minoia: uno spazio organizzato razionalmente si configura di sostanza materica pittorica in fisionomie di profili geometrici, fisici, catturati e definitivamente bloccati nella suggestione. Razionale anche la costruzione di Spizzico, un collage di forme sottili che evoca nella sua sistemazione una studiata stabilità. Declinazioni oniriche con utilizzo di colori brillanti ed immagini di gusto pop nell’opera di Palmiotta nella quale non è prevista la presenza umana, come per De Francesco, che fissa in un prodotto di serie, traccia del lusso femminile, un ricordo di viaggio. Attolico costruisce un luogo non-luogo con una presenza umana della quale è rimasto solo un simulacro, un’ombra scura che vuole sottolineare il distratto passaggio degli uomini. “Segnaletica” l’opera di Testini che invita a guardare fuori, al di là dello spazio espositivo c’è altro. Il dito tinto d’azzurro, metaforicamente e senza alcuna intenzionalità drammatica, conduce verso il mare. E se la narrazione di un corpo femminile è per Didonna una ironica La varietà dei linguaggi è testimoniata dalla colorata maiolica di accento cubista di Patruno, che sembra voler comunicare messaggi autobiografici, e dai frammenti di corpo umano di terracotta di Donatelli, che vengono inscatolati come reperti archeologici. L’esplosione di geometrici modelli frammentati di Petruzzella tagliano lo spazio, simbolo del caos e dell’inquietudine che invade il nostro quotidiano, la stessa vita quotidiana che Balice propone, al contrario, con la ricetta di una famosa torta al cioccolato come segreto da conservare e custodire. Una costante interrogazione dei punti di contatto tra arte e realtà spiazza lo spettatore dell’opera di Vilei. Il virtuosismo della tecnica pittorica raggiunge la sua pienezza in un intrigante gioco illusionistico, la resa mimetica della realtà coinvolge l’oggetto in una godibile e ingannevole visione. La mostra che è stata patrocinata dalla Provincia di Bari è documentata con un catalogo impaginato da Angelo Perrini Michele Volpicella *Giustina Coda è Docente di Storia dell’arte all’Accademia di Belle Arti di Bari contributi 34 A proposito di: c’è una generazione di artisti docenti che……… Messaggero notturno, 2010, tecnica mista su tessuto, 50x50 cm Di Stefano Pizzi Caro Gaetano, Sull’ultimo numero di Academy, nel tuo fondo, hai posto in luce quella che è la realtà del nostro Paese relativamente alla formazione artistica, al mercato dell’arte, alla sovrastruttura culturale e alla sconsiderata disattenzione che i governi, a mio parere di ogni colore, hanno sempre dimostrato nei confronti di questi contesti ai quali mi sento di aggiungere, non ultimi, i beni culturali e l’ambiente. Come tu sai il sottoscritto, benché allora giovanissimo, è stato uno dei protagonisti del movimento milanese e di cattedre ne ha bruciate e ribaltate parecchie, diatribe anche violente con i baroni ne ha condotte a non finire e non solo in accademia perché come te e tanti altri giovani artisti in formazione pretendeva di sapere, in quanto assetato di conoscenza. Grazie a noi e alle nostre lotte (che uscivano dai muri di Brera e si contaminavano con le drammatiche questioni sociali di quel periodo storico lasciando, ahimè, sui pavè di Milano numerose vittime), l’insegnamento accademico è mutato trasformandosi in pochissimo tempo da realtà semi-artigianale a contestualità laboratoriale-universitaria. Questa straordinaria ed accelerata metamorfosi ci ha permesso, a seguito dell’introduzione nella didattica dei cosiddetti Corsi Speciali, di studiare con quelli che erano tra i più lucidi e riconosciuti intellettuali del tempo: Roberto Sanesi, Luigi Pestalozza, Francesco Leonetti, tanto per fare dei nomi e gli artisti che per noi erano di riferimento: Fernando De Filippi, Davide Boriani, Gianni Colombo, ecc.senza naturalmente scordare l’apporto importantissimo di quei docenti che con noi condividevano le istanze, i sogni e le speranze: Alik Cavaliere, Mino Ceretti, Vincenzo Ferrari… Insomma, per nostra fortuna, siamo riusciti a mettere in pratica quello che chiamavamo “un uso parziale e alternativo dello studio” scegliendo scientemente, cioè, di cogliere quei contenuti che giudicavamo più appropriati alla nostra crescita culturale che convergeva con un sentito e diffuso bisogno di stravolgere i decrepiti stilemi dello stato sociale e di quella sua stravagante appendice che si occupava della mercificazione delle opere d’arte scansandone i contenuti e avvalorandone unicamente l’aspetto speculativo. Ma poi, però, tutto è tornato come prima, quasi avessimo interpretato il ruolo dei personaggi che animano le pagine del famoso romanzo di Tomasi di Lampedusa. Con la fine del movimento e lo svanire degli impianti teorici della Nuova Sinistra (grazie soprattutto alla sciagurata politica della sinistra ufficiale nei confronti di tutta la fenomenologia movimentista nonché l’incresciosa scelta del “compromesso storico”, che innescò in migliaia di giovani sentimenti di rabbia e sfiducia determinandone la scelta della lotta armata), anche nelle accademie iniziò una fase di stallo che perdurò fino ai primi anni ’80 e a Milano anche oltre. Fu un po’ come se quegli anni, che vennero definiti di piombo, avessero coperto con un velo le discussioni, le sperimentazioni e la febbricitante e contagiosa voglia di partecipazione che ci aveva contaminato nel precedente spazio temporale. E’ proprio in questa fase di stallo che dilaga la ventata post-moderna, sostenuta dal “pensiero debole” teorizzato da Vattimo e Rovatti e accompagnata da un ritorno al privato di quanti i si erano spesi con l’impegno ed i concetti: ricordi l’opera di Paladino del 1977 “Silenzioso mi ritiro a dipingere un quadro”? Io rimembro bene quegli anni: il ritorno alla pittura, la stagione del mostrismo, la “Milano da bere”, li ho vissuti appieno spendendomi in ogni eccesso, fisico e morale, perché nel mio intimo si era aperto un grande vuoto.E non ero certo il solo in quella condizione. Due accadimenti sono per me rappresentativi di quel vuoto in quella stagione: il mitico “Muro” di Mauro Staccioli posto all’ingresso dei Giardini alla Biennale di Venezia del 1978 che testimoniava la distanza tra il mondo dell’arte e il sociale e la morte nel medesimo anno di un insostituibile diverso, Pier Paolo Pasolini, che con i relativi interrogativi e aspetti polemici quantificava l’enorme distanza tra struttura e sovrastruttura. Ebbene, oggi, a più di trent’anni da allora, nel corso dei quali nessun esponente della politica italiana, si è mai preso la briga di prendere posizione e di svolgere una seria, veritiera e storica analisi del proprio passato prossimo, ma anzi concorrendo a una lettura revisionista che adduce agli anni della rivolta, perché di rivolta si trattava, l’origine di ogni male contemporaneo; e a seguito di una stagione giudiziaria decisamente mal gestita il cui esito finale è stato quello di distruggere una classe dirigente per sostituirla con elementi provenienti dal mondo dell’impresa, o dai raggruppamenti populisti territoriali, la situazione che già si presentava poco allegra è senz’altro peggiorata: *Stefano Pizzi è pittore e titolare di Pittura all’Accademia di Brera dove ha anche l’incarico di vice-direttore. Riflessioni sullo stato dell’arte e degli artisti a l’Aquila dopo il 06 aprile 2009 35 L’AQUILA, ABRUZZO, ITALIA: PARTECIPAZIONE E RESISTENZA MEDIATICA Di Sergio Nannicola Sin dai primi istanti dalla tragica data che ha segnato per sempre la storia, le persone e il territorio aquilano, gli artisti, anch’essi coinvolti in prima persona nei crolli delle loro case e dei loro studi, si sono chiesti nonostante le difficoltà personali del momento come potevano offrire il loro contributo alla causa collettiva. La risposta semplice e immediata è stata quella di continuare a fare ciò che di fatto stavamo già facendo. Alcuni, con la propria rete di collegamenti hanno cercato, come hanno potuto, di reperire beni di prima necessità, tempestivamente arrivati da ogni luogo d’Italia, altri invece hanno sostenuto e organizzato con grande determinazione iniziative di vario genere. Da subito è comunque apparso chiaro a tutti che dalla situazione in cui si era caduti nessuno ne sarebbe uscito in tempi ragionevolmente brevi, vista l’entità dei danni subita dalle abitazioni private e dal patrimonio storico/artistico millenario stuprato da una interminabile scossa durata circa trenta secondi (6.3 gradi Richter come dichiarato dai sismologi di tutto il mondo e non 5.8 come invece fatto risultare dall’Ingv italiano), e un tessuto economico e sociale oggi letteralmente da rifondare. Un territorio martoriato, smembrato da un eccezionale evento naturale, ma anche dall’uomo con le sue discutibili scelte, sono ora le questioni da considerare a futura memoria, quanto meno per non ricadere negli stessi errori. I cittadini aquilani, quelli che conservando nel tempo una capacità di analisi lucida e obiettiva degli accadimenti, sanno che la ripresa della loro esistenza e del loro territorio dipende dalla riconquista dei luoghi della vita sociale e culturale, dal ripristino del patrimonio artistico devastato dal sisma al rilancio di una economia attualmente frantumata e pressoché inesistente. I danni ingentissimi inferti al patrimonio storico della città (l’80% del patrimonio artistico è stato contributi - le organizzazioni capillari dei partiti e delle associazioni di massa sono sparite cosi che i rappresentanti dei cittadini vengono ora decisi “dall’alto” - viviamo in una nazione, se lo è mai davvero stata, i cui abitanti emigranti per secoli mostrano quotidianamente prove di generalizzata xenofobia - le libertà di stampa e di espressione vengono messe in discussione - i canali televisivi di stato, diversi canali televisivi privati, diversi quotidiani e settimanali e case editrici diffondono un informazione parziale e contenuti culturali che impongono valori etici e morali basati sul successo economico e sulla capacità sempre e comunque di apparire e rispondono per di più ad un unico proprietario che è anche il capo del governo - la creatività culturale, politica e strategica dei partiti di opposizione è tragica così com’è deplorevole la loro compartecipazione alle dinamiche di potere - il mercato dell’arte è finalmente diventato un “sistema dell’arte” con grande gaudio di chi come me i sistemi non voleva neanche cambiarli ma abbatterli - le accademie di belle arti poi, nonostante l’ingresso nel comparto universitario, l’ampliamento dell’offerta formativa, i nuovi statuti in vista di una futura ipotetica autonomia rimangono in attesa del completamento della riforma sopravvivendo a stento grazie alla capacità dei docenti, stranamente ancora motivati, di formare allievi destinati (pochissimi) a svolgere un ruolo di provocatori o stupitori, coordinati da una rete internazionale di curators, in un mercato globalizzato, anonimo, decisamente pompieristico e asservito all’economia. Infine, volevamo il pane e le rose ma il pane sta iniziando a scarseggiare e le rose sono state sostituite dalle antenne paraboliche. CHE FARE? Come tu indichi in chiusura del tuo scritto c’è oggi, all’interno delle accademie italiane, un gruppo generazionale di artisti docenti altamente rappresentativo, stimato e conosciuto in Italia e all’estero sia per il personale percorso di ricerca che per le proprie idee, nonché come sottolinei “con comuni identità di provenienza”, che potrebbe farsi promotore di nuovi orientamenti e future prospettive. Vogliamo come un tempo raccordarci? Vogliamo finalmente e di nuovo rimettere in discussione quanto stabilito dall’ ”Impero”, tanto per citare l’opera di un cattivo maestro? Vogliamo, magari con una coraggiosa conferenza di produzione che possiamo programmare perché no proprio a Brera, porre le basi di una futura e costruttiva era? Ho voglia di pensieri forti. Naturalmente senza scordarci della nostra tenerezza. Hasta siempre. Progetto di Installazione temporanea LAVORO, PARTECIPAZIONE, SOSTENIBILITA? contributi 36 distrutto o gravemente danneggiato), estesi su tutto il territorio comunale e buona parte di quello provinciale, lasciano aperti molti dubbi e frantumano le facili illusioni sul come potrà essere “l’Aquila” del domani (raro, e forse unico esempio in Europa di città medioevale interamente pianificata, con una griglia urbana tuttora presente). In tale clima di incertezza, alcuni artisti nati in questa area geografica ma anche di provenienza diversa insieme alle giovani presenze creative che affiorano in diverso modo nel ‘cratere’, agiscono sul territorio sin dall’inizio della tragedia, sperimentando modelli creativi e comunicativi che danno vita a spaccati culturali prodotti nella gran parte dei casi per necessità, con semplici mezzi di fortuna o con nuove tecnologie e strumenti informatici avanzati, all’insegna di una partecipazione popolare attiva rivolta alla soluzione del problema comune, aprendosi ad un confronto interpersonale e intergenerazionale mai visto prima da queste parti. Salvare i monumenti e i palazzi storici, il tessuto urbano e quello socio-economico della città insieme ai borghi che la circondano, sono gli obiettivi dei residenti e le priorità chieste più volte a gran voce al governo nazionale e alle istituzioni locali e regionali che gestiscono o gestiranno nel tempo la questione. A questo però è necessario che segua la conservazione della memoria collettiva e al tempo stesso l’apertura al nuovo, affidando tali compiti non solo agli architetti o ingegneri, ma anche agli artisti. Quegli artisti che con cognizione di sorta possono oggi farsi carico di traghettare con la loro esperienza, la loro visione e le loro opere, la città e l’intero comprensorio aquilano verso una rinascita non solo edificata ma anche implicitamente creativa. Coinvolgere gli artisti e le forze attive di questo e di altri territori nell’immane progetto di rinascita non deve essere un’elemosina concessa dal governo centrale o dalle amministrazioni locali, provinciali o regionali, ma un fattore di lungimiranza politica, sociale e culturale, consci del ruolo e delle potenzialità che esprimono tali energie. Una città, un territorio, sono l’espressione stessa della forza intellettuale e artistica che in essi si realizza, ce lo insegna la storia e il nostro recente passato. Dare fiducia ai giovani significa quindi costruire un futuro migliore per tutti, in cui si può trovare anche la mera ragione di restare a vivere in luoghi disastrati come questi. Se questa parte d’Italia si avvia a diventare il più grande cantiere d’Europa, per esserlo veramente deve partire dai diritti dei suoi abitanti, senza costringerli a subire direttive governative o commissariali che si traducono sistematicamente in ordinanze inefficaci e poco praticabili, il cui unico scopo sembra essere quello di dilatare i tempi e ritardare i lavori di (Ri)costruzione per mancanza di liquidità economica. Il governo e le istituzioni locali devono rendersi conto che c’è bisogno di un cambio di rotta e di una volontà politica nazionale che a monte scelga la vita e non la morte definitiva di questo territorio. Territorio nel quale da tempo si chiede un confronto vero tra le parti in causa, che porti certezza dei fondi (oggi erogati solo teoricamente), pianificazione degli interventi, rispetto dei tempi stimati per la ricostruzione, trasparenza, sostenibilità e partecipazione nelle scelte, come chiedono da mesi gli abitanti di questa parte d’Abruzzo, uomini e donne di cultura e i professionisti di tutte le categorie, impegnati nelle decine di convegni organizzati in città e come manifestano i vari comitati (primo tra tutti i giovani del 3e32) e gli enti di salvaguardia, tutti con una buona ragione da rivendicare. Se non si fa questo il rischio di rimanere impantanati è più che certo (di fatto lo siamo già per via delle contorte lungaggini burocratiche innescate ad hoc). Solo crescendo attraverso un dibattito serio, serrato, aspro ma alla fine condiviso, forse riusciremo a risalire la china. Provarci è sacrosanto, sperimentando nuovi modelli politici che alla fine potrebbero davvero fare la differenza, come ci prova sul versante culturale la fantasia creativa prodotta da queste parti, il cui unico scopo al momento è quello di riflettere (a volte anche ironicamente) sui problemi che affliggono il territorio, agendo da catalizzatore tra le persone e costruendo giorno dopo giorno una cassa di risonanza in grado di contrastare lo strapotere dei media governativi. Una creatività spontanea e necessaria, per certi versi stimolante e inaspettata che si manifesta nelle forme e nei modi più diversi. Una creatività contaminata e contaminante, una sorta di arte terapia popolare e trasversale che nonostante le difficoltà oggettive del momento e le continue delusioni derivanti da un confronto alterato e iniquo con i mass media nazionali, trova la forza di riuscire in qualche modo a risvegliare le coscienze sprofondate da tempo nel torpore più profondo, come dimostrano il crescente numero di partecipanti alle manifestazioni (in ventimila hanno manifestato il 16 giugno scorso a l’aquila per il ripristino repentino delle tasse a quattordici mesi dal sisma, occupando anche l’autostrada A24 Roma/L’Aquila/Teramo in entrambe le direzioni di marcia. Quanti in Italia ne sono venuti a conoscenza?) e alle assemblee cittadine che si tengono sotto l’oramai indispensabile tendone di Piazza del Duomo in piena zona rossa nel cuore del centro storico cittadino, comprese le decine di altri interventi realizzati trasversalmente in ruoli che difficilmente avremmo potuto immaginare prima, tutti con un obiettivo comune da raggiungere: ‘riprenderci la nostra esistenza e la nostra città’. L’arte sconfina nel sociale e torna a essere ‘espressione concreta della creatività’ riconquistando (almeno in questo pezzo d’Italia) un compito inatteso, vista l’appartenenza di questa specie legata a luoghi e funzioni che ci rimandano al clima rivoluzionario degli anni venti del novecento, in una realtà sud americana in cui David Alfaro Siqueiros, Rivera e Orozco, istruivano il popolo messicano attraverso i murales. Il sito: ‘www.3e32.com’; i ‘Comitati cittadini’; ‘Un Manifesto per l’Aquila’ (I decalogo di regole per la rinascita); ‘Sangue e cemento’ di M. Travaglio; ’Comando e controllo’ di A. Puliafito; il ‘Movimento delle carriole’; il Progetto: ‘ARTE SOTTO LE TENDE – Laboratori creativi nelle tendopoli’; ‘Recomenza Domà – Artisti Uniti per L’Aquila’; ‘http://www.diceche.com/’; ‘Guardarsi dentro – Incontrarsi con le arti’ di G. Gentilucci; ‘La Deriva’ – Installazioni artistiche; ‘Re_Place’ – Airò, Luci per l’Aquila; ‘Draquila’ di S. Guzzant; ‘www.laquila99.tv’ la prima wiki tv partecipata; ’J’Accuse!!!’ di A. Gasbarrini; le ‘Analisi socio-antropologiche’ di A. Ciccozzi; i ‘Moduli e containers’ alternativi al progetto C.A.S.E del governo proposti da ‘Laboratorio P.l.u.s.’ Politiche Locali Urbane Sostenibili; ‘l’Assemblea Cittadina’ organismo vitale di confronto democratico; il ruolo della ‘Rete’ e della ‘Grafica multimediale’; il contributo reso dai grafici nella comunicazione nel tradurre le parole in messaggi visuali immediati, attraverso ‘volantini, manifesti e mega cartelloni’; l’esperienza dell’Arte ambientale al servizio del popolo che la utilizza durante il G8 aquilano per (ri)scrivere ironicamente sulla collina di Roio il motto di Obama “Yes, we can!” (Si, noi possiamo), che diventa “Yes, we camp!” (Si, noi “campeggiamo”), come per “S.O.S.” (Sostegno all’economia, Occupazione, Sospensione delle tasse); i ”bambini (fantoccio) impiccati” da Cattelan a Milano che qui diventano decine di manichini (penzolanti dai viadotti) suicidi, vittime delle Tasse; poi altri progetti da realizzare: ‘Un monumento alla carriola’ inscindibile dai tre termini rivendicati: LAVORO, PARTECIPAZIONE, SOSTENIBILITA’; il ‘P.A.T. Parco Artistico Territoriale’, e cento altre iniziative culturali e sociali nate in rete e fuori dalla rete, di cui avete sentito già parlare o forse no, sono oggi l’ossatura di una tesi che vede l’arte, gli artisti e la gente comune sotto un unico ombrello, quello del risveglio e della partecipazione alla realizzazione di un progetto unitario non più utopico ma a portata di mano, come può essere una rinascita collettiva auspicata più che legittima. L’area del ‘cratere’ (così definita dai media la zona geografica terremotata), è di fatto oggi un grande laboratorio sociale, dove si sperimenta tra l’altro una resistenza mediatica estenuante ma vitale, al momento unica in Italia, in nome e per conto del sacrosanto diritto di continuare ad esistere, diritto che viene sistematicamente negato alla popolazione attraverso una comunicazione governativa distorta e praticamente a senso unico e ora, dopo la manifestazione a Roma del 07 luglio 2010, osteggiata anche con la forza. Se quindi perdura una certezza in queste latitudini, tale certezza risiede nella tenacia, nell’impegno e nell’azione di chi ha reagito fin dal primo istante dopo la tragedia e continua a reagire ora contrastando una ‘cultura mediatica al cloroformio’, fatta respirare alla popolazione terremotata durante e dopo la lunga permanenza nei campi di accoglienza e contestualmente e costantemente anche al resto d’Italia attraverso i Tg, sia delle reti di stato che in quelle private, salvo qualche eccezione. *Sergio Nannicola è artista e titolare di Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano 37 Prendersi cura dei luoghi della socialità urbana. Di Pino Di Gennaro Ho raccolto l’invito di Alessandro Gioiello, proposto in chiusura del suo originale articolo pubblicato sul numero 4 del 2010 di Academy, dove sollecita gli scultori a intervenire sullo stato delle scultura oggi; a questo articolo hanno fatto seguito le “Note sintetiche sulla scultura” di Pietro Coletta e l’interessante contributo di Gianni Caravaggio con “Al principio”. Ho sentito la necessità di intervenire pur non avendo l’intenzione, né tanto meno la presunzione, di fornire in questa occasione risposte esaustive al grande quesito “Cos’è la scultura oggi?”, ma avendo il desiderio di contribuire con alcune riflessioni sul tema. Credo che la scultura oggi non abbia bisogno di una sua ri-definizione, poiché individuarne una nuova risulterebbe inopportuno e restrittivo. Dal mio punto di vista, è preferibile lasciare aperto il libero confronto tra gli inafferrabili sconfinamenti e le peculiarità delle modalità espressive e ideali della scultura, anziché mantenere i tanto rassicuranti e confortevoli limiti delle belle definizioni. Sarebbe opportuno, invece, individuare una calzante definizione proprio per tutte quelle modalità artistiche che si ibridano tra loro, utilizzando contemporaneamente pittura, scultura, fotografia, grafica e video. contributi Scritturamondo, 2009, Bronzo cm. 500 diam. Progetto Scultura nella Città, Giardini I. Montanelli, Milano Oggi la scultura deve prendersi cura dei luoghi della socialità e più in generale della socialità urbana per creare luoghi d’incontro, per favorire l’integrazione delle differenti etnie che popolano i grandi centri urbani. Prendersi cura degli spazi urbani per creare occasioni di forte identità tra luoghi e cittadini. Il prossimo evento dell’EXPO 2015 a Milano potrebbe essere l’occasione per un grande coinvolgimento degli scultori, e non solo, per invadere con interventi trasformativi tutta l’area metropolitana, inoltre sarebbe indispensabile invitare in modo ufficiale tutte le istituzioni artistiche, prima tra tutte l’Accademia di Belle Arti di Brera, a fare sistema con l’evento. Ritengo piuttosto che sia necessario, da parte di noi scultori, prestare forte attenzione ai grandi temi ed eventi che coinvolgono le nostre città, mettendo a disposizione le nostre competenze, da sfruttare per migliorarne la vivibilità e la fruibilità, dal centro alle periferie e viceversa. Quei grandi spazi di parchi, piazze, luoghi di transito delle stazioni ferroviarie e metropolitane, piccoli slarghi delle zone pedonali, incroci della viabilità urbana e persino i non luoghi attendono di essere completati con le nostre proposte progettuali. Come dice l’urbanista Maurizio Carta su Il giornale dell’arte di aprile 2010, “possiamo immaginare la presenza dell’arte pubblica inserita nei tessuti urbani sterili come una cellula staminale che, cambiando il proprio DNA con quello dei tessuti, li rigenera, li vitalizza e produce una nuova identità.” Lo sanno bene i sociologi che la bellezza svolge un decisivo ruolo inibitore contro il degrado urbano, e può essere utilizzata come potenziale deterrente contro quei gratuiti atti vandalici che deturpano i luoghi condivisi della socialità. L’impegno per una funzione sociale ed etica della scultura chiaramente non mi priva di quel rapporto intimo della ricerca, dopo quarant’anni di esperienza sono ancora emozionato dalle rivelazioni spiazzanti ed espressive dei materiali, emozione che mi riporta a quando, bambino, modellavo l’informe materia della creta che vedevo trasformarsi, sotto le mie mani inesperte e con mio grande stupore, in forme fantastiche di pura energia. La ricerca in campo artistico, in particolare sui nuovi materiali e sulle nuove tecnologie, è da sempre finanziata unicamente dagli scultori stessi: infatti questo nostro “mestiere” si sa essere da sempre molto dispendioso in termini di spazi, attrezzature e tempo: infatti per imparare il “mestiere” occorrono almeno 10.000 ore di duro lavoro fisico e intellettuale. L’amministrazione della città, nei secoli passati, viveva di un progetto e di un sogno di metropoli in cui l’arredo urbano si trovava a essere un elemento molto importante e qualificante per la sua storia. Oggi invece, mostra una certa timidezza per scelte coraggiose, lungimiranti e condivise, preoccupata più di aver cura del consenso piuttosto che impegnarsi nell’offrire alle nuove generazioni segni di forte identità culturale della contemporaneità. Diciamo basta ai grandi investimenti a effetti speciali basati solo sull’effimero e di puro consumo! Occorre investire in proposte durature, che siano un valido riferimento per le nuove generazioni, da educare alla sensibilità e all’incanto, poiché il sapere e il conoscere ci consentono di capire più intensamente che cosa sia il bello. *Pino Di Gennaro è docente di Tecniche della Scultura e Tecniche espressive per la terapeutica artistica all’Accademia di Belle Arti di Brera 38 exfabbricadellebambole contributi associazione culturale via dionigi bussola, 6 - milano 377.190.2076 http://exfabbricadellebambole.jimdo.com/ Presidente: Gustavo Bonora Organizzazione e programmi mostre/eventi: Rosy Menta Ufficio Stampa&Relazioni Esterne: Daniela Basadelli Delegà Moira Ricci Custodia Domestica, installazione video, 2004 La fotografia è un “calco” della realtà, ma dipende da chi la fa, ad esempio il fotografo di Berlusconi non fa un gran “calco” della realtà. Intervisa a cura di Elisabetta Longari coperto dalla sabbia, fuori-scala, circondata da figure, come se tu fossi protagonista degli scarti dimensionali di Alice nel Paese delle Meraviglie o di Gulliver durante i suoi viaggi. Quanto la letteratura credi che incida nel tuo laboratorio creativo anche a livello inconscio? Penso che la letteratura, come il cinema e altri media, m’influenzi molto, come è normale che sia. in quel periodo facevo dei lavori in cui il mio corpo era spesso fuori-scala, piccolo o grande, non perchè mi rifacessi ad alice nel paese delle meraviglie, piuttosto per rendere visibile la mia sensazione di disagio di fronte alle cose. nel caso di “a lidiput” ad esempio io sono un gigante perché quando lavoravo come “scattina” in spiaggia a lido di savio a ravenna, nonostante facessi di tutto per farmi vedere e per interagire con le persone, queste mi evitavano e non mi salutavano per paura che io chiedessi loro di farsi fare le foto. L’umiliazione che mi davano mi faceva sentire goffa e pesante, come mi sono rappresentata in “a lidiput”: un gigante che tutti evitano e fanno finta di non vedere. Ricordo confusamente con un senso di rinnovato stupore il primo lavoro che vidi realizzato da te ancora studentessa a Brera ed esposto a Salon I: aveva a che fare con il corpo e con la possibilità che danno le nuove tecnologie di attraversarlo, mapparlo con l’immaginazione. Parleresti di quel lavoro, di come l’avevi concepito e di come lo consideri adesso? Il titolo è “faccio un giro e torno” ed è un lavoro del 2001. Ero in un periodo in cui mi rendevo conto che il tempo e la lontananza dalla mia casa in toscana mi stavano distaccando dalla mia terra. Avevo fatto dunque un calco intero del mio corpo (un’esperienza allucinante) percorso superficialmente da due strade in miniatura che partono da casa mia in maremma (ai piedi), a Milano (alla testa). lo spettatore doveva muovere la macchina sopra queste strade per vedere il viaggio tra modellini dei paesaggi e tra dettagli di corpo. Adesso questo lavoro, come gli altri precedenti a “20.13.53-10.08.04”, quello dedicato a mia madre, fanno parte di un’epoca della mia vita passata che guardo in modo molto distaccato. é un problema che non mi tocca più come prima l’allontanamento dalla famiglia, dalla casa e dalla terra, forse grazie al distacco fisico forzato che ho avuto da mia madre. Da buio a buio è l’ultima serie esposta al pubblico, ma è anche l’ultima che hai realizzato? Lo spostamento sembra sempre avvenire in un ambito coerente: dall’album di famiglia, che da diario segreto diventa pubblico e contraffatto, all’idea della catalogazione di anomalie che costituiscono una sorta di galleria lombrosiana. La fotografia, che per nascita e natura è deputata al “calco” della realtà, viene da te sottilmente trattata e capovolta di segno. Si è l’ultima serie che ho realizzato e ancora ci sto lavorando. In questo lavoro la fotografia, il video, gli oggetti come pezzi di giornale, insomma tutti i media che dovrebbero documentare, documentano cose mai documentate. Le storie di cui parlo sono arrivate a me fin da piccola come vere, molte persone della mia zona dicono che sono vere, ma non ci sono prove e io le ho realizzate. La fotografia è un “calco” della realtà, ma dipende da chi la fa, ad esempio il fotografo di Berlusconi non fa un gran “calco” della realtà. Ricordo anche delle foto, degli autoritratti scattati quando facevi il paparazzo estivo sulle spiagge: immagini con tuo corpo Cosa ti resta dell’esperienza vissuta all’Accademia? Mi resta soprattutto il ricordo di aver passato uno dei periodi più belli della mia vita e molte persone (compagni e professori) che hanno allargato il mio modo di vedere le cose. Tutto quello che ho fatto lo devo a questo. 39 ex studenti Il rapporto fra la fotografia e la morte. Il tuo lavoro è emblematico da questo punto di vista. Alludo certamente al ciclo dedicato a tua madre, nel cui vissuto ti sei introdotta anche quando non c’eri proprio usando il supporto della testimonianza fotografica e i “trucchi” del teatro e del digitale. Riusciresti a dire se nel tuo lavoro nasce prima d’allora la percezione del legame tra il linguaggio fotografico e la morte o se invece questo riconoscimento è avvenuto al momento del distacco da tua madre, nel tentativo di ripercorrerne la memoria? Prima d’allora non mi aveva mai toccato l’esperienza della morte così da vicino. i lavori precedenti a questo si riferiscono a esperienze di crescita, al rapporto con la mia famiglia e con la mia terra d’origine, all’ attaccamento e alla nostalgia del passato. il lavoro su mia madre è stato fatto proprio nel momento in cui è iniziato il lutto, senza pensare a qualcosa di concettuale o di artistico. era solo un desiderio, quello di entrare nelle foto di mia madre, dove essa era viva e sorridente, per starle vicino, per recuperare il tempo perso e per suggerirle di stare attenta al suo futuro. 40 ex studenti Da Buio a Buio, fotografie, video e installazione, 2009 MOIRA RICCI è nata a Orbetello nel 19.04.77, vive e lavora in Italia. Il suo lavoro (fotografia, video, installazione) spesso d’impronta autobiografica, indaga i temi dell’identità individuale e sociale, della storia familiare, della casa e del legame originario con il territorio, intrecciando invenzione tecnologica a riscoperta dell’immagine di appertenenza popolare. MOSTRE PERSONALI: Da Buio da Buio a cura di Andrea Lissoni, a cura di XING, Padiglione D’arte Contemporanea, Ferrara, IT, (2009); Interfuit. A cura di Emanuela De Cecco, Artopia, Milano (2006). MOSTRE COLLETTIVE: Realtà Manipolate. Come le immagini ridefiniscono il mondo. Curata da M.Marangoni, F.Nori, B.Rogers, L.Sabau, Strozzina-Palazzo Strozzi, Firenze , IT (2009); Hors Pistes 2009, Centre Pompidou, Paris – France; Aspettando manifesta, Curated by Paola Tognon, Bolzano (Bozen),IT (2008); a snake on a tree. Curated by Marco Antonini, White Box, New York, NY (2008); Location1 project’s room. Curated by Nathalie Angles, Location1’s gallery, New York, NY (2008); Invisible miracles, curated by A. Daneri - R. Pinto, XIII CSAV Fondazione Antonio Ratti, Viafarini, Milano, (2007); Netmage. A cura di Andrea Lissoni e Daniele Gasparinetti, Palazzo Re Enzo, Bologna (2007) A cura di Fausta Squatriti Nei primissimi anni ’60 a Milano il clima artistico era fervido, l’avanguardia più praticata era l’informale, Guido Le Noci esponeva il suo maestro internazionale, Fautrier, e i fratelli Pomodoro, che allora lavoravano insieme, quasi in simbiosi, creavano le loro prime sculture dentro alla poetica informale, cosa che per la scultura era davvero inedita, scavando segni nella materia. I critici d’arte erano pochi, e si dividevano tra i difensori della classicità, sia pure del 41 ex docenti GUIDO BALLO moderno, come Leonardo Borgese, che tuonava dalle pagine del Corriere contro tutto, perfino contro il liberty, Lepore, Monteverde, sono i nomi che ricordo. E poi c’era Marco Valsecchi, che firmò i primi inserti dedicati all’arte e pubblicati dal nuovo quotidiano Il Giorno, dove si spiegavano gli impressionisti, ancora ostici al grande pubblico. Chi seguiva l’avanguardia che si andava formando giorno per giorno era lui, Guido, Guido Ballo, che andava negli studi, che scriveva anche poesia, che era parte integrante della ricerca che freneticamente si andava compiendo negli studi milanesi, primo tra tutti quello di Lucio Fontana in corso Manforte 23. Lui insegnava al liceo artistico di Brera, ma i miei genitori mi mandarono dalle Suore Orsoline, considerando Brera un luogo pericoloso, per una ragazza di buona famiglia. Guido Ballo lo ebbi come professore di storia dell’arte quando mi iscrissi alla Accademia, dove nel frattempo lui era passato ad insegnare. Unico docente per tutte le classi, per tutte le cattedre. Forse saremmo stati, in tutta l’Accademia, trecento studenti o poco più. Quando per un malaugurato incidente Guido dovette andare ad insegnare a Torino, fummo in molti a disertare le lezioni del nuovo docente, del tutto inadeguate a quelle cui ci aveva abituato il nostro Maestro, presentandoci poi soltanto all’esame. Ma l’assenza durò poco, per fortuna, e feci in tempo a diplomarmi con lui. L’auletta di storia dell’arte era, e c’è ancora, quella distaccata dentro al cortile secondario, ingresso da via Fiori Chiari. Il riscaldamento, come d’altronde quello delle altre aule, si effettuava con la stufa a carbone. Guido insegnava partendo dall’arte antica, Sumèri, Egiziani, Greci, e avanti nei secoli, per i primi due anni. Negli altri due si passava al moderno, cominciando dagli Impressionisti. Molta attenzione Guido pose sulla ricerca di Klee e Kandinsky. Solo in quegli anni si tradusse “La teoria della forma e della figurazione”, pubblicata da Feltrinelli, leggendo la quale decisi per tempo di fare la mia tesi proprio su Klee. Ma ricordo anche una lezione memorabile su Lazlo Moholy Nagy, nome allora impronunciabile e sconosciuto ai più, che Peppino Palazzoli della galleria Blu, allora in via Andegari, aveva esposto, credo, per la prima volta in Italia. Così abbiamo imparato la storia dell’arte senza buchi, senza salti, costruendo quel filo logico che unisce la creatività all’esperienza e alla attualità dei mutamenti storici. Io mi sedevo sempre in prima fila, non volevo perdere neppure una parola, prendevo appunti. Lui parlava a braccio, camminando avanti e indietro nello spazio prospiciente la cattedra, le braccia dietro alla schiena, il capo leggermente inclinato in avanti, alla ricerca di una concentrazione estrema, che gli faceva dire il proprio pensiero con voce talvolta emozionata ed emozionante, quando sollevava il capo dalla propria introspezione a voce alta, per guardarci mentre diceva – il filo sottile dell’inconscio – per comunicarci, a proposito dell’arte, l’indicibile, quel mistero che lui, praticando la poesia in prima persona, conosceva e soffriva così bene. Ed a quella frase univa il gesto della mano, quasi un avvitamento delle dita magre, che faceva muovere nell’aria a completare, appunto, l’indicibile. Perché l’arte si può ex docenti 42 caffé Giamaica, dove ci chiedeva cosa volessimo bere, e tutti, per scegliere la consumazione meno costosa, chiedevamo un caffé. E così, seduti al tavolino, se in inverno intabarrati nei cappotti perché la ex latteria non era riscaldata, si parlava, se non proprio da pari a pari, quasi, perché il professore sorrideva, corteggiava le ragazze, ci domandava, ci ascoltava, ci invitava ai primi premi che in quegli anni pullulavano in Milano ma specialmente nella provincia. Se c’era un premio in danaro, andava a studenti talentuosi ma anche che ne avessero bisogno. Noi eravamo compiaciuti dalla attenzione che Guido ci dava, coltivando la speranza di entrare presto nel mondo delle mostre, dei critici, dei collezionisti, ma, almeno per quanto mi riguarda, con la paziente attesa che questo avvenisse per una inevitabile successione di fatti, di generazioni, ma specialmente, di merito. Poco contavano i giovani, era ancora vivo Carlo Carrà, cappottane blu scuro e basco, che ogni giorno, con sua moglie, si avviava a sedersi su una sedia nell’angolo della sua galleria, L’Annunciata, in via Manzoni. Ed era vivo Balla, che viveva a Roma dipingendo ritratti. Il futurismo, associato al fascismo, veniva tenuto lontano come un appestato, e fu proprio Guido Ballo a scrivere una importante monografia su Boccioni, che lo ripropose alla attenzione della critica e del mercato. Quelli erano i maestri, poi c’erano i “giovani” che avevano cinquant’anni. Si affermarono i quegli anni come classe emergente gli artisti tra i trenta e i quaranta, poi c’eravamo noi, che non contavamo nulla. Tutto cambiò proprio nella prima metà degli anni ’60, con uno sguardo più informato alle avanguardie internazionali, che sollevarono Guido Ballo con Chighine e Scanavino anche la critica dal provincialismo cui le restrizioni culturali, retaggio del fascismo e della guerra, avevano costretto la cultura italiana. spiegare, si deve spiegare, ma fino a un certo punto, oltre il quale si Guido, come tutti lo chiamavamo, perché era lui, nel mondo dell’arte deve usare l’intuizione, capire che, quel filo sottile dell’inconscio, se c’era un solo Guido, amico degli artisti, ebbe una lunga vita. Con il si spezza, cade l’opera. Questo era particolarmente evidente nell’arte passare degli anni, insieme all’ ironia, cifra che non lo abbandonò che si praticava in quegli anni, perché dopo, oggi specialmente, quel mai, adorava scherzare, raccontare barzellette delle quali era il primo filo si spezza di frequente, lasciando il posto alla sapienza, a volte a ridere, fare battute, emerse anche la malinconia, a volte virata di specialmente tecnica, alla speculazione intellettuale, alla costruzione amarezza. Sfumature di un carattere complesso, spesso scontento, dell’immagine che si rende comprensibile solo se sai tutto quello che inappagato, così come mi pare sia inevitabile per un uomo come le sta dietro. Quel filo cui Guido teneva tanto, quasi non esiste più, e lui, che ha toccato con mano molti cambiamenti, probabilmente l’artista e la sua opera si costruiscono nella officina della critica, non perduto speranze. Presente con la propria storia personale di uomo più interprete del mistero della creatività, ma spesso compartecipe. e di poeta, di critico militante, come si diceva un tempo, quando era Quando finiva la lezione, ci rilassavamo tutti, affollandoci attorno alla per lui il tempo per esserlo, e poi sempre più osservatore, poeta, cattedra. I più fedeli erano i ragazzi che, ancora studenti, formarono sempre attento a quel – filo sottile dell’inconscio – che lo avrà fatto il gruppo Miriorama, Colombo, Anceschi, Boriani, De Vecchi, Varisco. soffrire ma anche che lo avrà reso sempre consapevole del contatto Loro erano un poco più grandi di me, e mi facevano soggezione, emozionante tra l’interiorità e la materialità dell’opera che alla perché già erano certi della strada che avrebbero preso, strada fine, uscendo allo scoperto, solidifica l’emozione e la trasforma in innovativa, appoggiata dal più accademico dei maestri, e dal più concetto. capace di intendere i suoi geniali allievi, Achille Funi, e da Guido. Io a casa facevo disegni informali, a scuola disegnavo la modella, felice di potere studiare il segno in cui trasformare una forma data, un corpo. Guido, il professore, si avviava fuori dall’aula con il codazzo di coloro i quali stentavano a separarsi dal Maestro, e si avviava al 43 Gianni Maimeri nel suo studio alla Barona GIANNI MAIMERI accennavo dei protoindustriali milanesi, ha creato proprio a Milano una fabbrica di colori, sfidando le consistenze tecniche internazionali, che sempre più si è affermata. Maimeri tuttavia, pur assumendo quella iniziativa da vero imprenditore, tecnicamente più che preparato, non ha mai abbandonato sorella pittura, non è mai stato un industriale che dipinge, è sempre stato un pittore di professione. Nulla ha potuto allontanarlo dall’amata pittura, non l’attività industriale, non il fascismo, non la guerra. Fino all’ultimo, all’inizio degli anni cinquanta egli ha coltivato quasi in segreto l’amata pittura per cui un oggetto a lui consueto, un vaso, un bicchiere, fiori, un angolo di casa, diventavano protagonisti di una poetica della realtà, che non si è mai spenta. Il vero valore di Maimeri, è una vita varia e anche movimentata, non ha mai dipinto per imitazione, ma sempre seguendo un’idea, quella di rappresentare le cose amate in un’atmosfera di poesia filtrata a mezzo pittura. Riassumendo i miei pensieri su Gianni Maimeri mi pongo molti interrogativi sui perché questo ottimo, simpatico e chiaro artista lombardo, non abbia ancora la fama che merita e troppo facile sarebbe invocare la sua riservatezza, il fatto che egli sia stato riconosciuto come un industriale dei colori, che egli sia partito come seguace dell’ottocentista Emilio Gola, che infine egli si sia sviluppato come un bravo continuatore della figurazione dell’Ottocento lombardo. Non basta, ci sono altri artisti che hanno avuto una storia simile e che sono molto più conosciuti di lui. Come avviene che, quando la gente si trova in buona fede davanti fondazione maimeri Gianni Maimeri (1884-1951) aveva sedici anni quando sbocciò il secolo XX. Era un tempo in cui a Milano, dove egli era nato, sorgeva la grande industria moderna e dalle campagne giungevano gli artigiani, e anche i contadini, inesperti che per poche lire venivano portati davanti a una macchina che imparavano a poco a poco a far funzionare. Via via che imparavano cresceva il salario ma anche la responsabilità. Gli imprenditori si rendevano conto che l’acquisto di cultura dell’operaio era un bene prezioso anche per la loro impresa economica. I più intelligenti, come Luigi e Ferdinando Bocconi, istituivano le università commerciali che fornivano i quadri alle aziende. In questa società milanese che sta costruendo le prossime fortune d’Italia, Maimeri entra in scena con i suoi ritratti, veri ritratti senza quelle bizzarrie visive alle quali il terrore di soccombere alla banalità del quotidiano ha suggerito a tanti artisti contemporanei che vogliono sfuggire al sentimenti suggerito dal reale. Gli esempi sono tanti, coprono tutto un secolo. Fin dal principio Maimeri si è posto con coscienza fuori dalla moda del secolo nuovo, il secolo dei Carrà e dei Sironi, rischiando così di rimanere fuori da ciò che si chiama mercato, con le sue basi nelle cosiddette Fondazioni che escludono tutto ciò che non corrisponde alle mode mercantili, anche se autorevoli e in parte giuste. Il percorso di Maimeri non ha conosciuto ingombri modernisti nel suo sviluppo che abbraccia tutta la prima metà del secolo XX, sempre informato alla pittura. Tanto egli è stato convinto dell’eternità del percorso pittorico, che, nonostante tutte le scappatoie tecniche che lo tradiscono, egli sentendosi diretto erede di quella tradizione cui prima fondazione maimeri 44 Autoritratto giovanile, 1916 Olio su tela Oil on canvas, 50x40,5 cm Non firmato, datato alle opere di Maimeri, le apprezza con meraviglia, e poi se le scorda perché non le trova nei bollettini delle aste o nei luoghi deputati alla benedetta pubblicità? Il problema è più generale e dipende come sono orientati gli odierni studi di storia dell’arte. Maimeri ha sempre dipinto per necessità di vocazione, come Ugo Bernasconi, come mio padre De Grada e tanti altri. Ma la presenza di questi artisti è stata scarsamente avvertita perché la critica ha seguito soprattutto la moda dell’effimero, di coloro che per contare hanno seguito il chiasso dei tempi e con difficoltà si è posta davanti a tutto il panorama dell’arte del periodo o onde fare una scelta seriamente storica che costringerebbe a buttare a mare tanti nomi di “mercato” e a studiare quelli che veramente hanno rappresentato nella pittura un momento della vita e della storia. Ciò ci rimanda all’Alto Medioevo quando nei monasteri si compiva un vero “revisionismo” dell’arte greco-etrusco-romana. Confidiamo che le nuove generazioni compiano questo necessario “revisionismo”. Noi modestamente ci limitiamo a dargliene spunto, come possiamo. Tratto da Il ritorno di Gianni Maimeri Di Raffaele De Grada Donne sul divano (la siesta), 1920 Olio su cartone Oil on cardboard, 71x103 cm Non firmato, datato 45 fondazione maimeri Vele nella laguna, 1928 Olio su tela Oil on canvas, 60,5x90 cm Firmato e datato dalla Cartella “La femme visible”, 1971 ADRIANO ALTAMIRA allo Studio Giò Marconi Milano recensioni 46 Di Elisabetta Longari La Galleria Marconi di Milano espone ancora una volta una selezione di opere di Adriano Altamira, che, com’è noto, ha scelto di operare con la fotografia e di riflettere sulle immagini e sulla loro fenomenologia attraverso la fotografia (ricordiamo anche il suo impegno teorico che si è concretizzato nel corso del tempo in una serie di collaborazioni con quotidiani e riviste e nel recente volume La vera storia della fotografia concettuale, Rossellabigi editore). Mezzo versatile, volatile, ambiguo quant’altri mai, al tempo stesso calco della realtà e gioco di prestigio, la fotografia per Altamira è sin dal principio un dispositivo per vedere il mondo nei suoi lati più inattesi, nelle sue coincidenze virtuose. Area di coincidenza è il titolo della sua più famosa serie di opere, una serie potenzialmente infinita iniziata al principio degli anni Settanta e portata avanti fino al 2009. Anche la più recente Visti per caso, composta da cinque fotografie concepite e realizzate tra il 1995 e il 2009, si impernia sul principio della casualità, come è evidente sin dal titolo. L’incontro fortuito tra il ferro da stiro e la macchina per cucire sul tavolo anatomico, l’immagine di Lautremont presa a modella dall’estetica surrealista, è sempre attiva, colma di potere di seduzione e senza dubbio provocante meraviglia. Tra le opere che Altamira ha selezionato per l’esposizione ci sono cinque tavole estratte da Piccola Apocalisse (1999), una sorta di Atlante composto da centosessantacinque immagini in sequenza, luogo in cui si sono coagulati gli esperimenti fotografici dell’autore dai primi anni Ottanta fino alla soglia del 2000. Una mostra composta da una campionatura eccellente tra cui La femme visible dei primissimi anni Settanta (1971), realizzata da un autore appena ventiquattrenne: cinque lavori fotografici non più “usciti” dal 1973. Da questa serie è stata scelta l’immagine dell’invito, ambigua, intelligente e accattivante come tutto il lavoro di Altamira. *Adriano Altamira è docente di Storia dell’Arte Contemporanea e Teoria della Percezione e Psicologia della Forma all’Accademia di Belle Arti di Brera WORDS Un nuovo libro di Valerio Dehò Edito da MAT Edizioni (via Confalonieri, 36 Milano) WORDS è un lungo viaggio nei rapporti tra la parola, la poesia e le arti figurative. Un viaggio che ha inizio con l’innata visualità di chi scrive, con la necessità di superare le distinzioni tra l’immagine e il linguaggio verbale. Una storia fatta di amori e di contrasti, spesso nel nome di una complementarietà irriducibile, di un reciproco sopporto finalizzato alla comunicazione, al superare le barriere delle lingue nazionali, forse nell’inconscio desiderio di realizzare una lingua unica. Dai carmina figurata latini fino a Barbara Kruger o Jaume Plensa. Il libro è un punto di riferimento per le ricerche sui linguaggi logoiconici. Nomi eccellenti, ma anche scoperte si susseguono in una ricostruzione storica di estetiche e di posizioni personali, mettendo in luce legami magari poco appariscenti, ma anche riprese e risonanze che si sono succeduti in particolare nel corso di tutto in Novecento. WORDS è un panorama su di uno dei grandi temi aperti dell’arte moderna e contemporanea che affronta ormai i problemi della comunicazione digitale, delle ricchezze informative delle home page e del dominante linguaggio verbo-visivo imposto dalla net-society. Completano il volume una serie di utilissime schede su alcuni protagonisti della ricerca tra parola e immagine curate da Gudrun de Chirico. * Valerio Dehò è docente di Estetica all’Accademia di Belle Arti di Brera ALL’OPEN SPACE DI CATANZARO AFRICA IMMATERIALE, UNA SIGNIFICATIVA MOSTRA CON OPERE DI: ARCURI, COSTA, DE MITRI, PASCALI, VIOLETTA E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DI QUATTORDICI STUDENTI DELLA LOCALE ACCADEMIA DI BELLE ARTI Un realista visionario: FRANCESCO LEONETTI A cui è stato appena assegnato l’Ambrogino d’oro del Comune di Milano Di Fausta Squatriti “E allora, l’Ambrogino l’hai guardato? E’ proprio d’oro?”, domando a Francesco seduto nella poltroncina all’interno della quale il suo viso magro sembra esserne l’unico abitante, contornato dalla barba un po’ rustica, sbucando dalla giacca di panno abbastanza pesante per il clima settembrino. “Ma non lo so…”, e ride tra l’innocente, l’interrogativo e l’ironico, cifra espressiva, quest’ultima, nella quale lo riconosco pienamente. Gli occhi vivi, sorridenti e perfino dolci, di più negli ultimi anni, appena un po’ smarriti. Ma anche prima, Francesco è sempre stato, da che io lo ricordi, uomo entusiasmabile, senza barriere, a suo modo innocente, totalmente disinteressato al denaro, cosa che lo ha reso libero. Ha l’aria leggermente annoiata per questo festeggiamento, dapprima nella bella sala di Palazzo Marino, dove deve avere ascoltato il discorsetto aggraziato e veramente affettuoso del sindaco, tenendosene alla larga, distratto, come se la cosa non lo riguardasse poi tanto, e poi nella più domestica riunione di coloro i quali sono convenuti alla Fondazione Mudima, ospiti i cari compagni di tante iniziative culturali create insieme a Francesco ed altri, Gino e Viviana Di Maggio, ma anche tanti giovani ammiratori e forse curiosi. Invecchiando Francesco si è fatto più mite, almeno all’apparenza. Si permette di essere disinteressato a certi dettagli, e questo aumenta la sua affettività, attributo questo che anni fa, molti anni fa, sarebbe parso davvero contraddittorio con l’immagine che di Leonetti si coltivava nel mondo delle arti e della politica, ambiti entro i quali lui ha militato con grande coerenza fin dalla giovinezza. Di lui si potrebbe dire che è il prototipo dell’intellettuale di sinistra impegnato, arrabbiato, polemico, di quelli che, nati sotto il fascismo, ne hanno patito la stupidità ancor prima della crudeltà, pur dovendo, come lui, recarsi in guerra. La sordità da un orecchio di Francesco deriva dalla esplosione di una granata proprio vicino a lui, nella battaglia di Montecassino. Lo ha raccontato, ma senza mai soffermarsi sui lati terribili di quegli anni. Francesco è un uomo incline alla felicità assai più che al dramma. La sordità parrebbe essere l’unico segno citabile, di quella guerra che certo non gli deve avere fatto piacere combattere, da una parte che non credo gli sia piaciuta neppure allora, giovane del sud cresciuto a Bologna, laureato in filosofia e poi paleografo, infine bibliotecario. Mi raccontava qualche tempo fa che avendo ricevuto ordini superiori circa l’eliminazione di certi titoli sgraditi al regime, lui si limitò a spostarne le schede all’interno dei cassetti, rendendo di fatto i libri 47 recensioni Giovedì 24 giugno - nell’ambito della stagione artistica 2009/2010, promossa e organizzata dal Centro per l’arte contemporanea Open Space di Catanzaro, con il contributo delle Cattedre di Pittura e di Tecnica e tecnologia della pittura della locale Accademia di Belle Arti e con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale e Comunale, (Assessorati alla Cultura) di Catanzaro - l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea “Africa immateriale, liquidità della visione”, curata da Miriam Cristaldi, (critico e curatore indipendente), con testo introduttivo in catalogo di Renato Barilli, (critico, storico e direttore della Scuola di specializzazione di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Bologna) e con un testo poetico di Paolo Aita (critico e curatore indipendente). La mostra presenta opere di: Caterina Arcuri, Claudio Costa, Giulio De Mitri, Pino Pascali, Antonio Violetta, artisti appartenenti a formazione, generazioni e linguaggi visivi diversi, accomunati da questo significativo progetto artistico-culturale dedicato all’Africa, “capace di evocare - come afferma la curatrice nella presentazione in catalogo - misteriosi fascini antropologici, radice dell’umanità, origine della storia, “culla” del passato e - probabilmente - del futuro…Così, per Caterina Arcuri la sanguigna terra africana può trasformarsi in sottile pellicola capace di registrare il passaggio dell’uomo: l’impronta, precaria pressione sulla sabbia, evoca presenze-assenze trasformandole in tatuaggi indelebili sulla pelle dell’anima mentre per Claudio Costa, attraverso processualità concettuali, riconosce l’Africa settentrionale - coincidente con il profilo dell’Homo Erectus - come splendida Opera d’Arte. Giulio De Mitri, sotto l’impulso d’uno sposalizio mediterraneo, mette in campo vibrazioni liquidoenergetiche capaci di pervadere e sfondare spazi con iridescenti densità aeree e preziose liquidità marine virate sui toni del bluazzurrino nei riflessi iridescenti del diamante. Pino Pascali definisce questo luogo esotico con figurazioni ludiche stilizzate, stereotipate, non esente dal mettere in guardia da possibilità turistico-speculative. La visione di Antonio Violetta corrisponde invece alla insostenibile sensazione di “leggerezza” governata da ampi e lunghi respiri virtuali dove aritmiche estroflessioni/introflessioni creano moti sussultori capaci di scuotere la pelle dell’Africa in intimi brusii dell’inconscio.” Dopo l’inaugurazione della mostra seguirà la performance “Aprica, giovani creativi per un collettivo percorso nell’immaginario” con la partecipazione di quattordici studenti afferenti alle Cattedre di Tecniche e tecnologia della pittura e di Pittura II. Un progetto didattico realizzato e prodotto per l’occasione con diversificate espressioni artistiche (dai suoni onomatopeici, alla pantomima, dalla maschera al teatro della parola) che vedrà evocare l’Africa tra passato e presente. Per l’occasione è stata edita una pubblicazione per le Edizioni Open Space, contenente testi di Paolo Aita, Renato Barilli e Miriam Cristaldi, apparato iconografico e nota bio-bibliografica sugli artisti. Fausta Squatriti e Francesco Leonetti recensioni 48 irreperibili, ma non eliminati fisicamente, e mi piace pensare a questo sgambetto al potere ignorante, che chissà quanto lo deve avere soddisfatto. All’inizio degli anni ’60 lo incontravo qualche volta nello studio di Arnaldo Pomodoro, o a casa di sua sorella Teresa, e lui, più grande di noi due ragazze, già impegnatissimo nelle lotte delle opinioni, si faceva ascoltare con autorevolezza. Non era facile, anzi, era impossibile, discutere con lui, aveva la certezza delle proprie opinioni, e non sentiva repliche da me, che ai suoi occhi non ero che una ragazza borghese e come tale inevitabilmente viziata. Ricordo una litigata quando osai dire che io non disdegnavo di guardare la televisione, ritenendola parte della cultura pop, allora emergente. Non lo avessi mai detto! La divisione tra sciocchezze e cose serie, tra politico e non politico, era per lui capace di dividere. L’ironia, credo, la acquisì dopo, con qualche delusione ideologica. Il confine, allora, lo aveva tracciato con rigidità. Per farmi valere come interlocutrice ci sono voluti degli anni, quando gli chiesi la prefazione per il mio libro di poesia “La natura del desiderio”, edito da Scheiwiller. Se Francesco entra nel tuo mondo creativo, se ti stima, si riesce ad essere ascoltati, alla pari. Allora lui diventa entusiasta, ammirativo, generosissimo. Ed eravamo arrivati agli anni ’80, la visionarietà era già stata abbattuta, umiliata dagli anni di piombo. Dentro le ricerche più avanzate del dopoguerra, suoi compagni di strada, tanto per citarne due, Vittorini, Balestrini, il Gruppo ’63, le ricerche linguistiche, la contraddizione delle stesse avanguardie storiche del ‘900, e la mediazione che le grandi case editrici potevano offrire per pubblicare tali ricerche e renderle leggibili ad un pubblico sperato vasto, Leonetti si trovava a proprio agio, anche se rimase un solitario nella sua militanza di gruppo nel quale, credo, a stento poteva collocarsi permanentemente, troppo sincero, mai diplomatico, e difatti non lo fece, pur avendone avuto la possibilità. Gli premeva di più coltivare la mobilità del proprio pensiero, in sintonia con gli eventi storici, politici, culturali che via via ha attraversato nella sua ormai lunga vita. Litigioso, intransigente, appassionato, andava più d’accordo con Pasolini che con il potere delle case editrici. Saggista anomalo, poeta, con l’andare del tempo sempre più poeta, pensatore, e docente di estetica all’Accademia di Belle Arti di Brera, cosa che gli permise di influire su più generazioni di studenti con il suo straordinario fascino intellettuale. Aveva un modo di parlare di filosofia, direi apodittico, esaltato ma lucidissimo, in una parola, appassionato. Dico aveva, perché ora, da qualche anno, la voglia di fare rivoluzione deve essergli passata, le belle speranze di cambiamento, sconfitte dal conformismo, ancora una volta vincitore. Il mio amico Giulio Carlo Argan, mi diceva, “So che è un’utopia, ma quant’è buono il profumo della rivoluzione!”. Ecco, questo profumo, così come un esteta come Argan lo aveva metaforizzato a proposito della freschezza che si potrebbe ipotizzare nella fioritura che contraddistingue le idee nuove, dunque rivoluzionarie, in politica e nell’arte, da tempo non lo si respira più. Altri ripensamenti, introflessi, si fanno necessari, dopo tanto sfoggio rivoluzionario, spesso terminato in cenere. L’arte di oggi è più introflessa che estroflessa, e non si potrebbe fare diversamente, avendo consumato tanta energia dall’inizio del ‘900 fino a pochi anni fa, cosa che ci obbliga a lavorare sulla masticazione dei miti del pensiero del secolo scorso, spezzandoli, considerandone delle particelle, di volta in volta ingrandite a dismisura, analizzate al microsopio della introspezione. Leonetti, più sanguigno, più combattente di quanto non fosse il Professore amante del neoclassico, del bauhaus e della ragione, mi ha spesso detto di avere amato la lotta armata. Negli anni caldi a Milano, a Parigi, a Roma, le sue frequentazioni, esplicite o segrete, erano dalla parte della voglia imperiosa di cambiamento, di un cambiamento che doveva avvenire in fretta, e per spazzare via il vecchio e il guasto, si crearono molti drammatici errori, spreco di vite, di idee. Leonetti, che non farebbe male ad una mosca, parlando della “lotta” si esaltava. Prima che tutto precipitasse nel delitto, senza la ragione di un progetto forte. Comprensibile atteggiamento intellettuale per un uomo tutto sommato appassionato, voglioso di atti eroici, non so quanto puramente teorici, certo spavaldo, amante delle idee come passione e lotta, amante delle donne, dell’innamoramento, del sesso, dei gesti significativi. Incapace di drammatizzare sconfitte e mutamenti. Infatti Francesco sa dove l’utopia si è infranta, e non se ne è lasciato deprimere. La sua forza creativa lo conduce sempre avanti, verso nuove invenzioni, riflessioni, rivoluzioni se non più politiche, almeno culturali. Ricordo quando, negli anni ’90, insieme fondammo il “Teatro dell’autore in scena”, altrimenti detto “Drammi corti”. Era un continuo ripensamento, stesura di documenti teorici che andavamo a discutere a pranzo, nella trattoria vicina al mio studio, nel quartiere cinese. Il cibo più semplice, lo entusiasmava, tagliatelle con gamberi e rucola, prendeva sempre quello. E parlando abbastanza ad alta voce, le nostre idee erano ascoltate da quasi tutta la trattoria. Eravamo un gruppo di artisti, poeti, critici d’arte, e scrivevano piccoli pezzi teatrali, mettendoli in scena senza l’intermediario dell’attore. Riuscimmo a fare parecchio, andando anche al festival “Ricercare” di Reggio Emilia, alla Fondazione Mudima parecchie volte, a Venezia, e ancora a Milano per i “Teatri ‘90”, alla Rotonda Besana. Leonetti, Squatriti, Ceresoli, Fiorani, Dorfles, Nove, Voce, Scarpa, Cepollaro, Balestrini, Castaldi, Varisco, Occhipinti, Isgrò, Torri, e altri più di passaggio. Rivedendo ora i filmati di quei nostri teatrini, riconosco che, oltre ad esserci non poco divertiti, abbiamo fatto anche un buon lavoro, con mezzi che non fossero le nostre stesse capacità, gli oggetti portati da casa, le luci improvvisate, scenografie minimaliste per forza, e regia in parte autoctona, con la guida della giovane Marina Spada. Ricordo quando decisi di fare costruire una pedana di legno che poi dipingemmo di nero, per sopraelevare la scena, nell’angolo del primo piano alla Fondazione Mudima. Ah, bravissima, ecco quello che mancava, giusto, la pedana!! Tu ti svegli una mattina, e inventi che ci vuole la pedana! E tantissimo gli piacque l’idea di reggere i testi che leggevamo, proprio come i giornalisti in televisione, non avendoli imparati a memoria per principio, su tavolette di alluminio anodizzato da me fatte costruire! Se fosse stato per lui, il teatrino lo avremmo dovuto continuare ancora a lungo, e ci rimase male quando con Eleonora e Jacqueline gli dicemmo che nessuno di noi poteva stabilmente cambiare lavoro, e che il teatrino doveva considerarsi un episodio. Un entusiasmo che accompagna Francesco in tutto quello che fa, anche adesso che scrive bellissime poesie che parlano senza pudore e allo stesso tempo con fragranza, della vecchiaia, che lui affronta, con lo strepitoso aiuto di Eleonora Fiorani, compagna di un lungo percorso di vita, dalla quale lui ora sembra dipendere in tutto, con la leggerezza che si addice ad un anziano maestro le cui invenzioni sono, suo malgrado, sprofondate e confuse nella mischia, pur rimanendo testimoni della libertà creativa. Un segno nella polvere. b l e n ando i a i t n a v a d e v r a p p a e tt o z z e m o d n a u q i h c c o iei t n a v a I d e R v r O a T p p T a I e R t t C o n ella S m l e b l e n o d n a u q i h c c o miei i a i t n a v a d I e v S r a I p O p a N e t t no DA ndo nel mez a u q i h c c o i mie i a i t n a v a d e v r a p p a e t t no l e b l e n o d n a u q i h c c o i mie i a i t n a v a d e v r a p p a e nott a l l e n o d n a u q i h c c o e r d ma a p p a e t t o n a l l e d a c c a r ba E C S A N SI A T N E V DI Z .I . ic i - M o if t s a P i h ic t n Via A lf e t t a - 2 3 in fo @ li m T 0 8 0 .3 3 8 1 1 m a g in e.n e t graphic desig enio ner Gaetano Arm CARE I L B B U P I O U TALE P NUTI I E G T I N D O A C P I T M S A O T CON LA S CCOLE TIRATURE E A C IN PI E R E P O E I PER U L T A I E C L E P S I N O I CONDIZ ’ARTE I CATALOGHI D MAIMERI OLIO x red accademy 10-02-2010 17:46 Pagina 1 DAI POTENZA ALLA TUA FANTASIA modello Porsche dipinto da Alessandro Gedda, concept e photo Claudio Sforza 38 COLORI FORTI E BRILLANTI 4 PASTE A OLIO INNOVATIVO PRATICO IMMEDIATO EFFICACE GRANDE FORMATO CONVENIENTE RISPETTA L’AMBIENTE made in Italy dal 1923
Scaricare
pdf