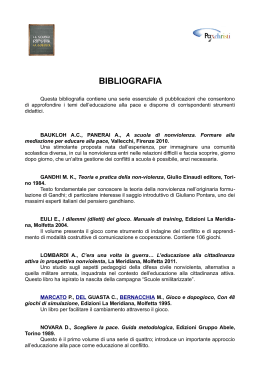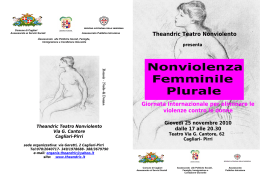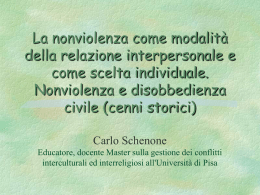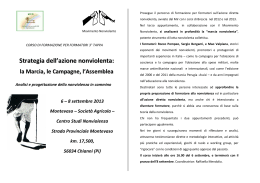CARITAS DIOCESANA Fano Fossombrone Cagli Pergola SCUOLA DI PACE Carlo Urbani Nonviolenza Giustizia Salvaguardia del creato Cittadinanza responsabile SUSSIDI - PRE ATTI 1° anno di corso - 2004 SUSSIDIO AGLI INCONTRI Sabato 10 gennaio 2004 ore 17:00 I cristiani, la nonviolenza, la pace: percorso teologico, di storia della Chiesa, di impegno odierno. Luigi Bettazzi Sabato 7 febbraio 2004 ore 17:00 I cristiani, la nonviolenza, la pace: percorso biblico. Giuseppe Barbaglio L’OPZIONE NONVIOLENTA NEL CRISTIANO(ESIMO) di Luciano Benini* (il testo è contenuto nel libro “Convertirsi alla nonviolenza? Credenti e non credenti si interrogano su laicità, religione, nonviolenza”, a cura di Matteo Soccio, Il segno dei Gabrielli editore. Il libro raccoglie gli atti di un convegno sul tema tenuto a Perugia nel 2002.) PREMESSA Circa 25 anni fa Enzo Bianchi, priore della Comunità monastica di Bose, in Piemonte, stava commentando il brano delle tentazioni di Gesù nel deserto nel Vangelo di Luca, laddove emerge con chiarezza che il potere, ogni potere, economico, politico, militare, religioso, è in mano al maligno. Dunque il cristiano che gestisce un qualche potere deve sapere di avere in mano un tizzone ardente: solamente se munito di “abiti virtuosi”, come diceva don Giuseppe Dossetti, è possibile per il cristiano gestire il potere come servizio, che è poi l’unico modo che è dato al cristiano di stare in mezzo agli uomini. Alla domanda “ma allora la Chiesa nel corso dei secoli non è stata fedele al Vangelo perché ha gestito poteri di ogni tipo”, Enzo Bianchi rispose che in fondo l’unico compito della Chiesa è quello di tenere alta la croce di Cristo annunciando che solamente in essa vi è salvezza, e a questo dovere la Chiesa non è mai venuta meno. Concordo sostanzialmente con questa risposta: se dunque la Chiesa non è venuta meno, nel corso dei secoli, al suo compito essenziale, ciò nondimeno a me pare che su diversi temi la Chiesa e i cristiani si siano allontanati dal messaggio evangelico, e sul tema che trattiamo oggi, pace e nonviolenza, in maniera particolare. Ciò è tanto più grave se è vero, come afferma di nuovo Enzo Bianchi, che “Gesù Cristo è la nostra pace, se con la sua croce e la sua resurrezione dai morti Dio ha riconciliato con sè il mondo intero che gli era nemico, allora il tema della pace è di ordine cristologico e rivelativo prima di essere etico e morale. Noi siamo convinti che oggi più che mai la chiesa gioca la sua fedeltà al Signore e misura la capacità di testimoniare l'Evangelo e di rispondere ai drammi della storia nella compagnia degli uomini proprio sulla dottrina e sulla prassi della pace. Questo significa però che la pace è dono di Dio e compito profetico dei cristiani nello stesso tempo. ... Gli atteggiamenti improntati a realismo politico rischiano spesso di risolversi in considerazioni scettiche nei confronti di una reale possibilità della pace. Il messaggio forte e netto della Parola di Dio viene così oscurato e sbiadito per lasciar posto a discorsi di sapienza mondana misconoscendo la "parola stolta" e il "discorso folle" della Croce che è l'unico criterio di giudizio su ogni atto e ogni parola della chiesa e del cristiano. ... L'annuncio della pace è dunque annuncio del Vangelo, ... Chi annuncia il regno, annuncia la pace, chi si pone sotto la signoria di Dio, si mostra anche servo e artefice di pace, chi accoglie il regno di salvezza accoglie la pace. 1 Dividerò allora l’intervento in tre parti: una prima nella quale percorrerò a grandi tappe la pedagogia di Dio nella Bibbia sul tema violenza-nonviolenza. Una seconda nella quale verranno tratteggiate le principali fasi della storia della Chiesa sul medesimo tema. Una terza più di attualità e di prospettive future. LA PACE NELLA BIBBIA ANTICO TESTAMENTO Il problema della violenza viene affrontato nella Bibbia sin dai primi capitoli del libro della Genesi. Già dopo la caduta di Adamo ed Eva, Dio dice alla donna: "Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà." (Gen 3,16), con ciò significando un rapporto conflittuale fra l'uomo e la donna. Una seconda riflessione sul tema del dominio e della violenza l'abbiamo con l'episodio di Caino e Abele, dove la violenza questa volta è fra fratello e fratello. Il diffondersi della violenza è esemplificato dallle parole di Lamech: "Ho ucciso un uomo per un mio graffio, un ragazzo per un mio livido. Se Caino sarà vendicato sette volte, io, Lamech, settanta sette." (Gen 4,23-24). 1 AA.VV, La pace dono e profezia, Edizioni Qiquajon, Magnano (BI). Questo dilagare della violenza porta Dio ad una affermazione sconvolgente in Gen 6,6: “E il Signore si pentì di aver fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo”. Dio constatata in Gen 6,11.13 che: "La terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. … La terra, per causa degli uomini, è piena di violenza". Dio però non accetta questa situazione di violenza e in Gen 9,5 afferma: "Domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello", con ciò ribaltando quanto affermato da Caino in Gen 3,9: "Sono forse il custode di mio fratello?". In questa situazione, il comandamento "Tu non ucciderai” di Es 20,13 e la legge del taglione di Es 21, 23-25 hanno il senso di arginare una violenza che altrimenti dilagherebbe in maniera esponenziale. Questa pedagogia di Dio giunge già nell'Antico Testamento ad affermazioni chiare e forti contro la violenza, come in Lv 26,3.6: "Se seguirete le mie leggi, se osserverete i miei comandi e li metterete in pratica ... io stabilirò la pace nel paese: nessuno vi incontrerà terrore ... e la spada non passerà per il vostro paese" e ancora in Lv 26,14.25: "ma se non mi ascolterete e non metterete in pratica tutti questi comandi ... manderò contro di voi la spada, vindice della mia alleanza". E ancora nei profeti, Is 2,4: “Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra”. NUOVO TESTAMENTO I poveri del Vangelo, che sono la Chiesa autentica, dovranno amare i nemici, fare del bene a chi li perseguita (Mt 5,44), perdonare fino a settanta volte sette (Mt 18,22) per coprire con una misura abbondante ed inesauribile di perdono la misura di violenza e di vendetta presente in ogni generazione umana. Sull'esempio di Gesù, i cristiani non ricorreranno alla spada (Mt 26,52: “52Allora Gesù gli disse: "Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada”.) non ricorreranno agli eserciti (Mt 26,53: “53Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di dodici legioni di angeli?”, non si difenderanno con la violenza. Sono infatti seguaci di un Signore che è Agnello sgozzato, ma ritto in piedi e vincitore del male. Questo è il luogo in cui la Chiesa verifica la sua fedeltà al Signore, il luogo in cui si vaglia la qualità di discepoli. Il modo per vincere la violenza non potrà mai essere quello di difendersi usando violenza. Il cristiano dovrebbe avere un tale orrore delle armi da non dare mai il suo contributo per la folle corsa agli armamenti o per spese militari di qualunque tipo. Di fronte alla violenza subita il cristiano non può far altro che diventare ministro del perdono di Dio, vincendo il male con il bene (Rm 12,14), rinunciando sempre ad adorare la bestia (Ap 20,4). LA TRADIZIONE E IL MAGISTERO DELLA CHIESA DA COSTANTINO ALLA PACEM IN TERRIS Nei primi tre secoli la trazione e il magistero della Chiesa ha costantemente annunciato e vissuto con coerenza il messaggio evangelico sulla nonviolenza Basterà qui citare alcuni autori. “Il catecumeno o il fedele che vogliono dedicarsi alla vita militare siano mandati via perchè hanno disprezzato Dio” (Ippolito di Roma, 215 dC). “Quando Dio interdice di uccidere, non interdice solamente il brigantaggio, illecito anche per le leggi dello stato, ma ci invita a non fare ciò che gli uomini ritengono lecito. È per questo che il giusto non può essere soldato, perchè il servizio militare del giusto è la giustizia stessa” (Firminio Lattanzio, 300 dC). La svolta avviene con l’editto di Costantino (313 dC) e l’editto di Milano di Teodosio (394 dC). Con Costantino, e poi soprattutto con Teodosio, i cristiani cominciano ad accettare di fare il servizio militare e la guerra perchè in cambio ottengono uno spazio separato per vivere l'esperienza di fede. L'esenzione dal militare e dalla guerra resta per i sacerdoti. Saranno Sant’Agostino prima (V secolo) e San Tommaso poi (XIV secolo) a dare sistematicità a tale svolta formulando la teoria della cosiddetta “guerra giusta”: • Il danno causato dall'aggressore sia durevole, grave e certo. • • • Tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci. Ci siano fondate condizioni di successo. Il ricorso alle armi non provochi mali più gravi di quelli che vuole eliminare. Per quanto formulata con lo scopo di “limitare” il ricorso alle guerre e la partecipazione ad esse dei cristiani, la teoria della “guerra giusta” ha di fatto portato al nascondimento, per oltre sedici secoli, del vangelo della nonviolenza. Non che in questo lunghissimo periodo non vi siano state figure luminosissime che hanno ricordato alla Chiesa e ai cristiani che l’annuncio evangelico poneva ben altri insegnamenti, ma di fatto la prassi cristiana è stata improntata ad un realismo e ad una mondanità che ha tradito lo spirito del Vangelo. Sarebbe doveroso trattare ampiamente sia l’esperienza e la prassi di S. Francesco, nonviolento fra i più profondi e convinti, che l’esperienza storica di cristiani quali i Quaccheri (la società degli amici) che hanno sviluppato una particolare sensibilità e attenzione ai temi della pace. Ma lo spazio a disposizione consente solo di farne un accenno. LA PACEM IN TERRIS, LA STAGIONE CONCILIARE E GLI ODIERNI PROFETI DELLA PACE La prima metà del XX° secolo vede lo scoppio di due guerre mondiali. Forse perché scossi da tali immani tragedie, i cristiani sembrano svegliarsi da un torpore durato più di milleseicento anni e avviano una riflessione diversa su guerra, violenza, pace, nonviolenza. Nel 1955 don Primo Mazzolari, prete di Bozzolo nella bassa mantovana, scrive un libretto destinato a sconvolgere tale secolare prassi. “Non è forse una contraddizione che dopo venti secoli di cristianesimo … l’omicida comune sia al bando come assassino mente chi, guerreggiando, stermina genti e città sia in onore come un eroe? … Che venga bollato come disertore e punito come traditore chi, ripugandogli in coscienza il mestiere delle armi, che è il mestiere dell’uccidere, si rifiuta al dovere? … Il cristiano è contro ogni male, non fino alla morte del malvagio ma fino alla propria morte, dato che non c’è amore più grande che quello di mettere al propria vita a servizio del bene e del fratello perduto. Vince chi si lascia uccidere, non chi uccide. La storia della nostra redenzione si apre con la strage degli Innocenti e si chiude con il Calvario: una storia, se osservata ben, un po’ meno assurda della storia delle guerre”. 2 Ma è il Concilio Vaticano II° ad avviare la svolta epocale. Durante il Concilio, verso la fine dei suoi giorni terreni, Papa Giovanni scrive l’enciclica “Pacem in Terris” al cui punto 67 è detto “È alieno dalla ragione pensare che nell'era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia”. È la fine della teoria della “guerra giusta”, anche se, purtroppo, sia negli scritti che nella prassi tale ritorno alle fonti evangeliche sulla pace è tutt’altro che un percorso concluso. Colui che più di ogni altro si è speso, al Concilio, senza riuscirvi, per una condanna chiara, totale e definitiva della guerra e della sua preparazione è stato il Cardinale di Bologna Giacomo Lercaro. Nel documento conciliare “Gaudium et Spes” del 1965 al n. 79 si legge “La guerra non è purtroppo estirpata dalla umana condizione. E fintantochè esisterà il pericolo della guerra e non ci sarà un'autorità internazionale competente, munita di forze efficaci, una volta esaurite tutte le possibilità di un pacifico accomodamento, non si potrà negare ai governi il diritto alla legittima difesa”. Riprendendo l’ analisi sulla Gaudium et Spes ,in un articolo apparso nel 1967 sulla rivista “Testimonianze”, affermava come "non soltanto la guerra totale, ma ogni genere di guerra, come si pone di fatto oggi, richiede una revisione dell’ antica dottrina con cui si giudicava della sua moralità" per sostenere infine "il trascendimento della falsa alternativa tra impiego della forza bellica e inerzia pacifista, mediante invece l’ impiego dei mezzi attivi della cosiddetta nonviolenza". 2 PRIMO MAZZOLARI, Tu non uccidere, Edizioni La Locusta, Vicenza 1955. Secondo il Cardinale la Chiesa deve farsi "facitrice di pace: per le vie non umane e tutte spirituali che le sono proprie ... la pace è Cristo stesso" (idem). Ma il momento pubblico più chiaro, e più gravido di conseguenze, della sua predicazione, direi anche della sua profezia, di pace si era dato il 1 gennaio del 1968 in occasione della prima giornata mondiale della pace quando aveva esortato gli Stati Uniti a "desistere dai bombardamenti aerei sul Vietnam del Nord". Sappiamo bene che in quella posizione va ricercata la causa ultima del suo allontanamento dalla guida della diocesi di Bologna che, annunciatogli da un inviato romano il 27 gennaio, divenne pubblico il 12 febbraio 1968. La Chiesa, secondo il Cardinale, deve esprimere un ruolo attivo di operatrice di pace, sviluppando la dimostrazione dell’ infondatezza evangelica della dottrina teologica della guerra giusta. Frutto della stagione conciliare è senza dubbio lo straordinario prete Lorenzo Milani. In risposta ai cappellani militari in congedo della Toscana, che sulla Nazione del 12 febbraio 1965 avevano scritto di considerare “un insulto alla patria e ai suoi caduti la cosiddetta «obiezione di coscienza» che, estranea al comandamento cristiano dell’amore, è espressione di viltà”, scrive un testo di straordinaria bellezza fra cui ricordiamo un famoso passaggio: “Se voi però avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati ed oppressi da un lato, privilegiati ed oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri. E se voi avete il diritto, senza essere richiamati dalla Curia, di insegnare che italiani e stranieri possono lecitamente anzi eroicamente squartarsi a vicenda, allora io reclamo il diritto di dire che anche i poveri possono e debbono combattere i ricchi. E almeno nella scelta dei mezzi sono migliori di voi: le armi che voi approvate sono orribili macchine per uccidere, mutilare, distruggere, far orfani e vedove. Le uniche armi che approvo io sono nobili e incruente: lo sciopero e il voto”. 3 Messo sotto processo per una denuncia da parte di un gruppo di ex combattenti, Lorenzo scriverà, assieme ai suoi ragazzi di Barbiana, quello che resta il più alto scritto di educazione morale e civile per i giovani, la Lettera ai Giudici. Eccone un passaggio: “E quando è l'ora non c'è scuola più grande che pagare di persona un'obiezione di coscienza. Cioè violare la legge di cui si ha coscienza che è cattiva e accettare la pena che essa prevede. ... Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo nè davanti agli uomini nè davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto. ... Spero che in tutto il mondo i miei colleghi preti e maestri d'ogni religione e d'ogni scuola insegneranno come me. Poi forse qualche generale troverà ugualmente il meschino che obbedisce e così non riusciremo a salvare l'umanità. Non è un motivo per non fare fino in fondo il nostro dovere di maestri. Se non potremo salvare l'umanità ci salveremo almeno l'anima”. 4 Contraddittoria è una frase contenuta nell’Enciclica di Paolo VI Populorum Progressio del 1967 che al n. 31 afferma “E tuttavia lo sappiamo: l'insurrezione rivoluzionaria - salvo nel caso di una tirannia evidente e prolungata che attentasse gravemente ai diritti fondamentali della persona e muovesse in modo pericoloso al bene comune del paese - è fonte di nuove ingiustizie”. C’è in questa posizione una apertura verso l’uso delle armi, e quindi la messa in ombra della forza della nonviolenza evangelica, anche se poi nella prassi quei cristiani che hanno preso davvero le armi per liberare i popoli dalle terribili tirannie latino-americane degli anni ‘60, ’70 e ’80 hanno subito la condanna e l’isolamento da parte della Chiesa gerarchica. Negli anni ’80, nel periodo di massima tensione Est-Ovest per la questione degli euromissili, sotto la pressione di un impressionamene movimento per la pace attivo soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, gli episcopati di mezzo mondo hanno pubblicato lettere sulla pace. La lettura di tali documenti esprime con chiarezza il travaglio e le oscillazioni della Chiesa fra guerra giusta ed 3 LORENZO MILANI, Risposta ai cappellani militari in L’obbedienza non è più una virtù, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1976. 4 LORENZO MILANI, Lettera ai giudici in L’obbedienza non è più una virtù, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1976. evangelo della pace, travaglio che ha caratterizzato le posizioni dei cristiani sul finire del secolo XX°. Complesso ma molto significativo sul versante dell’impegno per il superamento della guerra giusta è il pontificato di Giovanni Paolo II°. Ne diamo un breve cenno attraverso alcuni testi degli anni ’90. “Sembrava che l'ordine europeo, uscito dalla seconda guerra mondiale, ... potesse essere scosso soltanto da un'altra guerra. È stato, invece, superato dall'impegno non-violento di uomini che, mentre si sono sempre rifiutati di cedere al potere della forza, hanno saputo trovare di volta in volta forme efficaci di rendere testimonianza alla verità” (Enciclica Centesimus Annus. 1991). In tale passaggio è molto chiara la valorizzazione della nonviolenza nella lettura dei fatti dell’89, diversamente da quasi tutti i commentatori politici che non hanno saputo cogliere la grande novità di quella scelta. “Mai più la guerra, spirale di lutto e di violenze; mai questa guerra nel Golfo Persico”. (discorso al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, 16/1/1991) In queste ore di grande pericolo vorrei ripetere con forza che la guerra non può essere un mezzo adeguato per risolvere completamente i problemi esistenti fra le nazioni: non lo è mai stato, non lo sarà mai. (discorso al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, 18/1/1991). In questi passaggi si coglie tutta la posizione di contrarietà alla guerra del Papa, in momenti in cui gli Episcopati non prendevano posizione, i cristiani per la maggiorparte stavano a guardare e i parlamentari che facevano riferimento ai valori cristiani votavano a favore della guerra. “Sembra proprio che il dovere degli Stati sia di disarmare questo aggressore qualora tutti gli altri mezzi si siano rivelati inefficaci” (discorso alla Curia Romana sulla guerra in Somalia e Bosnia, 1992) Sintomatici di una certa oscillazione, e in parte di ritorni indietro rispetto alla valorizzazione della nonviolenza, sono alcuni passaggi inseriti nel nuovo “Catechismo della Chiesa Universale” del 1992. “Chi difende la propria vita non si rende colpevole di omicidio anche se è costretto a infliggere al suo aggressore un corpo mortale”. (2264) “Essa può non essere soltanto un diritto, ma un grave dovere, per chi è responsabile della vita di altri, del bene comune della famiglia o della comunità civile”. (2265) Quantomai chiara sul valore della nonviolenza come scelta morale e pratica è il documento del 1993 “Il frutto della giustizia è seminato nella pace” dell’episcopato cattolico degli Stati Uniti. IN esso leggiamo: “In situazioni di conflitto il nostro impegno costante dovrà essere, per quanto possibile, quello di lottare per la giustizia con mezzi non-violenti. La non-violenza non va interpretata semplicemente come scelta o vocazione personale, poichè la storia recente insegna che in determinate circostanze può essere anche un'azione pubblica efficace. Queste rivoluzioni non-violente ci provocano a trovare dei modi per mettere in piena luce il potere della non-violenza organizzata e attiva. I capi delle nazioni hanno l'obbligo morale di far si che le alternative non-violente siano prese seriamente in considerazione di fronte ai conflitti. Come nazione dovremmo promuovere una ricerca, un'educazione e una formazione sui metodi nonviolenti di resistenza la male. Le strategie non-violente richiedono una grande attenzione a livello internazionale. Nei conflitti futuri gli scioperi e la forza popolare potrebbero talora rivelarsi più efficaci di fucili e pallottole”. Si sente forte, in questo testo, il contributo di un grande teorico della nonviolenza, Gene Sharp, che ha collaborato alla stesura di un testo fra i più espliciti sul valore della nonviolenza non solo come scelta morale ma anche come efficacia pratica. Ancora Giovanni Paolo II° nel 1995, nell’Enciclica “Evangelium Vitae”, trattando dei vari aspetti della difesa della vita scrive: “E come non pensare alla violenza ... insita, prima ancora che nelle guerre, in uno scandaloso commercio delle armi, che favorisce la spirale dei tanti conflitti armati che insanguinano il mondo? Tra i segni di speranza va pure annoverata la crescita, in molti strati dell’opinione pubblica, di una nuova sensibilità sempre più contraria alla guerra come strumento di soluzione dei conflitti tra i popoli e sempre più orientata alla ricerca di strumenti efficaci ma «non violenti» per bloccare l’aggressore armato. Forse che questi crimini cesserebbero di essere tali se, invece di essere commessi da tiranni senza scrupoli, fossero legittimati dal consenso popolare? In realtà, la democrazia non può essere mitizzata fino a farne un surrogato della moralità o un toccasana dell’immoralità. Fondamentalmente, essa è un “ordinamento” e, come tale, uno strumento e non un fine. ... la legge civile deve assicurare per tutti i membri della società il rispetto di alcuni diritti fondamentali ... Per cui ogni atto dei poteri pubblici, che sia o implichi un misconoscimento o una violazione di quei diritti, è u atto contrastante con la loro stessa ragion d’essere e rimane per ciò stesso destituito d’ogni valore giuridico. Qualora pertanto le sue leggi o autorizzazioni siano in contrasto con quell’ordine, e quindi in contrasto con la volontà di Dio, esse non hanno forza di obbligare la coscienza ...; in tal caso, anzi, chiaramente l’autorità cessa di essere tale e degenera in sopruso. Leggi di questo tipo non solo non creano nessun obbligo per la coscienza, ma sollevano piuttosto un grave e preciso obbligo di opporsi ad esse mediante l’obiezione di coscienza. Infatti, da un punto di vista morale, non è mai lecito cooperare formalmente al male. Tale cooperazione si verifica quando l’azione compiuta, o per la sua stessa natura o per la configurazione che essa viene assumendo in un concreto contesto, si qualifica come partecipazione diretta a un atto contro la vita umana innocente o come condivisione dell’intenzione immorale dell’agente principale. Questa cooperazione non può mai essere giustificata nè invocando il rispetto della libertà altrui, nè facendo leva sul fatto che la legge civile la prevede e la richiede: per gli atti che ciascuno personalmente compie esiste, infatti, una responsabilità morale a cui nessuno può mai sottrarsi e sulla quale ciascuno sarà giudicato da Dio stesso (cf. Rm 2,6; 14,12)” “Quando la guerra, come in questi giorni in Iraq, minaccia le sorti dell'umanità, è ancora più urgente proclamare, con voce forte e decisa, che solo la pace è la strada per costruire una società più giusta e solidale. Mai le armi e la violenza possono risolvere i problemi degli uomini. Il pensiero delle vittime, delle distruzioni e delle sofferenze provocate dai conflitti armati arreca sempre profonda preoccupazione e grande dolore. Dovrebbe ormai essere chiaro a tutti che la guerra come strumento di risoluzione delle contese fra gli Stati è stata ripudiata, prima ancora che dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla coscienza di gran parte dell'umanità. Il vasto movimento contemporaneo a favore della pace traduce questa convinzione di uomini di ogni continente e di ogni cultura. A tutti viene ora chiesto l'impegno di lavorare e pregare affinché le guerre scompaiano dall'orizzonte dell'umanità." Ho vissuto la seconda guerra mondiale e sono sopravvissuto alla seconda guerra, per questo ho il dovere di ricordare a tutti i più giovani, a tutti quelli che non hanno avuto questa esperienza, ho il dovere di dire, ”mai più la guerra”. Chi decide che sono esauriti tutti i mezzi pacifici che il Diritto Internazionale mette a disposizione, si assume una grave responsabilità di fronte a Dio, alla sua coscienza e alla storia”. (Giovanni Paolo II° sulla guerra in Iraq, marzo 2003). Sul fronte italiano, dopo che negli anni ’80 l’Episcopato italiano era stato uno dei pochi a non intervenire nel dibattito sulla pace, elabora nel 1995 il “Catechismo degli adulti della CEI”. In questo testo, all'interno del capitolo 26 "Accoglienza e rispetto della vita" viene affrontato il tema della violenza e della guerra. Al n. 1037 si afferma: "Si dovrebbe togliere ai singoli stati il diritto di farsi giustizia da soli con la forza, come è già stato tolto ai privati cittadini e alle comunità intermedie". E al punto 1038 si aggiunge: "Appare pertanto urgente promuovere nell'opinione pubblica il ricorso a forme di difesa non violenta. Ugualmente meritano sostegno le proposte tendenti a cambiare struttura e formazione dell'esercito per assimilarlo a un corpo di polizia internazionale". Più avanti, al punto 1040 si dice: "In questo contesto risalta il significato educativo che può avere la scelta degli obiettori di coscienza di testimoniare il valore della non violenza sostituendo il servizio civile a quello militare, senza peraltro recare pregiudizio al valore e alla dignità del servizio dei militari quando operano come servitori della sicurezza e della libertà dei popoli". Merita ancora la citazione di quello che è stato considerato il più grande teologo morale del XX° secolo, Bernhard Häring. Sul finire della proprio vita, Häring sente l’esigenza di concentrarsi su ciò che è veramente importante e urgente. In un testo del 1998 egli scrive: “Oggi la morale deve essere concentrata sui problemi della pace e della nonviolenza. Per noi teologi morali è prioritario l'obbligo di lavorare per salvare il seme dell'uomo sulla Terra”. “Nei manuali tradizionali solitamente ci si limitava a trattare del diritto esclusivo dello Stato di dichiarare la guerra e a illustrare le condizioni di una «guerra giusta». Questa opera è un segno evidente che la missione dei cristiani a servizio della pace, della nonviolenza e della riconciliazione sta al centro della vocazione cristiana. E non solo questo. Il cammino sulla via della pace e della nonviolenza richiede il dialogo e la cooperazione fra tutte le religioni del mondo. L’invito di Papa Giovanni Paolo II alla preghiera comune con i rappresentanti di tutte le religioni rimane ancora una sfida per tutto il mondo”. “Il legame tra i peccati contro la pace, quelli contro la nonviolenza e quelli contro l’equilibro ecologico mette in gioco - solo un cieco non potrebbe vederlo - la sopravvivenza del genere umano sul nostro pianeta. Si tratta ormai di «salvare il seme dell’uomo sulla terra”. “Ci si domanda anche perché così pochi cristiani s’impegnano a fondo nei movimenti per la nonviolenza. Nei nostri paesi si trovano specialisti competenti per ogni problema sociale, economico, etc. Ma perché non li troviamo quando si tratta della missione per la pace e per la giustizia che guarisce, per la nonviolenza attiva e creativa? Perché il nostro grido angosciato tocca così pochi cuori tra i credenti?”. E Gianni Zaccherini, poco prima di morire, scriveva: “La Chiesa è il grande porto di pace per tutti gli uomini: non può guardare indietro, non può regredire ad una fase superata della storia della salvezza. Facciano pure gli uomini le guerre, ma in queste guerre i cristiani non possono più avere una parte attiva. Le guerre i cristiani possono ormai solo subirle e dare in esse la vita, vittime miti e innocenti della violenza demoniaca. Questa è la grande testimonianza della Chiesa e dei cristiani: la pace, sempre la pace, la pace ovunque. Solo così il suo annuncio della verità può diventare credibile, in questo tempo finale che è l’ultimo giorno della storia del mondo, offerto dalla pazienza di Dio alla conversione di tutte le genti”. CONCLUSIONE Se dobbiamo dire che la stagione della teologia della guerra giusta, avviata alla conclusione dalla Pacem in Terris e dal Concilio, non è ancora purtroppo completamente tramontata, pur tuttavia una nuova stagione si è aperta. Gli incontri delle religioni per la pace di Assisi 1986 e 2002, voluti da Giovanni Paolo II, e i suoi pronunciamenti netti contro le guerre degli anni ’90 (Golfo, Kossovo, Afghanistan) e più recenti (Iraq nel 2003), in contrasto coi poteri politici predominanti nel mondo, sono segni importanti di tale cambiamento di prospettiva nella Chiesa, anche se gli episcopati e i credenti sono ancora arretrati su tali temi. Ma la massiccia presenza dei cristiani nei movimenti antiglobalizzazione, per la pace e la giustizia economica, in Italia soprattutto rappresentati nella Rete di Lilliput, aprono ad una grande speranza. *Luciano Benini, (per contatti: [email protected]), membro del MIR (Movimento Internazionale della Riconciliazione) e del Movimento Nonviolento sin dagli anni '70, segretario nazionale del MIR negli anni '80, è stato Presidente Nazionale del MIR alla fine degli anni '90. Fisico sanitario ed ambientale, è stato attivo nelle lotte antinucleari a partire dagli anni '70, coordinatore nazionale della campagna per l'opposizione dei missili a Comiso e della campagna nazionale per l'obiezione alle spese militari. Nel 1986 ha curato l'opuscolo "Consumi e nuovo modello di sviluppo". Ha ideato e promosso a Fano la "Scuola di pace". Dal 1994 ha il ministero di Lettore nella Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola. Piccola Bibliografia PRIMO MAZZOLARI, Tu non uccidere, Edizioni La Locusta, Vicenza 1955. LORENZO MILANI, L’obbedienza non è più una virtù, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1976. A. CAVAGNA E G MATTAI (A CURA DI), Il disarmo e la pace, EDB, Bologna 1982. AA.VV, La pace dono e profezia, Edizioni Qiquajon, Magnano (BI). AA.VV., La pace nella Bibbia, Supplemento al n. 50 di Sussidi Biblici, Edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia, 1995. AA.VV., Al di là del non uccidere, CENS, Liscate (MI) 1989. VALENTINO SALVOLDI (A CURA DI), Mai più la guerra, Edizioni La Meridiana, Molfetta (BA) 1998. VALENTINO SALVOLDI, Beati i costruttori di pace, Edizioni Paoline, Milano 1994. AA.VV., Incontro ecumenico europeo per la giustizia, la pace, la salvaguardia del creato, Centro interconfessionale per la pace, Roma 1998. RENZO PETRAGLIO, Obiezione di coscienza, EDB, Bologna 1984. JEAN E HILDEGARDE GOSS-MAYR, La nonviolenza evangelica, Edizioni La Meridiana, Molfetta (BA) 1991. JEAN E HILDEGARDE GOSS-MAYR, Come i nemici diventano amici, EMI, Bologna 1997. ANGELO CAVAGNA (A CURA DI), Cultura della pace, Stampato in proprio, Prato 1996. RINALDO FABRIS, La nonviolenza nella Bibbia, Quaderni Caritas n. 4, Udine 1997. LEONARDO BASILISSI, I cristiani e la pace, Edizioni del Movimento Nonviolento, Perugia 1985. GIUSEPPE SOCCI, Chiesa della pace o chiesa delle stellette, Edizioni Qualevita, Torre dei Nolfi (AQ) 1986. MASSIMO TOSCHI, Pace e Vangelo. La tradizione cristiana di fronte al problema della guerra, Queriniana, Brescia 1980. SUSSIDIO ALL’INCONTRO Sabato 17 gennaio 2004 ore 17:00 Scenari internazionali dopo la caduta del muro di Berlino, fra guerre preventive e terrorismi: una lettura nonviolenta. Raniero La Valle LA STRATEGIA DELLA SICUREZZA NAZIONALE DEGLI STATI UNITI D’AMERICA di Raniero La Valle* Il documento sulla “Strategia della sicurezza nazionale degli Stati Uniti”, varato in America nel settembre 2002, presenta caratteri di straordinaria novità. Esso infatti enuncia politiche e dottrine che mai erano state formulate prima: per es. la teoria della guerra preventiva; l’assunto che “la migliore difesa è una buona offesa”, la proposizione di un unico modello di regime politico-economico-sociale per tutto il mondo; l’affermazione, come di un fatto irreversibile, e dunque come una realtà da valere in via di principio, della superiorità americana su ogni altra presente o futura potenza; l’affermazione sorprendente che il nostro tempo sarebbe il migliore da tre o quattro secoli a questa parte, cioè dalla formazione dello Stato moderno, e molte altre cose che dobbiamo appunto discutere in questa scuola. Ma c’è un’altra novità, ancora più importante, nel documento e consiste nel fatto che esso, in certo modo, consacra una discontinuità storica, nel senso che segna la novità del tempo dopo l’11 settembre. L’11 settembre si disse che nulla sarebbe stato come prima. In realtà tutto è rimasto come prima: si continua a volare, si continuano a costruire grattacieli di 400 metri e addirittura ponti sullo Stretto, si continua a far morire di fame, di malattie e di miseria mezzo mondo; i capitali continuano a girare da un computer all’altro da una parte all’altra del pianeta; tutto ciò che in qualche modo caratterizzava la realtà del mondo moderno, della globalizzazione, continua tale e quale. Il terrorismo non è riuscito a cambiare nulla di tutto questo. Altro è ciò che è cambiato: è cambiata la situazione geopolitica mondiale; è cambiata la figura dell’America ed il suo modo di pensare il mondo; e quello che è cambiato, come trapasso da un tempo ad un altro, è tutto scritto in questo documento, che stranamente non ha una data precisa, perché il 17 settembre 2002 è stato trasmesso dalla Casa Bianca al Congresso ed il 20 settembre è stato pubblicato sui giornali, ma la sua data non è una vera data ma piuttosto un anniversario, il primo anniversario dell’11 settembre 2001. Possiamo dire che questo è il documento di quell’anniversario e quella è la soglia del cambiamento. Si tratta dunque di prendere molto sul serio l’evento dell’11 settembre. L’11 settembre come spartiacque Lasciamo stare qui chi lo ha fatto, chi c’era dietro i kamikaze, se i Servizi Segreti lo sapevano o meno, il mistero dell’aereo che non si è mai schiantato sul Pentagono, il quale è stato attaccato in un altro modo; tutte queste cose fanno parte del “non detto” e non le possiamo sapere perché negli Stati Uniti sono state bloccate o scoraggiate tutte le inchieste indipendenti su quanto è avvenuto quel giorno. Ciò che più conta dell’11 settembre, al di là del fatto in sé, è la storia degli effetti: l’evento dell’11 settembre ha avuto un effetto sconvolgente e prima di tutto sugli americani stessi; lo choc è stato tremendo ed è stato enormemente amplificato dai media. Gli Stati Uniti, che si credevano invulnerabili, hanno sperimentato la loro vulnerabilità, la stessa idea fantasmagorica dello “scudo spaziale” che avrebbe dovuto assicurare l’ultima e definitiva sicurezza all’America è caduta nel ridicolo; e ciò che più ha traumatizzato gli americani è stata la sensazione forte di aver perduto la loro innocenza: erano convinti di essere amati da tutti, di essere benvoluti, di rappresentare i benefattori dell’umanità, al punto che durante la guerra del Vietnam il Card. Spellmann, arcivescovo di New York, andava lì a parlare dell’America come del “buon samaritano delle nazioni”; era questa l’immagine che l’America aveva di sé. Improvvisamente ci si trova di fronte ad un evento così coinvolgente per tutti e ci si accorge che “qualcuno ci odia, qualcuno non ci ama”; hanno iniziato alcuni vescovi a scrivere lettere, uno dei primi è stato mons. Robert Bowman, vescovo di Melbourne Beach, in Florida, che poneva la domanda: “perché gli americani non sono amati?” e tentava le prime risposte: “perché nella maggior parte del mondo, il nostro governo difende la dittatura, la schiavitù e lo sfruttamento umano. Siamo bersaglio dei terroristi perché siamo odiati. E siamo odiati perché il nostro governo ha fatto cose odiose” Gli Americani questo non se lo immaginavano e quindi l’11 settembre rappresenta questa grande rivelazione: l’America può non essere amata. Lo choc è stato tremendo, e a ciò si è aggiunta l’idea che il male si poteva abbattere di nuovo sull’America, idea suffragata da una martellante predicazione sugli attentati terroristici che si sarebbero potuti ripetere ogni giorno in tutte le forme, in tutti i modi e in tutti i luoghi. Per capire questa situazione, mi domando: “quale paragone si può fare storicamente? Quale altro trauma nella storia degli effetti ha avuto un impatto che si può, in qualche modo per analogia, paragonare a questo?”. Penso che il paragone che si possa fare, con tutte le debite proporzioni e stabilite le cautele per la diversità delle due fattispecie, sia con il cambiamento che nel sionismo ha prodotto la Shoah Prima e dopo la Shoah Fino alla Shoah la componente fondamentale dell’ebraismo, di cui abbiamo parlato in questa sede varie volte, che è il messianismo, che aveva il suo grande punto di forza nella speranza del ritorno a Sion, non era vissuta in modo tale da produrre politicamente il risultato del ritorno a Gerusalemme. Anzi il messianismo ebraico, che pure continuamente enunciava questo desiderio e questa speranza del ritorno a Sion visto come redenzione, era legato ad una passività politica, che per secoli gli ebrei hanno vissuto nella diaspora. Ciò non è stato un fatto fortuito ma aveva una ragione. Chi ha analizzato e cercato di chiarire questa situazione, come abbiamo visto altre volte, è stato Gershom Scholem, studioso del messianismo sabatiano e della Kabala, il quale afferma che la ragione sta nel fatto che il messianismo, col ritorno a Sion, è legato ad un’idea di catastrofe (il messianismo secondo Scholem è una “teoria della catastrofe”); è chiaro allora che se questa speranza, questo ideale deve realizzarsi attraverso una catastrofe, è meglio che non se ne affretti il compimento Deriva di qui un’idea della passività ebraica; non si doveva affrettare questo evento redentivo e perciò il potere non era cercato come obiettivo storico; questo faceva dire allo stesso Scholem che il prezzo del messianismo, di “questo dono che il popolo ebraico ha fatto al mondo”, è stato quello di un rinvio, di una vita vissuta nel differimento, qualcosa che si attende ma che non arriva, e quindi sostanzialmente una vita vissuta nell’irrealtà. L’avvento del Messia era troppo pericoloso e perciò non andava affrettato; come dicono nel Talmud tre maestri talmudici del III° e IV° sec.: “Che Egli venga, ma io non voglio vederlo”. Un attivismo messianico che miri ad affrettare la realizzazione dell’idea messianica non farebbe, com’è avvenuto ogni volta che lo si è fatto nel passato, che “spalancare abissi”, come dice Scholem, e “precipitare nell’assurdo”. Ed è per questo che, ancora secondo Scholem, “alla grandezza ed alla forza dell’idea messianica corrisponde l’infinita debolezza della storia giudaica”. Per secoli i rabbini hanno difeso questa debolezza. Come dice il rabbino americano Arthur Hertzberg, che insegna alla New York University in un articolo del 1996, “la principale spinta del giudaismo rabbinico nel Talmud e dopo di esso, è stata nella direzione di una passività politica”. “Il Talmud proibiva di cercare di fare congetture sulla data in cui il Messia avrebbe potuto apparire; decretava che qualsiasi azione volta a forzare la sua venuta era una ribellione alla volontà divina”. La cosa non cambia all’apparire del sionismo moderno, negli anni 1830. “Quando Theodor Herzl apparve verso la fine degli anni 1890 - continua il rabbino Hertzberg - la maggioranza dei “fondamentalisti” rimase contraria al Sionismo … In nome della religiosità essi sostenevano la dottrina della passività politica”. Questa linea subisce un drammatico rovesciamento con la Shoah. Questo rovesciamento trovò una fortissima, icastica espressione nella frase di Menachem Begin, il futuro primo Ministro di Israele, che, dice Herzberg, evocando “con insistenza ossessiva la memoria dell’Olocausto”, gridava: “Mai più, mai più gli ebrei saranno deboli e senza potere”. Il problema che era stato posto dalla modernità, dalla Shoà, era sì il problema della fede, “ma la questione veramente cruciale è stato il problema della mancanza di potere”. Il potere dunque va ristabilito, e il potere si concretizza nello Stato di Israele. Ed è questo che segna il carattere indelebile di questo Stato; per difendere questo potere, considerato come la condizione della sicurezza, lo Stato di Israele si rende capace di qualunque cosa e non si tira indietro da nessuna cosa. Per converso, la contrarietà allo Stato di Israele ed alla sua politica diventa il nuovo nome dell’antisemitismo. In un seminario del 1989, pubblicato ora in una raccolta di saggi edita da Tropea, Noam Chomsky ha raccontato che durante la campagna elettorale di Bush padre risultò che uno dei comitati che lo sosteneva, col compito di cercare voti tra le minoranze etniche, era diretto da neonazisti dell’Europa orientale, in particolare ucraini “antisemiti fino all’isterismo”. Quando si seppe non ci fu nessuno scandalo e la cosa fu passata sotto silenzio anche dalle organizzazioni ebraiche a cominciare dalla Lega contro la diffamazione. Chomsky si domanda perché, e risponde che ciò di cui queste organizzazioni in definitiva si preoccupano non è l’antisemitismo; “ciò che soprattutto le preoccupa è l’opposizione allo Stato di Israele, anzi alla idea che loro hanno della politica di Israele”; queste organizzazioni ebraiche ”avevano capito che i nazisti implicati nella campagna elettorale di Bush erano in sostanza filoisraeliani, ed allora perché preoccuparsene?” Su un giornale a loro molto vicino, New Republic, scrissero che quei nazisti del Partito Repubblicano erano sì antisemiti, negatori dell’Olocausto, ecc., ma si trattava di “un antisemitismo antiquato ed anemico”. Il vero antisemitismo, semmai, era quello del Partito Democratico, nella cui Convenzione qualcuno voleva proporre una risoluzione per chiedere l’autodeterminazione dei palestinesi. Mi sembra un episodio illuminante per capire tante dinamiche di oggi. E’ per questa identificazione tra lo Stato di Israele e la salvezza stessa, intesa ormai come salvezza dalla Shoah, che un intellettuale ebreo come Jacob Taubes arriva a dire, in un discorso a Gerusalemme del 1981, che l’istanza messianica evocata dalla Shoah aveva “permesso che una sfrenata fantasia apocalittica prendesse il controllo della realtà politica dello Stato di Israele”, rischiando di trasformare “il ‘paese della redenzione’ in una fiammeggiante apocalisse” (in Scholem, “Il prezzo del messianismo”, pag. 44). Il potere dopo l’11 settembre Fatte le debite proporzioni, l’11 settembre ha prodotto nell’immaginario americano un trauma in qualche modo paragonabile, e questo trauma è stato assunto come spartiacque, come causa di tutte le politiche successive. Certo, anche prima dell’11 settembre non c’era alcuna “passività politica” degli Stati Uniti - sono note le politiche di intervento fatte in tutti modi ed in particolare attraverso la CIA in ogni parte del mondo - ma è pur vero che nella continuità della tradizione americana storicamente è stata sempre presente una tendenza isolazionista, che affiorava anche nell’atteggiamento del giovane Bush al suo ingresso alla Casa Bianca, di un Bush che non voleva occuparsi dei problemi mondiali e della Palestina - aveva sbagliato Clinton a prendersela tanto -, di un Bush che l’11 settembre ha colto in mansioni casalinghe, mentre spiegava in una scuola elementare come si insegna l’inglese ai bambini. Dopo l’11 settembre il grido di Begin è diventato quello di Bush, “mai più, mai più gli americani deboli e senza potere”. Solo che per gli americani il potere non è il potere di un piccolo Stato gettato in Medio Oriente, è il potere di un sovrano universale. Questa, a mio parere, è la premessa, la chiave di lettura per capire il documento sulla nuova strategia della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che sono vissuti in realtà come il vero, nuovo Israele. Ieri sera c’è stata una sgradevolissima discussione alla televisione, sulla “7”, tra Gad Lerner ed Asor Rosa. Lerner ha accusato i critici dello Stato di Israele di demonizzare Israele assimilandolo agli Stati Uniti; in realtà è avvenuto il contrario: sono gli Stati Uniti che dopo l’11 settembre hanno preso a modello la politica dello Stato di Israele, di cui hanno fatto, per così dire, la gigantografia. Questo per la verità è accaduto anche prima in altri Paesi; ricordo un episodio: quando sequestrarono Moro ed in modo inopinato scattò in Italia la politica della fermezza, della intransigenza, di fronte a questa inaspettata spietatezza, che aveva come effetto la morte di Moro, ricordo un commento di Dossetti che disse: “ma questo è Israele, non è l’Italia”. Il manifesto della Nuova Destra Dunque, che documento è questo? In una riunione di un gruppo di persone vicine a Vasti dove si è deciso di mettere questo documento a tema dei nostri seminari, si è detto che esso è importante perché è un testo di teoria politica in cui si intrecciano tre piani: potere politico, potere economico e potere militare. Esprime dunque una totalità; e in questa totalità esso può essere visto come il manifesto della Nuova Destra, non solo americana, ma mondiale. E la sua novità starebbe non tanto nella dottrina militare, quanto nel fatto che questa Nuova Destra, che qui Bush interpreta, proclama e fonda un liberismo armato. Detto che il documento rappresenta il manifesto della Nuova Destra a livello mondiale, è importante però che lo si analizzi per ciò che riguarda specificamente l’America, perché c’è qualcosa di più di un liberismo armato: il liberismo è di tutti, ma le armi sono le sue. Questo che appare nel documento non è un progetto politico-militare di un soggetto plurale, così come era ancora la NATO quando il 24 aprile del 1999, a Washington, proclamava la sua nuova identità, la sua nuova natura, e si definiva come il nuovo sovrano collettivo che andava al di là dell’art. 5 del Trattato, che non si occupava più solo della difesa ma andava a portare l’ordine e la sicurezza in tutto il mondo; quello era ancora il documento di un soggetto plurale, dove erano rappresentati molti contraenti, 19 Stati, 19 Capi di Governo. Questo, invece è l’editto di un solo, di un unico soggetto e perciò si può considerare come il manifesto dell’Impero. Vediamo allora di approfondirne la natura, e cominciamo col definirlo. Un documento ideologico Si tratta di un documento ideologico nel senso che è una filosofia della politica e nello stesso tempo è un testo militante. E’ una dottrina politica, perché dice qual è il bene supremo della comunità politica, quali i presupposti di teoria e di storia su cui viene fondato e quali le vie per la sua realizzazione. Ma è anche un testo militante, perché definisce i mezzi politici, militari ed economici per assicurare quel bene politico ai fedeli di quella dottrina, ai seguaci di tale ideologia. In questo senso è un testo fondativo, perché contiene una teoria del potere e della guerra nel XXI° secolo, e nello stesso tempo è immediatamente esecutivo nel senso che chi pone questa teoria ha il potere (o crede di avere il potere) per realizzarla, e perciò ritiene, con quella “presunzione infinita” che il Vaticano gli rimprovera (Marco Politi, Wojtyla tra la guerra e l’America, La Repubblica, 13.01.2003), che basti decidere ciò che è voluto perché questo accada, non dipendendo da altri che da lui stesso. Il soggetto che formula questa dottrina è, infatti, una Potenza, anzi la sola Potenza nel senso politico e militare del termine, è una potenza cui manca solo la decisione per tradursi in atto. A lei la storia è interamente disponibile, indipendentemente dalla volontà degli altri, gli altri essendo concepiti come cooperanti e partecipi all’impresa o come ostacoli che saranno rimossi. Dobbiamo documentare queste affermazioni. Anzitutto che si tratta di un testo ideologico: ciò è mostrato fin dal suo incipit, fin dalla formulazione iniziale secondo cui l’unico modello valido per ogni nazione è riassumibile in tre termini libertà, democrazia e libera impresa; dunque è un’idea della convivenza che abbraccia tre mondi diversi, mettendo insieme una definizione antropologica, una indicazione di regime politico ed una forma obbligatoria di organizzazione economico-sociale, e questo composto è dichiarato come normativo per tutti. Dunque non ci sono tanti possibili regimi politici, economici e sociali, corrispondenti eventualmente a diverse teorie. Ce n’è uno solo che comporta un modello umano, quello dell’individualismo liberale, un modello politico, quello della democrazia occidentale, ed un modello economico, quello del capitalismo d’impresa. Altri modelli non sono ammessi e compito degli Stati Uniti è di diffondere questo modello in tutto il mondo. Gli Stati che non sono conformi a questo modello sono provvisoriamente accettati nella misura in cui tendano a realizzarlo, ed è per questo che la Russia viene considerata sulla buona strada e la Cina è sotto esame. Una ideologia della sicurezza nazionale In secondo luogo si tratta di una ideologia che estrapola dai beni da conseguire il bene che considera prevalente e lo assolutizza. Questo bene, dopo l’11 settembre, come dice il titolo stesso del documento, è la sicurezza nazionale. Si tratta perciò di una ideologia della sicurezza nazionale. In questo senso non è nuova: una ideologia della sicurezza nazionale fu quella su cui furono fondati i regimi militari ed autoritari dell’America Latina negli anni culminanti della guerra fredda. Ma a differenza di quella, che si ispirava piuttosto al caudillismo europeo, questa sicurezza nazionale si innesta sulla ideologia dell’ “American heritage” e dell’ “American way of life” e ne rappresenta lo sviluppo: la sicurezza consiste nell’affermare quel retaggio americano e nel preservare quel modo di vita. In terzo luogo è una ideologia che immediatamente dichiara i mezzi della sua esecuzione, organizzati in modo sistemico: si tratta infatti, come titola il documento, di una strategia della sicurezza nazionale. In quarto luogo si tratta di una ideologia della sicurezza nazionale che per definizione non è universale, non riguarda tutte le nazioni, non può servire da modello a nessun’altra nazione, anzi è dichiaratamente alternativa alla sicurezza delle altre nazioni al punto da assumere la guerra preventiva come suo ingrediente essenziale; è, come titola il documento, la strategia della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. In questo senso essa è sovversiva rispetto all’ideologia della Nazioni Unite. Essa segna un rovesciamento rispetto al principio fondatore che gli stessi Stati Uniti, di Roosevelt e di Truman, vollero fosse posto a base della costituzione dell’ONU, e che era il principio della indissolubilità tra pace e sicurezza, e della indivisibilità della pace e della sicurezza per tutte le nazioni. Il principio che sta alla base dell’ONU afferma che la pace c’è per tutti o non c’è per nessuno. Ora tutto questo non nasce all’improvviso; ha una lunga incubazione nella storia del nazionalismo americano, che ha pervaso ambedue i partiti, il repubblicano ed il democratico (vedi “Alle radici del nazionalismo americano” in Le Monde Diplomatique, ottobre 2002). Tuttavia l’11 settembre rappresenta il detonatore di questa esplosione del nazionalismo americano. Il rimedio a quel trauma è “mai più l’America debole e senza potere”. Ma il potere qui non vuol dire il potere su una piccola terra del Medio Oriente, considerata come eredità biblica, ma vuol dire il potere sul mondo, di cui, peraltro, non esiste alcuna Scrittura che ne assegni l’eredità all’America. Il principio è che la sicurezza dell’America è il potere sul mondo. E Dio non sta dall’altra parte; come ha detto Bush parlando tre giorni dopo l’11 settembre nella National Cathedral di Washington: ” abbiamo la garanzia che nulla potrà separarci dall’amore di Dio”. Dunque la sicurezza nazionale, che per l’America Latina era la sicurezza interna contro i comunisti, per Israele è uno Stato Ebraico come strumento di salvezza contro i nuovi Gentili che sono i palestinesi e gli arabi in generale, per l’America è l’Impero che estirpi il male, cioè tutto ciò che può minacciare gli Stati Uniti dentro e fuori i loro confini, prima che questo male abbia la possibilità di nuocere. Se l’esito di questa sicurezza cercata dagli americani nell’Impero planetario dovesse essere analogo all’esito della sicurezza cercata dallo Stato di Israele con la colonizzazione dei territori occupati, la catastrofe, per l’America e per il mondo, sarebbe di dimensioni inaudite. La fondazione di un Impero In che modo, nel documento che stiamo studiando, l’ideologia della sicurezza nazionale americana diventa Impero? A questo punto dobbiamo metterci d’accordo sulle parole; so bene che non è di buona creanza parlare di Impero, è difficile usare questa parola perché siamo abituati a pensare, da cinquant’anni, che l’età degli Imperi sia finita, si sia chiusa nel ’45 quando si è deciso di passare dall’ordine degli Stati sovrani, con le loro colonie e i loro dominii, all’ordine delle Nazioni Unite. Con la fine della guerra si è deciso di porre fine all’età degli Imperi. E’ questa in sostanza la decisione del ’45, tanto è vero che prima è finito l’Impero britannico, poi quello francese, poi quello portoghese e quello belga. Parlare quindi oggi di Impero significa parlare di qualcosa che non appartiene alla tradizione ed alla cultura del cinquantennio che abbiamo alle spalle, anche se ci sono stati degli imperialismi, si è parlato di un imperialismo americano o sovietico, di un imperialismo della globalizzazione: ma imperialismo era usato qui in senso figurato, per denunciare politiche di poteri o istituzioni che non erano imperi eppure dominavano (è il senso in cui ne parla Toni Negri). Al contrario oggi si può parlare di Impero come struttura politica formale, come categoria politica esplicitamente rivendicata, anche se non ancora con l’uso ufficiale della parola (che però usa il portavoce europeo Solana, quando dice che “il mondo ha bisogno di una leadership americana ma non di un Impero americano). Che dunque si abbia a che fare con un Impero è qualcosa che dobbiamo percepire, di cui dobbiamo renderci conto prima ancora che riceva tutti i riconoscimenti formali. E qui abbiamo una spia che ci fa capire in che senso si possa effettivamente parlare di Impero; e la possiamo trovare in quel punto del documento in cui si dice: “gli Stati Uniti godono di una potenza militare senza eguali e di una grande influenza economica e politica”. Questa è la premessa da cui tutto il resto discende. Gli Stati Uniti, si afferma, sono una potenza unica, una unicità che dipende dalla loro potenza e dalla loro missione. Ma questa unicità, questo primato militare assoluto dovrà essere mantenuto per sempre; questa unicità ormai è definitiva, deve essere definitiva; il documento dice infatti: “ le nostre Forze (armate) saranno abbastanza forti per dissuadere potenziali avversari dal perseguire un potenziamento militare nella speranza di sorpassare od eguagliare il potere degli Stati Uniti”; questo potere deve quindi durare per sempre. Nessuno potrà mai pensare non solo di poter superare, ma nemmeno eguagliare il potere americano. E quindi anche la politica degli equilibri, che in qualche modo viene rimpianta ed era presentata come uno strumento possibile di ordine del mondo per il futuro, viene rinnegata: deve esserci una sola potenza, ed essa deve essere superiore alle altre. Mai più quindi una potenza come l’URSS, ma anche mai una potenza come la Cina; nessuno, e dunque neppure l’Europa, può tentare di eguagliare gli Stati Uniti. E’ qui che, abbandonando ogni remora ed ogni cautela formale del linguaggio politicamente corretto, gli Stati Uniti dichiarano la volontà di costituire un grande Impero mondiale. E questa spia trova una contro-prova in un avanzamento della teoria della sovranità. Che cos’era la sovranità? La sovranità viene formalizzata, cioè tradotta in una formula destinata a diventare classica, alla fine del ’200 da Marino da Caramanico in una glossa al Liber Constitutionum di Federico II. Essa dice: “ rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator”, cioè “il re che non riconosce nessuno al di sopra di sé è l’imperatore”; è da questa formula che nasce il concetto di sovranità (dal termine superior-superiore, viene sovrano, souverain, sovranità; questa è la storia della parola ed anche della cosa). Sovranità significa quindi non riconoscere nessuno superiore a sé: chiunque non riconosce nessuno superiore a sé è per ciò stesso imperatore. Ma se di sovrani e di Imperi ce n’è più d’uno, è chiaro che mentre l’Imperatore non ha alcuno al di sopra di sé, può avere altri eguali a sé, come appunto avviene nella comunità internazionale; che è poi la ragione per cui il conflitto tra loro non aveva altra soluzione che la guerra. Ma qui scatta la novità, qui c’è l’avanzamento; esso sta nel fatto che qui il sovrano, diventato sovrano universale, non solo non riconosce nessuno come superiore a sé, ma neanche come eguale a sé; perciò di Imperi non ce ne sono molti, ce n’è uno solo, uno per il mondo intero. Questo è ciò che fa del sovrano dopo l’11 settembre un Imperator (o almeno lo dichiara ed esplicita come tale), e per questo, formalmente quello che si vara è un Impero, un Impero che non ha né superiori né eguali. Questo Impero ha tuttavia una missione; pertanto, dice il documento, gli Stati Uniti non useranno la loro forza per procacciarsi un “vantaggio unilaterale”. C’è infatti una missione che gli Stati Uniti devono compiere per il mondo. La guerra preventiva Come sappiamo, e come ci ha ricordato Alessandro Portelli in questa sede, c’è un messianismo americano. Suo strumento, almeno in questa fase nascente dell’Impero, è la guerra, anzi la guerra preventiva. Tutte le teorie sulla guerra si basavano, bene o male, sul fatto di considerare comunque la guerra una risposta, giusta o ingiusta che fosse, lecita o illecita, ragionevole o sbagliata, a qualche cosa che era accaduto; secondo Francisco De Vitoria la guerra era “il diritto del sovrano di vendicare sè ed i suoi e di perseguire le ingiurie” (“ius vindicandi se et suos et persequendi iniurias”). La guerra era quindi una cosa seconda, non prima: c’era un’ingiuria, una violazione dei diritti, un torto subito, ecc., ed il sovrano rispondeva facendosi giustizia con la guerra . Ora invece, così come è teorizzata nel documento, la guerra precede qualsiasi motivazione e ragione, essa è prima che i fatti avvengano, è il distruggere gli altri prima che possano distruggere, uccidere prima che possano uccidere, abbattere i regimi disobbedienti prima che possano nuocere. In questa idea della guerra che precede, soccombe anche la vecchia formula della deterrenza, che ha retto l’equilibrio del mondo in tutto il periodo della guerra fredda. La deterrenza consisteva nel dissuadere altri dall’attaccare con la minaccia della ritorsione. Nel documento si dice che la deterrenza e la dissuasione non funzionano più; non si può usare la deterrenza al posto della guerra, bisogna usare direttamente la guerra perché la deterrenza, bene o male, suppone che l’altro sia uomo, sia ragionevole, pensi che in fondo sia un bene non morire tutti. La deterrenza, pur nella sua violenza - e tutti l’abbiamo combattuta negli anni della guerra fredda - con l’equilibrio del terrore era ancora una cosa umana, politica: materialmente non disarmava l’avversario, lo convinceva a non attaccare e quindi passava attraverso la sua decisione, che era pur sempre una decisione politica. Ora qui, invece, la sfiducia nel nemico e nell’avversario è talmente grande, il nemico è considerato talmente inumano che non si può contare su un residuo di sua razionalità, così che diventa assolutamente necessario strappargli di mano le armi prima che addirittura le possa avere. Il nemico è considerato talmente malvagio che fisicamente bisogna impedirgli di nuocere, bisogna ucciderlo. In fondo la guerra all’Iraq, a parte tutto il resto, è un regidio, perché la si fa per uccidere Saddam Hussein. Per questa ragione, l’unica prevenzione è attaccare prima; dice la nuova dottrina strategica americana, abbandonando anche un linguaggio “politicamente corretto”: “la migliore difesa è una buona offesa”. Naturalmente il primo esperimento, la prima missione secondo questa dottrina è la guerra contro l’Iraq, di cui abbiamo parlato e stiamo parlando. E questa guerra non è come le altre per tante ragioni, ma soprattutto perché è la prima vera guerra dell’Impero, nel senso che un Impero che voglia essere tale e che voglia estendere il controllo sul mondo di oggi, non può starsene chiuso nell’isola americana, ma deve andare lì, in Medio Oriente, deve andare alla confluenza dei due fiumi, dove passavano le rotte carovaniere che univano l’Europa, l’Africa e l’Asia, dove ci sono i pozzi di petrolio. Un’altra conseguenza di questo nuovo modo di pensare il mondo da parte degli Stati Uniti si fa luce nelle innumerevoli volte in cui nel documento si dice che se tutto quello che gli Stati Uniti vogliono fare lo potranno fare con gli altri – fare la guerra con gli altri, debellare i nemici in accordo con gli altri, con l’accordo degli alleati e della comunità internazionale -, lo faranno insieme agli altri, altrimenti agiranno da soli. C’è qui una rivendicazione della solitudine americana; la parola “soli” ricorre più volte, l’America ci penserà “da sola”, alone. Se non ci sarà l’accordo sul fatto che la migliore difesa è una buona offesa l’America agirà da sola. Ciò non riguarda solo l’Iraq, ma è una dottrina che vale “erga omnes”, in qualsiasi circostanza. E quando il documento cita le alleanze, le organizzazioni internazionali con le quali gli Stati Uniti intendono collaborare, cita l’ONU, l’Organizzazione Mondiale del Commercio, l’Organizzazione degli Stati Americani e la NATO, ma la NATO non è più al primo posto, è un’alleanza tra tante. E in un altro punto del documento si citano come distinti gli Stati Uniti e la comunità euro-atlantica. L’America come altro dall’Occidente Dunque la conseguenza è questa: gli Stati Uniti non sono più una potenza dell’Occidente, non sono più l’Occidente. Noi eravamo abituati fino ad oggi a parlare degli Stati Uniti e dell’Occidente come di una cosa sola, anzi a parlare degli Stati Uniti come dell’espressione stessa dell’Occidente. D’ora in poi non sarà più così: l’America si pone come altro dall’Occidente. Non sta più da una parte del mondo contro l’altra, ma sta sopra il mondo come sovrano universale di una geografia globale di cui lo stesso Occidente è solo una parte. Che cosa permette agli Stati Uniti di immaginarsi in questo modo, di passare dalla parte alla totalità? Ciò che permette questo è il nemico, la nuova figura del nemico; il nemico non sta più ad Est, così da doverglisi opporre come Ovest, il nemico è dappertutto ed è l’identità del nemico che fa la nuova identità dell’America. Il nemico è il terrorismo. Ma il terrorismo, di cui tutti parlano ma nessuno dice cos’è, è definito in questo documento della Casa Bianca nel modo più flessibile, proteiforme e maneggevole possibile, così da poter essere impiegato per tutti gli usi; Il terrorismo è “una violenza premeditata, motivata da ragioni politiche e perpetrata contro degli innocenti”. E’ chiaro che in questa definizione non c’è alcun criterio di identificazione del terrorismo che lo differenzi da altre violenze istituzionali o politiche: tutte le conquiste, a cominciare dalla conquista dell’America, tutte le lotte d’indipendenza, a cominciare da quella di Israele, tutte le lotte di liberazione, a cominciare da quella contro il nazifascismo, tutte le guerre sono state violenze esercitate per ragioni politiche contro degli innocenti, sia che per innocenti si intendano civili, sia che si intendano soldati costretti ad ubbidire. Ma se nella indeterminazione del terrorismo si deve poi estrapolare la determinazione del nemico, è chiaro che la vera operazione non è quella di identificare i terroristi come nemici, ma di definire i nemici come terroristi. Questo è il rovesciamento semantico: terroristi sono tutti quelli che gli Stati Uniti assumono come nemici. Questa dottrina porta ad una grande libertà di scelta del nemico, fornisce la giustificazione necessaria per combatterlo e fonda come insindacabile la guerra preventiva, poiché la legittimazione della guerra è lo stesso nemico ed il nemico è quello che assumo come tale. Di fronte a questo un personaggio che certo non è un neutralista di sinistra, ma è l’ambasciatore Sergio Romano, si domanda: “ma può l’Europa accettare questo, può l’Europa accettare che tutti i nemici degli Stati Uniti siano nemici anche nostri?”. No, è certo che non lo può accettare. Una visione apocalittica La visione riassuntiva che emerge da questo manifesto dell’Impero è una visione apocalittica, un’antropologia apocalittica. La divisione del mondo tra gli Stati Uniti e i loro nemici è una divisione irrimediabile, è la divisione tra il mondo della luce e il mondo del terrore, tra l’ordine e il caos; in questa visione il mondo della luce si deve salvare, il mondo del terrore deve essere distrutto. E’ la versione secolarizzata della visione apocalittica del IV libro di Esdra, della visione gnostica, della visione manichea. Ci sono due mondi, uno dei quali è sbagliato, contro cui l’altro mondo deve giungere - sotto la mia guida, dice Bush - alla vittoria. Al mondo che deve essere distrutto appartengono gli Stati cosiddetti “canaglia”. Anche qui non c’è una definizione precisa di questi Stati canaglia: a volte sono definiti così quelli che hanno o vogliono avere armi di distruzione di massa; ma allora Stati canaglia sarebbero anche gli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Francia, l’India, il Pakistan, la Russia, Israele e via proliferando. Altra volta sono quelli che hanno o vogliono acquisire “pericolose tecnologie”; ma allora non sarebbero Stati canaglia solo quelli che fossero rimasti all’età della pietra. Né altre accuse appaiono più precise; dunque per sapere chi sono gli Stati canaglia bisogna aspettare che siano proclamati; alcuni si conoscono già, sono Iraq, Iran, Corea del Nord, altri sono in pectore, saranno rivelati a suo tempo. In ogni caso quello che conta è che questi Stati, e comunque i loro ordinamenti, devono essere estirpati. E qui il termine usato ci fa capire tutto. Gli Stati canaglia nell’inglese del documento americano sono detti “rogue States”. In botanica rogue è l’erba cattiva, la zizzania; to rogue significa estirpare l’erba cattiva. Ma una visione salvifica del mondo che consiste nello sradicare l’erba cattiva è una visione apocalittica, è il rovesciamento della parabola del grano e della zizzania che devono vivere insieme; ritorna la prospettiva apocalittica precristiana di Giovanni Battista che diceva: “la falce è posta alla radice dell’albero”. Gesù dice invece: il regno di Dio è che la gramigna non sia tolta, che il male non sia estirpato prima della mietitura, cioè prima della fine del mondo. Farsi giudici tra il grano e la zizzania, pretendere di liberare il mondo dal male, come promette Bush, significa anticipare la fine, mettersi dentro un pensiero apocalittico. Questa visione apocalittica traspare anche laddove il documento di Bush sostiene che oggi l’umanità vive il suo momento migliore dal 1600, quando si formarono gli Stati moderni, perché per la prima volta tutte le grandi Potenze stanno dalla stessa parte e non si combattono tra loro. Cioè si sarebbe realizzata quella condizione per una Santa Alleanza che la diplomazia della restaurazione di Metternich perseguiva nel 1815, e che la diplomazia di Kissinger insegue fin dagli anni ’70. Il documento di Bush insiste nel dire che questo è un momento di magica opportunità, preannunzio di decenni di felicità e di benessere. Ma com’è possibile? E la fame? E la miseria? E la sete? E i 70 milioni di morti di AIDS nei prossimi vent’anni? E i bambini che muoiono a milioni o sono fatti schiavi? E la fine delle risorse energetiche, del petrolio, del carbone, del gas, la crisi ecologica, l’effetto serra, le acque che si innalzano sopra la terra, i ghiacciai dei Poli che si sciolgono? Dove sono questi drammi, queste crisi, nel migliore dei mondi possibili di cui parla Bush? Sono nell’altro mondo, nel mondo a perdere, nel mondo dei poveri e degli scartati, dei disarmati e dei senza diritti, dei kamikaze e dei terroristi, non nel mondo che si salva, che siamo noi. Per noi, un quinto dell’umanità, per il Nord del mondo, ci saranno abbastanza risorse e per abbastanza tempo, purché gli altri non ci importunino con le loro pretese di partecipare alla tavola della vita. Qui si rivela la scelta apocalittica: perché non è apocalittico l’annuncio della catastrofe, ma è apocalittico non fare nulla per impedirla, e pretendere di scaricarla tutta sugli altri, sul mondo a perdere. In effetti i Grandi hanno rinunziato a qualsiasi rimedio, e il mondo dei poveri è abbandonato a se stesso. La prova di ciò sta nella ricetta di Bush, che sta scritta, come l’unica valida, in questo documento: mentre il mondo va in pezzi, la sola ricetta è “free market, free trade”, libero mercato e libero commercio. Il mercato è dunque il grande selettore, è lui che decide quelli che vengono presi e quelli che vengono lasciati (e anche questo è apocalittico: quelli che non hanno impresso sulla mano o sulla fronte il nome della bestia o il numero del suo nome non possono “né comprare né vendere”). Alla base pertanto c’è una antropologia della selezione e della cooptazione. L’Occidente ha espresso una antropologia della perfezione, gli uomini hanno tutta la dignità e tutti i diritti. Ma non si è uomini per natura o per nascita, c’è da passare un esame, uomini nel senso pieno dell’umanesimo occidentale sono quelli che sono ammessi, che sono cooptati . Chi siano gli uomini che godono dei diritti è un dato convenzionale, politico; l’antropologia non è filosofica, religiosa, scientifica, è convenzionale, politica, selettiva. Ed è sulla base di questa antropologia che ora si è rotto il mondo, e che la parte maggiore dell’umanità è lasciata fuori. Ma ha un sapore apocalittico anche fare la guerra per gli ultimi pozzi di petrolio: mentre le riserve di petrolio si stanno esaurendo, i pozzi iracheni, che hanno le riserve maggiori (forse superiori a quelle dell’Arabia Saudita), saranno probabilmente gli ultimi che rimarranno in produzione. E gli Stati Uniti sono naturalmente quelli che per ultimi li vogliono usare. E apocalittica è stata anche la salita di Sharon, nel settembre 2000, sulla spianata del Tempio, il luogo dove i pii ebrei non dovevano salire fino all’ultimo giorno, il giorno dell’arrivo del Messia, il giorno della redenzione. Il giorno in cui, per reazione a quel gesto di Sharon, cominciò la seconda Intifada. La posizione da prendere nei confronti dell’Impero non è quindi solo un decidersi riguardo a questa nuova e antica forma politica di dominio che formalmente riappare nel mondo, ma vuol dire anche prendere posizione rispetto a questa “politica della fine”, che è propria di tale Impero. *Raniero La Valle, direttore scuola di Vasti, giornalista e già parlamentare, autore di “Dalla parte di Abele”; “Fuori dal campo”; “Marianella e i suoi fratelli”; “Pacem in terris. L'enciclica della liberazione”, “Prima che l'amore finisca”. SUSSIDIO AGLI INCONTRI Sabato 14 febbraio 2004 ore 17:00 Le alternative alla guerra: ONU riformata, Corpi civili di pace, Difesa nonviolenta. Alberto L’Abate Sabato 6 marzo 2004 ore 17:00 La nonviolenza: motivazioni ideali, esempi storici, testimoni, metodi e azione. Beppe Marasso Sabato 13 marzo 2004 ore 17:00 L’educazione alla pace e alla nonviolenza. Il conflitto e la sua risoluzione nonviolenta. L’obiezione di coscienza e il servizio civile. Angela Dogliotti Marasso MOVIMENTO CONTRO LA GUERRA O MOVIMENTO PER LA PACE? di Nanni Salio* La storia sembra ripetersi sempre la stessa: in prossimità di una guerra, annunciata o combattuta, si creano comitati e movimenti spontanei che cercano di opporsi a una macchina ben oliata, che funziona ventiquattr'ore su ventiquattro, alimentata da un trilione di euro all'anno, tre miliardi di euro al giorno. L'esito è praticamente scontato: tranne in rari casi, molto particolari, la macchina non si arresta. È quanto è successo, ancora una volta, con la guerra di aggressione degli Usa contro l'Iraq, nonostante la straordinaria opposizione di un imponente movimento contro la guerra, forse il più grande nell'intera storia umana. Per quali ragioni questo movimento non è stato in grado di impedire la guerra? In realtà, questa domanda potrebbe essere intesa in un senso più ampio. Non c'è solo la guerra contro l'Iraq, ma molte altre più o meno dimenticate o trascurate, che il movimento per la pace non è stato in grado, e non lo è tuttora, di impedire o di contrastare con sufficiente visibilità ed efficacia (Colombia, Congo, Sri Lanka, Israele-Palestina, Cecenia, e tante altre). Obiettivi generali Si può tentare di rispondere a questo angosciante interrogativo individuando gli obiettivi generali che un movimento per la pace dovrebbe proporsi di conseguire e le cause profonde che stanno alla base del fenomeno guerra. Gli obiettivi generali essenziali sono tre, tutti quanti di grande portata e relativi alla struttura del sistema socio-politico nel quale siamo inseriti: trasformare gli attori sociali violenti, trasformare le strutture violente, trasformare le culture violente. Oggi siamo in presenza di attori, strutture e culture violente in un circolo vizioso che si autoalimenta e che occorre spezzare. A ciascuna di queste tre componenti (attori, strutture, culture) corrisponde una o più forme di potere, inteso come dominazione. Gli attori sociali violenti dispongono del potere politico, le strutture violente sono create e mantenute dal potere economico e militare, le culture violente si manifestano attraverso il potere culturale (mediatico, religioso, della tecnoscienza, dell'immaginario artistico, dei miti, dei traumi e della narrazione storica). Una ipotesi di lavoro dalla quale partire è che a questi poteri dall'alto occorre contrapporre e/o sostituire il "potere dal basso" fondato sulla nonviolenza. Ma questo potere, che ha una dimensione sia personale, basata sulla "forza interiore", sia collettiva, dev'essere costruito pazientemente, non può essere improvvisato. Teorie e forme del potere Mentre le quattro forme principale di potere dall'alto (politico, economico, militare e culturale) sono alimentate costantemente, pianificate e sorrette giorno dopo giorno dal circolo vizioso attoristrutture-culture, nulla di tutto ciò esiste, se non in uno stato embrionale, per quanto riguarda il "potere dal basso". Basti pensare alle dottrine e politiche militari, sorrette da una gigantesca spesa militare, da un apparato burocratico costituito da decine di milioni di persone che operano a tempo pieno e da un consenso ampiamente generalizzato. Quante sono le persone che operano a tempo pieno nei movimenti per la pace, per esempio in Italia? A essere generosi si possono approssimare a poche centinaia, realisticamente ancor meno. Con quali risorse? Pressochè nulle. È pensabile che in questo modo si possano contrastare scelte e decisioni come quelle che hanno portato alla guerra contro l'Iraq? No di certo. Questo non significa che ci siano facili ricette che si possono costruire a tavolino, con risultati sicuri e immediati. Si può tuttavia pensare a un ragionevole insieme di politiche e di iniziative che, in modo sistemico e complesso, possano avviare un processo di inversione di tendenza che può portare nel corso degli anni a conseguire risultati apprezzabili. Un punto centrale che paradossalmente è stato largamente trascurato è la critica radicale agli attuali modelli di difesa e di sicurezza e, più in generale, la critica alle dottrine militari. Quello che si attiva normalmente su larga scala è più un movimento contro la guerra (una specifica guerra, uno specifico sistema d'armi, come quelle nucleari oppure le mine antiuomo) che un vero e proprio movimento per la pace. Molti di coloro che hanno manifestato contro la guerra di Bush all'Iraq erano al tempo stesso favorevoli a mantenere gli eserciti, senza minimamente essere consapevoli delle dinamiche e delle conseguenze che questa scelta comporta. È proprio questa ambiguità che impedisce di uscire dal circolo vizioso della guerra. Con il nostro assenso a una difesa militare, peraltro altamente aggressiva e offensiva, consentiamo che le elite che governano le grandi potenze proseguano indisturbate nella loro logica di dominio e nella sfrenata corsa agli armamenti, in corso da oltre mezzo secolo. E quando decidono di ignorare e stracciare anche quel poco di accordi e di diritto internazionale che faticosamente si è riusciti a costruire, ci ritroviamo totalmente impotenti. Ma non siamo innocenti: abbiamo consegnato il nostro potere nelle mani criminali di chi ci governa. L'alternativa alla difesa militare dev'essere pertanto chiara e netta, anche se nel breve periodo può comportare una fase di transizione, di transarmo, un piccolo compromesso che vedrà convivere elementi residuali di un modello di difesa difensiva, ma non offensiva, con il costruendo modello di difesa popolare nonviolenta. Ma al momento questa ipotesi progettuale non è stata esplicitamente recepita neppure dal movimento per la pace, che rischia di ripetere solo slogan retorici e inefficaci. Tecniche e metodi di lotta della nonviolenza politica Uno dei lavori di riferimento per chiunque voglia comprendere i fondamenti della nonviolenza politica, superando schemi riduttivi e di banale contrapposizione tra i fautori del realismo e i persuasi della nonviolenza, è quello di Gene Sharp, La politica dell'azione nonviolenta (tre volumi, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1986-1997). I punti salienti del lavoro di Sharp sono i seguenti: la nonviolenza politica si basa su una diversa teoria del potere, che ha avuto modo di dimostrare la sua efficacia nel corso della storia in svariati e numerosi casi, in ogni latitudine e sotto ogni tipo di governo, democratico e/o totalitario, compreso il nazifascismo; i casi di studio sono talmente significativi che soltanto una pigrizia intellettuale, un permanere di concezioni teoriche errate, una narrazione storica miope e un insieme di interessi contingenti e limitati hanno impedito sinora che le tecniche e i metodi della nonviolenza si diffondessero più di quanto è già avvenuto. Purtroppo, questa critica vale anche per il movimento per la pace, che sinora non ha saputo fare propria la cultura della disobbedienza civile, del ju-jitsu politico, della noncollaborazione, del boicottaggio e di quella molteplicità di tecniche (Sharp ne ha classificate ben 198, ma nei trent'anni trascorsi da quando ha pubblicato il suo lavoro se ne sono aggiunte altre) indispensabili per rendere efficace la lotta nonviolenta. La disobbedienza è "civile" e non "incivile" quando si accetta il prezzo da pagare, anzi quando si fa leva su questo prezzo per scardinare un sistema basato su leggi ingiuste. "Riempire le carceri" è sempre stata l'indicazione politica dei maestri della nonviolenza, da Gandhi a Mandela. Bloccare i treni che trasportano armi, non pagare le tasse che servono per finanziare la guerra e l'apparato bellico, non accettare leggi ingiuste come la Bossi-Fini sull'immigrazione, richiedono il coraggio e la determinazione della disobbedienza creativa, che può mettere in difficoltà estrema anche il potere apparentemente più forte e monolitico e farlo cadere come un fragile castello di carte. Ma la scansione delle azioni dev'essere organizzata, pianificata, gestita politicamente secondo tempi e modalità che permettano di continuare la resistenza e la disobbedienza su tempi lunghi. Gli esempi storici delle lotte guidate da Gandhi e da Martin Luther King sono emblematici a tale riguardo. Il movimento per la pace è stato capace sinora di agire solo sui primi livelli dell'azione, quelli della sensibilizzazione, delle manifestazioni di massa, ma non è riuscito a passare alla fase successiva della disobbedienza. Per far questo è necessario un impegno continuativo di formazione all'azione diretta nonviolenta, come è avvenuto nei casi migliori della storia dei movimenti (1). Solo così potremo sperare di avere gruppi di attivisti capaci, preparati e pronti a intervenire tempestivamente e coerentemente secondo le tecniche della nonviolenza. Tutto ciò non si improvvisa all'ultimo momento. Per raggiungere questi obiettivi, ambiziosi e impegnativi ma tutt'altro che irrealistici, il movimento deve affrontare anche due altri ordini di problemi interni: 1. la totale carenza delle strutture logistiche e organizzative, da consolidarsi mantenendo una rigorosa indipendenza rispetto alle forze politiche partitiche, pur nella ricerca di un costante dialogo aperto di confronto e di critica costruttiva; 2. democrazia interna, partecipazione, modalità decisionali consensuali, ruolo crescente della componente femminile, autogestione. Dal punto di vista organizzativo, la forma migliore è probabilmente quella di una struttura a rete, decentrata ma stabile, che consenta al tempo stesso di valorizzare la grande ricchezza delle diversità ("uniti e diversi") e di condurre un'azione politica incisiva e attiva (anzi pro-attiva), non soltanto spontaneista e reattiva, che superi le emergenze e duri nel tempo, capace di elaborare progetti, realizzare esperienze, produrre cultura della nonviolenza e trasformare man mano la realtà. Occorre radicarsi stabilmente nei luoghi, essere tenaci e determinati, progettuali e creativi. Moltissime esperienze in corso permettono già di intravedere che cosa intendiamo per società nonviolenta e quali sono le direzioni verso le quali dobbiamo procedere, ma non abbiamo ancora raggiunto una massa critica sufficiente per conseguire risultati più stabili e visibili. Paradossi e limiti della democrazia Ci sentiamo sovente dire che la nonviolenza è possibile ed efficace solo nei contesti democratici. Questo non solo non è vero, come dimostrano molteplici casi storici (resistenza civile al nazifascismo, caduta di regimi dittatoriali nelle Filippine nel 1986 e nell'Europa dell'Est nel 1989), ma siamo ormai in presenza di un evidente paradosso: è molto più difficile lottare dentro una democrazia che non contro un potere dittatoriale (2). Intendiamoci, è vero che nella democrazia ci sono spazi e margini di manovra che, in prima istanza, sembrano più facili da attivare. Ma i risultati sono spesso modesti, quando non addirittura nulli. Proteste su larghissima scala come quelle del 15 febbraio 2003 che hanno coinvolto decine di milioni di cittadini/e non hanno impedito che il potere politico si comportasse con la ben nota tecnica del "muro di gomma". Analogamente, per i principali problemi che abbiamo di fronte (dalla povertà di massa agli squilibri ambientali, dalla crescente disoccupazione e precarizzazione ai drammi dell'immigrazione) i poteri dominanti presenti nelle democrazie si comportano seguendo strategie ben note, che di fatto stanno svuotando la democrazia del suo più autentico significato. Un 20% della popolazione è in grado di conseguire un risultato elettorale vincente, contro un altro 20% che vi si oppone e un 60% per lo più indifferente, terreno di caccia per gli indispensabili margini di manovra. Come è stato brillantemente evidenziato da vari autori (3), le democrazie occidentali stanno diventando sempre più delle oligarchie, capaci di rendere inefficace la protesta e il dissenso, se questo si limita alle forme più tradizionali di azione e non sa compiere il passaggio verso la disobbedienza civile. La trappola è ben congegnata: se l'oppositore ricorre alla violenza, viene schiacciato e messo nell'angolo; se invece si limita alla protesta verbale, la sua azione risulta inconcludente. L'alternativa necessaria e possibile è la disobbedienza civile su larga scala, organizzata nella forma della resistenza, dell'obiezione e del boicottaggio. A tutto ciò occorre aggiungere la capacità di elaborazione di un programma costruttivo basato sul cambiamento delle strutture di potere militare, passando dalla difesa armata a quella nonviolenta, e delle strutture economiche trasformando l'attuale folle e distruttivo modello della crescita e dei consumi illimitati in un altro basato sulla scelta della semplicità volontaria e sulla riscoperta di stili di vita che ci permettano di vivere in maniera più ricca, intensa e armoniosa le nostre relazioni intra e inter-personali. Sono cambiamenti parzialmente già in corso, che bisogna sostenere, rendere visibili, tradurre anche in programmi politici. Una modesta proposta: una politica del 5% Quando si delineano scenari globali, si rischia di cadere in una sindrome di disperazione che è bene contrastare osservando che il bicchiere non è mai tutto pieno o tutto vuoto, ma di solito mezzo pieno e mezzo vuoto. Accanto alle denunce, è necessario vedere e far conoscere le molteplici esperienze positive in corso in ogni angolo del mondo. Stanno crescendo la quantità di persone, i movimenti, le iniziative, la cultura, la sensibilità di coloro che si rendono conto che un mutamento è possibile, oltre che necessario. Ci sono tutte le premesse e forse stiamo già assistendo agli "ultimi giorni dell'impero americano", come recita il titolo di un bel libro di Chalmers Johnson (Garzanti, Milano 2001, e ristampa aggiornata 2003). È una tesi condivisa da molti altri autorevoli studiosi, tra cui Immanuel Wallerstein (4), Johan Galtung (5), Emmanuel Todd. Perchè questa transizione avvenga, c'è bisogno che l'attuale struttura imploda e si dissolva, il meno violentemente possibile, come è implosa l'altra superpotenza, dopo la straordinaria stagione di lotte nonviolente del 1989. Non abbiamo bisogno di superpotenze, se non di quella disarmata e nonviolenta del movimento per la pace transnazionale. Un obiettivo minimo ma concreto di questo movimento può essere quello di una politica "del 5%": proporre alle forze politiche, nelle prossime tornate elettorali, la riduzione delle spese militari del 5% all'anno per tutta la legislatura, con l'utilizzo di queste risorse per la costruzione di una alternativa nonviolenta (corpi civili di pace, forze nonviolente, caschi bianchi) e in parallelo la riduzione programmata annua del 5% dei consumi di energia fossile (in particolare il petrolio) con la crescita, nella stessa misura, della produzione di energie rinnovabili. In una sola legislatura otterremmo risultati concreti e straordinari, che ci avvicinerebbero a traguardi ancora più ambiziosi. Ma troveremo una forza politica che abbia il coraggio di assumere un simile programma? Sta al movimento per la pace attivarsi perchè tale proposta non rimanga nel cassetto dei sogni. (1) Si veda ad esempio il sito www.ruckus.org curato dalla Ruckus Society, uno dei gruppi internazionali più specializzati in questo campo. (2) Si vedano in proposito le riflessioni di Brian Martin, Nonviolence versus capitalism, www.uow.edu.au/sts/bmartin/pubs/01nvc (3) Si veda in particolare Emmanuel Todd, Dopo l'impero, Marco Tropea, Milano 2003. (4) Il declino dell'impero americano, www.iai.it/pdf/Wallersteintrad5.PDF (5) The fall of the empire, www.transcend.org * Nanni Salio (per contatti: [email protected]), torinese, segretario dell'Ipri (Italian Peace Research Institute), si occupa da diversi anni di ricerca, educazione e azione per la pace, ed è tra le voci più autorevoli della nonviolenza in Italia. Opere di Giovanni Salio: Difesa armata o difesa popolare nonviolenta?, Movimento Nonviolento, Perugia; Scienza e guerra (con Antonino Drago), Edizioni Gruppo Abele, Torino 1982; Ipri, Se vuoi la pace educa alla pace, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1983; Le centrali nucleari e la bomba, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1984; Ipri, I movimenti per la pace, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1986-1989; Progetto di educazione alla pace, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1985-1991; Le guerre del Golfo, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1991; Il potere della nonviolenza, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1995; Elementi di economia nonviolenta, Movimento Nonviolento, Verona 2001. Per contatti: Centro Studi "Domenico Sereno Regis", via Garibaldi 13, 10122 Torino, tel. 011532824, fax: 0115158000, e-mail: [email protected], sito: www.arpnet.it/regis].
Scaricare