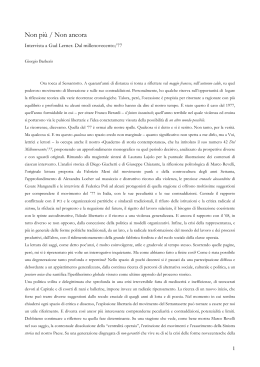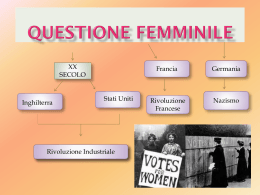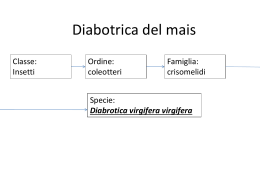Vostro Onore, Signor Presidente, signori Giurati Popolari, vista la mia impossibilità, già giustificata, ad essere fisicamente presente a questa udienza preliminare sul '68, faccio rispettosa istanza affinché sia messa agli atti del dibattimento, la mia testimonianza in forma di memoria scritta e sottoscritta, dandone pubblica lettura. Mi chiamo Carla Baroncelli e sono nata a Ravenna il 15 febbraio del 1949, quindi, nella prima metà del secolo scorso. Mi dichiaro fin da subito testimone in difesa del '68, nonché femminista. Fino al 1968, la mia rivoluzione è stata più che altro una ribellione alquanto codarda: si limita a sotterfugi anti-madre. In casa servizievole, girato l'angolo: ciglia da Bambi, rossetto e minigonna. A scuola, in quinta, il leader del movimento studentesco mi fa il filo e io, pedissequa, gongolo d'orgoglio per essere stata pre-scelta. Io sono tua, gli dico. Otteniamo il diritto all'assemblea di istituto dal Preside, ma solo se vi togliete le scarpe prima di entrare in palestra, per non rovinare il linoleum. L'anno dopo, ormai diplomata, durante le occupazioni corro da una scuola all'altra per tenere seminari di 'scuola e lotta di classe'. Diritto allo studio, trasporti gratis. La squadra politica mi definisce 'l'occupante itinerante'. Per le strade gridiamo: Rivoluzione, rivoluzione. La mia lotta all'autoritarismo scolastico si conclude andando a lavorare. Impiegata in una fabbrica di mangimi. La mia lotta contro l'autoritarismo nella famiglia si conclude invece con un matrimonio. Siccome sono ancora minorenne, il matrimonio mi apre le porte della libertà. Ora sono le fabbriche, gli operai, l'antifascismo, i partigiani al centro della nostra lotta politica. Seguivo mio marito, un compagno vero, in riunioni bisettimanali interminabili. Stanzoni gelidi. Spifferi tappati con la carta di giornale. Ci litigavamo i posti vicino alla stufa di pietra rossa. Ricordo le riunioni del Collettivo dell'Anic e gli eroici e tosti operai sardi. Capivo poco di chimica, di turni e isole di produzione, però sentivo quanto fossero giuste le loro parole, dal tono secco e tagliente delle loro voci. La forza della loro ragione era tutta nelle espressioni dei visi duri, nei capelli, nelle mani. Confesso, spesso mi addormentavo, ma dormivo bene vicino a quella stufa. Dovevo solo badare che non si spegnesse il fuoco. D'altra parte, questo era il mio compito, che i compagni, ridendo, mi avevano assegnato. Poi si andava all'osteria a bere vino e cantare canzoni, una più triste dell'altra. All'una di notte, ci chiedevamo: carbonara o arrabbiata? I mesi di lotte contro lo sfruttamento del lavoro a domicilio, mi piacquero molto: finalmente capivo qualcosa. Si andava nelle case e lì sentii sulla pelle lo strenuo sfruttamento delle donne. Nel periodo del collettivo operai studenti trovammo ospitalità allo PSIUP. Si stava bene e finalmente al caldo. Studenti, operai, uniti nella lotta, gridavamo in corteo coi metalmeccanici. Che orgoglio! Andammo in trasferta a Cervia, a fianco dei lavoratori stagionali. La polizia ci caricò e disperse. Un breve passaggio al Manifesto, che mi intimidì con i suoi intellettualismi. Finii in gattabuia dai Carabinieri quando mi presero mentre vendevo copie del giornale durante la manifestazione del PCI del 1° maggio, a Mezzano (90 per cento di comunisti). Lasciai. Finito il periodo Prendiamoci la città di Lotta Continua, col quale non ero d'accordo, entrai nel movimento. Di nuovo in stanzoni inospitali. Io andavo a parlare con le donne del quartiere, quelle più povere di mezzi e strumenti, con sei figli in una stanza, un marito disoccupato e spesso ubriaco, che voleva sempre far l'amore e metterla incinta, per sentirsi un uomo vero. Rimanevo basita e impotente. E la distribuzione di carne? Vendevamo a prezzi politici vari tagli di un vitellone, che avevamo macellato la sera prima. Fu un successo. Poi ci fu l'autoriduzione delle bollette telefoniche. Fu proprio a Lotta Continua che entrò nella mia vita il ciclostile: che informicolisce il braccio, sporca d'inchiostro le mani, strappa la matrice, si inchioda a metà. I tasti della mia 'lettera 22' sono sempre più duri per il gran battere a macchina. Impaginiamo i fogli girando attorno ad un tavolo per ore. E poi spilliamo, impiliamo e dividiamo il materiale per scuola, per fabbrica, per quartiere … A fare questo pallosissimo lavoro siamo sempre e solo noi ragazze. La commissione femminile di LC è sempre all'ultimo punto dell'ordine del giorno, fra le varie. L'esecutivo è riservato di fatto ai soli maschi. I testi, i documenti, le decisioni, pure. I compagni mi concedono di fare qualche comizio, ma mi mandano solo in paesini sperduti. Un pomeriggio nebbioso a Brisighella avevo solo un ascoltatore. L'ho visto uscire dal bar, fumarsi una sigaretta e rientrare. Si andava al cinema assieme e si scopava senza impegno. Un pomeriggio, dopo aver finito di confezionare un opuscolo ci guardammo e ci dicemmo: compagne, ma non ci siamo ancora stancate di eseguire, obbedire, tacere? Mia madre era l'angelo del focolare, io non voglio essere l'angelo del ciclostile. Se prima avevo lottato contro l'autoritarismo in casa, poi a scuola, ora mi ribellavo conto l'autoritarismo dei miei compagni. Sappiamo la fine di Lotta Continua. A Rimini nel 76. Il congresso si concluse col suo scioglimento. Determinante fu la protesta di noi compagne, non solo perché ci usavano come segretarie o per far le pulizie, ma soprattutto perché ne avevamo abbastanza della prevaricazione sessuale dei compagni mascherata da amore libero. Ricordo Adriano Sofri ammonire i delegati maschi: ormai bisogna che ci abituiamo a vivere col terremoto. E quel terremoto, come ci aveva definite Sofri, diede una forte scossa e abbandonammo il movimento. Intanto a Ravenna, noi femmine ci riunivamo nelle case, o da me o da Loretta. Tutte assieme studiammo curiose Noi e il nostro corpo. Ci guardavamo, scoprivamo le nostre terre intime. Le parole sussurrate alzarono il tono di voce: le mie cose si chiamano mestruazioni, la farfallina, clitoride. Eiaculazione. Masturbazione. Penetrazione. Autopalpazione. Ci chiediamo da dove viene il nostro orgasmo: il tuo è vaginale o clitorideo? Concludemmo che: il corpo è mio e lo gestisco io. Io sono mia, abbiamo urlato con mente e corpo. Scoprire il nostro corpo, ce lo rese amico, più nostro. Meraviglioso. Scoprire quello delle compagne, fu una rivelazione di bellezza e complicità. Ci divertivamo molto: l'ironia diventò un'arma spudorata. Ricordo una sera davanti al cinema Mariani, che allora era a luci rosse. Offrivamo dei preservativi colorati ai maschi perché non sporcassero le poltrone mentre si masturbavano. Scandalo! E gli spettacoli improvvisati? E la Paperina che ci trascinava con la sua chitarra a cantare la nostra gioia? Le mie sottane si allungarono, come anche i capelli e il pensiero. Tremate, tremate, le streghe son tornate. Non siamo più solo una 'questione femminile', ma l'altra metà del cielo, per dirla con Mao Tze-tung. Il personale è politico. La liberazione sessuale fu come respirare a bocca aperta, anche se, lo confesso, la coppia aperta è stata delizia e strazio nello stesso tempo. Entrammo nei consultori per incontrare le altre donne. Fu un momento magico, quello dell'autogestione del consultorio della Darsena. Salute e maternità. La pillola non è più clandestina, ma di contraccezione le donne sanno troppo poco: hanno ancora paura dei mariti! Impariamo e insegniamo ad usare il diaframma, a fare l'autopalpazione al seno. La sessualità non è sinonimo di procreazione. Abbiamo diritto al piacere. La maternità deve essere una scelta libera e consapevole. Non vogliamo più morire d'aborto. Non vogliamo dover andare in Inghilterra per abortire. Aborto libero … aborto libero. Nel 1978 otteniamo la legge 194. E' la nostra risposta al patriarcato che ci vuole solo madri. Ma in Italia c'è ancora il delitto d'onore. Il matrimonio riparatore. La lezione che ci ha dato Franca Viola nel 1965, col suo rifiuto di sottomettersi a qualsiasi forma di legalizzazione della violenza maschile, è ancora la nostra battaglia. La messa in crisi degli stereotipi di genere ha messo in crisi sia gli uomini che le donne, perché ha messo in discussione l'unico sistema di relazione fra i sessi che conoscevamo: quello patriarcale. Mistero Buffo di Dario Fo dà una botta esilarante allo strapotere della Chiesa, e Franca Rame ci delizia con l''uomo incinto'. Ma Franca ci fa riflettere anche sul dramma dello stupro. Era stata sequestrata e violentata prima, derisa dopo. Il suo monologo fa accapponare la pelle, ancora adesso. Se i maschi ci violentano, non è perché portiamo la minigonna, ma perché siamo femmine. A Ravenna ci fu un processo per uno stupro contro quattro ragazzi bene che una notte violentarono una giovane donna. Ci andammo tutte in massa. Gli imputati sghignazzavano e si davano di gomito. Il dibattimento fu umiliante, per lei e per noi tutte. La ragazza violentata era diventata l'imputata. Si è tolta le mutande da sola? Perché non si è difesa? In fondo le piaceva, no? Era gratificata da tanta attenzione? Perché non ha chiesto aiuto? Lei continuava a piangere: … erano in quattro, tre mi tenevano, l'altro …, mi hanno tappato la bocca … L'avvocato dei violentatori era del PCI, e per farci star zitte disse: non potete avercela con me, io sono stato il primo femminista della storia! Gli rispose un boato da parte nostra, e l'assoluzione dei suoi assistiti da parte della Corte. In Italia le aggressioni e le violenza sessuali diventarono sempre più frequenti, soprattutto di notte. Ricordo la manifestazione di Roma, nel 76. Eravamo decine di migliaia. Gridavamo: Riprendiamoci la notte. Vogliamo uscire in pace. Diciassette anni dopo, nel 1986, abbiamo ottenuto la legge contro la violenza sessuale. Finalmente lo stupro è considerato un delitto contro la persona e non contro la morale. E' vero, non abbiamo eliminato la violenza, ma abbiamo una legge, i centri antiviolenza, e qualche anno dopo abbiamo ottenuto anche la legge contro lo stalking, ma soprattutto abbiamo dato coraggio alle donne di denunciare e far emergere la violenza che prima subivano in silenzio e da sole. Il problema è essenzialmente culturale. Le leggi sono molto importanti, ma non bastano. Come non basta creare una riserva di 'quote rosa', per veder riconosciuto il nostro valore. Le donne studiano di più, si laureano con voti più alti, ma sono ancora sottopagate, più disoccupate dei maschi e con meno opportunità. Forse perché Un posto di potere a una donna, è un posto in meno per un uomo? Le donne, nei luoghi di potere, non devono starci perché sono donne e gli spetta una quota, ma per le loro capacità. Il femminismo aveva e ha obiettivi più alti delle quote rosa. Le leggi sono importanti, abbiamo ottenuto dei diritti e modificato qualche percezione, ma la cultura femminista che abbiamo diffuso non ha radicato come ci si aspettava. L'autonomia e il rispetto dei nostri corpi non è diventato patrimonio comune e cultura sociale. Così ci siamo incartate da sole sull'analisi delle parole. Il patriarcato, credendoci morte, ha alzato il tiro nell'esercizio del potere. Ha riempito i consultori di medici obiettori. Ci ha propinato la legge 40. La pubblicità ha vivi-sezionato i nostri corpi. Credevo che la cultura si sarebbe trasformata al tal punto da non aver più bisogno di pensare in termini di uomo/donna, ma di individui. E' stato un peccato di ottimismo. Se non ora quando, nel 2011, ci ha riportate in piazza. Tante, giovani e belle. Ammettiamolo: donne e uomini non sono uguali. Uguali nei diritti, sì, ma diritti che tengano conto della differenza sessuale. Purtroppo un obiettivo ancora lontano. Anche coniugando le parole al femminile. Abbiamo scardinato i ruoli, messo in crisi le certezze, abbiamo denunciato il re nudo, ma c'è ancora tanto da fare. Penso che agli uomini potrebbe servire un po' di autocoscienza e la lettura di ciò che le donne hanno scritto e dicono. Dovrebbero guardare la propria virilità e chiedersi che cosa voglia dire essere maschi fuori da logiche di dominio e di paura. Cosa li spinge ad uccidere le donne che non li amano più? Guerre, devastazioni, genocidi di interi popoli li ha fatti il sesso maschile, vorrei che gli uomini che non sono d'accordo si ponessero almeno il problema. In sostanza, Vostro Onore, non solo non ne rinnego il valore, ma sostengo che c'è ancora bisogno di '68 e di femminismo. Penso tutt'ora che nessuna rivoluzione sociale, ovviamente pacifica e non violenta, sia possibile senza la liberazione della donna. Ribadisco, Vostro Onore, non solo non sono pentita, ma ho ancora dentro di me le stesse pulsioni della rivoluzione culturale e politica del '68. Io ho fatto la mia parte per ribaltare gli schemi, cercare nuovi equilibri. Mi sono sposata con una donna, con amore e orgoglio. Mi sento una persona libera d'essere e sentire. Signori giurati, se condannerete il '68 e il femminismo, condannerete anche me, ma non mi appellerò alla clemenza della corte. Mi dichiarerò semplicemente prigioniera politica del patriarcato. Se ci assolverete, invece, ve ne sarò grata. In fede, Carla Baroncelli PS: Mi pare di cogliere nell'aria un leggero spiffero patriarcale, non è che dipenda dal fatto che su sette testimoni, sei sono maschi? Con rispetto, s'intende. Carla Baroncelli Prima considerazione. Come ci insegnano gli storici di professione, per giudicare un qualsiasi momento della storia passata non bisogna fidarsi troppo delle fonti orali e delle testimonianze degli stessi protagonisti. Perché tendenzialmente assolutorie, partigiane e sempre poco attendibili. Meglio le fonti documentarie materiali, perché resistono a qualsiasi tentativo di manipolazione giustificativa, reticenze varie, ecc. Un ottimo esempio sono quei manifesti del sessantotto che abbiamo esposto e pubblicato in questo libro. Una buona metà li ho progettati io (e poi stampati ed attaccati). Se non li avessi conservati e me li avessero fatti vedere oggi a distanza di 50 anni avrei fatto fatica a riconoscerli come miei. D'accordo; posso essere orgoglioso per il buon livello di creatività, sull'ansia di cambiamento che esprimono, su tante cose... ma c' è una questione di fondo non di poco conto che non è mai stata discussa e messa fuoco e che oggi invece salta agli occhi. Mi riferisco alla questione della forza, alla questione della violenza rivoluzionaria: noi davamo per scontato che "vince chi spara" e affermavamo "Solo violenza aiuta dove violenza regna" promettendo di "restituire tutto colpo su colpo"... Questa "cultura rivoluzionaria" ci era stata trasmessa attraverso una specie di didattica collettiva dalle precedenti generazioni che avevano fatto la resistenza e la guerra civile e che costituivano il nostro modello di riferimento. Il non aver mai voluto fare i conti con questa questione nell'immediato dopoguerra ha favorito la trasmissione di questo errore, che pochi anni più tardi risulterà fatale, ma comunque conseguente. Altra considerazione: non dobbiamo dimenticare, nel tentativo di ricostruire una qualche verità oggettiva sul sessantotto, che il fattore più importante è stato il fattore anagrafico. E va ricordato che non siamo stati noi a inventare il protagonismo sociale e politico dei giovani. La gioventù, in particolare quella studentesca già consistente nei primi anni del '900, irrompe nella storia con la prima guerra mondiale e negli anni immediatamente successivi, sotto la forma del reducismo, dell'arditismo del futurismo con connotati antiborghesi, anticapitalisti, anticlericali, in modo confuso e indeterminato, movimentista e antipartito, insomma rivoluzionario, ma anche nazionalistico e, venendo dalla guerra, inevitabilmente violento. E poi sappiamo come è andata a finire.... Terza e ultima considerazione: ci andrei piano ad augurarci un nuovo sessantotto. A parte che questa potrebbe essere catalogata come normale e banalissima nostalgia della gioventù passata, chi ha detto che non ci sia già in atto qualcosa che gli assomiglia? Certamente molto più scarso del nostro, molto meno divertente e per noi.... inevitabilmente incomprensibile. Saturno Carnoli Porto la testimonianza di chi ha vissuto il ’68 da adulto. Avevo 24 anni, ero laureato e insegnavo alle medie superiori. Ciò che mi ha colpito e infine coinvolto nel “lungo ‘68”, il periodo che va all’incirca dal ’67 al delitto Moro, fu la capacità del movimento di mettere in discussione i ruoli sociali e il loro rapporto funzionale al potere. Così nella scuola si creò un dialogo fecondo, direi una collaborazione, fra studenti e insegnanti democratici. Certo fu importante il libro di don Milani perché tolse la cenere dal fuoco. D’altra parte a Rimini la mia generazione veniva dall’intensa attività dei circoli culturali che per tutti gli anni sessanta aveva prodotto quadri che avrebbero poi occupato posti di responsabilità nei partiti e nelle istituzioni. Un breve elenco: Circolo Gobetti (sinistra storica), Circolo Astrolabio (area laico azionista), Circolo Maritain (cattolici del dissenso), Circolo Anti-H (pacifismo), Gioventù Studentesca (cattolici), Gioc e Acli (operai cattolici). Naturalmente le Federazioni giovanili dei partiti. C’era dunque fermento, c’era un terreno fertile, c’erano quadri formati: tutto ciò ha fatto del ’68 a Rimini un fenomeno non puramente ribellistico o rivendicazionistico. In generale il ’68 è stato un “passaggio d’epoca”, una “curva della storia”. Ci sono momenti in cui, per dirla con il filosofo con la barba, le forze produttive (cioè noi, la tecnica, le macchine, ecc.) entrano in contraddizione con i rapporti di produzione (cioè con le gerarchie sociali, gli assetti istituzionali, i rapporti di forza, le regole del gioco, ecc.). Lo sviluppo delle forze produttive è più rapido di quello dei rapporti di produzione, a un certo punto l’equilibrio si rompe. Questo è avvenuto nel ’68 studentesco e operaio ed è avvenuto praticamente in tutto il mondo. Poi certo ci furono fatti culturali e generazionali, come la musica, i giovani, la scoperta del terzo mondo, ecc. Ma la causa profonda fu la fine anticipata del Novecento, dei suoi equilibri sociali, delle sue tecniche, del suo modo di organizzare la produzione e la riproduzione sociale. Per emettere sentenze non possiamo però sottrarci ai bilanci. Dal punto di vista delle aspirazioni, guardando il mondo di oggi, non possiamo non dire che il ’68 ha fallito: -‐ aumento delle diseguaglianze -‐ narcisismo di massa -‐ de-valorizzazione del lavoro -‐ sottosviluppo -‐ terrorismo di varie matrici fondamentalismo che ha preso il posto del relativismo laico. Tuttavia il ’68 ha introdotto formidabili modelli culturali: -‐ rivoluzione sessuale -‐ femminismo -‐ partecipazione politica e sindacale -‐ la “critica del ruolo sociale” come matrice del cambiamento -‐ il tema dell’egualitarismo nella culla della civiltà dell’individuo. -‐ Perché questa spinta innovativa non seppe farsi stato? Per l’insufficienza dei modelli statuali e di democrazia capaci di contenerla (ci fu però molta ricerca: democrazia diretta, teoria consigliare, studenti/operai, critica del patrimonio ideologico ereditato dal comunismo della III Internazionale). Ed è legittimo chiedersi quanto pesò la fine della “spinta propulsiva” dei paesi del socialismo reale. In certa sociologia, soprattutto americana, si va affacciando oggi una nuova lettura “strutturale” del ’68: la società post fordista in declino sotto i colpi della classe operaia e l’avvento prossimo dell’era digitale avevano bisogno di una società più libera, più individualista, meno familistica. Il ’68 ne ha creato le premesse culturali, il mercato ha poi utilizzato ai propri fini i mutamenti di costume e di comportamento. Si tratta di una lettura interessante ma deterministica e leggermente complottarda, alla Bildenberg. Mi pare però evidente come il mercato sia riuscito a sviluppare una “rivoluzione passiva” (Gramsci) o una “restaurazione progressiva” (Vincenzo Cuoco) incorporando nei modelli di vita e di consumo i valori più compatibili del ’68. Ed anche l’organizzazione del lavoro, per scelta non certo inconsapevole, cambiò radicalmente cancellando, almeno in Europa e USA, la figura dell’operaio-massa, grazie anche alla tecnologia digitale. Anche la lotta contro la catena di montaggio divenne motore di sviluppo. Poi arrivò la finanziarizzazione dell’economia, sublime strumento di controllo delle classi e perfino degli stati. L’attuale segmentazione sociale è talmente sviluppata che, per ora, le teorie politiche si tengono alla larga dalla critica sociale. La politica ora è “politicante”, cioè si occupa degli equilibri istituzionali e delle elezioni. Nel vasto universo del sociale non c’è più nessuno se non un sindacato sempre più isolato nel contrastare la formidabile forza del mercato. Ci sarà un altro ’68? Certamente si, quando il nuovo assetto delle forze produttive confliggerà con i nuovi rapporti di produzione, così come è accaduto molte volte nella storia creando nuovi equilibri. Giuseppe Chicchi 1) Nella prima parte del mio intervento mi sono soffermato sulla contemporaneità planetaria del fenomeno ’68. Scoppiò quasi simultaneamente ovunque: a Parigi, come sappiamo tutti, ma prima ancora a Berkeley, a Torino, a Roma, a Bologna. Arrivò a Varsavia e, come vedremo a Praga anche se noi credemmo che fosse un’onda diversa. Eppure non c’era Internet, i satelliti si chiamavano Sputnik e servivano solo alla guerra fredda, il telefono era un soprammobile posato su un tavolino alto nell’ingresso, quando c’era in casa. Altrimenti bisognava riempirsi la tasca di gettoni e usare quelli appesi alla parete del bar. La televisione, in bianco e nero a due canali, era una vasca in cui avrebbero nuotato decine di pesci rossi. Ad esempio ho citato alcune righe del libro “I disorientati” di Amin Maalouf : Dio quanto ci piaceva discutere…. Credevamo sinceramente che le nostre idee potessero influire sul corso degli eventi. … Eravamo l’abbozzo dell’avvenire ma l’avvenire sarebbe restato allo stato di abbozzo. Maalouf parla di Beirut, poteva il sessantotto non scoppiare anche in Romagna? Era la prima generazione post-bellica autorizzata ai consumi di massa, alla musica, all’abbigliamento attraverso cui identificare una tribù. Dunque primo mio concetto: un primo esempio di tribù planetaria, però solidale, generosa che credeva di cambiare il mondo in modo egualitario. Le tribù oggi sono la regola però, cito ancora Maalouf, tribù planetarie che si combattono, che si odiano ma che, sotto l’effetto della globalizzazione, si nutrono, ogni giorno di più , della stessa broda culturale indifferenziata. Dunque come testimone a favore ho assegnato un punto a favore del ’68 2) Nella seconda parte ho parlato invece di quello che non abbiamo saputo vedere . La sinistra rivoluzionaria, erede legittima del ’68 fin dal 1969 aveva il torcicollo, era arrivata a un passo dal vedere i cambiamenti epocali grazie alla sua origine antiautoritaria e invece guardò al passato. Questo valse per PotOp che scambiò gli anni settanta per gli anni venti ma valse anche di più per noi, Manifesto e Pdup, proprio perché avevamo un po’ meno torcicollo degli altri. Così si esaurì la storia dei gruppi, tra passaggio alla lotta armata e riflusso. Solo il Pdup che via via inglobò una parte di Avanguardia Operaia e poi si unì al MLS (componente fondamentale del Movimento Studentesco Milanese) continuò ad esistere. Ma anche noi non fummo capaci di interpretare le stesse analisi di cui pure fummo capaci. Nel novembre del 1977, tenemmo a Venezia un convegno importante: Potere e opposizione nelle società post-rivoluzionarie. Nell’introduzione di quel convegno Rossanda disse che la separazione tra libertà e socialismo, il persistere del capitalismo di stato e le gerarchie inaccettabili non erano cose che si sarebbero aggiustate con un ritorno ai principi giusti. Si trattava di un enorme passo avanti rispetto alla vulgata post-’68 e gruppettara il cui approdo era essenzialmente al concetto di rivoluzione tradita o agli slogan filo cinesi. Subito dopo Rossanda dirà di più. E questa crisi esce dall’orizzonte della politica per investire la teoria: è la crisi del marxismo, di cui i “nuovi filosofi” sono la caricatura, ma che immense masse vivono come inconfessata realtà. Il marxismo, non come corpo teorico o filosofico, ma come grande forza ideale che mutava il mondo, s’è fatto ansante sotto la pesantezza di questa storia. Nello stesso convegno Althusser baserà il suo intervento su questo passaggio che invece sarà lasciato perdere dai più. Noi stessi lo dimenticammo presto, semmai ce ne fossimo accorti. Lucio Magri invece parlò della stessa questione ma con un approccio diverso. … perché non è pensabile di proporre oggi alla gente una transizione al socialismo in occidente, senza dire come e quanto sia diverso il modello di società che vogliamo costruire. … non è pensabile nell’attuale quadro internazionale arrivare al rovesciamento radicale degli equilibri sociali e politici senza chiedersi a quali processi ciò può corrispondere nel vicino e potente blocco sovietico. Magri sostenne che ai movimenti socialisti e comunisti dell’Europa occidentale conveniva la continuità dell’URSS, anche se con l’eurocomunismo ne prendevano le distanze. Mentre i socialdemocratici, come ha scritto Hobsbawm, si appoggiavano al Muro per ottenere maggiori conquiste dalla loro parte. In quel convegno di Venezia emersero posizioni diverse, eppure convergenti sul punto cardinale ovest. Rossanda vide prevalentemente “il peso” che le società post-rivoluzionarie rappresentano per il dispiegarsi del marxismo come forza che cambia la storia nelle società capitalistiche. Ne proclamò addirittura la crisi. Magri pensava che il blocco sovietico fosse tanto forte da condizionare negativamente le sinistre europee a cui sarebbe toccato comunque di indurne la trasformazione dopo aver cambiato lo stato di cose presenti in occidente. A mio rischio e pericolo penso che siamo stati ad un passo dal vedere la strada che avrebbero preso i fatti e l’impatto devastante che avrebbe avuto l’implosione dell’impero sovietico sulle sinistre comuniste. Non l’abbiamo visto perché aspettavamo la crisi del capitalismo a ovest e invece è arrivata prima quella del socialismo-stato dell’est. Il fatto di essere sopravvissuti e di aver capito che la storia della sinistra rivoluzionaria era finita tra il 1977 e il 1978 ci permise di approdare nel PCI per sostenere la sua svolta a sinistra dopo lo storico discorso di Berlinguer ai cancelli della Fiat nel 1980, a forme di lotta più acute, comprese forme di occupazione, sarebbe sicuro l'impegno politico, organizzativo e anche di idee e di esperienza del Partito Comunista, e dopo quella che fu definita la seconda svolta di Salerno, quella che abbandona il compromesso storico per un governo di alternativa democratica. Il percorso e le intenzioni di Berlinguer ci divennero quanto mai chiare quando nel marzo del 1984 il segretario generale del PCI si sedette in prima fila alla sala Corridoni a Milano, dove il Pdup teneva il suo congresso nazionale, per ascoltare la relazione di Lucio Magri. Una volta approdati al PCI non approfondimmo per niente o quasi la questione dell’est, premeva il reaganismo e al 17° congresso votammo per un disallineamento dalla Nato (emendamento Castellina) e contro le centrali nucleari (emendamenti di Mussi e Bassolino). Perdemmo. Ma perdemmo molto di più al congresso successivo che tutti pensavamo di aver vinto contro l’ala migliorista, tutti salvo Magri. Il documento preparato da lui come tesi alternativa della sinistra al XVIII congresso del PCI e pubblicato in appendice a Il sarto di Ulm è probabilmente la cosa più interessante, lungimirante e connessa alla storia del Pdup per il comunismo che sia stata scritta, anche se è stata scritta nel PCI. Eravamo ormai arrivati al 1987 e la maggior parte di noi si era concentrata sulla contraddizione ambientale e sul movimento per la pace. Il XVII congresso aveva sancito una sorta di compromesso sulle posizioni socialdemocratiche: stare nella Nato, essere amici dell’URSS. Più tardi diventammo tifosi della Perestroika senza intuirne la debolezza. Quando, dopo il XVIII congresso, arrivò la caduta del Muro se ne avvantaggiarono, contro di noi, proprio i miglioristi che spesso, come Napolitano, erano stati filo-sovietici fino al limite consentito dall’essere poi diventati filosocialisti. Il documento preparato da Magri nel 1987 rimase in un cassetto perché al XVIII Congresso la sinistra ingraiana aveva creduto alle aperture su ambiente e alterità dal PSI della relazione di Occhetto e accettato di ritirarlo. Eppure vi si parlava nuovamente di crisi del marxismo di fronte ai fenomeni nuovi della frammentazione e della globalizzazione e parlava dell’URSS dove le speranze di Lenin... si mostrarono via via incompatibili con una forma politica (il partito unico, il potere centralizzato,l’identificazione tra il dissenso e il nemico di classe) che si consolidava in privilegio burocratico, passivizzava politicamente le masse, cristallizzava il pensiero unico nel dogmatismo e, alla fine, paralizzava lo stesso dinamismo sociale e produttivo. La storia ha così dimostrato che l’esercizio pieno della democrazia politica per il socialismo non è meno, ma ancora più importante di quanto non lo sia stato per il capitalismo. A ben vedere, dieci anni dopo Venezia, c’erano progressi, purtroppo ancora insufficienti e soprattutto ormai tardivi. Avremmo dovuto invece continuare a cercare sulla strada di quel convegno di Venezia. Analizzare ancora di più la crisi di cui parlarono Rossanda e Althusser, cercare strade diverse sul tema della trasformazione in Stato delle forze sociali e politiche opposte al capitalismo. Certo, si tratta del senno di poi, ma gli strumenti c’erano e se fossero stati acuminati per tempo avremmo potuto precedere, o almeno tentare di farlo, il senso liquidatorio del XIX e del XX Congresso del PCI. In gran parte noi del Pdup per il comunismo fummo, assieme ai cossuttiani, la nervatura dell’opposizione allo scioglimento ma dovemmo appiattirci su posizioni difensive, tollerare nostalgie senza speranza e così segnammo anche il futuro del PRC. Perché avevamo intuito molte cose sul socialismo reale, ma avevamo continuato sempre a pensare che sarebbe stato il capitalismo a cedere prima. Ciò a cui non avremmo mai pensato è che una crisi così profonda e vasta come quella in atto ai nostri giorni, sarebbe avvenuta senza generare alternative di sistema. secondo punto dunque assegnato a sfavore 3) Di questo punto ho parlato solo in ritardo e dopo l’intervento con il mio compagno di banco Giuseppe Chicchi. Lui aveva evocato la necessità di un nuovo ’68. A me è venuta in mente una risposta: un nuovo ’68 è già in atto solo che noi non lo riconosciamo. Il motivo di questo misconoscimento deriva dalla nostra istintiva voglia di vedere le masse. Inoltre detestiamo il populismo facilone. Per questo non vediamo che il ’68 odierno ha preso le spoglie di Grillo, M5stelle, Indignados, Podemos, Ciudadanos… La sua diffusione italiana è solo internettiana e anche piuttosto qualunquista… ma possiamo negare che si tratti di una rivoluzione culturale e generazionale? Questa osservazione ci porta a comprendere cosa ci aspetta. Il nostro sessantotto portò grandi progressi nel costume, nei diritti civili nel rapporto uomo-donna. Non era però quello che volevamo, non raggiungemmo nessuno degli obbiettivi politici che via via ci demmo: dalla rivoluzione del 1968 al governo delle sinistre del 1976. Ottenemmo solo risposta violenta dello stato, stragismo e sbocco terroristico. Il sessantotto odierno quello degli indignati otterrà la distruzione della politica di mestiere e la distribuzione delle decisioni tra i cittadini?SI/NO. Otterrà probabilmente la distruzione della politica razionale, complessa e stratificata ma invece della distribuzione della decisione otterrà il dominio delle istituzioni a-democratiche. terzo punto dunque assegnato in parità GuidoPasi L'impaginazione al potere Il mondo è un grande cortile di prigione, se non sei un prigioniero, sei una guardia. Bob Dylan “George Jackson” 1971 Guidano od hanno guidato giornali, settimanali e Tg di Destra, di Centro e di Sinistra. Ma in gran parte vengono dalle piazze del ’68 e, più in generale, da quella che veniva definita la ‘sinistra extraparlamentare’. Non rappresentavano la maggioranza del Paese. Del resto, la Storia è sempre stata scritta da piccoli gruppi. Poi subentra il mito delle ‘masse’, basti pensare alla Rivoluzione Francese o alla Resistenza al nazifascismo: furono in 170mila secondo i dati dell’Associazione Nazionale partigiani Italiani. Gli altri, tutti dietro le finestre a guardare. Dunque i sessantottini, dall’immaginazione al potere sono passati all’impaginazione. Un passaggio quasi naturale per una generazione di giovani che aveva assunto la comunicazione come il principale terreno di scontro politico – generazionale, dove alla parola d’ordine “adattatevi” dei tecnocrati, veniva contrapposta quella di “esprimetevi”. La critica ai giornali ma non alla tv La critica all’industria del sapere e ai media dominanti accusati di mentire, manipolare e di rendere i cittadini passivi e schiavi non poteva che finire nell’ingresso, in varie forme, in quel mondo tanto analizzato e sezionato attraverso controcorsi, pamphlet, saggi sulla manipolazione del consenso, echi francofortesi con forti venature situazioniste debitrici de “La società dello spettacolo” di Guy Debord . Era una critica anche abbastanza facile: la stampa cosiddetta “borghese” era ancora espressione di quel genetico trasformismo che, dopo aver esaltato i valori e gli interessi della monarchia, del fascismo e della finanza, ora si identificava nello Stato romano e centralistico inefficiente e già corrotto. Uno Stato che aveva sempre ragione e dove le istituzioni erano sacre e polizia e carabinieri dicevano sempre la verità. I giovani, definiti “capelloni” dai giornali, furono tuttavia miopi rispetto alla Tv, come acutamente rileva Peppino Ortoleva nel suo solido saggio su “I Movimenti del ’68 in Europa e in America” , poiché: “ebbero come tratto distintivo un’attenzione critica, senza precedenti, alla sfera della comunicazione, ma furono stranamente disattenti rispetto al medium più influente nella società che essi intendevano sovvertire”. Insomma, un movimento ancora legato alla vecchia carta stampata e poco attento, anche per snobismo intellettuale, alla dimensione nazionalpopolare del nuovo mezzo televisivo che stava entrando prepotentemente in tutte le famiglie italiane. Studenti dunque poco attenti all’insegnamento gramsciano. Antonio Gramsci infatti non disdegnò di analizzare non solo giornali e riviste ma anche il cinema o il romanzo d’appendice, consapevole che per studiare uno Stato moderno non è sufficiente studiare i partiti politici e la struttura economica ma è necessario analizzare quell’insieme di fenomeni che il fondatore de “L’Unità” chiamò “L’organizzazione della cultura”. Solo qualche anno dopo il ’68 subentrò un interesse al sistema televisivo. Nel 1973 Umberto Eco indicava ne “Il costume di casa”, la sua proposta di “guerriglia semiologica”: “Bisogna occupare, in ogni luogo del mondo, la prima sedia davanti ad ogni apparecchio televisivo (e naturalmente la sedia del leader di gruppo davanti ad ogni schermo cinematografico, ad ogni transistor, ad ogni pagina di quotidiano”. Eco ha insegnato ad una generazione priva di mezzi di comunicazione ad interpretare, a ‘decodificare’ in maniera alternativa quanto il sistema veicolava. Un’attività che, secondo il professore, avrebbe portato ad uno smascheramento di massa dell’ideologia che veniva nascosta in ogni articolo di giornale, in ogni spezzone di telegiornale. Un testo base per chi in quegli anni tentava di usare la Tv “dalle masse alle masse” è il libro di Roberto Faenza “Senza chiedere permesso. Come rivoluzionare l’informazione”, vero e proprio manuale sull’uso del videotape e sulla televisione alternativa in Nord America e in America Latina. Divenne un testo base per futuri programmisti-registi e giornalisti tv. Dalle piazze al potere editoriale Chi prima scopre il mondo, prima sarà scoperto dal mondo. Non è un caso che la grande stampa italiana, che perlopiù era di tradizione massonica e liberale, si accorse di questi giovani. Passate le ubriacature barricadiere, si proponevano come giovani di buone letture, pieni di entusiasmo e di voglia di raccontare il mondo, magari non più con la volontà di cambiarlo, ma semplicemente di migliorarlo. Si muovono singolarmente, forti anche di esperienze giornalistiche nella galassia dell’ultrasinistra, dove diventano professionisti. In diversi trovarono canali facilitatori attraverso il Psi di Craxi. Involontariamente fedeli alla lapidaria definizione di Pier Paolo Pasolini (16 giugno 1968): “Perché voi siete borghesi e quindi anticomunisti”, ma non pochi trovarono una sponda anche attraverso quella parte del Pci che non aveva mai interrotto il dialogo con il movimento degli studenti. Il ’68 era stato un movimento di intellettuali in formazione e nel Pci c’era chi li considerava come “i comunisti che hanno studiato”. Poi il resto l’hanno conquistato con le loro forze, con una certa abilità, sapendo “muoversi come un pesce nell’acqua” (Mao Tse Tung), mettendo a frutto competenze e conoscenze (di cose e uomini) e incontrando in realtà ben poca resistenza. Un caso emblematico è quello di Roberto Briglia: da responsabile nazionale del servizio d’ordine di Lotta Continua e organizzatore di occupazione di case a Quarto Oggiaro, nel milanese a fondatore e direttore di Radio Popolare alla direzione di “Tempo Illustrato”, “Epoca” e “Panorama” per finire la carriera il 31 dicembre 2012 come direttore generale dei periodici Mondadori . Insomma, in nome della “meglio gioventù”, cadono uno per volta tutti i tabù editoriali. Ed oggi anche un buon sessantottino può ben scrivere, in contemporanea, sulla debenedettiana “Repubblica” ma anche sul berlusconiano “Panorama”. E’ una generazione, nata perlopiù fra il 1948 e il 1950, che da movimento si è fatta istituzione e che ora si sta preparando alla pensione o c’è già andata. Dalle biografie controverse, zigzaganti , incendiari diventati pompieri che, a volte, confermano quel che scrisse con sarcasmo il quotidiano conservatore inglese “Daily Telegraph” : “ i sessantottini volevano cambiare la società ma finirono solo col cambiare la casacca”. Un giudizio per alcuni certamente ingeneroso. Per altri, solo una constatazione. I nomi? Consapevole di far torto a molti, vado a volo d’uccello, ad elencare solo alcuni di quelli più noti, ancora fra noi, in rigoroso ordine alfabetico: Annunziata Lucia, Barbacetto Gianni, Capuozzo Toni, Crippa Mauro, Cucuzza Michele, Deaglio Enrico, De Luca Erri, Ferrara Giuliano, Lerner Gad, Liguori Paolo, Mieli Paolo, Mineo Corradino, Mughini Giampiero, Panella Carlo, Riotta Gianni, Rossella Carlo, Santoro Michele, Sgrena Giuliana,Sofri Adriano. Quale eredità? Finite le nostalgie dedite al ricordo e a quanto furono, almeno per alcuni, “formidabili quegli anni”, fra il fumo delle assemblee e le mani sporche di ciclostile , resta la necessità di un approfondimento su quale fu (se ci fu) il contributo del ’68 alla modernizzazione del sistema della comunicazione. Se cioè l’intento utopico “di una informazione orizzontale dalle masse alle masse” si è tradotto in qualcosa di diverso rispetto a un sistema dei media che tende a costruire il consenso o il consumo, confermando i cittadini in quel ruolo passivo che i sessantottini denunciavano. Una condizione di passività che, per alcuni, oggi è contrastabile con solidi anticorpi attraverso i new media. Sarà la Rete, come ottimisticamente auspicano i pentastellati, a contrastare l’apparato dell’“industria delle coscienze”, attraverso la critica al sistema dei media dominanti e concedendo a ognuno “la presa di parola” ? Oppure anche questa si rivelerà come l’ennesima utopia , ‘fedele’ allo slogan del maggio ’68 “ siate realisti, chiedete l’impossibile”? Giorgio Tonelli Nel ’68 non ero ancora nata ma tanti e tali sono le immagini, le storie, i film e i libri su quell’epoca mitologica, che potrei davvero esserci stata. E poi, forse, ci sono stata davvero quando, lavorando al mio documentario, mi sono immersa in quell’anno mirabile, leggendo e vedendo di tutto. Quegli anni sono stati un po’ come una giovinezza del mondo occidentale: il mondo vecchio era morto durante la seconda guerra mondiale, il mondo nuovo era passato dall’infanzia post bellica all’adolescenza post boom. Nel ’68 tutti erano giovani, o meglio tutti quelli che si facevano sentire, che urlavano la loro voce, che protestavano, manifestavano, scrivevano, giravano, cantavano erano giovani. Giovanissime, infatti, erano anche le protagoniste del documentario, non per nulla autodefinitesi Le più piccole del’68, che poi è il titolo del film che ho girato. Non solo erano giovani, quelle ragazze, ma anche incontaminate, dalla politica e dal grande mondo che fuori aveva cominciato a girare diversamente. Vivevano in un paesino, a quaranta chilometri da Roma, allora una distanza lunare. La loro lotta nasce come un gioco, una protesta immediata, un puntare i piedi di fronte ad un sopruso ingiusto del padrone: non concedere un permesso di due ore per farle partecipare alla festa del paese. Solo dopo, dopo la loro fuga in massa dalla fabbrica per cercare un pochino di felicità, diventa presa di coscienza, diventa opposizione all’ingiusto licenziamento di una compagna, diventa lotta per i diritti. Le operaie di Manziana, che non sapevano nulla di rivoluzione, che non avevano di certo letto sacri testi filosofici o i giornali d’ordinanza, cercavano di conquistare la loro felicità, quella felicità addirittura rivendicata come diritto nella costituzione americana. Mi sembra, ma potrei sbagliarmi, che nel ‘68 in quell’anno in cui ci furono anche violenze e morti, sono nati i giovani e la felicità, perché quei ragazzi, in modi diversissimi hanno cercato di rendere quel concetto astratto un fatto concreto, immediato, vitale, sperimentandolo attraverso l’azione, la liberazione mentale, sessuale e politica, anche attraverso l’estremismo e la violenza. Poi qualcosa si è perso… chissà dove sono adesso tutti quei giovani… Le “mie” ragazze, oggi, sono tutte belle persone, quasi felici, nonostante le botte che pur hanno preso nei 45 anni trascorsi dalla loro rivoluzione. Mi piacerebbe che il documentario, con i loro volti di ora e di ieri, potesse arrivare ai ragazzi, a chi adesso stenta a trovare la propria voce, e che dal ’68, da tutte quelle speranze e sogni e ideali e sbagli, trovasse la voglia e la forza, ancora di urlare il diritto ad essere felici. Elena Costa
Scaricare