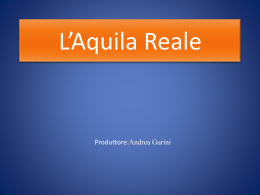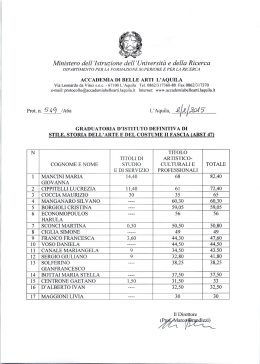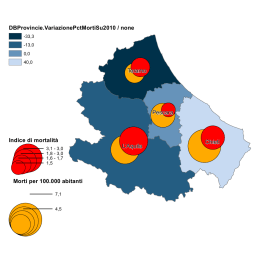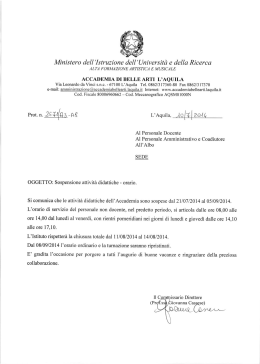Raffaele Colapietra Antimilitarismo e pacifismo in una città del Mezzogiorno dall’unità al fascismo* di Raffaele Colapietra Quando, il 1° aprile 1893, due giovani non ancora ventenni, l’orologiaio Francesco Donatelli ed il piccolo negoziante Cesare Falli, fondavano «L’Avvenire», che per un trentennio avrebbe rappresentato la tribuna della democrazia sociale e, ben presto, del socialismo all’Aquila, la presenza militare in città era già un dato di fatto strutturatosi nei precedenti trent’anni, quando dire dall’indomani immediato dell’unità d’Italia. Era stato infatti il 35° di linea, già nel novembre 1860, mentre la provincia era messa sottosopra dalla reazione e dal brigantaggio, a stanziarsi nel convento di S. Francesco, oggi convitto e liceo estremamente rimaneggiati, per allargarsi l’anno successivo a S. Domenico ed a S. Filippo, dove si sarebbe trasferito definitivamente, mentre la guardia nazionale si allocava a S. Bernardino e veniva requisito a scopo militare, nel febbraio 1861, il monastero delle Benedettine di S. Caterina Martire, sostituiti attualmente dai grandi edifici ecclesiastici e laici moderni tra via Sallustio e via Gaglioffi. Il “difetto assoluto” di una vera e propria caserma all’Aquila determinava nell’ottobre 1867 il primo episodio della vexata quaestio trascinatasi fino ai giorni nostri e cioè la requisizione del convento di S. Bernardino da parte dello Stato rilasciandosi al Comune solo l’ala settentrionale per alloggio dei frati, a cui successivamente si sarebbero aggiunti altri edifici già ecclesiastici più o meno rilevanti ed artisticamente pregevoli, i due conventi cappuccini, quello di S. Giuseppe alla Torretta adibito a polveriera e quello di S. Michele oggi sostituito dalle strutture regionali alla Villa, le chiese di S. Giusta e di S. Quinziano, e così via, con conseguenze gravi sia dal punto di vista culturale che da quello della mentalità collettiva, sottoposta ad un’invadenza soverchiante che non poteva non suscitare resistenze e malumori. * Le finalità latamente divulgative della pubblicazione nell’ambito della quale mi è stato richiesto il presente contributo mi hanno indotto ad eliminare le note ed a rimaneggiare in più punti le citazioni per renderne l’espressione più scorrevole e meglio aderente al linguaggio oggi in uso. Ne chiedo scusa agli addetti ai lavori che conoscono in merito la mia pedanteria. Essi vorranno anche rendere omaggio alla liberalità de «la Capitanata» e del suo direttore, l’ottimo e carissimo Franco Mercurio, che acconsentono ad ospitare questo testo, scritto nei giorni di Natale 2003 dal vecchio ed impenitente socialista, e perciò antimilitarista e pacifista, che è lo scrivente, perché richiestogli con somma urgenza demagogica e propagandistica dai movimenti che in proposito sono sorti e pullulati come funghi intorno alle note vicende internazionali, ma che come funghi si sono avvizziti ed estinti quando la parola è passata dalle piazze alle aule parlamentari ed ai salotti di partito e di televisione. Il sottoscritto è rimasto nella piazza. 137 Antimilitarismo e pacifismo in una città del Mezzogiorno dall’unità al fascismo Essi vennero alla luce per la prima volta con una certa vivacità nel marzo 1875, quando il 31° di linea aveva appena dato il cambio al 35°, allorché il sindaco Michele Iacobucci e l’assessore Francesco Cialente promossero il fitto per cinque anni all’autorità militare, che ben presto sarebbe diventato venticinquennale, a 1400 lire l’anno, dell’ospedale maggiore fiancheggiante S. Bernardino che solo nel 1883, peraltro, avrebbe ospitato l’infermeria presidiaria trasferitavi dal castello, le strutture ospedaliere essendosi trasferite alle Celestine di S. Agnese, primo nucleo di quello che sarebbe stato fino a ieri, dal vecchio nome dell’ospedale maggiore nel Quattrocento, il S. Salvatore. L’intrigantissimo Cialente, a cui si faceva risalire la responsabilità personale dell’occupazione militare per dieci mesi dell’insigne chiesa di S. Giusta con danni irreparabili al suo patrimonio artistico, si era giovato per l’ospedale “sia di mezzi ufficiali che di private raccomandazioni”, come denunziava a tutte lettere la «Gazzetta di Aquila» del 17 marzo 1875: e la mediazione ed il compromesso ovviamente prosperavano in una piccola città di meno di 15 mila abitanti in cui il commercio al minuto si alimentava con la vendita all’asta di migliaia di scarpe da parte del distretto militare ospitato a S. Filippo e centinaia di donne si applicavano alla confezione del vestiario delle truppe. Grandezza e miserie della vita militare sembravano del resto riflettersi efficacemente sulle pagine del «Fulmine» a poche settimane di distanza nell’estate 1876 dinanzi al riacutizzarsi della questione d’Oriente nella penisola balcanica che metteva ostilmente di fronte l’Inghilterra e la Russia, da un lato, il 10 giugno, l’auspicio che l’Italia faccia “ valere la propria influenza e la propria forza ponendosi dal lato della giustizia […] per affermare i suoi diritti” (è un discorso che ci accompagnerà a lungo), dall’altro, il 22 luglio, il suicidio di un povero soldato di Amatrice accusato di aver rubato un paio di lenzuola all’infermeria presidiaria. Era proprio Cialente il proprietario e direttore di quell’effimero giornale sorto in prospettiva delle elezioni generali di quell’anno: ma è significativo che l’ufficiosa «Gazzetta di Aquila» inaugurasse il 7 febbraio 1877 un suo Catechismo giuridico popolare, quanto dire un’illustrazione divulgativa dei doveri dei cittadini, con la difesa intransigente della leva militare obbligatoria, una novità, come è noto, per l’ex regno delle Due Sicilie e quindi anche per l’Abruzzo, ed a fine anno ospitasse gli articoli del tenente Luigi Pierantoni volti a difendere il grandioso programma di fortificazione di Roma contro le critiche che, a cominciare da Garibaldi, avrebbe voluto dare la precedenza alla bonifica dell’Agro. Se peraltro l’interessante serie di articoli purtroppo per anonimi che nell’estate 1878 illustrava per la prima volta al provinciale pubblico aquilano, e con sostanziale correttezza, i principi del marxismo in riferimento alla socialdemocrazia tedesca, non collegava affatto il tema all’internazionalismo proletario ed ai suoi risvolti pacifisti, un sussulto in merito poteva registrarsi a proposito della condanna a morte di Arcangelo Fucci, un disertore della provincia di Avellino che a Savona aveva ferito non gravemente un caporale. “Quella nazione - esplodeva la «Gazzetta di Aquila» 16 ottobre 1878 - che 138 Raffaele Colapietra considerasse interessante per la sua solidità la fucilazione di un soldato per lieve colpa [...] darebbe in verità misero spettacolo di sé [....]. Potrebbe allora con sicurezza affermarsi che l’esercito ha fatto il suo tempo e che fra non molto l’ultimo puntello dell’arbitrio e della forza cederà il suo posto al sistema grandioso degli arbitrati internazionali”. Due giorni prima, e lo si sarebbe letto all’Aquila il 2 novembre, si era riunita a Ginevra l’assemblea generale della lega internazionale per la pace e la libertà che aveva sconfessato il recente congresso di Berlino sulla questione d’Oriente perché rappresentante esclusivamente le grandi potenze (compresa l’Italia ) “disponendo senza consultarli dei popoli e dei territori che ad essi appartengono” sicché in tal modo “invece di assicurare la pace non ha fatto che preparare nuove guerre”: ed il 6 novembre era la volta di una lettera di Garibaldi auspicante la sostituzione della nazione armata di tipo svizzero all’esercito permanente, un’impostazione che veniva ripresa dal giornale il 29 gennaio 1879 nonostante l’irrigidimento autoritario e repressivo che in tutta Italia aveva provocato l’attentato Passanante del 17 novembre a Napoli contro il re, donde anche all’Aquila grida di morte agli assassini ed all’internazionale operaia che si accusava mandante dell’attentato medesimo (ma non mancava chi ci scorgesse, altrettanto a torto, i clericali). Ed è in proposito molto istruttivo il commento che il 19 marzo successivo la «Gazzetta di Aquila» dedicava alla proposta, venuta fuori a Berlino dai banchi liberali del Reichstag, di un congresso internazionale per il disarmo, a cui essa si dichiarava contraria opponendole “l’abolizione della caserma e la militarizzazione della gioventù nella scuola” cioè, appunto, la nazione armata e l’istruzione militare di tipo prussiano, pur concordando nell’analisi di base (“Noi comprendiamo che gli armamenti strepitosi della moderna Europa ci conducono alla rovina […] né è possibile che l’erario si esaurisca in queste spese che nulla rendono né producono alcunché”): ed in che consistesse, o potesse consistere, la rovina era espresso senza mezzi termini il 15 ottobre da Giorgio Gualdi (“La vera, terribile questione sta in ciò: che dietro una conflagrazione generale appare minacciosa la guerra sociale!”). La proposta di disarmo sarebbe stata ripetuta al Reichstag e formalmente respinta donde un commento 14 aprile 1880 della «Gazzetta di Aquila» che se ne indignava ritenendo che “proposta più giusta, più ragionevole, più opportuna per i nostri tempi, nessuno che abbia sentimento umano potrebbe concepire” e facendo in merito significativamente l’esempio degli Stati Uniti dell’epoca “che pensano alle arti della pace a tal punto da inondarci dei loro prodotti e delle loro industrie” a differenza della vecchia Europa “che ha tante parole di compianto e di umanità allorché si sente un attentato a qualche monarca, e contempla poi con compiacenza tutte le opere di distruzione, e non è mai sazia delle innocenti vittime che a migliaia getta nella catastrofe della guerra” (il riferimento polemico è agli attentati del 1878 in Italia e in Germania ma soprattutto a quelli russi contro lo zar Alessandro II che ne sarebbe rimasto vittima nel marzo 1881). Non solo: ma la disoccupazione dilagante in Germania suggeriva l’8 luglio un commento severissimo su quella nazione che “ha creduto di farsi prospera e 139 Antimilitarismo e pacifismo in una città del Mezzogiorno dall’unità al fascismo forte sostituendo l’arsenale all’officina, il cannone all’aratro, il soldato all’operaio, la strategia alla letteratura: errore che la Germania sconta oggi colle miserie del suo popolo e potrebbe scontare un giorno anche con la sua esistenza”, l’ombra del 1918 e del 1945, insomma, che sembra delinearsi sinistramente con tanti decenni di anticipo: e Medoro Savini, il battagliero giornalista e deputato progressista napoletano, incalzava il 21 luglio: “Il popolo non vuole la guerra, esso vuole vivere e sa che solamente il lavoro e la pace gli procacciano l’esistenza [...]. Dappertutto proteste di pace e preparativi di guerra […] E la diminuzione dei salari? E l’emigrazione degli agricoltori? E i capitali che si nascondono presi da timor panico? Questo turbamento generale, questa crisi economica, massima fonte di tutti i mali sociali, non può cessare se l’Europa non è sicura di una lunga pace”. Ed anche quando il male sociale esplodeva in Russia con l’accennata uccisione dello zar, la «Gazzetta di Aquila» non perdeva la testa e rimaneva ferma all’esigenza dell’analisi e della critica della situazione (“Il terrorismo va studiato e combattuto, e non relegato alla leggera fra le aberrazioni e fatto segno a facile riso” - 5 aprile 1881). Com’è purtroppo noto la crisi di Tunisi avrebbe di lì a poco improvvisamente condotto al diapason la febbre belligera nei confronti della Francia (“Forse la nazione è compromessa [...]. All’insulto deve darsi una conveniente risposta” - 9 aprile 1881 - “Noi non chiediamo la guerra [...] ma se fatale necessità la richiedesse sarà sempre preferibile ad una passiva rassegnazione” - 19 aprile 1881) senza che peraltro ciò influisse sulla contemporanea indagine intorno al terrorismo nichilista russo “idea nata da animo esaltato ma generoso” quando avesse “ristretto i suoi sforzi ad ottenere la libertà politica” (21 aprile 1881) senza ovviamente i risvolti sociali rivoluzionari che già all’epoca echeggiavano sullo sfondo. Il riarmo rimaneva comunque all’ordine del giorno e con esso la guerra alla Francia che il 28 giugno non si esitava a dare per estremamente popolare “e l’annunzio ne sarà accolto con un generale grido di entusiasmo e con l’accorrere spontaneo e generale di ogni cittadino sotto le bandiere”. Le cose non andarono così, per fortuna, alla guerra sostituendosi ben presto la confortante prospettiva dell’alleanza con Germania ed Austria Ungheria che nella primavera 1882 avrebbe condotto alla Triplice: e la piccola Aquila poteva tornare alla sua pacifica convivenza ordinaria con i militari di guarnigione, il 59° di linea che aveva dato il cambio ai suoi predecessori, le riviste al largo del castello, la banda in piazza ed alla Villa, le manovre tra le colline di Collebringioni e la piana di Preturo, tutt’al più la propaganda protestante fra i soldati che nell’estate 1878 aveva dato ai nervi all’arcivescovo Filippi ma poi, due anni più tardi, la partecipazione del clero al finto attacco notturno al castello, che concludeva le grandi manovre a mo’ di show e passatempo, in prima fila, ed ufficialmente, tra gli spettatori, la restituzione al culto della chiesa di S. Filippo che avrebbe fatto poi la lunga triste fine ben conosciuta. Certo, non mancavano le ombre del coscritto morto all’ospedale per misteriose percosse o del caporale suicidatosi al castello o del tenente suicidatosi anche lui “per onore e dovere” sì da meritare che il suo reggimento, il 68°, gli rendesse 140 Raffaele Colapietra onori militari col colonnello in testa («Gazzetta di Aquila» 26 e 31 gennaio 1882, 17 gennaio 1883) quello stesso colonnello Ronza che metteva agli arresti l’onesto sergente che aveva deposto a favore degli studenti e contro la forza pubblica in occasione dei tumulti per l’impiccagione di Guglielmo Oberdan, un’informazione 14 e 28 gennaio 1883 che prendiamo dal giornale che si era nel frattempo affiancato alla «Gazzetta di Aquila» in funzione più o meno dissidente, «Il Popolo Vestino». Quanto alla politica generale, peraltro, la svolta militarista si rendeva progressivamente irreversibile se è vero che il 2 maggio 1882, proprio nei giorni di stipulazione della Triplice, si poteva leggere sulla «Gazzetta di Aquila» che “se per completare il nostro armamento abbisognano denari, non si guardi alle esigenze di bilancio né si faccia della questione dell’esercito una questione di bilancio”: un appello che il 16 maggio assumeva tinte pericolosamente ideologiche col sottolineare che “il diritto non è una nuda teoria ed invece quasi sempre diventa la nuda espressione della forza materiale”. I ricordi del Risorgimento erano peraltro ancora abbastanza vivi perché, nel luglio successivo, il giornale si schierasse fermamente a difesa, in nome del principio di nazionalità, dell’indipendenza dell’Egitto contro il bombardamento inglese di Alessandria ed il “sentimento simulato di raccapriccio” che ipocritamente si era diffuso in proposito a Londra ed a Parigi per un’iniziativa che aveva “demeritato della stima del mondo civile” assumendosi “il facile compito di civilizzare col ferro e col fuoco un popolo [...] che ha il diritto di essere padrone in casa propria” mentre l’Italia “deve prendere le parti del più debole e dell’oppresso, ristabilire l’ordine in Egitto ma poi ridonargli la sua autonomia” e tutto ciò senza adoperare “le circonlocuzioni d’incivilimento e di sentimenti umanitari”. Le elezioni generali dell’ottobre 1882, le prime a suffragio allargato, avrebbero tolto attualità a questa significativa prospettiva di politica estera, mentre l’apertura della ferrovia per Roma attraverso Rieti e Terni, giusto un anno più tardi, avrebbe contribuito a rilanciare l’infatuazione militarista in chiave urbanistica, i monasteri celestini di S. Basilio e della Maddalena (sostituito in epoca fascista dall’ex liceo scientifico) da mettere a disposizione dell’autorità militare per fare dell’Aquila un caposaldo strategico a protezione della capitale, solo nell’estate 1883 il problema del reclutamento collegandosi con quello dell’incipiente emigrazione nella penisola balcanica come qualche cosa da mettere seriamente all’ordine del giorno, quanto meno a fianco delle consuete utopie sull’Aquila stazione climatica estiva, ora più che mai di moda col collegio militare prossimo ad inaugurarsi a Roma e con la ferrovia che rendeva relativamente agevole per i collegiali la vacanza abruzzese. Sarebbe stata la politica coloniale, con la spedizione di Assab ai primi del 1885, a riproporre sul tappeto la questione militare in una chiave nuova e più che mai pericolosa, dal momento che, osservava il 14 maggio la «Gazzetta di Aquila», “tutti ci siamo domandati che cosa faranno laggiù i nostri fratelli e figli, che pur costeranno alla nazione immensi sacrifici di sangue e di denari” il consueto avventurismo confidante nello stellone d’Italia, insomma, e magari il compiacimento, nell’estate 1886, per la militarizzazione del convitto nazionale, uno dei cinque in 141 Antimilitarismo e pacifismo in una città del Mezzogiorno dall’unità al fascismo Italia, promossa dal generale Marselli deputato di Pescina e segretario generale o sottosegretario al Ministero della Guerra. Una serie di crisi periodiche avrebbero a questo punto progressivamente cancellato il vecchio foglio crispino di Tito Fabi dalla carta del giornalismo cittadino: ma uno dei suoi ultimi numeri, 31 luglio 1890, ci è prezioso per intendere l’impasse pressoché insolubile in cui la politica coloniale così sbadatamente intrapresa era andata a cacciarsi (“Ora si tratta di fare il possibile per trar partito dall’Eritrea che bene o male ci pesa sullo stomaco”) non senza che il 28 agosto la riduzione della ferma venisse proposta come uno dei mezzi più idonei a non far crescere a dismisura il già pesantissimo bilancio militare. E tuttavia, prima che le elezioni generali spazzassero via definitivamente la «Gazzetta di Aquila» con la sconfitta del suo candidato Ludovico Fusco, abbiamo modo il 9 novembre di leggere una difesa d’ufficio della Triplice “unico e indispensabile elemento di pace nel continente europeo [...] colosso che preclude la via a qualunque velleità guerresca”, l’equilibrio del terrore, insomma, di cui tanto si è sentito parlare negli ultimi decenni fino alla caduta del muro di Berlino, e che liquida una volta per sempre, allora come oggi, “le splendide dissertazioni umanitarie ed il dottrinarismo fantastico dell’arbitrato internazionale”. Abbiamo già avuto modo d’incontrare il «Popolo Vestino», fondato nel capodanno 1881 con sfumatura di opposizione rispetto alla ministeriale «Gazzetta di Aquila», e ne dobbiamo ora rilevare il bellicismo oltranzista in occasione della crisi di Tunisi ma anche la freddezza nei confronti della ventilata stipulazione della Triplice (“La migliore alleanza [...] è quella che i governanti debbono stringere col popolo. Oggi l’armonia tra il popolo e il governo non esiste” - 7 gennaio 1882) e, diremmo di conseguenza, la simpatia per il principio di nazionalità affermatosi in Egitto e l’attenzione alla lega internazionale della pace e della libertà che già conosciamo e che nel settembre 1882 a Ginevra metteva all’ordine del giorno la neutralizzazione dei canali di Suez e di Panama, ma forse soprattutto, il 19 novembre successivo, quella all’assoluzione di un militare che stava scontando 18 anni di reclusione e che, esasperato da una vita intollerabile, aveva insultato i superiori all’espresso scopo di farsi fucilare, come infatti era stato richiesto dal pubblico ministero. L’evoluzione repubblicana del giovane Orazio D’Angelo, che da Brescia procurava la collaborazione di Ernesto Pozzi, il vecchio mazziniano Mario Aldisio Sammito che scriveva dalla Sicilia, l’indipendenza di Giuseppe Cecchini, tutto ciò spostava sempre più a sinistra l’orientamento del giornale, con riflessi, ovviamente, anche sul tema che ci interessa, la guerra, ad esempio, che la Francia si accingeva a combattere nel Tonchino, l’odierno Vietnam, e nella quale “ha contro di sé il clima, il territorio, le masse imponenti, il fanatismo e l’ostinazione di chi difende la propria casa” (9 dicembre 1883). Nessuna meraviglia pertanto che il 24 agosto 1884 sotto il titolo Vita di caserma si dedicasse l’intera prima pagina ad un elenco di recenti suicidi nell’esercito ed in genere a violenze imperversanti nell’ambito militare, concludendo come se142 Raffaele Colapietra gue il relativo commento: “È bene che certi fatti condannati dal mondo ufficiale a rimanere nel buio, perché sconci e ributtanti, ricevano invece l’ingrata sorpresa di un raggio di luce: e per carità di patria auguriamoci che almeno qualche commento si faccia intorno alla muta carneficina che lentamente ed in mille modi si compie sulla parte migliore del nostro popolo” (e tuttavia anche da questi democratici la militarizzazione del convitto nazionale dell’Aquila sarebbe stata accolta positivamente a mezzo tra la nazione armata e l’esempio prussiano, con un’ambiguità pericolosa e destinata a durare). “Se si vuole che l’esercito resti - aveva scritto il «Popolo Vestino» il 13 gennaio 1884 inaugurando con La tortura nei reclusori la serie conclusa con Vita di caserma - bisogna saperlo armonizzare coi tempi, colla cresciuta cultura della gioventù e col maggior sentimento della dignità e del diritto individuale”: e questa rimaneva l’eredità più apprezzabile del settimanale che l’esito disastroso per esso delle elezioni generali del 1886 condannava a scomparire. Ma, dopo la battagliera intransigenza dell’arcivescovo Filippi, una nuova voce si era levata nel frattempo dal mondo cattolico con l’aquilano Augusto Antonino Vicentini, chiamato a succedergli nella primavera 1881 e che due anni più tardi aveva dato vita a “La Palestra Aternina”, una delle tante forme in cui l’egemonia cattolica si riaffermava in città in prospettiva politica di conciliazione con lo Stato liberale ed in chiave squisitamente culturale. È ad essa che si richiama l’articolo inequivocabile Pace e guerra - Note contemporanee che nel dicembre 1886, all’indomani della fine del «Popolo Vestino», il giovanissimo caporedattore della rivista, il sacerdote Carlo Pietropaoli, firma in mezzo agli universali “timori di una tremenda catastrofe [...] guerra (che) nelle presenti condizioni degli Stati è diventata quasi inevitabile [...] non si aspetta che una parola ed un grido [...] lo scoppio dell’incendio è questione di giorni” e così via di seguito, in uno scenario apocalittico che le complicazioni balcaniche rendevano tutt’altro che immaginario o inattuale. Ovviamente la responsabilità di tutto ciò non poteva che spettare alle “perverse dottrine antireligiose” donde l’abbastanza semplicistica esortazione conclusiva a “tornare a Gesù Cristo”: né da tale semplicismo si discostava sostanzialmente la lettera pastorale che lo stesso arcivescovo Vicentini diramava il 20 febbraio 1887 nel nono anniversario dell’elezione di papa Leone XIII ed in vista della solenne celebrazione della pace che il pontefice aveva indetto per lo stesso anno, nella ricorrenza del proprio giubileo sacerdotale. Ma a quella data era già avvenuta in Africa, a Dogali, la strage della colonna De Cristoforis con oltre cinquecento morti, ed è qui che il Vicentini assume un ruolo assolutamente protagonistico, con l’allocuzione pronunziata il 26 febbraio, anziché in cattedrale, nella chiesa “civica” di S. Bernardino, il “sentimento di raccapriccio e di orrore” ben presto trasformatosi in “argomento di ammirazione e di orgoglio” per gli eroi che avevano dato vita alle “nuove Termopili” nel combattere “con le iene ed i leopardi in umane sembianze” e nel morire “per l’onore del proprio paese e per incivilire quei barbari” col conforto peraltro della religione cattoli143 Antimilitarismo e pacifismo in una città del Mezzogiorno dall’unità al fascismo ca che in quelle terre sarebbe stata diffusa dai missionari “precursori sempre di civiltà ed araldi di pace”, pace ai morti, s’intende, non alla “terra maledetta” dei negri che dovrà essere benedetta dai bianchi per affrettare “il trionfo della Fede e della civiltà, della Religione e della patria”, la spada e la croce, in poche parole, senza che degli abissini si faccia una più o meno fraterna parola e senza soprattutto che la pace dipenda se non dalla vittoria delle armi. È evidente che su questa strada non c’è molto da procedere sul terreno di un autentico pacifismo o quanto meno rispettosa valutazione dell’alterità con cui il colonialismo va spietatamente a misurarsi: e lo conferma nell’agosto 1888 il Pietropaoli quando, in occasione di un ennesimo disgraziato incidente in Africa, rifiuta bensì “il venir fuori colle solite frasi di eroismo, di dovere compiuto, di patria e simili” ma ad esse non sa contrapporre se non “fatti che riparino l’onore d’Italia così vilipeso” e la morte di giovani “traditi da un pugno di barbari”, col che il problema è semplicemente spostato e rimane irrisolto, a non parlare dell’ottobre successivo in cui lo stesso Pietropaoli non sa concludere uno scritto dal titolo suggestivo La pace armata che con una sorte di reiterata maledizione ideologica “Avete voluto bandire dal consorzio umano Iddio ed egli vi ha tolto la pace”. E l’argomento, già prima della scomparsa del Vicentini nel settembre 1892, e con lui della rivista, si attesta in pratica, nell’agosto 1889, col ribadimento, da parte sempre di Pietropaoli, di una linea particolare che ormai ci è divenuta familiare: “L’Italia si riabbracci sinceramente colla Chiesa: ed allora, ma allora soltanto, noi potremo attendere allo stabilimento dei nostri possessi africani ed il soldato italiano marcerà a fianco del missionario cattolico, e le conquiste dell’uno saranno benedette e consacrate dai trionfi dell’altro”. Nel campo che a questo punto possiamo chiamare genericamente laico «Il Risveglio» aveva preso nel frattempo il posto del «Popolo Vestino» con sfumature di dissidenza nei confronti dell’ufficiosa «Gazzetta di Aquila», salvo ben presto sostituirsi praticamente ad essa nell’infuocata atmosfera polemica, e soprattutto elettorale, che avrebbe contraddistinto questo scorcio di fine secolo, tra l’altro con la fioritura e l’irrequietezza di nuovi giornali, tra i quali «L’Avvenire» a cui torneremo fra breve. In tale stato di cose, col prevalere irrefrenabile del localismo, non ci si può meravigliare che i grandi temi culturali e civili vengano di massima accantonati, con l’eccezione vistosa del comizio per la pace e l’arbitrato internazionale che nel 1890 si volle far coincidere, al teatro comunale, con la festa eminentemente laica del 20 settembre ed affidare ad un oratore d’eccezione come Enrico Ferri, all’epoca già deputato radicale nella nativa provincia di Mantova ma noto soprattutto, s’intende, per le novità dirompenti introdotte da lui nell’ambito dell’antropologia criminale e del diritto penale. Il discorso di Ferri, che «Il Risveglio» ospita il 28 settembre, fa centro su un’affermazione capitale: “La nostra non è tanto una propaganda a favore della pace quanto direttamente contro la guerra” cronica, quest’ultima, quando si chiama pace armata, ma accettabile se difensiva nel presupporre “il supremo dovere di prendere le armi contro un ingiusto invasore” (ma il pastore protestante Vincenzo 144 Raffaele Colapietra Caressa, che prendeva la parola dopo Ferri, non esitava ad affiancare alla difensiva la guerra “per liberare i nostri fratelli irredenti”, mentre il deputato Alfonso Palitti osservava che “la pace scompagnata dal progresso economico non giova al paese”). Tutta la manifestazione s’impantanava dunque in quest’equivoco di fondo che toglieva vigore anche all’analisi approfondita che Ferri compiva della guerra “cronica” o pace armata, dalla polemica asperrima contro la vita di caserma a quella sulle spese militari ormai insostenibili con 24 milioni di soldati di prima linea o di riserva ammassati in tutta Europa, donde l’esigenza di un disarmo graduale e proporzionale, e di una propaganda relativa alla quale Ferri chiamava significativamente anche le donne. Ma c’era stato nel frattempo un giovane non ancora ventenne, il nipote dell’arcivescovo Filippi venuto dalla nativa Basilicata a completare all’Aquila gli studi liceali e ad inaugurare da protagonista giornalistico e culturale in città l’ultimo decennio del secolo, Silvio Spaventa Filippi, il futuro prestigioso collaboratore del «Corriere della Sera» ed inventore del «Corriere dei piccoli», che nell’aprile 1890 aveva già inventato il primo settimanale moderno della cronaca giornalistica aquilana, «La Campana Abruzzese», fin nel titolo richiamante le testate dell’emigrazione rivoluzionaria russa, che già il 10 maggio si era occupata anche essa della pace armata che “ci immiserisce di giorno in giorno più profondamente e ci conduce all’abisso”: e il 23 agosto, prendendo spunto dalle grandi manovre in corso in Lombardia, aveva stigmatizzato “la noncuranza dei nostri governanti riguardo al malessere ed alla crisi che affligge l’intera nazione. Essi, tutti assorti nei loro sogni megalomani, non curano i bisogni ed i voti del popolo, o li disprezzano”. A differenza di quanto abbiamo letto fin qui, comprese le ambiguità di Ferri, Spaventa Filippi teneva fermi i diversi aspetti che si connettevano logicamente nella politica internazionale, il 30 agosto bollava “come pazza e disastrosa” ogni prospettiva di espansione coloniale, scorgeva l’11 ottobre in tutta l’Europa “il fermento della democrazia cooperativa e del socialismo pratico, che si preparano a raccogliere l’eredità del militarismo, alimentato dall’ipocrisia della pace”, deplorava il 14 dicembre, dopo aver combattuto vittoriosamente una campagna elettorale di opposizione al Ministero Crispi, l’assenza di riduzione nel bilancio militare “l’unico dove sarebbero possibili le economie” (e se ne compiaceva quando queste cominciavano ad esserci, nel febbraio 1891, col nuovo gabinetto Di Rudinì), prendeva spunto il 12 marzo dagli scandali sanguinari e truffaldini venuti alla luce in Eritrea per rifiutare “la civiltà a colpi di cannone e a forza di usurpazioni” che si pretendeva d’imporre in Africa a popoli “insofferenti di ogni giogo” dimenticando tra l’altro “che fra noi la civiltà lascia ancora molto a desiderare”. Vale la pena di osservare, a questo punto, da un lato che «Il Risveglio» 15 marzo 1891 si allinea in proposito senz’altro a «La Campana Abruzzese» (“Non si risparmiò la retorica, non si trascurò di citare la storia [...] si profusero milioni che non c’erano nella speranza troppo vaga ed indeterminata di raccogliere tesori in tempo più o meno lontano [...] la colonia fu abbandonata nelle mani di gente indegna”) dall’altro che il nuovo settimanale, se giornalisticamente era animato da Spa145 Antimilitarismo e pacifismo in una città del Mezzogiorno dall’unità al fascismo venta Filippi e da altri giovanissimi aquilani, era promosso e diretto da Bernardino Vecchioni, l’intelligentissimo futuro editore che già allora stampava per i cattolici «La Palestra Aternina», a testimoniare una larga convergenza dell’opinione pubblica cittadina sul tema che attualmente ci interessa. Senza dubbio “le alte quanto misteriose ragioni della politica internazionale”, per dirla con «La Campana Abruzzese» del 26 marzo, impedivano quella che sarebbe stata la soluzione logica, il ritiro assoluto dall’Africa, in una visione solidaristica tra i popoli che era quella stessa che il 17 maggio induceva «Il Risveglio» a denunziare con forza la persecuzione degli ebrei imperversante in Russia ed in una prospettiva antimilitarista che il 2 aprile aveva fatto auspicare da Spaventa Filippi la fine della militarizzazione del convitto accolta all’Aquila, come si è visto, con tanto fervore, e che in effetti non si sarebbe fatta attendere troppo, non mancando il 12 giugno la sua voce in merito alla persecuzione degli ebrei. Si viene comunque nell’Aquila 1891 a delineare e strutturare una piattaforma larga ed omogenea ancora una volta contro la pace armata ed in favore dell’arbitrato internazionale («La Campana Abruzzese» 23 luglio) ma anticipante anche quella che vedremo essere un tipica tematica socialista e che il 13 agosto il giornale riassume col mettere alla berlina “l’errore di credere che l’esercito abbia diritto all’inviolabilità [...] ed il pregiudizio di credere che l’esercito non si possa e non si debba discutere, quasi che avesse diritto ad una certa infallibilità” (Spaventa Filippi è peraltro passato nel frattempo fin dall’aprile 1891 a collaborare ad un altro giornale più polemico in senso localistico «La Bandiera», sicché la piattaforma si sfrangia proprio mentre sembrava aver conseguito un’ampissima presa sulla pubblica opinione). Non a caso la sconfitta nelle elezioni generali del 1892 avrebbe procurato non solo il funerale simbolico ma anche la fine effettiva de il «Il Risveglio» («La Campana Abruzzese» era scomparsa col nuovo anno): e, quanto a «La Bandiera», se il 7 giugno 1891 si sarebbe spinta a riconoscere, essa sola, “la necessità di un’immediata liquidazione” della politica coloniale, il via dall’Africa! ed il “né un uomo né un soldo” di Andrea Costa e dell’intransigente polemica socialista, le accennate bufere municipali avrebbero fatto ritardare di giusto un anno (22 maggio 1892) la ripresa della tematica antimilitarista, ben presto annacquata e dissolta dall’appoggio prestato dal giornale alle candidature ministeriali nelle accennate elezioni del novembre 1892, la pace garantita dalla Triplice, gli armamenti indispensabili per garantire l’occupazione operaia, silenzio sull’Africa, sicché anche il ritorno al mito della nazione armata, con cui “bisognerebbe rinunziare ad ogni idea di espansione in Africa, alle guerre dinastiche, a tutto ciò che non è difesa del paese contro lo straniero” (13 maggio 1893) appare piuttosto una fuga in avanti che non una prospettiva concreta. A quella data, l’abbiamo visto in esordio, era apparso «L’Avvenire» a colmare un vuoto che la straordinaria abilità tecnica e letteraria di Spaventa Filippi non era più in grado di dissimulare: ed il processo per ingiuria che nel settembre 1893 vedeva condannato Donatelli nonostante la difesa di un gran nome dell’estrema sinistra repubblicana come il forlivese Antonio Fratti stava lì a dimostrare che que146 Raffaele Colapietra sti giovanissimi coetanei non avevano più nulla da dirsi e che ciascuno prendeva la propria strada. Cesare Falli aveva assunto “libertà e lavoro” come bandiera de «L’Avvenire» “organo dei lavoratori abruzzesi” senza parlare espressamente di pace: ma già il 28 maggio 1893 il nono numero del settimanale veniva sequestrato per incitamento all’odio di classe fra il popolo ed i militari mediante la noterella Le prodezze dei nostri ufficiali - La protesta delle società cittadine che, riprendendo le critiche alla “mania di persecuzione” dilagante tra gli ufficiali del 7° bersaglieri accasermato a S. Filippo, tra l’altro con le inumane fatiche ed i frequenti malori a cui le marce forzate sottoponevano i soldati, faceva la cronaca degli incidenti verificatisi per l’eccesso di galanteria degli stessi ufficiali nei confronti delle ragazze del popolo, i fischi, i tafferugli sotto i portici, l’aggressione a Donatelli ed il suo ferimento, la solidarietà espressa ai manifestanti dalla Società Operaia, il compattamento oltranzista che le si contrapponeva, il sindaco Mariano Iacobucci con un manifesto, «La Bandiera» con l’accennata schermaglia, Alfonso Vastarini Cresi e Federico Colajanni, deputati rispettivamente dell’Aquila e di Cittaducale, addirittura con un’interrogazione parlamentare che si sarebbe discussa il 30 maggio. Tutto ciò, e la relativa inchiesta, che veniva affidata, anche qui significativamente, a un generale di divisione, stava ad indicare che, ponendosi sul piano del costume, i socialisti avevano visto giusto, avevano scoperto che l’imperatore è nudo, per dirla in una battuta, avevano smontato la retorica e smascherato l’artificio di tutta una gigantesca costruzione egemonica d’immagine come l’esercito, l’amor patrio, l’onore militare. Non a caso a Montecitorio se il generale Pelloux ministro della Guerra e lo stesso interrogante Colajanni riducevano l’episodio a provocazioni gravi nella forma ma irrilevanti nella sostanza da parte di “ragazzi in questo momento un po’ traviati i quali [...] possono tornare sul retto sentiero”, Pietro Rosano sottosegretario all’Interno cercava di far passare quei ragazzi per clericali borbonici nemici dell’unità nazionale e perciò spregevoli e triviali in un’attività che si riduceva a “una profanazione della stampa ed un attentato contro l’ordine e la moralità, contro i quali tutti gli uomini che sentono altamente del proprio decoro e del decoro del proprio paese dovrebbero unirsi in una lega, per impedire almeno col disprezzo che essi vengano alla luce”. Squadrate così le parti con estrema nettezza e chiarezza, Ciò che costa il militarismo di Italo Tempestini il 14 luglio 1893 o Militarismo di Derby il 18 marzo successivo non fanno che ribadire rilievi già noti, in uno stato di cose dominato essenzialmente dai problemi interni dell’autoritarismo crispino, dei fasci siciliani e degli stati d’assedio, e perciò da un’esigenza assillante di libertà prevalente su quella di pace, alla quale si affianca sempre comunque la rivendicazione della “dignità personale dei poveri soldati, costretti a subire in silenzio le umiliazione più turpi”, la nota morale di costume tipica dei socialisti per affinità con quella attinente in genere al lavoratore che il 24 maggio 1894 si rinviene ancora ne L’educazione nazionale nell’esercito che si denunzia del tutto manchevole e controproducente. 147 Antimilitarismo e pacifismo in una città del Mezzogiorno dall’unità al fascismo Giusto un anno più tardi, infatti, il 16 maggio 1895, in occasione delle elezioni generali in cui per la prima volta si presentava all’Aquila una candidatura d’estrema sinistra, alla quale ovviamente aderivano i socialisti, quella di Camillo Camerini, non si poteva leggere nel suo programma che “riduzione nei bilanci militari ed abbandono della rovinosa politica coloniale”, niente di più vago e generico e già noto, insomma, per un problema che all’epoca, strategicamente parlando, aveva perduto gran parte della sua attualità. “Di tutta questa gloria noi moriremo consunti” si era limitato a dire ironicamente Camerini nel suo comizio elettorale: ma la guerra d’Africa, com’è noto, avrebbe ben presto soverchiato su ogni altro argomento, e con essa la sensibilità attualissima ai temi che c’interessano, al di là del comprensibile sbandamento determinato dall’elezione trionfale del candidato ministeriale Gennaro Manna che aveva tra l’altro indotto a sfumare la testata con «L’Avvenire della democrazia» sopprimendo l’impegnativo sottotitolo. Nell’estate, nel luglio 1895, la scomparsa di Carlo Arrigo Ulrichs aveva fatto rinverdire il ricordo pacifista legato all’estremo liberalismo romantico di quell’insigne latinista, una delle cui corone funebri era stata non a caso offerta dai giovani socialisti aquilani: e le grandi manovre del successivo settembre, alla presenza dei Reali, sembravano poterne rappresentare una sorta di chiaroscuro, reso più torbido dal suicidio del tenente Mencacci per sfuggire alle persecuzioni di un superiore e dalla notizia della condanna a nove mesi di reclusione a Massaua per un altro tenente che aveva esaltato il ruolo di Mazzini e Garibaldi nel Risorgimento italiano (“Si tratta di tutto un sistema - commentava «L’Avvenire della democrazia» 15 settembre 1895 - L’esercito in Italia è una istituzione esclusivamente monarchica [...] si fabbrica la storia secondo il tornaconto delle vigenti istituzioni”). Ma la storia incalzava concretamente dall’Etiopia e dall’ecatombe di Amba Alagi che il 15 dicembre faceva saldare i momenti ideologici del diritto di nazionalità e dell’antimilitarismo col condannare “conquiste rovinose che sono la violazione più aperta e brutale degli ideali nobilissimi in nome dei quali l’Italia assurse a dignità di nazione [...] imprese volte unicamente a rafforzare il militarismo, che il pensiero positivo ed illuminato dei tempi nuovi tende ad eliminare inesorabilmente”. Ideali e pensiero, dunque, una nuova scienza ed una moderna filosofia, che col capodanno 1896 convergevano in una conclusione lapidaria: “Qualunque notizia rechi il telegrafo, i proletari d’Italia, rispetto all’impresa africana, sono sempre, e non possono che essere, i vinti”: ed il numero dell’Epifania aggiungeva un nobile intervento di Napoleone Colajanni: “E un saluto lo mandiamo anche ai poveri ascari, morti in difesa di una causa non propria, e che per nostra vergogna abbiamo istruito alla civiltà occidentale, educandoli al tradimento della patria”. Ma l’equivoco politico post-elettorale tagliava le gambe al giornale proprio alla vigilia di Adua: e quando esso risorgeva, il 13 settembre 1896, significativamente col titolo e sottotitolo primitivi, “Via dall’Africa!” campeggiava in prima pagina contro “questa bassa ed iniqua speculazione borghese escogitata come diversivo alle difficoltà della politica interna italiana, per risvegliare dalla ignoranza delle masse 148 Raffaele Colapietra gli istinti bestiali della guerra ed addormentare il sentimento delle giuste loro rivendicazioni sociali”. Veniva dunque a delinearsi per la prima volta, e compiutamente, una schietta piattaforma socialista, riflessa nella rubrica di deliberati, avvisi e convocazioni che comincia ad apparire con una certa frequenza in riferimento al partito che va organizzandosi come tale, qui la funzione di classe dell’esercito stigmatizzata da Alfredo Bertesi, eletto deputato a Carpi proprio contro il figlio di uno dei più famosi generali risorgimentali, Manfredo Fanti, nella conferenza tenuta al circolo socialista di via Accursio ed introdotta dal diciannovenne Emidio Lopardi («L’Avvenire» 29 novembre 1896 ), lì, il 21 febbraio 1897, in campagna elettorale, la denunzia di Manna come uno dei “folli responsabili” della “grande sciagura” della guerra d’Africa in nome di “quel militarismo che ieri fucilava i contadini di Sicilia”, Francesco Donatelli che va a combattere a Creta insorta contro il dominio turco in nome del principio di nazionalità che un solenne conservatore cattolico come Vincenzo Gentile non esita ad illustrare con eloquenza all’Aquila, Oddino Morgari, appena eletto deputato di Torino, che viene a celebrare il 1° maggio in nome dell’internazionalismo proletario. Anche in questo periodo, peraltro, i problemi dell’organizzazione e della tattica elettorale del partito prevalgono a tal punto che nel primo congresso socialista abruzzese tenuto a Pescara il 28 novembre 1897 di pace e di militarismo non si fa minimamente parola, pur conferendosi a «L’Avvenire» il titolo di organo regionale dei socialisti abruzzesi che tuttavia, lo ripetiamo, non sono interessati dopo l’Africa e Creta a mantener viva la specifica attenzione al nostro tema. Essa si sarebbe ridestata drammaticamente per i tumulti che scuotevano tutta Italia nel maggio 1898, subito dopo che, il 28 marzo, si era parlato delle reclute sotto la dizione vaghissima di Macchiette militari letterariamente presentate quali “particelle minime dell’immenso insieme che forma il militarismo, atomi perduti nel caos inesplicabile dell’autorità” ed il 3 aprile, a proposito dell’insurrezione di Cuba contro la Spagna, che avrebbe dato adito all’intervento degli Stati Uniti, risorgeva la difficoltà consueta della tradizione democratica risorgimentale (“Noi aborriamo la guerra, la malediciamo, ma quando da essa deve scaturire la libertà di un popolo [...] allora la guerra sia benedetta [...] l’umanità opererà la propria palingenesi attraverso il sangue e la borghesia, sorta nel sangue, in esso affogherà”). E l’8 maggio il discorso si evolveva in una forma tanto suggestiva e rigorosa quando intimamente arrischiata: “Noi non abbiamo simpatia per il capitalismo. Ma fra quello bastardo e pidocchioso della Spagna e quello forte e vigoroso degli Stati Uniti la scelta a favore di quest’ultimo s’impone. Esso è necessario a quella trasformazione sociale che noi vagheggiamo”. Ma le cannonate di Milano avrebbero reso tangibile il sangue anche in Italia e risospinto indietro la trasformazione sociale fino all’elementare sopravvivenza ed alla questione del pane, una nuova squadratura sommaria a cui avrebbe corrisposto per otto mesi la soppressione d’autorità de «L’Avvenire». Ne prendeva solo fino ad un certo punto il posto, a partire dal gennaio 1898, «Tartarino», l’ultima e più geniale incarnazione giornalistica di Silvio Spaventa Filippi 149 Antimilitarismo e pacifismo in una città del Mezzogiorno dall’unità al fascismo prima di trasferirsi a Milano, cavalleresco con i socialisti ed in particolare con Lopardi, rispettoso del significato internazionale del 1° maggio, sottoposto anch’esso a qualche sequestro nell’imperversare della repressione, ma ormai non più in grado di evadere da atteggiamenti generici che hanno fatto il loro tempo e che comunque vanno accolti positivamente come il 4 settembre a proposito dell’invito al disarmo lanciato dallo zar Nicola II ed accolto da papa Leone XIII (“La triste commedia della pace armata accenna a finire, ormai s’è visto, l’artificioso equilibrio creato dalla diplomazia con puntelli e cuscinetti d’ogni genere non è più rimedio efficace”). «L’Avvenire» risorgeva il 29 gennaio 1899 come “organo dei socialisti abruzzesi” nel pieno delle vicende e dei colpi di scena che all’epoca caratterizzavano la vita pubblica cittadina, e dei quali non abbiamo modo di occuparci, che avevano monopolizzato l’attenzione brillante e spregiudicata, a tinte progressivamente repubblicane, di «Tartarino» ed il cui culmine sarebbe stato rappresentato, nel luglio 1899, dall’elezione di sei candidati socialisti nel rinnovamento parziale del consiglio comunale dell’Aquila. Anche «L’Avvenire», ovviamente, s’impegnava a fondo in proposito, mantenendo peraltro una propria ormai distinta ed inconfondibile capacità d’analisi nelle rare aperture che si registrano al di fuori del localismo e dell’ambito nazionale, il concetto moderno di colonia, ad esempio, quale “espansione [...] resa necessaria dal bisogno d’impiego dei capitali nazionali” (12 marzo 1899) o, il 23 aprile, I guerrafondai rialzano la testa in merito allo sciagurato episodio di San Mun ed al tentativo di presenza imperialistica italiana in Cina e ancora le larghe aperture pacifiste e solidaristiche che accompagnano in chiave cristianeggiante le polemiche con «L’eco degli Abruzzi», il nuovo foglio della Curia e dell’arcivescovo Carrano o, con più spiccata intonazione antimilitarista, i commenti all’affare Dreyfus ed al ruolo contrapposto svoltovi da Zola e dalle alte gerarchie dell’esercito (“Abbasso la guerra! Evviva la pace fra i popoli e la fratellanza universale!” si poteva perciò leggere a tutte lettere il 24 settembre 1899). Se poi dalle dichiarazioni di principio vogliamo tornare a riferirci anche noi alla modesta cronaca locale, allora conviene fare un passo indietro e ricordare il sequestro de «L’Avvenire» per aver protestato contro le eccezionali onoranze rese al 7° bersaglieri tornato dall’Africa ad accasermarsi in città donde il processo e la difesa di Enrico Ferri, che aveva illustrato la degenerazione militarista dell’esercito, negando comunque a quest’ultimo pregiudizialmente una qualsiasi funzione costituzionale di organo dello Stato («L’Avvenire» 16 e 29 novembre 1896, 8 febbraio 1897) o le povere donne del quartiere di S. Pietro che non ricevono più a lavare la biancheria del 18° artiglieria e la biada dello stesso reggimento sottratta e rivenduta da un grosso maneggione elettorale (1° e 29 agosto 1897) ancora una volta il costume civile e le magagne amministrative, in poche parole, che dall’ingerenza sopraffattrice del militarismo venivano l’uno messo a dura prova e le altre brutalmente smascherate. Era tra le magagne, a ben altro livello, lo sappiamo, per giustificare le guerre coloniali, “l’importazione di civiltà”: e di essa, e del “grande assassinio collettivo 150 Raffaele Colapietra che si chiama guerra” parla su «L’Avvenire» 4 marzo 1900, a proposito della guerra anglo-boera nel Sudafrica, Giuseppe Urbani, personaggio tra i più rappresentativi dell’irrequieta gioventù intellettuale aquilana di primo Novecento, mentre il 3 giugno, in campagna elettorale politica, avendo Manna, divenuto nel frattempo sottosegretario all’Istruzione, rivendicato la propria fedeltà a Crispi ed auspicato la vendetta di Adua, «L’Avvenire» rievoca a sua volta “migliaia di giovani italiani inviati nella lontana Africa a versare il loro nobile sangue in una causa ingiusta ed a morire senza onore” da “chi aveva lanciato l’Italia nel fallimento economico e morale [...] essiccando nelle enormi spese della guerra inumana e stolta ogni sorgente di ricchezza e di credito”. L’ irrequietezza aveva intanto già messo Urbani fuori dal partito ma Via dalla Cina! 16 dicembre 1900 di Carlo Sambucco, un esponente di rilievo nazionale che collaborava con assiduità a «L’Avvenire», ricordava con significativa ortodossia socialista che “l’espansione mercantile nelle colonie è inerente al sistema di produzione capitalistico [...]. Ma questa espansione avviene per forza intrinseca del capitalismo, non le armi ma le merci conquistano i mercati [...] le spedizioni militari rispondono all’interesse del militarismo che, irrobustito dalla società capitalista, ad essa stessa s’impone”. E l’asserzione sembrava ribadita dall’andamento della crisi del gabinetto Saracco in contrappunto allo sciopero dei portuali di Genova che suggeriva il 24 febbraio 1901 lo scioglimento della Camera e nuove elezioni generali “poiché l’Italia ha bisogno di riforme profonde, sollecite e coraggiose, e la questione delle spese militari, che è la grande pietra d’intoppo sulla via dei miglioramenti, è destinata a risorgere costantemente fino alla sua definitiva soluzione”. E poiché «L’Aquila», l’ufficioso ministeriale che da qualche tempo aveva preso il posto della «Gazzetta di Aquila», aveva confutato queste argomentazioni nei presupposti e nelle conclusioni, «L’Avvenire» si distende tra il 10 ed il 31 marzo a rimbeccarla in nome del principio, derivato dal liberismo rigoroso di Federico Flora, Luigi Bodio e Maffeo Pantaleoni opportunamente citati, “che l’entità delle spese va commisurata soltanto alle entrate disponibili ed alla ricchezza generale di uno Stato” appesantita in Italia dall’enormità del debito pubblico che rendeva il carico militare proporzionalmente più oneroso che per qualsiasi altra grande potenza. Era imminente la conquista del Comune da parte dei partiti popolari senza che nel loro programma, di cui magna pars erano naturalmente i socialisti, si facesse specifica menzione della presenza militare in città, resa più pesante da quella personale, come generale di brigata comandante della guarnigione, di quel Luigi Cadorna che sarebbe stato discusso generalissimo nella grande guerra e che già ora si rendeva protagonista di un clima tutt’altro che disteso («L’Avvenire» 18 e 25 novembre 1900). Sarebbe stato perciò un esponente nazionale come Nicola Badaloni ad intrattenersi polemicamente su La Chiesa e la guerra (“La benedizione del prete accompagna la nave da guerra che scende nel mare apportatrice di rovine e di lutti, accompagna le bandiere delle armi che partono per invadere il territorio altrui” 26 settembre 1901) e Lo spirito di casta 9 febbraio 1902 avrebbe affiancato militari e 151 Antimilitarismo e pacifismo in una città del Mezzogiorno dall’unità al fascismo magistrati prendendo spunto dal caso di un conosciutissimo scrittore di cose di caserma, il capitano Olivieri Sangiacomo, punito con tre anni di arresto per aver svelato le sfacciate ruberie dilaganti nelle amministrazioni militari e di cui, come s’è visto, neppure all’Aquila mancavano esempi. Non solo: ma il 9 marzo successivo al posto d’onore in prima pagina appariva Abbasso Tripoli!, il nuovo miraggio coloniale che, com’è noto, avrebbe suggestionato di lì a poco anche Antonio Labriola e che trova invece fra i socialisti aquilani il più drastico dei rifiuti (“Bisogna che il popolo italiano faccia sentire in tempo la sua voce. Provvediamo ai deserti che ci sono in casa nostra! Non cerchiamone degli altri! Non vogliamo saperne della Tripolitania!”). Anche qui il 20 aprile non sarebbe mancato l’intervento personale di Enrico Ferri che su «L’Avvenire» opportunamente collegava la campagna contro Tripoli a quella nazionale che il PSI aveva indetto contro le spese militari né, il 15 giugno, quello di Claudio Treves che commentava la fine del conflitto anglo-boero ancora una volta alla luce della più rigorosa dottrina socialista (“La guerra non necessaria e non fatale non fu voluta dall’Inghilterra capitalisticamente produttrice ma dall’Inghilterra capitalisticamente parassitaria, che mirava alla guerra per la guerra, la più insana e crudele delle speculazioni!”). Sfortunatamente questo exploit sottolineato dalla propaganda attiva che Ferri svolgeva nel contado approfittando di una villeggiatura durata l’intera estate 1902 fu interrotto dalla crisi amministrativa e dalla successiva disfatta elettorale su cui nuovamente non abbiamo modo di soffermarci ma che ricacciavano obiettivamente indietro così «L’Avvenire» come tutto intero il socialismo aquilano ben al di là dei consueti episodi di costume, il duello per motivi d’onore tra due ufficiali d’artiglieria svoltosi all’interno della caserma essendo stato impedito l’ingresso alla forza pubblica, il generale Cadorna che non ringrazia il sindaco repubblicano Berardino Marinacci dopo le manovre estive né gli porge gli auguri di capodanno, i fischi e gli sberleffi che accompagnano per rappresaglia la banda del 36° fanteria che rientra nella caserma De Amicis a S. Bernardino («L’Avvenire» 15 settembre 1901 e 5 gennaio 1902, «La Provincia» nuovo organo del blocco costituzionale diretto da Carlo Chiarizia 18 gennaio 1903, «Un altro giornale» 3 aprile 1903 ). «L’Avvenire» si restringeva allora ad essere “organo dei socialisti del collegio di Aquila” ma non smarriva certo la bussola, come conferma efficacemente, il 7 giugno 1903, Irredentismo e socialismo a proposito dei tumulti studenteschi all’università di Innsbruck di cui erano rimasti vittime i trentini, con grandissima commozione in tutta Italia (“Sventiamo il triste gioco dei patriottardi professionali i quali, speculando sul prorompere di un sentimento nobilissimo, cercano di presentare simpaticamente quel nefasto militarismo che è il cancro roditore della fortuna nazionale”): e poiché trentacinque ufficiali di marina querelavano Ferri per la sua campagna contro il ministro Bettolo ed i “secchioni” delle forniture militari, il 30 agosto «L’Avvenire» protestava ed apriva una sottoscrizione di solidarietà definendo la querela “un’aggressione contro il pubblico controllo della stampa ed un tentativo d’intimidazione contro coloro che vogliono esercitare il diritto di critica sul152 Raffaele Colapietra l’andamento delle pubblica amministrazione”. Non vi è dubbio peraltro che la nota del pacifismo e dell’antimilitarismo tenda a stemperarsi come pressoché ovvia all’interno di un socialismo essenzialmente amministrativo avviato, anche se non del tutto all’Aquila, sulla via di un riformismo collaborazionista, se è vero che si deve attendere fino al 27 marzo 1904 perché un appassionato anarchico sulmonese, destinato negli Stati Uniti ad un ben noto prestigio sindacale e ad una tragica fine, denunzi, prendendo la notizia dal bolognese «Pugno di ferro» diretto dall’indomabile Olindo Guerrini, lo Stecchetti del ribellismo di fine secolo, il suicidio di un giovane capitano non più in grado di tollerare “tutte le ingiustizie, le prepotenze, le turpitudini, di cui s’intesse l’argomento dell’esercito” a causa di coloro che “sempre dominati dall’istinto bestiale della violenza [...] educati alla guerra, imparano che il loro mestiere ha per fine il furto, per mezzo l’omicidio”. È lo stesso fervore concitatissimo di Carlo Tresca a farci comprendere che questo è lo sfogo esasperato di un individuo più che il risultato di una linea politica di partito: la quale peraltro viene inattesamente sensibilizzata da una nuova guerra dell’imperialismo, quella russo-giapponese, ed allora, il 24 aprile, reagisce con vivacità ma anche con una genericità enunciativa contro i “patriottardi” ed i “guerrafondai spadroneggianti” che mette nell’ombra, appunto, la natura schiettamente imperialistica del conflitto, come a Cuba e nel Sudafrica, per limitarsi ad una protesta ormai non più adeguata e sufficiente. Essa, prima e dopo la denunzia di Tresca, si era andata articolando sul giornale socialista con un resoconto impressionante di suicidi nelle caserme cittadine («L’Avvenire» 27 aprile 1902 e 19 luglio 1903; cfr. anche «Un altro giornale» 1° maggio 1903) culminato il 13 settembre 1903 con quello addirittura di una dozzina di morti durante le manovre estive a Pescocostanzo, non senza un retroscena agghiacciante (“Possiamo certo assicurare che un immenso numero di richiamati sono stati ridotti quasi agli estremi”). Non solo: ma, mentre i socialisti stigmatizzavano molto opinabilmente la stessa opportunità d’inaugurare all’Aquila, nel settembre 1903, un monumento a Sallustio, la presenza del generale Cadorna alla cerimonia era al centro di una serie di punture di spillo, un capitano del 18° artiglieria che picchia un soldato a piazza d’armi, il ritorno anacronistico all’alloggio militare d’autorità in case private, la denunzia di furti ed appropriazioni indebite con la connivenza del colonnello comandante del 18° che solo dopo un mese di prigione faceva ricoverare in infermeria un malato gravissimo, ed ancora il tentato suicidio di un furiere sempre dello stesso reggimento d’artiglieria, l’annegamento sospetto di un fante del 36° e l’azzoppamento di un suo camerata costretto a saltare la sbarra con zaino e fucile, le angherie del solito colonnello Secco sugli operai che stavano costruendo la palazzina comando del 18°, l’unica oggi rimasta a Villa Gioia («L’Avvenire» 4 ottobre 1903, 3 gennaio, 16 e 23 febbraio, 21 agosto 1904, 26 febbraio, 16 luglio, 6 settembre 1905, 15 luglio 1906) finché Francesco Piccinini, protagonista di una ventata anarco-sindacalista che avrebbe per reazione fatto irrigidire e fortemente snervare la maggioranza 153 Antimilitarismo e pacifismo in una città del Mezzogiorno dall’unità al fascismo riformista di Lopardi, rivolgeva senz’altro il 3 dicembre 1905 Il nostro saluto ai coscritti in nome di una conclamata solidarietà di classe (“Riflettete a quel che dovete fare! Abbiate una volontà! E fate tutto il possibile per restare uomini [...]. Se vi manderanno negli scioperi voi non sparerete. Si vuol fare di voi delle macchine per uccidere? Ribellatevi!”). Abbiamo largheggiato in questa serie di esempi con una certa libertà cronologica proprio per dimostrare che il piano del costume antimilitarista, fatto proprio, come si è visto, dai socialisti aquilani fin dal loro esordio, prevale di gran lunga su quello dell’analisi scientifica che, attraverso le contraddizioni imperialistiche, conduce all’internazionalismo pacifista. Riprendendo infatti su quest’ultima linea la nostra cronistoria al di là dell’incessante ma, in quanto tale, scialba cronaca dei suicidi nelle caserme («L’Avvenire» 8 dicembre 1907 e 1° gennaio 1908) «Socialismo ed irredentismo» ribadisce il 12 giugno 1904 la reciproca incompatibilità proprio a causa della pregiudiziale guerresca che illumina sinistramente quest’ultimo, salva il 10 luglio la condanna “in nome della civiltà” delle “orde compatte” protagoniste dei nuovi disordini studenteschi ad Innsbruck, la divaricazione accennata che va già profilandosi all’interno del socialismo aquilano e che il 28 agosto Il gregario, ben noto e trasparente pseudonimo di Lopardi, rende esplicita con l’affermare senza mezzi termini che “non vi sarebbe socialista che domani, occorrendo, non facesse scudo del suo petto alla patria minacciata d’invasione da un rapace nemico”. Patria ed internazionalismo, dunque, guerra di difesa e pacifismo, le posizioni sono nettamente squadrate, Lopardi candidato dimostrativo alle elezioni generali benché ineleggibile per età, l’ex sindaco Marinucci protagonista dell’exploit irredentista, ne sono chiaramente consapevoli rispetto alla fronda sindacalista di Tresca, Piccinini, Gaetano Camilli, Gli orrori della guerra sono ripresi dalle corrispondenze di Luigi Barzini al «Corriere della sera» sul conflitto tuttora in corso in estremo oriente che si legge su «L’Avvenire» del capodanno 1905, il numero precedente a quello che informa della condanna a vent’anni di un soldato per vie di fatto contro un superiore, ripetizione di schemi nobili ma vecchi, in poche parole, indice di una sensibilità umanitaria sempre vivissima, ma senza sostanziali progressi critici. Ed è significativo che sia lo stesso Camilli, il 9 aprile 1905, a lasciarsi andare ad una confessione preziosa (“Ben venga anche la guerra, noi non siamo dei pacifisti ad oltranza, e poi potrebbe anche essere il principio della fine”) in cui è tanta parte dell’ambiguità e dell’equivoco che prima, durante e dopo la guerra si sarebbero più o meno insensibilmente trasferiti dall’estrema sinistra all’interventismo, al combattentismo ed al fascismo. Per il momento, a dire il vero, siamo ancora molto lontani da quei torbidi traguardi: ed il convegno socialista italo-austriaco di Trieste strappa a «L’Avvenire» del 21 maggio accenti convinti e corretti (“Dobbiamo cercare di riunire tutto il proletariato nell’intesa comune d’impedire e strozzare sul nascere tutte le velleità militariste che, ammantandosi dell’amor di patria, cercano ancora di sottrarre alle finanze le risorse migliori per farne fortificazioni e cannoni”): e lo stesso dicasi per 154 Raffaele Colapietra Le spese improduttive presenti e future, una serie robusta di quattro articoli che si conclude il 2 luglio con, in prospettiva, quanto meno la riduzione degli stanziamenti militari. Ma si deve poi saltare al 28 ottobre 1906 Nuove spese militari per leggere una conclusione asettica (“Il partito socialista, sempre vigile tutore degli interessi degli umili, insorgerà contro tale pretesa e [...] si adopererà con tutti i mezzi perché i nuovi fondi non siano concessi”) che offre bene la misura di quanto ormai il tema sia marginale nell’ordine del giorno dei socialisti, e senza dubbio non esclusivamente di quelli aquilani. Sarà la sconfitta elettorale dei socialisti tedeschi a far riflettere sui risvolti militaristi del colonialismo come tessuto connettivo dell’irrigidimento conservatore (10 febbraio 1907), sarà ancora il congresso di Stoccarda dell’Internazionale, con la sua ben nota mozione contro il militarismo e l’imperialismo, a suggerire le ombre e le luci di una tattica tutt’altro che intransigente (“Evitare con ogni mezzo suggerito dal grado di evoluzione politico economica di un popolo lo scoppio della guerra, affrettarne energicamente, scoppiata che sia, la fine, trarre in qualsiasi caso motivo dalle sue vicende per minare e logorare incessantemente il privilegio economico e politico” - 8 settembre 1907), sarà infine la grande vittoria del sindacalismo riformista al congresso nazionale di Firenze a dettare a Tullio Rossi Doria parole non meno asettiche di quelle che abbiamo letto fin qui (“Predicare la pace fra i popoli e combattere il militarismo non si può fare entro i confini della patria ma solo in seno all’umanità” - 4 ottobre 1908). Quanto all’Aquila anche le note di costume, come si può agevolmente constatare, sono venute del tutto meno (deve essere ancora un dirigente nazionale come Giovanni Bacci a ricordare il 18 ottobre che “nel lavoro dell’organizzazione internazionale del proletariato organizzato per nazioni sta la maggior forza di lotta contro il militarismo per l’abolizione degli eserciti”) e non si esita il 1° novembre a far passare la grande vittoria diplomatica austriaca nel problema dell’annessione della Bosnia Erzegovina come “trionfo di quella tendenza, tutta popolare e proletaria, per cui i problemi internazionali dovranno risolversi pacificamente” ed a presentare il 15 il proletariato pronto a “difendere alacremente la patria se i suoi più vitali interessi fossero minacciati ed offesi” col che ovviamente si apriva la strada a qualsiasi soluzione. Non solo: ma il 29 novembre 1908 ancora Gavroche, un nuovo pseudonimo di Lopardi, flagella a tal punto La stupidità austriaca da concludere col ritenere “che ora più che mai il proletariato italiano debba premere sul governo nazionale perchè tronchi ogni relazione di alleanza con l’Austria, la più cordiale nemica dell’italianità dentro i nostri confini politici e fuori”, un’apertura, com’è chiaro, sul cui sfondo poteva esserci persino il nazionalismo, nonché il patriottismo. Certo, Opponiamoci ai nuovi armamenti era la parola d’ordine che il 20 dicembre 1908 chiudeva l’annata e la burrascosa crisi bosniaca, senza dubbio la riduzione della ferma, la democratizzazione dell’esercito, il disarmo graduale dei popoli, figuravano il 4 marzo 1909 in bella vista nel programma con cui Emidio Lopardi 155 Antimilitarismo e pacifismo in una città del Mezzogiorno dall’unità al fascismo affrontava per la prima volta secondo i crismi di legalità le elezioni generali, ma era semmai, il 30 maggio, ancora una volta un esperto a livello nazionale come Sylva Viviani a tornare sulle spese militari ed il 26 settembre sulle grandi manovre, in una collaborazione giornalistica tra «L’Avvenire» e «L’Avanguardia socialista» tanto simpatica quanto sintomatica della marginalità che ormai il tema aveva assunto per il periodico aquilano, incapace di elaborare un linguaggio proprio che non fosse quello dello “zarismo irredentista” come sempre Viviani titolava il 21 novembre collegando il rigurgito patriottardo e militarista col contrastatissimo viaggio italiano di Nicola II. La riconquista del Comune dell’Aquila ad opera dei partiti popolari non arrecava in proposito alcun elemento nuovo sicché l’appello Ai coscritti pubblicato su «L’Avvenire» 6 novembre 1910 recava le firme dell’Avanguardia e della federazione giovanile socialista ma senza alcun commento aquilano, così come La commedia del pacifismo borghese e la sincera alleanza del proletariato sarebbe stato il titolo annunziante, il 12 marzo 1911, il succedersi primaverile di convegni italo-austriaci da Trieste a Roma variamente miranti ad ammorbidire le relazioni tra i due paesi ma a firma di un esponente nazionale come lo Storchi e su una falsariga ormai ben conosciuta (“I proletari di entrambi gli Stati sono ben risoluti di non scannarsi vicendevolmente per qualsivoglia ragione”). I documenti in proposito si susseguivano nelle successive settimane ma sempre privi di riscontro locale, assente anche nel primo convegno regionale dei partiti popolari tenutosi a Sulmona in occasione del 1° maggio, i problemi amministrativi ed il suffragio universale monopolizzando comprensibilmente la tematica socialista fino all’irrompere prepotente della guerra di Libia. Era la sezione socialista di Milano a sollevare il problema con un ordine del giorno che «L’Avvenire» pubblicava il 20 settembre e faceva incondizionatamente proprio contrapponendo lo “stato endemico presociale” del Mezzogiorno e delle terre incolte “a questo nuovo e fatuo impulso di politica guerrafondaia” salvo la settimana successiva sfumare pericolosamente tale linea con l’identificare “la vera grandezza di una nazione” con “la sua affermazione di forza produttiva [...] che essa sa spiegare per difendere anche con le armi (sic!) le proprie posizioni conquistate sul mercato internazionale”. Non il pacifismo e l’antimilitarismo in quanto tali, dunque, si opponevano a Tripoli bensì “l’Africa che abbiamo in casa”, la priorità da assegnare all’educazione popolare ed alle bonifiche, e con essa la sofistica e tortuosa distinzione che faceva bensì aderire di fatto i socialisti alla “concorde manifestazione di fraternità e d’augurio” ai soldati in partenza dall’Aquila ma compiangendoli in quanto “immolati alla cupidigia insaziata dei capitalisti” con tutto il contorno fremebondo che si può immaginare. Se il 15 ottobre si sottolinea con allarme “la perversa follia dei sentimenti violenti, la triste ammirazione della violenza” suscitate dalla guerra in uno stato di cose che si rifletteva pesantemente sulla popolazione civile a causa delle difficoltà nel rifornimento del grano, se il 28 gennaio 1912 si rivendica con altrettanta finezza 156 Raffaele Colapietra “la virtù degli straccioni, dei servi, degli analfabeti” che oggi si rivela in mille episodi umanitari in Libia che “le trombe trionfale delle gazzette da salotto [...] non varranno a piegare ai fini dell’imperialismo”, se il 14 aprile dinanzi alla morte di Giovanni Pascoli si sa correttamente distinguere la sua recente infatuazione libica dal “grande amico del proletariato [...] che aveva sentito il dolore dei nostri emigranti”, tutto ciò rispecchia una preparazione politica, civile e culturale ormai ragguardevole nel socialismo aquilano (che non a caso regge vigorosamente alle burrasche interne determinate, a coinvolgere lo stesso Lopardi, dal congresso di Reggio Emilia e dall’espulsione dei riformisti), ma non apporta elementi davvero nuovi soprattutto in campo locale dove viceversa essi non erano mancati per iniziativa nazionalista e conservatrice. Intendiamo riferirci al battaglione scolastico per l’educazione militare degli studenti forte di 120 iscritti e di cui dà notizia il 4 giugno 1911 «La Città dell’Aquila», l’organo dell’opposizione costituzionale, promotori futuri esponenti del mondo combattentistico e fascista, Guido Petroni, Manlio Santilli, Silvio Masciocchi, battaglione che, dopo essersi esercitato alla meglio nello slargo di S. Basilio e nella chiesa sconsacrata di S. Nicola d’Anza, arrivò a prender parte alla rivista generale del novembre 1912 nel parco del castello. A quella data, com’è ben noto, la guerra di Libia era terminata con La bancarotta del nazionalismo come «L’Avvenire» 13 ottobre 1912 titolava con evidente soddisfazione dinanzi alla delusa rissosità degli avversari sull’inconcludenza vistosa di tutta l’impresa a cominciare dalle prospettive emigratorie, ma imperversava quella balcanica, a cui il foglio socialista dedicava il 10 novembre un commento tipico di quella sensibilità umana che ormai va culturalmente prevalendo sulla specifica combattività politica (“Le degenerazioni nazionaliste d’ogni paese arrivano ad esaltare la guerra per la sua stessa bellezza, a farla amare, a colorirla colle tinte più seducenti, circondandola di poesia e d’ammirazione”). L’efficientismo futurista e l’estetismo dannunziano cominciano dunque ad essere i nemici da battere più ancora del capitalismo in senso stretto, la “lotta senza quartiere” (6 gennaio 1913) contro i nazionalisti ormai liberatisi di ogni residuo democratico: ma c’è anche, a partire dal 30 marzo dello stesso anno, e dopo un ventennio, un nuovo concorrente, il “periodico settimanale cattolico” de «La Torre» che ha anch’esso, con i suoi giovani preti redattori, da dire la sua sul tormentato terreno della pace e della guerra, contrastando fortemente l’accentuato laicismo dell’amministrazione popolare ma mantenendosi con altrettanta fermezza indipendente nei confronti dello schieramento ministeriale di Gennaro Manna e Vincenzo Camerini. Pur ovviamente biasimandoli per non aver posto Dio al centro ed al culmine della loro prospettiva «La Torre» 20 luglio 1913 non può fare a meno di riconoscere che “i socialisti hanno levato più alto il grido della pace e, protestando contro gli armamenti che dissanguano e sfibrano i popoli, hanno cercato di dare il contenuto morale a questi sforzi, e fu, la loro, una bella parola, la fratellanza umana!”: e tuttavia il pregiudizio ideologico è da una parte e dall’altra così forte che la breve con157 Antimilitarismo e pacifismo in una città del Mezzogiorno dall’unità al fascismo vergenza non tarda a dissolversi, la massoneria, l’anticlericalismo, la laicizzazione dell’asilo infantile all’Aquila, la precedenza del matrimonio civile in Italia, e così via, la fanno da padroni a tal punto da non lasciare spazio se non ad interminabili e sconclusionate recriminazioni storiche e culturali: e quando, con l’attentato di Sarajevo, la grande guerra batte alle porte, non si può dire che «La Torre» 2 agosto 1914, con la sua criminalizzazione dell’evento e della Serbia che le è alle spalle, contribuisca molto ad una prospettiva che non sia velleitariamente pacifista (“Che la Divina Provvidenza ci scampi! [...] Il Cielo ci risparmi la tremenda sciagura!”). «L’Avvenire», intanto, la cui cronistoria comincia ad essere particolarmente accidentata dopo che Lopardi, nelle elezioni generali del novembre 1913 ha sfiorato la vittoria, intitola Socialismo e militarismo il pezzo d’apertura del 1° maggio 1914, ed a firma di Panfilo Gentile, la testa di gran lunga più forte della giovanissima generazione, che partendo da un presupposto estremista (“Gli interessi, le ragioni, l’esistenza nazionale, ci sono perfettamente indifferenti [...]. Sia perciò sdegnosamente respinto ogni appello che si faccia al nostro patriottismo”) conclude, da buon filosofo del diritto quale è, con una visione istituzionale che ha poco o nulla di socialista e molto della futura Società delle Nazioni se non addirittura delle Nazioni Unite (“Il coordinamento giuridico di tutta l’umanità, la valutazione e la risoluzione pacifica di ogni conflitto, l’attribuzione legale del suo ad ognuno, tale è la nostra meta rigorosa”). Quanto allo scoppio della guerra non c’è dubbio che Il fallimento della pace armata, il 9 agosto 1914, si lasci di gran lunga indietro le invocazioni e le ambiguità dei cattolici se non altro per la fredda obiettività dell’analisi (“Non ci si arma con intenzioni pacifiche [...]. Gli armamenti delle nazioni europee non potevano avere che lo sbocco logico della guerra”), salvo il 19 agosto quelle ambiguità ripresentarsi preoccupanti anche in campo socialista (“Auguriamoci che nessun tentativo di aggressione ci costringa alla difesa disperata cui tutti ci sentiremmo chiamati, auguriamoci che la guerra si decida nel minor tempo possibile [...]”). Il 23 agosto questa posizione diventa definitiva (“Una sola guerra il proletariato può concepire e all’occorrenza subire senza ribellarsi, la guerra per la difesa del territorio nazionale”) né le asserzioni successive volte a salvar l’anima (“Il socialismo rampolla dalla caduta del militarismo [...]. Il socialismo è la vendetta della civiltà contro la guerra” e così via) valgono sostanzialmente a scalfirla, finché il 13 settembre «L’Avvenire» fa completamente propria la tematica propagandistica di quei giorni e dinanzi alla “malvagità criminale” della “nazione barbara ed incivile” che è la Germania la pone “fuori di ogni legge umana di equa valutazione” essendo composta da “banditi, briganti e malfattori”. Senza dubbio si riproducono o si riassumono gli interventi di Claudio Treves ed Attilio Cabiati per la neutralità italiana, si stigmatizza il passaggio di Mussolini al campo della democrazia massonica da lui combattuto con tanta energia ancora pochi mesi prima al congresso di Ancona, ma si riconosce anche francamente, il 28 febbraio 1915, che “nessuno ha sostenuto la tesi dell’intervento con quella lucidezza di argomentazioni” dimostrata da Gaetano Salvemini nell’opuscolo Guerra o neutralità. 158 Raffaele Colapietra Ed è estremamente significativo che sia ancora Panfilo Gentile a dare il tono a «L’Avvenire» 1° maggio 1915 ma con un articolo Fedeltà e fiducia che alla spregiudicatezza del giudizio storico (“La guerra che forse farà l’Italia sarà guerra di conquista e di rapina e null’altro, non avrà alcun fondamento ideale né nazionale né internazionale, non soccorrerà popolazioni irredente né servirà la causa della giustizia e della libertà”) affianca la consapevolezza attuale della sconfitta proletaria (“Occorre piegare il capo, rassegnarsi ancora una volta [...]”) con sullo sfondo quel disfattismo rivoluzionario che, mutuato da Lenin, avrebbe giustificato la precocissima militanza comunista di Gentile (“Possiamo tenerci pronti in agguato per un domani, che io non stimo molto lontano, quando sarà suonata l’ora di vibrare la nostra pugnalata alla schiena di questo regime infausto”). Da un dovere ad un altro in prima linea era perciò logicamente la parola d’ordine con cui i socialisti aquilani non solo subivano ma praticamente accettavano e condividevano un certo tipo di guerra (“Essi non esitano a dichiarare che quando la nazione è in una lotta che investe la sua esistenza tutti gli italiani, senza distinzione di partiti, sono in armi”): e «La Torre», che tutta la battaglia neutralista aveva condotto in chiave antimassonica, non poteva lo stesso giorno, 30 maggio 1915, che affidarsi alla sorte delle armi ed alla protezione divina senza che dalla neutralità, e dalla valutazione dei suoi vantaggi, ci si fosse mai da parte cattolica sollevati ad un’autentica visione internazionale e pacifista del problema. Quest’ultima, e men che meno la sfumatura antimilitarista, non erano certo propiziate dal clima politico e psicologico della guerra combattuta, in vista del quale «L’Avvenire», superata la tentazione di tacere lungo l’intero conflitto, si proponeva di “ridurre al minimo possibile il danno”, di promuovere l’assistenza civile, di contrastare le false notizie (18 giugno 1915), una linea di correttezza difensiva, insomma, dinanzi alla settaria esclusione dei socialisti dal comitato di mobilitazione civile all’Aquila o alla temuta pratica emarginazione del Parlamento in Italia, alla censura postale ed al nascente “pescecanismo” di guerra, contro i protagonisti delle radiose giornate oggi imboscati e contro la persistente retorica guerrafondaia di D’Annunzio, il tutto in una situazione di crescente precarietà che dal febbraio all’aprile 1916 imponeva una pausa nella pubblicazione del giornale, ma che per il 1° maggio consentiva a Mario Trozzi, già messosi in luce come leader del socialismo abruzzese di sinistra, di salutare il convegno di Zimmerwald come “voto solenne di riunire il proletariato di tutti i paesi, diviso attualmente dalla terribile strage bellica, in un saldo indissolubile vincolo di fraternità e di amore”. La conversione bellicista e sopratutto antitedesca dei cattolici de «La Torre» è invece incondizionata; già il 18 luglio 1915 Vincenzo Franci parla di “guerra pel trionfo del diritto e per la difesa della patria, guerra doverosa, guerra santa” a patto, s’intende, di eliminare l’ipoteca democratica e massonica, La camorra verde, La calunnia massonica e così via, tanto per esemplificare alcuni titoli che offrono la misura della pressoché esclusiva preoccupazione cattolica. Quanto all’impostazione generale, infatti, leggiamo il 28 novembre 1915 che “il 159 Antimilitarismo e pacifismo in una città del Mezzogiorno dall’unità al fascismo cristianesimo subisce la guerra quando per l’imperfezione umana è necessaria al diritto della patria e, senza rinnegare il suo completo ideale d’una pace universale nel regno della giustizia per tutti, sostiene gli sforzi di coloro che combattono per la giustizia, dal momento che è necessario combattere per il trionfo della giustizia”, parole che si sarebbero potute sottoscrivere da qualsiasi gradazione dell’interventismo. L’articolo invece che Trozzi scrive per l’anniversario dell’entrata in guerra è massacrato dalla censura, che per fortuna non interviene l’11 giugno 1916 quando il giovane avvocato sulmonese inneggia alla “forte falange di socialisti” che accanto a Karl Liebknecht è al suo posto di combattimento “anche nella famigerata Germania” e, in mezzo a numerosi spazi bianchi, gli fa pronunziare il capodanno 1917 la parola d’ordine “guerra borghese ma pace proletaria” il cui presupposto irrinunziabile non può che essere il disarmo (ma si veda anche il 13 febbraio Giornalismo venduto del sempre intelligentissimo Panfilo Gentile che conclude con una massima valida per tutti i tempi: “La salvezza non sta tanto nel correggere e migliorare il giornalista quanto piuttosto nello svegliare il lettore”). Militarismo e Internazionale i due mostri, “i due giganti insidiosi e brutali” erano invece, fin dal 27 agosto 1916, morti entrambi per «La Torre» grazie ai “buoni effetti generali che la guerra ha prodotti”, l’obbedienza, la disciplina, il sacrificio, la carità, quella “fraterna dell’umanità sulla terra” destinata a risplendere “nella santità delle patrie riaffermate” grazie appunto alla guerra ed alla nazione “apparsa come la suprema realtà politica”. Ovviamente, non c’è il minimo cenno, sulle pagine del settimanale cattolico, di quella censura che avrebbe praticamente ed infine anche formalmente soppresso «L’Avvenire» per un paio d’anni, sicché è a «La Torre» che dobbiamo ricorrere per avere un’idea dell’atmosfera suscitata all’Aquila da Caporetto ed a constatare che, malgrado tutto, le priorità cattoliche non mutano e l’11 novembre 1917, con gli Austriaci sul Piave, ci si limita a domandare “come sia possibile tollerare una campagna denigratoria così stomachevole come quella che va facendo la massoneria e tutta la canaglia anticlericale convenientemente imboscata”. Andiamo dunque a giusto un anno più tardi, ai giorni della vittoria, e leggiamo l’8 novembre 1918 suonata “l’ora provvidenziale della giustizia nel mondo [...] per le nazioni che si costituiscono nella loro unità etnica e geografica [...] per l’umanità che vede avvicinarsi la fine di quell’immane flagello che è stato il militarismo [...] colpito dal cristianesimo nella parola pacifica dei suoi Pontefici che Wilson ha fatta sua”. Si era alla vigilia dell’appello di don Luigi Sturzo ai liberi e forti e della nascita del partito popolare che peraltro «La Torre» interpretava a senso unico quale “unica forza salda e reale contro le correnti bolsceviche che tentano di avvelenare anche il popolo italiano” (26 gennaio 1919) così come, l’abbiamo visto, e lo si ripeteva il 23 febbraio, la Società delle Nazioni non rifletteva altro che “la veneranda tradizione cristiana” salvo, s’intende, “insorgere come un sol uomo per protestare” il 27 aprile contro il messaggio del presidente americano e porre il 16 maggio per le prossime elezioni “una pregiudiziale assoluta ed insormontabile, niente massoni!” col che la nostra tematica in ambito cattolico può considerarsi esaurita. 160 Raffaele Colapietra Nasceva nel frattempo, come “organo settimanale della Federazione Socialista Abruzzese” e direzione all’Aquila in via dei Lombardi, Abruzzo rosso, testata della frazione massimalista per l’imminente congresso di Bologna, sulla quale fin dal secondo numero, 14 settembre 1919, Mario Trozzi inneggiava alla pace, alla libertà ed alla civiltà socialista (“Il liberticidio è il prodotto inevitabile, per fatale necessità di cose, dello stato di guerra”) senza, si noti, che il “fare come in Russia” echeggiasse minimamente in una prosa generosamente tradizionalista come questa. Se i Soviet dei soldati vengono evocati ciò si verifica il 25 settembre in occasione di Fiume contro la cui “avventura” promossa da “un gruppo profondamente militarista” i “compagni lavoratori” erano invitati a serrare compattamente le fila: ma subito dopo la repubblica universale dei Soviet diventa la parola d’ordine della frazione astensionista di Bordiga nella prospettiva congressuale con l’opporre alla “ubriacatura elettorale” la necessità di “un’azione energica e subitanea, fors’anche l’insurrezione, per alleviare il peso delle forze che soffocano la Russia rossa” (25 ottobre 1919). Trozzi e Lopardi risultavano eletti deputati da una campagna elettorale che «Abruzzo rosso» impostava il 7 novembre con una carica a fondo contro la “borghesia interventista” e la “bellica cuccagna [...] dei fornitori imboscati” la cui “retorica bolsa e idiota” non poteva nascondere neppure “la bancarotta completa e catastrofica della guerra democratica, che ha culminato nei crimini sanzionati a Versailles”, mentre il risorto «Avvenire» commentava il 6 dicembre l’esito delle urne in chiave essenzialmente polemica nei confronti della formazione politica del combattentismo, che in provincia dell’Aquila aveva ottenuto tre seggi, e che veniva presentato nell’ovvia luce di sfruttatore dell’irrigidimento antisocialista corruttore del proletariato. A questo punto «Abruzzo rosso» scompariva per riapparire nelle forme che vedremo tra breve mentre «Avvenire» proseguiva nella sua vita tutt’altro che facile e rispecchiante le vicissitudini socialiste dell’epoca anche nell’ambito locale e sui problemi che ci interessano, qui 14 marzo 1920 “Le iene borghesi” per la reazione imperversante in Ungheria, lì, l’11 aprile, sui tentativi occidentali d’imbrigliare la rivoluzione in corso in Turchia (“Dica il proletariato italiano, e lo dica forte, che non permette al governo d’impegnarsi in un atto di rapina e di oppressione per la maggior gloria dell’imperialismo inglese!”) ora, il 23 maggio, per mettere in guardia contro l’aggressione polacca alla Russia che avrebbe condotto l’Armata Rossa alle porte di Varsavia (“La solidarietà internazionale dei lavoratori, ecco il nemico formidabile per il capitalismo, ecco il vincitore sicuro per il domani!”) ora, il 1° agosto, individuando nella “teppa nazionalista” i protagonisti dell’assalto all’ «Avanti!» primo grande episodio della reazione squadrista. Vale la pena a questo proposito di segnalare il 15 agosto 1920 I disertori che annovera tra essi, da distinguere e contrapporre a quelli politici, i disertori militari “esseri superiori nei quali l’istinto umano predomina sull’istinto bestiale [...] (che) trascinati violentemente nel vortice di sangue, se ne ritrassero con coraggio e sacrificio”, tra essi, nominativamente, il Francesco Misiano contro il quale si sarebbe scagliata la violenza fascista e patriottarda: ed egualmente degno di nota, il 24 otto161 Antimilitarismo e pacifismo in una città del Mezzogiorno dall’unità al fascismo bre successivo, è il trafiletto Per la Russia e per la rivoluzione che denunzia “l’inanità degli sforzi” compiuti in proposito dei socialisti italiani e ciò a causa di “mancanza di volontà, assenza assoluta d’ogni spirito d’iniziativa, deficienza di elementi adatti, poca serietà e limitata energia nei dirigenti”. È la polemica riformista, naturalmente, che condurrà alla scissione di Livorno e nell’ambito della quale la linea aquilana di Lopardi va sottolineata per coerenza e concretezza anche dal nostro attuale angolo visuale e grazie alla presenza di un organizzatore ed animatore di prim’ordine come Mario Cavarocchi che si differenzia dal leader per un più accentuato stimolo antitetico all’infatuazione dannunziana e prefascista, la cerimonia del Milite Ignoto, ad esempio, nella ricorrenza del 4 novembre 1920 della vittoria, che egli bolla parlando il 17 novembre di “borghesia di pescicani che ricorre al diversivo, alla parata nazionalpatriottica, che dovrà, in un ritorno di entusiasmo, come nel maggio radioso, deviare il popolo e condurlo allo sbaraglio”. La scissione di Livorno contribuisce indubbiamente a circoscrivere a livello locale, secondo del resto una vecchia tradizione, il riformismo di Lopardi, aprendolo soltanto qua e là a sollecitazioni umanitarie (L’inferno del Volga 18 agosto 1921 sulla carestia in Russia: ma si vedano gli interventi di Giulio Stornelli che inclinano apertamente ad un socialismo cristiano): il 3 dicembre 1922, col fascismo al potere (“Siamo per l’Italia e per il Socialismo, per la Nazione e per il Proletariato”) l’assestamento su linee che vagamente possono definirsi socialdemocratiche è completo, e l’orizzonte internazionalista, presupposto del pacifismo e dell’antimilitarismo, sostanzialmente oscurato, anche se su posizioni, lo ripetiamo, d’innegabile e rispettabile solidità democratica. Né i comunisti, quanto ad essi, ci dicono in proposito molto di più. «Abruzzo rosso» è tornato a vivere come organo del partito, sempre all’Aquila, l’11 marzo 1922, ma su una prospettiva scontata ed enunciativa che non giova gran che al nostro discorso (“Il trionfo della Repubblica operaia della Russia è la prima pietra miliare nel nostro cammino. Domani altre tappe vi saranno per l’ultimo e più grande trionfo, per la Repubblica mondiale dei lavoratori”) in quanto concentrata prevedibilmente in modo esclusivo sul grande risultato rivoluzionario di Mosca, presupposto ineliminabile di ogni sviluppo internazionale, e rispetto al quale pace o guerra rappresentano soltanto scelte opinabili e strumentali. Il 1° maggio 1922 sarebbe stato contraddistinto dall’appello del proletariato per la rivoluzione mondiale ad illustrare il quale Costantino Lazzari e Ruggero Grieco parlavano prestigiosamente all’Aquila, quasi a mettere nell’ombra il riformismo localistico di Lopardi: ma il 4 giugno, riprendendo un suggerimento di Nicola Bombacci, si chiamavano senz’altro i proletari alle armi “occhio per occhio, dente per dente [...] la borghesia vuole guerra e guerra sia, lavoratori, ai vostri posti, con qualunque arma, per la vostra difesa disperata”. Un appello disperato, appunto, che in quanto tale rinunziava anche al postulato venerando della pace e della non violenza: non a caso l’8 ottobre, alla vigilia della marcia su Roma, si ammetteva e precisava che “l’Internazionale Comunista vuole la guerra, ma è guerra di classe, guerra contro il capitalismo. La sua avversione alla guer162 Raffaele Colapietra ra non è rassegnazione al macello per le borghesie ma si concreta nella parola d’ordine di guerra al regno della guerra [...]. La pace si conquista con la rivoluzione, e si assicura con la vittoria armata del proletariato in tutto il mondo”. Tutto nuovo linguaggio, è evidente, rispetto alle pagine che precedono: ma nel mutamento del linguaggio è insito il radicale mutamento della storia. 163
Scarica