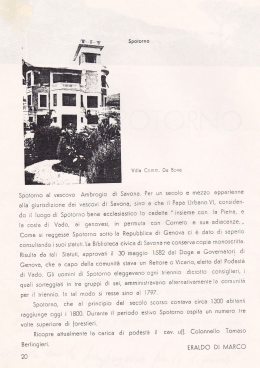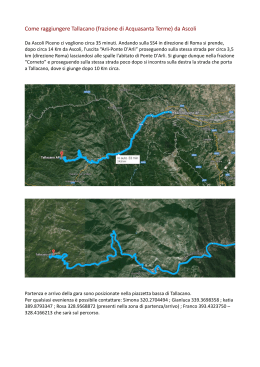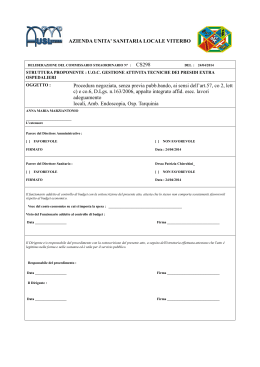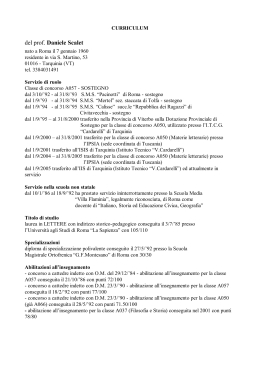L’APPORTO MARCHIGIANO AL POPOLAMENTO DI CORNETO 1. Maremma desolata Il processo di spopolamento della Maremma e dell’Agro romano è stato, dalla metà del Trecento a Ottocento inoltrato, fortissimo e, là dove è mancato il correttivo della immigrazione forestiera, inarrestabile. Ciò è ben noto per la Campagna romana 1 . Ad esempio la diocesi di Ostia nel 1701 era ridotta a 206 anime e nel 1782 risultava ormai disabilitata e soppressa. Più vicino a Corneto, Cerveteri passò dai 2.500 abitanti del secolo XIV ai 400 del 1701 ai 173 del 1708 ai 117 del 1782. Anche ad Anguillara, dove pure affluirono molti forestieri, si registrano cali di popolazione: dai 2.500 abitanti del Trecento ai 1.000 del 1701 ai 681 del 1782 2 . Un saldo nascite/morti costantemente negativo (caratterizzante tutta la parte occidentale dello Stato pontificio compresa la capitale) e lo stillicidio degli abbandoni sono le forme in cui si realizza la lunga depressione demografica maremmana; le cause possono essere individuate sì nelle sfavorevoli condizioni climatiche come anche nella concentrazione della proprietà in estesi latifondi, e nel prevalere dell’incolto, del pascolo, della coltura estensiva. I due fattori sembrano interagire e potenziarsi a vicenda, nel senso che, se la malaria desertifica le aree più basse e fertili consegnandole al latifondo, il latifondo demotiva l’insediamento sparso e con ciò elimina il presidio umano del territorio rendendolo più esposto all’impaludamento e all’abbandono. E’un circolo vizioso che non può essere rotto in un punto qualsiasi, ma precisamente nel nodo delle condizioni ambientali mediante il riassetto della proprietà e la bonifica dei suoli: ciò che appunto faranno, ma solo negli ultimi 1 Dell’ampia bibliografia sull’Agro romano basterà ricordare l’ormai classico G. TOMASSETTI, La campagna romana antica, medievale e moderna, 4 voll., Roma 1914 - 1922, e il recente e già fondamentale G. Rossi, l’Agro di Roma tra ‘500 e ‘800. Condizioni di vita e di lavoro, Roma 1985, al quale si rinvia anche come repertorio bibliografico. Della bibliografia relativa agli aspetti economici e sociali della Maremma cornetana il testo più cospicuo sembra ancora il vol. XI, curato da F. NOBILI VITELLESCHI, degli Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, t. I (Roma e Grosseto), Roma 1884. 2 TOMASSETTI, La campagna cit., I, p. 156; F. CORRIDORE, La popolazione dello Stato romano (1656-1901), Roma 1906, pp. 93-242; R. AGO, Braccianti, contadini e grandi proprietari in un villaggio laziale nel primo Ottocento, in “Quaderni Storici”, 46 (1981) pp. 60-91. cento anni, le riforme fondiarie 3 . 2. Lo spopolamento di Corneto Il ragguardevole sviluppo della città, e le sue prosperose vicende fecero salire la popolazione ad una cifra molto maggiore che non è oggidì. Afferma il Valesio in modo positivo, che nelle epoche medievali essa contava, compreso il distretto, 31.900 abitanti. Così della sua patria il Dasti nel 1878 4 quando Corneto-Tarquinia contava attorno ai 5000 abitanti. Ora, per quanto vaghe siano le connotazioni “epoche medioevali” e “distretto” e dunque piuttosto favolosa la notizia, è fuori discussione il drastico ridimensionamento demografico subito da Corneto tra medioevo ed età moderna. Sono ancora sotto gli occhi di tutti le testimonianze dell’ampiezza e dello splendore raggiunti dalla città nel basso medioevo, ed è certo che anche l’agro era allora popolato, al punto che fuori le mura della città si contavano 26 chiese 5 . Il crollo demografico della metà del Trecento, comune a tutta Italia 6 dovette colpire anche Corneto ed è pensabile che i meccanismi dello spopolamento della Campagna romana, forse allora innescati e accelerati dopo la metà del Cinquecento 7 si siano prodotti anche nella Tuscia costiera 8 . Fatto sta che, in una costituzione papale dell’inizio del Seicento, dell’Agro cornetano si diceva che da moltissimi anni giaceva incolto, e quello che un tempo costituiva il granaio di Roma, invece di essere coltivato in pro degli uomini era riservato a pascolo degli animali e forniva una modesta quantità di frumento 9 . 3 ENTE MAREMMA, La riforma fondiaria in Maremma. Programmi e prime realizzazioni, Roma 1953; per lo stretto rapporto fra malaria e latifondo, P. CORTI, Malaria e società contadina nel Mezzogiorno, in Storia d’Italia, Annali, 7, Torino 1984, pp. 635-678. 4 L. DASTI, Notizie storiche e archeologiche di Tarquinia e Corneto, Tarquinia 1910/2 (1. a ed. 1878), p. 99. 5 Ibid, pp. 410 e sgg. 6 A. BELLETTINI, La popolazione italiana dall’inizio dell’era volgare ai giorni nostri. Valutazioni e tendenze, in Storia d’Italia Einaudi, vol. V, Torino 1973, pp. 505 sgg. 7 TOMASSETTI, La campagna cit., I, pp. 128-158; P. PECCHIAI, Roma nel Cinquecento, Bologna 1948, pp. 286294; G. CAROCCI, Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI, Milano 1961, pp. 300-307; sui meccanismi di espulsione dei contadini E. SERENI, Il capitalismo nelle campagne (1860-1900), Torino 1968, pp. 166-175. 8 ROSSI, L’Agro, cit., p. 106; S. CONTI, Le sedi umane abbandonate nel Patrimonio di S. Pietro, Firenze 1980. Più in generale, C. KLAPISCH - ZUBER, Villaggi abbandonati ed emigrazioni interne, in Storia d’Italia Einaudi, vol. V, Torino 1973, pp. 309-364. 9 Costituzione Urbem Romam, M. P. di Paolo V del 6 ottobre 1608, riprodotta a stampa in Alla eccellentissima commissione mista incaricata della dimissione dei debiti delle Comunità. Cornetana. Di Tassa sopra i Pascoli Nel 1701 la popolazione della città toccava il suo minimo storico, 1.891 abitanti. Ma già nel 1439 era stato ristretto il circuito della Città verso la Chiesa di Castello, perché era rimasto disabitato da quella parte e nel 1478 a causa di una epidemia molti abitanti morirono e molti scasarono et detta città è restata senza popolazione et lavoranti 10 . Era già allora evidente l’urgenza di arrestare il declino demografico mediante introduzione di famiglie forestiere, e 200 famiglie provenienti dalla Lombardia nel 1474, e “molte famiglie Albanesi venute a domicilio” nel 1482, colmarono almeno in parte i vuoti. Si cercò di agevolare il loro inserimento, e un “sussidio da distribuirsi alle 200 famiglie di Lombardi” fu deliberato nel 1491 11 . Gli innesti di popolazione non potevano tuttavia avere che effetti limitati in presenza di cause strutturali demovore, a rimuovere le quali le autorità cittadine non avevano forse né consapevolezza né autorità né volontà. Si continuava così ad agire sugli effetti, e gli statuti di Corneto del 1545 disposero che, a qualunque forestiero volesse accasarsi in città, la comunità doveva assicurare la disponibilità (per quanto non gratuita, si crede) del terreno sufficiente a costruire una casa e a impiantare una vigna, il permesso di possedere dieci vacche e cinquanta pecore, e l’esenzione fiscale per un decennio 12 . Le agevolazioni non potevano essere sufficienti a creare condizioni veramente allettanti per gli “esteri”, i quali avrebbero dovuto disinvestire in patria per impiantarsi in una città che, a fronte di aleatorie prospettive di miglioramento economico, offriva le certezze di un difficile inserimento in un ambiente nuovo e in un clima micidiale. Sta di fatto che nel 1608 Paolo V certificava il declino di un’agricoltura ormai consegnata al pascolo, e i provvedimenti adottati in conseguenza, prevedendo facilitazioni Comunali. Per la popolazione di Corneto. Sommario, Roma 1821 (in ABFT); una valutazione del M.P. e dei suoi effetti è in Lotte e contrasti intorno alle lestre dell’Università agraria di Corneto e Tarquinia, a c. di B. BLASI, in “Bollettino S.T.A.S.”, n. 14 (1985), p. 260. 10 DASTI, Notizie, cit., pp. 346, 354. 11 Ibid, pp. 352-360. 12 M. RUSPANTINI, (a cura di), Gli statuti della città di Corneto, MDXLV, Tarquinia 1982, cap. XIII del lib. V. Extraordinariorum. alla commercializzazione dei cereali, dovettero effettivamente incentivare l’agricoltura e aprire per Corneto effettive possibilità di tenuta demografica e di ripresa nel lungo termine. L’azione combinata delle agevolazioni statutarie, degli incentivi papali, della posizione relativamente felice della città, del suo cospicuo patrimonio edilizio, di un tessuto sociale resistente, fece sì che, come si notava a metà dell’Ottocento, non pochi si son trasferiti a fissare la loro dimora a Corneto, e può asserirsi che quella città è l’aggregato di tante famiglie forastiere 13 3. Forme della migrazione In un ambiente come quello maremmano che si potrebbe definire di bassa pressione demografica e di elevato potenziale economico era naturale che si riversassero correnti migratorie da aree, come quella appenninica, nelle quali la pressione demografica eccedeva il potenzale economico: specie se questo denunciava, come avvenne sul finire del Cinquecento, rigidità superiori alla norma e il sistema manifestava incapacità di adeguamento 14 . Dalle Marche, in particolare, si registrano trasferimenti di famiglie già nel Quattrocento 15 : ma sono casi isolati, le Marche sono in quel periodo terra di colonnizazione intensa, e dunque prevalentemente di immigrazione 16 Nella seconda metà del Cinquecento invece la terra è ormai capillarmente appoderata e coltivata, e l’aumento di popolazione, che in montagna ha raggiunto uno dei suoi massimi storici, si accompagna alla messa coltura dei terreni sempre più elevati e marginali, con rese calanti fino alla rottura dell’equilibrio posizione-risorse. La rottura si manifesta drammaticamente nel 1590, ma se ne colgono segni fin dagli anni 13 N. MILELLA, Relazioni intorno all’incarico datogli di visitare i territori di Corneto e Montalto di Castro per investigare i bisogni di quelle popolazioni e per suggerire i mezzi più opportuni per provvedervi, Roma 1848 (in ACT); la frase successiva della relazione (“però.... da quarant’anni in qua non v’è stata alcuna persona che siasi recata a stabilire il suo domicilio a Corneto”) contrasta con altre risultanze e andrebbe verificata sulle scritture di anagrafe parrocchiale. 14 F.C. SPOONER, L’economia dell’Europa dal 1559 al 1609, in Storia del Mondo Moderno Cambridge, vol. III, trad. it. Milano 1968, pp. 14 - 17; R. ROMANO, La storia economica. Dal secolo XIV al Settecento, in Storia d’Italia Einaudi, vol. II, Torino 1974, pp. 1813-1934. 15 M. MUNARI, Monte Romano 1456-1853. Quattro secoli di urbanistica. Nascita di una comunità, Viterbo 1980, pp. 21-25; DASTI, Notizie cit., p. 254. 16 S. ANSELMI, L’agricoltura marchigiana nella dimensione storica, in ID. (a cura di), Insediamenti rurali, case coloniche, economia del podere nella storia dell’agricoltura marchigiana, Jesi 1985, pp. 31 sgg.; ID., La rivoluzione agricola dei secoli XIV e XV, in ID. (a cura di), Economia e società: le Marche tra XV e XX secolo, Bologna 1978. Settanta 17 . Ed è appunto negli anni Settanta che si registrano le prime testimonianze di emigrazioni stagionali collettive verso le Maremme: da Ussita (“discendentibus universis indigenis 18 ”) e da Mercatello (“familiae prope omnes 19 ”). Tali correnti, prodotte dal sovraccarico umano della montagna combinato alla fame di braccia delle spopolate campagne laziali, muovono lungo i percorsi della transumanza pastorale e con questa convivono per secoli. La transumanza, che ha tradizioni antichissime e forme ancestrali 20 , ha carattere di reciprocità, nel senso che in diversi periodi storici ma anche contemporaneamente possono essere i proprietari della montagna a spostare il loro bestiame per farlo svernare in pianura, o i proprietari dellla pianura a spingere il bestiame negli alpeggi estivi: nell’uno e nell’altro caso i pastori (vergaro, pecorari, biscini) sono generalmente originari della montagna. E’ sulla scia delle correnti transumanti che, a seguito anche dei provvedimenti di Pio V intesi a erodere il latifondo e a favorire l’agricoltura contro il preponderare della pastorizia 21 , si sviluppa nel tardo Cinquecento un afflusso di manodopera stagionale che viene impiegata soprattutto nella cerealicoltura, ma anche in altre lavorazioni agricole. Si tratta quasi sempre di piccoli proprietari coltivatori, che integrano un reddito divenuto nelle loro terre sempre più avaro sfruttando lo sfasamento stagionale della coltura dei cereali. In montagna si semina presto e si miete tardi. Arano i loro terreni, seminano e partono, lasciando allae famiglie la cura delle lavorazioni intermedie, che del resto in montagna per varie ragioni sono meno complesse. In Maremma sono attesi per le lavorazioni di sterpatura, ribattitura, terranera, mondarella. Molti, attorno ai centri collinari meno degradati, come Corneto, sono anche impiegati nelle operazioni invernali di viticoltura, di orticoltura. Presto comincia il taglio dei fieni, al quale fa seguito la mietitura. La “trita” conclude 17 Esemplari le vicende economiche e demografiche di un’area della montagna marchigiana studiate da E. DI STEFANO, Una comunità della montagna camerinese in età moderna: Appennino fra XVI e XVII secolo, in “Proposte e Ricerche”, 7 (1981)., pp. 108-126; ID., La “crisi” del Seicento nell’area appenninica: il territorio camerte, in “Proposte e Ricerche”, 17 (1986), pp. 73-85; per altre aree R. PACI, Politica ed economia in un comune del ducato di Urbino: Gubbio tra’ 500 e ‘600, Urbino 1967; S. ANSELMI (a cura di), La montagna tra Toscana e Marche. Ambiente, territorio, cultura, società dal medioevo al XIX secolo, Milano 1985; C. CASANOVA, Comunità e governo pontificio in Romagna in età moderna, Bologna 1981. 18 P. PIRRI, Ussita, Roma 1920, p. 201. 19 Visitatio urbinatem ecclesiae, item Mercatelli, Lamollarum, Sestini, Monasterii, in ARCH. SEGR. VAT., Visitationes Apostolicae, n. 22. 20 “Nessuno può seriamente obiettare oggi sull’antichità e la continuità attraverso i templi dell’economia della “transumanza”, almeno fin dal Neolitico” (G. CASELLI, La “Via Tyrrhenica” e altri percorsi pastoali della Toscana collinare, in Campagne maremmane tra ‘800 e ‘900, Firenze - Grosseto 1983, p. 288). Di un convegno su transumanza e pastorizia tenuto a Ussita nel settembre 1984 sono in corso di pubblicazione gli atti a cura del Cento di Studi Storici Maceratesi. il ciclo 22 , ma sono già partiti quasi tutti per tornare alle loro case 23 quando ormai anche i loro campi cominciano a imbiondire, e nelle maremme l’aria si è fatta greve e malsana. Così ogni anno, per secoli, fino agli inizi del Novecento. Le ondate migratorie degli stagionali generano fatalmente il terzo tipo di emigrazione, quella permanente. Chi in patria ha meno da perdere, anche sul piano umano; chi riesce a farsi un credito con la propria capacità e laboriosità; chi riesce a combinare i suoi piani con qualche zitella o vedova proprietaria di casa; chi sa inventarsi un mestiere; chi infine ha un gruzzoletto da investire ed è in grado di sfruttare le agevolazioni statutarie; chi trova uno stabile impiego nelle aziende di campagna o nei palazzi dei cornetani ricchi: tutti costoro finiscono per cogliere l’occasione e si accasano in città, acquisendo ben presto i diritti dei cittadini originari. 4. “L’aggregato di tante famiglie forastiere” Come, attraverso l’assorbimento di popolazione immigrata, Corneto sia riuscita (a differenza della maggior parte dei centri vicini) ad assicurarsi una sostanziale tenuta demografica e poi vistosi incrementi, e quale sia stato il contributo dei marchigiani al ripopolamento di questa città che per tanti di loro è stata maledizione e al tempo stesso west avventuroso e terra promessa, è dunque il tema di queste pagine. Il contributo si limita, anche per la distanza dell’autore delle fonti documentarie, alla tabulazione di dati che si ritengono in vario modo utili, e ad annotazioni che, rinviando a quei dati e senza pretesa di esaurire l’argomento, sottolineino, della storia quotidiana e umile di Corneto moderna 24 , gli aspetti che sono sembrati più significativi o più problematici. a) evoluzione complessiva; 21 CARAVALE, Da Martino V cit., p. 329. Sulle tecniche agrarie in area marchigiana G. BATTARRA, Pratica agraria distribuita in vari dialoghi, Cesena 1782/2 (1. a ed. 1778); G. PEDROCCO, Storia dell’agricoltura nelle Marche dall’Unità ad oggi, Urbino 1976; in area laziale L. DORIA, Istituzioni georgiche per la coltivazione de’ grani ad uso delle Campagne Romane, Roma 1799/2 (1. a ed. 1777); E. METALLI, Usi e costumi della Campagna romana, Roma 1982/3 (1. a ed. 1903); A.M. GIRELLI, Le terre dei Chigi ad Ariccia, Milano 1983; ROSSI, L’Agro cit. 23 Risultano quasi tutte stipulate nelle più vicine località della maremma interna, viterbese e toscana, le scritture concernenti la trebbiatura (“gavette di trita” e “trecce di cavalle”) conservate in ABFT, Scrittura ed apoche 1815-1827 e Apoche dell’azienda campestre 1850-1878. 24 Sono gli orientamenti di una storiografia nuova (cfr. L. OSBAT, Gli Statuti della Città di Corneto nel 1545 nel quadro dello sviluppo del centralismo amministrativo dello Stato Pontificio, in “Bollettino STAS”, n. 12 (1983), pp. 5 sgg;) che a Tarquinia, comprensibilmente dato l’immenso prestigio del patrimonio archeologico della città, più stenta a farsi strada. 22 Il dato a quo della demografia cornetana è costituito dai 31.900 abitanti delle “epoche medieali”. I numeri successivi, della metà del Seicento alla metà dell’Ottocento, si collocano su una piattaforma incomparabilmente più bassa. Essi attendono di essere convalidati o confutati, e in qualche passaggio spiegati, come nell’anomalo rigonfiamento dei rilevamenti 1636 e 1742. Nell’insieme tuttavia appaiono accettabili, e il trend positivo che si osserva dall’inizio del Settecento non contrasta che in superficie con la nozione di un saldo naturale costantemente negativo nel Lazio in età moderna (a Roma per tutto il Settecento 25 , ad esempio, e ancora a metà Ottocento a Corneto, dove il Dasti nel 1869 rileva una media annua di 131 nati e di 140 morti): con tutto ciò - osserva lo stesso Dasti - la popolazione in genere non diminuisce, anzi è in qualche aumento per l’aggregazione dei campagnuoli esteri, che si domiciliano di frequente in Corneto e vi si accasano 26 . b) i forestieri; L’incidenza degli “esteri” sulla popolazione residente della città si mantiene sempre molto alta. Nelle campionature dei decessi per i secoli XVII-XVIII i forestieri sono in rapporto di 4:1 con i cornetani. Con la saturazione delle disponibilità edilizie in città e il naturalizzarsi dei forestieri, l’immigrazione incide in proporzione via via minore: ma ancora nel 1874, su una popolazione di circa 5.000 abitanti, i residenti nati altrove sono 992; la stessa proporzione fra residenti e allogeni si rileva nel 1908 nella parrocchia di S. Leonardo. Nel decennio postbellico si registrano ancora ben 1.687 immigrazioni 27 . c) i marchigiani; I marchigiani incidono costantemente per più di un terzo sulla quota di immigrazione. Nel 1874 l’incidenza è ancora del 39,5%; solo sul finire del secolo si registra una netta diminuzione, e nel periodo postbellico la quota marchigiana nei 25 CORRIDORE, La popolazione cit., p. 56. L. DASTI, Statistica della Città di Corneto e suo territorio, quale fu constatata dal sottoscritto nel 1869, al suo ritorno in patria dalla Moldavia dopo nove anni di assenza, a c. di B. BLASI, in Bollettino STAS”, n. 10 (1981), pp. 7 sgg. (manoscritto in ACT). 27 La tab. 3 ne riporta solo 1.387 in quanto di 300 non è indicata la patria. 26 trasferimenti di residenza si riduce a un ormai modesto 8,8%. In definitiva, e malgrado la diminuita affluenza degli ultimi decenni, non si sarebbe troppo sorpresi se appropriate ricerche appurassero che da un quarto a un terzo della attuale popolazione di Tarquinia ha più o meno remote ascendenze marchigiane 28 . d) areali della immigrazione marchigiana; Nel periodo che va dalla fine del XVI secolo alla fine del XVIII prevale nettamente a Corneto la presenza di immigrati (permanenti o stagionali, le annotazioni di morte raramente consentono di distinguere) da un’area comprendente il Montefeltro, l’alta Valtiberina, l’Eugubino, il Camerte, il Vissano: più o meno la dorsale appenninica già indicata come teatro della crisi di fine Cinquecento. Nel campione 1646-1663 il solo Montefeltro è rappresentato da 36 casi, contro 45 casi di cornetani e 147 di altra provenienza. Emblema della crisi dell’area appenninica è Sasso di Simone (una utopica città fatta costruire attorno al 1570 da Cosimo I Medici a 1.200 metri di altitudine), ormai abbandonata dagli abitanti molti dei quali hanno cercato una possibilità di vita in Maremma: in una sola delle sei parrocchie di Corneto, dieci vi trovano la morte fra 1646 e 1662 29 . I dati del periodo napoleonico mostrano ancora una preponderanza del Montefeltro e in particolare di Pennabilli 30 : ma forte è anche la presenza del Vissano, mentre si va delineando quello che nel corso del secolo costituirà un vero e proprio esodo dalle colline intorno Macerata: dalla sola Montemilone-Pollenza proverà più di un sesto (e nel 1874 quasi un terzo) dell’intero contingente marchigiano. Sul finire dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento, estintasi o dirottata all’estero 31 l’emigrazione bracciantile del Maceratese, tornano a prevalere le aree, e le forme, dell’antica transumanza: soprattutto il Vissano, con vari casi di fortunata intraprendenza nell’industria armentizia 32 . 28 Ci piace vedere simboleggiata la “metà marchigiana” di Corneto nella lapide bifronte di cui C. DE CESARIS, Considerazioni su una lapide tombale, in “Bollettino STAS”, n. 11 (1982), pp. 11 sgg. 29 ALLEGRETTI, Disfecemi, cit. 30 Sulla emigrazione da Pennabilli a Corneto G. ALLEGRETTI, Dall’Appennino pesarese alle Maremme: l’emigrazione stagionale tra ‘700 e ‘800, in Campagne Maremmane cit., pp. 157 sgg. 31 Sui vari aspetti e momenti del fenomeno migratorio con particolare riferimento alle Marche si vedano L. NICOLETTI, L’emigrazione dal Comune di Pergola in relazione a quella di altri Comuni della Provincia di Pesaro Urbino, Roma 1909; E. SORI, L’emigrazione italiana dall’Unità alla seconda guerra mondiale, Bologna 1979; G. CAVAZZANI, L’emigrazione nel XX secolo: il caso marchigiano, in “Quaderni di Resistenza Marche”, nn. 11-12 (1986), pp. 5-32. 32 PIRRI, Ussita, cit., pp. 223-263; SERENI, Il capitalismo, cit., pp. 174, 198-199; F. COLETTI, La grande e la piccola industria armentizia dell’Appennino marchigiano, in “Giornale degli economisti”, ottobre 11984. e) gli stagionali; Sembra ovvio pensare che l’immigrazione permanente si alimenti almeno in parte della immigrazione stagionale 33 : ma lo stato attuale delle conoscenze non permette di stabilire precisi rapporti fra i due aspetti del fenomeno. Le migrazioni stagionali sono per la prima volta censite, in Italia, nel 1905. A quella data si danno per arrivati nel comune di Tarquinia 1.670 lavoratori nel periodo gennaio-aprile 1875 in maggio-luglio, 2.245 in agosto-dicembre. Il rapporto fra avventizi e popolazione stabile è di 38: 100 nel periodo di massima affluenza: è un rapporto alto, ma tale ancora da non condizionare totalmente l’economia della città e da non stravolgerne l’assetto sociale: molto più condizionante deve essere la presenza degli stagionali a Cerveteri, con un rapporto di 102:100, e soprattutto a Montalto, dove il rapporto è di 237:100 34 . Sessant’anni prima, nel 1848, la relazione Milella valutava in 2.000 gli avventizi presenti a Corneto 35 . Per l’antico regime non sono disponibili informazioni complessive, ma l’impressione è che nei secoli XVI-XVIII il numero resti molto al disotto delle 2.000 unità necessarie alla coltivazione del 16.000 ettari (su 27.700) effettivamente coltivati a metà Ottocento 36 : se così è, la palude, l’incolto, il pascolo e il bosco devono aver occupato nei secoli precedenti una estensione molto maggiore. f) i quadranti; Nello stato d’anime 1790 della parrocchia di Santa Margherita sono registrati, assieme ai 390 abitanti stabili, 157 quartieranti. Dei 390 parrocchiani, 175 sono indicati come cornetani (originari o naturalizzati) e 160 come forestieri; di questi, 58 sono marchigiani. Ma l’interesse maggiore del documento sta appunto nella insolita menzione dei quartieranti, che sono con ogni evidenza gli stagionali: si distinguono sia dai “garzoni” che coabitano stabilmente con le famiglie per le quali lavorano, sia dagli avventizi sistemati in campagna che nessuno conosce e si cura di conoscere. Negli archivi di Tarquinia capita di trovare elenchi di cavalle con nome, età, sommaria descrizione e note caratteristiche anche comportamentali, annotazioni di 33 Sui vari aspetti della emigrazione dalle Marche, e in special modo sulla emigrazione stagionale, ALLEGRETTI, Marchigiani, cit. 34 MIN. AGR. IND. COMM. UFF. LAVORO, Le correnti periodiche di migrazione interna in Italia durante il 1905, Roma 1907. 35 MILELLA, Relazioni cit., all. A/Corneto. Notizie statistiche ecc. 36 Ibidi, Distinzione della superficie ecc. figliatura e di morte: ma non esiste un solo elenco di lavoratori stagionali 37 . Essi entrano nella documentazione scritta solo in casi eccezionali e solo se qualche particolarità li colleghi ai residenti. Così, con la vedova Maria Domenica Bernasconi da Sant’Angelo in Vado e i suoi due figli di sette e due anni, è registrato nella casa del Capitolo anche “Domenico il castrataro, che dorme in campagna, ma è custodito circa i panni dalla suddetta Maria Domenica”: evidentemente è registrato fra le “anime” solo perché la giovane vedova lo accudisce “circa i panni”, e dunque in qualche modo ha un recapito fisso che lo rende identificabile, ma al di fuori di pur tenui possibilità di connotazione, si situa l’oscuro mondo degli stagionali senza recapito e senza identità. Le famiglie che ospitano quartieranti sono per lo più di origine forestiera, e generalmente ne tengono più d’uno. Biagio Rossi di San Leo ne ospita addirittura 45; Sebastiano Cerbini da Toscanella ha in casa 14 pigionali. Alcuni invece si acquartierano in proprio, come i 7 che vivono nella casa dei Padri di Castello; e un caso del genere si riscontra anche in parrocchia San Leonardo, dove nel 1792 si trovano riuniti in una casa 13 lavoratori di vari paesi del Montefeltro 38 . Nell’elenco dei 157 quartieranti di Santa Margherita, in 97 casi è indicata la professione: si tratta di lavoranti ai grani in 56 casi, di vaccari in 18, bifolchi 9, vignaroli 6, garzoni 5, casenghi 2, castratari 1. C’è anche qualche nucleo familiare al completo, con donne e bambini; ma in generale, salvo pochissime eccezioni, si tratta di emigranti maschi e adulti (con l’avvertenza che nel mondo della migrazione si diventa adulti a tredici anni). Nulla invece si può dire della loro proveninza, perché la “patria” non viene quasi mai indicata. Ma i numeri, e le classificazioni, dicono molto meno di una lettura “dall’interno” del documento; lettura che consente di ricostruire in modo più suggestivo e coinvolgente strutture familiari e rapporti sociali, insomma di “entrare in casa”. 37 Anche questo del 1790 è tutt’altro che esauriente: di pochissimi quartieranti si riferiscono cognome e patria, la maggior parte sono indicati con un numero complessivo (ad esempio: “Nella casa del Beneficio Riccardi. Biagio Rossi di San Leo, figlio di Antonio Rossi, anni 35, cr. com. Quartieranti numero quarantacinque, e la maggior parte di comunione: tutti lavorano ai grani”). E’ ancora inspiegata la ragione per la quale non viene registrata né l’assenza degli stagionali negli stati d’anime delle parrocchie d’origine, né la loro presenza negli stati d’anime delle parrocchie maremmane. Diversa la situazione per la diocesi di Porto, dove le gravissime condizioni morali e materiali dei monelli costringe i vescovi a tenere sotto controllo il fenomeno fin dal ‘600 (ROSSI, L’Agro cit.). Nelle scritture aziendali (ABFT) non si sono trovati neppure elenchi parziali. 38 ASLT, Stati d’anime 1768-1793¸Stato d’anime 1792. Tutti gli altri casi si riferiscono allo Stato d’anime 1790 di Santa Margherita, cit. Nella casa della confraternita della Misericordia abita una Maria Bernardini da Gubbio, ventitreenne vedova di un certo Marino, con la figlia Caterina di due anni. Tiene una famiglia di quartieranti: Andrea Piastra da San Sisto nel Montefeltro, 40 anni con la moglie di 30, un figlio di 9 e uno di 4, uno zio di 60 anni. Nella simbiosi tra padrone di casa e quartierante può capitare, come in questo caso, che sia l’ospite ad assumere funzione portante E, in questo caso, cogliamo probabilmente il momento di passaggio tra la condizione dello stagionale e quella dell’immigrato stabile; Andrea Piastra sarà arrivato nelle stagioni precedenti da solo, e poi si sarà deciso a portare anche la famiglia; il passo successivo sarà di metter su casa in proprio, appena possibile. Entriamo in un’altra casa, di proprietà dei Padri di Castello anche questa, dove abita Cesare Chienna di Parchiule nella Massa Trabaria, vedovo quarantaseinne di Maria Domenica Carciani (altro cognome massano), con la moglie di Pietra Savelli anche lei di Parchiule e anche lei vedova, e con tre figli di primo letto di lui e un figlio di primo letto di lei. La morte, in queste terre, moltiplica talami e bare. Tengono quattro quartieranti: Gian Andrea Sebastiani col figlio Domenico e Girolamo Monticelli col fratello Giovanni. Eccoli finalmente ubicati, i due figli di Domenico Monticelli di Piandimeleto, che la madre dà per dispersi “a Roma” e forse morti, assieme al padre, nelle scritture di affitto delle terre di famiglia 39 . Avere quartieranti “delle proprie parti” può essere una risorsa, se non proprio un mestiere, per molti marchigiani accasati a Corneto. Si riproduce nel capoluogo maremmano un microcosmo urbano della immigrazione che arricchisce le opportunità economiche e diversifica le figure sociali. Nel 1706, è stato già segnalato, un tale di Pennabilli possiede a Corneto una casa con un letto di tavole e un’altra casa da dare a nolo ai compaesani, ai quali fa anche credenza di piccole quantità di pane e denaro 40 . Nel 1811 la partizione della popolazione in cornetani, forestieri accasati e avventizi è chiara anche all’estensore della statistica. 255 sono i cornetani, 136 gli “esteri” e solo 74 le “persone avventizie dimoranti nella parrocchia [...] nel dì 23 marzo 1811 che nei mesi estivi ritornano alla loro patria”. Sono ancora prevalentemente iin gruppo, e il gruppo più numeroso, 22, è quello acquartierato nel magazzino del Seminario. Non ci 39 Il caso è segnalato in G. ALLEGRETTI, Piandimeleto 1574-1860, in corso di pubblicazione (cap; II/6). L’identità dei due giovani è stata verificata in ARCH. PARR. PIANDIMELETO, Libro dei battesimi 1793-1842. 40 ALLEGRETTI, Dall’Appennino cit., p. 160. sono donne; c’è un solo bambino sotto i quattordici anni 41 : si ha l’impressione che il fenomeno sia contenuto e controllato dalle nuove autorità di governo. g) cadaveri non identificati: 5 martii 1746. Inventum fuit in hoc teritorio cadaver cuius nomen et patria ingnorantur et [...] illud nemo cognovit licet expositum [...] 42 . Aveva ben ragione, la madre dei giovani Monticelli, non vedendoli tornare a casa, di sospettare che fosse accaduto a loro ciò che accadeva a molti. Nel campione 17461755, su 205 cadaveri sepolti, 39 sono trovati nei campi e in genere restano senza riconoscimento di identità. Responsabile maggiore di queste morti sembra la malaria, che colpisce soprattutto all’inizio dell’estate, quando i “montanari” stanno per tornare ai loro paesi: fra il 21 e il 26 giugno 1748 vengono trovati nelle campagne 5 cadaveri. Il fenomeno, che non si riscontra ancora nel campione 1646-1663, conserva invece rilevanza nel periodo 1790-1810: su 552 sepolti, figurano 70 morti in abbandono dei quali 20 restano senza nome, 20 morti per varie disgrazie connesse alla vita rurale, 15 morti per fatti di sangue. Sono numeri che dicono molto sulla durezza della condizione dei lavoratori in questa area (anche se par giusto ricordare che incidenti, delitti e morti repentine incidono fortemente in tutte le popolazioni di antico regime). Nel Seicento, il numero degli avventizi è minore e gli spazi disponibili all’interno delle mura cittadine sono maggiori: per questo, forse, tutti gli avventizi registrati muoiono in qualche casa di città, magari “in quodam stabulo super palea 43 , e non ancora dispersi nelle lestre o nei pantani come più tardi si verificherà; ma potrebbe anche supporsi che le confraternite non si curino ancora, o non siano in grado, di recuperare i cadaveri e di portarli a sepoltura in città. Anche sull’elevato numero di morti non identificati nel Settecento si potrebbero avanzare interpretazioni diverse e contrastanti (ad esempio: caporalato ancora poco diffuso, oppure efferata disumanità 41 Stato delle anime esistenti nella parrocchia della ven. Chiesa cattedrale e parrocchiale di S. Maria e Margarita di Corneto nel dì 23 marzo 1811, in ASMT. 42 ASMT, Liber mortuorum 1736-1683 cit. 43 ASMT, Liber mortuorum 1646-1683 cit.; sui morti in campagna e sulla assistenza agli avventizi A. PORFIDO, Mons. Bonaventura Gazola O.F.M., in “Bollettino S.T.A.S.”, n. 14 (1985), pp. 232-234. In campagna vengono censiti nel 1853 cento casali, ma sono o disabitati, o abitati da un garzone; d’inverno vi trovano ricovero i pastori (Relazione in ACT, XV/5); utili indicazioni sulla evoluzione dei casali in R. COMBA, Le origini medievali dall’assetto insediativo moderno nelle campagne italiane, in Storia d’Italia, Annali, 8, Torino 1985, pp. 795 sgg. dei caporali 44 ). Le ambivalenze denunciano l’inadeguatezza degli studi sulla materia e postulano una estensione delle ricerche. h) una popolazione pioniera; La popolazione residente di Corneto mostra, almeno fino a tutto il Settecento, evidenti caratteri di popolazione pioniera, cioè maschia e adulta: che è poi anche, va da sé, una popolazione meno vitale. Nel 1646-47 le donne rappresentano il 35,2% del totale dei morti; nel 1790-1810 rappresentano il 40,9%. La percentuale sarà naturalmente minore tra gli immigrati (nel 1853 tra i residenti di origine marchigiane le donne costituiscono il 25%), e minore ancora tra gli avventizi (fra i quartieranti del 1790 in parrocchia Santa Margherita il 4,2%). Per quanto riguarda l’età, è caratteristica di questa popolazione la bassa incidenza delle fasce estreme. Nel 1646-47 i morti in età inferiore a un anno sono il 9,1%; nel 1759-60 rappresentano il 24,5%; nel 1790-1810 il 18,6%; i morti in età inferiore ai 10 anni rappresentano, rispettivamente, il 27,3, il 44,9 e il 41,1%. Sono valori molto bassi rispetto ai livelli normali che possono collocarsi fra il 55 e il 60% 45 ; lo stesso può dirsi dei morti in età superiore ai 60 anni (rispettivamente 4,5, 12,2 e 11,4%, mentre una popolazione “normale” registra valori oscillanti tra il 16 e il 25%). A conclusioni analoghe si giunge esaminando la struttura della popolazione vivente: nello stato d’animo di Santa Margherita del 1790 gli abitanti inferiori ai 10 anni di età rappresentano il 20,8% del totale, quelli in età superiore ai 60 anni appena il 5,6%. i) la presenza femminile In uno studio su Anguillara, Renata Ago ha bene illustrato il significato della presenza femminile nella società di un villaggio laziale di immigrazione, anche per ciò che riguarda l’integrazione dei forestieri 46 . Si può dire che la scarsità delle donne ne esalti il ruolo: ciò è comprensibile e in qualche modo scontato. Non sarà tuttavia inutile aggiungere qualche elemento di informazione e giudizio. Anzitutto sulla longevità delle donne: muoiono oltre i 70 44 Propendiamo e per un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli avventizi tra XVII e XVIII secolo, e per una più tarda generalizzazione dell’istituto del caporalato; sulle confraternite cornetane M. CORTESELLI, A. PARDI, Corneto com’era. Chiese, Confraternite e Conventi cornetani di un tempo, Tarquinia 1983, pp. 155 sgg. 45 C. VERNELLI, Vicende demografiche di un comune agricolo delle Marche: Morro d’Alba, 1558-1861, in “Proposte e Ricerche”, nn. 3-4 (1979), pp. 99 sgg. 46 AGO, Braccianti, cit. anni, nel campione 1790-1810, il 7,1% delle donne e solo il 3,4% degli uomini (e questi quasi esclusivamente ecclesiastici o”signori”). Inoltre, in più di un caso la presenza delle donne rivela anche nel mondo del lavoro un peso molto maggiore di quanto ci si possa attendere: si pensi alla figura, ben nota ai cornetani, della contessa Maria Giustina Bruschi Falgari nata Quaglia, per lungo tempo energica amministratrice del patrimonio familiare 47 ; ma anche a quella, tanto più umile ma inedita e sorprendente, di Maria Magni, analfabeta “caporala nativa della terra di Monteromano”. E’ vero che la mercede per i suoi “uomini monelli” è un po' più bassa di quella spuntata dai colleghi maschi, e che i suoi contratti sono approvati e sottoscritti dal marito: ma insomma la donna resta attiva sulla piazza per molti anni, per lo meno dal 1841 al 1859, e nel mestiere di caporale, difficile non meno che famigerato, pochi sanno restare in sella tanto a lungo 48 . Infine, ci si aspetta di trovare la retribuzione delle donne nei lavori di campagna più bassa di quella degli uomini, e sarà senz’altro così. Tuttavia, nell’unica serie significativa (11 pagamenti fra 1803 e 1811) che nel corso di questa ricerca sia stato possibile ricostruire, e nella quale il raffronto è ineccepibile perché istituito fra pagamenti simultanei per lavori identici, la retribuzione media delle donne risulta di baiocchi 10.1, quella degli uomini di 9.2 49 . Non basta certo a concludere che le donne sono pagate meglio degli uomini, ma suggerisce per lo meno qualche riserva su inveterate convinzioni pregiudiziali, e ancora una volta evidenzia la necessità di ricerche sistematiche che queste pagine, nella più alta delle loro ambizioni, mirano a stimolare. Girolamo Allegretti L’autore desidera ringraziare quanti a Tarquinia gli hanno agevolato la consultazione degli archivi in particolare le dottoresse Patrizia Ceccarini e Maria Lidia Perotti, il maestro Bruno Blasi che gli ha sacrificato molto del proprio tempo e gli è stato prodigo della propria conoscenza di uomini e cose cornetane, padre Guglielmo Amadei parroco di San Giovanni Battista. 47 R. CIALDI, Notizie genealogiche della famiglia Bruschi Falgari dal 1592 al 1923, ms. in ABFT. ABFT, Anno 4°. Azienda di campagna. Stagione 1841 in 1842, fasc. 1 e 3; Apoche dell’azienda cit., nn. 94, 109, 129, 196. 49 ABFT, Inserti volanti in Esito ed introito vigne e chiuse Bruschi Falgari. 48 Un ringraziamento è dovuto all’Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione di Pesaro, che ha sostenuto con un contributo finanziario la ricerca. L’indagine negli archivi cornetani è confluita con altre ricerche nei saggi Marchigiani in Maremma (in S. ANSELMI (a cura di), Marche, di prossima pubblicazione per Storia d’Italia Einaudi, Regioni); Disfecemi Maremma. Note sulla disertata “città” del Sasso di Simone (di prossima pubblicazione in “Studi Montefeltrani”, 13). Il materiale non ancora utilizzato potrà essere elaborato in altri studi: ma solo con la paziente sistematica ricerca di studiosi locali si può pensare di giungere a risultati meno frammentari e precari. ABBREVIAZIONI ACT Archivio Storico comunale, Tarquinia ABFT Archivio privato Bruschi Falgari, presso Società Tarquiniense di Arte e Storia ASMT Archivio della parrocchia di Santa Maria e Margherita, presso Archivio del duomo, Tarquinia ASLT Archivio della parrocchia di San Leonardo, presso Archivio parrocchiale SS. Antonio e Giovanni Battista, Tarquinia. Ho utilizzato le risultanze delle indagini d’archivio svolte a Corneto nei saggi. REPUBBLICA MINORE Vicende 1848-49 della Corneto Repubblicana Corneto: 19 marzo 1849, festa di S. Giuseppe. Quella sera una Compagnia di Comici darà spettacolo nel Pubblico Teatro della Città di Corneto. Da circa quattro mesi il Pontefice Pio IX ha lasciato il Quirinale per mettersi al riparo in Gaeta sotto la protezione del Re di Napoli Federico II di Borbone. Da circa quaranta giorni l’Assemblea Costituente di Roma ha dichiarato decaduto il potere temporale del Papa e con 120 voti su 143 votanti, ha decretato la nascita della Repubblica Romana. Il potere esecutivo è in mano ad un primo triumvirato (Saliceti, Ermellini, Montecchi) che, fra dieci giorni, sarà sostituito dalla terna Mazzini, Saffi ed Armellini. Se è vero che la matrice di quanto sta avvenendo è di natura politica, è anche vero che in ogni angolo della novella repubblica, principalmente a Roma e nelle grandi città delle legazioni, dilagano in terrorismo e le vendette private. : A mantenere un minimo di ordine non servono pochi carabinieri, o bersaglieri, la Guardia Civica o qualche sgangherata Compagnia di Reduci residua di quel corpo di spedizione che Pio IX ha inviato l’anno scorso alla Guerra di Lombardia sotto il comando del Generale Durando. E Corneto? Nel suo piccolo la città fa quanto può per contribuire al marasma del momento ma senza raggiungere particolari eccessi. Gaeta è troppo vicina a Roma e Pio IX non ha alcuna intenzione di rimanervi a lungo. Diamogli assieme un’occhiata: Governatore della Città e custode dell’ordine repubblicano è il romano Augusto Colombo che dipende funzionalmente dal Preside (Prefetto, n.d.r.) di Civitavecchia Michele Mannucci. E’ un ex funzionario dello Stato Pontificio con famiglia a Roma e inquilino, a Tarquinia, in una casa di proprietà dei fratelli Alfonso e Cesare Sbrinchetti. Una specie di impiegato statale che cerca di servire la repubblica così come ha servito Pio IX. Non ama le decisioni drastiche nè gli spargimenti di sangue. Interviene solo se è preso per il collo dagli avvenimenti e cercando di non compromettersi più di tanto. Gonfaloniere della Città, quello che i posteri chiameranno sindaco, è Domenico Boccanera. Anch’esso sembra essere un moderato; gode di molto prestigio presso la cittadinanza e malgrado le incertezze politiche del momento ha il coraggio, forse per avere fatto male i suoi conti, di dichiararsi di fede repubblicana. Da pochi mesi è attivo il Circolo Popolare di Corneto del quale è vice presidente il signor Conte dr. Pietro Soderini. Il suo statuto è stato stilato nella base di quelli adottati dagli stessi circoli di Roma e di Ancona che godono fama di essere, tra gli ammazza-preti, i più spinti e facinorosi. Esso prevede “come diritto quello di petizione e come scopo quello soltanto di interessarsi di affari municipali quali potessero migliorare la condizione sociale dei cittadini.”. Vi aderiscono ceti diversi ma la sua matrice è ovviamente progressista e liberale. Tra gli aderenti più in vista si notano i cerusici dr. Francesco Mascioli, dr. Pietro Orazi e dr. Luigi Lattanzi: tre borghesi illuminati, che a tutela dello spirito e del corpo dei cornetani, alternano la dispensa di idee a quella del chinino. Quest’ultimo è la panacea di ogni malanno ma la civica salute è ulteriormente assicurata dall’Ospedale Pubblico Buonfratelli, condotto dai frati Fatebenefratelli, dove i tre dottori sunominati si alternano, con turni mensili, per la visita giornaliera ai ricoverati. L’organico dell’ospedale è poi completato da altri tre specialisti: il Reverendo Padre Priore Romualdo Michelacci per l’amministrazione, il laico Fra Camillo De Acetis come infermiere e infine il signor Giovan Battista Belli con funzioni di facchino e di becchino sia per l’ospedale che per la città. Il dr. Mascioli, tra l’attività cerusica e quella del Circolo Popolare, trova il tempo di curare l’amministrazione della “bottega ad uso di caffé” condotta da Giuseppe Forchieri e chiamata, dal nome dell’antico padrone, caffé Reali. Questo è certamente il locale che va per la maggiore. I suoi battenti, ad onta delle severe restrizioni del decaduto “governo dei preti” adesso restano solitamente aperti fino alle ore piccole del mattino. Tra un bicchiere e l’altro vi si parla di tutto ma principalmentem com’è facile intuire, si discutono le incalzanti vicende politiche del momento. Vi si incontrano sia “bianchi” che “neri”: i primi che vivono la loro stagione di gloria dando fiato alle loro corde vocali e i secondi che tacciono, appartati, ingoiando rabbia e caffé in attesa di una rivincita che non è improbabile. Infatti troppe incertezze mettono in dubbio la possibilità di sopravvivenza della repubblica. Figure di Santi e di Madonne hanno incominciato a piangere in vari angoli dell’ex Stato Pontificio; ma soprattutto fatti meno miracolosi alimentano le speranze dei neri: in Francia l’Assemblea “Repubblicana” non eclude ancora una possibile spedizione in aiuto del Papa. Queste incertezze alimentano l’esistenza tra i bianchi e i neri, di una terza e più numerosa frazione di cornetani pronta a dichiarare la sua profonda fede politica solo a cose sicuramente finite. Terminiamo qui il nostro tentativo di dare un quadro generale di quell’epoca ed una fotografia di Corneto ripresa nel giorno di S. Giuseppe del 1849. Abbiamo scelto questa data perché quella sera, durante e dopo lo spettacolo dato dai comici nel Pubblico Teatro della Città, avverrà l’unico fattaccio di sangue della Corneto repubblicana. Ma prima di soffermarmi su di esso narriamo, con le parole del cronista di allora, d’un paio di episodi già prima avvenuti: “Mentre si verificava in Roma un qualche principio di turbolenza popolare a carico specialmente di molti Cardinali su i primi di maggio del 1848, ed alcuni di questi intimoriti s’involavano alla Capitale, Casimiro Falzacappa la mattina del 3 detto mese spargeva voce in Corneto e asseriva di aver veduti dalla sua abitazione gli Eminentissimi Cardinali Macchi e Gizzi (Segretario di Stato e Presidente del Consiglio dei Ministri sotto Pio IX - n.d.r.) rifugiati nell’abitazione di contro di proprietà ed uso di Domenico Boccanera, e così dicendo istigava la Guardia Civica a procederne all’arresto. Un numero difatti di Militi Cittadini... guidati dal Tenente Domenico Marzoli si faceva ad intromettersi nella casa del Boccanera, e perquisiva ogni angolo, dopo di che correva pure a ricercarli nel vicino Convento e Chiesa di S. Francesco, dove il Falzacappa diceva averli veduti entrare travestiti. Nè paghi di ciò, veduto vano ogni tentativo, e seguendo sempre i suggerimenti del Falzacappa si recavano ancora quei Militi nei Casini di Campagna al Boccanera appartenenti, e ricercavano quelli puranco, ma sempre inutilmente, perché era stato il tutto un sogno del Falzacappa, fatto forse ad arte onde mettere in compromessia taluno, e probabilmente quel Gonfaloniere d’allora (Boccanera -- n.d.r.) il quale si mostrava restio a lasciarsi predominare dalle prepotenze dei due fratelli Falzacappa”. Per questo episodio, dopo la caduta della Repubblica Romana, alcuni Cornetani (dr. Mascioli, dr. Lattanzi, ed altri del Circolo Popolare - n.d.r.) dovranno rispondere al Supremo Tribunale della S. Consulta per l’accusa: “D’aver promossa la spedizione del 3 Maggio 1848 per il tentato sacrilego arresto degli Eminentissimi Cardinali Macchi e Gizzi, accompagnato da ingiurie atroci e violata immunità”. La Repubblica Romana viene proclamata il 9 febbraio 1849. Il Circolo Popolare di Corneto indice una grande festa cittadina con banda e luminarie che culmina con l’erezione, sulla piazza principale, dell’Albero della Libertà. Un gesto comune a molti centri, grandi e piccoli, dove capita che questi alberi vengano addirittura benedetti dai parroci locali. Ma quell’emblema assume subito i sapore di uno schiaffo in faccia per quei cornetani che la pensano diversamente e che se lo trovano davanti ogni volta che mettono il naso fuori casa. Le possibilità che qualcuno possa tentare di abbatterlo sono molte tanto che, nei giorni successivi, i cornetani più mattinieri scorgono: “il tronco di quello superficialmente bruciato, il che era certo indizio che nella scorsa notte si fosse proceduto ad appiccarvi il fuoco e farlo preda delle fiamme”. Visto però che l’albero repubblicano ben resiste al fuoco papalino qualcuno prende la decisione di usare un mezzo più sicuro e sbrigativo: “Al tocco dell’Ave Maria della sera del 3 marzo 1849 una mano della feccia del popolo, e d’individui tutti reduci dalla galera, e senza alcun dubbio prezzolati all’oggetto irrompeva improvvisamente sulla piazza, ed armata di accetta e di altre armi taglienti si scagliava addosso a quell’albero, e ne tentava con replicati colpi l’atterramento. Accorreva sull’istante la Guardia Civica e si faceva ad inseguire i colpevoli che si davano a precipitosa fuga. Fra questi avevano avuto la principale parte Giovanni ed Adriano Draghi, e Bernardo Molinari soprachiamato Belardo. Mentre i primi due scomparivano alla ricerca della forza, il Belardo si rifugiava a ridosso di un angolo esterno della Chiesa Cattedrale, eludendo così quei militi che lo inseguivano (godimento immunità nei luoghi ecclesiastici per cui, come nel gioco dei quattro cantoni, poteva essere arrestato solo se si fosse scostato dal muro - n.d.r.). Rimanevano i militi a guardarlo a vista e intanto si faceva tutto noto al Governatore Colombo, che udito il tumulto dalla sua residenza, era disceso al sottoposto Quartiere Civico dove si trovava pure il colonnello di quella Guardia, signor Conte Pietro Falzacappa. Si riferiva di più al Colombo che la piazza della Cattedrale era stipata di popolo il quale mostrava quel fermento che indicava poco di buono. Mentre si raddoppiavano le pattuglie Civiche per tutta la Città il Governatore si faceva per mezzo di gentil a richiedere all’E.mo Vescovo Clarelli la facoltà di poter estrarre da luogo immune il Molinari fattori reo di attentato alla sicurezza del Governo e all’ordine pubblico... Giungeva finalmente la risposta dell’E.mo Clarelli... che, contro ogni sua aspettativa, era negativa. Si rivolgeva allora il Colombo al Colonnello Falzacappa chiedendogli consiglio... e da molte non irragionevoli osservazioni veniva il Governatore indotto ad emettere l’ordine di arresto contro il Molinari, non tralasciando però di far preghiera affinché si fosse arrestato in un momento che si fosse staccato dall’immune, come gli si faceva supporre fosse avvenuto... per la grave ebrietà, che facendolo traballare lo costringeva talvolta a scostarsi dal suo posto. Veniva così arrestato il Molinari e in tutta quella notte null’altro avveniva di sinistro.” E veniamo adesso a quel giorno di S. Giuseppe 1849: “quella sera una Compagnia di Comici si esponeva al Pubblico Teatro di quella Città di Corneto. Negli intervalli dello spettacolo e in mezzo agli applausi degli intervenuti si udivano talvolta delle voci di: morte ai neri!.... uscivano specialmente quei gridi da una loggia dell’ordine terzo fuori della quale si vedeva talvolta apparire un lumicciolo acceso, col quale forse quei discoli volevano significare di dar lume a coloro che appellavano neri e probabilmente al Gonfaloniere che sedeva nella sottoposta loggia al lato del Governatore Augusto Colombo e del Signor Conte Dr. Pietro Soderini. Mal tollerando il Governatore quel disordine, nè d’altronde stimandolo degno di troppe energiche misure pregava il Soderini a volersi recare nella loggia donde uscivano quei rumori ed ottenere con buone maniere la cessazione o nel caso contrario minacciare severi provvedimenti. Vedeva gentilmente alle preghiere del Governatore il Soderini, e alle dimostranze di quest’ultimo cedevano pure quei schiamazzanti desistendo da ogni clamore e spegnendo l’accesa face. Aveva quindi termine lo spettacolo e si ritirava ognuno”. Prima di procedere nelle vicende di quella sera vediamo di conoscere chi erano quegli “schiamazzanti”. Ve li presentiamo: - “Salvatore Paniccia, di Francesco, di anni 20, scapolo di professione mugnaio”. - “Vincenzo Painasi, detto Bujolo, del fù Benedetto, di anni 27, ammogliato con una figlia, professione ganarista, addetto alla misura dei cereali”. - “Crispino Fioravanti del fù Giuseppe, pure di Corneto, ammogliato, lavorante alle Saline di Porto Clementino e cognato del Paniccia”. Il Paniccia appare il più interessante dei tre nonché il capo banda di quanto è avvenuto e di quanto avverrà quella notte. Egli è un “Reduce della Lombardia” e cioè uno di quei militi delle forze papaline inviate da Pio IX nel 1848 a marciare contro l’Austria sotto il comando del piemontese Giovanni Durando. E’ tornato da quella spedizione doppiamente inferocito sia per la batosta ricevuta dalle truppe austriache nella difesa di Vicenza sia a causa di: “una certa Gabriella Pampersi la quale, amante una volta del Paniccia, alla partenza di costui per la guerra della Lombardia si era gettata nelle braccia di tale Benedetto Lastrai, Cornetano, di professione scritturale, di anni 29, ammogliato, dal quale si vociferava perfino avesse di seguito procreato un figlio”. Quel Benedetto Lastrai non è peraltro uno stinco di santo: “egli è infatti quello stesso Lastrai il quale, a tacere d’altri fatti, nella tenera età, e mentre indossava pure gli abiti clericali, ebbe campo d’introdursi nell’abitazione dell’in allora Vescovo di Corneto Eminentissimo Cardinal Velzi, e di trafugargli un orologio d’oro a ripetizione, quale nascose dentro il campanile della Chiesa dei Reverendissimi Padri Agostiniani di colà, ma poi restituì perché venne a palesarsi in un subito e il furto e l’autore di quello”. Il Paniccia quindi ha un buon motivo per avercela con Lastrai e, se anche volesse dimenticare le corna della Pampersi, c’è un altro carico da undici a renderglielo odioso: Benedetto Lastrai è un papalino agguerrito e non ha alcun timore ad ostentare la sua fedeltà per il “Legittimo Governo del Clementissimo Sovrano il Pontefice Pio IX”. Questo è davvero troppo ma nessuno può pensare che la resa dei conti sia tanto vicina. Dopo il teatro, verso le tre di notte, il trio degli schiamazzanti “ebbri dal soverchio vino”, sia avvia verso il Caffé Reali. Potrebbe essere solo il bicchiere della staffa se non vi fossero tre piccoli particolari che non quadrano: Paniccia con una baionetta, Painasi con una sciabola e Fioravanti con un fucile! “Vuole il caso” che all’interno del caffé ci sia proprio il Lastrai il quale, ad escludere ogni possibilità di malinteso e per nulla intimorito da quell’arsenale, si fa premura di accoglierli amorevolmente con questa frase: “Ecco là li repubblicani; se la piglieranno in culo loro e la loro repubblica” e per essere più che certo di non essere stato frainteso ripete la frase una seconda volta. Possiamo immaginare l’effusione dei baci e degli abbracci che ne seguono! Non ci scappa il morto grazie all’intervento degli astanti e l’accorrere della Guardia Civica ma non manca qualche schizzo di sangue. Il Paniccia viene arrestato subito. Painasi fugge a casa e si infila sotto le coperte: più tardi viene arrestato in camicia da notte “macchiata di sangue nelle parti basse” e giustifica tali macchie asserendo “di avere lui mal venereo”. Un mese dopo viene “assalito da forte splenite” e ricoverato all’Ospedale dei Buonfratelli dal quale s’invola verso la latitanza mentre il Padre Priore, il Frate Infermiere ed il Becchino, vale a dire tutto il personale, è a cena. Fioravanti scompare ed ancora latitante nel 1851. L’unico a pagarla sarà il Paniccia che, il 3 marzo 1851, per l’accusa di “ferite con qulache pericolo di vita”, si beccherà tre anni di lavori forzati. Il 24 aprile 1849 una nave a vapore, la Panama, sbarca a Civitavecchia il primo contingente del Corpo di Spedizione Mediterraneo inviato dal Governo Francese. Per la giovane Repubblica Romana è l’inizio della fine! E’ un episodio triste e non solo per il sangue che dovrà inevitabilmente scorrere ma anche perché il colpo mortale viene da un’altra repubblica, quella francese, che ancora travagliata da pesanti problemi di consolidamento (cadrà anch’essa nel 1852) va a preoccuparsi di soffocarne un’altra. Il Preside repubblicano di Civitavecchia, Michele Mannucci, impartisce qualche disposizione di resistenza che però subito annulla in seguito ad un accordo secondo il quale italiani e francesi si riconoscono tutti fratelli e tutti repubblicani. Così la popolazione di Civitavecchia esulta, il Preside salva la faccia e il comandante della spedizione, Generale Oudinot, ha tutto il tempo di affilare quella sciabola che i monarchici e i clericali dell’Assemblea Francese gli hanno affidato per decapitare la Repubblica Romana. Nello stesso tempo e dagli altri stati della penisola molti liberali continuano ad affluire verso Roma per partecipare alla sua eventuale difesa. E torniamo a Corneto: “Approdata appena a Civitavecchia la Spedizione Francese si presentava a quelle sponde un bastimento contenente un battaglione di Militi Lombardi i quali chiedevano di sbarcare. Si opponeva il Generale Oudinot... che permetteva loro di approdare ma solo in un altro punto della spiaggia. Sembrava quindi che questi volessero avvicinarsi al Porto Clementino poco distante da Corneto. Nel tempo stesso nasceva a Corneto e si faceva subito estesa la voce che una Delegazione di Patrizi Cornetani si fosse diretta al Generale francese onde supplicarlo a porre impedimento a tale sbarco facendogli supporre che in Corneto regnasse l’anarchia e chiedergli l’intervento delle sue truppe mostrandogli il timore che quei Lombardi potessero dargli il sacco. L’aver recato simile insulto alla città.... facendola credere incivilizzata e inospitale per lo sgarbo che si andava ad usare a quei Lombardi, che dimandavano soltanto il transito onde dirigersi alla difesa di Roma, indispettì il Circolo Popolare e indusse il socio Eugenio Lucidi a far proposta di dichiarare i componenti la Deputazione nemici della patria. Non ammoniva sul momento il Circolo alla menzione del Lucidi, ma in mezzo a mille riflessioni decideva di voler prima conoscere se quella Deputazione venisse composta d’intrusi, oppure di individui appartenenti al Municipio o da questo aventi mandato. A tal uopo si rivolgeva il Circolo per mezzo di lettera al Gonfaloniere Domenico Boccanera, chiedendogli di poter conoscere la vera natura della Deputazione. Rispondeva il Boccanera protestando che il Municipio non aveva mai cessato di aderire alla Repubblica, che ora vi aderiva pià che mai, e che nessuna Deputazione era partita dal seno del Municipio con mandato municipale. Dopo tale risposta il Circolo, considerando come pochi intrusi si fossero assunti il nome di una città intera, l’avessero compromessa con tante menzogne e fossero incorsi negli estremi voluti dalle ordinanze ministeriali per essere dichiarati nemici dalla patria, emise il decreto col quali li dichiarò tali”. Siamo ora ai primi di maggio di quel 1849: qualche giorno dopo l’emanazione del decreto del Circolo Popolare ed appena prima che i suddetti “nemici della patria” avvertissero la sana opportunità di squagliarsela da Corneto. Per il Governatore Repubblicano Augusto Colombo incomincia una pesante odissea molto esplicativa dell’aria che tirava in quei momenti: “.... si presentava al Governatore Colombo un giovane il quale accusatosi per un certo Ravizza di Lombardia presentava il suo passaporto per il visto governativo necessario a recarsi a Viterbo. Osservava il Colombo la regolarità del documento, la vidimazione della polizia di Civitavecchia da cui veniva il Lombardo e secondava dopo ciò le di lui richieste. Intanto quegli si faceva a promuover discorso sugli affari politici di quei tempi e diceva di essere egli ai servigi del Triumvirato della Repubblica Romana e di dirigersi a Viterbo per operare in unione col Preside di quella Città e provincia Pietro Ricci al quale professava antica amicizia. Da tali discorsi passava quel Lombardo a mostrare la sua sorpresa sulla Deputazione da Corneto partita al Generale Francese e della quale diceva aver inteso parlare tanto in Civitavecchia quanto nei pochi momenti che si trovava in Corneto. Concludeva poi infine facendo le sue meraviglie al Colombo nel vedere impunito cotanto eccesso vieppiù delittuoso in quei momenti in cui tutti i Municipi dello Stato Romano emettevano le loro proteste contro l’intervento Militare Francese. Il Colombo rispondeva evasivamente a colui dicendo di non costargli abbastanza dell’esistenza della nota Deputazione... di non avere più ne’ Militi necessari... nè istruzioni dal suo Preside per poter prendere provvedimenti a carico di quella. - Il Lombardo, avvedutosi dei pretesti del Colombo, cercava di abbatterli dicendo che al tutto si poteva porre rimedio con l’invocare dal Preside di Viterbo una qualche forza militare e promettendo di volersi egli stesso interessare in quella sede di tale faccenda. Procurava di addurre il Colombo nuove difficoltà per dissuadere quel Lombardo dal suo progetto; ma quanto più egli parlava tanto più si avvedeva il Lombardo che erano meri pretesti e vane scuse per il che si partiva senza neppur rispondere alle ultime difficoltà dal Colombo messe in campo. - Rimaneva sorpreso il Colombo del contegno di quel facciendone, ma sperava pure che il Preside di Viterbo si sarebbe ricusato dall’intervenire (Corneto era fuori dalla sua provincia, n.d.r.). - S’ingannava però il Colombo perché non conosceva ancora di qual tempra fosse Pietro Ricci. - La mattina seguente, poco prima del mezzo giorno, si presentava di nuovo il Lombardo al Colombo e gli recava un foglio del Ricci con queste parole: - Mi ha sorpreso fortemente, Cittadino Governatore, l’ascoltare dal Lombardo come sia partita da costì una Deputazione sedicente Municipale al Generale Francese a fargli inique richieste, e come poi membri di quella si aggirino impuniti per le contrade di codesta Città. Penso che la vostra indolenza nel punire cotali traditori della patria possa nascere dalla sola mancanza di forza materiale e dalla impossibilità di rivolgervi al vostro Preside (quello di Civitavecchia, n.d.r.) che si trova circondato da nemici, vi spedisco da qui un picchetto della Guardia Civica Mobilizzata quale dietro le vostre istruzioni potrò venire al fermo dei colpevoli, che trasmetterete quindi a me per assoggettarli alle pene di cui si son fatti degni. Vi porrete in pieno concerto col Comandante del picchetto e con il Lombardo per la riuscita dell’operazione. Inoltre, dai dati del Lombardo rilevava il Colombo che il picchetto aveva fatto posta a Monteromano per attendere ivi le di lui istruzioni e il sopraggiungere della notte più propizia all’esecuzione del progetto”. Questa volta il nostro povero Governatore sembra irrimediabilmente messo con le spalle al muro e chiuso in un vicolo cieco dal quale appare impossibile uscire senza sbattere il muso da qualche parte. Il Colombo non vuole ammazzare nessuno ma, a sua volta, non vuole neanche passare qualche brutto guaio per cui: “....pensò in primo luogo a sbarazzarsi della presenza del Lombardo che respinse a Monteromano con l’insegnamento che colà, assieme alla spedizione, attendesse gli ordini suoi da parteciparglieli nella giornata. Rimasto solo e ruminati tra se mille e mille progetti onde impedire l’esecuzione dei pazzi voleri del Ricci, risolve alla fine di diportarsi a Civitavecchia per informare il Preside Michele Mannucci e da lui avere autorizzazione per far indietreggiare quel picchetto e impedire quell’arresto. .... pregava così i fratelli Alfonso e Cesare Sbrinchetti (suoi padroni di casa, n.d.r.) affinché si fossero compiaciuti somministrargli gentilmente il loro Calesse per recarsi sul momento stesso a Civitavecchia. I due fratelli si offrirono essi stessi a lui compagni e, posto in ordine il Calesse, volarono a Civitavecchia. Giunti appena colà e fermatesi sulla Piazza d’Armi, tale Domenico Annovazzi si avvicinava al Colombo e faceva noto l’arresto del Preside Mannucci poche ore prima avvenuto ad opera del Comando Francese. Po immaginare ognuno come restasse a tale notizia il Colombo il quale vedeva in quel momento caduti a terra i suoi progetti. Raccontando la sua vicenda all’Annovazzi, che minutava presso quella Presidenza, viene loro in capo l’idea che il fermo del Mannucci potesse servire di pretesto a respingere indietro il picchetto col fare appunto prontezza a quei militi chè l’arresto della Deputazione Cornetana avrebbe attirata l’ira del Comando Francese sul Mannucci ora che l’aveva in suo potere. Colla solita gentilezza si prestavano i Sbrinchetti ai desideri del Colombo e posto di nuovo all’ordine il calesse si partirono per Monteromano. Durante il viaggio, nel porre a tortura il suo cervello, rifletté egli che la migliore delle scuse sarebbe stato il dire di avere parlato personalmente col Mannucci rinchiuso nel forte di Civitavecchia e di avere da lui ricevuto l’ordine di impedire quell’arresto per la ragione di allontanare da lui le severe misure che avrebbe potuto il Comando Francese prendere a di lui danno. Ciò sopponendo che il Mannucci non sarebbe stato dimesso per allora e quindi non temeva potesse venire in luce la sua astuzia e menzogna. Giungevano coloro nelle vicinanze di Monteromano mentre andava già ad annottare. Al ridosso di quel paese posto sopra una collina evvi una breve si, ma coscesa salita che terminava colla posta dell’istesso paese. Si rifletté quindi fermare il Calesse prima della salita e ascenderla a piedi. Il minore dei fratelli Sbrinchetti rimase a guardare il Calesse ed il Colombo unito all’Alfonso si portò nel paese mentre si avvicinava la prima ora della notte. Entrati quei due appena la porta videro vari militari viterbesi che si trattenevano alcuni nella vicina Osteria della Posta alla sinistra di chi entra quel paese, alcuni sulla sporta spalancata di quella ed altri giravano all’esterno. Avvicinossi il Colombo ad uno di quei militi e gli richiese che avesse a lui indicato il loro Comandante. Sul momento venne ricercato e trovato il Capitano Cesare Bertarelli Comandante la Civica Mobilizzata di Viterbo. Presentatosi al Bertarelli il Colombo, annunciatosi per il Governatore di Corneto, narrò come essendo reduce da Civitavecchia aveva colà potuto parlare col Mannucci la mattina stessa arrestato, ed aveva da lui ricevuto l’ordine d’impedire quell’arresto che gli sarebbe stato certo cagione di gravi dispiaceri ora che si trovava in ostaggio dei Francesi. A tale parole unì il Colombo altre riflessioni parte vere e parte false riuscendo a persuadere quei militi d’indietreggiare e abbandonare l’impresa. Il Colombo e gli Sbrinchetti si avviarono quindi verso Corneto ove giunsero verso le tre ore della notte entrando dalla porta della Maddalena.” Il Colombo congeda i fratelli Sbrinchetti in Piazza S. Marco rivolgendo loro la raccomandazione di tacere i fatti di quella giornata e se ne va via a dormire stanco morto ma “immerso nel piacere di vedere così bene soddisfatti i suoi desideri”. Ma spesso le bugie hanno le gambe corte e per di più il nostro Governatore appare decisamente scalognato. Quello stesso giorno Mazzini aveva inviato a Civitavecchia Carlo Rusconi che era il Ministro degli Esteri della Repubblica Romana. Il suo compito doveva essere quello di sbattere in faccia al Generale Oudinot una formale protesta dell’Assemblea Repubblicana e farli soprattutto osservare che la sua invasione era sfacciatamente in contrasto con l’articolo 5 della Costituzione Repubblicana Francese per quanto concerneva la libertà dei popoli. Oudinot si rifiutò addirittura di riceverlo ed il Ministro, vista anche la fine fatta quel giorno dal Preside Mannucci, stimò più salubre allontanarsi da Civitavecchia per dirigersi verso Viterbo passando da Vetralla. Uscendo dalla città incrociò il calesse della spedizione. Colombo-Sbrinchetti che vi stava entrando e, guarda il caso, più tardi va ad imbattersi anche in un altro personaggio della nostra vicenda: “Il preside Ricci dopo avere divulgata per la Città di Viterbo la notizia della spedizione da lui fatta e dopo avere pubblicamente esternato il di lui desiderio di ordinare la fucilazione dei membri della nota Deputazione Cornetana appena fossero giunti arrestati nelle sue mani, si era recato a Vetralla, per farsi incontro a quei Militi reduci dall’impresa di Monteromano. Giunto a Vetralla in sulla sera si era imbattuto nell’in allora Ministro dell’Estero Carlo Rusconi, che appena arrestato il Mannucci si era dipartito da Civitavecchia dirigendosi verso Viterbo.... con un legno di Posta, involandosi forse al pericolo di correre anch’egli la medesima sorte del Preside. Riuniti pertanto il Ricci e il Rusconi a Vetralla rimasero attoniti nello scorgere il Picchetto reduce da Monteromano arrivare senza prigionieri. Si faceva il Bertarelli a narrare per esteso l’accato e quel Preside vedeva nel racconto del Bertarelli l’astuzia e le menzogne del Colombo tanto più che il Rusconi faceva riflettere non essere supponibile che il Comando Francese avesse permesso al Colombo di parlare al Mannucci prigioniero. Tali giustissime riflessioni davano materia a coloro di discorrer male sulla condotta del Colombo, e di esternare il loro sentimento sulla di lui fede politica poco a quel Governo confacente. Con tali ragionamenti conveniva il Lombardo Ravizza ivi presente il quale diceva di avere notato la dubbiezza della fede politica del Colombo. Dopo di ciò riedevano tutti a Viterbo e più di tutti rammaricato vi giungeva il Ricci nel vedere andati a vuoto i suoi progetti di sangue.” Pochissimi giorni dopo il mancato arresto dei Patrioti Cornetani, dei quali purtroppo non abbiamo potuto conoscere i nomi, gli esploratori, a cavallo, che il prudente Governatore Colombo aveva posto a sentinella tra Corneto e Tarquinia, correvano ad avvertire l’arrivo delle truppe francesi: “non esitò il Colombo ad allontanarsi dal luogo e di ritirarsi da un impiego che era stato cagione di continui dispiaceri e che già da vario tempo anelava di abbandonare”. Così, i primi giorni di maggio 1849, ha fine l’esperienza Repubblicana dei Cornetani molti dei quali dovranno poi vedersela coi tribunali del ripristinato Governo Papalino. Due mesi dopo, il 4 luglio 1849, i vessilli della Francia repubblicana completano l’occupazione di Roma e Mazzini si lascia sfuggire l’opportunità di coniare per primo quell’espressione che, un secolo dopo, parlerà di “pugnalate alla schiena”. A fine luglio Roma è già governata da un nuovo triunvirato: quello dei Cardinali commissari del Papa Della Genga, Altieri e Vannicelli che i romani chiameranno “i triunviri rossi”. Pio IX torna a fare il “Papa Re” nell’aprile 1850. Incominciano le punizioni e nel 1851 troviamo il nostro amico ex Governatore Augusto Colombo che, per avere cercato di nuotare senza lode e senza colpa in un mare di episodi più grandi di lui: “da un anno è condannato a trovarsi in un pubblico carcere, in associazione con quella feccia tolta dal crogiolo della società che si vomita ogni giorno in quel luogo”. Il poveraccio è in piedi davanti al Supremo Tribunale della S. Consulta che lo chiama a rispondere di ben sei capi d’accusa. Come sia finita la sua vicenda non lo sappiamo. Tuttavia ci è dato di nutrire buone speranze nel leggere la parte conclusiva dell’arringa difensiva concordata col suo avvocato: “.... che se pure tutte le ragioni superiormente affacciate non valessero a convincere il Supremo Tribunale in favore del Colombo e si volesse infliggere a lui un castigo, essendo la pena dovuta a simili trascorsi meramente disciplinare ed Ecclesiastica, e potendo questa consistere in esercizi spirituali, di buon grado vi si assoggetta il Colombo... bramandosi da lui come mezzo per rammentarsi nella solitudine tutti i doveri di cristiano”. Il che ci lascia pensare che la farà franca anche questa volta, seppure all’ombra di un chiostro e vestito da frate. Adrio Adami ETRUSCHI IN SVEZIA? La mostra del “tesoretto” di Hassle Nel settembre del 1986, come i lettori di questo Bollettino ricordano, è stata inaugurata nella Rocca Albornoz di Viterbo una mostra etrusca dedicata agli scavi svedesi di San Giovenale, Luni, Acquarossa. Con essa s’intendeva presentare al pubblico italiano, anche non specialistico, i risultati dell’impegno scientifico degli archeologi svedesi su un arco di oltre 30 anni. Per una coincidenza passata inosservata, nel mese di marzo si celebrava in Svezia un anniversario archeologico riguardante da vicino Tarquinia: quello del ritrovamento fortuito d’un reperto del VI sec. a.C. giudicato di provenienza etrusco-italica. Per ricordare l’avvenimento, fu presentato il reperto in una mostra a Glanshammar, nel cui territorio 50 anni fa aveva avuto luogo la scoperta. Il “tesoretto” fu esposto con criteri didattici esemplari. Attraverso una serie di carte topografiche, documenti di scavo, disegni su scala, gigantografie, diapositive, foto di particolari, si intese porre a disposizione del pubblico le informazioni visualizzate che guidassero alla lettura scientifica degli oggetti. Gli ampi commenti scritti sui pannelli, completati da una guida sonora registrata su nastro, oltre a narrare le modalità dello scavo e del restauro, presentavano le diverse interpretazioni archeologiche e storiche avanzate dagli studiosi. La mostra, patrocinata dal locale circolo storico e archeologico, dal museo provinciale, dall’assessorato alla cultura di Örebro, era aperta ogni giorno al pubblico ininterrottamente dalle 8 alle 20, con possibilità di visitarla, previo appuntamento, anche fino alle 23! Si calcola che dall’11 al 20 marzo l’abbiano visitata oltre 5.000 persone. Durante questo periodo sono stati organizzati programmi culturali di vario genere. Ogni mattinata Erik Persson - ex presidente del consiglio comunale per molti anni e cui si deve il merito di gran parte dei contatti culturali con la Tuscia viterbese ha parlato del ritrovamento ed ha commentato una cavalcata di diapositive dai suoi viaggi in Provincia di Viterbo, a scolaresche di vario ordine, ed associazioni e circoli, a gruppi di cittadini. Inoltre, sono state organizzate conferenze d’argomento archeologico concernenti il territorio di Glanshammar nei suoi rapporti col resto della Svezia. Il ciclo delle manifestazioni raggiunse la massima intensità il 16 marzo, quando nei locali comunali fu presentato un programma durato l’intera giornata, con discorsi ufficiali, proiezioni di diapositive, musiche e danze popolari. Nella stessa occasione fu tenuta dal sottoscritto una conferenza sulla civiltà degli etruschi e sulla loro presenza a Tarquinia e nel resto della Tuscia, davanti ad un pubblico di oltre 300 persone. Il successo della manifestazione è certo dipeso dalla sua stessa eccezionalità, ma anche dalla vivace vita associativa, caratteristica dei Paesi Scandinavi, sensibile a proposte culturali. Molte sono le persone che hanno collaborato negli sforzi per riportare sul luogo della scoperta il reperto e presenarlo per la prima volta alla popolazione. Oltre ad Erik Persson, il merito va ad Agneta Bruhn, che lavora alla direzione d’un centro diurno e alla coordinazione dell’attività di oltre cinquanta associazioni locali: alla sua gentilezza si deve gran parte della documentazione qui riportata; con lei ha collaborato Bengt Eriksson, presidente del circolo per la storia locale. Inizialmente, gran parte degli sforzi degli organizzatori furono tesi a superare le difficoltà burocratiche per ottenere il permesso di esporre gli oggetti all’esterno del museo ove sono normalmente custoditi. Non furono trascurate infatti le precauzioni: data l’eccezionalità degli oggetti esposti, una guardia armata li proteggeva giorno e notte. Le resistenze iniziali della sovrintendenza hanno riportato alla ribalta il dilemma: museo locale o museo nazionale? L’interrogativo è ben noto ai lettori, al corrente delle annose polemiche italiane. Per motivi storici, i musei archeologici centrali presero in consegna nell’800 i reperti più significativi delle varie regioni italiane, come si verificò nel caso delle statue di Ferento. Soltanto negli ultimi anni si è verificata un’inversione di tendenza, per cui si insiste a che i reperti restino in loco, come avvenne per i famosi bronzi di Riace. In Svezia, dove l’autorità statale è esistita per secoli, la tradizione centralistica vede una concentrazione degli istituti culturali nella capitale, malgrado malcelate resistenze regionali che sollecitano con insistenza un maggior decentramento. Secondo Hans-Ake Nordström, funzionario del museo storico nazionale e organizzatore della mostra di Glanshammar, è indispensabile che in Svezia esista un museo centrale, la cui funzione sia quella di offrire una visione d’insieme, quale non possono invece fornire i singoli musei su scala regionale. Essendo compito precipuo del museo centrale quello di descrivere il passato del Paese, durante la preistoria e il medioevo, sullo sfondo complessivo della storia europea, un reperto eccezionale come quello di Hassle, soltanto se esposto accanto ad altri documenti di varia provenienza geografica sfugge al pericolo d’una interpretazione campanilistica riduttiva, entrando invece nel suo autentico contesto storico che lo rende comprensibile. Occorre aggiungere, fa notare Nordström, che per ragioni storiche e ambientali il museo centrale svedese funge in realtà allo stesso tempo come un museo che può dirsi “locale”, anche se opera in un contesto molto più ampio degli altri musei regionali o provinciali: visto nel più vasto contesto europeo, infatti, il museo nazionale svedese è un museo pur sempre su scala “regionale”. Il reperto di Hassle, anche se assolutamente unico nel suo genere in Scandinavia, non è il solo apporto culturale giunto in passato dall’esterno. Infatti, il museo nazionale possiede un gran numero di oggetti fabbricati oltre confine, in zone anche molto remote, e giunti fin qui per vie e motivi diversi. Il fenomeno più noto ed evidente costituito dall’arte medioevale. Non soltanto i grandi costruttori di cattedrali gotiche erano maestri italiani, per lo più lombardi; ma si può dire che tutta l’arte medioevale svedese è tributaria di quella continentale. Numerosi e importanti oggetti, prodotti in Francia, Olanda, Germania o Inghilterra, sono oggi gelosamente conservati proprio nei musei svedesi: non è esagerato affermare che la Svezia sia depositaria di un vero e proprio tesoro di enorme valore per la storia dell’arte medievale europea. Mentre sul continente, per le traversie della storia, una grande quantità di preziosi oggetti artistici sono andati sfortunatamente perduti, in seguito a catastrofi naturali, guerre, incendi, distruzioni, incuria, qui hanno potuto trovare sicuro asilo documenti di grande valore storico. Francesco Petroselli Famosi oggetti di bronzo in mostra a Glanshammar Il 9 maggio 1936 ebbe luogo una singolare scoperta a Glanshammar. Il contadino Axel Nilsson, durante i lavori di bruciatura dell’erba sul suo campo, scoprì per caso sul greto di un ruscello qualcosa di rotondo che, a prima vista, aveva l’apparenza di una... ruota d’automobile. Ma non era una ruota abbandonata: era una caldaia di bronzo contenente al suo interno una serie di altri oggetti anch’essi in bronzo. Il terreno dove avvenne la scoperta era un appezzamento coltivato, acquistato da Axel Nilsson e frazionato da un podere denominato Hassle: per questo motivo gli oggetti presero il nome di “tesoretto di Hassle”. L’etimologia del toponimo (nel sec. XVI scritto Hässle) è di tipo botanico e va interpretato come “podere presso il boschetto di nocciòli”. Era questo uno dei tanti poderi appartenenti alla famiglia di Gustavo Vasa. Poiché questo è tra i reperti bronzei scientificamente più importanti e di pregiata qualità della Svezia, è conservato a Stoccolma, nel Museo storico nazionale. Ma quest’anno il tesoretto è andato in trasferta, cadendo il cinquantesimo della sua sensazionale scoperta. Infatti, in seguito alle pressioni esercitate dalla popolazione, il Museo nazionale ha consentito di esporre i celebri bronzi durante due settimane nella sede comunale di Glanshammar. L’unico oggetto che non è stato esposto è la grande caldaia. “E’ rotta in più punti e troppo fragile, per cui non abbiamo osato esporla ai rischi del trasporto”, afferma Hans-Ake Nordström, responsabile della sezione età della pietra e del bronzo del Museo e responsabile della mostra. Quel 9 maggio era per Axel Nilsson un giorno di lavoro assolutamente come tutti gli altri. Un suo vicino che stava arando notò che Nilsson quel giorno lavorava sulla riva del ruscello, dove un fossato di scolo si immette nel ruscello. Lo vide dirigersi improvvisamente verso casa, portando con sè la falce fienaia. Alcune ore dopo vide arrivare un’automobile da cui scesero alcune persone che si diressero al greto e si misero ad osservare attentamente qualcosa: si trattava del sovrintendente Bertil Waldén e di sua moglie, la scrittrice Margit Palmaer Waldén. Alex Nilsson, osservando meglio, aveva infatti visto che la caldaia conteneva alcuni oggetti e aveva estratto una delle spade di bronzo. Capito che si trattava di qualcosa di eccezionale, non di un relitto qualsiasi ma di un reperto archeologico, aveva telefonato a Örebro dando l’allarme alla Sovrintendenza. Il giorno successivo venne sul posto una spedizione tecnica di sette persone, le quali prepararono lo scavo, fotografando, effettuando il rilievo topografico, costruendo sopra il ruscello un ponticello di legno provvisorio. Al lavoro parteciparono vari archeologi. Margit Waldén ne scrisse subito su un diffuso settimanale nazionale e gli archeologi ne diedero la notizia al mondo scientifico sul bollettino della sovrintendenza. Secondo la testimonianza di Margit Waldén, alcuni ragazzi a pesca nel ruscello avevano già notato gli oggetti, ma avevano creduto si trattasse... d’un macchinario per la mungitura fuori uso e abbandonato. La caldaia era situata così in superficie che era stata danneggiata nel corso di scavi di drenaggio. Si può dire che fu salvato in extremis dagli archeologi, in quanto stava scivolando lentamente nel ruscello. Il vicino Axsel Nilsson spiega che gli oggetti vennero alla luce proprio quella primavera perché in aprile s’era verificato un forte innalzamento del livello delle acque del lago vicino. Ogni primavera la scarpata del ruscello era stata sommersa dall’acqua ed evidentemente la caldaia si era spostata un po' alla volta dalla posizione originaria. Il “tesoretto di Hassle” è normalmente conservato al Museo storico nazionale della capitale, esposto in una grande vetrina ben illuminata ed ermeticamente chiusa: il colore opaco del bronzo si staglia in modo perfetto contro lo sfondo azzurro. Molti si chiedono giustamente perché si conservi a Stoccolma e non nel museo provinciale di Örebro. Non dovrebbe restare in loco? Risponde il Docente Nordström: “Non è che noi vogliamo arraffare ogni reperto. Ma questo di Stoccolma è un museo a livello nazionale e quindi dobbiamo avere la possibilità di mostrare al pubblico reperti di ogni epoca e provenienti dall’intero territorio nazionale. Il “tesoretto” è uno dei reperti più eccezionali e singolari, per questo è stato sistemato nella capitale. Ma occorre aggiungere che però gli abbiamo dato il posto d’onore che meritava”. Kerstin Larsson dal “Nerikes Allehanda” del 10/03/1986 (Trad. di F. Petroselli) Il reperto di Hassle, uno dei più singolari della Svezia Il “tesoretto” è giudicato dagli esperti il reperto archeologico dell’età del bronzo più singolare rinvenuto in territorio svedese. Non c’è dubbio che gli oggetti siano stati confezionati in area mediterranea; la grande caldaia può risalire al VI sec. a.C. e assomiglia molto ad oggetti dello stesso tipo che si ammirano nel Museo Vaticano e in quello etrusco di Villa Giulia. Il reperto è costituito dalla grande caldaia, due secchielli, due spade e un’elsa, due ganci e dodici piastre di bronzo. La cosa unica per la Svezia è che si tratta di tutti oggetti non di fattura locale, ma importati; il che dimostra che anche gli uomini dell’età del bronzo intraprendevano lunghi viaggi attraverso l’Europa. Si ritiene che la caldaia con il suo contenuto sia stato seppellito nella terra di Glanshammar circa 500 anni a.C., perciò quando si stava passando dall’età del bronzo a quella del ferro. La caldaia (alta circa 34 cm. e di un diametro massimo di circa 64 cm.) è di un tipo che si ritrova nel mondo greco classico. Secondo il docente Hans-Ake Nordström, si tratta probabilmente di un oggetto costruito in area culturale greca, circa 600 anni a.C. Può anche essere arrivato dall’Italia meridionale in epoca greca. La caldaia di Hassle è l’unico reperto di quel tipo rinvenuto al nord delle Alpi. Il punto più prossimo alla Svezia dove sia stato rinvenuto un oggetto simile è Sainte Colombe nella Borgogna, in Francia; un terzo oggetto dello stesso tipo è stato rinvenuto in una famosa tomba etrusca, la Regolini Galassi, a Cerveteri. Caldaie del genere, ma con il bordo superiore decorato da colli di grifoni, potevano essere sistemati su treppiedi e posti davanti al tempio per fungere da catini sacrificali. Anche nella caldaia di Hassle si nota la presenza di fori, i quali mostrano che vi era una qualche forma di decorazione. Inoltre, l’oggetto è stato riparato in più parti durante il tempo in cui è stato utilizzato. I due secchielli sono del tipo chiamato ciste a cordone, per via del fregio inciso come ornamento sulla parete. Esemplari esattamente uguali sono stati trovati in più luoghi dell’Italia settentrionale e in località dell’Europa centrale, nei pressi di Older, Weichsel e in Austria. Le due spade, che sono state piegate per poterle farle entrare nella caldaia, si ritiene appartengano alla cultura di Hallstatt, nome di una celebre località archeologica austriaca. Alla cultura di Hallstatt sono collegate anche le piastre in bronzo che si crede siano state confezionate in territorio centro-europeo. E’ incerto l’uso delle piastre e dei ganci. Questi possono esser stati un particolare di morso da cavallo; le piastre possono aver ornato una bardatura equestre, oppure possono esser state applicate ad un abito o uniforme, dal momento che sono molto leggere. A giudicare dall’apparenza, sembrano esser state foggiate a colpi di martello su una matrice; la prominenza centrale è fissata con cinque chiodi ribattuti. Il diametro è di cm. 17,5. Sia il bordo che la borchia centrale sono in ferro; anzi, le piastre sono i più antichi oggetti con applicazioni in ferro posseduti dal Museo nazionale di Stoccolma. Quando un paio di anni fa furono sottoposte ad un intervento di conservazione da uno specialista che lavorava al microscopio, furono scoperte delle tracce di segni incisi, ma se ne ignora il significato. Le parti in ferro puro sono scomparse quasi completamente per ossidazione. Secondo Hans-Ake Nordström, lo stato di conservazione tutto sommato così buono degli oggetti è attribuibile al fatto che giacevano nell’argilla, dove non ha avuto luogo circolazione d’aria. Sono stati trattati in museo da un esperto restauratore, il quale, una volta allontanate incrostazioni e particelle staccate, li ha cosparsi di una vernice protettiva speciale, lavorando in ambiente sotto vuoto. Nei paesi mediterranei si usava nell’antichità trasportare vino in secchielli decorati con scanalature; così pure caldaie del formato di quella di Hassle non erano usate soltanto durante cerimonie religiose, ma anche nei conviti per contenervi vino. Hanno una capienza di circa 70 litri. Il docente Hans-Ake Nordström afferma: “Forse il reperto può essere interpretato come un servizio completo da usare in un convito o in una festa religiosa. Forse è stato sepolto nella terra di Glanshammar da un personaggio nobile come offerta alle divinità”. Kerstin Larsson dal “Nerikes Allehanda” del 10/03/86 (Trad. di F. Petroselli) Il Tesoretto di Hassle a cinquant’anni dalla scoperta E’ grazie al comportamento oculato ed esemplare di un agricoltore che questo eccezionale documento storico ha potuto esser fatto oggetto d’un tempestivo esame scientifico in loco. Axel Nilsson infatti, dopo un’esitazione iniziale, intuì che il recipiente era con tutta probabilità un oggetto di grande interesse archeologico, e lo lasciò senza toccarlo dove si trovava, avvertendo invece subito le autorità competenti. La prima ricognizione poté aver luogo il 12 maggio 1936, sotto la direzione scientifica dei sovrintendenti K.A. Gustawsson e Bertil Waldén, alla cui relazione di scavo attingiamo parte delle informazioni che seguono. Il luogo della scoperta, nel territorio di Glanshammar, è situato a circa 500 m. a nordovest del podere di Berga (local. Hassle), dove i Nilsson abitano, e ad ovest d’un modesto corso d’acqua, Averstaan. Il terreno è tuttora proprietà dei Nilsson. Al momento della prima ricognizione, l’apertura della caldaia affiorava quasi per intero allo scoperto: era colma di terriccio da dove spuntava l’estremità d’una spada; un’altra spada, al momento della scoperta, era stata trovata adagiata sopra il terriccio ed era stata estratta dal proprietario del terreno. All’interno dell’ampio recipiente si potevano intravedere due secchielli scanalati e una piastra, tutti di bronzo. La cavità esistente sul lato sinistro della caldaia provava che questa era slittata alcuni centimetri in direzione del corso d’acqua durante quella primavera: movimento dovuto al fatto, che a periodi, l’acqua aveva sommerso gli oggetti. Negli ultimi anni probabilmente la caldaia era stata visibile sulla scarpata. Ogni volta che l’acqua raggiungeva un livello più alto, la caldaia era sospinta un poco di più verso il ruscello; con grande verosimiglianza, la volta successiva che si fosse verificato un altro innalzamento sarebbe scivolata fatalmente sul fondo del ruscello: si può quindi dire che il salvataggio sia davvero avvenuto all’ultimo momento. I due archeologi constatarono che l’apertura della caldaia si trovava circa mezzo metro al disopra del livello dell’acqua e circa 0,7 m. sotto quello del terreno (l’altezza s.l.m. era di 25,47). La condizione della superficie attorno al reperto non era quella originaria, dato che la zona circostante è da secoli coltivata e in dolce declivio: durante i lavori agricoli, per es. di aratura, una quantità di terriccio è stata ogni volta trasportata in direzione dell’alveo. In passato il ruscello seguiva un percorso serpeggiante diverso dall’attuale. Nel 1884-85, nel corso di opere di rettifica e drenaggio, fu estratta anche una quantità di terriccio che in parte fu gettato sopra gli oggetti. Quando poi fu tracciato un fossato di scolo coperto nelle immediate adiacenze della caldaia, questa ne risultò danneggiata da sfondarne il lato sinistro. E’ perciò probabile che il reperto originariamente non si trovasse così in profondità come appariva nel 1936, ma più in superficie. Per primi furono estratti gli oggetti visibili nella caldaia: la spada, i due secchielli e una piastra; non fu toccato invece il contenuto giacente sul fondo della caldaia, sottoposto ad esame accurato in laboratorio, rinvenendovi altre undici piastre e due ganci. La parte del contenuto superficiale esaminato in loco appariva del tutto mescolato: tra gli oggetti si trovavano argilla mista a erbe, foglie, ramoscelli trasportati dall’acqua. Nemmeno il contenuto sul fondo era originario, ma il risultato del lungo avorio delle acque: colpì la presenza di abbondanti depositi ferrosi sia nel terriccio all’interno della caldaia che nelle sue adiacenze. Questa era adagiata su un banco di argilla vergine, presente anche all’interno dei recipienti; sul lato intatto della caldaia poggiava uno strato d’argilla di circa tre decimetri, mescolato a resti vegetali semidecomposti. E’ probabile che il luogo del reperto sia stato originariamente una sorgente, che in seguito ha trovato altro sbocco; oppure sia stato il vecchio ruscello, il cui percorso venne modificato coi lavori successivi al terreno. Questa ipotesi potrebbe fornire una spiegazione accettabile alla presenza d’un deposito di vegetali, attorno al reperto, di una composizione analoga a quella del letto originario. Nell’antichità, il corso d’acqua serpeggiante era più ampio di oggi ed era forse fiancheggiato da tratti paludosi periodicamente sommersi. I due archeologi ci hanno lasciato una dettagliata descrizione del reperto come apparve loro 50 anni or sono. La grande caldaia ha le seguenti dimensioni: alt. 34, cm.; diam. mass. 64. cm; diam. dell’apertura 40,5 cm.; largh. del bordo 3,1-3,4 cm., suo spessore 0,30 cm.; spessore del metallo 0,05 cm. La caldaia, dal fondo arrotondato, appariva riparata in ben sette punti differenti durante il periodo della sua utilizzazione: le accomodature erano state eseguite con lamina di bronzo e chiodi ribattuti. Al di sotto del bordo, in quattro punti equidistanti, si notavano tracce di impugnature; in due di questi, situati l’uno di fronte all’altro, si notava come depressione del metallo dovuta ad una piastra rotonda fissata da tre bulloni; negli altri tre bulloni; negli altri tre punti erano visibili tre chiodi ribattuti, ma nessun segno sulla lamina. I due secchielli (alt. 19,8 cm.; diam. mass. 23,4 cm.), quasi identici salvo la forma del fondo e degli agganci dei manici, sono decorati da nove robusti cerchi convessi o cordoni orizzontali, tra i quali corrono linee di punti martellati. Sull’esterno del fondo, una ridotta parte centrale, costituita da due cerchi concentrici (tre nell’altro secchio) attorno ad una leggera depressione, è circondata da una larga lista a rilievo ben marcata. La connessura dei recipienti è situata sotto uno degli agganci, cui sono fissati doppi manici, attori e mobili, culminanti in stilizzate teste di uccello. Ambedue le spade sono di bronzo e grosso modo dello stesso tipo (lungh. rispettiva 93,5 e 87 cm.); una borchia ha fatto parte dell’elsa di quella dalla punta arrotondata. Le spade erano state ripiegate per farle entrare nella caldaia, cosa che ricorre più di frequente con quelle di ferro. Le dodici piastre sono in leggera lamina bronzea (diam. 17,5-17,8 cm.; spessore 0,1 cm.): ciascuna ha sei cerchi concentrici convessi e un bordo piano, largo 0,8 cm., su cui era fissato con chiodi di ferro un aggancio semicircolare; al centro, una borchia, probabilmente in ferro, fissata in cinque punti con ribattiture. Ogni piastra ha potuto esser fissata ad un supporto mediante un dispositivo sul retro. Insieme con le piastre sono stati anche trovati due ganci di bronzo (lungh. 4,1 e 4,3 cm.) e una lamina di bronzo, forse apparentemente alla caldaia. Mentre le spade, ben conservate, erano con sicurezza del tipo noto come di Hallstatt, la grande sorpresa era costituita dalla caldaia, unica del genere nell’intera Europa settentrionale. Ai due sovrintendenti erano noti molto esemplari simili, in genere decorati lungo il bordo d’apertura con motivi zoomorfi, e talora muniti di treppiedi. Tra le poche caldaie del genere rinvenute fuori dell’area culturale greco-etrusca, ne era ben nota dalla letteratura una in particolare, in Francia, poggiante appunto su un treppiedi e decorata da quattro teste di grifoni. I due studiosi ritennero che la caldaia di Hassle avesse avuto lo stesso aspetto e fosse stata fabbricata in un paese del Mediterraneo, probabilmente in Magna Graecia oppure in area etrusca addirittura. Anche le ciste a cordoni non erano state prima di allora rinvenute in Scandinavia: dello stesso tipo di quelle trovate, in gran numero, all’interno di tombe in Germania, dovevano esser state fabbricate in Italia settentrionale. Incerto fu giudicato invece il luogo di provenienza delle dodici piastre, anche se dovevano appartenere alla cultura di Hallstatt. Altrettanto poco chiara la loro funzione: i due studiosi fecero l’ipotesi che si trattasse di particolari decorativi d’un equipaggiamento equestre. Lo faceva supporre un reperto di secchi di bronzo in un territorio tedesco, simili a quelli di Hassle, accanto ai quali era stato trovato una quantità di oggetti facenti parte del corredo d’un cavaliere. Sulla base di considerazioni comparative, si poté datare con sufficiente sicurezza il “tesoretto” attorno al VI sec. a.C., momento di passaggio dall’età del bronzo a quella del ferro: epoca in cui il ferro era un metallo raro in Svezia e, come si deduce da questi oggetti, usato soprattutto per scopi ornamentali. Ci si chiese subito il motivo per cui oggetti così preziosi fossero stati immersi in un corso d’acqua o in una sorgente che sboccava in esso. Secondo Gustawsson e Waldén, una spiegazione plausibile è che si sia trattato di un’offerta rituale da parte di un personaggio altolocato. L’usanza di immergere oggetti preziosi nelle sorgenti, a scopo religioso o magico, risale alle epoche più remote della storia e si trasmette per secoli fino a tempi recenti. Nel VI sec. a.C., questi oggetti, lungi dall’essere utensili d’uso comune, costituivano veramente un corredo di notevole valore economico. Anche se prima di raggiungere dal Mediterraneo le campagne di Glanshammar possono esser trascorsi molti anni, la presenza del “tesoretto” in area svedese riveste un’importanza grandissima, sul piano archeologico e culturale in genere, tennero subito a sottolineare i due studiosi che per primi se ne occuparono. Fin dal primo annuncio della scoperta, il reperto ha risvegliato l’immaginazione di cittadini d’ogni ceto in Svezia, affascinati dal mistero della sua inattesa e insospettata presenza a migliaia di chilometri dal luogo di origine. Come una sfida, ha parimenti attirato dal primo momento l’attenzione della comunità scientifica, suscitando tra gli archeologi una discussione protrattasi per decenni, nello sforzo di fornire un’interpretazione soddisfante del fenomeno. Si insiste dagli specialisti sull’importanza che si tratti di materiale non indigeno ma importato, il cui carattere è estraneo all’ambiente nordico. In una discussione critica riassuntiva delle ricerche precedenti, il Prof. B. Stjernquest di Lund, nel 1962, in una miscellanea di omaggio al Re Gustavo VI Adolfo, analizza con accuratezza la caldaia e i due secchielli, dato l’interesse che suscitano le loro forme, comparabili direttamente con quelle di oggetti appartenenti ad aree geografiche molto distanti dalla nordica, cioè al bacino del Mediterraneo. La caldaia, un recipiente che mostra tracce evidenti di usura, mancante di alcune parti, appartiene al gruppo di oggetti noto per numerosi esemplari simili presenti in area greca, italiana e francese. Quale fosse con esattezza l’aspetto originario della caldaia è impossibile stabilirlo, ma è assolutamente chiaro che la caldaia di Hassle appartiene allo stesso gruppo. Attraverso studi molto penetranti, è stato accertato con sicurezza che la caldaia forse più celebre d’Oltralpe, quella di Sainte Colombe, proviene dalla Magna Grecia e in seguito, per via di scambi, attraversata l’Etruria, sia giunta in Francia: quella di Hassle somiglia molto a questa. Sette caldaie dello stesso tipo sono note in Italia: due da Vetulonia, tre dalla tomba Regolini-Galassi di Caere, 2 da Praeneste, tutte pubblicate e ben note agli studiosi. Esistono inoltre vari ornamenti metallici zoomorfi, con teste di leone o grifoni, che debbono essere appartenuti a oggetti analoghi. Il materiale greco è molto più antico, ma si tratta in questo caso di oggetti frammentari: ciò è spiegabile col fatto che in Grecia questi grandi recipienti sono stati spesso utilizzati come doni votivi e quindi sepolti presso qualche santuario, esponendoli a maggior rischio di distruzione. Circa la questione della provenienza geografica delle caldaie, non è oggi più così assiomatico tra gli studiosi che esse abbiano l’Etruria necessariamente come terra d’origine. La decorazione presenta invece sia forti tratti greci, nella forma dei grifoni, sia tratti orientali, nel disegno dei leoni ornamentali. La questione è resa complicata dal fatto che sull’arte etrusca, come noto, si sono esercitati profondi influssi sia di tipo greco che orientale nel corso della sua storia. In più casi, i luoghi di fabbricazione appaiono senza il minimo dubbio orientali; in altri, le caldaie appaiono legate da vicino alle tradizioni artigianali greche e orientali. Estremamente complicata è la questione della provenienza della caldaia di Hassle, giudicata nel ‘43 di fattura etrusca (databile attorno al 550-575 a.C.) dal Prof. A. Akerström di Göteborg, autore nel ‘28 d’una tesi pionieristica, oggi di grande valore documentario, sulle tombe dipinte tarquiniesi. Non esistono oggi prove sicure che la caldaia sia stata fabbricata in territorio etrusco: i risultati emergenti dall’attento studio comparativo di Stjernquist vanno piuttosto in direzione della Grecia - forse della Magna Graecia, cioè l’Italia Meridionale - ma non è stata raggiunta l’assoluta sicurezza. Ciò non esclude che la caldaia possa esser passata per via di scambi successivi attraverso l’Etruria, beninteso. I due secchielli costituiscono, come si è detto, i due esemplari di ciste a cordoni di tipo etrusco rinvenuti più al Nord. Si tratta di prodotti artigianali che gli scavi in Europa centrale e meridionale hanno restituito in gran numero. Bologna è stato un importante centro produttivo di queste ciste, come testimonia il ricco materiale recuperato nella zona della Certosa; un altro epicentro vivace era situato nei pressi di Venezia e in Istria. Le ciste di Hassle sono con assoluta sicurezza prodotti importati di fattura etrusco-italica e rientrano pertanto in un contesto continentale di grandi dimensioni. A differenza di un altro sottotipo, altrettanto numeroso, dai manici fissi, queste di Hassle hanno manici mobili, caratteristica piuttosto comune in area italiana. Le piastre, date le loro caratteristiche, possono aver avuto soltanto funzione decorativa e non statica. Per la loro grandezza, si può ragionevolmente supporre che abbiano decorato una superficie relativamente estesa: possono ad esempio essere state applicate sui lati di un carro cerimoniale. Non esistono però prove sicure che corroborino questa vecchia ipotesi; anzi l’assenza sulle piastre dei fòri necessari ad appenderle porta ad escluderla, afferma Hans-Ake Nordström, curatore della mostra di Glanshammar. Egli attira l’attenzione sulla coincidenza non trascurabile che gli oggetti, a parte la caldaia, appaiono tutti in numero pari: due spade, due ciste, due ganci, dodici piastre. Si potrebbe pensare per es. a due personaggi, ciascuno recante una spada e una cista, ricoperti di un abito cerimoniale adornato di sei piastre, appese simmetricamente, tre sul petto e tre sul dorso. Durante il recente lavoro di consolidamento, sono state studiate le lievi tracca del metallo utilizzato per applicarvi la parte decorativa in ferro, ma non si sa ancora esattamente in che modo possono essere state fissate al supporto. Evidente appare invece dall’analisi che sono state fabbricate in forme leggermente diverse, ribattendo il metallo sopra matrici di legno. Eventualmente, il corredo di oggetti può essere stato usato in una qualche forma di offerta rituale di bevande, secondo una tradizione di tipo mediterraneo, conclude Nordström. Con la stessa prudenza si esprime circa il luogo di fabbricazione delle ciste, che lui esclude, personalmente, sia da ricercare entro l’area propriamente etrusca, anche se oggetti del genere vi siano ben attestati. Dall’evidenza cartografica della diffusione su piano europeo dei manufatti, si ricavano piuttosto indicazioni che suggeriscono l’Italia settentrionale o addirittura la zona alpina orientale, alle spalle del Veneto. La presenza di oggetti d’importazione a Hassle, mostrano che la Svezia centrale, nel periodo che segna il passaggio dall’età del bronzo a quella del ferro, ebbe contatti non sporadici ma intensi col continente, dato che bronzi rari come questi poterono superare distanze ragguardevoli fino a raggiungere, dopo un percorso sicuramente difficoltoso, la Scandinavia. A causa della rarità degli oggetti, soprattutto dovuto alla presenza di decorazione di ferro, il corredo rappresentava all’epoca un grande valore economico come dimostra la cura con cui più volte, anche se goffamente, si è riparata la grande caldaia. E’ impossibile invece accertare con esattezza i particolari del percorso seguito al nord delle Alpi. Il reperto mostra però l’esistenza inequivocabile di contatti regolari e su largo raggio; d’altra parte testimonia l’esistenza, in quest’area scandinava, di una forza economica notevole. All’epoca, la valle del lago Mälaren era un territorio ricco, fertile, relativamente ben popolato, che manteneva contatti regolari con territori anche molto lontani. Essendo la rete commerciale stabile e articolata, il territorio centrale dell’attuale Svezia non viveva affatto in condizioni di isolamento culturale, ma era strettamente legato sia con la Norvegia, sia a sud con la Scania e la Danimarca, sia a sud-est con l’isola di Gotland sul Baltico. Più a sud, in direzione del Mediterraneo, rivestivano evidentemente una grande importanza per i trasporti le vie fluviali, come quella dell’Oder che si apriva il passo attraverso il continente. Contro questa teoria, prevalente tra gli studiosi, che attribuisce la presenza degli oggetti a pacifiche attività commerciali, nel 1958 si è formulata l’ipotesi dal Reinecke, che gli oggetti di Hassle rappresentino un bottino di guerra. Stjenrquist, non avendo il Reinecke portato prove fondate dell’affermazione, ritiene la teoria insostenibile, trattandosi, nel caso di Hassle, non di un reperto isolato ed eccezionale, ma di un fenomeno che rientra in un articolato contesto di ampio raggio europeo. Secondo gli studiosi svedesi, la caldaia e i due secchi hanno insieme percorso il lungo cammino che dal meridione li ha portati a raggiungere la Scandinavia. La caldaia, se è da considerare di fattura etrusca, può esser giunta al Nord attraverso il territorio italiano settentrionale nel corso del VI secolo; lo stesso può essere avvenuto se è da considerare di fattura greca. Stjernquist è incline a individuare in Spina oppure in Adria, i due importantissimi centri commerciali all’epoca, una tappa possibile del loro passaggio, se non addirittura il luogo di provenienza. Anche i due secchi o ciste proverrebbero dalle zone etrusche di confine situate nella parte settentrionale della costa adriatica. Successivamente, caldaia e ciste passarono dall’area di fabbricazione originaria ai territori dell’Europa continentale, e per tappe successive alla Scandinavia. Nella storia della ricerca archeologica di questo secolo, il reperto di Hassle, lungi da costituire, come si potrebbe credere, una futile curiosità per dilettanti, ha gettato una luce nuova sulle condizioni culturali di epoche lontane, su quel periodo di transizione che vide l’avvento rivoluzionario del ferro nella regione di Närke, dove Glanshammar è situata. Smentendo la leggendaria opinione che la regione giacesse in assoluto isolamento, il reperto ha dimostrato, al contrario, l’esistenza, già vari secoli prima dell’era volgare, di relazioni commerciali vivaci e ha testimoniato la realtà di una corrente di scambi, diretti o indiretti, con i paesi remoti dell’area mediterranea. Una conferma di questa vivacità di scambi esistente in età remota, è giunta da un’altra recente scoperta di oggetti, anch’essi risalenti all’età del bronzo. La storia del rinvenimento è analoga a quella di Hassle; il luogo è Fröslunda, sulla penisola di Kalland, sulle rive del lago Vänern. Nell’autunno del 1985, quando il contadino Bert Ivarsson dovevano cominciare i lavori di aratura autunnale di uno dei molti campi paludosi coltivati presso il casale, l’aratro urtò contro una piastra metallica verdognola, larga circa mezzo metro, che gli sembrò un grande coperchio. Ma ebbe il sospetto di essersi imbattuto in un reperto archeologico, per cui avvisò la Soprintendenza e il museo di Skara. Quando, la mattina stessa di Ognissanti, l’archeologo Lars Jacobzon giunse sul posto, rimase stupefatto e provò la più grande emozione della sua carriera: nel solco tracciato dall’aratro giacevano i resti non di uno, ma di numerosi scudi di bronzo decorati. Non ebbe dubbi su che cosa si trattasse. Infatti, come archeologo gli era ben noto uno scudo dello stesso tipo trovato in Svezia in precedenza, a Nachhälle. Si tratta di uno degli oggetti dell’età del bronzo più famosi, eccezionalmente ben conservato, finemente adorno di una serie di anatre in rilievo lungo il bordo. Alla prima ricognizione, s’intravedevano cinque o sei scudi semicoperti dall’argilla ma, nelle condizioni climatiche piovose dell’autunno svedese, non era certo facile procedere alla delicata operazione di recupero in modo soddisfacente, per cui si decise di aspettare la primavera. Nel frattempo, la Sovrintendenza pose il vincolo sull’intero podere e durante l’inverno il reperto fu sottoposto invece in loco ai primi indispensabili e lunghi lavori di consolidamento, da parte del restauratore capo del laboratorio archeologico di Stoccolma. Si dovette aspettare la primavera per cominciare in maggio, passata la Pentecoste, i lavori di scavo, con le prime sovvenzioni elargite dalla Sovrintendenza per effettuare un primo sondaggio approfondito. Bastarono pochi giorni di lavoro perché fosse evidente che il reperto superava di molto le aspettative più ottimistiche degli archeologi. Infatti, fu possibile procedere al consolidamento di ben 18 scudi, in parte frammentari, situati a circa 40 cm. di profondità, subito sotto il livello dell’aratura. Lavorando con estrema prudenza, si riuscì a liberare gli oggetti dal fango e a sollevare quelli integri, inglobati all’interno di grandi blocchi di terra, per trasportarli al museo provinciale di Skara e quindi inviarli per il restauro in laboratorio a Stoccolma. Il lavoro, lungo e delicato, di analisi dettagliata degli oggetti e lo sforzo paziente di ricomporne il migliaio di frammenti, si può dire sia appena iniziato e prenderà certamente anni prima di arrivare alla pubblicazione scientifica conclusiva. Nel frattempo tuttavia, si è deciso di esporre senza indugi alcuni esemplari all’ammirazione del pubblico svedese. Come è noto, non avviene spesso, anzi quasi mai si verifica che un reperto venga esposto così rapidamente, a pochi mesi dal suo ritrovamento. La ragione è che si tratta d’un caso davvero eccezionale nella storia della ricerca archeologica: mai prima di oggi erano stati trovati nello stesso luogo tanti oggetti, e scudi in particolare, dell’età del bronzo. Dai primi esami risulta che hanno un diametro di circa 70 cm., uno spessore di 0,5 mm.; esistono tracce delle impugnature in piombo; sono stati lavorati a sbalzo martellando la lamina su matrici in legno; una serie di cerchi concentrici a rilievo, a linee o puntiformi, decora la superficie con motivi esclusivamente geometrici. Nella mostra si è voluto esibire il reperto non in modo isolato, ma ponendolo in relazione contestuale con altri coevi, provenienti dalla stessa regione e conservati in vari musei svedesi. Già agli inizi del secolo, a Lilla Edet sulla costa occidentale, furono trovate alcune strane spade, di cui non si apprezzò subito in pieno l’importanza scientifica. Una di esse non c’è dubbio che provenga dalla Baviera e appartenga alla cultura di Hallstatt. Come si è detto, è nel territorio alpino a nord di Venezia che nella tarda età del bronzo - tra il mille e il VI sec. a.C. - si sviluppò una civiltà molto ricca e progredita, basata sulla metallurgia: la prosperità di quei popoli dipendeva dall’estrazione di rame, oro e soprattutto salgemma. A testimonianza del ruolo di intermediario negli scambi commerciali tra il bacino del Mediterraneo e il Baltico, tra l’area greco-etrusca e quella nordica, svolto dalla cultura di Hallstatt, oltre il “tesoretto” di Hassle, il più ricco di oggetti importati, esiste inoltre un imponente vaso in bronzo con decorazioni ornitomorfe trovato in Scania e il grande scudo, unico del genere in Svezia, rinvenuto a un centinaio di chilometri più a nord, in Halland. Ma la nuova scoperta sovverte la “classifica” tra gli oggetti bronzei della cultura di Hallstatt, ponendo gli scudi di Fröslunda al primo posto. Nell’età del bronzo era diffusa la cremazione e al momento della cerimonia funebre venivano posti nella tomba, come doni al morto, gioielli di piccole dimensioni o oggetti personali da toletta. La maggior parte dei reperti di quell’epoca sono stati ritrovati in zone acquitrinose. Proprio in zone bagnate dalle acque sono stati trovati oggetti di culto, come tamburi cerimoniali, elmi, scudi, grandi trombe e corni, essendo la presenza delle acque caratteristica della dimora delle divinità. D’altronde, è lungo le vie fluviali o lungo le coste e sui laghi che avveniva il movimento di merci e persone. La funzione rituale di oggetti del genere è confermata da una serie di figurine bronzee provenienti dalla Danimarca che alludono a giochi e danze, del tipo di quelle rappresentate nelle pitture rupestri di Tanum nel Bohuslän. Oggetti di culto, come scudi ed elmi, così caratteristici della tarda età del bronzo, compaiono in genere a coppia, non isolati. Ciò ha fatto pensare agli archeologi che si possa trattare del culto di divinità gemelle, come Castore e Polluce: certe figurine sarde in terracotta, fornite di scudo, sembrano fornire elementi in questa direzione. La cosa certa è che gli scudi non possono essere stati mai usati come vere armi difensive. Si tratta invece di oggetti di lusso: lucidi e splendenti, ciascuno di essi rappresentava certamente un grande valore economico, misurato in capi di bestiame o prodotti agricoli. Il reperto mostra inequivocabilmente che in quella società esisteva una forte dose di controllo sociale in cui il prestigio individuale e della famiglia aveva gran peso. Basti pensare che, per confezionare pesanti e costosi gioielli femminili, non si esitava ad investire una ricchezza nell’acquisto di 1 chilogrammo del prezioso, nuovo metallo di moda, il bronzo. A causa del loro peso eccessivo, certamente le donne avranno potuto adornarsene solo nelle grandi occasioni, durante la cerimonia del matrimonio e per solennizzare qualche festa pubblica: la loro funzione non era tanto quella di sottolineare la bellezza forse, quanto di dimostrare pubblicamente la possibilità economica di cui disponeva la famiglia e accrescere il prestigio della parentela all’interno del gruppo. In tutta l’Europa è nota la presenza d’una ventina di scudi del genere, i quali dal nome della località ove vennero rinvenuti i primi, sono chiamati scudi di Herzsprung (Mecklenburg). Il direttore del museo di Skara, Ulf Erik Hagberg, ricorda che lo scudo nel corso della storia ha sempre rivestito grande valore simbolico: “Il re Salomone, si racconta nel Libro dei Re, fece fabbricare prima del suo incontro con la regina di Saba, 200 grandi e 200 piccoli scudi d’oro massiccio. Nel Foro, all’interno della Regia, erano conservati, insieme alla lancia di Marte, 12 scudi sacri che i Salii portavano in processione solenne: erano gli oggetti di culto più antichi e importanti di Roma. Anche nel tempio di Delfi c’era uno scudo votivo dello stesso tipo di quello trovato in Svezia, a Kalland”. Si tratta di alcuni esempi, conclude Hagberg, che mostrano l’ampiezza dei contatti culturali esistenti in Europa nella tarda età del bronzo, all’interno dei quali gli scudi di Fröslunda come il tesoretto di Hassle vanno interpretati. Francesco Petroselli Università di Göteborg Lettera dalla Svezia: un’amicizia trentennale. Cari amici tarquiniesi, quando una mattina di maggio 50 anni fa Axel Nilsson trovò nel suo campo quegli oggetti di bronzo - il “tesoretto di Hassle”, così chiamato dal luogo del rinvenimento non poteva lontanamente immaginare che ciò lo avrebbe fatto passare alla storia, né tanto meno che ciò avrebbe generato un’amicizia fiorente tra italiani e svedesi. Un’amicizia nata per l’entusiasmo ostinato e per l’amore fanatico di Renzo Javarone per la terra natia. E si sa anche che l’amicizia è una pianta delicata che va coltivata, altrimenti si appassisce. Gli amici tarquiniesi ricorderanno che Javarone era non solo un commerciante noto, ma anche un appassionato etruscologo dilettante. Segnato dall’esperienza tragica della guerra, voleva, in una catena internazionale di amicizie, collegare la Tuscia oggetto della sua adorazione e delle sue ricerche storiche - con tutte le località europee toccate dall’espansione commerciale e culturale dei suoi antenati etruschi. Nella vostra città, la città primigenia e più nobile dell’antica confederazione etrusca, nei primi anni Cinquanta era stato tenuto un congresso etruscologico internazionale, con la presenza di specialisti come Pallottino e Boethius. In quell’occasione si discusse dell’espansione commerciale etrusca e su una carta fu mostrato che una località svedese - Hassle - rappresentava il punto più settentrionale di tale espansione, essendovi stato trovato un reperto di probabile origine etrusca. Ciò bastò per dare a Javarone l’impulso per ideare una missione originale e stringere un contatto diretto tra la vostra città e Hassle. Con l’appoggio della vostra energica organizzazione Pro-Tarquinia, furono inviati due messaggeri - Francesco Petroselli e Remigio Gaisek - i quali partirono alla fine di luglio del 1955 per raggiungere con mezzi di fortuna e a piedi la lontana Hassle, di cui ignoravano l’ubicazione esatta, seguendo lo stesso cammino che si supponeva gli antichi mercanti etruschi avessero seguito. Il 9 settembre giunsero a Stoccolma e per gli archeologi Olof Vessberg e Erik Berggren del Museo mediterraneo cui si rivolsero si trattava di trovare la persona che doveva rappresentare “il sindaco di Hassle” - una “città” inesistente. La scelta cadde sul sottoscritto, allora presidente del consiglio comunale di Glanshammar, nel cui territorio il podere di Hassle è situato. Non mi restò che darmi da fare per organizzare con le autorità provinciali una degna accoglienza ai due originali messaggeri. Il 13 settembre ebbe luogo la cerimonia ufficiale del gemellaggio nella chiesa di Glanshammar gremita all’inverosimile. Quella sera memorabile, i due messaggeri, barbuti e abbronzati, lessero ad alta voce nelle due lingue il messaggio del vostro sindaco dell’epoca Adalberto Bellucci e successivamente il saluto melanconico e pieno di sentimento di Renzo Javarone indirizzato “Ad uno svedese...” Nell’uditorio commosso nacque subito un desiderio bruciante di poter ricambiare questa visita al più presto, per poter ammirare la vostra terra, tanto bella e ricca di monumenti. Ringraziando per il vostro saluto, manifestai l’augurio che i legami di amicizia allora allacciati si consolidassero e portassero ad altri regolari contatti. Presi in consegna una serie di stupendi regali, tra cui autentici oggetti etruschi in bronzo e ceramica, ora gelosamente conservati in una teca nella scuola comunale. Quando mia moglie ed io fummo invitati, con altri conterranei (Bertil e Margit Waldén, Broberg, Bärnhjelm ecc.) dal sindaco Bruno Blasi nel 1957 per una visita ufficiale in provincia di Viterbo, era questo il nostro primo viaggio fuori della Scandinavia. Non rimanemmo affatto delusi: il nostro giro da Milano, a Firenze e Roma bastò a farci innamorare per sempre della vostra bella Italia. Il viaggio ebbe anche aspetti informali divertenti, sia nelle trattorie di Trastevere che Bertil Waldén conosceva altrettanto bene del Forum Romanum, sia nelle escursioni nella vostra provincia. Ricordo un piccolo aneddoto. La nostra delegazione fu trasportata nelle Alfa Romeo dell’Amministrazione provinciale, con autisti in livrea, attraverso i meravigliosi paesaggi e le città ricche di storia; e la prima tappa d’obbligo fu Montefiascone, dove in prima mattinata - ci furono serviti assaggi delle migliori annate del famoso Est!Est!Est! La scrittrice Margit Waldén, che viaggiava invece in una piccola Fiat, aveva l’impressione che la velocità fosse un po' eccessiva per le strade tortuose e strette. Come risposta alle sue trepidazioni le arrivò dall’autista che aveva partecipato alle libagioni: “La Sua vita non ha mica più valore della mia”. E per essere sicuro di esser capito aggiunse: “La mia vita mi sta altrettanto a cuore”. E infatti tutto andò bene. Dopo le visite di omaggio alle autorità provinciali e comunali di Viterbo, giunse l’avvenimento indimenticabile: il ricevimento ufficiale della nostra delegazione nel vostro palazzo comunale da parte del sindaco Blasi, quest’uomo così genuino e amabile che ha fatto tanto per mantenere in questi decenni viva l’amicizia nata tra la vostra città e Glanshammar. Il signor Blasi ha sempre accolto noi svedesi con lo stesso calore nel corso di questi anni: nel 1960, 1964, 1970, 1972 senza dimenticare il 1983 e il 1985, quando giungemmo in autobus con un gruppo di quasi cento pensionati! A nostra volta, abbiamo avuto il piacere nel 1958 di accogliere a Glanshammar una simpatica delegazione ufficiale tarquiniese, formata da Bruno Blasi, Cesare De Cesaris, Alessandro Tappella e Giuseppe Guerri. Potranno loro stessi raccontare le loro avventure. Con la loro spontanea vivacità latina, la loro mimica, la loro eleganza e il loro calore si acquistarono le simpatie di tutti. Furono ospiti dei conti Mörner a Esplunda e poterono stringere la mano a Axel Nilsson, il quale li guidò in una ricognizione sul luogo preciso in cui era stato trovato il “tesoretto” etrusco. Altre gradite visite ci sono giunte dalla provincia di Viterbo tra cui una delegazione della Camera di Commercio con i dottori Corigliano e Felicetti. Negli ultimi anni hanno avuto luogo scambi sportivi tra le nostre province, con la partecipazione di squadre di calcio a tornei internazionali, come quello “GrossiMorera” organizzato dall’EPT. La vostra terra, la Tuscia che Javarone tanto amava, è ricca di bellezze sia naturalistiche che archeologiche e artistiche d’ogni epoca, dal villanoviano al neoclassico. Vi chiederete quindi che cosa può offrire il territorio del mio Comune agli amici italiani che speriamo di salutare nostri ospiti numerosi e graditi. Örebro e Glanshammar sono situati nella parte centro-meridionale della Svezia, “nel cuore del paese”, come dice la pubblicità turistica, a circa 250 km. dalla capitale. Glanshammar conta circa 3.000 abitanti, in parte contadini, in parte addetti occupati in due industrie estrattive e in una chimica; 204 persone si spostano come pendolari per lavorare nel terziario del capoluogo (78, inversamente vengono dall’esterno); abbiamo il 2,6% di disoccupati. Accanto a famiglie composte di 4 persone e oltre (31%), ci sono nuclei famigliari di 2 membri (30%) e il 21% di persone sole. Per il 1990 si prevede un aumento della popolazione. In seguito ad una riforma amministrativa, Glanshammar alcuni anni or sono ha perduto l’autonomia comunale è stata assorbita nel Comune di Örebro (120.000 circa). Il capoluogo provinciale (80.000 ab.), fondato oltre 700 anni fa, è situato al centro di un’ampia zona boscosa, paesaggisticamente attraente, dove già nel ‘500 si estraevano minierali. Un tempo Örebro era famosa per i suoi calzaturifici; attualmente, è un centro commerciale e industriale notevole (cellusosa, alimentari, meccanica), amministrativo e universitario. Oltre alle attrazioni naturali (un bel parco ornitologico, per esempio), vanta una vivace attività culturale, organizzata dalle numerose associazioni e dagli enti pubblici (teatro, concerti, pinacoteca, museo storico-etnografico, museo tecnico ecc.). Abbiamo anche noi monumenti importanti di cui andiamo fieri. Nel territorio di Glanshammar si possono ammirare vari castelli: Myrö, appartenuto all’ordine francescano prima della Riforma; quello di Esplunda, dei conti Mörner, con una delle più preziose biblioteche private di Svezia; Kägleholm, un tempo proprietà della famiglia di Santa Brigitta; Ekeberg, dove è nata la seconda moglie di Gustavo Vasa. La chiesa di Glanshammar, del sec. XII, è ricca di opere d’arte, tra cui un famoso crocifisso ligneo descritto da Selma Lagerlöf nel suo “Gerusalemme”. L’attività estrattiva nel nostro territorio è testimoniata da una miniera d’argento sfruttata nel ‘300 e tuttora da una moderna cava di marmo. Il Teatro d’arte drammatica di Stoccolma - diretto per molti anni da Ingemar Bergman è stato costruito nel 1908 con marmo proveniente da Glanshammar, d’una qualità molto simile a quello di Carrara. Un’altra attrazione, oltre quella paesaggistica, è la ricchezza di monumenti archeologici. La presenza umana è testimoniata in epoca preistorica e dell’età del ferro, da numerose tombe a dolmen o a forma di nave, alture fortificate, ecc. Due terzi delle iscrizioni runiche della provincia di Örebro si trovano nel nostro territorio. Quest’anno, in marzo, abbiamo celebrato il cinquantesimo anniversario del ritrovamento del “tesoretto di Hassle” con una riuscita mostra. Ogni giorno durante quel periodo ho avuto il piacere di parlare della vostra provincia e dei contatti amichevoli con Tarquinia e Viterbo, mostrando una serie di diapositive a scolaresche e altri gruppi di cittadini. Ogni volta l’uditorio ha mostrato lo stesso grande interesse. Il 16 marzo la manifestazione si concluse con un nutrito programma musicale e danze popolari in costume durato l’intera giornata, e con una conferenza molto apprezzata del professor Francesco Petroselli sulla civiltà etrusca e sulla vostra provincia. La mostra è stata visitata da oltre 5000 persone. Vorrei concludere con alcune considerazioni e un augurio. La nostra patria, la Svezia, ha un clima più duro del mediterraneo, la sua popolazione ha un carattere più calmo e silenzioso dell’italiana. Non abbiamo la vivacità che caratterizza le popolazioni di paesi meridionali, ma una dote l’abbiamo in comune con gli italiani: la cordialità e la fedeltà nell’amicizia. Gli svedesi sono tra i popoli della terra più amanti della pace, e la Svezia ha avuto il privilegio di poter vivere un lunghissimo periodo di libertà e di pace. I popoli della terra vivono tuttora in un mondo incerto e pieno di pericolo; e provano la stessa angoscia che provava Renzo Javarone scrivendo il suo commosso messaggio di saluto indirizzato “ad uno svedese” qualsiasi a cui offriva amicizia. Lasciatemi, cari amici tarquiniesi, esprimere l’augurio che gli uomini e le donne che guidano il destino dei popoli possano convincersi che la comprensione tra le nazioni e la pace può essere raggiunta e difesa, evitando di utilizzare follemente arti distruttive. Con un caro saluto a voi tutti, vostro amico Erik Persson (Trad. F. Petroselli) IMMAGINE PROPRIA DEL CARDINALE GIOVANNI VITELLESCHI Di numerosi colleghi e compagni d’epoca del Giovanni Vitelleschi (+1440) cardinale di Firenze e il più potente condottiero della Chiesa Romana, i tratti dei volti ci sono noti. Su monete e medaglie, su affreschi murali e tavole in legno, in cera e in marmo sono stati tramandati. Infatti proprio all’inizio del Rinascimento l’interesse per la personalità, la sua fisionomia ed espressione era molto vivace - non solo nel committente, cioè il raffigurato stesso, preoccupato per la sua fama, ma anche fra gli stessi artisti - e dopo la svolta del secolo ciò è stato ancora incrementato dall’intensificata richiesta dei collezionisti. Le premesse per una riproduzione fedele dei tratti del cardinale ci sono perciò tutte; sappiamo di due ritratti; uno era nel Vaticano, l’altro nel suo palazzo. Nonostante ciò non ci è pervenuto nessun originale a causa di avversità, riservate evidentemente non solo alla persona stessa. Se cerchiamo tuttavia di riconoscerlo dopo secoli, si tratta di un pezzo di storia del ritratto, che proviamo a ricostruire. Che Giovanni Vitelleschi fosse ben disposto verso gli artisti ci viene chiaro dalla ordinazione a Fra Filippo Lippi di un’immagine della Madonna, all’inizio della sua carriera come arcivescovo di Firenze. In detta immagine si vede attraverso la finestra una parte del colle con le mura cittadine della sua patria Corneto-Tarquinia, là dove era destinata come pala d’altare. Lì aveva fatto anche ornare la biblioteca del suo splendido palazzo nuovo con il programma di pitture scelte da lui personalmente e probabilmente allo stesso tempo anche la cappella Decem Milium Crucifixorum accanto. Però come stanno le cose con la tradizione dell’immagine? I Muzio Polidori (+ 1683) il cronista di Corneto, fa accenno ad un sigillo del cardinale del 1436; esso mostrava il Salvatore con la Vergine Maria, San Giovanni, il Santo del suo nome, e San Nicola. Sul retro c’era la sua immagine propria incorniciata dalla scritta SIGILLUM JOHANNIS CARDINALIS FLORENTINI DE CORNETO. Nell’archivio della cattedrale però non si trovano più i documenti del processo esecuzionale ai quali era fissato. Con essi è sparita questa immagine con ogni più preciso dettaglio, cioè se era ritratto in ginocchio, seduto, benedicente o in preghiera. Ma comunque date le misure e la funzione di un sigillo non darà molto schiarimento! II Un’indicazione più importante riceviamo da Giorgio Vasari (1511-1574). Lui che ha scritto le sue vite degli artisti su proposta oppure per conto del poliedrico studioso Paolo Giovio (1483-1552) parla di una copia di un affresco romano del nostro cardinale, che ha allora visto in possesso dello storiografo. Vasari la elenca nell’ordine delle 8 copie degli affreschi, con i quali furono adornate le stanze del Vaticano sotto Nicola V intorno al 1450. Piero della Francesca, nella stanza che fu in seguito detta stanza d’Eliodoro, aveva dipinto le teste di Carlo VII di Francia, Nicolò Fortebraccio, Antonio Colonna, principe di Salerno, Francesco Carmagnola, Giovanni Vitelleschi, Cardinal Bessarione, Francesco Spinola e Battista da Canneto così piene di vita, che Raffaello da Urbino ordinava di esse delle copie. Queste furono eseguite probabilmente dal Bramantino - Bartolomeo Suardi - prima che dovessero essere abbattuti gli affreschi di Piero per fare posto ai propri quadri “Liberazione di Pietro dal Carcere” e “Miracolo di Bolsena” (circa 1514). Tali copie furono donate da Giulio Romano, allievo ed erede di Raffaello, poco dopo il 1520, allo studioso Paolo Giovio. Questi allora aveva iniziato a Firenze la collezione di verae imagines. Perciò Giovanni Vitelleschi “in effige” (fig. 1) appartenne al nucleo del museo Giovio, più tardi molto famoso, che il vescovo, appassionato collezionista, costituì nella sua città natale, Como. Partì forse da queste copie romane l’unità di misura stabilita per la progettata galleria dei ritratti? La tela dovrebbe misurare circa 1 piede e ½ “in linteo sesquipedale”. Possiamo aspettarci dall’affresco dipinto 10 anni dopo la morte violenta del Vitelleschi una certa rassomiglianza, ciò non vale più nella stessa misura per la copia di esso. Crediamo tuttavia di riconoscere questo regalo di Giulio Romano in quel ritratto del Museo Giovio a Como, che è tornato là nel 1965 dopo lunghe traversie, causate da questioni ereditarie, in una successione che si è ridotta dai circa 300 ritratti ai 40 attuali. Stretto della cornice (78,5 x 95 cm.) appare la figura imponente dell’approssimativamente cinquantenne con la scritta JOANNES VITELLESCUS PATRIARCHA ALEXAN. CARDINALIS ET PONT. EXERCITUS IMPER. Proprio questo contrasto fra onori sacerdotali e mondani rende la persona di Giovanni Vitelleschi inconfondibile. E’ vestito con la cappa magna di un lucente rosso scarlatto. Un viso pallido, passionale, di profilo, 3/4 girato verso destra, appare illuminato sotto il grosso cappello, dal quale scende, ben tesa dalla nappa, la corda. Fra sopracciglia nere, diritte si staglia il naso aquilino. La sua punta arriva quasi fino a contorno della sua guancia. La bocca piena, con gli angoli piegati all’ingiù e il mento poco pronunciato invece mostrano tratti sensibili. Contrasti violenti fanno dedurre un temperamento impetuoso. Sotto la mozzetta larga con cappuccio, che chiude le forme in modo semplice, il braccio destro è alzato, perché la mano avvolge e poggia il bastone di comanco sull’anca. La sinistra regge l’impugnatura della spada. Il singolare di questa veste da cardinale, la spada (!) attaccata alla cintura, è autentico. Perché per caso Giovio ne parla nella biografia del Giovanni Vitelleschi nel descrivere l’atto della cattura del condottiero “incurvum gladium, quo militari mori cinctus erat” (VITAE ILLUSTRIUM VIRORUM, Basilea 1578, pagina 63). Tutti gli altri ritratti perciò derivano da questo. III La galleria dei ritratti del Paolo Giovio incontrava fra i principi del 16° secolo e generalmente fra le persone colte, enormi consensi. In tutta Europa, spronata dal fervore collezionistico del fondatore del museo di Como e vescovo di Nocera stessa, si sviluppava una grande richiesta di ritratti di personalità famose. Continuamente gli si chiedevano delle copie dei ritratti della sua collezione. Un altro ritratto di Giovanni Vitelleschi (fig.2) che ancora oggi è esposto negli Uffizi di Firenze, apparteneva sin dal 1568 alla collezione di Cosimo I dei Medici. Come sappiamo da una vasta corrispondenza, a partire dal 1552 il principe aveva affidato appositamente ad un pittore, Cristoforo Dell’Altissimo, il compito di copiare i quadri del museo iconografico di Como. Quello del nostro cardinale fa parte dei 280 ritratti, tutti un po' più grandi degli “originali” di Giovio, che Cristoforo dipinse su tela nel corso degli anni. Come il titolo, Joes CAR. VITELLESCHI, anche l’inquadratura è molto ridotta, cioè limitata alla riproduzione della testa. Le caratteristiche sono state attenuate, non solo nel viso. E’ andata persa la componente militaresca nello sguardo e negli ornamenti accessori, risulta attenuata la componente individuale a favore di una più grande spiritualità della copia fiorentina. IV Approfittando della fama crescente della collezione dello storico, i cui scritti sono nel frattempo molto letti, l’editore Perna di Basilea voleva aggiungere ai ritratti verbali anche quelli dipinti. Dopo la morte dello scrittore, mandò un artista a Como che doveva disegnare per suo conto dei ritratti. Della serie di 150 eroici guerrieri della sua raccolta, per i quali Giovio ha scritto la biografia, solamente 128 ritratti vengono stampati. L’edizione di Basilea della VITAE ILLUSTRIUM VIRORUM, del Giovio è adornata con queste silografie la prima volta nel 1578. Anche il ritratto del JOANNES VITELLIUS CORNETANUS / PATRIARCHA ET CARDINALIS ne fa parte (fig.3). Esso riproduce solo una parte del quadro di Como, però è più grande di quello dell’Altissimo (fatto più tardi) per il Medici; a ciò corrisponde anche il titolo più lungo. Risulta chiaro il significato della testa girata verso destra per via della mano destra alzata con il bastone di comando ancora appena visibile. Il ritratto è fedele per quanto riguarda lo sguardo e l’inclinazione della testa, anche se manca la spada. La silografia mostra in confronto al modello dipinto non solo una cornice con motivi a rilievo alla moda, ma anche forme ricche, mosse sulla corda del cappello e sulla mozzetta. Il viso in sé appare più largo e perciò meno severo. Evidentemente nel 16 secolo il dipinto non era ancora così scurito in modo che l’Altissimo e anche l’artista di Basilea potevano intravedere e riprodurre dalla tela romana nella casa di Giovio un berretto chiaro sotto il cappello; normalmente i cardinali portavano sotto il loro cappello a falde larghe il cappuccio. La precisione degli incisori di svizzeri è molto ammirevole, tenendo presente che l’illustrazione fino alla stampa era sottoposta a duplice traduzione: tramite il disegnatore inviato a Como e poi a Basilea attraverso l’intagliatore. Quanto guadagno si aspettasse Perna dalle illustrazioni viene evidenziato da un estratto pubblicato già un anno prima, nel 1577 a Basilea, che presentava, in riferimento alle stampe delle medesime matrici, sotto la silografia una breve “history” del raffigurato in lingua tedesca anziché in latino come la “Vita”. Non manca neanche la breve, avvincente storia di Vitelleschi sotto il suo ritratto. V Contro l’informazione di Vasari e la nostra genesi del quadro a Como sembra parlare una notizia, che viene tramandata da E. Muentz nel saggio fondamentale “Le musée de portraits de Paul Jove 1900/01, dove scrive senza esitazione: “Le portrait du Musaeum Jovianum avait été copié sur une peinture du palais Vitelleschi à Corneto”. Evidentemente si tratta di un errore, perché lo studioso francese non poteva conoscere il ritratto romano, dono di Giulio Romano (Pippi) allora ancora sepolto in una raccolta privata, oggi a Como (fig.1), ma probabilmente prese per il modello un altro affresco nominato dal Giovio. Negli scritti di Giovio non si parla della copia di Corneto; lui conclude la sua biografia di Vitelleschi con questa frase: “Cornetanus patriarcha et cardinalis vera Vitelli effiges depicta in magno conclavi eius domus Corneti spectatur “ (ELOGIA VIRORUM BELLICA VIRTUTE ILLUSTRIUM. Venezia 1546/1561). Non conosciamo nulla al riguardo nè il contenuto nè la storia di questo affresco. Forse ci diranno qualcosa i lavori di restauro, attualmente in corso a Palazzo Vitelleschi, se un giorno avranno portato alla luce “in magno conclavi” un ritratto del fondatore, che ha superato le bufere del tempo. Solo allora potremmo giudicare rassomiglianze e rapporti. In primo luogo dobbiamo però chiederci se la notizia si basa su una di Giovio, cioè se dopo circa 100 anni dalla morte violenta di Giovanni Vitelleschi per mano di un incaricato del Papa Eugenio IV, Antonio Rido, ci fosse ancora in vista nella sua casa una sua immagine. Giovio stesso informa che il palazzo degno di ammirazione viene ora nominato “Pontificum hospitio”. Ciò viene confortato inequivocabilmente dagli stemmi dei Papi Eugenio IV e Nicola V, lì presenti in affreschi e sculture. Hanno forse lasciato esistere quello del loro soccorritore e loro vittima? E’ vero che Nicola V permise, nell’anno del Giubileo 1450, il ritorno delle ossa del defunto cardinale a Corneto, dove venne eretto un “marmoreum cenotaphium” nel Duomo, a cura di suo nipote, vescovo, secondo un’iscrizione conservata fino ad oggi. VI Allorquando nell’anno 1629 il consiglio di Corneto decise di decorare la sala Consiliare del Palazzo Comunale, vennero scelti per gli affreschi delle quattro pareti delle scene, nelle quali si vedeva glorificata la grandezza della città, dipinte da C. Donati. Due pareti erano dedicate al grande cardinale: dopo la fuga sul Tevere, accompagna il Papa Eugenio IV (1434), da lui salvato, nel suo ingresso nell’Urbe. E prima di tutto: la seduta del Senato Romano del 1436 nel Palazzo dei Conservatori (fig.4). Durante questa seduta venne decretata l’esecuzione di una statua equestre sul Campidoglio per Giovanni Vitelleschi, come riconoscenza per la liberazione dai tiranni e difesa dalla carestia. Così sull’affresco - a differenza della realtà - alla decisione dell’assemblea si accompagna l’esecuzione. In primo piano, sulla destra, ecco il monumento del cardinale, in sella del cavallo a destra, mentre un genio alato pennella sullo zoccolo l’iscrizione JOHANNI VITELLESCO PATRIARCAE ALESSANDRINO TERTIO A ROMULO ROMANAE URBIS PARENTI. Ma il tema di questa creazione fantasiosa ha a che fare con la “vera effigies” citata da Giovio? Un’immagine del Cardinale nel rocchetto, in alto ai lati dell’albero genealogico di Corneto, è talmente mediocre che non può avere nessuna pretesa di un vero ritratto (fig.5). Seduto, indica con l’indice della mano destra, appoggiata, più o meno discretamente sul tavolo alla sua sinistra, dove accanto ad un libro e un campanello, dimorano, in modo da non poter sfuggire, il suo elmo e il bastone di comando (con nappa!). Nè la fisionomia, nè la composizione - che presuppone il quadro di Raffaello di Papa Giulio II - fanno pensare ad una conseguenza della “effigie in magno conclave” citata da Giovio, nel salone del suo palazzzo, distante solo un centinaio di metri. Tuttavia queste considerazioni possono aiutarci a sciogliere un modesto enigma della iconografia romana. VII Nella Chiesa di S. Maria Nova (S. Francesca Romana) a Roma si trova ancora oggi il suo monumento funebre di Antonio Rido di Padova (fig.6). Suo figlio Johannes Franciscus glielo ha fatto erigere dopo la morte. EX TESTAMENTO assicura l’iscrizione sul sarcofago, che serve da zoccolo. Due amorini alati si appoggiano ai lati su degli scudi gentilizi. Sopra si erige, seguendo immagini della Roma Antica, il monumento proprio in marmo bianco, il cippo, attorniato da pilastri scanalati. La superficie viene riempita dall’immagine di un cavaliere, ripreso di profilo, che eretto sulle staffe, guarda verso destra (cioè fuori dalla porta della chiesa). Corazzato completamente, saluta con il bastone di comando nella destra, mentre la sinistra regge le redini del cavallo, riccamente bardato. Sulla testa porta solo un berrettino. Forse sembrava più opportuno, adeguatamente alla santità del luogo e alla volontà di pace del defunto, di collocare l’elmo di guerra sotto il cavallo, che alza la zampa anteriore sinistra. Si tratta dell’unico monumento funebre del 15° secolo a Roma, che rappresenta il defunto a cavallo, come rilievo. Questa opera d’arte viene attribuita a Mino Del Reame di Napoli. Questo rilievo, molto spiccato negli strati anteriori, fa pensare ad una statua equestre, pregiata nella sua semplicità. Anche se fossimo tentati di pensare ad un artista, discepolo di Donatello a Padova, patria di Rido, come si spiega la scelta di questa singolare onoranza funebre, sotto forma di rilievo equestre a Roma? Evidentemente è da ricondurre al committente. Nel defunto è stato identificato quell’Antonio Rido che morì sotto Nicola V come comandante delle truppe papali. Castellano di Castel Sant’Angelo, come lo magnifica l’iscrizione, ha ricevuto lì il Papa Eugenio IV con l’imperatore Sigismondo, però in relazione alla nostra storia ha interpretato un ruolo ambiguo. Noi lo conosciamo in rapporto - su ordine vero o presunto di Eugenio IV - alla cattura e alla morte del Legato Papale Giovanni Vitelleschi. Da ciò, dalla sua biografia, si potrebbe spiegare il motivo del suo monumento funebre, come altamente personale. Al suo avversario, l’Arcivescovo di Firenze e Patriarca di Alessandria, non solo venne attribuito, come abbiamo già sentito, dal Senato Romano nel 1436, il titolo TERTIO PATER PATRIAE, ma venne anche promessa l’onoranza tramite un monumento equestre sul Campidoglio. Anche se non si giunse più all’esecuzione di esso e anche se può essere eccessiva la relazione dei contemporanei circa l’invidia di Rido verso Vitelleschi, ciò nonostante potrebbe essere stata la promessa del Senato di onorare in questo modo il nemico di Antonio, lo sprone per il Governatore dello Stato Pontificio, il PRAEFECTO, ad erigere a se stesso il desiderato monumento equestre, come propongono anche le fonti storiche. Anche se non poteva essere plastico e ufficiale, mostra per un monumento funebre privato una dignità sorprendente, quasi imperiale. L’opera d’arte in sé già esprime l’idea di un monumento equestre: nella sua forma strettamente essenziale, con la rinuncia a qualsiasi cenno al “privato” nell’assetto anticheggiante. Il cavallo con la zampa alzata ci ricorda la statua di Marco Aurelio, anche se questa è arrivata sul Campidoglio solamente cento anni più tardi. Nonostante l’alta posizione alla Corte Papale manca qualsiasi segno o parola cristiani. A favore dell’idea parla anche la scelta molto abile del luogo della sepoltura: nel cuore di Roma, al Forum Romanum, nella Chiesa (separata da Nicola V) Santa Maria Nova, precisamente nel suo atrio sud, il prolungamento diretto della Via Sacra. Già Giovio notò l’intenzione di questo monumento funebre, tanto è vero che nel finale della sua biografia del Cardinale Vitelleschi fa riferimento a Rido e la sua “marmoream equestrem statuam quae in vestibulo templi Divae Mariae novae ad arcum Titi conspicitur”. (Elogia 1561, 63). Fosse stata eseguita la statua equestre di Giovanni Vitelleschi come progettato, le sarebbe servita come modello, come per il rilievo del nemico mortale Rido, la statua equestre dell’imperatore Marco Aurelio (ca. 173 dopo Cristo) che durante il Medioevo è stata sempre visibile esempio al Laterano come il cosiddetto Costantino. Renate Schumacker Wolfgarten Traduzione della Sig.ra Theresia Cagnoli STENDHAL e CORNETO Prima parte: “Walks in Roma” Viaggio a Canino - Vasi etruschi Seconda parte: Stendhal e Merimée in Etruria Terza parte: un racconto stendhaliano: “Maria Fortuna”. Muriel Augry PREFAZIONE I passaggi dove è menzionata Corneto nella “Correspondance” di Stendhal, console di Francia a Civitavecchia dal 1831 al 1841, sono assai numerosi. “Les tombeaux de Corneto” 1) , libretto scritto verso la metà degli anni 1830, costituisce certamente l’omaggio più importante reso dall’autore alla piccola città. Ma esiste un frammento inedito 2) , pressapoco dello stesso periodo, che si rivela degno del più grande interesse. Esso si presenta come lo sviluppo di un passaggio del capitolo intitolato “Manière de voir Rome en dix jours” che conclude le “Promenades dans Rome”. “WALKS IN ROME” Seconda edizione. 6 maggio 11824 - Viaggio a Canino - Vasi Etruschi - 28 marzo (18)35. 6 maggio - Le nostre signore vanno a trascorrere tre o quattro giorni nel palazzo di una principessa mezzo-tedesca senza di noi perché abbiamo timore di annoiarci. Domani approfitteremo di questa vacanza per andare a comprare dei vasi nell’antica Etruria e, meglio ancora, per vedere in particolare e con occhio critico i luoghi dove essi sono stati scoperti. Andremo a Cerveteri, Ponte dell’Abbadia, Vulci, Massignano (sic) e Canino. 1) Vedere la prefazione di Gian Franco Grechi e la traduzione di Bruno Blasi delle “Tombe di Corneto”, pubblicate in occasione del bicentenario della nascita di Stendhal, a cura della Cassa di Risparmio di Civitavecchia. 2) Si tratta di un quaderno autografo di undici fogli in folio, appartenenti ad una collezione particolare. Corneto, 7 maggio - Siamo usciti alle quattro di stamattina attraverso la Porta di Roma, vicina al palazzo del (......) dove in questi ultimi giorni è stato messo in carcere un “capo d’ordine”, cosa che ha fatto scalpore per due giorni, ma oggi siamo forse i soli che si siano ricordati di questo pover’uomo passando vicino alla sua tomba. A Roma ci si dimentica facilmente dei poveri sventurati come dei morti. In quattro ore siamo arrivati a Cerveteri (il duca di Cerveteri è uno degli uomini più belli di Toscana). Un (........) e sua moglie, che è fittavola, conduce il lavoro di scavo e ci ha mostrato una collana di filigrana d’oro, lavorata con estrema raffinatezza. Questa collana d’oro senza lega pesa due once (175 grammi, credo) e la moglie ci chiede duemila franchi. Ne offriamo mille. Abbiamo provato degli anelli d’oro adattabili a tutte le dita; funzionano egregiamente ancora dopo duemila anni!... Abbiamo comprato un bellissimo vaso. Le figure sono dipinte in nero su fondo giallo. Non crediate che coloro che comprano questi vasi ne conoscano il vero valore. Il loro valore lo si giudica con lo stesso criterio con cui si stima un gioiello e cioé unicamente per la sua bellezza. M. Inghirami e gli altri hanno inventato su questi vasi delle storie che non sono punto divertenti e che in più non hanno il minimo buon senso. Inoltre tali storie non sono neppure interessanti. Dunque quando si trova un vaso dai colori finemente dipinti, vivaci, che non sia né troppo piccolo né troppo in cattivo stato, allora lo si dichiara di prima qualità e vale da quaranta a sessanta franchi. Il nostro vaso (comprato da un amico tedesco) ci è costato cinquantasette luigi. Ci siamo fermati a C.[ivita]-V[ecchi]a unicamente per vedere il bel negozio di M.D.B.xxx, il solo mercante d’arte che non sia un ciarlatano. Ci ha venduto per tre scudi dei vasi che a Roma ne costerebbero venticinque (for me: regali alla Signora (......) a questo volgare Rochester); abbiamo visto gli scavi del Signor c[on]te di Mxxx, e finalmente siamo venuti a passare la notte a Corneto, a venti leghe da Roma. Scrivo questo in un’osteria che è in realtà una casa d’abitazione, gestita da gente giovane e amabile. L’indomani, il Signor Mxxx ha volentieri acconsentito di condurci insieme al signor Avolta presso le tombe del “Père Lachaire de Tarquinies”. Questa necropoli, per dirla alla maniera pedante dotta ed accademica, ha due leghe di lunghezza e una e mezza di larghezza. Ciascuna tomba consiste in una piccola cantina di dieci piedi per otto, ricoperta da tre o quattro piedi di terra, e perfettamente nascosta. Le pareti di questa piccola stanza sono dipinte. Alcune di queste pitture (affreschi naturalmente) sono contemporanee del primo e più importante periodo della guerra di Troia (......... a.C.): altre pitture risalgono all’epoca dell’impero romano. Sono convinto comunque che la maggior parte sono coeve dell’epoca di Tarquinio. Sappiate che l’Etruria fu sotto la dominazione di potenti sacerdoti e che essa fu interamente conquistata quarantacinque anni dopo la fondazione della sua terribile vicina. Roma, la conquistatrice, era tranquilla e non voleva inimicarsi invano le popolazioni a lei soggette alle quali generosamente offriva lo status di alleati. Essa infatti rispettava e permetteva i loro culti. Dovette essere rispettosa soprattutto della religione, specie in Etruria, paese interamente dominato da un’abile casta sacerdotale. Se prima della conquista, gli aristocratici e la gente di rango avevano l’abitudine di farsi sotterrare dopo la Loro morte nelle piccole tombe dipinte di cui abbiamo parlato e di farsi mettere, dopo l’incinerazione, in vasi dipinti, questa è una usanza che i Romani dovettero lasciare intatta. Questo tipo di stoltezza era riservata ai tempi moderni. I Romani avevano il buon senso di non avere sacerdoti. 7 aprile - Da Corneto, attraverso percorsi impossibili o piuttosto estensioni ricoperte di fango, siamo arrivati a La Cucumella. E’ qui, o nei dintorni che il Signor Luigi B[onaparte, principe di Canino, ha trovato dei vasi che, in seguito, ha venduto a dodicimila franchi (ci riferiscono che corrispondono a circa due milioni al paese). Un piccolo corso d’acqua, o piuttosto fiume, poiché si va a gettare nel mare a sette miglia da qui, chiamato La Fiora, divide La Cucumella (vasto insieme di territori in pianura su cui non sorgono costruzioni e d’aspetto desolato) da un altopiano elevato dove si suppone con sufficiente probabilità che sia stato un tempo la città etrusca di Vulci. Un uomo di buon senso, il Signor Principe Mxxx, pensa che Vulci stessa, di cui oggi appena si trovano i resti e che millecinquecento anni fa, sotto il regno di Costantino, era appena un villaggio, fosse stata costruita sulle rovine di una città contemporanea a Troia, se non addirittura anteriore. Lo stato penoso in cui si trovano alcuni vasi rinvenuti nelle tombe a Vulci o nel suo sobborgo La Cucumella, ci ha suggerito tale ipotesi. Scrivo questo sotto una capannella di paglia, eretta sulle rovine di una cappella cristiana dell’anno 400. Gli intendenti posti a capo degli scavi hanno messo il loro caminetto là dove una volta c’era il pulpito: per fortuna il muro che fu eretto a difesa della tramontana tiene ancora, ma piove nella loro capanna, come lo sentiamo in questo momento. PREFAZIONE (parte seconda) La passione di Stendhal per gli etruschi cresce col passare degli anni. A Civitavecchia, preso dalla noia, egli diviene assai felice non appena, in occasione di una visita, può rivestire i panni del “Cicerone”. Allorché nell’autunno del 1839 lo scrittore francese Mérimée 1) sbarca a Civitavecchia col proposito di passare un mese a Roma e a Napoli in compagnia di Stendhal, quest’ultimo lo porta a conoscenza delle scoperte venute alla luce a Corneto e nell’agro romano e gli presenta un suo amico, Donato Bucci, mercante d’arte. Come archeologo, Mérimée viene subito affascinato da ciò che rappresentano questi scavi come testimonia il passo di una lettera indirizzata a Requiem il 16 novembre 1839. A Requien, Marsiglia, il 16 novembre (1839) ................. Ho comprato a Civita-Vecchia per cento franchi dei vasi etruschi. Ne ho una cassetta piena, tutti molto vecchi e alcuni abbastanza belli. Qui c’è un uomo molto onesto che li estrae nei dintorni dalle tombe etrusche. La più bella patera vale 100 franchi; per quindici franchi, si ha qualcosa di molto presentabile e vecchio di almeno 2700 anni. Vi raccomando quest’uomo per il vostro museo, semmai Vi prende l’interesse per l’Etruria. Addio ancora, a presto. Pr. Merimée PREFAZIONE (parte terza) MARIA FORTUNA 1) Il 9 ottobre Mérimée arriva a Roma. Egli la lascerà il 21 ottobre, diretto a Napoli in compagnia di Stendhal. Il loro viaggio durerà fino al 10 novembre. “La constante préoccupation de Beyle était l’étude des passions. Lorsque quelque provincial lui demandait quelle était la profession, il respondait gravement: observateur du coeur humain 1) . E in questa maniera che in “H.B. 2) , necrologio di carattere satirico, Mérimée, più giovane di Stendhal di venti anni, presenta ai posteri il suo amico e maestro di pensiero. Osservare i costumi, cogliere il fatto autentico, quello che costituisce la “couleur locale”, è questo, infatti, il passatempo preferito dal console di Francia a Civitavecchia nel 1830. E’ il motivo questo per cui lo scrittore francese fu attirato dalle avventure di Maria Fortuna. Tuttavia Mérimée, nell’omaggio postumo reso a Stendhal aggiunge: Sa curiosité constante de connaître tous les mystères du coeur humain l’attirait même parfois auprès des gens pour lesquels il avait peu d’estime 3) . Infatti soddisfatta tale curiosità, l’interesse scemava poiché Stendhal odiava più di ogni altra cosa la banalità e la volgarità. Questo spiega perché Stendhal non ha sviluppato la novella “Maria Fortuna” che è, senz’altro, il raccolto di un fatto autentico secondo il gusto dello stesso Stendhal: ma è in fondo la narrazione di una sordida vicenda criminale, senz’alcuna ampiezza strutturale e psicologica. Non essendovi basi sufficienti allo sviluppo della sua immaginazione, l’autore si è limitato a riportare il racconto che gli era stato fatto senza aggiungervi il dovuto studio psicologico. I personaggi della sua novella risultano quindi essere rozzi, grossolani, privi di nobili sentimenti. Bernardo Containi, amante di Livia Rangoni, alias Maria Fortuna, è un “omaccio” che uccide il di lei marito senza farsi il minimo scrupolo. I domestici di Rangoni, Gianvincenzo Mari e Tullio Rivolta, anch’essi privi di scrupoli morali, passano al servizio di Containi, guidati unicamente dall’interesse e così nella foresta di Cerveteri uccidono a tradimento Bernardo Containi, dopo averlo spogliato di duecento scudi. Nessuno di questi omicidi ha un movente nobile o giustificato. Possiamo ben dire di assistere ad una serie di delitti “vils, vulgaires, plats, communs 4) come Stendhal 1) “La costante preoccupazione di Beyle era lo studio delle passioni. Quando qualche provinciale gli chiedeva quale fosse la sua professione, rispondeva con aria seria: osservatore del cuore umano”. 2) Libretto di una quindicina di pagine, scritto nel 1850 per commemorare la memoria di Stendhal. 3) “Grazie alla sua viva curiosità di conoscere tutti i misteri del cuore umano, egli era perfino attirato da quelle persone verso le quali, altrimenti, non avrebbe nutrito che pochissima stima”. 4) “Vili, volgari, banali, comuni”. teneva a sottolinearlo e a notarlo in margine ai manoscritti italiani che aveva scoperti a Roma in via delle Botteghe Oscure. Ma se è quasi normale che i personaggi secondari nulla facciano per captare la nostra simpatia, ci aspetteremmo almeno che il personaggio principale possedesse un carattere tale da soddisfarci pienamente e ricompensarci della nostra delusione. Invece non è così. Livia Rangoni infatti è una donna che non si eleva mai alle dimensioni raggiunte dalle sue “sorelle italiane” tra cui Léonore, protagonista della novella intitolata “Le Philtre” o perfino da quello di Mina de Vanghel, giovane tedesca romantica. Livia Rangoni in effetti non la si può misurare con lo stesso metro con cui sono state valutate queste eroine stendhaliane. Aggressiva e volitiva e al tempo stesso dolce e fragile, la donna ideale che Stendhal vuole rappresentare nei suoi romanzi è un essere energico, passionale, che si prefigge uno scopo e fa di tutto per raggiungerlo, anche a costo di commettere le peggiori pazzie. Spesso in aperto contrasto con le regole dell’ambiente nel quale vive, essa aspira ad un ideale e sogna una vita vissuta all’insegna della passione, segno questo di una personalità d’eccezione. Il suo amore è una lotta, un mezzo eroico per affermare la sua originalità e una maniera sicura di mettere in pratica i valori in cui crede. Infatti il personaggio femminile stendhaliano si sottomette difficilmente ad un codice di leggi ad esso imposto; esso preferisce seguire la propria morale. Tenace, la donna stendhaliana non si dichiara mai vinta da nessun ostacolo: la passione giustifica tutto. Fisicamente, intellettualmente tale figura romantica è nata proprio per provare grandi sentimenti: il suo carattere di essere unico la spinge a fuggire ogni mediocrità, a conoscere il grande amore, perché tali sono i suoi più vivi desideri. Questa categoria di donna che Stendhal predilige nella descrizione è quella appunto dell’eroina della passione. Alcuni anni prima, in seguito ad un amore infelice per la contessa Métilde Dembovsky, Stendhal iniziò la redazione di un trattato teorico sull’amore che doveva poi portare alla stesura del celebre “De l’Amour”. In quest’opera l’autore aveva proceduto ad una classificazione delle varietà dell’amore. Distingueva quattro forme d’amore: l’amore-passione, l’amore-gusto, l’amore-fisico e l’amore-vanità. L’amore-passione è considerato dall’autore come il più degno d’essere vissuto; tale amore è posto senz’altro dubbio al di sopra di tutte le altre forme d’amore; esso è la somma aspirazione di quasi tutti i suoi personaggi femminili. L’amore che anima Livia Rangoni è ben lontano da quel sentimento nobile che è l’amore-passione. “Maria Fortuna” è la storia di un adulterio, quindi vi è rappresentato l’amore volgare, il più basso nella scala dei sentimenti, cioè l’amorefisico. Stendhal lo definisce così: “A la chasse, trouver una belle et fraîche paysanne qui fuit dans le bois. Tout le monde connaît l’amour fondé sur ce genre de plaisirs; quelque sec et malheureux que soit le caractère, on commence par là a seize ans 5) . L’amore fisico è in effetti il legame che unisce Bernardo Containi a Livia Rangoni. Stendhal è lungi dal condannare il piacere fisico poiché questo “étant dans la nature, est connu de tout le monde” 6) ; tuttavia egli ammette che esso “n’a qu’un rang subordonné aux yeux de tendres et passionnées 7) . Invece Livia Rangoni non appartiene a quest’ultima categoria di esseri Essa infatti non abbandona suo marito per seguire l’impulso irresistibile di un amore folle in compagnia del suo amante. Se così avesse fatto, la qualità del suo amore avrebbe entusiasmato il suo autore e affascinato il lettore. Forse avrebbe addirittura ricevuto l’approvazione di Stendhal; poiché il Nostro non si considera affatto un moralista. In ogni caso, ella avrebbe avuto tutta un’altra dimensione potendo l’immaginazione dell’autore trovare ulteriori trame di sviluppo. Ma, purtroppo, Livia Rangoni non è nemmeno ciò che oseremmo definire una “buona amante”. Allorché il suo amante muore, non prova nemmeno il minimo dolore. Di più, continua il suo cammino con i domestici come se niente fosse accaduto e, freddamente, non ha che un pensiero: provare la sua innocenza. Cattiva sposa, cattiva amante, Livia Rangoni non può che essere anche cattiva madre!..... Infatti abbandona i suoi tre bambini e questo ai nostri occhi suonerà come definitiva condanna. Incinta di alcuni mesi, essa perderà il suo bambino. Questo aborto accidentale causato naturalmente dal modo di vita che essa conduceva nella foresta, assume anche una significazione simbolica. Livia Rangoni non è degna del nobile ufficio di un amore consapevole: accidentalmente concepito, esso è stato accidentalmente perduto. Dopo questa descrizione, Livia Rangoni appare come un personaggio privo di qualsiasi sentimento. La fine del racconto non contribuisce affatto ad una rivalorizzazione di questa figura. Di certo è l’occasione per Stendhal di mostrare una 5) Durante la caccia, incontrare una belle e fresca contadina che fugge nei boschi. Ciascuno conosce l’amore che si alimenta di questo genere di piaceri; qualunque sia il carattere e lo spirito arido e infelice, si comincia da lì a sedici anni”. 6) “Essendo naturale, è prerogativa di tutti”. 7) ... riveste un’importanza di second’ordine agli occhi delle anime tenere, nobili e appassionate”. volta di più il suo anticlericalismo per mettere in risalto la corruzione della Chiesa; ma questa conclusione non fa che peggiorare il carattere negativo della protagonista. Infatti con ciò che le resta dei suoi beni, Livia acquista la sua libertà. Essa sa perfettamente come uscire dalla brutta situazione: per denaro si uccide, col denaro si libera un colpevole. Ecco che l’interesse è l’unica guida morale delle anime meschine. Livia Rangoni non è la sola che approfitta di tale meccanismo di corruzione, ma visto che ella vi aderisce perfettamente non mostrando nessuna incertezza, allora la sua figura in nessun momento acquista una luce diversa. Incarnando l’anti-eroina, Livia Rangoni non può far parte degli eletti, degli “happy few” stendhaliani. MARIA FORTUNA Eccovi il racconto tale e quale mi è stato fatto. Confrontare il vero racconto, perfettamente esatto, del signor Spinola. Estate del 1834, o piuttosto 13 settembre, festa di santa Rosa da Viterbo. Questa mattina, 5 febbraio 1835, Livia Rangoni è stata trasferita dal carcere femminile di Civita-Vecchia, ed è partita per quello di Manziana, feudo del Santo Spirito, dietro richiesta di Monsignor Cioia, capo supremo “commendatore di San[to] Spirito”. Circa tre mesi fa Livia Rangoni partì da Toscanella, dove abitava, e insieme a suo marito venne a trascorrere la notte a Canepina, borgo nelle vicinanze di Viterbo, presso Bernardo Containi, amico di suo marito e suo amante. L’indomani Rangoni e sua moglie partono per andare verso Corneto. Arrivati a dodici miglia da Canepina, un uomo mascherato aggredisce Rangoni e lo trapassa a colpi di coltello. L’assassino era Bernardo Containi, amante di Livia. Rangoni è lasciato come morto sulla strada. Containi fugge e ritorna a casa a Canepina. Livia va a chiamare alcuni contadini che abitavano vicino al luogo dov’era avvenuto l’assassinio, prende in affitto un asino, vi fa deporre il suo sfortunato consorte e infine lo riporta con grande fatica da Containi a Canepina dove aveva trascorso la notte. Il Containi si dispera per la disgrazia capitata al suo amico; vengono dati a Rangoni i primi soccorsi, ma alla fine questi muore due giorni dopo. (Nel romanzo prima di morire ha alcuni sospetti). Morto Rangoni, la vedova ritornata a Toscanella con Containi, suo amante, vende i buoi di suo marito, un gregge di pecore e anche alcuni ettari di terra, abbandona i suoi tre piccoli bambini e lascia infine Toscanella seguita da Containi, suo amante, da Gianvincenzo Mari e Tullio Rivolta, domestici di suo marito, i quali partono armati dei loro fucili come lo era il Containi. (Nel romanzo, Gianvincenzo è innamorato di Livia). Questi tre uomini e Livia, incinta di qualche mese, arrivano a Vetralla e di là alla “Ossetta”, osteria all’inizio di Grosseto, in mezzo a grandi alberi di ulivi. Dopo alcuni giorni fanno chiamare un vetturino e si mettono d’accordo per dargli venticinque paoli per condurli a Monterone (a mezza strada fra Civita-Vecchia e Roma). L’indomani si parte. Una volta arrivati nel bosco di Magnone, Containi e gli altri dicono al vetturino che non vogliono più proseguire oltre. Meno male; però almeno pagatemi - dice il vetturino. I tre uomini puntano i loro fucili e il vetturino è felicissimo di partire per Corneto anche senza essere pagato. Pare che Livia ed i tre uomini continuassero la loro strada a piedi. Arrivarono a Monterone. Intanto cominciarono a vedersi nei dintorni degli avvisi relativi all’uccisione di Rangoni e che parlano di arrestare Containi e Livia, fortemente sospetti. Da Monterone i quattro viaggiatori arrivarono a Cerveteri. Qui Livia Rangoni perse il bambino che aspettava e ciò la costrinse a letto per una quindicina di giorni. Dopo questo tempo, partì con i tre uomini, però Containi aveva da 150 a 200 scudi (1100 franchi). Nel bosco di Cerveteri, Gianvincenzo spara a Containi, lo deruba e abbandona il cadavere nella foresta. I carabinieri trovano questo cadavere, emanano avvisi di ricerca e indagano sugli assassini che si pensa siano nascosti nei boschi della Tolfa. Arrivati a La Bianca, piccolo villaggio proprio vicino a Tolfa, i carabinieri apprendono che la vigilia due uomini ed una donna, le cui caratteristiche rispondono a quelle delle persone ricercate, hanno in questo sito cenato con tre galline la sera precedente. Infine due giorni dopo Livia Rangoni, Gianvincenzo e Tullio vengono arrestati proprio mentre stavano per superare la frontiera toscana nei pressi di Farnese. Vengono tradotti a Civita-Vecchia per essere sottoposti a processo. Una persona onesta, che avesse visto come fosse andata la procedura, assicurerebbe che le due uccisioni avrebbero potuto essere imputate a carico dei carcerati. Poiché Livia aveva qualche bene da parte, invia del denaro a Roma e dopo qualche giorno arriva una lettera di M....... commendatore del Santo Spirito, con la quale costui chiede di istruire lui il processo a carico dei prigionieri in quanto l’ultimo delitto era stato consumato nel territorio di Manziana, feudo del Santo Spirito, al quale questo diritto spetta in virtù delle ultime leggi. Questa mattina, tutti i monelli di Civita-Vecchia si sono riuniti a lungo intorno alla carretta dove stava Livia Rangoni. Il comandante della fortezza non aveva ancora ricevuto l’ordine del Monsignore delegato per la liberazione di Gianvincenzo. Alla fine l’ordine arrivò, dopo tre ore di trattative, e Gianvincenzo, Livia e Tullio partirono per le prigioni di Manziana dove non c’è alcun dubbio che la loro innocenza sarà senz’altro e presto riconosciuta. LA VALLE DEL FIUME MARTA NELL’ETA’ DEL BRONZO Questa relazione è frutto del lavoro dell’équipe preistorica del GAR che, oltre a fornire un sussidio didattico al Gruppo, per quanto riguarda la Preistoria, e a collaborare con i settori di ricerca, le sezioni, e i Gruppi archeologici del Lazio, dal 1980 si occupa della preistoria tarquiniese. Tutto il lavoro di documentazione grafica e fotografica, di controlli sul terreno e di confronti tipologici, nonché l’elaborazione dei dati geologici e topografici è stato svolto da tutti i componenti dell’ équipe. I siti preistorici oggetto della relazione sono stati rinvenuti, nella quasi totalità, intorno al 1970 dall’allora “settore Tarquinia” composto da vari membri, tra cui vogliamo ricordare e ringraziare Lodovico Magrini e Gaetano Bellucci. I materiali recuperati vennero segnalati alla Soprintendenza competente (S.A.E.M.), ma non vennero studiati e, ritenendoli un patrimonio estremamente importante per la conoscenza della preistoria dell’Etruria, vennero affidati nel 1980 all’équipe preistorica perché ne curasse lo studio e la pubblicazione. La nostra équipe ha svolto finora due lavori paralleli e complementari: il ricontrollo della localizzazione dei siti, per poter analizzare il contesto ambientale, topografico e geologico, la classificazione, la documentazione e lo studio dei materiali recuperati. Questa organizzazione del lavoro ha permesso di individuare particolarità insediative interessanti e di recuperare ulteriori elementi datanti, nonché, estendendo le ricognizioni a zone circostanti, di individuare due siti nuovi rispetto a quelli localizzati nel 1970. Il sistema di lavoro ci ha permesso inoltre di rendere noti, seppure brevemente, alcuni dei siti man mano che terminava il lavoro di documentazione. Sono stati pubblicati i siti di Monterana, Ferleta, Larga Callare, Le Grotte, mentre sono in corso di stampa Pisciarello, Ancarano e Castellina della Roccaccia. Il lavoro si è concentrato sull’area costituita dal corso del fiume Marta, nel tratto che va da Tuscania al mare, area ricca di insediamenti dell’Età del Bronzo. Dal punto di vista geologico e topografico si tratta di un complesso piuttosto omogeneo di colline e altipiani incisi da corsi d’acqua di scarsa rilevanza, tra cui spicca il fiume Marta per lunghezza di corso e portata d’acqua. A Sud la zona osservata è limitata dal corso del fiume Mignone che sembra separare due aree culturalmente abbastanza diverse. A Nord il limite è costituito dal torrente Arrone che separa l’area tarquiniese da quella vulcente. Il territorio non presenta generalmente rilievi accentuati, trattandosi di deposizioni sedimentarie quasi esclusivamente marine, con prevalenza di sabbie e argille. I rilievi sono costituiti da arenarie, calcari e travertini mentre sono molto scarsi i lembi di formazione vulcanica; la valle del fiume Marta, infine, è composta da depositi alluvionali fluviopalustri, antichi, recenti e attuali. La vegetazione prevalente è costituita dalla macchia mediterranea mista a querceto, ma la maggior parte dell’area orientale è da secoli oggetto di lavori agricoli che hanno completamente sconvolto l’assetto ambientale originale. La scelta delle zone di insediamento nei vari periodi dell’Età del Bronzo presi in esame è stata fortemente influenzata dall’ambiente: vennero preferite in tutte le epoche aree, con substrati rocciosi resistenti (calcari, arenarie, tufi), anche se la conformazione topografica prescelta subì dei cambiamenti. Gli insediamenti del Bronzo Medio sono situati di preferenza intorno ai 100 metri sul livello del mare, su pendii di rilievo poco accentuati; nel Bronzo Recente e Finale gli insediamenti aumentano e si situano intorno ai 150 metri di latitudine sul livello del mare: vengono preferite colline isolate naturalmente dai pianori circostanti, spesso con pareti ripide; infine i siti che nascono ex novo nell’Età del Ferro si situano in pianura, vicino al mare, entro i 15 metri di altitudine. La vicinanza al sito di un corso d’acqua è fondamentale in tutti i periodi, ma più interessante appare la distribuzione degli insediamenti nelle tre fasi: nel Bronzo Medio i siti sono piuttosto distanziati e scarsi, nel Bronzo Recente - Finale (non c’è un solo insediamento ascrivibile interamente e solo al Bronzo Recente) il numero degli insediamenti aumenta e si assiste al fenomeno dei siti accoppiati, a poche centinaia di metri l’uno dall’altro, spesso separati da un corso d’acqua. Infine nell’Età del Ferro, oltre agli insediamenti che continuano nel tempo, nascono dei nuovi siti vicino alla costa, il loro numero decresce visibilmente e la distribuzione è molto più ampia. Date le condizioni dei ritrovamenti è molto difficile tentare una stima delle aree occupate in origine dagli insediamenti: nella maggior parte dei casi i materiali che sono stati recuperati affioravano per lavori agricoli profondi o a causa di sterri per costruire strade di campagna; nel primo caso la dispersione dei materiali dovute alle arature può falsare l’estensione originale del sito, ingrandendola; nel secondo caso il concentramento limitato può essere dovuto semplicemente alla ristrettezza della porzione di sito asportata dal taglio della strada. Solo nel caso di Ferleta, sito non interessato da lavori agricoli, è possibile stimare l’estensione originale dell’abitato in 3 ettari; altri siti non intaccati da lavori agricoli sono però stati interessati dall’insediamento nel Medio Evo (Torrionaccio, Le Grotte, Castellina della Roccaccia, Castellina della Civita, Santa Maria in Castello) che ha generalmente modificato la sommità dei siti e causato lo scivolamento lungo i pendii del materiale preistorico. I ritrovamenti ascrivibili all’Età del Bronzo Medio sono numericamente troppo scarsi per poter fornire stime statistiche sull’estensione dei siti. Gli Insediamenti Escluso Trocche di Casalta, i siti del Bronzo Medio sono monofase (Omo Morto, Pisciarello, Largo Callare, Ancarano). I materiali non sono di solito in buone condizioni a causa della lunga esposizione sul terreno o di lavori agricoli reiterati nel tempo. I tipi ceramici più caratteristici sono ciotole carenate con carena a spigolo molto accentuato, dolietti e olle con cordoni multipli, basse scodelle con anse a maniglia, manici forati. Su questi siti il lavoro di studio dei materiali deve ancora essere svolto in maniera approfondita; ad un’osservazione preliminare si può comunque notare la presenza di tutti gli elementi sia formali che decorativi che permettono di inserire i nostri siti in una fase avanzata del Bronzo Medio dell’Italia centrale. I siti del Bronzo Recente - Finale sono ben più numerosi e i materiali presentano per lo più un ottimo livello di conservazione. Non abbiamo individuato insediamenti con materiale ascrivibile esclusivamente al Bronzo Recente, mentre sono numerosi i siti che presentano l’associazione Bronzo Recente - Bronzo Finale e quelli monofase ascrivibili al Bronzo Finale. All’interno di quest’ultimo periodo si possono distinguere siti di periodo più antico (Montanara, Torrionaccio, Castellina della Roccaccia) e siti di periodo più recente (Ferleta, Castellina della Civita, Pian di Civita, Le Grotte e Trocche di Casalta). Le forme ceramiche rientrano pienamente nella tipologia creata per il SubAppenninico e per il Protovillanoviano nell’Italia centrale: ciotole con carene arrotondate, ciotole a labbro rientrante, tazze biconiche, anse a protome e cilindrorette. Le decorazioni a cuppelle e solcature, quelle applicate e la comparsa della tecnica “a cordicella” trovano confronti stretti con l’area Tosco-Adriatico-Laziale, ma il dato più interessante viene dall’analisi dei siti con cui si trovano i confronti più stretti: l’area Tolfetano-Cerite, ricca di presenze dell’Età del Bronzo, non offre confronti convincenti, mentre ben più significativi appaiono quelli con l’area del fiume Fiora; non si tratta comunque di confronti talmente stretti da far pensare ad un’unica area culturale. Per quanto riguarda l’Età del Ferro, come per il Bronzo Finale, si può identificare una fase antica e più recente. Particolarmente significativi i materiali della Ferleta e di Pian di Civita, che appartengono al Villanoviano evoluto, mentre quelli di Fontanile delle Serpi e Trocche di Casalta possono essere ascritti al Villanoviano iniziale. Una menzione a parte meritano i siti di Montarana e Ferleta: il sito di Monterana, separato dalla città di Tarquinia dalla Valle del fiume Marta, è stato fortemente intaccato dai lavori agricoli, ma mostrava ancora, a distanza di dieci anni dal ritrovamento, due concentramenti di materiali; sulla sommità della collina era concentrato il materiale del Bronzo Recente insieme ad alcuni frammenti ascrivibili al Bronzo antico, periodo attestato nella zona fino ad ora solo dai materiali recuperati in questo sito. Da rilevare in particolare la presenza del frammento di ciotola decorata nello stile del Bicchiere Campaniforme, che sembra di fattura meno accurata rispetto ai materiali di Torre Crognola (Vulci), ma che si può mettere in relazione con i materiali raccolti da Magrini intorno al 1970 alla Selvaccia di Spinicci, per tracciare una continuità di occupazione della zona tarquiniese per lo meno dall’Eneolitico tardo al Ferro. La felice posizione dell’insediamento, la quantità e la qualità dei materiali recuperati fanno supporre un grosso sito che ha avuto una lunga durata nel tempo e probabilmente un’estensione territoriale notevole. Ferleta, sito che dal Bronzo Recente arriva al Villanoviano evoluto, è una collina allungata di circa 300 x 100 metri, separata dal resto del pianoro per mezzo di un vallo artificiale scavato presumibilmente al tempo dell’insediamento. La sommità della collina e parte del pianoro retrostante sono occupati da un oliveto centenario rinselvatichito e primi materiali furono recuperati nella fossa creata dallo sradicamento di uno di questi enormi alberi. La particolarità del sito sta nel mostrare ancora parte delle strutture adattate per uso abitativo: lungo i fianchi scoscesi della collina si aprono delle cavità parzialmente franate e interrate, da noi definite “ripari”, di fronte a cui si rinvengono materiali ceramici. La sommità dell’insediamento doveva invece essere utilizzata da strutture costruite, ricordando così il modello abitativo di Sorgenti della Nova, che mostra strutture parzialmente scavate nella roccia lungo i pendii e capanne interamente costruite in legno sulla sommità. I materiali ascrivibili al Bronzo Finale evoluto mostrano analogie con quelli degli insediamenti dell’area settentrionale del Lazio (Sorgenti della Nova, Torre Crognola, Norchia). Particolarmente interessanti sono i materiali del Villanoviano evoluto, che trovano confronti proprio a Tarquinia tra i materiali della Necropoli di Monterozzi. Conclusioni Questa relazione rappresenta un sunto del lavoro svolto e da svolgere sulla zona, lavoro che costituirà una monografia sull’Età del Bronzo nell’area del fiume Marta da Tuscania al mare. A questo punto del lavoro è quindi difficile trarre delle conclusioni definitive, è possibile però cercare di tracciare un quadro della strategia dell’insediamento. Alla scarsa presenza di insediamenti oneolitici, segue nel Bronzo Medio un’occupazione del territorio che non è massiccia e che mostra di prediligere zone di altitudine media, inserite in un paesaggio generalmente ondulato e boscoso, con corsi d’acqua nelle vicinanze. Già con il Bronzo Recente il modello d’insediamento cambia: le zone sono morfologicamente più varie, con preferenza per colline isolate o isolabili, con pareti piuttosto ripide. La vicinanza dei corsi d’acqua è vista come elemento di scelta ancora più condizionante in zone che dovevano essere ricche di vegetazione boschiva. Il dato più interessante è l’aumento numerico e di dimensione dei siti, che si diffondono lungo la valle del Marta, spesso occupando colline affrontate. Quest’ultimo dato, che sembrerebbe indicare una funzione di controllo della via fluviale e di alcuni punti strategici, è quello che merita un’osservazione più accurata nell’ambito dello studio globale, soprattutto tenendo conto del fatto che il fenomeno non continua nell’Età del Ferro, ma anzi si assiste, in quest’ultimo periodo, ad una diminuzione degli insediamenti e ad un allontanamento dalle zone interne verso quelle costiere. Infine è da notare la continuità in tre dei siti esaminati (Ferleta, Pian di Civita, Trocche di Casalta) tra Bronzo Finale ed Età del Ferro, continuità che da molti veniva negata e che, se fosse testimoniata in maniera inequivocabile per mezzo di uno scavo stratigrafico, permetterebbe di rivedere la problematica relativa al passaggio tra l’Età del Bronzo e quella del Ferro. Anna Maria Conti GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO BIBLIOGRAFIA - AA.VV. “Sorgenti della Nova” - ED. C.N.R. Milano, Roma 1981 - Cassano S. - Manfredini A. “Torrionaccio (Vt) Scavo di un abitato protostorico” - in Notizie Scavi serie VIII vol. XXXII, 1978. -- Colonna G. “L’insediamento del Bronzo Finale in Italia”, Atti della XXI riun. sc. II. PP. Firenze, 1979. - Conti A.M. “La Ferleta: un insediamento dell’Età del Bronzo a Tarquinia” in Ricognizioni Archeologiche n. 2 - Roma, 1987 G.A.R. - Pennacchioni M. “Torre Crognola” - in “Vulci” rinvenimenti di superficie di epoca preistorica” Quaderni del G.A.R. n. 7 Roma, 1977. - Pennacchioni M. “Presenze dell’Età del Bronzo a Tarquinia: Pisciarello, Ancarano, Omo Morto” in Atti del V Conv. dei G.A. del Lazio, Bolsena 1980, in corso di stampa. Pennacchioni M. - Persiani C. “L’insediamento preistorico della Montarana” in Atti del IV Conv. dei G.A.del Lazio, Rieti, 1979, ed. Roma, 1982. Persiani C. “Nuovi ritrovamenti dell’Età del Bronzo nella valle del fiume Marta”, in “Ricognizioni Archeologiche n. 27 Roma, 1986./ UN SANTO VENUTO DA LONTANO Ho chiesto ad alcuni amici tarquiniesi notizie su uno dei loro Santi Protettori - S. Agapito-, ma nessuno di loro è stato preciso ed esauriente in merito. Qualcuno dei più “acculturati” conosceva i Santi Martiri Sinforiano, Saturnino, Sisinnio, Timoteo; qualcuno dei più tradizionalisti conosceva l’altro Protettore S. Secondiano e la sua festa; tutti ignoravano le vicende di questo Santo Agapito. E’ in realtà vero che si tratta di un martire del lontano III°secolo, ma è pur vero che, controllando negli Archivi cornetani, emergono numerosissimi dati e notizie del Santo, sia da vivo che da morto. Agapito era nato a Palestrina intorno al 259 ed apparteneva ad una nobile famiglia romana, con vasti possedimenti terrieri in Provincia. Il ragazzo era cresciuto nella fede cristiana come tutti i componenti della sua Gens. Nel 274, al tempo dell’Imperatore Aureliano, venne introdotto in Roma il culto del Sole di Emesa come religione di Stato e l’imperatore fu onorato come personaggio divino. In conseguenza di ciò iniziò una persecuzione che interessò anche i cristiani della Provincia. In quindicenne Agapito, individuato come cristiano, venne imprigionato e gli fu richiesto di abiurare e di riconoscere la natura divina dell’Imperatore. Il ragazzo rimase saldo nella sua fede, per cui fu flagellato alla presenza di Aureliano e successivamente sottoposto a tortura con l’imposizione sul capo di carboni ardenti. Poiché persisteva nel suo convincimento, gli vennero frantumate le mascelle e fu quindi esposto nell’Anfiteatro di Palestrina, insieme ai Santi Anastasio e Porfirio e il 18 agosto venne decapitato con un colpo di spada, come si usava per i nobili cittadini romani. Queste sono le notizie sulla vita e sulla morte del santo. Ma da un testo manoscritto del 19o sec. 1 , conservato nell’Archivio della STAS, apprendiamo ulteriori notizie su i luoghi di sepoltura, sulla nascita del culto, su “i vari viaggi” delle reliquie del corpo del Santo. Vediamo allora “il seguito”! 1 Da “MEMORIE STORICHE” di S. Agapito Martire della Città di Palestrina, raccolte ed ordinate da un devoto del medesimo Santo”. Tomo 14 La notte seguente la decollazione, alcuni pii cristiani suoi concittadini raccolsero il corpo del Martire e lo trasportano ad un miglio fuori da Palestrina, in un luogo chiamato “Le Quadrelle” che era stato utilizzato anche per la sepoltura dei corpi dei santi Gordiano, Abbondio, Miliano e Ninfa. Per la custodia del corpo si utilizzò “una cassa nuova ivi trovata”. Non appena la religione cristiana si potè professare liberamente, sul luogo della sepoltura dei corpi dei Santi venne eretta la chiesa rurale di S. Gordiano, restaurata da Papa Leone III alla fine dell’VIII secolo. Le memorie ricordano che nella chiesa esisteva un affresco riproducente il sacrificio del Santo quindicenne e che una vicina fonte portava il nome di S. Agapito. La crudezza del martirio del giovane e la forza d’animo dimostrata dal ragazzo nel sostenere il supplizio e le sofferenze fecero propagare nei luoghi vicini il culto del Santo giovanetto. I prenestini vollero portare in città il corpo di Agapito per il quale avevano costruito una chiesa: alla fine del 4o secolo provvidero alla traslazione nella nuova dimora, in una cripta appositamente predisposta. Nell’anno 974 si effettuò un sopralluogo su i resti del Santo ed in quella occasione le reliquie del braccio vennero donate ad alcuni monaci che le donarono a città anche distanti tra loro. Il 14 gennaio 1116 il corpo di S. Agapito venne traslato nella Cattedrale di Palestrina, su ordine del vescovo Carone, come attestato da una lapide esistente all’esterno di detta chiesa. Allorchè nel 1297 Papa Bonifacio VIII fece incendiare la città di Palestrina a lui ostile, la Cattedrale e le reliquie in essa contenute furono “esentate dalla distruzione”. Frattanto il culto e la devozione a S. Agapito aumentavano negli anni e le reliquie venivano ricercate per essere venerate con particolare pietà tra le cittadine del Lazio. Anche in Corneto il culto si sviluppò intorno al 1300 e si ha memoria di una processione nel 1379: in quella occasione venne esibita la reliquia del “braccio del santo donata da alcuni monaci”. Sicuramente si trattava di una parte della reliquia consegnata nell’anno 974 “ad alcuni monaci” e giunta misteriosamente in Corneto. Gli “Statuti dell’Arte degli Ortolani” redatti nel 1389 - al Capitolo 16o - prevedevano di portare nella processione del 18 agosto il cero di tre libbre, già utilizzate nella processione del Salvatore, alla vigilia della festa dell’Assunta. La reliquia del braccio era conservata nella Chiesa di S. Pancrazio, in una nicchia scavata nella colonna di sinistra, vicina all’altare del Crocefisso.. - Riporto uno stralcio delle “Historie Cornetane” del Camillo Falgari dalle quali apprendiamo: “..... Anno 1436. Era Giovanni Vitelleschi Patriarca e Capitano Pontificio. Lorenzo Colonna, con buon numero di soldatesche con sè, predando la Campagna di Roma, scorreva per il territorio, per lo chè il Patriarca, ritornato frettolosamente indietro da Piperno, dopo aver espugnato molte terre minori, pose il campo a Pellestrina, posseduta dal medesimo Lorenzo. Era la città difficile ad essere espugnata per essere essa situata sopra un alto e scosceso monte et alcune vie strette e tortuose, per le quali poteva ascendersi, erano difese da fortissimi cancelli (grate) con gente armata. Il Patriarca non perdutosi d’animo per questa difficoltà, posta una parte del suo esercito in agguato, con l’altra fece attaccare una fierissima battaglia alli cancelli. E, mentre tutti i nemici sono intenti a difendersi da questa banda (parte), coloro che erano nascosti ebbero lungo aggio con scale et altri istromenti (mezzi) di guadagnare l’altezza del monte, onde quei che difendeano li cancelli, abbandonato il posto, diedero campo a tutto l’esercito ecclesiastico di salire alla cima del monte e stringere più d’appresso la città, alla quale, mancando l’acqua e le vettovaglie, fu dopo qualche tempo costretta d’arrendersi. “Ritornato l’anno seguente - 1437 - in Roma, per dare memorabile esempio alle città dello Stato Ecclesiastico di non sottrarsi in avvenire dal clementissimo dominio pontificio, ai dì 20 maggio spedì dodici operai per ciaschedun Rione di Roma a Pellestrina per distruggerla, dato spazio (tempo) convenevole a quei cittadini di ritirare le loro sostanze. Mandò di poi il Patriarca in dono alla sua Patria (Corneto) non solo le campane, le mostre di marmo e le porte di bronzo della cattedrale di quella Città. ma anche un tesoro di reliquie, tra le quali il Corpo di S. Agapito Martire, la di cui testa donò alla Chiesa di S. Francesco dei Frati Minori, servandosi le altre reliquie nella Chiesa di S. Maria Margherita (eretta da Eugenio IV nel 1435 a nuova Cattedrale di Corneto 1) ”. Un Privilegio del Cardinale Ludovico Scarampi, emanato a Viterbo il 27 maggio 1440, autorizzava i frati francescani di Corneto a deporre le urne con le reliquie del Santo sopra l’altare maggiore, in una nicchia scavata nel muro divisorio tra la cappella e il 1) Le mostre di marmo e le porte di bronzo della Cattedrale prenestina furono utilizzate per ornare il portale del Palazzo Vitelleschi, in fase di costruzione, mentre alcune campane furono poste nella torre campanaria del Comune. Un’altra campane, chiamata “la Palestrina”, venne issata sul campanile della Chiesa di S. Francesco. Successivamente - nel 1697 - venne calata dal campanile per essere rifusa dai fonditori piemontesi Giovanni-Andrea e Giacomo-Antonio Berardi, con una speda di 100 scudi. Con la fusione la campana perse circa 10 libbre. Una nuova fusione di questa campana avvenne nel 1729, con una spesa per la Comunità di 50 scudi. coro: nicchia rifinita da una parte da una lapide di marmo e dall’altra da una grata o cancello chiuso da tre chiavi, tenute rispettivamente dal priore dei Minori, dal Camerlengo della Città e da quello dell’Arte dei Mercanti. Nel 1441 si solennizzò con particolare cura la festa del Santo con una processione nella quale vennero offerti due ceri da tre libbre. Essi furono accompagnati da un pallio “fatto correre la sera della vigilia della festa”. Il tutto fu offerto dall’Università degli Ortolani, con una spesa di 4 scudi. Anche i molinai cittadini contribuirono con una offerta di 16 scudi. Intervenne alla processione il Collegio dei Notai, la Società degli Speziali 1) e quella dei Casenghi. I nobili ed i patrizi, con torce in mano, circondavano le reliquie del Santo. Gli abitanti di Palestrina, rientrati nella loro città e ricostruitala per la quasi totalità, iniziarono a richiedere la restituzione almeno dei corpi dei Santi - ed in particolare di quello di S. Agapito -, rivolgendosi “ai Priori et all’inclito popolo di Corneto”. Da parte loro i Cornetani rifiutarono la restituzione delle reliquie, timorosi che così facendo, avrebbero poi dato il via alle pretese per la restituzione almeno dei corpi dei Santi - ed in particolare di quello di S. Agapito -, rivolgendosi “ai Priori et all’inclito popolo di Corneto”. Da parte loro i Cornetani rifiutarono la restituzione delle reliquie, timorosi che così facendo, avrebbero poi dato il via alle pretese per la restituzione di tutti gli altri beni asportati con la forza dal Vitelleschi. Risposero ai prenestini ricordando la giustezza della punizione inflitta dal Patriarca a motivo della loro protervia, soggiungendo di non voler essere più molestati con richieste di restituzione od altro. I prenestini invece tornarono alla carica e questa volta intervenne per loro Papa Innocenzo VIII, il quale nel 1492 autorizzò il cardinale di S. Clemente e Mons. Marco Barbo a prelevare parte delle reliquie conservate in una cassetta in S. Francesco. I cornetani richiesero un Breve papale che stabilisse che quella doveva essere l’ultima richiesta dei prenestini, ma Innocenzo morì proprio in quell’anno, il Breve non fu emanato e gli abitanti di Palestrina tornarono alla carica nel 1499, facendo questa volta intervenire il cardinale di S. Marcello, per ottenere la restituzione di un dito della mano del Santo. Ma intanto negli animi dei cornetani si era sviluppato un culto sincero per questo Santo “straniero”; la loro devozione era così aumentata che Papa Giulio II, nel 1503, nei primi giorni del suo pontificato, decise di far racchiudere parte della testa del santo in un reliquiario d’argento a forma di busto, a grandezza naturale. I resti del 1) Il Collegio degli Speziali venne fondato in Corneto nel 1424 da Antonello di Pietro e da Biagio di Cecco. cranio furono collocati all’interno in “un piattino d’argento con sponda, di una larghezza di un palmo, tra ovatta e un panno di taffetà rosso”. L’opera d’argento viene considerata una delle migliori e più riuscite esecuzioni del Rinascimento. Il busto, ornato da due collane d’argento dorato, con decorazioni a piccoli gigli di campo, è posto sopra un piedistallo ottogonale dell’altezza di 20 cm. ed è sostenuto da otto piccoli leoni 1) . Sulle otto facce si vedono gli stemmi: - di Papa Giulio II; - del cardinale Domenico della Rovere, vescovo di Corneto, morto nel 1501; - del cardinale Giovanni Vitelleschi; - del Comune di Corneto. Croce bianca in campo rosso, con ramo di corniolo; - di Clemente Galeotto, nipote del Papa Giulio II; - del Cardinale Giorgio Costa, morto nel 1508 a 102 anni. Era stato nominato nel 1495 vice-protettore dei Frati Minori in sostituzione di Giuliano Della Rovere, occupato nella Legazione di Francia. Lo stemma presenta una ruota d’argento in campo celeste; - una scritta a ricordo della traslazione delle reliquie del 1437; - l’assenso papale per la concessione di un’indulgenza plenaria da concedersi in occasione della prossima festa del Santo. La spesa per l’esecuzione dell’opera fu sostenuta dai Frati Minori di Corneto e dalla Comunità, le quali ricorsero a numerose oblazioni e copiosissime elemosine. Il 26 febbraio 1582, al tempo del Vescovo Bentivoglio, parte delle reliquie vennero rinchiuse in una nuova cassetta e collocate nella Cappella di S. Gerolamo, esistente nella Chiesa di S. Francesco: la cappella era patronato dalla Famiglia Martellacci e Papa Gregorio XIII, l’anno prima, vi aveva eretto un altare privilegiato. Intanto il braccio che si conservava nella Chiesa di S. Pancrazio nel 1583 venne racchiuso in un vaso d’argento e custodito in Cattedrale. Ma i traslochi non erano ancora bastati. Infatti, alla morte del Cardinale Carlo d’Angennes dei Signori di Rambouillet, si demolì l’altare maggiore della chiesa di S. Francesco per la costruzione di uno nuovo, un omaggio da parte degli eredi del Cardinale alla memoria del loro parente, morto nel 1585 nel Palazzo Vitelleschi. Per poter meglio realizzare il manufatto venne anche demolito il tramezzo che custodiva sin dal 1440 parte del Corpo del Santo. Le cassette con le reliquie furono provvisoriamente tumulate in un angolo della sagrestia. Nel 1587 - ultimata la sistemazione dell’altare maggiore - le ossa vennero esumate, poste in una nuova urna, sistemate decorosamente in una nicchia della cappella dell’altare maggiore. Anche questa volta l’urna veniva chiusa con tre chiavi custodite dai frati francescani, dalla Comunità cornetana e dagli eredi di Mattia Martellacci - cittadino e cornetano. I prenestini non erano ancora contenti! Per ottenere “giustizia” ricorsero a Papa Sisto V, il quale - con Breve del 7 luglio 1588 - ordinò che una considevole parte delle reliquie fosse consegnata al legato Francesco Ripa, vescovo di Capri, per essere ricondotta a Palestrina. Per evitare tentennamenti ed indugi da parte di Corneto si minacciò di scomunicare i Magistrati, gli Amministratori e tutto il popolo. Di fronte ad una simile minaccia convenne obbedire. E una lapide affissa il 25 agosto 1588 nella Cattedrale di Palestrina ricorda la restituzione e l’arrivo in città delle reliquie del Santo. I cornetani non si dettero per vinti, ma le 44 petizioni inviate all’autorità pontificia (comportanti una spesa di 33 scudi) non ebbero alcun effetto. Soltanto nel 1633 avvenne uno scambio con i prenestini: dietro cessione di un osso di S. Agapito si ebbe un osso di S. Ilario. Lo scambio avvenne alla presenza del patrizio prenestino Francesco Barberini. Ma l’urna di S. Agapito venne nuovamente aperta il 21 aprile 1634 per prelevare una piccola reliquia da consegnare alla città di Bisenzo, ove era iniziata una devozione per il Santo forse da parte di alcune famiglie di carbonai trasferitesi da Corneto in quella terra. La festa e gli onori tributati furono di risonanza provinciale e molte persone parteciparono alla processione di traslazione. A complicare le cose intervenne il 17 agosto 1671 un ritrovamento di reliquie nella Chiesa di S. Pancrazio. Mentre si provvedeva ad abbellire questa chiesa per l’imminente festività del Santo, il parroco - don Giovanni Morelli - nel collocare un vaso su di un capitello, volle “spianare” la base di appoggio, ma il muro cedette, scoprendo una nicchia ed un’urna in cui erano riposti alcuni resti ossei ed una targa di ferro e piombo con una scritta corrosa in cui si volle leggere: “Quì riposano le reliquie di S. Agapito”. A lume delle nostre conoscenze può ritenersi che il ritrovamento riguardasse altri Santi omonimi, a meno che non si voglia supporre che, per evitare di restituire il resto del corpo del Santo alla città di Palestrina, si fossero prelevate tutte le reliquie per essere conservate nascostamente nelle chiese cornetane. 1) Attualmente il busto di S. Agapito è conservato nel Monastero delle Monache Passioniste, essendo considerato il Ora il racconto si fa più interessante perché si dipinge di giallo! In una relazione redatta da don Sebastiano Vaiani e dai Minori Osservanti P. Antonio da Legogne e P. Pietro-Maria da Corneto, apprendiamo che: “il 17 agosto 1728 avvenne un misfatto per mancanza di culto in Bisenzo. Infatti, alla vigilia delle feste di S. Agapito, venne esposta la sua reliquia (quella per intenderci donata dalla Città di Corneto nel 1634). Ma il bifolco Ciandera, alle 18,30 del martedì 17 agosto, vedendo la poca gente presente che si dedicava a libagioni, bagordi e gozzoviglie, pensò di rubarla: cosa che eseguì con molta sveltezza. Presa la reliquia, la coprì con un fazzoletto e la mise “nella catana”. Si tolse il cappello e le scarpe in segno di rispetto e, per sentieri scoscesi solo a lui noti, si recò in un piccolo Castello diroccato, distante un miglio da Valentano, e depose la reliquia rubata nella Chiesa di S. Maria di Nempe, membro della Commenda di S. Magno in Gradoli. Alle 21,30 si recò a Valentano, ove la notizia dell’arrivo “misterioso” della reliquia si sparse in un attimo. Ci fu un accorrere di gente festante e la reliquia venne accompagnata processionalmente nella Chiesa Collegiata di questa Città. Ma più “misterioso” appare il fatto che erano stati predisposti “fuochi di legno, spari di bombarderia da tutti i soldati presenti in città, fontante di vino ed acquavite”. Sorge a questo punto spontaneo il sospetto che tutto fosse stato organizzativo e previsto. Il Ciandera fu inseguito dai bisentini senza essere raggiunto. Poco tempo dopo si rese spontaneamente al vescovo Pompilio Bonaventura, al quale chiese perdono, ma non fece nomi. Fu così carcerato per due mesi e liberato solo dietro pagamento di una multa di 25 scudi. Venne poi ordinata la restituzione della reliquia a Bisenzo, ma gli abitanti di Valentano nicchiavano, trovando pretesti e scuse per non restituire quanto era giunto in loro possesso. Alla fine dovettero piegarsi all’ordinanza vescovile, ma come ritorsione nei confronti del Bonaventura, nessun cittadino di Valentano poco dopo si recò a riceverlo, in occasione di una visita del presule. Egli così si rese conto del forte desiderio dei valentanesi di possedere una reliquia di S. Agapito, per cui nello stesso anno la richiesta venne girata a Corneto che “ben volentieri” il 14 febbraio 1730 inviò un dente e parte di un osso del Santo. Si ha memoria che dal 1730 inviò un dente e parte di un osso del Santo. Si ha memoria che dal 1730 in Valentano si prese l’usanza di recitare un Rosario in suffragio del povero bifolco Ciandera, che per suo merito dotò Valentano di una reliquia tanto desiderata. Convento dei Francescani pericolante. Ma le vicende avventurose non si arrestano più! Nella notte del 16 agosto 1786 cadde un fulmine sulla Chiesa di S. Francesco che “dalla volta reale” penetrò nella Cappella dell’altare maggiore ed entrò nell’armadio ove venivano conservate le Sante Reliquie, distruggendo cristalli, cassette ed urne, svanendo poi attraverso il campanile, senza arrecare ulteriori danni. Parte delle reliquie del nostro Santo si salvarono perché erano esposte nella Cappella di S. Gerolamo, ove si stava effettuando un triduo per la prossima festività, con esposizione del busto d’argento. Quell’anno la processione non fu effettuata per lo stato pietoso nel quale le urne erano state ridotte. Nell’anno 1788 il Vescovo Garampi volle rendersi conto dello stato di conservazione delle reliquie. Alla presenza di P. Ladislao da Viterbo si aprirono le cassette e con l’occasione si prelevò una piccola reliquia che venne donata alla Famiglia Marchetti, ancora di Palestrina. Si indisse poi una sottoscrizione per provvedere ai lavori di riparazione del campanile lavori che vennero ultimati nel 1789. I 26 scudi raccolti per il rifacimento e chiodatura delle urne, visto “il rincaro dei prezzi”, si utilizzarono per una festa e processione, con l’intervento del Vescovo Maury, che però accusò la Comunità di inutili sperperi. Nel 1912 Papa Benedetto XV contribuì alla rifusione di due campane. Alla maggiore venne dato il nome di S. Francesco e alla minore quello di S. Agapito. L’ultimo tentativo dei prenestini di tornare in possesso della testa del Santo si è verificato intorno al 1930, al tempo del Cardinale Salotti di Montefiascone. Quando l’urna fu aperta, si trovò soltanto un piccolo osso del cranio, essendosi ormai tutti i resti “sbriciolati”. Probabilmente i prenestini da allora - speriamo - avranno rinunciato a tornare in possesso delle ultime reliquie di S. Agapito. Ma il culto del Santo in Corneto rimase radicato per tutto il 1800, e si ha memoria della solenne processione ad esso dedicata. Si svolgeva il 18 agosto di ogni anno. Era preceduta, la sera della vigilia, dalla recita dei Vespri solenni nella Chiesa di S. Francesco, ove intervenivano il Magistrato e i maggiorenti della città. Essi venivano incensati e potevano lucrare l’indulgenza plenaria concessa da Giulio II nel 1503. Contemporaneamente nella Chiesa di S. Pancrazio veniva esposta la reliquia del braccio. In questa chiesa si trovavano riuniti il Capitolo cornetano, il clero secolare e quello regolare. La processione del 18 agosto partiva da S. Francesco ed era preceduta da un terziario francescano e due chierici. Seguivano “i signori della festa” - quello nuovo e quello vecchio”, con candele in mano. Venivano due sacerdoti con la cassetta e il busto di S. Agapito. Ad un segnale convenuto partiva dalla Chiesa di S. Pancrazio la processione recante il braccio del Santo. Esso era preceduto dai trombettieri comunali, dai Frati Minori Conventuali, dai Serviti, dagli Agostiniani con croce. Seguiva la croce capitolare e l’intero Capitolo. Venivano i patrizi che con le loro candele accese contornavano la reliquia. Chiudeva la sfilata il Magistrato, scortato dai suoi valletti. I due tronconi si univano presso l’odierno incrocio di Corso Vittorio Emanuele e Via Garibaldi. Suono di campane, sparo di mortaretti. La prima sosta avveniva presso la Chiesa di Santa Croce, ove i Fatebenefratelli allestivano un altare splendente di candele. Si passava poi alle chiese di S. Lucia e di San Marco per poi dividersi e tornare ai luoghi di partenza. Il giorno dopo, alla presenza del Magistrato, si ammetteva la cittadinanza al bacio del busto, tra suoni di tromba e tripudio popolare. Le spese venivano sostenute dall’Università degli Ortolani e da quella dei Calzolai. Queste sono le vicende del Santo Agapito da Palestrina, di questo Santo sconosciuto a Corneto, nonostante che ne sia il Patrono. Non è stato facile destreggiarsi tra leggenda e storia, ma l’avventura era degna di essere raccontata: una vicenda che lo ha visto viaggiare più da morto che da vivo; un corpo partito per intero e tornato in patria solo a piccoli resti. Un Santo venerato e con un culto diffuso, senza esagerare, in tutta l’Europa. Tralascio di enumerare tutte le città, chiese, ordini religiosi che vantano il possesso dei resti del Santo fanciullo. Egli, proprio per il supplizio dei carboni ardenti cui fu sottoposto era considerato il protettore di coloro che soffrivano di emicrania. Visti i tempi odierni, nei quali il mal di testa è male comune a tantissimi uomini e donne, si potrebbe riscoprire il Santo e ricorrere alla sua virtù traumaturgica, considerando il Suo lungo periodo di inoperosità. Ora finalmente i resti mortali di Agapito riposano sotto la predella dell’altare maggiore di S. Francesco, ove sono stati traslati, allorché nel 1961 è stato eretto il nuovo altare. Speriamo che finalmente i suoi resti possano trovare quel riposo dovuto a chi per giungere a Corneto da lontano ha dovuto sostenere tante traversie. Mario Corteselli LE MOLE DEL MIGNONE Sono stato con Silvio De Pietri a ritrovare ed a rintracciare le mole del Mignone: il vecchio Silvio fu l’ultimo mugnaio a lavorare alle Mole, che furono definitivamente chiuse nel 1916 quando lui aveva 16 anni. Del vecchio mulino si vedono distintamente ancora le due macine, le tracce del livello raggiunto dalle piene del fiume, l’ingresso delle tubine, le stanze dove abitavano i lavoranti e dove lui teneva la contabilità del grano che entrava e della farina che usciva. Ed esiste ancora il vecchio ponte a più arcate che attraversava il fiume. Fin dai tempi più remoti esistevano piccoli mulini che appena soddisfacevano le esigenze dei proprietari ed alle mole pertanto affluivano gli abitanti di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere e Monteromano, da tutte quelle località insomma, il cui territorio non possedeva che piccoli torrenti e non corsi d’acqua sui quali costruire mulini che garantissero un lavoro continuato delle macine anche in tempo di siccità. Tutti i paesi sopracitati, ed altri ancora, fino alla seconda metà del 1500 erano stati costretti a macinare i loro grani nelle maestose mole a sei macine sul fiume Marta, appartenenti alla Comunità di Corneto; ma la strada era lunga ed anche pericolosa, poiché i contadini il più delle volte erano costretti a trasportare i loro grani servendosi delle barche, data l’inesistenza di ponti abbastanza solidi sul fiume Mignone. Già nel 1471 si era sentita la necessità della costruzione di nuovi mulini, data l’indisponibilità, per restauri, delle Mole del Marta: Guittutio Vitelleschi, a quell’epoca, si offrì di fabbricare a sue spese, un mulino sul Melletra, affluente del Mignone, con l’intesa che “rassettati poi i molini pubblici (sul Marta) qua non si possa più macinare da alcuno” (1). La Comunità di Corneto, forse temendo di perdere l’esclusiva della molitura del grano che esercitava in Corneto e nel territorio limitrofo, qualora i nuovi mulini continuassero ad essere funzionanti anche dopo la riparazione delle sue mole, negò il permesso. Quasi cento anni dopo si fece avanti un cittadino di Civitavecchia, che, con l’appoggio del potentissimo cardinale Guido Ascanio Sforza, cercò di forzare la mano alla Comunità cornetana: il 9.1.1560 infatti, Guido Fulci, bolognese, in qualità di agente e procuratore del reverendissimo Guido Ascanio Sforza, cardinale diacono di Santa Fiora, e amministratore delle chiese di Corneto e Montefiascone, cede in enfiteusi perpetua al capitano Ettore Blancardo, civitavecchiese, un rubbio di terreno posto nella tenuta di Cencelle, vicino al fiume Mignone, di pertinenza delle suddette chiese, per la costruzione di un mulino a grano da edificarsi entro il mese di settembre 1561. L’affitto è stabilito in scudi 18 annui da pagarsi nel giorno della Pasqua di Resurrezione. I patti furono i seguenti: né il cardinale né i suoi successori potranno costruire nella tenuta di Cencelle un altro molino per uso degli abitanti di Civitavecchia e del suo porto e neanche concedere licenza ad altri di costruire molini nella stessa tenuta; in caso contrario il cardinale e i suoi successori saranno tenuti al risarcimento dei danni e, durante tutto il tempo della controversia, il Capitano non sarà tenuto a pagare alcun censo o canone. Qualora d’altro canto, il Blancardo o i suoi eredi non paghino il canone pattuito per un biennio, decadranno dal diritto di enfiteusi e il diretto dominio del fondo passerà nuovamente al Cardinale o ai suoi successori” (2). La prevedibile reazione cornetana non si fece attendere: di li a qualche mese, il 6 Maggio 1560, Fabrizio, guardiano comunale, avvertì la Comunità che i famigliari del Capitano Blancardo “asportano sassi, con bestie, dal territorio cornetano a Cencelle, per la costruzione di un mulino” (3). Il Consiglio Generale di Corneto si riunì subito e decise, nella seduta del 12 maggio, 1560, di inviare a Roma un messo per informare i procuratori del Comune, Giacomo Vipereschi ed Orazio Albizini, circa l’operato del Capitano Ettore ed ottenere un parere legale sulla faccenda (4). Il 19 Maggio 1560 il Consiglio Generale decise di mandare un ambasciatore a Roma, a conferire col Cardinale Camerlengo, onde ottenere di poter procedere contro il Capitano Blancardo, specificando che “questo non si fa per contro alla mente di Lei, ma solo per la conservazione delle nostre ragioni e delle poche nostre entrate” (5). Il Papa in persona, Pio IV, prese in mano la faccenda e con Motu Proprio che ratificava, in ultima analisi, l’atto di cessione in enfiteusi a favore del Capitano Blancardo, concesse di edificare un molino sul Mignone, nel territorio di Cencelle, spettante a Corneto, per il servizio di Civitavecchia e suo porto (6). Forte di questo, il nostro Capitano continuò la costruzione del mulino. Il Comune di Corneto tentò allora di procacciarsi con negoziato ciò che non aveva potuto ottenere con la forza: o l’uso delle mole del Mignone, o la diretta proprietà. Ai primi di novembre inviò, infatti, Scipione Vipereschi dal Cardinale Legato offrendosi di pagare il medesimo censo che pagava il Blancardo per l’affitto del terreno, impegnandosi, altresì, a risarcire il Capitano dei danni: contemporaneamente incaricò un architetto di recarsi sul posto per vedere se si poteva impedire la costruzione del mulino e, nel caso”, di fabbricare dal canto nostro” (7). Ma tutto rimase lettera morta ed allora il 4 Maggio 1561 il Consiglio decise di inviare una inibizione di ulteriore costruzione al Capitano Blancardo che, è bene ricordarlo, operava sul territorio cornetano, come ci mostra la pianta catastale che riportiamo (8). In data 6 Maggio 1561 si diede finalmente mandato al Procuratore del Comune di Roma di procedere, per vie legali, contro il Capitano Ettore Blancardo e la citazione in giudizio avvenne in data 2 Maggio. Il Capitano Blancardo nominò suo procuratore Benedetto Bona da Cortona. In attesa della discussione della causa il Capitano, forte dell’atto di enfiteusi del terreno e, soprattutto, del motu proprio di Pio V, preseguiva i lavori di costruzione che, come si ricorderà, dovevano essere portati a termine entro il mese di settembre, pena la decadenza del diritto. La reazione dei cornetani, direttamente minacciati nelle loro entrate divenne, a questo punto, violenta: è del 22 Luglio 1561 una lettera con la quale la Comunità di Civitavecchia informa quella di Corneto del fatto che il Capitano Blancardo ha fatto ricorso ad essa, lamentandosi che “alcuni uomini di Corneto.... con minacce hanno costretto i lavoranti ad abbandonare i lavori del mulino”. I cornetani rispondono, molto laconicamente, che “sebbene si sia un po' esagerato sulla portata del fatto, non di meno credono di haverlo fatto a ragione” (10). Finalmente il 25 Luglio 1561, la Comunità informa messer Laudizio Ziti, ambasciatore a Roma, dell’arrivo di Emilio Leli con il procuratore nella persona di Giacomo Vipereschi, relativo al giudizio intentato dal Comune contro il Capitano Blancardo. E’ da presumere che la controversia fu sfavorevole al Comune di Corneto in quanto non ci sono dubbi circa il fatto che il Capitano portò a termine la sua Lega (mulino): lo si deduce dal catasto rustico di Corneto che nel 1566 riporta quanto segue: in contrada Montericcio “la Magnifica Comunità di Corneto (possiede) some tre e stara quattro di poppe; confina verso Cencelle, il Mignone, dove era la Lega del Capitano Ettore” (11). Ma da quanto appena detto si deduce però, che se è vero che il mulino sul Mignone fu costruito, è pur vero che esso ebbe vita breve, forse perché il Comune di Corneto era riuscito alla fine, non si sa come, e far si che le nuove mole venissero disertate. Nell’anno 1571 la Comunità emanò uno statuto, col quale proibì ai cittadini ed abitanti nel territorio di Corneto, di macinare in altri mulini che non fossero quelli comunali sul Marta, sotto pena della perdita dei grani, intendendo con ciò garantire ulteriormente il proprio diritto di proprietà privata, nonché tutelarsi contro altri nuovi tentativi tendenti a ripetere l’esperienza dello sfortunato Capitano. E non aveva torto il lungimirante Comune di Corneto! Infatti, pochi anni dopo e precisamente il 1 Luglio 1579, Papa Gregorio XIII con motu proprio, concesse a Latino Orsini il diritto di fabbricare un mulino sul Mignone che dovesse servire per gli abitanti del Comune di Civitavecchia e delle galere pontificie (13). Nello stesso periodo di tempo vennero scoperte le miniere di allume sui monti della Tolfa e, poiché si formò una comunità di operai, con le loro famiglie, nella zona dove ancora attualmente sorge la chiesa di S. Maria della Farnesiana, si rese necessaria la costruzione, oltre che della chiesa di S. Severella, anche di una piccola mola per la comodità sia dei lavoranti che dei comuni di Tolfa e Allumiere. Ma, per tornare alle mole degli Orsini, le traversie non erano ancora finite: i molini vennero venduti, con istrumento datato 3 Marzo 1598, a Mario Fani (14). Tutto andò bene fino alla metà del 1600: ad un certo punto Francesco Fani ed i fratelli, eredi di Mario Fani, cominciarono ad allettare i cittadini del circondario, offrendo prezzi più bassi per il lavoro di molitura del grano. Non solo: cominciarono anche a vendere il pane, a prezzo competitivo col forno comunale di Corneto, nelle osterie di loro proprietà. Molti, forse troppi cittadini cornetani ed abitanti nei paesi limitrofi preferirono macinare al Mignone: inevitabilmente il Comune di Corneto, sentendosi ancora una volta minacciato nei suoi diritti, e, soprattutto, nelle sue entrate, dovette presentare, il 18 Dicembre 1651, una citazione in giudizio nei confronti di Francesco Fani “coram Aloysio Homodeo”, giudice e chierico della Reverendissima Camera Apostolica. La Comunità ottenne l’inibizione contro la famiglia Fani a non essere molestata nei suoi diritti (15). I Fani presentarono allora, una istanza per la revoca di tale inibizione, invocando il diritto dei cittadini a macinare i loro grani dove più a loro piacesse (16). La causa, rimessa da principio al Cardinale Sacchetto per la concordia, venne, dopo innumerevoli rinvii, definita nel 1654, “coram Pallavicino”, a favore dei signori Fani. Probabilmente la famiglia Fani non versava in buone condizioni economiche e per questo aveva cercato di accattivarsi la clientela praticando prezzi più bassi. Che le finanze dei conti Fani fossero in dissesto ci viene confermato da un atto del 2 Maggio 1731 col quale i tanto contrastati molini venivano dati in affitto, dal signor Giuseppe Serafino Requitani. Economo deputato dei creditori dell’eredità giacente del fu Fabio Fani, ad Antonio Maria Miniati, il quale aveva non solo l’appalto del forno di Civitavecchia, ma l’anno prima, 1730, aveva ottenuto anche quello del forno di Corneto, obbligandosi a “molare nel mulino del Comune” sul Marta, in virtù della clausola con la quale, nel 1571, veniva affittato il forno comunale: la faccenda è tanto assurda che i creditori dei Fani fanno istanza per la recissione del contratto (17). Successivamente, nel 1783, troviamo come proprietari delle mole del Mignone, gli eredi del fu conte Nicola Soderini e come affittuario Alessandro Chiocca, cornetano. Da questa data in poi non si hanno altre notizie di successivi passaggi di proprietà delle Mole, né sulle loro vicende. Silvio Di Pietri non ricorda quando la sua famiglia venne in possesso dei mulini, ma si vanta di essere nipote di mugnai, a loro volta mugnai di antica data e sempre sul Mignone. La mia mattinata col vecchio Silvio, densa di storia e di ricordi, è terminata ed io prendo sotto braccio l’amico che, claudicando, mi ripete ancora della diga sul fiume, del ponte a più arcate, dei danni che facevano le piene, ecc. ecc.... e ritorniamo alla macchina. Ma un pensiero mi balena: chissà quante legnate si saranno dati i cornetani ed i civitavecchiesi in quel lontano 22 luglio 1561! Mi viene da ridere: sono storie di fiume. Antonio Pardi MOTU PROPRIO DI GREGORIO XIII Copia dell’anno 1732 Sebbene nella nostra terra di Civitavecchia e nel suo territorio ci siano alcuni mulini ad acqua, tuttavia, quelli posti sui torrenti e che funzionano con le acque piovane possono entrare in funzione solo d’inverno e quando piove, cosicché soprattutto in estate e negli altri periodi di siccità la predetta terra, non avendo la comodità di macinare, soffre molto per questo e i suoi abitanti, cittadini della città e del territorio cornetano, per macinare sono costretti ad andare a circa dieci miglia di distanza con grande spesa di trasporto, grande perdita di tempo e grande fatica e dovendo per forza attraversare il fiume Mignone sul ponte di Carente, talvolta anche con grave pericolo di essere travolti, per cui non solo gli stessi abitanti e cittadini ma anche le triremi della nostra Camera Apostolica che lì stanno e le navi che approdano al porto di Civitavecchia per portare le merci anche alla nostra alma Urbe e lì si fermano subiscono un grave danno e svantaggio, perché i fornai sono costretti ad alzare il prezzo delle gallette e del pane, in relazione alle spese che sostengono per la macinazione. Ci è stato riferito che si può costruire e fabbricare un mulino sul detto fiume Mignone nel predetto territorio di Corneto, ma a mezza strada tra Civitavecchia e la Città di Corneto, vicino e al di là del Ponte rotto che esiste sullo stesso fiume, come anche nel passato sul medesimo fiume in un altro luogo per concessione e indulto di Papa Pio IV, nostro predecessore, o della Camera apostolica fu iniziata la costruzione di un mulino, ma, come si dice, non fu condotta a termine per lo scarso impegno e le poche forze di colui o di coloro che avevano intrapreso l’opera. Noi a tanti e così gravi inconvenienti predetti vogliamo ovviare per il futuro e provvedere con un opportuno rimedio giuridico e aiutare con speciali favori e concessioni il diletto figlio latino Urfino Domicello Romano, che, seguendo le orme insigni dei suoi antenati milita al servizio della nostra Chiesa con il grado, l’onore e l’ufficio che ricopre di Luogotenente generale delle armi e della milizia della stessa Chiesa e per il quale molto confidiamo in Dio e al medesimo Latino e ai suoi successori ed eredi e agli aventi diritto nel tempo da lui o da loro anche nel futuro concediamo che in quel sopra nominato fiume Mignone in un luogo pubblico presso il detto Ponte possa essere costruito un mulino con qualunque corpo centrale e appendici e modi e forme gli piaccia e anche qualunque altro edificio per qualunque uso gli sembrerà opportuno e gli piacerà costruire e fabbricare e tutte queste costruzioni mantenerle e usarle apertamente e pubblicamente o farle costruire e fabbricare e mantenere e usare e percepirne tutto il guadagno che di lì proverrà e che se ne potrà ricavare e adoperarle per proprio uso e utilità concediamo che per l’uso e la costruzione e la manutenzione di questo mulino e di tutti gli altri edifici a lui graditi possa servirsi, anche, per qualunque uso, delle colonne e dei pilastri e delle basi e delle strutture del detto Ponte e possa in quelle e sopra quelle costruire o appoggiare (sopraelevare?) i predetti edifici o qualunque altro edificio gli piaccia e anche (portare) l’acqua del predetto fiume per le rive e i luoghi ameni al mulino e gli altri edifici predetti; dovunque i cittadini o gli abitanti e gli abitatori della medesima città di Corneto possono scavare e portare via la Puteolana, altrimenti chiamata Porzolana, nel territorio di Corneto, e anche possono tagliare legna nei boschi di Tolfa e nei possessi e tenute della Camera apostolica e di Civitavecchia a lor piacimento, e anche nei possessi della stessa città e nelle sue tenute possono scavare ed estrarre pietre di qualunque genere per fabbricare (da costruzione). E per portare tali materiali ed altri di qualunque genere necessari per fabbricare questo mulino e gli altri edifici predetti sul luogo del mulino e degli edifici vicini concediamo che possano liberamente e lecitamente, con pieno diritto passare attraverso qualunque luogo, sia pubblico che privato, tanto con i carri che con i giumenti o in qualsiasi altro modo, pagando i danni ai privati, una volta fattane la stima, i suoi predetti e gli agenti di lui o di loro possano anche fare ciò che a tutti, ai singoli, a qualunque altra persona, di ogni grado, stato, condizione e dignità, eccetto naturalmente a Latino, ai suoi predetti o a chi ne ha licenza da lui, è assolutamente e in perpetuo proibito e non lecito. Sotto pena, in virtù della Santa obbedienza e del nostro sdegno, di mille ducati d’oro della Camera da pagare per una metà alla Camera apostolica e per l’altra metà a Latino e ai suoi predetti senza possibilità di condono e sotto pena di altre pene più gravi a nostro arbitrio e ogni volta che si contravverrà (a queste disposizioni) e per ognuno dei contravventori (incurren?) proibiamo che per 100 canne tanto al di qua che al di là del predetto Ponte si costruisca qualche edificio per macinare o per fare pane e qualsiasi altra cosa o allo stesso Latino e ai suoi eredi e successori e a chi avrà licenza da lui e da loro in questo spazio di 100 canne dall’uno e dall’altro lato del ponte, come in qualunque altra parte del fiume e delle sue rive permettiamo di costruire e gestire forni per costruire gli edifici predetti e qualunque di essi permettiamo di usare liberamente liberamente le colonne, i pilastri, le basi del predetto ponte, se lo vorranno, e vogliamo che, a riguardo di tutte le singole cose sopra dette e sotto scritte non debbano o possano essere molestati e impediti nell’uso e godimento di queste da nessuno, di qualsiasi autorità rivestito. Oltre a ciò concediamo che Latino stesso raccolga un qualche frutto delle sue fatiche in questo lavoro e che lo stesso Latino e i suoi eredi e successori e aventi diritto, o che lo avranno, da lui o da loro, da ora ed in perpetuo possano godere ed usare tutti i privilegi, facoltà, libertà, immunità, esenzioni, onori, vantaggi, concessioni, indulti, e tutte le altre grazie di cui godono i cittadini di Civitavecchia che abitano in essa secondo diritto, uso, consuetudine, privilegi e concessione e ugualmente ne possano godere in futuro. Concediamo anche allo stesso Latino e ai suoi eredi e successori, in perpetuo la licenza di prendere acqua dal fiume, di fare rivi ed argini, di mettere dentro travi, di costruire muri sulle rive del fiume, di fare rivi ed argini, di mettere dentro travi, di costruire muri sulle rive del fiume e di fare tutte le altre cose necessarie ed utili, per ora e per il futuro, al mulino e agli altri edifici da costruire e di passare e di trasportare per le strade e per i sentieri pubblici per quanto stretti e gli concediamo anche il passaggio e il trasporto e tutte le altre cose utili alla costruzione e alla gestione del mulino.... Stabiliamo anche dandone mandato ai diletti figli il Camerario, il Tesoriere, il Depositario, e anche i Governatori della città di Corneto e di Civitavecchia, i Generali della Camera Apostolica, ai loro luogotenenti, presenti e futuri, alle Comunità, alle Università e a tutti gli altri a cui spetta, di accettare e osservare e far osservare a tutti la presente e di curare che sia registrata nei registri della Camera Apostolica e decidano lettere, mandati e proibizioni anche penali a favore degli stessi nell’uso e godimento di queste cose. BIBLIOGRAFIA N. 1 - MUZIO POLIPORI - Croniche Cornetane, - pag. 263 N. 2 - ARCHIVIO STORICO COMUNALE TARQUININESE (A.S.C.T.): Brevi, Patenti, Privilegi, 1479, 1483, 1560 - Atti relativi alla compra della pesca sul Mignone e Carte Sparse 1560/1789. N. 3 - A.S.C.T. - Reformationes 1559-1564, c.100 v. N. 4 - A.S.C.T. - Reformationes 1559/1560, cc. 154 e 155 r. e Registro delle Lettere 1558/1564 c. 68 r. N.5 - A.S.C.T. - Reformationes 1559/1560 c. 158 v. N.6 - A.S.C.T. - Carte sparse 1560/1789: Motu Proprio di Pio IV (copia). N.7 - A.S.C.T. - Reformationes 1559/1560, c. 206 r. N.8 - A.S.C.T. - Carte Sparse 1559*1560, c. 206 r. N.9 - A.S.C.T. - Registro delle Lettere 1558/1564, c. 100 r. e Carte Sparse 150/1789. N. 10 - A.S.C.T. - Carte sparse 1560/1789 e Registro delle Lettere 1558/1564 c. 106 v. N. 11 - A.S.C.T. - Catasto 1566, V. B 12. N. 12 - A.S.C.T. - Carte sparse 1560/1789. N. 13 - A.S.C.T. - Carte sparse 1560/1789 e Archivio della S.T.A.S.: Motu Proprio di Gregorio XIII (integralmente riportato). N. 14 - A.S.C.T. - Carte Sparse 1560/1789 N. 15 - A.S.C.T. - Carte Sparse 1560/1789 N. 16 - A.S.C.T. - Carte Sparse 1560/1789 N. 17 - A.S.C.T. - Carte Sparse 1560/1789. Mi sento in dovere di ringraziare la sig.ra Lidia Perotti, dell’archivio storico del nostro Comune, per la preziosa e fattiva collaborazione. DIPINTI DEL SEI E SETTECENTO A TARQUINIA Le schede relative ad opere d’arte della città di Tarquinia sono estratte da un più ampio studio presentato alla Scuola di Perfezionamento in Storia dell’Arte dell’Università di Urbino a titolo di dissertazione scritta finale. Mi preme sottolineare che l’ingente massa di materiali analizzati nel lavoro suddetto, sono stati riprodotti fotograficamente e schedati dal sottoscritto nel corso di tre campagne promosse congiuntamente dal Comune di Tarquinia e dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Roma e del Lazio fin dal 1981-1982. Questi materiali, che vanno man mano rivelando l’importanza del complesso artistico accumulatosi nei secoli, vengono presentati come anticipazione alla consegna da parte della Soprintendenza al Comune di una copia delle singole schede di catalogo relative alle opere d’arte, ma anche egli oggetti, agli elementi ornamentali e architettonici, la restituzione delle quali dovrebbe iniziare fin dal prossimo autunno. L’Autore Giannino Tiziani La Crocefissione con la Vergine, S. Giovannino ed i Santi Crispino e Crispiniano (qui attribuita a Bartolomeo Cavozzi), olio su tela (261 x 178) già presso la cattedrale prima del 1642. In deposito presso il monastero delle Passioniste. Neg. Soprint. B.A.S. Roma n. 127691. Il dipinto, estremamente offuscato per la sporcizia ed il nerofumo sedimentato, è attualmente depositato presso il Monastero delle Passioniste di Tarquinia. Il fondo molto scurito non lascia intravedere nessuna figurazione mentre in primo piano emergono le quattro figure di santi composti in modi strettamente simmetrici attorno al Crocefisso. La proprietà disegnativa delle figure è notevolissima come anche il cromatismo intenso, quale il blu metallico del manto della Vergine, il rosso cupo del manto di S. Giovannino ed il verde smeraldo della sua veste. La figura di S. Crispino, la prima a sinistra, ha un acceso contrasto di timbri nella tunicella verde e nella clamide giallo oro. Forti i caratteri tardomanieristi a livello del taglio compositivo, piramidale, uniti al gusto caravaggesco delle soluzioni cromatiche e luminose. La tela è sicuramente quella già posta sull’altare della confraternita dei calzolai intitolata a S. Crispino, nella cattedrale, tela che aveva esattamente questo soggetto, come è riportato in un piccolo disegno seppure molto sommario, a matita, riprodotto dal Marchese 1) , dove la cappella è riconoscibile per lo stemma dell’arte sovrapposto all’arcone. Questa, già costruita nel 1580, nel 1629 risulta posta alla sinistra dell’altare maggiore 2) . Per le tracce evidenti di nerofumo, oltre che per i caratteri stilistici, il dipinto va posto ad una data anteriore all’incendio subito dall’edificio nel 1642. La cappella dell’arte dei calzolai che dopo la ricostruzione appare spostata sul lato destro della chiesa (1655), scompare nei restauri del 1879. L’artista autore della tela non è di facile collocazione (anche per le pessime condizioni di leggibilità dell’opera) nel complesso panorama dei due primi decenni del Seicento. Tra i caravaggeschi l’opera ritrova analogie con quella di Bartolomeo Cavarozzi (Viterbo 1590- Roma 1625) ad una data forse prossima alla Visitazione eseguita dall’artista per il Palazzo Comunale di Viterbo e dotata con certezza al 1622. La tela viterbese documenta il momento di massimo accostamento del pittore ai modi del Caravaggio nell’intensa resa veristica delle figure, rispetto ai quali l’opera tarquiniese dimostra caratteri stilistici molto vicini, sia nel modo di illuminare le figure con una luce leggermente direzionata da sinistra, che anche nel modo di panneggiare. Si confronti il manto di S. Giovanni con quello di S. Elisabetta del dipinto viterbese, ad ampie pieghe stazzonate, oltre alla composizione semplificata, ridotta a poche grandi figure primarie disposte a piramide delle prime opere quale la S. Orsola e le Vergini Compagne, del 1608 (Roma S. Marco), dipinto al quale quello della cattedrale di Tarquinia si avvicina ancora per una certa durezza dei volti levigati, dove la luce disegna profili netti e 1) 2) L. Marchese, Tarquinia nel Medioevo, Tarquinia Civitavecchia 1974, fig. p. 27. M. Corteselli, A. Pardi, Corneto com’era, Tarquinia 1983, pp. 87-88. contemporaneamente bamboleggianti, alla maniera del Roncalli, primo maestro del Cavarozzi. Di questa sua prima maniera la Crocefissione conserva (perché di lui sembra potersi trattare) l’allungamento delle figure, la grafia delle pieghe a “gorghi” paragonabili ad esempio quell’elemento ad “U” fatto dal manto sulla coscia della Vergine e lo stesso motivo nella medesima zona anatomica della S. Orsola - oltre all’appiombo delle due figure femminili e alla resa ed alla gestualità delle mani. Si confrontino in particolare quelle della Vergine con quelle della compagna di destra di S. Isidoro, vicinissime tra loro, come anche il gesto di preghiera della compagna alle spalle di S. Orsola con quello di S. Crispino. La Crocefissione, seppur ormai più spostata sul versante caravaggesco documenta un lessico ancora in mutamento, né del resto un risultato altissimo come quello della Visitazione di Viterbo può essere colto al primo tentativo, nè deve essere stata sufficiente all’artista per raggiungerlo l’esecuzione dell’unica altra opera nota della sua nuova maniera, il S. Isidoro Agricola (Viterbo, S. Angelo in Spatha). La Crocefissione, a nostro parere va posta tra l’esecuzione del S. Isidoro e quella della Visitazione, ritrovandosi in essa elementi riscontrabili in entrambe queste opere. Ad esempio la tela con S. Isidoro ha la stessa intensa qualità luministica intuibile nell’opera tarquiniese ed anche i rapporti proporzionali tra le due figure di S. Crispino e di S. Isidoro, al di là di analogie anatomiche quale il collo muscoloso ma snello, il viso barbato, sono rispettate. Un altro elemento accomuna le due tele: le aureole rese prospetticamente come un sottile filamento metallico, che poi scompaiono nei dipinti successivi del Cavarozzi. Tra il 1608, data del dipinto di S. Orsola e quella del 1622, data della Visitazione di Viterbo, la Crocefissione si pone più vicina alla prima opera, per i palesi ricordi compositivi che ne conserva. Papa Ciriaco raffigurato nella sinistra del dipinto romano, anticipa nello scorcio della testa volta verso l’alto a sinistra (dalle orbite profonde come quelle del S. Crispiniano) quella della figura identicamente stante, seppure tanto più “vera” di S. Crispino ai piedi del quale gli attribuiti quali la palma del martirio, la subbia ed il trincetto, acquistano quasi il senso di una minuscola natura morta dall’intenso verismo. Questas componente è poi sviluppata negli oggetti sul tavolo del S. Girolamo nella Galleria Palatina di Firenze, data anche ad Orazio Gentileschi, e negli attributi di S. Caterina nel dipinto con La Sacra Famiglia (già a Firenze Collezione Privata), verismo notato da Italo Faldi: “un altro tratto singolare, anche se marginale del Cavarozzi.... l’accanita e minuziosa resa veristica degli oggetti, riprodotti con una tale evidenza visiva da sfiorare gli inganni ottici di un Angelo Caroselli 3) . S. Teresa d’Avila caccia il demonio in vesti angeliche, prima metà del secolo XVII (qui attribuito a Vincenzo Basti o Bastici), olio su tela, (159,5 x 115), Museo Nazionale Etrusco (deposito del Comune di Tarquinia). Il dipinto, pulito e reintelato recentemente, era completamente illeggibile perfino nel soggetto iconografico. Dopo l’intervento dell’Istituto di Restauro della Provincia di Viterbo, seppure molto compromesso per la caduta della pellicola pittorica, ha rivelato un buon livello artistico nella notevole figura del demone dal complesso e tormentato panneggio a pieghe schiacciate, messo in fuga dalla santa mediante il crocefisso. In particolare il forte taglio obliquo della composizione ed i netti contrasti di luce e di ombra rivelano nell’artista una conoscenza da vicino della pittura, se non caravaggesca, almeno di quella che più direttamente da essa discende. Rivelatrice è l’ombra netta che stacca fortemente il collo dalla spalla nella figura giovanile. In questo artista va riconosciuto un minore, seppure, forse, educatosi su esempi caravaggeschi romani dell’ultimo periodo. La tela è probabilmente da attribuire a quello stesso Vincenzo Basti (“Vincentius Bastius de Vigevano”) che si firma nel dipinto con S. Michele Arcangelo, presso la Chiesa di S. Martino. Chissà perché Lorenzo Balduini che riproduce quest’ultima opera senza alcun commento ma riportando l’iscrizione con il nome del pittore, la dice di anonimo, forse confuso da quell’invenit che stà ovviamente per inventò (nel senso peraltro di formulare, e quindi “per dipinse”, e non “per rinvenne”) 1). . La tela con S. Teresa è accomunata al S. Michele Arcangelo dal medesimo taglio organizzativo della figura principale e dalla saldezza volumetrica, dalla sommaria, geometrizzante rotondità dei volti della santa e dell’Arcangelo. Anche i panneggi, per quel poco che se ne scorgono spuntare al di sotto della lorica sono i medesimi, leggieri 3) I Faldi, Pittori viterbesi di cinque secoli, Roma 1970, p. 281, fig. 225. I due santi Crispino e Crispiniano, a lungo venerati a Corneto come protettori della confraternita dei Calzolai, hanno una storia assai incerta e sicuramente interpolata è la parte che li riguarda nella passione dei santi Giovanni e Paolo, del IX secolo, favolosa e frutto di fantasia. I due sarebbero stati martirizzati nelle Gallie, a Soisson, nel 287, dove nel VI secolo fu costruita una grande chiesa a loro dedicata (cfr. G. Moroni,Dizionario di Erudizione storico ecclesiastica, vol. XVIII, Venezia 1843, p. 195, s.v. “Crispiniano”). 1). L. BALDUINI, Monaldo Trofi “civis cornetanus”, Tarquinia, 1985, fig. 89, p. 202. e schiacciati. Il presunto anonimo pittore, che nel quadro di S. Martino datato 1623 appare ancora legato ad un generico manierismo romano, subisce profondamente la lezione del nuovo naturalismo caravaggesco. L’artista, probabilmente lombardo (“de Viglievano”) è, a mio parere, quel Vincenzo Bastici che lavora fin dal 1598 nel Palazzo Comunale e che ancora nel 1601 era in vertenza con il comune per il pagamento degli stessi lavori 2) . Pier Francesco Mola (1612-1666), La Visione di S. Brigida, databile al 1647-1650, olio su tela (243 x 141), Chiesa di S. Francesco, cappella Cardini, poi Falzacappa. Negativo Soprint. B.A.S. Roma n. 127674. Idem, Santa Brigida in Estasi, neg. Soprint. B.A.S. Roma n. 127665. La pala d’altare, che raffigura il miracolo del crocefisso di S. Paolo Fuori le Mura che parla alla santa, deve essere riferito alla committenza della prima delle due famiglie che ebbero il patronato della cappella 1) . Il dipinto si adatta infatti perfettamente alla sua cornice di stucco seicentesca, e corrisponde cronologicamente alla data di esecuzione della cappella e del monumento funebre ad Arcangelo Cardini, opera inedita di scuola algardiana vicina ai modi del Bolgi e ancor più a quelli del Giorgetti 2) . Nell’attico dell’altare si trova un quadretto con la santa in estasi, le mani sul seno, lo sguardo volto al cielo. Opera certa dello stesso artista del dipinto maggiore, animata da un intenso luminismo in cui più che la lezione di Caravaggio e del Guercino si scorge l’interpretazione della luce franta, quasi riflessa dal soggetto, memore di Giovanni Serodine, conterraneo del Mola ed artista di poco più anziano che ebbe influenza su di lui 3) . L’attribuzione dell’opera al Mola è tradizionale, ma mai verificata; il dipinto è infatti completamente ignoto alla critica. L’unica fonte è lo storico francescano Casimiro da Roma (1742) che ne dà una laconica notizia: “Nella Cappella di S. Brigida ornata di stucchi, oggi spettante ai signori Falzacappa, vedesi una tela in cui dal Mola è stata 2) G. TIZIANI, Ricerche sul Palazzo Comunale e sugli affreschi della sala del consiglio, in: Bollettino Soc. tarquiniense di Arte e Storia, 1984, p. 82. 1) Localmente la tela è stata riesumata e confermata al Mola dallo scrivente, restituendo contemporaneamente la cappella ai Cardini (G. TIZIANI, Un dipinto del Mola e due minori “barocchi” inediti, in: Pro Tarquinia, IX, 7 luglio 1985, p. 3; idem, Famiglie e stemmi cornetani dalla schedatura dei beni artistici di Tarquinia, in: Bollettino della Soc. Tarquiniense di Arte e Storia, 1985, Tarquinia 1986, pp. 202-203. 2) Si ringrazia la Sig.ra Antonia Nava Cellini per la sua cortese perizia, espressa verbalmente, sull’opera scultorea. 3) S. RUDOLPH, Contributo per Pier Francesco Mola, in: Arte illustrata, nn. 15-16, 1967, p. 19. colorita la detta santa orante innanzi a un crocefisso” 4) . Effettivamente quest’opera può essere attribuita all’artista ticinese in base all’analisi stilistica e può essere collocata cronologicamente al suo secondo periodo romano (1647-1666), quando le sue opere si caratterizzarono per il tono basso, ma anche coloristicamente intenso, per il suo plasticismo conciliato con il cromatismo veneto e con una monumentalità nella resa della figura in cui agisce la lezione di Nicolas Poussin, tutto ciò interpretato sulla base di una sensibilità “romantica” che ne fa uno degli artisti più suggestivi del Seicento romano. Al Mola non sfuggì peraltro l’opera dei maggiori artisti contemporanei operanti a Roma, soprattutto Caravaggio, Mattia Preti e Pietro da Cortona. Nella S. Brigida dell’altare Cardini peraltro l’illuminazione è più vicina ai modi del Guercino e del Poussin che del Caravaggio. Proprio al potente classicismo di Poussin rimanda infatti in questa tela il saldo modellato del crocefisso e la figura semplificata, appassionata ma contenuta, della santa, tela priva di quegli aspetti ziganeschi rilevati dalla Rudolph 5) in tante sue opere. Il colore dominante è dato dai bruni terra e dai toni plumbei, analogo a quelle tinte “cupe, tra il verde marcio e piombo, caratteristiche del presepe e d’altre opere che si datano al primo decennio dell’attività romana” 6) dopo il suo ritorno nel 1647. Un elemento raro nella produzione del Mola è la raffigurazione di un interno e addirittura unica è quella del dipinto nel dipinto, qui un’immagine sacra della Madonna col Bambino posta sopra l’altare alle spalle della santa. Il pendone sopra l’immagine sacra è di un viola carico ed intenso che non può non rammentare certi viola del Caravaggio, come quello che domina la Madonna dei Pellegrini di S. Agostino a Roma. La tela per il monastero tarquiniese è in stretta relazione con due opere dell’artista in cui invece il paesaggio ha una larga parte. Lo stesso “taglio” diagonale, che si incardina da un lato ad una figura stante everticalizzata da alcuni elementi architettonici alle spalle, ritorna infatti nella predica di S. Barnaba nella chiesa romana di S. Carlo al Corso, del 1653, dove l’altare che nel dipinto tarquiniese chiude sul fondo in orizzontale viene tradotto con una muraglia. La stessa organizzazione spaziale si ha nel Giuseppe che incontra i fratelli (Roma, Palazzo del Quirinale) del 1657, con il quale la tela in S. Francesco ha i rapporti più calzanti. Ritengo infatti che 4) CASIMIRO DA ROMA, Memorie istoriche delle chiese e dei conventi dei frati minori della provincia romana, 2ª ed., Roma 1845, p. 188. L’affermazione dello storico settecentesco è riportata testualmente dal Romanelli (E. ROMANELLI, S. Francesco di Tarquinia, Roma, 1967, p. 82). 5) S. RUDOLPH, citi., p. 19. 6) Idem, p. 21. il disegno preparatorio per la S. Brigida sia servito come base per la composizione e per le figure principali dell’affresco romano, seppure rovesciato. La composizione sulla verticale, tutta spostata di lato ed il taglio orizzontale mediano dalla balaustra, quello che nell’affresco separa il primo piano dal pittorico paesaggio di esotica antichità, sono gli stessi della tela di S. Francesco di Tarquinia. Analoga funzione di secondo piano, (svolta nell’opera tarquiniese dal dipinto della Madonna col Bambino) nell’affresco romano è assolta dal loggiato che chiude a sinistra, in cui l’elemento obliquo del pendone è tradotto nella tettoia, secondo consuete modalità compositive del Mola per piani verticali ed orizzontali. Altri confronti a sostegno dell’attribuzione al Mola si possono portare tra la figura della mistica e quella della Vergine nella Fuga in Egitto (Roma, Galleria Pallavicini) per il cromatismo caldo e basso che si avvicina molto a quello della santa in estasi nel quadretto dell’attico, la cui stessa bellezza venusta è ben riscontrabile nel tipo della Madonna raffigurata nel raro soggetto con l’Immagine di S. Domenico portata a Soriano (Roma, Chiesa di S. Domenico e Sisto). Qualcuno ha ritenuto recentemente, contro ogni elemento di credibilità, che una tela, da lui detta Madonna di Cibona, una Madonna col Bambino, che si conserva presso la curia vescovile di Tarquinia, sarebbe opera dello stesso artista 7) . Di questa affermazione non viene data peraltro nessuna motivazione, né documentata né critica. L’opera è invece copia ottocentesca, o addirittura del primo Novecento, di un dipinto dai caratteri tardo quattrocenteschi, all’Antoniazzo Romano. Giovan Francesco Romanelli e scuola, l’Angelo Custode, databile alla metà del sec. XVII olio su tela (193 x 123 - senza gli ingrandimenti-), Chiesa dell’Addolorata, primo altare sinistro, dal precedente Oratorio dell’Angelo Custode. Neg. Soprint. B.A.S. Roma n. 127795. La tela, in cattivo stato di conservazione, ha diffuse cadute di colore numerosi ritocchi ossidati ed estese ridipinture, chiaramente visibili nella zona superiore destra. Il soggetto, tipicamente controriformista, è esaltato dalla spoglia composizione che si incentra sulla classica figura alata che indica il cielo al bambino. 7) L. BALDUINI, Monaldo Trofi “civis cornetanus”, Tarquinia 1985, fig. 101. In quest’opera, nonostante l’assurda attribuzione al Mola dell’opera suddetta, manca proprio la S. Brigida del convento di S. Francesco. Sull’opera del Mola v. J. GENTY, Pier Francesco Mola, pittore, Lugano 1979; R. COCKE, Pier Francesco Mola, Oxford, 1972; S. RUDOLPH, Contributo per Pier Francesco Mola, in Arte Illustrata, nn. 15-16, 1967, pp. 10-25. Il colore è tenue, accordato sui toni chiari: bianco madreperlaceo con cangianze gialle, violetti. Il paesaggio retrostante si mantiene anch’esso sui toni argentei ed azzurrini. L’opera si apparenta assai da vicino alle due tele precedenti qui date al Romanelli, la S. Lucia della chiesa omonima ed il S. Sebastiano gà nella cattedrale. Il linguaggio formale è il medesimo: un ampio “classicismo barocco”, quale è quello del maestro viterbese nel periodo della maturità, che concilia lo stile di Pietro da Cortona con le sottigliezze cromatico luministiche di Guido Reni. La medesima mano che intervenne nei volti di S. Sebastiano e di S. Lucia si rivela anche nel volto del Bambino, dove lo stesso “ductus” si riconosce nelle bocche piccole, nei larghi piani facciali, nei nasi sottili, nel modo di inclinare le teste e nei panneggi moderatamente mossi e con pieghe schiacciate. Particolarmente romanelliano è il volto dell’angelo dal perfetto ovale e dall’elegante incedere della figura, probabilmente di aiuti, o di restauro, è invece per la maggior parte la figura del bambino. Piuttosto attenutato dalla caduta del colore e dalle ridipinture è il fascio di luce dorata che piove dall’alto sulle due figure e che attenua la freddezza dei toni cromatici. Il dipinto, ingrandito nella seconda metà del Settecento su tutti e quattro i lati per adattarlo alla nuova sede, si ispira direttamente ad un’opera di Pietro da Cortona con lo stesso soggetto, ora alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Palazzo Corsini (inv. n. 1753). L’impostazione è identicamente di tre quarti e le figure similmente gradienti. L’Angelo Custode di Tarquinia ritrova molto da presso, sia stilisticamente che compositivamente, la tela con il S. Sebastiano, seppure ne rovesci la figura, sia nel taglio che nel caratteristico modo di panneggiare per pieghe non rigonfie ma schiacciate. Il dipinto, ingrandito nella seconda metà del Settecento su tutti e quattro i lati per adattarlo alla nuova sede, si ispira direttamente ad un’opera di Pietro da Cortona con lo stesso soggetto, ora alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Palazzo Corsini (inv. n. 1753). L’impostazione è identicamente di tre quarti e le figure similmente gradienti. L’Angelo Custode di Tarquinia ritrova molto da presso, sia stilisticamente che compositivamente, la tela con il S. Sebastiano, seppure ne rovesci la figura, sia nel taglio che nel caratteristico modo di panneggiare per pieghe non rigonfie ma schiacciate. Il dipinto, sconosciuto alla critica è stato recentemente dato ad anonimo del Settecento 1) senza rilevare l’analogia con le due altre tele succitate, gli vengono anzi accostate altre opere della stessa Chiesa di S. Leonardo, una delle quali di qualità estremamente scadente e comunque stilisticamente incongrue. La tela del Romanelli si pone attorno al 1640, data in cui l’oratorio dell’Angelo Custode fu ultimato, come già affermato in uno scritto precedente in cui davo l’opera al Romanelli e ad un aiuto 2) . Da ricerche nell’archivio storico comunale di Tarquinia si è risaliti ai responsabili degli interventi operati successivamente sul dipinto. Il pittore Lazzaro Nardeschi 3) lo ritoccava nel 1743 a causa delle macchie prodotte dall’umidità 4) , mentre l’ampliamento della tela, la pulitura ed il ritocco furono opera di Sebastiano Carelli “in Viterbo” nel 1789 5) . Nel suo insieme il dipinto, il disegno del quale fu sicuramente opera del maestro viterbese, si ritiene che sia opera di bottega tranne che nel volto dell’angelo, che il Romanelli dovette effettivamente eseguire tutto di sua mano. Ciò per una certa semplificazione dei panneggi e per una certa minore eleganza, particolarmente nella figura del bambino. Le condizioni attuali del dipinto non permettono peraltro una lettura ottimale dell’opera per la quale si auspica un intervento di restauro. Giovan Francesco Romanelli (Viterbo 1610-1662), S. Sebastiano, 1650 c. olio su tela (216 x 143), Monastero delle Passioniste, dalla Chiesa Cattedrale. Neg. Soprint. B.A.S. Roma n. 127697. La tela con il S. Sebastiano può essere assegnata con fondamento al Romanelli in base all’analisi stilistica 1) . Questa ne fa un’ opera della piena maturità, quando il cortonismo di fondo della sua cultura ha trovato “un nuovo equilibrio compositivo, di 1) L. BALDUINI, La Resurrezione di Tarquinia, Tarquinia 1983, p. 171 nota 7, p. 172 nota 9. G. TIZIANI, Inediti: Tre schede per Giovan Francesco Romanelli, in: Pro Tarquinia, IX, n. 9, settembre 1985, p. 3. 3) Lazzaro Nardeschi dipingeva nel 1761 le iscrizioni sopra gli archi della Chiesa di S. Leonardo (A.S.C., Fondo Serviti, libro di uscite, marzo 1761, c.n. 6). Precedentemente nel 1734 egli aveva “fatto tutte le iscrizioni nella sala del Palazzo Magistrale e... ripolito le pitture offuscate dalla polvere” (cfr. G. TIZIANI, Ricerche sul Palazzo Comunale, in: Bollettino S.T.A.S., 1984, p. 6). 4) A.S.C., Fondo Serviti, libro delle uscite 1740-1750, maggio giugno 1743, cc. 70, 78. 5) Ibidem, 1778-1801, c. 17 v. 2) 1) Il Romanelli, detto Raffaello da Viterbo, o il Raffaellino, fu allievo del Domenichino e di Pietro da Cortona. Artista di primo piano al tempo di Papa Urbano VIII Barberini (1623-1644) fu protetto da quella famiglia, dalla quale fu impiegato in varie imprese, tra le quali soprattutto spiccano gli affreschi nella Sala della Contessa Matilde in Vaticano e i disegni tradotti in arazzi per la corte francese. A Parigi dipinse nel palazzo del cardinale Mazarino (1646-1647) e, pacate cadenze, di tenere inclinazioni sentimentali, di una ricerca di bellezza formale, di decoro neoraffaelleschi” 2) . Tipico di questa fase, dopo il distacco dell’artista dal Cortona, è la chiarezza della tavolozza, la semplicità compositiva e cromatica. Questa tela, che si conserva in discrete condizioni, raffigura il martire secondo la più consueta iconografia: legato ad un albero contro un cielo color cobalto, coperto da un perizoma di un colore tra il viola ed il grigio. Posati in terra in bell’evidenza si trovano il manto color carminio e l’elmo piumato. L’ampio e semplificato paesaggio alle spalle della figura, un po' offuscato da depositi di polvere, ha toni color terra naturale sfumati negli azzurrini. Nella sua organizzazione l’artista adotta lo stesso metodo di procedere per contrapposti che si riscontra nella figura; alla curva del monte risponde quella contraria dell’emiciclo delle nubi. Al putto angelico che sostiene la corona del martirio sulla testa del Santo indicandogli il cielo risponde in basso a destra, spostato in secondo piano, l’elmo piumato. Il modellato della figura è fortemente plastico ma il movimento interno è così accentuato e il taglio per linee spezzate attraverso la diagonale del dipinto così esibito che se ne ha l’effetto teatrale di una figura danzante, quasi leziosa. Quest’opera, però, di grande nitore compositivo, può essere posta allo stesso momento in cui l’artista eseguiva gli affreschi di Palazzo Lante a Roma (1653), vi appare infatti già attiva e padroneggiata la conciliazione tra le diverse fonti a cui il Romanelli attinse; Pietro da Cortona, il Domenichino, l’Albani, Guido Reni. La presenza di quest’ultimo artista è infatti rilevante in quest’opera come anche nella tela con S. Lucia presso la chiesa delle Benedettine (v. chiesa successiva). Il S. Sebastiano richiama particolarmente la figura del Sansone vittorioso sui filistei di Guido Reni che si conserva nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, opera eseguita dopo il 1614, dove l’eroe è una figura accentuatamente classica, alla quale il Romanelli si ispirò rovesciandola però da sinistra a destra e accentuandone il plasticismo e l’enfasi sentimentale. Confronti con altre opere del Romanelli possono effettuarsi con il S. Lorenzo della Cattedrale di Viterbo (1648), di cui il dipinto tarquiniese riprende l’impaginazione e l’organizzazione della figura (ripetuta nell’angelo dell’Annunciazione del Museo Civico di Viterbo del 1657), con l’affrescho che raffigura la Storia e la Poesia in Palazzo Lante, particolarmente per la figura del durante il soggiorno francese successivo (1646-1647), in varie sale del Louvre. La sua pittura esercitò quindi un largo influsso sugli artisti francesi del Seicento. 2) I. FALDI, Pittori Viterbesi di Cinque secoli, Roma 1970, pp. 66-73, figg. 242-249. putto, una sigla tipicamente romanelliana, come anche con la Madonna del Rosario nella chiesa di S. Sisto a Roma (1652). Inoltre sia le due figure che il paesaggio retrostante, seppure molto semplificate, ricordano quelle del Battesimo di Cristo nel cartone per arazzi conservato nella Galleria Nazionale di Palazzo Barberini, del 1650 circa; ciò anche in stilemi peculiari dell’artista, il quale il panneggio del perizoma, ed il manto disposto in terra come elemento compositivo. La tela, che ben dimostra il “facile mestiere” di cui parla il Witkower riferendosi ai caratteri della produzione romanelliana 3) , dovette pervenire al monastero delle passioniste dalla cattedrale. Qui, secondo il Pardi ed il Corteselli, nel 1652 si trovava una cappella dedicata agli Innocenti ed a S. Sebastiano, ma si ha motivo di ritenere che gli stessi incorrano in un errore di lettura quando affermano che “La cappella aveva un altare di stucco bianco, sopra il quale era posta la statua di S. Sebastiano, opera del Romanelli. La statua veniva custodita in una teca ed era portata in processione nel giorno della festa del santo” 4) . Ora considerato che dell’artista viene dato solamente il cognome, ciò indica una sua cospicua notorietà, ma non risulta peraltro alcuno scultore seicentesco omonimo o assimilabile. Questa tela era assolutamente inedita fino al settembre 1985, quando chi scrive ne diede notizia su un giornale locale con queste stesse indicazioni critiche 5) nello stesso mese il Balduini diede anch’esso notizia dell’opera 6) seppure senza valutazioni critiche o stilistiche, nel dubbio poi che la sua assegnazione al Romanelli fosse inesatta poco oltre la dà come dubitativa, ma sempre in modo apodittico. Giovan Francesco Romanellii, S. Lucia, databile al secondo decennio del sec. XVII, olio su tela (209 x 116), Chiesa di S. Lucia, altare maggiore. Neg. Soprint. B.A.S. n. 127787. La tela raffigura la santa stante che regge nella destra una patena con i suoi occhi e nella sinistra la palma. Sul fondo compare la città di Siracusa con una scena del martirio della santa, rappresentata contro un edificio grandioso che riproduce il Pantheon. 3) R.WITTKOKER, Arte e Architettura in Italia 1600-1750, Torino 1972, p. 278. M. CORTESELLII, A. PARDI, Corneto com’era, Tarquinia 1983, pp. 89-91. 5) G. TIZIANI, Inediti: tre schede per Giovan Francesco Romanelli, in: Pro Tarquinia, IX, n. 9, settembre 1985, p.3. 6) L. BALDUINI, Monaldo Trofi “civis cornetanus”, Tarquinia 1985, pp. 70, 192, tav. XIII. 4) La figura, abbigliata all’antica, risente dei modi di Guido Reni, tanto che localmente se ne sostenne l’appartenenza alla scuola dell’artista bolognese, come ad esempio nella guida del Blasi 1) . Questa attribuzione fu originata dalla perizia di restauro del 1975. In questo intervento fu asportato un ingrandimento seriore che aveva aggiunto alla figura di due angeli reggipendone. Il Balduini, pur senza dichiarare le fonti di tale attribuzione si attiene a quella indicazione, mentre chi scrive l’ha da tempo attribuito al Romanelli 2) . La lettura stilistica fatta dai restauratori è in effetti plausibile; effettivamente il lessico del Reni è ben presente al Romanelli, i timbri perlacei ma anche densi del colore, il bianco della veste cangiante in grigio perla, il verde, cupo, elettrico del manto e l’oro della tunica, oltre che l’accentuato classicismo del soggetto, raffigurato secondo la più consueta iconografia. Il confronto tra questa tela ed il dipinto con S. Sebastiano conservato presso il monastero delle Passioniste, conferma l’attribuzione alla stessa mano sia per le palesi analogie tra i volti, sia per l’identico modo di spartire i capelli ai lati della fronte, per i larghi piani facciali dalle ampie arcate sopraccigliari (caratteri tutti che si riscontrano in un’opera certa quale il S. Lorenzo della Cattedrale di Viterbo, 1648) per i nasi regolari ma appuntiti, per gli snodi tra spalla e collo e tra questo e la testa oltre che per particolarità quali il modo di coprire in parte le orecchie con le capigliature fruenti dietro la nuca. Come il S. Sebastiano quest’opera si deve porre tra il 1650 e il 1662. Il luminismo che la caratterizza è del resto pienamente sviluppato nell’Ultima Cena del Duomo di Rieti, opera della maturità dell’artista viterbese (1653) 3) . La figura della martire d’altronde, seppure depurata dai più accesi accenti barocchi, riprende il taglio compositivo di un’opera giovanile di Gian Lorenzo Bernini, la Santa Bibiana (16241626), a cui si rifà anche per la contenuta espressione della mimica. Si può quindi inserire quest’opera, che spicca nella produzione romanelliana per la pacatezza degli accenti formali e per il suo insistito classicismo, in un momento che risente oltre che 1) B. BLASI, Chiese, palazzi e torri della città di Tarquinia, Tarquinia Roma, s.d., p. 51. L. BALDUINI, La Resurrezione di Tarquinia, Tarquinia 1983, p. 51 nota 21; Idem, Il pittore Monaldo “civis cornetanus”, Tarquinia, 1985, pp. 220, 226, tav. XVIII. G. TIZIANI, Inediti: tre schede per Giovan Francesco Romanelli, in: Pro Tarquinia, IX, n. 9, settembre 1985, p. 3. 3) Per un confronto v. I. FALDI, Pittori viterbesi di cinque secoli, Roma 11970, p. 69 fig. 257. I rapporti del Romanelli con il Reni sono stati messi in evidenza dalla Czabor (A. CZABOR, Le tableau de Giovan Francesco Romanelli dans la Galerie des Maîtres anciens, in Bulletin du Musée National Hongrois des Beaux Art, 14, 1959, pp. 68-74, v. p. 68 ss.), rapporti stilistici confermati dal Faldi (I. FALDI, cit., pp. 70, 257, nota 25). Per la biografia del Romanelli v. A. GARGANA, Un pittore di corte, Giovan Francesco Romanelli, in: Comune di Viterbo, Rassegna di attività cittadine, II, nn. 10-12, ottobre dicembre 1937, pp. 171-179. 2) della dominante reniana anche della reazione più strettamente classicista, concretizzatasi attorno ad Andrea Socchi. Il Wittkower rilevava come quest’ultima tendenza “il classicismo del barocco”, ebbe presa anche su artisti allievi di Pietro da Cortona come appunto Giovan Francesco Romanelli, proprio tra gli anni ‘40 e ‘50 del secolo. Teodoro Rusca, I Santi Francesco di Paola, Giovanni Nepomuceno, Luigi Gonzaga e Giuseppe Calasanzio, 1759. Olio su tela (263 x 173), Chiesa della Madonna del Suffragio. Neg. Soprint. B.A.S. Roma n. 127785. La tela si trova in non buone condizioni di conservazione per le cadute di colore, ampie soprattutto nella parte alta del dipinto. Secondo il Pardi ed il Corteselli una tela con questo soggetto sarebbe stata dipinta per la Chiesa del Suffragio da un tale Teodoro Rusca 1) , anch’esso artista ignoto alle fonti ed ai lessici degli artisti 2) . Costui l’avrebbe eseguita nel 1759 per la somma si 80,7 scudi. Il nome dell’artista (la fonte non è rilevata dagli autori succitati), e la data di esecuzione risulta peraltro dal manoscritto Falzacappa precedentemente citato. La tela si apparenta stilisticamente in modo molto stretto con quello di Giovanni Conca (cugino del famoso Sebastiano) nella Chiesa di Santa Maria della Luce, che raffigura i Santi Francesco di Sales, Francesco di Paola e Jeanne François di Valois (Neg. Soprint. B.A.S. Roma n. 51490). L’analogia si spinge fino alla caratterizzazione delle figure ed alla definizione fisionomica delle stesse, oltre a reperirsi anche nel tono correntemente piano e narrativo e, pure, nel colore sobrio, impostato su toni intermedi. La datazione a dopo il 1748 per quest’opera è sicura perr la presenza di Giuseppe Calasanzio, raffigurato in primo piano, fondatore delle Scuole Pie e degli Scolopi, che fu beatificato in quell’anno e che verrà canonizzato nel 1767. Il Rusca si pone quindi nella più stretta orbita del Conca minore che, fatti i primi studi a Napoli con il Solimena, imitò poi a lungo i modi del cugino Sebastiano 3) . Non sembra da escludere che sia la stessa mano del Rusca quelle che eseguì la bella tela proveniente dalla Chiesa di San Marco con S. Giovanni Facundo, ora nella collezione comunale, dai caratteri stilistici molto vicini (v. scheda successiva). La tela è organizzata su uno schema centralizzato che fa perno sulla figura di S. Francesco di 1) 2) Corteselli, A. Pardi, Corneto com’era, Tarquinia 1983, p. 108. Cognome frequente tra gli artisti lombardi o ticinesi. Paola, posta al centro sui gradini di un edificio che si intravede appena alle sue spalle. In primo piano inginocchiati si trovano a sinistra S. Giovanni Nepomuceno e a destra S. Giovanni Calasanzio 4) . Il primo vestito coi paramenti sacri e, alle sue spalle, un putto nel gesto del silenzio ricorda che il santo fu glorificato come martire della confessione e come tale adottato nel 1732 dai gesuiti. L’altro santo vestito del saio dell’ordine tiene alla sua destra un bambino orante a ricordo della sua attività di educatore. Un po' di lato rispetto alle figure suddette, disposte in semicerchio, si trova S. Luigi Gonzaga. Seppure dell’autore di questa opera, il presunto Teodoro Rusca, non si ha alcuna notizia, rimane il ritratto del cardinale Giovanni Battista Bussi, ora nel Museo Civico di Viterbo, datato 1714, dipinto di Giuseppe Rusca. A quest’ultimo artista, peraltro sconosciuto, il Faldi attribuisce il ritratto di Papirio Bussi, da lui datato tra il 1723 ed il 1752 5) . La cultura figurativa di Giuseppe Rusca, a differenza di quella di Teodoro, appare secondo il Faldi “affine ai modi di un Domenico Maria Muratori”. Considerate le cronologie di questo gruppo di opere è molto probabile che tra i due artisti corresse un rapporto di parentela, forse molto stretto, quale tra padre e figlio o, meno probabilmente, di fratellanza. Gioacchino Paver, Miracolo di S. Isidoro Agricola, 1759, olio su tela, (263 x 173), Chiesa dell’Addolorata, altare sinistro. Neg. Soprint. B.A.S. Roma n. 127786. Il dipinto offuscato e con numerosi ritocchi ossidati raffigura il classico motivo del santo che fa scaturire miracolosamente l’acqua alla presenza di un aggraziato gentiluomo, sotto lo sguardo benevolo della Vergine con il Bambino benedicente. Sullo sfondo del finissimo paesaggio di monti l’angelo va conducendo la coppia di buoi che trascinano l’aratro. Questa tela si contraddistingue per la freschezza delle luci riflesse e colorate, per i delicati controluce, per la finezza dei rapporti cromatici e chiaroscurali, per la grazia tutta settecentesca, rococò, che la pervade, in altre parole per il suo “ésprit de finèsse” piuttosto raro in ambito romano e tale da ricordare lo spirito francesizzante di un 3) Sul Conca cfr. S. Rudolph, La pittura del ‘700 a Roma, Milano 1983, pp. 180, 759, fig. 80. Sui due Santi v. L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, tomo 3, 2, Paris, 1958, pp. 728-731 (S. Giovanni Nepomuceno), 762 (S. Giovanni Colasanzio). 5) I. Faldi, Dipinti e sculture, in: Viterbo segreta, Viterbo, Palazzo dei Priori, 31 marzo - 17 aprile 1983, p. 36, fig. p. 37. 4) Michele Rocca o i cipriosi personaggi di Giacomo Triga. I modi del pittore sono inoltre caratterizzati dal procedere per velature invece che con una pittura a corpo. Il dipinto che in base a non specificate ricerche documentarie sarebbe opera di tale Gioacchino Paver 1) , artista ignoto alle fonti ed alla critica, che lo avrebbe dipinto nel 1759 per 60 scudi, appare legato ad una cultura settentrionale, austriaca o bavarese non lontana da quella di artisti come Ignazio Stern (morto nel 1748). In particolare è significativo il confronto con una sua opera: Il Sogno di S. Giuseppe, del 1723 (Milano) e, per quanto riguarda la figura della Vergine, con la figura della Primavera dello stesso Stern, entrambe figure diafane e porcellanose che uniscono ad una forma calligrafica una resa sensibile e nervosa ed il gusto per i tagli scorciati. Il cognome “Paver” (o forse “Bauer”?) sembrerebbe indicare un artista di area austriaca o, forse, sloveno-croata, come ad esempio nel caso di Franz Paver, pittore della prima metà del XIX secolo, originario di Fiume, che studiò a Venezia e a Roma. Questo dipinto ed il suo pendant (v. scheda successiva) potrebbero essere due di quelli che furono esportati da Roma il 2 ottobre 1759 dal nobile cornetano Giovan Francesco Falzacappa, il quale portò via “quattro quadri cioè tre d’altare di palmi 10 e 91/2 ed una piccola figurante diverse santi opere moderne 2) . Il terzo dipinto d’altare è probabilmente quello dell’altare maggiore che raffigura La Madonna e le Anime Purganti. Pittore della cerchia di Giovanni Conca (Teodoro Rusca?), S. Giovanni Facundo, inizi della seconda metà del XVIII secolo, olio su tela, (209 x 142), Museo Nazionale, collezione del Comune di Tarquinia, dalla Chiesa di S. Marco. Neg. Soprint. B.A.S. Roma n. 127767. Il dipinto era collocato al secondo altare destro della chiesa di S. Marco ancora nel 1907, quando fu preso in consegna dal comune 1) . La tela rappresenta la conversione di alcuni armati da parte del santo, ha toni pacati del colore ed un andamento che rifugge ad effetti dichiaratamente rocaille; anche l’impianto narrativo è piano, molto 1) M. Corteselli, A. Pardi, Corneto com’era, Tarquinia 1983, p. 108. Questi autori si rifanno certamente al manoscritto Falzacappa (Memorie di Corneto, vol. XIII, fasc. 17) in cui effettivamente compare il nome del Paver. 2) A. Bertolotti, Esportazione di oggetti di Belle arti da Roma nei secoli XVII-XVIII. Arch. Storico Letterario di Roma, II, fasc. 5, I gennaio 1878, p. 278. vicino a quello del dipinto con S. Francesco di Paola nella chiesa del Suffragio, dato da cronache ottocentesche, peraltro attendibili, a Teodoro Rusca. Il leggero andamento diagonale su cui si dispongono le figure ha in realtà la stessa angolazione del dipinto dell’Addolorata. Qui la figura che imposta la classica disposizione semicircolare su cui entrambe le opere si compongono si trova sulla sinistra (la figura dell’armato) invece che sulla destra, ma il modo di comporre è identico. Come nell’altra tela la figura monastica è il cardine, analogamente rialzata su alcuni gradini di un edificio retrostante di cui è similmente visibile la zona angolare con un brano di cielo schermato da quinte arboree alla sinistra. Sul gradino dove posa il santo rimane la scritta: S. Giovanni Facundo/Ispano 2) . Il santo infatti, eremitano (1430-1479), nato a Salamanca, è patrono degli agostiniani, ai quali apparteneva la chiesa di S. Marco. Nel retro del telaio è iscritto: S. Giovan. Sig. Orsi di Corneto. Il telaio è però quello usato al momento in cui il dipinto venne allungato inferiormente. Questo dipinto era firmato sul lato inferiore ma l’iscrizione è quasi completamente perduta. Dal confronto di questa tela con quella già citata della chiesa del Suffragio, vicinissima ai modi di Giovanni Conca, è già emerso in precedenza l’analogo gusto compositivo e cromatico che, depurato dagli stilemi barocchetti, approda ad una narrazione piana, dai toni sommessi, quasi di cronaca a cui si adegua la scelta cromatica per un “giusto mezzo” tra colore e rilievo chiaroscurale, con qualche cenno appena di ambientazione naturalistica. L’opera rivela anche un gustoso interesse per la pittura di genere popolaresco nelle due figure di sgherri, più atterriti della figura imponente del santo che convertiti. In particolare una eco caravaggesca si ritrova nella figura posta in primo piano, tradotta però in chiave settecentesca, arguta e “spiritosa”, nella consueta disposizione ad “S” che tende a rovesciarsi all’indietro. Tipicamente settecentesca è anche la figura del giovane chierico, da confrontare con il S. Luigi Gonzaga del Rusca, che si ritrova esibita in alcune opere di Benedetto Luti, ben presenti alla mente di questo interessante artista romano. Angelo Campanella (Roma 1746-1811), La Vergine col Bambino e i santi Caterina d’Antiochia e Secondiano (II Sacro Cuore), 1796, olio su tela (360 x 215), Neg. Soprint. B.A.S. Roma n. 127699. Il grande dipinto che 1) “Palma custode”, Elenco degli oggetti di antichità”, 7, n. 4 (“quadro moderno, S. Giovanni da S. Facundo, aut. Ignoto” 24 maggio 1907). La tela non è poi annoverata tra quelle consegnate dal comune al Ministero della P.I. nel 1916. proviene dalla cattedrale è firmato e datato in basso a destra entro un cartiglio: ANGELUS CAMPANELLA 1796. In via di rapido degrado questa tela è lacera nella parte superiore destra ed ha estese cadute di colore. I toni cromatici sono attenuati, pastello, e privilegiano quindi la resa plastica su quella coloristica. Completamente inedita fino a poco tempo orsono è stata resa nota da chi scrive nel 1985 1) . Angelo Campanella (1746-1811), di cui si conoscono poche opere, in questo dipinto ed in quello presso la Chiesa dell’Annunziata (v. scheda successiva) si rivela un artista fortemente conservatore, che dei nuovi canoni neoclassici accetta solo elementi secondari, marginali, rimanendo ancorato a quel protoneoclassicismo aggraziato di cui il massimo esponente fu Pompeo Batoni. Da costui il Campanella assorbì moltissimo, coincidendo l’affermazione ed il predominio artistico del Batoni nella Roma settecentesca con gli anni della sua formazione giovanile presso l’istituto di S. Michele a Ripa. Egli si formò inoltre sullo studio di Raffaello, di Fra Bartolomeo e dei classici 2) . In questa tela il pittore forse condizionato anche dal soggetto religioso, sia nei toni rialzati del colore, il rosso lacca e l’oro delle vesti, oltre che nell’enfasi sentimentale, mostra di aderire pienamente a quel “barocco di ritorno” rilevato dalla critica artistica nell’ultimo decennio del Settecento romano. Questa grande tela proviene dalla cattedrale e deve essere quella che fino al 1879 si trovava nella Cappella del Sacro Cuore 3) . Vi si leggono riferimenti stilistici soprattutto al Batoni e a Domenico Corvi nelle figure dei santi e dell’angelo sulla destra oltrechè alla tradizione raffaellesca nella Madonna col Bambino. La raffigurazione della città di Corneto, sul fondo, per la quale intercede il santo protettore è una immagine completamente di invenzione, non vi si rileva infatti alcun pur minimo riferimento ad aspetti reali o topografici della città. Non si capisce quindi come faccia il Balduini a supporre che il Campanella (che eseguì certamente la tela nel suo laboratorio romano) abbia potuto riprodurre “la città... prima che il vescovo Bartolomeo Vitelleschi voltasse l’entrata della cattedrale a mezzogiorno” 4) , modifica 2) 1) L. Réau, Iconographie dé l’art crétièn, tomo III, 2, Paris, 1958, p. 733. G. TIZIANI, Un dipinto del Mola e due minori “barocchi” inediti, in: Pro Tarquinia, IX, n. 7, luglio 1985, p. 3. Su Angelo Campanella v. U. THIEME-F. BECKER, Allgemeine Lexikon, vol. V, 1911, pp. 455-456. S. RUDOLPH, La pittura del ‘700 a Roma, Milano 1983, pp. 122-754. 3) A. PARDI M. CORTESELLI, Corneto com’era, Tarquinia 11983, p. 93. 4) L. BALDUINI, Monaldo Trofi “civis cornetanus”, Tarquinia 1985, fig. 2, p.5. 2) apportata nel sec. XV, né il motivo di un tale interesse “filologico”, sicuramente estraneo al pittore romano. Angelo Campanella, La Vergine col Bambino ed i Santi Francesco di Paola e Rocco, 1780-1790 c. (255 x 168,5), Chiesa dell’Annunziata. Neg. Soprint. B.A.S. Roma n. 127794. Il dipinto si caratterizza per i toni dominanti del colore alquanto bassi, sul grigio perlaceo e plumbeo, su cui risaltano i blu ed i rosa degli abiti della Vergine, il giallo cadmio dell’abito di S. Rocco ed il verde smeraldo del cuscino su cui posa i piedi la Vergine. Questa, assisa sul trono, sorregge il Bambino benedicente. Il cromatismo del Campanella in questa opera ha riscontro in quelle batoniane e corviane degli ottanta del secolo. La concezione monumentale del dipinto pur nelle sue piccole dimensioni, il grande respiro della composizione, l’ambientazione dell’evento in un nobile emiciclo colonnato e la classicità delle figure, unite alla maniera pastosa di panneggiare ed alla pennellata sensibile ed animata, ancora ricca di mezzi toni, confermano nel Campanella (che è riconoscibile per tale con certezza grazie al confronto con l’opera precedente) la sua sostanziale adesione alla tradizione tardo barocca ed in particolare alla riforma batoniana, erede del classicismo, del Luti del Chiari e del Maratta. Le analogie con il Sacro Cuore di Gesù e Maria e i Santi Secondiano e Margherita, già nella Cattedrale, sono palesi sia per il comune sentore devozionale delle due tele che per la composizione tradizionalmente piramidale con figure disposte simmetricamente ai lati di quelle primarie, in altri termini per l’identica concezione organizzativa dei due dipinti. Anche questa tela è stata da poco riconosciuta al pittore romano. Due opere possono essere chiamate in causa come precedenti di questo dipinto, entrambe famose ai tempi del Campanella ed esposte in sedi prestigiose: La Caduta di Simon Mago di Pompeo Batoni (Chiesa di S. Maria degli Angeli a Roma) e la Dea Roma, di Domenico Corvi, di cui rimane il cartone e la traduzione in arazzo nella Sala del Trono in Campidoglio. In entrambe le opere appare l’idea dell’alto trono sotto una solenne esedra semicircolare di ordine dorico. Scuola di Vincenzo Camuccini, Compianto sul corpo di Cristo, olio su tela (286 x 185), Monastero delle Benedettine, dalla chiesa annessa di S. Lucia. Neg. Soprint. B.A.S. Roma n. 127701. Il dipinto, come il suo pendant, era posto un lato della navata unica della chiesa di S. Lucia, delle stesse monache benedettine. La tela composta semplicemente è opera di ormai avanzato gusto neoclassico e di elevata qualità artistica. Il pittore che è da ricercarsi nella cerchia di Vincenzo Camuccini (Roma 1771-1844) si serve di un colore arido, impostato sui toni bassi, che conferisce alla figure una estrema nitidezza plastica ed una forte intensità chiaroscurale. La tela fu probabilmente eseguita nella bottega dell’artista romano del quale però alcuni elementi stilistici, particolarmente evidenti nei volti delle figure, impediscono di accettare l’autografia. Il soggetto e la composizione si rifanno però direttamente alla Pietà di Vincenzo Camuccini, che alla sua morte rimese presso il suo studio, e ad un suo disegno per la stessa opera, che si trova presso gli eredi di Cantalupo in Sabina 1) . Non è escluso che i disegni per questa opera siano stati forniti direttamente dal maestro. Nel dipinto tarquiniese rispetto al modello camucciano si è però verificata una rotazione delle figure, che qui si dispongono su di una leggera diagonale invece che su di un piano parallelo all’osservatore. L’origine delle figure resta però perfettamente riconoscibile seppure della più complessa composizione camucciniana siano rimaste solamente le figure primarie. In particolare è riconoscibile la figura di Cristo, di grande idealizzazione formale (tanto vicina ai modi del maestro romano ed al suo disegno di Cantalupo da poter pensare ad un suo diretto intervento), quella della Maddalena ed il volto di S. Giovannino. La Vergine, qui non più in deliquio, si svolge implorante verso il cielo mentre nelle opere camucciniane la sua figura, più contenuta, era una potente figura michelangiolesca. L’ignoto allievo del Camuccini (non facile da individuare per la lunga attività formativa svolta da questi) ha fatto scivolare la gamba sinistra della madre per far “salire” il corpo di Cristo ed inoltre, forse meccanicamente ha interpolato la composizione camucciniana con una idea tratta dal famossimo Giuramento degli Orazi di Jean Louis Davis (1784), giudicato a 1) Per i disegni dell’artista v. Vincenzo Camuccini, 1771-1844, bozzetti e disegni dallo studio dell’artista. Catalogo della mostra, Roma Galleria Nazionale d’Arte Moderna 27 ottobre-31 dicembre 1978, a cura di G. Piantoni De Angelis, prefazione a cura di I. Faldi. Per un profilo dello stesso: A. Bovero, in: Dizionario biografico degli Italiani, vol. 17, Roma 1974, pp. 627-630, s.v. suo tempo “il più bel quadro del secolo” 2) , come sembra potersi affermare dal confronto con il gruppo delle donne nel dipinto del Louvre. La figura del S. Giovanni che nel modello camucciniano sosteneva la Vergine è qui spostato sul fondo del dipinto, ammantato in una ampia tunica è una austera figura poussiniana ma ha perso lo stretto coordinamento figurativo che aveva nel progetto del maestro. Di origine chiaramente camucciniana sono del resto le grandi masse plastiche ed il colore volutamente povero, davidiano. La tela per il neoclassicismo avanzato, allora si sarebbe detto “dorico”, potrebbe essere datato addirittura agli inizi del XIX secolo ma deve essere trattenuto invece entro l’ultimo decennio del Settecento per i caratteri più tradizionali del suo pendant, con S. Benedetto. Uno studio del 1817 della Deposizione del Camuccini si trova ad Avignone (Museé Calvet) ma non offre maggiori analogie con il dipinto tarquiniese. Questa tela, sconosciuta alla critica, è stata divulgata recentemente ma priva di ogni definizione stilistica, cronologica, né é stato definito l’ambito culturale 3) . L’esecuzione dell’opera è in rapporto al nuovo allestimento avuto dalla chiesa dopo l’incendio del 1780 ed al suo conseguente restauro, terminato nel 1783 quando la chiesa fu riconsacrata 4) . Non è però detto che a quella data fossero completi tutti gli arredi dell’edificio sacro, l’unico della città con l’interno in stile Luigi XVI e che ha in Roma un calzante parallelo nella Chiesa di S. Caterina da Siena in Via Giulia, opera di Paolo Posi (17081776), costruita tra il 1766 ed il 1775. Sarebbe molto interessante sapere se la commissione di questa tela e della sua compagna abbiano a che fare con la figura del Cardinal Garampi, vescovo di Corneto e Montefiascone, il quale morendo nel 1792, ebbe modo forse di entrare in contatto con i nuovi e più oltranzisti sostenitori del Neoclassicismo, che tali non erano quelli presenti nel suo elenco precedentemente citato, seppure di alcuni, ad esempio di Giuseppe Pant e del Mitty non si conosce nulla. I nominativi di costoro sono: Batoni, Corvi, La Piccola, Maron, Unberbergher, Pant, Ceretta (di Milano, pittore ed incisore), Moore (pittore paesista), Hachert, Labruzzi, Morghen (incisore), Volpato (incisore), Mitty, Monsù, Filidoni (incisore), Kauffmann, Cades, Stefano Tofanelli, Peter (pittore di animali come Monsù 5) ). 2) A. Hauser, Storia sociale dell’Arte, Vol. II, Torino 1983, tav. fuori testo. L. Balduini, Monaldo Trofi “civis cornetanus”, Tarquinia 1985, p. 217, fig. 98. 4) M. Corteselli, A. Pardi, Corneto com’era, Tarquinia 1983, p. 60. 5) C. Faccioli, Da Due note nel “fondo Garampi” dell’Archivio Vaticano, in: l’Urbe, XXXIV, gennaio febbraio 19711, pp. 13-27, v. pp. 14-15. 3) Scuola di Vincenzo Camuccini, S. Benedetto intercede presso la Vergine per la salvezza di un uomo, 1784-1790 c., olio su tela, (268 x 185), Monastero delle Benedettine, dalla chiesa di S. Lucia Neg. Soprint. B.A.S. Roma N. 127703. Questo dipinto, già posto nella chiesa di S. Lucia era contrapposto a quello con il Compianto sul Corpo di Cristo (scheda precedente). E’ opera sicuramente della stessa mano, seppure di minore intensità espressiva e più legato al tema devozionale; sotto il profilo stilistico rimane vicino a formule più tradizionalmente rocaille seppure le figure della Vergine con il Bambino assisa sulle nubi eviti gli scorci consueti e tenda a disporsi sulla superficie, secondo un taglio orizzontale, a fregio, come dettato dal nuovo gusto neoclassico. In particolare la gloria angelica è nella scia della tradizione tardosettecentesca, appena aggiornata nei volti e nella nuova monumentalità statuaria. L’uomo a terra si può invece fare risalire al celebre dipinto di Marco Benefial con S. Margherita da Cortona che scopre il corpo dell’amato (Roma, chiesa dell’Aracoeli), che fece scuola a Roma si può riferire con buona approssimazione al disegno di Vincenzo Camuccini con la testa di Pietro Lombardo, tratto dalla Disputa del SS. Sacramento di Raffaello nelle Stanze Vaticane 1) . Il gusto per il taglio compositivo ancora ad X e per la linea serpentinata su cui si sviluppa la scena, dichiara un artista formatosi in un clima ancora pervaso dalla tradizione seppure la scelta di campo sia ormai nettamente neoclassica. Il nuovo indirizzo è operativo soprattutto nella selezione cromatica, addirittura estremista nella limitatezza del colore, che si ispira a quelli terrosi, ai bruni ed ai rossi aridi del Camuccini, ma in maniera addirittura esasperata, col che l’artista ottiene effetti quasi surreali, come se l’immagine fosse bruciata dallo stesso colore rossastro che la pervade. Virginio Monti (Genzano 1852-1942), I Santi Crispino e Crispiniano davanti a Rizio Vario rifiutano di adorare gli idoli, Chiesa cattedrale, abside sinistra (Cappella del Sacramento). Affresco firmato e datato in basso a 1) Vincenzo Camuccini 1771-1844, bozzetti e disegni dallo studio dell’artista, catalogo della mostra, Roma, Galleria Nazionale d’Arte moderna, 27 ottobre 31 dicembre 1978, a cura di G. Piantoni De Angelis, n. 11, p. 18. sinistra: V. Monti fece 1887 per commissione del rev. Sig. Arcidiacono Don Francesco Boccanera”. L’opera ha sofferto per le infiltrazioni di umidità che l’hanno in parte danneggiata. L’identificazione del soggetto si basa sul fatto che questo dipinto dovette sostituire, dopo otto anni dalla data dei grandi restauri subiti dalla chiesa nel 1879, la tela seicentesca con la Crocefissione ed i santi protettori della Confraternita dei Calzolai che, al momento dei restauri, era ancora in opera sul suo altare 1) . Del nuovo dipinto, di cui manca ogni riferimento bibliografico, si è persa la memoria del soggetto persino la chiesa stessa. Le due figure di santi mancano infatti di ogni attributo. Il Boccanera fece decorare la cappella con specchiature a finti marmi nella parte bassa, con la pala d’altare incorniciata da candelabre grottesche neocinquecentesche e con le figure di profeti nei pennacchi e nelle lunette della cupola. Fece anche dono della grandiosa bussola di legno intagliato del portale, dal pulpito, delle logge ai lati del presbiterio, dei due dipinti di S. Margherita (opera quasi certaa di Pietro Gagliardi) e della Madonna del Rosario 2) . La pala d’altare si caratterizza per l’elegante storicismo di raffinato gusto Art Nouveau, non lontano da quello di Cesare Maccari. L’affresco e le figure soprastanti sono rese con facile padronanza del disegno e della composizione in toni chiari, con ombre leggerissime e trasparenti. Forte l’interesse ricostruttivo dell’ambiente, tipico della pittura nella Roma Umbertina, ma privo di retorica e di pesantezze antiquarie. L’artista, attivissimo in Roma a cavallo tra i due secoli, è ampiamente ricordato nella guida delle chiese romane di Diego Angeli 3) . Del Monti, autore di oggetti sacri, che come molti altri della scuola romana dell’ottocento, lavorò anche nell’isola di Malta, rimangono numerose opere nelle chiese romane di S. Gioacchino, in Vaticano, in S. Andrea della Valle, in S. Brigida, in S. Carlo ai Catinari, in S. Chiara, nella Chiesa del Corpus Domini, del Sacro Cuore a Castro Pretorio. 1) M. CORTESELLI, A. PARDI, Corneto com’era, Tarquinia 1983, p. 93. C. DE CESARIS, La Cattedrale di Corneto”, Restauro del 1875-1879, in: Bollettino della Società Tarquiniense di Arte e Storia, anno 1984, p. 130. 3) D. ANGELI, Le Chiese di Roma, Roma s.d. (1903), pp. 77,82,94,103,120,160,215,360; A. CORNA,Dizionario della Storia dell’arte in Italia, Piacenza 1930, vol. II, p. 667; C. CESCHI, Le Chiese di Roma, Dagli inizi del neoclassico al 1961, Roma 1963, pp. 143-145; T.C.I. Guida di Roma e dintorni, ed. 1965, pp. 223, 476. 2) TRE DIPINTI OTTOCENTESCHI INEDITI DI CESARE MASINI E DI VIRGINIO MONTI Cesare Masini (Bologna 1812-1891), il Pentimento di S. Pietro, olio su tela (233 x 167) Chiesa di S. Maria di Valverde, Altare destro. La tela è firmata e datata in basso a destra, quasi invisibile: C. MASINI F. PERUGIA 1842. Il dipinto che, come il suo pendant nell’abside di sinistra corrisponde esattamente alla cornice che lo ospita, dovette essere eseguito per la sede attuale, che proprio in quegli anni ebbe un totale rifacimento dell’interno ad opera dell’architetto cornetano Giovan Battista Benedetti e che fu riconsacrata nel 1853. Cesare Masini fu pittore, storico dell’arte, incisore e xilografo ed anche segretario dell’Accademia di Bologna, è questa componente accademico-purista che emerge dal dipinto e dal suo compagno, posto nell’abside destra della stessa chiesa, purismo non lontano da quello di Tommaso Minardi, di Pietro Mussini e del Tenerani che proprio attorno a quegli anni si era definitivamente affermato. Il Purismo, movimento a sfondo romantico, in queste come nella maggior parte delle opere rinnovò più i contenuti, che sono per lo più di ispirazione religiosa, che non la forma, che rimase palesemente accademica ispirata ai maestri quattrocenteschi, al Perugino, a Raffaello giovane. L’immagine monumentale, potente, del santo abbigliato come una figura della statutaria romana con tunica grigia e manto bianco cereo, si staglia contro la sagoma oscura di una collina, unico elemento diagonale, dinamico della composizione e contro il cielo che albeggia in toni rosati. In questo caso “il ritratto” del santo, quasi un nobile studio accademico (in altri casi, come nel S. Filippo Benizzi, vero punto di forza, caratterizzante, dell’opera) redime solo in parte la compassatezza e la messa in posa, l’intenzionalità del modello, non riscattata neanche dall’accentuazione mimica, come raggelata dall’oltranzismo della semplificazione compositiva e formale. Elementi di stile che rispondono peraltro alla poetica del purismo. Nel Masini non è però assente la nuova sensibilità romantica che si tradisce innanzitutto nel sentore malinconico, assorto, delle due opere e nelle loro ambientazioni crepuscolari. Delle due tele, questa in particolare evidenzia macchie di umidità e sedimenti di polvere. Cesare Masini (qui attribuito), S. Filippo Benizzi, olio su tela (223 x 167), Chiesa di S. Maria di Valverde, altare sinistro. La tela raffigura il maggiore dei santi dell’ordine dei serviti, ordine che officiava la chiesa annessa al loro monastero, in cui erano installati fin dal secolo XVI. Come nel dipinto dell’abside destrra, la figura è stante, il santo è presentata secondo un taglio compositivo estremamente semplificato, mentre con un bastone fa sgorgare una sorgente di acqua calda dal suolo, iconografia che, come in numerosi altri casi di contaminazione tra repertori figurativi dei santi, S. Filippo Benizzi condivide con S. Isidoro agricola. Alle sue spalle, un angelo che alita a fil di terra si allontana con il triregno pontificio a ricordo del rifiuto che il santo fece della propria elevazione al soglio di Pietro. In terra, tra erbe e piante, dipinte con un esacerbato naturalismo da pittore “primitivo”, sono adagiati il volume ed i gigli, attributi del santo. Ritorna qui l’organizzazione dello sfondo su un’unica diagonale quella della vegetazione che, come il monte nel S. Pietro, fa da quinta alla figura, animata dalla diversa diagonale tracciata dall’angelo. La malinconica, assorta figura del giovane santo, di immediata evidenza ritrattistica, si intona con la luce vespertina del cielo al tramonto, fondale alla iconica immagine fermata, quasi come in un dipinto medioevale, nel gesto ieratico che presenta il fatto miracoloso. La tela, priva di ogni iscrizione, fu eseguita dal Masini assieme all’altra nel 1842, entrambi i dipinti sono del tutto inediti. L’artista perugino in entrambe le opere dimostra un consolidato mestiere pittorico, seppure quasi negato a favore della sapiente resa plastico-disegnativa che rammenta opere di scultura coeva di un Pietro Tenerani e di un Lorenzo Bartolini. Nella stessa chiesa di S. Maria di Valverde, oltre a questi dipinti ed a quelli di Pietro Gagliardi, provenienti dalla chiesa di S. Marco, si trovano altre due tele, anch’esse da S. Marco, opere modeste, inedite, di Giovanni Orsi pittore attivo nella prima metà del secolo a Forlì e a Ravenna, che raffigurano la Crocifissione con la Vergine e S. Giovannino, e la Vergine che appare a S. Nicola da Tolentino. Il primo dipinto riporta: “Giovanni Orsi in (...) fece 1846”, il secondo: Giov.i Orsi dip. e 1846. Entrambe le opere, improntate alla medesima cultura purista, ma di qualità molto minore di quelle del Masini, seppure registrate negli inventari comunali già nel 1907 e in quelli successivi, sono del tutto adespoti e privi di bibliografia. Su Cesare Masini U. THIEME-F. BECKER, Allgemeine Lexikon, vol. XXIV, 1930, p. 205; A. COMANDUCCI, Dizionario, vol. III, 1962, p. 1129; E. BENEZIT, Dictionaire, 1976, vol. 7, p. 238. QUIDAM GUIDOCTUS PISANUS ME FECIT... (in margine al libro “Corneto com’era 1) In quest’ultimo decennio gli studi di epigrafia in provincia di Viterbo segnano una sorprendente fioritura, confermando l’accresciuto interesse per questa disciplina “ancillare”, i cui apporti non sono sempre valorizzati appieno rispetto alle fonti definite “stricto sensu” letterarie e documentarie 2) . Non intendiamo tanto riferirci ai saggi, pur significativi, che illustrano singoli testi 3) , quanto ai cospicui contributi relativi all’antichità classica, i quali con aggiunte ed aggiornamenti, vanno ad integrare la monumentale opera del Corpus Inscriptionum Latinarum 4) , e soprattutto alle sillogi sul Medioevo e sulle età susseguenti, che si impongono per consistenza di epigrafi e per dovizia di apparato esegetico. La constatazione assume ancor più rilievo se si considera che 5) nonostante che la 1) Onde sgombrare il campo da possibili equivoci, (di-) chiariamo immediatamente che non è nelle nostre intenzione recensire il volume di Mario CORTESELLI e Antonio PARDI (Corneto com’era. Chiese, Confraternite e Conventi cornetani d’un tempo. Tarquinia, Tip. Giacchetti in coll. con la Grafica Romana di Roma, 1983, pp. 300, con ill. bn.), ma piuttosto trarre spunto da talune notizie nel medesimo contenute, per avviare una ricerca del tutto autonoma. Semmai consideriamo il saggio come un omaggio dovuto ad uno dei coautori, nostro conterraneo, ma residente ormai da diversi lustri a Tarquinia e divenuto di diritto cittadino cornetano, al quale ci legano affettuosi, seppur sfumati, ricordi d’infanzia. Desideriamo altresì esprimere il nostro ringraziamento al giovane studente di architettura Gianluca Cerri, per la valida collaborazione prestataci in ricerche bibliografiche presso gli istituti rromani. 2) Non bisogna tuttavia sottacere che anche nei secoli passati gli storici più avvertiti hanno registrato le epigrafi, riconoscendone l’intrinseca importanza documentaria. Si può menzionare per tutti Feliciano BUSSI, che nella Istoria della città di Viterbo (in Roma, nella Stamperia del Bernabò e Lazzarini, MDCCXLIII, pp. XX-478) riporta su 394 pagine di testo ben 163 iscrizioni pertinenti ai monumenti, agli avvenimenti e ai personaggi della città. 3) Citiamo exempli causa: A. CAROSI, Storie di tutti i giorni nei graffiti di San Rocco e Monte Calvello, in “Biblioteca e Società”, a. III, n. 2-3- 30 sett. 1981, pp. 5-12; N. ANGELI, I Belli, una dinastia di “campanari” viterbesi, idem, a. IV, n. 3-4, 21 dic. 1982, pp. 37-42 (ai testi pubblicati bisogna aggiungere quello della campana di San Benedetto a Montefiascone del 1830, vedi infra: BRECCOLA - MARI, p. 283); L. CIMARRA, Artefici e commitenti nelle iscrizioni cosmatesche di Civitacastellana, ibid., a. V., n. 3-4, 32 dic. 1983,pp. 37-40; I. DINI, G. PACCHIAROTTI, F. RICCI, L. SANTELLA, Il complesso monumentale di San Leonardo a Graffignano, in “Informazioni”, n. 2-3, dic. 1986, pp. 38-48. 4) Ci riferiamo segnatamente ai “Supplementa Italica” (Nuova serie. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1981, pp. 107-176) relativi alla Regio VII (Etruria: Falerii Novi) a cura dell’insigne epigrafista I. DI STEFFANO MANZELLA. 5) A. CAMPANA, Le iscrizioni medioevali di San Gemini, in “San Gemini e Casulae”, (Milano, 1976, pp. 81-132), p. 85, col.l. raccolta di iscrizioni medioevali d’Italia sia stata tante volte auspicata, desiderata, progettata, e nonostante una gloriosa tradizione di studi sulle iscrizioni medievali, che comincia addirittura nel Rinascimento, manca ancora una raccolta generale e ci si deve accontare, nei casi più fortunati, di raccolte limitate a singole città o monumenti, o collezioni, raramente ad alto livello scientifico, ancor più raramente fornite di documentazione fotografica; e per il resto si deve ricorrere a una enorme e ramificata bibliografia costituita da storie locali, pubblicazioni particolari di ogni genere, periodici di istituzioni storiche regionali o cittadine, ecc., spesso di non facile reperimento. In ordine cronologico il primo che ha approntato una raccolta sistematica delle iscrizioni esistenti od esistite in un determinato ambito territoriale è stato il dotto sacerdote Giacomo Pulcini di Civita Castellana: egli ha (ri-) pubblicato testi pertinenti all’antichità (falisca e romana) e al Medioevo, includendo inoltre quelli moderni e addirittura contemporanei, nell’opera “Falerii Veteres, Falerii Novi, Civita Castellana 6) , la quale, sebbene non sia scevra, nella sua farraginosa mole, da incongruenze, da errori di trascrizione e da omissioni, costituisce nondimeno uno strumento utile per le ricerche a venire. E’ seguito poi l’opuscolo di Pietro Volpini “Montefiascone attraverso le epigrafi 7) , nel quale “si presentano quaranta epigrafi incise nelle lapidi, che rievocano avvenimenti importanti e personaggi che hanno segnato profondamente venti secoli di storia della città falisca”. Da ultimo ancor fresca di stampa, la raccolta “Le epigrafi medievali di Viterbo 8) nella quale sono edite le iscrizioni del capoluogo provinciale dal VI al XV secolo, opera che si distingue per rigore scientifico e perizia filologica, curatore Attilio Carosi, ex direttore della Biblioteca Comunale degli Ardenti. Lavori meritori, occorre ribadirlo, che rappresentano la necessaria premessa per avviare indagini di maggior impegno su base provinciale od areale, ma che non sono del tutto esenti da mende: a parte i rilievi critici che a ciascun editore, a mo’ di recensione, si potrebbero muovere, un limite che ci sembra comune a tutti e tre, è quello di aver tralasciato o, meglio, trascurato di rilevare le iscrizioni che figurano sugli arredi sacri (come reliquiari, croci astili e stazionali, calici, teche e acquamanili), 6) G. PULCINI, Falerii Veteres, Falerii Novi, Civitacastellana.Biblioteca Falisca, 1970, pp. 270. P. VOLPINI, Montefiascone attraverso le epigrafi. 2° Quaderno di Studi Storici. Montefiascone, Centro di Iniziative Cultrurali, 1981, pp. 72. 8) A. CAROSI, Le epigrafi medievali di Viterbo (sec. VI-XV). Viterbo, Agnesotti, 1986, pp. 172. 7) sulle suppellettili in genere e soprattutto, data la usualità e la notorietà della presenza epigrafica su siffatti oggetti, sulle campane 9) . L’esame delle campane, ad esempio, permette di acquisire tutta una serie di dati relativi, oltreché alla tecnica fusoria, alla epigrafia, alla storia della iconografia, della religiosità, del costume e dell’arte. In effetti, con maggiore frequenza a partire dal secolo XII, vengono dapprima incise, poi apposte, su tali strumenti iscrizioni, che, su una o più linee di scrittura, riferiscono il nome del donatore o del fonditore, quello del santo titolare della chiesa, la data e la circostanza della dedica. Si accompagnano contestualmente invocazioni come quella, più spesso ricorrente, che sembra esser derivata dall’epitaffio di Sant’Agata 10) : Mentem sanctam spontaneum honorem Deo et patriae liberationem. oppure orazione come l’Ave Maria od inni come il Salve Regina, magari con le parole ridotte in sigla, formule devozionali e beneaugurali che la campana esprime in prima persona 11) : Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum, defunctos ploro, nimbum fugo, festa decoro. Funera plango, fulmina frango, sabbata pango excito lentos, dissipo ventos, paco cruentos. Convoco, signo, noto, compello, concino, ploro. 9) Il VOLPINI avrebbe potuto, ad esempio, ricavare dal volume di G. BRECCIOLA e M. MARI (Montefiascone. Grotte di Castro, C. Ceccarelli, 1979, pp. 281-282), edito dal medesimo Centro di Iniziative Culturali, una iscrizione campanaria del 1301, che reca il nome del fonditore Matteus de Viterbio.( La siglia MSSODEPL, che secondo gli autori del citato libro “sta per un acrostico motto sacro o di un detto della Bibbia o più probabilmente di una invocazione’, sarà da sciogliere ‘Mentem Sanctam Spontaneum (h) Onorem Deo Et Patriae Liberaationem’). 10) Sulla formula e il relativo significato ha scritto il SERAFINI (Torri campanarie di Roma e del Lazio nel Medioevo... Prefazione di C. Ricci, Roma, P. Sansani, MCMXXVII, p. 80, par. 103, col. L): “Parecchie campane di Roma recano, con leggere varianti, l’iscrizione Mentem sanctam, spontaneum honorem Deo et patriae Liberationem. Essa attira l’attenzione per la straordinaria forma grammaticale all’accusativo; ma a ben pensarci non è che una modificazione delle altre epigrafi, già riportate, per le quali la campana parla ai fedeli delle mansioni a lei affidate. Sono perciò sottintese delle voci verbali in prima persona, equivalenti a “invoco” o “signo”. Il fatto che le parole in origine abbiano forse fatto parte di un’iscrizione posta sul sepolcro della martire Sant’Agata, non ci spiega perché esse siano state adottate su tante campane, se non fosse che realmente dicevano in breve dell’ufficio proprio della campana’. 11) A. SERAFINI, op. cit. I., p. 76, par. 104, coll. 1-2 arma, dies, horas, fulgura, festa, rogos. Ad impreziosire la superficie esterna si aggiungono ben presto decorazioni come monete e medaglie, sigilli di dignitari ecclesiastici, stemmi nobiliari, effigi di santi, fregi e rilievi. Per limitarci alla Tuscia Viterbese, è sufficiente segnalare che proviene dal territorio di Canino uno degli esemplari più antichi che si conoscono in Italia 12) e che su un’antica campana della chiesa di san Sisto in Viterbo ci tramanda notizie precise lo storico settecentesco Feliciano Bussi 13) . Io trovo in un’antica memoria di questa città, che la campana grossa di San Sisto era del Comune della città di Nola e che essendo stata recata in Viterbo dall’imperador Federico II nell’anno 1243 egli stesso la donasse a tal chiesa; la quale notizia, benché peraltro grossa campana, di cui oggi la stessa chiesa si prevale non è altrimenti quella, mentre in questa trovasi formata in caratteri gotici la seguente iscrizione: AD. HONOREM. DEI. ET. BEATI. SISTI. ANNO. DOMINI MCCLVI. MAGISTER. BENCIVENNE. PISANUS. ME FECIT. MENTEM. SANCTAM. SPONTANEUM. HONOREM. DOMINI. ET PATRIAE. LIBERATIONEM. L’iscrizione, pur nella sua brevità, attesta l’opera del Magister Bencivenne, lo stesso che nel 1259 fuse la bella campana maggiore per la Chiesa di S. Domenico a Fermo 14) , confermando la presenza nell’Italia Centrale di fonditori pisani e la loro attività itinerante 15) : Andavano di luogo in luogo trasportando le loro officine, secondo un costume che durò fino al secolo XVIII (ma già nel secolo XVI vi furono fonderie stabili) praticando anche dal ‘400 in poi la fusione delle bocche da fuoco. Naturalmente una professione 12) G.B. DE ROSSI, Cloche avec inscription dédicatoire du VII ou du IX siècle trouvée à Canino, in “Revue de l’Art Chrétien” (1890n p.l). Il DERAFINI (op. cit., I, p. 75, par. 102, col.1),, che propone una diversa lettura commenta: “Campana medioevale proveniente dal territorio prossimo a Canino (Tuscia Romana). Secolo VIII o principio del secolo IX. E’ probabilmente una delle più antiche campane liturgiche che esistano, fusa in forma elegante con un bel bronzo dai riflessi argentei. Crediamo che in origine abbia appartenuto ad una abbazia posta sotto il titolo di San Michele Arcangelo nella regione esistente tra Tuscania e Tarquinia’. A rafforzare l’ipotesi di un dedicatore locale, come ha ben osservato D. MANTOVANI (Momenti di storia di Blera. I documenti. Roma, Tip. Veneziana, 1984, pp. 32-43), interviene l’elemento onomastico VIVENTIV (S), che rimanda a San Vivenzio, vescovo e patrono della città di Blera (“fuori di questa terra Vivenzio è ignoto). 13) F. BUSSI, op. cit., P. 63. 14) CALZINI E., Campane e fonditori di campane, in “Rassegna Bibliografica dell’arte italian”, a. XIV, 1911, p. 152; a. XVIII, 1915, P. 16. 15) Vd. E.I., vol. VIII, pp. 564-566, s.v. “campana”. A complemento vd. P. TOESCA Il Medioevo (Torino, UTET, 1965, vol. II, p. 1142, nota 2); A. DA MORRONA, Pisa illustrata nelle arti del disegno (Livorno, 1812, 2 ed., vol. I, pp. 441-2; vol..II, pp. 105-115, 414-422). così esercitata si trasmetteva di padre in figlio: è nota la famiglia francese dei DE CROISILLES, fonditori di campane nei secoli XIII-XIV; molte altre famiglie tedesche e olandesi furono attive fino al secolo XVIII. In Italia la fusione di campane fu praticata comunemente nel Medioevo; ed il ripetersi nel secolo XIII di nomi di fonditori pisani attivi a Roma, a Lucca, a Firenze (Bartolomeo, Loteringio di Bartolomeo, Guidoccio, Guidotto e Andrea Pisano di Guidotto, Bonoguida e Rico Fiorentini, Andreotto e Giovanni) dimostra anche da noi quella tradizione familiari e nomade. E proprio a Corneto troviamo attivo, (ma la data tramandata dovrebbre risultare erronea e di conseguenza essere posticipata di circa un decennio), uno degli artefici pisani menzonati, cioè Loteringio di Bartolomeo, dalla cui fonderia sono uscite anche altre campane per chiese della Toscana (Lucca, Museo: 1242; Pisa, campanile del Duomo: 1262) 16) : un ignoto cronista dei Serviti riporta che una campana della chiesa (scilicet: S. Maria in Valverde) portava la seguente iscrizione: Anno Domini 1211. Mi fece Lotteringio, figlio di Bartolomeo Pisano, al tempo dei fratelli Leonardo, Angelo e Simeone. Non è da escludere che la campana provenisse dalle chiese altrettanto antiche di S. Nicola o San Martinello, allorché nel 1582 i Serviti la acquistarono dal Vescovo Bentivoglio e che perciò la data riportata possa riferirsi ad una delle due chiese. I maestri fonditori pisani operarono durante tutto il secolo XIII nell’Italia Centrale, precisamente nelle regioni del versante tirrenico, risalendo fin nel cuore dell’Umbria e travalicando in qualche caso l’Appennino 17) : Bartolomeo gettò in bronzo le campane per la Basilica di San Francesco di Assisi nel 11239; un tal Magister Bonus è presente a Sangemini (TR) nel 1291, quando fonde una campana per la chiesa di Sant’Egidio 18) . L’attività di questi artefici si esplica anche a Roma: la tipologia delle loro campane si differenzia da altre uscite da diversa fonderia soprattutto per una forma tubolare, elegante ma non molto allungata, e per pareti più spesse. Se Bartolomeo firma la sua opera per la chiesa di San Cosimato a Trastevere, con maggiore frequenza ricorre il nome di Guidotto Pisano, il quale nella seconda metà del secolo dovette assurgere, per la sua abilità tecnica, ad una certa notorietà: dalla sua officina escono nel 1286 i due bronzi di San Nicola in carcere su commissione di Pandolfo de Sabello, pro redemptione anime sue; nel 1289 campana 16) M. CORTESELLI - A. PARDI, op. cit., p. 110. Con questa affermazione non si vuole escludere, beninteso, la presenza di fonditori pisani in altre regioni di Italia, ma semplicemente dire che un’indagine così estesa non rientra nei limiti che ci siamo imposti. 17) della “predica” di San Pietror, fatta per legato di un certo Riccardo, notaio del Pap Nicolò IV e, con la collaborazione del figlio Andrea, una delle campane di Santa Maria Maggiore, entrambe dapprima depositate al Museo Lateranense e trasferite poi al Museo Sacro Vaticano; nel 1291 quella di Sant’Angelo in Pescheria 19) ; alla fine del secolo XIII o nella prima decade di quello successivo un’altra campana di Santa Maria Maggiore su commissione di Pietro Savelli 20) . La documentazione di cui possiamo disporre conferma la presenza periodica del maestro pisano a Roma nell’arco di un trentennio, ma l’attività di Guidotto fu, come già si è accennato, itinerante su un’area più vasta, come si desume dalla scheda del repertorio ThiemeBecker 21) : Glockengiesser in Pisa von dem mehrere datierte Glocken erhalten sind, die frühste von 1273 aus S. Michele in Lucca (heute Pinak.), gegossen in Gemeinsch mit Bartolomeo Pisano. In S. Severo e Martino bei (zerstört) befand sich eine Glocke mit dem Datum 1277. Ferner: Lucca, San Giovanni (1281); Parma, Certosa (1287; erhalten); Rom, St. Peter (1289). Naturalmente tale attività non si limita alle grandi città, ma si estende con spostamenti successivi ai centri minori: nel 1272 a San Paolo in Sabina (Ri) Guidotto foggia, in onore della Vergine Maria e di San Pietro Apostolo, un elegante campana avente un’altezza di cm. 80 (nodo compreso) e il diametro maggiore di cm. 63 22) : + A.D. M. CC.LXXII. AD. HONOREM DI. ET BEATE MARIE VIRGINIS. ET. S. PETRI. APOLI + . GUIDACTUS PISEANUS ME FECIT. XCS VICIT. XCS REGNAT. XCS IMPERAT. AGLA. 18) A. CAMPANA, op. cit., p. 105, col. 2. A. SERAFINI, op. cit., I, pp. 77-79. L’ARMELLINI (Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX... Roma, Edizioni del Pasquino, 1982, p. 231) informa che la campana di Santa Maria Maggiore (quella del 1289) fu ai suoi tempi tolta, depositata nei Giardini del Vaticano e sostituita con un’altra donata dal Papa Leone XIII. Quella coeva di San Pietro nel 1891, si ruppe, colpita da un fulmine, e fu sostituita da una nuova campana rinfusa nel 1893, anno giubilare di Leone XIII. 20) A. SERAFINI (op. cit., I, P. 78, nota 1) a proposito delle due campane di S. Maria Maggiore annota: “la data tradizionale delle due campane dei Savelli era esattamente il 1285; ma mentre quella di Pandolfo è invece del 1289, l’altra parte posteriore di alquanti anni; l’intervento di Pietro Savelli fa supporre infatti che Pandolfo fosse già morto (an. 1306), e d’altra parte la presenza contemporanea del cardinale tuscolano (molto probabilmente il Buccamazza, +1309) ci impedisce di portare la data aldilà dei primi anni del secolo XIV. Dalla quale osservazione si desume che Guidotto fu attivo a Roma fino alla prima decade del sec. XIV. Un errore cronologico è rilevabile anche nel TOESCA (op. cit. II, p. 1142, nota 2), il quale per la campana più antica di Santa Maria Maggiore accoglie la data del 1279. 21) THIEME-BECKER, Allegemeines Lexicon der bildenden Künstler. Leipzig, 1968, s.v. “Guidotto da Pisa’. Trad.: “Fonditore di campane in Pisa, di cui sono conservate molte campane datate, la prima del 1273 da S. Michele in Lucca (oggi nella Pinacoteca) fusa in comune con Bartolomeo Pisano. In San Severo e Martino presso Orvieto (distrutta) si trovava una campana con la data 1277. Inoltre: Lucca, San Giovanni (1281); Parma, Certosa (1287, conservata?); Roma, San Pietro (1289). 22) M.G. MARA, Una campana di Guidotto Pisano a San Paolo in Sabina, in “Rivista di Archeologia Cristiana”, 36 (1960), pp. 151-158. 19) La chiusa della iscrizione declatoria reca oltre ad AGLA, parola di pregnante valore magico-religioso, la triplice acclamazione alla regalità di Cristo, formula trasmessa, durante l’esercizio di apprendistato e di collaborazione, da maestro Bartolomeo, che l’aveva impiegata almeno fin dal 1221 nella campana abbaziale di Livorno 23) . Nel 1278 a Velletri, sotto il guardianato di frate Andrea de Auricola, fonde per la chiesa di S. Francesco una campana pro anima D(omini) Boni Iohannis de Placentia 24) ed una altra ancora conservata nella torre del palazzo municipale 25) . Tre anni dopo lo troviamo a Corneto, dove per la chiesa di San Michele (detta anche Sant’Angelo de puteis o della pinca) firma una campana dedicata alla Vergine Maria e a San Michele Arcangelo, la quale più tardi sarà traslata nella chiesa di San Marco 26) . Anche in questo caso ricorre la formula Christus vincit - Christus regnat - Christus imperat, come avverrà nel 1290, quando sempre a Corneto egli presterà la sua opera alla Chiesa di Sant’Egidio 27) : Il campanile (scil.: della chiesa di S. Maria del Suffragio) recava due campane provenienti dalla chiesa di Sant’Egidio: esse vennero calate e rifuse il 24 aprile 1863 su ordine del cardinale Quaglia e con una spesa di 25 scudi. La campana maggiore portava la seguente iscrizione: Anno Domini 1290. Ad honorem Dei et Beatae Virginis Mariae et intus corum P.P.E. Prior Bartholomaei - XPC vincit - XPC regnat - XPC imperat. Quidam Guidoctus Pisanus me fecit. Luigi Cimarra RICERCA SU ALCUNE EFFIGI DIPINTE IN TELA 23) E. CALZINI, art. cit., p. 152. E allora la campana di San Paolo non costituisce più l’antica testimonianza di acclamazione alla regalità di Cristo che sia stata incisa nel bronzo, dovendosi il terminus a quo anticiparsi 1221. Un’osservazione a parte meritano le “laudes regiae”, il cui passaggio dalla sfera profana all’uso liturgico avviene nel secolo VIII nella chiesa gallicana, dove la formula si mantiene come nota caratteristica delle “laudes” gallicane. Verso la fine del sec. XII la triplice acclamazione appare sulle monete dei re. Secondo dex exemples authentiques de cette formule remarquable. Aupavarant, on ne la rencontre nulle part, pas plus en Gaule qu’à Rome et ailleurs dans l’epigraphie et la liturgie’ (H. LECLERQ, Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, VII, 2, 11908, s.v. “laudes”). 24) B. THEULI - A. COCCIA, La provincia Romana dei Frati Minori Conventuali dall’origine ai nostri giorni. Roma, Edizioni Lazio Francescano, 1967, P. 441. 25) G. TOMASSETTI, La campagna Romana antica medievale e moderna. Vol. II, p. 378; E. MARTINORI, Lazio Turrito... Roma, soc. Tip. Manuzio, MCMXXXIV, parte III, p. 205. 26) M. CORTESELLI - A. PARDI, op. cit., p. 119-120. 27) M. CORTESELLI - A. PARDI, op. cit., p. 108. Cesare Petrosellini e Caterina di Bernardo Gabriellis 1) furono i genitori di Domenico Ottavio Petrosellini, nato in Corneto il 10 ottobre 1683 e battezzato nella chiesa di S. Giovanni Battista 2) da Nicolaus Meconus, servita. Suo padrino fu Ottavio Dino, per procura di Domenico Falgari. Fu il primogenito di dieci figli che i Petrosellini ebbero nell’arco di 22 anni e che furono tutti annotati con tanto di bei nomi nei registri della Parrocchia di S. Giovanni Battista ed in quella di S. Pancrazio Martire di Corneto 3) . Il terzogenito di Cesare Petrosellini, Francesco, sposò Antonia di Pietro Antonio de Benedettis ed il 30 novembre 1727 ebbe un figlio che venne registrato nel “Libro dei Battesimi” nella Cattedrale di Corneto, con i nomi di Giuseppe Antonio Andrea 4) . 1) Cesare figlio di Domenico e Caterina figlia di Bernardino Gabrielli da Corneto si sposarono nella chiesa di S. Giovanni Battista il 25 dicembre 1682, come attesta la p.64r. nel “Libro dei Matrimoni” dal 1663 al 1726 (ms.) presso l’Archivio della chiesa di S. Giovanni Battista di Tarquinia. 2) “Libro dei Battesimi” dal 1663 al 1698, (ms.) iniziato dal Rettore Innocenzo Fasciani, presso l’Archivio della chiesa di S. Giovanni Battista; cfr. “Famiglie Diverse Cornetane” - Petrosellini - , p. 355, (ms), già n ell’Archivio Falzacappa ora presso l’Archivio della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (S.T.A.S.); “Diz. Enc. Italiano”, vol. IX, Roma 1958, p. 331”; C. Mariani, “Notizie dell’abate Domenico Ottavio Petrosellini”, Roma, 1890, p. 12. Il Mariani annota la data di nascita del Petrosellini 1- ottobre 1683 anziché 10 ottobre. A riguardo del nome egli scrive: “Si vede, che tanto il compare che il suo procuratore, vollero imporgli i loro nomi”. “DOMENICO OTTAVIO PETROSELLINI da Corneto (Tarquinia) (1683-1747), sacerdote e poetaarcade, buon improvvisatore, discepolo del Gravina, fondò nel 1717 l’Accademia dei Quirini, che accolse i Graviniani dissidenti dall’Arcadia. Durò quest’Accademia dal 1717 al 1764 e pubblicò due raccolte (1717 e 1730): vi appartennero alcuni poeti ricordati dal Martello nella II satira del Segretario Cliternate: Avvi Petrosellin, che può d’un morto Fare immortal coll’istancabil canto; Lemer ne’ versi suoi pulito e scòrto; Bucci, ch’andar può d’Alighieri accanto; che del Chiabrera appena invidia il manto. Il Petrosellini scrisse gli argomenti del RICCIARDETTO del Forteguerri e compose un poema satirico giocoso in IV canti d’ottave: il GIAMMARIA ovvero l’ARCADIA LIBERATA, rimasto inedito fino al 1892, quando fu pubblicato a Corneto-Tarquinia, premessovi un Discorso di Dione Crateo (il Gravina). Il poeta narra lo scisma famoso dei Quirini, cagionato dalla tirannia di Giammaria Crescimbeni, custode generale d’Arcadia, e termina coll’intervento di due figure allegoriche: l’Allegrezza e la Penitenza, la quale ultima, dopo aver conciato in malo il povero Alfesibeo Cario, reduce dai trionfi arcadici, gli predice le glorie dell’Accademia dei Quirini. Ma il Petrosellini rientrò nel grembo dell’Arcadia dopo la vittoria di questa sui dissidenti; e si leggono sue rime, col nome di Eniso Pelasgo, nei tomi X (1747), XI (1749), XII (1759), delle rime degli Arcadi: rime di uno che ha studiato il Chiabrera e il Filicaia e fa presentire, come ha notato il Calcaterra, la vacua e rumorosa maniera Frugoniana. Notevole il sonetto al Bentivoglio per la traduzione della Tebaide”. (Da: G. Natali, IL SETTECENTO, IV Ediz., parte II, Milano, (Vallardi), pp. 10541055. Per uno studio più completo su D.O. Petrosellini si rimanda: C. Mariani, “Notizie dell’Abate D.O. Petrosellini”, Roma 11890; C. Mariani, “Canzoni” dell’Abate Domenico Ottavio Petrosellini, pubblicate nel 2° Centenario di Arcadia dal suo concittadino Crispino Mariani, Roma, 1890; D. O. Petrosellini, “Il Giammaria”, Corneto-Tarquinia, 1892. Altri suoi manoscritti, sono reperibili in Roma presso l’Accademia Arcadia, in Piazza S. Agostino, dove esiste il poema satirico “L’Arcadia Liberata” o “Il Giammaria”. 3) Oltre a Domenico Ottavio, i Petrosellini ebbero nove figli con i nomi di Giovanni, 1685, p. 127; Francesco, 1686, p. 132; Francesco Stefano, 1688, p. 143; Rosa Sabbata, 1690, p. 148; Augusto Cesare, 1697, p. 112; Agata Maria Maddalena, 1702, p. 8; Giuseppe Antonio 1705, p. 18; tutti registrati nei libri presso la chiesa di S. Giovanni Battista di Corneto, mentre Giuseppe Bernardino, 1693, p. 22 e Francesca Maria Giacinta, 1695, p.5, sono registrati nei libri già presso la chiesa di S. Pancrazio M. di Corneto, ora presso l’Archivio della Cattedrale di Tarquinia. 4) “Libro dei Battesimi” dal 1727 al 1735, p. 6, presso l’Archivio della Cattedrale di Tarquinia. Sia Domenico Ottavio che Giuseppe - più grande il primo di ben 44 anni - furono nella vita abati, poeti “et arcadis ambo”, non per questo però devono essere creduti fratelli, ma, come riportano i documenti, da considerare zio e nipote a tutti gli effetti, anche se Domenico Ottavio ebbe un fratello di nome Giuseppe Antonio che nacque nel 1705 5) e fu il decimo ed ultimo figlio di Cesare e Caterina. Crispino Mariani, in “Notizie dell’Abate D.O. Petrosellini”, Roma 1890, p. 12, scrive di lui una piccola biografia, riportando anche alcune sue poesie con il nome pastorale di “Eniso Pelasgo”, ed in contrasto con Luigi Dasti nella sua “Storia di Corneto” 6) egli nega “recisamente” che il D.O. Petrosellini fu uno dei fondatori di Arcadia, mentre è pienamente d’accordo con Pietro Falzacappa quando questi scrive che il poeta ricoprì la carica di sottocustode di Arcadia. Se però Domenico Ottavio non fu uno dei fondatori di Arcadia, “fu certamente uno dei fondatori della non meno celebre Accademia Quirina”. Seguì gli studi nel celebre Seminario di Montefiascone, a 22 anni fu annoverato fra gli Arcadi - 19 dicembre 1705 - e visse in Roma, dove morì il 14 maggio 1747, come resistrato in Arcadia. Sempre nelle stesse “Notizie...”, p. 10, è scritta una breve biografia di Giuseppe Petrosellini, nipote di Domenico Ottavio. Anche questi fu valente poeta e membro di varie accademie: “visse in Roma, fu bussolante di N.S. e segretario del principe Giustiniani”. L’Abate Giuseppe Brogi, pro-custode generale di Arcadia, c’informa che Giuseppe fu nipote di Domenico Ottavio Petrosellini. Infatti, in un suo sonetto di lode al defunto Domenico Ottavio, alludendo al giovane Giuseppe, si esprime così: “di eccelso vate non minor nepote” 7) . Quanto detto finora lo ritengo necessario per quello che mi appresto a descrivere intorno ad alcune effigi, raffigurate su tela e che si trovano in Tarquinia, Montefiascone e Roma. Molto probabilmente le tele sono riconoscibili nella figura dell’Abate Domenico Ottavio Petrosellini. Inizierò col parlare della tela dipinta ad olio, attualmente esposta lungo una piccola scala del Seminario di Montefiascone (fig.1); essa è contrassegnata, nel retro, dal numero “6” e reca la scritta “Petrosellini”; il tutto segnato a gesso da lavagna, come del resto, in questo modo, sono trattati quasi tutti gli altri quadri esposti nel Seminario. 5) Vedi nota n°3. “Notizie Storico Archeologiche di Tarquinia e Corneto”, Roma, 1878, pp. 180-181. 7) C. Mariani, “Notizie”, op. cit., p. 10, Giuseppe Petrosellini portò il nome pastorale di Enisildo Prosindio. 6) Nelle sue “Notizie” (op.cit. p. 12), il Mariani ci parla del dipinto del Petrosellini nel Seminario di Montefiascone in questi termini: “dove tutt’ora si vede il suo ritratto, e sotto si legge - Poeta clarissimus-”. Anche il Bergamaschi in “Vita del Servo di Dio Card. M.A. Barbarigo”, Roma 1919, vol. I. p. 448, dice: “ tra i primi professori illustri del Seminario e Collegio di Montefiascone del tempo del fondatore card. M.A. Barbarigo, si deve ricordare Domenico Ottavio Petrosellini, di Corneto....” “Egli entrò in Seminario nel 1699. Il Seminario collocò nella galleria dei professori e degli Studenti Illustri il quadro commemorativo, aggiungendovi la seguente iscrizione: “DOMINICUS-OCTAVIUS/PETROSELLINI/CORNETANUS-POETACLARISSIMUS/ARCADIE/PRO CUSTOS ET CENSOR/15-IUNI - 1701. CONVICTOR”. Infine, secondo le affermazioni di un sacerdote ex rettore e professore del Seminario di Montefiascone e Corneto per un decennio (1961-1970), 8) la tela, esposta nelle pareti della piccola scala è stata sempre riconosciuta in Seminario per l’effige di Domenico Ottavio Petrosellini. Il Reverendo ricorda ancora quando il quadro era nella “Galleria dei Professori” e portava la scritta citata dal Bergamaschi. Il Canonico Meconi, Prefetto degli Studi del Collegio e Seminario di Corneto e Montefiascone, nel 1826, tramite il Card. Gazola, chiedeva al Gonfaloniere di Corneto, Francesco Maria Bruschi Falgari, di poter entrare in possesso del ritratto del celebre Domenico Ottavio Petrosellini, per collocarlo nei corridoi del nuovo braccio del Seminario, accanto agli altri ritratti degli allievi (“Il Procaccia”, n.9, pp.1-5). In realtà, non sappiamo se il quadro richiesto dal Meconi sia l’attuale esistente in Seminario; non è da escludere però che esso possa esserci arrivato tramite l’interessamento di qualche agiata famiglia di Corneto, per esempio la casa Mariani. Nell’ufficio del comandante i Vigili Urbani di Tarquinia, è appesa alle pareti una tela di minori dimensioni di quella nel Seminario (fig.2), proveniente dall’ex Archivio del 8) Mons. Antonio Patrizi ex Rettore e Professore del Seminario di Montefiascone e Corneto (1961-1970); oggi Parroco della Basilica Cattedrale del Santo Sepolcro di Acquapendente, in una lettera inviatami in data 16 ottobre 1986, così mi scrive: “Riguardo al quadro di Domenico Ottavio Petrosellini di Corneto, nonostante abbia passato una per una le carte (ed anche i libri e i registri) dell’Archivio storico del Seminario di Montefiascone, non ho trovato alcun accenno al tempo in cui il quadro possa essere stato donato alla galleria dei professori ed ex alunni illustri del Seminario stesso. Le posso però assicurare, con certezza, che il quadro del Petrosellini è di Domenico Ottavio e non dell’altro, Giuseppe, perché: 1) era collocato sopra l’iscrizione riportata dal Bergamaschi, la quale inizia con le parole: DOMINICUS-OCTAVIUS PETROSELLINI-CORNETANUS, 2) ricordo bene che il defunto Mons. Leonetti, Professore e Rettore del Seminario a cavallo degli anni ‘40, che sapeva a a memoria tutta la storia del Seminario tramandata oralmente dalle generazioni dei professori che l’avevano preceduto, ci additava questo Petrosellini di Corneto come un grande poeta del primo ‘700 ed accademico di Arcadia. 3) Giuseppe Petrosellini non risulta essere stato considerato tra gli ex alunni del Seminario, dato, ma non è certo, che ne debba essere stato alunno”. Palazzo Comunale. Essa risulta perfettamente uguale a quella del Seminario di Montefiascone 9) . Nel “Saggio o Cenni Brevissimi sull’Antichità e Pregi della Città di Corneto”, n. 103, p. 315, Corneto 1839 10) , è riportato che il concittadino Petrosellini fu poeta insigne ed “il di lui ritratto conservasi in seg.ria Magistrale”. Dalle annotazioni nelle “Famiglie Diverse Cornetane” F.5, si apprende che “il ritratto del Petrosellini fu posto in seg.ria nell’ottobre ca. 1827, e copiato dall’originale in Arcadia”. Non sappiamo, però, se le due annotazioni provenienti dall’Archivio Falzacappa, si riferiscono al quadro del Petrosellini che è nel comando dei Vigili Urbani. E’ più probabile invece che l’ultimo di questi scritti si riferisca ad altra tela inventariata, raffigurante il D.O. Petrosellini e facente parte della Raccolta Comunale (fig.3), oggi ubicata nel Palazzo Vitelleschi di Tarquinia 11) . Un quarto quadro del Petrosellini (fig.4), forse uno dei più certi, è quello che un tempo era presso l’Accademia Arcadia, oggi trasferito nei magazzini di Palazzo Braschi al Museo di Roma. Questo dipinto, che differisce per alcuni piccoli particolari da quello della Raccolta Comunale, può considerarsi quasi certamente il modello che servì a realizzare la tela della nostra Raccolta 12) . 9) La tela dell’archivio, che venne pubblicata per la prima volta in “Croniche di Corneto” di Mutio Polidori, Tav. I, con la denominazione: “Ritratto di ecclesiastico del XVII sec. (forse Muzio Polidori?”) (Corneto 1609-1683), oltre ad essere copia perfettamente uguale all’altra del seminario di Montefiascone, sia per il colore che nel disegno, sembrerebbe anche dipinta dal medesimo pennello. Stando poi ad una memoria, tramandata dal Sig. Giuseppe Volpini (Corneto 1883-1971) al Comm. Renzo Rotelli, che fu per molti anni responsabile dell’Archivio Comunale, il dipinto avrebbe dovuto raffigurare il Canonico Domenico Sensi (Viterbo 1805-Corneto 1880), già Arcidiacono della Cattedrale di Corneto. Ultimamente però, ottenuta la fotografia di questo Prelato, per gentile concessione dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma, e fatti i dovuti confronti, è da escludere qualsiasi somiglianza tra questo volto ed il ritratto dell’archivio. 10) Il manoscritto, già nell’Archivio Falzacappa, è ora visibile nell’Archivio della S.T.A.S. 11) Questa tela alla voce 3 di un “Elenco” è annotata: “Ritratto a mezzo busto di D.O. Petrosellini con cornice”. Nel 1916 la tela è consegnata dal Comune di Corneto-Tarquinia al Ministero della P.I. a firma G. Cultrera e C. Palma. Negli “Inventari” del 1947 e 1970, fatti compilare dalla Soprintendenza alle Antichità per l’Etruria Meridionale, a firma M. Moretti, il quadro della Raccolta Comunale, alla voce 9 è così annotato: “Ritratto a mezzo busto di Domenico Ottavio Petrosellini. Misura senza cornice m. 0,62 x 0,50. Valore app.vo L. 1000”. 12) La tela, che differisce da quella della Raccolta Comunale per avere il personaggio i capelli meno bianchi, risulta così annotata nella scheda del Museo di Roma: “Anonimo; prima metà del XIX sec. tela dipinta ad olio 72 x 61, cornice dorata, raffigurante Domenico Ottavio Petrosellini, Magazzini di Palazzo Braschi (Museo di Roma)”. Secondo uno scritto del 1957, inviato al Sindaco di Tarquinia Sig. Bruno Blasi dal Sig. Luigi Petrosellini, parente del poeta, per ottenere nella toponomastica della Città l’intestazione di una via con il nome dei due Petrosellini, risulterebbe che il quadro conservato già nell’Accademia Arcadia di Roma, è opera eseguita ad olio nell’anno 1760. Inoltre, stando ad uno scritto del prof. Italo Faldi, apparso in “Tuscia” 1983, è probabile che il dipinto del Petrosellini sia opera del pittore Vincenzo Milione (1735? - Roma, 1805), operante nella seconda metà del XVIII secolo in Roma ed avente lo studio in via del Sudario.”.... di lui conosciamo solo ritratti, che dovette dipingere a iosa considerando i tanti che ad ogni piè sospinto è dato incontrare, prevalentemente (a parte i circa trenta di Arcadi eseguiti per l’Accademia dell’Arcadia su commissione del Principe Luigi Gonzaga di Castiglione, conservati nel Museo di Roma a Palazzo Braschi), di cardinali o alti prelati, ...). Il Faldi inoltre dice che certe ripetitività del Milione, nei personaggi raffigurati a mezzo busto “tenendo nella mano destra una lettera”, fanno “pensare che i ritratti fossero già impostati in precedenza in serie comprendenti non più di due o tre tipologie, in attesa del committente del quale aggiungere il volto”. Fino al 1979, anche nella Sala Capitolare della nostra Cattedrale era appeso un quadro di D.O. Petrosellini che, è annotato nell’”Inventario” della S. Visita fatta alla Chiesa Cattedrale nel 1934, come fotografia con cornice dorata “dono fatto al Capitolo dal Signor Crispino Mariani 13) . Per il Rev. D. Giovanni Felici, il quadro, citato anche in precedenti Visite Vescovili, sarebbe riconoscibile (come da fotografia mostratagli) con la tela del Seminario di Montefiascone e con quella che si trova nell’ufficio del Comandante i Vigili Urbani di Tarquinia. Riepilogando, e a conclusione di quanto già detto, ci troviamo di fronte a quattro quadri, dei quali due, quello del Seminario e quello già nell’Archivio, perfettamente uguali; quello in Arcadia e l’altro della Raccolta Comunale, identici tra loro. A questo punto però, ci si chiede quale sia il vero Domenico Ottavio Petrosellini. Oppure trattasi di due ritratti distinti di Giuseppe e Domenico Ottavio Petrosellini? E’ anche possibile che il quadro del Seminario di Montefiascone sia pervenuto in quella sede dalla “Collezione” di casa Mariani 14) , mentre quello, già nell’Archivio Comunale, sia una copia di quest’ultimo. Del resto, non fu Crispino Mariani che nel 1883 donò al Comune di Corneto le poesie inedite del Petrosellini, estratte dal tomo X d’Arcadia? (“Notizie” op. cit., p.12). E non fu lo stesso Mariani che donò il quadroritratto del Poeta al Capitolo della Cattedrale di Corneto? E poi chi meglio di Crispino Mariani era a conoscenza dell’opera letteraria del Poeta di Corneto, soprattutto per aver dato alle stampe quelle preziose “notizie” sull’Abate? Considerando ancora che il quadro dell’Archivio non ebbe a subire la stessa sorte di essere messo da parte insieme agli altri dipinti della Raccolta Comunale 15) , ma restò appeso per tanti anni alle pareti di quell’ufficio di rappresentanza del nostro Comune, è ovvio pensare che per rimanere in quel luogo, una valida ragione doveva pur esserci. Infatti, quale personaggio se non il Petrosellini poteva essere raffigurato in un dipinto da porsi nella sala dell’Archivio Comunale? Non potrei considerare completa questa mia ricerca congetturale se prima non esprimessi, fra le tante probabilità accennate, anche quella, non meno trascurabile, 13) “Inventario”, esibito in S. Visita fatta alla Chiesa Cattedrale di Tarquinia nel 1934 dal Vescovo Mons. Luigi Drago e redatto dal Segretario capitolare D. Carlo Scoponi. 14) Per tutto l’arco dell’800 fino ai tempi nostri, nella Casa Mariani furono conservati molti dipinti che raffiguravano grandi personaggi di Corneto. 15) Il dipinto dell’Archivio, a differenza di tutti gli altri quadri della Raccolta Comunale, non è mai stato annotato negli “Inventari” fatti preparare dal Comune nelle prime decadi di questo secolo. Non sappiamo inoltre se il dipinto è annotato negli “Inventari Interni”, che certamente il Comune avrà fatto compilare. Nei vari archivi, dove attualmente sono conservate le pubblicazioni del Petrosellini, non si è riusciti a trovare alcuna sua effigie. Ciò avrebbe facilitato di molto il riconoscimento delle tele. della possibilità che le quattro tele in questione possano raffigurare la medesima effigie: quella del poeta D.O. Petrosellini. Infine, se il ritratto del D.O. Petrosellini è rimasto esposto nelle sale dell’Accademia Arcadia per molti anni, ciò è avvenuto soltanto perché l’Accademia era certa che quella tela raffigurava Petrosellini. Si può sostenere questo ragionamento anche per il ritratto del Petrosellini che si trova nel Seminario di Montefiascone, soprattutto se si prendono in considerazione gli scritti del Bergamaschi e le dichiarazioni rilasciate dall’ex Rettore del Seminario. Lorenzo Balduini BIBLIOGRAFIA - “Libro dei Battesimi”, dal 1663 al 1698, (ms) presso l’Archivio della chiesa di S. - Giovanni Battista di Tarquinia. “Libro dei Matrimoni”, dal 1663 al 1726, (ms) presso l’Archivio della chiesa di S. - Giovanni Battista di Tarquinia. “Libro dei Battesimi”, dal 1699 al 1759, (ms.) presso l’Archivio della chiesa di S. - Giovanni Battista di Tarquinia. “Libro dei Battesimi”, dal 1727 al 1735, (ms.) presso l’Archivio della Cattedrale di - Tarquinia. “Libro dei Battesimi” (ms.) presso l’Archivio della Cattedrale già nell’Archivio della Chiesa di S. Pancrazio M. di Corneto. ANONIMO, “Saggio o Cenni Brevissimi sull’Antichità e Pregi della Città di Corneto”, Corneto, 1839, (ms) nell’Archivio della S.T.A.S., già nell’archivio Falzacappa. ANONIMO, “Famiglie Diverse Cornetane”, - Petrosellini -, (ms) nell’Archivio della S.T.A.S., già nell’archivio Falzacappa. G. ROMAGNOLI, “Elogio Funebre al card. Angelo Quaglia”, Roma, 1872, pp. 1920. L. DASTI, “Notizie Storico Archeologiche di Tarquinia e Corneto”, Roma, 1878. C. MARIANI, “Notizie sull’Abate Domenico Ottavio Petrosellini”, Roma, 1890. C. MARIANI, “Canzoni”, dell’Abate Domenico Ottavio Petrosellini, pubblicate nel 2. Centenario di Arcadia dal suo concittadino Crispino Mariani, Roma, 1890. D.O. PETROSELLINI “Il Giammaria”, Corneto-Tarquinia, 1892. P. BERGAMASCHI, “Vita del Servo di Dio Card. Marc’Antonio Barbarigo. Vescovo di Montefiascone e Corneto”, vol. I, Roma, 1919. G. NATALI, “Il Settecento”, IV Ediz., parte II, Vallardi Ed. Milano. “Lettera del Sig. Petrosellini Luigi al Sindaco di Tarquinia”, Roma, 4 dicembre 1957 (A.S.C., F. 10, cl. 1, 1951) “Rimembranza Storica”. D. C. SCOPONI, “S. Visita fatta alla chiesa Cattedrale di Tarquinia da Mons. Luigi Drago”, 1934 (ms.) “Inventario” presso l’Archivio della Cattedrale di Tarquinia. “Dizionario enciclopedico italiano”, vol. IX, Roma, 1958, p. 331. “Inventari” del 1947 e 1970, nell’Archivio del Comune di Tarquinia, (Cat. 5, classe 1, fasc. 1, 1970). M. POLIDORI, “Croniche di Corneto”, a cura di A. R. Moschetti, Tarquinia, 1977. “Scheda” del dipinto raffigurante D.O. Petrosellini, presso l’Archivio dell’Accademia Arcadia in Roma. “Scheda” del dipinto raffigurante D.O. Petrosellini, presso l’Archivio di Palazzo Braschi (Museo di Roma). Fotografia del Canonico Domenico Sensi, presso l’Archivio Fotografico dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma. “Il Procaccia”, a cura di M. Brandi, P. Ceccarini, L.M. Perotti, Tarquinia, I. FALDI, pp. 1983, n. 9, pp. 1-5. “Vicedomino Videcomini il papa di un giorno”, in “Tuscia” 1983, n. 31, 32-33. Una tela dei “SETTE FONDATORI ORDINE SERVI DI MARIA” nella “RACCOLTA CIVICA”. A distanza di alcuni anni, da quando cioè fui chiamato per preventivare un restauro di alcune tele della “Raccolta Civica”, solo oggi ho avuto la possibilità di rivedere quelle opere che, rimaste per tanto tempo dimenticare nel più completo abbandono in ambienti di Palazzo Vitelleschi, sono di recente ritornate a Tarquinia, dopo aver subito un ottimo e provvidenziale restauro scientifico da parte del “Laboratorio di Restauro della provincia di Viterbo”. Il mio interesse nel rivedere le tele si ferma su alcune, ed in modo particolare su di una tela che forse un tempo aveva fatto bella mostra sugli altari di qualche chiesa officiata dai monaci dell’Ordine “Servi di Maria” nella città di Corneto. Da quel che mi risulta sapere, a proposito di questa tela, dirò che essa fu rinvenuta e consegnata al prof. Cultrera, (allora direttore del nostro museo), dal portiere della Scuola Comunale Sig. Angelo Cervellini, come si può constatare da una ricevuta (A.S.C., Cat. 9, cl. 8.F.1.), nella quale è detto: “Dichiaro di aver preso in consegna dal portiere della Scuola Comunale Sig. Angelo Cervellini, una tela con cornice dorata, rappresentante sette frati, di cui uno che sembra il superiore, con un libro aperto sulle ginocchia. Tarquinia, 24 novembre 1923. Giuseppe Cultrera”. La scuola citata nella ricevuta del Cultrera è da individuarsi nell’attuale Scuola Media, un tempo monastero Agostiniano O.S.A., dove il Cervellini svolse per parecchi anni la sua mansione di portiere abbinandola con l’attività di ciabattino che faceva durante le pause del suo lavoro. Il quadro descritto nella ricevuta può riconoscersi in quello che oggi fa parte della “Raccolta Civica”, anche se la misura attuale della tela, di cm. 94,4 x 138, sia leggermente aumentata rispetto a quella già conosciuta prima dell’intervento di restauro. Questa tela, dipinta ad olio, con molta probabilità è stata commissionata dai Servi di Maria ad artista che la dipinse circa la seconda metà del XVII secolo, e che per l’esattezza rappresenta “I SETTE FONDATORI ORDINE SERVI DI MARIA”. Da un “Inventario” della chiesa di Valverde (A.S.C., 1744, p. 45), sembra che un quadro, raffigurante i Sette Santi Fondatori, era “situato in mezzo al Coro” sotto di cui vi era collocato un Crocifisso. Non sappiamo però con esattezza se il quadro del Coro di Valverde sia lo stesso ritrovato nella scuola Comunale. Inoltre, questi “Inventari” non parlano di altri quadri con simile denominazione; anche da quelli comunali si ricava poco o nulla. Un’identica copia della tela di Tarquinia, la possiamo vedere affrescata nelle pareti dell’Abbazia di Praglia (ex convento dei “Servi”). “Si tratta di opera che dal punto di vista stilistico è ascrivibile alla seconda metà del ‘600, di artista padovano. Rappresenta i Sette Fondatori nell’atto di professare la Regola di S. Agostino: S. Bonfiglio 1) è seduto, con sulle ginocchia un libro aperto (la Regola di S. Agostino), e gli altri sono inginocchiati intorno” (P.M. Branchesi, “Il Servo di Maria”, n.1.2,, 1983, p.23). L’affresco di Praglia, e la tela della Collezione Comunale hanno una identica eccezionale iconografia e sono realizzate cromaticamente con toni bruno-ocra, anche se nella tela di Tarquinia è evidente una colorazione un po' più fredda di quella dell’affresco. Rimane pertanto uguale nelle due opere la disposizione dei monaci nell’interno dell’ambiente, mentre nella veduta di un esterno, attraverso una piccola loggia, l’architettura e le figurine che vi appaiono, sono leggermente diverse nei due dipinti. Come questa tela sia finita nel monastero degli Agostiniani non ci è dato conoscere, sappiamo solo che tale quadro, (forse per l’insolita iconografia) rappresenta, secondo esperti dell’Ordine dei “Servi”, un qualcosa di molto interessante e perciò non trascurabile, sia dal punto di vista della conservazione, che da quello storicoambientale, tenendo anche in considerazione che la presenza e le vicende in Corneto dei Servi di Maria si protrassero ininterrottamente per circa quattro secoli. Lorenzo Balduini IL SOFA’ DELLE MUSE Sull’estrema rampa di via delle Croci, nel cuore della Clementina, a lato di un cedimento geologico, esisteva un sedile, scavato nella viva roccia da non si sa bene chi; ma da qualcuno che aveva la capacità di modificarne la durezza modellandovi una spalliera un po' mossa, alla Luigi Filippo. Sarebbe dovuto servire probabilmente alla sosta di chi, in passato, si portava su quella salita, detta appunto delle Croci, dove i nostri padri seguivano le sacre rappresentazioni di Pasqua che avevano il merito di muovere a pietà il cuore degli uomini, indurito dalla miscredenza e dalle correnti di pensiero che cominciarono a serpeggiare, dopo la Riforma, in ogni strato sociale d’Europa e del mondo. Quella salita dunque stava lì a rammentare le tre cadute di Nostro Signore sotto il legno della croce, ancor prima che la dolorosa vicenda del Venerdì Santo si concludesse sul campo detto del Calvario. Ed è 1) S. Bonfiglio Monaldi (Firenze, 1198-1262), è uno dei Sette Santi Fondatori e primo Generale dell’Ordine Servi di Maria. facilmente immaginabile l’effetto che tutta quella messa in scena poteva esercitare sull’animo del popolo fedele. Ebbene, quel sedile venne battezzato da alcuni buontemponi che fra le due guerre rappresentarono la punta avanzata della cultura locale, con la più curiosa delle invenzioni: il Sofà delle Muse, quando già le Muse, per rivelazione di Leonardo Sinisgalli, non dimoravano più sul Parnaso così come ce le proponeva il telone del Teatro Comunale, ma appollaiate sui rami delle querce a mangiar ghiande e coccole. Ma più che un’invenzione, fu il plagio di una rubrica letteraria allora in voga su di un periodico del tempo, che il sor Ernesto Braghetti, con un pizzico di civetteria, volle compiere per dimostrare di essere a ragione il depositario della coltura. Data l’esposizione del sito, era consigliabile andarci d’estate, per appuntamento, a rifiatare sul tardo pomeriggio il ponentino; perché d’inverno e nelle stagioni più mutevoli, ci tenzonava sopra l’intiera progenie eolica. Per cui la maggior parte dell’anno ci si incontrava in zone più a riparo e prossime all’abitato, come Porta Firenze, per ripetere il mezzo giro della Circonvallazione, sotto le mura, così come accadeva nell’inferno dantesco ai prodighi e agli avari. Perché raggiunto il limite oltre il quale s’annidavano gli spifferi più insolenti, si girava e rigirava sotto l’imperio del sor Ernesto che su tutta quella brigata aveva la maggiore ascendenza. Lo si vedeva spuntare, non prima delle undici antimeridiane, su piazza Cavour, sempre elegantemente vestito con una delle tante lobbie, e un vecchio giornale in mano arrotolato, per dare inizio alle quotidiane deambulazioni. Si discorreva di tutto quel che stava accadendo o era già accaduto in paese e fuori, naturalmente con il senno del poi: e si finiva col parlare di giornalismo, di letteratura, ma soprattutto di musica. Su Giuseppe Verdi e sul discusso “un pa pa” dei suoi accompagnamenti orchestrali, il sor Ernesto tagliava corto, col ricorrere a quella canzone che Gabriele d’Annunzio, pronunciò in morte del Cigno di Busseto che “pianse ed amò per tutti”. Sentenze simili erano di suggello a qualsiasi disputa. Cosicché il discorso poteva poi deviare da parte dell’uno sulla dolcezza del proprio apparecchio radiofonico o intorno alla capacità interpretativa dei cantanti: o da parte dell’avvocato Latino Latini che, per avere una voce di basso profondo, si privilegiava di aver cantato addirittura col baritono De Luca di passaggio un giorno a Tarquinia non so bene in quale circostanza. Se lo si trovava in vena di esibizione, si metteva a cantare l’aria dal “Don Carlos” che era il suo cavallo di battaglia. Ma forse l’età o una naturale distorsione del timbro vocale, più che di un cavallo doveva trattarsi di un vero e proprio ronzino. Non è improbabile una sua partecipazione a un ruolo secondario nelle compagnie dei guitti che, alle stagioni morte, venivano a svernare a Corneto che vantava allora un efficiente teatro comunale. Bastavano due modestissime voci, tenore e soprano, per rimediare “in loco” comprimari, comparse, coristi; mentre per i musicanti dell’orchestra c’era la riserva delle due bande rivali, la Rossa e la Nera, che si riconciliavano soltanto in quelle occasioni. Si raccontava in proposito che, in una edizione della “Favorita”, un basso dilettante, dovendo recitarre in canto la frase “Sire che mai fu? La corte v’attende”, su quel fu, preso in piena profondità vocale e sul quale nemmeno Donizetti aveva creduto di collocare una mezza corona, il direttore d’orchestra dovette per ben tre volte abbassare la bacchetta per por termine a quel fu che tacque sol quando si svuotò la cassa toracica dell’interprete. E l’avvocato Latini, per statura e peso, avrebbe potuto benissimo rappresentare quel comprimario, sia per vanità che per passione. In quel teatro scomparso, come tante cose nobili di questo paese, si avvicendarono, secondo il sor Ernesto, molti attori di prosa, fra cui Giacinta Pezzana. Io ricordo di avervi visto recitare dal loggione, insieme ai miei genitori che nonostante la loro condizione culturale mi recavano di tanto in tanto a teatro, un drammone la cui interprete non faceva che entrare ed uscire di scena per lamentarsi della scomparsa di qualcheduno che era effigiato in un quadro che si portava continuamente dietro. Ma più m’incuriosiva il sorprendere nell’occhiaia di una maschera in mano a una Musa del telone, la mobilità dello sguardo del capocomico che ammiccava con brevi intervalli per accertare gli umori e l’entità del pubblico. Intorno ai fatti letterari, il più aggiornato era senza dubbio il sor Ernesto, grazie ad una personale corrispondenza con Vincenzo Cardarelli: cose che se lo inorgogliva, non lo faceva discostare di un et dalla stima e dalla venerazione per il poeta-soldato d’Annunzio della cui opera omnia aveva riempito la sua libreria. Non so se in omaggio a d’Annunzio si era fatto fotografare, per un giovanile peccato di presunzione, in un galoppatoio, vestito alla Sperelli o nella foggia di qualche altro eroe dannunziano. Riguardo a queste radicate preferenze che erano, nei confronti con Cardarelli, come il diavolo e l’acqua santa, egli finiva sempre col dare a Cesare quel che era di Cesare e a Dio quel che era di Dio. Non ammetteva confronti e tanto meno discussioni non so se per incapacità critica o per partito preso. Perché, a dire il vero, egli veniva sempre più diventando l’elemento catalizzatore attorno a cui finivano per gravitare tutte le persone che riteneva di prestigio e di utilità alla comitiva tutta. E tutti lo degnavano di rispetto e considerazione così come accadeva una volta nelle arcaiche famiglie contadine. Non perché ne avesse qualche provenienza, ma una certa esperienza specie nel modo di prevedere le variazioni del clima nelle quattro stagioni: se sarebbe piovuto o venuta la secca, come i venti avrebbero spirato, a seconda se la luna s’affacciava a ponente oppure a levante, se il sole calava rosso la sera o se il maestrale si faceva cavalcare dalla tramontana. Insomma sapeva dare gli appuntamenti più acconci senza venir mai meno alle sue vedute metereologiche, con più esperienza dei cacciatori maremmani che si bagnano di bava l’indice di una mano prima di esporlo all’aria per vaticinare il tempo. Ma questa sua capacità nessuno sospettava che gli derivasse dalla posizione della sua camera da letto da cui poteva comodamente vedere sulla torre del Municipio la direzione della banderuola. Fra le varie dispute, non è che non si affacciasse qualche conversazione politica, specie dopo la campagna etiopica e la conquista dell’Impero; oppure in piena guerra di Spagna o in previsione di quella che poi si sarebbe scatenata, con qualche accenno di critica, ma sempre al riparo da orecchie sospette. Tutto questo però non esonerava nessuno dalle adunanze di ogni sabato fascista dov’era d’obbligo la “cimicia” all’occhiello e la camicia nera. Altrimenti come sarebbe stato possibile al sor Ernesto esercitare, senza intralci, il commercio-monopolio dei prodotti caseari che variavano dal cacio pecorino alla vera ricotta romana che puntualmente ogni giorno venivano spediti per ferrovia a grande velocità verso Milano? Grazie al quale egli si poteva permettere, con un fratello in sott’ordine, una vita agiata e senza scossoni di sorta. Chi se la rideva di tutti e di tutto era il dottor Giuseppe Bellati, medico condotto in pensione, specie quando l’avvocato Latini si presentava nel gruppo di tarda mattina per spulciare dal suo taccuino unito e scucito una delle rarità o stravaganze linguistiche, racimolte chissà dove. E le discussioni erano infinite quando non ci si arenava di fronte alla scarsa conoscenza del greco e del latino che i due vantavano di aver studiato in epoche giovanili. Tanto che ogni membro, una volta che veniva a trovarsi fra le mani una parola scorbutica e antiquata, se la segnava per farne motivo di sfida e dibattito. Ma il sor Ernesto, sotto il gesto imperioso della sua mano, trovava sempre modo di collocare la ragione dalla parte giusta con l’agitare le bellissime mani, curate a dovere, con le unghie ampie e convesse come ghiande mature: il che dava modo all’avvocato Latini di intravedervi un segno nefasto, non so dire se suggerito dall’invidia di avere le proprie come quelle di un norcino. Fatto sta che il sor Ernesto cadde un pomeriggio d’estate sulla strada che più frequentava, nei pressi del Sofà delle Muse, senza portar a termine il discorso che aveva appena iniziato. Quando l’adagiarono sul lettino del pronto soccorso all’Ospedale, era già morto. E vederlo così in disordine da quella sua maniera abbottonatissima nel vestire, con la camicia aperta sul petto da dove spuntava un foglio di giornale (se l’era messo a protezione di un presunto dolore reumatico) e con i capelli rovesciati all’indietro che lui riusciva, quasi per magia, a portare sul davanti dalla nuca per mascherare la calvizie, ebbi la medesima impressione che subivo nel leggere di monatti e di camere mortuarie dove il mestiere faceva venir meno anche il rispetto. Certo è che se il dottor Bellati non l’avesse preceduto di qualche tempo, lo avrebbe messo in guardia da quella fine così inaspettata e improvvisa. Quando nelle buone giornate m’incammino verso quelle zone un po' fuori dell’abitato, anche se il Sofà delle Muse ha dovuto dar luogo alle esigenze della moderna edilizia, non riesco a dimenticare tutti quei personaggi che mi furono vicini nel tempo della mia giovinezza e tutte le vicende che ebbero protagonisti personaggi come il sor Ernesto, il dottor Bellati e l’avvocato Latini; e se oggi ne scrivo, è per una memoria da tramandare, dato che la sorte aveva negato loro ogni successione di prole. Uno degli ultimi ma fedelissimo frequentatore fu un tal pensionato delle ferrovie, certo Baldacchini, che aveva una vasta conoscenza del potenziometro, un accessorio, a quanto pareva, assai importante per il buon funzionamento degli apparecchi telefonici. La sua piccola statura, una pronuncia quasi nasale come di eterno raffreddato che gli faceva pronunciare “potezziometro”, era di generale utilità. Tanto che don Vincenzo Galano, parroco di san Giovanni, salito quassù in Maremma dal salernitano, lo appellava spesso col nome di “radiologo”; e con la stessa facilità con cui chiamava Vittoria la Sonnambula, la verduraia, “Vittoria verd’o mare”, o come consigliava le sue anime a non esporsi d’estate al sole perché avrebbero potuto contrarre la “pleurita”, fatale porta d’accesso alla “tubercolotica”. Ma a don Vincenzo, per rispetto anche al suo abito talare, non si facevano pesare queste ed altre improprietà linguistiche, nemmeno quando, dovendo far trascrivere all’ufficio di stato civile la nascita di un neonato, fece notare al funzionario che il genitore, essendo maschio, non poteva essere “geometra”, ma “geometro”. E così via. Di tutte queste cose l’avvocato Latini prendeva nota nel suo taccuino per poi farne motivo d’imitazione quando tutti si radunavano per le tradizionali merende estive, fatte in casa sua per consumare il pollo alla “Caraffa” (cuoco e funzionario-disegnatore della Soprintendenza ai Monumenti) o all’orto-giardino del notaro Sconocchia, in fondo all’Alberata, oppure a mangiare la “panzanella” nel fondo rustico di Valentino Boni, nella zona di Montarozzi, che in aperta campagna e in luogo appartato, acquistava un sapore inenarrabile. Qui, nonostante il pane fosse abbondantemente inzuppato e condito, si vuotavano fiaschi e bottiglioni di vino casareccio che il buon anfitrione metteva a disposizione della comitiva. Di queste pappate, io venivo a conoscenza nelle discussioni postume perché non venni mai ritenuto in grado, forse per la mia giovane età, di parteciparvi. Ed era il giorno che anche padre Bartolomeo Pucci, francescano, veniva ammesso a quelle cerimonie manducatorie, lui che aveva consumato gli occhi a tradurre dal latino l’Eneide di Virgilio in versi endecasillabi, sempre nella speranza che qualcuno un giorno o l’altro si ricordasse di questa sua enorme fatica di Sisifo. Era alto come uno stollo, corpacciuto, con una voce cavernosa che rideva a sbalzi e con lo sguardo rimpicciolito dietro due lenti più spesse di un culo di bicchiere. Era un sant’uomo, al punto che la notte veniva svegliato e infastidito da anime in pena per le quali egli pregava perché trovassero pace nel mondo dei più, ma dessero pace a lui nel mondo dei meno. Di fronte a questa sua disponibilità e per la miriade di spiriti che aspettavano la proverbiale goccia d’acqua come il ricco Epulone, era naturale che le anime dei trapassati non gli dessero un momento di tregua, nemmeno la notte. Ma lui ridacchiava e cercava di spiegare tutto con la bonomia e la sua grande bontà. E ridacchiava senza ombra di malizia anche di un altro membro della comitiva che, a causa della sua scarsissima cultura, cercava, senza successo ed in ogni occasione, d’intromettersi nelle dispute etimologiche. Una volta che costui se ne stava ad ascoltare di certe vicende che accadevano in Corsica contro le nostre truppe da sbarco, non appena caduta la Francia, se ne sortì crucciato con questa battuta: “Ma guarda che ti vanno a combinare questi corsari!” “La risata, anche se sommessa, fu generale: “Lo so, lo so. Avrei dovuto dire questi corsicani! “Ma la risata fu più rumorosa, anche se sempre inferiore all’ilarità che avrebbe dovuto suggerire. Se la segnò al dito e medità una vendetta. Un giorno si presentò con questo quesito. “Vediamo se sapete dirmi cosa significa Luna Park”. Tutti cercarono di dare la più logica delle spiegazioni. Ma lui, orgoglioso di aver trovato tutti impreparati, seguitava a sorridere sornione e a negare con il movimento del capo dicendo: “Ah, questa volta vi ci ho pizzicato! “Alla fine dette la stura al suo sapere sentenziando: “Luna Park vuol dire luna morta!” - E perché?” - ripresero tutti in coro. - “Perché le Parche erano le dee della morte”. C’era stata evidentemente qualche confusione di troppo. In quel periodo in cui al “Circolo Tarquinia” s’erano infiltrati, grazie alla politica del “largo ai giovani”, nuovi elementi perturbatori del tran tran della paciosa borghesia cornetana, il sor Ernesto aveva lasciato quel ritrovo, concedendosi maggiore libertà di passeggiare all’aperto e nei luoghi più vari, forse per parlare o mormorare liberamente su alla Clementina d’estate, sulla Circonvallazione nelle stagioni di mezzo, e lungo la strada della Gabelletta quando soffiava la tramontana di “bon core” che a Tarquinia la fa da padrona” per tre o sei o nove”. Insomma tutta una strategia peripatetica che avrebbe dovuto consentire alla comitiva una vita lunga e altrettanto beata. Intorno alla musica lirica, più di ogni altro manifestava un fornaretto del posto che, dopo ogni concerto radiofonico del lunedì sera offerto dalla Martini e Rossi, raggiungeva il gruppo sulla tarda mattinata. Con una voce da tenorino di grazia, accennava sempre a motivi musicali senza tralasciare giudizi sui cantanti che avevano partecipato a quel concerto; ed i pareri erano sempre i più discordi, perché facevano testo i mostri sacri della lirica che erano allora Giacomo Lauri Volpi, Beniamino Gigli, Tito Schipa, Aureliano Pertile e Galliano Masini. Tutto il resto non aveva senso per cui si storceva la bocca di fronte a qualche altra voce giovane che cominciava ad apparire sull’orizzonte del teatro italiano. I do di petto avevano sempre qualche ombra di velatura o di distorsione o di calata, con quella meticolosità che nemmeno i critici più avveduti si permettevano di mettere in discussione. Il sor Ernesto, quando lo vedeva spuntare di tra gli alberi del viale, sottovoce e ridanciano borbottava: “Ecco buciardella! a causa di un racconto che lo stesso aveva fatto un giorno che aveva partecipato ad un raduno combattentistico a Milano dov’era riuscito ad enumerare nientedimeno che mille bandiere e una. Su quell’una, cadde il sospetto che si trattasse di un’esagerazione che poteva sconfinare in una vera e propria bugia. Ma nonostante tutto, regnava sempre la più assoluta concordia, specie quando l’avvocato Latini si metteva ad imitare l’andatura di un certo vinaio di Bagnaia che aveva tutto un modo proprio di incedere quando veniva a Tarquinia a piazzare il suo prodotto vinicolo che aveva il pregio di non far male per via che a Bagnaia l’acqua è assai leggera e diuretica. Quando tuonò il primo colpo di cannone e l’Italia venne avvolta nel velo buio dell’oscuramento totale, tutti si preoccuparono di non farsi trovare a corto di alimenti. E fu la volta che l’avvocato Latini, senza chiedere consiglio a chi ne sapeva più di lui, acquistò da certi contadini cinque quintali di patate e una mezza dozzina di prosciutti, fra cosci e spallette, nascosta segretamente all’interno della sua cantina. Accadde però che le patate, nell’umidità del disotto, “ricicciarono”, il che ne comprometteva la commestibilità. E fu d’uopo trovare qualche acquirente prima che la merce deperisse. Chi entrò a far contrattare e portar via, non poté fare a meno di vedere appesa al soffitto quella mezza dozzina di prosciutti. La cosa si venne a sapere: e fu il sor Ernesto che un giorno, presente lo stesso avvocato Latini, accennò ad un certo concerto di un sestetto d’archi che aveva ascoltato passando sotto le finestre di un certo palazzo in via del Duomo. L’allusione era chiara, ma l’avvocato fece orecchio da mercante. Tanto che il sor Ernesto si permise di rimproverargli la sua furba quanto ingenua capacità di saper provvedere in eccesso e mai in difetto, riguardo alle patate. Ma la guerra era la guerra e ciascuno cercava di industriarsi secondo le proprie capacità e necessità. Don Vincenzo Galano, un po' per l’età ma più per deficienza organizzativa, finì con l’essere accolto nella famiglia dei frati francescani. Per cui si rese disponibile alla comunità con l’esercitare la funzione di cappellano all’Ospedale Civile. Perdurando la tragica divisione dell’Italia a causa della linea gotica, le Suore dell’Ospedale, settentrionali per la totalità, non ebbero più notizie nè dalla loro Casa Madre di Torino, nè dalle loro famiglie. Tanto che un giorno, la Superiora, confidandosi con lui per avere una parola di conforto ed uno spiraglio di speranza, gli chiese a bruciapelo: “Cosa ne pensa lei, reverendo padre?” Don Vincenzo che aveva nell’aspetto e nell’ironia una notevole rassomiglianza con Angelo Musco, accusò il colpo, ma immediata fu la sua risposta: “E lei, cosa ne penzate, reverenta Madre? La conversazione terminò lì. Nè ebbe ulteriore seguito. Un bel giorno Cardarelli scrisse a Braghetti che sarebbe arrivato a Tarquinia per passarvi un paio di giorni con due suoi amici, Cesare Zavattini e Giuseppe Cesetti. Perciò provvedesse all’albergo per tutti, ma più specialmente per lui che desiderava la solita camera nella locanda della “sora” Olimpia, a mezzogiorno e con la porta vicino al gabinetto. Per gli altri due lasciava all’amico la più ampia scelta nel modo di provvedervi. Ma gli alberghi a Tarquinia non c’erano e fu necessario trovare una camera a due letti in casa di un amico comune. Il sor Ernesto si mobilitò per la cena in casa propria che dovette essere abbastanza gustosa se gli ospiti si trattennero presso di lui fino alle ore piccole. Al momento di andare a letto, Zavattini e Cesetti non fecero che ridere per tutta la notte per i ronfi e le strombazzate di culo che, con crescendo rossiniano, filtravano attraverso una porta divisoria fra le due camere, da parte del proprietario dell’appartamento. Di tutto questo se ne parlò e rise ancora per tutto il giorno dopo, se non altro per allietare la giornata a Zavattini che, nel corso della visita al Museo e alle Tombe Etrusche, si dimostrava indifferente e annoiato. Di ciò il sor Ernesto restò sgomento per il fatto che la sua conoscenza con uomini di così celebrata notorietà dovesse rimaner offuscata da quel tristo e sconveniente ricordo. E di tutte queste faccende non se ne interessò mai più, anche perché il fratello, insieme ad altri, venne coinvolto in una vicenda giudiziaria che lo voleva complice di un atto di sabotaggio politico. Era accaduto che a causa dei bombardamenti su Napoli, fosse arrivato l’ordine di provvedere alla mattanza di qualche migliaio di abbacchi da spedire a grande velocità nella città partenopea. Il fratello di Braghetti, per una sua capacità professionale, il veterinario e un macellaio del posto provvidero alla mattanza, alla visita sanitaria ed alla spedizione in vagoni appositamente approntati per l’immediato inoltro. I vagoni, purtroppo, chissà per quali misteriosi intrighi che non vennero mai chiariti, vennero lasciati per due o tre giorni in un binario morto dello scalo ferroviario di San Lorenzo in Roma: quando arrivarono a Napoli, il fetore era tale che fu necessario bruciare tutta quella carne in momenti in cui la gente moriva di fame. Bisognò trovare un capro espiatorio. E i tre vennero arrestati, processati per direttissima e destinati a domicilio coatto, chi ad Assisi, chi a Montalto di Castro e chi altrove. Tutta questa vicenda pesò molto sull’animo del sor Ernesto che chiese aiuto a Cardarelli perché, grazie alle sue conoscenze, potesse trovare qualche personalità che facesse giustizia a questi tre poveri cristi che in verità non avevano né colpa né meriti. Ma il sor Ernesto per il fatto che era stato precettato presso l’ufficio comunale dell’ammasso granario e per una sua impratica disponibilità, non si mosse da casa e il fratello dovette scontare il confino fino a quando il Fascismo cadde ed i perseguitati politici poterono far ritorno alle loro case. Ma cadde anche l’amicizia con Vincenzo Cardarelli che s’incrinò definitivamente. Fu così che ad uno ad uno, tutti quelli della brigata scomparvero ed i superstiti, dopo la tragedia della guerra e la durezza dei cuori a causa delle privazioni, delle rovine, dei disagi, finirono per dimenticare quel Sofà delle Muse che rimase per qualche anno sulla strada delle Croci, senza più che uno vi si sedesse per riprendere il discorso interrotto così bruscamente dalla guerra. Ognuno cercò di salvaguardare se stesso e la propria famiglia; e le compagnie si dispersero vieppiù. L’ultimo ad andarsene fu l’avvocato Latini. Ricordo ancora la mestizia, anche se un po' superficiale, che mi dimostrò durante il funerale del sor Ernesto, con il cappello in mano, e fortemente turbato di essere l’ultimo superstite di quella allegra brigata. Il Sofà delle Muse non rappresentò più di un bisogno di riposo a chi vi passava accanto, perché venne a mancare il piacere di camminare a piedi; mentre nessuno riuscì a frenare l’espansione edilizia che tutto livella per costruire enormi alveari dove, al contrario, di quel che avviene fra le api, nessuno conosce il suo vicino di casa. Sono i tempi o meglio i segni dei tempi. E se scriviamo oggi di queste cose del passato, è perché ci piace rivivere quei momenti della nostra giovinezza e lasciare, se il Signore e gli uomini vorranno, la testimonianza di chi ha calcato prima di noi le strade di questo nostro paese che tutti cominciamo ad amare e rispettare sol quando avvertiamo vicino il passo sordo della Morte. Bruno Blasi BREVE STORIA DEL TEATRO DEL PUBBLICO PALAZZO OVVERTO DEL TEATRO COMUNALE DI TARQUINIA Il Palazzo Municipale di Tarquinia si trova sulla piazza chiamata un tempo Piazza Nazionale ed è uno degli edifici più antichi del paese. Sia l’Apollonj Ghetti che la Raspi Serra 1) attribuiscono la data della sua costruzione ai secoli XII-XVI. Il Palazzo constava di un piano terreno e due superiori al nord, e di un piano terreno e tre piani al sud. Le sue linee architettoniche sono state in gran parte mutate a causa di posteriori riparazioni e “appiccicature” come le chiama il La Valle. Si ha notizia di questo Palazzo 2) nel manoscritto esistente in Viterbo presso il conte Giovanni Pagliacci, intitolato: - Ricordi di casa Sacchi - che parte dal 1297. Esso contiene il seguente paragrafo scritto di pugno da Giovanni Sacchi: “1407. In questo anno del mese di luglio ed agosto fui fatto Confalonieri de la città di Corneto et feci rifar le mura di Corneto verso Viterbo, che, in gran parte, erano ruvinate. In quel tempo fecimo bonificar una parte del palazzo di esso Confalonier de’ Signori etc.” Lo stesso Dasti, nella descrizione delle parti più notevoli del Palazzo Municipale, dice che al centro di esso “è situato il Teatro Comunale”; e che pure nei secoli precedenti il Palazzo fosse adibito a Teatro, ci è data conferma 3) da un documento d’archivio 1) Joselita Raspi Serra, La Tuscia Romana, Milano 1972: Il Palazzo Comunale conserva, all’esterno, nella parte settentrionale, ancora le potenti strutture originali, mentre sulla facciata meridionale rimangono cornici di arco con decorazioni a bugne stellate. All’interno rimane un ampio salone chiuso da una capriata, delle strutture rimaste, attribuibile al XIV secolo”. 2) L. Dasti, Notizie storiche e archeologiche di Tarquinia e Corneto, Tarquinia 1910. 3) Registro del Consiglio 1567-1591, cons. del 5 gennaio 1567. dell’anno 1567 che dice: “che per qualche comodità alla commedia che si rappresenterà nel nostro Palazzo acciò che la si mostri con qualche magnificenza, suo parer è che se gli applichino lì diece scudi che deve l’appaltatore de nostri Molini di straordinario per le feste del Carnovale, et di più li sedici scudi che si devono ritener nelle provisioni et salarii del presente nostro sig. Commissario per le duo tazze d’argento de duo semestri ch’è quasi stato da noi et tutto si spenda accuratamente per servizio di dicta Comedia”. Di che tipo di Commedia si trattasse non ci è dato sapere ma deve essere stata importante ed interessante se il Consiglio aveva destinato ventisei scudi per mostrarla al pubblico “con qualche magnificenza”. Da altri documenti dell’anno 1607 4) : “Alli signori comici di Corneto... scudi... per le commedie che dovranno rappresentare in questo Carnevale nel Palazzo Pubblico conforme al solito”, si ricava che nel Palazzo Municipale le rappresentazioni teatrali comiche o tragiche (maggiormente comiche) si tenevano annualmente nel periodo del Carnevale con gran concorso di pubblico. In un documento del 1654 5) si parla di comici cornetani che hanno in pronto due bellissime commedie (proprie o altrui?) e chiedono sovvenzioni per la rappresentazione: “Li comici di Corneto umilissimi delle Signorie Vostre Illustrissime espongono havere in pronto due commedie bellissime per rappresentare questo presente Carnevale nel solito Palazzo della Comunità e perché vi è necessario per fare il palco et altre spese di qualche denaro supplicano le Signorie loro Illustrissime degnassi ordinare che venghi somministrato qualche poco di denaro che con quello deveno havere della gabbella del bollo possino supplire alla detta spesa, che il tutto riceveranno dalla benignità delle Signorie vostre obbligandosi il balio che si farà farlo restare per l’altrui anni nel modo che stava prima che il tutto ecc. ecc.”. Per tutto il 1600 e il 1700 il Palazzo continuò ad essere destinato a pubblico teatro dove furono fatte molteplici opere di restauro come si ricava dai Registri dei Consigli di vari anni: nel 1762 6) fu compiuto un restauro del Teatro per essere stato danneggiato durante la rinnovazione dei tetti e delle mura (a tal fine venivano destinati 400 scudi); nel 1765 7) fu deciso di impiegare il ricavato di un taglio di alberi nella costruzione e fabbrica del Teatro già incominciata; nel 1769 8) continua l’erogazione dei 400 scudi “a condizione però che, per il decorso di anno 20 a venire 4) Speculi 1607/1615 c. 117 recto. Fondo carte sparse 1654. 6) Reg. Cons. 1756-1764 c. 186 Cons. del 21 febbraio 1762. 7) Reg. Cons. 1765-1760 c. 5 cons. del 22 gennaio 1765. 8) Reg. Cons. 1765-1760 c. 139 cons. del 18 gennaio 1769. 5) dovesse rimanere sospesa e tolta dalla tabella l’uscita di annui scudi venti del cerchio carnevalesco”. Nell’anno 1772 9) con nuovi lavori si verifica un aumento del numero dei palchetti (peraltro già esistenti) che viene portato a sessanta per essere assegnati alle famiglie più cospicue di Corneto. Ed arriviamo al Febbraio del 1795, anno in cui il Consiglio delibera i provvedimenti da prendersi affinché siano salvate dalla rovina le famose scene del Bibiena 10) : “Molti sono stati i temperamenti presi della S. Congregazione del Buon Governo e da questo pubblico Consiglio, affinché le famose scene del Bibiena che noi abbiamo non andassero in ulteriore ruina: ma siccome tra li tanti stabilimenti fatti, niente si è posto in esecuzione, et il danno va sempre crescendo, sono di parere che questo pubblico Consiglio determini in quella guisa appunto, che stabilì il defunto Eminentissimo Lante già Prefetto della detta Sacra Congregazione in occasione della di lui personale visita fatta in questa città nell’anno 1762, cioè che gli scudi venti tabellati per il cerchio carnevalesco si erogassero nella costruzione del nuovo teatro, e però su lo stesso piede dico ancor’io, che nel futuro anno 1796 debbano incominciare a lasciarsi li suddetti scudi venti a benefizio del detto teatro e così continuare di anno in anno sino alla totale restaurazione delle scene, e compimento del medesimo”. “.... Il secondo (consulto) che riguarda l’erogazione delli scudi venti del cerchio a benefizio del pubblico teatro, riportò similmente voti favorevoli n. 14 e niuno contrario, e restò pienamente approvato”. Il Consiglio, dunque, decise di sottrarre venti scudi annui dalle spese del carnevale a beneficio del Teatro e per il restauro delle scene del Bibiena, e qui è doveroso soffermarci sul periodo storico in cui visse ed operò questa grande famiglia. Nel ‘600 in tutte le capitali europee trionfavano gli splendori delle scenografie ideate da pittori e scenotecnici italiani; nei teatri a palchetti, costruiti per la gioia delle classi ricche, venivano rappresentati spettacoli in prosa o in musica nei quali la parte visiva aveva quasi sopraffatto quella uditiva. Le messinscene barocche erano di una bellezza incomparabile e sbalordivano il pubblico che andava all’Opera più per vedere i trucchi, i meccanismi e i fulgori delle scene che per sentir cantare o recitare. A Parigi Giacomo Torelli di Fano (1608-1678) detto il “grande stregone”, arriva a fare quarantaquattro cambiamenti di scena in una sola opera 11) . E’ in questo periodo che nasce ed inizia la sua attività , che si svolgerà per quattro generazioni, la gloriosa 9) Reg. Cons. 1771-1777 c. 32 cons. del 16 febbraio 1772. Reg. Cons. 1791-1796 c. 168 cons. del 18 gennaio 1795. 11) S. D’Amico, Storia del Teatro, Milano 1968. 10) dinastia dei Bibiena (o Bibbiena; il loro vero nome era Galli ma rimasero denominati così per la loro provenienza da Bibbiena, cittadina del Casentino). Sappiamo che il fondatore fu Giovanni Maria Galli (1619-1665) e che con lui iniziò in famiglia l’arte della scenografia. I suoi figli furono: Maria Oriana, modesta pittrice e Francesco che lavorò in tutta Europa. Lo troviamo a Vienna, dove costruì un grande e magnifico teatro, a Verona per la costruzione del Teatro Filarmonico la cui soluzione dei palchi gradualmente salienti e sporgenti ed orientati tutti verso la scena restò fondamentale nella storia dell’edificio teatrale, e in Francia dove progettò il Teatro dell’Opera di Nancy 12) . Il più famoso dei figli di Giovanni Maria fu comunque Ferdinando (1657-1743). Allievo del Cignani, studiò prospettiva e architettura con Mauro Aldovrandini e Giacomo Antonio Mannini; lavorò alla corte di Francia per il famoso Rivani, macchinista di Luigi XIV quindi divenne architetto del Duca di Parma, Ranuccio Farnese, per il quale lavorò per ben diciotto anni e disegnò il celebre giardino di Colorno 13) . Ferdinando fu architetto e pittore famosissimo di decorazioni teatrali e perfezionò inoltre i meccanismi per mutare rapidamente le scene in teatro. Di lui ci restano due trattati: uno sull’archiettura civile e l’altro sulle prospettive. La fama europea gli derivò soprattutto dall’essere stato il teorico della scenografia opposta a quella tradizionale ad essa centrale; al centro delle sue scene, anziché uno sfondamento illusivo, si viene a creare un angolo dal quale si moltiplicano fughe e prospettive convergenti e divergenti dalla scena in infinite combinazioni. Le fortune delle scenografie di Ferdinando sono parallele alle esigenze del gusto del tempo che indulgeva alla spettacolarità fastosa e barocca 14) . La dinastia continuò con i figli di Ferdinando: Giovanni Maria che lavorò a Praga; Alessandro attivo a Mannheim e Giuseppe che lavorò come scenografo a Vienna nei teatri ma anche per cerimonie nuziali o funebri. Ultimo della serie Carlo, figlio di Giuseppe, grande apparatore e inventore di macchine teatrali di ogni genere. Questa grande dinastia di consumatissimi prospettici ed appassionati teorici continuò per tutto il ‘600 ed il ‘700 a diffondere nell’Europa intera la scenografia italiana 15) . La città di Corneto ebbe dunque la fortuna di avere nel suo teatro alcune scene di questa famosa famiglia ma, come si è visto, non si curava troppo di mantenerle in buono stato. 12) Dizionario di cognizioni utili di scienze, lettere e arti, Torino 1925. V. Golzio, Storia dell’Arte italiana (‘600 e ‘700) vol. IV tomo secondo. 14) V. Mariani, Enciclopedia dello spettacolo, Roma 1954-1965. 13) Altro non si sa né sul contenuto delle scene né delle opere nelle quali vennero impiegate. Durante il periodo napoleonico nell’anno 1802 16) , i documenti ci informano che nel teatro si continuavano a rappresentare spettacoli comici e drammatici e si davano feste da ballo; nel 1812 altre notizie interessanti 17) : furono fatte delle spese per mantenere le quattro mutazioni di scena che avevano i “cieli” rovinati nonché per l’illuminazione dei tre ordini di palchi, palcoscenico e quinte (illuminazione che veniva fatta con fiaccole ed andava controllata a vista per il pericolo continuo di incendi). Nel 1813, durante l’occupazione francese 18) , si parla di “praticare un solaio sopra lo scenario del Teatro per rendere più facile e variabile il meccanismo delle comiche decorazioni’. Si pone in opera anche una nuova scena che rappresentava un sotterraneo diviso in due parti ed un nuovo sipario, essendo il vecchio insufficiente. Questo sipario nuovo si alzava in senso verticale ed era molto bello; aveva dipinte sul panno delle scene raffiguranti Apollo con le nove Muse sul Parnaso, scene che erano costate 75 scudi. Il sipario rimase nel Teatro fino alla seconda guerra mondiale poi scomparve, probabilmente rubato da qualcuno. Nell’anno 1835 si fece la divisione 19) dei camerini per uomini e donne ed altri lavori generali di restauro come il mattonato sotto il palcoscenico, l’aggiustatura di alcune finestre e perfino della buca del suggeritore. Il tutto per 144 scudi. Furono anche ristrutturati i posti dell’orchestra, il che fa pensare che forse il Teatro possedesse una propria orchestra stabile. Nell’anno 1836 si esegue 20) la ristrutturazione totale di tutto il posto dell’orchestra, leggii e banchi compresi. Si mette in opera anche un altro scenario; il Comune appalta i lavori del palco al macchinista Materazzi e al pittore Scarabellotti che dipinge “un primo scenario raffigurante una camera fissa, ed un secondo raffigurante un bosco”. Nel 1840 viene eseguito il lavoro più grosso 21) : i pittori Tasca e Pasquini ridipingono tutto il soffitto e i parapetti dei palchi, dorature in oro zecchino comprese, per scudi 350. 15) F. Testi, La musica italiana nel ‘600 e nel ‘700, Milano 1970. Tit. 4, fasc. 20. 17) Tit. 4, fasc. 20. 18) Tit. 4, fasc. 20. 19) Tit. 4, fasc. 20. 20) Tit. 4, fasc. 20. 21) Tit. 4, fasc. 20. 16) Nel 1846 fu impiegato un operaio 22) fisso per l’accensione dei lampioni e il cambio delle scene, con carica di macchinista e illuminatore. E veniamo al 1853, anno in cui il Teatro Municipale fu dotato di un bel lampadario in cristallo che illuminava la platea. Questo era costituito da un fusto di ferro di sei palmi e mezzo, con sei catene dorate, lumi di ottone e applicazioni di pietre quadre, pendoli e gocce in cristallo 23) . Per altri trent’anni vengono fatte delle spese annuali di manutenzione pura e semplice e di miglioramento dell’illuminazione, ma nel 1884 la situazione del Teatro doveva esser molto peggiorata se si delibera 24) di demolire i palchi e la parte del tetto che li copre, lasciando soltanto il soffitto della platea. Il legname dei palchi demoliti viene venduto ed il ricavato distribuito ai palchettisti. Dal 1885 al 1893 sull’argomento Teatro manca il carteggio, si presuppone quindi un lungo periodo di inattività. Sul finire del secolo, nel 1893, si decide la ristrutturazione della sala con palcoscenico e la costruzione della nuova galleria (al posto dei palchi), secondo un progetto dell’ingegnere Camillo Grispini, utilizzando tra l’altro i fondi della disciolta Società Filodrammatica 25) . Il progetto viene approvato dal Genio Civile nel novembre del 1894 e con delibera del 16 settembre 1895 viene affidato l’appalto della ricostruzione della Sala ad Antonio Ghignoni che dovrà eseguire dei lavori per innalzare una “galleria semplice” su colonne di ghisa e costruire una nuova scala attigua alla sala teatrale 26) . Tali lavori vengono ultimati nell’agosto del 1897, quindi viene fatto un altro progetto per la trasformazione e l’adattamento del “già Teatro Comunale a Sala con palcoscenico e galleria” 27) . La sala si ammoderna con un impianto di illuminazione elettrica e viene finalmente collaudata nel 1898 28) . Per il pagamento dei lavori viene contratto un mutuo ipotecario con la Banca d’Italia. Agli inizi del nuovo secolo, nel 1906, la sala viene richiesta da diversi enti per feste da ballo e servizi musicali da eseguirsi il primo dell’anno e durante il carnevale, come d’uso 29) . Viene addirittura istituito un corpo di vigili (o pompieri), dipendente direttamente dal Comune, a tutela della sicurezza della Sala. 22) Tit. 4, fasc. 20. Tit. 4, fasc. 20. 24) Tit. 4, fasc. 3. 25) Tit. 4, fasc. 3. 26) Tit. 4, fasc. 32. 27) Tit. 4, fasc. 32. 28) Cat. 15 classe 3. 29) Cat. 15 classi 3-11. 23) Nel 1911 risultano dai carteggi molte richieste per l’utilizzazione della sala 30) durante il carnevale, per veglioni e feste di beneficenza allietati da concertini musicali e premi alle migliori maschere. Nel 1919 31) vengono fatte nuove richieste: vuole la Sala la Compagnia Drammatica “Ars Nova”, la vogliono i granatieri del distaccamento di Corneto per una recita di beneficenza, c’è addirittura una richiesta per una conferenza di propaganda proletaria il primo di maggio, nonché per concerti vocali e per numerose opere liriche come la Norma, la Favorita, il Barbiere di Siviglia ecc. Viene inoltrata per la prima volta una richiesta per dare un trattenimento cinematrografico a pagamento, due volte la settimana, con l’assicurazione che gli spettacoli proposti saranno “di carattere onesto e consono alla popolazione”. Purtroppo quasi tutte le richieste non potranno essere soddisfatte dal Consiglio, vista l’ubicazione della Sala troppo prossima ad uffici ed archivi comunali. Nel 1920 continuano le richieste da parte di un Comitato cittadino perché vengano dati per un anno spettacoli istruttivi e popolari 32) nel desiderio di “riparare allo stato di abbandono del Teatro stesso”. Un certo prof. Nyno vuole fare uno spettacolo “scientifico di telepatia, trasmissione del pensiero e suggestione”. Nel 1921 la Società di assistenza Croce Azzurra fa una richiesta 33) perché venga accordata la Sala alla Società Filodrammatica che vi deve rappresentare alcuni spettacoli. Ci sono anche altre curiose richieste da parte del prestigiatore Lord Kistner e del trasformista Fremo. Il Partito Comunista d’Italia, sez. della III Internazionale-Corneto-Tarquinia, chiede il Teatro per una conferenza nella ricorrenza del quarto anniversario della Rivoluzione russa. Ma già nel 1922 le Giovani Italiane premono per la concessione della Sala 34) in occasione dell’inaugurazione del gagliardetto. Anche la Società Tarquiniense d’Arte e Storia fa per la prima volta una richiesta per tenere l’assemblea generale dei soci. Pure in quest’anno non mancano le curiosità: il padre della signorina Adele Parrucci, che va sposa al signor Pietro Termentini di Roma, chiede al Sindaco se può utilizzare la Sala per il banchetto di nozze con cento invitati, servito da Pietro Giudizi (il quale 30) Cat. 15 classi 3-11. Cat. 15 classi 3-11. 32) Cat. 15 classi 3-11. 33) Cat. 15 classi 3-11. 34) Cat. 14 classi 3-11. 31) ultimo lamenta il fatto che le cento persone non possono entrare nel suo Ristorante). La richiesta ovviavemente non viene esaudita. Nel 1925 lo stato in cui era ridotto il teatro è così deplorevole che due animosi cittadini, Menotti Pampersi e Antonio Antonelli, offrono 30.000 lire per la ristrutturazione del Teatro ed il rifornimento 35) di tutti gli arredamenti necessari a patto che “il Teatro non venga più concesso per riunioni politiche”. Chiedono in cambio l’utilizzo della Sala per quindici anni anche come cinematografo. La richiesta fu accettata dalla Giunta poi, però, i due si dovettero scontrare con Vittorio Massi, proprietario del Cinema Teatro Etrusco (inaugurato nel 1924) il quale inondò il Commissario Prefettizio di lettere, lamentando la concorrenza. Il progetto quindi andò in fumo e lo stato del Teatro peggiorò sempre di più. Nel 1926 il Podestà 36) , sentita la Giunta e considerata la sempre più precaria condizione della Sala dava a tutti i richiedenti una risposta fissa che suonava così: “Lo stato di manutenzione (del teatro) è da tempo così deplorervole che già altre volte quest’anno ho ritenuto opportuno di non concederlo ad altri richiedenti, per tale motivo sono spiacente non poter aderire alla Sua richiesta”. Il degrado dell’edificio, da quest’anno in poi, non è più arrestabile, anche se vengono fatti nuovi tentativi per tenerlo in vita, con le solite concessioni per veglioni e balli di beneficenza. Negli anni 1927 e 1928 si alternano le concessioni e i rifiuti per utilizzare la Sala; ai primi del ‘27 c’è una lettera del Commissario Prefettizio al Prefetto di Viterbo che dice: “In questo Comune esiste soltanto il Teatro Comunale ed il Cinema-Teatro dei fr.lli Massi. Il Teatro comunale non viene più concesso per pubbliche rapprresentazioni avendo bisogno di importanti restauri. Il Cinema-Teatro è stato aperto al pubblico nel 1924 previa regolare visita della Commissione di Vigilanza”. Il Teatro viene quindi concesso per feste da ballo, per concerti del Corpo Bandistico, per feste danzanti proScuola Musicale e per conferenze, ma viene negato a Compagnie teatrali. Esiste poi, in data 3 aprile 1927, l’incongruente verbale della Commissione di vigilanza dei Pubblici Spettacoli, composta di tre membri, che autorizza le pubbliche rappresentazioni ed afferma che: “la costruzione sia del palcoscenico che della galleria esistente per gli spettatori è valida e non presenta alcun pericolo” 37) . 35) Cat. 15 classe 3 Cat. 15 classe 3 37) Cat. 15 classe 3 36) Nel 1929 il Teatro non viene mai concesso e c’è una lettera del Podestà al Prefetto che dice che il Teatro del Comune non è “agevolato pel suo funzionamento con specifiche sovvenzioni perché non più in efficienza, non trovandosi in buone condizioni statiche e quindi nell’impossibilità di poter agire” 38) . Seguono alcuni anni di silenzio poi, nel 1935, troviamo un’altra lettera del Podestà al Prefetto in cui si afferma che il Teatrro Comunale, non presentando requisiti di garanzia, non è più in esercizio. Negli anni che vanno dal 1936 al 1939 gli spettacoli teatrali sono sempre più spesso sostituiti da altro genere di rappresentazioni 39) : alla Barriera S. Giusto si fanno giochi ginnici all’aperto e spettacoli di prosa estivi, si autorizza l’apertura di un Parco Divertimenti con “autoscooter e tiro fografico”, si permettono le esibizioni di vari Circhi Equestri nonché le rappresentazioni del Teatro ambulante “Il carro di Tespi”. In Piazza S. Francesco si fanno “giochi umoristici”; si cerca insomma di sopperire in vari modi alla mancanza della Sala comunale. Nel 1938 troviamo una risposta del Podestà al Prefetto in cui si dichiara che: “non possono aderire al Consorzio dei Teatri Lirici poiché il Teatro è da vari anni inagibile”. Anche i balli pubblici vengono dirottati verso la sala del nuovo Cinema-Teatro Etrusco che, da quest’epoca in poi, sostituirà la Sala comunale in tutto e per tutto. Dal 1941 al ‘45 si trovano forti restrizioni sugli spettacoli di qualsiasi tipo a causa della guerra; nei documenti d’archivio, il glorioso Teatro non è più nominato e la sua decadenza è sempre più evidente, come risulta anche dalla fotografia del 1940 allegata al testo. Fu demolito quasi interamente negli anni ‘60 per poi essere ricostruito, restaurato ed adibito a Sala del Consiglio Comunale negli anni più recenti, ma la sua demolizione deve senz’altro aver provocato più d’una malinconia nei cuori di molti tarquiniesi. Maria Laura e Carla Santi BIBLIOGRAFIA B. APOLLONJ GHETTI, Architettura della Tuscia, Milano 1968, Città del Vaticano 1960 J. RASPI SERRA, Corneto Monumentale, Corneto Tarquinia 1913 L. DASTI, Notizie storiche e archeologiche di Tarquinia e Corneto, Tarquinia 1910 38) Cat. 15 classe 3 Dizionario di cognizioni utili di scienze, lettere e arti, Torino 1925 S. D’AMICO, Storia del Teatro, Milano 1968 V. GOLZIO, Storia dell’Arte italiana (‘600 e ‘700) vol. IV tomo secondo V. MARIANI, Enciclopedia dello Spettacolo, Roma 1954-1965 F. TESTI, La musica italiana nel ‘600 e nel ‘700, Milano 1970 Documenti dell’Archivio Storico Comunale Tarquiniese: registri dei Consigli anni 1567-1796; Speculi 1607-1715; Fondo carte sparse 1654; Tit. 4 fascicoli 20, 3, 32; Cat. 15 classi 3-11. SOCIETA’ CATTOLICA “GIOVANI FEDELI” di Tarquinia Ottanta anni fa, 18 marzo 1906, nasceva in Tarquinia, con tanto di approvazione ecclesiastica, una Associazione mariana giovanile dal titolo molto impegnativo: “Giovani Fedeli”. Era una associazione parallela alla Gioventù Cattolica Italiana che a questa poi si aggregò e da questa ancora fu incorporata e assorbita. Associazione di giovani perché attendessero alla formazione della prima coscienza e nello stesso tempo, legati alla gerarchia ecclesiastica, operassero nella chiesa per santificare ed evangelizzare. Giovani che portassero la loro modesta esperienza e ne assumessero la propria responsabilità nel mondo, nell’ambiente, per santificarlo e sopraelevarlo: la così detta “consecratio mundi” di pacellania memoria *** Angelo Rossi, per la gloria di Dio e Servo della S. Sede Apostolica, Vescovo di Corneto e Civitavecchia. Abbiamo letto e ponderato il presente regolamento della Società Cattolica Giovani Fedeli nella città di Corneto, e siccome nulla abbiamo ivi trovato che si opponga alla Fede e ai Buoni Costumi, ma piuttosto tutto è diretto allo scopo di perfezionare la 39) Cat. 15 classe 3 religiosa e morale educazione dei giovani, lo abbiamo approvato e ne inculchiamo l’osservanza. Civitavecchia 26 Marzo 1906 Angelo Vescovo Erigiamo poi canonicamente la predetta Società Cattolica Giovani Fedeli di Corneto Tarquinia ed eleggiamo ad Assistente Ecclesiastico della medesima il Rev.mo Sig. D. Girolamo Can. Pariboni e a Direttore lo stesso fondatore Rev.mo D. Benedetto Preposto Reali. Civitavecchia 26 Marzo 1906. *** Il fondatore D. Benedetto Reali fu il primo Direttore e lui resterà sempre fino alla estinzione della Società; il primo Presidente fu Amleto Fortuzzi, il primo Segretario fu Gaddi Alfredo e il primo Cassiere fu Amulio Silli. Queste cariche vennero fatte nella prima adunanza inaugurale 18 marzo 1906 in una sala “graziosamente” offerta dal Direttore, con l’altare ai piedi del quale i soci emisero la promessa solenne di osservare lo Statuto e il Regolamento. Questa promessa poi doveva essere fatta da tutti i soci che, dopo sei mesi di prova, venivano accolti tra gli effettivi. Queste notizie le ho desunte dall’Archivio della Curia Vescovile di Tarquinia VERBALI DELLA SOCIETA’ “Giovani Fedeli” 3 volumi manoscritti. Gli ascritti alla Società “Giovani fedeli” erano di quattro classi: a) I soci attivi, erano giovani secolari dimoranti in Tarquinia, i quali nel dare il loro nome alla Società, promettevano la perfetta osservanza dello Statuto e Regolamento, prestavano la loro opera nel praticare i mezzi indicati, adempivano con diligenza e fedeltà gli uffici loro affidati. A questa classe non potevano appartenere che giovani di esemplare condotta civile, morale e religiosa che avevano raggiunto almeno il quindicesimo anno di età e non prima di aver terminato un semestre di prova. I soli soci attivi avevano il voto consultivo e deliberativo nelle adunanze, eleggevano e potevano essere eletti a cariche. b) I soci partecipanti, giovani secolari, sempre dimoranti in Tarquinia, che nell’iscriversi alla Società promettevano di osservare esattamente lo statuto col regolamento, prendevano parte a tutte le funzioni e adunanze. In queste adunanze però non avevano nè voto consultivo e nè deliberativo e neanche potevano eleggere o essere eletti a qualche carica. Erano ricevuti in questa classe tutti quei soci di buone speranze che avevano frequentato o che frequentavano questa congregazione mariana e che erano giunti almeno agli anni 141/2. Volendo poi passare alla classe dei soci attivi dovevano essere disposti a fare prima il semestre di prova. c) I soci onorari divenivano quei soci attivi che cambiavano domicilio o che abbracciavano lo stato ecclesiastico o che avevano compiuto il venticinquesimo anno di età o che per altri motivi, cessavano spontaneamente di essere soci attivi. d) I soci benemeriti quei signori che per oblazioni, doni, protezione e altri motivi, avevano speciali titoli alla gratitudine della Società, partecipavano ai beni spirituali della medesima associazione. In questa classe potevano annoverarsi anche le signore e gli ecclesiastici. Lo scopo della Società “Giovani Fedeli” era: perfezionare l’educazione morale dei giovani e rassodarli nel bene, informare il socio ad uno spirito franco e coraggioso, alla professione pubblica di principi cattolici; adoperarsi, particolarmente col buon esempio, per ravvivare nella gioventù e nel popolo il sentimento religioso e il rispetto ai superiori. Con quali mezzi? sane letture, conferenze, il pronto ed esemplare esercizio di tutti gli atti di culto esterno, massime la partecipazione alle pubbliche solenni manifestazioni religiose, accostarsi in corpo alla SS. Eucarestia, nelle feste dei Santi Patroni, Immacolata, S. Giuseppe e S. Luigi Gonzaga, la fuga di tutto ciò che in qualche modo offendesse la religione e il buon costume, la reciproca tolleranza, l’emulazione nel bene, i vincoli di una pura e leale amicizia tra i soci, cooperare in genere all’Azione Cattolica. Giovani fedeli: fedeli a che cosa? al Vangelo. Erano cristiani? erano seguaci di Cristo tali giovani. Dunque dovevano seguire le sue orme: un grande amore al Padre Celeste, amore che poi li avrebbe condotti a una testimonianza di fede a tutta prova e senza vergogna, a una frequenza ai Sacramenti, a una partecipazione attiva agli atti di culto esterno, non dimenticando però la primaria importanza del culto interno, a una obbedienza senza condizione alla Chiesa Maestra e Guida e ai suoi legittimi Rappresentanti, a una carità operosa, a una disponibilità per i fratelli ecc. Erano cristiani questi giovani? pronti ad avere alta la fronte dinanzi all’errore e agli erranti, condendo tutto con la carità e la comprensione. I mezzi per riuscire in questo lavoro duro e diuturno, erano loro indicati, i dirigenti ne erano solleciti nel ricordarli, il regolamento ne indicava alcuni ma tutto stava chè ognuno ne approfittasse con amore, con entusiasmo. L’essere giovani doveva costituire per loro un motivo di più per agire in una certa maniera, con entusiasmo, con coraggio, con grande amore, sempre disponibili, sempre pronti. Avevano energie fresche non deteriorate dal peccato, dovevano saper sfruttare tali forze morali e fisiche, non dovevano intorbidire nell’ozio, nel peccato, nel disimpegno, nel divertimento a tutti i costi. Fedeltà a che cosa? allo studio, al lavoro, agli impegni derivanti dal loro stato giovanile. Era chiaro: nemo dat quod non habet. Se non si è carichi di idee sane, se non si ha una fede viva, se non si è santi o non si intende alla santità, come si potrà essere lievito, fermento nella massa, in un mondo materializzato? Come si potrà essere coraggiosi e testimoni in mezzo a un mondo pagano? C’erano sì degli errori che serpeggiavano nella società, ma s’avvertiva anche che qualcosa si andava muovendo, s’avvertiva che sotto la cenere c’era del fuoco, quindi era doveroso che si trovassero giovani pronti e ben preparati a risolvere o tentare di risolvere questioni di portata fondamentale per la chiesa e per la Patria. *** I soci nel dare il proprio nome alla Società, dovevano stare agli impegni; il Consiglio doveva vigilare perché la Società non deviasse dallo scopo prefissosi e dallo spirito cattolico che doveva animarla; tutte le adunanze dovevano iniziare e terminare con la preghiera e l’invocazione ai Santi Protettori: l’Immacolata, S. Giuseppe e S. Luigi Gonzaga, le feste di questi Protettori dovevano essere celebrate con solennità e con la partecipazione di tutti i soci. L’Assistente doveva premettere alle adunanze una conferenza spirituale per il bene dei soci e doveva vigilare “al morale e cattolico” andamento dell’Associazione. Il regolamento prevedeva anche delle Commissioni per risolvere casi particolari: sarebbero i così detti gruppi di studio, più o meno. Dopo i sei mesi di prova, se creduto degno, il giovane per passare tra i soci attivi doveva emettere la seguente promessa: “Io N.N. avendo spontaneamente dato il mio nome alla società cattolica “Giovani fedeli” di Corneto Tarquinia, dichiaro e prometto, senza alcuna restrizione mentale, ai componenti il Consiglio di Presidenza e a tutti i soci attivi e partecipanti della medesima Società, di osservare esattamente lo Statuto e il Regolamento e di adempiere con fedeltà gli incarichi che potranno essermi affidati” (Cfr. Verbale del 2L, 31-3-1906) La quota che ognuno doveva dare alla cassa comune era di centesimi 30 mensili da versarsi in due rate. L’Associazione aveva un distintivo e una bandiera. Il primo, consisteva in un piccolo cappio formato con nastrini di seta del colore della bandiera; poi fu cambiato in una forma più elegante e più duratura. (Cfr. Verbali del 31-3, 27-4, 20-10-1906). La bandiera doveva essere di colore rosa acceso, attraversata d’ambo le parti da una lista diagonale di seta bianca con al centro il motto “Fedeltà”, una frangia d’argento nell’intorno; il nastro doveva essere di seta bianca con frangia d’oro e con l’iscrizione: “Società Cattolica Giovani Fedeli” Corneto Tarquinia. Poi dopo, essendo stato impossibile trovare stoffa di tale colore e di altro, fu lasciato al Presidente la piena libertà di scegliere quel colore che meglio a lui fosse piaciuto. *** L’Associazione doveva essere una cosa seria, impegnativa e tali dovevano essere, agire e ritenuti, tutti i soci che dovevano stare alla promessa. E’ vero, erano giovani, e come i giovani di ogni tempo e di ogni regione, avevano i loro difetti tra i quali l’incostanza ed è per questo che l’Assistente ecclesiastico, il Direttore, i Dirigenti ripetutamente richiamavano gli ascritti ai propri doveri che liberamente erano stati sottoscritti con la promessa. Da tutti si voleva prontezza, coraggio, esemplarità in tutti gli atti di culto, vittoria sul rispetto umano ecc. ecc. Onde per questo non mancavano anche pene abbastanza serie: non accettazione tra i soci attivi, sospensione a tempo indeterminato, dimissione dalla Società (Cfr. Verbali del 28-7-1906). Per es. un tizio fu espulso dalla Società per diversi motivi: non pagava la quota mensile, spesso non prendeva parte alle adunanze, aveva poco coraggio nel manifestare pubblicamente la propria fede in quanto sorpreso a leggere periodici immorali, antireligiosi e sovversivi (Cfr. Verbale del 31-12-1907); il Direttore biasimò la condotta di un altro, per il suo poco sentimento religioso, per la noncuranza del regolamento, per aver partecipato a una festa da ballo il primo giorno di quaresima, poi per il suo poco coraggio (Cfr. Verbale del 5-7-1908); nella medesima seduta l’Assistente biasimò fortemente quei soci che senza giusti motivi, con frivoli pretesti non avevano partecipato alla Processione del Corpus Domini, non solo ma avevano infastidito chi vi aveva partecipato; venne ancora riprovata la condotta di un tizio che pubblicamente non aveva avuto difficoltà a leggere periodici antireligiosi e immorali (Cfr. Verbale del 17-10-1909); ancora; il Direttore biasimava fortemente la condotta di quei giovani che erano poco corretti nel parlare, che non ascoltavano per intero la S. Messa festiva e che non stavano in chiesa col dovuto rispetto (Cfr. Verbale del 288-1910); ancora: il Direttore dolentissimo biasimava vivamente il litigio avvenuto per la pubblica via fra due soci: uno di costoro, essendo recidivo e di condotta provocatoria, venne radiato ma poi riammesso per aver chiesto perdono (Cfr. Verbale del 19-11-1911). I soci attivi e partecipanti non potevano prendere parte a recite che la “Gioventù Cattolica” teneva nel suo teatrino (Cfr. Verbale del 11-1-1907), anzi avendo un tizio trasgredito tale ordine il 21-11-1909, venne ripreso severamente e poi espulso. Al contrario, venne pubblicamente lodato e portato come esempio la condotta di un tizio che, invitato a iscriversi a una società di principi sovversivi, diede nobile esempio di rifiuto (Cfr. Verbale del 24-2-1907). Gli iscritti non potevano far parte di altri circoli, tra i quali anche quello della Gioventù Cattolica; dal verbale del 30-3-1907 si sa che circolavano voci che alcuni soci di nascosto avevano fatto pratiche per essere ricevuti in tale circolo giovanile, ma da accertamenti fatti, tale notizia risultò falsa. La Società aveva una orchestrina: il 5-5-1910 era stata comprata una chitarra che doveva servire solo ed esclusivamente per il divertimento dei soci e solo per via del tutto eccezionale fu permesso che tale orchestrina suonasse per carnevale presso le Suore di S. Vincenzo (Cfr. Verbale del 25-1-1913). Alcuni chiesero di far parte di una associazione sportiva, ma non fu loro concesso onde due soci si dimisero dalla società “Giovani Fedeli”, per passare a quella sportiva (Cfr. Verbale del 29-6-1911). Non mancavano anche gite sociali o passeggiate, ma sapete ove si andava? A Civitavecchia, a Viterbo (Madonna della Quercia), a Vetralla, a Montefiascone. Le conferenze, le istruzioni le teneva sempre l’Assistente Ecclesiastico o il Direttore, ma anche dei soci ben preparati non mancavano di dare il loro contributo su questo punto: dal verbale del 20-9-1908 si sa che il socio attivo tale Marzi Ernesto, con eletti concetti e forbita parola, parlò sulla missione del giovane cattolico in mezzo all’odierna società; lo stesso socio tenne ancora un’altra conferenza sopra il rispetto umano, mostrando i gravi danni spirituali e sociali che causa questo vizio, e ancora una terza sulle cattive letture (Cfr. Verbale del 29-9-1909). Tali conferenze non erano sempre a sfondo morale, spesso avevano per oggetto questioni sociali: sul socialismo, sulla questione operaia, sulla stampa cattiva e sue deleterie conseguenze (Cfr. Verbale del 10-4-1910). E a proposito della stampa immorale, fu proposto ai soci di darsi da fare per ostacolarla con forza e coraggio: amici e famiglie consegnassero tutta la stampa di tal genere, venisse portata dal Direttore per poi essere distrutta. *** Intanto si andavano maturando idee nuove, più ecclesiali, idee che più aderissero ai desideri della S. Sede. Perché non aderire più fattivamente alle aspirazioni della S. Madre Chiesa Cattolica? E fu così che, dietro desideri più volte manifestati dai soci e dietro proposta del Direttore, fu deliberato l’aggregazione della società “Giovani Fedeli” alla Gioventù Italiana di Azione Cattolica (Cfr. Verbale del 9,10 Nov. 1910). Furono intanto preparati i documenti richiesti e inviati a Roma all’Ufficio di Presidenza della GIAC il quale in data 13-12-1910 rispondeva accogliendo tale adesione. Era solo adesione per ora, ma l’idea di fondersi non era lontana. Le conseguenze furono che si dovette prendere la tessera di riconoscimento (Cfr. Verbale del 29-6-1911), partecipare al pellegrinaggio nazionale della Gioventù cattolica in Roma nei giorni 9, 10, 11, 12, 13 sett. 1913, partecipare all’assemblea generale della GIAC tenutasi a Roma nei giorni 3-4-5 gennaio, usare il distintivo della GIAC (Cfr. Verbale 29-1-1915), partecipazione del presidente Fortuzzi Giulio alla Direzione diocesana voluta dal Vescovo che aveva lo scopo di promuovere, coordinare l’Azione Cattolica in Diocesi (Cfr. Verbale 19, 21, 11, 1910) partecipazione del presidente diocesano alle adunanze della “Giovani fedeli”. Però fino alla completa fusione della “Giovani fedeli” in quella della GIAC, si seguitò a fare come sempre. In vista dell’iniquo progetto di legge sulla precedenza obbligatoria del così detto matrimonio civile su quello ecclesiastico, i soci dopo ampia discussione e spiegazione del Direttore sulla portata di tale legge, unanimi, emettono un voto di protesta e di biasimo per questo settario disegno di legge e deliberano di portare il loro modesto contributo; il 25-11-1915 fu inviata una lettera circolare a tutti i militari ex associati esortandoli ad iscriversi in qualche circolo più vicino, ad essere esemplari in tutto, portando ovunque in alto il nome del cristiano, del cattolico; si commemorarono il 16-11-1916 gli esemplari soci Bozzi Fausto e Paparozzi Giulio morti sul campo di battaglia nel 119115; il 14 gennaio e il 24 febbraio 1917 due soci militari tale Rogani Gioacchino e Palma Umberto, venuti in licenza dal fronte, tennero dei discorsi di circostanza a tutti i presenti ispirati a sentimenti di cristiano patriottismo. Dalla semplice adesione o aggregazione si arrivò alla completa fusione con la GIAC. Così il 24 marzo 1917 cessava di esistere la tanto gloriosa società dei “Giovani Fedeli” che tanto bene aveva operato in Tarquinia anche se per poco spazio di tempo. Da questa data nei locali dell’attuale sede dei Giovani Fedeli, il medesimo Direttore disse che avrebbe aperta una sala Convegno Giovanile che poteva essere frequentata solo da ex soci che ne avessero fatta domanda a lui direttamente. Sciolta definitivamente la “Giovani Fedeli”, si autorizzava il Presidente di notificare tale decisione ultima alla Presidenza Generale della GIAC. Poi vennero alienati e venduti al Direttore D. Benedetto per lire 200 tutti i mobili e tutto quanto apparteneva all’ex Società “Giovani fedeli”. In questa associazione sono passati moltissimi giovani di Tarquinia - enumerarli è matematicamente impossibile - che furono parenti diretti di uomini che operano oggi nel nostro paese. Riporto sotto l’elenco dei Presidenti: Fortuzzi Amleto eletto il 18-3-1906, rieletto il 19-3-1907, ancora il 19-3-1908; il 1-XI1908 fu eletto Sileoni Ulderico; Fulvio Fortuzzi eletto il 19-3-1909, ancora il 19-31910 e ancora il 19-3-1911 e il 23-3-1912; Palma Umberto eletto il 4 agosto 1912; Paparozzi Giulio eletto il 30-3-1913, ancora il 22-3-1914; Fortuzzi Fulvio eletto il 9 agosto 1914; Stefani Antonio eletto il 24-1-1915; Ferrari Vincenzo eletto il 21-3-1915, lo stesso in data 19-3-1916; essendosi verificati degli inconvenienti dal 28-5-1916 il Direttore fu anche Presidente e il 18-6-1916 fu eletto V. Presidente Leardini Bruno; il 15 ottobre 1916 fu rieletto Fulvio Fortuzzi che rimase fino all’estinzione della Società. Adolfo Porfido APPENDICE AL GLOSSARIO DEL DIALETTO CORNETANO 1 A. Aggadiare (v.) 1 Prendersi pena di qualche cosa, preoccuparsi. Questa è la terza appendice al Glossario pubblicato nel Bollettino dell’anno 1983. Allecconire (v.) Invogliare con moine e promesse chicchessia per ottenere ciò che si desidera. Risvegliare l’appetito della gola. In forma figurata, vale anche per allettare. Dall’arcaico “allerconire”. B. Babbalèo (s.) Di persona buona a nulla. Derivazione da babbeo. Boccaio (s.) Porta-lampadina la cui apertura tonda è simile a bocca, dove grazie ad un’avvitatura, si colloca la lampadina. Budellona (s.) Riferito a persona bassa e grassa, malformata e sudicia. E’ anche riferito a donna di malaffare. Derivazione dalla parola budello che è il condotto stercorario animale. C. Cacatore (s.) Cacatoio, latrina. Più propriamente era il pozzo nero, ricavato in una parete delle scale o del cortile di un palazzo oppure in un piccolo stanzino, la cui apertura cilindrica era chiusa da un tappo di marmo, munito da un alto manico in ferro. Caciotta (s.) Oltre al vero significato della parola, viene usato anche in riferimento alla polpa bianca e dolciastra all’interno del ceppo disseccato del carciofo. Smegma. Callarella (l.a.) Viene usato come detto “callarella callarella” nel senso di non doversela prendere troppo per una discussione avuta o per un lavoro condotto allontanarsi senza meditare vendetta e tanto a buon fine; meno ma serbando rancore. Derivazione da “caldaia” che in dialetto vien detta “callara”. E la “callarella” era il recipiente in cui ogni lavoratore o pastore o guardiano di bestiame, la sera, approntava la sua magra cena. Cosicché prendeva la sua “callarella” e se ne nell’allontanarsi ognuno andava per i fatti suoi, con la buona o con la cattiva sorte, rassegnato. Cannara (s) L’allocuzione “culo a cannara” è riferita al sodomita, quando si dispone all’atto sessuale. Il Vigolo, nel commento ai Sonetti del Belli, il Morandi, era una grossa riporta la parola “cannarone” che, secondo canna, una specie di zufolo, fatto col gambo di un grosso cardo. Perciò la “cannara” o il “cannarone” non erano altro che il fallo. Cazzabùbbolo (s.) Uomo buono a nulla. Minchione. Simbiosi delle parole “cazzo” che viene usato con significato di scarsa intelligenza, come testa di c., e di bubbolo che è un tipo di sonaglio usato per i bambini. Cazzone (s.) Uomo buono a nulla. Generalmente si crede che le persone con ipertrofia sessuale abbiano scarsa intelligenza. Minchione. Commodezza o Comodità o comodo. Stare all’altrui o alla propria “commodezza” significa rassegnarsi all’altrui servizio, all’altrui agio o al proprio. commidezza Cularcione (s.) Dicesi di persona grassa o mal formata, dal grosso sedere. Vedi cularcio. F. Famigliola o Tipo di fungo mangereccio assai piccolo che cresce in cespi, ricchi di Famijjoola (s.)minuti funghi. Fava (s.) Oltre al significato che si dà comunemente all’ortaggio o al legume, è anche riferito al glande virile. Fijjare (v.) Figliare, far molti figli. G. Gregna (s.) Oltre al significato e all’etimologia della parola data nei precedenti glossari degli anni 1983, 1984 e 1985, si dà notizia che la parola gregna è stata usata da Matteo Palmieri ne “Il libro della vita civile” (1529) col significato “Unione di molti covoni”. I. Imbacucchito (ag.) Divenire bacucco. Vedi bacucco. Impicciaticcio (s.) Qualcosa di molto intrigato e confuso, da render difficile o quasi impossibile il disbrigo. Derivazione dalla parola impicciato o impiccio. Impuzzolire (v.) Impuzzire, spandere puzzo all’intorno. Incordonare (v.) L’effetto doloroso che si avverte nei testicoli quando non si riesce, dopo lungo tempo di eccitazione, a concludere il coito. E’ lo stesso dolore che si proverebbe se essi venissero cordonati, ossia sottoposti a tortura. Inculare o (v.) ‘nculare Fare azione di sodomia. Incùlete o (v.) ‘nculete Forma imperativa riflessiva del verbo inculare. Invito perentorio ad altri per trasferire su se stesso l’azione di sodomia. Ridurre se stesso ad azione di narcisismo. Infilzetta (s.) Passare interamente una fettuccia o un elastico da un orlo all’altro, di una blusa o di una veste, in modo da non essere vista. Derivazione diminutiva di filza. Insifonata o ‘nsifonata Atto materiale del coito. La parola prende avvio da sifone, nel senso che si fa passare, con forma violenta, il liquido spermatico dal sesso virile a quello femminile. Usata in forma quasi di dispregio verso la donna e di vanto da parte dell’uomo. Intopàta o ‘ntopata (ag.) Dicesi di donna sessualmente dotata ed eccitante fisicamente. In senso traslato può essere anche riferito all’uomo. Derivazione da “topa” che in gergo è la vagina ossia l’organo sessuale femminile. (Vedi topa). M. Mammaléo (s.) Dicesi di persona buona a niente e che ha sempre bisogno di stare fra le vesti della mamma. Dicesi anche di persona mancante di iniziativa. Mannàra (s.) Giuoco infantile dei tempi passati utilizzando i noccioli delle albicocche, delle pesche. Il più grosso svuotato della mandorla e riempito di pesante, veniva lanciato contro gli distanza in mucchietti di quattro. E prendeva mannara. La derivazione da mannaia è essenzialmente piombo, altri perciò noccioli, il reso collocati nome più a di dovuta al peso dello strumento di morte o all’azione che essa determinava. P. Patonza (s.) Organo sessuale della donna. Etimologia incerta. Piccasorcio (s.) Pungitopo o agrifoglio. E’ una trasposizione di pungi (picca) e topo Pisciarèlla (s.) (sorcio). Azione continua di orinare a causa di una paura o del freddo di una Porzétta (l.a.) forte emozione. Noto il detto “a porzetta”, cioé sollevare il corpo o un attrezzo pesante con la sola forza dei polsi. (alterazione di polso in porzo) Porzìno (s.) Fasciatura stretta di stoffa o di cuoio all’altezza dei polsi per evitare, nello slogature. (Diminutivo di sforzo dell’esercizio ginnastico, delle polso che in dialetto vien detto pòrzo). Puntarelle (s.) Le punte o i germogli teneri delle piante eduli. Punzò (l.a.) E’ comune il detto “ a culo punzò”. Lo stesso che “a cannara” (vedi cannara). Punzo è apocope di punzone. Nel senso cioè che il punzone s’esprime con forza, su metalli e materie dure. L’atto di sodomia richiede, da parte dell’uomo attivo, una disposizione di forza quasi a punzonare l’uomo passivo. R. Rifreddore (s.) ironico nei Rimessino (s.) riparo le Alterazione della parola raffreddore. Usasi anche in senso confronti di chi è affetto da blenorragia. Piccolo recinto di passoni o palizzata ove vengono rimesse al bestie domestiche e brade, come cavalli, buoi, pecore e simili. Diminutivo di rimessa che dal genere femminile passa a quello maschile. S. Sbarellare (v.) Far cadere violentemente giù dalla barella una persona. In senso Scacchiare (v.) Vedi figurato buttar tutto all’aria oppure uscir di senno. Togliere i germogli o i tralci (cacchi) dalla vite in primavera. cacchio. Scaccolare (v.) Togliere le caccole dal naso o da altra parte del corpo. Scaciare (v.) Togliere lo smegma dal glande virile. (Vedi caciotta). Schifetto (s.) Piccolo piatto di legno poco fondo, usato nelle campagne per selezionare legumi vari dalle impurità. Estensione di significato della parola “schifo”, termine marinaro per Scorsòne (s.) indicare piccoli palischermi. Percorso che l’acqua scava durante un’alluvione e che il contadino rispetta senza modificarne l’andatura. Parola che deriva dal verbo Scùlato (ag.) scorrere e scorso. Di persona esageratamente fortunata al gioco; con chiaro riferimento a culo, vale a dire senza fondo e senza limite. Semàro (s.) Semaio, venditore di semi. Sfavare (v.) Far retrocedere il prepuzio per mettere in mostra il glande virile. Vedi Sfonnòne (s.) Dal fava. Parolaccia, parola oscena che si usa nel linguaggio famigliare. verbo sfondare, ossia rompere il fondo per far uscire liberamente tutto il contenuto. Smaldrappàto (ag.) Dicesi di persona mal vestita e mal ridotta. Derivazione da “mal drappato” ossia mal vestito, con una s iniziale rafforzativa. Smemoriare (v.) Sottopunto (s.) Perdere la memoria. Mettere un punto sotto un altro a rinforzo di una cucitura. Rifinitura. Spaciàre (v.) Concludere in pareggio un rapporto economico di dare e avere. Appianare una contabilità in modo da non lasciare sospesi. Far pari e Spargiàra (s.) patta. Derivazione della parola pace. Chioma arruffata e mal curata. Derivazione da aspargeto o asparagiaia. Spulàre (v.) interamente al Spurciàre (v.) Rafforzativo di pulare (vedi gioco. Levar di dosso le pulci. Vedi purcia. pulare). Venir spogliato Spuzzolìre (v.) Il contrario di impuzzolire. Togliere il puzzo di dosso o da un ambiente. Stòpare (v.) Levar caccole dal naso che in dialetto vengono detti topi. Stranculète (v.) (vedi incùlete) Ha lo stesso significato della parola già citata (incùlete) ma con senso rafforzativo e ripetitivo. Strìgole (s.) Punte di erba selvatica edule. Svacàre (v.) Togliere gli acini d’uva da un grappolo o far uscire dal guscio, quando è seccato, fagioli, ceci, piselli, ed ogni altro legame. Vedi vaco o vago. T. Topa (s.) Vagina, organo femminile. Dicesi altresì, sempre in gergo, “sorca” ossia la femmina del sorcio o del topo. Il cui colore grigio scuro o nerastro, fa riferimento al colore cupo e nascosto del sesso femminile. I significati di derivazione possono essere molti altri. Z. Zebbedéi (s.) In termine eufemistico sono i testicoli. La trasposizione ha radice dal nome Zebedeo, padre di Giacomo e Giovanni discepoli di Gesù, i quali formavano una coppia. Siccome i testicoli sono due ossi a coppia, ecco il riferimento. L’accostamento potrebbe sembrare irriverente e irriguardoso; c’è da considerare che nel Patrimonio di S. Pietro o Stato della Chiesa, c’era un forte sentimento antipapale e laicistico per cui si spiega l’accostamento al nome di Zebedeo e ai due figli di Zebedeo detti anche Zebedei. Lo stesso G.G. Belli nel sonetto n.106 “Li penzieri libberi” usa nel 4. Zòccola (s.) di bassa a verso la forma “janna, minchione, zebbedei, gemelli”. Dicesi in riferimento a donna di malaffare. Come pure di sorcio fogna. Derivazione da zoccolo che è sempre la parte più contatto con la terra. Bruno Blasi CRONACA DELL’ANNO 1986 La Società Tarquiniense d’Arte e Storia, di concerto con l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo dell’Etruria Meridionale e con l’Amministrazione Comunale, ha preferito, per l’anno in corso, dare inizio ad una serie di concerti di musica cameristica giovandosi della disponibilità del complesso dei Solisti Aquilani, diretti dal maestro Vittorio Antonellini: una serie di concerti pomeridiani, sia strumentali che vocali, nelle giornate di giovedì, per i periodi primaverile e autunnale, dato che nel periodo estivo i concerti vengono eseguiti dall’Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma, in accordo con l’Assessorato alla Cultura del nostro Comune. Infatti, dall’aprile al giugno e dall’ottobre al dicembre, i nove concerti sono stati eseguiti nella sala G.B. Sacchetti della nostra sede, di fronte a un pubblico che via via è andato aumentando di presenze, sia per la serietà che per la preparazione degli esecutori. Dall’aprile al novembre, presso la sede del Palazzo Vitelleschi, sono stati presentati per la prima volta in Italia i disegni di alcune tombe etrusche, qualcuna delle quali scomparsa, eseguiti nel 1835 dal pittore romano Carlo Ruspi su incarico di Luigi I, re di Baviera. Questi cartoni lucidi, sovrapposti sulle pareti tombali, riproducono tutti i disegni così come si presentavano all’occhio del visitatore, con a fianco gli appunti e alcune memorie dello stesso riproduttore, a volte eseguiti con qualche arbitrio. Così che si sono conosciuti i disegni delle tombe del Citaredo, delle Iscrizioni, Querciola e di un fregio della tomba delle Bighe, andato pressochè distrutto, dove sono rappresentate gare sportive di tutte le discipline allora note, con il pubblico degli aristocratici e relative consorti sulle tribune, mentre i servi sostano sotto, in vari atteggiamenti, erotici compresi. Le altre tombe riprodotte sul lucido sono quelle del Triclinio, del Morto, del Barone. Questa esposizione, curata dalla Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Meridionale e dall’Istituto Germanico di Roma, è stata visitata da uno stuolo innumerevole di visitatori, consapevoli che tali testimonianze saranno collocate definitivamente presso gli archivi del Museo di Baviera. Per tale avvenimento è stato anche stampato un volume illustrato e celebrativo, grazie al contributo della Cassa di Risparmio di Civitavecchia. Per rimanere nel campo delle manifestazioni culturali, è stata aperta una nuova tomba etrusca nella zona del Calvario, chiamata dei “Démoni Azzurri”, scoperta casualmente a seguito di uno scavo lungo la strada provinciale di Ripagretta per la messa in opera di un nuovo acquedotto comunale. Tale tomba, fortemente danneggiata dalle vibrazioni prodotte dal traffico pesante, è tuttora affidata alla cura dei restauratori, mentre il traffico è stato limitato su di un solo lato. Ebbene questa scoperta è stata di corollario alla suddetta Mostra di Palazzo Vitelleschi. Con l’occasione di questi avvenimenti e con il rientro da Milano del materiale archeologico in prestito a quella città, si sarebbe dovuta mostrare una serie di acquarelli del pittore Adolfo Ajelli riproducenti tutte le tombe allora scoperte negli anni che vanno dal 1929 al 1932. Ma tutto è stato rinviato all’anno 1987, non avendo trovato la Soprintendenza fondi necessari per l’allestimento di tutta la Mostra. Nell’Auditorium di San Pancrazio sono state allestite manifestazioni artistiche: la prima con la presentazione degli acquarelli di Lorenzo Balduini, riproducenti aspetti della nostra città (marzo-aprile), la seconda con una Mostra Filatelica, approntata dalla locale Associazione Filatelico-Numismatica in occasione dell’apertura della Tomba dei Démoni Azzurri (agosto); e infine una interessante Mostra di Ceramiche, sotto il titolo “Il Bucchero 3.000 anni dopo” con la presentazione in prima assoluta di opere fittili di pregevolissima fattura, opera dei fratelli Cesare e Giovanni Calandrini, Lorenzo Paoloni e Marino Ceccarini (settembre). Sempre nell’Auditorium di San Pancrazio è stata fatta la presentazione del romanzo di Melo Freni “La passione di Petra” con l’intervento di Francesco Boneschi e di Fiorella Passamonti, alla presenza dello stesso autore. Nella sala G.B. Sacchetti, nei mesi di maggio e di giugno, si è avuta una serie di concerti di giovani pianisti; mentre dal 3 al 24 Luglio, la “Giovane Velka” ha presentato “La Sonata”, esecuzione di concerti per pianoforte e strumenti antichi. Nella medesima sala, il 12 luglio, sotto la presidenza dell’illustre scrittore Carlo Bo, è stata premiata l’opera vincitrice del concorso di poesia “Tarquinia-Cardarelli”, “Da brace a cenere” di Siro Angeli. Sono state organizzate a favori dei Soci due gite turistico-culturali, la prima per visitare Siena, Pienza e Monte Oliveto; la seconda alle abbazie di Fossanova e Casamari, rispettivamente il 20 luglio e il 7 settembre. Il 15 ottobre ha tenuto nella sala Sacchetti un concerto pianistico Stefano Albanese. I concerti dei Solisti Aquilani si sono tenuti secondo il seguente programma: 27 marzo 3 aprile - concerto da camera dei Solisti Aquilani diretti da V. Antonellini; concerto del pianista Andrea Serafini 17 aprile - concerto del duo pianistico Isabella Cristante e Patrizia Gallo 24 aprile - concerto vocale del mezzo-soprano Teresa Rocchino e del tenore Angelo Degli Innocenti, pianista accompagnatore, Domenico Poccia 01 maggio - concerto di Michele De Angelis, per liuto e chitarra 15 maggio - camerata polifonica viterbese, diretta da Zeno Scipioni 29 maggio - concerto dell’orchestra dei Solisti Aquilani diretti da V. Antonellini 24 ottobre - concerto del duo Maurizio Gambini, violoncello, e Massimo Giorgi, contrabbasso 13 novembre - concerto del soprano M. Vittoria Romano di musica da camera dal titolo “Dal salotto a Piedigrotta”, accompagnatore il pianista Marco Fumo. Su sollecitazione di alcuni giovani iscritti, la STAS si è prodigata, attraverso contatti con la Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Meridionale, per creare a Tarquinia un Gruppo Archeologico per collaborare alla pulitura e alla salvaguardia del patrimonio tombale del nostro territorio; si è avuto un incontro con la dott.ssa Cataldi e con una Ispettrice che dovrà guidare questo Gruppo alla pulizia e alla sorveglianza delle tombe già scavate e abbandonate, a cominciare, con la stagione estiva, dalle tombe del Calvario. In ottobre, lo scultore ternano Aurelio de Felice ha donato al socio Bruno Blasi una statua bronzea, raffigurante una figura di adolescente, eseguite anni addietro come omaggio a Vincenzo Cardarelli. Il socio Blasi l’ha donata a sua volta alla S.T.A.S. perché la collocasse alla sommità della scalea in via dell’Archetto, 4. Il 28 dicembre, venuto a scadere il triennio del mandato, il Consiglio Direttivo si è dimesso facendo convocare l’Assemblea dei Soci per approvare il Bilancio consuntivo dell’anno 1986 e procedere, nello stesso tempo, all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. I risultati ottenuti sono stati i seguenti: eletti Guerri Sergio, Tiziani Giannino, De Cesaris Cesare, Blasi Bruno, Corteselli Mario, Pardi Antonio, Moretti Carlo. A revisori dei conti sono risultati eletti i sigg. Santiloni Giuseppe, Cannucci Filippo e Tiberi Lilia Grazia. Nel corso dell’anno la biblioteca-archivio si è arricchita di nuove pubblicazioni: 7 volumi illustrati della Bibbia, 6 volumi della Divina Commedia illustrata, 6 volumi di capolavori nei secoli, omaggio del cardinale Sergio Guerri; da parte del socio Romano Cancellieri sono stati donati 6 volumi sulla 2ª Guerra Mondiale di Winston Churchill e 3 volumi sulla salvezza dei Beni Culturali in Italia e 6 volumi di Teodoro Momsen sulla storia di Roma Antica; da parte del consigliere De Cesaris Cesare sono stati donati 4 volumi di scritti scelti tra “Antico e moderno” di Benedetto Riposati; da parte di Bruno Blasi il volume “I Rasenna”, una “Collezione di stampe” e l’opuscolo completo della Mostra di Matta al “Centre Pompidou” di Parigi. Infine il socio Pierozzi Davide ha donato un quadro da lui eseguito, riproducente la pianta della città di Corneto nel 1800. Altri avvenimenti nel corso dell’anno sono stati la 37ª edizione della Mostra-Mercato delle Macchine Agricole e del Cavallo Maremmano, nonché la 800ª Fiera di Tarquinia (quartiere medioevale) nei giorni del 1, 2, 3, 4 maggio. Dal 17 al 31 maggio, presso la “Lestra” è stata presentata, sotto l’egida del Comune, una Mostra antologica del pittore tarquiniese Manlio Alfieri. Nei giorni 12, 13 e 14 settembre, è stata organizzata dalla Polisportiva Tarquiniese la 1ª Festa dello Sport, con esercitazioni sportive e con la rassegna di testimonianze fotografiche attraverso il tempo. Il 14 settembre, il Moto Club ha organizzato il 2ª Motoraduno a Tarquinia, mentre all’Hotel Helios è stata tenuta una grande manifestazione dal titolo “Una voce per l’Etruria”, manifestazione turistico-culturale con la presenza di molte autorità, scelte in ogni campo. Nel periodo natalizio, l’Associazione “Amici del Presepio” ha partecipato su invito alla Mostra Europea del Presepio a Verona, dove è stato mostrato il Presepio settecentesco che la Società Tarquiniense d’Arte e Storia ha recuperato dall’oblio e fatto restaurare. Stando alle notizie di stampa, il nostro Presepio è stato giudicato uno dei migliori in senso assoluto.
Scaricare