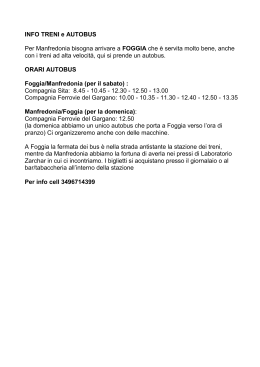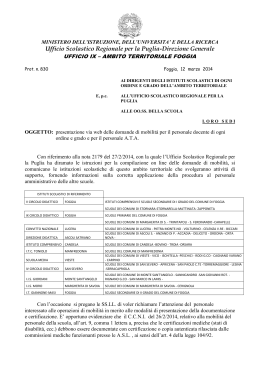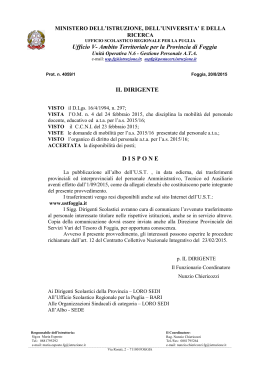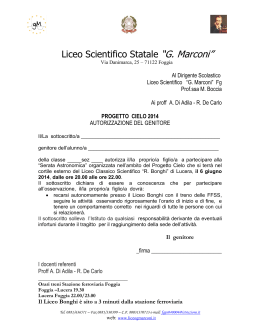Terzo millennio Collana di studi della Provincia di Foggia © 2000 Claudio Grenzi sas Printed in Italy Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere tradotta, ristampata o riprodotta, in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopie, film, diapositive o altro senza autorizzazione della Claudio Grenzi sas. Verso Sud Diari, novelle e poesie sulla Capitanata dal Quattrocento ad oggi a cura di Davide Grittani Claudio Grenzi Editore A Daniela, o capitano mio capitano ISBN 88-8431-034-2 © 2000 Claudio Grenzi sas Printed in Italy Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere tradotta, ristampata o riprodotta, in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopie, film, diapositive o altro senza autorizzazione della Claudio Grenzi sas. Claudio Grenzi sas Via Le Maestre, 71 71100 Foggia 5 Testamenti letterari di Capitanata Valeria de Trino Galante Responsabile “Agenzia per la Cultura della Provincia di Foggia” Quale occasione migliore di questa antologia per promuovere il famigerato “marchio Capitanata”? E quale maniera più consona, se non quella di raccogliere alcuni dei più significativi testamenti letterari lasciati in eredità alla nostra provincia dai più celebri scrittori italiani e stranieri? Un viaggio “Verso Sud” che è soprattutto un viaggio dentro il Sud: il nostro Sud, così mutevole e bizzarro, suggestivo e incantevole, selvaggio ed enigmatico. Un Sud che sembra - dalle pagine di questa preziosa monografia curata da Davide Grittani - si sia aperto agli scrittori che l’hanno viaggiato in lungo e in largo; come una terra che si lascia coltivare, attraversare da radici molto diverse eppure molto simili, le radici dell’anima. Un’opera che ha subito incontrato i favori dell’Amministrazione Provinciale perché la rappresenta tutta, in ogni angolo e anfratto. S’incontrano, descritte in queste pagine, le pietre sacre di Monte Sant’Angelo raccontate non senza ironia da Arthur Miller, la misteriosa figura di Padre Pio dipinta da Greene, Bacchelli, Piovene e D’Annunzio, la poesia delicata e severa della costa garganica raccontata da Anna Maria Ortese, e ancora brani di Gatto, Ungaretti, Accrocca, Pazienza, due lettere inedite di Umberto Giordano, contributi di Mascagni, Montale, Nigro, Marcone e il “nostro unico” premio Strega Mariateresa Di Lascia. Tutto questo ha pienamente convinto il Presidente della Provincia di Foggia Prof. Antonio Pellegrino ad inserire quest’opera, proposta dal Museo del Territorio nella Collana di studi della stessa Provincia con la consapevolezza che queste testimonianze letterarie possano essere il volano di una proiezione del Museo del Territorio, in un Museo-Racconto, un Museo-Itinerario inserito in un più vasto tragitto del sapere e della partecipazione. In un’epoca segnata fortemente dal progresso tecnologico, dalla telematica e dalle immagini virtuali si rinnova più forte il rapporto tra letteratura e storia per preservare le memorie di noi tutti e creare testimonianze culturali di questa terra per coloro che ancora non la conoscono. L’Antologia presenta brani scritti sia da chi in questo territorio è nato ed ha le sue radici, sia da chi invece viaggiando nella luce e nei colori di questa terra stupenda ma schiva, è riuscito a coglierne la bellezza e l’ospitalità, legandosi al passato più o meno lontano, ai suoi tesori e alle sue antiche memorie, intravedendone ed indicandone il suo possibile futuro. 7 Sommario 11 Prefazione “postuma” Mario Sansone PARTE III Foggia Corrado Augias 71 Foggia al tempo di Federico II di Svevia PARTE I 75 Foggia 13 Un lascito, una profezia La Capitanata al tempo dei Latini 17 La Via Appia John Northall 19 La Puglia negli autori antichi Aldo Luisi PARTE II Itinerari e luoghi 29 Viaggio pittoresco Abbé de Saint Non 35 Da Foggia a Lucera François Lenormant 39 La valle dell’Ofanto François Lenormant 45 Impressioni di viaggio Paolo Schubring 53 Il Tavoliere Giuseppe Ungaretti 55 Dal Subappennino al Tavoliere Raffaele Nigro 65 Garofani rossi per Fausto Vasco Pratolini 67 Le pietre si muovono Maria Marcone Ernesto Kantorowicz Jocelyn Brooke 77 Clizia a Foggia Eugenio Montale 83 La prima rappresentazione alla Scala del Re di Forzano e Giordano Eugenio Montale 85 Due lettere inedite Umberto Giordano 87 Il Piano delle Fosse Giuseppe Ungaretti 89 Foggia e il Tavoliere Guido Piovene 101 Omaggio a Foggia Pasquale Soccio 103 Foggia Eugenio Bennato PARTE IV San Severo 107 Pianura Umberto Fraccacreta 109 I confini territoriali del “Monasterium Terrae Maioris” Antonio Casiglio 8 117 San Severo Andrea Pazienza PARTE V Lucera 121 Lucera, colonia saracena degli Hohenstaufen Ferdinand Gregorovius 137 Lucera Riccardo Bacchelli 141 Lucera, città di Santa Maria Giuseppe Ungaretti 145 Lucera dei Saraceni Giuseppe Ungaretti PARTE VI Rocchetta Sant’Antonio 151 Rocchetta la poetica Francesco De Sanctis 157 Passaggio in ombra Mariateresa Di Lascia PARTE VII Bovino 161 Il vallo di Bovino Pietro Paolo Parzanese PARTE VIII Cerignola PARTE IX Manfredonia 179 L’angelo di Manfredonia Norman Douglas 191 Santa Maria Maggiore Sipontina Giuseppe Ungaretti 195 La giovine maternità Giuseppe Ungaretti 199 Sabato Santo a Manfredonia Leonardo Sinisgalli PARTE X Mattinata 203 Il farmacista di Mattinata Virgilio Lilli PARTE XI Rodi Garganico 209 Fotogrammi di Rodi Minor Giuseppe Cassieri PARTE XII Peschici 217 Peschici Antonio Baldini PARTE XIII Monte Sant’Angelo 167 Lettera da Cerignola 225 Descrittione del Monte Santo Angelo 169 Da Cerignola a Canne della Battaglia 233 Monte Sant’Angelo 173 Al capezzale di mia madre 247 La Montagna dell’Arcangelo 175 Ho ingannato persino il Sindaco 255 Monte Sant’Angelo Justus Tommasini Friedrich Leopold Stolberg Nicola Zingarelli Pietro Mascagni Leandro Alberti Arthur Miller Ferdinand Gregorovius Corrado Alvaro 259 La Tomba di Rotari Giuseppe Ungaretti 261 Pasqua Giuseppe Ungaretti 9 PARTE XIV San Giovanni Rotondo 267 Quelle due fotografie di Padre Pio Graham Greene 269 San Giovanni Rotondo Antonio Baldini Elio Filippo Accrocca 337 Dal pattume dei secoli... Cristanziano Serricchio 339 Sante Mattéie Giacomo Strizzi 341 Viaggio in Puglia PARTE XV Il Gargano 275 Il Gargano in una relazione per visita canonica di fine Seicento Egidio Mattielli 281 Al Gargano Consalvo Di Taranto 283 In Gargano Riccardo Bacchelli 303 Conquista del sasso Giuseppe Ungaretti 305 La Foresta Umbra Tommaso Fiore 309 M’ascolti tu, mia terra? 309 (Ode al Gargano) Joseph Tusiani 315 Ex voto Alfonso Gatto 317 Gargano sessantuno Roberto Roversi 321 Oltre l’isola dei coatti qualcuno ha chiamato Anna Maria Ortese Maria Luisa Spaziani 343 Lamento per il Sud Salvatore Quasimodo 345 Da Foggia a Lucera correndo... Giuseppe Ungaretti 347 Segnorina pugliese Luciano Luisi 349 Stringe l’inverno... Michele Urrasio 351 Dedicata alla mamma Andrea Pazienza 353 I pellegrine d’Incurnate Raffaele Lepore PARTE XVIII 355 Citazioni Affermazioni, frasi e interviste di Alberto Moravia, Silvia Ballestra, Vittorio Gassman, Massimo Troisi, Piero Chiara, Lalla Romano 359 Bibliografia 361 Indice alfabetico degli autori PARTE XVI Isole Tremiti 327 Le Isole Tremiti Émile Bertaux PARTE XVII 331 335 Tavoliere controvento Poesie 333 Lettera a Padre Pio da Pietrelcina Gabriele D’Annunzio 11 Prefazione “postuma” Mario Sansone La Puglia, in genere, e la Daunia, in ispecie, sono state, sino a tempi recenti e recentissimi, tra le terre d’Italia meno conosciute e ritenute tra le meno sviluppate, non solo economicamente. Non che non fossero conosciuti scrittori e poeti pugliesi e dauni, ma si trattava di singole personalità, delle quali sarebbe stato assurdo ignorare il prestigio e il valore: ma l’affermazione personale era il risultato dell’antico malanno dell’emigrazione dei cervelli. Questa raccolta si presenta invece come il risultato di un diffuso e concorde fervore regionale, come l’espressione di un gruppo idealmente congiunto e volto al culto della poesia; come il segno di una terra che si muove, e che acquista, anche per questa via, il senso della sua autonomia. E, naturalmente, quando si parla di autonomia in ambito poetico, bisogna intendersi. Non si tratta di una pretesa autonomia rispetto ai modi, gl’indirizzi, il livello della poesia nazionale, e non si tratta di un singolare e privilegiato filone d’oro scoperto tra il Subappennino, il Gargano e la grande piana della Capitanata; si tratta di una poesia che non si avverte come esercizio di una sparuta ed isolata minoranza, ma che fa i conti con se stessa, si riconosce nei suoi pregi, nei suoi limiti, nelle sue aspirazioni e si chiarisce nei suoi propositi: si tratta, in conclusione, di una cospicua manifestazione di cultura di una regione - la Daunia - che va acquistando la coscienza del contributo che reca ed intende recare alle nostre cronache di poesia... (...) Perciò questa raccolta non ha nulla di provinciale o di attardato rispetto al lavoro di tanti operatori di poesia in Italia. (...) A noi basta riaffermare il significato storico, culturale e civile di questo libro dove non mancano cose belle e talora assai belle - ed augurare nuovi provvidi segni di autonomia intellettuale della piccola patria che abbiamo comune coi poeti della terra dauna. Nota Bene. Questa prefazione, così fatalmente adatta alla presente antologia, rappresenta in realtà un “saccheggio letterario” compiuto al testo Poeti dauni contemporanei (a cura di CRISTANZIANO SERRICCHIO, ANTONIO MOTTA e COSMA SIANI, Apulia Editrice, Foggia 1977). Ho fatto mio l’ardore poetico dell’indimenticato prof. Sansone, nella duplice speranza di restituire alla Capitanata uno fra i suoi figli più illustri e di testimoniare degnamente la coralità degli interventi riportati in questa raccolta. il Curatore 13 Un lascito, una profezia Corrado Augias Molti italiani, ma anche parecchi stranieri; molti scrittori ma anche parecchi poeti; molti autori contemporanei ma anche qualcuno del passato. A scorrere l’indice dell’antologia curata da Davide Grittani questo è il primo dato che salta all’occhio: la varietà dei contributi, la loro eccellenza, l’unitarietà dell’argomento. Basta fare qualche nome, anche se bisognerebbe per giustizia farli tutti: Graham Grene e Arthur Miller, Anna Maria Ortese e Alfonso Gatto, Umberto Giordano e Pietro Mascagni. Gente di penna, gente d’intelletto, creativi come si dice oggi, persone che hanno attraversato zone come l’Ofanto, il Subappennino, il Gargano, la Capitanata, il Tavoliere e ne hanno scritto colpite da una particolarità del territorio, da un riverbero di luce, da un resto del passato che da queste parti ha lasciato tracce lungo i millenni. E questi resti affiorano improvvisi come un lampo della memoria e raccontano, a chi è capace di coglierlo, il senso della loro sopravvivenza. È bella l’idea di Grittani di mettere insieme un’antologia composta da questi testamenti letterari e lasciarli parlare, lasciare cioè che le pagine si facciano testimonianza, lascito e profezia. Verso Sud, pochi avrebbero detto che tante minute particolarità di paesaggio sarebbero diventate con il tempo elemento distintivo di questa parte del Mezzogiorno d’Italia. Solo spiriti raffinati, menti aperte, occhi che sapevano guardare lontano potevano prevederlo. Perché al viaggiatore distratto certe parti della Capitanata possono anche apparire aride e inospitali, altri possono ricevere l’impressione di una terra destinata ad essere attraversata, inadatta per ciò stesso all’agio di una sosta prolungata. Invece è accaduto il miracolo, si è operato il rovesciamento. La terra che sembrava segnata dalla sua anima transumante, votata più ai “passaggi” che alle permanenze, più al “transito” che alla dimora, ha aperto davanti agli occhi di viaggiatori attenti la sua anima segreta. A che punto del viaggio, in base a quali circostanze, è avvenuto questo rovesciamento? Quali fattori hanno fatto venire alla luce la soluzione? Leggendo le pagine che avete davanti credo che una risposta si possa trovare. O almeno una delle risposte possibili. Quel fattore, quella circostanza, sono a mio giudizio la gente di Capitanata, il suo popolo. La semplicità della vita, la severità dei costumi imposta dalla povertà, a volte da 14 Verso Sud D. Grittani una vera miseria, non hanno mai fatto venire meno la generosità anche quando la precarietà delle condizioni di vita riduceva quella generosità a un gesto o a un sorriso. È stata la gente che ha fissato nella memoria dei viaggiatori l’immagine della terra, le gente cioè il popolo, i contadini, e quando non i contadini quelle borghesia colta e civile di provincia che è stata (e tutt’ora è) il nerbo dell’Italia migliore memore del proprio passato, aperta verso un ragionevole avvenire. Lo studioso e amico carissimo Franco Cassano ha dato un nome alla civiltà meridionale di cui stiamo parlando. L’ha chiamata la civiltà del tempo meridiano, un tempo che scorre secondo un suo ritmo interno, che ha priorità e gerarchie sue, che ha, verrebbe voglia di dire, una sua moralità. C’è ancora quel tempo? Esiste? Francamente non lo credo, o se è ancora esistente lo è per una minima parte. Esiste tuttavia dentro di noi, come un memento, cioè un’utopia, un indice che ci permette di misurare ciò che abbiamo perduto rispetto ad allora ma anche ciò che (altrettanto indiscutibilmente) abbiamo guadagnato. Le pagine che state per leggere fanno parte di questi indicatori. Vi troverete ciò che ci piace ricordare ma anche in parte ciò che, oggi, sarebbe impossibile tenere in vita. Troverete le immagini e i sentimenti, le luci e i colori, le tante ragioni che ci tengono legati a quel passato più o meno lontano ma anche i motivi che mettono quel passato tra le memorie individuali o collettive con le quali i conti sono ormai stati chiusi. Non c‘è solo questo da dire sulla bella antologia Verso Sud. A me piace che i libri servano alla vita e viceversa, che ci siano insomma scambi tra le pagine lette e l’esistenza vissuta. Quali scambi e considerazioni allora l’antologia di Davide Grittani può suggerire? Ne indico due, libero ciascuno di rifiutarle o di aggiungerne altre. La prima è che se quel Sud è in gran parte sparito come stato d’animo, inclinazione e sentimento, una nuova consapevolezza l’ha sostituito: l’ambiente e la terra, il passato e la memoria intese come ricchezza. Se avessimo avuto questa consapevolezza anni fa, quando un certo sviluppo economico è cominciato in modo così disordinato e convulso, non avremmo commesso gli errori e gli scempi di cui invece ci siamo resi colpevoli. Nulla è compromesso, intendiamoci. La ricchezza era immensa, ne abbiamo sperperato una parte, teniamoci allora stretta quella che resta, che è sufficiente se sapremo bene amministrarla. Sufficiente a far sì che i visitatori capaci di guardare le nostre terre con gli occhi dei viaggiatori d’elite racchiusi in queste pagine diventino sempre più numerosi. E anche, seconda considerazione, che venga rispettata la vera vocazione di queste nostre terre. Abbiamo fatto tanti calcoli sbagliati sul possibile sviluppo del Mezzogiorno. Certe volte era inesperienza, altre malafede. Questa antologia non è soltanto una testimonianza letteraria, è anche un vademecum, indica una direzione, può diventare la guida a uno sviluppo possibile e sostenibile. Questo intendo dicendo che i libri, a saperli leggere, servono anche alla vita, che insegnano a vivere meglio. PARTE I La Capitanata al tempo dei Latini 17 La Via Appia John Northall John Northall (1723? - 1759), abile soldato del quale restano incerti luogo e data di nascita. Nel 1752 si recò a Minorca da dove s’imbarcò per Livorno, ma anziché visitare le città italiane più note dapprima conobbe a fondo la Toscana, quindi Roma, Napoli e seguendo la Via Appia arrivò fino a Brindisi. Un resoconto postumo di questo viaggio fu pubblicato nel 1766 con il titolo Travels through Italy. In questa antologia riportiamo le pagine relative al VI capitolo The Appian way (testo tradotto da Angela Cecere). Quando i Romani sottomisero le popolazioni dell’Apulia e dei paesi vicini, continuarono la Via Appia da Benevento a Brindisi. La data esatta in cui questa parte della strada fu costruita non si conosce; ma, come ricorda Tullio nelle sue Epistole, è certo che accadde prima della caduta dell’impero. Tre differenti strade conducevano da Benevento a Brindisi; una sulla destra attraverso Venosa, Troia e i dintorni di Taranto, l’altra sulla sinistra attraverso Aecae e Herdonia (Ordona), e la terza correva fra le due precedenti attraverso Trevicum (Trevico), i dintorni di Asculum (Ascoli) e Canusia (Canosa). Tutte e tre le differenti strade lasciano Benevento proprio all’Arco di Taranto ora chiamato Porta Aurea. La strada che si dirigeva sulla sinistra attraverso Aecae, ora Troja, si divideva dalle altre due che conducevano ad Eclarium (Eclano), le cui rovine si trovavano nei pressi di Mirabella. Da Eclano la Via Appia si dirigeva a destra verso Venosa. Da Canosa la strada si dirigeva verso Ruvo, una cittadina assai antica. Proseguiva poi per Botuntus, ora Bitonto, situata in una fertile pianura. Di lí la strada continuava lungo la costa dell’Adriatico verso Bari, che era un municipio romano. Infine, la Via Appia continuava fino a Brindisi, e lì terminava. Brindisi è famosa nella storia per l’antichità e la bontà del suo porto. Nell’anno di Roma 487 fu sottomessa dai Romani, che vi instaurarono una colonia nel 509. Pompeo vi si ritirò durante le guerre civili, ma fu obbligato da Giulio Cesare ad abbandonarla, ed a ritirarsi nell’Epiro. È stata parecchie volte saccheggiata dai barbari, ma è stata ricostruita per la bontà del suo porto. La cattedrale è una splendida Verso Sud 18 D. Grittani struttura fatta costruire da re Ruggero di Sicilia. Il mare precedentemente circondava tre lati della città; ma attualmente la sua estensione si è notevolmente contratta. Qui vediamo parecchie iscrizioni ed altri antichi monumenti. La Via Appia che passava vicino Taranto giungeva a Brindisi dove si ricongiungeva alla Via Traiana. La seguente è una nota delle distanze da Roma a Brindisi: Destinazione Ad Ariccia Al Foro Appio A Medias A Terracina A Fondi A Formia A Minturno A Sinnessa Miglia 16 26 9 10 14 14 9 9 Destinazione Al Ponte Campano Ad Octavum A Capua A Benevento A Ruvo A Bari A Brindisi Totale da Roma a Brindisi Miglia 9 9 8 32 107 21 71 364 Si può osservare che le distanze sulle colonne miliari erano calcolate da Roma fino all’estremità del Lazio, considerato nella sua massima estensione, cioè appena al di sotto di Sinuessa; ma in Campania le distanze sulle colonne erano numerate da Capua. Le grandi città erano come un punto centrale da cui tutte le distanze dei territori circostanti venivano calcolate. La strada romana che passava attraverso Troja era quasi della stessa lunghezza di quella ricordata prima; ma quella che passava da Venosa e dalle vicinanze di Taranto era più breve di circa otto o nove miglia. Plinio fa la media di queste distanze, e calcola con Strabone 360 miglia da Brindisi a Roma. [Tratto da Travels through Italy; containing new and curious observations on that country, Londra 1766] 19 La Puglia negli autori antichi Aldo Luisi Pubblicato nel numero 3-4 dell’VIII anno del periodico Il Rosone, questo documentato saggio di Aldo Luisi ripercorre le tracce dei popoli che hanno abitato la Puglia dal IV secolo a.C. Attraverso una preziosa ricostruzione storica ed etimologica, Luisi contribuisce a far chiarezza sulle derivazioni che in seguito avrebbero dato i nomi a molte città e paesi della Puglia. La regione che noi oggi chiamiamo Puglia, fu dai Greci chiamata Iapigia e dai Romani Apulia. Essa si estende lungo le coste dell’Adriatico dal Gargano al Capo di Leuca per una lunghezza di circa 340 km, fino alla foce del Bradano lungo il Mar Ionio, confinando con i Frentani, col Sannio e con la Lucania. L’antica Iapigia o Apulia era suddivisa in Daunia, corrispondente all’attuale Capitanata; Peucetia, corrispondente alla zona di Bari e provincia; Messapia, corrispondente alla terra d’Otranto e della provincia Jonica. Attorno a questi nomi è fiorita una copiosa letteratura. Il dato storico spesso si è confuso con quello fantastico producendo in tal modo risultati poco chiari. Tuttavia, volendo riassumere i fatti, dobbiamo dire che sul territorio iapigio preesistevano popolazioni indigene con la loro civiltà all’arrivo dei Greci. Gli storici greci antichi hanno imbastito meravigliose leggende per nobilitare le origini dei propri stanziamenti in terra iapigia. Ciò ha portato inevitabilmente a grande confusione perfino nella individuazione dei popoli. Basti dire che contemporaneamente quei gruppi o agglomerati abitanti la Messapia erano indicati anche col nome di Salentini, Calabri, Japigi, Messapi. Quattro nomi per un unico gruppo omogeneo. 20 Verso Sud D. Grittani Fonti antiche I primi storici della Magna Grecia compaiono solo nel V secolo a.C.; cito per esempio Antioco di Siracusa, Ferecide di Lero, Ellanico di Mitilene, dei quali ci restano frammenti, per lo più, in tradizione indiretta, tramite Dionisio di Alicarnasso e Stefano di Bisanzio. Di maggiore interesse sono le opere dei due grandi storici Erodoto e Tucidide. Questi autori trasmettono solo occasionalmente notizie e informazioni sull’Italia meridionale. Così dicasi anche per scrittori del IV secolo: Pseudo-Scilace, Eforo e Aristotele: questi, rifacendosi ai precedenti, presentano solo deboli varianti a una stessa tradizione. È interessante notare in questo periodo la presenza di storici originari della Magna Grecia, come Filisto di Siracusa, Lico di Reggio e Timeo di Taormina. Di quest’ultimo un filologo tedesco, J. Geffken, ha detto che la sua opera potrebbe essere considerata la “summa” di tutte le conoscenze greche sull’Italia meridionale e sulla Sicilia, e i suoi successori vi avrebbero attinto abbondantemente. Tutti questi autori hanno operato nel campo della mitografia un eccellente lavoro di sintesi e di sistemazione delle leggende che inizialmente avevano un carattere locale. Un vero concentrato di mitologia è l’opera La Biblioteca, attribuita forse erroneamente al grammatico alessandrino Apollodoro. Fonte importante per i miti sull’Italia meridionale è anche l’opera poetica Alessandra di Licofrone di Calcide (a noi restano solo circa 1500 trimetri giambici). In quest’opera si hanno, in particolare, notizie sul culto di Calcante e Podalirio in Daunia (culto localizzabile con ogni probabilità a Monte Sant’Angelo sul Gargano). L’ultimo gruppo di storici comprende autori del I secolo a.C., quali Diodoro Siculo, Dionisio di Alicarnasso e soprattutto Strabone. Questi autori parlano delle grandi città italiote e siciliote e del loro rapporto con le popolazioni primitive della penisola. Nel campo latino le cose non vanno meglio. Tolti gli autori della prima e seconda annalistica, di cui abbiamo scarsi e lacunosi frammenti, gli altri, cioè gli storici dell’età imperiale, sono in generale assai poveri, per quanto riguarda il nostro argomento. Tuttavia una certa messe di dati può essere raccolta da Tito Livio, Plinio, Tacito, Velleio Patercolo, Giustino, e perfino dai caotici Collectanea rerum memorabilium del grammatico Solino e dal Commento all’Eneide di Servio. Questi autori latini, oltre ad avere attinto più o meno direttamente agli storici greci, a Eforo e a Timeo, devono avere utilizzato assai largamente Varrone. Quali conclusioni si possono trarre da questa rassegna delle fonti letterarie della storia più antica dell’Italia meridionale? È chiaro che la tradizione trasmessaci dagli autori antichi, nonostante il carattere di continuità che presenta dal secolo V sino all’epoca bizantina, non ci è pervenuta senza lacune e senza errori; ma è anche sicuro che, per A. Luisi La Puglia negli autori antichi 21 quanto nel corso dei secoli abbia potuto subire mutilazioni o deformazioni, non deve essere considerata un tessuto di invenzioni tarde, senza valore e fondamento. Apuli e Dauni Dal geografo Strabone sappiamo che i veri Apuli abitavano intorno al golfo del Gargano; che erano simili in tutto ai Dauni e ai Peuceti; e che solo nell’antichità furono diversi anche nel linguaggio. Lo stesso Strabone dice che i Greci davano agli Apuli il nome di Dauni. Al cap. 242 egli scrive «i Greci chiamano Dauni gli Apuli». Al cap. 277 aggiunge anche i Peuceti: «Dopo i Calabri a nord sono i Peuceti e i Dauni, detti così in lingua greca; ma gli abitanti chiamano Apulia tutta la regione dopo i Calabri». Al cap. 283 ribadisce che il nome di Peuceti e Dauni non è indigeno; che fu dato solo nell’antichità e che egli non può discutere con sicurezza i confini di tali popolazioni, perché tutta la regione dai Calabri ai Frentani a tempo suo si chiamava Puglia. Sicché dalle dichiarazioni di Strabone possiamo ritenere verosimile che gli Apuli abitavano tutta la regione prima dell’arrivo dei Peuceti e Dauni, i quali avendo occupato le loro terre, li relegarono intorno al golfo del Gargano. Ma quando giunsero in Puglia tali popoli? Dionisio di Alicarnasso nel I libro, al cap. 11, delle sue Antichità Romane scrive: «Diciassette generazioni prima della guerra troiana Peucetio, lasciato il Peloponneso, con la flotta allestita navigò lo Ionio. Appena giunto in Italia sbarcò sul promontorio Iapigio e vi stabilì la sua gente. E gli abitanti di quelle terre si chiamarono Peuceti». Lo stesso Dionisio conclude il cap. 13 dicendo: «Non so vedere spedizione più antica di questa che si recasse dalla Grecia alle parti occidentali di Europa». Notizia confermata da un altro scrittore greco, Pausania detto il Periegeta, vissuto nel II sec. d.C. al tempo di Adriano e Antonino Pio. Comunque sappiamo che i Peuceti sono Pelasgi venuti armati in Apulia agli ordini di Peucezio figlio di Licaone re della Pelasgia, detta più tardi Arcadia. Iapigi - Messapi Erodoto (IV, 99) afferma che gli Iapigi abitano il promontorio che va dal porto di Brindisi sino a Taranto. Vennero in Iapigia cinque anni dopo la morte di Minosse, tre generazioni prima dei fatti troiani, cioè tra il 1290 e il 1280 a.C.: «Erano Cretesi e divennero Iapigi-Messapi e in luogo di isolani si fecero continentali» (VII, 170). 22 Verso Sud D. Grittani L’espressione di Erodoto ci conferma che già nel V sec. a.C. i due popoli venivano confusi fra loro. La confusione si riscontra anche in Tucidide, che li considera l’uno parte dell’altro. E Strabone è assai imbarazzato quando deve parlare di Messapi, Iapigi, Calabri e Salentini: tutti nomi che nel suo tempo venivano usati indifferentemente per indicare le stesse popolazioni: secondo Strabone la Iapigia era chiamata dai Greci anche Messapia, e per gli indigeni era costituita, nella parte meridionale, dalla regione salentina, e nella parte settentrionale dalla regione calabra; a nord dei Calabri cominciava la regione che gli indigeni chiamavano, con un termine generale, Apulia mentre i Greci distinguevano un paese dei Peuceti (o Pedicli) e un paese dei Dauni. Polibio dal canto suo, dà sugli Iapigi notizie del tutto diverse, per quanto conservi al nome un valore collettivo: gli Iapigi avrebbero compreso tre popoli: quello daunio, quello peucezio e quello messapico. Ma gli abitanti di questa zona sono ricordati anche con altri nomi: Calabri e Salentini. Quanto ai Salentini, le notizie antiche sulla loro origine cretese sono assai più chiare: così, Cretesi li considera Strabone, il quale situa nel loro territorio un ricco tempio di Atena, nella località che i latini chiamavano Castrum Minervae. Ma, a differenza degli Iapigi, questi Cretesi della penisola salentina sarebbero stati condotti in Italia da Idomeneo, il quale, secondo Virgilio, approdò in quella zona dopo la caduta di Troia ed era re di Licto, a Creta; si spiega così come Solino dica che i Salentini discendevano dai Licti. Indicazioni più esaurienti le troviamo in un passo di Varrone conservatoci da Probo: passo che però non sembra essere stato riportato con troppa esattezza, per cui nei dettagli, se non nell’insieme, resta un po’ oscuro. Secondo Varrone, dunque, i Salentini, il cui nome viene spiegato con un gioco di parole, avevano una triplice origine, cretese, illirica e locrese; Idomeneo, fuggito da Creta a causa di una sommossa, si recò nell’Illiria; ripartito di qui insieme a un gruppo di Illiri, e congiuntosi in mare a un altro gruppo di esuli locresi, approdò a Locri, i cui abitanti, spaventati, fuggirono; si stabilì così nella città abbandonata, e poi fondò molte fortezze, fra cui Uria e Castrum Minervae. Il passo di Varrone si chiude con la notizia che i Salentini erano suddivisi in tre «parti» e in dodici «popoli». Le stesse indicazioni ritroviamo, in forma abbreviata, in Festo: anche Festo parla della Triplice origine, cretese, illirica e locrese, dei Salentini. Tutte queste coincidenze non fanno altro che consolidare le tradizioni degli antichi; ma ci servono anche da monito per farci capire che esse per essere valide devono necessariamente confrontarsi con altre tradizioni, soprattutto quelle emergenti dai dati dell’archeologia, dell’onomastica, della toponomastica. Oggi gli studi devono essere condotti di concerto con altre discipline. Non è possibile indagare in un mondo così lontano, quale quello dei primordi dell’Italia antica, in modo solitario. Occorre invece che ci si muova interdisciplinarmente. D’altra parte di un po- A. Luisi La Puglia negli autori antichi 23 polo non è sufficiente conoscere il solo nome, è necessario penetrare nella sua civiltà, negli usi, costumi, lingua, religione, insomma in tutto ciò che ci dà la dimensione esatta della vitalità di quel popolo. Tutto ciò non lo si può scoprire solo leggendo le fonti degli antichi, ma comparando queste con i dati forniti dalle altre discipline: archeologia, epigrafia, onomastica, toponomastica ecc. La penetrazione romana L’esame finora condotto lascia qualche dubbio dovuto al fatto che non sempre si è sicuri che il dato riportato sia collegato col fatto storico, trattandosi di argomenti così lontani nel tempo e così suggestivi per la presenza di elementi mitologici nel racconto. Questa seconda parte invece si avvale di una più ricca documentazione, perché indaga sui contatti dei Romani con gli abitanti dell’Apulia e tratta di un periodo storico più interessante e più vicino a noi. Secondo Tito Livio (8,25,3; 27,2) gli Apuli entrarono per la prima volta in contatto con i Romani, chiedendone l’alleanza, nel 326 a.C., appunto agli inizi della seconda guerra di Roma contro i Sanniti. Se la notizia, molto discussa, è vera, è probabile però che per Apuli si intendessero qui solo gli abitanti di Arpi, egemoni della Daunia iapigia e sicuramente dalla parte dei Romani durante la guerra. Per il resto i centri dauni, da alcuni indizi delle azioni militari come lo stesso Livio altrove osserva (8,27; 29; 37; 9,12), paiono essere stati piuttosto dalla parte dei Sanniti. Dopo la vittoria romana le città daunie, divenute alleate di Roma, entrarono a far parte della sua lega italica, una sorta di confederazione organizzata e guidata da Roma. La penetrazione romana nella regione non era in realtà ancora solida. Pochi anni dopo, agli inizi del terzo secolo, durante la terza guerra della lega di Roma contro quella dei Sanniti, la maggior parte degli Apuli sembra essere stata dalla parte dei Sanniti. Contro gli Apuli, secondo la tradizione, i Romani dovettero sostenere un duro scontro militare nel 297 presso Maleventum (Benevento). Solo Arpi e Lucera rimasero sicuramente fedeli a Roma. Appena poterono dunque i Romani nel 291 cercarono di rafforzare la loro posizione nella regione con una massiccia dedizione coloniaria latina a Venosa e a Lucera. Era un passo avanti strategico di grande rilievo. Nella successiva guerra di Roma contro Taranto, Venosa, Lucera, Arpi ed Ascoli operarono contro Pirro una resistenza molto importante. Dopo il fondamentale scontro, Taranto entrò nella confederazione italica guidata da Roma, che intanto aveva debellato e costretto all’alleanza Lucani e Bruzi. Gli Iapigi/Messapi (Calabri/Salentini riuniti in leghe) furono infine le ultime popolazioni italiche, nel 267 e 266, ad essere assoggettate da Roma e ad entrare nella sua lega. 24 Verso Sud D. Grittani Alla metà del III secolo dunque si conclude la cosiddetta «conquista romana» della Puglia. Soltanto nell’età dei Gracchi, fra il 133 e il 122 a.C. si procedette a una vasta colonizzazione del territorio pugliese. La guerra dei soci (90-88) rappresenta la svolta fondamentale nella storia dei rapporti fra Roma e l’Italia e quindi anche fra Roma e la Puglia. Si può dire propriamente che solo ora e non all’epoca della «conquista romana» del III secolo, la Puglia viene romanizzata. Da alleati, tutti gli Apuli diventano cittadini romani. Le città conservano una propria autonomia amministrativa; ma ora è Roma che regola, probabilmente con una serie di leggi, i singoli statuti cittadini delle nuove organizzazioni. È da osservare che dopo la guerra italica i nuovi municipi non furono raggruppati in alcun distretto regionale. Una prima divisione regionale d’Italia si ebbe con Augusto: fu divisa allora in undici regioni: la Puglia divenne la Regio secunda. La configurazione regionale di Augusto non prevedeva però una unità regionale amministrativa con magistrati e funzionari che vi sovraintendessero: era semplicemente una suddivisione di comodo per i compiti del censo e forse anche delle entrate delle tessazioni straordinarie. La viabilità La Via Appia arrivò in Puglia fino alla colonia latina di Venosa agli inizi del II sec. a.C. Solo successivamente giunse a Taranto, attraverso Silvium e da qui a Brindisi attraverso Uria. Città importanti come Canosa erano tagliate fuori dall’arteria consolare, pur essendo collegate a strade secondarie molto note. Orazio nel 38 parte da Roma in compagnia di amici per giungere a Brindisi. Egli segue la via Appia solo per un tratto, poi effettua una deviazione che lo porta a Canosa (Sat. 1, 5, 91) e quindi a Ruvo, Bari, Egnazia e finalmente a Brindisi (finis viae est) ove termina il viaggio (ivi, v. 104). La strada percorsa da Orazio fu fatta lastricare dall’Imperatore Traiano nel II sec. d.C. Essa collegava Benevento a Brindisi e offriva al viandante un’alternativa alla più antica via Appia. Da Benevento a Brindisi la via Traiana toccava i centri di Aecae (Troia), Herdonia (Ordona), Canusium, (Canosa), Rubi, (Ruvo), Butuntum (Bitonto), Caelia (Ceglie di Bari), Egnazia, Brindisi. A queste due arterie fondamentali va aggiunta un’altra strada che seguiva la costa adriatica del Sannio e si congiungeva a Siponto con altre strade collegate a quelle per Brindisi. A. Luisi La Puglia negli autori antichi 25 Aspetti socio economici Verso la metà del I sec. a.C. la crisi sociale coinvolge gran parte del territorio pugliese. I motivi sono tanti: le guerre, l’insicurezza dei mercati mediterranei, la diffusione della pirateria, ed altre cause che concorreranno a fare della Puglia la regione più spopolata d’Italia (Cicerone nel 49 a.C. dirà: Apulia inanissima pars Italiae). Di desolate terre d’Apulia (in desertis Apuliae) parlerà Seneca in età neroniana. Orazio, a sua volta, parlerà di Puglia assetata (siticulosa) e dannosa per l’influenza dello scirocco (Atabulus); essa è conosciuta povera d’acqua da altri autori, quali: Varrone, Strabone, Columella. Cicerone e Seneca parlano di insalubrità dei luoghi, mentre Cesare nel 48 a.C. ricorda di essere preoccupato per la salute del suo esercito accampato in una zona insalubre del territorio brindisino. Nonostante le ostilità dei luoghi i contadini locali hanno sempre reagito, tanto che Orazio parla di operosità dell’agricoltore apulo (Carm. 3, 16, 26 quidquid arat impiger Apulus). Sulle attività di lavoro in Puglia abbiamo una pregevole documentazione che ci deriva oltre che da iscrizioni anche dagli autori antichi. Si parla di mercanti, uomini di affari, banchieri, lavoratori edili, armatori di navi, sarti, artigiani, medici, tessili collegati alla pastorizia. Marziale ricorda l’eccezionale qualità della lana pugliese (14, 155) ricavata dai ricchi greggi dell’Apulia (2, 46); il candore della lana è degno di essere paragonato col bianco Galeso (12, 63). Lo stesso Marziale ricorda anche i tessuti scuri di Canosa (14, 127) e le bianche toghe lavate nel Galeso (4, 28). Da un’espressione di Marziale (14, 155) sappiamo che la Puglia aveva il primato in Italia della lana: «la Puglia è famosa per le sue lane di prima qualità, Parma per quelle di seconda qualità: le lane di terza qualità fanno onore ad Altino». Personaggi Tra i personaggi noti in ambiente storico-letterario c’è da ricordare il poeta Quinto Ennio di Rudiae, vissuto tra il terzo e il secondo secolo a.C. Secondo un famoso aneddoto riportato da Aulo Gellio (II sec. d.C.) Ennio era solito dire che aveva tre anime, poiché sapeva parlare greco, latino e osco. Non abbiamo documenti che attestino la penetrazione linguistica osca in Messapia, mentre conosciamo la diffusione della lingua osca in Peucetia dalle iscrizioni trilingui (osco, greco, messapico) rinvenute a Rubi e Azetium. È probabile che l’osco di cui parla Gellio sia piuttosto il messapico parlato dal volgo all’epoca di Ennio. La lingua ufficiale e dotta in Puglia prima della romanizzazione era la greca. Il latino, come lingua, si diffonde Verso Sud 26 D. Grittani nella regione solo alla fine del II sec. a.C. È comunque da ritenere che nel I sec. a.C. le lingue ufficiali e più note fossero il greco e il latino. Orazio chiama gli abitanti di Canosa «more bilingues» e Porfirione che commenta il passo annota che il fenomeno era diffuso «per omnem illum tractum Italiae». Sono in molti a sostenere che l’altra lingua parlata dai Canosini fosse una lingua indigena, probabilmente il messapico, lingua diffusa in Peucetia e specialmente in Daunia. Oltre Ennio c’è da ricordare Livio Andronico, greco di Taranto, deportato a Roma come schiavo durante la guerra tarantina e poi affrancato dalla gens Livia. Egli a Roma curò due generi letterari: il drammatico, di modello greco, e l’epico, traducendo in latino l’Odissea. Di Brindisi fu invece il tragediografo Marco Pacuvio, nipote di Ennio per parte di madre. Infine da ricordare Orazio, Lucanus an Apulus anceps, come egli diceva di sé, ponendo in dubbio se fosse lucano o apulo. Marziale (8, 18) non ha dubbi, lo chiama apulo: «Virgilio non volle cimentarsi nella poesia lirica coltivata dall’apulo Orazio». Alcune corrispondenze Daunia: Aecae = Troia; Arpi = Foggia; Ausculum = Ascoli Satriano; Aeclanum = Eclano; Cannae = Canne; Canusium = Canosa; Herdonia = Ordona; Luceria = Lucera; Salapia = Sapi; Silvium = Gravina; Sipontum = Siponto; Venusia = Venosa. Peucetia: Azetium = Rutigliano; Barium = Bari; Butuntum = Bitonto; Caelia = Ceglie del Campo; Grumum = Grumo; Neapolis = Polignano a Mare; Norba = Conversano; Palio = Palo; Rubi = Ruvo; Turenum = Trani. Messapia: Aletium = Alezio; Caelia = Ceglie Messapico; Callipolis = Gallipoli; Gnathia = Egnazia; Hydruntum = Otranto; Lupiae = Lecce; Manduria = Manduria; Neretum = Nardò; Rudiae = Rudie; Uria = Oria; Uzentum = Ugento. [Tratto dal numero 3-4 dell’anno VIII de Il Rosone, ALDO LUISI, Edizioni del Rosone, Foggia 1983] PARTE II Itinerari e luoghi 29 Viaggio pittoresco Abbé de Saint Non Jean-Claude-Richard de Saint Non (1727-1791). Abate, esperto viaggiatore autore di cinque volumi intitolati Voyage pittoresque ou description des Royaumes de Naples et de Sicile, pubblicati a Parigi tra il 1781 e il 1786 dall’editore Delafosse. In Ispagna, tutte le pecore appartengono al Re ed i pascoli ai privati; qui tutti i pascoli sono del Sovrano ed i privati pagano in proporzione al numero delle bestie che pascolano. Queste pecore passano l’inverno e la primavera in pianura e durante l’estate si spostano in montagna. A sei miglia da Manfredonia il terreno comincia a salire avvicinandosi ai monti: qui il paese assomiglia del tutto per clima e caratteristiche del suolo alla Provenza. Dopo essere passati sul luogo dove era l’antica Siponto arrivammo a Manfredonia. Manfredonia fu costruita da Manfredi, quello stesso che fu ucciso davanti a Benevento. Dopo aver edificato questa città per popolarla vi fece venire delle famiglie da diverse parti della Puglia; la città fu poi distrutta e quasi completamente devastata dalle incursioni dei Turchi, ma fu poi ricostruita. C’è a Manfredonia un castello a prova di colpo di mano; un molo naturale sul mare forma un porto che per la sua scarsa profondità non può chiamarsi se non una rada ma assai sicuro per posizione ed al riparo dei venti del Nord per le montagne che formano lo sperone dello Stivale, chiamato Monte Gargano. Il fondo è poi così regolare che l’ancoraggio è ottimo; vi si vedono molte navi veneziane che vi portano tele, mercanzie minute e caricano granaglie, lana, etc., prodotti naturali del paese. La città di Manfredonia è ben costruita, aperta e popolata da quattromila abitanti; noi eravamo alloggiati nel Convento dei Domenicani ai quali eravamo stati indirizzati dal Preside di Lucera che ci aveva dato lettere per tutti i Sindaci del suo distretto; fummo ricevuti in modo perfetto dal Priore che era un uomo buono ed affabile. 30 Verso Sud D. Grittani L’indomani vedemmo arrivare il Governatore del Castello che aveva già mandato il suo luogotenente ad interrogarci. Con l’anima tutta piena del suo Castello ebbe sul principio l’aria di considerarci dei nuovi normanni che venissero a riconquistare la Puglia; è da credere poi che il nostro aspetto pacifico lo avesse rassicurato subito. Dopo pranzo, tornammo sui nostri passi per un miglio e mezzo, nel luogo dove era l’antica Sipontum, fondata da Diomede, il fondatore di città. Si ritiene che essa tragga il nome da Saepia e da Pontium, mare di seppie, a causa della quantità di seppie (supia o calamaro), specie di polipi che si trovano in abbondanza su questa spiaggia. Da lì ci recammo ad osservare, quattrocento tese più lontano, delle strade dove si vedono i resti di antichissime catacombe quasi a fior di terra: erano scavate in un tufo giallastro molto simile alla pozzolana ma che è una concrezione marina mescolata ad una infinità di conchiglie di ogni grandezza. La distribuzione e la forma delle tombe antiche è quasi simile a quella delle catacombe di Napoli e gli ossami vi sono del pari ben conservati. Questi sotterranei sono attualmente scoperti perché sono stati scavati per ricavarne le pietre con le quali fu costruita Manfredonia ma si vede ancora dappertutto la traccia delle torce che servivano anticamente agli abitanti di queste oscure dimore. All’ingresso di queste catacombe è stata presa la veduta incisa n. 6, nella quale l’artista ha riunito le strade, le rovine di Siponto, il sito stesso di Monte Sant’Angelo che si scorge dalle alture, come anche le montagne che formano il promontorio volgarmente chiamato lo Sperone dello Stivale. Non può riconoscersi subito l’esistenza dell’antica Siponto se non per il rilievo che le antiche volte sotterranee dànno al terreno. Non si sa quando fu distrutta, ma una chiesa costruita su quel suolo nell’undicesimo secolo permette di stabilire che la sua distruzione fu anteriore a quell’epoca. Il che dimostra come questa chiesa sia stata ricostruita dopo la distruzione della città di Sipuntum e che essa sia il solo edificio ancora integro esistente in quel luogo, costruito con antichi resti ricomposti secondo lo stile greco dell’epoca e con gli stessi caratteri della chiesa di Troja della quale abbiamo parlato prima. Essa è ancora la chiesa episcopale di Manfredonia. Sotto la chiesa è stata costruita una cappella sotterranea molto interessante e che costituisce un’altra prova di ciò che abbiamo ora detto essendo quasi interamente composta da fusti di colonne di marmo antico ma con capitelli moderni. Di queste due chiese sono state incise le vedute n. 7 e 8. Nello stesso luogo trovammo dei fusti di colonne, di grandezza media, di marmo cipollino e di granito, dei grandi capitelli antichi e corinzi, un fregio dorico ed un piedistallo con questa iscrizione in onore di Antonino: Abbé de Saint Non Viaggio pittoresco 31 imp. Caesari divi hadriani f. Divi traiani partici n. Divi nervae pronep. Tito aelio hadriano antonino avg. Pio. Pont. Maximo tri. Pot. Cos. Sipvnt. Publice D… D… Questo piedistallo di tre o quattro piedi di altezza e con un larghezza di base di due piedi e sei pollici, sosteneva senza dubbio una statua perché si vede ancora il segno del posto dove doveva essere collocata. Poiché la curiosità, il desiderio di vedere e di scoprire ci faceva ricercare ed osservare tutto ciò in cui ci imbattemmo, scoprimmo a qualche distanza da lì due piccole volte sotterranee che volemmo osservare più da vicino: erano sormontate e coperte da un paramento e da un intonaco che doveva formare il solaio di una antica casa. Queste rovine ci dettero inoltre il livello del suolo antico, a poca profondità. Vi erano pure dei frammenti sporgenti di antiche muraglie, a forma di settore circolare, che potrebbero indicare un teatro ma gli avanzi sono così diruti che non può aversene alcuna certezza. Il mare, a quanto sembra, arrivava a lambire le mura della città, dato che lo spazio che intercorre tra questa elevazione e l’attuale riva è uno stagno a fior d’acqua. Il giorno dopo il nostro arrivo a Manfredonia ci venne la curiosità di andare a Monte Sant’Angelo, uno dei primi santuari della Cattolicità, nel quale, si dice, il primo angelo del Paradiso ha voluto mostrarsi agli uomini in una brutta grotta umida e scura nella quale da quindici secoli si va a prendere il raffreddore. Nonostante la mia scarsa fiducia nei luoghi miracolosi, indussi i miei compagni ad accompagnarmi in questo pellegrinaggio e così arrivammo sul luogo cavalcando molto umilmente degli asini. Ciò che maggiormente stimolava la nostra curiosità era il desiderio di visitare un luogo che era stata la cagione prima della calata dei Normanni in Italia. Si sa che questi Paladini famosi vi furono attirati specialmente dai racconti meravigliosi che sentivano fare dai pellegrini dell’epoca e da tutto ciò che della bellezza e della feracità di questo paese essi narravano. Al posto però di tutte queste meraviglie non trovammo che una montagna arida, secca e dirupata; tanto alta che vi fa freddo quasi sempre e per tutto l’anno. Nonostante queste condizioni poco piacevoli vi sono però ottomila abitanti ma senza commercio, quasi senza attività produttive ed altra fonte di reddito oltre 32 Verso Sud D. Grittani quella costituita dall’affluenza dei pellegrini in alcuni mesi dell’anno. Eravamo diretti dal Governatore che non parlava alcuna lingua e ci mise nelle mani di un canonico che ne parlava una misteriosa. Avrei voluto poter trascrivere quello che diceva perché, quando ebbe finito il suo pio sproloquio, ci fu impossibile capire una sola della parole che aveva pronunciato. Da parte mia mi comportai a meraviglia: guardai, ammirai, baciai tutto ciò che egli mi volle far baciare ed ammirare. Comprai anche delle statuette dell’Arcangelo e mi caricai di pietre della Grotta. Ma ciò che ci piacque più di tutto e ci compensò di tutte le nostre pene fu il portarci via una affascinante veduta del luogo e della scena stessa alla quale avevamo assistito e che uno dei nostri disegnatori eseguì rendendone, con tutto lo spirito ed il realismo possibile, il tumulto ed il movimento di questo genere di feste popolari molto più comuni e gustate in Italia che in qualsiasi altro luogo. Dimenticavo di parlare del simulacro di San Michele che è famoso nel paese e che viene attribuito, per la somiglianza del nome, a Michelangelo Buonarroti. Questa brutta piccola statua è eretta su una specie di colonna tronca, sproporzionata e deturpata da un enorme capitello che funge da piedistallo. La figura del Santo è alta tre piedi, l’espressione della testa è priva di carattere ed è pochissimo adeguata all’azione del momento che è quello in cui l’Angelo atterra il Diavolo. Questo, poi, ha l’espressione di una vecchia arrabbiata. Nel complesso, l’atteggiamento della figura è brutto, i dettagli sono meschini e, nell’insieme, di qualità molto mediocre. Alla statua è stata impostata una armatura d’argento dorato che riesce ancor più ad impoverirla e guastarla. Non avendo potuto trovare a Manfredonia né calessi né cavalli, fummo costretti a prendere umilmente un carretto col quale ci mettemmo in istrada, seguendo la riva del mare lungo la spiaggia perfettamente piatta per cui avevamo sempre una ruota nell’acqua ed una sulla riva. Questa vasta, immensa piana si estende all’interno per una larghezza di quaranta miglia; è un terreno incolto, qualche volta arido e popolato di pecore e nelle parti più basse ed umide frequentato da bufali e da altro grosso bestiame, con capanne di paglia sparse per alloggio dei pastori. Lungo il litorale si trovano, ad ogni sei miglia, delle torri di guardia, costruite per la sicurezza del territorio e cioè per annunciare con il cannone le scorrerie che un tempo frequentemente facevano i Barbareschi, gli Albanesi ed i pirati turchi; ciò è molto meno frequente da quando gli sciabecchi e le feluche del Re di Napoli incrociano nei paraggi e soprattutto da quando la Repubblica di Venezia si è assunto l’incarico della polizia dell’Adriatico. Dopo aver traghettato su due fiumi o ruscelli che incontrammo sulla nostra strada e che si gettano poco lontano nel mare, ci fermammo presso una delle torri Abbé de Saint Non Viaggio pittoresco 33 per far riposare i cavalli e sei miglia più avanti giungemmo alle Saline che forniscono di sale tutto il Regno e che, volendo, lo fornirebbero a tutto il mondo per la facilità di estendere all’infinito le fosse di raccolta dell’acqua marina. [Tratto da Voyage pittoresque ou déscription des Royaume de Naples et de Sicile, ABBÉ DE SAINT NON, Delafosse, Parigi 1781-1786. Il testo è stato curato da Franco Silvestri e ristampato, nel 1972, dalle edizioni d’arte Carlo Bestetti, Roma] 35 Da Foggia a Lucera François Lenormant François Lenormant (Parigi 1837-1883). Archeologo francese che attraversò in lungo e in largo tutta la penisola italiana, soffermandosi con attenzione quasi morbosa nelle regioni meridionali. La descrizione dei sentieri di Capitanata di François Lenormant resta, ancora oggi, tra i documenti più suggestivi della storia di questa terra. Il testo Da Foggia a Lucera, così come gli altri che seguono, è tratto da Attraverso la Puglia e la Lucania, opera pubblicata nell’anno della sua morte. Augusto aveva qui inviato una nuova colonia di veterani e tanto gli scrittori quanto le iscrizioni mostrano che essa mantenne fino alla fine il suo grado coloniale, con i privilegi conseguenti. Nella Tavola di Peutinger essa è segnata come sede d’un praetorium provinciale. L’importanza di Luceria si mantenne oltre le invasioni barbariche e gli spaventosi saccheggi delle guerre dei Goti. Paolo Diacono la descrive come città opulenta sotto la dominazione dei Longobardi, che ne fecero il capoluogo d’un loro castaldato. Ma nel 663 l’imperatore greco Costante II la tolse a costoro e la distrusse quasi del tutto. Da questo momento, per sei secoli, Lucera rimase una semplice borgata, dove risiedeva comunque un vescovo. In tale stato essa era ancora nel 1223, quando Federico II, proprio l’anno in cui costruì il palazzo di Foggia, costrinse i musulmani ribelli di Sicilia a chiedere l’aman e a rimettersi alla sua mercé. Giudicando imprudente lasciarli in val di Mazzara, dove le loro tradizioni d’indipendenza erano troppo vive ed era per loro troppo facile, in caso di rivolta, ricevere aiuti dai fratelli d’Africa, non volendo neppure privare i suoi Stati di una tale valida e industriosa popolazione con una espulsione simile a quella compiuta in seguito dalla Spagna, egli si decise a spostarli sul continente italiano. La massa degli Arabi di Sicilia fu dunque per suo ordine trasportata a Lucera, Girofalco, Acerenza. Lucera fu la colonia principale, e per accogliere quella massa fu eretta un’enorme fortezza, dove in 36 Verso Sud D. Grittani un primo tempo essi vissero separati dalla popolazione cristiana della città. In tal modo trapiantati, dopo un tentativo di rivolta nel 1226, gli Arabi accettarono rapidamente il nuovo destino con la facile rassegnazione dei musulmani e ben presto si legarono persino con ardore e devozione al sovrano che aveva serbato loro la vita, nel momento in cui le abitudini e il diritto di guerra, secondo i costumi dell’epoca, gli avrebbero consentito il loro sterminio. Soggetti tutti al servizio militare, le loro milizie furono per più di vent’anni nerbo e nucleo permanente degli eserciti di Federico II, e la fortezza da loro occupata, portata a termine nel 1227, diventò il principale punto d’appoggio della denominazione degli Hohenstaufen nelle province bagnate dall’Adriatico; quando la rottura tra l’imperatore e il papa divenne palese e insanabile, la presenza dei musulmani a Lucera diventò doglianza di cui il sovrano pontefice fece maggiormente echeggiare il mondo cristiano contro Federico. Morto Manfredi e dispersa la sua famiglia, i saraceni di Lucera si sottomisero al conquistatore, il quale mantenne i loro privilegi e le leggi speciali. Ma l’anno seguente, all’annuncio dell’approssimarsi di Corradino, che si preparava a valicare le alpi, essi issarono di nuovo sulle loro torri lo stendardo della Casa Sveva sicché Lucera ridiventò il punto di coagulo dei Ghibellini nel Sud della penisola. Carlo d’Angiò volle tentare di far capitolare la roccaforte prima che il suo antagonista arrivasse dall’Alta Italia. Ma dopo parecchi mesi di inutili attacchi, dovette togliere l’assedio per avviarsi verso Corradino. Quando l’ebbe vinto e ridotto a morte, tornò davanti a Lucera nel 1269. I musulmani si difesero strenuamente ma, dopo un lungo assedio, furono infine costretti a capitolare per fame. Il 15 agosto, essi aprirono le porte della città e sfilarono davanti al vincitore irritato, il quale li costrinse a passare sotto il giogo. Ma Carlo non volle assolutamente privarsi dei servigi di guerrieri, di cui aveva potuto apprezzare il valore, sicché diede loro salva la vita e concesse di continuare ad abitare la città. Solo li privò dei privilegi, del diritto di governarsi da sé stessi all’interno della città e di avere quali ufficiali di giustizia i loro cadì, i quali giudicavano tutte le questioni secondo la legge musulmana. Li sottopose invece alla diretta autorità del giustiziere della provincia e mise sessanta lance come guarnigione nel castello, al fine di sorvegliarli. Nello stesso tempo, in ricordo della sua vittoria e al posto della principale moschea della città, ordinò di costruire una grande chiesa dedicata alla Vergine al posto dell’antica Cattedrale, dando alla città il nome ufficiale di Lucera Christianorum. Nel 1799 San Severo, come Andria e Trani in provincia di Bari, fu il luogo in cui F. Lenormant Da Foggia a Lucera 37 si riunirono i Borbonici per resistere alla nuova Repubblica creata in quel momento dai Francesi. Il generale Duhesme venne all’attacco con una divisione dell’esercito di Championnet e coi volontari napoletani comandati da Ettore Carafa, conte di Ruvo, poiché questo capo della grande famiglia dei Carafa, sì illustre nella storia, la prima del Napoletano del XVII secolo, aveva con ardore abbracciato la causa repubblicana, come gran parte dell’alta nobiltà del Regno. La resistenza e l’attacco ebbero l’accanimento proprio delle guerre civili. La lotta fu senza quartiere e la città fu presa solo dopo che Carafa, come era avvenuto ad Andria, fece dar fuoco alle case per stanare i loro difensori. In fatto di ferocia, poteva rivaleggiare con lo stesso cardinale Ruffo, suo avversario, che lo cacciò dalla Puglia, ma era un uomo di incomparabile valore e la sua morte fu bellissima. In seguito dalle bande infinitamente superiori per numero dei Sanfedisti, si rinchiuse in Pescara, dove la fame lo costrinse alla resa, a patto, regolarmente firmato, che avrebbe potuto liberamente ritirarsi con i suoi soldati. Incurante della parola data, il cardinale Ruffo lo fece arrestare e rinchiudere nella prigione di Castel Nuovo a Napoli, dove i giudicicarnefici della regina Carolina, al ritorno della corte, lo condannarono alla decapitazione. Salendo con passo deciso e con volto sereno il patibolo, egli chiese ed ottenne di essere disteso supino sul piano della ghigliottina, col viso verso la lama: «Io, nobile e discendente di prodi, disse, mentre muoio per la libertà della mia patria, voglio vedere lo strumento del supplizio davanti al quale tremano i vigliacchi». A metà strada tra Lucera e San Severo, sono le insignificanti rovine di Castel Fiorentino, il castello di villeggiatura dove, il 13 dicembre 1250, morì Federico II. Scoraggiato dalle sconfitte subite in Germania e nel Nord d’Italia, ma soprattutto dalla notizia della prigionia del figlio Enzo, indebolito dalla malattia, sentendo venir meno l’energia indomabile che lo aveva fino allora sostenuto nelle più grandi prove, intravedendo ovunque intorno a sé il tradimento pronto a manifestarsi, voleva rinchiudersi nella fortezza di Lucera tra i suoi fidi Saraceni. Giunto a Castel Fiorentino, il suo stato divenne tale che dovette fermarsi. Il nome del luogo, ricordandogli una predizione dei suoi astrologi, fece nascere nel suo animo sinistri presentimenti. «Morrete, – gli era stato detto – presso la porta di ferro, in un luogo il cui nome sarà formato dalla parola fiore». Siccome nella camera regale il letto nascondeva un’antica apertura da lungo tempo chiusa, che poteva immettere in una torre attigua, egli la fece aprire, sicché essa si trovò munita d’una porta di ferro. «Mio Dio, – esclamò allora Federico, – se devo rendervi l’anima, si compia la vostra volontà!». Poi, con perfetta calma, chiamò vicino a sé Berardo, arcivescovo di Palermo che da trent’anni, malgrado gli anatemi pontifici, gli serbava grandissima fedeltà; Bertoldo, marchese di Hohenburg, capo delle truppe tedesche e suo parente; 38 Verso Sud D. Grittani Riccardo di Montenegro gran giustiziere del Regno, il calabrese Pietro Ruffo, che da origini oscure egli aveva elevato alla dignità di maresciallo; infine Giovanni da Procida, suo amico e medico, lo stesso che in seguito sarebbe diventato l’anima della congiura dei Vespri Siciliani. Alla loro presenza, egli dettò il suo testamento al notaio Nicola da Bari. Ciò avveniva il 10 dicembre; tre giorni dopo, il sovrano che da trent’anni faceva risuonare il mondo dell’eco del suo nome, spirava nella notte, assistito dall’arcivescovo di Palermo, che gli somministrò i sacramenti. Per il resto, una profonda oscurità aleggia sui particolari dei suoi ultimi momenti. Per quanto attiene alla lotta tra Papato e Impero, le passioni avevano raggiunto sotto Federico II un tal grado di violenza, la menzogna e la calunnia s’erano sì trasformate in abitudine dalle due parti, che è impossibile prestare cieca fede ai racconti degli scrittori contemporanei sulla benché minima decisiva circostanza della sua vita. Ciascuno, senza alcuno scrupolo, secondo l’interesse del suo partito, inventa ciò che può recar vanto o offuscare la memoria dell’imperatore e la minore preoccupazione dei cronisti Guelfi e Ghibellini è il rispetto della verità. Secondo i Ghibellini, dopo aver professato in tutta la vita una filosofia scettica, Federico morì da cristiano pentito, rivestito, secondo l’uso del tempo, d’un saio monacale, piangendo sui suoi peccati e edificando coloro che lo assistevano. Invece i Guelfi lo rappresentano sul suo letto di morte in preda a rabbiose convulsioni, divorato dal veleno, senza alcun pentimento, senza desiderio dei Sacramenti, mentre minaccia la Chiesa e digrigna i denti. Se si è in diritto di pensare che i primi hanno forzato le cose come a loro pareva per onorare il loro eroe, gli stessi termini del testamento di Federico smentiscono il furore e l’empietà a lui attribuiti dai secondi nel suo ultimo momento di vita. Ma dove la calunnia dei cronisti Guelfi diventa avvero atroce e supera talmente la misura da tradire la sua menzogna, è quando sostiene che Federico II fu soffocato sotto il cuscino dal figlio Manfredi, avido di impadronirsi del denaro del tesoro e di aprirsi la strada per il trono. Nessuno storico serio si è soffermato su quest’abominevole accusa, smentita dalla sua stessa assurdità quanto dal nobile carattere di Manfredi, ben più retto e leale del padre, per il quale un parricidio, in qualunque circostanza si fosse verificato, avrebbe prodotto conseguenze più funeste per i suoi interessi. Una tale accusa è stata avanzata dopo la tragica morte di Manfredi, quando non bastava più agli odi di parte aver dissotterrato il suo cadavere alla fossa in cui i soldati di Carlo d’Angiò l’avevano deposto sul campo di battaglia di Benevento, per darlo in pasto ai corvi, volendo che persino il ricordo fosse coperto d’infamia. [Tratto da Attraverso la Puglia e la Lucania, FRANÇOIS LENORMANT, 1883] 39 La valle dell’Ofanto François Lenormant Fra tre anni al massimo si andrà da Foggia a Melfi in ferrovia: per ora non è compiuta ed è in esercizio soltanto una parte del percorso, quaranta chilometri circa. La linea, attraverso il piano, si dirige a sud verso le montagne, gradualmente allontanandosi da quella che conduce a Benevento ed indi a Napoli, e passa, a diciotto chilometri da Foggia, a pie’ della modesta collina sulla quale è il piccolo villaggio di Ordona, prossimo alle rovine di Herdonea. Questa era un’antica città degli Apuli, ricordata nella storia della seconda guerra punica per essere stata il teatro delle due successive vittorie di Annibale sui Romani, la prima, del 212 a.C., col pretore Cn. Fulvius Flaccus, e la seconda, del 210, col proconsole Cn. Fulvius Centomalus, in seguito alla quale il generale cartaginese, diffidando della fedeltà degli abitanti della città stessa al suo partito, che essi avevano abbracciato dopo la battaglia di Canne, la fece radere al suolo, e ne inviò con la forza tutti i cittadini, parte a Metaponto e parte a Thurioi: i superstiti di essi, otto anni più tardi, furono, finita la guerra, ridati dai Romani ai propri lari, ma la città ricostruita non riguadagnò mai più la sua importanza passata restando d’allora una località secondaria, per quanto sotto l’Impero fosse municipio, e riprendesse una qualche vita dopo la costruzione della grande via, che porta il nome di Traiano, da Benevento a Brindisi per Castelfranco (Equus Tuticus) e Canosa (Canusium), che divenne la principale strada per andarsi ad imbarcare per l’Oriente, e che attraversa Herdonea, la quale è appunto una delle stazioni che gli itinerari segnano sul suo percorso. I resti, assai numerosi ma del tutto informi, che ancora si osservano sul sito di questa antica città, mostrano nella loro costruzione la maniera dell’epoca degli Antonini: Herdonea fu distrutta nel IX secolo, in una delle incursioni dei saraceni che occupavano Bari dove avevano stabilito anche un Sultano. A tredici chilometri più oltre, presso un’altra stazione, v’è Ascoli, cittadina di poco più che cinquemila abitanti, sede vescovile, con una cattedrale della metà del secolo XVI e l’antico palazzo fortificato de’ suoi conti, di cui la successione rimonta 40 Verso Sud D. Grittani al tempo di Carlo d’Angiò, feudo che da Carlo V fu eretto a principato per Antonio de Leyva ed indi, nel XVIII secolo a ducea. Ascoli, posta a cavaliere d’una delle ondulazioni che qui incominciano a pronunziarsi in modo sensibile e si rannodano ai contrafforti dell’Appennino, ha conservato quasi senza alterazione il nome dell’antica città apula cui è succeduta, Asculum o più esattamente Ausculum come lo scrivevano le leggende monetarie, Auhusclum in ozeo, le rovine della quale, piuttosto rilevanti, si vedono fuori la cinta delle mura. Ausculum, al tempo della sua piena indipendenza, fu in effetti molto importante e prosperò tanto da battere monete proprie. Sotto le sue mura Pirro, nel 279 a.C., combattè la seconda battaglia contro i Romani, battaglia di cui anche ora, con Plutarco alla mano, si possono seguire le fasi principali sul terreno che presenta sempre le pieghe e le alture delle quali i consoli profittarono abilmente per condurre il loro esercito. Però vi si cercherebbe invano un avanzo dei fitti macchioni dai quali il suolo in gran parte era allora coverto in modo da ostacolare completamente le cariche degli elefanti del re d’Epiro e della brillante cavalleria dei Tarantini e da impedire che la fanteria legionaria fosse battuta come alla battaglia di Eraclea. La campagna d’intorno oggi è completamente brulla, essendo il territorio di Ascoli compreso nei confini del Tavoliere e quindi sottoposto al suo regime devastatore. In questi campi, forse più che altrove nella provincia, pullulano le famose tarantole. Ascoli ebbe a due riprese colonie di cittadini romani da Caio Gracco e da Giulio Cesare, e mantenne sempre un posto coloniale sotto gli Antonini. Le iscrizioni ci fanno conoscere che sotto Valentiniano era ancora tra le principali città dell’Apulia. S’ignora poi la sua sorte sotto i Goti e i Longobardi, ma da brevi indicazioni de’ cronisti si sa che i Bizantini vi s’installarono nel 950 e che indi, nel 970, l’imperatore Ottone il Grande la prese e la occupò per qualche tempo. Nel 1041 fu una delle prime città che si diedero spontaneamente ai Normanni per sfuggire ai Greci, e nella ripartizione famosa essa fu assegnata a Guglielmo Bracciodiferro, il primogenito dei figli di Tancredi d’Altavilla. Quando poi il conte Abagelardo o Abelardo, figlio d’Umfredo e sempre pronto ad erigersi a competitore di Roberto il Guiscardo, si fu ribellato per la seconda volta abbattendo Boemondo, s’impadronì di Ascoli di cui fece una delle sue piazzeforti (1076). Però presto Roberto venne ad assediarla personalmente e se ne impadronì di bel nuovo. Qualche anno dopo, avendo essa manifestato velleità di rivolta mentre Roberto guerreggiava in Oriente contro l’Imperatore greco, suo figlio Ruggiero la distrusse e ne disperse gli abitanti, per non ricostruirla, istallandovi nuovi coloni, che dopo essere diventato egli stesso, morto il padre, duca delle Puglie. Da quell’epoca la storia della città non offre più nulla di notevole, tranne il parlamento che vi tennero i baroni del partito angioino per F. Lenormant La valle dell’Ofanto 41 eleggere i sei deputati incaricati di governare, all’arrivo di Luigi II d’Angiò, la porzione del Regno che gli era favorevole. Del resto essa decadde rapidamente dal XIV secolo, decadenza principalmente dovuta alla fatalità dei cinque terremoti che la distrussero del tutto in un periodo di tre secoli, negli anni 1348, 1360, 1456, 1627 e 1694. Due leghe dopo Ascoli la ferrovia, pel momento, termina alla stazione di Candela, stazione costituita da una semplice baracca in legno che deve il suo nome a un borgo di tre o quattromila abitanti, posto a qualche chilometro di distanza, sulla cima di un’alta solitaria collina a pan di zucchero, dipendente nel passato dal ducato di Melfi. In tale stazione, in tempi normali, non si trova ad affittare che cavalli da sella per recarsi alle località vicine, ma noi vi eravamo attesi da una vettura che ci era stata mandata da Melfi, il cui cocchiere subito ci chiese se preferivamo battere la strada maestra o l’accorciatoia, avvertendoci che il primo percorso era doppio del secondo. Volendo guadagnar tempo ed arrivare ancora di buon’ora all’antica capitale dei conti di Puglia, preferimmo naturalmente l’accorciatoia, e, fatto caricare i bagagli sulla vettura, ci mettemmo subito in cammino a traverso i campi, o, al più, seguendo un sentiero sterrato, fatto solo pel passaggio dei carri da buoi a ruote piene, solcato da profonde carraie, dove si deve restare impantanati senza possibilità d’uscirne solo che faccia due o tre giorni di pioggia. Ma il viaggio divenne sopra tutto orribile raggiungendo i resti del selciato d’una vecchia strada medioevale, quella forse che al tempo dei Normanni univa Ascoli a Melfi; e ancora adesso non so spiegarmi come mai la carrozza non si sia cento volte squassata nel passare su queste grosse pietre disgiunte tra cui s’aprono buche profonde. Passandovi, io mi domandavo quante volte avevo maledetto in Grecia i resti, ridotti nel medesimo stato, delle antiche vie selciate dell’epoca veneziana e dei primi tempi della dominazione turca, dove il viaggiatore ad ogni passo intravede il momento in cui, sbalzato di cavallo, debba rompersi il collo cadendo. In tal modo, tra sobbalzi violenti, guadagnammo una catena di colline nude e povere d’alberi tanto quanto la prossima pianura, passate le quali vedemmo ai nostri piedi il corso dell’Ofanto, l’Aufidus degli antichi. Quasi secco in quel momento, non era che un filo d’acqua giallastra corrente in fondo ad una vallata stretta di cui uno dei fianchi si solleva rapidamente in pendio. Il letto, molto largo, è ingombro di ciottoli e di pezzi di roccia strappati alle montagne, donde discende, nella stagione in cui le piogge invernali e lo scioglimento delle nevi ne fanno il sonans Aufidus di cui canta Orazio. In questo tratto, di inverno esso è un torrente impetuoso che tutto travolge nel suo corso, ben diverso dal tratto prossimo al mare in cui, come l’ho visto qualche anno fa dinanzi a Canosa e a Canne, trascina pigra- 42 Verso Sud D. Grittani mente le sue acque nel piano, su di un terreno senza più quasi pendenza, e le sparge in impaludamenti irti di canne. Scesa una costa quasi a picco, eccoci in fondo alla valle, sull’argine del fiume, dove però la collocazione del pietriccio per la futura ferrovia ha soppresso il sentiero che costeggiava la riva sinistra, nè ve n’è altra tra i fitti boschi della destra. Il cocchiere spinge bravamente i suoi cavalli giù, sull’argine, guada la corrente, e dopo, invece di risalire dalla parte opposta, ritorna a destra, continuando sul letto dell’Ofanto che rimontiamo per circa due chilometri, Dio sa a prezzo di quali scosse per noi e di quali disagi pei nostri poveri cavalli, tagliando e ritagliando i meandri sinuosi della stessa corrente quasi a secco, arrestati ad ogni istante da pezzi di roccia o da tronchi d’alberi da essa portati al tempo della piena. Giungiamo finalmente ad un ponte in pietra e mattoni, uno dei tre che sonvi su tutto il corso del fiume; la base de suoi piloni è di costruzione romana, e può facilmente notarsi come dall’Impero esso sia stato più volte ricostruito e più volte asportato dalle piene invernali. È il ponte di Santa Venere. Qui la via da Benevento a Venosa (Venusia), per Equus Tuticus a pie’ dei monti, passava l’Ofanto. Ora questo ponte imbocca la via maestra da Foggia a Melfi, che finalmente raggiungiamo: per prenderla rimontiamo l’argine della riva sinistra, passiamo il ponte, ci arrampichiamo su per una lunga costa tra i boschi e, giunti in fondo, ci troviamo su d’una specie di promontorio di notevole altezza, contornato dal fiume, dal quale, da qualunque parte si volga lo sguardo, l’occhio spazia su di una incantevole ed ampia veduta. Quardando indietro, verso il lato donde siamo venuti, vediamo ai nostri piedi la valle aprirsi quasi subito nella pianura grigia e nuda in cui serpeggia il fiume, pianura che, diritto innanzi, si stende senza ondulazioni fino alle lagune del Pantano e di Salpi, e fino al mare, mostrando in mezzo ai suoi campi senz’alberi, su di una collinetta appena accentuata, le bianche case della città commerciale di Cerignola, dove il duca di Nemours nel 1503 perdette, contro Consalvo di Cordova, la battaglia che decise del possesso del Regno di Napoli. Sul limite estremo dell’orizzonte, a sinistra, il Gargano, di cui si vede solo una parte, chiude la pianura. A dritta, di là dall’Ofanto, il terreno si solleva un poco, mostrando subito un primo altipiano sul quale è costruito Lavello, che vide morire Corrado IV nel 1252; più lontano verso il mare, s’ergono le colline sulle quali è Canosa tanto ricca di monumenti e di memorie latine e medioevali; e finalmente un po’ più a destra, ha inizio la rocciosa catena delle Murge. Dal lato opposto si scorge la valle, sempre più stretta e profonda, dell’Ofanto superiore che discende dalle alte ed aspre montagne della Basilicata, da presso Pescopagano, montagne d’aspetto torvo e sinistro che ben si addice al ricetto di un F. Lenormant La valle dell’Ofanto 43 popolo di eroici briganti qual’è stato quello degli antichi Lucani. Le pendici della valle più prossima a noi son coverte di boschi e di campi disseminati di solitari ciuffi d’alberi, e in fondo si scorge un ponte antico a tre luci, il ponte dell’Olio, l’antica stazione di Pons Aufidi degli Itinerari Romani, dove la via Appia, nel suo primitivo tracciato, varcava il fiume andando da Benevento a Venosa. Poco più avanti, in linea retta, dall’altro lato della valle, è il borgo di Monteverde, pittorescamente posto a cavaliere d’un dirupo che forma come l’avanguardia delle montagne in cui si nasconde l’antica Aquilonia, una delle città del piccolo popolo degli Irpini, della quale il nome moderno è Lacedonia, curioso esempio della conservazione popolare degli antichi nomi locali, poiché esso si approssima assai più alla forma osco-sannita, nota per le monete, di Akudunniu, anzi che a quella latina di Aquilonia. Ancora un breve tratto fra i boschi di querce, e finalmente si è in vista del Vulture... [Tratto da Attraverso la Puglia e la Lucania, FRANÇOIS LENORMANT, 1883] 45 Impressioni di viaggio Paolo Schubring Scrittore e viaggiatore tedesco, visitò la Puglia nella metà dell’Ottocento. Nel testo qui riportato Schubring si produce in una descrizione abbastanza fedele della vasta pianura del Tavoliere delle Puglie. Si crede generalmente che la Puglia sia un deserto monotono, un paese privo di attrattive speciali e proprie della regione italiana. Ma «chi crede a questo cartello, non mangia vitello». L’immenso piano della campagna leggermente ondulata, il mare così maestoso, il cielo così infinito e sereno costituiscono una trinità grandiosa e singolare. In tutto si riscontra il carattere orientale, e specialmente nell’intensità e nella purezza de’ colori. L’aspetto della campagna muta, nella notte stellata, è poi indimenticabile! Plutarco racconta di un uomo, che, avendo visto il Giove di Fidia a Olimpia, ne aveva riportato una tale impressione, da ripetere sempre: «Chi ha visto una volta la testa fidiaca di Giove, non può diventare del tutto infelice». Lo stesso si può dire della beltà unica e maestosa della campagna pugliese. Il rapporto dell’uomo con la natura ha sempre in special modo richiamato la mia attenzione, e già a scuola io intuivo la diversità di sentimento naturale ne’ Salmi e nell’Iliade, senza saperla comprendere. Più tardi mi stupì l’indifferenza del medio evo per la natura, specialmente perché, nonostante questa indifferenza, i trovatori cantavano sempre sullo stesso tono l’amore insieme con la primavera. Alfredo Biese mi ha insegnato nel suo noto libro su Lo sviluppo del sentimento della natura nel medio evo e nell’età moderna, che il sentimento della natura come unità, come un giuoco di forze infinite, chiuse misteriosamente, non prospera nell’animo primitivo o ancora mezzo barbaro, ma che una tale aspirazione verso la grande unità invisibile sorge primieramente nello spirito ben educato, che indaga al di là dell’utile e del benessere materiale. Così solo si comprende come i Crociati, che tornavano dall’Oriente, vantassero in modo puerile i gioielli d’oro e d’avorio de’ reliquiari bizantini, e i broccati persiani, e le sete arabe, senza far cadere parola sul carattere 46 Verso Sud D. Grittani della contrada, o almeno mostrarsi stupiti del suo aspetto singolare. Per intendere la natura come unità, e capire il paesaggio come veduta, bisogna aspettare le grandi conquiste del Rinascimento. I poeti hanno festeggiato la natura prima de’ pittori: i diari del Petrarca e di Enea Silvio Piccolomini sono più vecchi rispettivamente di due e di un secolo della pittura del paesaggio presso i Veneziani. L’arte del paesaggio non ha però raggiunto la perfezione nel paese dove nacque. Già da lungo tempo questo genere di pittura ha iniziato la sua marcia trionfale attraverso il nord dell’Europa, e in questo secolo specialmente i Francesi ne hanno ottenuto il primato. Gl’Italiani, al contrario, ancora oggi, non accettano, di fronte al sentimento intimo, la pura immagine del paese. Questo popolo, così sviluppato artisticamente, non vede e non dipinge né il paysage intime, né, quel che a lui dovrebbe essere più simpatico, il paesaggio eroico. Furono artisti tedeschi e francesi quelli che scoprirono il fascino della linea continua, e trovarono il profilo delle catene montuose, nude, non coperte d’alcun bosco, la cui magnifica linea ci fa pensare al maestoso ritmo della vita ascendente e discendente. Questa purità lineare de’ pendii meridionali, che l’occhio gusta così intensamente, considerata al lato economico costa abbastanza cara. Un disboscamento privo di ogni precauzione, ha denudato i paesi del bacino mediterraneo. Il piccolo arbusto, che spontaneamente germogliava, è stato, sin dalle radici, rovinato dalle capre, come la grande selva è stata distrutta dall’uomo. L’unico bouquet d’alberi, singolarmente folto, che rimane ancora, come testimone della vecchia e verde maestà de’ boschi mediterranei, è il promontorio Athos nella Calcide. Qui i monaci vietano l’entrata alle femmine, così che anche la capra è compresa nella clausura! La sciocchezza umana ha una volta fatto bene a sé stessa! Non si può descrivere il modo che oggi tengono i pellegrini sul Gargano e a Bari, per dimostrare la loro devozione al Santo: è più una prurigine dei sensi che un elevarsi della mente e del cuore. Cupi suoni animaleschi vengono emessi; le lingue, che leccano il suolo, diventano sanguinanti; il piegarsi, l’alzarsi, il baciare sudici sassi, il mercanteggiare la manna, è tutto un quadro oltremodo indegno. E, sulla moltitudine piagnucolante e in ginocchio, sta il coro de’ preti in abito violaceo, che girano gli occhi e sorridono dolcemente, guardando intorno. Possono andar superbi dell’opera loro: essi sono padroni della massa, ma a qual prezzo! La povera gente s’abbruttisce nella sua libidine, i preti benedicono! Anche qui il passato può nuovamente venire a toglierci dallo sconforto dell’oggi. La dominazione bizantina non ha potuto mai consolidarsi nel Tavoliere; la storia del paese principia co’ Normanni. Questi hanno diretta la loro sistematica conquista della penisola da Melfi, che era proprio la loro cittadella. La conquista del Tavoliere riuscì, relativamente, facile; molto più facile del distretto del Catapano greco. E, come segno della loro vittoria, essi ampliarono, sulle alture dei monti a nord- P. Schubring Impressioni di viaggio 47 ovest di Foggia, la colonia greca di Troia, che fu la sede del loro Arcivescovo, la città d’incoronazione de’ Re Normanni. Troia, adagiata su di un monte, non può restar nascosta al viaggiatore che percorre la strada ferrata da Foggia a Napoli; ma raramente il turista si va a ficcare fin lassù. Un unico charà-bancs mette in comunicazione la stazione di Giardinetto con la sommità del monte. Lassù manca un albergo, un caffè. Potemmo avere esclusivamente de’ maccheroni in un portone, dove cavalli, asini, un cane, quattro polli, e undici bambini banchettarono con noi. La cara gioventù ci attorniò poi così fitta, durante la nostra visita alla cattedrale, che ce ne rammentammo per due giorni e due notti. Ma la cattedrale è così singolare, che si perdona alle stesse pulci! La sua costruzione risale a’ primi tempi del secolo XII; nel 1119 doveva essere già compita. Il piano superiore della facciata, come ha giustamente rilevato il Mothes, rimonta al secolo XIII. Questa facciata è la più splendida dell’Italia meridionale. Una poderosa cornice orizzontale la distingue in due piani, di cui l’inferiore è diviso in diverse arcate, il superiore è adorno di un ricchissimo cornicione interrotto nel mezzo da un rosone gigantesco. Questa disposizione differisce totalmente dal tipo delle altre costruzioni pugliesi. La tradizione lombarda, che fa le pareti intere, e articolate soltanto da due lievi pilastri, non è rispettata; qui si è invece provato a ornare la parete in un modo, che ricorda subito la cattedrale di Pisa, sorta proprio allora, e ritenuta e ammirata come una meraviglia del mondo. È chiaro che i Normanni volevano fabbricare le loro chiese diversamente da quelle della regione che conquistavano. Essi trovarono a Bovino, nelle vicinanze di Troia, una colonia di Pisani, che, il traffico della metropoli commerciale toscana, costituiva la stazione e l’emporio dell’esportazione di Levante. L’edifizio meraviglioso della cattedrale pisana, consacrata al culto nel 1118, diede il modello per la chiesa dell’Incoronazione di Troia. L’alternarsi delle pietre nere e bianche, l’ornamentazione de’ quadrati angolari, la pianta con la navata trasversale sporgente, il colonnato dell’abside son tutte reminiscenze di Pisa. I Normanni non aveva un’arte propria, quando nel principio del secolo XI irruppero nella Puglia. In Sicilia essi si sottomisero all’arte araba; in Puglia cercarono di importare almeno l’architettura di un’altra provincia italiana. Oltre questo di Troia, vi sono tre altri edifici, eretti dalla colonia pisana per commissione de’ Normanni: la cattedrale di Foggia, la chiesa oggi mezzo distrutta dell’abbandonata Siponto, e la cattedrale di Benevento, ricostruita nel secolo XI. Troia ha nella sua cattedrale due porte di bronzo: quella del portale maggiore sorpassa in splendore, bellezza e ricchezza tutte le altre dell’Italia meridionale, fatta eccezione di Benevento. In essa la tecnica bizantina del niello contrasta ancora con la fusione indigena del rilievo. Io non conosco ceffi d’animali più stupendi de’ leoni 48 Verso Sud D. Grittani e de’ cani che portano gli anelli de’ battenti di questo portone; e così pure sono lavorati in modo singolare i corpi scagliosi e inanellati de’ draghi anguiformi che recano i battenti della porta. Le porte sono state fuse a Benevento: la grande nel 1119, la piccola nel 1127. Doveva esser questa una chiesa molto ricca, se poté far costruire due simili porte di bronzo, allorché una tale decorazione era riguardata come l’ornamento più prezioso e più costoso di una chiesa. Se la cattedrale di Troia ci conserva vivo il ricordo della magnificenza de’ principi normanni, gli altri edifici di queste contrade ci riconducono col pensiero della signoria normanna, all’indimenticabile svevo Federico II. In Germania i Gesuiti tentarono di falsare e di distruggere la memoria di questo imperatore, a vantaggio del nonno Barbarossa, ma il paese, nel quale Federico ebbe la sua sede e morì, non se n’è lasciato defraudare. Per qual motivo l’imperatore, cui apparteneva mezzo settentrione, venne qui a scegliersi per residenza la piccola città di Foggia e non Palermo fu la sede del suo governo? La spiegazione è facile a darsi: a Palermo non si sentiva abbastanza sicuro; i nobili palermitani non avevano dimenticato le sanguinose giornate di Enrico VI, sebbene l’oppressore fosse finalmente perito, a loro vendetta, per mano della propria moglie. Ma a Foggia Federico era sicuro: nelle vicinanze di Lucera aveva stanziati, quali guardie del corpo, 20.000 Saraceni, che più volte dettero prova della loro grande fedeltà. E presso questa guardia, in Ferentino, egli morì. Le mura del castello di Lucera, che è stato molto ingrandito sotto gli Angioini, sono ancora in piedi. Nella grande corte, fiancheggiata da diciotto torri, vediamo, con gli occhi della nostra fantasia, avvicinarsi le vecchie truppe orientali: neri cavalli con gualdrappe rosse, feroci condottieri con mantello azzurro, turbante e scimitarra; quivi, predominante in mezzo a uno stuolo di dame dagli occhi lucenti, la bella Fartima, che regalò al suo imperatore il prediletto Manfredi; e poi tutta la suppellettile orientale variopinta, alla rinfusa, con tutta la sua clamorosità, con tutta la sua stupefacente stranezza, un quadro davvero multicolore, che avrà spesso ricreato l’occhio d’artista di Federico, quando egli entrava per la «Porta de’ Saraceni». Certamente Castel del Monte, il castello di caccia presso Andria, come edificio, è più importante; ma Lucera ci rammenta la presenza dell’Oriente, lo splendore della mezzaluna nel cuore d’un paese continuamente attraversato da’ Crociati. E non è veramente strano? L’imperatore stesso intraprese una crociata contro gl’infedeli, che allora egli medesimo aveva fatto stabilire nel suo proprio paese, senza punto esigerne la conversione. Del palazzo di Federico a Foggia è rimasto ben poco; solo un pregevole arco con fogliami e aquile ricorda la scomparsa magnificenza. Forse in avvenire l’edificio verrà restaurato e isolato con la stessa cura che si spese per il palazzo di Teodorico a P. Schubring Impressioni di viaggio 49 Ravenna; così si avvantaggerebbe molto la nostra conoscenza dell’architettura profana degli Staufen, e costruzioni come il palazzo imperiale di Gelnhasen, vicino a Francoforte, si comprenderebbero forse meglio nella loro origine. L’impero tedesco ha un obbligo di fronte a questi monumenti dell’arte sveva nel mezzogiorno d’Italia: i castelli dell’imperatore svevo, che nella sola Puglia son diciassette, dovrebbero essere isolati, esaminati e illustrati. Questa sarebbe un’impresa che ci converrebbe assai meglio di qualche spedizione in Oriente. Il movimento nazionale che con tanta passione avvampò per trent’anni, e scavò un profondo abisso fra sé e il passato clericale, ha dato fino a oggi pochi frutti. Si parla più di quel che non si agisca: ecco il male. Di fronte alle insostenibili condizioni economiche si vive in una precarietà permanente, alla quale sembra che si sia così bene abituati, che ogni energica innovazione viene risentita come rigorosità. Il contadino pugliese, per assicurarsi il sole, suole avvolgere un panno intorno alla poppa della capra madre, e quindi i piccoli capretti cadono estenuati, o tuttalpiù crescono mezzo morti di fame. L’ingenuità di un tal calcolo s’incontra qui a ogni passo: se si ha da vivere per domani, si può andare a letto soddisfatti. Io conobbi in Puglia de’ genitori, che avevano preso in abbonamento un palco al teatro, possedevano una bella carrozza, ergevano degli splendidi monumenti sepolcrali, ma tralasciavano per tutto l’anno di pagare la tassa scolastica per i loro figliuoli. Se possono con una qualunque parola insignificante trarsi fuori, per dieci minuti, da una situazione scabrosa, credono di esserne usciti onorevolmente. Da lungo tempo non sono più assuefatti alla lealtà e alla schiettezza: è evidente che dicono quel che nel momento è opportuno. Il più delle volte ciò ha la sua origine nella politica, nelle elezioni: un candidato sacrifica spesso mezzo patrimonio per una campagna elettorale: se egli vince, bene; se no, circa cinque famiglie restano rovinate per venti anni. Come si può a capo di una certa rettitudine con un simile governo parlamentare? Il paese qui geme affannosamente sotto il peso di spaventevoli tasse. Le imposte dirette, massime quelle sulla ricchezza mobile, sono sproporzionatamente alte. Ma soprattutto le indirette gravano in particolar modo, come una maledizione, sulla popolazione povera. Infatti per ogni bottiglia di vino si debbono pagare dodici centesimi di gabella comunale, e il pane quotidiano non può introdursi esente da dazio. Oltre a ciò esistono i molti monopoli: il tabacco e il sale sono immensamente cari. Spesso i contadini fanno tre quarti d’ora di corsa verso il mare con l’intento di risparmiar pochi grammi di sale per i maccheroni, che vengon cotti nell’acqua marina. Tutta questa miseria si potrebbe sopportare, se lo smercio fosse in qualche modo agevolato; ma appunto per i prodotti del suolo dominano ancora metodi 50 Verso Sud D. Grittani primitivi. Se a Bari negozianti tedeschi non avessero, da sessanta anni a questa parte, diretta l’esportazione de’ vini, degli oli e delle mandorle, il paese se ne starebbe ancora oggi derelitto in mezzo alla sua divina ricchezza. Lo Stato ha fatto poco per migliorare la tecnica agricola, per riguadagnare terre paludose e malariche con la piantagione di alberi, con l’imboschimento di terreni poveri e privi d’acqua. L’antico sistema del subaffitto fa poi che l’ultimo fittaiuolo guadagni pochissimo lavorando molto. Si potrebbe, innanzi a queste negligenze dello Stato, con una stretta di spalle passare all’ordine del giorno, se il povero popolo, per le sue buone qualità, non meritasse tutta la nostra compassione. Per quanto possano essere corrotti i diecimila altolocati, altrettanto sono sincere, pure, fedeli le classi inferiori. Chi viaggia nel treno diretto conosce soltanto l’ingenua impudenza di questi poveri diavoli, che si attaccano come mignatte a forestieri, da’ quali sperano un qualche momentaneo sollievo alla loro dura sorte. Ciò non è affatto piacevole, ma nondimeno è naturale comprensibile. Però si guardi ora un poco l’operaio e il contadino italiano non eccitato da nessun inglese. In lui si trovano ancora le virtù semplici e pur tanto difficili della sincerità, della gratitudine, della modestia, della castità. In questa gente non vi è nulla di falso, tutti hanno il pregio di un tatto interiore così delicato, che di rado ci pentiamo della schietta famigliarità loro accordata. Io ne ho incontrati alcuni che non concepivano la mancia; altri la prendevano, ma la portavano ai loro genitori. L’attaccamento ai genitori è proprio commovente. Un giovane di 36 anni, per rispetto, non fumava in presenza del padre, quantunque questi lo invitasse. Tali piccoli tratti sono notevoli, poiché ci danno la misura del sentimento, che poi si manifesta in casi più importanti. Che cosa non ci sarebbe da fare con tali uomini! Le donne, per abitudine, frequentano le chiese, sebbene la diffidenza verso i preti sia molto forte; gli uomini le accompagnano di rado, perché di domenica si continua a lavorare. Donde prende questa gente i sentimenti suoi più alti e benefici? Lo Stato si presenta più di frequente come vampiro, che come benefattore, e per lo più si accosta a loro nella dogana e nella caserma, due istituzioni assai odiate. Quindi, solo stimolo al bene, resta l’amore per la famiglia e un innato impulso di preparare ai figli un avvenire migliore del proprio. Pure dovrei parlare soltanto d’arte. Ma si vedono tante cose quando si viaggia in regioni dove i treni diretti sono poco conosciuti. Le strade ferrate, in Puglia sono un argomento doloroso, che non si può toccare sine ira. «Si spende tanto», «non si arriva mai», ecco quel che si sente dire tutti i momenti. Ad eccezione della Spagna, nessun paese europeo può gloriarsi di un servizio così strascinato e costoso. Ma è meglio non parlarne. P. Schubring Impressioni di viaggio 51 Una delle più belle gite che si possano intraprendere da Bari, è quella per Bitonto. La via costeggia il mare, quindi attraversa estese piantagioni di olivi, la cui forma stranamente fantastica mi ricorda sempre le antiche Driadi e fate boscherecce. Bitonto deve il suo splendore e il suo duomo all’Imperatore Federico II e al padre di costui, Enrico VI. La città fu una volta potentemente fortificata, e conserva ancora gli avanzi delle vecchie porte e delle mura, che han fatto buona prova in qualche assalto. Il Duomo in questi ultimi tempi, sotto la direzione dell’abile architetto Ettore Bernich, è stato liberato dagli ornamenti sovraccarichi, con i quali lo avevano coperto nel secolo XVIII; così esso offre la più chiara idea di quelle costruzioni lombardo-bizantine, che ho già descritte nei precedenti articoli. All’esterno risalta lo splendido corridoio de’ matronei (tribunale per le donne), la cui favolistica animalesca, selvaggiamente fantastica, illustra bene il capriccio inventivo di quel tempo. Si notano inoltre sontuosi portoni nella facciata occidentale, con ricche sculture (sull’architrave Cristo e i dodici apostoli; più su la Madonna con degli angeli; ai lati, l’intero sistema planetario; sul davanti due leoni, modellati così bene da sembrar vivi), e nel portone della parete meridionale si può forse scorgere l’influenza saracena. Ancor più rilevanti sono, nell’interno, l’ambone e il pergamo, ambedue del principio del secolo XIII. Pur troppo l’ambone non è conservato nella sua primitiva forma (con doppia entrata); però, anche così ridotto, produce un effetto grandioso, in grazia della sua purezza di stile. Si nota subito che l’età contribuì con tutte le sue forze per erigere una tribuna di così gran valore, in omaggio alla parola di Dio marmi, figure, ornamenti di vetro, colori, nulla è risparmiato. Il leggio viene portato dall’aquila superba, che ci rivela il protettore svevo; uno schiavo nudo, ginocchioni, la sostiene, ed è proprio una di quelle guardie saracene, che Federico aveva acquartierate a Lucera. Del resto non mancò lo stesso imperatore: una balaustra della scala rappresenta mentre viene ossequiato dai vassalli. Si comprende l’unione, in quei tempi, dell’imperatore col clero, anche se l’imperatore scrivesse, così, a caso, un libro De Tribus impostoribus (Federico non ha di certo composto il libro, ma lo avrebbe ben potuto scrivere). Sugli antichi capitelli delle arcate poggiano le alte pareti superiori, in cui si aprono le trifore delle logge. L’intelaiatura del tetto, scoperta e dipinta, accresce l’impressione dell’architettura leggera, e pur così saldamente piantata. E adesso ancora una gita alla tanto rinomata Canosa, che nell’antichità godette d’una fama universale per la sua fabbrica di vasi; poi, dal 216, celebre perché immediata al campo di battaglia di Canne; e finalmente nel secolo XI, nota come resistenza d’un nobile normanno. La battaglia cominciò alle cinque del mattino e sembrò dapprima favorevole ai Romani; ma verso mezzogiorno la sorte cambiò: i cavalieri di Annibale, che erano stati posti accortamente, lontani dal fiume, e che perciò godevano piena libertà di movimento accerchiarono da 52 Verso Sud D. Grittani oriente. Dei 90.000 Romani, così dice la tradizione, ne caddero 70.000! Quale strage dobbiamo immaginarci, se con spade e lance furono scannati, da 40.000 nemici, 70.000 uomini, in quattro ore? Canosa nella sua antica cattedrale di S. Sabino possiede una costruzione puramente bizantina de’ secoli X e XI. L’ideale dell’agia Sofia presente all’architetto, che cercò di riprodurlo modestamente. I preziosi avanzi di questo antico tempio, la sedia episcopale e l’ambone, giacciono oggi, infranti, nel granaio, e la grande Confessio è sorretta da travi di legno. Al contrario il mausoleo del Duca Boemondo di Taranto (morto il 1110) è ben conservato. Fu costruito durante la vita del principe, ed è un vero gioiello architettonico. La parte inferiore, rettangolare, coperta tutta di marmo e sostenuta da colonne e capitelli all’antica, viene coronata da una graziosa cupola ottagonale, il cui profilo e le cui colonnine non hanno pari. Anche qui abbiamo una porta di bronzo, metà bizantina in niello d’argento, e metà saracena con ornamentazione plastica e geometrica. L’artista si chiama Ruggerus Melfiae Campaniae. Per l’aggiunto di Campaniae si vuole riconoscere in questa Melfi, Amalfi; ma ciò nonostante si ritiene trattarsi di Melfi in Basilicata, avendosi sicura notizia della fonderia di questa città normanna. In ogni modo la porta è stata fusa in terra italiana, quantunque la tecnica sia bizantina. 53 Il Tavoliere Giuseppe Ungaretti Giuseppe Ungaretti (Alessandria d’Egitto 1888 - Milano 1970). Quelle dedicate alla Capitanata dal poeta caposcuola dell’ermetismo sono pagine che commuovono per la loro straordinaria intensità. Si tratta di prose che videro per la prima volta la luce come articoli della Gazzetta del Popolo, dal febbraio al settembre 1934. Successivamente le prose vennero raccolte in un volume intitolato Deserto e dopo (a proposito del quale Luigi Paglia, studioso foggiano docente di letteratura, deve ritenersi tra i più profondi conoscitori) contenente autentiche dichiarazioni d’amore nei confronti di una terra, la Capitanata, che deve aver riservato a Ungaretti un’indimenticabile accoglienza. Per l’appunto da Deserto e dopo sono estratti tutti i brani riportati in questa antologia, suddivisi - ci auguriamo opportunamente - a seconda delle aree geografiche che l’illustre poeta visitò e descrisse con commovente sentimento. Foggia, il 20 febbraio 1934 Fontane Non saprei dirvi dove potreste trovare una cosa più sorprendente e commovente, e augurale, delle tante fontane che s’incontrano oggi fra le palme, arrivando a Foggia. Foggia e le sue fontane! Non è quasi come dire un Sahara diventato Tivoli? L’acquedotto non c’era. Finalmente questi Pugliesi a furia di sperare e di gridare avevano ottenuto che fosse progettato e s’incominciasse a costruire. Questo lavoro da Romani era stato intrapreso: l’uomo, così forte, come dicono i santi, perché l’unico fra gli esseri viventi a sapersi debole, aveva raccolto e alzato nelle sue povere braccia un fiume, l’aveva con una grazia mitica voltato dall’altra parte del monte… alla fine, sì, c’era l’acquedotto; ma in mezzo ai litigi andava in malora. Alcuni tratti di diramazione, sì, erano arrivati sino alla Capitanata; ma chi credeva più che dovessero portarci l’acqua? Ed ecco che negli abitati ora è arrivata, l’acqua e le fognature, l’acqua e l’avvenire. Ed ecco che antiche città hanno ritrovato una furia di 54 Verso Sud D. Grittani sviluppo così lieta come se ora appena fossero state fondate. Fontane monumentali! Certo in tutta la Puglia l’acqua potabile ha un valore di miracolo, e c’erano nella regione zone più secche, tutto sacco; ma dove più amabile mi parrà la voce della volontà, se non in quest’acqua ultima arrivata? Spezzando la luce del sole, è la più festosa di tutte. L’amante del sole, l’hanno chiamata i poeti. Egli, il sole, la copre di gioie, come s’è visto. Non solo, e subito mi viene incontro l’altro suo simbolo: il fulgore d’uno scheletro, nell’infinito. Quale merito ci sarebbe altrimenti ad addomesticarlo? Sarà perché sono mezzo Affricano, e perché le immagini rimaste impresse da ragazzo sono sempre le più vive, non so immaginarlo se non furente e trionfante su qualche cosa d’annullato. Mi commuoverebbe altrimenti così a fondo, un sole reso gentile? Voglio dire che anche qui ha regno il sole autentico, il sole belva. Si sente dal polverone, fatti appena due passi fuori. Penso con nostalgia che dev’essere uno spettacolo inaudito qui vederlo d’estate, quand’è la sua ora, e va, nel colmo della forza, tramutando il sasso nel guizzare di lacerti. Non v’è un rigagnolo, non c’è un albero. La pianura s’apre come un mare. Vorrei qui vederlo nel suo sfogo immenso, ondeggiare coll’alito tormentoso del favonio sopra il grano impazzito. È il mio sole, creatore di solitudine; e, in essa, i belati che di questi mesi vagano, ne rendono troppo serale l’infinito; incrinato appena dalla strada che porta al mare. E a notte, ancora solo le pecore saranno a muovere le ombre, ammucchiate sotto i portici d’una masseria sperduta. [Tratto da Deserto e dopo, GIUSEPPE UNGARETTI, Mondadori, Milano 1961] 55 Dal Subappennino al Tavoliere Raffaele Nigro Raffaele Nigro (Melfi 1947). Dell’autore del memorabile romanzo I fuochi del Basento (Premio Campiello 1987) resta quasi anonima una raccolta di prose intitolata Viaggio in Puglia, pubblicata dalla editrice Laterza di Bari nel 1991. I brani che dell’autore lucano - ormai barese di adozione - abbiamo scelto, raccontano dell’inizio del viaggio dal Fortore al Salento, per la cui stesura Nigro non rinuncia ai propri tratti della narrazione favolistica. «Svegliati, andiamo». La luce si insinua tra gli interstizi delle serrande, aiuta il martellìo della sveglia a gettarmi dal letto. Sono le sette e bisogna partire. Livia si gira nel letto, cerca riparo nel buio delle lenzuola. La luce disegna la piccola curva acquattata sotto le coltri. Fa ancora freddo, siamo alle soglie dell’estate ma l’estate non viene. Nella penombra sfilo via dal letto, percorro il corridoio in cerca di interruttori, apro le serrande dello studio, della cucina. Il sole ha accesso di colori la siepe di edera e ligustri, ha svegliato i gatti; una tribù di gatti si stiracchia sulle cappotte delle automobili parcheggiate nel recinto condominiale. È tardi, proprio tardi. «Svegliati, Livia, andiamo». Leggera come una gatta appare in fondo al corridoio, sale con gli occhi ancora socchiusi, strofinandosi le braccia incrociate. L’autoclave già fa sentire il suo lamento, giù, dagli scantinati, mentre la casa si inonda di luce, man mano che sollevo le serrande, con fragore di listelli. Sono i rumori famigliari, le voci ripetitive della quotidianità. Il rubinetto del bagno, l’acqua che gorgoglia nel lavandino, il fischio della caffettiera, il ronfo del Quattro e del Quattro Sbarrato, gli autobus che scendono da Carbonara e da Ceglie verso il cuore della città. L’autostrada ha di bello i motel. Non sei mai solo. Ti fermi per un pieno di carburante e intanto puoi consumare un cappuccino al bar, con un cornetto alla crema e marmellata e acquistare i quotidiani; La Gazzetta del Mezzo- 56 Verso Sud D. Grittani giorno per la cronaca regionale, la Repubblica e Il Corriere della Sera per tutto il resto. Mastichi e scorri con gli occhi, un sorso e una voltata di pagina. C’è odore di aria pulita, dentro e fuori del bar. Le bariste ritardatarie vengono annodandosi il grembiule. Il barista sta nel retrobottega, lo senti armeggiare tra casse e scatole, intuisce la nostra presenza, si attarda, poi eccolo, che si stropiccia gli occhi, si sistema il berretto bianco sui capelli, apre la valvola del vapore o infila una tazza da caffè sotto la macchina a pressione. Livia si aggira tra le teche di vetro. Vi sono boccacci di peperoni, melanzane e pomodori in aceto e olio; barattoli di funghi porcini; confezioni di mandorle secche; ciotole di ceramica locale e cianfrusaglie. Livia si perde come in un paese di meraviglie, acquista poco o niente, il viaggio sarà lungo e ne troverà di cose belle. È giovane, Livia, ama i vestiti attillati e i capelli lunghi. Le invidiano una pelle di porcellana. L’autostrada per Candela pare disegnata con la riga, poche le curve difese dagli eucalipti che ad ogni inverno muoiono di gelo. E pochi i saliscendi, almeno fino a Canosa, poi si arrampica verso il falsopiano di Cerignola e ridiscende alla valle dell’Ofanto. Candela sta su un cocuzzolo. Dal terremoto dell’80 appare annunciata da una folta schiera di prefabbricati. Di sera è una punteggiatura di luci sui primi contrafforti del Subappennino. Feudo dei principi Doria il paese è stato teatro, nel settembre 1902, di una forte sollevazione di braccianti. I carabinieri aprirono il fuoco, furono uccise otto persone. Spaccando Candela a mezzo a mezzo, si giunge a Rocchetta Sant’Antonio. Nell’87 visitammo il paese su invito del sindaco. Livia ha parenti per parte di madre, ma non c’è mai stata occasione di conoscerli. L’invito del sindaco nasce da una ragione singolare. In un mio romanzo, I fuochi del Basento, ho immaginato che la protagonista femminile, Concetta Libera Palomba, sia nata nel paesino sulle montagne, a metà Settecento, e che abbia poi sposato Francesco Nigro di Melfi. Grande festa dunque in nome di un fantasma letterario. Il paese domina la valle dell’Ofanto. In periferia, i resti della rocca e, in centro, un ricordo marmoreo di Francesco De Sanctis, passato per Rocchetta durante il suo viaggio elettorale del 1874. Mentre attraversiamo il falsopiano dove Pirro sconfisse i romani, non riesco a fugare un moto di stizza. Da anni, ventotto vagoni carichi di liquami di magnesio provenienti da Bolzano sono bloccati presso la stazioncina sull’Ofanto. Erano destinati a una discarica abusiva in territorio di Monteverde, uno dei tanti cimiteri di rifiuti venduti con mano camorristica a qualche industria settentrionale. Fermati da un pretore a Rocchetta, sono rimasti lì, nella comoda dimenticanza di Dio e del mondo giudiziario e amministrativo. R. Nigro Dal Subappenino al Tavoliere 57 A destra nel fondovalle, la strada prosegue verso Sant’Agata, quindi per Accadia e infine per Deliceto. Deliceto è un serpente steso tra colle d’Elce e monte Silecchia. Un castello normanno in pietra nera lo domina. A vederlo dalla vallata sottostante pare un bastione sospeso sulle colture di olivi, viti a spalliera ed elci. De iliceto, da un bosco di elci, pare prendere nome il paese e un elce è raffigurato nel suo stemma. Ma la bellezza del paesaggio sta tutta in quella rocca mastodontica che chiama alla mente i castelli lavici di Melfi e Lagopesole e poco quelli in travertino e in tufo della Puglia marina. A sud di Deliceto, su un falsopiano che guarda il fiume Carapelle, c’è il collegio di Santa Maria della Consolazione. Tiriamo al collegio senza entrare in paese. Ad aspettarci è padre Pennetta, redentorista. «Il caffè l’avete preso?» Si toglie di testa il berretto e ci fa strada tra i corridoi freddi e puliti. «Qui dentro dormiva sant’Alfonso, ma come vi ho già detto al telefono, non date retta a fantasie, non è vero che abbia scritto qua la Cantata dei pastori. Oddio, può anche darsi, ma è solo una voce. Noi non abbiamo trovato alcun documento». Dal refettorio viene odore di cucina. Nella casa sono rimasti pochi religiosi. «Ecco, questa fu la stanza di san Gerardo Maiella». Finalmente sfila di sotto al braccio la pubblicazione voluminosa che si è tenuto bella stretta finora, è la Storia meravigliosa di san Gerardo, raccontata da Nicola Ferrante. «L’avevo qui per farvene dono». «Padre Francesco – gli dico – io sono qua per dare un’occhiata alla fortezza. Sono in giro di sopralluogo per un documentario televisivo. Non che un progetto abbastanza vago e un titolo provvisorio: Il paese di pietra. Ci darete spero il piacere di essere nostro ospite a ristorante?». L’aria è come impregnata da una sorta di mito, un’aria serafica. Da piccolo ho imparato ad amare e temere la figura di Gerardiello. Mi portò una volta mia madre in pellegrinaggio a Caposele, insieme a mio nonno. La statua del santo era stata riprodotta più volte a grandezza naturale e sistemata in vari ambienti. Era l’immagine di un giovane emaciato e tisico. Mi colpiva l’espressione dei suoi occhi, sempre rivolti al cielo. Mi colpivano le storie devote che raccontava il nostro accompagnatore, padre Massimiliano, da un microfono nel pullman. Storie che mi hanno accompagnato fino agli anni universitari, quando ho avuto un impatto fortissimo con le organizzazioni della sinistra extraparlamentare barese. E le impalcature hanno preso a vacillare. Linguine al peperone e capretto, in un ristorante di periferia, mentre padre Francesco mi racconta dei santi di casa. «Sant’Alfonso accettò l’eremitaggio di Deliceto alla fine del 1744. Era spossato da una lunga campagna apostolica. Vi restò due anni, a scrivere e meditare. Parlava molto bene del paese nelle sue lettere. Dice che ci sono magnifici boschi e acqua in abbondanza. Acqua di paradiso, dice lui, con una fontana propria della Madonna e con la peschiera per cui si può 58 Verso Sud D. Grittani adacquare in ogni tempo il giardino e si possono fare delle verdure». Tre anni dopo, nel 1749, arriva in collegio san Gerardo. È un ragazzotto così mingherlino che pensano subito di aver fatto un brutto affare. «Un giorno, durante la ricreazione, un superiore dice a Gerardo di portare della neve in sagrestia per farne un sorbetto. Il ragazzo corre in giardino e ne porta una brancata. Il superiore è uscito. Allora Gerardo posa la neve sul bancone dei paramenti e corre a chiamare il superiore. «Venite che altrimenti la neve si scioglie tutta». «Dove l’hai messa?» chiede il superiore. «In sagrestia, sul bancone». Il povero superiore si dà una manata in fronte. «I miei paramenti… chissà come me li avrai conciati». Si precipitarono in sagrestia. La neve s’era già sciolta e sgocciolava. Il superiore spaventato aprì il bancone e tirò fuori le pianete e i camici. Erano tutti asciutti». Ripartiamo nel primo pomeriggio senza aver potuto visitare il castello in restauro. Ripartiamo con una promessa di ritorno a Deliceto coi permessi della sovrintendenza e in più tranquillità. «Mio marito ha perso la strada della fede – ha detto – e solo voi gliela potete far ritrovare». Padre Pennetta le ha donato alcune medagliette dei santi redentoristi e della Madonna. Ci accostiamo a Troia con lo stomaco in subbuglio per l’andirivieni dei tornanti del Subappennino. Una bibita in un ristoro alla periferia del paese e saliamo a piedi verso la cattedrale, tra vicoli medievali che sanno di fumo, stretti e grigi, rovinati nella loro purezza architettonica da superfetazioni, da rivestimenti in ceramica e in marmo, da pitturazioni non in armonia con la seriosità che il tempo ha consegnato alle pietre, sfregiati da fastidiosi infissi di anticorodal. Poco prima della cattedrale, ecco la casa De’ Pazzi, alla quale appartenne Miale da Troia, uno dei tredici italiani della Disfida di Barletta. Saremo ospiti di un pittore del posto. Un autore dalla mano popolareggiante, docente a Brera, Leon Marino. Marino è un compagno che ha scelto la linea dura. Avvelenato contro gli scempi urbani non sa capire la scelta annacquata di Achille Occhetto. Prima che in cattedrale, vorrebbe portarmi in casa, per mostrarmi le sue tele, ma vale la pena approfittare delle ultime ore di luce e anteporre la visita della cattedrale. Strada strada mi parla dei suoi compagni, delle lotte sostenute, dal Sessanta in qua, a fianco ai contadini. Mentre saliamo su per un corso leggermente in pendenza, incontriamo alcuni giovani che si accodano a noi, mi mostrano un foglio mensile di tendenza che con sacrifici di ogni genere stampano a Foggia, «La Refola». Marino ne cura l’impostazione grafica, disegna vignette satiriche contro i politici locali e contro i parlamentari italiani, con gusto naif ma fortemente irridente e sarcastico. Ma all’improvviso ecco la cattedrale. Una costruzione straordinariamente imponente. Qui comincia la vera Puglia di pietra, quell’Apulia maior che annovera le grandi cattedrali, i mastodontici castelli nati tra età R. Nigro Dal Subappenino al Tavoliere 59 longobarda e angioina che Pina Belli d’Elia, Stella Calò Mariani, Karl Willemsen e Cesare Brandi hanno saputo raccontare con competenza. La città nasce secondo le cronache nel 1019 per volontà del catapano Basilio Boioannes, a difesa della Puglia dai longobardi di Benevento. Leon Marino sostiene adducendo informazioni di storici locali che nacque sui resti di una città romana, Aecae, saccheggiata dai goti nel VII secolo. Roccaforte bizantina, Troia resta comunque legata al rito latino e dedica la sua cattedrale a Santa Maria Assunta. Anno di fondazione incerto, ma da collocare a trent’anni dalla fine del Mille. Le sue mura ricordano comunque guerre sanguinose tra i normanni Altavilla e i bizantini. La cattedrale, a croce latina, sta tutta raccontata nella facciata, anzi, nel rosone. Ne ha undici di raggi, sono colonnine che si collegano con archi intrecciati. Tra le colonne è un puntagiorno nella pietra, un colabrodo di fori a losanghe stellette quadratini croci che deve aver fatto impazzire gli scalpellini. Immagino i cantieri di virtuosi dello scalpello, uomini che i notabili pagavano con un piatto di lenticchie, accosciati tra i blocchi di pietra, tutti pieni di volontà di stupire per la propria capacità di ricavare l’impossibile dalla roccia. Da un cantiere nascevano cento capitelli, mille statue, altrettante bestiole, grifi, basilischi, leoni cornuti e uccelli caudati, incubi notturni, sogni felici, fiori di favole e di leggende. Arrivava un architetto, un giovane con la faccia rasata, munito di carte imperiali, o con un seguito di cassieri, decideva, tacciava disegni, acquistava marmi belli e pronti, dava indicazioni. L’architetto assemblava i pezzi, a volte era un capomastro e ne sapeva più di cinquanta architetti, guidava i lavori, dalla costruzione delle impalcature alla copertura delle infrastrutture. Il più delle volte non lasciava il proprio nome sui marmi, sentiva che in troppi avevano gettato il sangue attorno a un edificio, troppe teste e troppe mani. In un affresco nella chiesa di San Donato a Ripacandida, questi architetti sono ai piedi del grande edificio dell’Arca con carte e squadri. Vestono abiti eleganti con cappe e calzerotti di fattura angioina, a differenza dei manovali che si arrampicano sulle impalcature e indossano ridicole vestagliette corte, strette in vita da legacci o pendenti a campana. Il rosone è protetto da un archivolto a tre arcate concentriche tempestate da sculture bizzarre. La facciata è tagliata orizzontalmente in due da un cornicione. La parte superiore è dominata dal rosone, l’inferiore da sei arcatelle su lesene che affiancano l’arco del portale. Una porta di bronzo, risalente al 1119, opera di Oderisio da Benevento, ospita la figura dello stesso scultore insieme a Cristo Giudicante e a un paio di committenti, il conte Bernardo e il vescovo Guglielmo. E ancora Oderisio è l’autore delle formelle in bronzo della porta sulla fiancata destra della chiesa. Ma a che servono le descrizioni, se non a raccontare a chi sta lontano un luogo irraggiungibile? A nulla servono se la bellezza va goduta coi propri sensi. Il viaggia- 60 Verso Sud D. Grittani tore dei nostri tempi forse deve limitarsi a suggerire chiavi di lettura, raccontare le proprie emozioni. La civiltà delle immagini ha ucciso quella della parola descrittiva. Per il resto, i monumenti sono dove li lasciammo, e attendono di essere visitati. Leon Marino si sbraccia per fare spazio alle tele. Un mondo incantato di contadini, preti volanti, donne chiuse da fazzolettoni, nella sobrietà di una pittura fintamente infantile, racconta la vita di Troia e delle sue campagne. Ma c’è sempre una punta di amarezza, di ironia, di scontento nelle sue figure, un briciolo di dadaismo. Come in una maternità dove la Madonna regge un Bambino che orina in un piccolo vaso da notte. Poi si decide per un ristorante con cucina casareccia. Prima di uscire, il pittore di Troia mi fa dono di un quadro, è una crocifissione sui generis. Due contadini stanno sollevando la carcassa di un maiale e attorno tre donne si danno da fare con recipienti. Il racconto può apparire blasfemo, ma Marino sa quanto per la famiglia contadina abbia potuto significare il sacrificio del maiale. La crocifissione è dunque costruita sulla scorta di maestri del Due e Trecento fiorentino, ma con sobrietà e sintesi iconografica. Dormire si dorme a Foggia. Martoriata dal terremoto del 1731 e dalla seconda guerra mondiale, la città ha compiuto sforzi enormi per risorgere. Ma del centro storico restano angoli, piccoli scorci, reliquie sperse nel mare di caseggiati popolari degli ultimi decenni. Una cattedrale romanica ricorda coi suoi pochi resti normanni il fasto del passato. Vi è annessa la cripta dell’Icona Vetere. Una icona bizantina attorno alla quale vortica la stessa origine della città. Esisteva, dice la leggenda, nei pressi dell’attuale sito di Foggia, un villaggio stretto da paludi, Borgo del Gufo, a poca distanza da Arpi, l’antico insediamento dauno. Sulle paludi del Borgo, alcuni pastori videro attorno al Mille tre fiammelle galleggianti. Accanto alle fiammelle, galleggiava un quadro dell’Assunta avvolto da veli, l’Icona Vetere o Madonna dei Sette Veli. Il quadro chiamò devoti dai paesi circostanti e li convinse a costruire un nuovo abitato. Proprio sulla via per Arpi sorgono alcuni palazzi seicenteschi di grande bellezza. Insieme al palazzo imperiale di Federico II costituiscono le reliquie di una città che svevi e angioini lasciarono ricca di testimonianze, la città di un’intera famiglia di architetti medievali, Bartolomeo e i figli Gualtiero e Niccolò. In questo palazzo nel 1241 morì la terza moglie dell’imperatore, Isabella d’Inghilterra. Federico volle che venisse trasportata ad Andria e sepolta a fianco alla seconda moglie, Jolanda di Brienne, nella cripta della cattedrale. E in questo palazzo si ammalò l’imperatore nell’invernata del 1250. Qui fu trasportato da Fiorentino già cadavere, qui il suo corpo venne imbalsamato per il trasporto a Palermo. Di icone, la Puglia è ricca. Esse testimoniano gli scambi che per secoli si sono R. Nigro Dal Subappenino al Tavoliere 61 intrecciati tra Mezzogiorno e paesi di cultura greco-bizantina. Se ne sono censite a tutt’oggi un’ottantina, eseguite tra XI e XVIII secolo, secondo alcuni da artisti ciprioti o mediorientali, secondo altri da maestri locali. Si fanno allora i nomi di Angelo Bizamano, Demetrio Bogdano e dell’otrantino Giovanni Maria Scupula. Fascinosi i nomi delle madonne raffigurate: Madonna della Madia, della Fonte, dell’Idria, dei Sette Veli. Un ricco catalogo curato dall’infaticabile Pina Belli d’Elia ha tentato di censirle una volta per tutte, a corredo di una mostra di icone. Ma la mostra ha suscitato un vespaio. Le chiese di Monopoli e di Foggia si opponevano al prestito. La diocesi foggiana non autorizzava infatti a mostrare in pubblico il volto della Madonna dei Sette Veli, nascosto da sempre agli stessi fedeli foggiani, come l’icona fosse il corpo vivo di Maria e non una tavola di conifera. La città resta, nonostante le trasformazioni sociali, la capitale del Tavoliere, il granaio del Mezzogiorno. Non a caso, una delle etimologie che si assegnano al nome di Foggia è foveae, fosse per il grano. Sede della Regia Dogana della Mena delle Pecore in età aragonese e borbonica, si è trasformata dopo la bonifica dei suoi territori, in più punti malarici, in capitale dell’agricoltura, sede di un’importante fiera del bestiame e dei prodotti della terra. Né si dimentichino le aspre lotte sindacali e antifasciste, con Trematore, Fioritto, Maitilasso, Cannelonga, Allegato, Pontone e altri fondatori dei partiti di opposizione di Capitanata. Avvenimenti piccoli e grandi e uomini di cui diffusamente discorrono le indagini documentatissime di Michele Magno e Raffaele Colapietra. La cultura della città, mi pare affidata oggi alla sua ricca biblioteca provinciale, al teatro Umberto Giordano e all’editrice Bastogi, di Angelo Manuali. Da Foggia si sale a San Severo. La città dà di vino e morga anche lontano dall’autunno. Una periferia sviluppatasi in modo selvaggio nasconde un centro storico ricco di testimonianze architettoniche barocche e rococò. Il Medioevo, presente negli edifici della cattedrale e della chiesa di San Severino, non riesce a dare un’impronta alla città, che appare segnata dalla presenza prepotente dei conventi cinque e seicenteschi. Benito Mundi, che oggi dirige la biblioteca comunale intestata a un tipografo quattrocentesco emigrato a Milano, Angelo Minziano, ha dato l’anima per l’apertura di un museo archeologico cittadino. Per anni ha lavorato con alcuni amici della locale sezione dell’Archeoclub, con loro ha condotto ricerche nella vicina grotta Paglicci, dove sono state rinvenute presenze in età neolitica. Finalmente, Mundi può oggi restarsene tutto il giorno tra le teche di vetro, innamorato della civiltà sanseverina. Ci accoglie infatti tra quelle sale rese luminose dal sole di fine maggio, un convento francescano incamerato dal comune, restaurato e adattato a museo. Un altro convento, appartenuto ai Celestini, oggi ospita l’amministrazione comunale. Incerti se proseguire per Lucera o ripiegare verso Monte Sant’Angelo, ci conce- 62 Verso Sud D. Grittani diamo, in compagnia di Mundi, una mattinata piacevole in una masseria agrituristica, in contrada Santa Giusta, a pochi chilometri da Castelfiorentino. La masseria fu feudo dei Di Sangro, signori di Torremaggiore. Vi praticavano la caccia. L’ultimo esponente della famiglia baronale, il principe Michele Di Sangro, privo di eredi, donò negli anni Cinquanta la tenuta alla propria governante, Elisa Crogan, che a sua volta donò tutto al comune di San Severo, con l’obbligo di istituire una fondazione per l’incremento dell’agricoltura. Il castelletto dove la ricca famiglia trascorreva primavera ed estate, è ora pericolante e richiede un intervento consistente. Mundi vi ha fatto trasportare alcune sculture mastodontiche, le ha collocate ai margini della strada d’accesso e ha fatto trasformare le stalle in ristorante e ambienti per pernottare. I magazzini sono stati trasformati in museo della civiltà contadina. Salendo sui terrazzi, si intravede nella distanza il castello di Lucera. In quel castello sono tornato alcuni anni orsono per assistere ad un evento teatrale. Giorgio Albertazzi aveva realizzato, pasticciando tra idee e testi di alcuni autori italiani viventi, tra i quali Sanguineti e Ruggeri, uno spettacolo orbitante attorno alla figura di Federico II di Svevia. Federico vi fece trasferire gli arabi quando si interruppero con loro i rapporti di amicizia. In questi luoghi venne a morire, qui fece costruire edifici. La sua ombra vive a Lucera e nelle campagne della Daunia, si allunga sulle città turrite della costa, fino a Brindisi, e in ogni città lascia una leggenda, un riferimento ad azioni furbe, di volpina prepotenza. A Motta Montecorvino dirime una questione tra due famiglie, rivali per via di una promessa sposa che non accetta di convolare a nozze per terrore della prima notte. Federico avrebbe fatto portare presso di sé la donna e le avrebbe insegnato in concreto il da farsi. A Bari si scontra con san Francesco. A Gioia del Colle Bianca Lancia si uccide per amore di lui e lascia nella pietra impressa la forma del proprio seno. Ma a San Severo, Federico è poco presente. D’altro canto sembra si disfacesse della città donandola ai Templari. Qui è nume tutelare Raimondo Di Sangro, il principe mago che avrebbe tentato la via della mummificazione dei corpi e avrebbe praticato in pieno Settecento la magia naturale avvalendosi delle regole di chimica. L’aria si è riscaldata e ci convince a salire a Monte Sant’Angelo. Inutilmente tento di mettermi in contatto telefonico con Pasquale Soccio, il curatore della Scienza Nuova di Vico. Abita da anni a Foggia, ma in realtà vive sui treni e in auto. Soccio è una meraviglia della natura. Cieco da diversi anni, continua a studiare e a mandare a memoria opere intere con l’aiuto di giovani lettori che registrano per lui su magnetofono il contenuto dei libri. Soccio ha studiato in maniera approfondita il brigantaggio postunitario che ha avuto in queste contrade molti proseliti, ha scritto libri sulla storia minore di Lucera e del Gargano, qui, gode, com’è giusto che sia, di molto rispetto. Insieme a Nino Casiglio, narratore della microstoria e dei miti di R. Nigro Dal Subappenino al Tavoliere 63 questi paesi, è certamente la figura più rappresentativa di quell’intellettualità della provincia italiana innamorata dei raccordi tra storia patria e storia nazionale. Nel primo pomeriggio, dopo una capatina alla cantina sociale per un rifornimento di bianco di San Severo, ripartiamo per Monte Sant’Angelo. [Tratto da Viaggio in Puglia, RAFFAELE NIGRO, Laterza, Bari 1991] 65 Garofani rossi per Fausto Vasco Pratolini Vasco Pratolini (Firenze 1913 - 1991). Fondatore con Alfonso Gatto della rivista letteraria “Campo di Marte”, Vasco Pratolini è ricordato soprattutto per Il quartiere (1943), Cronache di poveri amanti (1947), Le ragazze di San Frediano (1949), Metello (1955) e l’opera della sua maturità Lo scialo (1960). Scaltro e apprezzato cronista, Pratolini commentò per Il nuovo Corriere di Firenze molte tappe del Giro d’Italia, a proposito del quale il 4 giugno 1947 descrisse la fiera pedalata di Fausto Coppi per le strade di Capitanata. È fuori dubbio, ormai: nel subcosciente del signor Cougnet, specchiatissima persona, dimora un seviziatore. Non potendo trovare polvere, mulattiere, sentieri di campagna, ostacoli naturali e trabocchetti, riuscendogli impossibile compensare la relativa lunghezza della tappa di oggi con un tracciato da cross country, ha disposto la partenza per l’una dopo mezzogiorno. Dico le una dopo mezzogiorno: al 4 di giugno, precoce estate, lungo le strade del Tavoliere, allorché l’asfalto diventa fango nero e appiccicoso, le zolle sono aride come la pomice, e il sole scava il cervello e contorce i tronchi degli ulivi. Con la sua faccia di vecchio ufficiale coloniale, la pipetta in bocca, Cougnet s’è avventurato per primo, a testa eretta e scoperta, incontro alla calura. Ci siamo buttati sulla sua scia a dorso nudo. Il capo riparato dal berrettino donatoci dalla WilierTriestina, fidando nel vento protettore che la macchina solleva correndo (mi è mancato il coraggio di mettermi al piccolo trotto sul camioncino della Wally. Ho rimandato l’appuntamento a uno dei prossimi giorni). Dietro di noi, il Circo ha snodato la sua processione. Eravamo tanti penitenti che si recavano da Bari a Foggia per un voto. Ci guidava un uomo diabolico, dall’aria di certosino. I corridori hanno offerto la schiena al sole con la stessa disinvoltura con cui il Santo famoso si distese sulla graticola. I paesi ci attendevano al loro solito con l’intera popolazione bella e schierata, da 66 Verso Sud D. Grittani Modugno a Ruvo, da Andria a Canosa, ciascuno con un traguardo a premio, ciascuno col suo bambino e il suo cane che traversano la strada all’ultimo istante, ciascuno con le sue scritte e i suoi festoni. Bitonto ci ha accolto con la sirena di una schiacciasassi aperta a tutto vapore e il macchinista che saltava sulla grossa ruota per la gioia. Al di là del ponte sull’Ofanto solitario, un malinconico signore in nero agitava stancamente un fazzoletto: un corridore, era una maglia viola della Welter, passando glielo ha strappato di mano. A Corato l’equilibrista Maggini, che si esibiva nella volata, è precipitato dal filo per l’imprudenza di una spettatrice, appoggiatasi ai cavalletti di sostegno. È stata una caduta fortunata per lui e per lei, ma intanto anche il bel Luciano ha versato le sue goccie di sangue sull’arena. Alla tibia di Serse, al femore di Covolo, alla testa e alla mano di Desmet, di cui ci insegue la nostalgia, aggiungete, insieme al braccio di Ronconi, alla coscia di Brotto, alla caviglia di Bresci, al sedere di Zanassi, il ciglio di Maggini: anatomica esemplificazione del martire del Circo, ricoperto di cerotti e ingessature. Ma la campana suona anche per i seviziatori; ed è stato quando a Cougnet è venuta a mancare la complicità del sole, giusto alle porte di Cerignola. Avevamo preceduto la processione, stavamo fuori la soglia di un bar centellinando una granita di caffè con panna degna dei maccheroni di Foggia che fra poco mangeremo; allorché il cielo si è abbassato sulla terra nascondendo il sole, l’aria si è fatta improvvisamente ventilata e le prime goccie della pioggia estiva ci sono cadute addosso mescolandosi al sudore. Ce ne siamo rallegrati per le schiene dei corridori. I quali, come subitamente rinviviti, hanno messo la testa sul manubrio e l’acceleratore alle moltipliche. Così, anche a Foggia, mercé l’arrivo frazionato, il Circo ha salvato la faccia. Una faccia che si sta facendo grinzosa. Grinzosa e tuttavia feroce e sorridente dopo le volate finali. E l’eccitazione degli spettatori a cambiarle i connotati. Non il vincitore del giorno, Conte, Bertocchi o Ricci, ma Bartali e Coppi sono le calamite. Oggi, come a Roma, Gino I è caduto nella tagliola. La folla lo premeva da ogni lato; emergevano sulle teste i moschetti dei gendarmi disperatamente impegnati a proteggere il campione; due giovani frati francescani facevano leva delle mie spalle e di quelle di un collega per vederlo un attimo da vicino. Coppi, invece, era riuscito a dileguarsi. Tre uomini lo andavano cercando di qua e di là, framezzo alla marea, smarriti ma dignitosi, con un fascio di garofani rossi infiocchettato. Erano i rappresentanti del P.C.I. di Foggia, che a nome dei compagni volevano rendere omaggio a Fausto che ha fama di simpatizzante. [Tratto da Il nuovo Corriere di Firenze, VASCO PRATOLINI, Firenze 4 giugno 1947] 67 Le pietre si muovono Maria Marcone Maria Marcone (Foggia 1931). Una vita trascorsa tra la scuola e la scrittura, Maria Marcone ha firmato con Le pietre si muovono una delle pagine più significative della nuova letteratura meridionale, descrivendo il tragico «sfollare» dei foggiani verso la vicina Troia, nel disperato tentativo di sfuggire ai bombardamenti del secondo conflitto mondiale. (...) Ogni casa splendeva di un bianco accecante, e non c’erano più nella strada le ombre dei palazzi, ma cumuli enormi di macerie giacevano sotto il sole; squarci di interni si vedevano qua e là, con un quadro appeso alla parete, o un comodino in bilico sull’orlo di un pavimento crollato, o un lampadario di cristallo rimasto appeso a un lembo di soffitto, luccicante al sole come se avesse le lampadine accese. Stesso spettacolo si manifestò ai miei occhi, quando in uno dei bombardamenti che mi sono presa in testa, uscii dal rifugio e tra tanta distruzione, calpestando cumuli di macerie e forse frammenti di membra umane, mi avviavo verso la strada per Troia (lungo quella che è l’attuale via Vittime Civili) con mio padre e mio fratello alla ricerca di un qualsiasi mezzo di fortuna che ci avesse portato a Troia, dove gli altri familiari erano in ansia. Lungo la stessa strada, chiamata allora via Napoli, che era già quasi aperta campagna, ora è un’ampia strada con la stessa denominazione e con bei palazzi nuovi; in questa strada su Porta Troia (o Porta Napoli) vi era una piccola bottega di fabbro-meccanico: era di origine troiana e risiedeva a Foggia da moltissimi anni, non conosco il nome, ma lo chiamavano dialettalmente “CottCott” (a Troia “Cott-Cott” è la trippa bollita con i condimenti): lì era una specie di recapito e di deposito per i troiani in arrivo e in partenza o che si servivano per il trasporto di merci da e per Troia del “vetturino” concittadino Eleuterio Aquilino che andava e veniva quotidianamente e che perdette un figlio che lo aiutava, vittima appunto dei bombardamenti. Colà ci recavamo a piedi quel giorno appena usciti dal rifugio dopo il bombardamento per trovare qualche mezzo di fortuna per 68 Verso Sud D. Grittani raggiungere Troia. Fu durante il percorso che tra i cumuli di macerie raccolsi dei “souvenirs” che ancora conservo: una scheggia di bomba ancora caldissima quando la raccolsi, un Crocifisso dal quale nella caduta si era staccato il Cristo e una grossa fotografia-ricordo di una qualche cerimonia militare in cui si vede il Re Vittorio Emanuele III al centro circondato da alcuni alti ufficiali, ma con su ancora oggi una rossa macchiettina di sangue. [Tratto da Le pietre si muovono, MARIA MARCONE, Mursia, Milano 1989] PARTE III Foggia 71 Foggia al tempo di Federico II di Svevia Ernesto Kantorowicz Ernesto Kantorowicz (1895 - 1963). Celebre studioso tedesco di storia medievale, autore dell’opera I due corpi del Re (1957) e soprattutto del pregevole saggio Federico II di Svevia (1939). Da quest’ultima opera, che rappresenta la più attendibile e compiuta biografia dell’imperatore svevo, è tratto il brano qui riportato. Si dimentica facilmente che nonostante tutta la giurisprudenza e la dottrina, la gran Corte era pur sempre una Corte medioevale, ininterrottamente, per decenni, centro di vita cavalleresca e cortese, che poté così avere in Italia il suo pieno sviluppo. Poiché la Corte di Federico apparteneva a tutta l’Italia molto più della Corte normanna. Infatti non è Palermo la residenza abituale dell’imperatore, per quanto egli abbia celebrato con espressioni di entusiasmo le bellezze e le delizie della sua terra ereditaria, in realtà gli splendori della Corte di Federico a Palermo sono piuttosto leggendari, perché l’Imperatore negli ultimi anni si recò una volta sola in Sicilia, per reprimere la rivolta di Messina nel 1233. Palermo era nominalmente la capitale del regno, ma la sua posizione geografica incomoda a raggiungersi, sia con una pericolosa traversata marittima, sia con una lunghissima marcia terrestre, fece sì che Federico stimò opportuno di prendere dimora là dove era il nucleo più forte dello Stato, ossia nelle province verso Nord. La Puglia, le province costiere dell’Adriatico, la Terra Laboris, l’odierna Campania erano per Federico la terra promessa: egli stesso si chiamava l’uomo d’Apulia e la sua vera e propria patria fu la terra che univa quelle due province, la Capitanata e la Puglia intorno al golfo di Manfredonia. Fino ai tempi di Federico, la Capitanata aveva avuto poca importanza, e se per quasi un secolo le fila della politica europea conversero nel Tavoliere di Puglia, se Foggia divenne città nota in oriente come in Occidente, lo si deve soltanto alla predilezione di Federico per questa provincia, predilezione che aveva senza dubbio base politica. Ivi Federico si trovava nel punto più vicino al teatro delle sue 72 Verso Sud D. Grittani lotte, cioè all’Italia centrale e settentrionale e poteva tenersi sempre pronto ad intervenire personalmente; ma soprattutto il luogo costituiva un buon punto d’osservazione per ciò che accadeva a Roma. Altri elementi contribuirono anche alla scelta di quella località come quasi abituale soggiorno di Federico, poiché le terre ora deserte e sassose, pascolo a greggi vaganti, erano allora ricche di boschi, di amene valli, di fertili campi e, se non offrivano gli splendori lussureggianti e quasi tropicali di Palermo, né gli incanti del Golfo di Napoli, favorivano però la grande passione del sovrano per la caccia, tant’è vero che egli soleva passare l’inverno a Foggia e l’estate fra i monti. Molto probabilmente la maggior attrattiva fu appunto la vergine bellezza della campagna non ancora sfruttata, campo aperto a tutte le iniziative, e infatti Federico riuscì meravigliosamente a trasformare quei luoghi. Là c’erano i castelli da lui stesso fatti erigere. Già nel 1223 fu cominciata la costruzione di quello di Foggia, la cui iscrizione diceva che Federico aveva innalzato la città regale ai fastigi della dignità imperiale. Ben presto ne sorsero altri, castelli per villeggiatura, casine da caccia, casali di campagna a cui di solito era annesso un podere o una masseria. Quali misteriosi e inverosimili festini devono essersi svolti dietro le mura silenziose di quei castelli! Un cronista del tempo descrive il castello di Foggia come un palazzo marmoreo adorno di statue e colonne verde antico, di leoni, di vasche marmoree, e narra di feste grandiose in cui si alternavano cori e rappresentazioni, e gli occhi erano rallegrati dalle vesti di porpora degli attori. Di questi, alcuni venivano creati cavalieri, altri ricevevano distintivi ed onorificenze. I divertimenti si susseguivano tutto il giorno e continuavano la notte al lume delle fiaccole. Un altro cronista narra le meraviglie dei cortili interni, quando fu accolto nel castello il figlio del re d’Inghilterra Riccardo di Cornovaglia che tornava dalle Crociate. Il conte, stanco e sfinito dal lungo viaggio nella calda stagione, ebbe dapprima ristoro di bagni, salassi e corroboranti, quindi si passò ai divertimenti. Con sua grande meraviglia ascoltò musiche strane, suonate su strumenti mai visti, ammirò i giocolieri e le danzatrici saracene che eseguivano balli fra loro, scivolando leggermente su grosse sfere, sul pavimento liscio e lucente al ritmo di cembali e castagnette. Addirittura leggendaria è la descrizione delle feste che avevano luogo alla Corte quando centinaia di cavalieri d’ogni paese, ospiti di Federico, raccolti sotto seriche tende assistevano a rappresentazioni date da artisti venuti da ogni parte del mondo, o le ambascerie di altre potenze offrivano all’imperatore i doni più strani e preziosi, o i messi del re Prete Giovanni gli portarono, per esempio, una veste di amianto, un filtro di giovinezza, un anello che rendeva invisibili e la pietra filosofale. Si raccontavano inoltre meravigliose storie sul misterioso astrologo di Corte Michele Scoto, il cui solo nome faceva rabbrividire e che, fra gli altri miracoli, un giorno di gran caldo, E. Kantorowicz Foggia al tempo di Federico II di Svevia 73 per desiderio dell’imperatore, fece quello di attrarre nubi temporalesche e produrre una benefica pioggia. La cortese cavalleria, la pompa e lo splendore della Corte di Federico si spensero con lui. [Tratto da Federico II di Svevia, ERNESTO KANTOROWICZ, Garzanti, Milano 1939] 75 Foggia Jocelyn Brooke Il poeta Jocelyn Brooke giunse a Foggia, con gli eserciti alleati, nei mesi immediatamente successivi ai feroci bombardamenti del luglio 1943, rimanendo sensibilmente colpito dalla città semidistrutta. La sua lirica Foggia apparve per la prima volta nei quaderni di poesia Botteghe Oscure (n. II, anno 1948). Mi sporgo dalla finestra Nella sera glaciale, E vedo il crepuscolo d’inverno Dissolvere le dirute mura; e il tramonto ostile fiammeggia Sulla secca e vuota corteccia Del sobborgo cittadino, e cade Come un dito accusatore Sulle chiese sventrate, Sulle piccole case rotte Spaccate come giocattoli; o indugia Per le strade e cerca Con la perizia d’un poeta I piccoli, i trascurati Segni dell’antica, invincibile Vita che senza sosta, Tutta innocente e improtetta Ora si rinnova: il bimbo Che giuoca con un cerchio, la donna China sul fornello, E i lastricati con la lanugine 76 Verso Sud D. Grittani Del tenero verde primaverile Di finocchio selvatico e cicoria. Ed ora, calando la sera, Le case ruinate si adergono Scialbate di luna, bianche come ossa, Presso l’orlo della città, dove i campi Fluiscono dolcemente nell’ignoto Paese oscurato dalla guerra; E la porta appena illuminata Offre la sua visione incorniciata di buio (Una natura morta di Chardin); E i fuochi sul lastricato Che ardono per il pasto serale Come per una festa, Sfidano la dura costrizione Della Guerra e l’urgente, maschio assalto Del preparato disastro: Segnale luminoso per i futuri Giorni sorridenti Quando di nuovo i fuochi festivi Nella strada e sulla piazza avvamperanno E i getti e le candele romane Sprizzeranno la loro ingenua lode Delle sgargianti immagini di santi, Riscattando con ore liete Questo duro tempo senza amore; E la gente tornerà a danzare Nelle strade parate di fiori, Tra lo scorrere del vino nuovo. [Poesia tratta dai quaderni di Botteghe Oscure, JOCELYN BROOKE, n. II del 1948, traduzione di Salvatore Rosati] 77 Clizia a Foggia Eugenio Montale Eugenio Montale (Genova 1896 - Milano 1981). Il grande poeta ligure, nominato Senatore a vita nel 1967 e insignito del Premio Nobel nel 1975, ispirato dal sentimento che nutriva nei confronti di Irma Brandeis (avvenente “musa” alla quale l’autore di Ossi di Seppia dedicò molti componimenti), descrisse una sua visita immaginaria alla stazione di Foggia. Nel 1956 questa visita assunse forma di racconto, e venne pubblicata dall’editore vicentino Neri Pozza con l’emblematico titolo Clizia a Foggia. La conoscenza di questa prosa - che descrive con impareggiabile maestria la fissità di un «meriggio» trascorso sotto l’afa di una città senza più connotati a causa della guerra - si deve in particolar modo a Paolo De Caro, docente foggiano tra i più rispettati studiosi italiani dell’opera montaliana. Tuttavia il primo letterato foggiano che se ne occupò fu il filosofo Pasquale Soccio, che inserì il racconto Clizia a Foggia tra i contributi letterari della sua monografia sentimentale Omaggio a Foggia (Adda Editrice, Bari 1974). I binari erano incandescenti sotto il torrido cielo di Foggia. Al di sopra del loro barbaglio i vagoni color vinaccia, la fontana secca, i tronchi d’albero legati insieme (assurda anticipazione dell’inverno) sembravano sul punto di sciogliersi come gomma. Balenò nitida per un secondo la visione dell’ultimo respingente del treno che si allontanava con dolcezza quasi per suggerire l’idea che una corsetta di cento metri avrebbe permesso di raggiungere il vagone di coda. Ma nel tempo che Clizia impiegò a valutare le forze che le restavano dopo due giorni passati nell’afa di Foggia, i cento metri s’erano fatti centocinquanta, duecento. Troppi. Erano le tre del pomeriggio. Clizia sedette con precauzione sull’orlo di un sedile della sala d’aspetto e aprì l’orario. Fino alle sette non c’erano treni, poi un accelerato l’avrebbe trascinata per venti ore verso il nord. Guardò in alto col gesto istintivo, rassegnato e disperato insieme, con cui negli ex-voto delle chiese di campagna coloro che sono in bilico 78 Verso Sud D. Grittani sull’estremo pericolo cercano in cielo qualcuno che li aiuta, si afferrano quasi con gli occhi a qualche simbolo della loro interna fiducia. Ma il soffitto della sala d’aspetto non si schiuse ad alcuna consolante apparizione. Le apparve invece in tutta la sua lubrica e funebre pompa una lunga pavesata di acchiappamosche gialli, punteggiati di macchie nere, sibilanti, quasi urlanti dello spasimo di tante agonie riunite. Al centro della striscia più vicina un grosso ragno nero affondato in quella viscida superficie non si muoveva più. Come aveva potuto giungere fino al centro della striscia? Clizia si fermò su diverse ipotesi. Poi concluse che una corrente d’aria doveva essere stata la causa della sciagura; appeso al filo della sua bava il ragno s’era certo calato attraverso gli spazi della sua aerea architettura e il ciclone l’aveva sorpreso, spingendolo verso le sabbie mobili di quel fatale approdo. Esaurita l’indagine Clizia uscì sulla piazza. La valigetta di fibra era leggera ma le bruciava come un’ortica la mano accaldata. I bar della città non sono allegri, in piena estate, per le squadriglie di mosconi che succhiano voracemente clienti e consumazioni. E Clizia aveva disdetto la camera all’albergo. Provò un attimo di desolato smarrimento, poi la salvezza le si presentò improvvisamente nello spazio verde di un enorme manifesto murale. Nel salone del Municipio (che subito immaginò ombroso e ricco di morbide poltrone) i celebri professori Dobrowsky e Peterson, delle università di Bâton Rouge e dell’Istituto Avatar di Charleston (Sud Carolina) avrebbero svolto un importante dibattito sulla metempsicosi. Se qualcuno del pubblico si fosse prestato erano previsti esperimenti pratici del più alto interesse. L’ingresso costava poche lire. Poco dopo Clizia entrò in un portoncino adorno di stenti limoni e di fronde di pino. Alcune frecce la guidarono fino al salone. Un’ombra di navata la accolse e la ristorò. Nella sala c’erano forse una quindicina di persone che si tenevano prudentemente discoste dal tavolo dei due oratori, già fermi, in attesa, al loro tavolo. Due uomini diversi; uno calvo, allampanato, occhialuto, vestito di nero, l’altro pingue, rossiccio, in shorts e camicia di seta cruda. Girava fra il pubblico un inserviente, o forse un discepolo dei due maestri, e distribuiva opuscoli a pagamento. Clizia ne acquistò uno. In prima pagina un disegno riproduceva Pitagora nel tempio di Apollo a Branchide. Dal pallio tendeva il braccio e l’indice verso uno scudo appeso a una parete. Dal suo viso maschio e quadrato come quello dei giovinetti che l’attorniavano usciva una nuvoletta bianca nella quale era scritto a grossi caratteri: «Ecco lo scudo che usavo quand’ero Euforbo e Menelao mi ferì!» Nell’interno dell’oscupolo l’episodio era spiegato minutamente e non mancavano cenni sulla vita e le opere del sommo filosofo. Clizia lesse due o tre pagine. La sua energia di neofita scemava man mano che dalle finestre aperte il fresco di navata cedeva al caldo e minacciosi si affacciavano i primi sciami delle mosche. E. Montale Clizia a Foggia 79 Si spostò indietro di alcune file, nell’angolo più buio, sfuggendo allo sguardo indagatore del professor Peterson: e fu così che perdette a poco a poco contatto col mondo esterno, affondando per conto proprio in una palude nera ma non spiacevole. Le parve dapprima che al mondo non esistesse più alcuna forza di gravità. Si sentiva leggera, molleggiata su otto lunghissime zampe terminanti in soffici peli che attutivano dolcemente ogni passo: se così si può dire, perché di passi propriamente detti non si trattava nella sua marcia, bensì di frazioni di passi portati avanti ora da questa ora da quella zampa, in un ordinato movimento che si creava da sé, senza che lei si affaticasse a dargli impulso o direzione. Vedeva il mondo secondo una prospettiva orizzontale, non verticale come le pareva ricordare quella dell’uomo, piantato su due trampoli e procedente ad angolo retto con la terra. A questa nuova visione contribuiva certo la posizione del suo corpo prono in avanti, disteso sulle sue basi press’a poco come il soldato negli esercizi dell’«ordine sparso», ma anche la strana disposizione degli occhi, otto come le zampe e messi a semicerchio intorno al capo, tanto che – cosa sconosciuta agli uomini – una buona parte della pianura circostante le appariva simultaneamente accrescendo la sua illusione di spazio e di libertà. Degli occhi, poi, due erano come appannati, un po’ miopi di giorno, ma pure in questo Clizia vide una ragione che tendeva a darle una libertà anche maggiore: e infatti, appena scesa la sera, furono essi a entrare in azione, a illuminarle le tenebre, a renderle più facile il lavoro della tela. La sua tela era bella, solida e ben tessuta, la più bella che riuscisse a scorgere lungo le quattro pareti di quel cortiletto di marmo bianco in mezzo al quale una piccola fontana cantava notte e giorno spandendo il suo getto su uno strato di muschio morbidissimo. Veniva talora a passeggiare nel cortile un giovane vestito di bianco (ma dove l’aveva già visto?); col braccio ripiegato oltre l’orlo del pallio sorreggeva un libro che scorreva passeggiando su e giù per il portico, assente da ogni altra cosa. E accadeva ch’egli si fermasse e guardasse attentamente la tela. Anche di notte venne una volta a guardarla, e a lei parve che il giovane si accorgesse del bell’effetto che faceva la rugiada lungo le sottili trame dell’ordito, illuminata dalla luna. Mentre guardava il lavoro l’enorme viso del giovinetto non perdeva la sua espressione assorta e intensa. Pareva che la tela continuasse quasi i suoi pensieri, s’inserisse negli argomenti del libro che leggeva camminando lungo il portico, dal mattino alla sera. A volte altri ragazzi venivano a trovare il giovinetto dal bel viso quadro. Sedevano con lui accanto alla fontana, o sullo zoccolo che circondava il portico, non di rado proprio sotto il capitello che Clizia abitava. Parlavano, sfogliavano libri e pergamene, spinte dai loro gesti piccole onde d’aria arrivavano alla tela facendola on- 80 Verso Sud D. Grittani deggiare, il movimento ridestava ancora per un secondo le mosche invischiate e ormai intorpidite nell’agonia (qualcosa nella bava del ragno doveva toglier loro la vitalità, almeno a giudicare dalla poca resistenza che opponevano una volta cadute, facili prede ormai pronte ad essere abbracciate e succhiate). Spesso i giovinetti sbocconcellavano cibi e quando se ne andavano, il ragno scendeva a far bottino di briciole, di chicchi e talvolta di bucce dolciastre. Fu così che in un caldo pomeriggio egli avvistò appoggiata sullo zoccolo sottostante una fila di piattini colmi di una polpa dolce, bionda, odorosissima. Si appese alla tela e si calò, ahimè, con troppa furia per l’ingordigia, lungo il filo che si allungava man mano, sempre più: guardava il suo filo di sotto in su, stendersi stendersi così lucente e forte, con una specie di ebbrezza, di orgoglio. Quando si accorse di ciò che stava succedendo, era troppo tardi, il suo orrendo destino era segnato. Il nettare biondo e molliccio l’aveva afferrato per la peluria del dorso, si dimenò, si scosse, sputò fuori tutta la sua bava per rafforzare il filo e tentare di risalire. Nello sforzo il capo gli fu imprigionato, poco dopo anche una zampa affondò in quella viscida palude. Un odore dolciastro, nauseabondo si addensava su di lui, il corpo gli si induriva. In un anelito di suprema disperazione, di schifo senza limiti, stava buttando il capo indietro per affrettare la morte quando una mano posata dolcemente sul braccio la svegliò. Vide l’uomo in shorts e l’uomo in nero curvi su di lei. «Signora – disse il primo – lei è un soggetto veramente eccezionale. Voglia salire sulla cattedra ed esporre ciò che ha sognato. Vuol dirmi il suo nome, la sua professione, qualcosa di sé? È di questa città? Lavora qui, studia, viaggia?» «No, canto – disse Clizia tanto per dire qualche cosa (e infatti canticchiava spesso per sé).» «Signore e signori – tuonò il prof. Dobrowsky in pessimo italiano, rivolto al pubblico – forse abbiamo qui una reincarnazione della Malibran o della divina Saffo. Ma no, è impossibile, sarebbe un salto troppo forte nel tempo. Vuol dirci signorina chi ha sognato di essere? Questo sogno dev’essere rivelatore della sua precedente esistenza. Si lasci andare, parli con abbandono.» Clizia guardò dinanzi a sé e vide che le quindici persone di prima erano diventate forse una trentina. «Ecco – disse in preda a un imbarazzo enorme che rasentava un sentimento di pudore offeso – ecco, io credo di aver sognato di essere un ragno, sì, un ragno nel cortile della casa di Pitagora, almeno mi pare di averlo riconosciuto dal viso.» Il pubblico scoppiò in un’enorme risata e il prof. Dobrowsky si fece rosso fino alle orecchie. «Signora – disse – lei si burla della scienza, non è degna della facilità con cui la mia ipnosi ha agito su lei. Si rende conto della perfezione che occorrerebbe per E. Montale Clizia a Foggia 81 passare in un sol balzo dallo stadio di ragno a quello di essere umano? Parli sul serio, ci dica dunque chi ha sognato di essere.» «Un ragno nel cortile di Pitagora – ripeté Clizia, mentre le sghignazzate del pubblico salivano al soffitto e il professor Peterson la prendeva per un braccio e l’accompagnava alla porta ammonendola a non partecipare più a esperienze troppo più serie di lei.» Si ritrovò quasi di corsa nella strada, strinse con rabbia la valigetta, emise un piccolo gorgheggio per risentirsi viva e guardò l’orologio che portava al polso. Mancava appena un quarto d’ora alla partenza del treno, il pomeriggio foggiano era terminato. [Tratto da La Farfalla di Dinard, EUGENIO MONTALE, Neri Pozza, Vicenza 1956; Mondadori, Milano 1960) 83 La prima rappresentazione alla Scala del Re di Forzano e Giordano Eugenio Montale Il teatro lirico, preso troppo frequentemente di mira dai compositori di drammi a tinte forti e di convenzionali duetti d’amore, trova talvolta opportuno ristorarsi alle più modeste e dilettose fonti della novella e della fiaba, in cui l’immaginazione e la grazia, il colore del pittoresco e l’arguzia della satira possono benissimo armonizzare insieme e divenire materia d’arte. Questa opportunità deve essere stata sentita da Giovacchino Forzano e Umberto Giordano scegliendo la materia allegoriconovellistica del Re, andato ieri sera in scena alla Scala diretto da Arturo Toscanini. (...) Il pubblico, preparato dalla conoscenza della trama a intonare le proprie impressioni al genere, ha fatto buon viso al nuovo lavoro e con sei chiamate, delle quali quattro fragorose dirette a Toscanini e a Giordano e le ultime due anche a Forzano, si è dichiarato soddisfatto. La sala era magnifica, stipate apparivano le gallerie ed esauriti erano i posti di platea. (...) Alle prese con questo Re di carta pesta, il maestro Umberto Giordano aveva, come principale compito, da usare dei mezzi infiniti della musica per scolpire il comico della novella, sfiorare delicatamente le tenui corde affettive di Rosalina e Colombello, immergere la rappresentazione scenica in un’atmosfera di musicalità fiabesca, entro la quale sarebbe avvenuta la fusione degli elementi reali coi fantastici e giustificata la presenza, in qualche punto, del grottesco. (...) Ora Giordano, a modo suo, cioè impiegando i noti mezzi d’invenzione di cui egli diede ripetute prove di poter disporre, è pervenuto a non rallentare il movimento dell’azione scenica. (...) Diretta da Toscanini, l’esecuzione procedette snella, equilibrata, colorita. Lo strumentale di Giordano, pregevole in quanto afferma la mano sicura dell’autore e non manca di particolari interessanti, è uscito nitido dalla concertazione. L’elemento vocale di palcoscenico, sia solistico che corale, si è armonizzato nelle tinte, conservate nei toni discreti di un dinamismo di buon gusto. Allestita da Forzano, l’opera aveva assicurata a sé una interpretazione scenica perfettamente corrispondente alle intenzioni del librettista. 84 Verso Sud D. Grittani (...) La parte di Rosalina sembra scritta apposta per Toti Dal Monte, tanto bene a lei si adattano i passi agili scritti da Giordano e il carattere del personaggio concepito da Forzano. La sicurezza del canto della Del Monte, sempre facile, pronto, nitido, ha avuto ragione della struttura della musica, cosparsa di virtuosismi. (...) Apprezzata è stata pure la Pampanini come Nedda. Alla fine degli atti, Toscanini e gli altri interpreti sono stati ripetutamente acclamati al proscenio. [Articolo tratto dal Corriere della Sera, Milano 13 gennaio 1929. Il poeta ligure siglò questa recensione con le iniziali G.C., sebbene l’intervento sia senz’altro da ricondurre al periodo delle prime collaborazioni con la memorabile Terza Pagina del quotidiano milanese] 85 Due lettere inedite Umberto Giordano Umberto Giordano (Foggia 1867 - Milano 1948). Il foggiano più illustre di ogni tempo nacque - in una bella casa dell’allora via della Peschiera, oggi via Pescheria - dal farmacista Ludovico Giordano e la napoletana Sabata Scognamillo. Allievo del Conservatorio Musicale di Napoli, che frequentò assieme a un altro compositore destinato alla celebrità come Francesco Cilea, il maestro foggiano conobbe la popolarità grazie al Concorso Musicale per «opere prime in un solo atto» bandito dall’editore musicale Sonzogno nel 1888 (com’è noto il concorso fu vinto da Cavalleria Rusticana del livornese Pietro Mascagni, ma Giordano pur classificandosi sesto con l’opera Marina ottenne importanti riconoscimenti). Compositore tra i più stimati del movimento musicale verista di fine Ottocento, Umberto Giordano scrisse opere come Andrea Chénier (1896), Fedora (1898), Siberia (1903), Mese Mariano (1910), Cena delle Beffe (1924) e Il Re (1929) destinate a firmare alcune tra le più felici del cammino della lirica italiana nel mondo. Le due brevi lettere che pubblichiamo in questa antologia sono entrambe indirizzate al Commendatore Pecorella (l’allora direttore del Teatro Dauno di Foggia, istituzione successivamente dedicata al grande compositore foggiano) ed entrambe di significativo valore storico. La prima perché succede alla definitiva nomina, avvenuta quando il maestro era ancora in vita, del Teatro Comunale Umberto Giordano; la seconda perché commenta, con poche amare righe scritte otto mesi prima della morte, la mancata nomina di Senatore che invece andò al celebre Maestro Arturo Toscanini. Milano, 21 ottobre 1947 Carissimo amico Pecorella avete ricostruito il teatro che porta il mio nome, avete organizzato le superbe rappresentazioni di Chénier, avete diretto i festeggiamenti in mio onore, avete colmato di cortesie la mia consorte e avete fatto... l’impossibile. Verso Sud 86 D. Grittani Come posso ringraziarvi? Mi limito a dirvi semplicemente grazie di tutto cuore. So che spesso siete a Milano e vi prego venirmi a stringere la mano ché ne avrò gran piacere. Con cordiali saluti Umberto Giordano Milano, via Turini 2 7 marzo 1948 Carissimo Comm. e amico ricevo in questo momento la vostra gradita. Ringrazio voi e i miei amici concittadini per l’affettuosa premura presso il Governo: ma ormai è troppo tardi. Il Governo ha nominato il M. Toscanini. Vi stringo affettuosamente la mano Umberto Giordano 87 Il Piano delle Fosse Giuseppe Ungaretti Venosa, il 22 agosto 1934 Piazza ovale che non finisce più, d’una strana potenza. È tutta sparsa di gobbe, sconvolta, secca, accecante di polvere. Da un lato la chiude una fila di carri obliqui sulle ruote nelle profondità dei quali i fichidindia messi in mostra fanno come un mosaico coi loro colori gelati. Grandi scommesse a chi ne mangerà di più, e c’è chi arriva a mandarne giù anche cento. Mi sono avvicinato a una delle tante gobbe. Dietro aveva come le altre una piccola lapide. Smossa la terra, tolte le assicelle apparse sotto, s’è aperto un pozzo e dentro s’alza un monte di grano. Questa piazza a perdita d’occhio nasconde dunque l’uno accanto all’altro un’infinità di pozzi, conserva il grano della provincia che ne produce 3.000.000 di quintali, e più. Altro che grotta di Alì Babà. Ho visto cose antiche, nessuna m’è sembrata più antica di questa, e non solo perché forse il Piano c’era prima di Foggia stessa, come fa credere la curiosa analogia fra “Foggia” e “fossa”, ma questo alveare sotterraneo colmo di grano mi riconduce a tempi patriarcali, quando sopraggiungeva un arcangelo a mostrare a un uomo un incredibile crescere e moltiplicarsi di figli e di beni. Nessun luogo avrebbe più diritto d’essere dichiarato Monumento Nazionale. [Tratto da Deserto e dopo, GIUSEPPE UNGARETTI, Mondadori, Milano 1961] 89 Foggia e il Tavoliere Guido Piovene Guido Piovene (1907-1986). Scrittore vicentino legato al filone del cattolicesimo veneto, autore di un pregevole saggio-inchiesta sulle bellezze della nostra penisola dal titolo Viaggio in Italia, da cui è tratto il brano che segue: descrizione ironica e disincatata della terra e degli abitanti del Tavoliere. Quella pianura vasta e di un solo colore, un tempo tutta verde perché tutta pascolo, più tardi tutta gialla perché coltivata a grano, il Tavoliere della Puglia, è con la Sardegna ed alcune zone interne della Sicilia troppo scarsamente abitata. Si deve ai cattivi governi se una terra fertile, dove qualsiasi coltura risulta possibile, fu abbandonata gradualmente dagli uomini. Il cosiddetto regime di Tavoliere, voluto dai Borboni, che si protrasse fino al 1865 con il breve intervallo di Gioacchino Murat, proibiva le coltivazioni per riservare il pascolo a beneficio dell’erario. Il Tavoliere era il maggiore sbocco delle greggi che scendevano sui tratturi attraverso il Fortore dalle montagne molisane e abruzzesi. Le cronache ci parlano di quell’immensa landa verde in cui si protrasse, fino a meno di un secolo fa, la vita senza data della pastorizia. Decine di migliaia di animali vi pascolavano: pecore, capre, vacche, cavalli, bufali. Era un West italiano. Anche Foggia mescolava nell’aspetto e negli usi i caratteri di una cittadina del Texas a quelli d’una cittadina borbonica. Capitale del regno più vasto del bestiame nomade, era anche il maggiore mercato del bestiame e della lana grezza. Ferdinando II, appassionato di cavalli, vi andava con la scorta dei suoi ufficiali; ed in quel piccolo West napoletano si faceva baldoria, si stringevano fidanzamenti, si giocava d’azzardo. Molti, raccontano le cronache, venuti a vendere bestiame, ritornavano senza bestiame e senza danaro. Tenuto a bella posta incolto, con abitanti fissi sempre più rari, il Tavoliere decadeva a plaga selvaggia. Le acque impaludavano vasti tratti di terra; i venti di mare spingevano verso l’interno i miasmi delle paludi; si diffondeva la malaria. Gli alberi furono distrutti: in provincia di Foggia, il feroce diboscamento ha lasciato soltanto un’isola, la Foresta Umbra del 90 Verso Sud D. Grittani Gargano. La miseria de’ pochi abitanti superstiti stabilì un regime di furti, di rapine e di abigeati. Sulla distruzione degli alberi, che abbiamo constatato in Sardegna, in Calabria, in Lucania ed altrove, dovuta all’odio del pastore, che non tollerava un’ombra dove pascolava il suo gregge, ed aborrendo quella datagli dalle fronde cercava per sé stesso l’ombra delle prode dei fossi, vorrei aggiungere qualche riga. La miseria la spiega, ma una miseria convertitasi in moralismo. Non solamente l’albero è giudicato dannoso perché prende un pezzo di terra, ma aborrito come predone, perché “ladro di terra”. È un sentimento d’invidia per l’essere improduttivo (o almeno ritenuto tale), che non lavora, che non sgobba, eppure pretende di vivere: un atto di primitiva giustizia contro l’ozioso, il parassita, di cui si mette in causa, il diritto alla vita. È una condanna moralistica, l’esecuzione capitale di un presunto reo. La legge del 1865, che abolì il regime di pascolo, non ripopolò il Tavoliere ma provocò la nascita del latifondo. La pianura fu infatti divisa da speculatori che vi instaurarono una sola coltura, la coltura del grano, che non esigeva grandi capitali, strade, abbondante mano d’opera stabile. Due sole operazioni erano infatti necessarie, la semina e la raccolta. Non sorsero né case, né pozzi, né stalle, né alberi. Dall’uniforme color verde dell’epoca pastorale, la pianura passò all’uniforme color giallo dell’epoca cerealicola, egualmente deserta, sotto il sole ed il vento. La siccità la rendeva inadatta a colture più ricche. E l’emorragia demografica continuò in tutto il primo quarto del secolo. Alcuni villaggi della provincia si sdoppiarono riproducendosi per emigrazione oltre Oceano, e soprattutto in California. La rinascita vera del Tavoliere esigeva perciò una bonifica a fondo della terra divenuta ostile. Era necessario immettervi colture più varie e più ricche sottraendole al monopolio della coltura cerealicola, e perciò popolarla; ma anche distogliere parte degli abitanti dall’agricoltura per instaurarvi un’economia meno semplice. Lavori di bonifica furono infatti compiuti disordinatamente agli inizi del Regno. Il Consorzio formato nel 1933 costruì case e borgate. Una bonifica più integrale ed organica, iniziata nel dopoguerra, è ora in corso con grandi mezzi; e questa fase di passaggio si riflette anche nell’aspetto di Foggia. Foggia era stata pressoché distrutta dai bombardamenti aerei, che vi fecero 18 mila morti. La sua ricostruzione fu spettacolare. Nonostante la decimazione, gli abitanti salirono dai 62 mila censiti nel 1936 a 116 mila. Parte per l’immigrazione dalla provincia, parte da altre regioni, e perfino dal Nord. Tra l’altro Foggia è uno dei centri ferroviari e stradali più importanti d’Italia. Circa sessanta autolinee vi fanno capo. Se non lo sviluppo industriale, quello commerciale fu enorme, elevando il tenore di vita. Più carne, più vino, più dolci, più telefoni, più energia elettrica. Inoltre Foggia è al centro dell’opera di bonifica. La sua ambizione di diventare uno G. Piovene Foggia e il Tavoliere 91 dei perni della vita meridionale, e di competere con Bari, è palese. Certo ha uno slancio più forte di qualsiasi altra città della Puglia. Perciò Foggia ci appare oggi una città interamente moderna, o meglio, una città in cui il moderno, che occupa la facciata, trascina i resti anonimi di una vecchia decaduta. L’attrattiva maggiore è nel suo disegno spazioso di grande città in embrione, nelle strade del centro, ampie, ben arieggiate, nell’acqua squisita, nel vento fresco. Vi sono palazzi, negozi appariscenti di frigoriferi e di biancheria fine; anche se per la strada si incontrano ancora l’asino e il mulo. Vista sotto tale scorcio la città dà l’impressione della ricchezza; ma, addentrandosi nei suoi quartieri, ecco le case decadute ad un piano solo, di genere coloniale; e, dicono le statistiche, nonostante l’impulso edilizio stupefacente, 20.000 persone vivono ancora in grotte, in caverne, in baracche. Più che crescere gradatamente, il moderno sembra essere esploso, sovrapponendosi in modo vistoso alla vecchia anima meridionale, abitudinaria, guardinga. Si direbbe che la casa cambi più rapidamente degli animi e delle usanze, e sia troppo grande per essi. Forse un emblema del Sud, nella fase attuale, si scorge in certi interni, grigi ed affollati, dove nello squallore spicca la macchina bianca di un frigorifero lussuoso. Prima di diventare vero il moderno attraversa una fase retorica. Ma impressiona lo sviluppo fisico della città, la cadenza della trasformazione, la rapidità della corsa. La provincia di Foggia è prevalentemente agricola. L’industria più importante è una cartiera, proprietà dello Stato, con una buona produzione di cellulosa. Vi sono industrie alimentari, mulini e pastifici. La centrale del latte e lo stabilimento per sgranare il cotone sono sorti nel dopoguerra. Tra le risorse più importanti bisogna citarne almeno due: il sale delle saline di Margherita di Savoia, raccolto ma non lavorato in loco, e la miniera di bauxite presso San Giovanni Rotondo. Ma cellulosa e sale sono industrie statali, e la bauxite della Montecatini. Dopo la perdita dell’Istria quella citata or ora è l’unica miniera di bauxite italiana, e fornisce 270 mila tonnellate di alluminio all’anno. Si ritiene che nel Gargano vi siano altri giacimenti rimasti intatti. Piccole industrie, specie della pelle e del cuoio, potrebbero attecchire. Un notevole guadagno, connesso con lo sviluppo della bonifica, si avrà dall’apertura della centrale ortofrutticola. In questa grande plaga agricola fino ad oggi infatti è mancato il modo di conservare frutti ed ortaggi, così che si è dovuto vinificare con uva pregiata da tavola perché non si avevano i mezzi di mantenerla fresca. Si arrivava all’assurdo che pere, pesche ed albicocche, prodotte nel foggiano, erano conservate nei frigoriferi delle città del Nord, Milano, Verona, Bologna. Lo stesso per gli agrumi, che maturano tardi in Puglia, quando sono finiti quelli siciliani. Il Tavoliere pastorale, più tardi cerealicolo e latifondista, era la plaga più scarsa di strade in Italia, paludoso per vasti tratti, soggetto alle tragiche piene di torrente privi di regola. Le tre prime necessità erano costruire strade, eliminare le paludi, imbri- 92 Verso Sud D. Grittani gliare i torrenti. Coi fondi della Cassa del Mezzogiorno le strade sono state adesso portate a mille chilometri circa, raggiungendo così l’indice medio italiano, e la situazione appare nell’insieme soddisfacente. Di 30.000 ettari circa di acque nocive, oltre 20.000 sono stati già prosciugati, redimendo il terreno alla coltura. È sparito ad esempio il cosiddetto lago Contessa. Le restanti paludi, specie verso Manfredonia, spariranno tra breve. Terreni acquitrinosi o sabbiosi intorno ai graziosi laghi di Lesina e di Varno, ai margini del Gargano sulla costa marina, sono stati pure redenti, per coltivarli a cotone e ad ortaggi. Questa bonifica non è esente da controversie. A Lesina, per esempio, 1500 ettari sono stati occupati dai contadini via via che uscivano dalla palude, onde il conflitto con i quattro o cinque proprietari degli acquitrini. Un esperimento, finora compiuto su 500-600 ettari, dovrà estendersi su tremila: e cioè ricoprire le terre sabbiose con terra fertile dal fondo dei laghi. Frangiventi di alberi si stanno qui piantando come in Sardegna. La bonifica, dalla pianura, via via risale sulla collina. E per quanto riguarda specialmente la parte idraulica, con l’acquisizione di nuovi vasti terreni alla coltura, il 60 per 100 può considerarsi compiuto. Meno rapida invece procede la trasformazione. Bisogna coltivare più vigneti ed ortaggi; dare impulso alla zootecnia, finora scarsa e nomade; far sorgere una rete di industrie derivate. Un radicale cambiamento delle condizioni ambientali richiede inoltre l’irrigazione più diffusa. Dovranno provvedervi soprattutto le acque del Fortore e dell’Ofanto. L’invaso dell’Ofanto, già finanziato, irrigherà 10.000 ettari circa intorno a Cerignola. Opera più cospicua sarà la costruzione di una diga e la formazione di un lago artificiale, disciplinando le acque del Fortore, torrente fino ad oggi infausto. Il Fortore corre, tra monti, ai confini, delle province di Benevento e Campobasso; in una bella e povera zona, priva di ferrovie, percorsa ancora dalle mandrie, rigata dai tratturi delle transumanze. Da lì le acque dovrebbero irrigare 60.000 ettari circa delle pianure sottostanti. La bonifica è legata alla riforma agraria. Se pochi vi sono i coloni, il Tavoliere presenta forse la maggiore concentrazione di braccianti d’Italia. Una enorme massa di circa 70.000 braccianti, che ha Cerignola e San Severo come principali centri: soggetta alle vicende delle stagioni, ai capricci della siccità. La grande proprietà, dopo il frazionamento iniziato tra le due guerre, ha ricevuto un altro colpo dalla riforma. L’estensione media delle proprietà classificate come grandi è passata da 500 a 250 ettari. A differenza di altre parti d’Italia, non si è espropriato solo pascolo, ma anche vigneti ed oliveti, assumendo come criterio non la qualità del terreno, ma il reddito del proprietario. Sei borgate rurali sono sorte, in aggiunta a quelle dell’anteguerra. I braccianti, stipati in Cerignola, San Severo e in altri centri, formicai di lavoratori dei campi ma lontani da campi, secondo il costume del Sud, sono stati in parte assorbiti dalla piccola proprietà. Ma le quote assegnate ai braccianti risultano G. Piovene Foggia e il Tavoliere 93 troppo piccole perché vi possano vivere da contadini senza un’attività complementare; e soltanto le industrie potrebbero venire incontro al forte aumento demografico. Bonifica e trasformazione del Tavoliere delle Puglie sono una grandiosa impresa; tanto che non era possibile iniziare se non di qui il nostro giro della Puglia, per altri motivi stupenda. Lucera, con la splendida fortezza svevo-angioina, Troia con la sua cattedrale dalle porte di bronzo capricciosamente scolpite, che mescola il bizantino all’arabo ed al toscano, ci introducono nel meraviglioso e composito stile romanico pugliese, a poca distanza da Foggia. Ma la grande bellezza turistica della provincia è il Gargano. Promontorio montuoso, intorno al quale la letteratura è scarsa in paragone alle sue attrattive, e che perciò conserva qualche segreto, mi è apparso diverso da quello che le descrizioni altrui mi avevano prefigurato. Pensavo ad una montagna selvatica, scura, aspra, tendente all’orrido; mi sono trovato davanti ad una delle terre più greche d’Italia, nel senso del grazioso e del lieve. Con l’aiuto della stagione, vedevo un passaggio dolce, fiorito, quale si incontra nei poeti greci più lirici; coi mandorli metà bianchi di fiori e metà verdi di foglie, i greppi ricoperti di ireos selvaggi di colore violetto, e i gruppi degli olivi contorti sopra la roccia. Anche i villaggi, dalle case basse e intonacate a calcina, erano di una pulizia luminosa. Gli asini e i muli, le pecore, le capre nere attraversandoli spiccavano su quel bianco, e andavano ad abbeverarsi a fontane di marmo da poema cavalleresco, ricchezza di paesi poveri e fino a ieri isolati dal mondo. Nel mezzo delle strade le donne lavorano a maglia, e i banditori portano le notizie e le ordinanze del Comune. Un’aria classica, civile, per antichità. Se l’orecchio non mi ha tradito, ho udito un contadino rivolgere a una donna un complimento mitologico: «O Giuno!». Ai margini delle grandi concentrazioni bracciantili, è una terra di contadini, pastori e pescatori. Si pesca lungo tutta la costa, fino al golfo di Manfredonia, e nelle isole Tremiti al largo; in quei paesetti marinari, splendenti e scarni, che sono Peschici e Vieste. Leggera è anche la foresta cosiddetta umbra, non si sa bene se in memoria degli umbri, antichi abitatori di queste terre, o solamente perché è ombrosa; posta in alto sul monte, unico avanzo delle foreste che coprivano il promontorio. Vi predomina il faggio, albero chiaro, ma vi crescono l’agrifoglio e il tasso venefico; ed è popolata di uccelli, folta ma senza orrore. Sul Gargano si accavallarono, lasciando ciascuna un deposito, genti diverse di passaggio. La preistoria, la Grecia, Roma e il Medio Evo vi lasciarono i loro segni, non tutti ancora messi in luce. Nelle Tremiti, belle e poco note, secondo la leggenda fu sepolto Diomede. Il santuario di Monte Sant’Angelo fu il più famoso nel medio Evo. Mitologia pagana, magia, devozione cristiana si confusero in modo pressoché inestricabile. Il Gargano poi cadde in un oblio quasi totale, da cui solo ora si solleva. Agricoltura e pastorizia vi danno poco reddito. Squisita la pesca, e ricca di pesce 94 Verso Sud D. Grittani pregiato, oltre ad anguille e capitoni nei laghetti costieri; ma condotta ancor oggi con sistemi artigiani, senza trasporti organizzati, tanto che si è dovuto talvolta ributtare il pescato a mare. Questa situazione provoca forti malumori politici che contrastano stranamente con il grazioso arcaismo ambientale. Il turismo potrà alleviarla quando il Gargano sarà conosciuto di più. Lo amarono soprattutto viaggiatori stranieri, più curiosi degli italiani delle bellezze rare e di una vita primitiva, in cui mitologie diverse sembrano continuare a vivere. Già costruita è un’ottima rete di strade; si progetta ora una serie di piccoli alberghi, come quello esistente nella Foresta Umbra. Vicini a Manfredonia sorgono in solitudine due squisite chiese romaniche, Santa Maria di Siponto e San Leonardo; presso la prima sono in corso scavi archeologici sull’area dove sorse Siponto, altra città scomparsa. Che cos’era, che cos’è il Gargano, lo si vede a Monte Sant’Angelo. Il suo castello fu sede di principi e re. La basilica fu la più famosa meta medievale di pellegrinaggi, e l’itinerario garganico fu forse l’unico in Italia paragonabile ai grandi itinerari di pellegrini che rigarono di fiumi umani il suolo francese e spagnolo. Fu il santuario nazionale dei longobardi: qui si inginocchiarono papi, san Francesco d’Assisi, san Tommaso d’Aquino, santa Caterina da Siena, e i crociati in procinto di partire per la Terra Santa in omaggio all’Arcangelo guerriero. Da una basilica superiore si scende, per una scala sotterranea monumentale, fino alla grotta dove, secondo la leggenda, apparve l’Arcangelo. Entra da un’apertura l’aria e l’odore del mare, mescolandosi sotto le volte a quelli dei ceri, della muffa e dei devoti. Ancora oggi al santuario salgono, nelle feste, quasi 500.000 pellegrini all’anno. Ma nei giorni normali ogni splendore è spento. La borgata sorge su greppi pietrosi dai quali si domina il mare in lontananza; l’occhio per giungervi sorvola anfratti tra cui spunta qua e là un ulivo, qualche ciuffo di grano che contende la vita ai sassi. A Monte Sant’Angelo, dove mi fermo qualche ora, serpeggia nella piazza una curiosa effervescenza. Gli animi sono travagliati dalle parole, misteriose come quelle liturgiche, che hanno udito ai comizi. È una povera popolazione, ed esce da un inverno duro, in cui la neve l’ha bloccata con minaccia di fame. Adesso attribuiscono agli agiati del borgo sterminate ricchezze, giganteschi egoismi, cupidigie leggendarie. I due o tre signorotti escono dai loro limiti modesti per entrare nella mitologia. La parola che odo ripetere più spesso nell’atto di accusa è “azionisti”, possessori di azioni: è una parola liturgica, che si pronuncia con mistero, abbassando la voce. L’immaginazione cammina. Di un tal proprietario, sul cui nome s’insiste, domando che cosa possegga. Siamo in cima al paese, di dove si scorge un vasto panorama di alture che scendono verso mare: «Tutto quello che vede è suo», dice l’uomo che mi sta accanto, nominatosi mio cicerone d’autorità, e con un gesto circolare abbraccia tutto il panorama. Guardo più attentamente e vedo un’unica sassaia rotta da precipizi, tra G. Piovene Foggia e il Tavoliere 95 cui spunta qua e là un ulivo, qualche ciuffo di grano trapelante fra i sassi: disgraziato nababbo! Col mondo padronale ho un incontro subito dopo. Una vecchia padrona, forse di novant’anni, seduta davanti alla casa, sorveglia due serve al lavoro. L’una stende la biancheria, l’altra setaccia la farina, la quale si ammucchia cadendo in una specie di ampia culla di legno. Commetto l’errore di chiedere qualche spiegazione a lei, volgendo le spalle alla vecchia; chiedo se tutti facciano il pane in casa. Mi risponde che fanno in casa tutto il pane e in parte la pasta; in parte invece l’acquistano alla bottega. La vecchia alle mie spalle, offesa che la serva parli al suo posto, agita i piedi a nocche, coperti solo dalle calze, e starnazza. «La pasta che si compera nelle botteghe è per loro due che hanno i denti, ma per me è troppo dura. Io mangio quella fatta in casa.» Mi scopre le gengive nude e si rinchiude in un silenzio ingrugnato. Essere la padrone e mancare dei denti sono due titoli d’onore che si confondo, e insieme le danno il diritto a cibarsi più nobilmente. San Giovanni Rotondo, dove abita Padre Pio, è poco lontano da qui: e Padre Pio è una specie di presenza occulta a cui tutti ricorrono per le loro necessità. La monaca che mi ferma per chiedere un posto in macchina non fa che ringraziare Padre Pio durante il viaggio. Perduta la corriera, l’ha invocato dicendo: «Padre Pio, mandatemi una automobile». È ancora più sicura che sia stato lui a mandarmi quando le dico che mi appresto a fargli una visita. Padre Pio ha detto: «Mandiamole quel signore che sta per venire da me». Per arrivare a Padre Pio, bisogna passare attraverso questa efflorescenza magica, di cui la gente lo circonda fino a nasconderlo, non riuscendo a dividere il suo concetto d’un santo da quello d’un mago. Da questo si è più disturbati che attratti. La lettura delle anime, le lotte con i demoni, l’ubiquità… Appena giunto a San Giovanni Rotondo, ricevetti lo sfogo di un giovane settentrionale impiegato quaggiù. Si era presentato tre volte a Padre Pio per confessarsi, ed era stato rimandato tre volte senza assoluzione. Lo strano è che mi narrava queste ripulse in topo apologetico, come una prova di più della perspicacia del monaco francescano; quasi offrendo sé stesso e la sua provvisoria dannazione per testimoniarne la gloria. Parlavamo nell’atrio di un albergo. «Qui» mi disse «una sera, mentre stavo con altri quattro, il commendator X, l’ingegner Y, ecc., scoppiò improvvisamente un profumo di viola così forte, che ne rimasero storditi. Io solo non sentivo nulla». E mi guardava con un’aria avvilita, scuotendo il capo su sé stesso; anche quel castigo, quel segno, la privazione del profumo, diventavano un motivo d’ammirazione, una testimonianza della santità dell’uomo che sa giudicare e punire. «Ma Padre Pio» gli chiesi «era qui nell’albergo?» «Oh no» rispose il giovane con il sorriso col quale si accolgono le domande ingenue «stava in cella, a mezzo chilometro». «E manda il profumo così lontano?» Nuovo sorrisetto. «Qui è niente; in Egitto, in Alaska…» 96 Verso Sud D. Grittani Questa vicenda delle assoluzioni negate per straordinaria forza di penetrazione nelle anime fa parte della leggenda di Padre Pio. I motivi per cui Padre Pio può respingere sono, da quanto mi raccontano, i più semplici e più ortodossi. Il matrimonio volontariamente infecondo; non ricordare quante volte si è perduta la Messa, dimostrano così di annettervi poca importanza. In Egitto, in Alaska… Come se fosse scaturita da quell’atmosfera magica, sceso in paese vi trovai l’unica centenaria della mia vita. Era già nella farmacia dove entrai: un fantoccio di cenci fluidi, nei quali il corpo si perdeva senza disdegno. La pelle del volto pendeva come i cenci nello stesso senso, così che vesti, corpo e volto indistinti sembravano colare insieme. Aveva posato sul banco dieci lire e una bustina: il farmacista prendeva con un cucchiaio alcune pastiglie di gomma verde ed avvolte nello zucchero, e le metteva dentro alla bustina contandole. D’un tratto uscì dai cenci non una voce, ma uno strido di topo: «Di più, di più. Non lo sapete che devo mangiare per quattro giorni?». «Quante ne volete mangiare?» ribatté il farmacista «quattro al giorno, per caso? Due, due, dovete prenderne». La vecchia farfugliava che aveva fame; ed ottenute alcune pastiglie di più, uscì stringendo la bustina. «Ha visto» spiegò il farmacista. «Le ho detto due al giorno perché si limiti a prenderne quattro; se le dico quattro, è capace di mangiarne anche sei… Credo bene, che non mangi altro; che cosa dovrebbe mangiare alla sua età? Ha cent’anni passati. Sono pastiglie di mentolo: se le mette sotto la lingua e continua a succhiare per la giornata intera. Lo zucchero la nutre, e il mentolo la tiene su. A cent’anni ce n’è d’avanzo…» Poi, tornato all’albergo, di nuovo miracoli, miracolati. Ecco un diplomatico americano, un ebreo convertito, tra la moglie ed i figli, nell’attesa agitata della mattina dopo. Secondo il suo racconto, un frate gli era apparso miracolosamente negli Stati Uniti, venticinque anni fa, persuadendolo alla conversione, senza palesargli il suo nome. Solo recentemente lo riconobbe in una rivista illustrata, e si precipitò in Italia per ringraziarlo. Non conoscevo ancora il drappello delle devote, trasferitesi qui per stare sempre presso il Santo, ricavando da vivere dal commercio degli oggetti sacri. All’alba, prima della Messa, si stringono intorno alla porta della piccola chiesa perché nessuno entri prima di loro. Quando la porta s’apre, irrompono nella chiesa, occupando le prime due file davanti all’altare e le ali del breve passaggio che uscendo dalla sagrestia Padre Pio è costretto a percorrere. Appena appare lo aggrediscono, per toccarlo, mettersi in vista, competere nello zelo, facendolo vacillare, talvolta pestandogli i piedi piagati dalle stimmate. Giacché Padre Pio ha le stimmate; le mani e i piedi traforati, e una piaga al costato; e i buchi delle mani coperti di una lieve crosta che sanguina. G. Piovene Foggia e il Tavoliere 97 Più su di questo, vi è l’opera e la persona dell’unico uomo vivente che, almeno nel nostro Paese, abbia fama di santità. Nei giorni in cui lo vidi si preparava l’inaugurazione ufficiale dell’immenso ospedale (la Casa sollievo della sofferenza), fissata per il 5 maggio, perché il 5, mi dicono, è il numero di Padre Pio, e ha segnato gli eventi principali della sua vita. La costruzione, lunga 188 metri, con una superficie di 6000 metri quadrati, è sorta dove fino a pochi anni fa si vedeva soltanto un conventino sperduto tra i greppi sassosi, sopra una povera borgata di montanari del Gargano. Adesso il conventino scompare di fronte all’ospedale, alle costruzioni civili, agli alberghi che salgono verso di esso sulla rampa; si assiste alla nascita d’una città intorno alla fama di un uomo. Un altro grande ospedale è in progetto. Confesso che quello già sorto, mentre lo visitavo, ed ammiravo la modernità degli impianti, mi parve fin troppo pomposo e troppo carico di marmi. Ma l’impressione fu corretta quando entrai nel convento che genera questo sfarzo. È il convento più povero e sgangherato ch’io conosca. Le celle, intraviste dal corridoio, sono come le camere dei contadini del Sud; i muri devono essere umidi, se si giudica dai vecchi frati, che camminano un po’ sbilenchi. Eppure Padre Pio riceve qua dentro, da tutte le parti del mondo, molti milioni al giorno che fluiscono nell’ospedale, in lavori che costano miliardi, dai quali il conventino sarà sommerso come le vecchie casupole anacronistiche nascoste tra i grattacieli delle città. Padre Pio non si muove dal convento: non si occupa dei lavori che promuove, se non per sollecitarli, e li abbandona ai tecnici. Dire Messa è per lui l’avvenimento capitale della giornata. Nelle altre ore, prega e confessa. Queste opere riprendono in lui, come in antico, un valore di funzione pubblica. Dorme poco, si nutre di qualche erbaggio e di un bicchiere di birra. La Messa è alle cinque della mattina ad un altare secondario della chiesetta. La folla comincia però ad assediare di notte la porta chiusa. Quella Messa che, benché normale, dura un’ora abbondante, è un evento drammatico, che porta Padre Pio di sbalzo molto più su della leggenda diffusasi intorno a lui. Mi limito a ricordarlo nell’emozione di quel dramma, lasciando giudicare ad altri la sua fama di santo magico, su cui non saprei dire nulla. Padre Pio dice Messa in uno stato, certo autentico, di estasi e di rapimento: non un rapimento immobile; un rapimento travagliato, in cui si alternano sentimenti diversi, con una specie di altalena tra l’ebbrezza e l’affanno. Le mani, che durante il giorno ricopre con mezzi guanti di lana, sono nude all’altare e mostrano la grande macchia rossiccia delle stimmate. Si vede che gli dolgono; e specialmente soffre nel genuflettersi, come lo richiede il rito, pesando sul piede sinistro. Allora si aggrappa all’altare; un’ombra di dolore fisico gli appare in faccia, come nel sonno dei malati, che soffrono del male ma ne sono incoscienti; e si mescola ad una sofferenza maggiore. È chiaro che il frate rivive, anima e corpo, il sacrificio di Cristo; più che una 98 Verso Sud D. Grittani Messa, il suo è un colloquio con Cristo, concitato a momenti, ed in altri disteso. I sentimenti discordanti, di gioia o d’angoscia, che palesa sul volto, sono suscitati in lui dalla vicenda a cui partecipa. Ho visto Padre Pio togliersi dalla manica un fazzoletto, adoperarlo, e poi gettarlo sull’altare; la sua Messa è, nel tempo stesso, tragica e confidenziale. Qualche ora più tardi, ritrovai Padre Pio nel corridoio del convento, dove soltanto gli uomini sono ammessi. Non vidi niente in lui dell’indovino né del mago. La cerchia intorno a lui comprendeva fedeli di ogni professione e ceto, dottori, ingegneri, industriali, operai, pastori della montagna. Erano tutti uniformati dal sorrisetto beato ed un po’ melenso col quale bevevano le sue parole, senza staccargli un istante gli occhi di dosso, e cercando, appena possibile, di afferrargli una mano per baciarla. In mezzo, Padre Pio scherzava, raccontava modesti aneddoti, proverbiosi, gli stessi che si ascoltano nelle case dei contadini, e hanno come orizzonte la vita e i costumi della campagna. Nessuna sottigliezza intellettuale. Credo che soffrisse ancora, almeno a giudicare dal passo, vacillante, guardingo, da persona che cerca di pesare il meno possibile; ma quel nodo di sentimenti, alcuni dei quali affannosi, suscitati in lui dalla Messa, gli si era sciolto in gioia. Nell’occhio grande, sferico, tale che riempie le palpebre e dà loro una forma fortemente convessa, un occhio dove si direbbe che gli oggetti della visione s’ingrandiscano come traversando una lente, vi era un’espressione di gioia assoluta. Appena fuori del convento, ripiombai nell’informe aspirazione alla magia che alita in queste terre; quasiché un sentimento religioso vagante cerchi dove può il suo oggetto, pronto a farsi calamitare. Un crocchio di donnette si era raccolto intorno a una signora bionda, seduta in automobile in mezzo al piazzale. «Americana?» «No». «Capisci l’italiano?» «Certo, sono italiana». «Italiana è, capisce l’italiano!» cominciò a strillare una donna. «Quanto è bella! Che pelle tiene!» Le toccava la guancia per il finestrino aperto, si baciava la punta delle dita: «Santa martire! Santa martire!». Tutte le donne a turno toccavano quella guancia, per baciarsi le dita, per farsi il segno della croce: «Santa martire! Santa martire!». L’aggredita si difendeva e strillava a sua volta. «Non sono Padre Pio! Non sono Padre Pio!». Egli convoglia le credenze della nostra regione in cui la magia ha lasciato più profondi residui; qui polarizzate da un Santo, ed altrove da maghi e da guaritori profani. La Puglia è ricca di folclore interiore: il folclore esteriore, che si dispiega in pittoresche usanze arcaiche, è quasi estinto. Una viaggiatrice inglese, nel 1889, trovò i villaggi del Gargano con gli uomini tutti in costume, e le donne coperte d’oro come Madonne. Nulla si vede oggi di simile. Altra usanza era la G. Piovene Foggia e il Tavoliere 99 cosiddetta ditt, rappresentazione teatrale all’aria aperta, simile ai maggi reggiani e toscani, diversa però nello spirito, non desunta cioè dai poemi cavallereschi. Tre personaggi fissi vi intervenivano, Pulcinella, il demonio e San Michele. Anche questa usanza è scomparsa. Una difficoltà nel capire l’Italia è il contrasto tra la persistenza di sedimenti arcaici nelle coscienze, e la veloce sparizione delle espressioni più visibili, l’irruzione di una modernità di superficie. La Capitanata, con Foggia, è una Puglia sui generis, il cui aspetto oggi più preminente è la bonifica dei campi e la trasformazione delle colture. La vera Puglia comincia più a sud; e si può vederla, secondo gli umori, come una regione povera, o come un paradiso terrestre dell’agricoltura, dove raggiungono il primato, rispetto alle altre regioni d’Italia, il vino e la vite, l’oliva e il mandorlo, il tabacco ed il fico, l’avena e la melacotogna. [Tratto da Viaggio in Italia, GUIDO PIOVENE, Mondadori, Milano 1957] 101 Omaggio a Foggia Pasquale Soccio Pasquale Soccio (San Marco in Lamis 1907). Figlio di un fabbro ferraio e di una casalinga, Pasquale Soccio va senza dubbio annoverato tra le personalità culturali più autentiche della Puglia. E non solo, dato che il pensiero di Soccio ha prepotentemente varcato i confini continentali grazie a L’autobiografia, poesia e scienza nuova di Gian Battista Vico, saggio di straordinaria lucidità pubblicato nella collana Grandi Libri Garzanti (Milano 1983). L’opera più nota di Soccio è stata infatti tradotta in numerose lingue e adottata dalla prestigiosa Stanford University (California). Oltre ad ospitare alcuni brani tratti da Omaggio a Foggia (Adda 1974), questa antologia si fregia dell’onore di riservare a Soccio un posto da protagonista nello splendido racconto Gargano sessantuno di cui è autore il poeta Roberto Roversi (vedi capitolo dedicato al Gargano). Io dormo sul tuo cuore antico, o Foggia, e sogno oro di grano, oro di lana. Dove una volta confluivano i tratturi e si apriva il gibboso piano delle fosse, arche ricolme del frutto più cospicuo della tua terra, e dove ora invece il cemento tutto ha sepolto, io sono giunto, con la mia dimora, come a una estrema riva; e guardo estatico il tuo volto di oggi e di sempre. Con onde di messi, onde di greggi, in luce bionda si desta la tavola che ti contiene. In una cornice azzurra, che va da monte a monte, percorsa ad oriente dalla fuggitiva letizia delle onde adriatiche, immenso appare il tuo volto sulla piana immensa. ‘Hai per sede lo spazio, il deserto hai per matrice’. Al centro, onnivisibile faro d’orientamento, la verticale di un’opera di fede: sull’anonima nebbia delle case, prone e povere, vigile sale e ardita la cattedrale. Il campanile è l’asta puntata di un compasso ideale che con felice giro geometrico di vasto respiro circoscrive uno degli spazi più armoniosi nella divisione delle province italiane. È un dito proteso imperiosamente verso l’invisibile, verso orizzonti senza confini, verso l’infinito. Di giorno, quando i venti, non più domati dai monti intorno, dilagano 102 Verso Sud D. Grittani tripudiando nella piana a gara con bufali e cavalli superstiti, sta come saldo pennone fra tempeste di venti e di eventi. Di notte, quando si spalancano cieli favolosi di stelle e il Tavoliere a specchio, con la razionale disposizione delle sue città, imita e riflette la quiete stellare, esso addita una luce che trascende quelle visibili. Allora i treni, che, come i venti, con infrenato slancio hanno caracollato lungo le giogaie appenniniche, sfrecciano in pianura e intonano il canto fermo della velocità; e come fulgide meteore sono calamitate dal tuo lago luminoso. Fragile voglia al vento e della sorte, dopo incerto peregrinare con la mia dimora (non so se ultima), sono stato collocato dal destino nel punto dove tu, nascendo, avesti culla e giovine vita: qui il tuo spazio originario estua nel tempo, e cioè dove sorgiva e foce danno già vigoroso corso al fiume della tua storia, divenendo con onde impetuose città di frontiera, fatale crocevia della storia umana. Sento ora in me l’invito filiale ad ardere di consapevolezza nell’ascoltare e sentire la tua voce, nel riconoscere l’espressione del tuo volto. Oggi sono come ago di bussola che vibra magnetizzato dal tuo sguardo e oscilla tra i due poli del Vulture e del Gargano, visibili insieme da qui in giorni di chiarìa e che cingono di sereno la bionda pagina del Tavoliere. Da una pianta amica scende per un filo di ragno una goccia d’acqua di mattutina rugiada e rimane sospesa nel vuoto. Riflette l’arco del tuo centro antico e si immilla di luci. È una goccia di sole, che si illumina d’immenso. La sua vita fugace dipende da un breve moto d’aria, da un lieve brivido del vento. (Così la mia vita: un pensiero sospeso nella coscienza, pronto a vanire nell’infinita serenità). Ma in questo preciso istante, in questa goccia di umore s’incentra, s’addensa e riflette l’intero universo dauno dal Gargano all’Appennino. Lo slancio d’orizzonte che offre questa mia dimora, incombente sulle umili case dell’antico centro, accende una esaltazione inebriante. Oggi, dunque, sono io una luminosa stilla di gioia: la trasparenza effimera della coscienza; labile punto di luce reale e mentale. Uno scatto della memoria provoca una consaputa fata Morgana, e fantastica e delira con ombre e oggetti, eventi ed esistenze. Sia pure caduco al primo vento della sorte, sento di essere quella convergenza di luci, che si esalta a questi vertici singolari di spazio e di tempo. E mi tormento d’essere opaca, irrequieta materia; aver dentro grovigli di pensieri, sensi al dolore; creatura esposta al capriccio del caso: non poter essere fermo specchio del tuo cielo, il riso del tuo mattino. (...) [Tratto da Omaggio a Foggia, PASQUALE SOCCIO, Adda, Bari 1974] 103 Foggia Eugenio Bennato Artista impegnato nella ricerca delle più antiche sonorità, uomo profondamente innamorato della Capitanata, Eugenio Bennato ha trovato nei “Cantori di Carpino” i suoi ideali compagni di un viaggio a ritroso nel tempo, sulle tracce delle autentiche radici popolari garganiche. Quello che segue è il testo della canzone Foggia, dedicata dal cantautore alla città capoluogo della Daunia. Nella canzone si noterà un chiaro riferimento a Renzo Arbore, al quale Bennato si rivolge con la frase «tu che viene ’a Foggia e vuò fa o napulitano, tu nun ti si accorto e’ niente... » Foggia è chella musica che nasce int’ o paese e che more dint’e case addò se ferma o viento c’attraversa la campagna tutta spine e tutta rose addò se ferma o tiempo e addeventa tarantella addò nu santo dorme sott’e stelle Foggia è chella musica ca dura na jurnata e chi ’a sente è furtunato (Foggia è chello ca è passato e c’ancora adda venire) E tu pozza girare comme gira lu sole lu sole Verso Sud 104 e tu pozza sentire sentire o profumo ’e na rosa d’amore E’ na musica meridionale ca nun siente a la televisione è na rosa ca fa’ annammurare è a chitarra e’ Matteo Salvatore Tu che viene ’a Foggia e vuò fa o napulitano tu nun ti si accorto e’ niente e Napule se sape fa a furtuna ’e chi s’a venne e Foggia è sulamente terra antica e terra amara de rose e de canzoni mai sentute Tu che viene ’a Foggia e vuò fa o napulitano forse nun l’e cunusciute (Foggia è chello che è passato e ca ancora adda venire). [Tratto dall’album Angeli del Sud, EUGENIO BENNATO, 1995] D. Grittani PARTE IV San Severo 107 Pianura Umberto Fraccacreta Umberto Fraccacreta (San Severo 1892 - 1947). Apprezzato poeta, fine traduttore dal francese, Umberto Fraccacreta dedicò non molte liriche alla sua terra natale. Tra queste segnaliamo gli emozionanti versi di Pianura, che riportiamo in questa antologia. In questi versi v’è la trasparenza che abbaglia l’infinita mia pianura, la quale niuna forza mai misura se cuor non l’accompagna in sofferenza. Lieve ombra che non cangia la parvenza vi disegna la grama alberatura, mentre già ebre dalla gran caldura le cicale rinforzan la cadenza. Travaglio e sete il giorno, ma la notte variegata di lucciole e di stelle è l’oasi che affranca dalle lotte. E il pino solitario è l’incensiere che anela le boscaglie delle belle pendici, a cui s’inchina il Tavoliere. [Poesia tratta da Elevazione, UMBERTO FRACCACRETA, Cappelli, Bologna 1931] 109 I confini territoriali del “Monasterium Terrae Maioris” Antonio Casiglio Antonio Casiglio (San Severo 1921 - Foggia 1995). Tra i più rispettati scrittori degli anni Settanta, Nino Casiglio ha firmato con Il conservatore (Vallecchi 1972), Acqua e sale (Rusconi 1977, Premio Napoli nello stesso anno), La strada Francesca (Rusconi 1980) e La dama forestiera (Rusconi 1983) alcune tra le opere più brillanti dell’ultimo ventennio della narrativa italiana. Al punto che, un aneddoto piuttosto ricorrente, racconta di una cena consumatasi a Bologna nella metà degli anni Ottanta durante cui, interrogato sul più originale dei narratori italiani, Umberto Eco senza esitazioni avrebbe fatto il nome del sanseverese Casiglio. Tuttavia lo scrittore tendeva a non dimenticare mai le proprie origini di studioso e ricercatore, tant’è che si riteneva molto soddisfatto più che dei propri romanzi di una relazione-saggio che tenne in occasione di un convegno sulla storia di San Severo. In questa sede pubblichiamo integralmente l’intervento che personalmente Nino Casiglio consegnò al curatore di questa antologia, con la significativa dedica «questa pietra in saccoccia, per quando tirerà un po’ di vento». Nel suo recente, attentissimo studio su San Severo nel Medioevo Pasquale Corsi ha messo giustamente in evidenza la difficoltà di definire adeguatamente il confine del territorio di Terra Maggiore sul versante di Civitate. Il monastero possedeva beni in molti luoghi; ma la documentazione confinaria sul suo tenimento si riduce ai nn. 11 (a. 1152) e 21 (a. 1192) del Leccisotti. È vero altresì che una migliore conoscenza dei territori di Dragonara, Plantiliano, Fiorentino, Casale Novum, Bantia o Vanzo e San Giovanni in Piano ci consente oggi di escludere con maggiore o minore sicurezza alcune terre dall’ambito di Terra Maggiore e di trarre quindi alcune conferme negative. Indipendentemente da siffatto genere di conferme e dai dati ricavabili attraverso l’analisi dei toponimi presenti nella documentazione spicciola, 110 Verso Sud D. Grittani è opportuno riesaminare i due documenti fondamentali, dai quali mi sembra possibile trarre conclusioni in parte diverse da quelle già note. Ad evitare fastidiosi riscontri, è bene riportare qui almeno il dispositivo essenziale delle due confinazioni conservatesi. N. 11: … omnes terras universaque tenimenta, que sunt a vallone de Radicosa a loco ubi via Lucerina iungitur cum ipso vallone de Radicosa et sallendo per ipsam Radicosam ubi sunt ilices et sallit usque ad serram quae Ferratam se clamat, et descendit in rivum de Camerato, et dimisso rivo transit et vadit per limites collis Sancti Martini et per quandam cupam, quae est proxima ecclesie Sancti Nycolay de Viridamento, ad flumen Viridamenti in loco ubi monticellus stat super ripam ipsius fluminis subter ipsam ecclesiam Sancti Nycolay; quae terrae et tenimenta sunt in proprium et designatum territorium ipsius monasterii, ita ut quecumque terre vel tenimenta sunt infra predictos fines et terminos usque ad alia confinia dicti territorii Terre maioris, monasterium ipsum firmiter habeat et proprietario iure in perpetuum possideat. N. 21: De prima parte incipit a Radicosa et salit per illum vallonem unde stant illices et descendit usque ad serram et deinde vadit usque ad rivum Ferrandi. De secunda parte vadit per rivum Ferrandi usque ad finem eiusdem rivi Ferrandi. De tertia parte incipit a fine predicti rivi et vadit in cyrcuitu usque ad viam Lucerinam et sicut vadit via Lucerina et vadit usque Radicosa. De quarta parte incipit a via Lucerina ubi iungitur cum Radicosa et sallit a Radicosa ad vallonem ubi stant supradicte illices et vadit ad primum finem. Si sa che la seconda confinazione è in realtà la più antica, in quanto la conferma di Tancredi riporta un privilegio di Roberto il Guiscardo risalente al 1067, che a sua volta conferma un precetto del catapano Boiano. Ma una seconda e importante differenza tra il n. 11 e il n. 21 sta nel fatto che, mentre il n. 21 intende dare una completa anche se sommaria confinazione dell’intero tenimento, col n. 11 invece si intende restituire a Terra Maggiore una quota parte del tenimento, che era stata usurpata. Il conte Roberto, richiesto più volte (nella sua sede di Civitate) di assicurare la restituzione delle terre usurpate che si trovano ex illa parte Radicose et ex illa parte vici (intendo rivi come nella confinazione che segue) de Camerato, vale a dire, per l’osservatore posto a Civitate, rispettivamente sulla destra del Radicosa e sulla sinistra del canale del Frassino, che convoglia nello Staina le acque della contrada Cammerata, si porta nel monastero e riconosce gli antichi confini, in modo che Terra Maggiore eserciti pacificamente il suo diritto di proprietà infra predictos fines et terminos usque ad alia confinia dicti territorii Terre maioris. L’esigenza comporta quindi una confinazione più particolareggiata. Questa diversità, per così dire, di scala non va trascurata. Inoltre occorre correggere due errori del Leccisotti. Egli ha ritenuto, sulle orme del Barone, che il Viridamentum fosse il Fortore; ma sappiamo ora che è invece lo A. Casiglio I confini territoriali del “Monasterium Terrae Maioris” 111 Staina: il Martin ha opportunamente citato l’uso del toponimo “Guardamento” nella relativa carta tratturale della reintegra Capecelatro. È possibile aggiungere che il toponimo si ritrova nella carta Michele della locazione di Guardiola, per denominare due contrade contigue (Dragonara 421 e Cantigliano 424) nel corredo descrittivo dell’atlante Della Croce e ancora in alcune carte dell’Ottocento (Archivio di Stato di Foggia, Atti privati reg., F. 336, marzo 1843; Piante top., Atlante 17, n. 36). D’altronde il cartolario di Sculgola offre una conferma negativa di questo dato di per sé certo, distinguendo inequivocabilmente in numerosissimi luoghi il Fortore dal Viridamentum. Inoltre l’analisi topografica del cartolario, che ho in corso di pubblicazione, consente di constatare che il territorio di Dragonara si spingeva sulla destra dello Staina con Santa Maria in Aulicina, confinando col territorio di Plantiliano e probabilmente, a S. di Mezzana delle Ferole, con Terra Maggiore. In secondo luogo, il Leccisotti parla di “confine settentrionale” del tenimento. L’espressione è impropria, data la dislocazione di esso, di cui il n. 21 mostra di tener conto, facendo perno su due punti sicuri, il Radicosa e il Ferrante e descrivendo nella prima parte l’intero angolo nord-occidentale e nella quarta il tratto esclusivamente settentrionale, mentre il n. 11 unifica i due tratti e analizza particolareggiatamente il primo dei due, che è oggetto della contestazione. Ma soprattutto il Leccisotti ha ritenuto che il confine dal Radicosa si spingesse verso Civitate. A parte l’incongruità (a Civitate sarebbe rimasto ben poco), il confronto tra il n. 21 e il n. 11 e la lettura della confinazione del n. 11 sui fogli 155, II SO, e 155, III SE dell’I.G.M. portano a conclusioni diverse. La confinazione del n. 11 è in senso antiorario, prima da E verso O, poi, seguendo la conformazione del tenimento, da NO verso SE. Si parte dall’incrocio di una Via Lucerina col Radicosa. Questo punto, ancorché non accertabile con assoluta sicurezza, è presente anche nel n. 21 e costituisce la chiave della confinazione. Va quindi esaminato con particolare attenzione. A suo tempo il Fuiano ha ritenuto che si tratti di una via da Lesina a Lucera per San Severo. Di qui una conferma della posizione equivoca di San Severo e del suo territorio, solo in parte ricadente nel tenimento del monastero di San Pietro. Se tuttavia la strada del n. 21 è la stessa del n. 11, non sembra che possa trattarsi della Lesina-San Severo-Lucera, indipendentemente dalla validità in sé stessa dell’affermata importanza della così detta “via del pesce”. Proviamo infatti a rileggere la confinazione del n. 21 tenendo sotto gli occhi i fogli 155 (San Severo) e 163 (Lucera) allegati alla nota opera dell’Alvisi. In base al n. 21 il confine (secondo tratto) segue il Ferrante fino alla sua confluenza nel Triolo. Nel terzo tratto il confine, risalendo verso N attraverso E, parte da questa confluenza formando un arco (vadit in cyrcuitu) fino ad una Via Lucerina, che segue per un certo tratto fino al Radicosa. È difficile pensare che essa coincida con l’itinerario Lucera-Motta del Lupo-Ser- 112 Verso Sud D. Grittani pente (ad E di San Severo), giacché in tal caso includerebbe contrade come quella di Bantia o Vanzo, che sappiamo aver avuto vicenda feudale del tutto indipendente. Ma neppure l’itinerario Lucera-San Severo-Lesina può essere accettato facilmente. In questo caso, infatti, la Via Lucerina avrebbe raggiunto il Radicosa parecchio ad E di Torre della Gramigna, che sappiamo essere appartenuta a San Giovanni in Piano prima di una permuta che intorno al 1375 consentì ai Celestini di mettere radici in San Severo e portò Torre della Gramigna, almeno in parte (54 versure) e per vie finora sconosciute, tra i beni del monastero femminile sanseverese di San Lorenzo. Indipendentemente dalla natura giuridica dei possessi, non è facile accettare l’idea di una enclave di San Giovanni in Piano nel territorio dotale di San Pietro. E se la Via Lucerina doveva raggiungere il Radicosa ad O di Torre della Gramigna, occorre pensare ad una delle numerose vie che collegavano e collegano Lucera con la zona di Civitate, tagliando il Radicosa a N di Torremaggiore o a NO di San Severo. È difficile dire quale di esse fosse all’epoca maggiormente battuta e quindi meglio rispondente alla comprensibilità della confinazione quando i documenti furono redatti. Questo discorso non modifica quanto finora si è concordemente pensato, che cioè l’arco confinario dal Triolo risalisse verso N (probabilmente senza includere la contrada Motta del Lupo) fino alla contrada Vignali e, passando tra i tenimenti di Casale Novum (ad E) e Sant’Andrea (ad O), piegasse verso San Severo. Un problema particolare, che finora era sfuggito all’attenzione degli studiosi e che in questa sede non sono in grado di chiarire interamente, riguarda il territorio di Casalorda, a SE di Santa Giusta e a SO di Sant’Andrea. Esso, in base alla confinazione del n. 21, rientra nel territorio di Terra Maggiore, in quanto posto sulla sinistra del Ferrante. E in epoca moderna, nell’ambito del feudo dei principi di Sangro, rientra nel tenimento di Sant’Andrea. Ma non è nominato nelle conferme pontificie dei beni di Terra Maggiore e risulta feudo autonomo non solo nelle numerose menzioni dei Registri Angioini (cfr. i voll. 4°, 21°, 22°, 23°, 26°, 35°, ad vocem), ma anche, che è assai più, nel Catalogus Baronum (C 321). Occorre pensare che circostanze a noi ignote abbiano portato alla sua separazione successivamente al privilegio di Roberto il Guiscardo (1067) e anteriormente alla redazione ordinaria del Catalogus, senza che Terra Maggiore abbia avuto interesse a darne atto, secondo la tendenza a mantenere aperte e impregiudicate le questioni del genere. Con questa premessa, tentiamo ora la lettura della confinazione del n. 11. Dall’incrocio della via Lucerina il confine procede lungo il Radicosa verso O fino ad un vallone caratterizzato dalla presenza di lecci. In verità le querce erano diffuse ovunque, fino a tempi recentissimi, lungo i valloni torrentizi che nel Tavoliere settentrionale confluiscono tutti nel Candelaro. Nel caso particolare bisogna pensare ad uno A. Casiglio I confini territoriali del “Monasterium Terrae Maioris” 113 dei due valloncelli che danno vita al Radicosa, a quello per esempio che ora fa da confine tra i comuni di Torremaggiore e San Paolo. Di qui il confine sale alla serra Ferrata e discende al rivo de Camerato. Non voglio dire che l’attuale toponimo Ferrauto abbia a che fare con Ferrata; ma il confine attuale sfiora la coppa de Totra, che ben può essere quella che una volta era definita serra: un’altura accidentata, un piccolo massiccio che pendenze, vegetazione ed acque dovevano rendere disagevole. Di qui il confine scende ad un rivo che sembra non poter essere se non il canale del Frassino, che congloba appunto le acque provenienti dalla contrada Cammerata. Passato il canale, il confine segue il piede di un colle che sembra essere quello immediatamente ad E della contrada Mezzana delle Ferole. Di qui il confine raggiunge lo Staina (I.G.M., F. 155, III SE) per cupam, passando cioè per una gola, un avvallamento, là dove un monticello (quote 77 e 74) sovrasta la riva (quota 48), dalle parti e un po’ più in basso della chiesa di San Nicola de Viridamento, che dovremo porre poco più a S, sull’altura tra le masserie Pesacane e Creta Bianca. Rare volte accade di ritrovare, come in questo caso, tanta concordanza tra i dati documentari e i segni attuali. Occorre precisare che la chiesa di San Nicola de Viridamento nelle conferme di Alessandro III (a. 1168) e di Onorio III (a. 1216) è indicata come pertinente a Dragonara. Quest’angolo nord-occidentale del tenimento di Terra Maggiore sarebbe dunque confinante col territorio di Dragonara. Ma bisogna anche tener presente a) che la chiesa di San Nicola de Viridamento non è mai citata nel cartolario di Sculgola; b) che la secca citazione di un colle Sancti Nicolai in Martin, n. 70 (p. 126), non autorizza l’identificazione; c) che una chiesa intitolata a San Nicola esisteva nell’abitato di Dragonara e che ad essa sembrano riferirsi le svariate citazioni di terre “di San Nicola” in diverse contrade del territorio di Dragonara (Navaratorio, Oguale, San Biagio, Querceto), che comunque non hanno a che fare con la zona di cui qui ci occupiamo; d) che infine solo un rapido accenno in Martin, n. 11 (p. 22), ad un fons Salzule contiguo a terre Sancti Nicolai consentirebbe un ipotetico riferimento a San Nicola de Viridamento, in base alla sussistenza del toponimo “Salsoletta” a N della contrada Voiragni ed a NE del passo e ponte del Porco. Pertanto il problema del confine tra Terra Maggiore e Dragonara non si può ancora considerare risolto. Riepilogo qui brevemente le conclusioni: 1) Mentre il n. 21 del Leccisotti dà una confinazione generale del territorio, il n. 11, con cui si intende restituire terre usurpate nell’angolo nord-occidentale, contiene dati parziali ma più particolareggiati. Esiste dunque tra i due documenti una differenza di scala. 2) Occorre correggere due errori del Leccisotti. Egli riteneva che il Viridamentum 114 Verso Sud D. Grittani fosse il Fortore; sappiamo invece che è lo Staina. Inoltre egli parla inesattamente di un tratto “settentrionale” del territorio, descritto più genericamente dal n. 21 e più particolareggiatamente dal n. 11. In realtà il n. 21 descrive nel primo tratto l’angolo nordoccidentale e solo nel quarto tratto la parte confinaria esclusivamente settentrionale, mentre il n. 11 si occupa specificatamente dell’angolo nordoccidentale. 3) Entrambe le confinazioni nominano una via Lucerina. Si è pensato, dal Fuiano, che si tratti di una via da Lucera a Lesina. Ma essa non può essere né quella che saliva da Lucera per Motta del Lupo e Serpente, perché in tal caso avrebbe incluso una parte del territorio di Vanzo o Bantia, di cui conosciamo la vicenda feudale estranea a Terra Maggiore, né la Lucera-San Severo-Lesina, perché passa ad E di Torre della Gramigna, che sappiamo essere appartenuta a San Giovanni in Piano anteriormente ad uno scambio avvenuto nella seconda metà del XIV secolo. Tenendo conto anche della prospettiva in cui i documenti sono stati redatti, occorre pensare ad una delle parecchie strade che da Civitate scendevano e scendono verso Lucera, oltrepassando il Radicosa a N di Torremaggiore o a NO di San Severo. 4) Sui fogli 155, II SO e III SE dell’I.G.M è possibile riconoscere con insolita chiarezza il tratto confinario descritto dal n. 11: partendo da E verso O, da uno dei valloncelli da cui nasce il Radicosa all’attuale coppa de Totra, poi al canale del Frassino che raccoglie le acque della contrada Cammerata, poi lungo il piede di un colle (ad E della contrada Mezzana delle Ferole), poi allo Staina, passando per cupam (un avvallamento in ombra nettamente riconoscibile nella fotografia aerea), là dove un monticello (quote 77 e 74) sovrasta la riva (quota 48). A questo punto desidero aggiungere alcune considerazioni, problematiche e non conclusive, sul rapporto tra Terra Maggiore e l’insediamento di San Severo, riferendomi ai termini della questione, quali sono stati riesaminati da Pasquale Corsi, con la completezza che gli è solita, nel recente studio sopra citato. Metterei il problema in questi termini: ammesso che lo sviluppo dell’insediamento nel corso del XII secolo resta indissolubilmente legato ad iniziative del monastero di Terra Maggiore, la nascita dell’insediamento è conseguenza di un’iniziativa istituzionale del monastero o, viceversa, l’iniziativa è essa stessa una conseguenza di insediamenti di altra origine, che il monastero ha orientato e guidato? Spiegare il celebre documento del 1141 (in nostra… curia apud Sanctum Severum; actum in Castello Sancti Severini) come l’espressione di una fase di indistinzione tra i due toponimi mi sembra un’ipotesi non meno delle altre bisognosa di dimostrazione. Lo stesso Corsi e il Fuiano hanno messo in giusta luce il documento tremitense del 1059 contenente la donazione di due chiese, di San Severino e di Santa Lucia, da parte dei due Bocco, padre e figlio, abitanti di Civitate, mediante atto rogato a San Giovanni in Piano. Nel mio breve studio sul casale Sancte Lucie apparso nel 1984, A. Casiglio I confini territoriali del “Monasterium Terrae Maioris” 115 ho mostrato come il magnum tenimentum sia da porsi per necessità nell’immediata periferia orientale di San Severo, tra le porte di Foggia e di San Nicola. Il documento tremitense avrebbe così un duplice riferimento alla situazione insediativa sanseverese. Aggiungo che solo da qualche anno si comincia da noi a dedicare concreta attenzione al fenomeno delle chiese private, al così detto Eigenkirchenrecht, di cui trovo per ora che si sono interessati il Martin e il Vitolo. E nell’XI secolo il fenomeno doveva essere rilevante, così come stretto doveva essere il nesso tra vita religiosa e vita economica là dove l’estensione di un tenimento richiedeva la presenza in loco della mano d’opera. Un altro punto da tener presente è la velocità del mutamento sociale. Il ritmo degli eventi non è costante e tra l’inizio dell’XI secolo e l’inizio del XII il passaggio dai Bizantini al Ducato Normanno e poi al Regno comportò mutamenti accelerati, così come nel corso del XII secolo la messa a cultura di terre in presenza di una scarsa densità di popolazione fu un fenomeno inusuale e destinato ben presto ad esaurirsi. La disputa fra i cleri di San Nicola e di Santa Maria per il possesso del vicino tenimento di Santa Lucia sembrerebbe adattarsi meglio all’idea di mutamenti piuttosto rapidi nei rapporti di proprietà che non all’altra, della veloce crescita quantitativa di un casale inizialmente molto piccolo. E ancora: se il monastero di San Pietro diede prova di capacità promozionale, la diede solo a San Severo e non nella più vicina Torremaggiore, che ebbe una formazione assai più lenta e tortuosa. Ed è strano che si sia preoccupato solo di questa sorta di fiore all’occhiello. Per questo lo schema, da cui del resto anche Corsi è ben lontano, del Castrum nato e cresciuto come una zucca mi riesce poco persuasivo. Né l’incastellamento va inteso necessariamente come costruzione di un luogo forte; può essere anche l’istituzione di un sistema di norme attive e passive in un ambito spaziale definito, il che non mancherebbe nel caso di San Severo. Non dunque un nucleo precocemente arricchitosi di sobborghi; bensì l’istituzione di un luogo preferenziale che con la sua regolamentazione contribuisce a cementare un insediamento più rado e casuale. Se qualcosa di simile è accaduto a San Severo tra l’XI e il XII secolo, sarebbe agevole spiegare la posizione relativamente debole del monastero ai tempi di Federico II, che disponeva certamente della forza, ma era in grado anche di utilizzare strumenti giuridici sofisticati là dove le circostanze lo consentissero. E perfino il tardivo statuto aragonese basato sulle tre parrocchie di Santa Maria, San Nicola e San Giovanni potrebbe far pensare non solo, come fa il Corsi, ad una temporanea rarefazione di anime, ma anche a perplessità nella posizione giuridica di quella che restava la primitiva struttura organizzativa della baronia monastica, ormai ridotta in commenda. Aggiungo che anche la pianta della parrocchia di San Severino – ferma restando 116 Verso Sud D. Grittani la scarsa leggibilità complessiva del centro storico per l’inserimento di ampie dimore signorili in epoca relativamente tarda e posteriore al terremoto del 1627 – presenta in via Lucchino (quale continuazione di via Imbriani) e in vico Granata segni interpretabili come tracce di una primitiva recinzione che escludeva le altre tre parrocchie. Risulta evidente in ogni caso che sul confine orientale il tenimento di San Pietro era lontano dal coincidere non solo con l’attuale territorio comunale di San Severo, ma anche col suo demanio, quale risultava nel 1577, all’atto del secondo definitivo infeudamento ai principi di Sangro, e con zone come quella di Santa Lucia, su cui non pare che San Pietro potesse vantare un diretto dominio. Posta sul confine del tenimento di San Pietro, la città sembra aver mantenuto a lungo storicamente i segni di un’origine anomala. [Estratto dagli Atti del 12° Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia, ANTONIO CASIGLIO, San Severo 14-16 dicembre 1990; Atti, Tomo I, Tipografia Dotoli, San Severo 1991] 117 San Severo Andrea Pazienza Andrea Pazienza (San Benedetto del Tronto 1956 - Bologna 1988). L’eclettico e geniale disegnatore che ha rivoluzionato il fumetto italiano ha vissuto molti anni della sua vita a San Severo, città a cui era legato da un conflittuale rapporto di amore e odio e dove, tutt’ora, riposano le sue spoglie. Esiste una ferocia razziale inaudita nei confronti dei meridionali; il meridionale è accettato solo in due casi: o quando è perfettamente integrato e risponde nel gesto e nel comportamento a una serie di proposizioni non meridionali che non gli appartengono; oppure quando ha un enorme carisma e riesce a imporre con fatica e con intelligenza e comunque in modo improbo (perché dovrebbe?) la propria meridionalità, sia che si tratti di autori sia che si tratti di semplici macchine targate con sigle meridionali. La mia meridionalità è una meridionalità alla Mohammed Alí, in termini di difesa da quello che è uno sfruttamento da una serie di cose che io condanno enormemente. San Severo è una città orrida da un punto di vista di situazione politico-gestionaleamministrativa. Il potere ha questa gamma: ci sono dei ricchissimi, c’è il Country club, lo Sporting club, il Lions club, il Rotary club, c’è gente che gira con delle macchine incredibili e si va a comprare le scarpe a Bologna, c’è tutto un mondo di medici che si sono arricchiti restando nell’ombra senza aver mai scritto su una rivista medica; che hanno partecipato solo a congressi tennistici, perché si giocavano tutte le loro carte a livello tribù di medici. Vedi il torneo nazionale medici ospedalieri di Chiavari... Poi ci sono avvocati soprattutto notai che hanno guadagnato sulla povera gente, sul reddito della popolazione, tantissimi, poi c’è un sacco di droga accompagnata alla noia più totale e c’è un centro autogestito per tossicomani... Poi c’è una campagna meravigliosa, della gente bellissima: la gente che lavora nelle campagne. Io di San Severo ho dei ricordi che son fatti di sberleffi, 118 Verso Sud D. Grittani litigavo con dei monelli tremendi e mio fratello, che si chiama Michele detto Macaluso, che si buttava come un tornado nella mischia, lui aveva dodici anni, io quindici, e seminava il panico fra i miei assalitori. Poi ho passato un periodo tra i sedici e i diciotto anni a rissare stupidamente, prendendole e dandole, specialmente d’estate. A San Severo, si era venuto a creare per caso un piccolo nucleo di artisti, ognuno con una propria fede e una propria direzione. A questo proposito devo fare due nomi: Marcello D’Angelo che si è saputo conquistare il nostro affetto e la nostra amicizia con grande amore e poi Enrico Fraccacreta che da ragazzo aveva un umorismo dal quale tutti noi abbiamo attinto, non so, però, che fine abbia fatto la sua creatività. Erano estati bellissime, lunghissime, passate con la fila degli ombrellini, l’altalena sul mare, piogge di romani e milanesi in fila con i juke-box. [Tratto da Paz, ANDREA PAZIENZA, scritti, disegni, fumetti a cura di Vincenzo Mollica, Einaudi Stile Libero, Torino 1997] PARTE V Lucera 121 Lucera, colonia saracena degli Hohenstaufen Ferdinand Gregorovius Ferdinand Gregorovius (1821 - 1891). Storico tedesco, viaggiatore coltissimo, dotato di un invidiabile senso estetico, Gregorovius ha scritto sulla Capitanata pagine dalla cui fedeltà storica e pertinenza non si può prescindere. Le sue descrizioni rappresentano tutt’oggi un punto fermo per chiunque intende avventurarsi in una qualsiasi ricerca letteraria che riguardi la Daunia. Il testo qui riportato fa parte di un ampio saggio intitolato Nelle Puglie (Edizioni Barbera, 1882). Da un pezzo io nutrivo il desiderio di visitare nelle Puglie Lucera, Manfredonia e il Gargano, il Promontorio sull’Adriatico, il vero Hagion Oros dell’Occidente, il monte celebre pel suo pellegrinaggio. Solo nella primavera del 1874 potei appagare il desiderio mio. Miei compagni, nelle escursioni attraverso il bel paese della Puglia, furono mio fratello e Raffaele Mariano, col quale, venendo egli da Roma, ci eravamo data la posta a Caserta, ed ivi infatti c’incontrammo. A parecchi Tedeschi il nome di questo giovane di molto ingegno non dev’essere sconosciuto. Egli è uno de’ più caldi ammiratori della Germania e della sua cultura; e, come tale, ha fatto spesso sentire la voce sua. I migliori articoli nel Diritto, nel ragguardevole giornale che a viso aperto confessa le simpatie germaniche e sostiene l’alleanza dell’Italia con l’Alemagna, si devono alla penna di lui, o a quella del suo sagace amico Maraini, proprietario del giornale. Mariano è discepolo del Vera, il capo e fondatore della scuola egheliana a Napoli. Egli ha dato fuori una serie di scritti e di saggi, qualcuno anche in francese, fra i quali mi piace menzionare soprattutto un esame critico della filosofia italiana contemporanea, da lui dedicato al mio venerato maestro Carlo Rosen Franz. Il Vera stesso, che io sappia, non è stato per anco in Germania riconosciuto in modo condegno ai suoi meriti. Eppure la scuola di egheliani, fondata da lui, è già uno de’ fattori della cultura odierna dell’Italia. 122 Verso Sud D. Grittani Tutto quanto in opposizione al pensiero teologico-scolastico fosse atto a risollevare le energie della coscienza, l’attività libera e interiore dello spirito; tutto quanto potesse spianare, aprire la via alle idee riformatrici germaniche e redimere, rigenerare moralmente il paese, immerso in un pieno indifferentismo religioso; tutto ciò ha in gran parte i suoi seguaci, i suoi propugnatori nella scuola del Vera. Appunto nel mio viaggio ebbi ad imbattermi in discepoli di lui che ne parlavano con entusiasmo. Il che vuol dire che sulle coste dell’Adriatico, a Barletta e a Trani, m’incontrai in pari tempo negli amici più appassionati della Germania. Il 15 maggio muovemmo per Foggia, passando per Benevento: magnifico viaggio, attraverso i bacini del Volturno e del Calore. Ad ogni passo le storiche figure degli Hohenstaufen, nel momento supremo e drammatico del loro scomparire dalla scena del mondo, si presentavano vive alla fantasia. Qui, a Telese specialmente, Carlo d’Angiò alla testa del suo esercito in marcia; più in là il campo di battaglia presso Benevento. Nell’avvicinarci a Foggia, dopo esserci lasciate alle spalle le regioni montuose, vedevamo dispiegarcisi via via dinanzi il Tavoliere di Puglia, il grande agone da tempo immemorabile de’ pastori e delle greggi d’Italia. Esso si stende sino all’Adriatico; il mare però non è per anco visibile, lontano com’è da Foggia parecchie miglia e nascosto da una elevazione del suolo. Per ore intere l’occhio è intento a riguardare una lunga distesa di montagne di un bel celeste azzurro, che qual gigantesca muraglia rocciosa si protende in direzione di ovest ad est. È il Gargano, dove noi presto rivolgeremo i passi, come ad una delle mete delle nostre peregrinazioni. Ad occidente la pianura pugliese è cinta da poggi e colline, disposte in forma di emiciclo, estremi contrafforti che manda giù l’alta giogaia dell’Appennino. Essi separano i bacini del Candelaro e del Cervaro da quello del Fortore, che scorre a settentrione. Qui e là sulle alture spiccano castelli e città parecchie. Due soprattutto ne osservammo di lontano con la più viva curiosità: Troia e Lucera, l’una monumento della dominazione bizantina nelle Puglie, l’altra la famosa colonia saracena degli Hohenstaufen. Foggia è posta nel mezzo appunto del Tavoliere, su di un terreno affatto piano. È il capoluogo della Capitanata, e sino nel medio evo una delle più ragguardevoli città della Puglia. L’importanza sua la deve all’imperatore Federico II. In questa regione Foggia era la residenza da lui preferita. Non le bellezze naturali, ma la positura geografica gliela rendevano assai rilevante. Evidentemente, i pressi di Foggia potrebbero senza grande sforzo essere ridotti nel più bel giardino che sia mai stato. Ed è vero pure che tutto all’intorno le si dispiega un ampio e splendido orizzonte. Se non che, la città giace sulla pianura del Tavoliere, ove quasi non vedi albero né filo F. Gregorovius Lucera, colonia saracena degli Hohenstaufen 123 d’acqua; onde gli ardori del sole estivo vi devono, dal maggio all’ottobre, essere addirittura insopportabili. Bastano pochi passi, e tu ti trovi qui in un vero deserto, coperto di pascoli e popolato d’armenti. E bisogna correre ore ed ore, prima di arrivare al golfo di Siponto o Manfredonia, o di aver raggiunto le ubertose campagne di Cerignola, di Canosa e di Barletta. Nulladimeno, già al tempo degli Hohenstaufen, Foggia era un punto centrale, ove venivano ad intrecciarsi le grandi strade, che menano ad Ancona, Napoli e Roma da un lato, e dall’altro a Bari e a Brindisi. Ed oggi essa è rimasta ancora tale, il centro, cioè, di parecchie strade ferrate. Similmente, questa sua giacitura fa della città un emporio pel commercio e per gli scambi dell’Italia Meridionale; epperò essa fiorisce e vien su con rapido moto, ed è destinata ad un avvenire di più in più considerevole. Appunto ne’ giorni in che noi vi fummo, la città era in gran movimento. Doveva aver luogo una esposizione industriale ed agraria, ed era stato all’uopo costrutto un enorme baraccone. L’inaugurazione doveva essere onorata della presenza del principe ereditario, Umberto. Sembra che di Foggia si voglia fare un centro agricolo per le province meridionali. I prodotti naturali convergono qui, sul mercato, in grande copia da tutta la provincia; ed il ceto de’ mercatanti vi abbonda. Oggidì Foggia conta già 30.000 abitanti. È una grande città, bene edificata, con strade e piazze dall’apparenza tutta moderna, e sempre animate da gran calca di gente. Meno alcune chiese, fra le quali primeggia il Duomo, Santa Maria, notevote edifizio del XIII secolo, tutto il medio evo vi è scomparso. Del grande palazzo, residenza di Federico II, non rimane che un meschino avanzo, incastrato nella facciata di una casa privata: un arco in stile romano. Nel punto di congiunzione de’ pilastri si veggono due aquile imperiali in pietra. L’iscrizione, ben conservata su di una tavola di marmo, ricorda che Federico II fece edificare il palazzo nell’anno 1223: Hoc Fieri Jussit Fredericus Cesar Ut Urbs Sit Fogia Regalis Sedes Inclita Imperialis. L’architetto si chiamava Bartolomeo, come è detto in un’altra epigra: Sic CesarFieri Jussit Opas Istum Proto Bartholomeus Sic Construxit Illud. Una terza iscrizione suona così: A. Ab Incarnatione MCCXXIII. M. Junii XI. Ind. R. Dno. N. Frederico Imperatore R. Sep. Aug. A. III. Et Rege Sicilie A. XXVI. Hoc Opas Feliciter Inceptum Est Prephato Dno. Precipiente. Innanzi a quest’ultimo avanzo del palazzo imperiale, ove, tutto assorto nella sua idea di dominare sull’occidente e sull’oriente, consigliandosi col suo fido cancelliere Pier delle Vigne, e divisando i piani e i mezzi di condurre innanzi la sua lotta strepitosa con i Guelfi d’Italia e col Papato romano, il più geniale degli Hohenstaufen fece sì sovente dimora, nessun Tedesco può fermarsi senza sentirsi addentro commosso. In codesto palazzo morì, nel 1241, la moglie dell’Imperatore, Isabella d’Inghilterra. Essa fu sepolta non a Foggia, ma nella cripta del duomo di Andria, ove era 124 Verso Sud D. Grittani pure già stata deposta la prima moglie di Federico, Jolanta di Gerusalemme. Per quanto glielo consentivano le circostanze, specie le guerre insistenti che senza posa lo costringevano a correre innanzi e indietro dalle Alpi alla Sicilia, e a dover sempre lasciar daccapo il suo prediletto paradiso delle Puglie, il grande Imperatore abitò volentieri nel palazzo di Foggia. Il suo primo rescritto, emanato da questa città, è del febbraio 1221. Più tardi, nel 1225, quando il castello era stato terminato tutto, vi passò i mesi di maggio e giugno. Dal 1228 in poi, vi sono solo pochi anni ne’ quali l’avervi egli dimorato non appaia con certezza da documenti. Da Foggia egli poteva agevolmente visitare le altre sue residenze e i suoi castelli di caccia e di delizie nelle Puglie, in Andria, per esempio, e il magnifico Castel del Monte, ovvero, dall’altro lato di Foggia, Castel Fiorentino e Lucera. Oltre lo svago della caccia, furono, senza dubbio, queste condizioni di luogo eccezionalmente favorevoli che indussero anche i successori di Federico a fare, come lui, di Foggia una lor residenza. Manfredi, il quale tolse la città al Papa, e poi più tardi il vincitore suo Carlo d’Angiò soggiornarono spesso a Foggia. Carlo I si fece edificare ne’ pressi, in pantano, un castello di caccia. Nella Cattedrale di Foggia vennero celebrate le nozze tra la figlia di lui, Beatrice, e Filippo, figlio dell’imperatore di Costantinopoli Balduino. Ed egli stesso, Carlo, morì in Foggia appunto. Noi prendemmo a nolo una carrozza, la quale doveva portarci prima a Lucera, e poi, passando di nuovo per Foggia sul golfo di Manfredonia. Lucera è alla distanza di due ore da Foggia. Vi si va per un’ottima strada che corre diritta, quasi freccia, dall’una all’altra città e sempre attraverso la estesa pianura, sino al punto in che questa, leggermente elevandosi, va formando una cinta di poggi. Via facendo, passammo innanzi a ville e fattorie, ma rare e sparse in mezzo ad un paesaggio languido e morto, la cui ampia distesa però è in lontananza circoscritta da superbe montagne, mentre a manca sulle verdeggianti alture si mostra la bizantina Troia. Incontrammo un drappello di carabinieri che servivano di scorta ad un trasporto di malfattori, i quali dalla Corte d’Assise di Lucera avevano già sentito pronunziarsi la condanna. Oltre di questo, nulla: la strada era totalmente deserta: dopo un’ora di cammino comincia lievemente a salire. Lucera stessa è posta su di una eminenza. Simile a promontorio, questa s’inalza sul piano, per poi ricadervi in alcuni punti ripidamente. La catena di colli, che chiude qui e domina il Tavoliere di Puglia, esigeva per le sue condizioni naturali che vi si mettesse una città fortificata. Nacque così in antico la sannitica Lucera Apulorum. Caduto l’Impero Romano, il paese fu in principio goto; poscia divenne un vero pomo della discordia tra Bizantini e Longobardi. Ai Duchi longobardi di Benevento lo tolsero i Normanni. Finalmente Federico II fece della città il più forte baluardo del suo regno. F. Gregorovius Lucera, colonia saracena degli Hohenstaufen 125 Essa ora ci si presenta dinanzi come una città di qualche considerazione, abitata da 15.000 anime all’incirca, assisa sulla collina verde di pampani e di piante fruttifere, con avanzi qua e là delle antiche mura, con alcune torri del tempo feudale, con una piccola cupola da’ colori variopinti e luccicanti, i quali a noi, che sapevamo i Saraceni di Sicilia aver quivi abitato non meno di ottanta anni, ci dettero l’impressione di un non so che di arabo. Avremmo dovuto entrare per la porta di Foggia e battere la strada principale della città; ma la si lastricava appunto a nuovo; dovemmo quindi fare il giro delle mura, ed entrammo per la porta di Troia. Qui parve quasi ci muovesse incontro quella serena quiete, tutta propria in Italia alle città storiche di provincia, il cui fascino meraviglioso e attraente non ha l’uguale nel mondo. L’aria calda e soleggiata è pregna e mossa tutta dall’alito del passato. Tempi e culture, scomparse da secoli, mandano da’ loro monumenti una elettrica potenza: è il magnetismo della storia. Qui nulla di nebbioso, nulla di romantico, come nel settentrione. Ogni avvenimento si disegna innanzi alla fantasia netto, limpido, tranquillo, come le linee cilestri e il porporino delle montagne laggiù, nel lontano orizzonte. Lucera, formata di strade e piazze d’ordinario anguste e piccole, è costruita come la più parte delle città italiane medievali; ed anche, come queste, quasi tutta imbiancata. L’Italiano del Mezzogiorno è diverso in ciò dal Latino. Egli non ama vedere le case dello scuro color naturale della pietra. Le imbianca invece, e non bada né molto né poco alla riflessione solare che abbaglia. Così intanto, sotto l’imbiancatura, antichi edifizii perdono ogni carattere: gli è come se si coprisse con tela mobili eleganti. Questa deplorevole manía di dar di bianco a palazzi per vetustà rispettabili s’è oramai fatta generale in Italia: sciocca esagerazione della tendenza, che di presente domina, a voler tutto rimettere a nuovo. In Bari, per esempio, l’antico e pittoresco palazzo del Gran Giudice Roberto, della famiglia un tempo potente de’ Chyurlia, di colui che fu il carnefice giuridico di Corradino, lo trovai tutto pulito di calce e, come può immaginarsi, spogliato totalmente di ogni effetto architettonico. Sciaguratamente, codesta febbre dell’imbiancare si è dall’anno 1871 inoculata anche in Roma, dove già ad alcuni vecchi palazzi è stata tolta via la loro vernice storica. Non manca che di vedere affidato all’imbianchino il Colosseo e Castel Sant’Angelo: allora la vecchia Roma vorrà parer bella davvero e nuova di pianta! Del resto, quanto a Lucera, non si creda che essa faccia impressione peculiarmente insolita o antica. Pur troppo, anche in essa lo stile e il gusto moderni la fanno da un pezzo da padroni. Le chiese però e i chiostri e le maravigliose rovine del castello stanno lì, con la loro impronta di originalità, a rendere ancora testimonianza de’ tempi andati. La famosa fortezza de’ Saraceni trovasi a un quarto d’ora dalla città. A guardarne 126 Verso Sud D. Grittani le alte e lunghe mura di uno scuro cupo, e le torri che ancora in parte si tengono in piedi, l’impressione che se ne riceve è grandiosa. S’aggiunga, che il castello s’erge in mezzo ad una maestosa solitudine, sulla cima di un’altura brulla, i cui fianchi, coperti di erba o nudi e incrostati di pietra gialla, scendono giù in linee lunghe, ovvero scoscesi e ripidi. Allorché le venti torri, ond’era munito, e tutta la cinta della sue mura erano intatte, dev’essere stato una fortezza di prim’ordine. Ed era infatti la chiave delle Puglie e, così al tempo di Federico II, come a quello di Manfredi e di Corradino, il vero punto d’appoggio della dominazione degli Hohenstaufen nell’Italia Meridionale. Vediamone la costruzione. Una muraglia in mattoni e pietra cinge intorno e chiude la superficie della collina. Addossate alla muraglia si elevano quindici torri ad angoli retti, equidistanti l’una dall’altra. Questa era la cittadella, il quartiere arabo fortificato. Dal lato poi verso la città, si congiungeva ad essa, occupandone un angolo, la parte veramente essenziale della fortezza, il castello o palazzo dell’Imperatore, da lui abitato allorché era a Lucera. Quivi aveva pure sua dimora il castellano saraceno. Questo palazzo imperiale formava un quadrato perfetto. Stava di faccia alla città. Un fosso con ponte levatoio ne proteggeva l’ingresso. Era pure munito di parecchie torri, delle quali due rotonde; e di queste una, un vero colosso, è pressoché perfettamente conservata. La porta guardava la città, mentre dagli altri lati la collina forma un dirupo inaccessibile. Oggidì il superbo edifizio mostra solo le sue grosse mura di cinta. Delle camere nel palazzo dell’Imperatore sono appena riconoscibili le vestigia di una delle grandi sale. Qui e là si veggono avanzi di scale e di stanze rovinate. All’interno, del resto, tutto è vuoto e deserto: il grande edifizio è ridotto oramai a ricovero di capre e di pecore. La fortezza fu edificata da Federico II nel 1233, dappoiché ebbe represso il disperato sollevamento de’ Saraceni in Sicilia. Dove fosse anch’egli stato un fanatico come Ferdinando il Cattolico o Filippo di Spagna, avrebbe rimandato i Maomettani in Africa, ovvero, a maggior gloria di Dio, li avrebbe tutti fino ad uno fatti sgozzare. Invece egli trapiantò i prodi, operosi ed abili figliuoli dell’Oriente sul continente, in Puglia. Il loro trasmigrare ebbe luogo a più riprese. L’imperatore assegnò ai Saraceni per dimora alcune città, come Lucera, Girofalco, Acerenza. Un desiderio intenso per l’amato luogo natío, donde erano stati con la forza strappati, li spingeva a fuggire di nascosto in Sicilia. Allora Federico, per ovviare a codeste fughe, pensò unire insieme tutti i Maomettani in un luogo solo, a Lucera. Ciò accadde nell’anno 1239. Ancora nel 1245 vennero colà trasportati dalla Sicilia gli ultimi Saraceni. Così nac- F. Gregorovius Lucera, colonia saracena degli Hohenstaufen 127 que la colonia Lucera Saracenorum. Solo per errore il nome di Lucera fu scambiato con l’altro di Nucera, nel quale ultimo luogo non furono mai Saraceni. Questi stranieri in Puglia si trovarono su di una terra che uomini della stessa razza loro avevano calpestata e in parte anche dominata già, secoli innanzi, allorché a Bari sedeva un Sultano arabo, e tutto il paese del Gargano era in possesso di Saraceni. Essi presero adunque a Lucera dimora fissa e stabile, in sul principio di mala voglia e pieni di odio verso l’Imperatore, che non sapevano considerare altrimenti che qual tiranno e quale usurpatore del legittimo possesso degli antenati loro, della bella Sicilia; poscia, da veri orientali, rassegnandosi al fato; in fine con sincero amore e fedeltà pel loro Sultano, il grande Imperatore, l’accanito avversario del Papa, l’amico spregiudicato e illuminato dell’Oriente e de’ suoi colti dominatori. Così Lucera divenne la tomba degli Arabi di Sicilia, la cui storia toccò quivi al termine suo. Nel tempo in che i Saraceni vi furono trasferiti, la vecchia città giaceva nel più profondo scadimento, tuttoché un vescovo vi tenesse ancora presso la cattedrale la sua residenza. Il numero degli abitanti cristiani non poteva esservi che assai scarso, e quindi impotente rispetto ai pagani nuovi venuti. Nulladimeno, Federico separò da prima le due comunità, diverse per razza e per fede. Accanto alla vecchia, gettò le fondamenta della nuova Lucera, ch’è appunto il quartiere fortificato, alla cui edifıcazione gli avanzi dell’antichità, allora esistenti ancora in gran copia, fornirono i materiali. Michele Amari, lo storico de’ Saraceni di Sicilia, è dell’opinione che gl’ingegneri, che costruirono la fortezza, fossero, senza dubbio, arabi. Di ciò per altro mancano le prove; ed è d’altronde poco verosimile, avendo Federico II a sua disposizione numerosi architetti indigeni. Nel recinto della cittadella noi possiamo raffigurarci la piazza d’arme e le caserme de’ guerrieri saraceni, gli arsenali e le fabbriche di ogni natura ed anche le moschee. Più tardi si saranno via via andate estendendo anche di fuori, quasi sobborghi, le abitazioni del popolo arabo. La colonia, amministrata e retta dal Kadì di Lucera, era numerosa, ancoraché il numero di 60.000 anime, che notizie del tempo registrano, sia da tenere per esagerato. Protetta dall’Imperatore, essa salì tanto in fiore che divenne un centro di attività industriale di qualche considerazione. Gli Arabi avevano infatti portato seco dalla patria, dalla Sicilia, gli elementi e le nozioni di ricche industrie; e così si videro sorgere a Lucera fabbriche di armi e telai ed officine di eccellenti lavori in legno. L’Imperatore vi pose una cultura di razze arabe, e vi faceva pure allevare cammelli. Egli vi teneva altresì serragli di bestie feroci, importate dall’Africa; e i leopardi specialmente venivano addestrati alla caccia. Senza dubbio, il palazzo di Federico 128 Verso Sud D. Grittani era messo con lusso orientale; affinché le forme della corte imperiale nelle Puglie continuassero ad essere saracene, come lo erano state quelle de’ re normanni a Palermo. Oggi ancora si pretende mostrare ove fosse a Lucera il posto dell’Harem imperiale, assai ben provvisto e custodito da enunuchi. Egli cercava abbellire la sua colonia in ogni possibile modo. Pare non la dimenticasse neppure nelle sue lontane imprese guerresche. Allorché nel 1243 assediava Roma da’ monti Albani, portò via due figure antiche di bronzo per collocarle a Lucera. Ed anche da Napoli vi fece trasportare statue. Spesso l’Imperatore sarà venuto da Foggia a Lucera per osservare i progressi della colonia ed intrattenersi nello splendido castello, ov’egli teneva anche in serbo il suo tesoro. Da’ suoi Regesti, pubblicati da Huillard-Brébolles, appare, veramente, ch’egli passasse a Lucera solo l’aprile del 1231, l’aprile del 1240 e il novembre del 1246; ma tanto più numerose sono le date della residenza da lui fatta nella vicina Foggia. Come può immaginarsi, la fondazione di una colonia saracena nel bel mezzo della Puglia era pel Papa una spina negli occhi. Ne’ secoli andati, solo a costo di grandissimi sforzi, la Chiesa di Roma e gl’imperatori di Germania avevan potuto riuscire a mettere un termine alle incursioni degli Arabi in Italia e a distruggere i loro fortilizi nella Campania. Ed ora era appunto l’Imperatore medesimo che insediava codesti infedeli nel cuore d’Italia per servirsene contro la Chiesa ovvero il Papa. E di qui, dal fatto di Lucera, i suoi avversarii accaniti pigliavano soprattutto motivo per scaraventare addosso al grande Imperatore tutte le colpe, tutte le accuse, trattandolo da empio pagano e nemico di Cristo. Il Papa levò presso il mondo intero i suoi clamori contro Federico, come colui, che con animo deliberato abbatteva la religione cristiana e trapiantava il paganesimo in un’antica città vescovile d’Italia. Sembra infatti che gli Arabi si permettessero parecchi atti di violenza contro la popolazione cristiana di Lucera e delle campagne circostanti. Essi giunsero insino, almeno così venne riferito a Roma, a devastare la cattedrale del luogo; anzi dovettero finire addirittura per impadronirsi di tutta Lucera, tanto che la comunità de’ cristiani vi venne quasi interamente meno. Giammai monarca non ebbe sudditi più grati né più fedeli. Per Federico II i Saraceni di Lucera erano i suoi pretoriani, i suoi zuavi, i suoi turcos. La loro cavalleria leggiera, che combatteva con lance e dardi avvelenati, era il solo nucleo permanente dell’esercito imperiale. La loro grande caserma era l’arsenale sempre ben fornito e sempre parato alla lotta dell’impero contro il Papato. In molte spedizioni bellicose questi Maomettani misero a sacco e fuoco vescovadi e monasteri cristiani, e contro di essi non servivano scomuniche né anatemi papali. Con grande insistenza la Chiesa esigeva la conversione al Cristianesimo del ter- F. Gregorovius Lucera, colonia saracena degli Hohenstaufen 129 ribile popolo pagano. E Federico lasciava libero l’adito a Lucera a missionari francescani; benché poi con ironico sorriso sulle labbra facesse convenire insieme alla sua mensa vescovi e Saraceni di distinzione e di merito. A costringere intanto i suoi fedeli soldati a mutar fede e religione non pensava punto, ché la conversione ne avrebbe spuntato le armi nella lotta contro il Papa. Federico sentiva piuttosto ammirazione per la religione de’ suoi Arabi, le cui forme di culto forse trovava meno superstiziose di quelle della Chiesa romana; e, ad ogni modo, era sicuramente una religione meno ostile all’autorità dello Stato. «O Asia felice, o felici monarchi dell’Oriente, cui l’invenzione del Papato non procaccia affanni,» così scriveva egli una volta al genero suo Vatazes. E, più tardi, anche il re Filippo di Francia esclamava: «O felice Saladino, che non ha nulla da soffrire per opera de’ Papi». Da quei tempi ci separano lunghi secoli. Nulladimeno ancora al giorno d’oggi esclamazioni di tal genere potrebbero essere sentite, specialmente dalla bocca dell’Imperatore di Germania. La vista della fortezza saracena riconduce la mente a tempi di vera grandezza. Chi sappia per poco toccarne le mura con la bacchetta magica della fantasia, le vede a un tratto popolarsi di figure storiche della più notevole delle epoche nella vita dell’Europa. Arrampicandoci su e giù, sotto le raffiche di un vento impetuoso che ad ogni istante minacciava precipitarci dall’alto de’ merli, noi tre compagni di viaggio eravamo lì, quasi rappresentanti della nuova Germania e della nuova Italia. Con intimo compiacimento andavo ripensando che l’amico italiano era figliuolo di quella Capua stessa, ove il geniale Pier delle Vigne ebbe i suoi natali; e che mio fratello aveva combattuto la grande guerra germanica contro la Francia; la guerra che ha dato nel mondo il colpo di grazia al guelfismo e distrutto per sempre il potere temporale de’ Papi. Con noi intanto s’era per caso unito un giovane prete di Lucera, che ci faceva da guida. Guardandolo, egli mi appariva, malgrado delle sue maniere gentili e premurose, come il rappresentante del campo de’ furiosi avversari di Federico II, e come l’ombra tenebrosa, che s’accompagna con la libertà dello spirito e per lungo tempo non se ne lascerà staccare. Dal castello di Lucera la fantasia mi spinse repente di là da’ monti splendidi della luce e del sole di Puglia. Nella remota Germania, nella Svevia leggendaria, il paese degli Hohenstaufen, io rividi le rovine di un altro castello. Con stupore misurai le lunghe vie della storia, per le quali la stirpe eroica di Federico di Buren dal suo svevo castello avito erasi condotta sin qui, sin nelle terre pugliesi; e con stupore mi tornavano pure in mente gl’intimi legami, che congiungevano Hohenstaufen con Lucera e la sua fortezza. 130 Verso Sud D. Grittani Solo poche ore di cammino separano Hohenstaufen da Hohenzollern. All’Impero germanico occorsero però non meno di sei secoli interi di storia per percorrere il breve tratto. Il termine suo non lo ha toccato che il 1870. L’Impero tedesco si è ricostituito sotto la dinastia degli Hohenzollern, la quale ha ripreso in sua mano e continua la missione degli Hohenstaufen. La identica lotta, già combattuta con Roma dagl’Imperatori svevi, si è presto riaccesa con uguale ardore. E la Germania, sorta appena alla nuova esistenza d’impero nazionale, appare scissa e divisa di nuovo in partiti di guelfi e ghibellini, in seguaci dell’Impero e della Chiesa. Il fenomeno sembra sorprendente: pure può recare maraviglia solo a chi ignori il processo della storia e il concatenamento de’ suoi eventi. Codesto deplorevole risorgere dell’antica contesa incaglia, senza dubbio, il tranquillo ordinamento dell’Impero, cui nemici palesi o nascosti attorniano ed insidiano; ma è storica necessità. Forse l’esistenza nazionale della Germania è destinata a non potere per lungo tempo ancora trovare assetto sicuro e pacifico, quale toccò in sorte all’Inghilterra, compiuta che ebbe la sua rivoluzione. Il principio della Riforma costringe la nazione germanica a portare nel seno suo quegli elementi contrari ed opposti, sui quali riposa lo svolgimento della vita interiore dell’Europa. Codesto principio ha posto in Germania la sua sede e il suo centro. Ciò se non fu conseguenza al tutto diretta delle proprietà specifiche spirituali della nazione germanica, lo fu, certamente, del fatto di essere stato ad essa per secoli, a partire da Carlo Magno e dagli Ottoni, commesso il potere imperiale. Dato il fatto, era inevitabile pel popolo tedesco l’impigliarsi in una lotta incessante col potere papale e col Cristianesimo della Chiesa romana. Il moto degli spiriti in Europa sembra come descrivere un circolo perenne, ove tutto ritorna e si ripete lo stesso. Chiesa ed Impero, Papa ed Imperatore vi tengono sempre l’attitudine medesima, come già al tempo di Federico II e di Gregorio IX. In realtà, antichi pensieri organici giacciono nel fondo della cultura nostra, intorno ai quali questa s’aggira tuttora, comunque la costituzione politica ed ecclesiastica del mondo sia in molti rispetti mutata. L’Imperatore germanico, che oggi seguita a combattere il principio gerarchico del successore di Gregorio IX e d’Innocenzo IV, non è più lì, solo, non compreso dal tempo suo, come il geniale Federico II. E, d’altra parte, il pertinace nemico, che gli sta di contro, non dispone più de’ mezzi smisurati, de’ molti alleati, come al tempo in che la Chiesa, per opera di Gregorio VII e d’Innocenzo III, s’era levata nel mondo al grado di unica potenza ideale, di universale organismo spirituale; e la teologia, nel campo della scienza, esercitava dominio illimitato; e i nuovi Ordini de’ Francescani e Domenicani avevano destato nella cristianità tutta quanta un ardore, una febbre di fede religiosa; e le Crociate valevano ancora come le più nobili, le più eccelse imprese politiche di principi e F. Gregorovius Lucera, colonia saracena degli Hohenstaufen 131 popoli. Alla Chiesa di Roma, a codesta magica potenza che teneva sotto di sé il mondo intero, che disponeva di sì gran copia di elementi, e trovava di più nello spirito democratico e nazionale degl’Italiani il suo alleato, il grande Hohenstaufen, non sostenuto che dal suo proprio genio, non appoggiato tampoco dalla Germania, la quale era pure la sua base naturale, doveva solo opporre resistenza. E facile immaginare quanto dura, quanto spaventevole dovett’essere per lui la lotta con Roma, se oggi ancora le difficoltà, fra le quali per la contesa ecclesiastica il suo potente successore, il capo dell’Impero tedesco, si è cacciato, appaiono pur sempre immense! In vero, a petto della potenza ond’era in possesso all’epoca degli Hohenstanfen, e che investiva tutte le forme della vita, la Chiesa romana odierna è ridotta ad un meccanismo privo d’anima e di spirito. La Riforma religiosa germanica, cui il principio ghibellino di Federico II fu una delle presupposizioni, le rapì assai più che non fosse il dominio di molte terre e popoli. Essa l’ha interiormente impoverita ed esinanita. Tutto ciò che un tempo formava la grandezza sua, la scienza e le idee umane e civilizzatrici, sono diventate patrimonio del mondo della Riforma. E tutto ciò che da tre secoli a questa parte ha forza di muovere e spingere innanzi le società europee, è il risultato della efficacia del principio della Riforma. Il Papato romano, nel quale oramai la Chiesa cattolica s’è raccolta e concentrata tutta, ha cessato di essere una potenza mondiale, un regolatore della civiltà. Nessun pensiero pieno di senso profetico e di avvenire; nessuno che sia in grado di entusiasmare l’umanità e trascinarla può mai più sprigionarsi dal chiuso e cupo recinto del Vaticano. La fede ha perduto la sua forza. La scienza e la critica vanno ogni giorno più decomponendo il Cristianesimo storico e dommatico. Qual valore, quale importanza ha oggi la teologia a confronto del tempo di Tommaso d’Aquino? Gli ordini monastici, per cui mezzo soprattutto il Papato potette una volta esercitare il suo potere universale sui popoli dell’Europa, sono spariti. L’ultimo per ragion di tempo, l’ordine de’ Gesuiti sbandito ed esiliato, va in parte errando pel mondo. Quando si pongono a raffronto le idee contenute nella dottrina gesuitica con le regole di quella de’ Francescani, appare evidente che intima sostanza delle prime non è più la religione del Cristo, ma la politica della Curia romana. È, in una parola, il programma dell’assolutismo papale. Ora il principio dell’infallibilità del Papa o, ch’è lo stesso, dell’annientamento della ragione nella Chiesa e dell’assoggettamento del pensiero in generale, può essere forse concepito quale idea destinata a suscitare l’entusiasmo dell’umanità? Può l’umanità riporre fede in un domma, che a scopo supremo dello svolgimento suo le mette dinanzi l’al di là, l’avvenire estramondano? Domande siffatte non si può ascoltarle: non vi si può rispondere che con un sorriso. 132 Verso Sud D. Grittani Nulladimeno, questo Papato gesuitico-romano, grazie alla tradizione, al suo meraviglioso sistema di accentrata unità, al gran numero di coloro che fidamente e ciecamente gli aderiscono è ancora, assai potente. Ed è vero; esso dispone ancora di una forza politico-sociale. Esso costituisce sempre un centro tradizionale di unità per l’immensa moltitudine che professa una intuizione dommatica circa l’ordinamento e il governo del mondo e della vita. Onde gli si schierano intorno tutti i partigiani del Cristianesimo concepito nelle sue forme viete e scadenti, tutti gli elementi che aspirano alla conservazione e al legittimismo, e in generale tutti quei che cercano l’ideale loro nella fede autoritaria del passato. Di riscontro a codesto partito sta l’altro, il quale muove dal principio della determinazione autonoma ed intrinseca di ogni singolo individuo, cui è comunanza politica lo Stato moderno, il quale si svolge libero ed estraneo alle differenze confessionali. Nel luogo de’ guelfi e ghibellini di un tempo si sono oggi sostituiti la Chiesa e lo Stato, ovvero, rispetto alla Germania, la Chiesa dell’assolutismo romano e papale, e l’Impero moderno e irrazionale. Malgrado di Roma e de’ Gesuiti, l’Impero tedesco s’è oramai costituito sotto la dinastia protestante degli Hohenzollern. Sulla base solida della Germania unificata ed elevata ad esistenza nazionale il nuovo Imperatore può tenersi più saldo, più possente che non i più grandi degli Hohenstaufen e lo stesso Carlo V. Ciò è appunto perché il domma della dominazione universale di Roma nell’ambito dell’Impero germanico è venuto meno per sempre. Esso però continua, pur troppo, a vivere nel Papato; ed il combatterlo, sino a che non sia caduto morto anche in questo suo campo proprio, è in parte il contenuto e lo scopo della lotta del tempo presente, la lotta del mondo moderno col passato. Scopo siffatto s’erano a tempo loro prefisso i ghibellini; ma non lo raggiunsero. Il principio della monarchia universale essi pretendevano attribuirlo a sé. E gli Hohenstaufen caddero pure, poiché dell’Italia, di un paese straniero, vollero fare la base pratica di un impero che doveva abbracciare il mondo. L’Italia è patrimonio mio: diceva Federico II; ed il Papa affermava esattamente lo stesso. Roma, lo Stato della Chiesa, l’Italia, a partire dalla favolosa donazione di Costantino, erano stati il fondamento sempre agognato e, più o meno, anche realmente e praticamente mantenuto della dominazione universale de’ Papi. Ed occorre aggiungere che codesto fondamento era per lo meno più prossimo e più naturale ad essi che non agl’Imperatori tedeschi. Nel medio evo gl’Imperatori sapevano che senza l’Italia la loro monarchia universale era impossibile: non altrimenti erano convinti i Papi rispetto alla dominazione alla quale essi pure aspiravano. Ora il fondamento del dominio papale è stato tolto via: esso è caduto per sempre nel 1870. Distruttori dello Stato della Chiesa sono stati appunto i ghibellini, gli Hohenzollern. F. Gregorovius Lucera, colonia saracena degli Hohenstaufen 133 Dall’alto del castello di Lucera io riandava le fasi e lo svolgimento di questo gran processo storico. E, pieno di gioia, mandai un saluto all’ombra dell’immortale Hohenstanufen, che Dante stesso, comunque il più entusiastico de’sostenitori dell’idea dell’Impero e della monarchia universale che vi si connetteva, pure, qual pio e fedele cattolico, non poté a meno, tenendolo per eretico e saraceno, di cacciarlo giù nel profondo inferno e di metterlo a giacere in un letto di fuoco. Quale non sarebbe lo stupore di Federico II, se gli fosse dato oggi di riveder Roma! Quel trono temporale, tutto jeratico e per nulla cristiano, che a lui non riuscì abbattere, è ora finalmente gettato per terra: il Papa, che si tien chiuso in Vaticano, abbandonato dalle potenze politiche, come una volta lo fu egli stesso, Federico: un prigioniero libero e volontario, e non per tanto prigioniero vero e reale, siccome colui che i nuovi tempi hanno relegato a star chiuso là entro: a pochi passi poi da lui assiso tranquillamente sul trono di Roma il discendente de’ sovrani della piccola Savoia, divenuto Re d’Italia e, come tale, riconosciuto e circondato delle felicitazioni di tutti gli Stati, di tutti i popoli della terra! Anche morto Federico II, i Saraceni continuarono a rimanere a Lucera fedeli, irremovibilmente legati con la Casa sveva, cui infrattanto il Papa studiava ed affrettava i modi di strappare le Puglie. Solo ad essi Manfredi andò debitore dell’aver potuto salire sul trono del padre suo. Egli veramente non iniziò la sua splendida ed eroica carriera che appunto in codesta fortezza di Lucera. Quivi nel novembre 1254 venne a cercare e trovò salvezza dopo la sua fuga audace da Aversa, attraverso le montagne del Sannio. Giunto alle porte di Lucera e datosi a conoscere, i Musulmani, giubilando, lo condussero nella fortezza e lo proclamarono loro Signore. E quivi egli sentì di avere una base solida e sicura. Onde poté quindi scacciare i nemici dalla vicina Foggia, e poscia da Troia, donde il cardinale legato, Guglielmo Fieschi, messo in fuga, andò a riparare a Napoli presso il Papa. Nulla aveva più forza di esacerbare quest’ultimo, quanto il durare della colonia saracena di Lucera. Vani erano i tentativi di conversione da parte della Chiesa. Ed invano pure venivano rivolte istanze a Manfredi, perché rimandasse in Africa i suoi Maomettani. Egli non se la sentiva di disfarsene, vedendo in essi i più fidi guerrieri ed alleati suoi. Come suo padre, amava tenerseli intorno; onde i preti e Carlo d’Angiò lo nominavano il Sultano di Lucera. Sul campo di battaglia presso Benevento gli Arabi pugnarono valorosamente e caddero a migliaia. Prima di muovere contro l’Angioino, Manfredi aveva affidato alla custodia della guardia saracena di Lucera la sua giovane e bella consorte, Elena di Epiro, e i suoi figliuoli. E qui, a Lucera, fu portata alla sventurata la nuova che suo marito era caduto. Priva di consiglio, in preda alla disperazione, essa fuggì con i figlinoli a Trani per imbarcarsi e cercar rifugio in Epiro. Ma il castellano della 134 Verso Sud D. Grittani fortezza consegnò le vittime ai persecutori che già le cercavano ed inseguivano dappresso. I Saraceni di Lucera abbattuti, costernati, conclusero con l’usurpatore vittorioso un trattato, pel quale fu loro consentito di continuare, quali sudditi di lui, a vivere e governarsi con le istituzioni e le leggi date loro dagli Hohenstaufen. Però, già nell’anno 1267, allorché il giovane Corradino si apprestava alla spedizione in Italia, essi fecero sventolare di nuovo da’ merli della loro fortezza il vessillo di casa sveva. Lucera fu allora il centro di riunione e la base e il sostegno dei ghibellini dell’Italia del mezzogiorno, e quindi oggetto di massima inquietudine pel Papa come per Carlo d’Angiò. Dietro le insistenti sollecitazioni del primo aveva il secondo mandato un esercito a cingere d’assedio la fortezza, la quale però respinse vittoriosamente tutti gli assalti. Nell’aprile 1268 Carlo stesso, obbedendo al volere del Papa, venne in persona di Toscana nella Puglia per sottomettere Lucera. Ma dovette poscia levare daccapo l’assedio per andare incontro all’ultimo degli Hohenstaufen, Corradino, che per la via Valeria veniva giù verso il lago Fucino. La battaglia presso Sgurgola decise della sorte dell’infelice. Caduto lui, Lucera venne nuovamente assediata. I Saraceni si difesero con disperato coraggio, sino a che il 28 agosto 1269, un anno dopo la disfatta di Corradino, furono per fame costretti ad arrendersi. Il loro numero s’era via via assottigliato di molto. Nulladimeno, anche ora, benché privati delle loro franchige, seguitarono a tenere per sé Lucera. Anzi, nel 1271, si sollevarono ancora una volta contro l’odiato Angioino, il vassallo del Papa, facendo risorgere a Lucera un falso Corradino. Ridotti di nuovo alla sommissione e crudelmente puniti, restarono non per tanto ad abitare nella loro cittadella, imperocché in fondo l’Angioino stesso riconosceva l’importanza di questa colonia di prodi guerrieri. Egli fece anzi munire anche più la fortezza, e gran parte delle mura e delle torri esistenti è appunto del tempo di Carlo I. Molti decreti di questo re si riferiscono al compimento del Castello di Lucera, il quale, come prima, serviva anche di luogo di custodia pel tesoro reale. Quando in fine ogni speranza in una possibile restaurazione de’ ghibellini fu morta, e gli sventurati figliuoli di Manfredi giacevano sepolti ne’ sotterranei di una prigione, i Saraceni, spinti dal sentimento della propria conservazione, si misero al servigio degli Angioini. E questi si avvalsero di loro nel medesimo modo che avevan fatto gli Hohenstaufen. Nella guerra del Vespro Siciliano Carlo II li mandò a combattere contro Aragona sotto le insegne della Croce e sotto gli occhi del Legato papalino. Il Papa intanto domandava in maniera categorica l’esterminio de’ pagani; e Carlo II cedette finalmente al comando di lui. Senza motivo al mondo fece prendere F. Gregorovius Lucera, colonia saracena degli Hohenstaufen 135 d’assalto la fortezza e trucidarvi i Saraceni che vi eran dentro. I pochi che scamparono, rimanendo superstiti, vennero costretti ad abbracciare il Cristianesimo. Le moschee furono abbattute dalle fondamenta. La cattedrale cristiana venne riedifıcata. Insino l’antichissimo nome di Lucera si volle barattare con quello di Santa Maria, senza che però avesse forza di attecchire e mantenersi. Così, dopo una durata di quasi ottant’anni, si estinse, nel 1300, la città de’ Saraceni. Già nel 1525 Leandro Alberti trovò la cittadella caduta in rovina e diventata ricovero di animali. La storia di essa meriterebbe davvero di essere trattata in modo speciale da qualche conoscitore a fondo delle cose arabe. Anche non avendo per sé grande importanza, formerebbe sempre un capitolo attraente della storia de’ Saraceni di Sicilia. Ed è da deplorare che Michele Amari non abbia più colorito il disegno che ne aveva concepito. Allorché cominciò la sua dotta e seria opera su’ Musulmani di Sicilia, non gli fu dato consultare che solo in parte gli atti dell’Archivio di Stato di Napoli; mentre, a quanto egli assicura nell’Introduzione, in tale Archivio, ne’ Registri della Casa Angioina, sono a centinaia i documenti che si riferiscono ai Saraceni di Lucera. Per un uomo come l’Amari di sì rara potenza di lavoro non dovrebbe anche oggi esser diffıcile il mettere insieme da tali documenti una storia degli Arabi di Lucera. Chi dalle mura della fortezza giri intorno intorno lo sguardo, abbracciando le belle campagne pugliesi, splendide ed irradiate da un elisio etere azzurro, vede dispiegarglisi dinanzi un teatro veramente unico e, come in uno specchio, apparirvi concentrati e riflessi tutti gli eventi storici dell’Italia Meridionale. Romani, Cartaginesi - laggiù in fondo s’intraveggono i campi di Canne, il luogo della famosa battaglia di Annibale - Goti, Longobardi, Saraceni, Bizantini e Normanni, i Crociati, di lì, da quelle coste, salparono essi la prima volta - gli Hohenstaufen, gli Angioini, gli Aragonesi, gli Spagnuoli, i Francesi: egli vede passarsi via via innanzi allo sguardo l’una dopo l’altra tutte queste apparizioni e i fatti e le gesta che vi si congiungono! Tutto all’intorno un orizzonte veramente meraviglioso! A settentrione la catena del Gargano dal color di porpora; e un po’ a sinistra in lontananza il mare luccicante e l’isola di Tremiti, che emerge dal seno suo, come di mezzo a uno specchio d’argento. Ad oriente, di là da Foggia, l’Apulia Plana che si stende ampia, soleggiata sino al golfo di Manfredonia. Verso occidente e mezzogiorno le pendici maestose dell’Appennino beneventano e più in qua le montagne di Campobasso e di Boiano. Da quest’ultimo lato, a poche miglia di distanza, dirimpetto alla campagna lucerina, una catena di verdeggianti colline, sulle quali si disegna spiccatamente l’antica Troia. Il classico nome di questa città ci conduce assai lungi, riponendoci nella memoria luoghi e tempi omerici. La fondazione sua però non risale più in là degli inizii dell’XI secolo. Troia è una delle città pugliesi edificate da’ Bizantini. Il Catapano 136 Verso Sud D. Grittani Bugianus la fece costruire nel tempo in che la gente longobarda nelle Puglie, oppressa da’ Greci, insorse. E già nel 1022 la nuova Troia era luogo così ben munito che l’imperatore Enrico II, nella sua spedizione nell’Italia Meridionale, dovette cingerla in tutta regola d’assedio e darle l’assalto. Oggi conta seimila abitanti, e di specialmente notevole non ha che l’antica cattedrale. Di ritorno dal Castello, visitammo in Lucera alcune chiese: Sant’Antonio Abate, una volta appartenente all’Ordine de’ Cavalieri Teutonici, il quale al tempo degli Hohenstaufen ebbe ricchi possessi nelle Puglie; San Domenico; e poi il Duomo. Questo è opera degli Angioini. Dell’antica cattedrale vescovile i Saraceni di Federico avevano fatta una moschea, e poiché fu abbattuta e ridotta ad un mucchio di macerie, il successore di Carlo d’Angiò risolvette, nell’anno 1300, di far edificare di pianta la cattedrale Santa Maria. Due anni più tardi, benché non per anco finita, venne già consacrata. Dopo del Castello, è il più ragguardevole monumento della città e come il suo centro architettonico: edifizio gotico a tre navate, di armoniche proporzioni, semplice e dignitoso nelle forme. La facciata è una cuspide ad angolo ottuso, con un finestrone rotondo, e tre porte gotiche in tufo calcareo bruno. Le sta alato il non alto campanile, terminato in cima con un ottagono. Indarno, entrato dentro, cercai monumenti od epigrafi che ricordassero il passato: ovunque in Italia esse vanno scomparendo dalle chiese. Solo nel battistero esiste ancora una statua in marmo del fondatore della chiesa: figura giovanile dall’aspetto leggiadro. Le mani tiene conserte sul petto, e con i piedi, strano davvero!, poggia sopra due cani, i quali piegano sotto il suo peso. Sul piedistallo si legge scritto in caratteri moderni: Carolus II. Andeavensis A. S. MCCC. Templum Deo et Deiparae Dicavit. Il sarcofago, cui la figura in origine era annessa, disgraziatamente non esiste più. Il giovane prete, colui che ci fu guida al Castello, ci condusse pure a visitare la biblioteca comunale, posta nel palazzo appunto del Comune. Vi occupa due camere ben pulite. Fra le altre cose, mi venne mostrata tutta una serie di manoscritti, moderne compilazioni di documenti concernenti la storia di Lucera. Tale storia invero non è stata per anco sufficientemente descritta. Nel 1861, pe’ tipi di Salvatore Scepi, in Lucera, si ebbe bensì una storia della città, scritta da Giambattista d’Ameli, barone di Bineto e Meledugno; ma è libro codesto che non tien conto di alcuna esigenza scientifica. Nella biblioteca non ci era che un lettore solo, dal quale fatto, per altro, io voglio astenermi dal trarre sfavorevoli conclusioni circa le abitudini e tendenze studiose della città. Queste, di certo, non si distingueranno per operosità e fervore, benché il liceo di Lucera goda buona fama. [Tratto da Nelle Puglie, FERDINAND GREGOROVIUS, traduzione di Raffaele Mariano, Barbera Edizioni, Firenze 1882; ristampa anastatica La Terrazza Editrice, Pianoro di Bologna 1975] 137 Lucera Riccardo Bacchelli Riccardo Bacchelli (Bologna 1891 - 1985). Nel 1929 l’autore del Mulino del Po, invitato dal suo amico di studi universitari Giustiniano Serrilli di San Marco in Lamis, si recò in visita sul Gargano dove soggiornò dal 19 marzo al 15 aprile restando affascinato dalle tradizioni e dal paesaggio di questa ineguagliabile terra. E proprio da San Marco in Lamis, Bacchelli inviò al quotidiano La Stampa una serie di articoli che furono pubblicati nella primavera stessa del 1929. Soggetto di questi articoli, ciascuno dei quali fu successivamente raccolto nell’antologia Italia per terra e per mare (Rizzoli 1952), il fascinoso Gargano e la cordialità che Bacchelli qui conobbe. Si entra in Lucera da una porta militare, per una strada rustica e in pendìo, e naturalmente si ha la testa piena dei saraceni e del secondo Federico. Dei famosi saraceni, ch’egli trasportò qui dalla Sicilia, rimangono soltanto il ricordo e certi orridi ceffi moreschi, che furon messi a far da capitelli e da ornati sugli stipiti e negli angoli, per far paura ai ragazzi, diresti, e per commemorare le giornate in cui di teste vere musulmane s’addobbarono i muri della città. E anche di lui, dell’imperatore scomunicato, «martello della Chiesa Romana, luxuriosus, epicureus», rimane poco. Il castello, dominatore di una delle più belle vedute di Puglia, fra gli Appennini e il Gargano sulla gran distesa del Tavoliere, dov’egli ebbe palazzo e fortezza, è in massima parte costruzione degli Angioini; di svevo serba ben poco; ed è solatia rovina, dove intorno brucano le pecore sotto la guardia vigile dei cani da pastore, e dove solo della Torre della Regina resta tanto da risuscitare nella fantasia le eleganze architettoniche che l’abbellirono. E il vento primaverile, che stormisce nelle feritoie e nelle breccie del fiero recinto, par che dia al sole schietto la melanconia dell’ala del tempo, lieve cosa senza rimedio. Qui, nel luogo dove i distruttori del sangue svevo costruirono poi il castello, il lussurioso epicureo tenne il serraglio delle belle fiere e dei leopardi da caccia e delle bellissime femmine e degli abbominevoli eunuchi. 138 Verso Sud D. Grittani Qui campava da rinnegato alla moresca, ridendosi dei monitori papali e dei missionari che non riuscivano a convertire la «peste musulmana» da lui introdotta in terraferma. Qui anche, vicino, era una moschea dei suoi fidatissimi saraceni della colonia lucerina. Cotesto tedesco fantastico seppe molte cose, ma ignorò quel che si offende, e non si offende impunemente, quando si oltraggia la religione del popolo. A noi lo insegna il ribrezzo, che dura ancora dopo tanti secoli, in Lucera, e che si esprime nella leggenda. La tavola dell’altar maggiore in Duomo è fatta d’una grande e bellissima lastra di pietra la quale era la sua mensa in Castel Fiorentino, dove morì. E stata posta lì come segno d’espiazione? Certo è che il popolo lucerino favoleggia che del Duomo Federico si fosse fatto un lupanare di donne, e che proprio sul luogo dell’altar maggiore avesse messa la latrina. Favola; fra l’altro il Duomo è opera posteriore, di Carlo II lo Zoppo. Ma la fantasia è forte ed acre, e tenace il disprezzo popolare lucerino. Eccone un esempio. C’è accanto alla porta di sinistra, una pietra tombale incastrata nel muro. Colui che vi è effigiato, un innominato gentiluomo, a quel che pare dal vestito, del Seicento, non ha, che si sappia, altra colpa che quella d’avere una faccia brutta e maldisponente, da segnato da Dio: il popolo s’è messo in testa che sia il traditore Pier delle Vigne; e i vecchi lucerini, nonostante la sorveglianza e i divieti del sagrestano e dei canonici, ritengono di farsi un merito collo sputargli in viso. Traditore, essi lo detestano, non già dell’odiato Federico, ma della fede, eretico come il padrone, e dannato suicida. In quella loro giustizia, che non guarda per il sottile, né alla decenza, non possono ammettere che il capitolo della cattedrale tenga nella chiesa quella statua, e così l’ingiuriano. Quest’odio e quell’atto dura da secoli, e il nostro mondo, che a forza di decenza rischia d’ammollire il maschio vigore dei sentimenti, convien non dimentichi che detestare tradimento e traditori è, anche se in atti sconci, effetto di principii sani. Un tempo le genti si uccidevano per la fede, ed era una ragione più nobile che per il petrolio e le materie prime. Ma imparo da un’acuta e dotta monografia dello storico Egidi, che anche la distruzione dei saraceni di Lucera, dei quali Carlo lo Zoppo fece metterne ventimila a fil di spada dal suo ministro Pipino da Barletta fra il 15 e il 24 agosto del 1300, fu un’operazione finanziaria, un esproprio delle terre demaniali concesse agli infelici musulmani non che da Federico, anche da Carlo I, e da lui stesso, lo Zoppo, travagliato dalla guerra perpetua e dal bisogno orrendo di denaro e di frumento. Non ho l’autorità di discutere né di dubitare. Sotto ogni fatto della storia c’è quel fattore economico, ma la storia non sarebbe la storia, anzi l’uomo non sarebbe l’uomo, e non opererebbe storicamente, se non anche avesse motivi d’altro genere: primo e capitale, quello della religione e dei sentimenti. Quel povero Carlo lo Zoppo, che combattè non so quante battaglie e credo che R. Bacchelli Lucera 139 le perse tutte; che cominciò il regno in prigionia; che, quando Ruggiero di Lauria l’ebbe preso nella battaglia del Golfo di Napoli, sentì i capitani e le ciurme siciliane discuter lungo la traversata se era da tagliargli il collo o da metterlo a prezzo di riscatto; disprezzato già da suo padre (uno dei migliori cavalieri che mai fossero, secondo il suo gran rivale Giacomo d’Aragona), il quale, quando seppe la rotta navale e prigioniero il figlio e morti molti dei suoi migliori: «Così fosse morto lui disse - quel prete imbelle e sconsigliato!» quel povero Carlo lo Zoppo è effıgiato in una statua tombale che ho vista nel Duomo di Lucera, e che mi ha mosso la fantasia. Prete, lo chiamava suo padre, che pur era religiosissimo ma da quell’energico soldato e politico che fu, perché, nato più per le devozioni che per le armi, si narra che avesse la tenda piena di libri e di insegne sacre e di reliquie; prete, perché era debole di corpo, eccitabile, fantasioso, e facile a credere alle predizioni e ai voti. In tutta la sua vita travagliosa e nel suo regno, si scorge una specie di sbaldanzita tenacia nella sventura, che par più adatta a un penitente rassegnato, che a un re e guerriero. Povero Carlo! Se devo confessare la verità, ciò che più mi persuade che nell’operazione sui saraceni di Lucera ci fu veramente qualcosa di un eccidio religioso, di una notte di San Bartolomeo (24 agosto anche questa; vedi i casi e gli incontri delle date!) è il suo ritratto. (La cattedrale di Lucera, città dai bei portali, è una grande opera che sorge da un terreno disuguale; e l’industria degli architetti, invece di spianarlo, che sarebbero stati buoni tutti, s’è ingegnata coi contrafforti arditi e varii a sostenerla sulla disparità del terreno, in modo da farne una fabbrica piena di naturale imprevisto e di grazia ardita). Lo Zoppo giace a mani in croce, mani piccole in posa stanca e d’abbandono; ha indosso una corazza tutta lavorata, e quasi si direbbe che il corpo gracile v’abbia da poco smesso di respirarvi dentro, e che gli fosse di fatica; una spada troppo grande per lui gli pende rigida e pesante dal fianco. Ha le mascelle lunghe e il mento rotondo; le guancie, se posso dir così, affusolate; la fronte testarda e nella quale non si suppongono né molte né grandi né fervide idee. Per altro è una fronte nobile, e tutto l’uomo ha quel che esprime, sia anche in significato di decadenza, la parola «signorile». Il segno della tenacia sfortunata, e che sa d’esserlo, è fra occhio e occhio; una specie di corrugazione testarda e smarrita; sulla bocca infantile e imbronciata c’è uno scontento e un cruccio che non riesce ad esser crudele, ma che è tanto amaro da far credere che crudele possa essere stato. Gli occhi, che dovettero esser grandi e prominenti, sembrano arresi or ora a una grande stanchezza. Se questi fu lo Zoppo, par di leggergli in volto proprio quel tanto d’eccitabile e turbato che produce in certe anime il fanatismo; maniera di devozione diversa e 140 Verso Sud D. Grittani certo tanto inferiore a quella che nei maggiori spiriti di santi si chiama carità, e carità severa magari; ma adattata a fargli deliberare quel macello del 24 agosto 1300. E ci sarà stato anche il movente economico, a intrudersi in quella ch’egli avesse pensato come una vendetta di Dio: e ne sarà stato men contento e men certo di sé; e gli sarà cresciuta la paura dell’inferno e il cruccio della coscienza, e l’ostinazione e l’orgoglio stanco, figli quasi sempre della tristezza e della disgrazia. Se questi fu lo Zoppo. Infatti mi dicono alcuni cortesi e colti amici lucerini, lo scrittore Colucci, l’avvocato Gifuni e il professor Catalini fra gli altri, che si tratta di una attribuzione tradizionale e incerta. Ebbene, io trovo la risposta nel libro, che essi mi hanno regalato in ricordo di Lucera, di un celebre lucerino. Il Bonghi registra questo detto del Manzoni: «La storia è assai grande, e più assai dubbia. Ottavio Castiglione, uomo dottissimo, fınì per non crederne più nulla». Per me, credo che quella statua rappresenti davvero re Carlo II, e mando verso la quieta e ventosa Lucera queste fantasticherie di una mattina fresca di primavera in Duomo, quando fui a visitare, e tanto mi piacque, la città civile e colta e giuridica. [Articolo apparso sul quotidiano La Stampa nella primavera del 1929; successivamente pubblicato nel libro L’Italia per terra e per mare, RICCARDO BACCHELLI, Rizzoli, Milano 1952] 141 Lucera, città di Santa Maria Giuseppe Ungaretti Lucera, il 15 maggio 1934 Scriveva Gregorovius ricordando la sua entrata a Lucera: «Ti viene incontro la quiete tutta propria in Italia delle città storiche di provincia. È cosa d’una seduzione che non ha l’uguale nel mondo». In un delta oblungo, e come sposando il silenzio, il Duomo è fermo su una terra a onde. Duomo della città di S. Maria. Ma commemora lo scatenamento d’un furore. La pietra cotta e la cruda, stinte, patinate, penetrate l’una nell’altra, hanno avuto dal tempo un’unità di giallo leggermente ombrato: è una facciata alta, impettita, piallata, orba con quel suo finestrino nel rosone, tagliente, coperta dal tempo di un colore di grido represso. Ora che l’archeologo può sbucare segreto da una stradicciola e frugare in giro dietro le lenti cogli occhi affamati, si può gettare un’occhiata nei solenni portali settecenteschi di cui la città è ricca, arrivare a quello del Palazzo Ramamondi, di gesso ercolanense, affondato in quinte, e a bell’agio vedere che tutti finiscono in una corte piena di carri, carrette, d’arnesi per lavorare la terra e d’una carrozzella nel mezzo, così decrepita che le mani vi scappano a turarvi gli orecchi per paura che non si metta anche da ferma a cigolare; possiamo incontrare ragazzi del Real Collegio dove fu alunno Salandra, che passeggiando ripassano le lezioni con una serietà di statue; su e giù per la stessa strada, potrete osservare avvocati calmi discutere ore intere e accanto, passando, un prete in orazione può sentirsi come in un chiostro, e alzare appena gli occhi dal breviario per un salutino; ecc.: è questa la quiete? Giambattista Gifuni, direttore della Biblioteca Municipale, che m’accompagna e che conosce mirabilmente la storia della sua città per un amore che da secoli hanno da padre in figlio nella sua famiglia, mi fa segno d’avviarci. Ed ecco per dare il garbo all’abside, che la terra a onde s’è messa a girare come dentro una chiocciola, e i nostri passi con essa; ma presto tutto sembra immutabile e lo stesso colore dell’aria, arrivati come siamo a un punto dove è unico motore l’architettura. 142 Verso Sud D. Grittani Ora, per l’annodarsi stretto dei contrafforti, la mole fa da sporgenza a sporgenza effetto di galoppare tra altissimi agguati: è un’elegante mole con un nonnulla di calligrafico, pericolosa e anche serena, come s’addice a fabbrica provenzale trecentesca ancora ammaliata d’Oriente, sorta sotto il più largo cielo del mondo sulle rovine fumanti d’una moschea. Ma appare più di tutto, assediata e presa d’assalto dalle cose così com’è rimasta, nave gonfiata dall’affanno umano, veramente la forza dalla quale nascono o rinascono e vanno alla ventura città. Città di S. Maria! Ci basterà del resto fare due altri passi ed entrare nel Duomo per vedere gli stessi fantasmi approvare Gifuni d’avere nel suo scritto intorno alle “Origini del ferragosto lucerino”, opposto all’Egidi che non tanto la ragione economica quanto la passione religiosa mosse Carlo II a radunare un esercito e, al comando del “valoroso” Maestro Razionale della Curia Reale Giovanni Pipino da Barletta, spedirlo addosso a Lucera a farvi “macello” dei “tanto arditi et grandi Saracini cani” che la popolavano. Entrati in Duomo, il primo fantasma a farsi riconoscere – e che or ora, a quell’esterno dell’abside frutto di un’educata violenza, già avremmo potuto immaginare presente – è Dante. Carlo I d’Angiò, Carlo II d’Angiò: il Nasuto, il Ciotto, come Dante li ha crucciato soprannominati per sempre, sono qui nel centro del loro trionfo. Dicono che il Ciotto sia quel giovanotto di marmo dagli occhi pieni di sonnolenza, il cui viso paffuto chiede il grazioso ovale al mento sottile e che giace coi piedi poggiati sui cagnolini in una cappella laggiù in fondo. Era uso tramandare sui cenotafi il più leggiadro aspetto d’uno scomparso? E quindi d’un uomo attempato non doveva rimanere che la memoria del suo corpo giovane? Uso amabile, il che non impedisce alla statua d’essere d’un’esecuzione dozzinale, nonostante il giudizio di Riccardo Bacchelli, il quale, avendo una volta da interpretare in modo penetrante come sa il carattere del Ciotto, le dedicò alcune delle sue frasi ornate. Opera più originale, o anzi addirittura geniale, è un altro giacente che entrando vedrete alla vostra destra, tenuto in alto da due mensole. Da quel suo vestire che infagotta dall’inguine in su sbuffando alle spalle e in giù fascia, si capisce che è un gentiluomo della seconda metà del Cinquecento. Ma guarda un po’ e chissà perché, la gente l’ha voluto Pier delle Vigne. Eppure è gente che qui s’è stabilita al posto dei “Saracini cani”, cari e fedeli agli Svevi; e dunque non certo perché tradì Federico – che non tradì – gli sputano in faccia, lo chiamano “Segnato da Dio!”, “Sansone”, “Traditore!”. O, maltrattandolo, vogliono essi manifestare il loro atavico e cattolicissimo rancore nel medesimo tempo che contro lo scomunicato Federico, e contro i suoi “grandi et arditi Saracini”, contro specialmente Pier delle Vigne che fu l’atleta, il Sansone, G. Ungaretti Lucera, città di Santa Maria 143 appunto, dell’Impero, l’uomo dotto che dettava le grandi pagine nella polemica di fuoco con Onorio III, Gregorio IX e Innocenzo IV? Questa schiettezza d’animo dei Lucerini, quest’ostinazione nell’odio, anche questo è dantesco. Spostano le mensole, Piero giace sempre più su, cercano colle buone e colle cattive di convincerli che non è educazione; ma uno schizzo ogni tanto, ciac, lo raggiungerà sempre: mirano a quel suo povero naso acciaccato. Statua orrenda nella sua impeccabile eloquenza: è uno scheletro beffardo, uno scheletro vivente: tutta l’amarezza del Seicento… Gli sputi sono una bella prova dell’errore dell’Egidi. Ma ce n’è ancora un’altra: siamo entrati in sagrestia e ci fanno vedere alcuni oggetti del tesoro, e il sagrestano alza un vecchio camice di lino, lo alza colle braccia in alto e non basta, sale su una sedia e non basta, sale su una scala: è un camice di quasi tre metri, c’è entrato dentro il fantasma d’un gigante. Appartenne al beato Vescovo Agostino Cassiota da Traú, il quale era un Domenicano, e non bastava, era uno che, anche senz’essere Domenicano, al solo vederlo si era piccini e si tremava. Fu qui dal 1317 al 1323 per sradicare i resti dell’eresia musulmana. Compito per il quale nella mente del popolo è rimasta l’idea che a finire di schiacciare tanto mostro ci voleva Ercole in persona, e un Ercole spietato. Omaggio reso al valore del nemico, valore dunque leggendario, e prova lampante – poiché dal sentimento alla fantasia non trova altra via per manifestarsi se non nella leggenda – del carattere in prevalenza religioso di tale inimicizia. Vollero perfino cambiarle nome. Urlarono i fanatici neo-Lucerini: «Città di Santa Maria!». Ma è più difficile cambiare di nome che di naso, e Lucera rimase Lucera, come la chiamano le storie antiche di Roma che la segnalano per la sua fedeltà. Gifuni torna alla sua biblioteca e mi fermo nel giardino del Municipio. È un vasto rettangolo che dà strapiombando nell’infinito della pianura. Fra le piante vi sorprende duramente un enorme leone di scavo, un leone romano di bardiglio, steso minaccioso sulle zampe anteriori. Fu trovato nel 1830 insieme a un altro uguale, ma a pezzi, «le cui ossa – come dice in un suo quaderno un antenato di Gifuni – furono buttate al vento». Ora guardo la città nel suo panorama e penso: «L’Egidi non deve avere avuto tutti i torti ragionando come ragionava. L’errore suo fu di non far dipendere mezzi – quelli economici nel caso che esamina – da ciò ch’è sempre fondamentale negli impulsi umani: la nostra vita morale». E penso che l’argomento meriterebbe uno svolgimento apposito tanto più che mi permetterebbe di rivedere certe mie riflessioni sull’architettura; e la Lucera dei Saraceni col Federico e il Manfredi rimpianti da Dante non merita forse un artico- 144 Verso Sud D. Grittani lo? Starò dunque a Lucera coi miei quattro lettori, anche la prossima volta. C’è un’altra memoria di Federico: un segno vivo: non ci sono piccioni qui in piazza; ma, come sulla Leonessa e il Leone, sul campanile si alza il falco, e si ferma sull’aria: ha trovato nelle ali infiniti equilibri… Figli dei figli di quei falchi ch’egli ha fatto venire qui per mettersi in grado di dettare il suo trattato di falconeria? Mentre starai per partire, il tempo si guasterà. Apparirà nel cielo un affrettarsi di nuvole nere. Come succede sempre, alla imminente bufera le pietre balzeranno. Nell’arretrarsi dei loro sangui e dei loro ori che fra il Leone e la Leonessa incupiranno, esse assumeranno una nettezza strana: un giorno consumato ringiovanirà, astratto, eterno, nudità finalmente lucida… [Tratto da Deserto e dopo, GIUSEPPE UNGARETTI, Mondadori, Milano 1961] 145 Lucera dei Saraceni Giuseppe Ungaretti Lucera, il 5 giugno 1934 Quando t’apparirà da lontano l’arco ogivale di Porta Troia e vedrai, in un volgersi immenso di solitudine, Lucera, dal chiarore infinito del grano, balzata sui suoi tre poggi, potrà succederti che alcuni fra i più avventurosi fantasmi della storia vengano a mettersi allato. Avvolto nel vento leggero che muove la loro invisibile cavalcata, seduto in fondo a una carrozzella stridula, forse di loro, che per accompagnarti corrono lentissimi, t’accorgerai mentre, a poco a poco vedendo dall’ombra d’un muro la povera bestia attaccata alla tua vettura uscire con tutto il lungo tenebrore del suo corpo, udendola nel sole accrescere la solitudine col suo trotto invalido, andavi pensando che la grande malinconia superstito dell’800 è il cavallo. Ti sembrerà che uno dei fantasmi stia dicendo: «Ben Abu Zunghi, farete ordinare per ciascuna delle nostre signore un manto foderato di martora, due camicie e due veli di lino, una gonnella colla mazzetta a fibbia… Capito?» L’altro ha risposto baciandosi la mano e portandosela solennemente alla fronte e al cuore. Ha capito: ha capito la lode indiretta; ma non ve ne accorgereste che da segni impercettibili: da vvero eunuco ha una pelle senza età, e ora dalla gioia gli s’è tesa sulla faccia più del solito; da vero guardiano di harem ha gli occhi giallastri, che per un momento ora la crudeltà non oscura. L’Imperatore, senza parlare, alzando un dito, lo rimanda con quelli del seguito, gli sorride di nuovo… Legata al cavallino impaziente di Federico II, ora t’accorgerai che dietro la sella c’è una bestia dagli occhi bendati. Bruscamente egli s’è girato, la scioglie, la prende in braccio, la lancia, e di lì a poco quella bella pantera di Barberia gli torna con una gazzella fra i denti… Senza lasciare la preda, la bella fa le fusa, strusciandosi alle gambe del cavallo… A questo punto, il “Poeta e Fautore di Poeti” crederà giunto il tuo turno della sua attenzione: «Vedi, m’è caro d’essere Cesare (“l’ultimo” Cesare, dirà Dante) e 146 Verso Sud D. Grittani (saranno ancora, a suo riguardo e del suo bennato figliuolo Manfredi, prole di Dante) m’è caro quindi di seguire in modo eroico e non plebeo la superbia. E per questo alla mia Corte, e dandone io stesso l’esempio, la lingua parlata salirà i primi gradini della poesia colta, e dal luogo del nostro Seggio Regale le prime poesie scritte in italiano si chiameranno per sempre siciliane… Sei sorpreso di trovarti qui fra questi Arabi, di vedere là quei cammelli? Lo so, dolce sorpresa per te, che ti fa ritrovare l’infanzia e la prima giovinezza trascorse nei loro focosi paesi… In Sicilia baroni e… monaci me li avevano messi contro… Li ho sconfitti, e, sottomessi, li ho trasferiti in massa qui: ventimila Infedeli fra vecchi, donne, fanciulli, uomini… Su quelle alture segregate e come sole al mondo, è il loro accampamento vivace… In quella città peripatetica, li ho trasformati da nemici nei miei cavalieri più sicuri… Non è stato difficile: anch’io li conosco e voglio loro bene da quando ero piccolo… Perché ho scelto Lucera? Guardala: per la stessa natura del terreno, città non solo alta, ma tonda: città militare di quella perfetta forma che Vitruvio prevedeva “affinché il nemico sia da più lungi scoperto”… Ora, guarda quella strada scoccata come una freccia: si conficca laggiù a venti chilometri, nel cuore di Foggia… Ecco: ho capito che Lucera poteva essere come il mastio di Foggia, come il possesso di tutto il Tavoliere… Pane e armenti e tributi a volontà: ti sembra poco per uno che fa la guerra? «Dunque avrebbero ragione l’Egidi e il Lenormant sostenendo che Vostra Maestà, e il Nasuto e il Ciotto, e più tardi Francesi e Spagnuoli contendendosi il possesso del Regno di Napoli, non avevate precipitandovi sulla Capitanata se non motivi economici?» «Economici? Ai miei tempi, questa parola non c’era ancora… Certo, certo… Avevo la mia fede… Nessun vero Capitano, né Alessandro, né Cesare, né Napoleone hanno fatto la guerra se non per una fede… Ogni tempo ha la sua…» E così dicendo colui che da piccolo chiamavano “il fanciullo di Puglia”, sparve… Federico è quello che è: un uomo grande, e cioè un uomo più che dei suoi tempi, di tempi che aiuterà a nascere. Impersona il Medioevo, la parte epica del Medioevo che è germanica, che è feudale, e nello stesso tempo si dà a promuovere l’Umanesimo, il che è come dire che s’era gettato a capofitto in un’azione contro sé stesso. Economia, economia? No, sono tanti i lieviti, era la natura, la storia, la Provvidenza: l’uomo è condotto misteriosamente… Quando sarai arrivato già dentro Lucera, al Belvedere, e da quell’ameno paesaggio ti sporgerai sul precipizio che va a cadere dove la pianura fugge, la città ti apparirà che si inalbera simile a un promontorio, a un salire dalle sue porte militari per G. Ungaretti Lucera dei Saraceni 147 amabili pendii verso il brusco orrore del vuoto. Tenderai allora l’orecchio per sentire se dall’alto d’un minareto non s’alzi ancora almeno un grido… Non ci sono più minareti in questa che fu “la Città senza Croci!”. E come saranno state, come sono immaginabili di mattoni, “non bianche”, le moschee? Dei “Saracini cani” non è rimasto nulla: qualche vasetto, qualche pezzetto di ceramica… Le memorie qui sono romane o angioine. Roma, Roma, Roma qui non finirà mai di risuscitare: la sua antichità in questa terra è inesauribile e l’altro giorno ancora in mezzo al Belvedere s’è aperta una fossa e s’è messa a buttare pargoli in fasce, giovi, veneri, bracci, piedi, falli: una vera montagna di terrecotte votive… Di Federico II non è rimasto se non un enorme slancio di pietre come una cappa sbranata che sta su per miracolo; se non un movimento raccapricciante di pietre paragonabile per audacia solo alla volta della Basilica di Massenzio. D’una residenza che dovette essere una delle meraviglie del mondo a giudicare da Castel del Monte, questo rimane… Ma come nascenti da questo bellissimo rudere, ecco dal Belvedere vedrai che là in cima si svolgono, invece della Cittadella araba, i 900 metri di cinta della fortezza alzata dal nasuto. È come una corona posata, e da questo punto sembra che basterebbe un venticello a smuoverla. Salirai. La vedrai nelle sue pietre sbiadite, d’un rosso e d’un giallo quasi bianchi, mossa e annodata nella sua quadratura da ventidue torri poligonali, e dal Leone e la Leonessa, moli cilindriche altissime e grosse d’una vertigine unica sulla ripidità della scarpa. Dal lato meridionale, sotto ci sono le fornaci, coi loro laghetti fra il grigio della creta che verrà cotta: una miniatura: un vero presepio colle pecore che ora passano: ahimè, una gran disgrazia per la fortezza! Quei fornaciai coi loro scavi hanno fatto sì che ora sono lesionate e pendono la Leonessa e tutta la cortina colle torri da quella parte. Trattandosi di terreni appartenenti al Comune, non dovrebbe essere difficile concedere ai fornaciai altre cave in punti, che non mancano, dove la loro opera non sarebbe se non proficua. Entrerai nella fortezza: nessuna rovina produce un maggior effetto di ampiezza disabitata, di piazza morta e senza confine… Nessuna m’ha lasciato un uguale senso d’opacità del destino, un senso così esagerato di scoramento… Vedrai ancora i fantasmi; il deserto della fortezza si popolerà dei Provenzali di Giovanni Pipino da Barletta… E, ecco, dal lato di Levante che guarda Lucera e Foggia, i “Saracini cani” tentano un estremo assalto: lo squallore della fame ha reso sguaiati quegli artigiani fini, e i Provenzali li uccidono come per giuoco, e agli uccisi alle volte spaccano sghignazzando lo stomaco per mettere allo scoperto la poltiglia del poco trifoglio strappato e divorato eludendo la sorveglianza… 148 Verso Sud D. Grittani Lo Svevo non ha lasciato qui che un brandello di muro? C’è qui un altro suo segno: l’altare del Duomo e quella sua mensa di Castel Fiorentino, alla quale invitava a sedere insieme vescovi e ulema per ridere nel vederli guardarsi in cagnesco. Non fu guerra religiosa? E perché quella mensa è stata messa lì, se non in segno di riparazione? [Tratto da Deserto e dopo, GIUSEPPE UNGARETTI, Mondadori, Milano 1961] PARTE VI Rocchetta Sant’Antonio 151 Rocchetta la poetica Francesco De Sanctis Francesco De Sanctis (Morra Irpino, oggi Morra De Sanctis 1817 - Napoli 1883). Il celebre storico della letteratura italiana pubblicò un’originale opera autobiografica dal titolo Un viaggio elettorale (1876), diario romanzato che racconta le vicissitudini della candidatura di De Sanctis alle elezioni politiche del 1875 nel collegio Foggia-San Severo. Decretata la rinnovazione del ballottaggio, dissi: ora vado io là. E andai. Venivano meco due miei concittadini, Achille Molinari e Salvatore Derogatis. Giunsi a Foggia domenica sera, il 10 gennaio. L’altra domenica era il dì posto per il ballottaggio. Avevo sei giorni innanzi a me. Capitai improvviso in casa di Giovanni de Sanctis, dov’era pure un albergo. Colui me lo aveva fatto conoscere uno di quegli amici che la mente porta seco sino alla morte, Giorgio Maurea. «È qui Giorgio?» domandai. «No, è partito ieri. Ma ci sono tutti i vostri amici di Foggia, che sarebbero tanto lieti di stringervi la mano.» «Sarà per un’altra volta. Ora acqua in bocca. Ho bisogno che San Severo ignori il mio arrivo qui. Non voglio ch’essi dicano: De Sanctis è stato a Foggia, e non è venuto a vederci». Rimasi solo. I miei pensieri andavano veloci, come i miei passi... Se io andassi a San Severo! Tre quarti d’ora, e sarei a San Severo. Cosa è l’uomo! Io ho là un nido riposato e sicuro, là stimato da tutti, amato da molti, e debbo correre appresso alle ombre, cacciarmi tra monti e dirupi in paesi meno civili, dove pochi mi conoscono, e nessuno quasi mi comprende, e dove il mio nome è trastullo delle loro piccole lotte e piccole passioni. Tu non sei più un giovinotto, mi dice Marietta mia; pensa che t’incammini verso la vecchiaia. E ora, nel cuore dell’inverno, con tanti anni addosso... Ma respinsi questi pensieri come una tentazione. Questa è, dissi tra me, 152 Verso Sud D. Grittani quella tale seconda voce, che è sempre una traditora. Ubbidiamo alle prime ispirazioni che vengono dal cuore. Maggiore è il sacrifizio, e più grande sarà la soddisfazione della coscienza. Alto là! rispose un’altra voce. Tu posi, come un Iddio. Guarda bene in queste tue ispirazioni del core, e ci troverai un po’ di passioncella, un po’ d’impegno, un dispettuzzo, e forse anche una piccola vanità. Tu non vuoi apparire uno sconfitto. Mi esaminai, e sentii che questa voce non avea tutto il torto. E rimasi perplesso. Camillo de Meis aveva un po’ di ragione, quando mi chiamava un Amleto vagabondo tra le voci del pensiero. Io non sono un Amleto, ma sono pigro, e non mi movo se non ho una buona spinta dagli avvenimenti. Ma se mi movo, io vivo là entro e ci metto tutto me, o scriva, o insegni, qualsiasi cosa io faccia. Piccola o grande, buona o cattiva, una passione c’era in me che mi traeva seco. Ed io non l’analizzai più; le ubbidii. La mattina giunsi a Candela, e trovai per avventura alla stazione un agente di casa Ripandelli. Antichi legami, avevo con quella casa, fortificati da nuova amicizia col mio Ettore, già mio collega, perfetto gentiluomo e perfetto amico. Non trovai nessuno, ma quel bravo agente, saputo il mio nome e la mia intenzione, mi fece gli onori di casa, e mi si offerse compagno al viaggio. Fu spedito un corriere a Rocchetta di Sant’Antonio, la porta del mio collegio da quel lato. Doveva annunziare il mio arrivo, e consegnare una mia lettera al Sindaco. Chi fosse il Sindaco, non sapevo. Ma, conoscendo le piccole gelosie de’ paesi, è stato sempre mio costume di indirizzarmi ai sindaci, come quelli che rappresentano tutta la cittadinanza. Scrivevo al Sindaco: «Vengo costà, diretto alla casa comunale, la casa di tutti, e voglio parlare a tutti gli elettori, senza distinzione. Ne dia avviso specialmente all’arciprete Piccoli, mia vecchia conoscenza.» Alcuni non credettero vera la lettera. Nelle lotte elettorali tra gli altri bei costumi ci è falsar telegrammi e lettere. È proprio sua questa lettera? E mentre disputavano fu annunziata la mia carrozza. Allora si posero a cavallo tutti, e mi vennero incontro. Alla voltata mi fu mostrato quello spettacolo. Gridavano: Viva! Mi salutavano con le mani, impazienti di stringer la mia. E la faccia mi raggiò, come se l’anima fosse scesa lì. Fra molta folla giunsi alla casa Comunale, e mi feci presentare gli elettori ad uno ad uno. Strinsi la mano a parecchi, e tra gli altri a Ippolito e Piccoli, che passavano per miei avversari. Poi dissi così: «Saluto con viva commozione Rocchetta, la porta del mio collegio nativo. Il luogo dove son nato è Morra Irpino; ma la mia patria politica si stende da F. De Sanctis Rocchetta la poetica 153 Rocchetta insino ad Aquilonia. Io vengo a rivendicare la patria mia. Dopo un oblio di quattordici anni, voi miei concittadini, travagliati da lungo ed ostinato lavoro di parecchi candidati, avete all’ultima ora improvvisata la mia candidatura, ed avete intorno al mio nome inalberata la bandiera della moralità. Siate benedetti! E possa questa bandiera esser principio di vita nuova! Voi mi avete data una maggioranza notevole. Eppure quell’elezione gittò il lutto nell’anima mia. Io vi avevo telegrafato: Bravi gli elettori che intorno candidatura improvvisata inalberarono bandiera moralità! Auguro a quella bandiera strepitosa vittoria domenica. La domenica venne, la vittoria ci fu, e mi parve una sconfitta. Non mi sapevo dar ragione di tanto accanimento nella lotta, e del gran numero di voti contrari, e di certe proteste vergognose, che gittavano il disonore su questo sfortunato collegio. E in verità vi dico, che se quell’elezione fosse stata convalidata, con core sanguinante, ma deciso, vi avrei abbandonato. Ma benedissi quelle proteste che indussero Giunta e Camera a decretare la rinnovazione del ballottaggio. Era in questione l’onor mio, l’onore dei miei elettori. Ed io dissi: fin’ora sono stato in Napoli spettatore quasi indifferente di quella lotta. Non debbo io fare qualche cosa per questi elettori? Non mi conoscono, sono involti in una rete di menzogne e di equivoci. Io ho pure il debito d’illuminarli, di dire la verità, di togliere ogni scusa agli uomini di mala fede. Ed eccomi qui in mezzo a voi, miei cari concittadini. Ed ecco la verità. Il Collegio è diviso in due partiti che lottano accanitamente, comuni contro comuni, cittadini contro cittadini, ed io non sono qui che il prestanome delle vostre collere e delle vostre divisioni È così che volete rendere la patria a Francesco de Sanctis No, io non potrei essere mai deputato di un partito per schiacciare un altro partito; non posso essere lo scudo degli uni e il flagello degli altri; io voglio essere il deputato di tutti, voglio lasciare nella mia patria una memoria benedetta da tutti. Mi volete davvero? Volete che io passi gli ultimi miei anni in mezzo a voi? Stringete le destre, sia il mio nome simbolo della vostra unione. Ed io sarò vostro per tutta la vita.» La commozione fu grande. Vidi alcuni piangere; altri, avversari ieri, amici oggi, stringersi le mani. Tutti applaudivano. Ed io soggiunsi: «Signor Sindaco, ho pranzato a Candela, voi ci farete una cenetta, e voglio fare io il padrone di casa, voglio invitare i signori Ippolito e Piccoli. Mangeremo lo stesso pane, berremo lo stesso vino, faremo un brindisi a Rocchetta unita e prospera.» Benissimo! benissimo! Tutti batterono le mani. Rocchetta non dimenticherà più quel giorno. Prese allora la parola l’Arciprete Piccoli. Giovine e asciutto di viso, occhi vivi, avea nella fisionomia una cert’aria di finezza che non ti affida interamente. Rotto agli affari, uso a destreggiarsi mescolato in lotte locali, rimpiccolito in quel paesello, 154 Verso Sud D. Grittani mi parve che in teatro più vasto sarebbe riuscito un buon diplomatico. Mi disse molte gentilezze, con certi giri di frasi, che volevano dire: vedi, anch’io ho fatto i miei studi. Parlò poi Ippolito. Faccia austera, aria risoluta, parola semplice e diretta. Disse che, dissipato ogni equivoco, Rocchetta sarebbe stata unanime e desiderava che questo giorno fosse stato il preludio di unione sincera e durevole. Erano sentimenti di buon cittadino. Gli strinsi la mano con effusione. Notai un prete, molto attento al mio dire, ma sentii che non avevo fatto presa su di lui. Era in quel viso non so che di oscuro e compresso. Più tardi troverò io la via di quel cuore. Dopo cena, mi coricai subito. Sentivo sonno. Ma che sonno e sonno! Mi passavano innanzi le ombre della giornata. Vedevo l’arciprete Piccoli a cavallo correre, correre con quel suo cappello a tre pizzi, che mi parea sventolassero. Ferma, ferma. E tutta la cavalcata dietro. Come galoppava bene quel prete! Il povero Alfonso, ch’è il letterato del luogo, tirava forte le redini e faceva sì e no sul cavallo che poco lo capiva. Un altro prete mi stava accanto, rubizzo e mezzo secolaresco, con aria sicura, su di un cavallo che andava passo passo in grave atteggiamento, come uno di quei cavalli educati da Guillaume. Rocchetta si avvicinava, e quel gruppo di case in quel chiaroscuro mi parevano uomini che m’attendessero e gridassero: Viva! Le immagini si confusero: ero stanco e sentivo freddo. E mi accoccolavo, e mi strofinavo le gambe. Mi volsi dall’altro lato, non c’era verso di dormire. Ed ecco un suono di chitarra giungermi all’orecchio, con un canto a cadenze e a ritornello, tra gran folla di contadini, che battevano le mani e mi gridavano: Viva! Bravo Rocchetta, diss’io. Mi accoglie a suon di poesia. E tesi l’orecchio, ma non potei raccapezzar verbo di quella canzone. Lungo tempo cantarono e gridarono; forse quella brava gente avrebbe voluto vedermi, sentirmi. Poi a poco poco si fe’ silenzio, ma quel suono mi errava deliziosamente nell’orecchio. Io mi applaudiva di quell’accoglienza. E se tutti gli altri comuni rassomigliano a Rocchetta, chi potrà più separarsi da questo collegio? Che potenza ha la parola, pensavo, la parola sincera e calda che viene dal cuore! Io conquisterò con la mia parola tutto il collegio, e la mia conquista sarà un beneficio, lenirà i costumi, unirà gli animi. Ma la voce del buon senso rispondeva: credi tu di poter fare miracoli? Sei ben certo che tu, proprio tu hai procurata questa riconciliazione? Qui la materia era già ben disposta. Sarà il medesimo a Lacedonia? E un qualcuno m’aveva già detto: a Lacedonia non sarà così. Fantasticando, sofisticando, mi addormentai. La mattina girai un po’il paese. Faccie allegre e sincere, bella e forte gioventù. A destra, a sinistra, gruppi che mi salutavano. Volli vedere cantanti e sonatori, e dissi loro che volevo battezzare quel paese così allegro, e lo chiamai Rocchetta la poetica. F. De Sanctis Rocchetta la poetica 155 E vennero le visite. Rividi la Luisa, a cui ero stato fidanzato giovanissimo, ora madre felice di robusta e allegra prole. «E, buon per te - le dissi - che si fecero le nozze. Che vita avresti avuta appresso a me! Prigioni, esili e miseria. Tu hai avuto più giudizio di me, e ora sei ancora una rosa». Fui in casa Piccoli. E mi venne incontro un altro prete, faccia chiara e aperta che faceva contrasto con l’aria arguta del fratello arciprete. Vidi casa antica, illustrata dalle immagini degli antenati, guardata con sospetto da case nuove di gente laboriosa e industriosa. Feci altre visite. Attento! dicevo tra me. Un tal prete Marchigiani non visitato mi divenne in Sessa nemico inespugnabile. Eppure dimenticai uno, quel prete dal viso oscuro. E credo che me ne volle. Credo. Giunse il sindaco di Lacedonia con parecchi altri. Si fece una sola cavalcata e via a Lacedonia. Io mi sentivo purificato. Venuto con un disegno non ben chiaro, e con molta passione, alla vista dei miei concittadini non ci fu in me altro sentimento, che di riacquistar la mia patria. Essi m’avevano già conquistato; dovevo io conquistar loro, guadagnarmi i loro cuori. E la cosa mi pareva facile. Rocchetta la poetica aveva trovato il motto dell’elezione. Nel partire, serrandosi intorno a me, gridavano: «Tutti con tutti.» Ed io, rapito, risposi: «E uno con tutti.» Era realtà? Era poesia? In quel momento era realtà. Le mani si levarono. Pareva un giuramento. Tutti ci sentivamo migliori. [Tratto da Un viaggio elettorale, FRANCESCO DE SANCTIS, Napoli 1876] 157 Passaggio in ombra Mariateresa Di Lascia Mariateresa Di Lascia (Rocchetta Sant’Antonio 1954 - Roma 1994). Per la prima volta la provincia di Foggia sale sul gradino più alto del Premio Strega, e lo fa con un romanzo caratteriale ambientato in una terra arida di grandi eventi ma non certo di emozioni. Passaggio in ombra, così come Il Gattopardo, pur essendo un’opera postuma s’impone nel più prestigioso premio letterario italiano, e così come capitò per il memorabile romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (“cestinato” dalla Einaudi per volontà di Elio Vittorini) diviene un bestseller dopo essere stato rifiutato dai più grandi editori italiani. Tranne che da Gabriella D’Ina (direttore editoriale della Feltrinelli) che lo pubblica nel gennaio del 1995, a pochi mesi dalla morte dell’autrice. Nella casa dove sono rimasta, dopo che tutti se ne sono andati e finalmente si è fatto silenzio, mi trascino pigra e impolverata con i miei vecchi vestiti addosso, e le scatole arrampicate sui muri scoppiano di pezze prese nei mercatini sudati del venerdì. Ormai sono libera di non perderne neanche uno, e ho tutta la mattina per stare in mezzo alle baracche a rovistare a piene mani, fra stoffe colorate e sporche che qualcuno, per sempre sconosciuto, ha indossato tanto tempo fa. (...) Da ragazza mi vestivano come un’attrice del cinema, e io guardavo il mondo con i miei occhi di pupa di pezza, lunghi e ricciuti come le ali, di una farfalla. Nessuno si accorse mai che l’occhio destro era completamente cieco per una macchia che mi era venuta fin da bambina, contro la quale non hanno saputo fare nulla neanche i medici che poi ho incontrato nella vita. Avevo i capelli biondi e una testa leonina che si faceva guardare quando camminavo, immersa nei miei pensieri, e le macchine si fermavano bruscamente per non travolgermi sulla strada. Ho vissuto in ogni città di questo paese e non ho potuto fermarmi, inseguita com’ero sempre dai mille mostri atroci della mia fantasia. Sono andata pellegrina di strada in strada, di casa in casa, cambiando pure i bar dove mi 158 Verso Sud D. Grittani piaceva prendere il caffè della mattina, perché non trovassero le mie tracce. Le tracce dei miei racconti di principessa esule su questa terra senza anima, dove i miei polmoni hanno trovato difficile perfino respirare. (...) [Tratto da Passaggo in ombra, MARIATERESA DI LASCIA, Feltrinelli, Milano 1995] PARTE VII Bovino 161 Il vallo di Bovino Pietro Paolo Parzanese Pietro Paolo Parzanese (Ariano di Puglia 1809 - Napoli 1852). Poeta, docente di teologia, autore delle opere Canzoni popolari (1841), Canti del Viaggianese (1846) e della tragedia pubblicata postuma Sordello (1911). Abile traduttore di Hugo, Byron e Lamartine, compose la prosa Il vallo di Bovino durante un viaggio in Puglia compiuto nel 1845. Tacito, solo, e senza compagnia, me ne portavano i tre sparuti ronzini, attraversando le pianure di Camporeale le quali si stendevano come un tappeto di verzura un cotal poco gialleggiante; ed il sole inviandovi su qualche raggio furtivo, vi suscitava mille gradazioni di colori bellissimi. In questo prendemmo a discendere verso la valle irrigata dal fiume Cervàro, e guardammo con un po’ di stizza rotti i canali e dissipate le acque che mettevano nella fontana fabbricata per comandi di Re Carlo III, in capo al ponte. Io non sono di quelli che vogliono scritte in latino eziandio le tabelle de’ barbieri e de’ macellai: ma qualora mi viene sott’occhi una bella epigrafe latina, scritta con attica semplicità, e che non sia una noiosa ripetizione delle solite frasi imparate a scuola, me ne viene un gran piacere all’animo, e parmi di sentire rinascere nel mio petto la dignità de’ nostri avi conquistatori del mondo. E però non fu mai, che passassi d’innanzi alla fontana di Camporeale, che non rileggessi la stupenda iscrizione di Mazzocchi uno di quegli uomini di cui il simile non può impastarsi così presto. Che severità di stile! che nitor di parole! e come ne balza chiaro e nettissimo il concetto! Fu un tempo, che mi adoperai a volgere in italiano la epigrafe mazzocchiana: come vi sia riuscito non so; ma questo è utile studio a chi volesse addestrarsi a scriverne delle italiane. Questo cammino, o viandante, innanzi per lo stroppio degli animali immeritatamente detto CAMPO-REALE 162 Verso Sud D. Grittani CARLO RE DELLE SICILIE: P. A. F. PROVVEDENDO ORA A TANTO DISAGIO. APPIANATO IL SENTIERO ED AGGIUNTE LE DELIZIE DI UN’ACQUA PERENNE, IL. LUOGO AL NOME ACCONCIÒ A. D. MDCCXXXVII. In sul finire della discesa, e propriarnente dove il fiume facendo gomito divide Principato Ulteriore da Capitanata, stavasene diritto e immobile, come una statua, un giovinotto vestito con uno di quei camicini, che oggi dì si usano per viaggio da’ forestieri, siano signori baroni, siano venditori di coperte o di zolfanelli. All’avvicinarsi della nostra carrozza si appressò anch’egli, e in buono italiano disse al cocchiere: - Potrei avere un posto in carrozza? - Signore non posso accontentarvi; dacché dentro non si vuol compagnia: se volete acconciarvi ... - Sulla tua seggiola: tanto meglio, chè almeno potrò fumare senza recar fastidio a nessuno: e così dicendo, già saltava lesto e svelto per adagiarsi in sul di fuori: ma io non glielo consentii, e lo pregai volesse entrare in carrozza. Era un buon francese, il quale per i suoi negozi dimorava da parecchi anni nel nostro regno, ed allora viaggiava alla volta di Foggia. un po a piedi un po’ in vettura come gli tornava più opportuno; ma ciò solamente per giovanile bizzaria, a quanto mi parve; perchè la borsa aveva piena di bei gruzzoletti di oro e di argento. Non passarono tre minuti, ed eravamo già entrati di uno in altro ragionare, con quella disinvolta speditezza ch’è tutta propria de’ Francesi. Nelle lettere e nella storia mezzanamente informato, I’italiano parlava con qualche nettezza; ne’ modi pieno di urbanità e di cortesia. Non essendo letterato di professione, nè viaggiatore poeta, di noi e delle nostre cose parlava senza disprezzo: e la bontà del nostro ingegno confessava non temer paragone, nè per nemico volger di tempi potersi arrugginire. Ascoltandolo così parlare a me venivasi allargando il cuore, e se non fosse stato segno di troppa dimestichezza, me lo avrei abbracciato e baciato quel buon francese. Quanto diverso da molti suoi concittadini, i quali in versi e in prosa vomitano ogni mille bestemmie contro il nostro paese! O Esopo, e dove te ne stai, che non vieni a ricantare in faccia a costoro la favola dell’asino che tira un calcio al leone? Intanto che io così fantasticava e guardava la nebbia che lenta levavasi dal Cervàro, come fumo che sbocchi dal fondo di una fomace; il Francese con grande curiosità stavasi a sbirciare per entro una lente i due villaggi di Savignano, e di Greci, che l’uno contro l’altro si guardano dalla cima di due monti ripidi, scoscesi, selvaggi. Sono come due castelli fabbricati a guardia dell’ingresso che mette in quella lunga gola chiamata il Vallo. Su per una viottola che serpeggia un lato del monte, a sinistra P.P. Parzanese Il vallo di Bovino 163 tutta scheggiata e pietrosa, salivano in fila, come le grù, una quindicina di fanciulle, recandosi ciascuna sulle spalle accomodato a due funi un fascio di legna: e con molta armonia cantavano a coro una canzone, che nè io intendeva, nè il mio compagno. «Udite, come vanno di accordo quelle voci, e quanta passione si chiude in quel canto: ma per tendere che io faccia l’orecchio non ne capisco una parola: è pur difficile la vostra lingua!» «Voi v’ingannate. Signore’ io gli risposi; giacchè le parole di quel canto non sono mica italiane; e per quanta pratica io abbia di quella buona gente, non mi è riuscito giammai di impararne la lingua!» «Se non vi spiegate più chiaro’ è come se udissi il borbogliare di un fiasco.» «Eppure la cosa è naturalissima. Gli abitanti di quella terra situata lassù a sinistra non sono che una colonia di albanesi, venuti per quanto si dice a combattere contro i vostri avi, e capitanati dal celebre Scanderberg; or come potremmo intenderne la lingua, ch’è tuttora quella de’ loro padri?» «Ora capisco: e mi ricordo di averne udito a parlare anco in Napoli, dove mi han detto delle cose curiose intorno a’ costumi ed all’indole di cotesti albanesi italianizzati.» «Ma di questi costumi molto già si è perduto, e fra pochi anni, non rimarrà forse neppur memoria delle usanze superstiziose ed un po’ selvagge di questo popolo. Nella Basilicata sono molte terre di albanesi, poste qual dentro le gole de’ monti, e quali presso i boschi: contrabbandieri e banditi ferocissimi furono ne’ tempi passati, e molte istorie si raccontano di loro, piene di ferocia e di sangue. Guardate quell’uomo sulla porta della taverna, che ora mi fa di cappello: consideratene l’aspetto: quegli è un albanese. Bruna la carnagione, neri i capelli, fiera la guardatura, tumido il labbro; di questa stampa son quasi tutti gli albanesi, risoluti e di cuore. Gelosi delle loro donne, fino a lasciarsi per esse condurre a feroci delitti: ospitali sì, che un forestiero è sempre il ben venuto, e siede con loro presso il focolare come se fosse della famiglia. Usano come bevanda pregiata un vino generoso entro cui sono bolliti aromi forti ed inebbrianti; e pel forestiero ve ne ha sempre la sua tazza: lo chiamano vino caldo (ingroght). Nelle nozze e ne’ mortori hanno particolari cerimonie, ed usanze tradizionali. Alla nuova sposa la madre del marito presenta un pane, una pentola di olio, e forse anche la conocchia; nel che vuole raffigurarsi la cura delle domestiche faccende, dalla suocera ceduta alla sua giovine nuora, come per riposarsi nella vecchiezza. Nè il fidanzato recasi la sposa a casa senza aversela prima conquistata; perchè gli è mestieri rapirla di mezzo ad un cerchio di fanciulle, che tenendosi pcr mano le danzano attorno, e la difendono di tutta forza; onde spesso avvienc che qualche povero giovine nc riporti delle busse e delle ferite. 164 Verso Sud D. Grittani Tra le donne ve ne ha delle belle con occhi neri pieni di baldanza una bellezza come quella delle arabe, se ci dicono il vero i viaggiatori. Amano il canto, e la voce hanno limpida e passionata. In una canzone di amore che mi venne traducendo parola per parola un mio amico albanese, si vede chiaro, che in questa gente anche la più delicata passione è senza sguaiataggine, e piena di vero affetto. Sono due fidanzati che cantano a vicenda. Udite, se vi piace: «La donna mia è tra le belle bella: Nero l’occhio ed il crin La vidi all’alba e mi parea la stella Che si affaccia al mattin. - L’amico mio è bello e giovinetto Come un grappolo di or. A vederlo appoggiato al suo schiappetto Sentii tremarmi il cor. La donna mia va sola alla fontana Che sta in fondo al burron: Da una macchia mentr’ella si allontana, io ne odo la canzon. L’amico mio va solo alla foresta». [Tratto da Un viaggio di dieci giorni in Puglia, incluso nell’opera Poliorama pittoresco, Anno X, PIETRO PAOLO PARZANESE, Napoli 1845] PARTE VIII Cerignola 167 Lettera da Cerignola Justus Tommasini Viaggiatore tedesco che attraversò la Puglia verso la prima metà dell’Ottocento, Tommasini descrisse l’esperienza del suo faticoso viaggio in un suggestivo diario dal quale abbiamo estratto questa lettera scritta da Cerignola nell’autunno del 1825. Cerignola, 26 ottobre 1825 Anche la strada che da Trani porta a Barletta costeggia il mare. Fra le due località si vedono meno campi coltivati di quanti non se ne vedano in genere sulla costa. Barletta è una città dall’aspetto un po’ antico, con case alte, costruite con lastroni di pietra calcarea. Le opere di fortificazione che la circondano sono di scarsa importanza. Fuori della città si erge un castello di modeste proporzioni. Il porto ha un aspetto strano. Il molo, infatti, si incunea nel mare sino all’altezza di un secondo molo trasversale fonnato in parte da una roccia naturale, a ridosso del quale si trovava un numero infinito di brigantini. Era da Napoli che non ne vedevo tanti in una volta. Da questo molo si ha uno scorcio stupendo su tutta la costa, ma soprattutto sul Gargano che si protende a sinistra verso il mare. Per godermi il panorama non mi è certo mancato il tempo. Mi avevano detto, infatti, che, per ritirare il mio passaporto, non essendosi il sottintendente ancora alzato, sarei dovuto ripassare dopo due o tre ore. Avrei volentieri visitato le rovine di Canne che si trovano non lontano da qui, non tanto per le rovine in sé che saranno sicuramente di epoca posteriore e di scarso interesse, ma per la particolare configurazione del Canne della Battaglia. Il passaporto rilasciatomi da quei maledetti organi di polizia mi vieta, però, ogni deviazione dall’itinerario prestabilito. Da Barletta sino all’Ofanto la strada costeggia il mare. Dopo avere attraversato il fiume su un lungo ponte di legno. ci s’inoltra verso l’interno dove continua la serie di masserie e di terreni coltivabili. San Cassano, un piccolo centro abitato, si 168 Verso Sud D. Grittani trova a poca distanza dalla strada; a sinistra, dove incominciano a delinearsi i contorni delle prime montagne. Si scorge, in cima ad una roccia, Castel del Monte, e, a destra, verso il mare, l’importante Casale della Trinità e, nelle prossimità, le saline. La campagna è ora meno coltivata con delle masserie sparse qua e là mentre la carrozzabile, come già nel tratto Taranto-Lecce, a tratti è interrotta. Cerignola è una cittadina passabile con una locanda piú che discreta. L’oste, napoletano di nascita, mi ha chiesto i numeri del lotto, che gli ho dato, e, per ricompensanrmi, mi ha offerto una bottiglia di ottimo vino che, come mi è stato subito precisato, non sarebbe stata messa sul mio conto. Auguro a quel galantuomo che la sua bottiglia gli ritorni centuplicata, ma, quand’anche vincesse, è certo che non ne avrò alcun merito. Verso sera, provenienti da Bari, sopraggiunsero due cavalieri che subito riconobbero in me la persona di cui avevano già sentito parlare per via dell’arresto. Il primo cavaliere, un uomo un po’ grossolano, eccessivamente premuroso e gentile’ mi dà l’indirizzo di una locanda di Foggia, la cittadina dove sono diretto, dove pernottare e si rallegra sin d’ora del piacere che avrà di rivedermi. È chiaro che ha in mente qualcosa, ma non sono così bravo da indovinarlo. [Lettera di Justus Tommasini tratta da Viaggiatori tedeschi in Puglia nell’Ottocento, a cura di TEODORO SCAMARDI, Schena, Fasano 1992] 169 Da Cerignola a Canne della Battaglia Friedrich Leopold Stolberg Friedrich Leopold Stolberg (Bramstedt 1750 - Sondermühlen 1819). Apprezzato poeta tedesco, dopo la conversione al cattolicesimo Stolberg compose il poema apocalittico L’avvenire (1781) e il saggio Storia della religione di Cristo (1806-18). Sul finire del Settecento visitò a lungo la Puglia, regione dalla quale restò suggestionato al punto da ambientarvi gran parte dell’opera Viaggio in Germania, Svizzera, Italia e Sicilia (1822). Barletta, 4 maggio 1792 (...) A Cerignola, cittadina ben costruita, si rinviene ancora una pietra miliare romana con un’iscrizione del tempo di Traiano. Nella locanda si radunarono molte persone e, secondo l’usanza locale, anche la nostra stanza venne invasa dalla gente che ci guardava a bocca aperta come se fossimo delle marmotte. Ci ponevano domande sulla nostra terra natia, sul nostro viaggio e poi parlavano del loro paese, del campo di battaglia di Canne, delle antichità della zona. Il nostro gentile oste mandò a chiamare un certo Signor Giovanni Danielle, un giovanotto molto istruito che era ben informato e della regione e degli scrittori antichi. Con grande calore ci parlò del suo conterraneo Orazio, la cui città Venusium (ora Venosa) dista da Cerignola soltanto 18 miglia. Da lui appresi che l’Atabulus, che secondo Orazio dissecca i monti della Puglia, sarebbe un vento d’oriente scottante, chiamato ora dai pugliesi Altino. Egli ci fece vedere, da un colle, il golfo di Manfredonia e il Monte S. Angelo. Con il tempo limpido si dovrebbe scorgere anche Manfredonia e i resti dell’antica Arpi, fondata da Diomede. Non lontana da Cerignola si trovava l’antica Salapia, le cui rovine conservano il nome Salpe. Don Giovanni possedeva una casa di campagna proprio vicino a Salpe, dove dei lavoratori, mentre zappavano la terra, alcuni anni fa, rinvennero un vaso antico di grandi dimensioni, la cui imboccatura era sigillata accuratamente con piombo. Nella speranza di trovarvi del denaro, l’aprirono ma vi era soltanto dell’acqua molto 170 Verso Sud D. Grittani profumata. È usanza in tutta l’Italia del Sud e Sicilia di chiamare le persone con il loro nome di battesimo. Ma insieme al nome non si usa dire Signore, ma Don. Alla stessa maniera degli inglesi che mettono Sir davanti al nome del baronetto e del Cavaliere: Sir Isac, come Don Giovanni Don Giuseppe ecc. Colmi di delusioni per essersi ingannati, capovolsero il vaso, versando questa preziosa acqua di nardo, che diffuse, per ben tre giorni,un profumo gradevole nei dintorni. Si sa bene quale importanza attribuissero gli orientali, ma anche i greci e i romani, a quest’acqua di nardo. Durante la nostra passeggiata si era sparsa la voce della presenza di alcuni strani forestieri, e così si unì a noi un cospicuo seguito di curiosi. Alcuni ci seguirono persino nella stanza. L’oste pregò Iacobi di annotargli i nostri nomi con relativi indirizzi, in modo da potersi, per sua tranquillità, informarsi per lettera se eravamo ben rientrati. Don Giovanni ci ha accompagnato oggi a Canosa e a Canne, divenuta molto famosa per le vicende dei romani. Attraversammo il fiume Ofanto, l’Aufidus degli antichi. Già in questa stagione si abbassa notevolmente e a metà estate dovrebbe trasformare il suo largo letto di ciottoli in un ruscello; però in autunno e in inverno diventa impetuoso, meritandosi l’appellativo longe sonans, datogli da Orazio (IV, od.), ancora talvolta dovrebbe inondare i campi come al tempo dei poeta, che paragona questa corrente al giovane guerriero Claudius, figliastro di Augusto: Sic tauriformis volvitur Aufidus qui regna Dauni praefluit apuli, cum saevit horrendamque cultis diluviem meditatur agris. La Canosa odierna occupa soltanto una parte dell’antica città di cui si vedono ancora alcune tombe, una porta e i resti delle mura. Volentieri avremmo rintracciato la tomba della buona Busa, una nobile matrona che, dopo la battaglia di Canne, aveva rifornito generosamente di cereali, vestiti e denaro quattromila profughi romani, ai quali i cittadini di Canosa avevano dato alloggio, e per questo essa fu elogiata pubblicamente dal Senato (Tit. Liv. XXII c. 52). Su consiglio di Orazio, avevamo portato con noi del pane da Cerignola e avevamo fatto molto bene. Nam Canusi lapidosus. Il pane di Canosa è in effetti ancora oggi duro come la pietra e peggiore di quant’altro io abbia trovato in Italia, dove in molti luoghi il pane è cattivo. A buon diritto si attribuisce ciò alle macine dei mulini che a Canosa sono troppo morbide. Ma com’è mai possibile che gli abitanti da oltre diciotto secoli non abbiano pensato a procurarsi macine più idonee? Nella chiesa principale, un edificio gotico per il resto insignificante, vi sono sei colonne di verde antico. Vicino a questa chiesa è sepolto il Cavaliere Boemondo, reso immortale dalla Gerusalemme Liberata di Tasso. Con Livio alla mano ammirammo il campo di battaglia di Canne. In quale maniera la visione di quei luoghi fa F.L. Stolberg Da Cerignola a Canne della Battaglia 171 rivivere le vicende del passato, dando forma e colore alle loro ombre errabonde! La descrizione di Livio è eccellente! Potremo chiaramente vedere dove si trovava Annibale che schierava l’ala sinistra verso l’Aufidus e l’ala destra sulle dune, dalla parte del mare. E come i romani avevano in faccia il vento di Sud-ovest che spirava dal monte Volture (ventum Volturum) e, nello stesso tempo, il sole del pomeriggio. La battaglia si svolse nel periodo della vendemmia. Come allora, anche adesso il sole scottante del pomeriggio ci colpiva e il vento di Sud-ovest soffiava dal Volturno sulla pianura sabbiosa, sollevando con sé polvere. Non si è voluto comprendere come mai i romani fuggitivi abbiano cercato di salvarsi verso Canosa e non attraverso il fiume ! L’Ofanto infatti d’estate si abbassa sempre più in modo da poter essere attraversato; anche una parte della legione romana, che era accampata sull’altro lato, era passata all’attacco attraversando il fiume. Ma non si tiene conto però che, nella ritirata generale, i fuggiaschi si riversarono in tutte le direzioni e che soltanto un piccolo manipolo, a cui forse l’ottima cavalleria cartaginese aveva tagliato ogni via di salvezza, era riuscita a rifugiarsi a Canosa. Né si può escludere che lo stesso Annibale abbia gridato al suo esercito vincitore: fermatevi, risparmiate i vinti! Sotto una duna scorre una sorgente rumorosa ricca d’acqua. La tradizione vuole che Paulus Emilius, mentre le sue ferite lo dissanguavano, si fosse qui dissetato prima di morire. Questa intera regione è molto brulla. Vicino a Barletta si trovano però magnifici campi di grano e vigneti, le cui viti non si tirano su più di un cubito. Si sostiene che in questa maniera il vino maturi nel migliore dei modi, poiché il calore della terra, attraverso il terreno roccioso, penetra meglio negli acini dei grappoli. Il vino di questa zona è un rosso forte e focoso. Dato che si vende a buon prezzo, come da noi la birra, il vino era diventato per gli svizzeri, che tempo fa occupavano Barletta, causa di danno e pericolo per la quantità smisurata da loro trangugiata. (...) [Lettera sessantanovesima di Friedrich Leopold Stolberg tratta da Viaggio in Germania, Svizzera, Italia e Sicilia, Amburgo 1822; inclusa nella raccolta Viaggiatori in Puglia dalle origini alla fine dell’Ottocento, a cura di MARIA LUISA HERRMANN e ANGELO SEMERARO, Schena, Fasano 1990] 173 Al capezzale di mia madre Nicola Zingarelli Nicola Zingarelli (Cerignola 1860 - Torino 1935). L’autore del primo Vocabolario della lingua italiana, pubblicato nel 1922 e tutt’oggi strumento imprescindibile per la conoscenza del nostro lessico, in questa lettera confessa al suo amico Michele Barbi come le preoccupanti condizioni di salute della madre lo riportino, di tanto in tanto, nella natìa Cerignola. Napoli, Sabato Santo 24 marzo 1894 Carissimo, tu ti sarai meravigliato del mio silenzio, ma sappi che ho avuto mia madre in pericolo di vita, e ho dovuto accorrere al suo capezzale, laggiù a Cerignola, dove sono rimasto sette giorni. Ti manderò gli articoli subitissimo. Desideravo da te l’indice delle Prose o Operette Morali del Leopardi pubblicate costà dal Piatti il 1834. Il numero mancante della I serie del Bullettino è l’ottavo. Ma avendo ricevuto sino all’undicesimo, non so se dopo ne sia uscito qualche altro. Presi l’impegno di fare una edizione delle Op. Mor. del Leopardi per le scuole, e son quasi al termine. Ma è stato un lavoro faticosissimo per me, che son avvezzo a fare le cose senza leggerezza. Buona Pasqua e credimi aff. mo amico Zingarelli NA, [Lettera di Nicola Zingarelli tratta da Carteggi di Nicola Zingarelli, a cura di CARMEN PRENCIPE DI DONpubblicato con gli auspici della Società Dauna di Cultura, Apulia Editrice, Foggia 1979] 175 Ho ingannato persino il Sindaco Pietro Mascagni Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945). Il compositore, tra i maggiori interpreti del verismo musicale italiano, dimorò a Cerignola per almeno cinque anni, dal 1887 al 1892, periodo durante cui diresse la Compagnia Luigi Maresca e compose - o quantomeno ultimò - le opere musicali Cavalleria Rusticana, Amico Fritz, Rantau, Guglielmo Ratcliff e Silvano. In queste due lettere scritte a Vittorio Gianfranceschi, il maestro toscano descrive la sua permanenza nella cittadina dauna e la grande gioia dovuta alla nascita del figlio, avvenuta proprio a Cerignola. Avvenimento che per qualche mese fu costretto a nascondere, poiché non ancora sposato con Lina Carbognani (la compagna parmigiana con la quale Mascagni condivise la propria abitazione cerignolana). 17 febbraio 1887, Cerignola «Mi scritturai a Napoli con una compagnia d’infimo ordine, con una paga molto misera. Siamo stati oltre Napoli, a Benevento, a Foggia e poi qui a Cerignola. Io mi ero scritturato perché a Napoli non potevo più vivere (ho lasciato un monte di debitucci che vado pagando giornalmente, privandomi di un sigaro) [e sappiamo che il sigaro fu un compagno inseparabile per il musicista] - e fino a quindi giorni fa ci è stata sempre la speranza di venire al Fossati» [un teatro che a Milano allestiva spettacoli di operette di ottimo livello]. «Adesso è svanita questa speranza e la compagnia andrà in Sicilia, dico andrà perché è pure probabile che la Compagnia si sciolga, qui a Cerignola abbiamo fatto bruttissimi affari e regna un grande malumore. Se la compagnia si scioglie, io mi trovo a morire di fame. Stando qui a Cerignola, ho incontrato molta simpatia in tutta la cittadinanza e parecchi signori mi hanno domandato se sarei restato qui a dare lezioni di pianoforte». 176 Verso Sud D. Grittani 10 luglio 1887, Cerignola «Il periodo più brutto era per me il battesimo del bambino ed anche quello ho superato in un modo provvidenziale. Si trattava di ingannare persino il Sindaco, che è il mio più forte protettore e che mi ha affidato le figlie… Cerignola è un paese antico, bigotto, superstizioso, e Dio ne guardi se si sapesse che la donna che sta con me non è mia moglie!». Ma come aveva sistemato il Maestro la sua situazione di coppia illegale, in quel tempo davvero pericolosa per una carriera? È proprio vero che un buon amico si trova sempre e in questo caso sarà un «impiegato municipale, addetto alle nascite, ai matrimoni ed alle morti», questo giovane si è mostrato tanto mio amico che io ho voluto che fosse compare del bambino; io gli ho detto tutto, e ho pensato a regolare le cose in maniera che nessuno ha potuto dubitare della nostra legittimità di marito e moglie. Però per mille ragioni ho promesso a me stesso di sposare in realtà questa donna che merita tutto. [Lettere di Pietro Mascagni tratte da Mascagni ritrovato 1863/1945: l’uomo, il musicista, Edizioni Sonzogno, Milano 1995] PARTE IX Manfredonia 179 L’angelo di Manfredonia Norman Douglas Norman Douglas (Tilquihillie, Scozia 1868 - Capri 1952). Scrittore inglese, visse a lungo nell’Italia meridionale, terra da cui trasse ispirazione per i suoi romanzi Terra di sirene (1911), Vento del Sud (1917), Vecchia Calabria (1915) e Ultima messe (1946). La prosa che abbiamo scelto per questa antologia gli fu suggerita da un viaggio in carrozza compiuto da Manfredonia a Monte Sant’Angelo nel 1915. Chiunque guardi una carta geografica del promontorio del Gargano vedrà che è cosparso di nomi greci di persone e luoghi, Matteo, Marco, Nicandro, Onofrio, Pirgiano e così via. Non c’è da stupirsene, perché queste regioni orientali erano in contatto con Costantinopoli sin dai tempi antichi e lo spirito di Bisanzio ancor le sovrasta. Fu su questa montagna che l’Arcangelo Michele, durante la sua prima apparizione nell’Europa occidentale, si degnò di comparire a un vescovo greco di Siponto di nome Laurenzio; e sempre, da allora, una caverna, santificata dalla presenza di questo alato messaggero di Dio, è stata la meta di milioni di pellegrini. La roccaforte di Sant’Angelo, metropoli del culto europeo degli angeli, è sorta attorno a questa grotta devota e onorata; nei giorni di sole le sue case sono chiaramente visibili da Manfredonia. Coloro che desiderino offrire la propria devozione al santuario non possono far meglio che portarsi appresso Gregorovius, come cicerone e mistagogo. Invano attesi una bella giornata per scalare le alture. Infine decisi di farla finita e andarvi, con qualsiasi tempo. Fu convocato un vetturino e le trattative per partire il mattino successivo furono portate a termine. Sessantacinque franchi, cominciò a dirmi, era il prezzo pagato da un inglese l’anno precedente per una visita di un giorno al sacro monte. Forse è anche vero, gli stranieri sono pronti a far qualsiasi cosa, in Italia. O forse me lo disse solo per «incoraggiarmi». Ma oggidì è piuttosto difficile riuscire a incoraggiarmi. Ricordai all’uomo che c’era un servizio di diligen- 180 Verso Sud D. Grittani ze che faceva andata e ritorno per un franco e mezzo e già quel prezzo mi sembrava piuttosto esoso. Avevo visto tante grotte sante in vita mia! E, in fin dei conti, chi era questo San Michele? Il Padreterno, per caso? Nulla del genere: solo un angelo qualunque. Ne avevamo a dozzine in Inghilterra. Fortunatamente, soggiunsi, mi era già stata fatta l’offerta di unirmi a un gruppo privato per raggiungere la vetta in carrozza, una quindicina di persone dietro un minuscolo cavallino. E questa, come lui ben sapeva, era una spesa di pochi centesimi. E anche in tal caso, il cielo minaccioso... Sì, ripensandoci, forse era più saggio rimandare del tutto l’escursione. Un’altra volta, il cielo permettendo. Accettava un sigaro a ricompensa del suo disturbo per esser venuto fin qui? Con rapidità stupefacente e travolgente le sue pretese scesero a otto franchi. Fu il tabacco a compiere il miracolo. Un signore «che dà qualcosa in cambio di niente» (questa era la sua logica) – be’... non si può mai sapere che cosa si può riuscire a ricavarne. Si accetti il prezzo e si corra il rischio! Affidò il sigaro alla tasca del suo panciotto per fumarselo dopo cena e se ne andò, vinto ma raggiante, entro di sé, di accesa aspettativa. Quando aprii gli scuri mi si parò dinanzi agli occhi una mattinata orribile: raffiche di pioggia e nevischio battevano contro i vetri. Ma non importava. La carrozza era ferma da basso e dopo la detestabile parvenza di prima colazione che è quanto basta per volgere i pensieri dell’uomo più equilibrato al suicidio e al delitto – quando impareranno i meridionali a mangiare una prima colazione decorosa a un’ora decorosa? – ci mettemmo in viaggio. Il sol faceva apparizioni di una brevità irritante, per lasciarsi subito dopo inghiottire da un’oscurità pesante e, del percorso che facevamo, vidi solo il vecchio tracciato sassoso che taglia qua e là le ventun svolte della nuova strada carrozzabile. Cercai di raffigurarmi i prìncipi normanni, gli imperatori, i pontefici e altri diecimila pellegrini celebri che si arrampicavano per quei pendii rocciosi – scalzi – in giornate come questa. Dovette essere messa a dura prova persino la pazienza di San Francesco d’Assisi che compiva il pellegrinaggio con loro e che, secondo Pontano, fece qui, come era su abitudine, un piccolo miracolo, en passant. Dopo circa tre ore di viaggio raggiungemmo la città di Sant’Angelo. A quell’altezza di 800 metri faceva un freddo pungente. Seguendo il consiglio del vetturino scesi subito al santuario; secondo lui là sotto avrebbe dovuto far caldo. La grande festività dell’8 maggio era passata, ma torme di fedeli continuavano ad arrivare; e avevano un aspetto pittorescamente pagano, negli indumenti sudici e cenciosi, con i bordoni sormontati da rami di pino e con la bisaccia. Nelle massicce porte di bronzo della cappella, che erano state fatte a Costantinopoli nel 1076 per un ricco cittadino di Amalfi, sono infilati anelli metal- N. Douglas L’angelo di Manfredonia 181 lici, che il vero pellegrino deve percuotere furiosamente per attirare l’attenzione delle potenze divine sulla sua visita e che, nella perorazione, bisogna ancora una volta battere con la massima forza affinché il compimento dell’atto di adorazione possa essere debitamente segnalato: a giudicare dal frastuono la divinità deve essere assai dura d’orecchio. A volte esse sono stranamente sorde. I ventiquattro pannelli di queste porte sono ingenuamente incrostati con raffigurazioni smaltate di apparizioni di angeli assai svariati: alcune di esse recano iscrizioni e la seguente è degna di nota: «Prego e imploro i preti di San Michele di pulire questi cancelli una volta l’anno come ho ora mostrato loro, affinché abbiano sempre a essere lindi e lucenti». La raccomandazione evidentemente non è stata eseguita da un bel po’ di anni. Entrati dal portale si scende una lunga scalinata in mezzo a uno sciame fitto di straccioni devoti e maleodoranti, sino a un’ampia caverna, la dimora dell’arcangelo. È un’anfrattuosità naturale nella roccia, illuminata da candele. Qui la sacra funzione procede con accompagnamento di vivaci arie d’opera eseguite da un organo asmatico; l’acqua sgocciola senza sosta dalla volta rocciosa sulle teste devote dei fedeli inginocchiati, che coprono il pavimento, con candele accese in mano, dondolandosi estatici e biascicando e salmodiando. Una scena veramente irreale. E il vetturino aveva indovinato, quanto alla differenza di temperatura. Fa caldo laggiù, un caldo umido come in una serra. Ma l’aroma non può essere descritto come un’emanazione floreale: il bouquet di tredici secoli di pellegrini sporchi e sudati. «Terribilis est locus iste» dice un’iscrizione all’ingresso del santuario. Verissimo. In posti del genere si capiscono le usanze, e forse l’origine, dell’incenso. Ciò nonostante mi ci soffermai e i miei pensieri tornarono all’Oriente, da dove sono derivate queste pratiche misteriose. Ma una folla orientale di fedeli non mi commuove come queste masse europee di fanatici; non mi persuado mai a considerare dei pellegrini così appassionati senza una certa dose di inquietudine. Date loro il nuovo Messia, e tutta la nostra arte e le nostre conoscenze faticosamente accumulate, tutto ciò che riconcilia l’uomo civile con l’esistenza terrena, viene buttato ai quattro venti. La società può trattare con i suoi criminali, ma sono gli entusiasti appassionati come quegli altri che costituiscono la minaccia alla sua stabilità. Riflessioni amare: ma il viaggio in salita aveva raggelato la mia solidarietà umana; e inoltre, quella cosiddetta prima colazione... Mi lasciai alle spalle quella torma strisciante. Salii i gradini, e approfittando di un raggio di sole, mi arrampicai là dove, sopra la città, sorge un’orgogliosa rovina aerea nota come il Castello del Gigante. Su una delle sue pietre è incisa la data 1491 – una certa Regina di Napoli, si dice, fu uccisa tra quelle mura ora crollanti. Questi sovrani furono uccisi in tanti castelli che ci si chiede come abbiano mai trovato il 182 Verso Sud D. Grittani tempo di vivere, se pure per poco; la costruzione è un rudere e il suo portale è chiuso; ma nemmeno provavo un gran desiderio, in quel gelido soffiar del vento, di perlustrare l’interno privo di tetto. Potei tuttavia osservare che questa assurdità feudale reca un numero, come ogni casa abitata di Sant’Angelo, il numero 3. Questo è l’ultimo spasso del governo italiano: rinumerare le abitazioni di tutto il regno, e non solo le abitazioni occupate da esseri umani, ma mura, vecchie rovine, stalle, chiese, anche un occasionale stipite o una finestra. Si divertono un mondo con questo gioco, che promette di continuare a divertirli per un periodo di tempo illimitato – in effetti finché non si inventerà una nuova moda. Nel frattempo, fintanto che questa mania perdura, mezzo milione di funzionari dallo sguardo allegro, ardenti di giovanile vigore, vengono assunti per affiggere questi numeri, che poi segnano con fare sbrigativo su una quantità dieci volte maggiore di agende, e registrano in migliaia di archivi municipali, in tutto il paese, per scopi amministrativi imperscrutabili ma di enorme importanza. «Abbiamo gli impiegati», come mi disse una volta un deputato romano, «e pertanto essi debbono pur trovare qualche cosa da fare». In complesso, quel giorno il tempo mi tolse l’appetito della ricerca e dell’esplorazione. Sulla strada che conduceva al castello ebbi occasione di ammirare la bella torre e di rimpiangere che, a prima vista, non esistesse alcun punto vantaggioso dal quale la si potesse rimirare per benino; fui anche colpito dal numero di piccole raffigurazioni di San Michele, di un genere ultra giovanile; e infine, da certi vegliardi del luogo, ben sbarbati. Questi venerandi e decorativi briganti – perché tali sarebbero stati fino a pochi anni prima – se ne stavano ora pacifici sulla soglia di casa con addosso un mantello di pesante lana marrone, che donava loro assai, portato a mo’ di burbus. L’indumento mi interessava, poteva essere un’eredità degli arabi che avevano dominato su questa regione per qualche tempo, spogliando il sacro santuario e lasciando che il loro ricordo fosse perpetuato dall’attiguo Monte Saraceno. L’indumento, d’altra parte, potrebbe esser venuto dalla Grecia: è raffigurato sulle statuette di Tanagra ed è portato dai moderni pastori greci. Anche da quelli sardi... Potrebbe anche essere una forma primordiale di abbigliamento dell’umanità. La vista da questo castello deve essere stupenda nelle giornate limpide. Mentre me ne stavo lì, guardavo l’entroterra e ricordavo tutti i luoghi che avevo avuto intenzione di visitare – Vieste e Lesina con il suo lago, e la Selva Umbra, il cui stesso nome suggerisce il pensiero di radure rugiadose; quand’erano remote sotto nuvole così scoraggianti! Non le vedrò mai. La primavera esita a sorridere su questi gelidi altipiani; siamo ancora nella morsa dell’inverno. Aut aquilonibus Querceta Gargani laborant Et follis viduantur orni. N. Douglas L’angelo di Manfredonia 183 Così cantava il vecchio Orazio, dei venti garganici. Scrutai l’orizzonte, alla ricerca del suo Monte Vulture, ma tutta quella zona era ammantata in una grigia cortina di vapore: solo lo Stagno Salso – laghetto salato dove il Candelaro dimentica le sue acque mefitiche – brillava di una luce decisa, come un lenzuolo di piombo lucidato. Presto la pioggia riprese a cadere e mi indusse a cercar rifugio tra le case, dove intravidi la figura familiare del mio vetturino, seduto con aria sconsolata sotto un portico. Sollevò lo sguardo e osservò (in mancanza di meglio da dire) che mi aveva cercato per tutta la città, nella tema che mi fosse capitato qualche guaio. Fui intenerito da quelle parole; così intenerito che deposi un franco nel palmo riluttante della sua mano e lo invitai a comperarsi qualcosa da mangiare. Un franco intero... Ah! pensò indubbiamente lui, «la mia teoria del vero signore: comincia a funzionare». Eravamo appena a metà della giornata. E tuttavia ero già disgustato dell’angelica metropoli e i miei pensieri cominciarono a volgersi di nuovo in direzione di Manfredonia. A un angolo della strada, tuttavia, alcune sciolte vociferazioni in inglese e in italiano, che nulla mi avrebbe indotto a lasciar perdere qui, mi colpirono; provenivano – in apparenza – dai visceri della terra. Mi fermai ad ascoltare, scosso nell’udire un linguaggio scurrile in una città santa come questa; poi, spinto dalla curiosità, scesi una lunga rampa di gradini e mi trovai in uno scantinato. Lì un gruppo di emigranti stava bevendo e giocando a carte – gente allegra; una buona metà di loro parlava inglese e, nonostante alcune frasi irriverenti, presto mi conquistarono con un «Ecco! Bevete questo, signore!». Il cupo scantinato era un istruttivo pendant alla grotta dell’arcangelo. Un nuovo tipo di pellegrino si è evoluto; pellegrini convinti che la traversata fino a Pittsburg non sia più impegnativa di un viaggio in carrozza a Manfredonia. Ma la loro cantina era impregnata di un odore di vino versato e di fumo di tabacco, invece della sottile Essence des pèlerins des Abruzzes fleuris e, ahimè, l’oggetto della loro adorazione non era l’angelo caldeo ma un’altra forma orientale egualmente antica: Mammone. Parlavano molto di dollari; e udii anche diverse allusioni poco ortodosse al «commercio dell’angelo», commercio che loro definivano ormai «sfruttato»; nonché un’osservazione nel senso che «solo chi è maledettamente stupido rimane in questo paese». In breve, questi individui erano all’altro capo della scala umana; essi erano i forti, gli energici: forse gli spietati; ma sicuramente gli intelligenti. E per tutto il tempo il calice faceva il giro del gruppo, con gioviale ripetizione, e tutti erano d’accordo che, qualsiasi potessero essere gli inconvenienti di Sant’Angelo, non v’era nulla da ridire sull’alcool del luogo. Era, in verità, un prodotto divino: un vino di montagna di nobile pedigree. Questo pensavo mentre risalivo faticosamente le scale, rallegrato da questo incidente della caverna che faceva concorrenza all’altra, e leggermente stordito dal fumo del tabacco. E qui, appoggiato allo stipite della porta, 184 Verso Sud D. Grittani stava il vetturino che aveva indovinato dove mi trovavo, per un suo oscuro intuito massonico di solidarietà. Il suo volto si aprì in un sorriso vacuo, e vidi presto che invece di rafforzare la propria costituzione con sano cibo aveva sperimentato i metodi alcolici per difendersi dall’inclemenza del tempo. «Solo un bicchiere di vino spiegò -. Ma il cavallo non è assolutamente ubriaco». Quel quadrupede era pari all’eccezionalità della situazione. Gloriosamente indifferenti al nostro destino, scivolammo verso il basso, in un vertiginoso ma magistrale volo planato da quella città di montagna piuttosto riprovevole. Un accogliente scoppio di sole salutò il nostro arrivo in pianura. Culto cavernicolo Perché l’arcangelo esaltato ha scelto come dimora questa cella maleodorante invece di qualche tempio ben costruito alla luce del sole? A simbolizzare un raggio di luce che penetra nelle tenebre, così vi verrà risposto. È più probabile ch’egli vi sia penetrato da guerriero distruttore, per scacciare quella forma pagana, che Strabone descrive come dimorante in quel malsano recesso, e per impossessarsi dell’antro in nome del Cristianesimo. Sant’Angelo è uno dei tanti luoghi ove Michele ha eseguito il compito di un Ercole cristiano, a simiglianza di quello antico che ripulì le stalle di Augia. Per il resto, questo culto cavernicolo è più antico di qualsiasi divinità o diavolo. È il culto del principio femminile – un residuo di quell’ossessione aborigena dell’umanità di rifugiarsi in qualche antichissimo crepaccio nel sacro grembo di Madre Terra che ci dà cibo e che ci riceve dopo la morte. Le apparizioni, antiche e recenti, nelle grotte non sono altro che le spiegazioni popolari di questa oscura brama primordiale; e i gerofanti di tutti i secoli hanno capito il valore commerciale del sacro brivido che penetra nel cuore dei fedeli, in queste caverne, dando loro una risonanza di fatti divini. E così qui, proprio vicino all’altare, i preti vendono frammenti della cosiddetta «Pietra di San Michele». Il commercio è attivo. La statuetta dell’Arcangelo, conservata in questa cappella sotterranea, è un’opera del tardo Rinascimento. Pur risentendo di quell’elaborazione leziosa che allora cominciava a contaminare l’arte e la letteratura locale – ed è legata al nome del poeta Marino – è tuttavia figura di una virilità passabile. Ma quelle innumerevoli altre, nelle chiese o sopra le porte, raffigurano davvero l’uccisore del drago, il marziale principe degli angeli? Questo fanciullo grazioso dai lineamenti femminili – può costui essere il Lucifero del Cristianesimo, la Spada dell’Onnipossente? Quis ut Deus! Avrebbe potuto difficilmente far del male a una mosca. N. Douglas L’angelo di Manfredonia 185 Il venerando genio alato di Caldea che ha assorbito l’essenza di tante solenni divinità, ora, in tardissima età, è entrato in una seconda infanzia ed è diventato ormai troppo giovanile per il suo rôle, subendo una metamorfosi che va oltre i limiti della probabilità leggendaria o del buon senso; ogni traccia di divinità e di forza virile ne è stata spremuta. Così giovane e di bellezza tanto terrena, rassomiglia, piuttosto, a un bel ragazzetto che si è agghindato, per giuocare, con una spada e un elmo infantili – vien voglia quasi di divertircisi insieme. Questo non è un guerriero! C’est beau, mais ce n’est pas la guerre. Gli dei, si dice, son sempre giovani ed una nota piuttosto sensuale e carnale è essenziale per quelli italiani, se devono riuscire a conservarsi l’amore dei loro fedeli. D’accordo! Non ci serve un veterano sfregiato e irsuto; ma abbiamo per lo meno bisogno di un personaggio che sia in grado di brandire la spada, una figura all’incirca come questa: L’elmo lucente allentato mostrava il fiore di sua giovinezza nella virilità in cui finiva l’adolescenza; dal fianco gli pendeva, scintillante zodiaco, la spada terrore indicibile di Satana, e in mano sua la lancia... Ecco! questo è il vero arcangelo. E il gran drago, quel vecchio serpente, chiamato il Diavolo, e Satana, ha subíto un’analoga trasformazione. Si è rattrappito diventando un povero piccolo rettile, appena un vermiciattolo, che quasi non vale nemmeno la pena di schiacciare. Ma come potrebbe attrarre la gente comune una concezione sublime come l’eroe apocalittico? Queste figure poderose emergono dal crepuscolo, progenie di epoche fatali; se ne stanno in disparte, altere dapprima, ma subito la loro luminosa grandezza è smorzata, il loro profilo altezzoso è offuscato e cancellato dal logorio. Sono trascinati al livello dei loro adoratori più infimi perché l’intero gregge adatta il proprio passo a quello dell’agnello più debole. Nessuna divinità che abbia rispetto di sé sopporterebbe un simile trattamento – di essere volgarizzata e resa comprensibile a una folla. Le divinità capite dalle masse cessano di essere efficaci; gli egiziani e i bramini l’hanno capito. Non si tratta di dare agli dei la possibilità di interpretarli in modo incongruente e sleale. Ma il volgo non ha idea alcuna del decoro e della correttezza: non sa mantenersi alla giusta distanza; si prende costantemente delle libertà. E, alla fine, anche il più orgoglioso degli dei è costretto a cedere. Vediamo questa fatalità anche nella stessa parola Cherubino. Che diversa immagine suscita questo bimbo paffuto e frivolo di fronte al bel Ministro di Dio cinto da una spada di fiamma! La vediamo nella Madonna italiana in cui, nonostante ogni possibile novità assimilata dalla sua mente, bisogna presupporre una certa gravità 186 Verso Sud D. Grittani d’atteggiamento, e che, pur tuttavia, diventa di giorno in giorno di una leziosità sempre più infantile; nel suo Figliolo che – quanto meno da queste parti – ha abbandonato tutti gli attributi seri di virilità e si è ridotto a poco più di un bambolotto. Era la stessa cosa ai tempi antichi. Apollo (che San Michele ha soppiantato), Eros, e Afrodite – tutti passano attraverso un processo di edulcorazione deterioratrice. Le nostre creature più belle, quand’hanno superato l’apogeo del loro vigore, sono esposte all’assalto e alla distruzione da parte di una tendenza insidiosa al diabete. È questo istinto bamboleggiante dell’umanità che ha ridotto San Michele alla sua attuale condizione. E un influsso estraneo ha operato nella medesima direzione: il graduale rammollimento delle maniere entro i tempi storici. Quella svirilizzazione che va di pari passo con il crescente benessere sociale. La divinità riflette i propri creatori umani e il loro ambiente; divinità grandiose o battagliere diventano superflue e, infine, incomprensibili nei giorni monotoni della pace. Per sopravvivere, le nostre divinità (come il resto di noi) devono possedere una certa plasticità. Se recalcitrano, vengono silenziosamente esonerate dalle loro funzioni e dimenticate. Questo è quanto è accaduto in Italia al Dio Padre e allo Spirito Santo, che sono svaniti dall’Olimpo volgare; mentre il diavolo, grazie a quella versatilità spregiudicata per cui va famoso, resta sempre giovane e popolare. Le nozioni d’arte del Cinquecento sono pure da condannare; in effetti, per quel che riguarda le forme angeliche dell’Italia meridionale, l’influsso del Rinascimento è stato affatto malefico. Estranee a questo suolo, esse sono dapprima del tutto ignote – nessuna è raffigurata nelle catacombe napoletane. Subito dopo, viene il breve periodo della loro gloria artistica; quindi il sincretismo del Rinascimento, quando questi messaggeri alati furono amalgamati con gli amoretti pagani e presero a svolazzare in quello sciocco stile barocco attorno alla Regina dei Cieli, secondo il modello di quegli indecorosi piccoli geni al servizio di una Venere di cattiva scuola. Quello stesso istinto che degradava un Eros giovanile nell’infantile Cupido fu il colpo mortale inferto all’antica dignità e alla santità degli angeli. Oggidì vediamo la cattiveria di tutto ciò; siamo tornati al buon senso e riusciamo ad apprezzare quella rinascita tanto lodata al suo vero valore; e i nostri scultori moderni vi metteranno insieme un angelo rispettabile, un adolescente grave, secondo i migliori canoni del gusto – nel caso voi possediate ancora la fede che un tempo imponevano tali opere d’arte. Noi viaggiatori ci familiarizziamo con la discendenza di questo messaggero celeste ma è difficile supporre che i fedeli che ora si affollano davanti al suo santuario sappiano gran che di queste cose. Come sarà possibile scoprire i loro veri sentimenti per questo grande santo grottereccio e per la sua vita e le sue azioni? Be’, se ne può avere una vaga idea attraverso gli opuscoli che vendono sul posto. Ho acquistato tre di questi moderni trattatelli, stampati rispettivamente a Bitonto, N. Douglas L’angelo di Manfredonia 187 a Molfetta e a Napoli. Il Canto Popolare in onore di San Michele contiene questa strofa: Nell’ora della morte Ci salvi dall’inferno E a Regno Sempiterno Ci guidi per pietà. Ci guidi per pietà. Questa è l’eredità di Mercurio. Poi, La storia e i miracoli di San Michele si apre con un gioviale dialogo in versi tra l’arcangelo e il diavolo intorno all’anima; finisce con un elenco particolareggiato, in venticinque strofe, dei miracoli fatti dall’angelo, come ad esempio l’aiuto alle donne durante il parto, la cura dei ciechi, e altre meraviglie, in tutto e per tutto simili a quelle elaborate da più umili santi terreni. Infine la Novena in onore di San Michele Arcangelo stampata nel 1910 (terza edizione) con l’approvazione ecclesiastica, ha il seguente notevole paragrafo sulla Devozione per le sacre pietre della grotta di San Michele. «È assai salutare aver stima per le pietre che sono prelevate dalla sacra grotta, in parte perché da tempo immemorabile sono sempre state venerate dai fedeli e anche perché sono classificate come reliquie di sepolcri ed altari. Inoltre è noto che durante la pestilenza che afflisse il Regno di Napoli nell’anno 1656, Monsignor G. A. Puccini, arcivescovo di Manfredonia, raccomandò a ciascuno di trasportare devotamente sulla propria persona un frammento della pietra sacra in virtù della quale la maggioranza fu salvata alla pestilenza, e questo aumentò la devozione a loro tributata». Il colera è in aumento e questo può spiegare la rapida vendita delle pietre in questo momento. L’opuscolo contiene anche una litania in cui i titoli dell’arcangelo vengono enumerati. Egli è, tra le altre cose, Segretario di Dio, Liberatore delle Infernali Catene, Difensore nell’Ora della Morte, Custode del Pontefice, Spirito della Luce, Prudentissimo tra i Magistrati, Terrore dei Demoni, Comandante in Capo degli Eserciti del Signore, Sferza di Eresie, Adoratore del Verbo Incarnato, Guida dei Pellegrini, Accompagnatore dei Mortali: Marte, Mercurio, Ercole, Apollo, Mitra – quali antenati più nobili può desiderare un angelo? E tuttavia, quasi che queste funzioni complicate e responsabili non fossero sufficienti per le sue energie ne ha altre venti, tra cui c’è quella di Custode della Sacra Famiglia – che, a quanto pare, ha bisogno di un protettore, un Monsieur Paoli, come qualsiasi terrestre monarchia. «Assurdità blasfeme!» mi par di sentire esclamare qualche metodista. E si può esser senz’altro tentati di schernire questi pellegrini, per i più illuminati dei quali si 188 Verso Sud D. Grittani stampa questa roba. Perché essi sono indubbiamente una folla repellente: vecchie sporche per il viaggio, controfigure per la Maga di Endor; ragazze anemiche scapigliate, dall’aspetto attonito; ragazzi troppo deboli per maneggiare una vanga a casa loro, di modi pateticamente rozzi, con bocche spalancate e occhi che esprimono tutta una gamma di emozioni incontrollate, dalla gioia più selvaggia all’idiozia vera e propria. Come ci si rende conto, in fondo a questa grotta, dell’effetto che, su alcuni uomini colti dell’antichità, come Rutilio Namaziano, deve aver avuto il culto nelle catacombe, in mezzo a quei primi convertiti cristiani, a quegli «uomini che rifuggivano dalla luce», trascinati com’erano dalle stesse classi sociali verso gli stessi oscuri riti sotterranei! Persone simili non si possono né amare né rispettare. E simulare compassione nei loro riguardi sarebbe più consono alla loro religione che alla mia. Ma è facilissimo capirlo. Per tredici secoli il movimento dei pellegrini ha continuato a esistere. Tredici secoli? No. Il luogo in tempi antichi era un oracolo e sappiamo che luoghi simili erano frequentati da uomini niente affatto meno barbari e bigotti dei loro rappresentanti moderni – non c’è errore più grande che quello di supporre che le folle dell’antica Roma e di Atene fossero più raffinate delle nostre («Demostene, signore, parlava a un’assemblea di bruti»). Allora diciamo che, per trenta secoli, una divinità ha attirato i fedeli al suo santuario – Sant’Angelo è diventato un vuoto pneumatico, per così dire, che deve essere periodicamente riempito con elementi della campagna circostante. Questi pellegrinaggi sono nel sangue della gente: da bambini vi sono accompagnati; da adulti vi portano la prole; quando hanno la barba grigia i loro passi incerti sono sorretti da pellegrini come loro, gentili e più robusti. Pontefici e imperatori non si arrampicano più per quei pendii: il sentimento della pietà è calato, tra i grandi della terra; questo è sicuro. Ma i raggi della luce che toccano i rami più alti non hanno ancora penetrato il sottobosco rigoglioso ed effervescente. E allora, che altro si può offrire a questi montanari? La loro è una vita di miseria avvilente e rivoltante. Non hanno giuochi o sport, non hanno corse di cavalli, club, mostre di bestiame, caccia alla volpe, politica, caccia ai topi, o una di quelle tante gioie che rendono diversa la vita dei nostri contadini. Non sono sfiorati da alcun tocco di umanità, non ricevono marmellate o coperte da gentili dame, e nessun medico gioviale si interessa dei loro figlioli; non leggono giornali o libri e mancano loro persino le blande eccitazioni fornite dal contrasto tra anglicani e dissidenti, o dal romanzo d’amore della figlia del vicario, o dall’ultima lite del signorotto con la moglie – nulla! La loro esistenza è quasi animalesca nella sua vacuità. Li conosco, ho vissuto tra loro. Per quattro mesi l’anno sono stivati in tane umide che non si possono definire stanze, dove un inglese riterrebbe disonorante tenere un cane – stivati in uno squallore incredibile per chi non lo vede; per il resto del tempo si affannano, con il sudore della fronte, a strappare qualche spiga di N. Douglas L’angelo di Manfredonia 189 grano dall’ingrato terreno calcareo. Le visite all’arcangelo – quei picnic invernali e autunnali – sono la loro unica forma di divertimento. Si dice che l’affluenza sia diminuita dall’inizio del 1900, allorché ne venivano solitamente trentamila l’anno. Può esser benissimo; ma immagino che questo non sia tanto dovuto a un grado crescente di illuminazione quanto allo spopolamento provocato dall’America; molti villaggi sono stati di recente ridotti alla metà del loro numero precedente di abitanti. E qui si inginocchiano, la candela in mano, sulle pietre umide di questa caverna malsana e maleodorante, fissando rapiti l’idolo che sorride mellifluo, solleticati nella loro sensibilità da preti risplendenti che recitano biascicate frasi in latino, mentre l’organo sopra il loro capo suona brani ansimanti de «La forza del destino» o il valzer del «Mefistofele» di Boito... certo deve essere una pregustazione del Paradiso. Ed è assai probabile che questi siano «i poveri di spirito» cui è riservato quel regno. Questa potrebbe esser definita una forma adulterata del Cristianesimo. Forse il fondatore di questo culto l’avrebbe ritenuta disgustosa; ma questo è un altro problema e, adulterata o meno, è quanto meno viva e palpitante, il che già costituisce più di quanto si può dire per certe altre varietà. Ma l’arcangelo, come era inevitabile, ha subito un triste mutamento. Il suo più bell’attributo di Apportatore di Luce, di Apollo, non gli appartiene più; è stato requisito e assorbito dalla «Luce del Mondo», il suo nuovo padrone. A una a una, le sue funzioni gli sono state strappate, salvo nominalmente, come succede a uomini e angeli insieme, quando prendono servizio sotto padroni «gelosi». Che resta ora di San Michele, il gerarca lucente? Può egli ancora sopportare la luce del sole? O forse si è ridotto a un Hermes spettrale, un lugubre psicopompo che china la testa in una gloria rimpicciolita e che non guida più le anime degli uomini verso l’alto, bensì verso il basso – giù, alle smorte regioni delle cose che sono state? E trascorrerà molto tempo prima che anche egli sia gettato da qualche fiammeggiante demone dal volto di Gorgone negli stessi regni di Minosse, nel cupo sottomondo dove risiedono Saturno, e Kronos, e altri ideali frantumati e in pezzi? Così meditavo quel pomeriggio, scendendo in carrozza per il pendio di Sant’Angelo, comodamente al riparo dal temporale, mentre il generoso vino di montagna mi scorreva rapido nelle vene, scaldandomi la fantasia. Poi, finalmente, il sole uscì in un improvviso scoppio di luce, aprendo uno squarcio tra i vapori e rivelando l’intera catena appenninica, insieme con l’appuntito cratere di Monte Vulture. Lo spettacolo mi rallegrò e mi fece pensare che una giornata simile sarebbe stata degnamente completata da una visita a Siponto, a poche miglia al di là di Manfredonia, sulla strada di Foggia. Ma abbordai l’argomento con cautela, temendo che il vetturino potesse obiettare a questo lavoro in più. Fu tutto il contrario, invece. Mi ero guadagnato il suo affetto e mi avrebbe accompagnato da qualunque parte avessi desiderato. Solo a Siponto? 190 Verso Sud D. Grittani Perché non a Foggia, a Napoli, ai limiti della terra? Quanto al cavallo, il viaggio gli era indifferente, del tutto indifferente: non c’era cosa che gli piacesse di più della corsa davanti a una carrozza; inoltre «è suo dovere» dichiarò l’amico. Siponto è tanto antica che si dice fosse stata fondata da quel leggendario Diomede che fece la stessa cosa per Benevento, Arpi e altre città. Ma questo record non soddisfa Monsignor Sarnelli, storico della città, secondo il quale essa era già fiorente quando Sem, figlio di Noè, ne divenne il re. Regnò all’incirca nell’anno 1770 dalla creazione del mondo. Due anni dopo il diluvio aveva cento anni e, a quell’età, ebbe un figlio, Arfaxad, dopo la cui nascita visse ancora cinquecento anni. Il secondo re di Siponto fu Appulo, che regnò nell’anno 2213... Più tardi qui dimorò San Pietro che vi battezzò alcune persone. Di Siponto non resta nulla; nulla, ad eccezione di una chiesa e anche questa costruita di recente; è dell’XI secolo; una chiesa famosa, nello stile pisano, con colonne di marmo lavorate, e appoggiate con ornamenti romboidali a leoni, e altre eccellenti lavorazioni nella pietra che rallegrano l’occhio. Essa era stata sede arcivescovile e le sue belle sedie episcopali sono ora conservate a Sant’Angelo; e si può ancora fare omaggio all’autentica Madonna bizantina, dipinta su legno da San Luca, dalla carnagione scura, dal naso lungo, e dallo sguardo fisso, che regge l’Infante sul suo braccio sinistro. Terremoti e incursioni saracene hanno rovinato la città che è rimasta del tutto abbandonata quando Manfredonia fu costruita con le sue pietre. Di antichità pagane vi sono, sparsi qua e là, pochi capitelli, e così pure colonne di granito nella strana, antica cripta. Un pilastro se ne sta tutto abbandonato in un campo e, vicinissimi alla chiesa, ve ne sono altri due, in piedi, il più grande di cipollino, abbellito da una patina di lichene dorato; una testa di pozzo in marmo, mezzo consumata per l’uso delle funi, si trova sepolta nell’erba lussureggiante. La pianura su cui sorgeva la grande città di Sipus è ora coperta di aspra vegetazione. Il mare si è ritratto dalla sua antica spiaggia, e bestiame semi-inselvatichito pascola sul luogo di questi antichi moli e palazzi padronali. Non resta una pietra. La malaria e la desolazione regnano supreme. È un luogo profondamente malinconico. E tuttavia fui contento di quella rapida visione. Avrò ricordi cari e duraturi di quel santuario – il travertino della sua struttura elaboratamente scolpito, che brilla di un colore fulvo aranciato nel tramonto; e della pianura abbandonata, più oltre, piena di visioni fantomatiche del passato. Quanto a Manfredonia, è un luogo piccolo e triste dove il vento di mezzogiorno geme e le montagne sono velate nelle brume. [Tratto da Vecchia Calabria, NORMAN DOUGLAS, Londra 1915; ristampato da Martello, Milano 1962, tradotto da Grazia Lanzillo e Lidia Lax] 191 Santa Maria Maggiore Sipontina Giuseppe Ungaretti Poi dalla solitudine si sprigiona una colonnetta, e le fanno seguito a pochi passi, su leoni, le colonne che, fra le scure sopracciglia di archi ciechi, reggono in una facciata deserta il ricco portale di Santa Maria Maggiore di Siponto. Questa è dunque quell’arte solenne che dicono pisana, che un giorno a Lucca dolcemente mi svelò la Patria, che mette nel silenzio d’una pagina d’orazioni il rilievo prezioso dell’iniziale miniata. Non me ne intendo, ma non stupirei se questa cattedrale in mezzo al prato fosse davvero il primo esempio del costruire monastico e guerriero nel quale il Medioevo si provò a fondere le esperienze del suo rincorrere la visione del mondo, dall’innocente epica dei Mari del Nord alle erudite voluttà della svelta Persia. La nascita d’un’architettura significa il principio d’una chiarezza spirituale e d’una volontà vittoriosa. Perché nell’era cristiana non dovrebbe essere stata per prima questa terra, questo ponte dei Crociati, a immaginare saldamente, nella pietra murata e ornata, un’unità fra Occidente e Oriente? Sono le cose che mi commuovono di più, come di vedere, dopo la spedizione d’Alessandro, il canone di Fidia insinuarsi nella scultura indiana di 23 secoli fa. Perché questa regione pietrosa non dovrebbe essere una madre d’architettura? È venuta su dal tormento della pietra: dalla pietra, vittoria della forma sopra un immemorabile caos. Prolifica d’ogni sorta di pietre: dura, macerata, terra della sete: ci vorrebbero forse altri eccitamenti per inventare una forma? Nella sua desolata vecchiaia, Santa Maria Sipontina impartisce difatti oggi ancora la lezione più moderna. Dal faticoso svolgersi di due quadrati, guardate come al terzo la sua pianta ottiene che, sovrapponendosi di volo, 4 pilastri e 4 ogive e… 4 muri, e… (avete indovinato!) «quattro» colonne compongano alla cupola la salita potente d’un doppio spazio di cubi. Più cubisti di così… Non c’è da ridere: semplicità e ordine apriranno sempre le vie del sogno. Siamo usciti. I passi del sagrestano sono silenziosi come se andasse a piedi nudi. Per uno 192 Verso Sud D. Grittani strano mimetismo anche i nostri passi si sono fatti impercettibili. Siamo scomparsi. Al poco chiaro che può mandare un sanguigno di colonne, ci siamo ritrovati, sorpresi. Scorgiamo all’altare in fondo, in un cavo d’abside, gli occhi sbarrati d’una statua di legno dipinto. Sono gli enormi occhi bizantini, dimentichi del tempo. Solo Picasso potrebbe dirci perché i Bizantini sono così vicini ai selvaggi. Ripensavo – cogli occhi fissi a quello sguardo insensato, laggiù… – allo Scima che per occhi mette all’idolo pezzetti di specchio. Sarà mai rappresentata meglio l’insensibilità d’una vista eterna davanti al passare? Sparse come guardie, le gentili colonne – e sono… (bravi!) 4x4 – per il loro regolare i giuochi ora evidenti della volta, via via che avanziamo sembrano dividere il buio addirittura a tende, a scostarle. Vediamo anche quattro colonnoni; ma ci devono stare per prolungare e fortificare da questa cripta, i pilastri della chiesa di sopra; cercano di non disturbare e ritraggono più che possono nell’ombra la loro corpulenza. In tali penombre, presso la statua di legno arrampicandosi negli angoli, appariscono apparecchi ortopedici, grucce a mucchi, e vestitucci di tulle polverosi, inverosimili sulla durezza e la freddezza della pietra. A questo punto scopriamo appesi al muro – è uno scoppio – tutto un fiorire di quadri su rame. Di solito il popolo racconta bene, è la sua facoltà, e ne è prova questo genere di quadretti di voto. Ma questa volta le immagini hanno una vivacità straordinaria: sia che si faccia vedere uno che con una tavola sotto il braccio si getti dal piroscafo squarciato da un siluro, e riesca a raggiungere riva coll’aiuto di quella tavola; o si discorra d’un bambino che, caduto sotto cavalli impennati, attaccati ad un carro pesantissimo, passato il carro, mentre gli astanti urlano ancora disperati, si alzi e sorrida; ovvero s’indichi un albero schiantato dal fulmine mentre lo potano, e il potatore resti a cavallo d’un ramo della mezza pianta rimasta ritta, e guardi in giro come per dare i numeri al lotto; ecc. ecc. Il dramma è nel mare e nella nave, è nei cavalli impennati e negli astanti, è nell’albero e nel fulmine; non è mai in chi si salva. Ci sia o meno la volontà, c’è sempre il miracolo, c’è sempre la fede che rasserena. Stanno nella polvere e nel grigio, lì abbandonati i ricordi della sofferenza. L’uomo, si diceva incominciando, è debole e lo sa, e perché lo sa, per miracolo divino o per volontà, che è miracolo umano – e di solito le due forze si alleano – la sua condizione, e la sua dignità, è di superarsi. Per questo quando s’è salvato – come ha visto l’artista – è al di là di sé, al di là del dramma, egli è valore spirituale, e il dramma langue e perisce nella natura delle cose. Allora il sotterraneo mi s’è riempito di pellegrini. G. Ungaretti Santa Maria Maggiore Sipontina 193 Non c’era nessuno. C’erano impronte di piedi, impronte di mani, graffi sulla pietra, e un nome dentro ciascuna mano o ciascun piede. Pellegrini che erano arrivati qui cantando, anzi gridando: a piedi scalzi con il loro passo rapido, anzi impetuoso com’è la fede. E finalmente il loro piede aveva calcato il suolo sacro, la loro mano aveva toccato la pietra benedetta. Ne resti memoria per sempre! Sentirò per tutto questo mio correre dietro l’acqua, in su e in giù, dal Gargano a Caposele, il passo del pellegrino. E se non ne sentirò il passo, ne vedrò la traccia. Siamo tornati al prato. È il tocco. Ora si vede meglio come qui il sole detesti l’inverno. Ora ha potuto finire di aprirgli – direbbe Leonardo Sinisgalli, un giovane poeta delle parti d’Orazio, quasi di queste parti la mano superba e la noia del giorno ed esso, vinto, può prendere, come un presagio di primavera, un calore carnale. [Tratto da Deserto e dopo, GIUSEPPE UNGARETTI, Mondadori, Milano 1961] 195 La giovine maternità Giuseppe Ungaretti Manfredonia, il 6 marzo 1934 Là fu Siponto Siponto non è più che un nome musicale. Un Diomede laureato e il giavellotto fendente l’aria sopra la fuga d’un cinghiale: la celebrazione del fondatore d’una città in maremma, nel suono d’oro d’una moneta. Per tutta la riviera adriatica – come è del Tirreno, Enea – corre voce di questo Diomede dalla barba fiorita, e sono indecisi perfino quelli di Comacchio se vantarsi di discendere da lui o da Noè. La moneta è visibile nei musei. Ma perché il mito che porta i due rivali omerici a prosperare sui due lati della terra italica, non dovrebbe essere verità? È come una prima figura di quel mistero che avvierà sempre ogni sogno epico a sciogliere i suoi drammi sotto la chiarezza del nostro cielo. Un mucchio di monete nelle vetrine: Diomede e la ragazza con la corona di spighe, e l’uomo che rovescia un leone. Più alcune anfore piantate bene: memorie di braccia che, alzandosi per trattenere un peso nell’armonia rigogliosa dei passi, facevano impazzire. È tutta qui, Siponto? Ci sarebbe anche la cattedrale di cui si parlava l’altro giorno. E una città, finché una sua pietra sta ancora ritta, non può dirsi scomparsa e meta solo della memoria. Ma la speranza, perennemente attuale, in un certo senso ha strappato Santa Maria Maggiore al suo luogo e al suo tempo. Gridando aiuto, si chiama un generoso. Dov’è, che importa? E colla divinità che verrà mai a fare la storia? Eh, lo so che non si ha storia senza l’arrampicarsi verso lassù come un’edera, delle nostre passioni. E che, dopo tutto, all’uomo non resta che un pugno di storia. Che verrà mai a fare la storia? Questa Madonna dai grandi occhi non ha se non ricovero palese, fra gli unici muri di una metropoli rimasti ritti. Per miglia in giro, varcando solitudini, dal mare e dalla corona dei monti tutto un popolo nei suoi dolori 196 Verso Sud D. Grittani la sogna. Una chiesa non ha bisogno di dominare visibilmente un pigiarsi d’abitati per essere non il segno superstite d’una rovina, ma un nucleo vivo d’umanità. Anche come semplice lavorata pietra, è così poco ormai Siponto, decrepita pietra com’è. L’arte non la distacca più dalla natura. È, come la stessa Siponto, terreno anch’essa, stravaganza del terreno. Non è quasi più nemmeno una memoria anche l’acqua malata che a un re animoso fece ordinare l’esodo totale degli abitanti e fondare a qualche chilometro più in là, la città cui dette il nome. Ma forse la malaria non fu che un pretesto, e la necessità d’avere braccia per la costruzione d’un porto potente consigliò invece il guerriero. La memoria delle Paludi Sipontine stanno disperdendola le idrovore. Non ne resta ormai che un raro barlume viola nel vento. E in linea diritta davanti alla fu Siponto, l’arco di Manfredonia si volta giusto nel punto dove, pieno di freschezza e di appetito per l’abbondanza di seppie, lo sguardo dell’acqua marina si fa moro come quello di gitane. Azione e fede Torri, torri che a volte emergono da fondamenta marine e acquistano bellezza nel variare perenne dei riflessi, torri che si mantengono, nonostante l’altezza, d’una rotondità cospicua, torri, così carnali, malinconiche sotto i colpi della luce, torri che a volte armano una cattedrale ai quattro venti, guerra e preghiera, azione e fede alleate e fuse, ancora e sempre, è ciò che qui non ha paura del tempo. È il modo cordiale, diremmo, di celebrazione: è celebrare la divinità nell’uomo, cioè soltanto un momento umano particolarmente intenso, e quella luce che non ci abbandona mai e che vediamo così bene quando ci facciamo piccini piccini per amore e nei nostri momenti di disperazione. Un Italiano nella sua arte, anche parlando di morte, celebrerà sempre la vita. Se sono occhi, non avranno l’esorbitata fissità dell’icona, né tanto meno saranno quelli ghiacci e ancora più tremendi del feticcio sudanese. Noi non abbiamo mai pensato d’annientare la carriera del tempo immaginando, come gli Egiziani, una lancetta che ne avrebbe segnato senza fine il vano ripetersi. È un’idea di gente che il deserto circonda. Non mi sono mai meravigliato vivendo laggiù, che quegli Antichi pensassero che il tempo sia vinto dal tempo stesso, e cioè, il tempo essendo una misura, sia vinto dalla sua misura. Meridiane colossali, piramidi, una saetta d’ombra che i secoli non denaturano. E l’eterno? Morte! Mummie nell’orrore, nella cecità delle fosse di quelle piramidi. Per un Italiano poesia invece – anche se un’idea come quella degli Egiziani gli servirà da termine di rapporto – sarà G. Ungaretti La giovine maternità 197 l’illusione di perpetuare l’attimo che ci ha rapito il cuore, di perpetuare la vita d’un nostro attimo: ecco dove cerca pietà e forza e il divino, la nostra arte. La casa azzurra e gialla Con qualche torre che ci seguita, bruscamente entriamo in una selva di fichidindia. Il ficodindia non è una rarità. L’abbiamo incontrato tante volte a fare da siepe, o addossato a un rialzo di macerie, o come un’elefantiasi contendere lo spazio nei campi d’agrumi. Ma un intrico assoluto di questo verde idropico che tolga il respiro così a lungo, fino ai piedi del monte, può essere una sorpresa. Con che gioia uno di quegli «ahuan» che mangiano il vetro e i serpenti entrerebbe qui dentro e divorerebbe le foglie spinose, che evocano perfino la roccia nella loro mostruosità. Ma, sarà per un dolce venticello che muove quella pesantezza, ora tutte quelle foglie, quelle enormi orecchie sorde, sembrano essere salite sul naso di pagliacci equilibristi. E alle radici del Gargano, mentre la selva grottesca continua la sua risatina e ora vi ride alle spalle, e voi tornate invece a pensare a muri merlati nascenti dal mare, una casa azzurra e gialla vi accoglie sola sola. Un altro miracolo. Nel progetto di massima del 1902 per la distribuzione dell’acqua non erano compresi i comuni di Montesantangelo. E se l’acqua non riusciva mai ad arrivare dove avevano allora stabilito che dovesse arrivare, come avrebbe fatto ad arrivare un giorno lassù in cima? Nel 1925 si dà ordine che si compili un progetto di massima perché l’acqua vada fino lassù. Nel 1928 vengono compilati altri progetti esecutivi e i lavori vengono senz’altro rapidamente eseguiti. Non era una cosa facile. Sono stati risolti ardui problemi d’ingegneria che si presentavano per la prima volta: con semplicità, come sempre quando si fa sul serio. Ed ecco che, nella casa gialla ed azzurra, ora si muove l’impianto di sollevamento: sono pompe a stantuffo accoppiate a motori Diesel: sono le braccia e i polmoni d’acciaio di migliaia di ciclopi che mandano, senza affannarsi, silenziosamente, come nulla fosse, dallo spazio di poche decine i metri, una quarantina di litri d’acqua al secondo a un’altezza di quasi mille metri. Tutto questo organismo nero fa l’effetto di un’enorme dissimulata violenza che basta una mano d’uomo a dominare e a regolare senza sforzo. [Tratto da Deserto e dopo, GIUSEPPE UNGARETTI, Mondadori, Milano 1961] 199 Sabato Santo a Manfredonia Leonardo Sinisgalli Leonardo Sinisgalli (Montemurro, Potenza 1908 - 1981) Poeta fortemente legato al movimento ermetico - che rappresentò tuttavia senza eccessi di formalismo - autore di Poesie (1938), Campi Elisi (1939), I nuovi Campi Elisi (1947), La vigna vecchia (1956) e Fiori pari fiori dispari (1945). La lirica Sabato Santo a Manfredonia rappresenta un emozionante omaggio alla terra garganica, la cui suggestiva aridità deve aver rievocato in Sinisgalli i paesaggi brulli della Lucania. Di qua non resta più nessuno. Le anitre scivolano una dopo l’altra verso la buia sponda. Gli amici fondano una città celeste. Ci lasciano alle finestre contro il mare bruno come una montagna. Messaggeri tra vita e morte i fanciulli si tuffano a cogliere vermi sott’acqua e il vecchio pescatore aspetta che risorgano con un ramoscello di sangue tra le dita. [Poesia di LEONARDO SINISGALLI tratta da Cineraccio, Neri Pozza, Vicenza 1961] PARTE X Mattinata 203 Il farmacista di Mattinata Virgilio Lilli Virgilio Lilli (Cosenza 1907). Giornalista e scrittore, ha pubblicato Racconti di una guerra (1941), Gazzettino (1947) e Una donna s’allontana (1959). Inviato speciale del quotidiano milanese Corriere della Sera, sulle cui pagine il 17 luglio 1959 pubblicò il divertente elzeviro riportato in questa sede. A una ventina di chilometri da Manfredonia esiste un paese che ha un nome veramente chiaro e sereno. Si chiama Mattinata. Ma a Manfredonia la gente ve ne parla non per questo suo consolante nome, bensì a casa di una delle sue due farmacie. A noi, per esempio, accadde di sentirci dire: «Andate a Mattinata a comprarvi un tubetto d’aspirina o un calmante contro il mal di testa; ma fate attenzione: prima farmacia a sinistra entrando in paese. Ne vale la pena». Accettammo il suggerimento senza domandarci perché, per un tubetto d’aspirina del quale fra l’altro non avevamo bisogno, dovessimo fare quaranta chilometri andata e ritorno. Evidentemente volevamo riservarci il piacere (o la delusione) della sorpresa. Ci sembrò obbligatorio partire al mattino, convinti che un paese con un simile nome di pomeriggio non ci si sarebbe presentato nei suoi veri panni. Ma il tempo ci bloccò a Manfredonia quasi fino a sera. Improvvisamente, verso le dieci, scoppiò una gran tempesta di vento, subito seguita da una tempesta di pioggia e infine da una tempesta di mare, con onde gialle e sciroppose come fossero di catarro piuttosto che d’acqua. Verso le tre del pomeriggio, poi, una tromba d’aria. Detto fra parentesi, noi non avevamo mai assistito allo spettacolo d’una tromba d’aria. Ci trovavamo nell’atrio di un grazioso albergo moderno situato sul mare all’estremo limite del paese, e contemplavamo l’inferno della pioggia, del vento e dei cavalloni lungo la costa, quando udimmo una sirena lamentarsi con un grido lungo, cupo e accorato come in tempo di guerra. Pensammo si trattasse di qualche nuova difficoltà. Era, al contrario, la tromba d’aria. Constatammo così che le trombe d’aria suonano precisamente la tromba e ci domandammo se per caso esse non 204 Verso Sud D. Grittani dovessero il loro strano nome a questa particolarità più che alla forma di imbuto capovolto che ha il loro risucchio. Si tratta comunque di furie. Questa che ascoltammo con i nostri orecchi nel giro di pochi minuti aveva scoperchiato un grosso casamento sul mare, abbattuto un lungo muro sulla strada dietro quel casamento e sradicato una decina di pini. Sempre detto fra parentesi, noi finimmo col credere che a Manfredonia e dintorni le trombe d’aria fossero di casa, per il fatto che qualche minuto dopo quel putiferio la polizia era già arrivata sul posto e con la polizia era arrivata una squadra di operai e di tecnici che già rimettevano ordine, con una efficienza da veri e propri «specialisti in trombe d’aria». Qualcuno ci informò più tardi che trombe d’aria a Manfredonia, invece, non se ne vedono quasi mai. Segno che quei pugliesi, i quali nell’Italia del centro e del nord vengono ritenuti «meridionali sonnolenti, pigri, infingardi» e via di seguito, hanno i riflessi anche più rapidi di certi settentrionali; senza contare l’organizzazione. Mentre noi li osservavamo con piacere, così alacri ed efficienti sul luogo dell’incidente, la tempesta, che s’era alquanto addolcita tanto da consentirci d’uscire, se ne andò com’era venuta e il sole tornò a splendere come nulla fosse stato. Lavata dall’acquazzone, Manfredonia appariva ora d’una essenzialità perfino eccessiva, i filari delle sue case avevano assunto una piattezza grafica da tavola a colori. E a questo proposito vorrei anzi dire di passaggio che nei paesi marittimi della Puglia, sotto il Gargano, c’è molta Grecia e allo stesso tempo un po’ di Venezia. Non la Grecia, naturalmente, delle acropoli, dei templi, degli stadi, ma la Grecia d’oggi: la casta e asciutta magrezza dei paesi della costa del Peloponneso, soprattutto, e anche delle Cicladi. Quanto a Venezia, è chiaro non si tratti del molle e colorato sfarzo del Canal Grande ma della schematicità teatrale dei suoi quartieri più poveri: gli stessi intonachi delle mura, le stesse cornici bianche tutt’intorno alle finestre e alle porte, e per finire l’atmosfera di palazzo che hanno anche le catapecchie, da quella di palcoscenico, con la gente seduta sugli usci, all’aperto, quasi attendesse di cominciare una recita: come nei campielli. A parte queste considerazioni d’ordine generale, passata la tempesta ce ne andammo a Mattinata. Il sole era ora fulgido proprio come di mattina, e sarebbe stato veramente un capriccio letterario insistere su quel contrasto fra il nome «Mattinata» e il fatto «pomeriggio». Prendemmo dunque la strada litoranea garganica, che da Manfredonia segue l’intera costa del promontorio e, dopo Mattinata, andrà a Vieste, a Peschici, a San Menaio, a Rodi Garganico fino a lambire la laguna di Varano per poi innestarsi, a San Severo, sulla Foggia-Termoli. Si tratta di una delle strade più splendenti del mondo, una di quelle che si contano sulle dita di una mano, come la amalfitana, la GuernavacaAcapulco al Messico, quella costiera (occidentale) di Shikoku, in Giappone, la Atene-Capo Sunion in Grecia, eccetera. Dentro il sole, dopo il lavacro d’una pioggia V. Lilli Il farmacista di Mattinata 205 tempestosa, su questa strada i colori del mare, del cielo, delle rocce, dei fiori di campo e della campagna, non solo ma il colore dell’asfalto perfino sembra sia l’occhio a crearli nello stesso momento che li guarda; tanto immediata è la loro presenza e immacolata la loro purezza. (E quanti italiani del centro e del nord conoscono sia pure la sola esistenza d’una simile meraviglia?). A Mattinata, sulla sinistra della via centrale arrivandoci da Manfredonia, ci recammo alla farmacia indicataci. E ci sorprese che la via centrale, appunto, si chiamasse corso matino (con un t solo a differenza del nome del paese che ne ha due). Anzi ne domandammo un po’ qua un po’ là una spiegazione, subito: e alcuni ci dissero che il paese essendo esposto a Oriente, il sole lo scopre appena si leva dal mare, di primo mattino, e così gli ha dato il nome (passandolo anche alla sua strada principale); altri che quel nome non ha niente a che vedere col sole e il mattino, ma che si tratta d’una derivazione linguistica greca o addirittura sanscrita della quale non sanno di più. Fuori della farmacia non notammo nessuna insegna che ce ne dicesse il nome o il nome del proprietario; soltanto, al di sopra della porta riparata da una tenda di lunghi fili di perline colorate, una lanterna anch’essa colorata faceva trasparire attraverso i vetri smerigliati una piccola croce rossa. Superata la porta ci trovammo in un locale più profondo che largo, immerso in una gradevole penombra, diviso vagamente in due settori: un settore verso la strada con vetrine e armadi alle pareti, e un settore più interno col bancone di vendita dietro al quale, del resto, altre vetrine e armadi si incollavano alla parete. Un ampio retrobottega o studio infine, si intravedeva da una porta semiaperta sulla parete di fondo, con scaffali, armadi, vetrine e uno scrittoio maggiolini davanti a una poltrona con tappezzeria rosso vermiglio. Il farmacista era un uomo di mezza età, piuttosto piccolo e asciutto, di viso abbronzato, regolarissimo e di modi riservati, ma con qualche bruschezza. Non vestiva il camice bianco dei farmacisti e si muoveva fra i clienti, la più parte contadini, come un ufficiale fra la sua truppa, con affetto, cioè, e autorità. Lo aiutava nel suo lavoro una ragazzetta dagli occhi nerissimi, incantati. Noi gli chiedemmo un tubetto di aspirina in attesa che avvenisse qualcosa di interessante; ma egli ce lo dette cortesemente come in una qualsiasi farmacia del mondo. Ci disponevamo così, ad andarcene piuttosto contrariati (ma nello stesso tempo incerti se dire al farmacista: «Ebbene, che cosa c’è di nuovo e di bello qua dentro?»), quando, abituati gli occhi alla penombra, notammo nelle vetrine e negli armadietti più prossimi alla porta d’uscita oggetti piuttosto insoliti nelle vetrine e negli armadi delle farmacie. Si trattava di anfore di fattura greca, di lacrimatoi che parevano usciti allora da tombe precristiane, di piatti, vasi, ampolle, e poi monili, e poi specchi, e poi perfino spilli eccetera eccetera la cui età andava visibilmente sopra i due millenni. 206 Verso Sud D. Grittani Sorpresi, buttammo uno sguardo più attento sulle vetrine e sugli armadi dietro il bancone: anch’essi contenevano oggetti archeologici o comunque da museo. E ne contenevano teche e scaffali ai lati del bancone, insieme con lumi a petrolio del secolo scorso, assai lunghi e gracili, forse napoletani, e a ceramiche cinquecentesche e ottocentesche, di Faenza, di Napoli e anche pugliesi, a pezzi di cultura barocca e altro. Tutto, per la verità, un poco confuso, forse di proposito, nell’intento che una disposizione da catalogo non sfreddasse l’intimo calore di quel mescolarsi di così disparate testimonianze del tempo. Avvedutosi del nostro interesse, d’altra parte, il farmacista, sempre impegnato a servire i suoi taciturni clienti, ci fece segno con la testa di entrare nel retrobottega, e di dare un’occhiata a nostro comodo alle sue collezioni. Così noi facemmo; e trovammo il solito grazioso e prezioso confondersi di oggetti di scavo con oggetti di più recente antiquariato e perfino con qualche ciaffo. Ciotole romano-campane, vasi di Ruvo, brocche e anfore italiche, greche e simili sugli scaffali, e perfino sul pavimento di quel bizzarro laboratorio chimicofarmaceutico, alitavano decisamente intorno una atmosfera romana da via del Babuino e da Villa Giulia allo stesso tempo, sia pure in diciottesimo; fra una terracotta e l’altra s’avvertiva perfino la presenza enigmatica degli etruschi, molto grecizzati come mi pare avvenga particolarmente al sud, ma forse per questo più dolci e cordiali. Unica testimonianza d’oggi, una foto grande come un manifesto mostrava una bellissima ragazza in costume garganico, la quale volgendo le spalle all’obiettivo metteva elegantemente in luce un ampissimo scialle; ed era la figlia di lui, del farmacista. Né mancava San Michele. Questo arcangelo così congeniale ai cattolici anglosassoni è intensamente amato dai pugliesi che, sul Gargano, lo considerano una specie di padre della patria e lo venerano nel santuario di Monte Sant’Angelo sotto le spoglie d’una piacevole scultura attribuita al Sansovino. Nel laboratorio-studiomuseo nel quale ci trovavamo, di San Michele ce ne era una vasta collezione d’esemplari, fra i quali una copia abbastanza preziosa di quello sansoviniano. È necessario dichiarare ora che un uomo come questo farmacista archeologo è la stessa Puglia in carne ed ossa? Il figlio tipico di una civiltà che riesce a fondere senza stridori certi fatti della vita essenzialmente umani nel senso anche più pratico della parola con certi fatti della intelligenza essenzialmente umani nel senso anche più fantastico della parola. (Quanto alla nostra personale esperienza, la più simpatica aspirina della nostra esistenza è ovvio rimarrà quella di Mattinata). [Articolo di VIRGILIO LILLI tratto dal quotidiano Corriere della Sera, Milano 17 luglio 1959] PARTE XI Rodi Garganico 209 Fotogrammi di Rodi Minor Giuseppe Cassieri Giuseppe Cassieri (Rodi Garganico 1926). Autore tra i più originali della narrativa italiana, il garganico Giuseppe Cassieri è noto soprattutto per la sua opera d’esordio La cocuzza (1960), quindi per Ingannare l’attesa (1979, Premio Selezione Campiello), per lo sferzante romanzo Diario di un convertito (1985) e per Un asino al patibolo (1983, Premio Ennio Flaiano per il teatro). La prosa Fotogrammi di Rodi Minor, che qui viene riproposta integralmente, apparve in versione notevolmente ridotta sulle pagine culturali del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno il 23 agosto del 1989. Pare assodato che il Giannone, tutto preso dai suoi impegni storici e giusnaturalistici, precocemente coinvolto in circostanze politiche che dovevano allontanarlo per sempre dalla nativa Ischitella, non abbia lasciato alcuna impressione autobiografica sulla piccola Rodi, pur a tiro d’archibugio dalla casa dove venne alla luce. Non uno strappo lirico, non un atteggiamento stupefatto dinanzi alla natura che da monte a mare, a lago, passando per boschi e valloncelli, si compendiava in un guazzetto alla Poussin. Dimenticanza troppo grave all’occhio dei rodiani perché memorialisti coevi e posteriori a Pietro Giannone, specie Michele Rotunno e Antonio Vaccaro, non facessero del loro meglio per restringere nelle Appendici i meriti di chi minacciava di guadagnarsi la posterità nonostante quella e altrettali lacune. E anche quando, pochi decenni orsono, un prefetto di Foggia, imbeccato dall’alto, suggerì ai sindaci garganici di intitolare una strada all’autore del Triregno, nella piccola Rodi prevalse l’antico dispetto sul sussurrato rispetto, e il Consiglio municipale pervenne alla deliberazione di chiamare Corso Giannone una sconnessa fettuccia extramurale. Forse l’ubicazione della targa in quell’angolo derelitto fu soltanto genericamente irriguardoso: la periferia e basta; ma non si può escludere 210 Verso Sud D. Grittani che un ispirato giustiziere abbia suggerito quel «Corso» per applicare una sorta di contrappasso. Di che, in fondo, si era occupato l’autore del Triregno, parlando di sé, nella Vita? Per caso dei trastulli dell’infanzia al cospetto degli aranceti, dei gagliardi oliveti, dei giganteschi olmi e lecci, delle acque zampillanti al tocco di ogni verga? Per caso delle anguille e dei capitoni del Varano, con un sospiro nostalgico per gli eccezionali arrosti alla griglia, in una combinazione aromatica di menta e rosmarino? O delle dolci colline agrumifere da cui contemplare le Diomedee (non ancora volgarizzate in isole Tremiti) avvolte nell’oro del mito? Niente, niente in quelle pagine «raspose» che fosse spia di uno spirito innamorato della sua terra, lusingato di portarne in giro le tracce. Quel pochissimo che vi aveva dedicato, ricostruendo gli anni dell’infanzia, ecco in che si distillava: nome e cognome («ci mancherebbe!» commenta scandalizzato il Rotunno) dei genitori e di qualche stretto parente; nome e cognome del prete che gli insegnò grammatica latina; e dopo siffatte minutaglie l’episodio a piene lettere dell’imbarazzo viscerale, sicuramente grave («ma dov’è quel fanciullo che non ne ha avuto e non ne avrà?» – vedi A. Vaccaro) per cui Pietruccio stette tra vita e morte. E insistendo sui dettagli – con tutto quello che c’era da dire sulla popolazione e sul paesaggio – quale meraviglia giunge a insinuare il grande storico? L’imbecillità, l’ignoranza dello speziale («sissignore, sarà stato vero, ma carità di patria richiedeva di non perpetuar il qui-pro-quo di un conterraneo» – M. Rotunno, ibidem) che aveva venduto alla madre del malatino chissà che famigerato purgante, se gli fece rischiare la liberazione precoce dell’anima. Nessun dubbio che l’avesse scampata «col favore di un Arcangelo» e che Pietruccio fosse rimasto così traumatizzato da quella «profluvie», da risultare per contrasto molto stitico in veste di autobiografo. Ma si poteva liquidare in due pagine sommarie e fortemente «realistiche» l’ellenica bellezza dello «Sperone d’Italia» (M. Rotunno e A. Vaccaro all’unisono) e partirsene da mercenario? Meglio, allora, il totale rigetto. Si aggiunga che un contemporaneo dell’ischitellano, Giacomo Ventrella, frate cappuccino di incerta provenienza, scrivendo la sua «Istoria apula», usciva a dire, a coronamento di un inno antropico: «Qui, a Rodi minor, figlia diletta della Rodi major, innanzi che gli uomini abitarono gli dei». Si aggiunga che il frate, in agonia, volle essere trasportato dai confratelli sulla loggia del convento per godersi in un’estrema panoramica la dimora dei buongustai pagani, parafrasando nei gemiti il verso riferito a S. Cristoforo: «Rodi videas, postea beatus eas…». Si tenga presente questo parallelo sapientemente ravvicinato dal Rotunno e dal Vaccaro, e si spiegherà l’abbondanza delle monografie ventrelliane nelle contrade del Promontorio, nonché l’intestazione del Belvedere all’appassionato cappuccino, col corsivo: «Rodi videas, postea beatus eas». Un po’ più elaborato, se si vuole, del «Vedi Napoli e poi muori», ma appunto G. Cassieri Fotogrammi di Rodi Minor 211 per questo in armonia con la struttura notevolmente orgogliosa dei rodiani (a proposito, il Rotunno si batte per Rodî in disaccordo col Vaccaro che propone rodiesi) i quali, se accettano di discendere da Rodi Egeo, disdegnano legami di lingua e di sangue con le città del Tirreno, alla stessa stregua che da sempre disdegnano Roma e Garibaldi (l’una per non aver provveduto, nei fasti consolari, a una ramificazione dell’Appia, l’altro per non avervi fatto tappa nel suo zingaresco viaggio nel meridione), né si sgomentano di affrontare l’economia di mercato avventurandosi da soli nel mondo. Tanto che oggi non c’è volantino compilato dalla Pro-Loco che non riporti il verso del Ventrella, e finanche sulla «Frankfurter Allgemeine Zeitung», fidando sul romanticismo germanico, le inserzioni che vi fanno comparire gli affittacamere concludono col: «Rodi videas…». Cosa dunque troveranno, appena approdati, i visitatori stranieri e, similmente, gli italiani attratti dal medesimo slogan? Per la verità, di Omero non è accertabile alcunché, e perfino il Rotunno e il Vaccaro debbono convenire che l’«omerico» vale per definizione augurale, nel senso che un luogo così fatto sarebbe immensamente piaciuto a Omero. Su questo non si può dar loro torto. Rodi minor si pronuncia a sprone sullo spartiacque del medio e basso Adriatico dopo che – un’illusione ottica cui difficilmente si sfugge – ha «chiesto» alla campagna circostante di potersi sfoltire di alberi, coprirsi di caseggiati insolitamente alti, e bagnarsi tra gli scogli. Per essere situata, come si diceva, al punto di congiunzione del basso e medio Adriatico, accade che il paesino sfugga a ogni determinismo meteorologico e il campo cursorio dei venti e delle piogge obbedisca a una circoscritta validità ambientale. Questo non vuol dire che la sua posizione sia assolutamente privilegiata rispetto al resto del Gargano e che nella risacca si spengano per magìa le ire del grecolevante; ma è innegabile che un certo favorevole gioco di correnti si attui se l’inverno si congloba nell’autunno, se l’estate è lunga ma ombrosa, se la primavera si traduce in una frenesia di aranci fioriti. Giacché questa è, infine, la riprova della straordinaria mitezza: la predominanza di agrumi sugli oliveti e sulle altre colture. Scarsi i cereali, rari gli eucalipti, defilati i cipressi e, segno di squisita attenzione della dea Pomona (il Ventrella, il Rotunno e il Vaccaro in perfetta coincidenza di vedute), la varietà della frutta; dai fichi che maturano in cinque qualità e resistono sui rami da giugno a novembre, ai fichidindia della durezza di una cassata e del colore di un fiocco cardinalizio, prugne e susine, percoche e pere spadone, amarene e nespole, uva moscata, carrube grasse col miele che scorre come tiepido mercurio nella guainella e, si capisce, la regina del corteo, l’arancia. Quest’ultima, i rodiani hanno faticato un paio di secoli per imporla come la migliore del Mediterraneo, ma non avendo ottenuto autorevoli riscontri, hanno fatto sapere in Sicilia, in Calabria, a Sorrento 212 Verso Sud D. Grittani che la riconoscevano essi come tale ed erano superflue ulteriori tavole rotonde. Vittoria più facile, e forse mai contestata, l’ebbero viceversa con i limoni. Agronomi, docenti universitari, esportatori e medici di chiara fama non esitarono a individuare nel grado di acidità del limone rodiano una caratteristica che lo poneva automaticamente in una posizione di gran rilievo «su scala internazionale». Durante il colera del 1866, le statistiche assicurano che fu possibile risparmiare qualche migliaio di vite umane proprio in virtù dei rodianissimi limoni, mentre a San Severo, a Foggia e più lontano l’epidemia faceva tale strage da generare empietà nei sopravvissuti. Non si contarono i morti che poi non erano veramente morti ma appena presunti, seppelliti in fretta, con manifesti segni di «sepolti vivi». Anche nella piccola Rodi, ci tramanda un memorialista più equanime del Vaccaro e del Rotunno, Luigi Vigliaroli, un’anziana signora, colpita da semplice collasso, venne sepolta in un bagno di calce nella Chiesa del Crocifisso su istanza del figlioccio sconvolto dall’idea del contagio. Ma subito il Vigliaroli aggiunge che furono i bravi trabaccoli rodiani a sfidare i divieti delle autorità sanitarie, a caricare la stiva del prezioso prodotto e a trasportarlo nottetempo in Dalmazia, allorché nel 1893, nel 1907 e nel 1913 taluni centri di quella regione furono investiti dal disastroso morbo. Conti alla mano, non si può comunque negare che arance e limoni siano qui diventati un lusso da principato di Monaco. Con tutta la protezione della Vergine della Libera e la benignità atmosferica, ogni quattro, cinque, sei anni si verifica la «gelata»: a due gradi partono i limoni e a tre gradi sotto zero marciscono le più superbe arance. Il che significa non solo fallimento del raccolto in atto, bensì pregiudizio per moltissime piante ferite nel tronco. Se la natura rispetta i suoi cicli a un lustro dalla gelata è probabile che il raccolto venga su pieno, sì che molti agrumieri saldano i debiti, imbellettano la casa, mandano i figli all’università. Se però nelle annate di recupero Spagna e Israele inondano il mercato a prezzi concorrenziali, la completezza del raccolto paga un cospicuo tributo alla scarsa possibilità di reggere il confronto. Al quinto, al sesto o al settimo anno, stando alle statistiche, il gelo ricompare e il paese torna a radunare «le sue lacrime e le sue preci» dietro il manto della Vergine della Libera portata in processione dal Santuario al Belvedere, nella speranza, – mai assecondata, a detta dei memorialisti – che le falde di neve si posino impunemente sull’aurea scorza. Accertato infine, come pure è stato accertato, che Rodi minor è atavicamente edonistica, e la sua fisionomia tradisce quel tanto di fragile e iridescente che è nel carattere delle civiltà bizantine, essa vanta qualcosa che i paesi garganici della mezza montagna non possono assolutamente eguagliare: la nessuna inclinazione alla rissosità, all’avarizia, al crimine. G. Cassieri Fotogrammi di Rodi Minor 213 I registri della Pretura permettono di riscontrare come sia inequivoco questo aspetto sociale: contro la ridda dei delitti consumati, nel giro di trent’anni, in agro di Carpino, Cagnano, Sannicandro, San Marco, San Giovanni, il rapporto è di uno a mille. Il furto più frequente a Rodi minor avrebbe fatto impazzire di tenerezza Goethe, se costui si fosse spinto sullo «Sperone» (vedi il Vigliaroli, ibidem) «anziché perdere tanto tempo a Napoli»: l’innocente e davvero omerica concupiscenza di fichi che trova appagamento nelle «uccelline», nelle «verdesche», nelle «cipressuole», nei «faraoni». Per i cinque mesi in cui matura e si moltiplica questo frutto prodigioso, chi non ne possiede in proprio non resiste alla tentazione d’intrufolarsi nelle campagne altrui, arrampicarsi sulle piante, allentarsi la cinta e starsene lì accovacciato fino all’estinzione del desiderio. Non a caso, volendo dire nel gergo rodiano fare scempio di qualcosa, si dice comunemente: «È stato conciato a pedafico» (cioè ad albero di fico follemente strapazzato). Metastasi espressiva in cui è da leggere a un tempo il piacere della trasgressione in sé e il trionfo papillare della sensualità. [Testo di GIUSEPPE CASSIERI, pubblicato non integralmente dal quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, Bari 23 agosto 1989] PARTE XII Peschici 217 Peschici Antonio Baldini Antonio Baldini (Roma 1889 - 1962). Tra i più illustri rappresentanti del movimento letterario La Ronda, con il magistrale elzeviro Indicazione del Gargano a uno straniero dubbioso (pubblicato dal Corriere della Sera il 18 giugno 1925), Antonio Baldini ha firmato alcune delle pagine più belle che siano mai state dedicate alla cosiddetta “montagna sacra”. Nel racconto che segue, pubblicato nella raccolta di novelle Italia di Bonincontro, si noti curiosamente come Baldini potrebbe essere ritenuto presago della fortuna che (ben settantatre anni dopo, cioè nel 1998) avrebbe regalato a Peschici la straordinaria vincita di 63 miliardi al SuperEnalotto. Lo si noti, soprattutto, nel passo che recita «Che favola mai è questo vostro paese? Garantisco che potrebbe fornire ottimi scenari e argomenti a qualunque favola, leggenda o romanzo...» «E così non siete mai stato in Italia?» «Oimè signore! è mio desiderio, studio e proposito antico conoscere personalmente vostra bella Italia.» «E, di grazia, che aspettate a decidervi? Sento che conoscete già così bene la nostra lingua e mostrate d’essere informato delle cose nostre antiche e moderne assai meglio di tanti italiani.» «Grazie. Qui sta il male. Intanto vi dirò che una delle ragioni che mi tiene dal venire in Italia è che Alinari l’ha già tutta fotografata.» «E che male vi ha fatto con questo il povero Alinari?» «Che oramai Italia, senza esserci stato mi pare di conoscerla lo stesso.» «Che mi dite!» «Che vi dico? Venezia e la Ca’ d’oro, va bene? Firenze e il Ponte vecchio, va bene? Napoli, Pompei, il cratere che fuma, la grotta azzurra, va bene? il dolze far niente, il campanil di Pisa, pergole d’Amalfi e di Sorrento, il Colosseo, templi di Girgenti e di Pesto sotto la luna, va bene? – sono oramai cose troppo conosciute, troppo 218 Verso Sud D. Grittani suonate, sempre e dovunque sentite dire, da mio padre, da mio nonno, da mio suocero, e passate e ripassate per tutte le salse di colore e di parole; e io conosco per prova, signore, la delusione di ritrovar sul posto la cosa che c’eravamo immaginata né più né meno di come proprio ce l’eravamo immaginata. Vostra troppo famosa Italia mi desta molto affanno, signore. Domando: non ci sarebbe forse modo di entrare in lei da una porta di servizio dove non fosse nulla di famoso da vedere? non avreste, tanto per cominciare, un paese senza conosciute rovine, senza gondole, senza Garibaldi, senza torri che pendono, senza grotte che parlano, senza monti che fumano, senza tarantella, senza pescatore che accomoda le reti, senza tramonti al sugo di tomate? Scusate come parlo, mio signore. Non è detto che anche io a tempo e luogo non stimerei dovermi incontrare con vostri panorami e monumenti universalmente noti, ma un momento di respiro nel principio, oh pregherei molto, signore! Arrivarci di fianco, di sorpresa, incognito, quasi per combinazione, questo vorrei: non capitargli incontro a suono di musica, come in viaggi di nozze, ciceroni in testa e vetturali in coda, mio signore. E il campanile pendesse pure quanto gli pare, il Vesuvio fumasse pure con tutto il suo comodo, e la grotta fosse pure azzurra a suo talento, ma vorrei che venuto per me il momento di vederle, tutte queste meravigliose cose non avessero aria di darla a intendere come a un primo venuto. So bene, signore, che il difetto non è tanto nelle cose quanto nella memoria già guastata da troppe letture sull’argomento e nei miei occhi che hanno già veduto troppi quadri, troppe stampe, troppe oleografie, «Santuzza credimi», troppo Alinari. Voi, mio signore, avete l’aria di ridere; ma io torno a domandarvi: non avreste, per anticamera del mio soggiorno in vostro paese, da consigliarmi Italia di prova, di mezza luce, senza storia, per soli amatori, fuori delle zone troppo illustrate, bella senza cornice e all’insaputa di Alinari, di Dante, Carducci, Gregorovius, d’Annunzio, Bertacchi? da poterci fare un po’ di quarantena innanzi d’affrontare la gran tràppola aperta al forastiero? Vi siete reso conto, signore, di quello che senza offesa per nessuno io voglio dire?» «Perfettamente. E vi dirò che io credo d’aver avuto per le mani quanto di meglio farebbe al caso vostro e di altri che si possano trovare nelle vostre condizioni. Ascoltate. Che ne direste, se invece della grande Italia allungata da N. a S. pei viaggi di nozze coi grandi Espressi, vi dessi, come voi chiedete, una minuscola Italia di prova, che andasse invece da O. ad E., ancora «nuova per queste scene» e senza la più piccola traccia di strada ferrata? una piccolissima Italia, ancora inedita, quintesenziata, con degli abitanti sui generis, con un appennino e dei laghi tutti per lei, e con un assaggio assai compendioso e istruttivo (sopra una lunghezza di settanta e una larghezza di quaranta chilometri circa) del colore e delle caratteristiche di paesaggio e di cultura di molte, se non di tutte, le altre terre italiane di maggiore spicco: voglio A. Baldini Peschici 219 dire con un poco di Liguria e un poco di Sicilia, un poco d’Istria e un poco di Toscana, un poco d’Umbria e un poco di Calabria, un po’ di Capri e un po’ di Ciociarìa? Che ne direste?» «Accettato. Ma esiste questa terra veramente?» «Pensate dunque che bellezza! una piccola Italia così poco conosciuta dagli stessi italiani che anche tra le persone colte molti non sanno, facendo il suo nome, dove lasciar cadere l’accento; una vera piccola Italia ricca di boschi, di storie, di santità, di leggende, della quale il Baedeker non dice nulla e probabilmente lo stesso Alinari s’è dimenticato. Vi va? si combina?» «Corpo di mondo, io domando se esiste veramente la terra che voi dite.» «Esiste. Un’ora di mulo vi fa salire, dalla regione dei fichi d’India, dove abbondano i capperi sulle mura arroventate dal sole, a quella delle carboniere nelle gole umidissime del monte. Una mezz’ora di carrozza vi trasporta dalle agrumifere terre ancora profumate dalla canzone di Mignon alla rada turchina delle ecloghe pescherecce del Sannazaro. Una corsa a ruota libera in bicicletta, per ottime strade, attraverso pascolo e foresta, vi fa riuscire, giù da un grigio e scorbutico villaggio di Schiavonìa nella piazza deserta e abbagliante d’un paese tutto arabo sul mare. Gli ulivi che accuratamente coltivati per tutto un fronte di colline fanno tornare a mente certi dolci aspetti dell’Umbria francescana, per poco che salga la costa voi li vedete uscir di terra grandi e selvaggi come quelli del gebel tripolitano. E voi, voi che mostrate d’aver in tanto sospetto i motivi troppo pittoreschi della nostra vita regionale, dove io vi voglio portare potrete lasciarvi servire tranquillo. Le facce che incontrerete per le vie di quei monti è difficile che le abbiate viste in altre vetrine. Nel paese che dico debbono far presto a invecchiare, perché di giovani se ne vedono pochi: e invecchiando non pigliano quell’aria arzilla, benigna, quella comune dolce figura d’attaccabottoni che sullo scenario d’una qualunque piazzetta italiana si può sempre facilmente figurare in polpe goldoniane di scrivano pubblico o in berretta di «pescatore-affonda-l’esca»; ma dal loro viso di serio e buon galeotto tutto tagliuzzato di rughe traluce una certa chiusa illirica tristezza. Quello che offrono è un figurino assurdo, come chi dicesse un barcarolo di montagna. Essi e le loro famiglie vanno a bisdosso dell’antico cavallo pugliese, che nei tempi dei tempi fu incrociato coll’arabo; e quando il cavallo memore dell’antica generosità fa uno scarto escon dal gruppo nugoli di mosche. Paese incrostato di storia più di qualunque altro; ma con questo di buono, che lì la storia non fa più rumore di quanto ne possan fare nei meriggi estivi le onde del mare e le fronde del bosco: e quando tutto tace anch’essa tace e schiaccia il pisolino dell’erudito locale nella libreria senza pretese. I monumenti che ci sono cercano di non farsi vedere o spuntano con tutta discrezione da un verde di giardini profuma- 220 Verso Sud D. Grittani ti. Per lo più sono vecchie torri alzate un giorno invano sul litorale contro i pirati turchesi che desolarono a varie riprese la regione, e che ora, rimbiancate di calce, servono d’alloggio alle guardie di finanza. Potete fidarvi, signore. Qui la storia non abbaia e non morde. Sonnecchia. Ma come talora il buon vino dà forza mirabile a quei sapori misti di cedro, di fragole e di popone che son chiusi nella polpa dell’ananasso, così nell’ardente silenzio di questa regione voi potrete a momenti gustare senza troppa fatica come un sapore misto delle varie civiltà che lentamente una dopo l’altra vi si sono posate nel fondo, ogni volta lasciandovi qualche cosa di nuovo e d’inconfondibile per secoli dei secoli sulla faccia dei più poveri abituri, nell’aria stessa, nei visi degli abitanti, nei costumi, nella favella e fin nella bardatura degli animali domestici: trasmissioni e influenze longobarde, bizantine normanne, saracene… » «Che favola mai è questo vostro paese?» «Garantisco che potrebbe fornire ottimi scenari e argomenti a qualunque favola, leggenda o romanzo, ecloga o poema, tanto è vario, animato, risentito, pittoresco; e non ancora sfruttato. Chi voglia vederlo, c’è il sasso dove prima apparve all’Occidente Michele Arcangelo ancora sonante del suo lungo volo attraverso il mar di Venere. Chi voglia ricorrervi, c’è perfino un santo in carne e ossa e con tanto di stímmate, in un bianco convento di Minori Cappuccini. Chi li preferisca, troverà sul monte scenari di bosco e caverne, dove ancora non s’è bene spento il ricordo dei briganti che sul primo tempo del Regno assaltavano la corriera postale italiana al grido di viva Francesco secondo! E ci sono castelli e torri in rovina che la sera della domenica s’empiono di suonatori di chitarra con dei berretti che non avrete mai visto gli uguali sulle stampe che dite. E ci sono i grossi paesi del monte, candidi sulla roccia a ottocento e più metri sul mare, colle più capricciose accostature e incrociature di casa con casa, di scale esterne, arconi, terrazze, poggiuoli, che sia dato vedere per tutto l’Adriatico. Vanno le nere capre per le strade e le piazze, pare impossibile, senza insudiciare. La gente coglie tutti i pretesti per portare le seggiole sul marciapiede e siede soddisfatta guardandosi attorno. Le ragazze restano in piedi sull’uscio o sedute sul primo scalino. Tra le bianche case senza cornicione il giorno non finisce mai di tramontare e attorno alle minuscole finestre filze di bucce d’arancio messe a seccare pare che trattengano per loro conto la luce del sole fino a scuro. Secca allegria, questa per tutto diffusa decorazione di bucce, che sta a significare né più né meno che questo: che una delle più invidiate ricchezze del luogo non potendo essere inoltrata per mancanza di mezzi di comunicazione nei varî mercati di consumo marcisce sul posto e la gente non ne riesce a salvare e utilizzare che la sola corteccia. Secca allegria che lega meravigliosamente con quella dei balestrucci che rigano indefessi l’aria tra le rocche dei camini. Sull’ora più fresca finalmente anche A. Baldini Peschici 221 le famiglie della borghesia tiran su gli storini dipinti e comparendo colle sèggiole sul poggiuolo si assidono in ordinata mostra.» «Il bel paese che voi mi dipingete!» «Scendiamo alla marina, signore. Verdi, allegri, lucenti d’agrumi s’affacciano uno dopo l’altro sul mare deserto i colli del buon lavoro e deliziosi viottoli vi si perdon fra mezzo salendo. Su pei colli si vedono qua e là fitte incannucciate difendere i giardini dai crudi venti del nord, e dietro l’incannucciate, gli alberi punteggiati d’oro e caldi di sole sorridono come donne dietro il ventaglio. Però sulla strada litorale che il mare lambisce fanno miglior difesa contro i venti e il sale lunghe mura arcate che pel tesoro ombroso e profumato che celano al nostro sguardo possono con una certa insistenza far pensare anche alle bianche mura di un harem. Vi dico che di notte, alla viva luce delle stelle, quando un’arietta vagante porta in giro mescolati odori di pino e d’arancio e nel silenzio cullato dal mare fa cigolare un fanale che rabesca d’ombre strane quel muro di clausura, vien davvero la voglia di dargli la scalata… I paesi costieri scoprono i lumi un dell’altro protesi sul vuoto mare e vedono alterne accendersi e spegnersi le luci dei fari. Davvero non so in qual altro paese d’Italia possa esserci un silenzio così alto. Il treno più vicino si ferma a settanta chilometri. I pazienti coltivatori dormono in pace nelle loro villette in cima ai colli e dimenticando la frutta andata a male per anni e anni nei fossi ascoltano in sogno il fischio lontano della ferrovia che il sottosegretario deputato del luogo ha promesso in questi giorni alla nobile terra del Gargano.» [Tratto da Italia di Bonincontro, ANTONIO BALDINI, Sansoni 1940] PARTE XIII Monte Sant’Angelo 225 Descrittione del Monte Santo Angelo Leandro Alberti Leandro Alberti (Bologna 1479 - 1553). Frate domenicano, a seguito di un lungo viaggio compiuto al servizio del generale dell’ordine Francesco Silvestri da Ferrara pubblicò la vastissima opera Descrittione di tutta Italia nella quale si contiene il sito di essa, l’origine e la signoria delle città et de’ Castelli, risalente all’anno 1550. Da questa è tratta la Descrittione del Monte Santo Angelo, prosa che si rivelò un utile strumento per chi - qualche anno dopo riprese a battere i lunghi sentieri della fede della Via Sacra Langobardoruum. Seguitando poi il lito ritrovasi la città di Manfredonia posta sopra la sassosa rupe del golfo del mare del monte Gargano, che riguarda al Settentrione. Fu edificata questa città di Manfredi Ré, figliolo di Federico II. Imperatore nell’anno 1200. da che prese la nostra fragil carne il figliol di Dio, e la nominò dal suo nome Manfredonia, che avanti era detta porto di Capitanata, secondo Pondolfo Collenuccio nel 4. lib. dell’hist. del regno. Et la fece detta Manfredo essendo roinato Ciponte, e trasferico il seggio archiepiscopale quivi da Siponte, avvenga che si nomini esso Arcivescovo Sipontino. Ella è assai civile, e di popolo ben piena. Appresso al lito si vede una fortissima Rocca, la quale gli anni passati essendo venuto in questi luoghi Odetto di Lautreco Capitano di Francesco primo Ré di Francia per racquistare il Regno con gran numero di soldati, e havendo aquistato molti luoghi di Puglia non puotè mai però haverla ne meno la città, anzi sempre costantissimamente si mantenennero nella fede di Carlo V. Imper. Fuori della città al lito si vede un artificioso Molo per sicurezza delle navi che quivi vengono con le mercantie. Quivi si veggono alquanti scaglioni di pietra per scendere dal Molo alle navi. In uno de i quali, sono fomate le forme de i piedi della Signora Bona già figliuola di Giovan Galeazzo Sforza Duca di Milano, e d’Isabella d’Aragona sua consorte Duchessa di Barri, ove si fermò (dovendo scendere alle navi per passare il mare Adriatico, e andare in Polonia per consorte di Sigismondo Ré) per chiedere perdono, e buona 226 Verso Sud D. Grittani licentia con lagrime alla sua madre. Et oltra le dette forme, così è scritto nel sasso. Quì si fermò la Reina di Polonia, quando chiese venia, e licentia à Madama Isabella sua madre Duchessa di Milano, e di Barri. Furono alcuni che dissero che fosse edificata questa città, ove era Apeneste. Ma invero assai di lunga si ingannano costoro; imperò ch’egliè dipinto da Tolomeo Apeneste (come dimostrerò) di là da Siponte, secondo la sua misura, e non di quà. Et non li bastando questo errore, dipoi entrano in uno maggiore (non ricordandosi haver detto che quivi fosse Apeneste) dicendo più avanti vi fosse Vibarno citato da Tolomeo, e posto ne i Mediterranei de i Pugliesi Daunij; imperò che Manfredonia è appresso il lito del mare. Seguitando pure il lito da un miglio, appare sopra la sassosa rupe, alle radici del monte Gargano la roinata città di Siponte, nominata Sipontum da Plinio, Strabone, Pomponio Mela, e da Tolomeo, ma i Greci Sepiuntem lo addimandano, overo Sypie come dice Mela; e Silio Italico nell’ottavo libro lo dice Sipum, e littora Sipus. Fu addimandato dai Greci Sepiuntem per li pesci sepij gettati alla riva del lito dall’onde marine, che ivi si veggono in grande abbondanza, come etiandio insino al presente appareno. La fu nominata Sipa, e fu edificata de Diomede (come vuole Strabone) discosto da Salapia 150. stadij, cioè circa venti miglia. Ora giace rovinata, ma pur si vedono tali vestigi d’edifici, che facilmente si può dare sententia, che fosse nobile, e magnifica città. Vi si vede altresì la chiesa maggiore quasi tutta in piedi, ove era stato dato principio ad una sontuosa cappella di pietre quadrate, che poi rimase così. Appresso il lito (sotto però gli edifici sfasciati) vi è una bella Fontana di chiare acque che abbondantemente trascorrono alla Marina. Et questa Fontana soccorreva à i bisogni della città. Molte volte ne fa mentione Livio di questa città, tra i quali è nell’ottavo libro, e nel trentesimoquinto, ove scrive che Spurio Postumio Console fece intendere al Senato, come caminando intorno a ciascun lito del mar dell’Italia, havea ritrovato abbandonate due Colonie, cioè Siponte lungo il lito del mare supero, e Bussento appresso il mare infero. La onde il Senato creò tre huomini che conducessero à quei luoghi habitatori, cioè L. Scribonio Libo, M. Titio, Gn. Bebio Panfilo. Et nel 34. havea dimostrato come la fosse dedutta colonia da i tre huomini, cioè da D. Giunio Bruto, M. Bebio Panfilo e M. Elvio, e che fu partito il paese, che già era degli Irpini. Fu molto felice essa città insino a’ tempi de’ Saracini, che soggiugarono tutta Puglia, e habitarono insino a i tempi di Carlo Magno, onde ne furono poi scacciati. Ma avanti che si partissero di questi luoghi, prima saccheggiarono questa città, e uccisero tutto il popolo, e così la lasciarono abbandonata, et portarono con loro tutte le ricchezze di essa nell’Africa. Così dicono alcuni, descrivendo la roina di quella. Ma altri scrivono che ella talmente fu guasta dalle civili fattioni, che intravennero fra i cittadini: e altri narrano essere divenuta quella à tanta calamità per li grandi terre moti. Forse che sono concorse tutte tre queste cose L. Alberti Descrittione del Monte Santo Angelo 227 à condurla à tanta roina, come hora si trova. Fu Arcivescovo di questa città ne’ nostri giorni Niccolò Perotto da Sassoferrato, huomo bene intelligente, non solamente di lettere latine, ma altresì Grece, come dimostrano l’opere da lui lasciate. Parimente fu Arcivescovo di essa Giovan Maria di Monte, meritevolmente Cardinale della chiesa Romana, uomo di singolar prudentia, et di buone lettere ornato. Il quale fu poi creato sommo Pontefice nell’anno di nostra salute 1550. a gli 8. di Febraro, e coronato a i 24. del detto con grandissima pompa; e fecesi nominare Giulio III. Più avanti passando pur lungo il lito, vedesi il luogo ove era Apeneste totalmente roinata, della quale altra memoria non ritrovo, eccetto quella fatta da Tolomeo. Poscia ritrovasi Monte Gargano. Et per essere una curiosa descrittione questa di detto Monte, a me par di narrarla tutta di mano in mano; ancor che non osservi l’ordine, perché comincierò dal lito, che sarebbe cosa difficile di ridurla a tal ordine. Descrittione del Monte Santo Angelo Questo monte è dimandato Gargano da gli antichi scrittori, tra i quali è Strabone, Plinio, Pomponio Mela, Verg. nel II lib. quando dice. Victor Gargani condebat Iapygis. Et Lucano nel 5. Apulus Adriacas exit Garganus in undas. Et Oratio, nel 2. de i Carmini dice Querceta Gargani laborent, e Silio Italico nel 8. lib. e in molti altri luoghi, e Livio, e Tolo. con altri assai scrittori, e parimente Faccio degli Uberti nel cap. I del 3. lib. Dittamondo quando dice. Simile modo quando ei fu noto / Monte Gargano, la dove Sant’Agnolo / In fin’ a lui non mi parv’ire in voto. / Con quell’istudio che fa la tela il ragnolo / ci studiavamo per quel camin alpestro. / E passavamo hor questo hor quel rigagnolo. Avanti che più oltre io entri alla descrittione di questo monte, voglio avisar à i lettori, com’è stata fatta memoria di esso monte da quegli autori antichi che furono innanzi che mai S. Michele Arcangelo vi si dimostrasse, come narrano l’historie. La onde chiaramente si vede esser favola quella che si legge nell’apparitione di S. Michele, che’l detto monte acquistasse il nome da Gargano huomo ricco, il quale havea grand’armenti d’animali, e che volendo saetare il bue da lui fuggito, fosse egli dalla saeta (che tornò à dietro) ferito; Imperò che di monte centinaia d’anni egli è ricordato esso monte Gargano da gli antichi scrittori, avanti che fosse detta apparitione di S. Michele. Lasciando questa regione, entrerò alla descrittione di esso monte. È questo monte Gargano molt’alto, e evvi faticosa via da poterli salire. Nel qual sono alquante piacevoli selve, ma benché in più luoghi sia privo d’alberi, nondimeno vi si raccogliono molte specie di sanevoli erbe per l’infermità. Dal lato 228 Verso Sud D. Grittani che risguarda al mare (come etiandio dimostra Str.) si distende un braccio di monte verso l’oriente, lungo 320. stadij, o siano da 40. miglia. Nasce questo alto monte dall’Appellino, dalle cui radici esce una schiena molto alta, 2. miglia larga e 20. lunga. La quale passata, comincia il monte alzarsi a poco a poco, e così facendo esce molto alto, grande e largo, ben però fruttifero. Entra poi tanto nella marina, che quella gli circonda le radici che finiscono alla pianura da 200. miglia, avvenga che Plinio dica 134. Egli è in molti luoghi precipitoso, dal lato, che risguarda al mare, ove manda fuori quel braccio avanti descritto, secondo il riporto di Str. Pensò Diomede di far una fossa per spartire esso braccio dal resto del monte, acciò ch’entrandovi, l’acque marine, ne risultasse un’isola, ma non poté esequire il suo disegno, essendo sforzato a ritornare alla patria, ove si morì. Sono in questo monte alquanti luoghi da descrivere. Et prima veggonsi alquanti Laghi da pescare. Tra i quali vi è il lago di Varrano, che gira intorno 30. miglia, ove sono alquante castella cioè Caprino, Cognato, Iscitella, e nella faccia dell’antidetto braccio di monte, la città di Bestia così dal volgo nominata in vece di Vesta, imperò che quivi ne’ tempi antichi era il tempio dedicato a Vesta (secondo il Razano). Quindi a 10. miglia vedesi Vestice castello, et passato tutta la piegatura di detto braccio, la città di Rode, qual nomina Str. Ureum (ch’era picciola ne’ suoi tempi) e Pomp. Mela, Uris, ma credo, sia corrotto il lib. et voglia dire, Uryas. Et Pli. nomina i cittadini di essa, Irini. Ma il dotto Barbaro nelle correttioni Pliniane dice, ch’è guasto il li. di Pli. e ch’l vuol dire Hyrini, adducendo in testimonio Tolo. Eustathio, e Erodoto, che dicono che fosse Hyria una Colonia della Giapigia. Vero è, che Tolo accordandosi con Dionisio Afro, la nomina Hyriun, e non Hyria, come dice il Barbaro. Secondo però alcuni si doverebbe nominare dal volgo Rore, e non Rode, perché quivi scende dal Cielo tanta temperata rugiada, che fa produrre i campi con gli alberi buoni, e saporiti frutti. Da questa città si partì Alessandro Papa III. con 13. Galee dategli da Guglielmo Normano per varcare a Vinegia a pacificarsi con Federico Barbarossa Imperatore, come narra Biondo nell’historie. Termina a questo promontorio il Seno Ionio, e comincia l’Adriatrico, secondo Tolomeo (avvenga che altri dicano detto Golfo Ionio finire a Brindisi, secondo ch’è detto disopra). Disegna Hierio Tolomeo nel golfo Adriatico, ov’egli comincia. Par che questo monte Gargano con alcuni altri luoghi vicini si deono nominare Giapigia, della quale opinione par che fosse Verg. quando disse. Victor Gargani condebat Iapygis arces. Sì come dichiara Servio dicendo, esser la Giapigia parte di Puglia, ov’è il monte Gargano. Per hora altro non dirò di questa Giapigia, imperò che riservo più in giù à favellarne. Seguitando il camino lungo il lito del mare, ritrovansi alcuni luoghi di poco affare, e per tanto li lascierò senz’altra mentione. Di riscontro à questi luoghi, vedesi nel mare S. Maria di Tremite, già dette l’Isole di Diomede, delle quali nella descrittione dell’Isole attenenti all’Italia L. Alberti Descrittione del Monte Santo Angelo 229 ne parlerò. Più avanti pur seguitando il lito, ritrovasi la foce del fiume Fiterno, hora Fortore, appresso il lago di Lesina, come si dimostrerà più avanti. Havendo descritti i luoghi littorali posti alle radici del monte Gargano (hora di S. Angelo nominato) passerò alla descrittione de i luoghi posti fra quello. Ritrovasi primieramente in cima di detto monte il castello di S. Angelo così è nominato dalla devotissima spelonca consecrata all’Arcangelo San Michele, della quale presto ne parlerò. Giace adunque questo castello sopra il monte, et sopra l’alta rupe, che risguarda al mare ove è fabricata Manfredonia sei miglia discosto. Egli è ben’habitato, et è forte luogo, ove lungo tempo dimorarono i Saracini, a dispetto de’ Christiani, per essere il luogo forte di natura, e abondevole delle cose necessarie per il loro vivere, che si cavano di quei luoghi del monte. Insino ad oggidì si vedono le sepolture nel sasso cavate, secondo i loro malvagi riti, e profane cerimonie. Vi si raccogliono le cose per il vivere de’ mortali, et fra l’altre, buoni vini vermigli. Quivi si vede la devotissima Spelunca, et sacrato Tempio dedicato a San Michele Arcangelo, la quale fu ritrovata (manifestandola il S. Angelo) nell’anno della gratia 586. a gli otto di Maggio essendo Pontefice Romano Gelasio, e Imperatore Zenone, et Arcivescovo di Siponte Lorenzo, per essere stato ferito il servo di Gargona dalla propria saetta, c’havea tirata al bue del padrone, ch’era avanti la foce di detta spelunca. Io ritrovo gran differentia dell’anno che fu ritrovata questa spelunca, conciosia cosa che Giacomo Filippo Pelanegra dica che fu nel 536. da che il figliuolo di Dio s’incarnò, tenendo il seggio di Pietro Gelasio, e l’Imperio Zenone. et Sigisberto dimostra che fu questa cosa l’anno secondo di Gelasio 2. et il 17. di Zenone, dell’avenimento di Christo 492. onde ritrovo che vi sarebbe differenza di 44 anni tra questi dui. Imperò che il Pelanegra vi darebbe 44. anni piu che Sigisberto. Et perciò credo che’l sia in errore, perché nel 536. era Papa Giovanni secondo, et Imperatore Giustiniano primo. Talmente è disposta essa spelunca, come scrive Giacomo Filippo Pelanegra Troiano, in un suo libracciuolo, che mi fu dato da i Venerandi sacerdoti i quali servono a questo luogo, essendovi io andato nel 1525. È un luogo, non da humano artificio. e ingegno, ma da essa natura Angelica cavata a posta dentro un vivo sasso nell’antedetto monte, ove si comincia ad entrare da cima per una porta di marmo grandissima, da i Signori del Regno fabricata, posta al Mezo giorno. Et in quella si discende continuamente per 55. gradi verso il Settentrione. Et se le spesse fenestre, con artefatte, nel rotto sasso, non illuminassero le marmoree scale, ivi non si potria gire comodamente senza lume artificiale. Nel fine de i quali, si ritrova un Cimiterio in piano scoperto, ove sono molte cappelle, e sepolture. Fra queste, avanti che si entri nella santa grotta, a man sinistra, se ne vede una bella con l’insegne de i Puderichi gentil’huomini Napolitani, anticamente signori del luogo. Appresso questa Capella, per un’altra porta lavorata di arteficioso metallo, s’entra nella santa spelonca, Né 230 Verso Sud D. Grittani avanti che’l sole esca dell’onde del sottoposto mare Adriatico, e che copra le spalle del monte, ivi è lecito a persona entrare. questo uscio guarda all’Occaso. A man destra si vede la maravigliosa Grotta, casa del santissimo Arcangelo Michele distesa verso l’Oriente, tutta d’un pezzo, e viva pietra, sempre puro humore distillante: horrida, bassa, e oscura: Credo non ad altro fine, e ornamento fatta che per la salute dell’anime nostre. Nel mezzo trovasi un picciolo Coro, ove si saglie per quattro gradi. Ma come ti avicinerai al sacro altare dell’Angelo poco più in alto, e elevato, ò vogli ò nò, sei costretto di venerare detto luogo, ivi si vede il pargoletto Altare consacrato dal santo Angelo vestito di un’altro sopr’altare manualmente fatto, ove si celebra le più parte le quotidiane messe. Né questo luogo è aperto à tutte le persone. Indi non poco discosto è un Fonte picciolo di divin liquore, sempre scaturiente, che gli huomini della Città usano quasi in tutte le infirmità, per sanissima medicina. Da man sinistra sono più altri altari, capelle, e altri luoghi secreti da dir messa. Et tra gli altri vi sono due altri altari, che furono fatti dal S. Angelo. Vi sono anco quei luoghi di sopra da orare, non fatti apposta, ma produtti dalla natura in esso sasso, per invitar i mortali à contemplatione, e penitentia. Il suolo della spelunca è di bianco, e di rosso marmo dipinto. Dalla parte di fuore, cioè disopra della Grotta, è un verde, e folto boschetto, d’altissimi alberi ottuso carco, et vestito. Sopra i rami, de i quali pende grandissima quantità di pietre d’ogni sorte, che su per il monte alcuni pelegrini portano al collo per loro voti, et divotioni, et ivi poi l’appicano con le sue orationi. Egli è certamente cosa maravigliosa a veder questo boschetto conciosia cosa che per molto spatio di questo monte, non si vede alcun’albero. La onde par più tosto miracolo, che cosa naturale a vedere tanti alberi, et così grossi nel vivo sasso radicati. Fummi narrato (essendo quivi) che ne’ tempi di Carlo ottavo Re di Francia, il qual soggiugò il Reame, nel 1494. fu tagliato uno de’ detti alberi da un Francese, il che fatto divinamente ne rimase morto. Etiandio nella detta spelonca vidi una bella Croce di chiaro cristallo, lunga circa un palmo, e mezo, la quale secondo quei venerandi sacerdoti, fu quivi ritrovata essendo conosciuta miracolosamente la detta spelunca. Ritrovasi poi nel mezzo di questo Monte, ove è la bella pianura con vaghi prati, il castello di S. Giovanni Ritordo, ove ciascun’anno nel giorno di santo Onofro a gli undici di Giugno si raunano i vicini popoli, e havendo ben considerato la qualità de i raccolti del grano, orzo, e d’altre biade, di commun parere tassano il pretio a tutte le biave; la qual tassa non può trapassare alcuno. Ne’ lati di questo monte veggonsi in più luoghi vestigi d’antichi edifici, che lascierò per esser abbandonati. Vero è, che alle radici del detto, da mezo giorno appresso la pianura fra S. Severo, e Manfredonia, si scorge San Vito assai sufficiente castello di edifici, ma però abbandonato, per la moltitudine delle serpi, che vi sono, e di continuo l’abbondano. Et ciò non dee parere impossibile, perché anco Solino nel 7. L. Alberti Descrittione del Monte Santo Angelo 231 capo. narra come fossero roinate molte habitationi da i Serpenti, e massimamente nell’antica Calabria, le quali Serpi sono nominate Chersedri. Pur da questo lato, che risguarda al Meriggio nel principio del monte antidetto, vi è Arignano castello; e seguitando pur le radici di quello, piegandosi però all’Occidente, ove comincia la via da salire sopra detto monte d’Arignano, tre miglia discosto, e dal Mare cinque, si scopre Santo Alicandro castello, e più avanti altrettanto, et due dalla radice del detto, Precina, assai honorevole castello, e di popolo assai ben pieno. Quivi si vede un magnifico Palagio fatto da Federico II. Imperatore per cagione, che cacciando egli in questi luoghi, doppo molte fatiche conquistò un gran cinghiale quivi, e vi fece ordinare una bella cena, ove vi fu presente esso con tutti i suoi baroni. Il che fatto volse che in questo luogo a memoria di detta cosa si facesse un castello, e che se nominasse Apricena dal Cinghiale preso, e mangiato nella cena. Ben’è vero, che non sapendo il volgo la cagione di tal nome, e etiandio, non sapendolo isprimere, lo domandarono prima Pricena, poi Precina, e alfine, Procina, in vece d’Apricena. Poscia essendo fabricato, lo consignò detto Federico ed alcuni soldati vecchi, che havea condotto seco in Sicilia, per loro riposo. Così scrive Razano. Più avanti caminando sei miglia verso l’Occidente, si scopre Torre maggiore castello, quattro miglia vicino al fiume Fortore. Poscia dopo altrettanto verso il Meriggio, vedesi San Severo dal Monte di S. Angelo similmente quattro miglia lontano. Egliè questo castello molto, ricco, nobile, civile, e pieno di popolo; e è tanto opulento che non ha invidia ad alcun’altro di questa Regione. Secondo Strabone nel sesto libro erano nel territorio Daunio (benché dica il corrotto libro Sannio) circa un picciolo colle addimandato Driono due Tempij, uno de i quali apparea nella cima del detto collicello, consacrato à Calcante, ove sacrificavano quelli, che circavano haver risposta da lui, dormendo la notte sopra la pelle d’un Montone negro in terra istesa, l’altro Tempio era dedidato a Podalirio, e fabricato alle radici del detto collicello, cento stdij, ò siano dodici miglia, e mezo dal mar discosto. Usciva di questo Tempio un ruscelletto d’acqua giovevole à tutte l’infirmità de gli animali, Io credo che tai Tempii non fossero molto discosti da questi luoghi, vicini al monte di S. Angelo. Descritto il Monte Gargano, ò di S. Angelo co i luoghi posti alle radici di esso entrerò nella larga pianura di questa Regione, hora Capitinata detta. [Tratto da Descrittione di tutta Italia nella quale si contiene il sito di essa, l’origine e la signoria delle città et de’ Castelli, LEANDRO ALBERTI, 1550] 233 Monte Sant’Angelo Arthur Miller Arthur Miller (New York 1915-2000). Scrittore americano tra gli autori più rappresentativi del nostro tempo. Secondo marito di Norma Jean Baker (al secolo Marilyn Monroe), in seguito al discusso suicidio della quale scrisse Dopo la caduta (1963), opera che per il chiaro contenuto autobiografico gli valse numerose critiche ma anche la definitiva affermazione come drammaturgo. Tra i suoi testi teatrali più conosciuti Morte di un commesso viaggiatore (1949) e Uno sguardo dal ponte (1955). Apparso per la prima volta sulla rivista Harpers’s Magazine nel marzo del 1951, il racconto Monte Sant’Angelo fa parte della raccolta I dont’ need you any more (The Viking Press, New York 1967). Fu scritto in occasione di un viaggio che Arthur Miller compì in Italia nel 1948, allorquando si recò nelle regioni meridionali del paese accompagnato dal suo amico italo-americano Vincent Longhi. L’autista, ch’era rimasto in perfetto silenzio per quasi un’ora, traversando la verde, monotona piana di Foggia, disse d’un tratto qualcosa. Appello, dal sedile posteriore, si chinò in avanti chiedendogli cosa avesse detto. «Quello là davanti è Monte Sant’Angelo». Appello abbassò la testa per guardare attraverso il parabrezza della piccola Fiat rumorosa. Poi diede di gomito a Bernstein, che si svegliò risentito. «Eccolo lassù il paese» disse Appello. Il risentimento di Bernstein svanì, e anche lui si piegò in avanti. Stettero entrambi così per diversi minuti, guardando quel paese che gli sembrava situato in un modo così buffo, più buffo ancora di quelli che avevano visto nelle quattro settimane che avevano passato viaggiando per il paese in lungo e in largo. Sembrava una minuscola vecchia signora che si fosse appollaiata sul tetto per paura dei ladri. La piana davanti a loro restava piatta come una tavola ancora per qualche centinaio di metri. Poi s’innalzava una montagnola, squadrata e rigida come una colon- 234 Verso Sud D. Grittani na, restringendosi verso la sommità. E lassù, ormai, appena visibile, era accovacciato il paese; per un momento fu celato da bianche nuvole, poi ricomparve, minuscolo e sicuro come un porto su un’alta costiera al confine del mare. A quella distanza non si scorgeva alcuna strada, nessuna via d’accesso sul fianco della colonna. «Quelli che l’hanno costruito dovevano avere una tremenda paura di qualcosa» disse Bernstein, stringendosi il soprabito addosso. «Come faranno a salire lassù, ammesso che qualcuno ci salga!». Appello, in italiano, domandò all’autista notizie del paese. E quello, che c’era stato una volta in vita sua e che non conosceva nessun altro che ci fosse stato – benché risiedesse a Lucera, non molto lontano di lì – rispose, con una cert’aria divertita, che presto avrebbero visto quanto di rado qualcuno salisse a Monte Sant’Angelo. «I somari che incontreremo scapperanno o si metteranno a scalciare» disse «e quando entreremo in paese tutti verranno fuori a guardarci. Sono lontanissimi da tutto. Sembrano tutti fratelli, lassù. Non conoscono quasi niente di niente.» Si mise a ridere. «Che cosa dice il nostro collega di Princeton?» disse Bernstein. L’autista aveva i capelli tagliati a spazzola, il naso all’insù, una rossa faccia rotonda e gli occhi azzurri. L’automobile era sua, e benché quando stava con i piedi in terra parlasse come qualunque altro italiano, seduto al volante con due americani dietro aveva per tutto ciò che lo circondava un atteggiamento quanto mai divertito e superiore. Appello, dopo che ebbe tradotto le sue parole a Bernstein, gli domandò quanto ci sarebbe voluto per arrivare fin lassù. «Forse tre quarti d’ora… Quanto ci vuole a fare la salita» precisò. Bernstein e Appello si appoggiarono allo schienale e osservarono l’avvicinarsi della montagnola. I suoi fianchi, ora si vedeva, erano di una pietra bianca sbriciolata. A questa distanza ravvicinata sembrava che un qualche enorme, mostruoso martello le avesse dato un colpo terribile fendendone la struttura in milioni di crepe. Adesso avevano cominciato a salire per una strada di pietre rotte, taglienti. «È una strada romana» disse l’autista. Sapeva quanto apprezzano gli americani tutto ciò che è romano. Poi aggiunse: «L’automobile, però, è milanese». Lui e Appello si misero a ridere. Una polvere bianca cominciava a penetrare nella macchina. Al loro fianco, l’abisso stava diventando minaccioso. La strada non aveva alcun parapetto, e ogni centinaio di metri v’era un tornante. Gli sportelli della Fiat tentennavano. Una bianca, finissima polvere si posava sui loro vestiti, sulle loro ciglia. Cominciarono a tossire. Quando si riebbero, Bernstein disse: «Tanto per farmene un’idea, vecchio mio, vuoi per favore spiegarmi in tutte lettere perché diavolo ci arrampichiamo su questo blocco di polvere?» A. Miller Monte Sant’Angelo 235 Appello si mise a ridere e gli misurò scherzosamente un pugno. «Senza scherzi» disse Bernstein, cercando di sorridere. «Voglio vedere questa mia zia, ecco tutto» disse Appello, serio. «Sei proprio pazzo. Devi avere una sorta di complesso ancestrale. Da quando siamo in questo paese non abbiamo fatto che andare in cerca dei tuoi parenti.» «Accidenti, sono finalmente qui, e voglio vedere tutti i posti da cui provengo. Ti rendi conto che due miei antenati sono sepolti nella cripta di quella chiesa lassù? Dal millecento o giù di lì». «Oh, è questo il posto dei due monaci?» «Proprio questo. I due fratelli Appello. Furono tra i fondatori di quella chiesa. È famosissima, quella chiesa. Si dice che San Michele abbia fatto un’apparizione, qui, o qualcosa del genere». «Chi avrebbe immaginato che un giorno avrei conosciuto qualcuno con dei monaci tra i suoi antenati. Però, continuo a credere che tu sia un po’ tocco, a questo proposito.» «Dunque, tu non senti proprio niente, non hai nessuna curiosità per i tuoi antenati? Non ti piacerebbe tornare in Austria, patria d’origine della tua famiglia, e vedere i posti dove vivevano i tuoi vecchi? E magari ritrovare una famiglia imparentata con te, o qualcosa del genere?» Bernstein per un po’ non rispose. Non sapeva esattamente che cosa provava, e si domandò vagamente se non avesse continuato a vessare l’amico per un fondo d’invidia. Quando erano stati in quel tribunale di provincia dov’erano appesi i ritratti del nonno e del bisnonno di Appello, entrambi eminenti magistrati; quando avevano passato quella serata a Lucera, dove il nome Appello era indice di onorabilità e distinzione, e dove il suo amico Vinny aveva avuto quell’accoglienza così calorosa in quanto era un Appello… in tutti quei momenti Bernstein si era sentito tagliato fuori, e in certo modo, defraudato di qualcosa. Al principio si era detto che tanta agitazione era puerile, ma poi, accorgendosi che un fatto dopo l’altro, un cimelio dopo l’altro, riecheggiavano il nome di Appello, a poco a poco aveva cominciato a sentire il suo amico combinarsi con la storia di quel paese, e gli era parso che ciò rendesse Vinny più forte, e anche, in certo modo, meno morto, quando sarebbe venuta per lui l’ora di morire. «Io non ho parenti, in Europa, per quel che ne so» disse a Vinny. «E se ne avessi avuti, ormai sarebbero stati spazzati via tutti.» «È per questo che ti dispiacciono queste mie ricerche?» replicò Vinny. «Non dico che mi dispiacciano» disse Bernstein, con un sorriso forzato. Avrebbe voluto potersi aprire come si apriva Vinny; gli avrebbe dato forza, gli avrebbe dato un senso di benessere, pensò. Guardavano in giù verso la piana, e parlavano poco. 236 Verso Sud D. Grittani La polvere aveva schiarito le nere sopracciglia di Appello. Per un attimo Appello pensò che si rassomigliavano. Erano alti entrambi più di un metro e ottanta, bruni e larghi di spalle. Bernstein era più slanciato, addirittura scarno, e dalle braccia lunghe. Quelle di Appello erano più forti, e lui stava un po’ curvo, come se non volesse apparire alto. Ma i loro occhi erano diversi. Appello aveva un’aria un po’ asiatica, negli occhi, che erano nerissimi, diretti e, per le donne, appassionati. Quelli di Bernstein, più che guardare, fissavano; lui trovava pericoloso che si potessero scandagliare gli occhi, e per questo, spesso li distoglieva, li abbassava; sembrava esservi un che di difensivo, nei suoi occhi, di crudele e gentile nel tempo stesso. Avevano simpatia l’uno per l’altro, non tanto per delle ragioni precise quanto per delle possibilità, era come se entrambi sentissero di essere opposti. Ed erano attirati dai reciproci difetti. Con Bernstein accanto, Appello si sentiva distolto dalla sua irresponsabile sensualità, e in questo viaggio Bernstein aveva spesso il piacere e la pena di non dover più rinnegare sé stesso. La macchina superò un tornante strettissimo sollevando una nuvola di polvere, e d’un tratto si trovarono dinanzi la strada principale del paese. Non c’era nessuno in vista. Ciò che aveva predetto l’autista si era dimostrato vero… nei pochi fazzoletti d’erba che avevano incontrato salendo, i somari si erano messi a scalpitare, e dei pastori con ispidi baffi, neri berretti in testa, e lunghi e neri mantelli, li avevano guardati con la silenziosa attenzione di coloro che conducono una vita remota. Ma qui in paese non c’era nessuno. L’auto risalì la strada principale, che ora si faceva piana, e d’un tratto furono circondati da persone che uscivano dalle porte, infilandosi la giacca, mettendosi il berretto. Sembravano stranamente uguali, e più irlandesi che italiani. I due scesero dalla Fiat e controllarono il bagaglio legato sul tetto della vettura. Appello parlava ridendo con la gente, che continuava a domandare come mai fosse arrivato fin lassù, che cosa aveva da vendere, che cosa voleva comprare, finché lui disse chiaramente ch’era venuto soltanto per cercare sua zia. Quando disse il nome, gli uomini (le donne erano rimaste in casa e guardavano dalle finestre) non diedero segno di conoscerla, finché un vecchio con un paio di sandali di corda e un berrettino a maglia da pattinatore si fece avanti e disse che lui quella donna se la ricordava. Si voltò, e Appello e Bernstein lo seguirono per la strada principale, seguiti a loro volta da un codazzo di forse un centinaio di uomini. «Come mai nessuno la conosce?» domandò Bernstein. «È una vedova. Immagino che starà quasi sempre in casa. Gli uomini della famiglia morirono una ventina d’anni fa. Suo marito era l’ultimo Appello in questo paese. Le donne non contano molto qui; scommetto che questo vecchio si è ricordato il nome perché conosceva suo marito, non lei.» Il vento forte e costante soffiava attraverso il paese spazzando le sue pietre bian- A. Miller Monte Sant’Angelo 237 che. Il sole era fresco come un limone, il cielo di un azzurro puro, e le nubi così vicine che le loro chiglie sembravano affondare nella strada accanto. I due americani cominciarono a camminare con la gioia di tutto questo nei loro lunghi passi. Arrivarono a una casa di pietra a due piani, e percorsero un buio corridoio e bussarono. La guida era rimasta rispettosamente sul marciapiede. Per alcuni momenti, nell’interno non s’udì alcun rumore. Poi vi fu un frusciare, a brevi tratti, come di un topo che corresse, si fermasse, si guardasse attorno, riprendesse a correre. Appello bussò di nuovo. La maniglia girò, e la porta si aprì per uno spiraglio. Una piccola donna pallida, non troppo vecchia, teneva la porta aperta solo quel tanto che permetteva di mostrare la faccia. Sembrava molto agitata. «Eh?» disse. «Sono Vincenzo Giorgio.» «Eh?» ripeté lei. «Vincenzo Giorgio Appello». La mano scivolò via dalla maniglia, e la donna fece un passo indietro. Appello, col suo sorriso cordiale, entrò, seguito da Bernstein, e chiuse la porta. Una finestra lasciava che il sole inondasse la stanza, che era tuttavia fredda come una pietra. La donna era a bocca aperta, le mani congiunte come in preghiera, le dita puntate verso Vinny. Tutta ritirata in sé stessa, come sul punto di inginocchiarsi, non riusciva a parlare. Vinny le si accostò, la toccò sulla spalla ossuta, la fece sedere su una sedia. Anche lui e Bernstein sedettero. Cominciò a parlare della loro parentela, fece il nome di uomini e di donne; alcuni erano morti, di altri lei aveva sentito parlare ma non li aveva mai visti in vita sua. Parlava, finalmente, ma Appello non riusciva a capire che cosa dicesse. D’un tratto uscì di corsa dalla stanza: «Credo mi abbia preso per un fantasma o qualcosa del genere. Mio zio diceva che non aveva più visto nessuno della famiglia da venti o venticinque anni. Scommetto che non crede ci sia rimasto più nessuno.» Ritornò con una bottiglia che aveva nel fondo due dita di vino. Ignorò Bernstein e diede la bottiglia ad Appello. Lui bevve. Era aceto. Poi lei cominciò a singhiozzare, e continuava a tergersi le lacrime dagli occhi per poter vedere Appello. Non riusciva mai a finire una frase, e Appello continuava a chiederle che cosa voleva dire. Non faceva che correre da una parte all’altra della stanza. Il ritmo delle sue partenze e dei suoi ritorni alla sedia stava diventando così ossessivo che Appello alzò la voce e le ordinò di sedersi. «Non sono un fantasma, zietta. Sono venuto fin quei dall’America…». Si fermò. Dallo sguardo trasecolato, spaventato, che c’era negli occhi della zia era chiaro che lei non l’aveva affatto creduto un fantasma, ma che le riusciva altrettanto scon- 238 Verso Sud D. Grittani volgente il fatto che, quando nessuno veniva mai a trovarla da Lucera, uno avesse potuto pensare a lei dall’America, un posto che esisteva, sì, come esisteva il cielo, ma, per lei, proprio allo stesso modo. Non c’era alcuna possibilità di intrattenere una conversazione con lei. Alla fine se ne andarono, senza che lei fosse riuscita a dire una frase coerente, tranne una benedizione, ch’era il suo modo di esprimere il suo sollievo che Appello se ne andasse, poiché nonostante l’indicibile gioia di aver visto con i suoi occhi un parente del marito, un tale fatto era troppo terribile per le sue implicazioni, e per la responsabilità che a lei ne derivava di fargli una degna accoglienza. S’incamminarono in direzione della chiesa. Bernstein non era riuscito a dire nemmeno una parola. L’emozione di quella donna, così pura, così violenta, così selvaggia, l’aveva impressionato. Gettando un’occhiata su Appello, si stupì nel vedere che il suo amico aveva tratto dall’episodio nient’altro che una sorta di calma soddisfazione, come se sua zia si fosse comportata nel modo più normale. Ricordò confusamente che da ragazzo era andato a far visita a una sua zia al Bronx, una parente che non era in relazione con la sua famiglia e non l’aveva mai visto. Si ricordò di come l’avesse forzato a mangiare, gli avesse fatto ganascino, e gli avesse sorriso ogni volta che lui alzava gli occhi a guardarla. Ma sentì che non v’era nulla di quest’intensità, in quell’incontro, né ve ne sarebbe stata nemmeno se ora, al prossimo angolo, avesse dovuto incontrare una donna che avesse detto di essere sua parente. Tutt’al più avrebbe provato il desiderio di piantarla lì e andarsene, anche se era sempre andato d’accordo con i suoi parenti, né li aveva mai snobbati. Mentre entravano nella chiesa si disse che c’era una parte di lui che non era in circuito con tutto il resto, ma il fatto che se ne sentisse turbato lo sconcertava, e anche gli suscitava una certa irritazione verso Appello che ora stava domandando al prete dov’erano le tombe degli Appello. Scesero nella cripta, il cui pavimento di pietra era qua e là coperto d’acqua. Lungo le pareti e ai lati di tortuosi corridoi che si diramavano da una sala centrale a volte, v’erano delle tombe così antiche, con iscrizioni così consunte, da essere per la maggior parte illeggibili anche con l’aiuto di una candela. Il prete ricordava vagamente una nicchia degli Appello ma non aveva idea di dove fosse. Vinny passava da una cripta all’altra con la candela che aveva comprato dal prete. Bernstein rimase ad aspettarlo all’imboccatura del corridoio, piegando il collo per evitare di toccare il soffitto col cappello. Appello si curvava anche più del solito, sembrava lui stesso un monaco, o un archeologo, una figura che scompariva a poco a poco nella lunga oscurità dei tempi in cerca del suo nome su una pietra. Non riuscì a trovarlo. Avevano i piedi tutti bagnati. Dopo mezz’ora uscirono dalla chiesa, e appena fuori dovettero difendersi da una turba di ragazzini che vendevano sudicie cartoline religiose che il vento gli strappava continuamente dalle mani. A. Miller Monte Sant’Angelo 239 «Sono sicuro che ci sia» diceva Appello tutto eccitato. «Ma tu non te la sentiresti di fare una ricerca a fondo, vero?» disse in tono speranzoso. «Mi seccherebbe prendermi una polmonite» disse Bernstein. Erano arrivati al fondo di una strada secondaria. Fuori di alcune botteghe erano appesi a testa all’ingiù degli agnelli, le zampe rigide protese sopra il marciapiede. Bernstein strinse la zampa a uno, e a beneficio di Vinny immaginò una scena alla Chaplin in cui un monsignore lo incontrasse in questa via, facesse per stringergli la mano, e si sentisse nel palmo una fredda zampa d’agnello: la faccia mortificata che avrebbe fatto. In fondo alla via guardarono il cielo infinito e, dall’alto dell’abisso, l’Italia. «Magari saranno scesi a cavallo giù per questa montagna, con l’armatura addosso… gli Appello» disse Vinny, in tono rapito. «Sì. È probabile» disse Bernstein. La visione di Appello con l’armatura gli spazzò via ogni desiderio di prendere in giro l’amico. Si sentì solo, desolato, come gli aridi fianchi gessosi di questa colonna rotta in cima alla quale si trovava. Sicuramente nella sua famiglia non v’era stato nessun cavaliere. Ricordava i racconti di suo padre, del suo paese in Europa, la tinozza piena d’acqua dove tutti attingevano, lo scemo del villaggio, il barone del posto. Ecco tutto quello che gliene restava, e nessun motivo di orgoglio, nessun motivo di orgoglio in tutto questo, niente. E del resto, io sono americano, si disse. Però in questo non v’era la forza, l’intensità della passione di Appello. Guardò il profilo dell’amico e sentì il calore di quello sguardo sull’Italia, e si domandò se qualche americano si fosse mai sentito così negli Stati Uniti. Mai in vita sua aveva sentito con tanta acutezza che il passato poteva essere così popolato, così pullulante di generazioni, come un’ora fa dalla zia di Vinny. Una tinozza d’acqua, uno scemo di villaggio, un barone poco lontano… Tutto questo non aveva niente a che fare con lui; provò come un senso di vuoto e si domandò vagamente divertito se era questo che sentiva un bambino scoprendo che i genitori che l’avevano allevato non erano i suoi veri genitori, e che era entrato nella sua casa non dal calore ma dalla strada, da un luogo pubblico e disordinato… Cercarono e trovarono un ristorante dove far colazione. Era la margine opposto della città e sovrastava il precipizio. Dentro, era uno solo, immenso locale con quindici o venti tavoli; sulla parete di fondo v’era una fila di finestre che si affacciavano sulla piana sottostante. Sedettero a un tavolo e aspettarono che comparisse qualcuno. Nel locale faceva freddo. Sentivano il vento imperversare contro i vetri delle finestre, eppure le nubi che passavano a livello dell’occhio si muovevano con serena lentezza. Una ragazza, la figlia del padrone, arrivò dalla cucina, e Appello le stava domandando che cosa c’era da mangiare, quando la porta si aprì ed entrò un uomo. 240 Verso Sud D. Grittani Guardandolo, Bernstein provò un’improvvisa impressione di familiarità di cui non seppe trovare la ragione. La faccia era quella di un siciliano, rotonda, scura come la terra, gli zigomi alti, la mascella ampia. Fu lì lì per mettersi a ridere forte, poiché d’un tratto gli era venuta l’idea che sarebbe riuscito a parlare con quest’uomo in italiano, e quando la cameriera se ne fu andata, lo disse a Vinny, il quale si mise a sua volta a osservare l’uomo. Sentendo i loro sguardi, l’uomo li guardò con un’allegra smorfia del volto e disse: «Buongiorno». «Buongiorno» rispose Bernstein attraverso i quattro tavoli che li separavano; e poi, a Vinny: «Come mai ho questa sensazione, nei suoi confronti?». «Come diavolo vuoi che lo sappia?» disse Vinny, lieto di poter condividere ora con l’amico un argomento di comune interesse. Si misero a osservare l’uomo, il quale, evidentemente, veniva spesso a mangiare lì. Aveva già posato il cappello su una sedia, la giacca su un’altra, il panciotto su una terza. Sembrava volesse farsi dei suoi capi di vestiario altrettanti compagni di tavola. Era alle soglie della mezza età, ma molto rugoso in faccia. E per i due americani c’era qualcosa di strano nel suo abbigliamento. La sua giacca avrebbe potuto portarla un uomo del luogo; era nera, stretta, spiegazzata, e coperta di povere. I calzoni erano marrone scuro, molto pesanti, come quelli di un contadino, e le scarpe, di cuoio spesso, avevano la punta volta all’insù. Ma portava un cappello nero – insolito da quelle parti, dove tutti portavano il berretto – e la cravatta. Si pulì le mani prima di allentarne il nodo; era una cravatta di seta a strisce gialle e azzurre, un tipo di cravatta certamente non in vendita da quelle parti, e che nessuno fra quella gente avrebbe portato. E c’era uno sguardo nei suoi occhi che non era lo sguardo intento del campagnolo, né aveva l’innocenza degli altri uomini che li avevano guardati nelle strade di questo paese. La cameriera tornò con due piatti di agnello per gli americani. Dal suo tavolo l’uomo gettò uno sguardo interessato alla carne e agli stranieri. Bernstein diede un’occhiata nel proprio piatto e disse: «C’è un pelo.» Vinny richiamò la ragazza che stava già dirigendosi verso il nuovo venuto, e le indicò il pelo. «Ma è un pelo d’agnello» spiegò lei con semplicità. Loro dissero: «Oh» e finsero di cominciare a tagliare quella carne leggermente rosea. «Dovrebbe vergognarsi, signore, a ordinare carne, oggi.» L’uomo pareva divertito, ma non si capiva bene se era anche un pochino offeso. «E perché no?» disse Vinny. «Oggi è venerdì, signore» disse l’uomo, e sorrise con comprensione. A. Miller Monte Sant’Angelo 241 «Ah, è vero» disse Vinny, benché lo sapesse benissimo. «Dammi del pesce» disse l’uomo alla ragazza, e le domandò, con familiarità, notizie della madre, che in quei giorni era malata. Bernstein non era riuscito a staccare gli occhi dall’uomo. Non riusciva a mangiare quella carne, e se ne stava lì a masticare del pane, provando un crescente impulso di avvicinarsi a quell’uomo e parlargli. Gli sembrava tutta una pazzia. Il paese, le nubi nelle strade, l’aria fina, tutto stava diventando come un’allucinazione. Lui conosceva quell’uomo. Era sicuro di conoscerlo. E chiaramente era impossibile. Eppure, contro questa impossibilità si ergeva una sorta di cieca certezza: che se avesse osato avrebbe potuto mettersi a parlare correntemente in italiano con quell’uomo. Da quando aveva lasciato l’America, quello era il primo momento in cui non aveva provato il disagio di viaggiare, di sentirsi un viaggiatore. Ora si sentiva a posto come Vinny, gli parve. Riuscì a immaginare l’interno della cucina, ebbe un’immagine chiarissima di come doveva essere la faccia della cuoca, e il posto dove appendeva un certo grembiale sporco. «Che cosa ti succede?» gli domandò Appello. «Perché?» «Lo guardi in un modo!» «Ho voglia di parlargli.» «E perché non gli parli?» disse Vinny, sorridendo. «Non so l’italiano, lo sai benissimo». «Be’, gli parlerò io. Che cosa vuoi che gli dica?» «Vinny…» cominciò Bernstein, ma s’interruppe. «Cosa?» disse Appello, avvicinando la testa alla sua e guardando la tovaglia. «Fallo parlare. Di qualunque cosa. Forza.» Vinny, gustando la strana emozione dell’amico, guardò verso l’uomo, che ora stava mangiando, diligente, e con immensa soddisfazione. «Scusi, signore.» L’uomo alzò la testa. «Io sono un italiano d’America. Vorrei parlarle. Siamo forestieri, qui.» L’uomo, masticando con delizia, annuì col suo sorriso cordiale, divertito, e aggiustò meglio la sua giacca appesa allo schienale della sedia lì vicino. «Lei è di queste parti?» «Sì, di poco lontano.» «Come vanno le cose, qui?» «Lei di che cosa si occupa, se non sono indiscreto?» L’uomo aveva finito di mangiare. Bevve un’ultima, lunga sorsata del suo vino, si alzò e cominciò a rivestirsi; si strinse di nuovo il nodo della cravatta. Quando camminava lo faceva con una lenta e ampia falcata, come se ogni passo fosse da conservare. 242 Verso Sud D. Grittani «Vendo stoffe, qui, alla gente, e ai negozi, se così si possono chiamare» disse. Andò al suo fagotto posato su un tavolo e cominciò a disfarlo. «Vende stoffe» disse Vinny a Bernstein. Le guance di Bernstein cominciarono ad arrossarsi. Di lì dov’era seduto poteva scorgere l’ampio dorso dell’uomo, leggermente curvo sopra il suo fagotto. Vedeva le mani dell’uomo occupate a disfare il nodo, e appena l’angolo del suo occhio sinistro. Ora l’uomo stava togliendo la carta che avvolgeva due pezze di stoffa; ne spianò con cura le grinze sopra il tavolo. Era come se quella carta marrone fosse del cuoio prezioso che non dovesse screpolarsi o stazzonarsi malamente. La cameriera venne fuori dalla cucina con un’enorme pagnotta rotonda di almeno mezzo metro di diametro. Gliela diede, e lui la mise in cima alla pila di pezze, e un’ombra di sorriso increspò le labbra di Bernstein. Ora l’uomo riavvolgeva con attenzione la carta. Rifece il fagotto, lo chiuse con un laccio e lo riannodò, e Bernstein emise una piccola risata, una risata di sollievo. Vinny lo guardò, già sorridendo, pronto a ridere con lui, ma sconcertato. «Che c’è?» disse. Bernstein trasse un sospiro. C’era un che di trionfante, una nuova aria di sicurezza e di superiorità nella sua faccia e nella sua voce. «È un israelita, Vinny» disse. Vinny si voltò a guardare l’uomo. «Perché?» «Per il modo in cui ha fatto quel fagotto. È esattamente il modo in cui faceva un fagotto mio padre… e mio nonno. Tutta la nostra storia è far fagotto e andar via. Nessun altro sa essere così tenero e delicato nel fare i fagotti. Solo un israelita sa legare un fagotto così. Chiedigli come si chiama.» Vinny era molto divertito. «Signore» chiamò con quella cordialità che la sua natura riservava ai membri di una famiglia, di qualunque famiglia. L’uomo, ficcando l’estremità del legaccio entro l’orlo della carta, si volse verso di loro col suo sorriso cortese. «Posso chiederle come si chiama, signore?» «Come mi chiamo? Mauro di Benedetto.» «Mauro di Benedetto. Già» rise Vinny, guardando Bernstein. «Come a dire Morris of the Blessed.» «Digli che io sono israelita» disse Bernstein, gli occhi carichi di un’intensa animazione. «Il mio amico qui è israelita» disse Vinny all’uomo, che ora si stava caricando il fagotto sulle spalle. «Eh?» fece l’uomo, confuso dalla loro improvvisa vivacità. Stava lì, con un sorriso vacuo, cortese, come domandandosi se in tutto questo non vi fosse un qualche sottile sottinteso americano ch’egli avrebbe dovuto afferrare, pronto a condividere A. Miller Monte Sant’Angelo 243 l’umore degli altri. «Giudeo, il mio amico.» «Giudeo?» ripeté, mentre il desiderio di stare allo scherzo lo faceva continuare a sorridere. Di fronte alla sua persistente incomprensione Vinny esitò. «Giudeo. Il popolo della Bibbia» disse. «Oh, sì, sì!» L’uomo annui, sollevato, ora, di non essere stato colto in peccato d’ignoranza. «Ebreo» corresse. E accennò affabilmente a Bernstein, un po’ imbarazzato, incerto sul da farsi. «Ha capito che cosa gli hai detto?» domandò Bernstein. «Sì, ha detto “ebreo”, ma non sembra averci dato peso. Signore,» disse, rivolgendosi all’uomo, «perché non beve un bicchiere con noi? Venga a sedersi qui.» «Grazie, signore,» rispose l’altro in tono grato «ma devo essere a casa per il tramonto e sono già un po’ in ritardo.» Vinny tradusse, e Bernstein gli disse di domandargli perché doveva essere a casa per il tramonto. L’uomo a quanto parve non se l’era mai domandato. Scrollò le spalle, rise, e disse: «Non so. Per tutta la vita sono tornato a casa per l’ora di cena, il venerdì sera, e mi piace arrivare prima del tramonto. Dev’essere un fatto di abitudine, immagino; mio padre… Vedete, ho una strada segnata. Prima la facevo con mio padre, come lui l’aveva fatta con suo padre. Siamo conosciuti, qui, da molte generazioni. E mio padre il venerdì sera è sempre tornato a casa prima del tramonto. È un’abitudine di famiglia, immagino.» «Il Sabbath comincia al tramonto del venerdì» disse Bernstein, quando Vinny ebbe tradotto. «E porta anche a casa il pane fresco per il Sabbath. È un ebreo, ti dico. Domandaglielo, per piacere.» «Scusi, signore» sorrise Vinny. «Il mio amico vorrebbe sapere se anche lei è ebreo.» L’uomo alzò le sue folte sopracciglia non solo per la sorpresa, ma come se si sentisse in certo modo onorato del fatto che gli si attribuisse qualcosa di esotico. «Io?» disse. «Non intendo dire americano», disse Vinny, pensando d’interpretare il significato dello sguardo che l’uomo aveva gettato, volgendosi di colpo, su Bernstein, «ebreo» ripeté. L’uomo scosse la testa, come dispiaciuto di non poter compiacere Vinny. «No» disse. Era pronto per andarsene ma voleva continuare quella conversazione, che era evidentemente la più interessante che gli fosse capitato di fare da settimane. «Sono cattolici, gli ebrei?» «Mi domanda se gli ebrei sono cattolici» disse Vinny. 244 Verso Sud D. Grittani Bernstein si appoggiò all’indietro, gli occhi pieni di sconcertato stupore. Vinny rispose all’uomo, che di nuovo guardò Bernstein, ansioso di capire più a fondo la stranezza di quella cosa, ma la sua missione lo richiamava altrove. Augurò loro buona fortuna e si congedò. Andò alla porta della cucina e ad alta voce ringraziò la ragazza, dicendole che la pagnotta gli avrebbe riscaldato la schiena per tutta la discesa verso la pianura, quindi aprì la porta e uscì nel vento e nel sole, volgendo ancora un cenno di saluto a loro due. Tornando verso la macchina continuarono a ripetersi il loro stupore, e Bernstein raccontò di nuovo come suo padre confezionava i fagotti. «Forse non lo sa, di essere ebreo, ma come può non sapere che cosa sono gli ebrei?» disse. «Be’, ti ricordi mia zia, a Lucera?» disse Vinny. «È una maestra di scuola, e mi ha domandato se tu credevi in Gesù Cristo. Non ne sapeva assolutamente un’acca. Io credo che i pochi che hanno sentito parlare degli ebrei, in questi paesetti, credono che siano una qualche setta di cristiani. Una volta conoscevo un vecchio italiano che credeva che tutti i negri fossero ebrei, e che gli ebrei bianchi fossero solo dei convertiti.» «Ma il suo nome…» «“Benedetto” è anche un nome italiano. Ma “Mauro” non l’ho mai sentito. “Mauro” è senz’altro di antica origine.» «Ma con un nome simile, è possibile che non si sia mai domandato…» «Non è detto. A New York, il nome “Salvatore” diventa “Sam”. Gli italiani sono famosi per storpiare i nomi; il nome non vuol dire mai molto. Vincenzo diventa Enzo, oppure Vinny, o addirittura Chico. Nessuno si chiederebbe di dove viene Mauro, o qualunque altro nome. Chiaramente quell’uomo è ebreo, ma sono sicuro che non lo sa. Hai visto anche tu, no, com’era sconcertato?» «Ma, Dio mio, portare a casa una pagnotta per il Sabbath!» rise Bernstein, sbalordito e incredulo, scuotendo il capo. Arrivarono alla macchina, e Bernstein aveva già posato la mano sulla maniglia, quando si arrestò volgendosi a Vinny. Aveva un’aria accalorata, le palpebre un po’ gonfie. «È ancora presto… Se vuoi che torniamo alla chiesa, ti accompagno. Puoi dare un’altra occhiata.» Vinny cominciò a sorridere, e poi si misero a ridere tutti e due. Vinny gli diede una pacca sulla schiena, e poi lo afferrò a una spalla, come volesse abbracciarlo. «Accidenti, scommetto che ora comincia a divertirti, questo viaggio!» Mentre camminavano di buon passo verso la chiesa, la conversazione verteva sempre sullo stesso punto. Bernstein disse: «Non so perché, ma mi interessa. Non solo si comporta come un ebreo, ma come un ebreo ortodosso. E nemmeno se ne accorge… Non riesco proprio a capirlo». A. Miller Monte Sant’Angelo 245 «Hai un’aria tutta diversa, lo sai?» disse Vinny. «Perché?» «Mi puoi credere.» «Sai una cosa curiosa?» disse Bernstein, piano, come entravano nella chiesa e scendevano nella cripta. «Mi sento… a mio agio, qui. Non so come dire.» Cercavano di evitare le pozzanghere, guardavano entro cappelle, aprivano porte, in cerca del prete. Finalmente apparve, da non si sa dove, e Appello comprò da lui un’altra candela e scomparve nelle ombre dei corridoi fiancheggiati da sepolcri… Bernstein rimase lì… Tutto era bagnato, gocciolante, lì attorno. Ampia, dietro di lui, saliva la scala di pietra, i gradini consunti da milioni di piedi. Dalle narici gli uscivano sbuffi di vapore. Non v’era nulla da guardare, nient’altro che buio. Buio, umidità, angustia, un ingresso per l’inferno. Ogni tanto, lontanissimo, gli giungeva l’eco di un passo, di un altro, poi silenzio. Non si muoveva, cercava dentro di sé l’origine di un’estasi che non s’era mai sognato esistesse nella sua natura; vedeva quell’uomo cortese scendere giù per la montagna, camminare attraverso la piana, per strade segnate a lui da generazioni di uomini, un viandante senza nome che portava a casa una pagnotta ancora calda il venerdì sera… e inginocchiarsi in una chiesa la domenica. C’era in questo un’ironia che non avrebbe saputo descrivere. E tuttavia provava una sorta d’orgoglio. Di che cosa dovesse essere orgoglioso non avrebbe saputo dire; forse era soltanto perché sotto l’insensato impulso della storia un ebreo era segretamente sopravvissuto, spogliato della sua coscienza, ma preso per sempre in quell’inaudita impudenza di osservare il Sabbath in un paese cattolico, sì che la sua stessa inconsapevolezza finiva per essere una prova, una prova muta come una pietra, di un passato ancora vivo. Un passato per me, pensò Bernstein, attonito nel constatare quanta importanza ciò avesse per lui, quando in realtà non aveva mai avuto una religione, e nemmeno, ora se ne accorgeva, una storia. Scorse la forma di Vinny che si avvicinava per l’angusto corridoio, la fiamma della candela appiattita dalla fredda corrente d’aria. Sentì che avrebbe guardato Vinny negli occhi, in modo diverso, ora; la sua condiscendenza era svanita, e con essa anche un certo imbarazzo. Si sentì più libero, in certo modo alla pari col suo amico… e com’era curioso, pensò, che prima si fosse sentito in certo modo superiore a lui. D’un tratto, Vinny era ormai vicino, vide che la sua vita era stata coperta da una sorta d’inconsapevole vergogna. «L’ho trovata! È laggiù!» Vinny rideva come un ragazzo, indicando il fondo del corridoio. «Magnifico!» disse Bernstein. «Mi fa piacere, Vinny.» Stavano entrambi un po’ curvi sotto il soffitto basso e umido, la voce esalava 246 Verso Sud D. Grittani dalle loro bocche in echeggianti sussurri. Vinny rimase zitto per un istante, cogliendo la contenuta felicità di Bernstein e scorse in essa la prova che la sua ricerca non era stata un sentimento meschino. Alzò la candela per vedere meglio la faccia di Bernstein, poi rise, prese Bernstein per un polso e lo guidò verso la scalinata che saliva alla superficie. A Bernstein non era mai piaciuto che qualcuno lo tenesse afferrato, ma nel tocco di questa mano nel buio, stranamente, non v’era alcuna implicazione di un’odiosa debolezza. Camminarono fianco a fianco giù per la strada ripida. Il paese era di nuovo deserto. L’aria odorava di carbone di legna e di olio d’oliva. Qualche pallida stella era apparsa nel cielo. Le botteghe erano tutte chiuse. Bernstein pensò a Mauro di Benedetto che scendeva per la strada sassosa e serpeggiante, affrettandosi per arrivare prima del calar del sole. [Tratto da I dont’ need you any more, ARTHUR MILLER, The Viking Press, New York 1967; apparso per la prima volta sulla rivista Harpers’s Magazine nel marzo del 1951; tradotto in italiano da Bruno Fonzi per le edizioni Rizzoli nel 1970] 247 La Montagna dell’Arcangelo FERDINAND GREGOROVIUS [...] E così, battendo i denti, giungemmo alfine nella città del Gargano, che deve all’Arcangelo la sua origine e il suo nome. Essa ci appariva, come se si tenesse arrampicata al raso cocuzzolo del promontorio, in mezzo ad una solitudine grandiosa, col mare di sotto: un ammasso di bizzarre case imbiancate, sulle quali s’innalzano fumaiuoli innumerevoli delle più strane forme; e il tutto dominato da un’alta e scura torre. Le case poggiano sulla noda roccia: alcune seguono a scaglioni il digradar delle rupi, e folti arbusti di quercia fan loro corona. Nell’entrare in città, sbattuti dal vento e awolti in un turbinìo di polvere, noi potemmo immaginarci di esser come arrivati alla dimora di esseri favolosi. La popolazione maschile sembrava esser tutta fuori, in istrada, ed aveva aria di una moltitudine di demonii che andassero su e giù taciturni. Ciascuno di quegli uomini, causa il gran freddo, s’era imbacuccato nel suo oscuro pastrano, e tirato su il cappuccio. A vederli così tutt’insieme si sarebbero presi per una grande riunione di cappuccini o d’incappati. E così mutoli s’aggiravano a caso; mentre le campane del santuario, che ancora non vedevamo, suonavano a distesa. E del santuario andavamo impazienti in cerca, dopoché in una sudicia cànova di vino, che aveva qualcosa di un covo di malfattori, ci fummo alquanto riscaldati. La via che conduce alla cappella, passa per la piccola piazza della città. Ivi, su di una colonna, sorge una figura in marmo dell’Arcangelo, lavoro che viene attribuito a Michelangelo. Da un de’ lati s’innalza una grossa e nera torre a due piani, bella costruzione di Giordano da Monte Sant’Angelo, l’architetto di Carlo d’Angiò. La piazza rigurgitava di gente. Frotte di pellegrini facevan ressa alla porta del santuario, dove, nella grotta, la messa era sul punto di cominciare. Il vento fischiava violentissnno intorno e al di sopra di noi. Una banderuola in ferro, attaccata alla croce del campanile, un San Michele girante, scricchiolava e strideva in modo da mettere ribrezzo. Come fra il gridìo e lo strepito di spiriti elementari, noi ci awiammo a scendere nel misterioso regno delle ombre. La grotta giace profonda nel seno di una rupe, le cui pareti sono nascoste da’ 248 Verso Sud D. Grittani sacri edifizii, e nella sommità è un vecchio arbusto di quercia, a’ cui rami i pellegrini son soliti appender pietre. Per scendere giù ai santuarii nella caverna si entra per una porta gotica, poggiata su due colonne da ciascun de’ lati. Nel mezzo dell’arco acuto siede la Madonna col Bambino, tra San Pietro e San Paolo, gruppo in marmo eseguito con molta nobiltà di sentimento. L’epigrafe, ond’è fregiata, in cambio d’invitare il pellegrino ad entrare, sembra fatta apposta per incutergli terrore ed allontanarlo, quasi fosse qui proprio la Santa Sanctorum d’Iside: Terribilis Est Locus Iste, Hic Domus Dei Est Et Porta Coeli. La porta conduce ad una spaziosa scala discendente, in pietra di cinquanta gradini, al basso della quale si apre una seconda porta gotica. Poiché avemmo varcato la soglia della prima ci vedemmo dinanzi la grande scala, tagliata nella pietra viva, coperta di archi gotici, fiocamente illuminata dalla luce del giorno, che vi penetra pe’ fori lasciati dalla roccia stessa. Attraversammo prima parecchie stanze, gremite di rivenduglioli di mille gingilli tutti relativi all’Arcangelo: amuleti, medaglie, corone del rosario, rami di pino, conchiglie a mucchi, immagini rozzissime, e specialmente statuette rappresentanti San Michele; insomma, una fiera a buon mercato. Lungo le pareti, sopra tavole ed assi, codeste statuette eran disposte a centinaia e delle più svariate grandezze. Sono di marmo friabile del Gargano e fatte di pezzi: ali, capo, corona, scudo, spada, anche il piedistallo di legno giallo, si possono staccare pezzo a pezzo, e riporli in una cassetta. Questo modo tenni io per portarmi felicemente a casa il mio San Michele, che mi sta ora dinanzi sano e salvo. Non avevamo fatto la scala, che una torma di sciancati, di storpii, di pitocchi ci fu intorno, levando alte grida, e impedendoci l’andare oltre. Finalmente ad uno scaccino riuscì aprirci il cammino, offrendosi pure a servirci da mentore in quel mondo sotterraneo. Nello scendere avevamo notato in più luoghi su’ gradini e sulle pareti della scala l’impronta incisa di mani e di piedi, ciò che destò in noi un senso di orrore. Ora sapemmo, che sono segni per antica tradizione impressi da’ pellegrini. Così pure le pareti, come nelle catacombe di Roma, si veggono tutte imbrattate e scarabbochiate de’ loro nomi. Per la porta da basso entrammo quindi in una piccola corte quadrata, e qui rivedemmo di nuovo la luce del giorno. Questo è il più antico cimitero de’ pellegrini. Alle pareti sono addossate alcune tombe; ma niuna di esse va più in su del secolo XV. L’atrio mette alla chiesa, la quale è situata in lungo innanzi alla santa grotta. Vi si entra dal lato orientale della corte, per una porta in stile romano, con imposte di bronzo che il ricco amalfitano Pantaleone fece costruire, nel 1076, a Costantinopoli. F. Gregorovius La Montagna dell’Arcangelo 249 Sopra ventiquattro tavole contengono figure lavorate in niello in istile assai primitivo e ingenuo, ma piene di espressione, le quali rappresentano tutte apparizioni di angeli: la cacciata dal paradiso de’ primi progenitori, gli angeli in presenza di Abramo e Giacobbe, di Daniele e Zaccaria, la liberazione di San Pietro dal carcere, e scene simiglianti, sino all’apparizione di San Michele innanzi al vescovo Lorenzo in Siponto. Sulla porta si leggono le parole leggendarie che l’Arcangelo avrebbe dette a quel prelato: Ubi saxa pand untur, ibi peccata homimun d imittuntur. E poscia: Haec est domus specialis, in qua noxialis quaeque actio d il uitur. La chiesa fu edificata sotto il primo Angioino. Non ha che una sola navata, ardito lavoro di architettura gotica, per metà tagliato nella roccia. A sinistra è illuminata dalla luce del giorno, e da questo lato è pure il coro con i suoi banchi e stalli in legno pe’ canonici. A destra si apre l’accesso alla Sacta Sanctorum, alla famosa e miracolosa grotta, al punto centrale del culto dell’Arcangelo in tutto l’occidente. L’apertura ha quaranta piedi di larghezza e sedici di massima altezza. Mentre eravamo lì dinnanzi, una strana, una indescrivibile scena ci si offrì allo sguardo, quasi fıaba la cui azione si svolgesse nelle visceri di una montagna incantata e illuminata. Se Dante avesse potuto assistervi, n’avrebbe, di certo, fatto tesoro nella Divina Commedia. Folte schiere di pellegrini, che circondati da incerta e fıoca luce parevano spiriti, gremivano la scala di marmo, che dalla chiesa mette su alla grotta. Si pigiavano e spingevano per salire, o stavan fermi, o anche ginocchioni. Nell’oscuro fondo della spelonca, sull’altare coperto di porpora, ardevano candele, che irradiavano la bianca figura dell’Arcangelo, il quale pareva battesse le ali. Un sacerdote con un chiericozzo si muovevano in qua e in là, innanzi all’altare, compiendo fantastici inchini e genuflessioni. I preti in chiesa cantavano con stentorea voce, e di laggiù venivano pure a ondate gli accordi dell’organo. Le ombrose volte della chiesa, di sopra la gola oscura della caverna, il baglior tremolante che ne pioveva fuora, la solennità de’ canti e de’ suoni, quella calca di gente silenziosa, mutola: tutta questa vita misteriosa e sotterranea produceva un’impressione che non si lascia esprimere con parole. Si sarebbe potuto credere che fosse nient’altro che un sogno. Il prete dell’altare aveva appunto dato principio alla messa; epperò noi eravamo peritosi a spingerci più in là. Ma lo scaccino, che ci accompagnava, c’invitò a tenergli dietro. Con modi sgarbati e grossolani, senza riguardo di sorta, come se si fosse stati nella baracca del saltimbanco, ci fece largo tra la fitta moltitudine. Superata la scala, ci fece penetrare sin presso al jerofante, e lì, quasi dietro all’altare, dovemmo rimanere. Veramente, lo stare colà non era per noi poco penoso. Ci eravamo cacciati, quası ınvasori, in quel luogo, dove si compivano misteri che non ci riguardavano; e ciò senza nostra intenzione. Del resto, potemmo presto farci accorti che quella tolle- 250 Verso Sud D. Grittani ranza senza limiti, comunissima in quale che siasi chiesa d’Italia, per cui l’elemento profano può, come meglio gli pare e piace, andare e venire e aggirarsi nella dimora del santo, anche qui era ammessa ed esercitata. Dall’altare, è vero, il prete ci volgeva tratto tratto un’occhiata curiosa, investigatrice: ma si vedeva pure, che, più che con un rimprovero, l’accompagnava con un sorriso fuggitivo. La grotta era piena zeppa di pellegrini. Uomini e donne, che ci stavano vicini, o immersi nelle loro divozioni o intenti a fare le loro sacre gesticolazioni, non ci guardavano che con piena indifferenza. Infine, se pure qualche scrupolo ancora in noi rimaneva, venne a liberarcene l’incredibile ingenuità del nostro scaccino. Malgrado della sua condizione officiale di custode del tempio, egli riguardava tanto poco il Granduca celeste come un essere che bisognasse trattare col dovuto rispetto, che trovò affatto naturale l’accendere ad uno de’ candelieri, che ardevano sull’altare stesso, un moccolo attaccato ad una canna, e con esso illuminare in qua e in là, dal di dietro, la figura dell’Arcangelo, onde noi avessimo agio di vederla in modo più spiccato. E tutto questo nel momento appunto, che a due passi da noi il canonico compiva il sacrifizio della messa innanzi alla figura dell’Arcangelo! E non valsero a nulla i nostri segni di rifiuto, ché egli non vi badò. Certo, la sconcia azione non potette sfuggire al gran sacerdote dell’Arcangelo; ma il fatto è che nessuno se ne mostrò sorpreso! Così presso com’ero, io osservavo la scena meravigliosa con la stessa intensa curiosità, con la quale Erodoto e Plutarco assistettero un tempo ai misteri in Egitto, nella Siria e nella Grecia. Spettacolo più singolare non avevo mai visto in mia vita! Come quadro, illuminato alla maniera di Honthorst, avrebbe rappresentato il sublime del fantastico. Noi stavamo nella più riposta profondità della spelonca, dalla cui negra volta trapelavano e cadevano su noi gocce d’acqua. Intorno intorno pellegrini genuflessi ed oranti. Dinanzi a noi l’altare illuminato con sopra la figura dell’Arcangelo. Poi il prete e il chiericozzo che cantavano, intercalando il canto con inchini e riverenze. Più in là, in fondo, vedevamo la scala, letteralrnente coperta di devoti, e sulla oscura massa che formavano, e anche oltre nella chiesa, scorreva leggiero e tremolante il barlume delle candele. Quando pensai che questo culto per un essere creato dalla fantasia, o addirittura per un fantoccio, venne celebrato identicamente, sempre nella stessa cappella, per tredici secoli; ch’anzi per la sua origine semitica, superando il nascimento stesso del Cristianesimo, va a perdersi nella notte de’ secoli remoti; non devo negare che l’impressione in me fu grande. Questo Arcangelo, prima di assumere la figura che ora ha, è trapassato per una serie di miti cosmogonici. E la stessa figura presente ha per sé una storia ignota. Forse l’effigie di San Michele è qui, su questo altare, sin dal VI secolo. A1 tempo della persecuzione iconoclasta bizantina sarà stata abbattuta; e F. Gregorovius La Montagna dell’Arcangelo 251 poscia nel secolo VIII rimessa su di nuovo. Tale qual è oggi, è un lavoro della fine della Rinascenza una statua di marmo, alta forse tre piedi. L’Arcangelo è coperto di corazza, con un’alta corona sulla chioma inanellata le ampie ali distese, nella destra la spada, sulla sinistra lo scudo, e di sopra alla corazza una clamide che cade all’indietro. Tuttoché armato così marzialmente, pure, al pari di tutti gli angeli, San Michele fa un’impressione infantile E tutto il culto per lui riveste il carattere medesimo: una bambinería messa su per baloccarsi. I misteri nella grotta del Gargano non hanno in verità nulla in sé di orrido o di spaventevole Essi non sono che una fiaba fantastica, come quella dei Castello d’Arturo, di Dororoschen, del Venusberg e del Kyffllauser: soltanto una fiaba elevata sino all’idealità religiosa. I fedeli qui convenuti a pregare, non parevano dominati né agitati da tetre immagini. Solo una vecchia donna che era accanto a noi, dava qualche segno di movimenti convulsivi senza posa s’assestava violenti pugni al petto, mentre una giovane, che le stava vicino, aveva in cambio ogni ragione di trattarsi con dolcezza e riguardo. Io credo che tutti questi pellegrini sotto l’immagine dell’Arcangelo alato non si rappresentino che un essere celeste, amorevolmente disposto, un salvatore e un patrono, e soprattutto un genio tutelare. Egli siede presso il trono di Dio, e la dimora sua è la luce. Che cosa è qui la grotta tenebrosa Stando alla ingenua credenza del pellegrino, è il simbolo della terra o del mondo umano, nel quale è piovuto dall’alto un raggio del divino. Ma, anche quaggiù, nella caverna, il pensiero del devoto pellegrino va cercando il suo genio non nelle spaventose tenebre delle catacombe, bensì nelle regioni eteree. E a lui s’offre un’immagine bella e graziosa che lo rallegra e solleva, e cui non si mescola alcuna rappresentazione del deforme e nulla che ricordi il tormento, gli affanni e la morte. Gli angeli o i genii sono le uniche figure non nate a soffrire che i miti cristiani abbian create o, per dir meglio, ricevute dalle antiche religioni dell’oriente. Esse sono la più attraente delle creazioni poetiche della cosmogonia asiatica. Nessuna credenza più dolce e più tenera di quella in un angelo tutelare, che vada svolazzando sul sentiero dell’uomo errabondo. E la figura stessa di San Michele non ha altro significato, ancoraché la sua lotta con i titani, ribelli del ciclo, gli dia l’impronta di Ercole. Il culto di lui non ha in sé niente di quella ributtante materialità delle reliquie e di un magico feticismo, compagna indivisibile dell’adorazione de’ santi. Invece è e rimane sempre il culto del buon genio e della luce; un culto più umano, per lo meno più ideale di quello che onora gli altari de’ molti martiri della Chiesa. Senza dubbio, sapienti come Pitagora e Socrate, poeti come Milton e Klopstock non gli avrebbero rifiutata la loro adesione. La vista del grazioso genio non può disporre il pellegrino che ad impressioni e 252 Verso Sud D. Grittani sentimenti miti. Questi, non legandosi a nulla di determinatamente dommatico, non stando in relazione con alcun fatto della storia ecclesiastica, si risolvono in fondo tutti in puri concetti universali. Quelle rappresentazioni che la cavalleria nel medio evo si formò di San Michele, come del cavaliere celeste, come del debellatore degli infedeli e degli altri nemici della Chiesa, sono venute meno. Solo una propaganda tutta partigiana ha potuto ora tentare di voler fare dell’Arcangelo il gran maresciallo della rivincita per i disastri toccati nel 1870 alla Francia e al Papato. La possanza di lui sarebbe destinata ad annientare le conquiste germaniche ed espellere dal profanato Quirinale il novello Eliodoro. Impresa, per verità, ardua anche pel buon Arcangelo d’Avranches, ché in fatto di scienza di guerra egli dev’essere rimasto un po’indietr,o rispetto alle esigenze del tempo! E chi sa pure, se codesta impresa, che gli si vuole addossare, egli sia in fine disposto a riguardarla come una missione in servizio del principio della luce? Con la sua fine ironia il geniale Kaulbach ha dipinto il San Michele tedesco sotto l’effigie appunto dell’Arcangelo, coperto però il capo dell’elmo prussiano e in atto di sgominare, qual vittorioso riformatore, le potenze tenebrose del 1870. Questo intanto è da tenere per sicuro, che l’Arcangelo italiano sul Gargano non sarà mai per sguainare la spada contro Vittorio Emanuele. Per gl’intenti del legittimismo e della propaganda gesuitica egli non è accessibile al fanatismo e Don Carlos ed Enrico V hanno poco a sperare da lui. Allorché gl’Italiani entrarono nel suo Castel Sant’Angelo, egli non pensò punto a trar fuori la spada e salvare il Dominum Temporale. In cose di religione nessuna nazione fu ed è più facilmente accensibile della francese, di che son prova le sue molte e spaventevoli guerre di religione: gli Albigesi, gli Ugonotti, la notte di San Bartolomeo, le Dragonades e via di seguito. Nessuna al contrario lo è tanto poco quanto l’italiana. Processioni, come quelle che oggi in Francia si veggono andare in giro, nessuna potenza sacerdotale, neppure il comando espresso del Papa, potrebbe in Italia riuscire ad organizzarne, e volesse il Santo Padre condurle egli stesso in persona al Gargano, a Loreto o a San Nicola di Bari. Quando fui a visitare quest’ultimo santuario, anch’esso assai famoso, anch’esso uno de’ più frequentati pellegrinaggi nel mezzogiorno d’Italia, entrato nella sacrestia, vidi pendere dalle pareti l’uno rimpetto all’altro, nel migliore buon accordo del mondo, i ritratti di Pio IX e Vittorio Emanuele. Il re delle Due Sicilie è per antichissima tradizione canonico nella chiesa di San Nicola di Bari. La ecclesiastica dignità è stata, come prima, senza difficoltà trasmessa anche all’usurpatore. Il clero nell’Italia Meridionale seppe in ogni tempo accomodarsi ai fatti politici compiuti. Quale sia la dinastia regnante nel paese, a lui è in fondo indifferente. L’essenziale è stato sempre che lo si lasciasse valere e non si portasse la mano all’esercizio del suo culto. F. Gregorovius La Montagna dell’Arcangelo 253 Oggi come pel passato il clero mantiene quasi illimitato l’antico dominio sulla coscienza delle moltitudini. Le mutazioni quivi occorse hanno avuto carattere puramente politico e nessuno morale. Una inveterata maniera di vivere secondo antiquate abitudini ereditarie vi dura e vi si serba intatta, sostenuta da una superstizione millenaria; e a niuno è dato preconizzare il come e il quando il culto degli antichi santuarii italiani abbia a cadere estinto. L’unico cangiamento subito da’ misteri del Gargano consiste nel numero assottigliatosi degli oblatori di offerte e nell’essere spariti dalla lista de’ pellegrini e visitatori i nomi d’imperatori e di altri grandi e potenti della terra. Ma anche ciò potrebbe forse non essere che un fenomeno molto transitorio. Niuno assicura non possa venire il giorno che un papa 0 un re buon cattolico non abbia di nuovo a fare la sua comparsa sul Gargano. La messa era finita e la grotta andava sfollandosi. Allora potemmo osservarla a nostro agio. Presso l’altare è una pila, che pe’ pellegrini che vi attingono, è una vera fonte benedetta. Le si leva accanto una vecchia figura dell’Arcangelo: ed è in una pietra l’impronta di una sua pedata, l’unica reliquia che si abbia di lui. Vedemmo anche una vecchia cattedra in marmo con una effigie di San Michele ed un’antica figura di San Giacomo, il cui tempio a Campostella gareggiava nel medio evo con questo del Gargano. Il pavimento della grotta non è di pietra naturale, ma coperto di marmo bianco e rosso. Poiché fummo usciti fuori dall’antro a rivedere le stelle, la procella s’era calmata; e noi andammo un po’ in giro per la città di Sant’Angelo. Originariamente essa non comprendeva che ospedali pe’ pellegrini, de’ quali alcuni rimangono ancora oggi. Già nell’XI secolo era diventata un ragguardevole luogo fortificato, e insieme con tutto il paese del Gargano formò il centro di un feudo regio, del quale grandi signori portarono il titolo. I diritti che vi erano annessi, furono chiamati: I’onore di Monte Sant’Angelo. Federico II ne investì per testamento l’amato figliuolo suo, Manfredi. La città conta oggi più di 10.000 abitanti. Le sue case tinte a bianco, ornate pressoché tutte di una piccola nicchia con entro la figura dell’Arcangelo, sono del più bizzarro stile: la maggior parte a un sol piano, con scale di pietra scoperte, che per un uscio a volta menano su di una terrazza. La facciata d’ordinario forma un quadrato, dove la porta d’ingresso serve al tempo stesso di finestra. All’interno riboccano di sudiciume. Non una che avesse aspetto alquanto bello e pulito; eppure di persone ricche non dev’essere difetto in Sant’Angelo. Ci fu raccontato che tengono sepolti sottoterra mucchi d’oro e d’argento, e che traggono la vita più miserabile che possa immaginarsi; mentre mandano poi i figliuoli a studiare a Napoli. Dove la città verso l’interno della montagna si termina, si può gettare uno sguardo sulla grandezza selvaggia e deserta del Gargano. Negre foreste di pini e di querce 254 Verso Sud D. Grittani vanno così avvallandosi fra i profondi burroni. Pure quasi da ogni parte sono pezzi di terreno disposti a terrazzi ove vegetano viti ed olivi. E più in fondo vi sono anche campi di biade, ed orti innaffiati da sorgive che nel monte non mancano. Dall’anno 1860 al 1869, questa regione montuosa, al pari degli Abruzzi, brulicava di briganti: oggi è stata purgata di siffatto malore. Il Governo è intento a congiungere insieme tutti i paesi del Gargano con una rete di strade e di fili telegrafici; il che forse è il mezzo più sicuro per prowedere l’appartato mondo alpestre di elementi di più alta coltura. Con un certo tal quale desio spingemmo l’occhio entro gli ascosi recessi delle montagne e delle valli a noi sconosciute: il poterle percorrere a cavallo dovrebb’essere un vero gusto. Ma con maggior desiderio ancora guardavo io quell’ammasso di rupi selvagge, che dal lato d’oriente va a sprofondarsi nel mare. Colà sotto è Viesti, la remota, la perduta dal mondo. La sua solitudine dev’essere un incanto; ma a noi non fu dato visitarla. Da Sant’Angelo ci parve meglio tornarcene a Manfredonia, lieti di aver potuto felicemente compiere il nostro pellegrinaggio alla sede dell’Arcangelo sul Gargano. [Testo di FERDINAND GREGOROVIUS tratto da Viaggiatori tedeschi in Puglia nel Settecento, a cura di Teodoro Scamardi, Schena, Fasano 1990] 255 Monte Sant’Angelo Corrado Alvaro Corrado Alvaro (San Luca di Calabria 1895 - Roma 1956). Scrittore, redattore del quotidiano La Stampa, la sua prima consistente prova narrativa risale a Gente di Aspromonte (1930) a cui faranno seguito Misteri e avventure (1930), Vent’anni (1930), L’uomo è forte (1938), Ultimo diario (1959) e Tutto è accaduto (1961). Con ogni probabilità Alvaro visitò il Gargano nel 1940, lasciandoci nelle pagine che compongono il racconto Monte Sant’Angelo uno struggente ricordo di quel viaggio. Vi sono popoli che hanno un talento istintivo e storico per l’architettura. E si capisce per quelli che hanno da celebrare una potenza e da attestare una forza. Ma s’immagina difficilmente un gruppo di pastori e di contadini che porti una preoccupazione architettonica nella sua abitazione, nel suo forno, nel suo rifugio di montagna. Da Manfredonia a Monte S. Angelo, si va prima per un pendio sul mare, di poche case sparse tra i campi di olivi e di mandorli, di olivi e di pini d’aleppo. La montagna è una pietraia deserta là davanti, e si misura dove e come il vento la tormenta. In una piega del terreno, in una ruga, in una valle, dove il vento non arriva, qualche albero si leva, una macchia verde descrive la sua pace. Ma salendo per la strada bianca, quello che era il deserto appare un bastione di pietrame, e non qui soltanto, ma su tutti i poggi e i monti intorno; alla fine, sull’intero promontorio. Tutto quello che si scorge, dalle valli asciutte alle cime, è una immane opera di muri a secco che sostengono le terrazze degli olivi, dei mandorli, delle vigne, del grano. Un movimento a spirale avvolge monte dietro monte, i viottoli serpeggianti e le strade tortuose rifanno un movimento concorde; il mare che sembra levarsi inclinato sulla linea dell’orizzonte, è rigato allo stesso modo dalle correnti: tutto è sullo stesso disegno, simile all’avvolgersi di certe conchiglie. Sulla cima di qualche poggio sta come un fossile un edificio bianco. Si capisce d’essere capitati entro un’opera tra le più ingegnose degli uomini e, come succede, si pensa alla natura di 256 Verso Sud D. Grittani questi uomini. Una tale opera dei campi è stata compiuta in settant’anni, da quando il Gargano finì di essere un feudo regio coi suoi boschi profondi dell’interno. Il lavoro parla per gli abitanti. Come lo scatenarsi d’una girandola, questo vortice diventa sempre più grandioso e più complicato a mano a mano che si risale il monte. Poche volte la fatica umana dà uno sbigottimento simile. Una donna, nell’autobus, con due occhi di fuoco di notte, posa per un attimo lo sguardo su di voi. Non vi guarderà mai più. Tutto qui è molto importante. A un certo punto, l’occhio si abitua a discernere nient’altro che questa immane pazienza. Qua e là nelle valli, spuntano certi enormi comignoli, e non se ne scorge l’abitazione. Si scorge bensì la porta incardinata nel masso. La vigna è ancora nuda, i mandorli già verdi con qualche vecchio fiocco fiorito, colore della polvere, gli ulivi alleggeriti sono gracili; ma non c’è traccia d’uomo se non questi enormi camini dalla forma di torri, di campanili, di lanterne, di vecchi casolari, bianchi come la pietra, e un filo di fumo annunzia che qualcuno è vivo là sotto, chiuso come un minatore. Tutta la terra attorno è lavorata come una miniera. In fondo alla valle, una borgata è disposta in riga su quattro o cinque file, seguendo il disegno delle terrazze che la sovrastano per la montagna, tinta di bianco come tutta la pietra che si vede. Un lembo di terra miracolosamente in piano, arriva verde di grano proprio fino alla striscia del mare turchino. Gli stessi comignoli che si sono veduti prima, annunziano la città di Monte Sant’Angelo, prendono forma sopra al ciglio roccioso del monte, figurano come le cuspidi di una lontana città turrita e bianca; si scorgono poi i tetti, le case basse disposte in riga sulla cima, che coprono il monte come un tetto, della stessa forma, e spioventi come gli embrici d’un tetto, e, sopra, questi comignoli spropositati, a torrione, a elmo, a turbante; se una città moderna dovesse avere i suoi comignoli delle proporzioni di questi, in rapporto all’altezza degli edifici, si dovrebbe presentare con camini della grandezza delle Torri di Bologna o del campanile di Pisa. Questi camini dicono tutto: il vento che tira, il freddo d’inverno, la bisogna del pane. Da una casa esce un tale con un’asse sulla testa, e sopra ci sono due pani di dieci o dodici chili ciascuno, quanto basta a una famiglia di cinque o sei persone, di qui, per due giorni. Non avevo mai veduto un pane di questa posta. A parte la donna dell’autobus, con gli occhi di fuoco di notte, non ho veduto qui altre donne, fuori, se non vecchie. Una scritta all’ingresso della città avverte che qui si tocca il quaranta per mille della natalità, la quota più alta d’Italia, a quanto pare. Ci si accorge subito di trovarsi fra gente dura e gelosa, quella cioè che ha costruito l’enorme monumento dei bastione delle sue montagne. Tanto dura, che neppure il matrimonio accade senza dramma. L’uomo ha spesso bisogno di un atto di forza anche in ciò. Che un contrasto qualunque coi parenti della sua bella si faccia strada, che lo prenda un dubbio sui C. Alvaro Monte Sant’Angelo 257 sentimenti della donna amata, e l’uomo, che fino a quel giorno non è riuscito a parlare alla sua sospirata se non stando sulla soglia della porta, con la madre muta testimone, e la fanciulla rifugiata ai piedi del letto, quest’uomo spalleggiato dai suoi compagni si presenta nella casa di lei, in un’ora in cui ella è sola con la madre, e quando i suoi compagni con l’inganno o con la forza hanno condotto fuori la vecchia, egli si chiude la porta alle spalle e diventa signore dell’amata. A ogni denunzia di colpi di questo genere, e dei ratti in campagna, o nel corso d’una festa, i carabinieri sanno che tutto finirà col pranzo di nozze. Spesso, per la povera condizione degli sposi che non possono redigere lunghe note di beni e di oggetti di corredo da far leggere solennemente per bocca del notaio davanti al vicinato, e da far portare alle comari nelle canestre, il ratto è buonissimo rimedio che dispensa da tante malagevoli formalità. Pensano gli amici a preparare una lauta cena ai due fuggiaschi, e un buon letto. La mattina dopo, le madri dei due sposi per amore e per forza, vanno a informarsi se tutto sia andato bene. Il letto è molto alto, le assi sono sostenute da due alti trespoli, e per salirvi ci vuole una scaletta o una sedia, anche al prete e al medico quando sarà l’ora. Quella del ratto è una vecchia usanza illirica. È noto che di là, sull’altra sponda dell’Adriatico, il rituale del matrimonio comporta anche un ratto simulato, a cavallo, prima della celebrazione. Qui è rimasto l’uso nel suo vigore primitivo. Il ratto può capitare anche a una donna sorda al richiamo dell’amante, e che per avventura ami un altro. Tutto finirà ugualmente col matrimonio; ma con quale cuore? E si tratta proprio d’un richiamo d’amore, al modo degli uccelli e delle fiere, un sibilo sordo come dei grilli d’estate, cui la donna, se vuol rispondere, si affaccia dietro i vetri o sulla porta, a cui corre, se è fuori, strisciando lungo il muro fino alla porta di casa sua. E poi i figli, le grandi famiglie che servono per il lavoro della montagna, dove sono di pietra anche gli ammostatoi, dove sono scavate nella roccia le gabbie per i torchi, dove i pani sono grandi come la luna piena, dove il vento è chiamato lucifero, e suscita nei crudi inverni i racconti delle streghe, dove si lavora fino a settant’anni e si campa spesso fino a cento, dove gli uomini ripetono sempre la medesima storia e nascono forti, crescono intraprendenti contadini pastori e artigiani, negati a ogni forma d’industria, ma per quello che sanno fare ricercati in tutto il Tavoliere, per un buon grande pane sicuro, e che neppure nell’emigrazione scordano le loro attitudini, rimanendo carpentieri, muratori e imprenditori di lavori stradali e di costruzioni. Hanno il genio dell’architettura come in altri, non più molti, paesi d’Italia; e davanti alla loro città costruita mirabilmente sullo scrimolo del monte e su due valli, ci si può chiedere se, per avventura, tante invenzioni preziose d’architettura, non soltanto popolare, non vanno proposte a modello d’una moderna architettura povera di idee e pretenziosa, come è quella che ci propone 258 Verso Sud D. Grittani stabilimenti balneari e palagi tutti del medesimo stile. Non esiste da noi un documento che metta sotto gli occhi l’arte di costruire una casa come fanno qui, a Ischia, a Positano, e in pochi altri luoghi, e che rappresenta la forma attraverso cui anni ed anni si raccomandano alla considerazione dei posteri. Arte di fare scale, passaggi, portici, di risolvere problemi di pendenze, di prospettive, di variarle infinitamente. Arte di legare gli uomini ai loro luoghi. È tanta la vocazione di questi di Monte Sant’Angelo, che essi chiamano pagliai anche certi rifugi di montagna costruiti di pietra a forma di capanna. I loro avi della preistoria abitavano qui in caverne che si vedono ancora, adattate già mirabilmente ad abitazione. Appena il romanico glorioso fece illustre la Puglia, questi montanari trasportarono sulle loro abitazioni il modello delle facciate di quelle chiese, quadrate e rettangolari, e adattandole, in modo che la più moderata casuccia ha questo egregio frontespizio. In molti luoghi, è ancora la caverna primitiva sormontata da un comignolo e chiusa da una di queste facciate. Ed è una caverna il famoso santuario di S. Michele Arcangelo che pare sia apparso qui per la prima volta alla adorazione dei fedeli, prendendo il posto di Apollo che qui aveva un tempio. Poiché egli lasciò l’impronta del suo piede nudo, i pellegrini di tutta la regione e delle regioni vicine tracciano sui muri e sulle scale del santuario l’impronta della loro mano e del loro nome. Le impronte di quei piedi e di quelle mani sono come una lunga eco delle sessantamila persone che passano qui ogni anno. Il sagrestano del tempio, sotto la grotta umida ed enorme che si apre nella chiesa, mi offre una reliquia. Una scheggia del masso. Ancora pietra, la pietra. [Tratto da Itinerario italiano, CORRADO ALVARO, Bompiani, Milano 1941] 259 La Tomba di Rotari Giuseppe Ungaretti Ora ci appare Montesantangelo. Le sue case, per le porte sormontate dalla finestra a balconcino, a questa distanza le diresti una greca che coroni il monte. Arrivati a Montesantangelo, correte a vedere la cosiddetta tomba di Rotari. Un’architettura degna di Ispahan! È un monumento misterioso. All’esterno s’alza come una mole che faccia da testa al monte, e pure portando i segni netti d’un’arte molto avanzata, non riesce nel suo ritmo a dissimulare non so quale violenza caotica della natura ancora vergine. Misterioso monumento! Il suo nome la dichiara Tomba di Re Rotari longobardo. Ma, pare, perché si lesse male una scritta che diceva «Rodelgrimi». Quante volte i dotti ce l’hanno data a bere, leggendo male! Il popolo la chiama la Tomba di San Pietro perché attigua alla chiesa di questo nome. Chi la ritiene un campanile, chi un “sontuoso tipico battistero del XII secolo”, chi tomba e torre di vedetta da principio e poi battistero e chiesa… Possono avere tutti ragione. Ma come pensa il prof. Giovanni Tancredi che vuole essermi guida gentile e che questo monumento ha studiato con amore in tutti i suoi particolari, mettendone alcuni egli stessi in luce, quanto alla data di costruzione si dovrebbe risalire alla prima metà del XII secolo. Quanto all’essere tomba, anche a non credere agli esametri incisi che dicono: Incola Montani Parmensis Prole Pagani Et Montis Natus Rodelgrimi Vocitatus Hanc Fieri Tumbam Jusserunt Hi Duo Pulchram Vale a dire: Un abitatore del monte di origine parmense, Pagano, Ed uno nativo di Monte, chiamato Rodelgrimi, Fecero fare questa bella tomba. Perché andare a immaginare che tumba, volendo dire volta o cupola, non potrebbe essere una tomba? Tomba la dice il popolo, tomba la dichiarava la leggenda dotta. E tomba sia, per il fortunato visitatore che in essa si sprofonda. Verso Sud 260 D. Grittani Vita trionfante Il suo colore interno è d’un rosa secco. Un colore che verso l’alto diventa d’una accalorata luce diffusa. Si ha veramente l’impressione d’essere scesi in una profondità di tomba, circondati da visioni infernali, come quel potente groviglio che rappresenta l’avarizia tormentata. Ma alzando gli occhi in questo luogo di sogno, ecco un primo conforto: fra l’accidia e la lussuria, ecco la maternità, ecco la vita trionfante! Teniamo gli occhi alti, seguiamo gli spazi che salendo prendono a gradi una forma più raccolta, arriviamo alla sommità, lassù, lassù – l’occhio si fa piccolo per arrivare a vedere – e vedremo un’aria soprannaturale, contenuta come in un guscio d’uovo trasparente che una freschezza illumina… Molto probabilmente questa tomba sarà anche un battistero. Non è il battesimo un sacramento dei morti alla grazia? E non li risuscita? E sembra che ora possano essere sfidate tutte le pesanti leggi che tengono i nostri passi giù. Si è veramente morti alla materia, è veramente un nascere allo spirito. Non conta più il nostro peso a questo punto dell’aggirante salita. Conta una felicità ritmica, conta una divina precisione, è superato e oltrepassato l’inutile, conta la grazia. Com’è pura i quest’aria di sogno, la giovine maternità… [Tratto da Deserto e dopo, GIUSEPPE UNGARETTI, Mondadori, Milano 1961] 261 Pasqua Giuseppe Ungaretti San Michele del Gargano, il 1 aprile 1934 L’angelo nella caverna Dall’alto, così muoversi a perdita d’occhio, non avevo mai visto il grano giovane. Soggiace appena al suo alito in fiore; ma è un alito immenso, un alito di felicità finalmente palese, davvero da terra risorta. Un alito di Pasqua, davvero di terra finalmente di luce. E non lo definisce luce la sua incertezza stessa? Quell’essere ancora il tremito d’un calore libero da poco lungo lo stelo dalla zolla, d’un calore che ancora tralasciare non può, nello scorrere oltre la tenerezza dell’erba, qualche ombra di violenza segreta? Calando dai monti portato all’infinito in palma di mano, è stamani il Tavoliere d’una freschezza e d’una felicità… Ma ecco che una rivolta della strada ce lo nasconde. Pasqua! Li sentite gli agnellini? Siamo nel paese del grano e delle greggi. Un giorno un’idea, e conteneva in sé fuse tante altre forme, da una proda bizantina prese il volo e, chiamatasi San Michele Arcangelo, venne a posarsi su questo monte. Gli sono venute dietro tutte quelle case bianche che vedete, che s’arrampicano l’una dietro l’altra piene di 20.000 Cristiani, sormontate da fitti comignoli lunghi lunghi, che formano una strana roccia con mille feritoine per farci il nido. Gli è venuto dietro quel campanile angioino che alza – all’angolo d’un piazzale, chiuso dentro un’inferriata, ma non è feroce – i suoi 25 metri, come un enorme cero pasquale, imitando il poderoso e grazioso slancio delle torri ottagonali di Castel del Monte. Ha persino un portale della medesima breccia picchiettata di sangue del monumento svevo. Dal quinto secolo in qua, gli è venuta dietro questa città di Montesantangelo, brulicante a 900 metri sul Gargano. Il suddetto piazzale – noi diremmo corte; atrio esterno, direbbe il saccente: culonne, 262 Verso Sud D. Grittani dice meglio di tutti la gente di qui, perché una volta c’era un elce secolare nel mezzo. La culonne è fatta per li sammecalere - da San Michele – venditori ai loro banchi di statue del loro santo, da essi stessi lavorate in alabastro che pare allume. Sono due dinastie di artigiani: gli Iasio e i Parla, e dal tempo dei Re aragonesi hanno il privilegio di fare e vendere le statue. Circolano anche nella culonne gridi cristallini di montanine: offrono li mazzaredde, e con li mazzaredde ciuffi di pino di Aleppo e nastri e tutto l’occorrente perché il pellegrino non se ne torni a casa senza il suo bordone. Potrà acquistare anche schegge di calcare da portarsi al collo o da attaccarsi al cappello, e se avesse fame, li fascinedde, l’ostia chiene, li pupratidde, carrube, croccanti, ciambelle di cacio… Apparve in origine l’angelo all’uomo, dicono, impugnando una spada di sole che ci chiuse l’Eden. Gli angeli furono da allora le stelle, inaccessibili misure che guidavano i passi erranti nel deserto. Compresa la stella che condusse alla grotta i Magi, furono nature pure, assoluta fissità, segnali sicuri, operai adibiti all’eterna creazione del mondo, api mediatrici fra la divina potenza e l’umano fallire, vaghezza o terribilità balenanti da uno stato di beatitudine perduto, bramato, promesso. Erano i numeri dello strologare caldeo, e già erano i messi biblici che balenando gli occhi umani non disdegnavano prendere sembianze umane. E noi, dalle parti nostre, pronti non eravamo già a togliere le ali a Mercurio; a Ercole, il drago e la forza; a Apollo, la perfezione d’un corpo che dirada la notte – per cedere a Michele ogni cosa e farne, quando avrà da piombare sugli idoli, una famigliare immagine? Qui per la prima volta apparve chiaro in Occidente che il Cristianesimo poteva vantarsi d’avere schiacciato il drago, il quale era tutte le altre fedi: esse avevano dovuto trasmettere all’Angelo ogni loro speculazione e ogni loro seduzione. L’apparizione garganica abbagliò tutta l’Europa. Perché stupirsi che i Normanni, tornando dai Luoghi Santi, salissero il Monte per acclamarla? E perché quindi stupirsi che sino dal settimo secolo, a imitazione di questo San Michele di Puglia, il San Michele a Pericolo del Mare sul Monte Tomba nella Neustria, trovasse in un sasso druidico rifugio, stringendo tra i due santuari mistico patto di guerrieri? In un angolo della culonne, fra l’incrociarsi dei gridi, c’è un parlottare che solo qualcuno ode. È Melo da Bari che nel 1016 chiede ai Normanni d’aiutarlo a cacciare i Bizantini dalla sua Patria. Ah! Qui è nata una cosa da nulla: il Regno delle Due Sicilie, un avvenimento che darà per quasi mille anni un giro diverso alla storia d’Italia e alla storia d’Europa e alla Storia. In fondo alla culonne c’è una facciata con due archi che aprono un portico nell’ombra, dove una fata con uno spillo dev’essersi gingillata a ricavare figure e fogliame per due portali ogivali. Entriamo. Dentro buio ai lati indoviniamo i laboratori delle due tribù de li G. Ungaretti Pasqua 263 sammecalere: rappresentano la prima, quattro paia di baffoni scurissimi. Una scalinata ruzzola giù. Udiamo: Scala sante, pietra sante, Padre, figliuole e spirite sante… È il lamento di persone che fanno la scala in ginocchio. Pastori che incominciano a giungere prima di tornare ai loro monti, per ringraziare l’Angelo della buona svernagione? Come Santa Maria Maggiore di Siponto è la chiesa dei pescatori, questa è la chiesa dei pastori. S’è già detto: ogni apparizione d’angeli ci riporta prima di tutto all’infanzia del mondo: patriarchi, armenti, stelle, solitudine, smarrimento…: pastori… Non sono più tante migliaia come ai tempi del pascolo forzoso nel Tavoliere; ma quando saranno quassù in gran numero nella prima ottava del prossimo maggio, si vedrà che sono ancora molti, per fortuna nostra. Una nazione che ha ancora di questi cuori semplici, non invecchierà mai. La scala va giù, va di qua, va di là, trova un raggiolino di sole, lo perde; s’incontrano nella penombra a ogni pianerottolo: porte murate, altari, tombe… In fondo alla scala, finalmente ci siamo. C’è una porta, entriamo: eccoci tornati in pieno giorno in un cortile; su s’affaccia una ringhiera; a sinistra, al nostro fianco, delle arcate chiuse da cancelli: altre tombe, un vero cimitero. In fondo, la facciata con la sua mirabile porta di bronzo eseguita “da mano greca per Pantaleone Amalfitano” nella “regal città di Costantinopoli”, nel 1076. Sono, dal punto di vista dell’arte, il tesoro del santuario. Nei 23 riquadri dei 24 che formano le due imposte – nel 24° c’è un’iscrizione – appaiono figure bislunghe delle quali il bulino ha inciso il contorno, fatto risaltare da un filo d’argento premuto nel cavo. Alle estremità di ogni contorno intarsiato e dentro uno sparpagliamento di piastrine d’argento intagliate, s’irrigidiscono piedi, mani e facce. È un giocherellare sottile e goffo di lucettine sopra una piatta e dura tenebra: non resta di solito molto di più d’una grande tradizione giunta all’ultimo ieratismo della sua decadenza; ma qui è giunta, nel suo tremolare, a quella smemoratezza senile che annuncia la primitività. Entriamo. Attraversiamo una navata gotica. C’inoltriamo. Ci rinveniamo poi affondati nell’antro. Il luogo è umido, e in mezzo all’oscurità a poco a poco si rivela una statua corazzata d’oro, attorniata da un tremolare di lucette di candele. È l’Angelo! Vicino a me, aguzzando gli occhi, e per via della corazza di latta che portano, vedo che ci sono alcuni bimbi. Stanno in ginocchio con l’elmo di latta in mano, e giocherellano con la spada di latta. Mi fermo dove l’oscurità è più densa. Ecco, sono bene a contatto ora della natura cruda. Caverna: luogo d’armenti, e d’angeli dunque: luogo d’apparizioni e 264 Verso Sud D. Grittani d’oracoli. Ma forse c’è anche stato in questo cuore della terra un uomo anteriore ai terrori, vicino alla sua origine divina: profetico fantasma di sé, del suo penoso incivilirsi. Fantasma, dice un poeta, ed è, nella sua cieca sottomissione a certe contingenze d’ora e di luogo, l’immagine finita d’un tormento che può darsi sia eterno. Può darsi che una vita umana spesa bene, altro non sia se non un’aspirazione a lasciare di sé simile immagine. Angeli o fantasmi; ma per chi cerca il valore religioso dell’arte, per chi ci crede, quale prova questo tendere a esprimersi dell’uomo in tale modo che, per effetto di poesia, la sua presenza, dipendente da una brevità di vita e da un variare, permanga sciolta dalla sua vita, e da un luogo e da un’ora. Per gli uni, non essendo loro ancora negata la grazia incantevole, ci sono sempre gli angeli; per gli altri che possono essere solo uomini di buona volontà e conoscere solo la grazia militante, prevarrà l’uomo, quell’uomo che, sulla tela che sogna immortale, non vorrà stampare se non il proprio fantasma. È quest’ultimo il modo della pietà dell’uomo verso l’uomo: ma, in chi lo pratichi, c’è una fermezza e un’audacia, non so quale grande fondamento morale; c’è, in questo cercare la storia in sé stessi, cercando un barlume nella notte del proprio bruciare, quasi ricuperata la originale virtù umana. Uscimmo. Già era sera. La sera dei paesi è data dalle donne che vengono sulla porta di casa, dalla piazza che s’affolla d’uomini, dai ragazzi che s’agitano di più senza che s’oda più il loro chiasso, dall’attesa d’un avvenimento che è, in questo nascere di primavera, già tutto nell’aria, anche più che nei cuori. Ora di rapimento. Ora di tono petrarchesco: Passa la nave mia colma d’oblio… L’unico modo di rompere il silenzio è di chiudere gli occhi. E m’è rimasta nel pensier la luce… [Tratto da Deserto e dopo, GIUSEPPE UNGARETTI, Mondadori, Milano 1961] PARTE XIV San Giovanni Rotondo 267 Quelle due fotografie di Padre Pio Graham Greene Graham Greene (Berkhampstead 1904 - 1991). Scrittore inglese tra i più apprezzati al mondo, autore dal profondo senso religioso (la sua conversione al cattolicesimo influenzò tutta la produzione letteraria), compì nel 1949 un lungo viaggio a San Giovanni Rotondo, spinto dalla curiosità di conoscere il cosiddetto “frate dalle stimmate”. Di questo viaggio riferì in una intervista rilasciata a John Cornwell, pubblicata sul settimanale L’Espresso il 19 novembre 1989. GRAHAM GREENE: «Nel 1949 andai ad una messa celebrata da Padre Pio in Italia, nella penisola del Gargano. Vi andai per curiosità. Avevo sentito parlare delle sue stimmate. Il Vaticano non lo gradiva. Un monsignore che venne a farmi visita a Roma, disse: “Oh, quella santa frode”. Ma Padre Pio è stato visitato da medici di ogni credo… ebrei, protestanti, cattolici e senza fede. Aveva quelle ferite sulle mani e sui piedi della grandezza di una moneta, e visto che non poteva celebrare messa con i guanti, tirava giù le maniche per cercare di nasconderle. Aveva una simpatica faccia da contadino ed era un po’ pesante. Ero stato avvisato che le sue messe erano lunghissime, così mi recai, di primo mattino, a quella delle 5.30, in compagnia della mia amica di quel periodo. Celebrò il rito in latino e mi era parso che fossero passati trentacinque minuti. Una volta fuori dalla chiesa guardai l’orologio e constatai che era passata un’ora e mezzo o due ore. E così che sono arrivato ad avere un minimo di fede in quel mistero. Perché era successo qualcosa di straordinario». JOHN CORNWELL - Mi accorgo che Greene resta per un po’ trasognato, ma gli chiedo ugualmente se crede davvero che Dio intervenga nelle vicende umane in forma miracolosa. Con un leggero sorriso scrolla le spalle e dice: GRAHAM GREENE: «Beh, non so. Ho la sensazione di un mistero. C’è qualche cosa di inspiegabile nella vita umana e questo è una circostanza importante, perché le persone comunque non crederanno a tutte le spiegazioni date dalla Chiesa… È curioso, ma nel mio portafoglio conservo una fotografia di Padre Pio». 268 Verso Sud D. Grittani JOHN CORNWELL - Greene tira fuori dalla tasca dei pantaloni un bel consumato portafogli e ne toglie due piccole fotografie. Nel porgermele mi pare di constatare in lui un leggero senso d’imbarazzo, come se lui, la quintessenza dell’uomo britannico, fosse stato sorpreso nel compiere un gesto di stravaganza romana. Una delle foto rappresenta Padre Pio sorridente, l’altra lo ritrae mentre adora l’ostia durante la messa. GRAHAM GREENE: «Non so perché conservo queste fotografie nel portafoglio dice. Le ho infilate lì e non le ho mai tolte». [Da un’intervista rilasciata da GRAHAM GREENE a John Cornwell, pubblicata sul settimanale L’Espresso, Roma 19 novembre 1989] 269 San Giovanni Rotondo ANTONIO BALDINI Nella colonna del dare posso scrivere anche questa: d’esserci entrato per uno a fare scappar la pazienza a un santo. In una colle altre occasioni mancate potrò allineare anche l’incontro andato a male col famoso padre Pio da Pietrelcina, altrimenti detto il «Santo del Gargàno». Per quel che tocca me personalmente dico subito che avrei preferito non essere della partita e tirar di lungo col grosso della spedizione, che nel suo programma non aveva creduto d’includere visita di sorta ad alcun santo; ma il mio parere contando per uno e nell’automobile che mi portava essendoci altri quattro risoluti di sincerarsi a ogni modo delle stímmate di padre Pio, convenne ch’io facessi il piacer dei quattro. Mentirei se dicessi che le ragioni che mi sconsigliavano dall’andare fossero innanzi agli occhi della mia mente gran fatto chiare e lampanti; ma comprendevo per istinto come una visita fatta con quella fretta e in quelle condizioni di spirito dovesse rientrare per l’appunto nella categoria delle cose che non si fanno; e perciò, salendo al Convento dei Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo, il vecchio mònito «scherza coi fanti» mi rimbombava nella testa. Andando incontro al santo con questa cattiva coscienza era forse giusto ch’io fossi punito; e il santo cominciò col farmi mediocre impressione. Se veramente ci fosse un Paradiso dove in eterno si dovesse veder risplendere nella corona eccelsa dei Beati e dei Santi anche la luce di questo padre Pio conosciuto di persona il giorno tale, ora tale, loco tale, in compagnia de’ tali e tali amici, – che pena mai di rimorso, che figura barbina, che confusione, che vergogna verrebbe in eterno ad esser la nostra di non avergli reso, mentr’era in noi di farlo, quegli onori e usato quelle attenzioni e dimostrato quella compunzione che drittamente si convenivano alla persona d’un tanto Avvocato! (Scusa magra sarebbe addurre che la Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio abbia già negato una volta di riconoscere qualsiasi carattere soprannaturale ai fatti attribuiti a padre Pio; scusa magra, una volta che lui fosse veramente assunto nei Ranghi di Lassù). 270 Verso Sud D. Grittani Già dal modo come entrammo di furia, sull’ora più calda del pomeriggio, armati di bastoni, binocoli e carte topografiche, con le sopravvesti in disordine, gli occhiali verdi e gialli rialzati sopra la visiera del berretto, le barbe imbiancate di polvere, le fronti rigate di sudore, gli occhi imbambolati dalla luce, dovemmo al certo sembrare o una pattuglia scampata per miracolo dall’esplosione d’una fossa petriera, o meglio ancora degli attori truccati a metà che cercassero l’impresario per bastonarlo. Vedendoci entrare, il converso ch’era dietro a spazzar l’andito a terreno, s’appoggiò esterrefatto al muro. «Dov’è padre Pio?» chiese Adone Nosari con un tono che non ammetteva replica. «A quest’ora è in Cappella: in fondo, a sinistra.» Seduto in uno stallo del Coro, di lato alla finestra che dava sulla valle, c’era tutto solo un fraticello che a sentirci entrare volse ridente verso noi una faccia gialla di poca luce ma con due occhietti interrogativi. Pregava? dormiva? conversava cogli angioli? Noi ci facemmo avanti con inchini, subito cercandogli le mani per vedervi impressi i segni della passione di Cristo: ma un paio di mezziguanti di lana color marrone gliele copriva fino alla prima falange delle dita, che teneva posate in punta della panchetta. «È lei padre Pio?» chiese Nosari senza cerimonie. Il fraticello fece cenno di sì, sorridendo e guardandoci uno per uno, con quegli occhietti interrogativi di sotto una fronte quadrata di coscritto: e poi con un fil di voce ci chiese donde venivamo e dove eravamo diretti. Si capiva che il fatto di vederci così impolverati e quel nostro mezz’arnese da viaggio potesse toccare la sua riposata immaginazione. Gli dicemmo che venivamo da Roma, via Foggia. Quel nome di Roma, buttato lì con una certa intenzione, non parve interessarlo affatto. «Da Foggia? e quanto tempo ci avete messo?» Tutto questo detto con una vocina sottile, come se ci confessasse, e con un’espressione esagerata di meraviglia, come se Foggia fosse in capo al mondo. Poi volle sapere con chi e perché eravamo venuti sul Gargàno: ma tutto questo ce lo domandava col tono assente e manierato del maestro elementare che parla con uomini che già furono suoi scolari con le stesse inflessioni di voce di trent’anni prima. Nosari si sentì in obbligo di metter sùbito in chiaro il perché della nostra visita, e dette fuoco alle prime due tòpiche: esser noi dei giornalisti (e lo sciagurato fece anche colla mano il gesto dello scrivere) e volerci assicurare coi nostri occhi dei segni impressi sulle mani del padre. Padre Pio, senza farsi cadere quel sorriso dalle labbra, ma allungandoci di sotto in su certe occhiatine pietose e disarmate: «Oh non si può!» disse col suo vocino senza timbro, di grillo parlante. Seguì un silenzio imbarazzatissimo durante il quale ci guardammo in viso e ciascuno poté conoscere per la vista degli altri che aspetto poco simpatico e rassicurante s’avesse tutti, mascherati di polvere a quel modo. A. Baldini San Giovanni Rotondo 271 Qualcuno di noi dette un’occhiata alla porta socchiusa alle spalle e Nosari, con voce più insinuante (ci mancò poco non strizzasse l’occhio) insistette: «Sia buono: ce le faccia vedere solo un pochino» e con due dita faceva l’atto di chi scosta un guanto sul dorso della mano. (Dire a un Santo: Sia buono!). Abbuiato, padre Pio tornò a ripetere che non si poteva. «È il Vaticano, è Roma che non vuole?» «Non posso parlare. Perché mi domandate?» «E le ha anche ai piedi?» «Ho detto che non posso parlare.» «E… le fanno male? le dànno fastidio?» (Chiedere a un Santo se le stímate gli diano fastidio! Le nostre stesse facce, in giro, a quest’uscita, presero un’espressione stirata di cartapesta). «E ha sempre dei “fenomeni”? Ha operato dei miracoli anche ultimamente?» Una volta deciso di vuotare il sacco delle domande, il capotruppa aveva perso ogni pudore. Giornalisti! Il povero frate si dimenava sullo stallo e una insofferenza di momento in momento più viva gli si dipingeva sulla faccia: guardava ora noi ora la porta alle nostre spalle, non si capiva bene se per suggerirci d’uscire o pel timore che qualcuno del Convento venisse a spiare la figura che gli facevamo fare. Io me lo studiavo a trenta centimetri di distanza, nel bianco e nel nero degli occhi, per decidere fra me se quello potesse essere davvero un santo: o anche solo un mezzo santo. Ma quali punti di riferimento poteva avere la mia osservazione per leggergli nel cuore e giudicare della santità o meno di quel poveretto? Stava per perdere la pazienza, questo si capiva benissimo. Ma dov’è scritto che i santi non debbano mai perdere la pazienza? Io pensavo, puerilmente, che in una congiuntura simile un vero santo avrebbe trovato la parola da trattenerci o mandarci via col cuore dolcificato e molle come una pèsca giulebbata. Invece partimmo di lì non saprei dire se più mortificati, inquieti o beffardi e padre Pio, nell’atto di vederci partire, non si fidò nemmeno di darci la mano per segno di saluto. Pel corridoio del Convento, mentre uscivamo dalla Cappella, ecco che come per caso s’aperse una porta e v’apparve un pieno di frati che evidentemente ci aspettavano al varco per conoscere le nostre impressioni e forse anche, come parve da’ primi motti, per metterci qualche pulce nell’orecchio. Naturalmente ci guardammo dal dare a quei fratozzi troppa soddisfazione: anzi ci mostrammo molto contenti della visita fatta a padre Pio, e vantammo senza risparmio la sua modestia e discrezione. C’informammo così se facesse ancora dei miracoli e operasse delle guarigioni. Allora fu bello vedere come tutti nel quadro di quella porticina avrebbero voluto dir la loro, frati colla barba a punta, frati colla barba a corona, frati con tanto di pancia e tanto di cordone: ma all’infuori d’un sempliciotto entusiasta, che, per la 272 Verso Sud D. Grittani gloria dell’Ordine, si capiva che ci avrebbe fatto molto volentieri intendere che miracoli a San Giovanni se ne facevan sempre, tutti gli altri fratozzi fecero del loro meglio per farci capire, a forza di reticenze, di sguardi evasivi, di facce compunte, di mani aperte in alto, di parole messe là senza olio né aceto, a forza di «non so», «non risulterebbe», «io non c’ero», «io son venuto dopo», come tutti nel Convento tenessero dalla parte del Santo Uffizio contro il povero orante in Cappella. Nessuno è un grand’uomo pel suo cameriere. Figurarsi se un frate è disposto a riconoscere un santo proprio nel suo vicino di cella! Fatto si è che superato l’ingorgo di quei Cappuccini assiepati al varco del coridoio, ed usciti all’aria aperta, la figura del povero padre Pio mi parve di già lontanissima e in una luce, che se non era più quella del miracolo, era già un poco quella del martirio. [Tratto da Italia di Bonincontro, ANTONIO BALDINI, Sansoni 1940] PARTE XV Il Gargano 275 Il Gargano in una relazione per visita canonica di fine Seicento Egidio Mattielli Egidio Mattielli (Stroncone, Terni 1631 - 1712). Umile e dotto sacerdote, autore delle opere Umbria serafica e Viaggio nelle Puglie, testi di grande valore religioso e storiografico. Il suo viaggio in Capitanata, voluto dal Ministro Generale dei Frati Francescani, durò dal 17 maggio al 22 giugno 1683, periodo che fu sufficiente a Mattielli per redigere una approfondita analisi sullo stato delle comunità francescane allora presenti sul territorio. La rivelazione dei preziosi testi di Egidio Mattielli si deve allo storico Tommaso Nardella, che per la prima volta li pubblicò nella Rassegna di Studi Dauni nel 1976. Alli 31, hore otto partii da Stignano con il [Padre Francesco delle] Coppe compagno et altro laico, per S. Giovanni in Lamis 4 miglia distante. Caminassimo tre miglia per una selva su per la costa del monte e trovassimo S. Marco. Terra popolatissima dell’Abbatia di S. Giovanni in Lamis, che l’ha in commenda il cardinale Pignattelli. Poi un miglio più su trovassimo il convento di S. Giovanni posto in un poggio in cima del monte dell’Angiolo e quasi in mezzo a detto monte, poi che da qui a Procina che sta nell’estremità di esso sono 15 miglia verso tramontana et alla prima spelonca che sta nell’estremità a mezzo giorno sono altre 15 miglia. Questo fu antico monastero et abbatia ricchissima de’ Teutonici [sic] sicché erano padroni di S. Marco e di molte altre Terre per questo contorno, battevano moneta, havevano vassalli in mare et erano potentissimi. Ma mancati questi et occupate le terre da molti baroni restò l’abbatia con la terra di S. Marco in commenda delli monasteri secolari et hoggi l’ottiene l’E.mo Pignattelli che gli rende tre mila scudi annui d’entrata. La fabbrica di questa chiesa è antica e piuttosto a forma di rocca o fortezza che di convento con muraglie rosse. La chiesa è stata modernata da frati con una bella volta, ad essa si ascende con una scala bella nuova di molti scalini. Ha l’altare maggiore d’intaglio indorato 276 Verso Sud D. Grittani riguardevole con la statua di S. Matteo (da cui oggi si chiama per quel che diremo). Ha altri tre altari… quello di S. Giovanni comprende malamente l’organo e poi doi del Crocifisso e della Concettione. Il coro di noce bellissimo ma per andarvi bisogna passare per tutta la chiesa entrandovisi da piedi per una porticella picciola che entra nel cortile. Avanti la porta maggiore della chiesa è una piazzetta bella et a questa di fuori si ascende per la scala detta. Ha ancor campanile con buone campane. Dal cortile si entra in stanze buone che sono cinque e poi si ascende ad alto, dove sono altri doi dormitori, ma poco ordinati, con molte stanze, e il noviziato chiuso che ha diece celle. L’officine sono quasi sotterranee ma però luminose per essere posto in alto il convento, quale ha horti e selve ma non in clausura, eccetto un pezzo, che si comincia adesso. V’è il molino da schiena, tre cisterne et un pozzo, la conserva di neve e li parchi per l’animali. Hoggi il convento si chiama di S. Matteo perché vi fu portato un dente di questo S. Apostolo da Salerno, lo diede un cardinale commendatario, che si conserva in sagristia in un ostensorio d’argento et è in gran devotione appresso tutta la Puglia per li continui miracoli che fa e le gratie che se ne ricevono, massime per l’infermità degli animali de’ quali abbonda la Puglia: cavalle, pecore, vaccine, porci e tutti che toccati con l’oglio della lampada che arde avanti all’altare di esso Santo guariscono subito e ciò si vede ogni giorno, poi che vi conducono spesso le massaie intiere a toccargli e vanno sani. Li più lontani, cioè dell’Abruzzo, Puglia alta, di Bari di Terra di Lavoro che non possono condurgli, mandano a pigliare un frate con cavalli e lo portano ove bisogna e questo (sia sacerdote, chierico, laico o tertiario) mette un poco d’oglio in una conca d’acqua con la quale asperge le mandrie intiere e guariscono subito com’è stato verificato da persone degne di fede che lo vedono giornalmente non solo frati, ma preti, baroni e cavallieri. Per ciò il convento è commodissimo, che da tutta la Puglia riceve grosse limosine in specie tutti li segnano un polledro indistintamente e quando ha tre anni lo consegnano ai frati; così li vitelli et ogni volta che s’infermano li bestiami; onde alla fiera di Foggia dove si vanno a pigliare et il Sindico Apostolico li vende si riportano ogni anno molte centinaia di scudi. Il convento tiene 12 cavalli per servitio de’ frati e sono belli, ha mandre di porci, pecore. Si calcola che habbia più di tre mila scudi d’annue limosine, poi che nessuno ardisce negarli anzi tutti la danno copiosa per amore e timore di S. Matteo. (Oglio della lampada il quale oltre all’animali sana indistintamente tutte le persone morse da cane rabbioso). Tiene dieci novitii chierici, 4 o 6 laici, 6 tertiari, sacerdoti quanti pare al provinciale. Il dì di S. Marco li frati vanno alla Terra e fuori d’essa il guardiano si para con piviale, li ministri con tonicelle, cotte et alla porta della Terra sono ricevuti dal E. Mattielli Il Gargano in una relazione per visita canonica di fine Seicento 277 Vicario generale, da canonici, clero e tutto popolo; vanno processionalmente precedendo a tutti il guardiano con li frati parati et esso fa portare il pastorale da un chierico con cotta e con esso canta messa solenne nella Colleggiata e poi ritornano a casa. Questo pastorale è di rame indorato, assai antico, e si stima quell’istesso che usava l’abbate teutonico. Il dì di S. Giovanni Battista il clero e il popolo tutto vanno al convento processionalmente e sono ricevuti con la croce da’ frati; il Vicario generale canta la messa e mangiano in convento. Il Vicario generale presente è don Girolamo Perna, è di Gravina, canonico di Venosa, venne a visitarmi con gran comitiva di preti e gentilhuomini. Esso governa per il cardinale abbate in temporale e spirituale; il cardinale abbate pro tempore dà ottanta ducati l’anno al convento. Alli 2, la mattina a hore otto, partii con li miei compagni fra Diego da S. Severo et il padre Antonino da S. Giovanni per S. Leonardo, tredici miglia distante. Caminassimo per il monte Gargano quattro miglia sino a S. Giovanni Rotondo, Terra grossa del marchese Caccaniglia [recte: Canaviglia]. V’è di fuori un bel convento de’ Cappuccini, uno de’ Conventuali et un monastero di 40 monache claresse. Inde scendessimo tre miglia alla comunità di S. Giovanni ove ci rinfrescassimo. Quivi è un oliveto grande assai totalmente inculto. (Molte piscine frequenti della Puglia). Doppo un’hora ripigliassimo il camino per il piano di Puglia et, fate sei miglia, giungessimo a S. Leonardo che sta in sito elevato alquanto in quella pianura. Questa fu antica abbatia de’ Teutonici et hoggi l’ha in commenda il Cardinale Carlo Barberini et ne ha venti mila scudi d’entrata, consistenti in grani, biade, gran massarie di cavalli, vaccine et animali minuti. Questo mantiene li frati dandogli 50 ducati, cento barili di vino di settanta carafe, che sono venti boccali nostrali et 50 tomoli di grano, carta di legna, 5 tomoli di sale, castrati, vaccine, porci et tutto ciò che vogliono onde con questo e con le cerche è convento opulentissimo. Il convento o abbatia ha forma di castello con muraglia merlata e baluardi. Ha una sola porta, dentro v’è l’hostaria che la fanno li Abruzzesi in tempo d’inverno che vi tengono le pecore, v’ha hospidale mantenuto dal Cardinale che vi tiene doi ministri assistenti et il convento che ha forma di palazzo antico nel salone del quale il Cardinale Caetano fece un bel dormitorio con otto o dieci stanze comode e per altro appartamento stanno l’ufficine alte. A basso sono stalle, conserve con una piazza a tre cisterne. La Chiesa è antichissima a doi navate, divise da tre archi grandi di pietra. La porta maggiore è di bellissime pietre con rilievi bassi et statue alla grande. (Cupola, campanile, 3 campane). Ha 4 altari et il coro soprano. In essa chiesa sono alcuni riguardevoli depositi de’ principali cavallieri Teutonici ecc… 278 Verso Sud D. Grittani La chiesa piena di voti in specie di catene, ferri, manette è di gran devotione per tutta la Puglia. V’è una reliquia notabile di S. Leonardo e la testa di S. Donato martire. Quivi trovassimo il p. provinciale. Mangiassimo et posassimo et poi a 22 hore assieme con lui partissimo per Manfredonia camminando sei miglia per il piano… un miglio distante della città vedessimo il sito dell’antica Siponto della quale rimangono pochi segni di ruina et la cattedrale antica, stata rinovata et consacrata l’anni passati dal Cardinale Fra Vincenzo Maria Orsini. Giungessimo finalmente alle 24 a Manfredonia, città bagnata dal Mare Adriatico; è bislonga, in piano, con molte strade tutte dritte e corrispondenti. Si vede che è stata ricca e bella con palazzi superbi: ma per il sacco datogli dai Turchi più volte e miseramente nel 1620, per il teremoto del 1639 e 1643 per la pestilenza et per altri sinistri accidenti sta poco in ordine. È cinta adesso di buonissime muraglie et terrapieni, baluardi di cannoni con fossi interni et da levante verso il mare ha una fortezza et città della munitissima et tenuta con gelosia. Al tramontare del sole si chiudono le porte né s’aprono che doppo levato il sole. Il nostro convento stava fuori un terzo di miglio in buon sito alla marina: ma perché fu il primo saccheggiato dai Turchi e per il terremoto che lo guastò fu pigliato questo del 1645; è stato lasciato diruto e se ne fabbrica uno nuovo entro la città vicino alla fortezza. Sono fatti già doi dormitori et uno è bellissimo et contengono 15 stanze habitabili; l’officine sono tutte ragguardevoli. La chiesa che adesso è picciola ma si ha da ingrandire è dedicata a Santa Maria delle Grazie. È disegnato un bellissimo chiostro. È città reggia, v’è il preside e castellano spagnoli. Nella chiesa sono cinque altari e vi sono lì esposti di alcuni presidi spagnoli. Alli 3 di giugno martedì il padre provinciale volle condurmi con li compagni alla Spelonca di S. Michele Arcangelo. Venne anco il reverendo padre guardiano Salvatore di Foggia. Uscissimo al levare del sole passando vicino al mare sotto la fortezza. Caminassimo tre miglia per il piano; poscia arrivassimo al convento de’ Carmelitani Scalzi fuori della città dove entrassimo poi per una strada che gira tre miglia, adagiata [costruita] da Don Pietro d’Aragona, viceré. Giungessimo ad undici hore e ci fermassimo al convento de’ Carmelitani Scalzi fuori della città dove entrassimo poie per una dritta via ma con molta bella vista [giungessimo] alla Basilica che sta nel fine della città. Si scendono 60 scalini assai larghi a’ lati de’ quali son alcune cappellete. Si giunge all’atrio piano avanti la basilica, nel quale sono alcuni depositi dell’arcivescovo e poi per 4 scalini si entra nella basilica che ha le porte di bronzo mandate già da Costantinopoli. La basilica è stretta, all’entrare della porta è l’altare di San Lucia nel quale è impresso un Tau da S. Francesco; alla sinistra è il banco ove si segnano le messe; sopra il coro, più sù la sagristia et in faccia alla porta l’altare del Santissimo. E. Mattielli Il Gargano in una relazione per visita canonica di fine Seicento 279 La chiesa in tutto sarà longa 50 piedi, a la destra sopra l’altare di Santa Lucia sta la sacra spelonca. Infine sta l’altarino sopra il quale apparì l’Arcangelo e vi lasciò il vesteggio del piede, il pallio e la Croce. Detto altarino è coperto d’altro altare di marmo, e solo per un fenestrino con porta d’argento si mostra un tantino, se ne può vedere la strangulazione. Sopra questo sta la statua di S. Michele fatta da Michel’Angiolo Buonarrota. L’altare ha il palliotto di argento, la scalinata di tre ordini fatta da Don Pietro d’Aragona, il parapetto dietro tutto d’argento e un superbissimo e gran baldacchino d’argento del Re Filippo IV [recte: Carlo II], sostenuto da sei mazze d’argento et dodici candelieri. Avanti l’altare ardono nove lampade. Altari nove stanno davanti alla santa grotta. Sette avanti al Santissimo e doi o tre altari gran quantità di ceri e dentro la grotta sono altri quattro altarini non molto ben tenuti, ma però [a] tutti si dice messa. Al lato dell’evangelio è il pozzo di 60 carafe che se ben si cava [acqua] mai manca né cresce. La basilica ha quattro dignitari, arcipreti, arcidiacono, doi primiceri, dodici canonici e quattro prebendati. Le dignità portavano le mitre ma gli sono state levate. Fui ricevuto con urbanità grande da quei signori et in specie dal reverendissimo signor Don Carlo Gambadoro primicerio, nipote del reverendissimo Giovanni che mi servì con belli paramenti e con calice d’oro. Celebrassimo il segretario et io all’altare di S. Michele per la comunità di Stroncone et il compagno si comunicò. Ci furono mostrate tutte le reliquie e cose notabili ecc. Et io gli dissi che credevo et era fama per il mondo che la basilica fusse meglio tenuta. Ci diede il Gambadoro doi crocette e molte pietre della santa grotta ecc. Et il provinciale cinque statuette picciole et una più grande e tre medaglie di S. Michele benedetto al suo altare. S. Angiolo è del prencipe Ierace Grimaldi, genovese. Tornassimo a pranzo alli Carmelitani. Nel chiostro havendo il padre provinciale provveduto ecc. Fussimo regalati di pasticci et di selvaggine et di vini che vi son nobilissimi dal signor primicerio Gambadoro e dall’abate dei padri Celestini che ci voleva in monastero. Mangiassimo, posassimo, ritornassimo altra volta al santuario et partendo alle 22 hore giungessimo all’Ave Maria a Manfredonia, aspettati da doi religiosi et doi soldati che dovevano chiudere. Alli 4 venerdì visitai il Santissimo e li frati ecc. Il convento ha 25 ducati dalla città. Ha poche questue. Campa con messe. La città è amorevole ma povera. È arcivescovo monsignore Moscetta cavalliere napolitano prete Tiberio. Fuori della città si lavoro il salnitro. La chiesa metropolitana è bellissima rinovata dall’Eminentissimo Orsini. Adesso è ripiena di suppellettili. Ha quattro dignità e dodici canonici come il Monte Gargano. Vi sono Domenicani, Celestini, Conventuali et nostri dentro et doi monasteri di monache dentro, fuori li Cappuc- 280 Verso Sud D. Grittani cini. Fui a riverire il castellano della fortezza che è un cavaliere spagnolo molto cortese et devotissimo della religione. Il convento ha sei cisterne vecchie et doi nuovi che per anno non hanno acqua. Avanti al convento sono quattro cisterne del pubblico che spesso patisce d’acqua et bisogna pigliarla a Monte Gargano. Vi sono alcune sorgenti, ma sono salmastre che servono soltanto per lavare. [Testo di Egidio Mattielli tratto dalla Rassegna di Studi Dauni, Foggia 1976] 281 Al Gargano Consalvo Di Taranto Consalvo Di Taranto (Deliceto 1874 - 1944). Storiografo, poeta e scrittore, autore di opere importanti come La Capitanata nel 1848 (1910), La Capitanata al tempo dei Normanni e degli Svevi (1925, recentemente ristampata dalle Edizioni del Rosone, Foggia 1994) e L’infante di Spagna Carlo di Borbone prima della conquista del regno (1928). Te, mio Gargano, canto d’Italia aspro sperone proteso in Adria, te, nuda fortezza titana coronata di frassini e querce, che il primo sole dall’onde tremulo d’oro sorgendo nel nimbo croceo avvolto, saluta. Te, mio Gargano, in fiamme d’incendio canto, se dietro, vette più ardue il sole calando s’asconde nel tramonto di porpora e fiori amor del sole, Gargano fulgido, amor del cielo lieto nei secoli, amor della terra olezzante di silvestre serpillo e di timo. Ancor le grotte, gli antri di mistica penombra effusi, Calcante invocano ministro ai tuoi riti, paziente presso all’aria infiorata la nera Verso Sud 282 D. Grittani vittima attende, perché su morbida pelle ancora calda segga l’interprete de’ sogni e ne scerna il secreto cinto il capo di quercia e di alloro. Ma l’età nova fuga le pallide ombre de’ vati di luce fulgida innonda la sacra spelonca, e corusco l’Arcangelo appare Gargano, esulta di nuova gloria! Sei divenuto sede degli Angeli, la dolce dimora che accoglie d’ogni lido le genti ploranti Non so, Gargano, l’età novissima quale prepari nova a te gloria. I figli che edùchi alla patria le tue balze sporgenti sul mare contro al nemico voglion d’Italia irte d’acciaro che dritto fulmini Comunque, il lieto sorriso cerulo splenderà sempre, gargano nobile, di diva dolcezza negli occhi dei leggiadri ricciuti tuoi bimbi; e la soave pace di mistica gioia compresa, che nelle vergini pensose dal volto traspare circonfusa dai raggi che il sole molle diffonde, splenderà fulgida serena, avvolta nel baglior roseo d’un mito tramonto che langue come in nimbo di gloria immortale. [Poesia tratta da Canti della Daunia, CONSALVO DI TARANTO, Tipografia Conti, Matera 1924] 283 In Gargano Riccardo Bacchelli Da parecchio tempo mi ero impegnato a visitare il Gargano e a venire in San Marco in Lamis per rinnovare ricordi di Bologna con un mio compagno di Università, che è di San Marco, e che in Gargano e in Capitanata è uomo di conto e di facoltà, un «galantuomo», come si dice qui. E l’altro giorno mi presi la corriera automobile a Foggia, per venire a ritrovare questo mio compagno, addottorato in lettere a Bologna, Giustiniano Serrilli, che da quindici anni non rivedevo. Del paese in cui l’avrei ritrovato non avevo notizia, e intanto riguardavo, attraverso la pianura verdissima e un po’ strinata dai freddi di questa rigidissima annata, quella parte della Capitanata che si stende, piana fra le piane, da Foggia, capitale delle lane e delle granaglie, al Gargano, che mi cresceva, macchiato di neve in cima e d’oliveti al piede, innanzi agli occhi di miglio in miglio. Al piede del Gargano la pianura ondeggia e si avvalla, dando a rivedere scopertamente d’essere stata fondo di mare quando il Gargano era non so se un’isola o un promontorio di quella terra d’Adria, che i geologi ci fan credere affondata fra Italia e Balcania. Superate le prime pendici, cominciano gli avvallamenti, le creste e le spezzature dei dorsali, che fanno di queste terre un corso e ricorso di valli, un labirinto. Ed ecco aprirsi, dopo rigogliosi oliveti, sul bordo inaspettato di una deserta pendice di sassi e di mandorli che paiono stanchi d’aspettar tanto, quest’anno, la primavera, uno sprofondo aprico ed ameno, e il paese di San Marco in Lamis. Allo sbarco dalla corriera trovo l’amico, e saliamo nella sua casa patriarcale, e festeggiamo ben presto i nostri ricordi. Bella cosa era una volta far lo studente a Bologna. La fierezza delle tradizioni, e un certo amor dottorale, – Balanzone è la maschera bolognese – affezionavano all’Università i cittadini, più di quel che in oggi non consenta la vita odierna. L’osteria s’apriva allo studente, come il salotto patrizio accoglieva il professore. E l’eccellenza delle biblioteche attirava forse né più né meno che la premura delle affittacamere; le ragazze bolognesi non erano troppo più avare di favori, che non lo fossero 284 Verso Sud D. Grittani di dottrina le illustri lezioni. Così gli studenti accorrevano da molte parti, ma specialmente dal litorale adriatico, fin dal Friuli e fin dalla Calabria. Dalla Puglia poi erano moltissimi. Ho detto accorrevano, perché ora non so se l’Università sia più così fiorente: me lo auguro. Essa in allora eccelleva, oltre che nelle discipline legali, nelle scienze cliniche e sperimentali ed esatte, e nella filologia. L’amico Serrilli mi ricorda i suoi studi in materia di trattati di vita cortese nel Cinquecento, e di glottologia. Vario e dolce ingegno, buon filologo e buon letterato, uomo arguto, non risparmiava, e non risparmia, certe ridicolezze di alcuni accademici d’allora; e già ci facciamo le belle risate. Io gli ricordo l’olio, che si faceva venire da questa sua casa, dove adesso mi ospita. Egli aveva ben ragione di disdegnare quel cosiddetto Chianti e quel sedicente olio d’oliva, che diffamano la Toscana e la Liguria. E ci riunivamo nella sua camera di studente a mangiar le insalatine condite col sapido suo olio casalingo, di quello che sa d’oliva e che non piace a quelli che non s’intendono. La camera era in via Zamboni, via della Università e classica via degli studenti. «Risentirai di quell’olio a tavola stasera» mi dice il compagno facendomi vedere le schede per la bibliografia di un suo lavoro sui dialetti d’Italia. «Anzi, sappi che ho ricostruito ed ampliato per molte centinaia di ceppi oliveti e vigneti di mia proprietà.» Egli infatti, rientrato nel suo paese e restituitosi alla terra con passione, non tralascia la lettura né degli studi, per quanto abbia rinunciato alla carriera, – anzi forse per questo ad essi più affezionato, – ed esercita con passione ereditaria la coltivazione dei campi. Per sano affetto della sua terra, è richiesto e lascia desiderio di sé dove si occupa della cosa pubblica. Io lo ascolto e guardo la sua prospera e lieta e atticciata figura di umanista abbronzato dal sole; e penso che se maggior numero d’italiani sapesse serbarsi così, alacre negli studi e nelle opere, colto e curioso senza spaesarsi, un certo stampo d’uomo tutto nostrano e di civiltà italiana sarebbe più lontano di quel che non sia da diventare pio ricordo d’una nostra eccellenza e grandezza. Intanto è venuta sera, e le strade di San Marco sono affollate di abitanti che festeggiano la fine della domenica. È un bello spettacolo questa folla di contadini urbani per abitazione e per gentilezza. L’amico Don Giustiniano, primaria notabilità del paese e della regione, deve rispondere a decine e decine di «buona sera», rispettosi e cordiali. E troviamo anche un giovanotto che ha letto il mio Diavolo al Pontelungo, e che alla mia domanda se si sia divertito, risponde: «Abbastanza.» Non sorrida il maligno lettore. Abbastanza vuol dire: «A mia soddisfazione» ed è sinonimo di «assai», non già di «così così». Ed è un modo sobrio e robusto questo che mette nella propria soddisfazione un criterio di giusta, non modesta né smodata, esigenza e lode. R. Bacchelli In Gargano 285 E io dirò che la rusticale e civile cittadina di San Marco, mi piace «abbastanza». Sulla cresta della collina prossima v’è un passo, un piccolo giogo, dove San Marco da un lato e dall’altro il paese di Rignano appaiono come i due piatti di una bilancia. E quel giogo, che sarebbe sul fulcro, si chiama appunto La Bilancia. Rignano è paese aereo, posto sullo sperone che più si sporge e più vista di Tavoliere vanta alla parte di terra del Gargano. Vi andai la mattina seguente, e le vie esigue e scoscese per entro la stipata e salda struttura sorgente dal sasso, mi fecero sbucare sopra l’aperto, nella parte esterna del paese a picco. Sotto di me la Capitanata e il fondo marino, qua e là paludoso, che cinge il Gargano e dove poltrisce il torrente Candelaro, stavan sotto una nebbia lieve ed umida, che pareva la fecondità stessa stesa sui campi e su le verdi germinazioni. L’aria, che su quella rocca è sempre mossa, e che quest’anno pareva che non volesse più disinvernare, si intorpidiva dolcemente di quell’umido sentore di fecondità pigra e candida. A Rignano c’è anche un bell’organo di chiesa, un quadro interessante d’anime purganti riscattate per intercessione di fedeli del Carmine oranti alla Madonna, e un bel portale del decaduto palazzotto dei marchesi di Rignano. Non intendo di scoprire una scuola garganica, per carità, ma mi sono accorto che v’è in questa regione, come spesso in regioni appartate, un’aria, un fare degli uomini e delle opere loro, che è stile: e lo stile è proprio di ciò che basta a sé stesso. «Abbastanza», come diceva il giovanotto di San Marco in Lamis. Monte Sant’Angelo Passata la verde piana e l’acqua gialla del pantano mezzo bonificato di Sant’Egidio, la melanconia di Val Carbonara, triste nei ricordi della squallida fillossera che distrusse i suoi celebrati vigneti, conduce dietro la costa precipite e sotto i denti della cresta del Monte degli Angeli, aspro contro cielo. Si sale arditamente a ridosso del monte, e all’ultimo svolto si è sotto, d’improvviso, al castello normanno ingentilito da bastioni aragonesi. Il Monte degli Angeli, ultimo dosso della prima catena garganica, è come una man dritta che sia posata in piano col pollice verso settentrione, poiché all’ingrosso il massiccio garganico va a ponente a levante, e le altre dita aperte e curve verso il mare. Infatti a settentrione c’è la ripida valle; davanti ramificano gravine franose e contrafforti affilati, mentre da mezzodì, come fa il dorso esterno della mano, il Monte s’arrotonda più dolcemente verso la pianura di Manfredonia. Nel punto in cui s’articola il dito indice, il paese, anzi proprio la grotta sulla quale sorge la Basilica, incide il dosso del Monte degli Angeli. La cittadina di Mon- 286 Verso Sud D. Grittani te Sant’Angelo s’apre sul lato più aprico ed agiato; dal castello e dalla Basilica si posson numerare, come da un’aerea spia del Gargano, quante mai cime vedono il santuario. Venti passi cambiano la veduta del mondo, che da una parte è tutto monti, dall’altra tutto pianura e mare. Solo per la scelta del luogo, arte di generazioni come la creazione della lingua, Monte Sant’Angelo è un capolavoro in un paese, l’Italia, che di tali capolavori sovrabbonda. Ma non è arte soltanto, poiché qui concorse e precedette all’arte e con l’arte uno dei più antichi e venerati miracoli della cristianità: cioè l’apparizione dell’Arcangelo Michele ai pastori e poi al vescovo di Siponto, Lorenzo Maiorano, nella grotta, che apparve in visione mutata in chiesa angelica. Dunque la scelta seguì la fede illuminata, e l’arte toccò i fondi e le punte di quel che al tempo della sociologia si chiamava la «psiche popolare», e che noi ci contenteremo di chiamare, più umanamente, la religione. Così l’istinto del muratore garganico e la sapienza degli architetti di Re Carlo Primo d’Angiò, fra i quali nel campanile son ricordati singolarmente i frati Giordano e Maraldo, proprio di Monte Sant’Angelo, s’unirono in quel che si potrebbe dir grado eroico, seguendo le parole tramandate, dal 491, che l’Arcangelo disse al vescovo, annunciandogli d’essersi scelta e fabbricata e consacrata da sé a sé stesso la sua sovrumana basilica i quella grotta. Parole che si leggono sulla porta sinistra della facciata della scala, accanto a quelle di destra: «Terribilis est locus iste. Hic domus Dei est et porta Coeli». La visione fu nell’anno di Cristo 491. La scala, coperta d’alti archi ogivali, severi e puri, è nobile e profonda. D’arco in arco e di gradino in gradino, operai ed architetti hanno sentita, ornata, venerata la traccia del sentiero formato di greppo in greppo fino alla grotta dai piedi dei pastori e dei primi pellegrini. Quel che si dice un sentiero da capre, e l’opera di pietra, che è quanto mai ardita, dotta e superba, gli tien dietro con umiltà somma, come a cosa santa, e ne ricava il suo più singolare stile. Volendo sforzare il concetto, verrebbe fatto di dire che questi mistici costruttori abbiano inteso di umiliare, in tali fastigi, le origini babeliche dell’architettura, ma il fatto è che solo una natura semplicemente adorata come visibile intenzione divina poteva ispirare un partito ingegnoso così semplice e naturale. E le volte e le ogive angioine sono fedeli e piene di preghiera, come le devozioni ch’esse accolgono dei pellegrini oranti. Credo che pochi altri luoghi possano far intendere così sul vivo quel che furono dei fatti come quello delle Crociate. La scala e la Basilica, che è una delle quattro palatine di regia giurisdizione e come tale si fregia della croce sabauda, erede di tante dinastie, sono gloria e impronta di Re Carlo Primo, forte, austero ed anche arcigno e spietato regnante, alta mente politica e guerriera; anche fratello di San Luigi di Francia, crociato con lui e per la vita. R. Bacchelli In Gargano 287 Monte Sant’Angelo poi era una devozione dei crociati, che venivano in Puglia per gli imbarchi. In fondo alla scala si ritrova l’aria nel cortiletto, sul quale s’apre la Basilica dalla bella porta bizantina. I pellegrini toccano e baciano, arrivati qui, come per implorar l’entrata, gli eleganti anelli della porta, lustrati da tante mani. Sull’arco risponde alle inscrizioni severe dell’atrio una promessa di indulgenza: «Dove s’apriranno i sassi, là saran rimessi i peccati degli uomini». Quando ho visitato io la Basilica, non era l’epoca dei pellegrinaggi, che han luogo specialmente nel mese di Maria; e fu meglio, perché assistere da spettatore alle scene di fervore e di furore mistico che riempiono la Basilica, mi avrebbe messo probabilmente in uno stato di curiosità, forse di diffidenza; e discorrerne freddamente ora mi sembrerebbe dilettantesco. Se le mie impressioni là dentro hanno un merito, è d’essere serene. La grotta s’apre a destra della porta; a sinistra c’è il coro e una finestra che dà luce quanta può darne, splendidamente, l’aperto orizzonte sulla profonda valle. In coro stavan a dir gli uffizi i canonici. Dietro l’altare, dove splende il piccolo e bianco San Michele del Sansovino, a cui i pellegrini guardano in ginocchio, implorano, s’atterrano, si percuotono, rigano anche di sangue il pavimento, la cupa parete dello speco e la potente volta che s’incurva fino a mezza la chiesa, stillavano acqua miracolosa, della quale si beve in un secchiello d’argento, attinta da un pozzetto in fondo alla grotta. Credo che senza questo stillicidio perpetuo nella semiluce dei ceri e delle lampade, né la grotta né la chiesa né la stupenda sedia episcopale né le strane e vigorose scolture remote che paion nate a mezzo dal sasso o in via di tornar sasso, mi avrebber fatto tutta quell’impressione che mi fecero. Coteste gelide goccie spicciate dal buio dell’antro, che fan trasalire, cogliendoci in fronte o sulle mani, son l’ultimo tocco di fedeltà al sasso consacrato, e rigano il pavimento così come cadono sulle mense sacre, le quali fanno splendere l’oro ed il candore della liturgia e la sontuosità dell’apparato e dell’architettura, sul fondo scabro e squallido. C’è la fedeltà, e c’è il rispetto intatto e religioso, c’è infine in quel così nudo gocciar d’acqua una sprezzatura ultima e potente. In esso termina, e non può andar più oltre, quello sposarsi in fede dell’arte colla natura, che via via giù per la scala è venuto crescendo. E là finisce ogni anche più vaga estetica dilettosa in devozione abbandonata ed astratta, in violenza ascetica e mistica. Fra cose elette e cose orride, come le piaghe di cera degli ex-voto, nell’opera si legge un pensiero che nulla rifiuta e d’ogni cosa può fare a meno. Scendendo, non avevo posto mente alle impronte di mani che da secoli i pellegrini disegnano, graffiscono, scavano nelle pareti, scrivendo poi dentro il contorno 288 Verso Sud D. Grittani della mano aperta il proprio nome. Sono centinaia e centinaia, e, dove lo spazio è venuto meno, sono mani su mani, intricate e sovrapposte. Così l’innumerevole popolo, venuto a piangere ed ardere nella grotta dove vennero a scioglier voti, al pari di lui, re, imperatori, regine, papi e santi, lascia il suo segno: le mani che servono a pregare, a faticare e a peccare. Risalendo verso l’aperto, riconobbi in quel bisogno di lasciar il segno della mano sul punto di tornare, sciolto il voto e l’animo, verso la vita solita, un pensiero da Giudizio Finale, una di quelle espressioni senza parole, una di quelle follie egualitarie profonde ed oscure, che covano nell’anima delle plebi. E mi parve un bisogno di rifarsi, imponendo quel segno corporale, dell’annullamento umano che regna nella grotta e nel monumento, tutto fondato sulla verità della morte e sulla certezza del miracolo. Sulla piazzetta davanti all’atrio splendeva al sole il campanile ottagonale, bellissimo, fatto erigere da Re Carlo dai suoi due frati architetti. E ordinò che fosse ripreso uguale, forma e ogni dimensione, dai torrioni di Castel del Monte. Quale sarà stato il pensiero, poiché credo che un pensiero avesse certamente, nel far copiare una parte della più insigne opera sveva, del più grandioso castello di Federico Secondo? Come mai volle accostare la gloria di Federico con la gloria di Carlo in Monte Sant’Angelo; il profano castello dell’eresiarca imperiale col cattolico edificio del vicario della Chiesa? La Puglia era piena di distruzioni d’opere sveve, e di uccisioni di ghibellini; Re Carlo non era contento se, anche dove rifaceva, prima non aveva distrutto ciò ch’era svevo. Così le mura di Manfredonia anzi, fin del nome egli era mistico e spietato odiatore; e quando saliva il Monte a pregare e a vedere i lavori, guardando la sottoposta città e il porto in ricostruzione, ripensava che fin dal nome aveva voluto toglierle via Manfredi. Infatti tentò di farla chiamare Nuova Siponto, e non gli riuscì, per una di quelle riottose e segrete pietà umane, che vivono nell’anima della gente. Ma l’Angioino senza pietà né del nome di Manfredi né del sangue di Corradino, intese, se il mio immaginare qui non diventi sogno, di riprendere quel torrione svevo come insegna ed affermazione di regno. Non solo rinunciando ma dannando l’impero ghibellino quale l’aveva pensato Federico, con quel torrione egli intese di proclamarsi erede degli Svevi in quanto erano stati re legittimi del retaggio di Roberto Guiscardo. Forse pensava Monte Sant’Angelo come il luogo della consacrazione e dell’unzione regale, come la Reims della sua nuova dinastia nel Regno antico, mentre di Napoli voleva farne la Parigi. Il campanile era finito da poco, e Carlo pensava di muovere alla conquista dell’Impero d’Oriente, quando accadde quel che al vincitore di Benevento, all’uccisore degli Svevi, venne a rammentare ch’era sempre facilissimo conquistare il Regno, R. Bacchelli In Gargano 289 difficilissimo sempre tenerlo. A Benevento gliel’aveva dato la diserzione dei pugliesi, ed ora glielo minacciava, antica e grave vicenda, la sedizione dei siciliani a Palermo coi Vespri. Il campanile, monumento della sperata continuità regale nel luogo dove l’Arcangelo aveva significato la grazia di Dio, era finito da poco, e il re «dal maschio naso», che anche Dante, con tutte le sue collere ghibelline e cogli amori imperiali, pone in Purgatorio mentre su Federico calò il sasso eterno dell’arca degli eretici; il Re Carlo, invecchiato e prossimo a morir di stanchezza in Foggia, salendo ancora a Monte Sant’Angelo poteva vedere nel porto di Manfredonia parti della flotta apprestata invano per l’Oriente, o resti, dopo che gliel’ebbe bruciata Ruggero di Lauria. Poteva anche ripensare le conseguenze del suo guelfo e francese aver voluto influire e dominare l’elezione papale, che gli aveva fatta avversa la Chiesa, non meno di quel che l’avesse fatta ostile a Federico la guerra aperta ghibellina. A pochi passi di distanza c’era, come c’è, la delicata fronte della chiesa di Santa Maria Maggiore, innalzata dalla pia Imperatrice, dalla smonacata per forza, dalla caritatevole, che difese i siciliani della sua dote normanna contro la feroce tirannia del marito Arrigo. Si ricordava Re Carlo che «la gran Costanza» aveva affidato il piccolo Federico, morendo, alla tutela del Papa, quasi per conciliare i due poteri, forse presaga, invano, che avrebbero sempre lottato nel Regno? Risentiva i difetti grandi della sua dominazione straniera e dei suoi rapaci francesi, della conquista sempre fresca di un regno politicamente vecchio già tanto. E la malaria gli distruggeva le guarnigioni, mentre gli aragonesi s’impadronivano del mare. Egli pregava: «Signore, poiché mi hai fatto salire tant’altro rapidamente, fa che almeno la discesa sia lenta». Quest’immaginazione mi occupò in modo, che non seppi fare abbastanza attenzione al curiosissimo edificio detto, per errore insulso, Tomba di Rotari, e che il popolo, perdendo i termini come un poeta invasato, chiama addirittura Tomba di San Pietro. Ma le due strade lunghe e serpeggianti, candide sul grigio sasso, verso le due conche rigogliose di Manfredonia e di Mattinata, verdi di frumento, cupe di stupendi, doviziosi oliveti, mi condussero verso una nuova meraviglia. Poco si legge sulle pendici del monte di lontano o dalla cima, ma coll’approssimarsi vi si scorge quel che han fatto in quello sterminato frastaglio di valli e di lavine queste genti e la lor fame di terra. È tutto un correre e ricorrere di muretti a secco; ogni palmo di terra fertile è sostenuto, ogni greppo cercato e frugato. La terra lavorata «a coppola», recata dalle donne coi cestelli preziosamente, nutre magri frumenti e mandorli esercitati dal vento, e qua e là modesti olivi. Ma come l’amano queste famiglie, che, in più del lavoro, fanno ogni giorno miglia e miglia di monte per recarvisi, o, nei tempi di stagione buona, vivono in cavernette della roccia! C’è qualcosa dell’amor difficile e da lontano nella loro fame di terra. 290 Verso Sud D. Grittani I mandorli nell’annata rigida e tardiva non s’arrischiavano a fiorire, e stavano timidi, nudi, al sole limpido sui monti, sul mare, sui boschi garganici e sul Tavoliere; sulla fatica e sulla speranza degli uomini, che hanno imposto su queste ripe il loro lavoro, come i pellegrini han segnato di mani gremite le pareti della santa scala. Sentii dire che il disboscamento, relativamente recente, non fu utile pensiero, ed è cosa che si sa; le colture granarie e olearie lassù non sono le più opportune, ho saputo; ma non avevo animo a pensare all’economia, come non l’ebbi dentro la grotta a pensare ai concetti della mia filosofia razionale. Strade e paesi La strada che risale fra mandorli doviziosissimi, e che lungo le coste di Monte Jacotenente, fra i boschi di querce rade e poi giù per le pendici del Chanconcello fra vallate di lecci dall’ombria notturna e dalla lucente foglia, conduce a Vieste, è un beneficio della guerra. Fu compiuta per certe necessità dalla Regia Marina, la quale sento dire che la facesse anche progettare da ingegneri incaricati. Se così è veramente, non c’è che da rallegrarsi colle attitudini stradali della Regia Marina. Specialmente nella prima parte, a mezza costa del Jacotenente e, prima, nell’uscir fuori dalle conche di Matinata e di Mattinatella, la strada si svolge e sale con una maestosa ampiezza, con agevole e forte struttura, che ad ogni girar di spalla l’offrono già percorsa e la promettono innanzi all’occhio ammirato, con piacere di architettura vera ed espressa. Ed è una buona strada, sulla quale possono sbizzarrirsi gli automobilisti; se i muli dei carbonai e i cavalli riottosi e non avvezzi dei carrettieri, non gli si parin davanti in qualche svolto. Nel qual caso il severo e chiuso volto del montanaro garganico esprimerà con disdegno d’ogni parola tutte le maledizioni e i malaugurii, onde procedere ornata nel suo cammino la polverosa e spetezzante civiltà meccanica. Erma, solenne, accompagnata dalla vista del mare, va la strada fra selve, selvette e prati. Tutto era, quando vi passavo, ancor strinato dall’inverno, e le quercie brusivano colle lor foglie secche al vento. Solo le prime voci degli uccelli annunciavano la primavera. Sulle cime e negli anfratti la neve persisteva, scintillando il sole senza forza su di essa, come una rigida minaccia. Ma su Vieste che si protende, che s’adagia sopra il declino d’uno scoglio nel mare, bianca, moresca e marina, simile nell’indolenza a una bella creatura spossata voluttuosamente dal bagno, che si sia sdraiata sul letto dello scoglio per prendere il sole facendosi baciar i piedi dal mare, su Vieste dal nome leggiero e gentile come l’esistenza d’un primo bacio socchiuso, il sole è già vivo, la luce, se non il calore, è R. Bacchelli In Gargano 291 già estiva. Il mare è in tutto il grande incitatore di precoci primizie. Due grandi golfi e due spiaggie fuggenti, lunate, si aprono a levante e a ponente di Vieste. A mare le sta la rada breve, dove si tirano in secco le paranze, e un breve scoglio vicino le alza davanti la torricella del fanale. Dietro sonnecchia il castello, col semaforo e le antenne da segnali al posto dei cannoni sugli spalti. Il piroscafo bisettimanale delle Tremiti radeva l’isolotto del fanale, e animò, come sanno animar la stesa del mare i battelli, la gentilezza deserta delle onde primaverili. Dalla parte delle scogliere, sui golfi, volavano, o si posavano con quei loro atti impacciati e possenti quando s’acquattano sull’acqua o se ne rilevano, stormi di gabbiani. Alcune massaie versarono in mare cestelli d’immondizie, e i rauchi volatori vi s’avventarono, facendoci godere la più bella giostra e schermaglia e ronda di voli, che si potesse desiderare. Fremevano al vento fresco le lunghe braccia, le gracili impalcature e i cordami delle gran reti a bilancia, che si sporgono sull’Adriatico pescoso dalle rupi nelle vicinanze d’ogni paese della riviera garganica. E dappertutto vi sono gabbiani, come, dappertutto, la storia racconta terremoti e rovine di saraceni, di pirati dalmati, di turchi bestiali in questi paesetti, ai quali oggi il mare dà tanta pace quanta già diede guerra nei tempi andati. Ma la maggior dolcezza della costiera è da Pèschici a Rodi, che si guardano di lontano, candide sulle loro due rupi alte ai capi della spiaggia piena d’amenità. Pèschici era il paese poverissimo, senz’acqua, affastellato sullo scoglio, dove pare ancor timoroso. La gente viveva in parte in caverne scavate dentro la roccia tenera, e, da quel che si vedeva dentro gli usci delle casupole anguste e luride, quelli che stavano in caverne non stavan peggio. Veramente a Pèschici la miseria stringeva il cuore, e vi si conosceva la mancanza di molte cose di prima necessità. Ebbene, Pèschici ha nome d’essere il paese che dà le più belle ragazze del Gargano. Io non potrei giudicarne, perché la bella giornata le aveva condotte ai campi sui lavori, e in genere le ragazze sono tenute molto strette e in ritegno. Ma fui informato da alcuni giovanotti buoni conoscitori, e il fatto mi piacque molto, prima per senso di giustizia, poiché era equo compenso della povera Pèschici, ricca solo d’una vista superba marina; poi per il bellissimo sberleffo che questo fenomeno faceva all’igiene, della quale io sono nemico, dato che forse farà scemar le epidemie (se è vero), ma di certo sparge e cresce all’infinito per il mondo il fastidio dei paurosi, dei fissati, dei saccenti e intromettenti, risanatori, educatori, rigeneratori, eugenisti, e simili salutisti ficcanasi. Che nel più povero e sporco paese nascessero le più belle ragazze, quanto mi piacque! E devon esser belle assai, giudicando da quel che ho potuto scorgere passando. Ornate di collane e orecchini maiuscoli di vecchia filigrana, velate col fazzoletto o collo scialle, laboriose e riposate, salde donne sono le garganiche; contente dei 292 Verso Sud D. Grittani loro uomini, contenti questi di loro: gran principio di ordine e di civiltà. L’impressione era confermata poi dalla quantità e dalla salute dei bambini, che formicolavano per le strade. Passato Pèschici, attraversai l’ultimo lembo della grande pineta che veste il monte e la costa in quel punto; e poi cominciano gli aranceti di Rodi. Ma, voltando a monte, presi la strada che conduce a Vico, entratura alla regione dei grandi boschi interni. E da Vico andai a Ischitella, aprica e ben murata, dove un Pinto, Principe d’Ischitella, elevò ai primi del Settecento un palazzo di castigata grazia mirabile; e approfittai d’un lento tramonto aureo ed argentino per scendere coll’automobile a Carpino, bianca sul gran piano verde, e a Cagnano, mentre il Monte d’Elio incupiva contro il cielo crepuscolare, e la vasta palude pigra del lago di Varano trascolorava. Questo lago, e l’altro di Lesina, diffondevano la malaria in questa parte del Gargano, fertile e pur bellissima. Nei prati e nei seminati, più cupi, nelle roccie e nei monti, nel color del mare e degli uliveti pallidi, c’era una gravità, una melanconia, che ben si sposava e si rivelava coll’ora cadente, come per contro a Mattinata s’era rivelata e sposata fin nel nome del paese l’ora sorgente del giorno: era il colore della costa settentrionale e occidentale, di contro al colore orientale e di mezzodì dell’altra costa. Dalla regione dei due laghi, dove i tentativi di bonifica e di prosciugamento sono una storia lunga ed ardua, tornavamo verso Rodi. Ora nel Varano, che fu base d’idrovolanti durante la guerra e che potrebbe esser porto superbo, si tenevano aperte due foci per uso delle barche e per renderlo salino e risanarlo e impedir la malaria. Ma quando era palude d’acqua dolce, era pescoso, specialmente di capitoni celebratissimi. Uno della comitiva, un ghiottone, fece la riflessione, dolente molto, che se ne vanno i capitoli dal lago. Sua unica scusa poteva essere che la malaria la conosceva per averla avuta, e maligna. Ma che non son capaci di sfidare i golosi? Colloquio con uno che un giorno sarà forse sugli altari San Marco in Lamis, se non nacque, si ingrandì come ospizio di pellegrini longobardi, i quali si recavano per la via di San Severo (l’altra è quella di Manfredonia) a venerare la grotta e l’impronta dell’Arcangelo Michele sul famoso Monte Sant’Angelo. E un storico tedesco, il Gotheim, fa l’ipotesi che questa devozione longobardica sia la forma cattolica assunta presso i convertiti di Teodolinda dal culto pagano del guerriero Odino. E questo potrebbe anche dimostrare una delle ragioni per le quali i longobardi si sono fusi così bene coi latini; se è vero, come è R. Bacchelli In Gargano 293 vero, che una delle più spiccate e delle più belle attitudini italiane nel gran trapasso fu quella che salvò nel cattolicesimo popolare tanta e così poetica parte del paganesimo, e specialmente del più umano, che fu quello rustico. Lungo questa via, che per un incerto seguito di valli carsiche e lungo le pendici di terraferma del Gargano conduce fin dietro la parte interna e dirupata del Monte degli Angeli, dove la aggredisce con ardite svolte; quel che a San Giovanni Rotondo si vuol che fosse, ribattezzato in Chiesa di San Giovanni, il tempio rotondo di Giano, dio della pace, poco saprebbe dire, ma c’è la tradizione, e una quantità di ètimi, veri o favolosi, la testimoniano. Quel dio italico, dio delle porte e d’ogni entrata e d’ogni cosa che s’inizia, e del cominciar del giorno e del capodanno, protettore d’ogni opera che gli fosse consacrata sul principiarla, e dio di pace, fu dunque molto onorato in queste valli; e si spiega. Mi immagino che i contadini lo invocassero per le semine, e che gli consacrassero, sull’aprire, il solco degli aratri, gli innesti, le piantagioni, le opere delle loro stagioni varie e immutabili. L’agricoltura è arte di speranze fiduciose e di molti inizi, perciò molto augurale nelle sue devozioni, e Giano non si onorava solo qui; ma qui si trova, lungo queste valli, un Jancuglia, ossia Jani Culla, un Rignano, ossia Ara Jani, uno Stignano, ossia Ostium Jani, e Pirgiano, ossia Castello di Giano. San Giovanni, dove la tradizione pone il tempio, è nel centro della regione in costiera, dalla parte di terra, dove le selve furon dapprima vinte, dove si stabilì primamente l’agricoltura, dove si rifugiavano gli esuli cacciati dalle città distrutte del piano, e dove le memorie riposarono e si trasmisero, col sangue e coi costumi, più intatte, difese e separate dalle insidie e dalle tentazioni del mare, dai saraceni e dai turchi, e dai pirati. Lungo questa via, a Stignano, a San Marco e a San Giovanni, vi sono oggi dei conventi francescani, ai quali si svolge e si sofferma la devozione dei pellegrini, mentre gli abitanti dei paesi li visitano con quelle feste che tengon vive, nelle ricorrenze sacre, le cerimonie di propiziazione del paganesimo ingenuo campagnolo. Così nel santuario di Monte Sant’Angelo si mostra, poco distante dall’altare che copre l’orma dell’Arcangelo, il segno a T che lasciò nella roccia San Francesco, quando vi arrivò in pellegrinaggio, e non voleva entrare per umiltà, e s’appoggiò colla faccia alla roccia vicino all’entratura, e la segnò così colle orbite e col naso, mentre pregava chiuso contro il sasso. Noi non crediamo ai miracoli, troppo si sa. Resta a comprendere il miracolo per il quale le turbe, ignoranti di Odino e di Giano, abbiano con una leggenda chiarita così sicuramente tanta storia, unendo in due segni sul sasso il culto angelico della Chiesa primitiva con quello che gli storici chiamano «il moto francescano». Parliamo solo di storia, come a me conviene, e riconosciamo che le favole e le allucinazioni dei caprai d’Abruzzo e dei contadini del Tavoliere sanno trovar termini molto ma molto più espressivi che non gli storici. 294 Verso Sud D. Grittani Alcuni di questi conventi furono in origine benedettini e cistercensi, e oggi sono francescani, come quello di San Matteo, o abbandonati, come quello di Stignano cadente. Altri sono dei cappuccini; e questi nella loro rozza semplicità sbiancata, ricordano vivamente; ma Stignano cadente dà l’immagine di quel che fu il passaggio di guerre e di pestilenze e di carestie. In un convento di San Benedetto non manca mai un cortile con un bel pozzo nel mezzo. E c’è, elegantissimo fra l’erbaccia, a Stignano; c’è nel cortile austero ed alpestre di San Matteo, il quale domina dall’alto, severo e forte e bastionato, fra le roccie, la valle, che accoglie in basso, il viandante, soavemente fra colli leni ed olivi, col sagrato sereno e la piana fronte della chiesa di Stignano. Quando vi fui, aveva smesso di piovere da pochi giorni, e c’era ancor la muffa fresca nel refettorio, poiché l’acqua trapela dai tetti e franano pezzi ed angoli di muro nei corridoi quadrati, dove le esigue finestre aprono viste amenissime sull’apertura della valle nel piano. Muffa, tristezza, rovina e minaccia di rovine: fuori il sole di marzo brilla, come se vi fosse piovuto di fresco, sugli olivi e sul frumento verde. In uno dei due chiostri un ignoto, un pittore forse di quelli che hanno riempito di ex-voto un corridoio di San Matteo, ha affrescate le lunette colle storie della vita di San Francesco. Sono pitture del genere popolaresco, nelle quali un’ingenua audacia o una scorrezione timida possono conferire molta forza e carattere figurativo. In Gargano se ne vedono molte, e, attorno ai suoi numerosi ed antichi santuari miracolosi, colla fede si è stabilita una certa unità e continuità di tradizione pittorica particolare. Quanti ne stanno infracidando sulle pareti bianche e umide! Cerignola ha molta e speciale devozione per San Matteo, ed essendo città di grandi armenti e di commercio di ciuchi e di cavalli, vi ha mandato molte storie di pericoli e di miracolati con bestie da tiro e da sella. Ma pare che il tempo migliore per quest’arte sia stato nel secolo scorso, quando la diminuita bravura dei pittori e l’esempio della fotografia indussero, così mi è parso, gli artisti a sforzare certe qualità di evidenza, che nell’arte istintiva ed ignara toccano, collo sforzo appunto, valori di stile popolaresco. Scende da queste raccolte di vignette un senso fra penoso e consolato della pena e del pericolo quotidiano. Oggi si tende a mandar la fotografia in abito delle feste, con iscrizioni narrative. Non si salva più niente, salvo l’intenzione dei fedeli. I Padri cortesissimi ed accoglienti di San Matteo mi indicarono dalla loro stupenda loggia una sorgiva, dove i pagani venivano a bagnar d’acque sacre a Giano le bestie ammalate. Il popolo, poiché nel convento si venera un dente di San Matteo, ha favoleggiato che l’Evangelista abbia fatto il viaggio che stavo facendo io, e mostra la pietra dove, inginocchiandosi egli per bere, sarebbe rimasta l’impronta. Io andavo a visitare un cappuccino del convento di San Giovanni Rotondo, Padre Pio, del quale i giornali hanno discorso già più di una volta, e che porta le R. Bacchelli In Gargano 295 stimmate come San Francesco. La sua fama di santo va lontana e chiama molta gente, quantunque, mi fu assicurato da persone degne di fede, egli, obbediente ai superiori, cerchi di non aumentarla. Avviandomi al convento, che sorge solitario coi suoi cipressi e il bianco recinto in una stesa di magre erbe e di sassi, io mi tenevo in una disposizione equanime, non prevenuta dalla incredulità e neanche da quella voglia di meraviglie, che è quanto ci resta della fede antica nei miracoli. Insomma, ero disposto a rispettar un fatto ed a scrutare un uomo senza vana curiosità, ma fermamente. So bene quanto si possano spiegare scientificamente simili fatti, e so benissimo quanto non si spieghino scientificamente lo spirito umano, la storia e quel che si chiama vocazione. Dopo visto e parlato con questo cappuccino, non so se ho discorso con un santo, e di ciò se mai dovrà liberare a tempo suo la Chiesa, ma so di aver trovato un uomo il quale, per quanto ha mostrato a me in un’ora di colloquio agevole e sereno, porta l’insegna di ciò che deve percuotere più di ogni altro mistero la sua coscienza di fedele, o per lo meno costituire la più possente ed insidiosa tentazione d’ogni peccato dello spirito, con una chiara fierezza negli occhi, e con dignità modesta di frate e di sacerdote. Lo trovammo che stava facendosi rifare la tonsura da un fraticello, e la macchina da radere, visibilmente disaffilata, gli dava notevoli strappi ai capelli. Per qualche minuto egli, che ci voltava le spalle, non si addiede della nostra presenza; e sottostava alla fastidiosa operazione, a spalle tonde, rispondendo con affettuosa condiscendenza alle facezie del frate barbiere, che lo rimproverava di curar poco il taglio dei capelli. Quando s’accorse di noi, non mutò atteggiamento né umore. Padre Pio porta i mezzi guanti per celare le stimmate, e svia la conversazione se qualcuno gliene fa parola. Discorremmo del più e del meno, scherzando anche, e non capii se nel parlare d’argomenti seri egli si esprimesse con giustizia e criterio, come faceva, per naturale buon discernimento e per esercizio di studio. Diceva cose fini con parole illetterate, di solida semplicità insolita. Così, discorrendo di un suo detrattore invelenito, si espresse con risoluzione e fermezza, con una severa carità, che mi dissero molto sulla saldezza convinta dell’animo suo. Questa nasceva da un non so che di più spontaneo e nativo della umiltà ascetica e degli esercizi spirituali, che avevano contribuito a fortificarla. Parlando d’una ritrattazione del detrattore (pare, assai violento e velenoso), e dicendosi che costui pareva dire e fare sul serio nel pentirsi, il frate disse: «Questo lo spero per lui; per me non ne ho bisogno». Delle stimmate e dei miracoli non si discorse, quasi ci fossero usciti di mente. E questo, per quel che ne posso dir io con criterio naturale, mi fece al ripensarci più disposto alla meraviglia ed al rispetto insieme. 296 Verso Sud D. Grittani Tale è stato il mio incontro con uno che un giorno sarà forse sugli altari, e che vive nella valle che fu di Giano, ed è oggi francescana, in Gargano. Le isole delle acque verdi Il piroscafo che fa servizio, mare permettendo, due volte la settimana, per le Tremiti, dà fondo davanti ad ogni rada dei paesi costieri da Manfredonia a Rodi, sollecitando colla sirena i barcaiuoli. Li sollecita specialmente il sabato mattina, perché in quel giorno il piroscafo Epiro rientra a Bari, sua sede, dove l’equipaggio passa la sera di sabato e la domenica in famiglia. Non gli si può far carico d’aver fretta; non si può far torto ai barcaiuoli di stare all’orario; e allora, dopo mattutine zufolate, che sveglian tutti gli echi delle pinete sopra San Menaio, e delle rupi di Pèschici, e delle rade ampie di Vieste, avvengono sotto bordo bellissime contestazioni in lingua pugliese, che mi pare molto adatta a distinguere, sottilizzare, disputare e pungere, tanto nei baresi dell’Epiro quanto nei rivieraschi delle barche. Sola differenza l’accento, che è netto e sobrio quello dei garganici, quanto quello dei baresi è vocalizzante e spampanato. Intanto passeggieri e carico s’imbarcano e sbarcano e la partenza rasserena i contendenti. Ma questo succede al ritorno. L’arrivo alle Tremiti avviene per l’ora del tramonto. È noto che fin dai tempi dei Borboni esse furono adibite a luogo di relegazione e confino. Sul piroscafo Epiro s’incontran sempre dei coatti in traduzione, ai quali, come son tolte durante la navigazione le manette, è resa un po’ di quella confidenza che il popolo non nega a coloro che, purgando essi la pena del malfatto, non è nostro compito giudicare. Cordialità e confidenza lontanissime da ogni umanitarismo sentimentale di qualunque sorte; che provengono, più che da ispirazione, dalle «opere della misericordia»; e che il popolo nostro, profondo nella rettitudine del suo buon senso, ricava da un antico e sanissimo concetto della colpa purgata. Quando, come capita, il coatto, ex-carcerato o magari ex-galeotto, sia un gioviale compare, e il mare sia calmo, allora fra massaie, mercanti di pesce e contadini che popolano generalmente la Terza dell’epiro, e coatti benevolmente sorvegliati, senza confidenze per altro!, dai carabinieri, allora il gioviale coatto è capace di farsi il divertimento della traversata. Quando poi riprende le manette all’arrivo, cambia faccia e non è più lo stesso uomo, si conosce, né per sé né per gli altri. Io non ho mai ricevute le manette (è una cosa che può benissimo capitare), ma tutti mi dicono, quelli che le han provate, che per capire bisogna provare. Mi ricordo che all’imbarco un ammanettato scivolò sui gradini del modo di R. Bacchelli In Gargano 297 Rodi, e battè duramente, senza potersi aiutare colle mani, l’osso sacro sul calcestruzzo. Era un giovinastro pieno di sangue. Se fosse stato libero, chi sa qual impeto d’imprecazioni avrebbe avuto il suo sfogo. Invece si rialzò più presto che poté, guardò il gradino dove aveva battuto, non lievemente, e gli vidi la faccia di colui che deve sempre tacere, di quello che il torto è sempre suo: faccia di protervia invilita. Dopo un paio d’ore scarse di traversata, si palesa attorno alle Tremiti, già ben chiare e rilevate sull’orizzonte, il fatto per cui su tutta la costa si dice appunto, per dire andar coatto: esser mandato alle acque verdi. San Nicola, San Dòmino e Capperara, cogli scogli del Cretaccio e della Vecchia, il gruppo principale di quell’unico arcipelago della costa italiana in Adriatico, si offrono allo sguardo unite e raccolte attorno al seno d’acqua che fa golfo e porto naturale fra San Dòmino, San Nicola e il Cretaccio. Di lontano paiono anzi una sola schiena collinosa. A tutte le ore del giorno, ma sopra tutto quando il sole tramonta, e all’occhio di chi vi naviga da levante, le acque intorno e davanti le Tremiti appaiono verdi, non del verde che si vede sul mare alla superficie specialmente all’alba, ma d’un singolare verde, che par venuto dal fondo. Tutto lo spessore del mare par che sia verde; i colori del tramonto, vittoriosi e cangianti in cielo e sui monti del Gargano a poppavia e sulla costa Italia e sul lontano Appennino, quando è chiaro, e sul mare ovunque sia negli altri punti, lì di prua sulle acque delle isole perdono la partita, spariscono in quel colore di smeraldo, che di tutti gli splendori del tramonto, lungi da smorzarsi, prende foga, lucentezza, profondità, quasi che se ne nutra. Su quell’acque posano, radono, volteggiano stormi numerosissimi di gabbiani, che, nel venir meno del sole e nello scomporsi crepuscolare della luce in color, paiono neri. Sono i compagni di Diomede, poiché quando l’eroe, che sarebbe stato il primo dei greci se lo scettro non fosse stato di Agamennone e la gloria di Achille, venne a compiere il suo fato in Apulia, i compagni lo seppellirono in queste isole, e furon mutati dagli dèi in gabbiani, che le amano e che non le abbandonarono più. È una di quelle leggende che sapevan trovare i greci, ma, se ti capiti l’occasione, lettore mio, non perderla di visitare le isole Tremiti; e mi ringrazierai. È buona regola, nel visitare i paesi, far in modo che resti voglia di tornarci. Siccome il piroscafo arriva per l’ora del crepuscolo e riparte innanzi l’alba, posso ben dire d’averla seguita questa regola; e che mi sia rimasta voglia di tornarci si spiega. Tanto più, se vi dico che l’isola di San Nicola è una sorprendente e solenne cosa. Figuratevi una scogliera ardita tutta cinta di fortificazioni assai ben conservate. Si sale per un sentiero e per alcune scale difese da muri e da ridotte, e comandate dagli 298 Verso Sud D. Grittani spalti del gran castello. In pochi luoghi ho sentito che cosa fosse un «bello e forte arnese» di guerra, come laggiù. Era un’abbazia benedettina, e dicesi che i frati ci si trovassero così bene e animosamente a battagliar coi mori, coi saraceni e coi dalmati scorridori del mare, che finirono per farsi molto più guerrieri che monaci, tanto che nel duecento il papa li sostituì coi cistercensi. A questi seguirono i canonici lateranensi, che respinsero nel 1567 la flotta di Solimano II. Dentro la cerchia prima delle mura, in un ripiano, c’è lo squallido villaggio delle caserme, che dànno alloggio a pian terreno agli abitanti borghesi dell’isola, pescatori, commercianti, appaltatori, e al primo piano ai coatti. I quali passeggiavano negli spiazzi, chiacchierando. Io badavo a salire in fretta al corpo centrale della fortezza, dov’è il convento e la chiesa. E giunsi appena in tempo per ammirare cogli ultimi bagliori del giorno quel limpido e prezioso esemplare di architettura del primo Rinascimento, che è la facciata di Santa Maria. Non mi rincresce della breve luce, perché questa brevità di tempo aggiunta alla sorpresa dispose l’animo mio ad accogliere con una specie di appetito festoso e tripudiante la ricca gentilezza e grazia toscana di quel portale e della facciata. Vi si scorgono i segni di cannonate inglesi durante le guerre napoleoniche. Dopo, San Nicola ha subìto qualche tentativo di aeroplani austriaci; e ora una pace stupenda scendeva colla notte sull’isola monastica e guerriera. Il parroco fu tanto cortese da aprirmi la chiesa, e visitai il bellissimo e fastoso pavimento a mosaico, alcune opere insigni di legno e di pittura, e la mummia del Beato Tobia, protettore dei pescatori tremitani, a cui essi attribuiscono la grazia particolare di non perdersene mai uno in mare; tutto a lume di candela, come pure i refettori, i dormitori e i lunghi corridoi dei frati, dove ha sede la direzione della colonia penale. In un torrione di Carlo II d’Angiò – poiché in questa fortezza han lavorato, si può dire, tutte le dinastie del Regno – certi coatti bandisti si esercitavano e provavano musica. Tornati che fummo sullo spiazzo fra le caserme, era l’ora della ritirata, e sentii parlare il patrio dialetto. Eran certi bolognesi, ladri ed allegri, mi fu detto, i quali si rivolgevano motti «che il tacere è bello». Ebbi la tentazione, lo confesso, di dire: «O bolognesi, io sono della vostra terra», ma poi mi trattenni per varie ragioni, ed anche perché non mi facesser suonare dietro le spalle nel buio qualcuno di quei patrii motti e suoni sconci. All’ospitalità nei paesi garganici non è dato né permesso sottrarsi, e il signor Santoro, isolano di San Nicola, mi diede da cena e mi fece graditissima compagnia fino alla mezzanotte e all’imbarco, raccontando qual è la strana vita dei coatti e dei borghesi nella colonia (San Domino è coltivata dai coatti ed assai fertile), e parlandomi dei suoi figli pescatori ed abilissimi nuotatori. Aggiungasi che il vino delle Tremiti, dono del sasso e del mare, è ottimo e secco: la serata passò in un lampo. R. Bacchelli In Gargano 299 Mi destò assai per tempo la sirena, che sollecitava i barcaiuoli di Rodi; e poi dall’alba a mezzogiorno, ora dell’arrivo a Manfredonia, mi godetti la costa. Fino a Vieste l’ho già descritta; da Vieste, dove volge, a Manfredonia, è tutta impervia e deserta. Non si vede segno d’uomo fuor che le torri di guardia antiche e in rovina che si seguono, visibili una dall’altra, di capo in capo, in modo da passarsi l’allarme ai tempi che furono. La costa dirupata dal mare e dai terremoti è tutta un seguito meraviglioso di caverne e di altissimi archi naturali, scavati in una roccia bianca d’un caldo biancore giallino sul mare azzurro cupo, sul quale giocavano il vento, il sole, la scia e gli ultimi gabbiani, che ci seguirono fin sulla bocca del porto di Manfredonia. Le arance dell’Unità Italiana Si dice che sia tanto soave l’odor degli aranceti sul lido di Rodi Garganico, da far venir le lacrime agli occhi quando è il tempo della fioritura. Gli aranceti e i limoneti riempiono tutte le vallette e vestono ogni dosso di quella costiera, dove affiorano, a nutrirli, molte polle d’acqua gaia. A difendere dagli strapazzi del vento boreale le fioriture delicate ed il frutto greve, i coltivatori han tirato su, con scienza accorta e paziente, spalliere e filari e siepi di leccio e di alloro. Così, coi densi fogliami, onore della virtù militare e poetica, i coltivatori sviano le infilate, rompono i mulinelli e i golfi, disfano insomma i perniciosi giuochi del vento. Colla pesca, l’agrumeto è il primo guadagno del paese. Poco prima della guerra, sarà, mentre racconto, un quindici anni, il trabaccolo chiamato Unità Italiana era il più nuovo di quanti n’aveva la spiaggia. Anzi il padrone non l’aveva ancor pagato. Navigava così per mare col pensiero dei debiti a bordo. Veramente il trabaccolo, dipinto di nero con una fascia bianca, era un battello da stimarsene, calafato e padrone; e già nelle burrasche dell’inverno aveva fatto due volte buona prova di qualità nautiche. In quanto a qualità veliere, era dei più veloci e dei più utili e maneggevoli. Per questo, costava anche il suo prezzo, diceva il calafato quando dava una capata sulla spiaggia per covarsi il credito, come non fossero bastate le cambiali! Ai primi di aprile, il padrone caricò arance per la Dalmazia, e stivò l’Unità Italiana fin che ce ne poté uno. Poi fece in coperta una fila di cassette e di cesti, e, non contento, imbarcò pure non so quanti sacchi di buccia d’arancio. Occorre infatti sapere che la buccia d’arancio serve per cavarne essenza; e le distillerie di Dalmazia ne comprano. Guadagno piccolo, ma il guadagno si misura sul bisogno dei bisognosi e non sulle sazietà degli abbondanti. 300 Verso Sud D. Grittani Insomma, il padrone aveva fatto un carico tale, che sul ponto dell’Unità sparivano gli uomini dell’equipaggio: un fratello del padrone, giovine, un vecchio marinaio, un figlio mozzo. Non è da credere, perché la barca si chiamasse Unità Italiana, che il padrone fosse liberale, cosa di cui aveva un’idea vaghissima, o libero pensatore, cosa di cui non aveva nemmeno l’idea. Insomma, col nome di Unità Italiana egli era del tutto alieno ed ignaro di toccar la questione del potere temporale e del patrimonio di San Pietro. Queste erano questioni che riguardavano il Papa di Roma e il parroco di Rodi: quanto a lui, era devoto della Madonna della Libera, e aveva battezzata la sua barca patriotticamente, per un riflesso dei giornali del tempo di Tripoli. Anzi per quella guerra era stato richiamato, e non è escluso che il concetto dell’unità italiana gli fosse nato ascoltando qualche regolamentare «scuola morale» tenuta dagli ufficiali all’equipaggio, durante le lunghe crociere e gli ancoraggi nelle rade di Derna o di Tobruc. La Madonna della Libera arrivò a Rodi sulle onde, e si posò sopra un sasso, il quale si conserva sotto l’altare, scampando ai turchi, dice il latino dell’iscrizione. È una bella immagine bizantina e, forse, invece di turchi, si trattò, come per il solito fu di queste immagini recate in Italia dal mare, della greca persecuzione degli iconoclasti, quando l’imperatore Leone Isaurico volle dare il suo esempio anche lui di ciò che producono principi temporali in vena di teologare. Turchi o greci, la Madonna ha la sua chiesa sull’entrata di Rodi dalla parte di ponente, venendo dal lago Varano; chiesa «a divozione dei navigatori» dove gli exvoto appesi dietro l’altare a decine, dipingono grazie ricevute in mare, e che s’ingrandisce e si adorna per offerte e lasciti di rodiotti paesani o fortunati in America e non immemori. L’«Unità Italiana» recava a bordo, fissata sulla ruota di prua e protetta da un vetro, un’immagine benedetta della Madonna, e padrone ed equipaggio la rispettavano più che potevano, anche col tempo buono. Con quello cattivo, poi, l’invocavano con gran fede. E bisogno ne ebbe, quella volta che salpò col carico d’arance, il padrone, quando fu sotto Lissa. Avevan fatto ottima traversata, e la notte, quando cadde il vento, era così calma, che si addormentò anche il timoniere sul trabaccolo colmo, odoroso di catrame fresco e di buccia d’arancio. La luna in cielo terzo e cristallino, illuminava la groppa dell’isola a proravia. Le vele pendevano. Dormivano da un paio d’ore, perché, quando il vento li destò, la luna s’avviava al tramonto; un turbine boreale si scagliò sull’Unità Italiana. Le vele fecero uno schianto solo, e sparirono; il mare fremeva tenuto giù dal vento, e le due furie dell’aria e dell’acqua ogni tanto levavano una schiuma volante di polvere d’acqua. Il trabaccolo, spinto al largo, camminava fra una nube di tal polvere d’acqua. Il trabaccolo, spinto R. Bacchelli In Gargano 301 al largo, camminava fra una nube di tal polvere: pareva che non toccasse acqua, o che fosse nel ribollio di una cascata. Il timoniere aveva preso un colpo di barra nel costato, quando il vento aveva girata la barca al largo con quelle maniere che sono soltanto sue, e piangeva le sue costole. La luna al tramonto guardava la perdita di quegli uomini. Il colpo di vento smise com’era venuto. Il trabaccolo si fermò, come se avesse ritrovata acqua sotto la chiglia; si rivide Lissa fatta piccola e lontana, e il resto dell’equipaggio uscì a guardare i danni, dolorosi sopra tutti il padrone e il fratello. E non sapevano ancora quel che li attendeva, perché si combinarono due tempeste di vento contrastanti, e per tutt’il giorno, senza vele, rotto alla fine anche il timone, furono spinti e ricacciati dal largo alle isole e dalle isole al largo, aggirati, sconquassati, sbalzati sopra un mare rabbioso e accanito. Il vento vorticoso, pieno di rèmoli, aveva sgombrato e spogliato la coperta, pulita. E primi naturalmente eran partiti i sacchi delle buccie d’arancio, volatili. L’equipaggio, ricordando gli ex-voto, non aveva altro aiuto che quello d’invocare la Madonna della Libera, quando a notte il vento si decise, e si buttò in una gran tempesta spiegata di bora. Persero di vista la terra, e il mare ingrossato, dopo d’aver tentato di smantellare il fasciame coi colpi brevi, cominciò a lavorare coi colpi lunghi ed alti per vedere di rovesciare l’Unità Italiana. Ma il trabaccolo aveva mostrato quanto era saldo, e ora faceva vedere come era ben equilibrato. Sull’alba li accostò un vapore, che poté mandare una scialuppa e gettare un cavo. Ma quando si trattò d’imbarcarsi nella scialuppa, il padrone volle dall’ufficiale l’assicurazione che il vapore avrebbe preso a rimorchio l’«Unità Italiana». Altrimenti non si sarebbe mosso dal bordo; e il fratello, che era suo socio e vedeva la rovina comune nella perdita del trabaccolo nuovo e da pagare, fece l’atto di ributtarsi a bordo dell’«Unità» anche lui. Il capitano del vapore, un postale abbastanza grosso e lussuoso, non capiva quel che stessero a perder tempo in discorsi, e bestemmiava dietro i vetri del binoccolo, mentre scialuppa e trabaccolo ballavano a contrattempo sulle onde. Pareva che il tempo volesse migliorare. L’ufficiale finalmente non credette di far male promettendo e giurando, con grandi urli a quel testardo, che l’«Unità» sarebbe stata rimorchiata fino a Bari, prossimo scalo. Allora il padrone, traballando nei colpi di mare, andò a prua, si volse alla Madonna, e le disse: – Lascio la barca e il carico a Voi e al vostro aiuto –. E a bordo, incurante totalmente della stizza del comandante, lui e il suo sparuto e bagnato e affamato equipaggio volevano far la guardia al cavo. Quei pochi passeggeri che non soffrivano mal di mare, il vennero a vedere, e volevano farsi raccontare la traversia, ma cavarono poche parole. Allora si levarono la voglia di fotografare il gruppo dei salvati. L’impaccio e la noia erano accresciuti dal fatto di non aver indosso nemmeno gli abito loro proprii, che erano ad asciugare. 302 Verso Sud D. Grittani Intanto il padrone fu chiamato dal comandante per le notizie da mettere sul giornale di bordo, e il mare si rimise a infuriare. La rotta del vapore si trovava ad essere proprio nel filo del vento, e ogni tanto un colpo di mare buttava l’Unità Italiana a sbattere contro la poppa del vapore. Bisognò che si rassegnasse anche il padrone; fu tagliato il cavo del rimorchio, e il trabaccolo fu visto ancora per dieci minuti beccheggiante in balia delle onde, levando su la prua come se avesse cercato l’aria prima d’inabissarsi. I due fratelli non dissero una parola. Fin allora non avevan voluto mangiare, ora che il sacrificio era fatto e che almeno da mangiare avevan gratis, ne approfittarono per il giorno di digiuno passato, e per quelli venturi. Poi dormirono fino a Bari sulla loro miseria. A Bari presero il treno, e avevan pure scherzato con certi conoscenti incontrati alla capitaneria del porto, che li fece fornir di biglietti dalla questura per il rimpatrio. In treno poi c’era un piacevole suonatore di mandolino, e le ore passarono veloci. Soltanto arrivando colla diligenza in vista delle case bianche di Rodi, risentirono la loro disgrazia; peggio quando ogni cosa e il calafato li condussero a ripensare d’aver perduta la barca e di doverla pagare. La mattina dopo per tempo, – fra tutto eran passati tre giorni – il padrone sente bussare all’uscio, e un vocio per la strada. Chiamavan lui a gran voce; rimpiangeva che non l’avesser lasciato dormire, perché il dispiacere faceva come le botte e cresceva maturando; ecco, ad apertura d’uscio, gli invasero la casa. Allora credette di sognare e di non essersi svegliato. L’Unità Italiana aveva navigato verso Rodi da sé sola, e s’era venuta ad arenare quella stessa notte sul greto dalla parte di ponente. Due pescatori l’avevan scoperta, a poche centinaia di metri dal paese. Rodi è sulla rupe, tutto fatto a scale, ma il padrone non toccò un gradino, e volò più che non scendesse. Oggi un ex-voto nella chiesa della Madonna della Libera mostra l’Unità azzuccata sul greto, e quando il trabaccolo, ormai vecchio d’onorata età, non è in navigazione, si può ancor vedere, nero con fascia bianca, ancorato in rada o al secco sulla spiaggia di Rodi Garganico. Fu potuta ricuperar sana, per quanto maltrattata, anche buona parte del carico, che fu messo in vendita sulla spiaggia, dove tutti convennero a mangiar delle arance del miracolo. [Tratto dagli articoli apparsi sul quotidiano La Stampa nella primavera del 1929; contenuti nella raccolta di racconti L’Italia per terra e per mare, RICCARDO BACCHELLI, Rizzoli, Milano 1952, tranne il brano Le arance dell’Unità Italiana] 303 Conquista del sasso Giuseppe Ungaretti Il Gargano è il monte più vario che si possa immaginare. Ha nel suo cuore la Foresta Umbra, con faggi e cerri che hanno 50 metri d’altezza e un fusto d’una bracciata di 5 metri, e l’età di Matusalemme; con abeti, aceri, tassi; con un rigoglio, un colore, l’idea che le stagioni si siano incantate in sull’ora di sera; con caprioli, lepri, volpi che vi scappano di fra i piedi; con ogni gorgheggio, gemito, pigolìo d’uccelli… Ma queste pendici che vanno giù verso Manfredonia sono tutto sasso. Salendo da questo lato verso Montesantangelo la vegetazione è tutt’altro che facile. Ma questa è la giornata degli spettacoli commoventi. Giù, vedete, si estende a perdita d’occhio la pianura: terra, terra. E con tanta terra a due passi, guardate questi montanari: vanno a cercare la loro terra avara col cucchiaino; e quando trovano nel sasso un interstizio: giù quel granellino di terra. Sono arrivati così, conquistando un millimetro dopo l’altro, a rendere fruttuoso anche questo versante, e ora è tutto diviso a terrazze che fanno l’effetto di snodarsi sul suo dorso come lentissimi bruchi. Mi dice uno che sta zappando: «Avresti dovuto vedere quest’estate! Il nostro grano era alto così! Il più bello di tutta la Capitanata!» Mi dava del tu, davvero era un Antico! [Tratto da Deserto e dopo, GIUSEPPE UNGARETTI, Mondadori, Milano 1961] 305 La Foresta Umbra TOMMASO FIORE L’autore dello splendido romanzo Il cafone all’inferno (Einaudi 1955), punto di riferimento di ogni movimento poetico pugliese degli anni Settanta (a tal proposito corre d’obbligo citare l’antologia Poeti di Puglia e Basilicata, Adriatica Editrice da lui curata), compie nelle pagine de La Foresta Umbra un giro attorno a quell’universo naturale che sembra appartenergli nella vita prima ancora che nella letteratura. La cosa più bella della Foresta è il vivaio Giacomelli, dietro all’albergo, presso uno straccio di pineta, con qua e là un misto capriccioso di lecci, di castagni, di cipressi. Io guardavo quella novità senza saper andare innanzi, allorché il mio accompagnatore mi disse: «Tutto sarà spoglio tra breve, l’inverno di verde non resta che qualche abete dietro l’albergo, pochi tassi, qualche vialetto di “busso” e gli agrifogli che pungono le mani. Aprimmo un cancelletto: lo spiazzo, di non più che un ettaro quadrato, scendeva a vari ripiani con aiuole ben ordinate di piantine, ognuna col suo cartello: pino nero, castagno, ornello, pino bianco, abete, cipresso a felci per villa, cipresso per cimiteri. Al ritorno entriamo nella casuccia del capo vivaista: subito la contadina ci fa vedere che i suoi marmocchi non sono più sporchi, come poco fa: «Bisogna lavargli ogni mezz’ora». Ma più che altro le balza il cuore di gioia, ché possiede finalmente una casa, non lì, non quella catapecchia che è fredda, ma giù, a Vico. «È fatta coi nostri sacrifici, risparmiando cinquemila lire al mese.» Non devon essere molte le famiglie di lavoratori in questa condizione! Anche il marito ne è assai contento, sebbene avvezzo a parlar poco è come impacciato. Il suo compito è di mettere in terra da quaranta a cinquantamila piante all’anno; la zona di rimboschimento è a Jacotenente, a sette chilometri di qui,e lui ne fa quindi-venti ettari all’anno. Anche lui avrebbe il suo orario di lavoro, sulla carta, sette od otto ore; in realtà si trova 306 Verso Sud D. Grittani all’opera più di dodici ore al giorno, deve rimaner sempre a disposizione di chi comanda, tacere e ubbidire. Invece per tutto quello spazio non si vede la gioia di u fiore, nemmeno un garofano, appena in un vaso il solito basilico fogliuto. La donna si scusa: «Non sono appassiontata di fiori, nemmeno a Vico ho fiori. Mio cognato mi avea offerto dalie assai grandi e belle, tutti veniamo qui a strapparle, senza nemmen chiedere permesso. Allora io mi sono accattivata dal dispetto: non ne pianto più. Poi aggiunse: «Non sapete? È proibito tener fiori qui.» «Davvero? È proibito allevar fiori sul terreno del vivaio» speiga il marito. Povera foresta! Finalmente raggiungono contrada Signor Marchi, dove si scorge al lavoro nientemeno che un unico carbonaio, con moglie e figlia. Come mai? La stagione con è questa ed io ormai disperavo di veder carbonai all’opera. Di regola si lavora solo da settembre a metà giugno, lo appresi l’anno scorso a Monte. Vi sono a Monte non meno di settecento carbonai, tutti alla dipendenza d’impresari, ma non ne impiegano che due o trecento. A cottimo, lavorando giorno e notte, si arriva a ricavar 470 lire a quintale; il cottimista può produrre sino a un quintale e mezzo e dunque valore di 700 lire, sempre lavorando giorno e notte. A giornata invece si hanno ottocento lire. «Magro compenso» esclama l’operaio e mi addita la moglie e la figlia che lavorano con lui, dormono con lui in quelle impossibili baracche. «Quasi come gl’Indiani, i paria dell’India! Se la ditta ti mette le marche, prendi 227 lire al giorno di disoccupazione, più ottanta per i bambini, ma solo i giorni feriali. Altri mettono insieme il loro lavoro, due o tre persone, e si avvicendano per andar al paese, a cambiarsi. Sei stato in India?» «Sì, tre anni, ho visto con gli occhi miei. Non stiamo meglio di quelli là.» In quel momento a poca distanza verso la strada, s’ode uno sbattere, un trepestio, il guaito di un cane: accorriamo tutti, primo il carbonaio. La povera bestiola giace a terra, senza forza, vicino a lei un serpentello verde, un guardapassi, morto ormai, con la schiena spezzata. Gli occhi del cagnuolo, attraverso il folto pelo. Poi d’improvviso scatta su, corre alla baracca, a pochi passi, subito ne ritorna con qualcosa in mano, mentre noi siam rimasti lì costernati, senza saper che fare. Lui invece, eccolo di nuovo in ginocchio, con la sinistra afferra il cane per il muso, lo rovescia, e con la destra incide con la lametta sulla ferita, a croce. Il sangue spiccia dal petto, la povera bestia è salva. Di sera, dopo cena, a starsene all’aperto, sull’orlo della strada, il cielo è così basso sul nostro capo che pare tutto una via lattea. Vedremo lampeggiar gli occhi di qualche lupo, attraversando una radura? Qualche schioppettata darà uno strappo al T. Fiore La Foresta Umbra 307 silenzio immobile... No, gli operai-contadini se ne stanno tranquilli (non manca qualcuna delle loro donne), sdraiati per terra o poggiandosi a un panchetto, come se facessero parte dell’immobilità senza tempo del bosco e delle cose... È facile che la conversazione cominci dalle bestie. «Oggi i lupi son spariti dalla Foresta Umbra, sono stati completamente distrutti, come meritavano; li ha ammmazzati col veleno la Forestale.» «E le volpi?» «Se non lo sapete, la volpe è amica e comare della lepre. Dunque allorché comare volpe s’incontra in comare lepre, la prima cosa si mette a scappare, come avesse paura, finge di allontanarsi, non vuol disturbare la sua comarella. Allora la lepre resta lì a guardare come stupita, offesa di quelle maniere di comare volpe, finché l3altra, che le è madrina, quasi è costretta a fermarsi e si volge, torna indietro. Allora tutt’e due si salutano e si abbracciano da vere comari, e così si danno a giocar insieme, si rovesciano per terra, si rotolano, si stringono di sotto e di sopra oora l’una ora l’altra, finché coglie la volpe il momento e afferra la comarella sempliciotta alla gola, l’ha uccisa d’un colpo e per prima cosa si beve quel sangue, si toglie la sete. Qualche volta sul più bello ecco il cacciatore arrivare, ammazza la volpe e si prende la lepre, la vittima e la falsa traditrice.» «Ma ora volpi non se ne vedono più, quasi, nella Foresta: quelli della penna al cappello preparano loro buoni bocconi. Allorché muore un ciuco, quella carne ora vien destinata alle volpi, come già una volta ai lupi. Ne fanno polpette avvelenate: ho visto io mettere il velene nella carne, con i guanti. Restano stecchite dopo un minuto.» «E i cacciatori? Non è proibita la caccia?» «Sì, nella Foresta, ma i caprioli si spingono fuori del bosco, per mangiare; l’erba di fuori è più saporita. E allora... » «Qui tra gli alberi nessuno li distrurba; arrivano dinanzi a noi, rimpetto alla casa, pascolano tranquillamente a gruppi di tre o quattro. I ragazzi scendono in mezzo a loro e non hanno paura.» Colui che ha parlato da ultimo con la sua voce dolce è un bel pezzo di giovane; soffre di postumi di pleurite, che si è buscata soldato in Africa; basta una minaccia di maltempo per abbatterlo. È proprio lui che è stato alla mensa degli Americani e conferma che erano migliori degl’Inglesi, più democratici. «Ma la politica è un’altra cosa - dice uno si sa.» E tutti si trovano d’accordo. «Mi ha detto compare Pasquale, il fornaio di Monte, che un giorno, camminando per la vasta campagna della Russia, era priogioniero, scorse un cespuglio, l’unico della pianura, e si mise a frugarvi dentro. 308 Verso Sud D. Grittani C’era, sotto, un pezzo di legno, su cui una testa di morte era stata intagliata, ed insieme un piccolo volume. Sulla copertina era scritto: «I nostri pronipoti, leggendo la storia, troveranno che i loro padri hanno ucciso gente senza nemmeno conoscerla. Uccidete il mostro della guerra!» «Hai visto tu il libro?» «No, ma lo posso vedere quando voglio. Ora, ogni volta che il fornaio m’incontra, mi ripete: Compare, i nostri pronipoti, leggendo la storia... » Il cielo sembra curvarsi su di noi, le costellazioni stan ferme, grondano di luce. Uno alza la mano e fa segno alla puddara... 309 M’ascolti tu, mia terra? (Ode al Gargano) JOSEPH TUSIANI Joseph Tusiani (San Marco in Lamis 1924). Senza dubbio fra le personalità culturali più illustri della Capitanata. Docente di Letteratura Italiana presso l’Università di New York, traduttore dall’italiano all’americano di Michelangelo, Machiavelli, Tasso e Boccaccio, autore di romanzi, saggi nonché curatore di numerose antologie di poesia italiana. Nonostante il suo impegno letterario abbia assunto dimensioni ormai planetarie - Tusiani è di continuo chiamato a tenere lezioni e conferenze in tutte le università del mondo - il “professore sanmarchese” non perde occasione per rinvigorire il proprio legame con il luogo natìo, a cui ha dedicato numerosi componimenti dal sapore nostalgico ma di straordinaria intensità. Terra natale, io non ho mai sofferto, io non ho pianto e non son mai partito, se alla mesta pupilla, che ti ritrova, tu sei bella ancora e sei materna. Forse per selvaggi mari avanzò la sola mia paura; forse per venti e valli e per sere illuni procedé, sempre sgomento, il mio pensier solitario; ma l’anima, qual sangue tra le vene, passò per le tue radici eternamente e l’uomo restò bimbo e fu sereno. Serena, sí, tu sei, mia terra grande, or che sí vergine e vasto l’azzurro sopra di te tangibile s’espande 310 Verso Sud e ti chiama sua terra; e l’onda a te rifluisce, scontenta delle raggiunte distanze infinite, ed ecco canta e ti chiama sua madre. Qui mi son io fermato, su quest’erba che sempre rigermoglia, e con l’orecchio trepido ho seguito nel fiottar del mio sangue il lieve, arcano crescere della foglia e 1’appressar del tuono di lontano. E quando poi crosciò sui sassi stridula tutta la pioggia improvvisa, il tuo volto ho visto asperso e splendere d’umida meraviglia, chetando nelle tue sacre spelonche il mio terrore fino al nuovo sole. Ecco il sole è già parte di te, parte di me, sí basso che quasi ci tocca con l’ultimo suo dir melodioso. E sta su quella roccia a brucar l’erba imporporata la capra (e ci pare che mangi il sole), e su questo declivo, che sente il fresco favellar del mare, sta presso il gregge il pastorel silente, lieto di regger sull’aperta mano un cielo d’oro e per la prima volta fatto da te, sua madre, madre nostra un vestito di raggi. E son campane lontane e campani vicini, ed è la sera, questa cosa tranquilla che inumidisce la nostra pupilla all’improvviso e ci fa te guardare pensosamente prima della notte. Quando la notte è grigia, ed il grillo ed io sembriamo i soli spiriti viventi sotto un ciel ch’or si apre or si discopre all’occhio malinconico assonnato, D. Grittani J. Tusiani M’ascolti tu, mia terra? l’ultimo fil di ristoppia che brucia esala una fragranza di frumento fiore. Ah no, veglia lontano e canta una fiaba di vita un vecchio, e ascolta un pastorello, e dè religione questo silenzio della giovinezza al detto del profeta. Il mare tace, anch’esso ad ascoltare, e ancora un poco il vecchio canta, e sulla stessa pietra, che serve da giaciglio, nella mobile notte sono immoti il bianco capo e i lievi ricci biondi. Ora il silenzio gli abissi profondi colma, e la notte l’attonito cuore che veglia. E vegli tu. Terra d’amore, anche sul mio pensiero. Io so che sotto il rigido tuo ciglio trema perl figlio il tuo pianto di ieri, il tuo pianto del sole. E so che dentro il tuo marmoreo cuore è la speranza di nuov’erbe e d’uccelli e di pastori, è la stessa preghiera che non manchi domani il dolce volo e la pastura ad ogni tua novella creatura. Madre, io ti canto la lode notturna ancora, e tu m’ascolta, come udivi una volta il mio canto di maggio! Io son tornato dai mari lontani, e se pur sembri in allegrezza spento ogni anno amaro, non potrà nessuno annullare il passato e ricondurre al seme antico il già perfetto fiore. Era sí lieve, ai miei dí, questa pianta, ch’io con mano piccina ne scotevo tutta per me la brina; ed ora è tronco, e la mano robusta tocca a scorza e non più nuoce ai rami. Ma in quest’albero forte scorre ancora 311 312 Verso Sud l’umore del tuo grembo immacolato. Immacolato io mi sento tuttora (eppur m’han fatto rude gli anni e il male) come si fosse fermato il mio giorno alla sua prima aurora senza il declino alla sua prima sera. E costumi ho veduto diversi e gente diversa e, per vivere, anch’io quasi ho dovuto scordare i tuoi linguaggi e i tuoi silenzi e le tue selve fiere ed incorrotte. E ho imparato a dormir la mia notte senza i tuoi cieli, per sentirmi pronto a correre affannato, il dí seguente, allo stesso tramonto. E qui correvan liberi e veloci i tuoi venti, e sui greppi e dentro ai solchi saltellavano le lepri e nascevan viole. Tu non conosci il mondo sotto il sole, o severa montagna che amo. Or, di noi due, io non so dire chi più sappia e valga: io, che ho appreso il soffrire de’ fratelli, o tu, che sotto la pioggia che bagna e rode, all’alba nuova ancora possiedi l’innocenza di ieri. Io non lo so, perché sapere il male è forse un po’ dimenticate il bene. Ma certo vive senza l’uomo il fiore, e l’uomo è triste senza un fiore almeno. Tua la grandezza soltanto, se, al seno immune ritornati, si soffre di non essere più frammento vivo di te, come il boccio dormente beato, e come quei pastori avvinti in un unico sonno quasi dolore e amore stretti per sempre in un’intensa vita. D. Grittani J. Tusiani M’ascolti tu, mia terra? M’ascolti tu, mia terra? All’infinita tenebra (a me sembra infinita, eterna) il grillo ancora invia il suo messaggio antico, ed alla luna esce a guizzar la serpe, e sul pantano canta la vecchia vicenda la rana, ed or si sente nascer sulla via una canzone; è il carrettier che torna. In questo mondo innocuo e tranquillo, in pace sí sovrana, forse son io soltanto che parlo a te questo linguaggio strano, questo amarissimo inutile pianto. Io so che tu m’ascolti. Ha roso il vento e portato nell’onda un masso di tua roccia, e sette inverni han gravato i tuoi fianchi seppellendo nelle nevi i tuoi fiori e sette aprili han ferito di gioia il tuo grembo, ed hai sofferto lacerazioni d’uomo e schianto di nembo. Eppur sei buona ancora e sei materna. E tutto perdoni, mia terra, e il tuo silenzio è più che voce al fior che, nato nell’idea eterna, questa notte, fra breve la corolla aprirà sulla zolla stupita, a me che, giunto qui per mille gestazioni amare, qui rinasco e dico all’ure: «O mistero di gloria dove nascere è bello io sono nato!» Uomini e cose, udite! Il fiore è nato e il fiore brama il sole, e vuol l’infante la vita. Aspetta il vento giù la vela spiegata e ad esser bella attende il raggio la rugiada ch’esiste e non si svela ancora. Io sento che è segno d’aurora questo brusio tra le cime, quest’alito 313 314 Verso Sud sopra la vetta più grande, su tutte le vette. Io ti conosco, fremer di cento cerri, canto d’arpa timida e tinnula, or che ogni sogno sembra finire in colore, e il colore sembra mutarsi in cuore d’iomo. Correte, accorrete alla festa del monte che si dora, della foresta che bella si desta al giomo! È tardi già: quel che fu oro è croco, e cresce già sopra la crosta glabra un filo di bianchissimo crespo, e in un mar di candore la notte è naufragata, e in tutta questa luce il mio dolore. D. Grittani 315 Ex voto Alfonso Gatto Alfonso Gatto (Salerno 1909 - 1976). Tra le numerose testimonianze letterarie lasciate quale “futura memoria” delle pietre del Gargano, figura anche la breve ma bellissima Ex voto dell’indimenticato poeta Alfonso Gatto. Una prosa che prima apparve nella raccolta Carlomagno nella grotta (Mondadori 1962, silloge ripubblicata col titolo Napoli N. N., Vallecchi 1974) e che poi venne inclusa nel famoso Diario Pugliese. Da Vieste a Manfredonia la strada sale e scende tra foreste d’ombra e orizzonti di luce, in una solitudine quasi assoluta rotta ogni tanto dalla presenza di un boscaiolo o dallo strombettare di una vecchia macchina di funzionari. Il mare s’affaccia da ogni parte, è una piazza azzurra che ruota sotto il piede del promontorio. Si vede il Gargano levarsi con forza dal litorale soffiato giù giù sino alla bianca cattedrale di Trani: la sua altezza è intensa da quella soglia. Mattinata, nella valle, è più felice del suo nome. Montagne fitte fitte di muretti, a gironi verso il cielo, e, nei ripiani, contadini che battono il grano, gli uni sugli altri come nei quadri dei primitivi. Le piccole case di Monte Sant’Angelo, uguali, allineate sui gradoni della roccia: il tetto, il balcone, la porta: una stanza sopra una sotto. Gli arcangeli degli ex-voto uscendo dalle nuvole si fermano a parlare. Ma il duro del paese è nel santuario scavato col freddo dei marmi dentro la roccia. La stiva è carica di voti e di candele, tentenna nel buio ove salmodiano i ciechi. [Tratto da Carlomagno nella grotta, ALFONSO GATTO, Mondadori 1962] 317 Gargano sessantuno Roberto Roversi Roberto Roversi (Bologna 1923). Al poeta emiliano, fondatore assieme a Francesco Leonetti e Pier Paolo Pasolini della celebre rivista letteraria Officina, l’occasione di un viaggio in Capitanata si presentò nel 1961, allorquando in compagnia dei registi Carlo Di Carlo e Aldo D’Angelo raggiunse l’entroterra garganico per realizzare un documentario cinematografico. A fare da “guida” a Roberto Roversi si prestò il prof. Pasquale Soccio, che non mancò di mostrare all’autore del Motore del Duemila (canzone portata alla popolarità da Lucio Dalla) gli incantevoli tratti di montagna ispiratori di Gargano sessantuno. In un brogliaccio del ‘61 trovo queste varie indicazioni molto dirette e molto sommarie, che qua trascrivo lasciandole nella loro onesta e ingenua tempestività: oggi parto da solo per il Gargano dove troverò la troupe di Di Carlo per girare i due documentari. È un agosto molto caldo e molto sereno, un cielo tutto spianato ma mordicchiato da piccoli fori di colore più accentuato, chiazze di azzurro peregrino, come semi intravisti nel corpo polposo e rosso del cocomero. Sono in Abruzzo da tempo, dove sto bene; naturalmente. Qui i rumori arrivano portati sul movimento cauto e aggraziato, ma con una aggressività in controluce, dell’aria. Soprattutto il passaggio dei treni, così vicino al mare, è un teatro continuo; fischiano come nel Texas. Il breve viaggio di trasferimento è stato tranquillo e abbastanza solitario, per niente avventuroso. L’asfalto si attaccava alle gomme dell’Appia, che sbuffava come un cavallo intimorito indaffarato intorno (non ancora dentro) alle sabbie mobili. A destra e a sinistra della strada, spesso vicina al mare e con cespi di gerani crocchianti ai lati, i contadini accendevano falò per bruciare le stoppie e fumi bianchissimi, spessi come un nebbione bolognese, s’alzavano a coprire ogni cosa. A occhi chiusi si entrava nel nulla, nel limbo di Dante o nel cuore del mondo, ed era emozionante ogni volta uscirne fuori e toccare o sfiorare di nuovo pietre e foglie. Il Gargano mi piace. È così silenzioso o, meglio, è così solitario. Non una terra 318 Verso Sud D. Grittani abbandonata ma una terra ancora da scoprire. Strade sempre in curva sfiorano pendii pieni di olivi contorti scuri e risucchiati come le mani dello zio Rigo; e il verde scuro, quel verde scuro, ha una solennità da poema greco, intimorisce. Quasi che fossero lì ancora a tutela di tombe di guerrieri oppure di splendidi adolescenti toccati da una sorte infausta o di donne caute e attente, vissute nell’attesa e nella pazienza. Spesso si incontrano greggi che avanzano lentissime ingombrando la strada e le prode. E i pozzi davanti alle piccole masserie, gli asini che aspettano vicini ai muri, immobili, trapassati ogni tanto da brividi improvvisi per scacciare le mosche. Pecore, asini, ulivi e l’acqua raccolta tutelata difesa con il sentimento delle pietre perché neanche un goccio vada perduto; l’impressione immediata di una parsimonia attiva, di un obbligo di attenzione e di cautela per sottrarre ogni cosa, ogni piccolo bene, ai giri e ai tiri abbastanza perversi della sorte. Aggiungo che, muovendomi, percepisco il senso di una continua salita verso l’alto, un costante progredire in su ma gradevole, abbastanza armonico, senza strappi e senza paura; specie perché è un continuo snodarsi di curve da purgatorio dantesco e certamente, ripeto almeno per me, con il sentimento di una progressione liberatrice, per la conquista di un po’ più di luce, di un po’ più di spazio a vantaggio della sorpresa del cuore. Per liberarlo dai chiodi della terra. Non trovo altre spiegazioni. Ma poi anche i cani. I cani ci sono, ad ogni svolta, ad ogni porta, a tutti i pozzi, fra le gambe di tutti gli asini. Abbaiano poco ma è subito chiaro che sono lì a vigilare con una indifferenza astutissima, simulano il sonno con il muso fra le zampe e invece seguono ogni movimento intorno, con occhi lucidi nei quali si riflettono come in uno schermo atti voli persone, passi. Perfino le voci sembrano passare attraverso quegli occhi. Scattano all’improvviso in piedi con una rapidità e una agilità – e una furia – da pantera; quando con l’intelligenza dell’esperienza deducono che è necessario intervenire o prevenire… Ci muoviamo spesso, adesso, fra boschi spettacolosi, e così imponenti. Ho imparato lì dentro perfino a decifrare alcune voci, ma tutto è come bisbigliato quasi che passasse attraverso il fiato di un altro. I rumori o i suoni rapidi leggeri e vaganti sono cento ma nessuno infatti è gridato. La foresta è rispettosa del silenzio e a me pare che stia attenta ad ascoltare sé stessa. La foresta vigila e guarda; aspetta. Non lascia niente al caso. Gli alberi, così grossi e alti che sembrano perdersi nel vuoto, mi danno la sensazione che adagio, ma senza fatica, tutti insieme si mettano in movimento strisciando le ultime foglie, quelle più leggere fresche trasparenti, contro il cielo. La forma delle nuvole mi ricorda i quadri dei veneziani, i grandi del Cinquecento, che con nubi o in grangia e colore e con tempeste annunciate o in atto avevano un conto aperto e rapporti diretti. Nuvole grandi, gonfie di un latte giovane, che trasmigrano in fretta come uccelli di passo. Alle volte hanno il bordo affumicato quasi che trascinandosi così un poco affannose avessero strisciato sulla terra, sugli alberi, o sul dorso di una montagna. R. Roversi Gargano sessantuno 319 Nei paesi non siamo ancora entrati, dato l’oggetto delle nostre riprese. Ma siamo spesso al lago di Varano e al lago di Lesina. Fra i canneti della riva, al primo approccio, mi a colpito un canotto ormeggiato, in completa solitudine, ma fresco di vernice e con una solidissima gomena, che aveva a prua, tutta dipinta di rosso, una mitragliatrice ruotante della prima guerra mondiale, per la caccia delle anatre. Dicono: ne cadono a decine per volta. In una battuta anche due trecento. Un macello. Sul bordo del lago i pescatori vivono all’estate in capanne immerse fra i canneti, come in un paesaggio africano perso nel sogno. Tanto che si potrebbe immaginare che si muovano intorno, attenti ma tranquilli, i leoni. Così vicino al mare! I pescatori, allineati sulle chiuse, afferrano i cefali con le mani. Ieri sera hanno acceso un fuoco preparandoli per noi. Ciò che mi colpisce è la straordinaria compostezza del loro comportamento. Niente di volgare o di approssimato, con l’abitudine al rispetto di regole antiche che sono ormai, così mi sembra, educazione del sangue. Hanno capanne con interni poveri, essenziali, ma fra gli oggetti d’uso, quasi sempre, ecco un bicchiere, una ciotola, un sasso, una immagine di secolare fattura che la terra ha riconsegnato perché potessero continuare a collegarsi con la propria storia; e le proprie storie. Sono sempre più coinvolto con il passare dei giorni in questa educazione, cultura rituale (non espansa ma abbastanza cauta nel lasciarsi visitare) che mi sfiora ma che tuttavia sento che mi aiuta passo dopo passo a crescere, ad allargare e completare i dati della mia comprensione generale. Anche il pane, per esempio, con quelle forme e soprattutto con quell’odore d’albero bruciato all’aria aperta, vicino al mare, farina e foglie… Poi l’altro giorno ho avuto un’altra esperienza, di persone e di situazione, emozionante. Ho conosciuto il prof. Soccio nella sua casa di campagna, in un posto isolato alto sul mare. È una persona che mi fa soggezione e nello stesso tempo induce ad aprirti, a corrispondere, a non frapporre intermittenze nel piacere anzi nella necessità di comunicare; e di continuare a farlo. Questa capacità naturale, che è rara, di sciogliere lacci e barriere per lasciare corso all’ordine delle parole e delle emozioni, correlate ai vari problemi, è proprio dei veri maestri. Sono passate alcune ore che non saprò e non potrò dimenticare. Per noi, che avevamo trascorsa la giornata sotto il sole per le interminabili e talvolta tediosissime riprese ha stappato una bottiglia del 1898, un vino nero impeccabile – che si spandeva nel palato, sollecitandolo, come fa l’ombra sulla terra quando è portata da una nube. È un atto che ci lega emozionalmente alla percezione reale del tempo, alla scansione dei moti della storia; e non credo sia troppo ingenuamente retorico se uno come me, obbligatoriamente cittadino, e di una città conficcata nella schiena solida e polputa di una pianura senza mare, pensa (anzi, direi, può sentire dentro al pensiero) che un tale vino era già nella bisaccia dei soldati di Roma. Dalle mie parti invece la storia è solo da museo, catalogazione di 320 Verso Sud D. Grittani oggetti e di dati. Con il prof. Soccio si può parlare di tutto. Passavano le ore in questo modo, è arrivata la notte profonda, con un cielo tanto scuro che sembrava illuminato; in giardino, con la campagna intorno – io, Di Carlo, il professore e un suo giovane parente – seduti, a me è precipitato addosso come l’irruzione improvvisa di un vulcano senza fuoco il sentimento anzi la sensazione reale dell’infinito dilatato sopra di noi nel palpito di tutte le luci del cielo; e quella altrettanto e forse anche più emozionante, conturbante, del silenzio totale; completo. Il mondo era vivo ma in quel momento niente si muoveva; la natura era lì eppure sembrava trattenersi per non intaccare la perfezione di quel momento indicibile – che poteva ripetersi sera dietro sera. Era come se la terra, anche la terra, aspettasse qualche evento particolare e inglobasse inghiottendo rapidamente ogni sia pure piccolo fruscio – avida di quel momento di assoluta sospensione. Infatti, era tanto il silenzio che si aspettava qualcosa. Si muoveva perfino sulle nostre braccia, sul collo come un fiato trasparente delle cose. Era qualcosa di inesplicabile che questa terra conservava e dunque difendeva a segno della propria sovranità, della propria cultura; e della propria storia. Durò a lungo, per me. E io ho finito per accasciarmi quietamente nel sonno, per entrare a piedi nel regno dei sogni magici – dove non c’è più una fine per la vita dell’uomo. Devo questo spaccato di meraviglia al prof. Soccio, uomo di studio che non dimenticherò. Sono ripartito dal Gargano muovendo poi da S. Giovanni Rotondo, che è un paese tutto bianco e molto grande. Dove c’è padre Pio. Grandi palazzi e un muoversi di tanta gente. Mentre mi allontanavo girando le curve, e da lontano, calando la sera era tutto illuminato come una città del nord. Con abbondanza di luci terrestre, che il buio non beve. Pensavo ai pescatori, che a quell’ora non avevano acceso ancora le loro lampade, o le avevano già spente. E al prof. Soccio che, forse, era già seduto nel suo piccolo giardino a contemplare la notte. Portavo con me due forme di pane… 321 Oltre l’isola dei coatti qualcuno ha chiamato Anna Maria Ortese Anna Maria Ortese (Roma 1914 - Rapallo 1998). Narratrice e giornalista, nata in una famiglia molto povera, Anna Maria Ortese si distinse nel panorama letterario italiano ormai quarantenne grazie a Il mare non bagna Napoli (1953). Poi fu la volta di Poveri e semplici (1964) e del suo primo romanzo L’iguana (1965) che però non riscosse la fortuna che invece avrebbe meritato. Seguì la tormentata opera Il porto di Toledo (1975), quindi un lunghissimo silenzio narrativo rotto soltanto da Il cardillo innamorato (1993). La prosa che qui riportiamo fa parte invece della bellissima raccolta di impressioni di viaggio dal titolo La lente scura (1991). Il Gargano mi ha offerto un tale numero di sorprese, in due giorni, che ancora adesso ne serbo l’immagine di un paese stregato. Qui, la bellezza celeste delle cose, ha isolato e perduto gli uomini. In alcuni momenti, sembra non vi sia altro che beatitudine, subito dopo avvertite la presenza di un nero sconforto. Dopo le selvagge impressioni della sera precedente, fra la spiaggia e gli antri domestici di Peschici, e una lunga notte trascorsa nella locanda di Rodi, minacciata da presso dal vento e dal mare, che in quell’incertezza del buio esasperavano la loro potenza, non credetti a me stessa, quando la mattina dopo, aprendo le imposte, vidi davanti alla casa un mare liscio e celeste e grande, che nella luce nuovissima del giorno brillava con la stessa freschezza, faceva sentire la stessa voce favolosa dei mari apparsi a Omero nella sua Iliade. Sotto la finestra, certi pescatori, seduti su uno scalino, alcuni fumando, chiacchieravano. Ai loro piedi, grovigli di reti molli e intricate come chiome, e cestini anche neri, dove guizzava ancora, silenzioso e fulgente, il pesce azzurro e rosato. La stagione era finita, sulla spiaggia non si vede altro. Andai in cerca del fotografo, e seppi che la sua ardimentosa «topolino» stava poco bene, e in attesa che il meccanico la aiutasse a riprendere le forze, decidemmo di dare un’occhiata a Rodi. Facem- 322 Verso Sud D. Grittani mo una strada sola, tutta rampe, quella che dalla piazzetta di Rodi porta al mare, credo si chiami via Ferrucci. Da tutt’intorno, cominciava ad affacciarsi gente, apparivano busti nelle finestre piccolissime, come mezze figure in una cornice chiara. C’era molta infanzia, seduta per terra, come in tutta Italia, bambini vestiti alla meglio, coi cenci dei grandi, creature la cui esistenza è affidata, come quella dei fiori selvatici, alla bontà del cielo, alla clemenza dei venti, bambini protetti da ben poche cose, al mondo, salvi per caso, cresciuti per puro miracolo. Mentre le donne parlavano e ci raccontavano la loro vita e il numero dei figli, con una specie di gentile lamento, vedemmo venire su da una rampa bianchissima sul fondo turchino del mare, un fraticello minuto, di poco più di cinque anni. Levava un piedino dopo l’altro, nell’impaccio della tonaca, difendendosi con una manina lo sguardo. La sua testina brillava al sole, come una pallida arancia, e più pallide erano, quando le scorgemmo, le sue guance, le labbra. Era Tonino Fontanarosa, che questo inverno è stato malato e la sua mamma gli ha fato un saio, per voto, ma ancora non è sanato. Vedendoci, sorrise appena e aggrottò le sopracciglia. I suoi chiari occhi erano tutti arrossati, e a mala pena sopportava la luce del sole, ma circa questo particolare, nessuno seppe dirci niente, se non «malato... malato... ». Il fotografo fece scattare molte volte l’obiettivo, e tutti erano molto contenti, ora, sia Libera Altomare, che nella sua vita era stata sempre messa da un lato, sia Colajanni Maria, che seduta sulle scale andava pulendo la verdura, sia Russo Concetta, ch’è molto stimata fra tutti perché possiede un paio di occhiali, sia Lina di Lelle, ch’è una graziosa ragazza, e altri. E tornò, a ritroso, il paesaggio della sera prima. Ecco Peschici sotto il sole. Questa volta entriamo diritti in paese, abbagliati da una luce ardente, che accorcia o elimina ogni ombra. Non c’è che bianco e azzurro. Sembra una favola. La macchina rimane in bilico tra una strada e un marciapiede che si rassomigliano tanto da confondersi, circondata dai soliti cacciatori di lampadine, e noi ne usciamo storditi, ma ansiosi di conoscere finalmente Peschici. Dopo due minuti di strada, eravamo sicuri di aver raggiunto uno dei posti più squisiti del mondo. Forse, era il punto più alto della collina. Alla nostra sinistra, non era che un ricamo bianco, con appena qualche nota di azzurro e di rosso, data dai fiori e dall’erba, trama nivea di case, terrazze, scalette, balconi. In fondo a tutto il cobalto assoluto del mare. Donne e bambine uscivano ogni tanto dalle case, vestite di nero e raramente di chiaro, come sembra usi in tutta la Puglia, portando sul capo, con cura paziente, grandi latte per la benzina, e si dirigevano verso un pozzo bianchissimo, situato dove la stradetta terminava, contro la grande luce del mare. Tutta Peschici, ci dissero qua e là, era piena di quei pozzi. Solo dieci case erano provvedute di un elementare servizio igienico, e in quanto alle fontane non A.M. Ortese Oltre l’isola dei coatti qualcuno ha chiamato 323 davano acqua per qualche ora. Ce lo dissero, quelli che stavano seduti sulle porte, uomini e donne, con un sorriso curioso: dove la vergogna era diventata divertimento, e l’ira un sorriso e una sassata. In non vedevo la Puglia da moltissimi anni, e ora mi andavo lentamente ricordando ch’era stata sempre così, un’esistenza sprovveduta e ferice, un sole tremendo e una terra dimenticata, dove il livello di vita nelle campagne era poco più su di quello animale. Non eravamo che a poche centinaia di chilometri da Roma, col suo Governo, le Ambiasciate, i miliardi profusi come le lampade elettriche, e qui cadeva l’ombra delle caverne. La signora Lucrezia Falco, ex presidente delle Dame cattoliche, e ora, insieme a suo marito, l’ex maresciallo dei carabinieri Vincenzo Massa, proprietaria della locanda dove ci fermammo a mangiare, non dava però molta importanza a tutto questo. Anadando e venendo dalla cucina, invasa dal fumo della legna ci parlò invece delle altre benemerenze di Peschici: tre chiese, di cui una in campagna, un asilo retto dalle suore, alcuni locali scolastici per le elementari, un piccolo presidio con un brigadiere e due carabinieri, un regolare servizio di Finanza, con due o tre appuntati e qualche guardia, un ambulatorio per gli incidenti minimi, mentre per un pronto soccorso più serio bisognava recarsi a Foggia o a S. Severo. Ci parlò soprattutto, quasi religiosamente, dei quattro o cinque grandi proprietari di terre di Peschici: Della Torre, Martucci, Vigilante, Martella. A ciascuno di questi nomi, la voce le si addolciva, gli occhi mandavano reverenti lampi. La luce del giorno era giunta a quel punto che pare stia ferma, in uno splendore caldo, e un po’ triste, che dà sangue alle rocce e al cielo, ed è il momento preciso che comincia a mancare. Erano le cinque del pomeriggio, e lasciata la macchina sul bordo della strada, camminavamo con gli occhi alle porticine oscure delle grotte. Il chiarore del tramonto doveva entrare là dentro, attraverso l’esile trama delle tende, assai bello, come una luce di speranza e insieme di morte. Molti ragazzi ci seguivano, come sempre, viluppo di granchi e di uccelli. Erano neri, vivissimi, e fra tutti spiccava la testa stranamente aggressiva, rapata, di Maria di Mele. Sotto la strada, si stendeva quieto, senza una sola cresta, il mare. Là in fondo, molto lontano, c’erano le Isole Tremiti, con la loro colonia di coatti. «Bellu giovane, fammi la fotografia!», gridava continuamente, in quella gran pace, la voce metallica e dura di Maria di Mele. Essa era poco più grande di un gatto, ma intere generazioni di pirati fremevano in lei. Ripeteva il suo grido ogni cinque secondi, con uno scatto dove trapelava sempre più viva la meraviglia e l’ira di non essere obbedita. Non le bastano le lampadine, ne aveva già ottenute due o tre, lasciandosi sui compagni e strappandole loro a colpi di unghia, voleva la fotografia; nei suoi occhi nerissimi e lucidi di volatile, appariva il vigore e il tremito di un coltello. «Bellu giovane, fammi la fotografia!». Il mio compagno di viaggio non le dava troppo retta, andava invece guardando su, 324 Verso Sud D. Grittani alle porte che si aprivano nella roccia. Si affacciò, a una di quelle, una donna con un bimbo in braccio, e subito, spaventata, si ritrasse: non così in fretta che il sole che si spegneva di fronte, nel mare, non le mettesse un baleno sui denti. Ci accostammo a un’altra porta, e qui, dopo qualche titubante, carbonelli Mattea, moglie di un bracciante, acconsentì a farci entrare. Era una donna giovane, un po’ sciupata, con un sorriso sincero. Alzò appena una mano come a dire «tutto qui», e lasciò che guardassimo. C’era la miseria, in quell’antro, ma tutto era in ordine, quieto, pulito: il letto sotto la bassa volta di roccia, per gli sposi e i due bambini, il tavolo con i ritratti, i cestini e gli utensili di cucina attaccati in giro, i fasci di legna, gli abiti e la roba da rammendare accantonati in un angolo. La voce della donna, quando parlò, era incerta come il sorriso. Non si lamentò del suo alloggio. Disse soltanto di sperarne, in seguito, un altro, «di vera pietra, più grande». Questo misurava forse tre metri, era stretto e umido. «E come lo paghereste?», io dissi. Essa si confuse. Ammise che suo marito guadagnava quattrocento lire al giorno solo per tre mesi l’anno. Riudivamo dalla strada, sempre più accesa e insistente, la voce di Maria di Mele, che implorava e comandava una fotografia. Fosse l’ora, o le cose che avevamo viste, cominciava a farci paura quell’esserino. Lasciando la moglie del Carbonelli, e mentre riscendevamo pensierosi la scaletta, pregai il fotografo di accontentarla. Essa cominciò a saltargli intorno, con l’inquietudine di un lupo, allarmata e orgogliosa insieme. Per calmarla, mentre il fotografo andava innestando una lampadina, le chiesi di ripetermi il suo nome e cognome, e mi accinsi a scriverlo in un taccuino. Non ho mai visto un cambiamento più repentino e straordinario in una fisionomia. Da adulto e cattivo, quel viso si rifece infantile, tenero. I lineamenti si distesero; gli occhi piccoli e foschi si allargarono e risero. Una grande, una meravigliosa risata di gioia. Poi, guardando i compagni, guardando le rocce, e la gente ch’era affacciata alle rocce e guardando l’aria e il mare, e come bevendo e godendo improvvisamente di tutto, cominciò a gridare: «Mi ha scritta e mi basta, mi ha scritta e mi basta, mi ha scritta e mi basta.» Il fotografo aveva scattato qualche fotografia, ma essa era già corsa via. La ritrovammo più tardi nella macchina, seduta accanto alla guida, con gli occhietti buoni, ma fieri e felici come quelli di una signora: con una faceva dietro i vetri, ai compagni che la guardavano estatici, vaghi segni di saluto. Fu forza farla scendere a terra. Non ci odiava più, pensava. L’avevamo scritta, legata a qualche cosa, a qualcuno: oltre tutto quel mare, oltre l’isola dei coatti, oltre i boschi e le pietraie di questa terra, qualcuno aveva chiamato il suo nome, a cui la sua infanzia era cara, le aveva fatto intravedere l’approdo a una civiltà, un giorno, una vita. [Tratto da La lente scura. Racconti di viaggio, ANNA MARIA ORTESE, Marcos y Marcos, Milano 1991] PARTE XVI Isole Tremiti 327 Le Isole Tremiti Émile Bertaux Émile Bertaux (Fontenay-sous-Bois 1869 - Parigi 1917). Storico dell’arte, docente all’Università di Lione, tra le sue opere vanno citate Le tour du monde (1899), L’art dans l’Italie méridionale (1904) e Donatello (1910). Da Rodi vedevo l’arcipelago delle Tremiti stagliarsi sull’orizzonte del mare e non potevo resistere alla tentazione di recarmici per guardare da vicino le isole che, col Gargano e il Tavoliere, un tempo hanno dato vita al regno fantastico di Diomede. Molti ricordi storici mi spingevano là. Se non potevo sperare di scoprire la tomba di Giulia, nipote i Augusto, che morì esiliata in questo scoglio sperduto, contavo di trovare alcune rovine dell’abbazia che, al tempo della potenza benedettina, fu un Monte Cassino in mare aperto. Noleggiai dunque una barca di pescatori in una bella mattinata e un buon vento di scirocco. Il viaggio fu accidentato. I marinari, prudenti come i compagni di Ulisse, evitarono di lasciarsi trascinare dal vento contrario, diritto sulle isole. Seguendo l’usanza antica, costeggiarono la montagna fino alla punta che separa le due lagune di Lesina e di Varano, e che dista da Tremiti non più di venti miglia marine. Ma a mezzogiorno cadde la calma, che i marinai dell’Adriatico chiamano la «bonaccia morta». Dopo avere appreso in poche ore tutte le bestemmie che un pescatore del Gargano può proferire contro i Santi e Cristo in persona, quando è scontento di loro, arrivata la sera, gettammo l’ancora dinanzi alla spiaggia deserta di Varano e dormimmo, né bene né male, nella barca stessa, sotto la vela. L’indomani prima dell’alba, il vento di terra ci trascinò al largo e alle undici del mattino, più di venti quattro ore dalla partenza da Rodi, sbarcavo finalmente alla piccola «marina» dell’isola di San Nicola. Carabinieri e guardiaciurme, armati fino ai denti, ci aspettavano sulla spiaggia: quest’isola, infatti, come l’Elba e una delle Ponza, oggi funge da bagno penale. Tiro dalla tasca l’autorizzazione ufficiale a visitare le prigioni e le caserme, che mi era stata concessa, con la più perfetta cortesia, dal governo italiano, e, sotto buona scorta, mi incammino per sentieri coperti, 328 Verso Sud D. Grittani oltrepassando postierle fiancheggiate da torri e percorrendo tutto un dedalo di fortificazioni del XVI secolo. Il direttore della prigione mi riceve molto amabilmente, mi invita a pranzo e mi fa preparare una stanza. Un pomeriggio e un’intera mattinata sono appena sufficienti per esaminare attentamente il terreno e le costruzioni. Le Tremiti sono tre: l’isola di San Nicola, cinta dalle costruzioni dell’abbazia fortificata, oggi trasformata in luogo di detenzione; l’isola di San Domino, interamente boscosa o coltivata, dove i benedettini facevano un eccellente vino che serve ancora alla messa del buon prete dell’isola vicina, e di cui io posso, conoscendolo, vantare l’aroma e il bouquet. L’isola Caprara, molto più piccola delle altre due, è arida e deserta. Dall’alto del faro dell’isola di San Nicola si scorge ad est Pianosa, dove, con una buona vista, si possono distinguere due capanne di pescatori. Più lontano ancora, proprio in mezzo all’Adriatico, è Pelagosa che non appartiene più all’Italia. Da pochi anni, l’Austria ha in possesso quest’isola deserta, come res nullius: il che provocò le proteste violente del deputato Carlo Imbriani, il terribile ragazzo dell’irredentismo. Ho potuto, nel corso di un viaggio a bordo del Sénégal, passare a mezzo miglio da Pelagosa. Quest’isola è un sorella delle Tremiti, così perfettamente identica alle isole italiane, da sembrare uscita dallo stesso blocco di calcare. Della stessa formazione sono le grandi isole dalmate, di cui la più vicina è Lagosta. Si deve dire però che le Tremiti, con la foresta di San Domino e la faccia pelata di Caprara, sembrano un piccolo Gargano con le sue due regioni, una arida, l’altra verdeggiante, che un cataclisma avrebbe mandato in pezzi. E nel vedere le pareti frantumate di queste isole, che sembrano essere state violentemente separate, si è presi dall’evidenza di questa ipotesi, messa in luce da Suess: la montagna italica e le isole vicine hanno fatto parte di un grande continente adriatico, un giorno crollato, come le isole dalmate. L’abbazia, così arditamente costruita su questi scogli, che sembrano pronti essi stessi a sprofondarsi in un terremoto, non ha conservato costruzioni anteriori alla fine del secolo XVI. Solo la chiesa contiene pezzi considerevoli di un pavimento istoriato del XII secolo e un magnifico retablo veneziano di legno scolpito e dorato. La faccia, decorata con buone sculture, porta i buchi delle palle di cannone che nel 1809 la flotta austro-russa lanciò contro il battaglione cisalpino che difendeva l’isola, in nome di Napoleone. Già, nel XVI secolo, la superba fortezza dei benedettini, allora in possesso dei Regolari Lateranensi, aveva resistito coraggiosamente all’attacco dei vascelli turchi, comandati dal pascia Pialy. Quando volli lasciare l’isola, il vento si era alzato, e, per ritrovare la terra ferma, dovetti prendere una barca di pescatori dell’isola di San Nicola e far rotta per Termoli. La bora aspra e fredda sollevò la barca leggera; le onde alte spumeggiavano e sbattevano contro la bordatura. Un branco di delfini apparve sulla nostra scia e ci sfidò alla corsa. Allora io mi E. Bertaux Le Isole Tremiti 329 ritenni fuori del nostro secolo in questo battellino, simile a quelli che avevano portato verso la montagna cinta di nuvole, i pirati ellenici o illirici, in mezzo ai familiari delfini che ascoltavano la musica delle isole greche popolate di poeti, e che avevano trasportato sui flutti dell’arcipelago il cantore di Lesbo. I gabbiano che sfioravano la barca, lanciandoci un grido di richiamo, non erano i compagni di Diomede che Zeus, dopo la morte dell’eroe, trasformò in uccelli marini? Così mi lasciavo andare sul filo dei ricordi classici, quando un marinaio si mise a intonare una canzone contrastante col ritmo lento e doloroso dei canti dei montanari del Gargano. Un nome mi colpì: «Caserio!». E capii, ascoltando altre prole che suonavano stranamente sulla bocca di questi uomini semplici: «Sociale», «l’Internazionale»… Un altro marinaio, trascinato dall’esempio, prese a cantare l’«Inno dei lavoratori». Quelli che avevano portato questi canti di nuove battaglie nell’isola di Diomede, di Giulia Augusta e dei monaci di San Benedetto, erano gli ottocento uomini di ogni nazione, di ogni sorte, che il capriccio di un ministro dittatore aveva riunito su quest’isola, in cui dovevano trovare, secondo un amabile eufemismo, il domicilio forzato, domicilio coatto. Gli isolani di Tremiti cantavano al mare le canzoni sovversive degli «anarchici» di Crispi. [Tratto da Le tour du monde, tomo IV, giugno 1899, traduzione di Antonio Motta] PARTE XVII Poesie 333 Lettera a Padre Pio da Pietrelcina Gabriele D’Annunzio Sebbene l’archivio del Vittoriale parli di un incontro tra Padre Pio e il poeta abruzzese, è davvero difficile stabilire se nell’agosto del 1924 i due grandi personaggi storici si siano davvero incontrati. Certa è invece questa appassionata missiva che il vate inviò al frate delle stimmate, invitandolo a fargli visita «nel suo eremo». Mio fratello, so da quante favole mondane, o stupide o perfide, si è offuscato l’ardore verace del mio spirito. E per ciò m’è testimonianza della tua purità e del tuo acume di Veggente l’aver tu consentito a visitarmi nel mio Eremo, l’aver tu consentito a un colloquio fraterni con colui che non cessa di cercare coraggiosamente sé medesimo. Caterina la Senese mi ha insegnato a “gustare” le anime. Già conosco il pregio della tua anima, Padre Pio. E son certo che Francesco ci sorriderà come quando dall’inconsueto innesto prevedeva il fiore e il frutto inconsueti. Ave. Pax e bonum malum et pax Gabriele D’Annunzio [Lettera indirizzata a Padre Pio in San Francesco, pubblicata su Il Vittoriale del 28 novembre 1924] 335 Tavoliere controvento Elio Filippo Accrocca Elio Filippo Accrocca (Cori, Latina 1923 - Roma 1997). Poeta e critico d’arte, insegnò per alcuni anni all’Accademia di Belle Arti di Foggia. Tra le sue opere più significative Reliqua umana (Scheiwiller 1955), Ritorno a Portonaccio (Mondadori 1959) e Siamo non siamo (Rusconi 1974). L’indomito segno toglie la maschera agli «oggetti» che tu assapori dentro, senza inganni, mescolati nel gesto che riaffiora da remote radici: volti umani incisi dall’iperbole che sa il raccolto stento della vita. Mani da pesa ove si culla il fiato dei figli, come dono d’un mistero svelato, hanno solchi di terra, arata febbre nel possesso del nulla... Ma lo zoccolo dei tuoi cavalli s’impenna come furia scagliata controvento ed è l’attrito del ferro sulla pietra. Una scintilla riaccende il fuoco delle cattedrali esposte sopra il grano. Spazio e rabbia maturano parole come fionde per il nuovo alfabeto... [Poesia tratta da Siamo non siamo, ELIO FILIPPO ACCROCCA, Rusconi, Milano 1974] 337 Dal pattume dei secoli... Cristanziano Serricchio Cristanziano Serricchio (Monte Sant’Angelo 1922). Tra le voci più originali della nuova poesia pugliese, più volte segnalato dal Premio Internazionale Eugenio Montale, di Cristanziano Serricchio vanno citate le sillogi poetiche L’occhio di Noè (Rebellato 1960), Stele Daunie (Lacaita 1976), Poesie 19781992 (Editori Associati 1993) e la più recente Polena (Tracce 1997). Dal pattume dei secoli frantumi di vicende setacci, e cossi taglienti come gridi tramutati in onde larghe di gabbiani che antichi miti ammucchiano nel mare. Non danno più vita gli innumerevoli uteri scavati nella roccia: vi si attorce il fico con amare radici e il ramarro snida la vipera gonfia d’accecante veleno. Le parole sono ancora pietre rotolate fra i dirupi del tempo, spettrali teste a pinnacolo sui tondi coperti delle tombe-culle senza nome o nenia che s’alzi dopo l’alba. Il linguaggio del neolitico dauno come il mio il tuo di sempre e di domani ha lo stile geometrico della ceramica dipinta a bande rosse e nere, ma fesso come il vaso frammentario nel terriccio che setacci sotto l’alta estate e l’insopportabile cicala nell’etera luce. [Poesia tratta da Stele Daunie, CRISTANZIANO SERRICCHIO, Lacaita, Manduria 1976] 339 Sante Mattéie Giacomo Strizzi Giacomo Strizzi (Alberona 1888 - Torino 1961). Della romantica poesia dialettale di Giacomo Strizzi, caso quasi unico nel panorama letterario italiano, si sono occupati tra gli altri Eugenio Montale, Tommaso Fiore, Pier Paolo Pasolini e Francesco Piccolo. Tra le sue raccolte poetiche più conosciute Fattarédde e quatrétte (Il nuovo Belli 1959). Juste a sante Mattéie, muccecate u quatrate d’o cacciune ‘rrajate, ndo delirie d’a fréve, com’a n’aspeda-surde, pe ‘ntéerre ze sturcéve. Cercènne, a pòvra mamme, stujarle, pe nu pizze d’u maccature, a vócche, iisse sgregnave: - Arràssete, oie, ma’ ncóre te mòccheche! - [Poesia tratta da Fattarédde e quatrétte, GIACOMO STRIZZI, Il nuovo Belli, Roma 1959] 341 Viaggio in Puglia Maria Luisa Spaziani Tra gli autori che questa antologia si onora di ospitare figura anche Maria Luisa Spaziani, la celebre poetessa torinese la cui vita è ormai indissolubilmente legata a quella del grande Eugenio Montale. Difatti, continuamente invitata a conferire sulla figura poetica del Premio Nobel genovese, dev’essere capitato che di transito per la Puglia la Spaziani non abbia opposto resistenza al suo istinto creativo, dando così vita ai versi qui riportati. Cinquanta minuti d’aereo nel tratto Roma-Brindisi danno assurdi complessi nei confronti di Orazio. Lui sobbalzava a ogni ciottolo, beveva a ogni taverna, se fosse morto per strada sarebbe ancora là. Noi corriamo corriamo ma il diavolo sghignazza perché sa, vecchio saggio, la vera verità. I gesti e i movimenti si annullano a vicenda e i trentamila giorni sfumano, a Thule o qua. 343 Lamento per il Sud Salvatore Quasimodo Salvatore Quasimodo (Siracusa 1901 - Napoli 1968). Ovvio annoverare il Premio Nobel del 1959 tra i maggiori poeti della letteratura contemporanea. Durante un viaggio verso Milano, dove Quasimodo insegnava presso il Conservatorio Giuseppe Verdi, il poeta siciliano fu costretto a sostare per alcune ore in Puglia a causa di un’anomalia al locomotore del treno su cui viaggiava. La poetica immobilità del panorama, fissata attraverso il finestrino, gli suggerì i versi da tutti conosciuti col titolo di Lamento per il Sud. Oh, il Sud è stanco di trascinare morti in riva alle paludi di malaria, è stanco di solitudine, stanco di catene, è stanco della luce della sua bocca delle bestemmie di tutte le razze che hanno urlato morte con l’eco dei suoi pozzi che hanno bevuto il sangue del suo cuore. Per questo i suoi fanciulli tornano sui monti, costringono i cavalli sotto coltri di stelle, mangiano fiori d’acacia lungo le piste nuovamente rosse, ancora rosse, ancora rosse. Più nessuno mi porterà nel Sud. E questa sera carica d’inverno è ancora nostra, e qui ripeto a te il mio assurdo contrappunto di dolcezze e di fuori un lamento d’amore senza amore. 345 Da Foggia a Lucera correndo... GIUSEPPE UNGARETTI Da Foggia a Lucera correndo con i suoi fari inquieta .................................... [Poesia tratta da Un grido e paesaggi, GIUSEPPE UNGARETTI, Mondadori, Milano 1952] 347 Segnorina pugliese Luciano Luisi Luciano Luisi (Livorno 1924). Nato da padre pugliese, Luciano Luisi ha conservato di questa regione (e della Capitanata in particolare) un ricordo molto vivo. Critico d’arte e letteratura, nonché egli stesso pregevole poeta, Luisi per alcuni anni ha insegnato all’Accademia di Belle Arti di Foggia, curando le pubblicazioni di molte case editrici locali ed elevando notevolmente il dibattito culturale foggiano dei primi anni Ottanta. Ha sapore di menta quest’aria che allontana l’azzurro dalle pietre. La prima ombra inventa una precaria tenerezza in te. (Tra i pini dell’Ardenza perdersi in questo fiato che ha dilatato il cielo e riconduce i sogni a una pervenza!) Al tuo paese l’estate è una campana che chiama ad una festa. Ma qui, sulle strade di polvere, le viole non fioriscono, qui batte le pietre il passo duro dei soldati a cammini a cercare una freschezza con una inquieta nostalgia di prati. Cammini sui confini della piazza, cammini verso il mare Verso Sud 348 tra gli archi ove s’impiglia il vento della sera e ti protendi all’inasprito volo dei gabbiani. (Forse la vita è oltre, ove non giunge l’ombra di queste guglie, ove finisce un tempo e un altro s’apre all’imprevisto e un evento è li domni, da tentare). Ma basta un cenno e torni senza pena, e dici parole d’amore. (vengono vannogli stessi soldati, non hanno nome, non sanno come ti chiami). Torni al giardinetto della statua equestre (il mare è sugli scogli a disperare), costretta come un albero alla terra, ma dal tuo cuore sale uno svolo di sogni sulla piazza. Ora la bocca che conosce il fiato di mille solitudini si placa nel fuoco innocuo d’una sigaretta. (Anche fumare è accendere nell3aria un segno vivo, una bandiera umana di speranza, se da lontano stride l’ultima ruota in fuga lungo i Fossi). Tu sorridi a chi passa: meno vuota è la notte. [Poesia tratta da Un pugno di tempo, LUCIANO LUISI, Guanda, Parma 1967] D. Grittani 349 Stringe l’inverno... Michele Urrasio Michele Urrasio (Lucera 1937). Poeta raffinato, persona schiva e riservata, ha firmato opere che hanno suscitato l’interesse di Giorgio Bárberi Squarotti e Mario Sansone. La poesia riportata in questa sede è tratta da una delle raccolte più significative del poeta lucerino, cioè L’infinita pazienza (con prefazione proprio di G.B. Squarotti, Edizioni del Rosone 1992). Stringe l’inverno delle nostre fughe il campanile a picco sul Tavoliere riarso. Lungo la balza scoscesa rotolarono - a brani - i sogni che si illusero di saperci uomini sicuri nel perimetro del mondo sconfinato. Dalle gole dell’Est un vento impietoso disperdeva le nostre attese. [Poesia tratta da L’infinita Pazienza, MICHELE URRASIO, Edizioni del Rosone, Foggia 1992] 351 Dedicata alla mamma ANDREA PAZIENZA Dormi, dormi, dormi dormi almeno tu che puoi dormire. Io penso a te, tu non pensare a me. Tu pensa ad un cavallino d’argento, tu pensa ad un trenino che con i fari accesi ti diverte, tu pensa ad una mano che t’accarezza. Io penso a te, tu non pensare a me. [Poesia tratta da Paz, ANDREA PAZIENZA, scritti, disegni, fumetti a cura di Vincenzo Mollica, Einaudi Stile Libero, Torino 1997] 353 I pellegrine d’Incurnate Raffaele Lepore Raffaele Lepore (Foggia 1923 - 1989). Poeta dialettale iniziatore della lunga tradizione dei componimenti in vernacolo foggiano, autore di molte commedie rappresentate con fortuna anche in città dell’Italia settentrionale. Di Raffaele Lepore abbiamo scelto - ci auguriamo in sintonia con la sua ironia - la lirica I pellegrine d’Incurnate, che affronta con un certo disincanto l’aspetto ameno della religiosità. Scennèvene all’appide ’i pellegrine ’a caruvane indère, ’a cendenare, d’Abbruzze, da ’u Gargane, d’Appennine: gènde de tutt’età, ck’a vèra fède. N’ôme ck’a Croce jève annand’ annande, n’âte ck’u cambanille jève arrète; na voce ’ndunàve: «Viva Maria!», ’u core respunnève tutt’anzîme: «Maria sempre evviva!» e ’a latanije cundenuave sèmbe, ’nze fermave! Gènde ca jève scàveze, chiagnève, suffrève, pregàve, nen se stangàve! Quann’ arruvave annand’ o Sanduàrie, fatte ’i trè gire atturn’ atturne ’a Chise, ck’i denucchie pe ’ndérre e i vrazze alàrie sta génde lucculàve, e qualchèdune trasènne inde, sèmbe ’ngenucchiate s’avvecenave, lènga strascenùne fin’a l’altare andò stève ’a Madonne; cercave ’a grazie e i lacreme sengère 354 Verso Sud D. Grittani cadèvene pe ’ndèrre tonne tonne. Ditte i raziune, e avute ’u sègne ’mbronde d’o prèvete, cke l’uglie d’a Madonne, ’i pellegrine èrene già pronde p’ascì a gruppe oppure ’a specciulate. Finalmènte ind’o vósche se magnave: na merènne purtàte ind’a mappàte. Ma prime de turnà, è bangarèlle ognune jève pe purtà ’u recûrde: ’u cavallucce, ’a ’ndrite ck’i nucèlle, ’a medagliozze, ’a pupe de cartone, i pènne gialle e rosce p’u cavalle, na zènne de cupète, o nu pallone. ... ’A Croce annande e ’u cambanîlle arrète, pegghiave a vie de Fogge ’a cumbagnije: n’Avemmarie... nu mùzzeche ’a cupète. [Poesia tratta da Quann’ère uaglione, RAFFAELE LEPORE, Foggia 1967; ristampa a cura dell’Associazione Cittadina Foggia Viva, Foggia 1997] PARTE XVIII Citazioni 357 «Foggia è la città più brutta del mondo, assieme a Calcutta nelle Indie e a La Paz in Bolivia». Alberto Moravia [Dichiarazione rilasciata durante una conferenza tenutasi a Foggia, presso il Cine Teatro Ariston, nel dicembre del 1971. A questa dichiarazione seguì nei primi anni Ottanta un elzeviro pubblicato dal Corriere della Sera a firma di Giorgio Manganelli, il quale conveniva con Cesare Brandi circa le molte bellezze della Capitanata e condannava, invece, apertamente le incaute affermazioni di Moravia] «Ma con tutti i posti che ci sono al mondo guarda dove mi è venuto a portare. Nella rada di Foggia, perché la pianura concilia la riflessione intellettuale». Vittorio Gassman [Brano tratto dal testo dello spettacolo teatrale Camper, di Vittorio Gassman, con Vittorio Gassman, Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz. Testo pubblicato dalla Longanesi, Milano 1994] «Antò Lu Purk, priogioniero nel buio dello scompartimento respirava male, a labbra dischiuse. Stava sognando una festa di genitori e figli all’interno di un centro sociale occupato. A Foggia città». Silvia Ballestra [Brano tratto dal racconto intitolato Dams, sogni a Foggia, contenuto nella raccolta di racconti Compleanno dell’Iguana, Transeuropa, Ancona 1991] «Questa piazza di Lucera soddisfava l’austerità e la bellezza che cercavamo. Per questo abbiamo deciso di girare qui questo film». Massimo Troisi [Dichiarazione rilasciata durante un’intervista concessa sul set del film Le vie del Signore sono finite, aprile 1987] 358 Verso Sud D. Grittani (...) A Rodi Garganico fecero indigestione di anguille, a Vieste di carrubbe. A Polignano furono derubati del timone dentro le grotte Palazzesi. A Brindisi trovarono un vaglia della famiglia, a Torre Chianca furono derubati del pagliolo e fecero indigestione di frutta. Piero Chiara [Brano tratto dal romanzo Il piatto piange, Mondadori, Milano 1962] (...) Il monte Gargano già si allontana, di un azzurro poco più che intenso del cielo. Si distingue ancora il profilo da cittadella crociata di Monte Sant’Angelo e la falcatura luminosa, celeste, del golfo di Manfredonia. Lalla Romano [Brano tratto da Diario di Grecia, Einaudi, Torino 1974] 359 Bibliografia AA. VV., Narratori di Puglia e Basilicata, a cura di M. SANSONE - S. PAOLO, Mursia, Milano 1966. AA.VV., Poeti dauni contemporanei, a cura di C. SERRICCHIO - A. MOTTA - C. SIANI, Editrice Apulia, Foggia 1977. AA.VV., Viaggiatori antichi e moderni in terra di Bari e Foggia, Edizioni del Baricentro, Bari 1992. AA.VV., Mascagni ritrovato 1863/1945 l’uomo, il musicista, Casa Musica Sonzogno, Milano 1995. AA.VV., La Capitanata, Rassegna di vita e di studi a cura della Biblioteca Provinciale di Foggia, Provincia di Foggia, A. XXXIIXXXIII 1995/1996 n.s. 3 - 4. A. CASIGLIO, I confini territoriali del “Monasterium Terrae Maioris”, Atti del 12° convegno nazionale sulla Preistoria - Protostoria - Storia delle Daunia, Archeoclub D’Italia, Tipografia Dotoli, San Severo 1990. A. CECERE a cura di, Viaggiatori inglesi in Puglia nel Settecento, Schena, Fasano 1991. M. HEERRMANN-A. SEMERARO a cura di, Viaggiatori in Puglia dalle origini alla fine Ottocento, Schena, Fasano 1991. M. MARCONE, Le pietre si muovono, Mursia, Milano 1989. A. MOTTA a cura di, In viaggio per le terre dell’Arcangelo, Comunità Montana del Gargano, Tip. Calderini, Bologna 1991. A. MOTTA a cura di, In viaggio per la Magna Capitana, poeti, scrittori e viaggiatori tra Otto e Novencento in Capitanata, Bastogi, Foggia 1994. A. MOTTA a cura di, La terra dell’Ofanto, Piero Lacaita Editore, Roma-Bari-Manduria 1998. R. NIGRO, Viaggio in Puglia, Laterza, Bari 1991. A. PAZIENZA, Paz, scritti, disegni, fumetti a cura di VINCENZO MOLLICA, Einaudi “Stile Libero”, Torino 1997. G. PIOVENE, Viaggio in Italia, Mondadori, Milano 1965. C. PRENCIPE DI DONNA a cura di, Carteggi di Nicola Zingarelli, Società Dauna di Cultura, Foggia 1979. T. SCAMARDI a cura di, Viaggiatori tedeschi in Puglia nel Settecento, Schena, Fasano 1990. T. SCAMARDI a cura di, Viaggiatori tedeschi in Puglia nell’Ottocento, Schena, Fasano 1992. P. SOCCIO, Omaggio a Foggia, Adda Editore, Bari 1974. M. URRASIO, L’infinita pazienza, Edizioni del Rosone, Foggia 1992. 361 Indice alfabetico degli autori Accrocca, Elio Filippo 335 Alberti, Leandro 225 Alvaro, Corrado 255 Augias, Corrado 7 Bacchelli, Riccardo 137, 283 Baldini, Antonio 217, 269 Ballestra, Silvia 357 Bennato, Eugenio 103 Bertaux, Émile 327 Brooke, Jocelyn 75 Casiglio, Antonio 109 Cassieri, Giuseppe 209 Chiara, Piero 353 D’Annunzio, Gabriele 333 De Sanctis, Francesco 151 Di Lascia, Mariateresa 157 Di Taranto, Consalvo 281 Douglas, Norman 179 Fiore, Tommaso 305 Fraccacreta, Umberto 107 Gassman, Vittorio 357 Gatto, Alfonso 315 Giordano, Umberto 85 Greene, Graham 267 Gregorovius, Ferdinand 121, 247 Kantorowicz, Ernesto 71 Lenormant, François 35, 39 Lepore, Raffaele 353 Lilli, Virgilio 203 Luisi, Aldo 19 Luisi, Luciano 347 Marcone, Maria 67 Mascagni, Pietro 175 Mattielli, Egidio 275 Miller, Arthur 233 Montale, Eugenio 77, 83 Moravia, Alberto 357 Nigro, Raffaele 55 Northall, John 17 Ortese, Anna Maria 321 Parzanese, Pietro Paolo 161 Pazienza, Andrea 117, 351 Piovene, Guido 89 Pratolini, Vasco 65 Quasimodo, Salvatore 343 Romano, Lalla 358 Roversi, Roberto 317 Saint Non, Abbé de 29 Sansone, Mario 7 Schubring, Paolo 45 Serricchio, Cristanziano 337 Sinisgalli, Leonardo 199 Spaziani, Maria Luisa 341 Stolberg, Friedrich Leopold 169 Soccio, Pasquale 101 Strizzi, Giacomo 339 Tommasini, Justus 167 Troisi, Massimo 357 Tusiani, Joseph 309 Ungaretti, Giuseppe 53, 87, 141, 145, 191, 195, 259, 261, 303, 345, Urrasio, Michele 349 Zingarelli, Nicola 173 Finito di stampare nel mese di ottobre 2000 presso il Centrografico Francescano. Foggia per conto di Claudio Grenzi Editore ISBN 88-8431-034-2 Terzo millennio Collana di studi della Provincia di Foggia 1 Verso Sud a cura di Davide Grittani testi di Elio Filippo Accrocca Leandro Alberti Corrado Alvaro Corrado Augias Riccardo Bacchelli Antonio Baldini Silvia Ballestra Eugenio Bennato Émile Bertaux Jocelyn Brooke Antonio Casiglio Giuseppe Cassieri Piero Chiara Gabriele D’Annunzio Francesco De Sanctis Mariateresa Di Lascia Consalvo Di Taranto Norman Douglas Tommaso Fiore Umberto Fraccacreta Vittorio Gassman Alfonso Gatto Umberto Giordano Graham Greene Ferdinand Gregorovius Ernesto Kantorowicz François Lenormant Raffaele Lepore Virgilio Lilli Aldo Luisi Luciano Luisi Maria Marcone Pietro Mascagni Egidio Mattielli Arthur Miller Eugenio Montale Alberto Moravia Raffaele Nigro John Northall Anna Maria Ortese Pietro Paolo Parzanese Andrea Pazienza Guido Piovene Vasco Pratolini Salvatore Quasimodo Lalla Romano Roberto Roversi Abbé de Saint Non Mario Sansone Paolo Schubring Cristanziano Serricchio Leonardo Sinisgalli Maria Luisa Spaziani Friedrich Leopold Stolberg Pasquale Soccio Giacomo Strizzi Justus Tommasini Massimo Troisi Joseph Tusiani Giuseppe Ungaretti Michele Urrasio Nicola Zingarelli Edizione fuori commercio riservata alla Provincia di Foggia La pianura s’apre come un mare. Vorrei qui vederlo nel suo sfogo immenso, ondeggiare coll’alito tormentoso del favonio sopra il grano impazzito. Giuseppe Ungaretti
Scarica